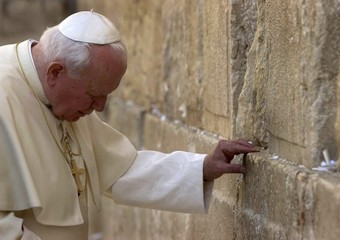
Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! Fonti cattoliche a confronto, in chiave dialettico-polemica. Ripreso Giovanni Paolo II, l’ennesimo affondo per il dibattito - di Federico La Sala
 AMORE E RESPONSABILITA’
AMORE E RESPONSABILITA’
 di Karol Wojtyla - Giovanni Paolo II *
di Karol Wojtyla - Giovanni Paolo II *
L’INDICE DEL LIBRO
I. La persona e la tendenza sessuale
Analisi della parola “godere”
1. La persona soggetto e oggetto dell’azione
2. Primo significato della parola “godere”
3. “Amare” contrapposto a “usare”
4. Secondo significato della parola “godere”
5. Critica dell’utilitarismo
6. Il comandamento dell’amore e la norma personalistica
Interpretazione della tendenza sessuale
7. Istinto o impulso?
8. La tendenza sessuale, proprietà dell’individuo
9. La tendenza sessuale e l’esistenza
10. Interpretazione religiosa
11. Interpretazione rigorista
12. La libido e il neo-malthusianismo
13. Considerazioni finali
II. La persona e l’amore
Analisi generale dell’amore
1. La parola “amore”
2. L’attrazione e la presa di coscienza dei valori
3. Due forme d’amore: la concupiscenza e la benevolenza
4. Il problema della reciprocità
5. Dalla simpatia all’amicizia
6. L’amore sponsale
Analisi psicologica dell’amore
7. La percezione e l’emozione
8. Analisi della sensualità
9. L’affettività e l’amore affettivo
10. Il problema dell’integrazione dell’amore
Analisi morale dell’amore
11. L’esperienza vissuta e la virtù
12. L’affermazione del valore della persona
13. L’appartenenza reciproca delle persone
14. La scelta e la responsabilità
15. L’impegno della libertà
16. Il problema dell’educazione dell’amore
III. La persona e la castità
Riabilitazione della castità
1. La castità e il risentimento
2. La concupiscenza carnale
3. Soggettivismo ed egoismo
4. La struttura del peccato
5. Il vero significato della castità
Metafisica del pudore
6. Il fenomeno del pudore sessuale e la sua interpretazione
7. La legge dell’assorbimento della vergogna da parte dell’amore
8. Il problema dell’impudicizia
Problemi della continenza
9. Il dominio di sé e l’oggettivazione
10. Tenerezza e sensualità
IV. Giustizia verso il Creatore
Il matrimonio
1. La monogamia e l’indissolubilità
2. Il valore dell’istituzione
3. Procreazione, paternità e maternità
4. La continenza periodica, metodo e interpretazione
La vocazione
5. Il concetto di giustizia verso il Creatore
6. 6 La verginità mistica e la verginità fisica
7. Il problema della vocazione
8. La paternità e la maternità
 Appendice: La sessuologia e la morale.
Appendice: La sessuologia e la morale.
 Sommario complementare
Sommario complementare
1. Introduzione
2. Il sesso
3. La tendenza sessuale
4. Problemi del matrimonio e dei rapporti coniugali
5. Il problema della regolazione delle nascite
6. La psicoterapia sessuale e morale
|
I genitori di Wojtyla e il piccolo Karol |
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" (Giovanni Paolo II, 2003)
 RIPARARE IL MONDO. LA CRISI EPOCALE DELLA CHIESA ’CATTOLICA’ E LA LEZIONE DI SIGMUND FREUD.
RIPARARE IL MONDO. LA CRISI EPOCALE DELLA CHIESA ’CATTOLICA’ E LA LEZIONE DI SIGMUND FREUD.
Federico La Sala
Forum
-
> Amore e responsabilità --- Al di là del ’cattolicesimo’ socratico-platonico. Una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso17 marzo 2024, di Federico La Sala
USCIRE DALL’#INFERNO DELLA #RIPETIZIONE E DAL #LETARGO DI MILLENNI (Par. XXX, III, 94).
 Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...
Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...IL PROGRAMMA DI #DANTEALIGHIERI ALL’ORDINE DEL GIORNO (#25MARZO 2024: #Dantedì).
Riprendere il cammino di "#Ulisse" e portarsi oltre il "Convivio", il #Simposio, di #Platone e del suo "socratico" #amore (#Eros), avido e cupìdo, #figlio nato dalla astuta alleanza (#Metis) dell’#uomo-#Ingegno (gr. #Poros) e della #donna-#Povertà (gr. #Penia). La lezione di Platone appare essere la chiara codificazione di una fenomenologia dello spirito della #tragedia e la sua parola una versione della #Legge del #Figlio di Dio (#Zeus) , #Apollo: "«non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (#Eschilo, #Eumenidi, 657 ss.): : un ’#cattolicesimo’ platonico.
- STORIAELETTERATURA, #FILOLOGIA E #CRITICA: #DIVINACOMMEDIA. Gianfranco #Contini: «[...] L’impressione genuina del postero, incontrandosi in Dante, non è d’imbattersi in un tenace e ben conservato sopravvissuto, ma di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui» (cfr. "Un’interpretazione di Dante", in Id., G. Contini, "Un’idea di Dante. Saggi danteschi", Torino, Einaudi, 2001, I ed. 1970, pp. 110-11).
ARTE, #ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA E #TEOLOGIA:
- MICHELANGELO BUONARROTI, I PROFETI E LE SIBILLE.
LA "STORICA" #LEZIONE ANTROPOLOGICA DELLA #CORNICE LIGNEA DEL #TONDODONI (E DELLA #NARRAZIONE DELLA #VOLTA DELLA #CAPPELLASISTINA: DUE PROFETI E #DUE SIBILLE "INDICANO" LO #SPAZIOTEMPO DELLA #NASCITA DEL #FIGLIO DI #MARIAEGIUSEPPE. Come mai gli esperti della #GalleriadegliUffizi "insistono" a sostenere che nella "cornice del Tondo [...] sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti"?!
-
> Amore e responsabilità --- È morta Wanda Półtawska - Wojtasik, “sorella” di Karol Wojtyła tra orrori e speranze del ’900: medico e psicologa, fu legata a Giovanni Paolo II da profonda amicizia (di Giampaolo Mattei).26 ottobre 2023, di Federico La Sala
È morta Wanda Półtawska, “sorella” di Karol Wojtyła tra orrori e speranze del ’900
Sopravvissuta agli inumani esperimenti nazisti condotti nel lager di Ravensbrück. Medico e psicologo, membro del Pontificio consiglio per la famiglia, della Pontificia Accademia per la Vita e consultore del Pontificio Consiglio della pastorale per gli operatori sanitari, Półtawska fu legata a Giovanni Paolo II da una profonda amicizia intellettuale e spirituale
di Giampaolo Mattei (Vatican News, 25 ottobre 2023)
«Karol Wojtyła è stato - e resta - per me un padre, un fratello e un amico straordinariamente insieme nella stessa persona, ma soprattutto è stato - e resta - una grazia inventata dallo Spirito Santo, una ventata di speranza cristiana tra le tenebre del mondo, e non solo per me». Wanda Półtawska - morta alle 23.30 di ieri, martedì 24 ottobre, e davvero ancora nell’orbita spirituale della memoria liturgica di san Giovanni Paolo ii celebrata domenica - scelse queste parole per dire “sì”, con uno slancio non infiacchito dall’età, alla richiesta de «L’Osservatore Romano» di scrivere una testimonianza nel numero speciale (18 maggio 2020) dedicato ai cento anni dalla nascita del suo «padre, fratello, amico» che la chiamava affettuosamente dusia e cioè sorellina.
Wanda Półtawska - Wojtasik il cognome da nubile - avrebbe compiuto 102 anni (classe 1921, un anno più giovane di Wojtyła) il 2 novembre: per quel “gioco” di coincidenze (che poi coincidenze non sono) giorno della “prima messa” di don Karol nella cripta di san Leonardo al Wawel di Cracovia (era il 1946).
Donna con stile e carattere di roccia, con modi diretti e parole essenziali di fronte a qualsiasi interlocutore. Donna libera, soprattutto. Con una storia personale che la rende oggi quasi una “icona” della travagliata storia del Novecento per la sua Polonia e la stessa Europa. Un travaglio che le cronache di questi giorni confermano tragicamente attuale.
Originaria di Lublino, Wanda ha vissuto esperienze fondanti nei circoli della gioventù cattolica, negli scout, anche nello sport, e ha studiato nel Collegio delle suore orsoline. Per poi rimboccarsi le maniche - un gesto energico che le era proprio, quasi come fosse un “segnale di battaglia” - nella resistenza polacca all’invasione nazista in Polonia avvenuta il 1° settembre 1939.
Arrestata il 17 febbraio 1941 - appena diciannovenne - è stata prima vittima di maltrattamenti nel lugubre carcere della sua Lublino e poi, dal 21 novembre dello stesso anno, ha visto il suo nome trasformato nel numero 7709 nel famigerato lager di Ravensbrück, particolarmente noto per gli inumani esperimenti sulle prigioniere (delle quarantamila donne polacche lì rinchiuse ne sono sopravvissute ottomila).
Wanda-7709 è stata ridotta a cavia. Per la precisione (usando l’ignobile terminologia nazista) a “Kaninchen” - e cioè “coniglio” - per la “clinica della morte” diretta dal “dottor” Kael Gebhard, medico personale di Heinrich Himmler, capo della Gestapo. Per studiare farmaci per i soldati al fronte, alle donne venivano provocate fratture e amputazioni. Ed erano sottoposte a ogni sorta di “sperimentazioni”, quasi sempre mortali.
Vivere «l’inferno», la disumanità - ha poi ripetuto Wanda per tutta la vita dopo essere sopravvissuta «per grazia di Dio e con un motivo, evidentemente» al lager (venne liberata tra aprile e maggio 1945 dall’Armata rossa) - è stato «l’incendio» che l’ha convinta a laurearsi in medicina e in psicologia con specializzazione in psichiatria, studiando anche filosofia. Al cuore di tutto, per lei, c’era la questione della persona umana, della sua dignità. «Chi è l’uomo?» la domanda unica, di fondo, che da donna cristiana si è posta durante e dopo Ravensbrück.
- [Foto] Wanda Półtawska
Finita la guerra, Wanda si è subito trasferita a Cracovia, proprio per provare a cancellare “l’incubo”. Non le era servito a nulla mettere per iscritto le sue memorie (Ho paura dei sogni). No, l’orrore non si cancella. Ma si può trasformare.
Ecco, far convivere la ruvidezza dell’esperienza di Ravensbrück in tenerezza per le persone sofferenti è, forse, la testimonianza più alta della dottoressa Półtawska. Sì, la scelta di non mettersi dalla parte del rancore vendicatore ma della ricostruzione di un popolo partendo dalla sua parte più debole: le persone malate, le persone con disabilità.
Facendolo, poi, con strategie innovative per quel tempo. Tanto da metter su una “pastorale familiare” che prendeva le mosse dal momento della malattia e dalla centralità della persona umana.
Ma non era proprio “sufficiente” per lei la missione di medico e psicologo, seppure davvero “in prima linea” nella Polonia comunista del dopoguerra. Wanda cercava “qualcosa in più”, quella “scintilla della fede” nella storia degli uomini e delle donne così duramente provati da una guerra senza sconti.
A cambiarle - letteralmente - la vita ecco l’incontro con don Karol Wojtyła («Ho capito subito che era un sacerdote santo e gli ho chiesto di essere il mio confessore»). Per un sodalizio spirituale di amicizia durato oltre mezzo secolo, tessuto di comunione, incontri, lettere, preghiera. Un sodalizio vivace spiritualmente e intellettualmente, e non interrotto, anzi rilanciato in modo nuovo, dall’elezione di Wojtyła al Pontificato il 16 ottobre 1978 («perché l’amicizia c’è o non c’è e se c’è resta per sempre»). Un sodalizio, ha confidato Wanda, che neppure la morte ha interrotto perché - dopo essergli stata accanto fino a quel 2 aprile 2005 (leggendogli testi spirituali e letteratura polacca: le passioni del suo amico morente) - convintissima che la fede dà la certezza che le autentiche relazioni umane non si spezzano.
La conoscenza con don Wojtyła è divenuta prima stima e poi amicizia in fraternità a partire da un vero e proprio “esercizio spirituale” quotidiano e dalle questioni più gravi che toccano la vita dell’uomo. A determinare una collaborazione “sul campo” è stata la promulgazione in Polonia, nel 1956, della legge sull’aborto. Wanda non hai mai usato giri di parole: «Nel lager di Ravensbrück ho visto i nazisti usare spregiudicatamente come cavie le donne incinte e anche buttare i neonati nei forni crematori e mi sono ripromessa che, se fossi sopravvissuta, avrei difeso la vita in ogni modo, soprattutto dei bambini, senza eccezioni». Per le sue posizioni, espresse in modo forte, contro l’aborto - radicate proprio nell’esperienza omicida dei lager - non sono mancati forti contrasti.
Ma è stata proprio quella legge a «impressionare» i due amici: «Lui come sacerdote, io come medico iniziammo una collaborazione per un lavoro comune» per contrastarla con i fatti. Ecco la praticità, la consapevolezza di una donna e di un uomo che avevano vissuto sulla loro pelle la guerra. Tanto che il giovane sacerdote aveva messo a disposizione il suo piccolo appartamento come punto di incontro per le coppie. Pastorale familiare senza piani pastorali complessi, dunque. Messa su alla buona, senza strutture, da quella dottoressa tenace e da quel sacerdote «pronto ad ascoltare con capacità rara» che scattavano all’unisono per provare a salvare la vita di un bambino - «fosse anche uno solo» - «salvandone, delicatamente, anche la famiglia».
Già, la famiglia. In Wanda, nel marito Andrzej, filosofo, e nei loro quattro figli «Karol Wojtyła ha trovato una seconda famiglia, quella famiglia che lui aveva perduto giovanissimo: prima la mamma, poi l’amato fratello medico Edmund poi, più tardi, anche il padre. Era rimasto solo negli affetti familiari». Una intimità semplice di vita familiare vissuta in modo particolare, nei periodi estivi, nella Villa pontificia a Castel Gandolfo. «Ho vissuto per tanti anni con una gamba a Cracovia e l’altra gamba a Roma» le sue parole. Sono «le persone a me più care» ebbe a confidare Papa Wojtyła, ricordando in particolare «il primo Natale a Roma». Di «quella famiglia ricordo la discrezione e la levatura culturale» ricorda Arturo Mari, fotografo dell’Osservatore, che ha vissuto in prima persona quella vicinanza.
Senza dubbio per Wanda “il segno” più forte di questa amicizia, «straordinaria perché semplice e semplice perché straordinaria», è il momento della malattia, frontiera dalla vita. Un cancro. Lei ha raccontato così lo stile spirituale, «mistico», scelto da Wojtyła «per provarle tutte» perché guarisse: «L’amicizia non ha mai momenti dolorosi. Nel 1962, quando il vescovo Karol era a Roma per il Concilio Vaticano II io mi sentii male e fu informato con un telegramma da mio marito che ero in ospedale a Cracovia. Su suggerimento di don Andrzej Maria Deskur, diventato cardinale, si rivolse direttamente a padre Pio da Pietrelcina chiedendogli preghiere per me ma senza fare il mio nome. In quel periodo, poi, in Polonia non sapevamo nulla - almeno io - di quel santo frate cappuccino nel sud dell’Italia. Solo a guarigione avvenuta ho saputo che Karol aveva scritto a padre Pio ed ho provato un brivido, che continua ancora oggi, nello scoprirne il contenuto. Per dire la verità la mia guarigione, invece di farmi mettermi in ginocchio per ringraziare Dio, ha provocato in me quasi una ribellione: ero spaventata dalla potenza di Dio e anche dal fatto che dipendiamo totalmente da Lui». Come a dire: cosa vuole ora Dio da me per avermi guarita? Quale missione mi affida?
Un’ampia raccolta di pensieri e lettere con Karol Wojtyła è stata curata da Wanda e pubblicata in Italia con il titolo Diario di una amicizia. La famiglia Półtawski e Karol Wojtyła (edizioni San Paolo).
Nel pieno dell’esperienza del Sinodo, la testimonianza di una donna di oltre cent’anni - sopravvissuta al sanguinoso Novecento e alle ideologie del nazismo e del comunismo - ha un’attualità sconcertante. Assai lontana da soggezioni clericali (ma di cosa può aver “paura” una cavia di Ravensbrück?), ha collaborato da protagonista, con quel “genio femminile” caro al suo amico, alla stesura di testi e documenti di alto livello. In uno stile di reciproco scambio di idee, progetti, visioni. Su questioni centrali, urgenti, come la persona umana, la famiglia, la sessualità. Ci sono anche l’intelligenza e il cuore di Wanda nell’apporto di Wojtyła all’enciclica Humanae vitae di Paolo vi. Con passione convinta Wanda non ha risparmiato energie nel rilanciare, a ogni livello, i contenuti di quell’enciclica, come anima dell’Istituto di teologia per la famiglia co-fondato a Cracovia con Wojtyła che - da sacerdote, vescovo e cardinale arcivescovo - ha sostenuto - non a parole - il ruolo dei laici e delle donne ovviamente.
Dal saggio Amore e responsabilità ai testi di Wojtyła, prima e dopo l’elezione al pontificato, Wanda ha incarnato, anche come docente universitaria, tutta quella «teologia del corpo» che afferma chiaramente come la stessa «trasmissione della vita deve essere un progetto di Dio» da scoprire. E significativamente, nella Curia romana è stata membro del Pontificio consiglio per la famiglia dal 1983, membro della Pontificia accademia per la vita dal 1994, e anche consultore del Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari.
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) --- Un’antropologia cristocentrica, al di là della cosmoteandria: Giovanni Paolo II ha insegnato a non aver paura di dirsi cristiani (di Giovanni Battista Re).20 ottobre 2023, di Federico La Sala
PER UN’ANTROPOLOGIA E UNA TEOLOGIA CRISTIANA, OLTRE LA COSMOTEANDRIA "CATTOLICO-COSTANTINIANA" (NICEA 325-2025) *
Il 16 ottobre di 45 anni fa l’elezione di san Giovanni Paolo II
Ha insegnato a non aver paura di dirsi cristiani
[di Giovanni Battista Re (L’Osservatore Romano, 16 ottobre 2023
Il 16 ottobre di 45 anni fa, ero sulla terrazza della Segreteria di Stato quando il cardinale Pericle Felici, dopo la fumata bianca, annunciò il nome del nuovo Papa: Karol Wojtyła. Monsignor Agostino Casaroli (divenuto cardinale l’anno dopo), che era lì con noi, commentò: «Che coraggio hanno avuto i cardinali, scegliendo un arcivescovo di un Paese oltre la “cortina di ferro”! Che coraggio!».
Circondammo tutti monsignor Casaroli, facendogli domande, mentre aspettavamo che il nuovo Papa si affacciasse al balcone della basilica Vaticana.
Ci rispose: è una personalità forte e affascinante per le tante sue doti, ma mai avevo pensato all’eventualità che il nuovo Papa potesse venire da oltre la “cortina di ferro”.
A 45 anni di distanza, il lungo pontificato di Giovanni Paolo II colpisce per la vastità e la grandiosità delle opere realizzate, per il grande numero di eventi e di iniziative, per il consenso ottenuto e per ciò che la sua guida spirituale e morale ha rappresentato per oltre un quarto di secolo.
Papa Wojtyła tuttavia ha stupito non solo per quello che ha fatto, ma anche per l’amore che lo animava e il desiderio che aveva di aiutare tutti nella ricerca di Dio e nel far crescere nel mondo il rispetto dei diritti umani, la fraternità e la solidarietà.
San Giovanni Paolo II è stato una personalità fuori dall’ordinario, un Papa che si è inserito nel solco della tradizione della Chiesa con un innegabile timbro di novità, ma anche di piena fedeltà alla dottrina che viene dagli apostoli.
Non possiamo non riconoscere che la Divina Provvidenza gli ha assegnato grandi compiti nella storia mondiale del suo tempo.
- Uomo di Dio
San Giovanni Paolo II è stato innanzi tutto un grande uomo di Dio, animato da una fede incrollabile.
La prima e fondamentale dimensione del suo pontificato è stata quella religiosa. Il movente dell’intero suo pontificato, il centro ispiratore dei suoi pensieri e di tutte le sue iniziative è stato di natura religiosa: tutti gli sforzi del Papa miravano ad avvicinare gli uomini a Dio e a fare rientrare Dio da protagonista in questo mondo. Voleva che in questo nostro mondo vi fosse ancora posto per Dio.
Il vibrante appello pronunciato nella sua prima celebrazione eucaristica in piazza San Pietro: «Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo», esprimeva bene la linea ispiratrice e il programma di tutto il suo pontificato. Quelle parole manifestavano l’ansia apostolica che lo avrebbe spinto sulle strade del mondo, incontro a popoli di ogni cultura e di ogni razza per annunciare a tutti che solo in Dio, che in Cristo si è fatto a noi vicino, l’umanità può trovare la vera salvezza.
Questa verità egli l’ha proclamata con fedeltà e con un coraggio che nemmeno le due pallottole sparategli contro il 13 maggio 1981 riuscirono a indebolire o a scalfire.
La grandezza del suo lungo pontificato sta soprattutto nell’avere risvegliato nel mondo il senso religioso. Nella società secolarizzata del suo tempo, egli ha aiutato i cristiani a liberarsi dai falsi sensi di inferiorità nei confronti della cultura laicista dominante, e a non avere timore ad essere e a dirsi cristiani. Instancabile fu il suo richiamo a ritornare a Dio, rivolto ad una società che in Occidente lo stava dimenticando e che oltre la “cortina di ferro” lo combatteva.
Ha fatto capire che non si possono limitare a questa terra gli orizzonti di noi, uomini e donne. Ha insegnato che la coscienza, «in cui l’uomo si trova solo con Dio e scopre una legge scritta nel cuore» (Gaudium et spes, 16), conferisce un’altissima dignità all’uomo e alla donna ed ha esortato a rinnovare la società facendole ritrovare la forza del messaggio di Cristo (Cfr. Insegnamenti 1986, i, p. 1379).
Giovanni Paolo II ha avuto fiducia nella forza delle istanze spirituali e morali ed è stato un testimone di eccezionale statura anche per la sua limpida coerenza: in lui non esisteva frattura fra ciò che pensava e ciò che diceva; fra ciò in cui credeva e ciò che egli era. In lui vi era piena unità di fede e di vita.
- Difensore dei diritti umani
Oltre che uomo di Dio, Giovanni Paolo II è stato un appassionato difensore dell’uomo, della dignità, dei diritti e della libertà di ogni persona umana. Fu anche questo un tema caratterizzante il suo insegnamento, che ha aiutato molte persone a scoprire il senso etico della vita. Alla radice di questo impegno per l’uomo si staglia una chiara visione della dignità di ogni persona umana, «unica e irrepetibile», come soleva dire. Ogni attentato contro la dignità di qualsiasi essere umano è un’offesa a Dio, nostro Creatore. I diritti umani erano da lui proclamati e difesi come diritti che Dio ha posto nella natura umana. Si schierò sempre in difesa del carattere inviolabile della vita umana, dal primo istante del concepimento fino al naturale tramonto.
L’uomo e la donna erano da lui visti con gli occhi di Dio e amati col cuore di Dio. La sua era un’antropologia cristocentrica: la creatura umana trova il senso della sua vita al di sopra di sé; lo trova in Dio, che in Cristo si è fatto uomo.
- Uomo di preghiera
Lavorando vicino a Giovanni Paolo II, molte erano le cose che colpivano (impressionavano la sua sicurezza, le sue certezze, la capacità di parlare alle folle... la capacità di veder più lontano degli altri), ma ciò che mi ha sempre stupito di più è stata la profonda intensità della sua preghiera. Non si può comprendere Papa Giovanni Paolo II se si prescinde dal suo rapporto con Dio. È stato un grande uomo di preghiera, animato da una forte spiritualità cristocentrica e mariana. Aveva in sé una tensione spirituale e mistica inconfondibile ed è dalla preghiera che fluivano la sua sicurezza, l’assoluta padronanza di sé e la sua serenità in ogni circostanza.
Colpiva come si abbandonava alla preghiera: si notava in lui un totale coinvolgimento, che lo assorbiva come se non avesse avuto problemi e impegni urgenti che lo chiamavano alla vita attiva. Il suo atteggiamento era raccolto e insieme spontaneamente naturale.
Dal modo con cui pregava si avvertiva come l’unione con Dio era per lui respiro dell’anima e umile ascolto della voce di Dio.
Commuovevano la facilità e la prontezza con le quali passava dal contatto umano con la gente al raccoglimento del colloquio intimo con Dio. Aveva una grande capacità di concentrazione. Quando era raccolto in preghiera, quello che accadeva attorno a lui sembrava non toccarlo e non riguardarlo, tanto si immergeva nell’incontro con Dio.
Durante la giornata, il passaggio da un’occupazione all’altra era sempre segnato da una breve preghiera.
Maturava ogni scelta importante nella preghiera. Prima di ogni decisione significativa Giovanni Paolo II vi pregava sopra a lungo, a volte per più giorni. Sembrava che trattasse con Dio i vari problemi.
Nelle scelte di un certo peso non decideva mai subito. Ai suoi interlocutori che gli chiedevano o proponevano qualcosa, rispondeva che desiderava riflettere prima di dare risposta. In realtà, guadagnava tempo per ascoltare qualche parere, ma soprattutto intendeva pregare per ottenere luce dall’alto prima di decidere.
Ricordo un caso, negli anni in cui ero sostituto della Segreteria di Stato, in cui mi sembrò che il Papa fosse già decisamente a favore di una determinata difficile scelta. Gli chiesi pertanto se si potesse procedere a darne comunicazione. La risposta fu: «Aspettiamo, voglio pregare ancora un po’ prima di decidere».
Nelle decisioni il suo primo interesse era di operare davanti a Dio secondo verità, giustizia ed equità, e non se esse fossero popolari o no. Non gli mancò mai il coraggio necessario.
Quando si stava studiando un problema e non si riusciva a trovare una soluzione giusta e adeguata, il Papa concludeva dicendo: «Dobbiamo pregare ancora, perché il Signore ci venga in aiuto». Si affidava alla preghiera per trovare luce sulla strada da seguire.
Punto forte della sua spiritualità è stata la devozione alla Madonna: la dimensione mariana, espressa nel motto “Totus tuus”, ha contrassegnato l’intera sua esistenza. Era un’eredità lasciatagli dalla mamma scomparsa prematuramente, che poi ha approfondito e sviluppato accompagnato dal padre nel cammino di maturazione spirituale. Karol Wojtyła nacque il 18 maggio 1920, alcuni minuti dopo le ore 17, mentre nella chiesa parrocchiale, vicinissima a casa sua, era in corso la funzione mariana del mese di maggio. Appena il piccolo Karol era venuto alla luce, la mamma, sentendo il canto delle litanie lauretane che giungeva dalla chiesa, disse: «Aprite le finestre, perché voglio che le prime voci ed i primi suoni che il mio bambino ascolta siano i canti della Madonna».
Nel periodo in cui andava a lavorare alla cava di pietra e poi alla fabbrica Solvay, Karol Wojtyła lesse il libro di san Luigi Maria Grignion de Montfort Trattato della vera devozione a Maria, che gli era stato dato da un laico, Jan Tyranowski. Questi aveva creato in parrocchia un gruppo di 15 giovani, fra i quali Karol Wojtyła, che si impegnavano a recitare ognuno una decina del rosario al giorno.
Non è senza significato che due settimane dopo la sua elezione alla sede di Pietro, nel pomeriggio della prima domenica per lui libera, sia andato al santuario della Mentorella per pregare la Madonna, ma anche per parlare della preghiera, affermando che considerava suo primo compito come Papa quello di pregare per la Chiesa e per il mondo e desiderava che la preghiera fosse «il primo annuncio del Papa« (Omelia al santuario della Mentorella, «L’Osservatore Romano», 30-31 ottobre 1978).
La messa era per lui la realtà più alta, più importante e più sacra. In un incontro con i sacerdoti nel 1995 disse: «la messa è in modo assoluto il centro della mia vita e di ogni mia giornata». «Celebrare ogni giorno la messa è per me un bisogno del cuore».
Il mondo intero ha seguito gli ultimi giorni di Papa Giovanni Paolo II. Col suo esempio ci ha insegnato che la vita è un dono che va vissuto fino alla fine con fiducia in Dio e accettando con serenità i disagi della malattia. Ci ha indicato come si percorre il cammino verso il mistero che ci attende, quando anche per ciascuno di noi si apriranno le porte dell’eternità. È stato questo il suo ultimo insegnamento: un insegnamento da Papa.
di Giovanni Battista Re
 Decano del Collegio cardinalizio
Decano del Collegio cardinalizio
NOTA:
Carlo Wojtyla,
 AMORE E RESPONSABILITA’.
AMORE E RESPONSABILITA’.
 Morale sessuale e vita interpersonale,
Morale sessuale e vita interpersonale,
 Marietti,Casale Monferrato-Torino 1968 (II edizione 1978)
Marietti,Casale Monferrato-Torino 1968 (II edizione 1978)fls
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) --- "Cum vir mulierque veritatem vocantem audiunt" (Giovanni Paolo II, Lettera apostolica per la proclamazione di san Tommaso Moro, 2000)23 giugno 2023, di Federico La Sala
CATTOLICESIMO RIFORMA PROTESTANTE E CHIESA ANGLICANA. STORIA E STORIOGRAFIA: TOMMASO MORO (THOMAS MORE, 1478-1535), ENRICO VIII (1491-1547), ED ELISABETTA D’INGHILTERRA (1533-1603) E SHAKESPEARE (1613). *
- TEATRO E METATEATRO: SHAKESPEARE, "ENRICO VIII" ( "[...] è l’ultimo dramma di [...] Correva l’anno 1613, e The famous history of the life of king Henry the Eight (per citare il titolo originale della tragedia: La famosa storia della vita del re Enrico Ottavo) riscosse un enorme successo di pubblico, a conforto dell’intelligenza degli spettatori, se si presta fede al Prologo che precede la rappresentazione. «Questa volta», spiega l’autore, «non vengo a farvi ridere; abbiamo da presentarvi cose gravi accigliate e tristi per alti travagli: scene di dolore d’una tale maestà e nobiltà da strapparvi dagli occhi fiumi di pianto. Quelli d’animo tenero e pietoso potranno ora, se vogliono, versare una lacrima; la vicenda la merita. Chi ha speso il suo denaro con la viva speranza di veder cose credibili, questa volta vedrà cose vere». [...]".
FILOLOGIA, "COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA" (1964), E MONARCHIA DEI #DUESOLI (DANTE ALIGHIERI):"CUM VIR MULIERQUE VERITATEM VOCANTEM AUDIUNT" (GIOVANNI PAOLO II, 2000). Alcuni appunti sul tema...
A) QUESTIONE ANTROPOLOGICA E #CHARITAS (#LOGOS). NELLA LETTERA APOSTOLICA DEL 31 OTTOBRE DEL 2000, "PER LA PROCLAMAZIONE DI SAN TOMMASO MORO PATRONO DEI GOVERNANTI E DEI POLITICI", PAPA GIOVANNI PAOLO II COSì SCRIVE:
 "1. Dalla vita e dal martirio di san Tommaso Moro scaturisce un messaggio che attraversa i secoli e parla agli uomini di tutti i tempi della dignità inalienabile della coscienza, nella quale, come ricorda il Concilio Vaticano II, risiede "il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nella sua intimità" (Gaudium et spes, 16). Quando l’uomo e la donna ascoltano il richiamo della verità [ "Cum vir mulierque veritatem vocantem audiunt"], allora la coscienza orienta con sicurezza i loro atti verso il bene. Proprio per la testimonianza, resa fino all’effusione del sangue, del primato della verità sul potere, san Tommaso Moro è venerato quale esempio imperituro di coerenza morale. E anche al di fuori della Chiesa, specie fra coloro che sono chiamati a guidare le sorti dei popoli, la sua figura viene riconosciuta quale fonte di ispirazione per una politica che si ponga come fine supremo il servizio alla persona umana. [...]".
"1. Dalla vita e dal martirio di san Tommaso Moro scaturisce un messaggio che attraversa i secoli e parla agli uomini di tutti i tempi della dignità inalienabile della coscienza, nella quale, come ricorda il Concilio Vaticano II, risiede "il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nella sua intimità" (Gaudium et spes, 16). Quando l’uomo e la donna ascoltano il richiamo della verità [ "Cum vir mulierque veritatem vocantem audiunt"], allora la coscienza orienta con sicurezza i loro atti verso il bene. Proprio per la testimonianza, resa fino all’effusione del sangue, del primato della verità sul potere, san Tommaso Moro è venerato quale esempio imperituro di coerenza morale. E anche al di fuori della Chiesa, specie fra coloro che sono chiamati a guidare le sorti dei popoli, la sua figura viene riconosciuta quale fonte di ispirazione per una politica che si ponga come fine supremo il servizio alla persona umana. [...]".B) SAN TOMMASO MORO: "[...] Come consigliere e segretario del re, è impegnato contro la Riforma protestante. Contribuisce alla stesura de “La #difesa dei #sette #sacramenti”, opera che valse ad Enrico VIII il titolo di #Defensorfidei. Un’ascesa inarrestabile, fino al culmine: è il primo laico ad essere nominato Gran Cancelliere. Siamo nel 1529. Solo pochi anni dopo, nel 1532, la sua vita cambierà decisamente.
 Muoio fedele servo del re ma prima servo di Dio.
La sua vicenda si intreccia con la stessa vita del re Enrico VIII che, deciso a sposare #AnnaBolena, fa dichiarare nullo dall’arcivescovo Thomas Cranmer il suo matrimonio con Caterina d’Aragona, giungendo, in un’escalation di opposizione a Papa #ClementeVII, ad assumere la guida della Chiesa d’Inghilterra. Nel 1534 l’Atto di Supremazia e l’Atto di Successione sanciscono la svolta. Tommaso si era già ritirato dal mondo politico: non poteva approvare e, soprattutto, non vuole rinnegare la fedeltà al Papa. Nel 1534 viene quindi imprigionato nella Torre di Londra ma questo non basta a piegarlo. La sua “linea”, che continua ad essere quella del silenzio, non è però sufficiente a salvargli la vita. Subisce un processo, nel corso del quale pronuncia una famosa apologia sull’indissolubilità del matrimonio, il rispetto del patrimonio giuridico ispirato ai valori cristiani, la libertà della Chiesa di fronte allo Stato. Viene condannato per alto tradimento e decapitato il #6luglio, pochi giorni dopo Giovanni Fisher, di cui era grande amico, condannato per le stesse idee e assieme a lui ricordato dalla Chiesa il #22giugno. (...)"
Muoio fedele servo del re ma prima servo di Dio.
La sua vicenda si intreccia con la stessa vita del re Enrico VIII che, deciso a sposare #AnnaBolena, fa dichiarare nullo dall’arcivescovo Thomas Cranmer il suo matrimonio con Caterina d’Aragona, giungendo, in un’escalation di opposizione a Papa #ClementeVII, ad assumere la guida della Chiesa d’Inghilterra. Nel 1534 l’Atto di Supremazia e l’Atto di Successione sanciscono la svolta. Tommaso si era già ritirato dal mondo politico: non poteva approvare e, soprattutto, non vuole rinnegare la fedeltà al Papa. Nel 1534 viene quindi imprigionato nella Torre di Londra ma questo non basta a piegarlo. La sua “linea”, che continua ad essere quella del silenzio, non è però sufficiente a salvargli la vita. Subisce un processo, nel corso del quale pronuncia una famosa apologia sull’indissolubilità del matrimonio, il rispetto del patrimonio giuridico ispirato ai valori cristiani, la libertà della Chiesa di fronte allo Stato. Viene condannato per alto tradimento e decapitato il #6luglio, pochi giorni dopo Giovanni Fisher, di cui era grande amico, condannato per le stesse idee e assieme a lui ricordato dalla Chiesa il #22giugno. (...)"C) EUROPA, CRISTIANESIMO E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ": IL "CORPO DEL SIGNORE (CORPUS DOMINI)" E L’EUCARISTIA (Eu -#charis -tia"). Due note: A) SACRAMENTALISMO. [...] B) SACRAMENTARISMO).
D) DANTE ALIGHIERI E MERCURINO ARBORIO DI GATTINARA. "Forse, è bene #ricordare, mi sia lecito, la lezione magistrale di Karl Brandi che, a conclusione della sua "lettura" della figura di "Carlo V" (1935), rievoca la figura (con le seguenti testuali parole) del "gran cancelliere Mercurino di Gattinara, il cui ideale imperiale non era stato diverso dal sogno imperiale di Dante; e aveva espresso la fede in un ordinamento del mondo retto dall’Impero e dal Papato, ciascuno nella sua sfera, l’uno e l’altro pienamente e sovranamente responsabili verso l’intera umanità" ( (Einaudi, Torino 2001) ); e, ancora, che Ernst H. #Kantorowicz, nel suo lavoro su "I due corpi del re" (1957), intitola e dedica l’intero ultimo capitolo a "La regalità antropocentrica: Dante" (Einaudi, Torino 2012). ".
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger)! --- Un saggio profetico: "Amore e responsabilità", la lezione di Wojtyła (di Antonio Tarallo).24 ottobre 2022, di Federico La Sala
UN SAGGIO PROFETICO
Amore e responsabilità, la lezione di Wojtyła
di Antonio Tarallo (La nuova Bussola quotidiana, 22.10.2022)
- Durante gli anni del corso di etica sessuale a Lublino, Karol Wojtyła scrisse il saggio Amore e responsabilità, coinvolgendo coppie di sposi e fidanzati. Nel testo, il futuro Giovanni Paolo II illustra perché utilitarismo e comandamento dell’amore siano in contrasto. E prende le mosse dal concetto di “persona” per spiegare cosa significhi davvero il dono di sé.
«In Amore e responsabilità ho cercato di dimostrare almeno una cosa. Il pericolo di mescolare due definizioni sullo sfondo del pensiero, delle parole e prima di tutto delle azioni. Il pensiero, la parola e le azioni riguardanti l’amore. (...) L’amore è prima di tutto una realtà interiore, interna alla persona. E contemporaneamente è una realtà interpersonale, da persona a persona, comunitaria. E in ogni dimensione, in questa dimensione interiore come in quella interpersonale o comunitaria, ha una propria particolarità evangelica. Ha ricevuto una certa luce».
Così Karol Wojtyła, in uno scritto rimasto inedito fino al 2016, spiegava il contenuto del suo saggio teologico e filosofico, Amore e responsabilità, scritto durante gli anni del corso di etica sessuale condotto presso l’Università Cattolica di Lublino. In questa istituzione accademica, era stato docente dal 1954 al 1961. Quel professore diventerà Pontefice di Santa Romana Chiesa; sarà proclamato santo nel 2014: la sua memoria liturgica sarà fissata per il 22 ottobre, giorno di inizio del suo pontificato durato ventisette anni. In un così prosperoso e lungo periodo, Giovanni Paolo II, in più occasioni, affronterà con grande attenzione il tema dell’amore sponsale: il fulcro di tutta la sua meditazione su questa tematica è da trovarsi - appunto - in quel saggio scritto negli anni della sua docenza universitaria di Lublino.
Assai curiosa e particolare la genesi dell’opera: l’estate precedente l’inizio del corso, il carismatico professor Wojtyła, approfittando di una gita sui laghi cristallini della Polonia, fa circolare, tra gli amici partecipanti alla gita, una prima bozza delle dispense preparate per il corso. Alla gita partecipano, per la maggior parte, coppie di sposi e fidanzati; chiede a loro di redigere una relazione su ogni capitolo del suo studio. Non è interessato soltanto al loro giudizio critico sui contenuti, ma vuole soprattutto sapere se ciò che ha scritto ha un senso concreto nella loro esperienza di vita. Il tempo speso con i giovani nelle gite in montagna, i corsi di preparazione al matrimonio, le confessioni ascoltate e i dialoghi in amicizia, diventano l’incipit, il materiale su cui basare Amore e responsabilità, libro che - come lo stesso autore scrive - «non costituisce l’esposizione di una dottrina, ma rappresenta prima di tutto il frutto di un continuo confronto tra dottrina e vita». Il segreto del testo è proprio questo: lo studioso Wojtyła si interroga sul tema della sessualità e del corpo, non partendo semplicemente da dati “empirici”, bensì da visioni, riflessioni, interrogativi, concretamente vissuti nell’esistenza di ognuno.
- Lo studio sull’amore dell’allora professor Wojtyła è suddiviso in cinque capitoli: 1. La persona e il desiderio sessuale; 2. La persona e l’amore; 3. La persona e la castità; 4. Giustizia verso il Creatore; 5. Sessuologia e morale. Nell’introduzione alla prima edizione (1960), l’autore descrive il perché abbia voluto cimentarsi in un simile testo, «nato principalmente dalla necessità di porre le norme della morale sessuale cattolica su una base solida, una base il più definitiva possibile, facendo affidamento sulle verità morali più elementari e incontrovertibili e sui valori più fondamentali». Il libro si apre con un’asserzione ben precisa: «L’etica sessuale costituisce il dominio della persona. Non si può capire l’etica se non si è capita la persona, il suo modo di essere, di agire». Compaiono due parole chiave: “persona” e “agire”, termini che troveremo in un altro suo saggio che potrebbe considerarsi complementare ad Amore e responsabilità: ci riferiamo a Persona e Atto, del 1969.
Nel testo, Wojtyła propone una prospettiva nuova all’etica sessuale introducendo, a fondamento di questa, il comandamento dell’amore e la conseguente “norma personalistica”: «Il principio dell’utilitarismo e il comandamento dell’amore si contrappongono, perché alla luce di questo principio il comandamento dell’amore perde di significato. È chiaro che se il comandamento dell’amore e l’amore, suo oggetto, devono conservare il loro significato, è necessario far sì che si fondino su un principio diverso da quello dell’utilitarismo, su un’assiologia e una norma principale diverse, e ciò il principio e la norma personalistici».
Porre l’attenzione sulla “persona” vuol dire che l’amore fra un uomo e una donna non può che rappresentare l’incontro fra due “persone”; considerazione che potrebbe sembrare, a prima lettura, alquanto scontata; eppure non è così. Proprio partendo dal concetto di “persona” è possibile comprendere il dono di sé verso l’altro; il dono della propria persona, appunto, all’altra persona. Scrive Wojtyła: «L’essenza dell’amore si realizza nel modo più profondo nel dono di sé che la persona amante fa alla persona amata. Grazie al suo carattere particolare, l’amore sponsale differisce radicalmente da tutte le altre forme e manifestazioni dell’amore. Ci si può rendere conto di questo quando si comprende in che cosa consista il valore della persona».
L’amore, di conseguenza, per il filosofo-teologo-antropologo Wojtyła può essere solo l’incontro di due libertà in cui ciascuna è responsabile per il bene dell’altro: da ciò, la parola della seconda parte del titolo del testo, “responsabilità”. Solo in questo modo il sesso cessa di essere qualcosa che semplicemente accade, o qualcosa di tollerato per altri fini, e diviene espressione di pienezza in cui uomo e donna cercano insieme il bene personale e comune donandosi reciprocamente l’uno all’altro. Wojtyła si spinge ancora più avanti, parlando - senza indugi - della sessualità di coppia, un tema-tabù che rappresentava, all’epoca, una terra relativamente inesplorata nel mondo cattolico.
Ci sono due domande di fondo che animano il testo. Due domande che sembrano essere scritte nel nostro oggi così “fluido” - per usare il termine coniato dal sociologo e filosofo Zygmunt Bauman - in cui i rapporti sono basati solo sull’aspetto utilitaristico, soprattutto nelle relazioni amorose: «Si può coltivare l’amore? Non è una cosa già fatta, data all’uomo, o più esattamente a due persone, una specie di avventura del cuore? È quel che si pensa spesso, soprattutto tra i giovani». La risposta che darà Karol Wojtyła è inequivocabile e nel nostro tempo presente dovrebbe riecheggiare ancora più forte che mai: «L’amore non è mai una cosa bell’e fatta e semplicemente “offerta” alla donna e all’uomo: deve essere elaborato. Ecco come bisogna vederlo: in certa misura, l’amore non “è” mai, ma “diventa” in ogni istante quel che ne fa l’apporto di ciascuna delle persone e la profondità del loro impegno». E, dietro a questo impegno umano, la Grazia che «è partecipazione nascosta del Creatore invisibile che, amore Lui stesso, ha potere di formare ogni amore».
-
> Amore e responsabilità --- Città del Vaticano, 1990. Date spazio alla psicoanalisi se volete capire che cosa avviene nell’ animo di un ministro di Dio! Non penso che papa Wojtyla, presente al Sinodo, abbia trasalito (di Domenico del Rio).12 agosto 2021, di Federico La Sala
IL SINODO APRE LE PORTE A FREUD
di DOMENICO DEL RIO (la Repubblica/Archivio, 06 ottobre 1990)
CITTA’ DEL VATICANO Date spazio alla psicoanalisi se volete capire che cosa avviene nell’ animo di un ministro di Dio! Aprite i seminari alle scoperte della psicologia del profondo! La raccomandazione è stata lanciata quasi ufficialmente al Sinodo dei vescovi. Non è stata la trovata di qualche padre sinodale americano o mitteleuropeo. La proposta è venuta dal lungo intervento di uno degli esperti di cui si è dotata la Segreteria speciale del Sinodo: padre Timoty J. Costello, un religioso della Congregazione dei Maristi, docente di Teologia negli Stati Uniti. Costello, che ha parlato alla presenza del papa, non ha pronunciato mai la parola psicoanalisi, ma ha usato terminologia ed espressioni equivalenti: moderna psicologia del profondo, livello inconscio, forze inconsce, blocchi occulti...
Una vera e propria lezione di psicoanalisi ai rappresentanti di tutti gli episcopati del mondo. E’ da qualche tempo che la psicoanalisi, dapprima completamente demonizzata, si è aperta qualche varco nella considerazione della Chiesa cattolica. Sulla strada di questi tentativi erano cadute vittime illustri, vescovi e preti, come Mendez Arceo, vescovo messicano di Cuernavaca, Ivan Illich e il più famoso e il più martoriato dal Sant’ Uffizio, Marc Oraison.
Ma è certamente eccezionale che, in una sede così autorevole come il Sinodo e con un intervento così articolato di un esperto della Segreteria, la moderna psicologia del profondo sia stata proposta come un mezzo per scrutare i cuori, come si diceva una volta, dei candidati al sacerdozio. Per una materia ancora in stato di sospetto, Costello ha fatto, evidentemente, le dovute distinzioni. Durante gli ultimi trent’ anni, ha detto, ci sono stati diversi casi di applicazioni indiscriminate di idee e di metodi psicologici alla formazione religiosa, spesso con risultati disastrosi. Non tutte le scuole di pensiero psicologico sono compatibili con la rivelazione cristiana. Scuola compatibile, invece, è l’ Università Gregoriana di Roma, diretta dai gesuiti. Costello l’ ha espressamente menzionata.
Il religioso marista ha cominciato col porsi alcuni interrogativi. Perché, ha detto, alcuni seminaristi e sacerdoti vanno bene e altri si stancano? Perché alcuni si tirano indietro? Perché vi sono fallimenti riguardo al celibato sacerdotale?. Per capire che cosa sta dietro a questi problemi, ha proseguito Costello, sono del parere che la Chiesa possa ricevere aiuto da alcune delle scoperte della moderna psicologia del profondo. Ad esempio, la ricerca intrapresa e pubblicata dal professor Luigi Rulla, gesuita, e dai suoi colleghi dell’ Università Gregoriana, tenta di chiarire il modo in cui i fattori psicologici possono influenzare la risposta di una persona alla Grazia e, tanto più, alla vocazione sacerdotale.
Rulla, che è anche medico e psichiatra, ha pubblicato cinque volumi sulla Antropologia della vocazione cristiana, il primo dei quali intitolato Psicologia del profondo e vocazione, editi in inglese dalla Gregoriana e in italiano dall’ editrice Piemme. La nostra, dice il gesuita, è in realtà una psicoanalisi adattata all’ antropologia cristiana.
Non penso che papa Wojtyla, presente al Sinodo, abbia trasalito. Il cardinale di Cracovia, prima di essere eletto papa, in alcune sue opere, per esempio in Persona e atto, aveva espresso posizioni conciliabili con una psicologia del profondo. E’ dunque sulla scorta dei lavori di padre Rulla e della conciliabilità di papa Wojtyla che Costello ha potuto illustrare perché si debbano mettere in funzione questi mezzi di conoscenza nel momento di decidere se un giovane è adatto o no a intraprendere la via del sacerdozio. E’ possibile, ha spiegato l’ esperto del Sinodo, che una persona fondamentalmente normale desideri e professi a livello conscio determinati ideali religiosi, pur essendo mossa, al tempo stesso, e senza esserne consapevole, da forze inconsce che possono essere opposte a questi stessi ideali. Come una porta girevole, una persona può proferire un sì consapevole e un no nello stesso preciso istante. Ciò lascia la persona in uno stato di dicotomia e di tensione interiore, definito incoerenza vocazionale. E’ letteralmente trascinata in direzioni diverse da due forze contrastanti. I suoi effetti sulla vita vocazionale possono essere drammatici.
Il relatore ha citato una ricerca secondo la quale il 60-80 per cento dei seminaristi sono deboli e vulnerabili sotto il profilo vocazionale. Come affrontare questa situazione? Gli attuali metodi di formazione, ha concluso Costello, non sono efficaci. Mi sembra che i metodi tradizionali della formazione religiosa e del discernimento vocazionale vadano completati, non sostituiti, con approcci che consentano al seminario di raggiungere le sue finalità con maggior efficacia. La chiave sta nella formazione dei formatori, la cui preparazione specifica dà la capacità di aiutare i seminaristi a individuare e a superare i blocchi occulti opposti all’ azione della Grazia di Dio nella loro vita.
In fatto di formazione dei seminaristi, ieri, un vescovo di Papua e Nuova Guinea, Gerard Francis Loft, nel sottolineare l’ urgenza di una maturità emotiva dei candidati al sacerdozio, ha suggerito sane relazioni tra i sacerdoti e le donne e una presenza di personale femminile nei seminari. La capacità di mantenere relazioni con i membri dell’ altro sesso, ha detto, è un dovere, specie in situazioni culturali dove la divisione tra i sessi è stata mantenuta rigidamente e in maniera non cristiana. Dopo tutto, le donne costituiscono più del 50 per cento della Chiesa e in gran parte sono fedeli praticanti. In una società dove le donne sono represse la Chiesa deve essere leader e fonte di ispirazione nel liberare chi è prigioniero. Ma come possiamo fare questo, se i nostri ministri sono tenuti nelle stesse catene e viene loro offerto un programma di formazione che li prepara in maniera malata a questo ruolo?
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! --- Italia: i dati dell’Istat del 2020 sulla natalità, e quella "postilla" di Hannah Arendt sulla «‘lieta novella’ dell’avvento: ‘un bambino è nato per noi’» (di Sergio Belardinelli).2 luglio 2021, di Federico La Sala
FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA. COME NASCONO I BAMBINI...*
- HANNAH ARENDT E IL PROBLEMA DELL’INIZIO, DELLA NASCITA: "Nella grande opera sulla Città di Dio Agostino enuncia, senza però darne spiegazione, ciò che avrebbe potuto divenire il sostegno ontologico di una filosofia della politica autenticamente romana o virgiliana. A suo dire, come sappiamo, Dio creò l’uomo come creatura temporale, homo temporalis; il tempo e l’uomo furono creati insieme, e tale temporalità era confermata dal fatto che ogni uomo deve la sua vita non semplicemente alla moltiplicazione della specie, ma alla nascita, l’ingresso di una creatura nuova che, come qualcosa di completamente nuovo, fa il suo ingresso nel mezzo del continuum temporale del mondo. Lo scopo della creazione dell’uomo fu di rendere possibile un inizio: «Acciocché vi fosse un inizio, fu creato l’uomo, prima del quale non ci fu nessuno», «Initium ... ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit» (Agostino, De civitate Dei, libro XII, cap. 21). La capacità stessa di cominciamento ha le sue radici nella natalità e non certo nella creatività, non in una dote o in un dono, ma nel fatto che gli esseri umani, uomini nuovi, sempre e sempre di nuovo appaiono nel mondo in virtù della nascita" (H. ARENDT, La vita della mente, Bologna 1987, p. 546).
È la nostra nascita il miracolo che salva il mondo
Quella postilla di Hannah Arendt che illumina i dati Istat sulla natalità
di Sergio Belardinelli (il Foglio, 24 apr 2021)
L’Istat ci ha comunicato di recente che, complice anche il Covid, in Italia nel 2020 i morti sono stati 746 mila e i nuovi nati 404 mila. Un dato agghiacciante nel suo significato sociale e culturale che a me, come una sorta di riflesso condizionato, richiama alla mente uno dei brani filosofici più intensi che abbia mai letto: “Il miracolo che salva il mondo, il dominio delle faccende umane dalla sua normale, naturale rovina è in definitiva il fatto della natalità in cui è ontologicamente radicata la facoltà dell’azione. È in altre parole la nascita di nuovi uomini, l’azione di cui essi sono capaci in virtù dell’esser nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell’esperienza umana, che l’antichità greca ignorò completamente. È questa fede e speranza nel mondo, che trova forse la sua gloriosa e stringata espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la ‘lieta novella’ dell’avvento: ‘un bambino è nato per noi’”.
Con queste parole Hannah Arendt conclude il capitolo di Vita Activa dedicato all’azione. Si tratta di un brano che cito e commento ormai da quarant’anni, nel quale viene messo a tema un nesso, quello tra la libertà e la natalità, tra la libertà e la vita, col quale, che io sappia, soltanto la Arendt ha avuto l’acutezza e il coraggio di cimentarsi e che, a prima vista, può apparire persino paradossale. La vita infatti, almeno immediatamente, sembra richiamare non tanto la libertà, quanto piuttosto il gigantesco, immutabile ripetersi dei cicli naturali, l’ambito di quelli che il grande biologo Adolf Portmann, autore peraltro assai caro alla Arendt, definirebbe i “rapporti preordinati” - il contrario, quindi, di ciò che in genere intendiamo allorché parliamo di libertà. Quanto poi alla vita specificamente umana, essa, è certo impastata di libertà, ma è anche qualcosa che, a diversi livelli, non dipende da noi, qualcosa di cui, nonostante le tecnologie della riproduzione, non possiamo avere il completo controllo: la riceviamo semplicemente; non scegliamo i nostri genitori, né il luogo dove venire al mondo; dobbiamo fare continuamente i conti con gli altri, con le nostre passioni, i nostri istinti, le nostre inclinazioni, con quel coacervo di natura, ragione, sentimenti, usi e costumi che vanno a costituire appunto il “gran mare” della vita. La vita insomma pone una serie di condizioni e condizionamenti alla libertà che possono renderla persino impossibile. Eppure, rompendo in un certo senso questa grande catena, è proprio la libertà che dà sapore e specificità alla vita umana; solo la libertà impedisce che il mondo si riduca spinozianamente a “sostanza”, a qualcosa di omogeneo, a qualcosa come un continuo fluire; solo la libertà è capace di introdurre nel mondo un elemento di novità, qualcosa di imprevisto.
Pensieri non nuovi, si potrebbe dire. Ma proprio qui si inserisce la fondamentale postilla arendtiana, preziosa per leggere in una chiave forse inusuale ma certo illuminante anche i dati Istat sulla natalità in Italia da cui siamo partiti: è la stessa vita umana, il nostro venire al mondo, la nascita unica e irripetibile di ciascuno di noi, a rappresentare la prima e più immediata forma di novità, il primo scompaginamento, se così si può dire, della routine della vita.
La facoltà dell’azione, dice la Arendt, “è ontologicamente radicata” nel “fatto della natalità”. In entrambe le dimensioni - la libertà e la natalità - ritroviamo non a caso una costitutiva “novità”, un costitutivo essere insieme agli altri (non si nasce, né si agisce da soli), qualcosa che implica l’accettazione della realtà nella quale siamo e insieme fiducia nel futuro. In questo senso ogni bambino che nasce è un segno di speranza nel mondo; è l’irruzione nel mondo di una “novità”, la cui memoria, è il caso di dire, ritroviamo da adulti nell’esercizio della nostra libertà, nella nostra capacità di incominciare qualcosa che senza di noi non incomincerebbe mai.
Novità, pluralità (gli uomini, non l’uomo abitano la terra, ripete spesso Hannah Arendt) e speranza: questo ci schiude direttamente e in modo straordinario il discorso arendtiano sulla libertà radicata nella natalità. Ma indirettamente, specialmente oggi, tale discorso ci schiude molto di più. Ci fa capire, ad esempio, quale tragedia, anche simbolica, si consuma nel momento in cui un paese come l’Italia registra in un anno un saldo passivo tra morti e nuovi nati di 342 mila unità. È un po’ come se il mondo e la nostra libertà perdessero la speranza, ossia ciò che dà loro sapore, ciò che è insieme accettazione della realtà nella quale viviamo e fiducia nel futuro.
È vero, tutto passa. La vita non è altro che un eterno dissolversi nel gigantesco circolo della natura dove, propriamente, non esiste inizio né fine e dove tutte le cose e gli eventi si svolgono in un’immutabile ripetizione: la mors immortalis di cui parlava Lucrezio. Ma la Arendt non accetta questa mestizia, poiché a suo avviso “la nascita e la morte di esseri umani non sono semplici eventi naturali”; avvengono in un mondo dove vivono altri uomini; un mondo che acquista significato grazie alle loro azioni e ai loro discorsi; un mondo che per questo è sempre aperto alla novità.
Con la creazione dell’uomo, dice la Arendt, “il principio del cominciamento entrò nel mondo stesso, e questo, naturalmente è solo un altro modo di dire che il principio della libertà fu creato quando fu creato l’uomo”. Di nuovo l’inizio, dunque, diciamo pure, la natalità.
È proprio perché, in quanto uomini, siamo initium, nuovi venuti, iniziatori, per virtù di nascita che secondo la Arendt, siamo indotti ad agire. La definizione che più si addice agli uomini non è quella di “mortali”, ma piuttosto quella di “coloro che nascono”. In questo modo, quasi per una sottile ironia della sorte, la categoria della natalità diventa fondamentale proprio nel pensiero di un’allieva (e anche qualcosa di più) di Martin Heidegger, l’inventore dell’essere per la morte. Non che la Arendt ovviamente trascuri che la morte rappresenta l’ineluttabile fine di ogni vita umana, solo che, a suo avviso, gli uomini, anche se debbono morire, non nascono per questo, bensì per incominciare. E siamo di nuovo al passo da cui siamo partiti: “Il miracolo che salva il mondo....”.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. --- "ESSERE E TEMPO" E FILOLOGIA. Note su "Martin Heidegger e Hannah Arendt: la storia della fedeltà all’amore".
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica L’EUROPA IN CAMMINO - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944)?!
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva
Federico La Sala
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) -- A cento anni dalla nascita. Giovanni Paolo II. «Totus tuus»: una vita per amore (di Gualtiero Bassetti).).6 maggio 2020, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO, FILIAZIONE DIVINA E IMITAZIONE DI CRISTO: CRISTO-FARO O CRISTO-FORO?! *
- È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
A cento anni dalla nascita.
Giovanni Paolo II. «Totus tuus»: una vita per amore
Il suo sguardo fisso in Cristo ci ha insegnato che tutto ciò che è umano ci riguarda, come cristiani e come Chiesa Il suo amore per Maria è un faro vitale, una strada maestra ...
di Gualtiero Bassetti (Avvenire, domenica 3 maggio 2020)
Il 27 ottobre 1986, Giovanni Paolo II - Papa da otto anni, sempre più amato e popolare - animò ad Assisi la Giornata di preghiera interreligiosa per la pace, rimasta nella storia. In quella come in molte altre occasioni, le telecamere di tutto il pianeta lo immortalarono come lo ricordiamo: intimamente, quasi dolorosamente raccolto, in dialogo profondissimo con Dio, la cui volontà non può che essere il bene e la pace di tutti. Pochi furono i testimoni di un altro momento, intenso e dolcissimo, che precedette lo storico incontro.
Il giorno prima, 26 ottobre, il Papa visitò Perugia, oggi mia diocesi. Incontrò tutte le fasce di popolazione, in particolare gli amati giovani. In un saluto a braccio, seppe fondere la bellezza del genio italiano e cristiano - l’arte di una piazza tra le più belle d’Italia - col prorompente entusiasmo dei giovani che lo stavano festeggiando.
«Mi piace stare qui, mi piace molto!», non poté trattenersi dall’esclamare. A Perugia trascorse la notte, in una struttura diocesana fuori porta voluta da un mio predecessore, il vescovo mantovano Giovanni Battista Rosa. Chi salutò il Papa al mattino, alla partenza, ricorda il suo sguardo limpido affacciarsi dalla terrazza sulla valle assisana, dove stava recandosi. Avvolse in una lunga occhiata sia la bellezza quasi mistica di quel panorama, sia la pace che ne emanava, chiedendo forse a Dio, col Salmo 19, di tradurla in tutte le lingue del mondo. Ma solo una fu la testimone del suo ultimo sguardo: la Vergine Maria, raffigurata, in una semplice statua, su una colonna al centro della terrazza.
 Totus tuus. La dedica a Maria nel motto apostolico di Karol Wojtyla è tratta da una frase di san Luigi Maria Grignion de Montfort: «Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt».
Totus tuus. La dedica a Maria nel motto apostolico di Karol Wojtyla è tratta da una frase di san Luigi Maria Grignion de Montfort: «Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt».Non è, come chiarì lo stesso pontefice, una semplice formula di devozione: si radica nel mistero della Santissima Trinità. Alla potenza teologica unisce una vigorosa efficacia. San Giovanni Paolo II era uomo di pensiero quanto di azione; era abituato così, sia dalla sua storia personale, sia da quella del suo popolo. Un’assonanza, una comune origine scritturale, si coglie nella mia cattedrale in un gonfalone votivo di scuola peruginesca, realizzato nella pestilenza del 1526 - una delle tante che sconvolsero la città e l’Europa. In un cartiglio, il popolo, ai piedi dei santi e della Vergine, grida: “Salus nostra in manu tua est, et nos et terra nostra tui sumus”.
 Altri approfondiranno le concordanze storico- artistiche: ci sono, a Dio piacendo, inediti filoni di bellezza di cui trovare origini e parentele, per scoprire, una volta di più, quanti canali uniscano l’umanità. A me interessa sottolineare l’efficacia della preghiera, quando davvero affida tutto l’essere. Siamo tuoi. La preghiera è universalità, coralità, unione fraterna, come ricorda papa Francesco; e pure intimità, sponsalità, unione mistica, come il Totus tuus di Wojtyla, che comunque, sulle labbra di un papa, sigilla l’offerta dell’intera umanità. Maria è via privilegiata al Cristo, di cui fu figlia e madre, come dice Dante con poesia incomparabile.
Altri approfondiranno le concordanze storico- artistiche: ci sono, a Dio piacendo, inediti filoni di bellezza di cui trovare origini e parentele, per scoprire, una volta di più, quanti canali uniscano l’umanità. A me interessa sottolineare l’efficacia della preghiera, quando davvero affida tutto l’essere. Siamo tuoi. La preghiera è universalità, coralità, unione fraterna, come ricorda papa Francesco; e pure intimità, sponsalità, unione mistica, come il Totus tuus di Wojtyla, che comunque, sulle labbra di un papa, sigilla l’offerta dell’intera umanità. Maria è via privilegiata al Cristo, di cui fu figlia e madre, come dice Dante con poesia incomparabile.Madre di Gesù, madre di tutti, dalle nozze di Cana all’affidamento a Giovanni, ai piedi della Croce. Cristo è veramente risorto! E ci attende come attese Maria, con le sorprese della gioia. In questi giorni difficili, ho rinnovato, sia come supplica sia come ringraziamento, l’affidamento della città e del mondo alla Vergine Maria: le parole accorate che il popolo ha reiterato nei secoli. Tutto ciò che è umano ci riguarda, come cristiani e come Chiesa. È una delle eredità di san Giovanni Paolo II, forse la più significativa. Raccogliere e offrire a Dio, nella preghiera e nell’azione, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce del mondo; gli aneliti alla pace, alla sicurezza, alla liberazione dai mali dell’anima e del corpo. Portare briciole di umanità dove dominano ancora barbarie, sopruso e ingiustizia, egoismo e indifferenza.
 Annunciare amore in nome di Cristo, come faceva san Giovanni Paolo II, significa portare Cristo stesso.
Annunciare amore in nome di Cristo, come faceva san Giovanni Paolo II, significa portare Cristo stesso.
*- Una nota
MESSAGGIO EVANGELICO, FILIAZIONE DIVINA E IMITAZIONE DI CRISTO: CRISTO-FARO O CRISTO-FORO?!
- UN CAMBIAMENTO DI ROTTA FONDAMENTALE, UNA METANOIA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA URGENTE, PER QUANTI PRETENDONO DI ESSERE "PORTATORI DI CRISTO" DA UNA RIVA ALL’ALTRA DEL FIUME DEL TEMPO... *
Caro don Santino Bove Balestra
Vista la tensione e la passione personali che animano la sua Lettera "a san Cristofaro al tempo del Coronavirus" e, al contempo,sollecitato dalle sue stesse associazioni collegate a questa figura di gigante buono («Ti hanno fatto - forse un po’ abusivamente - diventare il patrono degli automobilisti (dopo essere stato più propriamente il protettore dei facchini) : oggi dovresti ispirare chi dall’automobile passa alla bicicletta, al treno o all’uso dei propri piedi!»), il discorso fatto appare essere una forma implicita di autocritica "istituzionale" (cioè, da parte dell’intera Istituzione Chiesa paolina-costantiniana) della propria capacità di "portare Cristo" in giro, di qua e di là, avanti e indietro - e, della totale e più generale cecità antropologica e pedagogica, nei confronti del "Bambino" (che ognuno e ognuna di noi, tutti e tutte, è) !
SE, OGGI, AL TEMPO DEL CORONAVIRUS, VALE l’esortazione “Restiamo tutti a casa!”, altrettanto sicuramente, domani, vale la consapevolezza che “Nulla sarà più come prima!” e, ancor di più, se vogliamo veramente cambiare rotta, che la “conversione eco-logica” (la ristrutturazione della nostra stessa "casa"!) è già "oggi necessaria", ora e subito! Non c’è alcun tempo da perdere.
Portar-si il "bambino" sulle proprie spalle, «suprema fatica e suprema gioia», è impresa ancora tutta da tentare - e non ha nulla a che fare con il "sacrificio" e con la "messa in croce" di alcun "Bambino"! O no?! (Federico La Sala)
***
ARCHEOLOGIA E ARCHITETTURA. NOTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA “CASA” *
Caro don Santino Bove Balestra
SICCOME LA SUA SOLLECITAZIONE A RIFLETTERE SULLA FIGURA di “san Cristofaro al tempo del Coronavirus” appare essere carica di molte implicazioni e degna di grande attenzione per la nostra e generale “salute”, credo che sia opportuno non lasciar cadere l’occasione e La sollecito a meditare anche sulla differenza di significato che corre tra la parola “Cristo-foro” e la parola “Cristo-faro” (una variazione “parlata”, più che un refuso) : in gioco c’è la comprensione stessa di cosa significa “portare Cristo” e come “seguire Cristo”!
 Cristoforo è “Cristo-foro”, perché porta sulle spalle il Bambino, la “luce del mondo”(Gv. 8,12) e non va più in giro a spegnere “luci” o “fari”, e a “mettere in croce” bambini, uomini, donne: egli stesso (da Cristoforo) è diventato un “Cristo-faro”: «Non è forse scritto nella vostra Legge: “Io ho detto: voi siete dèi”[...]?»(Gv.10,34). Non è forse questa la “conversione eco-logica” da farsi: diventare “fari”?!
Cristoforo è “Cristo-foro”, perché porta sulle spalle il Bambino, la “luce del mondo”(Gv. 8,12) e non va più in giro a spegnere “luci” o “fari”, e a “mettere in croce” bambini, uomini, donne: egli stesso (da Cristoforo) è diventato un “Cristo-faro”: «Non è forse scritto nella vostra Legge: “Io ho detto: voi siete dèi”[...]?»(Gv.10,34). Non è forse questa la “conversione eco-logica” da farsi: diventare “fari”?!
 E come è possibile questa ristrutturazione della “casa” di tutti gli esseri umani, se continuiamo a negare anche al “cristoforico” Giuseppe la sua stessa “paternità” (cfr., mi sia consentito, “DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”. UNA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE...). Di quale “casa” e di quale “chiesa” si sta parlando?! Boh?! O no?!
E come è possibile questa ristrutturazione della “casa” di tutti gli esseri umani, se continuiamo a negare anche al “cristoforico” Giuseppe la sua stessa “paternità” (cfr., mi sia consentito, “DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”. UNA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE...). Di quale “casa” e di quale “chiesa” si sta parlando?! Boh?! O no?! -
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) --- "De domo David" ("ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph de domo David"). Un convegno e un libro. .15 novembre 2019, di Federico La Sala
"GIUSEPPE": "DE DOMO DAVID". Un convegno e un libro ... *
- Melchisedech, i tre anelli, e... la buona-notizia
- "GIUSEPPE", L’ANELLO DI CONGIUNZIONE DEI "TRE" MONOTEISMI. Un importante studio di Massimo Campanini sul patriarca d’Israele e sul profeta del Corano. A quando la ri-considerazione e il riconoscimento da parte della Chiesa cattolica dell’altro Giuseppe, quello ev-angelico?! Freud e Pirandello aspettano ancora
De Domo David e l’edizione di Nardò, dalla Congregazione degli Oblati di San Giuseppe
di padre Alberto Santiago (Fondazione "Terra d’Otranto", 12/11/2019)
Buona serata a voi tutti: saluto cordialmente mons. Filograna, vescovo di Nardò, il Rettore della Confraternita di San Giuseppe Patriarca monsignor Santantonio, le Autorità presenti, il Priore della Confraternita Mino De Benedittis, i sodali e tutti i convenuti.
Porto il saluto della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe fondata da san Giuseppe Marello nel 1870, e di tutto l’ambito giuseppino, che si compone anche della Congregazione di S.Giuseppe fondata da s.Leonardo Murialdo, e vari Istituti femminili, tutti informati ed entusiasti dell’iniziativa che si celebra nella diocesi di Nardò-Gallipoli.
Vengo inoltre come portavoce del Centro Studi del “Movimento Giuseppino” di Roma, che promuove l’interazione tra i devoti di san Giuseppe, per favorire e valorizzare la conoscenza della sua missione nel piano dell’Incarnazione, e animare la vita ecclesiale con la pratica delle virtù evangeliche tipiche di san Giuseppe.
Il sito del «Movimento Giuseppino» si propone di raccogliere e presentare con organicità di contenuti costantemente aggiornati, le informazioni riguardanti san Giuseppe in ogni suo aspetto, provenienti dai vari Centri nazionali e internazionali di studi. Il sito è aperto a ogni forma di confronto e collaborazione da parte di quanti volessero segnalare integrazioni, inesattezze e lacune, ma soprattutto ampliare l’orizzonte delle conoscenze. Sarà senz’altro disponibile a segnalare questa iniziativa di oggi nelle prossime settimane.
Vi trasmetto un fervido augurio poi da parte di p. Tarcisio Stramare, teologo e biblista, la cui opera di approfondimento negli studi teologici su san Giuseppe, e sui relativi documenti pontifici, ha diffuso la conoscenza e la devozione al Custode del Redentore. E’il titolo scelto da papa Giovanni Paolo II per riassumere il ruolo di san Giuseppe nel mistero dell’incarnazione, e risale però a un’antica concezione teologica che può aver ispirato lo scultore dell’angelo sull’altare maggiore di questa chiesa di Nardò: un angelo, appunto, “custode”, come una presenza che protegge dal male e da ogni pericolo. Quale miglior correlazione con la figura di san Giuseppe che porta in salvo il Figlio dalle insidie di Erode? La statua collocata nella parte più alta di questo bellissimo altare rispecchia l’atteggiamento di Giuseppe nei confronti di Gesù, chiamato ad assicurare la sua sopravvivenza e la sua crescita.
La giornata di oggi è punto di arrivo di un progetto, ideato per celebrare i quattrocento anni di vita della Confraternita di San Giuseppe Patriarca a Nardò, di ricerca e di approfondimento sul patrimonio artistico della chiesa, e sulle forme di devozione al santo.
Promosso con il patrocinio della Diocesi di Nardò-Gallipoli, della Fondazione Terra d’Otranto e della Confraternita, il libro che accompagna questo convegno richiama l’attenzione per il suo titolo, lungo come negli incunaboli di una volta: De domo David. La Confraternita di San Giuseppe Patriarca e la sua chiesa a Nardò. Studi e ricerche a quattro secoli dalla fondazione (1619-2019).
Ma sono soprattutto le prime parole a destare la curiosità del lettore: perché De domo David?
Questa espressione ricorre nella liturgia, e si legge nel vangelo di Luca ai versetti 26-27 del primo capitolo: “... missus est angelus Gabriel ... ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph de domo David ...” Possiamo ricordare anche la novena di Natale: “Ecce veniet Deus, et homo de domo David sedere in throno ...”.
Certamente da questi antecedenti deriva il motto della Confraternita di San Giuseppe Patriarca: De domo David, e quindi il titolo del libro, che si legge anche sulla convessa facciata della chiesa.
L’obiettivo di un libro ampiamente illustrato, come questo, è appunto che il lettore possa in qualche misura entrare in relazione con le opere, in modo che ogni immagine sia come uno specchio capace di coinvolgere lo spettatore. E che l’arte diventi una esperienza del mondo che modifica radicalmente chi la fa, ampliando la comprensione che il soggetto ha di sé e della realtà che lo circonda.
Concepito come libro di pregio, fuori commercio e con una tiratura di poche centinaia di copie, il volume curato da Marcello Gaballo e Stefania Colafranceschi è risultato un lavoro di altissima qualità sia per la strutturazione dei materiali, sia per la quantità di illustrazioni (quasi 800) in eccellente risoluzione.
Grazie alla collaborazione spontanea di studiosi in varie città d’Italia e delle diocesi del Salento, si è potuto realizzare un percorso ricco e qualificato, sorprendente per varietà di contributi; vi sono articoli di taglio dottrinale, storico e artistico, e molti contributi da Confraternite, Oratori, Associazioni legate a san Giuseppe. L’elaborato che ne è conseguito si rivela dunque molto rappresentativo.
Non potevamo immaginare questo lungo cammino attraverso il tempo - poiché gli articoli spaziano tra IV e XIX secolo -, come pure le conoscenze emerse sul patrimonio artistico di questa chiesa e i suoi significati.
Ringrazio tutti i collaboratori che hanno messo a frutto le loro competenze e lo spirito di ricerca, dando un apporto importante sul piano culturale nelle sue varie forme, ma anche considerevole per la conoscenza della figura di s. Giuseppe, solo apparentemente secondaria e silenziosa.
Esprimo l’apprezzamento inoltre per la disponibilità della Biblioteca Casanatense di Roma e il Museo Pitrè di Palermo, che hanno fornito materiale di particolare interesse; la Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo per le riproduzioni degli arazzi cinquecenteschi, la Pinacoteca di Brera, la Galleria Nazionale di Parma e tutti i numerosi prestatori delle immagini pubblicate.
Principalmente ringrazio la Confraternita, all’origine di questo ambizioso progetto, e la Fondazione Terra d’Otranto che l’ha sostenuto e realizzato.
Rivolgo i saluti più cordiali agli autori qui presenti: Giovanni Boraccesi -che ha preso in esame gli argenti pugliesi raffiguranti san Giuseppe-, Marino Caringella -che illustra esempi di iconografie giuseppine-, Stefano Cortese -che documenta le antiche pitture parietali nel Salento-, Giuseppe Fai -che tratta la devozione del santo nella sua città di Parabita-, Antonio Faita -che presenta le opere statuarie dei celebri Verzella-, Antonio Solmona -che pone in evidenza alcune iconografie presenti a Galatone- e Stefano Tanisi -che esamina i dipinti nelle diocesi di Otranto e Ugento-, unitamente agli altri collaboratori.
Altri autori, come da programma, esporranno personalmente i propri contributi.
Il lavoro compiuto in questa ricorrenza, che ha fatto scoprire a tutta l’Italia la storia e l’arte di questa chiesa e di questa confraternita, di questa diocesi e della Puglia, è importante per ideare e costruire nuovi traguardi; è augurabile che parte di questo libro sia condiviso nel futuro Simposio internazionale di studi su san Giuseppe, che si terrà tra due anni in Guatemala. E’ una mèta possibile, sulla base delle svariate testimonianze acquisite, e dell’esperienza maturata in itinere.
Le stesse intenzioni mi vengono riferite per una ulteriore presentazione di questo libro a Roma, nella prestigiosa sede dell’antichissima e prestigiosa Biblioteca Casanatense, che come vedrete ha contribuito a realizzarlo mettendo a disposizione centinaia di incisioni e miniature dei secoli XV - XVIII, omaggiando questa chiesa e questa Diocesi.
E centinaia sono anche le rare riproduzioni di canivet di Lo Cicero e santini di Damato, alcuni tra i più importanti collezionisti italiani, che hanno messo a disposizione per la prima volta tante preziosità, accrescendo il prestigio del lavoro editoriale che questa sera presentiamo.
Con questo auspicio invito a far tesoro delle oltre seicento pagine del volume, tutte a colori e in pregevole edizione, e a proiettarsi nel futuro prossimo, in unità di intenti con il mondo giuseppino, che ancora una volta ringrazia per la particolare attenzione che questo lembo d’Italia ha voluto dedicare al santo di cui porta il nome.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
FESTA DI SAN GIUSEPPE E DEL PAPA’ - NON DEL PAPA!!! BASTA CON LA "MALA EDUCACION" E CON LA "MALA FEDE"!!! RESTITUIRE A GIUSEPPE L’ANELLO DEL "PESCATORE" E GIUSEPPE A MARIA E ALLA SUA FAMIGLIA - UMANA E DIVINA!!! LA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE INVESTE L’ AVVENIRE DELL’INTERA UMANITA’, NON QUELLO DEI VESCOVI DELLA CHIESA "CATTOLICA"
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
Federico La Sala
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) --- «Perché o casti o superficiali?». La sessualità spiegata ai ragazzi. Percorso formativo dell’Azione Cattolica (di Luciano Moia).15 novembre 2019, di Federico La Sala
AMORE E RESPONSABILITA’. UN CORAGGIOSO PASSO ..... *
Il percorso.
«Perché o casti o superficiali?». La sessualità spiegata ai ragazzi
Da oggi a domenica percorso formativo dell’Azione Cattolica. Teologi, biblisti, psicologi, sessuologi e formatori a confronto su affettività e dintorni con duecento giovani
di Luciano Moia (Avvenire, venerdì 15 novembre 2019)
- L’Italia è tra gli ultimi Paesi in Europa per numero di matrimoni (3,2 ogni mille abitanti). In testa (dati Eurostat) Lituania (7,5) e Romania (7,3)
Educare all’affettività e alla sessualità al tempo del web. Compito tanto difficoltoso quanto inutile, sostiene chi pensa che tanto, in rete, i ragazzi dispongano di ogni tipo di informazione possibile. No, replica chi invece è convinto che senza lo sforzo di trovare un senso profondo a quegli "oggetti" meravigliosi ma non sempre facili da maneggiare che sono cuore e corpo, sia impossibile arrivare a un rapporto sereno con sé stessi e con gli altri. E che, dalla qualità delle relazioni affettive, discenda anche uno sguardo più maturo sulla fede, se è vero che il trascendente non è mai disincarnato ma sempre strettamente connesso alle nostre esperienze, soprattutto quelle più coinvolgenti e più intime. Ecco perché, quando si parla di educazione all’affettività e alla sessualità la Chiesa non può dire "non mi riguarda".
 Del resto lo spiegano in modo esplicito sia il Documento finale del Sinodo sui giovani, sia la Christus vivit che sottolinea l’importanza di «educare la propria sessualità, in modo che sia sempre meno uno strumento per usare gli altri e sempre più una capacità di donarsi pienamente a una persona in modo esclusivo e generoso» (Ch.v265).
Del resto lo spiegano in modo esplicito sia il Documento finale del Sinodo sui giovani, sia la Christus vivit che sottolinea l’importanza di «educare la propria sessualità, in modo che sia sempre meno uno strumento per usare gli altri e sempre più una capacità di donarsi pienamente a una persona in modo esclusivo e generoso» (Ch.v265).Per dare seguito a queste sollecitazioni, circa 200 giovani formatori di Azione Cattolica si ritrovano da oggi a domenica a Morlupo, alle porte di Roma, nella Casa dei padri rogazionisti, per un confronto con un gruppo di esperti. "A cuore scalzo" non è un convegno formale, ma un dialogo diretto. A ciascuno degli specialisti sono state inviate alcune domande. E avranno un solo un quarto d’ora ciascuno per rispondere. «Anche per noi è stata una sfida e l’occasione di un ripasso tutt’altro che semplice», scherzano ma non troppo la psicologa Roberta Carta e il marito Diego Buratta, responsabile della cooperativa "Pepita" che si occupa di servizi educativi.
Perché, quando tra le domande dei giovani ci sono temi come la difficoltà di trasmettere la visione cristiana della sessualità oppure le ragioni che devono motivare la necessità di non "bruciare i tempi" per avere il primo rapporto, anche i terapeuti più navigati sono chiamati a misurare le parole con attenzione. «Dobbiamo accompagnarli a vivere una sessualità che non sia solo il richiamo a una regola astratta. Conoscere sé stessi, dare senso alle proprie decisioni, aprirsi a relazioni serene ed equilibrate è più importante di un generico richiamo alla morale, anche perché rischiamo di rifugiarci in un linguaggio normativo che i giovani non comprendono più», osserva Roberta Carta.
LE DOMANDE
 1 Castità e poi?
1 Castità e poi?
 Perché noi giovani credenti siamo costretti a scegliere tra l’essere casti o l’essere superficiali?
Perché noi giovani credenti siamo costretti a scegliere tra l’essere casti o l’essere superficiali?
 2 Perché aspettare?
2 Perché aspettare?
 Per avere un rapporto matrimoniale è necessario dover aspettare e perché?
Per avere un rapporto matrimoniale è necessario dover aspettare e perché?
 3 Cybersex
3 Cybersex
 Come i media influenzano la sessualità? In che modo vivo il rapporto con il mio corpo sui social? Qual è l’influenza dei media sulla mia dimensione affettiva, inclusa l’identità di genere?
Come i media influenzano la sessualità? In che modo vivo il rapporto con il mio corpo sui social? Qual è l’influenza dei media sulla mia dimensione affettiva, inclusa l’identità di genere?
 4 Sensi di colpa
4 Sensi di colpa
 Come gestire gli eventuali sensi di colpa legati alle nostre pulsioni? E se il mio partner è di un’altra religione?
Come gestire gli eventuali sensi di colpa legati alle nostre pulsioni? E se il mio partner è di un’altra religione?E, quindi, come si risponde a chi chiede qual è l’età giusta per il primo rapporto? Considerando anche che i giovani formatori di Ac dovranno maturare dentro sé stessi un approccio equilibrato e sereno per trasmettere a loro volta queste indicazioni agli adolescenti loro affidati. C’è una via adeguata e comprensibile tra l’elenco dei divieti, ormai improponibile, e il laissez faire della rinuncia educativa? «La formula - riprende l’esperta - potrebbe essere di rivolgere loro una domanda del genere: "Quando pensi si essere abbastanza maturo per mettere la tua vita nelle mani di un altro/a dal punto di vista mentale e fisico? Pensi di avere la responsabilità sufficiente per farti carico della vita di un’altra persona?"». Perché la sfida è tutta qui, spiegare che cuore e corpo devono viaggiare sempre connessi. E proprio per questo occorre sottolineare l’importanza di curare le relazioni, cioè il rispetto reciproco, le attenzioni, le parole giuste.
Quelle che cercheranno di trovare anche Marinella Perroni, biblista, e don Aristide Fumagalli, teologo morale, chiamati a ricordare ciò che Scrittura e magistero indicano sul tema. A Nicoletta Musso, mediatrice familiare, e Piera Di Maria sessuologa Piera Di Maria, è stato chiesto di avventurarsi nelle emozioni filtrate, o distorte dal web. «Intanto diciamo loro che la sessualità è una cosa meravigliosa, un dono da custodire e da comprendere. Ai ragazzi vogliamo mandare messaggi semplici, senza parole troppo complesse, del tipo "fai pace con il tuo corpo, accettalo e rispettarlo e ringrazia Dio per quello che hai, fai pace con la tua storia e con quella della tua famiglia accogliendone luci e ombre, pensa che le relazioni vanno curate e costano fatica, ma questo è il senso della vita e da qui nasce l’amore"».
E Caterina Donato, giovane psicologa della diocesi di Messina, spiegherà ai ragazzi che pulsioni adolescenziali e vita di fede non sono in contrasto: «Le esperienze della corporeità non confliggono con l’amore di Dio perché il corpo è dono del Padre. Per accettare la relazione, occorre imparare ad accettarsi. Questione complessa, soprattutto oggi con la grande confusione sull’identità di genere».
Ne è consapevole padre Pino Piva, gesuita, educatore proprio sulla pastorale di frontiera, in particolare con i giovani omosessuali che «come tutti gli altri, hanno bisogno d’essere accompagnati nella loro crescita umana e spirituale, ed ecclesiale; come gli altri. E per questo riprenderò una parte del n. 150 del Documento finale del Sinodo dei giovani. In particolare dove i vescovi sollecitano ad aiutare i giovani "a leggere la propria storia; ad aderire con libertà e responsabilità alla propria chiamata battesimale; a riconoscere il desiderio di appartenere e contribuire alla vita della comunità; a discernere le migliori forme per realizzarlo. In questo modo si aiuta ogni giovane, nessuno escluso, a integrare sempre più la dimensione sessuale nella propria personalità, crescendo nella qualità delle relazioni e camminando verso il dono di sé"».
Un invito che Michele Tridente e Luisa Alfarano, vicepresidenti nazionali dell’Azione cattolica per il Settore giovani, non intendono lasciare cadere: «Il rischio in cui è facile cadere è quello di trattare questi temi come un tabù, preferendo il silenzio e rischiando di cedere alla tentazione del giudizio verso i comportamenti degli altri. Questo genera spesso incomprensioni e allontanamento dalla Chiesa. La strada invece - concludono - è quella del dialogo e del confronto soprattutto con chi la pensa diversamente e con chi vive in modo poco sereno il rapporto con il proprio corpo e le relazioni affettive».
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger)!!!
"PERVERSIONI. Sessualità, etica, psicoanalisi". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
Federico La Sala
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) --- Polonia. Beati i genitori di Wojtyla? I vescovi chiedono di aprire la causa.12 ottobre 2019, di Federico La Sala
Polonia. Beati i genitori di Wojtyla? I vescovi chiedono di aprire la causa
Emilia Kaczorowska morì quando il futuro pontefice aveva solo 9 anni. Il padre di Wojtyla, anch’egli di nome Karol, morì invece nel 1941, durante la Seconda guerra mondiale
di Redazione Catholica (Avvenire, venerdì 11 ottobre 2019)
- [Foto] I genitori di Wojtyla e il piccolo Karol
Nel corso della 384ª plenaria dell’episcopato polacco (8-9 ottobre) i vescovi hanno discusso diversi aspetti delle celebrazioni del 100° anniversario della nascita di Karol Wojtyla che cadrà il 18 maggio 2020. L’arcidiocesi di Cracovia ha ottenuto così da parte della Conferenza episcopale, come riporta l’agenzia Sir, l’assenso a rivolgersi alla Santa Sede per il nulla osta all’istruzione a livello diocesano del processo di beatificazione dei genitori di Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla e Emilia Kaczorowska.
«Non c’è il minimo dubbio che la spiritualità del futuro santo pontefice si sia formata in famiglia e grazie alla fede dei suoi genitori», ha osservato il cardinale Stanislaw Dziwisz, già segretario particolare di Giovanni Paolo II. Il porporato si è detto convinto che «i genitori del Papa polacco possano diventare un valido esempio per le famiglie moderne» e ha ricordato che papa Francesco, durante la cerimonia di canonizzazione ha conferito a Wojtyla proprio il titolo di «Papa delle famiglie».
 Emilia Kaczorowska morì quando il futuro pontefice aveva solo 9 anni. Il padre di Wojtyla, anch’egli di nome Karol, morì invece nel 1941, durante la Seconda guerra mondiale.
Emilia Kaczorowska morì quando il futuro pontefice aveva solo 9 anni. Il padre di Wojtyla, anch’egli di nome Karol, morì invece nel 1941, durante la Seconda guerra mondiale.L’episcopato polacco, nel corso della plenaria ha inoltre appoggiato l’idea che Giovanni Paolo II diventi patrono della riconciliazione tra polacchi e ucraini, necessaria in seguito ai terribili crimini commessi durante l’ultimo conflitto mondiale. La «teologia del dialogo, della riconciliazione e del perdono» promossa dal Papa polacco «in base ai valori del Vangelo» ha permesso ad entrambi i popoli “di compiere dei passi importanti sulla strada della reciproca comprensione”, concordano i vescovi.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Chiesa ed Eucharistia. Il comandamento dell’amore e la norma personalistica ....
 Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger)!!!
Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger)!!!INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - Il sesso non è un «mostro» da cui fuggire. Svolta del Papa: “Serve un’educazione oggettiva, senza ideologie”.30 gennaio 2019, di Federico La Sala
“Il sesso è un dono. Bisogna parlarne anche nelle scuole”
Svolta del Papa di ritorno dal viaggio a Panama
“Serve un’educazione oggettiva, senza ideologie”
di Domenico Agasso Jr (La Stampa 29.01.2019)
Il sesso non è un «mostro» da cui fuggire. Non deve essere un tabù. Anzi, è «un dono di Dio». E servirebbe «un’educazione sessuale» nelle scuole. Di più: possibilmente non troppo rigida e chiusa. Così se ne capirebbe il vero valore. Queste non sarebbero parole inconsuete, se a pronunciarle non fosse un Papa. Francesco lo afferma sull’aereo che lo ha riportato a Roma da Panama, dove è stato nei giorni scorsi per la Giornata mondiale della Gioventù.
E di giovani e sesso il Pontefice ragiona durante la tradizionale conferenza stampa sul volo papale, rispondendo a una giornalista americana che lo informa di un «problema comune in tutto il Centroamerica, incluso Panama e buona parte dell’America Latina: le gravidanze precoci». Solo a Panama sono state «diecimila lo scorso anno». La domanda è: «I detrattori della Chiesa cattolica incolpano la stessa Chiesa perché si oppone all’educazione sessuale nelle scuole. Qual è l’opinione del Papa?».
Francesco non si scompone, e con tono serio e concentrato inizia a riflettere. Mai nelle sue parole ci sarà una presa di posizione in difesa del proprio «fortino». Né prevedibili formulazioni prudenti per un tema così delicato. Quello di papa Francesco è un discorso cristiano e concreto. E umano. E innovativo, senza voler intaccare tradizione e insegnamento cattolici. Come da suo stile, insomma.
Dice: «Nelle scuole bisogna dare l’educazione sessuale». Precisando e sottolineando che innanzitutto «il sesso è un dono di Dio». E «non è un mostro». È il dono di Dio «per amare». Poi - ne è consapevole - può degenerare, ma «se qualcuno lo usa per guadagnare denaro o sfruttare l’altro, è un problema diverso», non intacca la purezza innata del dono. Bergoglio sostanzia la sua tesi per molti inaspettata: bisogna offrire «un’educazione sessuale» a scuola che sia «oggettiva, senza colonizzazioni ideologiche».
 Intende probabilmente le teorie del gender, spesso denunciate da Francesco come dinamiche e movimenti invasivi che possono «distruggere, fare tutto uguale», senza la capacità di «tollerare le differenze». Poi aggiunge e spiega: «Perché se nelle scuole si dà un’educazione sessuale imbevuta di colonizzazioni ideologiche, distruggi la persona». Allo stesso tempo il sesso inteso «come dono di Dio deve» essere «educato» non con «rigidezza», con chiusura mentale e ideologica. Creando tabù, appunto.
Intende probabilmente le teorie del gender, spesso denunciate da Francesco come dinamiche e movimenti invasivi che possono «distruggere, fare tutto uguale», senza la capacità di «tollerare le differenze». Poi aggiunge e spiega: «Perché se nelle scuole si dà un’educazione sessuale imbevuta di colonizzazioni ideologiche, distruggi la persona». Allo stesso tempo il sesso inteso «come dono di Dio deve» essere «educato» non con «rigidezza», con chiusura mentale e ideologica. Creando tabù, appunto.
 Il Papa precisa che va «educato, da “educere” (condurre, trarre fuori, ndr), per far emergere il meglio della persona e accompagnarla nel cammino». Il Vescovo di Roma si immerge totalmente nella questione e avverte: «Il problema è il sistema». E mette in guardia dai rischi che possono incontrare i «responsabili dell’educazione, sia a livello nazionale che locale come pure di ciascuna unità scolastica»: in particolare, il tipo di «maestri che si trovano» per questo compito, e i «libri di testo» che si adottano per bambini e ragazzi.
Il Papa precisa che va «educato, da “educere” (condurre, trarre fuori, ndr), per far emergere il meglio della persona e accompagnarla nel cammino». Il Vescovo di Roma si immerge totalmente nella questione e avverte: «Il problema è il sistema». E mette in guardia dai rischi che possono incontrare i «responsabili dell’educazione, sia a livello nazionale che locale come pure di ciascuna unità scolastica»: in particolare, il tipo di «maestri che si trovano» per questo compito, e i «libri di testo» che si adottano per bambini e ragazzi.«Io - confida il Papa - ne ho visti di ogni tipo», compresi alcuni inopportuni,«sporchi», li definisce. Perché anche e soprattutto in questo ambito «ci sono cose che fanno maturare e altre che fanno danno». Ciò che conta per il Papa è che le scuole spalanchino le porte a una vera e propria educazione sessuale, da trasmettere innanzitutto ai più piccoli. Anzi, l’ideale sarebbe che si «cominciasse a casa, con i genitori». Ma «non sempre è possibile per le tante situazioni della famiglia che possono essere complicate». O perché spesso papà e mamme «non sanno come affrontare il tema». Perciò la scuola può e deve «supplire» a questo, assumersi la responsabilità. «Sennò - teme il Papa - resta un vuoto che verrà riempito da qualsiasi ideologia» potenzialmente pericolosa.
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - "Le donne non possono essere prete": lo stop di Ladaria. "Sull’ordinazione di donne nella Chiesa l’ultima parola chiara è stata data da Giovanni Paolo II, e questa rimane", ha detto Papa Bergoglio (di Paolo Rodari)11 giugno 2018, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE....
"Le donne non possono essere prete": lo stop di Ladaria
Il cardinale prefetto dell’ex Sant’Uffizio: "La dottrina è definitiva, sbagliato creare dubbi tra i fedeli. Cristo conferì il sacramento ai 12 apostoli, tutti uomini"
di PAOLO RODARI (la Repubblica, 29 maggio 2018)
CITTÀ DEL VATICANO - Si tratta "di una verità appartenente al deposito della fede", nonostante sorgano "ancora in alcuni paesi delle voci che mettono in dubbio la definitività di questa dottrina". A ribadire il "no" del Vaticano all’ipotesi dell’ordinazione presbiterale femminile è il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il neo-cardinale gesuita Luis Ladaria, in un lungo e argomentato articolo pubblicato sull’Osservatore Romano. Intitolato "Il carattere definitivo della dottrina di ’Ordinatio sacerdotalis’", il testo è scritto per fugare "alcuni dubbi" in proposito.
Evidentemente, il ritorno di proposte aperturiste circa le donne-prete avanzate soprattutto in alcuni paesi sudamericani in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre dedicato all’Amazzonia, ha allarmato la Santa Sede che attraverso la sua massima autorità gerarchica ha voluto ribadire ciò che anche per Francesco sembra essere assodato: "Sull’ordinazione di donne nella Chiesa l’ultima parola chiara è stata data da Giovanni Paolo II, e questa rimane", ha detto Papa Bergoglio tornando nel novembre del 2016 dal suo viaggio lampo in Svezia.
Durante il Sinodo sull’Amazzonia uno dei temi centrali sarà quello della carenza di preti. Come superare il problema? In proposito, da tempo, si parla dell’opportunità di ordinare i cosiddetti viri probati, uomini sposati di una certa età e di provata fede che possano celebrare messa nelle comunità che, appunto, hanno scarsità di sacerdoti e dove è difficile che un prete possa recarsi con regolarità. Altri uomini di Chiesa fanno altre proposte: propongono, come ad esempio ha recentemente fatto monsignor Erwin Krautler della prelatura territoriale di Xingu in Amazzonia, che oltre ai viri probati si proceda con l’ordinazione delle diaconesse. Mentre altri ancora, invece, hanno parlato direttamente di donne-prete.
Ladaria ricorda che "Cristo ha voluto conferire questo sacramento ai dodici apostoli, tutti uomini, che, a loro volta, lo hanno comunicato ad altri uomini". E che per questo motivo la Chiesa si è riconosciuta "sempre vincolata a questa decisione del Signore", la quale esclude "che il sacerdozio ministeriale possa essere validamente conferito alle donne".
Già Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis del 22 maggio 1994, disse che "la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa". Mentre la Congregazione per la dottrina della fede, in risposta a un dubbio sull’insegnamento di Ordinatio sacerdotalis, ha ribadito che "si tratta di una verità appartenente al deposito della fede".
Chi vuole le donne-prete argomenta che la dottrina in merito non è stata definita ex cathedra e che, quindi, una decisione posteriore di un futuro Papa o concilio potrebbe rovesciarla. Dice, tuttavia, Ladaria che "seminando questi dubbi si crea grave confusione tra i fedeli" perché, Denzinger-Hünermann alla mano (l’autorevole volume che raccoglie simboli di fede, decisioni conciliari, provvedimenti di sinodi provinciali, dichiarazioni e scritti dottrinali dei Pontefici dalle origini del cristianesimo all’epoca contemporanea) la Chiesa riconosce che l’impossibilità di ordinare delle donne appartiene alla "sostanza del sacramento" dell’ordine. Una sostanza, dunque, che la Chiesa non può cambiare. "Se la Chiesa non può intervenire - dice ancora Ladaria - è perché in quel punto interviene l’amore originario di Dio".
Ladaria parla anche dell’infallibilità e del suo significato. Essa non riguarda solo pronunciamenti solenni di un concilio o del Papa quando parla ex cathedra, "ma anche l’insegnamento ordinario e universale dei vescovi sparsi per il mondo, quando propongono, in comunione tra loro e con il Papa, la dottrina cattolica da tenersi definitivamente". A questa infallibilità si è riferito Giovanni Paolo II in "Ordinatio sacerdotalis?, un testo che Wojtyla scrisse dopo un’ampia consultazione portata avanti a a Roma "con i presidenti delle conferenze episcopali che erano seriamente interessati a tale problematica". "Tutti, senza eccezione - ricorda Ladaria - hanno dichiarato, con piena convinzione, per l’obbedienza della Chiesa al Signore, che essa non possiede la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale".
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Una storia di lunga durata...
Federico La Sala
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - "Compendio della teologia del corpo di Giovanni Paolo II" ( Yves Semen)14 novembre 2017, di Federico La Sala
Il filosofo Semen.
Tutta la verità sull’amore secondo Wojtyla
Il filosofo francese Yves Semen spiega la teologia di Giovanni Paolo II su sessualità e matrimonio: «Le sue catechesi sono armi della luce per contrastare oggi l’ideologia del gender»
di Antonio Giuliano (Avvemire, martedì 7 novembre 2017)
Chiamatela pure “teologia del sesso”. Nessuna reticenza, nessun imbarazzo. L’ha definita proprio così il suo autore, un papa, un santo della Chiesa. La “scandalosa” Teologia del corpo di san Giovanni Paolo II è un tesoro prezioso che pur affermando verità scomode non ha alcuna soggezione nei confronti della cultura dominante. Sono ben 129 discorsi sull’amore umano che il pontefice polacco pronunciò nelle sue udienze del mercoledì dal 1979 al 1984. Una raccolta che spiazza ancora oggi come testimonia da anni un laico francese, il filosofo Yves Semen, presidente- fondatore dell’Istituto di Teologia del corpo a Lione e professore presso la Libera Facoltà di Filosofia a Parigi.
Appassionato e competente divulgatore delle lezioni di Karol Wojtyla, Semen ha curato ora un nuovo Compendio della teologia del corpo di Giovanni Paolo II (Ares, pagine 216, euro 15). Oltre a rivedere la traduzione dei testi, lo studioso ha tenuto conto del manoscritti originali di queste catechesi redatte in polacco ben prima dell’elezione al soglio pontificio. Non è dunque casuale che Wojtyla più che la sua firma personale abbia voluto mettere quella da pontefice: «Si tratta del più vasto insegnamento mai proposto da un Papa su uno stesso argomento ed è significativo che abbia voluto presentarlo all’inizio del suo pontificato come a farne il pilastro di tutto il suo magistero». A corredo del compendio, Semen inserisce anche un utile glossario che riprende parole e concetti dirompenti, come “godimento”: «Nella Teologia del corpo il piacere legato al godimento è talvolta considerato in senso positivo in quanto piacere erotico nobile conforme al disegno divino sulla sessualità umana, talvolta in senso negativo quando è ricercato per sé stesso e mediante l’uso e la strumentalizzazione dell’altra persona a servizio di un piacere egocentrico». Un manuale controcorrente che, smentendo i soliti pregiudizi, esalta il corpo e la sessualità umana, mettendo in luce un desiderio di infinito che nessun “consumo” o possesso può appagare.
George Weigel, biografo di Giovanni Paolo II, l’ha definita «una sorta di bomba ad orologeria teologica». Ma i cattolici hanno compreso la Teologia del corpo?
«Solo da qualche anno sono stati pubblicati libri di buona divulgazione e iniziative per farla conoscere. Adesso si stanno per diffondere anche all’estero i Forum Wahou (www.forumwahou. fr) che dal 2015 in Francia hanno già radunato migliaia di persone: nel corso di un week end la gente scopre la grandezza e la bellezza dell’amore nel piano divino. L’Istituto che presiedo dal 2014 ha già formato più di 120 persone in grado di insegnare questa teologia. Formiamo anche i genitori perché a loro spetta la responsabilità primaria dell’educazione sessuale dei ragazzi. Il successo che stiamo riscontrando, è il segno che qualcosa di nuovo sta nascendo nella Chiesa».
Difensore energico dell’Humanae vitae, Giovanni Paolo II ha detto che: «La prima, ed in certo senso la più grave difficoltà è che anche nella comunità cristiana si sono sentite e si sentono voci che mettono in dubbio la verità stessa dell’insegnamento della Chiesa». Crede che un giorno la Chiesa possa rivedere il magistero di Wojtyla?
«Non è la Chiesa che può cambiare la Teologia del Corpo ma è la Teologia del corpo che può cambiare la Chiesa! Bisogna lavorare alla sua larga e fedele diffusione perché la visione della persona e dell’amore che promuove è liberatrice e permette di comprendere la dimensione “profetica e sempre attuale” dell’ Humanae vitae, per usare le parole di Benedetto XVI».
La società oggi dà al “corpo” un significato diverso da quello di Giovanni Paolo II che risale al principio, all’uomo creato a immagine di Dio.
«La cultura contemporanea ha reso il corpo un materiale privo di senso che può essere manipolato in tanti modi. Fino alle affermazioni deliranti del transumanesimo. Per Wojtyla invece il corpo è stato fatto per realizzarsi nel dono di sé e per rivelare il divino: “Il corpo, e soltanto esso, è capace di rendere visibile ciò che è invisibile: lo spirituale e il divino. Esso è stato creato per trasferire nella realtà visibile del mondo il mistero nascosto dall’eternità in Dio, e così esserne segno”».
La Teologia del corpo insiste tanto sulla persona creata maschio e femmina. Un ammonimento profetico contro la diffusione del gender che oggi vuole annullare le differenze sessuali.
«Sì è una teologia della mascolinità e della femminilità che dimostra come il sesso non sia un semplice attributo, ma un dato fondamentale antropologico che qualifica la persona. È in questo senso che il cardinale Ouellet disse che la teologia di Giovanni Paolo II è l’unico vero “antidoto” all’ideologia del gender. Le catechesi di Wojtyla sono armi della luce per affrontare la corruzione antropologica del gender».
Niente contraccettivi, niente rapporti prematrimoniali... Spesso la Chiesa è stata accusata di dire sempre di “no”.
«Ma la Chiesa dice “sì”. Sì alla verità dell’amore come dono di sé. Sì alla verità del corpo fatto per essere donato. Sì alla nobiltà e alla dignità della sessualità. Sì alla grandezza del dono della vita. Sì al matrimonio come vocazione autentica alla santità. Sì al celibato offerto come annuncio profetico del Regno».
Perché i metodi naturali, che non sono contraccettivi, sono ancora poco conosciuti?
«Non se ne parla abbastanza, sebbene essi permettono di esercitare una maternità e una paternità realmente responsabili nel rispetto dell’integrità del corpo della donna. Molti però lo stanno comprendendo: in Francia, in dieci anni, la percentuale di donne che utilizzano la pillola è scesa dal 46% al 33%».
La teologia del corpo riprende un passo del Discorso della Montagna che Wojtyla stesso ammoniva dal considerarlo solo un divieto, ma come chiave per uno sguardo puro che ci permetterà un giorno di godere in anima e corpo il “sommo piacere” della visione di Dio.
«Quando Gesù dice: “Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore” rivolge un appello al cuore dell’uomo, a non farsi dominare dalla concupiscenza che mira ad usare l’altro e a considerarlo oggetto di godimento e possesso. Ecco perché Giovanni Paolo II non ha esitato a affermare che uno può essere adultero anche con la propria moglie se la considera come oggetto per appagare il proprio istinto sessuale. Quando gli è stato obiettato che era “troppo esigente”, ha semplicemente risposto: “Non sono io che sono esigente, è Cristo”».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
Federico La Sala
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - “Maschio e femmina Dio li creò” (di Enzo Bianchi)19 settembre 2017, di Federico La Sala
"DEUS CHARITAS EST" (1 Gv.): LO SPIRITO CHRISTICO, LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO... *
“Maschio e femmina Dio li creò”
di Enzo Bianchi *
- dalla lectio al FestivalFilosofia di Modena
Nel libro della Genesi, il primo libro della bibbia, il libro dell’in-principio (be-re’shit: Gen 1,1) troviamo due racconti della creazione, composti da autori e redattori umani, dunque segnati da una precisa cultura, in un tempo definito della nostra storia. Appartengono a un genere letterario che qualifichiamo come mitico: il mito è un racconto situato culturalmente, dotato di una visione specifica, ma che vuole significare ciò che è universale, costitutivamente antropologico; ovvero, nel nostro caso, cosa ne è dell’’adam, dell’essere umano, il “terrestre”. Sono redazioni diverse e non contemporanee della creazione, ma sono stati posti intenzionalmente l’uno dopo l’altro dai redattori finali della Torah: non giustapposti, ma collocati in successione, in modo che apparisse la dinamica dell’umanizzazione.
Nel primo racconto (Gen 1,1-2,4a), un vero e proprio inno, una narrazione ritmata e ripetitiva, è contenuta la creazione dell’’adam, dell’umano, descritta con un testo che nella sua armonia poetica scandisce il cuore del messaggio biblico su Dio e l’umanità nei suoi rapporti con Dio e con gli animali. Ascoltiamola in una versione calco dell’ebraico: “Ed ’Elohimdisse: Facciamo ’adam in nostra immagine, come nostra somiglianza: dominino i pesci del mare, i volatili dei cieli, il bestiame, tutta la terra e ogni strisciante sulla terra. Ed ’Elohim creò ha-’adam in sua immagine, in immagine di ’Elohim lo creò, maschio e femmina li creò” (Gen 1,26-27).
Chi è l’umano creato “in immagine di Dio”, chi è rispetto a Dio e rispetto agli animali? E cosa comporta quel singolare “lo creò”, ripetuto nel duale “maschio e femmina li creò”? Gli esseri umani, l’umanità immagine di Dio è in relazione con Dio stesso e con le altre creature. L’essere umano è in sé relazione, e ciò che lo attesta in modo paradigmatico è la differenza sessuale, perché l’umano esiste in quanto maschio e femmina, con tutte le possibili varianti e intersecazioni di questa polarità. Gli umani sono immagine di Dio, ciascuno di loro nell’umanità di cui fa parte, in sé sono uniti e si completano accettando la differenza reciproca. In questo testo vi è un’immensa valorizzazione del rapporto uomo-donna, valorizzazione della completezza: non c’è una svalutazione della sessualità né una visione cinica o angosciata della differenza sessuale! La sessualità è positiva e Dio vuole che l’uomo e la donna insieme portino a compimento l’opera di umanizzazione: creati a immagine di Dio, devono diventargli conformi, somiglianti.
Ciò deve avvenire nel vivere: nella vita e solo nella vita! Vivere significa venire al mondo, abitarlo, stare tra co-creature di cui gli umani devono assumersi una responsabilità. Gli umani hanno un corpo come gli animali, sono animali, ma sono anche diversi da loro, innanzitutto nella responsabilità. L’umano è e deve farsi responsabile della terra e dell’ambiente, non è la terra che deve essere responsabile dell’umanità.
Nel secondo racconto (Gen 2,4b-25), più antico di secoli, o forse addirittura di più di un millennio confluiscono elementi mitologici di diverse culture e intende collocare l’umano nel mondo e metterlo in relazione, riaffermare attraverso un altro percorso che l’umano è relazione, è alterità. Ora, la differenza sessuale è parabola di ogni alterità, in nome della quale l’altro, “gli altri - come diceva Jean-Paul Sartre - sono l’inferno”, o meglio, possono esserlo. L’umano è veramente tale quando vive la relazione, ma ogni relazione di differenza comporta tensione e conflitto. Il rapporto uomo-donna è l’epifania della differenza e della reciproca alterità. Solo nella relazione l’umano trova vita e felicità, ma la relazione va imparata, ordinata, esercitata, perché in essa occorre dominare l’animalità presente in ciascuno, che nel rapporto si manifesta come violenza.
Ecco dunque l’umano, un essere in relazione con la terra da cui è tratto, con gli animali in quanto animale, con l’altro da sé che ha il suo stesso soffio di vita ricevuto da Dio e infine con Dio stesso . È in questo fascio di relazioni che l’umano, uomo e donna, si umanizza. E quando il terrestre, uscito dal torpore in cui Dio lo aveva posto, vede l’altro lato, il partner, allora parla con stupore. Ecco l’accesso alla parola, possibile quando c’è di fronte l’altro: finalmente un partner degno, che accende la parola, che abilita all’io-tu, al dialogo, alla relazione! Finalmente - dice l’uomo - un essere che è “osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. La si chiamerà ’isshah perché da ’ish è stata tratta” (Gen 2,23). La relazione ormai è inaugurata: ecco l’uomo e la donna.
Ma se oggi riusciamo a fare questa lettura delle prime due pagine della Bibbia, occorre però ricordare che l’interpretazione non è sempre stata questa. Né si dimentichi che già nell’ultima parte del secondo racconto vi sono in luce tutti i segni del dramma che attraversa la storia fino a noi, fino al femminicidio che purtroppo tante volte appare ancora nei nostri giorni. In verità l’umano, ha-’adam, già qui si rivela in tutta la sua problematicità. Infatti, non appena l’uomo vede la donna, non parla alla donna, non imbocca la strada dell’io-tu, ma parla a se stesso: “Questa sì che osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne”. In tal modo esprime una verità, e cioè che la donna ha la stessa natura e perciò la stessa dignità e vocazione dell’uomo, ma la dice male, esprimendo subito la sua possessività: osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. Parla a se stesso e parla del suo possesso. La donna tace, è ridotta al silenzio e per l’uomo appare una cosa. Egli dice: “È stata tratta da me, è mia carne”, e così nega ogni alterità, quell’alterità che richiede che la donna sia un soggetto di fronte a lui. Subito la volontà e il progetto di Dio sono traditi, e il dramma che seguirà immediatamente è già abbozzato qui, nell’emergere della differenza negata!
Scriveva Thomas Stearns Eliot in uno dei suoi Quattro quartetti : “Nel mio principio è la mia fine ... Nella mia fine è il mio principio” (East Coker, inizio e fine del testo). In queste prime pagine dell’in-principio c’è già tutta la storia dell’umanità, c’è già il misconoscimento dell’altro partner, c’è già la pretesa che l’altro sia un possesso omologo, che l’altro non sia altro, differente, diverso! Culture patriarcali e rare culture matriarcali manifestano la lotta tra i sessi, manifestano la ferita che ognuno di noi sente di fronte alla differenza: ne è attratto ma ne ha paura, vuole relazione ma ne vuole il possesso, vuole comunione ma anche guerra.
Queste pagine tentano allora di dirci come le singolarità di ciascuno di noi, dovute a molte differenze, a partire da quella sessuale, devono coniugarsi affinché vi siano vita e felicità, seppur segnate dal limite. La differenza sessuale maschio-femmina è paradigma di ogni differenza, ma tutte le differenze sono legate a quel tragitto che ognuno umano compie, tra la nascita e la morte, quando ognuno di noi ritornerà alla terra da cui è stato tratto (cf. Gen 3,19), dunque ritornerà a colui che l’ha creato. Allora ciascuno darà una risposta personalissima alla domanda sul cammino di umanizzazione rivoltagli da Dio. Mi riferisco alla prima domanda di Dio, narrata subito dopo nella Genesi, domanda rinnovata in ogni giorno della nostra vita: “’Adam, dove sei?” (Gen 3,9). Nella nostra fine è la risposta alla domanda dell’in-principio, alla responsabilità dell’umanizzazione. (fonte: Monastero di Bose)
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Chiesa. Il comandamento dell’amore e la norma personalistica .... Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger)!!!
FEDE E CARITA’ ("CHARITAS"): CREDERE "ALL’AMORE" ("CHARITATI"). Enzo Bianchi si domanda "come si può credere in Dio se non si crede nell’altro?", ma non si rende conto che è il quadro teologico costantiniano e mammonico che va abbandonato!
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!
Federico La Sala
-
> AMORE, RSPONSABILITÀ, E SESSUALITÀ - SANT’AGOSTINO, GIOVANNI PAOLO II, PAPA FRANCESCO, E FREUD.6 settembre 2017, di Federico La Sala
FILOLOGIA E FILOSOFIA/TEOLOGIA. AMORE, RESPONSABILITÀ, E SESSUALITÀ... *
IN MEMORIA DI SANT’AGOSTINO (E IN ONORE DEL LAVORO DELLA FONDAZIONE "TERRA D’OTRANTO").
- Considerazioni a margine dell’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò (elevata a Basilica minore nel 1980, da papa Giovanni Paolo II, durante l’episcopato di Antonio Rosario Mennonna)
- "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS"), DALLA GRAZIA ("gr.: "XAPIS", lat.: "CHARIS") DI DIO AMORE ("CHARITAS"), NON DI DIO MAMMONA ("CARITAS") ...
Lode a Marcello Gaballo per questa bellissima e preziosa nota su "L’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò" (cfr.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/08/28/laffresco-di-santagostino-nella-cattedrale-di-nardo/#_ftn1) - e il lavoro di De Giorgi: la sua trascrizione della scritta sul cartiglio (ormai scomparsa) "iuste/et cas/te viv/ere et/ xarita(te)" - contrariamente alla protervia che ha portato allo "sproposito maiuscolo" e alla brutta abitudine instauratasi almeno a partire da Ludovico A, Muratori di una "caritas" latina! - conserva ancora la memoria del legame della tradizione dell’evangelo (non: "vangelo"!) con la lingua greca ("charis", "charites"... "charitas").
FILOLOGIA E FILOSOFIA/TEOLOGIA. Giambattista Vico ("De constantia iurisprudentis", 1721) giustamente e correttamente e onestamente così pensava e scriveva: "Solo la carità cristiana insegna la prassi del Bene metafisico"("Boni metaphysici praxim una charitas christiana docet"). Sapeva che Gesù ("Christo") aveva cacciato i mercanti FUORI dal tempio, e non aveva autorizzato i sacerdoti a vendere a "caro-prezzo" (lat.: "caritas") la "grazia" (gr.: "Xapis", lat.: "Charis") di Dio (lat.: "Charitas")!!! Due padroni: Dio "Charitas" o dio "Caritas"?!, Dio Amore o dio Mammona?! In questo bivio ("X") ancora siamo, oggi - e ancora non sappiamo sciogliere l’incognita (""x")!
Sul tema, mi sia consentito, si cfr. la seguente nota:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
 MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori.
MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori.
 MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!- SANT’AGOSTINO E L’ECUMENISMO UMANISTICO-RINASCIMENTALE ...
ALLA LUCE DEL lavoro di ARMANDO POLITO e MARCELLO GABALLO SU "SANTA MARIA DI CASOLE E LE SUE SIBILLE" (cfr.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/03/24/santa-maria-casole-copertino-le-sue-sibille/), all’affresco di Sant’Agostino (databile forse più precisamente nella seconda metà del sec. XV), mi augurerei una rinnovata e maggiore attenzione non solo a tutta la figura dell’affresco ma, in particolare, all’immagine del bastone-pastorale con i suoi DUE SERPENTI. Essa richiama, con chiarezza, non solo la figura di Mosè ma anche e soprattutto la figura di ERMETE TRISMEGISTO con il suo caducèo (e, con essa, della Sibilla Pizia, di Apollo, e di Delfi).
L’affresco di Sant’Agostino nella cattedrale di Nardò, a mio parere, è un luminosissimo segno "manifesto" della diffusione della concezione umanistico-rinascimentale nella Terra d’Otranto e, insieme, del grande lavoro che porterà infine la Chiesa e Michelangelo a celebrare le Sibille (5) insieme ai Profeti (7) nella Volta della Cappella Sistina: ovvero, dice chiaramente del ruolo "giocato" dalla figura di Agostino nella costruzione dell’ orizzonte ecumenico umanistico e rinascimentale.
Sul tema, si cfr., unitamente al già citato lavoro di A. Polito e M. Gaballo, la mia nota sul
 RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.- AGOSTINO, LE SIBILLE, LA LETTERA DELL’ALFABETO GRECO "X", E IL "PESCE"!
NEL LIBRO DI Marcello Gaballo e Armando Polito, "Santa Maria di Casole a Copertino (Lecce) ed altri repertori di Sibille" (Fondazione Terra d’Otranto 2017), è ripreso l’intero capitolo 23 del Libro XVIII del "De civitate Dei" (per eventuali approfondimenti, si cfr. sant’Agostino, "La città di Dio": http://www.augustinus.it/italiano/cdd/index2.htm)
- ... IL PASTORALE DI SANT’AGOSTINO CON *UN SOLO SERPENTE* E IL PASTORALE DI BARTOLOMEO I CON *DUE SERPENTI*
PER MEGLIO CAPIRE il filo che lega l’ecumenismo umanistico-rinascimentale (Niccolò Cusano, "La pace della fede", 1453) con l’ecumenismo del presente attuale (nuovo Concilio di Nicea, 2025) e, insieme, la portata simbolica del particolare PASTORALE di sant’Agostino nell’affresco della Cattedrale di Nardò, mi sia consentito rinviare all’immagine del pastorale del Patriarca di Costantinopoli e all’intervista relativa all’ INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL (cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5791).
Federico La Sala
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! Fonti cattoliche a confronto...
MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA. PER UNA NUOVA ERMENEUTICA E UN NUOVO PRINCIPIO DI CARITÀ ... *
Chi ha paura di Jorge Mario Bergoglio
di Riccardo Cristiano (Articolo 21, 1 settembre 2017)
Le anticipazioni di un libro intervista che contiene la trascrizione di dodici dialoghi con il sociologo Dominique Wolton (titolo: “Politique et sociétéˮ, edizioni L’Observatoire) riferiscono che Papa Francesco ha detto di essere andato per alcuni mesi da una psicanalista. In queste ore non sono pochi i giornali che riferiscono le condanne preconciliari della psicanalisi. Forse è il bisogno di trovare qualcosa di “inaudito” in quanto ha detto Bergoglio. Eppure a partire da Pio XII, passando attraverso gli apprezzamenti positivi del Vaticano II nei confronti della psicologia del profondo, si è giunti al riconoscimento di Paolo VI - nella Sacerdotalis coelibatus (1967) - della possibile necessità di un aiuto psicanalitico per i sacerdoti in difficoltà. Questa evoluzione è stata facilitata da una schiera di psicoanalisti dichiaratamente cattolici.
 C’è un saggio, ad esempio, del professor Bresciani sul debito della Chiesa verso la psicoanalisi e Sigmund Freud nel quale possiamo leggere: “Freud, nonostante proponesse una vera e propria antropologia, militava decisamente per l’alleanza terapeutica con il malato; mettendosi a livello del sofferente si prestava ad un ascolto profondo e ad una partecipazione alla sua vita emotiva. [Un studio del professor] Ancona vede qui un Freud vicino alla pedagogia cristiana più di quanto egli stesso pensasse. Il suo ideale di uomo come colui che è capace di «amare e lavorare», la sua posizione sulla possibilità di sublimazione della sessualità, la conclusione della sua opera di ricerca con l’affermazione che la coscienza «resta la sola luce che nelle tenebre della vita psichica ci illumina e ci guida», erano posizioni passibili di sviluppi meno conflittuali.”
C’è un saggio, ad esempio, del professor Bresciani sul debito della Chiesa verso la psicoanalisi e Sigmund Freud nel quale possiamo leggere: “Freud, nonostante proponesse una vera e propria antropologia, militava decisamente per l’alleanza terapeutica con il malato; mettendosi a livello del sofferente si prestava ad un ascolto profondo e ad una partecipazione alla sua vita emotiva. [Un studio del professor] Ancona vede qui un Freud vicino alla pedagogia cristiana più di quanto egli stesso pensasse. Il suo ideale di uomo come colui che è capace di «amare e lavorare», la sua posizione sulla possibilità di sublimazione della sessualità, la conclusione della sua opera di ricerca con l’affermazione che la coscienza «resta la sola luce che nelle tenebre della vita psichica ci illumina e ci guida», erano posizioni passibili di sviluppi meno conflittuali.”Passa in ombra così l’usuale coraggio di Jorge Mario Bergoglio, che anche in questa “confessione” di essere andato per sei mesi da una psicanalista ebrea, che lo ha molto aiutato, sembra stare in questo: anch’io sono un uomo, e tutti gli uomini hanno bisogno di aiuto. Lo dice lui, noi lo diciamo molto più difficilmente. -L’epoca buia dello scontro tra religione e psicanalisi è andata in soffitta da tempo. Ma siccome siamo in un’epoca che si fa nuovamente buia, intrisa di odio per l’altro, di pregiudizio, fondamentalmente di paura, sono moltissime le affermazioni fatte da Papa Francesco che colpiscono. E che per leggere bene dovremmo avere il suo stesso coraggio, cioè quello di toglierci il paraocchi e leggere per quel che sono. Un invito ad andare oltre gli steccati di oggi, oltre quei confini che ci chiudono in ghetti tanti asfittici quanto rassicuranti.
Leggiamo alcuni altri passaggi fondamentali delle sue riflessioni, partendo dall’ Africa e i migranti.
 “[...]L’Europa ha sfruttato l’Africa ... non so se possiamo dirlo! Ma alcune colonizzazioni europee... sì, hanno sfruttato. Ho letto che un capo di stato africano appena eletto come primo atto di governo ha presentato al Parlamento una legge per il rimboschimento del suo paese - ed è stata promulgata. Le potenze economiche del mondo avevano tagliato tutti gli alberi. Rimboschire. La terra è secca per essere stata sfruttata e non c’è più lavoro. La prima cosa da fare, come ho detto alle Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa in tutto il mondo, è trovare qui fonti per creare di posti di lavoro, investire. È vero che l’Europa deve investire anche a casa propria. Anche qui esiste un problema di disoccupazione. L’altro motivo per la migrazione è la guerra. Possiamo investire, le persone avranno una fonte di lavoro e non dovranno partire, ma se c’è guerra, dovranno ancora fuggire. Ora chi fa la guerra? Chi dà le armi? Noi.”
“[...]L’Europa ha sfruttato l’Africa ... non so se possiamo dirlo! Ma alcune colonizzazioni europee... sì, hanno sfruttato. Ho letto che un capo di stato africano appena eletto come primo atto di governo ha presentato al Parlamento una legge per il rimboschimento del suo paese - ed è stata promulgata. Le potenze economiche del mondo avevano tagliato tutti gli alberi. Rimboschire. La terra è secca per essere stata sfruttata e non c’è più lavoro. La prima cosa da fare, come ho detto alle Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa in tutto il mondo, è trovare qui fonti per creare di posti di lavoro, investire. È vero che l’Europa deve investire anche a casa propria. Anche qui esiste un problema di disoccupazione. L’altro motivo per la migrazione è la guerra. Possiamo investire, le persone avranno una fonte di lavoro e non dovranno partire, ma se c’è guerra, dovranno ancora fuggire. Ora chi fa la guerra? Chi dà le armi? Noi.”Per un uomo come Papa Francesco generalizzare è sempre difficile, ma se proprio deve farlo non generalizza sulle “razze”, ma sulle azioni degli Stati e le loro conseguenze. Per condannare? No, per esortare a invertire tendenza, a non cercare scorciatoie, a non vedere nelle vittime degli esseri inferiori, ma delle vittime.
Passiamo a Laicità e religioni. “Lo stato laico è una cosa sana. C’è una laicità sana. [...] Credo che la Francia - questo è il mio parere personale, non quello ufficiale della Chiesa - dovrebbe “elevareˮ un po’ il livello della laicità, nel senso che deve dire che anche le religioni sono parte della cultura. Come esprimerlo in modo laico? Attraverso l’apertura alla trascendenza. Ognuno può trovare la sua forma di apertura.” Come si vede, come si legge, qui non c’è una pretesa di superiorità del credente, ma la rivendicazione della spiritualità dell’uomo, del suo bisogno “naturale” di trascendenza.
Quarto punto, l’Europa. “Non vedo più Schumann, non vedo più Adenauer... L’Europa, in questo momento, ha paura. Chiude, chiude, chiude... L’Europa ha una storia di integrazione culturale, multiculturale come dice lei, molto forte. I Longobardi, i nostri Longobardi oggi, sono barbari che sono arrivati molto tempo fa... E poi tutto si fonde e abbiamo la nostra cultura. Ma qual è la cultura europea? Come definirei oggi la cultura europea? Sì, ha importanti radici cristiane, è vero. Ma non è sufficiente per definirla. Ci sono tutte le nostre capacità. Queste capacità per integrarsi, per ricevere gli altri. C’è anche la lingua nella cultura. Nella nostra lingua spagnola, il 40% delle parole è arabo. Perché? Perché erano lì per sette secoli. E hanno lasciato il segno... Credo che l’Europa abbia delle radici cristiane, ma non sono le uniche. Ci sono altre che non possono essere negati. Tuttavia, credo che sia stato un errore non citare le “radici cristianeˮ nel documento dell’Unione europea sulla prima Costituzione, e questo è stato anche commesso dai governi. Era un errore non vedere la realtà. Questo non significa che l’Europa debba essere interamente cristiana. Ma è un patrimonio, un patrimonio culturale, che abbiamo ricevuto.”
C’è qualcosa di enorme in queste parole, in questa capacità di ricordarci che quel che è stato vero ieri è vero anche oggi. Non esiste purezza, esiste contaminazione. La purezza è delle pietre, la contaminazione è della vita. Anche se non vogliamo più capirlo qualcuno, per fortuna, ce lo ripete.
L’insistenza sulla morale «sotto la cintura». “Ma noi cattolici, come insegniamo la moralità? Non puoi insegnarla con precetti del tipo: “Non puoi farlo, devi farlo, devi, non devi, puoi, non puoiˮ. La morale è una conseguenza dell’incontro con Gesù Cristo. È una conseguenza della fede, per noi cattolici. E per altri, la moralità è una conseguenza dell’incontro con un ideale, o con Dio, o con se stessi, ma con la parte migliore di se stessi. La morale è sempre una conseguenza... C’è un grande pericolo per i predicatori, quello di cadere nella mediocrità. Condannare solo la morale - la prego di perdonare l’espressione - “sotto la cinturaˮ. Ma degli altri peccati, quali l’odio, l’invidia, l’orgoglio, la vanità, l’uccisione dell’altro, prendere la vita, non se ne parla. Entrare nella mafia, fare accordi clandestini...”
Il Vaticano, se posso dir così, è apparso a lungo strabico: l’etica vista dalla Città del Vaticano sembrava riguardare l’inizio e la fine della vita, la morale limitata alla sfera sessuale... Ora l’etica torna a riguardare tutta la vita, dal momento in cui si concepisce a quando si muore, passando però per tutti i momenti della nostra esistenza: da quando sfruttiamo a quando veniamo sfruttati, da quando siamo vittime a quando facciamo nostra vittima un altro. Poco?
Amoris laetitia e rigidità. “La tentazione è sempre quella dell’uniformità delle regole... Prenda ad esempio l’esortazione apostolica Amoris laetitia. Quando parlo di famiglie in difficoltà, dico: “Dobbiamo accogliere, accompagnare, discernere, integrare...ˮ e poi ciascuno vedrà le porte aperte. Quello che sta realmente accadendo è che le persone sentono dire la gente: “Non possono fare la comunione”, “Non possono farlo”: la tentazione della Chiesa è lì. Ma “noˮ, “noˮ e “noˮ!”
Papa Francesco parla di uniformità delle regole, si potrebbe dire che allora la sua Chiesa non si pensa un giudice eterno ed esterno alla storia. Poco?
«L’aborto rimane un peccato grave». “ L’estensione del potere di assolvere il peccato dell’aborto a tutti i sacerdoti, «attenzione, questo non significa banalizzare l’aborto. L’aborto è grave, è un peccato grave. È l’omicidio di un innocente. Ma se c’è peccato, è necessario facilitare il perdono.” Un papa non poteva fare un esempio più rilevante e drammatico per indicare la portata rivoluzionaria della misericordia. Che non è “cancellare il peccato”, ma rigenerare la vita del peccatore. La misericordia così appare la vera cultura alternativa all’odio e, quindi, al terrorismo.
Reciprocità con i musulmani. “Non accettano il principio della reciprocità. Alcuni paesi del Golfo sono aperti e ci aiutano a costruire chiese. Perché sono aperti? Perché hanno lavoratori filippini, cattolici, indiani... Il problema in Arabia Saudita è che è davvero una questione di mentalità. Con l’Islam, comunque, il dialogo sta andando bene, perché non so se lo sa, ma l’Imam di Al-Azhar è venuto a trovarmi. E ci sarà incontro: vado. Penso che farebbe bene a loro fare uno studio critico sul Corano, come abbiamo fatto con le nostre Scritture. Il metodo storico e critico di interpretazione li farà evolvere.”
E’ questo il punto per me più importante, più forte. Senza nessuna pretesa di superiorità, né religiosa né culturale, Bergoglio indica la strada della salvezza dell’islam, in una parola: ermeneutica. Non esita a far presente ai suoi interlocutori il punto decisivo, il punto “critico”, ma lo fa per il bene dell’islam, dei musulmani. E questo, francamente, è commovente.
*
SUL TEMA, BEL SITO, SI CFR.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
- OBBEDIENZA CIECA: TUTTI, PRETI, VESCOVI, E CARDINALI AGGIOGATI ALLA "PAROLA" DI PAPA RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006). Materiali per riflettere
EUROPA ED EVANGELO. LA ’CROCE’ DI CRISTO ("X" = lettera alfabeto greco) NON HA NIENTE A CHE FARE CON IL "CROCIFISSO" DELLA TRADIZIONE COSTANTINIANA E CATTOLICO-ROMANA.
Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto.
 INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT.
INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT.- Per una nuova antropologia e una nuova pedagogia - quella dell’Amore (Deus charitas est), non quella di "Mammasantissima" e di "Mammona" ("Deus caritas est") della Chiesa Cattolico-romana!!!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> VORREI UNA CHIESA CON GLI STESSI SOGNI DI DIO. Papa Francesco: «Ma io mi domando: cosa accadrebbe in Curia se tutti noi ci permettessimo di sognare un po’ di più? Credo che dovremmo chiamare i vigili del fuoco...!».19 maggio 2016, di Federico La Sala
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA .... DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
-
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
Ermes Ronchi: VORREI UNA CHIESA CON GLI STESSI SOGNI DI DIO
C’è chi ormai lo chiama “il predicatore del Papa”. A tu per tu con il religioso che ha tenuto gli esercizi di Quaresima alla Curia romana. Ora un libro ne raccoglie le dieci meditazioni.
«Quando l’ho incontrato, la prima cosa che gli ho detto è stata: “Papa Francesco, posso abbracciarla?”. Mi ha risposto con un sorriso». I friulani dovrebbero essere schivi e riservati per natura, almeno così si dice. Eppure, a padre Ermes Ronchi, di Francesco è rimasto impresso l’abbraccio. «Appena potevo lo abbracciavo, ne ho proprio approfittato», dice ridendo, e aggiunge: «Papa Francesco è un uomo amico della vita, un uomo sereno e pacificato che emana benessere, è un vero piacere stargli vicino».
Sacerdote dell’ordine dei Servi di Maria, 69 anni, padre Ermes è un volto e una penna noti al grande pubblico. Per molti anni ha condotto il commento al Vangelo della domenica nella trasmissione A Sua immagine su Raiuno. Su Avvenire cura una rubrica di commento al Vangelo ogni giovedì. Lo scorso marzo, dopo una telefonata inaspettata di papa Francesco, ha guidato gli esercizi spirituali di Quaresima per la Curia romana. Le dieci meditazioni proposte in quell’occasione ora escono raccolte in un libro della San Paolo, intitolato Le nude domande del Vangelo.
LE DOMANDE DELLA VITA
«Ho scelto come filo conduttore degli incontri con il Papa dieci domande del Vangelo, che ne contiene ben 220, una messe sterminata!», spiega padre Ermes. «Era la tecnica di comunicazione preferita di Gesù, insieme alle parabole. Le sue erano le domande semplici: “Cosa cerchi?” o “Perché piangi?”. Domande della vita, che ti lasciano disarmato, perché ti costringono a tirar fuori qualcosa di nuovo dentro di te».
 Da molto tempo padre Ermes è uno che ama le domande più delle risposte. Lo ha imparato innanzitutto da padre Giovanni Vannucci, anch’egli frate dei Servi di Maria, che incontrò a 18 anni mentre studiava al liceo con l’intenzione di diventare frate. «Non si nutriva di teologia cattedratica, ma ci invitava a cercare Dio nel mondo, negli altri». A padre Ermes cambiò la vita.
Da molto tempo padre Ermes è uno che ama le domande più delle risposte. Lo ha imparato innanzitutto da padre Giovanni Vannucci, anch’egli frate dei Servi di Maria, che incontrò a 18 anni mentre studiava al liceo con l’intenzione di diventare frate. «Non si nutriva di teologia cattedratica, ma ci invitava a cercare Dio nel mondo, negli altri». A padre Ermes cambiò la vita.«Con gli anni ho capito che le risposte non vengono subito», dice a distanza di tanto tempo. «Le domande lavorano in un altro modo: bisogna lasciarle scendere dentro di sé, farle agire, hanno una gestazione dentro di noi, crescono fino a che trovano una risposta. Bisogna amarle, le domande, come dice il grande poeta Rainer Maria Rilke, custodirle, coltivarle, più tardi daranno il frutto della risposta». Oggi il luogo in cui padre Ermes scrive, vive e prega è la comunità dei Servi di Maria della basilica di San Carlo al Corso a Milano, di cui è parroco. La stessa dove visse e operò un altro famoso confratello, padre David Maria Turoldo, «poeta, profeta, disturbatore delle coscienze, uomo di fede, uomo di Dio, amico di tutti gli uomini», lo definì il cardinale Carlo Maria Martini. «Anche lui era un profeta degli ultimi, di chi è vittima dell’ingiustizia, di coloro che sono dimenticati da tutti. Con Francesco si sarebbero subito trovati, e abbracciati».
COME UN DONNA INCINTA
Per il ritiro del Papa, padre Ermes ha scelto un altro filo conduttore: la figura di Maria, partendo proprio da un’invocazione di padre Turoldo: “Vergine, se tu non riappari anche Dio sarà triste”. «Il riferimento non era alle apparizioni mariane ma alla necessità che Maria entri nell’anima, nella fede, dentro il nostro modo di vivere», spiega. «Ho parlato anche delle virtù “umane” di Maria, donna innamorata di normalità che ha sperimentato tutto lo spessore della sua femminilità, che prima di essere Regina del cielo ha mangiato la polvere di questa nostra povera terra. Siamo abituati a vedere la Madonna posta in alto, inarrivabile, irraggiungibile. Io ho voluto immaginarla in cucina, in questo luogo un po’ nascosto che è il luogo della prossimità. Santa Teresa d’Avila in una lettera alle consorelle ha lasciato scritto che “Dio va fra le pentole, in cucina”».
Alla Curia romana padre Ermes ha parlato di «un Dio domestico, famigliare, che viene a casa e a tavola». E citando Origene, grande teologo del III secolo, ha detto che l’immagine più bella del cristiano è una donna incinta che passa nel mondo gravida di una vita nuova: «Dovremmo passare nel mondo gravidi di Dio, incinti di luce».
A CONTATTO CON LA REALTÀ
Il lavoro, il contatto con la realtà è stato importante nella vita di padre Ermes Ronchi. Appena ordinato sacerdote, nel 1973, decise di lasciare il convento classico per dar vita, insieme ad altri frati, a una comunità sperimentale nella provincia di Vicenza, dove ognuno si manteneva con il proprio lavoro. «Poi sentii il bisogno di studiare», racconta, «andai a Parigi e qui mi mantenni agli studi facendo i lavori più disparati, dal bracciante agricolo, allo spazzino comunale, all’insegnante di italiano». Un percorso che potrebbe essere utile a molti sacerdoti: «Di sicuro rivedere la formazione del clero è una priorità che la Chiesa deve affrontare, insieme al ruolo delle donne», dice.
 «Alla Curia ho anche lanciato qualche provocazione, citando l’episodio del Vangelo in cui Gesù è a cena a casa di Simone e arriva la donna con il profumo di nardo. Gesù chiede: “Simone, la vedi questa donna?”. Alla Curia ho detto: “Se Gesù facesse questa domanda, qui e ora, se chiedesse: La vedi questa donna?”, io dovrei dire: No Signore, io qui non vedo nessuna donna”. E ho aggiunto: “Questo vi sembra normale?”. Ho fatto una pausa, perché volevo suscitare una domanda. Non ho risposte da dare, ma di certo il “governo” della Chiesa non è rappresentativo del mondo cristiano».
«Alla Curia ho anche lanciato qualche provocazione, citando l’episodio del Vangelo in cui Gesù è a cena a casa di Simone e arriva la donna con il profumo di nardo. Gesù chiede: “Simone, la vedi questa donna?”. Alla Curia ho detto: “Se Gesù facesse questa domanda, qui e ora, se chiedesse: La vedi questa donna?”, io dovrei dire: No Signore, io qui non vedo nessuna donna”. E ho aggiunto: “Questo vi sembra normale?”. Ho fatto una pausa, perché volevo suscitare una domanda. Non ho risposte da dare, ma di certo il “governo” della Chiesa non è rappresentativo del mondo cristiano».La più grande novità di papa Francesco? Per Ermes Ronchi è la conversione dello sguardo: «Da una Chiesa che si mette al centro, che gira i riflettori su se stessa, dove noi pastori vogliamo tirare la gente dentro, a una Chiesa che si mette a servizio dell’avvenire del mondo, della vita, della cultura, del domani, delle nuove generazioni. È questo il grande cambiamento che ci sta facendo fare papa Francesco. Ed è bello come trasmette il Vangelo. Non avvicina le persone come vasi vuoti da riempire, ma come fuochi da accendere. La fede non si genera, si propaga attraverso questo calore. Se il caffè bolle, il profumo si sente nella stanza. Ma se non bolle, non si sente niente!».
 IL LIBRO
IL LIBRO
 IL PROFUMO DELLA VITA IN DIECI MEDITAZIONI
IL PROFUMO DELLA VITA IN DIECI MEDITAZIONI«Alle volte pensiamo che il sogno sia una fantasia, come dipingere il cielo di blu. Eh no, il sogno è un’altra cosa. Ci vuole coraggio per sognare, il coraggio che hanno avuto i santi». A dirlo è stato Francesco, alla fine degli esercizi di Quaresima predicati da padre Ronchi. Il commento e ringraziamento del Papa è in appendice a Le domande del Vangelo (San Paolo), che raccoglie le riflessioni proposte dal frate servita. Al termine degli incontri il Papa ha “azzardato” un invito: «Ma io mi domando: cosa accadrebbe in Curia se tutti noi ci permettessimo di sognare un po’ di più? Credo che dovremmo chiamare i vigili del fuoco...!».
 Il libro uscirà la prossima settimana con Credere a 9,90 euro. Ordinazioni contattando il n. 02.48027575, vpc@stpauls.it, o sul sito www.edicolasanpaolo.it.
Il libro uscirà la prossima settimana con Credere a 9,90 euro. Ordinazioni contattando il n. 02.48027575, vpc@stpauls.it, o sul sito www.edicolasanpaolo.it.(Fonte: Credere - Testo di Emanuela Citterio )
-
> VORREI UNA CHIESA CON GLI STESSI SOGNI DI DIO. -- Il cielo si apre. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio (di Ermes Ronchi).10 gennaio 2019, di Federico La Sala
Il cielo si apre
Siamo tutti figli di Dio nel Figlio
di Ermes Ronchi ( Avvenire, giovedì 10 gennaio 2019)
- Battesimo del Signore - Anno C
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il Battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
«Viene dopo di me colui che è più forte di me". In che cosa consiste la forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l’unica che suona in mezzo all’anima. E parla parole di vita. «Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immergere l’uomo nell’oceano dell’Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso del suo respiro, e diventi figlio: a quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio (Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono venuto perché abbiano la vita in pienezza», Gv 10,10), forza liberante e creativa, come un vento che gonfia le vele, un fuoco che dona un calore impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano a passare nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, energia e luce. Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza di questo particolare: il cielo che si apre. La bellezza della speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli si fossero rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato.
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per ciascuno di noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme genera secondo la propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro.
“Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. Immeritato amore, incondizionato, unilaterale, asimmetrico. Amore che anticipa e che prescinde da tutto.
“Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene l’idea di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognuno: figlio mio, ti guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi immaginare di nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra di me come un abbraccio, un soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice con tenerezza e forza: figlio, amore mio, mia gioia, sarei molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita è al sicuro nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio prezioso, che vive della stessa vita indistruttibile e generante.
 (Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2,11-14;3,4-7; Luca 3, 15-16.21-22).
(Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2,11-14;3,4-7; Luca 3, 15-16.21-22).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
- GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> Papa Francesco: «Ma io mi domando: cosa accadrebbe in Curia se tutti noi ci permettessimo di sognare un po’ di più? Credo che dovremmo chiamare i vigili del fuoco...!». --- Pregare trasforma in ciò che si contempla (di Ermes Ronchi).16 marzo 2019, di Federico La Sala
«Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Ma come un vitello d’oro di Mammona ("caritas") o come il bambino, figlio dell’Amore ("charitas") di Giuseppe e Maria?! *
Il Vangelo.
Pregare trasforma in ciò che si contempla
di Ermes Ronchi (Avvenire, giovedì 14 marzo 2019)
 II Domenica di Quaresima
II Domenica di Quaresima
 Anno C
Anno C- In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. [...]
Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la terra che si fa verticale, la più vicina al cielo, dove posano i piedi di Dio, dice Amos. I monti sono indici puntati verso il mistero e la profondità del cosmo, verso l’infinito, sono la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare. La preghiera è appunto penetrare nel cuore di luce di Dio. E scoprire che siamo tutti mendicanti di luce.
 Secondo una parabola ebraica, Adamo in principio era rivestito da una pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi, dopo il peccato, la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. Quando verrà il Messia la tunica di luce affiorerà di nuovo da dentro l’uomo finalmente nato, “dato alla luce”. Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, diventi come Colui che preghi.
Secondo una parabola ebraica, Adamo in principio era rivestito da una pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi, dopo il peccato, la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. Quando verrà il Messia la tunica di luce affiorerà di nuovo da dentro l’uomo finalmente nato, “dato alla luce”. Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, diventi come Colui che preghi.
 Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo sull’abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una grande bellezza.
Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo sull’abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una grande bellezza.
 Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l’entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita - che bello! - Ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e puro dell’uomo.
Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l’entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita - che bello! - Ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e puro dell’uomo.
 Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la catechesi, di tutta la morale, di tutta la fede: smetterla di dire che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire un’altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar).
Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: viene una nube, e dalla nube una voce.
Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la catechesi, di tutta la morale, di tutta la fede: smetterla di dire che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire un’altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar).
Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: viene una nube, e dalla nube una voce.
 Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaico-cristiana si fonda sull’ascolto e non sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei rimandato all’ascolto della Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l’eco dell’ultima parola: Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, il visibile parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose.
Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaico-cristiana si fonda sull’ascolto e non sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei rimandato all’ascolto della Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l’eco dell’ultima parola: Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, il visibile parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose. (Letture: Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi 3,17- 4,1; Luca 9,28-36)
(Letture: Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi 3,17- 4,1; Luca 9,28-36)
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> Amore e responsabilità -- La teologia cristiana del corpo e il "Post-umano, troppo post-umano" (di Nunzio Galantino)3 aprile 2016, di Federico La Sala
- CIVILTA’ DELL’AMORE E VOLONTA’ DI GUERRA. DOPO GIOVANNI PAOLO II, IL VATICANO SOPRA TUTTO E CONTRO TUTTI. Il "peccato originale" e la "mala fede" antropo-teo-logica
Corpo
Post-umano, troppo post-umano
di Nunzio Galantino (Il Sole-24 ore, Domenica, 03.04.2016)
L’approccio contemporaneo al tema del corpo pone più interrogativi di quanti, per esempio, non se ne ponessero nel mondo greco, dove il confine fra corpo e corporeità era per lo più segnato dalle sfumature della parola soma. In particolare, i pitagorici hanno costruito un’approfondita antropologia sui rapporti dell’anima con il corpo, che poi ha avuto risvolti e approfondimenti nella filosofia greca.
Oggi il confine fra il corpo e la corporeità si è spostato più in là toccando il post-umano, che inevitabilmente apre interessanti piste di ricerca per la bioetica. Dopo aver stabilito il legame inevitabile fra il corpo e l’identità personale, si può comprendere come mai il corpo venga sottoposto a interventi che lo modificano sia in maniera superficiale sia in maniera profonda: tatuaggi, piercing, fino all’ingegneria genetica. Il corpo finisce così per non essere l’espressione di una condizione immutabile, ma l’interfaccia di una comunicazione con gli altri esseri umani e con l’ambiente socioculturale, in una condizione continuamente in via di definizione. Questo scenario mutevole di corpo e corporeità, per certi versi positivo, quando incontra l’orizzonte culturale del post-umano va incontro a qualche rischio, a volte grave.
Lo scenario del cyber-corpo (la relazione che intercorre fra l’uomo e la macchina) rischia di far perdere il confine fra l’artefice e il prodotto, perché il cyborg, fusione fra macchina e il corpo organico, oggi più che mai, apre a tanti scenari possibili. È dinanzi a questi scenari che si giocherà una nuova partita con la bioetica e con l’identità personale dove la corporeità non prevede più l’armonia con il cosmo, kosmos, ma l’armonia è ricercata o interrotta nel rapporto con le macchine.
La teologia cristiana del corpo, che ha superato ogni deriva dualistica e che si è sviluppata nella fedeltà al dato biblico, contiene in sé tutti gli elementi per sostenere una svolta, anche radicale rispetto alla deriva che si è consumata e che, stando alla lucida analisi di M. Horkheimer e Th. Adorno, continua a consumarsi. Una svolta che dal “sentire” il corpo, come oggetto rifiutato o sfruttato, porti a “sentirsi” corpo.
La nostra realizzazione armonica non dipende, in primo luogo, dal fare (o disfare) un corpo inteso come semplice oggetto, ma nel farsi corpo, abitando il mondo come con-tatto, come appartenenza, come dono. Farsi corpo! La fede cristiana non consiste nel credere in Dio come oggetto pensabile, ma nel seguire il “metodo” del Dio incarnato, ossia nel “farsi” corpo.
-
> Amore e responsabilità -- «Amoris laetitia», la gioia dell’amore. L’ esortazione post-sinodale di Papa Francesco (di A. Tornielli)9 aprile 2016, di Federico La Sala
DIFENDERE LA FAMIGLIA!? MA QUALE FAMIGLIA - QUELLA DI GESU’ (Maria - e Giuseppe!!!) O QUELLA DI EDIPO (Laio e Giocasta)?!
Il Papa: “Il sesso dono di Dio”E tende la mano ai divorziati
Bergoglio fissa in 260 pagine la nuova “costituzione per le famiglie”
No ai matrimoni gay, ma nessuno deve sentirsi condannato o escluso
di Andrea Tornielli (La Stampa, 09.04.2016)
La Chiesa è chiamata «a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle». È la frase chiave dell’esortazione post-sinodale di Papa Francesco «Amoris laetitia», la gioia dell’amore, nove capitoli per oltre 300 paragrafi distribuiti in 260 pagine.
Testo lungo e articolato, che fa proprie le conclusioni degli ultimi due Sinodi e rappresenta quasi una nuova «carta costituzionale» per le famiglie del terzo millennio, in un tempo di grandi cambiamenti. Il tentativo, che emerge quasi in ogni pagina, è quello di un approccio positivo, che parte dalla complessità della realtà e dal superamento della logica della semplice «condanna» e della «lamentela» per ciò che non va. Non ci sono cambiamenti della normativa generale sui sacramenti per i divorziati risposati, ma Francesco, seguendo la via indicata dal Sinodo, insiste sul «discernimento» caso per caso e sull’«integrazione» degli «irregolari».
Amore tra i coniugi
Non manca l’analisi delle sfide, come quella rappresentata dalla cultura individualista che porta a non prendere impegni definitivi, o quella rappresentata dalla povertà o ancora da ritmi di lavoro così frenetici da impedire un minimo di vita familiare. Si definisce «inquietante» il tentativo di imporre ai bambini l’ideologia gender, viene ribadito il no all’aborto, si accenna alla «minaccia» dell’eutanasia, viene ripetuta a chiare lettere la contrarietà a ogni equiparazione tra matrimonio e unioni gay. Tra le pagine più interessanti e innovative quelle sulla sessualità, presentata come un «dono meraviglioso» di Dio, con una significativa autocritica per aver insistito troppo sul fine procreativo del matrimonio e non altrettanto sul suo fine unitivo. Per troppo tempo, infatti, la Chiesa ha tenuto, riconosce Francesco, un atteggiamento troppo difensivo, «con poca capacità propositiva per indicare strade di felicità». Nei due capitoli dedicati all’amore tra i coniugi sono contenuti una serie di consigli importanti ma anche più spiccioli, per mantenere viva la «gioia dell’amore», imparando giorno dopo giorno ad amare l’altro uscendo da se stessi.
Nel testo, dove trovano spazio citazioni di Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Martin Luther King, Erich Fromm e si menziona il film «Il pranzo di Babette» come esempio di capacità di far godere gli altri, c’è ampio spazio dedicato all’educazione dei figli, da aiutare a crescere senza fare i «controllori», evitando la bulimia di smartphone e tablet che porta al rischio dell’«autismo tecnologico». Un intero capitolo, l’ottavo, è dedicato alle famiglie «ferite» e in particolare alla pastorale per i divorziati risposati. Francesco rilancia la necessità di «discernere» e di «integrare», deludendo sia chi chiedeva cambiamenti della norma canonica sull’accesso alla comunione, sia chi ribadiva che nulla può mai cambiare sulla disciplina dei sacramenti.
Caso per caso
Bergoglio ricorda che i divorziati in seconda unione, «possono trovarsi in situazioni molto diverse», non catalogabili in «affermazioni troppo rigide». Una cosa, ad esempio, è una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi figli, «con provata fedeltà, impegno cristiano, consapevolezza dell’irregolarità della propria situazione e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove colpe». C’è poi il caso di quanti hanno fatto «grandi sforzi» per salvare il primo matrimonio e hanno subito un abbandono ingiusto, o il caso di chi si è sposato nuovamente «in vista dell’educazione dei figli» e magari in coscienza è certo che il precedente matrimonio, «irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido». Un caso completamente diverso, invece, è una nuova unione che viene da un recente divorzio, con tutte le conseguenze di sofferenza e confusione che colpiscono i figli e le famiglie intere, o la situazione di chi ha ripetutamente «mancato ai suoi impegni familiari».
Nessuno può dunque avanzare pretese circa i sacramenti, ma «non è più possibile dire - scrive il Papa - che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato mortale». Ecco dunque lo spazio per valutazioni caso per caso, nella discrezione del rapporto con il confessore, senza il rischio di introdurre una doppia morale, ma con la consapevolezza che scendendo nei casi particolari ci possono essere circostanze che attenuano le responsabilità personali. Nessuno deve sentirsi condannato, nessuno disprezzato, nessuno escluso.
ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE AMORIS LAETITIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI VESCOVI AI PRESBITERI E AI DIACONI ALLE PERSONE CONSACRATE AGLI SPOSI CRISTIANI E A TUTTI I FEDELI LAICI SULL’AMORE NELLA FAMIGLIA
NEL CAPITOLO TERZO DELL’ "AMORIS LAETIZIA", intitolato "LO SGUARDO RIVOLTO A GESÙ: LA VOCAZIONE DELLA FAMIGLIA") così è scritto:
"(...) 70. «Benedetto XVI, nell’Enciclica Deus caritas est, ha ripreso il tema della verità dell’amore tra uomo e donna, che s’illumina pienamente solo alla luce dell’amore di Cristo crocifisso (cfr 2). Egli ribadisce come “il matrimonio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l’icona del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa: il modo di amare di Dio diventa la misura dell’amore umano” (11). Inoltre, nell’Enciclica Caritas in veritate, evidenzia l’importanza dell’amore come principio di vita nella società (cfr 44), luogo in cui s’impara l’esperienza del bene comune» (...)".
LA VERITA’ DELL’AMORE DEL "DIO MAMMONA" ("DEUS CARITAS") O LA VERITA’ DELL’AMORE DI "DIO AMORE" ("DEUS CHARITAS"?!:
OBBEDIENZA CIECA: TUTTI, PRETI, VESCOVI, E CARDINALI AGGIOGATI ALLA "PAROLA" DI PAPA RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006).
Ma sulla famiglia la Chiesa è ferma
di Chiara Saraceno (la Repubblica, 09.04.2016)
NEL LINGUAGGIO amorevole e compassionevole cui ci ha ormai abituati, sollecitando anche qualche ingenua aspettativa, il pontefice ha ribadito la immodificabilità delle posizioni della chiesa cattolica in merito alla famiglia. L’amore e il sesso sono dimensioni positive dell’agire umano, purché avvengano entro il matrimonio tra un uomo e una donna. Bisogna evitare di mettere al mondo figli cui non si è in grado di provvedere, ma gli unici strumenti contracettivi legittimi sono quelli naturali, ovvero l’astensione dai rapporti sessuali nei periodi in cui la donna è fertile. Le persone omosessuali vanno accolte e non discriminate, ma i loro rapporti di amore e la loro sessualità non ha nulla a che fare con il «disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia». Il che è perfettamente accettabile per chi crede esista un tale disegno.
Non si capisce però perché, in nome di questo, la chiesa e lo stesso pontefice ostacolino e condannino chi vuole inserire queste coppie in una configurazione della famiglia che non trovi il proprio fondamento nel disegno di Dio, ma nella legislazione civile e nel principio di uguaglianza e non discriminazione, che include anche il diritto a farsi una famiglia. Non manca, nel documento papale, neppure un accenno di condanna alla fantomatica teoria del genere, da cui dovrebbero essere protetti i bambini, ribadendo la più o meno intenzionale incomprensione degli obiettivi cui mira una educazione critica sul genere.
L’unica parziale apertura riguarda i divorziati risposati e la possibilità che possano essi accedere ai sacramenti. Facendo propria e persino andando oltre la posizione espressa dalla maggioranza dei padri sinodali, il pontefice sostiene che non tutti i casi sono uguali, che la condizione di peccato non è necessariamente per sempre, ma va valutata caso per caso. È ciò che avviene già di fatto in molte parrocchie, ma l’affermazione del papa può essere letta come una vera e propria modifica dottrinale, nella misura in cui toglie il divorzio e i divorziati dalla condizione di essere una categoria omogenea, e irreversibile, di peccato e peccatori, per tornare ad essere singoli, con le loro specifiche ragioni e circostanze, che possono o meno essere perdonate e superate.
Non è un passaggio di poco conto. Così come non lo è l’autocritica per le durezze che la chiesa ha manifestato in passato. Ma, pur senza sottovalutare l’attenzione per le difficoltà che incontrano molte famiglie in condizioni di disagio, la persistente discriminazione nei confronti delle donne e il richiamo all’importanza di politiche sociali adeguate, sono gli unici due passaggi che presentano qualche apertura, su cui può continuare a lavorare l’opera di riflessione collettiva messa in moto dai due sinodi.
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - Le lettere segrete tra Papa Giovanni Paolo II e una donna sposata spedite per 30 anni. Lo rivela la BBC.16 febbraio 2016, di Federico La Sala
Le lettere segrete tra Papa Giovanni Paolo II e una donna sposata spedite per 30 anni. Lo rivela la BBC *
Lettere, anche intime, spedite per 30 anni tra Papa Giovanni Paolo II e una donna sposata. La rivelazione arriva dalla Bbc, come riporta un articolo de Il Tirreno. Il carteggio racconta la storia di un’amicizia durata più di tre decenni iniziata quando Karol Wojtyla era ancora cardinale e arcivescovo di Cracovia. Tuttavia, riporta la BBC, "non vi è alcun segno che il Pontefice abbia violato il voto di castità". Riporta il Tirreno:
- L’amicizia tra i due sarebbe nata nel 1973, quando Anna-Teresa Tymieniecka (una filosofa americana di origine polacche) contatta l’allora cardinale Wojtyla per un libro di filosofia che il futuro Papa aveva scritto. Ne nasce una stretta corrispondenza, tanto che la donna decide di partire dagli Stati Uniti verso la Polonia per discutere della revisione di uno dei testi scritti da Wojtyla.
Lettere che all’inizio sono molto formali ma che poi diventano sempre più intime, dal momento che la filosofa americana inizia a manifestare i suoi "intensi sentimenti" nei confronti di Wojtyla. E il futuro Papa li ricambiava, ma senza mai oltrepassare la soglia dell’amicizia. L’autore del documentario per il canale inglese, Edward Stourton, ha trovato più di 350 lettere nella Biblioteca Nazionale di Polonia. "Direi che sono stati più che amici ma meno che amanti", ha commentato Stourton. Riporta ancora il Tirreno:
- In una missiva del 1976 la definisce "un dono di Dio" e scrive: "Mia cara Teresa. Tu parli di essere separati, ma io non so trovare risposta a queste parole". In un altra lettera sempre del 1976 si legge: "Già l’anno scorso stavo cercando una risposta a queste parole ’Io ti appartengo’, e finalmente, prima di lasciare la Polonia, ho trovato il modo, uno scapolare", un paramento sacro. L’allora cardinale Wojtyla donò il suo alla Tymieniecka. "La dimensione in cui ti accetto e ti sento dappertutto e in ogni genere di situazione, quando sei vicina e quando sei lontana", scrive ancora Wojtyla alla Tymieniecka, le cui lettere non sono state pubblicate.
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - “Più che amici, ma meno che amanti”. Papa Wojtyla e la filosofa americana Anna-Teresa (di Francesco A. Grana) Tymieniecka16 febbraio 2016, di Federico La Sala
Papa Wojtyla, pubblico lo scambio di lettere con la filosofa americana Anna-Teresa:
“Più che amici, ma meno che amanti”
A svelare l’ultimo intenso rapporto del Papa santo è un carteggio di 350 lettere ritrovato nella Biblioteca nazionale di Polonia dal giornalista Edward Stourton e oggetto di un documentario della Bbc. Le missive sono indirizzate ad una donna americana, il cui rapporto con san Giovanni Paolo II era fino a oggi sconosciuto
di Francesco Antonio Grana *
Nella vita di Karol Wojtyla è entrata più di una donna.. Il carteggio inizia nel 1973, quando Wojtyla era già cardinale arcivescovo di Cracovia, e arriva fino al 2005, ovvero a pochi giorni dalla morte del Pontefice. Più di 30 anni di confidenze e di un’intensa amicizia con una donna che Wojtyla, nel 1976, due anni prima di diventare Papa, definisce “un dono di Dio”.
“Mia cara Teresa - scrive il Pontefice polacco - tu parli di essere separati, ma io non so trovare risposta a queste parole”. In un’altra lettera datata sempre 1976 si legge: “Già l’anno scorso stavo cercando una risposta a queste parole ‘io ti appartengo’, e finalmente, prima di lasciare la Polonia, ho trovato il modo, uno scapolare”. L’allora cardinale donò alla Tymieniecka quel piccolo oggetto di devozione alla Madonna del Carmelo. Un segno della “dimensione in cui ti accetto - scrive ancora Wojtyla - e ti sento dappertutto e in ogni genere di situazione, quando sei vicina e quando sei lontana”. Un rapporto spirituale come ci tiene a chiarire Stourton: “Direi che sono stati più che amici, ma meno che amanti”.
Tra Wojtyla e la Tymieniecka l’amicizia nacque per caso, nel 1973, quando la donna cercò l’allora cardinale per un libro di filosofia che il futuro Papa aveva scritto. Iniziò così un’intensa corrispondenza, tanto che la Tymieniecka decise di partire dagli Stati Uniti dove si trovava verso la Polonia per discutere della revisione di uno dei testi scritti da Wojtyla. In un primo momento le lettere del cardinale erano molto formali, ma pian piano nacque una profonda amicizia tra i due che rese il loro carteggio molto più confidenziale. Per questioni di lavoro i due si incontrarono spesso, a volte in presenza del segretario, il fedelissimo Stanislao Dziwisz, per 40 anni accanto a Wojtyla, a volte da soli. Dalle lettere, ma anche da centinaia di fotografie che li ritraggono insieme, emerge che la donna avrebbe mostrato i suoi “intensi sentimenti” per il Papa polacco che invece avrebbe cercato di dare una direzione più amichevole al loro rapporto. Dopo la morte della Tymieniecka, nel 2014, il carteggio e le fotografie che lo accompagnano sono stati ritrovati.
Fino a oggi si conosceva la storia di Wanda Poltawska, infermiera polacca legatissima al futuro Papa che per lei chiese e ottenne da padre Pio il miracolo della guarigione dal cancro, improvvisamente scomparso prima dell’intervento chirurgico. Una vita segnata dalla drammatica esperienza nei campi di concentramento, dove fu sottoposta a esperimenti medici, fino all’incontro con don Karol Wojtyla che divenne la sua guida spirituale e il suo amico fraterno al punto di chiamarsi reciprocamente fratello e sorella. I campeggi trascorsi insieme, la malattia e la miracolosa guarigione di Wanda, le riflessioni spirituali sono tutti svelati nel lungo carteggio tra i due pubblicato, dopo la morte del Papa polacco, nel volume Diario di un’amicizia, che suscitò non poche polemiche.
Fu proprio Wanda, al capezzale di Wojtyla la sera della sua morte, il 2 aprile 2005, a somministrare al Papa l’ultima iniezione di antibiotico al posto di suor Tobiana. Quest’ultima altra donna chiave nella vita del futuro santo che aveva assistito per oltre 40 anni prima a Cracovia e poi a Roma e alla quale, nelle ultime ore di vita, aveva chiesto: “Lasciatemi andare alla casa del Padre”. Una richiesta, rivelata al mondo dall’allora portavoce vaticano, Joaquín Navarro-Valls, con la quale Wojtyla aveva rifiutato ogni tipo di accanimento terapeutico sul proprio corpo. Nei 27 anni del suo pontificato san Giovanni Paolo II è stato il primo, e fino a oggi l’unico Papa, a scrivere, nel 1995, una lettera alle donne nella quale celebrò il “genio femminile”. Così come la prima poesia di Wojtyla, Sulla tua bianca tomba, scritta a 19 anni, è rivolta a una donna: la mamma Emilia morta 10 anni prima.
Il Fatto - Francesco Antonio Grana | 15 febbraio 2016
-
> Amore e responsabilità --- «Diritto d’amore». L’amore non rinuncia al diritto. La legge non può colonizzare la vita affettiva e la sessualità di uomini e donne.7 gennaio 2016, di Federico La Sala
Rodotà, il divenire universale dell’autonomia individuale
Saggi. «Diritto d’amore» di Stefano Rodotà per Laterza. Dalle unioni civili alla laicità dell’istruzione. Un libro che segnala come la legge non può colonizzare la vita affettiva e la sessualità di uomini e donne. L’amore non rinuncia al diritto. Lo usa come un mezzo per realizzare una sua pienezza. Questo è possibile perché la sua storia è storia politica
di Roberto Ciccarelli (il manifesto, 07.01.2016)
È arduo per un giurista parlare del diritto di amare, dato che la disciplina che rappresenta ha usato l’amore come premessa di un progetto di controllo delle donne, ridotte a proprietà del coniuge, mentre la politica continua a decidere sulla vita di uomini e donne. E tuttavia, scrive Stefano Rodotà nel suo ultimo libro Diritto d’amore (Laterza, pp.151, euro 14), l’amore non rinuncia al diritto. Lo usa come un mezzo per realizzare una sua pienezza. Questo è possibile perché la sua storia è storia politica.
Proprietà, credito e obbedienza: questa è la triade usata dal «terribile diritto», il diritto privato, per assoggettare l’amore - e la vita delle persone - alla razionalità dello Stato e al dominio della legge. Rodotà conduce da sempre una critica instancabile a questo modello. Per lui il diritto d’amore, come tutti i diritti, non nasce dall’arbitrio soggettivo, né da un fondamento naturalistico, ma dal legame tra il diritto e la realizzazione di un progetto di vita. Il diritto è legittimato dalle persone che decidono di riconoscerlo e lo usano per affermare l’autonomia e la libertà di tutti, non solo la propria.
Ciò non toglie che il diritto e l’amore, il desiderio di unirsi a un’altra persona, indipendentemente dal suo sesso, mantengano una distanza irriducibile. Quasi mai, infatti, il diritto è un complice della vita. Anzi, esiste per disciplinare gli affetti e per creare il modello del cittadino laborioso, maschio, proprietario. L’amore, invece, non sopporta regole o norme. Preferisce crearle da sé, nell’esperienza delle relazioni, seguendo un divenire che difficilmente può essere contenuto in un’unica disciplina valida per tutti. Per questa ragione il diritto ha preferito confinare «l’amore senza legge in uno stato di eccezione», come ha scritto un grande giurista francese, Jean Carbonnier.
L’autonomia irrinunciabile
In questo stato di eccezione prevale l’originaria ispirazione del diritto privato - cioè la riduzione della passione a cosa e della persona a proprietà di qualcuno. Orientamenti presenti ancora oggi in alcune sentenza della Corte Costituzionali o in fatali decisioni come quella sulla legge 40 sulla fecondazione assistita approvata dal governo Berlusconi.
A tutela dell’autonomia e della libertà delle persone, Rodotà usa la Costituzione e dai suoi articoli fondamentali traccia un uso alternativo del diritto che distrugge i valori di cui la stessa carta fondamentale è espressione. A questo punto è quasi inevitabile per il giurista raccontare la storia dei movimenti che hanno fatto esplodere il perimetro formalizzato dei poteri e della legge nel secondo Dopoguerra. Prima il movimento femminista, oggi i movimenti Lgbtq a cui Rodotà dedica un intero capitolo. Il diritto di amare è diventato una questione politica di rilievo perché alimenta la ricerca dell’autonomia delle persone. Il conflitto è emerso, fortissimo, sulle unioni civili come, di recente, hanno dimostrato i movimenti Lgbtq che hanno organizzato una «marcia dei diritti» per criticare l’insufficienza, addirittura le potenziali discriminazioni presenti nel disegno di legge Cirinnà che il governo intende approvare.
Storia di un incontro
In questa partita rientra anche il conflitto sull’educazione alle differenze nelle scuole: da una parte, c’è un movimento vasto che sostiene la laicità dell’istruzione pubblica e la critica dei ruoli sessuali per tutelare la libertà dei bambini e degli insegnanti. Dall’altra parte, c’è una reazione furibonda che attraverso il meme dell’«ideologia del gender» - una narrazione tossica strumentale e infondata - ha saldato un ampio movimento conservatore con le istanze più reazionarie del cattolicesimo e mira a colpire la laicità dell’istruzione e la libertà nelle scelte d’amore.
Come accade nei suoi libri, Rodotà unisce la storia dei movimenti a quelle della Costituzione italiana e della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea alla quale ha contribuito. L’incontro con i movimenti serve al diritto per «conoscere se stesso, il proprio limite, l’illegittimità di ogni sua pretesa di impadronirsi della vita - scrive Rodotà -. Emerge così uno spazio di non diritto nel quale il diritto non può entrare e di cui deve farsi tutore, non con un ruolo paternalistico, ma con distanza e rispetto». Dal punto di vista dei movimenti, il diritto serve a riconoscere e a coltivare una tensione nel darsi regole che possono cambiare, seguendo una geometria delle passioni interna alle relazioni tra il soggetto e la sua vita.
In questo quadro è fondamentale il ruolo delle minoranze: il movimento omosessuale, insieme a quello femminista, quello Lgbtq, interpretano lo stesso modo di fare politica: per vincere i movimenti si coalizzano con altri soggetti attivi nella società al fine di ottenere un riconoscimento sociale e istituzionale. Le conquiste sulle libertà personali sono valide per tutti, come hanno dimostrato l’aborto e il divorzio. Il diritto d’amore si inserisce in questa nobile vicenda e risponde a un’esigenza che ha dato il titolo a un altro, notevole, libro di Rodotà: il diritto ad avere diritti.
Tensioni singolari
Auspicio, affermazione performativa, atto di cittadinanza: il diritto ad avere diritti è una formula che caratterizza l’azione coordinata delle minoranze e afferma i diritti universali di tutti: il welfare state, l’ambiente, i beni comuni, per esempio. L’universalismo singolare dei diritti si pratica sottraendosi dall’identità maggioritaria fissata per legge (Deleuze la definiva «divenire minoritario») e, allo stesso tempo, nella creazione di un diritto all’esistenza che sfugge ai principi della morale dominante e agli assetti del potere organizzato dal diritto. Questa duplice azione rivela l’esistenza di uno spazio rivoluzionario. Rodotà lavora alla sua riapertura, in un momento non certo felice di arretramento generale.
Diritto d’amore è infine un libro che va letto insieme a quello dedicato da Rodotà alla solidarietà. Da tempo il giurista è impegnato in una ricostruzione genealogica delle passioni e delle pratiche volte alla costituzione di una soggettività caratterizzata da un rapporto di reciprocità, irriducibile al narcisismo o alla naturalizzazione dei ruoli. Parla di uguaglianza e ne rintraccia la storia nelle pratiche della solidarietà e nella dignità della persona. In questa fittissima tessitura, l’amore è un «rapporto sociale», mentre la sua tensione singolare «a bassa istituzionalizzazione» spinge a creare mondi nuovi. Questa può essere considerata una risposta all’invocazione di Auden: «La verità, vi prego, sull’amore».
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! --- Non da seme, ma da “soffio mistico”. L’Immacolata Concezione, tra paganesimo e controllo sociale (di Maria Mantello)15 dicembre 2015, di Federico La Sala
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
MARIA MANTELLO -L’8 dicembre, l’Immacolata Concezione, tra paganesimo e controllo sociale *
- Non da seme, ma da “soffio mistico”
Apuleio, nelle Metamorfosi ci presenta questa apparizione:
- «Una massa di capelli folti leggermente ondulati, si allargava ovunque sulla divina nuca e fluiva giù con molle grazia. Una corona intessuta di molti e svariati fiori le cingeva il capo alla sommità; proprio nel mezzo, sopra la fronte, emetteva una chiara luce un disco dalla superficie piena, che somigliava ad uno specchio...simile alla luna (...) indossava una veste di lino sottile, dal colore cangiante, ora di un bianco accecante, ora gialla come il croco, ora fiammante di rosso splendore... un mantello correva intorno al capo... poi pendeva in basso con pieghe molteplici sino all’orlo inferiore...Sparse sull’orlo ricamato e sull’ampia superficie del mantello rifulgevano le stelle, e in mezzo ad esse una luna piena effondeva una luce di fiamma ... i suoi piedi d’ambrosia calzavano sandali di foglia di palma, simbolo della vittoria». (Metamorfosi, XI, 3).
È Iside che appare al protagonista Lucio, al momento della sua iniziazione-rinascita, ma la descrizione potrebbe tranquillamente riferirsi alle tante raffigurazioni di Maria, la madre del dio fatto uomo, La Vergine dall’Immacolata Concezione.
L’inno di s. Ambrogio
Nel suo inno di Natale, s. Ambrogio loda Il Redentore che ha fecondato Maria col suo "mistico soffio": «Veni, Redemptor Gentium, / Ostende partum virginis/ ...Non ex virili semine/ Sed mystico spiramine/ Verbum Dei factum est caro/ Fructusque ventris floruit» (Vieni Salvatore delle Genti, Rivelaci il parto verginale... non da seme umano/ ma da soffio mistico/ il Verbo di Dio si è fatto carne/ e il Frutto del ventre maturò). Si tratta del mito della fecondazione attraverso l’orecchio ("conceptio per aurem") usata dai padri della Chiesa per spiegare la verginità della Madonna e che richiama il mito pagano dove si credeva che la donnola, fosse fecondata attraverso l’orecchio. E questo molto probabilmente, come ha osservato uno dei più grandi esperti di mitologia, Karoly Kerenyi, suggerì ai padri della Chiesa che Maria fosse stata fecondata da dio attraverso le parole dell’angelo annunciatore.
Simone Martini, nella sua celebre "Annunciazione" conservata agli Uffizi, fa spiccare sul fondo oro della tavola, su cui si stagliano le figure dell’Angelo e della Madonna, le parole del versetto del Vangelo di Luca: Ave gratia plena, Dominus tecum, che si dipartono dalla bocca dell’angelo fino all’orecchio di Maria. E ancora, in un’altra celebre "Annunciazione" del 1486 di Carlo Crivelli (conservata alla National Gallery di Londra), c’è un raggio che dal cielo si dirige all’orecchio della Madonna.
Dalla Dea madre alla Madre di Cristo
La grande dea madre, che simboleggiava la nascita della natura tutta, con Maria, diviene la piena di grazia, l’ancella del Signore, la madre "puro spirito" di un figlio "puro spirito".
Tuttavia, nella società contadina dove la fertilità era considerata un valore primario, Maria sostituisce questi culti, prendendo il posto di Demetra, nel caso della madonna del frumento a Milano o quella del melograno di Pestum, al pari di tante altre Madonne sparse nel mondo dall’evangelizzazione cattolica.
A Capo Colonna, vicino Crotone, su una scogliera che domina il Golfo di Taranto, si ergeva un maestoso tempio dedicato ad Era Lacinia, protettrice dei matrimoni. Qui nel mese di maggio le donne di Crotone si recavano in processione per chiedere grazie alla dea. Oggi questa stessa processione si svolge, ma in onore di Maria Theotokos, la Madre di Dio.
Nell’"Apocalisse", Maria è la donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di stelle sul capo. E così è raffigurata nella stragrande maggioranza dell’iconografia che ha accompagnato fino ai nostri giorni il suo culto.
Una divinità lunare, dunque, come anche s. Bonaventura nei Proverbi la definiva: «che bella luna deve essere stata Maria quando quell’eterno Sole fu da lei pienamente ricevuto e in lei concepito (7.20)». Le divinità lunari, per la relazione della luna con le maree, erano associate al mare, ma anche alle stelle, come guida nella navigazione, impresa certamente non facile nell’antichità.
E Maria diviene la Stella maris, che guida nelle tempeste, e nel buio della notte del peccato (d’ogni fedel nocchier fidata guida, come la definì anche Petrarca), ma anche la protettrice dei marinai.
Originariamente, stella del mare (stella maris) era Afrodite, la prima a comparire sul far della sera, e la prima a scomparire alle prime luci dell’alba. Al Vespro era detta Espero, e all’alba Fosforo. Un canto mariano assai noto ne conserva la memoria nella metabolizzazione della stella Maria: De l’aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra. E fra gli astri che il cielo rinserra/ Non vi è stella più bella di te...
Attraverso Maria, la piena di grazia, quindi, i simboli cosmici della fertilità della terra e delle acque, legati alle dee madri continuano a veicolare.
A ricordo della vita cosmica, l’Immacolata Concezione conserva sul suo mantello il colore azzurro del cielo e del mare; il serpente sotto i suoi piedi. Il serpente cosmico, da simbolo di perenne vitalità e di conoscenza, è stato però trasformato dal cattolicesimo in emblema di peccato, e, primo su tutti, quel peccato originale di cui tutta l’umanità sarebbe macchiata, e sul quale si è costruita e incentrata l’ideologia del riscatto attraverso la grazia del cattolicesimo (cfr: Maria Mantello, Sessuofobia e caccia alle streghe nella storia della chiesa, in "Lettera Internazionale", n°69).
Ecco allora, che alla Vergine Maria si fa schiacciare il serpente, il peccato di unione sessuale. Ma nello schiacciare la vita concreta terrena, tuttavia, sono proprio quei simboli evocativi così carnali, che continuano a veicolare.
L’Immacolato concepimento della Madonna e di Cristo...
Il peccato originale, com’è noto, costituisce la base e il punto di partenza del Cristianesimo. Il sacrificio sulla croce del Dio-uomo, infatti, sarebbe inconcepibile sul piano dottrinario senza la presupposizione di un tale peccato, che quel sacrificio giustifica ai fini della salvezza escatologica di un’umanità “macchiata” e altrimenti condannata dal Dio padre alla dannazione eterna.
Poiché “il peccato” imbratta ogni nato bisogna che Cristo, il Dio-uomo, che proprio al riscatto da quella colpa originaria è stato preposto ne deve essere assolutamente immune.
Teologi ed ecclesiastici si preoccupano, allora, che sia concepito in un grembo immacolato.
Così in suo Decretale del 392 scriveva Papa Siricio: «Gesù non avrebbe deciso di nascere da una vergine, se non fosse stato certo della sua assoluta castità: che il suo grembo, in cui il corpo del Signore si sarebbe formato, dominio dell’Eterno Re, fosse stato insudiciato da seme maschile. Chi sostenesse questo non penserebbe in modo difforme dai perfidi ebrei».
Il concepimento ebraico narrato nella Bibbia da Isaia, dove «una giovane donna concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emmanuele» (7,14) è pertanto, trasformato dalla Chiesa in parto virginale.
Il mito pagano della partenogenesi lo si trova anche nel mondo classico e serviva a conferire una sorta di eccezionalità a personaggi illustri: si pensi a Platone (fonte: Diogene Laerzio) e ad Augusto (fonte: Svetonio) figli di Apollo, o ad Alessandro figlio del fulmine (fonte: Plutarco). Ma il cristianesimo, spogliatolo d’ogni significato metaforico, lo assume come fatto biologico reale.
La giovane donna fertile, l’alma della narrazione ebraica d’Isaia, diverrà allora Vergine: prima, durante e dopo il parto.
In tanta ossessione virginale, però, si trascura, ad esempio, che il vangelo di Marco, scritto attorno agli ultimi trenta anni del I secolo, parli esplicitamente di fratelli e sorelle di Gesù: «Non è costui il falegname, il figliuolo di Maria, e il fratello di Giacomo e di Giosè, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» ( Marco, 6.3).
Del resto il vangelo di Matteo, non escluderebbe rapporti matrimoniali tra Maria e Giuseppe, ma rinviarli semmai a dopo la nascita di Gesù: «ma egli (Giuseppe, ndr.) non ebbe con lei rapporti coniugali, finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose nome Gesù. » (Matteo, I. 25). Ma per la Chiesa romana, la madre del Cristo sarà la sempre vergine, secondo la definizione della Volgata di s. Gerolamo (morto nel 420 ca.), dove gli originari termini ebraici di fratelli e sorelle sono opportunamente sostituiti con quelli di cugini e cugine.
L’ossessione della castità e il fiat mariano
La difesa della castità nella terrena famiglia del Gesù cristiano è talmente importante per la dottrina cattolica che la stessa Vergine Maria si vuole concepita senza macchia e lo stesso Giuseppe, suo sposo, è fatto vergine, nonostante il protovangelo di Giacomo (del II secolo), seppure allo scopo di salvaguardare inviolato l’imene della Madonna, parli di fratellastri di Gesù (evidentemente, i figli avuti da Giuseppe da precedenti nozze).
Ma la madre del Redentore non è solo la Vergine, è anche l’Ancilla Domini.
Mentre in tutti gli altri casi il “miracolo” creazionistico, il “dono divino” della vita avviene, infatti, servendosi di un maschio, nel caso di Gesù esso è realizzato direttamente da dio.
Anzi, il dio-maschio evidenzia tutta la sua forza di dominio e d’onnipotenza proprio in virtù di questo concepimento virginale, dove la partecipazione all’evento della “prescelta Maria” è risolta nella comunicazione del fatto avvenuto e, per giunta, attraverso terzi: l’angelo. Alla donna-Maria, allora, non resta che far pronunciare il famoso fiat.
Un fiat ed una verginità che percorrono tutta la dottrina cattolica, e che ai giorni nostri in particolare papa Wojtyla ha riaffermato con forza con l’enciclica Redemptoris Mater.
Il dualismo Eva la strega - Maria la santa
Il mito dell’Incarnazione e della Madre Vergine, risponde ad un ben preciso criterio d’economicità asessuata: sostituire e contrapporre alla prima donna, Eva, una nuova prima donna, Maria.
Assai esplicite, già nel III secolo, le affermazioni in tal senso.
Ad esempio, s. Ireneo (morto intorno al 202) dichiara: «Come la razza umana fu condannata alla dannazione per colpa di una vergine (Eva, ndr.) [...] l’astuzia del serpente fu vinta dalla semplicità di una colomba». (Adversus Haereses, I, 5-19).
Ma è tutto il mito dell’incarnazione cristiana per il riscatto dell’umanità dal peccato originale a strutturarsi su una sorta d’incontaminata purezza: con la casta Maria, che si contrappone alla peccatrice Eva; col casto Cristo, il nuovo capostipite di un’umanità redenta, che già s. Paolo aveva sostituito ad Adamo per la fondazione della primigenia eternità cristologia (cfr: I Corinzi 15-22; II Corinzi 5-17; Romani 5-14).
Un uomo nuovo ed una donna nuova, dunque, servono per riscrivere il Genesi ed annunciare il Verus Israel. Solo così il cristianesimo può porsi come Verità superiore, Eterna, Rivelata, Unica ed Universale, quindi Cattolica, da kata olou (katà òlou) che significa “in tutto”, “su tutto”.
Come nasce il dogma della Madre di Dio immacolata
La questione dell’incarnazione divina di Cristo ha lacerato il mondo cristiano fin dai primi secoli. Tra il IV e V secolo, sulle controversie cristologiche si giocano non solo le lotte di potere dei vescovi, ma anche quelle per la superiorità del cristianesimo sull’ebraismo e sul mondo pagano. E’ in questo contesto che Maria prende il posto delle Grandi Dee della classicità e, seppure tra forti contrasti teologici, diventa la madre di Dio.
Nel V secolo il vescovo di Costantinopoli, Nestorio, faceva notare come Maria non potesse essere generatrice di Dio, ma solo madre dell’uomo: anqrwpotòkos (anthropotòkos). Affermare il contrario avrebbe significato, infatti, negare la preesistenza di Dio all’evento e, quindi, la Sua stessa eternità. Una questione non soltanto logica ma inerente alla sostanza dell’unico dio: «se dio avesse una madre - scriveva Nestorio al Vescovo di Roma Celestino I - la vera fede non ne risentirebbe? Maria non ha messo al mondo una divinità perché l’essere creato non può essere madre di colui che l’ha creato».
Come andò a finire è cosa nota: il Concilio di Efeso, nel 431, condannò come assurde ed eretiche le posizioni di Nestorio. L’artefice di tutta l’operazione era stato il patriarca di Alessandria, s.Cirillo. Questi si era distinto nella persecuzione contro gli ebrei: in Egitto si era impadronito di tutte le sinagoghe e aveva scacciato più di 100.000 ebrei da Alessandria, era stato il mandante dell’assassinio della filosofa Ipazia, violentata e fatta a pezzi dai suoi monaci analfabeti... E che adesso voleva affermare la sua supremazia tra le chiese d’Oriente e, pertanto, si affannava ad organizzare le sue orde di monaci fanatici, tutori della “pubblca morale” e processioni di fedeli osannanti alla Madonna, quella Vergine Maria che, proprio ad Efeso, la capitale del culto di Artemide, verrà proclamata madre di Dio: qeotòkos (theotòkos).
La questione della Verginità, però, non si chiudeva ad Efeso, giacché il V Concilio ecumenico di Costantinopoli del 553 si preoccupava ancora di onorare Maria col titolo di "sempre vergine" e il Concilio Lateranense del 649 ne sanciva infine il dogma. Qualche secolo dopo, di fronte alla rivoluzione della Riforma protestante, Paolo IV, nel 1555, anno in cui egli istituisce anche gli obbligatori ghetti per gli ebrei, riaffermava con forza la verginità di Maria (ante partum, in partu, post partum).
Del resto, di fronte a fermenti rivoluzionari che pongono in crisi il cattolicesimo e i suoi poteri, non ci sarà sempre una Madonna, magari piangente, posta a vestale di Controriforme e Restaurazioni?
La purezza della Vergine Maria come potente baluardo per la riaffermazione della dommatica cattolica!
Per le donne, un modello di castità cui conformarsi che la mitologia cattolica amplifica nella moltiplicazione di sante, quasi sempre vergini e, comunque, in lotta contro il “peccato della carne” al quale non cedono, a costo di torture e sofferenze tremende.
Pio XII e Santa Maria Goretti
Da quest’ampia schiera citiamo s. Maria Goretti anche perché riproposta ai nostri giorni da Wojtyla, nonché dalla televisione pubblica italiana che alla vicenda della giovinetta, forse in omaggio al Vaticano, ha dedicato una propria produzione filmica.
La poveretta, morta nel 1902 sotto i colpi del pugnale del seduttore a cui non aveva ceduto, veniva santificata nel 1950 da Pio XII con queste parole: “Dio è meraviglioso nei suoi santi...Egli ha dato alle giovani del nostro mondo crudele e degradato un modello e una protettrice, la piccola vergine Maria che ha santificato l’inizio del secolo col suo sangue innocente”.
Maria Goretti era continuamente portata ad esempio - come papa Pacelli voleva - e la visita alla sua casa era considerata una tappa importante per la formazione di una ragazza perbene.
Erano gli anni dell’avanzata delle sinistre e della partecipazione delle donne alla politica, “una deriva di degradazione” a cui la Chiesa cercava di contrapporre come deterrente il modello virginale mariano di cui la povera Maria Goretti rappresentava un fulgido esempio.
Pio IX l’Immacolata Concezione, Pio XII l’Assunzione in cielo della sempre Vergine
Del resto, circa un secolo prima, quando il processo risorgimentale italiano stava ponendo irreversibilmente in crisi la teocrazia pontificia, un altro papa oggi santo, Pio IX, non aveva utilizzato anch’egli ad efficace fortilizio il mito della purezza mariana, stabilendo nel 1854 il dogma dell’Immacolata Concezione della Madonna?
Pertanto, rientra perfettamente nella logica ecclesiale che Pio XII, nello stesso anno della santificazione di Maria Goretti, si sia preoccupato anche di definire il dogma dell’Assunzione della Madre di Cristo in cielo: “Era necessario che il corpo di colei, che anche nel parto aveva mantenuto la verginità, rimanesse incorrotto anche dopo la morte”. (Munifecentissimus Deus, definizione del dogma dell’Assunzione in anima e corpo alla gloria dei cieli di Maria, Vergine Madre di Dio)
Così la Madonna, che aveva avuto la patente del Concepimento Virginale, di essere rimasta sempre Vergine, di essere stata essa stessa generata senza contaminazione sessuale (Immacolata Concezione), proprio per la garanzia di castità sua e familiare, aveva assicurato anche il dogmatico lasciapassare d’incorruzione corporea per il cielo.
Maria Mantello
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - Com’è povero il diritto se non parla d’amore. Intervista a Stefano Rodotà (di Simonetta Fiori)20 novembre 2015, di Federico La Sala
Com’è povero il diritto se non parla d’amoreIntervista a Stefano Rodotà
di Simonetta Fiori (la Repubblica, 19 novembre 2015)
Nel codice la parola non compare mai, segno di una insofferenza forse reciproca, di una incompatibilità che in Italia è più forte che altrove. Al conflitto permanente tra diritto e amore dedica bellissime pagine Stefano Rodotà, un giurista da sempre attento al tumultuoso rapporto tra l’irregolarità e l’imprevedibilità della vita e l’astrazione formale della regola giuridica (Diritto d’amore, Laterza). Inutile aggiungere da che parte stia Rodotà. Ed è superfluo anticipare che in questa storia protagonisti non sono solo il diritto e i sentimenti ma anche la politica. Con alcune vittime - un tempo le donne, oggi gli omosessuali - che guidano il cambiamento.
Professor Rodotà, diritto e amore sono incompatibili?
«Ancora una volta mi aiuta Montaigne, che definisce la vita un movimento volubile e multiforme. Il diritto è esattamente il contrario, parla di regolarità e uniformità, è insofferente alle sorprese della vita. Quando poi si entra nel terreno amoroso, la soggettività prorompe. E il diritto è decisamente a disagio»
Perché?
«I rapporti affettivi possono essere qualcosa di esplosivo nell’organizzazione sociale. E dunque il diritto s’è proposto come strumento di disciplinamento delle relazioni sentimentali che non lascia spazio all’amore. Basta ripercorrere due secoli di storia: nella tradizione occidentale il diritto per un lungo periodo ha sancito l’irrilevanza dell’amore. E di fatto ha sacrificato le donne, codificando una diseguaglianza»
In che modo?
«Il rapporto di coppia è stato riconosciuto in funzione di qualcosa che non ha nulla a che vedere con i sentimenti: la stabilità sociale, la procreazione, la prosecuzione della specie. Sulle logiche affettive hanno prevalso quelle patrimoniali. E se San Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi predicava il possesso reciproco e paritario tra marito e moglie, da noi si è affermato il modello gerarchico maschilista che riduce il corpo delle donne a proprietà del marito»
Questo modello gerarchico è perdurato in Italia fino alla metà degli anni Settanta del Novecento. Un’anomalia italiana anche questa?
«No, sul piano storico non direi. Il modello famigliare della modernità occidentale - dalla fine del Settecento in avanti - è stato terribilmente gerarchico. Dopo l’unificazione noi assorbimmo il codice francese firmato da Napoleone, che sanciva la più cieca obbedienza della moglie al marito. Pare che Napoleone durante la campagna d’Egitto fosse rimasto colpito dal modo in cui il diritto islamico disciplinava il rapporto tra moglie e marito»
Da noi la storia successiva è stata condizionata dalla Chiesa cattolica. Ma anche la politica ha contribuito ad anestetizzare i sentimenti.
«Sì, il matrimonio ha mantenuto il suo impianto gerarchico anche grazie all’influenza della Chiesa. Quanto alla politica, per una fase non breve della storia, si è mossa in una logica di disciplinamento delle pulsioni, nell’incontro tra il rigorismo cattolico e quello socialcomunista»
Colpisce che anche i nostri padri costituenti - Calamandrei, Nitti, Orlando - si opponessero al principio dell’eguaglianza tra marito e moglie perché in conflitto con il codice civile.
«Incredibile. Nelle loro teste il modello matrimoniale consegnato alle regole giuridiche è un dato di realtà irriformabile. Non si rendevano conto che stavano cambiando le regole del gioco. E che la carta costituzionale stava sopra il codice civile»
Una rigidità che lei ritrova in una recente sentenza della Corte costituzionale, che dice no ai matrimoni gay in nome del codice civile.
«Sì, anche loro si piegano al codice che parla soltanto di matrimoni tra uomini e donne. Mi ha colpito il riferimento della Corte a una tradizione ultramillenaria del matrimonio: come se si trattasse di un dato naturale non soggetto ai mutamenti sociali e antropologici. Invece si tratta di una costruzione storica che è andata cambiando in Europa e in Italia. Ma l’Italia è l’unico paese che non vuole prenderne atto, nonostante abbia sottoscritto la carta dei diritti dell’Unione europea»
Una carta che nell’accesso al matrimonio cancella il riferimento alla diversità del sesso nella coppia.
«E infatti è stato proprio quell’articolo, l’articolo nove, bersaglio di una forte pressione da parte della Chiesa. Pressioni passate sotto silenzio, che però io sono in grado di testimoniare, visto che ero seduto al tavolo della convenzione. Aggiungo che il riferimento alla tradizione millenaria della famiglia, pronunciato dalla nostra Corte costituzionale, non compare in nessun’altra giurisprudenza»
Oggi facciamo fatica ad approvare perfino le unioni civili. Perché succede?
«Si tratta di un conflitto molto ideologizzato, favorito dallo sciagurato radicamento dei cosiddetti«valori non negoziabili" e«temi eticamente sensibili» Questi vengono sottratti al legislatore non perché il legislatore non se ne debba occupare ma perché il legislatore deve accettare il dato naturalistico e immodificabile»
Una barriera che non esisteva ai tempi delle battaglie sul divorzio e sull’aborto.
«E infatti non ci fu la stessa intolleranza. Pur nell’ostinata contrarietà, la Dc prendeva atto che erano intervenute novità sociali non più trascurabili»
Il disgelo era cominciato negli anni Sessanta, quando l’amore cessò di essere fuorilegge. Solo nel 1968 la Corte costituzionale cancellò il reato di adulterio per le donne. E nel 1975 arriva il nuovo diritto di famiglia, che mette fine al modello gerarchico.
«Sì, alle logiche proprietarie subentrano quelle affettive. E tuttavia anche in quella occasione il legislatore trattenne la sua mano di fronte alla parola amore. Si parla di fedeltà, collaborazione, ma non d’amore»
Ma si può mettere la parola amore in una legge?
«Qualcuno sostiene: più il diritto se ne tiene lontano, meno lo nomina, meglio è. Però bisogna domandarsi: il diritto non nomina l’amore perché lo rispetta fino in fondo o perché vuole subordinarlo ad altre esigenze come la stabilità sociale? Per un lungo periodo della storia italiana è stato così»
C’è il diritto d’amore delle coppie omosessuali, che devono poter accedere al matrimonio. Ma c’è anche il diritto d’amore dei figli, che devono poter essere amati da un padre e da una madre. Come si conciliano questi due diritti?
«Non c’è alcuna evidenza empirica che figli cresciuti in famiglie omosessuali mostrino ritardi sul piano del sviluppo della personalità e dell’affettività. E allora, domando, i figli dei genitori single?»
I genitori single - forse più di tutti gli altri - sanno che i figli hanno bisogno di un padre e di una madre, di una figura maschile e di una femminile. E anche la psichiatria formula dubbi sulle adozioni delle coppie gay.
«Lei pone una questione che però non si risolve con l’uso autoritario del diritto. Prima riconosciamo pari dignità a tutte le relazioni affettive e prima saremo in grado di costruire dei modelli culturali adatti a questa nuova situazione. Finché manteniamo il conflitto e l’esclusione, tutto questo diventa più difficile»
Lei dice: il matrimonio egualitario porta con sé la legittimità delle adozioni.
«Certo. Se una volta raggiunto questo risultato si vuole discutere, si potrà farlo senza ipoteche ideologiche. È una storia che non finisce. Come non si finisce mai di rispondere alla sollecitazione di Auden: la verità, vi prego, sull’amore»
-
> Amore e responsabilità --- Che cosa vuol dire essere casti oggi. È l’arte di non trattare mai l’altro come un oggetto, altrimenti lo si “consuma” (di Enzo Bianchi)1 luglio 2015, di Federico La Sala
Che cosa vuol dire essere casti oggi
È l’arte di non trattare mai l’altro come un oggetto, altrimenti lo si “consuma”
L’amore tra due persone è un lungo cammino e deve vincere ogni giorno
di Enzo Bianchi (la Repubblica, 01.07.2015) *
«A VOI giovani dico: siate casti ... fate lo sforzo di vivere l’amore castamente!». Queste parole di papa Francesco ai giovani pronunciate domenica scorsa hanno suscitato reazioni di ogni tipo ma tutte rivelative del dato che “castità” è una parola sovente incompresa, anzi misconosciuta e derisa, soprattutto perché è confusa con l’astinenza o la continenza sessuale o con il celibato. L’etimologia ci suggerisce che è casto (castus) colui che rifiuta l’incesto (in-castus). L’incesto avviene ogni volta che non si vive la distanza e non si rispetta l’alterità, che non è solo differenza. Non è casto chi cerca la fusione, l’attaccamento, il possesso: segno di tale ricerca è l’aggressività che, in questi casi, facilmente si accende e si manifesta.
Sono sempre più convinto che la sessualità sta nello spazio del dono, perché richiede di dare e di ricevere e si colloca sempre nella relazione tra due soggetti. La sessualità non si riduce alla genitalità e la capacità di dono e di accoglienza è più ampia di quella esercitata nella genitalità: investe, infatti, l’intera persona e le sue relazioni. Per questo la sessualità è cosa buona e bella, ma il suo uso può essere intelligente o stupido, amante o violento, legato all’amore o alla pulsione. La sessualità ci spinge alla relazione con l’altro, ma dipende da noi cercare, in questa relazione, l’incontro o il possesso, la sinfonia o la prepotenza, lo scambio o il narcisismo.
Potremmo dire che la castità è l’arte di non trattare mai l’altro come un oggetto, perché in questo caso lo si “consuma” e lo si distrugge. Arte difficile e faticosa, che richiede tempo: non si nasce casti ma al contrario - va detto con chiarezza - si nasce incestuosi, e l’esercizio di separazione e di distinzione ci conduce verso una soggettività vera e autonoma. La castità conferisce alle relazioni umane una trasparenza che permette alle persone di riconoscersi nel rispetto del loro essere più intimo.
Si pensi all’incontro sessuale dei corpi nella loro nudità e all’intimità che ne deriva. Quando i corpi nella nudità si incontrano e si intrecciano, si accende una conoscenza reciproca che non è comparabile a quella che possono avere l’uno dell’altro anche gli amici più intimi. Condividere il corpo e il respiro crea un’unione che è “conoscenza unica”, è - oserei dire, citando Giovanni Paolo II - “liturgia dei corpi”, è conoscenza penetrativa, di una profondità unica. Quando si tocca un corpo, non si tocca qualcosa, ma una persona, che non è un oggetto di piacere, che non può essere consumata, ma che è possibilità di comunione autentica. Senza questa comunione non è possibile la castità, ma solo l’obbedienza alla pulsione, all’estro, al possesso. Scriveva Rainer Maria Rilke: «Non c’è nulla di più arduo che amarsi: è un lavoro, un lavoro a giornata... L’amore è difficile e non è alla portata di tutti».
L’atto sessuale, compiuto nei tempi e nei modi che gli amanti sanno discernere come belli, buoni e “giusti”, è conoscenza, e non si deve avere paura di affermare che proprio il piacere sommo dell’atto sessuale incendia tale conoscenza. Ma non è facile distinguere questo piacere sommo dell’incontro dei corpi, dei cuori, delle intelligenze, dalla pulsione. Sì, la pulsione da sola, con la sua prepotenza, può creare l’inferno, eppure essa ci abita, e, se non ci fosse, non saremmo naturalmente capaci di darci e di accoglierci.
La pulsione da sola può addirittura portare a un’unione dei corpi che conosce solo l’attimo fuggente e a un’eccitazione dei sensi che conosce la senescenza precoce dei sensi stessi. Non è anche per questo che sovente le storie d’amore, anche sigillate pubblicamente, conoscono la fine e dunque il fallimento dell’amore? L’amore tra due persone è un lungo cammino che solo una forza più grande di loro - che il credente riconosce come la misericordia di Dio - può far leggere come cammino possibile senza interruzioni: da parte degli amanti c’è sempre un venir meno, un non essere adeguati all’altro, un’incapacità a essere sinfonici. L’amore deve vincere sempre, ogni giorno, su tutte le forze che gli sono contrarie perché obbediscono solo alla pulsione, la quale non vuole il bene dell’altro, anche se ci fa dire che all’altro si vuole bene.
Quando, di fronte all’altro soggetto, non si sa stare con rispetto, come davanti a un mistero, a una trascendenza; quando non si è capaci di inchinarsi di fronte all’altro e di farlo per amore; quando non si percepisce il segreto dell’altro, che sfugge alla nostra presa, allora non si è capaci di castità. Ecco la difficoltà della castità, quasi impossibile, invivibile si potrebbe dire; anche Gesù, del resto, ha messo in guardia i suoi discepoli: «Chiunque guarda una donna per bramarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore» (Mt 5,28). Guardare una donna per bramarla è vederla non in quanto donna, ma come oggetto, dunque non percepire in lei “la persona altra”; significa passare accanto a una possibile relazione autentica, per percorrere altre vie che non portano alla comunione.
Ma proprio mettendoci di fronte a questa esigenza, comprendiamo le nostre fragilità, le nostre incapacità, e misuriamo la dominante animale che è in noi e che non sempre siamo capaci di sottomettere e di ordinare. Proprio per questo - io credo - Gesù ha annunciato il mistero della sessualità e l’ha legato in modo escatologico al regno di Dio veniente. La castità è un lungo tragitto, e si sarà casti veramente solo se si accetterà di morire, se si sarà capaci di fare della morte un atto, un atto di scioglimento di legami.
Troppo spesso si assimila il celibato alla castità, dimenticando che il celibato è una situazione che si vive, mentre la castità è a un altro livello: non è una situazione, ma una dinamica che non raggiunge mai pienamente il suo obiettivo. Noi umani siamo così deboli, conosciamo così poco le nostre profondità, non abbiamo presa sul nostro intimo più nascosto e siamo abitati da pulsioni e desideri non sempre distinguibili.
Proprio per questo, oso dire che chi fa professione di celibato può promettere davanti a Dio ed esprimere con i voti questa situazione, mentre la castità non dovrebbe essere una promessa, perché a essa il soggetto può tendere, ma mai viverla senza incrinature né contraddizioni. Il celibato cristiano richiede di cercare la castità ma non si identifica con essa. Del celibato si può forse dire che è “grandezza”, ma si deve dire che è anche “miseria”, quella miseria che ognuno conosce nelle sue contraddizioni alla castità. Ecco perché credo sia bene che papa Francesco abbia ricordato ai giovani le esigenze della castità, tensione interiore preziosa in ogni scelta di vita legata all’amore e impossibile da raggiungere senza un cammino di umanizzazione.
* L’autore è priore della comunità monastica di Bose
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) ---- Responsabilità. Oggi nessuno vuole più rispondere di nulla ma chi scarica sugli altri ogni fardello nei fatti si dichiara sostituibile e superfluo (di Donatella Di Cesare)6 aprile 2015, di Federico La Sala
Responsabilità
Oggi nessuno vuole più rispondere di nulla ma chi scarica sugli altri ogni fardello nei fatti si dichiara sostituibile e superfluo
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, La Lettura, 05.04.2015)
«Non ne rispondo io - mi spiace». «Che si assuma la responsabilità chi di dovere!». «Sarà il caso di passare la palla ad altri». Quante volte al giorno capita di ascoltare frasi del genere? O persino di pronunciarle? Sfuggire alla responsabilità è una prassi diffusa nella vita privata come nella sfera pubblica. Dai piccoli gesti della quotidianità ai rapporti affettivi, dai legami sociali all’agire politico: non c’è ambito che non sia pervaso da una rinuncia sistematica alle risposte che ciascuno è chiamato a dare. E la rinuncia finisce per volgersi in vera abdicazione là dove le responsabilità aumentano.
Gli esempi sono molteplici: l’insegnante acquiescente che chiude gli occhi sulla prepotente bullaggine dell’allievo; il giornalista che sceglie sbrigativamente la parola più comoda o passa sotto silenzio quel che dovrebbe dire a gran voce; il magistrato che strizza l’occhio agli imputati, proscioglie quando dovrebbe condannare, allunga i tempi del processo fino alla prescrizione; il medico che tratta il paziente come un corpo malato, tra disattenzione e volontà di lucro; il politico che, mentre dovrebbe sollevare lo sguardo verso il bene comune, è chino sul proprio tornaconto.
La rinuncia ad assumere le proprie responsabilità erode ogni relazione, corrode la comunità. La corruzione nasce da qui. È un fenomeno etico, prima ancora che politico. Questo non vuol dire né diluirne la portata né ampliarne pericolosamente i confini. Ma non sarà mai possibile vederne con chiarezza gli effetti devastanti, se non si risale a quel luogo in cui la corruzione affiora. Ed è là dove il legame con l’altro si deteriora, dove chi dovrebbe rispondere preferisce sottrarsi. L’io si deresponsabilizza. Chiamato in causa, non si assume l’onere della decisione, e aggira l’impegno, evade l’obbligo che lo lega agli altri.
Così apre una falla, una incrinatura. E mentre una crepa si aggiunge alla precedente, la comunità, inevitabilmente, si sgretola. La corruzione non sta solo nelle mazzette - simbolo del disfacimento che prevale, dell’integrità che viene meno. Una comunità corrotta è quella i cui membri non rispondono di sé e non rispondono agli altri.
La leggerezza inebriante di cui si compiace l’io deresponsabilizzato è a ben guardare una trappola. Chi ha eluso il fardello della responsabilità, crede di averla fatta franca. Si prepara a schivare così tutti i fardelli a cui andrà incontro. L’onore senza l’onere diventa il suo stile di vita. Ma ogni volta che l’io abdica, che lascia agli altri la responsabilità a cui era stato chiamato, crede, e fa credere, di essere sostituibile. «Perché mai dovrei risponderne proprio io? Che se la veda qualcun altro!». Può darsi che il «qualcun altro» che viene dopo si comporti in modo analogo - in un continuo rinvio, un incessante riversarsi a vicenda pesi e obblighi.
Eppure nessuno è sostituibile. La responsabilità che incombe su di me, in questo momento, non può essere ceduta. Se la cedo, non solo apro una falla, ma accetto l’idea che qualcuno potrebbe rimpiazzarmi. Mentre nessuno, mai, può farlo. L’io deresponsabilizzato ammette invece di essere sostituibile, avvalora la sconcertante ipotesi della propria superfluità. Si crede in genere che la responsabilità sia un gesto ulteriore di un soggetto autonomo e sovrano.
Nella sua superba priorità questo soggetto, privo di vincoli, detterebbe legge a se stesso. Ma che cosa sarebbe l’io senza l’altro che sempre lo precede? Il mondo non è cominciato con me. Prima di me c’è sempre l’altro che mi convoca, mi interroga, e a cui sono chiamato a rispondere. Non per un atto di adesione volontaria - valutando se dire sì o no. Ma semplicemente volgendomi verso chi mi chiama. Prima ancora di ogni possibilità di scelta, perché è nella torsione verso l’altro che l’io si costituisce. Rispondo, dunque sono.
Senza la responsabilità, l’io non esisterebbe neppure. La mia esistenza si coagula ogni volta nell’obbligo che mi vincola all’altro. Se eludo l’obbligo, gli effetti ricadono sul mio stesso esistere. La leggerezza inebriante si rivela inconsistenza angosciosa. E quel detestabile io, che pretendeva di essere soggetto assoluto, rischia di restare tragicamente intrappolato nella sua errata idea di libertà astratta, senza più via d’uscita.
I filosofi non hanno mai parlato tanto di «responsabilità» come in questi ultimi decenni. Con Emmanuel Lévinas e con Hans Jonas la responsabilità è diventata, anzi, uno dei temi più discussi nel dibattito contemporaneo. Il che non sorprende. Perché viviamo nell’epoca di una crescente deresponsabilizzazione.
La complessità del mondo globale, la rilevanza assunta dalla scienza che, malgrado i progressi compiuti, appare sempre più incapace di offrire un orientamento e dar conto delle sue stesse scelte, la specializzazione estrema e il connesso ruolo dell’«esperto», al quale viene spesso lasciata la parola ultima, la frantumazione della responsabilità, che impedisce di scorgere le ripercussioni dei propri gesti: tutto ciò ha contribuito a privare i più della possibilità di decidere e di agire. È la razionalizzazione tecnica della vita a influire, però, in modo determinante.
Dove trionfa la tecnica viene meno la responsabilità. Non solo perché l’essere umano è diventato «antiquato» rispetto ai suoi stessi prodotti, costretto - come ha sostenuto Günther Anders - a rincorrerli disperatamente, nel tentativo vano di sincronizzarsi alla loro disumana rapidità. Ma anche perché l’ingranaggio della tecnica stravolge il rapporto tra mezzi e fini, nel senso che potenzia i mezzi e fa perdere di vista i fini, sia quelli individuali, sia quelli comuni, che rendono coesa una comunità. Si è in grado di fare molte più cose, ma non si sa bene a che scopo.
Così, mentre si moltiplicano le etiche applicate, dalla bioetica all’«etica degli affari», volte non di rado a rassicurare l’opinione pubblica sulla moralità di un settore, ad esempio quello delle imprese, mentre dunque l’etica può diventare a sua volta fonte di profitto, la «responsabilità» resta la terra incognita di questa tarda modernità, la stessa che abita un pianeta devastato, dove nulla sembra ci sia ancora da scoprire.
La responsabilità è infatti rispetto sia per gli altri, sia per quell’altro che sono le cose del mondo. Da quando gli esseri umani sono diventati più pericolosi per la natura, di quanto la natura fosse per loro, si rende necessaria un’etica che risponda all’esigenza di lasciare alle generazioni future un pianeta ancora vivibile.
Sono responsabile non solo verso l’altro che sempre mi precede, ma anche verso l’altro che viene dopo di me. E guardando al suo futuro non dovrei allora mai mancare di chiedermi se anche il più piccolo dei miei gesti non avrà ricadute su di lui. Proprio quello che non mi riguarda richiede la mia attenzione. Solo io sono responsabile - sta qui la suprema dignità umana.
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) ---- Caro Papa Francesco. LE “DONNE DEI PRETI” SCRIVONO AL PAPA.21 maggio 2014, di Federico La Sala
LE “DONNE DEI PRETI” SCRIVONO AL PAPA *
Caro Papa Francesco
siamo un gruppo di donne da tutte le parti d’Italia (e non solo) che ti scrive per rompere il muro di silenzio e indifferenza con cui ci scontriamo ogni giorno. Ognuna di noi sta vivendo, ha vissuto o vorrebbe vivere una relazione d’amore con un sacerdote, di cui è innamorata. Abbiamo deciso di unire le nostre voci dopo esserci rese conto che pur nella nostra diversità, i nostri vissuti non rappresentano casi isolati, ma che tantissime donne vivono nel silenzio, e per questo, pur essendo noi un piccolo campione, ci sentiamo di parlare a nome di tutte le donne coinvolte sentimentalmente con un sacerdote o religioso.
Come tu ben sai, sono state usate tantissime parole da chi si pone a favore del celibato opzionale, ma forse ben poco si conosce della devastante sofferenza a cui è soggetta una donna che vive con un prete la forte esperienza dell’innamoramento.
Vogliamo, con umiltà, porre ai tuoi piedi la nostra sofferenza affinchè qualcosa possa cambiare non solo per noi, ma per il bene di tutta la Chiesa.
Si, l’amore è proprio un’esperienza forte e rigenerante, che ti rimodula dentro, che ti fa crescere con l’altro, finchè ti ritrovi a desiderare con lui quel meraviglioso sogno di una vita insieme. Cosa che con un prete non è possibile, secondo le leggi attuali della chiesa cattolica romana.
Noi amiamo questi uomini, loro amano noi, e il più delle volte non si riesce pur con tutta la volontà possibile, a recidere un legame così solido e bello, che porta con se purtroppo tutto il dolore del "non pienamente vissuto". Una continua altalena di "tira e molla" che dilaniano l’anima.
Quando, straziati da tanto dolore, si decide per un allontanamento definitivo, le conseguenze non sono meno devastanti e spesso resta una cicatrice a vita per entrambi. Le alternative sono l’abbandono del sacerdozio o la persistenza a vita di una relazione segreta.
Nel primo caso la forte situazione con cui la coppia deve scontrarsi viene vissuta con grandissima sofferenza da parte di entrambi: anche noi donne desideriamo che la vocazione sacerdotale dei nostri compagni possa essere vissuta pienamente, che possano restare al servizio della comunità, a svolgere la missione che per tanti anni hanno svolto con passione e dedizione, rinvigoriti adesso ancor di più dalla forza vitale dell’amore che hanno scoperto insieme a noi, che vogliamo sostenerli e affiancarli nel loro mandato. Chi si sente chiamato al sacerdozio sceglie di vivere nel mondo, di partecipare alla vita sociale e di rendersi utile agli altri nella comunità in cui è inserito. La dolcezza e solarità di una donna può davvero essere sale e luce nel ministero di un sacerdote, per camminare insieme verso la Sua Luce e per maturare i frutti (che in due si moltiplicano esponenzialmente) da donare alla gente.
Nel secondo caso, ovvero nel mantenimento di una relazione segreta, si prospetta una vita nel continuo nascondimento, con la frustrazione di un amore non completo che non può sperare in un figlio, che non può esistere alla luce del sole. Può sembrare una situazione ipocrita, restare celibi avendo una donna accanto nel silenzio, ma purtroppo non di rado ci si vede costretti a questa dolorosa scelta per l’impossibilità di recidere un amore così forte che si è radicato comunque nel Signore.
L’amore è davvero la forza più potente che esista!
E allora ci chiediamo e ti chiediamo se è davvero giusto sacrificare l’Amore in virtù di un bene più alto e grande che è quello del servizio totale a Gesù e alla comunità, cosa che a nostro avviso sarebbe svolto con maggiore slancio da un sacerdote che non ha dovuto rinunciare alla sua vocazione all’amore coniugale,unitamente a quella sacerdotale, e che sarebbe anche supportato dalla moglie e dai figli. Probabilmente ne gioverebbe l’intera comunità, si respirerebbe aria di famiglia, di libertà e accoglienza. Questa nostra società ne ha bisogno!
Siamo tutti alla ricerca della propria identità, che possiamo solo trovare nel volto di Cristo; ma la chiesa ne riflette il suo volto? Noi speriamo che tu, con questa ventata di speranza che hai portato, possa davvero riuscire a ridare alla chiesa la sua dignità, liberandola dalla pretesa della Verità Assoluta, e affidandola semplicemente alla volontà di Dio.
Siamo fiduciose che il nostro grido, rimasto per troppo tempo inespresso, venga da te accolto e compreso, per discernere quale sia la giusta strada per una Chiesa migliore.
Se tu lo riterrai adeguato, siamo pronte e anzi ti chiediamo di essere da te convocate in un’udienza privata, per portare davanti a te umilmente le nostre storie e le nostre esperienze, sperando di poter attivamente aiutare la Chiesa, che tanto amiamo, verso una possibile strada da intraprendere con prudenza e giudizio.
Grazie Papa Francesco! Speriamo con tutto il cuore che tu benedica questi nostri Amori, donandoci la gioia più grande che un padre vuole per i suoi figli: VEDERCI FELICI!!!
Ti auguriamo ogni Bene.
*
FONTE. Adistanews: http://www.adistaonline.it/
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) ---- «La paternità responsabile? Francesco come Wojtyla e il Vaticano II». Il canonista Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, analizza le «radici» dell’intervento del Papa.22 gennaio 2015, di Federico La Sala
- PER UNA NUOVA TEOLOGIA-POLITICA E PER UNA NUOVA CHIESA. L’INDICAZIONE DI GIOVANNI XXIII E DI GIOVANNI PAOLO II: LA RESTITUZIONE DELL’ANELLO DEL PESCATORE A GIUSEPPE.
«La paternità responsabile? Francesco come Wojtyla e il Vaticano II»
Il canonista Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, analizza per Vatican Insider le «radici» dell’intervento del Papa al ritorno da Manila. «Bergoglio sa unire dottrina e realismo»
di GIACOMO GALEAZZI (La Stampa, 21.01.2015)
CITTA’ DEL VATICANO. E’ rimasto sorpreso dalle parole del Pontefice sulla necessità di una «paternità responsabile» e sul fatto che per essere buoni cattolici non «dobbiamo essere come conigli»?
«No. E’ un concetto in linea con l’insegnamento dei suoi predecessori. Il Concilio Vaticano II, attraverso la costituzione pastorale “Gaudium et spes” sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, afferma che, in virtù del diritto inalienabile dell’uomo al matrimonio e alla generazione della prole, la decisione circa il numero dei figli da mettere al mondo dipende dal retto giudizio dei genitori. Questo giudizio dei genitori suppone una coscienza ben formata, perciò, è fondamentale dare a tutti il modo di educarsi a una retta responsabilità quale veramente conviene a uomini, nel rispetto della legge divina e tenendo conto delle circostanze reali e di tempo. Nell’enciclica “Humanae Vitae” Paolo VI evidenzia che in rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali la paternità responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione, presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita».
In cosa si è ispirato a San Giovanni Paolo II?
«Karol Wojtyla ha più volte espresso lo stesso concetto di Francesco. In tante occasioni, per esempio nell’Angelus del 17 luglio 1994, l’Anno della Famiglia. “Il pensiero cattolico è sovente equivocato- sottolineò Giovanni Paolo II- come se la Chiesa sostenesse un’ideologia della fecondità ad oltranza, spingendo i coniugi a procreare senza alcun discernimento e alcuna progettualità. Ma basta un’attenta lettura dei pronunciamenti del Magistero per constatare che non è così”. In realtà, puntualizza San Giovanni Paolo II, nella generazione della vita, gli sposi realizzano una delle dimensioni più alte della loro vocazione: sono collaboratori di Dio».
Quali sono le conseguenze?
«Proprio per questo ruolo di collaboratori di Dio, secondo Giovanni Paolo II, i genitori sono tenuti ad un atteggiamento estremamente responsabile. Nel prendere la decisione di generare o di non generare essi devono lasciarsi ispirare non dall’egoismo né dalla leggerezza, ma da una generosità prudente e consapevole, che valuta le possibilità e le circostanze, e soprattutto che sa porre al centro il bene stesso del nascituro. Quando dunque si ha motivo per non procreare, questa scelta è lecita, e potrebbe persino essere doverosa. Insegnamenti già presenti in Pio XI e Pio XII riguardo alla paternità e maternità responsabili».
Francesco è nel segno della tradizione, quindi?
«Certo. Unisce realismo e dottrina. Al Parlamento europeo durante la sessione plenaria a Strasburgo, ha chiarito che la famiglia, unita, fertile e indissolubile, porta con sé gli elementi fondamentali per dare speranza al futuro. Senza tale solidità si finisce per costruire sulla sabbia, con gravi conseguenze sociali. Per Francesco ribadire l’importanza della famiglia non solo aiuta a dare prospettive e speranza alle nuove generazioni, ma anche ai numerosi anziani, spesso costretti a vivere in condizioni di solitudine e di abbandono perché non c’è più il calore di un focolare domestico in grado di accompagnarli e di sostenerli. Chi mostra di sorprendersi per le parole di Francesco si metta l’anima in pace: avrà molto altro di cui meravigliarsi. Francesco sta riportando la Chiesa alla fonte evangelica e la gente lo apprezza proprio per la sincerità e la capacità di esprimersi senza ipocrisia».
-
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! ---Sulla lettera di 26 donne indirizzata a Papa Francesco (di Vito Mancuso - Abolire il celibato per il bene della chiesa)20 maggio 2014, di Federico La Sala
Il matrimonio è un diritto anche per i preti
Abolire il celibato per il bene della chiesa
di Vito Mancuso (la Repubblica, 19.05.2014)
CHISSÀ come risponderà il Papa alla lettera indirizzatagli da 26 donne che (così si sono presentate) «stanno vivendo, hanno vissuto o vorrebbero vivere una relazione d’amore con un sacerdote di cui sono innamorate». Ignorarla non è da lui, telefonare a ogni singola firmataria è troppo macchinoso, penso non abbia altra strada che stendere a sua volta uno scritto. Avremo così la prima epistula de coelibato presbyterorum indirizzata da un Papa a figure che fino a poco fa nella Chiesa venivano chiamate, senza molti eufemismi, concubine.
Dai frammenti della lettera riportati sulla stampa risulta che le autrici hanno voluto presentare la «devastante sofferenza a cui è soggetta una donna che vive con un prete la forte esperienza dell’innamoramento ». Il loro obiettivo, scrivono al Papa, è stato «porre con umiltà ai tuoi piedi la nostra sofferenza affinché qualcosa possa cambiare non solo per noi, ma per il bene di tutta la Chiesa». Ecco la posta in gioco, il bene della Chiesa. L’attuale legge ecclesiastica che lega obbligatoriamente il sacerdozio al celibato favorisce il bene della Chiesa? Guardando ai due millenni del cattolicesimo, ritroviamo che nel primo il celibato dei preti non era obbligatorio («fino al 1100 c’era chi lo sceglieva e chi no», così scriveva il cardinale Bergoglio).
MENTRE lo divenne nel secondo in base a due motivi: 1) la progressiva valutazione negativa della sessualità, il cui esercizio era ritenuto indegno per i ministri del sacro; 2) la possibilità per le gerarchie di controllare meglio uomini privi di famiglia e di conseguenti complicate questioni ereditarie. Così il prete cattolico del secondo millennio divenne sempre più simile al monaco.
Si tratta però di due identità del tutto diverse. Un conto è il monaco il cui voto di castità è costitutivo del codice genetico perché vuole vivere solo a solo con Dio (come dice già il termine monaco, dal greco mònos, solo, solitario); un conto è il ministro della Chiesa che determina la sua vita nel servizio alla comunità. Il prete (diminutivo di presbitero, cioè “più anziano”) esiste in funzione della comunità, di cui è chiamato a essere “il più anziano”, cioè colui che la guida in quanto dotato di maggiore saggezza ed esperienza di vita. Ora la questione è: la celibatizzazione forzata favorisce tale saggezza e tale esperienza?
Quando i preti celibi parlano della famiglia, del sesso, dei figli e di tutti gli altri problemi della vita affettiva, di quale esperienza dispongono? Rispondo in base alla mia esperienza: alcuni sacerdoti dispongono di moltissima esperienza, perché il celibato consente loro la conoscenza di molte famiglie, altri di pochissima o nulla, perché il celibato li fa chiudere alle relazioni in una vita solitaria e fredda. Ne viene che il celibato ha valore positivo per alcuni, negativo per altri, e quindi deve essere lasciato, come nel primo millennio, alla libera scelta della coscienza.
Vi è poi da sottolineare che la qualità della vita spirituale non per tutti dipende dall’astinenza sessuale e meno che mai dall’essere privo di famiglia, basti pensare che quasi tutti gli apostoli erano sposati e che il Nuovo Testamento prevede esplicitamente il matrimonio dei presbiteri (cf. Tito 1,6).
Se poi guardiamo alla nostra epoca, vediamo che veri e propri giganti della fede come Pavel Florenskij, Sergej Bulgakov, Karl Barth, Paul Tillich erano sposati. Se i nazisti non l’avessero impiccato, anche Dietrich Bonhoeffer si sarebbe sposato, ed Etty Hillesum, una delle più radiose figure della mistica femminile contemporanea, ebbe una vita sessuale molto intensa. Anche Raimon Panikkar, sacerdote cattolico, tra i più grandi teologi del ‘900, si sposò civilmente senza che mai la Chiesa gli abbia tolto la funzione sacerdotale.
“Non è bene che l’uomo sia solo”, dichiara Genesi 2,18. Gesù però parla di “eunuchi che si sono resi tali per il regno dei cieli” ( Matteo 19,12). La bimillenaria esperienza della Chiesa cattolica si è svolta tra queste due affermazioni bibliche, privilegiando per i preti ora l’una ora l’altra. Penso però che nessuno possa sostenere che il primo millennio cristiano privo di celibato obbligatorio sia stato inferiore rispetto al secondo.
Oggi, a terzo millennio iniziato, penso sia giunto il momento di integrare le esperienze dei due millenni precedenti e di far sì che quei preti che vivono storie d’amore clandestine (che sono molto più di 26) possano avere la possibilità di uscire alla luce del sole continuando a servire le comunità ecclesiali a cui hanno legato la vita. La loro “anzianità” non ne potrà che trarre beneficio. Vi sono poi le molte migliaia di preti che hanno lasciato il ministero per amore di una donna (ma che rimangono preti per tutta la vita, perché il sacramento è indelebile) e che potrebbero tornare a dedicare la vita alla missione presbiterale, segnati da tanta, sofferta, anzianità.
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! ---- Gesù sposato e la chiesa nuda. Una gerarchia senza Grazie e e un papa che scambia la Grazia con Mammona.27 settembre 2012
 DIO E’ AMORE ("CHARITAS"), MA NON PER IL CATTOLICESIMO-ROMANO! Una gerarchia senza Grazie ( greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006).
DIO E’ AMORE ("CHARITAS"), MA NON PER IL CATTOLICESIMO-ROMANO! Una gerarchia senza Grazie ( greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006).
 GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA.
GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA.
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! ---- «Religioni e sessualità». Tesi non convincenti di teologi su “Confronti” (di David Gabrielli)28 settembre 2013, di Federico La Sala
Tesi non convincenti di teologi su “confronti”
di David Gabrielli
in “confronti” - il mensile di fede politica e vita quotidiana - n. 10 dell’ottobre 2013
H o letto con particolare interesse il numero monografico di settembre di Confronti , curato dal sempre solerte Brunetto Salvarani e dedicato quest’anno al tema «Religioni e sessualità». Ho trovato assai stimolanti molti dei contributi che l’arricchiscono. Qui, a quattro di essi (dedicati, si potrebbe dire, a «Cattolicesimo e sessualità»), vorrei esprimere una mia opinione, assai critica, su alcune tesi. Concordo pienamente con Giancarla Codrignani, quando tra l’altro afferma: «Il nuovo catechismo [della Chiesa cattolica, varato da Giovanni Paolo II nel 1992] unifica - parr. 2351-57 - adulterio, masturbazione, omosessualità, prostituzione e stupro, mostrando totale ignoranza di ciò di cui intende fare dottrina». Mi ritrovo, poi, abbastanza, nelle riflessioni di Luca Zottoli su «Il Concilio Vaticano II e la sessualità»; mi pare invece indifendibile quanto lo stesso autore, docente di teologia morale a Modena, afferma ne «Il dibattito sulla Humanae vitae fra dottrina e vita quotidiana», cioè sull’enciclica con cui Paolo VI, nel 1968, dichiarava immorale la contraccezione.
Da una parte lo studioso difende quel testo come un atto del magistero che i fedeli debbono accogliere; dall’altra tiene però conto delle difficoltà di molti coniugi a seguire quelle indicazioni e dunque, nel contempo, suggerisce ai confessori di valutarli con misericordia, secondo la «legge della gradualità», e sperando che essi arriveranno infine a fare proprie le normative papali.
L’ Humanae vitae - è bene ricordare - fu accolta con disagio da molti episcopati, con malessere da gran parte del mondo teologico, con aperto dissenso da diversi teologi/e e da moltissimi fedeli: come mai? Il quesito, riproposto anche oggi, all’osso si può riassumere così: chi rifiuta l’enciclica lo fa perché indisposto ad assumersi il peso che comporta seguire il Vangelo o non, invece, perché ha fondati motivi di ritenere quella normativa estranea al messaggio di Gesù e legata piuttosto ad una radicata sessuofobia e ad una mentalità - rispettabile ma in nessun modo obbligante - che quasi eleva a divinità la «legge naturale» come intesa dal magistero ecclesiastico? Condivido il secondo corno del dilemma, e perciò tutte le argomentazioni di Zottoli mi sembrano un castello di carta ideologico per salvare comunque il principio dell’autorità papale; non lo sfiora l’idea che la normativa espressa da Paolo VI sia un abuso di potere. Eppure fior di teologi e teologhe hanno dimostrato, con una logica ardua da contrastare, l’impossibilità di fondare biblicamente e antropologicamente i no dell’enciclica, pur sempre ripetuti con instancabile zelo anche da papa Wojtyla. Insomma, dal labirinto di quel testo non si esce, pensano in molti, se non rifiutandone le tesi di fondo.
D’altronde, senza dover citare teologi... pericolosi, trovo davvero strano che su Confronti non si siano ricordate le parole del cardinale Carlo Maria Martini nel 2011: dall’ Humanae vitae «è derivato un grave danno» giacché, a causa del divieto della contraccezione, «molte persone si sono allontanate dalla Chiesa e la Chiesa dalle persone». E, evidenziata la decisione «personale» di Paolo VI, il porporato aggiungeva: «In passato la Chiesa si è forse pronunciata anche troppo intorno al sesto comandamento. Talvolta sarebbe stato meglio tacere».
Analoga critica vorrei fare alle tesi di Giacomo Coccolini ne «La teologia del corpo in Giovanni Paolo II». Egli - a ragione - sottolinea la novità e, direi, l’arditezza delle catechesi proposte da papa Wojtyla in 133 udienze generali dal 1979 all’84; ma, poi, il docente presso l’Istituto di scienze religiose di Bologna bypassa tranquillamente quella che non si può non definire una lampante contraddizione: quel pontefice, infatti, dopo tante alate parole sull’amore, ribadì con tenacia le normative di Paolo VI e del cardinale Ratzinger in materia di sessualità, che pur erano figlie di un’altra ed avversa teologia.
Altri si ritroveranno nelle tesi dei due teologi citati, e avranno le loro ragioni; ma io resto del parere che con i silenzi sulle aporie del magistero papale si faccia un’analisi monca e fragilissima della tensione norma/coscienza, e una teologia che non ha futuro.
-
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla), - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! --- Il sogno di una "cosa" di Ratzinger - Benedetto XVI14 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla), - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! ---- L’infallibilità papale non può legittimare l’argomento di autorità.... ci troviamo di fronte ad un abuso di potere. Chi disobbedisce a chi?13 maggio 2012, di Federico La Sala
Chi disobbedisce a chi?
di Patrick Royannais, prete
in “La Croix” del 13 maggio 2012 (traduzione: www.finesettimana.org)
Durante l’ultima messa crismale, Benedetto XVI ha fatto riferimento all’appello lanciato da più di trecento preti austriaci un anno fa relativo all’urgenza delle riforme nella Chiesa: “Di recente, un gruppo di sacerdoti in un Paese europeo ha pubblicato un appello alla disobbedienza, portando al tempo stesso anche esempi concreti di come possa esprimersi questa disobbedienza, che dovrebbe ignorare addirittura decisioni definitive del Magistero - ad esempio nella questione circa l’Ordinazione delle donne, in merito alla quale il beato Papa Giovanni Paolo II ha dichiarato in maniera irrevocabile che la Chiesa, al riguardo, non ha avuto alcuna autorizzazione da parte del Signore.”
Benedetto XVI riconosce che questi preti vogliono servire la Chiesa ma si interroga sull’opportunità della disobbedienza, e lo possiamo capire. Ma, disobbedienza a chi? A Cristo? Non sembra si tratti di questo. Certo - in maniera fallace o per mancanza di rigore - il papa oppone “la conformazione a Cristo, che è il presupposto di ogni vero rinnovamento” e “la spinta disperata a fare qualcosa, a trasformare la Chiesa secondo i nostri desideri e le nostre idee”. Disobbedienza alla Chiesa? Non viene detto. La controversia riguarderebbe solo un punto, del resto discusso, dell’insegnamento di Giovanni Paolo II.
Che cosa dice la Chiesa? Chi non le è fedele? In che cosa? In quale ambito culturale o intellettuale bisogna trovarsi per pensare che, dato che il capo ha parlato, quello che ha detto è automaticamente vero? Nessun gruppo, nessuna persona, neppure il capo, può pretendere di detenere l’ultima parola della verità. Siamo lasciati al conflitto delle interpretazioni, non che si possa dire qualsiasi cosa o che la verità sia soggettiva, ma nulla garantisce in maniera definitiva qualsiasi interpretazione. Fragilità, recentemente riconosciuta, ma non nuova, della verità espressa in linguaggio umano. Inoltre, occorre ricordare che il capo della Chiesa cattolica non è il papa, ma Cristo? Questo evita di fare del governo del papa un regime politico mondano e permette di sottolineare, con l’ultimo concilio, che ogni discepolo è in ascolto della Rivelazione alla quale, magistero compreso, vuole obbedire.
“Il magistero non è superiore alla parola di Dio ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l’assistenza dello Spirito Santo, piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone quella parola” (Dei Verbum, n° 10).
Il papa e i preti austriaci ascoltano la parola del Signore, ma non comprendono la stessa cosa, almeno in punti molto periferici benché decisivi nel comportamento della Chiesa. Non può essere rimesso in discussione il loro attaccamento comune a Cristo che rivela nello Spirito la paternità di Dio; o alla Chiesa, che riceve missione di far risuonare la parola di Gesù e di lodare il Padre per i segni del Regno che germinano nel mondo; o alla forma storica della Chiesa cattolica in particolare nella sua strutturazione sacramentale del ministero.
Il conflitto delle interpretazioni deriva dal contraccolpo creato dalla secolarizzazione e dalla crisi delle istanze di verità o, in altri termini, dalla presa di coscienza della storicità della verità. Per essere fedeli all’insegnamento della Chiesa, non basta ripetere sempre la stessa cosa. Con il tempo, le stesse parole, le stesse pratiche hanno sensi diversi, di modo che chi si limita a ripetere, diventa inevitabilmente infedele. Per questo bisogna continuamente commentare le Scritture, commentare il Credo, reinterpretare la Tradizione della Chiesa, reinventare l’azione pastorale. La Chiesa ha sempre innovato per essere fedele alla sua tradizione e alla sua missione.
Quindi ci sono interpretazioni diverse o conflittuali tra quei preti e il papa. Ma quando chi ha l’autorità parla di disobbedienza, passa da un conflitto delle interpretazioni alla denuncia e all’esclusione di una posizione. Benedetto XVI pretende di chiudere il dibattito, ricorrendo de facto all’argomento d’autorità che la grande tradizione ha sempre contestato: “Al di sopra del papa in quanto espressione dell’autorità ecclesiale, c’è la coscienza alla quale bisogna innanzitutto obbedire, se necessario anche contro le richieste dell’autorità della Chiesa” (J. Ratzinger). Parlare di disobbedienza invece di ammettere la contingenza, l’indefinito conflitto delle interpretazioni, significa confiscare l’autorità e la verità. L’infallibilità papale non può legittimare l’argomento di autorità. Anche con la voce più dolce e lo spirito più umile che nessuno contesta a Benedetto XVI, potrebbe darsi che ci troviamo di fronte ad un abuso di potere. Chi disobbedisce a chi?
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla), - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! ---- L’infallibilità papale non può legittimare l’argomento di autorità.... ci troviamo di fronte ad un abuso di potere. Chi disobbedisce a chi?8 luglio 2013Nessun gruppo, nessuna persona, neppure il capo, può pretendere di detenere l’ultima parola della verità.... questo perchè la maggior parte di noi non ha coscienza ne conoscenza dell’autorità e considera Cristo un suo pari o un invezione ormai obsoleta e fuori dal tempo attuale, e quindi una contestabile opinione. Ma è proprio in nome della falsa libertà di opinione che il diavolo - che ha cominciato la sua carriera disobbedendo - trova così tanti discepoli in questo mondo, e vi lava il cervello facendovi credere che la libertà e l’obbedienza siano in antitesi. Cosi’ che rimaniamo cani al guinzaglio e crediamo di essere liberi perchè contestiamo la verità stessa, facendoci superiori a Essa. Dio abbia pietà di questa generazione perversa e incredula, me per primo.
-
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla), --- Il rimedio per la lussuria è l’amore (di Ruben Alves)31 gennaio 2012, di Federico La Sala
La lussuria
di Ruben Alves (Cem-Modialità, n. 1, gennaio 2012)
Lussuria! Che immagini vi vengono in mente quando sentite pronunciare questa parola? Non occorre dirlo, lo sappiamo. Sono immagini di orge, baccanali, uomini e donne che fanno sesso in qualsiasi maniera... Ma tengo a dirvi che la lussuria non è niente di tutto questo. La lussuria non vive nei genitali. Essa vive negli occhi. Proprio così: la lussuria è un modo di guardare. Il resto sono semplici deduzioni algebriche...
Il peccato della lussuria consiste proprio in questo: le persone che ne sono vittime perdono la capacità di vedere i volti. Vedono solo i genitali e ciò che si può fare con questi. In tale maniera, però, diventano incapaci di amare. Perché l’amore non inizia mai nei genitali. L’amore inizia nello sguardo. Guardando nel fondo degli occhi di chi è posseduto dal demone della lussuria, si vede solo una cosa: peni e vagine. Ora, una volta tanto, va ancora bene. Sono parti, piccole parti di un delizioso giocattolo che si chiama «fare l’amore». Ma quando quegli occhi vedono solo questo, il risultato è un’immensa monotonia. Perché tutte le orge, in fondo, sono la stessa cosa.
Quale cura, allora, per il disturbo oftalmico chiamato lussuria? Non la preghiera, neppure la promessa, non la flagellazione, neppure la minaccia. Il rimedio è la poesia. I demoni hanno in odio la poesia. Non c’è lussuria che resista ai poemi di Vinicius de Moraes, di Carlos Drummond de Andrade e di Adélia Prado. Rispetto a quest’ultima, ad esempio, ci sarà mai qualcosa di più erotico della sua poesia intitolata «Matrimonio»?
- Ci sono donne che dicono
 Mio marito, se vuole pescare, che peschi
Mio marito, se vuole pescare, che peschi
 Ma che pulisca i pesci.
Ma che pulisca i pesci.
 Io no. A qualsiasi ora della notte mi alzo
Io no. A qualsiasi ora della notte mi alzo
 Aiuto a pulire le squame, aprire, ritagliare e salare
Aiuto a pulire le squame, aprire, ritagliare e salare
 È così bello, solamente noi due in cucina
È così bello, solamente noi due in cucina
 E ogni tanto i menti s’incrociano
E ogni tanto i menti s’incrociano
 Lui dice cose come «questo è stato difficile»
Lui dice cose come «questo è stato difficile»
 «girò in aria dando colpi di coda»
«girò in aria dando colpi di coda»
 E fa il gesto con la mano
E fa il gesto con la mano
 Il silenzio di quando ci siamo visti per la prima volta
Il silenzio di quando ci siamo visti per la prima volta
 Attraversa la cucina come un fiume profondo
Attraversa la cucina come un fiume profondo
 Infine, i pesci sulla tavola
Infine, i pesci sulla tavola
 Andiamo a dormire
Andiamo a dormire
 Cose preparate sbocciano: siamo sposo e sposa
Cose preparate sbocciano: siamo sposo e sposa
Ai miei tempi antichi di protestante, eravamo soliti fare una cosa chiamata «culto domestico». La famiglia si riuniva per leggere la Bibbia e pregare. Credo che usanze simili sarebbero salutari: le famiglie che dopo cena si riuniscono per leggere poesia. Incluse le Sacre Scritture. Non c’è lussuria che resista al Canto dei Cantici
- Mi baci con i baci della tua bocca.
 Sì le tue tenerezze sono più dolci del vino
Sì le tue tenerezze sono più dolci del vino
 Come sei bella, amica mia, come sei bella
Come sei bella, amica mia, come sei bella
 Gli occhi tuoi sono colombe, dietro il tuo velo
Gli occhi tuoi sono colombe, dietro il tuo velo
 L’odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi
L’odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi
 Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa,
Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa,
 c’è miele e latte sotto la tua linguaCome sono belli i tuoi piedi
c’è miele e latte sotto la tua linguaCome sono belli i tuoi piedi
 Nei sandali, figlia di principe
Nei sandali, figlia di principe
 Le curve dei tuoi fianchi sono come monili, opera di mani d’artista
Le curve dei tuoi fianchi sono come monili, opera di mani d’artista
 Il tuo ombelico è una coppa rotonda
Il tuo ombelico è una coppa rotonda
 Che non manca mai di vino drogato
Che non manca mai di vino drogato
 Il tuo ventre è un mucchio di grano
Il tuo ventre è un mucchio di grano
 Circondato da gigli
Circondato da gigli
 I tuoi seni come due cerbiatti
I tuoi seni come due cerbiatti
 Gemelli di gazzella...
Gemelli di gazzella...
 Vieni mio amato... mi sono già tolta i vestiti...
Vieni mio amato... mi sono già tolta i vestiti...
Colui che è tentato dalla lussuria è perché non è amato. Il rimedio per la lussuria è l’amore.
(traduzione di Marco Dal Corso)
- Ci sono donne che dicono
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla), ---- L’ARCA DELL’ALLEANZA, IL PRESEPE, E L’AMORE. E "qualche verità su Maria" (di CCBF).8 dicembre 2011, di Federico La Sala
Premessa sul tema.
L’ARCA DELL’ALLEANZA, IL PRESEPE, E L’AMORE ("CHARITAS") CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE. Una nota
- DIO E’ AMORE (1 Gv.: 3.8)
- DEUS CHARITAS EST (1 Gv.: 4.8)
AI DUE CHERUBINI E AI DUE COLOMBI ... A MARIA E GIUSEPPE - E GESU’!!!
COME DA ARCA DELL’ALLEANZA ... COME DAL "GLORIA A DIO NEL PIU’ ALTO DEI CIELI", COME DALLA LEZIONE DEL PRESEPE DI SAN FRANCESCO ("Va’, ripara la mia casa") - E DALLA "MONARCHIA" DI DANTE:
Come MARIA: "FIGLIA DEL TUO FIGLIO", Così GIUSEPPE: "FIGLIO DEL TUO FIGLIO"!!! Dante non "cantò i mosaici" dei "faraoni", ma soprattutto la Legge del "Dio" di Mosè di Elia e di Gesù, del "Dio" dei nostri "Padri" e delle nostre "Madri".
L’Amore ("Charitas") muove il Sole e le altre stelle ... e non la Ricchezza ("caritas") del "santo-padre" del cattolicesimo-costantiniano.
In principio era il Logos - non il "Logo" della tradizione vaticana del "Latinorum"!!! (Federico La Sala)
Qualche verità su Maria
di CCBF
in “www.baptises.fr” dell’8 dicembre 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)
Celebriamo oggi la festa dell’Immacolata Concezione. Qualche parola a questo proposito. Abbiamo la tendenza a ritenere che Maria, la madre di Gesù, abbia uno status di eccezionalità, che sia un caso unico: «la» donna preservata dal peccato. Mi sembra che dovremmo guardarla piuttosto come quella che rappresenta in maniera esemplare una verità che fatichiamo a vedere, ma che si applica a tutti. Maria, si dice, porta Dio nel suo seno. Certo, ma ogni vita è presenza di Dio, così che ciascuno è, come Maria, portatore di Dio dentro di sé.
Sulla linea - abbastanza infelice, ammettiamolo - di Agostino e della sua teologia piuttosto nevrotica del peccato originale (Agostino aveva però altri ottimi talenti), diciamo che Maria è esente da ogni peccato, il che le permette di portare in sé il Figlio di Dio in maniera totalmente pura. Questa ossessione della purezza, in realtà, è poco fedele alla fede del Vangelo.
Diciamo piuttosto che Maria è per noi il segno che la vita che viene non è rinchiusa nei fatalismi e nelle ferite ereditate dal passato. Matteo e Luca, che mettono in scena Maria nei loro rispettivi vangeli, si curano anche di stabilire una genealogia di Gesù. Queste due genealogie, per quanto diverse, hanno tuttavia un punto in comune: ritracciano una storia carica di drammi e di infedeltà. Ciò che fa Maria, che legge le Scritture, e quindi rilegge questa storia, è di discernere il percorso del dono di Dio, senza rinchiudere la vita nella logica dei regolamenti di conti e dei risentimenti. Percepisce la vera finalità della vita, quello a cui Dio mira, ed è in questo che sfugge al peccato - il che etimologicamente vuol dire che non manca il bersaglio. È esemplare più che singolare, perché ci dice che, con la forza dell’Altissimo, con lo Spirito Santo, ciascuno di noi può accogliere questa intenzione e non imprigionare la vita. È quello che ha scoperto, molto più tardi, la psicanalisi, perché nel frattempo, troppi cristiani l’avevano dimenticato...
Smettiamola di pensare che lo Spirito Santo sostituisca gli spermatozoi o altre scempiaggini del genere. Ciò significa limitarsi ad una stupida lettura fondamentalista dei vangeli (in particolare dei due semi-versetti dell’inizio del vangelo di Matteo, suscettibili di molte interpretazioni contraddittorie). Scopriamo che Maria è il segno di ciò che è la nostra vera vocazione. La liturgia di oggi ci fa rileggere in parte il racconto della “caduta” nel libro della Genesi. La pericope comincia con il giudizio che Adamo rivolge a se stesso ritenendosi colpevole al punto da nascondersi a colui che dà la vita. Perde di vista l’essenziale, la vita stessa. Ecco il peccato. In Maria, scopriamo che possiamo credere alla vita, piuttosto che alla morte. È tutta un’altra cosa.
Per concludere, posso dire che vorrei che la nostra Chiesa alla fine dicesse questo, che sa perfettamente, piuttosto che lasciare credere delle stupidaggini per paura di perdere le ultime pecorelle che le restano?
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla), - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! Fonti cattoliche a confronto, in chiave dialettico-polemica. Ripreso Giovanni Paolo II, l’ennesimo affondo per il dibattito - di Federico La Sala6 ottobre 2011
 Grande successo per il libro di un frate francescano sulle gioie del sesso
Grande successo per il libro di un frate francescano sulle gioie del sesso
 "Mostratevi amore in ogni modo": ma è solo per coppie sposate e senza contraccezione
"Mostratevi amore in ogni modo": ma è solo per coppie sposate e senza contraccezione Polonia, un kamasutra cattolico
Polonia, un kamasutra cattolico
 con la "benedizione" della Chiesa
con la "benedizione" della Chiesa dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *LONDRA - Sesso, amore e fede. E’ una sorta di nuova santissima trinità, quella celebrata da un libro che è diventato rapidamente un best-seller in Polonia e sta per essere tradotto in mezza dozzina di lingue, compreso l’inglese e l’italiano: "Seks", ovvero sesso, sta scritto a caratteri cubitali in copertina, e nel sottotitolo, molto più in piccolo, "per le coppie sposate che amano Dio". Il Guardian di Londra ne parla oggi in prima pagina descrivendolo come un "kamasutra cattolico": già, perché l’autore è un frate francescano polacco, padre Ksawery Knotz, che prega e lavora in un monastero vicino a Cracovia.
Un manuale di sesso scritto da un sacerdote cattolico sarebbe già abbastanza sorprendente, ma ancora più sorprendenti sono le istruzioni che il frate dà alle coppie. Chi pensasse che il suo libro suggerisce di limitarsi alla posizione "del missionario" e a considerare il coito un esercizio unicamente diretto alla riproduzione della specie, resterebbe deluso, osserva il Guardian. Padre Knotz, al contrario, consiglia di prendere il sesso con allegria e di farlo, per così dire, in tutte le salse. "Ogni atto, un certo tipo di carezze, una certa posizione sessuale, fatto allo scopo di suscitare eccitazione, è permesso e fa piacere al Signore", scrive il frate. "Durante un rapporto sessuale, le coppie sposate possono mostrare il loro amore in qualsiasi modo, possono scambiarsi le carezze più ardite, possono fare ricorso a stimolazioni orali e manuali".
Il libro, che ha ricevuto la benedizione ossia l’approvazione della chiesa cattolica polacca, nota per il suo conservatorismo, segue l’ortodossia tradizionale in altro ambito: si rivolge esclusivamente alle coppie sposate, come se il sesso non potesse esistere fuori dal matrimonio, e scoraggia l’uso di qualunque genere di contraccettivi, "perché possono condurre una coppia fuori dalla cultura cattolica e verso uno stile di vita completamente differente". Ma a parte questo, una volta che l’unione è santificata dal sacramento del matrimonio, sotto le lenzuola tutto è permesso. "Alcune persone credono che il sesso nella vita matrimoniale debba essere privo di gioia, di frivola giocosità, di fantasia e di posizioni eccitanti. Pensano che debba essere triste come un tradizionale inno religioso", afferma padre Knotz nel suo libro. "Fanno fatica a capire che Dio è interessato anche alla felicità della loro vita sessuale, e che anche così ha dato loro un suo dono".
Sebbene il manuale del "kamasutra cattolico" abbia già avuto numerose ristampe in Polonia, e sia in procinto di essere tradotto in slovacco, italiano, inglese e altre lingue, qualcuno si domanda dove abbia messo insieme un’esperienza in fatto di sesso il suo autore, che come frate cattolico ha fatto voto di celibato.
Padre Knotz ammette che le sue informazioni in materia sono "di seconda mano", ma aggiunge che gli hanno dato lo stesso un’ampia conoscenza della materia. "Parlo con un sacco di coppie sposate, li ascolto, e cerco di aiutarli a essere più contenti della loro vita sessuale, a capire che il sesso nel matrimonio non deve avere sensi di colpa o provocare tensioni", spiega. Il successo è tale che, oltre al libro, ha aperto un sito internet dove dispensa i suoi insegnamenti in fatto di sesso ai devoti. A patto che siano sposati, naturalmente.
* la Repubblica, 15 maggio 2009
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! ---- L’innovativa teologia del corpo di Giovanni Paolo II racchiude un futuro dai risvolti impegnativi ancora imprevedibili (di Fergus Kerr OP - La visione di Wojtyla).2 maggio 2011, di Federico La Sala
La visione di Wojtyla
di Fergus Kerr OP (direttore di New Blackfriars)
 in “The Tablet” del 30 aprile (traduzione di Maria Teresa Pontara Pederiva)
in “The Tablet” del 30 aprile (traduzione di Maria Teresa Pontara Pederiva)Entrambi i papi - Giovanni Paolo II e Benedetto XVI - sono stati influenzati dalle radici cristiane dell’Europa e dalle lotte del continente contro i totalitarismi del XX secolo. Ma in questo primo di una serie di articoli, che vengono pubblicati questa settimana in occasione della beatificazione del papa polacco, cercherò di sottolineare la differenza tra i due soprattutto in termini di confronto tra le loro linee di pensiero.
I papi possono influenzare teologicamente i loro successori? E, in caso affermativo, in quale misura? Nei secoli passati la maggior parte non ha ritenuto necessario scrivere su questioni teologiche, di fatto pochi ne sarebbero stati in grado. Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI
 il primo definito un “intellettuale”, l’altro un “accademico” - erano stati in precedenza docenti
universitari di prestigio. E nessuno dei due avrebbe potuto seguire una strada diversa.
Nel 1951 Karol Wojtyla tornò alla Jagiellonian University di Cracovia per completare un secondo
dottorato, questa volta in filosofia, sulla possibilità di elaborare un’etica cristiana sulla base del
pensiero di Max Scheler (1874-1928) pensatore famoso per la sua fenomenologia dell’amore.
Ottenuto il dottorato, Wojtyla ha insegnato etica sociale all’università, continuando pure
l’insegnamento a Lublino, anche negli anni successivi al 1958 quando divenne arcivescovo di
Cracovia.
il primo definito un “intellettuale”, l’altro un “accademico” - erano stati in precedenza docenti
universitari di prestigio. E nessuno dei due avrebbe potuto seguire una strada diversa.
Nel 1951 Karol Wojtyla tornò alla Jagiellonian University di Cracovia per completare un secondo
dottorato, questa volta in filosofia, sulla possibilità di elaborare un’etica cristiana sulla base del
pensiero di Max Scheler (1874-1928) pensatore famoso per la sua fenomenologia dell’amore.
Ottenuto il dottorato, Wojtyla ha insegnato etica sociale all’università, continuando pure
l’insegnamento a Lublino, anche negli anni successivi al 1958 quando divenne arcivescovo di
Cracovia.Nel 1969 con il suo libro dal titolo “The Acting Person” come recita la versione inglese (“Persona e atto” Libreria Editrice Vaticana 1982) egli ha offerto un contributo importante alla filosofia. Una modalità di approccio a questo testo è la possibilità di considerarlo come un ulteriore sforzo per superare la concezione cartesiana della coscienza di sé, in parte lungo lo stesso percorso seguito da “The Self Agent” (1957) di John Macmurray o quello di Stuart Hampshire in “Thought and Action” (Pensiero e Azione, 1970).
Molto più tardi in “Crossing the Threshold of Hope” (Varcare le frontiere della speranza, 1994) Giovanni Paolo II ripetè la stessa critica a Cartesio che distingue il pensiero dall’esistenza. “Come è diverso l’approccio di san Tommaso per il quale non si ritiene il pensiero determinare l’esistenza, bensì l’esistenza che determina il pensiero”. Noi siamo agenti, non spettatori di un qualcosa autoincapsulato.
In aggiunta a ciò, con la dott.ssa Wanda Póltawska, psichiatra di Cracovia, Wojtyla aveva fondato l’”Istituto per la Famiglia” con lo scopo di educare i laici in materia di etica sessuale. Nel testo Amore e responsabilità del 1960 egli sostiene che né la procreazione, né il piacere possono da soli giustificare un rapporto coniugale: al contrario, egli rifiuta da una parte gli “utilitaristi”, come Freud, che si concentrano sul piacere, dall’altra i “rigoristi”, come i puritani, che limiterebbero l’attività sessuale alla procreazione. Wojtyla delinea piuttosto una dottrina elevata dove i rapporti sessuali sono visti come una donazione reciproca di sé.
In confronto le pubblicazioni dell’allora prof. Joseph Ratzinger non sono mai state così ambiziose. Egli conseguì il dottorato in teologia nel 1953 all’università di Monaco di Baviera con una tesi sui concetti di “popolo” e “casa” di Dio in sant’Agostino. Così come Karol Wojtyla, si allontanò, apparentemente senza preoccupazioni di sorta, dalla neoscolastica allora scontata. Avendo poi optato per una carriera accademica, Ratzinger ha quindi redatto una tesi post-doc di storia della teologia su san Bonaventura, dove si è definitivamente allontanato dal neo-tomismo all’epoca di routine. Infatti, come ha ricordato egli stesso, la tesi avrebbe dovuto essere rivista proprio per eliminare quella presunta qualifica di “modernista” che era stata ipotizzata da un esaminatore, come Michael Schmaus (1897-1993), in quel momento uno tra i più eminenti teologi a Monaco di Baviera.
Ratzinger si trasferì nel 1969 nella nuova università di Ratisbona nella sua natìa Baviera. Nel 1977, con la sua nomina ad arcivescovo di Monaco di Baviera, la sua carriera di professore universitario, durata due decenni, volse al termine. Non ancora cinquantenne, aveva prodotto una serie di pubblicazioni a suo nome, ma non la grande opera di cui senza dubbio ogni professore di teologia vada sognando. Ma c’era altro da scrivere negli anni a venire.
Tocca ai papi scrivere le encicliche. Giovanni Paolo II ne ha pubblicate 14. La prima, la Redemptor hominis (1979), centrata quasi programmaticamente sull’importanza della persona umana: questa ha continuato idealmente l’attenzione sulla persona del testo Persona e atto, ma con uno stile completamente differente.
Nel 1981 Giovanni Paolo II ha commemorato la Rerum Novarum di Leone XIII, la famosa enciclica sulla giustizia sociale, con un profilo su quanto aveva detto riguardo al conflitto tra lavoro e capitale e sui diritti dei lavoratori: non c’è dubbio che questo rifletta la sua esperienza lavorativa precedente. Nel 1987 ha ricordato la Populorum Progressio di papa Paolo VI con un’altra forte affermazione delle preoccupazioni sociali e politiche della Chiesa. Nel 1991 ha commemorato ancora la Rerum Novarum. In questi diversi interventi, correlati tra loro, il papa polacco non ha avuto esitazioni nel denunciare il liberal-capitalismo dell’Occidente, proprio mentre attaccava con fermezza il totalitarismo dell’Europa orientale.
Non c’è dubbio che sia stato un papa che ad un certo punto ha applaudito all’ecumenismo: con l’Ut Unum Sint (1995), infatti, Giovanni Paolo II, riconoscendo esplicitamente l’ostacolo che il papato costituisce per molti cristiani, ortodossi e protestanti, ha invitato tutti ad aiutarlo a rimodellare il ministero petrino così da fungere da punto di riferimento per incontri futuri.
Anche in questo caso le preoccupazioni pastorali potrebbero aver indotto ciascun papa a prendere in esame lo stato di salute della teologia morale e della filosofia in generale. Ma con la Veritatis Splendor (1993) e la Fides et ratio (1998), l’opposizione di Giovanni Paolo II a tutto quanto riteneva utilitaristico, in alcuni concetti della teologia morale cattolica, e la sua insistenza sul ruolo della ragione e quindi della filosofia stessa all’interno di ogni religione, riflette decisamente la mentalità del docente di etica sociale.
Nella sua "teologia del corpo", tuttavia, Giovanni Paolo II ha arato un nuovo campo. In quello che potremmo definire una antropologia cristiana della differenza sessuale e della complementarietà, egli ha inaugurato quello che molti commentatori, in particolare in Nord America, considerano come un cambiamento rivoluzionario nella dottrina e nella sensibilità cattolica.
Secondo George Weigel, per esempio, questo rappresenta quasi "una bomba a orologeria teologica, qualcosa che potrebbe esplodere all’interno della Chiesa ad un certo punto indeterminato del futuro, ma con grande effetto, rimodellando il modo in cui i cattolici pensano alla nostra corporeità in termini di maschile e femminile, la sessualità, il rapporto con l’altro e il rapporto con Dio - anche all’identità stessa di Dio "(cfr. la sua prefazione a Christopher West “Theology of the Body Explained” [2003] - una preziosa spiegazione).
Naturalmente questo richiama le preoccupazioni contenute già in “Amore e responsabilità”. L’arcivescovo di Cracovia (almeno parrebbe oggi) sembra aver avuto un’influenza decisiva su Papa Paolo VI quando, nella sua enciclica Humanae Vitae (1968), ha ribadito la fede cattolica nel legame inscindibile tra il rapporto coniugale e la procreazione, riaffermando così la condanna come immorale di tutte le forme di controllo delle nascite, tranne i metodi naturali.
Dal momento che molti cattolici sono stati, e rimangono, non persuasi da tali argomenti, che derivano essenzialmente dalla legge naturale, sembra che, subito dopo essere stato eletto papa, Giovanni Paolo II abbia deciso di intraprendere la strada di una teologia della differenza di genere, che confermerebbe come la contraccezione all’interno di un matrimonio cristiano sia da considerare peccaminosa. Nei 129 discorsi alle udienze settimanali, tra il 1979 e il 1984, Giovanni Paolo II ha sviluppato questa sua "teologia del corpo". Se il matrimonio è stato a lungo oggetto di un ripensamento della teologia cattolica, ora ne diventava un centro creativo.
Per spiegare in semplici parole un’argomentazione così profonda e complessa si potrebbe affermare così: L’uomo esiste da sempre come maschio o femmina (Gen 1,27). L’unità di Cristo e della Chiesa è il "grande mistero", esemplificato con l’espressione in "una sola carne" della coppia originaria, Adamo ed Eva, e poi di nuovo in qualsiasi autentica unione coniugale (Efesini 5,31-2). Il marito ama sua moglie come Cristo ama la sua sposa, la Chiesa - e dona se stesso per lei (Efesini 5,25). Lanozione di reciproca donazione di sé è fondamentale.
La comunione sponsale diventa la principale analogia di ogni tipo di rapporto. Considerando che nella teologia classica, compreso Tommaso d’Aquino, ci viene detto che siamo creati a immagine di Dio a causa della nostra razionalità, il dato essenziale per Giovanni Paolo II è la differenza sessuale: "... maschio e femmina li creò". La razionalità diventa comunicazione, comunione. L’unione della natura divina e umana in Cristo diventa come un matrimonio fra cielo e terra. Analogamente l’atto di Gesù che fa dono di se stesso agli altri, fa sì che anche la celebrazione eucaristica sia vista in analogia ad un’unione coniugale.
Si potrebbe quasi affermare che il racconto della storia della salvezza si snodi dalla coppia originaria nel giardino dell’Eden fino alla discesa della Città Santa, “che scende dal cielo, pronta come una sposa adorna per il suo sposo” (Apocalisse 21,2).
In questi casi, come in altri, l’immagine di Cristo sposo apre la strada per condurci ad esplorare l’intera realtà, ossia come deve intendersi il rapporto fra le creature e il Creatore, ciascuno di noi e il Salvatore, la Chiesa e Cristo. Certamente questo fa tesoro di immagini e temi familiari all’antica e moderna spiritualità, ma la teologia del corpo di Giovanni Paolo II mostra una coerenza e una forza che non ha precedenti.
Questa teologia ha implicazioni sociali e politiche di enorme portata, come lo stesso Giovanni Paolo II ha sottolineato più volte. Dal momento che la differenza sessuale è fondamentale, e l’unione coniugale viene ad essere la massima espressione della complementarietà, gli effetti a lungo termine della contraccezione diventerebbero distruttivi per l’intera umanità. La testimonianza dei coniugi cattolici deve quindi andare radicalmente controcorrente.
Se il rapporto nuziale può essere considerato la chiave interpretativa per ripensare quasi ogni altra dottrina cristiana, Giovanni Paolo II ha certamente lasciato in eredità un patrimonio teologico che ha appena cominciato ad influire sulla sensibilità e il pensiero della maggior parte dei cattolici.
Nel 1981 papa Giovanni Paolo II ha nominato il cardinale Ratzinger Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF). Quando gli archivi vaticani verranno aperti, in un prossimo futuro, forse sarà possibile andare a verificare in che misura i due papi siano stati concordi dal punto di vista teologico. Per fare un esempio, una certa qual freddezza dell’allora card. Ratzinger riguardo all’incontro interreligioso di Assisi nel 1986 potrebbe aver marcato una certa esitazione circa l’entusiasmo di Giovanni Paolo II per il dialogo interreligioso.
E ancora, nel 1987, l’enciclica Sollicitudo rei socialis, che ha condannato il capitalismo in maniera ancora più drastica di quanto non abbia fatto con il comunismo, è stata letta da alcuni commentatori come meno negativa riguardo alla “teologia della liberazione” rispetto alla linea politica della Sacra Congregazione sotto la guida del card. Ratzinger. Sembra alquanto improbabile, tuttavia, che nel corso dei 24 anni in cui Ratzinger fu alla guida della CDF, che egli non abbia avvallato ogni linea politica che non differisse in maniera significativa da quanto Giovanni Paolo II fosse contento di sostenere.
Benché siano trascorsi pochi anni dalla sua elezione, papa Benedetto XVI ha già delineato però un profilo teologico che si differenzia da quello del suo predecessore. Non c’è motivo di pensare che egli abbia preso le distanze deliberatamente, quasi per sfuggire in una tale dinamica l’ombra di un pensatore innovativo. Le sue iniziative - così come fu per Giovanni Paolo II - fanno piuttosto riferimento a interessi precedenti. Con la sua riconosciuta preoccupazione per la liturgia non è stata per nulla una sorpresa che egli abbia autorizzato l’antico rito e altri provvedimenti.
Per decenni poi i teologi di professione si erano mostrati preoccupati di integrare dal punto di vista storico-critico gli studi biblici con il dogma cattolico: lo studio di Benedetto XVI su Gesù sembrerebbe piuttosto il tentativo di un teologo in pensione, che, vista la prevedibile reazione contraria di teologi di professione, abbia preso coraggio.
Le tre encicliche di Benedetto XVI tracciano una strada ancora più caratteristica. La seconda metà della Deus Caritas Est (2006), prende le mosse da una serie di appunti lasciati incompleti da Giovanni Paolo II; la prima parte, al contrario, propone il rapporto fra l’amore così come era conosciuto dall’antica filosofia greca - nello specifico l’eros - e l’amore cristiano, l’agàpe.
Quantunque, mettendo insieme le due parti, Benedetto XVI appare discostarsi completamente dalla lunga tradizione cristiana che condannava qualsiasi forma di “amore erotico”. Dopo aver analizzatol’amore, egli si è rivolto nella Spe Salvi (2007) alla speranza e alla fede: l’enciclica si apre con la storia della sudanese Josephine Bakhita, una schiava convertita dal paganesimo alla speranza della redenzione. Nella Caritas in Veritate (2009), papa Benedetto XVI riprende i concetti dell’enciclica Populorum Progressio (1967) di Paolo VI, riaffermando con forza la dottrina sociale della Chiesa. Una grande attenzione è stata rivolta alla lezione che ha tenuto a Regensburg nel 2006: la sua citazione di un imperatore bizantino medievale nei confronti dell’Islam ha immediatamente provocato reazioni in tutto il mondo musulmano. Ma il punto centrale del suo discorso è stato quello di insistere sul ruolo della ragione nella ricerca di Dio e sulla compatibilità tra la filosofia greca pagana e la fede cristiana.
Nella Fides et Ratio (1998) Giovanni Paolo II aveva esteso la sua prospettiva ben oltre l’antica Grecia: tuttavia, pur all’interno della radici cristiane d’Europa, entrambi i papi hanno insistito per mantenere un legame fra Gerusalemme e Atene, cui l’Occidente deve la sua cultura e la sua civiltà. Ad ogni modo resta la possibilità che l’innovativa teologia del corpo di Giovanni Paolo II racchiuda un futuro dai risvolti impegnativi ancora imprevedibili.
-
>Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla), - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! ---- L’educazione sessuale. Occorre portare l’educazione sessuale alla vera altezza dell’erotica (di U. Galimberti).30 aprile 2011, di Federico La Sala
L’educazione sessuale
Occorre portare l’educazione sessuale alla vera altezza dell’erotica
Risponde Umberto Galimberti *
Benedetto XVI ha affermato che l’educazione sessuale nelle scuole di alcuni paesi europei è una minaccia alla libertà religiosa. Le cose però non stanno così, giacché la morale, compresa quella sessuale, viene inevitabilmente trasmessa dall’intera società (costumi, mezzi di comunicazione di massa, ecc.) Gli insegnanti sono costretti ad affrontare temi che toccano la sfera della sessualità, perché è difficile restare neutrali davanti a problemi quali l’aborto, la contraccezione, l’omosessualità, le coppie di fatto, ecc. In realtà Benedetto XVI ha il timore, sacrosanto essendo il Papa, che nelle scuole venga trasmessa una morale sessuale diversa da quella cattolica. Ma siamo certi che questa sia rispettosa delle libertà individuali?
 Renato Pierri ex docente di religione cattolica
Renato Pierri ex docente di religione cattolica
 renatopierri@tiscali.it
renatopierri@tiscali.itBenedetto XVI forse ha ragione. Nelle scuole bisognerebbe insegnare la morale sessuale della Chiesa cattolica. Nessun rapporto con la persona amata, anche se si è in età matura, persino per tutta la vita, se non si è sposati (art. 2353 del Catechismo). E, in mancanza di rapporti, attenzione a non masturbarsi, perché "la masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato" (art. 2352). Gli omosessuali, da accogliere con compassione, sono chiamati alla castità (art. 2358). Quindi nessun rapporto per tutta la vita con persone della stessa identità di genere. Atto "intrinsecamente cattivo", invece, anche per persone sposate in Chiesa, ricorrere al condom al fine di non procreare (art. 2370). Una donna che abortisce, anche nel caso in cui il feto sia affetto da malattia gravissima, oppure concepito a seguito di uno stupro, è un assassina come Caino (Giovanni Paolo II - Evangelium vitae). L’elenco sarebbe lungo, ma questo basta per rendersi conto che l’educazione sessuale cattolica è una minaccia alla libertà della persona.
 Francesca Ribeiro
Francesca Ribeiro
 ribesca@tiscali.it
ribesca@tiscali.itQuando la Chiesa si libererà dall’ossessione sessuale avrà più tempo per parlare di Dio e più capacità di persuadere che Dio è amore. Non nell’accezione protettiva e consolatoria secondo la quale Dio ama gli uomini che ha creato e redento, ma nel senso che senza un sprazzo di trascendenza, di cui Dio è la metafora, la sessualità perde la sua densità, la sua forza, il suo senso, la sua potenza. Questo bisogna insegnare ai giovani. E in questo deve consistere l’educazione sessuale affinché i ragazzi non si limitino alla pura meccanica dei corpi, ma sappiano, al di là del possesso e della loro appropriazione, leggere l’accadere di un mondo quale appare guardato con gli occhi dell’eros.
La negazione della sessualità, la sua proibizione, il silenzio sui temi sessuali, utile solo a custodirne l’ignoranza che non ha mai fatto fare un passo avanti a nessuno nella storia, non sono praticabili in quell’età in cui la natura sprigiona tutta la sua potenza sessuale in quei corpi giovani. E allora, se educazione ci deve essere, affinché la sessualità si esprima a livello umano e non solo animale, è necessario quel raggio di trascendenza, a cui ho accennato, che consente ai corpi di non chiudersi tristemente nel cerchio stretto della loro solitudine che si fa oppressiva, ma sappia articolare la passione in quella polifonia di linguaggi capace di trasfigurare la nudità nell’estasi della partecipazione, in modo da risvegliare la carne dalla sua opacità e, da puri funzionari della specie come natura ci prevede, ci faccia scoprire, proprio nell’atto sessuale, come individui, caratterizzati da un nome proprio che solo l’altro può chiamare.
E tutto ciò, vorrei dire a chi teme l’educazione sessuale intesa come qui ho cercato di illustrare, è profondamente religioso, se è vero quel che leggiamo nel Cantico dei Cantici (7, 12-13): "Vieni mio diletto, usciamo alla campagna, pernottiamo nei villaggi: di buon mattino andremo nei vigneti, vedremo se gemma la vite, se sbocciano i fiori, se fioriscono i melagrani, là ti darò i miei amori".
Educazione sessuale significa allora insegnare ai giovani come si passa dal corporeo all’incorporeo, per scoprire nel sorriso un offerta, nello sguardo una reciprocità di intenzioni, nel gesto quell’indistinta mescolanza di bellezza e tenerezza che consente di esprimere quella che poco prima era una timida gioia nascosta che la sessualità sprigiona. Non è una bella cosa insegnare tutto questo ai giovani, invece di proibire quello che la natura non consente a loro di ignorare?
* la Repubblica/D, 30.04.2011
-
> Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla), - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! ---- "In privato, tutti concordano sull’omosessualità di Ratzinger”.Il teologo David Berger: “Papa Benedetto XVI è gay”.18 aprile 2011
 Il teologo David Berger:
Il teologo David Berger:
 “Papa Benedetto XVI è gay”
“Papa Benedetto XVI è gay” Secondo lo studioso “quando si parla tra studiosi in privato, tutti concordano sull’omosessualità di Ratzinger”. Indignati i cattolici
Secondo lo studioso “quando si parla tra studiosi in privato, tutti concordano sull’omosessualità di Ratzinger”. Indignati i cattolici di Emiliana Costa *
di Emiliana Costa *“Papa Ratzinger è gay”. La scioccante dichiarazione è di David Berger, il teologo tedesco che nel novembre scorso era salito alla ribalta delle cronache per aver fatto coming out e aver lanciato input pruriginosi sull’omosessualità di molti preti nella chiesa cattolica. A distanza di pochi mesi, Berger è tornato con un pettegolezzo choc sulle inclinazioni sessuali di Benedetto XVI. E lo ha fatto dalle colonne del mensile gay “Fresh”.
Secondo il teologo “quando si parla tra studiosi in privato, tutti concordano sull’omosessualità di Ratzinger. Lui viene da una cultura clericale nella quale il tema dell’amore per persone dello stesso sesso era totalmente tabù. Quello che odia in sé lo proietta sugli altri e lo disprezza”.
Nel suo libro “Una sola illusione: un teologo gay nella Chiesa cattolica”ci sarebbero anche le dichiarazioni della giornalista Valeska von Roques, secondo cui Benedetto XVI durante la sua attività di cardinale avrebbe avuto storie omosessuali con alcune guardie svizzere.
“Il Papa - ha aggiunto Berger - è costantemente preoccupato dell’omosessualità, la prima cosa che ha fatto nel 2005 è stato un documento contro i preti gay, per lui sono pericolosi”. Secondo il teologo, Benedetto XVI avrebbe avuto contatti regolari con cardinali omosessuali.
Mentre sul web, la notizia rimbalza da un portale all’altro, il mondo cattolico si indigna davanti a simili dichiarazioni. Il sito cattolico kath.net sostiene che quella di Berger sia pura diffamazione di un uomo potente come papa Ratzinger. Anzi alcuni sono molto taglienti e ribattono che la tesi di Berger dimostrerebbe come l’omosessualità spenga il cervello.
Kreuz.net definisce Berger una “latrina omosessuale”, in quanto “avrebbe insultato il Papa nello squallido mensile omosessuale descrivendolo come un sodomita”.
* REPORTER: Emiliana Costa, 15 aprile 2011
-
> di Federico La Sala - Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla), - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! ---- Il cardinale Scola pensa ai suoi genitori e comincia apensare che sull’amore serve una riforma della chiesa (di Aldo Cazzullo - Intervista).18 luglio 2010, di Federico La Sala
Il cardinale Scola: sull’amore serve una riforma della Chiesa
intervista a Angelo Scola
a cura di Aldo Cazzullo (Corriere della sera, 18 luglio 2010)
«Io sono la madre del bell’amore ...». Il cardinale Angelo Scola, patriarca di Venezia, sta rivedendo gli appunti del discorso del Redentore. Partendo dal passo delle Scritture sul «bell’amore», toccherà temi delicati come sessualità, pedofilia, verginità e celibato. Perché questa scelta? «Per la fatica di noi cristiani a comunicare che lo stile di vita affettiva e sessuale indicato dalla Chiesa è buono e conveniente per l’uomo di oggi. Invece pare quasi che questa proposta non solo sia iperdatata, impotente a favorire il desiderio umano di gioia piena, ma che sia addirittura contraria alla libertà e priva di realismo, incapace di tener conto di ciò che l’uomo ha imparato circa se stesso e circa il mondo delle emozioni, degli affetti, dei rapporti con l’altro, grazie a una lunga storia e alle recenti scoperte scientifiche. Ho sentito tutto questo come una provocazione a dire che gli uomini e le donne di oggi, magari senza volerlo, rischiano di smarrire qualcosa di profondo, perdono una grande chance di realizzazione, se mettono da parte la proposta cristiana circa la vita affettiva e sessuale».
Ma su cosa si fonda questa proposta?
«Mi pare che l’idea biblica del "bell’amore", che la tradizione cristiana ha approfondito, sia particolarmente adeguata proprio per la sua capacità di coniugare l’amore alla bellezza, di vederlo scaturire da essa e percepirlo come "diffusivo" di bellezza, capace di farla splendere sul volto degli altri. I Padri della Chiesa riferiscono il tema biblico del "bell’amore" non solo alla Madonna ma anche a Gesù. Tommaso parla della bellezza come dello "splendore della verità"; per Bonaventura colui che contempla Dio, cioè che lo ama, è reso tutto bello. Ma questa capacità spesso manca nell’esperienza sessuale degli uomini e delle donne di oggi. Viverne la bellezza significa strappare la sessualità al dualismo tra spirito e corpo; come se trattenessimo la sessualità nell’animalesco e poi a tratti avessimo spiritualissimi slanci d’intenzione di bell’amore. Pascal diceva che l’uomo è a metà strada tra l’animale e l’angelo, ma deve stare bene attento a non guardare solo all’uno o all’altro; ognuno di noi, inscindibilmente uno di anima e di corpo, ha da fare i conti con la dimensione sessuale del proprio io per tutta la vita, dalla nascita fino alla morte».
Patriarca, lei conosce l’obiezione mossa agli uomini di Chiesa: parlano di cose che non vivono, se non talora in modo deviato, e non li riguardano.
«Ho appena detto che "ogni uomo e ogni donna" devono fare i conti con la dimensione sessuale per tutta la vita! Certo, chi è chiamato alla verginità o al celibato li fa in un modo singolare ma, sia ben chiaro, senza mutilazioni psichiche e spirituali. Il fatto poi che dalla castità mantengono l’io personale unito, aprendo la strada ad un possesso più autentico. Il sacrificio non annulla il possesso, è la condizione che lo potenzia. I dottori della Chiesa parlavano in proposito di "gaudium" (godimento). Il puro piacere, che per sua natura finisce subito, chiede di essere inserito nel godimento, perché se resta chiuso in se stesso annulla lentamente il possesso, lo intristisce, lo deprime. Mi colpisce il fatto che quando dico queste cose ai giovani incontro più sorpresa che obiezione».
Godimento e sessualità sembrano concetti incompatibili con la dottrina cattolica.
«Non è così. Il messaggio biblico è stato il primo storicamente parlando a far vedere la differenza sessuale in un’ottica assolutamente positiva e creativa, come dono di Dio. Ma, come in tutte le cose umane, il positivo, il bene, il vero non sono mai a buon mercato. Però senza il bello, il buono, il vero, la vita si affloscia, non ha in se energia per condurre alla pienezza del reale. Nei Libro dei Proverbi, tra le cose troppo ardue a comprendersi, l’autore considera "la via dell’uomo in una giovane donna". La donna è la figura di colei che sta all’inizio: io esco da lei quando nasco. Allora quando l’uomo e la donna si incontrano fanno al tempo stesso l’esperienza di ricominciare quel che in qualche modo già conoscevano e di dar vita a una novità. Qui c’è l’inestirpabile radice della fecondità. L’amore oggettivo non è mai un rapporto a due. Lo impariamo dalla Trinità».
Ma cosa c’entra questo con la riforma della Chiesa?
«C’entra e come! Fondamentale per la riforma della Chiesa è ritrovare testimoni credibili del bell’amore, che Cristo, con una schiera innumerevole di santi nella stragrande maggioranza anonimi, ha introdotto nella storia. Penso a tante generazioni vissute nella logica del bell’amore. Penso ai miei genitori, agli occhi con cui mio papà a novant’anni guardava mia mamma pure novantenne, moribonda, stremata da un cancro violento al rene. Penso alle coppie di anziani che quasi ogni domenica, alla fine della messa, vengono a dirmi: "Questa settimana sono cinquanta", oppure "questa settimana sono sessant’anni di matrimonio". Quale amore avrebbe custodito l’io meglio di questo legame indissolubile? Oggettivamente non c’è paragone tra la densità di un’esperienza così definitiva e il susseguirsi indefinito di una sequenza di relazioni precarie. Alla fine, sia la necessità di amare definitivamente, sia la fragilità sessuale sono segnate dal terrore della morte. Per amare veramente devo essere amato definitivamente, cioè oltre la morte; ed è quello che Gesù è venuto a fare. Se c’è un delitto che noi cristiani commettiamo è non far vedere il dono stupendo di Gesù: dare la vita per farci capire la bellezza dell’amore oggettivo ed effettivo. Esso ha sempre un carattere nuziale, inscindibile intreccio di differenza, dono di sé e fecondità. L’altro non è fuori dal mio io, l’altro mi attraversa tutti i giorni; lo stesso mio concepimento è legato a questo attraversarmi. Perciò umanizzare la sessualità attraverso la castità è una risorsa capitale per vincere la scommessa del postmoderno, per l’uomo del terzo millennio che voglia salvare la via del bell’amore, la quale ci fa godere davvero la vita». il messaggio cristiano sia portato in vasi di argilla, e quindi che uomini di Chiesa possano cadere in contraddizioni tragiche e gravissime a livello affettivo e sessuale, non inficia di per sé la proposta come tale. Ovviamente non lo dico per coprire scandali».
Come uscire dallo scandalo della pedofilia?
«Il Santo Padre, a partire dalla "Lettera ai cattolici di Irlanda", ha saputo affrontare la situazione in modo chiaro e deciso: una condanna senza mezzi termini della gravità estrema di questo peccato e di questo reato. Le parole chiave - misericordia, giustizia in leale collaborazione con le autorità civili, ed espiazione- consentono di affrontare ogni singolo caso. Il Papa non sottovaluta la corresponsabilità che ne viene ad ogni membro dell’unico corpo ecclesiale e, in particolare, del collegio episcopale. È uno scandalo che tocca l’intera Chiesa, chiamata ad una profonda penitenza e ad una riforma che non potrà non riguardare tutti i livelli della sua missione. Una cosa però mi ha colpito in questa vicenda: quelli che dovrebbero parlare, per aiutarci a capire la radice di questo male e tentare di espungerlo, stanno zitti». A chi pensa? «Agli psicologi, agli educatori, ai pedagogisti, agli uomini chiamati ad approfondire questi lati oscuri dell’io. La stampa ha denunciato il fenomeno con enfasi comprensibile, entro certi termini anche giustificabile, ma indiscutibilmente eccessiva».
Lei parla della necessità di riforma della Chiesa.
«Come il Santo Padre ci ha indicato, i casi terribili di pedofilia e le provate responsabilità di ingenua copertura o negligenza da parte delle autorità richiamano con forza alla Chiesa la sua condizione di realtà sempre in riforma. Benedetto XVI esige penitenza, andare alle radici della misericordia, cioè all’incontro personale con il Tu di Cristo, e ricorda che i nemici più pericolosi della Chiesa vengono dall’interno e non dall’esterno».
Ma in cosa dovrebbe consistere la riforma?
«Nello specifico, riscoprire il nesso tra il bell’amore e la sessualità. Mostrare che la soddisfazione piena del desiderio è ritrovare il vero volto dell’altro, soprattutto nel rapporto uomo-donna. E imparare di nuovo come la sfera della sessualità esiga di essere integrata nell’io attraverso una grande virtù purtroppo in disuso: la castità. Per riscoprirla occorre il coraggio di parlare del modo in cui noi viviamo oggi la sfera sessuale». A quale modo si riferisce? «Cito l’esempio più sofisticato. I più recenti studi della neuroscienza, come quelli di Helen Fisher, riconducono tutte le dimensioni dell’amore, compreso "l’amore romantico", a pure modificazioni neuronali del nostro cervello. Fine della libertà e della creatività anche in questo ambito? È vero che noi abbiamo bisogno di mangiare e bere, come gli animali; ma non mangiamo e beviamo come animali, anzi la cucina è diventata un’arte, un aspetto della civiltà; e questo vale a maggior ragione per la dimensione sessuale. Una pretesa riduzionistica come quella della Fisher è una variante della tentazione di concepire l’uomo come puro esperimento di se stesso. Così si crea una mentalità, un clima in cui il desiderio, l’energia della libertà che incontra la realtà, diventa privo di senso, e la dimensione sessuale assume una fisionomia quasi animalesca. Ma questo un uomo e una donna, quando sono in sé, non possono accettarlo».
Castità e sessualità sono sentite come antitesi.
«La castità tiene in ordine l’io. Eliminarla significa ridurre l’amore a mera abilità sessuale, veicolata da una sottocultura delle relazioni umane che si fonda su un grave equivoco e cioè sull’idea che nell’uomo esista un "istinto sessuale" come avviene negli animali. Non è vero, lo dimostra certa psicanalisi: anche nel nostro inconscio più profondo niente si gioca senza un coinvolgimento dell’io. Il sacrificio ed il distacco richiesti
-
> di Federico La Sala - Amore e responsabilità, e "caritas"!!! ----- Chiamati all’ amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II}, di Carl Anderson e José Granados (di Luigi Accattoli - Wojtyla, la rivoluzione del corpo)5 aprile 2010, di Federico La Sala
 Cristianesimo
Cristianesimo Due studiosi illustrano le idee di Giovanni Paolo II attraverso gli scritti e le poesie
Due studiosi illustrano le idee di Giovanni Paolo II attraverso gli scritti e le poesieWojtyla, la rivoluzione del corpo
 Nudità, tenerezza, eros: un pensiero che rivaluta la sfera sessuale
Nudità, tenerezza, eros: un pensiero che rivaluta la sfera sessuale
 Nel paradiso terrestre «Adamo ed Eva senza vestiti non provavano vergogna perché i loro occhi erano puri»
Nel paradiso terrestre «Adamo ed Eva senza vestiti non provavano vergogna perché i loro occhi erano puri»di Luigi Accattoli (Corriere della Sera, 31.03.2010).
Finalmente un libro che racconta in dettaglio la rivalutazione della corporeità operata da papa Wojtyla: Chiamati all’ amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II, di Carl Anderson e José Granados (Piemme editore, pagine 278, 17), docenti dell’ Istituto per studi su matrimonio e famiglia dell’ Università Lateranense. Nella premessa il preside dell’ Istituto Livio Melina indica la wojtyliana teologia del corpo come «uno dei doni più grandi» di quel Papa. Quella teologia - secondo Melina - «ha permesso di riscoprire la ricchezza dell’ antropologia biblica e della grande tradizione cristiana, superando visioni anguste e marginali».
Un’ attrattiva del volume è il ricorso alle poesie e ai drammi di Karol Wojtyla per aiutare il lettore a intendere i contenuti del suo magistero. Ecco i due autori alle prese con le affermazioni di papa Wojtyla sulla «nudità originaria» di Adamo ed Eva che secondo Genesi 2, 25 «erano nudi ma non ne provavano vergogna». Ci informano che per Giovanni Paolo II «quell’ assenza di vergogna non proveniva da una carenza di sviluppo psicologico» ma dipendeva «dal fatto di avere gli occhi puri», in grado di «percepire l’ immagine di Dio contenuta nel corpo umano» e dunque di «scoprire che uomo e donna, nel loro essere maschile e femminile, erano stati dati l’ uno all’ altro e nel loro reciproco donarsi completavano il viaggio fino alla fonte stessa del dono», cioè fino a Dio.
Materia ardua, come si vede. Il paragrafo è intitolato «L’ immagine di Dio nel corpo». Altri titoli provocanti: «L’ amore rivelato nel corpo», «Dio ci affida il corpo come un compito», «La bellezza dell’ amore: lo splendore del corpo». Gli autori si rendono conto che la strada è in salita. Fanno riferimento agli antichi Padri che parlavano della «carne dell’ uomo» che «Dio ha creato a sua immagine con le proprie mani» (Tertulliano), polemizzano con l’ assenza di vergogna dei «nudisti» e infine ricorrono al poemetto Trittico romano, pubblicato da papa Wojtyla nel 2003: «Per grazia di Dio ricevettero una virtù. / Presero dentro di sé - nella dimensione umana - / questo reciproco donarsi che è in Lui. / Tutti e due ignudi... / non provavano vergogna, finché permaneva questo dono. / La vergogna sopraggiungerà col peccato, / però adesso perdura l’ esaltazione. / Vivono coscienti del dono, / anche se non sanno esprimere tutto ciò. / Ma vivono di questo. Sono puri».
Gli autori sono convinti che il riscatto del corpo abbozzato da Giovanni Paolo II potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del cristianesimo nel tempo che viene. Egli ci ha trasmesso quell’ idea rileggendo la Genesi ma anche baciando le ragazze in fronte, lodando l’ audacia di rappresentare la «nudità dei progenitori» che ebbe Michelangelo, ammirando la «gioia di vivere» dei giovani.
Dietro a queste audacie c’ è la storia dei suoi rapporti durati oltre trent’ anni - da prete novello a cardinale - con le giovani coppie e le loro vicende d’ amore: «Da giovane sacerdote imparai ad amare l’ amore umano» scrive nel libro intervista con Vittorio Messori Varcare la soglia della speranza (Mondadori, 1993). Da Papa, Giovanni Paolo II parla addirittura di teologia del sesso: «La teologia del corpo (...) diventa, in certo modo, anche teologia del sesso, o piuttosto teologia della mascolinità e della femminilità» (14 novembre 1979). Una tale teologia ha il compito di «comprendere la ragione e le conseguenze della decisione del Creatore che l’ essere umano esista solo e sempre come femmina e come maschio» (Mulieris dignitatem).
Del significato teologico del corpo Giovanni Paolo II non parla una volta o due, ma per un lungo ciclo di «catechesi del mercoledì»: dall’ ottobre del 1979 all’ ottobre del 1984. A quella riflessione sulla corporeità fanno riferimento molti documenti del pontificato: l’ esortazione apostolica Familiaris consortio (1981), la Lettera ai giovani (1985), la lettera apostolica Mulieris dignitatem (1988), la Lettera alle famiglie (1994), la Lettera alle donne (1995). Teologia del corpo - nel dibattito cristiano contemporaneo - è espressione che allude a una valutazione positiva della sessualità e all’ apprezzamento della tenerezza nel rapporto di coppia. Ecco l’ affermazione più impegnativa dei due autori, interessati a «recuperare», sull’ esempio di Giovanni Paolo II, «il legame tra l’ amore e il cristianesimo», compreso l’ amore carnale e l’ eros: «Proprio perché la nostra fede consiste nella rivelazione dell’ amore, la fortuna dell’ amore è legata alla fortuna del cristianesimo».
www.luigiaccattoli.it
-
> di Federico La Sala - Fonti cattoliche a confronto, in chiave dialettico-polemica6 marzo 2006, di Federico La Sala
P.S. - Una nota
La Terra sotto i piedi - letteralmente e sempre più - cede, e ‘noi’ continuiamo imperterriti a far finta di nulla: al polo artico come al polo antartico, i ghiacciai si sciolgono a ritmo vertiginoso e ‘noi’ continuiamo a ripetere vecchi ritornelli del ‘bel tempo che fu’: “lo spirito è, questa assoluta sostanza la quale, nella perfetta libertà e indipendenza della propria opposizione, ossia di autocoscienze diverse per sé essenti, costituisce l’unità loro: Io che è Noi, e Noi che è Io” (Hegel, Fenomenologia dello Spirito). Leopardi aveva perfettamente ragione a sottolineare e a contestare: E gli uomini vollero le tenebre, piuttosto che la luce..!!! Chiuse le porte e le finestre, non ‘vogliamo’ sapere nulla e ‘continuiamo’ a cantare in coro ... e a prepararci alla guerra: Dio è amore!!! Ma cosa c’è di diverso nella “caritas” di Ratzinger-Benedetto XVI dallo spirito di Hegel: “L’amore è divino perché viene da Dio e ci unisce a Dio e, mediante questo processo unificante, ci trasforma in un Noi che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola, fino a che, alla fine, Dio sia tutto in tutti”(pf. 18)?! La Chiesa di Ratzinger come lo Stato di Hegel: “La Chiesa è la famiglia di Dio nel mondo” (pf. 25)?! Ma, dopo Auschwitz, non è meglio porsi qualche domanda?! Non sentiamo ancora nelle nostre orecchie l’urlo del “Dio lo vuole!”, “Dio è con Noi!”??! Di quale Chiesa’, di quale famiglia, di quale Dio, e di quale mondo si tratta? Di quale famiglia ?! Ma dov’ è nostra ‘madre’ e dov’è nostro ‘padre’ e dove sono i nostri ‘fratelli’ e le nostre ‘sorelle’?! Maria e Giuseppe, talvolta, si chiedevano: dov’è Gesù?! Ma’noi’, ‘noi’ che pensiamo di essere tutti e tutte figli e figlie di Maria e fratelli e sorelle di Gesù, quando ce lo chiederemo: dov’è Giuseppe, lo sposo di nostra madre e nostro padre?! E, ancora, da padri e madri, quando ci sveglieremo e ci chiederemo dove sono i nostri figli e dove sono le nostre figlie?! ... Chi?, che cosa?! Stai zitto e prega!!! Deus caritas est : questo è il ‘logo’ del ‘nostro’ tempo!!! Dormi! Continua a dormire ... fuori del tutto non c’è nulla!!! (06.03.2006) Federico La Sala
-
> di Federico La Sala - Fonti cattoliche a confronto, in chiave dialettico-polemica14 marzo 2006, di Federico La Sala
P. S.
AMORE E RESPONSABILITA’. UNA NOTA A MARGINE DI UN MATRIMONIO.
In una piccola chiesa cattolica di un piccolo comune, ai margini di Milano, in Italia, ieri, 11.03.2006, alle ore 11, è avvenuta la celebrazione del matrimonio di una coppia di giovani sposi - assolutamente inedito e straordinario! La sposa è già ‘in attesa’ - quasi all’ottavo mese di gravidanza; e gli sposi sanno già di che sesso è il nascituro e gli hanno dato già il nome. Il prete, che sa tutto (come i genitori dello sposo e della sposa), officia il rito con grande serenità e saggezza - in spirito di verità e amore. Parla agli sposi in modo chiaro e limpido - sul piano religioso e, alla fine, anche sul piano civile (del diritto di famiglia e della Costituzione Italiana). Il figlio che entrambi aspettano - dice agli sposi e a tutti i presenti - svela loro il segreto della Trinità: nel mettere al mondo un nuovo essere umano, essi comprendono che Chi li ha fatti incontrare è stato Dio, che il nome del “Padre Nostro”, di Dio è “Amore”, e che essi - tutti e due, padre e madre, sono “figli del figlio” (come Maria e Giuseppe di Gesù ... essi stessi del loro stesso figlio, e dice anche il nome del piccolo - già deciso dai genitori - che a breve nascerà). Essi, gli sposi (secondo il nuovo rito) sono i “sacerdoti” del loro stesso matrimonio e li invita a scambiarsi gli anelli - lo sposo: “io accolgo te”, la sposa: “io accolgo te”..... In alto, dietro l’altare, la luce del sole illumina la vetrata ... e la colomba dello Spirito Santo, del “Padre nostro”! Si esce, il vento soffia ... che porti un pò di questo spirito di questa piccola nuova chiesa e del suo modesto e saggissimo sacerdote (nella predica ha parlato dei suoi genitori - del loro grande amore, della loro differenza di età, dei suoi cinque fratelli, ecc.) nella Basilica di S. Pietro!!! Che tutti e tutte - figli e figlie, padri e madri, .... laici e religiosi, ricordino e riprendano la lezione di Matteo (Mt., 23. 9): non chiamate nessuno “Padre” sulla Terra. Chi lo sa?! Da Milano, di nuovo, forse, per l’Italia e la Chiesa, il cristianesimo e la democrazia, l’indicazione di un nuovo cammino - non all’indietro, ma in avanti, al di là di Costantino e del IV secolo! (12.03.2006)
Federico La Sala
-
> di Federico La Sala - Fonti cattoliche a confronto, in chiave dialettico-polemica ---- Riconciliare eros e libertà (di Margherita Pelaja e Lucetta Scaraffia).17 settembre 2008, di Federico La Sala
anticipazione
L’accusa è di quelle che pesano e attribuisce alla Chiesa un pensiero «antimoderno» sulla sessualità. Due studiose, una laica e l’altra credente, smontano il luogo comune
Riconciliare eros e libertà
Non si tratta di emancipazione o di oscurantismo. Il clima oggi è più favorevole a un confronto tra etica laica e religiosa che veda nell’atto sessuale un nuovo incontro fra anima e corpo
DI MARGHERITA PELAJA E LUCETTA SCARAFFIA (Avvenire, 17.09.2008) *
Quasi tutte le culture hanno fatto ricorso alla religione per governare la sessualità e conferirle un senso simbolico. La sessualità si presenta agli esseri umani come contraddittoria: da un lato potente origine della vita, dall’altro forza oscura che si impadronisce dell’uomo, gli fa perdere la padronanza di sé, e quindi deve essere domata. L’impeto della passione infatti può minacciare la debole coerenza dell’io: le religioni forniscono i mezzi più efficaci per salvaguardare la sua integrità e controllare la violenza degli istinti. Le più antiche attitudini umane nei confronti della sessualità sono state la divinizzazione e la sacralizzazione, entrambe espressioni della percezione dell’amplesso come di una esperienza superiore, divina, per l’energia del desiderio e l’estasi del piacere, per la partecipazione al potere fecondatore.
Il monoteismo, stabilendo la trascendenza del sacro, implica la desacralizzazione delle potenze vitali e sessuali. Il cristianesimo si differenzia tuttavia dagli altri monoteismi a causa dell’Incarnazione, e inaugura così un nuovo modo di dare senso spirituale, all’atto sessuale. Dio che si è fatto carne, i corpi che resuscitano, i corpi visti come tempio dello Spirito Santo conducono infatti a una complessità nuova del rapporto con la carne, che diventa essa stessa parte e strumento del cammino spirituale che ogni cristiano deve compiere. Per la cultura cristiana, il desiderio dell’altro fa parte della dimensione corporea, ed è quindi positivo, perché in essa si rispecchia la volontà di Dio. Il comportamento sessuale diventa allora un altro percorso dell’evoluzione spirituale, sia nella via ascetica, sia in quella matrimoniale: e in tale percorso si intrecciano naturalmente carne e spirito, sentimenti ed eros.
Ma la posizione attuale della Chiesa nei confronti della sessualità è veramente oppressiva e «antimoderna»? Abbiamo voluto consapevolmente sfuggire all’atteggiamento che Odo Marquard individua come specifico dell’epoca moderna, cioè la trasformazione della storia in un tribunale al quale «l’uomo sfugge solo identificandosi con esso». Abbiamo preferito non diventare un tribunale, né due tribunali in confronto fra loro, ma invece ricostruire il processo storico che ha portato fino alla situazione attuale sia la Chiesa sia i suoi critici. Nel ricorso alla storia che giudica infatti, abbiamo colto quello che si può considerare un luogo comune tipico della modernità: quello che fa sì che colui che accusa «assumendo monopolio dell’accusa biasima, quanto al male nel mondo, gli altri uomini in quanto riluttanti all’emancipazio- ne, in quanto cattivi uomini creatori, e li condanna immediatamente a diventare passato».
La concezione rivoluzionaria dell’atto sessuale proposta dal cristianesimo delle origini e poi approfondita e articolata dalla Chiesa è stata considerata negli ultimi secoli obsoleta e dannosa: le scienze moderne - medici, antropologi, poi sessuologi - hanno elaborato una categoria astratta, quella di sessualità,da studiare come fenomeno a parte, e da disciplinare secondo criteri generali, che si sarebbero voluti scientifici ma che spesso sono diventati ideologici. A tali criteri si sarebbe dovuto conformare il comportamento dei singoli, magari con il sostegno e il consiglio degli «esperti».
Per lunghissimi secoli, la visione cattolica ha inserito invece il comportamento sessuale all’interno del cammino personale di purificazione e di santificazione che è compito di ogni cristiano, in quel fragile equilibrio tra corpo e anima che è costitutivo di una tradizione religiosa fondata sull’Incarnazione; ma anche all’interno di un sistema morale globale, costruito sugli enunciati generali del peccato e della sua condanna, e sulla distinzione del lecito dall’illecito. Almeno fino alla metà del Novecento queste due impostazioni non potevano comunicare fra di loro, perché erano per molti aspetti incommensurabili.
Sarà solo quando la Chiesa - a partire dall’Humanae vitae, per proseguire più decisamente con la nuova proposta teorica di Wojtyla - comincia ad affrontare in termini astratti il problema del comportamento sessuale, che lo scontro si trasferirà su un terreno comune. Solo allora cioè diventerà chiaro che non si tratta semplicemente di una dialettica fra libertà e oppressione, tra emancipazione e oscurantismo, ma del conflitto fra due diverse concezioni di sessualità: l’una, quella laica, che colloca anche l’atto sessuale nella sfera della libertà individuale, l’altra, quella cattolica, che lo giudica e lo definisce come momento importante del percorso spirituale di ogni credente, un incontro fra anima e corpo che non si può sottrarre al rispetto delle regole religiose. L’una basata su un’analisi scientifica della sessualità e sull’autonomia del soggetto intesa come valore dominante, l’altra fondata sulla costituzione dell’individuo come soggetto morale in un sistema di norme definite. Per dirlo con le parole di Foucault, «il compito di mettersi alla prova, di analizzarsi, di controllarsi di una serie di esercizi ben definiti pone la questione della verità - di ciò che si è, di ciò che si fa e di ciò che si è capaci di fare - nel cuore della costituzione del soggetto morale».
Oggi - paradossalmente, vista l’asprezza del dibattito politico-ideologico - è possibile forse un approccio meno conflittuale al problema, almeno dal punto di vista teorico. La differenza fra le due concezioni non costituisce più un momento bruciante di scontro nelle società occidentali, come è stato almeno fino alla metà del Novecento: nei paesi «avanzati » sembra aver prevalso, nella mentalità comune, la proposta laica, ma questa nello stesso tempo è stata sottoposta a critiche da diversi punti di vista - quello femminile, ma anche quello di intellettuali laici come Marcel Gauchet - senza che ciò abbia comportato l’adesione alla visione cattolica, come sarebbe accaduto quando i due schieramenti si fronteggiavano polarizzati. Mentre sono caduti alcuni orpelli ideologici, e soprattutto l’illusione che la libertà sessuale costituisca di per sé una condizione fondamentale per la felicità individuale, altre categorie hanno subito slittamenti di collocazione e di significato: la natura, ad esempio, invocata dai teorici della rivoluzione sessuale come garante di una sessualità finalmente libera da condizionamenti sociali e religiosi, è diventata richiamo severo della Chiesa e un ordine immutabile nella procreazione; la sfera privata, difesa dai modernizzatori laici come ambito intoccabile di scelta individuale, appare prosciugata di senso e di valori, e sembra respingere soprattutto le donne in antiche solitudini, nel rapporto con il proprio corpo e con il proprio desiderio, nella scelta di maternità. È tempo, forse, che il comportamento sessuale torni a essere problema collettivo.
*
IL LIBRO
Oltre il cattivo stereotipo della sessuofobia cattolica
Il luogo comune è solido: per il cattolicesimo il piacere è colpa, il sesso peccato. Da praticare con parsimonia e disagio esclusivamente nel matrimonio e principalmente per procreare. Alcuni enunciati si ripetono nel corso del tempo nella predicazione cattolica fino a rendere possibile una sintesi così brutale. Ma sensibilità più libere, analisi circostanziate dei testi e delle politiche possono di volta in volta articolare, smentire, fino a sgretolare il potenziale conoscitivo di un assunto così generico. È quel che intende mostrare il libro «Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia» scritto da due studiose - una laica e l’altra cattolica, Margherita Pelaja e Lucetta Scaraffia - che esce oggi da Laterza (pagine 322, euro 18) e dal quale anticipiamo un brano.
La loro indagine rivela come il tentativo di unire lo spirito alla carne, e quindi valorizzare spiritualmente la sessualità, segni potentemente periodi e figure della storia della Chiesa - basti pensare al «Cantico dei Cantici» - mentre una politica della sessualità che alterna repressione e clemenza scorre parallela e agisce da efficace sistema di governo delle anime dei fedeli. La soluzione è sofisticata e funziona per secoli, finché non viene erosa dal primato della scienza che sembra dominare la modernità.
-
-
> di Federico La Sala - Fonti cattoliche a confronto, in chiave dialettico-polemica14 marzo 2006, di Federico La Sala
P. S.
AMORE E RESPONSABILITA’, AL DI LA’ DELL’ “EDIPO”.
La ‘lezione’ di un matrimonio.
di Federico La Sala
In una piccola chiesa cattolica di un piccolo comune, ai margini di Milano, in Italia, ieri, 11.03.2006, alle ore 11, è avvenuta la celebrazione del matrimonio di una coppia di giovani sposi - assolutamente inedito e straordinario! La sposa è già ‘in attesa’ - quasi all’ottavo mese di gravidanza; e gli sposi sanno già di che sesso è il nascituro e gli hanno dato già il nome. Il prete, che sa tutto (come i genitori dello sposo e della sposa), officia il rito con grande serenità e saggezza - in spirito di verità e amore. Parla agli sposi in modo chiaro e limpido - sul piano religioso e, alla fine, anche sul piano civile (del diritto di famiglia e della Costituzione Italiana). Il figlio che entrambi aspettano - dice agli sposi e a tutti i presenti - svela loro il segreto della Trinità: nel mettere al mondo un nuovo essere umano, essi comprendono che Chi li ha fatti incontrare è stato Dio, che il nome del “Padre Nostro”, di Dio, è “Amore”, e che essi - tutti e due, padre e madre, sono “figli del figlio” (come Maria e Giuseppe di Gesù ... essi stessi del loro stesso figlio, e dice anche il nome del piccolo - già deciso dai genitori - che a breve nascerà). Essi, gli sposi (secondo il nuovo rito) sono i “sacerdoti” del loro stesso matrimonio e li invita a scambiarsi gli anelli - lo sposo: “io accolgo te”, la sposa: “io accolgo te”..... In alto, dietro l’altare, la luce del sole illumina la vetrata ... e la colomba dello Spirito Santo, del “Padre nostro”! Si esce, il vento soffia ... che porti un pò di questo spirito di questa piccola nuova chiesa e del suo modesto e saggissimo sacerdote (nella predica ha parlato dei suoi genitori - del loro grande amore, della loro differenza di età, dei suoi cinque fratelli, ecc.) nella Basilica di S. Pietro!!! Che tutti e tutte - figli e figlie, padri e madri, .... laici e religiosi, ricordino e riprendano la lezione di Matteo (Mt., 23. 9): non chiamate nessuno “Padre” sulla Terra. Chi lo sa?! Da Milano, di nuovo, forse, per l’Italia e la Chiesa, il cristianesimo e la democrazia, l’indicazione di un nuovo cammino - non all’indietro, ma in avanti, al di là di Costantino e del IV secolo! (12.03.2006)
Federico La Sala
-
> di Federico La Sala - Fonti cattoliche a confronto, in chiave dialettico-polemica - Ebrei e cristiani, una disputa (e un mistero) in famiglia (di Vittorio Messori).19 gennaio 2010, di Federico La Sala
Ebrei e cristiani, una disputa (e un mistero) in famiglia
di Vittorio Messori (Corriere della Sera, 19 gennaio 2010)
In questi giorni, torrenti di parole per la visita di Benedetto XVI alla Sinagoga romana, eretta là dove sorgeva il ghetto e orientata in modo da fronteggiare, quasi a sfida, la basilica, la più grande del mondo, che copre il sepolcro di un tal Simone. Un pio giudeo, costui, un oscuro pescatore sul lago di Tiberiade, rinominato Kefas, Pietro, da un certo Gesù, colui che, storicamente, altro non è se non un predicatore ambulante ebraico dell’epoca del Secondo Tempio, uno dei tanti che si dissero il Messia atteso da Israele.
Il solito esaltato, all’apparenza (e tale apparve a un burocrate di Benevento, della famiglia dei Ponzi, chiamato controvoglia a giudicarlo), un visionario. Punita con la più vergognosa delle morti, quella riservata agli schiavi. Un illuso di cui si sarebbe perso il ricordo se i suoi discepoli- tutti circoncisi e fedeli alla Torah- non avessero cominciato a proclamare, con una testardaggine intrepida, che quel rabbì finito in malo modo era risorto ed era davvero l’Unto annunciato dai profeti.
Quel gruppetto di ebrei riuscì a convincere altri ebrei, prima a Gerusalemme e poi nelle sinagoghe dell’emigrazione, dove si recarono ad annunciare che l’attesa millenaria di Israele aveva avuto compimento. La messe maggiore tra i correligionari la fece un credente entusiasta, un altro figlio di Abramo, un Saulo detto Paolo che, perché le cose fossero chiare, precisava subito ai correligionari di essere «circonciso l’ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei». Anch’egli, come Pietro, finì ucciso dai pagani a Roma e anche sul suo sepolcro fu costruita una gigantesca basilica. Se da tutta l’Europa, per tutto il Medio Evo, folle di pellegrini convennero salmodianti e penitenti sul Tevere, è proprio per venerare la sepoltura di quelle due «colonne della fede»: entrambe, costituite da giudei sino al midollo.
A lungo, i pagani non si preoccuparono di distinguere, dividendo sbrigativamente gli ebrei in due gruppi, quelli che alla loro fede aggiungevano questo esotico Cristo e quelli che lo rifiutavano: noiose dispute, querelles teologiche viste tante volte all’interno di ogni religione.
Benedetto XVI, leggo in una cronaca, aveva con sé una piccola Bibbia che ha posato sul sedile dell’auto, scendendo davanti alla sinagoga. Ebbene, tra i 73 libri che compongono quel Testo su cui si fonda la fede della Chiesa solo Luca e, forse, Marco non sono figli di Israele. Tanto che si preferisce oggi sostituire l’indicazione di «Antico» e «Nuovo» Testamento con quella di «Primo» e «Secondo» Testamento, per sottolineare la continuità e l’omogeneità del messaggio. Perché ricordiamo tutto questo, e molto altro ancora che potremmo allegare? Ma perché numerosi commentatori, anche in questi giorni, sembrano dimenticare che, qui, vi è una storia in famiglia e, al contempo, un mistero religioso.
È una storia di fede, e di fede soltanto: il «laico» può soltanto intravederne, e spesso in modo fuorviante, i contorni esterni. È un confronto tra figli di Abramo, sia per nascita che per adozione. E anche questo aspetto familiare ne spiega le asprezze, non unicamente da una parte: gli Atti degli Apostoli e le lettere di Paolo mostrano quanto dura sia stata la reazione del giudaismo ufficiale nei confronti degli «eretici». Ma chi ignora che i contrasti più aspri sono proprio quelli tra parenti stretti, che le guerre più temibili sono quelle civili? Fratelli, coltelli. Il cristianesimo è da duemila anni la fede in un Messia di Israele annunciato e atteso nei duemila anni precedenti da quello stesso Israele che poi in parte- ma solo in parte- non lo ha riconosciuto.
Per l’ennesima volta, molte delle analisi e opinioni di questi giorni non sembrano consapevoli che qui siamo al di là delle categorie della storia, della politica, della cultura. I rapporti interni al giudeo-cristianesimo non sono un «problema» affrontabile con le consuete categorie: sono, lo dicevamo, un Mistero. Parola di Saulo-Paolo, e proprio ai Romani: «Non voglio, infatti, che ignoriate questo Mistero, perché non siate presuntuosi: l’indurimento di una parte d’Israele è in atto fino a quando saranno entrate tutte le genti. Allora, tutto Israele sarà salvato, come sta scritto». In ogni caso, anche gli «induriti», sono «amati a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili».
Del tutto insufficienti, qui, le sapienze di politologi e intellettuali che non siano consapevoli che il confronto tra ebrei e cristiani appartiene non alla storia, ma alla teologia della storia. Solvitur in Excelsis: qui vi è un enigma, troppo spesso doloroso, che trova spiegazione solo nei Cieli, per dirla con quel grande filosofo e insieme grande cristiano che fu Jean Guitton.
-
