
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. Sul tema, la prefazione di Fulvio Papi e parte della premessa del lavoro di Federico La Sala
- TONDO DONI. Attenzione: nella cornice "raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti" (Galleria degli Uffizi)? Ma, per Michelangelo, non sono due profeti e due sibille?!
- [...] La pittura disegna l’ eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale che colloca la filosofia e la teologia pagana in sequenza con il Cristianesimo. Ne deriva un’immagine del mondo come presenza divina nella quale abita l’uomo cóme unità di corpo e anima.
 Tuttavia questa grande sinfonia della sacralità del mondo conduce con sé l’esclusione della donna dal sacro: essa può essere solo portatrice di sacralità. Questa esclusione limita la tradizione e riapre
la domanda filosofica con l’estremo Kant della Logica: che cosa è l’uomo? Rispondere a questa domanda, interpretando quello che vuole dire l’autore, significa sottrarci alla nóstra carenza
di futuro. Concetto, merce, e definizione della vita sono tre linee che consumano un’unica perdita fatale [...]
Tuttavia questa grande sinfonia della sacralità del mondo conduce con sé l’esclusione della donna dal sacro: essa può essere solo portatrice di sacralità. Questa esclusione limita la tradizione e riapre
la domanda filosofica con l’estremo Kant della Logica: che cosa è l’uomo? Rispondere a questa domanda, interpretando quello che vuole dire l’autore, significa sottrarci alla nóstra carenza
di futuro. Concetto, merce, e definizione della vita sono tre linee che consumano un’unica perdita fatale [...]
- In fondo, in pdf, un pieghevole sulla Chiesa del Carmine di Contursi Terme (Salerno).
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- PIANETA TERRA TRAGEDIA E APOLLO 11. Il "nodo di Ercole", il rapporto caverna-Socrate, ancora non sciolto. Con Neil Armstrong e Buzz Aldrin "abbiamo" messo piede sulla Luna, ma sulla Terra "le regole del gioco" sono quelle di una "polis" edipica cosmoteandrica-mente organizzata.

Federico La Sala,
DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Note sul "Poema" rinascimentale di un ignoto Parmenide carmelitano (ritrovato a Contursi Terme nel 1989),
Prefazione di Fulvio Papi,
Edizioni Ripostes, Salerno-Roma 1996
SCHEMA NARRATIVO DELLE IMMAGINI, ALL’INTERNO DELLA CHIESA DI MARIA SS. DEL CARMINE - CONTURSI TERME (SALERNO):
Entrando, e avanzando verso l’altare
 a Sx:
a Sx:
1. Sibilla PERSICA, 2. Sibilla LIBICA, 3. Sibilla DELFICA, 4. Sibilla CUMEA [CHIMICA], 5. Sibilla ERITREA, 6. Sibilla [SAMIA]
 a Dx:
a Dx:
12. Sibilla EGIPTIA, 11. Sibilla E[V]ROPEA, 10. Sibilla TIBURTINA, 9. Sibilla FRIGGIA, 8. Sibilla LESPONTICA, 7 Sibilla CUMANA
In alto, dietro e sopra l’altare, una Pala del 1608 di Jacopo de Antora, con - sotto a sx, - il Profeta Elia, - e a dx, il profeta Giovanni Battista, in alto, sulla nuvola, - Maria con il Bambino, e alle loro spalle, - le colline del Carmelo, con chiese e grotte. Nella cupola dell’abside, infine, il Paradiso, realizzato dai pittori Innocenzo Gentile e Carmine de Matina.
PREFAZIONE
di Fulvio Papi
Con una immagine non inappropriata, si potrebbe dire che questo libro è una breve composizione sinfonica dove l’autore preleva temi dalla tradizione musicale che orchestra come preludi indispensabili all’apparizione del proprio tema. Nella dimensione letteraria si può dire che è un libro di citazioni dove anche la scrittura dell’autore vi compare come citazione che, più che dire, annuncia. L’insieme, ovviamente, non ha 1e tracce dell’esposizione legale e paterna, ma cerca la risonanza e la suggestione che il lettore deve accogliere come parola che tenta quasi una religiosa seduzione. Tutto questo è conseguenza coerente di una delle possibili strade che si possono prendere dopo il sospetto intorno alle architetture filosofiche che rappresentano con la spada tagliente del concetto una qualsiasi forma dell’essere.
Nel caso di La Sala il pensiero (e questo è il tema saliente del suo lavoro precedente, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica [Antonio Pellicani Editore, Roma 1991]), non deve istituire il giudizio come conseguenza della trasfigurazione simbolica del mondo, ma accogliere nel profondo 1a dimensione terrestre e sensibile della vita. Una voce, avevo pensato leggendo quel libro, che viene da un Nietzsche senza la volontà di potenza, declinato su quel "femminile" che è stato uno degli elementi di riflessione su un "vuoto" strutturale della nostra tradizione.
E ora, in breve, qualche cenno sul nuovo viaggio testuale. Il luogo di inizio è nella chiesetta di S. Maria del Carmine, a Contursi, dove, a causa di recenti restauri, viene scoperto un poema pittorico (tempera su muro) di un ignoto carmelitano dell’inizio del ‘600. Il testo raffigura le Sibille che annunciano al mondo pagano la prossima nascita del cristianesimo.
Le Sibille di Contursi hanno parentele più celebri nella Cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel Tempio Malatestiano di Rimini, nella Cappella Sistina di Michelangelo. La pittura disegna l’ eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale che colloca la filosofia e la teologia pagana in sequenza con il Cristianesimo. Ne deriva un’immagine del mondo come presenza divina nella quale abita l’uomo come unità di corpo e anima.
Tuttavia questa grande sinfonia della sacralità del mondo conduce con sé l’esclusione della donna dal sacro: essa può essere solo portatrice di sacralità. Questa esclusione limita la tradizione e riapre la domanda filosofica con l’estremo Kant della Logica: che cosa è l’uomo? Rispondere a questa domanda, interpretando quello che vuole dire l’autore, significa sottrarci alla nóstra carenza di futuro. Concetto, merce, e definizione della vita sono tre linee che consumano un’unica perdita fatale.
La Sala, con una mossa certamente ad effetto e piena di provocazione, dice: "guardiamo il nostro ombelico", rîconosciamoci come figli di una maternità e di una paternità che siano la terra del nostro fiorire non i luoghi delle nostre scissioni. La Sala pensa in termini di speranza e di salvezza e di uomo e donna: non sono sentieri miei. E questo dovrebbe testimoniare proprio alla attenta considerazione del lavoro che deriva dall’essere trasportato senza riserve da un testo, per così dire, in piena.
Fulvio Papi
Professore ordinario di Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Pavia.
PARTE INIZIALE DELLA "PREMESSA" DELL’AUTORE:
Nel 1608, in piena bufera controriformistica, pochi anni prima che in tutta Europa divampassero le guerre di religione e che il filologo Isaac Casaubon (De rebus sacris et eccleslasticis exercitatíones XVI. Ad Cardinalis Baronii prolegomena in Annales, Londra 1614) demolisse “in un sol colpo la costruzione del neoplatonismo rinascimentale con alla base il culto dei prisci teologi principale dei quali era Ermete Trismegisto; [...] la posizione del mago e della magia rinascimentali con il relativo fondamento ermetico- cabalistico; [...] il movimento ermetico cristiano non magico del XVI secolo; [...] la posizione di un ermetico estremista, quale era stato Giordano Bruno; [...] tutti i tentativi di costruire una teologia naturale sull’ermetismo, come quello in cui Campanella aveva riposto le sue speranze”, un ignoto teologo e filosofo carmelitano rimedita nelle linee essenziali il problema e la lezione di Niccolò Cusano, di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola e, con l’aiuto di modesti artisti, a Contursi - in provincia di Salerno, nella chiesetta di Maria SS. del Carmine (monastero di padri carmelitani dal 1561 al 1652), scrive il suo poema sulla nascita e sulla pace fidei.
Lo schema della narrazione è lineare e semplicissimo - si parla di un viaggio in cui profetesse pagane (12 Sibille) e profeti ebraici (Elia e Giovanni Battista) mostrano la strada all"iniziato" e lo conducono da Maria, madre di Gesù Cristo, da cui rinasce come figlio e, come Cristo, accede al Regno Celeste - ma le questioni che esso solleva vanno ben al di là del suo tempo e gettano una nuova luce su problemi decisivi del nostro passato come del nostro stesso presente.
Infatti il poema del teologo-filosofo carmelitano presenta una significativa corrispondenza con il viaggio descritto da Parmenide nella sua opera (il cammino all’iniziato è mostrato dalle Figlie del sole e la destinazione è l’incontro con la Dea Giustizia che gli rivela la verità [...]
*Cfr. Federico La Sala, DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Note sul "Poema" rinascimentale di un ignoto Parmenide carmelitano (ritrovato a Contursi Terme nel 1989), cit., p. 9.
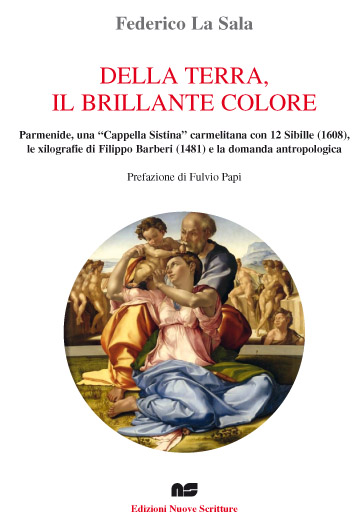
Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- "Nella Prima Giornata della Passione di Revello(1481), dopo le profezie dei profeti e delle sibille sulla nascita di Cristo, la sibilla Tiburtina giunge presso l’imperatore": si cfr. "Il piede di Ottaviano e la circolazione di un gesto tra il XIV e il XVII secolo" (di Nerida Newbigin);
- "La recente edizione critica della Passione di Revello presenta, [...] i « Vaticinia Sibillarum de ortu et morte Christi» [...]: "La raffigurazione delle Sibille nel Saluzzese e nelle zone circostanti" (di Marco Piccat).
- RINASCIMENTO. "I tre giardini nella scena paradisiaca del De hominis dignitate di Pico della Mirandola" (Pier Cesare Bori,Annali di storia dell’esegesi 13.2,1996.)
- TONDO DONI. Attenzione: nella cornice "raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti" (Galleria degli Uffizi)? Ma, per Michelangelo, non sono due profeti e due sibille?!
- Cappella Sistina-Volta: Sibille e Profeti (Musei Vaticani)
- MICHELANGELO, IL SERPENTE DI BRONZO, Cappella Sistina - Volta.
- CAPPELLA SISTINA (Wikipedia)
- PIANETA TERRA TRAGEDIA E APOLLO 11. Il "nodo di Ercole", il rapporto caverna-Socrate, ancora non sciolto. Con Neil Armstrong e Buzz Aldrin "abbiamo" messo piede sulla Luna, ma sulla Terra "le regole del gioco" sono quelle di una "polis" edipica cosmoteandrica-mente organizzata.
 Recensione di tre saggi di Federico La Sala:
Recensione di tre saggi di Federico La Sala:
 Metaphysical trilogy. Riccardo Pozzo reviews an Italian philosopher’s attempt to write a radical criticism of metaphysics (2004).
Metaphysical trilogy. Riccardo Pozzo reviews an Italian philosopher’s attempt to write a radical criticism of metaphysics (2004).
- PESSOAS IN MADRID. Rui Gomes da Silva, príncipe de Éboli.
- "L’uso della Cappella Reale nel periodo barocco: devozione o giustificazione politica?" (di Esther Jiménez Pablo).
- Trittico di Mérode (1427): L’annunciazione (Adoratrici).
- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).
- CHRISTUS DOMINUS: "PROEMIO. 1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per salvare il suo popolo dai peccati (1) e per santificare tutti gli uomini; com’egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli (2) e li santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l’edificazione del suo corpo » (Ef 4,12), che è la Chiesa.
- Il papa e i vescovi perpetuano l’opera di Cristo
- 2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese [...]" (PAOLO VI,"VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO A PERPETUA MEMORIA", "DECRETO SULLA MISSIONE PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA", 28 ottobre 1965 - senza le note).
- ANTONIO ROSMINI, "SE NEGLI ORACOLI SIBILLINI CI FURONO DELLE VERITIERE PROFEZIE SU CRISTO" (Patricia Salomoni, "Rosmini e le Sibille", ROSMINI STUDIES, 6, 2019
- Riflessioni comparative: la Sibilla come frontiera letteraria dell’identità dei popoli di (Elena Santilli - "Altre Modernità" -UNIMI, 02/2018).
Federico La Sala
|
LE 21 DONNE DELLA COSTITUENTE |
SISTINA (ROMA - CONTURSI T.)
RIPENSARE IL PROBLEMA "EDIPO" (Attilio Mangano - "Il Ponte", 1997),
Forum
-
>LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE --- LA MEMORIA DELLA "MADONNA DEL CARMINE" E LE "INDICAZIONI" DI MICHELANGELO E DI TERESA D’AVILA.17 luglio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT, 1724-2024), #STORIA, E #TEOLOGIA:
"N. S. MONTE #CARMELO", "MADONNA DEL #CARMINE, #16LUGLIO. Un filo di memoria e di tradizione culturale europea e mediterranea, carico di teoria, che tocca nel profondo la #questione antropologica dell’attuale #presentestorico , e richiama l’eccezionale intervento "critico" e "cristico" di #TeresadAvila (1515-1582) e, al contempo, dell’opera del filosofo e teologo Jakob #Boehme (Jacob #Böhme, 1575-1624).
I CARMELITANI SCALZI NEL REGNO DI NAPOLI (VICEREAME SPAGNOLO) E L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’#ECUMENISMO RINASCIMENTALE. Nel mio paese d’origine (#ContursiTerme, #Salerno), nella "vecchia" Chiesa della #MadonnadelCarmine, dedicata con i #CarmelitaniScalzi alla B.V. del Monte Carmelo (nel 1613), con una pala d’altare del 1608 (v. allegato), sono riemerse dopo il #terremoto del 1980 e il restauro completato nel 1989), le figure di 12 #Sibille (un richiamo forte ed esplicito alla lezione umanistico-rinascimentale, e a #Michelangelo #Buonarroti e alla sua "Sacra Famiglia" - il #TondoDoni).
NOTE:
- ANTROPOLOGIA, ARTE, STORIA, E FILOLOGIA. RICORDANDO IL TONDO DONI ("LA SACRA FAMIGLIA") DI #MICHELANGELO, ACCOGLIERE LA SOLLECITAZIONE DI #TERESA D’AVILA A RESTITUIRE ONORE E #GLORIA A SAN GIUSEPPE.
- TEATRO, METATEATRO, E FILOLOGIA. Amleto: "Oh! La mia anima profetica! Mio zio?" (#Shakespeare, "#Hamlet", I.5). Per duemila e più anni in un #letargo profondissimo, da #preistoria, incapaci di distinguere tra il Figlio di "Dio" ("#Charitas", "#Xapitas") e il Figlio di "Mammona" ("#Caritas").
- Arte, Antropologia, e "Dotta Ignoranza": "L’ interpretazionedeisogni" (1899) e il "Disagio della civiltà" (S. Freud, 1929). Se è vero, come è vero che ogni essere umano nasce da "Maria e Giuseppe", il discorso e la riflessione sulla figura di san Giuseppe ("de domo David") non può non essere "biblica" (richiama infatti l’interprete dei sogni del Faraone, "Giuseppe e i suoi fratelli", di cui si è occupato anche Thomas Mann). In generale, non è possibile pensare che, pur di non seguire #Giuditta e tagliare la testa a #Oloferne e #Davide a #Golia, e, fare chiarezza sulla #hamletica #questione antropologica (e cristologica), la tradizionale chiesa costantiniana (#Nicea, 325-2025) ha difficoltà a celebrare la figura di san Giuseppe in tutta la sua gloria (di "patrono"), di diritto (secondo la legge), e di fatto (secondo la natura), accogliendo l’indicazione e la lezione del #presepe di #Francesco di #Assisi e di #DanteAlighieri che, già con il Galileo e prima di #Galileo Galilei, pensarono a "Maria e Giuseppe" come a "#Due Soli" terrestri che sono mossi dall’#amore "che move il sole e le altre stelle"?!
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- RINASCIMENTO ELETTRONICO: A BILL VIOLA (New York, 25 gennaio 1951 - Long Beach, 12 luglio 2024), IN MEMORIA.13 luglio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, STORIA, ARTE, E RINASCIMENTO:
A BILL VIOLA (New York, 25 gennaio 1951 - Long Beach, 12 luglio 2024), IN MEMORIA.
Alcuni appunti...
A). MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). DOPO 500 ANNI E PIù, LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA #CAPPELLASISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
B). "RINASCIMENTO ELETTRONICO" (Palazzo Strozzi, 10 marzo-23 luglio 2017"): "The #Greeting di #BillViola e la "Visitazione" del #Pontormo - Capolavori a confronto, di Arturo #Galansino (In occasione della mostra "#Bill Viola. Rinascimento elettronico").
C). Bill Viola.
Nota:
- ANTROPOLOGIA, ARTE, #STORIA, E VIDEOARTE: BILL VIOLA. "È morto Bill Viola. Il gigante della videoarte aveva solo 73 anni. L’Alzheimer si porta via uno dei più grandi nomi dell’arte contemporanea del dopoguerra a livello globale. Per oltre 50 anni i suoi ambienti visionari hanno aperto a una riflessione radicale sulla vita, e sulla morte [...]" (di Giulia Giaume, ARTRIBUNE, 13/O9/2024):
- "[...] Tra i più importanti nomi dell’arte contemporanea al mondo, Viola ha realizzato in 50 anni di carriera installazioni e ambienti visionari, tra video immersivi e paesaggi sonori, concentrandosi sulle esperienze umane fondamentali: la nascita, la coscienza, la morte. Sviluppando così una riflessione che - con la guida costante dei grandi nomi della storia dell’arte, in primis Michelangelo - ha accompagnato il suo pubblico in una riscoperta [...]".
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- ANTROPOLOGIA E STORIA. RIPRENDERE IL FILO DALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN MEDICINA: ANATOMIA E COSTITUZIONE DEGLI UOMINI E DELLE DONNE.21 giugno 2024, di Federico La Sala
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO, E LA FILOSOFIA. UNA NOTA PER NON PERDERE DEFINITIVAMENTE LA BUSSOLA TRA I VARI CATTOLICISMI (ATEI E DEVOTI) E PER "ORIENTARSI NEL PENSIERO", SULLA #HAMLETICA #QUESTIONE ANTROPOLOGICA (#KANT, 1800).
IN VIAGGIO CON #ULISSE: "CONSIDERATE LA VOSTRA SEMENZA" (INF. XXVI, 118), "COME NASCONO I BAMBINI"?
- L’ IMMAGINARIO "METAFISICO" DEL #CATTOLICESIMO-"ROMANO": "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
L’ALLEANZA DI #FUOCO, L’AMORE, E LA "DIVINA COMMEDIA": UN SEGNAVIA PER USCIRE DALLA "PREISTORIA"! UNA NUOVA #ANTROPOLOGIA E UNA NUOVA TEOLOGIA-POLITICA: "#MARIA" E "#GIUSEPPE" UGUALI DAVANTI A "DIO" (#AGAPE, #CHARITAS). RIPARTIRE DAL "#PRESEPE" (#FRANCESCO DI #ASSISI, 1223).
 L’AMORE DI "#DUE SOLI" (#DANTEALIGHIERI) E IL
BAMBINO: "ECCE #HOMO" (#CRISTOLOGIA).
L’AMORE DI "#DUE SOLI" (#DANTEALIGHIERI) E IL
BAMBINO: "ECCE #HOMO" (#CRISTOLOGIA).NOTE:
- RIPRENDERE IL FILO DALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN MEDICINA (REALDO COLOMBO, ANDREA CESALPINO, JUAN AMUSCO DE VALVERDE): ANATOMIA E COSTITUZIONE DEGLI UOMINI E DELLE DONNE.
 L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap. 15 del Libro III dell’ Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli della Donna” (p. 91).
L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap. 15 del Libro III dell’ Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli della Donna” (p. 91).
- STORIA, FILOSOFIA, E STORIOGRAFIA. DOPO COPERNICO (1543), IL CAMMINO DELL’#ANTROPOLOGIA VA VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE. COME AVEVA INTUITO NIETZSCHE (CHE SAPEVA DI GRECO), "DA COPERNICO IN POI L’UOMO ROTOLA DAL CENTRO VERSO UNA X", VERSO UN "ALTRO" UOMO, VERSO UN "OLTRE-UOMO" (1886), MA I FILOSOFI E LE FILOSOFE (che non sanno più né di greco né di latino) non pensano affatto che si vada verso il "Xmas" (il "#Christmas", il "#Natale"), che chiarisce finalmente "Chi" ("X") siamo, e non sanno più distinguere "IXTHUS" da "ICTUS" (e "CHARITAS" da "CARITAS"), e sono caduti e cadute in un #letargo abissale (Par. XXXIII, 94).
- EUROPA, CHIESA CATTOLICA, E ANTROPOLOGIA (PLATONICO-PAOLINA): NON E’ TEMPO PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA? NON E’ ORA DI RIPARTIRE DA "MARIA" E "GIUSEPPE" E "GESÙ", DAL #PRESEPE (FRANCESCO DI ASSISI, 1223), E PORTARSI OLTRE LA #DOTTAIGNORANZA (#Cusano,1440), LA "DONAZIONE DI #COSTANTINO" (#LorenzoValla,1440), E "LA PACE DELLA #FEDE" (#Cusano, 1453)?.
- UNA DOMANDA: SE NON ORA, QUANDO?
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- UNA QUESTIONE DI LEGALITA’: CON ARISTOTELE, DANTE, E SHAKESPEARE, OLTRE LA TRAGEDIA.19 giugno 2024, di Federico La Sala
"SHAKESPEARE GLOBE", ELIOCENTRISMO, E "RIVOLUZIONE COPERNICANA" (KANT): FILOSOFIA (GIUSTIZIA - LOGOS), CRISTIANESIMO (AMORE - "AGAPE"), E CATTOLICESIMO (NICEA 325 -2025). Con (Parmenide ed Eraclito e) Aristotele, oltre: "In principio era il Logos" (Gv. I.1) - non un Logo.
- Una nota di commento a margine della "pretesa" di confinare l’opera di #Shakespeare (come di #Dante Alighieri) nella interpretazione e tradizione "cattolico-paolina" del messaggio evangelico.
- Un omaggio al lavoro in progress di Paul Adrian Fried ("Patrick Grey on Shakespeare, Christianity, and Aristotle’s Poetics" - June 18, 2024).
PREMESSO CHE la #question #hamletica è storica e storiografica e che, per comprendere il lavoro di Shakespeare, forse, è opportuno pensare il rapporto tra "Shakespeare, Christianity, and Aristotele’s Poetics" all’interno di un contesto europeo segnato dalla Riforma Protestante, dalla Riforma Anglicana, e dell’attacco cattolico-spagnolo all’Inghilterra della Regina e Papessa, Elisabetta I, figlia di Enrico VIII, e dalla Rivoluzione astronomica e scientifica, aperta dall’opera di Copernico, e rilanciata alla grande da Tommaso Campanella e da Giordano Bruno, condannato come eretico e bruciato sul rogo (17 febbraio 1600).
CONSIDERANDO IL CONTRIBUTO (ASSOLUTAMENTE "MODERNO", COME HA SCRITTO UNA VOLTA LO STORICO DELLA FILOSOFIA GILSON) DEL COSIDDETTO #MEDIOEVO DELLA "PRIMA #RINASCITA" (GRAZIE A FRANCESCO D’ASSISI, GIOACCHINO DA FIORE, E DANTE ALIGHIERI) E IL RAPPORTO DI DANTE CON "IL #MAESTRO DI COLOR CHE SANNO" (Inf. IV, 131), c’è da dire e da pensare che tra Aristotele e Shakespeare (come con lo stesso Dante) c’è molta amicizia, nello spirito dell’antico e nuovo Logos (e non del #Logo di una azienda personale).
NEL PORRE AL CENTRO DELL’#AMLETO la questione antropologica (e cristologica), Shakespeare pone "aristotelicamente" un problema di #legalità e di #giustizia e di #verità: la #critica al "nuovo" Re e Padre, che è un impostore, un mentitore, e un assassino, e l’introduzione nell’opera teatrale moderna (lo stesso "Hamlet") di un’opera teatrale "aristotelica", "The Mousetrap" ("La trappola per topi"). La Rivoluzione inglese è già iniziata...
SCIOLTO QUESTO NODO E, DANDO A SHAKESPEARE CIO’ CHE DI SHAKESPEARE E DI ARISTOTELE CIO’ CHE E DI ARISTOTELE, e, ancora, chiarito che il principe "Amleto" è figlio del "Re Amleto" e della "Regina Gertrude", si può senz’altro condividere l’opinione che "[...] for Aristotle, tragedy is amoral: it’s like the process of legal discovery that occurs in a court of law." (Patrick Grey).
NOTA:
STORIA E STORIOGRAFIA: "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (1929). DOPO DUEMILA ANNI E PIU’ IN COMPAGNIA DEL "#CATTOLICESIMO-ROMANO", “Sembra che una gran malinconia si sia impossessata in tutti i popoli del #Mediterraneo” (S. Freud," L’uomo Mosè e la religione monoteistica, 1939).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. -- STORIA E ANTROPOLOGIA: CON SHAKESPEARE E FREUD, OLTRE LO "SCILLA E CARIDDI" DEL "MATRIARCATO" E DEL "PATRIARCATO".18 giugno 2024, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA) ED ENIGMA DELLA SFINGE (EGITTO E GRECIA): CON SHAKESPEARE E FREUD, OLTRE LO "SCILLA E CARIDDI" DEL "MATRIARCATO" E DEL "PATRIARCATO".
- Una nota a margine dell’#Amleto e dell’#Uomo dei #topi ...
La #question di #Amleto (#Hamlet) è "BIBLICA" E "COSMICA". Si tratta di uscire dalla "preistoria" (#Marx), e di andare oltre la grande instaurazione di Zeus/Apollo/Atena, accettata e sopportata per compromesso "storico-olimpico" da Era/Giunone (#Freud pone #Giunone nella "testa" della sua "#Interpretazione dei #sogni" (1899). The #Mousetrap, teatro nel teatro del mondo planetario terrestre, è per fare affiorare alla coscienza (quanto ha già capito Francesco d’Assisi e Dante Alighieri) e andare oltre "#Adamo ed #Eva": #Amleto ("Gesù") è Figlio del Re #Amleto ("#Giuseppe") e della Regina #Gertrude ("#Maria"). Ciò che dice Freud, in una nota del testo di "L’uomo dei #topi" richiama un problema all’ordine del giorno dell’umanità: comporre in spirito di giustizia e amore la guerra tra #matriacato e #patriarcato, e, riprendere il cammino con tutte le "#sibille" e con tutti i "#profeti" (come da indicazione già di Michelangelo Buonarroti).
- Nota:
TEATRO (#FILOSOFIA) E #METATEATRO (#METAFILOSOFIA): #COSMOTEANDRIA #BOVILLUS-SIANA (#Androcentrismo, 1510) E #ANTROPOLOGIA #COPERNICANA (#COPERNICO 1543 - #KANT2024). Ricordare che il #mondo non è il #mappamondo e "la #mappa non è il #territorio" (Korzybski - Bateson). E la #question è quella di #DanteAlighieri, come di #GalileoGalilei, e di #Kant: #apriregliocchi sul "marcio nello stato di #Danimarca" (#Hamlet, I.4) e uscire dall’orizzonte della #tragedia.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- CON SIGMUND FREUD (E DANTE ALIGHIERI) ALLA RICERCA DELLA VIA D’USCITA DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA (E DELLA "CADUTA" LUCIFERINA ALL’INFERNO).14 giugno 2024, di Federico La Sala
L’ ITALIA, METAFORA DEL GIARDINO: SIGMUND FREUD (E DANTE ALIGHIERI) ALLA RICERCA DELLA VIA D’USCITA DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA (E DELLA "CADUTA" LUCIFERINA ALL’INFERNO).
- Una nota a margine del lavoro di Marina D’Angelo, su "I viaggi di Freud in Italia" (Boringhieri 2024) *
USCIRE DA SE’ PER CERCARE LA "ANTICA TERRA" E RI-TROVARE "I PROPRI #GENITORI". Come #DanteAlighieri, con #Virgilio ("dolcissimo patre"), così Sigmund #Freud, con più difficoltà edipiche (con il suo padre #Jakob): entrambi cercano "l’antica madre" (#Eneide, III, 116-117), il "sogno di una cosa" (K. #Marx), il "giardino dell’Impero" l’uno, la "Terra promessa" l’altro.
DANTE, MILTON, E FREUD. Alla fidanzata #Martha, il 7 agosto 1882, Sigmund Freud scrive che, nel "Paradiso perduto" (John Milton, 1667), «ancora di recente, in un momento in cui non mi sono sentito sicuro del tuo amore, ho trovato consolazione e conforto».
#AMARE L’ITALIA. Freud, confidando nell’amore di sua madre #Amalia (#Nathanson), come Dante, nell’amore di sua madre, la "#Bella e beata", "#Beatrice"), l’uno, come l’altro, affrontano un lungo cammino per risalire "salomonicamente" la corrente, e, finalmente, ritrovare al di là della dell’inferno e della tragedia, "l’antica matre" ("#Eva") e l’antico padre ("#Adamo"), e, finalmente, rigenerarsi nell’acqua viva dell’#amore "che muove il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145).
#COSMOLOGIA #POESIA E #LOGOS. Quando avremo sondato l’Universo alla ricerca della nostra incapacità di dominarlo e di capirlo, dovremo ritornare al Poeta e concludere che a muover il Sole e le altre stelle (a muoverle, ma non a spiegarle) è l’Amore. Allora la nostra fede non sarà più liberatrice, ma deduttiva, accettata per la nostra incapacità di andare oltre. Crederemo perché è evidente, non perché è assurdo." (#ENNIO #FLAIANO, "DIARIO DEGLI ERRORI", 1967).
- NOTE:
* MARINA D’ANGELO, "I VIAGGI DI FREUD IN ITALIA. LETTERE E MANOSCRITTI INEDITI", BORINGHIERI 2024:
- "Nella primavera del 2009, tra gli scaffali della Library of Congress di Washington D.C., Gerhard Fichtner e Albrecht Hirschmüller fanno una scoperta sorprendente: mentre sono intenti a fotografare alcuni documenti inediti presso la Manuscript Division, si imbattono in un contenitore mai esaminato prima con dieci scomparti, ciascuno con un piccolo taccuino. Realizzano così di aver ritrovato i taccuini tascabili che Sigmund Freud portava con sé durante i suoi viaggi e che fino ad allora erano stati considerati perduti. Si tratta di materiali sfuggiti - forse per un caso fortuito - all’opera di distruzione di documenti autobiografici operata da Freud stesso. [...]".
- CHE COSA CERCAVA FREUD IN ITALIA? “Così voglio sfuggire a me stesso” - I viaggi in Italia di S. Freud, di M. D’Angelo". Alla scoperta delle tracce di S. Freud in Italia e degli influssi dei viaggi italiani nella sua vita e nell’opera. Un vero e sostanziale contributo alla biografia e all’opera di Freud (di Prof. Dr. Jörg Robert, Università di Tubinga, "LA SPI" - WEb, 5/05/22).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- CATTEDRALE DI SIENA, CAPOLAVORI DEL PAVIMENTO. Le Sibille, secondo lo schema varroniano, sono dieci (cinque per ogni navata).18 maggio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, TEOLOGIA, ARTE E STORIA:
"Le #Sibille, secondo lo schema varroniano, sono #dieci (cinque per ogni navata) e derivano il loro nome dai luoghi di pertinenza geografica: la Sibilla Persica, l’Ellespontica, l’Eritrea, la Frigia, la Samia, la Delfica per quanto riguarda il mondo orientale e greco; la Libica per l’Africa; e poi quelle occidentali (con riferimento all’Italia): la Cumea o Cimmeria, la Cumana (virgiliana) e la Tiburtina." (https://operaduomo.siena.it/pavimento/).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---CHI E’ COME DIO? ("QUIS UT DEUS?"). UNA NOTA SUL TEMA TEOLOGICO-POLITICO DEI "DUE CORPI DELLA REGINA" (AURELIO MUSI).20 aprile 2024, di Federico La Sala
"QUIS UT DEUS?". UNA NOTA SUL TEMA TEOLOGICO-POLITICO DEI "DUE CORPI DEL RE" - E I DUE CORPI DELLA REGINA...
- ANTROPOLOGIA, #TEOLOGIA-#POLITICA, E #STORIOGRAFIA: LA #SOVRANITÀ, LA #COSTITUZIONE, E LA #DIGNITÀ DI OGNI #CITTADINO E DI OGNI #CITTADINA...
PLAUDENDO ALL’INIZIATIVA ANNUNCIATA DAL PROF. AURELIO MUSI ,
- "Mercoledì, 24 aprile, ore 15, all’Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli, Via Mezzocannone 8, terrò una conferenza su "I due corpi della regina" , ossia sulla sovranità femminile: i due corpi sono quello fisico e quello politico, il tema è il loro rapporto nelle regine regnanti, consorti, reggenti, supplenti nell’Europa moderna",
FORSE, è da pensare che sia opportuno riprendere la riflessione a tutti i livelli "sulla sovranità femminile: i due corpi sono quello fisico e quello politico" (Aurelio Musi) e, al contempo, ricordare il "caso" di Elisabetta I d’Inghilterra (e della #Riforma anglicana), e, unitariamente, considerare il #cruciverba e l’#enigmistica della #hamletica #question (#Shakespeare) del "#corpomistico" sia del #re (E. H. #Kantorowicz) sia della #regina (#AurelioMusi), e, quindi, non solo del corpo fisico, ma anche il #corpo teologico-politico.
"CHI E’ COME DIO?". Il problema, come aveva già capito e indicato Kantorowicz, è riprendere a riflettere sulla "#regalità #antropocentrica: #Dante" (così il titolo di un capitolo conclusivo del libro "I due corpi del re") e, possibilmente, tentare di uscire dalla caverna platonica e dall’orizzonte della #cosmoteandria logico-filosofica e teologico-politica del PianetaTerra.
- NOTE:
- STORIA E FILOSOFIA. Ernst H. #Kantorowicz, "I due corpi del Re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale"
- ARTE #ANTROPOLOGIA E #TEOLOGIA: "QUIS UT DEUS?" (CHI E’ COME DIO?"). L’INTERPRETAZIONE DELLA FIGURA DELL’#ARCANGELO #MICHELE, DI SAN MICHELE, DA PARTE DI #LUCA GIORDANO (1657): Chiesa dell’Ascensione a #Chiaia, Napoli.
- STORIA E #MEMORIA. #AURELIO #MUSI. "Maria Sofia", Neri Pozza, 2022.
- SINOSSI: Ultima #regina di #Napoli per poco più di un anno, #MariaSofia di #Baviera è l’eroina che dagli spalti di Gaeta infonde coraggio a quel che rimane dell’esercito borbonico annientato dall’arrembaggio piemontese. Alta, slanciata, elegante nel portamento no - bile e grazioso, con una magnifica capigliatura castana, bellissimi occhi di color azzurro-cupo, Maria Sofia trascorre l’infanzia e l’adolescenza nel castello di Possenhofen, dove le giovani Wittelsbach si esercitano in lunghe galoppate a caccia di animali selvatici. Oltre alle passeggiate a cavallo, pratica la scherma, il nuoto, la ginnastica, la danza, riceve una solida educazione musicale e una formazione al gusto estetico secondo i modelli ereditati dalle corti europee d’antico regime. È molto affascinata dalla fotografia [...].
- FILOLOGIA #ANTROPOLOGIA #STORIAELETTERATURA E #TEOLOGIA-#POLITICA. "Il significato spirituale del nome di San Michele... ( Philip Kosloski - 30/09/19).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- UN "VOCAL TURN"? Voce, corpo, relazione: "A più voci. Filosofia dell’espressione vocale" di Adriana Cavarero, a vent’anni dalla sua prima pubblicazione (di Annalisa Pellino).16 aprile 2024, di Federico La Sala
LINGUAGGI
- IMMAGINE: JOHN WILLIAM WATERHOUSE, ULYSSES AND THE SIRENS, 1891 *
Voce, corpo, relazione
- "A più voci. Filosofia dell’espressione vocale" di Adriana Cavarero, a vent’anni dalla sua prima pubblicazione.
di ANNALISA PELLINO *
- Annalisa Pellino è PhD in Visual and Media Studies e attualmente collabora come assistente alla didattica e ricercatrice con il Dipartimento di Comunicazione, Arti e Media dell’Università IULM di Milano. I suoi saggi sono apparsi in volumi e riviste scientifiche peer-reviewed e ha scritto di cinema, arte contemporanea e cultura visuale per diversi magazine online, tra cui FlashArt, Doppiozero e Kabul Magazine. È co-fondatrice e attivista di AWI - Art Workers Italia
"Are the humanities undergoing a vocal turn?”. In un articolo del 2015 apparso sulla rivista Polygraph, Brian Kane avanza l’ipotesi che gli studi umanistici siano stati interessati negli ultimi anni da un vero e proprio vocal turn, in grado di competere con il linguistic turn e il visual turn. L’attenzione del musicologo per l’espressione vocale rientra in una più generale tendenza a riconsiderare l’importanza del suono e dell’ascolto nella lettura dell’esperienza audiovisiva contemporanea e nei processi di soggettivazione. Altri studiosi, invece, preferiscono parlare di auditory turn, che effettivamente esprime meglio la varietà dei fenomeni aurali che interpellano l’ascolto e la sua interazione con gli altri sensi. Che si scelga di usare l’una o l’altra formula, la voce è certo uno degli oggetti più interessanti da considerare in questo ripensamento radicale del modo in cui percepiamo noi stessi e il mondo, entriamo in relazione, ripensiamo i termini della nostra stessa identità e il rapporto con la tecnologia: messaggi vocali, interfacce conversazionali, podcast, tecnologie di sintesi vocale per la lettura dei testi e deepfake della voce realizzati con sistemi di intelligenza artificiale (si pensi a quella di Warhol nella nuova serie di Netflix The Andy Warhol Diaries).
Di fronte a questo scenario, però, c’è un aspetto che viene sottovalutato nella riflessione sullo statuto della phoné, sulla sua materialità e sulle sue implicazioni socio-psicologiche, etiche, estetiche e politiche. È il fatto che essa resta comunque il più carnale di tutti i suoni, e a dispetto dei vari tentativi di ricreazione delle sue caratteristiche specifiche come il tono o il timbro, con effetti più o meno naturalistici. Di questa corporeità si è occupata Adriana Cavarero, che nel suo A più voci. Filosofia dell’espressione vocale (Castelvecchi, 2022) - appena ripubblicato dopo circa vent’anni dalla sua prima uscita - esplora lo statuto della voce risalendo alle origini metafisiche del pregiudizio epistemico che ci porta ad assegnare un peso conoscitivo più alla parola scritta che non alla voce che la esprime. L’analisi di Cavarero non solo scuote le fondamenta della cultura occidentale basata sul paradigma oculocentrico, ma sostiene la centralità della voce nell’articolazione del politico e del femminile e, a partire dal pensiero della differenza sessuale, mostra come tale articolazione sia orientata dal sistema del linguaggio. In particolare, la filosofa valorizza l’idea dell’eccedenza della phoné, che è insieme fonazione e relazione, misura del sé ma anche dell’altro, contemporaneamente medium del linguaggio e sua messa in discussione.
- Cavarero esplora lo statuto della voce risalendo alle origini metafisiche del pregiudizio epistemico che ci porta ad assegnare un peso conoscitivo più alla parola scritta che non alla voce che la esprime.
Il saggio parte da un confronto serrato con Platone per rileggere l’intera storia della filosofia come un processo di “devocalizzazione del logos”. Nelle concezioni arcaiche della voce, infatti, la phoné è assimilata sia al divino - come sua pura manifestazione sonora - sia al pensiero che si credeva prodotto dai polmoni e dall’apparato respiratorio e fonatorio: non a caso la parola nous (pensiero) rinvia a noos (naso). In questo senso è illuminante la differenza tra la cultura greca che, da Platone in poi, àncora la propria episteme alla sfera del visivo, e quella ebraica, che invece mantiene saldo il legame con la sfera uditiva. Nella prima la voce è sempre ricondotta alla parola scritta, quindi alla sua manifestazione visiva, insonora. Nella seconda, invece, la stessa potenza di Dio si manifesta non tanto nel Verbo, quanto nel respiro (ruah, in ebraico, pneuma nella versione greca dei Settanta e spiritus in latino) e nella voce (qol), sotto forma di “vento, brezza, bufera”, in una “sfera fondamentale di senso che viene prima della parola”. L’atto stesso della creazione consiste in un “puro vocalico, indifferente alla funzione semantica della lingua” e Dio diventa parola solo nella bocca dei profeti: è infatti la rilettura cristiana del Vecchio Testamento che riconduce alla parola (e non al respiro) l’atto della creazione. Sintomaticamente, la differenza si riflette anche nella lettura del testo sacro, che per gli ebrei avviene a voce alta con un’ondulazione ritmica del corpo che sottolinea la sonorità musicale della parola, mentre per i cristiani è silenziosa e immobile.
Un altro confronto importante per spiegare il fondamento “antiacustico e videocentrico” della filosofia e, per estensione, di tutto il pensiero occidentale, è quello che Cavarero stabilisce tra questa e l’epica, quindi tra Platone e Omero. Nell’epica, ciò che guida il discorso è la metrica, il ritmo e il suono, funzioni di un più complesso sistema mnemonico all’interno del quale il poeta cieco si fa cantore e interprete del messaggio della musa figlia di Mnemosyne. “Il vocalico comanda il semantico”, ma questo non è ammissibile nella casa della ratio androcentrica, tanto che Platone condanna l’epos e la mousiké, ovvero il piacere corporeo della musicalità: “sottratto all’evento dinamico del flusso vocale e consegnato alla fermezza del segno scritto, il linguaggio diventa un oggetto di osservazione [...] assume una forma organizzata, lineare e rivedibile”.
- Ciò che Cavarero contesta alla struttura del sapere occidentale, a partire dalle sue basi filosofiche, è il fatto di ridurre la voce a phoné semantiké, neutralizzandone la corporeità e il potere relazionale.
In particolare, ciò che Cavarero contesta alla struttura del sapere occidentale, a partire dalle sue basi filosofiche, è il fatto di ridurre la voce a phoné semantiké, neutralizzandone la corporeità e il potere relazionale. La filosofa, infatti, riconosce alla voce un ruolo centrale nella decostruzione del logocentrismo iniziata da Jacques Derrida con La voix et le phénomène (1967), al quale dedica l’appendice del libro riconoscendogli il merito di aver restituito indirettamente la voce alla sua materialità corporea. Nondimeno, se Derrida si concentra alla parola scritta (grammata) Cavarero si rivolge alla musicalità del vocalico che, attenzione, non va confuso con l’orale e, “come ogni strumento, necessita di una partitura”. Per chiarire la sottile ma sostanziale differenza fra le due dimensioni, la filosofa si richiama alla distinzione operata dal medievalista Paul Zumthor tra oralità, che indica “il funzionamento della voce in quanto portatrice di linguaggio”, e vocalità, intesa come “l’insieme delle attività e dei valori che le sono propri, indipendentemente dal linguaggio”. La voce, infatti, può essere sia portatrice di parola sia pura emissione sonora: del resto, se la prima può fare a meno della seconda, non si può certo dire il contrario. Che si tratti di parola scritta o proferita, la voce le contiene entrambe, ne stabilisce le condizioni di possibilità ma allo stesso tempo le eccede con la sua sonorità, stabilendo una tensione tra performativo e narrativo.
A questa tensione è dedicata tutta la seconda parte del libro, una galleria di ritratti di Donne che cantano, spesso figure femminili mostruose, teriomorfe e mortifere. Si pensi al canto mellifluo e seduttivo delle sirene, che sfidano il raziocinio di Odisseo, e sul cui corpo si consuma il complesso intreccio tra sistema del linguaggio e stereotipi di genere. Quella delle sirene, infatti, è originariamente una voce narrante, proprio come quella della Musa aedica, ma questo legame tra il canto e la phoné semantiké delle donne-uccello viene a perdersi nelle successive rappresentazioni che, non a caso, le trasforma in “sinuose, scarmigliate e pisciformi”, ridotte a puri vocalizzi o addirittura al silenzio. È questa solo la prima di tutta una serie di figurazioni in cui le voci femminili non sono mai presenti come parola o discorso, ma vanno incontro a un processo di sottrazione e fluidificazione: nell’acqua diventano puro suono ambientale che annacqua la soggettività e, per dirla con Douglas Kahn “spegne la scintilla dell’agency” (Noise, Water, Meat. A History of Sound in the Arts, MIT Press, 2001).
Un analogo destino di “nientificazione” (che nella nuova edizione diventa erroneamente “mentificazione”) tocca alla ninfa Eco. Punita da Giunone per il suo eccesso verbale e condannata a ripetere i suoni altrui. La ragazza ciarliera perde la facoltà di articolare i propri discorsi, il suo corpo si scarnifica fino quasi a mineralizzarsi e, assorbito dal paesaggio, si disperde nell’atmosfera. Nell’incontro erotico con Narciso, inoltre, Eco diventa un osceno “specchio acustico”, aspetto fortemente valorizzato nelle Metamorfosi di Ovidio, per cui l’huc coeamus (qui riuniamoci) di Narciso, muta, nella bocca di Eco, in coeamus (uniamoci) con riferimento al coito. Il loro duetto si basa sull’equivoco generato proprio dall’eccesso del vocalico che mina la comprensibilità del semantico: sul ritorno dello stesso suono da una parte e della stessa immagine dall’altra.
- Cavarero si sofferma a lungo sul confinamento della voce femminile nell’inarticolato o nei due estremi del canto e del silenzio, che si configurano sia come campi speciali di interdizione da parte dell’ordine simbolico patriarcale, sia della sua sovversione.
Cavarero si sofferma a lungo sul confinamento della voce femminile nell’inarticolato o nei due estremi del canto e del silenzio, che si configurano sia come campi speciali di interdizione da parte dell’ordine simbolico patriarcale, sia della sua sovversione. Si pensi ad Ada (Holly Hunter) in The piano (Jane Campion, 1993), o ancora a tutti i personaggi femminili inaddomesticati del melodramma che muoiono cantando: “Carmen è una zingara, Butterfly e Turandot sono esotiche, Tosca è una cantante, Violetta è una poco di buono. Donne che vivono al di fuori dei ruoli familiari, figure trasgressive e spesso capaci di indipendenza, esse non si limitano a morire, ma devono morire perché tutto torni a posto”. L’opera, fra l’altro, è per Cavarero il luogo per eccellenza dove il principio acustico che orienta il femminile vince su quello videocentrico del maschile: ciò avviene attraverso la figura del castrato che rinuncia ai propri connotati virili per farsi corpo-voce di donna. E anche quando si riversa nella scrittura, la voce femminile mantiene il suo legame con la “sfera preverbale e inconscia, non ancora abitata dalla legge del segno, dove regna l’impulso ritmico e vocale”. A tal proposito la filosofa fa riferimento a l’écriture feminine di Hélène Cixous - qui assimilata alla nozione di chora semiotica di Julia Kristeva - insieme gesto estetico e politico: “scrittura fluida, ritmica e debordante, che rompe le regole del simbolico facendo esplodere la sintassi. Essa precede ed eccede i codici che governano il logos fallocentrico.” Cixous è un’ebrea algerina che prova a scompaginare e reinventare la sintassi della lingua paterna - il francese, la lingua del colonizzatore - musicandola con il tedesco da ebrea askenazita della madre in maniera del tutto in(a)udita: si tratta di un piacere legato alla voce materna che si mescola con quello orale del latte e informa una “lingualatte (languelait) che, nella sua effusione gratuita, ricopre tutto il registro dei piaceri orali e delle vocalizzazioni infantili”.
Ma allora, viene da chiedersi, cosa significa la voce quando si sottrae al sistema della significazione? Due sono gli aspetti su cui insiste Cavarero: l’unicità della persona e la relazione. La phoné esprime innanzitutto il corpo che la emette, in quanto manifestazione di una “singolarità irripetibile” che si manifesta nel dire piuttosto che il detto: “la voce pertiene al vivente, comunica una presenza in carne e ossa, segnala una gola e un corpo particolare”. Inoltre, al contrario dello sguardo, la voce è sempre relazionale: in latino, ci ricorda la filosofa, vocare è chiamare: “prima ancora di farsi parola, la voce è un’invocazione rivolta all’altro e fiduciosa di un orecchio che la accoglie”. Nella “prossimità pneumatica” si stabilisce dunque l’essere per l’altro, ovvero la relazione che ha luogo nel contatto diretto tra le cavità di un corpo che emette un suono e quelle di un corpo che lo riceve, in ciò che di più nascosto e vibrante c’è in ognuno di noi.
Anche qui sono numerose le voci, filosofiche e letterarie, che si incontrano in questo viaggio a ritroso alla scoperta della materialità della phoné: da Ida Dominijanni ad Hannah Arendt, da Jean-Luc Nancy a Emmanuel Lévinas; dal Re in ascolto di Italo Calvino a Hurbinek - il bambino nato nel campo di concentramento di Auschwitz la cui vicenda, narrata da Primo Levi ne La Tregua (1963), chiude significativamente il saggio. Proprio le storie del Re in ascolto e di Hurbinek dicono di quanto la voce sia un plus-de-corp - per usare un’espressione di Mladen Dolar (La voce del padrone. Una teoria della voce tra arte, politica e psicoanalisi, Orthotes, 2014) - che si rivela attraverso una serie di manifestazioni fisiologiche e somatiche capaci di eccedere la struttura del linguaggio, occupando uno spazio di verità e di relazione non linguistica con l’alterità, dove umano e animale si approssimano e la voce “qualcosa dice, ma niente che si possa fissare in un significato. Mima il linguaggio, senza arrivare alla parola. Comanda, seduce”.
* cfr." LINGUAGGI ANNALISA PELLINO / IMMAGINE: JOHN WILLIAM WATERHOUSE, ULYSSES AND THE SIRENS, 1891 / 11.5.2022". Il Tascabile (ripresa parziale - senza immagine).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- STORIA E STORIOGRAFIA. I profeti nella Certosa di San Martino: il genio di Ribera attratto dalla magia di Napoli (di Aurelio Musi).29 marzo 2024, di Federico La Sala
SIBILLE E PROFETI NEL REGNO DI NAPOLI, NEL PRIMO SEICENTO.
ARTE, #STORIA, E #ANTROPOLOGIA: LA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO.
- Una recensione di Aurelio Musi di un libro che vale una "apocalittica" svolta storiografica:
I profeti nella Certosa di San Martino: il genio di Ribera attratto dalla magia di Napoli
di Aurelio Musi (Corriere della Sera, 27 marzo 2024)
In uno di quei minuscoli libretti, che hanno fatto la storia dell’editore Colonnese, può essere racchiuso un intero universo, una civiltà, il mondo di segni di un’epoca. José Vicente Quirante Rives, con “Dodici araldi grinzosi. I profeti di Ribera nella certosa di San Martino” (Colonnese ed.), dedicato alla memoria di Giuseppe Galasso, accompagna il lettore fra terra e cielo, fra l’umano e il divino, fra passione e luce: “perché non vi sarà più notte”.
 Nei dodici profeti di Ribera c’è la realtà quotidiana e precaria, c’è la vita dei vecchi, c’è Caravaggio, c’è la solitudine del profeta, la certosa come imitazione del deserto. I profeti, messaggeri che portano sulla superficie dei loro volti le profonde rughe, sedimenti di vita e di sapienza, ricevono la visione da Dio, la traducono in parole. Quirante fantastica sui certosini che entrano nell’ampia navata, fanno l’esegesi delle immagini, osservano le profezie realizzate, le inseriscono in una fittissima rete di relazioni, distendono il tempo tra passato, presente e futuro. Sopra i dodici profeti di Ribera i dodici apostoli di Lanfranco con i loro nomi. Dodici più dodici ventiquattro come gli anziani dell’Apocalisse, come la somma dell’Antico e Nuovo Testamento.
Nei dodici profeti di Ribera c’è la realtà quotidiana e precaria, c’è la vita dei vecchi, c’è Caravaggio, c’è la solitudine del profeta, la certosa come imitazione del deserto. I profeti, messaggeri che portano sulla superficie dei loro volti le profonde rughe, sedimenti di vita e di sapienza, ricevono la visione da Dio, la traducono in parole. Quirante fantastica sui certosini che entrano nell’ampia navata, fanno l’esegesi delle immagini, osservano le profezie realizzate, le inseriscono in una fittissima rete di relazioni, distendono il tempo tra passato, presente e futuro. Sopra i dodici profeti di Ribera i dodici apostoli di Lanfranco con i loro nomi. Dodici più dodici ventiquattro come gli anziani dell’Apocalisse, come la somma dell’Antico e Nuovo Testamento.“Solo chi si reca a Napoli e visita nel Duomo la cappella di San Gennaro, con lo splendido dipinto di Ribera vicino a opere del Domenichino e del Lanfranco, e poi sale alla Certosa, contempla nella cappella del Tesoro la profonda e monumentale Pietà, e vede nella chiesa la Comunione degli Apostoli e i profeti nella navata centrale, è in grado di percepire tutta la sapienza pittorica, la profondità emotiva, la solidità compositiva e la monumentalità di Ribera, che si presenta come uno dei grandi del suo tempo” (p. 23).
Lo spagnolo autore di questo aureo libretto è un vero innamorato di Napoli, della sua civiltà artistica, della sua anima aristocratica. E’ capace di scoprirne tesori nascosti e illuminare ulteriormente aspetti e personaggi noti o meno noti della sua ricchissima storia: anche per questi motivi Quirante, ex direttore del “Cervantes”, si è guadagnato la cittadinanza onoraria di Napoli.
Quirante scrive un capitolo su Gustaw Herling, “che passerà più della metà della sua vita a Napoli come José de Ribera. Entrambi si sposeranno e fonderanno una famiglia, entrambi intrappolati nella città feroce e seducente come la formica nell’ambra” (p. 47).
Ribera arriva a Napoli nel 1616. Insieme col Lanfranco opera alla Corte del viceré Monterey. Firma le sue opere come “español”, ma non vorrebbe tornare in patria. Ribera e Quirante: l’autore e, forse, il suo consapevole o inconsapevole doppio.
- NOTA: SIBILLE E PROFETI NEL #REGNODINAPOLI, NEL PRIMO #SEICENTO. UNA TRACCIA STORIOGRAFICA DI GRANDE IMPORTANZA: A CONTURSI TERME (SALERNO), NEL 1613, NELLA "CHIESA DELLA #MADONNADELCARMINE", AFFRESCHI CON 12 SIBILLE.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- DA MICHELANGELO A LOTTO: DALLA "CAPPELLA SISTINA" ALLA CASA DI LORETO. Una nota a margine della mostra "Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi" a Cuneo.9 marzo 2024, di Federico La Sala
ARTE RELIGIONE STORIA ANTROPOLOGIA E FILOLOGIA DEL RINASCIMENTO:
LORENZO LOTTO (1480-1556).
- Una nota a margine della mostra "Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto" (prorogata fino al 1 aprile).*
A MIO PARERE, LORENZO LOTTO MERITA ATTENZIONE CULTURALE E STORIOGRAFICA: LA LUNGA ONDA DELL’#INTERPRETAZIONE UMANISTICO-RINASCIMENTALE DEL MESSAGGIO EVANGELICO, COME DI UN #CAMMINO #PARALLELO DI #PROFETI E #SIBILLE, CHE ARRIVA MAGISTRALMENTE CON [MICHELANGELO BUONARROTI FINO IN CIMA ALLA VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA, E, CON LORENZO LOTTO, GIUNGE CON I PROFETI E LE SIBILLE DELLA "CAPPELLA SUARDI", NELLE OPERE DEL "CICLO LAURETANO", ALLA SANTA CASA DI LORETO, ALLA CASA DI MARIA E GIUSEPPE, E ALLA "ADORAZIONE DEL BAMBINO".
*
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- LA MEMORIA DELLE "CARITI", DELLE "GRAZIE". Una nota sul disagio "filologico" della civiltà.29 gennaio 2024, di Federico La Sala
LINGUISTICA STORIOGRAFIA E PSICOANALISI:
- UN "LAPSUS" DI LUNGA DURATA E UNA FILOLOGIA AL SERVIZIO DEL #LATINORUM.
RIFLETTENDO sul #nodo etimologico di #cuore e #cardine (in connessione con l’ #hamlet-ico tempo di #Shakespeare, "fuori dai cardini"), la memoria ha richiamato l’attenzione su una #immagine (qui, v. allegato) che continua a "#parlare" di un problematico #letargo di secoli (quantomeno a partire da #LorenzoValla, 1440), di uno strano "lapsus" storico e storiografico sul tema dell’#Amore per eccellenza: la #Carità, la #Charitas (gr. "#Xapitas"), e sulla famosa e falsa "donazione di Costantino".
IN PRINCIPIO ERA IL #LOGOS: CHARITAS (AMORE). Questa parola-chiave, la "password" del "regno dei cieli", è diventata nel tempo la Carità - #elemosina, la #Caritas (fatta derivare dal lat. "carus", "caro") e così, persa la "h" (l’#acca), anche in lingua greca (v. allegato) è diventata (addirittura) "#Kapitas" ( "Karitas").
"RIPENSARE #COSTANTINO"? NO! #DANTE2021? NO! RICORDARE L’ANNIVERSARIO DI #NICEA 325, 2025!
 OVVIAMENTE, così permanendo e stando le cose in tutte le Università e le Accademie del #PianetaTerra (con la loro forte segnatura culturale di epoca "rinascimentale"), il "sonno dogmatico" continua a tutti i livelli, sul piano non solo etimologico, ma filologico, antropologico, teologico e politico.
OVVIAMENTE, così permanendo e stando le cose in tutte le Università e le Accademie del #PianetaTerra (con la loro forte segnatura culturale di epoca "rinascimentale"), il "sonno dogmatico" continua a tutti i livelli, sul piano non solo etimologico, ma filologico, antropologico, teologico e politico.- P. S. - Per meglio capire la questione del disagio "filologico" della civiltà, forse, è bene riflettere sulle parole e al contempo sulle persone: Chi (gr. X) sono le cosiddette "Cariti": sono le "dame della Carità / Elemosina", o, al contrario, sono l’altrà metà del "genere umano", il cuore e il cardine della stessa vita sul Pianeta Terra?.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- NEL "TEMPO FUORI DAI CARDINI", SHAKESPEARE, CON AMLETO, SOLLECITA A RIORGANIZZARE LE IDEE.24 gennaio 2024, di Federico La Sala
L’EUROPA NEL "TEMPO FUORI DAI CARDINI":
- TEATRO, METATEATRO, E STORIOGRAFIA "IMPERIALISTICA".
SHAKESPEARE, CON IL ’MULINO’ DI "AMLETO" (1602), SOLLECITA A PORTARSI OLTRE "SCILLA E CARIDDI", OLTRE LA COSMOTEANDRIA CATTOLICA E PROTESTANTE.
- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E STORIA.
UN’IPOTESI DI LAVORO PER USCIRE DAL #LETARGO (DANTE ALIGHIERI, PAR. XXXIII, 94) E PER MEGLIO RIFLETTERE SULLA QUESTIONE TEOLOGICO-POLITICA (ENRICO VIII, 1534) E ANTROPOLOGICA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’EUROPA DEL SEICENTO (MA ANCORA IN PIEDI, SI PENSI A NICEA 2025) SEGNATA DAL CONFLITTO POLITICO-RELIGIOSO TRA SPAGNA E INGHILTERRA, FORSE, E’ OPPORTUNO NON DIMENTICARE LA LEZIONE DELLA "SORELLA" DELLO STESSO SHAKESPEARE, "JUDITH" (VIRGINIA WOOLF), E TENERE CONTO DELLO SPIRITO DI TERESA D’AVILA CHE SOFFIA FORTISSIMO NEL CAMPO CATTOLICO-SPAGNOLO E DEL "CORPO DI CRISTO" DELLA #REGINA E #PAPESSA, ELISABETTA I D’INGHILTERRA, CHE REGNA NEL CAMPO INGLESE E PROTESTANTE-ANGLICANO.
NOTE:
- ARTE, TRADIZIONE DEI CARMELITANI SCALZI, E QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA): MARIA E GIUSEPPE E TERESA D’AVILA.
- Un "racconto" di Francesco del Cairo (1640-1650, Parma), che dà da pensare: "Il quadro [...] Raffigura la Vergine e san Giuseppe che appaiono a Santa Teresa d’Avila, inginocchiata in preghiera con le mani incrociate sul petto, nell’atto di ricevere dalla Madonna che si sporge verso di lei una catena d’oro. Santa Teresa, vissuta tra 1515 e 1582, ebbe un ruolo primario nella dell’ordine del #CarmeloScalzo. Ella fu anche particolarmente devota a San Giuseppe, sposo di Maria e suo protettore, contribuendo alla diffusione del culto del santo e alla sua rappresentazione nell’arte devozionale. L’episodio raffigura una visione mistica che Teresa aveva avuto il 15 agosto 1561, giorno dell’#Assunzione, in cui la #Madonna e #Giuseppe comparivano insieme ponendole sulle spalle un manto bianco sfolgorante e al collo un ornamento d’oro con appesa una croce, segno dell’approvazione divina al suo progetto di fondazione di un monastero. [...] ".
- POLITICA, RELIGIONE, E STORIOGRAFIA. EUROPA,1534: UNA "STRANA" COINCIDENZA.
- Mentre a Londra, il re Enrico VIII, con l’Atto di Supremazia del 1534, si dichiara "Capo Supremo in terra della Chiesa d’Inghilterra" e apre la via alla Riforma Anglicana (e al trono ad Elibasetta, nata il 1533), nel Regno di Napoli, Vicereame spagnolo, il giureconsulto Giovanni Antonio #Pepi, sulle orme di #Cicerone (e del suo "De officiis") detto "#Piperone", dà alle stampe il "De Omni Vero Officio", traccia la linea di un programma teologico-politico per l’impero cattolico-spagnolo (cfr. "Piperonis De omni vero officio libri septem. Omnibus aeque ac aer ad vitam quo sine spirat nemo ad bene beateque viuendum necessarii. Authoris iniussu quisquam ne imprimito neue uspiam uendito").
- MEMORIA E #STORIA: #CARMELITANI SCALZI NEL #REGNO DI NAPOLI, VICEREAME SPAGNOLO. Dopo il #terremoto del 1980, ritrovato nella provincia di Salerno, a Contursi Terme, un "file" perduto del tardo #Rinascimento.
- STORIA D’EUROPA.
- Elisabetta I d’Inghilterra:"Elisabetta I Tudor (Greenwich, 7 settembre 1533 - Richmond upon Thames, 24 marzo 1603) è stata regina d’Inghilterra e d’Irlanda dal 17 novembre 1558 fino al 24 marzo 1603, giorno della sua morte [...]".
- METATEATRO E STORIOGRAFIA: SHAKESPEARE. La questione di #Amleto, come già quella del "giocastolaio" #Edipo, re di #Tebe, investe ogni #relazione (a tutti i livelli, dal più basso al più alto - da ogni "Adamo" e ogni "Eva" fino a "Dio" e al "corpo di "Cristo-Re"). Per #Shakespeare, non è solo un "gioco" (letterario) di interpretazione delle #sacre scritture, ma decisamente (e storicamente) una #question di "essere, o non essere": alle spalle, e nel suo presente, egli, con tutta la società inglese, e con la sua #Regina e #Papessa, ha ben #memoria dell’attacco della #Invincibile Armata (1588).
-
>LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- LA RINASCITA (GIOACCHINO DA FIORE, FRANCESCO DI ASSISI, E DANTE ALIGHIERI), LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453), E UN "NUOVO" PRESEPE "FRANCESCANO".29 dicembre 2023, di Federico La Sala
DOTTA IGNORANZA (1440), "PACE DELLA FEDE" (1453), E RILANCIO DI UN "NUOVO" #PRESEPE "FRANCESCANO" (ALL’ORIGINE DELLA "#CAPPELLASISTINA"): #ARCHEOLOGIA, #FILOLOGIA, E #STORIAELETTERATURA ...
- DOPO LA #CADUTA DI #COSTANTINOPOLI (1453), FINE DELLA RINASCITA (GIOACCHINO DA FIORE, FRANCESCO DI ASSISI, E DANTE ALIGHIERI) E RICOSTITUZIONE DELLA #TEOLOGIA-POLITICA DI #COSTANTINO (CON LA DEIFICAZIONE DELLA #MADRE DELL’#IMPERATORE-#PAPA).
Un invito alla lettura di un "vecchio" lavoro di #ricerca di Arnalda Dallaj:
"#ORAZIONE E #PITTURA TRA «#PROPAGANDA» E #DEVOZIONE AL TEMPO DI #SISTOIV. [...] A proposito del dibattito sull’Immacolata Concezione e delle vivacissime forme che lo caratterizzarono tra l’ottavo decennio del #Quattrocento e gli inizi del #Cinquecento sono state utilizzate di recente espressioni come « mezzi pubblicitari » e «manifesti dottrinali» ponendo così l’accento sull’intensa ricerca, da parte delle istituzioni ecclesiastiche, di appropriati canali di comunicazione per ampliare il confronto sulla dottrina che, proprio in quel secolo, aveva conquistato basi più salde, anche se il definitivo assestamento maturerà solo nel 1854. Una data cardine fu il 1477, allorché il #papa #francescano Sisto IV autorizzò la celebrazione della festa e approvò l’Ufficio, appositamente composto da Leonardo Nogarolo, concedendo ampia indulgenza per la partecipazione alla liturgia. La tesi della « preservazione » di Maria dal peccato originale, pur trovando sempre maggiori consensi, continuò ad essere avversata soprattutto dai Domenicani. [...]" (cf. Arnalda DALLAJ: "IL CASO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA DI GANNA").
- NOTA: CULTURA #IMMAGINARIO E #POLITICA. Sul #clima "artistico" e sulla "propaganda" del tempo, in #Lombardia, si cfr. l’illuminante lavoro di Marco Infurna, relativo alla figura di Ambrogio della Longhignana, signore di Porlezza, "Il duello di Rolando e Feraguto sul ponte in un affresco lombardo del Quattrocento" (“Par estude ou par acoustumance”. Saggi offerti a Marco Piccat per il suo 65° compleanno, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2016).
Federico La Sala #ARCHEOLOGIA, #FILOLOGIA, E #STORIAELETTERATURA ...
- DOPO LA #CADUTA DI #COSTANTINOPOLI (1453), FINE DELLA #RINASCITA (#GIOACCHINODAFIORE, #FRANCESCODIASSISI, E #DANTEALIGHIERI) E RICOSTITUZIONE DELLA #TEOLOGIA-POLITICA DI #COSTANTINO (CON LA DEIFICAZIONE DELLA #MADRE DELL’#IMPERATORE-#PAPA).
Un invito alla lettura di un "vecchio" lavoro di #ricerca di Arnalda Dallaj:
"#ORAZIONE E #PITTURA TRA «#PROPAGANDA» E #DEVOZIONE AL TEMPO DI #SISTOIV. [...] A proposito del dibattito sull’Immacolata Concezione e delle vivacissime forme che lo caratterizzarono tra l’ottavo decennio del #Quattrocento e gli inizi del #Cinquecento sono state utilizzate di recente espressioni come « mezzi pubblicitari » e «manifesti dottrinali» ponendo così l’accento sull’intensa ricerca, da parte delle istituzioni ecclesiastiche, di appropriati canali di comunicazione per ampliare il confronto sulla dottrina che, proprio in quel secolo, aveva conquistato basi più salde, anche se il definitivo assestamento maturerà solo nel 1854. Una data cardine fu il 1477, allorché il #papa #francescano Sisto IV autorizzò la celebrazione della festa e approvò l’Ufficio, appositamente composto da Leonardo Nogarolo, concedendo ampia indulgenza per la partecipazione alla liturgia. La tesi della « preservazione » di Maria dal peccato originale, pur trovando sempre maggiori consensi, continuò ad essere avversata soprattutto dai Domenicani. [...]" (cf. Arnalda DALLAJ: "IL CASO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA DI GANNA").
- NOTA: CULTURA #IMMAGINARIO E #POLITICA. Sul #clima "artistico" e sulla "propaganda" del tempo, in #Lombardia, si cfr. l’illuminante lavoro di Marco Infurna, relativo alla figura di Ambrogio della Longhignana, signore di Porlezza, "Il duello di Rolando e Feraguto sul ponte in un affresco lombardo del Quattrocento" (“Par estude ou par acoustumance”. Saggi offerti a Marco Piccat per il suo 65° compleanno, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2016).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- MALINCONIA BAROCCA: "RUBENS. ALLEGORIA DELLA FEDE. LA SIBILLA PERSICA" E FINE DELL’ONDA LUNGA DEL RINASCIMENTO.2 dicembre 2023, di Federico La Sala
ARTE STORIA STORIOGRAFIA: RUBENS, LA SIBILLA PERSICA, E LA FINE DELLA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO.
Una nota a margine di un evento...
A #NAPOLI, IL GIORNO 4 DICEMBRE 2023, Maura Sgarro con i suoi "Colloqui con quattordici artisti del Seicento europeo" (kimerik.it, 2023) e Aurelio Musi con la sua "Malinconia barocca" (Neri Pozza, 2023), faranno una doppia presentazione dei loro libri e, ad essa, come annuncia la dr.ssa Sgarro, «"sara’ presente" anche P. P. Rubens con il suo quadro "Le conseguenze della guerra" del 1638» (https://www.facebook.com/maura.sgarro.125/posts/pfbid0X5gFzPRc7MRdJTF2vsYEiDmQmM5GrP7KEpckAV9839aRxvfLUuXT2eydu7mQWdXxl). Approfittando dell’occasione, forse, è una buona idea richiamare l’attenzione su una opera giovanile di #Rubens, legata alla complessa storia del tema delle #Sibille, alla SibillaCumana, alle Sibille della #CappellaSistina, alla filosofia del Rinascimento, e allo stesso #Barocco (cfr. Giovan Battista Marino, "Dicerie Sacre", 1614; e "Adone", 1623).
"RUBENS. ALLEGORIA DELLA FEDE. LA SIBILLA PERSICA [...] L’Allegoria della Fede. La #SibillaPersica [...] È un capolavoro della prima maturità di Rubens (Siegen, 1577-Anversa, 1640), appena rientrato da Roma ad Anversa tra il 1611 e il 1614 [....] rappresenta l’Allegoria della Fede cristiana, come testimonia il libro aperto con il disegno dell’Immacolata Concezione sul quale la nobildonna punta l’indice. Nel monocolo la Vergine è colta nel suo ruolo di dominatrice del male. [...]
- LA PERIZIA DI GIOVANNI TESTORI:
[...] Il dipinto impone il riconoscimento della Sibilla, non in una generica allegoria della fede, ma nella Sibilla Persica, associata alla profezia della nascita di Cristo dalla Vergine, sottomettendo la bestia demoniaca per la salvezza del genere umano [...]
 La Persica viene per lo più rappresentata col capo coperto con veste damascata e ricami in oro così come appare nel presente dipinto, così come la scelta di rappresentare una sibilla non in vesti antiche o greco-romane o orientali è tipicamente fiamminga [...] Quasi nella posa di un’annunciata sorpresa durante la lettura, appare, diversamente da come ci si potrebbe attendere, per via dell’iscrizione circolare entro cui è racchiusa ancora giovane, con il volto non coperto dal velo o copricapo [...]
La Persica viene per lo più rappresentata col capo coperto con veste damascata e ricami in oro così come appare nel presente dipinto, così come la scelta di rappresentare una sibilla non in vesti antiche o greco-romane o orientali è tipicamente fiamminga [...] Quasi nella posa di un’annunciata sorpresa durante la lettura, appare, diversamente da come ci si potrebbe attendere, per via dell’iscrizione circolare entro cui è racchiusa ancora giovane, con il volto non coperto dal velo o copricapo [...]
 Un ritratto in veste sibillina di una donna di condizioni sociali elevate, dotata di virtù morali e intellettuali, di un’illuminazione mentale, assistita dal volere divino e alla qualità per eccellenza della profetessa, di età non avanzata, in opposizione alla vecchia lectio secondo la quale la Persica andava ritenuta la più vecchia delle sibille”. (Arte.it).
Un ritratto in veste sibillina di una donna di condizioni sociali elevate, dotata di virtù morali e intellettuali, di un’illuminazione mentale, assistita dal volere divino e alla qualità per eccellenza della profetessa, di età non avanzata, in opposizione alla vecchia lectio secondo la quale la Persica andava ritenuta la più vecchia delle sibille”. (Arte.it).-
>"RUBENS. ALLEGORIA DELLA FEDE. LA SIBILLA PERSICA" ---- ELSHEIMER E IL "CIELO STELLATO": GALILEO GALILEI E IL CIGOLI E LA LUNA IN SANTA MARIA MAGGIORE A ROMA.4 dicembre 2023, di Federico La Sala
CIELO STELLATO E MALINCONIA BAROCCA. COSMOLOGIA, RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E ARTISTICA, MA NON ANTROPOLOGICA: QUANDO L’ITALIA E L’EUROPA CADDERO IN UN VICOLO CIECO (1618-1648). Una sollecitazione a ripensare la #storiografia dei primi decenni del #Seicento...
Un omaggio al lavoro di Maura Sgarro ("Colloqui con quattordici artisti del Seicento europeo", Kimerik 2023) e di Aurelio Musi ("Malinconia barocca", Neri Pozza 2023).
MEMORIA E #STORIA: #ELSHEIMER E #RUBENS. "Adam #Elsheimer (Francoforte sul Meno, 16 settembre 1578 - Roma, 11 dicembre 1610): [...] Secondo i biografi, Elsheimer, che lavorava molto lentamente e che lasciò pochissime opere (oggi se ne contano una trentina), morì perciò quasi in povertà. Una famosa lettera, piena di dolore, di #Rubens a Johann Faber che lo informava da Roma della scomparsa dell’amico, è forse il miglior tributo fatto a questo artista. Fu sepolto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma, dove nel 2010 è stata apposta una lapide-cenotafio con profilo in bronzo e l’iscrizione che ricorda tra l’altro: "Nel 1609 dipinse / il cielo stellato / osservandolo / con uno dei primi / telescopi".
ARTE E #SCIENZA: CIGOLI, GALILEO GALILEI, E LA LUNA. [...] Quella fra Galileo e il Cigoli è, semplicemente, l’amicizia di una vita. Ce ne resta la testimonianza attraverso 29 lettere di Cigoli a Galileo e solo due dello scienziato al pittore perché gli eredi dell’artista, con eccessivo zelo, ritennero di dover distruggere tutte le prove di un sodalizio compromettente dopo la condanna papale. [...] Cigoli si trasferisce da Firenze a Roma nel 1604; Galileo all’epoca è ancora a Padova. Tornerà a Firenze nel 1610. [...]
 Nell’ottobre del 1610 Cigoli riceve da Papa Paolo V l’incarico di affrescare la cupola di Santa Maggiore Maggiore con l’Immacolata Concezione, Apostoli e Santi. La fatica è resa da questo passo nella lettera del 1° luglio 1611: “Nel resto, io attendo a salire 150 scalini a Santa Maria Maggiore et a tirare a fine allegramente, a questi caldi estivi che disfanno altrui; et ivi, senza esalare vento né punto di motivo di aria, tra il caldo e l’umido che contende, me la passerò tutta questa state”. Ma sui ponteggi e sulla cupola di Santa Maria Maggiore succedono cose bellissime. Succede, ad esempio (lettera del 23 marzo 2612), che Cigoli usi un cannocchiale galileiano per osservare le macchie solari: 26 osservazioni, disegnate appositamente per Galileo (fig. 3); [...] Succede poi che nell’ottobre del 1612, dopo oltre due anni di lavoro, l’affresco sia completato, e che l’Immacolata Concezione sia strutturata secondo un’iconografia del tutto nuova: una Madonna in piedi su una luna perfettamente galileiana (fig. 4) , la stessa luna (fig. 1) le cui fasi Galileo aveva dipinto all’acquerello in uno dei suoi studi (fig. 2). La testimonianza commovente di un amico fedele.
Nell’ottobre del 1610 Cigoli riceve da Papa Paolo V l’incarico di affrescare la cupola di Santa Maggiore Maggiore con l’Immacolata Concezione, Apostoli e Santi. La fatica è resa da questo passo nella lettera del 1° luglio 1611: “Nel resto, io attendo a salire 150 scalini a Santa Maria Maggiore et a tirare a fine allegramente, a questi caldi estivi che disfanno altrui; et ivi, senza esalare vento né punto di motivo di aria, tra il caldo e l’umido che contende, me la passerò tutta questa state”. Ma sui ponteggi e sulla cupola di Santa Maria Maggiore succedono cose bellissime. Succede, ad esempio (lettera del 23 marzo 2612), che Cigoli usi un cannocchiale galileiano per osservare le macchie solari: 26 osservazioni, disegnate appositamente per Galileo (fig. 3); [...] Succede poi che nell’ottobre del 1612, dopo oltre due anni di lavoro, l’affresco sia completato, e che l’Immacolata Concezione sia strutturata secondo un’iconografia del tutto nuova: una Madonna in piedi su una luna perfettamente galileiana (fig. 4) , la stessa luna (fig. 1) le cui fasi Galileo aveva dipinto all’acquerello in uno dei suoi studi (fig. 2). La testimonianza commovente di un amico fedele.
 Su Cigoli si può contare, e Galileo non esita a chiederne l’aiuto in vista della pubblicazione dell’Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, a cura dell’Accademia dei Lincei. Ad occuparsi della pubblicazione è direttamente Federico Cesi, il Principe dell’Accademia; ma per scegliere l’incisore che dovrà occuparsi della parte iconografica dell’opera sia Cesi sia Galileo concordano nel rivolgersi a Cigoli . Fu scelto poi l’incisore lussemburghese Matthias Greüter. [...]" (cfr. "
Su Cigoli si può contare, e Galileo non esita a chiederne l’aiuto in vista della pubblicazione dell’Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, a cura dell’Accademia dei Lincei. Ad occuparsi della pubblicazione è direttamente Federico Cesi, il Principe dell’Accademia; ma per scegliere l’incisore che dovrà occuparsi della parte iconografica dell’opera sia Cesi sia Galileo concordano nel rivolgersi a Cigoli . Fu scelto poi l’incisore lussemburghese Matthias Greüter. [...]" (cfr. "
RAGIONE E FEDE: GALILEO E LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA. "[..." class="spip_out">Galileo e Ludovico Cigoli: la Luna e le #macchiesolari fra scienza ed arte
Il 25 febbraio 1616 il papa ordinò al cardinale Bellarmino di «convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione; e se si fosse rifiutato di obbedire, il Padre Commissario, davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla». Nello stesso anno il De revolutionibus di Copernico fu messo all’Indice donec corrigatur (fino a che non fosse corretto). Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane: forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto, fecero cadere Galileo nell’illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. [...]" (https://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei).#Cosmicomiche #calvino100 #rinascimento #astronomia #barocco #8dicembre
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- LA "PRISCA THEOLOGIA", LA SIBILLA CUMANA, E LA "#CHARITAS". L’IDEA DI SAPIENZA DI ANTONIO ROSMINI, NELLA LETTERA "AD THEOLOGIAM PROMOVENDA".6 novembre 2023, di Federico La Sala
#PROFETI, #SIBILLE, #QUESTIONEANTROPOLOGICA (#KANT, 1800), E #FILOLOGIA:
ANTONIO #ROSMINI, LA "PRISCA THEOLOGIA", E LA "#CHARITAS".
- Una nota a margine della sollecitazione della Lettera apostolica "Ad theologiam promovenda" *, a riprendere e a ripensare la "Idea di Sapienza" di A. Rosmini *
Rileggere il testo della "BREVE DISSERTAZIONE DI ANTONIO ROSMINI SULLE SIBILLE" (#Patricia Salomoni, "#RosminiStudies", 6, 2019). Che Rosmini abbia iniziato il suo percorso riflettendo sulle figure delle Sibille, è da considerarsi un fatto degno della massima attenzione - e, ovviamente, di ulteriore approfondimento!
 La riflessione su tale tema, probabilmente, lo ha reso più vigile nel suo cammino e nella sua fedeltà alla lettera e allo spirito della "Charitas". Il "Kant italiano", infatti, iniziando il suo percorso con la tesi di laurea sulle Sibille (1822), non solo non ha perso il suo legame con la Grazia (Charis) e con le Grazie (Charites), ma - coerentemente - ha saputo custodire anche l’«h» della #Charitas! E ha cercato di tenere ferma la sua distanza dalla logica economica - sempre più dilagante - della "carità" del "mercato" ("caritas") e, al contempo, dalla politica di sostegno alla diffusione della "eu-carestia" - a tutti i livelli. Ma, alla fine, non è riuscito a coniugare - come voleva, in spirito di verità e carità - - il rapporto tra filosofia (sapienza pagana) e rivelazione (sapienza ebraica).
La riflessione su tale tema, probabilmente, lo ha reso più vigile nel suo cammino e nella sua fedeltà alla lettera e allo spirito della "Charitas". Il "Kant italiano", infatti, iniziando il suo percorso con la tesi di laurea sulle Sibille (1822), non solo non ha perso il suo legame con la Grazia (Charis) e con le Grazie (Charites), ma - coerentemente - ha saputo custodire anche l’«h» della #Charitas! E ha cercato di tenere ferma la sua distanza dalla logica economica - sempre più dilagante - della "carità" del "mercato" ("caritas") e, al contempo, dalla politica di sostegno alla diffusione della "eu-carestia" - a tutti i livelli. Ma, alla fine, non è riuscito a coniugare - come voleva, in spirito di verità e carità - - il rapporto tra filosofia (sapienza pagana) e rivelazione (sapienza ebraica).
 Già all’inizio del suo percorso, benché partito con buona volontà e - kantianamente ("Sapere aude!") - con gran coraggio, infatti, egli s’inchina all’autorità di sant’Agostino ("De Civitate Dei", XVIII, 47) e - pur rendendosi conto con lo stesso Agostino che "qualsiasi predizione su Cristo poteva essere dichiarata falsa dagli empi e soggiacere al medesimo discredito, sia che si trattasse degli oracoli delle Sibille o delle profezie degli Ebrei" - conclude con un "non è gradito a Lui stesso che, nelle dispute, noi dedichiamo troppe energie più a quelli che a queste" e attribuisce la palma della credibilità solo a "queste .. certissime, luminosissime, custodite dal popolo ebraico a noi assai ostile, e protette da ogni corruzione con incomparabile ed encomiabile cura nel corso di molti secoli" (P. Salomoni, cit, p. 227).
A partire da "queste" premesse (promesse già non mantenute!), ovviamente, accolta solo la parola dei "profeti" non si può che rinarrare e riscrivere la vecchia "storia dell’Amore" di Adamo ed Eva [...] E così, contravvenendo frettolosamente alle regole morali del suo stesso "metodo filosofico", il suo desiderio di lasciarsi guidare "in tutti i suoi passi dall’amore della verità", come dalla carità ("charitas") piena di grazia (charis), resta confinato nell’orizzonte della caduta e della minorità - e la presenza delle Sibille insieme ai Profeti nella Volta della #CappellaSistina è ancora un grosso problema! (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3...).
Già all’inizio del suo percorso, benché partito con buona volontà e - kantianamente ("Sapere aude!") - con gran coraggio, infatti, egli s’inchina all’autorità di sant’Agostino ("De Civitate Dei", XVIII, 47) e - pur rendendosi conto con lo stesso Agostino che "qualsiasi predizione su Cristo poteva essere dichiarata falsa dagli empi e soggiacere al medesimo discredito, sia che si trattasse degli oracoli delle Sibille o delle profezie degli Ebrei" - conclude con un "non è gradito a Lui stesso che, nelle dispute, noi dedichiamo troppe energie più a quelli che a queste" e attribuisce la palma della credibilità solo a "queste .. certissime, luminosissime, custodite dal popolo ebraico a noi assai ostile, e protette da ogni corruzione con incomparabile ed encomiabile cura nel corso di molti secoli" (P. Salomoni, cit, p. 227).
A partire da "queste" premesse (promesse già non mantenute!), ovviamente, accolta solo la parola dei "profeti" non si può che rinarrare e riscrivere la vecchia "storia dell’Amore" di Adamo ed Eva [...] E così, contravvenendo frettolosamente alle regole morali del suo stesso "metodo filosofico", il suo desiderio di lasciarsi guidare "in tutti i suoi passi dall’amore della verità", come dalla carità ("charitas") piena di grazia (charis), resta confinato nell’orizzonte della caduta e della minorità - e la presenza delle Sibille insieme ai Profeti nella Volta della #CappellaSistina è ancora un grosso problema! (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3...).*
"AD THEOLOGIAM PROMOVENDA" (L’Osservatore Romano, 03 novembre 2023). Per promuovere la teologia, nel paragrafo 7, è scritto che Rosmini considerava la #teologia una espressione sublime di “carità intellettuale” ... chiedeva che la ragione critica di tutti i saperi si orientasse all’Idea di #Sapienza e [sapesse stringere] interiormente in un “circolo solido” la Verità e la Carità insieme [...] (https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-11/quo-252/ad-theologiam-promovenda.html ).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- STORIA E ANTROPOLOGIA IN CAMMINO: MEMORIA DELLA "MADONNA DELLA NEVE" (5 AGOSTO) E DEL "TONDO DONI" DI MICHELANGELO.5 agosto 2023, di Federico La Sala
STORIA, LETTERATURA, E IMMAGINARIO COSMOLOGICO E TEOLOGICO-POLITICO:
EUROPA, 5 AGOSTO 2023...
A) RICORRENZA (E MEMORIA FACOLTATIVA) DELLA CHIESA CATTOLICA: "MADONNA DELLA NEVE. 5 AGOSTO".
"Santa Maria della Neve. Dedicazione della basilica di Santa Maria Maggiore":
- La festa della Beata Vergine della Neve è una delle più celebri, specie in Italia, ove numerosi sono i Santuari dedicati alla Madonna sotto questo titolo.
- Viveva in Roma nel secolo IV, sotto il pontificato del Papa Liberio, un nobile patrizio di nome Giovanni, il quale, non meno che la sua consorte, di nome Maria, era acceso di grande amore verso la SS. Vergine. Non avendo figliuoli, andava pensando quale fosse la volontà di Dio a loro riguardo acciocchè potessero sempre meglio servirlo usando in bene le loro cospicue ricchezze. Maria SS., alla quale essi di continuo rivolgevano ferventi suppliche, aveva però su di loro disegni cui certo essi non avrebbero mai pensato: voleva che in Roma venisse eretto un santuario in suo onore. Per questo apparve in sogno ai due suoi devoti manifestando il suo desiderio; indicò pure il luogo ove dovevano farlo costruire, annunziando che nel giorno appresso avrebbero trovato uno dei sette colli di Roma bianco di neve.
- Giovanni e Maria furono assai contenti e ringraziarono il Signore di gran cuore. Venuta poi la mattina, Giovanni volle visitare i colli sicuro di vedervi il miracolo nonostante la calma di agosto; ed il miracolo era veramente avvenuto sull’Esquilino ove doveva essere costruita la chiesa. Manifestò la visione e il miracolo al Papa, e questi, che aveva avuto la medesima visione « io pure, disse il Papa, ebbi la stessa visione, ed è segno che Maria scelse quel colle a stia gloria », fu ben lieto di approvare e benedire l’opera. Subito si scavarono le fondamenta ed in poco tempo la basilica fu compiuta per opera dei due bravi cristiani, rimanendo così a perpetuo ricordo della loro devozione a Maria.
- Questo grandioso monumento alla Madre di Dio fu dapprima chiamato Basilica Liberiana per ricordale il Pontefice Liberio che aveva approvato i disegni; ma in seguito, oltre al nome di S. Maria al Presepe venutole per la culla del Redentore ivi portata, venne chiamata S. Maria Maggiore e dedicata alla Beata Vergine della Neve. (Santo del giorno: "5 agosto"?
B) "L’AUTUNNO DEL MEDIOEVO" (J. HUIZINGA). "Filippo il Buono di Borgogna sposò nel 1430 Isabella del Portogallo. In questa occasione - o forse quale omaggio alla popolazione di allora, stupenda nel navigare - fondò l’ordine del Toson d’Oro. I suoi protettori erano Giasone e Gedeone. Anche nella loro storia un vello miracoloso aveva avuto la sua parte (Libro dei Giudici, VI, 36-40)" (cfr. DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA: P. S. 5).
C) "Sul valore simbolico del Toson d’oro: Giasone, Gedeone e il Vello d’oro in un’enciclopedia medievale": "Una nutrita serie di studi recenti testimonia dell’ininterrotto interesse destato dal più famoso e prestigioso degli ordini cavallereschi fondati nel Medio Evo, l’ordine del Toson d’oro . Pur analizzando la nobile confraternita, istituita il 10 gennaio del 1430 a Bruges, da molte angolature, i lavori degli ultimi anni non hanno portato novità importanti per la soluzione d’un problema senz’altro centrale, il perché della scelta del vellus aureum quale insegna della comunità. In questa nota vorrei gettare qualche luce sulla questione.
- Come si sa, l’ordine venne fondato da Filippo il Buono (1396-1467), duca di Borgogna a partire dal 1419. Nella sua biblioteca si trovava l’Ovide moralisé, un poema anonimo del primo Trecento che allegorizza in vari modi il mito della spedizione degli Argonauti così come lo raccontano le Metamorfosi ovidiane. Un passo del testo francese, commentato recentemente da Claudine Lemaire, stabilisce un parallelo tra la presa del Toson d’oro da parte di Giasone e la «presa di carne umana» da parte di Cristo, associando in qualche modo il mitico vello e il corpo di Gesù. Un altro brano dell’opera, sfuggito alla studiosa, offre qualcosa di più concreto: in esso, l’ignoto poeta identifica la pelle conquistata dall’eroe greco con la verginità di Maria [...]" (Tobias Leuker, Sul valore simbolico del Toson d’oro: Giasone, Gedeone e il Vello d’oro in un’enciclopedia medievale", "Studi Francesi", settembre-dicembre 2006, senza le note).
D) VOCAZIONE DI GEDEONE: "LA PROVA DEL VELLO" ("GIUDICI", VI. 36-40)
[36]Gedeone disse a Dio: «Se tu stai per salvare Israele per mia mano, come hai detto, [37]ecco, io metterò un vello di lana sull’aia: se c’è rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno resta asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto». [38]Così avvenne. La mattina dopo, Gedeone si alzò per tempo, strizzò il vello e ne spremette la rugiada: una coppa piena d’acqua. [39]Gedeone disse a Dio: «Non adirarti contro di me; io parlerò ancora una volta. Lasciami fare la prova con il vello, solo ancora una volta: resti asciutto soltanto il vello e ci sia la rugiada su tutto il terreno». [40]Dio fece così quella notte: il vello soltanto restò asciutto e ci fu rugiada su tutto il terreno.
E) CAPPELLA SISTINA (ROMA, 14775-1481). "La Cappella Sistina (in latino: Sacellum Sixtinum), dedicata a Maria Assunta in Cielo, è la principale cappella del palazzo apostolico, nonché uno dei più famosi tesori culturali e artistici della Città del Vaticano, inserita nel percorso dei Musei Vaticani. Fu costruita tra il 1475 e il 1481 circa, all’epoca di papa Sisto IV della Rovere, da cui prese il nome. È conosciuta in tutto il mondo sia per essere il luogo nel quale si tengono il conclave e altre cerimonie ufficiali del papa (in passato anche alcune incoronazioni papali), sia per essere decorata da opere d’arte tra le più conosciute e celebrate della civiltà artistica mondiale, tra le quali spiccano i celeberrimi affreschi di Michelangelo, che ricoprono la volta (1508-1512)[2] e la parete di fondo (del Giudizio universale) sopra l’altare (1535-1541 circa). È considerata forse la più completa e importante di quella «teologia visiva, che è stata chiamata Biblia pauperum». [...] Esiste anche una "Cappella Sistina" nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, edificata da Sisto V, e una nella cattedrale di Savona, fatta edificare da Sisto IV come mausoleo per i propri genitori defunti [...]" (Wikipedia).
F) ANTROPOLOGIA, ARTE, E CRISTOLOGIA ("ECCE HOMO"). La "memoria" di Michelangelo Buonarroti: Sacra famiglia, detta “Tondo Doni”.
G) UOMINI E DONNE, PROFETI E SIBILLE, OGGI: STORIA DELLE IDEE E DELLE IMMAGINI. A CONTURSI TERME (SALERNO), IN EREDITA’, L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE (1613).
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI. --- L’ UTOPIA DI TOMMASO MORO, IL MATRIMONIO DI MARTIN LUTERO E KATHARINA VON BORA, E "THE BOOK OF SIR THOMAS MORE" (SHAKESPEARE).22 luglio 2023, di Federico La Sala
CRISTIANESIMO E GEOPOLITICA, SENZA PREGIUDIZI, ALLA LUCE ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA DEI "DUE SOLI" (DANTE 2021):
- MEMORIA DEL MATRIMONIO DI MARTIN LUTERO E KATHARINA VON BORA (1525).
- Guardando con gli occhi di Shakespeare ("The Book of Sir Thomas More"), e di Elisabetta d’Inghilterra (dopo il 1588), lo "splendore" delle figure di Tommaso Moro e di Erasmo è alquanto oscurato, data la loro "amicizia" con la visione teologico-politica platonica (cosmoteandrica e "golematica") della Chiesa cattolico e del Papato dell’epoca. 🌞🌞🙏
STORIA DI EUROPA, DI IERI E DI OGGI: "THE BOOK OF SIR THOMAS MORE". Partendo dal suo tempo (quasi cento anni dopo), Shakespeare cerca di chiarire il percorso che l’Inghilterra di EnricoVIII ed Elisabetta ha fatto e che cosa ha guadagnato, a partire dagli eventi del 1517 e dopo la rottura con la Chiesa Cattolica e dopo la Riforma Anglicana!
 Una possibile chiave interpretativa sta proprio nella natura del conflitto teologico-politico (e nel legame di Tommaso Moro con le indicazioni di san Paolo, e del Papa):
Una possibile chiave interpretativa sta proprio nella natura del conflitto teologico-politico (e nel legame di Tommaso Moro con le indicazioni di san Paolo, e del Papa):
 " Voi volete schiacciare gli stranieri [...]"Supponiamo adesso che il re, nella sua clemenza verso i trasgressori pentiti, giudicasse il vostro grave reato limitandosi a punirvi con l’esilio: dove andreste, allora?
Quale paese vi accoglierebbe vedendo la natura del vostro errore? Che andiate in #Francia o nelle #Fiandre, in qualsiasi provincia della #Germania, in #Spagna o in #Portogallo, anzi no, un luogo qualunque #diverso dall’Inghilterra, vi ritroverete inevitabilmente stranieri.
Vi farebbe piacere trovare una nazione dal carattere così barbaro che [...] vi cacciasse via come cani, quasi che Dio non vi avesse creati né vi riconoscesse come suoi figli [...]?". Questo il problema, a mio parere.
" Voi volete schiacciare gli stranieri [...]"Supponiamo adesso che il re, nella sua clemenza verso i trasgressori pentiti, giudicasse il vostro grave reato limitandosi a punirvi con l’esilio: dove andreste, allora?
Quale paese vi accoglierebbe vedendo la natura del vostro errore? Che andiate in #Francia o nelle #Fiandre, in qualsiasi provincia della #Germania, in #Spagna o in #Portogallo, anzi no, un luogo qualunque #diverso dall’Inghilterra, vi ritroverete inevitabilmente stranieri.
Vi farebbe piacere trovare una nazione dal carattere così barbaro che [...] vi cacciasse via come cani, quasi che Dio non vi avesse creati né vi riconoscesse come suoi figli [...]?". Questo il problema, a mio parere. -
>LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, ANTROPOLOGIA, E TEOLOGIA: UN PIANETA TERRA DA RIPENSARE E UN IMMAGINARIO DA RISTRUTTURARE.9 luglio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E TEOLOGIA.
UN PIANETA TERRA DA RIPENSARE E UN IMMAGINARIO DA RISTRUTTURARE: PENSARE L’ EDIPO COMPLETO (S. FREUD). UNA QUESTIONE DI ILLUMINAZIONE (E DI ILLUMINISMO KANTIANO): "NOI ALUNNI DEL SOLE". In memoria di Italo Calvino.
- "Oriente e Occidente - scrive Nietzsche - sono tratti di gesso che qualcuno disegna davanti ai nostri occhi per beffarsi della nostra pavidità" ("Schopenhauer come educatore").
Appunti su un tema del "genere" (il Sole, l’astro del cielo, un dio o una dea?):
A) IL SOLE ("DIE SONNE") DI ZARATHUSTRA (NIETZSCHE):
"Quand’ebbe compiuto il trentesimo anno, Zarathustra lasciò la sua patria e il lago natìo, e si recò su la montagna. Là per dieci anni gioì, senza stancarsene, del suo spirito e della sua solitudine.
 Ma al fine il suo cuore si mutò; e un mattino egli si levò con l’aurora, s’avanzò verso il sole e così gli disse:
Ma al fine il suo cuore si mutò; e un mattino egli si levò con l’aurora, s’avanzò verso il sole e così gli disse:
 «Oh grande astro! Che sarebbe della tua felicità, se tu non avessi a chi splendere?
«Oh grande astro! Che sarebbe della tua felicità, se tu non avessi a chi splendere?
 Per dieci anni tu sei venuto alla mia caverna: ti saresti recato a noja la tua luce e il tuo cammino senza di me e del mio serpente.
Per dieci anni tu sei venuto alla mia caverna: ti saresti recato a noja la tua luce e il tuo cammino senza di me e del mio serpente.
 Ma noi ti attendevamo tutte le mattine, tu ci davi il tuo superfluo e ne avevi ricambio di benedizioni." ("Così parlò #Zarathustra/Parte prima/Prefazione");
Ma noi ti attendevamo tutte le mattine, tu ci davi il tuo superfluo e ne avevi ricambio di benedizioni." ("Così parlò #Zarathustra/Parte prima/Prefazione");- "Als Zarathustra dreissig Jahr alt war, verliess er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahr nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, - und eines Morgens stand er mit der Morgenröthe auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also:
 “Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest!
“Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest!
 Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange.
Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür.”.
Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange.
Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür.”.
B) MITOLOGIA NORRENA ("EDDA DI SNORRI"). LA SIGNORA DEL SOLE ("FRAU SUNNE"):
 "Sól era, nella mitologia norrena, la dea del Sole, figlia di Mundilfœri e moglie di Glenr.
Ogni giorno, Sól guida attraverso il cielo il suo carro, tirato da due cavalli, Árvakr e Alsviðr.
Così se ne parla nel Gylfaginning, la prima parte dell’Edda in prosa basso-medievale di Snorri Sturluson (circa 1220 d.C.) [...]
Sól era chiamata anche Sunna e Sunne, e inoltre Frau Sunne (Signora del Sole) [...]" (Sól);
"Sól era, nella mitologia norrena, la dea del Sole, figlia di Mundilfœri e moglie di Glenr.
Ogni giorno, Sól guida attraverso il cielo il suo carro, tirato da due cavalli, Árvakr e Alsviðr.
Così se ne parla nel Gylfaginning, la prima parte dell’Edda in prosa basso-medievale di Snorri Sturluson (circa 1220 d.C.) [...]
Sól era chiamata anche Sunna e Sunne, e inoltre Frau Sunne (Signora del Sole) [...]" (Sól);C) AMATERASU ("LA DEA DEL SOLE"):
 "Amaterasu-ō-mi-kami (天照大御神 lett. "Grande dea che splende nei cieli"?), generalmente abbreviato in Amaterasu, è la dea del Sole nello shintoismo giapponese. È considerata la mitica antenata diretta della famiglia imperiale giapponese.
Amaterasu è comunemente indicata come di genere femminile, nonostante il Kojiki, il più antico documento scritto della storia nipponica, dia pochi indizi riguardo al suo genere [...]" (Amaterasu);
"Amaterasu-ō-mi-kami (天照大御神 lett. "Grande dea che splende nei cieli"?), generalmente abbreviato in Amaterasu, è la dea del Sole nello shintoismo giapponese. È considerata la mitica antenata diretta della famiglia imperiale giapponese.
Amaterasu è comunemente indicata come di genere femminile, nonostante il Kojiki, il più antico documento scritto della storia nipponica, dia pochi indizi riguardo al suo genere [...]" (Amaterasu);D) QUESTIONE ANTROPOLOGICA E PSICOANALISI. L’ESISTENZA DEL "COMPLESSO EDIPICO COMPLETO" (S. FREUD, 1923);
 "[...] Vedere il caso del Giappone - nella cultura giapponese c’è la Dea in cielo, e l’imperatore sulla terra; ora-oggi!!!, dal momento che alla coppia imperiale è nata una bambina, si parla di cambiare la Costituzione per far sì che Lei possa accedere al trono ... ma il problema è più complesso - come si può ben immaginare - perché ... deve essere cambiata anche la Costituzione celeste dell’Impero del Sol Levante!!! Se no, l’Imperatrice con Chi si ’sposerà’?! Con la Dea?!!
"[...] Vedere il caso del Giappone - nella cultura giapponese c’è la Dea in cielo, e l’imperatore sulla terra; ora-oggi!!!, dal momento che alla coppia imperiale è nata una bambina, si parla di cambiare la Costituzione per far sì che Lei possa accedere al trono ... ma il problema è più complesso - come si può ben immaginare - perché ... deve essere cambiata anche la Costituzione celeste dell’Impero del Sol Levante!!! Se no, l’Imperatrice con Chi si ’sposerà’?! Con la Dea?!!
 Non è questa forse la ragione nascosta del “disagio della civiltà” dell’Oriente e dell’Occidente ..... e anche della sua fine, se non ci portiamo velocemente fuori da questo orizzonte edipico-capitalistico di peste, di guerra e di morte? [...]" (Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante).
Non è questa forse la ragione nascosta del “disagio della civiltà” dell’Oriente e dell’Occidente ..... e anche della sua fine, se non ci portiamo velocemente fuori da questo orizzonte edipico-capitalistico di peste, di guerra e di morte? [...]" (Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante). -
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- ANTROPOLOGIA E STORIOGRAFIA: EUROPA 1453-1614. "LA PACE DELLA FEDE" (CUSANO, 1453) LE “DICERIE SACRE” (G. B. MARINO, 1614), E UN’OPERA DI ANTONIO CANOVA.7 luglio 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, ARTE, FILOLOGIA, E STORIOGRAFIA.
- EUROPA 1453-1614: LA FINE DEL SOGNO DELLA "PACE DELLA FEDE" (CUSANO, 1453)
UNA “SOPRAVVIVENZA” DELLE “DICERIE SACRE” (G. B. MARINO, 1614) IN UN LAVORO IN CRETA DI ANTONO CANOVA (1757-1822). *
RI-LEGGENDO INSIEME LE “DICERIE SACRE” (1614) E IL POEMA “ADONE” (1623) di Giovan Battista Marino E RECUPERANDO (alla luce delle indicazioni date dal “professore con la rosa in mano”) il contesto ideologico del programma umanistico-rinascimentale della “prisca teologia” e della “docta religio”, e, AL CONTEMPO, RIPONENDO ATTENZIONE a un “modello in creta della dea Venere che abbraccia Adone morente”, realizzato da Antonio Canova, forse, non appare ("cum grano salis") ben visibile il filo che lega l’orizzonte storico-culturale di Michelangelo Buonarroti con quello di Giovan Battista Marino, e, infine, gli stessi Carmelitani scalzi di Contursi Terme (Salerno), che affrescano e dedicano (nel 1613) la loro Chiesa della Madonna del Carmine con la figure di 12 Sibille?
Qualche anno più tardi, dopo la morte di ShaKespeare, Cervantes, e Garcilaso El Inca de la Vega nel 1616, prenderà il via la Guerra dei Trentanni e tutti i sogni di una “pace della fede” (Niccolò Cusano, “De pace fidei”, 1453) vanno in fumo.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- PLATONISMO DI LUNGA DURATA, "PRISCA" TEOLOGIA E "DICERIE SACRE" (GIOVAN BATTISTA MARINO, 1614)1 luglio 2023, di Federico La Sala
PLATONISMO DI LUNGA DURATA E TRAGEDIA:
"MASCHERE PLATONICHE"... DI UNA RAGIONE TRAGICA E DI UNA "STORIA NOTTURNA".
- Un omaggio alla riflessione sul platonismo di Flavio Piero Cuniberto *
DIVINA COMMEDIA E ARCHEOLOGIA FILOSOFICA. Per meglio capire "il problema Socrate" e gli interi millenni di labirinto (Nietzsche) e, possibilmente, uscire dall’#inferno antropologico ed epistemologico della "storia notturna" (#CarloGinzburg) in cui ancora ci agitiamo pericolosamente, forse, è opportuno portarsi oltre "il platonismo classico" con chi, come #DanteAlighieri, ha saputo ascoltare il canto delle #Sirene e con Giasone ("Un punto solo m’è maggior letargo / che venticinquesecoli a la ‘mpresa, / che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo." (Pd. XXXIII, 94-96), ha saputo "ricostruire" la nuova Arca, la nuova Argo, e, finalmente, sollecitare a riprendere la navigazione nell’oceanoceleste (Keplero a Galileo Galilei, 1611).
P. S. - MASCHERE ANTICHE, "PRISCA TEOLOGIA", E "DICERIE SACRE" (1614): "[...] E chi non sa che sotto l’invoglio di così fatti velami et enimmi soleva molti, anzi tutti i più riposti e maravigliosi secreti nascondere la supestiziosa antichità? Che perciò ritrovate furono le statue de’ sileni, le cui concave viscere erano gravide de’ simulacri degl’iddii, accioché i divini arcani si tenessero alla gente vulgare appannati et occulti. Più oso di dire: che sotto queste bende misteriose non solo si celano le fallacie delle bugiarde deità degli Etnici, ma chiunque con zelo pio e con ingegno catolico prende a spiarle addentro, vi può contemplare eziandio adombrati assaissimi sacramenti della cristiana religione."(Giovan Battista Marino, "Dicerie Sacre", 1614).
- Note di approfondimento ... *
L’ONDA LUNGA DEL RINASCIMENTO MERIDIONALE E E LA LEZIONE CRITICA DI PADRE GIOVANNI POZZI: GIOVAN BATTISTA MARINO, LE “DICERIE SACRE”, E DUE MAGISTRATI DELLA FAMIGLIA PEPI DI CONTURSI TERME (SALERNO), NELLA BASILICA DI SAN DOMENICO MAGGIORE A NAPOLI.
A) - MEMORIA E STORIA: BASILICA DI SAN DOMENICO MAGGIORE (NAPOLI). NELLA CAPPELLA CON L’ALTARE dove c’è la “MadonnadellaNeve tra il Battista e S. Matteo”, a destra, c’è il cenotafio di Giambattista Marino (m. 1625), il famoso poeta secentista, con busto in bronzo, di Bartolomeo Viscontini (1682) e, a sinistra, il monumento sepolcrale di Bartolomeo e Girolamo Pepi (1580), illustri giureconsulti “da Contursi”, con una lapide su cui è scritto: “Bartholomaeo Pepi Iurisconsulto, qui claros gessit summa continentiae et æquitatis laude Magistratus, Parenti optvmo Hieronymoque germano fratri et nomini in omnibus vitæ partibus integerrimo. Marcus Antonius Pepi Dominus Contursii, Sancti Angeli Fasanellæ, Optati, Optatelli, et aliorum Benemerentibus. Anno Domini M.D.LXXX»”.
B) - POLITICA RELIGIONE E ARTE NEL REGNO DI NAPOLI: 12 SIBILLE CON I CARMELITANISCALZI NELLA TERRA (DEL PRINCIPE DI EBOLI E) DELLA FAMIGLIA PEPI. A CONTURSI, nell’ attuale Città di CONTURSI TERME (SALERNO), una grande pala d’altare, collocata sull’altare della Chiesa della Madonna del Carmine, con pareti affrescate con le figure di 12 Sibille, fu commissionata e dedicata dal giureconsulto Paolo Pepi, alla memoria dello zio Paolo Antonio Pepi: «AD HONOREM SACRATISS. VIRGI DE MO/TE CARMELO, ET IN MEMORIA CELE/BERRI IUREC: D. PAULI ANTO. PEPI/... PAULUS PEPI IUREC: PRONEPOS/ / F/EC. ANNO DOMINI 1608/IACOBUS DE ANTORA NEAP. PNGB».
C) - LA “PRISCA TEOLOGIA”, LE SIBILLE E I PROFETI DELLA “CAPPELLA SISTINA”, E ISAAC CASAUBON (Ginevra, 18 febbraio 1559 - Londra, 1º luglio 1614). “Nel 1608, in piena bufera controriformistica, pochi anni prima che in tutta Europa divampassero le guerre di religione e che il filologo Isaac Casaubon (De rebus sacris et eccleslasticis exercitatíones XVI. Ad Cardinalis Baronii prolegomena in Annales, Londra 1614) demolisse “in un sol colpo la costruzione del neoplatonismo rinascimentale con alla base il culto dei prisci teologi principale dei quali era Ermete Trismegisto; [...] la posizione del mago e della magia rinascimentali con il relativo fondamento ermetico- cabalistico; [...] il movimento ermetico cristiano non magico del XVI secolo; [...] la posizione di un ermetico estremista, quale era stato Giordano Bruno; [...] tutti i tentativi di costruire una teologia naturale sull’ermetismo, come quello in cui Campanella aveva riposto le sue speranze”, un ignoto teologo e filosofo carmelitano rimedita nelle linee essenziali il problema e la lezione di Niccolò Cusano, di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola e, con l’aiuto di modesti artisti, a Contursi - in provincia di Salerno, nella chiesetta di Maria SS. del Carmine (monastero di padri carmelitani dal 1561 al 1652), scrive il suo poema sulla nascita e sulla pace fidei. [...]” (Cfr. Federico La Sala, “DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Note sul “Poema” rinascimentale di un ignoto Parmenide carmelitano (ritrovato a Contursi Terme nel 1989)").
D ) GIOVAN BATTISTA MARINO, LE “DICERIE SACRE” (1614), E LA PROPOSTA DI “LETTURA” DI GIOVANNI POZZI: “[...] Possiamo accogliere l’indicazione metodologica di Pozzi anche per quanto riguarda il rapporto con il mito, qui assunto da Marino come “prisca teologia”: sulla scorta di una lunga tradizione, s’intende, ma declinata secondo modalità, se non del tutto inedite, certo pochissimo praticate. Subito all’inizio, Marino rintraccia in molti miti pagani il nucleo di altrettante verità cristiane. L’elenco è sorprendentemente lungo [...]".
 (cfr.Federico La Sala, "Le parole e le cose").
(cfr.Federico La Sala, "Le parole e le cose").FLS
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- MRMORIA E STORIA. Una nota a margine della mostra al Museo e Real Bosco di Capodimonte sul tema “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” .6 giugno 2023, di Federico La Sala
L’ONDA LUNGA DEL RINASCIMENTO.
Una nota a margine della mostra al Museo e Real Bosco di Capodimonte sul tema “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” *
MEMORIA E STORIA: BASILICA DI SAN DOMENICO MAGGIORE (NAPOLI). NELLA CAPPELLA CON L’ALTARE dove c’è la “Madonna della Neve tra il Battista e S. Matteo”, a destra, c’è il cenotafio di Giambattista Marino (m. 1625), il famoso poeta secentista, con busto in bronzo, di Bartolomeo Viscontini (1682) e, a sinistra, il monumento sepolcrale di Bartolomeo e Girolamo Pepi (1580), illustri giureconsulti “da Contursi”, con una lapide su cui è scritto: “Bartholomaeo Pepi Iurisconsulto, qui claros gessit summa continentiae et æquitatis laude Magistratus, Parenti optvmo Hieronymoque germano fratri et nomini in omnibus vitæ partibus integerrimo. Marcus Antonius Pepi Dominus Contursii, Sancti Angeli Fasanellæ, Optati, Optatelli, et aliorum Benemerentibus. Anno Domini M.D.LXXX»”.
12 SIBILLE CON I CARMELITANI SCALZI NELLA TERRA (DEL PRINCIPE DI EBOLI E) DELLA FAMIGLIA PEPI. A CONTURSI, nell’ attuale Città di CONTURSI TERME (SA), una grande pala d’altare, collocata sull’altare della Chiesa della Madonna del Carmine, con pareti affrescate con le figure di 12 Sibille, fu commissionata e dedicata dal giureconsulto Paolo Pepi, alla memoria dello zio Paolo Antonio Pepi: «AD HONOREM SACRATISS. VIRGI DE MO/TE CARMELO, ET IN MEMORIA CELE/BERRI IUREC: D. PAULI ANTO. PEPI/... PAULUS PEPI IUREC: PRONEPOS/ / F/EC. ANNO DOMINI 1608/IACOBUS DE ANTORA NEAP. PNGB».
Per approfondimenti, mi sia lecito, si cfr.: A CONTURSI TERME (SALERNO), IN EREDITA’, L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE).
*
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Il Simbolo Niceno-costantinopolitano (Nicea, 325), "La pace della fede" (N. Cusano, 1453), e la questione antropologica (Nicea, 2025).5 giugno 2023, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA: SPIRITO CRITICO E AMORE CONOSCITIVO...
Alcune considerazioni a margine di una riflessione sul Simbolo Niceno-costantinopolitano (Nicea, 325) o Credo niceno-costantinopolitano (Symbolum Nicaenum Costantinopolitanum):
- "4 GIUGNO 2023. SS. TRINITÀ. PER UNA CRITICA E UNA CELEBRAZIONE DELLA DOTTRINA TRINITARIA". [...] Il Simbolo Niceno dice che il Figlio è «generato» dal Padre, utilizzando un lessico biologico («generato, non creato») che solo l’esperienza concreta della vita naturale può rendere comprensibile. Ma sul piano biologico non c’è paternità e non c’è generazione senza un elemento femminile che riceva l’azione paterna, fungendo poi da «matrice» della prole (l’elemento materno è passivo nell’essere fecondato, e attivo nel mettere alla luce).
 Di questo elemento per così dire femminile, indispensabile alla semantica del Padre e del Figlio, nella teologia trinitaria non SEMBRA esserci traccia (non è lo Spirito a svolgere questa funzione). Non a caso la metafisica idealistica, cripto-teologica, tenterà di uscire dall’impasse eliminando il lessico «parentale» e sostituendolo con un lessico «neutro»: l’Io pone nell’Io un Non-io eccetera (Fichte). Uno-due-tre. Un lessico «principiale» che aggira e sterilizza, con quel «porre» («setzen»), l’ostacolo insormontabile della «generazione» biologica.
Di questo elemento per così dire femminile, indispensabile alla semantica del Padre e del Figlio, nella teologia trinitaria non SEMBRA esserci traccia (non è lo Spirito a svolgere questa funzione). Non a caso la metafisica idealistica, cripto-teologica, tenterà di uscire dall’impasse eliminando il lessico «parentale» e sostituendolo con un lessico «neutro»: l’Io pone nell’Io un Non-io eccetera (Fichte). Uno-due-tre. Un lessico «principiale» che aggira e sterilizza, con quel «porre» («setzen»), l’ostacolo insormontabile della «generazione» biologica.
 Ma è fondamentale quel «sembra». Non si tratta infatti di smontare-decostruire l’idea trinitaria, quanto piuttosto di suggerirne il significato nascosto, nascosto e tuttavia presente in qualche modo nella sua stessa formulazione. Di portare alla luce ciò che la «dottrina» già contiene, e che per qualche ragione rimane fino a un certo punto - in realtà per quasi duemila anni, fino all’estrema consunzione - allo stato di latenza. [...]" (Flavio Piero Cuniberto).
Ma è fondamentale quel «sembra». Non si tratta infatti di smontare-decostruire l’idea trinitaria, quanto piuttosto di suggerirne il significato nascosto, nascosto e tuttavia presente in qualche modo nella sua stessa formulazione. Di portare alla luce ciò che la «dottrina» già contiene, e che per qualche ragione rimane fino a un certo punto - in realtà per quasi duemila anni, fino all’estrema consunzione - allo stato di latenza. [...]" (Flavio Piero Cuniberto).
UN "COMPROMESSO STORICO" DI LUNGA DURATA: LA TRAGEDIA. La grande instaurazione "olimpica", con le parole di Atena, parla chiara e tondo: «non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (Eschilo, Eumenidi).
DIVINA COMMEDIA (DANTE 2021). LA SCOPERTA DEL LAOCOONTE (1506) E LA MEMORIA DI TROIA (VIRGILIO, "ENEIDE"): LA "SACRA FAMIGLIA" ("TONDO DONI"). Michelangelo, con i suoi profeti e le sue sibille, cosa ha indicato a Firenze (1506-1508), come a Roma (nella Volta della Cappella Sistina, 1508-1512)?
RINASCIMENTO, OGGI: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE" (1996) ... purtroppo da millenni, si preferisce ’navigare’ nel mare della tragica "dotta ignoranza" (Niccolò Cusano), e seguire ancora la rotta del "sapiente" Bovillus, con la sua "piramide" androcentrica (cfr. Stefano Mancuso - AlessandraViola, "Verde brillante", Giunti 2013, p. 19)!!!
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)?!
- "4 GIUGNO 2023. SS. TRINITÀ. PER UNA CRITICA E UNA CELEBRAZIONE DELLA DOTTRINA TRINITARIA". [...] Il Simbolo Niceno dice che il Figlio è «generato» dal Padre, utilizzando un lessico biologico («generato, non creato») che solo l’esperienza concreta della vita naturale può rendere comprensibile. Ma sul piano biologico non c’è paternità e non c’è generazione senza un elemento femminile che riceva l’azione paterna, fungendo poi da «matrice» della prole (l’elemento materno è passivo nell’essere fecondato, e attivo nel mettere alla luce).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE ---DANTE E GALILEO: COSMOLOGIA E ANTROPOLOGIA (E CRISTOLOGIA) NELLA DIVINA COMMEDIA.22 aprile 2023, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E DIVINA COMMEDIA: "SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610) E "SAPERE AUDE!"(I. KANT, 1784). Alcuni appunti sul tema dell’antropogenesi (e cristogenesi) nell’opera di Dante...
- FILOLOGIA E ARCHEOLOGIA FILOSOFICA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI ANDROLOGIA DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3);
- E DELLA SUA COSTRUZIONE DEL "CORPO DI CRISTO": "Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto [...] egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo [εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ], finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo [ἄνδρα] perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo." (Efesini, 4.1/11-13).
NELL’ANNO DANTE2021, SU MARTE, "INGENUITY" INIZIA LA SUA ATTIVITA’ E LA SUA MISSIONE ESPLORATIVA:
CON ULISSE, OLTRE: VIRTU’ E CONOSCENZA. Ai suoi tempi, Dante ha esplorato con il suo "oudemico" ingegno l’intero "oceano celeste" (Keplero) e, al ritorno, ha raccontato che, trovandosi nel V cielo, quello del Pianeta Marte, rimase colpito da "una melode/ che mi rapiva, sanza intender l’inno (Pd XIV, 101 e 123).
L’INGEGNO, IL GENERE UMANO ("GATTUNGSWESEN"), E LA "TERRA" DI MARTE:
NELL’ANNO 2023, "Lo scorso 13 aprile il piccolo elicottero marziano Ingenuity ha azionato le sue eliche per la 50esima volta, percorrendo 320 metri in poco più di 2 minuti e mezzo, durante i quali ha infranto anche il precedente record di altezza, salendo fino a 18 metri. Ingenuity, che il 19 aprile ha festeggiato i suoi primi due anni su Marte, fu inizialmente concepito come dimostratore tecnologico, un modo cioè per provare che il volo controllato a motore su un altro pianeta fosse possibile. [...]
 Costruito con molti componenti di serie, come processori e fotocamere di smartphone, Ingenuity ha superato di 23 mesi terrestri e 45 voli la durata prevista. Ad oggi, ha volato in totale per oltre 89 minuti e più di 11,6 chilometri. «Abbiamo fatto tanta strada e vogliamo andare ancora più lontano», dice Teddy Tzanetos, responsabile del team della missione al Jpl. «Ma sappiamo fin dall’inizio che il nostro tempo su Marte è limitato e ogni giorno operativo è una benedizione. Che la missione di Ingenuity finisca domani, la prossima settimana o tra qualche mese è qualcosa che nessuno può prevedere al momento. Quello che posso prevedere è che, quando succederà, ci sarà una bella festa». " (cfr. Jacopo Danieli, "Cinquanta voli per l’elicotterino marziano", INAF, 21/04/2023).
Costruito con molti componenti di serie, come processori e fotocamere di smartphone, Ingenuity ha superato di 23 mesi terrestri e 45 voli la durata prevista. Ad oggi, ha volato in totale per oltre 89 minuti e più di 11,6 chilometri. «Abbiamo fatto tanta strada e vogliamo andare ancora più lontano», dice Teddy Tzanetos, responsabile del team della missione al Jpl. «Ma sappiamo fin dall’inizio che il nostro tempo su Marte è limitato e ogni giorno operativo è una benedizione. Che la missione di Ingenuity finisca domani, la prossima settimana o tra qualche mese è qualcosa che nessuno può prevedere al momento. Quello che posso prevedere è che, quando succederà, ci sarà una bella festa». " (cfr. Jacopo Danieli, "Cinquanta voli per l’elicotterino marziano", INAF, 21/04/2023).EARTHDAY 2023 #Metaphysics #Anthropology #Theology #Cosmology #Koyaanisqatsi #Ubuntu #Earthrise
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---"IL SORRISO DI CATERINA" ILLUMINA IL CAMMINO DI LEONARDO: LA "CONFRATERNITA DELLA CONCEZIONE" DI MILANO E "LA VERGINE DELLE ROCCE".16 marzo 2023, di Federico La Sala
STORIA E LETTERATURA, FILOLOGIA, E STORIOGRAFIA:
SISTO IV DELLA ROVERE (1471-1484), IL PAPA DELLA CAPPELLA SISTINA (1475 -1481), LA "CONFRATERNITA DELLA CONCEZIONE" DI MILANO E LEONARDO DA VINCI (1483). APPUNTI INTORNO A "IL SORRISO DI CATERINA" (CARLO VECCE):
A) "Leonardo a Milano, in un luogo segreto: la chiesa di S. Francesco Grande: [...] Nel 1477, in seguito all’istituzione della festa dell’Immacolata Concezione da parte del papa Sisto IV, viene dedicata qui una cappella [...], sotto la tutela della Confraternita della Concezione. E qui avviene la svolta per cui è ancora ricordata la chiesa che non c’è più. Leonardo da Vinci infatti, nel 1483 viene invitato a dipingere per questo luogo la tavola con la Vergine delle Rocce. [...]".
B) "[...] A Milano, dietro Sant’Ambrogio, nei lavori per la nuova sede dell’Università Cattolica, sta ricomparendo la cappella dell’Immacolata Concezione, quella della Vergine delle rocce dipinta da Leonardo: tornano alla luce il muro vicino all’altare, il pavimento della cripta, i frammenti del cielo stellato dipinto sulla volta dagli Zavattari. Confusi tra loro, resti umani di antiche sepolture. Forse anche quelli di Caterina, morta a Milano tra le braccia di suo figlio nel 1494, e sepolta in quello stesso luogo. "(Maria Pirro, «La madre di Leonardo da Vinci? Schiava, esule nel Mediterraneo», Il Mattino, 14.03.2023).
C) "La Vergine delle Rocce. La prima versione della Vergine delle Rocce è un dipinto a olio su tavola trasportato su tela (198x123 cm) [...], databile al 1483-1486 e conservato nel Musée du Louvre di Parigi, mentre la seconda versione è conservata alla National Gallery di Londra(...)".
La madre di Leonardo era schiava e straniera, del Caucaso. Trovato un documento che lo conferma
di Costanzo Gatta (Stile Arte, 14 Marzo 2023)
Un documento trovato nell’archivio di Stato di Firenze da parte del professor Carlo Vecce dell’Università di Napoli conferma le origini straniere di Caterina, la madre di Leonardo. La donna era una circassa, di origini Caucasiche, che fu portata a Firenze da un uomo di nome Donato. Il suo lungo viaggio, prima di arrivare alla capitale fiorentina, la portò, in stato di schiavitù, prima sul mare di Azov, in Russia, poi a Bisanzio, quindi a Venezia. Successivamente, Caterina fu acquistata dalla famiglia Da Vinci.
Il documento ritrovato riguarda un atto di affrancamento dalla servitù, emesso da Piero da Vinci, padre di Leonardo e compagno transitorio della donna. La rinunzia a Caterina come a un “oggetto di proprietà” avvenne sei mesi dopo la nascita del grande artista. Il ritrovamento conferma ciò che già indicavano le indagini sulle impronti digitali di Leonardo stesso, condotte nel passato. riproponiamo ora un’importante intervista.
di Costanzo Gatta
All’Università di Chieti, dopo anni di ricerche su oltre 200 impronte lasciate su 52 fogli leonardeschi è stata ricostruita, con sofisticate tecniche dattiloscopiche, l’impronta di un polpastrello del genio di Vinci, forse l’indice della mano sinistra. Il dermatoglifo rivela caratteristiche arabe, la struttura risulta tipica in due terzi della popolazione, per l’esattezza il 65%. Stile aveva pubblicato in proposito due ampi servizi nel dicembre 2004, quando le ricerche erano agli inizi. “La trama dei polpastrelli - scrivevamo allora - avrebbe una tipologia orientale; ciò potrebbe confermare che la madre del pittore fosse una schiava venuta da lontano”.
 Sangue mediorientale nelle vene di Caterina, madre di Leonardo? Da un pezzo lo si diceva, senza dar eccessivo credito alla storia. Ora c’è un motivo in più per tornare a parlare delle origini orientali di quella donna: non una contadinotta della campagna toscana ma una giovane levantina che avrebbe avuto una relazione con ser Pietro, il padre del futuro genio da Vinci.
Sangue mediorientale nelle vene di Caterina, madre di Leonardo? Da un pezzo lo si diceva, senza dar eccessivo credito alla storia. Ora c’è un motivo in più per tornare a parlare delle origini orientali di quella donna: non una contadinotta della campagna toscana ma una giovane levantina che avrebbe avuto una relazione con ser Pietro, il padre del futuro genio da Vinci.Già molti anni fa si diceva che la mamma fosse una delle tante schiave che nel ’400 erano state portate a lavorare in Toscana: una poveraccia senza alcun diritto, senza un patronimico, forse appena convertita. Una serva chiamata come mille altre: Catharina. Uno studioso toscano aveva frugato negli archivi per cercare contratti d’acquisto di schiavi. Voleva raccapezzarsi in questo mistero. Aveva ripercorso i vari flussi migratori ipotizzando che la donna fosse ebrea, circassa, araba. A quei tempi i risultati furono negativi.
- Leonardo e il mistero della madre
E così, ai tanti misteri della vita di Leonardo, si aggiunse anche questo della madre, la povera Caterina, con la quale il donnaiolo ser Pietro faceva bellamente all’amore, nonostante stesse per portare all’altare Albiera, figlia dell’Amadori, notaio.
La storia - prima della scoperta del 2023 - dice poco. Si sa solo che quando la serva fu mandata - secondo il costume dei paesi sulle colline toscane - a sgravarsi nel casale che ancora oggi esiste, era l’aprile del 1452. Una camera dal soffitto basso con pagliericcio, attaccata alla cucina col camino, poche nicchie nel muro per riporvi ramaiole, caldaie e il pennato: qui la giovane Catharina attese, assieme alla levatrice, che si rompessero le acque. Non era misteriosa la relazione del giovane ser Pietro, uno dei tanti borghesi di Vinci, la cui casata sfornava rampolli notabili che alternativamente venivano avviati alla carriera legale o alla vita ecclesiastica.
Per i casi della vita la nascita del genio venne messa - nero su bianco - da Antonio, il nonno. “Nachue (nacque) un mio nipote, figliuolo di ser Piero mio figliuolo, a dì 15 d’aprile (1452) in sabato a ore 3 di notte. Ebbe nome Lionardo...”. Il resto si può immaginare: quattro soldi di dote per mandar via Caterina contenta e poi il battesimo, senza nemmeno la mamma. Lo sappiamo ancora dal nonno, che ebbe a registrare con precisione i presenti attorno a quel fonte di pietra, tuttora intatto. “Battizzollo Piero di Bartolomeo da Vinci, in presenza di Papino di Nanni, Meo di Torino, Pier di Malvolto, Monna Lisa di Domenico di Brettone”. Insomma c’erano tutti: prete, testimoni e intimi. Mancava Caterina, che ritroveremo poi sposata a tale Antonio del Vacha, detto Accattabriga, soprannome che non prometteva nulla di buono. In gioventù doveva essere stato un soldataccio di ventura.
Nelle note del catasto di Vinci per l’anno 1457 si trova che nonno Antonio, di 85 anni, abitava nel popolo di Santa Croce, era marito di Lucia, di anni 64, e aveva per figli Francesco e Piero, d’anni 30, sposato ad Albiera, ventunenne. Convivente con loro era “Lionardo figliuolo di detto ser Piero non legiptimo nato di lui e della Chatarina, al presente donna d’Achattabriga di Piero del Vacca da Vinci, d’anni 5”. Albiera non poteva avere figli e Piero aveva accolto in casa l’illegittimo. Intanto Caterina lavorava con il marito un piccolo appezzamento di proprietà e i campi delle suore del convento di San Pier Martire. Nonno Antonio morì novantaseienne, nel 1468, e negli atti catastali di Vinci Leonardo, che ha diciassette anni, risulta suo erede insieme con nonna Lucia, il padre Piero, la matrigna e gli zii Francesco e Alessandra. L’anno dopo, la famiglia del padre, divenuto notaio della Signoria fiorentina, e quella del fratello Francesco, che era iscritto nell’Arte della seta, erano in una casa di Firenze, abbattuta già nel Cinquecento, nell’attuale via dei Gondi.
Madonna Litta Dell’Accattabriga si hanno invece notizie da un verbale di citazione durante un processo alla Curia vescovile di Pistoia. La data è il 26 settembre 1470, dopo i disordini verificatisi all’inizio del mese nella pieve di Santa Maria di Massa Piscatoria, nella palude di Fucecchio. Alcune persone, armate di lancia, capeggiate da due preti (uno della diocesi di Lucca, l’altro sotto la potestà del vescovo di Firenze) avevano disturbato la celebrazione durante la festa in onore della Madonna e interrotto la Messa. Antonio fu chiamato a testimoniare ma non si presentò.
Di Caterina si sa che fu donna prolifica, e da Accattabriga ebbe sicuramente almeno quattro femmine e un maschio. Rimasta sempre lontana da Leonardo, si ricongiungerà al figlio - pare certo - nel 1493 a Milano. E in una casa di Porta Vercellina, nel territorio della parrocchia dei Santi Nabore e Felice, morirà il 26 giugno 1494, dopo lunga malattia. Per le cure prima e poi per i funerali, Leonardo annotò le spese (eccessive per una servente, non certo per una madre): “Quattro chierici, cinque sotterratori, un medico, le candele...”. Oggi Caterina ritorna in scena. A parlarci di lei sono le impronte digitali del figlio, quei polpastrelli che hanno creato uno sfumato magico, inimitabile. Evocano la donna, quelle ditate rimaste fra il cielo e il fogliame che fa da sfondo al ritratto di Ginevra Benci o su un disegno della Battaglia di Anghiari, fra i capelli di Cecilia Gallerani o sulle pagine dei Codici voltate con mani sporche.
Gli studi sulle impronte di Leonardo sono stati illustrati da Luigi Capasso, direttore dell’Istituto di antropologia e del Museo di storia delle scienze biomediche dell’Università di Chieti e Pescara, e da Alessandro Vezzosi, direttore del Museo Ideale di Vinci.
- “Sulle pagine e sui dipinti di Leonardo - ha detto Capasso - possiamo trovare tantissime tracce, non necessariamente dell’epoca, come per esempio macchie, aloni e tracce biologiche. Il nostro primo compito è stato quello di distinguere le tracce sincroniche da quelle non sincroniche e ci siamo concentrati sulle macchie d’inchiostro, dato che è stato più semplice stabilire se la macchia derivava dallo stesso inchiostro usato per vergare le frasi”.
Proprio nelle macchie d’inchiostro sono state scoperte numerose impronte digitali, anche se parziali, che hanno portato alla ricostruzione di un intero polpastrello dell’artista.
 “L’impronta - ha aggiunto Capasso - ha tra l’altro una struttura a vortice con diramazioni a y, dette triradio: tale tipologia di impronte è comune a circa il 65% della popolazione araba”. “A questo punto - ha affermato Vezzosi - si rafforza l’ipotesi che la madre del genio fosse orientale: nello specifico, secondo i miei studi, una schiava”.
“L’impronta - ha aggiunto Capasso - ha tra l’altro una struttura a vortice con diramazioni a y, dette triradio: tale tipologia di impronte è comune a circa il 65% della popolazione araba”. “A questo punto - ha affermato Vezzosi - si rafforza l’ipotesi che la madre del genio fosse orientale: nello specifico, secondo i miei studi, una schiava”.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- IL FALLIMENTO DELLA "CRISTOLOGIA" DELLA "PACE DELLA FEDE" (1453) E LA COSMOTEANDRIA DEL XXI SECOLO E LA "MEMORIA" DI NICEA (2025)7 marzo 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA E VITA FUORI DALLA BILANCIA" ("LIFE OUT OF BALANCE").
- APPUNTI PER IL CONGRESSO MONDIALE DI FILOSOFIA ROMA 2024. TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA, PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA. In memoria di Immanuel Kant...
COSMOTEANDRIA DEL XXI SECOLO: IL MONDO COME VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE DELL’UOMO SUPREMO.
 PIANETA TERRA: DOPO 1700 ANNI DAL PRIMO CONCILIO DI NICEA (325), DI "QUALE" ECUMENISMO, LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA E L’INTERA EUROPA (LAICA E RELIGIOSA) VUOLE FARE MEMORIA?
PIANETA TERRA: DOPO 1700 ANNI DAL PRIMO CONCILIO DI NICEA (325), DI "QUALE" ECUMENISMO, LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA E L’INTERA EUROPA (LAICA E RELIGIOSA) VUOLE FARE MEMORIA?A) - NICEA 325. "Il concilio di Nicea, tenutosi nel 325, è stato il primo concilio ecumenico cristiano. Venne convocato e presieduto dall’imperatore Costantino I, il quale intendeva ristabilire la pace religiosa e raggiungere l’unità dogmatica, minata da varie dispute, in particolare sull’arianesimo; il suo intento era anche politico, dal momento che i forti contrasti tra i cristiani indebolivano anche la società e, con essa, lo Stato romano. Con queste premesse, il concilio ebbe inizio il 20 maggio del 325. Data la posizione geografica di Nicea, la maggior parte dei vescovi partecipanti proveniva dalla parte orientale dell’Impero (...).
B) STORIA STORIOGRAFIA ED ECUMENISMO: COSTANTINOPOLI E LA "CRISTOLOGIA UMANISTICA". Riprendendo il filo dalla "Dotta Ignoranza" (Niccolò Cusano, 1440), la "Donazione di Costantino" (Lorenzo Valla, 1440, e dalla caduta di Costantinopoli (1453) e il fallimento della proposta "cristologica" del "De pace fidei" (N. Cusano, "La pace della fede", 1453, non è forse tempo di corre ai ripari, di ristrutturare il campo e riequilibrare la bilancia antropologica?!
C) BILANCIA DELLA COSTITUZIONE, BILANCIA DELL’ETICA, E "PACE PERPETUA". Una "foto" per riflettere non solo l’8 marzo 2023, ma anche l’8 marzo 2025...
-
>LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --ARCHEOLOGIA E MUSICA: CON LE MUSE E LE GRAZIE, NEL CIRCO DELLA MOIRA DI ORFEO.28 gennaio 2023, di Federico La Sala
LA FATTORIA DI PLATONE, IL PIFFERAIO ALGORITMICO, E L’ ARCHEOLOGIA FILOSOFICA:
- TRACCE PER UNA SVOLTA_ANTROPOLOGICA.
- Una nota a margine di un lavoro del 1991 (*)
#STORIA E #MEMORIA. Al #tramonto dell’#Occidente e alla #fine della #storia, qualche musicista constata amaramente che oggi la più bella delle arie d’opera viene utilizzata per #pubblicizzare un profumo. Verissimo, ma questo cosa significa? Non è una "bellissima" realizzazione storica dello #Stato sognato dal pitagorico Platone, quello della famosa teoria del #re filosofo (#sofista) e del filosofo (sofista) re?
#FILOLOGIA E #ANTROPOLOGIA. Le #Muse, le #Grazie, le #Sibille, dove sono?! Non sono state rapite come #Persefone da #Plutone e sono tutte rinchiuse nel #Circo (della buon’anima) della #Moira di #Orfeo? Dov’è #Diotima, dove #Arianna? Non è ora di cambiare #musica e uscire dall’Inferno (#Dante2021)?! Se non ora, quando?!
#Eleusis2023 #Earthrise
(*) La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica
-
> LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- PSICOANALISI, ESTASI, E RINASCIMENTO, OGGI: TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA.26 gennaio 2023, di Federico La Sala
PSICOANALISI, ESTASI, E RINASCIMENTO, OGGI: TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA.
- Una nota a margine di un mio lavoro del 1996 e in memoria di Teresa d’Avila (1622-2022): *
CULTURA E SOCIETA’. La vita e l’opera di Teresa d’Avila è ancora una sfida per la psicoanalisi freudiana, per la psicanalisi lacaniana, per la stessa chiesa cattolica, e per l’intera #cultura laica e devota (oggi, 2023). Nonostante le sollecitazioni generali a portarsi oltre l’orizzonte androcentrico platonico-hegeliano e, in particolare, edipico da parte di psicoanalisiti e psicoanaliste, come Elvio Fachinelli ("La mente estatica", Adelphi,1989) e Julia Kristeva ("Teresa, mon amour. Santa Teresa d’Ávila: l’estasi come un romanzo, Donzelli 2008), il problema del "roveto ardente" di Lacan, "la Cosa di Mosè", resta sempre e "encore" un enigma, quello stesso della Sfinge di #Edipo: "L’esperienza mistica - scriveva Fachinelli nel 1988 - è al di là della barriera dell’#incesto e in essa si manifesta un aspetto antropologico sinora rifiutato, o temuto, o assimilato tout cort all’impostazione religiosa. E così la #gioia eccessiva, che è al cuore dell’esperienza estatica, viene trascurata".
Ricordando che l’interpretazione del messaggio evangelico di Teresa d’Avila è connessa alle "Meditazioni sul Cantico dei cantici" (e non all’androcentrismo della lettura paolina), ed è molto prossima a quella di Michelangelo Buonarroti e al suo "Tondo Doni" e al suo Mosè, sollecita a riproblematizzare non solo il rapporto tra Freud e Lacan, ma anche, e soprattutto, a portarsi oltre la logica cosmoteandrica del "superuomo" del cattolicesimo europeo-costantiniano. Se non ora, quando?!
*http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5195
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---MEMORIA DELL’EUROPA DEL "SEÑOR DE ORGAZ (1323-2023)", DI FILIPPO II E DI TERESA D’AVILA.25 gennaio 2023, di Federico La Sala
MEMORIA E STORIA DI LUNGA DURATA. APPUNTI SU PROBLEMI DI PATRIMONIO CULTURALE, ARTE, E ANTROPOLOGIA
- NELL’EUROPA DI IERI (XVI SECOLO) E DI OGGI (XXI SECOLO):
A) SPAGNA: A 700 ANNI DALLA MORTE DI D. GONZALO RUIZ DI TOLEDO, "SEÑOR DE ORGAZ (1323-2023)", UNA BUONA OCCASIONE PER RI-ANALIZZARE L’OPERA DI "EL GRECO" ("LA SEPOLTURA DEL CONTE DI ORGAZ", TOLEDO 1586 -1588) ... E PER RIMEDITARE LO STRAORDINARIO IMPEGNO RIFORMATORE (CARICO DI TEORIA E DI FUTURO) DI TERESA D’AVILA (1515-1582).
B) TERESA D’AVILA (Avila 1515 - Alba de Tormes 1582): "[...] Teresa (Teresa Sánchez de Cepeda Ávila y Ahumada) nasce in una famiglia ricca; il padre era figlio di un ebreo convertito - dunque tTeresa fu di origini ebree. La madre trasmette alla figlia l’amore per i romanzi cavallereschi, ma muore quando Teresa ha solo 13 anni.
Diventa una donna determinata, affascinante e trascinatrice, estrema nelle sue scelte e insieme capace di amministrare i monasteri e di trattare con diplomazia coi grandi dell’epoca. Da ragazza convince il fratello a fuggire per andare a combattere contro gli infedeli. Sempre col fratello scrive un romanzo cavalleresco; manifesta, insomma, subito due grandi amori della sua vita: la fede e la scrittura.
È l’epoca della grande crisi della Chiesa, che all’apice della propria magnificenza è percorsa da profonde inquietudini, divisa dalla predicazione di #Lutero e Juan de Valdés, una ferita profonda e interna. Teresa ha trent’anni all’epoca del Concilio di Trento (1545-1563), tappa di quella “rifondazione” della chiesa cattolica, che si impegna tanto nella guida delle anime, con la fondazione di nuovi ordini religiosi e la promozione di una rinnovata austerità e spiritualità, quanto nel controllo delle stesse, imponendo nuove e più severe regole monastiche e potenziando i tribunali dell’#Inquisizione. In in Spagna in particolare, dopo il culmine della potenza raggiunto sotto il regno di Carlo V (1500-1558), suo figlio Filippo II (1527-1598) si fa paladino della ortodossia cattolica. [...]" (Cfr. Maria Rosa Panté, "Teresa d’Avila", Enciclopedia delle donne)
C) CARMELITANI SCALZI: L’ULTIMA LEZIONE DI TERESA D’AVILA. A CONTURSI TERME, IN PROVINCIA DI SALERNO, NELLA TERRA DEL "PRINCIPE DI EBOLI" (Rui Gomes da Silva), L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE (IN STATO DI PROGRESSIVO DEGRADO).
D) QUESTIONE ANTROPOLOGICA E PSICOANALISI: LA STORIA NON LA FANNO SOLO I PROFETI, MA ANCHE LE SIBILLE. Ricordando che l’interpretazione del messaggio evangelico di Teresa d’Avila è connessa alle "Meditazioni sul Cantico dei cantici" (e non all’androcentrismo della lettura paolina), ed è molto prossima a quella di Michelangelo Buonarroti e al suo "Tondo Doni" (e al suo Mosè), sollecita anche a riproblematizzare (Julia Kristeva, "Teresa, mon amour", 2009) il rapporto tra Freud e Lacan ("Encore", 1972-1973) ) e, infine, a portarsi oltre la logica del "superuomo" del cattolicesimo costantiniano!
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- RIPARTIRE DALLA NASCITA DI BOSCH (1453), DALLA CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453), E DAL "DE PACE FIDEI" (1453) DI NICCOLO’ CUSANO. e dal #sogno infranto di #NiccolòCusano (1453), dalla #MadonnaSalting (1460) e dal #GiardinoDelleDelizie di H. #Bosch17 novembre 2022, di Federico La Sala
FILOLOGIA, STORIA, E INTERPRETAZIONE DEI SOGNI (E DEI SEGNI):
LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453), IL "DE PACE FIDEI" DI NICCOLO’ CUSANO (1453), E LA "MADONNA SALTING" DI ANTONELLO DA MESSINA (1460).
Un segnavia per "arrivare" a Eleusis nel prossimo 2023.
ARTE E SOCIETÀ: LA MADONNA SALTING. A mio parere, l’influenza maggiore sulla produzione della "Madonna #Salting" di Antonello da Messina appare decisamente essere di scuola fiamminga. Tuttavia, essendo Antonello originario di Messina, forse, è da riguardare con particolare attenzione il senso simbolico della melagrana già aperta in mano al Bambino e, insieme, del cinturino annodato intorno al corpo del Figlio con i due fiocchetti (due piccole "#melagrana"), messi in una zona di chiara evidenza, che rimandano decisamente ai frutti del melograno in via di maturazione e alla fecondità della Madre, tutta vestita e "punteggiata" da infiniti "chicchi".
IPOTESI: QUESTIONE CRISTOLOGICA (ANTROPOLOGICA). Dato che il quadro è del 1460 circa, forse, potrebbe essere una "indicazione" di un discorso ancora sul nascere, di un dibattito all’ordine del giorno sul problema del Figlio, cioè sul tema decisivo dell’epoca (la caduta di Costantinopoli è del 1453 e il cardinale Niccolò Cusano cerca la via della pace della fede, nel 1453)": il nodo è proprio quello del Figlio (... e del "Presepe", e del "Natale"), quello dell’interpretazione teologico e antropologica della figura di Cristo (un tema ancora all’ordine del giorno), in un’ottica ecumenica.
CONSIDERATO CHE la "Dotta Ignoranza" di Cusano (1440) è del tutto segnata dalla tradizione filosofica e scientifica aristotelico-platonica (come sarà ancora per gli aristotelici dell’epoca di Galileo Galilei), la figura e il tema del bambino-homunculus è la parola chiave per comprendere non solo la teologia e l’anatomia dell’epoca, ma anche l’arte e l’antropologia, forse, è OPPORTUNO "RIPENSARE COSTANTINO": "IN HOC SIGNO VINCES". Proprio la caduta di Costantinopoli (1453), infatti, porterà l’Europa a svegliarsi dal letargo, a muoversi militarmente, e a prendere sotto la guida della Spagna la strada della riconquista (Granada,1492), della cacciata dei Mori e degli Ebrei (1492), della conquista dell’America (1492), e dell’avvio della prima globalizzazione teologico-politica del Pianeta Terra.
A) ANTONELLO DA MESSINA, "MADONNA SALTING".
B) BOSCH (1453-1516), ALL’ESCORIAL (1593). "Il Giardino delle delizie (o Il Millennio) è un trittico a olio su tavola (220×389 cm) di Hieronymus Bosch, databile 1480-1490 circa e conservato nel Museo del Prado di Madrid.[...]".
C) ELEUSIS 2023. Una delle capitali europee della cultura del 2023 è Eleusi: una buona opportunità storica per ripensare la figura della Terra-Madre, Demetra, della figlia, Persefone, e del tema dei misteri eleusini, e, al contempo, anche del melograno, e della melagrana, dell’agricoltura, delle stagioni, ecc.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- Sibille, Profeti e Patriarchi nel Campanile di Giotto. Capolavori di statuaria gotica e del primo Rinascimento.9 ottobre 2022, di Federico La Sala
OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE (Firenze 1296)
Sibille, Profeti e Patriarchi nel Campanile di Giotto
 Capolavori di statuaria gotica e del primo Rinascimento
Capolavori di statuaria gotica e del primo Rinascimento- I monumenti dell’Opera di Santa Maria del Fiore sono all’origine dell’arte occidentale moderna e, uno dei luoghi dove la statuaria rinacque dai tempi dell’antichità classica, sono le nicchie del terzo livello del Campanile di Giotto.
Il Campanile ha una decorazione scultorea esterna che fu realizzata nell’arco di cento anni, 1334-1436, iconograficamente molto elaborata, ordinata su tre livelli per ognuno dei quattro lati. In un nostro precedente articolo abbiamo già raccontato dei primi due livelli di queste decorazioni, ovvero i rilievi trecenteschi di Andrea Pisano e della sua bottega raffiguranti le scienze umane e le potenze celesti che le governano. Il terzo livello è occupato da sedici nicchie cuspidate, all’interno delle quali furono collocate, quattro per ciascun lato, altrettante sculture in marmo in altissimo rilievo e a tutto tondo, raffiguranti sibille, profeti e patriarchi.
Intorno alla metà del Trecento lo stesso Andrea Pisano con il figlio Nino e altri collaboratori avevano collocato sul lato ovest, quello maggiormente visibile dalla piazza, le sculture (lavorate in realtà solo sul lato frontale, l’unico visibile), raffiguranti la Sibilla eritrea, che secondo la tradizione cristiana antica aveva preannunciato la Redenzione; la Tiburtina, che per la stessa tradizione avrebbe profetizzato la nascita del Salvatore; David, re di Gerusalemme, autore dei Salmi e antenato di Cristo e suo figlio e successore il Re Salomone, creatore del grande tempio di Gerusalemme e sovrano di insuperabile sapienza. Ancora, i due Pisano e altri collaboratori scolpirono, per ornare il lato meridionale, un Mosè con in mano le tavole della legge e altri profeti non meglio identificati rappresentati barbati e con grandi cartigli. Sono tutte queste figure, connotate dall’elegante linearità e dalla possanza volumetrica insegnata in pittura da Giotto, transumanate e ieratiche, eccezion fatta per le sibille, che esprimono una certa umana allegrezza.
Completati questi due fronti per alcuni anni restarono vuote le nicchie degli altri due, l’orientale e il settentrionale, ed è qui che tra il 1409 e il 1436 la maniera giottesca del Pisano cedette il passo al rinascimento e cioè alla novità dirompente del naturalismo classico di Donatello e del suo collaboratore Nanni di Bartolo, detto “il Rosso”.
Per il lato orientale Donatello scolpì due splendidi profeti, difficilmente riconoscibili, forse Malachia e Isaia, perciò chiamati per consuetudine uno l’"imberbe" per via dell’acconciatura e l’altro “il pensieroso”, a ragione della posa con la mano riflessiva al mento. Si tratta di due straordinarie rappresentazioni connotate da un naturalismo senza precedenti di uomini avanti con l’età, vestiti con tuniche all’antica. L’espressione dei loro volti, ogni membro del loro corpo e ogni lembo delle loro vesti esprime con potenza il loro turbamento interiore provocato da quanto Dio gli ha rivelato. A loro si aggiunsero un terzo profeta (forse Zaccaria) opera di Nanni, che sembra arringare il popolo con la fierezza di un senatore romano sollevando una mano e lo sguardo e poi, una quarta statua, una delle più celebri del Rinascimento: il Sacrificio di Isacco, che Donatello e Nanni di Bartolo scolpirono insieme. Abramo è anziano, con lunga barba ed è colto nel momento in cui si torce con espressione sconvolta verso il cielo, richiamato dalla voce dell’angelo, un attimo prima di affondare il coltello nella gola del figlio Isacco che è inginocchiato ai suoi piedi nudo (il primo nudo a dimensioni naturali dell’arte moderna).
Alla coppia di geniali scultori fu affidata l’esecuzione anche della restante quaterna di statue per le nicchie rivolte a settentrione, le meno visibili perché dirimpetto al fianco della Cattedrale.
Di nuovo Donato e Nanni realizzarono quattro capolavori assoluti. Nanni scolpì il profeta Abdia, giovane bello e vigoroso con lo sguardo concentrato e triste verso coloro a cui mostra, aprendolo, il testo profetico del proprio rotolo; e San Giovanni Battista, ultimo dei profeti e primo dei santi, anche lui un giovane di bell’aspetto che, con espressione malinconica, mostra il cartiglio con l’annuncio dell’Agnello di Dio.
Donatello superò il compagno: il suo Geremia, impegnato a meditare su quanto scritto nel proprio cartiglio, è vigoroso e vibrante di spirito, ha le fattezze di un uomo di mezza età trasandato e di umili condizioni, ma esprime la forza fisica e la dignità morale di un eroe classico.
Lo Zuccone poi (forse il profeta Abacuc, così soprannominato dai fiorentini per riferimento affettuoso al cranio calvo con cui fu immaginato) è un’opera semplicemente insuperabile: Donatello ha dato forma a un uomo sui quaranta, dal corpo asciutto e nervoso avvolto in un largo manto e in un camice, che sbarra gli occhi per fissare qualcosa davanti a sé e tiene la bocca socchiusa per stupore di ciò che vede o per proferire parola a qualcuno che gli è di fronte.
Queste ultime quattro sculture erano troppo belle per restare “nascoste” sul fronte nord e nel 1464 furono “scambiate” con quelle trecentesche poste a ovest, così da dare miglior ornamento al lato del Campanile affiancato alla facciata della Cattedrale.
Le sedici sculture rimasero al loro posto per mezzo millennio finché, nel Novecento, si provvide a mettere al riparo questi splendidi marmi dalle ingiurie del tempo. Tra il 1939 e il 1945 Romano Romanelli e Natale Binazzi realizzarono a mano le copie in marmo bianco dei quattro profeti del lato ovest: i più esposti alle intemperie e, forse, i più belli.
Quindi, nel 1973-76 Enzo Cardini eseguì in cemento e polvere di marmo i calchi delle restanti 12 statue.
Gli originali di questi capolavori si possono ammirare nella sala del Museo dell’Opera del Duomo dedicata alle sculture del Campanile, a una distanza ravvicinata che nella collocazione originaria era impossibile, ma su un piano abbastanza elevato da poterne godere le pose e le espressioni dalla corretta prospettiva dal sotto in su.
*Fonte: Duomo di Firenze. Opera Magazine, 17/02/2022 (ripresa parziale, senza immagini).
-
>RINASCIMENTO ITALIANO --- SHAKESPEARE E GIORDANO BRUNO: RIVOLUZIONE COPERNICANA E RIFORMA TEOLOGICO-POLITICA IN CORSO.6 luglio 2022, di Federico La Sala
RIVOLUZIONECOPERNICANA E RIFORMA TEOLOGICO-POLITICA IN CORSO: NUOVO CIELO E NUOVA TERRA.
Una nota*
- "COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA" (PARTE IV): "[...] Detto a tre occhi - disse argutamente il vecchio papa (perché era cieco da un occhio) - nelle cose di Dio ne so più io dello stesso Zarathustra; e può ben essere così. Il mio amore ha servito a lui per tanti anni, la mia volontà ha fatto sempre quanto lui voleva. Un buon servitore sa tutto, e sa anche le cose che il suo padrone spesso nasconde a se stesso.
- Era un Dio nascosto, pieno di segreti. Per dir la verità, ad avere un figlio ci arrivò per vie traverse. Alla soglia del suo Credo ci sta un adulterio.
- Chi lo celebra come un dio d’amore non ha una grande opinione dell’amore. Non voleva forse questo dio fare anche il giudice? Ma chi ama, ama al di là del premio e della pena."(NIETZSCHE).
La grandezza di Shakespeare e l’importanza del suo "Amleto" è analoga a quella di Sofocle e del suo "Edipo Re": della loro lezione, anche dopo la sollecitazione di Freud, si stenta ancora a capire il legame tra il familismo amorale e le manipolazioni istituzionali della Legge (divina ed umana).
Con Lutero (1517), con Copernico (1543), e Giordano Bruno (Nola, 1548 - Roma, 17 febbraio1600), Shakespeare osa aprire un dibattito nel suo globo teatrale che fa tremare tutto l’ordine teologico-politico e sociale precedente e seguente: riapre il discorso sulla dottrina dei "Due corpi del Re" (Ernst H. Kantorowicz)!
La critica dell’adulterio in "Amleto", connesso (come è) all’intero ordine istituzionale e collegato fin nel cuore dello stesso messaggio biblico ed evangelico, pone all’ordine del giorno lo "spaccio della bestia trionfante" e sgombra la strada alla dea Giustizia, alla Vergine Astrea (Virgilio, Egloga IV, V. 6: "Iam redit et Virgo").
*
NOTA.
Europa 1600: RegnodiNapoli->Nola->Salerno->Eboli->Contursi Terme, Chiesa della Madonna del Carmine, 1608/1613..
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- ANTROPOLOGIA, COSTITUZIONE E BAMBINI. Stop al cognome del padre ai figli. Perché la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme.28 aprile 2022, di Federico La Sala
Stop al cognome del padre ai figli: cosa cambia in Italia
La Consulta ha stabilito che le norme che regolano l’attribuzione del cognome in Italia sono illegittime e in contrasto con la Costituzione *
In Italia cambiano le leggi che riguardano l’attribuzione del cognome al figlio, con una storica sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime le norme che regolano questo processo nell’ordinamento del nostro Paese. Nello specifico la Consulta si è pronunciata sulla legge che non consente di attribuire a un figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di un accordo tra i genitori, impone il solo nome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
Perché la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme sul cognome
La sentenza è arrivata dopo una lunga battaglia legale intrapresa da una giovane coppia lucana per i nomi dei tre figli. I primi due erano stati registrati col cognome della madre e il terzo era stato registrato automaticamente con il cognome del padre perché nato dopo il matrimonio dei genitori.
La famiglia avrebbe voluto registrare con il cognome della madre anche il terzo figlio, per rendere uguali tutti i fratelli, ma gli uffici comunali si erano opposti. I magistrati in primo grado avevano dato ragione al Comune, ma la Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale delle norme in materia, sollevata dai legali della coppia.
I due avvocati, Domenico Pittella e Giampaolo Brienza, hanno espresso, nei confronti della decisione della Consulta “grande soddisfazione”. Il primo ha raccontato che “la coppia che ha intrapreso questo complesso e faticoso iter giudiziario mi ha chiamato poco fa. I due coniugi sono commossi e consapevoli di avere scritto una pagina storica, loro ci hanno sempre creduto”
Come funziona l’attribuzione del cognome in Italia e come è cambiata negli anni
In Italia, come è noto, il cognome viene assegnato al momento della dichiarazione di nascita per l’iscrizione del nuovo nato nel registro dell’anagrafe. Per prassi avviene in questo modo.
- Se il neonato è figlio di una donna sposata, prende sempre il nome del marito, eventualmente seguito da quello della moglie se i due coniugi sono d’accordo.
- Se il neonato è figlio di una donna non sposata, se viene riconosciuto dal padre prende sempre il nome di lui, eventualmente seguito da quello de quello materno se i due coniugi sono d’accordo. Al contrario prende il cognome della madre.
Non esiste una legge specifica in maniera, ma una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse, come chiarito dalla Corte Costituzionale nel 2006. Nel 2014 la Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per la violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo, e nel periodo successivo si era discusso ampiamente nel nostro Paese su come cambiare la legge.
L’Europa ha infatti sottolineato che l’impossibilità di dare il cognome della madre al figlio e l’attribuzione automatica di quello del padre discrimina le donne. Era stata formulata anche una proposta di legge per il doppio cognome ai figli, fermata alla Camera dei Deputati, come vi avevamo raccontato qui.
La Consulta si era espressa contro lo status quo nel 2016 dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Dopo quella sentenza è diventato possibile trasmettere anche il cognome della madre, ma solo posponendolo a quello paterno, come già visto.
Secondo quali articoli della Costituzione le norme sul cognome sono illegittime
La nuova sentenza non è ancora stata depositata, ma l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale ha fatto sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con l’articolo 2, l’articolo 3 e l’articolo 117, primo comma, della Costituzione. Quest’ultimo in relazione all’articolo 8 e all’articolo 14 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo.
- L’articolo 2 della Costituzione dice che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
- L’articolo 3 della Costituzione stabilisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
- L’articolo 117 della Costituzione dice invece che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. L’articolo 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo riguarda il diritto al rispetto della vita privata e familiare, mentre l’articolo 14 riguarda il divieto di discriminazione.
Cosa cambia adesso in Italia per l’attribuzione del cognome ai figli: le nuove regole
La Consulta ritiene discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre al figlio. Per il principio di eguaglianza e per l’interesse del bambino, i giudici della Corte Costituzionale hanno stabilito che entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, in quanto elemento fondamentale dell’identità personale.
Dunque la nuova regola permette al figlio di assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato dai genitori, salvo che questi decidano di attribuirgli soltanto il cognome di uno dei due. Senza un accordo della coppia, spetterà al giudice intervenire, in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
La Corte Costituzionale ha dunque dichiarato illegittime tutte le norme che prevedono l’attribuzione automatica del cognome del padre al bambino, sia per i figli nati fuori dal matrimonio sia per i figli nati nel matrimonio e per i figli adottivi. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane, e spetterà a quel punto al legislatore formulare nuove norme per adattare il sistema a quanto deciso dai giudici.
* Fonte: Qui Finanza, 27 aprile 2022 (ripresa parziale).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. -- LA GIORNATA DELLA TERRA (2022) E LA "CASA COMUNE" DELL’INTERO GENERE UMANO: USCIRE DALLA CAVERNA.22 aprile 2022, di Federico La Sala
GIORNATA DELLA TERRA (22 aprile 2022): SORGERE DELLA TERRA, ANTROPOLOGIA ("ECCE HOMO"), E CONCORDIA.
In memoria del "discorso sulla dignità dell’uomo" (1486) di Giovanni Pico della Mirandola...
QUESTIONE ANTROPOLOGICA E FILOLOGIA. "Tutti dobbiamo contribuire a fermare la distruzione della nostra casa comune e ripristinare gli spazi naturali: governi, aziende e cittadini dobbiamo agire come fratelli e sorelle che condividono la Terra, la casa comune che Dio ci ha affidato" (Papa Francesco).
IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS. Memoria di Anselmo d’Aosta (21 aprile): riprendere il lavoro sul "Cur Deus Homo" e portarlo oltre l’orizzonte della Dotta Ignoranza (1440) e della Scuola di Atene: meglio seguire l’indicazione di Michelangelo già presente nel Tondo Doni e ripensare il cammino delle Sibille e dei Profeti.
USCIRE DALLA TERRA (CAVERNA)... E, FINALMENTE, VEDERE DALLO SPAZIO, DALLA LUNA, IL SORGERE DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE DELLA CASA COMUNE DELL’INTERO GENERE UMANO: L’ALBA DELLA MERAVIGLIA.... E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA!
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- In Francia si è costituito il gruppo "Toutes apôtres" ("All Women Apostles") per aprire il ministero alle donne. A colloquio con la storica e teologa Adriana Valerio (di Sabina Baral).).9 marzo 2022, di Federico La Sala
Donne protagoniste della loro storia di fede
A colloquio con la storica e teologa Adriana Valerio in occasione dell’8 marzo
di Sabina Baral (Chiesa Evangelica Valdese, Torre Pellice, 4 Marzo 2022)
Il cristianesimo e le donne, un rapporto difficile? A ridosso dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, ne abbiamo parlato con Adriana Valerio, storica e teologa, già docente di storia del cristianesimo e delle chiese all’Università “Federico II” di Napoli.
Una ricerca ventennale, la sua, volta a ricostruire la presenza delle donne nella storia cristiana.
C’è urgenza di femminismo nella chiesa e se sì di quale femminismo?
Se per femminismo si intende la consapevolezza da parte delle donne della propria dignità e la richiesta di superare le condizioni di discriminazione, dobbiamo dire che è un’esigenza antica che si pone con continuità nella storia della Chiesa. Non volendo risalire alle posizioni espresse nel Rinascimento dalle donne impegnate in progetti di riforma evangelica (tanto cattolica quanto riformata), è dall’Ottocento che si levano dalle Chiese voci di denuncia e richieste di considerare diversamente i ruoli femminili all’interno delle comunità. Molti sono gli esempi a riguardo: dalle partecipanti all’anticoncilio del 1969 che, in polemica con il Concilio Vaticano I, chiedevano il superamento del clericalismo che opprimeva le donne, alle protagoniste del movimento modernista che auspicavano la riforma liturgica e una diversa interpretazione della Bibbia; dalle uditrici presenti al Vaticano II, che auspicavano una nuova visione antropologica, alle teologhe che propongono oggi la revisione delle discipline teologiche rilette in una chiave di genere.
Oggi le religioni sono tutte in difficoltà storica: un limite o un’opportunità per le donne?
Nelle crisi ci sono sempre opportunità e possibilità di sviluppo. La crisi che sta attraversando la chiesa cattolica con il calo delle vocazioni spinge, per esempio, a riflettere sul ruolo dei laici e sulla necessità di riconoscere il lavoro che le donne già svolgono, soprattutto in terra di missione, dove laiche e religiose hanno importanti mansioni pastorali. Le crisi, però, accentuano anche le paure e tanti nella gerarchia ecclesiastica, davanti al nuovo, hanno paura dei cambiamenti e temono di perdere sicurezze.
Veniamo al binomio donna e teologia. È giusto parlarne al singolare?
No, perché non è mai esistita un’unica elaborazione teologica, nemmeno tra gli uomini. Le donne pongono nuovi interrogativi e fanno emergere la necessità di portare alla luce esperienze femminili dimenticate, mettendo in discussione la costruzione androcentrica delle discipline teologiche e delle strutture ecclesiastiche scarsamente inclusive. Le teologhe si esprimono con modalità diverse anche in sintonia con i diversi contesti culturali nei quali vivono.
 Ne è una prova il progetto internazionale, interconfessionale e interculturale «La Bibbia e le donne» che da 15 anni, in 4 lingue, pubblica volumi che studiano la Bibbia e la sua storia di ricezione, relativamente alle questioni di genere. All’interno di questi libri emergono scuole di pensiero che usano differenziati metodi di approccio. Troviamo così espresse la teologia narrativa accanto alla storico-critica, i queer studies accanto al femminismo post-coloniale espresso dai movimenti di liberazione del cosiddetto terzo mondo, in un mosaico variopinto di esperienze e proposte.
Ne è una prova il progetto internazionale, interconfessionale e interculturale «La Bibbia e le donne» che da 15 anni, in 4 lingue, pubblica volumi che studiano la Bibbia e la sua storia di ricezione, relativamente alle questioni di genere. All’interno di questi libri emergono scuole di pensiero che usano differenziati metodi di approccio. Troviamo così espresse la teologia narrativa accanto alla storico-critica, i queer studies accanto al femminismo post-coloniale espresso dai movimenti di liberazione del cosiddetto terzo mondo, in un mosaico variopinto di esperienze e proposte.Nel suo libro «Le ribelli di Dio», lei ricorda le importanti personalità femminili presenti nella Scrittura, dimostrando il ruolo fondamentale svolto dalle matriarche dell’ebraismo, dalle profetesse e dalle testimoni cristiane. Chi sono oggi le “ribelli di Dio”?
Le forme di dissenso all’interno della Chiesa cattolica si giocano perlopiù intorno alla questione dei ministeri e, nei confronti delle donne, permane la strategia del silenzio, non dando risonanza alle posizioni della teologia femminista, che mette in discussione l’impostazione patriarcale e androcentrica dell’interpretazione biblica, della teologia e della tradizione, e soffocando qualunque istanza di partecipazione ecclesiale che apra all’ordine sacro.
 Oggi, nonostante si cerchi di coprire con il silenzio casi scomodi, molte cattoliche in varie parti del mondo si preparano all’ordine sacro illegale o esercitano già il ministero presbiterale in comunità disposte ad accoglierle.
Oggi, nonostante si cerchi di coprire con il silenzio casi scomodi, molte cattoliche in varie parti del mondo si preparano all’ordine sacro illegale o esercitano già il ministero presbiterale in comunità disposte ad accoglierle.
 In Francia si è costituito il gruppo Toutes apôtres per aprire il ministero alle donne e la teologa francese Anne Soupa si è candidata alla guida come Vescova della sede vacante della Diocesi di Lione. Queste donne non accettano più di essere oggetto di riflessioni o di decisioni da parte del magistero, unico garante di verità e di ortodossia, ma, in opposizione, affermano di essere soggetti della propria vita di fede, di voler cambiare i canoni interpretativi aprendo le dottrine codificate a nuove prospettive. Verità ed errore, ortodossia ed eresia, in questa riscrittura teologica acquisiscono una diversa luce e il mio ultimo libro Eretiche (Il Mulino 2022) lo mette in evidenza.
In Francia si è costituito il gruppo Toutes apôtres per aprire il ministero alle donne e la teologa francese Anne Soupa si è candidata alla guida come Vescova della sede vacante della Diocesi di Lione. Queste donne non accettano più di essere oggetto di riflessioni o di decisioni da parte del magistero, unico garante di verità e di ortodossia, ma, in opposizione, affermano di essere soggetti della propria vita di fede, di voler cambiare i canoni interpretativi aprendo le dottrine codificate a nuove prospettive. Verità ed errore, ortodossia ed eresia, in questa riscrittura teologica acquisiscono una diversa luce e il mio ultimo libro Eretiche (Il Mulino 2022) lo mette in evidenza. -
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA E COSTITUZIONE: RIPENSARE COSTANTINO E LA TEOLOGIA POLITICA DELL’EUROPA.5 marzo 2022, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA E COSTITUZIONE:
RIPENSARE COSTANTINO E LA TEOLOGIA E LA POLITICA DELL’EUROPA.
Un omaggio a Beatrice Maria e Lucia (8 marzo) e a Dante Alighieri (25 marzo - Dantedì)...
USCIRE A RIVEDERE IL CIELO STELLATO. Non avendo sottratto alla teologia e alla logica dell’ Imperatore Costantino l’opera di Dante Alighieri (ridotto dalla Chiesa Cattolica di Giovanni XXII, prima che da Ugo Foscolo, a "ghibellino fuggiasco"), filosofi e storici hanno finito per banalizzare anche il lavoro di Ernst H. Kantorowicz! Si tenga presente, per capire bene e meglio l’uno e l’altro, che l’ultimo capitolo (l’ottavo) dei "Due corpi del re" è intitolato "La regalità antropocentrica: Dante" e, al contempo, che la regalità antropocentrica è da leggersi in senso antropologico (di ogni essere umano, "ecce homo"), non in senso di una andrologia costantiniana (di ogni essere umano-maschio, "ecce vir")!
COSTITUZIONE. La "Monarchia" dei "due Soli" non dice né della dittatura dell’Imperatore né della dittatura del Papa, ma indica che l’uno e l’altro, semplicemente (la cosa più difficile a farsi), dia a "Dio" (l’amor che muove il sole e le altre stelle) ciò che è di "Dio" e ognuno all’altro (entrambi sovrani - memoria di don Milani) ciò che tocca all’uno e all’altro - nel riconoscimento della sovranità di "Dio" stesso, della Legge dei nostri Padri Costituenti e delle nostre Madri Costituenti. Se in principio era la Costituzione (il Logos), "Quis Ut Deus?" ("Chi è come Dio")?!
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- USCIRE DAL LETARGO E RIPRENDERE IL CAMMINO. La “ricapitolazione” di tutte le cose in Cristo (Giovanni Paolo II - 2001).26 febbraio 2022, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO E QUESTIONE ANTROPOLOGICA: UT UNUM SINT... *
GIOVANNI PAOLO II
UDIENZA GENERALE
Mercoledì, 14 febbraio 2001
La “ricapitolazione” di tutte le cose in Cristo *
1. Il disegno salvifico di Dio, “il mistero della sua volontà” (Ef 1,9) concernente ogni creatura, è espresso nella Lettera agli Efesini con un termine caratteristico: “ricapitolare” in Cristo tutte le cose, celesti e terrestri (cfr Ef 1,10). L’immagine potrebbe rimandare anche a quell’asta attorno alla quale si avvolgeva il rotolo di pergamena o di papiro del volumen, recante su di sé uno scritto: Cristo conferisce un senso unitario a tutte le sillabe, le parole, le opere della creazione e della storia.
A cogliere per primo e a sviluppare in modo mirabile questo tema della ‘ricapitolazione’ è sant’Ireneo vescovo di Lione, grande Padre della Chiesa del secondo secolo. Contro ogni frammentazione della storia della salvezza, contro ogni separazione tra Antica e Nuova Alleanza, contro ogni dispersione della rivelazione e dell’azione divina, Ireneo esalta l’unico Signore, Gesù Cristo, che nell’Incarnazione annoda in sé tutta la storia della salvezza, l’umanità e l’intera creazione: “Egli, da re eterno, tutto ricapitola in sé” (Adversus haereses III, 21,9).
2. Ascoltiamo un brano in cui questo Padre della Chiesa commenta le parole dell’Apostolo riguardanti appunto la ricapitolazione in Cristo di tutte le cose. Nell’espressione “tutte le cose” - afferma Ireneo - è compreso l’uomo, toccato dal mistero dell’Incarnazione, allorché il Figlio di Dio “da invisibile divenne visibile, da incomprensibile comprensibile, da impassibile passibile, da Verbo divenne uomo. Egli ha ricapitolato tutto in se stesso, affinché come il Verbo di Dio ha il primato sugli esseri sopracelesti, spirituali e invisibili, allo stesso modo egli l’abbia sugli esseri visibili e corporei. Assumendo in sé questo primato e donandosi come capo alla Chiesa, egli attira tutto in sé” (Adversus haereses III, 16,6). Questo confluire di tutto l’essere in Cristo, centro del tempo e dello spazio, si compie progressivamente nella storia superando gli ostacoli, le resistenze del peccato e del Maligno.
3. Per illustrare questa tensione, Ireneo ricorre all’opposizione, già presentata da san Paolo, tra Cristo e Adamo (cfr Rm 5,12-21): Cristo è il nuovo Adamo, cioè il Primogenito dell’umanità fedele che accoglie con amore e obbedienza il disegno di redenzione che Dio ha tracciato come anima e meta della storia. Cristo deve, quindi, cancellare l’opera di devastazione, le orribili idolatrie, le violenze e ogni peccato che l’Adamo ribelle ha disseminato nella vicenda secolare dell’umanità e nell’orizzonte del creato. Con la sua piena obbedienza al Padre, Cristo apre l’era della pace con Dio e tra gli uomini, riconciliando in sé l’umanità dispersa (cfr Ef 2,16). Egli ‘ricapitola’ in sé Adamo, nel quale tutta l’umanità si riconosce, lo trasfigura in figlio di Dio, lo riporta alla comunione piena con il Padre. Proprio attraverso la sua fraternità con noi nella carne e nel sangue, nella vita e nella morte Cristo diviene ‘il capo’ dell’umanità salvata. Scrive ancora sant’Ireneo: “Cristo ha ricapitolato in se stesso tutto il sangue effuso da tutti i giusti e da tutti i profeti che sono esistiti dagli inizi” (Adversus haereses V, 14,1; cfr V, 14,2).
4. Bene e male sono, quindi, considerati alla luce dell’opera redentrice di Cristo. Essa, come fa intuire Paolo, coinvolge tutto il creato, nella varietà delle sue componenti (cfr Rm 8,18-30). La stessa natura infatti, come è sottoposta al non senso, al degrado e alla devastazione provocata dal peccato, così partecipa alla gioia della liberazione operata da Cristo nello Spirito Santo.
Si delinea, pertanto, l’attuazione piena del progetto originale del Creatore: quello di una creazione in cui Dio e uomo, uomo e donna, umanità e natura siano in armonia, in dialogo, in comunione. Questo progetto, sconvolto dal peccato, è ripreso in modo più mirabile da Cristo, che lo sta attuando misteriosamente ma efficacemente nella realtà presente, in attesa di portarlo a compimento. Gesù stesso ha dichiarato di essere il fulcro e il punto di convergenza di questo disegno di salvezza quando ha affermato: “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32). E l’evangelista Giovanni presenta quest’opera proprio come una specie di ricapitolazione, un “riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” (Gv 11,52).
5. Quest’opera giungerà a pienezza nel compimento della storia, allorché - è ancora Paolo a ricordarlo - “Dio sarà tutto in tutti” (1Cor 15,28).
L’ultima pagina dell’Apocalisse - che è stata proclamata in apertura del nostro incontro - dipinge a vivi colori questa meta. La Chiesa e lo Spirito attendono e invocano quel momento in cui Cristo “consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza... L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa (Dio) ha posto sotto i piedi” del suo Figlio (1Cor 15,24.26).
Al termine di questa battaglia - cantata in pagine mirabili dall’Apocalisse - Cristo compirà la ‘ricapitolazione’ e coloro che saranno uniti a lui formeranno la comunità dei redenti, che “non sarà più ferita dal peccato, dalle impurità, dall’amor proprio, che distruggono o feriscono la comunità terrena degli uomini. La visione beatifica, nella quale Dio si manifesterà in modo inesauribile agli eletti, sarà sorgente perenne di gaudio, di pace e di reciproca comunione” (CCC, 1045).
La Chiesa, sposa innamorata dell’Agnello, con lo sguardofisso a quel giorno di luce, eleva l’invocazione ardente:“Maranathà” (1Cor 16,22), “Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22,20).
* FONTE: VATICAN.VA, 14 FEBBRAIO 2001 (RIPRESA PARZIALE)
*
NOTA:
PER UNA RICAPITOLAZIONE ANTROPOLOGICAMENTE "INTERA" IN GESU’ ("ECCE HOMO"), NON ANDROLOGICAMENTE "DIMEZZATA" IN PAOLO ("ECCE VIR")!
- FILOLOGIA E FILOSOFIA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
- FILOLOGIA E DIRITTO: LEZIONE DI PONZIO PILATO «disse loro: "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: "«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi! Crocifiggi!" Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei : "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
- FILOLOGIA E RELIGIONE: LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
DUE SOLI IN TERRA E UNO SOLE IN CIELO. La Monarchia di Dante è una lezione di antropologia prima che di politica: il giardino dell’intera umanità (impero e chiesa) è uno solo - o l’aiuola della guerra o il paradiso terrestre
FLS
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---JAN VERMEER, LA "PESATRICE DI PERLE", E LA "PROFEZIA" DELLA SIBILLA LIBICA: UNA QUESTIONE DI BILANCIA.19 febbraio 2022, di Federico La Sala
UNA QUESTIONE DI GIUSTIZIA E DI BILANCIA (di una "statera" non di una "statua").
Ipotesi per una rilettura della "Pesatrice di perle" di Johannes van der Meer *
- LE SIBILLE, I PROFETI, E IL BAMBINO: RINASCIMENTO. - Nel testo di FILIPPO BARBIERI (o Filippo Barberi, Philippus de Barberis, Philippus Siculus), "Discordantiae sanctorum doctorum Hieronymi et Augustini" (1481), il testo più diffuso in epoca rinascimentale sulla importanza e sulla concordanza tra il messaggio dei profeti e delle sibille, nella didascalia alla base della figura della Sibilla Libica, è scritto:
- "La Sibilla Libica, che ha passato l’età della gioventù, con il capo adorno da una vigorosa ghirlanda di fiori, ricoperta da un bel mantello, parla in questo modo: «Ecco verrà il giorno e [il Signore] illuminerà le fitte tenebre e si scioglieranno i nodi della Sinagoga e taceranno le labbra degli uomini e vedranno il re dei viventi: lo terrà in grembo una vergine, signora delle genti, e regnerà nella misericordia, e il grembo di sua madre sarà la statua di tutti» («Ecce veniet dies et illuminabit condempsa tenebrarum et solventur nexus Synagoge et desinent labia hominum et videbunt regem viventium; tenebit illum in gremio virgo domina gentium et regnabit in misericordia et uterus matris erit statua cunctorum»"(Cfr. Federico La Sala, "Della Terra, il brillante colore", Milano 2013, p. 40).
NASCITA E "GIUDIZIO DI SALOMONE". Del dipinto Pesatrice di perle (o #Donna con una bilancia) di Jan Vermeer (databile al 1664 e conservato nella National Gallery of Art di Washington), anche alla luce del fatto che dentro il quadro c’è rappresentato un altro quadro - un dipinto con un Giudizio Universale - c’è da pensare, probabilmente, che la figura della donna in avanzato stato di gravidanza rimandi alla figura della Sibilla Libica (raffigurata da tantissimi artisti e anche da Michelangelo nella Cappella Sistina) e al suo specifico annuncio del messaggio evangelico, e comunichi il rapporto che esiste tra la bilancia (la giustizia e l’equilibrio), il grembo (il concepimento), e la nascita di un bambino, una bambina - una maestra, un maestro di umanità...
A quanto pare, anche Jan Vermeer (1632- 1675), conosceva bene il tema delle Sibille e della Giustizia (di Astrea, della Virgo della IV Ecloga di Virgilio, Dante, e Michelangelo) e della bilancia (la parola esatta della profezia della Sibilla Libica)... ed è riuscito a dare un bel quadro del tema della nascita del Bambino, dell’implicito riferimento all’esemplare giudizio di Salomone sul comportamento delle due madri e, infine, allo stesso Giudizio Universale.!
Della Sibilla Libica, infatti, questo è il suo messaggio: «Uterus Matris erit statera cunctorum. L’utero della Madre sarà la bilancia di tutti gli esseri umani». Una bilancia ("statera"), non una "statua"! Che re-fuso e che con-fusione - filo-logica e antropo-logica!
*
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- LA QUESTIONE DELL’ANTROPOCENTRISMO, IL RINASCIMENTO, E LA BIENNALE D’ARTE VENEZIA 2022.15 febbraio 2022, di Federico La Sala
LA QUESTIONE DELL’ANTROPOCENTRISMO, IL RINASCIMENTO, E LA BIENNALE D’ARTE VENEZIA 2022...
- "[...] L’antropocentrismo rinascimentale è messo in discussione dalle linee teoriche della Biennale di Cecilia Alemani, come anticipato dalla stessa curatrice.
- Che il meraviglioso, l’ibrido e il fantastico fossero di casa durante il Rinascimento lo testimoniano innanzitutto le opere d’arte: dipinti, sculture, disegni che raffigurano esseri dove il naturale si mescola con l’umano, l’umano con l’animale e il vegetale, il maschile con il femminile etc. etc. Una selva di esseri ibridi provenienti dal paganesimo antico si risvegliano dopo secoli di torpore monoteista. E, se non bastasse la visione diretta delle opere d’arte, che testimoniano in modo inequivocabile l’esplosione dell’immaginazione rinascimentale fatta di centauri, satiri, tritoni, esseri metà uomini e metà cavalli, capre e pesci che si accompagnano a esseri metà arborei e animali ed ermafroditi, abbondano i testi di incomparabile erudizione come La rinascita del paganesimo antico di Aby Warburg o i Misteri pagani nel rinascimento di Edgar Wind. Testi capitali che hanno avuto il compito, nel secolo scorso, di spazzare via la ormai vetusta e inservibile interpretazione che fa del Rinascimento un prodromo dell’Illuminismo, fenomeno figlio della modernità calvinista e iconoclasta, come testimonia James Simpson in Under the Hammer. La difficoltà di classificare un periodo storico come quello rinascimentale deriva dalla difficoltà che molti hanno di dismettere vuote contrapposizioni dicotomiche tipiche della modernità, come razionale vs irrazionale, fantastico vs realista e che dir si voglia. Ciò che tiene insieme artisti come Piero di Cosimo e Piero della Francesca, oppure Leonardo e Michelangelo nella loro diversità e insieme fortissima coesione è la comune appartenenza a un paradigma affatto diverso, tutto all’insegna del potere delle immagini e della loro indipendenza rispetto ad altre forme di pensiero.
- IL PUNTO DI VISTA DI CECILIA ALEMANI. Ecco che quindi fa benissimo la curatrice della nuova Biennale d’Arte, Cecilia Alemani, a inaugurare, nella sua presentazione, la serie delle opere in mostra con i dipinti di Remedios Varo e di Leonor Fini, che, emblematicamente, sono totalmente mutuate da un’iconografia chiaramente rinascimentale. E lo si vede sia nella scatola prospettica dotata di scacchiera albertiana, come in una predella di Paolo Uccello, nell’opera della Varo, oppure nell’acribia del disegno e della sovrapposizione di velature, come in un Cristofano Allori, del dipinto della Fini. Ma anche nell’eccezionale dipinto di Paula Rego si scorge l’organizzazione brunelleschiana dello spazio nella fuga prospettica del pavimento a scacchiera che spinge in avanti verso lo spettatore la grande figura in primo piano.
- È proprio nel tentativo novecentesco di artisti e artiste, come quelle che Alemani ha deciso di porre nuovamente in luce, poste ai margini della linea della modernità ortodossa (quella sì espressione della hubris faustiana e tecnica e quindi fondamentalmente aniconica), le quali ricercavano nell’immagine di matrice rinascimentale la fonte cui abbeverarsi come un antidoto allo strapotere della tecnica, che comprendiamo quanto l’arte del Rinascimento, nella sua irriducibile complessità, sia oggi sempre più che mai attuale e rilevante" (Nicola Verlato, Riflessioni sul Rinascimento in vista della Biennale di Cecilia Alemani, Artribune, 10 febbraio 2022).
ANTROPOLOGIA, STORIA, E FILOLOGIA. Per una messa in discussione critica dell’antropocentrismo rinascimentale (che ha matrici antiche, nella tradizione greco-romana), forse, sarebbe meglio ripartire dalla Trasfigurazione di Cristo del Beato Angelico del 1437-1446, e dall’opera di Lorenzo Valla, "Sulla Donazione di Costantino falsamente attribuita e falsificata" del 1440, e, infine, anche dall’uomo vitruviano (1490) e dal "bambino nel grembo materno" (del 1511) di Leonardo da Vinci.
PER RI-NASCERE, VEDERE DALLO SPAZIO IL SORGERE DELLA TERRA. Alla luce di questo capovolgimento di sguardo, si potrà osservare meglio il cammino della tentazione prometeica e faustiana dello stesso antropocentrismo del Rinascimento, fino ad arrivare alla hubris della tecnica, che si caratteriza per essere più un camuffato androcentrismo tragico (alla Socrate e alla Platone, come ha ben visto Nietzsche) che non un semplice antropocentrismo, antropologicamente fondato.
ARTE E SOCIETÀ. Piero di Cosimo è una figura-chiave del tempo: nel 1481 è a Roma col maestro Cosimo Rosselli, per lavorare nella Cappella Sistina (voluta da papa Sisto IV); e nel 1483 è a Firenze: del 1488 è la Sacra conversazione, ora nella Galleria dello Spedale degli Innocenti ("Era molto amico di Piero lo spedalingo de li Innocenti").
BAMBINI ABBANDONATI E ANDROCENTRISMO. Ricordato che anche Leonardo da Vinci era un figlio naturale e che il "presepe" era stato introdotto nella Firenze del ’400, nell’Ospedale degli Innocenti (l’Ospedale non ha la ruota ma una cappella aperta, il presepe, dove il bimbo veniva deposto tra le immagini di Gesù, nato povero e allevato nella carità), è da dire che il nodo di Ercole, il problema di come nascono i bambini, è ancora sciolto come la cosmoteandria tragica (Eschilo con Platone e Aristotele) comandava e, a metà 1500, con il Concilio di Trento "il matrimonio diventa un’istituzione obbligata, e l’ingresso dell’Ospedale viene chiuso da una grata; da luogo di accoglienza per i meno ricchi diviene rifugio per una sottospecie di infanzia, che nasce sotto il segno di una vergogna ereditata dalla madre" (Adriano Prosperi).
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- MICHELANGELO ("TONDO DONI"), GALILEO GALILEI ("SIDEREUS NUNCIUS"), E APOLLO 8 (EARTHRISE,1968).13 febbraio 2022, di Federico La Sala
Cosmologia, antropologia, cristianesimo e civiltà.
"IL FIGLIO DELL’UOMO": UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA E FILOLOGICA...
COSMOLOGIA. “Da Copernico in poi l’uomo rotola dal centro verso una X”. Così Nietzsche, nel 1886. Ma, per un filosofo nato filologo e, per di più, uno dei grandi maestri del sospetto, contrariamente a quanto si è sempre ripetuto in modo "umano, troppo umano", non è bene tornare a interrogarlo e cercare di avere ulteriori dati sulla destinazione "ignota"?
ANTROPOLOGIA. Nel 1888 pubblica "Ecce homo. Come si diviene ciò che si è": un Urlo contro la paolina religione del "Vir Dei", una critica radicale della cosmoteandria faraonica, e un aut aut epocale.
LA PUNTA DI UN ICEBERG BIMILLENARIO: PUGLIA (12 FEBBRAIO 2022). "Ecce Vir": il "caso serio" del quadro intitolato "Sabinus vir Dei".
Tracce per una seconda rivoluzione copernicana
- AL DI LÀ DELLA LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)
SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI E RINASCIMENTO, OGGI. Una ristrutturazione epocale e lo sgretolamento della cosmoteandria tradizionale (#cosmo, teologia/ #dio e #andrologia/uomo) è già da tempo in atto: la nascita di una antropologia annunciata già da Michelangelo nel suo "Tondo Doni", con le sue due sibille e i suoi due profeti - non "quattro profeti", come vuole la Galleria degli Uffizi, e da Galileo Galilei con il suo "Sidereus Nuncius" (1610), fondata sulla visione del sorgere della Terra, è già in cammino: un capovolgimento e una nuova ricapitolazione, una radicale inversione logico-storica!
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- VITA "EXTRATERRESTRE" E SGUARDO NUOVO SUL PIANETA TERRA.28 gennaio 2022, di Federico La Sala
VITA "EXTRATERRESTRE" E SGUARDO NUOVO. Tracce per una svolta_antropologica...
- Nota a margine dell’articolo di Martina Shalipour Jafari,
- Filosofia della scienza: un ritorno al passato per guardare al futuro
- In che modo un background filosofico può aiutarci ad essere scienziati migliori ("Future Brain", 28.01.2022).
IL PRESENTE. Come è possibile "guardare al futuro" se torniamo al passato? Grazie al "passato", siamo arrivati al "presente" ("futuro" del passato). Ma "un ritorno al passato", cosa può dirci di diverso da quanto già sappiamo, se ancora camminiamo e pensiamo come in "passato"?!
IL PASSATO. Un vento fortissimo viene dal passato e questo vento (ricordare Walter Benjamin) a noi, che siamo spinti sempre più avanti e che continuiamo a guardare ipnotizzati il "passato", quale "futuro" mostra? Un crescere oceanico di macerie e rifiuti...
Filosofia, Scienza, e DisagiodellaCiviltà (Freud, 1929). Il problema è proprio quello di liberare l’epistemologia dalla caverna platonica e ripartire da un ulteriore sguardo nel gorgo claustrofilico (Elvio Fachinelli, Claustrofilia, 1983) e soprattutto da un fatto inaudito e impensato: nascere, diventare un essere umano extraterrestre e aprire gli occhi sul ... SorgeredellaTerra.
Federico La Sala
MUSICA, MUSE, PROFETI E SIBILLE, ANTROPOLOGIA, E "MOS-ART" DI SALUTE E LIBERAZIONE:
- UNO STRAORDINARIO ESEMPIO DI EFETTO MOZART - DELLA "MOS-ART" ("arte di Mosè"):
- “THE SHAWSHANK REDEMPTION” (1994). Una breve sequenza dal #film “Le Ali della Libertà”, con
- "Sull’Aria..." da "Le Nozze di Figaro" .
DISAGIO DELLA CIVILTA’ (FREUD, 1929). Il problema, a mio parere, è che la ricerca e i risultati di Alfred A. Tomatis (Nizza, 1º gennaio1920 - Carcassonne, 25 dicembre2001) sono talmente innervati con la nostra non-volontà di sapere di sé che, pur comprendendo che già il solo "parlare è suonare il proprio corpo" (Alfred Tomatis), alle accademiche platoniche orecchie (cieche e sorde e zoppe, come quelle di Edipo) il messaggio non arriva o arriva assolutamente distorto.
DANTE 2021: MEMORIA DI APOLLO E DELLE MUSE
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- DANTE 2021: "GIUDITTA DECAPITA OLOFERNE". UNA MOSTRA A ROMA (PALAZZO BARBERINI). C’è Giuditta fra Caravaggio, Artemisia e gli altri (di Maurizio Cecchetti)31 dicembre 2021, di Federico La Sala
Roma. C’è Giuditta fra Caravaggio, Artemisia e gli altri
Una mostra affianca al capolavoro di Palazzo Barberini circa trenta opere sul tema dell’eroina biblica. Il confronto, come al solito, è con la figlia di Orazio Gentileschi
di Maurizio Cecchetti (Avvenire, giovedì 30 dicembre 2021)
- [Foto] Caravaggio, "Giuditta decapita Oloferne" (Roma, Palazzo Barberini)
Quando c’è di mezzo Caravaggio, è bene cercare sempre nel quadro un riflesso della sua vita interiore, della sua psicologia. Per un artista dal carattere rissoso e mosso da un forte sentimento competitivo, che a quanto riporta Gaspare Celio - pittore e trattatista seicentesco di cui qualche anno fa venne scoperta una copia del suo compendio alle Vite del Vasari - forse era fuggito da Milano ancora giovane per evitare processi per un omicidio non ben precisato, e che altri ne commetterà a Roma e altrove, si può pensare che mentre dipingeva il quadro Giuditta decapita Oloferne si ricordasse di ciò che aveva provato assistendo ad alcune esecuzioni capitali, riflettendo su se stesso («e se prima o poi dovesse capitare anche a me?). Nelle azioni drammatiche che dipingeva, spesso lui è dentro il quadro: nel Davide con la testa di Golia, è suo il volto del gigante. Nel Martirio di san Matteo, lui è ai margini della scena e si gira a guardare l’assassinio dell’evangelista; nella Cattura di Cristo è sulla destra che alza la testa per vedere sopra la fila dei soldati venuti per arrestare Gesù... Che cosa vede? Se l’immagine ha un senso, vede Giuda che sta per baciare il suo profeta disarmato mentre lo consegna alla giustizia romana: il quadro è un saggio di antropologia sul tradimento degli “amici”...
A voler stare ai fatti, non ci fu nessuna sfida fra Artemisia e Caravaggio. Tanto più che quando lui morì, nel 1610, ormai lontano da Roma da qualche anno, Artemisia aveva circa diciassette anni e aveva appreso gli strumenti della pittura attraverso il padre, nella cui bottega transitavano artisti di valore e notabili della Roma reduce, dopo il 1600, da uno dei giubilei più fastosi e più orientati al trionfalismo della Chiesa che stava da decenni contrastando l’avanzata protestante.
 Se di sfida si può parlare riguardo ad Artemisia, l’unica degna di approfondimenti è quella con la pittura del padre Orazio. Ma di questo parlerò fra poco, perché è un altro il tema della mostra romana ordinata a Palazzo Barberini fino al 27 marzo da Maria Cristina Terzaghi, storica dell’arte con un nutrito carnet di saggi sul Caravaggio (anche lei fu tra i primi a rinvenire la mano del pittore nell’Ecce homo spuntato come un fungo dalla sera alla mattina a Madrid in un’asta, poi ritirato e finito nel caveau del Prado che lo sta facendo pulire per capire se è veramente di Caravaggio).
Se di sfida si può parlare riguardo ad Artemisia, l’unica degna di approfondimenti è quella con la pittura del padre Orazio. Ma di questo parlerò fra poco, perché è un altro il tema della mostra romana ordinata a Palazzo Barberini fino al 27 marzo da Maria Cristina Terzaghi, storica dell’arte con un nutrito carnet di saggi sul Caravaggio (anche lei fu tra i primi a rinvenire la mano del pittore nell’Ecce homo spuntato come un fungo dalla sera alla mattina a Madrid in un’asta, poi ritirato e finito nel caveau del Prado che lo sta facendo pulire per capire se è veramente di Caravaggio).
 Il tema della mostra infatti è quello dell’episodio biblico di Giuditta e Oloferne, la cui interpretazione prima di Caravaggio non ebbe mai la stessa capacità di raffigurare un evento efferato e sacro come se stesse accadendo sotto i nostri occhi.
Il tema della mostra infatti è quello dell’episodio biblico di Giuditta e Oloferne, la cui interpretazione prima di Caravaggio non ebbe mai la stessa capacità di raffigurare un evento efferato e sacro come se stesse accadendo sotto i nostri occhi.La mostra è accompagnata da un catalogo (Officina libraria) con le opere esposte e le schede per ogni dipinto, precedute da alcuni saggi storici che seguono percorsi iconografici, letterari, sociali, fino agli sviluppi psicoanalitici su “Donne e violenza nell’arte occidentale”. Ovviamente, la curatrice ha redatto un saggio ampio e ponderoso sulla storia del dipinto caravaggesco, a partire dal primo proprietario, il banchiere Ottavio Costa, che possedeva altre due opere del pittore, ma della Giuditta fu particolarmente “geloso” (forse, come pensa la Terzaghi, non voleva che qualcuno convincesse Caravaggio a farne un’altra versione, in realtà io credo che le ragioni fossero legate alla natura e qualità stessa del quadro: inaudita potenza visiva e conturbante bellezza sacra). Quando la tela venne scoperta dal restauratore romano Pico Cellini nel 1951, la retrospettiva del Caravaggio a Milano era stata già inaugurata. Longhi, strabiliato dalla bellezza dell’opera, fece prorogare la mostra di due mesi perché il quadro potesse venire esposto. Ci fu anche il tentativo di venderlo all’estero, ma la pronta notifica vincolò il quadro, che venne acquistato dallo Stato vent’anni dopo, nel 1971, per 250 milioni di lire. Non mi dilungo sugli accostamenti, già fatti nei decenni scorsi, con un fatto di cronaca che fece scalpore, la decapitazione di Beatrice Cenci nel 1599 per aver ucciso il padre che la maltrattava e la segregava. Secondo Gianni Papi, in realtà, l’opera sarebbe successiva, anche a quelle della Cappella Contarelli (ciclo di san Matteo). Un documento che attesta un pagamento del banchiere Costa datato 1602 per un quadro imprecisato, rafforzerebbe il dubbio sulla cronologia. -Segnalo i riferimenti che Terzaghi fa con alcune opere che potrebbero aver ispirato Caravaggio nel momento in cui escogitava l’opera (in particolare una incisione del 1540 di Giovan Battista Scultori derivata da una Giuditta decapita Oloferne di Giulio Romano, che potrebbe far pensare alle peregrinazioni del Merisi in quegli anni “vacanti” tra Milano e Roma, che lo portarono quasi certamente fino a Venezia); e tralascio gli spunti per l’identificazione della modella che prestò la sua bellezza a Giuditta (Longhi l’aveva definita una «Fornarina del naturalismo»), con ogni probabilità Fillide Melandroni, cortigiana senese a Roma fin da adolescente.
Con Artemisia si entra, invece, in un campo minato, perché la “premiata ditta Gentileschi”, «padre e figlia», in realtà è ancora coperta da ombre e da dissidi familiari da chiarire. Da tempo è in atto una ricerca che aspira a distinguere con chiarezza le opere che sono di Orazio e quelle di Artemisia. Non è facile, almeno tra quelle che precedono l’esodo della pittrice da Roma. Resta però, a mio parere, un elemento dirimente che possono negare soltanto quelli che si richiamano ancora al mito femminista di Artemisia - il libro di Anna Banti diede la stura a questa interpretazione da superare -: Orazio è un pittore più bravo di sua figlia. Ed è sulle qualità pittoriche che bisogna trovare un maggior accordo fra gli studiosi.
Il caso da manuale riguarda le due versioni della Giuditta decapita Oloferne attribuite ad Artemisia: quella di Capodimonte, esposta ora a Roma, e quella degli Uffizi: quasi identica l’impostazione, ma in realtà diversa nello spazio, perché quella di Firenze è più ampia e mostra le gambe di Oloferne, ma soprattutto il sangue che sprizza ovunque con una violenza che nel quadro di Capodimonte, seppur più ravvicinato, è attenuata. Quel sangue che imbratta, come uno stigma psicologico, fa pensare a una mano femminile. Nel quadro di Napoli l’eroina indossa un abito azzurro-blu, mentre a Firenze è del tipico giallo che ricorre spesso nella pittura di Artemisia. Orazio dipinge con maggior eleganza e raffinatezza, con una luce che esalta la bellezza “sartoriale” dei tessuti e congela i toni in una visione quasi metafisica (per esempio il bianco dei lenzuoli), come si vede anche nella tela Giuditta e la fantesca con la testa di Oloferne di Hartford.
Vi fu sempre un certo traffico di opere dallo studio di Orazio, dove anche la giovane Artemisia lavorava, e i documenti, che anche la Terzaghi ricorda, oggi insinuano il dubbio che il quadro di Capodimonte possa essere, come sostenevo fin dalla mostra del 1991 che rilanciò il mito di Artemisia, non suo ma di Orazio. Questo, francamente, rende un po’ superficiale il giudizio di Keith Christiansen secondo cui Orazio non badava troppo alla paternità dei suoi dipinti. Se fosse per amore verso la figlia non so, può anche darsi, ma il problema potrebbe invece essere che Artemisia aveva il “complesso di Elettra”, come direbbero gli psicoanalisti, cioè invidiava l’intesa fra Orazio e la sua pittura, vedendola come sostituta della madre. Ci sarebbe ben altro da aggiungere riguardo ai quadri esposti, fra cui figurano, tra i più straordinari, quelli del Valentin, di Cristofano Allori, di Cagnacci, di Manfredi, di Lavinia Fontana, di Pierfrancesco Foschi e del Tintoretto.
Mi limito a due appunti finali sull’impostazione della mostra: aver poco approfondito la diversa interpretazione del tema da parte di mani femminili, rispetto alla predominanza di quelle maschili. Questo è il classico tema su cui si possono indagare due psicologie, se non opposte, complementari.
 La seconda riguarda il fatto biblico, rispetto al quale si offre una lettura poco puntuale per lo più vedendo la fortuna del tema in funzione antiprotestante. In sostanza, mi chiedo perché fra saggi storici molto curati, compreso quello del Giano bifronte Filippo Maria Ferro, grande studioso d’arte e psicoanalista, non abbia trovato posto il contributo di un teologo-biblista.
La seconda riguarda il fatto biblico, rispetto al quale si offre una lettura poco puntuale per lo più vedendo la fortuna del tema in funzione antiprotestante. In sostanza, mi chiedo perché fra saggi storici molto curati, compreso quello del Giano bifronte Filippo Maria Ferro, grande studioso d’arte e psicoanalista, non abbia trovato posto il contributo di un teologo-biblista.
 Chi vuole può compensare la carenza appoggiandosi all’ultimo numero di “La Civiltà Cattolica” (4114) dove i gesuiti Saverio Corradino e Giancarlo Pani offrono una propedeutica al tema, ovvero La teologia della storia nel Libro di Giuditta, che il testamento ebraico non ha accolto fra i canonici, ma che i due autori definiscono «a suo modo un midrash sull’intera storia della salvezza».
Chi vuole può compensare la carenza appoggiandosi all’ultimo numero di “La Civiltà Cattolica” (4114) dove i gesuiti Saverio Corradino e Giancarlo Pani offrono una propedeutica al tema, ovvero La teologia della storia nel Libro di Giuditta, che il testamento ebraico non ha accolto fra i canonici, ma che i due autori definiscono «a suo modo un midrash sull’intera storia della salvezza». -
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- DANTE 2021. A FUTURA MEMORIA: MESSAGGIO EVANGELICO E MAGISTERO ANTROPOLOGICO.17 dicembre 2021, di Federico La Sala
#DIVINA COMMEDIA (#DANTE 2021):
#MESSAGGIO EVANGELICO
E
#MAGISTERO ANTROPOLOGICO
A #FUTURA MEMORIA.
Per una #Cristologia
non andrologica,
lezione di #Teresa d’Avila,
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- STORIA, ARTE, E FILOLOGIA: MICHELANGELO E IL "TONDO DONI".23 novembre 2021, di Federico La Sala
#STORIA #ARTE #ARTERAPIA #FILOSOFIA #FILOLOGIA:
IL #QUADRO E LA #CORNICE DEL #TONDO DONI.
UNA #QUESTIONE DI #ANTROPOLOGIA E DI #PRESEPE ...
Ad #Arte? Se nella #cornice del #TondoDoni, "sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti" (Galleria degli Uffizi), e non quelle di #due profeti e di due #sibille, cosa si può capire dei #due soli di #Dante e del racconto della #Cappella Sistina?:
Michelangelo dipinse questa #SacraFamiglia per #AgnoloDoni, mercante fiorentino il cui prestigioso matrimonio nel 1504 con Maddalena Strozzi avvenne in un periodo cruciale per l’arte a #Firenze di inizio secolo. La compresenza in città di #Leonardo, #Michelangelo e #Raffaello apportò uno scatto di crescita al già vivace ambiente fiorentino, che nel primo decennio del secolo visse una stagione di altissimo fervore culturale.
 (...) La #cornice del #tondo, probabilmente su disegno di Michelangelo è stata intagliata da Francesco del Tasso, esponente della più alta tradizione dell’intaglio ligneo fiorentino. Vi sono raffigurate la #testa di #Cristo e quelle di #quattro #profeti, circondate da grottesche e racemi, in cui sono nascoste, in alto a sinistra, delle mezze lune, insegne araldiche della famiglia Strozzi.
(...) La #cornice del #tondo, probabilmente su disegno di Michelangelo è stata intagliata da Francesco del Tasso, esponente della più alta tradizione dell’intaglio ligneo fiorentino. Vi sono raffigurate la #testa di #Cristo e quelle di #quattro #profeti, circondate da grottesche e racemi, in cui sono nascoste, in alto a sinistra, delle mezze lune, insegne araldiche della famiglia Strozzi.Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- PSICOANALISI CATTOLICESIMO E "DISAGIO NELLA CIVILTÀ". Dante 2021: ricordando Sigmund Freud e Franca Ongaro Basaglia.15 novembre 2021, di Federico La Sala
L’AMORE UNIVERSALE E UN’APPROPRIAZIONE INDEBITA: LA MEMORIA DI MOSÈ E IL CAMMINO DI SIGMUND FREUD
PSICOANALISI CATTOLICESIMO E "DISAGIO NELLA CIVILTÀ" ("Das Unbehagen in der Kultur"). Un’appropriazione indebita dell’amore universale e "L’infelicità nella civiltà" ("Das Ungluck in der Kultur"):
"[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità critiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori; i Romani, che non avevano fondato la loro collettività statale sull’amore, non conobbero l’intolleranza religiosa, benché per loro la religione fosse un affare di Stato e lo stato fosse imbevuto di religione. Non fu un puro caso che il sogno germanico del dominio del mondo facesse appello all’antisemitismo come a suo complemento, e non è inconcepibile che il tentativo di stabilire una nuova civiltà comunista in Russia trovi il suo sostegno psicologico nella persecuzione della borghesia. Ci si chiede soltanto, con apprensione, che cosa si metteranno a fare i Sovieti, dopo che avranno sterminato la loro borghesia [...]".
“[...] mi manca il coraggio di erigermi a profeta di fronte ai miei simili e accetto il rimprovero di non saper portare loro nessuna consolazione, perché in fondo questo è ciò che tutti chiedono, i più fieri rivoluzionari non meno appassionatamente dei più virtuosi credenti. Il problema fondamentale del destino della specie umana a me sembra sia questo: se, e fino a che punto, l’evoluzione civile riuscirà a padroneggiare i turbamenti della vita collettiva provocati dalla pulsione aggressiva e auto distruttrice degli uomini. In questo aspetto proprio il tempo presentemerita forse particolare interesse. Gli uomini adesso hanno esteso talmente il proprio potere sulle forze naturali, che giovandosi di esse sarebbe facile sterminarsi a vicenda fino all’ultimo uomo. Lo sanno, donde buona parte della loro presente inquietudine, infelicità, apprensione. E ora c’è da aspettarsi che l’altra delle due potenze celesti, l’Eros eterno farà uno sforzo per affermarsi nella lotta contro il suo avversario parimenti immortale. Ma chi può prevedere se avrà successo e quale sarà l’esito?”(#SigmundFreud, "Il disagio della civiltà", 1929).
Per "orientarsi nel pensiero" (Kant), rileggere le note di Franca Ongaro Basaglia su "Così parlò Edipo a Cuernavaca" ("PM-Panorama Mese", novembre 1982) e ricordare il legame della "Interpretazione dei Sogni" (1900) con l’Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, #Acheronta #movebo") di Virgilio e "L’uomo Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’«In exitu Isräel de Aegypto» della Divina Commedia (Pg. II, 46-48) di Dante Alighieri.
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Il "disagio della civiltà" (Freud) e la "sprezzatura" (Baldassarre Castiglione): "si deve imparare anche l’amore" (Nietzsche)..15 novembre 2021, di Federico La Sala
RINASCIMENTO: STORIA, MEMORIA, E FILOLOGIA.
LA SPREZZATURA, LA GRAZIA, E UN LEGAME DA RISTABILIRE. Nota a margine dell’opera di Baldassarre Castiglione...
- sprezzare 1 v. tr. [lat. *expretiare, der. di prĕtium «pregio, valore»] (io sprèzzo, ecc.). - Forma letter. per disprezzare: il mio cor lasso ogni altra vista sprezza (Petrarca); Virtù viva sprezziam, lodiamo estinta (Leopardi); letter., non accogliere, rifiutare o mostrare altezzosamente di ignorare: la ... dimanda era stata sprezzata da quel senato, disposto a non fare tregua (Guicciardini); nel rifl., ant., trascurarsi, non avere cura di sé: Che per lungo sprezzarsi, come stolto, Avea di fera, più che d’uomo, il volto (Ariosto). ◆ Part. pres. sprezzante, molto usato come agg. (v. la voce). (Vocabolario - Treccani)
- sprèzzo s. m. [der. di sprezzare1], letter. - 1. Disprezzo: guardava attorno atterrita, ... riboccante di sprezzo di se stessa (Capuana); atteggiamento sprezzante, arrogante: guardare, trattare con s.; s’avanzava diritto, con passo superbo, con la testa alta, con la bocca composta all’alterigia e allo s. (Manzoni). 2. Per estens., noncuranza, disinteresse, mancanza di adeguata considerazione: avere, ostentare grande s. del denaro; mostrare s. del pericolo. (Vocabolario - Treccani)
- sprezzatura s. f. [der. di sprezzare1], letter. - 1. a. L’essere, il mostrarsi sprezzante. b. Atteggiamento ostentatamente disinvolto, di studiata noncuranza da parte di chi si sente molto sicuro di sé e dei proprî mezzi: usar in ogni cosa una certa s., che nasconda l’arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi (Castiglione); quelli ... che, col solo contegno, con una certa sicurezza nativa, con una s. signorile, parlando di cose grandi con termini famigliari, riuscivano, anche senza farlo apposta, a imprimere e rinfrescare, ogni momento, l’idea della superiorità e della potenza (Manzoni). 2. In senso concr., ciò in cui si manifesta tale atteggiamento: una prosa sorvegliata, con qualche s. di stile. (Vocabolario - Treccani)
- SPREZZATURA. "Sprezzatura è un termine in voga durante il XVI secolo italiano nell’ambito della descrizione del far musica sia a livello compositivo che esecutivo; ciò, però, declina in senso musicologico un’accezione comportamentale del termine, che descrive una condotta di estremo rigore e autocontrollo, al limite del sussiego. Nella musicologia.Il termine è stato inizialmente utilizzato, in senso musicale, per connotare taluni aspetti del recitar cantando teorizzato in seno alla Camerata de’ Bardi [...] Nel comportamento. l termine sprezzatura ha però origine non musicale, e riguarda alcuni aspetti della condotta del perfetto uomo di corte. Il termine viene utilizzato e spiegato ne Il Cortegiano di Baldassarre Castiglione [...]" (Wikipedia).
Baldassarre Castiglione (1478-1529):
«Trovo una regula universalissima, la qual mi par valer circa questo in tutte le cose umane che si facciano o dicano più che alcun altra: e cioè fuggir quanto più si po, e come un asperissimo e pericoloso scoglio, la affettazione; e, per dir forse una nova parola, usar in ogni cosa una certa sprezzatura, che nasconda l’arte e dimostri ciò, che si fa e dice, venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi...
Da questo credo io che derivi assai la grazia: perché delle cose rare e ben fatte ognun sa la difficultà, onde in esse la facilità genera grandissima maraviglia; e per lo contrario il sforzare e, come si dice, tirar per i capegli dà somma disgrazia e fa estimar poco ogni cosa, per grande ch’ella si sia. Però si po dire quella essere vera arte, che non pare essere arte; né più in altro si ha da poner studio che nella nasconderla: perché, se è scoperta, leva in tutto il credito e fa l’omo poco estimato» (Baldassarre Castiglione, Il Cortegiano, XVI)
UNA QUESTIONE DI GRAZIA, UNA QUESTIONE DI AMORE...
- Sul tema della sprezzatura (quando si fa qualcosa o si agisce in un modo tecnica-mente/cultural-mente acquisito tanto da apparire esser fatto naturalmente, "senza fatica e quasi senza pensarvi"), forse, è opportuno e necessario riportare alla memoria l’altro lato della medaglia, della parola, "la grazia: perché delle cose rare e ben fatte ognun sa la difficultà, onde in esse la facilità genera grandissima maraviglia" (Baldassarre Castiglione, 1478 - 1529)!
- GRAZIA "1. MAPPA La GRAZIA è la qualità naturale di tutto ciò che, per bellezza, delicatezza, spontaneità e finezza, o per l’armonica fusione di tutte queste qualità, fa un’impressione gradevole. Può esserci grazia nell’aspetto esteriore di una persona (la g. di un volto; lineamenti privi di g.) o nei suoi movimenti, nel suo modo di fare (camminare, salutare, offrire con g.); ma la grazia può anche essere la qualità di una cosa, e in particolare di ciò che è prodotto dall’arte o dall’ingegno dell’uomo (ammirare la g. di un dipinto, di una composizione architettonica). 2. MAPPA Con significato più specifico, la parola grazia può indicare gentilezza, cortesia e buone maniere (chiedere, rimproverare con g.), 3. oppure può descrivere una buona disposizione d’animo verso qualcuno (prendere in g. qualcuno; essere in g. di qualcuno). [...]" (Vocabolario - Treccani).
SI DEVE IMPARARE ANCHE L’AMORE: "CARISSIMI, NON CREDETE A OGNI SPIRITO ... DIO È AMORE":"CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1 Gv., 4. 1-16). UNA LEZIONE DI NIETZSCHE E DI FREUD:
Si deve imparare anche l’amore. Si deve imparare ad amare. Ecco quel che ci accade nella musica: si deve prima imparare a udire una sequenza e una melodia in genere, a enuclearla nell’ascolto e a distinguerla isolandola e delimitandola come se avesse una vita propria; quindi bisogna sforzarci e impiegare la nostra buona volontà per sopportarla, malgrado la sua estraneità, bisogna fare un esercizio di pazienza di fronte al suo sguardo e alla sua espressione, considerare con benevolenza quel che c’è di inusitato in essa - finalmente arriva un momento in cui ne abbiamo preso l’abitudine, in cui l’attendiamo, in cui si ha il presentimento che ne sentiremmo la mancanza, se non ci fosse più; e così essa continuamente dispiega la sua violenta suggestione e il suo incantesimo, finché non si sia diventati i suoi umili ed estasiati amanti, per cui non v’è più niente di meglio da chiedere al mondo se non la melodia e ancora la melodia.
 Questo ci accade però non soltanto con la musica: proprio in questo modo abbiamo imparato ad amare tutte le cose che oggi amiamo. In definitiva, siamo sempre ricompensati per la nostra buona volontà, per la nostra pazienza, equità, mitezza d’animo verso una realtà a noi estranea, quando lentamente essa depone il suo velo e si manifesta come una nuova inenarrabile bellezza: è questo il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. Anche chi ama se stesso, lo avrà appreso per questa strada: non ce ne sono altre. Si deve imparare anche l’amore.
Questo ci accade però non soltanto con la musica: proprio in questo modo abbiamo imparato ad amare tutte le cose che oggi amiamo. In definitiva, siamo sempre ricompensati per la nostra buona volontà, per la nostra pazienza, equità, mitezza d’animo verso una realtà a noi estranea, quando lentamente essa depone il suo velo e si manifesta come una nuova inenarrabile bellezza: è questo il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. Anche chi ama se stesso, lo avrà appreso per questa strada: non ce ne sono altre. Si deve imparare anche l’amore.
 F. Nietzsche, La gaia scienza, IV, fr. 334, Adelphi, Milano 1991).
F. Nietzsche, La gaia scienza, IV, fr. 334, Adelphi, Milano 1991).Disagio della civiltà: "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori; i Romani, che non avevano fondato la loro collettività statale sull’amore, non conobbero l’intolleranza religiosa, benché per loro la religione fosse un affare di Stato e lo stato fosse imbevuto di religione. Non fu un puro caso che il sogno germanico del dominio del mondo facesse appello all’antisemitismo come a suo complemento, e non è inconcepibile che il tentativo di stabilire una nuova civiltà comunista in Russia trovi il suo sostegno psicologico nella persecuzione della borghesia. Ci si chiede soltanto, con apprensione, che cosa si metteranno a fare i Sovieti, dopo che avranno sterminato la loro borghesia [...]" (S. Freud, Il disagio della civiltà, 1929).
CANOVA E IL VATICANO: LE GRAZIE, AMORE E PSICHE Una gerarchia senza Grazie (greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Caritas"). Materiali per riflettere
FLS
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- La "Sacra famiglia", detta “Tondo Doni”, e un’altra "interpretazione dei sogni" di Michelangelo (di Federico La Sala).11 novembre 2021, di Federico La Sala
"QUATTRO" ... QUATTRO PROFETI? IL "TONDO DONI" E LA TRACCIA PER UN’ALTRA "INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" DI MICHELANGELO E DEL SUO RACCONTO NELLA CAPPELLA SISTINA...
di Federico La Sala (Le parole e le cose, 9 novembre 2021)
AL FINE DI UN’INTERPRETAZIONE non riduttiva del "Tondo Doni" di Michelangelo è opportuno fare bene attenzione alla cornice lignea che sta intorno.
NELLA SCHEDA DELLA Galleria degli Uffizi, relativa alla Sacra famiglia, detta “Tondo Doni” di Michelangelo #Buonarroti è scritto:
- "La cornice del tondo, probabilmente su disegno di Michelangelo è stata intagliata da Francesco del Tasso, esponente della più alta tradizione dell’intaglio ligneo fiorentino. Vi sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti, circondate da grottesche e racemi, in cui sono nascoste, in alto a sinistra, delle mezze lune, insegne araldiche della famiglia Strozzi." (*).
"QUATTRO PROFETI": MA "COME NASCONO I BAMBINI"?!
Se il tema è quello della nascita di Cristo ("il Figlio dell’Uomo"), il discorso di Michelangelo è semplicemente chiaro e tondo e già anticipa alla grande il programma della Sistina: nella cornice vi sono raffigurate la testa di Cristo (in alto) e ai lati le teste di due profeti e due sibille e, al centro (il fuoco del cammino dell’intero genere umano), Gesù, il "Figlio dell’Uomo" ("Ecce Homo" - ogni essere umano, come da antropologia e filologia), con le figure dei genitori, il "profeta" Giuseppe e la "sibilla" Maria.
L’Uomo non è più un Lupo! L’uomo è per l’uomo un Dio ("Homo homini deus est"), come ricorderà Spinoza nella sua "Etica".
Sacra famiglia, detta “Tondo Doni”
Michelangelo Buonarroti (Caprese 1475 - Roma 1564) *
Michelangelo dipinse questa Sacra Famiglia per Agnolo Doni, mercante fiorentino il cui prestigioso matrimonio nel 1504 con Maddalena Strozzi avvenne in un periodo cruciale per l’arte a Firenze di inizio secolo. La compresenza in città di Leonardo, Michelangelo e Raffaello apportò uno scatto di crescita al già vivace ambiente fiorentino, che nel primo decennio del secolo visse una stagione di altissimo fervore culturale. Agnolo poté quindi celebrare le sue nobili nozze e la nascita della sua primogenita con alcune delle massime espressioni di questa eccezionale fioritura: i ritratti dei due coniugi dipinti da Raffaello, e il tondo di Michelangelo, che è l’unico dipinto certo su tavola del maestro.
Michelangelo aveva da poco studiato le potenzialità del formato circolare, molto apprezzato nel primo Rinascimento per gli arredi devozionali domestici, nei marmi del “Tondo Pitti” (Museo Nazionale del Bargello) e del “Tondo Taddei” (Royal Academy di Londra): in entrambi i casi la Madonna, il Bambino e San Giovannino occupano prepotentemente tutta la superficie del rilievo. Anche il “Tondo Doni” è concepito come una scultura, in cui la composizione piramidale del gruppo si impone su quasi tutta l’altezza e la larghezza della tavola. E’ stato notato che, nella sua compattezza, il gruppo ricorda la struttura di una cupola, tuttavia animata al suo interno dalle torsioni dei corpi e dalla concatenazione dei gesti per il passaggio delicatissimo del Bambino dalle mani di San Giuseppe a quelle della Vergine.
Questa composizione così articolata ed espressiva scaturisce dalla conoscenza e dallo studio da parte di Michelangelo dei grandi marmi del periodo ellenistico (III-I secolo a. C.), contraddistinti da movimenti serpentinati e forte espressività, che stavano emergendo dagli scavi delle ville romane. Alcuni di questi importanti ritrovamenti, come l’Apollo del Belvedere e il Laocoonte scavato nel gennaio 1506, sono citati puntualmente nel quadro fra le figure di nudi in piedi, appoggiati a una balaustra (rispettivamente a sinistra e a destra di San Giuseppe).
La presenza di Laocoonte permette di avanzare per il tondo una datazione che coincide con la nascita di Maria Doni (settembre 1507). I giovani nudi, la cui identificazione è complessa, sembrano rappresentare l’umanità pagana, separata dalla Sacra Famiglia da un basso muretto che rappresenta il peccato originale, oltre il quale c’è anche San Giovannino, che favorirebbe l’interpretazione battesimale del dipinto.
La cornice del tondo, probabilmente su disegno di Michelangelo è stata intagliata da Francesco del Tasso, esponente della più alta tradizione dell’intaglio ligneo fiorentino. Vi sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti, circondate da grottesche e racemi, in cui sono nascoste, in alto a sinistra, delle mezze lune, insegne araldiche della famiglia Strozzi.
* GLI UFFIZI, 11.11.2021 (ripresa parziale)
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- PROFETI E SIBILLLE. Patrimonio dell’Umanità, il "Canto della Sibilla". La versione premiata è quella diffusa nell’isola di Maiorma (Unesco, 2010).27 settembre 2021, di Federico La Sala
Il Canto della Sibilla
di Carlo Finocchietti *
Il “Canto della Sibilla” è un testo liturgico di genere apocalittico che descrive i segni della fine del mondo e il giudizio universale. La sua versione cantata si è diffusa nell’Italia centro-meridionale (per esempio ad Alghero) e nella penisola iberica (Castiglia, Catalogna e Baleari). L’Unesco ha voluto dichiararla, con una decisione del 2010, uno dei Capolavori del Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità.
 La versione premiata dall’Unesco è quella diffusa nell’isola di Maiorca, dove la popolarità del Canto è immensa: si può dire che ogni parrocchia lo canti in forma teatrale nella celebrazione della notte di Natale, per annunciare la venuta del Salvatore e il suo ritorno nel Giorno del Giudizio.
La versione premiata dall’Unesco è quella diffusa nell’isola di Maiorca, dove la popolarità del Canto è immensa: si può dire che ogni parrocchia lo canti in forma teatrale nella celebrazione della notte di Natale, per annunciare la venuta del Salvatore e il suo ritorno nel Giorno del Giudizio.- Foto] El Cant de la Sibilla
Il testo del canto è tratto dagli Oracoli Sibillini ed è stato utilizzato in un sermone dell’africano Quodvultdeus. Venerato come santo dalla Chiesa cattolica, Quodvultdeus (letteralmente “quello che Dio vuole”), è stato un vescovo berbero di Cartagine al tempo dell’invasione dei Vandali di Genserico e poi profugo a Napoli, dove è morto verso il 453. Ma è stato soprattutto il suo maestro e amico Agostino che ha reso celebre il testo inserendolo nella sua opera De Civitate Dei (La città di Dio), con il famoso incipit “Judicii signum tellus sudore madescet”.
- [Foto] L’Oracolo della Sibilla Eritrea (Michelangelo, Cappella Sistina)
La prefigurazione del Giorno del giudizio è contenuta nei testi di molti Profeti. Ma saranno anche le Sibille che proporranno questo genere di profezie. Le Sibille erano profetesse e sacerdotesse dotate di poteri divinatori e capaci di predire il futuro su ispirazione di divinità pagane. Le più conosciute erano l’Eritrea, la Cumana e la Delfica. Il mondo cristiano, basandosi sulle concordanze tra profezie bibliche e vaticini pagani, assimilerà progressivamente le Sibille e le porrà sullo stesso livello dei Profeti. Fino ad arrivare alla consacrazione finale in Vaticano, dove, nell’Appartamento Borgia, dodici Sibille sono affrescate in coppia con altrettanti Profeti.
- La Sibilla eritrea, David e i profeti spiegano i segni del Finimondo (Luca Signorelli, Orvieto)
Il Canto della Sibilla trova analogie con il Dies Irae, altro testo che ha avuto grande fortuna liturgica e musicale. Anche Tommaso da Celano si appoggia all’autorità della Sibilla: “Giorno dell’ira, quel giorno / che dissolverà il mondo terreno in cenere, / come annunciato da Davide e dalla Sibilla”.
 Luca Signorelli fa spiegare dalla Sibilla Eritrea e dal profeta David i segni del “Finimondo” affrescato nella Cappella di San Brizio del Duomo di Orvieto. Andrea Milanesi ha scritto che il Canto della Sibilla continua a rinnovare la sua straordinaria impronta di teatrale drammaticità, esaltata dagli sconvolgenti riferimenti al giudizio finale e al caos degli elementi (fuoco celeste, tremore della terra, eclissi lunare e solare): Il portato drammatico e trascendentale evocato da queste straordinarie melodie e la vertigine apocalittica risvegliata dalle profezie e dagli oracoli pronunciati da queste misteriose figure sfociano nelle domande esistenziali e nelle riflessioni sul destino dell’uomo, che trovano risposta ultima nella speranza della nuova prospettiva di salvezza eterna inaugurata con la nascita di Gesù Cristo.
Luca Signorelli fa spiegare dalla Sibilla Eritrea e dal profeta David i segni del “Finimondo” affrescato nella Cappella di San Brizio del Duomo di Orvieto. Andrea Milanesi ha scritto che il Canto della Sibilla continua a rinnovare la sua straordinaria impronta di teatrale drammaticità, esaltata dagli sconvolgenti riferimenti al giudizio finale e al caos degli elementi (fuoco celeste, tremore della terra, eclissi lunare e solare): Il portato drammatico e trascendentale evocato da queste straordinarie melodie e la vertigine apocalittica risvegliata dalle profezie e dagli oracoli pronunciati da queste misteriose figure sfociano nelle domande esistenziali e nelle riflessioni sul destino dell’uomo, che trovano risposta ultima nella speranza della nuova prospettiva di salvezza eterna inaugurata con la nascita di Gesù Cristo.- [Foto] I segni della fine del mondo (Lanciano, San Legonziano)
Leggiamo l’Oracolo sibillino citato da Sant’Agostino in una traduzione italiana.
Come segno del Giudizio la terra si bagnerà di sudore. / Dal cielo verrà il re che sarà nei secoli, certamente per giudicare con la sua presenza la carne e il mondo. / Perciò l’infedele e il fedele vedranno Dio in alto con i santi proprio alla fine del mondo. / Così appariranno con la carne le anime, che egli stesso giudica, quando la terra giace incolta tra densi roveti. / Gli uomini getteranno via gli idoli e ogni ricchezza; il fuoco brucerà la terra, il mare e il cielo e diffondendosi infrangerà le porte del tetro Averno. / Ma i corpi di tutti i santi saranno illuminati dalla luce della libertà, e una fiamma eterna brucerà i peccatori. / Allora, svelando le proprie azioni nascoste, ognuno manifesterà i suoi segreti, e Dio dischiuderà i cuori alla luce. / Allora vi sarà lutto e tutti faranno stridere i denti. / Si oscura lo splendore del sole e cessa la danza delle stelle. / Rotolerà il cielo e il chiarore lunare si spegnerà. / Abbasserà i colli, innalzerà dalla loro profondità le valli. / Tra le cose degli uomini non vi sarà più nulla di sublime o di alto. / Già i monti sono abbassati al livello dei campi e tutte le cerulee distese del mare scompariranno, / la terra ridotta in frantumi perirà: così parimenti fonti e fiumi sono seccati dal fuoco. / Ma allora dall’alto del cielo la tromba farà venir giù un suono lugubre, piangendo la miserabile catastrofe e i vari travagli, la terra spaccandosi farà vedere il caos infernale. / E qui dinanzi al Signore compariranno insieme i re e dal cielo ricadrà un fiume di fuoco e di zolfo.
* Fonte: "Visioni dell’Aldilà", 4 aprile 2019 (ripresa parziale, senza immagini).
- CONCERTO “IL CANTO DELLA SIBILLA” *
22 febbraio - Ore 19.00: Il Canto della Sibilla è un testo liturgico con melodia gregoriana che ebbe una grande diffusione durante il Medioevo nel sud d’Europa e che si interpreta tradizionalmente durante la Messa della Vigilia di Natale nelle chiese di Maiorca (tra i quali spiccano quelli interpretati nel Monastero di Lluc e nella Cattedrale di Palma) e nella Cattedrale di Alghero in Sardegna.
Maiorca e Alghero sono gli unici due luoghi nei quali il canto rappresenta una tradizione che si protrae dal Basso Medioevo fino ai giorni nostri, essendo rimasta immune anche all’abolizione avvenuta nel Concilio di Trento (1545-1563) e a qualsiasi altra vicissitudine. Il 16 novembre 2010 fu dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Precedentemente era stato dichiarato Bene di Interesse Culturale (BIC) dal Consiglio Insulare di Maiorca il 13 dicembre 2004.
* Accademia di Spagna (ripresa parziale).]
NOTA:
FREUD E "PROFETI E SIBILLE" DI SIGNORELLI:
"[...] Sigmund Freud giungeva a Orvieto la sera dell’8 settembre 1897. La mattina dopo, «presto», annotava, per la moglie, le prime impressioni in una cartolina postale:
- Ieri ancora viaggio a Chiusi e di sera giunti qui. Massa di stupende impressioni. Orvieto si trova su un’altura rocciosa come Hohensalzberg, da treno e cremagliera in città attraverso un tunnel. Tutto qui alto e massiccio, illuminato a elettricità. Gente nera come zingari nell’antica Etruria. Hotel Belle Arti pulitissimo, come tutto finora, vino famoso, ha un sapore simile al Porto. Il duomo policromo, facciata di giorno non ancora vista.
In quell’occasione, acquistava alcune fotografie, ancora oggi conservate nel Museo Freud di Londra: il panorama della città sotto la neve visto da Sud Ovest, alcuni particolari degli affreschi di Signorelli (Profeti e sibille, Empedocle, il particolare dei Dannati col diavolo alato che porta in volo sulle spalle una donna, la Resurrezione della carne), una panoramica delle tombe etrusche [...]"
 (cfr. Lucio Riccietti, Sigmund Freud a Orvieto negli anni della scoperta e della dispersione del patrimonio storico artistico, Orvieto, 2017).
(cfr. Lucio Riccietti, Sigmund Freud a Orvieto negli anni della scoperta e della dispersione del patrimonio storico artistico, Orvieto, 2017).FLS
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. -- MATEMATICA E ANTROPOLOGIA. NOTE PER RISCRIVERE UN “ROMANZO FAMILIARE” NUOVO.18 settembre 2021, di Federico La Sala
PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E MATEMATICA. NOTE PER RISCRIVERE UN “ROMANZO FAMILIARE” NUOVO...
ACHERONTA MOVEBO. “Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo” (Se non potrò piegare gli Dei, muoverò Acheronte: Virgilio, Eneide, VII, 312). A partire da questa citazione virgiliana, volendo, è possibile tentare di "rileggere" l’intero percorso della ricerca di Freud. Ricordando con lo stesso Freud della "Psicopatologia della vita quotidiana" (1901), l’altra importante citazione sempre ripresa dall’Eneide (IV, 625 ) : "Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor" (che nasca un giorno dalle mie ceneri un vendicatore), si comincia a capire cosa c’è nel "coraggio degli inizi" (Rubina Giorgi, 1977) e in questa identificazione di Freud con Giunone/Era (non solo la moglie di "Zeus", ma anche la sua stessa madre) con Didone e con Annibale, il grande nemico di Roma.
IL PROBLEMA DEL LIBERATORE. L’esergo dell’Interpretazione "dichiara" semplicemente la "natura" teologico-politica del suo progetto: cercare di fermare il matrimonio di Enea e la nascita della nuova Troia (Roma)! Con la stessa determinazione di Giunone/Era (Virgilio), Freud lavora a portare alla luce della coscienza europea la struttura edipica del sogno del Dio greco e cattolico-romano (di Platone come di Paolo di Tarso), e venir fuori dall’orizzonte della tragedia (come Dante e lo stesso Nietzsche). Con l’aiuto di "Zeus/Giove"" e di "Era/Giunone", pur tra mille difficoltà, egli riesce a venir fuori dall’inferno e a "nascere, di nuovo"! Nel 1938 arriva a Londra e porta a compimento il suo ultimo lavoro "L’uomo Mosè e la religione monoteistica". Un grande respiro di sollievo! Morirà l’anno successivo.
ANTROPOLOGIA, MATEMATICA, E PSICHIATRIA. Pur avendo Freud dato già dal 1907 chiare indicazioni per lavorare congiuntamente a una nuova educazione civica e a una nuova educazione sessuale per una "società sana" (Erich Fromm, 1955), l’Italia (comel’Europa e l’intero Pianeta) naviga ancora in un oceano illuminato da una diffusa cosmoteandria.
"UNA VOCE” FUORI DAL CORO. Come ha scritto Franca Ongaro Basaglia ("Una voce. Riflessioni sulla donna", il Saggiatore, 1982), continuiamo a fare "un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" e a leggere per lo più e sempre il vecchio "romanzo familiare", quello edipico! Che dire?! Che fare?! Non è meglio uscire dal "sonnodogmatico"?!
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- "L’AMORE CHE NON VERRA MAI MENO". QUALE? QUELLO EVANGELICO O QUELLO PAOLINO?!6 agosto 2021, di Federico La Sala
UNA QUESTIONE FILOLOGICA E ANTROPOLOGICA, EPOCALE:
"L’ #Amore non verrà mai meno": un breve video di @Mode_Valdese con una riflessione e un invito a seguirci - con le opportune restrizioni - nelle attività relative al #sinodovaldese e metodista tra il 22 e il 25 agosto, da Torre Pellice (TO).
"L’ #Amore non verrà mai meno" (1 Cor. 13, 8). Domanda, ma quello antropologico-evangelico o quello andrologico-paolino ("di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo (gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»), e capo di Cristo è Dio": 1 Cor. 11, 1-3).)?! Non è bene precisarlo? Grazie.
-
> "L’AMORE CHE NON VERRA MAI MENO". QUALE? QUELLO EVANGELICO O QUELLO PAOLINO?! --- L’ANTROPOLOGIA DELL’IMMAGINE E IL PAOLINO "TEMPO CHE RESTA". Una lettura del libro di Giovanni Careri di "Ebrei e cristiani nella Cappella Sistina" (di Corrado Bologna).28 agosto 2021, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, TEOLOGIA, E CRISTIANESIMO. Michelangelo con Francesco d’Assisi e Dante o "con Agostino e Paolo nella mente"?!
- TEOLOGIA E ANDROLOGIA: LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
CAPPELLA SISTINA
Il montaggio patetico della Salvezza
Giovanni Careri, Ebrei e cristiani nella Cappella Sistina, Quodlibet: gli affreschi di Michelangelo in una lettura warburghiana, e eisensteiniana, che li restituisce quale organismo vivente attraversato da dialettiche «formule di pathos»
di Corrado Bologna *
«Il buon Dio vive nei dettagli», diceva Aby Warburg. Il suo progetto era di connettere dettagli e affinità, ombre delle idee fermate nei gesti delle opere d’arte, per edificare un atlante iconologico reticolare, capace di restituire un’intera morfologia della civiltà ricostruendo il gioco di energie e di opposizioni dinamiche che dà forma e senso alle immagini. S’innamorò della Ninfa riconoscendola nel movimento seducente della fanciulla che il Ghirlandaio aveva colto al volo come una farfalla nella Cappella Tornabuoni di Santa Maria Novella. Poi lo inseguì per anni, quel gesto, sui sarcofaghi, nei dipinti, in innumerevoli minuzie ricondotte genialmente a «far sistema» in un percorso mentale e culturale vastissimo.
Invece, di Michelangelo, il più grande allievo di Ghirlandaio, Warburg si occupò poco. Però almeno in due tavole dell’ormai celebre Atlante di Mnemosyne, la 53 e la 56, pose implicitamente in rapporto, accostandoli per esaltarne il dinamismo semantico, alcuni dettagli degli affreschi della Sistina, i giovanili Antenati di Cristo nelle lunette della volta (1511-’12) e il maturo Giudizio Universale (1535-’41). In essi intuì forse una traccia di quel maestoso, occulto progetto che Giovanni Careri definisce «fabbrica del corpo glorioso», ricostruendone la vicenda in un libro densissimo, di alto profilo culturale, elegantemente warburghiano nel metodo interpretativo e nell’ampiezza della documentazione (Ebrei e cristiani nella Cappella Sistina, Quodlibet, pp. 293, € 28,00).
Questo libro affascinante, che «decostruisce» la Cappella smontandone il moto figurativo depositato lungo trent’anni di straordinaria concentrazione da uno dei più grandi artisti di ogni tempo, mi riporta alla memoria un piccolo capolavoro quasi dimenticato (e che conto di riproporre presto), La cattedrale come spazio dei tempi, pubblicato da Friedrich Ohly nel 1972. Ohly propose di «leggere» la Cattedrale di Siena come «immagine architettonica di storia della salvezza che parla attraverso le sue forme foggiate in gradi biblici al pari, su un altro piano, della cronaca universale nella letteratura e della rappresentazione del mondo figurata». Secondo la sua acuta interpretazione quello spazio sacro produce l’«inglobamento del passato e del futuro in un tutto che sta dinanzi agli occhi», recuperando l’effetto emozionale e devozionale di un «processo di visualizzazione» per cui «il fluire della storia diventa un bene stabile». Nella Cattedrale di Ohly, come nella Sistina di Careri, davvero «la storia del mondo si evolve in rappresentazione del mondo»: l’edificio si trasforma nello «spazio figurativo e temporale di una mappa mundi cosmica».
Nella Sistina, invece che la riproduzione dell’universo, il tema è la storia della Salvezza. Giovanni Careri dimostra con erudizione e sottigliezza ermeneutica quali energie spirituali, teologiche, ideologiche, si confrontano e si scontrano in quel luogo straordinario, in cui Michelangelo concentrò uno sforzo titanico, non solo artistico ma anche ermeneutico e teologico, depositandovi un pensiero nutrito dalla corrente degli Spirituali stretti intorno al cardinale Reginald Pole a Viterbo (con lui, a leggere il Beneficio di Cristo, c’erano anche Vittoria Colonna e Sebastiano dal Piombo).
Michelangelo raffigura in cifra, con Agostino e Paolo nella mente, «il passaggio dalla filiazione carnale alla filiazione divina dal punto di vista della storia cristiana, come pure la necessità antropologica di definire l’identità cristiana in rapporto al suo "altro"». Rappresenta così la salvezza dell’umanità che si staglia in un campo di tensione fra il tempo messianico e il paolino katéchon, la frenante forza d’inerzia con cui la temporalità storica incarnata negli Antenati, cioè insieme «gli ebrei "ostinati"» e «il cristiano negligente», ne ritarda l’adempimento. In questo senso la Cappella Sistina è attraversata da energie formidabili, e si trasforma in un teatro della memoria, in un dispositivo mnemotecnico di metamorfosi interiore simile a quello che Giulio Camillo ideò negli stessi anni: il percorso che lo spettatore compie nello spazio vivo, con il suo corpo e il suo sguardo, è un cammino iniziatico. L’«istanza del soggetto» coinvolge sia chi dipinge sia chi osserva, giacché «il corpo glorioso» dell’uomo può venir `fabbricato’ attraverso un’«inclusione» spirituale, che Careri definisce «conformazione per somiglianza» rispetto al corpo di Cristo.
Sono certo che a Warburg, e anche ad Ohly, sarebbe piaciuto questo Michelangelo segreto, colmo di straordinarie Pathosformeln, riportato alla luce da Giovanni Careri. Il metodo con cui è impostata la sua colta, molto documentata e originale «antropologia della Cappella Sistina», si fonda sull’«analisi cinematica della pittura» e sul riconoscimento di un «"montaggio" delle immagini messo a punto da Michelangelo stesso», che «il montaggio di Warburg non fa che riprendere e sviluppare». Questo montaggio è di fatto il cinema mentale dell’artista, che lo storico riporta in vita attraverso un’antropologia dell’immagine, e soprattutto del suo intrinseco dinamismo.
La Sistina è compresa come un organismo vivente, in cui le immagini invitano l’osservatore all’«attualizzazione del significato teologico e devozionale» che accennano, grazie al «montaggio patetico» con cui sono connesse. Proprio di un «montaggio patetico» che coinvolge le percezioni fisiche, le immagini mentali, gli affetti di chi entra nell’opera d’arte con il corpo e con la mente, Giovanni Careri parlava nel suo primo libro, Voli d’amore. Architettura, pittura e scultura nel «Bel composto» di Bernini. E anche allora si richiamava a quello che il grande regista russo Sergej Eizenstejn definiva «il montaggio delle attrazioni», «un’operazione estetica di scomposizione e ricomposizione di un molteplice eterogeneo che si compie nello spettatore».
Rimeditando l’intuizione di Eizenstejn, il quale come Warburg (probabilmente senza conoscerlo) parlava di «formule del pathos», Careri coglie, nel corpo vivente della Sistina, «la dinamica indotta dal passaggio da un sistema all’altro», e rilegge il Giudizio universale, accanto alle pareti di Perugino, Botticelli, Signorelli, Ghirlandaio, «come un’uscita dalle categorie visive della storicità umanista che regolano i cicli degli affreschi quattrocenteschi rispetto ai quali il grande affresco della parete di fondo viene non solo ad aggiungersi, bensì a "montarsi"».
Il Giudizio del Michelangelo maturo è in dialogo anche con la volta del Michelangelo trentenne: e Careri dimostra, con un’argomentazione serrata e molto solida, come gli Antenati, nelle lunette del soffitto, «incarnano il ruolo di contrappeso terreno al movimento d’ascensione e di caduta dei personaggi eroici», mentre il gesto possente del Cristo nel Giudizio, di fronte allo spettatore, diviene «il nucleo generativo di una serie di onde, espressione di una forza che attraversa i corpi, li lega fra loro e dà loro forma». Cristo, con «l’impulso dato dalla furia del movimento», nella serpentina del suo corpo immenso, non solo condanna i reprobi, ma accoglie e salva i giusti. Quel gesto costituisce un vortice ambivalente, fra parousia e terribilità, a cui gli astanti, nel dipinto e nello spazio della cappella, possono corrispondere compiendo l’«assunzione di somiglianza» che otterrà la loro «conformazione» gloriosa. Il tempo del Giudizio è quindi il paolino tempo che resta, «un tempo che si contrae e comincia a finire». E un’immagine dialettica, perfettamente benjaminiana: «corrisponde all’orizzonte temporale verso il quale gli affreschi delle pareti e quelli della volta dispiegavano le loro narrazioni e i loro annunci, ancor prima che il grande affresco della parete dell’altare venisse a dar figura visibile a questo punto di fuga del tempo, sino ad allora implicito». In una simile catastrofe il «punto di fuga del tempo della storia» si rovescia, messianicamente, «nel punto di vista privilegiato per comprenderla».
* Fonte: Quodlibet -«Alias - il manifesto», 25 aprile 2021
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
PER LA PACE PERPETUA. ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO....
 MICHELANGELO PER UN RITRATTO A PROUST: UNA ILLUMINANTE INDICAZIONE DI WALTER BENJAMIN.
MICHELANGELO PER UN RITRATTO A PROUST: UNA ILLUMINANTE INDICAZIONE DI WALTER BENJAMIN.Federico La Sala
-
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- IL "PARTO MASCHIO" DEL GLOBO. Tenochtitlan 13 agosto 1521. Conquistadores, la storia di un grande «desencuentro» (di Lucia Capuzzi).5 agosto 2021, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE... *
Tenochtitlan 13 agosto 1521. Conquistadores, la storia di un grande «desencuentro»
Forse quella dell’America non fu né scoperta né conquista, ma incontro mancato. C’è ancora tempo per un’altra modalità di relazione con l’alterità?
di Lucia Capuzzi (Avvenire, giovedì 5 agosto 2021)
- [Foto] “La conquista di Tenochtitlan”, dipinto anonimo del XVII secolo della serie “La conquista del Messico” conservata presso la Biblioteca del Congresso - Library of Congress/WikiCommons
«Il sole si alza dal tuo letto di ossa [...]. L’alba lacera la cortina. Città, pila di parole rotte». Cinquecento anni dopo la sconfitta dell’impero azteca con la caduta di Tenochtitlan, la lacerante attualità dei versi di Octavio Paz vibra nel corpo giunonico di Città del Messico. Un organismo vivente più che una città. La spugnosa carne coloniale copre viscere dell’antica capitale precolombiana, per essere a sua volta ricoperta da una sottile pelle ultra-moderna. Gli strati coesistono, a volte confliggono, sempre si alimentano a vicenda. In questo flusso incessante, la megalopoli palpita, respira, sussiste. Impossibile separarli senza ucciderla. Una consapevolezza che, però, la città è incapace di tradurre in parole, come dimostra la polarizzazione delle narrative per l’anniversario. Perché implica fare i conti con l’evento che l’ha generata. E che, in fondo, ha generato l’America Latina.
Più ancora del 12 ottobre 1492, fu l’entrata a Tenochtitlan dei conquistadores al seguito di Hernán Cortés a segnare la nascita del mondo nuovo. E con esso il principio dell’età moderna. Fu “scoperta” o fu “conquista”? Fu incontro o fu scontro? Di sicuro, come afferma Tzvetan Todorov, fu l’esperienza più radicale, estrema, intensa di «scoprimento dell’altro». A differenza degli africani o degli asiatici, gli indo-americani e la loro esistenza erano del tutto ignorati dagli europei. Il confronto, dunque, fu di forza inedita. Mai come allora, gli uni e gli altri dovettero affrontare dei “simili diversi”.
Quel 13 agosto 1521 diviene, dunque, in un certo senso, il “parto” - per parafrasare Amalia Podetti - del globo, inteso come totalità. E del nostro tempo. Con tutte le sue contraddizioni. Non per niente, secondo Todorov, nel XVI secolo si è perpetrato il più grande genocidio della storia umana. Il massacro fu inaudito, questo è incontestabile. La sua definizione aritmetica, invece, è oggetto di dibattito tra gli studiosi ma tutti parlano di decine di milioni di esseri umani ingoiati in un vortice di violenza, schiavitù, epidemie. Magari una simile proporzione non fu voluta e intenzionale. Magari la leggenda nera anglobritannica - non proprio neutrale e benintenzionata - ha esagerato dettagli e crudeltà. Magari numerosi leader politici hanno cavalcato e cavalcano la strage per opportunismo. In questo, l’enfasi posta dal presidente Andrés Manuel López Obrador sul cinquecentesimo come sconfitta dei «veri messicani» è emblematica. Peccato che il Messico è - nel bene e nel male - è figlio di Cortés quanto di Monteczuma. Non sono, tuttavia, gli intenti, più o meno raffinati, di minimizzazione ad accelerare l’uscita dall’impasse.
Oltre che oggetto di studio, la mattanza d’America è soggetto di una storia di dolore, impressa, tuttora, nella carne e nel sangue dei discendenti dei nativi. Per costoro gli abusi antichi non sono che l’eco di quelli presenti, poiché la discriminazione e il rifiuto non sono terminati con la colonizzazione né con l’indipendenza né con le rivoluzioni e controrivoluzioni del secolo scorso. Per questo, gli occhi degli attuali maya si sono velati di lacrime nell’ascoltare papa Francesco affermare, a San Cristóbal de las Casas, il 15 febbraio 2016: «Perdono, fratelli! Il mondo di oggi, spogliato dalla cultura dello scarto, ha bisogno di voi!». Curiosa, dunque, l’ostinata richiesta di López Obrador nel domandare delle “scuse” già fatte senza alcuna sollecitazione. Farsi carico della memoria ferita è la grande occasione offerta dall’anniversario. Non solo per riconciliare il passato. In fondo, cinque secoli dopo, l’essere umano si trova di fronte ancora l’enigma di Cortés. Esiste l’uguaglianza al di fuori dell’identità? C’è spazio per una differenza che non implichi la subordinazione? La distruzione di Tenochtitlan ci ha mostrato le conseguenze di una risposta negativa, come quella del conquistador.
Forse, più che scoperta o conquista, quella d’America fu un grande desencuentro, un incontro mancato. Eppure non è l’unica alternativa. Desencuentro, intraducibile in italiano come unica parola, contiene in se la dimensione dell’encuentro, l’incontro. Anche questo ci ha mostrato la storia del Continente. Dieci anni dopo la devastazione dell’impero azteca, non lontano dalle ceneri ancora fumanti di Tenochtitlan, a Tepeyac, una Madonna dalle fattezze indigene scelse il nativo Juan Diego come proprio testimone. Nello sguardo non assimilativo della Morenita si intuisce un’altra modalità di relazione possibile con l’alterità.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: «Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo» (Gal 1,11); "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- DANTE E IL CANONE BIBLICO FEMMINILE. Raab e Cunizza, due donne generose nell’amore (di Carlo Ossola).3 agosto 2021, di Federico La Sala
In cammino con Dante/20.
Raab e Cunizza, due donne generose nell’amore
Il IX canto del Paradiso ha come protagoniste la prostituta biblica che salvò Giosuè e la sorella di Ezzelino nota al suo tempo per i mariti e gli amanti: e Dante anticipa lo stupore di trovarle lassù
di Carlo Ossola ( Avvenire, domenica 1 agosto 2021)
- Terzine eponime
- Tu vuo’ saper chi è in questa lumera
- che qui appresso me così scintilla
- come raggio di sole in acqua mera.
- Or sappi che là entro si tranquilla
- Raab; e a nostr’ordine congiunta,
- di lei nel sommo grado si sigilla
- (Paradiso IX, 112-117)
- Federico Faruffini, “Sordello e Cunizza”, 1864, particolare. Milano, Pinacoteca di Brera - WikiCommons
Si direbbe che Dante, nella Commedia, abbia scelto di attestare il canone biblico femminile ricordato da Adam Scoto: «Eva, Sara, Rebecca, Lia, Rachel, Bala, Zelpha, Thamar, Raab, Debbora, Ruth, Anna, Bethsabee, Esther, Iudith, Elisabeth» (De tripartito tabernaculo, pars II, cap. VI, in PL, 198, 693B). Esse sono quasi tutte menzionate, spesso in Paradiso (o nel Paradiso Terrestre) e con ruoli eminenti: Lia e Rachele su tutte; nell’Empireo, al più alto grado, seggono Eva la progenitrice e Maria la rigeneratrice; e subito sotto, elette a far corona a Beatrice: «Ne l’ordine che fanno i terzi sedi, / siede Rachel di sotto da costei [Eva] / con Bëatrice, sì come tu vedi. / Sarra e Rebecca, Iudit e colei [Ruth] / che fu bisava al cantor che per doglia / del fallo disse: “Miserere mei”» (Par XXXII, 7-12).
Un rilievo speciale è dato, nel cielo di Venere, a Raab, la prostituta che diede ospitalità agli inviati di Giosuè, li nascose e li salvò dai nemici: «In seguito Giosuè, figlio di Nun, di nascosto inviò da Sittim due spie, ingiungendo: “Andate, osservate il territorio e Gerico”. Essi andarono ed entrarono in casa di una donna, una prostituta chiamata Raab, dove passarono la notte. Ma fu riferito al re di Gerico: “Ecco alcuni degli Israeliti sono venuti qui questa notte per esplorare il paese”. Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab: “Fa’ uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti per esplorare tutto il paese”. Allora la donna prese i due uomini e, dopo averli nascosti, rispose: “Sì, sono venuti da me quegli uomini, ma non sapevo di dove fossero. Ma quando stava per chiudersi la porta della città al cader della notte, essi uscirono e non so dove siano andati. Inseguiteli subito e li raggiungerete”. Essa invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti fra gli steli di lino che vi aveva accatastato» (Giosuè, 2, 1-6).
In un Breviarium in Psalmos (attribuito a sant’Agostino e a san Girolamo; cfr. PL, 26, 1085A) si legge addirittura - tanta è la forza dell’exemplum biblico: «Ergo anima nostra illa Raab, illa meretrix, potest concipere, et parere Salvatorem» (Psalmus LXXXVI). Anche la nostra anima, prostituta essa stessa, avvinghiata al peccato, può dar ricetto e generare il Salvatore! È certamente questo il caso più evidente dell’efficacia delle opere, la sollecitudine dell’accoglienza già ricordata nel Vangelo (Mt 25, 34-40) e ribadita da san Paolo nella lettera agli Ebrei: «Per fede Raab, la prostituta, non perì con gl’increduli, avendo accolto con benevolenza gli esploratori» (11, 31); e ripetuta da Beda e da molti altri: «Denique Raab meretrix, nonne ex operibus iustificata est, suscipiens nuntios?» (“E infine Raab, la prostituta, non fu forse giustificata e salva per le sue opere, lei che accolse gli esploratori?”; Allegorica expositio in Samuelem, in PL, 91, 650C): secondo, del resto, il detto evangelico: «Non chiunque dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli » (Mt 7, 21). E Beatrice stessa per Dante non è forse nel poema - con splendida definizione - «opra di fede»? (Purg XVIII, 48).
Dopo tanti affanni, e desolazioni, e cautele e astuzie, finalmente Raab «si tranquilla» in Paradiso: il termine, accostato a “scintilla”, è una delle rime più affascinanti di tutta la Commedia, come ben vide il Tommaseo: «E non a caso, credo io, dice che la donna di Gerico in quel pianeta alla fine si tranquilla scintillando come raggio di sole in acqua limpida [113-115], si tranquilla dall’irrequieto dibattere delle fiamme e degli amori suoi vaghi» (DDP, ad locum). Non diversa è la storia - che precede nel canto IX del Paradiso - di Cunizza da Romano, figlia di Ezzelino II, morta a Firenze dopo il 1279, donna dai molti amori e di tanti pentimenti, della quale può valere il ritratto in versi che ci lascia Ezra Pound: «e sesta figlia Madonna Cunizza / dapprima sposa a Riccardo di San Bonifacio / e poi da Sordello sottratta al marito. / E con lui giacque in Treviso / finché lui non ne venne cacciato. / E lei scappò con Bonio che era un soldato / pazza d’amore / e andò da un posto all’altro / spassandosela assai / spendendo e spandendo / finché Bonio fu ucciso una domenica / e lei passò a un signore di Braganza / e infine mise su casa in Verona» (I Cantos, XXIX, trad., per questo passo, di Giovanni Giudici).
Più volte presente nei Cantos (VI, LXXIV, LXXVI, LXXVIII), Cunizza è, per Pound, l’esempio stesso di una gratuità totalmente spesa nell’amore, un amore così pieno che non lascia - nella letizia - traccia di rimorso: «Cunizza fui chiamata, e qui refulgo / perché mi vinse il lume d’esta stella; / ma lietamente a me medesma indulgo / la cagion di mia sorte, e non mi noia; / che parria forse forte al vostro volgo» (Par IX, 3236). Quell’«indulgere a sé» è davvero “forte” ma risponde, osserva nel suo commento Benvenuto da Imola, a un impulso naturale: «essa dice bene, dacché gli ignoranti si sorprendono che una famosa prostituta sia beata, non considerando che questo vizio è naturale, e comune e quasi necessario nei giovani». Egli fa eco, qui, a Boccaccio, che negli stessi termini si era espresso, nelle sue Esposizioni, quanto agli amori di Paolo e Francesca: «Sono adunque dannati in questo cerchio, come assai fu dichiarato leggendo la lettera, i lussuriosi; intorno al vizio de’ quali è da sapere che la lussuria è vizio naturale, al quale la natura incita ciascuno animale» (commento al canto V dell’Inferno). E con più profonda verità di fede il Tommaseo: «indulgo: perdono a me il mio fallire che mi fu perdonato».
Così infine Giovanni Giudici, che da Pound eredita, volle intitolare la sua “satura drammatica” del Paradiso Perché mi vinse il lume d’esta stella (1991), aggiungendo, ai versi di questi, il proprio toccante e sommesso congedo: «Perché di tanta pena / L’amore sia narrato / La quasi santità / Del nostro unico peccato».
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Storia e memoria: a Venezia, le statue di dodici Sibille nella Chiesa dei Carmelitani Scalzi (Chiesa di Santa Maria di Nazareth).17 luglio 2021, di Federico La Sala
SCHEDA...*
VENEZIA:
LA CHIESA DI SANTA MARIA DI NAZARETH, O DEGLI SCALZI (E LA PRESENZA DI 12 SIBILLE).
La chiesa di Santa Maria di Nazareth, o chiesa degli Scalzi, è un edificio religioso della città di Venezia dei primi del XVIII secolo. Opera di Baldassarre Longhena ma con la facciata di Giuseppe Sardi, è situata nel sestiere di Cannaregio in prossimità della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia.
La chiesa di Santa Maria di Nazareth deve la sua origine all’insediamento dei Carmelitani scalzi nella città lagunare.
Fu edificata da Baldassarre Longhena in un’unica navata, con due cappelle laterali, ognuna a sua volta affiancata da due cappelle minori. Dopo l’arco trionfale, l’aula si immette nel presbiterio, rialzato e dotato di una cupola. Nell’abside, si nota il coro dei frati.
Venne consacrata nel 1705, ma subì un importante restauro fra il 1853 e il 1862 da parte del governo austriaco. Al suo interno l’11 febbraio 1723 venne tumulato Ferdinando II Gonzaga, quinto e ultimo principe di Castiglione[1].
Oggi è monumento nazionale. Al suo interno marmi colorati e sfarzosi corinzi danno una sensazione di opulenza e di meraviglia al visitatore.
- [...]
Presbiterio
L’altare maggiore è opera di Jacopo Antonio Pozzo (ovvero fra Giuseppe Pozzo) come anche il parato ligneo della sacrestia.[4] Il presbiterio è sovrastato da un baldacchino sorretto da colonne tortili. Il fastoso tabernacolo della mensa, vede la statua della Madonna con putto e profeti, proveniente dall’isola di Santa Maria di Nazareth, poi Lazzaretto.
Le statue di dodici Sibille, opera di Giuseppe Torretto, Giovanni Marchiori, Pietro Baratta, Giuseppe e Paolo Groppelli, stanno distribuite, cinque per parte, sulle pareti laterali e due giacenti sull’arco del baldacchino[5].
- [...]
- 5.Klemenčič , pp. 110-112 nn. 22-25, 29. Nel saggio viene riassunta la vicenda delle correzioni alle attribuzioni originarie espresse da Leopoldo Cicognara nel 1818 che assegnava l’intero corpus delle dodici Sibille a Giovanni Marchiori. Tali attribuzioni continuano a comparire qua e là per forza d’inerzia. Solo nel 1957 Luigi Coletti (Coletti p. 14) propose l’assegnazione di tutte le Sibille della parete destra (Libica, Persica e Delfica in piedi, Eritrea e Cumea giacenti) a Giuseppe Torretto, attribuzioni confermate e riprese da Camillo Semenzato nel 1966 (Semenzato, p. 108). Delle tre in piedi sul lato sinistro la Samia fu passata a Pietro Baratta da Massimo De Grassi nel 1997 (De Grassi 1997a, pp. 54, 57 fig. 6), la Tiburtina e la Ellespontica furono assegnate sempre dal De Grassi (De Grassi 1997b, pp.139,141) e, quasi contemporaneamente, da Klemenčič ai fratelli Groppelli. Rimangono al Marchiori le due sibille giacenti della parete sinistra (Frigia e Cimmeria) e quelle sopra l’altare (Agrippina ed Europea).
- [Matej Klemenčič, Nuovi contributi all’opera dei fratelli Paolo e Giuseppe Groppelli, Francesco Robba and the Venetian Sculpture of the Eighteenth Century - Papers from an International Symposium - Ljubljana, 16th - 18th October 1998, Ljubljana, Rokus, aprile 2000].
* Chiesa di Santa Maria di Nazareth (Venezia) (Wikipedia).
* Sulla presenza delle 12 Sibile nel "Presbiterio", in particolare, si cfr. anche il doc. su I Carmelitani Scalzi a Venezia. La chiesa di Santa Maria di Nazareth e il brolo del convento, Biblos Edizioni, 2015, pp. 22-26).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- OGGI, A 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE, SI PREFERISCE CELEBRARE ANCORA LA "DOTTA IGNORANZA" DI SOCRATE E DI CUSANO..10 luglio 2021, di Federico La Sala
#COSTITUZIONE
#EDUCAZIONE CIVICA
#TRAGEDIA
E
#DIVINA COMMEDIA
#oggi.
Dopo #Dante (1321)
e la #rivoluzione delle #sfere celesti
(#Copernico 1543)
e terrestri
(#Giovanni Valverde, #Anatomia 1560),
celebra ancora la
#dotta ignoranza
di
Socrate
e
Niccolò Cusano
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- OGGI, A 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE, SI PREFERISCE CELEBRARE ANCORA "IL GIOCO DELLA PALLA" SECONDO LA REGOLA "ANDROLOGICA".10 luglio 2021, di Federico La Sala
"IL GIOCO DELLA PALLA", SECONDO LA LOGICA "ANDROLOGICA" DEL CATTOLICESIMO-COSTANTINIANO...:
- "Dico che questo gioco esprime il movimento della nostra anima che va dal suo regno al regno della vita in cui è la quiete e la felicità eterna. Nel centro di questo regno siede, come monarca, Gesù Cristo, nostro re, che ci ha donato la vita. In quanto è simile a noi, egli muove la sfera della sua persona in modo da riposare nel centro della vita. Poiché egli ci ha lasciato il suo esempio, facciamo come egli ha fatto. La nostra palla segua la sua, anche se è impossibile che una palla diversa raggiunga la quiete nel medesimo centro di vita in cui riposa la palla di Cristo. Dentro il circolo ci sono, infatti, infiniti luoghi e fermate. La palla di ognuno si ferma nel punto e nell’atomo suo proprio che nessun altro potrà mai raggiungere"(Niccolò Cusano, Opere filosofiche, Torino, Utet, 1972).
#DANTE2021
E
#ANTROPOLOGIA (#HOMO LUDENS):
IL #GIOCO DELLA #PALLA
(#De ludo globi) DI
#NICCOLO’ CUSANO
riguarda «un gioco scoperto da poco che tutti comprendono facilmente e giocano volentieri»
E
LA #DOCTA IGNORANTIA
-
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. - Storiografia e filologia: Gesù r la questione del "Testimonium flavianum" (Giuseppe Flavio). Note.9 luglio 2021, di Federico La Sala
#ANTROPOLOGIA,
#FILOLOGIA
E
#STORIA.
#PILATO
(#Ecce Homo gr.: «idou ho #anthropos»),
#SAN PAOLO
(1Cor. 11, 3: "di ogni #uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’#uomo [gr. ἀνήρ]"),
#GIUSEPPEFLAVIO
("Egli era il #Cristo")
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- FILOLOGIA. Lezioni di metodo per il presente: le "Antichità giudaiche" e il "Testimonium Flavianum". Un saggio di Luciano Canfora su "come Giuseppe Flavio fu cristianizzato" (di Laura Bigoni).).8 luglio 2021, di Federico La Sala
“La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato” di Luciano Canfora
- Recensione a: Luciano Canfora, La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato, Salerno Editrice, Roma 2021, pp. 200, 18 euro (scheda libro)
Scritto da Laura Bigoni *
Lezioni di metodo per il presente
Nel XVIII libro delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio, autore ebreo di età romana imperiale (37-100 d.C. ca.), si fa menzione del processo a Gesù:
- «In quel tempo visse Gesù, uomo saggio, se pure lo si può chiamare uomo; poiché egli compì opere sorprendenti, e fu maestro di persone che accoglievano con piacere la verità. Egli conquistò molti Giudei e molti Greci. Egli era il Cristo. Quando Pilato udì che dai principali nostri uomini era accusato, lo condannò alla croce. Coloro che fin da principio lo avevano amato non cessarono di aderire a lui. Nel terzo giorno, apparve loro nuovamente vivo: perché i profeti di Dio avevano profetato queste e innumeri altre cose meravigliose su di lui. E fino ad oggi non è venuta meno la tribù di coloro che da lui sono detti Cristiani» (AJ, XVIII 63-64).
Queste parole, definite nel corso del tempo Testimonium Flavianum, hanno rappresentato il principale biglietto da visita del loro autore per accedere alla tradizione manoscritta occidentale, in massima parte come sappiamo dovuta a mani cristiane; esse costituiscono però anche un appassionante caso filologico, se non altro per la strana ambiguità che le contraddistingue, se le si pensa (così come ce le trasmettono i manoscritti) nella penna di un intellettuale ebreo. -Nella ristampa del 2018 dell’edizione UTET delle Antichità, a cura di Luigi Moraldi, da cui è tratta la traduzione sopra riportata, il passo è presentato addirittura in copertina al secondo volume, di per sé un riconoscimento della centralità di quelle poche righe all’interno dell’opera di Giuseppe Flavio.
 Si tratta però, prevedibilmente, di una centralità acquisita nel corso della tradizione e della sempre più grande fortuna che i padri della Chiesa costruirono attorno a Giuseppe Flavio e al suo Testimonium, decretandone di fatto la diffusione (e la copiatura). Proprio della storia di questa straordinaria fortuna ci fa dono Luciano Canfora nella breve ma densissima indagine dal titolo La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato, recentemente pubblicata per Salerno Editrice.
Il libro è organizzato in diciotto brevi capitoli, preceduti da un’introduzione e seguiti da un epilogo; ciascuno aggiunge un tassello al mosaico della tradizione testuale di Giuseppe Flavio, introducendone via via i protagonisti e i contesti. La struttura rende agevole a chi legge il viaggio tra i meandri di una tradizione testuale fatta di riconoscimenti, di attribuzioni pseudonime, di ritocchi più o meno tendenziosi, ma soprattutto, e fatalmente quando si tratta di testi cui si attribuisce valore religioso, di fazioni.
Si tratta però, prevedibilmente, di una centralità acquisita nel corso della tradizione e della sempre più grande fortuna che i padri della Chiesa costruirono attorno a Giuseppe Flavio e al suo Testimonium, decretandone di fatto la diffusione (e la copiatura). Proprio della storia di questa straordinaria fortuna ci fa dono Luciano Canfora nella breve ma densissima indagine dal titolo La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato, recentemente pubblicata per Salerno Editrice.
Il libro è organizzato in diciotto brevi capitoli, preceduti da un’introduzione e seguiti da un epilogo; ciascuno aggiunge un tassello al mosaico della tradizione testuale di Giuseppe Flavio, introducendone via via i protagonisti e i contesti. La struttura rende agevole a chi legge il viaggio tra i meandri di una tradizione testuale fatta di riconoscimenti, di attribuzioni pseudonime, di ritocchi più o meno tendenziosi, ma soprattutto, e fatalmente quando si tratta di testi cui si attribuisce valore religioso, di fazioni.
 La storia del testo di Giuseppe Flavio narrataci da Canfora diventa infatti ben presto simile a quella della traduzione greca delle Scritture di Israele detta dei Settanta, campo di battaglia per dispute di natura teologica e oggetto di ripetute canonizzazioni. Secondo la puntuale ricostruzione del libro, infatti, la sopravvivenza delle opere quasi complete dell’autore (ovvero Guerra giudaica, Antichità, Contro Apione e Autobiografia) nella tradizione manoscritta sembra ricollegabile ad una cosciente appropriazione culturale da parte dei pensatori cristiani, fin da Eusebio di Cesarea (260-337 ca.) e Girolamo (347-419 ca.).
La storia del testo di Giuseppe Flavio narrataci da Canfora diventa infatti ben presto simile a quella della traduzione greca delle Scritture di Israele detta dei Settanta, campo di battaglia per dispute di natura teologica e oggetto di ripetute canonizzazioni. Secondo la puntuale ricostruzione del libro, infatti, la sopravvivenza delle opere quasi complete dell’autore (ovvero Guerra giudaica, Antichità, Contro Apione e Autobiografia) nella tradizione manoscritta sembra ricollegabile ad una cosciente appropriazione culturale da parte dei pensatori cristiani, fin da Eusebio di Cesarea (260-337 ca.) e Girolamo (347-419 ca.).
 Nella temperie dei primi secoli del cristianesimo, apparve infatti vantaggioso che uno storico ebreo, che aveva assistito, dalla parte dei Romani, alla distruzione del Tempio a Gerusalemme, avesse anche solo menzionato Gesù e il suo processo, sebbene nel contesto di una serie di seditiones del tempo di Ponzio Pilato (cf. pp. 76ss.). Segno inequivocabile dell’avvenuta appropriazione è la migrazione del Testimonium all’altra grande opera di Giuseppe, la Guerra giudaica, che si trova in alcuni manoscritti, tra cui il Vossiano greco F 72, oggi conservato a Leiden, in cui il nostro testo è addirittura seguito da una scena di giudizio universale, che fa dunque della vicenda terrena di Gesù una tappa cruciale della storia della salvezza, secondo una visione strettamente cristiana; l’accoppiamento ha poi una vita propria nella tradizione successiva (cf. pp. 51s.).
Nella temperie dei primi secoli del cristianesimo, apparve infatti vantaggioso che uno storico ebreo, che aveva assistito, dalla parte dei Romani, alla distruzione del Tempio a Gerusalemme, avesse anche solo menzionato Gesù e il suo processo, sebbene nel contesto di una serie di seditiones del tempo di Ponzio Pilato (cf. pp. 76ss.). Segno inequivocabile dell’avvenuta appropriazione è la migrazione del Testimonium all’altra grande opera di Giuseppe, la Guerra giudaica, che si trova in alcuni manoscritti, tra cui il Vossiano greco F 72, oggi conservato a Leiden, in cui il nostro testo è addirittura seguito da una scena di giudizio universale, che fa dunque della vicenda terrena di Gesù una tappa cruciale della storia della salvezza, secondo una visione strettamente cristiana; l’accoppiamento ha poi una vita propria nella tradizione successiva (cf. pp. 51s.).
 Parallelamente alla fortuna negli ambienti dell’apologetica cristiana, nel mondo ebraico (come in quello pagano, in cui sempre cercò di inserirsi e di farsi leggere, senza successo) Giuseppe è stato ben presto ridotto al silenzio. Le vicende del testo sono alterne a seconda del contesto politico, ma per i cristiani il Testimonium sembra sempre un asso nella manica, come ad esempio nel periodo di crisi della Chiesa sotto Giuliano l’Apostata, in cui fu agevole forzare la dizione di un passo della Guerra guidaica (VI 250, 288-310) a significare una precisa volontà di Dio dietro la distruzione del Tempio, profetizzata ex post nei Vangeli (cf. pp. 155ss.).
Parallelamente alla fortuna negli ambienti dell’apologetica cristiana, nel mondo ebraico (come in quello pagano, in cui sempre cercò di inserirsi e di farsi leggere, senza successo) Giuseppe è stato ben presto ridotto al silenzio. Le vicende del testo sono alterne a seconda del contesto politico, ma per i cristiani il Testimonium sembra sempre un asso nella manica, come ad esempio nel periodo di crisi della Chiesa sotto Giuliano l’Apostata, in cui fu agevole forzare la dizione di un passo della Guerra guidaica (VI 250, 288-310) a significare una precisa volontà di Dio dietro la distruzione del Tempio, profetizzata ex post nei Vangeli (cf. pp. 155ss.).Soffermandosi sul Testimonium e tratteggiando uno status quaestionis, l’autore si chiede come mai non ci si sia mai dedicati troppo alla domanda, per lui al contrario centrale, relativa all’appropriazione culturale operata dai cristiani sul testo di Giuseppe Flavio. Verrebbe da chiedersi se non ci sia forse ancora un impalpabile velo di sostituzionismo latente in questo genere di studi, che scoraggi i tentativi di fare luce su stadi precristiani dei testi poi incardinati nella tradizione della Chiesa. Pur lasciando irrisolta l’aporia a proposito degli studi moderni, Canfora punta il dito sul dato, eclatante per la storia della tradizione, che l’opera in greco di Giuseppe sia giunta intera (a fronte del naufragio di gran parte della letteratura, storiografica e non, in greco classico e postclassico), mentre non è rimasta nessuna traccia delle stesure aramaiche (cf. pp. 35ss.).
 Importante è il riconoscimento e lo smascheramento del ruolo della progressiva cristianizzazione del Testimonium, che lo apparenta alla traduzione della Bibbia dei Settanta. Sul paragone l’autore si sofferma considerando un dato tanto ovvio quanto trascurato come l’appropriazione delle Scritture tradotte in greco dai giudei della diaspora ellenistica, che passano così nettamente nell’alveo della Chiesa da prendere il nome di ‘Antico Testamento’, che significa naturalmente un presupposto del Nuovo. Come Giuseppe Flavio perde terreno nella tradizione ebraica e di fatto ne scompare, lo stesso varrà per questa straordinaria impresa traduttoria del mondo antico.
Importante è il riconoscimento e lo smascheramento del ruolo della progressiva cristianizzazione del Testimonium, che lo apparenta alla traduzione della Bibbia dei Settanta. Sul paragone l’autore si sofferma considerando un dato tanto ovvio quanto trascurato come l’appropriazione delle Scritture tradotte in greco dai giudei della diaspora ellenistica, che passano così nettamente nell’alveo della Chiesa da prendere il nome di ‘Antico Testamento’, che significa naturalmente un presupposto del Nuovo. Come Giuseppe Flavio perde terreno nella tradizione ebraica e di fatto ne scompare, lo stesso varrà per questa straordinaria impresa traduttoria del mondo antico.Alla fine del capitolo IX è presentato con chiarezza il cruccio che fu di Ambrogio, ma anche di tutta la tradizione patristica, ovvero fino a quanto la Chiesa potesse permettersi di mostrare una continuità tra la tradizione cristiana e il mondo ebraico. In questo senso stabilire un canone diverso da quello ebraico, nella selezione dei libri sacri, nel loro ordine, nella denominazione e nel numero, fu un graduale ma vincente passo verso l’emancipazione della cristianità dalle sue pur irrinunciabili radici ebraiche[1].
 La comunanza di destini che lega due testi molto diversi come le Antichità (e a partire da esse, come si è visto, gli opera omnia di Giuseppe Flavio) e la traduzione della Bibbia è occasione per una riflessione sull’importanza della philologia sacra per il metodo storico-critico. Così si esprimeva Pasquali a proposito della eccessiva divisione del lavoro all’interno della filologia: «La colpa di questa ignoranza [della prefazione di Lachmann al Nuovo Testamento] è, credo, tutta della specializzazione. La metà del secolo XIX fu il tempo dei classicisti puri e dei latinisti puri: chi si occupava di Catullo, sdegnava di leggere e studiare il Nuovo Testamento. E d’altra parte i teologi, anche quelli protestanti, non avevano interesse per le quisquilie della storia dei testi. Tutto questo è una prova di più che nella filologia la specializzazione non può che nuocere»[2].
La comunanza di destini che lega due testi molto diversi come le Antichità (e a partire da esse, come si è visto, gli opera omnia di Giuseppe Flavio) e la traduzione della Bibbia è occasione per una riflessione sull’importanza della philologia sacra per il metodo storico-critico. Così si esprimeva Pasquali a proposito della eccessiva divisione del lavoro all’interno della filologia: «La colpa di questa ignoranza [della prefazione di Lachmann al Nuovo Testamento] è, credo, tutta della specializzazione. La metà del secolo XIX fu il tempo dei classicisti puri e dei latinisti puri: chi si occupava di Catullo, sdegnava di leggere e studiare il Nuovo Testamento. E d’altra parte i teologi, anche quelli protestanti, non avevano interesse per le quisquilie della storia dei testi. Tutto questo è una prova di più che nella filologia la specializzazione non può che nuocere»[2].
 Naturalmente, il testo di Giuseppe Flavio non è ritenuto sacro da alcuna confessione religiosa, ma si è visto come questo non impedisca alla sua storia testuale di presentare questioni simili a quelle tipiche dei testi religiosi, in quanto molto copiati e diffusi, proprio perché ritenuti oltremodo autorevoli. Un omaggio all’affinamento degli strumenti della philologia profana attraverso quella sacra sembra quindi doveroso (cf. pp. 87s.).
Naturalmente, il testo di Giuseppe Flavio non è ritenuto sacro da alcuna confessione religiosa, ma si è visto come questo non impedisca alla sua storia testuale di presentare questioni simili a quelle tipiche dei testi religiosi, in quanto molto copiati e diffusi, proprio perché ritenuti oltremodo autorevoli. Un omaggio all’affinamento degli strumenti della philologia profana attraverso quella sacra sembra quindi doveroso (cf. pp. 87s.).In questo libro, Canfora ha molti meriti: il primo è saper restituire gli ingranaggi di eventi molto lontani come se lontani non fossero, come se appartenessero a un presente senza tempo. Il merito di avvicinare le storie dei testi classici raccontandole per quello che sono, storie umane. E spogliandole così dell’aura di sacralità e intoccabilità che abbiamo progressivamente affibbiato all’antico. Nel suo narrare, assumono un ruolo centrale i recessi, il backstage che viene alla luce grazie alla minuzia filologica, col risultato di restituire un complesso vivo. Nei primi capitoli traccia un profilo dell’autore, sottolineando la tipicità e la concretezza della vita di un transfuga ebreo in epoca romana, il compromesso raggiunto con l’ellenismo e con la dominazione straniera, senza mai rinnegare la fede dei padri, ma tentando di inserirla nella (e legittimarla agli occhi della) cultura dominante. Come ci riferisce nel proemio, Giuseppe scrive «perché ritengo di essere debitore a tutti i Greci, perché - così mi pare - comprenderanno la nostra grande antichità e l’ordinamento politico degli Ebrei» (AJ, I 5). Nei capitoli successivi Canfora scava altrettanto scrupolosamente nelle ragioni dei rappresentanti delle fazioni pro e contra Giuseppe, restituendocene i tratti notevoli.
Un secondo merito è quello di aver sparso tra le pagine più di una lezione di filologia e di metodo, con un taglio divulgativo al punto giusto da essere comprensibile ai non addetti ai lavori, ma anche istruttivo, se non altro come memento, a chi addetto lo è eccome. Sfata, ad esempio, miti come quello del copista capriccioso che cambia il testo a suo (com)piacimento (pp. 42s.), e non lo fa per rendere meno appassionante la lettura di un saggio filologico, quanto per rinfrescare in chi legge l’attitudine al metodo storico-critico come valore inderogabile dello studio quotidiano; come ricorda, con felice espressione, a p. 49, «la via d’uscita è sempre la storia del testo».
In questo quadro credo debbano inserirsi anche le parole sferzanti riservate, spesso in nota ma non solo, ad alcune delle nuove imprese di studio comprensivo dell’antichità e dei suoi autori, in cui si ignora sistematicamente la discussione sei-settecentesca e in generale la storia della disciplina. Per esempio, l’affondo di p. 117 su studi contemporanei che, «purché espressi in inglese», possono dire quel che vogliono, dal momento che il nostro «è un ambito di studi nel quale non costa nulla fare passi indietro», o la desolante conclusione di p. 128: «Bilancio. Anche a seguito della feticistica devozione al monolinguismo anglico, si è andata via via smarrendo la conoscenza dei risultati cui era giunta la grande erudizione dei secoli XVI-XVII (quasi sempre in latino). Di conseguenza si riscrive goffamente e con qualche contributo peggiorativo ciò che era stato già da secoli prospettato e argomentato con ben altra finezza e disciplina critica». In effetti, quella di tornare a leggere la storia di una disciplina come la filologia, che funziona inevitabilmente per accumulazione, è nota importante, in un’epoca che sembra talora perdere l’attenzione per la storia[3]. Anche senza entrare in un discorso troppo generale e perciò troppo generico, occorre fare attenzione alla maniera in cui certe argomentazioni sono già state poste in passato; Canfora porta dunque alla luce del pubblico contemporaneo delle situazioni a loro modo paradigmatiche del mestiere della storia e della critica testuale, considerando uno spettro di fonti davvero ampio e riconoscendo il giusto credito a studiosi che sarebbero altrimenti dimenticati anche in opere di settore.
Oltre che illuminare sul metodo, Canfora ricorda a chi legge anche un dato cruciale della natura dei testi, ovvero la loro intrinseca mobilità (è forse questo che più di ogni altro cardine della filologia dovrebbe essere insegnato). L’autore riporta un breve ma significativo cenno ai tempi moderni, in cui sottolinea il valore costante e universale di questa caratteristica dei testi: «per chiarezza, è bene non dimenticare che una ‘citazione’ può nascere anche da un fraintendimento, o da una notizia di seconda mano, che - nel passaggio da una fonte all’altra - si gonfia e si complica, e magari [...] finisce in una ‘Enciclopedia’ (accade anche in tempi moderni)» (p. 51). Nel mutare continuo dei testi, anche una sola parola può bastare a cambiarne il volto, come nel caso del Testimonium, in cui è stato sufficiente sostituire un ‘era ritenuto’ con un ‘era’ nella frase cruciale «egli era il Cristo» (cf. p. 58). Non è certo la prima né l’ultima volta che un’unica parola è in grado di generare effetti così notevoli; si pensi al filioque dei primi concili cristiani, o al solum aggiunto da Lutero nella sua traduzione della Lettera ai Romani (3,28)[4].
Sebbene questo risulti quasi paradossale, vista la sua smisurata produzione scientifica, Canfora ricorda a chi si occupa di filologia il monito nietzschiano a proposito della lentezza di questa disciplina, per cui il/la filologo/a «non raggiunge nulla se non lo raggiunge lento»[5]. Proprio nel lento ascolto delle fonti e nell’attento vaglio di ciascuna di esse sta la straordinaria (e forse per alcuni inaspettata) apertura della filologia: una metodologia non dogmatica, che presta attenzione alla pluralità delle fonti e al loro intreccio: lo si vede nel libro, ad esempio nell’uso della tradizione araba (cui è dedicato il cap. VII), o di quella siriaca. Le interazioni sempre più strette con le discipline orientalistiche e con le tradizioni delle lingue semitiche spostano l’orizzonte di quello che siamo abituati a conoscere come il mondo classico, ampliandolo e riformandone il concetto stesso.
L’ultima e forse la più importante delle lezioni che si può trarre dalla conoscenza così approfondita di certe controversie sull’autorità dei testi, fitte di accuse e controaccuse dettate da opportunità di politica religiosa (o culturale in senso ampio), è quella di tentare un affrancamento dalla faziosità, una visione laica, inclusiva e basata sulla profondità storica quando si approcciano testi dalla tradizione così imponente. È insomma quella di provare a sostenere un campo di studi che sproni a lasciarsi questo tipo di controversie finalmente alle spalle.
[1] Cf. J. Mead, The Biblical Canon Lists from Early Christianity. Texts and Analysis, Oxford University Press, Oxford 2018.
[2] G. Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, Le Lettere, Firenze 2015, p. 8.
[3] Recentissimo il volumetto di Adriano Prosperi dall’eloquente titolo Un tempo senza storia. La distruzione del passato (Einaudi, Torino 2021).
[4] Sul primo caso, si veda l’inquadramento di L. Perrone, Da Nicea (325) a Calcedonia (451). I primi quattro concili ecumenici: istituzioni, dottrine, processi di redazione, in G. Alberigo (ed.), Storia dei concili ecumenici, Queriniana, Brescia 1990, pp. 11-118; sul secondo, basti leggere la luterana Lettera del tradurre, nella versione italiana a cura di E. Bonfatti (Marsilio, Venezia 2001).
[5] F. Nietzsche, Aurora. Pensieri su pregiudizi morali, trad. it. F. Masini, in B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica. Da Omero al V secolo, Feltrinelli, Milano 2006, p. 329.
- Laura Bigoni. Nasce a Bibbiena nel 1993. Dopo la laurea in Filologia greca a Bologna, dove è stata allieva del Collegio Superiore, è dottoranda in Storia delle Religioni all’Università di Strasburgo e si occupa principalmente di lessicografia greca e di tradizione e ricezione della Bibbia dei Settanta. Collabora al progetto “Historical and Theological Lexicon of the Septuagint” (Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna). È appassionata di teatro, lingue antiche e moderne e yoga.
* FONTE: PANDORA RIVISTA
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- "Dante è una figura colossale, è l’ultimo poeta del Medio Evo e il primo del Rinascimento" (Friedrich Engels).5 luglio 2021, di Federico La Sala
#Arte #storia e
#divina commedia.
dell’#ecumenismo rinascimentale di
come di
#PERUGINO,
con il suo
le sue #Sibille
e
i suoi #Profeti
del #Collegio del Cambio
a #Perugia
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- È la nostra nascita il miracolo che salva il mondo. Quella postilla di Hannah Arendt che illumina i dati Istat sulla natalità (di Sergio Belardinelli).2 luglio 2021, di Federico La Sala
FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA. COME NASCONO I BAMBINI...*
- HANNAH ARENDT E IL PROBLEMA DELL’INIZIO, DELLA NASCITA: "Nella grande opera sulla Città di Dio Agostino enuncia, senza però darne spiegazione, ciò che avrebbe potuto divenire il sostegno ontologico di una filosofia della politica autenticamente romana o virgiliana. A suo dire, come sappiamo, Dio creò l’uomo come creatura temporale, homo temporalis; il tempo e l’uomo furono creati insieme, e tale temporalità era confermata dal fatto che ogni uomo deve la sua vita non semplicemente alla moltiplicazione della specie, ma alla nascita, l’ingresso di una creatura nuova che, come qualcosa di completamente nuovo, fa il suo ingresso nel mezzo del continuum temporale del mondo. Lo scopo della creazione dell’uomo fu di rendere possibile un inizio: «Acciocché vi fosse un inizio, fu creato l’uomo, prima del quale non ci fu nessuno», «Initium ... ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit» (Agostino, De civitate Dei, libro XII, cap. 21). La capacità stessa di cominciamento ha le sue radici nella natalità e non certo nella creatività, non in una dote o in un dono, ma nel fatto che gli esseri umani, uomini nuovi, sempre e sempre di nuovo appaiono nel mondo in virtù della nascita" (H. ARENDT, La vita della mente, Bologna 1987, p. 546).
È la nostra nascita il miracolo che salva il mondo
Quella postilla di Hannah Arendt che illumina i dati Istat sulla natalità
di Sergio Belardinelli (il Foglio, 24 apr 2021)
L’Istat ci ha comunicato di recente che, complice anche il Covid, in Italia nel 2020 i morti sono stati 746 mila e i nuovi nati 404 mila. Un dato agghiacciante nel suo significato sociale e culturale che a me, come una sorta di riflesso condizionato, richiama alla mente uno dei brani filosofici più intensi che abbia mai letto: “Il miracolo che salva il mondo, il dominio delle faccende umane dalla sua normale, naturale rovina è in definitiva il fatto della natalità in cui è ontologicamente radicata la facoltà dell’azione. È in altre parole la nascita di nuovi uomini, l’azione di cui essi sono capaci in virtù dell’esser nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell’esperienza umana, che l’antichità greca ignorò completamente. È questa fede e speranza nel mondo, che trova forse la sua gloriosa e stringata espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la ‘lieta novella’ dell’avvento: ‘un bambino è nato per noi’”.
Con queste parole Hannah Arendt conclude il capitolo di Vita Activa dedicato all’azione. Si tratta di un brano che cito e commento ormai da quarant’anni, nel quale viene messo a tema un nesso, quello tra la libertà e la natalità, tra la libertà e la vita, col quale, che io sappia, soltanto la Arendt ha avuto l’acutezza e il coraggio di cimentarsi e che, a prima vista, può apparire persino paradossale. La vita infatti, almeno immediatamente, sembra richiamare non tanto la libertà, quanto piuttosto il gigantesco, immutabile ripetersi dei cicli naturali, l’ambito di quelli che il grande biologo Adolf Portmann, autore peraltro assai caro alla Arendt, definirebbe i “rapporti preordinati” - il contrario, quindi, di ciò che in genere intendiamo allorché parliamo di libertà. Quanto poi alla vita specificamente umana, essa, è certo impastata di libertà, ma è anche qualcosa che, a diversi livelli, non dipende da noi, qualcosa di cui, nonostante le tecnologie della riproduzione, non possiamo avere il completo controllo: la riceviamo semplicemente; non scegliamo i nostri genitori, né il luogo dove venire al mondo; dobbiamo fare continuamente i conti con gli altri, con le nostre passioni, i nostri istinti, le nostre inclinazioni, con quel coacervo di natura, ragione, sentimenti, usi e costumi che vanno a costituire appunto il “gran mare” della vita. La vita insomma pone una serie di condizioni e condizionamenti alla libertà che possono renderla persino impossibile. Eppure, rompendo in un certo senso questa grande catena, è proprio la libertà che dà sapore e specificità alla vita umana; solo la libertà impedisce che il mondo si riduca spinozianamente a “sostanza”, a qualcosa di omogeneo, a qualcosa come un continuo fluire; solo la libertà è capace di introdurre nel mondo un elemento di novità, qualcosa di imprevisto.
Pensieri non nuovi, si potrebbe dire. Ma proprio qui si inserisce la fondamentale postilla arendtiana, preziosa per leggere in una chiave forse inusuale ma certo illuminante anche i dati Istat sulla natalità in Italia da cui siamo partiti: è la stessa vita umana, il nostro venire al mondo, la nascita unica e irripetibile di ciascuno di noi, a rappresentare la prima e più immediata forma di novità, il primo scompaginamento, se così si può dire, della routine della vita.
La facoltà dell’azione, dice la Arendt, “è ontologicamente radicata” nel “fatto della natalità”. In entrambe le dimensioni - la libertà e la natalità - ritroviamo non a caso una costitutiva “novità”, un costitutivo essere insieme agli altri (non si nasce, né si agisce da soli), qualcosa che implica l’accettazione della realtà nella quale siamo e insieme fiducia nel futuro. In questo senso ogni bambino che nasce è un segno di speranza nel mondo; è l’irruzione nel mondo di una “novità”, la cui memoria, è il caso di dire, ritroviamo da adulti nell’esercizio della nostra libertà, nella nostra capacità di incominciare qualcosa che senza di noi non incomincerebbe mai.
Novità, pluralità (gli uomini, non l’uomo abitano la terra, ripete spesso Hannah Arendt) e speranza: questo ci schiude direttamente e in modo straordinario il discorso arendtiano sulla libertà radicata nella natalità. Ma indirettamente, specialmente oggi, tale discorso ci schiude molto di più. Ci fa capire, ad esempio, quale tragedia, anche simbolica, si consuma nel momento in cui un paese come l’Italia registra in un anno un saldo passivo tra morti e nuovi nati di 342 mila unità. È un po’ come se il mondo e la nostra libertà perdessero la speranza, ossia ciò che dà loro sapore, ciò che è insieme accettazione della realtà nella quale viviamo e fiducia nel futuro.
È vero, tutto passa. La vita non è altro che un eterno dissolversi nel gigantesco circolo della natura dove, propriamente, non esiste inizio né fine e dove tutte le cose e gli eventi si svolgono in un’immutabile ripetizione: la mors immortalis di cui parlava Lucrezio. Ma la Arendt non accetta questa mestizia, poiché a suo avviso “la nascita e la morte di esseri umani non sono semplici eventi naturali”; avvengono in un mondo dove vivono altri uomini; un mondo che acquista significato grazie alle loro azioni e ai loro discorsi; un mondo che per questo è sempre aperto alla novità.
Con la creazione dell’uomo, dice la Arendt, “il principio del cominciamento entrò nel mondo stesso, e questo, naturalmente è solo un altro modo di dire che il principio della libertà fu creato quando fu creato l’uomo”. Di nuovo l’inizio, dunque, diciamo pure, la natalità.
È proprio perché, in quanto uomini, siamo initium, nuovi venuti, iniziatori, per virtù di nascita che secondo la Arendt, siamo indotti ad agire. La definizione che più si addice agli uomini non è quella di “mortali”, ma piuttosto quella di “coloro che nascono”. In questo modo, quasi per una sottile ironia della sorte, la categoria della natalità diventa fondamentale proprio nel pensiero di un’allieva (e anche qualcosa di più) di Martin Heidegger, l’inventore dell’essere per la morte. Non che la Arendt ovviamente trascuri che la morte rappresenta l’ineluttabile fine di ogni vita umana, solo che, a suo avviso, gli uomini, anche se debbono morire, non nascono per questo, bensì per incominciare. E siamo di nuovo al passo da cui siamo partiti: “Il miracolo che salva il mondo....”.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. --- "ESSERE E TEMPO" E FILOLOGIA. Note su "Martin Heidegger e Hannah Arendt: la storia della fedeltà all’amore".
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica L’EUROPA IN CAMMINO - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944)?!
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. -- CON LE SUE 10 SIBILLE ED ERMETE TRISMEGISTO, TORNA VISIBILE IL PAVIMENTO DELLA CATTEDRALE DI SIENA.22 giugno 2021, di Federico La Sala
#STORIA #MEMORIA #ARTE.
#ERMETISMO ED #ECUMENISMO RINASCIMENTALE:
#ERMETE TRISMEGISTO E LE #SIBILLE.
la #meraviglia
del
della Cattedrale di Siena
-
>RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- EMANCIPAZIONE DONNE. G 20: Draghi, ad agosto summit ad hoc. Videomessaggio, al "Women Political Leaders Summit 2021" (Ansa).21 giugno 2021, di Federico La Sala
G20: Draghi, ad agosto summit ad hoc su emancipazione donne
’Sarà prima volta nella storia del vertice’
(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Il nostro governo vanta il numero più alto di sottosegretarie donne nella storia d’Italia. Abbiamo anche nominato una donna come capo dei servizi segreti per la prima volta in assoluto. In ogni caso, questi sono solo dei primi passi. Quest’anno l’Italia ha la presidenza del G20. Ad agosto terremo una conferenza ministeriale sull’emancipazione femminile per la prima volta nella storia del G20. Vogliamo aiutare le leader femminili in tutto il mondo a favorire l’emancipazione di altre donne."
 Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo, con un videomessaggio, al "Women Political Leaders Summit 2021". (ANSA).
Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo, con un videomessaggio, al "Women Political Leaders Summit 2021". (ANSA). -
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- MATTEO TAFURI, SULLE ORME DI MARSILIO FICINO. Il connubio tra "pia philosophia" e "docta religio": il "Commento agli Inni Orfici".20 giugno 2021, di Federico La Sala
SCHEDA EDITORIALE *
Il pensiero occidentale
Matteo Tafuri
Commento agli Inni Orfici
Il sottile e profondo fascino misterico degli Inni orfici è celebrato in questo Commento, l’unico superstite ad oggi nel mondo, in lingua greca, in cui il trionfante platonismo d’età laurenziana si coniuga con le nuove istanze religiose, dando vita ad una sapientia filosofica e teologica, della quale erano depositari gli antichi teologi da Zoroastro a Ermete Trismegisto, Orfeo, Aglaofemo, Pitagora e Platone; essa fu trasmessa poi dai neoplatonici e culminò nella teologia cristiana, acme di un percorso iniziatico che conduce all’unità della Verità Rivelata.
 Il Commento con la sua esegesi ai Poemi orfici rivela il nucleo dottrinale del pensiero dell’autore, in cui la teologia, la teurgia e la magia cerimoniale insegnano all’uomo come giungere al colloquio con gli angeli e ricongiungersi alla divinità. Gli Inni sotto il profilo ieratico-teurgico sono preghiere pronunciate dall’uomo per entrare in comunione con il divino, sotto quello magico, canti in grado di vincolare, di incantare, di infondere potere in colui che deve essere incantato e iniziato, il μύστης. Sulla base della translatio sapientiae pagana e biblicocristiana gli Inni orfici riproposti in questo Commento in chiave moderna rivendicano, sulle orme di Ficino, il connubio fra pia philosophia e docta religio. L’orfismo del Rinascimento è un rinascimento dell’orfismo, è la rinascita dei miti orfici ma soprattutto l’elaborazione delle dottrine orfiche in campo filosofico.
Il Commento con la sua esegesi ai Poemi orfici rivela il nucleo dottrinale del pensiero dell’autore, in cui la teologia, la teurgia e la magia cerimoniale insegnano all’uomo come giungere al colloquio con gli angeli e ricongiungersi alla divinità. Gli Inni sotto il profilo ieratico-teurgico sono preghiere pronunciate dall’uomo per entrare in comunione con il divino, sotto quello magico, canti in grado di vincolare, di incantare, di infondere potere in colui che deve essere incantato e iniziato, il μύστης. Sulla base della translatio sapientiae pagana e biblicocristiana gli Inni orfici riproposti in questo Commento in chiave moderna rivendicano, sulle orme di Ficino, il connubio fra pia philosophia e docta religio. L’orfismo del Rinascimento è un rinascimento dell’orfismo, è la rinascita dei miti orfici ma soprattutto l’elaborazione delle dottrine orfiche in campo filosofico.***
Matteo Tafuri
Vergato a Napoli per mano di Francesco Cavoti nel 1537, il Commento agli Inni orfici è l’unica opera, oltre ad un Pronostico ancora inedito, del filosofo e astrologo Matteo Tafuri, naturalista, raffinato interprete della fisiognomica e prodigioso nell’arte divinatoria. Affascinato dalle “scienze” occulte, dai sacri misteri divini e dai miti dei prisci theologi fa rivivere a nuova luce la sapienza orfica antica sovente concordata con le fonti evangeliche e restauratrice dell’originaria alleanza fra πίστις, εὐσέβεια ed ἔρως. Incline al platonismo, indulgente per i miti e per i fremiti religiosi, fedele alla philosophia Christi, tormentato dalle controversie teologiche, si accosta ai misteri divini orfici rivendicandone il carattere filosofico e teologico. L’impeto di fede, critico, d’impronta erasmiana, sembrò agli occhi dei suoi detractores superstizione e idolatria, più che palingenesi. L’impegno profuso per il rinnovamento della religio culminò in un’apologia dei veri principi del cristianesimo.
*FONTE: BOMPIANI.
* WIKIPEDIA: Matteo Tafuri (Soleto, 8 agosto 1492 - Soleto, 18 novembre 1584)
FLS
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (NON "ANDROLOGICA"). “Bibbia e Corano, un confronto” (di Piero Stefani - "Letture").7 giugno 2021, di Federico La Sala
Intervista - "Letture" *
“Bibbia e Corano, un confronto” di Piero Stefani
Prof. Piero Stefani, Lei è autore del libro Bibbia e Corano, un confronto edito da Carocci: quanto sono simili i due testi sacri?
Comincio da una precisazione rilevante: i testi sacri sono in realtà tre. Occorre infatti distinguere tra Bibbia ebraica e Bibbia cristiana. Uno stereotipo ancora abbastanza diffuso parla di Bibbia e Vangelo. In realtà, esistono la Bibbia ebraica, e la Bibbia cristiana formata da Antico e Nuovo Testamento. I libri dell’Antico Testamento, salvo alcuni casi particolari, coincidono con quelli della Bibbia ebraica; tuttavia in questo caso si è trattato non di aggiungere alcuni libri a quelli precedenti bensì di creare un insieme da leggere e interpretare in maniera diversa.
La somiglianza più profonda è che Bibbia e Corano sono sacri soltanto a motivo dell’esistenza di tre comunità che li considerano tali, in quanto li ricevono, li leggono nella liturgia, li commentano e li trasmettono. Tutte e tre le comunità religiose condividono la convinzione che, nel corso della storia, Dio abbia fatto giungere agli esseri umani parole destinate in seguito ad assumere una forma scritta. Ciò è avvenuto grazie a specifici mediatori che hanno trascritto nella “lingua degli uomini” la volontà di Dio. Per ricorrere alla classificazione consueta, ebraismo, cristianesimo e islam sono «religioni rivelate». Tra esse ci sono molte e non lievi differenze, ma tutte emergono a partire da questo terreno comune. Le si può paragonare a un bosco in cui ci sono alberi molto differenti tra loro, anzi a volte uno di essi fa ombra a un altro, tutti però condividono lo stesso suolo.
Quali sono i più significativi punti comuni tra Bibbia e Corano?
Il primo, irrinunciabile punto in comune è che Dio è definito creatore. Ciò significa che la realtà nel suo insieme ha avuto inizio a causa di un atto libero di Dio. Per tutte e tre non si tratta di dimostrare l’esistenza di Dio a partire da quanto sperimentiamo in noi e attorno a noi; quanto affermato dalle tre religioni è che in noi e attorno a noi ci sono segni dell’opera creatrice di Dio. Per così dire, il Cantico delle creature di Francesco di Assisi esprime un convincimento comune a ebrei, cristiani e musulmani. Per tutte e tre le tradizioni religiose, specie di età moderna, nasce poi il problema di sapere come confrontarsi con la visione del cosmo e della natura proposta dalla ricerca scientifica. Qui le strategie sono in parte diverse.
Altro punto accomunante è che Dio abbia comunicato agli esseri umani delle leggi (per limitarci a un solo esempio, si pensi ai “Dieci comandamenti”) volte a regolare sia i rapporti interni alle singole comunità religiose sia quelli con le altre persone e società. In questo caso ci si deve confrontare con il problema di quale rapporto esista tra queste leggi credute di origine divina e i tempi storici in cui sono sorte. Nasce poi anche l’interrogativo di quale sia la relazione tra le leggi di natura divina e quelle, fondate su altri principi, che regolano la società civile. La questione è accomunante, le risposte sono invece molteplici e spesso non concordi. Sono tali non soltanto tra ebraismo, cristianesimo ed islam, ma anche tra i vari gruppi o membri interni alle singole comunità religiose.
Le tre grandi religioni monoteiste fondano sulla rivelazione divina la propria dottrina, tanto da meritare l’appellativo di ‘popolo del libro’: come definiscono, i due testi sacri, la comunità dei credenti?
Come accennato in precedenza è vero che tutte e tre le comunità hanno testi sacri, tutt’altro che certo è invece che le si possa chiamare concordemente «popolo del libro». Per limitarmi a un solo esempio, per il cristianesimo la fonte prima della rivelazione è Gesù stesso, di cui i Vangeli sono memoria e testimonianza. Si può affermare che tanto l’ebraismo quanto il cristianesimo definiscono i loro rispettivi testi sacri in modo gerarchizzato.
 La Bibbia ebraica è costituita da tre parti: Torah (Legge, con parola derivata dal greco, detta Pentateuco), Neviim (Profeti) e Ketuvim (Scritti). Il ruolo decisivo è svolto della prima parte; nell’armadio sacro presente in ogni sinagoga è contenuta, non a caso, solo una copia manoscritta della Torah, l’unica che fonda i precetti osservati dagli ebrei.
La Bibbia ebraica è costituita da tre parti: Torah (Legge, con parola derivata dal greco, detta Pentateuco), Neviim (Profeti) e Ketuvim (Scritti). Il ruolo decisivo è svolto della prima parte; nell’armadio sacro presente in ogni sinagoga è contenuta, non a caso, solo una copia manoscritta della Torah, l’unica che fonda i precetti osservati dagli ebrei.
 Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli.
Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli.
 Il Corano ha avuto invece un processo redazionale molto più breve misurabile in qualche decennio. La sua scansione interna è tra sure (capitoli) “fatte scendere” (cioè rivelate) a Mecca e quelle, cosiddette medinesi, risalenti a un periodo successivo all’egira (622 d.C.). I contenuti del Corano si suddividono in annunci, narrazioni e leggi; queste ultime, che incidono maggiormente sulla vita della comunità, risalgono al periodo finale della vita di Muhammad, quando il Profeta esercitava già una forma di governo.
Il Corano ha avuto invece un processo redazionale molto più breve misurabile in qualche decennio. La sua scansione interna è tra sure (capitoli) “fatte scendere” (cioè rivelate) a Mecca e quelle, cosiddette medinesi, risalenti a un periodo successivo all’egira (622 d.C.). I contenuti del Corano si suddividono in annunci, narrazioni e leggi; queste ultime, che incidono maggiormente sulla vita della comunità, risalgono al periodo finale della vita di Muhammad, quando il Profeta esercitava già una forma di governo.L’espressione «comunità dei credenti» calza bene per cristiani e musulmani in quanto l’appartenenza alla Chiesa e all’ Umma (comunità musulmana) presuppone la fede, meno agli ebrei che costituiscono un popolo vero e proprio, non a caso si è ebrei innanzitutto per nascita (secondo una discendenza matrilineare).
Come descrivono Bibbia e Corano l’origine del male?
Vi è una dimensione accomunante che individua l’origine del male nella trasgressione. Come ben compreso da Paolo nella Lettera ai Romani, perché ci sia una trasgressione bisogna che prima ci sia una legge o un comando. Occorre quindi trovare miti fondativi che si muovano in questa direzione; il più noto è quello della proibizione di mangiare l’albero della conoscenza del bene e del male. Non è difficile comprendere il suo valore simbolico incentrato propria sulla connessione tra divieto e violazione. Al pari di prospettive presenti nell’apocalittica tanto giudaica quanto cristiana, il Corano pensa a una violazione antecedente a quella compiuta dalle creature umane. Ecco allora irrompere il peccato angelico, nell’islam connesso alla figura di Iblis, angelo superbo e disobbediente. D’altra parte conviene riflettere sul fatto che una trasgressione c’è eppure non ci dovrebbe essere; in questo senso si vede chiaramente la sua connessione con il male, altra realtà che c’è ma non dovrebbe esserci. Individuare la radice del male nella trasgressione porta con sé però altri problemi: chi spinge a trasgredire? Ecco allora che si “personalizza” il peccato, presentandolo come una forza che induce a compiere atti brutali. Sia per la Bibbia sia per il Corano la storia di Caino rappresenta il simbolo più conosciuto di tutto ciò: quando uccise il fratello, il primo fra i nati da donna non aveva ricevuto il comando di non uccidere.
Aumentare a dismisura la forza del peccato o della tentazione come causa del male rischia però di fa scivolare la visione di insieme verso una forma troppo prossima al dualismo, vale a dire di prospettare l’esistenza di un Dio del male; ecco allora che in alcuni passi sia biblici sia coranici si legge che Dio crea il male (Isaia 45,7). Affermazione che non va assolutizzata ma neppure del tutto accantonata. La presenza del male rappresenta per tutti uno scoglio complesso.
In che modo Bibbia e Corano affrontano il tema della resurrezione dei morti?
Il tema è presentato in maniera per così dire defilata nella Bibbia ebraica, infatti lo si trova con chiarezza solo nel tardo e apocalittico libro di Daniele (che nella Bibbia ebraica non è annoverato neppure tra i libri profetici). La resurrezione dei morti svolge invece un ruolo centrale nel Nuovo Testamento; il motivo è evidente: il kerygma - cioè l’annuncio originario e fondamentale della fede - ha il proprio centro nella «buona novella» di Gesù Cristo morto e risorto. -
 Come stabilito in modo definitivo da Paolo, per la fede cristiana vi è un legame inscindibile tra la risurrezione di Gesù Cristo e quella dei salvati. Anche per questo motivo nel cristianesimo, per quanto sia stato affermato più volte e venga attestato anche da alcuni passi neotestamentari, suscita sempre sconcerto la prospettiva secondo la quale ci sono dei risorti destinati alla dannazione eterna.
Come stabilito in modo definitivo da Paolo, per la fede cristiana vi è un legame inscindibile tra la risurrezione di Gesù Cristo e quella dei salvati. Anche per questo motivo nel cristianesimo, per quanto sia stato affermato più volte e venga attestato anche da alcuni passi neotestamentari, suscita sempre sconcerto la prospettiva secondo la quale ci sono dei risorti destinati alla dannazione eterna.
 Nel Corano la resurrezione dei morti è affermata in maniera forte e inequivocabile. Per trovarne il fondamento basta rifarsi alla perenne attività del Dio creatore: Allah, che ha plasmato l’uomo dalla polvere, è ben capace di dare nuova vita a ossa disseccate. La resurrezione è però intrinsecamente legata al giudizio in virtù del quale si è o beati o dannati; una prospettiva tanto presente nell’islam da essere anticipata da una specie di interrogatorio che avviene dentro le tombe.
Nel Corano la resurrezione dei morti è affermata in maniera forte e inequivocabile. Per trovarne il fondamento basta rifarsi alla perenne attività del Dio creatore: Allah, che ha plasmato l’uomo dalla polvere, è ben capace di dare nuova vita a ossa disseccate. La resurrezione è però intrinsecamente legata al giudizio in virtù del quale si è o beati o dannati; una prospettiva tanto presente nell’islam da essere anticipata da una specie di interrogatorio che avviene dentro le tombe.Piero Stefani, di formazione filosofica, insegna “Bibbia e cultura” presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano e “Diritto ebraico” all’Istituto internazionale di Diritto Canonico e Diritto comparato delle religioni dell’Università della Svizzera Italiana. È segretario generale di Biblia, associazione laica di cultura biblica. Tra le sue numerose pubblicazioni si segnalano Il grande racconto della Bibbia, il Mulino 2017 e per Carocci I volti della misericordia (2015).
* Fonte: Letture.org
Nota:
- "Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli" (Piero Stefani).
Al vertice del "cristianesimo" (cattolicesimo costantiniano), in realtà, non ci sono - come sostiene Piero Stefani - i "quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi)", ma - fondamentalmente - ma le lettere (e l’interpretazione "andrologica" della figura di Cristo) di Paolo di Tarso:
 "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
"Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (NON "ANDROLOGICA"). “La Chiesa corre il rischio di diventare una sotto-cultura”. Intervista a Albert Rouet (di Stéphanie Le Bars), 2010).7 giugno 2021, di Federico La Sala
COSTITUZIONE (DOGMATICA E ANDROLOGIA) E ANTROPOLOGIA. Messaggio Evangelico e Istituzioni....
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo""
- (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- Papa Francesco: no ai preti "superman", nella fragilità si incontra il Signore Il Pontefice all’incontro con i sacerdoti del Convitto San Luigi dei Francesi a Roma: non cadere nel chiacchiericcio, "abitudine dei preti che diventano zitelloni" (Avvenire, lunedì 7 giugno 2021)
“La Chiesa corre il rischio di diventare una sotto-cultura”.
Intervista a Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers,
a cura di Stéphanie Le Bars (Le Monde, 4 aprile 2010)
Arcivescovo di Poitiers, Mons. Albert Rouet è una delle figure più libere dell’episcopato francese.La sua opera J’aimerais vous dire (Bayard, 2009) è un best-seller nella sua categoria. Più ditrentamila copie vendute e vincitore del premio 2010 dei lettori di La Procure, questo libro-intervista getta uno sguardo molto critico sulla Chiesa cattolica. In occasione della Pasqua, Mons.Rouet offre le proprie riflessioni sull’attualità e la sua diagnosi sulla Chiesa.
La chiesa cattolica è scossa da molti mesi per la rivelazione di scandali di pedofilia in parecchi paesi europei. Tutto questo l’ha sorpresa?
Vorrei anzitutto precisare una cosa: perché ci sia pedofilia sono necessarie due condizioni, una profonda perversione e un potere. Questo vuol dire che ogni sistema chiuso, idealizzato,sacralizzato è un pericolo. Quando una istituzione, compresa la Chiesa, si erge in posizione di diritto privato, si ritiene in posizione di forza, le derive finanziarie e sessuali diventano possibili. E’ quanto rivela l’attuale crisi e tutto questo ci obbliga a tornare all’Evangelo; la debolezza del Cristo è costitutiva del modo di essere Chiesa.
 In Francia, la Chiesa non ha più questo tipo di potere; questo spiega perché si sia di fronte a devianze individuali, gravi e detestabili, ma non si riscontra una sistematizzazione di questi casi.
In Francia, la Chiesa non ha più questo tipo di potere; questo spiega perché si sia di fronte a devianze individuali, gravi e detestabili, ma non si riscontra una sistematizzazione di questi casi.Queste rivelazioni sopraggiungono dopo parecchie crisi, che hanno segnato il pontificato di Benedetto XVI. Chi maltratta la Chiesa?
Da qualche tempo, la Chiesa è flagellata da tempeste, esterne ed interne. C’è un papa che è più unteorico che uno storico, E’ rimasto il professore che pensa che un problema, una volta impostatobene, è per metà risolto. Ma nella vita non succede così. Ci si imbatte nella complessità, nella resistenza della realtà. Lo si vede bene nelle nostre diocesi, si fa quello che si può! La Chiesa fa fatica a situarsi nel mondo tumultuoso nel quale si trova oggi. E’ il cuore del problema. -Oltre a questo, due cose mi colpiscono nella situazione attuale della Chiesa. Oggi, si constata un certo gelo della parola. Oramai, il minimo interrogativo sull’esegesi o sulla morale viene giudicato blasfemo. Interrogarsi non è più ritenuto una cosa ovvia, ed è un peccato. Parallelamente regna nella Chiesa un clima di sospetto malsano. L’istituzione si trova ad affrontare un centralismo romano, che si basa su di una rete di denunce. Certi gruppi passano il loro tempo a denunciare le posizioni di questo o quel vescovo, a fare dei dossier contro qualcuno, a tenere delle informazioni contro qualcun altro. E questi comportamenti si sono intensificati con internet. Inoltre, noto una evoluzione della Chiesa parallela a quella della società. Questa vuole più sicurezza, più leggi, quella più identità, più decreti, più regolamenti. Ci si protegge, ci si rinchiude, è proprio il segno di un mondo chiuso, è catastrofico!
 In generale, la Chiesa è uno specchio fedele della società. Ma, oggi, nella Chiesa, le pressioni identitarie sono particolarmente forti. C’è tutta una corrente, che riflette poco, che ha sposato un’identità rivendicativa. Dopo la pubblicazione di alcune caricature sulla stampa riguardanti la pedofilia nella Chiesa, ci sono state delle reazioni degne degli integralisti islamici sulle caricature di Maometto! A voler apparire offensivi, ci si squalifica.
In generale, la Chiesa è uno specchio fedele della società. Ma, oggi, nella Chiesa, le pressioni identitarie sono particolarmente forti. C’è tutta una corrente, che riflette poco, che ha sposato un’identità rivendicativa. Dopo la pubblicazione di alcune caricature sulla stampa riguardanti la pedofilia nella Chiesa, ci sono state delle reazioni degne degli integralisti islamici sulle caricature di Maometto! A voler apparire offensivi, ci si squalifica.Il presidente della Conferenza episcopale (francese), Mons. André Vingt-Trois lo ha ripetuto a Lourdes il 26 marzo: la Chiesa francese è colpita dalla crisi delle vocazioni, dalla difficoltàdella trasmissione della fede, dalla diluizione della presenza cristiana nella società. Come vive questa situazione?
Cerco di prendere atto che ci troviamo alla fine di un’epoca. Si è passati da un cristianesimo diabitudine, ad un cristianesimo di convinzione. Il cristianesimo è perdurato grazie al fatto di essersiriservato il monopolio della gestione del sacro e delle celebrazioni. Di fronte alle nuove religioni,alla secolarizzazione, le persone non fanno più riferimento a questo sacro. Pur tuttavia, possiamo dire che la farfalla è “più” o “meno” della crisalide? E’ un’altra cosa. Allora,non ragiono in termini di degenerazione o di abbandono: stiamo mutando.
 Bisogna misurare l’ampiezza di questa mutazione. Si prenda la mia diocesi: Settantanni fa contava ottocento preti. Oggi ne ha duecento, ma conta anche 45 diaconi e 10mila persone impegnate nelle 320 comunità locali che abbiamo creatoquindici anni fa. E’ meglio. Bisogna arrestare la pastorale della SNCF (ndr.: ferrovie dello stato francesi). Bisogna chiudere delle linee e aprirne delle altre. Quando ci si adatta alle persone, al loro modo di vivere, ai loro orari, la frequenza aumenta, anche al catechismo! La Chiesa ha questa capacità di adattamento.
Bisogna misurare l’ampiezza di questa mutazione. Si prenda la mia diocesi: Settantanni fa contava ottocento preti. Oggi ne ha duecento, ma conta anche 45 diaconi e 10mila persone impegnate nelle 320 comunità locali che abbiamo creatoquindici anni fa. E’ meglio. Bisogna arrestare la pastorale della SNCF (ndr.: ferrovie dello stato francesi). Bisogna chiudere delle linee e aprirne delle altre. Quando ci si adatta alle persone, al loro modo di vivere, ai loro orari, la frequenza aumenta, anche al catechismo! La Chiesa ha questa capacità di adattamento.In quale modo?
Non abbiamo più un personale per mantenere una suddivisione di 36000 parrocchie. O si considerache si tratta di una miseria da cui bisogna uscire ad ogni costo e allora si torna a sacralizzare ilprete; oppure si inventa qualcosa d’altro. La povertà della Chiesa costituisce una provocazione per aprire nuove porte.
La Chiesa deve appoggiarsi sul clero o sui battezzati? Per mio conto, penso che occorra dare fiducia ai laici e smetterla di funzionare sulla base di una organizzazione medievale. E’un cambiamento fondamentale. E’ una sfida.
La sfida presuppone l’apertura del sacerdozio agli uomini sposati?
Sì e no! No, perché immaginate che domani io possa ordinare dieci uomini sposati, ne conosco, non è quello che manca. Ma non potrei pagarli. Quindi dovrebbero svolgere un altro lavoro e sarebbero disponibili solo nei fine settimana per i sacramenti. Allora si tornerebbe ad un’immagine cultuale del prete. Sarebbe una falsa modernità
Invece, se si cambia il modo di esercitare il ministero, se la sua posizione nella comunità è diversa, allora sì che si può immaginare l’ordinazione di uomini sposati. Il prete non deve più essere il capo della sua parrocchia; deve sostenere i battezzati perché diventino degli adulti nella fede, formarli, impedire loro di ripiegarsi su se stessi.Tocca a lui ricordare che si è cristiani per gli altri, non per sé; allora presiederà l’eucarestia come un gesto di fraternità. Se i laici resteranno dei minorenni, la Chiesa non sarà credibile. Deve parlare da adulto ad adulto.
Lei ritiene che la parola della Chiesa non sia più adatta al mondo. Perché?
Con la secolarizzazione, si sviluppa una “bolla spirituale” nella quale le parole fluttuano; a cominciare dalla parola “spirituale” che si può riferire più o meno a qualsiasi merce. Quindi è importante dare ai cristiani i mezzi per identificare e per esprimere gli elementi della loro fede. Non si tratta di ripetere una dottrina ufficiale ma di permettere loro di esprimere liberamente la propria adesione.È spesso il nostro modo di parlare che non funziona. Bisogna scendere dalla montagna, scendere in pianura, umilmente. Per far questo occorre un enorme lavoro di formazione. Perché la fede era diventata un qualcosa di cui non si parlava tra cristiani.
Qual è la sua maggiore preoccupazione per la Chiesa?
Il pericolo è reale. La minaccia per la Chiesa è di diventare una sottocultura. La mia generazioneteneva particolarmente all’inculturazione, all’immersione nella società. Oggi, il rischio è che icristiani si rinchiudano tra di loro, semplicemente perché hanno l’impressione di essere di fronte aun mondo di incomprensione. Ma non è accusando la società di tutti i mali che si diventa luce perl’umanità. Al contrario, occorre un’immensa misericordia per questo mondo in cui milioni di persone muoiono di fame. Tocca a noi aprirci al mondo e tocca a noi renderci amabili.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
MICHELANGELO E IL SOGNO DEI CARMELITANI SCALZI (Teresa d’Avila e Giovanni della Croce): A CONTURSI TERME, IN EREDITA’, L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE (1613) - RECUPERATO CON I LAVORI DI RESTAURO, DOPO IL TERREMOTO DEL 1980
 DON MARIANO ARCIERO, ILDEGARDA DI BINGEN, E UNA "CAPPELLA SISTINA" IN ROVINA. Al cardinale Angelo Amato, all’arcivescovo di Salerno Luigi Moretti, l’invito a un sollecito interessamento.
DON MARIANO ARCIERO, ILDEGARDA DI BINGEN, E UNA "CAPPELLA SISTINA" IN ROVINA. Al cardinale Angelo Amato, all’arcivescovo di Salerno Luigi Moretti, l’invito a un sollecito interessamento.Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE --- DOPO DANTE, IL CARDINAL CUSANO RITORNA SULLA STRADA SOCRATICA DELLA "DOTTA IGNORANZA" E DELLA TRAGEDIA (ESCHILO)."24 maggio 2021, di Federico La Sala
#DIVINACOMMEDIA E
#NiccoloCusano,
per indicare la #via alla
"#Visione di Dio" (1454),
si serve di
un quadro dell’artista Rogier Van der Wayden,
allievo di Robert #Campin,
autore del #TritticodiMerode
***
Con #Virgilio e #Beatrice (#dueSoli),
#NiccoloCusano,
con l’aiuto del solo #Apollo
(«Non è la madre che genera chi è chiamato figlio, ma solo nutrice è del seme gettato in lei»)
non esce dall’orbita
della #tragedia
(#Eschilo).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- L’ALTRA META’ DI DIO. La prima radice. Una ri-lettura del libro di Ginevra Bompiani (di Sandra Petrignani).4 maggio 2021, di Federico La Sala
La prima radice
- [Foto/Copertina] Ginevra Bompiani, L’altra metà di Dio.
Il castigo ha sostituito il destino, ma le donne erano altro. Petrignani ri-legge Bompiani
di Sandra Petrignani (Il Foglio, 22 nov 2019)
Suggerisco di cominciare a leggere L’altra metà di Dio (Feltrinelli) dalla fine. Nel senso: suggerisco di leggere - per cominciare - l’ultimo capitolo dal titolo “Ri-epilogo” perché, appunto, è un epilogo ed è un riepilogo, che aiuterà a orientarsi nelle intenzioni dell’autrice, Ginevra Bompiani, e nelle tante storie che ri-legge e ri-racconta (quanti “ri”, giusti e necessari). Io l’ho letto alla fine, con enorme commozione, e poi ho anch’io riavvolto e ri-capito la messe delle storie.
 Dice Ginevra: “Questo libro nasce dall’ansia”, non per le cose sue personali, ma per quel che ci tocca vivere nell’epoca in cui viviamo (e non solo noi donne). Spiega che ha diviso il testo in tre parti (Distruzione. Punizione. Mistificazione). Che ha voluto capire da dove è nata la “corsa suicida” che ci ha portato alla catastrofe del pianeta. Che il castigo ha sostituito il destino. Che l’Occidente (è sotto gli occhi di tutti) ha “definitivamente confuso la verità con la menzogna”.
Dice Ginevra: “Questo libro nasce dall’ansia”, non per le cose sue personali, ma per quel che ci tocca vivere nell’epoca in cui viviamo (e non solo noi donne). Spiega che ha diviso il testo in tre parti (Distruzione. Punizione. Mistificazione). Che ha voluto capire da dove è nata la “corsa suicida” che ci ha portato alla catastrofe del pianeta. Che il castigo ha sostituito il destino. Che l’Occidente (è sotto gli occhi di tutti) ha “definitivamente confuso la verità con la menzogna”.
 Perché siamo a questo punto, è la grande domanda. Perché l’umanità si è data una storia così violenta, distruttiva e autodistruttiva? Avrebbe potuto andare diversamente? Volendo provare a rispondere, l’autrice si mette in marcia, e parte da lontano, da molto lontano, dalla silenziosa preistoria. Dall’inizio dei tempi, dal regno delle madri o matriarcato che dir si voglia, quando non c’erano ancora storie da leggere, ma solo da ascoltare, e poi dall’inizio delle storie scritte, almeno quelle che sono arrivate fino a noi.
Perché siamo a questo punto, è la grande domanda. Perché l’umanità si è data una storia così violenta, distruttiva e autodistruttiva? Avrebbe potuto andare diversamente? Volendo provare a rispondere, l’autrice si mette in marcia, e parte da lontano, da molto lontano, dalla silenziosa preistoria. Dall’inizio dei tempi, dal regno delle madri o matriarcato che dir si voglia, quando non c’erano ancora storie da leggere, ma solo da ascoltare, e poi dall’inizio delle storie scritte, almeno quelle che sono arrivate fino a noi.Ma siccome “anche le storie hanno il loro inconscio”, Ginevra indaga nella loro misteriosa “primavoltità” (per citare con lei il neologismo di Bobi Bazlen), cerca l’ombra, la parte cancellata e orale che ha lasciato tracce delicate e sepolte, la parte lunare, quell’altra metà di Dio che è stata proditoriamente sottratta, “il femminile che non abbiamo ancora mai visto, affiancato a un maschile che non vediamo più”. Perché l’ipotesi (ma è molto più di un’ipotesi, ne restano tracce tangibili in tanti reperti archeologici e nel filo rosso che lega miti di civiltà diverse) è che “sia esistito un mondo in cui i valori maschili non sopraffacevano quelli femminili”, “un mondo vasto, splendido e mite” in cui regnavano le donne, che le armi non le conoscevano, non le costruivano, non le usavano e che dalle armi sarebbero state sopraffatte, sottomesse, ridotte al ruolo marginale di spose (nella migliore delle ipotesi).
 E, dice Bompiani, “non vi è mistificazione più antica e più durevole, più tenace e silenziosa di quella che qualche migliaio di anni fa ha sostituito il mondo pacifico e egualitario delle società matriarcali con il patriarcato, facendo delle prime il grande rimosso della storia e dell’altro la nostra seconda natura”.
E, dice Bompiani, “non vi è mistificazione più antica e più durevole, più tenace e silenziosa di quella che qualche migliaio di anni fa ha sostituito il mondo pacifico e egualitario delle società matriarcali con il patriarcato, facendo delle prime il grande rimosso della storia e dell’altro la nostra seconda natura”.Non faccio che citare direttamente l’autrice perché il suo è un libro scritto in modo incantevole e preciso, dotto e visionario insieme, che convince e affascina nel suo stare saldo sui testi di riferimento, ma non per noiosamente chiosarli o non solo per interpretarli, bensì per interrogare senza fine l’immaginario umano: “Non cerco la Storia, ma le storie che ci hanno formati nel sonno”.
 Che meraviglia. E così torniamo ad Adamo ed Eva, al sacrificio di Isacco, a Lot ridotta a statua di sale, alla Vergine Maria, cui non è concessa la divinità (nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: non dimentichiamo!), ma solo di essere “beata fra le donne”.
Che meraviglia. E così torniamo ad Adamo ed Eva, al sacrificio di Isacco, a Lot ridotta a statua di sale, alla Vergine Maria, cui non è concessa la divinità (nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: non dimentichiamo!), ma solo di essere “beata fra le donne”.Man mano che si procede nella lettura viene un sentimento di rabbia e d’indignazione per la grande impostura che ci domina da sempre, per la vasta simbologia (non solo quella ebreo-cristiana sangue del nostro sangue. Bompiani va dritta alle origini risalendo all’ispirazione mesopotamica delle storie bibliche e della mitologia greca) che ci ha nutriti e resi quelli che siamo, mentre forse potevamo essere un’umanità diversa, materna, più somigliante in tutto al volto, così femminile, di Gesù Cristo, un figlio non a caso, figlio però di un padre dispotico e disposto a sacrificarlo (“riparando” al mancato sacrificio di Isacco che tragicamente lo annuncia) e di una madre dolorosa, completamente priva di potere.
La temeraria Ginevra si concede ogni tanto (spesso) il lusso di seguire libere associazioni e ci illumina sull’ispirazione di scrittori e filosofi amati (da Kafka a Wittgenstein, per citarne due soltanto) in una vertiginosa scorribanda culturale che non è mai schiacciante, voglio dire che non sopraffà il lettore, ma lo suggestiona, lo illumina e lo incanta, in una lingua di grande dolcezza, quella stessa lingua che fa dire a Franz Kafka, appunto: “Consideratemi un sogno”. Le cose viste “in sogno” dalla pizia Ginevra hanno la forza convincente del presagio cui non si sfugge, della verità intravista e terribile.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE --- LA GENEALOGIA DI GESU’, L’ALBERO DI JESSE, E DANTE IN "PARADISO".21 aprile 2021, di Federico La Sala
#DANTE2021 #DivinaCommedia, #oggi. Nel #Cielo di #Marte, #Dante in #Paradiso (Pd XIV-XV): problemi di #genealogia e di #rinascita - la visione della #croce (#albero di Jesse) e l’incontro con #Cacciaguida:
- RISURREZIONE E RINASCITA (Par. XIV, 61-123): "[...] Tanto mi parver sùbiti e accorti /e l’uno e l’altro coro a dicer «Amme!», / che ben mostrar disio d’i corpi morti: / forse non pur per lor, ma per le mamme, /per li padri e per li altri che fuor cari /anzi che fosser sempiterne fiamme./ [...] Come distinta da minori e maggi /lumi biancheggia tra poli del mondo / Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi; / sì costellati facean nel profondo /Marte quei raggi il venerabil segno/ che fan giunture di quadranti in tondo. /Qui vince la memoria mia lo ‘ngegno; /ché quella croce lampeggiava Cristo, /sì ch’io non so trovare essempro degno; / ma chi prende sua croce e segue Cristo,/ ancor mi scuserà di quel ch’io lasso,/ vedendo in quell’albor balenar Cristo/ [...]. E come giga e arpa, in tempra tesa /di molte corde, fa dolce tintinno / a tal da cui la nota non è intesa, /così da’ lumi che lì m’apparinno /s’accogliea per la croce una melode / che mi rapiva, sanza intender l’inno [...]".
- CACCIAGUIDA SI AVVICINA A DANTE E LO SALUTA (Par. XV, 25-36): "[...] Sì pia l’ombra d’Anchise si porse, /se fede merta nostra maggior musa,/
quando in Eliso del figlio s’accorse./ «O sanguis meus, o superinfusa / gratia Dei, sicut tibi cui /bis unquam celi ianua reclusa?». / Così quel lume: ond’io m’attesi a lui; / poscia rivolsi a la mia donna il viso, / e quinci e quindi stupefatto fui; ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso / tal, ch’io pensai co’ miei toccar lo fondo /de la mia gloria e del mio paradiso [...]".
Albero di Jesse *
L’albero di Jesse (o Iesse) è un motivo frequente nell’arte cristiana tra l’XI e il XV secolo: rappresenta una schematizzazione dell’albero genealogico di Gesù a partire da Jesse, padre del re Davide, il quale è di particolare importanza nelle tre religioni abramitiche, l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam.
- [Foto] Un pannello dell’Armadio degli Argenti raffigurante la Genealogia di Gesù.
Origine
Il tema iconografico trae spunto da un famoso annuncio messianico contenuto nel capitolo 11 del libro del profeta Isaia (11,1.10) [1] da cui ha origine il suo nome greco [2]. Gli artisti combinarono la frase con la genealogia di Gesù come appare nel vangelo secondo Matteo [3] o secondo il Vangelo di Luca (3, 23-38)[4], genealogie che tuttavia presentano vistose differenze.
La più antica rappresentazione conosciuta dell’albero di Jesse è datata 1086, e compare nel Codice Vissegradesi, vangelo dell’incoronazione di Vratislao II di Boemia[5].
Iconografia
Jesse viene solitamente rappresentato coricato, semi-coricato o nell’iconografia meno antica seduto[6][7]. Nell’arte romanica, solitamente, egli è rappresentato coricato all’aperto mentre in quella gotica appare più spesso dentro ad un letto riccamente adornato, come nelle vetrate della chiesa di Saint-Étienne a Beauvais che datano al 1520.
Spesso Jesse appare addormentato, la testa appoggiata su una mano. Questa posizione è, a volte, associata ad un sogno profetico concernente la discendenza del dormiente. Dal suo fianco o dal suo ventre o anche dal dorso[7] o più raramente dalla sua bocca, s’innalza un albero i cui rami sorreggono gli antenati di Gesù, in particolare Davide riconoscibile per la sua arpa, fino a Maria. Le vetrate della cattedrale di Chartres rappresentano, dal basso in alto Davide, Salomone, Roboamo, Abias ed infine Maria. Ogni artista, a seconda del testo che ha utilizzato, del proprio gusto e dello spazio che ha a disposizione, aggiunge altri personaggi dell’Antico Testamento, spesso i profeti che gli esegeti del Medioevo pensavano avessero annunciato la venuta di Cristo (sono quattordici sulle vetrate di Chartres). Alla sommità si trova Gesù, a volte in croce, a volte bambino, sulle ginocchia della madre.
Nel XIII secolo, l’albero si sviluppa verticalmente, ed è solo nel XV che comincia a ramificarsi lateralmente[6]. Ancora presente nell’iconografia cristiana del XV sec., il motivo declina nel XVI per scomparire con la Controriforma[6].
Esistono naturalmente anche altre forme di rappresentazione della genealogia di Gesù, che non utilizzano l’albero di Jesse, il più famoso è quello dipinto nelle lunette della Cappella Sistina da Michelangelo tratto dal Vangelo secondo Matteo[8].
I supporti
L’albero di Jesse è stato un motivo popolare in tutte le arti: si trovano esempi nei manoscritti miniati, le stampe, le vetrate, la scultura monumentale, gli affreschi, le tappezzerie o nei ricami[6].
Manoscritti
- Salterio di Scherenberg, Strasburgo, c. 1260
Il motivo appare in parecchie bibbie romane, ad esempio nella Bibbia di Lambeth, sotto forma di una B maiuscola decorata all’inizio del Libro di Isaia o del vangelo di Matteo. La bibbia di San Benigno, del XII secolo, una delle più antiche che ci sono pervenute, mostra Jesse e le sette colombe rappresentanti i sette doni dello Spirito Santo[9]. La bibbia dei Cappuccini (ultimo quarto del XII sec.) conservata nella Bibliothèque nationale de France ne è un altro esempio, l’albero di Jessi decora la L maiuscula del Liber generationis nel vangelo di Matteo[10].
Poiché il re Davide era considerato l’autore dei Salmi, i salteri erano sovente illustrati con un albero di Jesse, soprattutto i manoscritti inglesi, dove l’albero di Jesse s’arrotola attorno alla B maiuscola del testo latino Beatus Vir all’inizio del primo salmo. Uno dei primi esempi è il salterio di Huntingfield, della fine del XII secolo. La British Library possiede un bellissimo salterio del XIV sec., detto di Gorleston. In questi due esemplari Jesse è allungato ai piedi della lettera B. Si potrebbero citare ancora il salterio di Macclesfield (Fitzmuseum, Cambridge) ed il Salterio e le Ore del duca di Bedford [11].
Alcuni manoscritti consacrano una pagina intera al motivo, aggiungendovi personaggi, per esempio la sacerdotessa di Apollo Sibilla Cumana del salterio d’Ingeburg (inizio del XII sec.). Presso Colonia, in un lezionario di prima del 1164 si descrive un Jesse insolito, morto in una tomba o bara, da cui l’albero cresce[12].
Una prestigiosa rappresentazione dell’Albero di Jesse si trova nella cappella Roano (voluta dall’Arcivescovo Giovanni Roano), detta cappella del Crocifisso, sita all’interno del Duomo di Monreale in Sicilia.
Evoluzione
L’albero di Jesse, contaminato dalla popolarità del tema della parentela santa si modifica fino a diventare, a partire dal X secolo, il modello da cui deriveranno le successive rappresentazioni degli alberi genealogici[13] e in particolare per sintetizzare figurativamente la genealogia delle famiglie reali[14].
Per Tilde Giani Gallino l’albero di Jesse dell’abbazia di Saint-Denis rappresenta, dissimulato, un fallo di dimensioni sproporzionate. Questa rappresentazione è risultato dell’inconscia compensazione del suo ideatore, l’abate Sugerio, che - sfavorito dalla natura, causa imbecille corpusculum - proiettò, tramite quello che per lui era simbolo di forza e autorità, la sua «volontà di potenza».[15][16]
L’immagine dell’albero che nasce direttamente dal fianco di Jesse, affermatasi nei secoli XI-XII, ha una sconcertante analogia con la scena in cui si vede Brahmā seduto su un loto che esce dal ventre di Viṣṇu, secondo i testi sacri Veda. Nell’arte romanica i personaggi sono collocati direttamente sui rami e non nei calici dei fiori come avverrà dopo un paio di secoli, analogamente a quanto rappresentato nelle sculture buddhiste in Birmania, Cambogia, Cina ed altre parti dell’Estremo Oriente. Queste immagini si ritrovano a Worms, Issoudun (cappella dell’Ospedale), Rouen (cattedrale), Sens (cattedrale).[17]
* Fonte: Wikipedia (ripresa parziale, senza immagini e senza note).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI"... DANTE "corre" fortissimo, supera i secoli, e oltrepassa HEGEL - Ratzinger e Habermas!!! MARX, come VIRGILIO, gli fa strada e lo segue. Contro il disfattismo, un’indicazione e un’ipotesi di ri-lettura.
FLS
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE ---- AL DI LA’ DELLA "DOTTA IGNORANZA" E DELLA "TEORIA" DEL "TRITTICO DI MERODE".19 aprile 2021, di Federico La Sala
#MENSCHWERDUNG.
ripartendo dal #saperedinonsapere,
Niccolò Cusano
ricade nella #antropologia zoppa e cieca di #Aristotele
e propone nella #Docta Ignorantia (III, 5) del 1440
la visione (#teoria) del trittico di Merode (1427)
-
> RINASCIMENTO ITALIANO --- «Profeti, Sibille, Cassandra e Tiresia dal lato greco; Samuele, Isaia, Geremia ed Ezechiele da quello ebraico: con un futuro spettacoloso che li vede tutti insieme nella volta della Cappella Sistina per mano di Michelangelo.» (Pietro Boitani)..19 aprile 2021, di Federico La Sala
Profeti e Sibille
di Rosanna Virgili (Avvenire, domenica 18 aprile 2021)
«Profeti, Sibille, Cassandra e Tiresia dal lato greco; Samuele, Isaia, Geremia ed Ezechiele da quello ebraico: con un futuro spettacoloso che li vede tutti insieme nella volta della Cappella Sistina per mano di Michelangelo. La profezia deriva da ispirazione divina: Cassandra da Apollo, Tiresia da Zeus; i profeti biblici da Dio. La chiamata di ciascuno di essi possiede una forza teologica e poetica formidabile». Così inizia un bell’articolo di Pietro Boitani dedicato ai “professionisti del futuro”.
Quelli cui ancora molti di noi chiedono lumi sui giorni a venire, cos’erano davvero anche nel mondo antico? Lo fa capire bene Boitani quando, a proposito della bella Cassandra, trova che nell’Iliade non faccia altro che constatare «la pura realtà» che ella coglie per prima, circa il cadavere di Ettore. «L’oracolo di Delfi - dice Eraclito - non dice e non nasconde: significa». Vede il futuro nelle pieghe del presente. Voce stessa di Dio, i profeti biblici, che riuscivano a capire quale sfacelo avrebbe fatto seguito alle testarde e reiterate violazioni della giustizia e della fraternità, con l’intelligenza della fede.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO --- GLI ANTICHI PROFESSIONISTI DEL FUTURO. Profeti e sibille, "tutti insieme nella volta della Cappella Sistina per mano di Michelangelo.» (di Pietro Boitani).19 aprile 2021, di Federico La Sala
Gli antichi professionisti del futuro
Per quello che accadrà domani ci si è sempre rivolti a profeti, sibille e oracoli
di Pietro Boitani ("San Francesco", 19.04.2021).
Il futuro è insondabile: la scienza moderna riesce a prevedere i moti degli astri; i comportamenti delle particelle, le reazioni degli elementi chimici; e via via con minore precisione a inquadrare le combinazioni di cellule e l’ evoluzione degli organismi viventi; infine, a elaborare proiezioni economiche, sociologiche, politiche. Ma il nostro immaginario ancestrale è dominato da due tipi di futuro, quello della fama e quello di coloro che lo annunciano ab antiquo: profeti, Sibille, estensori di apocalissi.
 Le figure maggiori sono Cassandra e Tiresia dal lato greco; Samuele, Isaia, Geremia ed Ezechiele da quello ebraico: con un "futuro" spettacoloso che li vede tutti insieme nella Volta della Cappella Sistina per mano di Michelangelo.
Le figure maggiori sono Cassandra e Tiresia dal lato greco; Samuele, Isaia, Geremia ed Ezechiele da quello ebraico: con un "futuro" spettacoloso che li vede tutti insieme nella Volta della Cappella Sistina per mano di Michelangelo.La profezia deriva da ispirazione divina: Cassandra da Apollo, Tiresia da Zeus o da Atena; i profeti biblici da Dio. La chiamata di ciascuno di essi possiede una forza teologica e poetica formidabile. Nel caso di Samuele, il testo gioca sulla ripetizione della "parola". Samuele, al servizio del vecchio sacerdote Eli, sente la Voce chiamarlo. Corre allora dal maestro: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma Eli: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Il messaggio divino deve essere ripetuto ben tre volte, e il futuro che esso minaccia è il "piano" stesso di Dio, la sua giustizia.
 In Eschilo, Cassandra "vede" l’ assassinio di Agamennone: la possiede, invasandola dopo aver desiderato invano di possederla fisicamente, Apollo, che la punisce per il suo rifiuto di darsi a lui con la condanna ad essere inascoltata. Ma nell’ Iliade Cassandra constata la pura realtà, scorgendo per prima il cadavere di Ettore che giunge a Troia, e chiamando tutti a contemplarlo. È il momento tremendo in cui la profezia si adempie. Al sorgere dell’ Aurora, Priamo e il suo araldo ritornano dalla tenda di Achille, tra grida e lamenti si avvicinano alla città. Non li vede nessuno, ma Cassandra, «bella come Afrodite d’ oro», sale sulla rocca e li avvista. C’ è qualcosa di infinitamente tragico nel contrasto tra la bellezza di Cassandra - «prima per bellezza delle figlie di Priamo», ripete Omero - e la morte che ella scorge e segnala. Lì, in quel cuneo del bello, sta la tragedia della profezia compiuta.
In Eschilo, Cassandra "vede" l’ assassinio di Agamennone: la possiede, invasandola dopo aver desiderato invano di possederla fisicamente, Apollo, che la punisce per il suo rifiuto di darsi a lui con la condanna ad essere inascoltata. Ma nell’ Iliade Cassandra constata la pura realtà, scorgendo per prima il cadavere di Ettore che giunge a Troia, e chiamando tutti a contemplarlo. È il momento tremendo in cui la profezia si adempie. Al sorgere dell’ Aurora, Priamo e il suo araldo ritornano dalla tenda di Achille, tra grida e lamenti si avvicinano alla città. Non li vede nessuno, ma Cassandra, «bella come Afrodite d’ oro», sale sulla rocca e li avvista. C’ è qualcosa di infinitamente tragico nel contrasto tra la bellezza di Cassandra - «prima per bellezza delle figlie di Priamo», ripete Omero - e la morte che ella scorge e segnala. Lì, in quel cuneo del bello, sta la tragedia della profezia compiuta.
 Altra tragedia, quella di Tiresia: «Ahi, ahi, com’ è terribile sapere», egli esclama nell’ Edipo re, «quando non giovi a chi sa! Io ne ero ben consapevole, ma l’ ho dimenticato; altrimenti non sarei venuto qui». Tiresia porta con sé il segreto del destino di Edipo: Tiresia, l’ uomo che ha sperimentato cosa voglia dire essere donna, colui che riceve il dono della profezia come compenso per la perdita della vista fisica: occhio per occhio, davvero.
Altra tragedia, quella di Tiresia: «Ahi, ahi, com’ è terribile sapere», egli esclama nell’ Edipo re, «quando non giovi a chi sa! Io ne ero ben consapevole, ma l’ ho dimenticato; altrimenti non sarei venuto qui». Tiresia porta con sé il segreto del destino di Edipo: Tiresia, l’ uomo che ha sperimentato cosa voglia dire essere donna, colui che riceve il dono della profezia come compenso per la perdita della vista fisica: occhio per occhio, davvero.Le profezie antiche sono enigmatiche e ambigue: «Il Signore di cui è l’ oracolo in Delfi», sostiene Eraclito, «non dice e non nasconde: significa». Solamente le previsioni di un Esiodo o di un Virgilio che legano astronomia e agricoltura sono chiare ed esatte, perché basate sull’ esperienza: «Quando le Pleiadi sorgono, dà inizio alla mietitura». Ma la durata più estesa del futuro che l’ antichità e le epoche successive riescono a concepire è quella fornita dalla fama: che non è la gloria, ma il parlar di qualcuno: Rumor, diceria. Per l’ immaginario del futuro che ha dominato l’ Occidente, è un concetto fondamentale almeno sino al Settecento. La rivoluzione scientifica del secolo XVII muta radicalmente il panorama. Il futuro porta ora il segno della precisione quantitativa: l’ ingresso della matematica e dello sperimentalismo nelle scienze fisiche altera definitivamente la previsione: non più profezia ma interpretazione di dati ed elaborazione di modelli. Su queste basi nascerà nel Novecento, seguendo germi antichi, la fantascienza, che elabora visioni del futuro fondate su previsioni scientifiche. C’ è chi immagina l’ apocalisse, come Walter Miller nel capolavoro Un cantico per Leibowitz; chi una successione di specie attraverso Anni senza fine, come Clifford Simak; e chi infine, come Stanley Kubrick in 2001: Odissea nello spazio, ricostruisce l’ intera storia dell’ umanità, dalla preistoria all’ oggi e poi al futuro remoto.
In Un cantico per Leibowitz la situazione di partenza è l’ olocausto nucleare (il «Diluvio di Fiamma») che ha avuto luogo sulla Terra nel XXI secolo e cui segue un nuovo Medioevo. All’ inizio dei secoli bui Isaac Edward Leibowitz trova rifugio in un monastero benedettino e fonda poi il proprio Ordine: il cui compito principale è quello di conservare i Memorabilia, gli scritti sopravvissuti al Diluvio di Fiamma. In effetti il primo protagonista del romanzo, Frate Francis Gerard dello Utah, ritrova antichissimi documenti che col tempo permettono lo sviluppo di una nuova scienza e di una nuova civiltà. Ancora una volta, però, l’ alta tecnologia conduce inevitabilmente al conflitto nucleare, e alla fine del romanzo i monaci sono costretti ad abbandonare la Terra su un’ astronave. Nel messaggio pessimista di Un cantico per Leibowitz ha una parte fondamentale l’ idea che un periodo di barbarie, di regresso della storia, sia necessario incubatore di una nuova civiltà. È un concetto cui pare accennare Dante quando enuncia la sua prima visione del futuro in Purgatorio XI: il celebre miniatore Oderisi da Gubbio parla dell’ umana vanità e, prima di mettere in scena i grandi artisti (Cimabue e Giotto, i due Guidi e Dante) che si succedono nel conquistare la gloria, enuncia la legge che governa il poco che l’ uomo può: quella della vana-gloria, che non dura se non seguita dalle «etati grosse». Le «etati grosse» sono appunto i periodi nei quali la civiltà viene meno e la barbarie impera. Gli uomini più grandi dell’ antichità non sarebbero famosi ora se non ci fosse stata tra loro e Dante una «etate grossa», un ...Medioevo.
Nel secondo grande classico, Anni senza fine di Simak, prevale invece il «tacito, infinito andar del tempo» (dall’ anno 2008 al milione) e il succedersi di specie diverse nel dominio sulla Terra: dotati di modifiche fondamentali al loro corpo o al loro habitat, i cani rimpiazzano l’ uomo - divenuto nel frattempo un mito da studiare filologicamente - e le formiche sostituiscono i cani, mentre la continuità è assicurata dal robot Jenkins, già maggiordomo della famiglia Webster e ora guardiano della cripta dove tutti i suoi membri giacciono in eterna ibernazione. «Una concezione della storia che voglia coprire la totalità delle cose umane», scriveva Karl Jaspers in Origine e senso della storia, «deve includere il futuro».
2001: Odissea nello spazio, il film iconico di Kubrick, ne provvede un altro. Il monolite nero piovuto da chissà dove segna qui, accompagnato dal rimbombare del Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, le tappe fondamentali dell’ evoluzione umana: sulla Terra dà l’ impulso fondamentale alla trasformazione degli ominidi in homines sapientes; ritrovato sulla Luna nel 2001, spinge l’ uomo alla navigazione verso Giove e i suoi satelliti mentre il computer assassino HAL viene disattivato.
 L’ unico astronauta superstite viene allora lanciato, dopo aver rinvenuto il monolite, in «folle volo» attraverso lo spazio e il tempo, sino a ritornare sulla Terra e morire sollevando l’ indice verso l’ Uovo Cosmico che contiene lo «Star-Child», il Puer Aeternus: come dichiara di nuovo la musica di Strauss, è l’ embrione del superuomo. Non esisterà più il tempo, recita il titolo di un bellissimo saggio di Riccardo Antonangeli, Eternità e trama nell’ arte del racconto (Roma, Studium).
L’ unico astronauta superstite viene allora lanciato, dopo aver rinvenuto il monolite, in «folle volo» attraverso lo spazio e il tempo, sino a ritornare sulla Terra e morire sollevando l’ indice verso l’ Uovo Cosmico che contiene lo «Star-Child», il Puer Aeternus: come dichiara di nuovo la musica di Strauss, è l’ embrione del superuomo. Non esisterà più il tempo, recita il titolo di un bellissimo saggio di Riccardo Antonangeli, Eternità e trama nell’ arte del racconto (Roma, Studium).
 Tramonto dell’ uomo o sua trasformazione: la fantascienza invita a porsi la domanda con la frase usata da Dante per immaginare noi, suoi posteri - coloro che, dice in Paradiso XVII parlando all’ antenato Cacciaguida e inventando il futuro, «questo (il suo) tempo chiameranno antico». L’ uomo diverrà una leggenda? Chi chiamerà il nostro tempo antico? I cani, le formiche, il superuomo?
Tramonto dell’ uomo o sua trasformazione: la fantascienza invita a porsi la domanda con la frase usata da Dante per immaginare noi, suoi posteri - coloro che, dice in Paradiso XVII parlando all’ antenato Cacciaguida e inventando il futuro, «questo (il suo) tempo chiameranno antico». L’ uomo diverrà una leggenda? Chi chiamerà il nostro tempo antico? I cani, le formiche, il superuomo?
-
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE --- UNA DI "QUELLE DOMANDE CHE NON MI DANNO PACE" (ANNE fRANK - 13 GIUGNO 1944).10 aprile 2021, di Federico La Sala
UNA LETTERA DI ANNE FRANK (13 GIUGNO 1944) *
Carissima Kitty,
[...] piú volte mi sono posta una di quelle domande che non mi danno pace, e cioè perché un tempo, e spesso anche adesso, la donna nei popoli occupa un posto molto meno importante rispetto all’uomo. Chiunque può dire che è ingiusto, ma a me non basta, vorrei tanto conoscere il motivo di questa grande ingiustizia!
Si può immaginare che l’uomo, fisicamente piú forte, fin dall’inizio abbia avuto una posizione di supremazia rispetto alla donna; l’uorno che guadagna, che genera i figli, l’uomo che può tutto... È già stato abbastartza stupido da parte di tutte quelle donne che fino a poco tempo fa hanno permesso che fosse cosí senza protestare, perché quanti piú secoli questa regola ha resistito, tanto piú ha preso piede. Per fortuna la scuola, il lavoro e il progresso hanno un po’ aperto gli occhi alle donne, In molti paesi le donne hanno ottenuto gli stessi diritti degli uomini; molte persone, soprattutto donne, ma anche uomini, adesso capiscono quanto questa suddivisione fosse sbagliata e le donne moderne vogliono avere il diritto all’indipendenza totale!
Ma non è solo questo, è il rispetto della donna, quello che manca! In tutto il mondo l’uomo viene rispettato, perché non si può dire lo stesso della donna? Soldati ed eroi di guerra vengono onorati e festeggiati, gli scopritori hanno fama immortale, i martiri vengono osannati, ma di tutta l’umanità, quanti considerano la donna anche come un soldato?
Nel libro Guerrieri per la vita c’è scritta una cosa che mi ha molto colpita, e cioè piú o meno che le donne in generale già soltanto per i parti soffrono piú di qualsiasi eroe di guerra. E quale successo spetta alla donna, dopo avere sofferto tanto? Viene spinta in un angolo quando è sformata dalla gravidanza, i figli ben presto non sono piú suoi, la bellezza svanisce. Le donne sono molto piú stoiche, sono soldati piú coraggiosi che lottano e soffrono per la sopravvivenza dell’umanirà molto piú di tanti eroi che non sanno fare altro che vantarsi!
Con questo non voglio affatto dire che le donne debbano rifiurarsi di mettere al mondo bambini, anzi, cosí è per natura, e cosí è giusto che sia. Condanno solo gli uomini e tutto l’ordinamemo del mondo che non ha mai voluto rendersi conto del grande, pesante ma d’altronde anche bel fardello che la donna porta nella società.
Paul de Kruif, lo scrittore del libro sopraccitato, ha tutta la mia approvazione quando dice che gli uomini devono imparare che la nascita ha cessato di essere un fatto narurale e normale in tutte quelle zone del mondo che vengono definite civilizzate. Hanno un bel dire, gli uomini! Non hanno mai sopportato, né mai sopporteranno, le pene che toccano alle donne!
Secondo me il concetto che sia dovere della donna avere figli nel corso del prossimo secolo si modificherà e verrà sostituito da rispetto e ammirazione nei confronti di colei che si prende sulle spalle i pesi senza brontolare né darsi tante arie!
Tua Anne M. Frank
* Fonte: Dialogando con Anne..
* ANNE FRANK, "DIARIO. Edizione integrale", Einaudi, Torino 1993.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- LA PROFEZIA DI MARIELLE FRANCO, DAL BRASILE A FIRENZE (di Glória Paiva).15 marzo 2021, di Federico La Sala
TRANSIZIONE CULTURALE... *
- "Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro (Mario Draghi)
Internazionale
Brasile, la profezia di Marielle Franco
Tre anni dopo. Resta senza mandanti l’omicidio della consigliera di Rio, avvenuto il 14 marzo 2018 per mano di due sicari. Ma alle ultime elezioni voti a valanga per 13 donne afrobrasiliane
di Glória Paiva (il manifesto, 14.03.2021)
Oggi il brutale omicidio della consigliera comunale brasiliana Marielle Franco e del suo autista Anderson Gomes compie tre anni. Militante, femminista, nera, residente a Favela da Maré e quinta consigliera più votata a Rio de Janeiro nel 2016, Marielle è diventata un simbolo mondiale della lotta antirazzista, per i diritti umani e lgbt+.
NONOSTANTE IL TEMPO trascorso, rimangono ancora domande sulle circostanze della sua morte. Perché le autorità locali e quelle nazionali non cooperano nella conduzione del caso? Qual è la conclusione dell’indagine relativa all’uso delle armi della polizia federale nel crimine? Chi ha spento le telecamere della strada in cui transitavano quella sera Marielle e Anderson? C’è stato un tentativo di depistaggio delle indagini? E la principale: chi ha ordinato l’omicidio di Marielle e perché?
Queste e altre questioni sono oggetto di un documento pubblicato dall’Istituto Marielle Franco, un’organizzazione creata dalla famiglia di Marielle per perpetuare la sua memoria. La famiglia chiede in modo costante risposte alle autorità di Rio de Janeiro che conducono le indagini. Tuttavia, si trovano spesso di fronte al silenzio: nell’ultima settimana, ad esempio, hanno cercato di incontrare il governatore dello stato, Cláudio Castro, e il procuratore generale, Luciano Mattos, ma non hanno avuto alcun riscontro, come ha riferito Anielle Franco, la sorella dell’attivista, in una conferenza stampa che si è tenuta venerdì 11 marzo.
FINORA, È NOTO SOLTANTO che Ronnie Lessa, poliziotto in pensione, e Élcio Queiroz, ex poliziotto, hanno aspettato l’auto di Marielle e Anderson nella Rua dos Inválidos, nel centro di Rio, prima di sparare contro il veicolo. Entrambi sono in un carcere di massima sicurezza e saranno sottoposti a un giudizio popolare, un processo in cui 25 cittadini, insieme al giudice, decideranno sulla colpevolezza o meno dell’imputato. L’ipotesi principale è che l’assassinio abbia avuto una motivazione politica e che vi abbiano partecipato delle milizie.
Secondo Jurema Werneck, direttrice esecutiva di Amnesty International in Brasile, i successivi cambiamenti negli organi responsabili delle indagini e la mancanza di trasparenza hanno ostacolato un’inchiesta rapida e imparziale. «In questi tre anni abbiamo avuto tre governatori, due procuratori generali, tre capi di polizia, tre pubblici ministeri. Nella pubblica sicurezza di Rio ci sono stati cinque cambi. Le autorità brasiliane non possono inviare un messaggio di impunità e di tolleranza rispetto alla violenza politica», dice Werneck. Che avverte: «Finché i mandanti sono liberi e sconosciuti, nessuno può sentirsi al sicuro».
«NON POSSIAMO ASPETTARE altri dieci anni prima che le donne nere vengano elette», aveva detto Marielle poche ore prima di essere uccisa. Il suo discorso è diventato una profezia: due anni dopo, nel 2020, alle ultime elezioni amministrative brasiliane, 13 donne nere sono state tra i candidati più votati nelle più grandi città del Brasile. Tra i consiglieri eletti, più di 70 si sono impegnati nella cosiddetta Agenda Marielle, che riunisce progetti di legge con pratiche e linee guida anti-razziste, femministe, lgbt + e popolari ispirate al lavoro svolto dall’attivista.
I politici sintonizzati su questi ideali, tuttavia, sono spesso a rischio. A Rio de Janeiro, le quattro donne nere elette con il Partito socialismo e libertà (Psol) hanno già registrato minacce di natura politica. «È necessario proteggere queste donne e inviare un messaggio a chi vuole mettere a tacere l’eredità di Marielle. Le persone che lottano per la giustizia, i diritti, la dignità devono essere protette perché sono un bene della società», dice Jurema Werneck.
Per il deputato federale Marcelo Freixo (Psol), amico ed ex compagno di lotta di Marielle, l’assassinio ha rivelato un lato brutale del Brasile. A cui il mondo ha reagito: «Le manifestazioni contro la morte di Marielle - osserva - mostrano la forza di ciò che lei ha rappresentato. Questa società capace di uccidere Marielle Franco non è la società che vogliamo»,
*
E Firenze le dedica una terrazza
Il messaggio di Marielle Franco ha fatto il giro del mondo e ha raggiunto anche Firenze. Dal 15 marzo l’attivista sarà la prima donna brasiliana nera ad avere il suo nome in uno spazio pubblico in Italia, sulla terrazza della Biblioteca delle Oblate.
 L’intitolazione è frutto della collaborazione tra la Cgil di Firenze e la Casa do Brasil a Firenze che hanno fatto specifica richiesta al Comune. «Questa terrazza non è uno spazio qualsiasi. Con vista sulla cupola del Brunelleschi, è un luogo simbolo del Rinascimento italiano. Possa la memoria di Marielle rinascere qui e offrire ai giovani la chance di riflettere su giustizia, diritti umani, diversità, tutto ciò che Marielle incarnava», commenta Ana Luiza Oliveira de Souza della Casa do Brasil a Firenze.
L’intitolazione è frutto della collaborazione tra la Cgil di Firenze e la Casa do Brasil a Firenze che hanno fatto specifica richiesta al Comune. «Questa terrazza non è uno spazio qualsiasi. Con vista sulla cupola del Brunelleschi, è un luogo simbolo del Rinascimento italiano. Possa la memoria di Marielle rinascere qui e offrire ai giovani la chance di riflettere su giustizia, diritti umani, diversità, tutto ciò che Marielle incarnava», commenta Ana Luiza Oliveira de Souza della Casa do Brasil a Firenze.
*SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" del 2004.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
FLS
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- STORIA DELL’ARTE E "DIVINA COMMEDIA": LA TRADIZIONE ICONOGRAFICA DELL’ ANNUNCIAZIONE E LA GIORNATA DEDICATA A DANTE.12 marzo 2021, di Federico La Sala
COME NASCONO I BAMBINI? LA “RISPOSTA” DELLA TRADIZIONE CATTOLICA NELLA RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA... *
- Una nota all’articolo di Nicola Fasano, "25 marzo. Annunciazione di Maria Vergine. Una tela a Maruggio" (Fondazione Terra d’Otranto, 25.03.2013).
SOLLECITANDO CON QUESTA “RIPRESA” UNA LODEVOLE E RINNOVATA ATTENZIONE AL TEMA DELLA “ANNUNCIAZIONE” NELLA RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA E RICORDANDO CHE L’EVENTO “rappresenta il momento in cui l’arcangelo Gabriele annuncia a Maria il concepimento di Gesù e la sua incarnazione [...] il 25 marzo, precisamente nove mesi prima della Natività di Cristo”, e, che “Iconograficamente la composizione vede protagonisti la Vergine, la colomba dello Spirito Santo e l’angelo annunciante”, FORSE, è UTILE riconsiderare come nel “corso dei secoli è cambiato il modo di rappresentare il tema” E ANCORA, se si vuole, cominciare a riesaminare con attenzione proprio il “mosaico dell’Annunciazione” di Pietro Cavallini (del 1291 - vedi, sopra: la seconda figura dell’articolo) e, poi, proseguire con le opere specifiche degli artisti “fiamminghi quali Van der Weyden, Campin, i quali dipingono la Vergine colta nella sua quotidianità domestica all’arrivo dell’angelo Gabriele” - e osservare con attenzione, IN PARTICOLARE, l’immagine del pannello centrale della “ANNUNCIAZIONE” (https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Campin#/media/File:Robert_Campin_011.jpg) del “Trittico di Mérode” (1427) di Robert Campin (https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Campin).
Proseguendo e, non dimenticando di riflettere anche sulla rilevanza per gli artisti del lavoro del cardinale Gabriele Paleotti sulle immagini sacre (“Discorso intorno alle immagini sacre e profane”, del 1582), è opportuno arrivare all’attuale presente storico (il prossimo 25 marzo è anche il giorno della prima Giornata dedicata all’opera e alla memoria di Dante - il “Dantedì”) e ricordare quanto “poco fa”, proprio all’inizio del Terzo Millennio dopo Cristo, il CARDINALE CASTRILLON HOYOS (proprio come un artista del 1200 o del 1400) dichiarò alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio” ("la Repubblica" del 17 novembre 2000, p. 35).
Forse, in questo “Anno speciale di San Giuseppe” indetto da papa Francesco (cfr. “DE DOMO DAVID”?! GIUSEPPE, MARIA, E L’IMMAGINARIO “COSMOTEANDRICO” .. https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/#comment-262319), sarà possibile sapere come nascono i bambini e le bambine e sarà possibile avere un’altra rappresentazione artistica della nostra stessa nascita?! Con Dante, non c’è affatto da dubitare: “L’amore muove il sole e le altre stelle” - e anche la Terra!
Buon lavoro...
*
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- FILOLOGIA E DIGNITA’ DELL’UOMO, OGGI. Jan van Ruusbroec, Benozzo Gozzoli, e Ponzio Pilato.11 marzo 2021, di Federico La Sala
#FILOLOGIA e #ARCHEOLOGIA. L’Uomo-#Sapienza di #Ruysbroec ("nel cuore di ogni uomo un #Ecco, cioè #Vedi, guarda"), il corteo "andrologico" dei #Magi (https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_dei_Magi), e l’«uomo» di #PonzioPilato («#Eccehomo»: gr. «idou ho #anthropos»), oggi... http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5195 ...
in dialogo con il testo di Giorgiomaria Cornelio, Verumtamen in imagine pertransit homo, "Nazione Indiana".
FLS
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Il restauro della Cappella Sistina (1980-1994) e la "Donna-Sapienza fin dal principio" (di Marinella Perroni).3 marzo 2021, di Federico La Sala
Donna Sapienza
fin dal principio
di Marinella Perroni
 Biblista, Pontificio Ateneo S. Anselmo *
Biblista, Pontificio Ateneo S. Anselmo *Salomone lo conoscono più o meno tutti. Se non altro per quello stratagemma di voler far tagliare in due un bambino conteso tra due madri: una storia raccontata nel primo libro dei Re (3, 16-28). Forse, alcuni sanno anche che la saggezza del figlio di Davide e di Betsabea, l’adultera, è divenuta proverbiale perché il regno di Salomone ha assicurato a Israele non soltanto pace e stabilità, ma anche il contatto con le altre grandi culture del Vicino Oriente e, quindi, un tempo di grande vivacità culturale e di progresso civile. Per questo Israele ha attribuito al re Salomone tutta la riflessione sapienziale che sta alla base di alcuni libri della Bibbia, scritti in realtà in epoche diverse (dal secolo V al II prima di Cristo), che contengono sentenze, orientamenti e norme che hanno di mira una vita proficua e felice. Quasi nessuno però sa che quella sapienza che ha reso famoso Salomone è una raffigurazione che, accanto ad altre due figure, la Legge e il Messia, consente di capire perché, ma soprattutto come, Dio si fa presente nella storia del suo popolo. Ed è figura femminile.
Donna-Sapienza
Tra le tante cose degne di stupore emerse grazie al restauro della Cappella Sistina (1980-1994) una è, a mio avviso, tutt’altro che marginale. Nell’affresco della creazione, che occupa la volta, l’attenzione viene catturata dal vigore dell’Adamo e dalla grandiosa potenza espressiva con cui Michelangelo ha saputo rendere conto del rapporto di vicinanza e al contempo di distanza tra il creatore e la creatura fatta a sua immagine e somiglianza.
 Eppure, il restauro ha fatto riemergere un particolare per troppi secoli rimasto del tutto oscurato: tra i putti che circondano e sostengono Dio nel suo atto creativo domina una figura femminile che Dio vincola a sé in un abbraccio. Eva? Inevitabile che in molti lo sostengano, anche se, in realtà, alla creazione di Eva il pittore dedica un riquadro specifico nelle storie della Genesi che corredano la volta.
Eppure, il restauro ha fatto riemergere un particolare per troppi secoli rimasto del tutto oscurato: tra i putti che circondano e sostengono Dio nel suo atto creativo domina una figura femminile che Dio vincola a sé in un abbraccio. Eva? Inevitabile che in molti lo sostengano, anche se, in realtà, alla creazione di Eva il pittore dedica un riquadro specifico nelle storie della Genesi che corredano la volta.Se gli storici dell’arte propendono per l’identificazione con Eva, i biblisti azzardano invece un’altra ipotesi, tutt’altro che fantasiosa perché molto ben accreditata dagli scritti sapienziali della Bibbia. Leggiamo nel libro dei Proverbi: «Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all’origine. Dall’eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. [...] Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio sull’abisso, [...] io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo» (Proverbi 8, 22-31).
 È la Sapienza stessa che si presenta come colei che presiede alla creazione, come la forza creativa che fa della creazione un’opera che - ce lo dice il racconto che apre il libro della Genesi - Dio considera una «cosa molto buona» (Genesi 1, 31). La reciprocità che Dio stabilisce con l’opera delle sue mani riflette, insomma, il rapporto ludico che intercorre tra Dio e la Sapienza. Il discorso sarebbe lungo: basti solo dire che, nonostante la struttura sociale di Israele fosse fortemente caratterizzata in senso patriarcale e nonostante ciò abbia spesso imposto alle donne anche pesanti restrizioni, nella letteratura biblica emergono invece, sia pure in modo carsico, attestazioni del ruolo decisivo giocato dalle donne nello sviluppo della storia di Dio con il suo popolo nonché riflessioni, spunti, allusioni che rivelano un immaginario religioso in cui la presenza femminile gioca un ruolo di primo piano. Al riguardo, gli scritti sapienziali sono una vera e propria miniera.
È la Sapienza stessa che si presenta come colei che presiede alla creazione, come la forza creativa che fa della creazione un’opera che - ce lo dice il racconto che apre il libro della Genesi - Dio considera una «cosa molto buona» (Genesi 1, 31). La reciprocità che Dio stabilisce con l’opera delle sue mani riflette, insomma, il rapporto ludico che intercorre tra Dio e la Sapienza. Il discorso sarebbe lungo: basti solo dire che, nonostante la struttura sociale di Israele fosse fortemente caratterizzata in senso patriarcale e nonostante ciò abbia spesso imposto alle donne anche pesanti restrizioni, nella letteratura biblica emergono invece, sia pure in modo carsico, attestazioni del ruolo decisivo giocato dalle donne nello sviluppo della storia di Dio con il suo popolo nonché riflessioni, spunti, allusioni che rivelano un immaginario religioso in cui la presenza femminile gioca un ruolo di primo piano. Al riguardo, gli scritti sapienziali sono una vera e propria miniera.Il termine italiano “sapienza”, come quello greco sofia, possono ingenerare un fraintendimento rispetto a quello ebraico hochmah, che ha una storia molto antica e rimanda a una qualità superiore che alcune persone hanno e altre no, l’aspirazione presente nelle radici più antiche della nostra cultura a saper orientare i nostri atteggiamenti di fondo nel mestiere di vivere. La sapienza non si insegna, ma questo non significa che la sapienza non si impari: il significato più arcaico di hakam è l’uomo abile, l’artigiano, in particolare, l’orefice, colui che conosce bene un mestiere.
La sapienza biblica tradizionale non ha quindi la pretesa di essere frutto di una rivelazione divina, per questo è stata definita una sapienza laica. E i libri sapienziali non contengono racconti mitici e nemmeno sono opere filosofiche o speculative, come quelle dei grandi pensatori greci. Sono un distillato di sapere pratico e di riflessioni sulla realtà vissuta, non vi si trovano discorsi edificanti e tanto meno devote esortazioni. La sapienza non trasmette neppure un facile moralismo religioso, ma piuttosto richiede, e in termini molto esigenti dal punto di vista umano, di saper riflettere e prendere posizione nei confronti di insegnamenti a volte perfino tra loro contraddittori. Per questo il valore della sapienza è inestimabile.
Un esempio eloquente
La divisione del libro dei Proverbi in sette sezioni potrebbe richiamare la dichiarazione che apre il c. 9 «La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue sette colonne» e alludere così al fatto che, chi legge i proverbi e i discorsi di ammonimento contenuti nel libro, accoglie l’invito della sapienza a farsi ospitare nella sua casa.
 Molto ci sarebbe da dire su indubbi tratti di misoginia presenti nel testo, ma non bisogna neppure dimenticare che, più ancora che nel testo, l’androcentrismo è stata una delle dominanti della storia della sua interpretazione. Da qui la forte diffidenza nei confronti soprattutto di un brano come l’elogio della donna forte (31, 10-31) che appariva come una vera e propria esaltazione della moglie ideale che vive solo in funzione del suo uomo e dei suoi figli.
Molto ci sarebbe da dire su indubbi tratti di misoginia presenti nel testo, ma non bisogna neppure dimenticare che, più ancora che nel testo, l’androcentrismo è stata una delle dominanti della storia della sua interpretazione. Da qui la forte diffidenza nei confronti soprattutto di un brano come l’elogio della donna forte (31, 10-31) che appariva come una vera e propria esaltazione della moglie ideale che vive solo in funzione del suo uomo e dei suoi figli.
 Il capitolo è intitolato Parole di Lemuèl, re di Massa, «che egli apprese da sua madre» e si deve quindi supporre che si tratti di insegnamenti che la madre di un re trasmette a suo figlio. Non stupisce che per lungo tempo anche il ritratto della donna forte che suggella il libro sia stato interpretato come una raccolta di suggerimenti della madre al futuro re perché scelga una sposa appropriata.
Il capitolo è intitolato Parole di Lemuèl, re di Massa, «che egli apprese da sua madre» e si deve quindi supporre che si tratti di insegnamenti che la madre di un re trasmette a suo figlio. Non stupisce che per lungo tempo anche il ritratto della donna forte che suggella il libro sia stato interpretato come una raccolta di suggerimenti della madre al futuro re perché scelga una sposa appropriata.
 A ben guardare, però, il poemetto si chiude chiamando in causa direttamente una tra le “molte figlie” e questo lascia lecitamente supporre che, se la prima parte del discorso della madre è rivolta al futuro re, l’ultima parte è invece l’elogio di una figlia che «ha compiuto cose eccellenti», a cui bisogna essere «riconoscenti per il frutto delle sue mani» e di cui va tessuta lode pubblica «alle porte della città».
A ben guardare, però, il poemetto si chiude chiamando in causa direttamente una tra le “molte figlie” e questo lascia lecitamente supporre che, se la prima parte del discorso della madre è rivolta al futuro re, l’ultima parte è invece l’elogio di una figlia che «ha compiuto cose eccellenti», a cui bisogna essere «riconoscenti per il frutto delle sue mani» e di cui va tessuta lode pubblica «alle porte della città». Ben lungi dall’essere l’elogio di una futura nuora da parte di una suocera illustre, dunque, il brano contiene gli insegnamenti funzionali all’ideale di educazione del principe Lemuèl e di una principessa, di cui non si dice il nome, ma che viene interpellata direttamente.
Ben lungi dall’essere l’elogio di una futura nuora da parte di una suocera illustre, dunque, il brano contiene gli insegnamenti funzionali all’ideale di educazione del principe Lemuèl e di una principessa, di cui non si dice il nome, ma che viene interpellata direttamente.
 Studi archeologici e storico-sociali hanno poi messo in luce che, all’epoca, le donne erano proprietarie terriere ed erano attive in tutti gli ambiti menzionati nel nostro testo, dal commercio alla produzione e alla vendita dei tessuti di lusso, ben lontane cioè dall’ideale casalingo che ne faceva le regine del focolare. Per non dire, infine, che i tessuti preziosi delle sue vesti (v. 22), il lino e la porpora, sono gli stessi che arredano l’arca che guida il popolo nel deserto o che vestono i sacerdoti del Tempio e che oltre a lei (v. 25), in tutta la Bibbia solo Yahweh veste di forza (Salmo 93, 1).
Studi archeologici e storico-sociali hanno poi messo in luce che, all’epoca, le donne erano proprietarie terriere ed erano attive in tutti gli ambiti menzionati nel nostro testo, dal commercio alla produzione e alla vendita dei tessuti di lusso, ben lontane cioè dall’ideale casalingo che ne faceva le regine del focolare. Per non dire, infine, che i tessuti preziosi delle sue vesti (v. 22), il lino e la porpora, sono gli stessi che arredano l’arca che guida il popolo nel deserto o che vestono i sacerdoti del Tempio e che oltre a lei (v. 25), in tutta la Bibbia solo Yahweh veste di forza (Salmo 93, 1).Descritta dunque con tratti caratteristici dell’epoca, la donna forte con cui l’autore del libro dei Proverbi suggella il suo scritto, è Donna-Sapienza, la personificazione della Sapienza di Dio. A lei deve legarsi il re, come mostra la straordinaria preghiera per ottenere la sapienza che, non a caso, viene attribuita a Salomone (Sapienza 9, 1-18). Non è la casalinga, ma colei che, costruita la sua casa, «ha imbandito la sua tavola. Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città: “Chi è inesperto venga qui!”. A chi è privo di senno ella dice: “Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. Abbandonate l’inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell’intelligenza” (Proverbi 9, 3-6).
I proverbi
- Una donna forte chi potrà trovarla?
 Ben superiore alle perle è il suo valore.
Ben superiore alle perle è il suo valore.
 In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto.
In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto.
 Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita.
Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita.
 Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani.
Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani.
 È simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste.
È simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste.
 Si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia
Si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia
 e dà ordini alle sue domestiche.
e dà ordini alle sue domestiche.
 Pensa a un campo e lo acquista
Pensa a un campo e lo acquista
 e con il frutto delle sue mani pianta una vigna.
e con il frutto delle sue mani pianta una vigna.
 Si cinge forte i fianchi e rafforza le sue braccia.
Si cinge forte i fianchi e rafforza le sue braccia.
 È soddisfatta, perché i suoi affari vanno bene;
È soddisfatta, perché i suoi affari vanno bene;
 neppure di notte si spegne la sua lampada.
neppure di notte si spegne la sua lampada.
 Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso.
Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso.
 Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero.
Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero.
 Non teme la neve per la sua famiglia,
Non teme la neve per la sua famiglia,
 perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito.
perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito.
 Si è procurata delle coperte, di lino e di porpora sono le sue vesti.
Si è procurata delle coperte, di lino e di porpora sono le sue vesti.
 Suo marito è stimato alle porte della città,
Suo marito è stimato alle porte della città,
 quando siede in giudizio con gli anziani del luogo.
quando siede in giudizio con gli anziani del luogo.
 Confeziona tuniche e le vende e fornisce cinture al mercante.
Confeziona tuniche e le vende e fornisce cinture al mercante.
 Forza e decoro sono il suo vestito
Forza e decoro sono il suo vestito
 e fiduciosa va incontro all’avvenire.
e fiduciosa va incontro all’avvenire.
 Apre la bocca con saggezza
Apre la bocca con saggezza
 e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà.
e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà.
 Sorveglia l’andamento della sua casa
Sorveglia l’andamento della sua casa
 e non mangia il pane della pigrizia.
e non mangia il pane della pigrizia.
 Sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti,
Sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti,
 suo marito ne tesse l’elogio:
suo marito ne tesse l’elogio:
 “Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti,
“Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti,
 ma tu le hai superate tutte!”.
ma tu le hai superate tutte!”.
 Illusorio è il fascino e fugace la bellezza,
Illusorio è il fascino e fugace la bellezza,
 ma la donna che teme Dio è da lodare.
ma la donna che teme Dio è da lodare.
 Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani
Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani
 e le sue opere la lodino alle porte della città.
e le sue opere la lodino alle porte della città.
Proverbi 31, 10-31
* Fonte: L’Osservatore Romano - 6 febbraio 2021 (ripresa parziale, senza immagini).
- Una donna forte chi potrà trovarla?
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---UNA NUOVA "COGNAZIONE" (Pd. XV 88-92): LA VIA DI DANTE PER UNA GENEALOGIA "BEATRICE-MENTE" ILLUMINATA.2 marzo 2021, di Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- QUESTIONE FILOLOGICA: ANDROLOGIA O ANTROPOLOGIA?!24 febbraio 2021, di Federico La Sala
-
>LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. -- LA LEZIONE DI DANTE, DI GALILEO GALILEI, E IL "VICISTI, GALILAEE" DI KEPLERO - OGGI (2021).15 febbraio 2021, di Federico La Sala
Tweet
#DANTE2021 A 700 anni dalla #morte di #Dante, ancora non compresi i #due significati (i #duesoli) del "vicisti, #Galilaee". PER #Keplero, come per #Kant, la vittoria di #GalileoGalilei è filosofico-scientifica!
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5061
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5061#Mathematics #anthropology #Theology #philosophy In #memoria di #GalileoGalilei (nato il #15febbraio 1564), ricordare i #duesoli (#Dante2021) e i #duelibri di #Galilei e che il #logos non è un #logo
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1205
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1205FLS
-
> LA NATURA TEANDRICA DELLA CHIESA E LA NATURA ANTROPOLOGICA DI CRISTO, OGGI. “Virgo et Sacerdos. Idee femminili di sacerdozio tra Ottocento e Novecento”. Intervista a Liviana Gazzetta (di "Letture").6 febbraio 2021, di Federico La Sala
“Virgo et Sacerdos. Idee femminili di sacerdozio tra Ottocento e Novecento” di Liviana Gazzetta
Intervista *
Dott.ssa Liviana Gazzetta, Lei è autrice del libro Virgo et Sacerdos. Idee femminili di sacerdozio tra Ottocento e Novecento pubblicato dalle Edizioni di Storia e Letteratura: in che modo, a cavallo tra ’800 e ’900, soprattutto in Francia e Italia, si pose il problema del ruolo femminile nel sacerdozio cattolico?
È noto che la questione del diaconato e del sacerdozio femminile si affaccia con chiarezza nella Chiesa della fase conciliare e, ancor più, postconciliare, a partire quindi dagli anni ’60 del XX secolo. Ciò che però emerge da questa ricerca è che anche prima della fase conciliare si è espresso un desiderio, o meglio, un’aspirazione femminile al sacerdozio: è nella devozione alla Vergine Sacerdote (Virgo sacerdos), che si sviluppò in particolare tra le figlie del Cuore di Gesù a cavallo tra ‘800 e ‘900, che si può mostrare l’esistenza di una domanda latente di sacerdozio. Si tratta di una via che definirei di natura cultuale e mariologica al sacerdozio femminile, dove l’aspirazione era espressa sotto il segno della vocazione, e non della rivendicazione, della dedizione e non della pretesa di spazi. E fu questa via a preoccupare la Chiesa ben prima che negli anni ’60 venisse ad essere ufficialmente sollevata la questione dell’ordinazione femminile.
Come si sviluppò la devozione alla «Vierge Prêtre?
La devozione alla «Vierge Prêtre» o «Virgo sacerdos» si sviluppò in special modo (ma non solo) nella congregazione delle figlie del Cuore di Gesù, fondata nel 1872 da Marie Deluil-Martiny e approvata nel 1902 da Leone XIII: un ordine contemplativo, nato all’incontro di complesse matrici spirituali, centrate sull’oblazione eucaristica, la riparazione dei peccati e l’imitazione di Maria al Calvario o -per usare le parole della stessa fondatrice- sullo spirito eucaristico, lo spirito di vittima, lo spirito sacerdotale.
Il titolo di «Virgo Sacerdos» era entrato apertamente nella liturgia cattolica a partire dal 1709, quando presso il seminario di Saint Sulpice si era cominciato ad utilizzare con regolarità, per la festa della Presentazione al tempio, un inno dei Vespri che lo conteneva. Tale festa era qui diventata la celebrazione per eccellenza della spiritualità sacerdotale e della devozione a Maria, costituendo anche il momento della rinnovazione pubblica della professione per i membri della congregazione di San Sulpizio, oltre che festa del seminario. Se nei secoli precedenti Maria era stata al centro soprattutto di una riflessione teologica e filosofica, ora la via al sacerdozio mariano era tutta spirituale e in alcuni casi misticheggiante: Maria era il modello del prete concepito come culmine delle virtù religiose, sempre più interpretata come riferimento contro ogni forma di degenerazione nella vita del clero.
La spiritualità e la devozione alla «Virgo Sacerdos» o «Vierge Prêtre» fu dunque ereditata dalla scuola francese del ‘700. All’interno di una più complessa elaborazione spirituale, l’aspettativa della madre Maria di Gesù (questo il nome assunto in religione dalla Deluil Martiny) era che si realizzasse il tempo in cui i preti avrebbero adempiuto pienamente il loro ministero, nella purezza e nella perfezione di vita che le sembrava mancare attorno a sé; le sue ‘figlie’ dovevano essere come delle vittime che, in analogia a Maria ai piedi della croce e accanto al ‘discepolo amato’, sostenessero i sacerdoti nella loro missione e si immolassero per riparare l’indegnità dei membri del clero.
Nel 1906 le religiose chiesero di poter usare l’appellativo di «Vierge Prêtre» nei riti del proprio istituto e Pio X accolse la richiesta, facendo stendere una preghiera che fu poi arricchita di indulgenze; lo stesso papa concesse nel 1910 che nelle cappelle dell’istituto si potesse aggiungere alle litanie mariane l’invocazione «Virgo Sacerdos, ora pro nobis». Le religiose fecero allora produrre anche delle immagini collegate alla devozione: immagini che raffiguravano la Vergine, abbigliata in vesti sacerdotali, che al di sopra del globo terrestre schiacciava il serpente con le braccia alzate verso il cielo.
Come si è articolata storicamente la riflessione teologica sul tema del sacerdozio di Maria?
Il tema del sacerdozio di Maria percorre un po’ tutta la storia della cristianità. In origine il titolo di «sacerdos» attribuito alla Vergine è attestato nell’ambito della tradizione omiletica: nel contesto, cioè, di un genere letterario, sviluppatosi nella cultura greca tra VII e IX secolo, in cui si usavano metafore e immagini che stabilivano un rapporto tra Maria e l’Eucarestia, o che riconoscevano un ruolo attivo della Madonna nel donare il pane di vita grazie al suo ruolo materno, anche se va detto che gli omelisti usavano idee e suggestioni che difficilmente possono essere ricondotte a concetti: alla base di questa tradizione, ad esempio, stava l’autorità dello Pseudo Epifanio, che attribuiva a Maria il valore di tavola, di altare e di prete.
Nel Medioevo l’idea del sacerdozio della Vergine conosce un significativo sviluppo sul piano teorico. Una delle vie filosofico-teologiche attraverso cui tra Alto e Basso Medioevo è possibile parlare di sacerdozio mariano è costituita dalla diffusione delle idee dello Pseudo Dionigi. Poiché nella prospettiva sincretistico-neoplatonica di questo autore (e dei molti suoi seguaci) la relazione tra i diversi ordini di realtà si pone in chiave gerarchica, ciò induce inevitabilmente a collocare la Vergine in una posizione di primato nei confronti delle gerarchie della Chiesa (e non di rado anche di quelle angeliche). Chi contribuisce in modo determinante in questa direzione è l’autore come lo Pseudo Alberto Magno: il suo Mariale super missus est in più punti sostiene che la pienezza conferita nell’ordinazione sacerdotale appartiene anche a Maria, anche se non la riceve con apposito sacramento, e lascia intendere che non esiste nessuna motivazione - neppure l’inferiorità indiscussa del sesso femminile - per fondare la sua esclusione dal sacerdozio.
In età moderna, oltre e più che la via dottrinale, si è profilata una ‘via al sacerdozio’ della Vergine di natura più propriamente devozionale e spirituale. Questa declinazione si manifesta in un sentimento del legame speciale tra il prete e la Vergine, in un ricorso particolare del sacerdote alla mediazione di Maria nelle funzioni sacramentali: quasi una somiglianza, un’imitazione particolare della Madonna ad opera del prete, che avvia la tradizione delle messe offerte secondo le intenzioni di Maria e la pratica della rinnovazione delle promesse sacerdotali in concomitanza con le feste mariane. Soprattutto all’interno della scuola francese (in primis il seminario di san Sulpizio) si sostiene che Maria ha una sovranità sugli apostoli che non le deriva tanto da una precisa giurisdizione, sempre ritenuta sconveniente al sesso femminile, ma dalla pienezza dello spirito e della grazia: ciò che la rende, dopo l’Ascensione, non il capo dotato di autorità sulla Chiesa, ma il cuore della comunità dei credenti.
Quali vicende segnarono l’indagine inquisitoriale cui fu sottoposto l’ordine delle Figlie del Cuore di Gesù della Deluil Martiny?
Dimostrando di temere soprattutto le conseguenze della devozione sul piano pastorale, per l’associazione tra figura femminile e titolo di sacerdote che essa comportava, il Sant’Uffizio impose una drastica censura alle figlie del Cuore di Gesù e alle loro iniziative. A partire dal 1912 l’ordine venne sottoposto a più riprese all’esame del Sant’Uffizio, che con tre interventi successivi nel 1913, 1916 e 1927 vietò dapprima le immagini, quindi le forme devozionali alla Vergine sacerdotale che vi erano state sviluppate; nel 1927 una lettera del cardinal Merry Del Val, segretario della Suprema, precisò che tale devozione non era approvata e non poteva essere propagata in nessuna forma. Nonostante non riguardassero la dottrina della partecipazione di Maria al sacerdozio in sé, tali interventi hanno quasi oscurato un’intera tradizione teologico-spirituale sul tema del sacerdozio della Vergine, che per secoli ha attraversato cristianesimo e il cattolicesimo occidentali.
Il Sant’Uffizio affermò che, se da un punto di vista dottrinale non si poteva non attribuire a Maria il titolo di mediatrice nella salvezza, e quindi di sacerdote, non era però conveniente farne uso, soprattutto se a farlo erano delle donne. Le conseguenze della devozione considerate più riprovevoli erano quelle che stabilivano un’associazione tra figura femminile e sacerdozio: perché cioè con il culto alla «Vierge Prêtre» le religiose potevano, da una parte, prefigurarsi quasi come delle sacerdotesse (e magari accreditare queste convinzioni presso i fedeli); dall’altra, proporsi come riparatrici degli errori del clero.
Dopo la bufera d’inizio secolo, nel 1989 la famiglia religiosa ha visto concludersi il processo di canonizzazione della fondatrice, proclamata beata da papa Giovanni Paolo II.
In che modo la vicenda del culto alla Virgo sacerdos offre spunti per il dibattito attuale intorno al divieto alle donne all’esercizio del ministero sacro?
Sul piano spirituale emerge il circuito virtuoso che già tra ‘800 e ‘900 poteva crearsi, in determinati settori del cattolicesimo femminile, tra una soggettività consapevole di sé e il modello della Vergine corredentrice: un circuito che può ‘ispirare’ ancor più oggi, a fronte di una crescita esponenziale dell’autonomia e dell’autorevolezza femminile nella vita ecclesiale.
Sul piano storico la vicenda mostra un protagonismo femminile fin qui insospettato, connesso sia all’esigenza di un maggior ruolo nell’accesso al sacro, sia alla richiesta di una profonda riforma ecclesiale. In essa emerge quanto diffusa e radicata fosse la preoccupazione per l’inadeguatezza del clero maschile tra le nuove fondazioni femminili nel primo ‘900, mentre nei procedimenti inquisitoriali emerge un altrettanto diffuso fastidio nei loro confronti. Sul piano storiografico la ricerca indica che la cosiddetta femminilizzazione del cattolicesimo, che interessa l’età contemporanea, porta con sé un’ambivalenza e una conflittualità strutturali. Se dalle spinte per un maggiore coinvolgimento femminile contro i ‘nemici’ della Chiesa si passava all’idea di una comunanza d’azione delle religiose col clero, si usciva dai confini prescritti alle donne e si poteva incorrere nell’interdizione; ed evidentemente lo sconfinamento risultava tanto più grave in quanto veicolato attraverso l’identificazione con Maria corredentrice. In sostanza si evidenzia come all’interno della Chiesa i rapporti tra i sessi non siano meno conflittuali che negli altri ambiti della società, e ciò nonostante la Chiesa si appelli ricorrentemente al contributo o al ‘genio’ femminile.
Nei fenomeni qui ricostruiti, infine, si comprende come la domanda femminile di sacerdozio possa espressa sotto il segno della vocazione e non della rivendicazione di un diritto, della dedizione di sé e non della protesta: un’offerta cui la Chiesa non riesce ancora a rispondere anche perché (si pensi che alla dichiarazione Inter insigniores) si confondono di fatto questi due piani.
Liviana Gazzetta è dottore di ricerca in Storia sociale europea (presso l’Università Cà Foscari di Venezia), socia del Coordinamento Teologhe Italiane e presidente dell’Istituto per la storia del Risorgimento di Padova. I suoi interessi di studio e la sua attività di ricerca si sono sviluppati nell’ambito della storia dei movimenti delle donne in età contemporanea; su questi temi ha pubblicato molti articoli e alcune monografie, l’ultima delle quali è Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia 1865-1925, Roma 2018.
* Fonte: Letture.org.
-
> LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- «Ambizioncella muliebre».Per superare i blocchi alla discussione sul titolo sacerdotale mariano (di Daniele Menozzi, storico - "Il Regno").6 febbraio 2021, di Federico La Sala
«Ambizioncella muliebre»: sul titolo sacerdotale mariano
di Daniele Menozzi, Storico (Il Regno, Re-blog, 2 Febbraio 2021)
- [Foto]Madonna dei Palafrenieri
La proclamazione del dogma dell’Immacolata concezione nel 1854 è stata interpretata come un «evento strutturante» nella storia del cattolicesimo contemporaneo. Ha in effetti avuto diverse conseguenze di rilievo. A esse si può ascrivere anche l’avvio della discussione, non ancora conclusa all’interno della Chiesa, sul sacerdozio femminile. Claude Langlois - il noto studioso della femminilizzazione del cattolicesimo ottocentesco, che per primo ha colto il nesso tra la valorizzazione della figura di Maria derivante dalla dichiarazione del suo concepimento senza peccato e la manifestazione del desiderio femminile per il sacerdozio - ha poi mostrato come l’aspirazione al ministero, chiaramente formulata da Teresa di Lisieux nel 1896, fosse condivisa anche da altre personalità del panorama religioso di fine Ottocento. Tra queste indicava Marie Deluil-Martiny, nata nel 1841 a Marsiglia da una famiglia aristocratica, fondatrice nel 1872 della congregazione delle Figlie del Sacro Cuore a Berchem presso Anversa, uccisa nel 1884 da un anarchico che era stato suo giardiniere e beatificata nel 1989 da Giovanni Paolo II.
Avvio della discussione sul sacerdozio femminile
L’attenzione della suora francese al tema è ora analizzata da Liviana Gazzetta, autrice di diverse opere sulla storia del movimento cattolico femminile. Il volume Virgo et sacerdos. Idee di sacerdozio femminile tra Ottocento e Novecento (Edizioni di storia e letteratura, Roma 2020), pur non potendo contare sull’insieme degli scritti di Deluil-Martiny, ancora inaccessibili per il processo di canonizzazione, si è potuto valere, oltre che di quanto già pubblicato, della serie documentaria «Devotiones variae» depositata presso l’Archivio della Congregazione per la dottrina della fede (Virgo et sacerdos. Idee di sacerdozio femminile tra Ottocento e Novecento, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2020). L’opera si presenta, più che sotto forma di una ricostruzione organica, come una serie di affondi successivi che sviluppano e approfondiscono alcune ipotesi di lavoro. Nonostante l’apparente frammentarietà e qualche ripetizione, il libro non solo risulta di straordinario interesse per una questione, il sacerdozio femminile, di bruciante attualità ecclesiale, ma anche del tutto persuasivo nei suoi, per quanto provvisori, esiti conoscitivi.
Il titolo di Virgo sacerdos.
Filo conduttore della ricostruzione è la declinazione tra Ottocento e Novecento del richiamo a Maria col titolo di Virgo sacerdos. Il sintagma, di origine patristica, trova nel Medioevo una duratura sistemazione dottrinale sulla base della pregiudiziale premessa dell’impedimentum sexus per l’accesso al sacerdozio. L’appellativo comporta l’attribuzione alla Vergine non del carattere sacerdotale, che appartiene esclusivamente a chi ha ricevuto l’ordine e detiene quindi il potere di sacrificio; bensì dello spirito sacerdotale. Maria possiede, in grado eminente rispetto a ogni creatura, questo attributo che condivide peraltro con tutti i battezzati in quanto comporta soltanto la capacità di rendersi vittime, ostie immolate per la salvezza del mondo.
In questa chiave la locuzione entra nella liturgia fin dal XVIII secolo, ma nella seconda metà dell’Ottocento diverse opere di ecclesiastici attivi nel prorompente movimento mariano inseriscono la distinzione in una più ampia interpretazione teologica della figura della Vergine. Gli episodi centrali della sua vita - generazione di Cristo, purificazione al Tempio, presenza sotto la croce - sono letti come una compartecipazione all’offerta al Padre della vittima divina che la portano ad assumere, sia pure in grado diverso, i titoli stessi del Figlio: mediatrice, corredentrice e sacerdote. Questa letteratura alimenta la spiritualità di Deluil-Martiny e del gruppo riunito attorno a lei, in particolare di Elise Le Vassor de Sorval, che, succedendole nella direzione della congregazione, la sviluppa con notevolissime capacità organizzative e politiche.
Maria con la dalmatica
Si tratta di una ricezione creativa che si fonda sulla comune adesione all’egemone cultura intransigente. Ne è infatti punto di partenza la prospettiva di riconquista cristiana di una società moderna che si è sottratta alla direzione ecclesiastica. Di fronte alla costatazione dell’inadeguatezza del clero nella lotta in corso per la restaurazione della cristianità, si definisce un carisma specifico dell’istituto religioso: l’offerta vittimale in riparazione degli errori e dell’insufficienza dei sacerdoti. Il riferimento alla Virgo sacerdos ne è la sintesi spirituale, simbolica e devozionale. Lo mostrano i testi delle preghiere in uso nella congregazione; le immagini devozionali in cui Maria, in piedi sul globo, indossa sopra la tunica la dalmatica mentre schiaccia la testa del serpente (all’epoca generalmente identificato con la rivoluzione anticristiana); l’abito delle suore che ripropone la pianeta dei preti.
Aspirazione a un ministero sacerdotale
Nel discorso pubblico delle appartenenti alla congregazione la generale interpretazione della figura di Maria come paradigma esemplare per stabilire il ruolo femminile nella Chiesa si applica anche alla funzione sacerdotale attribuita alla Vergine. Per questa via esse esprimono l’esigenza di un protagonismo ecclesiale della donna che ne affermi la parità senza metterne in questione la diversità. Ma i loro documenti privati lasciano chiaramente trasparire qualcosa di più: l’aspirazione all’esercizio di un ministero sacerdotale che le donne saprebbero svolgere in modo più degno e più adeguato ai bisogni dei tempi. Pur senza una specifica denuncia, il Sant’Uffizio - che aveva preso in esame una prima volta tra il 1838 e il 1842 il tema della Virgo sacerdos, senza assumere in merito alcuna decisione - avverte nelle pratiche dell’istituto un pericolo per l’ortodossia.
Da Roma concessioni poi revocate
Inizialmente Roma era stata larga di concessioni. Dopo il riconoscimento di Leone XIII, nel 1906 la congregazione aveva ottenuto da Pio X di inserire una menzione alla Vierge prêtre nelle preghiere della congregazione, ben presto arricchite di indulgenze. Poi nel 1910 il pontefice aveva concesso che nelle litanie mariane le religiose aggiungessero l’invocazione Virgo sacerdos, ora pro nobis. Provvedimenti assai significativi, perché in quegli stessi anni papa Sarto taglia corto sulle istanze di emancipazione femminile presenti nella comunità ecclesiale, escludendo le donne dal canto sacro e imponendo che non prendano la parola nelle assemblee del movimento cattolico. Ma il Sant’Uffizio, nel 1913 - ma renderà pubblica la decisione tre anni dopo - revoca tutte le precedenti concessioni e vieta l’uso dell’immagine devozionale che aveva avuto anche una traduzione pittorica in un’opera di Silverio Copperoni.
Le preoccupazioni del consultore
Opportunamente Gazzetta pubblica in appendice al libro il parere del consultore, il domenicano Giovanni Lottini, che spiega le motivazioni della decisione. Pur dicendosi sicuro che le religiose non abbiano la pretesa di proclamarsi sacerdotesse, afferma che, qualora non siano per tempo fermate, «mosse da una certa ambizioncella muliebre, queste donne giungeranno a darsi detto titolo ed a chiedere e forse con le loro femminee arti a strappare anche qualche approvazione». Il riconoscimento dell’abilità di chi governa la congregazione nel promuoverne il carisma sul piano istituzionale si traduce nell’individuazione delle misure per bloccarne le iniziative. Il domenicano sostiene quindi che, per quanto storicamente fondato e dottrinalmente irreprensibile, il riferimento alla Virgo sacerdos deve essere interdetto dalle pratiche religiose. Sottolinea in particolare che negli istituti femminili l’infima cultura teologica delle donne - evidentemente ritenute incapaci di distinguere tra ordine e spirito sacerdotale - potrebbe facilmente indurre a costruire su questa devozione pretese al ministero. Suggerisce perciò che la venerazione a Maria venga promossa sotto il titolo di madre, anziché sotto il titolo di sacerdote.
Una rimozione definitiva
Nel 1927 il segretario del Sant’Uffizio, cardinal Merry del Val, in risposta a una domanda apparsa su La Palestra del clero, conferma in una pubblica lettera che attorno al titolo sacerdotale mariano occorre mantenere completo silenzio. Poco dopo una revisione della costituzione delle Figlie del Sacro Cuore ne formalizza la rimozione dalla vita interna dell’istituto. In realtà collegamenti con il tema della Virgo sacerdos riemergono in comunità religiose - in primo luogo i Figli del Cuore sacerdotale di Gesù, oggi noti come padri Venturini dal nome del fondatore - e in pii sodalizi, come le Figlie della Regina degli angeli fondata da Elena da Persico. In effetti la loro spiritualità si alimenta alle stesse fonti dell’istituto franco-belga. In questi casi il richiamo all’imitazione di Maria consente di superare la visione di un mero ruolo oblativo delle donne nella Chiesa, ma non si traduce, almeno a livello delle testimonianze a oggi accessibili, in manifestazioni di aspirazioni ad un ruolo ministeriale.
Gli interventi dei papi nel post-concilio
Nel post-concilio, al momento in cui affiora nuovamente e con più forza, sulla spinta del rinnovamento ecclesiale, la questione del sacerdozio femminile, gli interventi del papato - come mostrano l’esortazione apostolica Marialis cultus emanata da Paolo VI nel 1974 e la lettera apostolica Mulieris dignitatem pubblicata da Giovanni Paolo II nel 1988 - lo hanno nuovamente collegato al ruolo idealtipico di Maria per la definizione della posizione ecclesiale della donna. Il riferimento mariano è stato però utilizzato per ribadire l’impedimentum sexus al sacerdozio femminile. La vicenda della congregazione delle Figlie del Sacro Cuore, oggi restituita alla memoria ecclesiale dalla ricerca storica, per quanto ancora bisognosa di approfondimenti, fornisce un prezioso aiuto per contestualizzare, e quindi relativizzare, questi interventi papali.
Per superare i blocchi alla discussione
Non solo perché essi appaiono ancorati a una mariologia riduttiva rispetto a una tradizione più ricca e articolata, che era stata rimossa dalla vita ecclesiale all’inizio del Novecento in seguito agli evidenti condizionamenti storici che caratterizzavano la visione dei rapporti di genere dei membri del Sant’Uffizio. Soprattutto perché i documenti papali rivelano i limiti di una decisione determinata da un clima ecclesiale in cui si riteneva necessario ribadire la natura teandrica della Chiesa in contrapposizione alla rivendicazione del diritto delle donne ad accedere al ministero. Il contesto ha fatto dimenticare che l’aspirazione al sacerdozio femminile non si era storicamente espressa in termini giuridici e rivendicativi; ma, fondata sull’adeguamento alle necessità dei tempi del tradizionale richiamo al carattere mariotipico della presenza femminile nella Chiesa, si era sviluppata su un terreno vocazionale, spirituale e cultuale. Ricollocare su questa piano la discussione, può aiutarne a superarne i blocchi.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE --- LA "NUOVA ALLEANZA" DI "MARIA E GIUSEPPE" E IL "MESSAGGIO EVANGELICO" DA RIPENSARE.27 gennaio 2021, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO E LA "NUOVA ALLEANZA" DI "MARIA E GIUSEPPE". EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA.... *
- ARTE E "MITOLOGIA GRECO-ROMANA". Trittico di Mérode: L’Annunciazione (1427).
La biblista francese. Pelletier: «Donne, Chiesa polifonica»
Per la studiosa occorre «ritrovare una struttura consonante a quanto presenta Paolo, cioè la Chiesa come corpo, dove l’istituzione si fonda su doni particolari assegnati agli uni e agli altri»
di Lorenzo Fazzini (Avvenire, mercoledì 27 gennaio 2021)
- [Foto] La biblista francese Anne-Marie Pelletier
Anne-Marie Pelletier non è solo una sagace esegeta e una brillante docente universitaria. Già Premio Ratzinger per la teologia, l’intellettuale francese diventa anche una paladina delle donne, dentro e fuori la Chiesa, quando affronta il tema dell’odierna condizione femminile.
 «Un club di uomini anziani, vestiti in modo strano, che dicono alla gente come si deve comportarsi a letto». Con questa sarcastica definizione Timothy Radcliffe illustra come, a suo dire, la gente vede la Chiesa. Perché non viene invece riconosciuto il grande apporto delle donne alla vita della Chiesa?
«Un club di uomini anziani, vestiti in modo strano, che dicono alla gente come si deve comportarsi a letto». Con questa sarcastica definizione Timothy Radcliffe illustra come, a suo dire, la gente vede la Chiesa. Perché non viene invece riconosciuto il grande apporto delle donne alla vita della Chiesa?
 Le parole di Radcliffe sono impietose ma esprimono bene la realtà. La visibilità della Chiesa cattolica resta incontestabilmente quella della sua gerarchia, esclusivamente composta da uomini. E questa visione non è un effetto ottico.
Le parole di Radcliffe sono impietose ma esprimono bene la realtà. La visibilità della Chiesa cattolica resta incontestabilmente quella della sua gerarchia, esclusivamente composta da uomini. E questa visione non è un effetto ottico.
 È sufficiente aprire la porta di una chiesa durante una celebrazione per constatare che il presbiterio è uno spazio che appartiene agli uomini, in via maggioritaria se non esclusiva. Inoltre, l’autorità viene collegata al sacerdozio ministeriale. E per molti questo tipo di sacerdozio resta la chiave di volta del corpo ecclesiale. Anzi, passa l’idea che ne costituisca l’espressione suprema.
È sufficiente aprire la porta di una chiesa durante una celebrazione per constatare che il presbiterio è uno spazio che appartiene agli uomini, in via maggioritaria se non esclusiva. Inoltre, l’autorità viene collegata al sacerdozio ministeriale. E per molti questo tipo di sacerdozio resta la chiave di volta del corpo ecclesiale. Anzi, passa l’idea che ne costituisca l’espressione suprema.
 Da qui le reiterate denunce di clericalismo da parte di papa Francesco.
Da qui le reiterate denunce di clericalismo da parte di papa Francesco.Cosa va perso in questa visione maschio-centrica?
Il dramma è che la verità della Chiesa viene nascosta. Infatti, la Chiesa non è innanzitutto la sua gerarchia, ma prima di tutto un corpo, che questa gerarchia ha la funzione di servire. Questo corpo è composto da uomini e donne che, nei loro diversi stati di vita, si riconoscono convocati dalla parola di Cristo. Questo popolo di battezzati dona carne e presenza al Vangelo nel mondo, spesso silenziosamente ma in modo autentico. E bisogna ammettere che le donne, in questo corpo, hanno un posto eminente, anzi dominante perché, in molti luoghi e circostanze, sono loro il volto e la mano della Chiesa per i nostri contemporanei. Io perdo un po’ la pazienza quando sento ripetere che ’bisogna fare spazio alle donne’ quando, invece, la prima cosa da fare è riconoscere il posto che esse occupano nelle parrocchie, nella catechesi, nelle missioni. Senza di loro, la Chiesa sarebbe già sparita.
Altrove lei ha sottolineato come l’attenzione della Chiesa con Francesco verso le donne non sia una questione nuova: da 50 anni i Papi prestano un’attenzione crescente al mondo femminile con diversi documenti. Allora è la Chiesa che ha fallito, rispetto all’uguaglianza uomo-donna, se ancora oggi viene percepita come maschile?
Si tratta di un dato impressionante. Dagli anni Sessanta il magistero ha prestato alle donne un’attenzione inedita. Non si era mai visto un elogio tale della donna da parte delle autorità della Chiesa. Eppure, nella Chiesa cattolica, le donne - in gran numero - hanno continuato a sentirsi emarginate, vedendosi assegnate a posti secondari, trattate con accondiscendenza, talvolta disprezzate da un mondo clericale che si arroga ogni decisione. Al punto da far sorgere l’opinione che molte poche cose sarebbero potute cambiare. Il problema di fondo non è semplicemente parlare delle donne, né parlare alle donne, ma lasciarle esistere, farle parlare a nome proprio nella Chiesa, far sì che siano esse a giudicare i problemi della vita e le questioni della fede, di cui hanno esperienza tanto quanto gli uomini.
In un suo testo su ’Vita e Pensiero’ lei scrive: «Il futuro dell’istituzione ecclesiale è intrinsecamente legato, nel cattolicesimo, a una riflessione polifonica ovvero alla condivisione della ricerca della verità, sempre più grande di quanto siamo capaci di cogliere». Può essere una riforma solo ’intellettuale’ sufficiente per far progredire il posto delle donne nella Chiesa? Oppure serve anche una riforma strutturale?
Per me è chiaro che una vera riforma della Chiesa deve incarnarsi nelle strutture della sua vita e nell’organigramma della sua governance. In questo senso non bastano tante belle parole. Il punto focale è che noi, uomini e donne, ci troviamo insieme nella responsabilità verso il Vangelo e nella missione della Chiesa. Rispetto al motu proprio recente, esso ritorna su un testo del 1972 che apriva il lettorato e il servizio di accolitato ai laici, a condizione che fossero uomini: in questo caso il magistero permette di metter fine ad un’aberrazione che squalifica la Chiesa. Resta il fatto che sarebbe troppo poco cercare solo di ridistribuire i poteri in una struttura immutata. Sono convinta che siamo in un momento cruciale in cui l’istituzione ecclesiale deve reinventarsi. Si deve tornare all’ecclesiologia. Non si significa fossilizzarsi su un’attività astrattamente intellettuale. Anzi, qui c’è la leva per un vero cambiamento di fondo. In questo senso mi piace comprendere la messa in guardia di papa Francesco di non attenersi alle semplici ’funzioni’. Per questo, mi trovo a disagio quando si pensa che l’accesso al sacerdozio femminile costituirebbe la soluzione della questione. Piuttosto vi constato un modo per ricondurre e confermare l’intero ordine ecclesiale al primato del sacerdozio ministeriale. Invece, penso che si debba uscire da questo schema per ritrovare una struttura consonante a quanto Paolo presenta, cioè la Chiesa come corpo, dove l’istituzione si fonda su doni particolari assegnati agli uni e agli altri per il servizio di tutti. E così la Chiesa si ridisegna come una comunità di battezzati, dove il sacerdozio battesimale, condiviso da tutti, ritorna ad essere il più importante.
Nel suo libro Una comunione di uomini e donne lei ha parlato di un «machismo diventato il marchio di fabbrica della Russia putiniana e dell’America trumpiana». Perché l’avversione all’emancipazione femminile è così forte nel sovranismo?
Le donne oggi si ritrovano ad essere sotto la minaccia di regimi autoritari che proliferano e che hanno un’aria di dejà vu, i cui leader sono esclusivamente uomini. La Russia vive sotto il comando di un dirigente che esalta la virilità brutale, che mostra mediaticamente i suoi muscoli e che porta avanti una repressione impietosa delle opposizioni: la guerra in Cecenia ne é un sinistro esempio. Non è un caso che una delle maggiori oppositrici di questa ideologia sia una donna, il premio Nobel Svetlana Aleksievic, che ha scritto un libro intitolato La guerra non ha volto di donna. -Quanto al populismo di Donald Trump o Jair Bolsonaro e altri, sappiamo bene come questi uomini disprezzino le donne, sia nei loro discorsi che nella loro vita privata. Non dimentichiamo che le più grandi manifestazioni nella storia degli Usa sono state quelle delle donne che denunciavano il machismo insolente di Donald Trump nel 2016.
I movimenti per l’emancipazione delle donne sono un segno dei tempi. Come far sì che diventino positivi per l’intera società e non restino relegati ad essere - per quanto giuste - solo proteste?
É indubbio che i femminismi, per natura, sono movimenti protestatari e militanti. Come stupirsi che, per denunciare le violenze che pesano di esse e gli asservimenti cui sono costrette, le donne scendano in piazza e brandiscano lo stendardo della rivolta? Ma l’obiettivo dovrebbe essere quello di uscire dalla guerra tra sessi, per arrivare ad un’auspicabile stima reciproca, fino a un’alleanza felice per la pienezza degli uni e delle altre. Non è certo quello che intendono quante oggi riesumano i testi di Valérie Solanas, l’intellettuale americana che sognava l’eliminazione del maschio dall’umanità. Un atteggiamento oltranzista, questo, che non opera per il bene delle donne ostaggio della miseria, delle povertà e del machismo che prospera su questo terreno.
*
SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:
- GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!!
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva
FLS
- ARTE E "MITOLOGIA GRECO-ROMANA". Trittico di Mérode: L’Annunciazione (1427).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- IL DIALOGO INTERRELIGIOSO EBREI E CATTOLICI E "LA BIBBIA DELL’AMICIZIA". Dedicato a Elia e ai Neviim/Profeti il secondo volume (di R. Maccioni)..18 gennaio 2021, di Federico La Sala
Dialogo interreligioso.
Ebrei e cristiani: l’amicizia è il segno dei profeti
È dedicato a Elia e ai suoi “colleghi” il secondo volume della “Bibbia dell’amicizia”, un commento del testo comune da parte di studiosi di entrambe le fedi
di Riccardo Maccioni ( Avvenire, domenica 17 gennaio 2021)
- [Foto] Papa Francesco con il rabbino ashkenazita David Lau e il rabbino sefardita Yitzhak Yosef durante una visita allo Heichal Shlomo Center a Gerusalemme il 26 maggio 2014 - Osservatore Romano/Ansa
Le relazioni vere per crescere hanno bisogno di attenzione. E di rispetto. Non basta parlare, occorre imparare l’ascolto, il confronto con opinioni diverse, per così dire il “vocabolario” dell’incontro. Senza per questo rinunciare a quel che si è. Vale nel “privato” di ciascuno così come, fatte le debite differenze, per il dialogo tra le fedi, che spesso matura anche grazie ai rapporti personali, al tu per tu. Uno stile che è tra gli aspetti originali di La Bibbia dell’amicizia di cui è stato da poco pubblicato il secondo volume (San Paolo, pagine 384, euro 30,00) dedicato ai Neviim/Profeti.
Il progetto, avviato due anni fa, rappresenta una novità nel panorama italiano. E non solo. Si tratta di un commento alla Bibbia scritto insieme, a più mani, da ebrei e cristiani. Con lo scopo, non di arrivare a una lettura unificata, ma «di conoscersi meglio e di conoscere meglio le rispettive interpretazioni, accettando che possano essere diverse». La pubblicazione - hanno scritto i due curatori, Giulio Michelini e Marco Cassuto Morselli, (presidente della Federazione delle Amicizie ebraico-cristiane in Italia, già docente di filosofia ebraica e storia dell’ebraismo) - nasce «da due realtà: l’amore per il Davar (la parola di Dio) e l’amicizia tra ebrei e cristiani».
Per la prima volta, spiega padre Michelini ordinario di esegesi neotestamentaria e preside dell’Istituto teologico di Assisi, «si commentano insieme dei libri della tradizione ebraica e poi cristiana in modo così sistematico e rilevante. Finora avevamo pubblicazioni anche molto ricche a due voci, ma di un solo libro, mai era successo che nel complesso dei volumi (stiamo preparando il terzo) 150 tra ebrei e cristiani lavorassero insieme per commentare una tale mole di pagine». Nuovo anche lo stile. «La forma più tradizionale, quella di leggere a due voci lo stesso brano, avrebbe potuto dare un’idea di contrapposizione, abbiamo preferito una metodologia che desse spazio all’interpretazione dell’altro».
L’iniziativa è nata durante uno degli ormai tradizionali colloqui di Camaldoli. «L’idea è venuta a me, poi è andata avanti con Marco Cassuto Morselli. A darmi grande forza, a fare da volano, sono stati, oltre agli studi, in particolare un Master a Gerusalemme, gli esercizi spirituali tenuti al Santo Padre (nel 2017, ndr) che mi hanno permesso di avere credito presso i colleghi. Questo progetto infatti nasce nell’assoluta gratuità, i collaboratori non hanno chiesto e ricevuto nulla e anche grazie alla Cei che ha coperto parte delle spese».
Nessuno comunque si è tirato indietro. «Tutti quelli che abbiamo interpellato - aggiunge Michelini - hanno accettato e molti si sono offerti di collaborare anche al terzo volume. Perché hanno capito che non è solo un’operazione esegetica ma culturale, direi anche politica, da polis, nel senso di casa comune, in cui dobbiamo e possiamo vivere insieme, accettando l’interpretazione dell’altro». Il ventaglio dei commentatori è molto ampio. «Ci sono i maggiori studiosi italiani ma abbiamo voluto anche una selezione di accademici a livello internazionale. Così nel prossimo volume avremo un contributo della Notre Dame University, la più importante università cattolica degli Usa. L’operazione, ripeto, non è commerciale, chi scrive non guadagna niente, ma di servizio, per questo abbiamo avuto l’appoggio anche di diversi vescovi. Per esempio nel prossimo volume monsignor Nazzareno Marconi commenterà Qohelet, il libro al centro anche dell’odierna Giornata per il dialogo tra cattolici ed ebrei».
L’uscita del primo volume è stata salutata da un successo persino inatteso. «La considero un’opera che va al di là delle capacità mie e di Marco. Ci ha molto aiutato la prefazione al primo volume di papa Francesco, avere un contributo così significativo ci ha incoraggiati, testimonia che questo lavoro va avanti da sé».
I volumi, come detto, raccolgono pagine scelte, compongono un’antologia. In particolare in questa seconda pubblicazione cinquantadue studiosi si soffermano sui Neviim/Profeti, ossia sui libri storici e profetici. «Sì, secondo il modo degli ebrei di considerarli e di dividere la Bibbia, il che ci fa cogliere una prospettiva diversa che viene semplicemente dall’indice, si potrebbe dire». Una prospettiva che si cala perfettamente nel significato della Giornata del 17 gennaio. «“Bibbia dell’amicizia” vuol dire che per conoscersi meglio, bisogna fare cose insieme. Il progetto, se si vuole, nasce dal Convegno ecclesiale nazionale di Firenze, nel 2015, quando il Papa sottolineò che solo progettando e lavorando insieme si può costruire un dialogo con chi è diverso da noi. E non è facile. Nel nostro caso ogni decisione viene presa in due, da me e Marco, e possono esserci tensioni e discussioni. Si pensi alla questione, che ci ha preso ore e ore, del nome di Dio, su come scriverlo. Lavorare insieme però ci ha permesso di creare una relazione, ed è stato importante».
Se amicizia è la parola chiave, forse il concetto che meglio l’accompagna è ascolto, ascolto dell’altro. «Esatto, che non significa perdere la propria identità, perché non è che se leggo l’interpretazione dell’altro devo considerare sbagliata la mia. In questo senso insieme a un grande rispetto e a una grande apertura mentale c’è bisogno di una forte coscienza della propria identità. Non è tutto uguale, infatti. Basta leggere quello che scrive un amico rabbino, Jack Bemporad, sul servo sofferente, che per noi cristiani è Gesù Cristo mentre lui nella sua bella trattazione spiega che per gli ebrei è Israele. Cosa fare di fronte a una posizione così diversa dalla mia? Mi chiudo? O mi domando perché gli ebrei pensano così? Se scelgo la seconda possibilità imparo qualcosa senza per questo rinunciare alla mia posizione: io continuerò a vedere in quel servo sofferente Gesù Cristo. E gli ebrei il popolo di Israele».
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- LE SIBILLE, I PROFETI, E LA "CHARITAS". Nota sulla tesi di laurea di Antonio Rosmini.14 dicembre 2020, di Federico La Sala
PROFETI, SIBILLE, E MESSAGGIO EVANGELICO:
ANTONIO ROSMINI E LA "CHARITAS". Un invito a ...
Rileggere il testo della "BREVE DISSERTAZIONE DI ANTONIO ROSMINI SULLE SIBILLE" (Patricia Salomoni, "Rosmini Studies", 6, 2019). Che Rosmini abbia iniziato il suo percorso riflettendo sulle figure delle Sibille, è da considerarsi un fatto degno della massima attenzione - e, ovviamente, di ulteriore approfondimento!
La riflessione su tale tema, probabilmente, lo ha reso più vigile nel suo cammino e nella sua fedeltà alla lettera e allo spirito della "Charitas". Il "Kant italiano", infatti, iniziando il suo percorso con la tesi di laurea sulle Sibille (1822), non solo non ha perso il suo legame con la Grazia (Charis) e con le Grazie (Charites), ma - coerentemente - ha saputo custodire anche l’«h» della Charitas! E ha cercato di tenere ferma la sua distanza dalla logica economica - sempre più dilagante - della "carità" del "mercato" ("caritas") e, al contempo, dalla politica di sostegno alla diffusione della "eu-carestia" - a tutti i livelli. Ma, alla fine, non è riuscito a coniugare - come voleva, in spirito di verità e carità - - il rapporto tra filosofia (sapienza pagana) e rivelazione (sapienza ebraica).
Già all’inizio del suo percorso, benché partito con buona volontà e - kantianamente ("Sapere aude!") - con gran coraggio, infatti, egli s’inchina all’autorità di sant’Agostino ("De Civitate Dei", XVIII, 47) e - pur rendendosi conto con lo stesso Agostino che "qualsiasi predizione su Cristo poteva essere dichiarata falsa dagli empi e soggiacere al medesimo discredito, sia che si trattasse degli oracoli delle Sibille o delle profezie degli Ebrei" - conclude con un "non è gradito a Lui stesso che, nelle dispute, noi dedichiamo troppe energie più a quelli che a queste" e attribuisce la palma della credibilità solo a "queste .. certissime, luminosissime, custodite dal popolo ebraico a noi assai ostile, e protette da ogni corruzione con incomparabile ed encomiabile cura nel corso di molti secoli" (P. Salomoni, cit, p. 227).
A partire da "queste" premesse (promesse già non mantenute!), ovviamente, accolta solo la parola dei "profeti" non si può che rinarrare e riscrivere la vecchia "storia dell’Amore" di Adamo ed Eva:
- L’Amore tra gli uomini nacque da Dio. L’Eden fu sua patria, ed ebbe gemella l’Innocenza. Nella creazione stessa dei progenitori del genere umano si ritrova la divina istituzione dell’amore: e in essa compaiono tutte le ragioni che devono rendere persuasi tutti gli uomini. Ecco quali sono le principali.
 La prima ragione dell’amore fra tutti gli uomini è l’unità dell’origine. Dio trae la donna dalla carne e dall’osso di Adamo, appunto al fine di indicare che Adamo è il principio unico del genere umano, dal quale non solo i figlioli sono venuti, ma anche la stessa sua moglie. Perciò tutta intera l’umana generazione è un solo corpo con un solo capo, e questo capo è formato da Dio. Da qui l’uomo è chiamato da san Paolo “divina progenie” (Atti 17,28), allegando un verso del poeta greco Arato, il quale ben mostra essersi conservata fra i gentili la tradizione di questa verità. Da dove parte dunque l’unità della stirpe umana, da lì parte anche la prima ragione dell’amicizia. L’una e l’altra da Dio; e l’una e l’altra si può chiamare ragionevolmente cosa divina. Se dunque gli uomini si devono amare per motivo dell’origine, per la stessa ragione devono prima amare Dio, dall’amore del quale come da fonte limpidissima scaturisce il loro proprio amore.
La prima ragione dell’amore fra tutti gli uomini è l’unità dell’origine. Dio trae la donna dalla carne e dall’osso di Adamo, appunto al fine di indicare che Adamo è il principio unico del genere umano, dal quale non solo i figlioli sono venuti, ma anche la stessa sua moglie. Perciò tutta intera l’umana generazione è un solo corpo con un solo capo, e questo capo è formato da Dio. Da qui l’uomo è chiamato da san Paolo “divina progenie” (Atti 17,28), allegando un verso del poeta greco Arato, il quale ben mostra essersi conservata fra i gentili la tradizione di questa verità. Da dove parte dunque l’unità della stirpe umana, da lì parte anche la prima ragione dell’amicizia. L’una e l’altra da Dio; e l’una e l’altra si può chiamare ragionevolmente cosa divina. Se dunque gli uomini si devono amare per motivo dell’origine, per la stessa ragione devono prima amare Dio, dall’amore del quale come da fonte limpidissima scaturisce il loro proprio amore. - La seconda ragione dell’amore fra gli uomini è nella similitudine della natura. Il divino istitutore della natura umana e dell’amore, nel formare Eva, disse che essa doveva essere ad Adamo un aiuto simile a lui, perché «buona cosa non era che egli stesse solo» (Gn 2, 18). Dio con queste parole faceva il più bello encomio della società umana, nel seno della quale nasciamo tutti, e dalle cui materne sollecitudini siamo educati e sollevati ad una inaspettata e meravigliosa perfezione, e quasi ad una nuova e più eccellente natura. E guai all’uomo solitario che si allontana e rifiuta i benefici della società dei suoi simili, presumendo del proprio giudizio e nutrendosi del proprio affetto individuale! Egli già comincia in quell’ora medesima ad isterilire nei suoi ragionamenti e nei suoi affetti. E appena si potrebbe chiamare ancora uomo, se troppo a lungo tenesse le orecchie chiuse alle amorevoli, alle sagge voci dei suoi simili. Perché i germi di bene più preziosi o starebbero in lui come non fossero, o tralignando porterebbero dei frutti inutili e tristi. Per cui veramente, come dice la Bibbia, «non è bene all’uomo starsene solo [...]».
- La terza ragione assegnata all’amore fu la felicità degli uomini. Gli uomini dovevano trarre vantaggio inestimabile dalla scambievole amicizia. Perciò Eva è nominata da Dio “un aiuto di Adamo”. Essa era aiuto al solitario Adamo allo scopo di rendergli piacevole la vita e permettergli di diffondere e comunicare in lei se stesso. Perché l’umano sentimento, l’uomo stesso, come il bene, cerca di essere diffusivo ed espansivo. Da qui ha origine la dottrina apostolica, che descrive l’uomo quale «immagine e gloria di Dio” e la donna quale “gloria dell’uomo [...]».
- Da tutte queste cose si può pertanto concludere, che nella sacra società coniugale, stabilita da Dio a principio fra gli uomini innocenti e felici, ebbero loro capo e inizio tutte le specie dei legittimi amori. Da lì nasceva l’amore naturale nelle famiglie, da lì l’amore di elezione nelle amicizie, da lì l’amore di vantaggio nell’umano commercio. E come da Dio partivano, così in Dio finivano ugualmente tutti questi affetti, temperati in un unico e sublimissimo affetto (Antonio Rosmini, La storia dell’Amore, "Charitas", 5, maggio 2016, pp. 111-112).
E così, contravvenendo frettolosamente alle regole morali del suo stesso "metodo filosofico", il suo desiderio di lasciarsi guidare "in tutti i suoi passi dall’amore della verità", come dalla carità ("charitas") piena di grazia (charis), resta confinato nell’orizzonte della caduta e della minorità - e la presenza delle Sibille insieme ai Profeti nella Volta della Cappella Sistina è ancora un grosso problema!
Federico La Sala
- L’Amore tra gli uomini nacque da Dio. L’Eden fu sua patria, ed ebbe gemella l’Innocenza. Nella creazione stessa dei progenitori del genere umano si ritrova la divina istituzione dell’amore: e in essa compaiono tutte le ragioni che devono rendere persuasi tutti gli uomini. Ecco quali sono le principali.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. -- CONTURSI TERME (SA), Monastero della B.V. del Carmine (Antonio Siani, 2016).).8 ottobre 2020, di Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- «Fratelli Tutti». Papa Francesco, la nuova enciclica discrimina le donne già dal titolo (di Franca Giansoldati).27 settembre 2020, di Federico La Sala
Papa Francesco, la nuova enciclica discrimina le donne già dal titolo «Fratelli Tutti». Critiche violentissime
di Franca Giansoldati *
Città del Vaticano - L’enciclica «Fratelli Tutti» non è ancora uscita che è già oggetto di feroci critiche. Stavolta da parte di donne che si battono per un linguaggio meno discriminatorio e per la parità di diritti, dentro e fuori la Chiesa. Il titolo scelto da Papa Francesco - secondo diverse teologhe, opinioniste, accademiche - sembra essere ben poco inclusivo visto che non tiene conto - esplicitamente - del mondo femminile. Praticamente la «spina dorsale della Chiesa».
Che il linguaggio racchiuda in sé anche un germe sessista non è una novità. Gli studi accademici in materia sono numerosissimi. Il linguaggio del resto serve a collegare, unire, relazionare ma può benissimo diventare strumento per discriminare, escludere, segregare. E così - anche nella Chiesa - modificare il linguaggio significa incidere sulla realtà con la consapevolezza che la questione non sia tanto grammaticale, ma culturale e che la lingua sia uno strumento utile per produrre i cambiamenti.
Ad essere al centro del dibattito è il titolo della imminente lettera enciclica che Papa Francesco firmerà ad Assisi il 3 ottobre dedicata alla pandemia. Un tempo difficile e doloroso per tutti, marcato da una condizione di fragilità e al tempo stesso dal bisogno di creare una fratellanza universale, una rete super partes capace di far superare il gap tra poveri e ricchi, tra giovani e vecchi, tra uomini e donne e ridisegnare i contorni di un mondo nuovo.
Il titolo scelto - tratto da uno scritto di San Francesco - uguale per tutte le lingue - Fratelli tutti - non è passato inosservato. Teologhe, accademiche e gruppi femminili che si battono per i diritti paritari a cominciare anche dal linguaggio hanno manifestato forti perplessità.
Naturalmente il termine “fratelli” - negli intenti del Papa - va inteso in senso estensivo, a chi è legato ad altri da un vincolo di affetto, di carità, da comunanza di patria. Un po’ come l’inno «Fratelli d’Italia» di Mameli o la celebre frase di Manzoni, «I fratelli hanno ucciso i fratelli». Il mancato riferimento alle sorelle ha però aperto il dibattito sui social e non sono mancati giudizi negativi e critiche.
Non è la prima volta che nei documenti magisteriali alle donne viene riservato una posizione marginale. Per esempio nella esortazione apostolica Evangelii Gaudium - praticamente il manifesto del pontificato di Bergoglio - alla enorme questione della donna vengono riservati solo 4 punti su un totale di quasi 300. Il tema della violenza viene poi liquidato in sette righe. Inoltre non si dice nulla sul fatto che la Santa Sede non ha finora mai voluto né firmare né ratificare la Convenzione di Istanbul - praticamente la magna charta per contrastare le radici culturali della violenza tra i sessi.
Fratelli Tutti di conseguenza non poteva non sollevare obiezioni. La teologa inglese Tina Beattie lamenta il solito linguaggio non inclusivo e così ha fatto Paola Lazzarini presidente di Donne Per La chiesa una associazione che appartiene alla Catholic Women’s Council, una realtà globale che lavora per il pieno riconoscimento della dignità e dell’uguaglianza tra i sessi nella Chiesa cattolica. «Chissà se qualcuno farà notare al Papa che le donne non possono essere fratelli e che questo linguaggio ci esclude» ha chiosato su Twitter. Lazzarini ha riportato un parere della Crusca sul termine di fratellanza, specificando che forse, in certi casi, sarebbe stato meglio parlare di sorellanza, perché «più appropriat»”.
Sul Tablet in un editoriale Lizz Dodd ha manifestato sconcerto. «Papa Francesco potrebbe rompere con la tradizione e chiamare l’enciclica con qualcosa di diverso dalla sua frase di apertura (...) Il fatto che questo titolo sia riuscito a superare ilproceso di editing mi suggerisce che nessuna donna sia stata consultata o che le donne hanno sollevato preoccupazioni che sono state trascurate». L’idea suggerita è di inserire la parola ’sorelle’ a quella di fratelli. «Sarebbe un gesto verso le donne che sono la spina dorsale della Chiesa da millenni, sebbene esclusa. Significherebbe sentirci dire che il nostro bisogno di sentirci incluse nella casa viene prima dei giochi linguistici. Cambiare titolo sarebbe come se Francesco dicesse: vi vedo».
Naturalmente in Vaticano la questione è finità già sotto il tappeto. Vatican News attraverso il direttore editoriale Andrea Tornielli è sceso in campo per spegnere gli incendi scrivendo in un editoriale: «Fraternità e amicizia sociale, i temi indicati nel sottotitolo, indicano ciò che unisce uomini e donne, un affetto che si instaura tra persone che non sono consanguinee e si esprime attraverso atti benevoli, con forme di aiuto e con azioni generose nel momento del bisogno. Un affetto disinteressato verso gli altri esseri umani, a prescindere da ogni differenza e appartenenza. Per questo motivo non sono possibili fraintendimenti o letture parziali del messaggio universale e inclusivo delle parole “Fratelli tutti”».
Nel frattempo sono partite anche appelli al Papa di cambiare il titolo della nuova enciclica. Sui social, per esempio, spicca quello dell’economista cattolico Luigi Bruni, editorialista di Avvenire. «Caro papa Francesco finchè è ancora in tempo per favore cambi il titolo della nuova enciclica. Quel Fratelli (senza sorelle) non si può usare nel 2020. Lei ci ha insegnato il peso delle parole. Il titolo si mangerà il contenuto e sarebbe un grande peccato. L’altro nome di Francesco è Chiara».
* Il Messaggero, Lunedì 21 Settembre 2020 Ultimo aggiornamento: 23 Settembre (ripresa parziale).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Orfeo, il Buon Pastore (di Fabrizio Bisconti).19 settembre 2020, di Federico La Sala
Orfeo, il Buon Pastore
di Fabrizio Bisconti *
La sinagoga di Dura Europos (città ai confini dell’impero romano, nell’attuale Siria, sulle sponde dell’Eufrate) propone un programma decorativo realizzato ad affresco. Tale decorazione (oggi conservata nel Museo Archeologico di Damasco) documenta quell’infrazione al divieto relativo alla rappresentazione del "sacro" che interesserà anche la civiltà cristiana dei due primi secoli. Lungo le pareti della sinagoga si snodano storie di Mosè, Aronne, Elia, Samuele, Ezechiele e si riconosce l’immagine di Davide Salmista che recupera l’antica immagine di Orfeo citaredo e che anticipa quella del Buon Pastore cristiano.
A Dura Europos esisteva una domus ecclesiae cristiana, il cui programma decorativo del battistero, staccato e oggi conservato alla Yale University Art Gallery di New Haven, presenta un’organizzazione iconografia non dissimile da quella della sinagoga, se non per l’inserimento di scene ovviamente ispirate al Nuovo Testamento. Nella lunetta che sovrasta la vasca battesimale vediamo che il Buon Pastore e Adamo ed Eva convivono per descrivere la «festa della salvezza», che prende avvio con la felix culpa di progenitori e si conclude con il recupero della pecorella smarrita.
Il Buon Pastore della domus e l’Orfeo della sinagoga sono figure che partecipano di uno stesso linguaggio, genericamente riconducibile alla tematica bucolica e che costituisce una delle ambientazioni passe par tout capaci di richiamare un contesto felice, tranquillo, beato, dunque paradisiaco.
Orfeo, poi, raffigurato mentre suona la cetra, confluisce nella cultura figurativa romana, specialmente nei pavimenti musivi, ma anche nei contesti funerari. L’immagine di Orfeo appare sulle fronti di tre sarcofagi di manifattura ostiense, uno dei quali conservato a Porto Torres, che sembrano essere utilizzati per la sepoltura di defunti cristiani, come suggeriscono le iscrizioni (anche se potrebbero essere state incise in un secondo momento). Ma la figura appare in contesti sicuramente cristiani quando decora ambienti catacombali. Orfeo citaredo appare effigiato tra due ovini, attorniato da mostri marini e uccelli. In alcuni affreschi, l’eroe è attorniato da altri animali, come in un affresco del cimitero dei Santi Marcellino e Pietro dove è accompagnato da un’aquila in volo. In un’altra pittura del medesimo cimitero si colloca alla sommità di quattro scene bibliche, dove si alternano episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, alludendo già al Cristo unificatore delle due economie. In un affresco ormai tardo del cimitero di Priscilla si accompagna alla solenne scena della Traditio legis.
Ma l’affresco catacombale più interessante è collocato a Domitilla e si riferisce agli anni centrali del IV secolo. Esso propone Orfeo citaredo al centro della volta di un cubicolo, mentre Davide con la fionda appare in un campo laterale, secondo un’iconografia rara, che torna però in un celebre affresco delle catacombe napoletane di San Gennaro. Dopo queste testimonianze antiche e oscillanti nel significato effettivo, tra l’immagine di Orfeo e Davide, la figura del cantore del mito si diffonde in tutto il mondo antico, come succede ad esempio nel mosaico pavimentale di una sinagoga a Gaza, dove si riconosce il re Davide, definito da una didascalia in ebraico, vestito di panni sontuosi, coronato, nimbato, mentre suona il kinnor bizantino tra animali selvaggi.
Da questa immagine, che un’iscrizione data al 508-509, l’iconografia del musico che ammansisce gli animali si diparte e si diffonde da Oriente a Occidente, interessando anche le arti minori, nella specie di oggetti di ceramica e di avorio. Ma anche lo ritroviamo in un mosaico pavimentale di una basilica, pure siriana, ad Apamea, del V secolo, dove si vede Adamo, identificato da una didascalia, che attribuisce i nomi agli animali. Questa iconografia - ripetuta in un mosaico di Hama e in un altro conservato a Copenaghen - si riferisce al passo della Genesi, che recita: «Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo per vedere come li avrebbe chiamati».
Appare interessante a questo punto seguire le voci dei Padri della Chiesa, che sentirono il desiderio di decodificare la figura di Orfeo, attribuendo all’immagine un significato cristologico, a cominciare da Clemente Alessandrino che tiene a precisare come il Logos sia il vero Orfeo, capace di addomesticare le bestie malvagie e feroci come il leone, il porco e il lupo. Ma potremmo continuare con Cirillo d’Alessandria, con lo Pseudo Giustino, sino a Eusebio di Cesarea: «Se Orfeo, con il suono della lira, ammansì le fiere... il Verbo di Dio fece di più: ammansì i costumi dei barbari e dei pagani».
Orfeo e Cristo si affrontano, si sovrappongono e si sciolgono attraverso l’esegesi dei Padri. Il Buon Pastore intrattiene con Orfeo, Adamo, Davide e con il Cristo molti motivi di confronto e, se nella letteratura patristica si apprende che un nesso collega Cristo ad Adamo, a maggior ragione Orfeo si giustappone al Buon Pastore, tanto che due singolari affreschi catacombali propongono altrettanti pastori che vigilano rispettivamente sugli animali da cortile a Priscilla, su pesci e ovini nel cimitero della via Ardeatina. È noto come la figura del Buon Pastore provenga dall’immaginario relativo all’otium campestre e, segnatamente, all’idillio agropastorale, dal quale viene estratto il tipico villico con l’ovino sulle spalle. Il contesto ameno, già definito in età ellenistica, trova la sua più compiuta realizzazione nei cosiddetti sarcofagi "a grandi pastorali", prodotti in un atelier romano negli anni centrali del III secolo.
 Da questi contesti, che rappresentano dei veri e propri "tessuti bucolici", emerge la figura del pastore con la pecorella sulle spalle che, in realtà, è tipica di molte epoche e culture, in quanto espressione simbolica dell’offerente, del crioforo (portatore di agnello), di colui che reca la vittima sacrificale.
Da questi contesti, che rappresentano dei veri e propri "tessuti bucolici", emerge la figura del pastore con la pecorella sulle spalle che, in realtà, è tipica di molte epoche e culture, in quanto espressione simbolica dell’offerente, del crioforo (portatore di agnello), di colui che reca la vittima sacrificale.
 Come figura abbreviata di una scena pastorale, il crioforo fu simbolo della philantropia e della humanitas, impersonando il Mercurio psicopompo, colto mentre conduce le anime dei defunti nell’aldilà. In questo senso dobbiamo considerare affreschi pagani, sincretici e cristiani: così nell’ipogeo della via Trionfale, così sulle catacombe di Vibia, così in un arcosolio di San Sebastiano, dove nel corso del IV secolo l’immagine del Buon Pastore convive con quella di Mercurio e dell’Orante.
Come figura abbreviata di una scena pastorale, il crioforo fu simbolo della philantropia e della humanitas, impersonando il Mercurio psicopompo, colto mentre conduce le anime dei defunti nell’aldilà. In questo senso dobbiamo considerare affreschi pagani, sincretici e cristiani: così nell’ipogeo della via Trionfale, così sulle catacombe di Vibia, così in un arcosolio di San Sebastiano, dove nel corso del IV secolo l’immagine del Buon Pastore convive con quella di Mercurio e dell’Orante.Nell’arte paleocristiana la figura del Buon Pastore costituisce, con l’immagine dell’Orante, uno dei due ideogrammi della storia della salvezza, impersonando rispettivamente il Salvatore e il defunto. L’«Io sono il Buon Pastore» del vangelo di Giovanni diviene argomento privilegiato dell’esegesi patristica, a cominciare dall’epitaffio di Abercio vescovo di Gerapoli che si definisce «discepolo del pio pastore». Il Buon Pastore diviene il più eloquente tipo cristologico, tanto che nel martirio di Policarpo si paragona Cristo, salvatore delle anime e guida dei nostri corpi, a pastore della Chiesa cattolica nel mondo, e nel Paedagogus di Clemente Alessandrino si allude al Logos come a un sollecito pastore dei bambini, cioè a un pedagogo che conduce i fanciulli alla salvezza. Un brano del De pudicitia di Tertulliano ci suggerisce che già tra la fine del II secolo e gli esordi del III il crioforo ha sicuramente un significato cristologico.
*Segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Nella Cattedrale di Santa Maria Assunta a Piacenza. Come scalare il Guercino (di Sivia Tomasi).31 luglio 2020, di Federico La Sala
Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (Cento, 1591, Bologna, 1666) *
Come scalare il Guercino
di Silvia Tomasi **
Conquistare una meta con fatica, la rende ancora più bella e apprezzata. Ecco: si può applicare questa piccola perla di saggezza per l’arrancata di 160 gradini, una vera salita in quota, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta a Piacenza per godere a 27 metri di altezza il piacere di avere a distanza di pochi metri gli affreschi del Guercino, il pittore emiliano che, al culmine della fama, arriva a Piacenza nel 1626 per lasciare la straordinaria sequenza pittorica “a buono fresco” negli spicchi della cupola.
 Per tutta la durata di Guercino tra sacro e profano, la rassegna piacentina dedicata al pittore centese aperta fino al 4 giugno (sito www.guercinopiacenza.com), i visitatori potranno inoltrarsi a piccoli gruppi negli stretti cunicoli di questa ascesa fra salite ardite e un arrotolarsi di scale a chiocciola con scalini larghi sì e no mezza suola di scarpa. Sembra quasi di trovarsi fra budella e diverticoli d’una colonscopia virtuale all’interno delle mura medievali della cattedrale, per approdare grazie a passerelle in legno, camminamenti provvisori ricavati nei sottotetti, a una “stazione” con una postazione multimediale. Finalmente poi si sguscia da un bassissimo ingresso, attenti alla testa, sul tamburo della cupola. Lì, in una regia di luci dovuta a Davide Groppi, si illuminano prima solo alcune vele della cupola e poi il flash con la visione globale di tutto il ciclo guercinesco, accompagnata in dissolvenza, per maggior coinvolgimento emozionale, dalla regale marcia musicale della Sarabande di Haendel. Poi il buio.
Per tutta la durata di Guercino tra sacro e profano, la rassegna piacentina dedicata al pittore centese aperta fino al 4 giugno (sito www.guercinopiacenza.com), i visitatori potranno inoltrarsi a piccoli gruppi negli stretti cunicoli di questa ascesa fra salite ardite e un arrotolarsi di scale a chiocciola con scalini larghi sì e no mezza suola di scarpa. Sembra quasi di trovarsi fra budella e diverticoli d’una colonscopia virtuale all’interno delle mura medievali della cattedrale, per approdare grazie a passerelle in legno, camminamenti provvisori ricavati nei sottotetti, a una “stazione” con una postazione multimediale. Finalmente poi si sguscia da un bassissimo ingresso, attenti alla testa, sul tamburo della cupola. Lì, in una regia di luci dovuta a Davide Groppi, si illuminano prima solo alcune vele della cupola e poi il flash con la visione globale di tutto il ciclo guercinesco, accompagnata in dissolvenza, per maggior coinvolgimento emozionale, dalla regale marcia musicale della Sarabande di Haendel. Poi il buio.Ce n’è abbastanza per sentirsi in un piccolo Paradiso, o più profanamente in una full immersion percettiva di bellezza.
- [Foto] Piacenza, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Cupola, Le vele con Davide e Isaia si devono al Morazzone, il resto del ciclo di affreschi è di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino
- [Foto] Piacenza, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Cupola Sibille
A portata d’occhio nerboruti profeti muscolari, Sibille curiose e sontuose, e poi gli episodi dell’infanzia di Cristo: nella lunetta della Fuga in Egitto, Giuseppe fra apprensione e affetto allunga il Bambin Gesù alla madre. Con tenerezza Maria porta la mano verso il seno come per dire: ma vuoi proprio la mamma?
- [Foto] Piacenza, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Cupola, Riposo durante la fuga in Egitto
- [Foto] Piacenza, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Cupola, Riposo durante la fuga in Egitto, particolare
Tutto ha un così caldo rispetto della dignità naturale... Anche se certo non manca il gusto teatrale: in Guercino si avverte una sorta di “recitar cantando” secondo le inflessioni del nuovo melodramma che avrebbe trionfato nel Settecento, «è un teatro dei sentimenti o degli affetti come si sarebbe detto allora» ribadisce Daniele Benati, curatore della mostra con Antonella Gigli (catalogo Skira). E prosegue: «Guercino è mal inquadrabile nelle comode griglie di naturalismo, classicismo o barocco: troppo naturale negli anni in cui andava affermandosi la pittura sbilanciata alla ricerca del bello ideale; troppo composto e recitato quando serviva l’estroversione barocca». È anche per questo che John Ruskin, dandy e raffinato critico, lo straccia senza appello nel 1846.
 Ma un altro grande britannico, Denis Mahon, collezionista e critico d’arte, ci ha ridato nel Novecento il Guercino dopo secoli di oscuramento, dedicandogli studi per tutto l’arco della sua vita. È proprio a lui e al suo metodo di analisi che Benati dedica la mostra di Piacenza, rispettando nelle partiture della sezione di Palazzo Farnese, che fa da pendant all’incontro ravvicinato col Guercino della cupola, quello sviluppo di diverse “maniere” pittoriche che hanno caratterizzato il lungo percorso dell’artista. Gli «anni degli esordi», gli «anni della fama» e gli «anni della gloria» sono le tre sezioni allestite all’interno della Cappella ducale dello storico palazzo con un «numero di opere ridottissimo, appena una ventina, ma selezionatissime», spiegano i curatori Gigli e Benati.
Ma un altro grande britannico, Denis Mahon, collezionista e critico d’arte, ci ha ridato nel Novecento il Guercino dopo secoli di oscuramento, dedicandogli studi per tutto l’arco della sua vita. È proprio a lui e al suo metodo di analisi che Benati dedica la mostra di Piacenza, rispettando nelle partiture della sezione di Palazzo Farnese, che fa da pendant all’incontro ravvicinato col Guercino della cupola, quello sviluppo di diverse “maniere” pittoriche che hanno caratterizzato il lungo percorso dell’artista. Gli «anni degli esordi», gli «anni della fama» e gli «anni della gloria» sono le tre sezioni allestite all’interno della Cappella ducale dello storico palazzo con un «numero di opere ridottissimo, appena una ventina, ma selezionatissime», spiegano i curatori Gigli e Benati.A Guercino basta una gamma essenziale di colori come il bianco e il porpora, che stempera in tutte le delicate nuances del rosa e del latte, per creare La morte di Cleopatra del 1648, così umana nella sua bellezza ideale: si nota perfino il lieve flettersi del materasso sotto il corpo della regina d’Egitto che si abbandona alla morte.
- [Foto] Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (Cento, 1591, Bologna, 1666) La morte di Cleopatra, 1648, Olio su tela, 173 × 238 cm, Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso
E a Maria luccicano gli occhi mentre, china, tocca quel figlio risorto che abbassa lo sguardo su di lei nella tela Cristo risorto appare alla Madre del 1628.
- [Foto] Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (Cento, 1591, Bologna, 1666) Cristo risorto appare alla Madre, 1628-1630, Olio su tela, 260 × 179,5 cm, Cento, Pinacoteca Civica “Il Guercino”
Per mantenere le stimmate del mondo terreno - e qui siamo alla Immacolata concezione del 1656 - Guercino elimina dalla figura sacra di Maria gli attributi usuali, dalla corona di stelle alla mandorla in cui veniva racchiusa la sua figura sacra. La Madonna si staglia su un paesaggio marino al chiaro di luna, un ultimo spicchio su cui si eleva pudicissima in un’aurora quasi crepuscolare, mentre una lieve brezza increspa le onde. C’è un sentimento lancinante del luogo e del paesaggio. Un nuovo modello vivo di pittura perché, affermava un esperto come Cesare Gnudi, «il Guercino cercava la bellezza nella realtà».
- [Foto]Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (Cento, 1591, Bologna, 1666), Immacolata Concenzione 1656, Olio su tela, 258 x 180cm, Ancona, Pinacoteca Civica “F. Podesti”
- [Foto] Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (Cento, 1591, Bologna, 1666), Immacolata Concenzione 1656, particolare
* * THE LIVINGSTONE, 19/03/2017
*
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
- BARBIERI, Filippo (BarberiFilippo, Philippus de Barberis, Philippus Siculus).
FILIPPO BARBERI o BARBIERI (Philippus de Barberis o Philippus Siculus),"Discordantiae Sanctorum doctorum Hieronymi et Augustini, et alia opuscola", Roma, 1481: La Sibilla Tiburtina.
PROFETI E SIBILLE. Storia delle immagini... Filippo Barberi, "Discordantiae sanctorum doctorum Hieronymi et Augustini", 1481
Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (Cento, 1591, Bologna, 1666)
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. -- SUGLI ALBURNI, A POSTIGLIONE, TRACCE DI "GESTI" MICHELANGIOLESCHI. Il policromato del profeta Elia (di Gerardo Pecci)20 maggio 2020, di Federico La Sala
Il policromato del profeta Elia
A Postiglione il busto in legno di Colombo
di Gerardo Pecci (la Città di Salerno, 09 ottobre 2017)
A Postiglione, la prima domenica di maggio è dedicata al culto del profeta Elia. In suo onore si svolge la festa di Sant’Elia Profeta. In tale festività si svolge un’interessante processione che partendo dalla chiesa di San Giorgio e attraversando stretti e contorti sentieri di montagna conduce alla grotta di Sant’Elia. Nelle adiacenze della grotta dedicata al profeta, vi si celebra la santa messa. Poi vi è un momento di pausa dove si consumano panini con frittate di asparagi. Infine, la processione fa ritorno in paese. Nella processione si porta a spalla, su una base processionale lignea, il busto in legno policromato di “Sant’Elia Profeta”. L’opera attualmente è conservata nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, laddove l’ho potuta fotografare, e in una scheda di catalogazione della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino l’opera d’arte è stata attribuita al grande scultore Giacomo Colombo.
Stilisticamente, il busto ligneo del profeta Elia effettivamente rivela tratti e modi scultorei propri del grande artista di Este, trasferitosi a Napoli fin dagli anni giovanili. Non si dimentichi che nella medesima chiesa è conservato anche il manichino processionale della “Madonna del Rosario” opera firmata dallo stesso Colombo e datata alla fine del XVII secolo.
Il profeta Elia, originario di Galaad visse in Israele nel regno del re Acab e morì intorno al 854-853 a.C. Egli lottò vittoriosamente contro la diffusione del culto pagano di Baal. Sul Monte Carmelo sfidò i sacerdoti di Baal e convinse il popolo d’Israele a uccidere i sacerdoti di Baal. Dovette quindi fuggire nel deserto dopo tale avvenimento. Lì un angelo gli portò da mangiare e lo incitò a proseguire il cammino fino al monte Oreb. La tradizione ci narra che Elia ascese al cielo su un carro di fuoco. In ciò è stata vista anche la prefigurazione della futura resurrezione di Cristo.
Nel busto in legno policromato di Postiglione, il profeta regge nel pugno della mano destra una torcia infuocata, simbolo della propria ascesa al cielo. La mano sinistra, invece, regge un libro sacro. L’impostazione iconografica e la solennità del personaggio ricordano altre statue colombiane in cui diversi santi, e santi vescovi in particolare, sorreggono con la mano sinistra libri sacri. Il volto barbuto del profeta Elia è vicino a quelli di “Sant’Arsenio abate” e di “Sant’Andrea apostolo”, opere colombiane che sono conservate rispettivamente a Sant’Arsenio, nel Vallo di Diano, e a Gricignano di Aversa.
Ma in quest’opera conservata a Postiglione vi sono elementi che non solo mettono in evidenza un marcato realismo fisiognomico dell’anziano profeta, ma sembra potersi riconoscere una vena stilistica che rimanda al ricordo dei volti michelangioleschi della figura di Dio Padre nella “Creazione di Adamo” nella volta della Cappella Sistina e in quello di “Mosè” in San Pietro in Vincoli a Roma. Come pure sono evidenti il realismo tipico delle figure presepiali napoletane e l’aria severa e accigliata del profeta, dalla lunga e fluente barba bianca. Anche il profeta Elia evidenzia la bocca semiaperta, che lascia intravvedere l’arcata dentale superiore, tipica delle opere colombiane e in genere della statuaria napoletana in legno dipinto tra il XVII e il XVIII secolo. In generale, la figura del profeta dell’Antico Testamento stilisticamente presenta, anche qui, una vena creativa equilibrata che, a dir la verità, è sempre stata una caratteristica delle opere colombiane, priva del linguaggio mosso, arioso e colorato, del rococò e priva degli sbuffi di stoffa svolazzanti nel vento.
L’opera si presenta con un’aura di grande compostezza e solennità, in linea con l’autorevolezza del personaggio biblico rappresentato. Anche in questo busto in legno dipinto di Postiglione si riconosce l’importanza della cultura scultorea napoletana, troppo spesso dimenticata.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. - ANTROPOLOGIA, TEOLOGIA, E CIELO STELLATO. Non è bene che Dio sia solo. .11 maggio 2020, di Federico La Sala
L’anima e la cetra/7.
Non è bene che Dio sia solo
di Luigino Bruni (Avvenire, domenica 10 maggio 2020)
- E quando miro in cielo arder le stelle; / Dico fra me pensando: / A che tante facelle? / Che fa l’aria infinita, e quel profondo / Infinito Seren? che vuol dir questa / Solitudine immensa? ed io che sono?
- Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.
Alcune persone ricordano per tutta la vita il giorno in cui hanno visto per la prima volta il cielo stellato. Lo avevano "visto" altre volte, ma in una benedetta notte è successo qualcosa di speciale e lo hanno visto veramente. Hanno fatto l’esperienza metafisica dell’immensità e, simultaneamente, hanno avvertito tutta la propria piccolezza e fragilità. Si sono, ci siamo, visti infinitamente piccoli. E lì, sotto il firmamento, sono fiorite domande diverse, quelle che quando arrivano segnano una tappa nuova e decisiva della vita: dove sono e cosa sono i miei affari? e i miei problemi? cosa è la mia vita? cosa i miei amori, i miei dolori? E poi è arrivata la domanda più difficile: e io, che sono? È il giorno tremendo e bellissimo; per alcuni segna l’inizio della domanda religiosa, per altri la fine della prima fede e l’inizio dell’ateismo - per poi scoprire, ma solo alla fine, che le due esperienze erano simili, che magari c’era molto mistero nella risposta atea e molta illusione in quella religiosa, ma lì non potevamo saperlo. Non tutti fanno questa esperienza, ma se la desideriamo possiamo provare a uscire di casa in queste notti fatte più calme e nitide dai mesi sabbatici, cercare le stelle, fare silenzio, attendere le domande - che, mi hanno detto, qualche volta arrivano.
Per qualcuno, poi, c’è stato un altro giorno decisivo. Quando quell’infinitamente piccolo ha fatto l’esperienza che quell’«Amor che move il sole e l’altre stelle» si interessava di lui, di lei, lo cercava, gli parlava, la incontrava. Giorno altrettanto decisivo, perché non basta l’esperienza vera del giorno delle stelle perché inizi la vita religiosa. Ci sono molte persone che sentono veramente vibrare lo spirito di Dio nella natura, odono la sua voce risuonare nelle notti stellate e in molti altri luoghi, ma non si sono mai sentite chiamare per nome da quella stessa voce. Come ci sono altri che hanno fatto un autentico incontro personale con la voce dentro, ma che poi non l’hanno mai sentita vivere nell’universo intero, che non si sono mai commossi riconoscendola nell’immensità del cosmo. È l’incontro tra questi due giorni che segna l’inizio della vita spirituale matura, quando l’immensità che ci svela la nostra infinita piccolezza diventa un tu più intimo del nostro nome.
L’autore del Salmo 8 ha fatto, credo, l’esperienza di entrambi questi giorni. Ha riconosciuto la presenza di YHWH nel firmamento infinitamente grande e si è sentito infinitamente piccolo; e poi ha intuito che la voce che gli parlava tra le galassie era la stessa voce che gli parlava nel cuore: «Come splende, YHWH, il tuo nome su tutta la terra: la bellezza tua voglio cantare, essa riempie i cieli immensi... Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, io mi chiedo davanti al creato: e l’uomo che cos’è? perché di lui ti ricordi? Che cosa è mai questo figlio d’uomo perché tu ne abbia una tale cura?» (8, 2-5). Versi meravigliosi. Dovremmo avere il cuore e le stigmate di Francesco per cantarli.
Assistiamo in presa diretta a una esperienza dell’assoluto. Quell’antico poeta ha avvertito l’immensità e la piccolezza, non si è sentito schiacciato, e ha iniziato un nuovo canto. Il canto dell’umiltà (humilitas) vera, perché l’humus ci dice chi siamo veramente solo se riusciamo per un attimo a guardarlo da distanza siderale; l’adamah (terra) svela l’Adam solo se vista dall’alto. È questa la gioia per la verità finalmente rivelatasi, per una nuova ignoranza che non umilia. L’umiltà è l’opposto dell’umiliazione. E si sperimenta una nuova infanzia, una sconfinata giovinezza: «Da fanciullo e lattante balbetto» (8,3).
Al centro del salmo una domanda: cosa è il figlio d’uomo (Ben Adam: espressione cara ai profeti e ai vangeli), di fronte a tanta immensità?! Splendida è la risposta: nonostante la sua insignificanza in rapporto alle stelle e la sua piccolezza nel tempo e nello spazio, tu ti prendi cura dell’uomo, tu ti ricordi di lui. Come a dire: se tu tenessi conto, o Dio, di quello che l’Adam è oggettivamente in rapporto all’universo sterminato, non dovresti occupartene; e invece ti prendi cura di lui, di lei. E quindi la domanda necessaria: ma questa voce che mi parla dentro è proprio la stessa che ha parlato tra le galassie? La risposta del primo giorno può essere soltanto un sì, altrimenti il cammino non incomincia! Col passare del tempo la risposta diventa: forse. Poi arrivano i lunghi anni quando la risposta è: no. Infine ritorna il sì, ma - se e quando ritorna - è un sì detto con un’altra profondità e un’altra umiltà. E qui nasce una nuova meraviglia, trabocca la gratitudine, riaffiora la preghiera degli ultimi tempi.
Sta in questa tensione tra le stelle e il cuore, abitati entrambi dalla stessa presenza, la dignità dell’Adam, dei suoi figli e delle sue figlie, la sua gloria e il suo onore. Ci si perde nelle varie ideologie quando si perde uno di questi due poli. Dobbiamo leggere il Salmo 8 in parallelo con i primi capitoli della Genesi: «E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò» (Gn 1,27). Il versetto della Bibbia che, forse, amo di più. L’Adam è posto da Elohim al centro del giardino della creazione perché ne fosse custode e responsabile. Il Salmo ce lo ridice: «Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi» (Salmo 8,7). L’Adam diventa il primo interlocutore di Dio, perché con la sua reciprocità potesse accompagnare anche la solitudine di Dio - «non è bene che l’uomo sia solo» (Gn 2,18) va letto insieme all’altra frase non scritta nella Bibbia ma altrettanto presente: non è bene che Dio sia solo.
Non mi stupirebbe se l’autore di quell’antico salmo mentre cantava avesse sottomano questi versi della Genesi. Forse stava meditando e contemplando "cosa è l’uomo" quando, ad un certo punto, non ha più retto l’emozione e ha composto uno dei versi più belli sull’uomo mai scritti da tutta la letteratura religiosa e laica. Dopo averlo visto sub specie aeternitatis, dopo essere andato con l’anima sulla luna e averlo perso di vista tanta era la sua piccolezza, tornato a quelle parole della Genesi ha rivisto un altro uomo. E ha pronunciato questo capolavoro, che va letto dopo qualche attimo di silenzio: -«Eppure l’hai fatto poco meno di Elohim, di gloria e di onore lo hai coronato» (8,6). Eppure: a volte la Bibbia sa racchiudere in una umile congiunzione tutta la sua profezia. Siamo effimeri, siamo come l’erba ... eppure... «Una voce dice: "Grida", e io rispondo: "Che cosa dovrò gridare?". Ogni uomo è come l’erba. Secca l’erba, il fiore appassisce ... Veramente il popolo è come l’erba» (Isaia 40,6-7).
 Veramente ... eppure. Siamo stati pensati, cercati e amati tra un veramente e un eppure. Veramente effimeri come l’erba, veramente infinitamente piccoli, veramente infedeli e peccatori; eppure poco meno di Dio, eppure sua immagine e somiglianza, eppure amati, curati e attesi come figli.
Veramente ... eppure. Siamo stati pensati, cercati e amati tra un veramente e un eppure. Veramente effimeri come l’erba, veramente infinitamente piccoli, veramente infedeli e peccatori; eppure poco meno di Dio, eppure sua immagine e somiglianza, eppure amati, curati e attesi come figli.Questa è l’immensa antropologia biblica. La letteratura antica conosceva la metafora dell’immagine di Dio applicata all’uomo. Ma era usata per il re, per il faraone. La Bibbia la usa per ciascuno di noi, per ogni uomo e per ogni donna, per te, per me. È l’Adam, ogni Adam, l’immagine e somiglianza di Elohim; e quindi lo siamo anche noi, tutti noi. È questa la magna carta di ogni dichiarazione dei diritti dell’uomo e della donna, dei bambini, delle bambine, della dignità del creato. Il Salmo 8 è un inno a Dio e insieme un inno all’uomo. Esalta la persona dicendoci chi è quel Dio di cui egli è immagine, ed esalta Dio dicendoci chi sono l’uomo e la donna che lo riflettono. Perché se l’uno è immagine dell’altro, più l’Adam diventa bello più dice la bellezza del suo Creatore, e più lasciamo libero Dio di diventare migliore di noi, più abbelliamo noi stessi. Non capiamo l’antropologia biblica se usciamo dalla reciprocità intrinseca al simbolo dell’immagine.
Ma la bellezza e la forza di questo canto esplodono se immaginiamo il salmista cantare quel versetto 6 mentre leggeva anche i capitoli tre e quattro della Genesi: quelli della disobbedienza, della seduzione vincente del serpente, e poi Caino e il sangue di Abele, di cui il salmista sentiva ancora l’odore. È troppo semplice cantare la gloria e l’onore dell’uomo fermandosi al capitolo due. La sfida decisiva è riuscire a continuare il canto mentre i capitoli scorrono e si entra nelle pagine buie e buissime del no, quelle della rottura dell’armonia uomo-donna-creato-Dio, nelle pagine della cacciata da quel giardino meraviglioso, quelle della notte oscura del primo fratricidio della terra. E giunti lì, non smettere il canto. E poi continuarlo con l’urlo tremendo di Lamek l’uccisore di fanciulli, con la ribellione di Babele, con i peccati dei patriarchi, con le bugie e gli inganni di Giacobbe, con l’omicidio dei beniaminiti, fino all’omicidio di Davide, alle infedeltà di Salomone e di quasi tutti i re d’Israele. E non smettere mai di cantare: «Veramente ... Eppure lo hai fatto poco meno di un Dio».
Tutta la forza dell’antropologia biblica si sprigiona quando riusciamo a vincere il dolore e la vergogna e ripetiamo "veramente ... eppure" non solo di fronte al firmamento ma anche nelle carceri, nelle meschinità, nelle violenze, nei bassifondi di Calcutta, nelle via crucis che portano al Golgota. Non c’è condizione umana che non sia racchiusa tra quel veramente e quell’eppure, nessuno resta fuori. La Bibbia non ha avuto paura di narrarci i peccati e le bassezze dei suoi uomini perché credeva veramente all’immagine di Elohim. E ogni volta che nascondiamo nelle nostre storie le pagine più buie abbiamo smesso di credere che siamo immagine.
Caino ha cancellato la sua fraternità e i suoi figli continuano a cancellarla uccidendo ogni giorno Abele. Ma non ha potuto cancellare l’immagine - e se il "segno di Caino" fosse proprio l’immagine di Elohim? «O Dio, Signore nostro, come splende il tuo nome su tutta la terra!» (8,10).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- L’importanza della parità di genere. Uno studio del Pew Research Center (di Stefania De Lellis).4 maggio 2020, di Federico La Sala
Sondaggio, il mondo è d’accordo su una cosa : l’importanza della parità di genere
Secondo la ricerca dell’istituto statunitense Pew Research Center in 34 paesi, il 94% degli intervistati definisce “importante” che le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini. Una percentuale che in Italia tocca il 95%
di STEFANIA DI LELLIS (la Repubblica, 30 aprile 2020)
Forse può sorprendere, ma una delle cose su cui la maggior parte del mondo è d’accordo è l’importanza della parità tra uomo-donna. A raccontarlo è l‘ultimo studio del Pew Research Center, un accreditato istituto americano di ricerche e sondaggi.
Pew ha contattato 38.426 persone in 34 paesi e il 94% degli intervistati ha definito “importante” che le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini. Una percentuale che in Italia tocca il 95%. La maggioranza in 30 nazioni sostiene che la parità di diritti sia anzi “molto importante” : tra queste la Svezia dove a pensarlo è il 96%. In Italia però la percentuale delle persone convinte di ciò (ovvero che sia molto importante) è la più bassa nell’Europa occidentale : 74%
Più di metà (54%) degli intervistati nella maggior parte dei paesi Ue, negli Usa, in Giappone, Israele, Australia e Corea del Sud dice che gli uomini sono favoriti quando si tratta di occupare posizioni lavorative con stipendi alti. Una valutazione che in Italia è condivisa dal 63%.
La ricerca è stata condotta tra maggio e ottobre dello scorso anno e viene pubblicata solo oggi. Ma ci offre spunti di riflessione molto attuali: il 40% delle persone nella maggioranza dei paesi ascoltati ritiene che gli uomini debbano avere la precedenza sulle donne in caso di scarsità di posti di lavoro. In Italia la percentuale di uomini fautori di questa corsia preferenziale tocca il 46% contro il 34% della popolazione femminile.
L’ottimismo sulla parità futura è più maschile che femminile. In Italia il 71% delle donne ritiene che si arriverà al traguardo, contro l’84% degli uomini. E più di metà dei sondati in Italia, come in Francia, Grecia, Slovacchia, Giappone, Corea del Sud, Turchia, Israele, Libano Tunisia pensa che la strada delle donne verso la leadership politica sia decisamente più in salita rispetto a quella degli uomini.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- “L’amore delle donne accompagna la passione di Gesù”. (di p. Giancarlo Pani S.I., vicedirettore de "La Civiltà Cattolica").5 aprile 2020, di Federico La Sala
Le note spirituali della Civiltà Cattolica
“L’amore delle donne accompagna la passione di Gesù”.
di p. Giancarlo Pani S.I., vicedirettore de "La Civiltà Cattolica" *
Il Vangelo di Matteo presenta il racconto della passione di Gesù incorniciato tra due episodi che hanno come protagoniste alcune donne. La prima è una donna di Betania, che unge il capo di Gesù con un prezioso olio di nardo (Mt 26,6-13), le altre sono Maria di Magdala e le donne sul Calvario quando Gesù muore (27,55s) e, dopo il sabato, si recano al sepolcro alla prima luce dell’alba (28,1). Sono figure che illuminano il mistero.
Mancavano due giorni alla Pasqua. «Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre egli stava a tavola» (Mt 26,6s). È un momento di convivialità con la presenza del Signore.
 Ad un certo punto compare una donna: chi sia, non si sa, non ha nome e non dice nemmeno una parola. Compie solo un gesto. Nella sala si spande la fragranza del profumo che suscita sdegno e proteste. Perché questo spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri!
Ad un certo punto compare una donna: chi sia, non si sa, non ha nome e non dice nemmeno una parola. Compie solo un gesto. Nella sala si spande la fragranza del profumo che suscita sdegno e proteste. Perché questo spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri!La donna tace, e Gesù afferma: «Perché infastidite questa donna? Ha compiuto un’azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura» (vv.10-13). La donna - rivela Gesù - ha preparato il suo corpo per la morte.
Quello che gli apostoli non riescono a comprendere e che Gesù aveva detto più volte, lo ha compreso una donna: i capi dei sacerdoti e gli scribi volevano ucciderlo. In ogni caso, lei è l’unica ad aver capito che la vita di Gesù ha un esito preciso, la morte, e la morte viene perché Gesù ha donato la vita, perché si è fatto tutto a tutti. La donna lo ha veduto, lo ha ascoltato, custodisce le sue parole nel cuore, lo ha amato; e ora vuole essergli vicino con gratitudine. Risponde con amore all’amore di Gesù. Quel profumo è il suo dono, è tutto quello che ha, è tutta la sua vita. Perciò glielo versa fino in fondo, fino all’eccesso, che è la misura dell’amore che si dona senza misura.
La donna ha fatto un’azione buona, dice Gesù; in greco, alla lettera, «un’opera bella». È la bellezza di chi ama e che non bada a nulla per la persona amata. Lei ha compreso che la morte a cui Gesù va incontro è il frutto di un’intera vita donata ai fratelli. E lei, nella sua piccolezza, nella sua povertà, ha voluto esprimerlo con il suo gesto di amore. E Gesù lo accoglie, perché sa accogliere l’amore che gli diamo, che sia poco o tanto. Per lui non conta quello che si dona, ma il cuore con cui lo si dona.
Qui è una donna che dona e la donna sa bene che cosa comporta dare al mondo una vita; lei sa che dando la vita rischia di perdere la propria. Ma è il dono di un amore totale, che non teme il dolore, la sofferenza, la morte. È la profezia di quanto Gesù sta per vivere fino alla croce. La fragranza di quel profumo accompagnerà il Signore nella passione, nella morte, nella resurrezione. È un annuncio di vita e di gioia: è il profumo di Dio, il profumo del Vangelo. «Dovunque sarà annunciato questo Vangelo, nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche ciò che lei ha fatto» (v. 13).
***
Sul Calvario, quando Gesù muore, ci sono le donne che lo accompagnano. Sono lì, nel dolore e nel pianto per il Signore che le ha amate e che loro hanno amato. Una presenza e un amore che sono un segno anche per noi. Quando la vita spesa per gli altri ci porta al calvario e alla croce, spesso la luce della risurrezione è talmente lontana da perdere ogni forza confortatrice. La sofferenza può essere così amara e così totalizzante da spingerci in una situazione di disperata solitudine, di fallimento senza rimedio: la forza del Vangelo per il quale abbiamo tentato di vivere ci si vanifica in mano.
Ai piedi della croce - nel Vangelo di Matteo - i discepoli non ci sono. Ai loro occhi Gesù che muore è il segno della fine di tutto, di una speranza delusa, di un drammatico fallimento. Singolare è allora la figura delle donne sotto la croce. Non è pensabile che ai loro occhi potessero esserci prospettive diverse. Anche per loro Gesù muore, anche per loro il domani è nelle tenebre. Ma c’è un amore più forte che, nel buio, le tiene ai piedi della croce: ed è a questo amore semplice ma pieno, piccolo ma autentico, che per primo si rivela la resurrezione di Gesù.
L’amore delle donne è una strada anche per noi: tante volte ci troviamo nel buio, nello sradicamento totale, nell’assurdo, nel silenzio di Dio. Ma come le donne sono rimaste ai piedi di Gesù che muore, così la nostra preghiera insistente e il nostro silenzio fedele di fronte a un Dio che sembra non rispondere, ha in sé il germe di una speranza: anche a noi, come alle donne, si manifesterà la gloria del Signore che risorge.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- 8 MARZO 2020 (AL TEMPO DEL "CORONA VIRUS"): ASTREA! (“IAM REDIT ET VIRGO”).9 marzo 2020, di Federico La Sala
ASTREA! “IAM REDIT ET VIRGO” ...
CARO ARMANDO... RICORDANDO DI NUOVO E ANCORA IL TUO PREGEVOLISSIMO LAVORO SU- GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA (si cfr. https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/08/gli-arcadi-di-terra-dotranto-premessa-1-x/#comment-238474), E LA TUA CONNESSIONE TRA LA “PIZANA” CAPACE DI “CONDURRE LE NAVI” CON LA FIERA E NOBILE Carola RacKete, A SUO E TUO OMAGGIO, riprendo qui una breve scheda su:
ASTREA - L’Astraea Virgo, ” vergine delle stelle “, simbolo della giustizia, abitò la terra nell’età dell’oro e la lasciò per ultima nell’età del ferro, cedendo all’iniquità ormai dominante. Il ‛ritorno di A. ‘ si identifica in Virgilio con il ritorno dell’età di Saturno (” magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. / iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, / iam nova progenies caelo demittitur alto “, Buc. IV 5-7). L’intero passo virgiliano è parafrasato in Pg XXII 70-72 Secol si rinova; / torna giustizia e primo tempo umano, / e progenïe scende da ciel nova; in Mn I XI 1 è riportato il v. 6 (cui segue la chiosa ‛ Virgo ‘... vocabatur iustitia, quam etiam ‛ Astraeam ‘ vocabant), ricordato anche in Ep VII 6; in Ep XI 15 il nome di A. è usato come metonimico di giustizia (http://www.treccani.it/enciclopedia/astrea_%28Enciclopedia-Dantesca%29/).
Buon 8 marzo 2020 - e buon lavoro...
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- SCUDERIE DEL QUIRINALE. Il fascino di Raffaello, più forte del virus. A Roma la più grande mostra di sempre, record assicurazioni 4 mld (Ansa).26 febbraio 2020, di Federico La Sala
Il fascino di Raffaello, più forte del virus
A Roma la più grande mostra di sempre, record assicurazioni 4 mld *
di Silvia Lambertucci *
ROMA. SCUDERIE DEL QUIRINALE - La qualità, prima di tutto, con un progetto scientifico che è il frutto di tre anni di lavoro e al quale ha collaborato un team di super esperti del settore, da Nicholas Penny a lungo direttore della National Gallery di Londra a Dominique Cordellier del Louvre, dalla direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta al suo predecessore, ex soprintendente di Firenze ed ex ministro della cultura Antonio Paolucci. Ma anche la quantità, con un numero di opere del maestro urbinate, che "mai prima d’ora si erano viste tutte insieme".
Roma celebra i 500 anni dalla morte di Raffaello, pittore grandissimo, ma anche architetto e primo storico soprintendente ai beni culturali, e dopo la meraviglia degli arazzi esposti per una settimana nella Cappella Sistina è conto alla rovescia per la rassegna allestita alle Scuderie del Quirinale.
 Epidemia da coronavirus permettendo , l’apertura al pubblico è prevista dal 5 marzo al 2 giugno, appuntamento "unico e irripetibile, senza nessuna possibilità di replica all’estero", sottolinea il presidente e ad di Ales Scuderie del Quirinale Mario De Simoni.
Epidemia da coronavirus permettendo , l’apertura al pubblico è prevista dal 5 marzo al 2 giugno, appuntamento "unico e irripetibile, senza nessuna possibilità di replica all’estero", sottolinea il presidente e ad di Ales Scuderie del Quirinale Mario De Simoni.
 Lo sforzo del resto è stato titanico, ribadisce, con 54 istituzioni coinvolte nei prestiti, dai Musei Vaticani al Prado, dalla National Gallery alla Pinacoteca di Monaco, il Louvre, la National Gallery di Washington. E un valore assicurativo monstre di 4 miliardi di euro, per le 206 opere esposte (120 di Raffaello) più alto persino del Leonardo colossal appena andato in scena al Louvre.
Lo sforzo del resto è stato titanico, ribadisce, con 54 istituzioni coinvolte nei prestiti, dai Musei Vaticani al Prado, dalla National Gallery alla Pinacoteca di Monaco, il Louvre, la National Gallery di Washington. E un valore assicurativo monstre di 4 miliardi di euro, per le 206 opere esposte (120 di Raffaello) più alto persino del Leonardo colossal appena andato in scena al Louvre.Le prenotazioni sono già tantissime, oltre 70 mila i biglietti acquistati, duemila solo nelle ultime ventiquattrore a dispetto delle notizie sempre più allarmanti che arrivano dal nord Italia. Nessuna disdetta. "Confermate anche tutte le presenze per l’inaugurazione", sottolinea De Simoni, che pure non nasconde la preoccupazione per l’evolversi degli eventi legati alla salute pubblica: "E’ chiaro che faremo quello che le autorità ci dicono di fare", allarga le braccia il manager culturale. Nella peggiore delle ipotesi, spiega, si tenterà "uno spostamento temporale". Tant’è, per ora si va avanti, con il fascino di Raffaello più forte di tutto.
Concepito "a ritroso" con un racconto che parte proprio da una ricostruzione della tomba dell’artista al Pantheon, per poi ripercorrerne tutta l’avventura creativa da Roma a Firenze all’Umbria fino alle radici urbinati, il percorso si sofferma in particolare sul periodo romano, "undici fecondissimi anni" dal 1509 al 6 aprile 1520, data della sua morte improvvisa e prematura, avvenuta "dopo giorni di febbre continua e acuta", come scrisse il Vasari.
 Sono gli anni dei papi mecenati, Giulio II prima Leone X poi, delle importantissime committenze, dalle Stanze dell’appartamento papale con la Segnatura, capolavoro dei suoi 25 anni, agli Arazzi, i lavori per il ricco banchiere Agostini Chigi e la sua Villa Farnesina. Ma è anche l’epoca dei dei dipinti più iconici, dalla Velata alla Fornarina, dal ritratto di Giulio II a quello di Innocenzo X (tutti in mostra) fino all’impegno di architetto per il cantiere di San Pietro.
Sono gli anni dei papi mecenati, Giulio II prima Leone X poi, delle importantissime committenze, dalle Stanze dell’appartamento papale con la Segnatura, capolavoro dei suoi 25 anni, agli Arazzi, i lavori per il ricco banchiere Agostini Chigi e la sua Villa Farnesina. Ma è anche l’epoca dei dei dipinti più iconici, dalla Velata alla Fornarina, dal ritratto di Giulio II a quello di Innocenzo X (tutti in mostra) fino all’impegno di architetto per il cantiere di San Pietro.Centrale in questo racconto, è la Lettera a Leone X , che Raffaello scrisse insieme a Baldassare Castiglione, una missiva destinata a diventare il fondamento stesso della idea italiana di tutela del patrimonio culturale, principio non a caso poi inserito nella Costituzione: le Scuderie ne espongono la preziosa minuta conservata nell’Archivio di Mantova e già questa è una emozione. Come emozionante sarà rivedere in Italia per la prima volta La Madonna d’Alba prestata dalla National Gallery di Washington o La Madonna della Rosa del Prado, la Madonna dei Tempi inviata dalla Pinacoteca di Monaco.
"E’ la mostra più imponente che avremo occasione di vedere dedicata a Raffaello, ma anche la più sensata perché basata su ricerche scientifiche e novità venute fuori dai restauri", fa notare il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, a cui si deve peraltro l’idea di una grande rassegna romana. Due in particolare "il colore del ritratto di Leone X, restaurato dall’opificio delle Pietre Dure". Ma anche la "riscoperta, che si deve a due giovani ricercatrici Roberta Aliventi e Laura Darimbettina, di un frammento di un cartone preparatorio di un dipinto di Giulio Romano che si trova oggi a Padova" .
Uno sforzo, sottolinea Marzia Faietti curatrice insieme al direttore delle Scuderie Matteo Lafranconi , "Che è stato anche un ripercorrere le tappe di un percorso intellettuale, quello della nostra generazione". Alla ricerca, tra l’altro, dei messaggi che ancora oggi l’opera di Raffaello può dare. Uno su tutti, "il più moderno" secondo la studiosa, "è quello di pace" che viene ad esempio dalla Scuola di Atene "dove tante persone di diverse culture dialogano tra loro". Proprio in quegli anni, ricorda, usciva il pamphlet di Erasmo da Rotterdam contro la guerra: " E Raffaello, spirito aperto, era allineato con i grandi pensatori d’Europa, i più grandi pacifisti". Lunga vita a Raffaello. (ANSA).
- Associate
* Fonte: Ansa, 24 febbraio 2020 (ripresa parziale).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- UNA "LEZIONE" SU COME NASCONO I BAMBINI E LE BAMBINE E I GENITORI, OGGI.11 febbraio 2020, di Federico La Sala
COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! ... *
Cantico dei Cantici.
Il corpo delle donne (intimità della Bibbia)
di Luigino Bruni (Avvenire, martedì 11 febbraio 2020)
Sono tra coloro che sono rimasti delusi dalla performance di Roberto Benigni al Festival di Sanremo dedicata al biblico Cantico dei Cantici. Forse perché avevo aspettative alte, grazie al ricordo, vivissimo, delle sue meravigliose letture di Dante, della Costituzione italiana, dei Dieci comandamenti; forse perché Benigni ci ha donato film molto amati per la loro poesia e forza etica.
Ma, forse, in questa delusione c’è anche qualcosa di più. Il corpo delle donne, insieme a quello dei bambini, è il primo bene che una civiltà deve tutelare e proteggere con tutte le sue forze. Quando un uomo, un maschio, parla del corpo della donna, prima deve togliersi i calzari dai piedi perché sta entrando in un territorio sacro, una terra fatta sacra da molto amore e da moltissimo dolore. Da sempre il corpo della donna, prima di essere icona dell’amore, è stato immagine di potere, di violenza, di abusi e di soprusi, di corpo ferito e di eros comprato dai maschi.
 Non si può parlare del corpo delle donne senza avere ben in mente i molti millenni di storia umana in cui le donne hanno vissuto il proprio corpo come luogo da custodire e da preservare dall’uso cattivo dei maschi, un uso sbagliato che ancora troppo spesso è presente e non solo storia.
Non si può parlare del corpo delle donne senza avere ben in mente i molti millenni di storia umana in cui le donne hanno vissuto il proprio corpo come luogo da custodire e da preservare dall’uso cattivo dei maschi, un uso sbagliato che ancora troppo spesso è presente e non solo storia.Ho guardato Benigni insieme a mia mamma e mia sorella. Due donne moderne, laiche, riconciliate con la vita e con i corpi loro, dei figli e dei mariti. Non hanno detto una parola durante lo spettacolo, ma l’aria di casa si è riempita di un pudore mescolato con l’imbarazzo e il disagio.
 Accanto a loro, io ho avuto forte l’impressione di vedere sullo schermo una donna denudata in pubblico da Benigni, senza che lei avesse dato il suo consenso, denudata ai soli fini dello show. Ho visto quella giovane donna medio-orientale, vissuta due millenni e mezzo fa, e in lei ho rivisto le bellissime ragazze delle Mezzaluna fertile (il Cantico mette insieme antichi poemi nuziali babilonesi e cananei).
Accanto a loro, io ho avuto forte l’impressione di vedere sullo schermo una donna denudata in pubblico da Benigni, senza che lei avesse dato il suo consenso, denudata ai soli fini dello show. Ho visto quella giovane donna medio-orientale, vissuta due millenni e mezzo fa, e in lei ho rivisto le bellissime ragazze delle Mezzaluna fertile (il Cantico mette insieme antichi poemi nuziali babilonesi e cananei).Una ragazza ’bruna’ in un mondo di maschi, in una cultura patriarcale che vedeva poco e male le donne, nascoste sotto la tenda, a occuparsi per tutta la vita di bambini e anziani. Quando nella Bibbia si incrocia una donna non è mai un incontro banale. Quelle donne hanno in genere lottato e sofferto molto per entrare in quel racconto, hanno dovuto farsi spazio in una cultura che non glielo dava spontaneamente.
Donne che vivevano poco e male, quasi tutte analfabete, e non di rado morivano per gravidanze non sempre volute e desiderate. Quale eros conosceva quella ragazza del Cantico? Non certamente quello delle fantasie di noi maschi del XXI secolo, né quello che ci ha raccontato Benigni.
 Il Cantico è testo profetico, perché dice ai maschi e alle donne del suo tempo quale fosse il disegno di Dio sulla donna e sull’amore. Non era la descrizione dell’eros che quegli antichi scrittori vedevano attorno a loro, ma l’eros di un mondo futuro sempre desiderato e mai raggiunto.
Il Cantico è testo profetico, perché dice ai maschi e alle donne del suo tempo quale fosse il disegno di Dio sulla donna e sull’amore. Non era la descrizione dell’eros che quegli antichi scrittori vedevano attorno a loro, ma l’eros di un mondo futuro sempre desiderato e mai raggiunto.
 Non dobbiamo infatti dimenticare che il Cantico è un intreccio di presenza e di assenza dell’amato. È anche un canto all’amore non trovato, che fugge, che non si trova:
Non dobbiamo infatti dimenticare che il Cantico è un intreccio di presenza e di assenza dell’amato. È anche un canto all’amore non trovato, che fugge, che non si trova:«Lungo la notte, ho cercato l’amore dell’anima mia; l’ho cercato, ma non l’ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze; voglio cercare l’amore dell’anima mia. L’ho cercato, ma non l’ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città: ’Avete visto l’amore dell’anima mia?’» (Cantico 3,1-3).
Senza questa dimensione di mancanza, di assenza, di limite, non si comprende l’eros che diventa solo gioco o sterile ricerca di piacere. L’eros è insieme pienezza e indigenza, ferita e benedizione. Ferita per tutti, uomini e donne, ma diversamente e di più per le donne (ferita, cioè vulnus).
Non credo che il Cantico sia stato scritto da una donna, e non lo credo per molte ragioni. Ma soprattutto non lo credo perché una donna non avrebbe parlato del proprio corpo e di quello del suo uomo con quelle parole. Le donne hanno altre parole per parlare dell’amore, dell’eros, della philia e dell’agape. Perché dell’eros le donne amano parlare solo due alla volta, nell’intimità di un rapporto d’amore, dove le parole non dette e quelle sussurrate sono importanti almeno quanto il corpo donato, e quando mancano queste poche parole diverse il corpo parla poco e male.
L’unico numero buono dell’eros è il due. E quando dell’eros si parla troppo e si parla in pubblico l’eros diventa altro, ed è bene usare altre parole molto meno nobili. La Bibbia ha da sempre letto quell’antico canto nuziale in modo sapienziale, allegorico e profetico, non per negare l’eros ma per salvarlo, perché l’unico modo per salvare l’eros è custodirlo nella sua intimità e nel suo nascondimento. E quando il Cantico viene letto senza ideologie e manipolazioni, non si fa una esperienza erotica, ma si fa una esperienza spirituale, mistica e soprattutto poetica:
«Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto! Perché, ecco, l’inverno è passato, è cessata la pioggia, se n’è andata; i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!» (2,10-13).
La poesia è stata infatti la grande assente dalla lettura di Benigni, una poesia mangiata dalla bramosia, molto infantile, di stupire gli spettatori con quell’eros ’nascosto’ dai preti e rabbini finalmente scoperto e liberato. Tutti i giorni i media usano i corpi delle donne per fare spettacolo, per vendere, per fare audience. E ogni giorno di più. La Bibbia non lo ha mai fatto. Parla poco di eros e di sesso, perché ne rispetta il mistero e l’intimità. La Bibbia va portata in tv, va portata ovunque, perché parla solo e sempre di vita. Ma se proviamo a manipolarla si chiude e non ci fa accedere al suo mistero e alla sua bellezza. Come, nonostante le probabili buone intenzioni, è accaduto l’altra sera sul palco di Sanremo.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO: "AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" (Cantico dei cantici: 8.6). Un omaggio a William Shakespeare e a Giovanni Garbini.
COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907
- ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS - NON IL "LOGO"! La questione della "Parola" e della "Lingua" ...
- RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!!
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- LA MOSTRA. Gli arazzi di Raffaello tornano nella Cappella Sistina, sotto gli affreschi di Michelangelo e Perugino (di Marco Bussagli).7 febbraio 2020, di Federico La Sala
La mostra.
Gli arazzi di Raffaello tornano nella Cappella Sistina
Per una settimana, dal 17 al 23 febbraio, i capolavori intessuti a Bruxelles su cartoni del "divino" tornano sotto gli affreschi di Michelangelo e Perugino, dove li volle Leone X
di Marco Busssagli (Avvenire, venerdì 7 febbraio 2020)
Dopo quasi quarant’anni gli arazzi disegnati dal grande artista per papa Leone X tornano per una settimana nel luogo per cui il pontefice li aveva voluti Raffaello, in questi giorni, inizia a far sentire la sua presenza in maniera sempre più insistente. In realtà, le iniziative hanno preso avvio già nel 2019, quando, proprio su queste pagine, abbiamo recensito la bella mostra (ancora in corso, fino al prossimo 17 marzo) dedicata a Giovanni Santi, il padre del grande artista.
 Ora, i Musei Vaticani vogliono (e possono) stupire tutti, come ha annunciato il direttore Barbara Jatta, esibendo dal 17 al 23 febbraio, una delle opere di Raffaello meno note al grande pubblico: gli arazzi realizzati per Leone X Medici. Non basta, però, perché non si tratta di una semplice esposizione.
Ora, i Musei Vaticani vogliono (e possono) stupire tutti, come ha annunciato il direttore Barbara Jatta, esibendo dal 17 al 23 febbraio, una delle opere di Raffaello meno note al grande pubblico: gli arazzi realizzati per Leone X Medici. Non basta, però, perché non si tratta di una semplice esposizione.
 Gli arazzi saranno ricollocati nella Cappella Sistina, per la quale erano stati pensati. Si tratta di un evento raro che non avveniva dal 1983, quando il mondo celebrò il cinquecentenario della nascita del grande artista.
Gli arazzi saranno ricollocati nella Cappella Sistina, per la quale erano stati pensati. Si tratta di un evento raro che non avveniva dal 1983, quando il mondo celebrò il cinquecentenario della nascita del grande artista.Quando papa Medici li fece appendere la prima volta, per coprire i finti velari ad affresco che appartengono alla prima decorazione della Cappella, quella voluta da Sisto IV Della Rovere che incaricò il Perugino di coordinare un manipolo di artisti stellari, da Botticelli a Luca Signorelli, passando per il Perugino stesso, non esisteva ancora il Giudizio Universale di Michelangelo che, però, aveva dipinto la volta. Allora, il desiderio di Leone X di lasciare la sua traccia nei Palazzi Pontifici lo spinse, forse già dal 1514, a commissionare i cartoni (oggi conservati al Victoria and Albert Museum di Londra) in modo da poter intervenire nella decorazione di uno dei luoghi che - già allora - era considerato il più prestigioso dei Palazzi Vaticani.
Realizzati, fra il 1515 e il 1519, gli arazzi furono tessuti nella bottega di Pieter van Aelst a Bruxelles e avrebbero pienamente assolto a questo compito. Per questo in occasione di cerimonie importanti, venivano appesi in Sistina, lungo le pareti dell’aula, dove avevano la funzione di completare il programma degli affreschi quattrocenteschi con gli episodi della vita di Mosè e di Cristo. Gli arazzi, infatti, focalizzavano l’attenzione sulle vicende di san Pietro e di san Paolo, cui si affiancava la scena del Martirio di santo Stefano, prima vittima del nuovo credo cristiano.
 Divennero una sorta di scuola pittorica del mondo (si pensi a Guido Reni e Carracci) e, come manufatti, furono copiati dalle principali corti europee mentre, nel XVII secolo, furono imitati da Rubens a Poussin e dalla stessa Santa Sede, quando papa Urbano VIII pensò bene di farne realizzare altri con gli episodi della propria vita.
Divennero una sorta di scuola pittorica del mondo (si pensi a Guido Reni e Carracci) e, come manufatti, furono copiati dalle principali corti europee mentre, nel XVII secolo, furono imitati da Rubens a Poussin e dalla stessa Santa Sede, quando papa Urbano VIII pensò bene di farne realizzare altri con gli episodi della propria vita.Dalla Pesca miracolosa, fino al bellissimo San Paolo in carcere (che prefigura, per certi versi, le soluzioni della Sala dei Giganti di Giulio Romano al Palazzo Te di Mantova), passando per la Punizione di Elima (Atti degli Apostoli 13) uno stregone che si era opposto alla predicazione di san Paolo, fino alla Predica di san Paolo, tanto per ricordare quelli dal maggior impatto visivo, gli arazzi sono una successione di capolavori di stoffa.
Si tratta di opere che hanno anche un profondo significato religioso e politico, come mostra, quello dedicato all’episodio evangelico della Guarigione dello storpio (Atti degli Apostoli, III, 1 ss.). Ogni giorno, a Gerusalemme, un uomo, storpio fin dalla nascita, chiedeva l’elemosina vicino al Tempio. Quando vide Pietro e Giovanni che si erano recati nella città, non mancò di chiederla anche a loro. Pietro, allora, gli rispose di non avere con sé oro né argento, ma di potergli donare solo la fede in Cristo e aggiunse: «...nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!». Raffaello ambienta la scena fra le colonne tortili del Tempio di Salomone che si riteneva fossero state portate a Roma dopo la distruzione operata dall’imperatore Tito. Esse, poi, avrebbero sorretto la pergola marmorea del San Pietro costantiniano. Non è un caso, però, che sia Pietro l’unico ad ergersi ritto in piedi a mo’ di colonna fra quelle del Tempio di Salomone. Infatti, è lui, la colonna del Tempio nuovo, quello fondato da Cristo. Ai lati (fra le quinte-navate laterali), si accalca la folla dei curiosi e dei fedeli. È il popolo della nuova Chiesa.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
RAFFELLO: AUGUSTO, LA SIBILLA TIBURTINA, E LA "MADONNA DI FOLIGNO".
UNA "CAPPELLA SISTINA" IN ROVINA: BENI CULTURALI, SCUOLA, E TERRITORIO: CONTURSI TERME.
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- "ADMIRABILE SIGNUM": "IL MIRABILE SEGNO" DEL PRESEPE E IL MISTERO DELL’INCARNAZIONE. Lettera apostolica di Papa Francesco.1 dicembre 2019, di Federico La Sala
 LETTERA APOSTOLICA
LETTERA APOSTOLICA
 Admirabile signum
Admirabile signum
 DEL SANTO PADRE
DEL SANTO PADRE
 FRANCESCO
FRANCESCO
 SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE *
SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE *1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata.
2. L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da cui presepe.
 Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana.
Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana.
 Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia.
Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia.
 Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. -La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.[2]
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero.
Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. -La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.[2]
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero.
 Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e toccante s’aggiunse anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia Gesù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia».[3]
Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e toccante s’aggiunse anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia Gesù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia».[3]3. San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità. D’altronde, il luogo stesso dove si realizzò il primo presepe esprime e suscita questi sentimenti. Greccio diventa un rifugio per l’anima che si nasconde sulla roccia per lasciarsi avvolgere nel silenzio.
 Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.
Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.
 Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali.
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali.
 In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).
In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).4. Mi piace ora passare in rassegna i vari segni del presepe per cogliere il senso che portano in sé. In primo luogo, rappresentiamo il contesto del cielo stellato nel buio e nel silenzio della notte. Non è solo per fedeltà ai racconti evangelici che lo facciamo così, ma anche per il significato che possiede. Pensiamo a quante volte la notte circonda la nostra vita. -Ebbene, anche in quei momenti, Dio non ci lascia soli, ma si fa presente per rispondere alle domande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza: chi sono io? Da dove vengo? Perché sono nato in questo tempo? Perché amo? Perché soffro? Perché morirò? Per dare una risposta a questi interrogativi Dio si è fatto uomo. La sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e rischiara quanti attraversano le tenebre della sofferenza (cfr Lc 1,79).
 Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte del presepe e che spesso rappresentano le rovine di case e palazzi antichi, che in alcuni casi sostituiscono la grotta di Betlemme e diventano l’abitazione della Santa Famiglia. Queste rovine sembra che si ispirino alla Legenda Aurea del domenicano Jacopo da Varazze (secolo XIII), dove si legge di una credenza pagana secondo cui il tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando una Vergine avesse partorito. Quelle rovine sono soprattutto il segno visibile dell’umanità decaduta, di tutto ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito. Questo scenario dice che Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro splendore originario.
Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte del presepe e che spesso rappresentano le rovine di case e palazzi antichi, che in alcuni casi sostituiscono la grotta di Betlemme e diventano l’abitazione della Santa Famiglia. Queste rovine sembra che si ispirino alla Legenda Aurea del domenicano Jacopo da Varazze (secolo XIII), dove si legge di una credenza pagana secondo cui il tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando una Vergine avesse partorito. Quelle rovine sono soprattutto il segno visibile dell’umanità decaduta, di tutto ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito. Questo scenario dice che Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro splendore originario.5. Quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre collochiamo nel presepe le montagne, i ruscelli, le pecore e i pastori! In questo modo ricordiamo, come avevano preannunciato i profeti, che tutto il creato partecipa alla festa della venuta del Messia. Gli angeli e la stella cometa sono il segno che noi pure siamo chiamati a metterci in cammino per raggiungere la grotta e adorare il Signore.
 «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene nella semplicità della descrizione. -A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe.
«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene nella semplicità della descrizione. -A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe.6. Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante statuine simboliche. Anzitutto, quelle di mendicanti e di gente che non conosce altra abbondanza se non quella del cuore. Anche loro stanno vicine a Gesù Bambino a pieno titolo, senza che nessuno possa sfrattarle o allontanarle da una culla talmente improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano affatto. I poveri, anzi, sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi.
 I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. -Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato.
Spesso i bambini - ma anche gli adulti! - amano aggiungere al presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere che in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che giocano...: tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina.
I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. -Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato.
Spesso i bambini - ma anche gli adulti! - amano aggiungere al presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere che in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che giocano...: tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina.
 7. Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbedienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” Maria diventava madre del Figlio di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica (cfr Gv 2,5).
7. Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbedienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” Maria diventava madre del Figlio di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica (cfr Gv 2,5).
 Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ed emigrare in Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.
Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ed emigrare in Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.8. Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, eppure è così: in Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque.
 La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti al loro figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe che guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita.
La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti al loro figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe che guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita.
 «La vita infatti si manifestò» (1 Gv 1,2): così l’apostolo Giovanni riassume il mistero dell’Incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a partire dal quale anche si ordina la numerazione degli anni, prima e dopo la nascita di Cristo.
Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché sembra impossibile che Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. -Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri schemi. Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo della vita.
«La vita infatti si manifestò» (1 Gv 1,2): così l’apostolo Giovanni riassume il mistero dell’Incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a partire dal quale anche si ordina la numerazione degli anni, prima e dopo la nascita di Cristo.
Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché sembra impossibile che Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. -Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri schemi. Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo della vita.9. Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si collocano nel presepe le tre statuine dei Re Magi. Osservando la stella, quei saggi e ricchi signori dell’Oriente si erano messi in cammino verso Betlemme per conoscere Gesù, e offrirgli in dono oro, incenso e mirra. Anche questi regali hanno un significato allegorico: l’oro onora la regalità di Gesù; l’incenso la sua divinità; la mirra la sua santa umanità che conoscerà la morte e la sepoltura.
 Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con concrete azioni di misericordia.
Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con concrete azioni di misericordia.
 I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Davanti al Re Bambino li pervade una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel loro Paese, avranno raccontato questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti.
I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Davanti al Re Bambino li pervade una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel loro Paese, avranno raccontato questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti.10. Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Questi ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è stato fatto trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la stessa esperienza. Non è importante come si allestisce il presepe, può essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi.
Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli.
Dato a Greccio, nel Santuario del Presepe, 1° dicembre 2019, settimo del pontificato.
FRANCESCO
 [1] Tommaso da Celano, Vita Prima, 84: Fonti francescane (FF), n. 468.
[1] Tommaso da Celano, Vita Prima, 84: Fonti francescane (FF), n. 468.
 [2] Cf. ibid., 85: FF, n. 469.
[2] Cf. ibid., 85: FF, n. 469.
 [3] Ibid., 86: FF, n. 470.
[3] Ibid., 86: FF, n. 470.
 [01938-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[01938-IT.01] [Testo originale: Italiano]
* Fonte: Lettera apostolica. Papa Francesco a Greccio: ecco il vero significato del presepe di Mimmo Muolo, Avvenire, 30.11.2019 (ripresa parziale).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- IL RINASCIMENTO E "LA LUNA vista da Leonardo". I 50 anni dell’Apollo 11 e i 500 anni del genio da Vinci (di Flavia Marcacci).19 novembre 2019, di Federico La Sala
Scienza. La Luna vista da Leonardo
Pochi hanno messo in connessione i 50 anni dell’Apollo 11 con i 500 anni del genio da Vinci che tra i primi studiò e disegnò il fenomeno della ’luce cinerea’
di Flavia Marcacci (Avvenire, martedì 19 novembre 2019)
Signora dell’anno 2019 è la Luna: si celebrano i 50 anni della conquista del suo suolo. Eventi e pubblicazioni si stanno succedendo rapidamente, ricordando quanto avvenne in quel frenetico 1969, che tra la protesta di Jan Palach e la nascita del progenitore di Internet Arpanet fu fitto di molti fatti decisivi per la grande e piccola storia. Eppure, il 20 luglio i passi silenziosi di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna ebbero il potere di fermare ogni altro vocio e ogni altra preoccupazione.
Il potere di vedere (video) a distanza (tele) promesso dallo strumento che stava cambiando la società, la televisione, giungeva a un impensabile lontano: la potenza della tecnica veniva consacrata, quasi riscattando i timori che era andata suscitando dopo l’esperienza atomica.
 La nostra Terra deve molto alla Luna, e non a caso essa è stata nei secoli un oggetto privilegiato per la scienza, la filosofia e l’arte. Il nostro satellite è stato il più vicino tra gli oggetti lontanissimi, la porta d’accesso al cielo deputato invalicabile e tramite esso finalmente accessibile. La luna fu scrutata da Leonardo da Vinci (1452-1519), altro protagonista del 2019, poiché del genio toscano ricorrono i 500 anni dalla morte. Pochi hanno notato la convergenza tra le due ricorrenze.
La nostra Terra deve molto alla Luna, e non a caso essa è stata nei secoli un oggetto privilegiato per la scienza, la filosofia e l’arte. Il nostro satellite è stato il più vicino tra gli oggetti lontanissimi, la porta d’accesso al cielo deputato invalicabile e tramite esso finalmente accessibile. La luna fu scrutata da Leonardo da Vinci (1452-1519), altro protagonista del 2019, poiché del genio toscano ricorrono i 500 anni dalla morte. Pochi hanno notato la convergenza tra le due ricorrenze.Leonardo aveva disegnato il satellite terrestre, dando nota del fenomeno della ’luce cinerea’ nel Codice Leicester (foglio 2 r), come ricordava fin dagli anni Settanta il noto studioso Carlo Pedretti (1928-2018). Il fenomeno si osserva tra novilunio e prima fase e nell’ultima fase: può capitare così che la luce del Sole venga riflessa dalla Terra e vada a illuminare una piccola porzione in ombra del satellite, in modo da renderlo visibile anche all’alba. Per lo stesso fenomeno, Armstrong e Aldrin dalla Luna avrebbero potuto osservare un bel ’chiaro di Terra’, con il nostro pianeta stabile nel cielo lunare (altezza in dipendenza dalla latitudine).
A completare la spiegazione della luce cinerea fu Galileo Galilei, chiamandola anche «candore lunare» a intendere le sfumature grigiastre, talvolta tendenti al verde o all’azzurro e capaci di conferire una leggerezza impercettibile al corpo celeste. Il Pisano diede alla Luna l’altro grande merito di segnare l’inizio dell’astronomia in senso moderno (ovvero usando strumenti), quando con il ’perspicillo’ (il telescopio, da perspicio, guardare in profondità) ne scoprì cavità e valli nel 1609 poi riprodotte nei famosi disegni pubblicati nel Sidereus nuncius (1610): da allora in poi, la scienza non sarebbe più tornata indietro.
 Si avviò così la pratica di descrivere la Luna: la selenografia vantò tra i suoi adepti molti italiani, che raramente trovano un posto nelle storie italiane della scienza destinate al grande pubblico. Solo dopo Galileo il noto gesuita Cristoph Scheiner, docente a Roma tra il 1624 e il 1633, propose una delle prime mappe lunari (1614); dopo di lui fu la volta del confratello Giuseppe Biancani (1620).
Si avviò così la pratica di descrivere la Luna: la selenografia vantò tra i suoi adepti molti italiani, che raramente trovano un posto nelle storie italiane della scienza destinate al grande pubblico. Solo dopo Galileo il noto gesuita Cristoph Scheiner, docente a Roma tra il 1624 e il 1633, propose una delle prime mappe lunari (1614); dopo di lui fu la volta del confratello Giuseppe Biancani (1620).Furono però soprattutto il bolognese Francesco Maria Grimaldi e il ferrarese Giovanni Battista Riccioli, entrambi ancora gesuiti, ad avere il merito di produrre gran parte della nomenclatura lunare che usiamo tutt’oggi. Il loro lavoro fu pubblicato nell’Almagestum novum ( 1651) e si dice che fu merito essenzialmente di Grimaldi, il quale compì la maggior parte delle osservazioni. I diritti d’autore sono però difficili da stabilire, essendo i due strettissimi collaboratori e Grimaldi una sorta di allievo di Riccioli. Ciò che conta è che sul suolo lunare essi impressero nomi celebri, molti dei quali già adoperati poco tempo prima dagli astronomi Michael F. van Langren e Johannes Hevelius (Jan Heweliusz): i due studiosi italiani ripresero le prime nomenclature per renderle più sistematiche e razionali. I crateri, le terre e i mari lunari furono battezzati con il nome di personaggi antichi, nell’emisfero nord, e moderni, nell’emisfero sud.
 Per questo motivo oggi sulle mappe lunari troviamo memoria di astronomi (da Tolomeo e Ipparco a Copernico e Biancani), di santi e sante (da san Teofilo e san Cirillo a santa Caterina da Siena), di filosofi (da Anassimandro a Platone).
Per questo motivo oggi sulle mappe lunari troviamo memoria di astronomi (da Tolomeo e Ipparco a Copernico e Biancani), di santi e sante (da san Teofilo e san Cirillo a santa Caterina da Siena), di filosofi (da Anassimandro a Platone).Guardare alla luna, però, non era utile solo per descriverla. Si cercava di comprendere la natura dei cieli (cf. La Lune aux XVIIe et XVIIIe siècles, edited by C. Grell and S. Taussig, Brepols, Turnhout, 2013). Nel Seicento alcuni pensavano, ad esempio, che il termine ’luna’ derivasse da lucuna (lux, luce e una, una) a intendere che la Luna fosse l’unica a essere sempre illuminata dal Sole. La Luna aveva anche un ruolo sociale rilevante, perché i suoi ritmi mensili andavano calcolati insieme a quelli del Sole per ottenere il calendario: fu proprio la sfasatura tra essi che portò alla grande riforma di papa Gregorio XIII.
Oltre alla cosmologia e alla scienza calendrica, il satellite della Terra stimolava anche il mito e la poesia. Gli appellativi del nostro satellite erano così tanti che è difficile elencarli: dal greco Selene a indicarne lo splendore, all’ebraico Lebana a richiamarne la bianchezza; da Artemide, Selene ed Ecate, dee che custodivano il grembo del corpo celeste nelle sue varie fasi, fino alla dea ’triforme’ citata da Cleomede e Virgilio.
La Luna non andava soltanto descritta, ma scritta. La ricchezza delle fantasie lunari di Luciano di Samosata (II sec. d.C.) ebbe una certa fortuna in epoca rinascimentale, probabilmente avvantaggiata dalla diffusione del fascino per i mirabilia e i fatti immaginati e prodigiosi: l’Icaromenippo proponeva il viaggio di Menippo sulla Luna, per giungere da lì fino alla casa degli dei. Su tutti non si può evitare di pensare all’Astolfo sulla Luna di Ludovico Ariosto, fino alle ipotesi di John Wilkins protese all’eventualità di abitanti sulla Luna (The discovery of a world in the moone, 1638).
La Luna era in grado di evocare fantasie, sentimenti ed emozioni, attingendo da ciò che nell’essere umano vi è di più profondo. Probabilmente ne tennero conto coloro che volevano solo descriverla fino a intravedere sul suo suolo i luoghi esistenziali della crisi, della siccità, della tranquillità, della serenità e della fecondità. Per questo nelle sue regioni si trovano la ’Terra della sterilità’ e la ’Terra della Vita’, il ’Mare della Crisi’ e il ’Mare della Tranquillità’.
Dai tempi di Leonardo e della selenografia torniamo così ai nostri tempi. Proprio il Mare della Tranquillità divenne famoso cinquant’anni fa, quando allunarono nei suoi pressi gli uomini della Missione Apollo 11. La Luna, lontana, scrutata, sognata era stata raggiunta. Il satellite forniva all’umanità l’ennesimo servizio, facendosi solcare da da orme umane sui luoghi della Tranquillità, forse proprio quelli a cui ambisce più profondamente ogni anima e dove la scienza dovrebbe contribuire ad avvicinarsi.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- ARTE E SACRO. COSA LEGGEVA LA MADONNA. Che cosa c’era sul leggio di Maria? (di Rosita Copioli).21 ottobre 2019, di Federico La Sala
IL MITO DELLE ORIGINI FAVOLOSE E IL PECCATO ORIGINALE... *
Arte e sacro. Che cosa c’era sul leggio di Maria?
Nelle raffigurazioni dell’Annunciazione il libro su cui legge Maria compare tardi, dal IX secolo. Il filologo Michele Feo va a caccia delle tante ipotesi sul contenuto del volume
di Rosita Copioli (Avvenire, sabato 19 ottobre 2019)
- [Foto] Antonello da Messina, “Vergine Annunciata” (1475 circa), particolare
La storia della Madonna è un meraviglioso romanzo per immagini. Più misteriosa tra tutte l’Annunciazione perché è il mistero stesso di Maria. Ma anche la più rivoluzionaria nella storia dell’umanità, perché fonda il mondo dopo Adamo: il mondo da Gesù Cristo, origine del nostro tempo. E poi perché racchiude tutto il turbamento, anzi lo sconvolgimento, e insieme la concentrata tenerezza della Vergine prima che concepisca e nel suo stesso istante: l’anticipazione dell’aurora, prima che irrompa il giorno in lei, in ognuno di noi.
Le scarne parole di Luca e Matteo non sono prive di immagini potenti, anzi assolute: per Alberto Magno l’ombra non è l’oscurità - che non viene dalla somma luce - ma l’immagine specchiata dell’onnipotenza; tuttavia solo i Vangeli apocrifi ci mostrano le scene, gli oggetti, i simboli, che i pittori prediligono. In essi Maria è alla fonte, al pozzo con la brocca, poi in casa, intenta a filare scarlatto e porpora (colori della regalità) accanto a un vaso dove fiorisce il giglio di Gesù; più tardi ha con sé un libro aperto e talora lo legge.
Sono queste le raffigurazioni che si susseguono dovunque nei secoli, in molteplici varianti. Soprattutto impone infinite riflessioni la presenza del libro, che compare tardi, dal IX secolo, su un cofanetto d’avorio francese dall’aria regale. Perché quella ragazza umile e il libro, che fu strumento di distinzione, non solo per la sapienza, ma nelle classi sociali? E significava soprattutto autorevolezza, garanzia di verità? E cosa era scritto nel libro di Maria, oltre alle parole dei profeti, dei salmi, dei Vangeli, del Magnificat?
Si può rispondere che Maria stessa è un libro, contiene il passato e soprattutto il futuro: un libro profetico al massimo grado. Ma c’è quella commistione di realtà e di sentimenti, che colpisce nel profondo, e non si accontenta di spiegazioni teologiche. In Maria il mistero teologico è reale e carnale, attraversa la vita quotidiana, gli affetti delle madri nelle famiglie, tutte le forme reali e immaginarie, che le madri quotidiane e le divinità femminili hanno mostrato in ogni tempo e spazio.
Michele Feo, filologo e acutissimo investigatore dei testi, ne è stato così commosso e catturato, da inventariarne le immagini per uno studio colto e appassionato (Cosa leggeva la Madonna; Polistampa, pagine 304, euro 20,00). Ma non dobbiamo pensare che l’indagine di Feo si limiti a un excursus erudito che riguarda soltanto l’abbinamento con il libro. Si estende a ogni riflessione che tocca Maria, con una condivisione totale e sottile della femminilità e dei suoi valori più profondi.
Mentre segue nei secoli e nelle contestualizzazioni delle opere le Annunciazioni, decifrando e commentando le iscrizioni e le composizioni, Feo non dimentica mai l’origine. Chi è veramente Maria? Cosa accade nel momento in cui riceve l’annuncio traumatico dell’angelo che ha sconvolto lei fino a noi stessi? Perché l’Annunciazione non è un evento che si conclude, ma un progetto che ci riguarda inesorabilmente? Come sono diventati lontani nei secoli i sensi originari? Come tutto è diventato infinitamente indecifrabile, sebbene continuino a colpirci quegli atti e quei gesti e quelle mani della ragazza non ancora madre, che talora si specchiano nelle mani dell’angelo, o - come nella Vergine Annunciata palermitana di Antonello da Messina - emergono in assoluta eloquenza fuori dal quadro?
La ricchezza di questo libro sta anche nella presentazione di testi preziosi che accompagnano la figura dell’Annunciazione; non solo quelli sacri, o Dante, o Petrarca (di cui Feo è massimo studioso), che nel cammino dell’amore che nobilita attraverso la donna, compie la «rivoluzionaria e decisiva collocazione della Vergine a chiusura dei Rerum vulgarium fragmenta». Feo ci traduce molti testi straordinari: ora popolari, ora dei più sofisticati umanisti che intrecciano la Vergine con le divinità greco-latine, ora di mistici ottocenteschi, ora di teologi moderni. Il valore del libro sta anche nel sapiente dialogo che Feo intrattiene tra culture diverse.
Vorrei aggiungere una testimonianza, che ha origine da due antiche tradizioni romagnole. Esse hanno riscontri nei calendari popolari e nel Tempio malatestiano di Rimini, dove compaiono le due porte che le anime passano: nel segno del Capricorno abbandonano la carne attraverso la porta degli dèi e dell’immortalità; nel segno del Cancro si incarnano. Nell’Annunciazione (e incarnazione) del 25 marzo, nell’equinozio di primavera, Maria è seduta, intenta a filare il lino “marzuolo”. In questa immagine, che riprende il protovangelo di Giacomo, Maria è l’umile donna antica, attenta alla rocca, al fuso, al telaio. Ma rievoca anche archetipi: Elena che in Omero tesse una tappezzeria di porpora con le lotte di Greci e Troiani in cui lei è al centro; Cloto che fila lo stame della vita.
La vigilia di Natale, a Ravenna, in una filastrocca che inizia con l’invocazione «Levati, levati mio sole / con il raggio del Signore», tre angeli donano a Maria tre forcine o tre falci d’oro: lei le porge al Signore, e Lui con queste mette in moto la ruota del cosmo: è la nascita di Gesù e del tempo: il compimento dell’Annunciazione avviene nel solstizio d’inverno, sotto il segno del Capricorno. In sintonia con tradizioni immemoriali, raccolte da quelle platoniche, Maria tra primavera ed estate incarna, mentre nel cuore dell’inverno, con il “sole invitto” libera dalla carne, verso l’eternità.
*
Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:
Michele Feo, Mio nonno era un re , "Il grande vetro".
- Maria Montessori, Il peccato originale [e "i reattivi psichici"], a cura di Fulvio De Giorgi, Morcelliana, Brescia 2019.
- DONNE, UOMINI E VIOLENZA...L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
Come MARIA: "FIGLIA DEL TUO FIGLIO", così GIUSEPPE: "FIGLIO DEL TUO FIGLIO"!!! Dante non "cantò i mosaici" dei "faraoni".
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- GIAMBATTISTA ROSSI E IL FILO "DELLE SIBILLE" - DA CONTURSI TERME (SALERNO) A RIPACANDIDA (POTENZA).30 agosto 2019, di Federico La Sala
GIAMBATTISTA ROSSI E IL FILO "DELLE SIBILLE" - "DELLE MONACHE" TERESIANE - DA CONTURSI TERME (SALERNO) A RIPACANDIDA (POTENZA). Note: *
- La Storia e le Chiese di Ripacandida: [...] La chiesa di S. Giuseppe, fondata nel 1173, è comunemente chiamata “delle monache” ed è passata sotto il titolo di Santa Teresa nel 1735, allorché l’arciprete Giovanni Battista Rossi fondò il convento delle suore Teresiane, conosciute anche
come “Carmelitane scalze”. Questo nel 1753 fu frequentato daS. Gerardo Maiella, quando ne era priora Suor Maria Araneo di Gesù, nata a Pescopagano nel 1725, nipote per parte materna di Giambattista Rossi, e morta nel 1801, il cui corpo èstato ritrovato integro dopo 190 anni, durante i lavori di riparazione della chiesa a causa del terremoto del 1980.
 Una lapide fatta affiggere nella cuspide della facciata nel1750 da don Giovanni Rossi, arcidiacono e presbitero, molto legato ed umilmente devoto a San Giuseppe, invita ad elevare preghiere (pia vota) per il defunto fratello Giovanni Battista al santo Patriarca, protettore di Santa Teresa, padre putativo di Gesù e vero sposo della Vergine:
Una lapide fatta affiggere nella cuspide della facciata nel1750 da don Giovanni Rossi, arcidiacono e presbitero, molto legato ed umilmente devoto a San Giuseppe, invita ad elevare preghiere (pia vota) per il defunto fratello Giovanni Battista al santo Patriarca, protettore di Santa Teresa, padre putativo di Gesù e vero sposo della Vergine:
- D.O.M. / INCARNATI VERBI PUTATIVO PATRI / VERO DEIPARAE VIRGINIS SPO(n)SO / S. THERESIAE PRAECIPUO TUTELARI / SS. PATRIARCHAE / JOSEPH / DEVINCTISSIMUS HUMILISSIMUS CLIE(n)S / U.J.D. JO(h)ANNES ROSSI / P. A. IOANNIS BAPTISTE DEFUNCTI FRATRIS / PIA VOTA PROSER(it) / A.D. MDCCL
- (“A Dio Ottimo Massimo. Al padre putativo del Verbo incarnato, vero sposo delle Vergine Madre di Dio, principale protettore di Santa Teresa, il santo patriarca Giuseppe, il fedele a lui assai legato ed umilmente devoto Giovanni Rossi dottore in entrambi i diritti presbitero e arcidiacono invita ad elevare fervide preghiere per il fratello defunto Giovanni Battista. A. D. 1750”).
- [...] A destra dell’altare maggiore, in cornu epistulae, è il maestoso monumento funebre dell’arciprete Giovanni Rossi, ornato dello stemma di famiglia, fatto erigere dal nipote Giambattista Maria Araneo, fratello della priora Suor Maria di Gesù, con il seguente epitaffio:
- D.O.M. /JOHANNES ROSSI / ARCHIPRESBYTER CONTURSINUS / HUJUS MONASTERIJ S. JOSEPH / MONALIUM S. THERESIAE FUNDATOR /IN SACRIS HUMANISQUE LITTERIS / PROFUNDA ERUDITIONE CONSPICUUS / DIGNITATES MERITUS OBLATAS DESPEXIT / CUI / SANCTISSIMI SUAVISSIMIQUE MORES /RERUMQUE HUMANARUM DESPECTUS / /SUMMAM APUD OMNES MERITAMQUE / VIRTUTIS COMMENDATIONEM PEPERERE / VIXIT ANNOS LXXII M. I D. II /RIPAECANDIDAE / LUCEM CLAUSIT EXTREMAM / DIE XXIII JULIJ MDCCLI /JOHANNES BAPTISTA MA. ARANEO /AVUNCULO DULCISSIMO AC INCOMPARABILI / GRATUS EJUSDEMQUE MEMORIAE STUDIOSISSIMUS / MONUMENTUM / L. M. P.
- Vi si esalta l’uomo di profonda cultura e di grande umiltà, fondatore insieme con il fratello Giambattista del monastero delle Teresiane: “A Dio ottimo massimo. Giovanni Rossi, arciprete, originario di Contursi, fondatore di questo Monastero di San Giuseppe e delle Monache di Santa Teresa, distintosi per la profonda conoscenza delle lettere sacre e umane, disdegnò le cariche offertegli, pur essendone meritevole, al quale i costumi santissimi e dolcissimi e il disprezzo delle cose umane procurarono presso tutti grandissimo e meritato titolo di affidamento per il suo valore. Visse 72 anni 1 mese e 2 giorni; a Ripacandida chiuse l’ultimo giorno il 23 luglio 1751. Giovanni Battista M.a Araneo allo zio dolcissimo ed incomparabile, grato e assai premuroso della sua memoria, questo sepolcro pose per mandato testamentario”
 (Cfr. LEO VITALE, La Storia e le Chiese di Ripacandida, Rionero in Vulture 2010, p. 161, e pp. 165-166).
(Cfr. LEO VITALE, La Storia e le Chiese di Ripacandida, Rionero in Vulture 2010, p. 161, e pp. 165-166).
[GIAMBATTISTA ROSSI: Padre Giambattista Francesco Donato Rossi (anche Giovanbattista, Johannes Baptista Rossi in latino) (Ripacandida, 10 marzo 1690 - Ripacandida, 25 ottobre 1746) è stato un presbitero italiano.
Figlio dell’avvocato Donatantonio Rossi (originario di Contursi) e di Porzia Baffari. Le sue spoglie sono custodite nel cappellone del Santissimo Sacramento, in un monumento opera di stuccatori napoletani, nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro di Ripacandida. Lo scrittore storico Giustino Fortunato affermò che:
- «"... nel settecento il Vulture fu teatro dell’onnipotenza divina, per opera di due venerabili servi del Signore, l’arciprete di Ripacandida Giambattista Rossi e il fratello laico liguorino San Gerardo Maiella."»
I suoi genitori pii e religiosissimi, ospitavano i pellegrini che giungevano nella festa solenne di San Donato d’Arezzo, patrono di Ripacandida, dividendo con loro il cibo. Fin da piccolo visse come eremita nelle stanze attigue alla cappella della Madonna del Carmine, con Tommaso da Potenza. Praticava la stessa penitenza del suo concittadino San Donatello, del quale era devotissimo.
Affetto da epilessia guarì per voto fatto a san Donato, era devoto anche di san Pietro d’Alcantara. Crebbe con la lettura delle opere di Santa Teresa d’Avila e di San Giovanni della Croce, alimentando così la sua vocazione carmelitana. Portava il cilicio sulla nuda carne; e sul petto una croce di legno con 45 chiodini premendola spesso sul petto. La sua alimentazione era di tipo quaresimale, mangiava solo olive ammuffite, malva, frutti acerbi, beveva acqua mista ad aceto ed usava per letto la nuda terra.
Nel 1703 manifestò ai genitori di voler diventare religioso dei Carmelitani. Ottenuto il consenso anche dal fratello don Giovanni, arciprete di Ripacandida, partì alla volta di Napoli ma non poté attuare il suo sogno: fu rifiutato perché miope. Richiamato in famiglia per combinare il suo matrimonio con una ragazza del luogo, rifiutò dicendo "sarò prete". Nell’aprile 1713 fu ordinato sacerdote. Celebrando la messa era spesso rapito in estasi e dopo la celebrazione Eucaristica ringraziava con il volto proteso a terra. Rimaneva a lungo nel confessionale, si dedicava alla catechesi dei ragazzi e degli adulti, si portava al tramonto nelle campagne per raggiungere chi non poteva seguirlo in paese.
Per acclamazione del popolo e dell’ordine diocesano veniva eletto arciprete e nel 1731 gli viene affidata la chiesa madre di Santa Maria del Sepolcro. Desideroso di costruire un ricovero per le ragazze esposte a gravi pericoli, con il consenso del fratello Giovanni, donò la sua casa natale per la fondazione del monastero nel 1735 delle carmelitane, nel quale accorsero ragazze dai paesi vicini. Per un intero quaresimale, si recò tutti i giorni nella vicina Rionero in Vulture, in quel momento senza confessori. Partiva a piedi, predicava, ascoltava le confessioni per tornare a Ripacandida in serata. I rioneresi, volevano ricompensarlo con elemosine, ma egli non accettò esortandoli a fare il possibile per la costruzione della nuova chiesa. Memori dell’apostolato dell’arciprete Rossi vollero l’immagine della Madonna del Carmine, da allora la patrona di Rionero. Il 25 ottobre 1746 il venerabile servo tornò alla casa del padre, l’elogio funebre fu tenuto dall’arciprete Fusco di Rionero (Wikipedia, ripresa parziale).
*
Sul tema si cfr.:
UOMINI E DONNE, PROFETI E SIBILLE, OGGI: STORIA DELLE IDEE E DELLE IMMAGINI. A CONTURSI TERME (SALERNO), IN EREDITA’, L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE .....
 RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.Federico La Sala
- La Storia e le Chiese di Ripacandida: [...] La chiesa di S. Giuseppe, fondata nel 1173, è comunemente chiamata “delle monache” ed è passata sotto il titolo di Santa Teresa nel 1735, allorché l’arciprete Giovanni Battista Rossi fondò il convento delle suore Teresiane, conosciute anche
come “Carmelitane scalze”. Questo nel 1753 fu frequentato daS. Gerardo Maiella, quando ne era priora Suor Maria Araneo di Gesù, nata a Pescopagano nel 1725, nipote per parte materna di Giambattista Rossi, e morta nel 1801, il cui corpo èstato ritrovato integro dopo 190 anni, durante i lavori di riparazione della chiesa a causa del terremoto del 1980.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- " Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500" (FINO AL 15 SETTEMBRE 2019)23 agosto 2019, di Federico La Sala
Mostra d’arte - PROROGATA AL 15 SETTEMBRE 2019
“Rinascimento visto da sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500” a Palazzo Lanfranchi
Giovedì 18 aprile 2019 alle ore 18 all’interno di Palazzo Lanfranchi a Matera è in programma l’inaugurazione della mostra d’arte “Rinascimento visto da sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500” a cura di Marta Ragozzino, Pierluigi Leone de Castris, Matteo Ceriana e Dora Catalano. La mostra resterà aperta fino al 19 luglio 2019.
- Da periferia a centro.
Non unico ma affatto secondario, del Rinascimento italiano. E’ il cambio di prospettiva che, rispetto ad una storiografia imperante, propone la grande mostra Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500 che si può ammirare dal 19 aprile al 19 agosto 2019 al Museo nazionale di arte medievale e moderna della Basilicata in Palazzo Lanfranchi, naturalmente a Matera, quest’anno Capitale Europea della Cultura. Ed è la Fondazione Matera-Basilicata 2019 insieme al Polo Museale della Basilicata che propongono e coproducono questa fondamentale rassegna, affidata alla cura di Marta Ragozzino, Pierluigi Leone de Castris, Matteo Ceriana e Dora Catalano.
200 selezionatissime opere, con prestiti dai più importanti musei europei, documentano la fioritura artistica e culturale avvenuta nell’Italia meridionale nel secolo a cavallo tra la metà del Quattrocento e la metà del Cinquecento. Allargando la visuale al più ampio contesto del Mediterraneo. In una mostra che rovescia il punto di vista tradizionale su uno dei più importanti periodi storico artistici e offre una nuova lettura del Rinascimento, mettendo in luce la centralità delle rotte mediterranee, gli scambi e i rapporti tra le culture, i viaggi degli artisti e delle loro opere.
Una storia meridiana, fatta di contaminazioni culturali e scambi intensissimi tra le sponde del Grande Mare, in quel secolo speciale durante il quale, con la scoperta dell’America, si è ‘allargato’ il mondo. Che mostra come e quanto questo spazio equoreo sia stato percepito come esiguo, facilmente percorribile e passibile di continui rapporti e, allo stesso tempo, avvertito come vasto, irrelato e ostile.
La grande esposizione materana “rivela - afferma Marta Ragozzino - la rete potente di circolazioni culturali e scambi, tra nord e sud ma anche tra est ed ovest, che hanno visto la Basilicata e il Sud farsi naturale epicentro di idee, innovazioni, culture. Dalle Fiandre alla Spagna, da Costantinopoli a Venezia, Firenze e Roma. Ad alimentare la fioritura di una vicenda artistica alternativa a quella ben nota e paradigmatica delle capitali del Rinascimento, frutto prezioso di una straordinaria koiné meridiana. Della quale appare importante riconoscere e leggere dinamiche, protagonisti e comprimari e il cui centro gravitazionale presto divenne Napoli, già capitale culturale ‘internazionale’ nel XIV secolo sotto i più importanti re angioini, in particolare durante il regno di re Roberto. Proponendo una rilettura interdisciplinare, attenta alla dialettica tra “centro e periferia”.
In Palazzo Lanfranchi e nella attigua Chiesa del Carmine ad essere proposta, in un percorso arricchito da grandi immagini e postazioni multimediali di approfondimento, è una stimolante rilettura di testimonianze culturali e scientifiche le più diverse: dipinti, sculture, miniature, medaglie, oreficerie, arazzi, tessuti, maioliche, libri e stampe ma anche oggetti preziosi, carte geografiche, portolani, strumenti di navigazione... Con l’obiettivo di mettere a fuoco una storia originale, diversa da quella sviluppata nelle grandi capitali del centro e del nord, come Firenze, Milano, Venezia, Roma, seppur continuamente interconnessa agli eventi e ai linguaggi che caratterizzarono queste capitali. “Tra le principali opere esposte - anticipano i curatori - la quattrocentesca Carta del navegar di Albino da Canepa, insieme a molte altre Carte, Mappamondi, Portolani e strumenti di navigazione. La grande Pianta prospettica di Venezia di Jacopo de Barbari a confronto con la Veduta di Napoli del Museo di San Martino, medaglie e fogli miniati che raccontano dei protagonisti della vicenda storica che la mostra illustra, accompagnate dalla maestosa Incoronazione di Ferrante I D’Aragona dal Bargello.
Il Martirio di Santa Lucia di Martorell da Barcellona con la Santa Lucia di Alvaro Pirez di Nola recentemente restaurata. L’Adorazione dei magi tratta da Van Eyck accanto all’Uomo con anello del maestro fiammingo proveniente da Sibiu, preziose opere di Colantonio e Antonello da Messina, tra le quali le tavolette di Reggio Calabria. Due opere di Jacomart Baço accanto a opere di pittori spagnoli attivi in Sardegna come Thomas e Figuera. E poi Francesco Laurana, Domenico Gagini, Andrea Guardi e la superba Testa di cavallo di Donatello, dal MAN di Napoli. L’Annunciazione di Bartolomeo Vivarini da Modugno, il San Girolamo di Lazzaro Bastiani da Monopoli, il polittico di Michele da Valona da Guglionesi, per illustrare i rapporti di dare e avere sulla sponda adriatica. E poi tessuti, libri, codici, uno dei busti di Carlo V del Montorsoli, il Ritratto del Sultano Solimano di Hieronymus Hopfer, ma soprattutto lo Studio preparatorio per la Madonna del Pesce di Raffaello e le opere ad essa collegate di Cesare da Sesto, Girolamo da Salerno, Giovan Francesco Penni, Giovan Filippo Criscuolo e del notevole Andrea Sabatini. Grandi polittici dalla Basilicata interna e opere venete giunte sulla sponda pugliese, tra cui dipinti di Lotto, Pordenone, Paris Bordon e altre opere che sorprenderanno i visitatori per finire con capolavori di Polidoro da Caravaggio e Pedro Machuca”. A comporre una spettacolare, intensa mostra affresco.
“La grande mostra sul Rinascimento visto da Sud - dichiara Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019 - ci offre la testimonianza di come, anche in una delle fasi più elevate della civiltà europea, il Mezzogiorno abbia avuto un ruolo da protagonista, a partire dal suo ruolo di hub tra il Mediterraneo e il continente. E’, in tutta evidenza, un tema di strettissima attualità che declina una delle principali direttrici di sviluppo della capitale europea della cultura. Nel 2019 da un piccolo centro del sud, Matera, si diffonderà il meglio delle produzioni artistiche e culturali europee. E tra queste c’è sicuramente la mostra che abbiamo coprodotto con il Polo Museale della Basilicata”.
RINASCIMENTO VISTO DA SUD. MATERA, L’ITALIA MERIDIONALE E IL MEDITERRANEO TRA 400 E 500.
Il grande progetto espositivo intitolato Rinascimento visto da sud: Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500, che si svolgerà dal 18 aprile al 19 agosto 2019 nel Museo di Palazzo Lanfranchi a Matera, intende ricostruire, attraverso un nuovo racconto visivo fatto di rare e preziose opere d’arte ma anche di oggetti e documenti storici di forte impatto, la fioritura artistica e culturale avvenuta nell’Italia meridionale nel secolo a cavallo tra la metà del Quattrocento e la metà del Cinquecento in relazione con il più ampio contesto del Mediterraneo.
La mostra, che prevede naturalmente un focus particolare su Matera e la Basilicata, sarà integrata e arricchita da speciali percorsi di conoscenza e valorizzazione delle opere d’arte tardogotiche e rinascimentali disseminate nel territorio regionale, inamovibili per tipologia o per dimensioni.
In tali percorsi saranno considerati i principali affreschi locali del tempo, ad esempio quelli di San Donato a Ripacandida, quelli della chiesa rupestre di Santa Barbara a Matera e quelli della Trinità di Miglionico, ma anche i grandi polittici come quello di Cima da Conegliano sempre a Miglionico, che testimonia, insieme alla straordinaria scultura raffigurante Sant’Eufemia del Duomo di Montepeloso oggi Irsina, l’attenzione locale alla cultura veneta; oppure le opere realizzate nei primi decenni del cinquecento da Giovanni Luce o Francesco da Tolentino a Pietrapertosa o, infine, i numerosi polittici eseguiti per i paesi lucani (Senise, San Chirico Raparo, Salandra, Stigliano etc), da Simone da Firenze, prolifico pittore-emigrante che nella Basilicata interna trovò una committenza pienamente soddisfatta del suo linguaggio “moderno”, che guardava ai maestri toscani della fine del secolo precedente.
I percorsi di valorizzazione territoriale coinvolgeranno anche la vicina Puglia, dove non si potranno dimenticare, ad esempio, gli affreschi della chiesa di Santa Caterina a Galatina o quelli di Santo Stefano a Soleto.
L’idea innovativa che guida il progetto scientifico della mostra, che si vuole rivolgere a un pubblico internazionale e non specialista e che è realizzata grazie alla collaborazione dei più importanti studiosi dei linguaggi artistici, della storia e della cultura rinascimentali, è quella di rovesciare il punto di vista tradizionale su questo ampio e importante periodo della storia europea, nell’ambito di un’articolata rilettura interdisciplinare, attenta alla dialettica tra “centro e periferia”. Una rilettura che avvicini in modo stimolante testimonianze culturali e scientifiche diverse (dipinti, sculture, miniature, medaglie, oreficerie, arazzi, tessuti, maioliche, libri e stampe ma anche oggetti preziosi, carte geografiche, portolani, strumenti di navigazione etc) mettendo a fuoco una storia diversa da quella sviluppata nelle grandi capitali del centro e del nord, come Firenze, Milano, Venezia, Roma, seppur continuamente interconnessa agli eventi e ai linguaggi che caratterizzarono queste capitali.
Una storia meridiana, fatta di contaminazioni culturali e scambi intensissimi avvenuti tra le sponde del mar Mediterraneo, in quel secolo speciale durante il quale si è ‘allargato’ il mondo, come si intende documentare visivamente grazie all’ausilio di grandi “mappa mundi” e atlanti del tempo, che accompagneranno il percorso della mostra, che sarà contraddistinta da un allestimento di forte impatto, in grado di far dialogare in modo sorprendente le opere d’arte con i molteplici e inconsueti ‘documenti’, che costituiranno il filo rosso della mostra.
Una storia che dia anche conto, oggi che il Mare Nostrum è tragicamente al centro dell’attenzione, della mutazione dell’idea di Mediterraneo nella mentalità dei popoli che vi si affacciavano, tra la caduta di Costantinopoli e il definitivo assetto della struttura geopolitica delle sue sponde. Di come e quanto questo spazio equoreo sia stato percepito come esiguo, facilmente percorribile e passibile di continui rapporti, ma sia stato anche avvertito come vasto, irrelato e ostile.
La mostra intende rivelare e illuminare circolazioni culturali e scambi importantissimi che hanno permesso la fioritura di una vicenda artistica alternativa a quella ben nota e paradigmatica delle capitali del Rinascimento, frutto prezioso di una straordinaria koiné meridiana, della quale appare importante riconoscere e leggere dinamiche, protagonisti e comprimari e il cui centro gravitazionale presto divenne Napoli, già capitale culturale ‘internazionale’ nel XIV secolo sotto i più importanti re angioini, in particolare durante il regno di re Roberto.
La città partenopea, rifiorita dal punto di vista delle arti durante il breve regno di Renato d’Angiò (1438-1442), consolidò il suo ruolo di baricentro culturale del Mediterraneo nella lunga stagione aragonese aperta dall’arrivo a Napoli di Alfonso I il Magnanimo (1442-1458), a cui seguì il figlio Ferrante (1458-1494). Dal 1503, dopo la breve parentesi francese, negli anni spagnoli che si intende approfondire, dal 1503 al 1535, Napoli mantenne il suo ruolo di grande capitale del Viceregno e, caratterizzata da una forte crescita demografica, divenne ben presto la seconda florida metropoli del Mediterraneo dopo Istanbul. Qui Carlo V entrò trionfalmente dalla Porta Capuana il 25 novembre del 1535, arrivando dalla Sicilia dove si era fermato dopo la conquista di Tunisi e la sconfitta del Barbarossa, atteso da don Pedro de Toledo, vicerè da due anni, a cui si deve la grande trasformazione urbanistica della città ‘spagnola’ (il completamento delle mura aragonesi, la costruzione di Castel Sant’Elmo, palazzi, chiese e soprattutto strade, oltre alla bonifica di zone malsane). L’articolato racconto che si dipana in quasi tutte le sale del museo copre circa un secolo di storia, dal 1438, data di inizio dell’ultimo regno angioino a Napoli, al 1535, anno in cui Carlo V riconquistò Tunisi e raggiunse poi le più importanti città del vicereame, Palermo, Messina, ed infine Napoli.
Una grande installazione multimediale e evocativa accoglierà i visitatori nella Chiesa del Carmine collegata a Palazzo Lanfranchi.
La mostra sarà aperta da una sezione sul Mediterraneo, le rotte, gli scambi, i commerci ma anche l’immagine del potere e le dinastie regnanti nel Quattrocento, con un successivo focus sul Mediterraneo nel Cinquecento, che accompagneranno come un filo rosso l’intero percorso espositivo e permetteranno di far emergere i grandi protagonisti del tempo. Queste due ricche sezioni trasversali e interdisciplinari, nelle quali si alternano documenti e oggetti particolarmente significativi, sono illuminate anche dalla presenza di preziosi ritratti dei protagonisti della vicenda storica che si vuole ricostruire, chiesti in prestito ai più grandi musei italiani e stranieri (tra i quali il Ritratto di Alfonso di Aragona dal Museo Jacquemart André di Parigi, l’Incoronazione di Ferrante d’Aragona di Benedetto da Maiano dal Bargello di Firenze, il busto di Carlo V del Montorsoli dal napoletano museo di Capodimonte, il Ritratto del vicerè Pedro de Toledo dal Museo della Certosa di San Martino ma anche lo stemma di Renato d’Angiò dal prezioso Codice di Santa Marta, conservato nell’Archivio di Stato di Napoli).
Alla notevole sezione introduttiva seguirà una ricca sezione dedicata alla lunga stagione del gotico internazionale nei due versanti occidentale e orientale, che permetterà di introdurre e descrivere il territorio, le corti, i feudi e le città (si potranno ammirare opere di Bernat Martorell, di Alvaro Pirez, del Maestro di Ladislao di Durazzo, di Giovanni di Francia, opere di orafi e scultori meridionali insieme a tavole del Maestro della Madonna di Atella e del Maestro di Santa Barbara, entrambi attivi in Basilicata).
Con la terza corposa sezione, nella quale si illustreranno Napoli, la Spagna, la Provenza e le Fiandre a confronto con Firenze e Roma ma anche con Venezia e l’Oriente, il progetto entrerà nel vivo del Rinascimento mediterraneo in rapporto al Rinascimento italiano, mettendo l’accento in particolare sul ruolo e i rapporti di dare e di avere degli artisti internazionali che hanno gravitato attorno alle corti di Renato, di Alfonso e di Ferrante, producendo opere per i più importanti committenti religiosi del tempo, tra i quali sono i principali ordini monastici. Saranno messi in relazione capolavori dei più importanti artisti catalani, spagnoli e fiamminghi accanto a opere degli artisti meridionali, attivi nel viceregno e poi anche in Spagna.
Anche per il grande pubblico sarà interessante verificare quanto queste idee artistiche abbiano progressivamente impregnato il territorio meridionale. E come si siano diffuse, seppure in maniera più limitata, in una regione interna come la Basilicata.
Artisti internazionali che hanno saputo fare propria, in tempi assai precoci e grazie a questi scambi, la lezione fiamminga e gli spunti nordici, mediati dalle presenze provenzali, borgognone e spagnole.
In questa sezione saranno messe a confronto, grazie a importanti prestiti internazionali, preziose opere dei principali protagonisti dell’arte e della cultura del tempo, tra i quali Colantonio, Antonello da Messina, Jacomart Baço, Roig de Corella, ma anche Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Bartolomeo Vivarini, Antoniazzo Romano, Pedro Befulco, Cristoforo Scacco, Cristoforo Faffeo, il Maestro di San Severino e Sossio, Francesco Pagano, Riccardo Quartararo per la pittura; Donatello, Domenico Gagini, Francesco Laurana, Guillermo Sagrera ma anche Pietro Alamanno per la scultura, senza dimenticare gli anonimi autori delle più importanti opere presenti nel territorio lucano o le preziose pagine miniate dai codici napoletani, come il Libro d’Ore di Alfonso d’Aragona o il Codice di Santa Marta.
Intenzione della mostra è quella di rileggere non solo quanto succedeva nella capitale partenopea e negli altri centri anche insulari del mediterraneo occidentale (ad esempio in Sardegna con i catalani Thomas e Figuera, il Mestro di Castelsardo e il Maestro di Sanluri ad esempio) ma anche quanto avveniva al contempo sulla dorsale adriatica dove, grazie ai porti della Capitanata, della Terra di Bari e di quella d’Otranto (Manfredonia, Molfetta, Bari, Otranto, Brindisi), si mantenevano più forti relazioni con la Serenissima, e attraverso Venezia con l’eredità dell’antico, ma anche con la cultura greco bizantina attestata dall’altra parte del mare. Anche perchè Matera, che in questi anni è ancora parte della Terra d’Otranto, appare permeata da una cultura più adriatica che tirrenica.
Oltre ai capolavori veneti che punteggiano soprattutto il versante est dello stivale meridionale, territorio murgiano-materano incluso (opere di Bellini, Vivarini, Cima da Conegliano anche a Matera, Genzano, Miglionico, oltre alle opere di scultura di ambito padovano che arrivano a Irsina), arrivano soprattutto in Puglia, pittori di ‘icone’, anche seguito delle migrazioni del secondo Quattrocento, che si attestano in diverse località dell’Italia meridionale, come ad esempio i fratelli Donato e Angelo Bizamano provenienti da Creta.
Oltre ai pittori, sulla sponda adriatica arrivano anche le icone (di cui è documentata l’importazione da parte dei mercanti veneziani) che avevano un buon mercato in gran parte del territorio. Non solo, scultori e lapicidi dalmati, che spediscono opere o transitano nelle terre meridionali, vero e proprio protettorato artistico della capitale adriatica.
Un successivo snodo del percorso, che riguarderà i rapporti e gli scambi della fase matura del periodo aragonese, durante i quali la capitale partenopea, che ha attratto i linguaggi mediterranei dei pittori spagnoli e provenzali, diventa centro di trasmissione della nuova cultura artistica, permetterà di entrare nella seconda parte della mostra, dedicata all’arrivo della ‘maniera moderna’ a Napoli e nelle province meridionali.
Nell’ultima grande sezione si tratteggeranno infatti i rapporti degli artisti e dei loro committenti del Viceregno con i modelli provenienti da Roma, Milano, Firenze, Venezia a partire dalle novità di Pinturicchio, Cesare Da Sesto, ma soprattutto Raffaello (nel 1517 arriva a Palermo nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo, l’Andata al Calvario) mediate, tra gli altri, da Polidoro da Caravaggio. Fondamentale la scultura del tempo, Diego de Siloe e Bartolomé Ordóñez, Pietro Belverte e l’allievo Giovanni da Nola, di cui non potranno mancare opere in mostra e la sintesi di Andrea Sabatini da Salerno, il Raffaello del Sud, le cui opere saranno presenti in maniera rilevante insieme a quelle di altri pittori italiani e stranieri attivi anche nelle province interne (il già ricordato Simone da Firenze, Pedro da Aponte, Bartolomeo Guelfo da Pistoia, Pedro Fernandez e Pedro Machuca, ma anche i veneti Lorenzo Lotto, Paris Bordon, Francesco Vecellio e Pordenone, che realizzarono nei primi decenni del 500 diverse opere per le province meridionali). Per arrivare infine alle prime prove di Altobello Persio, tra i più importanti artisti murgiani del Cinquecento.
Una fitta trama di relazioni e influenze, che i documenti materiali disseminati nel territorio (anche in Basilicata) permettono di illuminare. Relazioni che legano Napoli agli altri importanti porti e mercati affacciati sul Mediterraneo occidentale e orientale, Valenza, Barcellona, Marsiglia, Genova, Pisa, Cagliari, Palermo, Tunisi, Alessandria, Cairo, Beirut, Atene, Istanbul, Ragusa, Venezia, come si cercherà di raccontare anche grazie ad una speciale installazione ‘immersiva’ nella Chiesa del Carmine.
- CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- " Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500" (FINO AL 15 SETTEMBRE 2019)23 agosto 2019, di Federico La Sala
- continuazione e fine
Mostra d’arte - PROROGATA AL 15 SETTEMBRE 2019
“Rinascimento visto da sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500” a Palazzo Lanfranchi
- [...]
Non solo storia dell’arte ma anche storia delle idee, delle culture e delle società, per ricostruire, attraverso un inedito racconto, illuminato dalle opere e dagli oggetti, (fondamentali vettori di significati, stratificazioni e contaminazioni culturali), i rapporti e gli scambi culturali e artistici, oltre che economici e politici, tra le sponde del Mediterraneo. E per comprendere meglio anche la vicenda culturale di una terra apparentemente defilata e periferica come la Basilicata, la cui dimensione artistica, più contenuta ma lo stesso interessante, verrà ricostruita e intrecciata in relazione alle prove internazionali, che si diffondono nel territorio a partire dal centro irradiante napoletano.
La vicenda artistica di Matera (e in generale della Basilicata) non è stata infatti sufficientemente riscostruita, sebbene le sue tracce -innestate sul substrato tardo antico- risalgano ai secoli dell’alto medioevo, anche per colpa di un pregiudizio storiografico, dovuto ad una tradizione di studi più attenta alle emergenze e ai capolavori, di cui per altro il territorio non è completamente privo, che alla comprensione dei contesti. In pochi si sono cimentati, fino agli anni più recenti, nell’impresa di ricostruire la storia artistica della regione mettendola in relazione agli ambiti vicini, ai grandi centri e alle rotte di comunicazione, seguite anche dagli artisti nei secoli più alti. Anche di questo si darà conto in mostra.
Il progetto espositivo, centrale nel programma culturale di Matera-Basilicata 2019, intende dunque affrontare il nodo del Rinascimento da un’altra prospettiva: guardando al mare e alle sue rotte, alle coste e soprattutto agli approdi (i porti, i mercati, le città) che nei secoli hanno avvicinato le culture e i popoli, come a una grande ricchezza e opportunità, non come una a una separazione o barriera.
Dai tempi più remoti le popolazioni hanno attraversato il mare Mediterraneo (il mare di ieri e il mare di oggi, mare che univa e che oggi separa), muovendosi da un capo all’altro, in un continuo scambio di dare e di avere. La Basilicata, terra interna, defilata e montuosa ma affacciata su due mari, è sempre stata, a dispetto della sua orografia complicata, terra di passaggio e accoglienza, regione d’intersezione, incontro e collegamento, via di transito di popoli e culture, cerniera e non barriera: porta tra occidente e oriente.
Per questa dialettica incessante tra periferie e centri (nella quale sta anche Matera con la sua storia speciale), per l’importanza degli scambi e delle contaminazioni, specie nell’attuale fase storica, pensando all’Europa e alla sua ricchezza fatta di molteplicità e diversità, abbiamo immaginato un racconto più largo e avvincente, che sappia mettere in relazione la ricostruzione della storia locale e dei suoi protagonisti (riletta attraverso un piccolo nucleo di puntuali presenze lucane in mostra e opportuni percorsi che invece permettano di valorizzare tutte le emergenze del territorio: affreschi, polittici e singole opere) con una storia più grande e differenziata, cornice o tessuto connettivo che restituisca la koinè mediterranea in tutte le sue declinazioni occidentali e orientali, senza dimenticare il lato meridionale del mare, la sponda islamica con le sue specifiche tradizioni e contaminazioni culturali, sempre più importante dopo la conquista di Costantinopoli nel 1453.
Sono gli anni dei grandi viaggi, delle scoperte, delle esplorazioni, ma anche delle conquiste nel nuovo mondo (a partire dalla scoperta dell’America nel 1492). Quello che si conosce del mondo nella seconda metà del Cinquecento è ben diverso da quel che si sapeva nella prima metà del secolo precedente: in pochi decenni lo sguardo si è allargato, ci sono nuovi luoghi e un altro spazio (vogliamo mettere in relazione lo spaesamento di allora con la “crisi della ragione cartografica” di oggi, come scrive Franco Farinelli). E, di conseguenza, è cambiata la forma e la rappresentazione del mondo e le scoperte scientifiche hanno cominciato a ridisegnare anche il cielo. La mostra, che vuole raccontare attraverso le immagini materiali e immateriali (oggetti ma anche fotografie, supporti audiovisivi e piccoli inserti di realtà aumentata) la storia e i luoghi, ma soprattutto gli uomini e le loro idee, seguirà un andamento cronologico che intreccerà la scansione tematica.
Le Sezioni della grande Mostra
La mostra viene aperta da una sezione sul Mediterraneo, le rotte, gli scambi, i commerci ma anche l’immagine del potere e le dinastie regnanti nel Quattrocento, con un successivo focus sul Mediterraneo nel Cinquecento, che accompagneranno come un filo rosso l’intero percorso espositivo e permetteranno di far emergere i grandi protagonisti del tempo. Queste due ricche sezioni trasversali e interdisciplinari, nelle quali si alterneranno documenti e oggetti particolarmente significativi, sono illuminate anche dalla presenza di preziosi ritratti dei protagonisti della vicenda storica che si vuole ricostruire, chiesti in prestito ai più grandi musei italiani e stranieri (tra i quali il Ritratto di Alfonso di Aragona dal Museo Jacquemart André di Parigi, l’Incoronazione di Ferrante d’Aragona di Benedetto da Maiano dal Bargello di Firenze, il busto di Carlo V del Montorsoli dal napoletano museo di Capodimonte, il Ritratto del vicerè Pedro de Toledo dal Museo della Certosa di San Martino ma anche lo stemma di Renato d’Angiò dal prezioso Codice di Santa Marta, conservato nell’Archivio di Stato di Napoli).
Alla notevole sezione introduttiva segue una ricca sezione dedicata alla lunga stagione del gotico internazionale nei due versanti occidentale e orientale, che permette di introdurre e descrivere il territorio, le corti, i feudi e le città (vi si possono ammirare opere di Bernat Martorell, di Alvaro Pirez, del Maestro di Ladislao di Durazzo, di Giovanni di Francia, opere di orafi e scultori meridionali insieme a tavole del Maestro della Madonna di Atella e del Maestro di Santa Barbara, entrambi attivi in Basilicata).
Con la terza corposa sezione, nella quale si illustrano Napoli, la Spagna, la Provenza e le Fiandre a confronto con Firenze e Roma ma anche con Venezia e l’Oriente, il progetto entrerà nel vivo del Rinascimento mediterraneo in rapporto al Rinascimento italiano, mettendo l’accento in particolare sul ruolo e i rapporti di dare e di avere degli artisti internazionali che hanno gravitato attorno alle corti di Renato, di Alfonso e di Ferrante, producendo opere per i più importanti committenti religiosi del tempo, tra i quali sono i principali ordini monastici. Vi vengono messi in relazione capolavori dei più importanti artisti catalani, spagnoli, provenzali e fiamminghi accanto a opere degli artisti meridionali, attivi nel viceregno e poi anche in Spagna.
Anche per il grande pubblico risulta interessante verificare quanto queste idee artistiche abbiano progressivamente impregnato il territorio meridionale. E come si siano diffuse, seppure in maniera più limitata, in una regione interna come la Basilicata. Artisti internazionali che hanno saputo fare propria, in tempi assai precoci e grazie a questi scambi (ricostruiti nel corso degli ultimi anni a partire dal pionieristico studio di Ferdinando Bologna e dalla mostra curata da Mauro Natale del 2001 ai quali si fa riferimento), la lezione fiamminga e gli spunti nordici, mediati dalle presenze provenzali, borgognone e spagnole.
In questa sezione vengono messe a confronto, grazie a importanti prestiti internazionali, preziose opere dei principali protagonisti dell’arte e della cultura del tempo, tra i quali Colantonio, Antonello da Messina, Jacomart Baço, Barthelemy D’Eyck, Roig de Corella, Bartolomé Bermejo, Riccardo Quartararo ma anche Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Bartolomeo Vivarini, Antoniazzo Romano, Pedro Befulco, Cristoforo Scacco, Cristoforo Faffeo, il Maestro di San Severino e Sossio, Francesco Pagano, Riccardo Quartararo per la pittura; Donatello, Domenico Gagini, Francesco Laurana, Guillermo Sagrera ma anche Pietro Alamanno per la scultura, senza dimenticare gli anonimi autori delle più importanti opere presenti nel territorio lucano o le preziose pagine miniate dai codici napoletani, come il Libro d’Ore di Alfonso d’Aragona o il Codice di Santa Marta.
Intenzione della mostra è quella di rileggere non solo quanto succedeva nella capitale partenopea e negli altri centri anche insulari del mediterraneo occidentale (ad esempio in Sardegna con i catalani Tomas e Fuguera e il Maestro di Sanluri ad esempio) ma anche quanto avveniva al contempo sulla dorsale adriatica dove, grazie ai porti della Capitanata, della Terra di Bari e di quella d’Otranto (Manfredonia, Molfetta, Bari, Otranto, Brindisi), si mantenevano più forti relazioni con la Serenissima, e attraverso Venezia con l’eredità dell’antico, ma anche con la cultura greco bizantina attestata dall’altra parte del mare. Anche perchè Matera, che in questi anni è ancora parte della Terra d’Otranto, appare permeata da una cultura più adriatica che tirrenica.
Oltre ai capolavori veneti che punteggiano soprattutto il versante est dello stivale meridionale, territorio murgiano-materano incluso (opere di Bellini, Vivarini, Cima da Conegliano anche a Matera, Genzano, Miglionico, oltre alle opere di scultura di ambito padovano che arrivano a Irsina), arrivano soprattutto in Puglia, pittori di ‘icone’, anche seguito delle migrazioni del secondo Quattrocento, che si attestano in diverse località dell’Italia meridionale, come ad esempio i fratelli Donato e Angelo Bizamano provenienti da Creta.
Oltre ai pittori, sulla sponda adriatica arrivano anche le icone (di cui è documentata l’importazione da parte dei mercanti veneziani) che avevano un buon mercato in gran parte del territorio. Non solo, scultori e lapicidi dalmati, che spediscono opere o transitano nelle terre meridionali, vero e proprio protettorato artistico della capitale adriatica.
Un successivo snodo del percorso, che riguarda i rapporti e gli scambi della fase matura del periodo aragonese, durante i quali la capitale partenopea, che ha attratto i linguaggi mediterranei dei pittori spagnoli e provenzali, diventa centro di trasmissione della nuova cultura artistica, permetterà di entrare nella seconda parte della mostra, dedicata all’arrivo della ‘maniera moderna’ a Napoli e nelle province meridionali.
Nell’ultima grande sezione si tratteggeranno infatti i rapporti degli artisti e dei loro committenti del Viceregno con i modelli provenienti da Roma, Milano, Firenze, Venezia. A partire dalle novità di Pinturicchio, Cesare Da Sesto, ma soprattutto Raffaello (nel 1517 arriva a Palermo nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo, l’Andata al Calvario) mediate, tra gli altri, da Polidoro da Caravaggio.
Fondamentale la scultura del tempo, Diego de Siloe e Bartolomé Ordóñez, Pietro Belverte e l’allievo Giovanni da Nola, di cui non potranno mancare opere in mostra e la sintesi di Andrea Sabatini da Salerno, il Raffaello del Sud, le cui opere saranno presenti in maniera rilevante insieme a quelle di altri pittori italiani e stranieri attivi anche nelle province interne (il già ricordato Simone da Firenze, Pedro da Aponte, Bartolomeo Guelfo da Pistoia, Pedro Fernandez e Pedro Machuca. E i veneti Lorenzo Lotto, Paris Bordon, Francesco Vecellio e Pordenone, che realizzarono nei primi decenni del 500 diverse opere per le province meridionali). Per arrivare infine alle prime prove di Altobello Persio, tra i più importanti artisti murgiani del Cinquecento.
Una fitta trama di relazioni e influenze, che i documenti materiali disseminati nel territorio (anche in Basilicata) permettono di illuminare. Relazioni che legano Napoli agli altri importanti porti e mercati affacciati sul Mediterraneo occidentale e orientale, Valenza, Barcellona, Marsiglia, Genova, Pisa, Cagliari, Palermo, Tunisi, Alessandria, Cairo, Beirut, Atene, Istanbul, Ragusa, Venezia, come si cercherà di raccontare anche grazie ad una speciale installazione ‘immersiva’ nella Chiesa del Carmine.
Non solo storia dell’arte ma anche storia delle idee, delle culture e delle società, per ricostruire, attraverso un inedito racconto, illuminato dalle opere e dagli oggetti, (fondamentali vettori di significati, stratificazioni e contaminazioni culturali), i rapporti e gli scambi culturali e artistici, oltre che economici e politici, tra le sponde del Mediterraneo. E per comprendere meglio anche la vicenda culturale di una terra apparentemente defilata e periferica come la Basilicata, la cui dimensione artistica, più contenuta ma lo stesso interessante, verrà ricostruita e intrecciata in relazione alle prove internazionali, che si diffondono nel territorio a partire dal centro irradiante napoletano.
La vicenda artistica di Matera (e in generale della Basilicata) non è stata infatti sufficientemente riscostruita, sebbene le sue tracce -innestate sul substrato tardo antico- risalgano ai secoli dell’alto medioevo, anche per colpa di un pregiudizio storiografico, dovuto ad una tradizione di studi più attenta alle emergenze e ai capolavori, di cui per altro il territorio non è completamente privo, che alla comprensione dei contesti. In pochi si sono cimentati, fino agli anni più recenti, nell’impresa di ricostruire la storia artistica della regione mettendola in relazione agli ambiti vicini, ai grandi centri e alle rotte di comunicazione, seguite anche dagli artisti nei secoli più alti. Anche di questo si da conto in mostra.
Intorno alla mostra percorsi tra Basilicata e Puglia alla scoperta dei tesori del Rinascimento
La mostra, che prevede naturalmente un focus particolare su Matera e la Basilicata, è integrata e arricchita da speciali percorsi di conoscenza e valorizzazione delle opere d’arte tardogotiche e rinascimentali disseminate nel territorio regionale, inamovibili per tipologia o per dimensioni.
In tali percorsi vengono considerati i principali affreschi locali del tempo, ad esempio quelli di San Donato a Ripacandida, di San Pietro Caveoso, della chiesa rupestre di Santa Barbara e del Convicinio di sant’Antonio a Matera, dell’Abbazia di Montescaglioso, e quelli della Trinità di Miglionico. Ma anche i grandi polittici come quello di Cima da Conegliano sempre a Miglionico, che testimonia, insieme alla straordinaria scultura raffigurante Sant’Eufemia del Duomo di Montepeloso oggi Irsina, l’attenzione locale alla cultura veneta. Oppure le opere realizzate nei primi decenni del cinquecento da Giovanni Luce o Francesco da Tolentino a Pietrapertosa o, infine, i numerosi polittici eseguiti per i paesi lucani (Senise, San Chirico Raparo, Salandra, Stigliano etc), da Simone da Firenze, prolifico pittore-emigrante che nella Basilicata interna trovò una committenza pienamente soddisfatta del suo linguaggio “moderno”, che guardava ai maestri toscani della fine del secolo precedente. Ma anche le sculture dei Persio e degli altri artisti che hanno lasciato le loro opere nei numerosi piccoli centri della regione
I percorsi di valorizzazione territoriale coinvolgeranno anche la vicina Puglia, dove non si potranno dimenticare, ad esempio, gli affreschi della chiesa di Santa Caterina a Galatina e quelli di Santo Stefano di Soleto.
* Fonte: http://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/arte-cultura-e-spettacoli/mostra-darte-rinascimento-visto-da-sud-matera-litalia-meridionale-e-il-mediterraneo-tra-400-e-500-a-palazzo-lanfranchi/
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- "VERITATIS GAUDIUM" ("LA GIOIA DELLA VERITà"): IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO22 giugno 2019, di Federico La Sala
IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE...*
1. La gioia della verità (Veritatis gaudium) esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la Luce di Dio[1]. La verità, infatti, non è un’idea astratta, ma è Gesù, il Verbo di Dio in cui è la Vita che è la Luce degli uomini (cfr. Gv 1,4), il Figlio di Dio che è insieme il Figlio dell’uomo. Egli soltanto, «rivelando il mistero del Padre e del suo amore, rivela l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione»[2].
Nell’incontro con Lui, il Vivente (cfr Ap 1,18) e il Primogenito tra molti fratelli (cfr Rm 8,29), il cuore dell’uomo sperimenta già sin d’ora, nel chiaroscuro della storia, la luce e la festa senza più tramonto dell’unione con Dio e dell’unità coi fratelli e le sorelle nella casa comune del creato di cui godrà senza fine nella piena comunione con Dio. Nella preghiera di Gesù al Padre: «perché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi» (Gv 17,21) è racchiuso il segreto della gioia che Gesù ci vuole comunicare in pienezza (cfr 15,11) da parte del Padre col dono dello Spirito Santo: Spirito di verità e di amore, di libertà, di giustizia e di unità. [:::] "(Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 29.01.2018. Proemio)
- Intervento del Santo Padre Francesco all’Incontro sul tema: “La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo”, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli, 20-21 giugno 2019), 21.06.2019
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante. Un nota sul “disagio della civiltà”
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
- "Dominus Iesus": RATZINGER, LO "STERMINATORE DI ECUMENISMO". Un ’vecchio’ commento del teologo francescano Leonard Boff
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI -- MOSTRA. Il Rinascimento parla ebraico. Fino al 15 settembre, presso il MEIS di Ferrara (di Alessandro Brogani).15 giugno 2019, di Federico La Sala
Il Rinascimento parla ebraico
Fino al 15 settembre, presso il MEIS di Ferrara, sarà possibile visitare un percorso espositivo che mette bene in luce i forti legami che, durante il secolo e mezzo del periodo rinascimentale italiano, si instaurarono tra la comunità ebraica e quella cristiana italiane.
di Alessandro Brogani *
- Il Rinascimento parla ebraico © Silvana Editoriale
Ferrara è un piccolo comune italiano riconosciuto nel 1995 dall’UNESCO patrimonio dell’umanità come città del Rinascimento, periodo che ne vide uno sviluppo politico ed artistico senza precedenti. Ma il piccolo centro situato nel cuore dell’Emilia-Romagna, a metà strada fra Bologna e Venezia, è indissolubilmente legato anche alla comunità ebraica che soprattutto sotto Ercole I d’Este, che ne accolse la comunità sefardita cacciata dalla Spagna di Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, assunse vieppiù importanza nella storia culturale, politica e artistica della città. Lo testimonia bene la mostra “Il Rinascimento parla ebraico” (aperta fino al 15 settembre), curata dai professori Giulio Busi e Silvana Greco della Freie Universität di Berlino, che si può visitare presso il MEIS, il Museo nazionale del giudaismo italiano e della Shoah, presente nella cittadina romagnola.
- Vettore Carpaccio - Nascita di Maria © Silvana Editoriale
La mostra prende in considerazione un periodo temporale che va dagli inizi del Quattrocento alla metà del Cinquecento, ossia dall’affermarsi dell’Umanesimo alla conclusione del Concilio di Trento (1545 - 1563), che portò alla Controriforma della Chiesa cattolica in risposta alla Riforma luterana. Dunque uno dei periodi storici più densi di significato politico-sociale e, ovviamente, artistico. Tra il XIV e il XVI secolo la presenza ebraica (gli ebrei erano circa l’un per cento della popolazione) nella parte settentrionale della Penisola vide un notevole incremento in ben il 15 per cento dei comuni e le sue attività erano per lo più legate al commercio e al finanziamento. Va peraltro ricordato che fin dal medioevo la Chiesa cattolica aveva proibito agli ebrei di coltivare la terra (cosa al contrario assai comune fra i cristiani, che vedevano nell’agricoltura una delle principali fonti di sostentamento), pertanto fra le attività loro concesse c’era il prestito ad usura, che all’epoca era consentito e non aveva una valenza negativa come quella che ha assunto ai giorni nostri. La proibizione della lavorazione della terra fece sì che i giovani ebrei fossero indirizzati allo
- Vettore Carpaccio - Nascita di Maria © Silvana Editoriale
studio, molto più di quanto non fosse comune fra i cristiani. Questo consentì loro di avere un grado di acculturamento maggiore, e li pose nella condizione di esercitare un’influenza notevole in campo culturale, stabilendo così uno scambio reciproco con la comunità cristiana, e dando luogo a notevoli progetti culturali lungo tutta la Penisola, anche se poco riconosciuti come tali. Il pregiudizio e le persecuzioni ebbero infatti una parte predominante nei rapporti, anche se, come rileva Busi nell’introduzione al catalogo della Silvana Editoriale che accompagna la mostra, «... La presenza ebraica nelle città italiane è varia e cangiante, proprio come sempre diversi sono i volti del panorama urbanistico e politico della Penisola».
Così, oltre ad un piano temporale l’esposizione si snoda anche su un piano espositivo delle attività predominanti tra gli ebrei italiani dell’epoca e al loro mondo spirituale, declinate sia al maschile che al femminile. Ed è così che si scopre che le attività non erano solo quelle legate al denaro, ma che ruotavano attorno a professioni assai variegate, da quella medica a quella musicale, da quella poetica a quella filosofica solo per citarne alcune.
- Mantegna La sacra famiglia e la famiglia del Battista particolare © Silvana Editoriale
Vi è poi una sezione che mette in luce il lato più tristemente famoso, quello legato alle persecuzioni. Sono infatti numerosi gli episodi di intolleranza, di minacce e di antagonismi che si sono snodati nel corso del Rinascimento italiano, tanto in luoghi differenti che, talvolta, nel contesto del medesimo perimetro cittadino. Famoso l’episodio legato al processo tenutosi a Trento, sotto il governo del principe vescovo Johann Hinderbach, che sfociò nella condanna e messa a morte di quindici ebrei della locale comunità, accusati di aver ucciso un bimbo cristiano di nome Simon Unferdorben, durante la Pasqua 1475. Episodio ovviamente falso.
- Mantegna - Pallade scaccia i Vizi dal giardino delle Virtù © Silvana Editoriale
Una quarta parte mette in rilievo, invece, i rapporti di scambio ed amicizia tra le due comunità italiane, con curiosità reciproca, contatti quotidiani e di compenetrazione.
- «Basta scorrere i dipinti dei grandi maestri della pittura italiana dell’epoca, per accorgersi che i soggetti ebraici, e la stessa lingua santa, sono messi in bella evidenza, risaltano in primo piano. E non nelle opere minori. Sono i grandi a sciorinare davanti ai fedeli in chiesa, e ai ricchi committenti nei palazzi e nei castelli, un ebraismo antico, autorevole, quasi sempre rispettato e preso a modello. Giotto, Beato Angelico, Cosmè Tura, Ghirlandaio, Mantegna, Carpaccio, Michelangelo, Raffaello. Non sono tutti i nomi di quest’albo dell’ebraistica in punta di pennello (e di scalpello), ma bastano per capire con chi si ha a che fare. Tra fine Duecento e inizi Cinquecento, l’ebraismo entra nel cuore della creatività artistica, in alcuni dei più importanti centri intellettuali della Penisola. Firenze, Ferrara, Mantova, Venezia, Roma sono alcuni degli scenari di questo studiarsi reciproco, che porta gli umanisti cristiani a raccogliere libri ebraici e a immergersi nella lingua santa, spesso grazie all’aiuto e all’amicizia dei dotti ebrei. L’arte non è che un segnale, splendido, di quello che avviene negli studi degli eruditi, e anche nelle corti dei potenti del Rinascimento», sottolinea Busi.
- Ludovico Mazzolino - Gesù dodicenne al Tempio © Silvana Editoriale
Berlino ha contribuito all’allestimento della mostra con un opera di Ludovico Mazzolino, Gesù dodicenne al Tempio (1520-1521 circa), presente nella collezione della Gemäldegalerie. L’opera, già appartenuta alla Collezione Giustiniani, reca nella sua parte superiore un’iscrizione in ebraico che tradotta significa “Il Tempio che Salomone ha costruito per il Signore”. L’espressione “per il Signore” fa chiaramente pensare che la frase fosse stata suggerita al pittore ferrarese da un ebreo (probabilmente il dotto Avraham Farissol che operava in quel periodo a Ferrara), poiché rivela l’intenzione esplicita di non nominare il Tetragramma, ossia il nome di Dio, come prescrive la religione ebraica. È solo un esempio della presenza ebraica in campo artistico durante il Rinascimento, come ha avuto occasione di sottolineare la direttrice del museo ferrarese, Simonetta Della Seta, in occasione della presentazione della mostra presso l’Ambasciata italiana nella Capitale tedesca tenutasi lo scorso maggio. Le altre meraviglie le si possono ammirare direttamente presso il MEIS.
* Il Deutsch -Italia, 14.06.2019 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO --- Papa Sisto IV (Francesco della Rovere), Papa Giulio II (Giuliano della Rovere), e la "Cappella Sistina" di Savona.4 maggio 2019, di Federico La Sala
La Cappella Sistina di Savona, città dei Papi *
L’espressione Cappella Sistina evoca immediatamente Roma e l’elezione dei Papi nel Conclave. Ebbene, c’è una Cappella Sistina anche a Savona, in Liguria, una città che pure ha avuto a che fare con alcuni Pontefici romani.
Soprattutto con papa Sisto IV, nato nel 1414 nei dintorni della città ligure. Il pontificato di Francesco della Rovere (1471-1484) è famoso anche perché coincide con l’inaugurazione della “renovatio Urbis”, cioè la trasformazione urbanistica di Roma che segna il trapasso dalla città medievale a quella rinascimentale.
Fu Sisto IV a dare inizio alla ricostruzione della celebre Cappella papale del Vaticano, che solo successivamente prese il suo nome: fu “battezzata” Cappella Sistina ai tempi del pontificato di Giulio II della Rovere, nipote di Sisto IV.
Anche Giulio II, il celebre pontefice-mecenate di Bramante, Raffaello e Michelangelo, era nato nei dintorni di Savona.
Sisto IV decise di costruire la Cappella Sistina savonese come mausoleo per i propri genitori, entrambi nati nella città ligure.
Così, tra il 1481 e il 1483, essa fu realizzata accanto alla Cattedrale di Maria Assunta, e nel corso del XVIII secolo l’interno dell’edificio - visitato spesso da un altro Papa, Pio VII, che a Savona trascorse gran parte dell’esilio cui fu condannato da Napoleone tra il 1809 e il 1814 - fu ricoperto da affreschi e stucchi, opera di artisti locali.
Savona ospita interessantissimi edifici religiosi, che non vanno dimenticati quando si visita la città.
Tra essi, la citata Cattedrale dell’Assunta (con l’annesso Museo del Tesoro e un bellissimo coro ligneo d’inizio Cinquecento), l’Oratorio di Nostra Signora di Castello (con un polittico di fine XV secolo), la Cappella romanica di San Martino (con un raro esempio di scultura medievale savonese).
*
La Cappella Sistina di Savona, città dei Papi
 Savona
Savona
 Piazza del Duomo
Piazza del Duomo
 +39 019 8389636
+39 019 8389636
 cristina.gamberini@diocesisavona.it
cristina.gamberini@diocesisavona.it
 www.savona.chiesacattolica.it
www.savona.chiesacattolica.it
 (ripresa parziale - senza immagini).
(ripresa parziale - senza immagini).Schede:
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. -- DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Due note .11 marzo 2019, di Federico La Sala
DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Due note ...
A)
- 20. - La Sala (Federico). Della terra, il brillante colore; Prefaz. di Fulvio Papi. Salerno/Roma , Ripostes, 1996. 156 p., Lit. 30.000.
 L’opera s’inquadra in una antropologia filosofica, che ritiene urgente riproporre la domanda capitale “che cos’è l’uomo?”, a partire da un complesso di filologiche e dotte Note sul "poema " di un ignoto Parmenide carmelitano ritrovato a Contursi Terme, Salerno, nel 1989. Siamo nei luoghi dove la metafisica è nata, con la sua primazia dell’Essere e dell’Uno, nei luoghi degli enigmi parmenidei e della loro sapienza unilaterale; e qui in particolare nella cappella dedicata alle dodici Sibille, che il frate carmelitano del primo Seicento accosta, nel suo poema pittorico, all’alleanza di Dio Padre con la Figlia, Maria mediatrice di nuovo pensiero profetico per l’uomo nuovo, ma ribadendo, nell’assetto figurale, una volta di più l’esclusione della Donna dalla creazione, dal sacro e dal Pensiero che è solo Padre, e onnipotente Maschio-Padrone.
L’opera s’inquadra in una antropologia filosofica, che ritiene urgente riproporre la domanda capitale “che cos’è l’uomo?”, a partire da un complesso di filologiche e dotte Note sul "poema " di un ignoto Parmenide carmelitano ritrovato a Contursi Terme, Salerno, nel 1989. Siamo nei luoghi dove la metafisica è nata, con la sua primazia dell’Essere e dell’Uno, nei luoghi degli enigmi parmenidei e della loro sapienza unilaterale; e qui in particolare nella cappella dedicata alle dodici Sibille, che il frate carmelitano del primo Seicento accosta, nel suo poema pittorico, all’alleanza di Dio Padre con la Figlia, Maria mediatrice di nuovo pensiero profetico per l’uomo nuovo, ma ribadendo, nell’assetto figurale, una volta di più l’esclusione della Donna dalla creazione, dal sacro e dal Pensiero che è solo Padre, e onnipotente Maschio-Padrone.
 Da questo viluppo di grecità e cristianesimo l’autore riesamina globalmente nel suo excursus filosofico, che solca anche l’eclettismo ermetico- cabalistico-neoplatonico rinascimentale, le radici del pensiero moderno ritrovando fin nell’uomo del presente quella mutilazione della comunione complessa e assolutamente originaria Uomo-Donna. Padre-Madre, che ha mutilato il pensiero e l’esperienza dell’uomo stesso, che storicamente non ha potuto costruirsi e gioire di ciò che veramente è : un Terzo cui ha dato nascita un Due, un Padre e una Madre e un Figlio, generatore a sua volta in armonia circolare di nuova storia debitrice pariteticamente sia alla Madre che al Padre.
Da questo viluppo di grecità e cristianesimo l’autore riesamina globalmente nel suo excursus filosofico, che solca anche l’eclettismo ermetico- cabalistico-neoplatonico rinascimentale, le radici del pensiero moderno ritrovando fin nell’uomo del presente quella mutilazione della comunione complessa e assolutamente originaria Uomo-Donna. Padre-Madre, che ha mutilato il pensiero e l’esperienza dell’uomo stesso, che storicamente non ha potuto costruirsi e gioire di ciò che veramente è : un Terzo cui ha dato nascita un Due, un Padre e una Madre e un Figlio, generatore a sua volta in armonia circolare di nuova storia debitrice pariteticamente sia alla Madre che al Padre.
 Occorre, di conseguenza, nel pensare, oltre che in ogni esperienza vitale, compiere un salto : quel salto che, accantonando grecità esclusiva e cattolicità esclusiva, e traendo l’uomo dal suo stato di minorità, permetta di riconoscere la filosofia (e le religioni) come maschile e femminile, patema e materna, e così la terra come l’armonia movente e commovente che congiunge le donne e gli uomini e i figli e le figlie.
Occorre, di conseguenza, nel pensare, oltre che in ogni esperienza vitale, compiere un salto : quel salto che, accantonando grecità esclusiva e cattolicità esclusiva, e traendo l’uomo dal suo stato di minorità, permetta di riconoscere la filosofia (e le religioni) come maschile e femminile, patema e materna, e così la terra come l’armonia movente e commovente che congiunge le donne e gli uomini e i figli e le figlie.
 R. G.
R. G."BIBLIOGRAPHY OF PHILOSOPHY" (Vol. 44 Fase. 1 p. 14, PARIS 01/03-1997).
B)
- Della terra, il brillante colore. Parmenide, una “Cappella Sistina” carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barbieri (1481) e la domanda antropologica di Federico La Sala, Edizioni Nuove Scritture, Milano, 2013 156 p., 15€
Il libro di Federico La Sala offre un punto di vista raro. Quello di un pensiero maschile che osserva e riflette e su alcuni pilastri del pensero filosofico occidentale in modo non neutro ma a partire dal riconoscimento della propria parzialità - di individuo e di genere.
Il libro si compone di più saggi che affondano nel profondo delle nostre radici culturali come “carotaggi” a campione. La sensazione all’inizio spaesante di saltare da un frammento all’altro in campi diversi del sapere e in momenti diversi della storia è ricomposta nel filo conduttore che pian piano si manifesta. Più che un filo conduttore teorico, la tensione etica, intellettuale, di cuore, di un essere umano in ricerca.
Nella prima parte del testo l’autore si spinge in regioni dove la religione cattolica si intreccia con la tradizione ermetica. Incontriamo Ermete Trismegisto e la grande stagione Rinascimentale poi affogata nel rigore censorio della Controriforma. Incontriamo diverse manifestazioni delle Sibille, qui visibili nella riproduzione di xilografie di Filippo Barberi (1481) - una versione inedita. Percorsi incrociati tra Kabbalah, carmelitani e profeti islamici.
Sembra di navigare su un fiume sotterraneo che congiunge Oriente e Occidente. Così arriviamo alle note su Parmenide, Freud, Kant, Rousseau - tra gli altri. L’autore offre spunti e visioni prendendoli da un bagaglio di conoscenze che spazia dalla storia della religione alla filosofia alla psicoanalisi. Si alternano luce solare e lunare. Tra le tante le citazioni, il ritmo conciso e il gesto schietto, senza pose accademiche, rendono la lettura scorrevole. Nella pennellata di Fulvio Papi nell’introduzione, sulla spinta della lettura di questo “testo in piena”:
 La Sala, con una mossa certamente ad effetto e piena di provocazione, dice: “guardiamo il nostro ombelico”, riconosciamoci come figli di una maternità e di una paternità che siano la terra del nostro fiorire e non i luoghi delle nostre scissioni.
La Sala, con una mossa certamente ad effetto e piena di provocazione, dice: “guardiamo il nostro ombelico”, riconosciamoci come figli di una maternità e di una paternità che siano la terra del nostro fiorire e non i luoghi delle nostre scissioni.
 E. C.
E. C. -
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- IL REGNO DI NAPOLI, IL PRINCIPE DI EBOLI, IL PARTITO "EBOLISTA", E I CARMELITANI SCALZI. Note18 dicembre 2018, di Federico La Sala
LA SPAGNA, IL REGNO DI NAPOLI, IL PRINCIPE DI EBOLI, IL PARTITO "EBOLISTA", E I CARMELITANI SCALZI. Note
A) Ruy Gómez de Silva, Grande di Spagna, Principe di Eboli. *
- Don Ruy Gómez de Silva, 1º Principe di Eboli, 1º Duca di Pastrana, 5º Signore di Ulme e Chamusca, conte di Melito (Chamusca, 27 ottobre 1516 - Madrid, 29 luglio 1573), è stato un aristocratico portoghese, principale consigliere del re Filippo II di Spagna dove fu conosciuto col nome spagnolo di Ruy Gómez de Silva, e famoso rappresentante di una delle più antiche ed illustri famiglie di Spagna e Portogallo dal X secolo ai nostri giorni [...].
- Quando Filippo ereditò il trono di Spagna nel 1556 come Filippo II, Ruy, uno dei ministri più influenti, ricevette numerosi riconoscimenti, tra i quali: principe di Eboli e gentiluomo di camera del re. Come ministro di Filippo II, Ruy Gómez de Silva, ebbe una notevole importanza nella politica spagnola e Filippo II gli concesse il titolo nobiliare più alto: Grande di Spagna.
- Il Partito Ebolista
- Grazie alla sua influenza nella Corte spagnola, Ruy era noto tra gli ambasciatori stranieri come "Rey Gomes" (Re Gomes) al posto del suo nome ispanizzato di "Ruy Gomez". Il suo più grande avversario politico fu Fernando Álvarez de Toledo, terzo duca d’Alba, avendo entrambi diverse opinioni in merito al governo di Spagna. Mentre il duca di Pastrana difendeva un sistema orientato molto più verso il federalismo ed il compromesso, il duca d’Alba era per la centralizzazione del potere sotto una monarchia unitaria e marziale.
- Matrimonio e discendenti
- Nel 1552 Ruy si fidanzò con la dodicenne Ana de Mendoza, figlia di Diego Hurtado de Mendoza primo duca di Francavilla, sotto suggerimento e richiesta di Filippo II. La promessa di matrimonio formale ebbe luogo il 18 aprile 1553.
 Ebbero dieci figli [...]"
Ebbero dieci figli [...]" - Wikipedia (ripresa parziale, senza note).
B) FILIPPO II E LA FAZIONE "EBOLISTA". L’uso della Cappella Reale nel periodo barocco: devozione o giustificazione politica? *
"[...] Dal 1554, Filippo II fu assente dal regno perché impegnato a raggiungere i Paesi Bassi e l’Inghilterra (dove avrebbe sposato Maria Tudor) e lasciò sua sorella Juana come reggente in Castiglia. In questa occasione, il nobile portoghese Ruy Gomez de Silva, in seguito principe di Eboli, che era stato all’ombra del governo contrastando l’influenza del duca d’Alba nella corte, accompagnò Filippo II nel suo viaggio. Questa vicinanza al re permise a Eboli di tessere la propria rete di potere nella corte spagnola fino a formare una fazione politica e cortigiana chiamata "ebolista". I membri di questo gruppo aprofittarono della fiducia della principessa reggente per consolidare il proprio potere nella corte, raggiungendo le più alte posizioni nell’amministrazione della monarchia e attuando una strategia per isolare il capo della fazione opposta, don Fernando Álvarez de Toledo, III duca d’Alba. [8] L’occasione per allontanare il duca d’Alba dalla corte fu la crisi in Italia: quando il Duca venne inviato a Milano, e poi a Napoli, per risolvere le questioni ivi sorte, gli "albistas" vennero allontanati e sostituiti dai membri della fazione "ebolista".
Nonostante ció, la Corte era ancora influenzata da un personaggio che non poteva tollerare l’influenza degli "ebolistas" nell’amministrazione della monarchia. Si trattava dell’Inquisitore Generale Fernando Valdés, caratterizzato da una rigida ortodossia ed un esacerbato formalismo religioso. Valdés cercó di formare una propria fazione all’interno della Corte, ma non fu mai così coesa come la fazione nobile "ebolista". Tra i sostenitori di Valdés c’erano teologi influenti come il domenicano Melchior Cano, professore di Salamanca, con cui Valdés inizió la persecuzione contro la Compagnia di Gesù, l’Ordine religioso protetto dagli "ebolistas". Di conseguenza in quegli anni molti gesuiti vennero accusati e processati per essere considerati illuminati o alumbrados. In realtà si è poi constatato che l’influenza di Valdés e dei suoi sostenitori nella corte spagnola si esprimeva solo al livello teorico e unicamente nel campo inquisitoriale. In pochi anni Valdés pubblicò il catalogo dei libri proibiti del 1559 (causa effettiva del processo contro Carranza), gestì la decomposizione del foco luterano di Valladolid e iniziò la persecuzione inquisitoriale contro Francisco de Borja.
Tale azione inquisitoriale influenzò in modo decisivo l’evoluzione della Cappella Reale: iniziarono i processi e si infuse il sospetto su un certo numero di predicatori e cappellani, tutti della sezione castigliana della cappella reale di Filippo II e tutti protetti dai membri della fazione "ebolista". Non è un caso che tutti gli imputati provenissero da famiglie di origine ebraica, costrette alla conversione per paura di una persecuzione inquisitoriale, e con una spiritualità più personale e intima, lontana dall’ortodossia religiosa che Valdés aveva cercato di imporre alla società. Da quel momento, Carranza venne allontanato dalla corte e l’inquisizione diede avvio alla sua prigionia e alla distruzione dei suoi libri e documenti. Un altro personaggio allontanato della cappella reale per la sua posizione, legata alla fazione degli "ebolistas", fu il cappellano e predicatore Agustín de Cazalla, che aveva servito nella Casa castigliana di Carlo V. Era figlio del contador reale Pedro de Cazalla e di Leonor di Vibero, che erano stati diffamati dall’Inquisizione di Siviglia e accusati di essere ebrei. [...]
Le persecuzioni inquisitoriali di Carranza e Cazalla servono per comprendere la rimozione dalla cappella reale dei membri che, anni prima, avevano monopolizzato l’orientamento religioso della corte e dei regni iberici. Si trattava di religiosi che sostenevano gli interessi politici del gruppo "ebolista" (e, viceversa, "ebolistas" che condividevano la spiritualità di questi religiosi), e ciò evidenzia come la persecuzione inquisitoriale contro di essi nascondesse connotazioni spirituali e politiche. La rimozione dalla cappella reale di questo gruppo di religiosi, tutti cappellani e predicatori, fu un cambiamento radicale nella concezione religiosa e spirituale che aveva, fino ad allora, dominato nella cappella reale. Dal momento in cui ereditò i regni lasciati da suo padre, il Re Prudente si trovò con il doppio compito di articolare i così vasti ed eterogenei territori della monarchia e di impiantare la confessione cattolica adottata come religione della dinastia. Senza dubbio, il processo di confesionalización di Filippo II , iniziato nel 1560, serviva per dare alla Monarchia un’unità religiosa, oltre che istituzionale. In questo processo, l’Inquisizione fu l’istituzione che controllava il grado di assimilazione del cattolicesimo nella società. Così, per ottenere un incarico di governo nella monarchia o nella Chiesa era necessario non solo la purezza del sangue in stile tradizionale (cioè, non avere ascendenza ebraica o araba), ma anche non avere antenati processati dall’Inquisizione per qualsiasi eresia. Il monarca si circondò quindi di un gruppo di letrados castigliani per dare vita a un progetto così ambizioso, che imponeva una certa interpretazione del dogma cattolico e determinate pratiche religiose, in maniera non dissimile dalle élites che, durante il XV secolo, avevano spinto i monarchi ad escludere i "nuovi cristiani" dagli incarichi di governo e ad istituire l’Inquisizione. Era il trionfo di una ortodossia intellettuale e formale, già sostenuta dalla scolastica dei domenicani, per la quale avvicinarsi alla divinità era possibile soltanto attraverso l’intelletto, la liturgia e le cerimonie esteriori. [...]"
* SI CFR.: L’uso della Cappella Reale nel periodo barocco: devozione o giustificazione politica? (di Esther Jiménez Pablo - Università di Teramo).
Federico La Sala
Sul tema, nel sito, si cfr.:
CON LA SPAGNA DI "PUERTA DEL SOL", PER LA DEMOCRAZIA "REALE", SUBITO: RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DELL’UMANESIMO RINASCIMENTALE - E ANDARE OLTRE. IL MESSAGGIO DELLA "CAPPELLA SISTINA" CARMELITANA (1608) RITROVATO A CONTURSI TERME (SALERNO). Documenti e materiali sul tema.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --"CRISTO E LA SFINGE" (Romeo De Maio). Enigma per due: si dice Sfinge, si pensa a Cristo9 novembre 2018, di Federico La Sala
CRISTO ED EDIPO: LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Un omaggio al lavoro del prof. Romeo De Maio ...
- IL PROBLEMA MOSE’ E LA BANALITA’ DEL MALE: FREUD NELLA SCIA DI KANT (MA NON DEL TUTTO).
Recensioni editoriali
Enigma per due: si dice Sfinge, si pensa a Cristo *
È molto presente e non se ne fa accorgere. Sta nelle cattedrali, sui frontespizi degli edifici delle istituzioni, nei dipinti e nelle sculture, nelle illustrazioni dei codici, della Bibbia, nei poemi, nell’inafferrabilità delle migliori musiche. È la Sfinge, questo essere che noi umani chiamiamo mostruoso perché ha artigli al posto delle mani e lo sguardo non sfuggente. Ti guarda, lei, trapassandoti in un attimo, ti consegna al mistero, ai suoi abissi che si fanno domanda, e probabilmente fu proprio quell’attimo che, dieci anni fa, colse lo storico Romeo De Maio nella cattedrale di Bari quando, per la prima volta, si accorse della Sfinge rappresentata sulla finestra absidale del Duomo. C’era stato molte volte, lì, non l’aveva scorta mai. Dietro di lei, raffigurata sopra un carro, i simboli dell’eucarestia. Fu una folgore. Che cosa univa il pagano al sacro? E perché?
Cominciò in quel momento, per lui, “un’esperienza molto simile al poeta Theodor Däubler, che andò in Egitto per la Sfinge e le trovò Cristo accanto”. I risultati di quell’esperienza sono il libro “Cristo e la Sfinge - la storia di un enigma” (Mondadori, 350 pagine), in libreria. Negli ultimi dieci anni De Maio è andato in giro per il mondo (occidentale soprattutto) alla ricerca delle testimonianze che affiancano la Sfinge al Cristianesimo.
Perché? ” Il motivo fu l’impressionante creazione-incisione di Nicolas Poussin, pittore francese dimorato a Roma, per la copia della Bibbia destinata al re di Francia, nel 1642. Il pittore la intitolò “Chiesa e Sinagoga”, e raffigura il Dio Padre che benedice il Vecchio e il Nuovo Testamento. Sulla Bibbia tenuta in mano dal Vecchio c’è, distesa, una Sfinge che guarda da tutt’altro lato, verso est, dove sorge il sole”.
È solo un esempio dei migliaia ritrovati dall’autore. Testimonianze che non si riferiscono all’ufficialità dei documenti nel senso di rogiti, nel senso di carte bollate, nel senso di trattati con le firme apposte in calce. È questo uno dei rari casi in cui si elevano a documento storico, e dunque attendibili come una data con sopra il timbro dell’ufficialità, le espressioni degli artisti. Pittori, scultori, architetti, poeti. Teologi. Musicisti. Dicono la Storia, i suoi limiti, le sue possibilità. Le fanno i connotati.
Donatello, Bernini, Michelangelo, Klimt, De Chirico, Purcell, Giovanbattista Marino, Oscar Wilde, Mantegna, Stravinskij, Kirker, Pico della Mirandola, Cocteau, Mozart, l’abate Kirker, Flaubert. “L’artista - dice De Maio - ha la visione, l’intuizione al pari del Vate. Queste sono indispensabili, fondamentali per la conoscenza. Io ho sottoposto le creazioni artistiche alle regole della filologia e al rispetto dell’esperienza mistica”. In loro la Sfinge non è mai elemento ornamentale. Sia essa alla base di un trono gestatorio, sia riferimento poetico, sia nella scenografia di una rappresentazione teatrale. Così le madonne vegliate dalla Sfinge, da essa protette, i volti spesso uguali: i rimandi poetici, le allusioni cromatiche, la disposizione degli elementi. “Quando gli artisti la dipingono, anche su commissione papale, è per far aprire gli occhi agli ecclesiastici. Per svolgere un mistero, avviare una conoscenza non dogmatica”.
Più di tremila testimonianze ha trovato De Maio, ignorate dalla Chiesa in questi tremila anni. Come dire: volutamente non considerate. Perché è pericoloso ammettere quelle che oggi il linguaggio contemporaneo definirebbe contaminazioni. Perché il Potere Temporale, la sua Legge, non ammette altro Dio. Come avrebbe mai potuto accettare la presenza, accanto al figlio del Padre, accanto alla Madre del Figlio, lo sguardo misterioso e definitivo del simbolo pagano per eccellenza, che ha ispirato il mito tra i più antichi dell’uomo ed esplorati dalla psicanalisi nel secolo appena trascorso, con Freud che ha posto Edipo, e la profezia che a lui fece la Sfinge, tra noi e la vita che conduciamo?
De Maio considera “rivoluzionario” questo lavoro, questo lavoro, il suo “testamento anticipato. Lo avrei potuto anche intitolare “Cristo prima del Cristianesimo”. La Sfinge ci porta verso l’aspetto mistico dell’uomo, di Cristo; aspetto non considerato dal Potere Istituzionale Ecclesiastico nella sua nuda verità”. È un nuovo senso, una nuova possibilità vista da altro punto di vista. Una visione allargata e non ristretta. Senza inquisizioni. Che si apre alla domanda. Basta questa, vuole dirci De Maio, per avere la risposta.
*
Fonte: Esonet.org, 14.05.2010
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IL PROBLEMA MOSE’ E LA BANALITA’ DEL MALE: FREUD NELLA SCIA DI KANT (MA NON DEL TUTTO).
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI - MARSILIO FICINO E LA "VERA RELIGIO". Guido Bartolucci (Paideia) analizza l’opera di uno dei maggiori esponenti del filone umanista fiorentino.13 aprile 2018, di Federico La Sala
Teologia
Guido Bartolucci (Paideia) analizza l’opera di uno dei maggiori esponenti del filone umanista fiorentino
E Marsilio Ficino recuperò la spiritualità ebraica
di Marco Rizzi (Corriere della Sera, 12.04.2018)
È ormai diventato un luogo comune l’affermazione secondo cui le radici della civiltà europea sarebbero, al tempo stesso, greco-latine, cristiane ed ebraiche.
È anche possibile individuare il momento preciso in cui si è costituita questa triplice eredità nella forma in cui ancora oggi la conosciamo. Essa è infatti il frutto della riscoperta, accanto a quella dei classici, della tradizione ebraica ad opera degli umanisti fiorentini del XV secolo, tra cui spicca il pensatore Marsilio Ficino. È costui, infatti, che per primo propone la conciliazione non solo tra la filosofia greca, specie quella platonica, e il cristianesimo, ma anche con il più antico strato della sapienza ebraica risalente ai patriarchi, che Ficino ritiene di ritrovare in alcuni elementi della qabbalah medievale.
L’interesse di Marsilio, osserva Guido Bartolucci nel libro Vera religio (Paideia), nasceva dal tentativo di ripensare la tradizione teologica e spirituale cristiana, di cui si avvertivano nitidamente i segni di una crisi destinata ad esplodere drammaticamente nel secolo successivo. Al momento, però, prevaleva ancora l’idea che un rinnovamento della Chiesa fosse possibile e che a questo fine la dimensione intellettuale potesse risultare decisiva.
Così, di lì a poco sarà Pico della Mirandola a sviluppare appieno l’idea di una originaria sapienza (la prisca theologia) di cui il cristianesimo rappresenta certo il culmine, ma cui a buon diritto appartengono anche ebraismo e classicità.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- Guido Bartolucci, Vera religio. Marsilio Ficino e la tradizione ebraica, Indice, Torino, Claudiana/Paideia, 2017, pp. 158, 32.00 EUR:
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. Le Sibille di Contursi hanno parentele più celebri nella Cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel Tempio Malatestiano di Rimini, nella Cappella Sistina di Michelangelo. La pittura disegna l’ eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale (...)
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGIFederico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI -- GRANDEZZA E CATASTROFE DI BISANZIO: LA CROCIATA DIMENTICATA. Costantinopoli presa dai “fratelli” latini (di Silvia Ronchey)17 marzo 2018, di Federico La Sala
La storia
Bisanzio brucia nella crociata dimenticata
Nel 1204, due secoli prima di cadere in mano turca, Costantinopoli fu presa dai “fratelli” latini. Parte del suo patrimonio di arte e cultura passò a Venezia. Ora nuovi studi ricostruiscono quell’episodio drammatico
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 17.03.2018)
Il 13 aprile 1204, in una fredda giornata di primavera, una colonna di profughi dall’aspetto di fantasmi si incamminò fuori dalla grande città di Costantinopoli. Era “gente vestita di stracci, emaciata dal digiuno, trascolorata, cadaverica, con gli occhi così rossi che parevano colare sangue anziché lacrime”.
Erano stati torturati, depredati delle loro case e dei loro beni, avevano visto rapite le loro mogli, violentate le loro figlie. Non erano stati i turchi a compiere quello scempio, come sarebbe accaduto due secoli e mezzo dopo, nel 1453.
Erano stati i crociati occidentali. E non era contro gli infedeli che lo avevano portato, ma contro i loro correligionari, i bizantini.
La ferocia di quella singolare guerra santa ebbe tra i suoi testimoni oculari il più acuto, spregiudicato e disincantato degli osservatori politici dello Stato più prospero del medioevo: lo storico Niceta Coniata, massimo intellettuale della sua generazione, segretario del basileus fino a poco prima in trono ma anche suo indomabile critico, pensatore indipendente e non certo corifeo del potere, della cui opera è ora stata completata dalla Fondazione Lorenzo Valla l’edizione italiana (Grandezza e catastrofe di Bisanzio - Narrazione cronologica, traduzione di A. e F. Pontani, testo greco a cura di J.-L. van Dieten, introduzione di G. Cavallo, Fondazione Valla Mondadori, tre volumi).
Come ha scritto Steven Runciman, le crociate furono “le ultime invasioni barbariche”. I “barbari”, nelle frasi di Niceta, non sono gli islamici, che anzi i bizantini difesero strenuamente quando fu attaccata la locale moschea, ma quell’“accozzaglia di stirpi oscure e disperse” che erano gli eserciti latini, quei “precursori dell’Anticristo” che “portavano la croce cucita sulle spalle” e che in quei giorni di aprile del 1204 avevano devastato la culla stessa dell’impero romano cristiano, la città che ne custodiva da nove secoli l’identità religiosa oltre che l’eredità artistica, culturale, bibliografica così come la vocazione politica: un modello di Stato multietnico, meritocratico e sostanzialmente egualitario, dotato di una struttura diplomatica rivolta, come l’aquila bicipite, tanto a oriente quanto a occidente.
I profughi che si incamminavano “come una colonia di formiche” stanata dal fuoco avevano assistito al “più grande saccheggio della storia del mondo”, come lo definì lo stesso cronista francese Goffredo di Villehardouin che vi aveva partecipato al seguito di Bonifacio di Monferrato. Le atrocità perpetrate dai cavalieri della quarta crociata sono testimoniate non solo dagli storici bizantini ma anche dai cronisti occidentali, nonché dal papa che l’aveva indetta, Innocenzo III, inorridito nel suo epistolario.
La Città traboccava di capolavori d’arte e di inestimabili libri. Ma ad attrarre gli incolti latini era il fatto che, secondo i loro calcoli, contenesse i due terzi delle ricchezze del mondo conosciuto. Portarono “abominio e desolazione” nel Sacro Palazzo del Boukoleon, coprirono di sterco i marmi policromi della Grande Chiesa di Santa Sofia. Si precipitavano furiosi e urlanti per le strade distruggendo ogni cosa non apparisse trasportabile, fermandosi solo per trucidare gli abitanti e per spalancare le cantine e dissetarsi con il loro vino. Non risparmiarono monasteri, né chiese, né antichi monumenti, lasciarono bruciare gli archivi e le biblioteche. Una parte dei classici greci oggi perduti sarebbe arrivata fino a noi, non fosse stato per quella vandalica insipienza. Nel viaggio degli antichi testi la presa di Costantinopoli del 1204 segnò un naufragio paragonabile all’incendio della biblioteca di Alessandria.
Ciò che i veneziani non portarono a casa i francesi distrussero. I cavalli di bronzo dorato dell’Ippodromo sono oggi noti come Cavalli di San Marco, altre inestimabili opere d’arte formano il ricco bottino oggi conosciuto come Tesoro di San Marco. Ma le altre antiche statue bronzee dell’Ippodromo e quelle del Foro di Costantino furono fatte a pezzi e fuse. Nella stessa Santa Sofia si potevano vedere soldati ubriachi saccheggiare le reliquie, strappare i paramenti, svellere le suppellettili, calpestare i libri sacri e le icone, dilaniare gli arazzi.
L’orrore continuò per giorni, finché la capitale dell’ortodossia fu ridotta, scrivono i testimoni, a un macello. Perfino i saraceni, annotò Niceta, sarebbero stati più misericordiosi: “Dalla gente latina, ora come allora, Cristo è stato di nuovo spogliato e deriso, e le sue vesti sono state spartite, e il fiume del Sangue Divino ha di nuovo inondato la terra”, lamenta alla fine della sua opera.
La presa latina di Costantinopoli del 1204 è l’esempio più notevole di quella cruda verità economica delle crociate di cui, al di là dell’ideologia o della retorica confessionale, un libro dello storico oxfordiano Christopher Tyerman, in uscita in traduzione italiana, spiega in dettaglio mentalità, pragmatismo, finalità materiale e obiettivi strategici (C. Tyerman, Come organizzare una crociata, Utet). Si parla di “deviazione” della Quarta Crociata, quasi fosse stata un’idea repentina e non un preciso piano di conquista, già prospettato da Federico Barbarossa e da Enrico VI. Ben prima di entrare a Costantinopoli gli alleati avevano minuziosamente discusso e patteggiato tra loro, e soprattutto con Venezia, la spartizione dell’impero che avrebbero sostituito a quello bizantino, istituendo anche una gerarchia ecclesiastica cattolica al posto di quella ortodossa e insediando sul soglio patriarcale un veneziano.
L’alleanza della Realpolitik dei papi di Roma con l’Europa dei traffici, del protocapitalismo delle repubbliche mercantili, portò, con il successivo aiuto dei turchi, alla distruzione di una realtà politica che aveva garantito per secoli benessere e pace governando i conflitti fra le diverse etnie in un immenso territorio unificato dalla lingua greca, dalla religione cristiana, dal diritto romano, dominato da un formidabile sistema di pubblica istruzione e di cooptazione nelle burocrazie che assicurava il dinamismo delle élite e il loro costante ricambio sociale.
Per cinque giorni Niceta, la moglie incinta e il loro gruppo di amici dell’intelligencija costantinopolitana rimasero nascosti. Poi anche loro dovettero sfollare strisciando per i vicoli, i bambini piccoli in spalla, il viso delle ragazze mimetizzato col fango, in direzione della Porta d’Oro. Appena superate le sue torri, Niceta si gettò a terra e inveì contro le grandi mura di Teodosio: perché si reggevano ancora dritte in piedi? non vedevano che la civiltà che custodivano era finita? Poi, “gettando lacrime come semi” lungo la loro strada, si incamminarono per ricongiungersi al resto degli esuli e al governo in esilio insediato a Nicea, in Asia Minore.
 Ma quella che Niceta, partito da Costantinopoli con in mano solo il suo manoscritto, pianse come un’irrimediabile fine si rivelò un inizio. Per più di cinquant’anni l’impero di Nicea coltivò non solo la resistenza politica ma anche quella culturale, ricreando un sistema scolastico e universitario, proseguendo la produzione libraria. Quegli intellettuali avevano imparato una lezione: i barbari esistevano. Non erano i popoli che si diceva avessero fatto cadere l’impero romano d’occidente, diversamente da quello d’oriente, che era stato invece capace di assimilarli e accoglierli nella sua classe dirigente.
Ma quella che Niceta, partito da Costantinopoli con in mano solo il suo manoscritto, pianse come un’irrimediabile fine si rivelò un inizio. Per più di cinquant’anni l’impero di Nicea coltivò non solo la resistenza politica ma anche quella culturale, ricreando un sistema scolastico e universitario, proseguendo la produzione libraria. Quegli intellettuali avevano imparato una lezione: i barbari esistevano. Non erano i popoli che si diceva avessero fatto cadere l’impero romano d’occidente, diversamente da quello d’oriente, che era stato invece capace di assimilarli e accoglierli nella sua classe dirigente.
 Erano i figli del feudalesimo, che il sistema statale di Bisanzio aveva sempre combattuto, e di quel “satanico spirito del commercio”, per citare Baudelaire, da sempre incompatibile con la mentalità bizantina, dove la diffidenza dei cittadini verso il mercato e il rifiuto delle premesse etiche della mercatura espresso dagli intellettuali si univa alla condanna teologica del profitto e del lucro.
Erano i figli del feudalesimo, che il sistema statale di Bisanzio aveva sempre combattuto, e di quel “satanico spirito del commercio”, per citare Baudelaire, da sempre incompatibile con la mentalità bizantina, dove la diffidenza dei cittadini verso il mercato e il rifiuto delle premesse etiche della mercatura espresso dagli intellettuali si univa alla condanna teologica del profitto e del lucro.Anche dopo la riconquista del 1261 e l’insediamento della nuova dinastia dei Paleologhi, la guerra tra banchieri - genovesi e veneziani - continuerà a devastare economicamente e militarmente Bisanzio, a scarnificare quell’istmo culturale e strategico tra oriente e occidente. Ma per quanto cieche possano essere le strategie finanziarie e belliche, gli intellettuali possono sempre, discretamente, mobilitarsi.
Sempre di più si affermerà, tra i protagonisti della cosiddetta rinascenza paleologa, la coscienza dell’insopprimibilità di un’arma incruenta: la cultura. Il duello dei governanti, il risentimento delle masse, lo scontro delle chiese saranno trascesi da una simmetrica e inversa, silenziosa e superiore solidarietà tra umanisti orientali e occidentali. Sarà l’inizio di quella sempre più fitta circolazione di maestri e libri, liberamente scambiati dall’internazionale dei dotti, che darà vita a ciò che chiamiamo “il” rinascimento.
 L’antica cultura oltraggiata dai crociati conquisterà la loro stessa patria, la loro stessa curia, la stessa repubblica di Venezia, dove sorgerà, per volere di un umanista bizantino, Bessarione, la prima biblioteca pubblica della storia occidentale moderna. Da Bisanzio verranno e si metteranno all’opera, alacri, i copisti. Nascerà la stampa e non uno ma dieci, cento, mille libri sorgeranno sulle ceneri di quelli distrutti, insieme alle vite dei loro possessori, nella primavera del 1204.
L’antica cultura oltraggiata dai crociati conquisterà la loro stessa patria, la loro stessa curia, la stessa repubblica di Venezia, dove sorgerà, per volere di un umanista bizantino, Bessarione, la prima biblioteca pubblica della storia occidentale moderna. Da Bisanzio verranno e si metteranno all’opera, alacri, i copisti. Nascerà la stampa e non uno ma dieci, cento, mille libri sorgeranno sulle ceneri di quelli distrutti, insieme alle vite dei loro possessori, nella primavera del 1204.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL. Un’intervista a John Chryssavgis di Chiara Santomiero
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL. Un’intervista a John Chryssavgis di Chiara SantomieroFederico La Sala
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. -- DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. «In mezzo a tutti sta il Sole»: Michelangelo precursore di Copernico.16 gennaio 2018, di Federico La Sala
DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Michelangelo precursore di Copernico ...
- "SOL SOLUS IN MEDIO. «In mezzo a tutti sta il Sole»: Copernico l’ha riscoperto e ripetuto, ma nessun saggissimo ha voluto restare «fedele alla terra» (Nietzsche), e pochi l’hanno seguito nella navigazione e nell’esplorazione dell’«oceano celeste» (Keplero). Tutti, pur di restare fermi al centro del loro bel mondo, si sono vestiti alla moda e... si sono trasferiti a corte, dal «re Sole»: come prima e peggio di prima - troni, altari e roghi su tutta la Terra. Molare lenti (Spinoza), per vedere e far vedere meglio, non è mai stata attività di nobili - né ieri, né oggi" (Federico La Sala, "Della Terra, il brillante colore. Parmenide, una Cappella Sistina" carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barberi (1481) e la domanda antropologica", Milano 2013, pp. 136-137.).
Arte e astronomiaMichelangelo precursore di Copernico
di Antonio Rocca (la Repubblica, 15.01.2018)
Alcuni studi attestano che nel dipingere il Cristo del “Giudizio universale” Buonarroti abbia offerto una figurazione dell’eliocentrismo. E ciò anche per iniziativa del papa Clemente VII
Trovatosi a constatare la stringente analogia tra la rivoluzione copernicana e la rivoluzione iconografica con la quale Michelangelo impone un Cristo-Apollo nel cuore del Giudizio sistino, Charles de Tolnay scrive che il Buonarroti «giunge a una visione dell’universo curiosamente anticipante quella del suo contemporaneo Copernico. L’idea della composizione di Michelangelo precede di sette anni la pubblicazione dell’astronomo di Thorn (uscita a stampa nel 1543)».
Mancano documenti ad attestare un rapporto diretto tra l’astronomo e l’artista, pertanto Tolnay è costretto a utilizzare il termine “curiosamente”, ma il legame è evidente e con l’intento di colmare tale lacuna si è mossa Valerie Shrimplin. La studiosa britannica ha ricostruito il quadro che tiene assieme i due, sottolineando l’importanza di un episodio del 1533.
 In giugno Clemente VII invita Albert Waldstadt affinché, nei giardini del Vaticano e di fronte a un ristretto cenacolo di cardinali, gli illustri il modello copernicano.
Quella visione eliocentrica, disposta nel solco del neoplatonismo fiorentino, appassionò il Medici che donò al Waldstadt un prezioso manoscritto. Secondo la Shrimplin il papa maturò allora la decisione di realizzare il Giudizio.
In giugno Clemente VII invita Albert Waldstadt affinché, nei giardini del Vaticano e di fronte a un ristretto cenacolo di cardinali, gli illustri il modello copernicano.
Quella visione eliocentrica, disposta nel solco del neoplatonismo fiorentino, appassionò il Medici che donò al Waldstadt un prezioso manoscritto. Secondo la Shrimplin il papa maturò allora la decisione di realizzare il Giudizio.La commissione al Buonarroti si concretizzò già alla fine dell’estate del 1533 e la morte del pontefice non bloccò il progetto, che fu immediatamente ripreso da Paolo III Farnese.
La memoria dei processi a Giordano Bruno e Galileo Galilei sembra gettare un’ombra sulla possibilità che due papi potessero concepire la realizzazione di un colossale manifesto eliocentrico nel cuore della cristianità, tuttavia dobbiamo ricordare che siamo negli anni trenta del ‘500 e che la difesa del sistema tolemaico s’impone solo nel secolo successivo. Il De revolutionibus orbium coelestium fu messo all’Indice nel 1616. Avversione peraltro incerta come dimostrano le simpatie per Galilei del cardinal Barberini, divenuto in seguito Urbano VIII, e l’affresco di Andrea Sacchi in palazzo Barberini, che all’eliocentrismo allude.
Ipotesi antica, quella eliocentrica, che aveva conosciuto una fase di svolta con la pubblicazione del De Sole di Marsilio Ficino. Riprendiamola da questo momento, osservandola dalla prospettiva dei protagonisti della nostra storia, allora solo tre ragazzi. È il 1493, Copernico ha vent’anni e studia astronomia a Cracovia, il De Sole è libro di testo; Michelangelo gode della protezione di Piero de’ Medici, cui il De Sole è dedicato; Alessandro Farnese, già studente di Ficino, si appresta a diventare cardinale.
Il trattato esprime pochi concetti con grande chiarezza: il sole, immagine di Dio, occupa una posizione centrale nell’universo e rappresenta la giustizia divina. «La giustizia, regina di tutte le cose», scrive Ficino, «si diffonde attraverso il tutto a partire dal trono del Sole, e tutto dirige, quasi sia il Sole a guidare tutte le cose».
Copernico prese allora a cercare una via per allineare matematica, astronomia e platonismo. Nel corso del suo pluridecennale lavoro non ottenne risultati decisivi perché i suoi calcoli furono inficiati da assiomi interni al platonismo. Così, a dispetto di ogni dato empirico, il polacco non intese mai rinunciare alla perfetta circolarità delle orbite planetarie.
Concetti pitagorici che Copernico insegnava nelle sue lezioni romane del 1500, cui pare partecipassero anche Michelangelo e Alessandro Farnese. Col senno di poi, sapendo che Paolo III sarà il committente finale del Giudizio e che a lui è dedicato il De revolutionibus, si è portati a ritenere che sin da allora, sin dal principio del secolo, tra i tre si fossero instaurati dei rapporti diretti. Troppo stretti i giri, nella Roma agostiniana e neoplatonica, per immaginare che simili personaggi s’ignorassero, tuttavia ciò che qui interessa è osservare come l’artista, lo scienziato e l’uomo di chiesa, abbiano saputo inverare concetti astratti appresi in gioventù.
Diventati anziani uomini di successo, il Farnese, Michelangelo e Copernico declinarono i principi ficiniani, attribuendogli sostanza e creando un panorama culturale coerente. Intanto, però, tutto era cambiato. Il Giudizio e il De revolutionibus sono inattuali, nascono già vecchi o pregni di un futuro che li rende incomprensibili. Nel presentare il suo lavoro, Ficino aveva scritto che il libro andava letto in modo allegorico e anagogico, non dogmatico. La traduzione in immagine di quel testo vedeva la luce nel momento in cui la chiesa di Roma puntava a bandire modelli di lettura figurale, a vantaggio di una precisa rappresentazione dei dogmi formulati a Trento.
Il conflitto era inevitabile, sia sul piano formale che su quello del merito. Michelangelo aveva posto tra i beati una donna che esibisce un copricapo ebreo, due indios e una coppia d’infedeli, afferrati da un angelo per mezzo di un rosario a cento grani, tipico dei musulmani. Decisamente troppo per Paolo IV, il pontefice del ghetto, dell’indice dei libri proibiti e dell’Inquisizione.
Fortunatamente l’affresco restò intatto, seppure dovette subire qualche limitato intervento censorio. Integro ma incompreso, reso opaco e preso a tenaglia da pedanti cattolici e dalle favole protestanti di una Roma pagana, nella quale gli idoli greci avevano preso il posto di Dio. Del resto cosa poteva apprezzare un uomo come Lutero, vagamente iconoclasta e avversario di Copernico?
Ma ciò che ha fatto più danno è stata la Modernità o, meglio, la ricostruzione apologetica delle origini della Rivoluzione scientifica. Progresso scientifico e anticlericalismo col tempo presero a divenire quasi sinonimi. Si ricostruì la narrazione di una faticosa e costante riemersione alla luce ottenuta per mezzo della lotta contro l’oscurantismo cattolico, fatto di libri proibiti, processi, abiure, torture e condanne.
 Episodi reali, ma infilati su di un percorso unilineare nel quale sono trascurati l’eliocentrismo del vescovo Cusano, del sacerdote Ficino e l’ortodossia del canonico agostiniano Copernico. Tutti loro, come il domenicano Bruno, osservavano la volta celeste perché, come recita il Salmo 18, «i cieli narrano la gloria del Signore». Oltre la Modernità, dopo aver preso congedo dai miti solari di ogni Illuminismo, è più facile riconoscere che il Giudizio non è un’incongrua esaltazione della bellezza pagana e che Copernico non era un precursore del libero pensiero.
Episodi reali, ma infilati su di un percorso unilineare nel quale sono trascurati l’eliocentrismo del vescovo Cusano, del sacerdote Ficino e l’ortodossia del canonico agostiniano Copernico. Tutti loro, come il domenicano Bruno, osservavano la volta celeste perché, come recita il Salmo 18, «i cieli narrano la gloria del Signore». Oltre la Modernità, dopo aver preso congedo dai miti solari di ogni Illuminismo, è più facile riconoscere che il Giudizio non è un’incongrua esaltazione della bellezza pagana e che Copernico non era un precursore del libero pensiero.
 Leggiamo nel De revolutionibus: «La macchina dell’universo è stata creata per noi dal migliore e più perfetto artefice (...) E in mezzo a tutto sta il Sole.
Chi infatti, in tale splendido tempio, disporrebbe questa lampada in un altro posto o in un posto migliore, da cui poter illuminare contemporaneamente ogni cosa? Non a sproposito quindi taluni lo chiamano lucerna del mondo, altri mente, altri regolatore. Trismegisto lo definisce il dio visibile, l’Elettra di Sofocle colui che vede tutte le cose. Così il Sole, sedendo in verità come su un trono regale, governa la famiglia degli astri che gli fa da corona». La Cappella Sistina, che ha le stesse dimensioni del tempio di Gerusalemme, è quel tempio.
Leggiamo nel De revolutionibus: «La macchina dell’universo è stata creata per noi dal migliore e più perfetto artefice (...) E in mezzo a tutto sta il Sole.
Chi infatti, in tale splendido tempio, disporrebbe questa lampada in un altro posto o in un posto migliore, da cui poter illuminare contemporaneamente ogni cosa? Non a sproposito quindi taluni lo chiamano lucerna del mondo, altri mente, altri regolatore. Trismegisto lo definisce il dio visibile, l’Elettra di Sofocle colui che vede tutte le cose. Così il Sole, sedendo in verità come su un trono regale, governa la famiglia degli astri che gli fa da corona». La Cappella Sistina, che ha le stesse dimensioni del tempio di Gerusalemme, è quel tempio.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. In memoria di Kurt H. Wolff.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI -- PETIZIONE. Salviamo il convento di San Marco (Firenze) dal nuovo provvedimento di chiusura.23 dicembre 2017, di Federico La Sala
Salviamo il convento di San Marco (Firenze) dal nuovo provvedimento di chiusura
FIRMA LA PETIZIONE
Al Maestro Generale dell’Ordine Domenicano Bruno Cadoré
Dopo quattro anni la situazione è tornata al punto di partenza: il Capitolo Provinciale dei Frati Domenicani dell’Italia Centrale ha nuovamente deciso, nel luglio 2017, di chiudere il Convento di San Marco a Firenze; rimarrà aperta la parte del convento che è Museo statale e la chiesa, ma non ci sarà più una comunità di frati e un convento senza frati non è più un vero convento.
Dopo la grande mobilitazione - di popolo, di artisti, di intellettuali - per salvare il convento, concretizzata in varie iniziative e soprattutto nella Petizione su www.change.org l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori e il Maestro Generale dell’Ordine Domenicano, Padre Bruno Cadoré, avevano stipulato un accordo che impegnava i domenicani a tenere aperto il convento almeno fino al termine del processo di beatificazione di Giorgio La Pira, celebre sindaco di Firenze, legato per tanti motivi al convento di San Marco.
Ma la Provincia Domenicana, incurante di questo accordo, ha domandato al Generale di chiudere il convento, proprio come quattro anni fa. Il cardinale Betori ha cercato di rimediare contattando il Generale Cadoré, è nato un dialogo da cui è emersa la disponibilità del Generale a non chiudere il convento. Tale disponibilità però non si è tradotta in decisioni concrete e il convento (e i frati che vi risiedono) permane in una situazione di incertezza totale.
Domandiamo al Generale di trovare quanto prima una soluzione, affinché nel convento di San Marco risieda una comunità con un congruo numero di frati, in grado di valorizzare ed incrementare le sue attività.
Ricordiamo qui l’importanza unica del convento: San Marco dal XV secolo fa parte integrante della storia e dell’identità di Firenze, San Marco è il convento domenicano più famoso al mondo e uno dei più ricchi di opere d’arte, uno dei principali centri del Rinascimento, un laboratorio dove si sono fecondate a vicenda la religione cattolica, la cultura e l’arte.
Nel corso di quasi sei secoli moltissimi personaggi illustri (nella santità, nella cultura, nell’arte, nella politica) hanno abitato il convento oppure lo hanno frequentato assiduamente. Ancora oggi, benché rimasto con pochi frati, il convento è un punto di riferimento per le tante persone che desiderano un contatto con l’Ordine Domenicano, per gli studiosi di religione e arte che frequentano la chiesa, la biblioteca di spiritualità e le conferenze organizzate dai frati.
Firenze, 20 dicembre 2017
Il testo completo della petizione può essere letto su questa pagina di change.org.
*fonte: marcovannini
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI -- “Memoria storica e Rinascimento in Europa”. Seminario su “Cieli d’Europa. Cultura, creatività, uguaglianza” (di S. Settis). alla Normale di Pisa.19 dicembre 2017
Memoria storica e Rinascimento in Europa *
 18/12/2017
18/12/2017Si intitola “Memoria storica e Rinascimento in Europa” il seminario aperto a tutto il pubblico che il professor Roberto Esposito terrà con Salvatore Settis in occasione della pubblicazione del volume “Cieli d’Europa. Cultura, creatività, uguaglianza” (Utet 2017), dello stesso Settis.
Il seminario si tiene mercoledì 20 dicembre alle ore 17 nella Sala Stemmi della Scuola Normale.
Partecipano, oltre al professor Esposito e Settis, Gianpiero Rosati della Scuola Normale e Federico Vercellone dell’Università degli Studi Torino.
-
>LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. -- "Rinascimento cristiano. Innovazioni e riforma religiosa nell’Italia del XV e XVI secolo" (C. Moreschini).24 settembre 2017, di Federico La Sala
Claudio Moreschini,
Rinascimento cristiano. Innovazioni e riforma religiosa nell’Italia del Quindicesimo e Sedicesimo secolo,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017 *
- Tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo un forte sentimento di crisi colpisce la cultura del Rinascimento italiano in un punto cruciale della sua storia. Oggetto del volume è proprio l’interpretazione di questa crisi, durante la quale si afferma un cristianesimo ermetico, ora piegato soprattutto verso la tradizione antica ora verso la reinterpretazione cristiana della tradizione stessa.
 L’Autore si sofferma su motivi normalmente trascurati nella storia dell’Umanesimo italiano, ma che progressivamente stanno emergendo all’attenzione degli studiosi: le profonde inquietudini e i fermenti religiosi e spirituali che sfuggono a certe presentazioni troppo sistematiche di alcune dottrine filosofiche, come il ‘neoplatonismo del Rinascimento’ o ‘la filosofia dell’amore platonico’.
L’Autore si sofferma su motivi normalmente trascurati nella storia dell’Umanesimo italiano, ma che progressivamente stanno emergendo all’attenzione degli studiosi: le profonde inquietudini e i fermenti religiosi e spirituali che sfuggono a certe presentazioni troppo sistematiche di alcune dottrine filosofiche, come il ‘neoplatonismo del Rinascimento’ o ‘la filosofia dell’amore platonico’.
INDICE DEL VOLUME
Prefazione ................................................................................................ VII
Parteprima
Difesa del Cristianesimo
I. Gianfrancesco Pico della Mirandola tra Savonarola e Giovanni Pico........................3
II. Francesco Zorzi: Teologia e cosmogonia .............................................................71
III. L’autenticità del Corpus Dionysianum: contestazioni e difese........................95
Parte Seconda
Aspetti della poesia cristiana
I. La poesia ermetica e cristiana di Ludovico Lazzarelli: i Fasti Christianae Religionis.....143
II. La poesia di Gian Francesco Pico della Mirandola ........................ 163
III. La riscrittura cristiana di un testo ‘poetico’: Francesco Zorzi e il Cantico dei Cantici..... 219
Parte terza
Le tradizioni teosofiche antiche si inverano nella religione cristiana
I. Cristianesimo e tradizione ermetica .............................................................. 231
II. La tradizione caldaica ..................................................................................265
III. La tradizione (neo)platonica ..........................................................................295
Appendice
Ioannes Francisci Pici Mirandulae domini Concordiaeque Com. Hymnus ad Sanctiss. Trinitatem. Con traduzione a fronte ..... 344
Indice dei nomi .......................................................................................365
* SCHEDA EDITORIALE. - STORIA E LETTERATURA.
- Tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo un forte sentimento di crisi colpisce la cultura del Rinascimento italiano in un punto cruciale della sua storia. Oggetto del volume è proprio l’interpretazione di questa crisi, durante la quale si afferma un cristianesimo ermetico, ora piegato soprattutto verso la tradizione antica ora verso la reinterpretazione cristiana della tradizione stessa.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI -- "Michelangelo’s Poetry and Iconography in the Heart of the Reformation" (Ambra Moroncini)3 settembre 2017, di Federico La Sala
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA .... *
Artisti & fedeAll’anima di Michelangelo
Un libro indaga la complessa religiosità michelangiolesca, e allarga il campo a iconografia e Riforma
di Giulio Busi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 03.09.2017)
- Ambra Moroncini, Michelangelo’s Poetry and Iconography in the Heart of the Reformation , Routledge, London - New York, pagg. 171, € 122
È nell’orto di casa, la notte è serena. Prega. Quando alza gli occhi, nel cielo c’è una stella. Grande, enorme, con tre code. Il raggio d’oriente ha colore dell’argento. O forse è una spada lucente, torta alla sommità come un uncino? L’altro raggio, quello che si proietta su Roma, è vermiglio come il sangue. Il terzo strale s’incunea tra settentrione e occidente. È così lungo che arriva di sicuro fino a Firenze. In cima si biforca, ed è infuocato. Lui corre in casa, prende un foglio, torna fuori nell’orto, butta giù un’immagine. Disegnare è il suo mestiere.
Vorreste vederlo, questo schizzo misterioso? Il frate Benedetto Luschini, che ha raccontato tutta la storia, ci indica dove andare: «Se pure tu ti contenti di vederlo, va et truova el decto scultore, che al presente si truova et lavora in Firenze. Et lui benignamente ti mostrerrà la cosa, et humilmente ti dirà la verità del tucto, et così resterai satisfacto et troverrai che io non t0ho decto alcuno mendacio». Chi è lo scultore? Ha un nome facile da ricordare. Michelangelo.
Frate domenicano, grande sostenitore di Girolamo Savonarola, Luschini ha avuto guai con la giustizia. Mentre scrive, s’è già fatto un bel po’ d’anni di prigione per un omicidio, sembra preterintenzionale. È autentica la storia della stella, e il disegno, lo ha visto davvero? Sappiamo così poco, sul mondo interiore di Michelangelo, soprattutto durante la giovinezza e la prima maturità, che ogni indizio è prezioso.
Attese e paura di punizione celeste, speranze di trasformazione epocale. Le prediche dell’ossuto Savonarola, Michelangelo le ha sentite con le proprie orecchie, prima di partire per l’Urbe nel giugno 1496. Come quasi tutti i fiorentini, ne è rimasto impressionato, esaltato, turbato. Un’esaltazione di cui ancora si ricorderà nella vecchiaia, ma che non gli ha impedito di starsene al sicuro a Roma, e di lavorare per cardinali e banchieri, proprio mentre la stella di Savonarola, tanto più fragile della cometa celeste, sale al dominio della città e poi cade a precipizio, fino alla morte sul rogo.
La religione di Michelangelo è un tema profondo e contradditorio come tutto l’uomo. Generoso e taccagno, idealista e crudamente pragmatico, malinconico e ironico. Della sua tendenza a dar credito a profezie e attese millenariste si fanno beffe i familiari. E lui, permaloso, si risente: «Io non vo drieto a favole e non sono però pazzo afacto chome voi credete», scrive polemico, nel 1515, al fratello Buonarroto, che lo ha accusato di lasciarsi prendere da «frati e favole».
Favole - se le vogliamo chiamare così - ma quali? Al voluminoso dossier sulla religiosità michelangiolesca, Ambra Moroncini aggiunge ora un’indagine su poesia, iconografia e Riforma. La triade del titolo disegna il percorso di tutto il libro. Spirituali, evangelici, luterani, eretici: le possibili sfumature lessicali e storiche sono molte, ma il significato di fondo è univoco. È la ricerca di un Michelangelo che, nascostamente, fra amici - Vittoria Colonna, innanzitutto - o dietro il velo simbolico delle proprie opere, è in polemica con la Chiesa del potere e della pompa ed è lambito, o preso in pieno, dal grande vento che ha cominciato a soffiare a Wittenberg, il 31 ottobre 1517, quando Lutero ha deciso di proporre alla discussione pubblica le sue 95 tesi sulle indulgenze.
E poiché le date, per i visionari, contano, eccovi una coincidenza importante. Il 31 ottobre 1541, per i vespri alla vigilia d’Ognissanti, papa Paolo III inaugura, nella Cappella Sistina, il Giudizio Universale di Michelangelo. Ottobre è il più crudele dei mesi? No, il più eretico.
Secondo Moroncini, dietro l’apoteosi di santi e dannati, tutti egualmente svestitissimi, sotto la procace galassia di corpi che vortica attorno al Cristo risorto del Giudizio sistino, vi sono le simpatie evangeliche di Michelangelo, la sua polemica anti-ecclesiastica. Sulla scorta del commento al Vecchio e Nuovo Testamento del luterano Antonio Brucioli, s’ipotizza nel volume che i nudi vogliano rappresentare la condizione di peccato, dal quale la sola fede può salvare e non l’umana ipocrisia e le cerimonie esteriori della Chiesa.
Vien da chiedersi se sia questa l’unica spiegazione possibile per la fastosa, e provocatoria, nudità del Giudizio. Che l’esibizione di carni desse ad alcuni subito fastidio, è risaputo, giacché le prime critiche sono dello stesso 1541, e provengono dall’ambiente di due potenti cardinali e futuri papi, Marcello Cervini (Marcello II) e Gian Pietro Carafa (Paolo IV). Alla fine, ma solo più d’un ventennio più tardi, la revanche copritiva avrà la meglio, e all’ottimo allievo e amico di Michelangelo, Daniele da Volterra, detto poi il Braghettone, verrà affidato il compito di stendere pietose pennellate pudiche.
Non ci voleva però la Riforma protestante per far dipingere sodi e sensuali corpi al Buonarroti. Già qualche anno dopo l’affrescatura michelangiolesca sul soffitto della Sistina, papa Adriano VI aveva storto il suo naso fiammingo, e aveva definito la Volta, proprio per quelle pudende bene in vista, «una stufa d’ignudi», o bagno termale che dir si voglia.
Perché, allora, i nudi? E perché proprio nella cappella pontificia? È domanda religiosa d’importanza. Quali le ragioni, oltre, naturalmente, alla coerenza dell’artista, che comincia a scolpire nudi da ragazzo, nella Zuffa dei centauri, e mai si ferma per tutta la sua lunghissima vita? Credo carnis resurrectionem, dice il catechismo cattolico. Carnis, della carne, e non in tunica e camicia. Ma anche a voler azzardare qualche fonte più particolare, basta prendere una predica, tenuta nel Duomo di Firenze durante l’Avvento del 1493 (Michelangelo è quel giovanotto in fondo, tra la folla?) e poi pubblicata in volgare: «Nella resurrettione noi saremo nudi et semplici, cioè spogliati di queste superfluità del mondo». Chi è il predicatore? Ha un nome facile da ricordare. Savonarola.
SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:
- SANT’AGOSTINO, (FILIPPO BARBERI) E MICHELANGELO: "[...] L’affresco di Sant’Agostino nella cattedrale di Nardò, a mio parere, è un luminosissimo segno "manifesto" della diffusione della concezione umanistico-rinascimentale nella Terra d’Otranto e, insieme, del grande lavoro che porterà infine la Chiesa e Michelangelo a celebrare le Sibille (5) insieme ai Profeti (7) nella Volta della Cappella Sistina: ovvero, dice chiaramente del ruolo "giocato" dalla figura di Agostino nella costruzione dell’ orizzonte ecumenico umanistico e rinascimentale [...]".
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL. -
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- VENEZIA 2017. Maghe, streghe, sciamane, guaritrici: le artiste alla Biennale d’Arte.21 maggio 2017, di Federico La Sala
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA...
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali).
- LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI.
Maghe, streghe, sciamane, guaritrici: le artiste alla Biennale d’Arte di Venezia 2017
Aperta ai Giardini e all’Arsenale la 57esima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, diretta dalla francese Christine Macel
inserito da Flavia Matitti *
Sono maghe, streghe, sciamane, guaritrici. Consolano, curano, condividono, ma quando svelano ansie e minacce dei nostri giorni diventano perturbanti. Appaiono così le artiste presenti alla 57esima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, aperta ai Giardini e all’Arsenale dal 13 maggio al 26 novembre 2017.
L’edizione 2017 della Biennale di Venezia, del resto, conta su una marcata presenza femminile. A cominciare dalla direzione artistica, affidata alla storica dell’arte parigina Christine Macel (n.1969), curatrice capo al Centre Pompidou, convinta che: “L’arte di oggi, di fronte ai conflitti e ai sussulti del mondo, testimonia la parte più preziosa dell’umanità, in un momento in cui l’umanesimo è messo in pericolo”. Nella sua mostra intitolata “Viva Arte Viva” (una programmatica dichiarazione di fiducia nel potere rigenerante dell’arte) Christine Macel ha inserito oltre quaranta artiste su un totale di 120 nominativi.
Tra queste vi sono alcune figure leggendarie come Maria Lai (1919-2013), sarda, custode del bagaglio culturale della sua isola, autrice di poetici lavori incentrati sull’uso del filo. Qui è rievocata anche la performance collettiva “Legarsi alla montagna”, realizzata dall’artista con gli abitanti del suo paese, Ulassai, l’8 settembre del 1981, un esempio di come l’arte possa innescare un processo di partecipazione e condivisione.
 Singolare la coincidenza con il lavoro della coreografa americana Anna Halprin (n.1920), attiva dalla fine degli anni ’30, che nel 1981, in seguito allo shock provocato dall’assassinio di sette donne sui sentieri del Monte Tamalpais, vicino San Francisco, sviluppa una danza rituale di gruppo, per riconciliare la montagna con la comunità, poi divenuta la “Planetary Dance”, una danza per la pace che viene ripetuta annualmente ed eseguita in mostra nei giorni del vernissage.
Singolare la coincidenza con il lavoro della coreografa americana Anna Halprin (n.1920), attiva dalla fine degli anni ’30, che nel 1981, in seguito allo shock provocato dall’assassinio di sette donne sui sentieri del Monte Tamalpais, vicino San Francisco, sviluppa una danza rituale di gruppo, per riconciliare la montagna con la comunità, poi divenuta la “Planetary Dance”, una danza per la pace che viene ripetuta annualmente ed eseguita in mostra nei giorni del vernissage.Tra i tanti lavori esposti spicca ai Giardini la bella sala dedicata a Kiki Smith (n.1954), popolata di sculture e delicati disegni a inchiostro su carta nepalese, mentre all’Arsenale si segnalano la vivace installazione, fatta di balle colorate, dell’americana Sheila Hicks (n.1934), che ama definire le sue opere “tessiture senza pregiudizi” e il lavoro della polacca Alicja Kwade (n.1979), attiva a Berlino, una raffinata installazione che sfida le nostre capacità percettive.
Numerose sono anche le artiste chiamate a rappresentare il loro Paese attraverso progetti individuali concepiti appositamente per i rispettivi padiglioni nazionali, che quest’anno sono 86, sparsi tra i Giardini, l’Arsenale e il resto della città. Per il Padiglione della Germania, ad esempio, Anne Imhof (n. 1978) ha ideato “Faust”, un lavoro cupo sul tema del controllo e della sicurezza, col quale il padiglione tedesco si è aggiudicato il Leone d’oro per la migliore partecipazione nazionale.
 L’artista ha trasformato lo storico edificio ai Giardini in un bunker recintato e sorvegliato all’esterno da guardie accompagnate da cani feroci, mentre l’interno appare come un carcere, in cui un team di performer mette in scena episodi di arbitrio e autorità, resistenza e libertà.
L’artista ha trasformato lo storico edificio ai Giardini in un bunker recintato e sorvegliato all’esterno da guardie accompagnate da cani feroci, mentre l’interno appare come un carcere, in cui un team di performer mette in scena episodi di arbitrio e autorità, resistenza e libertà.
 La sensazione di trovarsi in un luogo minaccioso si avverte anche nel Padiglione del Brasile (premiato con una menzione speciale), dove Cinthia Marcelle (n.1974) ha realizzato il progetto “Hunting Ground”, sostituendo al pavimento delle grate metalliche disposte secondo piani inclinati.
La sensazione di trovarsi in un luogo minaccioso si avverte anche nel Padiglione del Brasile (premiato con una menzione speciale), dove Cinthia Marcelle (n.1974) ha realizzato il progetto “Hunting Ground”, sostituendo al pavimento delle grate metalliche disposte secondo piani inclinati.
 Il Padiglione della Gran Bretagna appare invece invaso da sculture informi e colorate, festose e inquietanti, secondo il progetto “Folly” di Phyllida Barlow (n.1944).
Il Padiglione della Gran Bretagna appare invece invaso da sculture informi e colorate, festose e inquietanti, secondo il progetto “Folly” di Phyllida Barlow (n.1944).
 Kirstine Roepstorff (n.1972) vorrebbe al contrario rassicurare e dal Padiglione della Danimarca invita, tramite un’esperienza immersiva, ad accettare la precarietà, l’ignoto e la trasformazione come componenti naturali del processo di crescita. L’artista ha allestito un teatro nel quale il visitatore si impegna a trascorrere mezz’ora, al buio, in un’oscurità mistica evocatrice dell’utero materno, del cosmo o dell’aldilà, mentre una voce sussurra: “Hai tutto dentro di te, devi essere disposto a cambiare completamente dal vecchio sistema di orientamento al nuovo: l’oscurità è il vuoto gravido da cui sorge e nasce ogni cosa”. -Tracey Moffatt (n.1960), la prima artista indigena a rappresentare l’Australia con una mostra individuale, presenta il progetto “My Horizon”, che attraverso fotografie, filmati e video affronta, tra realtà e finzione, il tema dei migranti e dello spaesamento quale condizione esistenziale.
Kirstine Roepstorff (n.1972) vorrebbe al contrario rassicurare e dal Padiglione della Danimarca invita, tramite un’esperienza immersiva, ad accettare la precarietà, l’ignoto e la trasformazione come componenti naturali del processo di crescita. L’artista ha allestito un teatro nel quale il visitatore si impegna a trascorrere mezz’ora, al buio, in un’oscurità mistica evocatrice dell’utero materno, del cosmo o dell’aldilà, mentre una voce sussurra: “Hai tutto dentro di te, devi essere disposto a cambiare completamente dal vecchio sistema di orientamento al nuovo: l’oscurità è il vuoto gravido da cui sorge e nasce ogni cosa”. -Tracey Moffatt (n.1960), la prima artista indigena a rappresentare l’Australia con una mostra individuale, presenta il progetto “My Horizon”, che attraverso fotografie, filmati e video affronta, tra realtà e finzione, il tema dei migranti e dello spaesamento quale condizione esistenziale.
 Tra l’altro si può vedere un vecchio filmato (Tracey Moffatt dice di averlo recentemente riscoperto) girato dai popoli indigeni australiani nel 1788, quando le prime navi della flotta britannica entrarono nel porto di Sidney.
Tra l’altro si può vedere un vecchio filmato (Tracey Moffatt dice di averlo recentemente riscoperto) girato dai popoli indigeni australiani nel 1788, quando le prime navi della flotta britannica entrarono nel porto di Sidney.
 La Romania dedica per la prima volta a una donna, Geta Brătescu (n.1926), una mostra individuale, offrendo così l’occasione per conoscere il lavoro di quest’artista, che attraverso disegni, collage, fotografie, oggetti e film conduce una riflessione affascinante sulla soggettività femminile.
La Romania dedica per la prima volta a una donna, Geta Brătescu (n.1926), una mostra individuale, offrendo così l’occasione per conoscere il lavoro di quest’artista, che attraverso disegni, collage, fotografie, oggetti e film conduce una riflessione affascinante sulla soggettività femminile.
 Vale la pena ricordare, infine, Jesse Jones (n.1978) col suo progetto video “Tremble, tremble” per il Padiglione dell’Irlanda in cui recupera, con la straordinaria performer Olwen Fouéré, la figura della strega quale archetipo femminista ed elemento di rottura in grado di trasformare la realtà. Il titolo riprende lo slogan delle femministe italiane degli anni ’70 “Tremate, tremate, le streghe son tornate!” e invoca una trasformazione dei rapporti tra Chiesa e Stato nell’Irlanda di oggi.
Vale la pena ricordare, infine, Jesse Jones (n.1978) col suo progetto video “Tremble, tremble” per il Padiglione dell’Irlanda in cui recupera, con la straordinaria performer Olwen Fouéré, la figura della strega quale archetipo femminista ed elemento di rottura in grado di trasformare la realtà. Il titolo riprende lo slogan delle femministe italiane degli anni ’70 “Tremate, tremate, le streghe son tornate!” e invoca una trasformazione dei rapporti tra Chiesa e Stato nell’Irlanda di oggi.Spesso anche la direzione artistica dei padiglioni nazionali è donna, come nel caso del Padiglione Italia, senza dubbio uno dei migliori di questa edizione. Da notare che la curatrice, Cecilia Alemani, ha voluto richiamare il tema della magia fin dal titolo della sua mostra - “Il mondo magico” (dal libro di Ernesto de Martino) - un tema che i tre artisti invitati (Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi e Adelita Husni-Bey) hanno declinato magnificamente, ciascuno a suo modo.
Su proposta di Christine Macel, inoltre, il Leone d’oro alla carriera è andato quest’anno all’americana Carolee Schneemann (n.1939), pioniera della performance femminista fin dagli anni ’60. “Schneemann - si legge nella motivazione - ha utilizzato il corpo nudo come forza primitiva e arcaica in grado di unificare le energie”.
Come sempre, durante la Biennale, sono innumerevoli gli eventi organizzati in città, ma sulle artiste si segnalano in particolare: la piccola mostra-dossier sulla pittrice surrealista danese Rita Kernn-Larsen (1904-1998), una riscoperta promossa dalla Collezione Peggy Guggenheim (fino al 26/6); l’esposizione “The Home of My Eyes”, che presenta 26 fotografie e il toccante video “Roja” (2016) dell’iraniana Shirin Neshat al Museo Correr (fino al 26/11); i raffinati progetti site specific realizzati da Marzia Migliora, in collaborazione con la Fondazione Merz, per le sale di Ca’ Rezzonico (fino al 26/11) e da Elisabetta Di Maggio (fino al 24/9) e Maria Morganti per gli spazi della Querini Stampalia.
 Da non perdere, infine, la mostra collettiva “Intuition” a Palazzo Fortuny (fino al 27/11), che spazia da Hilma af Klint a Marina Abramovic, e “Future Generation Art Prize@Venice 2017” a Palazzo Contarini Polignac (fino al 13/8).
Da non perdere, infine, la mostra collettiva “Intuition” a Palazzo Fortuny (fino al 27/11), che spazia da Hilma af Klint a Marina Abramovic, e “Future Generation Art Prize@Venice 2017” a Palazzo Contarini Polignac (fino al 13/8).
 In quest’ultima spiccano la misteriosa installazione rituale dell’artista sudafricana Dineo Seshee Bopape, vincitrice di questa quarta edizione del premio istituito dal mecenate ucraino Victor Pinchuk, e la fiabesca opera multisensoriale “Mutumia” (donna in Kikuyu) dell’artista kenyota Phoebe Boswell, vincitrice del premio speciale.
In quest’ultima spiccano la misteriosa installazione rituale dell’artista sudafricana Dineo Seshee Bopape, vincitrice di questa quarta edizione del premio istituito dal mecenate ucraino Victor Pinchuk, e la fiabesca opera multisensoriale “Mutumia” (donna in Kikuyu) dell’artista kenyota Phoebe Boswell, vincitrice del premio speciale.Biennale di Venezia 2017- didascalie
1. Sheila Hicks, Scalata al di là dei terreni cromatici, 2016-17, Arsenale, 57. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, Viva Arte Viva (Photo Flavia Matitti)
2. Alicja Kwade, WeltenLinie, 2017, Arsenale, 57. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, Viva Arte Viva (Photo Flavia Matitti)
3.Tracey Moffatt, Madre con bambino, dalla serie Traversata, 2017, Padiglione dell’Australia, Giardini, 57. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia (Photo courtesy the Artist, Australia Council for the Arts).
4. Una veduta esterna del Padiglione della Germania trasformato da Anne Imhof, Giardini, 57. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia (Photo by Flavia Matitti).
*
LA BIENNALE DI VENEZIA - Noi Donne, 15 Maggio 2017 (ripresa parziale).
-
> UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE (SALERNO, CONTURSI - 1613). -- il Seicento italiano caro ai re di Spagna. Alle Scuderie del Quirinale una grande mostra (di Nicolettta Speltra).14 aprile 2017
- SALERNO: CONTURSI - 1613: RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. Sul tema, la prefazione di Fulvio Papi e parte della premesssa del lavoro di Federico La Sala
Da Caravaggio a Bernini, a Roma il Seicento italiano caro ai re di Spagna
Alle Scuderie del Quirinale una grande mostra sulle relazioni artistiche tra le due culture nel diciassettesimo secolo. Sessanta opere in arrivo dai celebrati palazzi reali di Madrid e dintorni. Sino al 30 luglio
di NICOLETTA SPELTRA (la Repubblica, 13 aprile 2017)
E’ dedicata alle relazioni artistiche tra Spagna e Italia nel XVII secolo la mostra che apre domani, 14 aprile, alle Scuderie del Quirinale, per concludersi il prossimo 30 luglio. Relazioni che nacquero nel corso del dominio spagnolo su diversi territori della nostra penisola, durato oltre un secolo e mezzo, a partire dalla pace di Cateau Cambrésis, datata 1559. In questo lunghissimo lasso di tempo le due culture, quella iberica e quella italiana, ebbero modo di influenzarsi considerevolmente a vicenda.
Il barocco italiano era molto apprezzato da vicerè, principi, ambasciatori e dignitari di corte, che acquistavano o commissionavano opere per inviarle ai sovrani di Spagna, su loro diretta richiesta o, come dono, per riceverne in cambio appoggio e favori, considerato che gli Asburgo erano grandi appassionati d’arte. Queste acquisizioni contribuirono alla nascita, nel 1821, del Museo del Prado, mentre le opere rimaste nelle residenze reali, prima annoverate nel “Patrimonio de la Corona de España”, sono poi divenute, ufficialmente dal 1940, “Patrimonio Nacional”.
La mostra, intitolata “Da Caravaggio a Bernini - Capolavori del Seicento italiano nelle Collezioni Reali di Spagna” e curata da Gonzalo Redín Michaus, attinge proprio dalle importanti collezioni di questo patrimonio, con sessanta opere seicentesche di pittura e scultura che provengono dal palazzo reale di Madrid e dagli altri siti reali: per esempio, l’Escorial, El Pardo, che, dal 1940 al ’75, fu anche la residenza ufficiale di Francisco Franco, e il palazzo reale della Granja di San Ildefonso, conosciuto come la “piccola Versailles”.
In esposizione ci sono pezzi molto noti accanto a opere conservate in luoghi non aperti al pubblico e rimaste inedite fino allo scorso anno, quando furono esposte in una mostra presso la reggia madrilena che ha fatto da fondamentale prologo a quella romana.
Sono molti, infatti, i capolavori che tornano, per l’occasione, nella terra in cui furono concepiti. Tra questi, “La tunica di Giuseppe”, olio su tela di grandi dimensioni realizzato da Diego Velázquez, presumibilmente subito dopo il suo primo viaggio in Italia, tra il 1629 e il 1631, quando aveva ancora negli occhi le immagini dell’arte classica ma anche delle opere caravaggesche e dei maestri della scuola bolognese. Il dipinto, tra i più belli e interessanti della rassegna e perciò collocato in posizione centrale nell’allestimento, illustra con grande chiarezza e compostezza compositiva, come se si trattasse della scena di una rappresentazione teatrale, il momento in cui i fratelli di Giuseppe, dopo averlo venduto come schiavo, raccontano al padre Giacobbe la menzogna della sua morte, mostrandogli una tunica insaguinata. Solo il cane in primo piano, fiutandola, riconosce che il sangue è quello di un capretto e abbaia inutilmente, ignorato da tutti.
Altro capolavoro ben noto è la “Salomè con la testa del Battista” di Caravaggio, proveniente dal palazzo reale di Madrid e databile intorno al 1607, quindi un po’ anteriormente rispetto all’altro quadro caravaggesco a medesimo tema conservato presso la National Gallery di Londra.
Nel dipinto, che faceva parte della collezione di García de Avellaneda y Haro, conte di Castrillo, viceré di Napoli tra il 1653 e il 1659, da uno sfondo verde scuro, riscoperto da un recente restauro, emergono i busti della principessa giudaica che ha tra le mani il vassoio con il capo mozzo del Battista, della madre di lei, Erodiade, e del giovane giustiziere che regge la spada, rappresentati con tutto il contrasto luministico e la drammaticità caratteristici del linguaggio dell’autore.
E a Napoli hanno la loro prima origine anche molte altre opere presenti in questa mostra, dal momento che la città dette un contributo veramente significativo al Patrimonio Nacional spagnolo. Basti pensare a tutti i nomi di artisti attivissimi in terra partenopea che troviamo tra le sale dell’esposizione, quali Jusepe de Ribera, noto anche come “lo Spagnoletto” (molto intenso il suo “San Gerolamo penitente”, del 1638), Andrea Vaccaro, Massimo Stanzione e Luca Giordano. Consistente anche il contributo dalla Collezione Maratti, appartenuta alla poetessa Faustina Maratti, figlia del pittore Carlo, acquistata nel 1722 a Roma per il palazzo della Granja. Da questa raccolta provengono opere dedicate a regine ed eroiche figure femminili, come “Lucrezia si dà la morte” di Carlo Maratti (1685 circa).
Nella sezione dedicata alla scultura risaltano due opere in bronzo del Bernini: un modello della Fontana dei Quattro Fiumi e un Cristo crocifisso, inizialmente molto sottovalutato in Spagna e per motivi ancora ignoti sostituito poco dopo il suo arrivo al Pantheon reale dell’Escorial da un crocifisso di minor valore di Domenico Guidi, allievo di Alessandro Algardi, uno dei principali antagonisti di Bernini. Eppure il grande crocifisso berniniano è ritenuto dalla critica un manufatto di eccezionale qualità, anche perché, come scrive Tomaso Montanari nel catalogo della mostra, è l’unico esemplare di figura completa in metallo, autonoma e mobile, di Bernini che ci sia pervenuta, vale a dire l’unica non legata, fisicamente o anche solo concettualmente, a una architettura o a un complesso monumentale.
Interessantissima, infine, la storia di una delle due opere di Guido Reni presenti in mostra. Oltre a una “Santa Caterina”, c’è la “Conversione di Saulo”, realizzata intorno al 1620. L’episodio, tratto dagli Atti degli Apostoli, è ben noto: mentre cavalca sulla via di Damasco, Saulo, fino ad allora feroce persecutore dei cristiani, viene disarcionato dal cavallo da una luce folgorante accompagnata dal rimprovero di Cristo. Il dipinto, finora quasi sconosciuto, è stato attribuito al suo autore proprio dal curatore della mostra, Redín Michaus, che ne ha ricostruito anche la complicata, prestigiosa e a tratti sfortunata vicenda collezionistica, che ha origine tra le ricche raccolte del cardinale Ludovico Ludovisi e tra le sale della sua villa situata sulle colline del Pincio, a Roma. Guido Reni riprende un tema già affrontato per ben due volte, circa vent’anni prima, da Caravaggio. Tra i due non correva buon sangue e, anche se quando Reni dipinge la sua opera, il rivale è già morto, il linguaggio che adopera, teso alla ricerca del bello ideale, vuole rappresentare una sorta di contrapposizione e di critica al linguaggio, fortemente realistico, dell’altro, e forse un tentativo di oscurarne la fama. E’ l’emblema stesso, in questo senso, di un inquieto passaggio di consegne e del tramonto di un’epoca.
- SALERNO: CONTURSI - 1613: RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. Sul tema, la prefazione di Fulvio Papi e parte della premesssa del lavoro di Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Copertino si scopre casa delle Sibille (di Pier Paolo Tarsi)31 marzo 2017
- PROFETI E SIBILLE. Storia delle immagini ...
- MILANO. ALLA MOSTRA DEL LIBRO ANTICO RUBATI DUE VOLUMI. Di uno, quello di Filippo Barberi, si è occupato anche il nostro prof. Federico La Sala. In un suo suggestivo libro ha riprodotto tutte le xilografie del Barberi.
- Filippo Barberi, "Discordantiae sanctorum doctorum Hieronymi et Augustini", 1481
Copertino si scopre casa delle Sibille
di Pier Paolo TARSI *
Copertino si riscopre in possesso di un altro tesoro: il volto delle Sibille di Santa Maria di Casole! C’è sempre un enigma misterioso da svelare quando si tratta delle celeberrime profetesse, vergini che da millenni affascinano la cultura occidentale, dalla Grecia classica a noi, passando per la civiltà romana e la cristianità medievale e moderna. In effetti, risulta già inspiegabile capire come sia potuto sfuggire a tutti gli osservatori, storici e ricercatori locali, l’unicità che hanno invece colto ed evidenziato con questo studio Marcello Gaballo, medico e storico dell’arte locale, e il professore Armando Polito, entrambi colonne portanti della Fondazione Terra d’Otranto.
Grazie proprio al loro sguardo particolarmente attento, da oggi Copertino può vantare una eccezionalità che può divenire, se opportunamente divulgata e valorizzata con politiche culturali serie e a lungo raggio - ossia non estemporanee ma continuative, ben progettate e strutturate -, una ulteriore e nuova ragione per collocare di buon diritto Copertino nel circuito delle mete obbligate nei tragitti turistico-culturali e artistici del Salento e della Puglia.
Ci auguriamo che i nostri amministratori e gli operatori del settore turistico sappiano cogliere la preziosa opportunità che questa rivelazione apre al loro operato e al nostro territorio. Per dare una concreta idea del perché Santa Maria di Casole possa apparire oggi così speciale, basti pensare che, allo stato attuale delle conoscenze, su tutto il territorio pugliese non sono noti altri cicli completi delle 12 Sibille della tradizione.
Anche a livello nazionale possiamo vantare la rarità dell’esempio di Casole: in mancanza di un censimento nazionale ufficiale che ci restituisca un quadro definitivo, pare dobbiamo giungere a Salerno o fino a Bergamo per poter scrutare il fascino affrescato che emana dal ciclo completo di tutte le 12 profetesse. Sappiamo invece ora con certezza che la famiglia al completo delle Sibille ha una casa anche in Puglia, precisamente a Copertino!
Al di là di questa importante e significativa segnalazione, già di per sé sufficiente a far comprendere la rilevanza del luogo e la necessità di scommettere sul fascino attrattivo di Casole - per esempio, riportando quanto prima alla luce tutto il corredo pittorico -, lo studio di Marcello Gaballo e Armando Polito evidenzia anche l’altissimo livello culturale della comunità religiosa che animava il luogo. Ne offrono prova la quantità e la rilevanza dei libri che appartenevano al Convento, parte dei quali si trova oggi nella Biblioteca Vergari di Nardò, i cui frontespizi sono peraltro riprodotti nel testo.
Che sia proprio Casole, col suo fascino sibillino, uno degli snodi patrimoniali per rilanciare il potenziale attrattivo di questa città, favorendone un percorso di sviluppo turistico da far lievitare intorno alle inattese nuove risorse? Questo luogo che ha rappresentato nei secoli un importante volano della cultura, oggi, mentre se ne svelano ulteriori valenze storiche e unicità artistiche, si candida infatti a divenire fonte e impulso di nuovo vigore per l’economia del territorio.
Varrebbe dunque la pena investirci per renderlo uno degli altari su cui il nostro passato può celebrare il lascito del testimone ad un futuro sostenibile, tutto ancora da progettare e scrivere tanto per Copertino quanto per il Salento. Dipende solo da noi e dall’intelligenza politica locale a questo punto; la storia, come ci mostra egregiamente questo studio, ha già fatto ampiamente la sua parte, al punto che ci sorprende ancora con eredità di cui non eravamo nemmeno consapevoli. Ora è nostro compito saperle raccogliere, preservare e valorizzare in tutta la loro rarità.
* Fondazione Terra D’Otranto, 30/03/2017 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- PIACENZA. Il ’600 di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino (di Nicoletta Castagni)6 febbraio 2017, di Federico La Sala
- UOMINI E DONNE, PROFETI E SIBILLE, OGGI: STORIA DELLE IDEE E DELLE IMMAGINI. RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
Il ’600 di Guercino tra Sacro e Profano
Dal 4/3 a Piacenza si visiteranno anche affreschi cupola Duomo
di Nicoletta Castagni *
PIACENZA - Una mostra dei suoi capolavori a Palazzo Farnese e la possibilità di poter ammirare da vicino, per la prima volta, il ciclo di affreschi della cupola della Cattedrale: dal 4 marzo Piacenza celebra Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, e il suo sublime ’600, di cui, tra immagini sacre e raffigurazioni profane, il pittore di Cento fu uno degli indiscussi protagonisti. Fino al 4 giugno, la rassegna presenterà infatti una ventina di opere tra oli e disegni, mentre una serie d’iniziative di grande suggestione e rilevanza storico-artistica accompagneranno l’ascesa all’interno della cupola decorata dal maestro emiliano con le storie dall’Antico e Nuovo Testamento. Intitolato ’Guercino a Piacenza’, il progetto espositivo è stato promosso dalla Fondazione Piacenza e Vigevano, dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio e dal comune di Piacenza, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Mibact e col contributo della Camera di Commercio di Piacenza, Apt Servizi Regione Emilia Romagna, Iren (main sponsor Credit Agricole Cariparma). Fulcro di tutta la manifestazione sarà ovviamente la Cattedrale, con lo straordinario ciclo di affreschi realizzato da Guercino tra il 1626 e il 1627 e che si presenterà in tutta la sua bellezza grazie alla nuova illuminazione realizzata da Davide Groppi.
Tra i vertici assoluti della sua arte, le pitture della cupola sono suddivise in sei scomparti raffiguranti le immagini dei profeti Aggeo, Osea, Zaccaria, Ezechiele, Michea, Geremia. Nelle le lunette ecco dunque alcuni episodi dell’infanzia di Gesù (Annuncio ai Pastori, Adorazione dei pastori, Presentazione al Tempio e Fuga in Egitto) che si alternano alle immagini di otto Sibille e il fregio del tamburo.
Chiamato per primo a dipingere i Profeti nella volta della Cattedrale, fu nel 1625 Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone, che ne realizzò due, Davide e Isaia, ma morì appena ultimati i primi due spicchi, notevoli per cromia e impianto. Quindi, nel 1626 gli subentrò il Guercino, che completò entro l’anno successivo gli altri sei scomparti della cupola e le lunette.
Per preparare all’ascesa della cupola, il visitatore sarà invitato, come prima tappa del percorso espositivo, all’interno delle sagrestie superiori della Cattedrale, dove verrà allestita una sala multimediale circolare che conterrà un grande videowall di oltre 10 m di lunghezza.
Il filmato di impatto spettacolare, condurrà virtualmente nella storia, al momento in cui il Vescovo Linati invita Guercino a Piacenza per decorare la cupola secondo i canoni imposti dal Concilio. Grazie all’impiego delle più attuali tecnologie, a una base scientifica che poggia su documenti d’archivio e disegni preparatori, alle foto ad altissima risoluzione del ciclo pittorico, lo spettatore potrà comprendere i tempi, le tecniche di lavorazione e le difficoltà riscontrate nella realizzazione di quello che la critica ha definito uno dei maggiori capolavori del maestro di Cento.
Sempre dal 4 marzo, la Cappella ducale di Palazzo Farnese ospiterà la bella mostra curata da Daniele Benati e Antonella Gigli, che insieme (e con il supporto di un comitato scientifico composto da Antonio Paolucci, Fausto Gozzi e David Stone) hanno selezionato 20 capolavori del Guercino, capaci di restituire la lunga parabola creativa che lo ha portato a divenire uno degli artisti del ’600 italiano più amati a livello internazionale. I dipinti scelti, infatti, testimonieranno la ’poetica degli affetti’ con cui il pittore, lungo l’arco cronologico della sua operosa attività artistica, ha realizzato sia i temi sacri sia quelli profani.
Tra i capolavori esposti ci saranno in prevalenza pale d’altare, ma non mancheranno i quadri ’da stanza’ a soggetto profano, in modo da scoprire il vero volto di Guercino e apprezzarne la straordinaria qualità e le prerogative messe a punto prima e dopo la grande impresa della volta piacentina. Il percorso espositivo illustrerà quindi le prime esperienze pittoriche a Cento, paese natale, svolte nel segno di una romantica adesione al linguaggio di Ludovico Carracci e indagherà la sua maturazione artistica avvenuta durante i lunghi soggiorni a Bologna e quindi a Roma. Fino ad arrivare all’ultima fase, quando, pur rimanendo inconfondibile, il suo linguaggio si apre a nuove sollecitazioni di tipo classicheggiante, incontrando il favore dei più illustri committenti.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- E LA SCUOLA MEDICA SALERNITANA.9 gennaio 2017, di Federico La Sala
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. Sul tema, la prefazione di Fulvio Papi e parte della premessa del lavoro di Federico La Sala
 Le Sibille di Contursi hanno parentele più celebri nella Cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel Tempio Malatestiano di Rimini, nella Cappella Sistina di Michelangelo. La pittura disegna l’ eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale (...)
Le Sibille di Contursi hanno parentele più celebri nella Cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel Tempio Malatestiano di Rimini, nella Cappella Sistina di Michelangelo. La pittura disegna l’ eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale (...)-
> UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- E LA SCUOLA MEDICA SALERNITANA. TESTO DEL PROTOCOLLO PER LA CANDIDATURA A PATRIMONIO CULTURALE DELL’UNESCO.8 febbraio 2021, di Federico La Sala
Scuola Medica Salernitana, protocollo per farla diventare Patrimonio dell’Unesco
Obiettivo unico: candidarla come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità *
di Redazione "ASalerno" *
Può considerarsi storico l’evento avvenuto questa mattina a Palazzo di Città dove è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Salerno, l’Università degli Studi di Salerno, la Soprintendenza Areceologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e la Scuola Medica Salernitana. Un protocollo, come detto, finalizzato alla richiesta di candidare all’Unesco la Scuola Medica Salernitana nella lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.
Le Interviste
- [...]
Ecco il Protocollo di intesa
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SALERNO, L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO, LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO E LA FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA finalizzato alla richiesta di candidatura all’UNESCO della SCUOLA MEDICA SALERNITANA nella LISTA RAPPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELL’UMANITA’.
L’anno 2020 nel mese di presso il Comune di Salerno si sono riuniti:
1. COMUNE DI SALERNO rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, che assume il ruolo di Ente responsabile, coordinatore e referente per tutte le fasi e attività del progetto. Cura i procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione del progetto giusta Deliberazione della Giunta Comunale allegata in atti.
2. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO, rappresentata dal Soprintendente Pro-Tempore Arch. Francesca Casule, preposta sul territorio alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico, paesaggistico e demoetnoantropologico, anche al fine di favorire la pubblica fruizione.
3. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO rappresentata dal prof. Vincenzo Loia Magnifico Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano in via Giovanni Paolo II, 132, n. P.IVA 00851300657 - C.F. 80018670655, autorizzato alla sottoscrizione dal Consiglio di Amministrazione con delibera del
4. FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA rappresentata dal Presidente dott. Corrado LIQUORI, tutti partner del progetto evidenziato in oggetto, in un’ottica di rete su scala territoriale/locale, che approvano e sottoscrivono la presente intesa;
PREMESSO:
 che il patrimonio culturale non è solo monumenti e collezioni di oggetti ma anche tutte le tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati: espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, sociali, riti e feste, conoscenza e pratiche concernenti la natura e l’universo, artigianato tradizionale;
che il patrimonio culturale non è solo monumenti e collezioni di oggetti ma anche tutte le tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati: espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, sociali, riti e feste, conoscenza e pratiche concernenti la natura e l’universo, artigianato tradizionale; che questo patrimonio culturale immateriale è fondamentale nel mantenimento della diversità culturale di fronte alla globalizzazione e la sua comprensione aiuta il dialogo interculturale e incoraggia il rispetto reciproco dei diversi modi di vivere;
che questo patrimonio culturale immateriale è fondamentale nel mantenimento della diversità culturale di fronte alla globalizzazione e la sua comprensione aiuta il dialogo interculturale e incoraggia il rispetto reciproco dei diversi modi di vivere; che la sua importanza non risiede nella manifestazione culturale in sé, bensì nella ricchezza di conoscenza e competenze che vengono trasmesse da una generazione all’altra;
che la sua importanza non risiede nella manifestazione culturale in sé, bensì nella ricchezza di conoscenza e competenze che vengono trasmesse da una generazione all’altra;
 che l‘Unesco ha tra i suoi obiettivi prioritari l’attuazione di misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni, e per questo nel 2003 ha adottato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall’Italia nel 2007, nella quale è prevista una serie di procedure per l’identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale.
che l‘Unesco ha tra i suoi obiettivi prioritari l’attuazione di misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni, e per questo nel 2003 ha adottato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall’Italia nel 2007, nella quale è prevista una serie di procedure per l’identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale. che ai sensi di tale Convenzione è stata istituita “La Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)”, che contribuisce a divulgare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza;
che ai sensi di tale Convenzione è stata istituita “La Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)”, che contribuisce a divulgare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza; che la Scuola medica Salernitana, nata intorno al IX secolo a Salerno, è stata la prima e più importante istituzione medica d’Europa nel Medioevo e come tale è da considerarsi l’antesignana delle moderne università, fondata sulla tradizione greco-latina, integrata dalle nozioni provenienti dalle culture araba ed ebraica, conoscenze che, la posizione strategica della città di Salerno, posta al centro del Mediterraneo, favoriva;
che la Scuola medica Salernitana, nata intorno al IX secolo a Salerno, è stata la prima e più importante istituzione medica d’Europa nel Medioevo e come tale è da considerarsi l’antesignana delle moderne università, fondata sulla tradizione greco-latina, integrata dalle nozioni provenienti dalle culture araba ed ebraica, conoscenze che, la posizione strategica della città di Salerno, posta al centro del Mediterraneo, favoriva; che ha rappresentato la pietra miliare della storia della medicina per le innovazioni introdotte relative al metodo e all’impostazione della profilassi, basate sulla pratica e sull’esperienza, agevolando il metodo empirico e la cultura della prevenzione;
che ha rappresentato la pietra miliare della storia della medicina per le innovazioni introdotte relative al metodo e all’impostazione della profilassi, basate sulla pratica e sull’esperienza, agevolando il metodo empirico e la cultura della prevenzione; che la Scuola Medica Salernitana, comprende una serie di competenze, conoscenze, simboli e tradizioni concernenti i saperi e le terapie mediche e del benessere anche psicofisico;
che la Scuola Medica Salernitana, comprende una serie di competenze, conoscenze, simboli e tradizioni concernenti i saperi e le terapie mediche e del benessere anche psicofisico;
 che dette competenze sono state trasmesse, attraverso una copiosa tradizione manoscritta e costituiscono tutt’ora fondamento di un modello di cura “tradizionale” del corpo e dell’anima;
che dette competenze sono state trasmesse, attraverso una copiosa tradizione manoscritta e costituiscono tutt’ora fondamento di un modello di cura “tradizionale” del corpo e dell’anima;
 che la Scuola Medica Salernitana costituisce la base identitaria della città di Salerno battezzata nel corso del Medioevo Hippocratica Civitas (definizione che compare anche nello stemma comunale);
che la Scuola Medica Salernitana costituisce la base identitaria della città di Salerno battezzata nel corso del Medioevo Hippocratica Civitas (definizione che compare anche nello stemma comunale); che la Scuola Medica Salernitana, ponte tra Oriente ed Occidente, ha enfatizzato i valori del dialogo interculturale e interreligioso, dell’accoglienza e del rispetto delle diversità, oltre ad essere pioniera delle pari opportunità in quanto ha inserito le donne nella pratica e nell’insegnamento della medicina;
che la Scuola Medica Salernitana, ponte tra Oriente ed Occidente, ha enfatizzato i valori del dialogo interculturale e interreligioso, dell’accoglienza e del rispetto delle diversità, oltre ad essere pioniera delle pari opportunità in quanto ha inserito le donne nella pratica e nell’insegnamento della medicina; che l’ars medica Salernitana ha influenzato anche i diversi linguaggi artistici, dall’arte alla letteratura, alla poesia, dalla musica al cinema e perfino il fumetto;
che l’ars medica Salernitana ha influenzato anche i diversi linguaggi artistici, dall’arte alla letteratura, alla poesia, dalla musica al cinema e perfino il fumetto; che, al fine di preservare e tramandare ai posteri la grandezza della Scuola medica Salernitana, si intende avviare la procedura per il formale riconoscimento di essa quale patrimonio Culturale immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco, ritenendo che la candidatura rappresenti una occasione imprescindibile per la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché un’opportunità di sviluppo non solo della comunità Salernitana, ma della comunità internazionale, per la testimonianza storica di ricchezza di conoscenze e competenze che merita di essere trasmessa da una generazione all’altra;
che, al fine di preservare e tramandare ai posteri la grandezza della Scuola medica Salernitana, si intende avviare la procedura per il formale riconoscimento di essa quale patrimonio Culturale immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco, ritenendo che la candidatura rappresenti una occasione imprescindibile per la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché un’opportunità di sviluppo non solo della comunità Salernitana, ma della comunità internazionale, per la testimonianza storica di ricchezza di conoscenze e competenze che merita di essere trasmessa da una generazione all’altra; che con delibera di G.C. n. 19 del 23.01.2020 è stato dato formale indirizzo in tal senso individuando altresì i partner pubblici indispensabili per l’istruttoria della pratica;
che con delibera di G.C. n. 19 del 23.01.2020 è stato dato formale indirizzo in tal senso individuando altresì i partner pubblici indispensabili per l’istruttoria della pratica;
 che la Scuola Medica Salernitana merita di essere candidata all’Unesco sulla base del più ampio riscontro di partecipazione da parte della comunità salernitana, coinvolgendo anche gruppi o, eventualmente, persone singole che spontaneamente e gratuitamente intendano rendere disponibile il loro qualificato impegno;
che la Scuola Medica Salernitana merita di essere candidata all’Unesco sulla base del più ampio riscontro di partecipazione da parte della comunità salernitana, coinvolgendo anche gruppi o, eventualmente, persone singole che spontaneamente e gratuitamente intendano rendere disponibile il loro qualificato impegno; che, per la realizzazione del dossier di candidatura (programma, attività, identificazione, documentazione, ricerca, salvaguardia, promozione, valorizzazione, trasmissione, formazione, rivitalizzazione e innovazione dei vari aspetti della Scuola medica salernitana) occorre un progetto di rete tra organismi competenti e istituzioni culturali che si riconoscono in questa stessa finalità, quali appunto Comune, Università, Soprintendenza e Fondazione Scuola Medica Salernitana, ed esperti, nonché la costituzione di un gruppo di riflessione, studio e lavoro che si impegni anche nel promuovere eventi, iniziative e manifestazioni su territorio locale, regionale, nazionale ed internazionale a supporto del progetto di candidatura Unesco;
che, per la realizzazione del dossier di candidatura (programma, attività, identificazione, documentazione, ricerca, salvaguardia, promozione, valorizzazione, trasmissione, formazione, rivitalizzazione e innovazione dei vari aspetti della Scuola medica salernitana) occorre un progetto di rete tra organismi competenti e istituzioni culturali che si riconoscono in questa stessa finalità, quali appunto Comune, Università, Soprintendenza e Fondazione Scuola Medica Salernitana, ed esperti, nonché la costituzione di un gruppo di riflessione, studio e lavoro che si impegni anche nel promuovere eventi, iniziative e manifestazioni su territorio locale, regionale, nazionale ed internazionale a supporto del progetto di candidatura Unesco; che le parti (Comune, Università, Soprintendenza, Fondazione) sono interessate ad operare in sinergia nell’ambito delle rispettive finalità e competenze per raggiungere l’obiettivo proposto;
che le parti (Comune, Università, Soprintendenza, Fondazione) sono interessate ad operare in sinergia nell’ambito delle rispettive finalità e competenze per raggiungere l’obiettivo proposto;Tutto ciò premesso ed approvato, i soggetti sopra indicati convengono e stabiliscono quanto segue:
Art. 1 Impegni generali
Gli enti in premessa indicati stabiliscono di collaborare, per la realizzazione del progetto definito in oggetto.
 Ciascun aderente al presente atto conferma il proprio impegno alla realizzazione del progetto, secondo indirizzi e finalità espresse.
Ciascun aderente al presente atto conferma il proprio impegno alla realizzazione del progetto, secondo indirizzi e finalità espresse.Art. 2 Oggetto della Convenzione e designazione del Comune capofila
Il Presente Accordo ha per oggetto la definizione dei rapporti collaborativi, amministrativi e giuridici tra gli Enti che aderiscono al progetto.
 I sottoscrittori del presente atto designano il Comune di Salerno quale Ente capofila, dando mandato al suo legale rappresentante o suo delegato di assumere ogni necessaria e opportuna determinazione, finalizzata alla realizzazione e attuazione del progetto identificato in oggetto.
I sottoscrittori del presente atto designano il Comune di Salerno quale Ente capofila, dando mandato al suo legale rappresentante o suo delegato di assumere ogni necessaria e opportuna determinazione, finalizzata alla realizzazione e attuazione del progetto identificato in oggetto.Art. 3 - Ruolo e obblighi degli Enti
Al raggiungimento degli obiettivi previsti al precedente articolo, le parti si impegnano secondo la propria specifica competenza e secondo il proprio statuto istituzionale, garantendo quanto segue:
La Soprintendenza provvederà a:
 svolgere tutte le attività necessarie a garantire il raccordo con le strutture del MIBACT deputate al coordinamento delle candidature UNESCO;
svolgere tutte le attività necessarie a garantire il raccordo con le strutture del MIBACT deputate al coordinamento delle candidature UNESCO;
 garantire l’elaborazione, l’adeguamento e l’implementazione, in collaborazione per la parte tecnologica con l’Università di Salerno, dei contenuti scientifici relativi al nuovo allestimento del Museo Scuola Medica Salernitana;
garantire l’elaborazione, l’adeguamento e l’implementazione, in collaborazione per la parte tecnologica con l’Università di Salerno, dei contenuti scientifici relativi al nuovo allestimento del Museo Scuola Medica Salernitana;
 elaborare i dati scientifici relativi ai siti archeologici, storico-artistici, architettonici, paesaggistici e demoetnoantropologici che afferiscono al contesto culturale in cui l’istituzione medica salernitana è inserita dalle origini fino ai giorni nostri.
elaborare i dati scientifici relativi ai siti archeologici, storico-artistici, architettonici, paesaggistici e demoetnoantropologici che afferiscono al contesto culturale in cui l’istituzione medica salernitana è inserita dalle origini fino ai giorni nostri.
 collaborare alle azioni di promozione, divulgazione ed educazione, finalizzate alla candidatura nel Patrimonio Immateriale Unesco;
collaborare alle azioni di promozione, divulgazione ed educazione, finalizzate alla candidatura nel Patrimonio Immateriale Unesco;
 collaborare, per gli aspetti di propria competenza, alla stesura del Piano di Gestione del Bene inscritto nelle Liste del Patrimonio Immateriale Unesco;
collaborare, per gli aspetti di propria competenza, alla stesura del Piano di Gestione del Bene inscritto nelle Liste del Patrimonio Immateriale Unesco;
 facilitare l’accesso alla documentazione conservata nei propri archivi.
facilitare l’accesso alla documentazione conservata nei propri archivi.L’Università provvederà a:
 coordinare attività di studio e ricerca nei suoi molteplici ambiti di competenza, e principalmente:
coordinare attività di studio e ricerca nei suoi molteplici ambiti di competenza, e principalmente:
 effettuare ricerche di archivio e bibliografiche e procedere alla catalogazione dei dati servendosi di professionalità in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente;
effettuare ricerche di archivio e bibliografiche e procedere alla catalogazione dei dati servendosi di professionalità in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente;
 diffondere il patrimonio di conoscenze della Scuola Medica Salernitana, sviluppandone i contenuti alla luce delle evidenze della farmacologia, farmacoterapia, fitoterapia, cosmesi e fitocosmesi, scienza della nutrizione del III millennio;
diffondere il patrimonio di conoscenze della Scuola Medica Salernitana, sviluppandone i contenuti alla luce delle evidenze della farmacologia, farmacoterapia, fitoterapia, cosmesi e fitocosmesi, scienza della nutrizione del III millennio;
 interpretare tale patrimonio alla luce degli attuali paradigmi scientifici propri della biologia, biologia molecolare, chimica e tecnologie farmaceutiche;
interpretare tale patrimonio alla luce degli attuali paradigmi scientifici propri della biologia, biologia molecolare, chimica e tecnologie farmaceutiche;
 curare la pubblicazione di testi in formato stampa e digitale e la creazione di banche dati su una piattaforma open source cooperare alle attività di divulgazione e disseminazione dei risultati della ricerca attraverso i social media;
curare la pubblicazione di testi in formato stampa e digitale e la creazione di banche dati su una piattaforma open source cooperare alle attività di divulgazione e disseminazione dei risultati della ricerca attraverso i social media;
 promuovere la conoscenza, la storia e l’immagine della Scuola medica salernitana in ambito nazionale e internazionale favorendo la creazione di una rete di relazioni con enti e istituzioni scientifiche;
promuovere la conoscenza, la storia e l’immagine della Scuola medica salernitana in ambito nazionale e internazionale favorendo la creazione di una rete di relazioni con enti e istituzioni scientifiche;
 promuovere attività didattiche connesse alla ricerca;
promuovere attività didattiche connesse alla ricerca;
 promuovere incontri scientifici e conferenze sul tema;
promuovere incontri scientifici e conferenze sul tema;La Fondazione della Scuola Medica Salernitana:
 documenterà il rapporto antico e moderno tra la medicina e le terapie naturali;
promuoverà e sosterrà la ricerca, la formazione e l’aggiornamento storico-culturale nel campo della medicina;
tutelerà e valorizzerà, in termini culturali ed economici, i beni di interesse storico ed artistico, in particolare quelli riferiti alla tradizione dell’antica “Scuola Medica Salernitana”, in quanto ne rappresenta l’eredità culturale e scientifica;
documenterà il rapporto antico e moderno tra la medicina e le terapie naturali;
promuoverà e sosterrà la ricerca, la formazione e l’aggiornamento storico-culturale nel campo della medicina;
tutelerà e valorizzerà, in termini culturali ed economici, i beni di interesse storico ed artistico, in particolare quelli riferiti alla tradizione dell’antica “Scuola Medica Salernitana”, in quanto ne rappresenta l’eredità culturale e scientifica;
 svilupperà progetti incentrati sull’interazione tra nutrizione e stati di salute attraverso l’Ebris, il proprio istituto di ricerca di medicina, una vera eccellenza nel panorama medico internazionale, nato nel 2012 su iniziativa della Fondazione della Scuola Medica Salernitana e del Mass General Hospital for Children dell’Università di Harvard;
svilupperà progetti incentrati sull’interazione tra nutrizione e stati di salute attraverso l’Ebris, il proprio istituto di ricerca di medicina, una vera eccellenza nel panorama medico internazionale, nato nel 2012 su iniziativa della Fondazione della Scuola Medica Salernitana e del Mass General Hospital for Children dell’Università di Harvard;
 garantirà la manutenzione e la conservazione del Giardino della Minerva, antesignano degli orti botanici intesi nell’accezione moderna del termine, attraverso azioni volte alla fruizione, valorizzazione, divulgazione e promozione dell’Orto, anche con laboratori didattici, visite guidate, convegni, congressi, corsi di formazione;
curerà particolarmente il vivaio delle piante officinali, alcune delle quali preziose e rare, dando rilevanza a quelle specie citate nel Regimen Sanitatis Salernitanum e nell’Opus Pandectarum Medicinae;
garantirà la manutenzione e la conservazione del Giardino della Minerva, antesignano degli orti botanici intesi nell’accezione moderna del termine, attraverso azioni volte alla fruizione, valorizzazione, divulgazione e promozione dell’Orto, anche con laboratori didattici, visite guidate, convegni, congressi, corsi di formazione;
curerà particolarmente il vivaio delle piante officinali, alcune delle quali preziose e rare, dando rilevanza a quelle specie citate nel Regimen Sanitatis Salernitanum e nell’Opus Pandectarum Medicinae;
 fornirà un congruo aggiornamento storico-culturale con il Museo Papi che, con la sua raccolta di strumenti ed attrezzi medico-chirurgici databili tra il XVII e il XX secolo, costituisce a livello mondiale uno dei più importanti musei per quantità di materiale ed interesse scientifico; un’esposizione permanente di pezzi appartenenti a quasi tutte le branche della medicina come oculistica, chirurgia, ortopedia, odontoiatria, cardiologia, pneumologia e attrezzi della farmaceutica, materiale per anestesia e vaccinazioni;
fornirà un congruo aggiornamento storico-culturale con il Museo Papi che, con la sua raccolta di strumenti ed attrezzi medico-chirurgici databili tra il XVII e il XX secolo, costituisce a livello mondiale uno dei più importanti musei per quantità di materiale ed interesse scientifico; un’esposizione permanente di pezzi appartenenti a quasi tutte le branche della medicina come oculistica, chirurgia, ortopedia, odontoiatria, cardiologia, pneumologia e attrezzi della farmaceutica, materiale per anestesia e vaccinazioni;
 farà rivivere nel Museo virtuale Scuola Medica Salernitana, in un racconto coinvolgente, ma essenziale e rigoroso, i protagonisti di quella gloriosa pagina di storia che, negli anni seguenti al Mille, vide Salerno con la sua Scuola Medica Salernitana al centro del rinascimento scientifico dell’occidente;
farà rivivere nel Museo virtuale Scuola Medica Salernitana, in un racconto coinvolgente, ma essenziale e rigoroso, i protagonisti di quella gloriosa pagina di storia che, negli anni seguenti al Mille, vide Salerno con la sua Scuola Medica Salernitana al centro del rinascimento scientifico dell’occidente;
 garantirà, nell’ambito delle proposte formative e divulgatrici dell’antica scuola medica salernitana, lo svolgimento di Worck Shop formativo per gli studenti liceali del territorio;
garantirà, nell’ambito delle proposte formative e divulgatrici dell’antica scuola medica salernitana, lo svolgimento di Worck Shop formativo per gli studenti liceali del territorio;
 assicurerà, infine, eventi e iniziative nel campo medico scientifico e di ricerca storica della Scuola Medica che diano visibilità nazionale ed internazionale all’istituzione attraverso un progetto, “Storia della medicina prima della scuola medica salernitana”, legato ad un convegno cui parteciperanno esponenti della storia della cultura cattolica ed araba, rettori delle Università di Tunisi e di Salerno, rappresentanti dell’ordine dei medici, farmacisti ed odontoiatri di Salerno, con lo scopo di costituire un centro di studi di storia della medicina mediterranea.
assicurerà, infine, eventi e iniziative nel campo medico scientifico e di ricerca storica della Scuola Medica che diano visibilità nazionale ed internazionale all’istituzione attraverso un progetto, “Storia della medicina prima della scuola medica salernitana”, legato ad un convegno cui parteciperanno esponenti della storia della cultura cattolica ed araba, rettori delle Università di Tunisi e di Salerno, rappresentanti dell’ordine dei medici, farmacisti ed odontoiatri di Salerno, con lo scopo di costituire un centro di studi di storia della medicina mediterranea.
 Il Comune capofila assume:
Il Comune capofila assume:
 il ruolo di Ente responsabile, coordinatore e referente per tutte le fasi e attività dell’istruttoria anche avvalendosi del contributo spontaneo e gratuito di professionisti salernitani desiderosi di contribuire a questo progetto ambizioso. Cura i procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione della candidatura in oggetto per il tramite dei suoi uffici.
il ruolo di Ente responsabile, coordinatore e referente per tutte le fasi e attività dell’istruttoria anche avvalendosi del contributo spontaneo e gratuito di professionisti salernitani desiderosi di contribuire a questo progetto ambizioso. Cura i procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione della candidatura in oggetto per il tramite dei suoi uffici.
 Gli enti aderenti sono partner del progetto. Ciascuno di essi si rende disponibile a raccogliere la documentazione e le testimonianze inerenti la Scuola Medica Salernitana, nonché a compiere le attività e gli interventi utili a formare il dossier per la presentazione della candidatura in un’ottica di rete su scala territoriale/locale integrata.
Gli enti aderenti sono partner del progetto. Ciascuno di essi si rende disponibile a raccogliere la documentazione e le testimonianze inerenti la Scuola Medica Salernitana, nonché a compiere le attività e gli interventi utili a formare il dossier per la presentazione della candidatura in un’ottica di rete su scala territoriale/locale integrata.
 Le Parti si impegnano, inoltre, congiuntamente a proporre e partecipare a convegni nazionali e internazionali per promuovere e valorizzare il più possibile le attività oggetto del presente progetto e ad elaborare una pubblicazione da diffondere capillarmente anche attraverso eventi e manifestazioni utili alla divulgazione dei saperi della Scuola Medica Salernitana, radice culturale e orgoglio di un intero territorio e della sua comunità.
Le Parti si impegnano, inoltre, congiuntamente a proporre e partecipare a convegni nazionali e internazionali per promuovere e valorizzare il più possibile le attività oggetto del presente progetto e ad elaborare una pubblicazione da diffondere capillarmente anche attraverso eventi e manifestazioni utili alla divulgazione dei saperi della Scuola Medica Salernitana, radice culturale e orgoglio di un intero territorio e della sua comunità.Art. 5 Referenti tecnici e istituzionali
Il Comune capofila ha provveduto alla designazione del RUP, nella persona del Segretario Generale dell’Ente, per ogni attività connessa alla realizzazione del progetto. Gli Enti aderenti designano uno o più referenti tecnici e istituzionali per ogni utile attività di raccordo e collaborazione.
Art. 6 Gestione del progetto
La gestione della candidatura di riconoscimento della Scuola medica Salernitana nella Lista italiana del Patrimonio Culturale Immateriale Mondiale dell’Unesco - fa capo al Comune capofila.
Art. 7 Dovere di leale collaborazione
E’ fatto obbligo a tutti i sottoscrittori di garantire la massima collaborazione per le attività da svolgersi e di fornire i dati utili e la documentazione necessaria alla formazione del dossier per promuovere la candidatura. Allo scopo di consentire ed accertare l’efficacia e l’efficienza dello stato di attuazione del progetto, sarà cura del Comune capofila richiedere ai partner aderenti dati e informazioni utili ai fini della ottimale realizzazione delle attività progettuali.
 Ciascun partecipante adotta tutte le misure organizzative necessarie per consentire all’Ente capofila di poter disporre delle informazioni inerenti le attività di progetto.
Ciascun partecipante adotta tutte le misure organizzative necessarie per consentire all’Ente capofila di poter disporre delle informazioni inerenti le attività di progetto.Art. 8 Durata della presente Convenzione
Si conviene di fissare la durata del presente intesa sino al raggiungimento dell’obiettivo di progetto.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali saranno utilizzati dal Comune capofila per soli fini istituzionali e di progetto, assicurando protezione e riservatezza delle informazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Art. 10 Norme transitorie e finali
Per quanto non espressamente contenuto nel presente, si rimanda alle vigenti norme legislative, statutarie e regolamentari.
Letto, approvato e sottoscritto.
Salerno,
COMUNE DI SALERNO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 Il Sindaco PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO
Il Sindaco PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO
— arch. Vincenzo NAPOLI - Il Sovraintendente ff
— arch . Francesca CASULE -UNIVERSITA’ DI SALERNO FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA
 Il Rettore Il Presidente
Il Rettore Il Presidente
— prof Vincenzo LOIA - - dott. Corrado LIQUORI -* Fonte: "ASalerno", 6 novembre 2020
-
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- LE SIBILLE, I PROFETI, E IL SERPENTE DI BRONZO: MICHELANGELO, ABY WARBURG, E UN ANAGRAMMA!!!9 ottobre 2016, di Federico La Sala
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- LE SIBILLE, I PROFETI, E IL SERPENTE DI BRONZO: MICHELANGELO, ABY WARBURG, E UN ANAGRAMMA!!!
- COME UN VECCHIO LIBRO INSEGNA, ATENE E ORAIBI SONO PARENTI (Aby Warburg)***
"SERPENTE? PRESENTE!"
NOTE A MARGINE DI UN RICCO E BRILLANTISSIMO LAVORO di ARMANDO POLITO:
SERPENTE? PRESENTE! Proprio un brillantissimo (http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/10/04/serpente-presente/) excursus!!! In segno di ringraziamento, mi permetto di rendere onore a Ermete Trismegisto (cfr. note al seguente art.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/06/10/iapige-fantomatico-progenitore-salentini/) e di aggiungere - a questa del prof. Polito - un’altra tessera al "mosaico sempre in fieri".
RICORDANDO CHE "l’abitudine non può rendere insipida la varietà infinita della bellezza" - prodotta dalla LUCE - e, RENDENDO OMAGGIO alla "Analisi della Bellezza" di Hogarth, metto a disposizione della riflessione alcune note di "epistimologia geneSica" (dove la "S", maiuscola, sta a dire proprio della "serpentina" (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5794) e della necessità di aprire gli occhi e saper distinguere (cfr. note all’art.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/09/26/la-terra-dotranto-mappa-delleuropa-del-secolo-xvi/) tra la "serpentina" di "Salomone" e le "serpentine" di salsicce di "Salamone".
*
I MIEI PIù VIVI COMPLIMENTI ALL’AMICO SERPENTE, AL PROF. ARMANDO POLITO, E AL LAVORO DELLA FONDAZIONE!!!
Federico La Sala
- [...]
CRUCIVERBA ed ENIGMISTICA.
 "Dal metodo non nasce niente": un omaggio a Edipo, "Il mancino zoppo" (Michel Serres)
"Dal metodo non nasce niente": un omaggio a Edipo, "Il mancino zoppo" (Michel Serres)Pur sapendo a quali "pericoli" ("So benissimo...") andava incontro, il prof. Polito, ha aggiunto CORAGGIOSAMENTE al "mosaico sempre in fieri" (vale a dire, in cammino!) una "tessera" e, pur sapendo di ERMETE TRISMEGISTO, ha aperto - SENZA VOLERLO - non solo (come ha fatto alla fine dell’articolo) la porta della CATTEDRALE DI SIENA, ma anche la porta della CAPPELLA SISTINA (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5195)!!!
CON un semplice ANAGRAMMA ("Serpente? Presente!": http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/10/04/serpente-presente/) ha sollecitato a riconsiderare e a riguardare tutte le tessere del MOSAICO. A questo punto, però, non è più solo un "gioco di parole"! Ora, non si sono solo Apollo, Pitone, le Sibille, e le Muse, c’è anche MOSÈ e MICHELANGELO - e FREUD ("L’uomo Mosè e la religione monoteistica": http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4829).
C’è il richiamo a tutto l’immaginario biblico e, in particolare, alla interpretazione di Michelangelo della vicenda del SERPENTE DI BRONZO, racchiuso nel "pennacchio" della Volta della Cappella Sistina - https://it.wikipedia.org/wiki/Serpente_di_bronzo_(Michelangelo): il richiamo a un ALTRO serpente, "all’amico serpente" - "al sulfureo amico" -"all’amico ritrovato"!!!
ENIGMI: CRUCI-VERBA!!! A MEMORIA, e ad evitare EQUIVOCI, è BENE ricordare che i "verba volant"!!! Se, e solo se, le parole, i "VERBA" sono agganciati alla croce ("CRUCI"), al "palo", al "bastone" - alla "colonna vertebrale" della propria persona, diventano "scripta", parole scritte, parole degne di essere ricordate - scrittura, Scrittura!!! Altrimenti, sono solo parole al vento di serpenti impazziti - in un mare di sabbia!!!
Federico La Sala
***
Aby Warburg
Il rituale del serpente
Una relazione di viaggio *
Aby Warburg è stato forse l’uomo che più ha influenzato, in questo secolo, la nostra visione della storia dell’arte. Attraverso i suoi studi egli ha indicato la via che consente di ritrovare nelle arti figurative la concrezione di una intera civiltà, con tutte le sue oscure tensioni psichiche. Ma lo stesso Warburg, mentre sviluppava la sua opera grandiosa, era periodicamente colpito da crisi nervose, che lo obbligavano a prolungati soggiorni in clinica.
 Nel 1923, al termine di uno di questi soggiorni, per dimostrare la propria guarigione, egli tenne ai pazienti e ai medici della casa di cura di Kreuzlingen un «discorso d’addio» - la celebre conferenza sul Rituale del serpente, apparsa poi nel 1939 sul «Journal» del Warburg Institute con una pudibonda nota che la diceva pronunciata per la prima volta «davanti a un pubblico non specialistico». Di fatto, quel discorso era insieme una confessione e un testamento.
Nel 1923, al termine di uno di questi soggiorni, per dimostrare la propria guarigione, egli tenne ai pazienti e ai medici della casa di cura di Kreuzlingen un «discorso d’addio» - la celebre conferenza sul Rituale del serpente, apparsa poi nel 1939 sul «Journal» del Warburg Institute con una pudibonda nota che la diceva pronunciata per la prima volta «davanti a un pubblico non specialistico». Di fatto, quel discorso era insieme una confessione e un testamento.
 In poche pagine, prendendo spunto da una sua spedizione presso gli indiani Pueblo, Warburg risale alle origini del paganesimo e della magia. E illumina il potere stesso - innanzitutto psichico - delle immagini, il loro potere di ferire e di guarire, stabilendo così un circuito fulmineo fra il serpente dell’arcaico rito dei Pueblo e quello che Mosè invitava a innalzare nel deserto.
In poche pagine, prendendo spunto da una sua spedizione presso gli indiani Pueblo, Warburg risale alle origini del paganesimo e della magia. E illumina il potere stesso - innanzitutto psichico - delle immagini, il loro potere di ferire e di guarire, stabilendo così un circuito fulmineo fra il serpente dell’arcaico rito dei Pueblo e quello che Mosè invitava a innalzare nel deserto.
 Per comprendere un testo fondamentale come Il rituale del serpente occorre considerarne in ogni dettaglio la genesi e le allusioni: compito che qui assolve il prezioso saggio di Ulrich Raulff.
Per comprendere un testo fondamentale come Il rituale del serpente occorre considerarne in ogni dettaglio la genesi e le allusioni: compito che qui assolve il prezioso saggio di Ulrich Raulff.* SCHEDA EDITORIALE: ADELPHI (Risvolto - copertina).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- LE SIBILLE, I PROFETI, E IL SERPENTE DI BRONZO -- Lo sdoganamento di Satana (di Marco Ventura).10 ottobre 2016, di Federico La Sala
SERPENTE? PRESENTE! - UN ANAGRAMMA, IL SERPENTE DI BRONZO, E LO SDOGANAMENTO DI SATANA.
- [...] CON un semplice ANAGRAMMA ("Serpente? Presente!": http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/10/04/serpente-presente/) ha sollecitato a riconsiderare e a riguardare tutte le tessere del MOSAICO. A questo punto, però, non è più solo un "gioco di parole"! Ora, non si sono solo Apollo, Pitone, le Sibille, e le Muse, c’è anche MOSÈ e MICHELANGELO - e FREUD ("L’uomo Mosè e la religione monoteistica": http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4829).
Lo sdoganamento di Satana
 Dalla Polonia al Bataclan, invocare Lucifero sta diventando normale
Dalla Polonia al Bataclan, invocare Lucifero sta diventando normale
 Gli adoratori del demonio hanno aperto un tempio a Salem dove una volta s’impiccavano le streghe
Gli adoratori del demonio hanno aperto un tempio a Salem dove una volta s’impiccavano le streghe
 Il loro obiettivo è essere riconosciuti e legittimati come ogni altra religione
Il loro obiettivo è essere riconosciuti e legittimati come ogni altra religionedi Marco Ventura (Corriere della Sera, La Lettura, 09.10.2016)
Una tipica casa vittoriana di Salem, nella contea di Essex, sulla baia del Massachusetts. Tetto scuro a punta, pareti d’assi orizzontali in legno bianco, portico con colonne. Sul cartello nero, la scritta «The Satanic Temple». Il Tempio di Satana. È qui il quartier generale mondiale di un’organizzazione che vanta 40 mila aderenti nei soli Stati Uniti, la maggior parte a Detroit. Appena inaugurato. Per chi subisce il fascino del diavolo, per chi è contro la religione dei più, Salem è la città giusta.
La sede del Tempio di Satana si trova a un chilometro da Gallows Hill, dove a fine Seicento morirono sul patibolo in 19, i più sfortunati tra i quasi 300 inquisiti e imprigionati per stregoneria. Nella Salem puritana della caccia alle streghe, dove apparivano ancora impensabili l’Illuminismo, le rivoluzioni francese e americana, la tolleranza e la libertà, il diavolo era il nemico della comunità e se ne sapeva riconoscere la presenza.
Ereditava un lungo passato, la gente di Salem che trascinava gli amanti del demonio sulla collina del patibolo. Per secoli di storia cristiana, gli adoratori di Satana sono stati l’antitesi del credente. Il diavolo combattuto dai cristiani riassumeva in sé tutte le divinità nemiche dell’unico vero Dio. Gli idoli dei popoli nemici di Israele, il vitello d’oro degli Ebrei fedifraghi, il culto dell’imperatore di Roma, le statuine sugli altari privati dei Romani, le divinità naturali di Britanni e Germani. Sbaragliati i quali, l’Inquisizione aveva ritrovato il nemico di sempre in eretici e streghe: diverse le forme d’espressione, identica l’impronta della Bestia.
Nel lungo percorso verso la tolleranza, la mappa era ancora cambiata. Il diavolo papista e il satana luterano erano divenuti, l’uno per l’altro, sempre meno diabolici. Poco a poco, i cristiani avevano smesso di vedere lo zampino del demonio nelle difformi dottrine di altri battezzati.
 Satana si spostava nei territori di missione, nelle colonie. Uscito dal corpo di cattolici e luterani, era entrato nelle statue dei templi taoisti e nel ghigno rosso fuoco di una delle tante facce del Buddha; nelle maschere ancestrali del Congo e nell’inferno del Punjab; nelle possessioni degli schiavi neri di Bahia. Lo riconoscevamo, sempre spaventoso, sempre temibile, in quelle nuove forme. Sono diavoli dalla pelle scura, sulla stampa britannica, gli indiani che ammazzano migliaia di inglesi nell’ammutinamento del 1857.
Satana si spostava nei territori di missione, nelle colonie. Uscito dal corpo di cattolici e luterani, era entrato nelle statue dei templi taoisti e nel ghigno rosso fuoco di una delle tante facce del Buddha; nelle maschere ancestrali del Congo e nell’inferno del Punjab; nelle possessioni degli schiavi neri di Bahia. Lo riconoscevamo, sempre spaventoso, sempre temibile, in quelle nuove forme. Sono diavoli dalla pelle scura, sulla stampa britannica, gli indiani che ammazzano migliaia di inglesi nell’ammutinamento del 1857.
 Pensavamo che grazie a noi, alla nostra civilizzazione, anche i popoli del mondo potessero riconoscere la potenza diabolica, abbandonare la superstizione e abbracciare la nostra fede nell’unico Dio. Invece no. Proprio allora, quando tutto sembrava di nuovo chiaro, il diavolo si rimetteva in viaggio. Per tenere le colonie, gli occidentali imparavano ad accettare le braccia di Kali e il sorriso del Bodhisattva, a leggere i Veda e la Gita. Ne beneficiò Gandhi, che a Londra comprese la religione dell’India e incontrò il nuovo avatar di Satana: sul marciapiede di una stazione, quel giorno di gennaio del 1891, quando vide un sacerdote aggredito da militanti atei.
Pensavamo che grazie a noi, alla nostra civilizzazione, anche i popoli del mondo potessero riconoscere la potenza diabolica, abbandonare la superstizione e abbracciare la nostra fede nell’unico Dio. Invece no. Proprio allora, quando tutto sembrava di nuovo chiaro, il diavolo si rimetteva in viaggio. Per tenere le colonie, gli occidentali imparavano ad accettare le braccia di Kali e il sorriso del Bodhisattva, a leggere i Veda e la Gita. Ne beneficiò Gandhi, che a Londra comprese la religione dell’India e incontrò il nuovo avatar di Satana: sul marciapiede di una stazione, quel giorno di gennaio del 1891, quando vide un sacerdote aggredito da militanti atei.Dall’altra parte dell’Atlantico era appena stata costruita la casa di Salem in cui oggi ha sede il Satanic Temple; dopo due anni, a Chicago, si sarebbe riunito per la prima volta il Parlamento mondiale delle religioni. A Gandhi il diavolo era sembrato farsi ateo, ma durante la lotta moderna tra i credenti e i materialisti il principe delle tenebre parve piuttosto eclissarsi. Se era morto Dio, perché non sarebbe dovuto morire il suo Nemico? Poi vennero Khomeini e Wojtyla, i mujaheddin pagati dai protestanti americani cacciarono i sovietici. Tirammo giù il muro; e dietro le macerie c’era lui.
Fin dagli anni Sessanta il diavolo era apparso anzitutto ai cristiani che ritrovavano la fede antica e popolare, spronati dall’energia carismatica. Per tanti nuovi battezzati il demonio non apparteneva più a una religiosità negativa e isterica, da riscattare nella modernità cristiana positiva e razionale. L’inferno esisteva davvero, e non era certo vuoto. Il ritorno del diavolo divise i cristiani buoni da quelli che militavano per i diritti gay, le donne prete e il dialogo ecumenico, quelli che facevano guerra alla verità e al matrimonio, quelli, appunto, che non credevano più a Belzebù, agli inferi, all’Apocalisse.
Il ritorno del diavolo, tuttavia, fu molto più ampio. Fiorì l’interesse per il demonio di teologi e letterati. Sadik al-Azm scrisse fin da metà anni Sessanta che il rinnovamento religioso islamico dipendeva da una rilettura del rapporto tra Satana e Allah basata su fonti sufi. Salman Rushdie pubblicò i suoi dirompenti Versi satanici. Vi fu poi la protesta generazionale di chi percorreva all’inverso le scale verso il paradiso dei Led Zeppelin, ascoltava i Black Sabbath, simpatizzava con il diavolo dei Rolling Stones. Crebbe inoltre il pubblico interessato all’occultismo e alla magia. Per l’opinione pubblica tutto si esauriva nel settarismo satanista, nei suoi riti blasfemi e nei suoi atti criminali. Eppure le sette sataniche erano solo un pezzetto di un fenomeno molto più grande.
L’occasione per comprenderlo capita il 13 novembre 2007. Al club Ucho di Gdynia, a nord di Danzica, si esibiscono i Behemoth, band metal polacca affascinata dal diavolo. Il leader Adam Darski, noto come Nergal, canta il suo pezzo più celebre, Lucifero, poi straccia una Bibbia e ne getta frammenti al pubblico. È un libro di bugie, grida, è sterco, ipocrisia, la Chiesa cattolica è la religione più assassina del pianeta. Ne nasce un caso che tiene occupati i giudici polacchi fino al 2012, quando la Corte suprema risparmia la condanna a Darski per ragioni procedurali. Non è un caso eccentrico, isolato. Come tanti altri, Nergal usa il diavolo per aggredire il cattolicesimo nazionalista e conservatore. E usa la denuncia del cattolicesimo retrivo di Radio Maryja e dei fratelli Kaczynski per costruire intorno al diavolo un credo polimorfo. C’è identità, visibilità mediatica, politica, commercio. C’è il collegamento con pezzi di società. C’è la resistenza in tribunale che si tramuta in indiretto riconoscimento.
Stentiamo a crederci, ma è proprio così. Stanno diventando una religione i seguaci del demonio. Imparano da chi negli ultimi decenni ha fatto la stessa strada: da chi era un’associazione criminale, e poi non riconosciuta, e gode ora dello statuto di religione. Come i mormoni, i testimoni di Geova, i seguaci di Scientology e, quasi quasi, gli atei. Come il movimento Wicca dei neo-pagani e delle neo-streghe.
Anche il satanismo sta diventando una delle tante religioni organizzate che lottano per la propria legittimità, e persino per il proprio diritto a essere eguali alle altre. La società è propizia. I satanisti organizzati seguono il flusso della corrente che porta al mare sempre più vasto delle organizzazioni di religione o di credo. Mitigano gli eccessi, si mostrano socialmente impegnati, propugnano il dialogo, curano la comunicazione, proclamano i diritti dell’uomo, si compromettono col mercato.
Cambia di conseguenza la percezione della dimensione criminale del fenomeno satanico. Non c’è differenza, per il giudice, tra il bambino di Satana che stupra un’adolescente e un prete reo di pedofilia. Per i gruppi satanici, come per la Chiesa di Scientology e la Santa Sede, l’importante non è non delinquere, in ogni organizzazione c’è un delinquente, ma è schivare l’accusa di associazione a delinquere.
Il Tempio satanico di Salem, come gran parte del satanismo americano rifugiatosi sotto l’ombrello della libertà religiosa, è l’esempio perfetto. I cittadini di Salem non hanno niente da temere, sostengono i rappresentanti «della maggiore organizzazione satanista al mondo», hanno anzitutto da guadagnare da un’associazione di gente onesta, dedita all’interesse sociale, all’emancipazione dall’oscurantismo, alla libertà individuale, al pluralismo e al progresso. La corrente trascina i gruppi satanici verso il mare della religione.
Adorare il diavolo può catalizzare significati diversissimi, e al contempo avere senso per molti. La prova più significativa, e più drammatica, viene la notte del 13 novembre 2015. Al Bataclan di Parigi, la nostra migliore gioventù canta «bacia il diavolo» in un gesto di libertà, di evasione, di sfogo, di energia, e viene ammazzata dalla peggiore gioventù islamica, nichilista e omicida, persuasa che non meriti altro chi inneggia a Satana. Si è capovolto l’ordine di un tempo.
Il Tempio del Massachusetts non è un’americanata, Salem e Parigi sono connesse. Si è allargato il mare delle religioni e del credere: c’è spazio per tutti, e per ogni contraddizione; per far festa col diavolo, e per morirne. Parigi e Salem si chiamano. Anche in Europa, tra pochi giorni, si celebra Halloween. A Salem si preparano le zucche: in 250 mila visiteranno la città dove per il diavolo si finiva impiccati.
-
> LE SIBILLE, I PROFETI, E IL SERPENTE DI BRONZO: MICHELANGELO, ABY WARBURG, E UN ANAGRAMMA!!! --- «SPERENT IN TE»: IL FILO DEL «SERPENTE». "Divina Commedia", il viaggio della speranza (di Giuliano Vigini).30 marzo 2021, di Federico La Sala
L’ATLANTE DEL "PARADISO IN TERRA", BOLOGNA, DANTE, E LA "MEMORIA" DI ABY WARBURG.... *
- "Non permetto che mi si trascini attraverso l’Inferno se non a colui che confido sappiaa anche portarmi attraverso il Purgatorio fino al Paradiso" (Aby Warburg, 26.06.1896).
Riletture.
"Divina Commedia", il viaggio della speranza
L’itinerario di Dante si conclude sulle più alte vette. Le miserie lasciate nella desolata pianura degli uomini non sono state dimenticate, ma ormai sono viste con occhi nuovi
Giuliano Vigini (Avvenire, domenica 28 marzo 2021)
- [Foto] Inf., III-IV: Dante e Virgilio nel Limbo al cospetto di Omero, Orazio, Ovidio, Lucano - Biblioteca Vaticana
Dall’esilio terreno alla patria celeste, la Divina Commedia è tutta un’epifania di speranza. Inizialmente è l’angosciante anelito di Dante di uscire dalla «selva oscura» ( Inf. I,1) in cui si era smarrito; poi, la forte tensione per raggiungere il colle della «divina foresta» ( Purg. XXVIII, 2); infine, dopo il doloroso distacco da Virgilio e la comparsa di Beatrice, la consolante certezza di esser entrato nel regno «che solo amore e luce ha per confine» ( Par. XXVIII, 53.54).
 Dall’umana necessità di sperare - bene supremo che i dannati dell’Inferno hanno definitivamente perduto ( Inf. III,9) - si passa dunque, procedendo nell’ascesa, alla speranza come virtù teologale, che si affianca alle due sorelle maggiori - come avrebbe detto Péguy -, la fede e la carità, per camminare insieme verso Dio.
Dall’umana necessità di sperare - bene supremo che i dannati dell’Inferno hanno definitivamente perduto ( Inf. III,9) - si passa dunque, procedendo nell’ascesa, alla speranza come virtù teologale, che si affianca alle due sorelle maggiori - come avrebbe detto Péguy -, la fede e la carità, per camminare insieme verso Dio.Sono le tre “donne” che nel canto XXIX, 121-129 del Purgatorio danzano in cerchio sul lato destro del carro, ciascuna risplendente di un proprio colore (bianca la fede, verde smeraldo la speranza, rossa la carità). La fede è la radice della speranza (Par. XXIV, 73-75), perché se l’uomo non arriva a «conoscere» il Suo nome (Sal 9,11; 91,14), cioè a professare la fede nel Signore («Sperino in te»; «Sperent in te», Par. XXV, 73, 98), la sua speranza cammina al buio, senza mai trovare la via maestra della verità di sé stesso e della sua sospirata felicità. La carità è l’altra virtù essenziale, che dà forma e compimento alla fede, perché, quanto più si esercita la carità, fondandola in Dio e nel suo amore, tanto più ci si avvicina all’«amore perfetto» (1Gv 4,12) che in modo perfetto unisce anche le altre virtù. Beatrice è per Dante il volto della speranza. È lei che, mossa dall’amore («amor mi mosse», Inf. II, 72), lo guida e lo spinge in avanti verso quell’Amore di cui già gode; è lei che, innalzata da creatura umana a figura della teologia e a rappresentante della sapienza divina, è scesa dal cielo per aiutarlo a salire verso il Bene sommo che è Dio.
Di grado in grado, Beatrice non emana più soltanto il dolce profumo della donna bella e virtuosa amata da Dante in gioventù; lei gli porta il profumo stesso di Dio, dei santi e dei beati, dei maestri e dei testimoni della fede (da Tommaso a Bonaventura, da Francesco a Domenico a Bernardo) che sono con lei in paradiso. Sotto la guida di Beatrice, con davanti i suoi occhi luminosi e il suo radioso sorriso, la speranza di Dante si fa via via realtà concreta; non è un’illusione destinata a perdersi e a svanire; la speranza è sempre davanti a lui come orizzonte verso il quale alzare lo sguardo e camminare.
 Quando raggiunge questo orizzonte, la speranza ha compiuto il suo ultimo tragitto e si trasforma in un’epifania di luce, nell’inebriante realtà della gloria di Dio e della gloria di Cristo, che da sole tutto illuminano. Lì anche Dante può contemplare il mistero trinitario (il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo) e volgere la sua devota preghiera a Maria, la «vergine madre », «umile e alta più che creatura », «termine fisso d’etterno consiglio» ( Par. XXXIII, 1-3). Il viaggio di Dante si conclude sulle più alte vette. Le miserie lasciate nella desolata pianura degli uomini non sono state dimenticate, ma il mondo di lassù gli fa ormai vedere con occhi nuovi anche le realtà di quaggiù.
Quando raggiunge questo orizzonte, la speranza ha compiuto il suo ultimo tragitto e si trasforma in un’epifania di luce, nell’inebriante realtà della gloria di Dio e della gloria di Cristo, che da sole tutto illuminano. Lì anche Dante può contemplare il mistero trinitario (il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo) e volgere la sua devota preghiera a Maria, la «vergine madre », «umile e alta più che creatura », «termine fisso d’etterno consiglio» ( Par. XXXIII, 1-3). Il viaggio di Dante si conclude sulle più alte vette. Le miserie lasciate nella desolata pianura degli uomini non sono state dimenticate, ma il mondo di lassù gli fa ormai vedere con occhi nuovi anche le realtà di quaggiù.
*Sul tema, nel sito, si cfr.:
- LE SIBILLE, I PROFETI, E IL SERPENTE DI BRONZO: MICHELANGELO, ABY WARBURG, E UN ANAGRAMMA!!!
L’ATLANTE DEL "PARADISO IN TERRA", BOLOGNA, DANTE, E LA "MEMORIA" DI ABY WARBURG.
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaFederico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- LE SIBILLE, I PROFETI, E IL SERPENTE DI BRONZO: UNA DOMANDA DI UMBERTO SABA E LA SPERANZA (IL FILO DEL "SERPENTE") DI DANTE ALIGHIERI.6 febbraio 2024, di Federico La Sala
MITO E ANTROPOLOGIA: UNA DOMANDA DI UMBERTO SABA E LA SPERANZA (IL FILO DEL "SERPENTE") DI DANTE ALIGHIERI
 (Par. XXV, 97-99: "E prima, appresso al fin d’este parole, / ‘#Sperent in te’ di sopr’a noi s’udì: a che rispuoser tutte le carole.").
(Par. XXV, 97-99: "E prima, appresso al fin d’este parole, / ‘#Sperent in te’ di sopr’a noi s’udì: a che rispuoser tutte le carole.").- Appunti in margine di una "citazione", condivisa da Ernesto Scelza (v. allegato) *
STORIA E LETTERATURA E #STORIOGRAFIA. Nella dimensione dell’#immaginario di Saba, nella lotta di "fratelli contro fratelli", gli "italiani" affondano con i piedi e con la testa non solo nella #Terra di #Romolo e #Remo ("#Cesare", ma anche di #Caino ed #Abele ("#Cristo"): e di qui, forse, la possibilità di risalire la corrente dei fiumi e, come i #salmoni e le #anguille, con #Salomone (e #Freud e Trieste e Napoli) e Dante Alighieri, e ritrovare la #sorgente, "l’amor che move il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145).
DIVINA COMMEDIA. Nel non detto delle parole di Umberto Saba, non emerge un #segnavia "delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo" (#RenéGirard) che sollecita a proseguire il cammino e portarsi oltre la #tragedia?
#Earthrise #Dante2021 #Kant2024
*
- «Vi siete mai chiesti perché l’Italia non ha avuto, in tutta la sua storia - da Roma ad oggi - una sola vera rivoluzione? La risposta - chiave che apre molte porte - è forse la storia d’Italia in poche righe.
- Gli italiani non sono parricidi; sono fratricidi. Romolo e Remo, Ferruccio e Maramaldo, Mussolini e i socialisti, Badoglio e Graziani. “Combatteremo - fece stampare quest’ultimo in un suo manifesto - fratelli contro fratelli”. Favorito, non determinato, dalle circostanze, fu un grido del cuore, il grido di uno che - diventato chiaro a se stesso - finalmente si sfoghi. Gli italiani sono l’unico popolo, credo, che abbiano, alla base della loro storia, o della loro leggenda, un fratricidio. Ed è solo col parricidio, con l’uccisione del vecchio, che si inizia una rivoluzione. Gli italiani vogliono darsi al padre, ed avere da lui, in cambio, il permesso di uccidere gli altri fratelli»
- (Umberto Saba, "Scorciatoie e raccontini", 1946).
Note:
A) CON #DANTE, RICORDANDO #MICHELANGELO E LA SUA #RAPPRESENTAZIONE DEL BIBLICO "SERPENTE DI BRONZO" NELLA VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA.
B) INCONTRO DEL #RE #SALOMONE E DELLA #REGINA DI #SABA (Part. della "Porta del Paradiso" del #Battistero di San Giovanni Battista di Firenze realizzato da Lorenzo Ghiberti, tra il 1425 e il 1452.
C) PER (RIFLESSIONI SUL TESTO DI) UMBERTO SABA, cfr. "Italiani fratricidi / commenti /", a c. di Helena Janeczek ("Doppiozero", 7 Marzo 2011).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Chi era veramente Maria Maddalena? (di Cristina Uguccioni)22 luglio 2016, di Federico La Sala
- CANOVA E IL VATICANO: LE GRAZIE, AMORE E PSICHE Una gerarchia senza Grazie (greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Caritas"). Materiali per riflettere
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
Chi era veramente Maria Maddalena?Per volere di papa Francesco il 22 luglio, per la prima volta, si celebra la festa di santa Maria Maddalena, che sino a oggi era memoria obbligatoria. La storia di questa donna nelle parole dei Vangeli e nei commenti di Gianfranco Ravasi, Carlo Maria Martini, Cristiana Dobner e Timothy Verdon
- Noli me tangere - Giotto *
Lo scorso 3 giugno la Congregazione per il Culto Divino ha pubblicato un decreto con il quale, «per espresso desiderio di papa Francesco», la celebrazione di santa Maria Maddalena, che era memoria obbligatoria, viene elevata al grado di festa. Il Papa ha preso questa decisione «per significare la rilevanza di questa donna che mostrò un grande amore a Cristo e fu da Cristo tanto amata», ha spiegato il segretario del Dicastero, l’arcivescovo Arthur Roche. Ma chi era Maria Maddalena, che Tommaso d’Aquino definì «apostola degli apostoli»?
Magdala
Nei Vangeli si legge che era originaria di Magdala, villaggio di pescatori sulla sponda occidentale del lago di Tiberiade, centro commerciale ittico denominato in greco Tarichea (Pesce salato). Qui, negli anni Settanta del Novecento è stata condotta un’estesa campagna di scavi dai francescani dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme: è venuta alla luce una vasta porzione del tessuto urbano comprendente, fra gli altri, una grande piazza a quadriportico, una villa mosaicata e un completo complesso termale. Con successivi scavi i francescani hanno riportato alla luce anche importanti resti di strutture portuali. In un’area adiacente, di proprietà dei Legionari di Cristo, una campagna di scavi avviata nel 2009 ha invece permesso di rinvenire la sinagoga cittadina, una delle più antiche scoperte in Israele: per la sua posizione, sulla strada che collega Nazaret e Cafarnao, si ritiene che probabilmente sia stata frequentata da Gesù.
Gli equivoci sull’identità
Maria Maddalena fa la sua comparsa nel capitolo 8 del Vangelo di Luca: Gesù andava per città e villaggi annunciando la buona notizia del regno di Dio e c’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità e li servivano con i loro beni. Fra loro vi era «Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni». Come ha scritto il cardinale Gianfranco Ravasi, «di per sé, l’espressione [sette demoni] poteva indicare un gravissimo (sette è il numero della pienezza) male fisico o morale che aveva colpito la donna e da cui Gesù l’aveva liberata. Ma la tradizione, perdurante sino a oggi, ha fatto di Maria una prostituta e questo solo perché nella pagina evangelica precedente - il capitolo 7 di Luca - si narra la storia della conversione di un’anonima “peccatrice nota in quella città”, che aveva cosparso di olio profumato i piedi di Gesù, ospite in casa di un notabile fariseo, li aveva bagnati con le sue lacrime e li aveva asciugati coi suoi capelli». Così, senza nessun reale collegamento testuale, Maria di Magdala è stata identificata con quella prostituta senza nome.
Ma c’è un ulteriore equivoco: infatti, prosegue Ravasi, l’unzione con l’olio profumato è un gesto che è stato compiuto anche da Maria, la sorella di Marta e Lazzaro, in una diversa occasione (Gv 12,1-8). E così, Maria di Magdala «da alcune tradizioni popolari verrà identificata proprio con questa Maria di Betania, dopo essere stata confusa con la prostituta di Galilea».
La liberazione dal male
Afflitta da un gravissimo male, di cui si ignora la natura, Maria Maddalena appartiene dunque a quel popolo di uomini, donne e bambini in molti modi feriti che Gesù sottrae alla disperazione restituendoli alla vita e ai loro affetti più cari. Gesù, nel nome di Dio, compie solo gesti di liberazione dal male e di riscatto della speranza perduta. Il desiderio umano di una vita buona e felice è giusto e appartiene all’intenzione di Dio, che è Dio della cura, mai complice del male, anche se l’uomo (fuori e dentro la religione) ha sempre la tentazione di immaginarlo come un prevaricatore dalle intenzioni indecifrabili.
Sotto la croce
Maria Maddalena compare ancora nei Vangeli nel momento più terribile e drammatico della vita di Gesù. Nel suo attaccamento fedele e tenace al Maestro Lo accompagna sino al Calvario e rimane, insieme ad altre donne, ad osservarlo da lontano. È poi presente quando Giuseppe d’Arimatea depone il corpo di Gesù nel sepolcro, che viene chiuso con una pietra. Dopo il sabato, al mattino del primo giorno della settimana - si legge al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni - torna al sepolcro: scopre che la pietra è stata tolta e corre ad avvisare Pietro e Giovanni, i quali, a loro volta, correranno al sepolcro scoprendo l’assenza del corpo del Signore.
L’incontro con il Risorto
Mentre i due discepoli fanno ritorno a casa, lei rimane, in lacrime. E ha inizio un percorso che dall’incredulità si apre progressivamente alla fede. Chinandosi verso il sepolcro scorge due angeli e dice loro di non sapere dove sia stato posto il corpo del Signore. Poi, volgendosi indietro, vede Gesù ma non lo riconosce, pensa sia il custode del giardino e quando Lui le chiede il motivo di quelle lacrime e chi stia cercando, lei risponde: «“Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo”. Gesù le disse: “Maria!”» (Gv 20,15-16).
Il cardinale Carlo Maria Martini al riguardo commentava: «Avremmo potuto immaginare altri modi di presentarsi. Gesù sceglie il modo più personale e il più immediato: l’appellazione per nome. Di per sé non dice niente perché “Maria” può pronunciarlo chiunque e non spiega la risurrezione e nemmeno il fatto che è il Signore a chiamarla. Tutti però comprendiamo che quell’appellazione, in quel momento, in quella situazione, con quella voce, con quel tono, è il modo più personale di rivelazione e che non riguarda solo Gesù, ma Gesù nel suo rapporto con lei. Egli si rivela come il suo Signore, colui che lei cerca».
Il dialogo al sepolcro prosegue: Maria Maddalena, «si voltò e gli disse in ebraico: “Rabbunì!”, che significa: “Maestro!”. Gesù le disse: “Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”. Maria di Magdala andò ad annunziare ai discepoli: “Ho visto il Signore!” e anche ciò che le aveva detto» (Gv 20, 16-18).
La maternità della Maddalena
«La Maddalena è la prima fra le donne al seguito di Gesù a proclamarlo come Colui che ha vinto la morte, la prima apostola ad annunciare il gioioso messaggio centrale della Pasqua», osserva la teologa Cristiana Dobner, carmelitana scalza. «Ella esprime la maternità nella fede e della fede ossia quella attitudine a generare vita vera, una vita da figli di Dio, nella quale il travaglio esistenziale comune ad ogni uomo trova il suo destino nella risurrezione e nell’eternità promesse e inaugurate dal Figlio, «primogenito» di molti fratelli (Rom 8,29). Con Maria Maddalena si apre quella lunga schiera, ancor oggi poco conosciuta, di madri che, lungo i secoli, si sono consegnate alla generazione di figli di Dio e si possono affiancare ai padri della Chiesa: insieme alla Patristica esiste anche, nascosta ma presente, una Matristica.
La decisione di Francesco è un dono bello, espressione di una rivoluzione antropologica che tocca la donna e investe l’intera realtà ecclesiale. L’istituzione di questa festa, infatti, non va letta come una rivincita muliebre: si cadrebbe stolidamente nella mentalità delle quote rosa. Il significato è ben altro: comprendere che uomo e donna insieme e solo insieme, in una dualità incarnata, possono diventare annunciatori luminosi del Risorto».
Nella storia dell’arte: la mirofora
Maria Maddalena, nel corso dei secoli, è stata raffigurata principalmente in quattro modi: «Anzitutto - afferma monsignor Timothy Verdon, docente di storia dell’arte alla Stanford University e direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze - è spesso ritratta come una delle mirofore, le pie donne che la mattina di Pasqua si recarono al sepolcro portando gli unguenti per il corpo del Signore. Fra loro la Maddalena è riconoscibile per il fatto che, a partire dalla fine del Medioevo, viene raffigurata con lunghi capelli sciolti, spesso biondi: questo fa capire che gli artisti, secondo una tradizione affermatasi in Occidente (e non condivisa nell’Oriente cristiano), la identificavano con la donna peccatrice che aveva asciugato i piedi di Gesù con i propri capelli. I capelli lunghi sono quindi un’allusione a questo intimo contatto e alla condizione di prostituta: le donne per bene non andavano in giro con i capelli sciolti».
La penitente
Nell’arte del tardo Medioevo Maria Maddalena compare anche come penitente perché - spiega Verdon - secondo una leggenda ella era una grande peccatrice che, dopo la conversione e l’incontro con il Risorto, era andata a vivere come romitessa nel sud della Francia, vicino a Marsiglia, dove annunciava il vangelo: «Il culto della Maddalena penitente ha affascinato molti artisti, che l’hanno considerata il corrispettivo femminile di Giovanni Battista. In genere viene raffigurata con abiti simili a quelli del Battista oppure è coperta solo dai capelli. La bellezza esteriore l’ha abbandonata, il volto è segnato dai digiuni e dalle veglie notturne in preghiera, ma è illuminata dalla bellezza interiore perché ha trovato pace e gioia nel Signore. La statua della Maddalena penitente di Donatello, scolpita per il Battistero di Firenze, è un autentico capolavoro».
L’addolorata
Sovente la Maddalena è ritratta anche ai piedi della croce: una delle opere più significative, a giudizio di Verdon, è un piccolo pannello di Masaccio (esposto a Napoli) nel quale la Maddalena è ritratta di spalle, sotto la croce, le braccia protese a Cristo, i lunghi capelli biondi che cadono quasi a ventaglio su un enorme mantello rosso: «Un’immagine di forte drammaticità. Non di rado il dolore composto della Vergine è stato contrapposto a quello della Maddalena, quasi senza controllo. Si pensi ad esempio, alla Pietà di Tiziano, nella quale la donna avanza come volesse chiamare il mondo intero a riconoscere l’ingiustizia della morte di Gesù, che giace fra le braccia di Maria; oppure si pensi al celebre gruppo scultoreo di Niccolò dell’Arca, nel quale fra le molte figure la più teatrale è proprio quella della Maddalena che si precipita con la forza di un uragano verso il Cristo morto».
Chiamata per nome
Vi sono inoltre molte raffigurazioni dell’incontro con il Risorto: «Esemplari e magnifiche sono quelle di Giotto, nella Cappella degli Scrovegni, e del Beato Angelico nel convento di san Marco», conclude Verdon. «Maria Maddalena ha vissuto un’esperienza di salvezza profonda per opera di Gesù: quando si sente chiamata per nome in lei si accende il ricordo dell’intera storia vissuta con Lui: c’è tutto questo nell’iconografia della scena che chiamiamo “Noli me tangere”».
*
fonte: Vatican Insider, articolo di Cristina Uguccioni del 20/07/2016 (senza foto)
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- Chi era veramente Maria Maddalena? Storia e leggenda dell’apostola degli apostoli (di Vito Mancuso)31 agosto 2016, di Federico La Sala
Maddalena
Storia e leggenda dell’apostola degli apostoli
Fu Gregorio Magno a identificarla come una ex prostituta convertita. Ma i Vangeli non la descrivono così
di Vito Mancuso (la Repubblica, 31.08.2016)
Da sempre icona della predicazione ascetica e della storia dell’arte, ai nostri giorni è diventata protagonista anche della fiction cinematografica (Martin Scorsese) e della letteratura d’evasione (Dan Brown). Eppure Maddalena è citata solo dodici volte nei vangeli canonici e mai da san Paolo e dagli altri agiografi neotestamentari: ma quei pochi versetti evangelici sono stati sufficienti per scatenare l’immaginazione di teologi, predicatori, padri spirituali, eretici, pittori, romanzieri, registi, costruendo un mito che acquista sempre più vigore.
A tale potenziamento ha contribuito di recente nel modo più autorevole un decreto della Congregazione per il culto divino del 3 giugno scorso mediante cui la celebrazione di Maria Maddalena, fino ad allora solo “memoria” viene elevata al grado di “festa”, il medesimo riservato ai dodici apostoli.
Il motivo di questa decisione, dietro cui ovviamente c’è l’esplicito volere di papa Francesco, è indicato dallo stesso documento: «La decisione si inscrive nell’attuale contesto ecclesiale, che domanda di riflettere più profondamente sulla dignità della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza del mistero della misericordia divina». Si tratta, in altri termini, di una mossa per rafforzare il ruolo delle donne nella Chiesa. C’è quindi da sperare che tale promozione della Maddalena possa ispirare più importanti cambiamenti nella struttura ecclesiale aprendo la via nell’immediato al diaconato femminile: se infatti una donna è stata apostola, perché altre non possono diventare per lo meno diaconesse?
In realtà, per quanto il titolo di “apostola” sia stato assegnato alla Maddalena già da Tommaso d’Aquino che la definisce “apostola degli apostoli”, è sufficiente un’occhiata alla vastissima iconografia per rendersi conto che mai tale qualifica ha trovato finora un’applicazione reale nella concreta struttura ecclesiastica. I dipinti infatti non la ritraggono mai nell’atto di annunciare agli apostoli rinchiusi per paura l’avvenuta risurrezione di Cristo, ma in altre ben più tradizionali fattezze: piangente ai piedi della croce, al sepolcro con il vasetto di mirra, mentre è tenuta a distanza dal Risorto che le dice “Noli me tangere”, in estasi, in meditazione e soprattutto in veste di penitente con i lunghi capelli disciolti e buona parte del corpo scoperto. Per la tradizione occidentale infatti, e ancora oggi per molte persone, Maria Maddalena è la prostituta che bagna i piedi di Gesù con le sue lacrime e li asciuga con i suoi capelli.
I 12 versetti evangelici che ne parlano non consentono però tale identificazione, risalente a una scorretta interpretazione di papa Gregorio Magno nel VI secolo e divenuta poi pressoché canonica. Come si legge in Luca 8,2-3, si deve piuttosto ritenere che Maria, detta Magdalena in quanto originaria della cittadina galilaica di Magdala, fosse una donna benestante assuntasi il compito insieme ad altre di sostenere Gesù e i discepoli con i suoi beni come riconoscenza per essere stata guarita da una grave malattia a cui il vangelo accenna dicendo che da lei «erano usciti sette demoni ».
Da allora la Maddalena seguì sempre Gesù, fino ai piedi della croce. E di certo Gesù ebbe con lei un rapporto privilegiato, che ai nostri giorni ha scatenato una serie di improbabili fantasie ma che già nel II secolo aveva portato un vangelo apocrifo di tradizione gnostica a scrivere: «La compagna del Figlio è Maria Maddalena. Il Signore amava Maria più di tutti i discepoli e spesso la baciava sulla bocca» (Vangelo di Filippo, 64). Anche a prescindere da tale intimità, la vicinanza di Gesù alla Maddalena è comprovata dal fatto che in tutti i quattro Vangeli canonici lei è sempre nominata per prima tra i pochi testimoni cui apparve il Risorto.
Il quarto vangelo giunge a dedicarle una scena tutta sua, nello struggente dialogo della mattina di Pasqua in cui Gesù risorto per farsi riconoscere la chiama per nome: “Maria!” (Giovanni 20,16); e poi la manda ad annunciare la risurrezione agli apostoli consacrandola per l’appunto “apostola degli apostoli”.
Quelle antiche parole di Gesù attendono ancora di diventare vita concreta all’interno della Chiesa, ma forse qualcosa si sta davvero muovendo.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. In memoria di Kurt H. Wolff.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- DALL’ECO DELLE SIBILLE, LA VOCE DELLA PROFEZIA (Chiara Magaraggia)19 luglio 2016, di Federico La Sala
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
- MICHELANGELO E IL SOGNO DEI CARMELITANI SCALZI (Teresa d’Avila e Giovanni della Croce): A CONTURSI TERME, IN EREDITA’, L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE (1613) - RECUPERATO CON I LAVORI DI RESTAURO, DOPO IL TERREMOTO DEL 1980
 DON MARIANO ARCIERO, ILDEGARDA DI BINGEN, E UNA "CAPPELLA SISTINA" IN ROVINA.
DON MARIANO ARCIERO, ILDEGARDA DI BINGEN, E UNA "CAPPELLA SISTINA" IN ROVINA.
DALL’ECO DELLE SIBILLE, LA VOCE DELLA PROFEZIA
di Chiara Magaraggia*
- FOTO. Perugino, Profeti e Sibille, Aula dell’Udienza, Collegio del Cambio di Perugia
Sono le creature più misteriose della storia della salvezza: non sono nominate nella Bibbia, non sappiamo quante siano,vengono dalla notte dei tempi, vengono dai quattro angoli del mondo allora conosciuto, vengono da quei confini inconoscibili in cui storia e leggenda si fondono, in cui mondo pagano e mondo cristiano si saldano. Sono donne, sono sapienti e sono la voce del Verbo. La loro parola è capace di scrutare segni di secoli remoti e leggerli in un’ottica di salvezza futura; la loro immagine è da sempre legata al rotolo o al libro, in cui questa parola un tempo oscura e misteriosa si imprime, diventando finalmente chiara solo nella pienezza dei tempi.
Creature affascinanti, le Sibille: un tempo vergini dotate di virtù profetiche ispirate dal dio Apollo, nel mondo cristiano le profetesse di Cristo, le facce femminili della profezia.
- FOTO. Le Sibille
E’ vero che la Sacra Scrittura ci presenta alcune profetesse: Maria sorella di Mosè, Debora, Anna. Nessuna di loro, però, ha conseguito la popolarità delle Sibille, né ha avuto la loro fortuna. L’arte cristiana si è impossessata di loro a piene mani, la poesia e la musica hanno loro riservato una posizione privilegiata in pagine rimaste immortali.
“Dies irae, dies illa / solvet saeculum in favilla / teste Davide cum Sibylla”. La celebre sequenza duecentesca attribuita a Tommaso di Celano, in cui, con immagini di forte impatto emotivo e figurativo, viene rappresentata la grandiosa scena del Giudizio Universale - il terribile giorno in cui il mondo e il tempo saranno ridotti in cenere - collega la profezia biblica di Davide con quella di origine classica delle Sibille: pagani e cristiani, uomini e donne, ovunque abbia alitato lo spirito di Dio, hanno profetizzato “dies illa”, quel giorno. Dalla musica raccolta degli antichi monasteri alla sublime solennità dell’ultimo Mozart fino alla travolgente grandiosità di Verdi, ovunque il Requiem con la sequenza del “Dies irae” ha scandito la colonna musicale di secoli e secoli, così che, come scrive Dante nell’ultimo canto del Paradiso “al vento nelle foglie lievi si perde la sentenza di Sibilla” (Par. 33, vv. 65-66).
Amatissime nell’arte di ogni tempo, con i loro volti dai mille lineamenti a seconda dei luoghi, delle epoche, dei contesti, della sensibilità degli artisti, fanno capolino dai posti più impensati. Potremmo quasi affermare che le mutevoli Sibille incarnino l’immagine stessa della donna, che si trasforma senza sosta per rendere continuamente nuova l’antica attesa dell’avvento di Dio nel mondo. Ci vengono incontro leggiadre e piene di grazia in un luogo veramente particolare: il Collegio del Cambio di Perugia, affrescato, negli ultimi anni del Quattrocento dal pittore umbro Perugino, forse con la collaborazione del giovane allievo Raffaello.
Un luogo davvero inconsueto: la sede ufficiale dei cambiavalute perugini, in cui si stabiliva il valore delle monete del tempo per renderle più competitive negli scambi commerciali e in cui si tentava di controllare la diffusione del prestito ad usura. Una piccola Borsa rinascimentale. Ma perché proprio qui, nel tempio degli affari, si sono dipinte le Sibille?
La lunetta peruginesca della Sala dell’Udienza (la stanza in cui si prendevano le decisioni più importanti), sullo sfondo di un verde, luminoso paesaggio umbro ci mostra due distinti gruppi di personaggi: da un lato sei Profeti (Isaia, Mosè, Daniele, Geremia, Davide, Salomone) dal volto grave e ispirato, dall’altro le sei Sibille (Eritrea, Persica, Cumana, Libica, Tiburtina, Delfica) dai visi dolci, botticelliani e gli sguardi assorti di chi più che sul presente, è concentrato sul futuro; i capelli sono acconciati secondo i dettami del tempo, gli abiti leggeri, sobri, dalle delicate sfumature cromatiche, i piedi atteggiati a passo di danza, le mani dai gesti “parlanti”. Profeti e Sibille sono avvolti da filatteri con brani allusivi alla prima e all’ultima venuta di Cristo. Il Padre Eterno benedicente, circonfuso da una mandorla dorata, sovrasta i due gruppi.
Nella parete opposta della Sala, Perugino dipinge le Virtù di cui uomini e donne devono rivestirsi: la venuta di Cristo, dunque, dovrà originare nuove creature, dotate di quelle virtù che sole possono guidarci nella realizzazione concreta del progetto divino.
In questo affresco, dipinto in pieno Umanesimo, è celebrata la dignità dell’uomo: il pittore l’ha qui rappresentato così come Dio l’ha creato, maschio e femmina, senza distinzioni di provenienza, biblica o pagana, anche nella profezia. Ognuno è inserito nel progetto divino, ne è non solo testimone, ma attore e responsabile in prima persona. Sembrano riecheggiare qui le splendide parole con cui in questi stessi anni Giovanni Pico della Mirandola ha tessuto forse il più bell’elogio alla dignità e al libero arbitrio dell’essere umano: “Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale perché sia tu stesso, quasi libero e sovrano, a plasmarti secondo la tua libera decisione: potrai annullarti in terra come le creature brute, potrai sollevarti fino alle cose più alte che sono divine”. Così un mestiere come quello del cambiavalute, inviso nel Medioevo perché a contatto col denaro considerato materiale impuro e ora rivalutato nell’ottica dei nuovi tempi e delle profonde trasformazioni, esercitato con prudenza, con giustizia, con sobrietà, guidato dalla fede, dalla speranza, dalla carità, sarà nella società strumento di cambiamento positivo per tutti e perciò degno della benedizione divina.
- FOTO. Sibilla Cumana, Jan Van Eyck, Gand, Cattedrale di San Bavone
Dal centro dell’Italia alla ricca città di Gand. Siamo nelle Fiandre del primo Quattrocento, una delle aree più ricche dell’Europa: i mercanti, i banchieri, i borghesi attivi nei piccoli liberi centri stanno creando un mercato economico dove transitano merci di ogni tipo, con investimenti e profitti che segnano l’alba del capitalismo europeo. Fasto e splendore in breve rendono splendide Bruges, Gand, Anversa. E proprio a Gand opera il maggiore pittore del Rinascimento nordico: Jan Van Eyck. Per la cattedrale di San Bavone egli realizza un grandioso polittico in 20 pannelli in legno di quercia, in cui, attraverso 250 figure dai colori squillanti, sviluppa la storia della Redenzione dal peccato originale al trionfo finale di Cristo. E lì, sopra la scena dell’Annunciazione, avvolta in vesti sontuose, la Sibilla Cumana dà il suo vaticinio: “Verrà il tuo Re dei secoli futuri”. Parole che precedono e sottolineano il sottostante annuncio dell’angelo a Maria. Ciò che colpisce nella Sibilla fiamminga è lo splendido copricapo trapuntato da una reticella di candide perle e il verde mantello di pesante velluto con le maniche e il collo di preziosa pelliccia. E’ la moda con cui le ricche dame del nord si riparavano dai geli invernali. Colpiscono quel volto intenso e meditativo, quelle mani dai gesti così femminili: una sul grembo, come farà Maria, a sottolineare che quel Re verrà proprio da un corpo di donna, l’altra sorregge l’abito, nel gesto di alzarsi in piedi, stupita, ancora una volta come Maria, da un annuncio tanto solenne. Eppure la Sibilla sembra comunicarci dell’altro col suo viso pensoso: quel re non nascerà avvolto in velluti e pellicce, né sarà coccolato da banchieri e mercanti. Chi lo accoglierà? E come?
- FOTO. Sibilla Libica, Siena, Cattedrale
Il dialogo dai quattro confini del mondo si fa stringente e drammatico. Le risposte ci riportano ancora in Italia, nella città di Siena. La Cattedrale dedicata all’Assunta domina la città del Palio dal colle più alto. Ci accoglie con la facciata dai bianchi marmi, ci apre la porta guidando gli occhi verso la splendida vetrata multicolore con cui Duccio di Buoninsegna celebra Maria. Ma ciò che subito attira l’attenzione è lo straordinario pavimento, che in 56 grandi tarsìe di marmi bianchi, neri, colorati compone con un originale programma teologico la storia del tempo, dell’uomo, della salvezza. E’ come se il fedele si mettesse lui stesso in cammino per arrivare, col suo fardello di dolori, di speranze, di errori a Cristo che dall’altare tutti accoglie, sotto la luminosa custodia di Maria. Può qui mancare la voce delle Sibille? Le loro figure occupano i 10 riquadri delle navate laterali, con un effetto di bianche statue classicheggianti, ciascuna con la propria profezia. Ma, sorpresa, la prima Sibilla, quella Libica “di cui parla Euripide” ha il viso, le mani, i piedi neri. L’immagine è di assoluta novità: è una delle prime raffigurazioni di un personaggio femminile di pelle nera nella storia della salvezza e nell’arte in senso generale. Da una donna nera viene una delle profezie più drammatiche, che risponde in modo spiazzante ai dubbi della Sibilla fiamminga. Mostra nelle pagine del volume aperto alla sua destra la scritta latina che annuncia: “Ricevendo pugni tacerà”, che si collega alla tabella sorretta da un vaso fiorito a cui s’attorcigliano due serpenti: “Capiterà in mani malvagie. Daranno a Dio schiaffi a piene mani. Misero e vergognoso recherà speranza ai miseri”. Che sia proprio una donna nera, da sempre negletta, da sempre umiliata e battuta, a pronunciare la profezia della Passione è un fatto sconvolgente. E’ un’immagine che perfora i secoli e che per noi, oggi, assume un significato ulteriormente nuovo. Nella certezza consolante che dopo la Passione c’è la Resurrezione.
- FOTO. La Sibilla Cumana di Michelangelo nella Cappella Sistina
Certo, fra tutte le Sibille, l’immaginario di tutti non può non volare a Roma, nella Cappella Sistina, lo scrigno del genio di Michelangelo. Come i cicli in mosaico delle antiche basiliche, quello della Sistina è l’esempio più alto dell’arte al servizio della parola: un credo per immagini capace di tradurre in forme concrete, comprensibili a tutti, le verità che per tanto tempo erano appannaggio solo dei sapienti. Occorreva però che, accanto ad artisti pur grandi (Perugino, Botticelli, ecc.) che avevano affrescato le pareti laterali se ne aggiungesse un altro capace di imprimere unità e organicità al ciclo. Siamo nel 1508: Michelangelo riceve da papa Giulio II l’incarico di affrescare la volta, un lavoro immane (680 mq di superficie). Sette anni di lavoro massacrante, solo con i suoi tormenti e la sua immaginazione, con i pennelli e i colori ad ideare le nove scene della Genesi, dalla Separazione delle tenebre dalla luce al Diluvio e all’Ebbrezza di Noè, simbolo di un’umanità ineluttabilmente schiava degli istinti, degli errori, della perdizione. Occorreva far irrompere la speranza, riecheggiando le parole di Paolo: Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo trionfo?
Ed ecco, nel cornicione che affianca le nove scene, le figure dei Profeti e delle Sibille: tutti ispirati da Dio, ma in modo diverso, hanno il presentimento della Redenzione: se i primi la prevedevano con certezza, le Sibille, dal confuso orizzonte del mondo pagano, hanno saputo farsi interpreti del perpetuo anelito al rinnovamento dell’uomo, al di là delle tenebre. Sembrano compresse in troni troppo piccoli, le Sibille di Michelangelo, esponenti di un’umanità quasi asessuata, primordiale, colta nel momento di un improvviso risveglio, quasi una faticosa percezione della profezia, che suscita faticose, titaniche torsioni, in uno sforzo immane per uscire da una materia che sembra opprimerle: lo sforzo tutto michelangiolesco di una verità nascosta, di uno spirito incatenato che si dibatte per liberarsi e sprigionarsi.
La Sibilla Cumana della Sistina è agli antipodi della ricca signora dipinta da Van Eyck: non c’è grazia, non c’è femminilità in quelle forme gigantesche e mascoline della corporatura, in quel braccio poderoso che sorregge il libro, che sembrano contrastare con i tratti marcati e rugosi di un volto di vecchia. Le vesti sono disadorne, essenziali, spoglie; una sacca appesa al sedile sembra suggerire che non è propria dell’uomo la stabilità, che siamo tutti eterni pellegrini nel tempo della salvezza. Eppure, a questa donna così fuori dai canoni della femminilità ideale, è affidata, partendo dalle parole del poeta latino Virgilio, la profezia della nascita di un bambino generato da una vergine, che avrebbe aperto agli uomini un’era di pace e di felicità. Virgilio, primo secolo avanti Cristo, si salda idealmente alle parole del più antico Isaia, che, non a caso, Michelangelo ha affrescato proprio accanto alla Cumana: “Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che si chiamerà Emmanuele”. La grazia di Perugino, l’eleganza pensosa di Van Eyck, la pelle nera di Siena, la vecchiaia quasi deforme di Michelangelo: ritratti di donne di mondi diversi, capaci di andare oltre, di guardare lontano... in ognuna di esse possiamo trovare qualcosa di noi. Tanti accordi che si uniscono in un’unica grande voce. La voce delle Sibille capace di vincere di mille secoli il silenzio.
* Chiara Magaraggia
*FONTE. Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro cuore di Maria (ripresa parziale - senza immagini).
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- "DAVID E LA SIBILLA": MOZART, "DIES IRAE" (K 626)18 luglio 2016, di Federico La Sala
Teste David cum Sibylla
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
MOZART, Requiem (K 626):
DIES IRAE (Coro)
- "Dies irae, dies illa,
 Solvet saeclum in favilla,
Solvet saeclum in favilla,
 Teste David cum Sibylla.
Teste David cum Sibylla.
- Quantus tremor est futurus,
 Quando Judex est venturus,
Quando Judex est venturus,
 Cuncta stricte discussurus!"
Cuncta stricte discussurus!"
- "Giorno d’ira, quel giorno
 distruggerà il mondo in faville,
distruggerà il mondo in faville,
 com’è attestato da Davide e dalla Sibilla.
com’è attestato da Davide e dalla Sibilla.
- Quanto grande sarà il terrore quando verrà il giudice
 a valutare ogni cosa severamente."
a valutare ogni cosa severamente."
MOZART,
(dal "Requiem")
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- NEL NOME DELLA BELLEZZA. E’ tempo che la cultura non sia più una merce, tornare all’esperienza umana, ai sentimenti, alla vita ( di Gao Xingjian)29 giugno 2016, di Federico La Sala
Un nuovo Rinascimento nel nome della bellezza
Gli ultimi cento anni non hanno prodotto alcuna civiltà: è tempo che la cultura non sia più una merce, bisogna tornare all’esperienza umana, ai sentimenti, alla vita
di Gao Xingjian (La Stampa, 29.06.2016)
In quest’epoca di globalizzazione, un’epoca in cui la politica e la propaganda commerciale occupano tutti gli spazi, persino la cultura è piegata alle leggi dell’economia di mercato. Arte e letteratura possono non degenerare nel consumismo culturale, e difendere la loro intrinseca autonomia spirituale e totale libertà creativa? [...]
Un nuovo Rinascimento è realizzabile? Se ci slegassimo dalla visione storica del mondo artistico-letterario fondata sulla modernità, instaurata dal XX secolo, se poi gettassimo nella spazzatura la teoria della perenne negazione e con essa tutte le provocazioni e gli esibizionismi, e se poi riesaminassimo la storia dell’arte e della letteratura, non tarderemmo a scoprire che questi ultimi cent’anni e più non hanno prodotto una nuova civiltà, anzi, non hanno fatto altro che involgere l’umanità in un circolo vizioso. L’Oriente ha intrapreso la strada già battuta dall’Occidente, e l’Occidente quella già battuta dall’Oriente, e quindi ora si sono scambiati le direzioni. Questo mondo è talmente assurdo...
Tornare al bello
Lasciamo da parte la follia della sovversione estetica e delle campagne di moda, e così un nuovo Rinascimento verrà da sé. Liberandoci dai banali interessi materiali capiremo che l’arte e la letteratura non sono un’arma né uno strumento, né tantomeno una merce. Torniamo quindi al loro scopo originario, torniamo a osservare l’umanità, torniamo alla natura umana e ai sentimenti umani, torniamo alla ricerca del bello. E tutto ciò non è affatto un’illusione. Solo con una piena consapevolezza, artisti e scrittori possono riuscire a padroneggiare la creazione.
Un tale Rinascimento, com’è prevedibile, non viene promosso da uno Stato-nazione, il cui unico scopo è quello di portare la creazione artistico-letteraria nelle mani del potere politico, rendendola una sorta di incarto ufficiale del nazionalismo. Se prima c’era il realismo socialista, sbandierato dall’Unione Sovietica, e poi il motto maoista di «arte e letteratura al servizio degli operai, dei contadini e dei soldati», ora è il momento delle varie identità etniche, dei discorsi politici che portano l’arte e la letteratura ad arrendersi all’odierna politica di partito e di voto.
Un tale Rinascimento può soltanto sorgere dalla cognizione personale di artisti e scrittori. Non deve seguire le politiche culturali formulate, avviate e sviluppate dagli organismi di governo. Al contrario, richiede la distensione e la tolleranza sociale; e sarebbe molto meglio se le istituzioni della cultura in mano al governo fossero gestite dal popolo, e quanto più possibile varie e diversificate. Un tale Rinascimento, pur necessitando del sostegno di fondazioni culturali no-profit, in prima istanza si fonda sulla consapevolezza individuale. Artisti e scrittori devono lanciare un appello capace di destare l’attenzione, devono far risuonare la propria voce dapprima nei circoli culturali, perché poi si propaghi come un eco. E questa è l’unica possibilità di suscitare una sorta di coscienza comune. [...]
La crisi
Un tale Rinascimento, ai nostri giorni non può essere circoscritto a certi Stati o certe aree del mondo, come fu per l’Italia del ’400 e del ’500, o per la Francia del ’700. In quest’epoca di globalizzazione, la situazione di ogni artista e scrittore è pressoché identica. Tuttavia, ora, dietro la crisi economica e il declino culturale vi è una crisi di pensiero e una prostrazione spirituale. La dottrina della rivoluzione sociale o il liberalismo, come pure il nazionalismo e tutte le altre ideologie, non hanno salvato l’uomo dalla sua triste condizione. L’umanità ha bisogno di un pensiero nuovo, prodigioso, che arrivi all’orecchio dei sordi e sulla bocca dei muti. Ma dove sta questo pensiero?
Queste sono le basi dell’appello a un nuovo Rinascimento. È chiaro che questo nuovo pensiero a cui mi riferisco non possa fare affidamento su esperti della politica di partito, tantomeno sugli economisti che ogni giorno compaiono sui media con i loro sproloqui, o su sondaggi d’opinione e statistiche. Ci troviamo in un’epoca di povertà d’animo e di miseria filosofica, in cui la riflessione filosofica è degenerata in uno sterile gioco di analisi linguistica, a causa di tutte le teorie della sovversione che hanno svuotato di senso ogni cosa. Non serve profetizzare il futuro dell’uomo. Lasciamo da parte queste promesse utopistiche che rievocano l’incubo del XX secolo, ancora vivo nella memoria. Torniamo piuttosto al momento presente e alla reale condizione dell’uomo. Il principio della mens sana in corpore sano ideato dal vecchio umanesimo è senza fondamento, come pure le idee sulla libertà e sui diritti umani innati: nulla di tutto ciò è conferito a titolo gratuito.
Il disagio umano
Al contrario, l’individuo, debole e vivo, è sempre immerso nei tormenti dell’esistenza terrena, e del destino del genere umano non è dato sapere. Appurato che la speculazione filosofica non è in grado di guarire il disagio dell’uomo contemporaneo, all’uomo non resta che affidarsi alla letteratura e all’arte per poter affermare se stesso, in questa vita sconcertante.
Filosofia, religione e arte e letteratura sono tre diversi metodi per acquisire conoscenza della propria esistenza. La filosofia ricorre alla speculazione, la religione conduce alla fede, mentre l’arte e la letteratura si rivolgono all’estetica, e attraverso l’estetica offrono all’uomo un’affermazione del sé. Quest’epoca è segnata dal declino della religiosità, ma in compenso è devota al materialismo. E l’ideologia, che continua a corteggiare il potere politico, ha compromesso gravemente la condizione della filosofia, che in origine era incorrotta. Arte e letteratura - strette dalla morsa della politica e del mercato - non di rado sono state private dell’intrinseco giudizio estetico. Mentre il mercato governa il consumo culturale, ormai il potere sfrutta il principio del «politicamente corretto». Ma lanciare un appello a un nuovo Rinascimento significa ritornare all’esperienza del bello, ritornare alla natura umana e ai sentimenti umani, ritornare alla vita.
La coscienza morale
Un tale Rinascimento poggia sulla coscienza morale innata e sulla consapevolezza di artisti e scrittori. È naturale che non possa limitarsi a pochi Paesi o aree del mondo, né ad alcuni lingue o forme espressive; al contrario invece, un tale Rinascimento può avvenire in ogni angolo della Terra. Solo una volta acquisita una piena e lucida cognizione della realtà e dell’uomo, artisti e scrittori danno inizio ad una propria ricerca espressiva. Un tale Rinascimento è realizzabile. Difatti, la storia ha già attraversato momenti bui, ma alla fine s’è squarciata l’oscurità e rotto il silenzio, il cielo è tornato a splendere e la voce a risuonare. E vantando anche di queste esperienze come punto di riferimento, l’uomo d’oggi perché mai non potrebbe riuscirci?
[Traduzione di Simona Gallo]
-
> UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Donne nella Chiesa. Papa Francesco istituirà una Commissione di studio sul diaconato femminile nella Chiesa primitiva.12 maggio 2016, di Federico La Sala
- CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Donne nella Chiesa, il Papa apre al diaconato femminile *
- E’ il primo grado dell’ordine sacro, seguito dal sacerdozio e dall’episcopato. I diaconi possono amministrare alcuni sacramenti come battesimo e matrimonio. Bocciata da Giovanni Paolo II, la possibilità prefigurata da Francesco avvicinerebbe la Chiesa Cattolica a quella anglicana che ha donne preti e vescovi. Uno "spazio aperto", così come l’avrebbe voluto il cardinal Martini
Papa Francesco ha annunciato che istituirà una Commissione di studio sul diaconato femminile nella Chiesa primitiva ritenendo che le donne diacone sono "una possibilità per oggi".
Se all’annuncio seguirà una decisione, per la prima volta in questo millennio si riaprirà una prospettiva che era considerata definitivamente chiusa da una decisione di Giovanni Paolo II. Il diaconato, infatti, è il primo grado dell’ordine sacro, seguito dal sacerdozio e dall’episcopato. I diaconi possono amministrare alcuni sacramenti tra i quali il battesimo e il matrimonio e in alcuni paesi ci sono intere regioni nelle quali sostituiscono ormai i sacerdoti nella guida delle comunità parrocchiali.
L’apertura prefigurata da Francesco avvicinerebbe la Chiesa Cattolica a quella anglicana dove ci sono donne preti e vescovi. Al Sinodo si era parlato di questo "tema audace" con l’intervento del reverendo Jeremias Schroder, arciabate presidente della Congregazione benedettina di Sant’Ottilia.
"Sul diaconato femminile la Chiesa non ha detto no", aveva spiegato già nel 1994 il cardinale Carlo Maria Martini, commentando lo stop di Giovanni Paolo II alle donne prete: una dichiarazione solenne, ad un passo dai crismi dell’infallibilità pontificia ed alla quale Papa Francesco ha detto più volte di volersi attenere.
Malgrado quel "no", per il porporato c’erano però ancora "spazi aperti", perchè il discorso sul ruolo della donna avrebbe potuto continuare a partire dal diaconato, "che il documento non menziona, quindi non esclude". Questo perchè, avvertiva il cardinale, occorre evitare che l’ecumenismo si blocchi proprio sul tema delle donne. Il diaconato è il primo grado di consacrazione "ufficiale" che precede l’ ammissione al sacerdozio e nelle prime comunità cristiane era aperto anche alle donne. Per Martini, dunque, non sarebbe stato male riaprire anche alle donne, pur ammettendo che sul sacerdozio femminile "il documento papale è decisivo, non ammette replica, nè riformabilità".
"Tuttavia credo che il vero compito di fronte a questa lettera - aveva osservato il cardinale - non è l’ esegesi puntigliosa dal punto di vista dogmatico, ma è vedere come, con questa lettera e malgrado le difficoltà che potrà suscitare, è ancora possibile sia un cammino di dialogo ecumenico, sia soprattutto un cammino in cui mostrare presenza e missione della donna a tutto campo. Rispetto a un documento di questo tipo, che sembra chiudere una via, come già altri in passato, mentre in realtà hanno favorito un ripensamento teologico e pratico che ha fatto superare certi scogli e ha fatto comprender meglio la natura e la forza della presenza della donna nella Chiesa, io penso che uno spazio rimanga aperto".
Di fatto il principale argomento per il "no" al sacerdozio femminile è infatti l’assenza delle donne nel cenacolo al momento dell’istituzione dell’Eucaristia. Ma una recente decisione di Papa Francesco già lo "smontava" in parte: quella sull’ammissione delle donne alla Lavanda dei piedi che il Papa aveva già attuato nel primo giovedì santo del suo Pontificato, quando andando al carcere minorile di Casal del Marmo, decise che quel giorno anche le ragazze potessero partecipare come protagoniste al rito della Lavanda dei piedi, diventa quest’anno una possibilità per tutte le parrocchie del mondo.
E’ significativo che Papa Francesco abbia scelto l’incontro di oggi nell’Aula Nervi con circa 900 superiore generali degli istituti religiosi femminili per affrontare questo tema così decisivo. Le religiose gli hanno chiesto, nel corso di una sessione di domande e risposte perchè la Chiesa esclude le donne dal servire come diaconi.
E una ha aggiunto "Perchè non costruire una commissione ufficiale che potrebbe studiare la domanda?". Il papa ha risposto che aveva parlato della questione una volta qualche anno fa con un "buon, saggio professore", che aveva studiato l’uso delle diaconesse nei primi secoli della Chiesa e gli ha aveva detto che ancora non è del tutto chiaro quale ruolo avessero. E soprattutto se "avevano l’ordinazione o no? "E’ rimasto un pò oscuro quale fossero ruolo e statuto delle diaconesse in quel momento". Costituire una commissione ufficiale potrebbe studiare la questione?", si è chiesto il Papa ad alta voce. E poi si è risposto: "Credo di sì. Sarebbe fare il bene della Chiesa di chiarire questo punto. Sono d’accordo. Io parlerò per fare qualcosa di simile. Accetto la proposta. Sembra utile per me avere una commissione che chiarisca bene".
-
> UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Donne nella Chiesa. - L’urgenza di una riforma (di Vito Mancuso).13 maggio 2016, di Federico La Sala
- CANOVA E IL VATICANO: LE GRAZIE, AMORE E PSICHE Una gerarchia senza Grazie (greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Caritas"). Materiali per riflettere
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
L’urgenza di una riforma
di Vito Mancuso (la Repubblica, 13.05.2016)
FORSE ci troviamo al cospetto della prima significativa mossa di quella che potrebbe essere una rivoluzione davvero epocale. Credo la più importante tra tutte le meritorie iniziative di riforma intraprese finora dal pontificato di Francesco. Se c’è una via privilegiata infatti per il rinnovamento di cui la Chiesa cattolica ha oggi un immenso bisogno, essa è la via femminile.
PIÙ della riforma della curia, più dell’ecumenismo, più della riforma della morale sessuale, più della libertà di insegnamento nelle facoltà teologiche, più di molte altre cose, l’ingresso delle donne nella struttura gerarchica della Chiesa cattolica avrebbe l’effetto di trasformare in modo irreversibile tale veneranda e anche un po’ acciaccata istituzione.
Prendendo atto dell’emancipazione femminile ormai giunta a compimento in Occidente in tutti gli ambiti vitali, Giovanni Paolo II aveva prodotto una serie di documenti altamente elogiativi verso ciò che egli definiva “genio femminile”, si pensi alla lettera apostolica Mulieris dignitatem del 1988 e alla specifica Lettera alle donne del 1995. Né in questi testi né altrove però il papa polacco definì mai cosa intendesse realmente con tale espressione, usata in seguito più di una volta anche da Benedetto XVI nei suoi interventi in materia. Anche papa Francesco nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium del 2013 ha parlato di “genio femminile”. Ieri però, con l’apertura al diaconato femminile, parlando davanti a oltre ottocento suore superiore, questa ermetica espressione papale ha ricevuto finalmente la possibilità di passare da edificante proclamazione retorica a concreto sentiero istituzionale.
Forse a breve non si parlerà più di genio femminile, ma di geni femminili, perché le singole donne avranno finalmente la possibilità di tornare a donare a pieno titolo il loro patrimonio genetico all’intero organismo di madre Chiesa, la quale ora nella sua mente è femminile unicamente quanto alla grammatica, mentre quanto al diritto canonico è esclusivamente maschile (e da qui le deriva l’attuale sterilità, perché anche la vita spirituale, oltre a quella biologica, ha bisogno di cromosomi y e di cromosomi x).
Ho usato l’espressione “tornare a donare” perché l’apertura al diaconato femminile da parte di Francesco non è una novità assoluta, già nel Nuovo Testamento si parla di diaconesse. Anzi, tale apertura papale può comportare la rivoluzione epocale di cui parlavo proprio perché rimanda a una doppia fedeltà: a una fedeltà al presente, al fine di rendere la Chiesa cattolica all’altezza di tempi in cui l’emancipazione femminile è almeno in Occidente un processo pressoché compiuto, e a una fedeltà al passato, al fine di recuperare la straordinaria innovazione neotestamentaria quanto al ruolo delle donne.
Se si leggono i Vangeli infatti si vede come Gesù, in modo del tutto discontinuo rispetto alla prassi rabbinica del tempo, ricercasse e incoraggiasse la presenza femminile. Luca per esempio scrive che nel suo ministero itinerante «c’erano con lui i Dodici e alcune donne», dando anche i nomi delle stesse: Maria Maddalena, Giovanna, Susanna e aggiunge «molte altre», espressione da cui è lecito inferire un numero di seguaci donne più o meno pari a quello dei seguaci uomini.
Non deve sorprendere quindi che la Chiesa primitiva conoscesse le diaconesse, come appare da san Paolo che scrive: «Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencre» (Romani 16,1; il testo ufficiale della Cei purtroppo è infedele all’originale perché traduce il greco diákonon con “al servizio”! Ben diversa la Bible de Jérusalem che traduce correttamente “ diaconesse de l’Église”).
Che esito avrà l’istituenda commissione di studio sul diaconato femminile? Quanto tempo passerà prima che sia effettivamente al lavoro? Quanto prima che consegni i risultati? E questi che sapore avranno? Sono domande a cui al momento non è possibile rispondere, di certo però la riforma al femminile di papa Francesco è un’urgenza da cui la Chiesa non si può più esimere. Si tratta semplicemente di giustizia: quando si entra in una qualunque chiesa per la messa le donne sono sempre in netta maggioranza, com’è possibile che nessuna di esse possa commentare il Vangelo dall’altare? Il diaconato femminile metterebbe fine a questa ingiustizia e aprirà molte nuove strade.
È un sogno destinato ad avverarsi? Nessuno lo sa, certamente però il successo della riforma al femminile di papa Francesco dipenderà dalla capacità di saper mostrare la doppia fedeltà che vi è in gioco: fedeltà alle donne di oggi e fedeltà al Maestro di duemila anni fa, fedeltà all’attualità e fedeltà a quell’eterno principio di parità emerso al momento della creazione: «E Dio creò l’essere umano a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò» (Genesi 1,27).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI -- Per fare l’Europa non basta l’euro: "I libri che hanno fatto l’Europa" (Mostra dei Lincei - Palazzo Corsini, Roma).30 marzo 2016, di Federico La Sala
- Sibille e profeti oggi. L’onda lunga del Rinascimento (di Nicola Fanizza - "L’Acropoli")
Per fare l’Europa non basta l’euro
Bisogna tornare all’umanesimo
In mostra a Roma le opere fondamentali della cultura «comunitaria»: 186 manoscritti e stampe della Biblioteca Corsiniana, da altre biblioteche pubbliche e dalla Vaticana
di Paolo Di Stefano (Corriere della Sera, 30.03.16)
Non è mai troppo tardi per interrogarsi sull’identità culturale europea: e anzi diventa urgente in un’epoca in cui le migrazioni mettono in gioco idee di chiusura che si scontrano con prospettive più aperte, in una fase di crisi economica, in un momento di tragedie e di odi primitivi. Sono passati quasi quindici anni, ma fatto l’euro bisognerà prima o poi fare l’Europa, meglio: gli europei. I libri che hanno fatto l’Europa è una mostra che parte da questo presupposto: interrogarsi sulle sue numerose radici e ramificazioni, rappresentando materialmente, attraverso una ricca serie di opere fondamentali, il percorso storico-culturale che si è sviluppato da Carlo Magno alla rivoluzione gutenberghiana, gli oltre sei secoli che hanno portato dalla cultura e letteratura classico-cristiana e mediolatina a quella romanza e moderna. Va da sé che un tale cammino si può illustrare solo attraverso l’evoluzione della forma-libro, l’oggetto principe in cui si conserva la memoria culturale europea.
Dunque, la mostra di Palazzo Corsini presenta 186 manoscritti e stampe, in gran parte della Biblioteca Corsiniana, ma anche provenienti dalle altre biblioteche pubbliche romane (Angelica, Casanatense, Nazionale, Vallicelliana), oltre che dalla Vaticana.
«Dalla consapevolezza che l’euro non basta - dice il filologo Roberto Antonelli, accademico dei Lincei cui si deve il progetto - abbiamo avviato da tempo, alla Sapienza, varie ricerche sull’importanza di coltivare una coscienza europea, di riconoscere l’importanza di valori comuni».
Antonelli, che insegna Filologia romanza all’Università di Roma, parla della necessità di unificare il canone letterario europeo nella formazione scolastica, così come si è fatto per avvalorare l’unità italiana: «È necessario l’insegnamento di una “letteratura europea”, tale da fornire un minimo comun denominatore ai vari Paesi dell’Ue per la formazione letteraria dei giovani: questo problema è stato da noi analizzato e collegato, in una ricerca che ha coinvolto cinque grandi Paesi europei (Portogallo, Spagna, Germania, Romania e Italia), anche al rapporto tra emozioni e letteratura nei giovani».
Intanto, la mostra dei Lincei, che non riguarda solo la letteratura, parte dalla tradizione classico-cristiana, risultato della convergenza tra patrimonio greco-latino e insegnamento soprattutto della Bibbia: padri fondatori Sant’Agostino e San Girolamo; mezzi di trasmissione i codici attraverso la fitta rete dei monasteri. Viene rappresentato il sistema scolastico medievale, che si basa sul ciclo delle sette arti liberali: da una parte il Trivio dedicato alla parola, dall’altra il Quadrivio consacrato alle capacità di «conto», «calcolo» e «misura». Il canone degli autori latini (Virgilio, Orazio, Ovidio...) è il fondamento dell’insegnamento linguistico che si prolunga fino all’Umanesimo e oltre e che, come la Bibbia, si presta a una lettura allegorica in chiave di exemplum e di insegnamento morale. Due culture, quella pagana e quella cristiana, diverse e opposte, che si fondono in una «gigantesca trasmissione e consegna di valori e di testi, sia scritti che orali, formando, di generazione in generazione, una tradizione (da tradere, tramandare, consegnare) che diviene nel tempo una vera e propria forma mentale».
Nella prima sezione, le Bibbie miniate e istoriate (la cosiddetta «atlantica», di enormi dimensioni, proviene dalla Nazionale) si accompagnano con i trattati di retorica (la diffusissima Rethorica ad Herennium in volgare) e, tra gli altri, con quelli di aritmetica. Continuità della tradizione è un concetto chiave: si vedano, per esempio, gli approfondimenti delle Confessioni di Agostino (modello per Petrarca) e della Consolatio Philosophiae di Boezio. Le enciclopedie medievali, che con le immagini dello speculum e del thesaurus rielaborano concetti greci, avranno in Vincenzo di Beauvais e in Brunetto Latini (il maestro di Dante) i loro interpreti più illustri in senso moderno, mentre la compilazione etimologica di Isidoro da Siviglia puntava su un presunto statuto originario del linguaggio.
Si diceva che la continuità è tutto e che non si può parlare di cultura europea prescindendo dalla tradizione: da Plinio discende un filone di trattatistica scientifica che si coniuga con il lascito della medicina greca e araba (Ippocrate, Galeno, Avicenna). La Corsiniana conserva un trattato arabo di oftalmologia che contiene la prima rappresentazione occidentale dell’occhio.
Nel cuore della cultura europea del Basso Medioevo si colloca il sapere giuridico, che si estende, anche in chiave «politica», nell’ambito universitario in concorrenza con la teologia fin lì dominante. Ma un’altra grande svolta per la cultura europea è rappresentata dall’aristotelismo che, entrato nell’Occidente latino con le traduzioni arabe nel XII secolo e quasi integralmente tradotto nel Duecento, va a impattare con l’idealismo cristiano, «permettendo di inserire il sapere in una sintesi razionale», come osservano le schede della mostra che compongono una profonda e insieme agile sintesi di storia della cultura europea: dal filosofo islamico Averroè si va alla Summa di Tommaso d’Aquino e al suo sforzo di «trovare un accordo tra filosofia aristotelica e rivelazione cristiana, innestando le strutture metafisiche, logiche e fisiche desunte da Aristotele nella teologia».
Agiografia, letteratura didattica, storiografia, epica e romanzo. Sono voci di una rassegna che reca titoli illustri: a cominciare dalla Legenda aurea di Iacopo da Varazze e dai Fioretti di San Francesco , passando per il Roman de la Rose e per i vari libri di moralità laica, fino alle tipologie testuali, spesso contaminate, che ci portano verso la modernità. Il filone della chanson de geste si apre con la Chanson de Roland per arrivare fino all’Ariosto, mentre il romanzo (termine che deriva da romanz, che significa parlare in volgare) avrà lunga vita nelle sue molteplici declinazioni, a partire dall’invenzione del triangolo amoroso di Tristano e Isotta o dalle avventure cavalleresche di Chrétien de Troyes con la ricerca del Graal, archetipo vitale fino ai colossal hollywoodiani e alle fiction televisive.
Ed eccoci alla lirica, che nasce dai trovatori ma troverà un punto di passaggio cruciale nella riflessione dantesca (il prezioso codice Vaticano Chigiano, con la Vita nuova, è visibile in mostra). L’Italia darà il suo massimo contributo alla letteratura europea con il primo canone di lunghissima durata: il padre Dante («e l’invenzione dell’io», ricorda Antonelli), la lirica petrarchesca, la narrativa di Boccaccio. La coscienza della nostra dimensione europea passa anche (o soprattutto) da lì. Chi volesse rinfrescarsi la memoria faccia un viaggio a Palazzo Corsini.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI. PROFETI E SIBILLE. --- LA "PORTA DEL PARADISO" DEL GHIBERTI E IL "TONDO DONI" DI MICHELANGELO.19 gennaio 2016
MICHELANGELO E GHIBERTI. Una nota:
PROFETI E SIBILLE.LA PORTA DEL PARADISO: Forse deriva proprio dall’antico nome del luogo l’appellativo di "Porta del Paradiso", mentre Vasari fornì un versione diversa, attribuendo l’idea a Michelangelo, che osservando le due ante bronzee avrebbe pronunciato: «elle son tanto belle che elle starebbon bene alle porte del Paradiso».
PROFETI E SIBILLE. Storia delle immagini ...
 MILANO. ALLA MOSTRA DEL LIBRO ANTICO RUBATI DUE VOLUMI. Di uno, quello di Filippo Barberi, si è occupato anche il nostro prof. Federico La Sala. In un suo suggestivo libro ha riprodotto tutte le xilografie del Barberi.
Filippo Barberi, "Discordantiae sanctorum doctorum Hieronymi et Augustini", 1481
MILANO. ALLA MOSTRA DEL LIBRO ANTICO RUBATI DUE VOLUMI. Di uno, quello di Filippo Barberi, si è occupato anche il nostro prof. Federico La Sala. In un suo suggestivo libro ha riprodotto tutte le xilografie del Barberi.
Filippo Barberi, "Discordantiae sanctorum doctorum Hieronymi et Augustini", 1481 -
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- PROFETI E SIBILLE. La copia della Porta Nord del Battistero di Firenze (l’originale del Ghiberti, all’Opera del Duomo) svelata il 23 gennaio.19 gennaio 2016
- L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, OGGI...
 LE SIBILLE E VICO: L’ONDA LUNGA DEL RINASCIMENTO. RELAZIONE DEL PROF. GIUSEPPE CACCIATORE (UNIVERSITA’ DI NAPOLI) SUL LAVORO DI FEDERICO LA SALA
LE SIBILLE E VICO: L’ONDA LUNGA DEL RINASCIMENTO. RELAZIONE DEL PROF. GIUSEPPE CACCIATORE (UNIVERSITA’ DI NAPOLI) SUL LAVORO DI FEDERICO LA SALA
- Sibille e profeti oggi. L’onda lunga del Rinascimento (Nicola Fanizza, "L’Acropoli")
Battistero di Firenze, la porta «copiata» con quattro anni di lavoro (e quattro milioni di euro)La replica del capolavoro realizzata con l’impiego di tecniche antiche e moderne. L’opera finanziata da un’associazione di magnati internazionali
di Marco Gasperetti *
FIRENZE - Mai copia fu così attesa, mai replica così blasonata. Basta guardare le foto e il video che pubblichiamo in anteprima per comprendere questo primato. Dopo 40 mila ore e 4 anni di lavoro, 3,5 tonnellate di bronzo cesellato finemente come l’oro con arte antica e modernissime tecnologie e 50 mila metri cubi di gas per accendere il forno di cottura, la copia della Porta Nord del Battistero di Firenze (l’originale del Ghiberti, capolavoro del Rinascimento, è custodito al museo dell’Opera del Duomo) sarà svelata per la prima volta il 23 gennaio a Firenze. E’ un evento. Replica e restauro sono stati realizzati grazie a 4,2 milioni di euro dell’Opera di Santa Maria del Fiore e della Guild of the Dome, associazione formata da magnati internazionali presieduta dall’imprenditore Enrico Marinelli.
La Porta Nord è la seconda delle tre porte del Battistero di San Giovanni a Firenze e, capolavoro nel capolavoro, è composta da 28 formelle dedicate a Nuovo Testamento, Evangelisti e Dottori della Chiesa. «E’ stata restaurata per la prima volta dopo sei secoli dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze - spiegano all’Opera di Santa Maria del Fiore - e durante i lavori è riemersa la meravigliosa doratura originale presente nei rilievi scultorei delle formelle, nelle testine di Profeti e Sibille e nel bellissimo fregio a motivi vegetali brulicante di piccoli animali». Insomma, un monumento che già troneggia nel museo dell’Opera del Duomo. Adesso la sua replica la sostituirà con tutta la sua opulenza.
I numeri della sua costruzione, in quattro anni di lavoro, sono anch’essi da capolavoro di modernità. I costruttori hanno impiegato 6 mesi di studio per apprendere le tecniche con la quale Ghiberti costruì la Porta Nord. Sono state realizzate 56 formelle (28 per la replica ad arte e 28 per i donatori). Sono state impiegate 15 persone a tempo pieno e 350 sono le ore spese di cesello per ognuno dei 28 pannelli. Sono stati utilizzati 1 tonnellata di silicone per poter fare i calchi dei pannelli e dei fregi della cornice, 400 chili di cera per realizzare gli stampi, 3,5 tonnellate di bronzo, 15 tonnellate di materiale refrattarii e 50.000 metri cubi di gas per accendere il forno di cottura.
L’Associazione Guild of the Dom, che insieme all’Opera di Santa Maria del Fiore ha finanziato l’opera, è stata fondata da imprenditori di tutto il mondo. «Che hanno in comune il desiderio di supportare I valori universali artistici, sociali ed etici alla base del complesso monumentale della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze. - spiega Enrico Marinelli, il presidente -. La Guild si propone di operare con lo stesso intento che animava le Arti o Corporazioni fiorentine che finanziarono la costruzione della complesso oltre sette secoli fa».
* Corriere della Sera, 17 gennaio 2016 (ripresa parziale).
- L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, OGGI...
-
>LA SCOPERTA DI UA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE --- SINCRETISMO. Quando i buddisti eravamo noi. La scoperta del Gesù-Siddharta apre nuovi studi e riflessioni sul rapporto tra filosofia orientale e occidentale (di Silvia Ronchey).16 gennaio 2016, di Federico La Sala
Quando i buddisti eravamo noi
La scoperta dell’immagine del Gesù-Siddharta venerato per secoli da una comunità manichea nel sud della Cina apre nuovi studi e riflessioni sul rapporto tra filosofia orientale e occidentale
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 16.01.2016)
La figura solitaria dal viso assorto, i capelli neri raccolti sulla nuca, siede su un alto trono esagonale. La testa è circondata da un’aureola di luce inscritta nel contorno di una più ampia mandorla che si intravede sullo sfondo brunito del lungo rotolo di seta dipinta. Uno sfolgorio di rosso e oro accomuna i petali dell’immenso fiore di loto dischiuso sotto le sue gambe incrociate e il simbolo della croce che regge tra le dita sottili della mano sinistra, all’altezza del cuore, mentre le dita della destra compongono un esoterico gesto.
 È il Buddha, ed è insieme il Cristo, e in entrambe le vesti è stato venerato per secoli dagli adepti della comunità manichea del sud della Cina per cui la sua immagine, conservata dall’inizio del Seicento nel tempio zen di Seiun-ji in Giappone, fu prodotta fra il XII e il XIII secolo.
È il Buddha, ed è insieme il Cristo, e in entrambe le vesti è stato venerato per secoli dagli adepti della comunità manichea del sud della Cina per cui la sua immagine, conservata dall’inizio del Seicento nel tempio zen di Seiun-ji in Giappone, fu prodotta fra il XII e il XIII secolo.«O vasto e gentile Gesù Buddha, ascolta le mie parole di dolore. Modesto e sempre desto Re della Mente, Anticipatore del Pensiero, guidami fuori da questo mare avvelenato, verso l’acqua fragrante dell’Emancipazione», si legge nel Rotolo innologico manicheo della British Library, la più antica attestazione liturgica del culto di Gesù in quanto Buddha tra i seguaci di Mani della Cina medievale.
Quest’immagine e queste parole provengono dalle pagine di un articolo pubblicato su una rivista scientifica svizzera da una studiosa ugroamericana di arte religiosa dell’Asia Centrale, Zsuzsanna Gulacsi, grande esperta di manicheismo. La sua argomentazione e la sua tesi finale - nella raffigurazione del “profeta” Gesù Buddha è in realtà esplicitata la dottrina della religione dualistica e connaturatamente sincretistica di Mani, cui vanno attribuiti sia il simbolo della Croce di Luce, materializzato nella statuetta, sia il principio della separazione tra luce e tenebra, simboleggiato dal gesto della mano destra - danno nuovo senso a dati già acquisiti ma non ancora elaborati dagli eruditi.
Al di là dello specialismo, l’emergere dal passato orientale del Gesù-Buddha - Mani di Seiun-ji, i suoi epiteti, la forza delle invocazioni parlano in modo immediato al presente occidentale, dove sempre di più il buddismo si radica nella prassi di una crescente élite di figli dell’esistenzialismo, nell’utopia di una non-religione dall’etica resistente alla secolarizzazione ma compatibile con gli approdi della filosofia e con le conquiste della psicologia.
A metà del Novecento il Siddharta di Hesse aveva spontaneamente orientato il suo revival nella cultura pop. Anticipata da pionieri del modernismo cattolico come Thomas Merton, l’accoglienza del buddismo in occidente aveva prodotto un’ibridazione confessionale in cui lo yoga e le tecniche ancestrali di meditazione proprie dell’esicasmo cristiano e del sufismo islamico, come già prima delle scuole platoniche e pitagoriche, erano sostanzialmente tollerate se non promosse dai residui esponenti delle religioni ufficiali.
«Perché non possiamo non dirci cristiani», si domandava Benedetto Croce all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, riflettendo sulle radici comuni dell’Europa. Con altrettanta onestà dovremmo oggi riflettere sul perché non possiamo non dirci buddisti. Più di una filosofia, meno di una religione, mai una dogmatica, il buddismo è oggi la dottrina più condivisa del mondo contemporaneo. Ne è pervasa, ben più che dal cristianesimo, la filosofia moderna. In genere si fa risalire il suo influsso nel pensiero, nella cultura e nel modo di sentire occidentali allo slancio degli studi di orientalistica che influenzarono il giovane Schopenhauer.
Ma quella conoscenza era già ben diffusa tra gli illuministi, per il tramite privilegiato delle missioni in Cina e in Giappone, ma anche in Tibet e Sri Lanka, degli avventurosi gesuiti che tra Cinque e Settecento avevano trasmesso accurati resoconti, in particolare, sul buddismo tibetano.
Di recente una studiosa americana, Alison Gopnik, ha cercato di dimostrare l’influenza diretta delle Notizie istoriche del Tibet del padre Desideri sulla composizione del Trattato sulla natura umana di Hume, avvenuta a stretto contatto con l’ambiente gesuita del Collège de La Flèche, nel nord della Francia. Ma già il Seicento spagnolo era impregnato di buddismo. Il suo riflesso più occidentale è ne La vida es sueño di Calderón de la Barca, attraverso cui la trama della vita del Tathagata si trasmetterà alla letteratura otto e novecentesca.
Ancora molto prima il buddismo era penetrato in occidente, ne aveva permeato la psiche collettiva, si era innestato nel suo Dna culturale, predisponendo subliminalmente il terreno alla definitiva svolta che non possiamo non considerare oggi compiuta. La Controriforma aveva dovuto prendere atto che a Bisanzio fin dall’XI secolo il Buddha era venerato dalla chiesa e nonostante lo scetticismo di Bellarmino nel 1583 il cardinal Baronio lo aveva incluso nel Martirologio Romano come santo «apud Indos Persis finitimos. Il buddismo non aveva mai avuto una Scrittura.
Ma la forza plasmatrice di Bisanzio, civiltà del libro, aveva trasformato la vita del Buddha in libro: la cosiddetta Storia di Barlaam e Ioasaf, composta nell’età di sincretismo e cosmopolitismo immediatamente successiva all’espansione militare e culturale araba e al cosiddetto iconoclasmo. È a partire da questo decalcarsi dell’impronta buddista nello stampo greco per il tramite dell’islam che quel Siddharta ante litteram si riprodurrà in progressione geometrica nella letteratura globale e Buddha estenderà la sua predicazione nell’occidente ancora del tutto cristiano.
Detti e fatti dell’interpretazione cristiana del principe Siddharta risuoneranno in ogni lingua europea con una diffusione non raggiunta da nessun’altra leggenda agiografica. Sedurrà l’Italia più mistica, si trasfonderà nel Trecento senese di Caterina, attraverso il Novellino si trasmetterà al Decameron di Boccaccio e di qui al teatro di Shakespeare. Aveva raggiunto, prima, la Provenza dei catari e degli albigesi, attraverso il latino ma con l’influenza del manicheismo orientale. È in effetti la pista manichea, desunta dai frammenti in turco uiguro e in neo-persiano portati alla luce dalle spedizioni archeologiche di inizio Novecento, quella che con più forza è emersa nel rompicapo degli eruditi sull’origine del Buddha cristiano. Ed ecco, il cerchio si chiude, riportandoci al rotolo di Seiun-ji.
Quest’immagine di perfetto sincretismo a sua volta permette un ulteriore passo indietro. Dal bacino del manicheismo emergeva, tra il IV e il V secolo, il massimo cervello cristiano di tutti i tempi, Agostino. Quella che aveva conosciuto in Mani era una dottrina gnostica già impregnata di un’idea di salvezza propriamente religiosa.
Ma in realtà, nel seno della filosofia ellenistica in cui il flusso oriente-occidente era continuo, lungo la rotta della conquista di Alessandro, nello splendore dei regni indogreci, nelle predicazioni dei monaci greci buddisti che re Ashoka inviò ai monarchi affacciati sul Mediterraneo, o degli asceti erranti che giunsero fino alla corte di Augusto, lo stesso germoglio di ciò che chiamiamo buddhismo dovette essere rinvigorito dallo scambio, prima che con lagnosi, con il pensiero delle scuole elleniche.
Anche se la prima menzione del Buddha nella storia della letteratura europea si trova solo alla fine del II secolo, negli Stromata, i “Tappeti” letterari di Clemente di Alessandria, è congetturabile una coabitazione e contaminazione tra le dottrine del Gautama Sakyamuni e quelle, ancora recentemente evocate da Christopher Beckwith, dei filosofi scettici, o dello stoicismo antico.
Se non possiamo non dirci buddisti, cos’è allora che veramente noi occidentali chiamiamo buddismo? Non una dottrina, non una religione, non una filosofia, piuttosto la prensile erba di una conoscenza capace di allacciarsi e adattarsi e dare linfa a diverse religioni, dottrine, filosofie.
Il germe radicato nel nostro passato, ciclicamente reinterrato e rifiorito, di una verità universalmente diffusa perché straordinariamente persuasiva, indiscutibile e intuibile, in certi folgoranti attimi, anche a livello prerazionale: la percezione, continuamente rimossa, delle “cose come sono”, per usare l’espressione di Hervé Clerc; la stupefazione che sta all’origine di ogni visione filosofica; dove il riconoscimento dell’illusorietà dell’esistenza e dell’impermanenza dell’essere è in realtà il nucleo stesso di ciò che gli antichi greci, poco dopo la morte del Gautama storico, chiamarono per la prima volta filosofia.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Riti di Mitra, misteri dionisiaci, saturnali e la “vera” Epifania. Rec. di “Jesus Rex” di Robert Graves (di Silvia Ronchey).6 gennaio 2016, di Federico La Sala
Riti di Mitra, misteri dionisiaci, saturnali e la “vera” Epifania.
Ritorna “Jesus Rex”, il capolavoro di Robert Graves
Tutti gli dèi nascosti dietro al dio chiamato Gesù
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 06.01.2016)
Nel 1614 Keplero, dopo laboriosi calcoli, dimostrò che nel 7 a.C., quando dovette grossomodo avere luogo la nascita di Gesù (che il calendario etiopico colloca nell’8 a.C. e che comunque non poté precedere il 5 a.c., anno di morte di Erode), Giove e Saturno ebbero tre congiunzioni ravvicinate nella costellazione del Pesce, un evento raro che avviene ogni svariate centinaia di anni e che era stato tuttavia già, previsto, si dice, dagli astronomi caldei. Una di queste congiunzioni fu nel mese di dicembre.
Non che l’evento in sé spieghi la “stella grandissima”, che secondo i testi sacri - Matteo 2, 1-12, ma soprattutto gli apocrifi - sarebbe apparsa in quel tempo e avrebbe segnalato ai Magi la nascita di “un re per Israele”; o giustifichi un aumento della luminosità tale da oscurare le altre stelle, come scritto nel Protoevangelo di Giacomo. Né risulta compatibile con la cronologia della nascita di Gesù la visibilità della cometa di Halley, il cui passaggio si ascrive al 12 a.C. Ma la relazione tra il formarsi del calendario liturgico protocristiano e gli eventi astronomici che già sostanziavano i riti delle più antiche religioni, zoroastriana anzitutto e poi romana, è indubitabile.
La festività che nel mondo cristiano ortodosso è detta “delle Luci” ( ton Photon) accomuna in un breve giro di calendario il pellegrinaggio escatologico dell’élite pagana d’oriente e la festa solare chiamata nell’antica Roma dies natalis Solis Invicti, e ancora oggi da noi Natale; a sua volta legata sia ai Saturnali, sia alla festa di Mitra, il cui culto misterico prettamente maschile, originariamente indopersiano, romanizzato nella pratica rituale degli eserciti, era in grande espansione nel periodo in cui nacque la fortunata eresia giudaica che le scritture canoniche ed extracanoniche associano alla nascita di un “nuovo re di Israele” proprio in occasione dell’evento che qui festeggiamo il 6 gennaio e chiamiamo Epifania.
Nome a sua volta desunto dalla terminologia dei misteri greci. È l’epiphàneia di un dio, la sua sacra manifestazione, al centro della leggenda della stella e dei Magi. I tre maghi persiani dal cappello a cono del mosaico di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna, i Drei Könige sulle cui magnetiche reliquie si impennò la cattedrale di Colonia,i tre savii stranieri dai nomi incerti e contorti che seguirono la stella ed ebbero l’epifania di un fanciullo divino, si prostrarono, scrive Matteo, con la rituale proskynesis che si riconosce al capo di un’altra e nuova religione, recandogli il crisma dei sommi doni sapienziali.
«I misteri religiosi sono in gran parte connessi con le predizioni astronomiche», scrive con apparente candore Robert Graves all’inizio della terza e culminante parte di Io, Gesù, il capolavoro (ora ripubblicato da Longanesi, e all’epoca intitolato Jesus Rex) che settant’anni fa dedicò al formarsi del culto di quelli che chiama i crestiani - i seguaci del Chrestòs, in greco “il Buono” - nell’epoca che va appunto dalla teofania occorsa ai Magi a quello che definisce «lo scisma dei gentili, capeggiato dal visionario Paolo di Tarso. Un culto che sancisce - è la grande teoria di Graves, che fa qui la sua prima comparsa - la vittoria delle religioni dominate da divinità maschili, di cui JHWH, il dio onnipotente del monoteismo biblico, è l’esempio massimo, sulla religione femminile originaria, quella della Grande Dea, cui Graves dedicherà due anni dopo il suo libro più noto, La dea bianca.
 L’eclissi della divinità lunare e l’oblio del suo culto porteranno a fraintendere l’identità storica di Gesù, che nella ricostruzione di Graves, fantastorica, deliberatamente fantasmagorica ma non per questo meno scientificamente probante, riunisce in sé, per discendenza matrilineare, un’effettiva e clamorosa regalità.
L’eclissi della divinità lunare e l’oblio del suo culto porteranno a fraintendere l’identità storica di Gesù, che nella ricostruzione di Graves, fantastorica, deliberatamente fantasmagorica ma non per questo meno scientificamente probante, riunisce in sé, per discendenza matrilineare, un’effettiva e clamorosa regalità.
 La legittima successione del trono di Davide, ossia dell’antica Israele, e di Erode, ossia della Giudea romana, gli è assicurata da Maria, vergine di sangue regale consacrata al Tempio, che ha però segretamente sposato uno dei figli di Erode, avuto dalla prima moglie, di altrettanto impeccabile discendenza idumonea.
La legittima successione del trono di Davide, ossia dell’antica Israele, e di Erode, ossia della Giudea romana, gli è assicurata da Maria, vergine di sangue regale consacrata al Tempio, che ha però segretamente sposato uno dei figli di Erode, avuto dalla prima moglie, di altrettanto impeccabile discendenza idumonea.
 È alla luce dell’effettivo status di aspirante Rex Iudaeorum che Graves interpreta, nel finale del libro, l’udienza personale concessa da Pilato a Gesù, il suo straordinario favore, l’inusuale titulus, INRI, apposto per suo ordine alla croce; così come il successivo, irrazionale e imprevedibile svolgersi del fatti, la catena di fraintendimenti, censure, tendenziosità che plasmeranno, in un sincretismo assoluto e a tratti costernante, la nuova religione maschile destinata a pervadere i confini dell’impero romano, dal medio oriente giudaico all’estremo occidente celtico, di quella gelosa idea di elezione e linearità, legata a un’inquietante promessa di “al di là”, che si sostituirà alla preesistente idea femminile di ciclicità della storia come della natura del cosmo.
È alla luce dell’effettivo status di aspirante Rex Iudaeorum che Graves interpreta, nel finale del libro, l’udienza personale concessa da Pilato a Gesù, il suo straordinario favore, l’inusuale titulus, INRI, apposto per suo ordine alla croce; così come il successivo, irrazionale e imprevedibile svolgersi del fatti, la catena di fraintendimenti, censure, tendenziosità che plasmeranno, in un sincretismo assoluto e a tratti costernante, la nuova religione maschile destinata a pervadere i confini dell’impero romano, dal medio oriente giudaico all’estremo occidente celtico, di quella gelosa idea di elezione e linearità, legata a un’inquietante promessa di “al di là”, che si sostituirà alla preesistente idea femminile di ciclicità della storia come della natura del cosmo.Al bene informato Agabo, alter ego narrante di Graves nell’ipotetico anno Domini 93 d.C. cui la narrazione è ascritta, il nuovo culto si presenta dominato da un rito conosciuto col nome di eucarestia [eu-charis-tia, fls] e adibito «a comodo ponte tra il giudaismo e i culti misterici greci e siriani, in cui il sacro corpo di Tammuz viene mangiato sacramentalmente e sacramentalmente bevuto il sacro sangue di Dioniso», il dio “Figlio della Duplice Porta”, nato prima a sua madre Semele e poi al padre Zeus, cui Gesù somiglia anche nell’avere due date astronomiche di nascita: a quella del solstizio d’inverno, che coincide con la nascita del sole, si aggiunge quella estiva cui si riconduce il suo battesimo - rappresentato con matematica perfezione neoplatonica da Piero della Francesca - che coincide con la levata eliaca di Sirio, la stella messianica del versetto di Isaia.
In Io, Gesù Graves, superbo esperto di mitografia greca ed ebraica, dipana il sincretismo fin dalla Natività. Se la Vergine Madre dalla veste azzurra e dalla corona di stelle d’argento è necessaria ipòstasi di Iside, nella grotta la mangiatoia dov’è adagiato il Bambino ripropone quella usata allo stesso scopo nei misteri delfici ed elusini e il bue e l’asino, cui già allude Isaia, simboleggiano i due messia promessi, il figlio di Giuseppe e il figlio di Davide, che il neonato adorato dai Magi riunisce. La sua storia ha tratti in comune con quella di Pèrseo, che il re Acrisio tenta di uccidere in fasce.
Nella narrazione di Graves, ironicamente accademica, irresistibilmente sacrilega, implacabilmente laica, i Magi non sono nulla di ciò che per due millenni l’esegesi dei teologi cristiani o degli storici delle religioni o tanto meno degli esoteristi e teosofi in voga in quegli anni ha abilmente e spesso fondatamente congetturato, ma solo tre ebrei damasceni della tribù di Issachar, che nel palazzo di Erode a Gerico si presentano come astrologi appartenenti alla nuova setta degli “alleanzisti”: hanno stipulato una nuova alleanza con Dio attraverso la mediazione di uno spirito chiamato “Colui che viene” ovvero “la Stella”, che secondo la loro previsione si incarnerà quanto prima sotto spoglie umane e darà a Erode gloria eterna. Ma Erode stesso ha basato la sua politica e il suo regno sulla congiunzione astrale di Giove e Saturno individuata da Keplero nel 1614.
Dal fallimento del piano dinastico di Erode, che in Graves si snoda in sostanziale aderenza a Matteo, ascende l’astro del nuovo re che i tre astrologi giudei hanno correttamente individuato e adorato, ma che non sarà scorto in vera luce dai gentili. I suoi Atti e detti, originariamente scritti in aramaico, riceveranno, riferisce il beffardo Agabo, versioni multiple di una traduzione greca «erronea, a volte goffa e di tanto in tanto fraudolenta », cosicché i fondatori delle chiese gentili fraintenderanno «così stranamente la sua missione da fare di lui la figura centrale di un nuovo culto che, se lui oggi fosse vivo, giudicherebbe solo con avversione e orrore». Lo vedranno come un giudeo rinnegato che «unendo la propria sorte a quella degli gnostici greci aspirò a una sorta di divinità apollinea, per di più fornendo credenziali che devono essere accettate per cieca fede - suppongo perché nessuna persona ragionevole», aggiunge Agabo, «potrebbe mai accettarle in alcun altro modo».
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- VATICANO. Papa Francesco, pericoloso «femminista» (di Bia Sarasini))18 settembre 2015, di Federico La Sala
L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO (il maggiorasco), REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI"). Una pagina di Kant e una nota (federico la sala)
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI"). Una pagina di Kant e una nota (federico la sala)
Francesco, pericoloso «femminista»
Vaticano. Bergoglio, un uomo del nostro tempo
di Bia Sarasini (il manifesto, 18.09.2015)
Ieri per definirsi papa Francesco ha usato una parola proibita e quasi temuta, in ambito ecclesiale: «Perdonatemi se sono un po’ femminista». Parlava a braccio a un’udienza ai giovani consacrati, e voleva ringraziare «la testimonianza delle donne consacrate». Due giorni fa invece, nel concludere una settimana dedicata alla famiglia, ha demolito un mito tenace, Eva e il suo serpente che corrompono Adamo, l’uomo: «Esistono molti luoghi comuni, alcuni anche offensivi, sulla donna tentatrice» ha detto nell’omelia.
In passato aveva già parlato della «brutta figura che ha fatto Adamo, quando Dio gli ha detto: ’Ma perché hai mangiato il frutto dell’albero?’ E lui: ’La donna me l’ha dato’». Ma c’è un orientamento, una direzione, o meglio un’intenzione in tutte le parole che dall’inizio del suo pontificato papa Bergoglio ha dedicato alle donne?
In verità non è facile orientarsi, e questo è sorprendente, in un pontefice che mostra una straordinaria chiarezza di predicazione, di pastorale e di politica.
Nell’omelia di due giorni fa la riflessione in realtà non era colloquiale, come altre sue battute. «Invece c’è spazio per una teologia della donna che sia all’altezza di questa generazione di Dio». Un passaggio significativo, anche se non si può dimenticare che da anni tante teologhe lavorano in questa direzione, con risultati di altissima qualità.
Come importante è stata una considerazione di qualche tempo fa, quando ha detto che nulla può giustificare la disparità di retribuzione tra uomo e donna. «Perché si dà per scontato che le donne debbano guadagnare di meno degli uomini? Si tratta di maschilismo», ha commentato senza tanti di giri di parole, applaudito dalla folla di San Pietro.
Non c’è materiale sufficiente per delineare una “dottrina” del papa sulle donne, forse, ma abbastanza per accorgersi di un cambiamento profondo, che più che sui principi, si muove sui comportamenti, sul senso comune, sulla pratica quotidiana.
Certo, bisogna essere cattolici, praticanti o perlomeno formati in quel contesto, per “sentire” quanto queste parole siano forti, incongrue, fuori da qualunque tradizione precedente. Papa Francesco non è magniloquente, non proclama l’elogio del «genio femminile» come fece Woityla, ma ha deciso che con il Giubileo si «perdoni» il peccato di aborto. Anche questa decisione ha fatto molto discutere. A molte - e anche molti laici - è sembrata un’ insopportabile offesa, la riaffermazione di un principio. È comprensibile, ma è evidente che si tratta del contrario. Si tratta della derubricazione della colpa assoluta, demonizzata, e imperdonabile che ha agitato non solo lo stretto ambito del mondo cattolico in questi ultimi anni. Si potrebbe dire che a poco a poco, discorso dopo discorso, omelia dopo omelia, vengono ridotti - decostruiti per essere precisa - tutti gli elementi che fanno della donna un essere speciale e pericoloso. In una visione non solo cattolica, non solo teologica, e non solo mitica, su un terreno in cui ha senso richiamarsi alle radici cristiane dell’Europa e del mondo occidentale, perché è questa visione che ancora ne nutre l’immaginario.
Anche nella relazione con le donne papa Francesco ha portato la forza di una linguaggio quotidiano, semplice, diretto. È un uomo del nostro tempo e risulta evidente, da quello che dice e che fa, che conosce la vita, il mondo. Conosce gli uomini e le donne. È sufficiente a sciogliere la diffidenza, se non l’ostilità delle donne nei suoi confronti? Anzi, meglio sarebbe dire la delusione, impossibile comprendere il giudizio durissimo da lui espresso sulle «teorie del gender», che ha definito «espressione di una frustrazione», una forma di «colonizzazione ideologica».
Il 4 ottobre comincia il Sinodo ordinario, quello che dovrà operare le scelte pastorali sulla famiglia. Divorziati, omosessuali sono i principali temi sul tappeto. Nulla che riguardi le donne, neppure la contraccezione è stata discussa, l’anno scorso.
Papa Francesco è un uomo coraggioso. Abbiamo ammirato tutti la forza con cui propone alla sua Chiesa una pratica che corrisponda agli insegnamenti del Vangelo. L’accoglienza, mettere a disposizione ciò che si possiede, il rispetto delle leggi. Appena eletto, disse « mi chiamano comunista». Viene da pensare che dichiararsi «un po’ femminista» in un’istituzione che da due millenni è fatta da soli uomini, sia perfino più pericoloso.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Enzo Bianchi: "Critichiamo l’Islam, ma poi emarginiamo le donne". Intervista al priore di Bose (di Silvia Ronchey)11 settembre 2015, di Federico La Sala
Le sfide del cristianesimo, la minaccia dell’Is, il ruolo femminile e il pontificato di Francesco.
Intervista al priore di Bose che da oggi ospita il Convegno Ecumenico di spiritualità ortodossa dedicato a "Misericordia e perdono"
La Chiesa del futuro
Enzo Bianchi: "Critichiamo l’Islam, ma poi emarginiamo le donne".
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 9 settembre 2015)
«Il papa ha lanciato l’allarme già due anni fa, dopo la visita a Lampedusa. È rimasto inascoltato e credo che anche questo suo nuovo appello lo sarà. Il fastidio di un certo clero verrà magari dissimulato dall’ipocrisia religiosa, che è la più bieca e spaventosa di tutte». Siamo a Bose, alla vigilia dell’apertura dell’annuale convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, e il priore Enzo Bianchi commenta l’esortazione di Bergoglio ad accogliere nelle parrocchie i rifugiati del grande movimento di popoli di cui quest’estate, con i suoi avvenimenti sconvolgenti, sembra avere cambiato la percezione generale. «Un mese fa il vescovo di Crema ha chiesto di ospitare i rifugiati in locali adiacenti a una scuola cattolica, è stato contestato dalle famiglie. La situazione italiana è una vergogna, soprattutto nelle regioni tradizionalmente più cattoliche, il Veneto e la Lombardia».
Il rifiuto è più sociale o più confessionale?
«Quello confessionale l’hanno gridato a suo tempo il cardinal Biffi e il vescovo Maggiolini, secondo cui bisognava eventualmente accogliere solo i cristiani. Ma il problema è la vera e propria fabbrica di paura dei barbari, edificata da forze politiche attente solo all’interesse locale, forze che prima di Francesco la chiesa italiana ha assecondato, anche se all’inizio sembravano assumere riti pagani, precristiani, quelli sì barbarici. Ora si proclamano cattolici ma io li chiamo cristiani del campanile. Il grande silenzio di una chiesa complice li ha aiutati a iniettare nel tessuto sociale del territorio il veleno della xenofobia».
Guardiamo gli eventi nella misura dei millenni di storia anche ecclesiastica, parliamo del V secolo, quando alle cosiddette invasioni barbariche si è affiancata l’assunzione del cristianesimo a religione di stato.
«Quando con Teodosio il cristianesimo è diventato religione dello stato imperiale la furia dei monaci - lo dico con dolore, mi strappa il cuore - ha distrutto i templi pagani, fatto uno scempio di opere d’arte non diverso da quello dell’Is, ma ben più vasto. È il motivo per cui san Basilio non ha mai usato nei suoi scritti la parola "monaco": designava integralisti violenti, i talebani del momento. Guardando i secoli mi permetto di dire, pur con tutte le differenze: vediamo che altri rifanno a noi quello che abbiamo fatto».
Come ad Alessandria d’Egitto, quando fu distrutto il Serapeo e i parabalani del vescovo Cirillo assassinarono Ipazia. Nel "Libro dei testimoni", lo straordinario martirologio ecumenico di Bose, questa martire pagana potrebbe trovare posto?
«Sì, come tutti coloro che - da Buddha a Savonarola, da Rumi a Gandhi - in qualunque religione o anche all’esterno hanno perseverato in una posizione di umanità e di tolleranza. La dottrina cattolica del Vaticano II ribadisce con chiarezza che la coscienza prevale su qualsiasi autorità, anche su quella papale».
Torniamo ai movimenti di popoli della cosiddetta fine dell’antichità.
«Con saggezza papa Gregorio Magno chiese accoglienza per i barbari in arrivo dando un’unica dignità a stranieri e latini, che si espresse nel monachesimo benedettino e fece fiorire il cristianesimo, allora esangue soprattutto in occidente. La storia serve da un lato a non stupirci dell’intolleranza, dall’altro a spegnerla richiamandoci alla razionalità, che oggi significa mostrare ai popoli dell’oriente postcoloniale che gli riconosciamo soggettività, dignità, diritto di sedere alla tavola delle genti, anziché continuare a sfruttarli economicamente».
La memoria storica ecclesiastica, la conoscenza delle ere passate di cui si nutre, non ha anche il dovere di ricordare a tutti l’onda lunga della tolleranza islamica?
«Al tempo della conquista musulmana i cristiani del Medio Oriente hanno aperto le porte delle loro città agli arabi che portavano libertà di culto e affrancavano dalle angherie economiche del governo imperiale cristiano. La convivenza di cristiani, ebrei e musulmani nel corso del medioevo islamico ha fatto fiorire momenti di cultura straordinari, come nel mondo sufita, che conosco bene. L’islam è una religione di pace e mitezza con una mistica di forza pari a quella cristiana. Se nel Corano ci sono testi di violenza, non sono molto diversi da quelli che troviamo nella Bibbia e che ci fanno inorridire. La lettura integralista della Bibbia può rendere integralisti quanto quella del Corano. L’esegesi storico-critica delle scritture, cui il cristianesimo è approdato con fatica e subendo terribili condanne dell’autorità ecclesiastica, è il primo passo di un lungo cammino che aspetta anche i musulmani. Nel frattempo servono ascolto, dialogo, seri studi universitari per dissipare la propaganda ideologica che attecchisce sull’ignoranza: non è vero che l’islam è una religione della violenza e della jihad, affermarlo serve solo a giustificare la nostra nei suoi confronti».
Dai Buddha di Bamyan al tempio di Bel a Palmira, il nostro secolo assiste ad atti islamisti di cancellazione del passato dal contenuto altamente simbolico. Ma non è chiaro quanta parte effettiva vi abbia la religione o la religiosità.
«Una parte minima. Il problema non è religioso, è sociale ed economico. Gli integralisti islamici, anche abbattendo una chiesa, non mirano tanto a offendere la fede cristiana quanto a colpire l’occidente. Un pacifico abitante di Palmira mi ha detto: "Voi occidentali, piangendo la distruzione di templi etichettati dall’Unesco, date l’idea di averli più cari della nostra popolazione. Cosi li fate diventare una protesi dell’occidente nella nostra terra". Mostrando di tenere così tanto a un pezzo di colonna - giustamente, perché è segno di un cammino di umanizzazione - ma facendo saltare in aria le persone nelle guerre da noi scatenate in Iraq, in Siria, in Libia, finiamo per apparire mostruosi. Certo le distruzioni dell’Is sono crimini contro l’umanità oltre che contro la cultura e la dignità dei monumenti va difesa, ma abbiamo la stessa forza nel difendere le popolazioni perché non soccombano alle nostre armi o non trovino vie di morte nella migrazione?».
I popoli sono in marcia e un’ibridazione, che la si voglia o no, dovrà avvenire, perché questa è la storia. Il che pone anche specifici problemi sociali come quello del ruolo della donna: l’islam impone il velo, ma non trovi che anche nella chiesa cristiana ci sia un ritardo?
«Si dice sbrigativamente che certi musulmani siano ancora nel medioevo. Ma il velo completo per le suore di clausura è stato abolito solo nel 1982. È molto recente la presa di coscienza della pari dignità della donna e dell’uomo nel cristianesimo, che non ha ancora nemmeno il linguaggio per esprimerla. La soggezione delle donne agli uomini è un retaggio scritturale nell’islam, ma è presente anche nelle nostre scritture: san Paolo afferma che le donne non devono assolutamente parlare nell’assemblea della chiesa e devono stare a capo coperto. Di nuovo, serve una rilettura storico-critica di tutti i libri sacri, per scorgerne l’intenzione e non le forme. Nella chiesa c’è buona volontà ma poi della donna si hanno immagini irreali: il modello di Maria, vergine e madre, che non può essere il riferimento per una promozione della donna nella chiesa; l’idea, insinuata per moda, che la Madonna sia più importante di San Pietro, idea insipiente come dire che la ruota in un carro è più importante del volano... Non siamo ancora capaci di prendere sul serio l’uguaglianza indubbia tra uomini e donne. Il cammino per la chiesa è ancora lunghissimo perché ovunque ci sia un esercizio di comando restano gli uomini, mentre le donne sono confinate al servizio umile».
Il convegno che si apre oggi è dedicato a "Misericordia e perdono": sono istanze che, dall’ambito ecclesiale cui appartengono, possono suggerire prassi anche giuridiche e sociali?
«Declinare la giustizia con il perdono, anche a livello politico, è un’esigenza che già Giovanni Paolo II aveva evocato con forza in un suo messaggio per la Giornata della pace. L’insistenza di papa Francesco sulla pratica della misericordia, vissuta nei secoli da tanti cristiani d’oriente e d’occidente anche in controtendenza rispetto alla mentalità dominante, dischiude percorsi fecondi nella faticosa purificazione della memoria cui non ci possiamo più sottrarre, pena l’abbrutimento di ogni nostra relazione».
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Spiando Gian Lorenzo Bernini e la sua santa Teresa d’Avila dietro le quinte (di Tomaso Montanari)11 giugno 2015, di Federico La Sala
Spiando Bernini e la sua santa Teresa dietro le quinte
di Tomaso Montanari (la Repubblica, 11.06.2015)
Gian Lorenzo Bernini, probabilmente, non avrebbe apprezzato: come tutti i maghi, non svelava i suoi trucchi. Ma è impossibile star lontani dai ponteggi su cui Giuseppe Mantella e Sante Guido (tra i migliori restauratori di scultura che conti l’Italia) stanno pulendo la Cappella Cornaro, nella chiesa romana di Santa Maria della Vittoria: dove Teresa d’Avila geme di piacere e muore per sempre, eternamente trafitta dalla freccia infuocata dell’amor di Dio.
La Cappella è un palcoscenico gremito di attori, pietrificati all’apice dell’azione drammatica. Entrarci vuol dire toccare le “toppe” fantasmagoriche con cui il regista ha rimediato alle lacune dei già spettacolari, coloratissimi marmi antichi, rendendoli ancora più pirotecnici. Vuol dire scoprire che è stato lui in persona, Bernini, a scolpire il grande capitello della parasta di sinistra: tra le cui foglie si contorce un minuscolo alberello, spettacolarmente autografo.
Ma, soprattutto, intrufolarsi dietro le quinte permette di scoprire le tracce degli aggiustamenti dell’ultim’ora: proprio quella fatica che il regista-prestigiatore avrebbe voluto cancellare per sempre. La mano destra di Teresa è un informe grumo di marmo, ma ha tre dite spettacolarmente cesellate: chiaramente eseguite a parte, e attaccate in un secondo momento.
Stupefacente, visto che tutto il resto del gruppo (Teresa e l’angelo) è scolpito in un unico, enorme bocco. Forse il frutto di una rottura posteriore? No, la trovata di un consumato illusionista: fino a quando il gruppo non fu innalzato alla quota stabilita, Bernini non era sicuro di che cosa si sarebbe visto, di quella mano. Ma gli serviva, invece, che si vedesse: per dare un confine leggibile all’oceano di panni in tempesta che risucchia il corpo della santa. E dunque fissò le dita solo stando lassù, muovendole fino a trovare il punto da cui potevano entrare nel campo visivo dello spettatore: «tutto è finto perché tutto sembri vero», era il suo motto.
Ma se ogni cosa era predisposta con sapienza, perché - con apparente spreco di tempo e lavoro - l’angelo e Teresa sono perfettamente lavorati anche sui lati, cioè dove nessun occhio, dal basso, può vedere? Ecco la prova che il grado di rotazione delle figure rispetto alla parete fu deciso solo all’ultimo momento: non si poteva rischiare di mettere in mostra, e proprio lì, qualche dettaglio incompiuto.
Camminando sempre sul filo, però, anche il team di Bernini qualche volta cadeva. I cardinali Cornaro che si affacciano a destra di chi guarda furono scolpiti in un’unica, lunghissima lastra di marmo: un’esibizione spaccona di virtuosismo. Puntualmente punita, però: perché le misure non tornarono, e ci si dovette acconciare a rilavorarli in loco (le schegge di marmo sono ancora lì dietro: commoventi), adagiandoli poi in un’intercapedine di stucco.
Infine, sono proprio i due celeberrimi attori protagonisti ad apparire in una luce nuova. Chi avrebbe mai detto che al meraviglioso cherubino mancasse tutta la metà anteriore del piede destro? Piede che affonda nella base di marmo come, d’estate, il piede di un bambino scompare nell’acqua di mare. Ma anche Teresa ha qualche segreto da svelare: solo vedendola di fronte, si capisce che indossa anche il grande mantello bianco dei carmelitani, perfettamente riprodotto con tanto di fermaglio, che è simile a uno sbarazzino bottone da montgomery.
Una volta sui ponteggi è impossibile non pensare al primissimo palco, quello su cui salirono Bernini e i suoi. Le biografie dicono che quando Gian Lorenzo era lassù, bisognava sempre tenergli vicino un garzone: perché tendeva a estraniarsi e rischiava di cader di sotto. A chi cercava di richiamarlo alla realtà, rispondeva: «lasciatemi stare, ché sono innamorato ». Quasi quattrocento anni dopo, quell’amore rende ancora rovente l’aria della Cappella Cornaro.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Lettera ai Carmelitani scalzi per cinquecento anni della nascita di Teresa di Ávila (di Papa Francesco)31 marzo 2015, di Federico La Sala
Donna eccezionale
· Francesco per il quinto centenario di santa Teresa di Gesù · *
«Donna eccezionale» e «modello attraente di donazione totale a Dio»: è il ritratto con cui Papa Francesco descrive Teresa di Gesù nella lettera inviata al preposito generale dei Carmelitani scalzi per i cinquecento anni della nascita della santa di Ávila.
Dopo essersi unito all’«ora di preghiera per la pace» promossa in tutte le comunità carmelitane del mondo per la ricorrenza di sabato 28 marzo, nello stesso giorno il Pontefice ha scritto a padre Saverio Cannistrà, ricordando come l’anniversario teresiano coincida con l’Anno dedicato alla vita consacrata», nella quale Teresa è stata e resta esempio tra i più attraenti.
Nel dipinto di Juan de la Miseria l’unico ritratto eseguito quando Teresa era ancora viva (1576)
Approfondendone la figura, il Papa si è soffermato in particolare sulla dimensione orante, missionaria, ecclesiale e comunitaria della sua spiritualità. Santa Teresa è anzitutto, ha affermato in proposito, «maestra di preghiera». Infatti «nella sua esperienza è stata centrale la scoperta dell’umanità di Cristo. Mossa dal desiderio di condividere questa esperienza personale con gli altri, la descrive in maniera vivace e semplice, alla portata di tutti». Al punto che la sua «non è stata una preghiera riservata unicamente ad uno spazio o ad un momento della giornata», al contrario «sorgeva spontanea nelle occasioni più diverse».
Per questo con il suo esempio «la Santa ci chiede di essere perseveranti, fedeli, anche in mezzo all’aridità, alle difficoltà personali o alle necessità pressanti che ci chiamano».
Quanto alla dimensione missionaria ed ecclesiale, che ha da sempre contraddistinto la famiglia religiosa carmelitana, «anche oggi la Santa apre nuovi orizzonti, convoca per una grande impresa, per guardare il mondo con gli occhi di Cristo, per cercare ciò che Lui cerca e amare ciò che Lui ama».
Infine, ha concluso, «santa Teresa sapeva che né la preghiera né la missione si possono sostenere senza un’autentica vita comunitaria. Perciò, il fondamento che pose nei suoi monasteri fu la fraternità».
*
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- LE SIBILLE E I PROFETI DEL PERUGINO NEL COLLEGIO DEL CAMBIO A PERUGIA2 febbraio 2015, di Federico La Sala
PERUGIA
IL COLLEGIO
Sala delle Udienze
di Pietro Scarpellini *
Tra le corporazioni delle arti a Perugia le più potenti furono quelle della Mercanzia e del Cambio per il significato che vennero a prendere nella vita urbana e nel governo della città. La matricola del Cambio del 1377 dice esplicitamente “Ars Cambi quae est pars magna totius Reipublicar Civitatis”. Scopi principali dell’arte furono quelli di vigilare sulla legittima commutazione del denaro e di pronunciare sentenze intorno a cause civili nell’ambito delle proprie specifiche competenze, per cui il Collegio assumeva le funzioni di tribunale. Di qui le figure di “uditori” assunte dai consoli e il nome di Udienza preso dal luogo ove questi si riunivano. I lavori per la nuova sede, compresa entro il Palazzo Pubblico, iniziarono nel 1452 ed erano compiuti nel 1457.
A partire dal 1490 si cominciò a decorare l’ambiente, dapprima fu il fiorentino Domenico del Tasso a realizzare, il bancone e i postergali. Nel 1492 venne da Firenze la statua della Giustizia in terracotta dorata attribuita a Benedetto da Maiano.
Il 26 gennaio 1496 i consoli insieme ad i giurati, stabilirono di far dipingere le volte e le pareti, e poco dopo dovette venir stipulato il contratto con Pietro Perugino (tuttavia non rintracciato per la perdita dei libri relativi).
I lavori cominciarono dalla volta dove, nelle sette vele, furono rappresentate soprattutto figurazioni allegoriche dei pianeti, Luna, Mercurio, Marte, Saturno, Giove, Venere, ed al centro Apollo, in una ricca decorazione a grottesche, ove si inseguono figurazioni decorative e mostruose, le cui fonti sono da rintracciarsi sia nel mondo antico, in specie nella “Domus Aurea” neroniana, sia in quello moderno, nei motivi ceramici, nell’araldica locale, negli ornamenti a finto mosaico, secondo partiti già utilizzati nei soffitti romani del Pinturicchio.
Compiuta questa parte dell’impresa dai discepoli del Maestro su suoi disegni si passò alle pareti dove i temi vennero, a quanto pare, dettati dall’umanista Francesco Maturanzio, professore a Vicenza ed a Venezia, e poi, dopo il suo ritorno in patria, verso il 1498, segretario dei Decemviri. Al Maturanzio sembra si debbano i magniloquenti versi latini che figurano nelle tabelle esplicative rette da putti ed inserite negli affreschi e da cui si desume il pensiero conduttore di pura marca neoplatonica.
Vi si esprime cioè il concetto che la relativa perfezione dell’uomo in terra si conquista attraverso l’accordo tra le antiche virtù e la rivelazione cristiana.
Nelle pareti, subito a destra dell’attuale ingresso, è Catone. A sinistra, nella parete lunga, nei due lunettoni, le Virtù cardinale, Prudenza e Giustizia, con i personaggi dell’antichità classica, Fabio Massimo, Socrate, Numa Pompilio, Furio Camillo, Pittaco e Traiano; poi la Fortezza e la Temperanza con altri sei eroi, Lucio Siconio, Leonida, Orazio Coclite, Publio Scipione, Pericle, Cincinnato.
Nella parete di fondo la Trasfigurazione e la Natività, mentre nell’altra parete lunga, solo lo spazio corrispondente la seconda campata è dipinto con sei profeti, sei Sibille e l’Eterno benedicente in alto. Gran parte di questi affreschi fu direttamente eseguita da Pietro Perugino.
L’artista si servì di collaboratori (i documenti fanno i nomi di Giovanni, di Francesco Ciambella detto il Fantasia e di Roberto da Montevarchi) ma seppe controllarli perfettamente, tanto è vero che il complesso può venir considerato come una delle più alte manifestazioni della sua arte matura. In passato, in varie parti dell’opera, si sono voluti ravvisare anche altri artisti, tra cui Andrea d’Assisi detto l’Ingegno ed il giovane Raffaello. Tuttavia oggi, anche in seguito ai risultati dell’attuale accurato restauro, tale ipotesi sembrano più difficili a sostenersi, data l’unitarietà di tutto l’insieme.
L’opera era compiuta nel 1500, come dice la tabella del finto pilastro divisorio nella parete di destra, mentre nel 1501 vennero montate le porte lignee eseguite da Antonio da Mercatello, ove secondo alcuni si rintracciano disegni o quanto meno idee dello stesso Perugino. L’artista a conclusione dei lavori si ritrasse in un finto quadretto appeso nel finto pilastro divisorio della parete sinistra. Sotto di esso è una iperbolica iscrizione laudativa che testimonia dell’enorme successo dell’impresa e conferma la gran fama conquistata da Pietro, ritenuto allora da molti il primo pittore d’Italia.
*
Fonte/Sito: Pietro Scarpellini)
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Fine dell’uomo rinascimentale. Le tecnologie cambiano la percezione del mondo. De Kerckhove: anziché guardare, siamo immersi.5 gennaio 2015, di Federico La Sala
Discussioni. L’erede intellettuale di Marshall McLuhan racconta come, mutando il linguaggio, muta la nostra psicologia
Fine dell’uomo rinascimentale
Le tecnologie cambiano la percezione del mondo. De Kerckhove: anziché guardare, siamo immersi
di Massimo Sideri *
Derrick de Kerckhove, considerato l’erede intellettuale di Marshall McLuhan, con il quale ha lavorato a lungo, oggi ha 70 anni e vive tra Toronto e Roma. Una scelta non solo estetica: proprio qui in Italia per de Kerckhove tutto ha avuto inizio in termini di strategia cognitiva. Un tutto che però, con l’avvento della cultura digitale, sta cambiando: per il sociologo dell’arte che ha diretto tra il 1983 e il 2008 il McLuhan Program in Culture and Technology siamo di fronte alla fine dell’uomo rinascimentale.
 «Quello che io chiamo il “punto di essere” - spiega a “la Lettura” - è la risposta al punto di vista del Rinascimento: quest’ultima era la definizione del rapporto tra corpo e spazio, un rapporto nel quale il corpo si trovava al di fuori e lo spazio era l’ambito di osservazione. Tutto questo viene capovolto con la realtà virtuale: invece di trovarci fuori dallo spettacolo penetriamo al suo interno proprio come nel film Avatar. È la sensazione del posto dove si trova il mio corpo a prevalere, una dimensione tattile, ma anche paradossale: è complicato cogliere la dimensione tattile dell’elettricità. Eppure esiste».
«Quello che io chiamo il “punto di essere” - spiega a “la Lettura” - è la risposta al punto di vista del Rinascimento: quest’ultima era la definizione del rapporto tra corpo e spazio, un rapporto nel quale il corpo si trovava al di fuori e lo spazio era l’ambito di osservazione. Tutto questo viene capovolto con la realtà virtuale: invece di trovarci fuori dallo spettacolo penetriamo al suo interno proprio come nel film Avatar. È la sensazione del posto dove si trova il mio corpo a prevalere, una dimensione tattile, ma anche paradossale: è complicato cogliere la dimensione tattile dell’elettricità. Eppure esiste».Il suo «punto di essere» ricorda lo strano mondo degli squali che vivono di percezioni elettriche assorbite da sensori sottocutanei. La virtualità può essere considerata un nuovo «sesto senso»? Non solo, dunque, un mondo che abbiamo costruito all’interno delle macchine, ma un modo del tutto nuovo di percepire dell’essere umano?
«Sì certamente. Ma non direi un sesto senso quanto un senso generale, come l’esternalizzazione del senso comune, una situazione totalmente nuova. Il punto di vista è quello che abbiamo normalmente come strategia di conoscenza: siamo sempre, mentalmente o fisicamente, di fronte a qualcosa da giudicare. Tutto questo è nato nel Rinascimento. Certo, c’era anche prima, ma è stato teorizzato nel Rinascimento da artisti come Masaccio».
Ora quell’uomo rinascimentale sta morendo?
«Per arrivare al “punto di essere” immaginate che la vostra fonte di esperienza nel mondo, invece che nella vostra testa e negli occhi, sia nel corpo. È una percezione che abbiamo perso perché obnubilati dal punto di vista. Il trompe-l’oeil ha represso gli altri sensi. Ora, la realtà virtuale è già passata di moda ma continua ad avere un impatto epistemologico, fa vedere che penetriamo nello spettacolo invece di essere buttati fuori. È simbolica della nostra presenza immersiva nella globalità dell’informazione. Dal telegrafo ai Big Data il nuovo inconscio si è trasformato: non è più quello di Freud ma è un inconscio digitale dal quale siamo bagnati continuamente. Pensate ai nostri smartphone, con i quali siamo seguiti e ricordati da qualche parte online. È un’ombra elettronica che ci precede: se voglio sapere qualcosa di te vado su Google prima di vederti».
La tecnologia touch screen che usiamo ormai senza pensarci, in qualche maniera ci ha permesso di riscoprire il tatto, la centralità della mano nell’esperienza umana?
«Sì e no, perché è un’esperienza paradidossale: il tatto sta prendendo nuove proprietà».
Nei suoi libri e nelle sue ricerche emerge la passione per l’alfabeto. Oggi siamo, per certi versi, già nell’era della post-scrittura. Le tecnologie touch screen nascondono percorsi che a noi possono apparire misteriosi ma che per dei bambini di 5-6 anni non hanno segreti. Siamo di fronte a una generazione per cui la scrittura non è così centrale. Noi se non leggevamo non imparavamo. Loro sembrano potere imparare senza leggere...
«Questo può essere parte dei problemi che derivano dalle nuove tecnologie. L’immaginario e le strutture cognitive dipendono molto dalle tecnologie che trasmettono il linguaggio. È quella che io chiamo psicotecnologia, perché il modo con cui arriva il linguaggio determina anche le competenze per usarlo. Nella cultura orale il linguaggio era fuori dai corpi ed era fatto di comandi, rapporti condivisi. Nel momento in cui l’alfabeto ha portato il linguaggio fuori dal corpo facendolo diventare silenzioso ce ne siamo riappropriati. Non siamo più servitori, ma controllori del destino privato: posso scrivere anche solo una lista delle cose da comprare nel negozio, ma in realtà sto scrivendo il mio destino. Ma che cosa succede oggi? Condividiamo un linguaggio elettronico incredibilmente veloce e creativo, un matrimonio tra il massimo della velocità, quella della luce, e il massimo della complessità, quella del linguaggio, iniziato già con il telegrafo. Ora però questo linguaggio elettronico è di nuovo fuori e porta con sé anche l’aspetto privato, costringendoci a immaginare un’etica della trasparenza: come comportarsi quando si sa tutto su di te? Comunque - per tornare ai bambini - è vero: la nostra conoscenza di adulti passa più attraverso la lettura».
Le abitudini cambiano anche in altre fasce di età: nel campus di Google si chatta pur trovandosi uno di fronte all’altro. Per la nostra cultura è quasi un gesto di maleducazione.
«È quasi maleducato, sì, ma è pertinente per una cultura che ha messo il linguaggio dentro il sistema di comunicazione elettronico. Il nuovo linguaggio si riduce: è molto più facile parlare con 140 caratteri perché a un certo livello il linguaggio si organizza diversamente. In Snapchat il linguaggio sparisce, non lascia traccia. I ragazzi con questa applicazione vogliono dare una certa oralità al discorso scritto».
Soprattutto vogliono nascondere le prove di cosa hanno fatto o detto...
«Sì, e fanno questo perché siamo nell’era del “capitale reputazionale”. Più importante del denaro e della conoscenza, la reputazione oggi diventa la vecchia vergogna del mondo orale, da cui viene il senso di colpa. Si parla già oggi di una nuova aristocrazia, l’aristocratico è una persona per bene dal momento che si può sapere tutto su di noi. La reputazione può essere usata come moneta di scambio».
È dunque una nuova struttura economica: non è solo l’evoluzione, grazie al digitale, del capitalismo.
«Sì, come nel crowdfunding: non ho soldi ma ho gli amici che possono vedere il progetto e raccomandarlo. Il capitale degli amici si può trasformare in denaro. Funziona perché è un’economia nuova, personale. L’investimento è anche emozionale. Un altro esempio di nuova economia è quello della stampante 3D. Consiglio di regalarne una ai figli per Natale. Come il crowdfunding redistribuisce le fonti dell’economia, la stampante 3D redistribuisce le fonti delle manifatture e le ridemocratizza. È un dono cognitivo, il passaggio dal punto di vista al “punto di essere”, dove la sensibilità 3D già precede la possibilità del 3D».
Massimo Sideri
*
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- ECUMENISMO ALL’INSEGNA DEL CADUCEO DI ERMES: INCONTRO DI FRANCESCO E BARTOLOMEO I. Intervista a Chryssavgis (Patriarcato Costantinopoli)9 dicembre 2014, di Federico La Sala
A Istanbul l’unità dei cristiani è più vicina
Chryssavgis (Patriarcato Costantinopoli): "l’immagine dei due leader che pregano insieme ricorda al mondo che lavorare per la pace e la giustizia è un obbligo"
di CHIARA SANTOMIERO (www.aleteia.org, 30.11.2014 (ripresa senza le foto - da vedersi, ovviamente!).)
Un evento storico, ha definito lo stesso patriarca ecumenico Bartolomeo I, la visita di papa Francesco in Turchia per la ricorrenza della solennità di S. Andrea, che costituisce la prosecuzione del cammino di amichevoli rapporti tra le due chiese e un buon auspicio per il futuro del completo ristabilimento dell’unità. Un futuro che sembra ancora più a portata di mano grazie all’amicizia personale tra le due autorità religiose, come conferma l’arcidiacono John Chryssavgis, consulente teologico del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli che Aleteia ha incontrato durante i giorni della permanenza in Turchia del pontefice.
Quale valore assume la visita di papa Francesco al patriarca Bartolomeo I e quelle del patriarca a lui, quasi una sorta di "ecumenismo delle visite"?
Chryssavgis: La visita di papa Francesco si inserisce nella tradizione dei viaggi dei pontefici a Istanbul, subito dopo la loro elezione, come espressione dell’impegno per la sacra causa dell’unità. Papa Francesco è il terzo pontefice a seguire la tradizione, dopo papa Giovanni Paolo II nel 1979 e Benedetto XVI nel 2006. Naturalmente, sebbene ciò che ci unisce sia molto più di ciò che ci divide, restano ancora i temi critici del primato e della collegialità, che sono sul tavolo di discussione del dialogo teologico ufficiale tra le due chiese. Tuttavia papa Francesco e il patriarca Bartolomeo si incontrano in questi giorni per la quarta volta dall’elezione, oltre ogni precedente, confermando la fedeltà dei due leader alla preghiera di Cristo sui suoi discepoli "che siano una cosa sola".
L’amicizia personale tra il papa e il patriarca quale influenza ha sul dialogo tra teologi considerato che sembra difficile trovare “reali soluzioni” come è evidenziato dal lavoro della Commissione teologica mista?
Chryssavgis: In questi ultimi mesi, il papa e il patriarca hanno sigillato la loro personale amicizia e il fraterno impegno per una testimonianza di unità nel mondo contemporaneo e nella chiesa. Il significato di questi incontri è immenso. Dobbiamo ricordare che, per novecento anni, c’era scarsa o nessuna comunicazione tra le due chiese. Il fatto che, oggi, le due "chiese sorelle" si scambino visite ufficiali, organizzino eventi insieme e producano dichiarazioni comuni, è un chiaro segno di cambiamento di mentalità e comportamenti. L’obiettivo finale è ristabilire la completa unità e condividere in pienezza i sacramenti. Ma la visita di papa Francesco a Istanbul dimostra che le antiche polemiche e i sospetti del passato sono stati superati. Inoltre, anche se non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo dell’unità dei cristiani, possiamo continuare a "camminare nella carità" (Ef. 5,2), secondo il motto della visita di quest’anno del papa al Patriarcato Ecumenico.
Cosa si aspettano i cristiani di Turchia da questa visita?
Chryssavgis: In anni recenti, ci sono stati molti cambiamenti in positivo nelle relazioni tra il governo turco e i cristiani ortodossi di questo paese. Numerose proprietà sono state restituite alle minoranze non musulmane e c’è meno ingerenza nelle questioni interne della Chiesa. Tuttavia, la Scuola teologica di Halki (n.d.r il seminario è stato chiuso dalle autorità turche come conseguenza di una controversia giuridica sulla natura dell’istituzione), si pone come un potente e doloroso ricordo del proseguire delle restrizioni religiose in Turchia. La verità è che la libertà di religione non può essere separata dalla libertà di insegnare religione. Del resto, il governo turco avrebbe molto da guadagnare da un Halki aperto, da un seminario che storicamente ha formato il clero con la maggiore apertura mentale del mondo, tra cui l’attuale patriarca ecumenico Bartolomeo.
Quali argomenti potrebbero entrare nella dichiarazione congiunta finale?
Chryssavgis: Nella dichiarazione congiunta, oltre all’accento sul rafforzamento delle relazioni tra cristiani, in particolare tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa, sono certo che i due profetici leader si concentreranno su come annunciare il Vangelo nel mondo contemporaneo, soprattutto alla luce delle sfide che il mondo sta affrontando. Di certo essi esprimeranno la loro preoccupazione e lo sgomento per la brutale persecuzione dei cristiani nella regione in cui il cristianesimo è nato - come l’Iraq e la Siria, ma più in generale il Medio Oriente - e dove la popolazione cristiana è drasticamente diminuita. Si deve ricordare che, insieme, le due chiese rappresentano circa due miliardi di fedeli. E in un’epoca di così grande fermento e divisione, l’immagine di loro due in piedi mentre pregano insieme servirà per ricordare al mondo che siamo chiamati - anzi è un obbligo - a lavorare insieme per la pace e la giustizia nel nostro mondo.
Il rapporto con la Chiesa cattolica entrerà nella riflessione del Sinodo pan-ortodosso del 2016?
Chryssavgis: Il Grande Concilio del 2016 radunerà per la prima volta i rappresentanti di tutte le quattordici chiese autocefale ortodosse. La convocazione stessa di un grande concilio generale è di fatto senza precedenti, perché l’incontro sarà molto più rappresentativo di qualsiasi altro concilio mai convocato in passato. Uno degli argomenti più importanti che verrà affrontato nel Grande Sinodo sarà il rapporto tra la cristianità ortodossa e le altre confessioni cristiane, così come con le altre comunità religiose. Tra queste relazioni, il dialogo di amore e verità con la Chiesa cattolica di Roma occupa un posto speciale nel cuore del Patriarcato ecumenico. Sono sicuro che il Grande Concilio capirà quanto sia cruciale conservare una linea comune positiva nella relazione con la Chiesa di Roma e formare in modo collettivo i fedeli sull’importanza di lavorare per il ristabilimento dell’unità nella fede e nei sacramenti.
E’ in programma di celebrare insieme i 1700 anni del primo Concilio ecumenico di Nicea, celebrato quando le chiese erano ancora unite?
Chryssavgis: La possibilità di un evento comune nel 2025, per commemorare e celebrare l’anniversario del Concilio di Nicea è stata presa in considerazione; tuttavia non ci sono programmi concreti o nell’immediato in proposito. Sarebbe chiaramente, però, un’occasione importante per segnare una tappa fondamentale nella storia della Chiesa cristiana.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO ---- Sibille e profeti oggi. L’onda lunga del Rinascimento (di Nicola Fanizza)25 giugno 2014
Sibille e profeti oggi. L’onda lunga del Rinascimento
di Nicola Fanizza
(L’Acropoli, n. 3, maggio 2014,
rivista bimestrale diretta da Giuseppe Galasso,
Rubbettino Editore)
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- IL PROBLEMA DEL SIGNIFICATO DEL RINASCIMENTO NELLA STORIA EUROPEA RIAPERTO ORA DA JACQUES LE GOFF (di Michele Ciliberto - Eterno Rinascimento)26 gennaio 2014, di Federico La Sala
 Eterno Rinascimento
Eterno Rinascimento
 Le Goff lo cancella ma «l’era nuova» si decifra in chiave soprattutto politica
Le Goff lo cancella ma «l’era nuova» si decifra in chiave soprattutto politica
 L’oggetto del contendere è l’interpretazione della «identità» della cultura e della «coscienza» d’Europa
L’oggetto del contendere è l’interpretazione della «identità» della cultura e della «coscienza» d’Europadi Michele Ciliberto (l’Unità, 26.01.2014)
IL PROBLEMA DEL SIGNIFICATO DEL RINASCIMENTO NELLA STORIA EUROPEA RIAPERTO ORA DA JACQUES LE GOFF CON IL SUO INTERVENTO SUL «MESSAGGERO» È ASSAI ANTICO: per molti aspetti sono stati proprio gli umanisti a costruire la ideologia della Rinascenza, cioè di una «età nuova» frontalmente opposta ai «secoli bui» del Medioevo. Sono poi stati gli illuministi -in modo particolare d’Alembert nel Discorso preliminare alla Enciclopedia a sistemare il concetto sul piano filosoficostorico individuando nella «rinascita» italiana delle arti lettere l’«aurora» del «sole» che si sarebbe poi compiutamente dispiegato nell’epoca dei lumi.
Come dimostrano questi autori, il Rinascimento non è mai stato un concetto storiografico di carattere descrittivo, ma fin dall’inizio ha espresso, già con il nome, un giudizio di «valore» appunto, il «rinascere» -, ed è in questi termini che è diventato un archetipo della coscienza e della autobiografia dei «moderni» dal Quattrocento al XVII secolo, ed oltre.
È stato però proprio questo elemento fortemente «ideologico» che ha complicato la discussione sul Rinascimento, perché in essa si sono intrecciate valutazioni di ordine etico-politico e giudizi di ordine storiografico, sia negli apologeti dell’«età nuova» che negli studiosi che, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, hanno insistito sulla continuità fra Medio e umanesimo, sottolineando la genesi medievale dello stesso termine che aveva identificato fin dall’inizio e in chiave polemica l’età nuova : renovatio, rinascentia.
Anche nei più autorevoli rappresentanti di questa tendenza, come ad esempio Konrad Burdach è però chiaro l’intreccio tra motivi ideologici e giudizi storiografici, come appare assai evidente dalla polemica che egli svolge, simmetricamente, sia contro il Rinascimento che l’Illuminismo. Proprio per questo alcuni storici hanno addirittura proposto di eliminare il termine Rinascimento, sostituendolo con quello di «età umanistica» un lungo periodo della storia europea che andrebbe da Petrarca fino a Rousseau appunto dal Rinascimento all’Illuminismo. Ma è una proposta che, comprensibilmente, non ha avuto successo.
Di «continuità» o «discontinuità» si discute, dunque, da molto tempo. Ma per capire la lunga durata e la asprezza di questa discussione occorre tenere presente l’interpretazione che è stata data prima dagli Illuministi, poi nell’Ottocento del Rinascimento come «genesi» del «mondo moderno».
Ciò di cui si discute attraverso il Rinascimento è, precisamente, il carattere, e il significato, di quella che con termine sommario si è soliti chiamare «modernità». Questa è stato, in sostanza, il vero oggetto del contendere; ed esso naturalmente, non riguarda, ovviamente, solo il campo storiografico: qui in discussione è la interpretazione della «identità» della cultura e della «coscienza» europea, definita, a seconda dei momenti storici, secondo parametri differenti. Dalla seconda metà del Novecento, ad esempio, alla periodizzazione classica del «mondo moderno» incentrata sul Rinascimento se ne è affiancata, fino a sostituirla, un’altra che fa capo al paradigma della «rivoluzione scientifica» moderna.
Personalmente, sono persuaso che siano problemi, e discussioni, di cui sarebbe bene liberarsi se si vuole aprire una nuova stagione negli studi rinascimentali, ponendo in termini nuovi anche la questione della «continuità» della storia europea e quello del significato del Rinascimento, chiarendo però, in via preliminare, un punto.
Sul piano storico sono individuabili, senza dubbio, molte «rinascite», a cominciare da quella del XII secolo, su cui insistono molto gli storici francesi; ma il Rinascimento italiano è stato un fenomeno assai più importante ed significativo, ed ha inciso a fondo nella costituzione della «coscienza» europea. Quando gli umanisti parlavano di «età nuova» e gli illuministi di «aurora cinquecentesca» avevano ragione; anche se nel pieno di una grande battaglia culturale ed etico-politica enfatizzavano fortemente la rottura con i «secoli bui».
In breve: la «rinascita» è esistita, sul piano storico, anche se ha dato origine a una secolare «tradizione» storiografica che ne ha selezionato temi e motivi alla luce di quella che si può chiamare l’«autobiografia» dei moderni, espressa nel modo più rigoroso e coinvolgente dagli Illuministi.
Oggi però il problema essenziale è un altro, e risiede nel guardare al Rinascimento per quello che esso è stato, liberandosi proprio dal peso di una «tradizione» che ha condizionato a fondo questi studi e che è ormai non ha più molto da dire. A mio giudizio, è su queste nuove basirigorosamente storiche che deve essere affrontato il problema del «significato» del Rinascimento nella storia europea, al quale fa riferimento Le Goff, analizzando a questa luce anche il problema della «continuità» europea, e distinguendone forme e livelli.
Qualche esempio. Si sono consumati fiumi di inchiostro per indagare i rapporti tra Rinascimento e «scienza moderna» , dando risposte differenti o, addirittura, opposte a cominciare dal problema del rapporto tra «ermetismo» e «rivoluzione scientifica» moderna. \Tra Machiavelli o Bruno e il concetto di «natura» di Spinoza o Cartesio c’è una differenza radicale e insuperabile, come del resto Cartesio sapeva per primo e assai bene. Cercare di Individuare «continuità» su questo piano non serve, se non a creare, o perpetuare, falsi problemi.
Ma dal punto di vista politico ed etico-politico le cose stanno in modo assai diverso, come dimostra, ad esempio, il fatto che Spinoza nel Trattato politico assuma proprio Machiavelli come uno dei suoi principali interlocutori sulla base di un riconoscimento che sotto la sua penna assume un valore eccezionale: «risulta che stava dalla parte della libertà».
Sul terreno storico è un problema affascinante sul quale occorrerebbe riflettere anche dal punto di vista del metodo: l’adesione ad ontologie diverse ed anche opposte visibile, in questo caso, sul piano della concezione della natura e della scienza non toglie e non ostacola, la convergenza su problemi etici e politici fondamentali. La mancata distinzione tra questi due livelli genera, però, una quantità di discussioni interessati, certo, sul piano storiografico, e ideologico; ma inconcludenti sul piano storico.
Questo, a mio parere, è oggi il compito della ricerca sul significato del Rinascimento nel «mondo moderno»: distinguere piani e livelli e riuscire a individuare nelle differenze, quando e dove ci siano, motivi ed elementi di affinità o convergenza, considerando come una «fonte», e solo in quanto tale, la «tradizione» costruita dai «moderni». I discorsi generali sono importanti e talvolta divertenti; ma rischiano spesso di essere generici, e perciò inutili sul piano storico, si intende.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- RAFFAELLO A MILANO: AUGUSTO, LA SIBILLA TIBURTINA, E LA "MADONNA DI FOLIGNO".9 dicembre 2013, di Federico La Sala
RAFFAELLO A MILANO. LA "MADONNA DI FOLIGNO" A PALAZZO MARINO
MADONNA DI FOLIGNO
Note per decifrare il significato del quadro:
Commissionata nel 1511 dal segretario papale Sigismondo de’ Conti per la chiesa dell’Aracoeli la pala raffigura la visione della Vergine che Augusto ebbe il giorno della nascita di Cristo ... La chiave per comprendere l’apparizione si trova nella Legenda Aurea di Jacopo da Varazze (cfr. Carlo Carminati, L’enigma del fulmine, Il Sole-24 0re, 08.12.2013, p. 37)
Nella sua Legenda Aurea, Jacopo da Varagine [Varazze] così scrive: "Narra papa Innocenzo III che il senato voleva adorare come un dio Ottaviano per aver riunito e pacificato tutto il mondo; ma il prudente imperatore non volle usurpare il nome di immortale poiché ben sapeva di essere come uomo, mortale. Insistevano i senatori nel loro proposito onde Ottaviano interrogò la Sibilla per sapere se mai sarebbe nato nel mondo qualcuno più grande di lui.
 Era il giorno della Natività di Cristo e la Sibilla si trovava in una stanza, sola con l’imperatore: ed ecco apparire un cerchio d’oro attorno al sole e in questo cerchio una vergine bellissima con un fanciullo in grembo. La Sibilla mostrò questo portento all’imperatore: mentre costui teneva gli occhi fissi alla visione sentì una voce che diceva: - Questa è l’ara del cielo! -. Esclamò allora la Sibilla: - Questo fanciullo è più grande di te; adoralo -.
Era il giorno della Natività di Cristo e la Sibilla si trovava in una stanza, sola con l’imperatore: ed ecco apparire un cerchio d’oro attorno al sole e in questo cerchio una vergine bellissima con un fanciullo in grembo. La Sibilla mostrò questo portento all’imperatore: mentre costui teneva gli occhi fissi alla visione sentì una voce che diceva: - Questa è l’ara del cielo! -. Esclamò allora la Sibilla: - Questo fanciullo è più grande di te; adoralo -.
 La stanza dove avvenne tale fatto è stata poi consacrata alla Madonna ed ora si chiama Santa Maria Ara Coeli.
La stanza dove avvenne tale fatto è stata poi consacrata alla Madonna ed ora si chiama Santa Maria Ara Coeli.
 Timoteo ci dice di aver trovato negli antichi libri romani lo stesso fatto raccontato in modo diverso: dopo trentacinque anni di regno, Ottaviano salì in Campidoglio e chiese agli dei chi avrebbe retto l’impero dopo di lui. Udì in risposta queste parole: - Un fanciullo celeste, figlio del Dio vivente, nato da una vergine immacolata -. Ottaviano fece allora costruire un altare e vi fece scolpire queste parole: - Questo è l’altare del figlio del Dio vivente - (...)" (Jacopo da Varagine, Legenda Aurea, Libreria Editrice Fiorentina, p. 52 s.)
Timoteo ci dice di aver trovato negli antichi libri romani lo stesso fatto raccontato in modo diverso: dopo trentacinque anni di regno, Ottaviano salì in Campidoglio e chiese agli dei chi avrebbe retto l’impero dopo di lui. Udì in risposta queste parole: - Un fanciullo celeste, figlio del Dio vivente, nato da una vergine immacolata -. Ottaviano fece allora costruire un altare e vi fece scolpire queste parole: - Questo è l’altare del figlio del Dio vivente - (...)" (Jacopo da Varagine, Legenda Aurea, Libreria Editrice Fiorentina, p. 52 s.)
SIBILLA TIBURTINA *
[...] Nella seconda metà del IV secolo apparve dunque in oriente una profezia sibillina ambientata a Roma, che ha avuto ampia diffusione anche in occidente, dove è stata tradotta in latino e dove, lungo i secoli, è stata oggetto di varie riscritture. Più di un centinaio sono i manoscritti noti che ne conservano il testo, che fu ricopiato ininterrottamente dall’XI fino agli inizi del XVI secolo. Le maggiori versioni latine furono prodotte tra l’XI e il XII secolo.
Gli oracoli sibillini godettero dunque di grande diffusione nel Medioevo. Nella tradizione greca non si parla mai esplicitamente della Sibilla Tiburtina; tuttavia, come accennato, la veggente pronunzia il suo oracolo a Roma: la profetessa rivela ad Augusto l’avvento prossimo del figlio di Dio. Di questo celeberrimo racconto, sono note due differenti versioni, una diffusa in oriente e l’altra in occidente. Nella versione orientale, attestata nel VI secolo dal Chronicon di Giovanni Malalas, autrice della rivelazione non è una Sibilla, bensì la Pizia: è a lei, infatti che si sarebbe rivolto Augusto per conoscere il nome del proprio successore. La sacerdotessa di Apollo, simbolo di tutti gli oracoli pagani, ridotti al silenzio dall’avvento di Cristo, avrebbe detto all’imperatore di allontanarsi dagli altari, perché un fanciullo ebreo le imponeva ormai di tornarsene nell’Ade. L’imperatore avrebbe in seguito eretto un altare sul Campidoglio dedicato al figlio di Dio.
Il venerabile Beda (672 -735 d. C.), invece, attesta nella sua opera che tale oracolo fosse attribuito alla Sibilla Tiburtina e non alla Pizia.
A ricordo dell’ evento, per molti secoli, i francescani della Chiesa portavano in processione un’insegna della Sibilla che indicava un cerchio all’interno del quale era rappresentata la Vergine con il bambino in grembo. Tale rappresentazione sarà di grande uso nell’iconografia medievale come specificheremo in seguito. I francescani cantano tuttora tali versi: Stellato hic in circulo Sibyllae tunc oraculo, te vidit, Rex in coelo durante le feste di Natale.
La leggenda godette di enorme fortuna: ad essa si riferisce un sermone sulla Natività di papa Innocenzo III (1198-1216) . Nel XII secolo, nei Cronica imperatorum, la Sibilla Tiburtina figura sia come la profetessa della leggenda dell’Ara coeli, sia come l’interprete del sogno dei nove soli. Tra l’XI e il XII secolo, è attestata la confluenza, sulla figura di una Sibilla chiamata Tiburtina, di tre diverse tradizioni profetiche: il sogno dei nove soli, l’acrostico sul Giudizio Finale e la profezia della nascita di Cristo.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Il libro di Federico La Sala offre un punto di vista raro (di E. C.)27 novembre 2013
Della Terra, il brillante colore
2013, nov 27*
Il libro di Federico La Sala offre un punto di vista raro. Quello di un pensiero maschile che osserva e riflette e su alcuni pilastri del pensero filosofico occidentale in modo non neutro ma a partire dal riconoscimento della propria parzialità - di individuo e di genere.
Il libro si compone di più saggi che affondano nel profondo delle nostre radici culturali come “carotaggi” a campione. La sensazione all’inizio spaesante di saltare da un frammento all’altro in campi diversi del sapere e in momenti diversi della storia è ricomposta nel filo conduttore che pian piano si manifesta. Più che un filo conduttore teorico, la tensione etica, intellettuale, di cuore, di un essere umano in ricerca.
Nella prima parte del testo l’autore si spinge in regioni dove la religione cattolica si intreccia con la tradizione ermetica. Incontriamo Ermete Trismegisto e la grande stagione Rinascimentale poi affogata nel rigore censorio della Controriforma. Incontriamo diverse manifestazioni delle Sibille, qui visibili nella riproduzione di xilografie di Filippo Barberi (1481) - una versione inedita. Percorsi incrociati tra Kabbalah, carmelitani e profeti islamici.
Sembra di navigare su un fiume sotterraneo che congiunge Oriente e Occidente. Così arriviamo alle note su Parmenide, Freud, Kant, Rousseau - tra gli altri. L’autore offre spunti e visioni prendendoli da un bagaglio di conoscenze che spazia dalla storia della religione alla filosofia alla psicoanalisi. Si alternano luce solare e lunare. Tra le tante le citazioni, il ritmo conciso e il gesto schietto, senza pose accademiche, rendono la lettura scorrevole. Nella pennellata di Fulvio Papi nell’introduzione, sulla spinta della lettura di questo “testo in piena”:
La Sala, con una mossa certamente ad effetto e piena di provocazione, dice: “guardiamo il nostro ombelico”, riconosciamoci come figli di una maternità e di una paternità che siano la terra del nostro fiorire e non i luoghi delle nostre scissioni.
 Della Terra, il brillante colore. Parmenide, una “Cappella Sistina” carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barbieri (1481) e la domanda antropologica
Della Terra, il brillante colore. Parmenide, una “Cappella Sistina” carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barbieri (1481) e la domanda antropologica di Federico La Sala,
di Federico La Sala,
 Edizioni Nuove Scritture, Milano, 2013
Edizioni Nuove Scritture, Milano, 2013
 156 p., 15€
156 p., 15€* E.C.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- NUOVA EDIZIONE DEL LAVORO DI FEDERICO LA SALA, "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE".5 settembre 2013
nuova edizione
DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE
PARMENIDE, UNA "CAPPELLA SISTINA" CARMELITANA, LE XILOGRAFIE DI FILIPPO BARBERI E LA DOMANDA ANTROPOLOGICA. Un lavoro di Federico La Sala, con pref. di Fulvio Papi
-
>UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE --- Nuovi studi analizzano l’iconografia della Sistina. Quelle Sibille così maschili a immagine di Dio (di Carlo Alberto Bucci)25 maggio 2013, di Federico La Sala
 Michelangelo e le donne
Michelangelo e le donne
 Quelle Sibille così maschili a immagine di Dio
Quelle Sibille così maschili a immagine di Dio
 Nuovi studi analizzano l’iconografia della Sistina alla luce dell’influenza di Agostino e della riforma
Nuovi studi analizzano l’iconografia della Sistina alla luce dell’influenza di Agostino e della riforma di Carlo Alberto Bucci (la Repubblica, 25.05.2013)
di Carlo Alberto Bucci (la Repubblica, 25.05.2013)Le parti femminili nel teatro furono per molti secoli interpretate esclusivamente da attori maschi. Le donne non erano giudicate all’altezza di quel podio. Ma nella scena pittorica della Genesi, liberamente e magistralmente ribaltata sulla volta della Sistina cancellando nel 1508 il vecchio cielo stellato, che necessità aveva Michelangelo di dare alle Sibille e alle altre eroine dell’Antico Testamento il corpo muscoloso di un “palestrato”? Le ragioni della mascolinità del femminino michelangiolesco, addirittura esibita nella cappella dei conclavi in Vaticano, non sfuggono all’immagine caricaturale di un mondo tutto virile quasi fosse imposto a Buonarroti dalla propria omosessualità. Come se l’immenso artista toscano non fosse stato in grado di contemplare e rappresentare anche una bellezza altra da sé e dall’amato Tommaso Cavalieri. Di fronte all’evidente, conturbante machismo della sibilla Cumana, e che si riscontra anche già nelle straordinarie braccia virili (per la prima volta nude) della Madonna nel Tondo Doni, si è parlato di «marchio della cultura patriarcale del Rinascimento» (Yael Even) ; di «passione fisica (omoerotica) per il corpo maschile» (Howard Hibbard) ; di «misoginia» (Gill Sauders).
C’è però anche un motivo più profondo per cui la splendida sibilla Libica o la possente, anziana Persica, ma anche Caterina e le altre sante presenti nel Giudizio Universale affrescato dal 1536 sulla parete d’altare della Sistina, hanno il corpo muscoloso dei ragazzi spogliati e presi a modello da Michelangelo nella sua bottega. E si spiega col pensiero di sant’Agostino, attraverso uno dei suoi massimi esegeti del tempo, Egidio da Viterbo: teologo e predicatore caro alla corte di papa Giulio II ma anche interprete nel pensiero neoplatonico al quale si era abbeverato Michelangelo negli anni della formazione fiorentina. «La chiave di volta nell’interpretazione della Sistina è l’imago Dei nell’interpretazione del vescovo di Ippona», dice Costanza Barbieri, che lunedì, alla giornata di studi organizzata dall’Università Europea di Roma, per i 500 anni (1512-2012) della Sistina, terrà un intervento dal titolo Un uomo in una donna, anzi uno dio per la sua bocca parla: sant’Agostino e le donne mascoline di Michelangelo.
La prima parte del titolo è tratta da una poesia scritta dal Buonarroti per una donna, quella Vittoria Colonna che il maestro frequentò a partire dalla seconda metà degli anni Trenta. «In questo sonetto - spiega Barbieri - l’artista rivolge all’amica poetessa un complimento inaspettato. La paragona a un uomo. Di più: a “uno dio” che “per sua bocca parla”, quasi una sibilla. E stare a sentirla è fonte per Michelangelo di una illuminazione così intensa che il maestro si dichiara conquistato: “ond’io per ascoltarla/ son fatto tal, che ma’ più sarò mio».
Questa visione “maschia” delle donne non è una prerogativa di Buonarroti. «No, è un topos letterario. Molti umanisti esaltano la donna colta e letterata trasfor-mandone l’identità sessuale. Ad esempio, Lauro Querini si rivolge con queste parole all’umanista veronese Isotta Nogarola: “Tu sei vittoriosa sulla tua stessa natura perché con singolare zelo e impegno hai ricercato la vera virtù, che è essenzialmente maschile”».
Come le Vergini affettuose di Raffaello, le Madonne materne di Leonardo, per non parlare delle carnosissime Veneri di Tiziano, anche Michelangelo aveva in gioventù - certo, a suo modo - reso femmine le donne. «Infatti, la mascolinizzazione non avviene sistematicamente - interviene Barbieri - e, prima della Sistina, abbiamo figure femminili assolutamente graziose quali la Vergine della Pietà di San Pietro, la Madonna con il Bambino di Bruges o la stessa Eva della Sistina. Ma nella Volta avviene una metamorfosi», precisa la studiosa di iconologia, autrice nel 2004 di un’importante mostra e di un saggio sulla Pietà di Viterbo dipinta, fra il 1512 e il 1516, da Sebastiano del Piombo con l’aiuto di Michelangelo, e su commissione dell’agostiniano Giovanni Botonti.
La città dei Papi è anche il luogo dove dal 1541 Vittoria Colonna visse per tre anni dando vita, con il cardinale inglese Reginald Pole e il protonotario apostolico Pietro Carnesecchi, a quel cenacolo che fu protagonista di un progetto di rinnovamento interno alla Chiesa e che venne tuttavia accusato d’eresia per la contiguità con tesi della la riforma protestante.
Ma torniamo agli anni della Sistina, al 1508 quando papa Giulio II Della Rovere distolse a forza Michelangelo dall’incarico di scolpirgli la tomba per impegnarlo per quattro anni ad affrescare la Volta, e quando Martin Lutero non aveva ancora affisso a Wittemberg le sue clamorose 95 tesi. «Anche Lutero era un agostiniano, e l’agostinianesimo informa le istanze rinnovatrici, e non eretiche, del circolo di Viterbo. Però certo - precisa Barbieri - sant’Agostino è presente nella Sistina, attraverso Michelangelo, in un’altra veste. Secondo Esther Gordon Dotson e Maurizio Calvesi, agostiniana è l’impalcatura teologica che sottende alla Sistina e, possiamo aggiungere, anche la ragione profonda dei mascolinizzati corpi femminili, in una visione che contempla anche la bellezza secondo il pensiero dei platonici».
Al centro di tutto c’è il Dio che ha creato Adamo “a sua immagine e somiglianza” e, attraverso suo Figlio, si è incarnato in un uomo.
«Per san Paolo esiste una sostanziale incompatibilità tra la divinità e la femminilità» spiega Barbieri. Tale da precludere alle donne la resurrezione poiché, secondo l’apostolo, i risorti “saranno conformi all’immagine del Figlio di Dio”, ossia a un maschio. «Sant’Agostino però è convinto che le donne nel giorno del Giudizio risorgeranno conservando la loro identità di genere. Questo elemento cruciale è stato affrontato da Kari Elisabeth Borresen, la prima teologa cattolica a coniugare i gender studies con l’esegesi. Il vescovo d’Ippona risolve il dilemma di san Paolo teorizzando che, mentre l’uomo riflette il suo creatore anima e corpo, la donna è duplice e, mentre rispecchia l’imago dei nell’anima razionale, se ne discosta nel corpo. Come è possibile che le donne - si interroga il dottore della Chiesa - perdano il loro sesso una volta risorte? No, non lo perderanno, ma si conformeranno a una nuova immagine. Per visualizzare questa nuova immagine di una donna più vicina all’immagine di Dio, Michelangelo escogita un corpo femminile mascolinizzato in quanto spiritualizzato, più conforme al Figlio, che aumenta in virilità con l’età e con la saggezza».
Ed è la predicazione di Egidio da Viterbo «ad affrontare all’inizio del ’500 i temi della dignità dell’uomo, della bellezza e armonia del corpo maschile, specchio del suo creatore, in sermoni di fronte alla corte papale».
Alla luce dell’agostinianesimo e del neoplatonismo di Marsilio Ficino sintetizzati dal predicatore agostiniano, Michelangelo trova la giustificazione teologica alla sua visione della centralità della perfetta immagine del maschile, rispecchiamento di quella divina. «E le sue figure femminili - chiosa la studiosa romana - sono infatti tanto più mascolinizzate quanto più si avvicinano spiritualmente a Dio».
Lunedì dalla mattina giornata di studi alla Università Europea di Roma Michelangelo e la Sistina, l’arte e l’esegesi biblica, a cura di Costanza Barbieri e Lucina Vattuone. Interventi di Antonio Paolucci, Silvia Danesi Squarzina, P. Heinrich Pfeiffer, Timothy Verdon, Maurizio Calvesi, Gianluigi Colalucci oltreché di Barbieri e Vattuone.
-
> UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- DONNE E LEADERSHIP. Dichiarazione del Forum 2013 delle teologhe indiane (di Indian Women Thologians’ Forum 2013).24 maggio 2013, di Federico La Sala
 DONNE, UOMINI, E L’USCITA DA INTERI MILLENNI DI "PREISTORIA" E DI "LABIRINTO"- OGGI, 2013 dopo Cristo ....
DONNE, UOMINI, E L’USCITA DA INTERI MILLENNI DI "PREISTORIA" E DI "LABIRINTO"- OGGI, 2013 dopo Cristo ....
 INDIA E CHIESA CATTOLICA: DONNE E LEADERSHIP. Dichiarazione del Forum 2013 delle teologhe indiane di Indian Women Thologians’ Forum 2013
INDIA E CHIESA CATTOLICA: DONNE E LEADERSHIP. Dichiarazione del Forum 2013 delle teologhe indiane di Indian Women Thologians’ Forum 2013
 Condividere la nostra personale esperienza di donne leader in vari ambiti ha rivelato un filo comune dell’esperienza delle donne nella presenza del divino e nella loro capacità di rispondere con fede e coraggio. L’ingiunzione scritturale “egli dominerà su di te” (Gen 3,16) sembra essere la sanzione religiosa che legittima il controllo maschile sulle donne all’interno delle sfere di famiglia, chiesa e società in senso generale.
Condividere la nostra personale esperienza di donne leader in vari ambiti ha rivelato un filo comune dell’esperienza delle donne nella presenza del divino e nella loro capacità di rispondere con fede e coraggio. L’ingiunzione scritturale “egli dominerà su di te” (Gen 3,16) sembra essere la sanzione religiosa che legittima il controllo maschile sulle donne all’interno delle sfere di famiglia, chiesa e società in senso generale.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- LA SCELTA DI ERCOLE. ERCOLE AL BIVIO: LA LEZIONE DI ERWIN PANOFSKY.19 maggio 2013, di Federico La Sala
 ICONOLOGIA, ESTETICA, ED ETICA. I pittori del rinascimento alla mitologia greco-romana, interpretata allegoricamente, affidavano lo stesso ruolo filosofico a essa affidato dalla letteratura.
ICONOLOGIA, ESTETICA, ED ETICA. I pittori del rinascimento alla mitologia greco-romana, interpretata allegoricamente, affidavano lo stesso ruolo filosofico a essa affidato dalla letteratura.
 LA SCELTA DI ERCOLE: LA LEZIONE DI ERWIN PANOFSKY. Note di Antonio Gnoli e Anna Li Vigni
LA SCELTA DI ERCOLE: LA LEZIONE DI ERWIN PANOFSKY. Note di Antonio Gnoli e Anna Li Vigni
 Ercole sapeva scegliere (e fare) la cosa giusta (...) E noi? L’ Italia, maestra dell’ arabesco, ha quasi sempre preferito l’ arte del rimando, come dire: è sempre meglio che la decisione la prenda qualcun’ altro.
Ercole sapeva scegliere (e fare) la cosa giusta (...) E noi? L’ Italia, maestra dell’ arabesco, ha quasi sempre preferito l’ arte del rimando, come dire: è sempre meglio che la decisione la prenda qualcun’ altro.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- AL DI LA’ DI CASAUBON E CESARE BARONIO: LA LEZIONE DI GIAMBATTISTA VICO.19 maggio 2013, di Federico La Sala
OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- Il filo del rispetto che lega le grandi religioni (di Bruno Forte)6 maggio 2013
Il filo del rispetto che lega le grandi religioni
di Bruno Forte (Il Sole 24 Ore, 5 maggio 2013)
«Fra le più alte partecipazioni di pubblico mai registrate». Così commentava la riuscita dell’evento il responsabile della Konrad Adenauer Foundation in Israele, sponsor del convegno internazionale tenutosi in questi giorni a Gerusalemme su «Giovanni XXIII e il popolo ebraico» a cinquant’anni dalla morte del "Papa buono". Ciò che ha sorpreso non è stata tanto la presenza di studiosi di ogni parte del mondo, cui si aggiungeva quella dei membri della commissione congiunta della Santa Sede e del Gran Rabbinato d’Israele, quanto l’interesse che l’iniziativa ha riscosso in ambito ebraico. In realtà, è dal Venerdì Santo del 1959, quando Papa Giovanni da non molto eletto, sorprendendo tutti, aveva voluto che si eliminasse l’aggettivo "perfidi" davanti al termine "Giudei" nella preghiera per il popolo ebraico, che una nuova era ha avuto inizio nelle relazioni fra il popolo da cui è venuto Gesù, e di cui Egli fa parte per sempre, e la Chiesa da Lui voluta, affidata agli apostoli, in particolare a Pietro, il pescatore di Galilea, e ai loro successori.
Dall’insegnamento del disprezzo, che troppo a lungo aveva ispirato l’atteggiamento della maggioranza dei cristiani nei riguardi d’Israele, si è passati al rispetto e all’amicizia fra chi riconosce nell’alleanza mai revocata e nel popolo dei Patriarchi e dei Profeti la radice santa della Chiesa - come fa Paolo nella lettera ai Romani (capitolo 11) - e questo stesso popolo. L’Apostolo sottolinea, inoltre, che non è l’albero a portare la radice, ma questa a portare l’albero! Da una tale consapevolezza deriva un rapporto di coappartenenza e di fiducia tra cristiani ed ebrei, consacrato dal decreto Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, di cui è stato da poco celebrato il cinquantesimo anniversario dall’apertura. Non si può essere discepoli di Gesù e amarlo se non si ama al contempo il popolo da cui è venuto!
Nel clima positivo e stimolante del Convegno anche i lavori ad esso seguiti della Commissione congiunta fra la Santa Sede e il Gran Rabbinato d’Israele si sono occupati dell’attualità del messaggio di Papa Giovanni e del Concilio. Se da una parte si è constatata la straordinaria crescita nella fiducia reciproca fra cristiani ed ebrei a livello ufficiale, grazie anche alla testimonianza dei Papi succedutisi a Roncalli e oggi in particolare ai rapporti che da sempre legano Papa Francesco alla comunità ebraica, molto numerosa a Buenos Aires, dall’altra si è osservato come ci sia ancora bisogno di grande impegno perché la stima reciproca e il rifiuto convinto di ogni antisemitismo pervadano mentalità e costumi.
La visita del Presidente Simon Peres al Papa - coincidente con l’incontro di Gerusalemme - e l’invito rivolto al Vescovo di Roma a visitare Israele, stimolano cristiani ed ebrei a un rinnovato sforzo volto a «educare le rispettive comunità riguardo alla natura, ai contenuti e al significato dei cambiamenti» intercorsi da cinquant’anni a questa parte, come afferma il Comunicato congiunto della riunione della commissione fra la Santa Sede e il Gran Rabbinato. «Il rispetto reciproco e l’amicizia che si è stabilita fra noi in questi anni - aggiunge il testo - implicano la responsabilità di difendere e promuovere reciprocamente il bene dell’altra comunità. Ciò richiede di reagire ai pregiudizi e al disprezzo, in particolare contro ebrei e cristiani. Specialmente là dove una comunità è maggioritaria e ispira l’ethos di una nazione, e l’altra è minoranza vulnerabile, la responsabilità della prima è ancora maggiore». La speranza condivisa è che questo spirito di collaborazione, di rispetto e di comune servizio alla giustizia e alla pace possa estendersi a ogni relazione all’altro: da quella fra israeliani e palestinesi, a quella con lo straniero e il diverso da noi e in ogni parte del mondo, fino a quella - per chiudere con uno sguardo all’attualità italiana - fra avversari politici, abituati fino a ieri al reciproco rigetto e chiamati oggi dalle drammatiche urgenze della crisi economico - sociale, di cui ha saputo farsi voce autorevole il Capo dello Stato, a collaborare con onestà e disponibilità reciproca per il bene comune. A tutti i livelli, insomma, finché non ci sarà riconoscimento e valorizzazione della dignità dell’altro e del diverso, non potranno esserci né giustizia, né crescita, né pace. II Grande Codice dell’ethos che ci unisce - la Bibbia - ne é il testimone assoluto, di cui possono fidarsi tanto gli ebrei, quanto i cristiani, quanto tutti gli uomini e le donne di buona volontà.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- AL NUOVO PAPA, PER NON DIMENTICARE. Francesco, sì, ma con Chiara (di Anne Soupa)15 marzo 2013, di Federico La Sala
Francesco, sì, ma con Chiara
di Anne Soupa
in “quebec.huffingtonpost.ca” del 14 marzo 2013 (traduzione: www.finesettimana.org)
La veloce elezione del papa porta con sé la sua dose di sorpresa e di domande a cui si muore dalla voglia di poter rispondere. Si ha un bel dire che il cardinal Bergoglio era il numero due dell’elezione del 2005, non era comunque tra i favoriti del 2013. Senza dubbio le caratteristiche abbastanza evidenti della sua personalità, grande rigore morale, ascesi, livello intellettuale elevato (gesuita) e forte orientamento a favore dei poveri, mostrano, a specchio, i bisogni urgenti a cui rispondere: ricentramento sull’essenziale, risanamento morale, capacità di discernimento.
Questa maniera di far adottare dai cardinali, questa convinzione che i disordini collettivi devono essere curati innanzitutto con l’esempio di uno solo la cui personalità, la cui esperienza, il cui ardore sono considerati determinanti, mi sembra assolutamente conforme alla grande tradizione della Chiesa e, andando oltre, alla corrente profetica della Bibbia. Il profeta è quella figura unica nella quale si gioca la conversione di tutti. Ora, oggi, è di una conversione gigantesca di cui ha bisogno la Chiesa. Il collegio dei cardinali ha voluto mostrare che l’esempio viene dall’alto.
La lezione mi pare chiara e potrebbe ispirare le politiche di ciascuno di noi, elettore, quando mette la sua scheda nell’urna: non sarebbe fruttuoso, in questi tempi di crisi, che l’esempio venga dai politici stessi? Perché il successo di una politica non viene solo dalla soluzione di un problema tecnico, per la quale basterebbero le competenze, ma anche della capacità di accogliere l’uomo nella sua interezza: non solo colui che guida, ma anche coloro che, solo se lui mostra l’esempio, lo seguiranno. La vera politica è l’arte di creare dei rapporti, non dimentichiamolo.
Spero quindi che questo papa sappia trascinare con sé molti fedeli nella conversione che intraprenderà. Allora, il problema sarà di non fare di questa figura emblematica il padre, il capo, l’idolo, bensì il fratello. Anche in questo, i pochi indizi che abbiamo già, sono chiari.
Questo papa si chiama Francesco, in riferimento al poverello di Assisi, il campione della fraternità, l’uomo che non ha mai voluto essere prete per non rischiare di creare la minima distanza coi suoi fratelli!
Se il nuovo papa riesce a restare l’uomo che incarna la conversione della Chiesa senza cadere nella trappola della “papolatria”, cosa che il suo primo messaggio fa pensare (non ha pronunciato la parola papa, ma quella di vescovo di Roma), avremo guadagnato qualcosa. Che cosa?
Forse l’inizio per la Chiesa cattolica di un migliore rapporto con il mondo, il rapporto della fraternità, di cui il vangelo è una inesauribile miniera, nel mondo aperto che è diventato quello in cui viviamo. Nessun dubbio anche che la scelta di un nome che non era ancora mai stato portato sia presagio di questa volontà di fare cose nuove, inedite.
In ogni caso, il riferimento francescano mi sembra di estrema ricchezza e si adatta al meglio alle realtà attuali. Francesco è un grande innovatore, un essere in ascolto dei bisogni nuovi del mondo del suo tempo. È anche il santo che non ha mai represso il suo essere profondo, ma lo ha unificato, accettando il male, la finitudine, il fallimento. Leonardo Boff, il teologo della Liberazione, opponeva il santo “perfetto” che combatteva le sue tendenze “cattive” per raggiungere la perfezione, il cui modello era Carlo Borromeo, a Francesco, modello del santo “unificato”, che accoglie tutti gli aspetti del suo essere e li mette al loro giusto posto.
Nella sensibilità francescana c’è un grande ascolto di se stesso. Sicuramente è ciò che ha fatto dire al cardinal Bergoglio, quando gli avevano proposto un incarico romano, nel 2001: “Per carità, in curia muoio!”
Bella prova di salute! Certamente un tale sussulto fa presagire l’estrema vigilanza che questo papa manifesterà nei confronti della curia. Ma non basterà che sia vigilante, occorrerà che non abbassi la guardia, perché la forza della curia è di durare, mentre i papi passano. La curia è una fenice che rinasce dalle proprie ceneri quando la si credeva morta. Basta un solo esempio: i titolari dei dicasteri non danno mai le dimissioni: muoiono con la loro carica.
Sicuramente le donne hanno qualcosa da guadagnare dal fatto che la curia venga governata, perché questo luogo è con tutta evidenza quello della massima paura nei loro confronti. Ma un altro indizio, ancor più simpatico, è a favore di una revisione profonda della concezione inaccettabile che prevale ancora a Roma sulle donne. Ancora una volta, si tratta del riferimento francescano.
L’amicizia di Francesco e di Chiara, nobile ragazza di Assisi che Francesco ha trascinato al suo seguito, è uno dei tesori del cristianesimo. Francesco ha manifestato verso Chiara una estrema delicatezza di sentimenti, una capacità di presenza straordinaria. Non c’è cristiano che non sia nutrito da questa amicizia, tanto essa va al limite dei sentimenti umani, tanto li lascia esprimere senza reprimerli.
Quindi, posso solo rallegrarmi dell’elezione di un papa non compromesso con la curia, armato per il discernimento, che si mette sui passi del Poverello d’Assisi, fratello prima di tutto; “neanche prete”. E, come donna, poiché lo sono, non posso che ripetere: Francesco sì, ma non senza Chiara!
-
>RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- LA SISTINA. ELEZIONE DEL NUOVO PAPA: "SOTTO LO SGUARDO DI DIO". Parla il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci (di Giacomo Gambassi)..11 marzo 2013, di Federico La Sala
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
LA SISTINA
Sotto lo sguardo di Dio
di Giacomo Gambassi (Avvenire, 11 marzo 2013)
Varcheranno la soglia della Cappella Sistina in processione invocando lo Spirito Santo con il canto del Veni Creator. «E, quando i cardinali elettori entreranno nella sala, il loro sguardo si poserà immancabilmente sulla destra. L’immagine che vedranno sarà l’affresco del Perugino con la Consegna delle chiavi a Pietro da parte di Cristo», spiega il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci.
Nel capolavoro del Tibi dabo claves si pone l’accento sull’autorità conferita al primo degli Apostoli. «L’iconografia è talmente chiara che il messaggio può essere percepito da chiunque osservi la scena - afferma Paolucci -. Ed è un richiamo preciso ai cardinali che si appresteranno a scegliere il successore di Pietro».
Per la venticinquesima volta l’aula che porta il nome di papa Sisto IV della Rovere ospiterà il Conclave. Un «rito che da sempre affascina il mondo», sostiene Paolucci, e che fa dell’antica Cappella magna all’interno del Palazzo apostolico un simbolo identitario per la Chiesa cattolica. Giovanni Paolo II l’ha definita il «luogo dell’azione dello Spirito Santo» quando ha inaugurato i restauri degli affreschi nel 1994. E Benedetto XVI ci ha scorto «un invito alla lode» da «elevare al Dio creatore, redentore e giudice dei vivi e dei morti».
È quanto raccontano i cicli pittorici delle sue pareti e del soffitto che l’hanno elevata a gioiello indiscusso dell’arte sacra e della creatività a servizio della gioia di credere. -«Perché qui - assicura il direttore dei Musei Vaticani - sono sintetizzati i contenuti della Rivelazione. Direi che la Sistina è un compendio di tutto quanto può essere raccolto in intere biblioteche ecclesiastiche. Le verità della fede ci parlano da ogni parte. Si va dal fit lux all’Apocalisse, dalle storie di Mosè a quelle di Cristo, fino al Giudizio finale».
Quando gli occhi si alzano verso la volta, i passi della Genesi vengono come narrati dalla mano di Michelangelo che fra il 1508 e il 1512 li ha dipinti su incarico di Giulio II. E quell’incontro fra due dita nella Creazione di Adamo ne rappresentano l’emblema.
 «Sono affreschi che dimostrano la capacità mitopoietica di Michelangelo, ossia la sua abilità nell’inventare situazioni figurative radicalmente inedite - sottolinea Paolucci -. Fino a quel momento la Creazione dell’uomo era stata una traslitterazione del primo libro della Bibbia con Dio che impasta la terra, gli dà forma e soffia il suo Spirito. Invece Michelangelo immagina un uomo già perfettamente formato. E ci propone un Adamo che viene dalla terra ed è parte della terra».
«Sono affreschi che dimostrano la capacità mitopoietica di Michelangelo, ossia la sua abilità nell’inventare situazioni figurative radicalmente inedite - sottolinea Paolucci -. Fino a quel momento la Creazione dell’uomo era stata una traslitterazione del primo libro della Bibbia con Dio che impasta la terra, gli dà forma e soffia il suo Spirito. Invece Michelangelo immagina un uomo già perfettamente formato. E ci propone un Adamo che viene dalla terra ed è parte della terra».Qui avviene l’abbraccio con Dio attraverso il dito del Padre che protende verso di lui. «E, invece di un fluido elettrico, il Signore gli dà anima e destino immortale - spiega l’ex ministro dei Beni culturali -. Si tratta di un’invenzione artistica formidabile che non ha mai cessato di suscitare domande. Recentemente uno studioso americano ha creduto di vedere nei lineamenti di Dio, che giunge in una ghirlanda di angeli ed è avvolto da un mantello rosso gonfiato dal vento della Creazione, il profilo di un cervello umano. Quasi che tutto ciò mostrasse un Michelangelo creazionista. Questo per dire quante interpretazioni ancora oggi consentono di offrire i testi figurativi della Sistina».
Nella Cappella grandi artisti fiorentini e umbri, da Botticelli al Pinturicchio, dal Ghirlandaio a Signorelli, si sono spinti fino all’ultimo orizzonte della teologia, additando l’alfa e l’omega e componendo un’opera dove il bello è epifania della bellezza suprema dell’Onnipotente. Le centoquindici sedie dei cardinali correranno lungo le pareti laterali che ospitano le fasce quattrocentesche con le storie di Mosè e di Cristo.
«È un percorso che sembra una sorta di lectio divina - segnala Paolucci - da cui emerge l’unità dell’Antico e del Nuovo Testamento nel dipanarsi della storia della salvezza, che dagli eventi dell’Esodo porta alla pienezza della rivelazione in Cristo. E nelle storie del grande legislatore e del Figlio di Dio non è difficile cogliere simmetrie e richiami, quasi fossimo in un gioco di specchi.
Ad esempio, se da un lato possiamo notare la chiamata degli Apostoli che ha sullo sfondo il lago di Tiberiade e che quindi rimanda a una vicenda di acqua e di salvezza, abbiamo di fronte il passaggio del Mar Rosso che è anch’esso momento in cui l’acqua salva. E, quando viene proposto il Discorso della montagna di Cristo, troviamo dirimpetto l’episodio di Mosè che consegna le tavole della Legge al popolo d’Israele. Di fatto assistiamo a un’imponente spola all’interno del testo sacro con continue citazioni della Scrittura».
Nelle decorazioni della Sistina, che da martedì torna a essere il più prestigioso seggio elettorale, Giovanni Paolo II leggeva un «inno a Cristo» a cui «tutto conduce». «Il protagonista è il Salvatore, l’Emmanuele, che può avere il volto sia del Cristo atteso, sia di quello incarnato, sia del Cristo giudice», sostiene il direttore dei Musei Vaticani.
E sull’altare ai piedi del Giudizio universale sarà posta l’urna dove i porporati faranno scivolare le schede da un vassoio. «Nella scena di Michelangelo - dichiara Paolucci - siamo di fronte a un Salvatore che possiede in sé un’antica grazia e che ci presenta il mistero della sua gloria legato alla Risurrezione». Un Cristo di cui il genio nato nell’Aretino esalta la sua umanità fra lo splendore dei corpi glorificati e sottoposti alla condanna eterna.
Ed è ammirando anche questo scorcio che papa Wojtyla ha parlato della Sistina come di un «santuario della teologia del corpo umano». «Nell’ambito della luce che proviene da Dio - precisa lo storico dell’arte - anche il corpo umano mantiene la sua magnificenza e la sua dignità. Ciò spinse Michelangelo a un dilagante primato del nudo che lasciò interdetti i benpensanti dell’epoca. Tanto è vero che, dopo la sua morte, si provvide a celare alcune delle nudità più evidenti. Ma Michelangelo aveva buon gioco nel rispondere ai suoi detrattori: dinanzi agli occhi di Dio il corpo può rimanere scoperto e conservare la sua purezza. Un concetto teologicamente ineccepibile che, tuttavia, apparve a molti sconvolgente».
Lo scorso 31 ottobre, per i cinquecento anni dall’inaugurazione della volta, Benedetto XVI ricordava che gli affreschi della Cappella «trovano nella liturgia il loro ambiente vitale». E aggiungeva: «La Sistina, contemplata in preghiera, è ancora più autentica e si rivela in tutta la sua ricchezza». «Sarà l’esperienza che faranno i cardinali elettori - afferma Paolucci - che nell’atteggiamento orante dei giorni del Conclave potranno gustare la bellezza dell’aula e la pregnanza del suo significato». Più difficile per il turista che in questo tempio del colore e delle forme conclude il suo percorso fra i Musei Vaticani. «Eppure gli affreschi hanno un impatto comunicativo che travalica appartenenze e culture. Tutti vengono toccati dall’emozione spirituale che i dipinti provocano. Ed è un effetto psicologico talmente intenso che turba e interroga anche chi non crede».
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- All’interno della chiesa, la questione conciliare torna a riproporsi: e con essa i temi della direzione collegiale, del celibato del clero, del sacerdozio femminile, soprattutto della "chiesa dei poveri" (Franco Cardini - Coraggioso sacrificio o grande sconfitta?)..12 febbraio 2013, di Federico La Sala
Coraggioso sacrificio o grande sconfitta?
di Franco Cardini (il manifesto, 12 febbraio 2013)
Potenza delle coincidenze simboliche, ironia della storia. Il settimo vescovo di Roma dopo quello che fu il protagonista della Conciliazione tra la chiesa e lo stato italiano se ne va - caso, più che raro, propriamente unico nella lunga storia del pontificato - l’11 febbraio, esattamente nell’ottantaquattresimo anniversario di quell’evento: e al tempo stesso due giorni prima della solennità penitenziale delle ceneri. E il giorno dopo, 12 febbraio, martedì grasso, scoppia il gran carnevale romano delle dietrologie e del totopapa. Perché se n’è andato Benedetto XVI? E chi gli terrà dietro? Se i media sembrano impazziti, la follia dei blog trionfa in termini d’un caleidoscopio rabelaisiano.
Il papa se ne va dicendo che lo fa «per il bene della chiesa»: ma, secondo l’antica cosiddetta Profezia di san Malachia, discusso ma comunque inquietante testo forse del XII, forse del XVI secolo, che mette in fila 112 motti latini ciascuno attribuibile alle caratteristiche di altrettanti papi, tanti quanti a metà del XII secolo si diceva dovessero succedersi nella storia sino alla fine della chiesa (e del mondo?), a Benedetto XVI sarebbe spettato l’epiteto di De pace olivae. Non è forse l’olivo il simbolo della pace? E non sarà che papa Ratzinger, andandosene «per il bene della chiesa», se ne sia in realtà andato pro bono pacis, sentendo di non poter più reggere ai conflitti interni alla gerarchia e alla stessa comunità dei credenti: conflitti dei quali egli, a torto o a ragione, si è sentito almeno in parte responsabile, o per aver contribuito a farli maturare o per non riuscire a gestirli?
E adesso, quo vadis, romana ecclesia? Chi sarà il prossimo ad ascendere al soglio del principe degli apostoli? Ratzinger s’immergerà probabilmente nel silenzio, come alcuni anni or sono scelse di fare Carlo Maria Martini, che in molti avrebbero voluto veder papa al suo posto. Continuerà senza dubbio a studiare e a pregare, scriverà magari altri libri, ma forse tornerà ai suoi prediletti conforti, il pianoforte e i gatti. E su chi all’interno del Sacro Collegio gli succederà, dopo un conclave che possiamo aspettarci abbastanza a breve e al quale evidentemente il cardinal Ratzinger non parteciperà, impazza la ridda delle scommesse.
Ci si affida anche alle tradizioni, alle leggende. Come quella che i cognomi dei pontefici si alternino tra quelli con e quelli senza la lettera "r": il che escluderebbe automaticamente, ad esempio, Bertone, il quale è però favorito da due altre circostanze profetico-leggendarie: la prima ch’egli è il camerlengo pontificio (i camerlenghi sono molto favoriti, come futuri papi); la seconda che egli si chiama di primo nome Tarcisio ma di secondo Pietro e ch’è nato in un paese piemontese di nome Romano.
Ora, la Profezia di Malachia nomina come papa successore di De pace olivae un Petrus romanus, e aggiunge che sarà l’ultimo della storia della chiesa. In che senso? In quello che da allora in poi tale istituzione muterà il suo assetto direzionale e non saranno più eletti papi, o in quello che sarà la chiesa stessa a scomparire, o in quello che finirà il mondo?
Ma le profezie riguardano il futuro. Pensiamo al presente. Era parecchio tempo, per la verità, che tra gli addetti ai lavori, i vaticanisti, circolava la dicerìa dell’intenzione del papa di tirarsi da parte. L’abbiamo sottovalutata tutti, anche perché di vere e proprie dimissioni, nella lunga storia del papato, non se ne sono in fondo mai avute. Anche qui, la ridda delle ipotesi è vertiginosa.
Le ragioni gravi di salute - alcuni hanno parlato di problemi oculistici massicci, altri hanno addirittura evocato lo spettro di un diagnosticato Alzheimer - sono state escluse dall’abilissimo responsabile della sala stampa vaticana, padre Lombardi, che è maestro nell’eludere con affabile eleganza le domande compromettenti ma che è di solito molto affidabile: e che ha esplicitamente detto che nessun processo morboso in atto o in vista è stato causa delle decisioni del Santo Padre.
Ma allora, che ruolo hanno le ragioni fisiche nel terzetto di motivi che il papa stesso ha indicato nel suo breve scritto in tedesco che ha fatto seguito alla dichiarazione, pronunziata in latino alla fine del concistoro del mattino dell’11?
Egli ha alluso con sobrietà ma anche con precisione a ragioni fisiche, psichiche e spirituali: in quest’ordine, omettendo però di dirci se stava enumerandole dalle più gravi alle più leggere o viceversa.
Ora, è abbastanza normale che un ultraottantenne accusi qualche acciacco e che senta vivo il desiderio di ritirarsi e di godersi un po’ di riposo. Ma che questa sacrosanta necessità fisica si accompagni a uno stress "psichico" e addirittura "spirituale", quindi - più che a una somma di tensioni e di preoccupazioni - a un vero e proprio turbamento, fa pensare. Il concistoro, cioè la solenne riunione con i cardinali, alla fine del quale si è avuto l’annunzio del papa, lascia quasi ipotizzare che la sua decisione, magari a lungo meditata e maturata, sia arrivata in tempi così inattesi in seguito a un qualche evento all’interno dei lavori della mattinata.
Si discuteva sulla canonizzazione dei "martiri di Otranto", cioè delle vittime di una scorreria turca nel salentino del 1480. Che l’evento abbia provocato fra i cardinali una discussione sull’opportunità o meno di richiamare un episodio che mette di nuovo in luce la lotta tra cristiani e musulmani, con tutti i risvolti attualistici del problema, e che ciò sia stato causa di un nuovo e più duro emergere delle tensioni interne alla chiesa, delle lacerazioni che ormai attraversano la comunità dei fedeli non meno della gerarchia?
O che abbiano qualche ragione gli osservatori statunitensi che hanno interpretato il gesto di papa Ratzinger come un risultato delle difficoltà economiche e finanziarie che ultimamente hanno sfiorato la stessa cattedra di Pietro? Ma anche quei problemi hanno un risvolto ben più profondo, in termini addirittura di concezione del cristianesimo.
Che cosa intendeva dire Paolo VI quando alluse al «fumo di Satana» insinuatosi all’interno della Chiesa? Che rapporto può esserci, ormai, proprio nella compagine dei cattolici - e parlo da cattolico anch’io - tra i soliti ignoti o seminoti che hanno potuto favorire la resistibile ascesa di un Gotti Tedeschi da una parte e gli Enzo Bianchi o gli Andrea Gallo dall’altra? Tra i prelati che benedicono le lobbies multinazionali e i loro business e quelli che stanno dalla parte degli "ultimi", ora che secondo i calcoli più recenti il 90% della popolazione mondiale vivacchia gestendo appena il 10% delle risorse del mondo, e che quindi gli "ultimi" rasentano i 6 miliardi di persone mentre la ricchezza è concentrata nelle mani di poche centinaia tra famiglie e gruppi? Come si può fare tranquillamente il "mestiere di papa", mentre la sofferenza dei poveri arriva davvero a lambire il trono di Dio e grida sul serio vendetta al Suo cospetto?
Accanto al presente, è il passato ad aiutarci: a patto di leggerlo correttamente. Lasciamo perdere il caso di Celestino V, un mistico eremita ignaro delle cose del mondo eletto nel 1294 in quanto considerato docile strumento nelle mani di chi lo avrebbe diretto e ritiratosi dopo cinque mesi per manifeste debolezza e incapacità: sia o no lui - non è mai stato provato con certezza - che Dante indica senza nominarlo come «colui che fece per viltade il gran rifiuto», nulla lo può avvicinare al colto, avveduto, prudente e competentissimo Joseph Ratzinger, che conosceva alla perfezione i meccanismi curiali e che per anni ha retto la chiesa anche prima di esser papa, discretamente nascosto dietro la mole gigantesca di quel Giovanni Paolo II che regnava eccome, ma non governava per nulla.
E lasciamo da parte anche i divertenti casi del fosco e ferreo XI secolo, Benedetto IX che più che dar le dimissioni vendette letteralmente l’ufficio pontificale, per parecchie libbre d’oro, a Gregorio VI suo pupillo che lo acquistò, e che a causa di ciò fu poi deposto per simonia. Ma forse ci aiuta il paragone con il Quattrocento, e più in particolare con il quinquennio 1409-1414, quando lo scandalo dello scisma e della chiesa divisa tra obbedienza romana e obbedienza avignonese causò la deposizione, uno dopo l’altro, di ben tre pontefici (Gregorio XII, Benedetto XIII e Alessandro V) e la convocazione del concilio di Costanza.
Forse è proprio questo, il problema del concilio e quindi della direzione monarchica o collegiale della chiesa, quel che nel Quattrocento fu messo a tacere dopo il 1449 e lo scioglimento del concilio di Basilea, ma che con forza tornò a venir discusso con il vaticano II.
Può darsi che, nelle tensioni vigenti oggi all’interno della chiesa, la questione conciliare sia tornata a riproporsi: e con essa i temi della direzione collegiale, del celibato del clero, del sacerdozio femminile, soprattutto della "chiesa dei poveri".
Dopo l’orgia di bestialità con le quali neocons e teocons, cristianisti libertarians e "atei devoti" ci hanno ammorbato negli ultimi lustri, può darsi che la discussione sul senso da dare al tema dell’Avvento del regno dei cieli all’inizio del III millennio si sia riproposta con forza, e il tempo delle scelte si stia avvicinando. Che un teologo e giurista ultraottantenne non se la sia sentita di esser lui ad affrontare e gestire l’insorgere di queste antiche eppur sempre nuove problematiche, sarebbe più che comprensibile.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- VERSO UN’ERA COLLEGIALE. Uno spettro si aggira nella storia della Chiesa cattolica moderna: il Concilio (di Franco Cardini)13 febbraio 2013, di Federico La Sala
Verso un’era collegiale
di Franco Cardini
in “Quotidiano.Net” (Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione) del 13 febbraio 2013
È ancora presto per aspettarsi risposte sicure o comunque più attendibili e verosimili alla domanda che tutti ci andiamo ponendo in queste ore: quali sono state, nello specifico, le vere grandi ragioni che hanno indotto Joseph Ratzinger a rinunziare al suo alto ufficio?
Dalla ridda delle ipotesi va emergendo una direzione interpretativa che non va sottovalutata: che cioè Benedetto XVI si sia tirato indietro non in quanto disorientato dinanzi all’enigma delle prove che ancora attendono il pontificato e la Chiesa bensì, al contrario, in quanto fin troppo conscio della loro qualità ed entità. Non è escluso che l’autentico nucleo del messaggio inviato con queste dimissioni sia che sta giungendo per l’intera comunità cristiano-cattolica il momento di voltare sul serio pagine.
La ‘Profezia di Malachia’, qualunque sia il valore che vogliamo attribuirle, assegna al prossimo pontefice, Petrus Romanus, il ruolo di ultimo papa: e poi? Fine della Chiesa e magari fine del mondo, si è detto. Ma forse - proseguiamo nel gioco dell’attribuzione di un qualche valore a quell’antico e dubbio testo - ciò cui si allude è semplicemente un sia pure rivoluzionario mutamento istituzionale. È la funzione pontificia che potrebbe venir messa in discussione ed esser fatta oggetto di cambiamenti radicali in un futuro magari prossimo. E potrebb’essere la consapevolezza di questa incombente rivoluzione ad aver suggerito a papa Benedetto che è ormai arrivata l’ora di farsi da parte. È a questo punto più chiaro il senso delle polemiche relative al valore e alla funzione del Concilio Vaticano II, che negli ultimi tempi erano arrivate a un livello d’intensità e di durezza che non si giustificava solo con la coincidenza del cinquantesimo anniversario di quell’evento.
In effetti potremmo affermare, parafrasando Marx ed Engels, che uno spettro si aggira nella storia della Chiesa cattolica moderna: il Concilio. L’assemblea dei capi delle singole comunità (le «chiese» vere e proprie) che nel loro insieme costituivano la comunità dei credenti nel Cristo, si affermò fino dai primi tempi di libera vita della Chiesa a partire dal IV secolo. I vescovi si riunivano periodicamente per regolare le questioni concernenti i dogmi, la liturgia e la disciplina comuni. Tali riunioni riunivano di solito solo alcune circoscrizioni locali, ma in casi di maggior importanza tutti i vescovi del mondo cristiano erano tenuti a partecipare: si aveva allora il «Concilio ecumenico», durante il quale si prendevano le grandi decisioni.
In tutto, la Chiesa ha fino ad oggi tenuto 21 Concilii ecumenici: fondamentali tra essi quelli del IV-V secolo (di Nicea, di Efeso, di Calcedonia), nei quali letteralmente si fondarono dogma, liturgia e disciplina; tra gli altri, ebbero speciale rilievo i quattro Concili lateranensi del 1123, del 1139, del 1179, del 1215, durante i quali si andò affermando, dopo lo scisma che aveva separato dal 1054 la Chiesa greca dalla latina, il principio - già del resto precedentemente proposto - del «primato di Pietro», cioè dell’autorità e del potere del vescovo di Roma come capo effettivo e supremo della compagine ecclesiale latina.
Il nucleo profondo della vita della Chiesa, espressa attraverso i vari Concili, era la continua necessità di riformarne la vita e i costumi. Reformatio è quasi la parola magica che attraversa il mondo ecclesiale soprattutto tra XI e XVI secolo. Ma appunto durante il medioevo apparve sempre più chiaro che autorità personale del vescovo di Roma e autorità collegiale degli altri vescovi erano in obiettivo conflitto tra loro. Esso divenne drammatico nella prima metà del Quattrocento allorché
 dopo il lungo periodo avignonese e il cosiddetto «Grande Scisma d’Occidente» che lo aveva
seguito a ruota, tra 1378 e 1414 - la deposizione l’uno dopo l’altro di ben tre pontefici (Gregorio
XII, Benedetto XIII e Alessandro V) in soli cinque anni tra 1409 e 1414 e la successiva
convocazione di due grandi Concilii, a Costanza fra ’14 e ’17 e a Basilea (poi trasferito a Ferrara e
quindi a Firenze) fra ’39 e ’49, mise talmente in discussione l’autorità papale da consentir la nascita
di una nuova dottrina, detta appunto “conciliarismo”, che postulava la superiorità del Concilio sul
papa in termini di direzione della Chiesa.
dopo il lungo periodo avignonese e il cosiddetto «Grande Scisma d’Occidente» che lo aveva
seguito a ruota, tra 1378 e 1414 - la deposizione l’uno dopo l’altro di ben tre pontefici (Gregorio
XII, Benedetto XIII e Alessandro V) in soli cinque anni tra 1409 e 1414 e la successiva
convocazione di due grandi Concilii, a Costanza fra ’14 e ’17 e a Basilea (poi trasferito a Ferrara e
quindi a Firenze) fra ’39 e ’49, mise talmente in discussione l’autorità papale da consentir la nascita
di una nuova dottrina, detta appunto “conciliarismo”, che postulava la superiorità del Concilio sul
papa in termini di direzione della Chiesa.Una di quelle coincidenze non infrequenti nella storia volle che fosse proprio l’intellettuale che come segretario del Concilio di Basilea aveva contribuito in modo determinante alla nascita della dottrina conciliaristica, il senese Enea Silvio Piccolomini, una volta divenuto papa col nome di Pio II si rivelò il più deciso e feroce paladino del monarchismo pontificio.
Dopo la metà del Quattrocento, i Concilii diventarono molto rari. Il V Concilio lateranense tra 1512 e 1517, che avrebbe dovuto decisamente riformare la Chiesa sconvolta dal malcostume dei pontefici e dei prelati del secolo precedente, si concluse con quella che è passata alla storia come la «Riforma» per eccellenza, la protestante, che coincise peraltro con un grande scisma all’interno della Chiesa d’Occidente.
Dopo allora, il fallimento al suo principale scopo del Concilio di Trento, che si svolse dal 1545 al 1563 con l’iniziale obiettivo del risanamento dello scisma avviato da Lutero, servì quasi da vaccino per i vertici della Chiesa romana: dopo allora non si convocarono più Concilii ecumenici prima del grande Vaticano I del 1870, che fu riunito appositamente per rafforzare l’autorità del papa di Roma e addirittura - in un grave momento di crisi politica, la fine del potere temporale - ne proclamò l’infallibilità ex cathedra.
Il Vaticano II emendò, modificò e corresse l’indirizzo del Concilio precedente e dette vita a una nuova stagione di teorie neoconciliariste, sostenute soprattutto dalla scuola dei teologi e degli storici dossettiani di Bologna. Dopo allora, il lungo pontificato di Giovanni Paolo II coincise con una rinnovata era di forte monarchismo papale, del quale Joseph Ratzinger fu il teologo. Ma è proprio lui, una volta divenuto papa, che dopo un governo di otto anni lascia significativamente l’incarico subito dopo un concistoro di cardinali che (non lo sappiamo) può essere stato tempestoso. E allora, la domanda che è legittimo formulare è questa: che la nuova età della Chiesa, quella che Benedetto XVI ha compreso necessaria ma non si è sentito di gestire, sia quella di una rinnovata proposta conciliaristica di direzione non più monarchica, bensì collegiale della Chiesa cattolica? Il prossimo conclave e il nuovo pontefice risponderanno a questa domanda.
di Franco Cardini
-
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- RIDEFINIRE I FONDAMENTI. La dichiarazione di Torino: «un nuovo Rinascimento per l’Europa». L’atto finale del vertice dei Progressisti europei11 febbraio 2013, di Federico La Sala
 La dichiarazione di Torino: un rinascimento per l’Europa
La dichiarazione di Torino: un rinascimento per l’Europa
 Pubblichiamo l’atto finale del vertice dei Progressisti europei, concluso sabato a Torino
Pubblichiamo l’atto finale del vertice dei Progressisti europei, concluso sabato a Torino «Per una Unione democratica di pace, prosperità e progresso»
«Per una Unione democratica di pace, prosperità e progresso» Completare un’autentica Unione economica e monetaria richiede una revisione dei Trattati
Completare un’autentica Unione economica e monetaria richiede una revisione dei Trattati
 Una Unione democratica è indispensabile per dare agli europei la possibilità di incidere sul mondo *
Una Unione democratica è indispensabile per dare agli europei la possibilità di incidere sul mondo *Il 2013 è un anno cruciale per l’Europa progressista. Dopo le vittorie dei socialisti in Slovacchia, Francia e Romania nel 2012, le elezioni in Italia e Germania potrebbero cambiare gli equilibri in seno al Consiglio europeo, aprendo la strada a una maggioranza progressista dopo le elezioni europee del 2014.
La dichiarazione di Parigi e il lancio dell’iniziativa Renaissance for Europe nel marzo 2012 si sono concentrate sulla necessità di andare oltre le politiche di austerità, delineando i tratti di un nuovo e più equilibrato corso per un’Europa basata su stabilità, crescita e solidarietà. A Torino vogliamo elaborare la nostra visione dell’Europa politica: una Unione della democrazia basata su una sovranità condivisa, che costituisce la condizione essenziale per affrontare la crisi e per restituire potere ai cittadini e fiducia nel progetto europeo. Ciò che vogliamo realizzare è una Unione di progresso e prosperità per tutti, con un forte mandato da parte dei cittadini europei.
RIDEFINIRE I FONDAMENTI: SVILUPPARE LA DEMOCRAZIA
La crisi economica e finanziaria ha evidenziato la debolezza della governance dell’euro. L’introduzione di una moneta comune non è stata seguita dal completamento di una vera unione economica. Quindi, nonostante l’euro sia divenuto un simbolo importante del progresso nell’integrazione, esso non è diventato sinonimo di sicurezza, stabilità e controllo democratico. L’assenza di una adeguata architettura istituzionale si è riflessa in un compromesso tra l’intergovernativismo delle risorse da un lato, e il metodo comunitario delle regole dall’altro. Il primo ha implicato la canalizzazione dell’aiuto finanziario da parte degli Stati membri attraverso organismi intergovernativi. Il secondo, invece, si è tradotto in regole più severe di disciplina fiscale al livello europeo, con la conseguente attuazione delle politiche di austerità.
Questo impianto si è dimostrato inefficace, sia politicamente che economicamente. Non ha migliorato la stabilità finanziaria e la sostenibilità fiscale. Al contrario, ha innescato un circolo vizioso di recessione e peggioramento dei conti pubblici, le cui conseguenze economiche e soprattutto sociali sono devastanti. Il deficit democratico delle politiche europee è arrivato fino agli Stati membri, erodendo il consenso pubblico non solo nei confronti del progetto europeo, ma anche delle stesse democrazie nazionali.
Un’Unione di regole fiscali gestita da tecnocrati non può andare oltre l’austerità e priva i cittadini del proprio diritto all’autodeterminazione. La disciplina di bilancio deve trasmettere un senso di sicurezza, attraverso meccanismi sostenibili e non soggetti a continue negoziazioni tra gli Stati membri e al loro interno. La continua trattativa non fa che minare ulteriormente la solidarietà europea, incentivando un modello di governance fondato sugli equilibri di potere e una gerarchia basata sulla ricchezza, e portando al tempo stesso le democrazie nazionali in rotta di collisione l’una con l’altra, divise tra chi sente di pagare portando il peso delle altre e quante, invece, si sentono governate dalle prime.
Il paradosso è che il tentativo di proteggere la sovranità nazionale ed evitare i trasferimenti fiscali ha generato un sistema di governance meno efficace, più invadente e meno rispettoso della sovranità degli Stati di ogni altro modello federale esistente, e al tempo stesso più oneroso per i contribuenti.
RISTABILIRE LA LEGITTIMITÀ: PIÙ POTERE AGLI EUROPEI
Una autentica Unione economica e monetaria richiede di un diverso modello di governance, che si basi sui seguenti elementi: a) un’attuazione equilibrata del Patto di stabilità e crescita, che riconcili la responsabilità fiscale con la crescita e l’occupazione, salvaguardando gli investimenti e i servizi pubblici e, allo stesso tempo, perseguendo la riduzione del deficit e del debito; b) un coordinamento più forte e più equilibrato delle politiche economiche al livello di Uem e politiche europee nuove e potenziate; c) un’unione bancaria completa, una Banca centrale europea attiva nella promozione della stabilità finanziaria e una effettiva regolamentazione dei mercati, che incentivi gli investimenti a lungo termine e scoraggi la speculazione; d) le politiche economiche devono essere accompagnate da un robusto sistema di politiche sociali responsabili, che divengano obiettivi vincolanti e rispondano agli impegni presi per il progresso e la prosperità.
Questa è la ragione per cui deve essere elaborato un nuovo patto sociale che divenga una garanzia per tutti gli europei. L’autonomia dei partner sociali e il loro ruolo devono essere salvaguardati e rafforzati, favorendo l’emergere di un dialogo sociale europeo; e) un bilancio dell’Unione adeguato, fondato su risorse proprie, per promuovere la crescita e la competitività, per affrontare gli squilibri ciclici e quelli strutturali e sostenere la coesione sociale e territoriale; f) una capacità di emettere eurobond, per dare fondamenta più solide alla solidarietà finanziaria e facilitare il riscatto del debito.
Questo modello di governance richiede una migliore e più chiara divisione delle competenze e delle risorse tra l’Unione e gli Stati membri, oltre a una maggiore legittimità democratica e responsabilità a entrambi i livelli. Non deve fondarsi sul metodo intergovernativo, ma sulle istituzioni europee e sul «metodo comunitario», con una Commissione europea forte da un lato, che agisca come un vero e proprio governo, e una piena codecisione tra il Consiglio e il Parlamento europeo dall’altro. Il bilancio dell’Ue e dell’Uem deve venire da risorse proprie chiaramente legate alla ricchezza generata all’interno dell’Unione e alle specifiche funzioni regolatrici connesse alle competenze dell’Unione stessa. Gli Stati membri devono mantenere la responsabilità dell’attuazione delle linee-guida di politica economica co-decise a Bruxelles e dei bilanci nazionali all’interno dei limiti del quadro fiscale europeo.
Condividere la sovranità su una base democratica è l’unico modo per ripristinarla e dare potere ai cittadini. Il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali dovranno essere le forze motrici di questo processo e dovranno cooperare strettamente, esercitando al tempo stesso le rispettive prerogative sulla base del principio che la legittimità e il controllo democratico devono essere assicurati al livello in cui le decisioni vengono prese e attuate. Il completamento di un’autentica Unione economica e monetaria richiede una revisione dei Trattati. Noi chiediamo la convocazione di una Convenzione nel corso della prossima legislatura, che possa costituire l’avvio di una nuova fase deliberativa sul futuro dell’Europa. Un simile obiettivo deve essere preparato facendo un pronto e pieno ricorso agli strumenti previsti dai Trattati esistenti (dalla cooperazione rafforzata all’articolo 136 del Tfue, alla clausola di flessibilità) e con un ampio dibattito pubblico che coinvolga la società civile, le parti sociali, i partiti politici, il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali. Le fondazioni di ispirazione progressista promuoveranno tale dibattito, fornendo il proprio contributo e le proprie proposte per una vera Unione economica e monetaria in un’Unione democratica.
RIACCENDERE L’AMBIZIONE: RIDARE SPERANZA
Politiche europee migliori e più forti non sono possibili senza una vera politica europea. Un’unione fiscale ed economica, infatti, richiede un’unione politica. Deve emergere una sfera pubblica davvero europea, che valorizzi il ruolo della società civile. Questa unità dei cittadini d’Europa dovrà rispettare pienamente e utilizzare al meglio i valori del pluralismo culturale e della diversità nazionale, portando il dibattito e il processo decisionale dell’Unione lungo assi politico-ideologici transnazionali, invece che lungo le tradizionali divisioni nazionali.
Le elezioni legislative nazionali devono essere concepite come parte integrante del processo politico europeo. A loro volta, le elezioni europee non devono essere più considerate come test di metà mandato per i partiti nazionali nei 28 Paesi membri, bensì come il momento in cui il cittadino europeo sceglie la direzione per l’Europa, offrendo un mandato democratico al Parlamento e al governo europeo.
Il Pse ha già deciso di indicare, prima delle elezioni, il proprio candidato «di punta» per il ruolo di Presidente della Commissione. Invitiamo tutti i partiti europei a fare lo stesso, conformandosi alla risoluzione approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo. La nomina di tali candidati deve essere collegata alla presentazione agli elettori di programmi basati su politiche europee alternative, sottoscritti dai partiti nazionali e dai loro candidati al Parlamento europeo.
La politicizzazione della Commissione e l’europeizzazione delle elezioni del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali sono tappe cruciali verso una Unione politica, ma non sono sufficienti. È necessario promuovere e rafforzare la partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale europeo. L’Iniziativa cittadina europea deve diventare uno strumento ordinario per coinvolgere la società civile e i partiti politici in campagne su base transnazionale. Gli scioperi e le lotte sociali devono essere condotti a livello europeo, controbilanciando con il ruolo dei cittadini e dei lavoratori il crescente peso delle lobby e degli interessi costituiti nelle decisioni dell’Unione. I gruppi socialisti e democratici al Parlamento europeo e nei Parlamenti nazionali devono promuovere una stretta cooperazione sia con il Pse che con i partiti nazionali.
I giovani devono essere la forza portante del processo di costruzione di una vera società europea. Quindi, iniziative fondate su pari e qualificanti opportunità, come la Garanzia europea per i giovani o il programma Erasmus devono essere visti come un investimento nel futuro collettivo dell’Unione. I progressisti devono collaborare per promuovere un dialogo transnazionale e programmi di scambio, che favorirebbero la circolazione orizzontale delle buone pratiche e delle esperienze nazionali, rafforzando lo spirito europeo e la famiglia progressista. È un modo per recuperare il senso della militanza, arricchendola e conferendo una dimensione paneuropea all’attivismo politico. Ciò si potrà realizzare attraverso l’istituzione di un Erasmus progressista militante che, grazie allo sforzo collettivo dei partiti europei, potrà dare la possibilità di effettuare stage e scambi di attivisti tra le organizzazioni nazionali.
L’economia globale richiede una democrazia sovranazionale. Una Unione politica è la condizione per poter dare all’Europa un modello di governance efficace e legittimo, che promuova stabilità, crescita e solidarietà. Una Unione democratica è indispensabile per dare agli europei una voce e la possibilità di incidere sul mondo in cui vivono. L’impegno di «un nuovo Rinascimento per l’Europa» è proposta credibile su come realizzare questo sogno ambizioso.
* l’Unità 11.02.2013
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- GIOVANI E CIVILTA’ DELLE IMMAGINI. UNA SCUOLA "NOVANTICA" PER IL XXI SECOLO. Un’indicazione di Marc Fumaroli9 febbraio 2013, di Federico La Sala
 SCUOLA, SOCIETA’, E RINASCIMENTO - OGGI. Perché la storia dell’arte può offrire lo spunto per inventare la didattica futura ....
SCUOLA, SOCIETA’, E RINASCIMENTO - OGGI. Perché la storia dell’arte può offrire lo spunto per inventare la didattica futura ....
 GIOVANI E CIVILTA’ DELLE IMMAGINI. UNA SCUOLA "NOVANTICA" PER IL XXI SECOLO. Un’indicazione di Marc Fumaroli
GIOVANI E CIVILTA’ DELLE IMMAGINI. UNA SCUOLA "NOVANTICA" PER IL XXI SECOLO. Un’indicazione di Marc Fumaroli
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- E LA RICOSTITUZIONE DELL’ORDINE SACERDOTALE, IERI E OGGI.31 gennaio 2013, di Federico La Sala
 SAN PAOLO, IL ’PARTITO’ SACERDOTALE RICOSTITUITO E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO ROMANO.
SAN PAOLO, IL ’PARTITO’ SACERDOTALE RICOSTITUITO E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO ROMANO.
 LA "DONAZIONE DI PIETRO" - PAOLO: "come Platone (...), afferra l’anima della vita evangelica degli apostoli, delle cristiane e dei cristiani, approfittando delle incertezze e dei tentennamenti di Pietro, si fa apostolo dei pagani e, da cittadino romano, la porta e consegna nelle mani di Roma (...).
LA "DONAZIONE DI PIETRO" - PAOLO: "come Platone (...), afferra l’anima della vita evangelica degli apostoli, delle cristiane e dei cristiani, approfittando delle incertezze e dei tentennamenti di Pietro, si fa apostolo dei pagani e, da cittadino romano, la porta e consegna nelle mani di Roma (...).
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- Non «un deserto, ma un giardino». Se il Paradiso è in questa terra. Le riflessioni sulla preghiera della teologa Adriana Zarri (di Umberto Galimberti).26 gennaio 2013, di Federico La Sala
 Se il Paradiso è in questa terra
Se il Paradiso è in questa terra
 Le riflessioni sulla preghiera della teologa Adriana Zarri
Le riflessioni sulla preghiera della teologa Adriana Zarri di Umberto Galimberti (la Repubblica 26.01.2013)
di Umberto Galimberti (la Repubblica 26.01.2013)«Vi scongiuro fratelli, rimanete fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze». Queste parole di Nietzsche le sento risuonare in ogni pagina del libro di Adriana Zarri, Quasi una preghiera.
Quasi perché siamo soliti chiamare “preghiera” l’invocazione, o la richiesta di grazie, o quelle noiosissime nenie che recitano formule senz’anima, senza partecipazione, senza canto. Queste «formule scritte da altri e assunte da noi senza che spesso riusciamo ad aggiungere nulla di nostro» non sono per Adriana Zarri vere preghiere perché «non consentono un libero e personale esprimerci e parlare col Signore».
Ma perché questa preghiera possa sorgere e scaturire spontanea e sincera con tutta la partecipazione del cuore bisogna ribaltare quella concezione teologica che descrive la terra come «valle di lacrime» o come «esilio», perché, scrive la teologa, monaco ed eremita, Adriana Zarri, se la terra è «la creazione bella e buona predisposta dal Signore per noi», se non è «un deserto, ma un giardino: il giardino dell’Eden», se «il Signore non ci ha messi in esilio, ma ci ha collocati nella nostra patria, nella casa che aveva amorevolmente preparato per noi», allora a questa patria, a questa casa, a questo giardino a questa terra dobbiamo essere fedeli e «pregare Dio per questa terra in senso proprio, questa terra di terra, per questo cielo d’aria e non per quello metaforico popolato dagli angeli, per questo cielo nostro, questo cielo di nuvole e di vento, percorso dalle ali degli uccelli».
Così risuona nelle parole di Adriana Zarri l’invocazione di Nietzsche: «Vi scongiuro fratelli, rimanete fedeli alla terra», ma risuonano anche le «sovraterrene speranze» a cui Nietzsche invita a non credere.
Eppure la fedeltà alla terra di Adriana Zarri fa la sua comparsa anche nelle «sovraterrene speranze» se appena ascoltiamo l’invocazione della sua ultima preghiera: «E questo nostro dolce mondo, ti prego, Dio, fallo risorgere tutto, così com’è, perché è così com’è che noi lo amiamo, ed è così com’è che noi lo attendiamo quando “i cieli nuovi” e “le terre nuove” che ci hai promesso risorgeranno dal gran rogo finale. Ti prego, non dimenticartene, Signore, perché io aspetto di trovarle di là. Se non ci fossero ne resterei delusa, e in paradiso non può esserci delusione».
Possiamo leggere questo libro di Adriana Zarri, che prega il Signore con il canto che si leva dalla contemplazione delle sue creature e delle sue bellezze, che il succedersi delle stagioni offre nella loro varietà, in sintonia con la variazione che caratterizzala la gamma dei nostri sentimenti, come un libro lirico, mistico, non dissimile dalla mistica francescana.
Ma Adriana Zarri non è solo questo. Perché da teologa ha anticipato il Concilio Vaticano II, e da voce libera e forte ha avuto il coraggio di ribaltare quella visione che il cristianesimo, dimentico del Vangelo, ha ereditato da Platone, il quale ha disprezzato la terra e il mondo sensibile per il mondo delle idee collocate sopra il cielo. Questa tradizione greca e non cristiana è stato ripresa da Agostino che ha deprezzato la città terrena per esaltare quella celeste, e da allora in poi la terra è diventata valle di lacrime e di dolore: il dolore che redime. Quasi una preghiera, prima di essere un libro lirico o mistico, è un libro teologico, dove ciò che si chiede è di abbandonare il dualismo platonico e poi cristiano che oppone la terra al cielo, lasciando l’uomo senza quella patria, quella casa, quel giardino che il Signore aveva amorevolmente preparato per lui.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- Il rinnovamento della società e della politica in crisi richiede l’apporto delle donne (di Maria Cristina Bartolomei - Le donne come soggetti, oltre il ruolo di madri e spose).17 gennaio 2013, di Federico La Sala
Le donne come soggetti, oltre il ruolo di madri e spose
di Maria Cristina Bartolomei (“Jesus”, gennaio 2013)
L’atmosfera natalizia colora di sé l’inizio del nuovo anno, proseguendo liturgicamente nella celebrazione della maternità di Maria, della Sacra Famiglia e dell’Epifania. Anche indipendentemente dalla fede, tali festività comunicano un forte messaggio simbolico di attenzione al mistero di vita nuova che ogni neonato reca con sé in dono per tutti, alla famiglia e, in modo tutto particolare, alla figura della madre. Ma quanto tali simboli hanno veramente improntato di sé la nostra civiltà? Gli orrendi crimini che si consumano oggi sui bambini (pedofilia, traffico d’organi, sfruttamento del lavoro, schiavizzazione, prostituzione) sono versioni aggiornate di una violenza sui minori che, semmai, in epoca moderna si è attenuata, e che oggi viene almeno condannata e combattuta sul piano sociale e legislativo.
Sembra invece accrescersi, anziché attenuarsi, la violenza sulle donne, che presenta forme sempre più estreme. Maltrattamenti, stupri, molestie, molte forme di oppressione e schiavizzazione, fino al femminicidio: nel 2012 nella sola Italia più di cento donne sono state uccise da uomini quasi sempre loro partner o familiari. Una strage sulla quale ci si deve interrogare e che impone risposte sul piano del costume e della cultura.
Quando si parla della famiglia non si dovrebbe dimenticare, accanto a tutte le note positive, anche tale nota sinistra: di famiglia le donne non solo vivono, ma anche muoiono. Per questo, la stessa esaltazione della figura materna può rivelarsi un’arma a doppio taglio, giacché rischia di ridurre la donna a una, per quanto nobile e altissima, funzione, invece di valorizzarla in sé, in quanto essere umano.
L’attenzione alla madre può infatti celare e indurre una distorsione dello sguardo: la donna vale in quanto e perché genera, perché genera uomini. E, così, le categorie entro le quali la vita femminile è stata a lungo compresa e compressa (vergine-sposa-madre), che ci danno un’immagine della donna non come un soggetto che guarda il mondo, ma come un oggetto, come una guardata dagli uomini, definita dalla sua relazione con l’universo maschile.
Mai si è, invece, pensato di poter comprendere l’uomo riducendolo alle categorie di vergine-sposo-padre, che pure gli si attagliano. La coscienza media ecclesiale non si sente investita dal fenomeno della violenza sulle donne quanto dovrebbe, giacché, nonostante la forza liberante dell’Evangelo, della prassi di Gesù e della comunità cristiana primitiva, e benché il cristianesimo abbia contribuito moltissimo alla liberazione delle donne, le tradizioni e la mentalità ecclesiastiche sono state e sono ancor oggi profondamente contaminate da misoginia, dal disprezzo per le donne, dalla non percezione della necessità del loro apporto nella vita sociale e ancor più ecclesiale, dal non riconoscimento che la loro umanità e quella dell’uomo sono equivalenti nella loro diversità, segnate da una non adeguata coscienza della piena soggettività e libertà femminili e da molte consuetudini e pregiudizi ad esse avverse.
Il 25 novembre scorso si è celebrata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nello stesso giorno ricorre la memoria liturgica di santa Caterina d’Alessandria che, secondo la tradizione, subì il martirio nel 305: si era infatti rifiutata di adorare gli dei pagani durante i festeggiamenti per il tetrarca Massimino Daia, cercando, anzi, con argomentazioni profonde, di convertire quest’ultimo. Data la sua giovinezza, bellezza e il suo essere di stirpe regale, l’imperatore tentò di salvarla, inviandole un gruppo di filosofi e retori per indurla ad abiurare la sua fede. Ma fu lei a persuaderli: aderirono al cristianesimo e morirono martiri.
È difficile distinguere in tutto ciò la storia dalla leggenda (tanto che per quattro decenni la Chiesa cattolica la escluse dal martirologio, riammettendovela nel 2002), essendo i documenti disponibili assai tardivi. Santa Caterina - alla quale Giustiniano intitolò il celebre monastero sul monte Sinai, dove narra la leggenda il suo corpo sia stato trasportato dagli angeli - è tuttavia venerata da tempi antichissimi da tutte le Chiese cristiane che ammettono il culto dei santi e che ci hanno in tal modo trasmesso il messaggio della capacità apostolica, teologica e filosofica delle donne.
Una cosa così inaudita per la cultura patriarcale e androcentrica da far pensare che la storia sia vera: tanto è difficile immaginare che se la siano inventata! La figura di santa Caterina addita una via decisiva: valorizzare le capacità dello spirito e della mente delle donne, liberandole dall’essere ridotte allo sguardo della cultura androcentrica. Ciò è a vantaggio non solo delle donne, ma di tutta l’umanità, e al fine di una maggiore trasparenza della Chiesa nel servizio all’Evangelo.
Il rinnovamento della società e della politica in crisi richiede l’apporto delle donne. E perché il messaggio evangelico possa raggiungere le donne, queste debbono sentirsi rispettate e riconosciute: non ci sarà un’evangelizzazione veramente nuova senza che le donne ne siano piene destinatarie e coprotagoniste.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- E LA RIMOZIONE DEL FEMMINILE A CUI ABBIAMO OVVIATO CON IL DOMINIO (di Alessandro Esposito - Donne in cerca di guai)29 dicembre 2012, di Federico La Sala
di Alessandro Esposito (“MicroMega”, 28 dicembre 2012)
Noi malpensanti e femministi avevamo provato ad accostare all’indignazione dinanzi alla reiterata violenza di cui le donne sono vittime per mano d’uomo la riflessione relativa alle cause che possono scatenare tale ingiustificabile efferatezza: fortunatamente è giunto, inaspettato, il soccorso di un pio ed acuto parroco ligure ad illuminare la nostra insipienza.
Ma come abbiamo fatto a non pensarci prima? Era evidente: la causa prima della violenza fisica, psicologica, sociale e religiosa quotidianamente inflitta alle donne sono le donne stesse. Il fatto è che era talmente ovvio da essere sfuggito alla nostra capacità d’analisi, immancabilmente condizionata da una lettura ideologica della realtà dei fatti. Ebbene, questa realtà, se ben osservata, ci porta alla conclusione insindacabile che siano le donne le principali (giusto perché affermare «le uniche» deve sembrare eccessivo persino a questi irreprensibili cavalieri della fede) responsabili degli istinti che colpevolmente scatenano nel maschio altrimenti avvezzo per natura a docilità e candore: per cui «chi è causa del suo mal...».
Ci sarebbe da rimanere attoniti se non prevalesse lo sdegno: eppure, una volta ancora, voglio pensare che alla doverosa espressione dei sentimenti sia da preferire un’indefessa ricerca delle cause. In qualità di «addetto ai lavori», vorrei concentrare la mia analisi sul retroterra religioso dal quale questa trivialità continua a trarre alimento e a ricevere legittimazione: a tale proposito limiterò le mie considerazioni a tre aspetti che mi paiono nevralgici.
1. L’universo cattolico intransigente entro il quale quest’ignoranza attecchisce è un universo rigorosamente declinato al maschile: la donna non vi è contemplata se non in qualità di figura deliberatamente relegata ai margini che riflette l’immagine, assai rassicurante per l’uomo, di un’obbedienza che rasenta la remissività. A questa malcelata misoginia l’associazionismo cattolico sta reagendo provando a gettare le basi di un’organizzazione ecclesiale profondamente distinta, che si ispira ai documenti di quel Vaticano II tradito dall’impronta autoritaria degli ultimi due pontificati [1]: l’impressione, però, è che sia la gerarchia, sia una fetta ancora troppo ampia della base cattolica siano sostanzialmente indifferenti (quando non espressamente ostili) alla necessità di proseguire (e in alcuni casi persino di avviare) un percorso di riflessione concernente la centralità e la peculiarità dello sguardo femminile al fine di rifondare il cristianesimo.
2. La tendenza sembra, piuttosto, quella volta a sollecitare l’immaginario sia maschile che femminile rimandandolo a figure in cui non è possibile rinvenire la pienezza della femminilità nella molteplicità delle sue forme espressive, affettive come sessuali. Di qui l’elogio tutt’altro che disinteressato di atteggiamenti quali la castità quando non addirittura di condizioni quali la verginità: null’altro che argini entro cui imprigionare il desiderio. Quello femminile, va da sé.
3. Affinché, però, non sia il desiderio maschile a ridestarsi da quel fondo oscuro entro cui l’educazione ecclesiastica lo relega, nulla di meglio che la famiglia, quella tradizionale, si capisce, per estinguerlo. Pazienza poi se la maggior parte delle violenze di cui le donne sono vittime si consumano entro pareti falsamente protettive che diventano prigioni. Ma tant’è, la famiglia rassicura: specie noi maschi, che così possiamo proseguire nella rimozione di quel timore del femminile a cui abbiamo ovviato con il dominio. E le donne seguitare in aeternum nel silenzio che è loro comandato. Come in chiesa, così in casa.
[1] Vorrei citare, su tutti, il prezioso lavoro svolto dal CTI (Coordinamento Teologhe Italiane; sito intetrnet: www.teologhe.org), presieduto dalla filosofa, teologa e biblista Marinella Perroni.
Alessandro Esposito - pastore valdese
-
>LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- L’enigma di Lascaux. La «cappella Sistina» della preistoria è di nuovo visibile e permette di confrontare le visioni dei sapiens all’arte di oggi (di Luca Sebastiani).11 novembre 2012, di Federico La Sala
 L’enigma di Lascaux
L’enigma di Lascaux
 La grotta con i dipinti preistorici ricostruita in 3d
La grotta con i dipinti preistorici ricostruita in 3d La «cappella Sistina» della preistoria è di nuovo visibile e permette di confrontare le visioni dei sapiens all’arte di oggi
La «cappella Sistina» della preistoria è di nuovo visibile e permette di confrontare le visioni dei sapiens all’arte di oggi
 Picasso affascinato da quelle pitture vecchie di 20mila anni disse: «Finalmente ho trovato il mio maestro!»
Picasso affascinato da quelle pitture vecchie di 20mila anni disse: «Finalmente ho trovato il mio maestro!»di Luca Sebastiani (l’Unità, 11.11.2012)
- PARIGI LA SECONDA GUERRA MONDIALE ERA IN CORSO E LE TRUPPE TEDESCHE AVEVANO GIÀ OCCUPATO LA FRANCIA.
All’inizio di settembre, nel 1940, quattro ragazzi si aggiravano scioperati nella valle della Vézère quando d’improvviso il loro cane s’infilò in un cunicolo all’inseguimento di un coniglio. I giovani, in cerca d’avventura, lo seguirono e si trovarono davanti gli imponenti cavalli al galoppo, i cervi e i tori policromi tratteggiati tra 18mila e 20mila anni fa dagli uomini sapiens del paleolitico superiore. Si trattò di una scoperta miracolosa, del ritorno alla luce della grotta di Lascaux, che per la magnificenza delle sue volte dipinte venne subito ribattezzata la «cappella Sistina della preistoria».
Il ritrovamento fece clamore e numerosi si recarono in Dordogna. Tra i primi ad arrivare anche Pablo Picasso, che dopo esser riemerso dalle caverne esclamò meravigliato: «Finalmente ho trovato il mio maestro!». La ricerca del maestro della modernità terminava così al cospetto dell’enigma estetico della grotta di Lascaux. Ma cosa può accomunare l’arte moderna con quella dell’origine?
Oggi capire lo stupore che suscitò il rinvenimento delle pitture rupestri è più difficile. E i battenti della grotta chiusero nel 1963 per salvaguardare l’opera preistorica. Ora però, prima che approdi oltre Atlantico e poi in giro per il mondo, è possibile rivivere l’esperienza di Picasso visitando a Bordeaux Lascaux 3, riproduzione a grandezza naturale della grotta. Un falso, certo, ma almeno si possono avvicinare le visioni dei sapiens e quello che Picasso intendesse dire.
Cosa si può dire allora di questi misteriosi dipinti di Lascaux? Si tratta di un bestiario di figure che allora popolavano la valle, tratteggiate con sicurezza realistica e emananti una grande vitalità. Una cavalcata energica di cavalli al galoppo, cervi in gruppo, bovini e tori. Evidentemente però la sola lettura realistica non esaurisce il senso di ciò che è stato dipinto nella profondità oscura del tempo. Anche solo in considerazione della presenza nella grotta di una specie di liocorno tratteggiato nei pressi dell’entrata, e per la totale assenza di figure umane se si eccettua l’uomo dell’impervia sala detta del «pozzo», infantilmente stilizzato e con un viso da uccello.
Molti esperti ritengono che i dipinti abbiano una funzione propiziatoria per una caccia florida, che servano cioè a far presa sulla forza estranea della natura per mezzo della magia. Altri però credono che non tutto in Lascaux possa essere ridotto ad un fine utilitario, che laggiù ci sia molto di più. Qualcosa che conserva delle origini il momento aurorale della nascita contestuale dell’uomo, del sacro e dell’arte come congedo da un’animalità ormai lontana.
Georges Bataille, tra i primi ad arrivare in Dordogna nel 1940, e che nel mistero estetico delle caverne trovò l’anello mancante delle sua antropologia, l’ha scritto molto bene nel suo Lascaux ou La naissance de l’art. L’uomo del pozzo dimostra per lui il chiasmo che si è prodotto nella storia dell’uomo tra l’animalità e l’umanità. Mentre oggi l’uomo si afferma negando la propria origine animale relegandola nel tabù dell’animalità, ai tempi di Lascaux, all’origine, era l’uomo che provava vergogna della propria umanità dissimulandola sotto una maschera animale.
L’originalità umana era vissuta cioè come un tragico distacco dalla propria natura profonda: perciò sacralizzata nell’animale prima di divenire, più tardi, sacrificabile. Il congedo dall’immanenza sacra dell’animale per entrare in un tempo consegnato alla sovranità del futuro e della ragione pratica del lavoro, avviene però solo con il primo atto veramente umano, cioè, per Bataille, col gesto artistico: libero, disinteressato, senza altra finalità se non quella del dispendio e della trasgressione di un ordine profano.
Per questo Picasso, risalito alla superficie dopo l’immersione di Lascaux, disse che in fondo noi moderni «non abbiamo inventato nulla». Perché la trasgressione nell’arte delle leggi che ci determinano, l’immaginazione della libertà, apparve già col nostro primo vero fratello, l’uomo di Lascaux.
-
> 5 SIBILLE NELLA VOLTA DELLA SISTINA. PER IL CARDINALE RAVASI E’ L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO - PER LA CHIESA E’ UN GROSSO PROBLEMA!!!2 novembre 2012, di Federico La Sala
 MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.In un bel documentario dal titolo «1512. La volta di Michelangelo nella Sistina compie 500 anni» mandato in onda, ieri, 31 ottobre 2012 (giorno dell’anniversario) su TV2000 alle ore 13.05 (e replicato alle 23.05) con Antonio Paolucci, Gianluigi Colalucci e cardinale Gianfranco Ravasi.
 il cardinale dichiara, con la massima autorevolezza e con la massima ’innocenza’, che nella Volta della Sistina insieme alle figure centrali relative al testo del Genesi, ci sono i profeti e le sibille, e la presenza di "queste donne" è definita come "il più curioso" elemento della narrazione michelangiolesca.
il cardinale dichiara, con la massima autorevolezza e con la massima ’innocenza’, che nella Volta della Sistina insieme alle figure centrali relative al testo del Genesi, ci sono i profeti e le sibille, e la presenza di "queste donne" è definita come "il più curioso" elemento della narrazione michelangiolesca.Evidentemente, dopo 500 anni, per la teologia della Chiesa cattolico-romana, la loro presenza è decisamente ancora un problema, un grosso problema!
Federico La Sala (1.11.2012)
-
>CAPPELLA SISTINA ---- DOCUMENTARI, 2012: «1512. La volta di Michelangelo nella Sistina compie 500 anni» (TV2000) - «Michelangelo e la Sistina. Storia di un’opera d’arte» (RAI STORIA).30 ottobre 2012, di Federico La Sala
«1512. La volta di Michelangelo nella Sistina compie 500 anni» è il titolo del documentario realizzato da Nino Criscenti in onda il 31 ottobre (giorno dell’anniversario) su TV2000 alle ore 13.05 (replica 23.05) con Antonio Paolucci, Gianluigi Colalucci e cardinale Gianfranco Ravasi.
Lo stesso 31 ottobre, su Rai Storia (ore 23), va in onda il documentario «Michelangelo e la Sistina. Storia di un’opera d’arte» di Piero Badaloni e Nino Criscenti con Antonio Paolucci, Gianluigi Colalucci e Massimo Firpo.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- «1512. La volta di Michelangelo nella Sistina compie 500 anni» (di Antonio Paolucci)28 ottobre 2012, di Federico La Sala
La Volta Sistina compie 500 anni
di Antonio Paolucci (Il Sole-24 Ore, 28 ottobre 2012)
Ci sono date destinate a rimanere indimenticabili nella universale storia delle arti. Una di queste è il 1508. Quell’anno Giulio II della Rovere un vecchio papa che sembrava amare la politica, la diplomazia e la guerra più di quanto non amasse la pittura, chiama al suo cospetto due artisti. Uno è un ragazzo di appena venticinque anni, Raffaello Sanzio da Urbino, e a lui chiede di dipingergli ad affresco le pareti del suo appartamento privato, le Stanze più famose del mondo, quelle che da allora in poi tutti conosceranno come "di Raffaello".
L’altro è Michelangelo Buonarroti, giovane uomo di trentatré anni, celebre per i capolavori di scultura (la Pietà di San Pietro, il David di Piazza della Signoria) lasciati a Roma e a Firenze. A quest’ultimo affida la decorazione della volta nella "cappella magna" che quasi trent’anni prima (1481-83) il papa all’epoca regnante, lo zio Sisto IV, aveva fatto affrescare lungo le pareti dai grandi professionisti umbri e toscani di quegli anni; dal Ghirlandaio, dal Botticelli, dal Perugino, fra gli altri.
Incomincia così nel 1508 l’avventura della volta della Sistina, il duello, quasi il corpo a corpo di Michelangelo con gli oltre mille metri quadrati di intonaco da riempire di centinaia di figure. Il contratto è dell’8 Maggio 1508, l’inaugurazione della prima parte, dall’ingresso fino al centro, è del 15 agosto del 1511, del 31 ottobre 1512 la conclusione dei lavori.
Nel pomeriggio del 31 ottobre di Cinquecento anni fa, ai Vespri della vigilia di Ognissanti, il Papa (con «17 cardinali in cappa festiva» scrive il cronista) inaugurava la grande impresa. Da quei più di mille metri di pittura oggi sospesi sui cinque milioni di visitatori che ogni anno attraversano la Sistina, è precipitato sulla storia dell’arte italiana ed europea - scriverà il Wölfflin nel 1899 con una bella metafora - qualcosa di paragonabile a un «violento torrente montano portatore di felicità e al tempo stesso di devastazione».
Di fatto, dopo la volta della Sistina, nulla sarà più come prima. Incomincia da quel 31 ottobre del 1512 la stagione che i manuali chiamano del Manierismo. Al punto che Giorgio Vasari, in un passaggio famoso delle Vite, potrà scrivere: «questa opera è stata ed è veramente la lucerna dell’arte nostra, che ha fatto tanto giovamento e lume all’arte della pittura, che ha bastato a illuminare il mondo». In una trentina di parole tre volte con tre diversi vocaboli ("lucerna", "lume", "illuminare") il Vasari esalta il concetto di un’opera destinata a svelare e a guidare il destino delle arti nel tempo a venire. In un certo senso le cose sono andate proprio così, a tal punto grande è stata l’influenza che quegli affreschi hanno esercitato sugli artisti d’Italia e d’Europa.
La bibliografia sulla volta della Sistina è così vasta che basterebbe a riempire una biblioteca di medie dimensioni. Del resto l’immane sciarada teologico scritturale che Michelangelo dispiegò nel cielo della "cappella magna" offre di continuo occasioni di singolari interpretazioni e decodificazioni. Il formidabile genio mitopoietico del Buonarroti, la sua ineguagliata capacità di inventare situazioni iconografiche radicalmente nuove, spalancano praterie sterminate agli esegeti contemporanei, specie a quelli di scuola americana.
Per esempio. Di recente, qualcuno con una ipotesi certo fantasiosa e improbabile però suggestiva, ha voluto riconoscere nel gruppo di Dio Padre circondato dagli angeli che "crea" un Adamo già esistente e perfettamente formato, il profilo di un cervello umano. Quasi che quella scena fosse il manifesto di un Michelangelo creazionista precursore del "disegno intelligente".
Molte cose si sono dette e si diranno ancora sulla volta della Sistina. A me piace ricordare l’impresa della volta così come ce la racconta Michelangelo stesso in un celebre sonetto autocaricaturale il cui originale si conserva negli archivi di Casa Buonarroti a Firenze.
 I’ho già fatto un gozzo in questo stento
I’ho già fatto un gozzo in questo stento
 come fa l’acqua a’ gacti in Lombardia
come fa l’acqua a’ gacti in Lombardia
 o ver d’altro paese che si sia,
o ver d’altro paese che si sia,
 ch’a forza ’l ventre appicco sotto l’mento
ch’a forza ’l ventre appicco sotto l’mento
 la barba al ciel, e la memoria sento
la barba al ciel, e la memoria sento
 in sullo scrigno, e l’pecto fo d’arpia
in sullo scrigno, e l’pecto fo d’arpia
 e ’l pennel sopra ’l viso tuctavia
e ’l pennel sopra ’l viso tuctavia
 mel fa, gocciando, un ricco pavimento...
mel fa, gocciando, un ricco pavimento...Il testo è grottesco, surreale, sulfureo. Parla di un uomo che il lavoro stravolge e disarticola, che non si sente adatto, da scultore, alla pratica della pittura a fresco, che prova rabbia, delusione, sconforto e che pure è capace di esaltare con due versi bellissimi («e ’l pennel sopra ’l viso tuctavia mel fa gocciando un ricco pavimento») la faticosa gloria dell’arte.
in tv
«1512. La volta di Michelangelo nella Sistina compie 500 anni» è il titolo del documentario realizzato da Nino Criscenti in onda il 31 ottobre (giorno dell’anniversario) su TV2000 alle ore 13.05 (replica 23.05) con Antonio Paolucci, Gianluigi Colalucci e cardinale Gianfranco Ravasi.
 Lo stesso 31 ottobre, su Rai Storia (ore 23), va in onda il documentario «Michelangelo e la Sistina. Storia di un’opera d’arte» di Piero Badaloni e Nino Criscenti con Antonio Paolucci, Gianluigi Colalucci e Massimo Firpo.
Lo stesso 31 ottobre, su Rai Storia (ore 23), va in onda il documentario «Michelangelo e la Sistina. Storia di un’opera d’arte» di Piero Badaloni e Nino Criscenti con Antonio Paolucci, Gianluigi Colalucci e Massimo Firpo. -
> UNA CAPPELLA SISTINA carmelitana CON 12 SIBILLE. --- OGGI, FESTA DI SANTA TERESA D’AVILA. Una nota (di don Aldo Antonelli)15 ottobre 2012, di Federico La Sala
SANTA TERESA D’AVILA
Una nota
di don Aldo Antonelli
Oggi ricorre la festa di Santa Teresa d’Avila.
A suo tempo, nella relazione al Papa sulla vita della Santa, il Nunzio Apostolico così scriveva:
"Femmina inquieta, vagabonda, disubbidiente e contumace, che sotto titolo di Divozione inventava perniciose Dottrine; che contra i divieti del Concilio di Trento usciva fuori della Clausura, e contra il dettame di S. Paolo voleva insegnare, e farla da Maestro" (Vita II, XXXI).
L’amico Alberto Maggi, che qualcuno ricorderà avemmo il piacere di avere ospite in uno degli incontri ad Antrosano, così commenta:
"La femmina inquieta e vagabonda sarà proclamata Dottore della Chiesa. Il nunzio finirà nel dimenticatoio della storia".
Pace e bene.
Aldo
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA (di Federico La Sala)21 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> LA SCOPERTA --- A Faded Piece of Papyrus Refers to Jesus’ Wife. The finding was made public in Rome ... The discussion is particularly animated in the Roman Catholic Church, where despite calls for change, the Vatican has reiterated the teaching that the priesthood cannot be opened to women and married men because of the model set by Jesus (di Laurie Goodstein - "The New York Times").20 settembre 2012, di Federico La Sala
A Faded Piece of Papyrus Refers to Jesus’ Wife
By LAURIE GOODSTEIN *
CAMBRIDGE, Mass. - A historian of early Christianity at Harvard Divinity School has identified a scrap of papyrus that she says was written in Coptic in the fourth century and contains a phrase never seen in any piece of Scripture: “Jesus said to them, ‘My wife ...’ ”
The faded papyrus fragment is smaller than a business card, with eight lines on one side, in black ink legible under a magnifying glass. Just below the line about Jesus having a wife, the papyrus includes a second provocative clause that purportedly says, “she will be able to be my disciple.”
The finding was made public in Rome on Tuesday at the International Congress of Coptic Studies by Karen L. King, a historian who has published several books about new Gospel discoveries and is the first woman to hold the nation’s oldest endowed chair, the Hollis professor of divinity.
The provenance of the papyrus fragment is a mystery, and its owner has asked to remain anonymous. Until Tuesday, Dr. King had shown the fragment to only a small circle of experts in papyrology and Coptic linguistics, who concluded that it is most likely not a forgery. But she and her collaborators say they are eager for more scholars to weigh in and perhaps upend their conclusions.
Even with many questions unsettled, the discovery could reignite the debate over whether Jesus was married, whether Mary Magdalene was his wife and whether he had a female disciple. These debates date to the early centuries of Christianity, scholars say. But they are relevant today, when global Christianity is roiling over the place of women in ministry and the boundaries of marriage.
The discussion is particularly animated in the Roman Catholic Church, where despite calls for change, the Vatican has reiterated the teaching that the priesthood cannot be opened to women and married men because of the model set by Jesus.
Dr. King gave an interview and showed the papyrus fragment, encased in glass, to reporters from The New York Times, The Boston Globe and Harvard Magazine in her garret office in the tower at Harvard Divinity School last Thursday.
She repeatedly cautioned that this fragment should not be taken as proof that Jesus, the historical person, was actually married. The text was probably written centuries after Jesus lived, and all other early, historically reliable Christian literature is silent on the question, she said.
But the discovery is exciting, Dr. King said, because it is the first known statement from antiquity that refers to Jesus speaking of a wife. It provides further evidence that there was an active discussion among early Christians about whether Jesus was celibate or married, and which path his followers should choose.
“This fragment suggests that some early Christians had a tradition that Jesus was married,” she said. “There was, we already know, a controversy in the second century over whether Jesus was married, caught up with a debate about whether Christians should marry and have sex.”
Dr. King first learned about what she calls “The Gospel of Jesus’s Wife” when she received an e-mail in 2010 from a private collector who asked her to translate it. Dr. King, 58, specializes in Coptic literature, and has written books on the Gospel of Judas, the Gospel of Mary of Magdala, Gnosticism and women in antiquity.
The owner, who has a collection of Greek, Coptic and Arabic papyri, is not willing to be identified by name, nationality or location, because, Dr. King said, “He doesn’t want to be hounded by people who want to buy this.”
When, where or how the fragment was discovered is unknown. The collector acquired it in a batch of papyri in 1997 from the previous owner, a German. It came with a handwritten note in German that names a professor of Egyptology in Berlin, now deceased, and cited him calling the fragment “the sole example” of a text in which Jesus claims a wife.
The owner took the fragment to the Divinity School in December 2011 and left it with Dr. King. In March, she carried the fragment in her red handbag to New York to show it to two papyrologists: Roger Bagnall, director of the Institute for the Study of the Ancient World, at New York University, and AnneMarie Luijendijk, an associate professor of religion at Princeton University.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA --- Antico papiro: Gesù era sposato. Karen King, studiosa di storia della cristianità ad Harvard, ha annunciato la scoperta di un frammento di papiro in cui Gesù fa riferimento a sua «moglie»19 settembre 2012
 Antico papiro: Gesù era sposato
Antico papiro: Gesù era sposato
 «Mia moglie Maria sarà discepola»
«Mia moglie Maria sarà discepola»Karen King, studiosa di storia della cristianità ad Harvard, ha annunciato la scoperta di un frammento di papiro in cui Gesù fa riferimento a sua «moglie». *
Karen King, studiosa di storia della cristianità ad Harvard, ha annunciato la scoperta di un frammento (4 per 8 cm) di un papiro del IV secolo scritto in copto (l’egiziano non scritto in geroglifici) in cui Gesù fa riferimento a sua «moglie». Nel testo, ha spiegato la professoressa King, c’è un dialogo in cui Gesù parla di «mia moglie», che chiama «Maria». «La tradizione cristiana ha sostenuto sempre che Gesù non fosse sposato, ma malgrado ciò non ci sono evidenze storiche a supporto di questa tesi», ha detto la King.
«Questo nuovo vangelo non prova che Gesù fosse sposato - aggiunge - ma ci dice che la questione del matrimonio e della sessualità è aperta». La Chiesta cattolica ha sempre sostenuto che Gesù non fosse sposato, ma la tesi contraria ha ripreso corpo e voce nel 2003 quando Dan Brown pubblicò il suo best-seller ’Il Codice Da Vincì. Il romanzo fece storcere il naso a molti cristiani perchè era basato, appunto, sull’idea che Gesù avesse una moglie di nome Maria Maddalena e dei figli. Secondo la professoressa King il frammento fornisce la prima prova che fra i primi cristiani alcuni credevano che Gesù fosse sposato. Roger Bagnall, direttore dell’Institute for the Study of the Ancient World di New York ha detto di credere che il frammento, che la King ha definito ’Vangelo della moglie di Gesu«, sia autentico. Ora monta l’attesa intorno agli ulteriori esami che dovranno essere effettuati dagli esperti.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA --- “Così ho trovato il papiro sulla moglie di Gesù”. Parla Karen King, storica della cristianità ad Harvard (di Marco Ansaldo)20 settembre 2012, di Federico La Sala
Parla Karen King, storica della cristianità ad Harvard
“Così ho trovato il papiro sulla moglie di Gesù”
“C’è un frammento su di lei. Ma Dan Brown non c’entra”
di Marco Ansaldo (la Repubblica, 20.09.2012)
CITTÀ DEL VATICANO «Questo frammento non prova che Gesù fosse sposato. Tuttavia ci dice quanto nella Chiesa, fin dai primi secoli, la questione del matrimonio e della sessualità fosse già aperta». Getta acqua sul fuoco - come è giusto - Karen L. King, docente a Harvard, inseguita da torme di giornalisti, cameramen e fotografi dopo il suo annuncio del ritrovamento di un piccolo pezzo di papiro in lingua copta in cui Gesù si riferirebbe a «mia moglie». Una frase appena accennata, però niente affatto di poco conto. Capace anzi di spalancare un dibattito su più fronti: in sede storica e religiosa innanzitutto, ma senza trascurare la fiction comunque cara ai tanti lettori nel mondo di Dan Brown, che nel Codice da Vinci sostenne l’ipotesi che Gesù avesse dei figli e una moglie di nome Maria Maddalena. La studiosa, 58 anni, insegnante di Divinità e prima donna a ricoprire la cattedra più antica degli Stati Uniti, ammette che la sua ricerca è solo all’inizio ed è in ogni caso appassionante. L’altro giorno ha annunciato la sua scoperta al Decimo congresso internazionale di studi copti, organizzato dal professor Alberto Camplani della Sapienza, e inaugurato con un saluto del rettore Luigi Frati e del prorettore Antonello Biagini.
Professoressa King, come è entrata in possesso di questo documento?
«Nel 2010 ho ricevuto una email da un collezionista privato che conosceva i miei libri e che mi chiese di tradurlo».
Chi era?
«È una persona che ha una collezione di papiri greci, arabi e copti. Preferisce non essere identificato perché non desidera essere assalito da possibili acquirenti».
Ma lui dove lo aveva acquisito?
«Nel 1997, da un collezionista tedesco, da una partita di papiri. Il documento aveva con sé una nota a mano che citava di un professore di Egittologia a Berlino, ora deceduto, il quale lo indicava come il solo esempio di un testo in cui Gesù parlasse di una moglie».
E lì è cominciata la sua ricerca?
«Il collezionista mi portò il frammento nel dicembre 2011. Il marzo seguente giravo con il documento chiuso nella mia borsetta per mostrarlo a due papirologi, il professor Roger Bagnall, dell’Università di New York, e Anne Marie Luijendijk, docente di religione a Princeton».
Com’è composto?
«È di circa 4 centimetri per 8, non più grande di una carta di credito. È del IV secolo d.C., scritto per l’esattezza in copto sahidico, un dialetto del sud dell’Egitto che usava caratteri greci. Ci sono otto righe di scrittura in inchiostro nero, leggibili solo con la lente di ingrandimento ».
Cosa c’è scritto?
«Gesù disse loro, “Mia moglie...”» .
Una frase che non c’è nelle Scritture. E gli studiosi che cosa le risposero circa l’eventuale autenticità?
«Volli ascoltare anche l’opinione di Ariel Shisha-Halevy, dell’Università di Gerusalemme, uno dei due-tre studiosi al mondo che conoscono a perfezione la lingua copta. Lo scorso settembre mi ha spedito una e-mail in cui scriveva: “Ritengo - sulla base della lingua e della grammatica - che il testo sia autentico”».
Ma le prove tecniche?
«Quello che ha convinto gli studiosi della sua genuinità è la dissolvenza dell’inchiostro sul papiro, e le tracce di scrittura che aderiscono alle fibre curvate sui bordi lacerati. Mi hanno risposto: fabbricarlo è impossibile».
Altre frasi?
«Lei sarà in grado di essere mia discepola».
E nella parte posteriore?
«È così fioca che si leggono solo cinque parole: “mia madre”, “tre”, e “merita che”. Potrebbero significare: “Mia madre mi ha dato la vita”, e “Maria lo merita”».
Però il documento è del IV secolo dopo Cristo.
«Sì, l’ipotesi è dunque che si tratti di una copia basata su un testo originale in greco risalente al II secolo d.C.».
Dunque non è coevo di Gesù di Nazareth?
«No. Ma fornisce la prova che fra i primi cristiani alcuni credevano che Gesù fosse sposato. Era dunque già presente un dibattito sulla questione se dovessero sposarsi e avere rapporti sessuali».
Potrebbe aprirsi ora un dibattito sul celibato dei sacerdoti. Ha ricevuto reazioni ufficiali da parte della Chiesa cattolica?
«Non ancora. So che questo frammento adesso causerà discussioni su sessualità e celibato, che negli Stati Uniti sono già a uno stadio avanzato».
Ha aspettato di essere a Roma per annunciare la scoperta?
«È un puro caso. Quattro anni fa il congresso di studi copti si svolse al Cairo».
Dan Brown allora aveva ragione?
«Il frammento non lo dimostra. Brown ha scritto un romanzo. Qui si tratta di storia, e siamo appena all’inizio della ricerca».
-
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- 23 DONNE AL VATICANO II. Rivoluzione femminile al Concilio (di Lucetta Scaraffia).22 luglio 2012, di Federico La Sala
- LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
 La Costituzione è (...) la nostra “Bibbia civile”, la Legge e il Patto di Alleanza dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ Costituenti (21 cittadine-sovrane presero parte ai lavori dell’Assemblea).
La Costituzione è (...) la nostra “Bibbia civile”, la Legge e il Patto di Alleanza dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ Costituenti (21 cittadine-sovrane presero parte ai lavori dell’Assemblea).
Rivoluzione femminile al Conciliodi Lucetta Scaraffia (Il Sole-24 Ore, 22 luglio 2012) *
Le 23 donne invitate da Paolo VI a partecipare al concilio Vaticano II come uditrici presenziavano alle riunioni vestite di nero, con un velo sul capo come a una funzione pontificia. Negli intervalli potevano andare in una saletta-bar separata, approntata per loro, e per due volte fu negata a Pilar Bellosillo, presidente dell’Unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche, la possibilità di prendere la parola in pubblico. Tutte cose che oggi ci indignano, ma normali se giudicate con criteri storici: nel 1964 nessuna riunione della Banca d’Italia, del Consiglio superiore della magistratura, e neppure della Corte suprema statunitense, per limitarsi a qualche esempio, prevedeva presenze femminili.
Piuttosto, libri come questo di Adriana Valerio fanno capire quanto velocemente e radicalmente sia cambiato il mondo - anche un mondo lento come quello della Chiesa - grazie alla rivoluzione delle donne. Già nell’enciclica Pacem in terris Giovanni XXIII aveva riconosciuto l’emancipazione femminile come un importante e positivo «segno dei tempi», e molti cardinali e vescovi appoggiarono la proposta di Paolo VI di aprire le porte del Concilio alle uditrici.
La scelta delle invitate fu comunque faticosa, anche se la loro presenza avrebbe dovuto essere simbolica - così la definì Papa Montini - non avendo diritto né di parola né di voto. Invece, le uditrici parteciparono attivamente ai gruppi di lavoro, presentarono memorie e contribuirono con la loro esperienza alla stesura dei documenti, in particolare su temi come la vita religiosa, la famiglia, l’apostolato dei laici.
La presenza di due vedove di guerra contribuì a rafforzare il peso femminile anche nelle discussioni sulla pace, alle quali, dall’esterno, contribuiva con la sua attività di lobbying l’americana Dorothy Day. Delle uditrici facevano parte 10 religiose e 13 laiche. Molte di loro, specie le religiose, costituivano il filo terminale di gruppi costituiti ai margini dell’assemblea conciliare per preparare commenti e richieste. In particolare, il peso di questo lavoro di mediazione gravò sulle spalle di Sabine de Valon, superiora generale della Società del Sacro Cuore che, nel 1962, aveva organizzato l’Unione internazionale delle superiore generali, di cui era presidente. Superiora anche delle uditrici ed entrata nell’aula conciliare piena di entusiasmo - salutò quel momento come «il passaggio dalla sala di attesa al soggiorno» - si scontrò poi con tensioni e ansietà crescenti.
La più vivace delle uditrici laiche fu senza dubbio Pilar Bellosillo, presidente dell’Unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche, scelta proprio per questo due volte come portavoce dal gruppo degli uditori. Nel 1965, per l’ultimo periodo, fu chiamata la più giovane delle partecipanti, l’argentina Margarita Moyano Llerena, presidente del Consiglio superiore delle giovani, combattiva come Gladys Parentelli, uruguaiana, che non rinunciò durante il concilio ad andare a capo scoperto e con le maniche corte, così da essere poi espunta dalle foto ufficiali. Gladys si sentì delusa dal poco spazio dato agli uditori laici durante i lavori conciliari, tanto da non partecipare alla sessione conclusiva.
Leggendo le biografie ricostruite nel libro si può vedere come molte uditrici, fra cui la Parentelli, si siano poi avvicinate a posizioni progressiste, considerate poco ortodosse. Molte delle partecipanti, inoltre, si sarebbero dichiarate a favore del sacerdozio femminile. L’autrice si schiera senza remore con queste ultime, presentando con sguardo critico le osservazioni conclusive sulle donne di Paolo VI, che parlano di «un modello che rappresentava il femminile nella funzione "naturale" di custode di un’umanità da salvare», perché ribadiva in sostanza il ruolo materno.
Il materiale offerto dal libro meriterebbe invece un’analisi più approfondita, con un occhio più attento anche al rapporto con il mondo esterno alla Chiesa e ai cambiamenti di quegli anni, per superare la facile interpretazione di ogni fatto conciliare come progressista o conservatore.
Anche perché la presenza delle donne, per il solo fatto di esserci stata, segna una svolta importante nella storia della Chiesa e del Novecento, mentre gli esiti possibili sono più numerosi e sfumati dell’alternativa tra conservazione e progresso.
*
Adriana Valerio, Madri del Concilio. Ventitrè donne al Vaticano II, Carocci, Roma, pagg. 168,
- LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- Per il nostro patrimonio culturale, una lettera-appello di Associazioni e intellettuali al Presidente della Repubblica e del Consiglio-10 luglio 2012, di Federico La Sala
"No" a nuovi tagli alla tutela dei beni culturali e del paesaggio
- Una lettera di Associazioni e intellettuali ai Presidenti della Repubblica e del Consiglio: il nostro patrimonio culturale merita un altro destino. (m.p.g.) *
Sulla tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio non devono abbattersi altri tagli di fondi né amputazioni di strutture e di personale dopo quelle già pesantemente inferte nei mesi e negli anni scorsi fino ad intaccare l’ossatura stessa dei Beni Culturali e quindi la copertura territoriale della tutela. Rivolgiamo un appello forte e accorato al governo Monti affinché con la “revisione della spesa” in corso non pratichi né nuovi tagli di risorse né l’assurdo accorpamento burocratico delle Soprintendenze con altri uffici dello Stato, del tutto estranei alla tutela, né il pre-pensionamento di tecnici di grande esperienza e qualificazione di cui si parla in queste ore e che sguarnirebbe in modo decisivo la salvaguardia territoriale.
Il disastroso terremoto che ha colpito l’Emilia-Romagna e i gravi danni subiti dal patrimonio storico-artistico hanno confermato la mancanza di una politica di prevenzione e di messa in sicurezza antisismica del Belpaese e svelato la contraddizione di fondo di quanti pretendono che una parte del patrimonio diventi una “fabbrica di soldi” e però trascurano poi gli elementi fondamentali della conservazione del patrimonio stesso, “redditizio” o no che esso sia.
Nuovi colpi di accetta sui pochi fondi disponibili e nuovi vuoti nella rete della tutela aggraverebbero in modo irreversibile una situazione, già vicina al coma, la quale esibisce al mondo intero i nostri paesaggi aggrediti da cemento e asfalto senza piani regionali e spesso senza neppure controlli pubblici di sorta, con pesanti infiltrazioni malavitose; i nostri centri storici a rischio di svuotamento totale e/o di trasformazione in sempre più volgari “divertimentifici”; i nostri musei, siti archeologici, archivi, biblioteche immersi in crescenti, penose difficoltà; un Ministero ormai inerte da anni, Soprintendenze devitalizzate, disossate, private di fondi, di mezzi, di tecnici, frustrate da commissariamenti fallimentari a base di supposti “manager” (L’Aquila, Pompei, ecc.). Eppure c’è chi, a livello economico, individua la Salvezza nella magica formula “far fruttare i beni culturali”, “sfruttarli a fondo”, monetizzare in chiave privatistica il nostro patrimonio collettivo.
I firmatari di questo appello vogliono dire chiaro e forte:
“Noi non ci stiamo ad assistere inerti al massacro del Belpaese. Una vera, generalizzata politica di tutela dei beni culturali è l’opposto di una politica che riduce fondi, mezzi, strutture e punta contemporaneamente allo sfruttamento dei beni considerati “redditizi” secondo una logica privatistica.
L’Italia ha bisogno di una vera rinascita culturale, ma, per ritrovare un rapporto forte con la cultura, dobbiamo sgombrare il campo da una serie di luoghi comuni economicistici stratificati su cultura e beni culturali. Eliminiamo per sempre dal nostro lessico la frase: “la cultura è il nostro petrolio”. Dizione altamente pericolosa, anche perché equipara la cultura alla rendita fornita da un propellente fra i più inquinanti. La cultura non è una rendita di posizione. E’ un processo creativo continuo che presuppone ricerca, studio, tutela, restauro, conservazione. E’ un patrimonio di tutti.
I siti archeologici o i centri storici, gli archivi o le biblioteche, non sono “giacimenti” industriali sui quali intervenire con misure sbrigative ignorando, oltretutto, la storia specifica dell’amministrazione. Non sono cioè rendite da “sfruttare”: sono beni complessi e delicati, da tutelare, da restaurare, da conservare, da vivere, sì, da vivere con rispetto. Sono la nostra storia, la nostra identità, concorrono a fare la nostra qualità di vita. Come il paesaggio dove tutto si tiene. Il momento economico è grave, gravissimo per il Paese, ma l’Italia, che è già agli ultimi posti negli investimenti pubblici e privati per la cultura e per i beni culturali (pur avendo un patrimonio ingentissimo), non può rattrappire ancor più questa spesa già modesta e talora avvilente. Non può pensare di “risparmiare” sul personale e sugli strumenti della tutela che provvedono a salvaguardare il Belpaese minacciato da ogni parte da cemento legale e illegale. Né stabilire una gerarchia fra beni maggiori e beni minori.
Verrebbe colpita a morte la cultura del “contesto”, cioè una delle conquiste centrali dalla nostra idea di tutela, da Raffaello in qua. Per noi non c’è edilizia maggiore e edilizia minore, non ci sono “monumenti” scissi dal resto della città antica che quindi si può abbattere, sventrare, diradare, ecc. Questa logica aberrante - proposta di recente dall’Ocse per l’Aquila - ci fa regredire, quanto meno, agli sventramenti mussoliniani. Mentre l’Italia può vantare di aver raggiunto negli anni ’60 e ’70 del ‘900 un autentico primato culturale in materia di restauro integrale dei centri storici (anche della città “vecchia”), di vivibilità, di tutela accurata. Sarebbe quindi una regressione raccapricciante.
Possiamo operare salvaguardie e anche risparmi importanti (per esempio nel dissennato consumo di suolo) riportando in onore la pianificazione. A cominciare dai piani paesaggistici lasciati invece marcire da tutti i ministri, da Bondi a Ornaghi, nonostante il Codice per il Paesaggio. Dobbiamo richiamare Stato, Regioni, Enti locali ai loro compiti strategici, alla responsabilità così chiaramente identificata dall’articolo 9 della Costituzione, uno dei più disattesi negli ultimi anni. Da tutti. Dobbiamo richiamare con energia i partiti, i sindacati, i movimenti politici alle loro responsabilità: così il Belpaese corre verso l’autodistruzione. Senza un piano generale per la difesa del suolo e per la messa in sicurezza antisismica (che darebbero molto più lavoro, e più diffuso, alle imprese delle grandi opere), il Belpaese va incontro ad altri disastri, ad altre vittime innocenti, ad altre dissipazioni di beni preziosi ed irripetibili.
Non dobbiamo stancarci di chiarire che la tanto declamata “redditività” dei beni culturali e paesaggistici è semmai indiretta e non diretta. Non sono i musei, ad esempio, a “fruttare” (i mega-musei come il Louvre non “rendono” un solo euro, ma registrano un forte passivo coperto, per oltre la metà, con denaro pubblico). Può rendere invece, può produrre reddito e occupazione l’indotto turistico creato attorno ad essi, con una rete di accoglienza turistica “virtuosa” e rispettosa. Non il turismo miope e speculativo che sfrutta, invade, degrada e consuma sempre più centri storici e paesaggi.
Siamo pienamente favorevoli ad una seria e trasparente politica di detassazione per le donazioni e per gli investimenti privati nei beni culturali recuperando, ad esempio, i criteri della buona legge Scotti del 1982, che favorì in modo molto concreto gli interventi privati in dimore e giardini storici senza far perdere una lira al fisco. Anzi, facendone guadagnare coi maggiori lavori. Buona legge purtroppo mutilata nella grande crisi del 1992-93.
Siamo anche pienamente favorevoli ad una riorganizzazione in senso tecnico (ma tecnico davvero) dell’Amministrazione dei Beni culturali che la renda più snella, che semplifichi le procedure di spesa riducendo grandemente i pesanti residui passivi: bisogna dare più poteri ai Soprintendenti e insieme garantire tutti con regole inattaccabili sul piano della trasparenza e della qualità degli appalti. Su entrambi i versanti sentiamo di dover lavorare con approfondimenti e proposte.
Noi crediamo infatti alla ricerca, alla cultura e ai suoi beni come straordinario generatore di una nuova, epocale rinascita, anche economica, del Paese. Noi crediamo alla Bellezza come pilastro di tale politica, come diritto civile, come bene sociale fondamentale. Di cui dobbiamo essere assai più coscienti di quanto non siamo stati sinora.
 Vittorio Emiliani e Desideria Pasolini dall’Onda (Comitato per la Bellezza), Irene Berlingò (Assotecnici), Marisa Dalai (Associazione R.Bianchi Bandinelli), Alberto Asor Rosa (Rete Comitati), Maria Pia Guermandi (Eddyburg), Donata Levi (PatrimonioSos), Carlo Alberto Pinelli (Mountains Wilderness), Giuserppe Basile (Associazione Cesare Brandi), Marina Foschi (Italia Nostra, presidente regionale Emilia-Romagna), Antonio Pinelli, Licia Borrelli Vlad, Pier Luigi Cervellati, Vezio De Lucia, Luigi Manconi, Salvatore Settis, Arturo Osio, Carlo Ripa di Meana (presidente sezione romana di Italia Nostra), Anna Donati (assessore alla Mobilità del Comune di Napoli), Francesco Caglioti, Cesare De Seta, Andrea Emiliani, Mario Torelli, Rita Paris, Anna Coliva, Rossella Rea, Carlo Pavolini, Nicola Spinosa, Ruggero Martines, Bernardino Osio, Maria Luisa Polichetti, Corrado Stajano, Marino Sinibaldi, Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Sandro Petraglia, Jacqueline Risset, Chiara Valentini, Carmine Donzelli, Gianfranco Pasquino, Furio Colombo, Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, Tomaso Montanari, Massimo Teodori, Giovanna Borgese, Enrico Menduni, Andrea Purgatori, Chiara Frugoni, Marta Bruscia, Sauro Turroni, Gianni Mattioli, Franca Fossati Bellani, Carla Ravaioli, Annarita Bartolomei, Vito Raponi, Mario Canti, Milton Gendel, Gianni Venturi, Benedetta Origo, Giuseppe Marchetti Tricamo, Elena Doni, Roberto Meneghini, Giuseppe Barbalace, Gianandrea Piccioli, Alfredo Antonaros, Antonio Lubrano, Elio Veltri, Violante Pallavicino, Ivana Della Portella, Paolo Sorcinelli, Toni Jop, Isa e Mario Sanfilippo, Arturo Guastella, Nino Criscenti, Stefano Rolando, Fernando Ferrigno, Pino Coscetta, Gabriella Turnaturi, Massimo Loche, Giovanna Arciprete, Paola Germoni, Stefano Antonetti, Giorgio Cerboni Baiardi, Mario Baccianini, Patrizia Guastella, Valentina Gallenti, Gianluca Guastella, Maria Nicoletta Pagliardi, Fedora Filippi, i consiglieri nazionali di Italia Nostra: Nicola Caracciolo, Maria Teresa Roli, Luca Carra, Giovanni Gabriele, Oreste Rutigliano, Teresa Liguori, Leandro Janni, Franca Leverotti, Maria Rosaria Jacono, Ebe Giacometti, Maria Rita Signorini.
Vittorio Emiliani e Desideria Pasolini dall’Onda (Comitato per la Bellezza), Irene Berlingò (Assotecnici), Marisa Dalai (Associazione R.Bianchi Bandinelli), Alberto Asor Rosa (Rete Comitati), Maria Pia Guermandi (Eddyburg), Donata Levi (PatrimonioSos), Carlo Alberto Pinelli (Mountains Wilderness), Giuserppe Basile (Associazione Cesare Brandi), Marina Foschi (Italia Nostra, presidente regionale Emilia-Romagna), Antonio Pinelli, Licia Borrelli Vlad, Pier Luigi Cervellati, Vezio De Lucia, Luigi Manconi, Salvatore Settis, Arturo Osio, Carlo Ripa di Meana (presidente sezione romana di Italia Nostra), Anna Donati (assessore alla Mobilità del Comune di Napoli), Francesco Caglioti, Cesare De Seta, Andrea Emiliani, Mario Torelli, Rita Paris, Anna Coliva, Rossella Rea, Carlo Pavolini, Nicola Spinosa, Ruggero Martines, Bernardino Osio, Maria Luisa Polichetti, Corrado Stajano, Marino Sinibaldi, Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Sandro Petraglia, Jacqueline Risset, Chiara Valentini, Carmine Donzelli, Gianfranco Pasquino, Furio Colombo, Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, Tomaso Montanari, Massimo Teodori, Giovanna Borgese, Enrico Menduni, Andrea Purgatori, Chiara Frugoni, Marta Bruscia, Sauro Turroni, Gianni Mattioli, Franca Fossati Bellani, Carla Ravaioli, Annarita Bartolomei, Vito Raponi, Mario Canti, Milton Gendel, Gianni Venturi, Benedetta Origo, Giuseppe Marchetti Tricamo, Elena Doni, Roberto Meneghini, Giuseppe Barbalace, Gianandrea Piccioli, Alfredo Antonaros, Antonio Lubrano, Elio Veltri, Violante Pallavicino, Ivana Della Portella, Paolo Sorcinelli, Toni Jop, Isa e Mario Sanfilippo, Arturo Guastella, Nino Criscenti, Stefano Rolando, Fernando Ferrigno, Pino Coscetta, Gabriella Turnaturi, Massimo Loche, Giovanna Arciprete, Paola Germoni, Stefano Antonetti, Giorgio Cerboni Baiardi, Mario Baccianini, Patrizia Guastella, Valentina Gallenti, Gianluca Guastella, Maria Nicoletta Pagliardi, Fedora Filippi, i consiglieri nazionali di Italia Nostra: Nicola Caracciolo, Maria Teresa Roli, Luca Carra, Giovanni Gabriele, Oreste Rutigliano, Teresa Liguori, Leandro Janni, Franca Leverotti, Maria Rosaria Jacono, Ebe Giacometti, Maria Rita Signorini. -
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- PICO DELLA MIRANDOLA, ORIGENE E LA DIGNITA’ DELL’UOMO - LA LIBERTA’ (di Giulio Busi - Origene, uomo senza qualità).25 giugno 2012, di Federico La Sala
Origene, uomo senza qualità
di Giulio Busi (Il Sole 24 Ore, 24 giugno 2012)
Quando nasce l’uomo senza qualità? Verrebbe da dire tra il 1930 e il 1932, gli anni in cui Robert Musil pubblica il suo romanzo-sfogo contro la società di massa. O forse è meglio risalire di qualche decennio indietro, quando l’ottimismo borghese dell’Ottocento comincia a sfiorire? Certo, il personaggio che non sa decidersi su se stesso è icona recente, espressione di crisi e smarrimento. Ma a ben guardare, ha un progenitore più antico e più nobile.
L’individuo senza qualità precede di molto il naufragio dell’età moderna. Spunta già nell’Orazione sulla dignità dell’uomo di Giovanni Pico, scritto emblematico del Rinascimento italiano. Per il Conte della Mirandola, solo l’uomo, tra tutte le creature, non ha un ruolo determinato, una natura prefissata a cui restare ancorato.
Trascinato dall’entusiasmo dei suoi 23 anni, Pico vede l’essere umano come un camaleonte, capace di trasformarsi senza posa. Può innalzarsi al cielo come un angelo o sprofondare in basso, a modo di belva o di demone: «L’uomo è animale di natura varia, multiforme e cangiante» solo a lui «è concesso di ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole». La mancanza di qualità significa per Giovanni la massima libertà e il vero fondamento dell’autonomia dell’uomo.
Questo pensiero, nel 1486, parve pericoloso e valse al Conte una condanna pontificia. L’enfasi sulla capacità di giudizio autonomo non piacque a Innocenzo VIII e ai suoi inquisitori. E ancor meno piacquero i maestri da cui Pico aveva appreso ad amare l’amorfa potenzialità umana.
Uno fra tutti, tra i nomi citati nell’Orazione, destava i sospetti dell’ortodossia. Era quello di Origene, padre della chiesa censurato come eretico, e vero ispiratore di tratti decisivi dell’antropologia pichiana.
Probabilmente nessuno è stato tanto amato e odiato, letto e censurato come Origene. Il più grande teologo dell’età tardo antica (prima e accanto Agostino) condannato per le sue idee dal concilio di Costantinopoli del 533. Giustiniano ordinò che tutta la sua opera fosse distrutta. Fu un atto di barbarie che, secondo il teologo Henri de Lubac, getta sull’imperatore una macchia che neppure la costruzione di Santa Sofia basta a compensare. Per fortuna, Origene aveva scritto moltissimo, e parecchio si salvò dall’ardore distruttivo. Letto di nascosto, o spesso trasmesso in forma anonima, il pensiero di Origene ha lavorato durante il Medioevo come un lievito occulto.
Per districarsi dalle spire dello gnosticismo, Origine immaginò ciò che la filosofia greca non aveva ancora saputo fare. Ovvero una seconda natura, accanto a quella rigorosamente codificata dalle leggi fisiche. Le azioni degli uomini (e degli esseri celesti, a cui Origene credeva fermamente) sono determinate da un atto individuale di volontà. Per esempio, chi sceglie la menzogna, «non lo fa in obbedienza a una struttura preesistente, ma solo per decisione propria o, per dirla con una parola nuova, facendosi egli stesso natura».
In questa frase del commento al Vangelo di Giovanni, e nei molti passi paralleli sparsi per gli altri suoi libri, Origene costruisce la grandezza dell’essere senza qualità. Capace di sbagliare certo, e colpevole nel farlo, ma anche in grado di spezzare le catene del destino.
Questo fondamento metafisico della libertà nasceva dalla lotta contro gli gnostici, i quali propugnavano un soffocante determinismo, una gerarchia dell’essere che inchiodava ciascuno a un posto prefissato. Illuminati da una parte, schiavi della materia dall’altra, e poi angeli e demoni obbligati a ripetere in eterno azioni buone o malvage, in un perenne dejà vu.
Secondo Origene, invece, l’uomo, che di per sé non è nulla, può essere ciò che vuole, se solo lo vuole. D’altra parte, questa indeterminatezza rende reversibile ogni conquista (e ogni colpa). Il bene non è mai raggiunto una volta per tutte, così come il male non è dannazione eterna. Un’opinione, quest’ultima, che pesò molto nel dossier eretico a carico di Origene.
Nelle sue Conclusiones del 1486, Pico non fa mistero della propria simpatia per il vecchio eresiarca alessandrino e anzi, ne proclama a gran voce l’innocenza: «È più razionale ritenere che Origene sia salvo piuttosto che darlo per dannato». Con un colpo di teatro, il giovin signore di Mirandola pretende di sostituirsi ai Concili e al magistero della Chiesa, e non c’è da meravigliarsi se proprio su questa riabilitazione postuma, sostenuta da Pico, si siano concentrati gli strali della commissione papale incaricata di vagliare le Conclusiones.
Ma a parte il gusto per il paradosso e l’intenzione di stupire il proprio uditorio, nel farsi promotore di una rinascita origeniana Pico aveva precise ragioni filosofiche. Un solido filo intellettuale lega il Conte al teologo del III secolo. Un filo che si chiama libertà. È infatti proprio dagli scritti di Origene, che Pico attinge la particolare idea di uomo che è alla base del suo progetto di "dignitas".
Un nuovo libro, curato da Alfons Fürst e da Christian Hengestermann, percorre la carriera dell’uomo senza qualità in panni filosofici, attraverso un ambizioso progetto interdisciplinare tra storia del pensiero politico, teologia, filosofia e letteratura.
Se Pico fu il primo moderno ad accettare la sfida di una simile «teologia della liberazione» ante litteram, la filosofia dei secoli successivi ebbe in Origene un costante punto di riferimento. Da Erasmo ai platonici di Cambridge, a Shaftesbury e, attraverso di questi, a Kant e fino a Schelling, l’antropologia tra Cinque e Ottocento si nutre dell’universalismo origeniano. Riportata alla sua prima matrice storica, l’idea della dignità dell’uomo rivela inaspettate radici teologiche.
Anziché essere frutto esclusivo del secolarismo illuministico, la libertà come diritto inalienabile dell’individuo nasce piuttosto dalla rottura della gabbia cosmica intuita da Origene nel III secolo. È uno sguardo che ci fa riscoprire una corrente sopita del pensiero occidentale, a patto però di chiamare una simile teologia col nome che gli fu dato a suo tempo, tanto a proposito di Origene quanto di Pico: eresia.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- Rosario Villari: «Un sogno di libertà. Napoli e un declino di un impero, 1585-1648». Per chiunque voglia voltarsi indietro per rilanciare oggi la questione meridionale (di Giovanni De Luna - Quelle teste mozzate invocano Masaniello)16 giugno 2012, di Federico La Sala
Rosario Villari
Ritorno di un classico: «Un sogno di libertà. Napoli e un declino di un impero, 1585-1648»
Quelle teste mozzate invocano Masaniello
di Giovanni De Luna (La Stampa - TuttoLibri, 16.06.2012)
Un oceano quasi immobile di subalternità, increspato ogni tanto da un improvviso ed effimero moto di ribellione. Tra i tanti luoghi comuni affiorati nel dibattito che ha accompagnato, nel 2011, la riflessione sulla nostra storia unitaria, questo, che si riferisce alla storia del Mezzogiorno, è uno dei più consolidati, fronteggiato da quelli che favoleggiano sulle ricchezze saccheggiate dal Nord o sulla virtuosità del sistema di governo dei Borboni.
Sono immagini speculari, molto diffuse nel senso comune, ma che c’entrano poco o niente con la ricerca storica. Sembra così opportuna la scelta di Rosario Villari di ripubblicare una sua opera classica, del 1967, ampliandola con parti completamente nuove, dedicata a Napoli tra il 1585 e il 1648 ( Un sogno di libertà. Napoli e un declino di un impero, 1585-1648, Mondadori). Due date, per due rivolte contro il dominio spagnolo. Entrambe concentrate in pochi giorni di violenza, ma con uno spessore che non si lascia imprigionare nello schema dell’accensione improvvisa e della follia sanguinaria del popolo.
La prima si concluse con l’esposizione delle teste dei rivoltosi in un macabro monumento. Avrebbe dovuto essere un monito severo contro chi si ribellava all’autorità spagnola; in realtà fu rimosso perché perpetuava la collera degli sconfitti, pronta a riesplodere, come avvenne nel 1647, con lo stesso tragico epilogo, con l’eccidio di Masaniello e dei suoi compagni.
Le pagine di Villari ci accompagnano nei meandri delle rivolte, permettendoci di entrare in contatto con un composito universo di figure individuali e di attori sociali, in una serie di cerchi concentrici che partono dal più largo (Madrid e il potere lontano della Corona) e riattraversano in successione la corte napoletana del Vicerè, i baroni insaziabilmente a caccia di privilegi, il banditismo delle campagne, esponenti dei ceti provinciali e periferici («leggitori di libri» li definì un cronista dell’epoca) che alimentarono i primi progetti di indipendenza e di rifiuto del dominio baronale, le «profezie» visionarie di Tommaso Campanella e, infine, il popolo, con i suoi istinti plebei ma anche con la generosità di alcune figure di uomini consapevoli, come Giulio Genoino e lo stesso Masaniello.
Un groviglio di interessi contrapposti, un affresco complesso che interagisce con le rivolte in Portogallo, in Catalogna, nelle Fiandre, teatri di guerra lontani, ma che scardinano il nostro Mezzogiorno da ogni ruolo periferico e marginale, lo inseriscono nel cuore della crisi dei domini spagnoli, della rete delle relazioni diplomatiche con la Francia, in una dimensione che si nutre dei fermenti sociali e culturali dell’Europa di allora.
Certo tutto finisce male. Ma in quelle rivolte ci sono speranze di futuro, aneliti di libertà che appartengono al Mezzogiorno italiano così come il conformismo, l’ossequio ai potenti, l’immobilismo. C’è di tutto: proteste per la fame, ansie religiose, banditismo, attese messianiche, fremiti libertini, «una volontà di rifiuto radicale, di eversione». E su tutto incombe il prezzo enorme pagato dal Mezzogiorno a quelle sconfitte.
Scrivendone secoli dopo, Vincenzo Cuoco osservava come «una rivoluzione ritardata o respinta è un male gravissimo, di cui l’umanità non si libera se non quando le sue idee saranno di nuovo al livello coi governi suoi... Ma talora passano dei secoli e si soffre la barbarie prima che questi tempi ritornino». Nel 1799, lui stesso era stato protagonista dell’effimera ma straordinaria avventura della Repubblica partenopea, soffocata nel sangue dai cattolicissimi sanfedisti del cardinale Ruffo.
Per chiunque voglia voltarsi indietro per rilanciare oggi la questione meridionale, questo libro offre una traccia importante, proponendo di leggere in quei sussulti e in quelle sconfitte uno dei cardini su cui fondare la ricerca delle energie che si sono proposte di riscattare il Sud dalla miseria e la sua storia dalla suggestione dei luoghi comuni.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- LA GRECIA E LA MEDIAZIONE DELLA CALABRIA. LA LEZIONE STORICA E TEOLOGIO-POLITICA DI BOCCACCIO.24 maggio 2012, di Federico La Sala
 LA GRECIA, LA MEDIAZIONE DELLA CALABRIA, E IL RINASCIMENTO ITALIANO ED EUROPEO. In memoria di Barlaam (Bernardo) e di Leonzio Pilato ...
LA GRECIA, LA MEDIAZIONE DELLA CALABRIA, E IL RINASCIMENTO ITALIANO ED EUROPEO. In memoria di Barlaam (Bernardo) e di Leonzio Pilato ...
 PER BOCCACCIO, NEL 2013, UNA GRANDE FESTA IN TUTTA L’ITALIA E L’EUROPA!!! Dopo 700 anni (dalla nascita), tutta viva la sua sacrosanta indignazione e tutto libero il suo spirito critico. Materiali sul tema
PER BOCCACCIO, NEL 2013, UNA GRANDE FESTA IN TUTTA L’ITALIA E L’EUROPA!!! Dopo 700 anni (dalla nascita), tutta viva la sua sacrosanta indignazione e tutto libero il suo spirito critico. Materiali sul tema
-
> UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- INGIUSTIZIA EPISTEMICA. Una rivoluzione culturale. Ma bisogna fare in fretta. Subito. Contro il femminicidio migliaia di firme: «È una strage, ora basta» (Note di Daniela Amenta e di Natalia Apesi).29 aprile 2012, di Federico La Sala
- ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO?" (Franca Ongaro Basaglia). Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
 DONNE, UOMINI, E INGIUSTIZIA EPISTEMICA:«CHANGING THE IDEOLOGY AND CULTURE OF PHILOSOPHY»! La “rabbia” di Sally Haslanger, filosofa del Mit. Una nota di Franca D’Agostini
DONNE, UOMINI, E INGIUSTIZIA EPISTEMICA:«CHANGING THE IDEOLOGY AND CULTURE OF PHILOSOPHY»! La “rabbia” di Sally Haslanger, filosofa del Mit. Una nota di Franca D’Agostini
 Contro il femminicidio migliaia di firme
Contro il femminicidio migliaia di firme
 «È una strage, ora basta»
«È una strage, ora basta» All’appello delle donne risponde il web compatto. E moltissimi uomini ai quali si chiede di non essere complici della mattanza.
All’appello delle donne risponde il web compatto. E moltissimi uomini ai quali si chiede di non essere complici della mattanza.
 Aderiscono, tra gli altri, Camusso, Bersani, Finocchiaro, Saviano e il direttore dell’Unità Sardo
Aderiscono, tra gli altri, Camusso, Bersani, Finocchiaro, Saviano e il direttore dell’Unità Sardo di Daniela Amenta (l’Unità, 29.04.2012)
di Daniela Amenta (l’Unità, 29.04.2012)Telefono Rosa. «Il volontariato non può sostenere da solo questa battaglia» I numeri dell’orrore. La violenza maschile in Italia è la prima causa di morte
Cinquantaquattro con Vanessa dall’inizio dell’anno. Una media aberrante, tragica. Un mattatoio. Il mattatoio delle donne in Italia. Cinquantaquattro in quattro mesi. Massacrate, stuprate, violate, uccise. Uccise da uomini che conoscevano. L’Orco difficilmente è lo sconosciuto incontrato per strada o in Rete. E’ in casa l’Orco, il Barbablù, l’assassino. È l’ex che non ci sta, è il fidanzato geloso, è il marito violento.
Sempre lo stesso rituale. Sempre le stesse vittime. Cambiano nomi, luoghi, situazioni, ma le vittime sono sempre le stesse. Hanno gli occhi scuri di Vanessa, 21 anni di Enna, i capelli chiari di Edyta massacrata il giorno di San Valentino a Modena, il sorriso di Stefania ammazzata dal fidanzato che «l’ amava più della sua stessa vita».
Le donne hanno detto basta mille volte, un milione di volte. Sono scese in piazza, hanno trovato la chiave di lettura per il femminismo del terzo millennio grazie alle mobilitazioni di Se non ora quando, alla denuncia di Lorella Zanardo attraverso Il corpo delle donne, alle inchieste, alle manifestazioni. Eppure, eppure sembra non bastare mai. Per questo, dopo la morte assurda di Vanessa, parte un nuovo appello che chiede agli uomini di non essere complici di questa strage, e alle donne di tenere altissima l’attenzione. Serve, in questo nostro Paese, una rivoluzione che rimetta le donne al centro della comunità, restituendo loro rispetto e dignità.
Un appello lanciato da Snoq, Zanardo, Loredana Lipperini e che potete firmare anche sul nostro sito, unita.it. Hanno già aderito in migliaia. Dalla leader Cgil Susanna Camusso al segretario Pd Pier Luigi Bersani che su Twitter scrive: «Si uccidono le donne. Le uccidono i maschi. È ora di dirlo, di vergognarcene, di fare qualcosa per stroncare la barbarie». Migliaia di firme: da Roberto Saviano a Renata Polverini, da Beppe Vacca ad Anna Finocchiaro, da Vendola all’Idv, dal direttore dell’Unità Claudio Sardo al presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che spiega: «Come uomo penso sia necessario impegnarmi affinché questa violenza persecutoria possa arrestarsi».
Una sequenza di nomi: lo stesso , lo stesso sgomento per commentare il femminicidio. Un neologismo, coniato nel 2009 per la condanna del Messico alla Corte interamericana dei diritti umani dopo morte di 500 donne e la scomparsa di altrettante a Ciudad Juarez. Dallo scorso otto marzo questa parola lugubre e drammatica è stata usata anche per il nostro Paese da Rashida Manjoo, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne. «È la prima causa di morte in Italia perledonnetrai16ei44anni».Il femminicidio indica «ogni forma di discriminazione e violenza rivolta contro la donna in quanto donna». Psicologica, sociale, fisica, fino alla morte: una violenza continua che in Italia continua a mietere vittime per «fattori culturali», quando si considera la donna come un oggetto di proprietà e chiunque «padre, marito e figli» decidono della sua vita. «Con dati statistici che vanno dal 70% all’87% la violenza domestica risulta essere la forma di violenza più pervasiva che continua a colpire le donne italiane» ha detto Rashida Manjoo.
E intanto le donne continuano a morire. Solo il 10% ha la forza di denunciare molestie e abusi. Perché non è facile sfuggire allo stalking, alla violenza. Anzi, diventa un calvario se si hanno figli. Esistono, è vero, residenze protette ma sono poche, gestite con un residuo di fondi. Una piaga mostruosa lasciata in mano al volontariato, soprattutto. Per questo Maria Gabriella Moscatelli presidente di Telefono Rosa, la storica associazione contro la violenza sulle donne, ha scritto al premier «Chiediamo al governo di farsi carico di questa situazione intollerabile. Servono risorse economiche e una Commissione straordinaria per fronteggiare questa tragedia. Sono queste le due condizioni senza le quali nessuna azione può realmente portare a dei risultati». Per la presidente «è evidente che strumenti, risorse e azioni al momento in atto non siano sufficienti». Fondi, certo. E leggi. E impegno. Perché le donne non siano lasciate sole. Soprattutto serve una rivoluzione culturale. Ma bisogna fare in fretta. Subito.
I maschi padroni delle nostre vite
di Natalia Aspesi (la Repubblica, 29.04.2012)
E va bene, aderiamo all’appello; e poi? Siamo d’accordo, lo sono tutti, chissà, anche quell’uomo sconosciuto e adesso certo del suo equilibrio che magari tra mesi o anni strangolerà furibondo una moglie disubbidiente e in fuga. Ascoltate le donne di "Se non ora quando".
E su Twitter una valanga di femmine e maschi, il femminicidio riguarda la politica, è la politica che deve intervenire. Per impedire che in Italia le donne continuino a crepare per il solo fatto di essere donne: nel 2006 gli uomini ne hanno uccise 101, nel 2007 107, nel 2008 112, nel 2009 119, nel 2010 120, nel 2011 137; e nel 2012 le donne ammazzate sono già 54. Ammazzate soprattutto da mariti o ex mariti, da conviventi o ex conviventi, da innamorati respinti: il 70 % delle assassinate erano italiane, il 76 % degli assassini sono italiani.
Ma quanti articoli arrabbiati abbiamo scritto, quanti appelli sdegnati abbiamo firmato, ad ogni efferata, cieca, mortale vendetta di un uomo che ammazza la sua donna "per troppo amore", negli ultimi decenni? Quante volte il cronista, preso dall’idea che la passione giustifica tutto, ammanta le coltellate, le randellate, come sì certo era meglio che no, ma si sa, un uomo innamorato poverino, si acceca e chissà quanto era stato provocato. E giù il passato della morta, a scovarne, storie e possibili deviazioni, in più, meticolosa descrizione del povero cadavere, possibilmente con foto dei poveri resti.
C’è una misteriosa, segreta abitudine italiana di considerare le donne come gran brave persone certo, con gli stessi diritti certo, ma diverse, nel senso di un po’ ambigue, e sempre un po’ colpevoli: dall’aver lasciato scuocere la pasta a volersene andare, sfuggendo, meglio tentando di sfuggire a un ordine, a una consuetudine, a una sudditanza, in qualche modo disubbidendo a un uomo che, proprio perché sempre più fragile e insicuro, spaventato da quella persona che lo giudica e gli si oppone o addirittura non ne vuole più sapere, sente il bisogno di prevaricare, di essere riconosciuto come maschio, quindi come padrone.
Guai a dirlo, ma è così: del resto il famoso delitto d’onore, pare impossibile, è stato cancellato dalla nostra legislazione solo nel 1981. E la legge che condannava alla galera la traditrice (ma non il traditore), è stata abrogata del tutto nel 1969.
Quando, alla fine degli anni ’60, cominciarono i processi per stupro, perché finalmente le ragazze superando la vergogna personale e il disprezzo popolare, osavano denunciare il loro stupratore, bisognava sentire gli avvocati in difesa del ragazzone stupratore, come infierivano sulla "colpevole", chiedendo conto del passato della sua verginità, e che mutande portava, e perché non si era comportata come Maria Goretti, per non parlare delle mamme dei maschi "vittime" di quella sporcacciona, a lacrimare, a raccontarne l’indole pia e innocente.
Certo il paese è cambiato, la giustizia pure, ma gli uomini e la loro idea di potere legata al sesso, meno: in guerra lo stupro di massa fa parte del conflitto, in pace la donna continua ad essere una preda: la ventenne rapita e torturata da omacci l’altra sera a Voghera, gli episodi milanesi di una madre violentata in un parco in pieno giorno, di ragazze palpeggiate in metropolitana, continuano la storia del corpo della donna disponibile al desiderio di qualunque maschio, come un oggetto tra l’altro senza valore, usabile, deteriorabile.
Anche qui, siamo nella tradizione: da ragazze, noi vecchiette di oggi, sapevamo che in tram saremmo state palpate, pizzicate, che una mano, ed altro, si sarebbero appiccicati al nostro sedere. Si diventava rosse e si stava zitte, e ci si rassegnava all’odiosa imposizione. E quando adolescenti tornando in pieno giorno da scuola, c’era sempre in un angolo un signore con la patta aperta, tanto così per mostrare con orgoglio le sue virtù virili? Anche lì zitte, come se in qualche modo fosse colpa nostra.
Sono storie lontane, ormai ridicole, e fortunatamente oggi una palpata non richiesta viene denunciata, suscita l’indignazione di massa e uno stupratore rischia anni e anni di galera. A beccarlo naturalmente. Perché ciò che indigna di più della violenza misogina, e ovviamente ancor più della vita strappata a tante donne, è che troppo spesso non si trova il colpevole: il fidanzato? Forse. Il compagno? Potrebbe essere. L’ex marito? Chissà. Ci sono ammazzamenti di donne che rendono furibonda la televisione che mette in piedi a ogni ora dibattiti infuocati, presente anche il sospettato autore del delitto. Poi ci si stufa e non se ne parla più, né interessa sapere se poi il delinquente è stato trovato o se invece si è condannato un innocente.
Ai processi qualche volta ci si arriva, ma poi, come nel "delitto di via Poma", la condanna era ingiusta, il condannato innocente viene giustamente liberato, e intanto, ancora una volta resta impunito l’omicidio di una povera giovane bella ragazza di cui a fatica ormai ci ricordiamo il nome. Le donne ammazzate, diventando una notizia troppo frequente, finiscono col meritarsi ormai poche righe frettolose, oppure ne scrivono solo i giornali di provincia, a meno che la storia sia particolarmente efferata o se appunto qualcuno, donne, si stufa e si ribella. E propone un appello: certo che in tanti si aderisce all’appello affinché la strage finisca. Ma la domanda che per ora non ha risposta è: perché questa strage? Perché ancora è così difficile per un uomo, non necessariamente un criminale, sarebbero troppi, accettare la libertà della donna, l’integrità del suo corpo, la sua volontà, le sue scelte? Perché la sua difesa troppo spesso è solo la violenza? Perché? Ma se lo chiedono gli uomini, tutti quanti, anche i più irreprensibili, e generosi, e ahi! innamorati?
- ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO?" (Franca Ongaro Basaglia). Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- Le campane suonano per le “sepolte vive”. Storia delle monache, 1450 al 1700, un panorama grandioso (di Mirella Appiotti).18 aprile 2012, di Federico La Sala
 Storia delle monache
Storia delle monache
 Dal 1450 al 1700, un panorama grandioso tra avvelenamenti, ricatti, autoflagellazioni, ribellioni vere o sognate
Dal 1450 al 1700, un panorama grandioso tra avvelenamenti, ricatti, autoflagellazioni, ribellioni vere o sognate
 Per molte donne il convento era l’unica via, pre e post Controriforma, per la costruzione di una propria identità
Per molte donne il convento era l’unica via, pre e post Controriforma, per la costruzione di una propria identità
 Le campane suonano per le “sepolte vive”
Le campane suonano per le “sepolte vive” di Mirella Appiotti (La Stampa TuttoLibri, 14.04.2012)
di Mirella Appiotti (La Stampa TuttoLibri, 14.04.2012)- Siliva Evangelisti, Storia delle monache (1450-1700) Il Mulino, pp. 281, 26
Sassi e tegole piovono sui muratori incaricati di rinforzare le mura del convento di Santa Cristina (Bologna, 1628) e, dalla finestra, «un grosso marmoro» ha come bersaglio la testa del notaio inviato dalle autorità: è la lotta «armata» delle promesse spose di Gesù contro l’inasprirsi della clausura postridentina. Un secolo e rotti più tardi, per la povera Suzanne Simonin chiusa nel monastero delle Clarisse a Longchamp, «furono suonate le campane affinché tutti sapessero che si stava creando un’infelice», ovvero la discesa agli inferi della piccola, intramontabile Religeuse di Diderot (usurpata poi dalla Rivoluzione). Del resto Lutero è un ex agostiniano sposato alla ex suora Caterina von Bora.
A fronte di ribellioni, vere, sognate o cantate da secoli in ogni forma d’arte, nella grande «fiction», Dante e Manzoni, Boccaccio e Stendhal, Verga e Pascoli (Myricae «... queste bimbe, queste vergini... »), tra Abelardo e Eloisa e La monaca portoghese, nella splendida ricostruzione teatrale di Maricla Boggio, in realtà l’avventura della «monacazione» posa su consensi (ancor vivi, con o forse grazie a Internet), fortissimi all’epoca. Non solo nelle fughe notturne di superagiate e nobili ragazze «per cercare rifugio nel monastero» dai soprusi familiari, o nell’estremo gesto di buttarsi «nell’acqua bollente allo scopo di deturpare la propria apparenza e rendersi, così, poco appetibili sul mercato matrimoniale... » quando la fede viene contrastata o, più comunemente, lo sposo designato è vecchio e laido...
Contro la «circoncisione dell’intelletto», Jacqueline Pascal, la sorella di Blaise, combatte a fianco della Mère Angélique e consorelle per la difesa di Port Royal; il dramma delle monache costrette, a metà ’500 dai seguaci delle 95 tesi di Wittenberg, a lasciare il convento violato, è tuttora vivido nella Petite Chronique di Jeanne de Jussie, badessa a Ginevra. Un panorama grandioso, tra enormi miserie (avvelenamenti, ricatti, autoflagellazioni oltre all’uso di sesso), che Silvia Evangelisti ridisegna nella sua Storia delle monache .
La docente di Storia Moderna all’Università East Anglia prende in esame il periodo dal 1450 al 1700, in una prospettiva che indaga, con un più di passione attraverso la vita delle «sepolte vive» che non attraverso le opere largamente note delle appartenenti a comunità aperte, «la funzione sociale e politica dei conventi a partire dal tema specifico dell’espansione degli ordini religiosi e femminili dentro e fuori dell’Europa e nel nuovo mondo» (le missionarie, eroiche, da sempre): secoli cruciali per gli strumenti della religione, per l’affermarsi degli scismi, per l’influenza delle grandi mistiche.
Di questa rivoluzione sotto spoglie reazionarie, una protagonista assoluta sarà Teresa d’Avila che «sposando» la sottomissione delle monache alla clausura, sposava «una missione ben precisa, secondo la quale la Chiesa cattolica se voleva la pace e tornare a essere unita, aveva bisogno delle donne e del loro contributo». A tal punto che il mondo del silenzio (non sempre così stretto, certe recluse di Strasburgo potevano parlare tra loro «in ore prestabilite, però in latino... ») diventerà pressoché l’unica via aperta alle donne, pre e post Controriforma, per la costruzione di una propria identità. In alternativa al matrimonio, era il monastero a offrire buone se non ottime chances.
Non si contano, infatti, in quei decenni le donne scrittrici: da Teresa a Maria Alacoque, altra celebrata mistica, a Fiammetta Frescobaldi, alla prolifica Tarabotti. E così musiciste, pittrici, sponsor (la magnifica «Camera di San Paolo» del Correggio a Parma). Assecondate dalle famiglie per ragioni di immagine e di prestigio, in specie di moneta (essendo anche tre volte meno costosa la dote per una monaca di quella per una ragazza da marito: sicché a Firenze, tra ’500 e ’700, il 46% delle figlie dell’élite prende i voti) e, molto, di politica.
Le donne in Cristo sono state determinanti intermediarie con i poteri, al tempo, davvero «forti» (a Madrid le rampolle Asburgo dal convento delle Descalzes Reales «negoziavano questioni di primaria importanza»), occupandosi del pari delle faccende di casta, al di là e al di qua delle mura, entro le quali soltanto il Vaticano II riuscirà a far saltare, dopo oltre cinque secoli, la ferrea gerarchia tra monache coriste e monache converse. Al contrario, da allora, contro il maschilismo ecclesiastico, ben poco ha potuto la mai spenta «querelle des femmes»: il «contributo delle religiose a una tradizione intellettuale il cui sviluppo si collega al pensiero femminista moderno». Perché, parafrasando Luisa Muraro, «il Dio era ed è delle donne».
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma. E la Chiesa censurò il «Fato» (di Massimo Firpo)17 aprile 2012, di Federico La Sala
E la Chiesa censurò il «Fato»
di Massimo Firpo (Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2012)
Quando Michelangelo, dopo quattro anni di massacrante lavoro, portò a termine la volta della cappella Sistina, sul trono papale sedeva Giulio II (Giuliano della Rovere, 1443-1513, papa dal 1503), impegnato a guidare i suoi eserciti nel carnaio delle guerre d’Italia, con il loro seguito di carestie, pestilenze, saccheggi, violenze d’ogni sorta. Lungi dal liberarla dai barbari - come papa Della Rovere auspicava - quelle guerre avrebbero cancellato l’autonomia delle sue piccole corti rinascimentali, ricche d’arte e di cultura ma militarmente impotenti di fronte ai poderosi eserciti dei grandi Stati in costruzione come la Spagna e la Francia, che ambivano a farsi padroni della penisola. Nel 1527 Roma stessa fu presa e messa a sacco, e Clemente VII (Giuliano de’ Medici, papa dal 1523 al 1534) poté solo rinchiudersi per otto mesi in Castel Sant’Angelo mentre i lanzi tedeschi scorazzavano nelle Stanze vaticane, dove qualcuno incise con la punta della lancia il nome di Lutero sugli affreschi di Raffaello.
Alla crisi politica si aggiunse infatti la crisi religiosa, con la Riforma protestante dilagante non solo in Germania e in tutta l’Europa del nord, ma anche in Svizzera, in Ungheria, in Polonia, in Inghilterra, nelle Fiandre e nella stessa Francia. La drammatica frattura della cristianità parve mettere in discussione l’esistenza stessa della Chiesa di Roma.
Alla metà degli anni 30 Michelangelo tornò a lavorare nella Sistina, ma questa volta per dipingervi sulla parete d’altare il Giudizio, voluto da Clemente VII in segno di penitenza, così come segno di penitenza fu la barba che il papa si fece crescere dopo il sacco e che i suoi successori avrebbero portato a lungo. Quel capolavoro fu scoperto nel 1541, e da allora i vicari di Cristo avrebbero celebrato la messa vedendo davanti a se la bocca dell’inferno. Di lì a poco Paolo III (Alessandro Farnese, papa dal 1534 a1 1545) convocò il concilio di Trento per fronteggiare le eresie che si diffondevano anche in Italia, si affacciavano nel sacro collegio e affioravano negli ultimi affreschi di Michelangelo nella cappella Paolina, finiti in gran fretta nel 1549 per ospitarvi il conclave che avrebbe visto il primo successo della neonata Inquisizione.
Dai pontificati di Alessandro VI e di Leone X a quelli di Pio V e di Sisto V, dall’età di Ludovico Ariosto e di Baldassar Castiglione, di Niccolò Machiavelli e di Pietro Bembo a quello di Torquato Tasso e di Giovanni Botero, di san Carlo Borromeo e di san Roberto Bellarmino - dal Rinascimento alla Controriforma insomma -, trasformazioni profonde investirono l’Italia, con conseguenze destinate a protrarsi fino a oggi, nelle strutture economiche e politiche, nell’identità culturale e religiosa, nel costume sociale.
Mentre il Mediterraneo perdeva la sua millenaria centralità economica a vantaggio dell’Atlantico, le grandi monarchie sviluppavano nuove strutture politiche e l’Italia restava sotto il controllo della feudalità meridionale o degli inamovibili patriziati centrosettentrionali. Fenomeni di aristocratizzazione sociale, teorizzati nelle pagine del Cortegiano di Baldassar Castiglione e del Galateo di Giovanni Della Casa (entrambi ecclesiastici), accompagnavano il crescente pauperismo di contadini affamati che si affollavano pericolosamente nelle città. Alla stagione dell’umanesimo e di un dilagante anticlericalismo (che traeva alimento da una Chiesa screditata e corrotta) succedeva quella della censura, della disciplina, dell’obbedienza, della repressione.
Fu in quei decenni che presero corpo non pochi elementi della "fede degli italiani" sulla quale ha più volte insistito Adriano Prosperi, e del loro disagio della libertà, secondo il titolo dell’ultimo libro di Corrado Augias. Al cuore di queste molteplici trasformazioni conducono gli studi di Gigliola Fragnito ora raccolti nel volume Cinquecento italiano. Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma, esito di uno scavo in più direzioni che restituisce con efficacia e rigore la grande complessità dei problemi che vi sono indagati. Ne emergono passaggi cruciali nella storia della Chiesa e con essa della società italiana, che molti manuali continuano a insegnare come incentrata sul concilio di Trento, senza coglierne anche la valenza ideologica di mito fondatore della cosiddetta riforma cattolica, che trovò invece nell’Inquisizione il suo strumento più efficace.
L’energica ripresa del papato postridentino, con il rapido mutare del ruolo del sacro collegio e delle corti cardinalizie nella Roma cinquecentesca, non tardò infatti a mettere a tacere ogni istanza di autonomia di un episcopato che il concilio aveva richiamato al dovere della residenza per valorizzarne l’impegno pastorale, ma poi depotenziato dal centralismo della curia romana, e dalle strutture preposte a un occhiuto controllo della vita religiosa.
Nei suoi primi decenni di vita, del resto, l’Inquisizione mirò soprattutto a stroncare il dissenso religioso penetrato ai vertici stessi della Chiesa, a combattere cioè ogni istanza di rinnovamento che non fosse quella fondata sul ripristino dell’ortodossia tomistica e del primato petrino, usando senza troppi scrupoli l’arma del sospetto ereticale per colpire i suoi avversari e impadronirsi in tal modo dei meccanismi dell’elezione papale.
Mentre si estinguevano le incoercibili ambizioni temporali e nepotistiche che segnarono il pontificato di Paolo III, il Sant’Ufficio divenne il canale privilegiato per la promozione delle carriere ecclesiastiche. Di qui, anche i persistenti conflitti tra Chiesa e Stato che inficiano la prospettiva di una loro sostanziale concordia nell’imporre quel "disciplinamento" sociale e politico in cui si è voluto vedere un elemento costitutivo del mondo moderno.
Al di là della baldanza apologetica e del compiacimento per le patrie glorie di chi ha voluto presentare l’Italia come un perenne faro di civiltà (artium studiorumque plena recita l’iscrizione sotto un trionfante trono papale posta in copertina del recente libro di Francesco Bruni, Italia. Vita e avventure di un’idea, il Mulino), quella svolta fu decisiva nel definire gli spazi di libertà, la sensibilità e l’identità stessa degli intellettuali.
Un occhiuto sistema censorio si instaurò allora in ogni parte della penisola, dove anche i poeti dovettero guardarsi non solo dall’evocare immagini lascive ma anche dall’usare parole come "fato", che poteva suonare come un’allusione alla dottrina della predestinazione.
Non solo i teologi, dunque, ma anche i letterati, gli scienziati, i filosofi furono censurati e inquisiti, come hanno mostrato gli studi della stessa Fragnito sugli Indici dei libri proibiti nel secondo ’500 e sulle loro conseguenze, a cominciare dall’assoluto divieto fatto ai laici di leggere una sola riga della Bibbia in volgare, presupposto del plurisecolare analfabetismo religioso degli italiani. Studi essenziali per capire 1’Italia moderna: sia l’antico e capillare ruolo non solo pastorale ma anche politico che vi esercita la Chiesa, sia le peculiari modalità di intendere e di vivere la propria fede in un paese più familiare con il clero e con le pratiche devozionali che con la parola di Dio.
-
>LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- E IL RITORNO DI MELUSINA, LA SIRENA CON LA CODA DOPPIA, A CONTURSI TERME.6 aprile 2012, di Federico La Sala
IL RITORNO DI MELUSINA, LA SIRENA CON LA CODA DOPPIA, E DELLE SIBILLE,
NELLA CITTA’ DI CONTURSI TERME, NELLA VALLE DEL SELE.
Materiali per riflettere ancora e di nuovo sul tema
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- RIMEDITARE LA LEZIONE DELLA VOLTA DELLA "CAPPELLA SISTINA". Al cardinale Angelo Amato e all’arcivescovo di Salerno Luigi Moretti, una sollecitazione.30 marzo 2012
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- VALENTINA DEL PIZZO, ARCHEOLOGA: Salvare la Chiesa di Maria SS. del Carmine a Contursi.31 marzo 2012
Salvare la Chiesa di Maria SS. del Carmine a Contursi
di Valentina del Pizzo *
Dalle pagine della rivista online “La voce di Fiore”, si è levato un accorato appello rivolto sotto forma di missiva, a cura di Federico la Sala, indirizzata al Soprintendente per i Beni architettonici della Provincia di Salerno, Gennaro Miccio, perché intervenga al fine di salvaguardare la Chiesa di Contursi dedicata a Maria Santissima del Carmine.
Intitolata probabilmente al patrono di Contursi, San Donato Vescovo, la fondazione della Chiesa, in principio una cappella, risale ad un periodo antecedente il XV sec.: composta da un’unica navata culminante in un’abside a pianta quadrata, la chiesa è stata di recente restaurata dalla locale Soprintendenza. Questi lavori hanno consentito di mettere in luce le decorazioni a tempera che adornano le pareti interne delle dieci cappelle in muratura, decorate con stucchi e cornici, che si aprono lungo le pareti laterali: si sono potute così distinguere delle Sibille i cui diretti confronti sono nella Cappella Sistina di Michelangelo o con gli affreschi di Raffaello nella Chiesa romana di Santa Maria della Pace, secondo un motivo iconografico caro al Rinascimento italiano e che data i nostri al pieno XVI sec.
I lavori di restauro architettonico hanno interessato il consolidamento generale della struttura e delle murature che versavano in cattive condizioni. Il tetto è stato sostituito da una nuova copertura in pianellato di cotto ed orditura di legno, sovrapposta a capriate lignee, con l’inserimento di elementi strutturali di ferro.
L’intervento, resosi necessario a seguito del terremoto del novembre 1980, si sono conclusi nel 1989, tuttavia oggi la chiesa versa in uno stato di abbandono, con erbacce che intasano il corretto deflusso delle acque e che vanno ad infiltrarsi nelle pareti provocando danni già disastrosi ed evidenti all’interno, nonché favorendo l’avvio del cedimento dell’orditura che tiene l’intero manto delle tegole.
Problemi non del tutto risolti di umidità non rassicurano sulla conservazione delle decorazioni parietali, rischiando di sottrasse alla fruizione da parte della comunità e dei potenziali visitatori delle dodici Sibille rinascimentali e del loro messaggio di Rivelazione. Queste infatti dalla Sibilla Cumana alla Sibilla Aegyptia, di modesta fattura e di complessa lettura, si susseguono fino all’altare, dietro il quale sorge una pala del 1608 di Jacopo de Antora, raffigurante il Profeta Elia, il profeta Giovanni Battista ed in alto, su una nuvola, Maria con il Bambino, mentre alle loro spalle svettano le colline del Carmelo, con chiese e grotte, ed un’iscrizione che menziona il committente Paolo Pepe, nipote di Paolo Antonio Pepe, alla cuimemoria l’opera è dedicata: un patrimonio fondamentale per il quale urgono interventi urgenti di recupero e consolidamento affinché non si perda del tutto l’effettodel restauro dello scorcio degli anni ottanta, determinando così un doppio spreco, delle opere e di risorse impiegate in passato.
Una curiosità: i Pepe sono gli antenati dei Rosapepe, noti oggi per gli stabilimenti termali e chissà se non fossero disponibili ad assumere anche il ruolo di Mecenati, finanziando, in tempi di magra, per la gestione e la manutenzione del nostro patrimonio culturale, un restauro degno di un paesino che ha fatto dell’industria turisticalegata agli stabilimenti termali, il proprio vanto.
Valentina Del Pizzo
* Fonte: “UNICO Settimanale”, n. 11, 24.03.2012, PAG. 18
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Gemisto Pletone. Incontro con Massimo Cacciari (di Marco Filoni - "Politica e amicizia dal neoplatonismo ai social network")15 aprile 2012, di Federico La Sala
"Politica e amicizia dal neoplatonismo ai social network"
Incontro con Cacciari sull`influenza di filosofi come Ficino e Pico
di Marco Foloni (la Repubblica, 12 aprile 2012)
Per governare bene e con sapienza ci vorrebbe un mago. Nella Firenze a cavallo fra Quattro e Cinquecento l`espressione non avrebbe suscitato scalpore. Per capirne il motivo converrà allora ripercorrere Il viaggio di Platone nel Rinascimento italiano, ovvero la trasmissione del platonismo e del neoplatonismo nel nostro paese. Per farlo abbiamo a disposizione una serie di testi che l`editore Bompiani ha pubblicato negli ultimi anni. Alcuni di questi (Marsilio Ficino, Teologia platonica; Pico della Mirandola, Dell`ente e dell`uno; Gemisto Pletone, Trattato delle virtù) saranno presentati oggi a Milano da Massimo Cacciari e altri studiosi (Marco Bertozzi, Michele Ciliberto e Giovanni Reale, alle 18.30 nel Teatro Franco Parenti di Milano).
Professor Cacciari, perché queste opere sono così importanti? «Abbiamo a che fare contesti capitali per la cultura europea. La teologia platonica di Marsilio Ficino segnainmanieraindelebilel`Umanesimo e il Rinascimento. Così come l`opera di Pico della Mirandola. Fu Cosimo de` Medici a creare l`Accademia Neoplatonica, affidata a Ficino, con l`intento di trasmettere e far conoscere Platone. Bisognaperò tener conto che ilPlatone ficiniano è strettamente legato all`ermetismo. Direi anzi che la vera novità del platonismo fiorentino è proprio questa combinazione fra un Platone ermetico, iniziatico, e uno logico-filosofico».
E come si traduceva sul piano politico questa specie di sincretismo? «I platonici fiorentini avevano un dramma teoretico che era la concordia fra Platone e Aristotele. Ma dovevafar parte di una concordia più ampia, che risuona nel tema della prisca theologia: l`idea di un`origine comune di tutte le filosofie ma anche di tutte le teologie. E poiché si pretendeva di poter intuire questa comune origine, questo rendeva possibile pensare un fine comune».
Che era un fine politico... «Lo scopo era la pace: quella religiosa, certo, ma anche politica. Basti ricordare l`appello di Pio II, il papa umanista, al sultano. La prisca theologia era considerata la sola in grado di fondare la pace universale e superare così le controversie che affliggevano i monoteismi abramitici. Ma questa pro- spettiva era pericolosissima: in fondo implicava che le religioni storiche fossero destinate a scomparire».
In fondo questi filosofi ispiravano l`azione politica. «Questi grandi teologi erano anche uomini politici e avevano in mente il modello platonico. Ma non quello di consigliere del tiranno, del re-filosofo. Piuttosto pensano alla paideia della città, all`istruzione e all`educazione da cui emerge un`élite - dalla quale può anche venir fuori il tiranno, ma filosofo o educato filosoficamente. Non si immaginano mai come consiglieri del tiranno, ma pedagoghi dell`élite politica».
E quali sono i capisaldi di questa educazione al governo? «Per esempio un grande tema è quello dell`eros, dell`amore. Un aspetto presente poi anche in Giordano Bruno quando descrive l`aspetto pratico-politico del vero mago (che vuol dire sapiente). La natura costruisce vincoli: il piùforte di tutti e quello che deve sussistere affinché nella cittàvi sia polis è il vincolo d`amore. Il vero politico è colui che sa informare la città di questo vincolo, che sa immetterlo con tutta la sua potenza perché legagli uomini».
Per governare avremmo bisogno di maghi di questo tipo? «È importante ripensare il Rinascimento non solo sottolineando la sua dimensione etico-pratica. Vi era un aspetto ontologico, espresso da questo platonismo, che vari valutato - e da qui l`importanza di questi libri. Tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato finora sono aspetti teologici, ontologici e politici che formano una visione complessiva, un "cosmo" impossibile oggi da ricostruire o ripensare. Tuttavia ci poniamo alcune domande: può esserci una città in cui il nomos, la legge, ciò che ci unisce, è puramente norma e non ha nulla a che fare con l`idea di amore o con l`idea di amicizia?».
Oggi esistono però altre forme di amicizia, come quelle digitali sui social network, che l`hanno anche coinvolta in una polemica perché le ha definite "per frustrati"... «In quella comunicazione tutto si eguaglia, non ci sono più i vincoli tra i distinti, tutte le parole che circolano sono uguali. Poi possono esser necessari, ineludibili, tutti siamo costretti a usarli. Ma questo non significa che hanno a che fare con il vincolo di amicizia».
L`hanno accusata di parlare di cose che non conosce... «Sono tre anni che combatto contro i falsi profili su Twitter e su Facebook, quindi li conosco bene».
Per tornare ai platonici fiorentini, c`era un ruolo previsto per i tecnici? «Allora c`era la politica, ed era il mestiere di Cosimo e di Lorenzo de` Medici. E poi c`erano anche i tecnici: i vari Brunelleschi, Alberti, Michelangelo, gli architetti, i banchieri e gli amministratori. Del resto nella repubblica platonica non c`è mica soltanto il filosofo-re, ci sono anche le tecniche fondamentali per fare la città. Ma perché vi sia davvero governo della città ci vuole un progetto, ci vogliono grandi idee culturali. Da cosa nasce l`egemonia culturale, artistica e intellettuale italiana dal Trecento al Seicento? Nasce da queste corti, da queste città, dove c`è un`élite politica in grado di comprendere che una cittànon è fatta soltanto dalPil (seppur importante), ma è fatta da Ficino, Pico, Michelangelo, Alberti ...».
E oggi? «Manca l`educazione, manca la paideia, e finché mancherà non possiamo pensare di avere un fine».
-
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- LA GUERRA NELLA TESTA DELLA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA E L’INDICAZIONE ’DIMENTICATA’ DI GIOVANNI PAOLO II28 marzo 2012, di Federico La Sala
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- APPELLO DI CONTURSI: SALVATE LA NOSTRA CAPPELLA SISTINA (di Margherita Siani)28 marzo 2012
APPELLO DI CONTURSI: SALVATE LA NOSTRA CAPPELLA SISTINA
(di Margherita Siani, Il Mattino.Salerno, 26.03.2012)
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- LA SIBILLA ERITREA (di Giovanni Boccaccio - De mulieribus claris, 1361)6 aprile 2012, di Federico La Sala
Giovanni Boccaccio - De mulieribus claris (1361)
Traduzione di Donato Albanzani da Casentino (1397)
Capitolo XIX. Eritrea Sibilla *
ERITREA, o che ella fosse chiamata Erifila, molto maravigliosa donna, fu una delle Sibille. Alcuni certamente pensano che fussero dieci in numero; e chiamarono quelle per proprj nomi. E perchè elleno seppero molto degli augurj, così hanno chiamato quelle per soprannome; perchè sios in Eolio è a dire in latino di Dio, e biles è a dire mente[1]: e per questi due nomi[2] Sibilla è a dire mente divina, ovvero mente di Dio. Delle quali tutte venerabili, dicono, questa essere stata sommamente famosa, appresso quegli di Babilonia essere sua origine alcun tempo innanzi la guerra di Troja[3], benchè molti pensano che ella desse i suoi augurj al tempo di Romolo, re de’ Romani.
E, secondo che dicono, questa ebbe nome Erifila, e fu chiamata Eritrea, perchè lungo tempo abitò appresso Eritrea isola; e in quel luogo compose più scritture. E ebbe questa tanta virtù d’ingegno, ovvero eloquenza, e merito di devozione nel cospetto di Dio, che per sollecito studio, non senza divino dono, meritò (se è vero quello che si legge da lei detto) descrivere con tanta[4] chiarezza le cose future, che piuttosto parve Evangelio che augurio.
Questa certamente, domandata dai Greci[5], disse in versi sì chiaramente le fatiche loro, e la disfazione d’Ilione, che niente ne fu saputo più certo dopo il fatto. E così comprese in poche e vere parole lo imperio de’ Romani e le sue varie fortune per gran tempo innanzi che cominciasse, sicchè piuttosto pareva che ella avesse scritto un’abbreviazione al nostro tempo, che avere predette le cose future.
E (che molto più è segreto della mente divina, secondo mia sentenzia) aperse le parole della Incarnazione del Figliuolo di Dio, dette innanzi interamente per figura dagli antichi profeti; sicchè pare avere dettata una storia, e non avere predetto gli atti che dovessero essere della Incarnazione, della natività, delle opere, del tradimento, della presa e dello scherno, e della disonesta morte, e del trionfo della risurrezione, dell’ascensione, e finalmente del giudizio, e del tornare delle anime.
Fra donne degli antichi fu sì degna di riverenzia, che furono ancora alcuni i quali affermarono, quella avere serrata perpetua virginità: la qual cosa io crederò lievemente, perchè non mi pare che in uno macchiato petto fosse potuto abitare tanta chiarezza di cose future. È scuro in che parte ella morisse.
* WIKISOURCE: De mulieribus claris/XIX (senza le note)
-
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Sebben che siamo donne non ci fa paura la filosofia (e la teologia)! «Changing the Ideology and Culture of Philosophy», un articolo di Sally Haslanger, una delle più brillanti filosofe americane, apparso su Hypathia (di Franca D’Agostini)27 marzo 2012, di Federico La Sala
Sebben che siamo donne non ci fa paura la filosofia
Il «pensiero femminile» è socialmente discriminato: un condizionamento negativo
La “rabbia” di una filosofa americana del Mit: in questo campo siamo discriminate, molte di noi costrette a lasciare
di Franca D’Agostini (La Stampa, 25.03.2012)
Sally Haslanger è una delle più brillanti filosofe americane: in un articolo su Hypathia confessa che da quanto è arrivata al Mit, nel ’98, si è più volte domandata se non fosse il caso di lasciare la filosofia “C’ è in me una rabbia profonda. Rabbia per come io sono stata trattata in filosofia. Rabbia per le condizioni ingiuste in cui molte altre donne e altre minoranze si sono trovate, e hanno spinto molti a lasciare. Da quando sono arrivata al Mit, nel 1998, sono stata in costante dialogo con me stessa sull’eventualità di lasciare la filosofia. E io sono stata molto fortunata. Sono una che ha avuto successo, in base agli standard professionali dominanti». S’inizia così «Changing the Ideology and Culture of Philosophy», un articolo di Sally Haslanger, una delle più brillanti filosofe americane, apparso su Hypathia .
C’è un problema, che riguarda le donne e la filosofia: inutile negarlo. «Nella mia esperienza è veramente difficile trovare un luogo in filosofia che non sia ostile verso le donne e altre minoranze», scrive Haslanger. E se capita così al Mit, potete immaginare quel che succede in Italia. È facile vedere che, mentre in tutte le facoltà le donne iniziano a essere presenti (anche se rimane il cosiddetto «tetto di cristallo», vale a dire: ai gradi accademici più alti ci sono quasi esclusivamente uomini), in filosofia la presenza femminile scarseggia.
Non sarà forse che le donne sono refrattarie alla filosofia, non la capiscono, non la apprezzano? Stephen Stich e Wesley Buchwalter, in «Gender and Philosophical Intuition» (in Experimental Philosophy, vol. 2), hanno riproposto il problema, esaminandolo nella prospettiva della filosofia sperimentale: una tendenza filosofica emergente, che mette in collegamento le tesi e i concetti filosofici con ricerche di tipo empirico (statistico, neurologico, sociologico, ecc). La prima conclusione di Stich e Buchwalter è che effettivamente sembra esserci una «resistenza» del «pensiero femminile» di fronte ad almeno alcuni importanti problemi filosofici. Stich e Buchwalter si chiedono perché, e avanzano alcune ipotesi, ma non giungono a una conclusione definitiva.
Le femministe italiane di Diotima avrebbero pronta la risposta: la filosofia praticata nel modo previsto da Stich e compagni è espressione estrema del «logocentrismo» maschile, dunque è chiaro che le donne non la praticano: sono interessate a qualcosa di meglio, coltivano un «altro pensiero». Ma qui si presenta un classico problema: in che cosa consisterebbe «l’altro pensiero» di cui le donne sarebbero portatrici? Se si tratta per esempio di «pensiero vivente», attento alle emozioni e alla vita, come a volte è stato detto, resta sempre da chiedersi: perché mai questo pensiero sarebbe proprio delle donne? Kierkegaard, che praticava e difendeva una filosofia di questo tipo, era forse una donna?
Forse si può adottare un’altra ipotesi. Come spiega Miranda Fricker in Epistemic Injustice (Oxford University Press, 2007) le donne subiscono spesso ciò che Ficker chiama ingiustizia testimoniale, vale a dire: ciò che pensano e dicono viene sistematicamente sottovalutato e frainteso. Un’osservazione fatta da una donna che gli uomini non capiscono, per ignoranza o per altri limiti, viene all’istante rubricata come errore, o come vaga intuizione. Fricker cita Il talento di Mr. Ripley: «Un conto sono i fatti, Marge, e un conto le intuizioni femminili», dice il signor Greenleaf. Ma Marge aveva ottime ragioni nel sostenere che Ripley aveva ucciso il figlio di Greeenleaf.
In questa prospettiva il quadro muta. Consideriamo la rilevazione dell’attività cerebrale di un ragazzo e una ragazza che svolgono una prestazione intellettuale «di livello superiore», ossia risolvono per esempio un’equazione difficile. A quanto pare, mentre il cervello del ragazzo si illumina in una sezione molto circoscritta dell’emisfero frontale, il cervello della ragazza si illumina in modo diffuso, diverse zone dell’encefalo sono coinvolte. Ecco dunque la differenza emergere dai fatti cerebrali: le donne - così si dice - avrebbero un’intelligenza aperta e «diffusa». Naturalmente, questa diffusività è un limite: è appunto la ragione per cui le prestazioni intellettuali femminili sarebbero meno rapide ed efficaci. L’ipotesi differenzialista a questo punto ribatte: attenzione, l’intelligenza diffusa è un pregio, ed è il mondo che privilegia rapidità ed efficacia a essere sbagliato.
Ma l’altra ipotesi - che tanto Haslanger quanto Fricker indirettamente sostengono - sembra più ragionevole: se c’è un «pensiero femminile», la sua prima caratteristica consiste nell’essere un pensiero socialmente discriminato, che subisce sistematicamente ingiustizie testimoniali. Il cervello discriminato è coinvolto sul piano emotivo, a causa del grande quantitativo di ingiustizia che ha dovuto subire. E a questo punto il mistero è risolto: provate voi a risolvere un difficile problema filosofico in un ambiente in cui tutto vi dice che non sapete risolverlo. Provate, in più, avendo dentro di voi la rabbia descritta da Haslanger: quella che vi viene dal conoscere questa ingiustizia, che riguarda voi ma anche altre persone, e altre minoranze discriminate (anche tra i neri non ci sono molti filosofi). Poi vedete un po’ se non vi si illumina tutto il cervello.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Un’esclusione che interpella tutti. Donne e ministeri da segno dei tempi a indice di autenticità (di Lilia Sebastiani, teologa).20 marzo 2012, di Federico La Sala
Donne e ministeri da segno dei tempi a indice di autenticità
di Lilia Sebastiani
in “Viandanti” (www.viandanti.org) del 10 marzo 2012
Nell’enciclica ‘conciliare’ Pacem in terris di Giovanni XXIII (1963) al n.22 l’ingresso crescente delle donne nella vita pubblica veniva annoverato tra i segni dei tempi, insieme alla crescita delle classi lavoratrici (n.21) e alla fine del colonialismo (n.23).
Ricordare l’enciclica è doveroso, per il valore storico di questo semplice e cauto riconoscimento: infatti è la prima volta che un documento magisteriale rileva la cosiddetta promozione della donna senza deplorarla - anzi come un fatto positivo. I segni dei tempi sono ancora al centro della nostra attenzione, ma per quanto riguarda le donne la questione cruciale e non ignorabile è ormai quella del loro accesso al ministero nella Chiesa, a tutti i ministeri.
Venerande esclusioni
Certo il problema dei ministeri non è l’unico connesso con lo status della donna nella Chiesa, ma senza dubbio è fondamentale; guardando al futuro, è decisivo. Non solo e non tanto in se stesso, ma per la sua natura di segno.
In questo momento nella Chiesa la donna è ancora esclusa dai ministeri ecclesialmente riconosciuti: non solo da quelli ordinati (l’Ordine sacro, cioè, nei suoi tre gradi: episcopato, presbiterato, diaconato) ma anche da quelli istituiti, il lettorato e l’accolitato. Questi ultimi, chiamati un tempo “ordini minori” e considerati solo tappe di passaggio obbligatorie per accedere all’ordinazione, furono reintrodotti nel 1972 da Paolo VI (Ministeria quaedam) come “ministeri istituiti” - per distinguerli da quelli ordinati, mantenendo però l’elemento della stabilità e del riconoscimento ecclesiale - e furono aperti anche a laici non incamminati verso l’Ordine; tuttavia si specificava chiaramente che tali ministeri erano riservati agli uomini, “secondo la veneranda tradizione della chiesa latina”.
Un po’ più recente l’istituzione dei “ministri straordinari dell’Eucaristia”: con prerogative non molto diverse da quelle degli accoliti, questi possono essere anche donne. E di fatto sono più spesso donne che uomini. Un passo avanti, forse? Certo però la dichiarata ‘straordinarietà’ sembra messa lì a ricordare che si tratta di un’eccezione, di una supplenza..., di qualcosa che normalmente non dovrebbe esserci.
A parte i servizi non liturgici ma fondamentali, come la catechesi dei fanciulli, quasi interamente femminile, e le varie attività organizzative e caritative della parrocchia, le letture nella Messa vengono proclamate più spesso da donne che da uomini; ma si tratta sempre e comunque di un ministero di fatto, che in teoria sarebbe da autorizzare caso per caso, anche se poi, di solito, l’autorizzazione viene presunta.
Il Concilio e l’incompiuta apertura
Il problema dell’accesso femminile ai ministeri è diventato di attualità nella Chiesa nell’immediato post-concilio, nel fervore di dibattito che caratterizzò quell’epoca feconda e rimpianta della storia della Chiesa. Il Vaticano II aveva mostrato una notevole apertura sulle questioni che maggiormente sembravano concernere il problema della donna in generale e della donna nella Chiesa in particolare. Sulle questioni più specifiche e sul problema dei ministeri i documenti conciliari erano generici fino alla reticenza, ma senza chiusure di principio. Ciò autorizzava a sperare nel superamento, non proprio immediato ma neppure troppo lontano, di certe innegabili contraddizioni che persistevano sul piano disciplinare. Inoltre altre chiese cristiane avevano cominciato da qualche anno, certo non senza resistenze anche aspre, a riconsiderare e a superare gradualmente il problema dell’esclusione (a nostra conoscenza, la chiesa luterana svedese fu la prima ad ammettere donne al pastorato, nel 1958)
.Una chiusura fragile
Nel decennio che seguì il Concilio, il dibattito in proposito fu intenso. La Chiesa ufficiale mantenne però una posizione di cautela e di sostanziale chiusura sempre più netta, che culminò - volendo chiudere la questione una volta per sempre - nella dichiarazione vaticana Inter insigniores, che è della fine del 1976, ma resa pubblica nel 1977.
In questo documento l’esclusione delle donne dal ministero ordinato veniva ribadita con caratteri di definitività vagamente ‘infallibilista’, ma anche con un significativo mutamento di argomentazione, che ci sembra importante poiché dimostra che l’esclusione è un fatto storico-sociologico in divenire e non un fatto teologico-sacramentale. Non si dice più, come affermava Tommaso d’Aquino, che la donna è per natura inferiore all’uomo e quindi esclusa per volere divino da ogni funzione implicante autorità; si richiama invece l’ininterrotta tradizione della Chiesa (che è evidente, ma è anche evidentissimo portato della storia e delle culture) e soprattutto la maschilità dell’uomo Gesù di Nazaret, da cui deriverebbe la congruenza simbolica della maschilità del prete che, presiedendo l’assemblea, agisce in persona Christi.
Quest’ultimo argomento fragile e sconveniente è stato lasciato cadere, infatti, nei pronunciamenti successivi: questi si rifanno solo alla tradizione della Chiesa e a quella che viene indicata come l’esplicita volontà di Gesù manifestata dalla sua prassi.
Anche questo argomento non funziona. Gesù, che non mostra alcun interesse di tipo ‘istituzionale’, alle donne accorda, con naturalezza, una piena parità nel gruppo dei suoi seguaci. Sembra insieme scorretto e pleonastico dire che “non ha ordinato nessuna donna”, dal momento che, semplicemente, non ha ordinato nessuno. Non vi è sacerdozio nella sua comunità, ma servizio e testimonianza, diakonìa non formalizzata - eppure rispondente a una chiamata precisa - che, prima di essere attività, è opzione fondamentale, stile di vita, sull’esempio di Gesù stesso “venuto per servire”.
Nel Nuovo Testamento di sacerdozio si può parlare solo in riferimento al sacerdozio universale dei fedeli (cfr 1 Pt 2,9; Ap 1,6), negli ultimi decenni tanto rispettato a parole quanto sfuggente e ininfluente nel concreto del vissuto ecclesiale; oppure in riferimento all’unico sacerdote della Nuova Alleanza - sacerdote nel senso di mediatore fra Dio e gli esseri umani -, Gesù di Nazaret (cfr Ebr 9), il quale nella società religiosa era un laico, oltretutto in rapporti abbastanza conflittuali con il sacerdozio del suo tempo.
Un’esclusione che interpella tutti
Vi sono due fatti, molto modesti ma significativi, che aiutano a tenere viva la speranza. Il primo, che i pronunciamenti dell’autorità ecclesiastica volti a chiudere ‘definitivamente’ la questione sono diventati abbastanza ricorrenti, il che dimostra che non è poi tanto facile chiuderla. Il dibattito è aperto e procede. Il secondo, che l’argomentazione teologica sembra cambiata ancora: felicemente sepolto l’infelicissimo argomento della coerenza simbolica, già pilastro dell’Inter insigniores, si richiama solo la prassi ininterrotta della chiesa romana e sempre più spesso si sente riconoscere, anche dalle voci più autorevoli, che contro l’ordinazione delle donne non ci si può appellare a ragioni biblico-teologiche.
No, non si tratta di banali rivendicazioni. L’esclusione interpella tutti: nessuna/nessun credente adulto può disinteressarsi di questo problema chiave finché le donne nella chiesa non avranno di fatto le stesse possibilità degli uomini, la stessa dignità di rappresentanza.
E’ necessario ricordare che vi sono donne cattoliche di alto valore e seriamente impegnate - tra loro anche alcune teologhe - che a una domanda precisa sul problema dei ministeri istituiti rispondono o risponderebbero più o meno così: no grazie, il sacerdozio così com’è proprio non ci interessa. E’ un atteggiamento che merita rispetto: almeno in quanto manifesta il timore che insistere troppo sul tema dell’ordinazione induca ad accentuare l’importanza dei ministri ordinati nella Chiesa (mentre sarebbe urgente semmai ridurre quell’importanza, insomma ‘declericalizzare’).
Ma dobbiamo ricordare che il “sacerdozio così com’è”, nella storia e nella mentalità corrente, si fonda proprio sulla ‘separazione’, sullo spirito di casta, sul sospetto previo e sul rifiuto nei confronti della donna, che nella chiesa di Roma si esprime in una doppia modalità: l’esclusione delle donne dalle funzioni di culto, di governo e di magistero, è parallela all’obbligo istituzionale di essere “senza donna” per coloro che le esercitano. Il divieto per le donne di essere ministri ordinati el’obbligo per i ministri ordinati di restare celibi sembrano due problemi ben distinti, mentre sono congiunti alla radice. E ormai sappiamo che potranno giungere a soluzione solo insieme.
Segno dei tempi, certo. Segno di trasformazione, segno contraddittorio, segno incompleto, proprio come il tempo in cui viviamo. Per quanto riguarda la chiesa cattolica, però, non solo segno, ma indice di autenticità. Non temiamo di dire che sulla questione dei ministeri, che solo a uno sguardo superficiale o ideologico può apparire circoscritta, si gioca il futuro della chiesa.
Lilia Sebastiani
Teologa
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- EUGENIO GARIN. Restano fondamentali i suoi studi sul Rinascimento (di Armando Torno - Garin, l’ultimo maestro tra Gramsci e Nietzsche)18 marzo 2012, di Federico La Sala
Garin, l’ultimo maestro tra Gramsci e Nietzsche
Restano fondamentali i suoi studi sul Rinascimento
di Armando Torno (Corriere della Sera, 18.03.2012)
Eugenio Garin, scomparso il 29 dicembre 2004 a 95 anni, è stato uno degli ultimi maestri. O forse un’anima rara che avrebbe preferito vivere al tempo di Lorenzo il Magnifico, quando si faceva politica dopo aver discusso sull’immortalità dell’anima. Gli capitò il Novecento. Seppe farsi onore anche in quest’epoca, da uomo di sinistra che non accettò né il Sessantotto, né la cultura che si adeguava a quanto era politicamente corretto.
Garin torna in libreria grazie a una serie di riproposte delle Edizioni di Storia e Letteratura. In quest’uomo dal rigore morale assoluto, che parlava pacatamente e sapeva rendere indimenticabile una telefonata, che aveva confidenza con Giovanni Pico della Mirandola o Descartes («il nostro Cartesio», soleva intercalare), con i moralisti inglesi del Settecento o con il Rousseau politico, convivevano gli innamoramenti per i Quaderni del carcere di Gramsci e il rispetto per il pensiero di Giovanni Gentile.
Forse fu la sua acutezza di storico delle idee a indurre Roderigo di Castiglia, ovvero Palmiro Togliatti, a recensire favorevolmente le Cronache di filosofia italiana da lui pubblicate presso Laterza nel 1955. Il Migliore - chiamiamo ancora così il più acuto e abile dei segretari politici del dopoguerra - lo portò verso il Pci. Vero è che nel gennaio 1958 fu lo stesso Garin ad aprire il convegno per i vent’anni della morte di Gramsci. Ovviamente con Togliatti presente.
Molto ha giovato in questi ultimi mesi il profilo che ha scritto il suo allievo Michele Ciliberto: Eugenio Garin. Un intellettuale del Novecento (Laterza pp. 176, 20). Sono pagine che offrono un profilo ricco e documentato, soprattutto non dimenticano le ricerche e gli innumerevoli carteggi. Ci restituiscono uno studioso che ha scritto pagine importanti sulla condizione umana lavorando nel laboratorio del «suo» Rinascimento. Lui che rifiutava la qualifica di filosofo, sapeva portare alla filosofia come nessun altro: e lì si congedava sempre dagli allievi con indicazioni per continuare il viaggio, per comprendere uomini e idee.
Il suo lavoro, soprattutto per le ricerche sull’età della Rinascenza, ha un credito mondiale indiscutibile. Non a caso James Hankins, della Harvard University, ha partecipato al convegno fiorentino del marzo 2009 per ricordarne il centenario della nascita con una relazione dedicata ai rapporti tra lo studioso italiano e Paul Oskar Kristeller (il suo contributo si trova nel volume Eugenio Garin. Dal Rinascimento all’Illuminismo, uscito da Storia e Letteratura nel 2011). L’importanza dei suoi studi, agli antipodi di tanto dilettantismo dilagante nelle attuali università italiane (dove ci si può laureare in filosofia medievale senza conoscere il latino), si coglie nei due tomi Interpretazioni del Rinascimento, entrambi pubblicati da Storia e Letteratura. Quasi 700 pagine, nelle quali si ritrovano dei saggi che restano un modello di ricerca, da tempo non reperibili.
Ecco, per esempio, una recensione del 1943, apparsa negli «Annali della Scuola Normale Superiore» di Pisa, a un volume dedicato al processo di Giordano Bruno uscito in Vaticano: in essa, impeccabilmente, contestualizza avvenimenti e fonti e invita a riflettere anche sui casi di Campanella e dello Stigliola, il quale, tra l’altro, finì nei guai per la pretesa di spiegare scientificamente i miracoli. Oppure si ritrova un saggio del 1944 su I trattati morali di Coluccio Salutati. Garin entra in queste pagine «prive delle ricercate grazie umanistiche» per cogliere «la rivalutazione della sanità della vita e del mondo».
E poi altre ricerche, anche recenti - l’ultima è del 1993 - dedicate a magia, astrologia, aspetti ermetici, all’amato Leon Battista Alberti o a Galileo o al tumulto dei Ciompi. Viene ristampato da Storia e Letteratura anche l’importante saggio che Garin terminò all’inizio del 1934, ma che uscì soltanto nel 1937: Giovanni Pico della Mirandola. Vita e dottrina. Lo scrisse a Palermo dove, prima della guerra d’Etiopia, insegnò al liceo. Cesare Vasoli, che firma la prefazione, offre l’analisi degli studi da lui lasciati sul prodigioso pensatore.
Ogni volta che si riprendono in mano le opere di Garin si resta colpiti dalla straordinaria cultura e dall’accuratezza delle citazioni, dal fascino che conservano i suoi argomenti a distanza di decenni. Quel suo saper cogliere le idee essenziali, senza perdersi in minuzie, si constata aprendo la Storia della filosofia che gli venne chiesta da Enrico Vallecchi alla fine del 1943 (con lo stratosferico compenso di ottomila lire!) e che vide la luce nel 1945 (ora anch’essa è ristampata da Storia e Letteratura). Quest’opera - da non confondersi con la Storia della filosofia italiana, che vide la luce da Einaudi nel 1966 in tre volumi - stupisce per l’impostazione e la lungimiranza. Nel capitolo «pensatori d’oggi» già analizza Heidegger e Jaspers, Husserl e Scheler; anzi, Garin segnala l’importanza di Dostoevskij e di Nietzsche (per quest’ultimo evidenzia il tema della «morte di Dio»). Tutto in un’epoca nella quale i manuali di storia del pensiero erano fermi all’Ottocento, intenti a far conoscere Rosmini e Gioberti e magari Ardigò, mentre Nietzsche era considerato, se ci si ricordava di citarlo, ispiratore di Mussolini o di d’Annunzio. O un seguace di Darwin.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- Allora, donne e uomini, apriamo gli occhi, curiamo la nostra Chiesa denunciando quello che le fa male (di Comité de la Jupe - Per un 8 marzo nella Chiesa)11 marzo 2012, di Federico La Sala
Per un 8 marzo nella Chiesa
di Comité de la Jupe
in “www.comitedelajupe.fr” del 7 marzo 2012 (traduzione: www.finesettimana.org)
Buona festa a voi, donne della Chiesa, in questo 8 marzo 2012, giornata internazionale delle donne! Attraverso una serie di contributi diversi, il Comité de la Jupe denuncia fermamente la dominazione maschile in una istituzione che costantemente umilia la metà dell’umanità. “Il Comité de la Jupe ha già ampiamente denunciato, da un lato la discriminazione fobica di cui sono vittime le ragazze e le donne nella liturgia - anche per la predicazione e per l’accesso al ministero ordinato - dall’altro il tentativo di dominio sul corpo delle donne che l’istituzione perpetua giudicando l’esercizio della sessualità e demonizzando la teoria del genere.
È urgente proseguire, denunciando, ad esempio:
 un linguaggio che, in buona coscienza, impone il maschile come definizione di tutto l’umano;
un linguaggio che, in buona coscienza, impone il maschile come definizione di tutto l’umano;
 l’uso ricorrente del singolare “la donna” come se esistesse un modello unico;
l’uso ricorrente del singolare “la donna” come se esistesse un modello unico;
 l’esaltazione di una figura mariana eterea, vergine e condiscendente a tutto ciò che viene dal modello paterno clericale;
l’esaltazione di una figura mariana eterea, vergine e condiscendente a tutto ciò che viene dal modello paterno clericale;
 il quasi generale dominio degli ordini religiosi monastici maschili sulle branche femminili.
il quasi generale dominio degli ordini religiosi monastici maschili sulle branche femminili.
 Sì, la Chiesa non fa meglio degli altri: ha le sue proletarie, quelle “manine laboriose”, quelle domestiche per tutti i servizi, quel corpo che non vuole vedere. Il suo corpo che offende ogni giorno.
Sì, la Chiesa non fa meglio degli altri: ha le sue proletarie, quelle “manine laboriose”, quelle domestiche per tutti i servizi, quel corpo che non vuole vedere. Il suo corpo che offende ogni giorno.
 Allora, donne e uomini, apriamo gli occhi, curiamo la nostra Chiesa denunciando quello che le fa male. La nostra parola - la sua - non le fa che bene.” (Anne Soupa)
Allora, donne e uomini, apriamo gli occhi, curiamo la nostra Chiesa denunciando quello che le fa male. La nostra parola - la sua - non le fa che bene.” (Anne Soupa)“Un giorno un vescovo mi confidava quanto le donne nella vita politica avessero difficoltà nel conquistarsi uno spazio. Lo deplorava sinceramente. Maliziosamente, gli ho fatto notare che, almeno, anche se è difficile, nella società civile le donne potevano essere ministri! La mia riflessione lo ha lasciato senza parole! La Chiesa cattolica romana si priva così di tesori di fede, di energia, di competenza, escludendo le donne dai ministeri ordinati. Essa giustifica così una visione del femminile che non può che essere in posizione di ricezione e non di iniziativa, una visione del femminile che non può rappresentare l’iniziativa di Dio. Così facendo, e benché il discorso ufficiale lo neghi, essa giustifica, nei fatti, un posto di second’ordine per le donne. Quando usciremo da questo immobilismo?” (Sr. Michèle Jeunet, rc)
“Padre Moingt, in un articolo su Etudes, esprimeva la preoccupazione per la disaffezione delle donne rispetto alla Chiesa, allontanate dagli altari e umiliate. È ancora peggio. Tristezza fondamentale nel constatare che il dominio maschile è onnipresente e che è peggiore nella religione, perché viene fondato su giustificazioni teologiche che fanno passare le discriminazioni per volontà divina. La tendenza recente di affidare ai soli uomini o ragazzi maschi le letture liturgiche mi sembra un provvedimento inverosimile: ingiustizia enorme nei confronti delle donne e cieca di fronte al modo di funzionare delle società moderne. Oggi, la pratica religiosa si accompagna troppo spesso per me ad un sentimento di alienazione. Esperienza quanto mai dolorosa!” (Sylvie)
“Trent’anni fa, infastidita dai singolari su “La” Donna e la sua vocazione, avevo scritto un articolo“Donne e Chiesa: un amore difficile!”. A distanza di trent’anni, dopo che molte mie contemporanee hanno lasciato la Chiesa in punta di piedi, dovrei scrivere: “Donne e Chiesa: un disamore consumato.” Emorragia annunciata, proposta fatta di istituzionalizzare i servizi delle donne nella Chiesa: donne cappellane, diaconesse, e perché no, preti. Un sistema obsoleto, unito ad un discorso unisex sulla sessualità, è tuttavia continuato. Delle teologhe come France Quéré hanno allora spalancato la porta di una parola sul ruolo decisivo delle donne bibliche nella Rivelazione, non guardiane di un Tempio intoccabile, ma vettori irrinunciabili della Speranza cristiana in un mondo in trasformazione. Al fiat di Maria “celestificata” ad vitam, successe la valorizzazione di Maria radicata, contestatrice dell’ordine stabilito maschile, che ha visto la miseria di un popolo maltrattato dai superbi. Le nuove tecnologie dell’informazione svolgeranno un ruolo per il riconoscimento della dignità delle donne nella Chiesa cattolica, importante quanto quello svolto nelle recenti primavere di popoli asserviti.” (Blandine)
“Parlare dell’ordinazione delle donne resta un tabù nella Chiesa cattolica, e il prendere ufficialmente posizione a suo favore viene minacciato di scomunica. Per la Chiesa cattolica, il prete è un “altro Cristo”. Riflettiamo un po’ su questo...
 Non siamo tutti chiamati ad essere “configurati a Cristo” secondo l’espressione di Paolo?
Non siamo tutti chiamati ad essere “configurati a Cristo” secondo l’espressione di Paolo?
 Noi confessiamo, seguendo gli apostoli, che Dio si è fatto “uomo”. Ma la parola usata è “umano” e non “maschio”... Incarnandosi, Dio ha optato per il maschile, piegandosi alle convenienze del suo tempo per poter essere ascoltato.
Noi confessiamo, seguendo gli apostoli, che Dio si è fatto “uomo”. Ma la parola usata è “umano” e non “maschio”... Incarnandosi, Dio ha optato per il maschile, piegandosi alle convenienze del suo tempo per poter essere ascoltato.
 Non è lo Spirito Santo che consacra il pane e il vino delle nostre tavole eucaristiche?
Non è lo Spirito Santo che consacra il pane e il vino delle nostre tavole eucaristiche?
 La donna resterà sempre quell’essere incompleto, inferiore, tentatore ed impuro?” (Claude)
La donna resterà sempre quell’essere incompleto, inferiore, tentatore ed impuro?” (Claude)“Nella mia vita professionale, familiare, cittadina, posso far sentire la mia voce e pesare sulle decisioni. Nella Chiesa, sono doppiamente muta ed impotente poiché laica e donna. Eppure si può essere cattolica e femminista. Ma perché restare in questa Chiesa il cui discorso ufficiale mi glorifica per meglio togliermi la parola?
 Perché, come la Samaritana, voglio avvicinarmi il più possibile e bere alla sorgente che disseta per sempre. Perché essere vicini a Cristo è possibile, senza la mediazione delle pompe, dell’organo, dell’incenso e del latino, dei riti e dei divieti, ma attraverso la preghiera e l’incontro dei miei fratelli e delle mie sorelle nella Chiesa.
Perché, come la Samaritana, voglio avvicinarmi il più possibile e bere alla sorgente che disseta per sempre. Perché essere vicini a Cristo è possibile, senza la mediazione delle pompe, dell’organo, dell’incenso e del latino, dei riti e dei divieti, ma attraverso la preghiera e l’incontro dei miei fratelli e delle mie sorelle nella Chiesa.
 Ecco quello che fa paura al clero: perdere il potere che conferisce loro lo statuto che si sono concessi (malgrado l’insegnamento di Cristo) di mediatori, soli atti a veicolare il “sacro” nei due sensi...
Ecco quello che fa paura al clero: perdere il potere che conferisce loro lo statuto che si sono concessi (malgrado l’insegnamento di Cristo) di mediatori, soli atti a veicolare il “sacro” nei due sensi...
 L’intrusione delle donne - del femminile - nell’edificio lo farà andare in frantumi. Da Maria Maddalena a santa Teresa di Lisieux, in tutta la storia della Chiesa, delle donne - e degli uomini come san Francesco d’Assisi! - hanno fatto sentire la loro musica delicata: un incontro è possibile e questo incontro passa dal cuore.” (Françoise)
L’intrusione delle donne - del femminile - nell’edificio lo farà andare in frantumi. Da Maria Maddalena a santa Teresa di Lisieux, in tutta la storia della Chiesa, delle donne - e degli uomini come san Francesco d’Assisi! - hanno fatto sentire la loro musica delicata: un incontro è possibile e questo incontro passa dal cuore.” (Françoise)“Il magistero cattolico maschile, quasi muto sugli uomini (maschi), affronta la “differenza dei sessi” solo attraverso le donne. Questo non è estraneo al fatto che sono degli uomini a definire la natura delle donne. Loro sono i soggetti della dottrina, e le donne gli oggetti. Della loro natura maschile non parlano. Senza dubbio la identificano alla natura umana. Gli uomini (vir) si identificano agli uomini (homo), all’universale, al neutro, al prototipo, mentre assegnano le donne alla particolarità, alla specificità, alla differenza.
Che cos’è il genere? I documenti romani lo manifestano: uomini investiti dell’autorità dicono alle donne chi esse sono e quali rapporti devono intrattenere con gli uomini. Il genere quindi è un rapporto di potere che si costruisce nello stesso tempo in cui costruisce i suoi due termini.” (Gonzague JD)
“La frase infelice del cardinal Vingt-Trois che ha provocato la nascita del Comité de la Jupe non era un increscioso incidente. Era, nel senso psicanalitico del termine, una parola involontaria. Svela non la misoginia dell’uomo, ma quella di un’istituzione che è in una fase di ripiegamento. Nel fenomeno di “restaurazione” al quale assistiamo oggi nella Chiesa cattolica, le donne sono le prime vittime: le si rimette “al loro posto”, quello “di ausiliaria di vita” della solo metà dell’umanità che conta, la metà maschile che si prende per il tutto.
 In questo 8 marzo, noi donne cattoliche possiamo dare l’allarme. Quando delle società o delle istituzioni sono in crisi, le donne ci rimettono per prime. L’emancipazione delle donne nelle nostre società occidentali è un bene prezioso ma ancora fragile; il rischio di “restaurazione patriarcale” è reale per l’insieme della società. Queste circostanze invitano alla vigilanza e alla solidarietà di tutte le donne e anche degli uomini che considerano come un ottimo bene che le donne siano loro contemporanee sulla base di parità.” (Christine Pedotti)
In questo 8 marzo, noi donne cattoliche possiamo dare l’allarme. Quando delle società o delle istituzioni sono in crisi, le donne ci rimettono per prime. L’emancipazione delle donne nelle nostre società occidentali è un bene prezioso ma ancora fragile; il rischio di “restaurazione patriarcale” è reale per l’insieme della società. Queste circostanze invitano alla vigilanza e alla solidarietà di tutte le donne e anche degli uomini che considerano come un ottimo bene che le donne siano loro contemporanee sulla base di parità.” (Christine Pedotti)“Buona festa a voi, sì, a voi, donne della Chiesa. Quelle che hanno seguito gli stessi incontri di catechismo di tutti gli altri bambini. Quelle che hanno detto sì, a un uomo o a una vita consacrata a Dio. Quelle che hanno portato un figlio o una figlia al fonte battesimale, come madre o come madrina. Buona festa a voi che tornate ogni giorno, ogni settimana, ogni domenica, per accompagnare, studiare, condividere, organizzare, informare, pulire, benedire, ornare di fiori, insegnare, cantare, preparare, lodare, predicare, pregare, meditare, tenere per mano, sollevare la testa... Buona festa a voi tutte, che siete Chiesa, che fate la Chiesa...” (Estelle Roure)
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. --- RELIGIONI IN ANALISI. 8 marzo 2012, ancora streghe (di Giancarla Codrignani)11 marzo 2012, di Federico La Sala
8 marzo 2012, ancora streghe
di Giancarla Codrignani (Adista - Segni Nuovi, - n. 10, 10 marzo 2012)
A Bologna, un islamico osservante ha sentito «impuro» il proprio rapporto con una donna cristianoortodossa e ha tentato di decapitarla «come Abramo fece con Isacco» (la donna, un’u-craina di 45 anni, se la scampa, rischia di ritrovarsi paraplegica). Non è solo un caso di fondamentalismo maniacale. In questi giorni, si apre a Palmi un processo di stupro che testimonia il persistere italico della maledizione di Eva: a San Martino di Taurianova una bambina di 12 anni (che oggi ne ha 24 e vive sotto protezione perché alcuni dei persecutori che ha denunciato erano mafiosi) per anni è stata considerata da tutto il paese la colpevole degli stupri di gruppo, delle violenze e dei ricatti subiti e anche il parroco a cui aveva tentato di confidarsi giudicava peccatrice una dodicenne violata che solo la penitenza poteva redimere.
Sembra incredibile, ma nella santità delle religioni albergano tabù ancestrali che gli studi antropologici e le secolarizzazioni non sono riusciti a eliminare. Sono i tabù peggiori perché responsabili dei pregiudizi sessuofobici e misogini che, sacralizzati, hanno prodotto, nel nome di dio, discriminazioni e violenze.
Nel terzo millennio le religioni dovrebbero andare in analisi e domandarsi quanto la sessuofobia e la misoginia insidino nel profondo la loro possibilità di futuro. Il concetto di “purezza” che ha represso, nell’ipocrisia mercantile e proprietaria dei valori familiari, milioni di ragazze non è nato certo dalla scelta delle donne. Alla Lucy delle origini, mestruata e responsabile della riproduzione, non sarebbe mai venuto in mente di sentirsi sporca o colpevole. Forse percepiva già come colpa, certo non sua, la violenza che connotava la bassa qualità di molte prestazioni maschili. Tanto meno, quando si fosse inventato il diritto, avrebbe distinto i “suoi” figli in legittimi o illegittimi.
Eppure si continua a credere che la mestruata faccia ingiallire le foglie e inacidire il latte; in Africa, in “quei giorni”, è confinata in capanne speciali per non contaminare le case; a Roma Paolo la voleva velata e zittita, mentre i papi, forse senza sapere perché, le hanno vietato di consacrare. Siamo ancora qui, a fare conti sul puro e l’impuro e a ripetere il capro espiatorio nel corpo di qualche altro Isacco per volere di qualche Abramo che credeva di interpretare Dio, di qualche altra Ifigenia proprietà di Agamennone padrone della sua morte.
Noi donne non siamo certo migliori degli uomini, ma nelle società maschili permangono residui di paure che neppure Darwin ha fatto sparire. I responsabili delle religioni che intendono salvare la fede per le generazioni future debbono purificarle dalle ombre del sacro antropologico: il papa cattolico deve non condannare, bensì accogliere come servizio di verità nelle scuole un’educazione sessuale che dia valore all’affettività non solo biologica delle relazioni fra i generi e al rispetto delle diverse tendenze sessuali; l’islam che fa imparare a memoria fin da piccoli le sure del Corano, si deve rendere conto che i tabù violenti producono strani effetti se un uomo si sente un dio punitore davanti a donne-Isacco; i rabbini dovrebbero fare i conti con Levi Strauss e smettere di chiedere autobus separati per genere e di insultare le bambine non velate; in Cina e in India non si deve perpetuare l’insignificanza femminile trasferendo gli infanticidi delle neonate alla “scelta” ecografica, mortale solo per le bimbe. Sono tutte scelte di morte. Per ragioni di genere.
Ma, se la responsabilità delle religioni monoteiste è particolarmente grave per l’immagine anche non raffigurata di una divinità di fatto maschile, più precisa è quella dei cristiani. Si è detto infinite volte: perché il nostro clero, ancora così pronto a chiedere cerimonie riparatrici per spettacoli che non ha visto, non pensa ad evangelizzare i maschi invece di sospettare costantemente peccati di cui non può essere giudice, condannato com’è al masochismo celibatario per paura della purezza originaria della sessualità umana?
C’è un salto logico - certamente non illogico per le donne che stanno leggendo i pezzi sull’8 marzo ma anche la società civile persevera troppo nel negare rispetto al corpo delle donne: i tre caporali del 33esimo reggimento Acqui indagati per lo stupro di Pizzoli (L’Aquila) sono rientrati in servizio nei servizi di pattugliamento del centro storico nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”...
-
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- IL RINASCIMENTO A ROMA. NEL SEGNO DI MICHELANGELO E RAFFAELLO. MOSTRA PROROGATA FINO AL 18 MARZO 2012.9 marzo 2012, di Federico La Sala
 IL RINASCIMENTO A ROMA. NEL SEGNO DI MICHELANGELO E RAFFAELLO
IL RINASCIMENTO A ROMA. NEL SEGNO DI MICHELANGELO E RAFFAELLO
 25 ottobre 2011 - 12 febbraio 2012 > PROROGATA FINO AL 18 MARZO
25 ottobre 2011 - 12 febbraio 2012 > PROROGATA FINO AL 18 MARZO
 Roma, Fondazione Roma Museo, Palazzo Sciarra *
Roma, Fondazione Roma Museo, Palazzo Sciarra *La mostra "Il Rinascimento a Roma" indaga e approfondisce, per la prima volta, tutti gli aspetti artistici, architettonici ed urbanistici del Cinquecento a Roma. Curata da Maria Grazia Bernardini e Marco Bussagli, l’esposizione si articola in sette sezioni, che documentano il percorso artistico del XVI secolo, attraverso il passaggio dall’alto e superbo magistero dell’arte del primo Rinascimento, ancora sostanziato dalla cultura umanistica, ad un’arte fortemente condizionata da una nuova e coinvolgente spiritualità religiosa. In mostra sono esposti capolavori di Raffaello, quali l’Autoritratto e il Ritratto di Fedra Inghirami - entrambi prestati eccezionalmente dalla Galleria degli Uffizi di Firenze - di Michelangelo, quale il David-Apollo proveniente dal Museo Nazionale del Bargello, di Sebastiano del Piombo, quale il Ritratto del cardinale Reginald Pole dell’Ermitage, e di molti altri artisti, tra cui Perin del Vaga e Francesco Salviati.
Per l’occasione la Fondazione Roma ha provveduto a restaurare alcune importantissime opere, tra cui la Pietà di Buffalo (Stati Uniti) di ambito michelangiolesco (con attribuzione a Michelangelo stesso da parte di alcuni studiosi), esposta in mostra.
La mostra presenta anche apparati didattici e integrativi del tutto inediti come la ricostruzione tridimensionale della Loggia di Psiche di Raffaello.
* http://www.fondazioneromamuseo.it/it/738.html
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- Teologi italiani, riprendete la parola, senza paura e senza reticenze. Appello di preti e religiosi (a c. di Luca Kocci).31 dicembre 2011, di Federico La Sala
Teologi italiani, riprendete la parola, senza paura e senza reticenze. Appello di preti e religiosi
di Luca Kocci
in “Adista” n. 1 del 7 gennaio 2012
Il “dio denaro” governa il mondo, la guerra è tornata ad essere «continuazione della politica», i cambiamenti climatici sconvolgono il pianeta, i poveri aumentano, eppure i teologi tacciono, forse perché sono convinti che la teologia viva fuori dal mondo e non debba avere rapporti con la storia.
Ma non è così, anzi è compito della teologia e dei teologi «fare sogni» incarnati nella realtà e «diventare profeti» nel nostro tempo. Lo dicono, con forza e passione, in una “lettera aperta” a tutti i teologi e le teologhe italiane, alcuni parroci, preti e religiosi:
Alessandro Santoro (prete della Comunità delle Piagge di Firenze), la teologa domenicana Antonietta Potente, Andrea Bigalli (prete di S. Andrea in Percussina, Firenze), Pasquale Gentili (parroco di Sorrivoli, Cesena), Benito Fusco (frate dei Servi di Maria), Pier Luigi Di Piazza del Centro Balducci di Zugliano (Udine) e Paolo Tofani (parroco di Agliana, Pistoia).
Chiedono loro di riprendere la parola e li invitano il prossimo 20 gennaio (dalle 17.30) alla Comunità delle Piagge di Firenze, per un «incontro aperto» su tali questioni. Occasione forse unica - e comunque la prima da diversi anni a questa parte - per rompere il silenzio, per riscoprire la «Bibbia e il giornale», come affermava il teologo evangelico Karl Barth («È necessario che tra la Bibbia e il giornale, come tra due poli di un arco elettrico, comincino ad accendersi lampi di luce per rischiarare la terra») o la lezione della Teologia della liberazione capace di coniugare Parola di Dio e realtà sociale di oppressione.
Di seguito Il testo integrale della lettera.
Lettera alle teologhe e ai teologi italiani di alcuni presbiteri e teologi
in “Adista” n. 1 del 7 gennaio 2012 *
«Dove stai tu quando si soffrono cambiamenti climatici e cambiamenti di umore? Dove stai tu mentre il nostro pianeta va al collasso e le multinazionali e le banche, vendute al dio profitto e al dio denaro, governano il mondo? Dove stai tu quando si deve decidere se intervenire per sostenere un intervento armato della Nato nella terra degli altri? Dove stai tu quando si riducono tutte le spese per il sociale, la sanità e la scuola, mentre continuano ad aumentare i bilanci della difesa e si spendono cifre folli per le armi? Dove stai tu quando la gente dei Sud del mondo si sospinge fino alle spiagge di Lampedusa e viene ricacciata indietro o chiusa nei Cie, colpevoli soltanto di immigrazione? Dove stai tu quando qualcuno dice che l’ex primo ministro è meglio che un politico dichiarato gay, perché il primo è “secondo natura”? Dove stai tu quando il bilancio familiare è insufficiente e si vive una precarietà che riduce a brandelli sogni e progetti? Dove stai tu quando gli indignados scendono in piazza o fanno rete virtuale su internet?
E ancora... perché accettiamo solamente che qualcuno tenga le chiavi del Regno e decida chi farci entrare? Forse tu ci sei? E se ci sei, ci sei clandestinamente perché la tua teologia non appartiene a questi ambiti?
Quando il profeta Gioele (3,1-2) dice che tutti diventeranno profeti e gli anziani faranno sogni e i giovani avranno visioni, a chi si rivolge? Forse non parla a tutti gli uomini e le donne del nostro tempo? E allora, se fare sogni e interpretarli e diventare profeti è proprio della teologia, non è forse vero che tutti i credenti sono teologi? E perché non glielo diciamo più?».
 Alessandro Santoro (prete della Comunità delle Piagge di Firenze),
Alessandro Santoro (prete della Comunità delle Piagge di Firenze),
 Antonietta Potente (teologa domenicana),
Antonietta Potente (teologa domenicana),
 Andrea Bigalli (prete di S. Andrea in Percussina, Firenze),
Andrea Bigalli (prete di S. Andrea in Percussina, Firenze),
 Pasquale Gentili (parroco di Sorrivoli, Cesena),
Pasquale Gentili (parroco di Sorrivoli, Cesena),
 Benito Fusco (frate dei Servi di Maria),
Benito Fusco (frate dei Servi di Maria),
 Pier Luigi Di Piazza del Centro Balducci di Zugliano (Udine),
Pier Luigi Di Piazza del Centro Balducci di Zugliano (Udine),
 Paolo Tofani (parroco di Agliana, Pistoia)
Paolo Tofani (parroco di Agliana, Pistoia) -
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- LA LEZIONE DI KAFKA. "alla nascita di Cristo nella capanna semiaperta era subito presente il mondo intero, i pastori e i savi d’Oriente" (F. Kafka13 ottobre 2011, di Federico La Sala
- "[...] alla nascita di Cristo nella capanna semiaperta era subito presente il mondo intero, i pastori e i savi d’Oriente" (F. Kafka, Lettera a Helli Hermann, autunno 1921)
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- ELIA IN CERCA DI DIO. Dio è nel sussurro (di Angelo Casati - Ancora cercare il tuo volto).14 settembre 2011, di Federico La Sala
Ancora cercare il tuo volto
di Angelo Casati (Il Gallo, settembre 2011)
Mi seducono, lo confesso, immagini e simboli. E sogno, tu lo sai, una chiesa che non si scosti molto da Gesú. Dalla sua arte sorprendente di parlare per immagini e simboli.
- Elia in cerca di Dio
Tra le immagini a seduzione oggi vorrei evocare la caverna. Precisamente la caverna del monte di Dio, l’Oreb, in cui entrò per passarvi la notte il profeta Elia. Elia arriva al monte Oreb. Il suo non è, come uno potrebbe immaginare, un pellegrinaggio di tutto riposo. Arriva, Elia. dopo aver scannato quattrocentocinquanta profeti di Baal nelle acque del torrente Kison. Così gli sembrò si dovessero difendere i diritti di Dio. Con questo zelo. Succede! Succede anche oggi.
«Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti» risponderà al Signore che gli chiedeva «Che fai qui Elia? Che fai qui, nella caverna?».
La caverna, fin dall’antichità, è sempre stata un simbolo. Un simbolo di avvistamento del mistero e, insieme, di distanza dal mistero. Avvistamento e nascondimento: Dio c’è, e ci sono luci e ci sono ombre nella caverna.
Ed Elia prende coscienza che Dio è distante. Distante dal suo modo di immaginarlo, lontano dallo zelo, che gli aveva fatto scannare quattrocentocinquanta profeti. Pensando di onorare cosí Dio! Dio non era, come lo aveva immaginato, nei segni della potenza: non era nell’uragano, non era nel terremoto. Era -la nostra traduzione dice «nel mormorio di una brezza leggera», o meglio, come dice il testo ebraico, era «nel suono di un silenzio sottile»- il suono... del silenzio. Pensava, Elia, di trovare sul monte la conferma a una fede dal volto agguerrito. Trova un Dio che fa tacere la rabbia, l’intransigenza, l’uragano del suo cuore. È un Dio che mette silenzio, il Dio del silenzio sottile.
È un Dio che è presente non nella forza delle armi, ma nella forza mite della fede, nella forza mite della ragione. Non nella forza degli urli. Altro è lo stile di Dio.
- Alterità di Dio
L’immagine della caverna sul monte, terra di avvistamento, ma anche terra di piccolezza e di ombra, ha sostato a lungo nei miei pensieri in questi mesi, quasi a fugare un certo disagio patito per le molte parole proclamate da una parte e dall’altra, a proposito e a sproposito di relativismo.
C’è, e non vogliamo negarlo, un relativismo rozzo e spento, quello superficiale di coloro per i quali una cosa vale l’altra. Né vale la pena di consumare cuore e fatica nell’assurda ricerca. Quasi non esistesse luce da cui lasciarsi guidare, né preghiera che ce l’avvicini. La caverna è vuota. Ma c’è anche un relativismo cristiano. Cosí lo chiamò il cardinale Martini nell’omelia del suo venticinquesimo di episcopato nel Duomo di Milano. È il relativismo, oserei dire, della caverna. Da cui intravedi luci e rimani sedotto, affascinato. Ma mai e poi mai ti azzarderesti a dire che la caverna possiede l’intera luce dell’orizzonte. C’è il miracolo della luce, ma è quella che può filtrare da uno squarcio del monte, quasi figura di una finestra in attesa.
Sarebbe una grazia, io penso, se fossimo tutti piú consapevoli che il nostro è e sarà sempre un balbettare. Di Dio e degli umani. Se fossimo interiormente persuasi che la verità è anche Altro, è anche oltre e che Dio non può stare solo nelle nostre parole, è anche in altre parole, che Dio non può stare solo nel nostro colore, è anche in altri colori.
In un midrash della letteratura rabbinica si narra di alcuni rabbini che un giorno si misero a disputare accesamente su un punto della legge. Rabbi Eliezer produsse argomenti possibili per dimostrare il suo punto di vista. Ma gli altri rabbini non si lasciavano convincere dagli argomenti di Rabbi Eliezer. Alla fine una voce celeste sembrò confermare il pensiero di Rabbi Eliezer. Ma Rabbi Joshua súbito esclamò: «Non è in cielo!». «Che cosa significa questa citazione delDeuteronomio "non è in cielo"?». Rabbi Jirmijah spiegò: «La Torah fu rivelata sul monte Sinai. Perciò non occorre che continuiamo a occuparci di voci celesti: la Torah del Sinai contiene già il principio che è decisivo, il voto di maggioranza».
Il midrash sulla accesa disputa si conclude raccontando che quel giorno Rabbi Nathan incontrò il profeta Elia. E gli domandò: «Che cosa ha fatto Dio in quel momento?». Il profeta rispose: «Dio ha sorriso e ha detto: "I miei figli mi hanno superato!"». Incantamento e povertà delle parole
Che il Dio della Bibbia abbia il volto del Dio che sorride per i figli che mettono in campo tutta la loro arte di interrogare e di interrogarsi, e non per i figli che sonnecchiano pigri accettando tutto passivamente, è una buona notizia. È notizia di un Dio che onora ed è onorato dall’intelligenza, un’intelligenza che è incantamento davanti al mistero, che è la gioia di dire un nome e súbito percepirlo relativo, segnato da una povera misura e súbito ricorrere a un altro nome e a un altro ancora. In una gara da innamorati.
Come succede agli amanti del Cantico dei cantici, inesausti nel dare nomi all’amato, all’amata. Sembra loro di ricongiungersi, ma ecco si perdono. In un gioco che non è solo quello dell’amore, ma anche della verità. Un gioco che non è, se non per chi vive nell’asfissia dei palazzi grigi delle presunte verità, rozzezza dello spirito, ma freschezza di incantamento, un’esperienza di innamorati.
 Solo uomini
Solo uomini
 cui non toccò mai
cui non toccò mai
 l’avventura di amare
l’avventura di amare
 né il brivido d’innamorarsi
né il brivido d’innamorarsi
 oseranno dire
oseranno dire
 sempre uguale, monotono,
sempre uguale, monotono,
 il racconto misterioso
il racconto misterioso
 del torrente dei monti.
del torrente dei monti.Incantamento e, insieme, confessione della povertà delle parole a dire l’avventura che ci conduce. Noi confessiamo, non senza emozione, che Gesú è la verità, è la luce, ma le parole hanno la debolezza della nostra fragile tenda. La tenda dà ospitalità al mistero, ma riconosce anche la povera misura dei suoi teli.
Leggerezza della verità
Non tutto è nella mia tenda. L’infinito è accaduto nella tenda di Gesú, nella sua carne. Ma non sempre ci soffermiamo a pensare che nelle mani noi abbiamo non uno solo, ma quattro vangeli. Quasi a dire che una notizia cosí sorprendente, come quella della vita di Gesú, non sarebbe bastato uno a raccontarla. Ci vollero quattro voci. E forse non è cosí stravagante pensare che qualche sussulto di lui sia rimasto nell’aria, qualche voce forse al di là dei quattro vangeli. Non aveva forse detto Gesú ai discepoli: «Molte cose ho ancóra da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando poi verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà alla verità tutta intera»? (Gv 16, 12-13)
La verità dunque non è un muro di fine corsa, è la porta, è l’ introduzione .
La verità, si dice, è roccia di solidità. Ma l’immagine qualche volta purtroppo è stata usata nel senso della pesantezza. Giusto un anno fa, un gesuita dell’Istituto biblico di Gerusalemme, occhi chiari, ci additava le rocce del deserto, l’incanto delle loro striature e ci parlava della roccia come bellezza. La verità come pesantezza, come arroganza del possesso, ha generato profeti che scannano profeti e ancóra oggi torrenti portano il segno e la maledizione del sangue versato. Perché la verità senza amore diventa dominio, imposizione. E dove c’è dominio non c’è Dio. Dove c’è dominio, fosse pure delle coscienze, dove uno è in alto e uno è in basso, diventa sacrilegio mettere il nome di Dio. Come insegna un midrash della tradizione rabbinica.
- Dio è nel sussurro
Quando ero un ragazzino il signor Maestro stava insegnandomi a lèggere. Una volta mi mostrò nel libro di preghiere due minuscole lettere, simili a due puntini quadrati. E mi disse: «Vedi Uri, queste due lettere, una accanto all’altra? È il monogramma del nome di Dio; e, ovunque, nelle preghiere, scorgi insieme questi due puntini, devi pronunciare il nome di Dio, anche se non è scritto per intero».
Continuammo a lèggere con il Maestro, finché non trovammo, alla fine di una frase, i due punti. Erano ugualmente due puntini quadrati, solo non uno accanto all’altro, ma uno sotto l’altro. Pensai che si trattasse del monogramma di Dio perciò pronunciai il suo nome. Il Maestro disse però: «No, no, Uri. Quel segno non indica il nome di Dio. Solo là dove i puntini sono a fianco l’uno dell’altro, dove uno vede nell’altro un compagno a lui uguale, solo là c’è il nome di Dio. Ma dove i due puntini sono uno sotto e l’altro sopra, là non c’è il nome di Dio».
Dio non è nell’arroganza. Nemmeno nell’arroganza della verità. È nel suono di un silenzio sottile. È nel sussurro. Sussurro, una parola che ho ritrovato piú volte nella lettera dell’estate di una giovane amica che raccontava del cambiamento radicale della sua vita grazie al sussurro della voce di Dio: Dentro di me appena un sussurro, ma continuo, incessante. Ho passato mesi faticosi e dolorosi, ma alla fine cosí rigeneranti, di una vita nuova che non conoscevo come mia.
Ora è un’ansia continua che mi sospinge al di là di quelle che un tempo reputavo fossero barriere, adesso intravedo varchi. passi e sentieri, anche tra le mura della nostra invivibile città, ci sono vie cosí belle dietro le orme del Signore! Non sai
Non so per quale motivo Dio mi si è messo accanto con tale insistenza da farmi cambiare tutte le mie prospettive e da allentare le mie rigidità.
Da allora non mi ha mai abbandonato il sussurro. E la gioia piú grande è riuscire a condividere con gli altri la mia fede. Da quando ho incominciato a tirar fuori Dio dall’oscuro sgabuzzino in cui l’avevo rinchiuso solo per me, riesco a parlare di lui senza vergogna e timore di giudizi, e mi rende felice.
La verità non è immobilità. È la freschezza, la leggerezza, la bellezza di un cammino. Con un auspicio:
 all’ultimo tornante
all’ultimo tornante
 ancóra
ancóra
 cercare
cercare
 il tuo volto.
il tuo volto. -
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- 300 preti austriaci scrivono un appello per il sacerdozio alle donne e una riforma della Chiesa (di Cindy Wooden).15 luglio 2011, di Federico La Sala
300 preti austriaci scrivono un appello per il sacerdozio alle donne e una riforma della Chiesa
di Cindy Wooden
in “National Catholic Reporter” (“Catholic News Service”) del 12 luglio 2011 (traduzione di Maria Teresa Pontara Pederiva)
I vescovi austriaci hanno criticato l’attività di un gruppo di preti che chiede riforme nella prassi della chiesa - tra cui l’apertura al sacerdozio alle donne e agli uomini sposati - ma non hanno compiuto né minacciato azioni disciplinari.
Michael Pruller, portavoce del cardinale di Vienna, Christoph Schönborn, ha dichiarato che il cardinale ha in programma di incontrare a fine agosto/settembre i preti della diocesi viennese che sono tra i leader dell’"Iniziativa dei parroci", che ha lanciato un "Invito alla disobbedienza" nello scorso mese di giugno .
L’iniziativa, che afferma di raccogliere poco più di 300 membri, prevede di recitare una preghiera pubblica nel corso di ogni Messa per la riforma della Chiesa, di offrire la Comunione a tutti coloro che si avvicinano all’altare in buona fede, compresi i cattolici divorziati risposati, e privi di annullamento matrimoniale, di permettere alle donne di predicare durante la messa, e sostenere in ogni modo l’ordinazione delle donne e di uomini sposati.
In una intervista telefonica da Vienna, lo scorso 11 luglio, Pruller ha detto che per quanto ne sapeva, i vescovi austriaci non hanno discusso l’eventualità di una risposta comune da presentare ai preti. "Nessun vescovo ha minacciato azioni disciplinari, ma se un prete conduce la sua parrocchia lontano da quanto insegna la Chiesa, una sanzione la si dovrebbe prendere”, ha detto Pruller. Nell’ "Invito alla disobbedienza", si afferma che i preti si sono sentiti costretti a seguire la propria coscienza per il bene della Chiesa in Austria, anche perché i vescovi finora si sono rifiutati di agire in merito.
Il Cardinale Schönborn ha rilasciato una dichiarazione il 22 giugno dove diceva che avrebbe aspettato tre giorni prima di rispondere, perché non voleva reagire d’impulso "con la rabbia e il dolore" che l’iniziativa dei preti gli aveva causato.
"L’invito aperto alla disobbedienza mi ha letteralmente shoccato", ha detto. Il cardinale ha affermato che nessuno dei preti firmatari è stato ordinato con la forza e tutti loro hanno giurato obbedienza così come si sforzano di compiere la volontà di Dio. Il Cardinale Schönborn ha detto che è giusto per ogni uomo seguire la propria coscienza, e se i preti veramente credono di vivere un tale conflitto estremo tra la propria coscienza e la Chiesa, probabilmente essi dovrebbero considerare se appartengono ancora alla Chiesa. "Io credo e spero, però, che questo caso estremo non possa verificarsi qui da noi", ha scritto. Ma alla fine, "sta a tutti noi decidere se vogliamo percorrere la strada insieme al Papa, i vescovi e la Chiesa universale, o meno".
Il vescovo di Graz, Egon Kapellari, vice presidente della Conferenza episcopale austriaca, ha rilasciato una dichiarazione il 28 giugno, nella quale afferma che “le proposte dei preti stanno minacciando seriamente l’identità e l’unità della Chiesa cattolica".
“Mentre i pastori hanno ragione a essere preoccupati per fornire una cura pastorale migliore ai cattolici del Paese, la situazione in Austria non è così drammatica da richiedere ai preti di agire al di fuori della comunione con la Chiesa universale”.
“Una cosa è richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica alle necessità della Chiesa - ha detto Kapellari - altro è incoraggiare le persone a disobbedire agli insegnamenti e alla prassi della Chiesa stessa.”
Mons. Kapellari ha aggiunto che mentre la coscienza personale è riconosciuta dalla Chiesa come un "valore di tutto rispetto", è sbagliato insinuare che il papa e i vescovi non agiscono secondo la propria coscienza quando promuovono l’unità e il rispetto della tradizione della Chiesa.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- UNA "RIPRESA" NEL SENSO CHE ELVIO FACHINELLI DAVA A QUESTO TERMINE (di Lea Melandri - Il movimento delle donne ci riprova).11 luglio 2011, di Federico La Sala
IL MOVIMENTO DELLE DONNE CI RIPROVA
di LEA MELANDRI (Gli altri, 08.07.2011)*
Sembra un destino dei movimenti rendersi "visibili" solo quando scuotono la compagine istituzionale, le sue chiusure, i suoi modelli, la sua cecita’ rispetto a tutto cio’ che si muove intorno e al suo interno. La divisione tradizionale tra politica e societa’ e’ ancora cosi’ salda che e’ bastata l’imprevista partecipazione alle elezioni amministrative e al referendum per qualificare come "nuovi" protagonisti che sono da decenni tutt’altro che assenti dalla scena pubblica e dai suoi conflitti. I cortei degli studenti e dei precari, le occupazioni delle universita’, le singolari forme di lotta adottate negli ultimi tempi dagli operai, le grandi manifestazioni delle donne, dal 2006 al 13 febbraio, appaiono nonostante tutto "carsici" finche’ non producono cambiamenti riconoscibili nei luoghi deputati della politica.
"Il clima d’opinione, scrive Ilvo Diamanti ("La Repubblica", 27 giugno 2011), non cambia da solo. Ci vogliono nuovi ’attori’ in grado di riscrivere l’agenda pubblica imponendo all’attenzione dei cittadini nuovi temi (...) Si tratta di una partecipazione nuova, caratterizzata da componenti sociali tradizionalmente periferiche, rispetto all’impegno politico. In primo luogo le donne e i giovani".
Ma come e’ possibile che i "soggetti imprevisti" del ’68, a distanza di quarant’anni, siano ancora tali? Anche ammettendo che non si tratti di un disperante ritorno dell’uguale ma di una "ripresa" nel senso che Elvio Fachinelli dava a questo termine - il gia’ noto che cerca nuove vie di uscita -, non possiamo non chiederci se il primo nemico del cambiamento non sia la politica stessa, la strenua difesa dei confini astratti che si e’ data storicamente, fatti di esclusioni ingiustificate, di strappi violenti, privilegi, poteri e linguaggi sempre piu’ vacillanti. La radicalita’ della dissidenza giovanile e del femminismo degli anni ’70 e’ stata, principalmente, la ridefinizione dell’agire politico: il lavoro, ma anche la quotidianita’, la persona, i corpi, i ruoli sessuali, la formazione dell’individuo, le professioni, il rapporto con la natura, con l’ambiente, con la diversita’ sotto qualsiasi forma si presenti. Sul tracciato che si e’ aperto allora, si puo’ dire che l’onda lunga di alcuni movimenti non ha mai smesso di scavare solchi profondi e sempre piu’ estesi, fino a far balenare l’idea che "un altro mondo e’ possibile".
Eppure, la loro presenza e i cambiamenti di cui sono gli anonimi protagonisti, vengono registrati solo quando i "nuovi barbari" riescono ad abbattere qualche paletto della fatiscente impalcatura istituzionale: la cancellazione o la conquista di una legge, un risultato favorevole alle elezioni, l’accostamento alle regole di una politica ancora sostanzialmente separata dalla vita. A questa visione dicotomica non sfugge neppure l’analisi di un osservatore acuto come Ilvo Diamanti che, pur rilevando la "moltitudine di esperienze diverse, diffuse, articolate" del popolo che oggi esprime il suo desiderio di partecipazione, accosta ancora una volta le donne ai giovani, agli studenti e agli operai. Mi chiedo se il femminismo stesso, la’ dove ha rinunciato a interrogarsi sul rapporto tra il corpo e la polis, la sessualita’ e la politica, non abbia avallato involontariamente una classificazione che vede le donne come un gruppo sociale tra altri, sia che le si consideri alla stregua di una minoranza svantaggiata o, al contrario, una "risorsa viva" da reintegrare, a sostengo di un sistema in declino.
"Il risultato vero che la manifestazione del 13 febbraio ha dato con successo - scrive Franca Chiaromonte (www.donnealtri.it, 17 giugno 2011) - e’ stato quello di mettere in scena una mobilitazione di popolo a egemonia femminile (...) quello che voglio dire e’: cosi’ come innumerevoli manifestazioni - che di solito chiamiamo di carattere generale, per es. quelle dei sindacati o dei partiti -, sono piene anche di donne (...) altrettanto ora si renderanno possibili e ugualmente potenti, se non di piu’, manifestazioni all’inverso, dove cioe’ saranno le donne a segnare i passi decisivi".
Le oltre duecento piazze che hanno accolto l’appello del comitato romano "Se non ora quando" possono far pensare a una forza unitaria delle donne, capace di imporre i suoi temi all’agenda politica, cosi’ come suggerire l’idea che uno spazio pubblico segnato per secoli dall’autorita’ maschile cambi finalmente volto. Ma se si vuole dare una risposta alla domanda di continuita’ che viene oggi dai comitati diffusi su tutto il territorio nazionale, e’ importante - come ha scritto Serena Sapegno ("Gli Altri", primo luglio 2011) tener conto che, se il 13 febbraio ha fato cadere "vecchi steccati e pregiudizi aprendosi a donne molto diverse per eta’ e ceto sociale, cultura e esperienza di vita, posizioni politiche, opzioni religiose, scelte sessuali", non per questo viene meno il carattere problematico, contraddittorio, della "frammentazione" che caratterizza da sempre il movimento delle donne. Connaturata a una pratica che parte da "se’", dall’esperienza particolare di singole, gruppi, associazioni, per estendersi a un orizzonte piu’ generale, la pluralita’ dei soggetti, delle situazioni locali, dei percorsi storici, mal sopportano strette organizzative omologanti, cosi’ come la rassegnazione a vedere trasformarsi l’autonomia in isolamento.
L’assemblea di Snoq che si terra’ a Siena il 9-10 luglio non puo’ non richiamare alla memoria tentativi analoghi che quasi sempre hanno fatto seguito a mobilitazioni riuscite, ma la ripresa, oltre che essere in questo momento nelle aspettative di molte, prende una valenza nuova e la speranza di riuscita dal contesto in cui avviene. La concomitanza tra le piazze segnate dall’autonomia del movimento delle donne con quelle occupate per giorni dai comitati elettorali e referendari, ha creato occasioni di incontro, scambio, condivisioni inaspettate tra donne di formazione culturale e politica diversa, tra associazioni del femminismo e donne provenienti da ambiti sindacali e partitici. Per alcune citta’, come Milano, si tratta di una situazione nuova, che richiede come tale attenzione, impegno, disponibilita’ a interpretare le ragioni che ci hanno tenuto a lungo separate, estranee e diffidenti le une verso le altre. A un livello ancora piu’ esteso, quale e’ un’assemblea nazionale, sara’ possibile fare interagire realta’ cosi’ diverse, darsi una forma minima di organizzazione che non ricalchi modelli noti - lobby o partiti -, trovare "un sentire comune, terreni condivisi, azioni concertate"?
Sara’ questa la sfida maggiore: non scambiare la forza collettiva con l’obbedienza al pensiero unico, la valorizzazione delle differenze con l’assenza di conflitto, la solidarieta’ con l’adeguamento. Molto dipendera’ dall’ascolto reciproco e dall’apertura ai temi molteplici che via via sono venuti allo scoperto nei percorsi della coscienza femminile, oltre che dall’attenzione ai nessi non sempre evidenti che li attraversano. Non solo percio’ la rappresentazione della donna nei media, l’ideologia assorbita oggi dalle leggi del mercato e della pubblicita’ che da sempre l’ha identificata col corpo - erotico e materno -, ma anche la violenza domestica, la subalternita’ inconsapevole alla cultura maschile dominante, la divisione sessuale del lavoro, che ancora vede le donne - direttamente o attraverso la messa al lavoro di donne, per lo più straniere - responsabili "naturali" della conservazione della vita, l’estensione indebita del concetto di maternita’ a tutte le funzioni di cura indifferentemente prodigate a persone non autosufficienti e perfettamente autonome, la tentazione di assolutizzare, assumendole come proprie, le attrattive femminili che l’uomo ha asservito ai propri bisogni e desideri.
Dietro i corpi artificiali e mercificati, "offerti ossessivamente al consumo", come scrive Sapegno, ci sono donne non meno reali di quelle che giustamente criticano l’imposizione di modelli. Si possono trovare di volta in volta "obiettivi strategici" all’azione comune, se si ha, al medesimo tempo, la voglia di costruire una visione di insieme che si avvalga della ricchezza di saperi prodotta, paradossalmente, proprio dalla frammentazione conosciuta finora.
* Fonte: http://www.universitadelledonne.it/
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- Siena, oggi, è dunque una griglia di partenza avanzata. Quando? Ora! (di Cinzia sasso).10 luglio 2011, di Federico La Sala
Quando? Ora!
di Cinzia Sasso *
Che meraviglia la manifestazione di Siena. Ti guardi in giro, vedi le facce, i cappelli, le magliette, i sorrisi, e ti chiedi: ma quanto sono belle, le donne? Immaginate la stessa scena riempita da un’altro genere... beh, sarebbe proprio diversa. E però non è solo questione di estetica. Questo è un appuntamento di sostanza: non era facile immaginare che cinque mesi dopo le donne - di tutte le età, professioni, cultura, origine geografica - avessero ancora la forza e la voglia di incontrarsi tutte insieme e di mettere al centro del dibattito politico proprio se stesse.
Era successo il 13 febbraio, ma allora le piazze d’Italia piene di donne potevano sembrare la risposta di istinto a quella gigantesca offesa collettiva che era stata la scoperta - e soprattutto la spiegazione da parte dei protagonisti - delle notti di Arcore. Il guerriero stanco aveva spiegato che era suo diritto rilassarsi così, con ragazze a cachet. Chiarendo due radicati concetti: che il guerriero è il maschio e che le donne quello sono capaci a fare. Era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso, è chiaro: perché alle spalle avevamo la scelta di una classe dirigente femminile fatta con questi criteri e la mancanza assoluta di una idea del mondo più vicina alle donne e dunque alla vita e alla realtà.
Non so se sia bastato riempire le piazze e gridare collettivamente ”non ne possiamo più”; certo in questi cinque mesi molte cose sono cambiate. Oggi le giunte delle più importanti città che hanno rinnovato la loro amministrazione - da Milano a Cagliari - vedono uomini e donne, assessori e assessore, ugualmente divisi. E se non tutti hanno la lucidità di decidere in autonomia questo mix di genere, oggi c’è pure una legge che ti costringe: legge imperfetta, quella delle quote nei cda, ma comunque per l’Italia un passo avanti radicale come una rivoluzione.
Siena, oggi, è dunque una griglia di partenza avanzata. Forse davvero il momento di svolta. Il luogo dove alla domanda “quando?” è possibile rispondere “ora”. Buon lavoro, ragazze. Il futuro è nelle nostre mani: noi lo sappiamo, ma adesso lo spieghermo anche a tutti gli altri.
* la Repubblica - Blog di Cinzia Sasso: WWWOMEN
http://sasso.blogautore.repubblica.it/2011/07/09/quando-ora/?ref=HREC1-2
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- MANIFESTAZIONE A SIENA. Libertà per le donne. Se non ora quando (di Michela Marzano).10 luglio 2011, di Federico La Sala
Libertà per le donne Se non ora quando
di Michela Marzano (la Repubblica, 10 luglio 2011)
Non ci sarà mai un buon governo finché si calpesteranno o si dimenticheranno i diritti delle donne. La prima ad averlo detto era stata, nel 1791, Olympe de Gouges, due anni prima di essere ghigliottinata. Oggi sono tante le donne che condividono quest’affermazione. Lo dimostra la manifestazione di Siena.
Dove è stato scelto di farne uno degli slogan dell’incontro organizzato per questo fine settimana dall’ormai celebre movimento "se non ora, quando?". Sono tante e diverse le donne che non vogliono più essere ostaggio del potere maschile. Tante e diverse coloro che desiderano battersi perché gli uomini e le donne siano realmente uguali. Uguali in termini di diritti e di libertà. Uguali in termini di opportunità lavorative e intellettuali.
Uguali non solo di fronte alla legge, ma anche nella vita di tutti i giorni. Perché, nonostante tutte le conquiste degli anni Sessanta e Settanta, la condizione della donna in Italia si è oggi notevolmente degradata e l’uguaglianza effettiva sembra ormai una mera chimera. Quante donne, pur lavorando come gli uomini (e talvolta più di loro) sono costrette ad occuparsi da sole dei figli e della casa? Quante ragazze hanno gli strumenti critici necessari per decostruire le immagini e i discorsi che arrivano loro attraverso la televisione e la pubblicità?
La strada per l’emancipazione e l’uguaglianza è ancora lunga. Soprattutto quando ci si rende conto che, nonostante tutto, il concetto di uguaglianza viene ancora oggi frainteso. Molti continuano a confonderlo con quello di identità, come se, per godere degli stessi diritti, gli esseri umani dovessero per forza essere identici. Come se le donne, per potersi affermare a livello lavorativo e rompere il famoso "soffitto di cristallo", dovessero necessariamente rinunciare alla propria femminilità e "diventare uomini". L’uguaglianza per cui ci si batte oggi, invece, non ha affatto lo scopo di cancellare ogni differenza tra gli uomini e le donne, di tendere al "neutro", o di considerare che valore e dignità dell’essere umano dipendano solo dalla razionalità priva di sesso.
L’uguaglianza per la quale tante donne si mobilitano oggi è un’uguaglianza che valorizza le differenze, tutte le differenze. Come scriveva negli anni Novanta la femminista americana Audre Lorde: «Stare insieme alle donne non era abbastanza, eravamo diverse. (...) Ognuna di noi aveva i suoi propri bisogni ed i suoi obiettivi e tante e diverse alleanze. C’è voluto un bel po’ di tempo prima che ci rendessimo conto che il nostro posto era proprio la casa della differenza».
Certo, ci sono sempre quelle che pretendono di aver capito tutto e che vorrebbero imporre alle altre la propria concezione della femminilità o la propria visione della sessualità. Ciò che è giusto o sbagliato. Quello che si deve o meno fare. E che finiscono paradossalmente col proporre una nuova forma di "paternalismo al femminile", un mondo in cui poche donne avrebbero il diritto di imporre a tutte le altre il proprio modo di pensare e di agire.
Ma si tratta sempre e solo di una minoranza. Perché la maggior parte delle donne che si battono oggi per la difesa dell’uguaglianza e della libertà hanno ormai capito che la donna, per natura o per essenza, non è proprio nulla. Non è naturalmente gentile, dolce, materna, fedele. Esattamente come non è naturalmente perfida, libidinosa o pericolosa. Come l’uomo, la donna ha tante qualità e tanti difetti. Solo che, a differenza dell’uomo, non ha ancora avuto la possibilità di mostrare al mondo ciò di cui è capace. In quanto donna, non ha ancora accesso alle stesse opportunità degli uomini e viene spesso penalizzata.
L’unica vera battaglia che vale la pena di combattere oggi perché l’uguaglianza tra gli uomini e le donne diventi effettiva è quella per la libertà. È solo quando si è liberi che ci si può assumere la responsabilità delle proprie scelte, dei propri atti e delle loro conseguenze: la libertà è il cardine dell’autonomia personale; ciò che permette ad ogni persona di diventare attore della propria vita. Al tempo stesso, però, perché la libertà non resti un valore astratto, è necessario organizzare le condizioni adatte al suo esercizio.
Alla libertà come "non interferenza", la famosa libertà da della tradizione filosofica liberale, si deve aggiungere la libertà come "non dominazione" della tradizione repubblicana, la libertà di, quella libertà effettiva che permette ad ognuno di partecipare alla "cosa pubblica" senza subire le conseguenze di discriminazioni intollerabili sulla base del sesso, dell’orientamento sessuale, del colore della pelle o della fede religiosa.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- Se non ora quando. Nuovo protagonismo. Una valanga rosa verso Siena «Anche stavolta saremo migliaia» (di Augusto Mattioli).9 luglio 2011, di Federico La Sala
- DONNE, UOMINI, E COSTITUZIONE. Un’altra storia è possibile
 13 FEBBRAIO 2011: ORA BASTA! MANIFESTAZIONE DELLE DONNE E DELLE CITTADINE, PER LA LORO DIGNITA’ E PER UNA NUOVA ITALIA, AL DI LA’ DEL GOVERNO DEI "PAPI". L’appello di "Se non ora QUANDO?" - e (a seguire) materiali sul tema
13 FEBBRAIO 2011: ORA BASTA! MANIFESTAZIONE DELLE DONNE E DELLE CITTADINE, PER LA LORO DIGNITA’ E PER UNA NUOVA ITALIA, AL DI LA’ DEL GOVERNO DEI "PAPI". L’appello di "Se non ora QUANDO?" - e (a seguire) materiali sul tema
 Se non ora quando
Se non ora quando
 Un fine settimana all’insegna del confronto.
Un fine settimana all’insegna del confronto.
 «Dare voce a coloro che non hanno voce»
«Dare voce a coloro che non hanno voce»
 Nuovo protagonismo
Nuovo protagonismo
 Cristina Comencini: «Faremo un bilancio per guardare al futuro»
Cristina Comencini: «Faremo un bilancio per guardare al futuro» Una valanga rosa verso Siena «Anche stavolta saremo migliaia»
Una valanga rosa verso Siena «Anche stavolta saremo migliaia» di Augusto Mattioli (l’Unità, 08.07.2011)
di Augusto Mattioli (l’Unità, 08.07.2011)Quelle piazze piene del 13 febbraio le donne non le hanno dimenticate. Quel giorno è stato solo un inizio. Da allora hanno continuato a lavorare insieme, a dibattere sul loro ruolo, sui temi che le avevano indotte ad andare in piazza. Al di là delle appartenenze politiche. Come un fiume carsico, le donne del 13 febbraio tornano a farsi vedere e sentire. E lo fanno a Siena questo fine settimana. Si incontrano nella città del Palio per fare un bilancio di ciò che è stato fatto fino ad oggi, discutere ancora dei temi che maggiormente le interessano (il lavoro, la maternità, la rappresentazione che viene fatta del loro corpo, rapporto uomo-donna) e per capire cosa fare nei prossimi mesi della forza che, con le loro manifestazioni, hanno mostrato di possedere.
«L’appuntamento di Siena non sarà certo la conclusione del nostro lavoro ha ricordato ieri la regista Cristina Comencini ma faremo un bilancio di ciò che abbiamo fatto e rilanceremo andando avanti con iniziative comuni e forti». «In effetti ricorda Albalisa Sampieri, del comitato senese Donne del 13 febbraio abbiamo lavorato molto in questi mesi per l’appuntamento di Siena. Sarà importante che prendano la parola le donne comuni». Con le loro testimonianze. Quella di Sofia Sabatino, per esempio, che è portavoce nazionale della rete degli studenti. O quella di Sohueir Katkhuouda, presidente dell’associazione nazionale delle donne musulmane in Italia. O della teologa Agnese Fortuna.
La due giorni senese sta lievitando di ora in ora. Il numero delle partecipanti dovrebbe superare quota 1200. Una presenza che ha spiazzato le organizzatrici senesi e nazionali che si dichiarano soddisfatte. Per questo motivo è stata addirittura cambiata la sede dell’incontro dal museo Santa Maria della Scala alla vicina Piazza sant’Agostino nei pressi del Liceo Classico Piccolomini che ha messo a disposizione un’aula multimediale per la sala stampa. Un piccolo segnale della disponibilità della città ad accogliere le donne di «Se non ora quando». Del resto anche l’appello ai senesi per ospitare nella propria abitazione alcune di loro è stato accolto per una settantina di persone. Collaborazione piena anche dalle istituzioni, a partire dal Comune. «Siamo orgogliosi ha sottolineato il sindaco Franco Ceccuzzi che Siena sia stata scelta per questo appuntamento. Spero che da questa città continui a soffiare quel vento che ha innescato qualcosa di importante nel nostro Paese come il protagonismo delle donne».
- DONNE, UOMINI, E COSTITUZIONE. Un’altra storia è possibile
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA ---- IL DUOMO DI MONREALE E L’ ECUMENISMO RELIGIOSO DI FEDERICO II. I mosaici del duomo completati da Federico II? Lo sostiene il professor Heinrich Pfeiffer (di Maria Modica).23 giugno 2011, di Federico La Sala
I mosaici del duomo completati da Federico II?
Lo sostiene il professor Heinrich Pfeiffer, che ha tenuto una lezione in cattedrale
di Maria Modica *
MONREALE, 26 febbraio 2011 - I mosaici del duomo di Monreale potrebbero essere stati completati da Federico II.
La rivoluzionaria tesi è sostenuta da uno dei maggiori esperti mondiali di Storia dell’arte, il gesuita Heinrich Pfeiffer della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Lo studioso è stato invitato dall’arcivescovo di Monreale, Monsignor Salvatore Di Cristina, per esporre la terza lezione - concerto, dedicata ai mosaici del duomo. Ultimo appuntamento del ciclo che ha voluto lanciare un dialogo ideale con la Settimana di Musica sacra in programma il prossimo anno.
La prolusione è stata preceduta dall’esecuzione del coro di voci bianche del Conservatorio Bellini di Palermo.
L’oratore ha incantato la platea con osservazioni acute e stimoli lanciati alla mente e al cuore.
«Questo luogo - ha esordito Pfeiffer - è unico al mondo. Presenta una divisione dello spazio basilicale per tematiche, ma quel che stupisce è l’ampiezza della descrizione dedicata al Vecchio testamento: tutta la navata centrale. La narrazione biblica comincia con la morte di Caino per il colpo di una freccia e termina con storia di Giacobbe e l’Angelo, centrale nella storia dell’Ebraismo perché da questo deriva il nome di Israele che significa lotta con Dio. Un’ampiezza descrittiva degna di una sinagoga. Questo spazio E .
Primo indizio che porta all’imperatore svevo è, dunque, l’ecumenismo religioso a lungo accarezzato da Federico II. Ma la stimolante tesi è suffragata dall’osservazione dei canoni estetici che contraddistinguono le raffigurazioni musive, una difformità di stile che non trova giustificazioni nell’esiguo spazio temporale, nemmeno un ventennio, durante il quale sarebbe stato ultimato il duomo.
«La differenza fra alcune icone - ha continuato Pfeiffer - di chiaro stile bizantine, di sicuro risalenti al XII s., e altre raffigurazioni, fra cui il Pantocratore, in cui la plasticità prelude alla soluzione prospettica del ’400, ci indica il trascorrere di almeno un secolo. La "sproporzione" fra il Cristo absidale e le figure circostanti non può essere stata concepita da una personalità mite quale quella del re normanno».
Secondo lo studioso tedesco, la conferma implicita si trova nella leggenda del Carrubo, sotto il quale Guglielmo avrebbe rinvenuto un immenso tesoro con cui edificare il tempio.
«La leggenda - ha proseguito - risponde ad una domanda cui manca una giustificazione storica: chi ha pagato tutto questo? Il regno normanno non avrebbe potuto permetterselo, soltanto l’Impero avrebbe potuto farlo».
La spiegazione del mistero si troverebbe nella "damnatio memoriae" che ha colpito gli Svevi snaturandone la reale portata storica, soprattutto in Sicilia.
«Una damnatio memoriae - ha concluso lo studioso - deve essere tolta da un cristiano: perciò ho parlato».
* MONREALE NEWS - 26 Febbraio 2011 http://www.monrealenews.it/chiesanotizie-della-diocesi/curiala-curia-del-territorio-diocesano/1375-i-mosaici-del-duomo-completati-da-federico-ii.html
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- «Arte e fede devono dialogare». È questo il senso profondo della mostra Lo splendore della verità, la bellezza della carità (di Gian Guido Vecchi).18 giugno 2011, di Federico La Sala
«Arte e fede devono dialogare»
di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 18 giugno 2011)
È come nella morte di Bergotte, narrata da Marcel Proust ne La prigioniera. L’anziano scrittore che crolla esanime mentre ammira la perfezione d’una «piccola ala di muro gialla» dipinta da Vermeer, «nelle condizioni della nostra vita su questa terra, non c’è nessuna ragione (...) perché un artista ateo si creda in dovere di fare cento volte un "pezzo"...» , la tensione verso «un altro mondo, fondato sulla bontà, lo scrupolo, lo spirito di sacrificio» , un «oltre» misterioso che l’autore della Recherche tratteggia in quello che forse è l’omaggio più bello della letteratura contemporanea alla fatica creativa: «Durante l’intera notte funebre, nelle vetrine illuminate, i suoi libri disposti a tre a tre vegliarono come angeli dalle ali spiegate e sembravano, per colui che non era più, il simbolo della sua resurrezione».
Il cardinale Gianfranco Ravasi ne è convinto da tempo e ora ripete: «Il dialogo tra arte e fede è necessario, data la parentela che intercorre tra queste due espressioni diverse dello spirito umano, che tendono entrambe, su strade diverse, verso l’eterno e l’infinito». Eppure, spiega, le due strade «si sono divaricate». Da una parte «la teologia, la liturgia sono andate su altre traiettorie quando dovevano introdurre nell’interno dei loro spazi il tema estetico». Dall’altra «le arti hanno avuto i loro percorsi, spesso in maniera abbastanza sorprendente e sconcertante, fino al punto di essere blasfeme, quindi provocatorie nei confronti del punto di partenza: quello religioso che, per secoli, è stato complice della cultura».
Fede e arte devono tornare a parlarsi. È questo il senso profondo della mostra Lo splendore della verità, la bellezza della carità che il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura ha voluto come omaggio a Benedetto XVI nel sessantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Era il 29 giugno 1951 quando Joseph Ratzinger ricevette la consacrazione nel Duomo di Frisinga. E così, per festeggiare i sessant’anni, il cardinale Ravasi ha invitato sessanta artisti a celebrare l’occasione con le loro opere, come anticipato dal «Corriere» la settimana scorsa: la mostra, inaugurata dallo stesso Papa il 4 luglio, troverà spazio nell’atrio dell’aula Paolo VI, in Vaticano, e si potrà visitare dal 5 luglio al 4 settembre.
Ad ogni artista è stato chiesto di presentare un’opera per l’evento - e quindi su «lo splendore della verità, la bellezza della carità» - in modo da riprendere quel dialogo interrotto, anche se mai del tutto: Ravasi ha ricordato il Crocifisso che Andy Warhol teneva in camera o i celebri «tagli» che Lucio Fontana descriveva come «spiragli sull’assoluto» . Ognuno si regolerà come crede. Il grande architetto brasiliano Oscar Niemeyer, 103 anni, ha mandato il modello del campanile della cattedrale in costruzione a Belo Horizonte «perché voleva che il Papa lo vedesse», ha spiegato il cardinale. Il poeta Davide Rondoni ha scritto invece Autoritratto con Papa, una poesia inedita che allude alla definizione che Benedetto XVI diede di sé («un umile operaio nella vigna del Signore») e affronta il tema con un incipit sul filo dell’ironia: «Vendemmia o bestemmia?».
Certo la scelta degli inviti non è stata facile e non ha mancato di creare discussioni. L’idea era di abbracciare le più svariate forme di arte: e nell’elenco ci sono pittori e scultori, architetti e musicisti, poeti e scrittori, registi, fotografi e orafi. Nomi celebrati come Arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladino e Kengiro Azuma, Santiago Calatrava, Mario Botta, Renzo Piano e Paolo Portoghesi, e ancora Ennio Morricone o Pupi Avati. E altri meno conosciuti, almeno al grande pubblico. C’è anche Oliviero Rainaldi, l’autore della discussa statua di Wojtyla alla stazione Termini.
Lo spirito è quello del grande incontro con Benedetto XVI nella Cappella Sistina, il 21 novembre del 2009: l’invito «all’amicizia, al dialogo, alla collaborazione» che il Papa rivolse agli artisti come «custodi della bellezza nel mondo». Solo che allora ne arrivarono 260 e stavolta, per mantenere la simmetria con l’anniversario del Pontefice, c’era posto solo per 60 persone. Gli esclusi rispetto ad allora sono la maggioranza e nell’ambiente trapela qualche malumore anche fra gli invitati. Ma una scelta si doveva pur fare: «Nei 60 ogni arte doveva essere rappresentata, cercando di far essere presenti esponenti di diverse aree geografiche e culturali, e in più c’era poco tempo», allarga le braccia il cardinale Ravasi. «Come sempre le selezioni possono creare giudizi e critiche, ogni artista siconsidera insostituibile...» .
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- USCIRE DALLA "PREISTORIA". CURARE LA DEMOCRAZIA ... SULLA STRADA DELLA DEMOCRAZIA "REALE", SUBITO.6 giugno 2011, di Federico La Sala
 USCIRE DALLA "PREISTORIA". CURARE LA DEMOCRAZIA ...
USCIRE DALLA "PREISTORIA". CURARE LA DEMOCRAZIA ...
 SULLA STRADA DELLA DEMOCRAZIA "REALE", SUBITO. Chiarimenti e materiali sul tema
SULLA STRADA DELLA DEMOCRAZIA "REALE", SUBITO. Chiarimenti e materiali sul tema
 “Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani (...) bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto. A questo patto l’umanità potrà dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico (...)
“Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani (...) bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto. A questo patto l’umanità potrà dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico (...)
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA ---- ANTROPOLOGIA ’PREISTORICA’. Lei a caccia, lui nelle caverne quando le donne usavano la clava Uno studio di Oxford sulla preistoria ribalta le tesi tradizionali (di Enrico Franceschini)3 giugno 2011, di Federico La Sala
Lei a caccia, lui nelle caverne quando le donne usavano la clava
Uno studio di Oxford sulla preistoria ribalta le tesi tradizionali
Fra 3 milioni e un milione e mezzo di anni fa, le femmine erano assai più mobili dei maschi
di Enrico Franceschini (la Repubblica, 03.06.2011)
LONDRA - "Wilma, dammi la clava!", tuona Fred Flintstone nella classica scenetta degli "Antenati", il cartone animato sui nostri lontani progenitori. Ma forse la clava sapevano maneggiarla anche le donne. Scienziati dell’università di Oxford hanno scoperto «con sorpresa» che le femmine dei primi ominidi, in un periodo compreso fra 3 milioni e un milione e mezzo di anni fa, erano assai più mobili dei maschi: mentre molte di loro lasciavano la caverna e la valle natia per spingersi in nuovi territori, l’uomo nasceva e moriva prevalentemente nello stesso luogo. Un fatto che induce i media britannici a ribaltare il luogo comune sul cavernicolo che va a caccia (talvolta anche di donne, per procurarsi una compagna), mentre la femmina rimane seduta al focolare ad allevare i piccoli: di colpo diventa possibile il contrario, la donna che lascia l’accampamento e cerca cibo, l’uomo che rimane a "casa", a protezione del fuoco, dei cuccioli, del tetto. E’ per caso successo qualcosa intorno a un milione di anni fa, si chiedono i giornali e la Bbc, che ha tolto alle donne l’indipendenza di cui godevano all’inizio della preistoria, sicché hanno dovuto aspettare il femminismo per riconquistarla almeno in parte?
Il comportamento riscontrato negli ominidi di 2-3 milioni di anni or sono, osserva la professoressa Julia Lee-Thorp, docente di antropologia alla Oxford University e curatrice dello studio pubblicato sulla rivista Nature, è simile a quello degli scimpanzé, il primate geneticamente più simile all’uomo. «Anche fra gli scimpanzé, i maschi tendono a stare all’interno del gruppo familiare, cacciando tutti insieme nell’ambito di un singolo territorio conosciuto, mentre le femmine vengono allontanate», afferma la scienziata. Una spiegazione del fenomeno è che i maschi, in tal modo, vogliono evitare che le femmine abbiano rapporti sessuali con più membri dello stesso gruppo. Ma le abitudini di un’altra specie di primati, i gorilla, sono differenti: un maschio dominante ha rapporti sessuali con più femmine dello stesso branco.
«Sarebbe azzardato concludere, dai risultati della nostra ricerca, che nella preistoria i maschi stavano a casa ad allevare i figli e le donne uscivano a caccia», avverte la professoressa Lee-Thorp, notando che niente del genere accade neppure tra gli scimpanzé. Altri studiosi ammoniscono che il campione usato per la ricerca è piccolo e «occorre essere cauti nel trarne conseguenze», pur concedendo che è uno sviluppo estremamente interessante. Riconosce l’antropologa Lee-Thorp: «Quando ci siamo resi conto della scoperta, siamo rimasti sbalorditi».
I ricercatori di Oxford hanno esaminato i resti fossilizzati di un gruppo di umani preistorici rinvenuti in caverne a nord-est di Johannesburg, in Sud Africa. Dall’esame di denti ed ossa, così come di piante e minerali, sono risaliti al cibo di cui si nutrivano e lo hanno confrontato con le regioni circostanti. E’ risultato che soltanto un maschio su dieci si era spostato dalla comunità in cui era nato e cresciuto, mentre più della metà delle donne provenivano da altre zone, altre valli, altre comunità. «Non sappiamo perché le donne si spostassero più degli uomini», conclude l’autrice della ricerca.
La certezza però è che si muovevano, non passavano la vita attaccate al focolare. Perciò ai loro discendenti viene oggi istintivo definirle «le femmine Alfa della preistoria», forti, sicure, autonome, come scrive il Daily Mail. La Wilma degli "Antenati", che lascia la clava a Fred ma comanda, e la Raquel Welch del film "Un milione di anni fa", audace più degli uomini, potrebbero essere più vicine alla realtà di quanto pensassimo.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- MUTAMENTI ANTROPOLOGICI E COMA PROFONDO DELLA PSICOANALISI (E NON SOLO). IL LETTINO DI MISS FREUD E LA LEZIONE DI FACHINELLI NEGATA E IGNORATA..1 giugno 2011, di Federico La SalaFREUD, FACHINELLI, E LA MENTE ACCOGLIENTE. «Al momento di diventare sciamani, si dice, gli uomini cambiano sesso. È così posta in rilievo la profondità del mutamento necessario. Il femminile come atteggiamento recettivo non abolisce però il maschile, gli propone un mutamento parallelo» (E. Fachinelli, La mente estatica, 1989).
 LA PSICOANALISI, IL LETTINO DI MISS FREUD, E LA LEZIONE DI FACHINELLI NEGATA E IGNORATA. Un’inchiesta di Vera Schiavazzi, una riflessione di Michela Marzano, e un nota in premessa
Sulla carta, dal 1989, tutti sono uguali: laureati in medicina e in psicologia possono frequentare per 4 anni una delle scuole riconosciute di psicoterapia, poi un tirocinio e un esame (...)
LA PSICOANALISI, IL LETTINO DI MISS FREUD, E LA LEZIONE DI FACHINELLI NEGATA E IGNORATA. Un’inchiesta di Vera Schiavazzi, una riflessione di Michela Marzano, e un nota in premessa
Sulla carta, dal 1989, tutti sono uguali: laureati in medicina e in psicologia possono frequentare per 4 anni una delle scuole riconosciute di psicoterapia, poi un tirocinio e un esame (...)
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- E’ SOLO L’INIZIO! DEMOCRAZIA "REALE", ORA!: IN ITALIA, A NAPOLI, CON FILANGIERI E DON MILANI. Un omaggio e un augurio al nuovo sindaco, Luigi De Magistris, e a tutto il popolo napoletano.31 maggio 2011, di Federico La Sala
 ILLUMINISMO NAPOLETANO: RINASCIMENTO ITALIANO. LA LEZIONE DI GAETANO FILANGIERI E DI DON LORENZO MILANI - OGGI.....
ILLUMINISMO NAPOLETANO: RINASCIMENTO ITALIANO. LA LEZIONE DI GAETANO FILANGIERI E DI DON LORENZO MILANI - OGGI.....
 E’ SOLO L’INIZIO! DEMOCRAZIA "REALE", ORA!: IN ITALIA, A NAPOLI, CON FILANGIERI E DON MILANI. Un omaggio e un augurio al nuovo sindaco, Luigi De Magistris, e a tutto il popolo napoletano
E’ SOLO L’INIZIO! DEMOCRAZIA "REALE", ORA!: IN ITALIA, A NAPOLI, CON FILANGIERI E DON MILANI. Un omaggio e un augurio al nuovo sindaco, Luigi De Magistris, e a tutto il popolo napoletano
-
> RINASCIMENTO ITALIANO: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. ---- PASSANDO PER LA STAZIONE DI CONTURSI, IN VIAGGIO CON DON GIUSEPPE DE LUCA (cit. da "Ballata alla Madonna di Czestochova). .13 maggio 2011, di Federico La Sala
UN VIAGGIO:
SUI LUOGHI DELLA METAFISICA. IN COMPAGMA DI DON GIUSEPPE DE LUCA **
Tutte le volte, e non furono tante, che io son tornato nella casa dove nacqui (è in un paese montano, sul margine di faggete eterne che mai nessuno ha traversato, nel cuore più nascosto della Basilicata; e sì che vi si è a distanza pari, lassù, tra l’Adriatico, lo Ionlo, ll Tirreno, e io fanciullo coi pastori spiavo se, di tra una radura e l’altra della sommità più alta, si vedessero in lontananza scintillare insieme le tre marine); tutte le volte che sono tornato a casa, dicevo, giungendovi da Salerno per il Vallo di Diano, non appena oltrepassato il crinale che il Vallo separa dalla vallata del Pergola, d’ún subito scoprivo, là sulla costa di fronte, il mio paese nel sole, e poco più giù sulla destra il camposanto, dove dorme colei che, dando in cambio la vita sua per la mia, mi fece uomo; e accanto ad essa, dorme il prete che fece me prete.
Voi direte: il Pergola, peuh! gran fiume che è! e poi anche la valle di cotanto fiume, e poi... Adagio, lettore. Da quei monti dietro il mio paese, da quelle faggète, scende il Melandro; il Melandro per ùna matassa lenta di andirivieni va a riversarsi nel Pergola, il Pergola nel Tanagro; e così, dolce dolce, una valle appresso all’altra ora costeggiando l’uno ora.l’altro paese, antiquos subterlabentia muros, quei magri fiumi si gettano alla fine nel Sele
- [nei pressi della stazione ferroviaria del Comune di CONTURSÌ, fls],
e il Sele entra nel mare a Pesto, dove I’acqua del mare serba ancora una sua certa luce: poco più su insomma dell’antica Elea, dove nacque un giorno la metafisica, come sullo Ionio a Metaponto, ora coltivata ma sempre solitaria, nacque un giorno la filosofia religiosa.
Lettor mio, vuoi proprio levarti la voglia e il gusto di darci di “area depressa”? Padrone. Io pure, rintronato sin da fanciullo tra nomi come Melandro, Tanagro, Sele, Palinuro, Elea, Metaponto, anche io mi sento quando perplesso e quando depresso. Non forse in quel senso che dici tu, ma è un fatto, sento che mi opprime, quasi un peso troppo grande, il peso di tre millenni continuati nella luce della civiltà; e se non ti dispiace, mi sento turbare tutte le volte da quelle terre, quei cieli,.quei boschi, quelle acque, quei luoghi senza gloria, così poveri e antichi. Tutte le volte. Te ne accorgerai tu pure, un giorno non lontano *.
*
Questo è il paesaggio in cui si trova Contursi Terme, e questo è il sorprendente avvio dell’articolo, intitolato Ballata alla Madonna di Czestochova (“Osservatore Romano”, 25.2.1962), scritto da don Giuseppe De Luca (su invito di Giovanni XXIII, in occasione della visita a Roma del primate polacco, il cardinale Wyschinski), a meno di un mese dalla sua repentina morte avvenuta il 19.3.1962 (cfr. “Bailamme”, nn. 5-6, 1999, pp. 11 e sgg.). Egli era nato a Sasso di Castalda, in provincia di Potenza, il 15.09.1898, da una famiglia contadina.
 Della sua instancabile e preziosa attività culturale, degna di nota (per i problemi qui trattati) è la cura e la risrampa, accresciuúa con ricchi dati bibliografici, della dissertazione del 1907 di Angelo Roncalli su Il
Cardinale Cesare Baronio. Per il terzo centenario della morte, cfr. Angelo
Roncalli, Il Cardinale Cesare Baronio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1961.
Della sua instancabile e preziosa attività culturale, degna di nota (per i problemi qui trattati) è la cura e la risrampa, accresciuúa con ricchi dati bibliografici, della dissertazione del 1907 di Angelo Roncalli su Il
Cardinale Cesare Baronio. Per il terzo centenario della morte, cfr. Angelo
Roncalli, Il Cardinale Cesare Baronio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1961.** Cfr. Federico La Sala, Della Terra, il brillante colore. Note sul “poema” rinascimentale di un ignoto Parmenide carmelitano (ritrovato a Contursi Terme nel 1989), Prefazione di Fulvio Papi, Edizioni Ripostes, Salerno-Roma 1996, pp. 14-15.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- MOBILITAZIONE REFERENDUM. Dal Sele a Caorso catene umane contro il ritorno del nucleare21 maggio 2011, di Federico La Sala
LA MOBILITAZIONE
Un weekend di catene umane contro il ritorno del nucleare
Tra oggi e domani dieci manifestazioni in tutta Italia per dire no ai progetti atomici del governo e al tentativo di far saltare con la falsa moratoria il referendum del 12 e 13 giugno *
ROMA - Reazione "a catene" contro il nucleare. Ha preso il via stamattina da Palma di Montechiaro (Siracusa), località papabile per ospitare una delle nuove centrali del programma atomico del governo, il weekend antinucleare organizzato dalle oltre 80 associazioni del comitato "vota sì per fermare il nucleare".
Tra oggi e domani 10 catene umane cingeranno siti nucleari e località candidate ad ospitare nuove centrali "per dire a chi intende riportare l’atomo in italia che non ci stiamo, e che, come ha dimostrato il plebiscito in Sardegna, gli italiani non accetteranno trucchetti. Non accetteranno che, senza cancellare il nucleare, si cancelli il loro diritto ad esprimersi col referendum sul loro futuro e sulla loro sicurezza".
Dopo l’anticipo mattutino in Sicilia, nel pomeriggio teatro delle manifestazioni saranno la ex centrale nucleare di Caorso (Piacenza), il deposito per combustibile irraggiato di Saluggia (Vercelli) e poi a Chioggia, Monfalcone, Termoli e la foce del fiume Sele (Salerno), tutte località candidate ad accogliere i nuovi impianti. Catene umane sono in programma anche a Scanzano Jonico (Matera), sito indicato nel 2003 come sede del deposito nazionale delle scorie. In serata, alle 19.30, sarà la volta di Nardò (Lecce), altra località dove il governo potrebbe decidere di costruire una nuova centrale. La serie delle catene umane si chiude infine domani mattina a Montalto di Castro (Viterbo). "I cittadini - promette una nota del comitato organizzatore - faranno sentire la loro voce contro la censura che cerca di nascondere i referendum agli italiani e contro i tentativi di sabotare il voto del 12 e 13 giugno".
Al momento l’emendamento al decreto omnibus con cui il governo vorrebbe rendere superfluo il referendum sull’atomo è all’esame della Camera. Palazzo Chigi punterebbe a porre la fiducia sul provvedimento, ottenendo - salvo sorprese legate alla tenuta della maggioranza - un via libera entro martedì o mercoledì della prossima settimana. A quel punto il testo dovrà essere firmato dal presidente della Repubblica e se il capo dello Stato non solleverà dei profili di illegittimità costituzionale (che pure alcuni osservatori ritengono di cogliere nel decreto), sarà poi la Cassazione a valutare se le modifiche introdotte siano sufficienti a far saltare la consultazione. Una decisione che al momento appare di difficile previsione.
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- CURARE LA DEMOCRAZIA .... DEMOCRAZIA REALE SUBITO: "DEMOCRACIA REAL YA"!!! NOTIZIE DALLA SPAGNA21 maggio 2011, di Giovanni
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- W o ITALY !!!: INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT.25 maggio 2011, di Federico La Sala
 Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto.
Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto.
 INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT. Un omaggio a WOJTYLA: UN CAMPIONE "OLIMPIONICO", GRANDISSIMO. W o ITALY !!!
INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT. Un omaggio a WOJTYLA: UN CAMPIONE "OLIMPIONICO", GRANDISSIMO. W o ITALY !!!
-
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- A NAPOLI, DE MAGISTRIS. "Saviano deve essere uno dei protagonisti del cambiamento di Napoli". E poi lancia la proposta al rettore di Salerno, Raimondo Pasquino,a sindaco.26 maggio 2011, di Federico La Sala
 De Magistris: "Presto Saviano libero a Napoli
De Magistris: "Presto Saviano libero a Napoli
 Pasquino presidente dell’assemblea"
Pasquino presidente dell’assemblea"Il candidato dell’Idv risponde così alle dichiarazioni di sostegno dell’autore di Gomorra. "Saviano deve essere uno dei protagonisti del cambiamento di Napoli". E poi lancia la proposta al rettore di Salerno, sconfitto al primo turno delle elezioni a sindaco *
"Voglio creare le condizioni perchè Saviano possa tornare liberamente a Napoli". Con questa promessa Luigi de Magistris risponde a l’autore di Gomorra che ha dichiarato di voler sostenere l’ex magistrato al ballottaggio. di domenica.
"Saviano ha avuto il coraggio di portare il tema dei rapporti tra camorra e politica fuori dai confini nazionali - piega il candidato Idv - e lui deve essere uno dei protagonisti del cambiamento che vuole Napoli".
Per questo, fa sapere di essere intenzionato a "organizzare una passeggiata con Saviano e i giovani di Napoli". De Magistris aggiunge: "Mi è piaciuta l’espressione che ha usato ’Liberare Napoli’. E’ la stessa che ho utilizzato io in campagna elettorale". Oggi, per l’ex pm, è il giorno dell’incontro con i giovani sulle scale dell’Università di Napoli Federico II, in corso Umberto. Anche stavolta prende il megafono e parla ai ragazzi. "Adotta un astenuto e portalo a votare", dice. Gli studenti intonano il coro "Sindaco, sindaco".
Poi, il candidato di centrosinistra, riprende a parlare e sottolinea di "voler creare le condizioni" per evitare la fuga dei cervelli. "Da europarlamentare - spiega De Magistris - ho incontrato troppi ragazzi che sono andati via perchè qui non c’è lavoro".
"Credo che Pasquino possa essere un ottimo presidente del Consiglio e quando sarò sindaco voglio lui in questo ruolo". Lo ha detto Luigi de Magistris, candidato sindaco di Napoli, parlando del rettore dell’Università di Salerno Raimondo Pasquino, candidato sindaco del Terzo polo escluso dai ballottaggi. " una persona che ho imparato ad apprezzare in campagna elettorale per il suo stile - ha affermato a margine di un incontro con i giovani - così come ho apprezzato il suo annuncio di voler rimanere in Consiglio comunale".
* la Repubblica, 26 maggio 2011
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- L’ISLAM A MILANO E IL PLURALISMO ASSENTE (di Filippo Gentiloni).29 maggio 2011, di Federico La Sala
L’islam a Milano e il pluralismo assente
di Filippo Gentiloni (il manifesto, 28 maggio 2011)
Nell’acceso dibattito di questi giorni a proposito delle elezioni al comune di Milano è entrato a vele spiegate un protagonista nuovo, a dir poco insolito, l’islam. Non ce lo aspettavamo, né come compagno né come avversario. I sostenitori della Moratti hanno accusato Pisapia di volere "islamizzare" Milano, una accusa, a detta di tutti, assolutamente infondata. Al di fuori della realtà e della storia. Una accusa che sembra collegare il dibattito di oggi a quelli di parecchi secoli fa. Una accusa sulla quale, comunque, vale la pena di riflettere.
Nei momenti più gravi della vita politica e sociale del nostro paese la religione ritorna in primo piano. Sempre, o quasi, per sottolineare il primato cattolico e per mettere, invece, in secondo piano, le altre fedi religiose. Un vecchio primato che viene ribadito. Una situazione che dovrebbe essere superata, a vantaggio di quel pluralismo religioso che vige in quasi tutto il mondo moderno, ma da noi non ancora. Anche se in questa occasione l’Arcivescovo di Milano, cardinale Tettamanzi ha opportunamente affermato di non essere assolutamente turbato dalla possibile minacciata islamizzazione di Milano. Meno male.
In realtà questa ambigua vicenda milanese ha dimostrato ancora una volta come da noi il vero e proprio pluralismo religioso non sia ancora affermato. Il cattolicesimo gode di una posizione di privilegio, ancora sostenuta e affermata. Basti pensare alla scuola, dove l’insegnamento della religione cattolica gode ancora di notevoli privilegi, assistenziali e finanziari. Le altre religioni, invece, continuano a mantenere una situazione di secondo piano. A dir poco.
La vicenda delle elezioni milanesi con la minaccia dell’islam lo ha confermato. Che cosa si potrebbe fare per arrivare a un vero e sostanziale pluralismo? È difficile dirlo. Forse ci vorrebbe qualche iniziativa che partisse proprio dal mondo cattolico, il più diretto interessato.
Forse soltanto da oltretevere può venire una vera e sincera accettazione del pluralismo. E sarebbe proprio il cattolicesimo a godere di un nuovo vigore se rinunciasse a privilegi che ormai si mantengono soltanto a fatica e con sforzi non soltanto poco democratici ma anche poco cristiani.
-
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- ARTE E LITURGIA. Le opere d’arte... la capacità di essere concelebranti, di essere mistagogiche, in grado cioè di condurre al mistero di Cristo (di Enzo Bianchi - Perché non tutta l’arte «religiosa» è adatta alle chiese).29 maggio 2011, di Federico La Sala
Perché non tutta l’arte «religiosa» è adatta alle chiese
di Enzo Bianchi (Avvenire, 29 marzo 2011)
La liturgia ha bisogno dell’arte, sia in quanto liturgia dell’incarnazione sia perché non si può concepire una liturgia senza arte. La liturgia confessa la trasfigurazione della realtà e l’arte è capace di evocare in modo particolare questa trasformazione, di alludere a questo processo di metamorfosi che ha come soggetto lo Spirito santo. È dunque vero che la liturgia abbisogna del linguaggio dell’arte, espresso nell’architettura, nella scultura, nella pittura, nelle vetrate, nella musica.
Nello stesso tempo, però, la liturgia cristiana deve discernere e giudicare quali opere d’arte possono entrare in essa e acquisire la capacità di essere concelebranti, di essere mistagogiche, in grado cioè di condurre al mistero di Cristo; oppure deve valutare se, al contrario, le opere d’arte costituiscono una contraddizione, un impedimento alla liturgia stessa. Non si dimentichi che c’è un’arte religiosa, a volte straordinaria, che però non è adeguata, non ha la capacità di entrare nella liturgia. Oggi regna molta confusione sull’argomento, e per questo ci si avventura troppo facilmente sulle vie della sperimentazione e dell’improvvisazione, ma tale modo di procedere contraddice lo statuto della liturgia cristiana. Occorre pertanto ricordare che una cosa è l’arte religiosa, anche cristiana, e un’altra è l’arte cristiana liturgica: quest’ultima è giudicata a partire dalla sua capacità mistagogica.
Non dovremmo mai dimenticare, in proposito, le parole dette da Henri Matisse (che destarono anche una certa sorpresa): «Tutta la mia opera è religiosa, ma non tutte le mie opere religiose possono stare in una chiesa». Qual è dunque il fine a cui deve tendere l’arte quando vuole entrare nella liturgia? Con la sua bellezza, della materia e dell’arte umana, è chiamata a narrare la bellezza della presenza e dell’azione del Signore vivente. Simboli e arte testimoniano la convinzione che l’invisibile esiste, che la liturgia è una finestra aperta sull’invisibile, che il credente vuole esercitarsi a vedere l’invisibile (Eb 11,27), per restare saldo in un mondo in cui il visibile sembra essere l’unica possibilità di lettura.
In un mondo limitato al visibile, e di conseguenza all’empirico, simboli e arte chiedono di essere letti, di essere presenti per aiutare gli uomini a una comprensione più profonda e totale della loro vocazione.
Detto altrimenti, il problema è quale simbolica, quale linguaggio e immaginario simbolico può attivare il desiderio spirituale dell’uomo attuale e aprire la sua mente e il suo immaginario verso l’eschaton e l’eterno, cosa già difficile di per sé, e oggi ancora di più per l’uomo contemporaneo costantemente di corsa, «in fuga».
Questa simbolica (e arte) nella liturgia deve avere come fine quello di suscitare la capacità di gratuità e di contemplazione, non di consumo o di possesso; deve saper introdurre al senso del mistero, che non è affatto l’inconoscibile, ma ciò per il quale l’interesse e la ricerca non si esauriscono mai, anche quando lo si conosce parzialmente: il mistero infatti, e in particolare il mistero di Dio, diviene sempre più interessante, seducente, capace di condurre a sé, nella misura in cui a esso ci si avvicina progressivamente e se ne conosce qualcosa.
Occorrono una lunga disciplina e una costante educazione di ogni cristiano, perché possa percepire la vera bellezza nell’arte la quale, se è autentica, insegna, fa memoria, emoziona, plasma il cristiano stesso. E noi dobbiamo credere, insieme alla tradizione cristiana orientale, che l’arte non solo può narrare l’agere Dei , ma può anche riflettersi sul cristiano che la legge e la abita, trasfigurandolo di gloria in gloria, a immagine di colui che è la fonte di ogni bellezza
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- ARTE E LITURGIA. --- Il racconto di Dio nell’umanità della liturgia (di Enzo Bianchi)9 giugno 2011
Il racconto di Dio nell’umanità della liturgia
di Enzo Bianchi (Jesus, n. 5, maggio 2011)
L’«oggi» della vita ecclesiale, un oggi che riguarda a grandi linee gli ultimi quindici anni, è contrassegnato dal conflitto: la liturgia, che per sua natura vuole essere luogo di comunione e spazio in cui il Signore risorto e vivente dona alla sua comunità la pace («Pax vobis!»: Gv 20,19.21.26), è luogo di conflitto, di contrapposizione, di delegittimazione reciproca, di accuse proprie a una logica settaria e in ogni caso non conforme allo spirito del Vangelo. Tutta la chiesa ne soffre, è una chiesa «afflicta», per riprendere un’espressione del magistero, e in questa vera e propria situazione di aporia in cui molti non sanno cosa dire e cosa fare si registra una paralisi che non è conservazione della tradizione né preparazione di un futuro ecclesiale fecondo.
Ma chiediamoci: la liturgia che viviamo oggi nella chiesa, la liturgia voluta dal Concilio Vaticano II è in grado di essere il luogo, il sito in cui i fedeli possono essere soggetti della fede cristiana, capaci di sperimentare che cosa la fede permette di vivere, capaci di accogliere una speranza da offrire e proporre agli altri uomini? Oppure la liturgia è tentata di diventare un non-luogo, cioè uno spazio in cui gli uomini non vivono il loro oggi nell’oggi di Dio, in cui non trova accoglienza l’umanità reale, concreta e quotidiana, in cui si consuma un «sacro» che nulla ha a che fare con Gesù Cristo?
In questo contesto alcuni elementi assumono un’importanza particolare per il nostro futuro di credenti, convinti che la liturgia sia «fons et culmen» (cf. SC 10) di tutta la loro identità, del loro stare nel mondo. Innanzitutto credo che nel prossimo futuro un vero impegno della chiesa dovrebbe essere rivolto all’acquisizione e alla comprensione della qualità sacramentale della Parola, senza la quale permane la patologia di un primato dell’eco della Parola di Dio detta e predicata, e non della Parola stessa. È Cristo che parla quando si proclamano le Scritture che contengono la Parola; non solo, è il Signore che opera, agisce, crea l’evento di salvezza. Lo ricorda una purtroppo trascurata sottolineatura delle premesse all’Ordinamento delle letture della messa del 1981, che così esprimeva uno dei compiti di chi presiede la liturgia: «[egli] alimenta la fede dei presenti per ciò che riguarda quella Parola che nella celebrazione, sotto l’azione dello Spirito Santo, si fa sacramento» (§ 41).
Occorre davvero comprendere la liturgia come esegesi viva della Parola di Dio e luogo ecclesiale dell’esegesi della Parola stessa. Manca tuttora una riflessione adeguata sull’esegesi liturgica delle Scritture e si trascura anche il fatto che i fedeli cattolici hanno il loro contatto con le sante Scritture quasi esclusivamente nella liturgia eucaristica: solo attraverso questa riflessione si potrà condurre i cristiani a vivere la verità del sacramentum quale visibile verbum!
Devo poi confessare tutta la mia preoccupazione, e anche la mia sofferenza, per una permanente incomprensione del rapporto tra liturgia e spiritualità, anzi per un misconoscimento che mi pare sempre più profondo e attestato. Chi come me ha conosciuto per età una vita cristiana alimentata dai «pia populi cristiani exercitia», da devozioni e manifestazioni della pietà popolare, ha nutrito grandi speranze nell’ora della riforma liturgica: in quel momento infatti si scopriva e si assumeva la convinzione che la vita spirituale personale non può avere altra fonte che non la liturgia, la liturgia eucaristica innanzitutto, la liturgia delle ore, la liturgia dei sacramenti.
Come non confessare, per esempio, che la restaurazione della veglia pasquale voluta dalla riforma di Pio XII all’inizio degli anni ’50 cambiò la nostra spiritualità, ponendo al suo centro il mistero pasquale, il mistero della morte e resurrezione del Signore Gesù? L’eucologia delle collette del tempo liturgico e per le varie necessità, poi, assieme alla liturgia delle ore domenicale erano la fonte della nostra spiritualità. Ma cosa è successo dopo, in contraddizione con l’intenzione della riforma liturgica e l’amplissimo materiale che essa poneva a disposizione quale fonte di spiritualità autentica per ogni cristiano?
Perché in Italia le diocesi e i loro uffici liturgici, quando vi è un’assemblea diocesana, o di presbiteri, o di religiose, anziché celebrare la liturgia delle ore preferiscono fabbricare, sovente con dilettantismo, delle liturgie in cui non si è più capaci di esprimere una lex orandi?
Purtroppo nella spiritualità attuale il riferimento alla liturgia è assente: molti sono i riferimenti alla preghiera, rarissimi quelli alla liturgia... È bene che si parli del rapporto tra Bibbia e spiritualità o della lectio divina, ma lo stesso sforzo per la lectio, fatto da alcuni vescovi e chiese locali, così come da molti fedeli andrebbe accompagnato da un’attenzione e un impegno a favore della liturgia, la fonte della spiritualità: tutto questo nella consapevolezza che il sito privilegiato per accogliere la Parola è proprio la liturgia!
Sì, la liturgia è luogo dell’esperienza della Parola e dello Spirito, ma luogo che resta umanissimo, in cui l’uomo intero, nella sua unità di corpo, psiche e spirito, è soggetto dell’esperienza del Dio che viene a lui. Ecco, solo con un’attenzione e un’intelligenza che sappia cogliere l’umanità della liturgia è possibile accogliere in essa il «mistero della fede». Si legge nel prologo del quarto vangelo: «Dio nessuno lo ha mai visto, ma il Figlio», l’uomo Gesù, «exeghésato, ce ne ha fatto il racconto» (Gv 1,18). Parallelamente, potremmo dire che solo nell’umanità autentica della liturgia si può trovare il racconto di Dio, perché la liturgia è l’exeghésato, qui e ora, per noi cristiani.
-
-
-
> RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI ---- IL SELE, L’ACQUEDOTTO PUGLIESE, E LA BATTAGLIA CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA DI PIERO DELFINO PESCE (1874-1939)1 giugno 2011, di Federico La Sala
 IL SELE, L’ACQUEDOTTO PUGLIESE, E LA BATTAGLIA CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA DI PIERO DELFINO PESCE (1874-1939). Alcune pagine dal lavoro di Nicola Fanizza sulla vita dell’intellettuale repubblicano di Mola di Bari
IL SELE, L’ACQUEDOTTO PUGLIESE, E LA BATTAGLIA CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA DI PIERO DELFINO PESCE (1874-1939). Alcune pagine dal lavoro di Nicola Fanizza sulla vita dell’intellettuale repubblicano di Mola di Bari
 (...) Contro il disegno di privatizzare la gestione dell’acquedotto che avrebbe dato più da mangiare (ai gestori) che da bere (alla popolazione), Pesce continuò la sua battaglia, scrivendo nel 1912 anche un libello L’Acquedotto Pugliese - Storia di un carrozzone (...)
(...) Contro il disegno di privatizzare la gestione dell’acquedotto che avrebbe dato più da mangiare (ai gestori) che da bere (alla popolazione), Pesce continuò la sua battaglia, scrivendo nel 1912 anche un libello L’Acquedotto Pugliese - Storia di un carrozzone (...)

