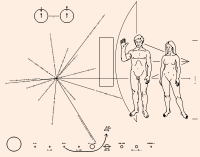
IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo. Una nota di Sandro Modeo - a c. di Federico La Sala
- [...] tali scoperte - enunciate, per inciso, in un latino insieme esatto e visionario, come se Galileo stesse già modulando l’ineguagliabile italiano del Saggiatore e del Dialogo - sono sconvolgenti per le loro implicazioni concettuali e cognitive, per lo shock che comportano a livello di visione del mondo [...]
- GALILEO GALILEI, Sidereus Nuncius - versione in italiano dell’opera.
- MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO.GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!
- FOTO: Immagine della placca del Pioneer 10.
E la rivolta di Galileo scongelò il cosmo dai rigori di Tolomeo
L’alba di una nuova visione del mondo
di Sandro Modeo (Corriere della Sera, 26.01.2011)
Al momento di scrivere il Sidereus Nuncius (prima edizione marzo 1610), Galileo ha quasi cinquant’anni. Come ricorda lo storico delle idee Andrea Battistini, lo scienziato - che fino a quel momento ha pubblicato solo studi minori e specialistici- teme di non poter esprimere in pieno la propria vocazione e di non poter comunicare i risultati delle proprie scoperte. Schiacciato dalle continue richieste dei committenti della Serenissima (deve occuparsi di macchine idrauliche, trapani per le viti, bussole e orologi), sente la vita sfuggirgli: quella routine alienante (il «servizio cotidiano» e la «servitù meretricia» ) gli lascia poche energie residue per dedicarsi ai «grandi e oltremodo mirabili» spettacoli del cosmo.
Scrivere il Nuncius, dunque, è il tentativo disperato (e riuscito) di ribellarsi a quella costrizione al silenzio; anche se il libro conserva tracce della sua gestazione inquieta, perché in molti punti lo scienziato evoca «l’angustia del tempo» per giustificare osservazioni a suo dire incomplete.
Frutto di 55 notti trascorse al cannocchiale (strumento rivoluzionario arrivato dall’Olanda), il Nuncius è anzitutto una fitta successione di scoperte fattuali: sulla superficie della luna (che si rivela «disuguale, scabra, piena di cavità e sporgenze» e «variata da macchie, come occhi cerulei d’una coda di pavone» ); sulla grandezza variabile degli astri (che «in mezzo alle tenebre» «sono visti chiomati» , mentre la luce diurna rade loro «i crini» e li ridimensiona); sulla Via Lattea, che si spalanca per la prima volta come «una congerie di innumerevoli stelle, disseminate a mucchi» , proprio col suo «candore latteo come di nube albeggiante» ; e sui satelliti di Giove, studiati nei loro più minuti movimenti. Il tutto con l’aiuto di numerosi, fondamentali disegni esplicativi.
Ma tali scoperte - enunciate, per inciso, in un latino insieme esatto e visionario, come se Galileo stesse già modulando l’ineguagliabile italiano del Saggiatore e del Dialogo - sono sconvolgenti per le loro implicazioni concettuali e cognitive, per lo shock che comportano a livello di visione del mondo.
I pochi estratti appena citati sono sufficienti a dimostrare come Galileo - al momento del Nuncius già copernicano da sette anni- non si limiti a demolire la fissità congelata del cosmo aristotelico tolemaico e il connesso, rassicurante meccano astrologico. Come non si limiti, cioè, a rivelare un universo metamorfico, discontinuo, infinito, dove nulla è centro e tutto è periferia; ma tolga anche all’assetto cosmico la sua eleganza stilizzata, perché è vero (come scriverà nel Saggiatore) che il linguaggio della natura ha per caratteri «triangoli, cerchi ed altre figure geometriche» , ma tali caratteri sono avvolti da una materia fisico-biologica molto più ribelle e instabile di quanto sembri (come dimostrano proprio le scabrosità lunari). Ed è vero che la vita si regge su leggi e simmetrie, ma entro un costante agguato caotico.
Oltre che diffidenze e calunnie (sia da parte di accademici che di ecclesiastici, in primis gli scienziati famuli della corte medicea, in cui Galileo sta per trasferirsi), il successo del Nuncius innesca anche un certo immaginario fantascientifico, per esempio sulla pluralità dei mondi abitati.
Oggi, un simile slittamento è ancora più naturale, perché gli eredi del cannocchiale galileiano (i potenti telescopi, da Hubble in poi) ci permettono di scrutare l’universo sempre più lontano e - per quanto possa sembrare paradossale- sempre più indietro nel tempo. Quando infatti osserviamo stelle e galassie remote, non le vediamo come sono ora, ma come erano milioni o miliardi di anni fa.
La spiegazione di questa vertigine - abbozzata da Poe nel poema Eureka ma di fatto formulata da Einstein - dipende dalla luce, la cui propagazione non è istantanea: anche se velocissima per i nostri parametri (300 mila km al secondo), la luce impiega del tempo a trasmetterci le immagini degli oggetti da cui proviene. Se volessimo vedere le galassie come sono ora, dovremmo dunque trovarci nel futuro. Ma anche questo nuovo «annuncio sidereo», per quanto frastornante, è destinato a essere superato - o integrato - dai successivi. Ogni acquisizione, nella scienza, è sempre la penultima.
- GALILEO GALILEI, Sidereus Nuncius - versione in italiano dell’opera.
- Aristotele fu un uomo, vedde con gli occhi, ascoltò con gli orecchi, discorse col cervello. Io sono un uomo, veggo con gli occhi, e assai più che non vedde lui: quanto al discorrere, credo che discorresse intorno a più cose di me; ma se più o meglio di me, intorno a quelle che abbiamo discorso ambedue, lo mostreranno le nostre ragioni, e non le nostre autorità (Galileo Galilei)
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- MUSICA E SCIENZA(VINCENZO GALILEI9. Esperimenti armonici e origine della rivoluzione scientifica (di Gianni Zanarini - SCIENZA IN RETE,02/10/2009)
- MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO.GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!
- I PAPI E LA SCIENZA NELL’EPOCA CONTEMPORANEA, A c. di M. S. Sorondo, PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE [«Nuovi Lincei»] /JACA BOOK, 2009.
- Il "caso Galileo" dopo 400 anni di Ennio Brovedani
 Il testo sottoposto a censura del gesuita Ennio Brovedani sul "caso Galileo", con i tagli, evidenziati in rosso, operati dalla redazione di Civiltà Cattolica.
Il testo sottoposto a censura del gesuita Ennio Brovedani sul "caso Galileo", con i tagli, evidenziati in rosso, operati dalla redazione di Civiltà Cattolica.
- La Luna fotografata dagli astronauti della NASA
 Le immagini sono state pubblicate su Flickr, sono oltre 8mila e raccontano la missione Apollo 8 e tutte quelle dalla 10 alla 17
Le immagini sono state pubblicate su Flickr, sono oltre 8mila e raccontano la missione Apollo 8 e tutte quelle dalla 10 alla 17
 Da alcune ore sono disponibili su Flickr più di 8.400 fotografie scattate da astronauti della NASA durante le missioni del Programma Apollo, che il 20 luglio 1969 consentì all’uomo - e più precisamente a Neil Armstrong e Buzz Aldrin - di arrivare sulla Luna. Le immagini su Flickr del Project Apollo Archive riguardano la missione Apollo 8 e tutte quelle dalla 10 alla 17. La maggior parte delle foto sono state scattate con macchine fotografiche Hasselblad, un’azienda svedese famosa per i suoi prodotti di alta qualità, e sono di dominio pubblico. Dentro ciascuna immagine c’è una breve didascalia che specifica la missione durante la quale è stata scattata quella foto e il rullino fotografico di cui è parte. Tutte le altre foto, anche quelle che non ha scelto il Post,si vedono qui.
Da alcune ore sono disponibili su Flickr più di 8.400 fotografie scattate da astronauti della NASA durante le missioni del Programma Apollo, che il 20 luglio 1969 consentì all’uomo - e più precisamente a Neil Armstrong e Buzz Aldrin - di arrivare sulla Luna. Le immagini su Flickr del Project Apollo Archive riguardano la missione Apollo 8 e tutte quelle dalla 10 alla 17. La maggior parte delle foto sono state scattate con macchine fotografiche Hasselblad, un’azienda svedese famosa per i suoi prodotti di alta qualità, e sono di dominio pubblico. Dentro ciascuna immagine c’è una breve didascalia che specifica la missione durante la quale è stata scattata quella foto e il rullino fotografico di cui è parte. Tutte le altre foto, anche quelle che non ha scelto il Post,si vedono qui.
Federico La Sala
Forum
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" --- COSMOLOGIA QUOTIDIANA: "SÀPERE AUDE!". Enrico Fermi e lo spirito di Galileo. Un omaggio alla sollecitazione a riflettere del prof. Antonino Zichichi.23 maggio 2025, di Federico La Sala
FISICA (#RAGIONE), METAFISICA (#FEDE), TEOANTROPOLOGIA E COSMOLOGIA QUOTIDIANA: "SÀPERE AUDE!" (#KANT, 1784).
- Un omaggio alla sollecitazione a riflettere del prof. Antonino Zichichi. Una breve nota a margine della sua considerazione:
- "Enrico Fermi fu il più grande galileiano dell’ultimo secolo. E con questo non intendo solo dire che fu un genio della fisica - cosa indiscutibile - ma che incarnò in pieno lo #spirito di Galileo: il #coraggio di pensare in modo nuovo, la lucidità logica e la devozione assoluta alla verità scientifica.
- Fermi comprese qualcosa che ancora oggi sfugge a molti: la Cultura non è un ornamento, ma una necessità per la vita quotidiana. È dalla Cultura - quella vera, fondata sulla conoscenza, sul metodo, sul dubbio costruttivo - che nasce ogni progresso: medico, tecnologico, sociale.
- Lui, uomo schivo e rigoroso, visse sulle proprie spalle questa responsabilità. Sapeva che fare scienza non è solo risolvere equazioni o scoprire leggi dell’Universo. È aiutare l’#uomo a capire dove si trova, chi è, e come costruire un mondo migliore.
- Fermi non fu solo un Nobel. Fu una #coscienza etica della scienza.
- E noi, oggi, abbiamo il dovere di tenere viva quella lezione. Perché senza cultura vera, non c’è #libertà vera. " (cfr. Antonino Zichichi, Fbook, 20 maggio 2025).
***
CULTURA E #SOCIETÀ : #FERMI TUTTI E TUTTE, E, "CUM GRANO SALIS", SI CERCHI (E CERCHIAMO) DI PENSARCI ANCORA E BENE SUL #GALILEO DI CUI SI STA PARLANDO: "VICISTI, GALILAEE" (#KEPLERO, 1611).
La #rivoluzionecopernicana (contro i profeti della "fine della storia"), a mio parere, è solo iniziata, e, la navigazione nell’#oceanoceleste, con la #nave di #GalileoGalilei, se ha oltrepassato Scilla e Cariddi, non è andata affatto oltre le colonne d’Ercole della #cosmoteandria dell #tragedia.
"DIVINA COMMEDIA" (#Dante Alighieri). Non è meglio continuare a rifletterci? Così #Ennio Flaiano, nella sua “Autobiografia del Blu di Prussia”, scriveva: “L’amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco un verso di Dante che vede oltre il telescopio di Galilei”. Una forte e bella illuminante idea! Non è bene tenerne conto?
- Nota:
- ARITMETICA E #ANTROPOLOGIA: #IMPARARE A #CONTARE. UNA #HAMLETICA #DOMANDA TEOLOGICO-POLITICA AI MATEMATICI PER USCIRE DALL’#IMMAGINARIO DELLA #TORRE DI BABELE. Come "è stata possibile un’operazione #matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#Franca Ongaro #Basaglia)?!? Non è il caso di ripensare i fondamenti?! ...
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" --- FEDE E SCIENZA: RIPENSANDO AL GALILEO, "CUM PETRO ET SUB PETRO", ALCUNI SEGNAVIA DELL’EREDITA’ DI JORGE MARIO BERGOGLIO E DI PAPA #FRANCESCO:26 aprile 2025, di Federico La Sala
RIPENSANDO AL GALILEO, "CUM PETRO ET SUB PETRO", ALCUNI SEGNAVIA DELL’EREDITA’ DI JORGE MARIO BERGOGLIO E DI #PAPA #FRANCESCO: "QUELLE SCARPE CONSUMATE" E LA "SCELTA" DELLA #BASILICA DI "SANTA MARIA MAGGIORE" (ROMA)
- Una nota a margine di una riflessione di Andrea Arena in omaggio e in memoria di Papa Francesco (26aprile 2025).
ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA. "LE SCARPE CONSUMATE, I SORRISI SINCERI, E I DIALOGHI AUTENTICI" INDICANO, A MIO PARERE, IN UNA BREVISSIMA SINTESI ANTROPOLOGICA, I TRATTI ESSENZIALI DEL #VIAGGIO TERRENO E TERRESTRE DELL’#UOMO BERGOGLIO E DEL #PAPA FRANCESCO, DEL SUO #CAMMINARE #SINODALE ("CUM PETRO ET SUB PETRO", 2014), SUL "COME SI VA IN CIELO" (EVANGELICAMENTE), SUL "COME VA IL CIELO" (SCIENTIFICAMENTE ), E, APRENDO STORIOGRAFICAMENTE E FRANCESCANAMENTE MENTE OCCHI E CUORE, SUL COME E DA DOVE RIPARTIRE PER PORTARE AVANTI LA #SECONDA "#RIVOLUZIONECOPERNICANA": "VICISTI, #GALILAEE" (COSì #KEPLERO A #GALILEO, 1611).
FEDE E SCIENZA: "DUE SOLI" (DANTEALIGHIERI). LA BASILICA PAPALE DI #SANTAMARIAMAGGIORE E’ UN LUOGO LEGATO NON SOLO ALLA TRADIZIONE RELIGIOSA DEL CATTOLICESIMO-ROMANO E AL FAMOSO MIRACOLO DELLA #NEVE AD AGOSTO, MA ANCHE ALLA TRADIZIONE ARTISTICA E SCIENTIFICA DELL’EUROPA MODERNA, AL "SIDEREUS NUNCIUS" DI #GALILEO GALILEI (1610), E, ALL’OPERA DEL SUO AMICO PITTORE, #LUDOVICOCARDI, DETTO IL CIGOLI: [LA LUNA GALILEIANA, PRESENTE NEL QUADRO DELLA "IMMACOLATA CONCEZIONE CON APOSTOLI E SANTI", NELLA CAPPELLA PAOLINA DI SANTA MARIA MAGGIORE, INFATTI, E’ OPERA SUA.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI --- IL "MESSAGGERO CELESTE" (1610), IL "MESSAGGERO DI PACE" ("PACIS NUNTIUS", 1964), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO (NICEA 325-2’25):17 marzo 2025, di Federico La Sala
LA STORIA (TEATRO), L’ARATRO (TERRA), LO STILO (SCRITTURA ALFABETICA), LO STORYTELLING ("GLOBE THEATRE"), E L’ANTROPOLOGIA DELLA "INTELLIGENZA ARTIFICIALE" (AI=IA).
- In memoria di Immanuel Kant...
CONSIDERANDO la storia dell’ "agricoltura" e l’importanza dell’invenzione dell’aratro per la seminagione del grano e del suo mito fondante connesso al rapimento di Persefone/Proserpina, la figlia di Demetra /Cerere, da parte di Ade/Plutone, si comprende meglio quale "matrimonio" impone la Legge della antica Grecia e cosa "nasconde" la nascita della tragedia: "«non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (Eschilo, "Eumenidi", 657 ss.). #Shakespeare insegna: "The time is out of joint" ("Hamlet", I.5).
TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA. A reimpostare, antropologicamente e matematicamentre, la questione, è da dire che aveva ragione #Whitehead (con #BertrandRussell, autore dei "Principia Mathematica"): "Tutta la storia della filosofia occidentale non è che una serie di note a margine a #Platone".
Se è vero, come è stato scritto, che "un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, 1978), che fare, oggi, se non andare oltre l’antico programma, codificato nella "macchina" di "scrittura" della tragedia, e portarsi fuori dal rapporto sociale di produzione "cinematografico" platonico?
A mio parere, la "question" è epocalmente hamletica - alla Shakespeare (#Freud): antropologica. Il nodo è che la narrazione della intelligenza artificiale (AI = IA) di questa odierna "società elettronica" è fondata sul codice di una "immaginazione sociologica" (vale a dire, alla Karl #Marx e alla Charles Wright Mills, su un "rapporto sociale di produzione"), proprio e ancora di quello della tragedia (Eschilo, Sofocle, Euripide) della Grecia antica (cfr. Jesper Svenbro, "Phrasikleia, anthropologie de la lecture en Grèce ancienne", Paris 1988).
DIVINA COMMEDIA E CREATIVITA’. Il grande racconto cosmoteandrico di un "mondo come volontà e rappresentazione" di un #Autore - #Sovrano, a tutti i livelli, è finito, e, se non si vuole finire asfissiati nella sua "caverna", non si può non seguire #DanteAlighieri e cercare di ritrovare la "diritta via" della #Commedia!
Meglio riprendere con "Il Nome della rosa (#UmbertoEco), il filo del "maestro di color che sanno" (Inf., IV, 131), #Aristotele, rileggere criticamente "La sposa meccanica" (Marshall McLuhan), e, dopo millenni, uscire dallo storico inferno epistemologico e riequilibrare la teoria del campo cosmo-politico e antropologico: "il resto è silenzio" ("Amleto", V.2).
#Dantedì, #25marzo 2025
- NOTA:
- LA TERRA, LA #SCRITTURA ALFABETICA E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO (#Nicea, 325-2025): SAN BENEDETTO, “CON LA CROCE, CON IL #LIBRO E CON L’ #ARATRO”. Un invito a a riconsiderare, storiograficamente e antropologicamente. la “tenuta” dell’#architettura costituzionale della “casa comune” europea e terrestre ...
- Una nota in memoria di #Galileo #Galilei e di #Immanuel #Kant...
- CULTURA E SOCIETA’. SE NEL “LONTANO” 1610, #GALILEO #GALILEI PUBBLICA IL SUO “#MESSAGGERO #CELESTE” (“SIDEREUS NUNCIUS”), nel non troppo “recente” 1964, il 24 ottobre, nel secondo anno del suo Pontificato, papa Paolo VI, con la “Lettera apostolica”, intitolata “PACIS NUNTIUS” (“MESSAGGERO DI PACE”), proclama SAN BENEDETTO, PATRONO D’#EUROPA....
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" --- STORIA DELL’ARTE E DELLA SCIENZA: DUE "GIOVANNI BATTISTA DELLA PORTA" (UN ARCHITETTO E UNO SCIENZIATO) NELL’ITALIA E NELL’EUROPA DEL TARDO RINASCIMENTO.10 marzo 2025, di Federico La Sala
STORIA CRITICA E ARCHEOLOGIA FILOSOFICA: NELL’#ITALIA E NELL’#EUROPA DELLA FINE DEL #CINQUECENTO E DELLA PRIMA META’ DEL #SEICENTO, VIVONO
DUE "GIOVANNI BATTISTA DELLA PORTA".
- UN INVITO "STORIOGRAFICO" A RIGUARDARE LE LORO "STORIE" E A RIPENSARE IL LORO #TEMPO #STORICO #COMUNE:
- A) Giovanni Battista Della Porta (nato a #Porlezza, in provincia di Como, nel 1542, e morto a Roma, nel 1597), architetto e scultore ; e
- B) Giovanni Battista Della Porta (nato a #VicoEquense, il 1º novembre 1535, e, morto a Napoli, il 4 febbraio 1615), filosofo, alchimista, commediografo e scienziato.
La "COINCIDENZA" OFFRE UNA BUONA "SOLLECITAZIONE" A RI-CONSIDERARE MEGLIO L’ #ORIZZONTE STORICO-CULTURALE ENTRO CUI SONO VISSUTI NON SOLO I DUE (DIVERSI E DISTINTI) "DELLA PORTA", MA ANCHE #GIORDANOBRUNO, #TOMMASOCAMPANELLA, WILLIAM #SHAKESPEARE, MIGUEL #CERVANTES, #GALILEI, ECC. e, al contempo, a riflettere ancora e di nuovo sulla "Magiae Naturalis" di Giovan Battista della Porta (di cui è stata pubblicata l’edizione critica ( per i Tipi dell’ Edizione Scientifica Italiana di Napoli a cura di Alfonso Paolella ).
- NOTE:
- ROMANZO STORICO E #STORIOGRAFIA: A riprendere il filo dalla "storia" del XVII secolo, che prende il via da "quel ramo del lago di #Como" (Alessandro #Manzoni, "I #Promessi Sposi"), e dal fatto "straordinario" che, al centro di Milano, ci sia una strada breve e stretta, tra piazza Cairoli a via Dante, che si chiami "Via Porlezza" , forse, è possibile e facile risalire nel tempo e nello spazio e ricomprendere la "base" socio-culturale da cui è "partito" Il Giovanni Battista Della Porta, diventato poi architetto e scultore di notevole valore e fama, e, nello stesso tempo storico, il Giovanni Battista Della Porta, diventato altrettanto poi scienziato e filosofo di grande valore e fama.
- A PARTIRE DALLA MILANO E DALLA NAPOLI DEL QUATTROCENTO E DEL CINQUECENTO. Per orientarsi, e "ricollocarsi" nell’orizzonte spazio-temporale di vita dei due "Della Porta", è opportuno ripensare alla caduta di Costantinopoli (1453) e, in particolare, alla #Pace di #Lodi (1454): "Con questo documento Francesco Sforza e Alfonso d’Aragona furono riconosciuti rispettivamente #Duca di #Milano e #Re di #Napoli, la Repubblica di Venezia estese il suo dominio fino all’Adda e fu conclusa la Santissima Lega Italica contro i Turchi.".
 Ora, se si tiene presente che, in questi anni (a partire dal 1470), il signore di #Porlezza, è il condottiero di ventura, Ambrogino da Longhignana, un ghibellino, legato al clan familiare di Vitaliano #Borromeo e "agli stipendi del duca di Milano Francesco Sforza", si può cominciare a capire in quale ambiente socio- politico e culturale sia nato Giovanni Battista Della Porta (1542-1597).
Ora, se si tiene presente che, in questi anni (a partire dal 1470), il signore di #Porlezza, è il condottiero di ventura, Ambrogino da Longhignana, un ghibellino, legato al clan familiare di Vitaliano #Borromeo e "agli stipendi del duca di Milano Francesco Sforza", si può cominciare a capire in quale ambiente socio- politico e culturale sia nato Giovanni Battista Della Porta (1542-1597).
- ARTE, LETTERATURA, E #TEOLOGIA-#POLITICA: A #PORLEZZA SI COMBATTE PER "LA #PACE DELLA #FEDE" (NICCOLO’ #CUSANO, 1453) E SI RICORDA #CARLOMAGNO E LA "#STORIA" DEL #DUELLO TRA #ROLANDO E #FERRAU’. === "In località Bilate, nel comune di Carlazzo (Co), in Val Menaggio o Valle di Porlezza, come viene anche talvolta indicata, si trova un edificio [...] al cui interno era presente un ciclo di affreschi di soggetto cavalleresco databile tra la metà del Quattrocento e il 1480-1490. Noto come “Pretura” o “Prigione”, forse perché si trattava all’epoca di un ufficio giudiziario e/o di polizia [...] L’edificio si presenta affrescato anche sui muri esterni: sulla facciata principale è collocato un affresco che raffigura la Trinità; sulla parete nord, si trovava invece un affresco della Vergine Maria seduta su un trono, oggi non più visibile, eseguito utilizzando solo le tonalità del rosso.
L’affresco di soggetto cavalleresco che si trovava dentro l’edificio è incentrato sul duello tra Rolando e Ferraù presso Lazera (l’attuale Najèra), il cui racconto originario proviene dalla Cronaca dello pseudo-Turpino. Staccato dalle pareti dell’edificio nel 1961, messo su tela e restaurato, esso fa parte attualmente di una collezione privata milanese. [...]" (cfr. Serena Modena, "Didascalie nel ciclo di affreschi della “Pretura” di Bilate (Como)", RialFri, 15 marzo 2020).
 Per approfondimenti ulteriori sul tema del duello, molto interesanti, per capire meglio il persorso professionale e artistico dell’architetto e scultore Della Porta (che arriverà a lavorare intorno al 1570 nel Santuario di Loreto, nella casa della Natività), si cfr. l’illuminante lavoro di Marco Infurna, relativo alla figura di Ambrogio della Longhignana, signore di Porlezza, "Il duello di Rolando e Feraguto sul ponte in un affresco lombardo del Quattrocento" (“Par estude ou par acoustumance”. Saggi offerti a Marco Piccat per il suo 65° compleanno, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2016).
Per approfondimenti ulteriori sul tema del duello, molto interesanti, per capire meglio il persorso professionale e artistico dell’architetto e scultore Della Porta (che arriverà a lavorare intorno al 1570 nel Santuario di Loreto, nella casa della Natività), si cfr. l’illuminante lavoro di Marco Infurna, relativo alla figura di Ambrogio della Longhignana, signore di Porlezza, "Il duello di Rolando e Feraguto sul ponte in un affresco lombardo del Quattrocento" (“Par estude ou par acoustumance”. Saggi offerti a Marco Piccat per il suo 65° compleanno, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2016).
- Presso la Santa Casa di #Loreto vi sono dieci #Sibille e tre #profeti, e alla realizzazione ha lavorato e contribuito intorno al 1570 l’architetto e scultore Giovanni Battista #DellaPorta (#Porlezza, 1542 - #Roma, 1597).
- STORIA E #FILOSOFIA DELL’#EUROPA E DELL’#ITALIA (1440-1570). L’ ONDA LUNGA DELLA #TEOLOGIA-#POLITICA DELLA "#DOTTAIGNORANZA" (1440) E DEL "DE #PACE FIDEI" (1453) DI NICCOLO’ #CUSANO E LO #STENDARDO COSTANTINIANO CON IL SUO "IN HOC SIGNO VINCES" DEL 1570: LA BATTAGLIA DI #LEPANTO DEL 1571. #Michelangelo #Buonarroti è morto nel 1564... e la "storia" del "duello di Rolando e Ferraù" continua, all’esterno come all’interno dell’area europea e mediterranea.
- CULTURA, #SOCIETA’, E #FAMIGLIA (FONDATA SUL #DIRITTO DI #MAGGIORASCO). DAL DUCATO DI #MILANO A #PORLEZZA E DA PORLEZZA A #NAPOLI, NEL #REGNODINAPOLI (#VICEREAME SPAGNOLO): #MEMORIA DI CARLO GESUALDO (#Venosa, 8 marzo 1566 - Gesualdo, 8 settembre 1613) Per meglio tratteggiare la scena italiana (ed europea) in cui si colloca la vita del Della Porta architetto.scultore e del Della Porta scienziato-alchimista, è bene ricordare, con Ambrosino da Longhignana (che, per i suoi legami con la famiglia Borromeo, fu sepolto nella "Isola Bella", ad #Arona, sul Lago Maggiore), la figura dei cardinali #CarloBorromeo (1538-1584) e del suo cugino cardinale #FedericoBorromeo (1564 -1631) e della sorella di Carlo, #Geronima #Borromeo, madre di Carlo Gesualdo (1566-1613), il "Napoletanissimo" musicista e compositore, destinato "a intraprendere la carriera ecclesiastica", ma segnato dalla sorte e dal #diritto a ricoprire il ruolo di #primogemito: "Nel 1585, il fratello Luigi, all’epoca ventunenne e non ancora sposato né con eredi maschi, subì una caduta da cavallo e morì. Questo evento fece di Carlo, diciottenne, l’unico erede dei titoli e delle tenute paterne, ragion per cui ci si mosse in fretta per organizzare le sue nozze. La scelta finale ricadde su Maria d’Avalos, figlia di Carlo d’Avalos, marchese di Montesarchio, e cugina di primo grado dell’aristocratico, ragion per cui occorse una dispensa papale. Maria aveva già avuto precedentemente due mariti e dei figli". Un "segno dei tempi" dalle conseguenze catastrofiche, come ben visto agli inizi dell’#Ottocento da #Manzoni, quando, nei suoi "#Promessi Sposi" (IX), apre la "parentesi" sulla "storia" della "monaca di Monza": sulla base della lezione del nonno materno, #Cesare #Beccaria, egli aveva ben capito di che stava parlando (già, al di là di Hegel, e prima di Marx)!
- SCIENZA E MAGIA NEL #REGNODINAPOLI (XVI-XVII SEC.): IMPARARE A "LEGGERE" IL "LIBRO" DELLA #NATURA. Del filosofo, alchimista, e scienziato GIOVANNI BATTISTA DELLA PORTA (#VicoEquense, 1º novembre 1535 - #Napoli, 4 febbraio 1615), è da dire che la sua opera più famosa, "Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium" ( https://it.wikipedia.org/wiki/Magiae_naturalis_sive_de_miraculis_rerum_naturalium ), risale al 1558, ma fu accresciuta "fino a venti volumi, e fu compendiata in un volume unico nel 1584: questo compendio fu largamente diffuso e fu tradotto dal latino nelle principali lingue europee"; la sua grande erudizione e i suoi suggestivi principi esplicativi, sia empirici che filosofici, hanno dominato la scena culturale italiana nel delineare i tratti della nuova razionalità scientifica moderna, prima che Galileo salisse alla ribalta intorno al 1600. ( https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Della_Porta ). Accompagnato nell’opinione popolare dalla fama di mago, ma noto negli ambienti scientifici di tutta l’Europa per le sue sperimentazioni e per la molteplicità degli interessi, fu in rapporto epistolare e personale con gli studiosi più famosi del suo tempo. Invitato dall’imperatore del Sacro Romano Impero #RodolfoII d’Asburgo (1552 - 1612) a trasferirsi a #Praga, Della Porta progetta "un’opera per la quale aveva inventato il titolo di #Taumatologia e aveva indicato come dedicatarlo l’imperatore Rodolfo II, ma che per varie difficoltà, non riuscì a completare e mandare alla stampa": l’idea "è successivamente abbandonata e il dedicatario diventa #Federico #Borromeo, vescovo di #Milano. Tuttavia, nonostante l’impegno di Federico#Cesi, la Taumatologia non riceve l’imprimatur ecclesiastico e Della Porta abbandona il progetto" (#Donato Verardi, 2018).
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- STORIA E STORIOGRAFIA. L’ALBERO DI NATALE NELL’EUROPA MODERNA: LA PUNTA DI UN ICEBERG DELL’IMMAGINARIO OCCIDENTALE28 dicembre 2024, di Federico La Sala
L’ALBERO DI NATALE NELL’EUROPA MODERNA E IL "SIDEREUS NUNCIUS" DI GALILEO GALILEI: LA PUNTA DI UN ICEBERG DELL’IMMAGINARIO OCCIDENTALE
UNA NOTA sulla considerazione che "Nella sua concezione moderna, l’albero di Natale casalingo sarebbe stato creato quasi casualmente da una nobildonna tedesca nel 1611, desiderosa di illuminare un angolo vuoto della casa, la duchessa di Brieg." (cfr. Elisa Chiari, "Albero di Natale, la vera storia dalle radici antiche a noi", "Famiglia cristiana", 18.12.2024 )
CULTURA E SOCIETA’. Tenendo conto di quanto sta succedendo nella società europea, a partire dalla #RiformaProtestante (1517), e dal "Sacco di Roma" dei lanzichenecchi al soldo dell’imperatore Carlo V (1527), dalla #Riforma #Anglicana (1534), dalla stampa dell’opera di #Astronomia di #Copernico (1543) e dell’opera di #Anatomia di #Vesalio (1543), dalla #Controriforma Cattolica (#ConciliodiTrento,1545-1563), e, ancora, dalla introduzione del #CalendarioGregoriano del 1582 (non accettato né dalla Germania e dall’Olanda fino al 1700, né dall’Inghilterra fino al 1752), e, al contempo, dall’attacco della cattolicissima "Invincibile Armada" spagnola di Filippo II all’Inghilterra di Regina Elisabetta I d’Inghilterra (1588), si può comprendere meglio (e subito) perché all’#Amleto di #Shakespeare non piaccia il "#presepe" della "Danimarca" cattolica, e, al contempo, nella Germania protestante si comincia a diffondere in occasione del Natale la tradizione dell’#albero, sia come critica della tradizione religiosa cattolico-spagnola sia come sollecitazione a ripensare all’albero del #Paradisoterrestre e anche a un rinnovato legame matrimoniale tra "#Adamo ed #Eva" (come già indicato e fatto da Lutero e da #EnricoVIII, padre della regina Elisabetta).
"SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610). Alla #luce di questa "contestualizzazione" relativa al diffondersi della tradizione dell’ Albero di Natale nei Paesi Protestanti, forse, è bene ricordare che l’Annuncio Sidereo (il "Sidereus Nuncius"), relativo alla "scoperta" della #Luna come la Terra e della #Terra come la Luna, di Galileo Galilei è del 1610 ed è salutato da #Keplero proprio nel 1611 con parole augurali che fanno tremare ancora oggi di "paura" tutta la teologia-politica cattolico-costantiniana dell’epoca: "Vicisti, Galilaee!" (Hai vinto, o Galileo!).
PIANETA TERRA: SPERANZA. Forse, oggi, alla fine del 2024, la navigazione nell’#oceano celeste (come da indicazione e sollecitazione dello stesso Keplero al Galileo, nella lettera del 1611) può riprendere.
#Buonanno, #Buon2025.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS", OGGI. --- QUALE FUTURO PER IL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (GALILEO GALILEI, 1632)? UNA DOMANDA HAMLETICA PER "RE-SHAKESPEARE" BENE.11 novembre 2024, di Federico La Sala
A PARTIRE DA #AMLETO, CON #PIRANDELLO ED #EDUARDODEFILIPPO: «TE PIACE ’O PRESEPIO?» DEL #PIANETATERRA?!
- A PARTIRE DAL "#NATALE IN CASA CUPIELLO" (1931), ALCUNE NOTE DI #FILOLOGIA E #ARCHEOLOGIA FILOSOFICA INTORNO AL #CATTOLICESIMO COSTANTINIANO.
INTRODUZIONE. Si racconta che Saulo / Paolo di Tarso, un "cittadino romano"(At. 22, 25-28), sia stato portato fino al terzo cielo (2 Corinzi 12:2): va bene! Da ricordare, però, che #DanteAlighieri ("Io non Enëa, io non Paulo sono") è andato ben oltre i cieli di #Aristotele, come racconta l’astrofisico Carlo Rovelli, una volta uscito dal "buco nero" in cui lucifericamente era caduto!
#METATEATRO E #STORIOGRAFIA: UNA DOMANDA #HAMLETICA PER "RE-SHAKESPEARE" BENE. Antropologicamente (e cristologicamente), c’è da chiedersi, se Paolo ha visto “Gesù Cristo”, come mai - contriamente a quanto visto e insegnato da #Francesco di Assisi con il suo “presepe” (#Greccio, 1223) - non ha notato, accanto a “Cristo” che lo “sgridava” («Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?»), “Giuseppe” accanto a “Maria”?! Dov’è finito il "Giuseppe", discendente della "casa del #ReDavide" ("de domo David")?
UNA "#IMITAZIONEDICRISTO" ALLA PAOLO DI TARSO DI LUNGA DURATA: #NICEA (325 -2025). La domanda logico-storica è: come mai alla sua proposta di imitarlo e seguirlo, tutti e tutte si sono sbagliati e sbagliate a tal punto da seguire lui, Saulo (Paolo di Tarso), e non Gesù: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e #capo della #donna è l’#uomo [gr. ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)?
"ECCE HOMO" (F. #NIETZSCHE, 1888): QUALE #PRESEPE SI VUOLE CONTINUARE ANCORA A "COSTRUIRE", OGGI? Quello di Paolo di Tarso o quello di #FrancescodiAssisi? #Dante, cosa aveva già capito, come anche Shakespeare, e Pirandello e, infine, #Eduardo De Filippo (1931)?
"#SIDEREUSNUNCIUS" (#GALILEOGALILEI, 1610): QUALE FUTURO PER IL "#DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (#GALILEO GALILEI, 1632)?
- NOTE:
- TEATRO (FILOSOFIA) E #METATEATRO (METAFILOSOFIA): "NATALEINCASACUPIELLO".
- STORIAELETTERATURA #TEATRO, #METATEATRO E #FILOLOGIA: RE-#SHAKESPEARE CHIARA-MENTE, CON #VICTORHUGO, LUIGI #PIRANDELLO ED #EDUARDODEFILIPPO.
- In onore e memoria di Victor Hugo e Charles Baudelaire...
- LA «CHARITE’» DEL VESCOVO #MYRIEL DEI "MISERABILI", LA #CRITICA (#KANT) DELLA #ECONOMIAPOLITICA (#MARX), E IL #CATTOLICESIMO DELL’#AGAPE COSTANTINIANO....
- LA «CHARITE’» DEL VESCOVO #MYRIEL DEI "MISERABILI", LA #CRITICA (#KANT) DELLA #ECONOMIAPOLITICA (#MARX), E IL #CATTOLICESIMO DELL’#AGAPE COSTANTINIANO....
- Alcuni appunti a margine della presentazione nell’articolo allegato - v. in fondo - di Paola Martino, “Perdere la testa”: a Milano una mostra sulla decapitazione", (#Artuu, 29 Ottobre 2024 ), presso la Galleria BKV Fine Art di #Milano.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS", OGGI. --- L’AVVIO DELLA "RIVOLUZIONE COPERNICANA" DEL GALILEO (1610). ASTRONOMIA STORIA E MEMORIA: "Cosmo". Il 9 novembre 1934 nasceva Carl Sagan.9 novembre 2024, di Federico La Sala
 MEMORIA STORIA E ASTRONOMIA: "COSMO".
MEMORIA STORIA E ASTRONOMIA: "COSMO".- Il 9 novembre 1934 nasceva Carl Sagan:
«La Terra è l’unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c’è altro posto, per lo meno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare, sì. Colonizzare, non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l’astronomia è un’esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c’è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l’uno dell’altro, e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l’unica casa che abbiamo mai conosciuto». (Carl Sagan).
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. -- C’è vita su Europa? La vita sulla luna di Giove potrebbe svilupparsi vicino a sorgenti vulcaniche presenti nelle profondità del suo oceano, proprio come avviene sui fondali marini della Terra (di U. Guidoni).15 ottobre 2024, di Federico La Sala
"SIDEREUS NUNCIUS (1610), "OCEANO CELESTE" (KEPLERO, 1611), E RICERCA SCIENTIFICA (2024).
***
C’è vita su Europa?
La vita sulla luna di Giove potrebbe svilupparsi vicino a sorgenti vulcaniche presenti nelle profondità del suo oceano, proprio come avviene sui fondali marini della Terra
di Umberto Guidoni ("HuffPost", 14 Ottobre 2024)
Ovviamente stiamo parlando della luna di Giove e della possibilità che possa ospitare forme di vita elementari. Europa è grande più o meno come la nostra Luna ma è coperta da uno strato di ghiaccio spesso diversi chilometri. A prima vista, un ambiente tutt’altro che ospitale.
- La sonda Galileo, inviata a studiare Giove negli anni Novanta, ha fornito immagini ad alta risoluzione di Europa, che hanno evidenziato la presenza di fratture e suggerito la possibilità che sotto la crosta ghiacciata ci fosse acqua allo stato liquido. Ulteriori analisi condotte dagli strumenti della sonda hanno confermato la presenza di un oceano di acqua salata, addirittura più grande di tutti quelli presenti sulla Terra. Non sorprende, quindi, che Europa sia diventata uno dei corpi celesti più interessanti per la ricerca di vita oltre la Terra, né che sia stata messa a punto una missione diretta a studiare da vicino la sua superficie e l’oceano sottostante.
E arriviamo così al lancio della sonda Europa Clipper, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Il razzo Falcon Heavy di SpaceX, si è sollevato dalla rampa 39A del Kennedy Space Center, in Florida, la stessa da cui sono decollato con lo Space Shuttle Endeavour nel 2001. La missione della NASA da 5 miliardi di dollari, dovrebbe durare oltre 10 anni, con circa la metà passati nel viaggio verso il sistema gioviano, un tragitto di circa 3 miliardi di chilometri.
Se tutto andrà come previsto, Europa Clipper passerà vicino a Marte a marzo del 2025 e sfiorerà la Terra alla fine del 2026, seguendo una traiettoria complessa, scelta per sfruttare la “fionda gravitazionale” dei due pianeti. Dopo questi incontri ravvicinati, la sonda guadagnerà la velocità necessaria per raggiungere Giove nella primavera del 2030. In orbita attorno a Giove, Europa Clipper condurrà un’indagine dettagliata della sua luna ghiacciata per verificare se vi sono condizioni adatte alla vita. Si tratta della più grande sonda spaziale mai sviluppata per una missione planetaria, equipaggiata con una decina di strumenti scientifici.
La NASA ha specificato che Europa Clipper non è una missione per la ricerca di forme di vita, ma per determinare se esistono le condizioni favorevoli alla vita. Sembra una sottile differenza che dimostra, però, la prudenza dell’agenzia spaziale americana riguardo ai risultati di una missione così complessa.
Anche se la sonda non atterrerà su Europa, cercherà di determinare se sono presenti gli ingredienti che riteniamo necessari per la vita. Certamente, per la vita come la conosciamo, è essenziale acqua liquida, che sappiamo essere presente sotto lo strato ghiacciato. Tuttavia, abbiamo bisogno anche di altri elementi chimici, come il carbonio la cui presenza sulla superficie è stata confermata in modo spettacolare dal telescopio spaziale James Webb. È stato anche identificato lo zolfo, un altro ingrediente importante per la vita, ma non abbiamo ancora evidenza di altri elementi come l’azoto o il fosforo. Inoltre, in un ambiente buio come le profondità oceaniche, è necessaria una fonte di energia continua, come ad esempio le sorgenti idrotermali. La vita su Europa potrebbe svilupparsi vicino a sorgenti vulcaniche presenti nelle profondità del suo oceano, proprio come avviene sui fondali marini della Terra.
Grazie alle sofisticate apparecchiature della sonda, la NASA spera di rispondere a molte di queste domande. Per tutti noi rimane la curiosità di sapere se la vita si sia sviluppata anche al di fuori del nostro pianeta. Tra qualche anno potremmo avere una risposta che potrebbe cambiare il nostro punto di vista sull’universo.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" --- INFANZIA, ANTROPOLOGIA, E STORIOGRAFIA: USCIRE DALLA CAVERNA DI "POLIFEMO" E RICORDARE IL "SEGRETO" DEL VIAGGIO DI "ULISSE" ("#DIVINACOMMEDIA").5 aprile 2024, di Federico La Sala
L’ALBA DELLA MERAVIGLIA E LA STORIA DELLA COSMOLOGIA E DELLA FILOSOFIA (#KANT2024): CON #DANTEALIGHIERI E #GALILEO #GALILEI, DALLA LUNA IL SORGERE DELLA TERRA:
- «Entro la fine di questo secolo, i nostri nipoti lavoreranno sulla Luna, vivranno in avamposti permanenti su Marte e utilizzeranno materie prime provenienti dagli asteroidi: in una parola, l’umanità diventerà una vera specie interplanetaria» (Umberto Guidoni, "Sfidare lo spazio", Mursia 2024)
INFANZIA, ANTROPOLOGIA, E STORIOGRAFIA: USCIRE DALLA #CAVERNA DEL POLIFEMICO PLATONISMO DI SOCRATE E RICORDARE IL "SEGRETO" DEL VIAGGIO DI "ULISSE" ("#DIVINACOMMEDIA"):
- "O superbi cristian, miseri lassi,
 che, de la vista de la mente infermi,
che, de la vista de la mente infermi,
 fidanza avete ne’ retrosi passi,
fidanza avete ne’ retrosi passi,
 non v’accorgete voi che noi siam vermi
non v’accorgete voi che noi siam vermi
 nati a formar l’angelica farfalla,
nati a formar l’angelica farfalla,
 che vola a la giustizia sanza schermi?"
che vola a la giustizia sanza schermi?"
 (Dante Alighieri, Purg., 121-126).
(Dante Alighieri, Purg., 121-126).
ITACA, LE "ITACHE": L’#ODISSEA, LE "ODISSEE". Un piccolo passo del cammino della #coscienza terrestre sulla importanza di #storiciżżare il legame con il proprio #Sé, con la propria #Tradizione, e con il proprio Pianeta, con la propria "#Terra" - con le proprie "Itache", come precisa Konstantinos #Kavafis.
- NOTA. Le "Tesi di #filosofia della #storia" (o Tesi "Sul concetto di storia") di W. #Benjamin hanno una grande consonanza con l’opera di #DanteAlighieri, Marcel #Proust, e #Michelangelo (e anche con la nuova-#Polis, "Nea-Polis", #Napoli): sono un messaggio in bottiglia, una #mappa per non perdersi nell’#oceano dello spazio-tempo dell’immane #catastrofe in avanzamento progressivo e andare "alla ricerca del tempo perduto"! #Benjamin, come #Ulisse e come #Calvino, sa della "memoria del mondo" (#ItaloCalvino) e ha ascoltato "il #canto delle #sirene" (e degli #angeli), ed era più che fiducioso che il suo #messaggio sarebbe stato r-accolto.
EARTHRISE
NOTA
- STORIAELETTERATURA E POESIA. Constantinos Kavafis: vita e opera di un poeta universale.
- PENELOPE-IDEA E COMMEDIA: FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA. Con lo spirito dell’opera “The #Penelopiad” di Margaret Atwood e della #DivinaCommedia di #DanteAlighieri, un #segnavia di uscita dall’orizzonte della #tragedia....
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- CON IL GALILEO, DALLA LUNA, UNO SGUARDO DA EXTRATERRESTRI: UN’ALTRATERRA E’ POSSIBILE,17 dicembre 2023, di Federico La Sala
PREISTORIA E IPERSTORIA: #ANTROPOLOGIA, #STORIA E #LETTERATURA. #BuonNatale, buon #Natale2023: #Earthrise...
- Un piccolo omaggio alla formidabile riflessione di Emiliano Morrone, alla #Calabria - e alle "#Cittàinvisibili" (#ItaloCalvino 1923 - 1985):
- "Buona domenica. Noi calabresi vediamo la Calabria come un unico paese, unito da una storia, da una cultura, da una lingua, da uno spirito comune. Questo succede solo fuori regione, purtroppo." (Emiliano Antonino Morrone).
#DESTINI #INCROCIATI E #MEMORIA DEL #MONDO: UNO #SGUARDO DA #EXTRATERRESTRI. E’ VERO, concordo: noi "terroni" (#terrestri) siamo capaci di vedere la "Terra" come un unico "#Pianeta", unito da una storia, da una cultura, da una lingua, da uno spirito comune... solo dallo #spazio, solo da fuori della #Terra, purtroppo. Ma, uscire dalla #caverna, #oggi, è possibile...
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- CON CALVINO, LA SFIDA A INTERI MILLENNI DI LABIRINTO PUO’ ESSERE VINTA E IL "SENNO DI ORLANDO" (LUDOVICO ARIOSTO) PUO’ ESSERE RITROVATO.5 dicembre 2023, di Federico La Sala
CALVINO, LA SFIDA A INTERI MILLENNI DI LABIRINTO PUO’ ESSERE VINTA E IL "SENNO DI ORLANDO" (LUDOVICO ARIOSTO) PUO’ ESSERE RITROVATO.
- "Ed ecco: meraviglioso caso! /che ritornò la mente al primier uso;/e ne’ suoi bei discorsi l’intelletto/rivenne, più che mai lucido e netto ("Orlando Furioso", Canto XXXIX, 46-57).
COSMICOMICHE (#CALVINO100), ANTROPOLOGIA, LETTERATURA, E SORGERE DELLA TERRA (EARTHRISE):
Con "Leggerezza": "[...] la lentezza della coscienza umana a uscire dal parochialism antropocentrico può essere annullata in un istante dall’invenzione poetica. [...] Abituato come sono a considerare la letteratura come ricerca di conoscenza, per muovermi sul terreno esistenziale ho bisogno di considerarlo esteso all’antropologia, all’etnologia, alla mitologia. [...]
 Credo che sia una costante antropologica questo nesso tra levitazione desiderata e privazione sofferta. E’ questo dispositivo antropologico che la letteratura perpetua" (Italo Calvino, "Lezioni americane").
Credo che sia una costante antropologica questo nesso tra levitazione desiderata e privazione sofferta. E’ questo dispositivo antropologico che la letteratura perpetua" (Italo Calvino, "Lezioni americane").- Un omaggio a "Insula Europea": la condivisione dell’articolo di Giulio Pantalei sulla mostra su Calvino da lui curata (cfr. "Con Calvino, nel labirinto di Caracalla", 3 Dicembre 2023).
CIELO STELLATO E MALINCONIA BAROCCA. COSMOLOGIA, RIVOLUZIONESCIENTIFICA E ARTISTICA, MA NON ANTROPOLOGICA: QUANDO L’ITALIA E L’EUROPA CADDERO IN UN VICOLO CIECO (1618-1648).
Una sollecitazione a ripensare la storiografia dei primi decenni del Seicento... *
- Un omaggio al lavoro di Maura Sgarro ("Colloqui con quattordici artisti del Seicento europeo", Kimerik 2023) e di Aurelio Musi ("Malinconia barocca", Neri Pozza 2023).
MEMORIA E STORIA: ELSHEIMER E RUBENS. "Adam Elsheimer (Francoforte sul Meno, 16 settembre 1578 - Roma, 11 dicembre 1610): [...] Secondo i biografi, Elsheimer, che lavorava molto lentamente e che lasciò pochissime opere (oggi se ne contano una trentina), morì perciò quasi in povertà. Una famosa lettera, piena di dolore, di #Rubens a Johann Faber che lo informava da Roma della scomparsa dell’amico, è forse il miglior tributo fatto a questo artista. Fu sepolto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma, dove nel 2010 è stata apposta una lapide-cenotafio con profilo in bronzo e l’iscrizione che ricorda tra l’altro: "Nel 1609 dipinse / il cielo stellato / osservandolo / con uno dei primi / telescopi". (https://it.wikipedia.org/wiki/Adam_Elsheimer...).
ARTE E SCIENZA: CIGOLI, GALILEO GALILEI, E LA LUNA. [...] Quella fra Galileo e il Cigoli è, semplicemente, l’amicizia di una vita. Ce ne resta la testimonianza attraverso 29 lettere di Cigoli a Galileo e solo due dello scienziato al pittore perché gli eredi dell’artista, con eccessivo zelo, ritennero di dover distruggere tutte le prove di un sodalizio compromettente dopo la condanna papale. [...] Cigoli si trasferisce da Firenze a Roma nel 1604; Galileo all’epoca è ancora a Padova. Tornerà a Firenze nel 1610. [...]
 Nell’ottobre del 1610 Cigoli riceve da Papa Paolo V l’incarico di affrescare la cupola di Santa Maggiore Maggiore con l’Immacolata Concezione, Apostoli e Santi. La fatica è resa da questo passo nella lettera del 1° luglio 1611: “Nel resto, io attendo a salire 150 scalini a Santa Maria Maggiore et a tirare a fine allegramente, a questi caldi estivi che disfanno altrui; et ivi, senza esalare vento né punto di motivo di aria, tra il caldo e l’umido che contende, me la passerò tutta questa state”. Ma sui ponteggi e sulla cupola di Santa Maria Maggiore succedono cose bellissime. Succede, ad esempio (lettera del 23 marzo 2612), che Cigoli usi un cannocchiale galileiano per osservare le macchie solari: 26 osservazioni, disegnate appositamente per Galileo (fig. 3); [...]
Nell’ottobre del 1610 Cigoli riceve da Papa Paolo V l’incarico di affrescare la cupola di Santa Maggiore Maggiore con l’Immacolata Concezione, Apostoli e Santi. La fatica è resa da questo passo nella lettera del 1° luglio 1611: “Nel resto, io attendo a salire 150 scalini a Santa Maria Maggiore et a tirare a fine allegramente, a questi caldi estivi che disfanno altrui; et ivi, senza esalare vento né punto di motivo di aria, tra il caldo e l’umido che contende, me la passerò tutta questa state”. Ma sui ponteggi e sulla cupola di Santa Maria Maggiore succedono cose bellissime. Succede, ad esempio (lettera del 23 marzo 2612), che Cigoli usi un cannocchiale galileiano per osservare le macchie solari: 26 osservazioni, disegnate appositamente per Galileo (fig. 3); [...]
 Succede poi che nell’ottobre del 1612, dopo oltre due anni di lavoro, l’affresco sia completato, e che l’Immacolata Concezione sia strutturata secondo un’iconografia del tutto nuova: una Madonna in piedi su una luna perfettamente galileiana (fig. 4) , la stessa luna (fig. 1) le cui fasi Galileo aveva dipinto all’acquerello in uno dei suoi studi (fig. 2). La testimonianza commovente di un amico fedele.
Succede poi che nell’ottobre del 1612, dopo oltre due anni di lavoro, l’affresco sia completato, e che l’Immacolata Concezione sia strutturata secondo un’iconografia del tutto nuova: una Madonna in piedi su una luna perfettamente galileiana (fig. 4) , la stessa luna (fig. 1) le cui fasi Galileo aveva dipinto all’acquerello in uno dei suoi studi (fig. 2). La testimonianza commovente di un amico fedele.
 Su Cigoli si può contare, e Galileo non esita a chiederne l’aiuto in vista della pubblicazione dell’Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, a cura dell’Accademia dei Lincei. Ad occuparsi della pubblicazione è direttamente Federico Cesi, il Principe dell’Accademia; ma per scegliere l’incisore che dovrà occuparsi della parte iconografica dell’opera sia Cesi sia Galileo concordano nel rivolgersi a Cigoli . Fu scelto poi l’incisore lussemburghese Matthias Greüter. [...]" (cfr. "Galileo e Ludovico Cigoli: la Luna e le #macchiesolari fra scienza ed arte")
Su Cigoli si può contare, e Galileo non esita a chiederne l’aiuto in vista della pubblicazione dell’Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, a cura dell’Accademia dei Lincei. Ad occuparsi della pubblicazione è direttamente Federico Cesi, il Principe dell’Accademia; ma per scegliere l’incisore che dovrà occuparsi della parte iconografica dell’opera sia Cesi sia Galileo concordano nel rivolgersi a Cigoli . Fu scelto poi l’incisore lussemburghese Matthias Greüter. [...]" (cfr. "Galileo e Ludovico Cigoli: la Luna e le #macchiesolari fra scienza ed arte")RAGIONE E FEDE: GALILEO E LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA: "(...) Il 25 febbraio 1616 il papa ordinò al cardinale Bellarmino di «convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione; e se si fosse rifiutato di obbedire, il Padre Commissario, davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla». Nello stesso anno il De revolutionibus di Copernico fu messo all’Indice donec corrigatur (fino a che non fosse corretto). Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane: forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto, fecero cadere Galileo nell’illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. [...]" (cf. https://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei ).
NOTE:
GALILEO E LA PITTURA. "[...] Galileo era appassionato di pittura e pittore dilettante. Era amico di tutti i maggiori pittori dell’epoca, tra i quali in particolare Ludovico Cigoli, con il quale tenne una nutrita corrispondenza e al quale aveva regalato un cannocchiale per osservare la Luna di cui il Cigoli doveva aver fatto un ottimo uso, come si deduce dalla rappresentazione della Madonna in Santa Maria Maggiore a Roma. Il Cigoli aveva rappresentato la Luna ai piedi della Santa Vergine così com’è vista al telescopio «con le divisioni merlate e le sue isolette». (cfr. Lamberto Maffei, "Il cervello artistico di Galileo Galilei", Il Sole-24 Ore, 10 aprile 2011).
OLTRE L’ORIZZONTE•ITALO CALVINO•SUPERLUNA•ARTE E LETTERATURA
 La Luna cancellata (di Stefano Sandrelli, Edu-Inaf, 18 Maggio 2021/ Aggiornato 10 Maggio 2023).
La Luna cancellata (di Stefano Sandrelli, Edu-Inaf, 18 Maggio 2021/ Aggiornato 10 Maggio 2023).FLS
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- SCIENZA, FEDE, E " IL CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI" (ITALO CALVINO). Appunti sui "I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei (1611-1741).4 novembre 2023, di Federico La Sala
"LA LINGUA BATTE DOVE IL DENTE DUOLE". Alcune note a margine di "I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei (1611-1741). Nuova edizione accresciuta, rivista e annotata da SERGIO PAGANO, 2009, pp. CCLVIII, 332, tav. 24 ISBN 978-88-85042-62-9. *
- I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei
 SERGIO M. PAGANO
SERGIO M. PAGANO
 a cura di
a cura di
- Lev, Città del Vaticano 2009
 Anno di edizione originale: 2009
Anno di edizione originale: 2009
 ISBN: 9788885042629
ISBN: 9788885042629
- Il volume rappresenta la nuova edizione accresciuta, rivista e annotata dal prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, mons. Sergio Pagano, della precedente raccolta di documenti pubblicata con lo stesso titolo nel 1984. L’A. afferma che la brevità dei tempi allora a disposizione lo costrinse a produrre un risultato non del tutto soddisfacente, ora completato dalla presente nuova edizione di 550 pagine, 16 tavole fuori testo e 1300 note, un’edizione che può essere considerata come un “contributo umile e silenzioso dell’Archivio Segreto alla celebrazione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia" [2009].
 Il lavoro tiene conto non solo dei numerosi studi relativi a caso Galileo apparsi dal 1984 alla data della presente pubblicazione, ma soprattutto del fatto che a, partire dal 22 gennaio 1998, gli archivi del Sant’Officio e quello della Congregazione dell’Indice, entrambi conservati nell’Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, furono ufficialmente aperti agli studiosi.
Il lavoro tiene conto non solo dei numerosi studi relativi a caso Galileo apparsi dal 1984 alla data della presente pubblicazione, ma soprattutto del fatto che a, partire dal 22 gennaio 1998, gli archivi del Sant’Officio e quello della Congregazione dell’Indice, entrambi conservati nell’Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, furono ufficialmente aperti agli studiosi.
 Rispetto alle edizioni precedenti degli atti processuali galileiani le novità più rilevanti della nuova opera sono determinate dalla maggiore conoscenza dei personaggi implicati nel procedimento, tutti precisati nelle note, compresi moltissimi inquisitori; dai documenti presentati nella loro genuinità - originali, copie, sunti, note d’ufficio - con rigorose note archivistiche; dal panorama delle fonti "vaticane" riguardanti il processo allo scienziato pisano e cioè l’Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, l’Archivio Segreto Vaticano, la Biblioteca Apostolica Vaticana. La presente nuova edizione comprende naturalmente tutte le carte già note e almeno una ventina di nuovi documenti reperiti nell’Archivio del Santo Officio dopo il 1991 da alcuni ricercatori: in particolare Ugo Baldini e Leen Spruit.
Rispetto alle edizioni precedenti degli atti processuali galileiani le novità più rilevanti della nuova opera sono determinate dalla maggiore conoscenza dei personaggi implicati nel procedimento, tutti precisati nelle note, compresi moltissimi inquisitori; dai documenti presentati nella loro genuinità - originali, copie, sunti, note d’ufficio - con rigorose note archivistiche; dal panorama delle fonti "vaticane" riguardanti il processo allo scienziato pisano e cioè l’Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede, l’Archivio Segreto Vaticano, la Biblioteca Apostolica Vaticana. La presente nuova edizione comprende naturalmente tutte le carte già note e almeno una ventina di nuovi documenti reperiti nell’Archivio del Santo Officio dopo il 1991 da alcuni ricercatori: in particolare Ugo Baldini e Leen Spruit.
 Il volume annota criticamente i vari documenti dei quali propone una edizione fedele agli originali. L’edizione dei documenti è preceduta da una ampia introduzione storica alle vicende che gradualmente portarono all’istruzione e allo svolgimento del processo, a partire dalle denunce del domenicano Tommaso Caccini, dal 1616 al 1633 e fino al 1741, quando, sotto il pontificato di Papa Benedetto XIV, fu permessa la costruzione del mausoleo nella basilica di Santa Croce di Firenze e consentita la pubblicazione a Padova dell’opera galileiana.
Il volume annota criticamente i vari documenti dei quali propone una edizione fedele agli originali. L’edizione dei documenti è preceduta da una ampia introduzione storica alle vicende che gradualmente portarono all’istruzione e allo svolgimento del processo, a partire dalle denunce del domenicano Tommaso Caccini, dal 1616 al 1633 e fino al 1741, quando, sotto il pontificato di Papa Benedetto XIV, fu permessa la costruzione del mausoleo nella basilica di Santa Croce di Firenze e consentita la pubblicazione a Padova dell’opera galileiana.
*
UNA RIFLESSIONE DI ANTONIO CASTRONUOVO (1 novembre 2023): "Penso a Bruno e a Sarpi e a come la rivoluzione copernicana della morale sia stata avviata da frati, domenicani o serviti che siano. In qualche modo, la cosa fa sorridere; come fa sorridere il fatto che se Bruno andò al rogo, Sarpi fu invece un temuto scomunicato cui fu concesso di continuare a vivere nel proprio convento veneziano.
 Ma a questi frati - ancorché versati agli esperimenti scientifici - mancò quel che a Bologna si dice "lo sbuzzo", il talento pratico, quello che determina effetti sulla realtà materiale. Ne godette Galileo, che infatti diventò sommamente pericoloso, da cui i processi, le estorte abiure ecc.
Ma a questi frati - ancorché versati agli esperimenti scientifici - mancò quel che a Bologna si dice "lo sbuzzo", il talento pratico, quello che determina effetti sulla realtà materiale. Ne godette Galileo, che infatti diventò sommamente pericoloso, da cui i processi, le estorte abiure ecc.
 Torno spesso a questa lugubre storia, mediante un magnifico volume che nasce "da dentro", dal Vaticano. Me ne chiedo la ragione, e a volte penso che non resti altro agli sconfitti - ai nemici della scienza, alle intelligenze offuscate dalle fedi - che fare il verso di «studiare i propri errori». (A. Castronuovo).
Torno spesso a questa lugubre storia, mediante un magnifico volume che nasce "da dentro", dal Vaticano. Me ne chiedo la ragione, e a volte penso che non resti altro agli sconfitti - ai nemici della scienza, alle intelligenze offuscate dalle fedi - che fare il verso di «studiare i propri errori». (A. Castronuovo).
DUE NOTE:
a) #FISICA E #METAFISICA.#Patafisica-#mente, non si è ancora ascoltato il #suono del #nome e del #cognome di #GalileoGalilei, #Galileo, #Galilei; e, ancora, non si è visto che le radici della #Terra sono #Cosmicomiche (#ItaloCalvino), e, che è "l’amor che move il sole e le altre stelle"(#DanteAlighieri).
b) #STORIA #STORIOGRAFIA E #COSMOLOGIA: "#ECCE #HOMO" (#NIETZSCHE, 1888). BRILLANTISSIMA E OPPORTUNISSIMA SOLLECITAZIONE PER RIFLETTERE NON SOLO SU #GIORDANOBRUNO E #PAOLOSARPI, MA ANCHE SU #ITALOCALVINO E "#SIGISMONDO DI #VINDOBONA" (RILEGGERE "IL #CASTELLO DEI #DESTINI #INCROCIATI). SULLA IN-#CROCIATA DISCUSSIONE SU #RAGIONE E #FEDE (#CHIESACATTOLICA), FORSE, è tempo di cambiare decisamente #orizzonte e #logica della #ricercascientiffica e filosofica: la condanna di Gesù della #Galilea, come la condanna di #Galileo #Galilei, è di natura teologica e politica prima di tutto, e, poi scientifica e tecnica: la questione fondamentale è quella antropologica (cristologica), come aveva ben capito #Kant (e già #Orazio di #Venosa): "#sàpere aude!". Ricordare anche #Feuerbach, #naturalmente!
- I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo. Una nota di Sandro Modeo - a c. di Federico La Sala21 giugno 2023, di Federico La Sala
MATURITA’ 2023.
- POESIA, COSMOLOGIA, E ANTROPOLOGIA (NON COSMOTEANDRIA):
CON SALVATORE QUASIMODO, GUARDARE "LA TERRA IMPAREGGIABILE" (1955-1958), DALLA LUNA, DALLA "NUOVA LUNA":
"Alla nuova luna
In principio Dio creò il cielo
 e la terra, poi nel suo giorno
e la terra, poi nel suo giorno
 esatto mise i luminari in cielo
esatto mise i luminari in cielo
 e al settimo giorno si riposò
e al settimo giorno si riposò
 Dopo miliardi di anni l’uomo,
Dopo miliardi di anni l’uomo,
 fatto a sua immagine e somiglianza,
fatto a sua immagine e somiglianza,
 senza mai riposare, con la sua
senza mai riposare, con la sua
 intelligenza laica,
intelligenza laica,
 senza timore, nel cielo sereno
senza timore, nel cielo sereno
 d’una notte d’ottobre,
d’una notte d’ottobre,
 mise altri luminari uguali
mise altri luminari uguali
 a quelli che giravano
a quelli che giravano
 dalla creazione dle mondo. Amen."
dalla creazione dle mondo. Amen." -
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- NELL’ANNO DANTE2021, INGENUITY INIZIA LA SUA MISSIONE. Il 13 aprile 2023 ha azionato le sue eliche per la 50esima volta (di Jacopo Danieli)22 aprile 2023, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E DIVINA COMMEDIA: "SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610) E "SAPERE AUDE!"(I. KANT, 1784). Alcuni appunti sul tema dell’antropogenesi (e cristogenesi) nell’opera di Dante...
- FILOLOGIA E ARCHEOLOGIA FILOSOFICA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI ANDROLOGIA DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3);
- E DELLA SUA COSTRUZIONE DEL "CORPO DI CRISTO": "Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto [...] egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo [εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ], finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo [ἄνδρα] perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo." (Efesini, 4.1/11-13).
NELL’ANNO DANTE2021, SU MARTE, "INGENUITY" INIZIA LA SUA ATTIVITA’ E LA SUA MISSIONE ESPLORATIVA:
CON ULISSE, OLTRE: VIRTU’ E CONOSCENZA. Ai suoi tempi, Dante ha esplorato con il suo "oudemico" ingegno l’intero "oceano celeste" (Keplero) e, al ritorno, ha raccontato che, trovandosi nel V cielo, quello del Pianeta Marte, rimase colpito da "una melode/ che mi rapiva, sanza intender l’inno (Pd XIV, 101 e 123).
L’INGEGNO, IL GENERE UMANO ("GATTUNGSWESEN"), E LA "TERRA" DI MARTE:
NELL’ANNO 2023, "Lo scorso 13 aprile il piccolo elicottero marziano Ingenuity ha azionato le sue eliche per la 50esima volta, percorrendo 320 metri in poco più di 2 minuti e mezzo, durante i quali ha infranto anche il precedente record di altezza, salendo fino a 18 metri. Ingenuity, che il 19 aprile ha festeggiato i suoi primi due anni su Marte, fu inizialmente concepito come dimostratore tecnologico, un modo cioè per provare che il volo controllato a motore su un altro pianeta fosse possibile. [...]
 Costruito con molti componenti di serie, come processori e fotocamere di smartphone, Ingenuity ha superato di 23 mesi terrestri e 45 voli la durata prevista. Ad oggi, ha volato in totale per oltre 89 minuti e più di 11,6 chilometri. «Abbiamo fatto tanta strada e vogliamo andare ancora più lontano», dice Teddy Tzanetos, responsabile del team della missione al Jpl. «Ma sappiamo fin dall’inizio che il nostro tempo su Marte è limitato e ogni giorno operativo è una benedizione. Che la missione di Ingenuity finisca domani, la prossima settimana o tra qualche mese è qualcosa che nessuno può prevedere al momento. Quello che posso prevedere è che, quando succederà, ci sarà una bella festa». " (cfr. Jacopo Danieli, "Cinquanta voli per l’elicotterino marziano", INAF, 21/04/2023).
Costruito con molti componenti di serie, come processori e fotocamere di smartphone, Ingenuity ha superato di 23 mesi terrestri e 45 voli la durata prevista. Ad oggi, ha volato in totale per oltre 89 minuti e più di 11,6 chilometri. «Abbiamo fatto tanta strada e vogliamo andare ancora più lontano», dice Teddy Tzanetos, responsabile del team della missione al Jpl. «Ma sappiamo fin dall’inizio che il nostro tempo su Marte è limitato e ogni giorno operativo è una benedizione. Che la missione di Ingenuity finisca domani, la prossima settimana o tra qualche mese è qualcosa che nessuno può prevedere al momento. Quello che posso prevedere è che, quando succederà, ci sarà una bella festa». " (cfr. Jacopo Danieli, "Cinquanta voli per l’elicotterino marziano", INAF, 21/04/2023).EARTHDAY 2023 #Metaphysics #Anthropology #Theology #Cosmology #Koyaanisqatsi #Ubuntu #Earthrise
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI ---- ANTROPOLOGIA SPAZIALE E FILOLOGIA: NOTE SUL "CORDONE OMBELICALE".4 dicembre 2022, di Federico La Sala
PIANETA TERRA 2022.
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, ANALFABETISMO, E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (FREUD, 1929):
COME NASCONO I BAMBINI? COSA "STA SCRITTO AL CENTRO DELLE NOSTRE PANCE" DI ESSERI UMANI?
***
- "SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610). Nel momento stesso in cui sono cominciati i viaggi extra-terrestri, forse, è possibile cominciare anche a capire l’importanza del cordone ombelicale e preoccuparsi meglio e di più delle condizioni che rendono possibile la vita sul Pianeta Terra.
- TERRA-MADRE (DEMETRA ->ELEUSIS, una delle capitali europee della cultura 2023). Senza cordone ombelicale (il filo "tecnologico", il "pezzo di terra", che assicura condizioni di vita terrestre ad un essere umano) nessuno può avventurarsi fuori dalla Terra (non solo nell’aria o nell’acqua del #Pianeta , ma nemmeno e ancor di più nello spazio planetario o cosmico) e tornare a Casa.
***
CORDONE OMBELICALE
di Annalisa Teggi (L’ Osservatore Romano, 02 dicembre 2022
"Se dovessi scegliere la notizia dell’anno di questo 2022 che si avvia al termine, la tirerei fuori dalle pieghe più silenziose della realtà. Lo scorso maggio a Catania è stato trovato un neonato abbandonato in una cesta con il cordone ombelicale ancora attaccato. Proprio quest’ultimo dettaglio mi è rimasto impresso, quasi fosse un grido. Che grande vulnerabilità esposta in quel cordone, segno di una dipendenza totale. Guai a manifestare una cosa del genere, oggi. I nostri cordoni ombelicali li tagliamo spavaldamente, o piuttosto li nascondiamo con cura (anche noi stessi). Ostentiamo la fierezza di traguardi che ci siamo guadagnati da soli, con le nostre forze. Senza chiedere niente a nessuno - la medaglia da appuntarsi al petto. Ma sarà poi vero?
[...]
«Sono» nasce da un «siamo», e sta scritto al centro delle nostre pance. È un «siamo» che è durato nove mesi dentro il grembo e non sparisce quando siamo creature separate da nostra madre. Restiamo bisognosi di non recisi dal cuore del mondo.
In una lettera datata 8 gennaio 1944 J.R.R. Tolkien scrisse a suo figlio Christopher: «Ma Dio è anche (si fa per dire) dietro di noi, sostenendoci, nutrendoci (dato che siamo creature sue). Quel luminoso punto di potere dove il cordone della vita, il cordone ombelicale dello spirito termina, là è il nostro angelo, che guarda in due direzioni: a Dio dietro di noi, senza che noi possiamo vederlo, e a noi». Ce lo immaginiamo sempre presente, l’angelo custode. Ma un po’ staccato da noi. Magari su un’imprecisata nuvoletta sopra la nostra testa. Solo un genio profondamente intuitivo poteva regalarci quest’istantanea dell’angelo custode che sta a reggere il cordone ombelicale che ci lega fecondamente al Cielo. Verrebbe da attribuirgli tutta l’energia vivace che si vede nei corpi e nei volti di chi fa il tiro alla fune. Solo che non c’è nessuna gara per l’angelo, solo l’inesausto desiderio di non separarci dal vero bene.
E questo «cordone ombelicale dello spirito» non è il filo del burattino che viene manovrato, è una cascata di nutrimento che ci tiene in piedi, per essere davvero liberi. Liberi, perché legati come figli. " (L’Osservatore Romano, 02 dicembre 2022).
***
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" --- "CIAULA SCOPRE LA LUNA", IL "MALEDETTO SIA COPERNICO!", L’ABIURA DI GALILEO GALILEI, E IL DISAGIO DELLA CIVILTA’.29 giugno 2022, di Federico La Sala
STORIA E MEMORIA... *
L’#ABIURA DI #GALILEOGALILEI (letta il #22giugno 1633), IL "MALEDETTO SIA #COPERNICO!" (L. #Pirandello, “Il fu Mattia Pascal”, 1904), E IL #DISAGIODELLACIVILTA’ (#SigmundFreud, 1929). #Storia e #memoria...
Ricordando che ieri (#28giugno) era il #giorno della #nascita nel 1867 di #LuigiPirandello e che una delle sue novelle più famose è "CIAULA SCOPRE LA #LUNA", non si può non ricordare ancora oggi alla #ChiesaCattolica (#29giugno, memoria di #PietroePaolo) la frase di #Keplero del 1611 : "Hai vinto, o #Galileo!" ("#Vicisti, #Galilaee": una #duplice #vittoria, sul piano scientifico e sul piano della preistorica #cosmoteandria "cattolica"!
La #rivoluzionecopernicana continua il suo #cammino... con #DanteAlighieri, #Shakespeare, #Kant, #Freud, #Ciaùla, e Samantha Cristoforetti, l’intero #genereumano è riuscito a "rivedere le stelle" (Inf. XXXIV, 139).
- PER NON DIMENTICARE
- Abiura di Galileo Galilei
- Letta il 22 giugno 1633
Io Galileo, fìg.lo del q. Vinc.o Galileo di Fiorenza, dell’età mia d’anni 70, constituto personalmente in giudizio, e inginocchiato avanti di voi Emin.mi e Rev.mi Cardinali, in tutta la Republica Cristiana contro l’eretica pravità generali Inquisitori; avendo davanti gl’occhi miei li sacrosanti Vangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro che sempre ho creduto, credo adesso, e con l’aiuto di Dio crederò per l’avvenire, tutto quello che tiene, predica e insegna la S.a Cattolica e Apostolica Chiesa. Ma perché da questo S. Off.o, per aver io, dopo d’essermi stato con precetto dall’istesso giuridicamente intimato che omninamente dovessi lasciar la falsa opinione che il sole sia centro del mondo e che non si muova e che la terra non sia centro del mondo e che si muova, e che non potessi tenere, difendere ne insegnare in qualsivoglia modo, ne in voce ne in scritto, la detta falsa dottrina, e dopo d’essermi notificato che detta dottrina è contraria alla Sacra Scrittura, scritto e dato alle stampe un libro nel quale tratto l’istessa dottrina già dannata e apporto ragioni con molta efficacia a favor di essa, senza apportar alcuna soluzione, sono stato giudicato veementemente sospetto d’eresia, cioè d’aver tenuto e creduto che il sole sia centro del mondo e imobile e che la terra non sia centro e che si muova; Pertanto volendo io levar dalla mente delle Eminenze V.re e d’ogni fedel Cristiano questa veemente sospizione, giustamente di me conceputa, con cuor sincero e fede non fìnta abiuro, maledico e detesto li sudetti errori e eresie, e generalmente ogni e qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla S.ta Chiesa; e giuro che per l’avvenire non dirò mai più ne asserirò, in voce o in scritto, cose tali per le quali si possa aver di me simil sospizione; ma se conoscerò alcun eretico o che sia sospetto d’eresia lo denonziarò a questo S. Offizio, o vero all’Inquisitore o Ordinario del luogo, dove mi trovarò.
 Giuro anco e prometto d’adempire e osservare intieramente tutte le penitenze che mi sono state o mi saranno da questo S. Off.o imposte; e contravenendo ad alcuna delle dette mie promesse e giuramenti, il che Dio non voglia, mi sottometto a tutte le pene e castighi che sono da’ sacri canoni e altre constituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate.
Giuro anco e prometto d’adempire e osservare intieramente tutte le penitenze che mi sono state o mi saranno da questo S. Off.o imposte; e contravenendo ad alcuna delle dette mie promesse e giuramenti, il che Dio non voglia, mi sottometto a tutte le pene e castighi che sono da’ sacri canoni e altre constituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate.
 Così Dio m’aiuti e questi suoi santi Vangeli, che tocco con le proprie mani. Io Galileo Galilei sodetto ho abiurato, giurato, promesso e mi sono obligato come sopra; e in fede del vero, di mia propria mano ho sottoscritta la presente cedola di mia abiurazione e recitatala di parola in parola, in Roma, nel convento della Minerva, questo dì 22 giugno 1633.
Così Dio m’aiuti e questi suoi santi Vangeli, che tocco con le proprie mani. Io Galileo Galilei sodetto ho abiurato, giurato, promesso e mi sono obligato come sopra; e in fede del vero, di mia propria mano ho sottoscritta la presente cedola di mia abiurazione e recitatala di parola in parola, in Roma, nel convento della Minerva, questo dì 22 giugno 1633. Io, Galileo Galilei ho abiurato come di sopra, mano propria.
Io, Galileo Galilei ho abiurato come di sopra, mano propria.*
Federico La Sala (29 giugno 2022)
-
> L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo. --- Il soorgere della Terra e una nuova "ricapitolazione": una radicale inversione logico-storica.13 febbraio 2022, di Federico La Sala
Cosmologia, antropologia, cristianesimo e civiltà.
"IL FIGLIO DELL’UOMO": UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA E FILOLOGICA...
COSMOLOGIA. “Da Copernico in poi l’uomo rotola dal centro verso una X”. Così Nietzsche, nel 1886. Ma, per un filosofo nato filologo e, per di più, uno dei grandi maestri del sospetto, contrariamente a quanto si è sempre ripetuto in modo "umano, troppo umano", non è bene tornare a interrogarlo e cercare di avere ulteriori dati sulla destinazione "ignota"?
ANTROPOLOGIA. Nel 1888 pubblica "Ecce homo. Come si diviene ciò che si è": un Urlo contro la paolina religione del "Vir Dei", una critica radicale della cosmoteandria faraonica, e un aut aut epocale.
LA PUNTA DI UN ICEBERG BIMILLENARIO: PUGLIA (12 FEBBRAIO 2022). "Ecce Vir": il "caso serio" del quadro intitolato "Sabinus vir Dei".
Tracce per una seconda rivoluzione copernicana
- AL DI LÀ DELLA LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)
SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI E RINASCIMENTO, OGGI. Una ristrutturazione epocale e lo sgretolamento della cosmoteandria tradizionale (#cosmo, teologia/ #dio e #andrologia/uomo) è già da tempo in atto: la nascita di una antropologia annunciata già da Michelangelo nel suo "Tondo Doni", con le sue due sibille e i suoi due profeti - non "quattro profeti", come vuole la Galleria degli Uffizi, e da Galileo Galilei con il suo "Sidereus Nuncius" (1610), fondata sulla visione del sorgere della Terra, è già in cammino: un capovolgimento e una nuova ricapitolazione, una radicale inversione logico-storica!
Federico La Sala
-
> L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo. --- Astrobiologia. La Nasa ha chiamato 24 teologi in un progetto per dare vita a «ponti di comprensione per pensare insieme - e informare il pubblico - sulle preoccupazioni globali» sulla vita extraterrestre (di Luigi Bignami).3 gennaio 2022, di Federico La Sala
Spazio.
Fratello alieno: la Nasa "arruola" i teologi
La Nasa ha chiamato 24 teologi in un progetto per dare vita a «ponti di comprensione per pensare insieme - e informare il pubblico - sulle preoccupazioni globali» sulla vita extraterrestre
di Luigi Bignami (Avvenire, martedì 28 dicembre 2021)
- [Foto] La placca attaccata al Pioneer 10 nel 1972 con alcune informazioni sull’uomo rivolte a eventuali intelligenze extraterrestri - Nasa
Mentre le agenzie spaziali lanciano nuovi telescopi, sonde e rover per cercare forme di vita aliena oltre la Terra, La Nasa ha chiamato 24 teologi a far parte di un progetto voluto dall’ente spaziale a cui farà parte il Center for Theological Inquiry a Princeton negli Usa il cui obiettivo è dare vita a «ponti di comprensione convocando teologi, scienziati, studiosi e responsabili politici per pensare insieme - e informare il pubblico - sulle preoccupazioni globali». Tra questi problemi risultano di rilevante importanza anche domande quali «Cos’è la vita? Qual è la linea di confine tra uomo e alieno? Quali sono le possibilità che esista vita su altri mondi?».
Tra i teologi che verranno chiamati spicca Andrew Davison, sacerdote e teologo dell’Università di Cambridge con un dottorato in biochimica, il quale si è recentemente occupato di astrobiologia (la scienza che studia la ricerca di vita extraterrestre) e di sintesi evolutiva. Presto sarà pubblicato un suo lavoro sull’esobiologia (Astrobiology and Christian Doctrine) che tratta il rapporto tra vita aliena e principali aspetti della fede cristiana. «Le tradizioni religiose sarebbero una caratteristica importante nel modo in cui l’umanità affronterebbe le conferma della vita altrove - ha scritto Davison sul sito dell’Università di Cambridge -, per questo motivo, fa parte dell’obiettivo della Nasa sostenere il lavoro sulle ’implicazioni sociali dell’astrobiologia».
Spiega Davison: «Il mio progetto (all’interno di quello della Nasa) è semplice da definire. Sto realizzando un’indagine sui temi principali della fede cristiana dal punto di vista della vita altrove nell’Universo. Penso al suo rapporto con le dottrine della creazione, del peccato, della persona e dell’opera di Gesù, della Redenzione, della rivelazione e dell’escatologia. Finora la mia attenzione si è concentrata principalmente su ciò che i teologi chiamano cristologia: la discussione su chi fosse Gesù, e in particolare su cosa significa ritenerlo insieme umano e divino. Ora, vista l’elevata probabilità che esista vita aliena, c’è una domanda teologica a cui dare risposta e riguarda la prospettiva della vita su altri mondi: dobbiamo pensare a molte incarnazioni o solo a quella di cui parlano i teologi in Gesù?». Un problema che dev’essere giustamente affrontato prima che possa arrivare il grande annuncio.
Anche José Gabriel Funes, direttore della Specola Vaticana, interpellato sui rapporti tra astronomia e fede ha più volte ribadito della possibilità di vita extraterrestre: «A mio giudizio questa possibilità esiste. Gli astronomi ritengono che l’Universo sia formato da cento miliardi di galassie, ciascuna delle quali è composta da centinaia di miliardi di stelle. Molte di queste, o quasi tutte, potrebbero avere dei pianeti. Come si può escludere che la vita si sia sviluppata anche altrove?». E anche se non ci sono prove, ribadisce Funes, non si può escludere che esistano esseri simili a noi o più evoluti. E se si scoprisse la loro esistenza non ci sarebbero problemi per la nostra fede. «Come esiste una molteplicità di creature sulla Terra, così potrebbero esserci altri esseri, anche intelligenti, creati da Dio. Questo non contrasta con la nostra Fede, perché non possiamo porre limiti alla libertà creatrice di Dio. Per dirla con san Francesco, se consideriamo le creature terrene come ’fratello’ e ’sorella’, perché non potremmo parlare anche di un ’fratello extraterrestre’? Farebbe comunque parte della creazione».
___
Nota:
#COSMOTEANDRIA #VITA #EXTRATERRESTRE E #NASA. #SIDEREUS NUNCIUS: LA #TEOLOGIA RIFLETTE SULLA #CRISTOLOGIA. L’autore di "#Astrobiology and #ChristianDoctrine" spiega: "dobbiamo pensare a molte incarnazioni o solo a quella di cui parlano i teologi in Gesù?"
FLS
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS". L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo. --- Nel 2022, l’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale (ISS).28 maggio 2021, di Federico La Sala
Cristoforetti prima donna in Europa a guidare una stazione spaziale *
Nel 2022 Samantha sarà lanciata verso la "base" dalla Florida: "E’ un onore, coordinerò una squadra eccezionale"
- [Foto] Cristoforetti prima donna in Europa a guidare una stazione spaziale (ansa)
L’astronauta Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale (ISS). E la terza al mondo dopo due americane: accadrà nel corso della Expedition 68 che la vedrà in orbita nel 2022. Lo annuncia l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).
AstroSamantha si dice "onorata" della nomina. "Ritornare sulla Stazione spaziale internazionale per rappresentare l’Europa è un onore di per sé", afferma l’astronauta. "Sono onorata della mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto competente in orbita".
Come membro dell’equipaggio "Crew-4" insieme agli astronauti NASA Kjell Lindgren e Bob Hines, nel 2022 Samantha sarà lanciata verso la Stazione Spaziale dalla Florida, USA, su un veicolo spaziale Crew Dragon di SpaceX. Questa sarà la seconda missione spaziale di Samantha. L’esperienza maturata in questi anni le sarà sicuramente utile per il suo nuovo ruolo.
Il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher ha spiegato che "la nomina di Samantha al ruolo di comandante della ISS è un’ispirazione per un’intera generazione che sta concorrendo per entrare nel corpo astronauti dell’ESA. Non vedo l’ora di incontrare i candidati finali e colgo l’occasione per incoraggiare ancora una volta le donne a farsi avanti".
* Fonte: la Repubblica, 28 Maggio 2021
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo. --- Abitare nello spazio non è più fantascienza (di Silvia Camisasca).19 febbraio 2021, di Federico La Sala
Tecnologia.
Abitare nello spazio non è più fantascienza
Colonizzare la Luna e costruire in orbita sono ricerche ormai all’ordine del giorno. Vittorio Netti: «Una sfida non solo tecnologica, ma di pensiero architettonico»
di Silvia Camisasca (Avvenire, venerdì 19 febbraio 2021)
- [Foto] Un progetto di architettura spaziale della Sicsa di Houston - Sicsa
«La terra è la culla dell’umanità, ma nessuno può vivere in una culla per sempre »: furono le parole con cui nel 1890 Konstantin Ciolkovskij, scienziato russo e inventore della missilistica, motivò la scelta di dare vita nel suo appartamento al primo laboratorio di aerodinamica. Accolto ai consessi internazionale dallo scetticismo di colleghi, che in lui vedevano una mente folle quanto basta, non cessò di esporre le sue teorie visionarie su stazioni spaziali e razzi che avrebbero solcato lo spazio siderale e portato a spasso nel cosmo l’umanità. Autodidatta, costretto ad abbandonare la scuola a 14 anni a causa della scarlattina che gli procurò la sordità, elaborò, ispirato dai romanzi di Jules Verne, la “torre orbitale”, ovvero l’ascensore spaziale ormai parte dell’immaginario collettivo. Ma “il sognatore di Kaluga”, nelle parole di Nikolai Rynin, era un matematico e fisico estremamente rigoroso: lui, per primo, calcolò, infatti, la velocità necessaria ad un veicolo spaziale per vincere l’attrazione gravitazionale terrestre e raggiungere le stelle.
Come lui, nella storia si incontrano altre figure - Leonardo Da Vinci, Nikola Tesla, Wernher Von Braun - capaci di viaggiare nel tempo guidati dalla potenza di un’immaginazione incontenibile. Lo stesso Von Braun, già inventore del razzo che portò i primi astronauti sulla luna con il programma Apollo, racconta, in Progetto Marte, il suo piano per colonizzare il pianeta rosso per mezzo di una flotta di astronavi, mascherandolo da romanzo di fantascienza. L’ex scienziato nazista, divenuto padre del programma spaziale americano, descriveva in ogni dettaglio le vite dei neocoloni, immaginando giganteschi razzi riciclabili e basi sotterranee brulicanti di una nuova generazione di scienziati, ingegneri e biologi. La premessa è di straordinaria attualità in questo particolare passaggio storicamente delicatissimo per tutte le dinamiche inerenti lo spazio, ingegneria ed economia incluse, ma, soprattutto, relative alla possibilità di una permanenza prolungata e sostenibile in un “altrove”, oltre il pianeta Terra.
- [Foto] Vittorio Netti - Sicsa
«Immaginare il futuro, anche con voli pindarici della mente, è fondamentale per costruirselo - esordisce Vittorio Netti, ricercatore al Sicsa (Sasakawa International Center for Space Architecture) di Houston, e Ph.D. candidate in Ingegneria e Scienze Aerospaziali al Politecnico di Bari - È come tracciare una rotta, attraverso acque ignote, per arriva a destinazione, anche se ancora nessuna la vede».
 Al Sicsa, il più avanzato centro di ricerca al mondo di ingegneria aerospaziale, vengono studiate soluzioni e tecnologie per la prossima generazione di missioni spaziali con equipaggio umano, perché vivere e abitare oltre il pianeta Terra non è più oggetto di pertinenza della fantascienza: «Da oltre 20 anni non viviamo interamente sullo stesso pianeta. Un certo numero di esseri umani occupa costantemente la ISS in orbita dal 2000 - ricorda Netti - e dal 2017 con il lancio del programma Artemis della Nasa, dopo 50 anni, si sta pianificando il ritorno dell’uomo (e della prima donna) sulla Luna. Questa volta, però, per restarci». La road map, del resto, è già definita: si articolerà in tre fasi e procederà con la prima missione esplorativa nel 2024 e l’installazione delle strutture permanenti dal 2028.
Al Sicsa, il più avanzato centro di ricerca al mondo di ingegneria aerospaziale, vengono studiate soluzioni e tecnologie per la prossima generazione di missioni spaziali con equipaggio umano, perché vivere e abitare oltre il pianeta Terra non è più oggetto di pertinenza della fantascienza: «Da oltre 20 anni non viviamo interamente sullo stesso pianeta. Un certo numero di esseri umani occupa costantemente la ISS in orbita dal 2000 - ricorda Netti - e dal 2017 con il lancio del programma Artemis della Nasa, dopo 50 anni, si sta pianificando il ritorno dell’uomo (e della prima donna) sulla Luna. Questa volta, però, per restarci». La road map, del resto, è già definita: si articolerà in tre fasi e procederà con la prima missione esplorativa nel 2024 e l’installazione delle strutture permanenti dal 2028.Se passeggiare sul suolo lunare è già parte delle nostre conquiste, come specie, l’impresa, mai tentata prima, di abitarci stabilmente comporta una serie di sfide incredibilmente ardue. A cominciare dal dovere fare i conti con il fattore umano, con una fisiologia e psicologia messe a dura prova dall’ambiente lunare: uno spazio assai ostico, che costantemente incrina l’equilibrio psicofisico ed emotivo umano: radiazioni, pressione, mancanza di ossigeno, microgravità. Nulla di quello che c’è lì fuori è compatibile con la vita, perlomeno quella umana, nulla favorisce il benessere della persona». Per garantire la permanenza in un contesto così avverso, gli habitat spaziali, come la ISS, devono riprodurre microecosistemi contenenti tutto quanto necessario a sostenere gli astronauti, limitando il più possibile i rifornimenti dalla Terra. I sistemi di sostentamento vitale (Eclss nel gergo Nasa) sono attualmente in grado di riciclare una percentuale notevolissima di tutto ciò che è a bordo, ovvero la quasi totalità dell’acqua (90%) e il 40% dell’ossigeno.
Gli Eclsss sono addirittura osservabili come modelli virtuosi di economia circolare, e sulla Luna la loro efficienza potrebbe essere anche superiore; inoltre, l’inesorabile consumo di risorse potrebbe essere rifornito dall’impiego dei materiali locali, il cui ricorso è già al vaglio non solo per l’ambiente lunare. Allo studio, infatti, ci sono soluzioni per utilizzare la sabbia lunare (regolite) e l’acqua dei giacimenti polari per la costruzione delle basi di superficie, nella stessa maniera in cui qui impastiamo cemento e malta.
 «Costruire sulla Luna significa reinventare l’architettura, non solo le tecniche costruttive» puntualizza Netti, ricordando che nel 1960, agli albori dei programmi di esplorazione spaziale umana, la Nasa reclutò un team multidisciplinare di artisti, designer e architetti per immaginare il futuro dell’uomo nello spazio: lo scopo consisteva nel visualizzare e concretizzare quanto, fino ad allora, era stato solo teorizzato dagli scienziati e, in un certo senso, viveva limitatamente alla dimensione dell’immaginazione.
«Costruire sulla Luna significa reinventare l’architettura, non solo le tecniche costruttive» puntualizza Netti, ricordando che nel 1960, agli albori dei programmi di esplorazione spaziale umana, la Nasa reclutò un team multidisciplinare di artisti, designer e architetti per immaginare il futuro dell’uomo nello spazio: lo scopo consisteva nel visualizzare e concretizzare quanto, fino ad allora, era stato solo teorizzato dagli scienziati e, in un certo senso, viveva limitatamente alla dimensione dell’immaginazione.Da quell’esperienza sono nate alcune tra le più suggestive creazioni delle sfere di Bernal e dei Cilindri di O’Neill, fino ad allora solo costrutti teorici di gigantesche città orbitanti capaci di sfruttare la propria rotazione per generare una gravità simile a quella terrestre. Dall’altra parte della cortina di ferro, l’architetto russo Galina Balašova disegnava stazioni spaziali per l’agenzia sovietica. La capacità di architetti e designer di visualizzare il futuro è da allora diventata un requisito fondamentale per le agenzie spaziali e, più recentemente, anche per le aziende private di settore: alla fine degli anni ’80, l’architetto della Nasa Gary Kitmacher disegnò “ISS cupola”, la più grande finestra della Stazione Spaziale dalla quale è possibile osservare la Terra, e tutt’oggi uno dei luoghi preferiti dagli astronauti, davanti alla quale passare il poco tempo libero sulla ISS. Trent’anni dopo, Axiom space, azienda di Houston autorizzata dalla Nasa a costruire la prima stazione spaziale commerciale, chiamò il designer Philippe Stark per progettarne gli interni, mentre le navette private di SpaceX inaugurarono il turismo dei privati nello spazio, portandovi la prima generazione di astronauti non professionisti e non incaricati dai governi: questo, come intuibile, apre le porte di una rivoluzione senza precedenti nell’industria di settore.
Quelle basi marziane e flotte di navi passeggeri che fanno la spola tra la Terra e i corpi celesti del sistema solare immaginate da Von Braun non sono più un sogno lontano: la soglia di una rinnovata era dell’esplorazione spaziale chiama una generazione di professionisti a disegnare le carte nautiche del contemporaneo “passaggio a Nord Ovest”. Tornano le parole che l’astronomo e astrofisico Carl Sagan scrisse in Cosmos: «L’esplorazione è nella nostra natura. Abbiamo iniziato come vagabondi e siamo ancora vagabondi. Siamo rimasti abbastanza a lungo sulle rive dell’oceano cosmico. Siamo finalmente pronti per salpare verso le stelle».
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS". L’alba di una nuova visione del mondo.... Scienza, storia e filosofia: con i "due soli" di Dante, ricordare anche i "due libri" di Galilei (nato il 15 febbraio del 1564).15 febbraio 2021, di Federico La Sala
Tweet
#DANTE2021 A 700 anni dalla #morte di #Dante, ancora non compresi i #due significati (i #duesoli) del "vicisti, #Galilaee". PER #Keplero, come per #Kant, la vittoria di #GalileoGalilei è filosofico-scientifica!
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5061
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5061#Mathematics #anthropology #Theology #philosophy In #memoria di #GalileoGalilei (nato il #15febbraio 1564), ricordare i #duesoli (#Dante2021) e i #duelibri di #Galilei e che il #logos non è un #logo
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1205
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1205FLS
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. -- La congiunzione fra Giove e Saturno e la ’stella’ di Natale: fu Keplero a suggerire che i Magi si siano ispirati ad essa (di Monica Nardone).20 dicembre 2020, di Federico La Sala
Il 21 dicembre il solstizio e la ’stella’ che guido’ i Magi
E’ l’abbraccio tra Giove e Saturno, che saluta l’inverno
di Monica Nardone*
Tripletta di eventi astronomici per il 21 dicembre, con il solstizio d’inverno che è anche il giorno piu’ breve dell’anno e saluta un fenomeno che non si osservava da circa 400 anni: Giove e Saturno vicini come lo sono stati solo nel 1623, quando erano ancora in vita Galileo e Keplero. La congiunzione dei due pianeti e’ stata probamente la ’stella’ di Natale che, secondo il racconto dei Vangeli, avrebbe guidato i Magi.
Il solstizio è previsto alle ore 11,02 italiane e segna l’inizio dell’inverno. In questo giorno "il Sole nel suo movimento apparente lungo l’eclittica, ovvero la proiezione nel cielo dell’orbita della Terra, raggiunge la posizione piu’ a Sud rispetto all’equatore celeste, che e’ la proiezione nel cielo dell’equatore terrestre", spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.
"Questo fa si’ - prosegue - che nel giorno del solstizio invernale l’arco corrispondente al cammino del Sole al di sopra del nostro orizzonte boreale sia il piu’ modesto dell’anno e, di riflesso, ci regala la notte piu’ lunga".
Il solstizio è salutato dalla rara congiunzione tra Giove e Saturno, che sono cosi’ vicini da poter essere osservati insieme nel campo di un telescopio. Naturalmente e’ un avvicinamento apparente, visibile dalla Terra. -Il fenomeno potrebbe essere la stella di Natale dei Vangeli: "nel 7 a.C - ha spiegato Masi - la congiunzione tra i due pianeti e’ avvenuta addirittura tre volte e fu Keplero a suggerire che i Magi si siano ispirati ad essa, anche perche’ la durata della triplice congiunzione richiede mesi e questo e’ compatibile con l’organizzazione di un lungo viaggio, mentre altri fenomeni, come una cometa, hanno una finestra di visibilita’ piu’ modesta".
Nei Vangeli, inoltre, non si parla di cometa ma di stella. A darle la ’veste’ di cometa, ha proseguito, e’ stato Giotto: "affrescando la scena dell’Adorazione dei Magi nella cappella degli Scrovegni, raffiguro’ una bellissima cometa, con grande verosimiglianza perche’ egli stesso aveva visto il passaggio della cometa di Halley e si ispiro’ evidentemente a quella visione".
La congiunzione fra Giove e Saturno è uno spettacolo da non perdere e per osservarlo al meglio Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai) consiglia di "aspettare che il Sole tramonti e guardare in quella direzione.
 Verso le 17,00 si potra’ cominciare a vedere i due pianeti vicinissimi. Il momento clou è previsto tra le 17,30 e le 18,30 del 21 dicembre. E’ importante cercare un luogo con l’orizzonte a Sud.Ovest libero. Il fenomeno e’ visibile a occhio nudo, ma con un piccolo telescopio e’ possibile vedere gli anelli di Saturno e le lune di Giove".
Verso le 17,00 si potra’ cominciare a vedere i due pianeti vicinissimi. Il momento clou è previsto tra le 17,30 e le 18,30 del 21 dicembre. E’ importante cercare un luogo con l’orizzonte a Sud.Ovest libero. Il fenomeno e’ visibile a occhio nudo, ma con un piccolo telescopio e’ possibile vedere gli anelli di Saturno e le lune di Giove".* Fonte: Ansa, 20.12.2020.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS"... L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo. --- Sulla Luna c’è acqua: "Galileo e l’acqua lunare che c’è ma non si vede" (di Flavia Marcacci).4 novembre 2020, di Federico La Sala
Ricerca.
Galileo e l’acqua lunare che c’è ma non si vede
L’astronomo aveva ipotizzato l’assenza di acqua sulla Luna. Oggi il suo metodo è servito a dimostrare il contrario
di Flavia Marcacci (Avvenire, mercoledì 4 novembre 2020)
- [Foto] Galileo Galilei (1564-1642)
Sulla Luna c’è acqua: cosa avrebbe detto Galileo Galilei il 26 ottobre 2020, leggendo questa notizia su “Nature Astronomy”? Notizia riportata in ben due articoli e diffusa dalla Nasa con una certa enfasi, pubblicando i risultati degli studi svolti presso lo Stratospheric observatory for infrared astronomy (Sofia). Sulla superficie lunare illuminata dal Sole c’è acqua, o meglio, ci sono indizi compatibili con la presenza di acqua. I dati sono relativi alla zona del cratere Clavio, uno dei più grandi nell’emisfero meridionale del nostro satellite (quasi 230 km di diametro e 3,5 km di profondità) e rivelano acqua in concentrazioni da 100 a 412 parti per milione (12 once, scrive la Nasa, più o meno una bottiglietta molto piccola) in un volume pari a circa un metro cubo di terreno. Circa un centesimo di quella rintracciabile nelle zone desertiche del Sahara, dunque ben poca, ma in quantità significativa se si pensa che si riteneva che l’acqua potesse essere conservata sotto forma di ghiaccio solo ai poli della Luna.
 L’astrofisico Paul Hayne (Università del Colorado, Boulder) e il suo gruppo hanno tratto analoghe considerazioni dalle immagini della fotocamera e dalle misurazioni termometriche prese dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. Studiando il comportamento delle ombre nei pressi di cavità molto piccole, si è visto che il ghiaccio resterebbe stabile nonostante i picchi di riscaldamento superficiale, a causa dell’aumento esponenziale della sublimazione causata dalle forti escursioni termiche.
L’astrofisico Paul Hayne (Università del Colorado, Boulder) e il suo gruppo hanno tratto analoghe considerazioni dalle immagini della fotocamera e dalle misurazioni termometriche prese dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. Studiando il comportamento delle ombre nei pressi di cavità molto piccole, si è visto che il ghiaccio resterebbe stabile nonostante i picchi di riscaldamento superficiale, a causa dell’aumento esponenziale della sublimazione causata dalle forti escursioni termiche.I risultati sono stati confortanti e il dubbio che le particelle di ossigeno e idrogeno fossero solo ioni di idrossido (OH, una parte di idrogeno e una di ossigeno) sembra fugato. Restano alcune differenze importanti tra i due studi: ad esempio, le riserve di acqua/ghiaccio sono solo locali o no?
 In ogni modo, da quando nel 1969 gli astronauti della missione Apollo 11 attestarono un suolo lunare anidro, a oggi, le cose sono cambiate e c’è chi spera che queste riserve di acqua saranno utili per alimentare sonde. E molto altro.
In ogni modo, da quando nel 1969 gli astronauti della missione Apollo 11 attestarono un suolo lunare anidro, a oggi, le cose sono cambiate e c’è chi spera che queste riserve di acqua saranno utili per alimentare sonde. E molto altro.
 Cosa direbbe, oggi, Galileo? Molto probabilmente non ripeterebbe quanto scrisse a Giacomo Muti (lettera del 28 febbraio 1616, in Edizione nazionale, vol. XII, p. 240): «Non credo che il corpo lunare sia composto di terra e di acqua». -Scriveva così, lo scienziato pisano a Muti, in risposta alle critiche relative alla scoperta delle montuosità della Luna che gli rivolgeva Alessandro Capoano, frequentatore di personaggi di rilievo. Capoano riteneva che la Luna non avesse monti e valli, perché in tal caso ci sarebbero state zone ricche di piante e animali e probabilmente anche esseri razionali superiori, come accade sulla Terra. Ma non essendovi sulla Luna tutto ciò, allora sulla Luna non ci devono essere neanche monti e valli. Non bisogna dimenticare che l’idea della vita fuori dal nostro pianeta poteva infastidire i teologi a quel tempo. Ma l’argomento era troppo debole e Galileo non cadde in inganno. Le conseguenze supposte, per cui la Luna non avrebbe monti e valli, debbono «non solamente non esser necessarie, ma assolutamente false e impossibili».
Cosa direbbe, oggi, Galileo? Molto probabilmente non ripeterebbe quanto scrisse a Giacomo Muti (lettera del 28 febbraio 1616, in Edizione nazionale, vol. XII, p. 240): «Non credo che il corpo lunare sia composto di terra e di acqua». -Scriveva così, lo scienziato pisano a Muti, in risposta alle critiche relative alla scoperta delle montuosità della Luna che gli rivolgeva Alessandro Capoano, frequentatore di personaggi di rilievo. Capoano riteneva che la Luna non avesse monti e valli, perché in tal caso ci sarebbero state zone ricche di piante e animali e probabilmente anche esseri razionali superiori, come accade sulla Terra. Ma non essendovi sulla Luna tutto ciò, allora sulla Luna non ci devono essere neanche monti e valli. Non bisogna dimenticare che l’idea della vita fuori dal nostro pianeta poteva infastidire i teologi a quel tempo. Ma l’argomento era troppo debole e Galileo non cadde in inganno. Le conseguenze supposte, per cui la Luna non avrebbe monti e valli, debbono «non solamente non esser necessarie, ma assolutamente false e impossibili».Da dove gli proveniva tanta certezza per smentire il ragionamento di Capoano? Da un ragionamento basato sulla posizione reciproca di Sole e Luna e sull’evidenza delle fasi. Il Sole, sul suolo lunare, non garantisce la ciclicità di calore e luce necessaria alla vita, come vediamo sulla Terra. Questo era l’unico argomento certo per dire che sulla Luna non c’è vita, per «le vicissitudini, dependenti dall’illuminazion del Sole». E la presenza di acqua? Il cauto Galileo scriveva di non credere che la Luna fosse fatta degli elementi della Terra... ma anche se fosse, anche se acqua e terra potessero mescolarsi, non ci sarebbero luce e calore sufficienti allo sviluppo della vita.
 Sulla presenza dell’acqua il telescopio non poteva rivelargli molto di più e la natura degli elementi lunari restava oggetto di pura speculazione. E tale rimarrà a lungo perché i sensi, anche se potenziati dal telescopio, non davano dati utili. Non c’era la spettrografia a fornire aiuti. Non c’erano le sonde spaziali per raccogliere quantità di materiale lunare da riportare sulla Terra. Non c’erano i dati a infrarosso di Sofia.
Sulla presenza dell’acqua il telescopio non poteva rivelargli molto di più e la natura degli elementi lunari restava oggetto di pura speculazione. E tale rimarrà a lungo perché i sensi, anche se potenziati dal telescopio, non davano dati utili. Non c’era la spettrografia a fornire aiuti. Non c’erano le sonde spaziali per raccogliere quantità di materiale lunare da riportare sulla Terra. Non c’erano i dati a infrarosso di Sofia.
 C’erano però dati a sufficienza per star sicuri dell’esistenza di monti e valli, avendone avuto «sensata esperienza per mezzo del telescopio», come dimostrato nel 1610 nel Sidereus nuncius. Le sensate esperienze sono il punto di partenza, per ottenere certezze e per sviluppare ipotesi.
C’erano però dati a sufficienza per star sicuri dell’esistenza di monti e valli, avendone avuto «sensata esperienza per mezzo del telescopio», come dimostrato nel 1610 nel Sidereus nuncius. Le sensate esperienze sono il punto di partenza, per ottenere certezze e per sviluppare ipotesi.
 Così accade anche oggi. Si osserva, si verifica, si suppone. Guidati da un’ipotesi («So far, evidence for similar ice deposits on the Moon has been inconsistent, despite a strong theoretical basis for their existence...», scrive Hayne), gli astronomi hanno guardato in questo decennio al fondo del suolo lunare ottenendo infine la firma spettrale della molecola d’acqua e convincendosi della presenza di questo elemento. Probabilmente oggi farebbe altrettanto Galileo.
Così accade anche oggi. Si osserva, si verifica, si suppone. Guidati da un’ipotesi («So far, evidence for similar ice deposits on the Moon has been inconsistent, despite a strong theoretical basis for their existence...», scrive Hayne), gli astronomi hanno guardato in questo decennio al fondo del suolo lunare ottenendo infine la firma spettrale della molecola d’acqua e convincendosi della presenza di questo elemento. Probabilmente oggi farebbe altrettanto Galileo. -
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" - Signora dell’anno 2019 è la Luna. Due ricorrenze: i 50 anni dell’Apollo 11 con i 500 anni del genio da Vinci (di Flavia Marcacci)19 novembre 2019, di Federico La Sala
Scienza. La Luna vista da Leonardo
Pochi hanno messo in connessione i 50 anni dell’Apollo 11 con i 500 anni del genio da Vinci che tra i primi studiò e disegnò il fenomeno della ’luce cinerea’
di Flavia Marcacci (Avvenire, martedì 19 novembre 2019)
Signora dell’anno 2019 è la Luna: si celebrano i 50 anni della conquista del suo suolo. Eventi e pubblicazioni si stanno succedendo rapidamente, ricordando quanto avvenne in quel frenetico 1969, che tra la protesta di Jan Palach e la nascita del progenitore di Internet Arpanet fu fitto di molti fatti decisivi per la grande e piccola storia. Eppure, il 20 luglio i passi silenziosi di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna ebbero il potere di fermare ogni altro vocio e ogni altra preoccupazione.
Il potere di vedere (video) a distanza (tele) promesso dallo strumento che stava cambiando la società, la televisione, giungeva a un impensabile lontano: la potenza della tecnica veniva consacrata, quasi riscattando i timori che era andata suscitando dopo l’esperienza atomica.
 La nostra Terra deve molto alla Luna, e non a caso essa è stata nei secoli un oggetto privilegiato per la scienza, la filosofia e l’arte. Il nostro satellite è stato il più vicino tra gli oggetti lontanissimi, la porta d’accesso al cielo deputato invalicabile e tramite esso finalmente accessibile. La luna fu scrutata da Leonardo da Vinci (1452-1519), altro protagonista del 2019, poiché del genio toscano ricorrono i 500 anni dalla morte. Pochi hanno notato la convergenza tra le due ricorrenze.
La nostra Terra deve molto alla Luna, e non a caso essa è stata nei secoli un oggetto privilegiato per la scienza, la filosofia e l’arte. Il nostro satellite è stato il più vicino tra gli oggetti lontanissimi, la porta d’accesso al cielo deputato invalicabile e tramite esso finalmente accessibile. La luna fu scrutata da Leonardo da Vinci (1452-1519), altro protagonista del 2019, poiché del genio toscano ricorrono i 500 anni dalla morte. Pochi hanno notato la convergenza tra le due ricorrenze.Leonardo aveva disegnato il satellite terrestre, dando nota del fenomeno della ’luce cinerea’ nel Codice Leicester (foglio 2 r), come ricordava fin dagli anni Settanta il noto studioso Carlo Pedretti (1928-2018). Il fenomeno si osserva tra novilunio e prima fase e nell’ultima fase: può capitare così che la luce del Sole venga riflessa dalla Terra e vada a illuminare una piccola porzione in ombra del satellite, in modo da renderlo visibile anche all’alba. Per lo stesso fenomeno, Armstrong e Aldrin dalla Luna avrebbero potuto osservare un bel ’chiaro di Terra’, con il nostro pianeta stabile nel cielo lunare (altezza in dipendenza dalla latitudine).
A completare la spiegazione della luce cinerea fu Galileo Galilei, chiamandola anche «candore lunare» a intendere le sfumature grigiastre, talvolta tendenti al verde o all’azzurro e capaci di conferire una leggerezza impercettibile al corpo celeste. Il Pisano diede alla Luna l’altro grande merito di segnare l’inizio dell’astronomia in senso moderno (ovvero usando strumenti), quando con il ’perspicillo’ (il telescopio, da perspicio, guardare in profondità) ne scoprì cavità e valli nel 1609 poi riprodotte nei famosi disegni pubblicati nel Sidereus nuncius (1610): da allora in poi, la scienza non sarebbe più tornata indietro.
 Si avviò così la pratica di descrivere la Luna: la selenografia vantò tra i suoi adepti molti italiani, che raramente trovano un posto nelle storie italiane della scienza destinate al grande pubblico. Solo dopo Galileo il noto gesuita Cristoph Scheiner, docente a Roma tra il 1624 e il 1633, propose una delle prime mappe lunari (1614); dopo di lui fu la volta del confratello Giuseppe Biancani (1620).
Si avviò così la pratica di descrivere la Luna: la selenografia vantò tra i suoi adepti molti italiani, che raramente trovano un posto nelle storie italiane della scienza destinate al grande pubblico. Solo dopo Galileo il noto gesuita Cristoph Scheiner, docente a Roma tra il 1624 e il 1633, propose una delle prime mappe lunari (1614); dopo di lui fu la volta del confratello Giuseppe Biancani (1620).Furono però soprattutto il bolognese Francesco Maria Grimaldi e il ferrarese Giovanni Battista Riccioli, entrambi ancora gesuiti, ad avere il merito di produrre gran parte della nomenclatura lunare che usiamo tutt’oggi. Il loro lavoro fu pubblicato nell’Almagestum novum ( 1651) e si dice che fu merito essenzialmente di Grimaldi, il quale compì la maggior parte delle osservazioni. I diritti d’autore sono però difficili da stabilire, essendo i due strettissimi collaboratori e Grimaldi una sorta di allievo di Riccioli. Ciò che conta è che sul suolo lunare essi impressero nomi celebri, molti dei quali già adoperati poco tempo prima dagli astronomi Michael F. van Langren e Johannes Hevelius (Jan Heweliusz): i due studiosi italiani ripresero le prime nomenclature per renderle più sistematiche e razionali. I crateri, le terre e i mari lunari furono battezzati con il nome di personaggi antichi, nell’emisfero nord, e moderni, nell’emisfero sud.
 Per questo motivo oggi sulle mappe lunari troviamo memoria di astronomi (da Tolomeo e Ipparco a Copernico e Biancani), di santi e sante (da san Teofilo e san Cirillo a santa Caterina da Siena), di filosofi (da Anassimandro a Platone).
Per questo motivo oggi sulle mappe lunari troviamo memoria di astronomi (da Tolomeo e Ipparco a Copernico e Biancani), di santi e sante (da san Teofilo e san Cirillo a santa Caterina da Siena), di filosofi (da Anassimandro a Platone).Guardare alla luna, però, non era utile solo per descriverla. Si cercava di comprendere la natura dei cieli (cf. La Lune aux XVIIe et XVIIIe siècles, edited by C. Grell and S. Taussig, Brepols, Turnhout, 2013). Nel Seicento alcuni pensavano, ad esempio, che il termine ’luna’ derivasse da lucuna (lux, luce e una, una) a intendere che la Luna fosse l’unica a essere sempre illuminata dal Sole. La Luna aveva anche un ruolo sociale rilevante, perché i suoi ritmi mensili andavano calcolati insieme a quelli del Sole per ottenere il calendario: fu proprio la sfasatura tra essi che portò alla grande riforma di papa Gregorio XIII.
Oltre alla cosmologia e alla scienza calendrica, il satellite della Terra stimolava anche il mito e la poesia. Gli appellativi del nostro satellite erano così tanti che è difficile elencarli: dal greco Selene a indicarne lo splendore, all’ebraico Lebana a richiamarne la bianchezza; da Artemide, Selene ed Ecate, dee che custodivano il grembo del corpo celeste nelle sue varie fasi, fino alla dea ’triforme’ citata da Cleomede e Virgilio.
La Luna non andava soltanto descritta, ma scritta. La ricchezza delle fantasie lunari di Luciano di Samosata (II sec. d.C.) ebbe una certa fortuna in epoca rinascimentale, probabilmente avvantaggiata dalla diffusione del fascino per i mirabilia e i fatti immaginati e prodigiosi: l’Icaromenippo proponeva il viaggio di Menippo sulla Luna, per giungere da lì fino alla casa degli dei. Su tutti non si può evitare di pensare all’Astolfo sulla Luna di Ludovico Ariosto, fino alle ipotesi di John Wilkins protese all’eventualità di abitanti sulla Luna (The discovery of a world in the moone, 1638).
La Luna era in grado di evocare fantasie, sentimenti ed emozioni, attingendo da ciò che nell’essere umano vi è di più profondo. Probabilmente ne tennero conto coloro che volevano solo descriverla fino a intravedere sul suo suolo i luoghi esistenziali della crisi, della siccità, della tranquillità, della serenità e della fecondità. Per questo nelle sue regioni si trovano la ’Terra della sterilità’ e la ’Terra della Vita’, il ’Mare della Crisi’ e il ’Mare della Tranquillità’.
Dai tempi di Leonardo e della selenografia torniamo così ai nostri tempi. Proprio il Mare della Tranquillità divenne famoso cinquant’anni fa, quando allunarono nei suoi pressi gli uomini della Missione Apollo 11. La Luna, lontana, scrutata, sognata era stata raggiunta. Il satellite forniva all’umanità l’ennesimo servizio, facendosi solcare da da orme umane sui luoghi della Tranquillità, forse proprio quelli a cui ambisce più profondamente ogni anima e dove la scienza dovrebbe contribuire ad avvicinarsi.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" -- Sulla luna per ritrovare il senno perduto d’Orlando. Nel cuore del metodo galileiano c’è la poesia dell’Ariosto (di M. Mandelli).24 luglio 2019, di Federico La Sala
Nel cuore del metodo galileiano c’è la poesia dell’Ariosto
di Massimo Mandelli *
È risaputo che Galileo Galilei ebbe una convinta predilezione per la poesia di Ludovico Ariosto, autore del poema Orlando Furioso, che si manifestò anche, per prova contraria, nella partigiana e poco generosa critica all’arte poetica del suo ‘rivale’ (perlomeno come tale fu percepito dai contemporanei) Torquato Tasso, autore della Gerusalemme liberata. Non per nulla delle ottave ariostesche si ricordò Bonaventura Cavalieri allorché poté finalmente leggere un esemplare fresco di stampa del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo che Galilei, dopo un accidentato percorso, aveva editato nel 1632, esattamente cento anni dopo la definitiva edizione (la terza) dell’Orlando Furioso.
Così il geniale pensatore della Geometria degli indivisibili partecipava al Maestro le sue fresche impressioni di lettura:
- Lo viddi, anzi lo devorai, per dir così con li occhi: et invero sento in me, in più volte ch’ho ripreso la lettura di quello, l’effetto che mi ricordo avere esperimentato nel leggere il Furioso, che dovunque io dia principio a leggere, non posso ritrovarne il fine (Lettera del 22 marzo 1632).
Non era osservazione da poco, visto che si rilevava l’inaudita forma di un trattato scientifico che non aveva una struttura lineare, tutta protesa a una logica dimostrativa, bensì una struttura circolare, quale quella complessa del poema ariostesco, basato com’era sulla presenza di più personaggi e più azioni che si intersecano e divergono fra loro condizionandosi e definendosi a vicenda.
L’aura ariostesca, messa in luce da Cavalieri, fu certamente il frutto di una consapevole scelta di Galilei, giustificata, tra l’altro, dalla sua convenienza con l’intento anche divulgativo dell’opera, unitamente alla necessità di ‘leggerezza’ argomentativa finalizzata ad aggirare i divieti della censura ecclesiastica.
Ma, detto ciò, solitamente si tralascia di aggiungere che una forma così inconsueta, adottata per trattare addirittura della costituzione dell’universo, doveva avere una sua più radicale ragione di coerenza intesa come necessaria inerenza al contenuto da esprimere e cioè al problema sostanziale ch’era in campo: quello che ricorda Erwin Panofsky, in Galileo critico delle arti, quando scrive della concezione della circolarità quale paradigma della cultura e delle arti rinascimentali, capace di meglio rappresentare la realtà nella sua caotica complessità e nel suo desiderio di ordine.
Il poema di Ariosto in questo è esemplare: come ogni circonferenza che si rispetti non comincia e non finisce; esso racchiude la complessità, ma pare non esaurirne mai la sovrabbondanza. Perciò un senso di precario equilibrio e di estraneità della materia pervade il poema: è la datità della realtà che urge e preme e che si può solo osservare, descrivere, interpretare, ma non possedere. La poesia per Ariosto non comprende il mondo, non lo riflette come fosse uno specchio, essa piuttosto è l’espressione del paradosso che per poter riprodurre in modo oggettivo la realtà occorre un soggetto che la osservi, che ne parli, che la canti facendosi carico di essa ed anche della sua impossibile estraneità.
Così, liberatosi dalla costrizione di essere scimmia della datità, e dal gravoso dovere di imprigionarla nel proprio io speculare, prende agio l’immaginazione quale facoltà di inchiesta e conoscenza del reale, di cui indaga le possibilità, lasciando che le finzioni dicano, se le possiedono, le loro verità.
Galilei non ha mai scritto un trattato sul metodo e forse, accanto ad altre motivazioni, se ne sentiva esonerato perché conosceva a memoria le ottave del Furioso, dalle quali poteva ben ricavare il metodo ipotetico-sperimentale: quello che getta sulla realtà libere ipotesi immaginative dal sapore dell’irreale, quali quella che un pezzo di piombo cade verso terra con la stessa velocità di una piuma, o quella di una terra così grave che gira a pazza velocità per l’universo, o, ancora, quella di un linguaggio matematico-quantitativo che certamente nulla aveva in comune con le sensazioni percettive.
Tutto ciò era possibile e sensato perché v’era nella poesia ariostesca l’avverbio ‘forse’, fonte della sua geniale ironia e segno di rinuncia ad un punto di vista onnisciente, ad una presunzione di specularità che avrebbe depotenziato qualsiasi evasione immaginativa. Un ‘forse’, dunque, che non solo rimandava alla umile necessità dell’osservazione diretta (sperimentale), ma anche alla consapevolezza del limite dell’umano, della relatività del suo sguardo e all’inesauribile gioco interpretativo fra finzione e verità che diede inizio alla età moderna.
Galilei immaginò, in un esperimento ideale nella cabina di una nave, descritto nel suo Dialogo, la concreta situazione in cui si esprimeva il fondamentale principio della relatività dei moti e la sua descrizione letteraria ha la stessa ‘illusione’ realistica, nella nettezza del disegno e nella attenzione ai particolari, che hanno i versi di Ariosto, il quale si avvaleva solitamente di tale accorgimento per rendere verosimile l’inverosimile. Cosicché nella pittura poetica e letteraria, la logica della rappresentazione veniva a coincidere con quella della realtà (l’esperimento ideale ‘era come’, stava ‘al posto di’) e i loro limiti apparvero, a priori, impossibili da stabilire.
Un problema filosofico, questo, che nella sua fondante interrogazione si ritrova in primo piano nelle riflessioni novecentesche, non per nulla inaugurate dal Tractatus logico-philosophicus di Ludwig Wittgenstein, il quale, detto in sintesi, affermerà che la ‘mondità’ del mondo è semplicemente e solamente la sua traducibilità. Forse fu proprio questa traduzione dai versi ariosteschi in un nuovo e più potente linguaggio conoscitivo ciò che frullò per il capo a Galilei sul finire del 1609, quando puntò il suo cannocchiale nella tersa notte di Padova verso la luna e vide lo stesso astro descritto quasi un secolo prima dal suo poeta. Egli nella meraviglia della scoperta prese quindi su di sé la missione che un tempo fu del paladino Astolfo: il quale s’era recato sulla luna per ritrovare il senno perduto d’Orlando; Galilei vi andò per riportare sulla terra il senno perduto dall’umanità.
- Bibliografia
 Galileo Galilei, Scritti letterari, a cura di Alberto Chiara, Le Monnier, Firenze 1943.
Galileo Galilei, Scritti letterari, a cura di Alberto Chiara, Le Monnier, Firenze 1943.
 Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano, edizione critica a cura di Ottavio Besomi e Mario Helbing, 2 voll., Editrice Antenore, Padova 1998.
Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano, edizione critica a cura di Ottavio Besomi e Mario Helbing, 2 voll., Editrice Antenore, Padova 1998.
 Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, prefazione e note di Lanfranco Caretti, Einaudi, Torino 1966.
Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, prefazione e note di Lanfranco Caretti, Einaudi, Torino 1966.
 Erwin Panofsky, Galileo critico delle arti, Cluva, Venezia 1985.
Erwin Panofsky, Galileo critico delle arti, Cluva, Venezia 1985.
 Michele Camerota, Galileo Galilei e la cultura scientifica nell’età della controriforma, Salerno editrice, Roma 2004. -Michele Catalano, Vita di Ludovico Ariosto, L.S. Olschki, Ginevra 1930-31.
Michele Camerota, Galileo Galilei e la cultura scientifica nell’età della controriforma, Salerno editrice, Roma 2004. -Michele Catalano, Vita di Ludovico Ariosto, L.S. Olschki, Ginevra 1930-31.
 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Einaudi, Torino 1964.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Einaudi, Torino 1964.* Cfr.: "Filosofia Blog" - http://www.filosofiablog.it/filosofia-moderna/nel-cuore-del-metodo-galileiano-ce-la-poesia-dellariosto/.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. -- STORIA DELLA SCIENZA E SCIENZA DELLA STORIA. "Al CNR la storia è una scienza?" Note a margine.6 giugno 2019, di Federico La Sala
PER UN NUOVO CNR ....
NOTE A MARGINE DELLA LETTERA "Al CNR la storia è una scienza? Una risposta all’intervento di Gilberto Corbellini"
- Recensendo un volume dell’epistemologo statunitense Alex Rosenberg, in un articolo dal titolo Questa storia è davvero molto falsa apparso sul supplemento domenicale del “Sole - 24 ore” il 12 maggio scorso, il professor Gilberto Corbellini ne ha preso spunto per asserire, in polemica con un recente appello in difesa dell’insegnamento della storia, l’assenza di scientificità e di utilità sociale della disciplina stessa. [...] (ALFABETA-2, 26 MAGGIO 2019)
1. PER LA STORIA DELLLA SCIENZA E PER LA SCIENZA DELLA STORIA, FORSE, E’ MEGLIO RI-DISCENDERE “SOTTO COVERTA DI ALCUN GRAN NAVILIO” E RIPRENDERE IL LAVORO GALILEANO DELLA CONVERSAZIONE E DELLA CONOSCENZA 29 Maggio 2019 :
- «Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. (..)
 Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.» (Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”, 1632 - Salviati, giornata II)
Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.» (Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”, 1632 - Salviati, giornata II)
2. STORIA, SCIENZA, ED ECLISSI. Da Galileo Galilei ad Albert Einstein 30 maggio 2019...
Al di là delle pretese “mitideologiche” (atee e devote) del “post-positivismo” contemporaneo (Paolo Fabbri) di dare il via a un’ epoca in cui la storia del mondo dev’essere riscritta secondo l’indicazione rosenberghiana!), ricordiamo che il 29 maggio 1919 Arthur Eddington provò sperimentalmente la teoria della relatività (cfr. : Franco Gabici, “Cento anni fa l’eclissi che diede ragione a Einstein” - https://www.avvenire.it/agora/pagine/cento-anni-fa-leclissi-che-diede-ragione-a-einstein). Buon lavoro!
3. COSTITUZIONE E CNR. UN PROBLEMA STORIOGRAFICO (SCIENTIFICO) DI LUNGA DURATA 31 Maggio 2019...
CONDIVIDO LA PREOCCUPAZIONE E, AL CONTEMPO, LA CONSAPEVOLEZZA dei firmatari della lettera. La “provocazione” - da parte di chi dirige il Dipartimento del CNR, “al cui interno operano decine di storici, storici della filosofia, giuristi e altri ricercatori nel campo delle scienze umane e sociali” - evidenzia il sintomo non tanto e non solo “di un profondo problema culturale e scientifico”, ma anche e soprattutto di un problema politico-filosofico (metafisico), costituzionale, di CRITICA della “ragion pura” (di questo parla il “principio della relatività galileiana”, condensato nel “Rinserratevi” del “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”)!,
DOPO GALILEI, DOPO KANT, DOPO EINSTEIN, DOPO LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA... UNA “PROVOCAZIONE” al CNR DA ACCOGLIERE!
Strana “coincidenza”, oggi!:
- A) Il 9 Aprile 2019, in una nota (dal titolo
“CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. A che gioco giochiamo?!: https://www.alfabeta2.it/2019/03/31/marcel-detienne-memorie-felici-e-concetti-indelebili/#comment-639227), così scrivevo:
 “La totale incomprensione del “relazionismo” proposto da Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius (e non solo!) di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790)”.
“La totale incomprensione del “relazionismo” proposto da Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius (e non solo!) di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790)”.
- B) Il 12 maggio 2019, “recensendo un volume - come scrivono gli studiosi e le studiose del CNR - dell’epistemologo statunitense Alex Rosenberg, in un articolo dal titolo Questa storia è davvero molto falsa apparso sul supplemento domenicale del “Sole - 24 ore” il 12 maggio scorso, il professor Gilberto Corbellini ne ha preso spunto per asserire, in polemica con un recente appello in difesa dell’insegnamento della storia, l’assenza di scientificità e di utilità sociale della disciplina stessa”.
Prima che sia troppo tardi, che fare?! Alle studiose e alle studiose di scienze umane e sociali (del CNR e non solo), consiglierei (mi sia permesso) la ri-lettura del “Dialogo sopra i due massimi sistemi iolemaico e copernicano” di Galileo Galilei, la ri-lettura dei “Sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica” di Immanuel Kant, e, infine, la rilettura dei “Principi” della Costituzione della Repubblica Italiana - e, alla luce della “ferocissima” provocazione, ri-prendere il lavoro storiografico-scientifico con più grande entusiamo e responsabilità di prima!
VIVA IL CNR,
VIVA L’ITALIA!
4. PER UN NUOVO CNR! ALL’INSEGNA DI ERMES: “IO VORREI PENSARE CON IL CERVELLO INTERO”. IN MEMORIA DI ENRICO FILIPPINI E DI MICHEL SERRES 3 Giugno 2019 ...
“[...] all’insegna di Ermes, che per me è il simbolo della scienza contemporanea”.
 In che senso? “Nel senso che Mercurio, a cui ho dedicato ben cinque libri, è il dio della comunicazione. A differenza di quanto pensavano i marxisti, io ritenevo che il problema della comunicazione fosse più importante di quello della produzione, e che l’ economia stessa fosse più una questione di comunicazione che di produzione. Sono fiero di quell’ assunto, mi scusi la superbia: infatti, i paesi che hanno scommesso in questo senso, per esempio il Giappone, hanno evitato la crisi”.
In che senso? “Nel senso che Mercurio, a cui ho dedicato ben cinque libri, è il dio della comunicazione. A differenza di quanto pensavano i marxisti, io ritenevo che il problema della comunicazione fosse più importante di quello della produzione, e che l’ economia stessa fosse più una questione di comunicazione che di produzione. Sono fiero di quell’ assunto, mi scusi la superbia: infatti, i paesi che hanno scommesso in questo senso, per esempio il Giappone, hanno evitato la crisi”.
 Ma comunicazione che vuol dire? “All’ inizio, all’ epoca dello strutturalismo, davo del termine “struttura” un’ interpretazione algebrica, esatta. Poi, studiando il XIX secolo, la fisica ottocentesca, e cioè essenzialmente la termodinamica, finii per attribuire un ruolo centrale alla teoria dell’ informazione. In fondo, se del mio lavoro dovessi tracciare un profilo, ecco: per tutta la vita ho cercato di tenermi al corrente, da filosofo, del sapere scientifico (il che in Francia ø raro), e insieme di non dimenticare la tradizione letteraria: ho scritto su Zola e su Jules Verne. Ecco, ho cercato di tenere unite, con le due mani, la scienza e la letteratura, di passare dall’ una all’ altra. E’ quello che chiamo, nel quinto volume dedicato a Mercurio, il Passaggio a Nord-Ovest: passaggio difficile, pericoloso, tempestoso, ma passaggio. Per me la filosofia è questa alleanza. In Italia ciò dovrebbe essere comprensibile”.
Ma comunicazione che vuol dire? “All’ inizio, all’ epoca dello strutturalismo, davo del termine “struttura” un’ interpretazione algebrica, esatta. Poi, studiando il XIX secolo, la fisica ottocentesca, e cioè essenzialmente la termodinamica, finii per attribuire un ruolo centrale alla teoria dell’ informazione. In fondo, se del mio lavoro dovessi tracciare un profilo, ecco: per tutta la vita ho cercato di tenermi al corrente, da filosofo, del sapere scientifico (il che in Francia ø raro), e insieme di non dimenticare la tradizione letteraria: ho scritto su Zola e su Jules Verne. Ecco, ho cercato di tenere unite, con le due mani, la scienza e la letteratura, di passare dall’ una all’ altra. E’ quello che chiamo, nel quinto volume dedicato a Mercurio, il Passaggio a Nord-Ovest: passaggio difficile, pericoloso, tempestoso, ma passaggio. Per me la filosofia è questa alleanza. In Italia ciò dovrebbe essere comprensibile”.
 In Italia c’ è stata una forte tradizione idealista e marxista. L’ interesse per la scienza tende a diventare scientismo. “Come nel mondo anglosassone. Ma il fatto è che nella letteratura c’ è spesso più rigore che nella scienza. In Tito Livio c’ è più epistemologia che in Popper. Il mio sogno è di scrivere un’ opera che compia la riconciliazione enciclopedica, proprio alla maniera di Diderot e di D’ Alembert, ma non solo nel senso storico (per cui si pensa sempre soltanto nel solco della propria tradizione), anche nel senso del concetto: quello è il campo che si percorre e che si deve percorrere. La filosofia ha perduto troppo non sapendo nulla di scienza, ma oggi che ne sa qualcosa, ha perduto la dimensione culturale. E’ come un cervello tagliato in due. Io vorrei pensare col cervello intero”.
In Italia c’ è stata una forte tradizione idealista e marxista. L’ interesse per la scienza tende a diventare scientismo. “Come nel mondo anglosassone. Ma il fatto è che nella letteratura c’ è spesso più rigore che nella scienza. In Tito Livio c’ è più epistemologia che in Popper. Il mio sogno è di scrivere un’ opera che compia la riconciliazione enciclopedica, proprio alla maniera di Diderot e di D’ Alembert, ma non solo nel senso storico (per cui si pensa sempre soltanto nel solco della propria tradizione), anche nel senso del concetto: quello è il campo che si percorre e che si deve percorrere. La filosofia ha perduto troppo non sapendo nulla di scienza, ma oggi che ne sa qualcosa, ha perduto la dimensione culturale. E’ come un cervello tagliato in due. Io vorrei pensare col cervello intero”.
 Ora sta scrivendo qualche cosa? “Un libro sui cinque sensi, e, appunto, in una forma letteraria, anche se sono partito da un sistema rigorosamente formale. E’ un tentativo di alleanza tra le due forme di sapere, è anche il tentativo di ritrovare, come diceva Edmund Husserl, le radici profonde della cultura europea. Lei conosce La crisi delle scienze europee?”.
Ora sta scrivendo qualche cosa? “Un libro sui cinque sensi, e, appunto, in una forma letteraria, anche se sono partito da un sistema rigorosamente formale. E’ un tentativo di alleanza tra le due forme di sapere, è anche il tentativo di ritrovare, come diceva Edmund Husserl, le radici profonde della cultura europea. Lei conosce La crisi delle scienze europee?”.
 L’ ho tradotta in italiano da studente. Ma Husserl parlava appunto di “crisi” di quell’ idea e di quella tradizione. C’ è il problema della tecnicizzazione della scienza. E poi c’ è la difficoltà della estrema specializzazione dei settori scientifici [...]
L’ ho tradotta in italiano da studente. Ma Husserl parlava appunto di “crisi” di quell’ idea e di quella tradizione. C’ è il problema della tecnicizzazione della scienza. E poi c’ è la difficoltà della estrema specializzazione dei settori scientifici [...]
 (cfr. ENRICO FILIPPINI, “Il mio amico Mercurio”, “la Repubblica”, 15 giugno 1984: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/06/15/il-mio-amico-mercurio.html).
(cfr. ENRICO FILIPPINI, “Il mio amico Mercurio”, “la Repubblica”, 15 giugno 1984: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/06/15/il-mio-amico-mercurio.html).5. STORIA E SCIENZA: “VICISTI, GALILAEE” (KEPLERO, 1611) 5 Giugno 2019.
La rotazione della Terra rimescola le acque del lago di Garda ... http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/terra_poli/2019/06/05/la-rotazione-della-terra-rimescola-le-acque-del-lago-di-garda-_8cbe9d78-1459-4088-a0a4-12016cd675b9.html.
Federico La Sala
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS". L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei --- LA TERRA VISTA DALLA LUNA. I compiti delle Nazioni (di Roberto Mussapi).9 febbraio 2019, di Federico La Sala
PIANETA TERRA. LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE, E LA LEZIONE DI NIETZSCHE.... *
- "Oriente e Occidente - scrive Nietzsche in Schopenhauer come educatore - sono tratti di gesso che qualcuno disegna davanti ai nostri occhi per beffarsi della nostra pavidità".
- La Terra vista dalla Luna: "Se il programma spaziale non avesse dato alcun frutto (e spesso io faccio mólta fatica a discernere che cosa ci abbia dato), gli dobbiamo essere grati per aver prodotto tale fotografia" (M. Konner, L’ala impigliata. I condizionamenti bilogici dello spirito umano, Milano, Feltrinelli, 1984).
I compiti delle Nazioni
di Roberto Mussapi (Avvenire, sabato 9 febbraio 2019)
«Spesso si è discussa l’utilità delle spedizioni polari. Se si considera solo il vantaggio morale che si ricava da tali spedizioni, io lo credo sufficiente a compensare i sacrifici che per esse si fanno. Come gli uomini, che nelle lotte quotidiane, col superare le difficoltà, si sentono più forti per affrontarne delle maggiori, così è delle Nazioni, che dai successi riportati dai propri figli si devono sentire maggiormente incoraggiate e spinte a perseverare nei loro sforzi per la propria grandezza e prosperità».
Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, tra il 1899 e il 1900 guida una spedizione, Stella Polare, con lo scopo di portarsi con una nave lungo una terra il più a settentrione possibile, e dal sito di sverno procedere con le slitte verso il Polo. La meta non fu raggiunta, ma lo scopo fu conseguito. Lo scopo della sua e di ogni altra spedizione, scrive Amedeo di Savoia, è di offrire un conforto e un modello all’uomo che nelle sue «lotte quotidiane», col superare le difficoltà si sente più forte per affrontarne altre maggiori. Così devono fare le Nazioni, «che dai successi riportati ai propri figli si devono sentire maggiormente incoraggiate.» Figli non mandati in guerra, ma all’avventura della conoscenza del mondo.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo.
PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986). Tracce per una svolta antropologica
 OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE.
OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE.Federico La Sala
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. -- IL “CIMENTO” DELL’ACCADEMIA GALILEIANA E LA “PIETRA” DEI FILOSOFI. «La farfalla e la crisalide» (Edoardo Boncinelli).26 ottobre 2018, di Federico La Sala
Conoscenza. Il saggio di Edoardo Boncinelli
E la scienza divenne sperimentale
L’approccio soltanto speculativo ha grossi limiti che molti filosofi non riconoscono
La ricostruzione dello scienziato nel saggio «La farfalla e la crisalide» (Raffaello Cortina)
di Stefano Gattei (Corriere della Sera, 26.10.2018)
Che cos’è la scienza? E che cosa la distingue dalle altre discipline? La domanda ha impegnato i filosofi per secoli. Se la pone ora, nel libro La farfalla e la crisalide (Raffaello Cortina), un grande scienziato, Edoardo Boncinelli, autore di importanti scoperte in campo genetico.
Il saggio ripercorre per importanti snodi concettuali la storia della scienza, dalla sua nascita nella Grecia di 2.500 anni fa, quando l’indagine della realtà era ancora difficilmente distinguibile dalla riflessione filosofica, al presente, nel quale scienza e filosofia appaiono del tutto separate, incommensurabili per capacità di analisi e significatività dei risultati. La farfalla - questa la metafora scelta dall’autore - è la scienza così come la conosciamo oggi: nasce dalla crisalide della filosofia, un intreccio di modi di pensare spesso in competizione fra loro, ma capaci di influenzare profondamente la nostra vita. Poco più di quattro secoli fa, la scienza si svincola dal ruolo ancillare nei confronti della filosofia, sviluppandosi autonomamente e ramificandosi gradualmente in una serie di discipline che, dalla fisica alla biologia all’intelligenza artificiale, hanno sostituito la filosofia come strumento di conoscenza del mondo. Con Galileo, tra scienza e filosofia si apre un baratro che oggi forse non vale neppure la pena di provare a colmare.
All’inizio, con i Presocratici, la filosofia avanza ipotesi sul mondo. Nasce libera, svincolata da ogni verità rivelata. La messa a morte di Socrate, «corruttore» dei giovani ateniesi con la critica implacabile della religiosità che la società si attende da loro, inaugura paradossalmente la grande stagione del pensiero greco. Consapevole dell’importanza della tecnica, la riflessione classica accompagna l’osservazione del mondo (culminata nei trattati naturalistici di Aristotele) all’indagine ipotetico-deduttiva, che si sviluppa senza bisogno di conferme sperimentali. Gli enormi successi della geometria euclidea e dell’astronomia matematica convincono però i filosofi che la verità sia raggiungibile per via puramente speculativa. Così, pur rimanendo sostanzialmente indistinguibili, scienza e filosofia iniziano a perdere contatto. Un ruolo non secondario nella separazione è svolto da Platone, sostenitore di una teoria della conoscenza «innatista» dall’indiscutibile sapore biologico, che Boncinelli apprezza, ma che inchioda l’uomo alla sterile fissità di un mondo delle idee sempre uguale a sé stesso. Se però Platone non poteva conoscere l’evoluzione, non così i molti filosofi che oggi a lui direttamente si rifanno, e che ignorano l’impatto rivoluzionario del cambiamento che si impone di continuo in biologia.
Una discussione serrata e tranchant, che non risparmia neppure Cartesio, porta il lettore al Seicento, quando dalla crisalide della filosofia occidentale si libera finalmente la farfalla della scienza sperimentale. Se, fino ad allora, scienziati e filosofi si erano limitati a porsi domande e a tentare di dare risposte attraverso l’osservazione, con la possibilità e l’opportunità di condurre esperimenti, lo scienziato «costringe» la natura a rispondere a domande specifiche. Mentre l’osservazione si limita a registrare ciò che accade, lo sperimentatore svolge un ruolo attivo, preparando le condizioni per portare la natura stessa su un terreno a noi favorevole. L’adozione del metodo sperimentale, spesso accompagnato da un’analisi quantitativa, è per Boncinelli un rivoluzionario atto di umiltà: segna il riconoscimento che per certi problemi l’approccio speculativo non è sufficiente - riconoscimento, questo, che l’autore non manca di contestare come estraneo a molti filosofi di ieri e di oggi.
Con l’Accademia del Cimento e il suo motto, «provando e riprovando», inizia la stagione della grande scienza, che giunge fino a noi. Ma non si chiude la stagione della filosofia, che pure arriva fino a noi, ignorando però (o fingendo di ignorare) l’abisso che la separa dalla scienza. Né, forse, può essere altrimenti: la crisalide è fondamentale per la nascita della farfalla, ma appena questa nasce le due strutture biologiche si devono separare una volta per tutte, perché la presenza della crisalide si rivelerebbe ora tossica per l’insetto alato. Fuor di metafora, la filosofia è stata fondamentale per la nascita del pensiero scientifico, ma col passare del tempo ha avuto un’influenza sempre più negativa, come una sorta di a priori indiscusso che ha finito per ostacolare il progresso scientifico.
L’analisi di Boncinelli è spietata. E senza dubbio corretta, anche se a volte scivola in qualche semplificazione eccessiva. Ma questo nulla toglie alla tesi generale di La farfalla e la crisalide, che interroga e sfida gli studiosi: un libro utile agli scienziati, che dalla riflessione dell’autore possono trarre spunti per meditare sul significato e sulla portata della propria disciplina, e necessario ai filosofi, per considerare i limiti della propria attività e i modi per ripensarla.
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
IL “CIMENTO” DELL’ACCADEMIA GALILEIANA E LA “PIETRA” DEI FILOSOFI: “PROVANDO E RIPROVANDO”!
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS"L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo. --- Fede e numeri: il metodo di Newton laico devoto, La tesi di Iliffe.12 agosto 2018, di Federico La Sala
RIVOLUZIONE SCIENTIFICA, STORIOGRAFIA, E DEMOCRAZIA. LA VITTORIA DI GALILEO NON SOLO E’ SCIENTIFICA, MA è ANCHE VITTORIA TEOLOGICA E POLITICA....*
La tesi di Iliffe
Fede e numeri: il metodo di Newton laico devoto
di Stefano Gattei (Corriere della Sera, La Lettura, 12.08.2018)
Che Isaac Newton (1642-1727) fosse profondamente religioso è noto. Che avesse studiato alchimia, teologia e le profezie bibliche, e che avesse approfondito la cronologia antica, non lo è altrettanto, anche se gli studiosi lo considerano ormai un dato acquisito («la Lettura» #69 ne scrisse il 10 marzo 2013). Per anni, tuttavia, gli ammiratori dei Principia mathematica o dei lavori sul calcolo infinitesimale hanno faticato a riconciliare ambiti di ricerca così apparentemente lontani, tanto che non pochi studiosi hanno avanzato l’ipotesi che gli interessi religiosi e pseudoscientifici del grande scienziato (molti dei quali affidati a manoscritti pubblicati dopo la morte) risalissero agli ultimi anni della sua vita, costituendo quindi un sorta di prodotto «senile» del genio.
Nel suo ultimo studio sullo scienziato inglese (Priest of Nature: The Religious Worlds of Isaac Newton, Oxford University Press, 2017) Rob Iliffe mostra l’infondatezza di tale lettura. Professore a Oxford, e direttore del Newton Project, Iliffe prende ferma posizione contro quanti hanno inteso sostenere che gran parte delle ricerche newtoniane siano il residuo imbarazzante di superstizioni.
Parallelamente al racconto della vita dello scienziato, Iliffe ricostruisce come Newton abbia gestito il difficile rapporto tra la propria immagine pubblica e le sue credenze religiose, e ne esplora gli scritti meno noti, soffermandosi sulle idee in tema di creazione del mondo e di Apocalisse, e analizzando la sua tesi che le dottrine centrali del cristianesimo (in particolare sulla Trinità) non fossero che mostruosa idolatria, perversioni sataniche della vera religione.
Agli occhi di Iliffe, non solo le convinzioni religiose di Newton permeano le sue prime ricerche scientifiche, ma le tecniche da lui impiegate per smascherare la corruzione della dottrina cristiana delle origini sono simili a quelle utilizzate per confutare le tesi degli avversari in ambito scientifico. Per Iliffe, Newton è stato un laico devoto che ha messo al centro della propria riflessione la libertà e l’indipendenza del pensiero.
Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:
- PIANETA TERRA: DOPO COPERNICO, UNA RIVOLUZIONE GENERALE."VICISTI, GALILAEE"! PER KEPLERO (1611), COME PER KANT, LA VITTORIA DI GALILEO NON SOLO E’ SCIENTIFICA, MA E’ ANCHE VITTORIA TEOLOGICA E POLITICA!!!
MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO.
- Atomi e coscienza (di Paul K Feyerabend, Atoms and consciousness, «Common Knowledge», 1, 28-32, 1992).
LA VIA DI KANT: USCIRE DAL MONDO, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI "DIO", CONCEPITO COME L’“UOMO SUPREMO”! La “Prefazione” della “Storia universale della natura e teoria del cielo”. Note per una rilettura
L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI: L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" DEI "VISONARI" DELLA TEOLOGIA POLITICA ATEA E DEVOTA. Note per una rilettura della "Critica della Ragion pura" (e non solo)
Federico La Sala
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- L’ANNUNCIO STELLARE (2018). Scoperto su Marte un lago sotterraneo di acqua salata. Con un radar italiano (Ansa).25 luglio 2018, di Federico La Sala
Scoperto su Marte un lago sotterraneo di acqua salata
 L’ANNUNCIO IN DIRETTA
L’ANNUNCIO IN DIRETTACon un radar italiano, ha tutti i requisiti per la vita
di Enrica Battifoglia *
 [Foto] Rappresentazione artistica della missione Mars Express nell’orbita di Marte (fonte: Orosei et al.) © ANSA
[Foto] Rappresentazione artistica della missione Mars Express nell’orbita di Marte (fonte: Orosei et al.) © ANSAA un chilometro e mezzo sotto i ghiacci del Polo Sud di Marte c’è un grande lago di acqua liquida e salata: lo ha scoperto il radar italiano Marsis della sonda Mars Express. Pubblicata su Science, la scoperta è stata presentata da Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), università Roma Tre, Sapienza e Gabriele d’Annunzio (Pescara), Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).
Ha tutti i requisiti per ospitare la vita, il grande lago sotterraneo scoperto su Marte dai ricercatori italiani che hanno utilizzato i dati del radar Marsis, a bordo della sonda europea Mars Express. Esiste da molto tempo, ha acqua liquida, sali ed è protetto dai raggi cosmici: questi, dicono gli autori della ricerca, sono elementi che potrebbero far pensare anche a una nicchia biologica.
La scoperta di un lago di acqua liquida nel sottosuolo di Marte "è una delle più importanti degli ultimi anni": lo ha detto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Roberto Battiston. "Sono decenni che il sistema spaziale italiano è impegnato nelle ricerche su Marte insieme a Esa e Nasa. I risultati di Marsis - ha rilevato Battiston - confermano l’eccellenza dei nostri scienziati e della nostra tecnologia e sono un’ulteriore riprova dell’importanza della missione europea a leadership italiana ExoMars, che nel 2020 arriverà sul pianeta rosso alla ricerca di tracce di vita"
Rappresentazione artistica della sonda Mars Express nell’orbita di Marte e della traccia radar che indica la presenza di acqua nel sottosuolo del pianeta (fonte: Orosei et al.)
Ad individuare il lago, stabile da molto tempo, con un diametro di 20 chilometri e una forma vagamente triangolare, è stato il radar Marsis (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), attivo dal 2005 a bordo sulla sonda Mars Express, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). Come il radar Marsis, ideato da Giovanni Picardi dell’università Sapienza di Roma e costruito dalla Thales Alenia Space (Thales-Leonardo), sono italiani tutti gli autori della ricerca.
Rappresentazione grafica dell’acqua nel sottosuolo di Marte (fonte: ESA (fonte: ESA )
A presentare i risultati sono il responsabile scientifico del radar Marsis Roberto Orosei, dell’Istituto di Radioastronomia di Bologna dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e primo autore della ricerca, Enrico Flamini, docente di Planetologia presso l’Università di Chieti-Pescara e responsabile di progetto dell’esperimento Marsis per l’Asi, Elena Pettinelli, responsabile del laboratorio di Fisica Applicata alla Terra e ai Pianeti dell’Università Roma Tre, co-investigator di Marsis. Arriva finalmente la risposta alla domanda che dal 1976 avevano sollevato le missioni Viking della Nasa: i loro dati indicavano con chiarezza che in passato Marte aveva avuto laghi, fiumi e mari, ma finora non si sapeva che fine avesse fatto tutta quell’acqua.
"C’è stato un tempo in cui Marte era abitabile, con un clima simile alla Terra, ma nel tempo il pianeta ha perso la sua atmosfera e con essa l’effetto serra che riscaldava, e di conseguenza l’acqua è ghiacciata e poi è scomparsa. Restavano i segni lasciati dalla presenza dell’acqua, ma restava da capire dove fosse finita e capire dove andare a cercarla", ha detto Orosei, dell’Istituto di Radioastronomia di Bologna dell’Inaf. Il lago, buio e salato, è probabilmente profondo qualche metro e si trova nella regione di Marte chiamata Planum Australe, nel Polo Sud del pianeta. "E’ la prima evidenza che c’è acqua liquida su Marte, in un lago subglaciale", ha detto Flamini. "E’ una notizia - ha aggiunto - che si aspettava da 30 o 40 anni". I dati raccolti dal radar Marsis fra maggio 2012 e dicembre 2015 mostrano che si tratta di una massa d’acqua stabile. Il grande lago buio e salato del Polo Sud potrebbe non essere l’unico: secondo i ricercatori potrebbero essercene altri e, adesso che sanno come cercarli, continueranno a farlo.
* ANSA, 25 luglio 2018 16:31 (ripresa parziale, senza immagini).
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- Scoperta su Marte acqua liquida e salata L’annuncio è arrivato oggi nel corso di una conferenza stampa internazionale25 luglio 2018, di Federico La Sala
Scoperta su Marte acqua liquida e salata*
Su Marte si è ormai a un passo da scoprire la vita. Dopo decenni di ricerche è arrivata infatti la conferma definitiva: sul pianeta rosso c’è sicuramente acqua liquida e salata e in più si trova in un luogo che ha tutti i canoni per essere una "nicchia biologica". E’ la prima volta che si ottiene la prova che sotto la superficie di Marte c’è dell’acqua allo stato liquido e la straordinaria scoperta è arrivata grazie a un team di scienziati italiani che hanno indagato, con un nuovo metodo, i dati forniti dal radar italiano Marsis che si trova a bordo della sonda europea Mars Express.
I dati di Marsis indicano che probabilmente l’acqua è salata poiché alla profondità di 1.5 chilometri, dove l’acqua è stata identificata, la temperatura è sicuramente ben al di sotto di 0°C. I sali, che probabilmente sono simili a quelli che la sonda Nasa Phoenix ha trovato nel ghiaccio della zona circumpolare nord, agiscono da "antigelo" aiutando a mantenere l’acqua allo stato liquido. L’annuncio è arrivato oggi nel corso di una conferenza stampa internazionale congiunta dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Università Roma Tre, convocata nella sede dell’Asi per illustrare lo studio pubblicato su Science.
Acqua, sali, rocce e protezione dalla radiazione cosmica sono ingredienti che gli scienziati ritengono potrebbero far pensare anche a "una nicchia biologica". "Tutto questo ci fa comprendere che le precondizioni per trovare vita su Marte ci sono" afferma all’Adnkronos Enrico Flamini, Chief Scientist dell’Agenzia Spaziale Italiana. "Ora sappiamo che Marte è più adatto ad ospitare vita di quanto pensavamo. Ora sappiamo che acqua liquida c’è ed è stabile da centinaia di milioni di anni. Siamo a un passo, siamo più vicini a pensare che ci possa essere vita" sul pianeta rosso, scandisce Flamini.
Lo studio pubblicato su Science con il titolo ’Radar evidence of subglacial liquid water on Mars’ è stato realizzato da un team composto da ricercatori appartenenti a centri di ricerca e università italiane: Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Nazionale di Astrofisica, Università degli studi Roma Tre, Università degli studi D’Annunzio, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Sapienza Università di Roma. "Marsis è uno strumento straordinario" e questa scoperta "è un passo enorme, uno studio interamente firmato da italiani" dice ancora Enrico Flamini.
"I dati non sono riservati, erano già stati condivisi da tanti team di scienziati, ma chi ha visto l’anomalia, chi ha trovato la chiave di lettura di questi materiali sono stati gli italiani" spiega ancora Flamini, un ’marziano storico’ come gli altri studiosi italiani autori dello studio che contano 30 anni di competenze sui dati relativi a Marte. Quella annunciata oggi "è una scoperta epocale ma non è la risposta finale sulla presenza di vita su Marte" chiarisce Enrico Flamini spiegando che ora gli scienziati italiani hanno messo "a punto un metodo che aiuterà anche altri studiosi a rivedere i dati che arrivano da Marte con occhi diversi".
I ricercatori sono convinti che potrebbero esserci altre zone con condizioni favorevoli alla presenza di acqua in profondità su Marte e ora, messo a punto il metodo di analisi, potranno continuare a investigare. E sono decenni che si studia il pianeta rosso. Grazie alla sonda Viking della Nasa dal 1976 è diventato evidente il fatto che la superficie di Marte fosse un tempo coperta da mari, laghi e fiumi e le successive missioni hanno confermato sempre più tale presenza. "Il grande dilemma era quindi quello di dove sia finita tutta quell’acqua" racconta Roberto Orosei dell’Inaf, primo autore dell’articolo. "Buona parte di questa - evidenzia Orosei - è stata portata via dal vento solare, che spazzò quella che mano a mano si vaporizzava dalla superficie degli specchi d’acqua".
Un’altra significativa porzione di acqua, continua Roberto Orosei, "è depositata sotto forma di ghiaccio nelle calotte, soprattutto quella nord, e negli strati prossimi alla superficie o è legata al terreno nel permafrost. Ma una parte doveva essere rimasta intrappolata nelle profondità e potrebbe ancora trovarsi allo stato liquido". Questo era ciò che si ipotizzava a metà degli anni ’90, quando la missione Mars Express fu annunciata dall’Agenzia Spaziale Europea e l’Asi propose di adottare un radar a bassa frequenza per investigare il sottosuolo a grande profondità.
Il radar Marsis fu ideato e proposto dal professore Giovanni Picardi dell’Università La Sapienza di Roma, e la sua realizzazione fu gestita dall’Agenzia Spaziale Italiana e affidata a Thales Alenia Space Italia. La Nasa, attraverso il Jet Propulsion Laboratory e l’Università dell’Iowa, ha fornito una parte dell’elettronica e la speciale antenna ben visibile in tutte le immagini di Mars Express. L’Asi lo consegnò all’Agenzia Spaziale Europea per installarlo sul satellite che venne poi lanciato il 2 giugno 2003. Marsis è un radar sounder, ovvero un radar che opera a frequenze tra 1.5 e 5 MHz in grado di penetrare nel terreno marziano fino a 4 o 5 chilometri di profondità, a seconda delle caratteristiche geofisiche degli strati profondi, ma anche di misurare con accuratezza lo stato e le variazioni della ionosfera marziana.
"Era uno strumento di concezione innovativa, completamente diverso dall’unico lontano precursore volato un quarto di secolo prima sull’ultima missione Apollo, estremamente promettente di cui si doveva non solo sviluppare l’elettronica, ma anche il modo di elaborarne i dati. Un contributo importante venne dai colleghi del Jpl della Nasa e dell’Università dell’Iowa" segnala infine Enrico Flamini, Chief Scientist di Asi.
BATTISTON - "Questa scoperta è una delle più importanti degli ultimi anni" commenta il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. "Sono decenni che il sistema spaziale italiano è impegnato nelle ricerche su Marte insieme a Esa e Nasa" ricorda Battiston. "I risultati di Marsis - afferma ancora il numero uno di Asi - confermano l’eccellenza dei nostri scienziati e della nostra tecnologia e sono un’ulteriore riprova dell’importanza della missione Esa a leadership italiana ExoMars, che nel 2020 arriverà sul Pianeta Rosso alla ricerca di tracce di vita".
OROSEI (INAF) - "Se si trova la vita su Marte si dovrà concludere che c’è vita nell’Universo" sottolinea l’astrofisico Orosei. Quello che è stato scoperto su Marte è "una sorta di lago di acqua salata di circa 20 chilometri di diametro e che si trova a una profondità di circa un metro". Parlando a margine della conferenza stampa all’Asi, Orosei spiega che "questo corrisponde a una quantità di acqua di diverse centinaia di milioni di metri cubi". La ’nicchia biologica’, come l’hanno definita gli scienziati, "si trova a 81 gradi Sud, è vicina al Polo Sud di Marte".
PETTINELLI (ROMA TRE) - Su Marte è stata scoperta "una nicchia biologica perché sicuramente i batteri potrebbero vivere in queste condizioni, così avviene anche in Antartide con i batteri estremofili" sottolinea Elena Pettinelli, geofisica del Dipartimento di Fisica e Matematica dell’Università degli Studi di Roma Tre. Pettinelli ricorda l’esclamazione degli scienziati quando hanno capito di aver scoperto acqua liquida e salata su Marte. "’Accidenti questa è proprio acqua!’ abbiamo urlato", riferisce Pettinelli.
*ADNKRONOS, 25/07/2018 16:13 (ripresa parziale, senza immagini).
-
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" -- IL GRAN TEATRO DEL CIELO: 27-28 lLUGLIO 2018. L’eclissi di Luna più lunga del secolo: ecco come osservarla al meglio (di Leopoldo Benacchio)22 luglio 2018, di Federico La Sala
il gran teatro del cielo
L’eclissi di Luna più lunga del secolo: ecco come osservarla al meglio
di Leopoldo Benacchio *
Fra un mese circa, nella notte tra il 27 e 28 luglio, il gran teatro del cielo ci regalerà uno spettacolo affascinante. Avremo infatti un’eclissi di Luna che, nuvole permettendo, sarà uno spettacolo particolare e affascinante. In Italia inizierà verso le 19:30 e durerà fino a oltre le 2:00 del giorno seguente; la fase di totalità, in genere la più bella, si avrà attorno alle 22:21. Chiariamo subito che le eclissi di Luna non sono certo un fatto eccezionale: quest’anno ne è già avvenuta una il 31 gennaio scorso, ma la particolarità di questa è che sarà molto lunga in termini di tempo: la fase di totalità durerà circa un’ora e 43 minuti, un 40 minuti in più della media. Sarà anche l’eclissi più lunga da qui al 2100, un piccolo record da non perdere.
Ricordiamo che un’eclissi di Luna si ha quando la nostra Terra si mette in mezzo fra il Sole e la Luna stessa, oscurandola. Il nostro satellite infatti non emette luce propria, ma riflette piuttosto bene quella solare. Per avere un’eclissi occorre anche che Sole, Terra e Luna siano sullo stesso piano, cosa che può capitare solo un paio di volte all’anno: la Luna infatti ha un’orbita inclinata attorno alla Terra e noi attorno al Sole. Altrimenti avremmo una eclissi ogni mese.
Che cosa vedremo quindi il 27 luglio prossimo, a partire dalle 19.30? Sdraiati sulla spiaggia o in montagna o anche, molto semplicemente, a casa nostra - però da un posto non troppo luminoso - vedremo la Luna che, man mano, si offusca entrando nella penombra e poi lentamente si avvicinerà alla totalità, verso le 22.20, assumendo un colore più o meno rossastro. L’uscita dalla totalità è simile all’entrata, il nostro satellite riprenderà il suo colore bianco splendente e il fenomeno sarà terminato.
Come mai, ci si potrebbe chiedere, se la Terra si interpone fra Sole e Luna, si vede il nostro satellite anche durante la fase di totalità? L’apparenza data dalla tenue luce rossastra durante il culmine del fenomeno è dovuta al fatto che il nostro Pianeta copre sì completamente il disco lunare, ma anche diffonde nello spazio la luce solare che lo colpisce, grazie anche al filtro della nostra atmosfera. Il colore di questa luce va dal bianco latte a un grigio più cinereo fino a volte al rosso tenue, per un effetto fisico che è quello scoperto dai fisici inglese Raleigh e Jeans circa 120 anni fa. La polvere presente nell’atmosfera infatti assorbe la luce solare e la emette di nuovo nelle frequenze del rosso.
L’ultima cosa che ci resta capire è come mai l’eclissi, questa volta, sia così lunga. Dobbiamo fare mente locale sul fatto che la Luna gira intorno alla Terra, d’accordo, ma non in un’orbita proprio circolare, bensì un po’ ellittica. Per questo motivo la distanza Terra-Luna varia tra i 363.104 chilometri e i 405.696: il primo punto è chiamato perigeo - più vicino alla Terra, in greco antico - l’altro apogeo. Il 27 luglio prossimo sarà proprio all’apogeo, nel punto più lontano, e quindi, per le leggi scoperte dal grande astronomo Giovanni Keplero nel 1600, la Luna deve percorrere la sua orbita un po’ più lentamente nel cielo: ecco quindi che il fenomeno ci metterà un bel 40 minuti in più della media, stabilendo il record del secolo.
Resta da dare un suggerimento importante: osserviamo bene la Luna, come fece a suo tempo il grande Galilei. Proprio così, anche se può sembrare strano, ma Galilei usò per le prime osservazioni lunari un cannocchiale, “cannone” lo chiamava nel senso di grande canna, che oggi non esiteremmo a definire di pessima qualità, data la primitiva tecnologia di costruzione delle lenti ottiche a quei tempi. Comunque il primo da lui usato aveva solo 3 ingrandimenti, come un cannocchiale da teatro che molti di noi hanno in casa. Eppure la scoperta del vero “volto della Luna” che fece cambiò la storia dell’umanità.
Se poi in casa c’è un appassionato di montagna o di mare che abbia un cannocchiale con caratteristiche tipo 7x50, allora userà qualcosa di molto simile al secondo cannocchiale usato da Galilei, che con questi due riuscì nell’inverno del 1609 a capire, come lui stesso scrisse nel “Sidereus Nuncius”, il messaggero delle stelle, che «la superficie della Luna non è affatto liscia, uniforme e di sfericità esattissima, come di essa e degli altri corpi celesti una numerosa schiera di filosofi riteneva, ma al contrario, disuguale, scabra, ripiena di cavità e di sporgenze, non altrimenti che la faccia stessa della Terra ...».
Un consiglio quindi: non aspettiamo l’eclissi del 27 luglio per guardare la Luna, osserviamola ogni sera nel prossimo mese per un attimo, da soli o in compagnia, magari dei figli. Basta un attimo ogni sera per vedere come cambia e come è sempre mutevolmente affascinante.
* Il Sole-24 Ore, 07 luglio 2018 - ripresa parziale.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" -- Stephen Hawking, l’erede di Galileo, si è spento all’età di 76 anni - 130 anni dopo la nascita di Einstein14 marzo 2018, di Federico La Sala
É morto Stephen Hawking, esattamente 130 anni dopo la nascita di Einstein
L’astrofisico di fama mondiale si è spento all’età di 76 anni nella sua abitazione.
di Redazione ANSA *
- Un omaggio a Stephen Hawking © ANSA/EPA
Il mondo della scienza è a lutto. É morto Stephen Hawking, uno dei cosmologi più celebri degli ultimi decenni per le sue teorie sui buchi neri e l’origine dell’universo, e uno dei ricercatori che più hanno fatto discutere per le affermazioni al confine tra cosmologia e religione, come quella secondo cui si può spiegare la nascita dell’universo senza l’intervento di Dio. E proprio sulla sua lapide - ha detto all’ANSA Remo Ruffini, direttore del Centro Internazionale per la Rete di Astrofisica Relativistica (IcraNet) e presidente del Centro Internazionale di Astrofisica Relativistica (Icra) - avrebbe voluto la formula di massa, ossia la formula matematica che misura l’energia emessa dai buchi neri al momento della loro nascita, una sorta di vagito di quei giganti cosmici. Era accaduto, ha proseguito Riffini che che ha collaborato a lungo con Hawking e che ha elaborato con lui e con il matematico Roy Kerr quella formula, anche "dopo un seminario che avevo tenuto a Cambridge ed ero stato invitato a cena a casa di Hawking insieme a Kerr".
A quel desiderio di Hawking, Ruffini e Kerr avevano risposto, scherzando, che quella formula apparteneva a tutti e tre. Ruffini ricorda inoltre i complimenti che lui e Kerr fecero a Hawking per la sua casa, ai quali Hawking rispose che l’aveva costruita lui, una battuta che dimostra la grande ironia e leggerezza con cui ha sempre affrontato la vita. "Con la sua ironia e la sua serenità - ha detto ancora l’astrofisico italiano - Hawking per me è stato un esempio di vita unico e sorprendente". Uno dei ricordi più vivi è "il sorriso che aveva negli occhi e il grande affetto tra noi, che ha permeato la mia vita in tutti questi anni".
Hawking morto a 130 anni dalla nascita di Einstein
Un’altra curiosità che riguarda il più celebre degli astrofisici contemporanei è che è morto esattamente a 130 anni dalla nascita di Albert Einstein. Il padre della teoria della relatività era infatti nato il 14 marzo 1879. Non è la prima coincidenza del genere nella vita di Hawking, che era nato a Oxford l’8 gennaio 1942: una data che, come egli stesso teneva moltissimo a precisare, segnava 300 anni esatti dalla morte di un altro gigante dell’astronomia, Galileo Galilei, che si era spento ad Arcetri l’8 gennaio 1642.
- VIDEO
Se ne è andato all’età di 76 anni, dopo avere sfidato fin dall’adolescenza la forma di atrofia muscolare progressiva che progressivamente lo aveva costretto alla paralisi. Una sedia a rotelle progettata su misura e un computer con sintetizzatore vocale sono i mezzi che gli hanno permesso di comunicare con il mondo. Lo scienziato vrebbe voluto sulla sua lapide la formula di massa, ossia la formula matematica che misura l’energia emessa dai buchi neri al momento della loro nascita, una sorta di vagito di quei giganti cosmici, secondo quanto riferisce all’ANSA Remo Ruffini, direttore del Centro Internazionale per la Rete di Astrofisica Relativistica (IcraNet) e presidente del Centro Internazionale di Astrofisica Relativistica (Icra), che ha collaborato a lungo con Hawking e che ha elaborato con lui e con il matematico Roy Kerr quella formula.
Con la stessa determinazione ha sfidato la fisica del suo tempo e ha dato alla cosmologia un’impronta decisiva: grazie a lui i buchi neri hanno smesso di essere un’ipotesi fantasiosa e una delle sue convinzioni più ferme vedeva nella colonizzazione dello spazio la speranza di sopravvivenza dell’umanità.
Nato a Oxford l’8 gennaio 1942 (esattamente 300 anni dopo la morte di Galileo Galilei, come ha sempre tenuto a precisare) Hawking ha sempre descritto se stesso come un bambino disordinato e svogliato, tanto che ha imparato a leggere solo all’età di 8 anni. Le cose hanno preso una piega diversa quando gli à stata diagnosticata la malattia. In quel momento "ogni cosa è cambiata: quando hai di fronte l’eventualità di una morte precoce, realizzi tutte le cose che vorresti fare e che la vita deve essere vissuta a pieno’’, diceva.
- L’ironia di Hawking e la partita a poker con i fisici
L’universo aveva da sempre esercitato su di lui un enorme fascino e nel 1963 questa passione lo aveva portato all’università di Cambridge. Gli anni tra il 1965 e il 1975 sono stati scientificamente tra i più produttivi della sua vita: è allora che ha scritto il suo libro più famoso: "Dal Big Bang ai buchi neri, breve storia del tempo". Sempre a Cambridge, dal 1976 al 30 settembre 2009 ha occupato la cattedra che era stata di Isaac Newton.
Le sue ricerche sui buchi neri hanno permesso di confermare la teoria del Big Bang, l’esplosione dalla quale è nato l’universo. Dagli anni ’70 ha cominciato a lavorare sulla possibilità di integrare le due grandi teorie della fisica contemporanea: la teoria della relatività di Einstein e la meccanica quantistica. Le sognava riunite nella "teoria del tutto", che nel 2014 ha ispirato il film di James Marsh dedicato a Hawking.
Una delle teorie più recenti che il fisico e cosmologo britannico aveva formulato con il fisico Thomas Hertog, del Cern di Ginevra, prevede che l’universo non abbia avuto un inizio e una storia unici, ma una moltitudine di inizi e di storie diversi. La maggior parte di questi mondi alternativi sarebbe però scomparsa molto precocemente dopo il Big Bang, lasciando spazio all’universo che conosciamo.
D’Amico (Inaf), le ricerche hanno gettato una nuova luce sull’universo - "Quello che mi ha sempre colpito di più è la caratteristica formidabile di lui come uomo, la dimostrazione vivente che il pensiero trascende la materia". Così commenta per l’Ansa Nichi D’Amico, il presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), nel giorno della scomparsa di Stephen Hawking. "È diventato uno dei principali studiosi di cosmologia del mondo, nonostante le sue difficili condizioni fisiche", aggiunge D’Amico. Uno dei suoi contributi scientifici più importanti è stato senza dubbio il grande lavoro sui buchi neri e sulla radiazione che prende il suo nome, la radiazione di Hawking, che lo ha reso celebre. "Le sue indagini e le sue eccezionali doti intellettuali ci hanno permesso di gettare una nuova luce sull’universo", dichiara il presidente dell’Inaf. "È anche grazie a lui e alla sua incessante attività di divulgazione al pubblico se oggi concetti come ’buco nero’ o ’spaziotempo’ ci sono più familiari". D’Amico aggiunge che un altro aspetto interessante è che spesso nei lavori di Stephen Hawking si affronta il tema di un creatore o di un atto creativo per l’origine dell’universo. Hawking si è sempre dichiarato agnostico e ha sempre sostenuto che non è necessario un creatore per spiegare la nascita del cosmo, "ma si poneva ugualmente il problema, e questo - conclude - è interessante".
Theresa May rende omaggio a una mente straordinaria "Il professor Stephen Hawking è stata una mente brillante e straordinaria, uno dei grandi scienziati della sua generazione". Theresa May, primo ministro britannico, ricorda con questa parole via Twitter il celebre astrofisico di Cambridge, gloria dell’accademia del Regno Unito, scomparso a 76 anni. "Il suo coraggio, il suo senso dell’umorismo e la determinazione di ottenere il massimo dalla vita sono stati - prosegue May - un’ispirazione. La sua eredità non sarà dimenticata".
- Scheda. Hawking, le teorie che lo hanno reso celebre
 Addio a Stephen Hawking, la sua vita in un film
Addio a Stephen Hawking, la sua vita in un film
 Fotoracconto. Stephen Hawking, l’erede di Galileo
Fotoracconto. Stephen Hawking, l’erede di Galileo
 Video. Lutto nella scienza, e’ morto Stephen Hawking
Video. Lutto nella scienza, e’ morto Stephen Hawking
* ANSA, 14 marzo 2018 (ripresa parziale)
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" - OGGI. -- COSMONAUTICA. Luca Parmitano, astronauta: “Il futuro Cristoforo Colombo lo stiamo già addestrando” ("Wired").21 maggio 2017, di Federico La Sala
- LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
- MATERA 2019: UN VIAGGIO IN BASILICATA CON DON GIUSEPPE DE LUCA ( - e ROCCO PETRONE). Un ’ricordo’
- 2060: APOCALISSE. NUOVA TERRA E NUOVI CIELI. CONTRO I PROFETI DI SVENTURA, DOPO NEWTON ED EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO ... "NEW TON"!!!
- "voglio superare il concetto secondo cui la Terra sarebbe la culla dell’umanità; in questo momento ne è anche la gabbia e a nessuno piace vivere in cattività" (Luca Parmitano).
INTERVISTA *
Luca Parmitano, astronauta: “Il futuro Cristoforo Colombo lo stiamo già addestrando”
Secondo il primo astronauta italiano protagonista di una passeggiata spaziale, nel futuro non sarebbero da escludere cosmonauti mutanti. E no, non è fantascienza
Di una cosa Luca Parmitano sembra davvero orgoglioso. Ma è difficile scovarla. E non perché l’astronauta catanese, protagonista della prima missione di lunga durata dell’Agenzia spaziale italiana, non vada fiero di quello che fa, anzi. È che complici il suo contegno militare - è Maggiore Tenente Colonnello pilota dell’Aeronautica - e soprattutto il suo carattere. Mai, nei suoi occhi o nelle sue parole, traspare l’ombra del vanto.
Per Parmitano il successo è sempre della squadra. Ogni traguardo, foss’anche Marte, diventa raggiungibile solo grazie alla collaborazione.
E questo, nonostante di risultati personali potrebbe sfoggiarne un elenco: come collaudatore ha accumulato 2mila ore di volo su oltre 40 tipi di velivoli; nel 2005 è stato decorato con la medaglia d’argento al valore per aver portato a terra il suo Amx dopo che l’impatto con una cicogna l’aveva compromesso. Selezionato dall’Agenzia spaziale europea nel 2009 è diventato il sesto astronauta italiano, il quarto ad abitare la Stazione spaziale internazionale (nel 2013, per 166 giorni) e il primo ad averci passeggiato attorno, in due attività extraveicolari, o Eva, portate a termine nonostante una grave avaria della tuta nella seconda occasione.
Nel 2014 è stato comandante della spedizione Caves, con cui l’Esa prepara gli astronauti alle missioni spaziali facendo loro trascorrere sette giorni sottoterra nella diaclasi Sa Grutta, vicino Olbia.
L’anno successivo ha partecipato, sempre come comandante, alla spedizione della Nasa, Neemo20, due settimane vissute dentro Aquarius, una stazione 19 metri sotto la superficie marina al largo della Florida.
Eppure, si diceva, è di un’altra cosa che Luca Parmitano sembra orgoglioso: è il primo europeo a fare da regista a due Eva. Il che significa comunicare direttamente con gli astronauti fuori dalla Iss per guidarli nelle procedure.
Perché, dice lui, “la conquista spaziale non è un’impresa di qualche eroe solitario. E al futuro ci si prepara insieme“.
A proposito, in che modo Neemo e Caves c’entrano con il nostro futuro nello Spazio?
“Entrambe rimandano alla componente esplorativa dei viaggi spaziali, le sono complementari. Consistono in un addestramento in condizioni estreme, come quelle che affronteremo nei prossimi lanci.
“Sottacqua abbiamo un habitat che, per molti aspetti, è come quello di un’astronave sommersa: non solo consente di simulare gravità diverse, implica anche la componente scientifica di ogni missione, con gli esperimenti nel laboratorio, e quella esplorativa grazie alle uscite nello scafandro.
“Che cosa c’entra l’esperienza sottomarina con quella cosmica? Tutto. Lo scafandro è immerso in un ambiente alieno, che consente di testare ingegneria e design degli strumenti che utilizzeremo.
“In Caves ci sono altre componenti: spostarsi dentro grotte sotterranee implica affrontare posti inesplorati e inadatti al nostro soggiorno. Senza supporto, isolati, dove tutto quello che ti serve te lo devi portare appresso. È un contesto in cui sperimentare la dimensione fisica e logistica delle missioni spaziali.
“In sintesi, Neemo e Caves insegnano come addestrare gli astronauti nel futuro. Non è un caso se a breve continuerò la preparazione a Lanzarote, nelle Canarie; quelle zone sono come un pezzo di suolo marziano sulla Terra”.
È plausibile che in tempi brevi colonizzeremo il Pianeta Rosso?
“Al momento prevediamo di raggiungerlo negli anni Trenta [a fine marzo la Nasa ha pubblicato il suo piano in 5 fasi per arrivarci nel 2033, ndr]. Ma meglio non parlare di tempi brevi quando c’è il cosmo di mezzo”.
È pessimista?
“Tutt’altro, ci arriveremo. Mi riferivo al dopo: voglio superare il concetto secondo cui la Terra sarebbe la culla dell’umanità; in questo momento ne è anche la gabbia e a nessuno piace vivere in cattività. A parte la curiosità innata, è per una questione di sopravvivenza ed espansione nel tempo. In questo senso non abbiamo fatto che un primo passo: siamo in orbita in modo continuativo.
“Ce ne sarà presto un secondo, costituito da una probabile permanenza nel sistema Terra-Luna. Questo almeno vorrebbe l’Esa, creare un ambiente adatto alla colonizzazione e allo sfruttamento locale delle risorse. Quindi procedere verso Marte. Il che imporrà si riesca ad affrontare un viaggio interplanetario.
“Non mi azzardo a parlare di terraforming, di trasformazione a nostro uso e consumo di un ambiente extraterrestre. Siamo ancora lontani da questa eventualità, ma molto prossimi a vedere da vicino com’è l’ambiente marziano”.
Poi?
“Poi la prospettiva andrebbe estesa: oggi siamo in grado di confermare la presenza di pianeti abitabili intorno a quasi tutte le stelle, miliardi di mondi in cui la vita è possibile, in cui c’è acqua, con un’atmosfera simile alla nostra. E allora credo sia il caso di pensare al futuro.
“Ecco perché il concetto di tempi brevi, se non altro inteso come un periodo compreso nell’arco della vita umana, andrebbe rivisto.
“I passaggi per effettuare un viaggio interstellare sono esponenzialmente più complessi del volo interplanetario, ma come ricordava Lao Tzu anche il cammino più lungo inizia con un passo.
“Tanto che c’è già chi parla di come inviare un microchip oltre il nostro sistema solare, lambendo frazioni decimali della velocità della luce. Come non intravedere la possibilità di arrivare prima o poi a un’astronave, ovviamente attraverso tutte le tappe intermedie, dai robot ai lander fino all’uomo?”.
L’attività sulla Stazione spaziale rientra in questa progressione?
“Come non potrebbe? Si pensi al Beam, anagramma di Bigelow Expandable Activity Module, installato sulla Stazione nell’aprile del 2016. È un modulo gonfiabile, un esperimento per verificare la resistenza fuori dall’atmosfera terrestre di un ambiente espandibile composto da vari strati, fra cui uno in Vectran, un materiale due volte più resistente del Kevlar.
“È fondamentale comprenderne l’importanza se parliamo del nostro futuro nel cosmo, visto che sarà molto difficile affrontare un viaggio interplanetario con un veicolo di grandi dimensioni.
“L’idea è allora di lanciare masse ridotte per poi espanderle, costruire in volo l’astronave di 2001: Odissea nello spazio con moduli gonfiabili in progressione”.
Adesso mi sembra troppo fiducioso. Eppure visse in prima persona gli imprevisti dello Spazio. Come affrontò l’incidente durante la sua seconda passeggiata fuori dall’Iss? E come lo concilia con il suo entusiasmo attuale?
“Ricordando che nello Spazio non c’è posto per gli individualismi. Se non capissimo noi per primi l’importanza inestimabile del lavoro di squadra, a terra e a bordo, commetteremmo un errore grave. Di quelli che possono costare cari”.
Che cosa intende?
“Il 16 luglio 2013, poco dopo l’inizio della mia seconda attività extraveicolare, l’Eva 23, per un malfunzionamento il mio casco ha cominciato a riempirsi d’acqua. In tutto l’emergenza è durata 35 minuti e per circa 8 l’avaria è stata grave, tanto da costringermi al rientro: in quel frangente ho perso ogni contatto radio oltre che sensoriale. Avevo acqua negli auricolari, nel naso, mi aveva coperto gli occhi. Faticavo a respirare, non potevo sentire né parlare, perché i sistemi di comunicazione, microfoni compresi, si erano bagnati.
“In più, una volta nell’airlock della Stazione, ho dovuto sopportare per 15 minuti la pressurizzazione con il sistema di Valsalva compromesso. È un apparato di compensazione che permette, tappando il naso, di pressurizzare le orecchie, ma essendo spugnoso e zuppo d’acqua si era strappato. Non una bella sensazione: è come scendere di colpo da 3mila metri al livello del mare senza contrastare la spinta sui timpani. Un dolore lancinante cui non ci si può opporre.
“Bene, non voglio sminuire le difficoltà di una situazione critica, fingerei. Sono momenti in cui la tua vita è a rischio. Quello che voglio ridimensionare è il merito dell’individuo.
“Oltre agli astronauti, un’Eva coinvolge numerosi collaboratori a Terra, persone che hanno scelto e curato l’addestramento, selezionato gli strumenti e concordato le procedure. Questo insieme è quello che ti permette di avere il battito cardiaco invariabile durante un’avaria, quello che ti concede l’opportunità di pensare...
“Quel 16 luglio, fuori dall’Iss e con un litro e mezzo di acqua nel casco, non ero solo: portavo con me un bagaglio di esperienze costruitomi, per mesi, da una squadra“.
Sta dicendo di non aver avuto paura?
“Certamente ne ho avuta. Ma la differenza tra una persona senza addestramento e chi è preparato consiste nella gestione dello stress. Fino a un certo livello ha effetti fisiologici positivi: il cuore pompa più forte per preparare i muscoli, l’aumento di adrenalina nel sangue stimola la reattività del cervello, la velocità di ragionamento cresce. È fondamentale imparare a utilizzare queste risposte come uno strumento e non permettere siano loro a controllarci. Proprio a questo obbiettivo punta l’addestramento”.
Qual è il problema maggiore nell’evoluzione dei viaggi spaziali?
“L’essere umano”.
Cioè?
“I nostri limiti fisiologici”.
Si riferisce, per esempio, all’esposizione alle radiazioni cosmiche durante viaggi lunghi?
“Focalizzarsi su un problema non serve. Se non ha soluzione, è un dato: saremo di certo esposti alle radiazioni. Possiamo solo aggirare l’ostacolo”.
Come?
“Tralasciamo per un momento le implicazioni etiche e chiediamoci se sia possibile stimolare un’evoluzione mirata. Sappiamo che il dna umano contiene geni di cui non si conoscono ancora proprietà o funzioni. Per esempio, condividiamo quella parte di corredo cromosomico che permette all’orso bruno di andare in letargo. È possibile attivare quel gene in modo da mandare anche l’uomo in ibernazione?
“In questa condizione il metabolismo rallenta fino quasi ad arrestarsi ed è bene ricordare che le radiazioni hanno effetto sugli esseri umani solo durante meiosi o mitosi, vale a dire quando le cellule si duplicano. Se quindi, durante un viaggio interplanetario, si è in ibernazione, il rischio che si verifichi una mutazione cellulare può essere ridotto di molto”.
Astronauti in letargo?
“Esatto. A questo punto la questione si sposta in ambito eto-biologico: è lecito intervenire sul dna degli esseri umani? O, di contro, fino a che punto è sensato escludere un’evoluzione mirata per una parte di umanità, che possa destinarla all’esplorazione del cosmo e farne il nostro prossimo gradino evolutivo: i viaggiatori interstellari.
“Ricordiamoci che l’etica è flessibile e che trattandosi di evoluzione le questioni da soppesare sono più grandi del singolo individuo.
“Detto altrimenti, se mi trovassi fra mille anni a osservare una parte evoluta della razza umana, capace di andare in letargo, quadrumane e con coda prensile - caratteristiche perfette per l’habitat spaziale -, perché dovrei pensare che è un male?“.
Insiste tanto sulla dimensione esplorativa dei viaggi spaziali.
“Perché è la sintesi di scienza e tecnologia, è l’ampliamento delle nostre conoscenze. Ripercorrendo i tempi, è bene ricordare che siamo andati sulla Luna negli anni ’60. Quel decennio costituì una breve parentesi di stimoli straordinari, capaci di spingere l’uomo a fare cose incredibili. Ma pensiamoci, che cosa abbiamo fatto? Siamo stati come i vichinghi che hanno attraversato la Danimarca, l’Oceano Atlantico, il Circolo polare artico. E arrivati in un nuovo Continente, sono tornati indietro. Un passaggio epocale, un salto nell’ignoto senza precedenti, ma anche un evento a sé stante.
“Poi, per quanto nessun vichingo si sia più avventurato attraverso l’Atlantico, nel Mediterraneo le grandi repubbliche marinare hanno sviluppato enormemente la tecnologia delle proprie imbarcazioni, migliorandone la capacità di navigazione, stoccaggio e anche la strumentazione di bordo. Ecco perché, secoli dopo, si è arrivati in America.
“Cristoforo Colombo ha contrassegnato un altro passaggio, proprio come faremo noi nei prossimi anni con la Luna e Marte. Ecco, probabilmente saremo un po’ come Colombo, nel senso che non riusciremo a rimanere per lungo tempo dove andremo. Non subito, almeno.
“Il vero salto evolutivo sarà quando, come con il Mayflower, diventeremo coloni. E per farlo, avremo bisogno di un balzo non solo tecnologico, ma anche sociale. Chi diventa colone? Quelli che in inglese sono chiamati misfits”.
Reietti?
“Piuttosto persone che non tollerano l’essere costretti in un ambiente. Uomini che hanno un bisogno quasi fisico delle difficoltà, che sono addirittura attratti dalla scomodità.
“Oggi molti vorrebbero rendere il volo spaziale più simile a quello terrestre. Si tende a un ambiente ergonomico, confortevole. Ma quelli che diventeranno i nostri coloni lunari o marziani cercheranno tutt’altro: si imbarcheranno perché hanno bisogno del Far West, di orizzonti aspri, di esperienze ruvide, di una bellezza che non è quella del design raffinato. Ma molto, molto più spartana”.
Ce la faremo a vederli?
“Una parte: forse non vedremo salpare il Mayflower, ma Cristoforo Colombo sì. Lo stiamo già addestrando“.
* WIRED, 19.05.2017 (Ripresa parziale - senza immagini).
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS". L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei -- Telescopi puntati sul ’fratello’ della Terra, per aprire la via alla futura flotta di vele solari.12 gennaio 2017, di Federico La Sala
Telescopi puntati sul ’fratello’ della Terra
Si osserva Proxima b per aprire la via alla futura flotta di vele solari *
Il progetto per inviare una flotta di vele solari a caccia di vita nel pianeta scoperto nel sistema stellare Alpha Centauri, trova l’alleanza con i telescopi dell’Osservatorio Meridionale Europeo (Eso), che si trovano in Cile.
Per preparare il viaggio delle vele solari previsto dal progetto Breakthrough Starshot, rende noto l’Eso, il Very Large Telescope (Vlt) verrà modificato in modo da fotografare i dettagli del pianeta ’gemello’ della Terra scoperto recentemente attorno alla stella più vicina a noi, Proxima Centauri e che potrebbe ospitare forme di vita.
"Da poco tempo - ha spiegato Giancarlo Genta, del Politecnico di Torino e unico italiano membro del comitato scientifico di Breakthrough Starshot - sappiamo con certezza che lì esiste un pianeta, e sembrerebbe avere caratteristiche simili alla Terra, ma niente di più. Prima di mandare una sonda servirebbe saperne di più".
Per questo è nato un’accordo tra Eso, l’osservatorio che ha scoperto l’esistenza di Proxima b, e Breakthrough Starshot, il progetto che prevede di inviare una flotta di mini-sonde capaci di viaggiare a velocità altissime per raggiungere Alpha Centauri in appena 20 anni.
Il progetto Breakthrough Starshot è nato dalle idee di alcuni dei più importanti ricercatori del mondo, tra i quali l’astrofisico Stephen Hawkings, è finanziato dal magnate russo Yuri Milner ed è previsto nel 2069, ma i ricercatori sono già al lavoro. Dopo l’annuncio della realizzazione di una Google Map dello spazio interstellare, grazie ai dati del telescopio spaziale Hubble, fondamentale per guidare il viaggio delle sonde, arriva adesso l’accordo con uno dei più potenti telescopi al mondo.
"Le sonde - ha spiegato Genta - non potranno essere telecontrollate, ma dovranno essere autonome, quindi maggiori informazioni potremo avere più facile potrà essere il loro lavoro". Per questo si è concordato di fare di miglioramenti allo strumento Visir installato su Vlt, il maxi telescopio di oltre 8 metri di diametro che si trova nel deserto di Atacama, e di trasferire i miglioramenti anche su E-Elt (European Extremely Large Telescope), il super telescopio da 40 metri dell’Eso, ancora in fase di costruzione.
*Ansa, 11 gennaio 2017 (ripresa parziale).
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS"(1610), l’alba di una nuova visione del mondo --- C’è vita nell’universo, molta vita: "Kepler" e i nuovi pianeti extra-solari (di Guido Tonelli)26 giugno 2016, di Federico La Sala
C’è vita nell’universo, molta vita
Gli scienziati di Kepler, un grande telescopio lanciato in orbita nel 2009, hanno da poco annunciato di avere scoperto 1.284 nuovi pianeti extra-solari (o esopianeti), cioè pianeti che ruotano attorno a una stella diversa dalla nostra. Tutto fa immaginare che ce ne siano miliardi, alcuni «ospitali». Il mondo sta entrando in una nuova epoca
di Guido Tonelli (Corriere della Sera, La Lettura, 26.06.2016)
Stiamo entrando in una nuova epoca e nessuno sembra rendersene conto. Di tanto in tanto giornali e televisioni riportano qualche notizia; se ne parla per un paio di giorni poi tutto viene macinato dal tritacarne dell’attualità. L’ultima, di qualche settimana fa, riguarda Kepler, una sonda della Nasa che prende il nome dal grande astronomo tedesco. La sua missione è la scoperta di esopianeti, o pianeti extra-solari, che orbitano cioè attorno ad altre stelle; il fine ultimo è quello di identificare pianeti abitabili, simili alla nostra Terra.
Le primissime ricerche risalgono addirittura agli anni Quaranta, ma utilizzavano tecniche di osservazione piuttosto grossolane. Usando i migliori telescopi allora disponibili si cercavano nuovi sistemi solari sperando di osservare una perturbazione periodica nella posizione della stella-madre. È ben noto che, per le leggi della gravitazione, in presenza di un pianeta la stella-madre non sta ferma, ma compie anch’essa una piccola rotazione intorno al centro di massa del sistema.
Tanto più massiccio è il pianeta tanto maggiore è lo spostamento periodico della stella. Il metodo, detto astrometrico, non ha portato a risultati di rilievo; sono stati identificati un gruppo di potenziali candidati ma nessuno è mai stato confermato. Risultati molto più interessanti si sono avuti con il metodo della misura della velocità radiale. Il principio è lo stesso, si cerca di osservare il minuscolo spostamento periodico della stella-madre, ma la tecnica è basata su misure spettroscopiche che consentono maggiori precisioni. Si analizza lo spettro di emissione luminosa della stella e si controllano nel tempo le righe corrispondenti alle varie frequenze. Se la stella presenta un piccolo movimento orbitale causato dalla presenza di un pianeta, si misura una piccola variazione periodica in frequenza della sua emissione luminosa dovuta all’effetto Doppler.
Quando la stella ha una velocità radiale positiva - cioè si avvicina al nostro punto di osservazione sulla Terra - le righe di emissione si spostano verso il blu, per poi passare dal lato opposto, verso il rosso, quando la stella si allontana. È lo stesso metodo che ci permette di riconoscere, dal suono della sirena, se un’ambulanza si sta avvicinando o si sta allontanando. Con la misura della velocità radiale della stella possiamo calcolare il periodo del moto orbitale del pianeta e la sua massa. I primi pianeti extra-solari sono stati scoperti, con questo sistema, negli anni Novanta. Si trattava di enormi corpi celesti, simili al nostro Giove. Giganti caldi, per lo più gassosi, che gravitavano molto vicini alle loro stelle-madri e avevano quindi una temperatura superficiale spaventosa.
Il metodo della velocità radiale è limitato dal fatto che si deve osservare una stella per volta ed è efficace solo per stelle relativamente vicine a noi, si fa per dire, entro una distanza di circa 160 anni luce, mentre la stragrande maggioranza delle stelle della nostra galassia sta a distanze maggiori.
La vera rivoluzione nella caccia ai pianeti extra-solari è venuta da quando è stato messo a punto il metodo dei transiti. È una tecnica basata sulla fotometria di precisione, cioè si tiene sotto controllo la luminosità della stella e si misura la lievissima attenuazione della luce prodotta dal pianeta che le transita davanti. Anche in questo caso si richiede che la perturbazione, il segnale di transito, abbia carattere periodico. La forma caratteristica del disturbo permette di misurare le dimensioni del pianeta e questa informazione, combinata con la misura della velocità radiale che dà la massa, permette di conoscerne la densità. In questo modo, da alcuni anni, la ricerca di nuove «Terre» ha ricevuto un impulso incredibile e si sono identificati i primi pianeti rocciosi simili al nostro.
Il grande vantaggio del metodo dei transiti è che si possono tenere sotto osservazione, in contemporanea, centinaia di migliaia di stelle e la sensibilità raggiunta dagli strumenti più moderni è tale che il campo d’azione si può estendere fino a distanze di migliaia di anni luce. La sensibilità del metodo è talmente spinta che si possono identificare pianeti addirittura più piccoli di Mercurio. Occorre poi considerare che, nel caso che il pianeta abbia una atmosfera, la luce della stella-madre giunge fino a noi dopo averne attraversato gli strati superiori. Misure accurate della polarizzazione della luce emessa dalla stella permettono quindi di ricavare informazioni essenziali sulla presenza di atmosfera nel pianeta.
L’unico problema del sistema dei transiti è che, per produrre segnali il punto di osservazione deve appartenere al piano delle orbite, cosa che statisticamente avviene solo per una frazione delle stelle osservate. Se poi si cercano pianeti simili alla Terra, che hanno una massa compresa fra metà e due volte quella del nostro pianeta, e che compiono una rivoluzione completa intorno alla loro stella in circa un anno, occorre aspettare molti anni per essere sicuri di avere visto un transito periodico.
Kepler è un grande telescopio lanciato in orbita nel 2009, che sorveglia da anni una piccola zona del cielo compresa fra le costellazioni del Cigno e della Lira. L’apparato tiene sotto controllo circa 150 mila stelle della nostra galassia, distribuite in una regione di dimensioni paragonabili a quella che copriamo con il palmo della nostra mano, se tendiamo il braccio verso il cielo.
La zona di osservazione copre un cono di circa duemila anni luce intorno al nostro Sole che si trova in Orione, un piccolo braccio secondario della spirale che costituisce la nostra Via Lattea. Il telescopio è ottimizzato per misure di fotometria e utilizza un sistema di camere fotografiche molto sofisticate, da 95 milioni di pixel, ma concettualmente simili a quelle che usiamo nei nostri cellulari.
Un mese fa gli scienziati di Kepler hanno annunciato di avere scoperto 1.284 nuovi pianeti extra-solari. La maggior parte dei nuovi corpi celesti sarebbero posti assolutamente inospitali, caratterizzati da atmosfere molto dense, composte essenzialmente da elio e idrogeno, e temperature torride alla superficie. Ma la novità davvero eclatante è la scoperta che pianeti simili alla Terra sono corpi celesti molto comuni fra quelli che orbitano intorno alle stelle.
Fra i nuovi venuti almeno nove dovrebbero essere pianeti rocciosi che si trovano nella fascia cosiddetta abitabile, cioè a una distanza dalla stella-madre tale da consentire temperature simili a quelle che abbiamo qui da noi. Se un pianeta roccioso si trova nella fascia abitabile e contiene acqua, questa potrebbe formare laghi e oceani come quelli che sono così diffusi sulla nostra Terra. Ecco che, di colpo il numero dei nostri potenziali cugini è quasi raddoppiato. E la cosa sorprendente è che Kepler ha osservato soltanto una piccola porzione della nostra galassia. Si stanno già preparando nuove missioni e nuove campagne di osservazioni e nel prossimo futuro si costruirà una mappa sempre più dettagliata delle «nuove Terre». Nel giro di un paio d’anni sarà lanciato un nuovo telescopio per tenere sotto osservazione le 200 mila stelle più vicine a noi fra le quali ci si aspetta di scoprire 500 pianeti rocciosi simili al nostro.
La nostra Via Lattea contiene circa 200 miliardi di stelle ed è soltanto una fra cento miliardi di galassie che popolano il nostro universo. I numeri fanno impressione: se soltanto una stella su diecimila ospitasse pianeti rocciosi nella fascia abitabile dovremmo accettare l’idea che il numero di «Terre» della nostra galassia, quindi astronomicamente vicine a noi, potrebbero essere decine di milioni. Se si considerano i 100 miliardi di galassie dell’Universo intero si potrebbe raggiungere la cifra fantastica di miliardi di miliardi. Insomma c’è pieno di pianeti abitabili intorno a noi ed è molto probabile che ci sia abbondanza di forme di vita nell’universo. Non c’è alcun motivo di credere che acqua e materia organica siano componenti ultra rari.
Fra qualche tempo saremo in grado di analizzare la composizione dell’atmosfera dei nuovi pianeti che orbitano nelle fasce abitabili per cercare eventuali composti organici, chiari indizi della presenza di forme di vita simili a quelle che ci sono familiari. Non mi interessa qui discutere il problema delle distanze e neanche la tecnologia con cui potremo stabilire una comunicazione o un contatto. Sarebbe sciocco argomentare oggi intorno a questioni che, ne sono sicuro, faranno sorridere gli scienziati del futuro.
Vorrei invece sottolineare la necessità di prepararsi a quello che sarà sicuramente un grosso choc culturale. Un’umanità che fa fatica a convivere con se stessa, sarà in grado di superare la crisi di valori legata alla scoperta di altre forme di vita? Che rapporti instaureremo fra noi, per prepararci a queste prime forme di contatto con «gli altri»? Noi che nella colonizzazione della terra non siamo stati capaci di praticare altro che depredazione e spoliazione delle popolazioni con cui siamo venuti in contatto, accetteremo di essere «i primitivi» al cospetto di civiltà che si sono sviluppate qualche milione di anni prima di noi?
E viceversa, quali relazioni saremo in grado di instaurare con forme di vita, magari simili alle nostre, ma che ci potranno apparire a un livello di sviluppo primordiale? È pensabile che si cominci a ragionare dei problemi etici connessi a questo passaggio? Noi che non siamo in grado di gestire l’integrazione di alcuni milioni di rifugiati o di emigranti che sfuggono la guerra o precarie condizioni di vita, con quali strumenti culturali arriveremo a questo appuntamento che ci chiama a un salto di civiltà?
I nostri pronipoti vedranno un mondo che noi, oggi, possiamo solo immaginare. Riusciremo ad attrezzarci nel giro di qualche generazione a questo cambio di paradigma sul piano antropologico?
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" --- CORRISPONDENZA INFINITA. Lettera di Sir Henry Wotton, a Giacomo I, per informarlo della «più insolita notizia». «Carteggio» (Aggiornamento dell’Edizione Nazionale delle Opere di Galileo).28 febbraio 2016, di Federico La Sala
Galileo Galilei (1564-1642)
Corrispondenza infinita
Pubblicato un aggiornamento del «Carteggio» curato circa un secolo fa da Antonio Favaro, colui che contribuì enormemente alla creazione del «mito» dell scienziato pisano
di Franco Giudice (Il Sole-24 Ore, Domenica, 28.2.16
- Galileo Galilei, Carteggio (Aggiornamento dell’Edizione Nazionale) , a cura di Michele Camerota e Patrizia Ruffo, con la collaborazione di Massimo Bucciantini, Giunti Editore, Firenze, pagg. 661, € 150
L’Edizione Nazionale delle Opere di Galileo non è un monumento esornativo al più celebre scienziato italiano di tutti i tempi o, peggio ancora, una mera raccolta dei suoi scritti concepita per rivendicarne, in modo velatamente apologetico, la genialità. E tanto meno lo fu per Antonio Favaro, lo studioso padovano che ideò e portò a compimento il progetto tra il 1890 e il 1909. Certo, Favaro diede un contributo decisivo all’affermazione del “mito” di Galileo come padre del metodo sperimentale. È innegabile tuttavia che il suo lavoro si basò sempre sulla centralità del documento, respingendo ogni interpretazione non suffragata dalle fonti.
Nell’approntare quella che più volte definì «l’impresa della mia vita», Favaro seguì ineccepibili criteri ecdotici, grazie anche alla collaborazione di due esperti filologi come Isidoro Del Lungo e Umberto Marchesini. Così, tra difficoltà finanziarie e nella quasi assoluta indifferenza della cultura accademica italiana, in poco meno di vent’anni riuscì a realizzare uno dei più importanti progetti della storia dell’editoria del nostro paese: la pubblicazione integrale - in venti volumi e secondo un ordine rigorosamente cronologico - degli scritti di Galileo, del carteggio, dei documenti relativi alla sua vita e alle sue opere, insieme a quelle di altri autori che lo scienziato postillò con commenti e annotazioni. Un’operazione lunga e faticosa che, in un’epoca priva di tecnologie informatiche, venne completata in tempi davvero record. E che ha il merito di essersi sottratta al triste destino condiviso dalle altre edizioni nazionali intraprese contemporaneamente in Italia, quasi tutte rimaste incomplete e in alcuni casi addirittura mai iniziate.
Oltre a costituire uno strumento indispensabile per tutti quelli che si accingono a studiare Galileo, questa Edizione Nazionale ha assunto anche il ruolo di modello per chiunque voglia cimentarsi con imprese di pari complessità. Tanto più che, rispetto ad altre iniziative analoghe realizzate negli stessi anni all’estero, il lavoro di Favaro conserva ancora quel carattere di edizione “definitiva” cui ambiva.
È dunque nel segno di questa preziosa eredità che, a distanza di un secolo, Michele Camerota, Patrizia Ruffo e Massimo Bucciantini hanno provveduto a una corposa integrazione del carteggio galileiano. Il volume si aggiunge a quello dell’Iconografia galileiana (uscito nel 2013 e curato da Federico Tognoni) e fa parte di un piano generale di Aggiornamento dell’ Edizione Nazionale, che ne prevede altri due, già in fase avanzata di preparazione, dove saranno raccolti una serie di testi non pubblicati da Favaro e i documenti e gli atti inquisitoriali emersi dopo il 1909. Un progetto di grande rilievo, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e affidato a un comitato scientifico internazionale presieduto da Paolo Galluzzi, direttore del Museo Galileo di Firenze.
Durante la preparazione del carteggio, Favaro compì una scelta quanto mai felice: pubblicare non solo le lettere di Galileo e quelle a lui indirizzate, ma anche le corrispondenze dei contemporanei in cui si trovavano riferimenti sia alle sue vicende biografiche sia alle sue straordinarie scoperte scientifiche. Per lo studioso padovano, infatti, l’epistolario si configurava come un autentico «dramma»: una rappresentazione scenica, dove il protagonista andava inserito nel contesto del dibattito culturale del suo tempo. Un risultato che ottenne in modo mirabile, mettendo a disposizione degli studiosi 4290 lettere, tutte presentate in sequenza cronologica, e che occupano ben nove ponderosi volumi dell’intera Edizione Nazionale.
Adottando in larga parte i criteri di Favaro, i curatori dell’aggiornamento del Carteggio lo arricchiscono ora di altre 588 lettere che sono nel frattempo venute alla luce e via via pubblicate in libri e articoli specialistici. Di esse, centoventi, più di un quinto dunque, erano inedite e sono state rinvenute con accurate ricerche svolte in fondi archivistici e bibliotecari nazionali ed esteri. Tutte le lettere, il cui arco temporale va dal 1588 al 1643, sono corredate di note che chiariscono i riferimenti a persone, opere ed episodi specifici, fornendo altresì una fitta trama di rimandi interni che facilitano la consultazione dell’intero corpus del carteggio.
Potrà forse deludere qualche aspettativa scoprire che soltanto poche lettere sono di Galileo o a lui dirette. È bene però sottolineare che il valore di questa nuova raccolta epistolare va individuato nella sua capacità di far emergere un panorama in precedenza poco esplorato: una rete di comunicazione cioè intensa e vivace, popolata di filosofi, astronomi, matematici, teologi, ma anche di artigiani, ambasciatori, cortigiani, nunzi pontifici e sovrani, che si scambiano opinioni e discutono su Galileo e sul significato delle sue opere. Una polifonia di voci insomma, che disegnano una mappa della diffusione e della “fortuna” dell’autore del Dialogo sopra i due massimi sistemi, e la cui estensione geografica copre l’intero continente europeo.
Più nello specifico poi, l’Aggiornamento contiene diversi elementi di novità rispetto a quanto si sapeva già. È il caso, giusto per fare qualche esempio, della fitta corrispondenza intercorsa tra i gesuiti tedeschi sulle osservazioni telescopiche del biennio 1609-1610, o delle numerosissime lettere (ben 77, alcune inedite) che documentano il costante interesse dello scienziato dilettante francese Nicolas Fabri de Peiresc per le dottrine galileiane, così come, dopo il 1633, il suo coraggio nel cercare di convincere le autorità ecclesiastiche a mitigare gli effetti della condanna.
Ma merita anche di essere ricordata una bellissima lettera, mai prima edita in Italia integralmente, scritta il 13 marzo 1610, proprio il giorno della pubblicazione del Sidereus nuncius, dall’ambasciatore inglese a Venezia, Sir Henry Wotton, a Giacomo I, per informarlo della «più insolita notizia» che il sovrano «avesse mai ricevuto da qualsiasi parte del mondo», la scoperta cioè dei quattro satelliti di Giove. Wotton vi accludeva un esemplare dell’opera e, nel darne un dettagliato resoconto dei contenuti al re d’Inghilterra, osservava che a Venezia «se ne parla in ogni angolo della città» e che «l’autore corre il rischio di diventare o estremamente famoso o estremamente ridicolo».
Questa integrazione del carteggio offre inoltre spunti notevoli sui rapporti tra Galileo e i suoi mecenati e protettori, i Medici, aiutando a illuminare aspetti ignoti della sua stessa biografia. Così, una sua lettera del 1° giugno 1616 all’ambasciatore fiorentino a Roma, Piero Guicciardini, ci informa delle spese sconsiderate sostenute durante il soggiorno romano nella primavera di quell’anno, e tali da far dire all’ambasciatore che Galileo si era dato alla «pazza vita».
L’Aggiornamento, infine, apre squarci inediti sui contatti tra Galileo e Giovanni di Guevara, uno studioso di questioni meccaniche da lui molto apprezzato. E lo fa ancor di più in merito alle sue relazioni, tutte da approfondire e chiarire, con il padre Niccolò Riccardi, il Maestro di Sacro Palazzo, che fu uno dei protagonisti della complessa vicenda processuale del 1632, in quanto responsabile della concessione dell’imprimatur al Dialogo.
Pochi anni prima di morire Favaro lamentava lo stato di «quasi clandestinità» in cui versava l’Edizione Nazionale, a causa dell’esiguo numero di copie stampate (appena 500) e distribuite per di più fuori commercio. Da allora, ovviamente, le cose sono cambiate: ristampata tra il 1929 e il 1939, e poi nel 1964, l’opera si trova oggi in tutte le più importanti biblioteche del mondo. Non si può tuttavia dire che essa goda di ampia circolazione, anche perché è venduta a un prezzo troppo elevato per i lettori comuni. Sarebbe dunque davvero lodevole, oltre che auspicabile, se la Giunti seguisse il suggerimento, all’epoca caduto nel vuoto, che dava lo stesso Favaro, mettere cioè sul mercato una versione economica dell’Edizione Nazionale. D’altronde, i buoni esempi non mancano. Basti pensare che dal 1996 Vrin vende i tredici volumi delle Oeuvres complètes di Descartes all’accessibile cifra di 153 euro, praticamente quasi allo stesso prezzo di questo splendido aggiornamento del Carteggio galileiano.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" -- Sotto il segno di Copernico. L’edizione critica del "De revolutionibus orbium coelestium" (di Massimo Bucciantini)24 gennaio 2016, di Federico La Sala
Sotto il segno di Copernico
 Una splendida edizione critica dell’«opera-mondo» che rivoluzionò l’astronomia e l’umanità.
Una splendida edizione critica dell’«opera-mondo» che rivoluzionò l’astronomia e l’umanità.
 La Chiesa l’avrebbe condannata nel 1616, ma l’autore fu incoraggiato a uscire allo scoperto dal cattolico Nicolas Schönberg
La Chiesa l’avrebbe condannata nel 1616, ma l’autore fu incoraggiato a uscire allo scoperto dal cattolico Nicolas Schönbergdi Massimo Bucciantini (Il Sole-24 Ore, Domenica, 24.01.2016)
- Niccolò Copernico, De revolutionibus orbium coelestium. Des révolutions des orbes célestes , édition critique, traduction et notes par Michel-Pierre Lerner, Alain-Philippe Segonds et Jean-Pierre Verdet, Les Belles Lettres, Paris, voll. 3 (pagg. XXVIII 859, VIII 536, XVIII 783), € 199
Il 21 marzo 1543 Sébastien Kurtz, agente dei banchieri Fugger alla corte imperiale, informava Carlo V dell’imminente pubblicazione a Norimberga di un libro che certamente lo avrebbe incuriosito: «Niccolò Copernico, matematico, ha dato in questi giorni alle stampe sei libri de Revolutionibus orbium coelestium. E si tratta di una cosa non meno meravigliosa che nuova, e mai vista, né intesa, né pensata, che il Sole sarebbe il centro di tutto e che non si muove come si è sempre creduto, e che il nostro mondo si muove sullo zodiaco esattamente come fino a oggi ha fatto il Sole». Kurtz, che conosceva la passione per l’astronomia dell’imperatore, decideva di inviargliene un esemplare, convinto che sarebbe stato felice di apprendere la nuova concezione del mondo «di questo autore che molti matematici lodano» e attraverso la quale «si spiegano più facilmente tutti i movimenti del cielo».
Che fine abbia fatto quella copia non è noto. Nella Biblioteca San Lorenzo dell’Escorial si trova una prima edizione del De revolutionibus, ma non si tratta della copia spedita all’imperatore, bensì di quella acquisita nel 1545 dal figlio Filippo II. Né si sa, e sarebbe cosa più importante, se Carlo V lesse mai il libro. A cominciare da quell’anonimo Avvertimento al lettore che - come osservò Tiedemann Giese, vescovo di Culm e amico fraterno di Copernico - tradiva completamente il pensiero dell’autore.
Giese fu il primo a denunciare quel “crimine”, che trasformava l’indagine su un universo considerato vero e reale in un’ingegnosa ma fittizia ipotesi matematica introdotta al semplice scopo di salvare le apparenze dei movimenti celesti. Si sbagliava solo su un punto: ne addossò la responsabilità allo stampatore Johannes Petreius invece che al teologo luterano Andreas Osiander. Per il resto aveva visto giusto, tanto che nel difendere l’onorabilità dell’amico appena scomparso si rivolse perfino al Senato di Norimberga. All’insaputa dell’autore era stata compiuta un’operazione indegna, che svuotava di significato una vita spesa a «osare d’immaginare qualche movimento della Terra, contro l’opinione universalmente accolta dai matematici e contro il senso comune».
Una vera e propria impostura che contraddiceva la nova ratio mundi ricercata ossessivamente da Copernico e che, nella prefazione a Paolo III, gli faceva dichiarare in modo solenne: «quanto più assurda apparirà ora la mia dottrina sul movimento della Terra, tanta maggiore ammirazione e gratitudine riceverà una volta che si sarà vista l’edizione dei miei commentari in cui le tenebre delle assurdità saranno dissolte con chiarissime dimostrazioni».
Nessuno prima di lui aveva accettato di correre un simile rischio. A nessuno era mai venuto in mente di realizzare un progetto così ambizioso e al tempo stesso considerato dai suoi contemporanei così assurdo. Da solo, per giunta, e in un momento per tanti versi ostile ad accogliere tali novità Copernico confezionò un libro che - per riprendere una fortunata immagine di Franco Moretti - è davvero un’opera-mondo. Che fin da subito venne etichettato come il nuovo Almagesto. E il suo autore come un nuovo Tolomeo. E come quest’ultimo sarebbe diventato altrettanto grande, anzi più grande ancora, a tal punto che toccò a lui, dopo quattrodici secoli di incontrastato dominio, decretarne l’inesorabile tramonto.
Sotto il segno della grandezza va inscritto anche questo lavoro appena uscito. Senza retorica va detto che oggi Copernico ha finalmente trovato una “casa” degna della sua straordinaria impresa. Grazie a questa edizione - frutto di anni di studio da parte di un gruppo di specialisti nel campo dell’astronomia, della matematica, della filologia, della storia e della filosofia coordinato da Michel-Pierre Lerner, Alain-Philippe Segonds e Jean-Pierre Verdet - il De revolutionibus torna di nuovo a parlarci. Una sfida, anch’essa, che non era affatto scontato vincere, e che suona come una mirabile conferma - semmai ce ne fosse ancora bisogno - di come la cultura sia una, e di come solo dalla collaborazione di forze intellettuali diverse possano nascere opere di questo valore.
La ricostruzione di questa opera-mondo si compone di tre volumi. Il secondo e il terzo contengono il testo con traduzione francese a fronte, un ampio commento e un vasto apparato di note e appendici di documenti e materiale iconografico. Il primo, invece, è di fatto un libro su Copernico, dove per la prima volta sono indagati in modo esaustivo sia i molteplici aspetti della sua biografia sia le numerose tracce della circolazione europea che il libro ottenne fino alla condanna decretata dal Sant’Uffizio romano il 5 marzo 1616.
L’intricata e in gran parte sconosciuta genesi del De revolutionibus ha giustamente meritato l’attenzione (e la fantasia) di uno scrittore come John Banville (il suo Doctor Copernicus sta finalmente per uscire in Italia da Guanda). Non sappiamo infatti quando Copernico prese la decisione di pubblicare un trattato di astronomia paragonabile all’Almagesto di Tolomeo, ovvero un’opera che doveva contenere, accanto all’esposizione di un nuovo sistema cosmologico, «un catalogo delle stelle fisse, le dimostrazioni matematiche dei movimenti planetari sia in longitudine che in latitudine e, infine, le tavole di tali movimenti».
Si sa che l’idea originaria era quella di stampare soltanto queste ultime, sul modello delle tolemaiche Tavole alfonsine, ma fondate sulla dottrina del movimento della Terra. L’incoraggiamento a fare di più, ad abbandonare ogni prudenza e a rendere pubblici i principi della sua concezione del mondo, «diametralmente opposta alle ipotesi degli Antichi», gli venne da un personaggio di primo piano della Chiesa cattolica: Nicolas Schönberg. Nominato cardinale da Paolo III nel 1535, e in precedenza legato pontificio in Germania, Ungheria e Polonia (dove forse incontrò Copernico), nel 1537 partecipò al Concilio di Trento, e fu uno dei pochi - secondo la testimonianza di Melantone - a schierarsi a favore di alcune concessioni nei confronti dei luterani.
 Nel novembre 1536, da Roma, Schönberg scrisse una lettera a Copernico, invitandolo a comunicare quanto prima agli studiosi la sua dottrina del mondo, nella quale si insegna che «la Terra si muove e l’ottavo cielo rimane perpetuamente immoto e fisso».
Nel novembre 1536, da Roma, Schönberg scrisse una lettera a Copernico, invitandolo a comunicare quanto prima agli studiosi la sua dottrina del mondo, nella quale si insegna che «la Terra si muove e l’ottavo cielo rimane perpetuamente immoto e fisso».Difficile sapere cosa avrebbe fatto Copernico se non avesse ricevuto questa lettera che custodì gelosamente per sette anni e poi volle riprodurre proprio all’inizio dell’opera. Assai meno incerto è invece il giudizio - e lo conferma anche questo lavoro - sul ruolo svolto da Georg Rheticus nella stampa del De revolutionibus. L’entusiasmo e la determinazione del giovane matematico luterano proveniente dall’università di Wittenberg, che alla fine di maggio del 1539 si recò nella cattolicissima Warmia per conoscere il canonico e astronomo polacco, furono decisivi. Sua l’idea di fornire una breve esposizione della concezione eliocentrica che anticipasse l’uscita dell’opera del maestro. E fu un successo: ben due edizioni nel giro di due anni. Senza la Narratio prima di Rheticus molto probabilmente il De revolutionibus avrebbe fatto la fine del Commentariolus redatto da Copernico prima del 1514: sarebbe rimasto manoscritto e la sua circolazione non sarebbe andata oltre la ristretta cerchia di matematici e astronomi.
L’opera venne pubblicata a Norimberga nella primavera del 1543. A portare una copia del manoscritto nella città tedesca e poi a seguirne la lunga e delicata fase della stampa toccò a Rheticus. Almeno fino a quando, nell’agosto del 1542, non venne richiamato a Wittenberg, lasciando così Andreas Osiander libero di mettere in atto la sua strategia editoriale.
Alla fine di quello stesso anno Copernico si ammalò gravemente. La morte lo colse il 24 maggio 1543. Come scriverà Giese a Rheticus il 26 luglio, una grave paralisi lo aveva colpito lungo tutta la parte destra del corpo e già da qualche tempo aveva perso la memoria. Crudeltà della sorte volle che l’opera arrivasse a Frombork proprio nei suoi ultimi giorni. Copernico la poté vedere e sfogliare solo poche ore prima di morire. Forse senza neppure rendersi conto che tra le sue mani c’era il suo libro, il libro di un’intera vita.
-
> Keplero nei panni di avvocato: «Mia madre non è una strega». "The Astronomer and the Witch" (Ulinka Rublack).11 gennaio 2016, di Federico La Sala
Processi
«Mia madre non è una strega»
 Keplero nei panni di avvocato
Keplero nei panni di avvocato Nella Germania del Seicento il grande astronomo scese in campo per amore filiale e salvò Katharina dal rogo
Nella Germania del Seicento il grande astronomo scese in campo per amore filiale e salvò Katharina dal rogo
 Una vicenda che dimostra quali rischi corressero all’epoca le donne e come fosse labile il confine tra razionale e irrazionale
Una vicenda che dimostra quali rischi corressero all’epoca le donne e come fosse labile il confine tra razionale e irrazionaledi Stefano Gattei (Corriere della Sera, La Lettura, 10.01.2016)
Quando bussarono alla sua porta, la sera del 29 dicembre 1615, Keplero aveva appena festeggiato il quarantaquattresimo compleanno. Era arrivato da pochi anni a Linz da Praga, dove alla morte di Tycho Brahe, nel 1601, era stato nominato matematico imperiale da Rodolfo II. Nella capitale ceca aveva pubblicato rivoluzionari lavori di ottica e diottrica, «dialogato» con il Sidereus nuncius di Galileo e iniziato il lungo lavoro che, nel 1627, sarebbe sfociato nelle Tabulae Rudolphinae, manifesto e simbolo della nuova astronomia.
Nel 1609, in particolare, aveva enunciato le prime due leggi dei movimenti planetari che ancora oggi portano il suo nome, rompendo con la tradizione millenaria della perfetta circolarità delle orbite e del moto uniforme dei corpi celesti. E proprio a Linz stava continuando il lavoro che lo avrebbe portato alla scoperta, nel 1619, della terza legge, sintesi dell’armonia delle sfere che Keplero affermava con orgoglio di aver letto nella mente di Dio.
Un messaggero gli consegnò una lettera inviata dalla sorella tre mesi prima: la loro anziana madre, Katharina, era stata accusata di aver provocato l’improvvisa malattia di una donna particolarmente in vista nella piccola città di Leonberg, dove entrambe risiedevano. Katharina aveva portato in tribunale gli accusatori per diffamazione, ma contro di lei si erano mossi personaggi potenti e il governatore della regione non aveva potuto fare a meno di procedere nei suoi riguardi.
Il processo sarebbe durato sei anni, per la maggior parte dei quali Keplero seguì lo svolgersi degli eventi a distanza, intervenendo con lettere private o attraverso persone di fiducia. Nel 1620, tuttavia, la situazione precipitò. Il 7 agosto Katharina venne svegliata nel cuore della notte, le guardie erano venute a prenderla. Provò inutilmente a nascondersi nel cesto della biancheria, ma la trovarono e la condussero in prigione, dove rimase per mesi, incatenata al muro della propria cella. Di lì a poco il figlio sciolse ogni indugio e ne assunse ufficialmente la difesa: nessun altro intellettuale di spicco avrebbe mai compiuto un gesto del genere. Keplero lasciò Linz, mise da parte gli studi, impacchettò libri, manoscritti e strumenti e si trasferì con l’intera famiglia nel Sud della Germania per quasi un intero anno.
La situazione era grave, come leggiamo nell’avvincente ricostruzione di Ulinka Rublack, docente di Storia della prima età moderna all’Università di Cambridge: The Astronomer and the Witch. Johannes Kepler’s Fight for his Mother (Oxford University Press). Tra il 1500 e il 1700 circa 73 mila uomini e donne vennero processati per stregoneria in Europa. Di questi, 40-50 mila vennero giustiziati, metà di loro entro i confini dell’odierna Germania; tre quarti degli accusati erano donne. Katharina - vedova, analfabeta, ma relativamente benestante - fu una delle migliaia di donne costrette a subire un processo in tarda età: reagì con forza, negando l’accusa, ma poco poté contro un meccanismo che, una volta innescato, sarebbe stato difficile fermare.
Lo stesso Keplero, inviso ai teologi della luterana Württemberg perché considerato troppo vicino a Calvino, non si faceva illusioni sull’esito del dibattimento. Provò quindi a coinvolgere parenti, amici e mecenati, anche a dispetto di parte della famiglia e in particolare del fratello minore, Christoph, che, preoccupato per le possibili ripercussioni sulla propria attività artigianale di lavorazione del peltro, aveva finito per prendere le distanze dalla madre.
Quello a Katharina è uno dei processi di stregoneria meglio documentati della storia. La comunità entro la quale si svolse è ben conosciuta agli studiosi, e questo ci consente di ricostruire il mondo e le credenze dell’imputata con precisione. Sappiamo come la gente si guadagnava da vivere, come si nutriva, quali erano le sue ambizioni, come le persone vedevano e gestivano eventuali conflitti che coinvolgevano il soprannaturale.
Come Rublack mostra in modo del tutto convincente - prendendo posizione critica nei confronti di alcuni studi precedenti, troppo affrettati nelle conclusioni - la popolazione non fu vittima di un’improvvisa smania collettiva, né ci sono prove che i giudici fossero a conoscenza delle idee scientifiche di Keplero, in particolare del suo sostegno all’opinione copernicana (cosa che avrebbe potuto spingerli ad accusare la madre per attaccare il celebre figlio).
Ricostruire la vita e il processo di Katharina, sostiene Rublack, ha un duplice significato. Da un lato, ci consente di rivedere la nostra comprensione della figura e dell’opera di Keplero, e con lui quella di altri intellettuali suoi contemporanei. È infatti riduttivo vedere Keplero, Galileo o Newton (grandi scienziati, dediti però anche all’astrologia, all’alchimia o all’esegesi biblica) come campioni del pensiero razionale che, dopo secoli di sonno della ragione, hanno misurato e geometrizzato il mondo: la netta distinzione, tutta contemporanea, tra razionale e irrazionale, tra religione e magia, finisce infatti per oscurare aspetti chiave della loro visione del mondo, impedendoci di penetrarla fino in fondo.
Dall’altro, il processo getta anche luce sulla difficile condizione delle donne, specialmente se anziane, vedove e sole, in un periodo in cui chiacchiere o liti di paese si trasformavano facilmente in controversie che, trascinandosi nel tempo, potevano avere conclusioni tragiche.
 Lo stesso Galileo non esitò a descrivere la madre in termini analoghi a quelli con cui gli avversari trascinarono Katharina in tribunale: attaccabrighe, piantagrane, fisicamente ripugnante - tanto da spingerla a denunciare il figlio all’Inquisizione per averle dato della prostituta («gabrina», l’apostrofò Galileo, ricorrendo al nome dato da Ariosto a una vecchia strega, maligna e sgradevole, nell’ Orlando furioso: «Gabrina è il nome di costei, che nacque/ sol per tradire ognun che in man le cada»).
Lo stesso Galileo non esitò a descrivere la madre in termini analoghi a quelli con cui gli avversari trascinarono Katharina in tribunale: attaccabrighe, piantagrane, fisicamente ripugnante - tanto da spingerla a denunciare il figlio all’Inquisizione per averle dato della prostituta («gabrina», l’apostrofò Galileo, ricorrendo al nome dato da Ariosto a una vecchia strega, maligna e sgradevole, nell’ Orlando furioso: «Gabrina è il nome di costei, che nacque/ sol per tradire ognun che in man le cada»).Alla fine, Keplero riuscì a salvare la madre dal rogo, mostrando l’infondatezza delle accuse, la debolezza delle argomentazioni e l’inconsistenza delle prove portate in loro sostegno. Katharina morì sei mesi più tardi, nel proprio letto, a 76 anni. La loro vicenda ci fa guardare con occhi diversi a una delle pagine più buie della nostra storia e, al medesimo tempo, pensare in modo nuovo il complesso legame tra scienza, religione e società che ha contribuito a plasmare l’Europa in cui oggi viviamo.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. -- LA LUNA FOTOGRAFATA DAGLI ASTRONAUTI DELLA NASA.12 novembre 2015, di Federico La Sala
 La Luna fotografata dagli astronauti della NASA
La Luna fotografata dagli astronauti della NASA Le immagini sono state pubblicate su Flickr, sono oltre 8mila e raccontano la missione Apollo 8 e tutte quelle dalla 10 alla 17
Le immagini sono state pubblicate su Flickr, sono oltre 8mila e raccontano la missione Apollo 8 e tutte quelle dalla 10 alla 17 Da alcune ore sono disponibili su Flickr più di 8.400 fotografie scattate da astronauti della NASA durante le missioni del Programma Apollo, che il 20 luglio 1969 consentì all’uomo - e più precisamente a Neil Armstrong e Buzz Aldrin - di arrivare sulla Luna. Le immagini su Flickr del Project Apollo Archive riguardano la missione Apollo 8 e tutte quelle dalla 10 alla 17. La maggior parte delle foto sono state scattate con macchine fotografiche Hasselblad, un’azienda svedese famosa per i suoi prodotti di alta qualità, e sono di dominio pubblico. Dentro ciascuna immagine c’è una breve didascalia che specifica la missione durante la quale è stata scattata quella foto e il rullino fotografico di cui è parte. Tutte le altre foto, anche quelle che non ha scelto il Post,si vedono qui.
Da alcune ore sono disponibili su Flickr più di 8.400 fotografie scattate da astronauti della NASA durante le missioni del Programma Apollo, che il 20 luglio 1969 consentì all’uomo - e più precisamente a Neil Armstrong e Buzz Aldrin - di arrivare sulla Luna. Le immagini su Flickr del Project Apollo Archive riguardano la missione Apollo 8 e tutte quelle dalla 10 alla 17. La maggior parte delle foto sono state scattate con macchine fotografiche Hasselblad, un’azienda svedese famosa per i suoi prodotti di alta qualità, e sono di dominio pubblico. Dentro ciascuna immagine c’è una breve didascalia che specifica la missione durante la quale è stata scattata quella foto e il rullino fotografico di cui è parte. Tutte le altre foto, anche quelle che non ha scelto il Post,si vedono qui. -
> IL "SIDEREUS NUNCIUS" --- ARISTOTELE, CHE FISICO! «Io mi rendo sicuro che se Aristotele tornasse al mondo, egli riceverebbe me tra i suoi seguaci, in virtù delle mie poche contraddizioni alla sua dottrina» (Galileo).18 ottobre 2015, di Federico La Sala
- Aristotele fu un uomo, vedde con gli occhi, ascoltò con gli orecchi, discorse col cervello. Io sono un uomo, veggo con gli occhi, e assai più che non vedde lui: quanto al discorrere, credo che discorresse intorno a più cose di me; ma se più o meglio di me, intorno a quelle che abbiamo discorso ambedue, lo mostreranno le nostre ragioni, e non le nostre autorità (Galileo Galilei).
MAESTRI. Galileo attaccò il filosofo greco, poi in tarda età se ne proclamò seguace
Aristotele che fisico!
Le sue teorie scientifiche godono di cattiva fama. Ma a torto: furono la base dei successivi progressi
di Carlo Rovelli (Corriere della Sera-La Lettura, 18.10.2015)
Cadono alla stessa velocità oggetti di peso diverso? A scuola ci raccontano che Galileo Galilei avrebbe mostrato che la risposta è sì, lasciando cadere delle palle dalla torre di Pisa. Nel corso dei due millenni precedenti, invece, sarebbero stati tutti accecati dal dogma di Aristotele secondo cui oggetti più pesanti cadono più in fretta; curiosamente, a nessuno era mai venuto in mente di provare. Galileo e i suoi contemporanei osservano la natura, e si liberano dalla camicia di forza del dogmatismo aristotelico.
Bella storia, ma c’è un problema. Provate a buttare dal balcone una biglia di vetro e una pallina di carta. Neanche per idea arrivano assieme: la biglia pesante cade molto più veloce, esattamente come dice Aristotele. Qualcuno obietterà che questo avviene a causa dell’aria. Ma Aristotele non ha mai scritto che le cose cadrebbero a velocità diversa se togliessimo l’aria. Ha scritto che le cose cadono a velocità diversa nel nostro mondo, dove l’aria c’è. E non sbagliava. Aveva osservato la natura con attenzione. Meglio di generazioni di insegnanti e studenti moderni, che si bevono nozioni senza pensarci, e senza provare.
La fisica di Aristotele gode di cattiva stampa. Viene descritta come costruita a priori, svincolata dall’osservazione, palesemente sbagliata. È un giudizio largamente ingiusto. La fisica di Aristotele è rimasta a lungo la teoria di riferimento per la civiltà mediterranea: non perché fosse dogmatica, ma perché è ottima. Descrive bene la realtà, e offre uno schema concettuale così efficace che per due millenni nessuno è riuscito a fare di meglio. Il succo della teoria è che, in assenza di altre influenze, un oggetto si muove verso il suo «luogo naturale»: più in basso per la terra, un po’ più in alto per l’acqua, ancora più in alto per l’aria, ancora più in alto per il fuoco; la velocità del «moto naturale» cresce con il peso e diminuisce con la densità del fluido in cui l’oggetto è immerso. Una teoria semplice e generale che rende conto con eleganza di una grande varietà di fenomeni, per esempio perché il fumo va in alto, o perché un pezzo di legno scende in aria, ma sale in acqua. Ovviamente la teoria non era perfetta, ma se è per questo neanche la scienza moderna è perfetta.
Il cattivo nome di cui soffre la fisica di Aristotele è in parte colpa dello stesso Galileo, che nei suoi scritti attacca Aristotele a testa bassa, e fa apparire sciocchi i suoi seguaci. Ne aveva bisogno a fini polemici. In parte è dovuto alla separazione che si è scioccamente allargata fra le culture scientifica e umanistica-filosofica. Chi studia Aristotele in generale conosce poco la fisica e chi si occupa di fisica si interessa poco ad Aristotele. La genialità scientifica dei libri di Aristotele come il De Coelo, o la Fisica, il libro che ha dato il nome alla disciplina, passa facilmente inosservata.
Ma c’è un altro fattore per la cecità odierna alla genialità di Aristotele scienziato. Ed è quello più interessante: l’idea che non si possa, anzi non si debba, confrontare pensieri prodotti da universi culturali così lontani, come Aristotele e la fisica moderna. Molti storici oggi inorridiscono all’idea di guardare la fisica aristotelica come approssimazione della fisica newtoniana. Per capire l’Aristotele originale, sostengono, dobbiamo studiarlo alla luce del suo tempo, non con schemi concettuali successivi di secoli. Questo è vero se siamo interessati a meglio decifrare Aristotele, ma se siamo interessati a capire il sapere di oggi, come è emerso dal passato, sono le relazioni fra mondi distanti che ci interessano.
I filosofi e storici della scienza Karl Popper e Thomas Kuhn, che hanno avuto grande influenza sul pensiero odierno, hanno sottolineato l’importanza delle rotture nel corso dell’evoluzione del sapere. Esempi di tali «rivoluzioni scientifiche», dove si abbandona la vecchia teoria, sono i passaggi dalla fisica di Aristotele a Newton, o da Newton ad Einstein. Nel corso di tali passaggi ci sarebbe, secondo Kuhn, una ristrutturazione radicale del pensiero, al punto che le idee precedenti diventano irrilevanti, addirittura incomprensibili: «incommensurabili» con la teoria successiva, scrive Kuhn.
Popper e Kuhn hanno avuto il merito di mettere a fuoco questo aspetto evolutivo della scienza e l’importanza delle fratture, ma la loro influenza ha portato a una assurda negazione degli ovvi aspetti cumulativi del sapere. Peggio, a non voler vedere le chiarissime relazioni logiche e storiche fra teorie prima e dopo ogni passo avanti: la fisica di Newton è perfettamente riconoscibile come approssimazione della relatività generale di Einstein; la teoria di Aristotele è perfettamente riconoscibile come approssimazione all’interno della teoria di Newton.
Non solo, ma all’interno della teoria di Newton si riconoscono aspetti della struttura della fisica aristotelica. Per esempio, la grande idea di distinguere il movimento «naturale» di un corpo da quello «forzato», sopravvive intatta nella fisica newtoniana, e poi in quella di Einstein. Cambia il ruolo della gravità: causa di moto forzato in Newton (dove il moto naturale è rettilineo uniforme), parte del moto naturale in Aristotele, e, curiosamente, di nuovo in Einstein (dove il moto naturale, chiamato «geodetico», torna ad essere quello di un oggetto in caduta libera, come per Aristotele).
Gli scienziati non avanzano né per solo accumulo, né per rivoluzioni totali, in cui tutto è buttato e si ricomincia da zero. Avanzano piuttosto, come in una bella analogia di Otto Neurath spesso citata da Willard Van Orman Quine, «come marinai in mare aperto che devono ricostruire la loro barca, ma non possono farlo da zero: dove tolgono una trave devono subito rimpiazzarla (...), in questo modo, pezzo a pezzo avanza la ricostruzione». Nella grande nave che è la fisica moderna si riconoscono ancora antiche strutture - come la distinzione fra moto naturale e forzato - della vecchia barca del pensiero aristotelico.
Torniamo allora ai corpi che cadono nell’aria o nell’acqua, e vediamo cosa effettivamente succede. La caduta non è né a velocità costante e dipendente dal peso, come voleva Aristotele, né ad accelerazione costante e indipendente dal peso, come voleva Galileo (neanche se trascuriamo l’attrito!). Quando un corpo cade, attraversa una prima fase in cui accelera, per poi stabilizzarsi a velocità costante, maggiore per i corpi pesanti. Questa seconda fase è ben descritta da Aristotele.
La prima fase invece è di solito molto breve, difficile da osservare, e per questo è sfuggita ad Aristotele. L’esistenza di questa fase iniziale era già stata notata nell’antichità: nel terzo secolo prima della nostra era, per esempio, Stratone di Lampsaco (città sullo stretto dei Dardanelli) osserva che un filo d’acqua che cade si rompe in gocce: questo indica che le gocce cadendo accelerano, come una fila di auto che si sgrana man mano che le auto prendono velocità.
Per studiare questa fase iniziale, difficile da osservare perché tutto avviene in fretta, Galileo scova uno stratagemma geniale. Invece di osservare corpi che cadono, osserva palle che rotolano lungo una lieve pendenza. La sua intuizione, difficile da giustificare al suo tempo ma corretta, è che la «caduta rallentata» delle palle che rotolano riproduca il moto di oggetti che cadono liberi. In questo modo, Galileo riesce a notare che all’inizio della caduta è l’accelerazione ad essere costante, non la velocità. Forte di questa nuova capacità di interrogare la natura, e di una padronanza della matematica che mancava ad Aristotele, Galileo è riuscito a stanare il dettaglio quasi impercettibile ai nostri sensi dove la fisica di Aristotele funziona male. È come l’osservazione all’inizio del Novecento usata da Einstein per superare Newton: il movimento del pianeta Mercurio, a ben guardare, non segue esattamente le orbite di Newton. Il diavolo è nei dettagli.
Einstein farà di Newton quello che Galileo e Newton hanno fatto di Aristotele: mostrerà che nonostante la sua efficacia, anche questa fisica è solo buona in prima approssimazione. Oggi sappiamo che anche la fisica di Einstein non è perfetta: sbaglia là dove entra troppo in gioco la meccanica quantistica. Anche la fisica di Einstein ha bisogno di essere migliorata. Ma non siamo ancora ben sicuri di come.
Galileo non ha costruito la sua nuova fisica ribellandosi a un dogma o dimenticando Aristotele. Al contrario, ha saputo modificare aspetti della cattedrale concettuale aristotelica, imparando a fondo da Aristotele: non c’è incommensurabilità fra lui e Aristotele, c’è serrato dialogo.
Credo che sia lo stesso fra le culture, le persone, i popoli. Non è vero che, come oggi si ama ripetere, mondi culturali diversi sono intraducibili, impermeabili. È vero il contrario: le frontiere fra teorie, discipline, epoche, culture, popoli, persone, sono terribilmente permeabili, e il nostro sapere si nutre degli scambi attraverso questa permeabilità. Anzi, il sapere è il risultato in continua evoluzione di questa fitta rete di scambi. Quello che ci interessa di più è proprio questo scambio: confrontare, scambiare idee, imparare, costruire dalle differenze. Mescolare, non tenere separato.
C’è grande distanza fra l’Atene del IV secolo e la Firenze del XVII. Ma né rottura radicale, né incomprensione. È perché sa dialogare con Aristotele, e penetrare a fondo la sua fisica, che Galileo riesce a trovare il passaggio stretto dove correggerla e migliorarla. Lo dice splendidamente lui stesso, in una lettera scritta in tarda età: «Io mi rendo sicuro che se Aristotele tornasse al mondo, egli riceverebbe me tra i suoi seguaci, in virtù delle mie poche contraddizioni alla sua dottrina».
- Bibliografia
 La Fisica e Del Cielo di Aristotele si trovano nel terzo volume delle sue Opere edite da Laterza (traduzioni di Antonio Russo e Oddone Longo, 1973). La metafora della barca e dei marinai dello studioso austriaco Otto Neurath (1882-1945) è citata dal filosofo americano Willard Van Orman Quine (1908-2000) nel libro Parola e oggetto (introduzione e traduzione di Fabrizio Mondadori, Il Saggiatore, 1970). Il riconoscimento di Galileo Galilei nei riguardi di Aristotele si trova nella «Lettera a Fortunio Liceti, 15 settembre 1640», a pagina 247 nel diciottesimo volume delle sue Opere (Giunti-Barbera, 1890). Carlo Rovelli ha approfondito questi temi nell’articolo Aristotle’s Physics: A Physicist’s Look («La fisica di Aristotele: lo sguardo di un fisico»), uscito di recente sulla rivista «Journal of the American philosophical association». Il famoso saggio dell’epistemologo americano Thomas Kuhn (1922-1996) La struttura delle rivoluzioni scientifiche è stato pubblicato in Italia nel 1969 da Einaudi (traduzione di Adriano Carugo)
La Fisica e Del Cielo di Aristotele si trovano nel terzo volume delle sue Opere edite da Laterza (traduzioni di Antonio Russo e Oddone Longo, 1973). La metafora della barca e dei marinai dello studioso austriaco Otto Neurath (1882-1945) è citata dal filosofo americano Willard Van Orman Quine (1908-2000) nel libro Parola e oggetto (introduzione e traduzione di Fabrizio Mondadori, Il Saggiatore, 1970). Il riconoscimento di Galileo Galilei nei riguardi di Aristotele si trova nella «Lettera a Fortunio Liceti, 15 settembre 1640», a pagina 247 nel diciottesimo volume delle sue Opere (Giunti-Barbera, 1890). Carlo Rovelli ha approfondito questi temi nell’articolo Aristotle’s Physics: A Physicist’s Look («La fisica di Aristotele: lo sguardo di un fisico»), uscito di recente sulla rivista «Journal of the American philosophical association». Il famoso saggio dell’epistemologo americano Thomas Kuhn (1922-1996) La struttura delle rivoluzioni scientifiche è stato pubblicato in Italia nel 1969 da Einaudi (traduzione di Adriano Carugo)-
>ARISTOTELE UOMO DELL’ANNO, PER L’UNESCO. - «Io mi rendo sicuro che se Aristotele tornasse al mondo, egli riceverebbe me tra i suoi seguaci, in virtù delle mie poche contraddizioni alla sua dottrina» (Galileo).14 febbraio 2016, di Federico La Sala
I 2400 anni del filosofo
Aristotele uomo dell’anno
di Dorella Cianci (Il Sole-24 Ore, Domenica, 14.02.2016)
- Aristotele fatto volgare. Tradizione aristotelica e cultura volgare nel Rinascimento, a cura di David Lines ed Eugenio Refini, Ets edizioni, Pisa 2015, pp. 357, €35.Info sui 2400 anni di Aristotele : http://aristotleworldcongress2016.web.auth.gr/?q=en
Il 2016 per l’Unesco è l’anno di Aristotele e già si annunciano iniziative nel mondo, fra cui spicca quella dell’Università di Salonicco, che terrà un grande convegno in Maggio. Com’è noto Aristotele è stato ed è un pilastro della cultura occidentale che si è consolidato lungo il Medioevo,soprattutto per l’aspetto etico e religioso, ma anche per tutto il Rinascimento, divenendo un autore canonico nella formazione pedagogica. Nonostante il ritorno di Platone nel Quattrocento, lo Stagirita non perse mai, per i giovani di diverse epoche, il ruolo di richiamo alla scienza, ma anche alle possibilità dell’uomo, poiché aveva inquadrato il suo punto di vista sulla terra, togliendolo esclusivamente a una dimensione celeste.
A differenza di Platone, Aristotele aveva compreso che l’educabilità dell’uomo sente spesso l’esigenza di confrontarsi con il tribunale della realtà, senza dover necessariamente delegare tutto al cielo ed è qui che nasce il concetto del “guardando s’impara” teorizzato nella Poetica, perché - per il filosofo - più degli insegnamenti è opportuno affidarsi alla consuetudine.
Nel volume Aristotele fatto volgare, a cura di David Lines (University of Warwick) e Eugenio Refini (John Hopkins University), pubblicato nella collana diretta da Claudio Ciociola e scaturito da un convegno tenutosi nella Normale di Pisa, è riportato un passo della Prefazione dell’Etica Nicomachea nella tradizione latina medievale di Concetto Marchesi dove si comprende la centralità di Aristotele per la storia: «La storia dell’aristotelismo è ancora da farsi: e sarà una storia grandiosa. Ricercare le vie per cui il pensiero umano si lasciò condurre nella successione di molti secoli è rivelare la genesi, lo sviluppo, la lotta giovanile e il trionfo finale di una civiltà nova che procede alla conquiste del vero» (1904).
Magistrali si rivelano, anche oggi, le parole di Garin sul ritorno dei filosofi antichi inteso come il ritorno di un mondo mai scomparso e resistente ai soprassalti del tempo, allora come oggi. Il ritorno dell’antico non è una curiosità da musealizzare, non è un surplus del sapere da utilizzare a effetto, ma è un corredo genetico che di autore in autore porta alla riconquista delle origini.
Veniamo dunque alla peculiarità di Aristotele, tanto da dover pensare di dedicare proprio a lui l’anno in corso, nonostante i trend interpretativi della società contemporanea ci appaiano molto diversi. Già nel nono, nel dodicesimo e nel tredicesimo secolo, le traduzioni si occuparono sempre più di Aristotele, non di Platone e, pian piano, dall’Aristotele “morale”si passò all’Aristotele “logico” della Poetica, figlio dei tempi moderni, maestro nel vero, inventore di ogni riflessioni scientifica sul teatro teorico di ogni produzione artistica.
L’anno di Aristotele ci invita ad alcune riflessioni incardinate sull’importanza delle azioni più che dei tipi umani (i caratteri). Aristotele è stato il primo a teorizzare l’ineluttabilità: ciò che accade deve accadere. Quando si parla del dolore però per l’uomo, nella tragedia come nella vita, è consigliabile mettersi a guardare, imparando dal dolore (proprio e altrui), ma di certo l’azione non si può bloccare, né si può intervenire sull’evento.
L’ineluttabilità tuttavia non vuol dire lasciarsi trasportare senza agire. L’agire umano è sorretto dal volere, poiché, nella tragedia e nella vita, i personaggi assumono dignità più dell’autore. L’autore lentamente scompare e l’azione dei personaggi è protagonista sulla scena, senza il bisogno di scusarsi delle nefandezze compiute, poiché Aristotele ci insegna che l’uomo può scegliere di compiere azioni terribili, anche quando è stato educato al bene. Come ha affermato Taplin nel 1996 le azioni tragiche non hanno bisogno della «parabasi», come accade nella commedia, cioè le azioni terribili non hanno bisogno di un’apologia, poiché è nella natura umana l’ineluttabilità del eventi peggiori. Siamo personaggi in cerca di autore? No. Siamo personaggi il cui autore è un doppiatore, dove il venticello dell’ineluttabilità ci passa accanto, ma l’azione ha il centro della scena.
Aristotele è il maestro di Pirandello e anche di Borges nelle sue riflessioni sull’autore-doppiatore. Non è un caso che maschera e volto, nel mondo greco, siano la stessa parola, poiché entrambi costituiscono ciò che “offriamo agli altri” tramite la vista. Siamo maschere non “addomesticate” dall’autore, né lo cerchiamo; sappiamo che egli esiste e doppia le nostre stesse azioni. Per capire questo è interessante una miniatura di un codice Vaticano Urbinate 355 dell’Hercules furens di Seneca,conservato nella Biblioteca Vaticana, dove ci sono sopra i personaggi, sotto il coro e in un cantuccio l’autore che legge, anzi doppia ciò che accade in un modo senza «parabasi», in un mondo senza giustificazioni.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- Responsabilità e metodo: "Cattivi scienziati", libro di Enrico Bucci.26 settembre 2015, di Federico La Sala
Responsabilità e metodo.
Perché è indispensabile difendere la buona scienza
di Elena Cattaneo (la Repubblica, 26.09.2015)
- Questo testo è parte della prefazione di Elena Cattaneo a Cattivi scienziati di Enrico Bucci (Add editore, pagg. 160, euro 14)
Cattivi Scienziati. Un titolo, nella sua sinteticità, può trarre in inganno. Questo libro di Enrico Bucci non parla di Scienziati e di Scienza, ma è una manifestazione dell’amore per la Scienza. Una “dichiarazione per assurdo”, perché fatta non esaltando la bellezza di fare Scienza, ma raccontando esempi di cattive condotte e quindi di ciò che non può essere considerato Scienza. Leggiamo questo libro come un utile e necessario richiamo alla responsabilità sociale della comunità scientifica e alla “tolleranza zero” verso chiunque manipoli i fatti sperimentali per ottenerne benefici personali.
Gli scienziati non possono esimersi dal mettersi in gioco e dal partecipare alla costruzione della società portando la loro voce in ogni dibattito pubblico affinché i fatti documentati e controllabili possano essere esaminati e costituiscano le fondamenta su cui costruire decisioni legislative giuste e nell’interesse pubblico. Per svolgere questo ruolo ogni giorno, c’è la necessità di presentarsi come un modello di comunità fatta di individui che si interrogano e si confrontano pubblicamente, anche aspramente e senza omertà, per il valore delle prove, controllandosi quotidianamente e arricchendo così di controlli e validazioni ogni teoria.
Una comunità di pari che non aspetta la pressione di un’opinione pubblica e che nelle sue linee ispiratrici rifugge ogni autoritarismo e gerarchia precostituita, e dove la componente reputazionale, prima ancora di qualsiasi intervento regolatorio pure auspicabile (se ragionevole ed equilibrato), è essenziale perché vi sia la libertà di guardare negli occhi ogni collega e riconoscervi la garanzia che il metodo di lavoro sia quello condiviso, trasparente, intellegibile e verificabile. Nello sforzo scientifico quotidiano non deve mai calare la tensione verso il continuo perfezionamento di questo patto sulle regole che ne sono alla base.
Il metodo scientifico ha dato molto all’umanità, fin dal suo comparire. È stato applicato in moltissimi campi, ed ha consegnato una mole impressionante di fatti e di descrizioni, coerenti tra loro, universali nel linguaggio utilizzato e unificati in un quadro complessivo che, sebbene migliorabile e in continua evoluzione, è di gran lunga la costruzione culturale più impressionante che la nostra specie abbia prodotto. Esso rappresenta anche quel corpus di conoscenze che ci permette di affrontare con successo le piccole e grandi sfide che ci si pongono quotidianamente davanti.
La società deve potere attingere con fiducia a questa conoscenza, conquistata ogni giorno da un innumerevole stuolo di ricercatori di ogni campo nei laboratori di ogni angolo del mondo, i quali sottopongono a esame critico le proprie scoperte, le comunicano e ne rivendicano i meriti pubblicando quei risultati in riviste specializzate. A questo segue il controllo collettivo mondiale della validità di quella pubblicazione, che è quanto di meglio la comunità degli scienziati abbia escogitato per controllare la validità delle proprie scoperte.
Una singola pubblicazione, anche se su riviste ad alto impatto, non costruisce di per sé una verità, ma sarà il confronto con altri dati e protocolli, lo scetticismo dei colleghi e la riproducibilità dei risultati, a decretarne il valore conoscitivo e la solidità, oltre a concorrere alla reputazione dello scienziato. Ecco perché mentire e manipolare i dati scientifici non solo è socialmente riprovevole, ma anche stupido. La comunità scientifica nel suo insieme è in grado di individuare, impietosamente, comportamenti abnormi, e può avvalersi oggi di nuovi sistemi di analisi dei dati, automatizzati e sempre più efficienti, supportati dall’indagine umana sui casi meritevoli di interesse.
Ecco perché è necessario ribadire, come insisteva già quasi mezzo secolo fa Jacques Monod, che l’etica è intrinseca alla scienza e al metodo scientifico: anche se lo scienziato non giura su una costituzione scritta o su un testo sacro, la sua adesione a una comunità di cittadini liberi e dediti a ricercare come stanno davvero le cose, implica il tacito ma non negoziabile impegno a essere sempre sincero e a riportare e rispettare i fatti, cioè le prove. Se si deroga da questo impegno, ci si colloca automaticamente fuori dal mondo della Scienza.
 In definitiva, non esistono i “cattivi scienziati”. Semplicemente costoro non sono scienziati.
In definitiva, non esistono i “cattivi scienziati”. Semplicemente costoro non sono scienziati. -
> IL "SIDEREUS NUNCIUS"... L’annuncio stellare --- K 452b. Trovata un’altra Terra? Difficile da dire al momento, ma certo che il pianeta trovato da Nasa con il suo satellite Kepler a soli 1400 anni luce da noi, vicinissimo quindi, è un buon candidato.23 luglio 2015, di Federico La Sala
Nasa: scoperta Terra gemella che ruota attorno a un suo Sole, con una «zona abitabile»
di Leopoldo Benacchio (Il Sole-24 Ore, 23 luglio 2015)
Trovata un’altra Terra? Difficile da dire al momento, ma certo che il pianeta trovato da Nasa con il suo satellite Kepler a soli 1400 anni luce da noi, vicinissimo quindi, è un buon candidato: ruota attorno a una stella molto simile al nostro Sole, anche se più vecchia di un miliardo di anni, in 385 giorni, contro i nostri 365, ed è solo il 60% più grande del nostro Pianeta, quindi comparabile anche se lì peseremmo molto di più.
Ma quello che intriga maggiormente nella scoperta di K 452b, questo il nome provvisorio del pianeta appena scoperto, è che starebbe nella parte abitabile del suo sistema solare, così come facciamo noi, e questo è raro e importante.
La situazione è in realtà semplice: per essere abitabile si pensa oggi che un pianeta debba essere sufficientemente distante dalla sua stella madre per non essere letteralmente bruciato, come nel caso del nostro Mercurio vicinissimo al Sole, e al tempo stesso non deve essere troppo lontano, dato che anche le temperature troppo basse impediscono la vita. Ci deve in sostanza essere la possibilità per l’acqua di rimanere liquida.
Le condizioni per la presenza di vita sono moltissime, ma quelle sulle dimensioni, simili a quelle terrestri che garantiscono ad esempio la presenza di una atmosfera stabile, e sulla distanza dalla stella madre, per via della giusta temperatura per gli oceani, sono preliminari ad ogni altra considerazione, e in questo caso pare che si siamo.
Il fatto che il nuovo pianeta riceva dal suo Sole il 10% in più di quanto riceva la Terra da suo non pare un problema, viste le maggiori dimensioni.
L’annuncio è stato dato in conferenza stampa da Nasa oggi alle 18 ora italiana, assieme alla notizia che sono stati trovati altri 500 possibili pianeti attorno ad altre stella, anche se questi ultimi non sono comparabili alla nostra Terra.
In tutto questo spietato cacciatore di “altri mondi”, Kepler di Nasa, ha nel suo carniere la bella cifra di 4175 pianeti scoperti, ovviamente da confermare con osservazioni accurate e prolungate dal suolo. Da specificare che il satellite non vede direttamente i pianeti attorno ad altre stelle, ma li individua notando delle mini eclissi quando il pianeta ruotando attorno alla sua stella madre, si pone sulla linea di vista fra noi e la stella in questione. Quindi chissà quanti non ne vediamo dato che mica tutti passano fra ni e la stella che gli compete.
Comunque nelle 150.000 stelle che Kepler sta osservando costantemente dal 2006 i pianeti abbondano come abbiamo visto e molti altri se ne troveranno. Certo i più piccoli, come la nostra Terra, sono molto difficili da vedere perché l’effetto che provocano e minimo, ma in questo caso siamo stati fortunati. Quanto al numero, sembrano tante le stelle esaminate, e sono un numero enorme per noi, ma pensiamo che nella sola nostra Galassia, la Via Lattea, di stelle ce ne sono almeno 100 miliardi.
Finora di possibili candidati a essere la nuova Terra ce ne erano una dozzina, ma K 451b li batte tutti e sale in cima alla lista.
Gli scienziati non possono dire altro, sia ben chiaro, né se su quel mondo ci sia acqua o vita o atmosfera, ma certamente a questo punto si scateneranno le osservazioni di moltissimi scienziati con altri strumenti per capire di che si tratta, se il sogno di un mondo gemello può essere rappresentato dalla nuova scoperta. A presto, si spera, la conferma.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS"... L’annuncio stellare --- K 452b. "Per il momento osserviamo Kepler-452b da lontano - ha detto -, ad una distanza di 1.400 anni luce. Per raggiungerlo le nostre sonde ci metterebbero dai 30 ai 40 milioni di anni".25 luglio 2015, di Federico La Sala
Asi, presto altri pianeti come Kepler-452b
Presidente Battiston a Expo commenta scoperta nuovo pianeta
(di Michela Nana) (ANSA) - MILANO, 24 LUG - Venti anni fa quando è iniziato lo studio dei pianeti che si trovano al di fuori del sistema solare "non si pensava di potere vedere un pianeta come Kepler-452b, che sembra riprodurre in modo impressionante le caratteristiche della nostra Terra, ma vi assicuro che entro pochi mesi ne vedremo degli altri. Avremo altre opportunità". Ne è convinto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, che a margine di un incontro a Expo ha commentato "con entusiasmo" la nuova scoperta resa nota dalla Nasa. A scoprire quello che è stato battezzato come il ’pianeta gemello’ della Terra è stato un potente telescopio, Kepler, da cui il pianeta ha preso il nome. Grazie a questi potenti strumenti tecnologici oggi si scoprono centinaia di nuovi pianeti con caratteristiche diverse, "ce n’è per tutti i gusti - ha scherzato Battiston -. Ne è stato osservato uno, ad esempio, fatto di diamante. Ce ne sono quasi 4 mila che sono stati via via analizzati". Quello che conta è che "siamo finalmente arrivati ad un caso che assomiglia molto a quello del nostro sistema planetario - ha spiegato - con una stella grande come il Sole, con un pianeta grande come la Terra che in circa 385 giorni, poco più del nostro anno, e lo fa a una distanza corrispondente a quella tra la Terra e il Sole".
Secondo Battiston, i pianeti come la Terra "esistono di sicuro". "Sono pronto a scommettere che ne avremo una famiglia intera tra qualche mese o un anno. Quello su cui ci si interroga e che sembra ancora unico è la vita che riempie il nostro pianeta". Questa è la domanda a cui la scienza tenta di rispondere ed è il punto cruciale che affascina non solo gli scienziati. "Per il momento osserviamo Kepler-452b da lontano - ha detto -, ad una distanza di 1.400 anni luce. Per raggiungerlo le nostre sonde ci metterebbero dai 30 ai 40 milioni di anni".
Di questo parente stretto della Terra si osservano "alcune proprietà e mano a mano che gli strumenti si affinano riusciremo a capire di cosa è fatta la sua atmosfera, se c’è dell’ossigeno o tracce di molecole complesse". Intanto il confine tra scienza e fantascienza si fa più sottile e gli scienziati osservano oggi nella realtà quelle che fino a qualche anno fa erano solo ipotesi. Lo fanno grazie a strumenti sofisticati come Kepler.
"Riesce a catturare piccolissime variazioni di luminosità - ha spiegato Battiston - che corrispondono al passaggio di un pianeta davanti alla sua stella". Quando un pianeta passa davanti alla propria stella la offusca leggermente. Kepler riesce a cogliere quella variazione. "Stiamo espandendo enormemente la capacità di studiare gli esopianeti. L’obiettivo è quello di rispondere alla domanda delle domande, se la vita esista". La Terra ha 4,5 miliardi di anni "e sappiamo che la vita si è sviluppata solo negli ultimi 100 o 200 milioni. Forse noi stiamo osservando Kepler-452b nel tempo in cui la vita su di esso non è ancora esplosa". (ANSA).
-
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- L’ Idea del Teatro di Giulio Camillo e la lettera a Paolo Giovio di Galilei (di A. Massarenti - Così la memoria non è più un magazzino).5 maggio 2015, di Federico La Sala
Così la memoria non è più un magazzino
di Armando Massarenti (Il Sole-24 Ore, Domenica, 03.05.2015)
All’ingresso della Galleria Alberto Sordi di Roma, è emozionante vedere, esposta fino al 31 maggio dentro una teca trasparente, l’originale della lettera inviata da Galileo Galilei al matematico gesuita Paolo Giovio nel 1610, per confermargli di aver veduto attraverso il cannocchiale i satelliti di Giove e di aver così dimostrato la veridicità dell’ipotesi di un sistema eliocentrico copernicano.
Fino ad allora il Sole aveva goduto di una centralità solamente di ordine allegorico e simbolico, soprattutto in quei sistemi filosofici e retorici che risentivano del neoplatonismo ficiniano e che abbracciavano un approccio magico ed ermetico alla natura: stiamo parlando anche del Teatro della Memoria di Giulio Camillo, che nell’immaginare una topica della memoria intitola le sette porte o colonne portanti ai sette pianeti, lasciando che il Sole vi occupi un posto rilevante, in quanto espressione pura dell’energia divina nel cosmo, capace di irradiarsi ovunque anche nella mente e nell’anima umane. In un certo senso, il teatro di Camillo era a suo modo un sistema eliocentrico.
Ma quale legame unisce due testi apparentemente così lontani come l’Idea del Teatro di Camillo e la lettera di Galilei più tardi di un sessantennio? Come mostra Lina Bolzoni, nel teatro di Camillo, c’era più di un sistema retorico ed enciclopedico, adatto alla perfetta imitazione di Cicerone, più di un sistema simbolico dal sapore intensamente alchemico: c’era l’idea di una immensa mente artificiale, dove tutte le informazioni possibili e tutte le possibili interconnessioni tra queste informazioni fossero a disposizione dell’oratore o del filosofo, per stimolarne creativamente il pensiero. Una sorta di grande ipertesto, una macchina per l’invenzione. Alla base di questo enorme progetto culturale, erede dell’ars combinatoria di Lullo e della lezione di logica e mnemotecnica di Rodolphus Agricola, sta una visione moderna della memoria: non più considerata uno strumento passivo del pensiero, un serbatoio di informazioni utili a costruire i discorsi, la memoria assume il valore di uno strumento gnoseologico attivo, capace di generare sempre nuove informazioni sulla base di quelle già presenti.
La parola inventio, che nel gergo retorico ciceroniano aveva significato semplicemente il «reperimento» degli argomenti, assume ora un senso più moderno con una forte connotazione creativa. Di questo e di altro scriveva già un filosofo veronese coevo di Camillo, quel Girolamo Fracastoro che, in un importante dialogo latino dedicato all’intellezione umana, Della Torre ovvero dell’intellezione, attribuisce alla memoria un ruolo centrale nell’articolazione del pensiero intellettuale.
Nella visione modernissima che Fracastoro ha del pensiero umano, la mente desume gli universali dalle informazioni conservate in memoria, ogni pensiero astratto non può essere altro che la sintesi sublimata in modo logico a partire dall’esperienza pratica. Una condizione epistemologica imprescindibile per giungere alle «sensate esperienze» di Galilei: contrariamente a quanto si riteneva nelle accademie del tempo, si perviene ora alla certezza che non può esistere pensiero astratto o calcolo mentale, che non parta dall’esperienza e dalla realtà del mondo catturata dai nostri sensi.
A complicare e rendere ancora più affascinante la lettura di questi decenni fondamentali per la storia della scienza e della filosofia - quelli tra la metà del XVI e l’inizio del XVII secolo -, interviene l’avventura intellettuale di Giordano Bruno, il quale nel suo De umbris idearum, come osservato da Frances A. Yates e da Paolo Rossi, costruisce un sistema della conoscenza di ispirazione neoplatonica incentrato sull’arte della memoria intesa quale strumento utile ad aiutare la limitata mente umana a catturare le scintille di verità divina disperse nella natura.
È la memoria l’anello di congiunzione tra uomo e Dio, è nella memoria e nella fantasia - altro strumento, quest’ultimo, imprescindibile per la conoscenza e strettamente legato al primo -, che l’intelletto umano riesce a rappresentarsi l’infinità di Dio e perviene alla conclusione dell’impossibilità di una natura e di un cosmo finiti. La teoria di Bruno degli infiniti mondi, che abbraccia e supera la proposta dell’eliocentrismo copernicano - e che per questo viene considerata così pericolosa dall’ortodossia tridentina -, è impensabile separatamente dal suo teatro della memoria.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- Dallo Sputnik a Rosetta, l’era spaziale in 10 tappe. I primati nella storia dell’esplorazione spaziale.13 novembre 2014
Dallo Sputnik a Rosetta, l’era spaziale in 10 tappe
I primati nella storia dell’esplorazione spaziale *
Che Rosetta sia già una missione da record non ci sono dubbi: non solo la sonda dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) punta al primo atterraggio su una cometa, ma ha attraversato il Sistema Solare per dieci anni per raggiungere il suo obiettivo. Un viaggio che sembra ripercorrere le principali tappe dell’esplorazione spaziale, cominciata 57 anni fa.
A inaugurare l’era spaziale, il 4 ottobre 1957, infatti, è stato il primo satellite artificiale, lo Sputnik, primo oggetto costruito dall’uomo ad orbitare attorno alla Terra.
E’ ancora l’Unione Sovietica, in quella che era ormai diventata la corsa allo spazio, a portare il primo uomo tra le stelle: il 12 aprile 1961 Yuri Gagarin è il primo a raggiungere lo spazio con un volo di 108 minuti. Il 18 marzo 1965 è la volta della prima passeggiata spaziale: ancora un sovietico, il cosmonauta Aleksej Leonov, primo uomo a ’nuotare’ fra le stelle.
Quattro anni più tardi l’esplorazione spaziale raggiunge probabilmente l’apice, con lo sbarco sulla Luna. Il 20 luglio 1969 Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono i primi uomini a camminare su un altro corpo celeste, mentre il loro collega Michael Collins li aspettava a bordo del modulo lunare.
Nel 1971 l’uomo ha la prima casa tra le stelle, con la stazione spaziale Saljut, sovietica. Da allora le stazioni orbitali sono state ben dieci, due delle quali attive oggi: la Stazione Spaziale Internazionale (nata dalla collaborazione fra Nasa, Russia, Europa, Canada e Giappone) e la cinese Tiangong.
A conquistare il primo pianeta sono le sonde americane Viking, arrivate su Marte il 20 agosto 1975. Da allora il pianeta rosso non è mai più rimasto solo e l’ultima celebre missione è quella del rover americano Curiosity, arrivato su Marte il 6 agosto 2012.
I confini del Sistema Solare sono l’obiettivo delle sonde Voyager della Nasa, lanciate nel 1977: dopo avere osservato Giove, Saturno, Urano e Nettuno sono ancora attive e la Voyager 1 sta navigando nello spazio interstellare.
La prima sonda ad avvicinarsi ad una cometa è l’europea Giotto, che il 13 marzo 1986 ha salutato la cometa di Halley dalla distanza di quasi 600 chilometri.
Nel marzo 2011 l’americana Stardust ha portato a Terra la polvere di una cometa e oggi Rosetta si prepara a battere tutti i primati, liberando il lander Philae sul nucleo della cometa Churyumov-Gerasimenko.
Il 14 aprile 1990 l’osservazione del cosmo ha superato i confini dell’atmosfera, con il telescopio spaziale Hubble.
Le prime immagini spettacolari di una luna aliena sono state quelle di Titano, la più grande luna di Saturno. A inviarle a Terra, il 14 gennaio 2005, è stata la sonda europea Huygens.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- UNA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA. Galileo Galilei e la seconda era delle macchine (di Remo Bodei)10 ottobre 2014, di Federico La Sala
Sottovalutata per secoli, l’arte meccanica diventa vera scienza solo grazie al genio pisano
Ecco perché inizia da qui la nostra rivoluzione tecnologica
Galileo Galilei e la seconda era delle macchine
di Remo Bodei (la Repubblica, 08.10.2014)
PER cogliere il senso della moderna civiltà delle macchine bisogna partire dal carattere innovativo delle proposte di Galileo nel campo della meccanica, misurandone dapprima la distanza rispetto a una lunga tradizione che parte dalla Grecia antica.
In origine, infatti, il termine mechane significa soltanto “astuzia”, “inganno”, “artificio” e in questa accezione compare già nell’Iliade. Soltanto più tardi (accanto alle connotazioni “uso appropriato di uno strumento” e “macchina teatrale”, da cui l’espressione theos epi mechanes, deus ex machina) viene a designare la macchina in genere, e, in particolare la macchina semplice - leva, carrucola, cuneo, piano inclinato, vite - la macchina da guerra e l’automa. La meccanica, sapere attorno alle macchine, è dunque preposta alla costruzione di entità artificiali, di trappole tese alla natura per catturarne l’energia e volgerla in direzione dei vantaggi e dei capricci degli uomini.
Perché la macchina eredita i significati dell’astuzia e dell’inganno? Perché per lungo tempo non si riesce a spiegare il suo funzionamento. Non si capisce, ad esempio, come una leva possa innalzare con minimo sforzo dei pesi enormi o come un cuneo riesca a spaccare pietre o giganteschi tronchi d’albero. Di questo stupore offre testimonianza la Mechanica, attribuita per lungo tempo (e da alcuni studiosi anche oggi) ad Aristotele, ma forse opera di uno dei suoi successori alla direzione della Scuola come Stratone il Fisico.
In tale testo (su cui Galileo fece lezione a Padova nel 1597/98) è chiaramente affermato che «molte cose meravigliose, la cui causa è sconosciuta, avvengono secondo natura, mentre altre avvengono contro natura prodotte dalla techne a beneficio degli uomini ». Quando la natura è contraria alla nostra utilità, noi riusciamo a padroneggiarla mediante l’artificio (mechane).
Le arti meccaniche, proprio in quanto appartengono al regno dell’astuzia e di ciò che è «contro natura», non fanno parte della fisica, che si occupa di ciò che avviene secondo natura. Le arti meccaniche si presentano come operazioni contro natura o come giocattoli stupendi. Archimede pare si vergognasse di aver costruito macchine e avesse invece fatto scolpire sulla sua tomba il famoso cilindro che contiene una sfera. Ancora nel Cinquecento la meccanica non è scienza a pieno titolo, ma scienza «mista » o «media». Ancora più tardi, specie tra i dotti gesuiti del Colbeffata legio Romano, essa è soprattutto mechanica practica ad uso degli “ingegnierii”.
Pur non pienamente apprezzata, la meccanica guadagna terreno e prestigio nel corso del Cinquecento finché continua a restare legata alla funzione di provocare meraviglia. Nel 1508 Leonardo progetta - per la villa di Carlo d’Amboise a Milano - un mulino idraulico quale motore d’automi che emettevano suoni. A partire dal 1569, poi, Bernardo Buontalenti crea, nella villa medicea di Pratolino, una serie di meravigliose macchine idrauliche e pneumatiche (oggi perdute) che mettono in moto statue, porte e getti d’acqua.
Con Galileo ci si comincia a rendere conto che alla natura si comanda ubbidendole, che essa non può essere semplicemente e che il compito principale della meccanica non è quello di provocare stupore. Per padroneggiare la natura bisogna servirla, piegarsi alle sue leggi e alle sue ingiunzioni, traendo profitto dalla loro conoscenza.
Il concetto di astuzia, nel senso del più debole che prevale sul più forte, dell’uomo che - simile a Odisseo - inganna l’ottuso Polifemo della natura, viene a tramontare. Allo stesso modo, la meraviglia suscitata da una presunta alterazione della legalità naturale si trasferisce su un altro piano, quello del potere effettivo dell’uomo di servirsi legittimamente delle energie naturali.
In Galileo l’astuzia cambia di significato (consiste ora nell’utilizzare le energie naturali a fini economici, così da godere di energia a basso costo) e la violenza in quanto tale scompare, perché la meccanica cessa di essere contro natura.
Queste idee vengono esposte dal giovane Galileo ne Le mecaniche. L’ultima stesura comincia con una polemica contro la tradizione secondo cui le macchine ingannano la natura. Non si deve più cedere alla fantasticheria di cogliere la natura in fallo, di indurla a piegarsi alla nostra volontà. Le critiche non si rivolgono tuttavia soltanto ai teorici della meccanica ma anche ai cattivi pratici, agli ingegneri incapaci. Nel tentativo di spiegare razionalmente «le cause degli effetti miracolosi» che si riscontrano nella «meccanica dell’istrumento » o della macchina, Galileo riconduce tutte le macchine semplici alla bilancia (per la quale riprende temi già affrontati nel suo trattato La bilancetta del 1586) e decreta che l’astuzia delle macchine consiste ora nell’utilità che la meccanica consente.
Ne Le mecaniche vengono elencati tre tipi di utilità. La prima sta nel comprendere che l’astuzia che si crede rivolta verso la natura si ritorce contro il presuntuoso meccanico, il quale (avendo scarsità di forza, ma non di tempo) si ostina nel cercare macchine potentissime e insieme rapidissime nell’esecuzione dei loro compiti. Così chi credesse da un pozzo, «con machine di qualsivoglia sorte cavare, con istessa forza, nel medesimo tempo, maggior quantità di acqua [...] è in grandissimo errore; e tanto più spesso e maggiormente si troverà ingannato ».
La seconda astuzia consiste nel trovare strumenti che si conformino alla funzione da svolgere, poiché «non in tutti i luoghi, con uguale commodità, si adattano tutti gli strumenti». Così, per tenere asciutta la sentina di una nave, non si utilizzeranno delle secchie, ma delle «trombe», che pescano meglio nel fondo.
La terza e più importante «utilità» viene appunto individuata nel trovare fonti di energia a buon mercato e nell’inventare delle «prese» che si adattino ad esse (mentre gli strumenti devono adattarsi agli organi dell’uomo o dell’animale, ad esempio alle mani e al collo, le macchine devono conformarsi al genere di energia che le muove, ad esempio al vento attraverso le pale dei mulini o, molto più tardi, alla caduta dell’acqua attraverso le turbine).
In prospettiva, sono proprio le macchine (ora costruibili con criteri e calcoli pienamente razionali) a non rendere più conveniente la schiavitù e a permetterne la virtuale abolizione. La forza lavoro umana nella forma di mera erogazione di energia non è più indispensabile, mentre - ed è questa un’altra grande intuizione di Galileo - le macchine sostituiscono la mancanza di intelligenza delle forze o degli animali che erogano energia. Mediante «artificii ed invenzioni» egli è ora in grado di far risparmiare fatica e denaro agli uomini, scaricando sulla natura inanimata e animata l’onere di erogare energia previamente indirizzata all’ottenimento dell’effetto desiderato.
È così che, da Galileo in poi, la meccanica prende l’aggettivo “razionale”, proprio per contrastare la sua precedente immagine di sapere pratico, di arte non liberale o di artigianato. Con la qualifica di “razionale” essa riceve la sua patente di nobiltà, il riconoscimento del suo carattere interamente conforme alle leggi della natura. Solo ora viene equiparata alle altre scienze esatte, con la conseguenza che le macchine cessano gradualmente di apparire oggetti miracolosi che incomprensibilmente profanano l’ordine perfetto del mondo. Ma non per questo perdono il loro fascino e il loro ruolo. Anzi la loro astuzia si avvia a diventare la moderna intelligenza tecnica, il dominio dispiegato sulla realtà, l’insieme dei vantaggi a cui è ormai impossibile rinunciare.
© Remo Bodei 2014
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS". --- Il Rinascimento di Galileo. Da John Heilbron una nuova biografia dell’italiano che più di tutti ha influenzato la storia del mondo (di Carlo Rovelli).22 dicembre 2013, di Federico La Sala
Il Rinascimento di Galileo
- Da John Heilbron una nuova biografia dell’italiano che più di tutti ha influenzato la storia del mondo
- Fu un grande umanista e fondò la scienza moderna
di Carlo Rovelli (Il Sole-24 Ore-Domenica, 22.12.2013)
L’ italiano che ha avuto più influenza sulla storia del mondo, sullo sviluppo della civiltà nella quale viviamo oggi, è con ogni probabilità Galileo Galilei. Il suo contributo alla cultura dell’umanità è impressionante. Galileo è stato il primo a comprendere che possiamo imparare interrogando la natura con degli esperimenti: i primi esperimenti scientifici della storia sono stati compiuti da lui. È stato il primo ascrivere una precisa legge matematica per descrivere i movimenti delle cose sulla Terra. Questo ha aperto la strada al mondo moderno, dove oggi calcoliamo tutto usando la matematica: dai ponti ai computer, dalle previsioni del tempo ai viaggi interplanetari Galileo è stato il primo a usare strumenti scientifici (il telescopio) per osservare il mondo. È stato il primo a osservare cose, fuori dalla Terra, che nessun umano aveva mai visto prima: dai satelliti di Giove, alle fasi di Venere, dagli anelli di Saturno alle macchie solari. Il mondo con Galileo si è ingrandito immensamente: l’umanità si è resa conto di avere la possibilità di vedere lontano. Quasi nulla, né della nostra attuale visione del mondo, né del modo in cui viviamo oggi esisterebbe, senza questo passaggio essenziale che è stata la scoperta della metodologia scientifica di base. Il fatto che sia stata la stessa persona a essere il primo sperimentatore, il primo fisico matematico, e il primo a osservare il cielo, ha del prodigioso e lascia ancora esterrefatti. Eppure l’uomo Galileo Galilei resta controverso, come è stato tutta la sua vita. La valutazione di ciò che ha fatto, perché lo ha fatto e come lo ha fatto, resta dibattuta. Chi era Galileo Galilei? Italianissimo nelle sue straordinarie doti di acume e inventiva, quanto nei suoi giganteschi difetti, è stato descritto come megalomane, attaccabrighe, inaffidabile, adulatore, venditore di fumo, vanitoso, isterico. Un ciarlatano, per il filosofo della scienza austriaco Paul Feyerabend. Un disonesto, per Arthur Koestler. Anche il modo in cui è arrivato ai suoi risultati mirabolanti è oggetto di controversia. La sua prima legge ci dice che i corpi pesanti cadono con accelerazione costante. Oggi ci sembra naturale, ma per secoli nessuno lo sapeva. L’idea stessa di accelerazione, rivelatasi poi fondamentale per la fisica di Newton e la scienza moderna, è stata chiarita con precisione solo da Galileo. Galileo scrive che ha scoperto la sua legge misurando la velocità a cui rotolano palle lungo una discesa. Ma negli anni Trenta lo storico della scienza Alexandre Koyré ha messo in dubbio il suo resoconto, sostenendo che Galileo non aveva mai fatto gli esperimenti che dice di aver fatto. Sennonché negli anni Sessanta lo storico inglese Stillman Drake ha mostrato che Koyré sbagliava, studiando i manoscritti sparpagliati che restano di Galileo, riuscendo a ricostruirne l’ordine cronologico grazie all’evoluzione della grafia (mettete la data sulle vostre note, se pensate di avere qualche chance che il futuro si interessi a voi) e trovando i numeri delle misure delle palle che rotolano, a conferma, almeno parziale, della versione di Galileo.
Ma la questione che più suscita conflitto è l’accanimento della Chiesa cattolica contro di lui. Aveva ragione Galileo a dire che la Terra gira attorno al Sole. Però aveva ragione il cardinale Bellarmino, poi santo, a dire che prove certe Galileo non le aveva, e quindi si trattava solo di ipotesi. Ma aveva ragione Galileo a dire che era alle «sensate osservazioni e ragionevoli deduzioni» che bisognava rivolgersi per sapere chi girasse intorno a cosa, e gli interpreti della Bibbia avrebbero dovuto adeguarsi. Ma aveva ragione Bellarmino a dire che chi interpretasse la Bibbia era affare della Chiesa e non di Galileo. D’altra parte aveva ragione Galileo a dire che lui voleva poter cercare la verità a modo suo. E ancora oggi di questo la Chiesa cattolica non è del tutto convinta. Ma obbligare un vecchio di settantanni, malato, stanco, coraggioso, un immenso scienziato, a inginocchiarsi davanti ai Cardinali e chiedere perdono per le sue idee («Io, Galileo inginocchiato davanti a voi ... giuro che ho sempre creduto, credo adesso, e... sempre crederò, tutto quello che tiene e predica et insegna la Santa Chiesa... abiuro e maledico e detesto i miei errori ed heresie... giuro che per l’avvenire non dirò mai più né asserirò, in voce o in scritto, cose tali per le quali si possa haver di me simil sospitione»), impedirgli di scrivere quello che pensava, imprigionarlo in casa per il resto della vita, tutto questo resterà un’onta sul cattolicesimo. Ma in fondo non era forse colpa di Galileo, che aveva dato importanza al Vaticano? Fosse restato a Padova, avesse parlato di scienza con gli scienziati del Nord Europa, come Keplero che non chiedeva che di comunicare di più con lui, invece di andare a Firenze e poi a Roma, probabilmente nessuno gli avrebbe dato fastidio. Forse Galileo è stato troppo buon cattolico, cercando di smuovere quello che non si poteva smuovere. Da parte sua, quello che la Chiesa cattolica è riuscita a ottenere condannando Galileo è stato solo tagliare fuori l’Italia dalla crescita culturale dell’Europa dei secoli seguenti. L’eredità del grande italiano sarà raccolta in Inghilterra, nei Paesi Bassi, in Germania, in Francia, dove le gerarchie cattoliche potevano poco. Da ogni parte lo si guardi, Galileo è personaggio che suscita controversie. Come potrebbe essere altrimenti, forse, per l’uomo che ha preteso di essere il paladino della ricerca libera della verità, ma ha abiurato per paura? L’uomo che poteva starsene a Padova, sotto la libera e liberale Venezia che lo lasciava pubblicare quello che voleva, ma è andato invece a cacciarsi sotto l’ala di un principe assolutista a Firenze, Cosimo dei Medici, e poi di sua volontà a Roma a disturbare gesuiti e cardinali per farsi dare ragione anche loro?
A cercare di mettere ordine in questo guazzabuglio storico, e fare un punto sulla vasta letteratura dedicata a Galileo, esce in Italia un corposo volume di un grande storico della scienza inglese, John Heilbron, ottimamente tradotto da, e a cura di, Stefano Gattei. Con una quantità di informazioni che lascia stupiti, e una acuta comprensione del mondo in cui si muove Galileo e della sua scienza in farsi, Heilbron ricostruisce puntigliosamente la sua vita tempestosa, i suoi scontri, l’evolvere delle sue idee, le cautele e le presunzioni. Soprattutto, le sue molte relazioni intellettuali, dalle amicizie giovanili dalle quali nascono le prime idee sul moto, all’inizio dell’Accademia dei Lincei («una banda omoerotica incline al misticismo e al melodramma, organizzata come un ordine religioso e pericolosamente vicina all’eresia»; oggi è cambiata, l’Accademia dei Lincei). Heilbron cerca di alleggerire il testo aggiungendo ironia e giochi di parole (Galileo, carattere ostinato, che va verso Roma a cavallo di una mula diventa: «La piccola mula e il grande mulo»...), giochi di parole continui, fortunatamente diradati nella traduzione italiana. La vita di Galileo scorre giorno dopo giorno davanti ai nostri occhi, con i suoi crucci e le sue debolezze. Il Galileo che ne emerge è un uomo profondamente parte della cultura tardo rinascimentale italiana, un prodotto di questo momento splendido del nostro passato.
Grandissimo scrittore, forse fra i più grandi prosatori che abbia avuto la nostra lingua, musicista, critico letterario, artigiano, cortigiano, intrallazzatore, capace di mettere tutto questo al servizio di una grande nuova idea. È bella questa immagine di Galileo umanista, appassionato di Dante e innamorato di Ariosto quanto di Euclide e Archimede, grande maestro nell’uso delle parole, che ci riporta all’unità e alla coerenza spesso dimenticata del nostro sapere. Il segreto del genio di Galileo, per Heilbron, è nella combinazione delle sue doti di scrittore, musicista, artigiano, disegnatore, matematico e filosofo, nella capacità profondamente rinascimentale di fare funzionare tutto questo insieme. La scienza moderna è radicata in questa splendida alchimia italiana. Ma il Galileo di Heilbron è anche un Galileo che sembra si occupi di più di politica che di scienza, un Galileo che sembra trovare per caso sue straordinarie intuizioni, e si occupa principalmente di divulgarle. Tutt’altro Galileo era descritto in La figlia di Galileo di Dava Sobel, ripubblicato l’anno scorso da Rizzoli nella Biblioteca Universale. Costruito come un commento intorno alle lettere che Suor Maria Celeste, ovvero Virginia, figlia prediletta di Galileo, mandava regolarmente al padre adorato, il libro si legge con facilità e ci mostra un lato molto umano dello scienziato. A Padova, dove aveva fatto le prime scoperte che lo renderanno famosissimo, il giovane scienziato aveva amato Marina, donna Veneziana del popolo, senza poterla sposare, e ne aveva avuto tre figli «nati da fornicazione» come si diceva, a cui era rimasto molto legato. Virginia muore a trentatré anni, poco dopo il processo di Roma e l’abiura che hanno devastato suo padre. «Una tristizia e melanconia immensa, inappetenza estrema, odioso a me stesso, et insomma mi sento continuamente chiamare dalla mia diletta figliola», scrive il vecchio leone.
Continuerà a lavorare scrivendo in vecchiaia pagine fondamentali per la nascita della meccanica, ma perderà la vista: «Quell’universo ch’io con mie meravigliose osservazioni e chiare dimostrazioni aveva ampliato per cento e mille volte più del comunemente creduto da’ sapienti di tutti i secoli passati, ora per me si è diminuito e ristretto, ch’è maggiore quello che occupa la persona mia». Il libro di Dava Sobel aggiunge poco a quello che di Galileo già si sapeva, ma ci fa sentire il suo dolore, la sua passione, ci fa meravigliare alla sua grandezza. Forse non è ancora stata scritta la biografia di Galileo che sappia ricostruire il Galileo che stava dietro tutto questo. Quello che deve avere passato innumerevoli notti a guardare le stelle con il suo cannocchiale mal funzionante, prendendo appunti alla luce di una candela, provando e riprovando una lente dopo l’altra. Quello che deve avere passato innumerevoli ore a scrivere e riscrivere linee di matematica su taccuini sgualciti, a rileggere Aristotele per capire dove fosse il giusto e dove fosse l’errore, rileggere Archimede per trovare il teorema giusto. Quello che deve avere passato giorni e giorni a fare rotolare palle lungo discese di legno, senza all’inizio riuscire a capire come davvero cadessero. È da questo Galileo segreto e forse irraccontabile, credo, che è nata la scienza moderna, non dall’attaccabrighe che voleva farsi dare ragione dai cardinali. Heilbron prova a permettersi solo un’occhiata verso tutto questo, in un bellissimo dialogo sulla scienza del moto fra Galileo e Alessandro, un suo alter ego immaginario, che è la pagina più bella del libro. Non di più. Qualcosa di questo genio universale, che ha cambiato la nostra relazione con la realtà, resta ancora misterioso. Ma chiunque fosse stato davvero Galileo, ci resta il cuore del suo messaggio, un messaggio di scoperte, di idee e di metodo che hanno fondato il mondo moderno, un messaggio scritto in libri bellissimi, in un italiano incantevole, che indicano una strada che si è rivelata essere una strada meravigliosa: la possibilità di studiare e comprendere il mondo, di imparare cose infinitamente utili, di guardare più lontano. Grazie Galileo.
 John Heilbron, Galileo, trad. e cura di Stefano Gattei, Einaudi, Torino, pagg. 544, € 32,00
John Heilbron, Galileo, trad. e cura di Stefano Gattei, Einaudi, Torino, pagg. 544, € 32,00 Dava Sobel, La figlia di Galileo, Rizzoli, Milano, pagg. 426, € 10,90
Dava Sobel, La figlia di Galileo, Rizzoli, Milano, pagg. 426, € 10,90 -
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. ---- Ho visto stelle che voi umani...Parla Riccardo Giacconi (di Piero Bianucci)10 dicembre 2012, di Federico La Sala
Ho visto stelle che voi umani...
di Piero Bianucci (La Stampa, 10.12.2012)
Mentre oggi a Stoccolma si consegna il Nobel per la fisica parla Riccardo Giacconi, l’ultimo italiano ad averlo vinto: 50 anni fa, con l’astronomia in raggi X, ha aperto un nuova finestra sul cielo Riccardo Giacconi è nato a Genova 81 anni fa ma ha lavorato per gran parte della sua vita in America. Nel 2002 ha vinto il premio Nobel per la fisica
Oggi a Stoccolma i fisici David Wineland e Serge Haroche ritirano il premio Nobel per le loro ricerche di meccanica quantistica che aprono la strada a computer ultraveloci. Bisogna risalire ahimè a 10 anni fa per trovare un fisico italiano laureato con il Nobel. È Riccardo Giacconi. Ma mentre Wineland e Haroche si muovono nel microcosmo dell’atomo, il laboratorio di Giacconi è l’universo intero.
Nel 1962 aveva 31 anni ed era un cervello in fuga negli Usa quando aprì una finestra sul cielo che con i raggi X ci invia notizie di stelle esplose, buchi neri, galassie primordiali. Come Galileo inventò il telescopio ottico, lui inventò il telescopio per la radiazione X. C’è però un problema. Il suo telescopio non funziona al suolo perché l’aria assorbe i raggi X che arrivano dallo spazio. Bisogna metterlo in orbita. Il primo volò nel 1978 con il satellite Einstein e ora Giacconi sonda il cielo con Chandra, lanciato nel 1999, molto più potente. Ma l’astronomia X l’aveva fatta nascere prima, con strumenti rudimentali messi a bordo di razzi americani.
«Le cose erano partite male racconta -. Il primo dei nostri razzi esplose sulla rampa di lancio. Il secondo salì a 200 chilometri ma non si aprirono le ante che avevano protetto gli strumenti durante il volo. La terza volta andò bene. Era il 18 giugno 1962, mancava un minuto a mezzanotte. Cercavamo raggi X che allora si pensava provenissero dalla Luna. Invece scoprimmo la prima stella X, una sorgente nella costellazione dello Scorpione».
Ci sta il paragone con Galileo? «Soltanto in un senso: l’epoca di Galileo e la nostra hanno in comune una enorme potenzialità di scoperte. Anzi, noi ne abbiamo di più. Oggi sappiamo che l’universo alla portata dei nostri occhi è soltanto il 3% di ciò che esiste. Del restante 97% ignoriamo tutto. Sotto questo aspetto, il 2012 è meglio del 1609, l’anno in cui Galileo costruì il cannocchiale. L’astronomia in raggi X è ciò che serve per esplorare questo universo sconosciuto, fatto di materia e di energia oscure».
Genovese di nascita (6 ottobre 1931), milanese di laurea, americano per biografia scientifica, Giacconi spiega: «Noi viviamo in un mondo a bassa energia, l’energia della luce visibile. I telescopi a raggi X invece vedono fenomeni ad alta energia, per esempio buchi neri che inghiottono stelle. Bene: nell’universo i fenomeni ad alta energia non sono l’eccezione ma la regola. Solo grazie a essi potremo capire l’evoluzione dell’universo. L’astronomia in raggi X è la più adatta per rispondere alle grandi domande della cosmologia. Abbiamo una straordinaria opportunità di imparare cose nuove. Ma ci vorrebbe un telescopio per i raggi X con una potenza pari a quella che il telescopio spaziale Hubble ci offre per la luce visibile».
Peccato che scarseggino i finanziamenti. «Il vero problema dice Giacconi è che oggi tutti i soldi della Nasa sono assorbiti da un unico colossale progetto: il James Webb Telescope, lo strumento destinato a prendere il posto di Hubble. Doveva costare alcune centinaia di milioni di dollari, siamo già a parecchi miliardi ed è in ritardo di anni. Ora si parla di lanciarlo nel 2018. Sa cosa le dico? Quando il James Webb Telescope avrà finito la sua missione, il caro vecchio Hubble sarà ancora lì a scrutare il cielo dalla sua orbita intorno alla Terra... ».
Giacconi il telescopio Hubble lo conosce bene: è stato il primo direttore dello Space Telescope Science Institute di Baltimora, dove affluiscono i dati del super-occhio spaziale, e ne ha organizzato la gestione su scala planetaria: «Quando nel 1978 lanciammo il satellite per raggi X Einstein, una cosa fu chiara: i dati richiedevano uno speciale trattamento preliminare, senza il quale gli scienziati non avrebbero saputo utilizzarli. Decidemmo di farlo e di mettere i dati a disposizione di tutti. Ciò ha dato un forte impulso alla ricerca. Nel caso di Hubble abbiamo fatto la stessa cosa».
Odia la burocrazia e le pastoie accademiche. «Il periodo più bello della mia vita è quello in cui ho lavorato per una ditta privata, la American Science and Engineering. Per parecchi anni, mentre facevamo nascere l’astronomia X, l’unico limite è stato nei nostri cervelli. Se ci veniva un’idea buona, i soldi per metterla alla prova erano subito lì. Con la Nasa, arrivare al lancio del satellite Uhuru e poi dei satelliti Einstein e dell’attuale Chandra, è stata una fatica durata decenni».
E il premio Nobel? «Anche questa è una storia lunga. Dopo la scoperta del cielo in raggi X mia madre mi diceva: che cosa aspettano? Non sai farti valere! Parlo degli Anni 70. Ai primi di ottobre del 2002, una mattina alle 6 suona il telefono. Grande spavento. Sarà successa una disgrazia? No, mi spiegano che ho avuto il Nobel. Non ci pensavo più da un sacco di tempo. Poi suonarono alla porta. Aprii e fui abbagliato dai flash dei fotografi».
Che cosa sogna? «Finora è stato come guardare dal buco della serratura. Sogno un telescopio a raggi X a largo campo, che permetta di inquadrare in un solo colpo d’occhio un bel pezzo di universo».
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. ---- Addio a Neil Armstrong, primo ’moonwalker’ (di Ugo Caltagirone)28 agosto 2012, di Federico La Sala
Addio a Neil Armstrong, primo ’moonwalker’
di Ugo Caltagirone *
"Un vero eroe americano". Così é stato definito Neil Armstrong, timido e tranquillo ingegnere dell’Ohio destinato però a diventare un eroe globale: il primo uomo a posare piede sulla luna, nell’ormai lontano 20 luglio 1969. Oggi Armstrong ha lasciato questa Terra, quella che commosso riuscì a contemplare dalla superficie lunare. Si è spento ad 82 anni per complicazioni cardiovascolari, in seguito ad una delicatissima operazione al cuore subita all’inizio di agosto. "Neil è stato uno dei più grandi eroi di tutti i tempi e ci ha insegnato l’enorme potere di un piccolo passo", sono state le parole del presidente statunitense, Barack Obama, che insieme alla First Lady Michelle si è detto "profondamente colpito".
La costernazione per la scomparsa del primo ’moonwalker’ della storia coinvolge ogni angolo del mondo. Insieme a Edwin ’Buzz’ Aldrin e Michael Collins quel giorno di 43 anni fa emozionò un’intera generazione. E le sue prime parole, appena toccato il suolo lunare, sono rimaste impresse nella memoria e nei libri di storia: "That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind", un piccolo passo per un uomo, un balzo da gigante per l’umanità. Si coronava il sogno del presidente americano John Fitzgerald Kennedy a cui, in piena guerra fredda, l’Unione Sovietica aveva lanciato il guanto di sfida anche sul fronte della corsa allo spazio, lanciando in orbita nel 1957 il satellite Sputnik.
Ora l’America aveva vinto. Il simbolo di questa vittoria era proprio Armstrong che, in quelle ore passate sulla Luna, insieme ad Aldrin raccolse reperti, scattò fotografie, fece esperimenti, gettando le basi per la futura esplorazione dello spazio. Dopo di loro altri dieci astronauti americani lasciarono le loro impronte sulla luna tra il 1969 e il 1972. Armstrong mostrò anche un enorme coraggio, lui che alcuni amici di infanzia ricordano come un giovane un po’ ’nerdy’, imbranato: quando il computer del modulo lunare Eagle in fase di atterraggio fece le bizze, prese i comandi manuali e si rese protagonista di un atterraggio mozzafiato: "Houston, qui Base della Tranquillità. L’Aquila è atterrata", disse alla fine della spericolata ma decisiva manovra, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo.
Anche ai milioni di telespettatori che in tutto il mondo seguirono - in bianco e nero - l’evento. Forse il primo grande evento mediatico globale della storia della televisione. Armstrong, nato in Ohio da genitori di origine tedesca, è rimasto schivo e poco avvezzo alle luci della ribalta anche dopo essere andato in pensione. Ha continuato a insegnare all’università e le sue apparizioni negli anni sono state sporadiche. Solo nel 2010 fece parlare di sé per essere per la prima volta intervenuto nel dibattito politico, criticando la politica spaziale dell’amministrazione Obama che, in tempi di crisi economica, aveva secondo lui indebolito il ruolo della Nasa promuovendo la corsa allo spazio da parte delle compagnie private. I problemi al cuore lo avevano costretto ai primi di agosto ad un delicato intervento per installare un bypass. Sembrava tutto fosse andato per il verso giusto, come la stessa moglie Carol aveva confermato. "Lo spirito pioneristico di Neil gli è stato utile in questo momento difficile", erano state le parole del numero uno della Nasa, Charles Bolden. Ma stavolta Neil non ce l’ha fatta. E ora l’America, ma non solo, piange il suo eroe.
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. --- Il Telescopio di Galileo. Una storia europea (di Sergio Luzzatto - Galileo guardava lontano)13 maggio 2012, di Federico La Sala
Galileo guardava lontano
di Sergio Luzzatto (Il sole 24 Ore” - Domenica, 13 maggio 2012)
Noi tutti abbiamo toccato con mano, molto recentemente, gli splendori (e le miserie) della comunicazione di una sensazionale scoperta scientifica. Settembre 2011: il Cern di Ginevra annuncia urbi et orbi i risultati di un esperimento compiuto insieme ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, che dimostrerebbe la capacità dei neutrini di viaggiare a una velocità superiore a quella della luce. Tutto il mondo ne parla, e il ministro italiano della Ricerca scientifica si vanta di avere contribuito a una scoperta di eccezionale importanza, tale da revocare in dubbio la teoria della relatività generale di Einstein. Marzo 2012: riconoscendo un errore di misurazione, il Cern smentisce che i neutrini siano più veloci della luce. Tutto il mondo ne ride, e il direttore italiano dell’esperimento annuncia le proprie dimissioni.
È tenendo a mente questa storia di poche settimane fa - gli onori, e gli oneri di scoperte scientifiche sbandierate come rivoluzionarie - che possiamo accostarci a una storia assai più remota, ma ben diversamente decisiva. Novembre 1609: un oscuro professore di matematica dello Studio di Padova, Galileo Galilei, impiega uno strano «occhiale» per scoprire nel cielo cose inaudite, tali da revocare in dubbio un’intera visione dell’universo. Marzo 1610: Galileo rende pubbliche in un libro, Sidereus Nuncius, le sue prime sensazionali scoperte, la presenza di montagne sulla Luna, l’esistenza di satelliti orbitanti intorno a Giove. L’edizione viene esaurita in pochi giorni, mentre Venezia tutta si interroga sull’accoglienza che al volumetto sarebbe stata riservata. «Qui se ne parla in ogni angolo della città», informa l’ambasciatore inglese, sir Henry Wotton, «e l’autore corre il rischio di diventare o estremamente famoso o estremamente ridicolo».
Oggi noi sappiamo che le scoperte di Galileo lo resero famosissimo piuttosto che ridicolissimo. Ma quando ci si occupa di storia (e tanto più di storia della scienza), bisogna guardarsi dalle insidie del senno di poi, dal demone dell’anacronismo. Se ricostruita in medias res, la vicenda del telescopio di Galileo si presenta come tutt’altro che una success story annunciata, quasi inevitabile. E non soltanto perché lo scienziato pisano sarebbe stato costretto, da ultimo, a rinnegare le sue scoperte davanti al tribunale del Sant’Uffizio: anche perché, da subito, vari ambienti della Repubblica delle Scienze reagirono con diffidenza al «messaggero sidereo» e, in generale, al telescopio come strumento di nuova conoscenza.
Già nell’agosto 1609, da Napoli, un personaggio rispettato qual era Giovan Battista Della Porta aveva scritto al principe romano Federico Cesi, il fondatore dell’Accademia dei Lincei: «del secreto dell’occhiale l’ho visto, et è una coglionaria».
La vicenda del cannocchiale va studiata nello spazio, come una rete di storie orizzontali, prima ancora che nel tempo, come una trama di storie possibili: è quanto hanno splendidamente fatto Massimo Bucciantini, Michele Camerota e Franco Giudice, autori per Einaudi di un libro intitolato Il telescopio di Galileo e sottotitolato Una storia europea. Storia cominciata nei Paesi Bassi del 1608 quando un ottico di provincia, Hans Lipperhey, accoppiando una lente concava e una lente convessa inventa un dispositivo «grazie al quale tutte le cose a grande distanza possono essere viste come se fossero vicine». Storia proseguita nella Repubblica Serenissima dell’anno dopo, quando il matematico di Padova muove da un «occhiale di canna» giunto d’oltralpe per metter sotto i migliori vetrai e occhialai di Venezia, per mettersi lui stesso a molare lenti, insomma per trasformare un rudimentale aggeggio da pochi ingrandimenti in uno strumento poderoso, l’«occhiale di Galileo».
Veneziana è la settimana cruciale di questa storia: dal 22 al 29 agosto 1609, Galileo riesce a costruire un telescopio capace (scrive orgogliosamente) di mostrare un oggetto «lontano 50 miglia, così grande e vicino come se fussi lontano 5 miglia». Veneziana è la puntata successiva: Galileo che sale sul campanile di San Marco con i maggiorenti della Repubblica, li invita a scrutare nel mirino del suo cannocchiale, fa loro «scoprire in mare vele e vasselli» invisibili a occhio nudo, e il campanile di Chioggia quasi fosse a portata di mano... Veneziana è anche la puntata seguente, quella con Galileo che rivolge lo strumento verso il cielo e che in rapida successione, dal novembre 1609 al gennaio 1620, scopre le montagne della Luna e i satelliti di Giove. Ancora, veneziana è l’uscita del Sidereus Nuncius, pubblicato in 550 copie il 13 marzo di quel fatidico 1610.
Ma continentali - davvero europee - sono le puntate ulteriori della storia. Europeo è il passaparola per cui tutta una folla di astronomi professionisti o dilettanti, di matematici, di fisici, di astrologi, di ambasciatori o dignitari di corte, di prelati di Santa Romana Chiesa, di re e di imperatori in persona, dapprima attende con impazienza la pubblicazione del Sidereus Nuncius, poi si contende le copie del libretto con un’energia pari alla foga con cui cerca di assicurarsi sul mercato un «occhiale di Galileo». Ed europea è la risonanza delle scoperte galileiane, la consapevolezza immediata e diffusa che queste, se riscontrate, avrebbero inaugurato non solo una nuova cosmologia, ma una nuova antropologia: non solo un altro mondo, ma un altro modo di stare al mondo.
Impossibile seguire qui passo passo gli autori onniscienti del Telescopio di Galileo, dall’Inghilterra in cui un amico dell’ambasciatore sir Wotton -il poeta John Donne - denuncia le nuove scoperte astronomiche come un segno dell’umana protervia, alla Francia da dove un re morituro, Enrico IV, corteggia Galileo per vedersi dedicato lui pure un qualche astro del firmamento (non voleva esser da meno dei Medici, cui lo scopritore aveva intestato i satelliti di Giove); dalla Milano del cardinal Federico Borromeo, così «invaghito» di cannocchiali da voler scriverne un trattato, alla Bologna pontificia dove i detrattori universitari di Galileo presentano come fallita la verifica delle sedicenti sue scoperte, e descrivono il Nuncius come un uomo a pezzi, annichilito dallo smacco: «gli cadono i capelli», «la testa è guasta, e il cervello in preda al delirio», «i nervi ottici sono troncati, perché con troppa curiosità e presunzione ha osservato le distanze in minuti e secondi attorno a Giove».
In realtà, Galileo sapeva che la vera partita si giocava altrove: non a Bologna ma a Praga, la Praga dell’imperatore Rodolfo II d’Asburgo e del matematico di corte Johannes Kepler, cioè l’astronomo più autorevole del suo tempo. Galileo sapeva che un endorsement di Keplero avrebbe spalancato un orizzonte di gloria così alle nuove come alle nuovissime sue scoperte (dopo le montuosità lunari e i pianeti medicei, il telescopio gli aveva rivelato anche qualcosa come gli anelli di Saturno, e poi le fasi di Venere); mentre un giudizio negativo avrebbe rinfocolato la polemica intorno sia ai limiti tecnici dell’osservazione telescopica, sia ai limiti teorici della cultura ottica di Galileo.
Con l’onestà intellettuale dello scienziato di razza, il tedesco Keplero finì effettivamente per rendere pubblica una sua adesione alla rivoluzionaria cosmologia suggerita, grazie al cannocchiale, da quel collega italiano tanto meno celebre di lui. E incominciò allora un’altra storia, ben nota, questa: la storia di Galileo trionfante, strapagato dai Medici per lasciare la Repubblica di Venezia e ritornare nel Granducato di Toscana quale matematico e addirittura filosofo di corte; la storia di Galileo caduto, sorvegliato dall’Inquisizione, processato come copernicano, sospinto all’abiura.
Nell’anno di grazia 1611, la caduta sembrava ancora di là da venire. Il 22 aprile il «messaggero sidereo» fu ufficialmente ricevuto, a Roma, dal papa Paolo V, che neppure «una parola» gli chiese di dire «in ginocchioni». Il fatto è che non in pubblico, ma in privato la Chiesa affilava le armi, per vendicare una fede che la scienza di Galileo - spostando l’uomo fuori dal centro del mondo - pareva drammaticamente minacciare.
Fin dall’estate del 1610, corrispondendo con un amico, il protonotario apostolico Bonifacio Vannozzi (futuro segretario di Paolo V) aveva dettato la linea: «Che la Luna sia terrea, con valli e colline, è tanto dire che vi son degli armenti che vi pascono e de’ bifolchi che la coltivano. Stiancene con la Chiesa, nemica delle novità da sfuggirsi, secondo l’ammaestramento di S. Paolo».
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. ---- L’ILLUSIONE DI UN VATICANO SENZA MEMORIA: L’ITALIA RIDOTTA A SUO CORTILE! Come se il Galileo della Galilea e Galileo Galilei non fossero mai esistiti! La lettera scritta da Benedetto XVI al presidente Napolitano in occasione del 150° dell’Unità d’Italia commentata da Piero Stefani.8 aprile 2011, di Federico La Sala
Cliccare sul rosso, per leggere l’articolo:
 SCIENZA, FEDE, E "SIDEREUS NUNCIUS": "VICISTI, GALILAEE"! PER KEPLERO (1611), GALILEO HA VINTO NON SOLO SUL PIANO SCIENTIFICO, MA ANCHE TEOLOGICO E POLITICO!!! COSI’ PER KANT ....
SCIENZA, FEDE, E "SIDEREUS NUNCIUS": "VICISTI, GALILAEE"! PER KEPLERO (1611), GALILEO HA VINTO NON SOLO SUL PIANO SCIENTIFICO, MA ANCHE TEOLOGICO E POLITICO!!! COSI’ PER KANT ....
 L’ILLUSIONE DI UN VATICANO SENZA MEMORIA: L’ITALIA RIDOTTA A SUO CORTILE! Come se il Galileo della Galilea e Galileo Galilei non fossero mai esistiti! La lettera scritta da Benedetto XVI al presidente Napolitano in occasione del 150° dell’Unità d’Italia commentata da Piero Stefani
L’ILLUSIONE DI UN VATICANO SENZA MEMORIA: L’ITALIA RIDOTTA A SUO CORTILE! Come se il Galileo della Galilea e Galileo Galilei non fossero mai esistiti! La lettera scritta da Benedetto XVI al presidente Napolitano in occasione del 150° dell’Unità d’Italia commentata da Piero Stefani
 (...) L’omissis più macroscopico è però un altro. Si tratta di un nome studiato anche in sede di letteratura italiana. Parliamo, è scontato dirlo, di Galileo, colui che scrisse in italiano quanto fino ad allora era riservato al latino. Per una Chiesa non ipocrita sarebbe stato il primo nome da citare, anche al fine di confutare, attraverso la sincerità, l’uso strumentale fattone da altri. Ciò vale anche per Savonarola e Giordano Bruno (...)
(...) L’omissis più macroscopico è però un altro. Si tratta di un nome studiato anche in sede di letteratura italiana. Parliamo, è scontato dirlo, di Galileo, colui che scrisse in italiano quanto fino ad allora era riservato al latino. Per una Chiesa non ipocrita sarebbe stato il primo nome da citare, anche al fine di confutare, attraverso la sincerità, l’uso strumentale fattone da altri. Ciò vale anche per Savonarola e Giordano Bruno (...) -
> IL "SIDEREUS NUNCIUS", OGGI. ---- L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI E GLI INTELLETTUALI ATEI E DEVOTI ANCORA AI PIEDI DEI PAPI.27 gennaio 2011, di Federico La Sala
L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI. Materiali sul tema:
PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI.
Federico La Sala
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS", OGGI. ---- IL LAVORO DI GALILEO COME IL LAVORO DI KANT TUTTO DA RIVISITARE (COME DA INDICAZIONE DI FULVIO PAPI)28 gennaio 2011, di Federico La Sala
NEI CONFRONTI DI GALILEO, LA STORIOGRAFIA CRITICA HA FATTO UN ERRORE ENORME, ANALOGO A QUELLO FATTO DA ENGELS (E DAL MARXISMO) NEI CONFRONTI DI KANT - COME HA BEN VISTO FULVIO PAPI:
 “E’ quindi inutile con Kant ricorrere a modelli storiografici che vogliano sceverare un’autenticità del suo pensiero e un piano ideale di natura operativa o tattica o politica tale che faccia nascere un insieme di questioni marginali, che però non corrispondono alla centrale linea speculativa. Quando, ad esempio, Engels nell’Antischelling sottolinea nella Storia generale della natura l’aspetto cosmologico, vedendone solo l’apporto di natura scientifica procede a una semplificazione che vede unilateralmente solo una faccia della problematica kantiana.
“E’ quindi inutile con Kant ricorrere a modelli storiografici che vogliano sceverare un’autenticità del suo pensiero e un piano ideale di natura operativa o tattica o politica tale che faccia nascere un insieme di questioni marginali, che però non corrispondono alla centrale linea speculativa. Quando, ad esempio, Engels nell’Antischelling sottolinea nella Storia generale della natura l’aspetto cosmologico, vedendone solo l’apporto di natura scientifica procede a una semplificazione che vede unilateralmente solo una faccia della problematica kantiana.
 Che dal punto di vista engelsiano questo modo di procedere fosse ovvio e che questa valutazione settorialmente scientifica sia stata fatta altre volte e anche con legittimità in quanto la cosmologia costituisce una zona obiettiva del sapere scientifico, non esclude che traducendo in un modello storiografico questo tipo di semplificazione e di riduzione non sia poi più possibile una ricostruzione della totalità filosofica del pensiero kantiano di questo periodo.
Che dal punto di vista engelsiano questo modo di procedere fosse ovvio e che questa valutazione settorialmente scientifica sia stata fatta altre volte e anche con legittimità in quanto la cosmologia costituisce una zona obiettiva del sapere scientifico, non esclude che traducendo in un modello storiografico questo tipo di semplificazione e di riduzione non sia poi più possibile una ricostruzione della totalità filosofica del pensiero kantiano di questo periodo.
 Ciò che interessa vedere è invece come il giovane Kant armonizzi in un discorso filosofico questa doppia esigenza, scientifica e religiosa, e nella delineazione di questo come è il compito di chi si proponga di mostrare la forma originale con cui Kant darà equilibrio speculativo al suo problema” (Fulvio Papi, Cosmologia e civiltà. Due momenti del Kant precritco, Argalia Editore, Urbino 1969, pp. 13-15).
Ciò che interessa vedere è invece come il giovane Kant armonizzi in un discorso filosofico questa doppia esigenza, scientifica e religiosa, e nella delineazione di questo come è il compito di chi si proponga di mostrare la forma originale con cui Kant darà equilibrio speculativo al suo problema” (Fulvio Papi, Cosmologia e civiltà. Due momenti del Kant precritco, Argalia Editore, Urbino 1969, pp. 13-15).Federico La Sala
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS", OGGI. ---- Il telescopio Kepler della Nasa ha scoperto a 2.000 anni luce da noi un sistema planetario simile al nostro: orbita intorno a una stella simile al Sole ed è composto da sei pianeti grandi più o meno come la Terra. Interv. a Margherita Hack (di Pietro Greco).3 febbraio 2011, di Federico La Sala
Kepler 11. Sono pianeti che orbitano intorno alla stessa stella. Di questi, 5 sono piccoli come la Terra Una conferma dell’intuizione di Giordano Bruno che l’universo è fatto da infiniti sistemi
Scoperti sei nuovi mondi e assomigliano al nostro
Il telescopio Kepler della Nasa ha scoperto a 2.000 anni luce da noi un sistema planetario simile al nostro: orbita intorno a una stella simile al Sole ed è composto da sei pianeti grandi più o meno come la Terra
di Pietro Greco (L’Unità, 03.02.2011)
C’è un sistema planetario con cinque «piccole terre» che orbitano intorno alla stella Kepler-11, laggiù a 2.000 anni luce di distanza da noi. Lo afferma un team del telescopio spaziale Kepler in un articolo pubblicato oggi dalla rivista Nature. La scoperta si è meritata, a ragione, la copertina della rivista scientifica inglese. Per svariati motivi.
In primo luogo perché è il più grande sistema planetario extra-solare finora rilevato. Orbita intorno a una stella del tutto simile al Sole, battezzata Kepler-11 dal team di ricercatori, ed è composto da ben sei pianeti.
Inoltre uno solo di questi pianeti ha una massa non ancora ben determinata, ma gli altri cinque hanno una massa compresa tra 2,3 e 13,5 masse terrestri. Insomma, sono solo un po’ più grandi della Terra. Dal 1992 a oggi, da quando cioè gli astronomi sono riusciti a individuare pianeti intorno a stelle diversa dal Sole, sono stati catalogati oltre 520 esopianeti. Per la gran parte si tratta di pianeti giganti, grandi come Giove e più: ovvero con un massa di due o tre ordini superiore a quella terrestre. Solo raramente si è scoperto un pianeta di massa simile alla Terra. Kepler stesso aveva individuato poco tempo fa un sistema planetario costituito da cinque pianeti giganti. Ora, però, Kepler ha scoperto addirittura cinque pianeti piccoli come la Terra e tutti orbitanti intorno alla medesima stella. Bel colpo, non c’è che dire, per il telescopio mandato nello spazio dalla Nasa nel 2009 con questa specifica missione: trovare oggetti della stessa specie e della stessa grandezza della Terra. Poco importa che il sistema è instabile. Il team di ricercatori, infatti, ha rilevato che i cinque pianeti di grandezza paragonabile alla Terra hanno un periodo orbitale piuttosto breve, compreso tra 10 e 47 giorni; la loro orbita è molto vicina a quella della loro stella (la distanza è all’incirca come quella di Mercurio); sono molto vicini tra loro e, inoltre, viaggiano nel bel mezzo di una nube di gas, polvere e forse di oggetti più grandi. Un sistema così non è stabile. Ha un comportamento caotico e certamente è destinato a cambiare nel tempo.
Certo la scoperta non convince del tutto tutti. La fotometria di transito, utilizzata per rilevare la presenza di pianeti così lontani, è una tecnica molto delicata e molto nuova. Si basa su un principio chiaro: quando un pianeta transita davanti alla sua stella (ovvero si interpone tra noi e la stella) assorbe una parte della luce emessa. E questo assorbimento è proporzionale al suo raggio. La sua grandezza può dunque essere dedotta dalla quantità di luce assorbita. E la frequenza del transito è proporzionale al suo periodo orbitale e alla distanza dalla stella. Le misure di fotometria sono semplici. Ma le distanze sono enormi. La luce in gioco è pochissima. Errori sono sempre possibili. Tuttavia, al di là delle sue performance, le implicazioni delle scoperte del telescopio Kepler sono notevoli. Per due motivi. È la conferma di quel «principio di mediocrità» che portava il filosofo Giordano Bruno a sostenere, più di quattrocento anni fa e prima che fosse messo a punto qualsiasi telescopio, che l’universo è fatto da infiniti mondi e, dunque, da infiniti oggetti «della stessa specie» della Terra. Il telescopio Kepler ce ne ha dato una conferma.
Il secondo motivo è che gli ultimi venti anni di osservazioni hanno dimostrato che ci sono i sistemi planetari i più diversi. Non tutti previsti dalle teorie. E che, dunque, anche per i pianeti valeva la felice intuizione di un altro grande del XVI secolo, William Shakespeare, quando fa dire ad Amleto: «Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quanto ne sogni la tua filosofia».
Margherita Hack: «C’è vita nell’universo. Ma è difficile trovarla»
L’astrofisica: «Si tratta di una scoperta importante perché dimostra che esistono miliardi di pianeti “abitabili” con condizioni molto simili alla nostra»
 l’Unità, 03.02.2011
l’Unità, 03.02.2011Margherita Hack, come giudica quest’ultima scoperta del telescopio spaziale Kepler?
«La giudico una scoperta davvero di grande rilievo. Perché certo ormai siamo quasi abituati a scoperte di pianeti extrasolari. Negli ultimi anni ne abbiamo rilevati tantissimi. Ma questa volta è stato scoperto un intero sistema planetario. Per di più costituito da diversi pianeti di grandezza paragonabile a quella della Terra. Finora erano stati scoperti quasi solo pianeti giganti. In genere gassosi e dunque molto diversi dalla Terra. Ora sono stati scoperti cinque pianeti simili alla Terra e per di più intorno a un pianeta simile al nostro Sole».
Perché questi dettagli sono importanti?
«Beh, al di là delle performance tecniche necessarie per rilevarli significa che nell’universo non ci sono solo miliardi di pianeti, ma miliardi di pianeti “abitabili”. E questo ha una profonda implicazione per l’esistenza di altra vita nell’universo».
Questi pianeti, tuttavia, sono molto vicini alla loro stella.
«Sì, in questo caso i pianeti orbitano a distanze molto ravvicinate alla loro stella e quindi sono caldissimi. Questo li rende di fatto inospitali. Ma il fatto che esistano e ne esistano in gran numero con questa grandezza ci induce a credere che in giro nella galassia e nell’universo ve ne siano anche a distanza “giusta”, in “un’area di abitabilità”».
Ma basta la presenza di pianeti “abitabili” per affermare che c’è altra vita nell’universo?
«Certo la scienza ci dice che solo una prova empirica può darci la certezza. Ma io e molti altri studiosi siamo convinti che la vita nasca ovunque vi siano le condizioni. Ecco, Kepler ha dimostrato che le condizioni per la presenza di vita simile alla nostra nell’universo ci sono».
Non sarà facile trovare una prova empirica di esistenza di vita, però.
«Infatti io penso che quella prova non l’avremo mai. Le distanze tra le stelle sono troppo grandi. La stella Kepler-11 dista 2.000 anni luce da noi. Il che significa che il telescopio Kepler ha visto ciò che accedeva 2.000 anni fa, al tempo dei Romani. Immagini che lì ci sia vita intelligente e capace di dialogare con noi - cosa niente affatto scontata. Se oggi noi ponessimo loro una domanda, dovremmo attendere 4.000 anni per sapere cosa ci hanno risposto. In definitiva possiamo dire che la vita certamente c’è nell’universo. Ma difficilmente la troveremo. Almeno con le conoscenze e le tecnologie attuali». PI.GRE
-
> IL "SIDEREUS NUNCIUS", OGGI. ---- IL CEERVELLO ARTISTICO DI GALILEO.... Galileo era appassionato di pittura e pittore dilettante. Era amico di tutti i maggiori pittori dell’epoca, tra i quali in particolare Ludovico Cigoli (di Lamberto Maffei).10 aprile 2011, di Federico La Sala
Il cervello artistico di Galileo Galilei
di Lamberto Maffei (Il Sole-24 Ore, 10 aprile 2011)
Che cosa c’entra Galileo Galilei con le rane? Con lui siamo nel campo dell’astronomia, naturalmente, nel mondo del Sidereus Nuncius. Galileo puntò il suo cannocchiale verso la Luna e vide macchie e ombre che interpretò correttamente come asperità della superficie lunare, e precisamente come monti e crateri, «altissima montium iuga» o «cavitates» che egli stesso rappresenta con bellissimi disegni ad acquarello nella sua opera pubblicata nel 1610. Questi disegni sono molto simili alle fotografie della superficie lunare ottenute recentemente dai satelliti. Galileo distinse correttamente tra irregolarità concave e convesse della superficie della Luna a seconda delle ombre che esse presentavano e della posizione delle zone più chiare e più scure rispetto alla direzione di provenienza della luce del Sole. La sicurezza con la quale Galileo interpretò le ombreggiature di queste immagini come prove dell’evidenza di crateri e montagne appare tanto più sorprendente se si pensa che ai suoi tempi si riteneva che la superficie della Luna fosse perfettamente liscia e levigata.
Altri studiosi contemporanei di Galileo avevano osservato nello stesso tempo e anche nei mesi precedenti la superficie lunare al telescopio e ne avevano fatto, come Galileo, dei disegni, ma con risultati completamente diversi. Tra questi si trovano riportati i disegni dell’astronomo inglese Thomas Harriot che si rifanno alla descrizione aristotelica della superficie lunare. Poniamoci una semplice domanda: come fu possibile che Galileo riuscisse a interpretare correttamente le ombre della Luna come crateri e montagne quando altri studiosi del suo tempo davano interpretazioni ben diverse delle stesse immagini ottenute utilizzando il cannocchiale?
Galileo era appassionato di pittura e pittore dilettante. Era amico di tutti i maggiori pittori dell’epoca, tra i quali in particolare Ludovico Cigoli, con il quale tenne una nutrita corrispondenza e al quale aveva regalato un cannocchiale per osservare la Luna di cui il Cigoli doveva aver fatto un ottimo uso, come si deduce dalla rappresentazione della Madonna in Santa Maria Maggiore a Roma. Il Cigoli aveva rappresentato la Luna ai piedi della Santa Vergine così com’è vista al telescopio «con le divisioni merlate e le sue isolette».
Senza dubbio le osservazioni di Galileo al telescopio furono influenzate dalle sue conoscenze della teoria delle ombre e del chiaroscuro e cioè dal suo cervello. Scriveva in una lettera al Cigoli del 26 giugno 1612: «Conosciamo dunque la profondità, non come oggetto della vista, per sé et assolutamente, ma per accidente rispetto al chiaro et allo scuro».
Il cervello di Galileo, meglio sarebbe dire la sua corteccia cerebrale, che possedeva informazioni ed esperienza di pittura e teoria delle ombre, era riuscita a dare un’interpretazione corretta dell’evento visivo «immagini della Luna al cannocchiale». In un Homo sapiens per eccellenza come Galileo è la corteccia che interpreta e guida la visione; si potrebbe scrivere, a complemento di un lavoro sulla rana e a parziale sua contrapposizione, un lavoro dal titolo provocatorio «Cosa il cervello di Galileo disse al suo occhio».
La corteccia dell’astronomo inglese Harriot, indottrinata da preconcetti filosofici e priva di esperienze e conoscenze nell’interpretazione della terza dimensione e della visione dello spazio, aveva portato a un’interpretazione completamente diversa degli stessi eventi visivi percepiti al cannocchiale da Galileo, a dimostrazione che la percezione visiva, e si potrebbe dire più in generale sensoriale, non è una trasposizione passiva dell’informazione pervenuta al sensore, nel caso trattato, la retina.
Se è facile comprendere - come nel caso della rana - la trasmissione attraverso le vie ottiche del l’informazione visiva dalla periferia al centro, cioè dall’occhio al cervello della rana, più difficile è comprendere il caso inverso del cervello che informa l’occhio cambiandone la funzione. Si potrebbe arguire che in alcuni animali esistono delle fibre cosiddette «centrifughe» che dai centri cerebrali raggiungono le cellule retiniche, ma queste fibre non esistono nei mammiferi superiori e nell’uomo e, anche negli animali dove sono state descritte, la loro funzione non è chiara ed è attribuita a una regolazione quantitativa delle risposte. Vero è che come aveva già detto Plinio nella Naturalis Historia non è con l’occhio che si vede ma con il cervello.
L’asportazione della corteccia visiva produce infatti cecità. Cervelli diversi vedono cose diverse e capiscono cose diverse anche quando il messaggio in arrivo è lo stesso. La cultura fa parte della percezione. Imparare significa modificarsi e cambiare il mondo che ci circonda.
L’occhio della rana trasmette al suo cervello quel che succede nel mondo e si può supporre che non esista o sia ridotta al minimo la parte di interpretazione individuale del messaggio da parte dell’animale. La grande corteccia dei mammiferi invece, e in particolare quella dell’uomo, interpreta e cambia il messaggio proveniente dall’occhio a seconda del contesto e della dinamica dei suoi circuiti neurali in quel determinato momento.
-
-
-