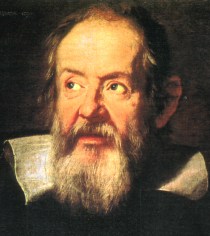
MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!
domenica 31 dicembre 2006.
- Aristotele fu un uomo, vedde con gli occhi, ascoltò con gli orecchi, discorse col cervello. Io sono un uomo, veggo con gli occhi, e assai più che non vedde lui: quanto al discorrere, credo che discorresse intorno a più cose di me; ma se più o meglio di me, intorno a quelle che abbiamo discorso ambedue, lo mostreranno le nostre ragioni, e non le nostre autorità (Galileo Galilei)
Per Giandomenico Boffi, ordinario di Algebra, la scienza dei numeri apre più di uno spiraglio alla plausibilità di un Ente trascendente
Matematica e mistero
«Da questa attività creativa dell’uomo emerge quasi un potere predittivo nei confronti della realtà, che rimane sconcertante»
di Antonio Giorgi (Avvenire, 22.11.2006)
Trovare l’equazione fondamentale della vita, oppure quella che esprime l’essenza dell’universo? Dare una risposta numerica - magari formulata in codice binario - agli interrogativi esistenziali dell’uomo del XXI secolo? Individuare la formula della felicità, del benessere, della salute, della coesistenza tra i popoli? «Via, non diciamo sciocchezze. La matematica non può spiegare ogni cosa e perfino nel dominio del razionale è ancora da dimostrare la possibilità di matematizzare tutto. Però la matematica è una scienza che va coltivata, strumento prezioso al servizio dell’uomo». Pronunciate da un matematico.
Il professor Giandomenico Boffi, ordinario di algebra all’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, queste parole possono essere interpretare come un modo di tirare l’acqua al proprio mulino, di svolgere una sorta di attività promozionale per una branca dello scibile che vede diminuire - in Italia e non solo - il numero dei cultori. E si capisce perché: «Studiarla - sottolinea Boffi - è attività faticosa che richiede un impegno razionale molto serio non disgiunto da una buona dose di fantasia, creatività, perfino senso estetico. Oggi i giovani preferiscono altro, purtroppo».
Eppure adesso la matematica può vantare di avere dalla sua nientemeno che il Papa. Intervenendo al recente Convegno ecclesiale di Verona Benedetto XVI l’ha esaltata come sublime creazione dell’intelligenza umana e chiave di lettura di un universo strutturato in maniera intelligente in modo che esista corrispondenza tra la ragione soggettiva e la ragione oggettivata nella natura, espressioni entrambe di un’unica intelligenza originaria «comune fonte dell’una e dell’altra».
«Che la matematica sia pura creazione della mente umana è un fatto largamente condiviso», dice Boffi. «Desta perciò meraviglia l’eccezionale efficacia che questa scienza ha dimostrato nel consentire da un lato l’interpretazione della realtà e dall’altro l’intervento concreto, anche tecnologico, su di essa. La matema tica è una delle poche cose universali che noi sperimentiamo, e già questo è sorprendente. Lo è ancora di più il fatto che l’universo risponde in qualche modo alle nostre sollecitazioni basate sugli strumenti matematici. Da questa attività creativa dell’uomo emerge quasi un potere predittivo nei confronti della realtà, il che è alquanto sconcertante». Il professore ricorda James Maxwell e i suoi studi sull’elettromagnetismo, l’intuizione dello scienziato di inserire nelle equazioni un termine in più non per ragioni ispirate da esperienza fisica ma per simmetria. Un audace azzardo, «ma successivamente è stato accertato che quel termine in più corrispondeva alle onde radio». Fu come se il reale, per qualche arcano motivo, si fosse adattato alla speculazione teorica del ricercatore scozzese.
«È naturale che io apprezzi le argomentazioni portate dal Papa al Convegno di Verona», continua Giandomenico Boffi. «Nella misura in cui non si è ancora riusciti a giustificare l’indubbia consonanza verificabile tra una creazione della nostra mente, la matematica, e una realtà data a prescindere da noi, diventa legittimo ipotizzare l’esistenza di un Ente superiore intelligente che si pone alla radice tanto della realtà che ci circonda, quanto della nostra stessa mente. Arriviamo anche noi a chiederci con il Santo Padre se non debba esservi un’unica intelligenza originaria, in quanto ammetterne l’esistenza spiega questa consonanza. Galileo diceva - il Papa lo ha ricordato - che il libro della natura è scritto in linguaggio matematico, quindi conoscendo la matematica possiamo leggerlo. In effetti l’idea che abbiamo oggi è un po’ più cauta: la scienza elabora modelli matematicamente strutturati che hanno sicura attinenza con la realtà (altrimenti le auto non funzionerebbero, le astronavi non potrebbero volare), però da qui a dedurre che il mondo è fatto esattamente come il modello ce ne corre. Ai fini del nostro discorso tuttavia non cambia nulla: il dato fondamentale è che esiste i n qualche modo una sintonia tra la mente e la realtà esterna alla mente, sintonia che si spiega bene con l’esistenza di Qualcosa che sta sopra e che unifica».
Siamo davanti ad una consonanza che già il fisico Wigner descriveva con i termini calzanti di sorpresa e mistero, espressioni che Boffi fa proprie ragionando a sua volta del rapporto tra la mente umana, i frutti della mente e la realtà che ci sta attorno. Che conclusione trarre, se non quella, obbligata, che «tutto ciò apre uno spiraglio alla plausibilità dell’idea di Dio?». Diventa di conseguenza arbitrario sostenere «che la nostra fede nel Creatore è un atto completamente irrazionale». La riflessione si concentra sulla relazione tra fede e scienza, fede e intelligenza. «La fede cristiana attribuisce grande importanza all’intelligenza. È una fede che ha bisogno dell’intelligenza e Dio, in ultima analisi, è un’intelligenza amante, una ragione capace di amare. Dentro la matematica troviamo tutte le prospettive per un ampliamento della razionalità».
E anche qualcosa di più, a ben guardare. Oltre ad esprimere la plausibilità dell’idea di Dio, la scienza che Boffi professa fornisce probabilmente anche un elemento a favore dell’esistenza dell’anima. «L’uomo è l’unico essere capace di fare matematica. L’esistenza di attività umane precluse al mondo animale corrobora la plausibilità di una differenza qualitativa tra l’uomo e le altre specie. Riconoscerla, significa dare plausibilità all’idea di un elemento di trascendenza».
Benedetto XVI: Logos e natura
Proprio alla matematica Papa Ratzinger ha dedicato un passaggio nel suo discorso ai partecipanti del Convegno di Verona, lo scorso 19 ottobre. «La matematica», sottolineava il Pontefice, «come tale è una creazione della nostra intelligenza: la corrispondenza tra le sue strutture e le strutture reali dell’universo - che è il presupposto di tutti i moderni sviluppi scientifici e tecnologici, già espressamente formulato da Galileo Galilei con la celebre affermazione che il libro della natura è scritto in linguaggio matematico - suscita la nostra ammirazione e pone una grande domanda. Implica infatti che l’universo stesso sia strutturato in maniera intelligente, in modo che esista una corrispondenza profonda tra la nostra ragione soggettiva e la ragione oggettivata nella natura. Diventa allora inevitabile chiedersi se non debba esservi un’unica intelligenza originaria, che sia la comune fonte dell’una e dell’altra. Così proprio la riflessione sullo sviluppo delle scienze ci riporta verso il Logos creatore». Un approdo, questo, che per Benedetto XVI può riaprire una razionalità atrofizzatasi nel tempo: «Viene capovolta la tendenza a dare il primato all’irrazionale, al caso e alla necessità, a ricondurre ad esso anche la nostra intelligenza e la nostra libertà. Su queste basi diventa anche di nuovo possibile allargare gli spazi della nostra razionalità, riaprirla alle grandi questioni del vero e del bene, coniugare tra loro la teologia, la filosofia e le scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi propri e della loro reciproca autonomia, ma anche nella consapevolezza dell’intrinseca unità che le tiene insieme. È questo un compito che sta davanti a noi, un’avventura affascinante...».
Sul tema, nel sito, cfr.
 FESTIVAL DELLA MATEMATICA 2009. Salvare il mondo con i numeri....
FESTIVAL DELLA MATEMATICA 2009. Salvare il mondo con i numeri....
 ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?
ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?
 Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
 EV-ANGELO E "MALA-EDUCAZIONE"!!!
EV-ANGELO E "MALA-EDUCAZIONE"!!!
 Lo spirito di Assisi e la lezione del "presepe"
Lo spirito di Assisi e la lezione del "presepe"
 Con la morte di Giovanni paolo II, il Libro è stato chiuso
Con la morte di Giovanni paolo II, il Libro è stato chiuso
 L’Ev-angelo non è un "messaggio" di "mammasantissima"!!!
L’Ev-angelo non è un "messaggio" di "mammasantissima"!!!
PER NON DIMENTICARE
 Abiura di Galileo Galilei
Abiura di Galileo Galilei
 Letta il 22 giugno 1633
Letta il 22 giugno 1633
Io Galileo, fìg.lo del q. Vinc.o Galileo di Fiorenza, dell’età mia d’anni 70, constituto personalmente in giudizio, e inginocchiato avanti di voi Emin.mi e Rev.mi Cardinali, in tutta la Republica Cristiana contro l’eretica pravità generali Inquisitori; avendo davanti gl’occhi miei li sacrosanti Vangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro che sempre ho creduto, credo adesso, e con l’aiuto di Dio crederò per l’avvenire, tutto quello che tiene, predica e insegna la S.a Cattolica e Apostolica Chiesa. Ma perché da questo S. Off.o, per aver io, dopo d’essermi stato con precetto dall’istesso giuridicamente intimato che omninamente dovessi lasciar la falsa opinione che il sole sia centro del mondo e che non si muova e che la terra non sia centro del mondo e che si muova, e che non potessi tenere, difendere ne insegnare in qualsivoglia modo, ne in voce ne in scritto, la detta falsa dottrina, e dopo d’essermi notificato che detta dottrina è contraria alla Sacra Scrittura, scritto e dato alle stampe un libro nel quale tratto l’istessa dottrina già dannata e apporto ragioni con molta efficacia a favor di essa, senza apportar alcuna soluzione, sono stato giudicato veementemente sospetto d’eresia, cioè d’aver tenuto e creduto che il sole sia centro del mondo e imobile e che la terra non sia centro e che si muova; Pertanto volendo io levar dalla mente delle Eminenze V.re e d’ogni fedel Cristiano questa veemente sospizione, giustamente di me conceputa, con cuor sincero e fede non fìnta abiuro, maledico e detesto li sudetti errori e eresie, e generalmente ogni e qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla S.ta Chiesa; e giuro che per l’avvenire non dirò mai più ne asserirò, in voce o in scritto, cose tali per le quali si possa aver di me simil sospizione; ma se conoscerò alcun eretico o che sia sospetto d’eresia lo denonziarò a questo S. Offizio, o vero all’Inquisitore o Ordinario del luogo, dove mi trovarò.
Giuro anco e prometto d’adempire e osservare intieramente tutte le penitenze che mi sono state o mi saranno da questo S. Off.o imposte; e contravenendo ad alcuna delle dette mie promesse e giuramenti, il che Dio non voglia, mi sottometto a tutte le pene e castighi che sono da’ sacri canoni e altre constituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate.
Così Dio m’aiuti e questi suoi santi Vangeli, che tocco con le proprie mani. Io Galileo Galilei sodetto ho abiurato, giurato, promesso e mi sono obligato come sopra; e in fede del vero, di mia propria mano ho sottoscritta la presente cedola di mia abiurazione e recitatala di parola in parola, in Roma, nel convento della Minerva, questo dì 22 giugno 1633.
Io, Galileo Galilei ho abiurato come di sopra, mano propria.
- “Il 12 febbraio 1633 il Pontefice ordinò alla Terra di fermarsi; un’esternazione inaudita alla quale il Santo Padre fu indotto dalle folli affermazioni e dalla ostinazione di un maestro di scuola, Galilei. (...) Tre anni durò la sosta, tre anni durante i quali il detto insegnante di scuola restò in prigione” (Oskar Panizza, L’Immacolata Concezione dei Papi, 1893).
- I PAPI E LA SCIENZA NELL’EPOCA CONTEMPORANEA, A c. di M. S. Sorondo, PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE [«Nuovi Lincei»] /JACA BOOK, 2009.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
FLS
Forum
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... NELL’ARTISTICO "SPAZIOTEMPO" DEL "TONDO DONI" DI MICHELANGELO, IL "PRESEPE" NEL "GRAN NAVILIO" DEL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI".18 marzo 2024, di Federico La Sala
"LO #ZODIACO DELLA #VITA" E LA #FILOLOGIA DEL #RINASCIMENTO: NELL’ARTISTICO #SPAZIOTEMPO DI #MICHELANGELOBUONARROTI, UNA "RILETTURA" DELLE FIGURE DI "MARIA" E "GIUSEPPE" E DELLA LORO #RELAZIONE CON LE "#SIBILLE" E I "#PROFETI" DELLA "#SACRAFAMIGLIA".
- ARTE, ANTROPOLOGIA, ARCHEOLOGIA, FILOSOFIA E TEOLOGIA. Una nota a margine di una "scheda" della Galleria degli Uffizi *
DAL #LAOCOONTE (ROMA, 1506) AL #TONDODONI (FIRENZE, 1506-1508). NELLA "STORICA" LEZIONE ANTROPOLOGICA DELLA #CORNICE LIGNEA DEL #TONDODONI (E NELLA "NARRAZIONE" DELLA VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA), CON DUE PROFETI E #DUE SIBILLE, #MICHELANGELO "INDICA" LA PARADIGMATICA #NASCITA "ETERNA" DEL #FIGLIO DI "MARIA E GIUSEPPE" NEL TEMPO.
*
- "SAPERE AUDE!" (#KANT2024): DOMANDA. Come mai gli esperti della Galleria degli Uffizi "insistono" a sostenere che nella "cornice del Tondo [...] sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti"?!. Non è meglio con #Dante, e, con "#Virgilio" e "#Beatrice", proseguire il cammino oltre "#Ulisse", e oltre "Paolo" ed "Enea", e, con le sibille e i profeti, uscire dal tragico LETARGO (Par. XXXIII, 94)?!
- #19MARZO #21MARZO #25MARZO #25DICEMBRE ...
NOTE:
- STORIAELETTERATURA #ARCHEOLOGIA E #ARTE: IL LAOCOONTE.
- ANTROPOLOGIA "BIBLICA", #STORIAELETTERATURA, E #FILOLOGIA "EV-ANGELICA". Per#Dante, il #profeta #ReDavide ("colui che l’arca traslatò di villa in villa", Pd XX 39) e la #SibillaCumana dicono della #Virgo "desponsata viro cui nomen erat #Ioseph, #dedomoDavid et nomen virginis #Maria"(Lc. 1, 27), non altro!
- FISICA E "METAFISICA CONCRETA" (#KANT2024): LA #LEZIONE DI #GALILEO #GALILEI E LA #QUESTIONE DELLO #SPAZIOTEMPO. Sul tema, si cfr. il brillante contributo di Roger Penrose, "LA #STRADA CHE PORTA ALLA #REALTÀ" ("THE #ROAD TO #REALITY. A Complete Guide to the Laws of the Universe", 2005).
- Metaphysics #Mathematics. Galileo (Keplero: "Vicisti, Galilaee") e il "#presepe" del #gran_navilio del "#Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo" (1632): "Da quando un #Bambino nacque in una #mangiatoia, è #dubbio che un #Evento di così grande importanza abbia prodotto così poco scompiglio" (A.N. Whitehead).
-
>GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... La teologia è la madre di ogni fantascienza (di Stefano Jorio)16 ottobre 2023, di Federico La Sala
La teologia è la madre di ogni fantascienza
Teologia e pensiero scientifico sono opposti o complementari? La ricerca della trascendenza può collaborare alla ricerca?
di Stefano Jorio (L’Indiscreto, 13/10/2023)
Uno dei primi uomini a scrivere quel che oggi chiameremmo un romanzo di fantascienza fu l’astronomo Giovanni Keplero. Il nome evoca un’aura favolosa in chiunque abbia frequentato le scuole superiori: Keplero è insieme a Galilei il convalidatore e perfezionatore della tesi eliocentrica. Scoprì che l’orbita dei pianeti è in verità ellittica, dimostrò che il loro moto non uniforme è reale e non solo apparente; con la «terza legge» mise in relazione tra loro, tramite il comune riferimento al Sole, le velocità dei pianeti sulle diverse orbite. Tutto questo fa di lui un protagonista della rivoluzione scientifica e un padre fondatore, dotato in quanto tale di una qualità eroica perché per fondare il nuovo dovette lottare contro il vecchio: in questo caso la tradizione religiosa, metafisica e oscurantista, fedele fino alla malafede all’autorità di Aristotele e delle Scritture, che aveva nella Chiesa un difensore potente e pericoloso. Forse a causa di tale qualità eroica, le due grandi forze nate dalle rivoluzioni borghesi della modernità - la tradizione liberale e quella marxista, accomunate da scientismo e razionalismo come strumenti del Progresso - hanno sempre mostrato di Keplero un’immagine parziale come in certe genealogie degli avi, depurata da ogni elemento che potesse comprometterne la rispettabilità. Come però sanno gli storici davvero dotati di senso storico, possiamo rendere giustizia al passato solo smettendo di mutilarlo come rudimentale annuncio del presente.
Tra questi storici fu Paolo Rossi: nel suo libro La nascita della scienza moderna in Europa (1997) mostrò che nei primi decenni del XVII secolo le strade della metafisica, della mistica e della scienza non erano separate, e che alcuni degli uomini che cominciarono a indagare matematicamente le leggi del cosmo e il moto dei pianeti trovarono utili e sensate anche la metafisica platonica e la teologia cristiana. Nell’esporre l’ipotesi eliocentrica Copernico menzionò il Corpus Hermeticum, nel quale il divino Uno neoplatonico viene pensato tramite la metafora del Sole, e ascrisse l’immobilità di quest’ultimo alla sua natura divina; nello sforzo di dimostrare le «ragioni fisiche e metafisiche» del sistema copernicano, convinto della «mirabile corrispondenza fra le tre cose immobili nell’universo e le tre persone della Trinità», Keplero non soltanto rese complementari rigore matematico e misticismo numerico, osservazione del cosmo e Scrittura, ma presentò i risultati del proprio lavoro come rivelazioni divine, tanto che venne ignorato da Bacon, guardato con diffidenza da Galilei, e le sue leggi diventarono «scientifiche» solo quando Newton mostrò che descrivevano con esattezza i moti dei pianeti intorno al Sole.
Che nel sapere del XVII secolo l’indagine della natura potesse seguire sentieri ritenuti oggi incompatibili con la scienza è mostrato dal racconto fantastico-scientifico Somnium, seu opus posthumum de astronomia lunari. Scritto da Keplero nel 1609, pubblicato dal figlio nel 1634, esso ha un valore soprattutto simbolico ai fini della presente riflessione: nell’epoca in cui metafisica e teologia cominciavano a spegnersi, un astronomo che non escludeva il ricorso a strumenti conoscitivi di lì a poco proibiti sentì il bisogno di esplorare l’ignoto anche per via immaginativa e poetica. Non fu il solo: per tutto il XVII secolo vennero scritti «romanzi di fisica» (come si diceva allora) che impiegavano le recenti scoperte nel campo dell’astronomia, dell’ottica e della medicina per raccontare - facendo seguito alla tesi bruniana degli infiniti mondi possibili - mondi che come quello pensato dalla metafisica erano «altri» o «paralleli» al nostro. Francis Godwin, The man in the Moone (1638); Cyrano de Bergerac, Histoire comique des états et empires de la Lune (1656); Pierre Borel, Discours nouveau prouvant que les astres sont des terres habitées (1657); Margaret Cavendish, Description of a new world (1666); Bernard de Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes (1686). Questi racconti hanno in comune due cose: da un lato segnano il passaggio dal genere rinascimentale dell’utopia (i cui orizzonti, pur aprendo lo spazio di un altrove, restavano terrestri) a quello moderno e tuttora attuale della fantascienza interplanetaria; dall’altro espongono con semplicità al vasto pubblico della stampa preoccupazioni che dovettero essere assillanti nei decenni in cui si compiva il passaggio tra due diverse epoche. Nelle parole di Paolo Rossi: «Dalla tesi della pluralità dei mondi abitati emergevano domande inquietanti: qual è il senso della vicenda della caduta e della redenzione, del peccato originale e del sacrificio di Cristo, se la Terra, che è la grande scena ove si svolge questo grande dramma, è solo uno fra i molti mondi? Se ci sono più mondi e molti di essi sono abitati, il Salvatore avrà redento anche quei mondi?» Rispetto a tutto questo Fontenelle fu forse il primo a esprimere lo “sgomento cosmico” nichilista che avrebbe ispirato tanta letteratura moderna: «un universo così immenso che mi ci perdo. Non so più dove mi trovo. Io sono un niente. Il nostro mondo è terrificante nella sua insignificanza,» dice la protagonista degli Entretiens.
Sulla luna gli alberi parlano oppure sono tre volte più grandi, i «lunari» si nutrono di fumo e sono «più veloci dei cammelli», respirano lentamente e sanno nuotare. Ci sono spiagge, equinozi, «zone astronomiche analoghe alle vostre», una fauna dalle dimensioni enormi e dalla crescita assai rapida. I lunari non conoscono omicidi, odiano il vizio e vivono nell’amore. L’elenco potrebbe proseguire: qui ci interessa però che accanto a queste caratteristiche che finiscono per fare degli altri pianeti una copia bizzarra ma omogenea del nostro, nei romanzi di fisica del XVII secolo troviamo anche un’alterità radicale, ontologica, che la fantascienza continuerà a proporre fino ai nostri giorni. Un modo d’essere costitutivamente misterioso perché trascende il mondo fisico e non è dunque indagabile in base ai principi (causalità, spazio, tempo, numero, principio di non contraddizione) secondo cui conosciamo e dobbiamo conoscere la natura. Questa alterità ontologica viene descritta, per esempio da Francis Godwin, con parole che ricordano da vicino quelle della metafisica e della mistica: «un colore mai visto nel nostro mondo terreno e dunque impossibile da descrivere [...] e da concepire [...] Solo questo posso dirne, che era il più glorioso e dilettevole che si possa immaginare». È «un grande mistero» che sulla luna i cadaveri non vadano in putrefazione, che gli abitanti cadano in un sonno mortale («this sister of death») e si risveglino dopo tredici giorni. Lo stesso Keplero, raccontando un Somnium, entrò in un dominio dell’esperienza in cui non valgono la ragione e il principio di identità (e in cui l’astronomo Duracotus è figlio di una maga come lo era lui); la narratrice della Description di Margaret Cavendish arriva al «Blazing World», il Mondo Splendente, attraversando un «labirinto quasi impenetrabile» dopo il quale la Luna viene presentata, come ha scritto Mary Baine Campbell nel suo Wonder and Science (1999), «come un Altro Mondo; non, o non solo, uno specchio, ma un vero Altro» che è al tempo stesso «perfettamente visibile quasi ogni notte» («ciò che è invisibile e insieme ciò che è più visibile», si dice nel Corpus Hermeticum dell’Essere); «otherness by and for the Other», precisa Campbell con un’espressione che potrebbe ben tradurre il kath’auto, lo sfuggente essere «per sé» dell’ontologia dei Greci. Un essere a sé, costitutivamente inafferrabile perché non riconducibile ad altro che - essendo a noi noto - potrebbe aiutarci a definirlo: Giorgio è un uomo, l’uomo è un animale, l’animale è un vivente, il vivente è un ente, l’ente... è, l’essente è essente, non lo si può più definire tramite le categorie della logica perché non ci sono più categorie disponibili. La lingua come pensiero logico arriva qui alla fine delle proprie risorse.
A partire dai romanzi di fisica, mano a mano che la metafisica perdeva il suo ruolo apicale di guida delle scienze e veniva respinta come secolare menzogna, la modernità vide una crescita ininterrotta dei racconti sull’«altra dimensione», o dimensione «parallela», con autori e percorsi che uno storico del genere potrebbe catalogare esaurientemente accanto a quelli della rassicurante fantascienza “cartesiana”, ambientata in un altrove solo apparente. Mano a mano che il sapere dimenticava il pensiero dell’essere e si addentrava nel nichilismo, la fantascienza - ma come vedremo anche la stessa scienza - immaginò in modo allegorico e quasi clandestino, con maggiore o minore consapevolezza, una “realtà” inquietante perché di essa possiamo sapere solo che è. Resta inspiegabile, resiste all’indagine, tanto che i racconti di fantascienza parlano volentieri di un’«entità». Qualcosa di simile dovette intendere Platone quando per primo diede speciale significato filosofico al termine οὐσία (nella lingua comune «i beni», «le sostanze») che crea un sostantivo femminile dal participio presente del verbo essere; così Aristotele quando ne fece un elemento centrale della propria ontologia. Tanto che la traduzione italiana letterale e oggi più sensata di οὐσία è proprio «entità». Nel pensiero di Platone l’οὐσία è immateriale ed efficace come per la scienza moderna la forza di gravità; in Aristotele le determinazioni categoriali di un ente sensibile (genere, peso, dimensione) sono tutte detraibili, tutte accidentali, e quanto resta alla fine sarà un’«entità». Un puro essere che è, accade, e solo per questo, stando “sotto”, può “sorreggere” gli accidenti e le corrispondenti predicazioni (sub-stantia in latino, in italiano «sostanza», è appunto uno dei termini con cui la tradizione filosofica tradusse οὐσία). È in questo allarmante senso “fantascientifico” - il fallimento irrimediabile delle risorse conoscitive umane davanti a un Ignoto - che l’essere, come scrisse Heidegger all’inizio di Essere e tempo, «per il suo nascondimento sospinse e mantenne nell’inquietudine il filosofare degli antichi» (la bella traduzione è di Pietro Chiodi). In questo stesso senso, sempre in Essere e tempo, l’angoscia è via d’accesso privilegiata allo svelamento dell’essere.
Prendiamo un testo fantascientifico a noi relativamente vicino, un romanzo (e film) dal valore paradigmatico: Solaris di Stanislaw Lem, pubblicato nel 1961 e filmato nel 1972 da Andrej Tarkovskij. Entrambi, con poche discrepanze, raccontano la storia di uno psicologo (la professione è solo apparentemente incongrua) inviato in missione su una stazione spaziale da cui arrivano segnali anomali e preoccupanti. La stazione orbita intorno al pianeta Solaris, oggetto di una secolare quanto inconcludente esplorazione scientifica e definibile a detta di alcuni - con un’ipotesi che non può essere confermata né rifiutata - come una «sostanza pensante». I vertici scientifici e militari del programma ascoltano increduli i rapporti degli astronauti, classificano come allucinazioni quei confusi racconti di giardini con alberi e sentieri fuggevolmente creati dall’oceano gelatinoso del pianeta, di giganteschi bambini nudi che nuotano nello spazio: anche perché le immagini girate dagli astronauti per comprovare queste loro visioni mostrano solo delle nuvole. Quei rapporti «non corrispondono alla realtà», sono fatti da gente «senza alcuna qualifica scientifica»: si valuta l’opportunità di abbandonare il progetto perché Solaris, nonostante tutti gli sforzi, resta un mistero. Lo psicologo Kelvin dovrà capire cosa sta accadendo sulla stazione spaziale (restano solo tre membri degli iniziali ottanta dell’equipaggio) e in base a questo decidere se sospendere l’intero programma oppure proseguire con l’attività di ricerca.
Solaris è ai nostri fini un caso speciale e privilegiato: da un lato il pianeta pensante e misterioso funziona come una Trascendenza sostitutiva, elaborata dalla fantascienza in un’epoca convinta che l’essere sia in realtà niente e che la Trascendenza (fraintesa come secondo mondo e «al di là» cristiano) sia una vecchia e ormai insostenibile favola; dall’altro romanzo e film mettono consapevolmente in scena l’oblio della Trascendenza nel progressivo dispiegarsi del pensiero razionalista: il pianeta Solaris è un’allusione al Sole divino, Essere e Uno della tradizione neoplatonica, di Copernico e Keplero; la «solaristica» (l’indagine dell’essere del mondo naturale) è arrivata secondo gli scienziati a un punto di stallo a causa del «fantasticare di alcuni irresponsabili» che hanno eretto «una montagna di fatti irrelati e incoerenti»; «tutto ciò che sappiamo di Solaris è negativo», argomentano i positivisti fautori della sospensione del programma, e aspirando a distruggere quanto non possono capire suggeriscono di bombardare l’oceano di Solaris con delle radiazioni. L’io narrante racconta esplicitamente nel romanzo come l’incessante metamorfosi del pianeta pensante sia per alcuni un’«incarnazione dell’Essere», l’attività di «un cervello immane, in anticipo di milioni di anni rispetto allo sviluppo della nostra civiltà; qualcosa come uno “yogi del cosmo”, un saggio, onniscienza divenuta forma [...] inadeguata all’immaginazione umana». Arrivato in orbita, Kelvin scopre che i tre uomini superstiti e ormai quasi pazzi vengono visitati con regolarità da misteriose presenze umane, presto anche lui verrà visitato da una figura identica a sua moglie, morta da tanti anni; le presenze (gli enti, quanto l’uomo percepisce e ama) sono apparentemente originate dall’interazione di Solaris con l’uomo stesso, eliminarle con mezzi ordinari è impossibile perché dopo una breve assenza ritornano. Solo la tecnologia (un apparecchio «annichilatore») permetterà di sbarazzarsene in modo definitivo.
- CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO
-
> GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... La teologia è la madre di ogni fantascienza (di Stefano Jorio)16 ottobre 2023, di Federico La Sala
- CONTINUAZIONE DEL POST PRECEDENTE E CONCLUSIONE
- La teologia è la madre di ogni fantascienza
- Teologia e pensiero scientifico sono opposti o complementari? La ricerca della trascendenza può collaborare alla ricerca?
- di Stefano Jorio (L’Indiscreto, 13/10/2023)
 [...]
[...]Secondo una metafora da sempre importante per la metafisica, possiamo immaginare le infinite «entità» dell’ontologia greca risultanti dalla sottrazione di tutte le determinazioni, anche le dimensioni e la massa, come punti di irradiazione di luce o di energia. Punti di essere. Come i punti della geometria razionale euclidea sono solo intuibili, non definibili, e non hanno massa; come gli elettroni della meccanica quantistica sono senza essere in un luogo (nelle parole del fisico Carlo Rovelli: «gli elettroni [...] si materializzano in un luogo, con una probabilità calcolabile, quando sbattono contro qualcos’altro. [...] Quando nessuno lo disturba, [un elettrone] non è in alcun luogo preciso. Non è in un luogo»). Essendo puri punti di essere, non sono più differenziabili tra loro: sono uno stesso omogeneo essere in essere. Questo universale essere in atto senza dimensioni e senza confini è la Trascendenza: un salto, certo, che da un lato non ha nulla di “soprannaturale” perché l’essere in essere è un evento del mondo quanto un gatto o una pietra; dall’altro invece è anche soprannaturale perché l’essere non è una «cosa» del mondo fisico, indagabile con la lingua e la logica. È onto-logicamente diverso dall’essere delle cose del mondo. È un accadere simultaneo e universale. Come la forza di gravità, per essere non ha bisogno di materia, dimensioni e collocazione spaziale: ma non è nemmeno più «di gravità»: è, senz’altro. L’Uno è l’essere in essere del mondo come pluralità infinita. Prima che un «concetto logico» (la categoria mentale più generale e astratta) è essere che attua se stesso, essere in atto che fin dai primi fisico-teologi greci (e poi in Platone, in Plotino, nell’ermetismo rinascimentale) coincide con la forza ordinatrice dell’universo, attività di pensiero - anziché di attrazione - alla quale l’uomo, in quanto pensante, partecipa. In questa prospettiva lo stesso cosmo è un ente consenziente che nel suo moto regolare, indice ed espressione di un’anima razionale, si conforma alla legge «divina».
Di tutto questo parla Solaris, il racconto sul pianeta-«entità» pensante; di questo parla - in modo per lo più inconsapevole - la fortunata narrativa popolare “distopica” sia nel senso peggiorativo del prefisso (negli scenari totalitari creati da un Potere invisibile e ubiquo l’Essere-luce, poi Dio cristiano onnipotente e provvidenziale, si riduce all’umano e si perverte, emana una luce nera); sia nel senso dispersivo-separativo del prefisso proprio delle distopie che hanno il loro archetipo nel romanzo Picnic sul ciglio della strada, scritto nel 1972 dai fratelli Strugackij e filmato (di nuovo da Tarkovskij) nel 1979. Evitando di determinare il proprio referente narrativo come fa invece la distopia totalitaria, mettendo in scena territori ignoti e proibiti, animati da una presenza invisibile, indubitabile e al tempo stesso ambigua, l’epoca nichilista continua a esprimere la propria nostalgia di un essere che misteriosamente e puramente è, ed è pensante, senza per questo essere volitivo né agente in modo meccanico. Raccontando un’«alterità» presente e insieme sfuggente, in cui addentrarsi a proprio rischio con l’aiuto di una guida dai tratti sciamanici (lo stalker del titolo), l’epoca che ha bandito l’Essere e la Trascendenza in quanto menzogne può ancora, quasi per scherzo, pensarli. Allo stesso modo, nel Fedone platonico, Cebète (che non si fida dei ragionamenti filosofici sull’immortalità dell’anima) dice a Socrate:
- vedi di persuaderci e di farci coraggio; o meglio, non come se s’avesse paura noi: perché c’è forse, anche dentro di noi, un fanciullino, ed è lui che ha di questi sgomenti. Tu dunque fai in modo che muti animo questo fanciullo, e si persuada a non aver paura della morte come dell’Orco.
- Bene, disse Socrate, bisogna fargli l’incantesimo a codesto fanciullo, ogni giorno, finché non siate riusciti a incantarlo totalmente.
Nel finale del dialogo, parecchie pagine dopo questo scambio di battute, Socrate farà davvero l’incantesimo all’allievo disperato per la vicina morte del maestro: racconterà («Si dice così») che dopo il giudizio le anime dei morti arrivano nell’Ade, dove aspettano «il tempo che devono aspettare». L’anima impura se ne va errando tutta sola; l’anima pura, trovati per compagni gli dèi, andrà ad abitare in «molti e mirabili luoghi» sulla «terra» che in verità è una cosa del tutto diversa da quella che immaginiamo noi. È un mondo fatto di grandi cavità che noi abitiamo senza accorgercene, credendo anzi di abitare in alto, sulla superficie: «ma essa la vera terra si libra pura nel cielo puro dove sono le stelle», e se - come pesci che salgono alla superficie dell’acqua - fossimo capaci di levare il capo dalle cavità che abitiamo, vedremmo anche «le ben superiori bellezze di lassù». Il mondo è iridescente, splendido, «uno spettacolo di spettatori beati», con viventi che abitano sulle rive dell’aria come noi su quelle del mare: e «anche il sole, la luna e le stelle sono visti da questi uomini direttamente quali sono in realtà». Socrate descrive ancora il Tartaro e i suoi quattro fiumi, racconta del premio e del castigo per le anime, la loro ripartizione nei diversi luoghi infernali secondo una tecnica classificatoria che verrà ripresa da Dante nella Divina Commedia (gli omicidi, i violenti contro il padre...). Dopo avere ricordato che da un lato sarebbe sciocco ostinarsi a sostenere che le cose stiano proprio così, dall’altro che giova fare tali incantesimi, Socrate conclude la sua favola con le parole: «Orsù dunque, state quieti e siate forti». Di lì a poco beve la cicuta.
Nei secoli del nichilismo europeo la fantascienza, o una certa parte di essa, ha fatto l’incantesimo: mentre il sapere ufficiale mutilava la filosofia e la riduceva a inutile custode delle questioni di metodo, mentre la mistica e le esperienze estatiche venivano dileggiate o guardate con crescente e severo sospetto, un genere “minore” produceva quei racconti che per rassicurare i bambini nominano l’innominabile e visualizzano l’invisibile Entità. Immaginava (con tutto ciò che l’Entità può avere anche di inquietante) quella teologia illustrata, “per tutti”, che - nell’impossibilità di proporre le due vie maestre ma elitarie della metafisica e dell’estasi mistica - allude e gioca, conforta e appaga senza peraltro pretendere che le si creda fino in fondo. Al mitologico spazio interstellare della fantascienza, alle sue storie di viaggi, di ricerche in terre sconosciute e di ritorni con doni magico-tecnologici, capaci di sospendere le leggi del mondo sensibile, potrebbe applicarsi in questo senso ciò che Heinrich Zimmer scrisse del ciclo arturiano medioevale:
- Merlino abita la “foresta incantata”, la “valle del non ritorno”, che è la terra della morte, il volto oscuro del mondo. La foresta magica è sempre piena di avventure. Nessuno può entrarci senza smarrire la strada. Ma il prescelto, l’eletto che sopravvive ai suoi pericoli mortali, rinasce e ne esce come un uomo nuovo. La foresta è da sempre un luogo di iniziazione.
Non sappiamo se Isaac Newton amasse la mitologia, è certo che non scrisse romanzi di fantascienza: ma già a partire dalla seconda edizione dei Principi (1713) reintrodusse la causa finale aristotelica nello studio della natura. «Questa elegantissima compagine del Sole, dei pianeti e delle comete non poté sorgere senza la presenza di un Essere onnipotente e intelligente,» scrisse, tanto che Leibnitz - già in lite con lui per la paternità del calcolo infinitesimale - lo accusò di avere riportato la fisica alle «qualità occulte» della Scolastica. Questa esplicita presa di posizione circa la causa della gravitazione universale aprì la strada nel Settecento al teismo degli illuministi; la progressiva pubblicazione dei suoi manoscritti alchemici e teologici arricchì e sfumò ulteriormente tra il XVIII e il XIX secolo la sua figura di padre della fisica classica, provocando malessere in molti custodi della purezza “razionale” della rivoluzione meccanicista. «Alla morte di Newton, la Royal Society rifiutò di acquisire i suoi manoscritti di argomento religioso e li restituì alla famiglia con la raccomandazione di non mostrarli ad alcuno» (P. Rossi); lo stesso rifiuto venne opposto dal British Museum e dalle università di Cambridge, Harvard, Yale, Princeton. In quei manoscritti c’era qualcosa di intollerabile per la scienza moderna, al punto che John Maynard Keynes - venutone in possesso nel 1936 - definì Newton «l’ultimo dei maghi» anziché il primo degli scienziati moderni. La mole straordinaria dei manoscritti postumi, una ventina di volumi, ha da allora alterato presso gli specialisti l’immagine dello scienziato positivo, rigoroso e razionalista: in essi Newton parla di cicli cosmici, di un mondo che «non può essere uscito dal caos a opera delle semplici leggi di natura»; sostiene la necessità di un «principio attivo» che conservi in vita l’universo e riprende il tema ermetico della grande e perduta Sapienza delle origini.
Che restituita alla sua verità storica la figura di Newton ricordi quella dei primi fisico-teologi greci è cosa in fondo ovvia, dal momento che i filosofi greci furono uomini di scienza che studiavano con interesse la natura; per questo motivo avrebbero trovato inconcepibile abbandonare un’indagine così poco “soprannaturale “ e “metafisica” come quella che verte sull’essere in essere del mondo (lo stesso termine «metafisica» venne del resto coniato dopo la morte di Platone e Aristotele). Non è la fisica di Empedocle e Anassimandro a essere “imperfetta” perché ancora priva di rigore metodico, non è l’astronomia di Keplero e Newton a ospitare indebite “tentazioni irrazionali”: al contrario, è stata ed è tuttora la scienza moderna nichilista ad avere tradito e mutilato l’indagine sull’essere, inebriata da quanto le appare fin dalla sua nascita come un dominio completo del mondo. Non è più abbastanza audace da tentare altre strade, resta al sicuro tra i propri sudditi-oggetti. Ma il pensiero dell’essere, come ogni rimosso, si insinua clandestinamente nella ricerca: la Trascendenza della fisica relativistica è l’essere “prima” del Big Bang, la realtà inconoscibile che viene postulata dall’esistenza storica dell’universo. Di essa la scienza sa solo che nulla ne può dire: è un’alterità ontologica, una dimensione dell’essere per la quale non valgono la casualità, il tempo e lo spazio, il principio di non contraddizione. “Prima” del Big Bang le leggi dell’universo non valgono perché solo con esso sono nate; determinare cosa abbia prodotto la misteriosa «singolarità» del Big Bang è impossibile, la ricerca deve astenersi. È il gesto che inaugura ogni metafisica, il riconoscimento della Trascendenza: ma dopo averlo compiuto, la scienza chiude con sollievo la porta che aveva aperto e si volge agli oggetti del mondo come al solo lecito fine del sapere; come se l’universo, nascendo con il Big Bang, avesse istantaneamente sostituito l’«altro» essere e preso il suo posto per relegarlo nel passato. Se però la Trascendenza avesse un posto nello spazio e potesse appartenere al passato, l’altra dimensione sarebbe in realtà solo adiacente, sarebbe parte di uno svolgimento. È la grande aporia della relatività, rispetto alla quale il sapere ufficiale ha spesso mantenuto una posizione di sorprendente indifferenza.
Negli ultimi tre decenni, applicando la meccanica quantistica all’indagine delle fasi iniziali dell’universo, la fisica ha cercato di aggirare la propria aporia: ha «scoperto che l’estensione dello spazio-tempo non è necessariamente limitata da una singolarità iniziale, e le domande circa il possibile stato dell’Universo prima del Big Bang sono pienamente legittime e ben poste. [...] Secondo i modelli della cosmologia delle stringhe, all’epoca del Big Bang l’Universo non era un neonato ma una creatura piuttosto vecchia, nel mezzo di un’evoluzione dalla durata probabilmente infinita» (M. Gasperini, The Universe before the Big Bang, 2008). Presentando il Big Bang come una transizione tra due fasi, sostituendo al progresso storico lineare un ciclo eterno in cui epoche di «vacuum» si alternano ad epoche di mondo nel permanere di «alcune proprietà geometriche come la curvatura dello spazio-tempo», la teoria delle stringhe cerca di conoscere l’Ignoto ridimensionandolo: adattandolo preventivamente alla ragione lo colloca nel tempo e nello spazio come intermezzo tra Universo e Universo anziché “prima”. In questo dimentica, nichilisticamente, che il Tutto è parziale se non comprende il suo essere in essere, l’infinito inavvicinabile e sempre qui perché il suo «oltre» non è spaziale o temporale; e paragona all’ingenua indagine degli antichi il vecchio «modello standard» relativistico che ponendo un non plus ultra al sapere induceva a «identificare i limiti della nostra conoscenza attuale con una barriera naturale, come se la natura avesse posto un definitivo, non oltrepassabile cancello nel punto del Big Bang» (Gasperini).
È paradossale che il sapere degli antichi venga visto come una barriera alla conoscenza da parte di una fisica che si è sbarazzata dell’Essere del mondo; da parte di una scienza che nascendo con Copernico, Keplero e Newton aveva saputo concepire il progresso anche come una rinnovata attenzione alla perduta sapienza del passato.
Che da secoli l’Occidente rimuova il pensiero dell’essere significa in fondo proprio questo: nel constatare la propria impotenza, anziché contemplare, sollecitare o frequentare modalità conoscitive complementari, la scienza estende il dominio della ragione rendendo semplicemente “ancora ignoto” l’inconoscibile; e interdice come disonesta ogni altra possibile ricerca della Trascendenza come se l’inizio dell’universo o un’eterna alternanza di fasi potessero annichilire l’essere. Formula davanti al limite e all’ulteriorità il proprio non plus ultra, toglie la chiave nel senso di Luca, XI, 52: «Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare l’avete impedito». In questo senso il meccanicismo positivista razionalista è una forma di oscurantismo.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA ---- COSMOLOGIA. Convegno su "Eternità tra spazio e tempo: dalla coscienza al cosmo". Una sintesi dell’intervento di Piero Benvenuti.16 maggio 2022, di Federico La Sala
Cosmologia.
Sull’eternità anche la scienza è davanti a un atto di fede
Multiversi e universo circolare sono teorie che non possono essere provate sperimentalmente. Per uscire dall’impasse serve un approccio che faccia propri i metodi della filosofia e della teologia
di Piero Benvenuti (Avvenire, domenica 15 maggio 2022)
- Pubblichiamo una sintesi dell’intervento che l’astrofisico Piero Benvenuti terrà al convegno "Eternità tra spazio e tempo: dalla coscienza al cosmo", organizzato dall’Università di Padova e dalla Facoltà teologica del Triveneto, in programma a Padova dal 19 al 21 maggio. Tra gli altri interverranno i premi Nobel Roger Penrose e Gerard t’Hooft.
Sin dall’emergere della coscienza, l’umanità si è confrontata con l’evidente temporalità della propria vita terrena contrapposta all’esistenza di un cosmo irraggiungibile e apparentemente eterno. La regolare ripetizione dei fenomeni celesti, dai più semplici, come l’alternarsi del giorno e della notte o delle fasi lunari, sino ai più complessi, come il ripetersi ciclico delle eclissi ogni 18 anni o il moto di precessione delle costellazioni che richiesero secoli di accurate osservazioni per essere rivelati, testimoniavano una immutabilità cosmica nel tempo che sta alla base del concetto di eternità. Anche da questo confronto nasce l’aspirazione della coscienza umana a superare il limite imposto dalla morte fisica, immaginando la possibilità di proseguire o quantomeno di conservare la propria esperienza in un’altra dimensione simile, se non addirittura coincidente con l’atemporalità o eternità del cosmo.
Questo desiderio primordiale prese forma concreta nei secoli grazie, da un lato, alla visione aristotelica del cosmo, che separava nettamente il mondo terreno, mutevole e corruttibile, dall’empireo eternamente perfetto delle sfere cristalline e dall’altro alla teologia scolastica che, sposando il modello aristotelico, identificava nel cielo quasi il luogo fisico, il Paradiso, dove godere della vita ultraterrena, della vita eterna, come recita tutt’ora il Credo apostolico.
Le sfere cristalline vennero definitivamente infrante da Galilei nelle notti fatali del dicembre 1609 con le prime osservazioni del cielo con il suo cannocchiale, ma il concetto di eternità celeste rimase vivo, anche se non più sostenuto da una cosmologia comprensibile. Solamente a partire dalla metà del secolo scorso, grazie alle rivoluzionarie teorie della fisica quantistica e della relatività generale e al contemporaneo progresso tecnologico, una nuova cosmologia ha cominciato a prender forma. Sin dall’inizio il nuovo modello interpretativo rivelò la sua caratteristica fondamentale: l’universo è essenzialmente evolutivo, ha una storia che lo ha fatto passare attraverso fasi diversissime tra loro, ma tutte strettamente collegate da un processo unitario che ha prodotto entità e fenomeni di crescente complessità. Negli ultimi decenni, i nuovi sofisticati strumenti osservativi - gli eredi del cannocchiale galileiano - operanti sia da terra che dallo spazio, hanno permesso ai cosmologi di ricostruire la storia cosmica con notevole precisione lungo un periodo di ben 13,8 miliardi di anni.
Tralasciando i dettagli del modello cosmologico e soffermandoci unicamente sulla sua caratteristica essenziale, ovvero la sua evoluzione spazio-temporale, dovremmo ora riprendere l’analisi del concetto di eternità alla luce della nostra nuova interpretazione scientifica della realtà. Prima però di addentrarci nel tema, sono necessarie alcune premesse, tutte conseguenti dalla epistemologia cosmologica.
Innanzitutto dobbiamo chiederci se il metodo scientifico galileiano, che ci ha permesso di ricostruire e descrivere con successo le singole fasi dell’evoluzione cosmica e soprattutto di averne evidenziato l’evoluzione, sia veramente in grado di descrivere il cosmo come fenomeno unico e unitario. La risposta non può che essere negativa: infatti il metodo scientifico poggia sulla possibilità di ripetere l’esperimento che si vuole descrivere, eventualmente modificando le condizioni al contorno in modo da far emergere quelle regolarità che vanno sotto il nome generico di leggi fisiche. Nel caso dell’universo, tale essenziale procedimento è impossibile per l’unicità del fenomeno cosmico. Inoltre, non solo non possiamo modificare le condizioni di partenza, ma non siamo nemmeno in grado di quantificarle, il che impedisce di distinguere tra condizioni iniziali e leggi fisiche preesistenti.
Da decenni ormai i cosmologi stanno indagando la possibilità di unificare le due grandi teorie fisiche del ventesimo secolo, la fisica quantistica e la relatività generale, ma sorge sempre più prepotentemente il dubbio che l’esistenza di leggi universali - la gravità e le interazioni fondamentali - e la loro validità in ogni epoca dell’evoluzione, sia un’illazione indebita. In altre parole, anche le cosiddette leggi universali, dedotte nel presente, potrebbero essere emerse in epoche primordiali come prodotto dell’evoluzione stessa. In definitiva, un motivo in più per ammettere, con umiltà galileiana, che il metodo scientifico da solo non è adatto a descrivere la totalità cosmica e soprattutto le sue fasi iniziali.
Di fronte a questa crisi epistemologica, la cosmologia ha reagito proponendo modelli che cercano di aggirare il problema delle condizioni iniziali e dell’inizio stesso. Il nostro universo sarebbe uno dei tanti o infiniti possibili "multiversi", ognuno dei quali potrebbe aver avuto condizioni iniziali diverse e seguire quindi storie evolutive indipendenti. Oppure l’universo potrebbe avere una storia ciclica, senza un vero e proprio inizio. Teorie affascinanti e scientificamente plausibili, ma intrinsecamente non verificabili in quanto gli eventuali universi paralleli non potranno mai comunicare tra loro, così come un universo ciclico non può inviarci messaggi circa la sua precedente esistenza. Queste proposte di uscita dall’impasse cosmologico non sono scientificamente verificabili e appartengono quindi alla più ampia categoria delle teorie filosofiche e teologiche. Conseguentemente richiedono, per essere accettate, un atto di fede: torneremo a breve su questo punto.
Possiamo ora trarre una prima conclusione sul concetto di eternità: banalmente potremmo associarlo alla evoluzione cosmica che non prevede un termine temporale. Tale accostamento è però di scarso o nullo interesse, visto che l’evoluzione locale del nostro sistema solare ne prevede comunque una fine fisica, unitamente all’umanità tutta: una fine molto lontana nel tempo, quando il Sole diventerà una stella gigante e ingloberà tutti i pianeti, ma pur sempre inevitabile.
Questo concetto di durata eterna del cosmo, applicabile anche ai multiversi e all’universo ciclico, non si pone quindi in alcuna relazione con la nostra coscienza e con l’escatologia, ovvero la speranza di una sua sopravvivenza alla morte. La discussione diviene più interessante se superiamo il concetto di cosmologia scientifica, che si occupa unicamente della realtà fisica e misurabile del cosmo, e, consapevoli che l’evoluzione cosmica è unitaria e comprende nella sua storia anche l’emergere della vita biologica e della coscienza, abbracciamo il concetto di una cosmologia globale. Quest’ultima dovrà necessariamente tener conto dei risultati che il metodo scientifico ha evidenziato relativamente alle singole fasi evolutive, ma, ove questo perda, come abbiamo visto, la sua applicabilità, si avvarrà di altre epistemologie, tipicamente filosofiche o teologiche.
Il risultato non sarà quindi una singola cosmologia, ma diversi modelli cosmologici tutti aventi pari dignità veritativa. La scelta di uno di questi non sarà più obbligata da evidenze scientifiche, ma si baserà su un libero atto di fede. Potrò per esempio credere che il cosmo e la sua evoluzione, ivi compresa l’emergere della vita e della coscienza sia frutto del caso (mi trovo per caso nell’unico universo, tra gli infiniti possibili, compatibile con la vita). In questo modello, come abbiamo visto, eternità ed escatologia si trovano su piani incomunicabili. Alternativamente e, sottolineo, con uguale dignità, posso scegliere un modello nel quale il cosmo e la sua evoluzione siano frutto di un libero atto d’amore che mantiene tutta la realtà in esistenza, nell’attesa paziente che da essa emerga una coscienza che, altrettanto liberamente, voglia riconoscere tale atto d’amore e lo ricambi nei confronti del prossimo e di tutto il cosmo. La relazione che si crea in questo mutuo scambio, come conosce bene chi l’ha sperimentata con persone amate che non sono più, resiste agli insulti del tempo ed è per sempre. L’eternità comincia da qui.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!
Federico La Sala
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... Scienza e filosofia: "Da quando un #Bambino nacque in una #mangiatoia, è #dubbio che un #Evento di così grande importanza abbia prodotto così poco scompiglio" (di A.N. #Whitehead).24 febbraio 2021, di Federico La Sala
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. Cerchiamo di "non dare i numeri" --- Imparare a contare! Perché oggi anche la scienza ha bisogno di avere più donne (di Vittorio A. Sironi).14 febbraio 2021, di Federico La Sala
Pari opportunità.
Perché oggi anche la scienza ha bisogno di avere più donne
A livello globale riesce ad affermarsi nel mondo della ricerca non più del 30% di esponenti del genere femminile, e solo poche di esse raggiungono posizioni apicali
di Vittorio A. Sironi (Avvenire, sabato 13 febbraio 2021)
«Vogliamo incoraggiare una nuova generazione di donne scienziate per affrontare le principali sfide del nostro tempo, facendo leva sulla loro creatività e favorendo l’innovazione che le donne possono portare nella scienza». Lo ha ricordato la direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay per la celebrazione della “Giornata internazionale delle donne nella scienza” (11 febbraio).
 Una ricorrenza annuale istituita dall’Onu a partite dal 2015 per promuovere e sensibilizzare l’uguaglianza di genere a favore dell’accesso paritario delle donne nella scienza. “Il mondo ha bisogno della scienza e la scienza ha bisogno delle donne” è il titolo-programma del manifesto delle Nazioni Unite, ben consapevoli che per trasformare e migliorare il mondo è necessaria una solida formazione scientifica, che deve essere accessibile in uguale misura agli uomini e alle donne, superando quelle differenze (e diffidenze) di genere che per troppo tempo hanno limitato alle donne l’accesso alla scienza.
Una ricorrenza annuale istituita dall’Onu a partite dal 2015 per promuovere e sensibilizzare l’uguaglianza di genere a favore dell’accesso paritario delle donne nella scienza. “Il mondo ha bisogno della scienza e la scienza ha bisogno delle donne” è il titolo-programma del manifesto delle Nazioni Unite, ben consapevoli che per trasformare e migliorare il mondo è necessaria una solida formazione scientifica, che deve essere accessibile in uguale misura agli uomini e alle donne, superando quelle differenze (e diffidenze) di genere che per troppo tempo hanno limitato alle donne l’accesso alla scienza.Per secoli la loro presenza nella vita pubblica - tranne poche eccezioni - è stata modesta. Solo a partire dagli inizi del Novecento il crescente ruolo dell’istruzione femminile ha permesso alle donne, sia pure in modo non facile e con fatica, di iniziare ad affermarsi in ambito scientifico. È pur vero che la storia ricorda emblematiche figure femminili del passato che hanno saputo fornire importanti contributi alla scienza.
 Nell’XI secolo Trotula de’ Ruggiero è stata la prima donna medico d’Europa, prima e unica magistra della celebre Scuola medica di Salerno ad avere coltivato nella storia una “medicina per le donne”. In tempi a noi più vicini altre due figure hanno segnato nel profondo, con i loro studi, la comprensione del mondo dell’infanzia. Maria Montessori (1870-1952), una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia, ha elaborato un originale metodo pedagogico per l’insegnamento infantile, operando anche attivamente per contrastare l’analfabetismo mondiale. Anna Freud (1895-1982), figlia del padre della psicanalisi Sigmund, ha dedicato la sua vita allo studio e alla comprensione dei meccanismi psichici delle prime età della vita.
Nell’XI secolo Trotula de’ Ruggiero è stata la prima donna medico d’Europa, prima e unica magistra della celebre Scuola medica di Salerno ad avere coltivato nella storia una “medicina per le donne”. In tempi a noi più vicini altre due figure hanno segnato nel profondo, con i loro studi, la comprensione del mondo dell’infanzia. Maria Montessori (1870-1952), una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia, ha elaborato un originale metodo pedagogico per l’insegnamento infantile, operando anche attivamente per contrastare l’analfabetismo mondiale. Anna Freud (1895-1982), figlia del padre della psicanalisi Sigmund, ha dedicato la sua vita allo studio e alla comprensione dei meccanismi psichici delle prime età della vita.Per la matematica giganteggia nel XVIII secolo la figura di Maria Gaetana Agnesi (1718-1799), mentre tra fine Ottocento e inizio Novecento domina la personalità di Marie Curie (1867-1934), vincitrice di due premi Nobel: nel 1903 per la fisica e nel 1911 per la chimica. Ancora però eccezioni in un mondo dominato dalla cultura e dal potere maschili. In questi ultimi decenni molte più donne hanno saputo affermarsi in ambito accademico e scientifico, anche se la loro presenza resta tuttora minoritaria.
 L’ultimo rapporto “Women in science” dell’Unesco dello scorso anno evidenzia come nel mondo della scienza riesca ad affermarsi a livello globale non più del 30 per cento delle donne e che solo poche di esse riescono a raggiungere posizioni apicali. Eppure “primedonne della scienza” che hanno rivoluzionato conoscenze consolidate non sono mancate.
L’ultimo rapporto “Women in science” dell’Unesco dello scorso anno evidenzia come nel mondo della scienza riesca ad affermarsi a livello globale non più del 30 per cento delle donne e che solo poche di esse riescono a raggiungere posizioni apicali. Eppure “primedonne della scienza” che hanno rivoluzionato conoscenze consolidate non sono mancate.Emblematico in tal senso il ruolo svolto in ambito medico da due italiane. Rita Levi Montalcini (1909-2012), neurologa e premio Nobel per la medicina nel 1986 per aver scoperto il Nerve Growth Factor (fattore di crescita nervoso), con la sua tenacia scientifica ha rivoluzionato, dopo due secoli di consolidate nozioni neuroanatomiche, le conoscenze sul funzionamento del sistema nervoso centrale, ribaltando la convinzione che, a differenza di altri organi, esso fosse una struttura statica nella vita adulta e dimostrando invece uno dei principi fondamentali delle moderne neuroscienze: la plasticità neuronale, cioè la caratteristica dinamicità intrinseca del sistema nervoso che dura per tutta la vita di un individuo.
 Ilaria Capua, veterinaria e virologa, attuale direttrice dell’One Health Centre of Excellence dell’Università della Florida, ha cambiato il modo di fare ricerca quando nel 2006 ha sconvolto il mondo accademico con la sua scelta di rendere di pubblico dominio la sequenza genica del virus dell’influenza aviaria. Una decisione che ha avuto notevole risonanza internazionale e ha contribuito alla diffusione dell’open access ai contributi scientifici (prima gelosamente custoditi come preziosi segreti nell’ambito dei santuari accademici della ricerca), iniziando così a promuovere una campagna internazionale a favore del libero accesso ai dati sulle sequenze genetiche dei virus patogeni, in modo da favorire e velocizzare la ricerca di mezzi e metodi per contrastarne la diffusione. Se oggi non ci fosse questa libera condivisione globale delle informazioni scientifiche inaugurata dalla scienziata italiana, certamente non si sarebbe potuto arrivare in tempi così rapidi alla realizzazione dei vaccini per sconfiggere la pandemia di Covid-19.
Ilaria Capua, veterinaria e virologa, attuale direttrice dell’One Health Centre of Excellence dell’Università della Florida, ha cambiato il modo di fare ricerca quando nel 2006 ha sconvolto il mondo accademico con la sua scelta di rendere di pubblico dominio la sequenza genica del virus dell’influenza aviaria. Una decisione che ha avuto notevole risonanza internazionale e ha contribuito alla diffusione dell’open access ai contributi scientifici (prima gelosamente custoditi come preziosi segreti nell’ambito dei santuari accademici della ricerca), iniziando così a promuovere una campagna internazionale a favore del libero accesso ai dati sulle sequenze genetiche dei virus patogeni, in modo da favorire e velocizzare la ricerca di mezzi e metodi per contrastarne la diffusione. Se oggi non ci fosse questa libera condivisione globale delle informazioni scientifiche inaugurata dalla scienziata italiana, certamente non si sarebbe potuto arrivare in tempi così rapidi alla realizzazione dei vaccini per sconfiggere la pandemia di Covid-19.Nella fisica delle particelle e in quella dello spazio, altre due donne hanno saputo dimostrare l’importanza e l’autorevolezza femminile in questi ambiti: Fabiola Gianotti, dal 2106 direttrice generale del Centro Europeo Ricerche Nucleari (Cern) di Ginevra, di recente riconfermata sino al 2025 (è la prima volta nella storia di questo ente che un direttore generale è selezionato per un secondo mandato), e Samantha Cristoforetti, ingegnere e astronauta, che con le missioni spaziali del 2014 e del 2015 ha stabilito il record europeo e il primo record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo (199 giorni).
Anche nell’ambito dello studio della natura nell’ultimo secolo le donne hanno svolto un ruolo di primo piano nella conoscenza dell’uomo e dei suoi stretti parenti animali. La zoologa statunitense Dian Fossey (1932-1985) - la “signora dei gorilla”, come è passata alla storia - ha contribuito in modo determinante a far conoscere le abitudini comportamentali dei gorilla di montagna del Parco nazionale dei vulcani in Ruanda, aprendo le porte a una nuova disciplina: l’etologia dei primati. Un filone di ricerca ripreso e ampliato dall’antropologa Jane Goodall con lo studio degli scimpanzé nel Parco Gombe in Tanzania, che ha portato alla comprensione del comportamento sociale di questi animali, dei loro processi di pensiero e della loro cultura. Un percorso metodologicamente non dissimile da quello pionieristico intrapreso molti anni prima da un’altra antropologa statunitense, Margaret Mead (1901-1978), applicato però alla specie umana, per illustrarne la complessità e le potenzialità individuali, mettendo in discussione i modelli culturali della sessualità alla base di ogni struttura sociale. Modelli che sono continuamente usati per costruire categorie stereotipate e per riprodurre all’infinito gerarchie di potere e ineguaglianza di diritti tra uomini e donne.
Oggi le neuroscienze forniscono un ulteriore contributo alla rivoluzione antropologica operata dalla Mead per il superamento delle discriminazioni uomo/donna. Il sesso è determinato dal fatto che un individuo è biologicamente maschio o femmina, mentre il genere è il risultato di un costrutto sociale o culturale. Altre differenze, come quelle cognitive, sono legate a una diversa organizzazione dell’encefalo nei due sessi, che però non indica la presenza di un talento più marcato negli uomini rispetto alle donne, ma semplicemente è espressione di possibili diverse modalità di funzionamento cerebrale. Nessun neurosessismo, dunque, ma una parità intellettuale tra generi che può e deve trasformarsi in positiva integrazione cognitiva. “Il futuro è delle donne” è uno slogan, ma racchiude una grande verità: pari capacità, pari diritti e pari opportunità tra uomini e donne costituiranno sempre più un vantaggio a favore di tutta l’umanità.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO....il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!! - IPAZIA, CIRILLO D’ALESSANDRIA, E UNA "BUSTINA" DI UMBERTO eCO ("iPAZZIAMMO!)..27 giugno 2020, di Federico La Sala
La bustina di minerva
Ipazziammo!
Il film ’Agorà’ di Amenabar sulla filosofa, matematica e astronoma Ipazia fatta a pezzi dal vescovo Cirillo, ha scatenato una guerra di religione e ha fatto gridare al complotto. Che non c’è
di Umberto Eco (L’Espresso, 30 aprile 2010
- Foto del film "Agorà"
È difficile che con il battage pubblicitario e la serie di dibattiti intorno al film ’Agorà’ di Alejandro Amenabar qualcuno non abbia almeno sentito nominare Ipazia. Comunque, per coloro ancora poco informati dei fatti, dirò che all’alba del quinto secolo d. C., in un impero in cui anche l’imperatore ormai è cristiano, in una Alessandria dove si scontrano l’ultima aristocrazia pagana, il nuovo potere religioso rappresentato dal vescovo Cirillo e una vasta comunità ebraica, vive e insegna Ipazia, filosofa neoplatonica, matematica e astronoma, bellissima (si diceva) e idolatrata dai suoi allievi. Una banda di parabalani, talebani cristiani dell’epoca, milizia personale del vescovo Cirillo, si scaglia su Ipazia e la fa letteralmente a pezzi.
Di Ipazia non rimangono opere (forse Cirillo le ha fatte distruggere), e pochissime testimonianze, vuoi cristiane che pagane. Tutte più o meno ammettono che Cirillo qualche responsabilità ce l’aveva. A lungo Ipazia cade nel dimenticatoio, sinché viene rivalutata dal Seicento in avanti, e particolarmente dagli illuministi, come martire del libero pensiero, celebrata da Gibbon, Voltaire, Diderot, Nerval, Leopardi, e via via sino a Proust e a Luzi, sino che diventa icona del femminismo.
Il film non è certo tenero coi cristiani e con Cirillo (anche se non cela le violenze dei pagani e degli ebrei) e si è subito diffusa la voce che le forze oscure della reazione in agguato stessero per impedirne la circolazione in Italia, così che era partita una sottoscrizione di migliaia di firme. Per quello che ho capito, la distribuzione italiana era piuttosto esitante a far circolare un film che forse avrebbe suscitato forti opposizioni da parte cattolica, compromettendone la circolazione, ma quelle firme l’hanno decisa a tentare l’avventura. Ma non è del film che voglio occuparmi (filmicamente ben fatto, malgrado alcuni vistosi anacronismi) bensì della sindrome del complotto che ha scatenato.
Navigando per Internet ho trovato attacchi cattolici, in cui si protestava contro chi voleva mostrare solo il lato violento delle religioni (ma il regista ripete che il suo obiettivo polemico era il fondamentalismo di ogni sorta), ma nessuno ha tentato di negare che Cirillo, che non era solo uomo di chiesa ma anche personaggio politico, fosse stato un duro, con gli ebrei come coi pagani. Non è un caso se santo e dottore della chiesa lo ha fatto quasi millecinquecento anni dopo Leone XIII, un papa ossessionato dal nuovo paganesimo rappresentato dalla massoneria e dai liberali mangiapreti che dominavano nella Roma dei suoi tempi. Ed è imbarazzante la celebrazione di Cirillo tenuta il 3 ottobre 2007 da papa Ratzinger, il quale loda "la grande energia" del suo governo senza spendere due righe per assolverlo da quell’ombra che la storia ha fatto pesare su di lui.
Cirillo mette a disagio tutti: su Internet trovo Rino Camilleri (già difensore del Sillabo) che a garantire l’innocenza di Cirillo chiama in causa Eusebio di Cesarea. Eccellente testimone, salvo che Eusebio era morto settantacinque anni prima del supplizio di Ipazia e quindi non aveva potuto testimoniare nulla. Dico, se si deve scatenare una guerra di religione, almeno si consulti Wikipedia.
Ma veniamo al complotto: circolano su Internet varie notizie sulla censura attuata (da chi?) per celare lo scandalo Ipazia. Per esempio si denuncia che il volume otto della ’Storia della filosofia greca e romana’ di Giovanni Reale (Bompiani) dedicato al Neoplatonismo, con notizie su Ipazia, sia misteriosamente scomparso dalle librerie. Una telefonata alla Bompiani mi ha chiarito che è vero che di tutta la serie dei dieci volumi gli unici due esauriti (e che quindi saranno ristampati) sono il sette e l’otto, certamente perché toccano argomenti come il ’Corpus Hermeticum’ e alcuni aspetti del neoplatonismo che non interessano solo chi si occupa di filosofia ma arrazzano tutti i dissennati che si impicciano di scienze occulte vero o presunte. Ma poi sono andato a vedere nei miei scaffali questo famigerato volume otto e ho visto che Reale, il quale è uno storico della filosofia e si occupa solo di testi consultabili, mentre di Ipazia non ci è rimasto nulla, dedica a Ipazia sette righe (dico sette) dove si limita a dire il poco che seriamente si sa. E allora perché censurarlo?
Ma la teoria del complotto va oltre e sempre su Internet si dice che sono scomparsi dalle librerie tutti i libri sul neoplatonismo, asineria da far sghignazzare qualsiasi studente del primo anno di filosofia. Insomma, se volete sapere qualche cosa di serio su Ipazia, cercate in linea ’enciclopediadelledonne.it’ con una bella voce di Sylvie Coyaud sul tema e, per qualcosa di più erudito, chiedete a Google ’Silvia Ronchey Ipazia’ e troverete pane (non censurato) per i vostri denti.
Il santo del giorno
Cirillo di Alessandria.
Nell’unione di due nature il fascino del cristianesimo
di Matteo Liut (Avvenire, sabato 27 giugno 2020)
Un Dio che rimane sé stesso, anche se si “mescola” con l’umanità senza svilirne l’identità profonda: è questo uno dei messaggi più affascinanti e profondi del cristianesimo. Un appello a trovare Dio nel volto del compagno di strada sapendo che comunque Egli rimane il “totalmente altro”. Non è stato facile rendere a parole il complesso concetto teologico delle due nature, umana e divina, unite nella persona di Cristo; una formulazione cui hanno contribuito padri come san Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa. Nato attorno al 370, nel 412 divenne vescovo di Alessandria, comunità che guidò fino alla morte, nel 444. Il confronto teologico vide Cirillo (difensore anche del titolo mariano di “Madre di Dio”) contrapposto soprattutto a Nestorio, la cui dottrina, basata sulla divisione tra le due nature di Cristo, fu condannata dal Concilio di Efeso del 431.
 Altri santi. San Sansone, sacerdote (VI sec.); sant’Arialdo di Milano, diacono e martire (XI sec.).
Altri santi. San Sansone, sacerdote (VI sec.); sant’Arialdo di Milano, diacono e martire (XI sec.).
 Letture. Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17.
Letture. Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17.
 Ambrosiano. Lv 23,9.15-22; Sal 96 (97); Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42.
Ambrosiano. Lv 23,9.15-22; Sal 96 (97); Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42. -
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!! --- Ecce Homo: la lezione di Ponzio Pilato e la memoria di Christine de Pizan, oggi.10 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ECCE HOMO, L’8 MARZO AL TEMPO DEL “CORONA VIRUS”, E LA MEMORIA DI CHRISTINE DE PIZAN ...
ALLA LUCE DEL CHIARIMENTO DEL SIGNIFICATO DELLE PAROLE DI PONZIO PILATO: “ECCE HOMO”(cfr. sopra : https://www.fondazioneterradotranto.it/2020/02/26/dialetti-salentini-piticinu/#comment-269838), si comprende meglio anche il significato delle parole di Christine de Pizan, l’autrice della “Città delle dame” : «Or fus jee vrais homs, n’est pa fable,/De nefs mener entremettable » (« Allora diventai un vero uomo, non è una favola,/capace di condurre le navi» - cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan), che dicono ovviamente non della “metamorfosi” in “vir” - uomo, ma della “metanoia” in “homo” - essere umano (su questo, in particolare, si cfr. Michele Feo, “HOMO - Metanoia non Metamorfosi”, “dalla parte del torto”, Parma, autunno 2019, numero 86, pp. 12-13).
***
ASTREA ! “IAM REDIT ET VIRGO” ...
CARO ARMANDO... RICORDANDO DI NUOVO E ANCORA IL TUO PREGEVOLISSIMO LAVORO SU- GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA (si cfr. https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/08/gli-arcadi-di-terra-dotranto-premessa-1-x/#comment-238474), E LA TUA CONNESSIONE TRA LA “PIZANA” CAPACE DI “CONDURRE LE NAVI” CON LA FIERA E NOBILE Carola Rackete, A SUO E TUO OMAGGIO, riprendo qui una breve scheda su:
- ASTREA - L’Astraea Virgo, ” vergine delle stelle “, simbolo della giustizia, abitò la terra nell’età dell’oro e la lasciò per ultima nell’età del ferro, cedendo all’iniquità ormai dominante. Il ‛ritorno di A.‘ si identifica in Virgilio con il ritorno dell’età di Saturno (” magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. / iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, / iam nova progenies caelo demittitur alto “, Buc. IV 5-7). L’intero passo virgiliano è parafrasato in Pg XXII 70-72 Secol si rinova ; / torna giustizia e primo tempo umano, / e progenïe scende da ciel nova ; in Mn I XI 1 è riportato il v. 6 (cui segue la chiosa ‛ Virgo ‘... vocabatur iustitia, quam etiam ‛Astraeam‘ vocabant), ricordato anche in Ep VII 6 ; in Ep XI 15 il nome di A. è usato come metonimico di giustizia (http://www.treccani.it/enciclopedia/astrea_%28Enciclopedia-Dantesca%29/).
Buon 8 marzo 2020 - e buon lavoro...
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA. --- IMPARARE A CONTARE "INSIEME"! La storia dei primi numeri (di Paolo Boldrini - "Mathone".28 novembre 2019, di Federico La Sala
LINGUISTICA GENERALE (SAUSSURE) E MATEMATICA (RUSSELL), E LA "CORRISPONDENZA BIUNIVOCA" SCOMPARSA. Una questione antropo-logica epocale... *
Mathone. Pillole di matematica per comprenderla meglio ogni giorno
La matematica conta: storia dei primi numeri
di Paolo Boldrini *
Leggere, scrivere e contare sono tra le attività più importanti che la nostra mente riesce a svolgere e costituiscono la base dello sviluppo umano. In questo articolo analizzeremo l’operazione di contare e il concetto strettemente legato di numero naturale. Mentre lettura e scrittura sono invenzioni relativamente recenti, diffuse a partire dal 3000 a.C. l’usanza del contare ha radici molto più antiche.
- [Foto]
- Tavola dei contenuti
 1 Perchè gli uomini hanno iniziato a contare?
1 Perchè gli uomini hanno iniziato a contare?
 2 Piccole e grandi quantità
2 Piccole e grandi quantità
 3 Il corvo conta fino a 5
3 Il corvo conta fino a 5
 4 Terzetti e numeri naturali
4 Terzetti e numeri naturali
 5 Un’apparente tautologia
5 Un’apparente tautologia
 6 Cosa significa contare?
6 Cosa significa contare?Perchè gli uomini hanno iniziato a contare?
Le prime tracce di conteggi risalgono addirittura al paleolitico. I principali reperti che testimoniano questa capacità sono un osso di lupo risalente al 40000 a.C e il cosiddetto osso di Ishago, risalente al 20000 a.C. Entrambi i ritrovamenti presentano delle tacche incise. Mentre per il primo non si può escludere si trattasse di una funzione decorativa; nel caso dell’osso di Ishago, l’asimmetria delle incisioni rende concordi gli studiosi nell’affermare che la finalità non fu estetica ma pratica.
- [ Foto] Osso di Ishago
Ma che cosa contavano gli uomini nella preistoria? Non è difficile immaginare quali possano essere le utilità di un tale strumento: per un cacciatore era fondamentale sapere quante lance avesse a disposizione, mentre un raccoglitore era interessato a sapere quanti frutti era stato in grado di trovare in una giornata.
In seguito, con la diffusione dell’agricoltura e dell’allevamento, divenne ancora più importante saper contare: un pastore deve conoscere esattamente la quantità di pecore nel suo gregge, altrimenti rischia di dimenticarne qualcuna! Ah di pecore e numeri naturali ne avevamo parlato anche qui Numeri Naturali: dalle pecore al concetto di numero .
Piccole e grandi quantità
Nonostante il contare abbia risposto originariamente a problemi pratici, si tratta di un’operazione astratta e tutt’altro che naturale. Essa non va confusa con la capacità di distinguere piccole quantità di oggetti; per comprendere la differenza è sufficiente un rapido esperimento.
Quanti oggetti contengono i seguenti gruppi?
- [Foto] 1
Ovviamente è molto semplice distinguere le differenze, senza la necessità di mettersi effettivamente a contare quante figure sono presenti in ogni insieme.
Questo però funziona solo con piccole quantità: prova a valutare il numero degli oggetti nei seguenti insiemi:
- [Foto] 2
In questo caso è stato certamente più difficile capire il numero “a colpo d’occhio” e probabilmente sarà stato necessario contare le forme a piccoli gruppi di due o tre elementi per avere la certezza del numero totale.
Mentre la capacità di contare sembra essere prerogativa umana, la distinzione tra piccoli gruppi di oggetti è diffusa anche in alcuni animali, soprattutto uccelli. A questo proposito è interessante riportare un racconto risalente al Settecento.
- [Foto] Corvo e matematica. I corvi sanno contare
Il corvo conta fino a 5
Un contadino voleva uccidere un corvo che aveva nidificato in cima a una torre, dentro ai suoi poderi. Ogni volta che si avvicinava, però, l’uccello volava via, fuori dalla portata del suo fucile, finché il contadino non si allontanava. Solo allora l’animale ritornava nella torre, riprendendo le incursioni sui terreni dell’uomo. Il contadino pensò allora di chiedere aiuto a un suo vicino. I due, armati, entrarono insieme nella torre e poco dopo ne uscì soltanto uno. Il corvo però non si lasciò ingannare, e non ritornò al nido finché non fu uscito anche il secondo contadino. Per riuscire ad ingannarlo entrarono poi tre uomini e successivamente quattro e cinque. Ma il corvo ogni volta aspettava che fossero usciti tutti prima di far ritorno al nido. Soltanto in sei finalmente, i contadini ebbero la meglio, infatti il corvo aspettò che cinque di loro fossero usciti e quindi fiducioso rientrò sulla torre, dove il sesto contadino lo uccise.
Stimolati da questo racconto, diversi studiosi si sono interessati dell’effettiva capacità di conto di alcuni animali, in particolare l’etologo tedesco Otto Koehler dimostrò con una serie di esperimenti che il suo corvo, Jacob era in grado di contare fino a 6, quindi al contadino per stanarlo sarebbe servita una persona in più rispetto a quelle del racconto!
Terzetti e numeri naturali
É giunto il momento di interrogarci sul vero significato del contare [**]. Fino ad ora abbiamo dato per scontato un legame tra il processo di conteggio e i numeri naturali. Essi sono talmente basilari che raramente ci soffermiamo sul loro reale significato.
L’idea, apparentemente banale, che sta alla base dei numeri naturali e di conseguenza del conteggio è che un terzetto di pecore, un terzetto di mele e un terzetto di pietre hanno una cosa in comune: il numero 3!
Tuttavia, come spiega il filosofo e matematico Bertrand Russell, nel suo saggio “Introduzione alla filosofia matematica”, non bisogna commettere questo fraintendimento: “Un terzetto d’uomini è un esempio del numero tre, e il numero tre è un esempio di numero; ma il terzetto non è un esempio di numero“.
Tutti i terzetti hanno in comune il numero 3, ma nessuno dei terzetti costituisce il numero 3. Essi sono ben distinti dai duetti e dai quartetti, e ciò che li distingue è proprio il fatto di essere 3. Quindi un numero è la caratteristica comune a tutti gli insiemi costituiti da quel determinato numero di elementi. Il numero 7 per esempio è tecnicamente definito come l’insieme degli insiemi di 7 elementi.
Un’apparente tautologia
Questa affermazione sembra tautologica: come posso sapere il “numero di elementi di un insieme” se non conosco la definizione di numero e non so nemmeno cosa significhi contare?
Immaginiamo di avere duetti, terzetti e in generale insiemi di n elementi, come posso raccogliere tutti quelli con lo stesso numero di elementi senza effettivamente contarli?
Russell utilizza il criterio della corrispondenza biunivoca. Dati due insiemi, essi hanno la stessa cardinalità (numero di elementi) se e solo se è possibile creare una funzione biunivoca tra i due. Ovvero una funzione che ad ogni elemento del primo insieme associa uno e un solo elemento del secondo.
- [Foto] Biiezione e contare
In questo modo è possibile raggruppare gli insiemi con la stessa cardinalità senza presupporre la capacità di contare. Fatto ciò è sufficiente dare un nome agli insiemi di insiemi (1 a quelli di 1 elemento, 2 a quelli di 2 e così via). In questo modo abbiamo definito i numeri in maniera consistente!
Cosa significa contare?
A questo punto resta solo da capire cosa significhi contare. Anche in questo caso è utile ragionare in termini di corrispondenze biunivoche. Soffermiamoci sul caso dell’osso di Ishago, su di esso ogni tacca sta a rappresentare un’unità. Non si sa cosa sia stato contato in questo modo, supponiamo i frutti raccolti durante la giornata. Ad ogni frutto corrisponde una tacca, quindi esiste una corrispondenza biunivoca tra l’insieme dei frutti e l’insieme delle tacche. Astraendo possiamo asserire che l’operazione di contare non è nient’altro che creare una corrispondenza biunivoca tra l’insieme degli oggetti da contare e un sottoinsieme dei numeri naturali!
Se vuoi approfondire ti consiglio l’articolo GEORG CANTOR: QUANTO È INFINITO L’INFINITO? in cui Lorenzo spiega come contare insiemi di infiniti elementi!
Spero che questo articolo ti sia piaciuto, nel prossimo vedremo come il concetto di numero si è evoluto nelle diverse culture. Ospite speciale: il numero 0!
Se ti interessa l’argomento dei numeri, del contare e la matematica più in generale ti consiglio questo libretto leggero ma interessante: L’uomo che sapeva contare.
* Fonte: Mathone (ripresa parziale - senza immagini).
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!!
DONNE, UOMINI E MATEMATICA. Se le donne non "contano", non sanno nemmeno contare; e gli uomini, se "contano", altrettanto non sanno nemmeno contare!!! La punta di un "iceberg": una "nota" del "disagio della civiltà"
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
Federico La Sala
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... La Luna vista da Leonardo. Ricoorenze: i 50 anni dell’Apollo 11 con i 500 anni del genio da Vinci che tra i primi studiò e disegnò il fenomeno della ’luce cinerea’ (di Flavia Marcacci).19 novembre 2019, di Federico La Sala
Scienza. La Luna vista da Leonardo
Pochi hanno messo in connessione i 50 anni dell’Apollo 11 con i 500 anni del genio da Vinci che tra i primi studiò e disegnò il fenomeno della ’luce cinerea’
di Flavia Marcacci (Avvenire, martedì 19 novembre 2019)
Signora dell’anno 2019 è la Luna: si celebrano i 50 anni della conquista del suo suolo. Eventi e pubblicazioni si stanno succedendo rapidamente, ricordando quanto avvenne in quel frenetico 1969, che tra la protesta di Jan Palach e la nascita del progenitore di Internet Arpanet fu fitto di molti fatti decisivi per la grande e piccola storia. Eppure, il 20 luglio i passi silenziosi di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna ebbero il potere di fermare ogni altro vocio e ogni altra preoccupazione.
Il potere di vedere (video) a distanza (tele) promesso dallo strumento che stava cambiando la società, la televisione, giungeva a un impensabile lontano: la potenza della tecnica veniva consacrata, quasi riscattando i timori che era andata suscitando dopo l’esperienza atomica.
 La nostra Terra deve molto alla Luna, e non a caso essa è stata nei secoli un oggetto privilegiato per la scienza, la filosofia e l’arte. Il nostro satellite è stato il più vicino tra gli oggetti lontanissimi, la porta d’accesso al cielo deputato invalicabile e tramite esso finalmente accessibile. La luna fu scrutata da Leonardo da Vinci (1452-1519), altro protagonista del 2019, poiché del genio toscano ricorrono i 500 anni dalla morte. Pochi hanno notato la convergenza tra le due ricorrenze.
La nostra Terra deve molto alla Luna, e non a caso essa è stata nei secoli un oggetto privilegiato per la scienza, la filosofia e l’arte. Il nostro satellite è stato il più vicino tra gli oggetti lontanissimi, la porta d’accesso al cielo deputato invalicabile e tramite esso finalmente accessibile. La luna fu scrutata da Leonardo da Vinci (1452-1519), altro protagonista del 2019, poiché del genio toscano ricorrono i 500 anni dalla morte. Pochi hanno notato la convergenza tra le due ricorrenze.Leonardo aveva disegnato il satellite terrestre, dando nota del fenomeno della ’luce cinerea’ nel Codice Leicester (foglio 2 r), come ricordava fin dagli anni Settanta il noto studioso Carlo Pedretti (1928-2018). Il fenomeno si osserva tra novilunio e prima fase e nell’ultima fase: può capitare così che la luce del Sole venga riflessa dalla Terra e vada a illuminare una piccola porzione in ombra del satellite, in modo da renderlo visibile anche all’alba. Per lo stesso fenomeno, Armstrong e Aldrin dalla Luna avrebbero potuto osservare un bel ’chiaro di Terra’, con il nostro pianeta stabile nel cielo lunare (altezza in dipendenza dalla latitudine).
A completare la spiegazione della luce cinerea fu Galileo Galilei, chiamandola anche «candore lunare» a intendere le sfumature grigiastre, talvolta tendenti al verde o all’azzurro e capaci di conferire una leggerezza impercettibile al corpo celeste. Il Pisano diede alla Luna l’altro grande merito di segnare l’inizio dell’astronomia in senso moderno (ovvero usando strumenti), quando con il ’perspicillo’ (il telescopio, da perspicio, guardare in profondità) ne scoprì cavità e valli nel 1609 poi riprodotte nei famosi disegni pubblicati nel Sidereus nuncius (1610): da allora in poi, la scienza non sarebbe più tornata indietro.
 Si avviò così la pratica di descrivere la Luna: la selenografia vantò tra i suoi adepti molti italiani, che raramente trovano un posto nelle storie italiane della scienza destinate al grande pubblico. Solo dopo Galileo il noto gesuita Cristoph Scheiner, docente a Roma tra il 1624 e il 1633, propose una delle prime mappe lunari (1614); dopo di lui fu la volta del confratello Giuseppe Biancani (1620).
Si avviò così la pratica di descrivere la Luna: la selenografia vantò tra i suoi adepti molti italiani, che raramente trovano un posto nelle storie italiane della scienza destinate al grande pubblico. Solo dopo Galileo il noto gesuita Cristoph Scheiner, docente a Roma tra il 1624 e il 1633, propose una delle prime mappe lunari (1614); dopo di lui fu la volta del confratello Giuseppe Biancani (1620).Furono però soprattutto il bolognese Francesco Maria Grimaldi e il ferrarese Giovanni Battista Riccioli, entrambi ancora gesuiti, ad avere il merito di produrre gran parte della nomenclatura lunare che usiamo tutt’oggi. Il loro lavoro fu pubblicato nell’Almagestum novum ( 1651) e si dice che fu merito essenzialmente di Grimaldi, il quale compì la maggior parte delle osservazioni. I diritti d’autore sono però difficili da stabilire, essendo i due strettissimi collaboratori e Grimaldi una sorta di allievo di Riccioli. Ciò che conta è che sul suolo lunare essi impressero nomi celebri, molti dei quali già adoperati poco tempo prima dagli astronomi Michael F. van Langren e Johannes Hevelius (Jan Heweliusz): i due studiosi italiani ripresero le prime nomenclature per renderle più sistematiche e razionali. I crateri, le terre e i mari lunari furono battezzati con il nome di personaggi antichi, nell’emisfero nord, e moderni, nell’emisfero sud.
 Per questo motivo oggi sulle mappe lunari troviamo memoria di astronomi (da Tolomeo e Ipparco a Copernico e Biancani), di santi e sante (da san Teofilo e san Cirillo a santa Caterina da Siena), di filosofi (da Anassimandro a Platone).
Per questo motivo oggi sulle mappe lunari troviamo memoria di astronomi (da Tolomeo e Ipparco a Copernico e Biancani), di santi e sante (da san Teofilo e san Cirillo a santa Caterina da Siena), di filosofi (da Anassimandro a Platone).Guardare alla luna, però, non era utile solo per descriverla. Si cercava di comprendere la natura dei cieli (cf. La Lune aux XVIIe et XVIIIe siècles, edited by C. Grell and S. Taussig, Brepols, Turnhout, 2013). Nel Seicento alcuni pensavano, ad esempio, che il termine ’luna’ derivasse da lucuna (lux, luce e una, una) a intendere che la Luna fosse l’unica a essere sempre illuminata dal Sole. La Luna aveva anche un ruolo sociale rilevante, perché i suoi ritmi mensili andavano calcolati insieme a quelli del Sole per ottenere il calendario: fu proprio la sfasatura tra essi che portò alla grande riforma di papa Gregorio XIII.
Oltre alla cosmologia e alla scienza calendrica, il satellite della Terra stimolava anche il mito e la poesia. Gli appellativi del nostro satellite erano così tanti che è difficile elencarli: dal greco Selene a indicarne lo splendore, all’ebraico Lebana a richiamarne la bianchezza; da Artemide, Selene ed Ecate, dee che custodivano il grembo del corpo celeste nelle sue varie fasi, fino alla dea ’triforme’ citata da Cleomede e Virgilio.
La Luna non andava soltanto descritta, ma scritta. La ricchezza delle fantasie lunari di Luciano di Samosata (II sec. d.C.) ebbe una certa fortuna in epoca rinascimentale, probabilmente avvantaggiata dalla diffusione del fascino per i mirabilia e i fatti immaginati e prodigiosi: l’Icaromenippo proponeva il viaggio di Menippo sulla Luna, per giungere da lì fino alla casa degli dei. Su tutti non si può evitare di pensare all’Astolfo sulla Luna di Ludovico Ariosto, fino alle ipotesi di John Wilkins protese all’eventualità di abitanti sulla Luna (The discovery of a world in the moone, 1638).
La Luna era in grado di evocare fantasie, sentimenti ed emozioni, attingendo da ciò che nell’essere umano vi è di più profondo. Probabilmente ne tennero conto coloro che volevano solo descriverla fino a intravedere sul suo suolo i luoghi esistenziali della crisi, della siccità, della tranquillità, della serenità e della fecondità. Per questo nelle sue regioni si trovano la ’Terra della sterilità’ e la ’Terra della Vita’, il ’Mare della Crisi’ e il ’Mare della Tranquillità’.
Dai tempi di Leonardo e della selenografia torniamo così ai nostri tempi. Proprio il Mare della Tranquillità divenne famoso cinquant’anni fa, quando allunarono nei suoi pressi gli uomini della Missione Apollo 11. La Luna, lontana, scrutata, sognata era stata raggiunta. Il satellite forniva all’umanità l’ennesimo servizio, facendosi solcare da da orme umane sui luoghi della Tranquillità, forse proprio quelli a cui ambisce più profondamente ogni anima e dove la scienza dovrebbe contribuire ad avvicinarsi.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA. Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo" --- Il principio di relatività di Galilei, il Cnr, e la rotazione della Terra. Note a margine della lettera "Al CNR la storia è una scienza?6 giugno 2019, di Federico La Sala
PER UN NUOVO CNR ....
NOTE A MARGINE DELLA LETTERA "Al CNR la storia è una scienza? Una risposta all’intervento di Gilberto Corbellini"
- Recensendo un volume dell’epistemologo statunitense Alex Rosenberg, in un articolo dal titolo Questa storia è davvero molto falsa apparso sul supplemento domenicale del “Sole - 24 ore” il 12 maggio scorso, il professor Gilberto Corbellini ne ha preso spunto per asserire, in polemica con un recente appello in difesa dell’insegnamento della storia, l’assenza di scientificità e di utilità sociale della disciplina stessa. [...] (ALFABETA-2, 26 MAGGIO 2019)
1. PER LA STORIA DELLLA SCIENZA E PER LA SCIENZA DELLA STORIA, FORSE, E’ MEGLIO RI-DISCENDERE “SOTTO COVERTA DI ALCUN GRAN NAVILIO” E RIPRENDERE IL LAVORO GALILEANO DELLA CONVERSAZIONE E DELLA CONOSCENZA 29 Maggio 2019 :
- «Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. (..)
 Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.» (Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”, 1632 - Salviati, giornata II)
Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.» (Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”, 1632 - Salviati, giornata II)
2. STORIA, SCIENZA, ED ECLISSI. Da Galileo Galilei ad Albert Einstein 30 maggio 2019...
Al di là delle pretese “mitideologiche” (atee e devote) del “post-positivismo” contemporaneo (Paolo Fabbri) di dare il via a un’ epoca in cui la storia del mondo dev’essere riscritta secondo l’indicazione rosenberghiana!), ricordiamo che il 29 maggio 1919 Arthur Eddington provò sperimentalmente la teoria della relatività (cfr. : Franco Gabici, “Cento anni fa l’eclissi che diede ragione a Einstein” - https://www.avvenire.it/agora/pagine/cento-anni-fa-leclissi-che-diede-ragione-a-einstein). Buon lavoro!
3. COSTITUZIONE E CNR. UN PROBLEMA STORIOGRAFICO (SCIENTIFICO) DI LUNGA DURATA 31 Maggio 2019...
CONDIVIDO LA PREOCCUPAZIONE E, AL CONTEMPO, LA CONSAPEVOLEZZA dei firmatari della lettera. La “provocazione” - da parte di chi dirige il Dipartimento del CNR, “al cui interno operano decine di storici, storici della filosofia, giuristi e altri ricercatori nel campo delle scienze umane e sociali” - evidenzia il sintomo non tanto e non solo “di un profondo problema culturale e scientifico”, ma anche e soprattutto di un problema politico-filosofico (metafisico), costituzionale, di CRITICA della “ragion pura” (di questo parla il “principio della relatività galileiana”, condensato nel “Rinserratevi” del “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”)!,
DOPO GALILEI, DOPO KANT, DOPO EINSTEIN, DOPO LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA... UNA “PROVOCAZIONE” al CNR DA ACCOGLIERE!
Strana “coincidenza”, oggi!:
- A) Il 9 Aprile 2019, in una nota (dal titolo
“CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. A che gioco giochiamo?!: https://www.alfabeta2.it/2019/03/31/marcel-detienne-memorie-felici-e-concetti-indelebili/#comment-639227), così scrivevo:
 “La totale incomprensione del “relazionismo” proposto da Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius (e non solo!) di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790)”.
“La totale incomprensione del “relazionismo” proposto da Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius (e non solo!) di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790)”.
- B) Il 12 maggio 2019, “recensendo un volume - come scrivono gli studiosi e le studiose del CNR - dell’epistemologo statunitense Alex Rosenberg, in un articolo dal titolo Questa storia è davvero molto falsa apparso sul supplemento domenicale del “Sole - 24 ore” il 12 maggio scorso, il professor Gilberto Corbellini ne ha preso spunto per asserire, in polemica con un recente appello in difesa dell’insegnamento della storia, l’assenza di scientificità e di utilità sociale della disciplina stessa”.
Prima che sia troppo tardi, che fare?! Alle studiose e alle studiose di scienze umane e sociali (del CNR e non solo), consiglierei (mi sia permesso) la ri-lettura del “Dialogo sopra i due massimi sistemi iolemaico e copernicano” di Galileo Galilei, la ri-lettura dei “Sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica” di Immanuel Kant, e, infine, la rilettura dei “Principi” della Costituzione della Repubblica Italiana - e, alla luce della “ferocissima” provocazione, ri-prendere il lavoro storiografico-scientifico con più grande entusiamo e responsabilità di prima!
VIVA IL CNR,
VIVA L’ITALIA!
4. PER UN NUOVO CNR! ALL’INSEGNA DI ERMES: “IO VORREI PENSARE CON IL CERVELLO INTERO”. IN MEMORIA DI ENRICO FILIPPINI E DI MICHEL SERRES 3 Giugno 2019 ...
“[...] all’insegna di Ermes, che per me è il simbolo della scienza contemporanea”.
 In che senso? “Nel senso che Mercurio, a cui ho dedicato ben cinque libri, è il dio della comunicazione. A differenza di quanto pensavano i marxisti, io ritenevo che il problema della comunicazione fosse più importante di quello della produzione, e che l’ economia stessa fosse più una questione di comunicazione che di produzione. Sono fiero di quell’ assunto, mi scusi la superbia: infatti, i paesi che hanno scommesso in questo senso, per esempio il Giappone, hanno evitato la crisi”.
In che senso? “Nel senso che Mercurio, a cui ho dedicato ben cinque libri, è il dio della comunicazione. A differenza di quanto pensavano i marxisti, io ritenevo che il problema della comunicazione fosse più importante di quello della produzione, e che l’ economia stessa fosse più una questione di comunicazione che di produzione. Sono fiero di quell’ assunto, mi scusi la superbia: infatti, i paesi che hanno scommesso in questo senso, per esempio il Giappone, hanno evitato la crisi”.
 Ma comunicazione che vuol dire? “All’ inizio, all’ epoca dello strutturalismo, davo del termine “struttura” un’ interpretazione algebrica, esatta. Poi, studiando il XIX secolo, la fisica ottocentesca, e cioè essenzialmente la termodinamica, finii per attribuire un ruolo centrale alla teoria dell’ informazione. In fondo, se del mio lavoro dovessi tracciare un profilo, ecco: per tutta la vita ho cercato di tenermi al corrente, da filosofo, del sapere scientifico (il che in Francia ø raro), e insieme di non dimenticare la tradizione letteraria: ho scritto su Zola e su Jules Verne. Ecco, ho cercato di tenere unite, con le due mani, la scienza e la letteratura, di passare dall’ una all’ altra. E’ quello che chiamo, nel quinto volume dedicato a Mercurio, il Passaggio a Nord-Ovest: passaggio difficile, pericoloso, tempestoso, ma passaggio. Per me la filosofia è questa alleanza. In Italia ciò dovrebbe essere comprensibile”.
Ma comunicazione che vuol dire? “All’ inizio, all’ epoca dello strutturalismo, davo del termine “struttura” un’ interpretazione algebrica, esatta. Poi, studiando il XIX secolo, la fisica ottocentesca, e cioè essenzialmente la termodinamica, finii per attribuire un ruolo centrale alla teoria dell’ informazione. In fondo, se del mio lavoro dovessi tracciare un profilo, ecco: per tutta la vita ho cercato di tenermi al corrente, da filosofo, del sapere scientifico (il che in Francia ø raro), e insieme di non dimenticare la tradizione letteraria: ho scritto su Zola e su Jules Verne. Ecco, ho cercato di tenere unite, con le due mani, la scienza e la letteratura, di passare dall’ una all’ altra. E’ quello che chiamo, nel quinto volume dedicato a Mercurio, il Passaggio a Nord-Ovest: passaggio difficile, pericoloso, tempestoso, ma passaggio. Per me la filosofia è questa alleanza. In Italia ciò dovrebbe essere comprensibile”.
 In Italia c’ è stata una forte tradizione idealista e marxista. L’ interesse per la scienza tende a diventare scientismo. “Come nel mondo anglosassone. Ma il fatto è che nella letteratura c’ è spesso più rigore che nella scienza. In Tito Livio c’ è più epistemologia che in Popper. Il mio sogno è di scrivere un’ opera che compia la riconciliazione enciclopedica, proprio alla maniera di Diderot e di D’ Alembert, ma non solo nel senso storico (per cui si pensa sempre soltanto nel solco della propria tradizione), anche nel senso del concetto: quello è il campo che si percorre e che si deve percorrere. La filosofia ha perduto troppo non sapendo nulla di scienza, ma oggi che ne sa qualcosa, ha perduto la dimensione culturale. E’ come un cervello tagliato in due. Io vorrei pensare col cervello intero”.
In Italia c’ è stata una forte tradizione idealista e marxista. L’ interesse per la scienza tende a diventare scientismo. “Come nel mondo anglosassone. Ma il fatto è che nella letteratura c’ è spesso più rigore che nella scienza. In Tito Livio c’ è più epistemologia che in Popper. Il mio sogno è di scrivere un’ opera che compia la riconciliazione enciclopedica, proprio alla maniera di Diderot e di D’ Alembert, ma non solo nel senso storico (per cui si pensa sempre soltanto nel solco della propria tradizione), anche nel senso del concetto: quello è il campo che si percorre e che si deve percorrere. La filosofia ha perduto troppo non sapendo nulla di scienza, ma oggi che ne sa qualcosa, ha perduto la dimensione culturale. E’ come un cervello tagliato in due. Io vorrei pensare col cervello intero”.
 Ora sta scrivendo qualche cosa? “Un libro sui cinque sensi, e, appunto, in una forma letteraria, anche se sono partito da un sistema rigorosamente formale. E’ un tentativo di alleanza tra le due forme di sapere, è anche il tentativo di ritrovare, come diceva Edmund Husserl, le radici profonde della cultura europea. Lei conosce La crisi delle scienze europee?”.
Ora sta scrivendo qualche cosa? “Un libro sui cinque sensi, e, appunto, in una forma letteraria, anche se sono partito da un sistema rigorosamente formale. E’ un tentativo di alleanza tra le due forme di sapere, è anche il tentativo di ritrovare, come diceva Edmund Husserl, le radici profonde della cultura europea. Lei conosce La crisi delle scienze europee?”.
 L’ ho tradotta in italiano da studente. Ma Husserl parlava appunto di “crisi” di quell’ idea e di quella tradizione. C’ è il problema della tecnicizzazione della scienza. E poi c’ è la difficoltà della estrema specializzazione dei settori scientifici [...]
L’ ho tradotta in italiano da studente. Ma Husserl parlava appunto di “crisi” di quell’ idea e di quella tradizione. C’ è il problema della tecnicizzazione della scienza. E poi c’ è la difficoltà della estrema specializzazione dei settori scientifici [...]
 (cfr. ENRICO FILIPPINI, “Il mio amico Mercurio”, “la Repubblica”, 15 giugno 1984: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/06/15/il-mio-amico-mercurio.html).
(cfr. ENRICO FILIPPINI, “Il mio amico Mercurio”, “la Repubblica”, 15 giugno 1984: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/06/15/il-mio-amico-mercurio.html).5. STORIA E SCIENZA: “VICISTI, GALILAEE” (KEPLERO, 1611) 5 Giugno 2019.
La rotazione della Terra rimescola le acque del lago di Garda ... http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/terra_poli/2019/06/05/la-rotazione-della-terra-rimescola-le-acque-del-lago-di-garda-_8cbe9d78-1459-4088-a0a4-12016cd675b9.html.
Federico La Sala
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... Cerchiamo di "non dare i numeri" --- Un Patto scellerato in nome della Scienza (di Giorgio Ferrari, Angelo Baracca).12 gennaio 2019, di Federico La Sala
Un Patto scellerato in nome della Scienza
Il manifesto trasversale. Con preoccupanti finalità interdittive, il patto firmato da Grillo e Renzi, quando annuncia che non saranno tollerate forme di pseudoscienza e pseudomedicina, brandisce la Scienza come una clava con cui colpire i “reprobi” che non ne riconoscono la sacralità
di Giorgio Ferrari, Angelo Baracca (il manifesto, 12.01.2019)
Non è la prima volta che nel nostro paese il mondo della scienza si rivolge alla politica affinché questa si faccia carico di questioni riguardanti il benessere della popolazione. È successo per il clima, per le scelte energetiche e per questioni etiche: ora, sembra, è la volta della salute. Tale infatti l’ambito privilegiato, ma non esclusivo, del Patto Trasversale per la Scienza che tanti consensi ha suscitato sia nei mezzi di informazione che nella stessa politica, al punto da mettere d’accordo persino due noti avversari come Beppe Grillo e Matteo Renzi. Fuori dal coro dei consensi a noi pare che questa iniziativa abbia qualcosa di inquietante nella forma e nella sostanza del suo testo. Intanto non è un appello, ma un “patto” che le forze politiche tutte sono chiamate a sottoscrivere per finalità non solamente propositive (l’informazione, la ricerca) ma decisamente interdittive. E questa è una spiacevole novità. Di appelli fortemente connaturati alla sacralità della Scienza, ne avevamo già visti in passato e sempre in occasione di forti tensioni culturali e sociali come quelle dei referendum antinucleari. Così fu per gli scienziati filonucleari che si rivolsero al presidente della repubblica all’indomani dell’incidente di Chernobyl, poi nel 2010 quelli che si rivolsero a Bersani affinché il Pd non chiudesse la porta al nucleare e infine nel 2011 quelli che ritenevano senza fondamento l’imminente referendum post Fukushima. Il tratto comune di questi appelli era l’accusa, esplicita o implicita, di antiscientificità nei confronti degli antinucleari: «Caro Segretario, occorre evitare il rischio che nel Pd prenda piede uno spirito antiscientifico, un atteggiamento elitario e snobistico che isolerebbe l’Italia, non solo in questo campo, dalle frontiere dell’innovazione. Noi ti chiediamo di prendere atto che il nucleare non è né di sinistra, né di destra e che, anzi, al mondo molti leader di governi di sinistra e progressisti puntano su di esso per sviluppare un sistema economico e modelli di vita e di società eco-compatibili» questo nell’appello del 2010, mentre in quello del 2011 si diceva: «Nell’appellarci alla ragione, noi richiamiamo l’attenzione sul fatto che la legittima prudenza e la giusta richiesta di corretta informazione non siano oscurate da furori emotivi fuori luogo o da ossessionanti atteggiamenti di contrapposizione che rischiano di sfociare in anacronistiche “cacce alle streghe” invocate da guru o santoni d’occasione nonché da contingenti interessi elettorali».
Considerazioni queste, in linea con quella presunta neutralità della scienza che anche il testo del presente “Patto” vuole accreditare, quando sostiene che la Scienza (e il progresso che ne consegue) «non ha alcun colore politico». Non siamo d’accordo; e ce ne sarebbero di esempi per dimostrare che la “Scienza”- non altrimenti definita - si è macchiata più volte di crimini contro l’umanità, sia in tempo di pace che di guerra. Ma questo, se vogliamo, è ancora un ambito dialettico sull’operato della scienza stessa che fu, ed è ancora, largamente di parte. Diverso invece (e più inquietante) è quando nel “Patto”si annuncia che non saranno tollerate forme di pseudoscienza e pseudomedicina fino al punto di auspicare leggi contro l’operato di chi sarà ritenuto, conseguentemente, uno pseudoscienziato.
E chi lo stabilirà? Con quali criteri? Se tutto questo non è una boutade elettoralistica che ammicca ad un asse tra Pd e 5S, allora i tempi bui di cui scriveva Brecht sono più vicini di quanto pensiamo e magari c’è già chi sogna di ripristinare le regole del Sant’Uffizio:
 «Diciamo, pronuntiamo, sententiamo e dichiariamo che tu, Galileo sudetto, per le cose dedotte in processo e da te confessate come sopra, ti sei reso a questo S. Offizio vehementemente sospetto d’heresia, cioè d’haver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle Sacre e Divine Scritture».
«Diciamo, pronuntiamo, sententiamo e dichiariamo che tu, Galileo sudetto, per le cose dedotte in processo e da te confessate come sopra, ti sei reso a questo S. Offizio vehementemente sospetto d’heresia, cioè d’haver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle Sacre e Divine Scritture».
 Del resto sono già due i medici italiani radiati dall’ordine per aver assunto posizioni critiche sul decreto vaccini. E tanto per restare in tema, come dimenticare il falso allarme pandemia del 2010 che costò solo in Europa miliardi di euro di spesa in vaccini inutilizzati, o la denuncia di appena un anno fa dell’Istituto Negri, sulla immane inutilità dei farmaci in commercio e sulle cure prescritte senza alcuna evidenza scientifica?
Del resto sono già due i medici italiani radiati dall’ordine per aver assunto posizioni critiche sul decreto vaccini. E tanto per restare in tema, come dimenticare il falso allarme pandemia del 2010 che costò solo in Europa miliardi di euro di spesa in vaccini inutilizzati, o la denuncia di appena un anno fa dell’Istituto Negri, sulla immane inutilità dei farmaci in commercio e sulle cure prescritte senza alcuna evidenza scientifica?Attenzione dunque a brandire la Scienza come una clava con cui colpire i “reprobi” che non ne riconoscono la sacralità. Così facendo avalleremmo l’idea che la Scienza debba essere separata dalla realtà sociale e dallo stesso scienziato che, al pari di un sacerdote, non esprime più un suo punto di vista in quanto, per definizione, esso è già contenuto nella Scienza-religione, ormai basata solo su se stessa e sulla sua infallibilità.
-
> GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... Cerchiamo di "non dare i numeri" --- Politica, scienza, e valori. Il "patto per la scienza". Note di W. Ricciardi e M. Ferrera.12 gennaio 2019, di Federico La Sala
C’è del buono in quel «patto».
Scienza e politica: sviluppo opportuno
di Walter Ricciardi (Avvenire, sabato 12 gennaio 2019)
Il "patto per la scienza" siglato giovedì 10 gennaio 2019 è una importante innovazione nello scenario culturale del nostro Paese perché segna un passaggio di qualità nel rapporto tra scienza e politica. E questo al di là della discussione strettamente politica sul fatto che - dopo tanti anni di posizioni critiche e anche francamente ostili - il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha improvvisamente cambiato opinione sulla straordinaria tecnologia dei vaccini e delle vaccinazioni.
La scienza è un sistema di conoscenze caratterizzato dalla ricerca della verità, attraverso prove riproducibili, mentre la politica è una vocazione pienamente impegnata nelle circostanze e nei compromessi del mondo reale. Politici e scienziati hanno funzioni sociali diverse che non poche volte li portano a contrapporsi, ma che in fin dei conti riescono a essere complementari anche se spesso attraverso un difficile cammino di mutue incomprensioni, ostacoli e interessi. Ovviamente questa mutua interazione e questo percorso non sono scevri da possibili rischi e distorsioni.
Non è difficile trovare esempi di politici che negano o distorcono le evidenze scientifiche a favore di proprie posizioni su determinate temi, magari compromettendo in tal modo la comprensione da parte dell’opinione pubblica dei fattori in campo. Per di più, quando ciò accade, gli scienziati generalmente rispondono nella lingua della scienza e raramente, perciò, riescono a risolvere la confusione e l’incomprensione ormai generata e diffusasi nell’opinione pubblica.
E d’altra parte, è difficile anche capire in che misura gli scienziati dovrebbero essere coinvolti nel prendere parte alle decisioni politiche. La domanda è ardua per le società democratiche tecnologicamente avanzate. Se gli scienziati non mettono a disposizione le loro conoscenze nei processi politici, si rischia di prendere decisioni malinformate su tematiche complesse. Ma, allo stesso tempo, se gli scienziati giocano un ruolo troppo grande nella definizione di problemi e soluzioni, si rischia di sostituire un governo democratico con un controllo tecnocratico.
Quale relazione politica-scienza rappresenta, dunque, l’optimum? È possibile identificare tre condizioni in cui è più probabile che le evidenze derivanti dalla scienza vengano utilizzate dai decisori politici per identificare e implementare le policy.In primo luogo, è più probabile che la scienza influenzi i politici se le evidenze fornite rientrano entro i limiti e le pressioni (anche istituzionali) a cui essi sono sottoposti, se "risuonano" con i loro presupposti ideologici oppure se subiscono, esternamente, una pressione tale da indurli a sfidare e oltrepassare quei limiti.
In secondo luogo, le prove scientifiche devono essere credibili e convincenti, fornire soluzioni pratiche ai problemi di politica correnti ed essere presentate in modo da attrarre l’interesse dei politici. In terzo luogo, la scienza è maggiormente in grado di contribuire a politiche migliori se i ricercatori e i decisori politici, i policy maker, condividono reti comuni, si fidano l’uno dell’altro, rappresentano gli interessi di tutte le parti interessate in modo onesto e aperto e comunicano in modo efficace.
Nella pratica queste tre condizioni sono raramente soddisfatte, perché i ricercatori hanno una limitata capacità di influenzare il contesto politico o di sviluppo all’interno del quale lavorano. E purtroppo i processi politici stessi sono probabilmente il principale ostacolo alla formulazione di policy basate sull’evidenza. Far sì che il dialogo tra scienza e politica non sia un dialogo tra sordi è un problema che si pone con urgenza in Italia e non solo.
Per questo il ’patto’ prevede che le forze politiche italiane s’impegnino:
1) a sostenere la scienza come valore universale di progresso dell’umanità, che non ha alcun colore politico, e che ha lo scopo di aumentare la conoscenza umana e migliorare la qualità di vita dei nostri simili;
2) a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica come il negazionismo dell’Aids, l’anti-vaccinismo, le terapie non basate sulle prove scientifiche;
3) a governare e legiferare in modo tale da fermare l’operato di quegli pseudoscienziati che, con affermazioni non-dimostrate e allarmiste, creano paure ingiustificate tra la popolazione nei confronti di presidi terapeutici validati dall’evidenza scientifica e medica;
4) a implementare programmi capillari d’informazione sulla scienza per la popolazione, a partire dalla scuola dell’obbligo, e coinvolgendo media, divulgatori, comunicatori e ogni categoria di professionisti della ricerca e della sanità;
5) ad assicurare alla scienza adeguati finanziamenti pubblici, a partire da un immediato raddoppio dei fondi ministeriali per la ricerca biomedica. Questo testo è, insomma, un importante passo avanti di cui siamo grati a Roberto Burioni e Guido Silvestri. Certo, nel ’patto’ non si entra nell’ambito degli impegnativi scenari etici in cui dovremo prendere importanti decisioni nel prossimo futuro, e questo è un argomento su cui bisognerà tornare con decisione.
* Ordinario d’igiene e medicina preventiva Università Cattolica del Sacro Cuore e già presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss).
I valori che offre la scienza
Verità è dire le cose come stanno. Pensare e parlare ricordando sempre che «là fuori» c’è una realtà ostinata e indipendente dalle nostre opinioni
di Maurizio Ferrera (Corriere della Sera, 12.01.2019)
Beppe Grillo ha firmato il Patto trasversale sulla Scienza promosso da Roberto Burioni e Guido Silvestri, due noti e autorevoli docenti e studiosi di medicina. Si tratta di un segnale importante, in controtendenza rispetto agli atteggiamenti anti-scientifici dei 5 Stelle: emblematico il caso dei vaccini. A giudicare dai social media, non tutta la base grillina condivide questa scelta. Beppe Grillo resta nondimeno il fondatore e padre nobile del Movimento. La sua posizione ha comunque peso politico e rilevanza simbolica.
Il Patto sulla Scienza dice cose molto semplici, che dovrebbero essere scontate in ogni democrazia liberale. Primo: la scienza è un valore, in quanto produce conoscenze affidabili sul mondo e ci indica sia come trarne vantaggio sia come evitare danni (pensiamo alle epidemie o ai disastri naturali). Secondo: occorre combattere la pseudo-scienza, ossia tutte le idee e indicazioni che non rispettano quei criteri di metodo che da secoli ispirano il lavoro degli scienziati. Chi stabilisce i criteri e chi «accredita» la qualità di un lavoro scientifico? La comunità scientifica, e solo questa. Come rammenta il Patto, la scienza non ha colore politico. I politici possono trascurare le indicazioni degli scienziati. Ma non possono giustificarsi dicendo che gli scienziati sbagliano, che le conoscenze accettate e condivise dalla comunità scientifica non «dicono la verità». g li ultimi due punti del Patto spiegano in che modo si deve promuovere e proteggere la scienza. Innanzitutto occorre mettere i cittadini in condizioni di riconoscere la conoscenza affidabile da quella che non lo è. In secondo luogo, bisogna mettere gli scienziati in condizione di lavorare autonomamente, garantendo un flusso adeguato di risorse.
Ho menzionato la parola «verità». Di questi tempi è frequente sentire che la verità non esiste, oppure che ce ne sono tante e che ciascuno può scegliere la sua. E poi: gli scienziati non sono mai neutrali - si dice -, spesso agiscono in base a interessi di parte. Il cosiddetto progresso scientifico non dimostra forse che ciò che appare vero in un dato momento a un certo punto viene gettato nel cestino delle falsità? Osservazioni comprensibili. Gli scienziati sono donne e uomini in carne e ossa, e dunque imperfetti, «legni storti», come diceva Kant. Il loro lavoro «scopre» le cose per tentativi ed errori. La conoscenza scientifica è dunque sempre provvisoria, valida fino a prova contraria. Ciò che dovrebbe succedere (una guarigione) non succede; accadono eventi non previsti, spesso indesiderati (una calamità). Solo gli scienziati possono tuttavia stabilire se e quando una prova contraria è decisiva per il destino di una teoria.
Grazie a Internet, ciascuno di noi può oggi farsi un’idea riguardo a qualsiasi fenomeno. È forte la tentazione di decidere da soli. Sulla Rete si trovano le tesi più incredibili. Negli Stati Uniti c’è un gruppo che sostiene che la terra in realtà sia piatta. I «terrapiattisti» si sono trasformati in un movimento, che ora si riunisce periodicamente in compagnia di pseudo-scienziati. Per ora, non fanno male a nessuno. Ma un conto è sostenere credenze false relativamente innocue. Un altro conto è danneggiare gli altri sulla base di opinioni dogmatiche, non suffragate da evidenza e ragionamento. Non solo su temi che riguardano la fisica o la medicina, ma anche l’immigrazione o le differenze razziali.
Nei dibattiti pubblici, soprattutto in televisione, il confronto fra due punti di vista si conclude talvolta con uno dei due interlocutori (spesso un Cinque Stelle) che liquida l’altro dicendo «è una sua opinione, io non sono d’accordo». In alcuni casi è davvero difficile procedere al di là delle opinioni. Ma per una grande quantità di temi c’è davvero modo di controllare come stanno le cose, di stabilire chi ha ragione. Un’abitudine ancor peggiore è fermare il confronto politico dicendo: se «quello» non è d’accordo con me, che ho vinto le elezioni, allora si candidi (pensiamo a Salvini). Un’assurdità. Come insegnava Bobbio, la verità non si decide a maggioranza. I cittadini di una democrazia possono deliberare su moltissime questioni. Ma l’idea che possa esistere un cittadino «totale», titolato a sottrarsi ad ogni forma di autorità basata sulla competenza invece che sulla maggioranza è l’anticamera della dittatura.
Torniamo al Patto sulla Scienza. Il testo richiama la politica a «legiferare» contro la pseudo-scienza. Se ciò che si chiede è l’adozione di norme che rafforzino la sfera scientifica e che leghino le mani ai politici nella presa di decisioni in certi ambiti delicati (ad esempio costringendoli a chiedere il parere degli scienziati e a tenerne adeguatamente conto), l’appello è ineccepibile. Non bisogna però mai affidare alla politica il ruolo di giudice nelle controversie scientifiche e nemmeno quello di scendere a compromessi incoerenti, come nel caso dell’«obbligo flessibile» alla dichiarazione vaccinale da parte dei genitori.
Il messaggio operativo più importante del Patto è quello che riguarda l’informazione e la scuola. È in queste due sfere che si deve imparare a usare correttamente il concetto di verità. Il che vuol dire una cosa semplice, ben riassunta già da Platone: verità è dire le cose come stanno. Pensare e parlare ricordando sempre che «là fuori» c’è una realtà ostinata e indipendente dalle nostre opinioni. E che può danneggiarci seriamente se ci illudiamo di poterla ignorare o peggio ancora piegare a nostro libero piacimento.
-
-
> Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!! --- Il lato matematico di Platone. Così Giovanni Reale recuperò i Greci (di D. Di Cesare).26 novembre 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA, ARITMETICA, E ANTROPOLOGIA. I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE ... *
DiscussioniIl lato matematico di Platone
Così Reale recuperò i Greci
Esce una raccolta di studi del grande antichista italiano, difensore dei classici contro la visione scientista e il disprezzo diffuso per la teoria. La concezione delle idee come principi numerici, il primato della dottrina non scritta
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, La Lettura, 25.11.2018, p. 11)
Nel Fedone Socrate si mostra assai deluso dall’indagine rivolta ai fenomeni naturali. Teme che pretendere di cogliere le cose con i cinque sensi finisca per accecare l’anima. Qui si compie il passaggio decisivo dal sensibile all’intellegibile, dal sapere che si accontenta dell’apparenza a quello che si innalza ai concetti
Nel corso degli anni Novanta, quando la filosofia analitica, quella che si concepisce come analisi logico-formale, aveva raggiunto il suo apice, c’era chi aveva cominciato a gettare discredito sul pensiero antico, nonché ovviamente sullo studio della lingua greca e di quella latina. A che pro studiare quel capitolo chiuso e concluso? Perché perdere tempo con Platone anziché risolvere i problemi attuali?
In quel delicato frangente, che ha lasciato segni evidenti altrove, Giovanni Reale (scomparso nel 2014) ha svolto in Italia un ruolo decisivo a difesa della filosofia classica. Ne è testimonianza il volume Storia della filosofia greca e romana che, appena pubblicato da Bompiani, raccoglie gli studi del grande antichista in un percorso suggestivo che va dai primi frammenti, risalenti almeno al VI secolo a.C., fino al decreto con cui l’imperatore bizantino Giustiniano chiuse nel 529 d.C. tutte le scuole dell’Impero guidate da pagani. Oltre mille anni di storia della filosofia narrati con perizia, sapienza, semplicità.
 Reale ha lavorato a quest’opera per quattro decenni, intendendola quasi come un commento e un supporto alla fortunata collana del «Pensiero occidentale», dove sono usciti in edizione italiana, con testo a fronte, numerosissimi classici.
Reale ha lavorato a quest’opera per quattro decenni, intendendola quasi come un commento e un supporto alla fortunata collana del «Pensiero occidentale», dove sono usciti in edizione italiana, con testo a fronte, numerosissimi classici.Il richiamo a Martin Heidegger è significativo. L’inizio greco non è destinato ad essere superato in grandezza dalle altre epoche. Al contrario: la filosofia dei Greci è la più grande. E la filosofia è prettamente greca. Perciò è peculiarità dell’Occidente; non esiste in altre tradizioni nulla di paragonabile. Da un canto Reale punta l’indice contro lo scientismo, che pretenderebbe di misurare la filosofia con i criteri della scienza, dall’altro denuncia il dilagante disprezzo per la «teoria» che non servirebbe alla vita pratica. Occorre guardare alla filosofia greca dove la teoria è una forma di prassi. Come sostiene Aristotele nella Politica, attivi al più alto grado sono coloro che esercitano un’attività di pensiero; tanto più che theoreîn non significa solo «vedere», ma anche «partecipare».
 Reale si riconosce nell’ermeneutica di Hans-Georg Gadamer che, rilanciando l’insegnamento di Heidegger, ribadiva l’attualità del pensiero greco. Erano gli anni in cui il conflitto con la filosofia analitica veniva letto secondo il paradigma: «Noi greci, loro moderni». Ma la ripresa della riflessione antica non è antiquaria. Se la filosofia è indissolubilmente legata alla sua storia, questa storia non segue la freccia del progresso. Ecco perché, nell’apertura circolare di un dialogo, ammette e, anzi, sollecita la partecipazione. Al contrario di quel che avviene nella scienza, le domande della filosofia sono sempre le medesime, solo poste in modo differente. In tal senso l’incontro con la filosofia greca è «l’incontro con noi stessi».
Reale si riconosce nell’ermeneutica di Hans-Georg Gadamer che, rilanciando l’insegnamento di Heidegger, ribadiva l’attualità del pensiero greco. Erano gli anni in cui il conflitto con la filosofia analitica veniva letto secondo il paradigma: «Noi greci, loro moderni». Ma la ripresa della riflessione antica non è antiquaria. Se la filosofia è indissolubilmente legata alla sua storia, questa storia non segue la freccia del progresso. Ecco perché, nell’apertura circolare di un dialogo, ammette e, anzi, sollecita la partecipazione. Al contrario di quel che avviene nella scienza, le domande della filosofia sono sempre le medesime, solo poste in modo differente. In tal senso l’incontro con la filosofia greca è «l’incontro con noi stessi».Nata nelle vie e nelle piazze della pólis, dove il cittadino è chiamato alla vita politica, la filosofia si sviluppa lungo il filo conduttore del lógos, del discorso, dell’argomentazione, della ragione. Ma per Reale ciò che contraddistingue la tradizione greca è la metafisica, quel modo di pensare oltre i dati sensibili della realtà presente. Ne scorge le tracce già nell’orfismo, in quella iniziale religiosità ascetica, che per la prima volta parla di un che di «divino», che alberga nel corpo umano, cioè l’anima, la psyché. La morte è una liberazione dalla prigione del corpo, un ritorno all’origine dopo le sofferenze patite in terra. Questa potente dottrina della trasmigrazione delle anime, scaturita dalla fantasia orfica, capace di dischiudere l’aldilà, si sarebbe poi innestata nel cristianesimo.
Protagonista del volume è Platone, in cui Reale riconosce il «vertice del pensiero antico». È stato infatti il primo filosofo a guardare la realtà con «nuovi occhi», quelli dell’anima. Reale ricorda la «seconda navigazione» descritta da Platone nel dialogo Fedone. A parlare è Socrate, deluso dall’indagine sui fenomeni naturali; il suo timore è che, seguendo coloro che si volgono immediatamente alle cose, pretendendo di coglierle con i cinque sensi, finisca per accecare la propria anima. Si prepara allora alla «seconda navigazione», metafora del linguaggio marinaresco, che indicava il caso in cui, non essendoci più vento, la nave poteva essere spinta solo dai remi.
 Questo è il passaggio decisivo dal sensibile all’intellegibile, dalla conoscenza che si accontenta dei sensi a quella che si innalza alle idee, intese da Platone come le «forme» delle cose. In questo varco metafisico sta per Reale il vero inizio della filosofia. Le idee sono principi formali, numerici, sono anzi numeri ideali.
Questo è il passaggio decisivo dal sensibile all’intellegibile, dalla conoscenza che si accontenta dei sensi a quella che si innalza alle idee, intese da Platone come le «forme» delle cose. In questo varco metafisico sta per Reale il vero inizio della filosofia. Le idee sono principi formali, numerici, sono anzi numeri ideali.Vale la pena ricordare che Reale aderì alla Scuola di Tubinga, le cui figure più significative furono Konrad Gaiser, Hans Krämer, e in seguito Thomas A. Szlezák. L’insegnamento di Platone non può essere confinato agli scritti, ma va ricercato piuttosto nella dottrina «non scritta» trasmessa, fra gli altri, anche da Aristotele.
 Ne risulta una filosofia sistematica e fortemente matematizzata, dove assume rilievo la riflessione sull’uno, ma soprattutto sul due - che cosa significa due? - sulla diade infinita, «principio e radice della molteplicità degli esseri». -Anche chi non ne condivida i contenuti, dovrà ammettere che questa interpretazione, di cui Reale è stato il maggior esponente in Italia, ha aperto nuove vie di ricerca.
Ne risulta una filosofia sistematica e fortemente matematizzata, dove assume rilievo la riflessione sull’uno, ma soprattutto sul due - che cosa significa due? - sulla diade infinita, «principio e radice della molteplicità degli esseri». -Anche chi non ne condivida i contenuti, dovrà ammettere che questa interpretazione, di cui Reale è stato il maggior esponente in Italia, ha aperto nuove vie di ricerca.L’ammirazione per Platone, il grande pioniere del soprasensibile, non impedisce a Reale di scrivere pagine eccellenti su Aristotele, dalla fisica all’etica, dalla logica alla poetica, ricostruendo la portata epocale del suo pensiero. Ma a segnare una cesura, capace di ripercuotersi sulla filosofia, è il tramonto definitivo della pólis nel tempo di Alessandro Magno. Al cittadino subentra il suddito e, mentre vengono meno le antiche passioni, ciascuno è rinviato a se stesso e alla propria individualità in un mondo dove l’etica si scinde dalla politica, come attestano le scuole filosofiche successive.
Il volume contiene un’ultima parte in cui, da Filone d’Alessandria ad Agostino d’Ippona, viene delineato l’incontro fra tradizione ebraica e filosofia platonica, da cui sarebbe scaturito il cristianesimo. Particolare risalto assumono anche le figure di Plotino e di Proclo.
 Viene prospettata allora una «terza navigazione», quella che non si ferma all’oltresensibile delle idee, alle forme immutabili, ma si apre agli imponderabili misteri della fede.
Viene prospettata allora una «terza navigazione», quella che non si ferma all’oltresensibile delle idee, alle forme immutabili, ma si apre agli imponderabili misteri della fede.
 Si legge qui in filigrana il cammino sia intellettuale sia autobiografico di Reale, molto improntato, in particolare negli ultimi anni, a un’ispirazione religiosa. L’oltre della metafisica, che riteneva di non trovare più nel mondo attuale, ha improntato la vita contemplativa di questo grande maestro.
Si legge qui in filigrana il cammino sia intellettuale sia autobiografico di Reale, molto improntato, in particolare negli ultimi anni, a un’ispirazione religiosa. L’oltre della metafisica, che riteneva di non trovare più nel mondo attuale, ha improntato la vita contemplativa di questo grande maestro.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- PER CARITÀ!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!! L’amore evangelico è "charitas", non "caritas"!!!
- UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> «Un dubbio sulle date, così ho trovato la lettera di Galileo»(Salvatore Ricciardo) ... Ritrovato l’autografo della celebre lettera galileiana inviata a Benedetto Castelli il 21 dicembre 1613, all’origine dello scontro con la Chiesa.23 settembre 2018, di Federico La Sala
L’italiano che ha scoperto il manoscritto a Londra. «Il complimento più bello? Dalla mia compagna»
«Un dubbio sulle date, così ho trovato la lettera di Galileo»
di Donatella Tiraboschi (Corriere della Sera, 23.09.2018)
Professore, cosa faceva alla biblioteca della Royal Society di Londra il 2 agosto?
«Quello che faccio sempre fin dai tempi del dottorato in Antropologia ed Epistemologia che ho conseguito all’Università di Bergamo nel 2011, e cioè ricerche. È una enorme miniera di scienza, manoscritti e lettere». Salvatore Ricciardo ha trovato qui la pepita d’oro della sua vita, l’originale lettera eretica di Galileo: il professore ha 40 anni, una laurea in filosofia all’Università di Milano ed è assegnista di ricerca per l’ateneo di Bergamo.
Emozionato?
«È il mio mestiere. Mi sono specializzato in Storia della Scienza nell’Inghilterra del 1600 e mi sono trovato tra le mani parecchi scritti autografi di secoli fa, in particolare di Robert Boyle, il chimico scettico, figura interessante, tanto che ci ho scritto un libro. Più che emozione, direi che mi è presa una certa eccitazione».
Ma come è arrivato a Galileo? Racconti la scoperta.
«Nell’ambito di un progetto nazionale di ricerca, la mia università ha in carico un segmento di approfondimento sulla diffusione delle sue teorie proprio nell’Inghilterra del ‘600. Quella mattina ho preso il mio pc e sono andato in biblioteca. Mi sono seduto in una delle 10 postazioni e ho digitato il nome di Benedetto Castelli, un monaco, fisico e matematico bresciano, il suo collaboratore numero uno. Si è aperto l’archivio on line con una “stringa”; una lettera datata 1613. Che strano mi sono detto. La Royal Society sarebbe stata fondata solo 47 anni dopo. Che ci fa qui una lettera di decine di anni prima? Anche la data di stesura era stata interpretata 21 ottobre, ma in realtà è stata scritta il 21 dicembre di quell’anno».
L’hanno riesumata per lei dagli archivi.
«Diamogli un’occhiata, ho pensato, magari è una delle copie già in circolazione, una di quelle 12 missive in versione edulcorata. Quando però mi hanno messo in mano quei sette fogli, ho avuto subito il sospetto che non si trattasse di una di quelle copie».
La scoperta era sotto i suoi occhi.
«Sì, ma io non me ne sono reso conto subito. Ho scattato foto e fatto scansioni. Poi ho chiamato il professor Franco Giudice a Bergamo. Guardi ho trovato questa lettera, magari è di Galileo, ma non ne sono sicuro».
Lei è uomo di scienza, servono prove certe.
«Prima della fine di agosto è arrivata la conferma. Ci siamo resi conto dalle perizie grafologiche e dalle varianti d’autore dell’autenticità del manoscritto».
Il senso del ritrovamento?
«Ci porta a rivedere l’interpretazione delle vicende che portarono alla messa all’indice del libro di Copernico e all’ammonizione di Galileo da parte del cardinale Bellarmino. Per secoli si pensò che Lorini avesse inoltrato al Sant’Uffizio una copia spuria della lettera inviata da Galileo a Castelli. In realtà l’autografo, al netto delle interpolazioni e cancellazioni, rivela che il testo della lettera inviata da Lorini ricalca l’originale stesura di Galileo».
Il più bel complimento?
«Quello della mia compagna. Sono un tipo insicuro, ma lei mi sprona: “fai sempre di testa tua che hai sempre fatto bene”».
Bella scoperta. Ritrovato l’autografo della celebre lettera galileiana inviata a Benedetto Castelli il 21 dicembre 1613, all’origine dello scontro con la Chiesa
L’autocensura di Galileo è riemersa a Londra
di Paolo Galluzzi
 Direttore del Museo Galileo (Il Sole-24 Ore, Domenica, 23.09.18
Direttore del Museo Galileo (Il Sole-24 Ore, Domenica, 23.09.18Di Galileo si pensa di conoscere ormai tutto o quasi. E con alle spalle una tradizione storiografica più di tre secoli, non ci si aspetta certo di trovare nuovi documenti che illumino episodi importanti delle sue vicende biografiche. Ma le ricerche d’archivio riservano talvolta sorprese, facendo riemergere testi che si consideravano irrimediabilmente perduti. Ed è proprio quello che è accaduto alcune settimane fa quando alla Royal Society Library di Londra è stato rinvenuto l’autografo della celebre Lettera di Galileo a Benedetto Castelli del 21 dicembre 1613. Un documento di inestimabile valore - la prima delle celeberrime Lettere Copernicane - che è in realtà un breve trattato in forma epistolare, nel quale Galileo espone per la prima volta la propria visione dei rapporti tra scienza e religione, rivendicando la piena autonomia della ricerca scientifica dalla teologia, e difende il sistema copernicano dalle accuse di inconciliabilità con la Sacra Scrittura.
La scoperta di questo autografo - una delle acquisizioni più rilevanti degli ultimi decenni per quanto attiene agli studi galileiani - è il frutto delle ricerche intraprese grazie al PRIN (Progetto di rilevante interesse nazionale) «Scienza e il mito di Galileo in Europa tra il XVII e il XIX secolo», finanziato dal MIUR e coordinato da Massimo Bucciantini dell’Università di Siena, che vede coinvolti studiosi di diverse università italiane in collaborazione con il Museo Galileo di Firenze.
 In tale contesto, l’unità locale dell’Università di Bergamo, responsabile delle indagini sulla fortuna di Galileo nell’Inghilterra del XVII secolo, ha incaricato Salvatore Ricciardo, assegnista in quell’Ateneo, di verificare se nelle edizioni di opere galileiane possedute da British Library e Royal Society fossero presenti glosse marginali, commenti o note di lettura.
In tale contesto, l’unità locale dell’Università di Bergamo, responsabile delle indagini sulla fortuna di Galileo nell’Inghilterra del XVII secolo, ha incaricato Salvatore Ricciardo, assegnista in quell’Ateneo, di verificare se nelle edizioni di opere galileiane possedute da British Library e Royal Society fossero presenti glosse marginali, commenti o note di lettura.Ricciardo ha notato che nel catalogo dei manoscritti della Royal Society era segnalata una lettera di Galileo a Castelli, datata 21 ottobre 1613. Ottenuto in consultazione il documento, si è accorto che la data in calce era diversa: 21 dicembre 1613, perfettamente coincidente con quella della lettera copernicana al Castelli. Vi ha inoltre verificato la presenza di numerose cancellature e correzioni della medesima mano. Ricciardo si è affrettato a inviarne una riproduzione fotografica a Franco Giudice e a Michele Camerota, responsabili rispettivamente delle unità locali dell’Università di Bergamo e di quella di Cagliari, oltre che direttori, insieme a Massimo Bucciantini, di «Galilaena», la rivista internazionale del Museo Galileo specializzata in studi galileiani. Dopo accurati controlli, anche di tipo grafologico, i tre studiosi sono giunti alla conclusione che la lettera della Royal Society è senza dubbio di mano galileiana.
L’esistenza di questo importantissimo documento non è stata mai segnalata in precedenza, nonostante fosse registrato nel catalogo dei manoscritti della Royal Society fin dal 1840, e sia indicato nel catalogo online della prestigiosa istituzione britannica. Finora la Lettera a Castelli era conosciuta soltanto attraverso copie manoscritte: i dodici testimoni collazionati da Antonio Favaro per l’edizione critica del documento pubblicata, nel 1895, nel quinto volume dell’Edizione Nazionale delle Opere di Galileo.
Il ritrovamento dell’autografo rappresenta molto più di una mera acquisizione documentaria, poiché obbliga a riconsiderare non solo la dinamica di stesura del testo, ma, soprattutto, la storia della sua immediata ricezione e la funzione decisiva che recitò nel motivare le autorità ecclesiastiche ad assumere un atteggiamento di risoluta opposizione nei confronti delle novità celesti galileiane. La Lettera a Castelli è infatti all’origine delle vicende che porteranno nel 1616 alla sospensione del De revolutionibus di Copernico e all’ammonizione del cardinale Bellarmino a Galileo ad abbandonare la dottrina copernicana.
L’autografo della Lettera permette di ricostruire anche il modo nel quale Galileo reagì alla notizia che la missiva al Castelli era finita nelle mani degli occhiuti censori. Vivamente preoccupato dalla vasta circolazione del documento, il 7 febbraio 1615, il domenicano fiorentino Niccolò Lorini ne aveva infatti inviata copia a Roma, denunciando come «sospette e temerarie» le teorie espostevi da Galileo; il quale - prese cura di sottolineare - «seguendo le posizioni di Copernico» ardiva presentare come vera un’opinione «in tutto contraria alle Sacre Lettere».
 Una settimana più tardi, Galileo inviò a Roma al fidato amico Monsignor Piero Dini la versione della Lettera redatta «nel modo giusto che l’ho scritta io», manifestando il sospetto che «forse chi l’ha trascritta può inavvertitamente aver mutata qualche parola», facendo «apparire le cose molto diverse dalla mia intenzione». Galileo chiese a Dini di far leggere la versione “autorizzata” della Lettera al matematico gesuita Christoph Grienberger e soprattutto al cardinale Bellarmino, il principale teologo del Sant’Uffizio.
Una settimana più tardi, Galileo inviò a Roma al fidato amico Monsignor Piero Dini la versione della Lettera redatta «nel modo giusto che l’ho scritta io», manifestando il sospetto che «forse chi l’ha trascritta può inavvertitamente aver mutata qualche parola», facendo «apparire le cose molto diverse dalla mia intenzione». Galileo chiese a Dini di far leggere la versione “autorizzata” della Lettera al matematico gesuita Christoph Grienberger e soprattutto al cardinale Bellarmino, il principale teologo del Sant’Uffizio.Rispetto agli altri testimoni pervenutici, la copia trasmessa a Roma da Lorini, conservata presso l’Archivio Segreto Vaticano (contrassegnata dalla sigla Pr), contiene un significativo numero di varianti, che evidenziano il ricorso a espressioni più dirette e perentorie sulla mancanza di autorità delle Scritture Sacre nelle questioni naturali. Favaro segnalò quelle varianti, ma, giudicando l’esemplare vaticano lontano dalla «lezione genuina», esemplò la propria edizione sugli altri testimoni. Esattamente come Galileo, Favaro sospettava che Lorini avesse interpolato il testo della Lettera per farne risaltare maggiormente le pericolose implicazioni teologiche.
L’autografo appena riemerso dal lungo oblio racconta una storia diversa. Anzi, capovolge i termini stessi della ricostruzione fin qui dominante. Le numerose parole e intere frasi cancellate ed emendate nel manoscritto della Royal Society trovano infatti corrispondenza speculare nella copia trasmessa a Roma da Lorini. A titolo di esempio, Galileo aveva originariamente scritto che la Bibbia contiene «molte proposizioni false quanto al nudo senso delle parole». Tale espressione, che ricorre tale e quale in Pr, venne successivamente sostituita da quella, meno censurabile teologicamente, tramandata dal resto della tradizione manoscritta: «molte proposizioni le quali, quanto al nudo senso delle parole, hanno aspetto diverso dal vero».
L’accurato esame dell’autografo induce a concludere che Pr rappresenta una copia fedele del testo inviato a Castelli da Galileo, il quale, venuto a conoscenza della denuncia, si preoccupò di moderare le espressioni che temeva potessero urtare la sensibilità degli inquisitori. Il documento della Royal Society impone dunque non solo di riconsiderare il processo di compilazione della Lettera a Castelli, ma getta nuova luce sulle vicende che nel marzo 1616 portarono alla condanna del copernicanesimo.
La scoperta fornisce solida base documentaria alla tesi formulata da Mauro Pesce in un saggio del 1992 apparso su «Filologia e critica», nel quale contestò che Pr fosse stato artatamente manipolato da Lorini. Pesce vi sostenne - oggi possiamo dire a ragione - che il codice dell’Archivio Segreto conteneva la copia fedele della stesura originaria della Lettera a Castelli modificata successivamente da Galileo. L’autografo spiega, tra l’altro, perché, nonostante le pressanti richieste degli inquisitori, Benedetto Castelli non consegnò mai l’originale della lettera galileiana in suo possesso: avrebbe infatti dovuto spedire ai censori un testo identico a quello trasmesso a Roma da Niccolò Lorini.
Camerota, Giudice e Ricciardo pubblicheranno a breve una nuova edizione critica e un dettagliato studio storico sull’autografo della Lettera a Castelli, che lascia intravedere promettenti prospettive di approfondimento delle ricostruzioni tradizionali dei drammatici eventi innescati dalla trasmissione alle autorità ecclesiastiche romane della copia della lettera galileiana del dicembre 1613.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... A Londra la lettera perduta di Galileo Galilei. Scoperta da Salvatore Ricciardo, giovane ricercatore dell’università di Bergamo22 settembre 2018, di Federico La Sala
Londra, ritrovata la lettera "eretica" di Galileo Galilei. "E’ l’originale"
La missiva considerata perduta è stata scoperta da un ricercatore italiano nella biblioteca della Royal Society. Del testo finora si conoscevano due copie, una delle quali con toni più soft. "Ora sappiamo che lo scienziato la riscrisse"
di ELENA DUSI e MARIA FRANCESCA FORTUNATO (la Repubblica, 21 settembre 2018)
Non era neanche troppo nascosta. La lettera perduta in cui Galileo Galilei mise giù le sue tesi contro l’idea, sostenuta dalla Chiesa, che fosse il Sole a ruotare intorno alla Terra, si trovava in una biblioteca di Londra. In possesso della Royal Society - la prestigiosa associazione scientifica britannica fondata il 28 novembre 1660 - da almeno due secoli e mezzo, era inspiegabilmente sfuggita all’attenzione degli storici per tutto questo tempo. É stata rintracciata e scoperta da Salvatore Ricciardo, giovane ricercatore dell’università di Bergamo che fra l’altro visitò il 2 agosto scorso con tutt’altri obiettivi. «Non potevo credere ai miei occhi - commenta il ricercatore - si trattava della lettera che tutti hanno cercato per oltre due secoli e non si nascondeva in un posto sperduto, ma proprio nella Royal Society Library».
La missiva considerata perduta è stata scoperta proprio da questo studioso nella biblioteca della Royal Society. Del testo sinora si conoscevano due copie, ma in nessuno dei due documenti la teoria galileiana che gli costò, il 22 giugno 1633 la condanna per eresia, l’abiura forzata delle sue concezioni astronomiche e infine il confino nella sua villa di Arcetri. Si tratta di una scoperta sensazionale perché dimostra che lo scienziato, vent’anni prima del processo, ribadì in modo più netto le sue teorie.
Il documento è scritto con la sanguigna, contiene qualche correzione ed è lunga sette pagine e firmata in calce G. G. Il padre della scienza moderna la indirizzò all’amico Benedetto Castelli, monaco cristiano e illustre matematico e fisico dell’università di Pisa.
In queste pagine Galileo sostiene per la prima volta che la ricerca scientifica deve essere libera dalla dottrina teologica. Una lettera che scatenò un putiferio, ma che si tinse anche di giallo.
Il testo venne inviato all’Inquisizione il 7 febbraio del 1615 dal frate domenicano Niccolò Lorini e la copia di quella lettera è custodita ora negli Archivi Segreti Vaticani. Una settimana dopo, Galileo scrisse anche all’amico Piero Dini, suggerendo che la versione spedita dal Lorini all’Inquisizione fosse stata alterata. Galileo allegò anche una versione «edulcorata» della lettera spedita a Castelli, presentandola come la versione originale, e gli chiese di farla avere ai teologi vaticani.
Scrivendo a Dini, Galileo - che nel 1633, dopo la pubblicazione del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, sarebbe stato processato e condannato per eresia - si lamentava della malvagità e dell’ignoranza dei suoi nemici e si diceva preoccupato che l’Inquisizione potesse essere ingannata “da questa truffa, coperta dal mantello dello zelo e della carità”.
Com’era andata davvero? Galileo affidò davvero all’amico Castelli il suo sfogo contro le ingerenze e le pressioni della Chiesa o qualcuno inviò una lettera falsa all’Inquisizione contro lo scienziato?
Il documento ritrovato da Ricciardo mostra che lo scienziato avrebbe corretto ed edulcorato le proprie parole, per evitare l’ira dell’Inquisizione. Il testo - Castelli a un certo punto aveva rimandato a Galileo la sua lettera - è puntellato da correzioni, con modifiche significative, come nota Nature, che ha anticipato la scoperta. In un punto, ad esempio, l’aggettivo “falso” attribuito ad “alcune affermazioni della Bibbia” è sostituito con un “appare diverso dalla verità”. Ma sotto le modifiche e le cancellature, il testo originale risulta proprio quello trasmesso da Lorini al Tribunale dell’Inquisizione.
Ricciardo, insieme al suo supervisore Franco Giudice e allo storico Michele Camerota dell’università di Cagliari, ha verificato l’originalità della lettera confrontando singole parole con altre simili scritte da Galileo nello stesso periodo. La scoperta è descritta in un articolo che sarà pubblicato sulla rivista Notes and Records della Royal Society.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. Cerchiamo di "non dare i numeri" --Woman as inventor”(1870): l’effetto Matilda raccontato da Ben Barres, scienziato transgender.26 agosto 2018, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DELLA FACOLTÀ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITÀ DELL’ "UOMO SUPREMO" ... *
L’effetto Matilda raccontato da Ben Barres, scienziato transgender
Un’attivista per i diritti delle donne vissuta alla fine dell’Ottocento, una storica della scienza e un importante neurobiologo. Il filo rosso che collega queste tre persone si chiama effetto Matilda.
di Simone Petralia (OggiScienza, 16 agosto 2018)
IPAZIA - Matilda Joslyn Gage è stata una femminista e una libera pensatrice statunitense. Nel corso della sua vita ha lottato per il suffragio femminile, per i diritti dei nativi americani e per l’abolizione della schiavitù. “Woman as inventor”, un suo breve saggio del 1870, è al tempo stesso un elogio dell’inventiva femminile e una denuncia lucida e argomentata delle discriminazioni e delle disparità di trattamento a causa delle quali il talento delle donne è spesso calpestato o non riconosciuto.
- [Foto] Da sinistra a destra: Matilda Joslyn Gage, la prima pagina di “The Matilda effect in Science”, il paper di Margaret W. Rossiter pubblicato su “Social Studies of Science” Vol. 23 (1993) e Ben Barres, neurobiologo della Stanford University
L’effetto Matilda: cos’è
La comunità scientifica, si sa, non è esente da pregiudizi. A parità di abilità e conoscenze, per esempio, uno scienziato famoso godrà di maggior credito rispetto a un ricercatore poco noto. Nel 1968, il sociologo Robert K. Merton ha definito questa forma di discriminazione “effetto san Matteo”, dal verso attribuito all’evangelista: “a chiunque ha, sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha” (Mt 13, 12). Prendendo spunto dal lavoro di Merton e dal saggio di Matilda Joslyn Gage, nel 1993 la storica della scienza Margaret W. Rossiter ha sviluppato il concetto di “effetto Matilda”.
L’effetto Matilda indica la tendenza a sottovalutare o a sminuire i risultati scientifici conseguiti dalle donne. È stato dimostrato che le ricerche condotte da scienziate suscitano in media meno interesse e vengono citate con minor frequenza rispetto a lavori analoghi realizzati da uomini; quando l’importanza di una scoperta compiuta da una donna è innegabile, invece, questa viene spesso attribuita a un collega maschio. L’effetto Matilda ha segnato la carriera di molte grandi scienziate - da Nettie Stevens a Rosalind Franklin, da Cecilia Payne Gaposchkin a Wu Jianxiong - le quali spesso si sono viste negare un premio Nobel che sarebbe spettato loro di diritto; ma a subirne gli effetti sono state e sono tuttora anche migliaia di ricercatrici sconosciute che vedono il loro lavoro ignorato o svilito a causa di questo pregiudizio.
Il punto di vista di Ben Barres
“Ho vissuto nei panni di una donna e in quelli di un uomo. Questo mi ha dato la possibilità di riflettere sulle barriere che le donne devono affrontare”. Sono parole di Ben Barres, neurobiologo americano. Morto prematuramente nel dicembre del 2017, Barres è ricordato soprattutto per le sue importanti ricerche sul modo in cui le cellule gliali contribuiscono alla formazione e allo sviluppo dei neuroni. È stato uno scienziato di successo, ma - da uomo transgender - anche un alfiere della causa LGBTQ+, sempre in prima linea per il raggiungimento della parità dei diritti di tutte le minoranze.
 Barres ha effettuato la transizione dal genere femminile a quello maschile nel 1997, quando aveva 42 anni e lavorava già da tempo alla Stanford University. Nel corso della sua vita ha avuto quindi la possibilità di toccare con mano le piccole e grandi differenze nel modo in cui solitamente ci si relaziona a un altro essere umano, a seconda che lo si percepisca come un uomo o come una donna. Soprattutto ha vissuto sulla sua pelle, per anni, ciò che per la maggior parte degli uomini è pura teoria: l’effetto Matilda.
Barres ha effettuato la transizione dal genere femminile a quello maschile nel 1997, quando aveva 42 anni e lavorava già da tempo alla Stanford University. Nel corso della sua vita ha avuto quindi la possibilità di toccare con mano le piccole e grandi differenze nel modo in cui solitamente ci si relaziona a un altro essere umano, a seconda che lo si percepisca come un uomo o come una donna. Soprattutto ha vissuto sulla sua pelle, per anni, ciò che per la maggior parte degli uomini è pura teoria: l’effetto Matilda.Nel corso di una conferenza tenutasi nel gennaio del 2005, Lawrence Summers - importante economista, all’epoca presidente della Harvard University - aveva sostenuto che la scarsa presenza femminile in certi ambiti scientifici, come la matematica o l’ingegneria, è da imputare a una caratteristica innata delle donne, la mancanza di una attitudine intrinseca alla scienza. Poco tempo dopo anche lo psicologo cognitivo Steven Pinker e il biologo Peter Lawrence avevano formulato ipotesi analoghe. Quella del determinismo sessuale è un’idea che, in forme e con sfumature differenti, viene riproposta periodicamente. Alcuni scienziati e intellettuali - tra cui il nostro Piergiorgio Odifreddi - sostengono ancora oggi che la difficoltà che le donne hanno a emergere in certe discipline, come la matematica, sia dovuta al fatto che non sono biologicamente portate per l’astrazione.
Nel luglio del 2006, a distanza di alcuni mesi dalle esternazioni Summers e degli altri studiosi, esce su Nature un lungo articolo in cui Barres espone il suo punto di vista sulla questione. La domanda a cui cerca di rispondere è evidente sin dal titolo: “Does gender matter?”, il genere condiziona davvero le performance in ambito scientifico? La risposta è molto chiara: sì. Il genere conta, dice Barres, non tanto perché le donne abbiano caratteristiche innate che le rendono meno capaci degli uomini, quanto piuttosto per l’assunzione sociale che le donne siano per natura meno capaci. In altre parole, a condizionare i risultati scientifici femminili è proprio l’effetto Matilda.
Barres ha la possibilità di replicare alle affermazioni di Summers e degli altri sostenitori dell’innatismo biologico non da un punto di vista puramente teorico, ma rifacendosi alle sue esperienze personali. Avendo vissuto la prima parte della sua vita da donna, ha toccato con mano il sessismo strisciante e ha poi potuto paragonarlo al trattamento successivo riservatogli in quanto uomo. Quando studiava al MIT, racconta, era stata l’unica persona della sua classe - composta soprattutto da ragazzi - a risolvere un complesso problema matematico; il professore, non si sa se per gioco o sul serio, le aveva detto che a risolverlo doveva essere stato il suo fidanzato. Durante il dottorato ad Harvard aveva fatto domanda per un posto all’università; i candidati erano solo due: lei, che all’attivo aveva sei importanti pubblicazioni, e un uomo che aveva pubblicato un solo paper. Venne scelto il candidato maschile. Poco dopo la transizione, un membro della facoltà che aveva assistito a un seminario di Barres non sapendo che fosse transgender, aveva detto che le sue ricerche erano con ogni evidenza superiori a quelle della sorella. Aveva letto le pubblicazioni precedenti di Barres, firmate col nome femminile, senza capire che si trattava della stessa persona; il solo fatto che a scriverle fosse stata una donna era bastato a modificare, in peggio, la sua percezione sulla qualità complessiva del lavoro.
Nel suo articolo, oltre a raccontare episodi legati alla sua storia personale, Barres dimostra la pervasività dell’effetto Matilda ricorrendo anche ai dati. Numerose statistiche, infatti, dimostrano come il pregiudizio di genere sia un potente bias, una vera e propria distorsione cognitiva che condiziona il modo in cui si giudicano le persone. Questo avviene in tutti gli ambiti, anche in un contesto apparentemente evoluto e razionale come quello scientifico. Le donne che fanno domanda di finanziamento per le loro ricerche, per esempio, devono essere 2.5 volte più produttive degli uomini per essere considerate egualmente competenti.
Altri studi sulle minoranze
Altri studi dimostrano come il pregiudizio riguardi, oltre che le donne, anche tutte le persone appartenenti a minoranze di qualche tipo, sia etniche che legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Sembra che l’unico modo per tenersi al riparo da questo bias sia essere maschi, bianchi, cisgender - cioè non transgender - e ovviamente eterosessuali. “La gente che non sa che sono transgender”, scrive Barres nel suo articolo, “mi tratta con molto più rispetto. Posso persino completare un’intera frase senza essere interrotto da un uomo”. Le persone riconosciute come transgender, invece, devono affrontare pregiudizi analoghi a quelli delle donne, soprattutto coloro che affrontano un percorso di transizione contrario rispetto a quello di Barres, ovvero dal genere maschile a quello femminile; passaggio percepito da molti, in maniera più o meno inconscia, come una sorta di “declassamento sociale”.
Tornando all’effetto Matilda, Barres nota come siano in pochi ad ammettere che si tratti di un problema reale del mondo scientifico. Non solo quasi tutti gli uomini sono inconsapevoli dei loro privilegi, ma anche molte donne sembrano essere riluttanti a riconoscere il peso reale della discriminazione di genere. Questo per varie ragioni, tra cui un fenomeno noto come “rifiuto dello svantaggio personale”, per cui le donne confrontano i loro risultati solo con quelli ottenuti da altre donne, escludendo gli uomini e inserendosi implicitamente in una categoria a parte.
Sono molte le cose che si potrebbero fare per contrastare l’effetto Matilda. In primo luogo, sostiene Barres, evitare di far sentire le ragazze - a scuola, in famiglia e in qualsivoglia contesto - non all’altezza dei loro coetanei maschi o non adatte a intraprendere una carriera scientifica; a lanciare segnali di questo tipo sono, in maniera il più delle volte inconsapevole, gli stessi genitori o gli insegnanti. Occorre poi che la comunità scientifica lavori per migliorare l’equità nei processi di selezione e per dare sempre più posizioni di leadership alle donne e a persone appartenenti a minoranze. “La diversità fornisce un punto di vista più ampio, più sensibilità e maggior rispetto per le diverse prospettive, valori inestimabili in qualsiasi ambito”. Serve, infine, riconoscere che il problema esiste. Non voltarsi dall’altra parte, ma parlare, esporsi, raccontare quello che si è subito e non vergognarsi - mai - di essere chi si è. Seguire, insomma, l’esempio di Ben Barres.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
FILOSOFIA, E TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA....
 LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER (COME RATZINGER) A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG.
LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER (COME RATZINGER) A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG.- SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. -- Siamo tutti figli dei numeri. Parla l’antropologo, Caleb Everett, che ha studiato le società primitive che non ne fanno uso21 agosto 2018, di Federico La Sala
ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti"? ..... *
Antropologia.
Caleb Everett: Siamo tutti figli dei numeri
Sono fondamentali per lo sviluppo della civiltà, delle relazioni umane e della coscienza di sé. Parla l’antropologo che ha studiato le società primitive che non ne fanno uso
di Eugenio Giannetta (Avvenire, mercoledì 15 agosto 2018)
Che ore sono? Quanto è alto? Quanto pesa? Domande semplici, che richiedono una risposta semplice, perlopiù racchiusa in un numero. Eppure ci sono società, popoli diversi dal nostro, che vivono senza i numeri per come li conosciamo e utilizziamo quotidianamente. Tutto ciò è al centro del lavoro di Caleb Everett, docente di Antropologia all’Università di Miami, che ha ripercorso le tappe dell’invenzione dei numeri: «Un insieme fondamentale di innovazioni di carattere linguistico che hanno contraddistinto la nostra specie in modi che non hanno trovato adeguato riconoscimento».
I numeri in effetti sono un’invenzione umana che di fatto ha trasformato l’evoluzione della nostra esperienza, a partire appunto da domande semplici.
 «Nella popolazione Munduruku dell’Amazzonia - spiega Everett -, non esistono parole esatte per i numeri superiori al ’due’. Nel caso di un altro popolo amazzonico, i Piraha, le parole per indicare i numeri non esistono affatto, nemmeno per il numero 1. Gli individui di queste popolazioni come fanno allora a rispondere alla domanda ’quanti anni hai?’, o ad altre domande che si basano sul concetto di numero e che per la maggior parte delle persone della nostra società riguardano aspetti fondamentali della vita?». Everett ricorda come i numeri siano protagonisti nel nostro presente, ma anche nel nostro passato, poiché segnano la cronologia degli eventi e la percezione del trascorrere del tempo. La sua analisi, però, non si limita a questo, tocca infatti altri aspetti, come quello simbolico, le concezioni numeriche di bambini in età pre-linguistica e le capacità numeriche di alcune specie animali.
«Nella popolazione Munduruku dell’Amazzonia - spiega Everett -, non esistono parole esatte per i numeri superiori al ’due’. Nel caso di un altro popolo amazzonico, i Piraha, le parole per indicare i numeri non esistono affatto, nemmeno per il numero 1. Gli individui di queste popolazioni come fanno allora a rispondere alla domanda ’quanti anni hai?’, o ad altre domande che si basano sul concetto di numero e che per la maggior parte delle persone della nostra società riguardano aspetti fondamentali della vita?». Everett ricorda come i numeri siano protagonisti nel nostro presente, ma anche nel nostro passato, poiché segnano la cronologia degli eventi e la percezione del trascorrere del tempo. La sua analisi, però, non si limita a questo, tocca infatti altri aspetti, come quello simbolico, le concezioni numeriche di bambini in età pre-linguistica e le capacità numeriche di alcune specie animali.È un lavoro antropologico tout court, che attraversa la storia dei numeri e del linguaggio, e che ne definisce appunto il tratto numerico e il valore della quantità, a partire da misurazioni primitive, quindi da unità di misura indicate inizialmente con parti del corpo umano, fino a un diverso e più sviluppato livello di astrazione. Il risultato finale di queste ricerche, che hanno portato Everett in Amazzonia e Nicaragua,- è il saggio I numeri e la nascita della civiltà. Un’invenzione che ha cambiato il corso della storia (Franco Angeli, pagine 282, euro 25), di cui abbiamo parlato con l’autore, la cui tesi, riferita già dal prologo del volume, rivela come i numeri abbiano nel tempo consentito una fioritura di tecnologie materiali e comportamentali:
 «Nella vita quotidiana ci affidiamo a conoscenze che non sono propriamente nostre, che possiamo ricavare dalle menti altrui, e che in molti casi sono state acquisite casualmente e in modo violento nel corso dei millenni. Pensate ad alcuni esempi della vostra cultura: non avete dovuto inventare l’automobile, gli impianti di riscaldamento o il modo più efficiente per sfilettare il pollo: sono tecnologie e comportamenti che avete ereditato. Le vostre azioni sono state modellate attraverso gli altri e siete stati educati ai vostri comportamenti, sia in modo formale che informale, attraverso il linguaggio».
«Nella vita quotidiana ci affidiamo a conoscenze che non sono propriamente nostre, che possiamo ricavare dalle menti altrui, e che in molti casi sono state acquisite casualmente e in modo violento nel corso dei millenni. Pensate ad alcuni esempi della vostra cultura: non avete dovuto inventare l’automobile, gli impianti di riscaldamento o il modo più efficiente per sfilettare il pollo: sono tecnologie e comportamenti che avete ereditato. Le vostre azioni sono state modellate attraverso gli altri e siete stati educati ai vostri comportamenti, sia in modo formale che informale, attraverso il linguaggio».
 Riflessioni, quelle dell’autore, che sono il risultato di un approfondimento capillare di ulteriori studi condotti da archeologi, linguisti e psicologi, che negli ultimi anni hanno provato a mostrare come i numeri siano un’invenzione in primo luogo linguistica, spesso creati a partire dalla parola mano, che ha consentito di definire le quantità con minore approssimazione. Un passaggio non distante, ad esempio, da quanto accadde con l’invenzione delle parole per definire i colori.
Riflessioni, quelle dell’autore, che sono il risultato di un approfondimento capillare di ulteriori studi condotti da archeologi, linguisti e psicologi, che negli ultimi anni hanno provato a mostrare come i numeri siano un’invenzione in primo luogo linguistica, spesso creati a partire dalla parola mano, che ha consentito di definire le quantità con minore approssimazione. Un passaggio non distante, ad esempio, da quanto accadde con l’invenzione delle parole per definire i colori.Proviamo a immaginare: che cosa potrebbe accadere a una popolazione che si ritrovasse improvvisamente senza numeri?
«Ci vorrebbe molto tempo, a meno che non siano stati cancellati anche dalla mente delle persone, oltre che dalla lingua parlata e scritta. Ma presumendo che siano magicamente scomparsi, dovremmo lottare per gestire molte delle tecnologie che ci circondano, che richiedono una certa consapevolezza di quantità precise. Ad esempio, non saremmo in grado di comunicare il tempo in modo preciso, il che avrebbe un impatto su qualsiasi altra cosa. Le popolazioni anumeriche, o quelle con pochi numeri, non tengono traccia di cose come ore, minuti e secondi».
Senza i numeri, come sarebbe la nostra vita?
«Senza numeri le nostre vite sarebbero probabilmente molto più simili a quelle delle persone di cui parlo nel libro. Probabilmente saremmo cacciatori, raccoglitori e non indu-strializzati, dal momento che sia l’agricoltura che l’industrializzazione si basano sugli strumenti concettuali che chiamiamo numeri».
I suoi genitori erano missionari e si sono occupati della traduzione della Bibbia in varie lingue, cosa che le ha dato la possibilità di passare molto tempo tra le tribù dell’Amazzonia. La sua esperienza da bambino in quei luoghi e con quelle culture ha ispirato questo lavoro?
«Certamente, mi ha dato un’esperienza di prima mano con un gruppo di persone che non ha numeri, che alla fine mi ha portato a interessarmi a questo argomento, come ricercatore, anni dopo».
È possibile che cambi la cultura numerica di una popolazione?
«Le culture numeriche cambiano continuamente. Basta considerare quanto sia cambiata la cultura numerica dell’Europa, o più specificamente la regione che ora è l’Italia. Durante l’impero romano fu usato un insieme di numeri completamente diverso, che aveva alcuni svantaggi rispetto al sistema numerico indù-arabo che ora usiamo. Fibonacci lo riconobbe nel XIII secolo e, in parte per via del suo lavoro, i numeri che ora usiamo arrivarono alla diffusione in tutto il mondo. E hanno svolto un ruolo importante nella rivoluzione scientifica».
Nella nostra epoca numeri e dati sono sempre più importanti, basti ragionare sul concetto di big-data. Quanto emerge questo aspetto dal suo lavoro?
«Faccio ricerche anche su altri argomenti, ad esempio sui suoni prodotti dagli esseri umani. E questa ricerca richiede l’utilizzo di big data. In un recente lavoro con migliaia di linguaggi, ad esempio, il mio lavoro suggerisce che il clima potrebbe influire sul modo in cui le lingue evolvono».
È possibile pensare a numeri scollegati dalla loro rappresentazione linguistica?
«Potrebbe essere possibile, ma possiamo dire con certezza che, prima di essere annotati o espressi in altri modi non verbali, in ogni cultura i numeri venivano prima pronunciati».
C’è una differenza tra tradizione orale e scritta riguardo ai numeri?
«La tradizione orale ha il primato, ma tornando a Fibonacci, ad esempio, i numeri che ha introdotto avevano una storia diversa rispetto ai numeri parlati italiani»
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
- IMPARARE A CONTARE! ODIFREDDI CHIEDE A "CACCIARI, SOGNO O SON DESTO?". MA CONTINUA A ’DORMIRE’, NELLA SUA POSIZIONE PREFERITA! Sul problema dell’Uno e dei Molti (e, con esso, anche quello dei "tre anelli" - o delle "tre carte") le sue considerazioni, con alcune note
CHI SIAMO NOI IN REALTA’? Relazioni chiasmatiche e civiltà: UN NUOVO PARADIGMA.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA... Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"! - Fede e numeri: il metodo di Newton e la tesi di Rob Iliffe.12 agosto 2018, di Federico La Sala
RIVOLUZIONE SCIENTIFICA, STORIOGRAFIA, E DEMOCRAZIA. LA VITTORIA DI GALILEO NON SOLO E’ SCIENTIFICA, MA è ANCHE VITTORIA TEOLOGICA E POLITICA....*
La tesi di Iliffe
Fede e numeri: il metodo di Newton laico devoto
di Stefano Gattei (Corriere della Sera, La Lettura, 12.08.2018)
Che Isaac Newton (1642-1727) fosse profondamente religioso è noto. Che avesse studiato alchimia, teologia e le profezie bibliche, e che avesse approfondito la cronologia antica, non lo è altrettanto, anche se gli studiosi lo considerano ormai un dato acquisito («la Lettura» #69 ne scrisse il 10 marzo 2013). Per anni, tuttavia, gli ammiratori dei Principia mathematica o dei lavori sul calcolo infinitesimale hanno faticato a riconciliare ambiti di ricerca così apparentemente lontani, tanto che non pochi studiosi hanno avanzato l’ipotesi che gli interessi religiosi e pseudoscientifici del grande scienziato (molti dei quali affidati a manoscritti pubblicati dopo la morte) risalissero agli ultimi anni della sua vita, costituendo quindi un sorta di prodotto «senile» del genio.
Nel suo ultimo studio sullo scienziato inglese (Priest of Nature: The Religious Worlds of Isaac Newton, Oxford University Press, 2017) Rob Iliffe mostra l’infondatezza di tale lettura. Professore a Oxford, e direttore del Newton Project, Iliffe prende ferma posizione contro quanti hanno inteso sostenere che gran parte delle ricerche newtoniane siano il residuo imbarazzante di superstizioni.
Parallelamente al racconto della vita dello scienziato, Iliffe ricostruisce come Newton abbia gestito il difficile rapporto tra la propria immagine pubblica e le sue credenze religiose, e ne esplora gli scritti meno noti, soffermandosi sulle idee in tema di creazione del mondo e di Apocalisse, e analizzando la sua tesi che le dottrine centrali del cristianesimo (in particolare sulla Trinità) non fossero che mostruosa idolatria, perversioni sataniche della vera religione.
Agli occhi di Iliffe, non solo le convinzioni religiose di Newton permeano le sue prime ricerche scientifiche, ma le tecniche da lui impiegate per smascherare la corruzione della dottrina cristiana delle origini sono simili a quelle utilizzate per confutare le tesi degli avversari in ambito scientifico. Per Iliffe, Newton è stato un laico devoto che ha messo al centro della propria riflessione la libertà e l’indipendenza del pensiero.
Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:
- PIANETA TERRA: DOPO COPERNICO, UNA RIVOLUZIONE GENERALE."VICISTI, GALILAEE"! PER KEPLERO (1611), COME PER KANT, LA VITTORIA DI GALILEO NON SOLO E’ SCIENTIFICA, MA E’ ANCHE VITTORIA TEOLOGICA E POLITICA!!!
MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO.
- Atomi e coscienza (di Paul K Feyerabend, Atoms and consciousness, «Common Knowledge», 1, 28-32, 1992).
LA VIA DI KANT: USCIRE DAL MONDO, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI "DIO", CONCEPITO COME L’“UOMO SUPREMO”! La “Prefazione” della “Storia universale della natura e teoria del cielo”. Note per una rilettura
L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI: L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" DEI "VISONARI" DELLA TEOLOGIA POLITICA ATEA E DEVOTA. Note per una rilettura della "Critica della Ragion pura" (e non solo)
Federico La Sala
-
> GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... Pio Paschini, ovvero la verità, sempre. "L’epistolario" e la censura della sua «Vita di Galileo» (di Stefano Damiani).26 luglio 2018, di Federico La Sala
IL «CASO GALILEO»: LA «VITA DI GALILEO» DI PIO PASCHINI ... *
Pubblicato l’epistolario che ricostruisce la personalità del grande storico friulano
Paschini, ovvero la verità, sempre
di Stefano Damiani *
Iniziativa dell’Istituto a lui intitolato. Emergono la novità e il rigore del suo metodo basato sulle fonti, ma anche l’amarezza per la censura della sua «Vita di Galileo»
IL RITRATTO DI UNO storico, ma anche uomo, sacerdote e insegnante, che ha fatto della lettura fedele delle fonti la base del suo lavoro di ricerca della verità, tra successi, battaglie ed anche qualche amarezza. Così la figura dello storico friulano Pio Paschini emerge dal suo epistolario che è giunto in questi giorni a pubblicazione e che sarà presentato martedì 5 giugno nella sala Paolino d’Aquileia, a Udine. Ad impegnarsi nell’impresa l’Istituto «Pio Paschini» per la Storia della Chiesa in Friuli, che appunto dal grande storico prende il nome e che, come spiega il presidente dell’Istituto, Cesare Scalon, ha scelto di celebrare in questo modo i suoi 40 anni di attività.
Curata da Michela Giorgiutti ed edita da Forum nella collana di «Fonti per la storia della Chiesa in Friuli. Serie moderna e contemporanea», la pubblicazione consta di due volumi che contengono un’antologia di 922 testi, 491 selezionati tra quelli inviati da oltre millecinquecento corrispondenti e 431 fra missive e responsive intercorse con il friulano Giuseppe Vale, confratello, amico e confidente. Allegato ai volumi, c’è un cd rom con i regesti di tutte le 5.029 lettere dell’epistolario.
- Emerge il Paschini storico, ma anche uomo e sacerdote, facendoci cogliere i riflessi del mondo ecclesiastico in cui viveva e della realtà politica del suo tempo
Nato a Tolmezzo nel 1878 e morto a Roma il 14 dicembre del 1962, mons. Pio Paschini è stato insegnante nel Seminario di Udine dal 1901 al 1913, docente di Storia ecclesiastica al Pontificio Seminario Romano Maggiore e, dal 1932 al 1957, Magnifico rettore della Pontificia Università Lateranense. Enorme la sua produzione scientifica (sono circa 500 i titoli della sua bibliografia) che ruota attorno a due filoni principali: la storia del Friuli e la storia del Cinquecento religioso in Italia.
L’epistolario fa luce sull’intera parabola umana e scientifica dello storico, dalla prima lettera, del 1898, all’ultima, scritta pochi mesi prima di morire, nel 1962. I testi delle lettere si trovano in diversi Archivi e Fondi archivistici. Come spiega la curatrice Michela Giorgiutti, la maggior parte delle lettere è conservata nella Biblioteca «P. Bertolla» del Seminario Arcivescovile di Udine, dov’è arrivata grazie ad alcune donazioni, la prima quella della sorella di Paschini, Anna; altre due recentissime, ovvero il nucleo «Caterina Moretti», dal nome della governante di Paschini a Roma, e il nucleo «Annapia Mazzanti», dal nome dell’erede di una cugina di Paschini.
«Le lettere sono rivolte ai corrispondenti più vari - prosegue Giorgiutti - oltre agli interlocutori di ambito locale, come gli arcivescovi Zaffonato, Nogara, Rossi, gli storici e archeologi, come Giovani Battista Brusin e Piersilverio Leicht, ci sono anche personalità di livello internazionale: i futuri papi Angelo Roncalli e Giovanni Battista Montini, storici del calibro di Agostino Gemelli o Louis Duchesne. In esse - prosegue Giorgiutti - emerge una prospettiva completa sui caratteri del Paschini storico, ma anche uomo e sacerdote, facendoci cogliere i riflessi del mondo ecclesiastico in cui viveva e della realtà politica del suo tempo: la Prima Guerra Mondiale, che descrive dai racconti dei seminaristi al fronte e che lo lascia sbigottito, il fascismo, che guarda con distacco, il dopoguerra, la ricostruzione».
Che personalità di Paschini emerge dalle lettere? «Sfaccettata - risponde mons. Sandro Piussi, direttore della Biblioteca “P. Bertolla” e degli Archivi e Biblioteche storiche dell’Arcidiocesi di Udine, il quale ha scritto la prefazione e seguito la ricerca -. Ci sono le lettere del periodo giovanile quando egli ha dovuto superare le critiche per la sua nuova impostazione di ricerca che mirava al vero, perché utilizzava documenti e fonti, senza volersi piegare a dimensioni tradizionaliste e apologetiche relativamente alle origini Marciane del Cristianesimo aquileiese. Ci sono poi le lettere legate alla costruzione di quel monumento che è la sua “Storia del Friuli”. Dalle lettere dei suoi interlocutori emerge poi il riconosci- mento che gli veniva attribuito a livello internazionale in virtù del metodo storico critico».
L’epistolario, infine, ci restituisce anche informazioni sull’episodio che più fece soffrire il Paschini, ovvero il cosiddetto «Caso Galileo». Nel 1942, infatti, il Paschini ricevette dalla Pontificia Accademia delle scienze l’incarico di scrivere una vita dello scienziato. L’opera venne bloccata dal Sant’Uffizio perché considerata troppo dura nel condannare l’azione svolta dai Gesuiti contro Galileo. L’autore però non ebbe mai chiarimenti su tale insabbiamento.
- Nel 1942 ricevette dalla Pontificia Accademia delle scienze l’incarico di scrivere una vita di Galileo, bloccata poi dal Sant’Uffizio perché considerata troppo dura nel condannare l’azione dei Gesuiti contro lo scienziato.
Il testo venne poi pubblicato nel 1964, due anni dopo la morte di Paschini, a sua firma, ma non nella versione originale, bensì con numerose modifiche del gesuita Edmond Lamalle, che ne stravolsero il senso. E proprio in questa versione l’opera venne citata negli atti del Concilio Vaticano II, in particolare nella «Gaudium et Spes», ed utilizzata paradossalmente, ricorda il prof. Gianpaolo Romanato che su questo tema interverrà alla presentazione, «proprio nel punto in cui si afferma che la Chiesa ha sempre sostenuto la libertà di ricerca e che nella tradizione ecclesiastica non ci sono mai stati interventi censori».
La questione venne portata alla luce per la prima volta in un convegno dedicato a Paschini nel 1978 a Udine, in cui il bibliotecario Pietro Bertolla denunciò le interpolazioni che erano stati apportate al testo originale nella pubblicazione.
 Ne nacque un «Caso Galileo», successivamente ripreso, ricorda Piussi, «da Paolo Simoncelli con un’impostazione molto combattiva e polemica, e dopo, nel 2012, da Mario Sensi, docente alla Pontificia Università Lateranense, il quale ha evidenziato le carenze del “Galileo” di Paschini, dovute al non essere egli un professionista della Scienza, cosa che lo stesso autore, per altro aveva ammesso». In sostanza, Sensi evidenziò come il giudizio di Paschini sulla vicenda della condanna di Galileo fosse in un certo senso antistorico.
Ne nacque un «Caso Galileo», successivamente ripreso, ricorda Piussi, «da Paolo Simoncelli con un’impostazione molto combattiva e polemica, e dopo, nel 2012, da Mario Sensi, docente alla Pontificia Università Lateranense, il quale ha evidenziato le carenze del “Galileo” di Paschini, dovute al non essere egli un professionista della Scienza, cosa che lo stesso autore, per altro aveva ammesso». In sostanza, Sensi evidenziò come il giudizio di Paschini sulla vicenda della condanna di Galileo fosse in un certo senso antistorico.In ogni caso, le critiche alla validità scientifica dell’opera nulla tolgono alla scorrettezza del comportamento che fu tenuto nei confronti dello storico friulano, «al quale - evidenzia Piussi - per vent’anni non fu data ragione della mancata pubblicazione». E proprio l’epistolario dà testimonianza dell’amarezza con cui lo storico visse questa vicenda.
In una lettera del 1946 a Giovanni Battista Montini, allora sostituto alla Segreteria di Stato, così Paschini si esprime: «In tutte le mie pubblicazioni mi sono proposto di procedere colla più assoluta imparzialità, e perciò mi è riuscito di sommo stupore e disgusto che mi sia rivolta ora l’accusa di non aver fatto altro che l’apologia di Galileo. Essa intacca infatti la mia probità scientifica di studioso e di insegnante, il quale in tutto il corso della sua attività pubblicitaria e scolastica può dire di essersi sempre proposto come dovere lasciar parlare la verità e di liberarla da ogni ingombro creato dall’ignoranza o dallo spirito di parte». STEFANO DAMIANI
*
Presentazione i due volumi de «L’epistolario di Pio Paschini (1898-1962)» saranno presentati martedì 5 giugno, alle ore 18, nella sala Paolino di Aquileia, in via Treppo 5/B, a Udine. Dopo il saluto delle autorità interverranno Bernard Ardura, presidente del Pontificio Comitato di Scienze storiche, Andrea Zannini, del- l’Università di Udine, Gianpaolo Romanato, dell’Università di Padova. Nel corso della presentazione Fabiano Fantini leggerà alcuni brani dell’epistolario.
 La pubblicazione, edita da Forum, è promossa dall’«Istituto «Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli» nella collana «Serie moderna e contemporanea». «Nel 1978, in occasione del convegno di studio nel centenario della nascita di Pio Paschini - scrive, nella premessa ai volumi, il presidente dell’Istituto, Cesare Scalon - l’allora arcivescovo di Udine, Alfredo Battisti, propose di creare un Istituto di Fonti e ricerche di Storia ecclesiastica friulana a lui intitolato. La scelta era motivata per il “suo coraggioso tentativo di conciliare cultura e fede, ma anche per il suo validissimo contributo di ricerca sulle origini e sulla storia della Chiesa di Aquileia”.
La pubblicazione, edita da Forum, è promossa dall’«Istituto «Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli» nella collana «Serie moderna e contemporanea». «Nel 1978, in occasione del convegno di studio nel centenario della nascita di Pio Paschini - scrive, nella premessa ai volumi, il presidente dell’Istituto, Cesare Scalon - l’allora arcivescovo di Udine, Alfredo Battisti, propose di creare un Istituto di Fonti e ricerche di Storia ecclesiastica friulana a lui intitolato. La scelta era motivata per il “suo coraggioso tentativo di conciliare cultura e fede, ma anche per il suo validissimo contributo di ricerca sulle origini e sulla storia della Chiesa di Aquileia”.
 Per ricordare i suo quarant’anni di vita - continua Scalon - l’Istituto aveva pensato in un primo momento a una riedizione della “Vita di Galileo”, ripulita dai tagli e dalle manipolazioni che il testo aveva subito. La proposta fu però accantonata in considerazione del fatto che gli interventi censori erano ormai noti agli studiosi e che una riedizione della “Vita” non avrebbe offerto alcun contributo originale alla ricerca storica. Nacque allora l’idea di questo “Epistolario”».
Per ricordare i suo quarant’anni di vita - continua Scalon - l’Istituto aveva pensato in un primo momento a una riedizione della “Vita di Galileo”, ripulita dai tagli e dalle manipolazioni che il testo aveva subito. La proposta fu però accantonata in considerazione del fatto che gli interventi censori erano ormai noti agli studiosi e che una riedizione della “Vita” non avrebbe offerto alcun contributo originale alla ricerca storica. Nacque allora l’idea di questo “Epistolario”».
 «L’ampia selezione delle lettere in ordine cronologico - conclude Scalon - ripercorre l’itinerario scientifico, la carriera accademica ed ecclesiastica del protagonista e al tempo stesso fa emergere in modo inconfondibile i tratti della sua personalità di uomo, di studioso e di sacerdote».
«L’ampia selezione delle lettere in ordine cronologico - conclude Scalon - ripercorre l’itinerario scientifico, la carriera accademica ed ecclesiastica del protagonista e al tempo stesso fa emergere in modo inconfondibile i tratti della sua personalità di uomo, di studioso e di sacerdote».* LA VITA CATTOLICA, 30- 05.2018
Sul tema, in rete, si cfr.:
PIO PASCHINI (Marino Zabbia - Dizionario Biografico degli Italiani - 2014)
Federico La Sala
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA. Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!! - KANT, LA COLOMBA, E IL VOLO NELL’OCEANO COSMICO.11 settembre 2017, di Federico La Sala
FILOSOFIA E PEDAGOGIA
ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?! ... *
PER UNA SCUOLA CHE INSEGNI A VOLARE. Una nota a margine di "Una domanda eterna: che cosa significa educare?" ...
- "La matematica ci dà uno splendido esempio di quanto possiamo spingerci innanzi nella conoscenza a priori, indipendentemente dall’esperienza. È vero che essa ha che fare con oggetti e conoscenze solo in quanto si possono presentare nell’intuizione: ma questa circostanza vien facilmente trascurata, perché l’intuizione stessa può essere data a priori, e perciò difficilmente si può distinguere da un concetto puro. Eccitato da una siffatta prova del potere della ragione, l’impulso a spaziare più largamente non vede più confini.
 La colomba leggiera, mentre nel libero volo fende l’aria di cui sente la resistenza, potrebbe immaginare che le riuscirebbe assai meglio volare nello spazio vuoto di aria. Ed appunto così Platone abbandonò il mondo sensibile, poiché esso pone troppo angusti limiti all’intelletto; e si lanciò sulle ali delle idee al di là di esso, nello spazio vuoto dell’intelletto puro. Egli non si accorse che non guadagnava strada, malgrado i suoi sforzi; giacché non aveva, per così dire, nessun appoggio, sul quale potesse sostenersi e a cui potesse applicare le sue forze per muovere l’intelletto.
La colomba leggiera, mentre nel libero volo fende l’aria di cui sente la resistenza, potrebbe immaginare che le riuscirebbe assai meglio volare nello spazio vuoto di aria. Ed appunto così Platone abbandonò il mondo sensibile, poiché esso pone troppo angusti limiti all’intelletto; e si lanciò sulle ali delle idee al di là di esso, nello spazio vuoto dell’intelletto puro. Egli non si accorse che non guadagnava strada, malgrado i suoi sforzi; giacché non aveva, per così dire, nessun appoggio, sul quale potesse sostenersi e a cui potesse applicare le sue forze per muovere l’intelletto.
 Ma è un consueto destino della ragione umana nella speculazione allestire più presto che sia possibile il suo edifizio, e solo alla fine cercare se gli sia stato gettato un buon fondamento. Se non che, poi si cercano abbellimenti esterni di ogni specie per confortarci sulla sua saldezza, o anche per evitare del tutto tale tardiva e pericolosa verifica" (Immanuel Kant, Critica della ragion pura, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 38).
Ma è un consueto destino della ragione umana nella speculazione allestire più presto che sia possibile il suo edifizio, e solo alla fine cercare se gli sia stato gettato un buon fondamento. Se non che, poi si cercano abbellimenti esterni di ogni specie per confortarci sulla sua saldezza, o anche per evitare del tutto tale tardiva e pericolosa verifica" (Immanuel Kant, Critica della ragion pura, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 38).
EDUCAZIONE? CHI EDUCA CHI: INSEGNARE A VOLARE. I SOGGETTI sono DUE, e tutto è da ripensare...
Pur condividendo con l’Autore di "Una domanda eterna: che cosa significa educare?", la linea strategica della sua riflessione ("della libertà faccio il perno centrale dell’educazione, un perno che ricomprende l’idea di educazione come introduzione alla realtà, il punto che sussume tutti i percorsi e le esperienze attivate per educare i cittadini di domani a una vita virtuosa"), credo che sia necessario e opportuno (anche sul filo delle sue stesse accennate indicazioni di Aristotele, Rousseau, Kant) portarci oltre e RIFLETTERE su quanto nella domanda è "nascosto", vale a dire su "CHI" educa "CHI" - a tutti i livelli! I SOGGETTI sono DUE, e tutto è da ripensare...
Se di Rousseau non vogliamo (continuare a) farne un teorizzatore dell’e-duc-azione autoritaria ( "ex-DUX-azione"), dobbiamo problematizzare proprio la sua frase finale, (ripresa dall’ "Emilio"), sull’uomo virtuoso, sul diventare "padrone di se stesso", e sul comandare al proprio "cuore", e, con lo stesso Rousseau, reinterrogarci sulla nostra condizione: "L’uomo è nato libero, e ovunque è in catene. Anche chi si crede padrone degli altri, non è per questo meno schiavo degli altri" ("Il contratto sociale"); e, insieme, sul tema del "CAPO" (preziosa al riguardo la "lezione" di Gramsci del 1924).
La questione è "eterna" ed è ... intrecciata con la questione delle Sibille e dei Profeti di Copertino (cfr. Pierpaolo Parsi: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/03/30/copertino-si-scopre-casa-delle-sibille/), con la filologia e l’affresco di sant’Agostino di Nardò (cfr. M. Gaballo: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/08/28/laffresco-di-santagostino-nella-cattedrale-di-nardo/), e, ancora e in particolare, con il lavoro di Sigmund Freud. Non a caso in un mio lavoro su questi temi (cfr.: "Della Terra, il brillante colore. Parmenide, una "Cappella Sistina" carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barberi (1481) e la domanda antropologica", Prefazione di Fulvio Papi, Milano 2013), un capitolo è dedicato al problema J.-J. ROUSSEAU: "Al di là della cecità edipico-parmenidea e al di là della "società civile". J.-J. Rousseau: una coscienza aperta e una triplice fedeltà" (pp. 101-110).
PER ANDARE AVANTI democraticamente occorre rimeditare (come Pierpaolo Tarsi sollecita a fare) la lezione kantiana racchiusa nell’immagine della colomba della "Critica della Ragion Pura", occorre INSEGNARE A VOLARE. E, su questo, il contributo di KANT è enorme. Se si vuole uscire dallo "stato di minorità", non si può non tenerne conto!
ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN!
Federico La Sala
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
- "La matematica ci dà uno splendido esempio di quanto possiamo spingerci innanzi nella conoscenza a priori, indipendentemente dall’esperienza. È vero che essa ha che fare con oggetti e conoscenze solo in quanto si possono presentare nell’intuizione: ma questa circostanza vien facilmente trascurata, perché l’intuizione stessa può essere data a priori, e perciò difficilmente si può distinguere da un concetto puro. Eccitato da una siffatta prova del potere della ragione, l’impulso a spaziare più largamente non vede più confini.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!! -- L’«Elogio delle matematiche». La crociata di Alain Badiou (di S. Montefiori).15 luglio 2017, di Federico La Sala
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.... *
INTERVISTA
L’invito di Alain Badiou: i filosofi imparino (dal)la matematica
La crociata di Alain Badiou: non basta avere opinioni per essere pensatori, occorre conoscere le scienze.
L’«Elogio» a teoremi e calcoli pubblicato da Mimesis
di STEFANO MONTEFIORI, corrispondente a Parigi *
- Jodie Glen-Martin (1972), «Colour by numbers» (2009, acrilico su tela), courtesy dell’artista, Saatchi Art Gallery Jodie Glen-Martin (1972), «Colour by numbers» (2009, acrilico su tela), courtesy dell’artista, Saatchi Art Gallery shadow
«Chiunque è ormai considerato un filosofo», protesta Alain Badiou. «Oggi è sufficiente avere delle opinioni (e relazioni mediatiche giuste) per farle credere universali, benché assolutamente banali». Il filosofo de L’essere e l’evento (il Melangolo, 1995) a 80 anni critica l’abitudine contemporanea, specialmente francese, a confondere tra le figure del filosofo e dell’opinionista. «Non si può certo dominare l’intero campo delle scienze ma si può, e si deve, averne una conoscenza sufficiente, un’esperienza abbastanza approfondita e ampia. Invece, oggi sono numerosi i “filosofi” ben lontani da questo requisito minimo e, in particolare, lontani dal sapere matematico che, da sempre, è stato il più importante per la filosofia». Così nasce Elogio delle matematiche (Mimesis), il libro con il quale Badiou reagisce a quella che ritiene l’usurpazione della qualifica di «filosofo». Il discrimine è lo studio e la conoscenza della matematica: «Con lei è impossibile barare». La matematica come via per il rigore filosofico dunque, e come fonte di gioia intellettuale per tutti.
- «Elogio delle matematiche» di Alain Badiou, edito da Mimesis, a cura di Marcello Losito (pagine 86 €10)
Da dove deriva la sua fascinazione per la matematica?
«Si tratta senza dubbio di una tripla origine. Famigliare, per cominciare: mio padre era professore di matematica, e fino alla sua morte ha continuato a risolvere problemi per il semplice piacere di farlo. Un’origine scolastica, poi: ho avuto molti insegnanti di matematica capaci di entusiasmare la classe, in particolare mettendo in evidenza la raffinatezza e la formidabile inventiva che una dimostrazione, anche apparentemente semplice, può contenere. E un’origine filosofica, infine: ho dovuto constatare che, nella storia della filosofia, la matematica occupa un posto decisivo e questo dall’inizio, a cominciare da Platone. Due grandissimi filosofi moderni, Cartesio e Leibniz, sono anche dei grandissimi matematici. Pure Hegel, secondo il quale i matematici riescono a pensare solo un ”falso infinito”, consacra loro un capitolo molto brillante della sua Logica. Mi inscrivo in questa tradizione. Mi oppongo dunque, in ragione della stessa origine della mia passione, a due correnti contemporanee: quella che trascura completamente la matematica o addirittura la disprezza, corrente che ha come iniziatore e leader senza dubbio Nietzsche; e la corrente che tributa alla matematica un culto accademico, sviluppando una filosofia molto povera, ovvero la filosofia analitica americana».
- Alain Badiou, filosofo e professore emerito alla Scuola normale superiore di Parigi
Lei si dedica con regolarità alla matematica?
«Sì. Lo faccio adesso in legame stretto con lo sviluppo della mia costruzione filosofica. Lo studio dettagliato della teoria moderna degli insiemi, con i magnifici teoremi di Gödel e di Cohen, ha accompagnato tutta la concezione e la scrittura de L’essere e l’evento (edito in Francia nel 1988, ndr). Mi sono immerso in seguito nella visione recente della matematica rappresentata dalla teoria delle categorie, secondo la quale non ci sono oggetti matematici in senso proprio ma solo delle relazioni. Faccio il bilancio filosofico di questo studio nelle Logiche dei mondi (2005). In questo momento sto completando un terzo libro sistematico, L’immanenza della verità, per il quale ho studiato a fondo la teoria contemporanea dei ”grandi infiniti”. Tutto questo rappresenta, mi creda, un numero di ore, giorni, o mesi, davvero considerevole»
Esiste un atteggiamento tipico, tradizionale, del filosofo nei confronti del matematico? Magari una diffidenza basata sull’incomprensione? E viceversa?
«La filosofia è nata in Grecia con la matematica, come dicevo prima, nello stesso movimento, e questa vicinanza si è mantenuta, sotto forme diverse, fino a oggi. È vero che una corrente empirista, esistenzialista, vitalista, spesso legata alla psicologia, ha sviluppato un disprezzo diffidente nei confronti della matematica, soprattutto dopo la fine dell’Ottocento. Ma penso che questo atteggiamento, anche in Sartre che fu uno dei miei maestri, è fondato nella maggior parte dei casi sull’ignoranza. Il dramma, in Francia, è che i due grandi pensatori della matematica a metà del secolo scorso, Cavaillès e Lautman, hanno scelto senza esitazione, durante la guerra, il campo della Resistenza e sono stati entrambi uccisi dai nazisti. Questo ha prodotto un ritardo importante, in Francia, nel legame fondamentale che deve esistere tra l’invenzione matematica più recente e la creazione filosofica. Possiamo dire che con il compianto Jean-Toussaint Desanti abbiamo cercato di contribuire all’eliminazione di questo ritardo. Peraltro, in un certo senso, c’è una risposta molto semplice alla sua domanda: chi pratica, davvero, la matematica, non può che amarla. Chi non la ama dimostra per questo stesso fatto di ignorarla»
Pensa che i filosofi potrebbero o dovrebbero trarre maggiore ispirazione dal rigore dei matematici?
«Certo! La filosofia è una disciplina argomentativa, anche se si autorizza retorica politica, transfert sulla persona del Maestro, e le risorse seducenti della poesia. Tutto questo si trova nel fondatore di quel che ancora oggi noi chiamiamo ”filosofia”, ossia Platone. Detto questo, c’è un limite. La matematica propone un modello rigoroso di dimostrazione, del quale conosciamo tutte le regole logiche, dove tutte le nozioni sono chiaramente definite, e che può pure essere formalizzato in una lingua artificiale. La filosofia, che opera nella lingua ordinaria, e che tratta dei problemi fondamentali della vita umana, individuale e collettiva, evidentemente non può pretendere questa trasparenza formale. Ma deve proporre degli argomenti quanto più rigorosi è possibile».
Una figura come Alexandre Grothendieck, con le sue prese di posizione filosofiche e politiche, potrebbe essere considerata come un esempio della relazione possibile tra i due mondi?
«È vero che per intendersi bisogna essere in due. Il legame tra filosofia e matematica deve, se possibile, coinvolgere anche i matematici. Ma è difficile. Era più facile ai tempi di Cartesio e Leibniz, che erano allo stesso tempo grandi filosofi e creatori matematici. È vero che alcuni giganti della matematica, come Poincaré, Gödel o, in effetti, proprio Grothendieck, hanno manifestato un reale interesse per la nostra disciplina. Non sono sicuro, tuttavia, che siano andati lontano quanto avrebbero potuto in questa direzione. Quello di Grothendieck è un caso limite, perché possiamo supporre che convinzioni di natura polito-filosofica lo abbiamo in qualche modo sviato dalla carriera matematica. In generale, tuttavia, la forza dimostrativa della matematica affascina molti filosofi ma la debolezza dimostrativa, inevitabile, della filosofia, i cui fini abbordano il destino umano nel suo insieme, delude i matematici. È normale che sia così...».
Un filosofo del passato come Spinoza è stato influenzato dalla matematica?
«Nel Seicento, il modello matematico ha un tale ascendente che alcuni grandi filosofi tentano di presentare il loro sistema sotto la forma deduttiva che troviamo nel più antico trattato di matematica conosciuto, ovvero gli Elementi di Euclide. Si dice allora che la presentazione della filosofia si fa ”more geometrico”, al modo della geometria. Cartesio ha affermato così i ”principi” della sua filosofia. Leibniz ha anche cercato, per tutta la vita, una lingua in qualche modo assolutamente pura e universale, una ”Mathesis Universalis”, per esprimervi ugualmente le sue scoperte matematiche come il suo sistema filosofico. Il grande libro di Spinoza, l’Etica, che parla di Dio, delle Idee, delle Passioni, della vera vita, è scritto dall’inizio alla fine sotto forma di assiomi, di definizioni, e di proposizioni seguite dalle dimostrazioni. Ma questo non ha assicurato a Spinoza un’adesione universale. Esistono, prima e dopo Spinoza, molteplici orientamenti filosofici, spesso conflittuali, e una sola matematica che è, tranne in qualche periodo di crisi, del tutto consensuale».
Sempre più spesso, soprattutto in Francia, la carriera scolastica di un allievo è determinata dai suoi risultati in matematica, principale strumento di selezione. La cultura generale «respirata in famiglia», come direbbe Pierre Bourdieu, vi gioca un ruolo inferiore rispetto alle scienze umane? La matematica potrebbe dunque essere un’arma di democrazia e di parità delle opportunità, ma viene accusata al contrario di accentuare la separazione delle élite.
«Questo ruolo selettivo della matematica è una piaga. Non c’è niente di più egalitario della matematica perché normalmente, con un po’ di attenzione, una dimostrazione esposta chiaramente, e nella quale il linguaggio sia stato precisato in modo corretto, può convincere chiunque, ovunque si trovi, alla sola condizione che questi appartenga all’umanità. Inoltre, c’è un aspetto ludico nella matematica, perché risolvere un problema è un gioco appassionante. Penso che la matematica possa e debba essere imparata e praticata a lungo e da tutti, tutta la vita, e tenuta lontana dai processi sociali di selezione e di gerarchia. La matematica deve essere considerata come la più bella musica della quale sia capace il pensiero puro».
Perché la matematica può renderci felici? E in che modo?
«Mi piace paragonare il lavoro matematico a un’escursione in montagna. La partenza può essere faticosa, su una salita ripida. La cima può sembrare lontana. Dopo un tornante, eccone un altro, e si perde il respiro. Ci si può perdere, e cercare la direzione su una bussola di fortuna. In matematica, allo stesso modo, l’enunciato del problema può apparire complesso. I teoremi già conosciuti sui quali appoggiarsi sfuggono alla nostra memoria. A un certo punto, ti accorgi che hai seguito una pista sbagliata, che devi ricominciare. Ma quando il camminatore arriva sulla cima, che gioia immensa! Che vittoria! Con la matematica succede la stessa cosa. Quando alla fine hai risolto il problema, ti trovi davanti a un paesaggio mentale illimitato, ammiri in te stesso ciò di cui è capace il pensiero. Provi allora quel che Spinoza chiamava “la beatitudine intellettuale”».
* Corriere della Sera, 13 luglio 2017 (modifica il 14 luglio 2017 | 22:34) (ripresa parziale - senza immagini).
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI:
 COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?!LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 KANT, FREUD, E LA BANALITÀ DEL MALE.
KANT, FREUD, E LA BANALITÀ DEL MALE. -
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI --- MATEMATICA DIVINA, CALCOLO UMANO (di Michele Emmer).18 febbraio 2017, di Federico La Sala
- ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
Matematica divina, calcolo umano
di Michele Emmer *
- Paolo Zellini, La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini, Adelphi, 2016, 258 pp., € 14
“È importante rendersi conto che non sono gli algoritmi a decidere di per sé la verità matematica. La validità di un algoritmo dev’essere sempre stabilita con mezzi esterni. La computabilità è un’idea matematica, indipendente da qualsiasi particolare concetto di macchina per il calcolo, ma anche perché illustra l’efficacia di idee astratte in matematica [...]. In matematica ci sono cose per le quali l’espressione scoperta è in effetti molto più appropriata di invenzione. Questi sono i casi in cui dalla struttura emerge molto di più di quanto non vi sia posto in principio. Qualcuno potrebbe pensare che in tali casi i matematici si siano imbattuti in opere di Dio. Ci sono altri casi in cui la struttura matematica non ha una unicità altrettanto convincente, come quando nel corso della dimostrazione il matematico ha bisogno di introdurre una qualche costruzione artificiosa e tutt’altro che unica per conseguire qualche fine molto specifico. In tali casi è probabile che dalla costruzione non venga fuori più di quanto vi è stato messo in principio, e la parola invenzione sembra più appropriata che scoperta. Queste sono in effetti opere dell’uomo”.
Così scriveva Roger Penrose nel 1989, in The Emperor’s New Mind. La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini è il titolo di un libro del matematico Paolo Zellini. Un libro che parla di matematica e dei procedimenti di calcolo, gli algoritmi appunto. Ma perché a un non matematico dovrebbe interessare riflettere su cosa sia la matematica, come può essere originata, che cosa significano un procedimento di calcolo e la sua affidabilità?
Quando si ha qualche dubbio sulla nostra esistenza, sulle mostre vite, a chi ci si rivolge? Ai filosofi ovviamente. Loro sì che sono in grado di farci capire quale sia lo scopo ultimo della nostra esistenza, ovvero il fatto che non vi è alcuno scopo. E la matematica è solo questione per addetti ai lavori. Magari è utile, serve a risolvere problemi, ma in fondo non è altro che una forma raffinata di ingegneria e nulla di più.
“In fondo le matematiche sono la più convincente delle invenzioni umane per esercitarsi a quello che è la chiave di tutto il progresso collettivo come di tutta la felicità individuale: dimenticare i nostri limiti per toccare in modo luminoso, l’universalità del vero”: sono parole di un filosofo, Alain Badiou, che da anni, oltre a pubblicare ampi volumi sulle questioni fondamentali del pensiero filosofico, interviene puntualmente nella vita politica e sociale con veri e propri instant book. Un filosofo immerso nella vita di oggi ma che riflette a fondo sulle grandi questioni. La matematica non poteva non interessarlo.
Come qualsiasi altro matematico che voglia parlare anche ai non matematici, Zellini si pone la questione di quale realtà parli la matematica. “È opinione diffusa che i matematici si occupino di formalismi astratti e che solo per ragioni inspiegabili questi formalismi si applicano in ogni ambito della scienza. Concepiamo entità immateriali che sembrano poi destinate a definire modelli di fenomeni che accadono realmente nel mondo”.
 Per far capire perché queste riflessioni sono non solo dedicate a entità immateriali e inspiegabili formalismi, è utile arrivare subito al capitolo conclusivo del libro di Zellini, intitolato Verum et factum, citazione da Giambattista Vico. (Bisogna perdonare all’autore le tante citazioni e note, spesso essenziali.) “La realtà è qualcosa che dipende dal fare, dal portarla effettivamente a termine con l’azione. La soluzione di un problema matematico dipende dalla possibilità di calcolarla in modo efficiente nello spazio e nel tempo fisici di una esecuzione automatica, che è l’unica strategia possibile a causa dell’elevata dimensione dei problemi”. (Sistemi di milioni di equazioni che simulano un fenomeno fisico, di cui non si può trovare una soluzione esplicita.) “Non sembra esserci nulla di più certo di un processo che, in un numero finito di passi, esegue i calcoli necessari in funzione di dati assegnati. Ma la realtà degli enti matematici si riassume davvero, in modo esauriente, in questa conclusione?”
Per far capire perché queste riflessioni sono non solo dedicate a entità immateriali e inspiegabili formalismi, è utile arrivare subito al capitolo conclusivo del libro di Zellini, intitolato Verum et factum, citazione da Giambattista Vico. (Bisogna perdonare all’autore le tante citazioni e note, spesso essenziali.) “La realtà è qualcosa che dipende dal fare, dal portarla effettivamente a termine con l’azione. La soluzione di un problema matematico dipende dalla possibilità di calcolarla in modo efficiente nello spazio e nel tempo fisici di una esecuzione automatica, che è l’unica strategia possibile a causa dell’elevata dimensione dei problemi”. (Sistemi di milioni di equazioni che simulano un fenomeno fisico, di cui non si può trovare una soluzione esplicita.) “Non sembra esserci nulla di più certo di un processo che, in un numero finito di passi, esegue i calcoli necessari in funzione di dati assegnati. Ma la realtà degli enti matematici si riassume davvero, in modo esauriente, in questa conclusione?”Torna la domanda, che difficilmente avrà mai una risposta definitiva - fortunatamente, è il caso di dire -, del legame tra matematica e realtà. Quale migliore esempio della rete? “Ogni pagina o documento del web, della immensa ragnatela dell’informazione su scala planetaria, si rappresenta come un nodo di un grafo di enormi dimensioni al quale si può associare una matrice di dimensioni equivalenti (una enorme tabella di numeri) con miliardi di righe e di colonne [...]. L’importanza del nodo, cioè del documento web, dipende dall’entità dei collegamenti. L’aggiornamento si esprime allora nel calcolo iterativo, approssimato, dell’autovettore corrispondente all’autovalore massimo di una matrice” (ho volutamente lasciato le esatte parole matematiche di Zellini usando termini elementari della teoria delle matrici) “Un criterio di invarianza presiede al calcolo iterativo della soluzione del problema del web, che consiste nell’assegnare la maggiore o minore importanza di una pagina per elaborare la risposta ad un generico quesito”.
Esempio che tanti nel mondo hanno davanti agli occhi ogni giorno, ma che quasi tutti ignorano da quali calcoli derivino, da quali algoritmi umani che qualcuno ha elaborato immettendo i dati. Dettagli trascurati da parte dei nostri intellettuali e filosofi. Scrive Badiou che “oggi basta avere delle opinioni e una rete adeguata mediatica, per far credere che tali opinioni sono universali mentre sono assolutamente banali. Nella matematica non si può bluffare. I matematici sono coloro che dimostrano risultati prima sconosciuti, e di questo è impossibile farne un sottoprodotto o una caricatura, è impossibile”.
Ma se umani sono gli algoritmi, umane le scelte dei calcoli, perché la matematica ha origini divine? Due sono le parole chiave: crescita e invarianza. “Il fenomeno della crescita non è marginale, perché interviene nella più intima compagine dell’algoritmo”. Il calcolo ricorsivo e la ricerca dell’invarianza, di strutture che si ripetono, della velocità e affidabilità del calcolo, sono le regole auree della computazione.
 E quando nasce l’idea di crescita, iterazione e invarianza in matematica? “I motivi della crescita dei numeri sono strettamente matematici e si chiariscono grazie a teoremi relativamente avanzati. Ma non è superfluo notare che il motivo della crescita, in ogni suo risvolto è stato oggetto della massima attenzione già nel pensiero antico, ed è precisamente il modo in cui la crescita delle grandezze è trattata nella geometria Greca, nei calcoli Vedici e nell’aritmetica Mesopotamica a far capire le cause della crescita dei numeri negli algoritmi moderni. La ragione è tanto semplice quanto sorprendente: alcuni importanti schemi computazionali sono rimasti immutati da allora fino alle più complesse strategie di cui si avvale oggi il calcolo su grande scala [...]. Furono gli dei Indiani Vedici e quelli Graci, molto prima del dio di Descartes, ad assicurare l’esistenza di un nesso tra le concezioni del mistico e della natura, tra la nostra sfera più intima e la realtà esterna”.
E quando nasce l’idea di crescita, iterazione e invarianza in matematica? “I motivi della crescita dei numeri sono strettamente matematici e si chiariscono grazie a teoremi relativamente avanzati. Ma non è superfluo notare che il motivo della crescita, in ogni suo risvolto è stato oggetto della massima attenzione già nel pensiero antico, ed è precisamente il modo in cui la crescita delle grandezze è trattata nella geometria Greca, nei calcoli Vedici e nell’aritmetica Mesopotamica a far capire le cause della crescita dei numeri negli algoritmi moderni. La ragione è tanto semplice quanto sorprendente: alcuni importanti schemi computazionali sono rimasti immutati da allora fino alle più complesse strategie di cui si avvale oggi il calcolo su grande scala [...]. Furono gli dei Indiani Vedici e quelli Graci, molto prima del dio di Descartes, ad assicurare l’esistenza di un nesso tra le concezioni del mistico e della natura, tra la nostra sfera più intima e la realtà esterna”.Se non si è ancora capito si sta parlando di cultura, di cui la matematica divina e il calcolo umano fanno parte, in modo essenziale ai nostri tempi così poco razionali. Un libro importante, interessante che richiede, come è giusto che sia, un certo sforzo. Comprendere è umano o divino?
- ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
CHI SIAMO NOI, IN REALTÀ?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"! -- Galileo Galilei. A Dio piacendo, o alla scienza? (di Massimo Firpo)28 marzo 2016, di Federico La Sala
Galileo Galilei (1564-1642)
A Dio piacendo, o alla scienza?
di Massimo Firpo (Il Sole - 24 Ore, Domenica, 27.03.2016)
È a tutti ovvio che oggi l’ancor vitalissima questione galileiana non è più una questione scientifica, non investe più la natura del cosmo, ma è una questione storica, che investe il giudizio su ciò che allora accadde e ciò che ne conseguì. Da questo punto di vista, a trent’anni di distanza appaiono assai fragili le istanze apologetiche che ancora ispiravano il volume Galileo Galilei 350 anni di storia (1633-1983), apparso nel 1984, dove per esempio c’era ancora chi insisteva nel denunciare «l’aggressività anticlericale» di quanti si ostinavano a non capire «la ragione, nascosta ma profonda», della condanna di Galileo, e cioè il fatto che egli «veniva a trovarsi troppo in avanti rispetto al suo tempo», quasi che fosse un dovere della Chiesa combattere le più ardite innovazioni scientifiche.
Quel volume scaturiva dai lavori di un’apposita commissione istituita da Giovanni Paolo II, che sarebbero infine approdati alla solenne ammissione di questo e altri errori della Chiesa, o meglio di «alcuni uomini di Chiesa» - e «in un certo senso in nome suo» - per i quali il pontefice volle chiedere perdono in occasione del giubileo dell’anno 2000. Non stupisce che quella distinzione tra la Chiesa e gli uomini di Chiesa, pur dotata di antichi precedenti, diventasse oggetto di polemiche, sulle quali non è questa la sede per tornare. Mi limito a osservare che tale distinzione - come ha scritto Giovanni Miccoli - ha «come conseguenza una sorta di sottrazione della Chiesa dalla storia» e che pertanto essa «vale e può valere solo per coloro che partecipano della fede cattolica». Ed è qui, a mio avviso, proprio sul terreno storico che intorno alla vicenda galileiana si stringono i nodi più aggrovigliati, a cominciare dal cruciale rapporto tra mutamento storico e verità teologica.
Tutto cambia, tutto evolve nella storia, e presidiarla in nome di una verità immutabile è un’impresa titanica, che l’odierna accelerazione della storia stessa rende ancor più ardua. Si pensi solo alle delicate questioni dibattute nelle settimane scorse dal Parlamento, nelle quali si riflettono profondi mutamenti di costume, mentalità, sensibilità individuali e collettive, peraltro in costante evoluzione, e sulle quali è del tutto legittimo avere opinioni molto diverse, tutte meritevoli di rispetto.
Per questo mi è parso curioso che, in relazione a un punto particolarmente controverso della legge, un autorevole uomo politico abbia evocato i principi di un’astratta “natura”, così come gli anticopernicani difendevano il cosmo tolemaico che appariva come una natura tanto più certa quanto più suffragata dalla parola di Dio.
In realtà, dovrebbe essere noto che la natura non è affatto astorica, ma è sempre una rappresentazione, una costruzione storico-culturale, un modo di pensarla e interpretarla. E in quanto tale anch’essa cambia, sta mutando sotto i nostri occhi: da un lato noi stessi la cambiamo, talora brutalmente, e dall’altro fino a ieri non sapevamo nulla del genoma o del bosone di Higgs, dopo il quale sono arrivate le onde gravitazionali e un giorno toccherà all’antimateria e alla forza oscura. Per certi versi la storia dell’uomo ha coinciso con una battaglia incessante per sottrarsi al dominio cieco di una natura onnipotente, delle sue forze telluriche, delle sue catastrofi climatiche, dei suoi agenti patogeni.
Certo, adesso i problemi più delicati non sono la cosmologia o la fisica subatomica, e neanche il paradigma darwiniano (che pure contraddiceva il dettato scritturale), ma la biologia, le neuroscienze, le tecniche della fecondazione artificiale e in prospettiva l’eugenetica, dove scienza e tecnologia pongono serie questioni morali, sulle quali la Chiesa esercita il suo magistero muovendosi sulle impervie frontiere tra ineludibile (e imprevedibile) mutamento storico e verità immutabili. Il dirompente passaggio dalle rigide chiusure del concilio Vaticano I e del Sillabo alle aperture del concilio Vaticano II sono una prova evidente della storicità del magistero, passato in meno di un secolo da uno scontro frontale contro la cultura laica e i processi di secolarizzazione al tentativo di dialogare con la modernità.
In questa prospettiva, il caso Galileo ripropone ancora una volta la sua attualità non solo nell’ambito oggi più vivo che mai del rapporto tra scienza e fede (o meglio, tra scienza e magistero ecclesiastico), ma in quello non meno sensibile del rapporto tra Chiesa e storia, tra una Chiesa che ovviamente si muove dentro la storia e che dunque cambia, evolve e talora si contraddice o sbaglia, e una Chiesa che in nome della verità di cui si sente depositaria quella stessa storia giudica, ponendosi al di fuori e al di sopra di essa, e cerca di indirizzare secondo i propri fini, i propri valori le proprie certezze.
La bimillenaria durata della Chiesa è senza dubbio una ragione della sua autorevolezza, del suo prestigio, della sua forza, della sua stessa identità, ma quella stessa bimillenaria storia è anche un fardello che rischia qualche volta di diventare troppo pesante per traghettarlo tutto quanto verso il futuro, senza modificarne neanche una virgola, ne iota unum. Ieri come oggi il problema resta quello della storicità del vero e del giusto, che impone anche alla Chiesa l’esigenza di far proprie almeno in parte le ragioni di quel relativismo che essa combatte nei suoi esiti scettici.
Un compito immane e sempre più difficilmente componibile nelle cautele pastorali e nella prudenza della ragion di Chiesa, anche perché ormai fa parte del senso comune il fatto che né la storia né la scienza postulino un fondamento divino o una legittimazione teologica. Storici e scienziati possono essere responsabili di errori anche gravi, e magari gravissimi, così come lo furono papa Urbano VIII e san Roberto Bellarmino, ma oggi a vigilare su di essi - errori e non eresie - può essere solo la comunità scientifica e non qualche tribunale della coscienza. Un principio, questo, ormai auspicabilmente condiviso da laici e cattolici.
*
(Sintesi del discorso tenuto alla Camera dei Deputati a Roma il 4 marzo scorso nel quattrocentesimo anniversario della prima condanna di Galilei)
-
>GALILEO GALILEI. Corrispondenza infinita. Un aggiornamento del «Carteggio» dell’Edizione Nazionale delle Opere di Galileo (di Franco Giudice)..28 febbraio 2016, di Federico La Sala
Galileo Galilei (1564-1642)
Corrispondenza infinita
Pubblicato un aggiornamento del «Carteggio» curato circa un secolo fa da Antonio Favaro, colui che contribuì enormemente alla creazione del «mito» dell scienziato pisano
di Franco Giudice (Il Sole-24 Ore, Domenica, 28.2.16
- Galileo Galilei, Carteggio (Aggiornamento dell’Edizione Nazionale) , a cura di Michele Camerota e Patrizia Ruffo, con la collaborazione di Massimo Bucciantini, Giunti Editore, Firenze, pagg. 661, € 150
L’ Edizione Nazionale delle Opere di Galileo non è un monumento esornativo al più celebre scienziato italiano di tutti i tempi o, peggio ancora, una mera raccolta dei suoi scritti concepita per rivendicarne, in modo velatamente apologetico, la genialità. E tanto meno lo fu per Antonio Favaro, lo studioso padovano che ideò e portò a compimento il progetto tra il 1890 e il 1909. Certo, Favaro diede un contributo decisivo all’affermazione del “mito” di Galileo come padre del metodo sperimentale. È innegabile tuttavia che il suo lavoro si basò sempre sulla centralità del documento, respingendo ogni interpretazione non suffragata dalle fonti.
Nell’approntare quella che più volte definì «l’impresa della mia vita», Favaro seguì ineccepibili criteri ecdotici, grazie anche alla collaborazione di due esperti filologi come Isidoro Del Lungo e Umberto Marchesini. Così, tra difficoltà finanziarie e nella quasi assoluta indifferenza della cultura accademica italiana, in poco meno di vent’anni riuscì a realizzare uno dei più importanti progetti della storia dell’editoria del nostro paese: la pubblicazione integrale - in venti volumi e secondo un ordine rigorosamente cronologico - degli scritti di Galileo, del carteggio, dei documenti relativi alla sua vita e alle sue opere, insieme a quelle di altri autori che lo scienziato postillò con commenti e annotazioni. Un’operazione lunga e faticosa che, in un’epoca priva di tecnologie informatiche, venne completata in tempi davvero record. E che ha il merito di essersi sottratta al triste destino condiviso dalle altre edizioni nazionali intraprese contemporaneamente in Italia, quasi tutte rimaste incomplete e in alcuni casi addirittura mai iniziate.
Oltre a costituire uno strumento indispensabile per tutti quelli che si accingono a studiare Galileo, questa Edizione Nazionale ha assunto anche il ruolo di modello per chiunque voglia cimentarsi con imprese di pari complessità. Tanto più che, rispetto ad altre iniziative analoghe realizzate negli stessi anni all’estero, il lavoro di Favaro conserva ancora quel carattere di edizione “definitiva” cui ambiva.
È dunque nel segno di questa preziosa eredità che, a distanza di un secolo, Michele Camerota, Patrizia Ruffo e Massimo Bucciantini hanno provveduto a una corposa integrazione del carteggio galileiano. Il volume si aggiunge a quello dell’Iconografia galileiana (uscito nel 2013 e curato da Federico Tognoni) e fa parte di un piano generale di Aggiornamento dell’ Edizione Nazionale, che ne prevede altri due, già in fase avanzata di preparazione, dove saranno raccolti una serie di testi non pubblicati da Favaro e i documenti e gli atti inquisitoriali emersi dopo il 1909. Un progetto di grande rilievo, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e affidato a un comitato scientifico internazionale presieduto da Paolo Galluzzi, direttore del Museo Galileo di Firenze.
Durante la preparazione del carteggio, Favaro compì una scelta quanto mai felice: pubblicare non solo le lettere di Galileo e quelle a lui indirizzate, ma anche le corrispondenze dei contemporanei in cui si trovavano riferimenti sia alle sue vicende biografiche sia alle sue straordinarie scoperte scientifiche. Per lo studioso padovano, infatti, l’epistolario si configurava come un autentico «dramma»: una rappresentazione scenica, dove il protagonista andava inserito nel contesto del dibattito culturale del suo tempo. Un risultato che ottenne in modo mirabile, mettendo a disposizione degli studiosi 4290 lettere, tutte presentate in sequenza cronologica, e che occupano ben nove ponderosi volumi dell’intera Edizione Nazionale.
Adottando in larga parte i criteri di Favaro, i curatori dell’aggiornamento del Carteggio lo arricchiscono ora di altre 588 lettere che sono nel frattempo venute alla luce e via via pubblicate in libri e articoli specialistici. Di esse, centoventi, più di un quinto dunque, erano inedite e sono state rinvenute con accurate ricerche svolte in fondi archivistici e bibliotecari nazionali ed esteri. Tutte le lettere, il cui arco temporale va dal 1588 al 1643, sono corredate di note che chiariscono i riferimenti a persone, opere ed episodi specifici, fornendo altresì una fitta trama di rimandi interni che facilitano la consultazione dell’intero corpus del carteggio.
Potrà forse deludere qualche aspettativa scoprire che soltanto poche lettere sono di Galileo o a lui dirette. È bene però sottolineare che il valore di questa nuova raccolta epistolare va individuato nella sua capacità di far emergere un panorama in precedenza poco esplorato: una rete di comunicazione cioè intensa e vivace, popolata di filosofi, astronomi, matematici, teologi, ma anche di artigiani, ambasciatori, cortigiani, nunzi pontifici e sovrani, che si scambiano opinioni e discutono su Galileo e sul significato delle sue opere. Una polifonia di voci insomma, che disegnano una mappa della diffusione e della “fortuna” dell’autore del Dialogo sopra i due massimi sistemi, e la cui estensione geografica copre l’intero continente europeo.
Più nello specifico poi, l’Aggiornamento contiene diversi elementi di novità rispetto a quanto si sapeva già. È il caso, giusto per fare qualche esempio, della fitta corrispondenza intercorsa tra i gesuiti tedeschi sulle osservazioni telescopiche del biennio 1609-1610, o delle numerosissime lettere (ben 77, alcune inedite) che documentano il costante interesse dello scienziato dilettante francese Nicolas Fabri de Peiresc per le dottrine galileiane, così come, dopo il 1633, il suo coraggio nel cercare di convincere le autorità ecclesiastiche a mitigare gli effetti della condanna.
Ma merita anche di essere ricordata una bellissima lettera, mai prima edita in Italia integralmente, scritta il 13 marzo 1610, proprio il giorno della pubblicazione del Sidereus nuncius, dall’ambasciatore inglese a Venezia, Sir Henry Wotton, a Giacomo I, per informarlo della «più insolita notizia» che il sovrano «avesse mai ricevuto da qualsiasi parte del mondo», la scoperta cioè dei quattro satelliti di Giove. Wotton vi accludeva un esemplare dell’opera e, nel darne un dettagliato resoconto dei contenuti al re d’Inghilterra, osservava che a Venezia «se ne parla in ogni angolo della città» e che «l’autore corre il rischio di diventare o estremamente famoso o estremamente ridicolo».
Questa integrazione del carteggio offre inoltre spunti notevoli sui rapporti tra Galileo e i suoi mecenati e protettori, i Medici, aiutando a illuminare aspetti ignoti della sua stessa biografia. Così, una sua lettera del 1° giugno 1616 all’ambasciatore fiorentino a Roma, Piero Guicciardini, ci informa delle spese sconsiderate sostenute durante il soggiorno romano nella primavera di quell’anno, e tali da far dire all’ambasciatore che Galileo si era dato alla «pazza vita».
L’Aggiornamento, infine, apre squarci inediti sui contatti tra Galileo e Giovanni di Guevara, uno studioso di questioni meccaniche da lui molto apprezzato. E lo fa ancor di più in merito alle sue relazioni, tutte da approfondire e chiarire, con il padre Niccolò Riccardi, il Maestro di Sacro Palazzo, che fu uno dei protagonisti della complessa vicenda processuale del 1632, in quanto responsabile della concessione dell’imprimatur al Dialogo.
Pochi anni prima di morire Favaro lamentava lo stato di «quasi clandestinità» in cui versava l’Edizione Nazionale, a causa dell’esiguo numero di copie stampate (appena 500) e distribuite per di più fuori commercio. Da allora, ovviamente, le cose sono cambiate: ristampata tra il 1929 e il 1939, e poi nel 1964, l’opera si trova oggi in tutte le più importanti biblioteche del mondo. Non si può tuttavia dire che essa goda di ampia circolazione, anche perché è venduta a un prezzo troppo elevato per i lettori comuni. Sarebbe dunque davvero lodevole, oltre che auspicabile, se la Giunti seguisse il suggerimento, all’epoca caduto nel vuoto, che dava lo stesso Favaro, mettere cioè sul mercato una versione economica dell’Edizione Nazionale. D’altronde, i buoni esempi non mancano. Basti pensare che dal 1996 Vrin vende i tredici volumi delle Oeuvres complètes di Descartes all’accessibile cifra di 153 euro, praticamente quasi allo stesso prezzo di questo splendido aggiornamento del Carteggio galileiano.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO --- L’abuso della matematica. Trionfi e miserie della visione meccanica del mondo (di Michel Emmer)6 dicembre 2015, di Federico La Sala
Saperi. L’esperienza umana non è riducibile ad algoritmi: l’attacco di Giorgio Israel agli eccessi del meccanicismo
L’abuso della matematica
I modelli che funzionano bene nel campo della fisica mostrano gravi limiti se applicati alle scienze sociali
Non possono dirci che cosa succederò nell’economia
di Michele Emmer (Corriere della Sera, La Lettura, 06.12.2015)
- GIORGIO ISRAEL, Meccanicismo. Trionfi e miserie della visione meccanica del mondo, Zanichelli, Pagine 322, e. 28.
Olivier Peyon ha realizzato nel 2013 un documentario dal titolo Comment j’ai détesté les maths. In realtà il film vuole essere un elogio dei matematici, della loro vita di ricercatori, della loro passione. Alla fine del film intervengono due matematici che si sono occupati di economia, George Papanicolaou, greco, e Jim Simons, che, dopo una brillante carriera scientifica, è diventato un ricco uomo d’affari creando il fondo speculativo Renaissance Technologies.
Parla della matematica economica e dei dannati algoritmi che hanno mandato in rovina l’economia globale, rendendo lui miliardario con le speculazioni sulla finanza virtuale. Per Papanicolaou gli algoritmi matematici di Simons non erano stati testati a sufficienza. Nessuno sapeva in che modo avrebbero reagito in situazioni di emergenza. Insomma, ci si può fidare della matematica?
Di matematica, matematica applicata e modelli matematici parla il libro di Giorgio Israel Meccanicismo (Zanichelli), pubblicato poco dopo la morte dell’autore. Nel film di Peyon, Cedric Villani, direttore dell’Institut Poincaré di Parigi, afferma che la separazione tra matematica e matematica applicata è superata. Frasi tipo quelle di G. H. Hardy, scritte nel 1940 per elogiare la matematica inutile, oggi non hanno senso. Hardy non sapeva che a Bletchley Park, matematici, fisici, ingegneri stavano lavorando alla decriptazione del codice nazista Enigma, usato in guerra per rendere incomprensibili i messaggi. Tra quei matematici Alan Turing, alla cui vita è dedicato il film Imitation Game, Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.
Uno dei problemi centrali del libro di Israel è la questione della applicabilità di modelli e metodi matematici nelle discipline non strettamente matematiche e fisiche, in particolare all’economia e alle scienze sociali. Il capitolo «Oltre il mondo inanimato» si apre con una frase del matematico dell’Ottocento Augustin Cauchy: «Coltiviamo con ardore le scienze matematiche, senza volerle ostentare al di là del loro dominio; non illudiamoci che si possa affrontare la storia con delle formule, né sanzionare la morale con dei teoremi o del calcolo integrale». Israel parte da Galileo, dall’«idea che la struttura su cui Dio ha edificato il mondo è la matematica». Ma in nessun modo si può pensare che Galileo «includesse nel “mondo” anche la sfera dell’uomo, della soggettività, del pensiero».
Poi abbiamo i tentativi di trovare un equo sistema elettorale del matematico Condorcet, alla vigilia della Rivoluzione francese, e i modelli per lo studio della diffusione del vaiolo alla metà del Settecento da parte di Daniel Bernoulli, con l’introduzione del calcolo delle probabilità. Il primo modello matematico per l’economia è di Dupont de Nemours alla fine del Settecento: «L’aspetto più interessante da evidenziare - scrive Israel - è l’importanza attribuita alla nozione di equilibrio, che testimonia l’influsso della mentalità fisico-matematica, del modello della meccanica, e di un indirizzo che la matematizzazione dell’economia, e più in generale delle scienze sociali, sta prendendo».
Agli inizi del Novecento la svolta, con i modelli per la dinamica delle popolazioni, l’epidemiologia matematica. Ed ecco la motivazione di Israel: «Conosciamo bene la versione più famosa e influente del riduzionismo, la concezione epistemologica che tende a formulare i concetti e il linguaggio di una teoria scientifica nei termini di una teoria considerata fondamentale. È l’argomento centrale di questo libro: il meccanicismo, che consiste nel ritenere che tutti i fenomeni si riducono a fenomeni di moto, per cui il fine fondamentale della scienza è ricondurre ogni forma di conoscenza alla meccanica». Ed è questa la malattia di fondo delle teorie matematiche utilizzate in ambiti non matematici e fisici.
Il matematico von Neumann nel 1932 scrive: «Le scienze non cercano di spiegare, a malapena tentano di interpretare, ma fanno soprattutto modelli. Per modello si intende un costrutto matematico che, con l’aggiunta di interpretazioni verbali, descrive dei fenomeni osservati. La giustificazione è soltanto e precisamente che funzioni, descriva correttamente i fenomeni in un’area abbastanza ampia, e soddisfi dei criteri estetici, cioè deve essere piuttosto semplice». Nei modelli biologici, a partire dalla dinamica delle popolazioni, via via che la complessità del sistema aumenta, non si ha un aumento di stabilità bensì del suo contrario.
Si trattava quindi di mettere in discussione i modelli matematici, cosa che, sottolinea Israel, non è mai stata lontanamente considerata. Tanto che nel 1976 i matematici Oster e Guckenheimer osservano: «Vi sono persone che affermano che non esiste un solo progresso nel campo della biologia che possa essere attribuito alle teorie matematiche. Quando entrano in gioco i sistemi complessi, il linguaggio appropriato è l’inglese, non quello matematico».
Alla luce delle ricerche recenti, ricorda Israel, «l’espansione della modellistica matematica in ambito biologico è diventata talmente frammentata da distruggere persino la possibilità di un confronto e sintesi tra le miriadi di modelli... malgrado alcune marginali differenze, si dimostra il ruolo centrale dell’analogia meccanica nel processo di fondazione dei più importanti settori della biologia matematica».
I successi predittivi della matematica in fisica non garantiscono analoghi successi in ambiti di natura ben diversa. Il tutto si complica ulteriormente quando si passa ai rapporti sociali ed economici. Entrano in gioco modelli teorici di matrice fortemente ideologica, come nel caso della teoria dell’equilibrio economico generale, i cui paradigmi fondazionali sono: dimostrare che l’equilibrio economico esiste, che tale equilibrio è unico, che il mercato possiede la virtù salvifica di realizzare tale equilibrio, purché non si introducano vincoli e legacci e l’azione dei singoli soggetti economici possa esplicarsi in piena libertà. Un paragrafo è dedicato alla scienza della complessità. «Il concetto di complessità - osserva Israel - continua a vagare in un limbo situato tra ontologia ed epistemologia. L’aspirazione a definirlo come una proprietà del mondo reale si scontra con la vaghezza delle definizioni di carattere empirico... D’altra parte ogni sua caduta nella sfera puramente epistemologica fa di esso una versione disillusa e pessimista del concetto di complicazione».
Le conclusioni di Israel: «La modellizzazione nell’ambito dei contesti non fisici non ha mai raggiunto neanche lontanamente l’ombra della precisione che ha raggiunto in gran parte dei contesti fisici... confrontare il grado di precisione che è possibile ottenere nel contesto dei fenomeni meccanici propriamente detti con quello sociale è desolante; nessun modello matematico è in grado di dire, neppure con un grado di approssimazione generoso, che cosa accadrà domani all’economia».
Un esempio è la valutazione della attività scientifica dei ricercatori mediante indicatori «oggettivi», che tendono a sostituire l’esame della qualità dei risultati. L’International Mathemathical Union ha osservato che si sta creando una cultura dei numeri per cui le istituzioni e gli individui credono che si possano ottenere decisioni eque mediante valutazioni algoritmiche e alcuni dati statistici. Non è certamente un caso che tale mitologia faccia presa su coloro che meno capiscono di numeri e scienza. Nell’ultimo capitolo si parla delle due culture, dello stretto legame tra letteratura, narrazione e matematica. Classico esempio la questione dell’infinito.
Nell’ Eloge des Mathématiques (2015) il filosofo francese Alain Badiou, invitando i filosofi a studiare la matematica moderna, scrive: «La matematica è la più convincente delle invenzioni umane per esercitarsi a quello che è la chiave sia di tutto il progresso collettivo comune che della felicità individuale: dimenticare i nostri limiti per arrivare all’universalità del vero». Dobbiamo ancora inventare e creare tanta matematica per affrontare le grandi questioni del nostro mondo, non solo nel senso di Galileo. Fortunatamente.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. --- NUMERI. La domanda è sempre la stessa (di Carlo Rovelli - L’arte di scolpire teoremi)15 marzo 2015, di Federico La Sala
Matematica
L’arte di scolpire teoremi
Da Pitagora a Gödel la domanda ricorrente sui numeri è sempre la stessa: esistevano già prima che li scoprissimo oppure li inventiamo?
di Carlo Rovelli (Il Sole-24 Ore, Domenica, 15.03.2015)
- Umberto Bottazzini, Numeri, il Mulino, Bologna, pagg.208, € 14,00
«Oh, amici, cosa sono dunque questi meravigliosi “numeri” sui quali voi state ragionando?». Così Platone ai matematici, nel VII libro della Repubblica. Ventiquattro secoli più tardi ci poniamo ancora la domanda. La risposta sembra facile: i numeri sono quelle “cose” come 1, 2, 3, 4 eccetera. Ma intanto ci sono altri numeri oltre a questi numeri “naturali”; per esempio, 3,14 è un numero. E poi, cosa sono queste “cose-numero”»? Sono una nostra invenzione, oppure sono qualcosa che esiste indipendentemente da noi?
Molti matematici rispondono con convinzione che i numeri, con tutta la matematica, esistono indipendentemente da noi. L’insieme delle verità matematiche forma una realtà astratta che i matematici vanno esplorando e scoprendo un po’ alla volta, come gli esploratori dell’Ottocento esploravano l’Africa. Alain Connes, grandissimo matematico francese, scrive che per lui i numeri hanno «una realtà più stabile della realtà materiale che ci circonda». Roger Penrose, grandissimo matematico inglese, gli fa eco: «C’è qualcosa d’importante che si guadagna pensando che le strutture matematiche abbiano una realtà in se stesse». Raro caso di accordo fra francesi e inglesi. Platone sarebbe stato felice di queste risposte: lui immaginava un mondo di idee perfetto, del quale il nostro mondo non sarebbe che un pallido riflesso. In questo ideale mondo platonico, la matematica aveva una posizione regina.
Ma ci sono altri modi di pensare cosa siano i numeri: per esempio un’utile costruzione che noi abbiamo inventato. Oppure l’utile sviluppo di un sistema di regole che noi decidiamo di studiare, perché è bello e perché ci torna utile. Insomma, una costruzione umana, molto umana. «Noi creiamo nuovi numeri», scriveva per esempio nel XIX secolo Richard Dedekind, il matematico che ha formulato la moderna teoria dei numeri che misurano quantità continue, come la lunghezza di un segmento.
La domanda sulla natura dei numeri apre e chiude un testo di Umberto Bottazzini, Numeri. Il libro è di facile lettura, ma denso di fatti di storia della matematica. Ripercorre secoli di evoluzione del concetto di numero, da Pitagora al teorema di incompletezza di Gödel. Si parla dei numeri naturali, delle complesse strutture che questi nascondono, come i numeri primi, ma anche dei numeri razionali, come 0,1, dei numeri reali, come la radice quadrata di due, dei numeri complessi, come la radice quadrata di -1 eccetera. Ciascuna classe di numeri con le sue proprietà, ciascuna rivelatasi poi utilissima, anzi essenziale, per la scienza.
Bottazzini prende risolutamente parte nella disputa sulla natura dei numeri, fino a concludere: «La credenza nell’esistenza di una matematica platonica che trascende i corpi e le menti umane e struttura il nostro universo - credenza che corrisponde alla filosofia “spontanea” diffusa fra i matematici - appare sempre più destinata a essere relegata a materia di fede, non dissimile dalla fede religiosa». Questa posizione anti platonica è illustrata ricordando il pensiero classico dei matematici dell’Ottocento che l’hanno sostenuta, ma soprattutto viene collegata da Bottazzini ai risultati recenti delle ricerche scientifiche sul modo in cui i numeri sono codificati nel nostro cervello, sulle capacità numeriche di altre specie animali e sulla variabilità nella padronanza dei numeri delle diverse culture umane.
Quello che emerge da questa sintesi è che forse non è del tutto vero che i numeri li «creiamo liberamente noi», come voleva Dedekind, ma solo nella misura in cui la nostra istintiva padronanza dell’azione del numerare non è che un risultato della nostra evoluzione biologica. Come in molti altri campi, la sensazione dell’esistenza di realtà trascendenti indipendenti da noi è un abbaglio, che viene dall’assumere che i termini del nostro linguaggio facciano sempre riferimento a qualcosa, quando invece spesso la loro funzione è diversa da quella di designare. Insomma, i numeri sono strumenti e forme di una attività in cui siamo impegnati, e alla quale in parte l’evoluzione ci ha predisposti, non entità con esistenza autonoma. E la sensazione dei matematici di scoprire cose che già esistevano?
Michelangelo ci ha lasciato scritto che uno scultore non crea una statua, perché la statua esiste prima dell’artista: è già nel blocco di marmo. Quello che l’artista deve fare è solo levare la pietra in più e «tirare fuori» la statua dal blocco di marmo. Nello stesso modo, dall’insieme amorfo e privo di senso di tutte le «proposizioni vere» che seguono dall’insieme di «tutti i possibili sistemi assiomatici», il matematico estrae, come Michelangelo dal marmo, gli scintillanti teoremi che fanno la bellezza e l’utilità della matematica. Agli occhi di Michelangelo, di Alain Connes o di Roger Penrose, forse non si tratta che trovare quello che già “esiste” - in fondo “esistere” è un verbo che possiamo usare come ci pare -. Ma agli occhi del resto di noi, sono Michelangelo e i Matematici che creano le forme. Le forme che parlano a noi che sono utili a noi che hanno senso per noi creature naturali in un mondo naturale. Senza bisogno di immaginare realtà al di là della realtà.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA --- "Our Mathematical Universe" (Max Tegmark): l’universo non è matematico, risponde comunque alla nostra realtà cerebrale (di Sndro Modeo)30 marzo 2014, di Federico La Sala
Niente illusioni, l’universo non è matematico
Per quanto possano apparire coerenti e ragionevoli i modelli aritmetici o geometrici, la rappresentazione del cosmo non è oggettiva
Risponde comunque alla nostra realtà cerebrale
di Sandro Modeo (Corriere della Sera La Lettura, 30.03.2014)
Narrazione saggistica serrata e avvolgente, il recente libro del fisico del Mit Max Tegmark (Our Mathematical Universe ) è un ambizioso tour de force sulle più aggiornate conoscenze fisico-cosmologiche, dalle fluttuazioni quantistiche all’estensione spazio-temporale dell’universo osservabile.
Insieme concreto e speculativo fino all’azzardo, Tegmark incrina il rigore teorico-sperimentale (Big Bang e Big Crunch, energia e materia oscura) con troppi cedimenti alla fisica fanta-new age (il multiverso e i mondi paralleli); ma fatta la tara a queste concessioni meta o patafisiche, il libro ha il merito indubbio di rilanciare con forza l’ipotesi, riassunta nel titolo, di un universo intrinsecamente fisico-matematico. Pur poggiandosi sulle più recenti teorie della coscienza, Tegmark vede infatti il cervello come una soglia più passiva che attiva, una mini-specola da cui osservare e scoprire - passo a passo - la rete immutabile di relazioni numeriche entro cui si organizzano stati e dinamiche della materia, dalle galassie più remote agli alberi di una foresta, dai moti dei pianeti al traffico urbano.
Nella sua versione hard - come quella di certi matematici «formalisti» - questa visione si spinge a rendere la trama matematica (aritmetica, geometria, algebra e topologia) totalmente autonoma non solo rispetto al Soggetto (al cervello), ma anche alla materia stessa. Questo senso di onnipotenza - come mostra il matematico Steven Strogatz nel suo La gioia dei numeri - è dovuto sia alle proprietà della disciplina (la sua coerenza, che si traduce spesso in concisione e bellezza), sia soprattutto alla sua efficacia descrittivo-esplicativa, tutt’altro che «irragionevole», come vorrebbe l’adagio di Eugene Wigner: vedi i nessi tra le equazioni differenziali e le leggi del moto, tra il calcolo infinitesimale e i cambiamenti di stato (dalle epidemie all’«effetto» di una palla), tra la logica binaria (0 e 1) e la codifica di suoni e immagini su un tablet. Vertice di questa efficacia sono forse le onde sinusoidali, che troviamo nelle dune desertiche, nelle vibrazioni della voce umana e nelle «increspature» della materia da cui si è originato il cosmo che abitiamo.
Eppure, ricorrendo a uno scienziato cognitivo come Stanislas Dehaene o alle riflessioni di un neurobiologo come Jean-Pierre Changeux (in un dialogo memorabile con il matematico Alain Connes), possiamo ribaltare la prospettiva, e vedere gli oggetti matematici (teoremi, proposizioni, assiomi) come «oggetti mentali stabili» prodotti dall’evoluzione, selezionati e aggregati via via proprio per la loro adeguatezza nell’aderire alle regolarità del mondo esterno, di cui il nostro cervello è incessantemente vorace per meglio adattarsi all’ambiente.
Questa continuità tra biologia e cultura è ben riassunta dalla simmetria, proiettata in tempi preistorici dalla nostra morfologia bilaterale in schemi di orientamento e giudizio estetico (la scelta del partner) e poi eletta a pattern artistico (come in un quadro di Piero della Francesca o in una fuga di Bach) e a principio di teorie matematiche come quella dei «gruppi», oggi decisiva nel tentativo di armonizzare la dimensione «macro» della gravitazione con quella «micro» dei quanti.
È una continuità che tocchiamo, ancora più concretamente, nel «senso dei numeri» di cui siamo tutti, più o meno, dotati: riscontrato anche in altri animali (le capacità di conteggio nei ratti e nei colombi) e nei bambini già tra 2 e 6 mesi, questa predisposizione ha prodotto, in vari periodi e regioni geografiche, sequenze sempre più complesse e astratte, dalle tacche sulle ossa neolitiche per conteggiare i successi di caccia ai recenti oggetti elastici della topologia (i nastri di Moebius usati per raddoppiare certe memorie informatiche), passando per le misurazioni astronomiche babilonesi o la trigonometria usata dagli agrimensori.
Ed è proprio questa storicità uno degli argomenti contro il platonismo matematico: perché se è vero che la matematica non patisce i vincoli delle scienze sperimentali - che le sue teorie non smentiscono le precedenti ma le integrano, com’è successo per le geometrie non euclidee con le euclidee - il suo processo cumulativo è ugualmente sottoposto a spietati scarti di ipotesi e a congetture tormentate, come conferma la «possessione» patologica di tanti grandi matematici.
E anche se Connes insiste nel distinguere l’immenso paesaggio matematico dai suoi esploratori (la Realtà matematica dagli strumenti che la decifrano), non bisogna dimenticare che quegli strumenti sono antropomorfici, vincolati alla categorie dell’immaginazione e della logica del cervello umano. Se così non fosse, l’adeguatezza descrittiva della matematica risulterebbe davvero «irragionevole».
Inoltre, indagare proprio le basi neurofisiologiche del «senso dei numeri» dissolve un altro equivoco: quello sulla glacialità anaffettiva della disciplina. Se è infatti innegabile che l’attività matematica coinvolga soprattutto aree corticali (in particolare la corteccia parietale inferiore), una simile specializzazione, come per tutte le funzioni cerebrali, va collocata in un contesto più plastico e distribuito.
Lo vediamo bene nella creazione-scoperta del matematico: da un lato (esemplare il caso «proustiano» di Poincaré, che vede emergere d’improvviso la soluzione d’un problema al rientro da un’escursione geologica, dopo averlo lasciato in stand-by ) anche le intuizioni matematiche seguono un processo di incubazione-ruminazione, per lo più inconscio, in cui l’illuminazione irrompe come risonanza di elementi preesistenti. Dall’altro, l’illuminazione stessa scatena un’intensa gratificazione del cervello «limbico» (affettivo-emotivo), tanto da essere paragonata da diversi matematici all’estasi mistica.
Potente in quanto linguaggio universale e privo di ambiguità, la matematica non può però trascendere limiti e vincoli; quelli intrinseci al suo stesso linguaggio (ben descritti da Gödel) e quelli dei matematici che lo producono, così come la fisica, nelle misurazioni subatomiche, ha dovuto affrontare l’interferenza dell’osservatore.
Non può cioè descrivere il mondo «dal punto di vista di Dio»: le sue complesse elaborazioni si adattano ma non coincidono con gli oggetti fisici: le traiettorie dei pianeti - ricorda Dehaene - non sono ellittiche, e la Terra non è perfettamente sferica. La realtà della materia conserva sempre un margine irriducibile di irregolarità, verso cui l’astrazione matematica è insieme approssimata e idealizzante, come un guanto elegante, ma - anche di poco - troppo stretto o troppo largo.
In quanto attività umana, la matematica può solo mediare tra le estensioni di materia «là fuori» (entità, proprietà e relazioni di un mondo senza etichette) e le elaborazioni che avvengono «là dentro», nella coscienza e soprattutto nell’inconscio della nostra materia cerebrale. In questo senso, e solo in questo senso, è lo strumento privilegiato che ci permette di essere «la misura di tutte le cose».
-
>LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! --- "Transcendence". «Cyber» cristiani? (si Andrea Vaccaro).19 giugno 2013, di Federico La Sala
IDEE
«Cyber» cristiani?
di Andrea Vaccaro (Avvenire, 19 giugno 2013)
Le parole - lo sappiamo - non hanno un copyright. Ed è anche lecito usarle con un certo margine di libertà. Così, non è infrequente che il loro significato slitti in modo sorprendente, per mutamento dei contesti, per ragioni inspiegate, per strategie ideologiche ...
Si pensi al significato antico e a quello attuale di "pneumatico", al senso etimologico di "pedofilia", al crocevia attuale in cui si trova il termine "matrimonio". Di peculiare importanza, in ambito filosofico-teologico, è il "travaglio" che sta vivendo, recentemente, l’espressione "trascendenza". Dopo la questione dell’anima, un altro cardine del pensiero religioso sta ricevendo una "particolare attenzione" dalla cultura contemporanea. Di trascendenza infatti si torna a parlare, mentre il "purtroppo" e il "per fortuna" combattono per completar la frase.
Sì, perché l’accezione ora di moda non è proprio quella canonica. Dall’ambito dei Principi singolaritiani, ad esempio, Eliezer Yudkowsky dichiara che un adepto della Singolarità «crede in una Trascendenza o un Evento Orizzonte», in perfetto ossequio al padre fondatore Vernon Vinge che nel suo manifesto La Singolarità tecnologica assicurava come «l’Intelligenza artificiale permette la nostra partecipazione ad una specie di trascendenza». Dai laboratori della Realtà Virtuale, d’altro canto, Michael Benedikt vaticina che nel cyber-spazio trascenderemo il mondo materiale e, per rendere più perspicua l’idea, predice che «potremo mangiare dell’Albero senza essere puniti, stare con gli angeli, entrare in paradiso e non morire» (Cyber-spazio).
Margaret Wertheim chiama con nonchalance tale insorgente trascendenza «Nuova Gerusalemme». Dal fronte della robotica, inoltre, abbiamo uno dei leader massimi, Hans Moravec, che ha posto il termine sin nel titolo del suo best-seller Robot. La pura macchina verso la mente trascendente. Poi c’è Ray Kurzweil, l’«uomo trascendente» per eccellenza (così è intitolato il docu-film tuttora in circolazione sulla sua vita e le sue invenzioni), autore di La Singolarità è vicina. Quando gli esseri umani trascendono la biologia (2005) e del più diretto Transcend (2009).
Su un piano maggiormente divulgativo, il cyber-scrittore cult William Gibson in Neuromante ci presenta Wintermute, un’Intelligenza artificiale con espliciti «desideri di trascendenza» ed è di questi giorni l’annuncio della preparazione di un nuovo film con mega-produzione e celebri star: Johnny Depp - o meglio il suo personaggio - morirà e la sua coscienza sarà fatta sopravvivere in una sorta di computer. Titolo senza orpelli e senza equivoci: Transcendence. L’uscita del film è destinata a scatenare un gran risuonare della parola "trascendenza" e sarà interessante riscontrare, in tale deflagrazione, come il suo significato originario verrà stiracchiato, ri-modellato, deturpato.
Dinanzi ad un incedere così incalzante del progetto, per così dire, di "ingegnerizzazione della trascendenza" si potrà obiettare che, in fondo, non c’è niente di granché nuovo sotto il sole. Non sono trascorsi poi molti decenni da quando una certa ideologia inneggiava, con Ernst Bloch, ad un «trascendere senza trascendenza, perché è l’avanti che attira - potendolo plasmare - piuttosto che il lassù» (Il principio speranza, 1959). La risposta più evidente e drammatica è pervenuta dalla storia; quella più arguta, forse, da Augusto Del Noce secondo cui, all’incirca, una trascendenza intramondana presto avvizzisce e, come una giovane avvenente divenuta vecchia, perde molto del suo impulso attrattivo (battuta da contestualizzare rigorosamente in epoca pre-gender).
Davvero, dunque, solo il ritorno di un’uguale questione già liquidata dalla storia e dalla filosofia? In realtà, nel ritorno della trascendenza di oggi, un nuovo attore è entrato vistosamente in scena: la tecnologia. Con un inaspettato dirottamento della trama.
Se infatti la trascendenza del marxismo e dell’umanesimo ateo aveva uno sguardo totalmente orizzontale, e verticale è la direzione della trascendenza tradizionale, si può avanzare che l’orizzonte della trascendenza tecnologica sia diagonale, o forse obliquo. Si ha un bel dire, infatti, con un malcelato sciovinismo di specie, che i computer fanno solo quello che l’essere umano dice loro di fare. In realtà, se la tecnologia elettrica cessasse improvvisamente di assisterci, con tutte le nostre abilità dismesse, cadremmo in un nuovo Medioevo. Rinascimento, al massimo.
Da qui derivano consapevoli sensi di dipendenza e di inferiorità nei confronti della tecnologia, stranamente affini al sentimento di creaturalità dell’essere religioso nei confronti di Dio. Così i piani vengono ad intrecciarsi ulteriormente e v’è qualche fondatezza nel chiedersi se dietro il fenomeno della trascendenza tecnologica vi sia solo un colossale equivoco, un preciso disegno ideologico anti-religioso oppure esso non sia altro che l’estremo grido verso il Cielo dell’essere umano contemporaneo, l’unico possibile in una cultura post-simbolica, iper-esplicitante e secolarizzata come la nostra.
In effetti, invertendo una rotta filosofica lunga quasi un secolo che opponeva senza attenuazioni efficientismo tecnico e afflato spirituale, cominciano sorprendentemente a proporsi - e proprio dall’ambito teologico - posizioni che interpretano la tecnologia come possibile Grande Medium per risvegliare sopite tendenze spirituali e per vincere quella singolare forma di xenofobia che attanaglia la nostra epoca: non più fobia dell’altra persona, ma fobia dell’altra dimensione dell’Essere.
Così, ad esempio, il teologo protestante Ronald Cole-Turner, nella silloge da lui curata Transhumanism and Transcendence (2012), pone l’obiettivo di «esplorare le forme del desiderio umano di trascendenza» presenti nella tecnologia; Giuseppe Tanzella-Nitti ravvisa in essa «categorie quasi teologiche», come l’anelito a superare la finitezza, una speranza di largo respiro nel futuro, l’aspirazione a conservare la memoria individuale e collettiva, la propensione ad una tessitura estesa di relazioni ... (Pensare la tecnologia in prospettiva teologica, 2011) e René Munnik della Facoltà teologica di Tilburg ha di recente avviato il progetto di ricerca "Trasformazioni della trascendenza nel contesto della cultura tecnologica".
Sembrerebbe il germogliare di una teologia della tecnologia di taglio radicalmente nuovo, tesa a leggere nella tecnica non più un farmaco per assopire - o allucinare - le tensioni trascendenti, ma un elisir per risvegliarle; una teologia desiderosa di approfondire (con uno speciale esercizio di "inculturazione") le innegabili propensioni spirituali della tecnologia e che, su questa base, si senta di consigliare - sulla falsariga del frequente invito «cristiani, entrate in politica» - un inusuale «cristiani, entrate in tecnologia!». Anche per rimarcare che la "trascendenza immanente" è una contradictio in terminis o, più poeticamente, un evocativo ossimoro, che per sua natura è efficace solo se delocalizza la ragione e rimanda altrove.
Andrea Vaccaro
-
>GALELO GALILEI ... LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! --- Immaginare diversamente la relazione con la trascendenza. La Chiesa ha bisogno di una riforma profonda (di Christian Terras - "Le Monde")15 febbraio 2013, di Federico La Sala
- AI CARDINALI, PER L’ELEZIONE DEL NUOVO PAPA, NELLA CAPPELLA SISTINA: GUARDARE IN ALTO! L’orologio della storia della Chiesa è fermo almeno da 500 anni. I Profeti e le Sibille insieme nella Volta della "Cappella Sistina" (Michelangelo, 1512) sono ancora un grosso problema ...
- IL MESSAGGIO EVANGELICO DEL(LA) "LUMEN GENTIUM" O IL CATTOLICESIMO RATZINGERIANO DEL(LA) "DOMINUS IESUS"? I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?". "Deus charitas est" (1 Gv. 4.8)! LA SOVRANA CERTEZZA DI BENEDETTO XVI - RATZINGER E L’OSCURO AVVENIRE DELLA CHIESA: IL SONNO DOGMATICO DEI VESCOVI.
La Chiesa ha bisogno di una riforma profondadi Christian Terras*
in “Le Monde” del 15 febbraio 2013 (traduzione: www.finesettimana.org)
Che il papa dia le dimissioni a causa dell’età, è già un fatto eccezionale! Ma che aggiunga a questa motivazione quella di un mondo che avanza troppo rapidamente per lui è una cosa da sottolineare. A questo punto, come interpreterà il suo atto, il suo successore? Per governare la barca di Pietro in un mondo ricco di cambiamenti, occorre un pontefice che li accolga o che li rifiuti? Alcuni riterranno che a questa alternativa manca la prospettiva di un’accoglienza critica della postmodernità. Perché, di fatto, le dimissioni di Benedetto XVI illuminano di nuova luce la crisi attraversata dalla Chiesa.
Dopo il grande discorso d’addio di Gesù, i suoi discepoli sanno di essere nel mondo senza essere del mondo, ma non hanno ancora finito di discernere il modo in cui possono essere testimoni del Vangelo. Ma da quando la religione non struttura più la realtà sociale, siamo messi di fronte ad una situazione inedita nella storia dell’umanità: quest’ultima può vivere come se Dio non esistesse!
Benedetto XVI ha lottato contro questa scomparsa di Dio come fondamento della verità dell’umano. Avrebbe lottato fino all’esaurimento? Stando così le cose, le sue dimissioni non sarebbero il segno di un fallimento di questa battaglia persa in anticipo?
Il prossimo papa potrebbe chiarire in quale modo la mentalità contemporanea ci permette di scoprire un nuovo volto di Dio, in fedeltà con l’itinerario di Cristo. Per il papa attuale, solo la sottomissione a Dio, e quindi alla sua Chiesa che ne interpreta le volontà, permette di scoprirla. Ma non è possibile immaginare diversamente la relazione con la trascendenza?
La Chiesa ci mostra un Dio nascosto nella carne del mondo che le autorità religiose rifiutano di vedere! Dio non è più in competizione con l’umanità. La sua alterità penetra il nostro desiderio, il suo infinito vive nella nostra finitezza. Gesù ci ha insegnato a scoprirlo nei più piccoli, che sono i suoi fratelli. La questione della verità è quindi intimamente legata a quella della solidarietà. Se Dio si fa solidale, è per insegnarci un altro modo di vivere con gli altri.
L’imitazione di Cristo ci proibisce quindi di assomigliare agli scribi che impongono agli altri i fardelli di una legge falsamente divina. Se il pontefice romano vuole assomigliare a Gesù dovrà, come lui, essere accogliente e dialogante, soprattutto con coloro che sono rifiutati. Non si tratta di carità compassionevole, ma di una lotta con coloro che rifiutano le strutture economiche e politiche inique.
Ma che la verità si trova in un dialogo solidale implica anche un nuovo modo di governare. I vescovi, tra cui quello di Roma, non possono più pretendere di sapere per e al posto degli altri. Sono al contrario invitati a cercare un Dio sempre più grande che sfugge ai nostri ragionamenti.
La Chiesa istituzionale adotta ancora nella maggior parte dei casi il comportamento dei farisei, nel meglio e nel peggio. Come loro, corre il rischio allontanarsi da coloro che credono, pensano e vivono diversamente da come prevedono le sue definizioni.
Certo, la Chiesa ha fatto, dal Vaticano II, degli sforzi di dialogo, ma a livello pastorale. La teologia non ne è stato toccata. Il catechismo resta lo stesso e le voci discordanti all’interno della Chiesa faticano a farsi sentire. E il cardinale Ratzinger è stato l’artigiano di una “stretta” sui teologi, privando la chiesa di una ricerca indispensabile, in particolare in dialogo con le scienze umane.
Questo modo di governare è diventato insopportabile per i nostri contemporanei per i quali l’autonomia è ineliminabile. È anche in contraddizione con la testimonianza del Nuovo Testamento.
Dall’accoglienza della Samaritana o dell’adultera a quella del buon ladrone sulla croce, Gesù ha spezzato i confini delle leggi disumane. Ogni incontro è stato l’occasione per dire un Dio che libera. Ha aiutato i suoi discepoli a trasgredire delle tradizioni percepite come divine mentre erano solo umane.
La Chiesa è ancora invitata a proseguire questo lavoro di decostruzione. Del resto Luca negli Atti non nasconde i conflitti che portarono la Chiesa ed abbandonare certe prescrizioni, inventando nuovi ministeri e precisando le esigenze della fede. Questi racconti devono ispirare l’agire pontificio.
In materia di morale familiare, ad esempio, è indispensabile un vero dialogo all’interno della Chiesa con le coppie divorziate risposate o le persone omosessuali, nonché il tener conto delle problematiche del genere. Le donne non potranno più essere ancora a lungo messe da parte e impiegate in compiti subalterni.
È anche urgente che il ministero petrino sia messo in tensione con la figura di Paolo: Pietro non ebbe ragione senza l’apostolo dei gentili. Tra i vescovi deve circolare una parola libera su tutti i problemi cruciali del nostro mondo. Non sono semplici cinghie di trasmissione della curia romana.
Inoltre, è altrettanto urgente uno scambio franco e onesto con le Chiese sorelle, soprattutto con i protestanti. È una condizione perché il vangelo si radichi in tutte le culture. Il papa non potrà neppure trascurare l’opinione dei fedeli. Ascoltare come rendono conto del loro modo di vivere, permetterà alla Chiesa di sfuggire alla logica caricaturale del bianco e nero, cercando il senso in tutte le zone grige delle nostre esistenze, per parlare come il defunto cardinal Martini.
In questo senso, ciò di cui la Chiesa ha bisogno non è tanto un nuovo concilio di vescovi, quanto una riforma fondamentale sui temi istituzionali e dottrinali. Essa potrà così essere testimone della pertinenza del cristianesimo nella nostra postmodernità e dire Dio diversamente in un nuovo modo di fare Chiesa, in un dialogo aperto con il mondo, per tentare di raccoglierne le sfide.
*redattore capo di “Golias Hebdo” e di “Golias Magazine”
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ---- FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI.4 ottobre 2012, di Federico La Sala
 AL DI LA’ DELLE "ROBINSONATE" (MARX) E AL DI LA’ DELL’EDIPO (FREUD). INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA. I soggetti sono due, e tutto è da ripensare...
AL DI LA’ DELLE "ROBINSONATE" (MARX) E AL DI LA’ DELL’EDIPO (FREUD). INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA. I soggetti sono due, e tutto è da ripensare...
 FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI. “Su Freud”, un’ottima introduzione a “La mente estatica”
FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI. “Su Freud”, un’ottima introduzione a “La mente estatica”
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. ---- Aprite quella porta sui numeri. A Venezia, il convegno «Matematica e cultura»(di Michele Emmer)28 marzo 2012, di Federico La Sala
 Matematica e cultura
Matematica e cultura Aprite quella porta sui numeri
Aprite quella porta sui numeri Non è facile decifrare la sua irragionevole efficacia
Non è facile decifrare la sua irragionevole efficacia
 Difficile ma ipnotica: “E’ la matematica a dominare ogni nostro gesto”
Difficile ma ipnotica: “E’ la matematica a dominare ogni nostro gesto” di Michele Emmer (La Stampa TuttoScienze, 28.03.2012)
di Michele Emmer (La Stampa TuttoScienze, 28.03.2012)Il 23 settembre 1949 va in stampa un libro destinato a diventare famoso: «Le modulor. Essai sur une misure harmonique à l’échelle humaine applicable universellement à l’architecture et à la mécanique». Autore Le Corbusier.
Aveva un sogno l’architetto francese: «Il mio sogno è di erigere, nelle aree fabbricabili, una griglia delle proporzioni, che serva come indicazione per l’intero progetto, un modello che presenti un’infinita serie di differenti combinazioni e proporzioni e che il muratore, il carpentiere, il falegname dovranno consultare ogni qualvolta debbano scegliere le misure per il loro lavoro; in modo che tutte le opere saranno unificate dall’armonia. Prendiamo un uomo con il braccio alzato che in questa posizione raggiunga l’altezza di due metri e venti... Con tale griglia da costruzione, disegnata per essere in armonia con l’uomo collocatovi dentro, sono certo che si otterranno una serie di misure concilianti la dimensione umana a quella matematica».
Perché la matematica? «La matematica è la struttura regale studiata dall’uomo per avvicinarlo alla comprensione dell’universo. Afferra l’assoluto e l’infinito, il comprensibile e l’eternamente ambiguo. Ha muri sui quali si può salire e scendere senza alcun risultato; ogni tanto c’è una porta, allora si apre, si entra e ci si trova in un altro regno, il regno degli dei, il luogo che racchiude la chiave dei grandi sistemi. Queste porte sono le porte del miracolo».
Qualche anno dopo, nel 1958, un artista olandese destinato a diventare famoso, Maurits C. Escher, apriva un’altra porta: «Mi è capitato di imbattermi nel problema della divisione regolare del piano, delle figure che si ripetono all’infinito. Ho visto un alto muro e, dato che avevo la premonizione che nascondesse un enigma, vi sono salito con qualche difficoltà. Una volta arrivato dall’altra parte, mi sono ritrovato in un luogo selvaggio e ho avuto grande difficoltà a trovare la mia strada, sino a quando sono arrivato alla grande porta aperta della matematica».
Negli stessi anni di Escher Paperino compiva un viaggio nel regno della «matemagica» che si concludeva con le parole: «Non ci sono limiti a ciò che la mente può concepire e creare. Ogni giorno che passa le porte si spalancano su nuove conquiste scientifiche e le porte che oggi sono chiuse saranno aperte domani, con la stessa chiave: la matematica! La matematica è l’alfabeto con cui Dio compose l’Universo».
I legami tra la matematica e le arti, la letteratura, la poesia, l’architettura, la musica, il teatro e il cinema, hanno una storia antica che si rinnova continuamente. Insomma, il rapporto è inestricabile e la matematica è parte essenziale della cultura. «La matematica è una forza culturale di primo piano nella civiltà occidentale ha osservato Morris Kline, nel 1953, in “Mathematics in Western Culture”. - La matematica ha determinato la direzione e il contenuto di buona parte del pensiero filosofico, ha distrutto e ricostruito dottrine religiose, ha costituito il nerbo di teorie economiche e politiche, ha plasmato i principali stili pittorici, musicali, architettonici e letterari, ha procreato la nostra logica e ha fornito le risposte migliori che abbiamo alle domande fondamentali sull’uomo. Infine, essendo una realizzazione incomparabilmente raffinata, offre soddisfazioni e valori estetici almeno pari a quelli offerti da qualsiasi altro settore della cultura». Si dirà, parole di un matematico!
Non ci sono dubbi che negli ultimi anni, oltre ad un travolgente utilizzo di idee e strumenti matematici in tutti i campi del sapere e delle tecnologia, i rapporti tra matematica e cultura hanno visto una grande ripresa. Dal teatro all’architettura. In questo ultimo caso non solo come strumento del costruire, ma come fonte di ispirazione di nuove forme e idee. Il che non deve tuttavia far cadere nell’errore che la matematica sia una disciplina semplice e facilmente divulgabile.
«La matematica è un mondo a sé stante e bisogna viverci a lungo per sentire tutto ciò che necessariamente vi appartiene», ha osservato Robert Musil ne «I turbamenti del giovane Törless». A se stante ma, per dirla con una frase del fisico Eugene P. Wigner, è indubbia «l’irragionevole efficacia della matematica», non solo per le scienze della natura ma anche nella cultura. «La matematica non è solo uno dei mezzi essenziali del pensiero primario, ma anche una scienza delle proporzioni. E, poiché questa scienza ha in sé questi elementi fondamentali e li mette in relazione significativa, è naturale che simili fatti possano essere trasformati in immagini». Parole di uno dei grandi artisti del Novecento, Max Bill, nell’articolo «Il modo matematico di pensare nell’arte del nostro tempo», pubblicato nel 1949, lo stesso anno del libro di Le Corbusier.
A questi temi è dedicato da 14 anni, a Venezia, il convegno «Matematica e cultura»: l’edizione che si apre il 30 marzo tratterà di cinema, letteratura, musica e della tante applicazioni della matematica (info su www.mat.uniroma1.it/venezia2012). Con un omaggio a un genio dei numeri come Alan Turing: nel 2012 si celebrano i 100 anni della nascita.
*
 E’ PROFESSORE DI MATEMATICA ALL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
E’ PROFESSORE DI MATEMATICA ALL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
 IL LIBRO: «NUMERI IMMAGINARI. CINEMA E MATEMATICA» BOLLATI BORINGHIERI"
IL LIBRO: «NUMERI IMMAGINARI. CINEMA E MATEMATICA» BOLLATI BORINGHIERI" -
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA ---- Antropologia e matematica. Dai modelli della complessità la nuova interpretazione del linguaggio.16 febbraio 2012, di Federico La Sala
Antropologia e matematica
Alla Fondazione Isi e all’Università La Sapienza le ricerche sull’origine della comunicazione
Così imparammo a dire rosso
Dai modelli della complessità la nuova interpretazione del linguaggio
di Gabriele Beccaria (La Stampa TuttoScienze 15.02.2012)
 Vittorio Loreto Fisico RUOLO: E’ PROFESSORE DI FISICA ALL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA E COORDINATORE DEL GRUPPO DI «INFORMATION DYNAMICS» ALLA FONDAZIONE ISI DI TORINO
Vittorio Loreto Fisico RUOLO: E’ PROFESSORE DI FISICA ALL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA E COORDINATORE DEL GRUPPO DI «INFORMATION DYNAMICS» ALLA FONDAZIONE ISI DI TORINOSe le parole si inceppano, meglio saltare sui numeri. Per esempio quando si indagano le acrobazie dei linguaggi, come sbocciano e si trasformano, come si impongono e si estinguono. E infatti nella nicchia ecologica dei linguisti si stanno intrufolando i fisici ed i matematici, trascinando con sé la potenza di calcolo delle formule e i verdetti spiazzanti degli algoritmi. E non solo. Insinuano punti di vista inattesi e a volte provocatori, incrinando la sacralità di quella che consideriamo la nostra dote più sofisticata, e allo stesso tempo plasmano modelli inediti per rispondere a un interrogativo antichissimo: perché parliamo e così tanto?
Professor Vittorio Loreto, lei è fisico all’Università La Sapienza di Roma e coordinatore del gruppo di «Information Dynamics» alla Fondazione ISI di Torino ed è proprio uno di questi «alieni»: incrocia strumenti teorici e computazionali (come i giochi linguistici) con test sul Web. Che cosa pretendono di svelare i suoi numeri?
«Partiamo dal metodo: il mio team costruisce dei modelli sintetici al calcolatore, che riproducono le interazioni tra coppie di individui e le replicano in serie per studiarne gli effetti su larga scala. Si tratta di simulazioni numeriche, con cui si esplorano alcune ipotesi cognitive sui modi in cui comunichiamo».
Lei si è interessato, tra l’altro, a come si possano inventare i nomi dei colori.
«In particolare all’universalità della categorizzazione dei colori. Si è osservato che in alcune popolazioni pre-industrializzate i nomi dei colori primari si limitano a due e indicano il chiaro e lo scuro. Quando emerge un terzo vocabolo, questo è quasi invariabilmente il rosso, seguito - di nuovo in una successione pressoché costante dal verde e dal giallo e in una fase ulteriore da blu, marrone e poi violetto, rosa, arancio e grigio. Finora nessuno aveva dato una spiegazione convincente di questo ordine».
Qual è l’interpretazione?
«Siamo partiti da un punto fondamentale, anteriore al linguaggio stesso e di tipo fisiologico: ciò che ci accomuna è il potere risolutivo dell’occhio, vale a dire la capacità di discriminare i colori sulla base delle loro frequenze. Per alcune, come il blu o l’arancio, siamo più sensibili, mentre nei confronti di altre, come il rosso, abbiamo prestazioni inferiori. La conseguenza è significativa».
Può spiegarla?
«Se si ha una bassa capacità di discriminazione per le tonalità del rosso, è probabile che le persone si accorderanno rapidamente su che cosa sia. Quando invece cresce l’accuratezza della visione di altre tonalità, tipo il blu o l’arancio, l’accordo su ciò che sono e non sono richiede molto più tempo, perché si moltiplicano i distinguo. Queste differenze sono importanti, perché permettono di stabilire delle ipotesi con cui quantificare i tempi evolutivi richiesti per far emergere un sistema condiviso con il quale nominare i colori. Sono risultati nuovi, numerici, appunto, con i quali cominciamo a osservare il linguaggio a partire da principi di comunicazione».
Si riferiscono ai «giochi linguistici», in cui riproducete la transizione da una fase di frammentazione della comunicazione a un’altra di consenso generalizzato?
«Partiamo da simulazioni della comunicazione tra due persone e le allarghiamo a intere popolazioni, analizzando modi e tempi. L’approccio vale per le categorie dei colori, ma anche per altre realtà a cui ci stiamo dedicando: l’emergere delle strutture sintattiche, per esempio, oltre che dei significati e dei simboli».
E così ai linguisti «tradizionali» servite un’ingombrante sorpresa, cioè una nuova disciplina, la «linguistica in silico»: non vi accontentate di teorie, ma tentate esperimenti su larga scala.
«La chiamiamo “in silico” per le caratteristiche dei test: vengono condotti con i calcolatori sia su popolazioni artificiali sia in modi ancora più sofisticati. Alla Fondazione ISI e all’Università Sapienza studiamo come utilizzare il Web, esaltandone le caratteristiche di laboratorio ideale. Se finora le scienze sociali dovevano accontentarsi di campioni limitati, ora i social networks garantiscono una base enorme di utenti e permettono di riprodurre realisticamente i protocolli d’interazione tra individui, e non solo in ambito linguistico».
Può fare un esempio?
«“Mechanical Turk”: è una piattaforma Web che riproduce un mercato del lavoro virtuale, in cui gli utenti svolgono una serie di compiti - dalla categorizzazione di immagini alla trascrizione di registrazioni - e vengono retribuiti da specifici “datori di lavoro”. E’ l’esempio di una tendenza generale in cui il Web sta diventando un’infrastruttura per una “computazione sociale”, poiché consente di coordinare le capacità cognitive di computer umani, realizzando così esperimenti di massa nell’ambito delle scienze sociali. Si tratta di uno scenario agli albori, ma ricco di promesse e applicazioni: all’ISI e alla Sapienza lavoriamo a un progetto europeo sulle dinamiche di opinione. Vogliamo capire come si formano e si trasformano, dall’inquinamento ai cambiamenti climatici».
Ritorniamo al linguaggio: una volta filtrato dai numeri, che cosa appare?
«Un sistema complesso. Dall’interazione ripetuta di tanti elementi semplici vengono alla superficie esiti non prevedibili. Il linguaggio significa cambiamenti continui: ecco perché abbiamo appena iniziato a scalfirne i misteri».
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. ---- Tra chi predica che la Verità è Unica, Assoluta (e lui ne è depositario), e chi sostiene che non c’è criterio generale per scegliere fra le opinioni, esiste una terza strada: quella della discussione e della ragione (di Carlo Rovelli - Ebbene sì la Terra è rotonda).27 settembre 2011, di Federico La Sala
 Ebbene sì, la terra è rotonda
Ebbene sì, la terra è rotonda
 Perché non tutte le teorie sono equivalenti
Perché non tutte le teorie sono equivalenti
 Non sempre è decisivo il contesto culturale: i cinesi hanno accettato Eratostene
Non sempre è decisivo il contesto culturale: i cinesi hanno accettato Eratostene
 Lo studioso interviene nel dibattito e spiega il punto di vista della scienza: non si possono costruire dei modelli indipendenti dalla realtà
Lo studioso interviene nel dibattito e spiega il punto di vista della scienza: non si possono costruire dei modelli indipendenti dalla realtà di Carlo Rovelli (la Repubblica, 27.09.2011)
di Carlo Rovelli (la Repubblica, 27.09.2011)Il Zhou Bi Suan Jing (il "Classico dell’Aritmetica") è uno dei più antichi testi di matematica cinesi, completato intorno al III secolo a. C. Il libro discute, tra l’altro, della variazione dell’altezza del sole andando verso sud (a Palermo il sole è più alto nel cielo che a Milano). Basandosi sull’idea che la Terra sia piatta, lo Zhou Bi Suan Jing calcola che il Sole sia a circa 10.000 "li" sopra alla nostra testa: poche migliaia di chilometri. Più o meno nello stesso periodo, in Egitto, il direttore della Biblioteca di Alessandria, Eratostene, utilizza la stessa misura, ma si basa sull’idea che la Terra sia una sfera, e conclude che il Sole è lontanissimo e il perimetro del nostro pianeta è 252.000 "stadi", cioè 40.000 chilometri: la dimensione della Terra riportata oggi negli atlanti. Il contesto culturale della Cina della dinastia Han è molto diverso da quello del Mediterraneo Ellenistico, e culture diverse danno interpretazioni diverse della stessa osservazione. L’occidente continuerà a immaginare la Terra come una sfera (pensate a Dante), e il Sole molto lontano e grande; mentre la Cina continuerà a pensare che il Sole sia una pallina, e la Terra sia piatta.
Eratostene e lo Zhou Bi Suan Jing hanno egualmente ragione, ciascuno all’interno del proprio contesto culturale? Oppure Eratostene è più vicino alla realtà? Per usare la bellissima domanda con cui Gianni Vattimo chiude il suo dialogo con Maurizio Ferraris su Repubblica: dando ragione ad Eratostene, «credi davvero di parlare from nowhere?», di accedere alla realtà, parlando da un luogo fuori da ogni contesto culturale? Se diciamo che Eratostene ha ragione, non stiamo forse esprimendo nient’altro che assunzioni arbitrarie del nostro contesto culturale? Vattimo e Ferraris ripropongono, in versione un po’ italiana, una vasta questione che ha interessato la filosofia europea ed americana, la cui eco era giunta al pubblico italiano nel "dibattito fra Analitici e Continentali" lanciato diversi anni fa da Armando Massarenti. È difendibile il realismo, messo in discussione da Vattimo e difeso da Ferraris, cioè la tesi che cose e proprietà esistano indipendentemente dalle convinzioni, dagli schemi concettuali, o dal contesto culturale?
Torniamo in Cina. Verso la fine del 1500 arrivano in Cina i gesuiti, guidati da Matteo Ricci, colto astronomo. Quando i gesuiti vengono a conoscenza delle idee dell’Istituto Imperiale di Astronomia, sorridono. Quando i Cinesi ascoltano dai gesuiti le idee astronomiche occidentali, in brevissimo tempo rinunciano al proprio punto di vista, e adottano la prospettiva occidentale. Si badi, erano tempi politicamente non sospetti: l’esercito del Celeste Impero avrebbe spazzato via facilmente qualunque armata europea. Non è certo stata la forza politica a convincere i Cinesi che l’"interpretazione" occidentale fosse migliore. Cos’è stato? L’osservazione che i valori del vero e del falso sono intimamente influenzati dal contesto culturale è profonda ed intelligente. Parliamo dall’interno di sistemi di credenze, più o meno coerenti. Ma da questo non segue che non si possano mettere a confronto idee diverse, confrontarle, scegliere fra queste e imparare qualcosa "sulla realtà". Soprattutto non segue che la scelta sia solo questione di rapporti di potere o fattori irrazionali. La scelta può essere, anzi, il più delle volte effettivamente è determinata da un serio uso della ragione critica, che ci aiuta a vedere quale fra due alternative sia migliore: più coerente, più efficace e più confortata dai fatti.
Il motivo è che i nostri sistemi di pensiero non sono chiusi in sé stessi. Sono strutturalmente rivolti all’esterno e in continuo dialogo e scambio. Il nostro pensiero è pensiero sulla realtà, ed è in relazione costante sia con fatti inaspettati, con "la realtà, dura e irriducibile, che ci fa cambiare idea", sia con idee diverse. In questo confronto cresce, si modifica, e apprende. Il dialogo, se è sereno, può arrivare a mostrare chi ha ragione e chi ha torto. L’intera storia della scienza, antica e moderna, è una lunga dimostrazione dell’efficacia della ragione: i dibattiti sono feroci, ma prima o poi si arriva a comprendere chi ha ragione e chi ha torto. La Terra è rotonda, non è piatta.
Ragione e torto dal punto di vista di chi? Dal punto di vista from nowhere? No, dal punto di vista degli stessi dialoganti. Il confronto con opinioni diverse e con i fatti esterni conforta una posizione e ne indebolisce un’altra, per quanto la «realtà dei fatti» sia filtrata dalle interpretazioni. Per quanto si voglia interpretare la Terra come piatta, arriva comunque il giorno in cui fare i conti con la nave di Ferdinando Magellano, partita verso occidente e tornata da oriente. Impariamo qualcosa sulla realtà.
L’Italia, ha una difficoltà particolare ad accettare l’idea che si possa dialogare serenamente, cambiare idea ascoltando altri, e arrivare a trovare insieme una convinzione più fondata o una soluzione migliore. Manchiamo di una tradizione di democrazia, dove questo modo di mettersi a confronto abbia avuto tempo di affinarsi. Siamo abituati a lasciar decidere dominatori stranieri, principi, vescovi, o capi carismatici, invece che cercare soluzioni ragionevoli discutendo. Ci facciamo forti di alleanze e reti di amici, piuttosto che di argomenti convincenti. Siamo l’unico paese del mondo in cui nei dibattiti televisivi si toglie la parola all’altro; in ogni altro paese, chi interrompe è giudicato poco credibile dal pubblico: vuol dire che non ha buoni argomenti. Condividiamo con l’Iran il dubbio primato di essere i paesi che si fanno più influenzare da una potente casta sacerdotale. Io ho simpatia per il ribellismo irriducibile di Gianni Vattimo e la sua voglia di cambiamento. Ma dalla democrazia di Atene alla rivoluzione francese, un’arma di cui l’umanità dispone per difendersi dalla concentrazione del potere, come dalla dittatura mediatica, è la ragione.
Credo che l’equivoco di fondo sia confondere conoscenza e certezza. L’umanità vorrebbe un’àncora alla quale aggrappare certezze. Per il pensiero antico poteva essere la fiducia in negli dèi, un Sacro Testo, gli Ayatollah, o il Santo Padre. All’inizio del mondo moderno i limiti della Tradizione diventano palesi e la certezza è cercata nell’esperienza o nella ragione astratta. Nel XIX secolo sembra che la Scienza possa fornire risposte certe, prima di scoprire che perfino le efficacissime teorie di Newton sono poi messe in dubbio da Einstein. Abbiamo imparato che non esistono garanzie su cui fondare certezze. Ma questo non toglie che possiamo riconoscere le soluzioni più ragionevoli e il sapere più credibile. Possiamo ragionevolmente conoscere la realtà indipendente da noi. L’irriducibilità dell’esperienza e l’accordo a cui arriviamo sono le nostre garanzie, imperfette ma sufficienti, che stiamo parlando di una realtà indipendente da noi. Tra chi predica che la Verità è Unica, Assoluta (e lui ne è depositario), e chi sostiene che non c’è criterio generale per scegliere fra le opinioni, esiste una terza strada: quella della discussione e della ragione.
La Cina di oggi sta lentamente avviandosi a tornare quella che è stata per la maggior parte dei cinquanta secoli di civiltà umana: la più grande potenza del pianeta. Non sappiamo se ci riuscirà, né che idee porterà. Ma certo tra queste non ci sarà l’idea che il sole sia a 10.000 "li" e la Terra sia piatta. Perché? Semplicemente perché nonostante le differenze iniziali, grazie al dialogo e al confronto sereno fra interpretazioni diverse, abbiamo trovato ottime ragioni per credere che la Terra sia "realmente" rotonda.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... Nessun dubbio, ecco il vero Cartesio. Intervista a teologo e storico francese Jean-Robert Armogathe.21 settembre 2011, di Federico La Sala
INTERVISTA
Nessun dubbio, ecco il vero Cartesio
«La spiegazione del mondo della teologia cristiana e quelle della scienza contemporanea esprimono i presupposti fondamentali e comuni di un ordine del mondo e di una singolarità dell’essere umano nell’insieme dell’universo. In fondo, è una conseguenza di quanto aveva già intuito Cartesio». *
Anche per questo, sostiene il noto teologo e storico francese Jean-Robert Armogathe, rileggere oggi le opere di René Descartes, e in particolare le sue Meditazioni metafisiche, non è di certo un’avventura oziosa. Con il declino dei più chiusi razionalismi e scientismi del secolo scorso, il XXI secolo torna sensibile alla lezione cartesiana. Armogathe, specialista di Cartesio e direttore di ricerche all’Ecole pratique des hautes études di Parigi, oltre che sacerdote con importanti missioni pastorali, ne discuterà oggi a Sassuolo in piazza Avanzini alle ore 11,30, nel quadro del Festival Filosofia di Modena, dedicato quest’anno alla Natura.
Padre Armogathe, Cartesio è spesso ricordato per aver postulato il dubbio iperbolico, in particolare nelle «Meditazioni metafisiche». Dove risiede l’originalità di quest’approccio?
«Il dubbio radicale di Cartesio si distingue chiaramente dalla tradizione scettica. Almeno in due modi. Innanzitutto, è un dubbio metodologico, necessario per compiere un percorso. Cartesio non dubita per dubitare, ma per ricercare la verità. È un dubbio provvisorio. In secondo luogo, è molto più radicale del dubbio degli scettici. Solo il pensiero, trovandosi al di là del dubbio, può in tal modo fondare l’esistenza permettendo di uscire dallo stesso dubbio».
Nelle «Meditazioni», le dimostrazioni razionali restano in simbiosi con una sorta di ascesi quasi religiosa. Un paradosso?
«Si tratta di un testo probabilmente unico nella storia del pensiero occidentale. A parte certi dialoghi di Platone, non abbiamo altri esempi di testi filosofici che in così poche pagine contengono uno sviluppo tanto profondo e radicale. È un testo nervoso e alla prima persona, ma il paradosso fra ragione e meditazione è solo apparente. Quando si qualifica Cartesio come padre della razionalità moderna, non bisogna pensare al razionalismo, come fanno molti, ma alla ragione come insieme complesso dove convergono nella ricerca della verità pure le passioni dell’anima, le circostanze e l’insieme della personalità umana. L’evidenza e la chiarezza sono ingredienti del percorso filosofico così come le passioni. L’uomo non è una terza sostanza, ma l’unione sostanziale del corpo e dell’anima».
Come altre grandi figure del suo tempo, Cartesio si preoccupa al contempo di scienza e teologia...
«Cartesio non era un ecclesiastico, né un professore di filosofia, ma un gentiluomo con trascorsi giuridici e funzioni nell’esercito. Così fiero della sua geometria e della sua matematica, Cartesio ha cercato di fondare un mondo meccanico, ma ha provato al contempo il bisogno d’indagare sulle radici metafisiche del mondo. Sarà così in parte ancora per Newton, il quale tuttavia nasconderà la sua importante produzione teologica ed esegetica. Nel frattempo, è infatti avvenuta una sorta di cesura fra scienza e religione. Per Cartesio, invece, la cesura non esiste. L’esempio più eloquente della sua fisica consiste in una riflessione sulla transustanziazione eucaristica».
In molte ricerche dedicate al Seicento, lei ha evidenziato i legami fra scienza e modelli teologici. Può parlarcene?
«Fino al Seicento, è rimasta vitale una corrente scientifica spesso definita come fisica mosaica. La Bibbia veniva di fatto utilizzata come un libro di scienza. Ma al contempo, già nello stesso secolo, si è osservato il processo inverso. Si è cercato d’interpretare la Bibbia a partire dalla scienza, ad esempio per mostrare Mosé come un atomista. Oltre che da parte del Newton rimasto segreto, questi sforzi proseguiranno in modo minoritario anche nel Settecento. Lo stesso Hegel sarà un erede di questa tradizione».
Si potrà parlare anche in seguito di un certo substrato teologico nella scienza occidentale?
«Si può evocare il concetto di matrice dell’origine delle idee scientifiche. Ebbene, in tale matrice, c’è una dimensione teologica. Il mondo occidentale ha creduto in una creazione ordinata ed ha così potuto cercare delle leggi nel mondo. Il mondo occidentale ha creduto nell’incarnazione di Dio ed ha così potuto costruire un’antropologia specifica. Il discorso scientifico corrente sul mondo e sull’uomo ha ancora nella propria matrice forti componenti teologiche cristiane».
Ciò fu vero anche per figure come Galileo?
«Già attento lettore di Dante, Galileo rimase a lungo sotto l’influenza dei padri gesuiti del Collegio romano. Le ricerche tanto di Galileo quanto del suo contemporaneo Keplero furono profondamente segnate dal quadro religioso del tempo. Si pensi alla lettera a Cristina di Lorena in cui Galileo sottolinea la differenza fra la Bibbia e la scienza. Si può sottolineare questa differenza perché si è all’interno di un sistema religioso».
Riflessioni dal sapore talora religioso sono riemerse nel Novecento con scienziati come Einstein. L’eterno ritorno dello spirito cartesiano?
«In un certo senso, sì. In proposito, è importante ricordare pure la fecondità dell’influenza contraria, quella della scienza sulla teologia. Oggi, dopo gli scontri ideologici del XX secolo, siamo alla ricerca di una nuova logica capace di schivare tanto il dogmatismo, quanto il relativismo. Cartesio può aiutarci. Penso in particolare alla sua sesta meditazione, che segna un ritorno alla natura e alla scoperta del mondo esteriore».
Daniele Zappalà
* Avvenire, 16 settembre 2011
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E IL MAGISTERO RATZINGERIANO AL C.N.R.: CASO DE MATTEI. A VERGOGNA DELLA COMUNITA’ SCIENTIFICA E ACCADEMICA ITALIANA, CATTOLICA E LAICA.12 aprile 2011, di Federico La Sala
 SCIENZA E FEDE DELLA CHIESA DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
SCIENZA E FEDE DELLA CHIESA DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
 MAGISTERO RATZINGERIANO AL C.N.R.: CASO DE MATTEI. A VERGOGNA DELLA COMUNITA’ SCIENTIFICA E ACCADEMICA ITALIANA, CATTOLICA E LAICA. Un’intervista al "fondamentalista non riluttante" di Antonio Gnoli e una nota su "il barone e l’invertito" di Marco D’Eramo
MAGISTERO RATZINGERIANO AL C.N.R.: CASO DE MATTEI. A VERGOGNA DELLA COMUNITA’ SCIENTIFICA E ACCADEMICA ITALIANA, CATTOLICA E LAICA. Un’intervista al "fondamentalista non riluttante" di Antonio Gnoli e una nota su "il barone e l’invertito" di Marco D’Eramo
 ROBERTO DE MATTEI. «Io ripropongo una cosmologia cristiana che fa capo alla stessa visione di Benedetto XVI»
ROBERTO DE MATTEI. «Io ripropongo una cosmologia cristiana che fa capo alla stessa visione di Benedetto XVI»
 MARCO D’ERAMO. È così che discepoli di Galileo, scienziati evoluzionisti e baciapile oscurantisti vivono tutti insieme felici e contenti.
MARCO D’ERAMO. È così che discepoli di Galileo, scienziati evoluzionisti e baciapile oscurantisti vivono tutti insieme felici e contenti.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. ----NON SAPPIAMO ANCORA DEL NUMERO E DELL’UOMO! MATEMATICA E CIVILTA’: UNA CRISI EPOCALE.23 febbraio 2011, di Federico La Sala
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... IL "SIDEREUS NUNCIUS", OGGI.28 gennaio 2011, di Federico La Sala
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. ---- The lost women of Victorian science (Le donne dimenticate della scienza vittoriana).Per secoli la Royal Society ha escluso le studiose.23 novembre 2010, di Federico La Sala
Per secoli la Royal Society ha escluso le studiose. Adesso un libro racconta le invenzioni al femminile
Dall’astronomia alla matematica Londra riscopre le donne scienziate
In età vittoriana i colleghi uomini facevano di tutto per sminuirne il valore
di Enrico Franceschini (la Repubblica, 23.11.2010)
Fondata nel 1660 per discutere le idee del filosofo Francis Bacon, la Royal Society non è solo l’accademia delle scienze inglese e una delle confraternite di scienziati più antiche e prestigiose del mondo: è anche, e soprattutto, il simbolo della scienza intesa come progresso umano, come costante avanzamento della società in cui viviamo. Ma c’è un campo in cui l’illustre istituto londinese è avanzato poco, tardi e male per gran parte della sua storia: quello della parità dei sessi. La lista dei suoi cervelloni, da Isaac Newton in poi, è un elenco maschile, come se fossero stati soltanto gli uomini a scrivere la storia delle scoperte e della sperimentazione. Solo nel 1945, in effetti, la Royal Society ha emendato le proprie norme ammettendo le donne fra i soci (prima fece un’eccezione per la regina Vittoria, nominata membro onorario). E perfino oggi, nelle celebrazioni per il 350esimo anniversario della sua fondazione, fra i tanti seminari, mostre e pubblicazioni che hanno festeggiato l’evento, risaltava una vistosa assenza: quella delle scienziate, sebbene ora nelle sue file ce ne siano sessanta su 1200 membri, tra cui l’italiana Rita Levi Montalcini.
Non si tratta di semplice dimenticanza o indifferenza. Uno storico inglese, Richard Holmes, il primo a ottenere libero accesso agli archivi della Royal Society, ha portato alla luce una politica di deliberata discriminazione nei confronti delle donne e di occultamento del loro ruolo. C’erano anche delle scienziate, studiose di matematica, astronomia, botanica e altre discipline, nell’era del grande progresso scientifico: ma i loro colleghi uomini, a dispetto dell’ambiente illuminato dell’accademia delle scienze, facevano di tutto per sminuirne il valore e tenerle nascoste. Giunge dunque come atto riparatore il libro di Holmes, The lost women of Victorian science (Le donne dimenticate della scienza vittoriana), pubblicato in questi giorni in Gran Bretagna.
Nell’Inghilterra vittoriana, il concetto di donne impegnate nella ricerca scientifica veniva regolarmente ridicolizzato, scrive l’autore. Un famoso studioso del tempo, il naturalista Thomas Henry Huxley, soprannominato "il bulldog di Darwin", così scriveva nel 1860 a un collega geologo: «I cinque sesti delle donne si fermano allo stato evolutivo delle bambole, degradando qualsiasi cosa in cui si intrufolano». Gli unici settori in cui veniva tollerata la loro presenza erano la geologia e la botanica, sebbene quest’ultima fosse giudicata dai puritani moralmente pericolosa, a causa dell’esame degli apparati sessuali delle piante. Molti scienziati, ha appurato Holmes frugando negli archivi, condividevano il luogo comune secondo cui il cervello femminile sarebbe "fisiologicamente inadatto" al lavoro scientifico, alle procedure di laboratorio, alla matematica. In realtà era adatto, eccome.
Da Caroline Herschel, l’astronoma scopritrice di comete, ad Ada Lovelace, la matematica autrice dell’algoritmo poi considerato il primo "programma per computer", da Anna Barbauld, la chimica che notando le reazioni ai test di laboratorio scrisse il primo trattato sui diritti degli animali, a Jane Marcet, autrice dei primi manuali scolastici per popolarizzare la chimica e la botanica, da Mary Sommerville, che coniò il temine "scienziato", a Margaret Cavendish, autrice del primo racconto di fantascienza, le donne diedero un contributo fondamentale allo sviluppo della scienza, afferma il libro-denuncia dello storico. Un contributo riassumibile nelle parole dell’astronoma Maria Mitchell: «Anche la scienza ha bisogno di immaginazione. In essa non c’è solo matematica e logica, ma pure bellezza e poesia». Un uomo, da solo, non ci sarebbe mai arrivato.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. ----- CONTIAMO E PENSIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE!!! CONTARE E PENSARE: MARE, "NUMERO E LOGOS".4 ottobre 2010, di Federico La Sala
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. ---- «Sto tentando di dimostrare che la matematica contemporanea è inconsistente».Parla Edward Nelson (di Luigi Dell’Aglio - Ma far di conto è un’arte spirituale).17 agosto 2010, di Federico La Sala
INTERVISTA. Serve pure per lanciare i missili nello spazio, ma l’essenza della matematica sta altrove. Parla Nelson, che sarà al Meeting di Rimini
Ma far di conto è un’arte spirituale
«Il mio ruolo è interiore Quando Dio chiederà conto della mia vita, gli riferirò della ricerca sui numeri perfetti...» «Il 99% del nostro lavoro ha solo interesse tecnico, però le formule più affascinanti e belle sono quelle ’inutili’»
DI LUIGI DELL’AGLIO (Avvenire, 17.08.2010)
Sono i primi anni Sessanta e a Edward Nelson, giovane professore a Princeton, dove segue gli studenti appena iscritti al Department of Mathematics, si presenta una matricola proveniente da Scienze della Religione: -«Vorrei passare da voi». «E perché?», chiede Nelson. -«Perché i corsi di matematica sono veramente difficili. Provocano un’enorme sofferenza. E la sofferenza è un bene per la mia anima». «Come motivo per studiare la mia disciplina mi sembrò strano - racconta oggi lo scienziato -. Per procurarsi la sofferenza, quel ragazzo non aveva bisogno dei corsi di matematica; c’erano tanti altri modi. Allora gli dissi: ’Tu vorresti usare come un cilicio la scienza di Euclide e Archimede. Debbo proprio sconsigliartelo. Resta nel dipartimento di Religione, e studia con impegno. Se invece sceglierai la matematica, sappi che questa disciplina è anche gioia e spiritualità’».
A 78 anni, Edward Nelson è uno dei ’mostri sacri’ del pensatoio scientifico più prestigioso del mondo (quello di Princeton, dove ha insegnato per più di mezzo secolo) e il 24 agosto sarà al Meeting di Rimini a parlare nel quadro della mostra «Da uno a infinito. Al cuore della matematica».
Professore, il confine tra «ars mathematica» e filosofia è sempre più labile. La matematica si pone domande molto simili a quelle che da millenni inquietano l’uomo e riguardano la sua origine e il suo futuro...
«Forse questa è un’idea un po’ romantica della matematica. Il 99% del nostro lavoro ha solo interesse tecnico. Ma ci sono eccezioni, come la scoperta (o l’invenzione) della geometria non-euclidea, che hanno una profonda importanza per la filosofia e l’umana conoscenza».
Quali sono le «fonti misteriose» (come le ha chiamate felicemente lei) da cui trae ispirazione il matematico?
«Una mattina stavo preparando una lezione sui campi vettoriali (dunque un tema molto astratto) e, misteriosamente, ho sentito come un’orma di memoria muscolare nelle braccia. Mi sono reso conto che la formula astratta descriveva proprio il movimento che uno fa quando parcheggia un’auto».
È vero che scoprire nuove proprietà o dimostrare un nuovo teorema fa percepire al matematico quella intensa emozione creativa che prova l’artista quando sente di aver realizzato un capolavoro?
«Sì, di solito è così. E non è necessario aver realizzato un ’capolavoro’... Conta la bellezza concettuale della formula».
Ma qual è oggi il ruolo della matematica?
«Il suo compito principale sembra quello di sostenere la scienza e la tecnologia. Ma ce ne è un altro, più vicino alla sua essenza. Le più grandi scoperte della matematica in anni recenti (sono stati dimostrati l’ultimo teorema di Fermat e l’ipotesi di Poincaré) non hanno nessun rapporto (almeno così sembra, ma non si sa mai!) con la scienza o la tecnologia. E il pubblico è affascinato da queste scoperte e comprende che il ruolo più importante della matematica è spirituale».
È vero che il matematico non chiede finanziamenti, e vuole soprattutto che la società si renda conto della funzione della matematica nel progredire della conoscenza?
«Purtroppo, non vedo evidenza di questo. Noi siamo tanto avidi di denaro quanto gli altri esseri umani».
La matematica è già oggi la scienza senza la quale le altre non potrebbero né esistere né svilupparsi. È così?
«Al Meeting di Rimini i visitatori potranno vedere, tra gli altri, un pannello con l’immagine del lancio d’un razzo. E la seguente annotazione: ’È solo grazie alla matematica che l’uomo può mettere in orbita, in un punto preciso dello spazio, i satelliti artificiali’».
Lei ha detto che l’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, come vuole la Bibbia, deve sempre tentare di realizzare qualcosa di bello e di profondo. È vero che il matematico ha soprattutto il compito di pensare, cioè «viene pagato per pensare», specie in una culla della genialità quale è l’università di Princeton?
«Il matematico viene pagato per pensare e per insegnare. Chi insegna trova difficoltà e ricompense ben diverse da quelle della ricerca; almeno è così nei primi anni dei corsi universitari. Una volta stavo correggendo, con un gruppo di colleghi, dei compiti di analisi elementare. Gli studenti avevano fatto un sacco di errori. Dal subconscio mi venne fuori un’esclamazione: sono quarant’anni che insegno a questi ragazzi, ma ancora non capiscono! Poi mi arriva la lettera di uno studente: ’Ho sempre odiato la matematica, ma questo corso è stato un piacere’. Non si può immaginare la gioia che questo riconoscimento infonde».
Su che cosa vertono ora i suoi studi?
«Sto tentando di dimostrare che la matematica contemporanea è inconsistente».
Gli studi cui ha lavorato di più?
«Esiste, o no, un’infinità di numeri perfetti? (I ’numeri perfetti’ sono quelli uguali alla somma dei loro divisori. Per esempio: 6=1+2+3). Quando il Signore mi chiederà: ’Che cosa hai fatto della vita che ti ho dato?’, gli riferirò su questa mia ricerca».
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri" --- Dio e la matematica (Ennio De Giorgi)8 gennaio 2010, di Federico La Sala
Dio e la matematica, Ennio De Giorgi dà lezione a Odifreddi *
Chi l’ha detto che vale l’equazione «matematici = non irrazionali, ergo atei»? Se lo domanda, sulle colonne dell’ultimo numero del bimestrale scientifico «Sapere», Michele Emmer, docente di Istituzioni di Matematica alla Facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza di Roma. L’articolo di Emmer, intitolato «Per farla finita con i giudizi su Dio», si focalizza su un doppio bersaglio: elogia il cattolico Ennio De Giorgi, uno dei più grandi matematici del secondo Novecento (1928-1996); e critica in maniera non polemica Piergiorgio Odifreddi, autore di pamphlet anticattolici.
Emmer rilancia, nella diatriba su matematica e religione, una ponderata affermazione di De Giorgi fatta poco prima della sua scomparsa: «Penso che la matematica sia una delle manifestazioni più significative dell’amore per la sapienza e come tale la matematica è caratterizzata da una grande libertà e da una intuizione che il mondo è grandissimo, è fatto di cose visibili e invisibili, e la matematica ha forse una capacità unica tra tutte le scienze di passare dall’osservazionedelle cose visbili all’immaginazione delle cose invisibili. Questo è forse il grande segreto della matematica».
Commenta Emmer: «De Giorgi era profondamente credente, come molti altri matematici. Così come tanti altri non lo sono. Non è mai stato un problema per i matematici sapere quali siano le credenze religiose degli altri matematici con cui si interagisce.
Conta l’abilità nel fare ricerca matematica». Di De Giorgi Emmer ricorda un tratto: «Era rispettoso delle opinioni di tutti», forte di una convinzione: «Il segreto della forza della matematica è la libertà e la convivialità, la disponibilità e la necessità del dialogo». Chissa se quel matematico di Torino che ritiene ’cretini’ i cristiani sarà d’accordo. (L.Fazz.)
* Avvenire, 08.01.2010
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. --- IL MATEMATICO, GLI EBREI E IL FASCISMO. L’ Accademia dei Lincei rende omaggio a Guido Castelnuovo (1865-1952), uno dei grandi matematici italiani (di Paolo Simoncelli).17 dicembre 2009, di Federico La Sala
IL MATEMATICO, GLI EBREI E IL FASCISMO
di PAOLO SIMONCELLI (Avvenire, 17.12.2009)
L’ Accademia dei Lincei rende omaggio con una mostra e pubblica l’edizione delle «Opere matematiche» di Guido Castelnuovo (1865-1952), uno dei grandi matematici italiani a cavallo dei due secoli, dal 1891 docente di Geometria all’Università di Roma, quindi passato allo studio del calcolo delle probabilità e del calcolo infinitesimale. Accademico dei Lincei dal 1901, espulso nel 1938 a seguito delle leggi razziali, dinamico componente della relativa commissione di epurazione nel 1944-46, primo presidente dell’Accademia di questo dopoguerra, nominato da Einaudi senatore a vita nel 1949.
Il suo percorso biografico, screziato in modo inqualificabile dall’espulsione dall’Accademia nel 1938, e la sua doverosa riammissione al termine dell’epurazione, ci offre tuttavia motivo di riflessione relativamente a non pochi altri casi di colleghi ebrei espulsi, riammessi, poi di nuovo radiati, in un convulso susseguirsi di misure normative e non di rado di rancori personali.
Tanto più che con commendevole onestà intellettuale, la mostra presenta il verbale di giuramento di fedeltà al regime fascista prestato da Castelnuovo nel 1934 per restare a far parte dell’Accademia, a seguito di un altro, meno noto decreto del 21 settembre 1933 che, come già per l’obbligo imposto ai professori universitari di giurare fedeltà al regime pena la perdita della cattedra, ora lo imponeva di nuovo, pena la perdita del titolo di socio. E Castelnuovo, e tanti altri colleghi, ebrei e non ebrei, giurarono anche nel ’34 così come avevano giurato già nel ’31.
Si potrebbe eccepire che questo nuovo giuramento, non comportando pene dannose per l’educazione morale e scientifica delle nuove generazioni come quello del ’31 (per il quale sia Croce che ’La Civiltà Cattolica’ che dirigenti del Pci clandestino legittimarono comportamenti nicodemitici, ricordati esplicitamente da Concetto Marchesi), avrebbe potuto consentire un rifiuto privo di conseguenze pedagogiche e privo anche di personali danni materiali.
Ai Lincei non giurarono in dieci: sei rifiutando esplicitamente (Croce, Gaetano De Sanctis, Volterra, Orlando, De Viti De Marco, De Sarlo); tre dimettendosi con vari motivi (Alessio, Bresciani Turroni, Umberto Ricci), uno, Emanuele Paternò, premorendo alla misura di radiazione (Leone Caetani acquisendo la cittadinanza canadese decadde dall’Accademia). Tra loro dunque cattolici, ebrei, liberali più o meno sospetti di massoneria; scienziati e umanisti. Nell’elenco platealmente più lungo di quanti invece giurarono, parimenti cattolici, ebrei, liberali, marxisti (o futuri tali, così come futuri e radicali azionisti); scienziati e umanisti.
Tristezze di regime e di cultura. Il problema che viene tuttavia posto al termine del fascismo e della guerra è il difficile e controverso tracciato della linea di demarcazione tra i «sommersi» e i «salvati», indipendentemente dal giuramento prestato (si capisce: sarebbe stata spopolata l’Accademia). A gestire di fatto l’epurazione sarebbero stati però esponenti mai refrattari ad alcun giuramento; a strepitare con giacobina furia dai quotidiani per un’epurazione radicale, persone che come Concetto Marchesi giurarono assieme (a distanza di un giorno) a scienziati ebrei come Tullio Terni. Non fu seguito il logico criterio di valutare quanti avessero politicamente abusato di titoli littori anziché scientifici per essere ascritti ai Lincei (e giustamente radiati: Bottai, De Vecchi, Federzoni e Sabato Visco). Ma per chi avesse avuto titoli adeguati e che fosse stato già membro dell’Accademia prima del fascismo? E più ancora, quale dunque il confine morale, per separare gli ammessi dai nuovi radiati tra cui incredibilmente di nuovo ebrei?
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! --- CASO GALILEO... tutta la violenza contro la Ragione di cui la Fede è capace (di Adriano Prosperi).30 maggio 2009, di Federico La Sala
L’attualità del caso Galileo mentre si chiude a Firenze un convegno a lui dedicato
Se la Chiesa processa gli eretici di oggi
A cento anni dalle sue scoperte, il rito accusatorio contro lo scienziato ripropone tutta la violenza contro la Ragione di cui la Fede è capace
di Adriano ProsperiRepubblica 30.5.09
L’invito a rileggere il processo a Galileo spicca nel programma del convegno fiorentino che si chiude oggi ad Arcetri. E’ un invito da prendere sul serio. La ricorrenza centenaria di quello straordinario 1609 quando Galileo passò le notti a guardare il cielo col cannocchiale ha certamente qualcosa da dire al nostro presente. Quello fu un momento altissimo della cultura italiana nella fase matura della sua egemonia europea, come documenta la splendida mostra fiorentina curata da Paolo Galluzzi. Ad esso seguì un precipitoso declino. Anche a causa di quel processo, col quale, scrisse John Milton, la censura ecclesiastica «spense l’ardore dell’ingegno italiano». Si chiudeva il processo a Galileo, si apriva quello alla Chiesa . Oggi sono le autorità della Chiesa cattolica a difendersi, parlando di un «malinteso», di una «reciproca incomprensione» (così papa Wojtyla), di un problema del rapporto «tra ragione e fede», come scrive l’attuale arcivescovo di Firenze. Fede e Ragione, Chiesa e Ricerca: grandi parole, frastornanti per chi vuol capire che cosa accadde allora. Per questo bisogna rileggere i documenti.
Davanti alle carte processuali si è presi come da una vertigine pensando alla storia che documentano e a quella che hanno creato. Una storia non di avventure, di fede e di passione, come avrebbe detto Benedetto Croce, ma piuttosto di violenze e di astuzie, di volpi e di leoni. Astuzia di Galileo, per esempio. Aveva a che fare con poteri occhiuti e sospettosi. Perciò si tutelò con ben due «imprimatur» nel pubblicare il suo Dialogo: il che mise in imbarazzo i giudici e dette al processo un andamento peculiare. Il potere gli si presentò coi modi vellutati del gesuita Bellarmino nell’incontro del febbraio 1616, quando il cardinale cercò di convincere quel brillante professore a dissimulare la sostanza della sua scoperta. Ma la violenza dei nemici - tanti, per l’odio che sempre si scatena davanti alla vera creatività - era già nell’aria se, come sembra, è autentico il discusso documento dell’intimazione del Commissario Segizzi su cui il processo del 1633 fece leva. Il processo, un testo di inesauribile fascino drammatico, all’altezza delle massime espressioni del teatro barocco, si concluse come doveva. Galileo si arrese alla forza mascherata di diritto: «Son qua nelle loro mani, faccino quello li piace».
Il fascicolo fu riposto nell’archivio del Sant’Uffizio, il carcere-tribunale più antico di tutta Italia, un vero monumento storico dell’immobilità del potere nel paese più ballerino e traballante d’Europa. Ci vollero le armate di Napoleone per farlo uscire da lì. Quello che se ne seppe fu solo la sentenza di condanna, inviata a pochi e ben mirati destinatari. In Italia i professori lessero e giurarono. Lo stesso fecero quasi tutti i loro eredi del secolo scorso, negli anni dell’abbraccio fra regime fascista e Santa Sede. Riflessi condizionati. Su questi precedenti si basano i tentativi che ancora si fanno da noi di imporre vincoli di legge a chi cura gli immigrati , i malati, i morenti.
Oggi su queste carte antiche si tenta di aprire un processo nuovo: non più quello di rito inquisitorio, della rigorosa ricerca della verità, ma quello di rito accusatorio in cui il giudice media tra due contendenti . Al posto di Galileo che voleva che la terra si muovesse c’è oggi la Scienza. Al posto di papa Barberini che la voleva immobile c’è la Fede, candida e benevolente. E’ tra questi due contendenti che si vuole cercare l’accordo. Ma, come sono in genere i patteggiamenti che nei tribunali permettono di beffare la giustizia, anche questa offerta di accomodamento sembra piuttosto truffaldina. La fede, quella con la minuscola, non c’entra, non è una istituzione, è una cosa che ha tante forme quanti sono gli esseri umani. C’entra la Chiesa come potere, quel potere che in Italia ha fatto di ogni riformatore un eretico.
La «reciproca incomprensione» è una formula adatta alle liquidazioni di incidenti automobilistici per «concorso di colpa». E la colpa di Galileo è una sola: a lui si dovette la sconfitta del sistema di potere che saldava filosofia aristotelica e geografia tolemaica nel disegno di un mondo chiuso sotto il sigillo simbolico del Libro sacro affidato da un Dio al di sopra delle nubi a un Vicedeo in terra. Quel fatto è incancellabile. Dagli orizzonti di allora il mondo si è allontanato quanto da noi si allontanano i satelliti che portano il nome di Galileo tra le stelle.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. ---- Sesso. Perché va insegnato insieme alle tabelline (di Anais Ginori)3 aprile 2009, di Federico La Sala
 Dopo il caso della maestra sospesa per una lezione "hard", si discute su quando sia bene
Dopo il caso della maestra sospesa per una lezione "hard", si discute su quando sia bene
 iniziare a essere espliciti La psicologa americana Sharon Maxwell, in un libro,
iniziare a essere espliciti La psicologa americana Sharon Maxwell, in un libro,
 avverte: "Meglio essere i primi ad affrontare questi temi"
avverte: "Meglio essere i primi ad affrontare questi temi" Sesso. Perché va insegnato insieme alle tabelline
Sesso. Perché va insegnato insieme alle tabelline "I ragazzini sono già bersagliati di informazioni sull’argomento. Ci pensano amici e tv"
"I ragazzini sono già bersagliati di informazioni sull’argomento. Ci pensano amici e tv"
 L’esperienza italiana dell’Aied: un tempo teneva corsi nei licei, oggi va nelle elementari
L’esperienza italiana dell’Aied: un tempo teneva corsi nei licei, oggi va nelle elementari di Anais Ginori (la Repubblica, 03.04.2009)
di Anais Ginori (la Repubblica, 03.04.2009)«Mamma, tu lo sai che cos’è una spogliarellista? E una prostituta?». Ben Maxwell aveva appena 7 anni. Quando fece quella domanda, era imbrigliato dalla cintura di sicurezza sul sedile posteriore della macchina, di ritorno da scuola. «Faticai a tenere saldo il volante - ricorda la madre Sharon - . Dove diavolo aveva sentito parlare di spogliarelliste e prostitute?».
A Novara una maestra è appena stata ammonita dal preside perché durante la lezione di scienze ha risposto in modo esplicito a quesiti che assomigliavano molto a quelli del piccolo Ben. I genitori della scuola elementare non hanno gradito e la maestra è stata temporaneamente sospesa.
Negli Usa, invece, Sharon Maxwell è ormai diventata una star, specializzata in lezioni di sesso per bambini. Dopo aver tentato di rispondere alle domande piccanti del figlio, questa psicologa americana ha infatti deciso di trasformare l’istintivo imbarazzo in una sfida professionale. Dieci anni fa ha iniziato organizzando centinaia di corsi e incontri di educazione sessuale nelle scuole. Il successo è stato tale che ha pubblicato un manuale diventato bestseller, "The Talk", in cui invita i genitori ad affrontare il tema del sesso già alle elementari e spiega come superare il disagio. Nostro, non loro. «Dobbiamo essere i primi a farlo» ammonisce la psicologa nel suo libro, "È ora di parlarne", in uscita per Feltrinelli. «Oppure - avverte - lo farà qualcun altro al posto nostro».
L’invito della psicologa americana nasce da una semplice constatazione. «Bisogna aprire gli occhi sul fatto che il mondo intero parla di sesso ai nostri figli». Suo figlio Ben aveva scoperto la parola "prostituta", ma l’originale era ancora più triviale, imparata passando il pomeriggio a casa di un amico a divertirsi con un videogioco. Nel libro, Maxwell nota come - a dispetto della liberazione dei costumi - discutere di sesso in famiglia è ancora assai complicato.
«Prima se ne parla, meglio è». Anna Sampaolo, coordinatrice dei corsi dell’Aied (associazione per l’educazione demografica), condivide la tesi della Maxwell. L’episodio di Novara non deve quindi stupire. «Dalla mia esperienza - racconta Sampaolo - posso dire che le domande dei bambini di quinta elementare sono precise. Vogliono sapere cos’è un omosessuale, cos’è una prostituta. Utilizzano spesso un linguaggio molto crudo». L’Aied è stata costretta a cominciare sempre più presto le sue lezioni. «Trent’anni fa ci occupavamo solo dei licei - ricorda la psicologa - . Poi siamo passati alle medie, e oggi andiamo anche nelle quinte elementari». Tutto su base volontaria, visto che l’educazione sessuale non è prevista da nessuna legge. «Ci affidiamo a quei pochi illuminati dirigenti scolastici che ci chiamano».
La difficoltà ad affrontare il sesso in famiglia non è prettamente italiana. Secondo un sondaggio europeo, la principale fonte di informazione sessuale per i ragazzi sono i media (stampa, tv e Internet) e gli amici. «I bambini ne parlano tra di loro in un modo differente. La parola dell’adulto è dunque fondamentale».
I corsi dell’Aied sono di «affetto e sesso», cercano di estendere il discorso a emozioni e sentimenti. Per chi se la sente, consiglia l’Aied, è giusto intavolare un discorso su come nascono i bambini, o almeno provarci. «Se c’è vergogna da parte dei genitori, meglio esplicitarla piuttosto che mantenere un non-detto».
E comunque, rispondere sempre. «Per non perdere un’occasione di integrare e correggere l’educazione sessuale che i bambini si fanno altrove». È quel che ha potuto verificare Sharon Maxwell. «Ben, so cosa sono una spogliarellista e una prostituta. E tu lo sai?». «Sì. La spogliarellista è una che si sfila il reggiseno, la prostituta è una che si toglie tutto».
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. ---- Ecco perché c’è la crisi: nessuno studia matematica. Sheldon Glashow, Nobel per la fisica: «I manager non conoscono l’aritmetica».10 marzo 2009
 Allarme contro la disaffezione verso i numeri. Poi Sheldon Glashow spiega come l’uso delle formule serva a descrivere la Natura
Allarme contro la disaffezione verso i numeri. Poi Sheldon Glashow spiega come l’uso delle formule serva a descrivere la Natura Ecco perché c’è la crisi: nessuno studia matematica
Ecco perché c’è la crisi: nessuno studia matematica
 Il Nobel per la fisica: «I manager non conoscono l’aritmetica»
Il Nobel per la fisica: «I manager non conoscono l’aritmetica» di Sheldon Glashow (Corriere della Sera, 10.3.09)
di Sheldon Glashow (Corriere della Sera, 10.3.09)Molto tempo fa, gli uomini inventarono i numeri per regolare le loro transazioni. Oggi più che mai la matematica ha un ruolo dominante nella società; è irragionevolmente efficace in questioni che riguardano tutto lo spettro dell’esperienza umana: dalla gestione delle finanze personali ai più vasti fenomeni sociali.
Avendo insegnato fisica per decenni a studenti di facoltà non scientifiche, vedevo che molti di essi, pur essendo intelligenti, avevano paura della matematica. Si laureavano senza aver veramente capito i numeri, l’aritmetica e l’algebra elementare. La crisi finanziaria che si è ora abbattuta su di noi potrebbe essere dipesa anche dalla diffusa mancanza di cognizioni matematiche in chi si occupa di denaro: mi riferisco non solo ai banchieri, ai finanzieri e ai politici che si trovano ai vertici del potere economico, ma anche ai normali cittadini. Forse le cose sarebbero andate diversamente se avessero partecipato a un Festival della matematica.
Per tutta la mia carriera la matematica è stata per me uno strumento essenziale, ma anche bello e divertente. Spesso trovavo difficile distinguere il lavoro dal gioco. Da studente ero affascinato dall’uso delle matrici per capire le simmetrie della natura, come quelle dei fiocchi di neve e dei diamanti. Una matrice consiste in uno schieramento rettangolare di numeri o di simboli matematici. Nei primi anni di università ho incontrato le semplici matrici 2 per 2 che descrivono la natura dello «spin dell’elettrone» e la relazione tra protoni e neutroni. Ho poi imparato che le matrici 3 per 3 caratterizzano le rotazioni nello spazio, e che possono essere usate per analizzare le vibrazioni di una molecola di ozono. In seguito mi hanno insegnato che certe matrici 4 per 4 hanno permesso a Paul Dirac di formulare la prima equazione quantistica compatibile con la teoria speciale della relatività. Dirac diceva spesso, scherzando, che la sua equazione era più intelligente di lui: aveva predetto l’esistenza dell’antimateria! Tutte queste importanti scoperte nacquero negli anni Venti da scienziati di talento che si valevano della matematica. Decisi di seguire le loro orme.
Il relatore della mia tesi, Julian Schwinger, pensava che potesse esserci un legame tra l’interazione debole e le forze elettromagnetiche e formulò una teoria in cui i fotoni che mediano l’elettromagnetismo erano collegati, da qualche sorta di simmetria, a due particelle pesanti, allora solo ipotizzate (ora chiamate W±), che mediano la forza debole. Mi sfidò poi a dimostrare quella teoria, ma c’erano grossi ostacoli da sormontare:
 1) È stato notato che le interazioni deboli sono le sole forze in natura a violare la simmetria speculare. Come poteva una teoria includere questa scoperta?
1) È stato notato che le interazioni deboli sono le sole forze in natura a violare la simmetria speculare. Come poteva una teoria includere questa scoperta?
 2) Il fotone è una particella priva di massa, ma gli ipotetici bosoni W dovevano essere molto pesanti.
Che tipo di simmetria poteva collegare particelle con proprietà così diverse?
2) Il fotone è una particella priva di massa, ma gli ipotetici bosoni W dovevano essere molto pesanti.
Che tipo di simmetria poteva collegare particelle con proprietà così diverse?
 3) Il modello più semplice di interazione elettrodebole ha a che fare solo con i leptoni, particelle simili agli elettroni e ai neutrini. Come poteva essere esteso in modo da includere altre particelle, come i neutroni e i protoni, di cui siamo fatti? Ho risolto il primo problema nel 1961, usando semplici matrici 2 per 2. Scoprii che la sfida che mi aveva lanciato Schwinger era senza esito. Per spiegare la violazione della parità bisognava postulare l’esistenza di un’altra particella pesante: il bosone neutro Z. (Allora non lo sapevo, ma quel lavoro mi avrebbe portato vent’anni dopo a vincere il premio Nobel). A questo punto la teoria contemplava tre nuove particelle, le cui masse consistenti dovevano trovare una spiegazione.
3) Il modello più semplice di interazione elettrodebole ha a che fare solo con i leptoni, particelle simili agli elettroni e ai neutrini. Come poteva essere esteso in modo da includere altre particelle, come i neutroni e i protoni, di cui siamo fatti? Ho risolto il primo problema nel 1961, usando semplici matrici 2 per 2. Scoprii che la sfida che mi aveva lanciato Schwinger era senza esito. Per spiegare la violazione della parità bisognava postulare l’esistenza di un’altra particella pesante: il bosone neutro Z. (Allora non lo sapevo, ma quel lavoro mi avrebbe portato vent’anni dopo a vincere il premio Nobel). A questo punto la teoria contemplava tre nuove particelle, le cui masse consistenti dovevano trovare una spiegazione.Il secondo problema, l’origine di masse W e Z è stato risolto in linea di principio dal mio compagno di liceo Steven Weinberg (e, indipendentemente, da Abdus Salam). Applicando a schemi semplici il concetto di rottura spontanea della simmetria, hanno dimostrato come queste particelle potessero acquisire una massa. Il loro modello prevedeva una nuova particella, il bosone di Higgs, che finora è stato cercato senza successo. Il gigantesco collisore di protoni presso il Cern, l’LHC, ci dirà presto se la particella che hanno teorizzato esiste realmente.
La nuova teoria elettrodebole aveva a che fare solo con i leptoni. Prima che la teoria venisse estesa, la natura di particelle che interagivano con forza (come protoni, neutroni e altri adroni) doveva essere meglio compresa. Poco dopo avermi chiamato a lavorare con lui al California Institute of Technology, Murray Gell-Mann inventò la cosiddetta «via dell’ottetto», dove gli adroni sono descritti da matrici 8 per 8. Sidney Coleman e io abbiamo dimostrato che si potevano anche usare semplici matrici 3 per 3 per spiegare la teoria di Murray. Con l’uso di queste giungemmo alla «formula di Coleman-Glashow», che descrive correttamente le caratteristiche della massa elettromagnetica dei barioni. Poco dopo, Nicola Cabibbo trovò che l’impiego di matrici simili, applicate alle interazioni deboli, dava luogo a molte nuove teorie, tutte poi confermate sperimentalmente.
La «via dell’ottetto» ha avuto molto successo nella forma della teoria dei tre quark di Gell-Mann e Zweig. La teoria elettrodebole era però ancora incompleta. Prediceva l’esistenza di qualcosa chiamata correnti neutre con variazioni di «stranezza». Non spiegherò in che consistano, dirò solamente che non esistono in natura. John Iliopoulos, Luciano Maiani e io abbiamo affrontato questo problema. Ancora una volta, abbiamo trovato la soluzione giocando con le matrici più piccole. Abbiamo dovuto valerci di matrici 4 per 4 in luogo delle matrici 3 per 3 usate da Cabibbo. Doveva esistere un quarto «quark charm», e infatti è stato trovato.
La storia avrebbe potuto finire qui, ma così non è stato. Due scienziati giapponesi, Makoto Kobayashi e Toshihide Maskawa, continuando a giocare con le matrici, hanno scoperto che sostituendo le matrici 4 per 4 con matrici 6 per 6 (introducendo così altri due quark) riuscivano a risolvere il mistero della violazione di CP. I quark top e bottom sono stati infine scoperti, e lo scorso anno Kabayashi e Maskawa hanno ricevuto il premio Nobel per la loro intuizione. Oggi l’idea premonitrice di Schwinger di una teoria elettrodebole unificata è pienamente confermata: nel frattempo mi sono molto divertito a lavorare con le piccole matrici. (Traduzione di Maria Sepa)
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! --- Galileo e le chiavi del cielo (di Daniele Del Giudice)22 febbraio 2009, di Federico La Sala
Galileo e le chiavi del cielo
Vetro, ferro, cuoio per viaggiare dentro l’universo
di Daniele del Giudice (la Repubblica, 22.02.2009)
L’Onu ha proclamato il 2009 Anno internazionale dell’Astronomia per ricordare le grandi scoperte dello scienziato pisano in quel passaggio cruciale che fu il 1609. Ora una mostra a Firenze permetterà di ammirare gli strumenti da lui inventati o perfezionati per potenziare il senso che gli uomini preferiscono: quello della vista, "perché procura più conoscenza e rende manifeste le differenze tra le cose"
A Venezia seppe di un occhiale di produzione olandese "col quale le cose lontane si vedevano come se fussero molto vicine", se lo procurò ma non lo trovò sufficiente: quelle macchine rozze gli sembravano giocattoli. Fu così che cominciò la sua metamorfosi da insegnante di matematica a industriale dell’ottica
Nel 1611 fabbricò un micrometro per misurare la distanza tra Giove e i suoi satelliti. Lo offrì al re di Spagna e per convincerlo che l’osservazione del pianeta era possibile anche in condizioni di instabilità, creò lì per lì un altro attrezzo: il celatone
Galileo Galilei (Pisa 1564-Arcetri 1642) pensava all’universo come a un «concetto immenso e pieno di filosofia, astronomia e geometria», come scrive nella lettera a Belisario Vinta datata 7 maggio 1610. Un immenso che l’esperienza dei sensi, sensata esperienza, può rivelare se non è «cieca» ma illuminata dalle dimostrazioni necessarie e da una teoria sulle cause dei fatti osservabili. L’universo è un immenso che tuttavia, a dispetto di questo nome, è misurabile con strumenti adeguati.
Galileo non apprezzava gli aristotelici dei suoi tempi, filosofi in libris, che davano troppa importanza all’aspetto qualitativo e osservavano la natura controvoglia come se l’osservare fosse un passatempo ozioso e inconcludente. Anziché misurare con il saggiatore, la bilancia di precisione che serve agli orefici per pesare la polvere d’oro, usavano la grossolana libra, la stadera, e con quella pesavano anche le opinioni proprie e altrui. Era il caso del gesuita Orazio Grassi che gli rivolse una Disputatio astronomica sulle comete e poi, sotto lo pseudonimo di Lotario Sarsi, gli indirizzò la Libra astronomica alla quale Galileo rispose appunto con Il Saggiatore, nel quale con bilancia squisita e giusta si ponderano le cose contenute nella Libra. Lotario Sarsi parlava di uova, fionde e Babilonesi. Galileo annotò: «Se il Sarsi vuole ch’io creda che i Babilonii cocesser l’uova col girarle velocemente nella fionda, io lo crederò, ma a noi questo non succede [...]. Ora, a noi non mancano uova, né fionde, né uomini robusti che le girino, e pur non si cuocono [...]. E poiché non ci manca altro che l’esser di Babilonia, adunque l’esser Babilonii è causa dell’indurirsi delle uova, e non l’attrizione dell’aria». Galileo non apprezzava gli aristotelici ma non poté non subire il noto assunto che apre la Metafisica: gli uomini preferiscono il senso della vista perché procura più conoscenza e rende manifeste le molte differenze tra le cose. E Galileo voleva vedere.
In gita a Venezia nel 1609 seppe di un occhiale di produzione olandese «col quale le cose lontane si vedevano come se fussero molto vicine», se lo procurò ma non lo trovò sufficiente, quelle macchine rozze gli sembravano dei giocattoli per bambini, e allora prese contatto con gli occhialai e poi con i maestri vetrai di Murano e imparò a fabbricare lenti e a combinarle tra loro nel modo più utile, sottoponendosi di buon grado ad una metamorfosi abbastanza coerente, da insegnante di matematica nell’Università di Padova - dove rimase diciotto anni, fino al 1608, insegnando con poca convinzione il sistema tolemaico - a industriale dell’ottica.
Andava a fare la spesa e nella lista (come quella annotata su una lettera di Ottavio Brenzoni del 23 novembre 1609 conservata nella Biblioteca Centrale di Firenze) scriveva ceci, farro, zucchero, pepe, chiodi di garofano e cannella, e di seguito pezzi di specchio, ferro da spianare e altri materiali utili ad allestire un laboratorio ottico. Si confezionò da sé degli "occhialetti" sempre più raffinati che ingrandivano fino a venti o trenta volte più di quelli olandesi, una lente da miope per oculare e una da presbite per obbiettivo, e il telaio in legno o in pelle.
Ne fabbricò in grandi quantità, così numerosi che qualche esemplare lo esportò; ne inviò uno all’Elettore di Colonia e questi, un uomo molto colto, dopo aver esclamato «Vicisti, Galilaee!» come l’imperatore Giuliano l’Apostata, lo prestò a Keplero. Senza quel cannocchiale Keplero non avrebbe potuto osservare le ultime novità celesti. E anche Giovan Battista della Porta, che dal 1589 tentava di costruire un cannocchiale a Venezia dopo averlo teorizzato nel Magia naturalis, riconobbe la superiorità di Galileo; se il 28 agosto 1609, in una lettera all’insigne naturalista Federico Cesi che si era fatto promotore della nomina di Galileo all’Accademia dei Lincei, aveva scritto del cannocchiale: «L’ho visto, et è una coglionaria, presa dal mio libro De Refractione», l’anno seguente dichiarò ancora a Cesi che l’invenzione era sua ma Galileo «l’have accomodata e ha trovato [�] gran cose che empiscono il mondo di stupore».
Galileo battezzò i suoi nuovi cannocchiali "telescopi" perché gli permettevano di vedere oggetti distanti, li puntò verso il cielo e osservò per la prima volta i crateri lunari, le stelle della Via Lattea, e nel 1610 i primi quattro satelliti di Giove, Cosmica Sidera, nome che in breve gli dispiacque e che sostituì con Medicea Sidera. Queste scoperte, immediatamente divulgate nel Sidereus Nuncius (Venezia 1610), le dedicò a un suo allievo, Cosimo II di Toscana. E Cosimo lo invitò a Firenze come primario matematico e filosofo del granducato, e gli permise la tanto desiderata dispensa dall’insegnamento, che Galileo non amava per nulla. Le lezioni pubbliche o private erano una schiavitù cui si piegava solo per saldare i debiti, e la presenza di dozzine di studenti in casa sua come ospiti paganti lo contrariava, violava la sua intimità.
Tanto più che proprio uno studente, tale Baldassarre Capra discepolo dell’astronomo tedesco Simon Mayr, Simone Mario, forse per compiacere il suo maestro si era dichiarato nel 1607 l’inventore del compasso geometrico e militare, uno strumento efficace in astronomia e in agrimensura come in balistica e topografia (tra l’altro permetteva di determinare con discreta esattezza l’altitudine di monti inaccessibili) al quale Galileo lavorava dal 1597 e che aveva dedicato allo stesso Cosimo II nel 1606. Il compasso sfruttava la proporzionalità tra i lati omologhi di due triangoli ed era composto di due bracci imperniati su un disco detto nocella, un quadrante, e un cursore infilato in uno dei due bracci, detto zanca, che Galileo maneggiava con le dita, ivi compreso il dito medio attualmente visibile nelle sale dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze; quel dito, esempio della venerazione tributata al Pisano quale eroe della scienza, venne tolto ai suoi resti mortali da Anton Francesco Gori nel 1737, quando la salma fu traslata al sepolcro monumentale nella Basilica di Santa Croce.
Galileo pubblicò una Difesa contro alle calunnie et imposture di Baldessar Capra Milanese, gli intentò un processo e lo vinse. Giunto a Firenze, donò la lente oculare del suo miglior cannocchiale a Ferdinando II, figlio di Cosimo, ma il giovane o chissà chi altro la ruppe accidentalmente. Allora gli fece omaggio di qualcosa di più solido, una calamita, per di più "armata" cioè imbrigliata con una fascetta di ferro posizionata in modo tale da moltiplicare la forza di attrazione del magnete; con sole sei once di peso quella calamita sollevava «quindici libbre di ferro lavorato in forma di sepolcro», come riferì il monaco Benedetto Castelli, matematico e fisico, nel suo Discorso sopra la calamita. A Cosimo il dono piacque moltissimo.
Galileo voleva guardare e misurare i triangoli, i cerchi e le altre figure geometriche che formano l’alfabeto del cosmo, tentava di decifrare il libro della natura per imparare la sua lingua e discorrere con l’universo dei rapporti di quantità che sono la sua struttura. Aveva un grande ideale che era quello della misura come criterio dell’oggettività, e non pensava piccolo o grande e vicino o lontano, ma piccolo o grande in relazione a un’unità di misura, vicino o lontano rispetto a un determinato punto, e così andava formulando il metodo della scienza moderna.
A Firenze continuò gli esperimenti sul termoscopio, progenitore dei termometri d’oggi, una piccola macchina che aveva ideato sul finire del Cinquecento, con la quale misurava le variazioni della densità atmosferica prodotte dalle variazioni di temperatura; si trattava di una caraffa di vetro con il collo molto lungo, sottile «come un gambo di grano», che lui riscaldava tra le mani e poi immergeva nell’acqua in posizione rovesciata e quando sottraeva alla caraffa il calore delle mani osservava l’acqua salire nel collo della caraffa. Continuò le osservazioni idrauliche; nel 1594 la Serenissima Repubblica di Venezia gli aveva rilasciato il brevetto per un sistema meccanico capace di azionare quattro pompe grazie al movimento di un solo asse.
Ma soprattutto continuò a studiare i periodi dei satelliti di Giove. Nel 1611 fabbricò un micrometro per misurare l’esatta distanza tra il pianeta e i suoi satelliti; offrì ripetutamente il micrometro insieme ai cannocchiali al re di Spagna (dal 1611 al 1628), e per convincerlo che l’osservazione del pianeta era possibile anche in condizioni di instabilità, ad esempio dal ponte di una nave, inventò lì per lì un altro strumento simile a una celata che per questo è conosciuto come celatone. E poiché il re di Spagna non apprezzò né il micrometro né il celatone provò con gli Stati Generali d’Olanda dove la sua proposta riscosse un certo interesse ma fu nuovamente rifiutata.
Sempre osservando i periodi dei satelliti di Giove Galileo mise a punto un proprio metodo per determinare la longitudine, dipendente dall’esatta misurazione del tempo cronologico. Era il 1637, correvano cinque anni dalla pubblicazione del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo che gli avrebbe causato il processo da parte del Sant’Uffizio, quando si accorse che due pendoli di uguale lunghezza oscillano alla medesima frequenza; applicò il pendolo all’orologio e immaginò un sofisticato congegno che illustrò nella Lettera a Lorenzo Realio. Quel congegno lo realizzò ad arte suo figlio Vincenzo Galilei, abile inventore di strumenti musicali, e una ventina d’anni più tardi, nel 1656, l’applicazione del pendolo all’orologio fu rivendicata da Christiaan Huygens, matematico, astronomo e fisico olandese autore del primo libro sulla teoria delle probabilità che non solo brevettò l’orologio a pendolo ma lo perfezionò con un bilanciere a molla, introdusse la molla a spirale negli orologi portatili e nel 1675 inventò l’orologio da taschino.
Nel 1633 fu chiamato a Roma, fu processato, e costretto ad abiurare le sue convinzioni scientifiche. Segregato ad Arcetri, l’anno seguente inviò a Leida i Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze e poi si rassegnò a congedarsi poco a poco dalla sensazione che amava di più (come noi tutti, lo ha detto Aristotele) e infine morì cieco. Era stato uno dei pochi fautori di una scienza nuova, e quei pochi avevano ragione a dispetto dei molti. Come scrisse nel Saggiatore: «Poca più stima farei dell’attestazione di molti che di quella di pochi, essendo sicuro che il numero di quelli che nelle cose difficili discorron bene è minore assai che di quei che discorrono male. Se il discorrere circa un problema difficile fusse come il portare pesi, dove molti cavalli porteranno più grano che un cavallo solo, io acconsentirei che i molti discorsi facessero più che uno solo. Ma il discorrere è come il correre, e non come il portare. Ed un solo cavallo barbero correrà più che cento frisoni».
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! ----- Bruno De Finetti, Un matematico scomodo (di Giulio Giorello).29 dicembre 2008, di Federico La Sala
Bruno De Finetti. Il padre del relativismo
 Il suo pensiero, a partire dagli anni Trenta, demolisce la vecchia idea della ricerca «intesa come scopritrice di verità assolute» e la rende «carne della nostra carne, frutto del nostro tormento»
Il suo pensiero, a partire dagli anni Trenta, demolisce la vecchia idea della ricerca «intesa come scopritrice di verità assolute» e la rende «carne della nostra carne, frutto del nostro tormento»
 Matematico scomodo, rifiutò di fare della scienza un idolo Irredentista, fascista della prima ora, simpatizzò con il ’68
Matematico scomodo, rifiutò di fare della scienza un idolo Irredentista, fascista della prima ora, simpatizzò con il ’68di Giulio Giorello (Corriere della Sera, 29.12.2008)
Gli studenti contestano i professori? La maggioranza dei «baroni» trova che sia uno scandalo. «Io credo, invece, che si debba chiedere il privilegio di essere i principali imputati: solo accettando e sollecitando la critica... potremo liberare le molte e valide energie latenti che si trovano tra noi, accendere la volontà di rinnovamento, combattere con fiducia e con fermezza la battaglia contro i mali che altrimenti continueranno a sopraffarci e cui saremo costretti ad assuefarci, non foss’altro che per non morire di rabbia». Così il matematico Bruno de Finetti (1906-1985) parlava della «rivolta degli studenti» nel formidabile Sessantotto: «Se i giovani non rifiutano a 18 o 20 anni quello che è da rifiutare nella società, non ne saranno capaci mai più».
Fa bene leggere parole come queste in momenti in cui alcune tendenze «revisioniste» liquidano come infantile o dogmatica la «ribellione» di quarant’anni fa - dimenticando cos’era l’Italia di allora e come quella «rivolta» abbia contribuito a cambiarla: dalla condizione femminile a una concezione laica della famiglia, dal diritto allo studio allo svecchiamento delle strutture burocratiche (altro che ridurre il Sessantotto alle squallide esibizioni muscolari dei servizi d’ordine di qualche gruppetto neostalinista). Era l’epoca di slogan come «l’immaginazione al potere». Bruno de Finetti non avrebbe mai pensato al potere politico, bensì a quello dell’intelligenza scientifica e artistica: l’immaginazione è «l’energia mentale che permette l’emergere della novità». Un’energia che a torto una scuola fossilizzata reprime «facendo passare per sempre la voglia ai giovani di occuparsi di tutte le cose che vengono loro insegnate».
Bastano riflessioni del genere a farci capire perché de Finetti fosse davvero «un matematico scomodo» - così recita il titolo del volume costruito dalla figlia Fulvia de Finetti e dal giornalista Luca Nicotra come una sorta di «intervista postuma »; che sfrutta non solo pubblicazioni scientifiche ma anche interventi estemporanei, articoli su quotidiani e riviste, lettere a colleghi e familiari ( Bruno de Finetti. Un matematico scomodo, Belforte, pp. 293, € 22).
Nato a Innsbruck da famiglia italiana, «piccolo simpatizzante dell’irredentismo» affascinato dal «patriota» Cesare Battisti, poi fascista della prima ora («movimentista», per usare la terminologia dello storico Renzo De Felice), inizialmente studioso di genetica delle popolazioni, passato quindi alle basi concettuali del calcolo delle probabilità, grande maestro della statistica italiana prima ancora che cattedratico universitario, decisamente avverso a sfruttare la sua affiliazione politica per fare carriera - e, nel secondo dopoguerra, sempre più incline ad appoggiare battaglie libertarie (come quelle condotte dal Partito radicale) - Bruno de Finetti riassume non poche contraddizioni del secolo scorso, ma anche le speranze per quello in cui noi stiamo vivendo. I suoi tentativi di liberare il calcolo delle probabilità da qualsiasi incrostazione metafisica, di rendere l’insegnamento della matematica più vicino alle esigenze dei fisici, degli economisti o degli ingegneri, la sua fiducia nella «economia di pensiero» consentita dai nuovi mezzi dell’informatica non sono soltanto elementi interni a una riflessione che lo aveva condotto dalla matematica alla filosofia, ma scelte di vita in cui continuamente lo studioso si metteva alla prova senza timore di quella «critica» che costituisce il lievito della crescita scientifica come della fioritura di una società libera.
Senza bisogno di entrare in particolari tecnici, basterà ricordare come l’impostazione soggettivistica di de Finetti nel campo della probabilità (semplicemente «il grado di fiducia che ognuno sente nel verificarsi di un dato evento») non solo non distrugge il carattere intersoggettivo dell’impresa tecnico-scientifica, ma anzi lo esalta.
Come scriveva nel suo capolavoro del 1931 (dal titolo Probabilismo), con il soggettivismo viene meno solo una concezione della scienza «intesa come scopritrice di verità assolute» (che rimane «disoccupata» per mancanza di tali verità!), «ma mentre cade infranto il freddo idolo marmoreo di una scienza perfetta, eterna e universale», compare «al nostro fianco una creatura viva, la scienza che il nostro pensiero liberamente crea: carne della nostra carne, frutto del nostro tormento, compagna nella lotta e guida alla conquista».
Lo stesso spirito si ritrova nella splendida lezione filosofica che nel 1934 Bruno aveva dedicato all’Invenzione della verità - testo che ha visto la luce solo due anni fa grazie alla cura di Fulvia (Raffaello Cortina, pp. 204, € 19). La logica «viva e psicologica » invocata da Bruno non nega la verità scientifica; piuttosto, rifiuta di farne un idolo. Lo stesso dovrebbe dirsi delle strutture istituzionali, a cominciare dallo Stato: mezzi cui si ricorre per soddisfare ai nostri bisogni e desideri, non fini a cui sacrificare l’autonomia degli individui o l’indipendenza dei popoli. Solo così i nostri concetti fondamentali - dalla matematica alla morale - non si riducono alle marionette di una commedia dove ogni ruolo è definito una volta per tutte, ma restano «i sei personaggi in cerca d’autore» di Pirandello, capaci di stimolare il cambiamento in campo scientifico e tecnologico. Relativismo? Fin dai lavori degli anni Trenta, Bruno de Finetti non aveva paura di pronunciare quella parola che oggi sembra tanto godere di cattiva stampa!
Mi sia lecita una nota personale: in un appassionato intervento sul Corriere del 12 dicembre, Claudio Magris - alludendo anche al mio dialogo con Dario Antiseri sulla Libertà (Bompiani, pp. 180, € 17) - ha ripreso la fiera immagine dei calvinisti scozzesi che pregano Dio restando in piedi e non strisciando in ginocchio. Quel loro Dio non era un sapere assoluto, ma l’impossibilità di un sapere di tal genere! In un bel libro ( Molte nature. Saggio sull’evoluzione culturale, Raffaello Cortina, pp. 172, € 18) scrive il fisico Enrico Bellone: «Solo gli dei promulgano verità non negoziabili. Gli umani, invece, fabbricano teorie per meglio adattarsi al loro ambiente »; e nelle comunità ove si tende ostinatamente a proteggere dalla critica principi o valori «non negoziabili» si finisce col portare in tribunale l’innovazione, come vari episodi mostrano: dalla condanna di Galileo all’attuale messa sotto accusa delle biotecnologie. Sono d’accordo con de Finetti: teniamocelo stretto, il relativismo - è uno dei modi di resistere a tutto quello che non ci piace del nostro Paese e «non morire di rabbia»!
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... ---- La matematica inafferrabile (di Giulio Giorello).29 novembre 2008, di Federico La Sala
Scienza
Spesso gli studiosi somigliano a Cristoforo Colombo: partono con un programma di ricerca e arrivano dove non si aspettavano
La matematica inafferrabile
Sfugge alle categorie dei filosofi e si spinge su territori inesplorati
di Giulio Giorello (Corriere della Sera, 29.11.2008)
«La biologia studia gli organismi viventi; l’astronomia i corpi celesti; la chimica la varietà della materia e i modi delle sue trasformazioni... ma che cosa studia la matematica?», chiede il grande matematico russo Yuri Manin, ora alla Northwestern University a Evanston nell’Illinois. La domanda sembra assillare non pochi studenti ai quali, forse, manca il coraggio di rivolgerla al loro insegnante. La differenza importante, però, è che Manin ha tentato una risposta: «La matematica ha a che fare con concetti che si possono trattare come se fossero oggetti reali».
Concetti che devono essere sufficientemente chiari da essere riconoscibili in ogni contesto in cui possano venire utilizzati, ma anche dotati di «forti potenzialità di connessione con altri concetti dello stesso tipo». Tali connessioni possono a loro volta assurgere a oggetti, iniziando «una gerarchia di astrazioni» che in linea teorica non ha fine: così, per esempio, l’algebra ha fatto diventare le operazioni aritmetiche i suoi nuovi oggetti, ecc. Salendo in questa gerarchia, comunque, non si perde il contatto con la realtà: decollando dal loro terreno di origine le nozioni matematiche si rivelano capaci di applicazioni insospettate, sia nella spiegazione dei fenomeni naturali sia nell’intervento tecnologico. Pensiamo alla lunghissima storia che lega la prima attività del contare - coi vecchi e familiari numeri interi uno, due, tre ecc. - ai computer superveloci. Qualche millennio fa alcuni «protomatematici», ovvero prudenti pastori e sagaci amministratori, «numeravano pecore in fenicio», per dirla con una battuta del poeta Ezra Pound; oggi potenti apparati di calcolo contribuiscono a dimostrare sofisticate congetture, realizzando un’economia di pensiero che cambia la natura stessa del lavoro umano.
Questo e altri aspetti della ricerca matematica sono messi in luce dall’articolo di Manin che apre il secondo volume della serie (di quattro) La matematica, a cura di Claudio Bartocci e di Piergiorgio Odifreddi (Einaudi). È dedicato a Problemi e teoremi, cioè alla linfa vitale di un’attività che forse più di ogni altra, a parte la musica, è insieme comprensione scientifica e opera d’arte, costruzione linguistica ed espressione di razionalità. Il lettore vi troverà la storia delle grandi congetture che hanno resistito agli sforzi umani per decenni o addirittura secoli, cedendovi solo di recente, come «l’ultimo teorema di Fermat» (dimostrato da Andrew Wiles) o la congettura di Poincaré (dimostrata da Grigori Perelman), e quelle che ancora restano delle sfide aperte all’immaginazione di coloro che amano leggere nel grande libro matematico del mondo.
È il caso, per esempio, della celebre «ipotesi di Riemann», cui è dedicato nel volume il bel saggio di J. Brian Conrey. E tutti i collaboratori mostrano come problemi e teoremi possono anche venire immersi in «programmi di ricerca», simili, per certi versi, a carte geografiche in cui alcune aree sono raffigurate con notevole chiarezza (sono quelle da dove partiamo: gli elementi di cui siamo sufficientemente sicuri), mentre altre vengono ricostruite sulla scorta di analogie (sono le «terre incognite»: i nuovi settori da investigare) - sicché le indagini qui assumono i caratteri dell’avventura, non troppo diversamente dall’impresa di Colombo. Com’è noto, questi si sbagliò nel suo tentativo di raggiungere l’Oriente passando per l’Occidente; ma l’ostacolo che trovò sulla sua rotta verso le Indie doveva rivelarsi un continente ricco di risorse inaspettate. E - dal calcolo infinitesimale alle geometrie non euclidee, dalla teoria dei numeri allo studio delle probabilità, dalle matematiche combinatorie alla topologia generale - l’impresa dei matematici ha saputo trovare la sua «America della conoscenza ». Si è trattato di un tipo di esplorazione così vario e complesso da rendere impossibile una rigida definizione dell’essenza della matematica. Sono stati soprattutto i filosofi a cimentarsi in questa impresa degna del despota Procuste; ma appena ne avevano tracciati i confini, si accorgevano che ne era rimasta esclusa una qualche componente di grande rilevanza e fascino. E forse la matematica è simile a un organismo vivente, che non si può costringere in uno spazio angusto, come faceva quel mitico tiranno, senza ucciderlo.
Un po’ malignamente Manin osserva come, al tempo dell’antica Roma, che si veniva aprendo sempre di più alla cultura greca e a quella orientale, la matematica non ebbe grandi riconoscimenti: i valori imperiali di coraggio, onore, gloria, disciplina le lasciavano poco spazio. Colpa degli stessi matematici? Quando si mettono al tavolo e iniziano a lavorare, essi «dimenticano valori in conflitto come autorità, efficienza, ambizione, fede e così via». Ma questa indipendenza è il segreto della loro forza: non solo nei confronti del potere, ma anche della stessa filosofia, che talvolta cerca di rinchiudere l’animale matematico in gabbia, salvo accorgersi che, appena serrato il chiavistello, questo è evaso.
Dobbiamo allora rinunciare a qualsiasi filosofia della matematica? O magari a qualunque filosofia, senza ulteriori qualificazioni? Le categorie filosofiche, al contrario dei concetti matematici, difficilmente diventano «oggetti» di quel tipo di indagine operativa che consente al matematico di trovare «al di là della superficie delle apparenze» (come diceva Bernhard Riemann) connessioni profonde tra campi apparentemente scollegati. Né esse hanno l’incisività delle idee portanti della fisica o della biologia - capaci di rinnovare di continuo ingegneria e biotecnologie. E infine, se è la matematica a innervare concettualmente l’impresa della conoscenza, c’è ancora bisogno di una filosofia che ci dica lei che cos’è la razionalità, e che cos’è la realtà?
Mi ricordo che (un po’ di anni fa) il mio maestro e amico Ludovico Geymonat, di formazione sia filosofica che matematica, ammoniva noi giovani a non cadere nella trappola di definizioni frettolose, guardando invece alla «effettualità» della pratica matematica (tra l’altro, segnalo che Bollati Boringhieri ha ristampato, di Geymonat, la Storia e filosofia dell’analisi infinitesimale, in origine 1948, con una nuova introduzione di Gabriele Lolli, che bene mostra come quel libro non sia affatto invecchiato).
Alle prese con problemi formidabili, armato degli strumenti concettuali che la tradizione gli fornisce, ma al tempo stesso sospettoso di tutto quello che viene dato semplicemente per scontato, il matematico creativo è davvero il cittadino di un paese ove «regna la libertà», come diceva Georg Cantor, che edificò nell’Ottocento l’imponente teoria dei «numeri infiniti», nonostante l’ostilità di autorevoli colleghi e le perplessità di importanti filosofi. Glossa Manin: questa libertà è «la libertà di scelta tra alternative incompatibili», e perciò - aggiungerei io - è un’assunzione di responsabilità. E dove c’è libertà c’è anche spazio per la (buona) filosofia.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO...... SCUOLA: PIU’ PROMOSSI, MA EMERGENZA MATEMATICA (- E ANTROPOLOGICA, pfls)23 luglio 2008, di Federico La Sala
Ansa» 2008-07-22 20:16
SCUOLA: PIU PROMOSSI, EMERGENZA MATEMATICA
ROMA - "La matematica è una emergenza didattica nazionale, necessario aprire una riflessione su apprendimento e didattica della materia. Ragazze più brave dei ragazzi. Aumentano i promossi agli scrutini".
E’ quanto rende noto il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Mariastella Gelmini, commentando i risultati dell’anno scolastico appena concluso. Questi i dati ufficiali ma non ancora definitivi: Promossi, 59,4%; Giudizio sospeso, 26,9%; Non ammessi, 13,7%.
"Dopo quasi 15 anni - ha aggiunto Mariastella Gelmini - si ritorna a studiare d’estate per recuperare le insufficienze. Studiare a luglio e agosto non è certo piacevole per gli studenti ma contribuisce a dare un po’ di serietà e credibilità alla valutazione degli studenti nella scuola italiana".
"Si deve purtroppo prendere atto che la matematica costituisce, per la scuola italiana, un’autentica emergenza didattica. Il problema accomuna gli studenti dell’intera penisola, senza distinzione di sesso, tipologia di scuola o dislocazione geografica. Forse è il momento di chiedersi se non siano necessarie la ricerca e l’applicazione di nuove metodologie d’insegnamento. Dovremo porci - conclude Gelmini - la stessa domanda anche riguardo allo studio delle lingue straniere, la seconda più grave lacuna dei nostri ragazzi".
MATEMATICA E LINGUE EMERGENZA STUDENTI ITALIANI La matematica, ma anche le lingue straniere, sono lo spauracchio degli studenti italiani, provocando una situazione di ’’emergenza didattica nazionale’’, con il 45,7% ammessi con ’’debito’’. E’ quanto si evince dai risultati (’’quasi definitivi’’) degli scrutini resi noti dal ministero Istruzione, Universita’ e Ricerca, da cui emerge un aumento (+10%) dei promossi.
Ecco la situazione settore per settore.
 MATEMATICA: La materia in cui gli studenti di tutta Italia incontrano le maggiori difficolta’ e’, infatti, la matematica, anche tenendo conto che si tratta di una tra le discipline piu’ presenti nei diversi corsi di studi: il 45,7% dei ragazzi ammessi con giudizio sospeso all’anno scolastico successivo dovra’ dimostrare di aver superato l’insufficienza in questa disciplina. Da notare che - rileva Viale Trastevere - rispetto all’anno scorso, in cui c’era il 43,1% degli studenti ammessi con debito in matematica, c’e’ stato un ulteriore aumento di 2,6 punti percentuali.
MATEMATICA: La materia in cui gli studenti di tutta Italia incontrano le maggiori difficolta’ e’, infatti, la matematica, anche tenendo conto che si tratta di una tra le discipline piu’ presenti nei diversi corsi di studi: il 45,7% dei ragazzi ammessi con giudizio sospeso all’anno scolastico successivo dovra’ dimostrare di aver superato l’insufficienza in questa disciplina. Da notare che - rileva Viale Trastevere - rispetto all’anno scorso, in cui c’era il 43,1% degli studenti ammessi con debito in matematica, c’e’ stato un ulteriore aumento di 2,6 punti percentuali. ALTRE CRITICITA’: Dopo la matematica la materia piu’ ostica per gli studenti italiani e’ la lingua straniera. Il 30,6% degli studenti ammessi all’anno scolastico successivo con giudizio sospeso ha avuto un debito formativo in lingua o in letteratura straniera; seguono le altre discipline scientifiche (fisica, chimica, biologia etc.) col 23,6%; infine l’italiano con il 14% (percentuale rimasta stabile rispetto al 14,5% del 2007).
ALTRE CRITICITA’: Dopo la matematica la materia piu’ ostica per gli studenti italiani e’ la lingua straniera. Il 30,6% degli studenti ammessi all’anno scolastico successivo con giudizio sospeso ha avuto un debito formativo in lingua o in letteratura straniera; seguono le altre discipline scientifiche (fisica, chimica, biologia etc.) col 23,6%; infine l’italiano con il 14% (percentuale rimasta stabile rispetto al 14,5% del 2007).- AUMENTO PROMOSSI AGLI SCRUTINI: Promossi: 59,4%; Giudizio sospeso: 26,9%, Non ammessi: 13,7% Aumentano i promossi (confrontando il dato con quello relativo agli alunni ammessi senza debito lo scorso anno) alla classe successiva: e’ quanto emerge dalle rilevazioni effettuate dal Ministero sugli scrutini finali della scuola secondaria di secondo grado e sui risultati relativi agli esami di Stato 2007-2008. Le promozioni sono aumentate del 10% rispetto allo scorso anno, un ’’dato che potrebbe significare come il sistema del recupero dei debiti formativi abbia innescato un meccanismo virtuoso che ha responsabilizzato gli studenti. Ma una valutazione finale potra’ essere fatta solo a settembre con i dati definitivi’’.
 SCUOLA SECONDARIA: Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado promossi quest’anno sono stati il 59,4% del totale; l’anno scorso, invece, gli studenti ammessi senza debito alla classe successiva erano il 49,8%. Un reale confronto dei dati con l’anno scolastico 2006-2007, comunque, sara’ possibile solo a settembre, quando gli studenti con giudizio sospeso, che quest’anno sono il 26,9% (quelli ammessi con debito erano il 36%), saranno giudicati nella valutazione finale, dopo aver seguito i corsi di recupero estivi.
SCUOLA SECONDARIA: Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado promossi quest’anno sono stati il 59,4% del totale; l’anno scorso, invece, gli studenti ammessi senza debito alla classe successiva erano il 49,8%. Un reale confronto dei dati con l’anno scolastico 2006-2007, comunque, sara’ possibile solo a settembre, quando gli studenti con giudizio sospeso, che quest’anno sono il 26,9% (quelli ammessi con debito erano il 36%), saranno giudicati nella valutazione finale, dopo aver seguito i corsi di recupero estivi. ISTITUTI TECNICI CON PIU’ DEBITI: Sono gli istituti tecnici quelli in cui ci sono piu’ alunni con giudizio sospeso (il 30% del totale), mentre nel 2007 gli alunni degli istituti tecnici con debito alla fine dell’anno erano il 38,9%.
ISTITUTI TECNICI CON PIU’ DEBITI: Sono gli istituti tecnici quelli in cui ci sono piu’ alunni con giudizio sospeso (il 30% del totale), mentre nel 2007 gli alunni degli istituti tecnici con debito alla fine dell’anno erano il 38,9%. MEGLIO IL LICEO CLASSICO: La scuola con meno studenti con giudizio sospeso e’ il liceo classico (21,2% del totale), mentre nella stessa tipologia di scuola l’anno scorso il 28,9% aveva riportato il debito.
MEGLIO IL LICEO CLASSICO: La scuola con meno studenti con giudizio sospeso e’ il liceo classico (21,2% del totale), mentre nella stessa tipologia di scuola l’anno scorso il 28,9% aveva riportato il debito. GIUDIZI SOSPESI: Tra i ragazzi con giudizio sospeso, quelli che dovranno dimostrare di aver superato una sola insufficienza sono il 39,3%, i ragazzi con debiti in due discipline, invece, sono il 35,3%, mentre gli alunni con tre o piu’ insufficienze sono il 25,4%.
GIUDIZI SOSPESI: Tra i ragazzi con giudizio sospeso, quelli che dovranno dimostrare di aver superato una sola insufficienza sono il 39,3%, i ragazzi con debiti in due discipline, invece, sono il 35,3%, mentre gli alunni con tre o piu’ insufficienze sono il 25,4%.- I BOCCIATI: Per adesso, comunque, i ragazzi bocciati sono il 13,7%, mentre i non ammessi alla classe successiva alla fine dell’anno scolastico 2006-2007 erano il 14,2%.
 DOVE SI STUDIA DI PIU’: Le tipologie di scuola in cui si sono avuti piu’ successi sono il liceo classico, con il 73,2% dei promossi senza debito, con un aumento di 7,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente, e il liceo linguistico, anch’esso con il 73,2% (anche qui si e’ avuto un aumento dei promossi senza debito del 10,5%). Segue il liceo scientifico con il 68,4% degli ammessi all’anno successivo, con un 7,8% in piu’ di promossi.
DOVE SI STUDIA DI PIU’: Le tipologie di scuola in cui si sono avuti piu’ successi sono il liceo classico, con il 73,2% dei promossi senza debito, con un aumento di 7,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente, e il liceo linguistico, anch’esso con il 73,2% (anche qui si e’ avuto un aumento dei promossi senza debito del 10,5%). Segue il liceo scientifico con il 68,4% degli ammessi all’anno successivo, con un 7,8% in piu’ di promossi.Gli istituti professionali, invece, si confermano una delle tipologie di scuola in cui ci sono meno promossi; meno della meta’ dei frequentanti (il 48,2%), infatti, e’ stato promosso senza debito. In ogni tipologia di scuola superiore, i passaggi piu’ critici risultano essere il primo ed il terzo anno. In queste due classi il maggior numero di studenti non viene promosso.
 LA SITUAZIONE NELLE REGIONI: la maggiore concentrazione di ragazzi promossi e’ in Calabria, a fronte del primato delle bocciature di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
LA SITUAZIONE NELLE REGIONI: la maggiore concentrazione di ragazzi promossi e’ in Calabria, a fronte del primato delle bocciature di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. -
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. ---- DONNE E MATEMATICA.Non c’è alcuna predisposizione genetica dei maschi ad avere successo in matematica. Piuttosto è una questione di potere o di mancata emancipazione delle donne, in termini politici, sociali e culturali. Così chi ha più potere, più è bravo a fare di conto. O meglio: dove le donne sono meno considerate nella società la distanza tra i due sessi sulle materie scientifiche si allarga (di Roberto Mania).30 maggio 2008, di Federico La Sala
 Dove c’è più emancipazione sono abili come gli uomini. Italia fanalino di coda
Dove c’è più emancipazione sono abili come gli uomini. Italia fanalino di coda
 Una ricerca di quattro economisti italiani pubblicata su Science
Una ricerca di quattro economisti italiani pubblicata su ScienceDonne e matematica questione di potere
di ROBERTO MANIA *
ROMA - Non c’è alcuna predisposizione genetica dei maschi ad avere successo in matematica. Piuttosto è una questione di potere o di mancata emancipazione delle donne, in termini politici, sociali e culturali. Così chi ha più potere, più è bravo a fare di conto. O meglio: dove le donne sono meno considerate nella società la distanza tra i due sessi sulle materie scientifiche si allarga. E infatti mentre in Islanda il gap si è ribaltato a favore delle donne, e Svezia, Norvegia e Finlandia lo stanno per azzerare; l’Italia è in fondo alla classifica, al pari di Giappone e Grecia, e solo poco sopra la Corea e la Turchia.
Lo hanno studiato quattro economisti italiani, Luigi Guiso dell’Università europea di Firenze, Ferdinando Monte, dell’Università di Chicago, Paola Sapienza dell’Università del Northwestern e, infine, Luigi Zingales della School of Business di Chicago. La ricerca è stata pubblicata sull’ultimo numero della prestigiosa rivista americana Science, ed è anche una risposta alla clamorosa tesi di Lawrence Summers, l’ex ministro del Tesoro di Bill Clinton, che nel 2005, quando da rettore di Harvard, sostenne, in un convegno a porte chiuse a Boston, che le donne sono biologicamente svantaggiate nel campo scientifico.
Summers fu travolto dalle critiche, provenienti non solo del mondo femminista, e l’anno dopo costretto a lasciare Harvard.
Dunque anziché il Dna bisogna indagare sulle regole sociali. Ma i quattro economisti non si sono sostituiti ai politologi o ai sociologi. Per questo hanno guardato innanzitutto alle performance. Questo è il loro campo di indagine: capire come funzionano i sistemi economici, individuarne i limiti o punti di forza. E allora, perché oltre metà della forza lavoro (cioè le donne) non ottiene risultati positivi sul terreno delle materie scientifiche? Come mai alla School of Science del mitico Mit, la quota di scienziati femmine è solo dell’8 per cento? E ancora: perché al dipartimento di Fisica della stessa scuola su 95 membri solo 5 sono donne? E al dipartimento delle Scienze cognitive e del cervello sono donne 11 su 41? Da queste domande è cominciata la ricerca.
Per avvicinarsi alla risposta il primo step dei quattro economisti è stato quello di analizzare l’indice Pisa, che sta per Programme for international student assessment. E’ un’indagine periodica tra i 30 paesi dell’Ocse e un gruppo di altri 11 che ha come obiettivo quello di valutare la capacità cognitiva degli studenti quindicenni in matematica e nelle materie letterarie. In genere nella prima primeggiano i maschi e nelle seconde le femmine.
L’Italia si colloca in entrambe le classifiche agli ultimi posti. E va molto male nella graduatoria che registra il gap tra maschi e femmine in matematica: siamo al 36º posto su 40 paesi.
I quattro economisti hanno poi messo in correlazione il gap tra maschi e femmine nelle materie scientifiche con un altro indice, utilizzato anche dal World economic Forum, che segnala il livello di emancipazione delle donne. E’ il "Gender gap index" (Ggi) che tiene conto di diverse variabili: dalla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, alla loro presenza in politica e nei luoghi di comando, e così via. Alla fine è emerso che dove l’indice di emancipazione è più basso è anche più marcata la distanza tra maschi e femmine sulle materie scientifiche e viceversa.
Conclusione: sono i fattori culturali che portano le femmine ad essere meno brillanti in matematica, non la composizione dei loro geni. E poi se il gentil sesso migliora in matematica, crescono anche le performance maschili in letteratura. Come dimostrano i casi di alcuni Stati degli Stati Uniti. Insomma più donne al potere, più maschi bravi in letteratura. E - certo - più donne scienziate.
* la Repubblica, 30 maggio 2008.
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA ---- Per anni l’insegnamento della matematica si è basato su mele, pere ma pare che gli insegnanti abbiano fatto male i loro conti perché il metodo non aiuta l’apprendimento dei suoi concetti astratti.Lo rivelano alcuni esperimenti della Ohio State University condotti con studenti delle scuole superiori...28 aprile 2008, di Federico La Sala
Mele e pere non aiutano ad imparare la matematica
NEW YORK Per anni l’insegnamento della matematica si è basato su mele, pere ma pare che gli insegnanti abbiano fatto male i loro conti perché il metodo non aiuta l’apprendimento dei suoi concetti astratti.
Lo rivelano alcuni esperimenti della Ohio State University condotti con studenti delle scuole superiori: i ricercatori, indossati i panni degli insegnanti, hanno semplicemente spiegato ai ragazzi, divisi in gruppi, un sistema matematico a loro sconosciuto (essenzialmente una serie di regole) attraverso due approcci diversi. Uno astratto, insegnando le nuove regole con simboli puri, e uno concreto, usando liquidi e palline da tennis.
Il gruppo “più svelto” nell’apprendimento è stato quello che aveva fronteggiato il nuovo concetto matematico astratto tramite il sistema di insegnamento astratto a sua volta.
Secondo la dottoressa Jennifer Kaminski questo accadrebbe perchè, attraverso gli esempi concreti, «si tende a ricordare la superficie». In buona sostanza, assimiliamo l’immagine specifica di treni e mele, ma non la matematica che vi sta sotto.
Per ora le prove sono state portate a termine solo nelle scuole superiori ma i ricercatori hanno iniziato la loro sperimentazione anche alle elementari, dove oggi le strategie di insegnamento basato su oggetti concreti sono più diffuse che mai e dove sono convinti che la loro teoria risulti valida.
* La Stampa, 28/4/2008
-
> MATEMATICA E ANTROPOLOGIA, ALTRO CHE MISTERO. GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!1 novembre 2007, di Federico La Sala
Il divenire di una matematica senza cogito
Tradotto il manoscritto del matematico e filosofo Jean Cavaillès «Sulla logica e la teoria della scienza». Un testo che ha influenzato un’intera generazione di epistemiologi francesi
di Roberto Ciccarelli (il manifesto, 31.10.2007)
Tra gli studenti che seguirono le due conferenze sul senso e sull’essenza della fenomenologia che Edmund Husserl tenne il 23 e il 25 febbraio 1929 a Parigi nell’Amphithéâtre Descartes della Sorbona c’era anche il matematico, e storico della scienza, Jean Cavaillès. Il suo libro Sulla logica e la teoria della scienza, scritto a partire dal 1942 durante la prigionia per le sue attività di resistente anti-nazista, poco prima della morte per fucilazione, avrebbe segnato un’intera generazione di epistemologi e di filosofi, invitandola a definirsi «in funzione di Husserl, e anche un po’ contro di lui».
Questo libro smilzo e ambizioso viene oggi tradotto da Vittorio Morfino e da Luca Scarantino per la collana «epistemologia» dell’editore milanese Mimesis (pp.77, euro 11) nell’ambito di un progetto culturale che ha acquisito negli ultimi anni un profilo di tutto rispetto. In contemporanea con l’uscita di questo Cavaillès, infatti, c’è da registrare la ripubblicazione dell’ormai esaurita traduzione del Materialismo aleatorio di Louis Althusser (nella collana «althusseriana» di Mimesis, pp. 148, euro 15).
La traduzione di Sulla logica e la teoria della scienza è qualcosa di più di un omaggio al suo autore, uno dei principali dirigenti della resistenza francese, che seppe coniugare il rigore delle sue ricerche matematiche in ambito neopositivistico (il «Circolo di Vienna») con una peculiare ispirazione spinozista che ha influenzato una parte cospicua dei suoi contemporanei, in particolare il grandissimo epistemologo Georges Canguilhem, e dei suoi successori Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu e Michel Foucault. Il problema su cui si arrovella Cavaillès è quello di giustificare il rapporto tra la logica trascendentale e la logica formale e quindi l’esistenza di una soggettività trascendentale. Il suo scopo era quello di definire una filosofia delle matematiche senza Cogito, sostituendo al primato della coscienza quello del concetto, o meglio del divenire proprio del concetto. In questo senso, Cavaillès può essere considerato il capostipite della via anti-storicista e anti-dialettica ad una filosofia dell’immanenza.
La redazione di questo scritto grondante intuizioni per la teoria matematica degli insiemi, come per la critica della fenomenologia, è un romanzo ancora tutto da scrivere. Arrestato dalla polizia tedesca a Parigi nel 1943, Cavaillès proseguì la stesura del suo «trattato di logica» in carcere. La benevolenza del generale de Lattre de Tassigny, comandante della regione militare di Montpellier, gli consentì di ricevere i libri dal suo amico Albert Lautman e di consegnare un manoscritto alla sorella Gabrielle Ferrières che ebbe solo il tempo di trascriverlo, prima che una perquisizione glielo sottraesse definitivamente. Dopo la guerra, Canguilhem e Lautman pubblicarono il monoscritto, ma senza l’importante introduzione del suo autore.
È spinozista, ha ricordato Canguilhem in una memorabile orazione in onore di Cavaillès, colui che ha compreso il corollario dell’Etica secondo il quale «la volontà e l’intelletto sono una sola e stessa cosa» e che ha letto fino alla fine anche il corollario corrispondente: «questa dottrina è non poco utile alla comune società, in quanto insegna in qual modo i cittadini debbano essere governati e guidati, non per servire, ma per compiere quelle azioni che sono le migliori». Azione etico-politica e conoscenza sono legate in maniera imprescindibile nella vita di Cavaillès: «Jean Cavaillès è la logica della Resistenza vissuta fino alla morte. Che i filosofi dell’esistenza e della persona facciano lo stesso, la prossima volta, se possono».
La polemica di Canguilhem era contro Jean-Paul Sartre il quale, mentre Cavaillès veniva fucilato, era in vacanza nei Paesi baschi in compagnia di Simone De Beauvoir. In Cavaillès, proprio in quanto spinozista, Canguilhem intravedeva invece il legame tra il filosofo e il combattente. Lo aveva confermato per tempo lo stesso autore di Sulla logica e la teoria della scienza: «Sono spinoziano, credo che noi cogliamo ovunque la necessità. Necessari i concatenamenti della matematica, necessarie le tappe della scienza matematica e persino la lotta che conduciamo». È questa la disposizione verso il mondo nella quale Gaston Bachelard ravvisava «un’autentica grandezza» e «una bellezza astratta che si fa sempre più rara ai nostri giorni».
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!30 maggio 2007, di Federico La Sala
 Già a 5 anni sono in grado di fare addizioni e sottrazioni con grandi numeri
Già a 5 anni sono in grado di fare addizioni e sottrazioni con grandi numeri
 Ricerca Usa-Gb: "E’ una competenza naturale per tutti, che va sviluppata nelle scuole"
Ricerca Usa-Gb: "E’ una competenza naturale per tutti, che va sviluppata nelle scuole" La matematica è innata nei bambini
La matematica è innata nei bambini
 Fanno calcoli prima di imparare le operazioni
Fanno calcoli prima di imparare le operazionidi ALESSIA MANFREDI *
ROMA - La matematica? Un gioco da ragazzi, anzi da bambini. Chi da piccolo ha faticato con addizioni e divisioni, calcoli sempre più complessi e ragionamenti che parevano inafferrabili farà fatica a mandarlo giù, ma una nuova ricerca indica che i bimbi sono in grado di risolvere problemi con grandi numeri ben prima che venga loro insegnata l’aritmetica.
La capacità di afferrare i principi matematici, come quelli che regolano le operazioni di calcolo, sarebbe insomma innata e non un dono riservato a pochi fortunati, invidiati dagli altri. La dottoressa Camilla Gilmore ed i colleghi dell’università di Nottingham, in Gran Bretagna, e Harvard, negli Stati Uniti, che hanno pubblicato il loro lavoro su Nature, sostengono che non è necessario per i più piccoli padroneggiare la logica di un sistema numerico simbolico per riuscire a fare addizioni e sottrazioni approssimate.
I ricercatori sono arrivati a questa conclusione mettendo di fronte a bambini di cinque anni con background diversi una serie di problemi sotto forma di scenari ipotetici in cui figuravano addizioni e sottrazioni di numeri, da 5 a 98. I bambini non avevano ricevuto una formazione specifica di aritmetica, ma sono riusciti ugualmente e con buoni risultati nelle operazioni di calcolo, rispondendo a domande come: "Se Sara ha 64 caramelle e ne regala 13 e Giovanni ne ha 34, chi di loro ne ha di più?". Non solo: hanno fatto anche molto meglio di quanto gli scienziati si aspettassero, spesso non arrivando ad un risultato esatto, ma ad una buona approssimazione.
Come hanno fatto? "Sappiamo che i bambini hanno un sistema di rappresentazione dei numeri non simbolico, che permette loro di fare sottrazioni ed addizioni approssimate di quantità non simboliche, come, ad esempio un gruppo di puntini o una sequenza di toni", spiega a Repubblica.it la dottoressa Camilla Gilmore, che ha guidato lo studio. "E’ questa stessa capacità che usano anche per fare addizioni e sottrazioni di quantità simboliche".
I test sono stati fatti in ambienti diversi, nella quiete di un laboratorio e nell’atmosfera più caotica di una classe: in quest’ultimo caso i risultati sono stati leggermente inferiori, forse per il fattore distrazione.
"Da tempo si sa che adulti e bambini, ma anche neonati e animali, hanno un senso per i numeri. Ma quello che ci ha sorpreso è vedere che i bambini usano in modo spontaneo questa facoltà quando si presentano loro problemi di aritmetica simbolica. Questi bambini non l’hanno ancora studiata, eppure il loro senso innato per i numeri dà loro un modo di pensare aritmetico", spiega ancora la dottoressa Elizabeth Spelke, co-autrice dello studio.
La matematica, quindi, è una competenza naturale nei più piccoli, che riescono ad applicarla anche senza una specifica istruzione scolastica. Un bel cambio di prospettiva, per chi, finora, ha sempre distinto fra chi ha il dono dei numeri e chi, invece, delle lettere. Non ci sono più scuse, insomma: e gli autori della ricerca suggeriscono proprio questo, di insistere su aritmetica e calcoli su tutti i bambini fin dalla più tenera età per coltivare questa facoltà nascosta. Provare per credere: "Gli insegnanti erano preoccupati che i nostri problemi finissero solo per frustrare i bambini - dice Gilmore - ma anche loro sono rimasti molto colpiti, sia dal loro entusiasmo che dai loro successi".
* la Repubblica, 30 maggio 2007
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!1 marzo 2007, di Federico La Sala
I NUMMERI *
Conterò poco, è vero:
 diceva l’Uno ar Zero -
diceva l’Uno ar Zero -ma tu che vali! Gnente: proprio gnente!
Sia ne l’azzione come ner pensiero
Rimani un coso voto e incorcrudente.
Io invece se me metto a capofila
De cinque zeri tale e quale a te, lo sai quanto divento? Centomila.
E’ questione de nummeri. A un dipresso
è quello che succede ar dittatore
che cresce de potenza e de valore
più so’ li zeri che je vanno appresso
* TRILUSSA, Poesie scelte, Mondadori.
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!16 marzo 2007, di Federico La Sala
Nei numeri la misura della vera conoscenza
di Paolo Zellini (il manifesto, 15.03.2007)
«Quando sei in grado di misurare ciò di cui stai parlando, e di esprimerlo in numeri, allora puoi dire di conoscere qualcosa che lo riguardi». Così affermava Lord Kelvin, celebre fisico, ingegnere e matematico del XIX secolo, confermando implicitamente la vecchia tesi pitagorica che tutto è numero. Ma se si affida la conoscenza delle cose al numero occorre pure chiedersi: che cosa sono i numeri?
Cercare di rispondere è come evocare le mille teste dell’Idra, perché tante sono le diverse specie di numeri e tante le prospettive da cui trattare ciascuna specie. Lo conferma un’importante osservazione di Hermann Weyl: cercando nel 1951 di riassumere mezzo secolo di progressi nella matematica, il grande matematico tedesco osservava che il campo dei numeri reali è come un Giano bifronte, che guarda in due direzioni opposte: da un lato l’esecuzione di operazioni aritmetiche, come l’addizione e la moltiplicazione, dall’altro le somme infinite e i processi al limite. Una è la faccia più familiare del numero, quella aritmetica e algebrica, l’altra è la faccia analitica e topologica, che coinvolge le grandezze continue, come il tempo o le linee che si tracciano su un foglio. Una divisione che dipende da due diversi significati dei numeri: ci immaginiamo innanzitutto un campo di numeri come un dominio chiuso, in cui le operazioni aritmetiche tra due suoi elementi danno un risultato che sta ancora nello stesso dominio. L’esempio classico sono i numeri razionali, cioè le frazioni, perché sommando o moltiplicando due frazioni si ottiene un’altra frazione.
Versione aritmetica del continuo
D’altro canto, le frazioni non bastano. I matematici greci scoprirono che esistono grandezze incommensurabili, il cui rapporto non può essere uguagliato al rapporto tra due numeri interi, cioè a una frazione. Per questo sono stati introdotti i numeri reali, un campo molto più esteso che include i numeri razionali e i numeri irrazionali, e che sta alla base di tutte le nostre scienze. Esso fornisce la versione aritmetica del continuo, perché con un numero reale si riesce a dire quale lunghezza compete a una linea che nessuna frazione riuscirebbe a misurare: l’esempio più semplice è la diagonale di un quadrato di lato unitario, la cui lunghezza è uguale alla radice quadrata di due, che è appunto un numero irrazionale.
Le moderne teorie assiomatiche, notava Hermann Weyl, avevano in qualche modo assecondato questa doppia prospettiva: la matematica non è la politica, diceva ironicamente, e non apprezza ambigue commistioni tra pace e guerra; ha quindi preferito separare in modo netto i due aspetti del numero, evitando conflitti di competenze. Egli aggiungeva però anche un singolare avvertimento: neppure alla metà del XX secolo, dopo secoli di progressi nell’analisi e nella teoria dei numeri, e dopo approfondite ricerche sui fondamenti, si poteva affermare di aver chiarito in modo definitivo tutte le questioni che riguardavano il concetto di numero reale.
Questa difficoltà di chiarimento si deve anche a un’altra divisione di prospettiva, che risale a tempi relativamente remoti, tipicamente alla geometria greca, e che non è certo estranea alla doppiezza del Giano evocato da Weyl: la distinzione tra aspetti descrittivi e aspetti algoritmici della matematica. I primi hanno a che fare con l’esistenza e le proprietà di possibili soluzioni di un problema, per esempio di un sistema di equazioni; i secondi con la costruzione effettiva, passo per passo, della soluzione. Se si deve pensare a un’origine della matematica (per quanto sia possibile parlare di origine), il punto di vista algoritmico appare prioritario, in qualche modo più «primordiale», anche se sarebbe un errore grossolano pensare che si tratti solo di una connotazione «primitiva» della matematica, destinata a essere superata da concetti astratti più avanzati. È un fatto che nella matematica babilonese antica (circa 1800 a.C.) si avevano conoscenze relativamente avanzate di calcolo aritmetico, le cui formule, si è notato, assomigliavano molto più a programmi o procedure eseguibili da una macchina che a pure espressioni simboliche. Nell’India vedica una raffinata geometria serviva a costruire altari rituali di diverse forme e grandezze, prestando pure attenzione, ove la costruzione lo richiedesse, a complessi algoritmi numerici.
Ora, per un misterioso caso di sincronia, le analisi di Hermann Weyl seguivano di poco una delle autentiche rivoluzioni scientifiche del secolo, cioè la costruzione - a Philadelphia, intorno al 1945 - del primo grande calcolatore della storia e il conseguente primo delinearsi della nuova scienza informatica.
Un nesso tra le due facce di Giano
Non si trattava solo di un’innovazione tecnologica, perché il calcolo stesso, e le teorie matematiche che lo rendevano possibile, assumevano nuovi aspetti e si arricchivano di elementi inusitati. Si profilava per la prima volta un calcolo scientifico su grande scala, che affrontava problemi di matematica applicata di dimensioni inaudite, che implicavano la risoluzione - necessariamente approssimata - di migliaia di equazioni in migliaia di incognite. E tra le conseguenze di questa innovazione c’era pure la possibilità di riconoscere un nesso tra le due facce di Giano: infatti il nuovo calcolo doveva occuparsi di tradurre tutta l’informazione di un modello definito sul continuo, di un’equazione in cui le variabili assumevano valori nel campo reale, in un insieme di calcoli aritmetici, di somme e moltiplicazioni, eseguibili in modo automatico da un calcolatore.
Herman H. Goldstine e John von Neumann, tra coloro che più contribuirono all’incipiente rivoluzione informatica, spiegavano che i problemi della matematica, dati di solito in termini di variabili continue, dovevano essere approssimati - per le esigenze del calcolo digitale - da procedure puramente aritmetiche e «finitiste». Il calcolo scientifico riesce a risolvere miracolosamente i problemi della matematica applicata con un insieme finito di numeri finiti che non è neppure un campo, perché non è chiuso rispetto alle operazioni: la somma e il prodotto di due «numeri di macchina» non è un «numero di macchina». Come affermava nel 1744 il grande matematico Leonhard Euler, nella perfetta macchina dell’Universo nulla accade che non segua un criterio di minimo (o di massimo): minima energia, minimo costo, minima distanza, minima superficie.
Ma ora la macchina digitale, anche ignorando che cosa sono i punti di minimo e i numeri reali che li quantificano, li approssima con complesse strategie algoritmiche in cui si eseguono solo operazioni aritmetiche elementari. Non si tratta dunque di definire un nuovo sistema di assiomi che unisca le due facce del numero, ma di articolare un passaggio dal continuo al discreto per via di gradi successivi: approssimazione del modello continuo con un problema algebrico o aritmetico; scelta di un algoritmo efficiente per risolvere il problema algebrico e infine l’esecuzione automatica, in aritmetica approssimata, di questo algoritmo. Passaggi che implicavano regolarmente teorie e questioni difficili, di natura sia astratta sia concreta: teoremi e strutture della matematica «pura», errori di approssimazione, problemi di stabilità, possibili esplosioni di complessità algoritmica, sostanziale impossibilità di ingerenza o di controllo del soggetto umano nel corso del processo, analisi del significato dei numeri che il calcolatore stampa alla fine del processo.
Da simili strategie continua a dipendere la possibilità di una matematica applicata, cioè di tutte le applicazioni scientifiche che oggi ci sono così familiari: dalle previsioni meteorologiche alla costruzione di automobili, dalle tomografie o risonanze magnetiche per immagini alle serie temporali, dai motori di ricerca alla trasmissione di segnali. Ma non bisogna neppure pensare che la matematica applicata fosse l’unica ragione e l’unica fonte di significati per il nuovo calcolo. Lo svela, se non altro, quella parola, «finitiste», usata da Goldstine e von Neumann a proposito delle procedure aritmetiche del calcolatore. Una parola che ricorda il carattere finito dei processi elementari e intuitivi dell’aritmetica in cui il celebre matematico tedesco David Hilbert, cercando di venire a capo della crisi dei fondamenti della matematica nel primo ’900, individuava un nucleo di assolute certezze, una zona di sicurezza al riparo dall’infinito e dai suoi paradossi. E il calcolatore divenne infatti il più competente manipolatore di quel gioco algoritmico di segni al quale Hilbert voleva ricondurre, almeno in linea di principio, tutta la matematica.
Su un piano più filosofico, si trattava pure di rivalutare il carattere intuitivo dei numeri e la tesi kantiana per cui «la struttura del ragionamento matematico è dovuta alla struttura del nostro apparato di percezione» (Hintikka), e dipende quindi, appunto, dall’intuizione, ovvero dalla sua forma pura, cioè non empirica. Su questo punto, almeno, c’era pieno accordo tra Hilbert e Brouwer, suo avversario per altri versi, ma pienamente concorde nel riconoscere una base di affidabilità alle costruzioni elementari dell’aritmetica. Tra le migliori procedure che dovevano approssimare i problemi della matematica Goldstine e von Neumann menzionavano gli algoritmi iterativi, che si basano tipicamente su un criterio di invarianza: per tutto il processo si eseguono in qualche modo le stesse istruzioni, cioè si calcola la stessa funzione per diversi valori della variabile. Conosciuti da tempi remoti, ripresi dai matematici arabi, dagli algebristi italiani del ’500 e poi da Viète e da Newton, questi algoritmi, che imitavano inizialmente certe costruzioni elementari della geometria, servirono ad edificare la computatio algebrica, l’analisi moderna e lo stesso calcolo scientifico nel ’900.
In questa nuova prospettiva i numeri moderni ritrovano una strana rassomiglianza con quelli antichi. Si dice di solito che i Greci, pur avendone la possibilità, non seppero generalizzare il concetto di numero intero naturale (arithmos), impresa che toccò alla matematica occidentale moderna, che seppe infine concepire e definire in modo rigoroso i numeri reali e complessi, i quaternioni, i numeri transfiniti e i numeri non-standard.
Ma sarebbe più giusto affermare che i Greci ricavarono per astrazione dalla geometria, dalla meccanica e dall’aritmetica il concetto generale di logos, che in matematica voleva dire rapporto, e che da questo concetto di logos ebbero origine le generalizzazioni moderne, in particolare il concetto di numero reale (razionale o irrazionale). Il numero reale pensato come «sezione», ovvero come una partizione in due classi di numeri razionali, riprende infatti - come lo introdusse Richard Dedekind nel 1872 - il concetto di proporzione del V libro degli Elementi di Euclide. Nella definizione di Dedekind si rivela pure un tratto caratteristico della matematica di fine ’800: ripensare il numero, per così dire, dal nulla, riconducendolo all’idea di insieme e alle relazioni tra insiemi. Un tratto che ispirò regolarmente il tentativo di ricondurre la matematica a pochi concetti fondamentali della logica, da Bertrand Russell fino a Willard van Orman Quine.
Ma un presupposto della teoria di Dedekind sono anche gli algoritmi, perché in origine le classi della sua definizione consistevano in insiemi di frazioni effettivamente calcolate, che approssimano il numero per eccesso e difetto. Un’analoga osservazione vale per la definizione di numero reale dovuta a Georg Cantor. Il concetto di classe o di insieme poteva insomma rivendicare una priorità logica, ma storicamente sono venuti prima gli algoritmi.
Uno schema che è una necessità
Ora, con il nuovo calcolo scientifico, l’algoritmo rivendica, in un certo senso, il suo statuto di concetto «primordiale» che sta alla base del numero. Il numero reale non è un ente calcolato o calcolabile con un algoritmo: è piuttosto, esso stesso, un algoritmo. Una scatola nera, propone ad esempio Lovász, in cui si inserisce la precisione che si vuole ottenere nel calcolo delle sue cifre, e da cui esce il numero alla fine del processo. Dentro la scatola potrebbero pure funzionare gli stessi algoritmi che gli antichi Greci, Indiani o Babilonesi usavano in tempi remoti; non esattamente quelli, ma altri che ne riprendono, in modo sorprendentemente simile, lo schema; quasi che questo schema fosse una necessità, una sorta di a priori nel grande avvicendarsi storico delle idee matematiche.
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!20 marzo 2007, di Federico La Sala
Da Michael Atiyah una sfida alle tentazioni della logica
«Molti sono convinti che la matematica si risolva nell’esibire dimostrazioni, ma il suo motore è l’immaginazione, non il cieco calcolo». Un dialogo con il celebre studioso anglolibanese noto per il teorema che porta il suo nome e ha rivelato inattese connessioni tra topologia, geometria e analisi
di Luca Tomassini (il manifesto, 18.03.2007)
«Credo che la matematica sia costruita a partire dalla nostra esperienza del mondo esterno». C’è una tensione, una vera linea di frattura, che attraversa la matematica fin dalle sue origini, quella tra intuizione e formalismo, verità immediatamente percepibile e dimostrazione. Un contrasto cui Michael Francis Atiyah - che abbiamo incontrato ai margini del Festival della matematica a Roma - non si è mai arreso, come dimostra la sua straordinaria biografia scientifica. Nato a Londra settantanove anni fa da padre libanese e madre scozzese, cresciuto prima in Sudan e poi nel Regno Unito, è universalmente riconosciuto come una delle più geniali menti matematiche del Novecento. «Per tutta la vita - spiega - ho sempre cercato di costruire ponti», e il celebrato teorema che porta il suo nome (insieme a quello del collega Isadore M. Singer) ha non solo rivelato profonde e inattese connessioni tra topologia, geometria e analisi ma ha avuto un ruolo straordinario nel colmare il divario tra il mondo della matematica pura e quello della fisica teorica. «La matematica - dice ancora Atiyah - comincia con idee generali che diventano via via più precise e specializzate. Durante il XX secolo le sue parti principali sono state affrontate separatamente, con la ben fondata speranza di realizzare progressi più rapidi. Sul lungo periodo questa strategia espone però al pericolo di perdere una visione di insieme, ma oggi per fortuna viviamo di nuovo in un’epoca di sintesi».
Ci può spiegare come giustifica la sua scelta di avversare, nel dibattito sui fondamenti della matematica, un orientamento basato sulla logica?
Molti sono convinti che la matematica si risolva nell’esibire dimostrazioni, dimostrazioni di carattere logico: credo sia un grave errore. È vero, è il cemento che tiene unita tutta la matematica, il suo obiettivo ultimo, ma il mezzo con cui la otteniamo è l’immaginazione, non il cieco calcolo. Non si comincia un lavoro con chiodi e martello, ma con un’idea. Il calcolo, appunto, viene spesso identificato con l’algebra e contrapposto alla geometria.
Anche per lei è così?
Ho sempre avuto un grande interesse per la questione del rapporto tra algebra e geometria. E poiché la nostra percezione di noi stessi e del mondo si articola intorno alle categorie di tempo e spazio, trovo del tutto naturale supporre che esse siano al cuore di questo problema. Per quanto riguarda la geometria, nessuno dubita del fatto che il suo principale oggetto di studio sia lo proprio spazio, come lo percepiamo in un determinato istante. Al contrario, nell’algebra moderna effettuiamo operazioni in una determinata sequenza, una dopo l’altra, nel tempo appunto: è un algoritmo di calcolo, niente affatto diverso da quelli utilizzati da un computer che elabora i suoi dati. Del resto, il pensiero logico-simbolico comporta il passaggio da una serie di assunzioni a delle conclusioni.
Lei ha definito i vantaggi offerti dall’uso del computer come una «offerta faustiana». Quali sarebbero le tentazioni in campo?
Era una provocazione, naturalmente, e ne ho pagato il prezzo subendo un gran numero di critiche. Per capire quale sia il problema torniamo al pensiero geometrico: la sua natura sintetica, intuitiva, è il miglior esempio di ciò che intendo per comprensione. Nella storia della matematica invece l’algebra è nata come un ausilio per il calcolo, la verifica, compito questo che svolge in maniera davvero egregia. Quando facciamo un’operazione algebrica introduciamo un input e smettiamo di pensare al suo significato, semplicemente manipoliamo simboli seguendo regole formali e infine otteniamo una risposta. In mezzo c’è una scatola nera. La scomparsa del desiderio di dare un’occhiata al suo interno è il pericolo che vedo nella diffusione del calcolo automatizzato. Quando ho definito questo fenomeno «faustiano», immaginavo il diavolo mentre si presenta a uno scienziato e gli dice, suadente: «ecco una macchina meravigliosa, basta formulare un problema e lei ti fornisce la risposta. Tutto quello che devi fare per averla è rinunciare alla tua anima, al desiderio di comprendere». Certo, come dimostra la disputa tra Isaac Newton e Gottfried Leibniz, le cose non sono sempre così semplici. Newton sviluppò il suo calcolo infinitesimale per descrivere il movimento dei corpi e in ogni suo ragionamento il riferimento al mondo reale conservava un’importanza centrale. Leibniz era invece un formalista e il suo calcolo era un’algebra molto più semplice da utilizzare. Tra i due, è il filosofo che alla fine ha avuto la meglio: oggi, infatti, scriviamo il calcolo differenziale seguendo la sua notazione. Resta però il fatto che questa scelta non favoriva la comprensione sintetica di tutti gli aspetti del problema. Capire è vedere, tutto insieme e nello stesso istante. Persino nel procedimento artistico possiamo distinguere un aspetto tecnico e uno concettuale, e la tentazione diabolica sta nel considerare solo il primo.
In passato lei ha collaborato all’organizzazione di esperimenti il cui intento era quello di chiarire i fondamenti biologici del pensiero matematico. Ce ne può sintetizzare i risultati?
Alcuni miei colleghi sostengono che per loro ragionare in termini geometrici sia completamente naturale, altri hanno la stessa sensazione riguardo la formulazione algebrica dei problemi. Mi è sempre interessato stabilire se queste inclinazioni avessero un fondamento neurologico e per questo ho cercato di verificare dov’è che nel cervello «avviene la geometria» e dove «avviene l’algebra». La mia ipotesi è che la geometria coinvolga l’emisfero deputato alla visione mentre l’algebra, proprio come il linguaggio, abbia a che fare con l’emisfero specializzato nella percezione del movimento. L’idea era molto semplice: utilizzare tecniche di imaging cerebrale per «vedere» cosa succede durante la risoluzione di problemi matematici. Naturalmente abbiamo iniziato con domande elementari e abbiamo poi verificato che, come previsto, semplici calcoli aritmetici coinvolgono le aree del linguaggio mentre all’opposto problemi più complessi sulla natura dei numeri richiedono l’attivazione dell’altro emisfero. Sono risultati incoraggianti e sono convinto che proseguendo su questa strada nel giro di dieci o vent’anni avremo la possibilità di rispondere a una serie di interrogativi che per secoli hanno impegnato senza successo i filosofi. Se vogliamo capire come pensa il cervello, la matematica è un ottimo punto di partenza.
Eppure importanti filosofi della mente come John Searle ritengono gli strumenti concettuali attualmente a nostra disposizione insufficienti a rispondere a interrogativi quali la natura del pensiero, anche matematico. Lei è d’accordo?
Talvolta un problema può essere così complesso da rendere impossibile una risposta definitiva. Per esempio, cosa è la coscienza? Cosa è il pensiero? Credo che quesiti del genere siano destinati a svanire, a perdere di significato. Per millenni gli esseri umani si sono interrogati sulla natura della vita, oggi ragioniamo in termini di selezione naturale, cellule, proteine, Dna. La domanda si è moltiplicata in tante domande, più specifiche e sofisticate.
Dunque ha un fondamento biologico quella che Eugene Wiegner definiva la «irragionevole efficacia della matematica» nella descrizione scientifica della realtà?
Come le dicevo, la matematica è costruita a partire dal mondo esterno. È poi così sorprendente che sia anche efficace quando si tratta di descriverlo? In fondo, la mente umana è stata modellata dalla selezione naturale, che in qualche modo l’ha resa «compatibile» con la realtà. Ma la nostra esistenza, le nostre percezioni restano confinate a scale macroscopiche e per questa ragione considero sorprendente che la matematica continui a essere applicabile anche al mondo delle particelle elementari. Ma chi può dire qual è la verità? La matematica è veramente uno specchio della realtà o solamente l’immagine che ce ne restituisce il cervello, con tutti i suoi limiti e possibili errori? È proprio ora che la fisica diviene sempre più sofisticata, proprio come la matematica necessaria a descriverla, che le domande poste da Kant tornano di grande importanza. Stiamo sfiorando la natura ultima dello spazio e del tempo o solo costruendo modelli matematici sempre più complicati per adattarli al meglio a quello che osserviamo? I rapporti tra matematica, fisica e realtà continuano a restare un mistero.
Lei ha formulato e dimostrato un teorema che porta il suo nome e che ha trovato sorprendenti applicazioni proprio nel campo della fisica quantistica, influenzando profondamente lo sviluppo della teoria delle stringhe. Ritiene che l’uso sempre più massiccio di sofisticati strumenti matematici stia cambiando la natura della ricerca nel campo della fisica?
La fisica si confronta oggi con domande sulla realtà a scale talmente piccole e energie talmente alte che la verifica sperimentale diventa sempre più difficile, se non addirittura impossibile, e per questo le tecniche che si hanno a disposizione sono per lo più matematiche. Non sappiamo se quelli della fisica odierna siano veri passi avanti nella comprensione del mondo o solo eleganti costruzioni concettuali, ma francamente non vedo alternative all’uso della matematica.
Viceversa alcuni ricercatori hanno messo in discussione il significato della dimostrazione come garanzia della certezza matematica. Oggi esiste persino una rivista dedicata alla cosidetta «matematica teorica», dove sono presentati «teoremi» corroborati da analogie con la fisica. Considera positivi questi sviluppi?
Se un nuovo strumento matematico applicato alla fisica non supera la prova dell’esperimento, non abbiamo alternative a rinunciare al suo uso. Ma se qualcuno partendo da idee fisiche è in grado di ottenere risultati matematici, questi resteranno per sempre. In questo senso la matematica ha tutto da gudagnare da questo rapporto. Molti ricercatori lamentano che le teorie fisiche non sono rigorose ma basate sull’intuizione, ma non colgono l’essenza del problema. Da esse, come è sempre successo nella storia della matematica, vengono suggerimenti, nascono congetture che in molti casi sono state successivamente verificate con altri metodi. Non credo esista il rischio che si possa confondere ciò che è stato dimostrato con quello che non lo è stato.
Nel discorso con cui nel 1995 lasciava la presidenza della Royal Society lei denunciava con parole molto aspre il disinteresse degli scienziati per il crescente «sospetto» che la società nutre nei loro confronti. La pensa ancora così?
Più che mai. Il ruolo della scienza e della tecnologia è enormemente cresciuto negli ultimi due secoli e per questa ragione in una società democratica sono i cittadini che, almeno in linea di principio, dovrebbero prendere decisioni sui finanziamenti alla ricerca. Ma la scienza, specialmente la «grande scienza», è oggi sempre più prigioniera del rapporto con privati, governi e apparati militari che non amano dire alle persone quello che, secondo loro, non devono sapere e i rischi di corruzione intellettuale si sono moltiplicati. Gli scienziati dovrebbero mantenere la loro integrità, senza nascondersi dietro pretesti futili come quello per cui il pubblico non sarebbe mai sufficientemente «educato» per compiere delle scelte. Oggi purtroppo gli scienziati non si muovono così e le conseguenze sono sotto i nostri occhi: il sospetto nei loro confronti è sempre più diffuso.
Tra i suoi numerosi impegni sul fronte pubblico c’è stato anche quello al vertice di Pugwash, un’organizzazione internazionale di scienziati che da più di cinquant’anni si batte contro la proliferazione nucleare. Qual è oggi il suo bilancio?
Dopo la caduta del Muro abbiamo avuto una grande opportunità che per ragioni politiche non è stata colta e oggi la guerra è tornata sulla scena, insieme alla proliferazione nucleare. Sono sempre stato ottimista, ma è difficile esserlo oggi su basi razionali. Mi ricordo che Robert MacNamara, ministro della difesa di Kennedy e poi sostenitore dell’eliminazione delle armi nucleari, mi confidò di essere approdato alle sue convinzioni dopo la sua esperienza nella crisi dei missili a Cuba, quando sembrò che fossimo arrivati molto vicini a un conflitto nucleare. Benché ritenesse questa eventualità effettivamente remota, sottolineava però che una piccola probabilità su lungo arco di tempo può trasformarsi in certezza.
-
-
> "MATEMATICA E MISTERO". SIAMO TUTTI E TUTTE MATEMATICI E MATEMATICHE ... Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!20 marzo 2007, di Federico La Sala
Fra scienza e responsabilità
Un linguaggio in continuo divenire *
«Siamo tutti matematici», è questo il messaggio di Michael F. Atiyah alle giovani generazioni ma anche il titolo di un suo agile e denso libricino affidato ai tipi della casa editrice Di Rienzo (pp. 80, euro 11). Una passione per la sintesi che emerge persino dalle grandi figure del passato da lui scelte a riferimento: Bernahrd Riemann, per esempio, «perché le sue opere complete occupano lo spazio di un volume, mentre quelle di Eulero ne contano oltre ottanta». Spunti autobiografici, acute osservazioni sulla natura della matematica, folgoranti incursioni sulle sue relazioni con la fisica, ma anche un capitolo dedicato al tema «Scienza e responsabilità», il tutto in uno stile semplice e lineare che talvolta sembra risolversi in una vera e propria collezione di bellissimi aforismi. La matematica, sostiene Atiyah, è «un linguaggio ancora in divenire, che non è stato scritto una volta per tutte», e proprio per questo indica nella libertà intellettuale dei ricercatori a venire il più prezioso dei patrimoni. Non a caso nel capitolo dedicato alla «Creatività nella ricerca scientifica» dedica grande attenzione allo stato dell’insegnamento della matematica in Gran Bretagna, lamentando i rischi connessi all’abbassamento della preparazione dei docenti. Per Atiyah la chiave del futuro è nella cultura, non certo nella «acquisizione di competenze».
* il manifesto, 18.03.2007)
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!1 agosto 2007, di Federicco La Sala
 Oltre il 40% degli allievi delle superiori deve recuperare
Oltre il 40% degli allievi delle superiori deve recuperare
 E fra questi quasi la metà ha grossi problemi con la matematica
E fra questi quasi la metà ha grossi problemi con la matematica Fioroni: "Troppi studenti con i debiti
Fioroni: "Troppi studenti con i debiti
 Torniamo agli esami di riparazione" *
Torniamo agli esami di riparazione" *ROMA - Gli studenti italiani accumulano quelli che si chiamano debiti formativi, ma non c’è alcuna certezza che le lacune vengano colmate. Ecco perché il ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, propone di tornare al passato, ripristinando gli esami di riparazione.
Il titolare del dicastero di viale Trastevere ha commentato i dati sugli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie. Si tratta di dati preoccupanti, se si pensa che il 41% degli studenti accumula un debito di formazione. La percentuale maggiore, 44%, riguarda lo studio della matematica, seguito dalle lingue straniere. La questione è che questi arretrati, accumulati soprattutto al secondo e al quarto anno, raramente vengono recuperati. Solo il 60% dei ragazzi in questa situazione, infatti, frequenta i corsi di recupero, e, fra questi, appena il 40% lo fa con successo. Ragione per cui soltanto uno studente su quattro colma la lacuna.
Il debito pubblico è sì un problema grave, ma quello scolastico "ci dovrebbe preoccupare di più", dice il ministro che non vuol sentir parlare di "smantellamento" degli arretrati. Al contrario, "bisogna avere una certificazione certa del loro superamento, per evitare che tre studenti su quattro si presentino alla maturità con questo fardello di lacune". Se l’obiettivo è colmare il debito di formazione, i corsi di recupero, che pure "vanno potenziati", non bastano. Serve "una seria riflessione sul ripristino degli esami di riparazione". Bisogna tornare a rimandare gli studenti a settembre, insomma. I tempi per il ritorno alle vecchie abitudini non sono ancora certi. Fioroni si è limitato a dire che avvierà un monitoraggio nelle scuole per vagliare il consenso alla sua proposta. Poi si vedrà.
Intanto sono giunte le prime, discordanti, reazioni. Un secco no arriva dalla senatrice di Rifondazione Comunista, Giovanna Capelli, per la quale "il recupero va fatto nel corso dell’anno, con un insegnamento pomeridiano, anche individuale", mentre l’esame di riparazione "scaricherebbe tutto sulle spalle della famiglia, che nel corso dell’estate dovrebbe pagare ripetizioni per i figli". Sulla stessa lunghezza d’onda Francesco Scrima, segretario generale della Cisl-Scuola, per cui "bisogna evitare il lezionificio, quel sistema di lezioni a pagamento che non tutti si possono permettere".
Docenti e presidi stanno invece col ministro. Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, parla di "ipotesi ragionevole, sensata". Giorgio Rembado, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, parla di un sistema di recupero-debiti "farraginoso", per cui il ritorno degli esami di riparazione è benvenuto, sempre che "serva come verifica, e non come alibi per spostare la fase del recupero dall’interno all’esterno della scuola".
Fioroni si è soffermato in particolare sull’emergenza-matematica. "Non sarà il mio mestiere", cantava a questo proposito Antonello Venditti. E a giudicare dai dati del ministero, ad avere problemi con la matematica sono in tanti, ben il 44% degli studenti delle secondarie. Una bestia nera che accomuna Nord e Sud, Centro e Isole, allievi del liceo scientifico e degli istituti professionali. Il ministro arriva a parlare di emergenza formativa, "legata non ai programmi e ai loro contenuti, ma alla capacità di far appassionare i ragazzi allo studio della materia". Fioroni intende insediare presso il Ministero un comitato di matematici, docenti di scuole medie superiori e università. Perché c’è bisogno di proposte per superare l’emergenza, "perché bisogna far capire che la matematica non è un club esclusivo per pochi, ma un esercizio che ha attinenze con la realtà".
* la Repubblica, 31 luglio 2007
-
-
> "MATEMATICA E MISTERO". il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!13 febbraio 2007, di Federico La Sala
Vaticano
Il papa con il copyright *
Il vaticano sta lavorando a un provvedimento con il quale si intende tutelare con il diritto d’autore testi, fotografie, immagini e registrazioni della voce dei papi, e gli atti della Santa sede. La notizia è apparsa ieri sul «Sole 24 Ore». Il quotidiano scrive che nel testo, pronto tra un paio di mesi e scritto rifacendosi alla legge dello stato italiano, sarà previsto che per utilizzare libri, immagini e registrazioni audio, salvo eccezioni stabilite nel regolamento, servirà un’autorizzazione e sarà possibile esigere il pagamento delle royalties. Della stesura del provevdimento si sta occupando la Libreria editrice vaticana.
* il manifesto, 11.02.2007.
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!23 novembre 2006, di Federico La Sala
Contro ogni pretesa "teocratica" (in fondo, atea e astuta!!!), "resistere, resistere, resistere": "solo Dio è sapiente" (Socrate), "solo Dio è buono"(Gesù)!!! (fls)
GESU’ PER PRIMO FU UN VERO RELATIVISTA!!!
di Giancarlo STORTI GAJANI (docente universitario - Politecnico di Milano) *
Leggo con preoccupazione l’intervento di Domitia su Metro del 15 novembre a proposito del relativismo (e mi metto quindi in gioco, citando l’autrice). Affermare che l’etica sia appannaggio esclusivo della Chiesa, con la "C" maiuscola, è sbagliato, aberrante, e antioccidentale. Lo dico da cristiano, quindi da persona non disposta a rinunciare alla dialettica. Da cristiano non cattolico: sono valdese (e temo che la "C" dell’intervento fosse la "C" di cattolico, non di Chiesa), un popolo che oggi non solo non avrebbe alcun diritto a dire la sua, ma avrebbe forse cessato di esistere in una delle tante crociate, mosse in nome della Chiesa con la "C" maiuscola, se il relativismo, anche etico, non fosse diventato proprio in quei tempi una delle conquiste del pensiero occidentale.
A partire da Galileo, se non si fossero messi in gioco i "principi etici" in modo dialettico, e cioè senza affermare che "il bene e il male" sono cosa assoluta, non ci sarebbe stata alcuna scienza così come noi la conosciamo. Forse non crederemmo ancora in una Terra piatta, ma, molto peggio, avremmo dovuto aspettare l’autorizzazione per pensarla diversamente (anche la forma della Terra rientrava nell’etica un tempo). Il relativismo è forse la maggiore conquista del pensiero occidentale, e, contrariamente a quanto alcuni anche importanti esponenti di varie Chiese credono, la forza fondamentale del cristianesimo deriva proprio dal relativismo di Cristo contrapposto al dogmatismo assoluto dei Farisei, contro i quali Cristo non risparmia alcuna fatica dialettica.
Questa posizione spaventa, come tutte le posizioni che richiedono grande responsabilità: dover continuamente discriminare tra ciò che possiamo accettare come "bene" e ciò che dobbiamo rifiutare in quanto "male" costa sicuramente più tempo e fatica, rispetto a chi pensa di poter demandare queste scelte ad altri: la Chiesa, ma anche il partito, chi ha potere, il branco o chi urla più forte.
Le scelte di minor fatica, come sperimentiamo ogni giorno, sono raramente quelle giuste, ed è nostro dovere discutere tutto, ma proprio tutto, anche e soprattutto la Bibbia (lo dico da cristiano) e ciò comporta prendersi la responsabilità degli errori che si fanno, e non cercare capri espiatori (il diavolo, il fato, i sindacati, i politici, le cattive compagnie).
Il vero responsabile delle brutture dei giorni nostri non è il relativismo, ma la mancanza di voglia, o di capacità di discutere anche le cose minime, tipica di coloro che preferiscono usare una tavola della legge (con guerre e pene di morte annesse) piuttosto del cervello che ci è stato donato.
* metro- milano, 23.11.2006
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!13 aprile 2007, di Federico La Sala
L’origine della fede
di Pietro Greco *
È appena uscito in Germania per i tipi dell’editore Suv un libro dal titolo «Schöpfung und Evolution», creazione ed evoluzione, ha per tema l’origine della vita e il cambiamento della specie. L’autore è Joseph Ratzinger. Il Papa di Roma.
Non abbiamo letto il volume, che presto sarà disponibile anche in italiano. Ma, se le anticipazioni di stampa sono corrette, si tratta di un libro destinato a far discutere. Per almeno tre ordini di questioni che Benedetto XVI solleva e che sono, per l’appunto, discutibili.
La prima questione riguarda l’origine della vita: il Papa sostiene che da sola la scienza non è in grado di spiegarla e che, a ogni modo, sia all’origine della vita sia all’origine dell’universo (ovvero di “ogni cosa”) non ci può essere il caso, ma deve esserci un progetto - un “disegno” - che riconduce direttamente a Dio.
La seconda questione riguarda la teoria proposta da Darwin per spiegare l’evoluzione biologica: Joseph Ratzinger sostiene che non è completamente dimostrata e neppure è completamente dimostrabile, perché centinaia di migliaia di anni di mutazioni non possono essere riprodotte in esperimenti controllati in laboratorio.
La terza questione riguarda la scienza stessa, strutturalmente incapace di rispondere a questioni filosofiche del tipo: da dove viene e dove sta andando l’universo, da dove viene e dove sta andando l’uomo. Per dare risposte a questi quesiti, sostiene Benedetto XVI, occorre una razionalità che include la scienza, ma che va oltre la scienza.
Questo pensiero è stato più volte espresso dal Papa, ma ha preso la forma compiuta del libro in seguito al discorso tenuto in un seminario chiuso e, finora, segreto su “creazione ed evoluzione” che si è svolto a Roma lo scorso mese di settembre, nell’ambito dei tradizionali incontri del «Circolo degli allievi del professor Joseph Ratzinger».
Le tre questioni sollevate dal Benedetto XVI sono tutte legittime. Ma, come dicevamo, sono tutte piuttosto discutibili. Il Papa ha diritto di dire ciò che vuole. Ma, soprattutto in materia di filosofia naturale, tutti hanno diritto di discutere ciò che il Papa dice.
Prima questione: è vero che la scienza non ha, finora, fornito una spiegazione esaustiva su quello che il biologo darwiniano Theodosius Dobzhanski definiva il primo e più grande “trascendimento evolutivo”: la transizione dal non vivente al vivente. E neppure ha fornito, finora, una spiegazione esaustiva su quell’altro straordinario “trascendimento evolutivo” che è la transizione dal nulla a qualcosa, che è la nascita dell’universo. Ma è anche vero entrambi questi processi non sono affatto “oltre la scienza”, ma al contrario sono oggetto di ricerca da parte degli scienziati. D’altra parte non c’è spiegazione scientifica possibile se non in un quadro naturalistico: l’opzione della creazione divina non può che essere proposta che come atto di fede. Inoltre, non è affatto vero che all’origine della vita e dell’universo, secondo la scienza, ci sia solo il “caso”. Le spiegazioni cercate intorno all’origine dell’universo sono tutte interne ai vincoli non deterministici, ma non per questo completamente aleatori, della fisica quantistica. Le spiegazioni cercate intorno all’origine della vita sono tutte interne ai vincoli stocastici, ma ancora una volta non completamente aleatori, della chimica e della biologia.
Quanto alla seconda questione posta dal Papa, ovvero che la teoria dell’evoluzione biologica di Darwin non è completamente dimostrata né completamente dimostrabile, è ancor più opinabile. Per molti motivi. Una teoria scientifica non è che il modo più economico e logicamente solido per spiegare i fatti noti intorno alla realtà naturale. Può succedere che esistano più modi economici di spiegare i medesimi fatti noti. Ovvero più teorie scientifiche. È successo persino in fisica. Per esempio quando, tra il 1916 e il 1919, esistevano due teorie - quella di Newton e quella di Einstein - per spiegare i medesimi fatti noti sulla gravitazione universale. Poi nel 1919 gli scienziati si sono imbattuti in un fatto nuovo - una certa deviazione della luce di una stella lontana da parte del campo gravitazionale del Sole - che trovava una spiegazione nella teoria di Einstein e non in quella di Newton. Per questo, da allora, la teoria più generale è quella della relatività einsteiniana.
Da molti decenni a questa parte esiste nell’agone scientifico una sola teoria economica in grado di spiegare tutti i fatti noti dell’evoluzione biologica. Questa teoria è corroborata, per usare un termine caro a Karl Popper, da un numero semplicemente enorme di evidenze empiriche indipendenti prodotte in discipline le più diverse: dalla paleontologia alla biologia molecolare. D’altra parte nessun fatto empirico noto è stato finora in grado di falsificare, per usare un altro concetto caro a Popper, la teoria di Darwin. Mentre tutte le altre teorie contrapposte a quella darwiniana o risultano meno economiche o sono state falsificate. È vero che, come sostiene papa Ratzinger, la storia evolutiva della vita non può essere ripetuta in laboratorio, e quindi la teoria di Darwin non può essere tutta verificata mediante esperimenti controllati, come avviene in fisica. Ma, come hanno dimostrato Ernst Mayr e una costellazione di filosofi della biologia, questo non significa affatto che la biologia non sia una scienza. E che le teorie biologiche non siano teorie compiutamente scientifiche.
Anche la terza questione sollevata da benedetto XVI è discutibile. La scienza non ha pretesa alcuna di completezza. Ma pretende che nessun ambito sia precluso alla ricerca. In particolare non possono essere preclusi alla ricerca scientifica neppure quegli ambiti - da dove vengono e dove vanno l’uomo e l’universo - che Joseph Ratzinger pretende esclusivi della filosofia e della teologia: ovvero esclusivi di una ragione che non pretende una verifica empirica. La scienza vuole dire la sua - e sta dicendo la sua - anche in questi ambiti.
E, facendo ciò, per la verità allarga gli orizzonti, non li restringe affatto. Quale sarebbe oggi l’immagine che l’uomo ha di se stesso e dell’universo che lo circonda senza i fatti, le teorie o anche solo le ipotesi proposte dalla scienza in questi ultimi quattro secoli intorno sia all’origine dell’uomo e del mondo sia alla loro evoluzione?
E cosa sarebbe dell’immagine che l’uomo ha di se stesso e dell’universo che lo circonda se la ricerca della verità si limitasse, come ai temi prima di Galileo, a costruzioni logiche sopra «un mondo di carte» invece che a «certe dimostrazioni» verificate da «sensate esperienze»?
Già, Galileo. Nel 1616 il cardinale Roberto Bellarmino consigliò al pioniere della scienza moderna di limitarsi a spiegare «come vada il cielo» e di non cercare di spiegare «come si vada in cielo». Naturalmente vale anche il contrario. Se vogliamo che i rapporti tra scienza e religione non diventino conflittuali, ma siano improntati al reciproco rispetto, è bene che i religiosi si limitino a spiegare «come si vada in cielo» e non cerchino di spiegare agli scienziati «come vada il cielo». Lo stesso Bellarmino venne meno al suo saggio consiglio sulla separazione delle sfere d’intervento. E ne nacque un conflitto tra scienza e religione (cattolica) che a quattrocento anni di distanza non sembra essere stato ancora sanato.
* l’Unità, Pubblicato il: 13.04.07. Modificato il: 13.04.07 alle ore 8.59
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!16 luglio 2007, di Federico La Sala
SCIENZA
La visione tecnica che domina le società democratiche occidentali pretende di dire l’ultima parola sulle origini e le ragioni della vita. Nel discorso per la Festa del Redentore il Patriarca di Venezia mette in luce i punti di forza della religione e della filosofia nella ricerca, anche oggi, del senso dell’esistenza
L’anima? Non è più un tabù, ma una chance per le neuroscienze *
Fino a ieri l’ipoteca della fede sembrava complicare il lavoro agli scienziati che studiavano la mente e la coscienza. Oggi è diventato chiaro a molti che la razionalità ha forme molteplici che non sono riducibili unicamente ai paradigmi della scienza, ma trovano nello «spirito» un sostegno decisivo per la comprensione dell’umano e della realtà. Non tutto si può spiegare meccanicamente con la biochimica del cervello
I cultori delle neuroscienze convinti che la comprensione del cervello rappresenti la svolta epocale più radicale (una rivoluzione più grande di quelle copernicana, darwiniana e freudiana) affermano a chiare lettere non solo che la nozione di vita è assai complessa, ma anche che vita è un termine troppo generico ed applicabile ad un insieme di processi. A tal punto che lo spirito di vita e la vita sarebbero concetti «intorno a cui gli scienziati hanno cessato da tempo di interrogarsi» (V.S. Rachamandran, Che cosa sappiamo della mente, Mondadori, p. 98).
La fede cristiana, non complica ulteriormente le cose pretendendo che, per descrivere compiutamente la vita umana, si debba parlare non solo di mente e di cervello, ma anche di spirito (anima) e per di più di spirito individuale intimamente legato ad una carne destinata a risorgere? Rispondere a queste e simili domande in termini il più possibile adeguati è diventata una questione stantis vel cadentis per la fede cristiana.
Accogliere la sfida contenuta in questa provocazione è diventata ancor più una questione di vita e di morte per l’etica da quando William Safire ha coniato il termine «neuroetica» per indicare quell’insieme universale di risposte biologiche, connaturate al nostro cervello, da dare ai dilemmi di natura etica.
È decisamente positivo il fatto che siamo usciti dall’epoca in cui le scienze vietavano di «porre la domanda delle domande». Esse stesse non temono ormai di parlare, in qualche modo, di verità. La tecnoscienza, che non esclude di poter fornire spiegazioni per tutto il processo evolutivo, macro e micro - dal Big-Bang fino all’insorgere della prima cellula di vivente - sembra voler farsi carico di quelli che una volta erano i contenuti dell’etica filosofica e della religio. Taluni cultori delle neuroscienze affermano addirittura che «il nostro cervello vuole credere» (M.S. Gazzaniga, La mente etica, Codice edizioni, p. XVII) e quindi si apre uno spazio per una religiosità riconosciuta come fenomeno di una qualche rilevanza sociale. Essi dicono: pur sapendo che «di fronte ad un conflitto morale reagiamo di fatto in modi molto simili guidati da reti neurali o da sistemi di rinforzo comuni al nostro cervello» (ibid., 158) non si può evitare di confrontarsi col fatto che, almeno fino ad oggi, le persone, quotidianamente, vivono e muoiono in nome delle loro credenze religiose. Ci dividono le nostre teorie religiose e morali, ma la "mente etica" ci unirà e ci salverà!
La concezione tecnoscientifica della vita umana e della sua storia è divenuta assai rilevante nelle democrazie avanzate soprattutto dell’Occidente. Se la democrazia plurale si costruisce autonomamente solo su procedure, è però la tecnoscienza (non più le religioni e le filosofie) a volerci dire che cos’è la vita nella sua origine, nel suo svolgimento e nel suo termine. A ben vedere il fenomeno stesso della globalizzazione è strettamente dipendente dal fatto che l’Occidente sta imponendo a tutto il mondo una concezione della felicità come puro prodotto progressivo della tecnoscienza. In questa visione delle cose non v’è più posto per l’anima, la risurrezione della carne, la vita eterna.
Ci si può anzitutto porre una domanda. Una simile visione della realtà è per l’autentico profitto della stessa tecnoscienza?
Conviene anzitutto rilevare che la tecnoscienza fa leva su una visione del reale che consente la progressiva scoperta solo di ulteriori stati di cose, ma non quella di ulteriorità di senso rispetto a quello definito dall’impresa scientifica. Riaffiora qui obiettivamente il rischio, che ogni autentica impresa scientifica deve invece scongiurare, di una nuova forma di riduzionismo (non di corretta "riduzione") che finisce per produrre inedite, potenti varianti di scientismo, che in ogni sua forma, da quelle più rozze a quelle più raffinate, è fondato su una triplice ingiustificata identificazione: «ciò che è» è «ciò che è conoscibile»; «ciò che è conoscibile» è «ciò che è conoscibile s cientificamente»; «ciò che è conoscibile scientificamente» è «ciò che è conoscibile mediante la scienza empirica». Così che, in definitiva, solo le scienze, e in specie quelle empirico-sperimentali, ci danno la conoscenza di ciò che è.
Non la scienza astrattamente intesa, ma l’uomo di scienza non può però eludere la domanda: l’orizzonte della ragione umana oltrepassa o no l’orizzonte della ragione scientifica?
Esistono almeno due buoni motivi per rispondere positivamente. Anzitutto i processi umani, gli stati e le operazioni della mente quali intenzionalità, comportamento, cognizione, libero arbitrio non sono come tali oggetto possibile dell’indagine scientifca, che al più può analizzare solo le loro condizioni fisiche o psichiche. Non mancano conferme a questa affermazione da parte dei più recenti studi legati alle scienze cognitive. Inoltre vi è il problema dell’organismo che tiene in collegamento tali strutture, del perché esse svolgano la loro funzione, del come si siano formate. Emerge con forza già a questo livello la questione dell’Io (Self), che dovrà nella sua complessa articolazione (continuità, unità, corporeità, azione volontaria) trovare spiegazione. E i cultori delle neuroscienze sono ben lungi dall’aver dimostrato che questa sia correlabile con una qualche funzione neuronale od area cerebrale.
In secondo luogo esistono forme di razionalità differenti dalla razionalità scientifica. Il logos umano, infatti, pur essendo uno, si esercita ed è produttivo secondo plurime forme teoriche, pratiche ed espressive - come già affermava Aristotele - che oggi possiamo identifcare in almeno cinque forme differenziate ed irriducibili di razionalità (cfr. i diversi gradi del sapere di Maritain e le diverse forme della conoscenza secondo Lonergan): teorica-scientifica (scienza), teorica-speculativa (filosofia/teologia), pratica tecnica (tecnologia), pratica-morale (etica) e teorico-pratica espressiva (poetica). Per questo Benedetto XVI molto opportunamente non cess a di invocare il rispetto dell’"ampiezza" della ragione, articolata nella pluralità delle sue capacità e funzioni, e quindi né arbitraria, né indifferenziata pena la caduta nella frammentazione del senso.
Anche quando le neuroscienze fossero in grado di descrivere il come gli stati neuronali del cervello si colleghino a tutti i fenomeni che, per intenderci, chiameremo spirituali, resterebbe intatta la questione del che cosa essi siano in realtà. Anche ammesso un rapporto di causalità tra stati neuronali ed emozioni, operazioni ed opzioni spirituali, tale confronto non potrebbe mai escludere, ma piuttosto suggerire l’esistenza di un principio che muove l’Io (Self) nella sua relazione profonda verso il Sé e verso l’altro. Come escludere che la biochimica del cervello descriva solo una dimensione del complesso comportamento spirituale di un essere che vive dell’insopprimibile unità duale di anima e di corpo?
Se la biochimica del cervello risponderà alla domanda su che cosa sono il libero arbitrio, l’arte, su chi siamo noi, allora la grande questione della natura dell’Io e della vita - e alla fine dell’anima - troveranno una spiegazione in cui il problema della natura dell’io non svanirà affatto, ma solo sarà risolto da una pura lettura tecnoscientifica, che comunque dovrà mostrare la sua sufficienza. Oppure la biochimica del cervello, come personalmente ritengo occorra concludere, potrà solo dire sempre meglio il come del suo nesso con la mente, lasciando spazio ad altri procedimenti razionali per indagare il che cosa della mente stessa oltre che del bios.
Questo che cosa, da quando l’uomo esiste, non è mai stato messo da parte semplicemente perché irresistibilmente l’uomo, a partire dalla domanda che lo costituisce, «alla fine chi mi assicura definitivamente?», sempre lo ripropone. È la sua dimensione spirituale, l’anima e il destino immortale di tutta la persona, che impone all’uomo la domanda sulla natura della mente e attraverso di essa sulla sua natura tout- court.
VENEZIA
Tutta la Laguna nel segno del Redentore
Ogni anno in occasione della Festa del Redentore, festa religiosa e civile di Venezia e cara a tutte le terre venete, il Patriarca di Venezia rivolge alla città e non solo un discorso che mette in luce le sfide più urgenti per gli uomini e le donne di oggi di fronte alla realtà contemporanea. Negli anni questo appuntamento ha toccato le questioni del meticciato di civiltà, della nuova laicità, dell’educazione e della scuola nel nostro Paese, fino ad approdare, nel discorso che il Cardinale Angelo Scola (foto sopra) leggerà questa sera, al tema del rapporto tra l’anima e le scienze. Il discorso del Redentore sarà ripreso in un filo diretto radiofonico in onda sulle radio del circuito nazionale «In Blu» domani, dalle 11 alle 12, al quale parteciperanno tra gli altri il filosofo Emanuele Severino, l’astronomo Guido Chincarini, il matematico Giorgio Israel, l’imprenditore Polegato, il filosofo Francesco Botturi.
* Avvenire, 15.07.2007
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!17 luglio 2007, di Federico La Sala
IL DIBATTITO
Neuroscienze, quante sfide al pensiero
Da Venezia Maria Laura Conte (Avvenire, 17.07.2007)
Ma che c’entra un cardinale con le neuroscienze? Non dovrebbe occuparsi d’altro un vescovo nel giorno della Festa del Redentore e nel suo discorso rivolto alla città e divenuto ormai una tradizione consolidata? L’obiezione che ha aperto il vivace dibattito radiofonico in onda sul circuito delle radio Inblu di ieri mattina, dedicato al tema del discorso del Patriarca di Venezia di quest’anno, «Infrangere il tabù dell’anima per giovarci delle scienze», pronunciato domenica sera e pubblicato su Avvenire, ha trovato subito la pronta risposta di Francesco Botturi, filosofo: «Un cardinale si occupa di queste cose perché queste cose si occupano di lui». Un vescovo come ogni persona e di buon senso, ha osservato Botturi, si rende conto che oggi «le neuroscienze, come tendenza della cultura e della riorganizzazione culturale che è in atto, si stanno occupando sempre più dell’uomo come tale e della sua identità». Oggi è come se le categorie usate normalmente nella fede cristiana fossero emarginate o sostituite, per cui per il filosofo è tempo di affrontare la domanda di fondo: «Che valore hanno ancora termini fondamentali della tradizione cristiana come il tema dell’anima? Le tecnoscienze aprono spazi inediti sull’intervento tecnico sull’uomo e ancora più vastamente sembrano stabilire una svolta epocale del rapporto tra natura e cultura. Questo è il punto serio che va affrontato».
Anche «allargando la ragione», tema ripreso da Emanuele Severino: «La filosofia - ha richiamato il filosofo - ha sempre mostrato che la ragione ha una larghezza essenzialmente maggiore del sapere scientifico e qui la Chiesa fa bene a rivendicare qualcosa che solo l’ingenuità di alcuni scienziati nega. I problemi e le difficoltà emergono poi sui contenuti di questa ragione». Una «larghezza» nella quale su muove nel suo mestiere quotidiano di cosmologo e astronomo Guido Chincarini, per il quale «la scienza non può in realtà spiegare la fede né dare spiegazioni razionali delle religioni, così come la fede e la religione non possono condizionare il procedimento scientifico». Ma restano come realtà tremendamente necessarie alla vita umana che, per Chincarini, devono convivere e interessarsi l’una dell’altra. Anche perché, per quanto irruento sia il progresso delle neuroscienze, secondo Giorgio Israel, matematico, resterà sempre qualcosa di non riducibile a pure questioni di processi di numeri o materia: «C’è un pericolo mediatico: si fa credere tutti i giorni di aver scoperto il gene di questo e quello e di aver spiegato tutto. In realtà si è descritto, ma non si è spiegato nulla. Le neuroscienze possono descrivere cosa accade nel mio cervello quando penso, ma di qui a dire che quello che accade nel mio cervello sia la causa dei miei pensieri, questo non solo non è stato dimostrato, ma è indimostrabile». Per questo le neuroscienze per il matematico sono destinate al fallimento, perché il loro progetto di ricostruire su basi materiali tutte le manifestazioni del pensiero presume comunque una base di carattere metafisico, quindi è di fatto auto-contraddittorio.
Come è carica di contraddizioni la promessa di felicità che si pretende dalla tecnoscienza: «Il problema - ha rilevato Alberto Strumia, teologo e fisico-matematico - è mettere a fuoco la connessione tra il grado di vivibilità delle nostre società e i principi metafisici e antropologici su cui esse si fondano». Perché secondo Strumia le cause dell’invivibilità delle nostre società stanno nei nodi teorici che riguardano la ragione umana e la concezione dell’uomo. Per pensare il quale - è tornato ad approdare qui il dibattito - è impossibile eludere la dualità anima-corpo.
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!17 luglio 2007, di Federico La Sala
Tra Ratzinger e il diavolo
di GIAN ENRICO RUSCONI (LA Stampa, 17/7/2007)
Nel suo «discorso pubblico» un cardinale afferma che la Chiesa è rimasta l’unica istituzione in Italia in grado di difendere la famiglia. Raccoglie l’applauso del pubblico.
Applaudono in prima fila anche quelli che la Conferenza episcopale italiana certifica come i «veri laici», includendovi pure gli agnostici che di Dio, di Cristo o della storia della Chiesa non sanno quasi nulla, ma stanno dalla parte della Chiesa contro la (presunta) deriva lassista e illuministica della società contemporanea e contro l’islamismo strisciante.
In effetti, oggi il consenso alla Chiesa può fare a meno di qualunque informazione e competenza teologica. L’età post-secolare si presenta anche come l’età dell’impoverimento del quadro teologico, quantomeno nell’ambito del discorso pubblico che sta a cuore alla Chiesa di oggi. Conosco le seccate obiezioni di quanti mi accusano di essere disinformato non solo del fervore delle nicchie teologiche specializzate, ma anche dei libri che ogni anno escono in Italia e che sono esposti nelle vetrine delle grandi librerie laiche. In realtà si tratta per lo più di opere di dottrina morale o di esegesi biblico-evangelica, dove i riferimenti teologici sono soltanto di supporto e funzionali alle raccomandazioni morali. Si confonde la letteratura religiosa edificante con la riflessione teologica. Un sintomo grottesco è stato quello di uno zelante cardinale che in occasione della festa di Natale (evento fondante della teologia dell’incarnazione) non ha trovato di meglio - nel clima dell’offensiva contro «le coppie di fatto» - che parlare della grotta di Betlemme come del luogo in cui c’era la «vera famiglia».
Nell’attuale ritorno del classico tema «ragione e fede», che rimette in circolazione i non meno classici motivi contrapposti, chi esce perdente è la ragionevolezza. È sconfitto cioè chi non vuol «vincere», chi non intende imporre le sue convinzioni ma vuole creare una comunità di cittadini che si parlano seriamente, partendo dalla constatazione che su alcune «verità» importanti non c’è possibilità di convergenza tra differenti convinzioni. Eppure è necessario creare un ragionevole modo di vivere insieme. Solo la ragionevolezza (che viene diffamata come relativismo) può costruire una società di cittadini maturi.
In questo contesto va collocato anche uno dei motivi-guida del pensiero di Papa Ratzinger: la razionalità della fede. La strategia ratzingeriana conferma e insieme tenta di controbattere l’impoverimento teologico nella comunicazione pubblica della Chiesa, di cui parlavo sopra. Quello della razionalità della fede è il tema centrale nella complessa attività espressiva del Pontefice, che pure spazia negli ambiti più diversi. Oggi polarizza l’opinione pubblica soprattutto attorno al recupero delle forme della traditio cristiana. Ma anche la reinvenzione della tradizione (tale è la Messa in latino) rientra nello sforzo di trovare attraverso le antiche radici greco-latine la ratio cristiana. Questa tematica lascia con discrezione sullo sfondo i grandi temi teologici della redenzione, della colpa originale, della salvezza o della dottrina trinitaria, che sono diventati troppo ostici e difficili da spiegare a un pubblico religiosamente deculturalizzato come l’attuale. Si concentra su argomenti apparentemente più accessibili e universali come la «natura /natura umana» e appunto «la razionalità».
Parte decisiva dell’operazione ratzingeriana che declina il discorso religioso con le categorie del logos e della ragione, è il richiamo all’originaria ellenizzazione del cristianesimo. Con questo concetto si intende l’operazione culturale con la quale, tra il II e il IV secolo, gli esponenti più qualificati della Chiesa in formazione hanno strutturato, tramite categorie prese dalla tradizione platonica, i dogmi originari del cristianesimo - non senza profondi traumi e laceranti conflitti. Ma Ratzinger non si cura di quei conflitti: a lui preme presentare l’ellenizzazione come riuscito e insuperabile modello del rapporto tra ragione e fede.
Il tema dell’ellenizzazione / disellenizzazione del messaggio cristiano - fortemente sviluppato nella lezione di Ratisbona - ha colto di sorpresa e impreparati i commentatori cattolici nostrani. Ha provocato invece una vivace reazione polemica nel mondo protestante tedesco e americano e, in generale, là dove esiste ancora una cultura storica e religiosa degna di questo nome.
Da noi invece i commentatori del discorso papale continuano a elogiare soltanto l’argomento (certamente centrale) che l’autentica ragione religiosa è nemica della violenza, non solo della violenza maldestramente attribuita all’Islam con l’infelice citazione dell’imperatore bizantino poi chiarita, ma anche della violenza del nichilismo contemporaneo e dello scientismo, da cui discenderebbe il disprezzo dei valori dell’uomo.
Ma se si esamina attentamente l’argomentazione di Ratzinger si arriva presto alla conclusione che il suo bersaglio non è lo scientismo, bensì la razionalità scientifica stessa, vista come riduzione dell’orizzonte della vera ragione che si proietta verso il trascendente. Insomma la vera ragione per il Papa è «la ragione della fede», quella «che s’interroga su Dio».
A questo punto viene il dubbio se Ratzinger, nonostante la sua dichiarata ammirazione per la conoscenza scientifica, non ne disconosca di fatto l’essenziale. Che la ragione sia limitata lo sappiamo da sempre, in modo sistematico nell’età moderna a partire da Kant, verso il quale Ratzinger invece formula un giudizio sorprendentemente negativo. Ma se Ratzinger accetta l’autonomia della logica e della ricerca scientifica soltanto in una logica di subalternità alla ragione religiosa, se nega alla scienza la capacità autonoma di conoscenza sull’uomo e sulla natura, nega di fatto l’essenza stessa della ragione moderna.
Non sono io a dirlo, ma Jürgen Habermas, che i cattolici additano volentieri come il partner laico ideale del discorso religioso, fraintendendo e trasfigurando il suo colloquio con l’allora cardinale Ratzinger (in realtà si è trattato di un dialogo finto, dettato da reciproca cortesia intellettuale). Ebbene il Pontefice - ha scritto Habermas - «ha dato al vecchio dibattito sulla ellenizzazione e disellenizzazione del cristianesimo una svolta inattesa nel senso di una critica alla modernità.
Con questo, ha fornito anche una risposta negativa alla domanda se la teologia cristiana deve tenere conto delle sfide della ragione moderna, post-metafisica». Ogni possibilità di dialogo viene annientato alla radice.
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!19 luglio 2007, di Federico La Sala
MATEMATICA
Le speculazioni numeriche risalgono ai Semiti ma con i Padri della Chiesa diventano una forma di sapienza estetica
Un simbolo dietro ogni cifra
Dopo Dio, niente è più perfetto delle serie numeriche. Ma dall’uno al dodici, pagani e cristiani rintracciano in essi le risposte ai misteri universali e alle domande sulla natura
Di Elio Guerriero (Avvenire, 19.07.2007)
John Barrow, professore di matematica all’università di Cambridge, ha vinto nel 2006 il prestigioso premio Templeton. Nel discorso di accettazione dell’onorificenza, ha esaltato la disciplina dei numeri perché le equazioni matematiche, in fondo pochi scarabocchi su pezzi di carta, ci dicono come si comporta l’universo: «C’è una logica più grande dell’universo, e ci stupisce perché ci permette di capirne una parte significativa».
A dire il vero, la logica e soprattutto la meraviglia che genera non sono nuove. Le tradizioni numeriche risalgono al tempo dei Semiti e dei Greci e trovano estesa applicazione nella Bibbia. È tuttavia nell’antichità cristiana che l’interpretazione e la simbolica dei numeri divengono una forma di sapienza che alla visione del mondo dei Padri della Chiesa conferivano impronta di conoscenza e oggettività, carattere estetico. E se per Boezio «le cose costruite dalla natura all’inizio, sembrano formate con calcolo numerico», Agostino subito alza il tono: «Guarda il cielo, guarda il mare, ciò che brilla là in alto e ciò che striscia in basso, guarda ciò che vola e ciò che nuota: tutto è bello, perché tutto racchiude un numero. La mano che opera, le membra che si compongono per l’atto gratuito della danza, il tempo che scorre, la musica che si modula, tutto ha per anima e artista nascosto il numero». Ma il discorso si allargava ulteriormente. Per Isidoro di Siviglia il numero è all’origine di ordine, misura, ritmo e proporzione.
La visione generale veniva poi approfondita con la speculazione sui singoli numeri. Questa partiva da Dio, autore del numero, il cui nome, però, non può essere pronunciato così come non può essere misurato. Dopo Dio, tuttavia, niente è più perfetto del numero. L’unità non rientra propriamente nella serie numerica, ma è principio, fonte e origine di ogni numero. È generatrice della moltitudine, numerosa al di sopra di tutti i numeri, che ad essa possono essere ridotti per sottrazione e divisione. Il nu mero due non possiede principio di unità: è piuttosto l’unità divisa, per questo significa scissione, opposizione, scandalo. Era questa l’opinione degli Orfici e di Platone. Un verso di Virgilio: «Dio trova piacere nel numero dispari», la rese popolare anche tra i Padri della Chiesa. Ne seguono alcune applicazioni: ad una considerazione storica i Testamenti sono due, appena si guarda, tuttavia, con l’occhio della fede essi contribuiscono a formare l’unica rivelazione di Dio.
Similmente i comandamenti della carità sono due, ma la radice è una sola: l’amore di Dio che, riversato nel cuore dei fedeli, genera amore di gratitudine per il Padre e amore di fraternità per il prossimo. Se l’uno è al di là della serie e il due è il numero imperfetto, il tre è il primo vero numero. Primo numero come Dio è il primo essere; numero dispari come Dio che non ha eguale al di fuori di sé e il cui essere non comporta variazione o cambiamento; numero virile, cioè attivo, come Dio che non è passivo in niente e agisce sempre. Il tre, infine, è segno dell’anima creata ad immagine di Dio, per questo sant’Ambrogio la definisce «un numero di salvezza».
Dopo il tre viene a cadere la maledizione del numero pari. Per Sant’Agostino il quattro è il riflesso della sapienza di Dio nel governo del mondo. È anche il numero della solidità e della stabilità: una pietra quadrata dovunque venga lanciata si fissa sempre su una posizione stabile. Anche l’arca del diluvio, fatta di legni quadri, era essa stessa quadrata per potersi reggere sulle acque. Quattro, in breve, è il numero cosmico. Con i suoi quattro punti cardinali, i quattro venti, i quattro elementi di cui è formato, le quattro fasi della luna, le quattro stagioni, il mondo si regge su un ordine quadrato che ne assicura la permanenza all’interno del flusso temporale. Anche la rivelazione poggia sul numero quattro. Tanti sono i fiumi del paradiso, le colonne del tabernacolo, le quattro facce dei viventi di Ezechiele, i grandi profeti. Nel Nuo vo Testamento, poi, quattro sono i Vangeli «da cui scorre tutto quello che sa ognuno che è nel mondo» ( Vangelo di Gozelino). Per questo quattro sono i grandi concili, i grandi dottori, le forme della carità, le virtù cardinali.
Non possiamo qui proseguire nella serie dei numeri ciascuno dei quali ha un suo spunto significativo, una sua applicazione. I Padri, tuttavia, riconoscono una gerarchia, dovuta per lo più alla frequenza del ricorso nella Scrittura. Per questo, qui di seguito accenno ancora ai significati di sette, otto, dodici, tre dei numeri che più spesso ricorrono nell’Antico come nel Nuovo Testamento. Numero misterioso per i pagani, il numero sette indica per la Scrittura la pienezza del tempo e lo spazio del riposo, l’integrità della dottrina e la purezza dello spirito. È poi il numero dello Spirito settiforme, il numero che scandisce la storia della salvezza. Il settimo è il giorno del riposo del Signore dopo la creazione, l’inizio del grande sabato eterno. Ad esso l’ottavo aggiunge solo un accento di trionfo, perché è il giorno della risurrezione del Signore. Vero sabato, è insieme il primo e l’ultimo giorno della settimana senza fine. Numero delle beatitudini, l’otto è anche il numero dell’armonia perfetta: è l’ottava corda della cetra, il cui suono riproduce quello della prima. In esso tutto è ricapitolato in Cristo «cetra gloriosa, cetra sonora e dolce nella quale è inserita tutta la musica del Padre» (Ruperto di Deutz). Il dodici, numero sovrabbondante, è in stretto rapporto con il sette. Per i pagani era il numero dello zodiaco, per i cristiani sta a significare la totalità della storia e l’universalità della salvezza. Un breve elenco delle ricorrenze del dodici: nell’anno vi sono dodici mesi e in ogni giorno dodici ore; dodici furono i patriarchi, dodici gli esploratori della terra promessa, dodici le pietre scelte per l’attraversamento dell’arca nel Giordano, dodici le pietre preziose sul pettorale del sommo sacerdote. Il Nuovo Tes tamento non è da meno: il dodici è il numero degli apostoli perché essi dovevano annunciare la fede nella Trinità ai quattro angoli della terra. Come ricorda poi la parte conclusiva dell’Apocalisse, il dodici è il numero della città santa, la nuova Gerusalemme scesa dal cielo. Essa ha dodici porte sulle quali stanno dodici angeli e ognuna è chiamata con il nome di una delle dodici tribù di Israele. «Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello» (Ap. 21,14).
Con l’aiuto del quarto volume di Esegesi Medievale di Henry de Lubac ho riportato un florilegio delle speculazioni patristiche sui numeri. Dante vi attinse a piene mani per la geografia della sua Commedia. Ha scritto John Barrow nell’articolo ricordato in apertura: «Spira una nuova vita nei tanti interrogativi che si pone la religione sulle questioni ultime, e tutto ciò ha un fascino infinito. Molte delle domande più profonde e più coinvolgenti sulla natura dell’universo, alle quali cerchiamo istintivamente di dare una risposta, nascono dalla nostra esigenza, schiettamente religiosa, di trovare un significato nelle cose». Alcune delle considerazioni patristiche sui numeri ci fanno sorridere. Nello stesso tempo evidenziano un sentimento profondo, una meraviglia sincera, un desiderio inesauribile di giungere alle fonti della conoscenza e della sapienza.
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri": il "Logos" non è un "Logo", e la "Charitas" non è la "caritas"!!!23 settembre 2007, di Federico La Sala
TRA FEDE E SCIENZA
Owen Gingerich, astronomo dell’Università di Harvard, spiega perché la visione di un mondo frutto del caso ha in sé qualcosa di assurdo. Sulla scia di Keplero, Galileo, Newton e altri teorici del cosmo
Impronte digitali di Dio nel cosmo
«Sarebbe bastata una minima discrepanza in uno solo di questi parametri e avremmo avuto un universo totalmente inadatto alla vita e all’uomo»
Di Luigi Dell’Aglio (Avvenire, 21.09.2007)
Quando sente parlare i suoi colleghi atei, prova delusione Owen Gingerich, famoso astronomo di Harvard. Fra loro, in particolare, gli risulta disarmante e deprimente Steven Weinberg, con lo slogan: «Più l’universo diventa comprensibile, più appare inutile». Gingerich obietta che questa mancanza di fede è del tutto immotivata. E cita la grande scienza da Giovanni Keplero (1571-1630) a oggi. Keplero, concludendo le sue Harmonices Mundi, scriveva: «Non c’è in me ambizione più grande né desiderio più ardente dello scoprire se posso trovare Dio anche dentro di me; questo Dio che, quando osservo l’universo, riesco quasi a toccare con mano». Profondo come «teologo per passione» non meno che come scienziato, Gingerich, che a Harvard ha insegnato a lungo astronomia e storia della scienza, scende di nuovo in campo con il saggio Cercando Dio nell’Universo (editore Lindau, 14 euro), in questi giorni in libreria. (Molto significativo è il titolo originale del libro: God’s Universe, l’Universo di Dio). E fa capire, da scienziato, le ragioni per cui ritiene che il cosmo sia frutto non di un caso (incomprensibilmente fortunato), ma di un disegno soprannaturale. Quanto ai colleghi atei, sottolinea, sono ovviamente liberi di pensarla come vogliono ma non dovrebbero servirsi della loro posizione «e presentarsi come portavoce della scienza, per propugnare la causa dell’ateismo». «Contro questo atteggiamento» aggiunge «è necessario e legittimo opporre resistenza».
Come si spiegano l’Universo e la vita? Prima di tutto c’è il fine tuning, il bilanciamento dei parametri della fisica. L’astronomo inglese Sir Martin Rees ha accertato che sei sono i numeri-chiave. «Sarebbe bastata una minima discrepanza in uno solo di questi parametri e avremmo avuto un universo totalmente inadatto alla vita» osserva Gingerich. Se l’energia del Big Bang fosse stata minore, il cosmo avrebbe presto avuto termine collassando su se stesso. Se fosse stata maggiore, la forza di gravità si sarebbe ridotta rapidamente. In entrambi i casi, l’universo non avrebbe prodotto gli elementi necessari alla vita. «Se un dipnoo preistorico, strisciando sulla riva, fosse andato a sinistra invece che a destra, l’evoluzione dei vertebrati avrebbe preso un’altra direzione». Quando dalla fisica si passa alla biologia, le «coincidenze» sono ancora più impressionanti, rileva. Il Dna può formarsi per caso? E una proteina, fatta di 2000 atomi? Gingerich dà la parola a Freeman Dyson: «Questo è un universo che doveva già sapere che saremmo arrivati». (Non manca un’apertura a ET. «Nel 1277, il vescovo di Parigi dichiarò "eretico" il limitare alla sola Terra la potenza creatrice di Dio»).
Il libro racconta come i grandi astronomi abbiano posto in cima ai loro pensieri due obiettivi - la conoscenza e Dio - spesso riunendoli in uno. Tipico il caso di Niccolò Copernico (1473-1543), il padre della teoria eliocentrica. Per inciso, Owen Gingerich spiega che il sistema copernicano, poi abbracciato da Galileo Galilei (1564-1642), sarebbe stato provato soltanto dalla legge di gravitazione universale di Isaac Newton (1642-1727) e dal pendolo che nel 1851 Leon Foucault fece oscillare nel Panthéon di Parigi. All’epoca del duro scontro tra geocentristi ed eliocentristi, i primi chiedevano ai secondi la «prova apodittica» del moto terrestre. E astronomi come il danese Tycho Brahe (1546-1601) si domandavano: «Ammettiamo che la Terra ruoti a questa vertiginosa velocità. Ma allora, come mai, quando lanciamo in alto un sasso, questo ricade nello stesso punto, e non più in là? E come fa la Terra - nel suo moto attorno al Sole - a trascinarsi appresso Luna?» Newton avrebbe chiarito tutto con la forza di gravità, ma quasi due secoli dopo. La prova convincente non l’aveva scovata neanche Copernico, che nel 1536 aveva ultimato la sua opera fondamentale, De revolutionibus orbium coelestium libri VI. La Terra che si muove attorno al Sole era ipotesi destinata a urtare contro la tradizione scientifica di matrice aristotelica e contro l’interpretazione letterale delle Scritture (anche se già Sant’Agostino aveva consigliato di tener conto del valore simbolico del testo biblico). Ma Copernico non aveva alcuna intenzione di contestare la metafisica e scontrarsi con le autorità religiose. Il grande scienziato polacco, fa notare Gingerich, era semplicemente convinto che il sistema eliocentrico, comportando una più armoniosa struttura del cosmo, una coerenza e un’eleganza maggiore, fosse più adatto a rispecchiare la grandezza di Dio. «Troviamo in questo ordinamento un’ammirevole simmetria del mondo, quale altrimenti non è possibile incontrare» scrisse.
Fra gli astronomi animati dalla fede, Gingerich mette se stesso. «Sono persuaso della presenza di un Creatore, dotato di un’intelligenza superiore. E non mi sento in contraddizione con la mia qualità di scienziato». Per l’astronomia ha un amore esuberante; da bambino aveva costruito, con il padre, un telescopio rudimentale. Gingerich crede nella «creatio continua». E trova conferma nei fossili di creature estinte milioni di anni fa. «Non suggeriscono l’idea di un universo progettato per essere ’istantaneamente perfetto». «Inoltre, se l’universo fosse predeterminato anche nei minimi particolari, l’uomo perderebbe la libertà e la possibilità di scelta. Dio può realizzarsi in molti modi, non solo per mezzo di un progetto di cui fin dall’inizio è previsto ogni dettaglio».
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri" ... Teologia della scienza platonica - il Deus "charitas" (Agape, Amore) spacciato come "Deus caritas est"!!!5 aprile 2008, di Maria Paola Falqui
INTERVISTA.
Siamo il culmine dell’evoluzione di un cosmo pensato da Dio su basi matematiche. Parla il premio Templeton Michal Heller
Una teologia dell’universo
 «Il nostro cervello è la realtà più complessa e pensa seguendo gli schemi utilizzati dal Creatore mentre dava forma al mondo.
«Il nostro cervello è la realtà più complessa e pensa seguendo gli schemi utilizzati dal Creatore mentre dava forma al mondo.
 Il rapporto fra scienza e religione sarà un punto nodale del dibattito nel prossimo futuro»
Il rapporto fra scienza e religione sarà un punto nodale del dibattito nel prossimo futuro»di LUIGI DELL’AGLIO (Avvenire, 05.04.2008)
Per creare l’Universo e il mondo, Dio ha pensato strutture matematiche. Questa idea-chiave parte dal filosofo e scienziato Gottfried Leibniz (1646-1716), ed è confermata due secoli dopo da Albert Einstein. Ma Michal Heller, il cosmologo e pensatore polacco cui è stato assegnato il mese scorso il Templeton Prize (il ’Nobel della teologia’), la rilancia, e formula una deduzione: «Il mondo è matematico perché Dio pensa in maniera analoga al nostro pensiero matematico». Heller, che è sacerdote, e professore all’Università di Cracovia, è stato sempre animato dal desiderio di costruire un ponte tra fede e scienza. Nel 1969 partecipava ai primissimi incontri tra teologi, filosofi e scienziati, promossi dall’allora arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, dai quali prendeva vita il leggendario Center for Interdisciplinary Studies. Per aggirare i divieti delle autorità comuniste, per lungo tempo gli intellettuali e religiosi polacchi di questo gruppo si riunivano al riparo di case private. Solo grazie all’amicizia del futuro pontefice e al suo autorevole intervento, Heller potè andare all’estero e discutere con altri scienziati e teologi nei convegni internazionali.
Professore, la conoscenza suggerisce che esiste una relazione tra la Mente creatrice di Dio e la mente investigatrice dell’uomo. Può parlarci di questa relazione?
«Per rispondere in breve, posso dire che il nostro cervello si è for- mato come prodotto di una lunga evoluzione dell’Universo o, per usare la metafora di Leibniz, come effetto dell’azione di Dio che pensava l’Universo. Nel cervello umano, l’evoluzione dell’Universo ha raggiunto il suo punto focale, cioè la capacità di riflettere su se stesso e di interpretare la Mente di Dio, presente nella struttura dell’Universo ».
Lei invita a riscoprire l’idea-chiave di Leibniz: per creare l’Universo, Dio ha pensato strutture matematiche. Ma le leggi matematiche come si integrano con quello che lei chiama il ’Grande Mistero’?
«Non è possibile risolvere il Grande Mistero. Einstein, una volta, l’ha detto chiaramente: non potremo mai svelare e comprendere questo Mistero. Ma io faccio un piccolo passo in più: il mondo ’è matematico’ perché Dio pensa in maniera analoga al nostro pensiero matematico». In un Universo creato, come si giustificano gli eventi casuali?
«Non è facile definire il caso. La definizione più ovvia è che l’evento casuale è un evento di bassa probabilità che si verifica nonostante abbia una bassa probabilità di verificarsi. Per stabilire se un fatto ha molte o poche probabilità di avvenire, si ricorre al calcolo delle probabilità. Ma comunque il calcolo delle probabilità è una splendida struttura matematica e, in quanto tale, è parte della Mente di Dio. Quelli che noi chiamiamo eventi casuali si collocano nel progetto dell’Universo ».
Lei sostiene che l’Universo ha un progetto, che l’Universo ’non può spiegarsi da solo’. Ma ha definito ’errore teologico’ la teoria dell’intelligent design.
«C’è un motivo preciso. Si è fatto un abuso dell’espressione ’disegno intelligente’. L’hanno adoperata quanti affermano che esiste opposizione tra Dio e il caso. Io preferisco l’espressione ’Mente di Dio’».
Come giudica la recente tendenza a negare all’uomo una posizione al vertice dell’evoluzione della vita?
«Se osserviamo le specie viventi in base alla semplicità di organizzazione, allora non c’è dubbio che un’ameba batte l’homo sapiens. Ma, se ci basiamo sul criterio della complessità, è il cervello umano la struttura più complessa dell’Universo. Ed è proprio nella complessità del cervello umano che l’evoluzione dell’Universo raggiunge il suo traguardo».
Per lanciare un ponte tra scienza e fede, lei propone una ’teologia della scienza’. Di che cosa si tratta?
«Da un lato abbiamo un metodo scientifico che descrive l’Universo com’è visto dalla scienza. Se si segue questo metodo, i limiti del metodo scientifico sono i limiti dell’Universo. Pertanto tutto ciò che trascende l’investigazione empirica trascende l’Universo della scienza. La teologia pensa invece che l’Universo è quello creato da Dio. Grazie all’Universo, i teologi comprendono tutto ciò che è stato creato da Dio. È dunque evidente che l’Universo delle scienze e l’Universo della teologia differiscono l’uno dall’altro. La differenza deriva dal fatto che i metodi di queste due discipline rispecchiano le loro diverse visioni della realtà. Il metodo della teologia riesce a ’vedere’ nell’’universo materiale’ alcuni aspetti che non appartengono all’Universo delle scienze. E l’’Universo materiale’, così come è contemplato dalla teologia, è più ricco dell’Universo visto da una prospettiva puramente scientifica».
E come s’imposta, in queste condizioni, una teologia della scienza?
«Proprio a questo punto emerge la possibilità di fare teologia della scienza. Come riflessione teologica sulle scienze, la teologia della scienza può investigare le conseguenze del fatto che le scienze empiriche investigano un Universo creato da Dio. La teologia della scienza dovrebbe essere una parte integrante e autentica della teologia, con tutte le peculiarità metodologiche di una disciplina teologica».
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri" ... La matematica ha anche un cuore. Michael Atiyah: «Deve essere il collante intellettuale che tiene unita l’umanità» (di Giulio Giorello).25 giugno 2008, di Federico La Sala
Il filosofo della scienza si confronta con lo studioso premio Abel
La matematica ha anche un cuore
Michael Atiyah: «Deve essere il collante intellettuale che tiene unita l’umanità»
di Giulio Giorello (Corriere della Sera, 25.o6.2008)
«Il matematico persegue la propria indagine per ragioni non troppo diverse da quelle per cui il pittore dipinge o il musicista compone. Lo spinge quella che grandi pensatori hanno definito la gloria dello spirito umano». Così Michael Atiyah, uno dei maggiori matematici viventi, insignito tra l’altro della Medaglia Fields (1966) e del Premio Abel (2004). Del resto, nel saggio di apertura del volume collettivo La matematica. I luoghi e i tempi (a cura di Claudio Bartocci e Piergiorgio Odifreddi, Einaudi, Torino 2007), aveva paragonato la condizione dei matematici a quella degli artisti che si formavano nelle grandi botteghe rinascimentali: «In matematica, come nell’arte, non c’è alternativa allo scambio intellettuale tramite cui si tramandano le tecniche, la conoscenza di base e lo spirito di ricerca ». Ma come gli artisti di Firenze avevano bisogno di Lorenzo il Magnifico, così anche i matematici «necessitano di un mecenate, che può essere tanto un privato quanto un’istituzione», nella convinzione che «la matematica abbia anche una valenza economica».
L’affinità con le arti non si ferma qui. Per Atiyah, «anche in matematica la bellezza è una guida importante per raggiungere la verità». Questa idea era cara già a un grandissimo matematico come Jacques Hadamard, il quale in una memorabile discussione con Paul Valéry negli anni ’30 dichiarava orgogliosamente come la scoperta in matematica dipendesse dal senso della bellezza il quale verrebbe poi tradotto nell’eleganza delle formule. Era stato semmai il poeta a rilevare come talvolta quel senso di bellezza avesse teso delle trappole anche agli intelletti migliori. Il punto è, osserva Atiyah, che «quello che si ottiene deve essere sempre controllato dalla dimostrazione. All’inizio il rigore può lasciare campo all’immaginazione. È l’immaginazione che crea, ma è la logica che conclude».
Questo appello alla logica non va, però, inteso nel senso dello slogan per cui la matematica non sarebbe altro che logica travestita. Precisa infatti Atiyah: «La matematica non coincide con la logica più di quanto la composizione musicale coincida con la teoria delle scale armoniche o la pittura con la chimica dei colori». Se fin dai tempi di Pitagora o di Platone la matematica veniva unita alla filosofia come chiave di comprensione del mondo naturale o anche come strumento di buona gestione degli affari della polis, oggi è forse ancor più necessario che essa giovi alle altre scienze, sia naturali sia sociali, fornendo il «collante intellettuale che ci tiene uniti come esseri umani». La logica, dunque, non è tutto. Sono la forza dell’immaginazione e la capacità di portare i concetti all’estremo che possono rivelarci i tratti più profondi della mente umana. Lo diceva, seppur in maniera polemica, quel «bizzarro filosofo» che era l’irlandese George Berkeley. Doveva ribadirlo, agli inizi del Novecento, il matematico, fisico e filosofo Jules-Henri Poincaré, per il quale la matematica aveva due sorelle, la fisica e la filosofia, quest’ultima intesa come indagine dei nostri processi mentali. Per Atiyah, «la matematica deve essere considerata in tutti i suoi aspetti e deve essere indagata in una prospettiva che tenga conto del suo sforzo di comprensione e dei meccanismi neurofisiologici che sono sottesi a esso».
Gli anni della riflessione di Poincaré erano anche quelli in cui un altro grandissimo matematico David Hilbert si chiedeva (al Congresso Internazionale del 1900) se la specializzazione raggiunta nelle singole branche non avrebbe infine impedito anche il più semplice scambio di idee tra i cultori dei diversi settori. Oggi, anche se talora si parla, per esempio in fisica, di grandi teorie di unificazione, il panorama della ricerca appare sempre più differenziato e complesso, e al pubblico più ampio sembra spesso una sorta di impraticabile labirinto. Per Atiyah, tuttavia, il rischio di una progressiva disintegrazione del sapere e delle competenze può essere contrastato proprio da una seria educazione alla matematica: «Mirando di continuo a grandi principi architettonici e a un’astrazione sempre crescente i matematici riescono a comprimere la conoscenza più importante conquistata dalle generazioni passate in pacchetti coerenti che possono essere tramandati a quelle future».
Restano certo grandi tendenze di fondo. Non c’è forse maniera migliore della raffigurazione geometrica per rappresentare ciò che il nostro cervello apprende in modo globale e pressoché istantaneo. Ma la geometria, aggiunge Atiyah, «è essenzialmente statica, è lo studio dello spazio. L’algebra, invece, è lo studio del tempo. Questa è una concezione forse più nuova. Emerge nell’Ottocento con i grandi lavori dell’irlandese William Rowan Hamilton; e oggi per algebra dovremmo intendere tutte le procedure algoritmiche, in particolare quelle che aiutano così potentemente il calcolo nei computer. Questi ultimi assistono la mente umana eseguendo lunghi calcoli in modo meccanico».
Non c’è, però, ragione di temere quell’assoggettamento degli umani alle macchine che il sarcastico Samuel Butler rinfacciava al vecchio Charles Darwin come nostro possibile futuro! Per Atiyah, «geometria e algebra restano due facce del pensiero umano». Ritroviamo così il grande tema dello spazio e del tempo che tanto ha appassionato filosofi come David Hume e Immanuel Kant. «Ma anche Einstein! - esclama Atiyah -. È da lui che abbiamo imparato che lo spazio e il tempo vanno unificati, anche se questa impresa così importante per la fisica contemporanea sembra sollevare difficoltà non indifferenti per il nostro cervello. Tuttavia - scherza Atiyah - il cinema qui sembra non avere poi troppi problemi».
-
> "MATEMATICA E MISTERO". GALILEO GALILEI E’ GALILEO GALILEI ... E LA TRASCENDENZA CRISTIANA NON E’ LA TRASCENDENZA "DELL’ENTE ...CATTOLICO-ROMANO", DEL VATICANO!!! Cerchiamo di "non dare i numeri" ... Intervista ad Antonio Ambrosetti (di Luigi Dell’Aglio).11 dicembre 2008, di Federico La Sala
NUMERI E FEDE/1
Perché alla matematica sfugge il divino
Questa intervista ad Antonio Ambrosetti apre un ciclo di colloqui dedicato ai rapporti tra la matematica (e i matematici) e la fede, che sfatano la fallace equazione che identifica scienze esatte con ateismo.
di Luigi Dell’Aglio (Avvenire, 11.12.2008)
«Sulla parete del mio studio campeggia il Crocifisso. La giornalista, che è di fronte a me, lo osserva. Poi, meravigliata, mi fa: "Professore, è credente?". "Sì", rispondo io, con naturalezza. E lei: "Ma come fa uno scienziato - anzi un matematico - a credere in Dio?". E sottolinea la parola "matematico", scandendo le sillabe. L’equazione razionalità-mancanza di fede è un luogo comune che oggi va molto di moda, e mi irrita. Perché è del tutto errata. Lo prova il gran numero di illustri pensatori, del passato e di oggi - in prima fila i matematici - la cui fede è nota a tutti. Negli ultimi anni in televisione è stato dato troppo spazio a personaggi come Odifreddi che hanno portato avanti la tesi dell’incompatibiltà tra fede e scienza con argomentazioni logico-filosofiche che, comunque, hanno poco a che fare con la matematica». Il professor Antonio Ambrosetti, per lunghi anni ordinario di Analisi matematica alla Normale di Pisa e ora alla Scuola internazionale superiore di Studi avanzati (Sissa) di Trieste, ha avuto due maestri sia nella scienza che nella fede: Giovanni Prodi, eminente matematico «e anche grande uomo», ed Ennio De Giorgi, uno dei massimi matematici del secolo scorso, entrambi animati da un profondo senso religioso.
Professore, c’è chi si propone addirittura di dimostrare matematicamente che Dio non esiste.
«Un’impresa del genere è tempo perso. Cito un libro che mi ha colpito: Irreligion, di John Allen Paulos, alla cui versione in italiano, per fare sensazione, è stato dato il titolo La prova matematica dell’inesistenza di Dio. Ma nel libro non c’è nessuna dimostrazione matematica. Nessuno dei geni della matematica, dai Greci fino a oggi, ha potuto dimostrare matematicamente l’inesistenza (o l’esistenza) di Dio. Nemmeno una scienza precisa come la matematica può dare una risposta al quesito cruciale che ha tormentato gli uomini di ogni tempo. Ho appena finito di scrivere un breve saggio dal titolo Matematica e Dio in cui mostro, tra l’altro, come sia un inutile tentativo quello di usare la matematica per dimostrare che Dio esiste o no».
Oggi si è diffusa nell’immaginario collettivo l’idea che i matematici siano in qualche modo onnipotenti...
«Niente di più falso. Ognuno di loro, anche il più grande intelletto, aveva dei limiti imposti, se non altro, dalle limitate conoscenze scientifiche dell’epoca. Per esempio, il famoso teorema di Fermat, enunciato agli inizi del Seicento, è stato dimostrato solo pochi anni fa, e via dicendo. Anche in matematica ha luogo uno sviluppo graduale delle conoscenze che porta la ricerca a fare passi avanti. Ma c’è sempre qualche risultato che ci sfugge e che verrà dimostrato probabilmente nel futuro».
Ma che cosa vuol dire "dimostrazione matematica"?
«In matematica si dimostrano teoremi, e per far questo occorre, innanzi tutto, fissare dei postulati. Poi bisogna fare delle ipotesi, e infine si cerca di dimostrare la tesi. Ecco un esempio conosciuto: il Teorema di Pitagora. I postulati sono quelli della geometria euclidea; l’ipotesi è che il triangolo sia rettangolo, la tesi è che la somma dei quadrati costruiti sui cateti equivale al quadrato costruito sull’ipotenusa. Ma il teorema può non valere, se sostituiamo gli assiomi della geometria euclidea con altri postulati o se ci riferiamo a un triangolo che non sia rettangolo. Ora, quando si parla dell’esistenza di Dio, quali ipotesi si possono fare? E quali sono i postulati? Tutto è inevitabilmente vago e aleatorio. Stesso discorso, se voglio addirittura provare l’inesistenza di Dio. Si aggiunga che una proposizione può benissimo essere vera, anche se, dati i nostri limiti, non siamo in grado di dimostrarla compiutamente. Lungi dal fornirci certezze, un teorema di matematica non può svelare il mistero di Dio, che sovrasta le nostre capacità. Del resto, si sa che bisogna stare attenti quando si cerca di applicare i risultati matematici alle varie situazioni concrete».
La matematica non è un abito pret-à-porter.
«I teoremi sono spesso dei risultati teorici. Anche quando vengono usati per problemi di fisica o nelle applicazioni, vanno tenuti nei loro limiti e non estrapolati per adoperarli in situazioni che ci fanno comodo. C’è un famoso teorema di Poincaré in cui, in parole povere, si dimostra che un pneumatico bucato si rigonfia da solo dopo un tempo sufficientemente lungo. Ma chi è quel ciclista che si ferma ad aspettare questo evento straordinario? Potrebbe dover attendere secoli. Non parliamo poi di ragionamenti di tipo probabilistico che spesso si fanno quando si discute sull’esistenza di Dio»
Sono i più azzardati.
«Prendiamo la Legge dei grandi numeri, o di Bernoulli, di cui chi gioca alla roulette ha sentito parlare. In base a questa legge, dopo un numero "sufficientemente grande" di lanci, ci sono ottime speranze di vincere. Ma quanti lanci bisogna fare (aumentando sempre la puntata)? Mille, un milione o più ancora? Potrebbe non bastare una vita intera. L’incertezza è ancora maggiore, se pretendiamo di usare la matematica per discutere su Dio. D’altra parte, se per assurdo fosse possibile dimostrare matematicamente che Dio esiste o no, dovremmo essere tutti credenti o tutti atei, con buona pace della nostra libertà. Invece Dio la rispetta, permettendoci persino di rifiutarlo. Ma chi Lo cerca con la mente e soprattutto col cuore, ne sente la presenza e pregusta la visione di Dio quando i tempi saranno maturi».
La matematica non può dimostrare nulla sul mistero di Dio. Ma può sostenere la fede?
«La matematica mi fa intuire la presenza di Dio. Parliamo dell’infinito, l’argomento risale a Pascal. In matematica, ogni numero reale è superato da "+infinito". In questo io scorgo Dio, che è sempre al di sopra di noi. Dio che conosce tutti i teoremi ma non ce li svela, aspettando che noi lentamente progrediamo nella ricerca. Dio non vuole dei robot, ma degli uomini che con umiltà, coscienti dei propri limiti, vanno avanti e Lo cercano sapendo che non potranno mai capirne completamente il mistero. Alla fine, solo la nostra coscienza può dire sì a Dio, con scelte fatte liberamente con la mente e soprattutto con il cuore. Diceva Ennio De Giorgi: "All’inizio e alla fine, abbiamo il mistero. La matematica ci avvicina al mistero, ma nel mistero non riesce a penetrare"».
di Luigi Dell’Aglio
-
-
-
-
-
-
-
-
-