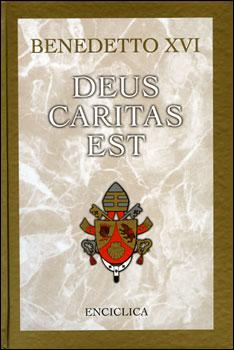
"Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Quello a "motu proprio"? "Sàpere aude!". Faccia come insegna CONFUCIO. Provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ (Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.
- [...] Nell’anniversario del “Giorno della memoria”, il 27 gennaio, non poteva essere ‘lanciato’ nel ‘mondo’ un “Logo” ... più ‘bello’ e più ‘accattivante’, molto ‘ac-captivante’!!! [...]
- FORZA “Deus caritas est”?!
 Altro che la Chiesa di Maria... - e Giuseppe!?
Altro che la Chiesa di Maria... - e Giuseppe!?
 Questa è la Chiesa ... del “latinorum”!!!
Questa è la Chiesa ... del “latinorum”!!!
- Caro BENEDETTO XVI ...
- Corra, corra ai ripari (... invece di pensare alle scomuniche)! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. L’Eu-angélo dell’AMORE (“charitas”) è diventato il Van-gélo della preziosi-tà (“caritas”), e la Parola (“Logos”) è diventato il marchio capitalistico di una fabbrica (“Logo”) infernale ... di affari e di morte?! Ci illumini: un pò di CHIAREZZA!!! FRANCESCO e CHIARA di Assisi si sbagliavano?! Claritas e Charitas, Charitas e Claritas... o no?! Federico La Sala (gennaio 2006)
- Deus charitas est: et qui manet in charitate, in Deo manet, et Deus in eo (1 Gv., 4.16).
- "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" (Giovanni Paolo II, 2003)
“DEUS CARITAS EST”: IL “LOGO” DEL GRANDE MERCANTE
di Federico La Sala *
In principio era il Logos, non il “Logo”!!! “Arbeit Macht Frei”: “il lavoro rende liberi”, così sul campo recintato degli esseri umani!!! “Deus caritas est”: Dio è ’amore’, così sul campo recintato della Parola (del Verbo, del Logos)!!! “La prima enciclica di Ratzinger è a pagamento”, L’Unità, 26.01.2006)!!!
Il grande discendente dei mercanti del Tempio si sarà ripetuto in cor suo e riscritto davanti ai suoi occhi il vecchio slogan: con questo ‘logo’ vincerai! Ha preso ‘carta e penna’ e, sul campo recintato della Parola, ha cancellato la vecchia ‘dicitura’ e ri-scritto la ‘nuova’: “Deus caritas est” [Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006]!
Nell’anniversario del “Giorno della memoria”, il 27 gennaio, non poteva essere ‘lanciato’ nel ‘mondo’ un “Logo” ... più ‘bello’ e più ‘accattivante’, molto ‘ac-captivante’!!!
Il Faraone, travestito da Mosè, da Elia, e da Gesù, ha dato inizio alla ‘campagna’ del Terzo Millennio - avanti Cristo!!! (Federico La Sala)
*www.ildialogo.org/filosofia, Giovedì, 26 gennaio 2006.
P.S. - Una nota
- La Terra sotto i piedi - letteralmente e sempre più - cede, e ‘noi’ continuiamo imperterriti a far finta di nulla: al polo artico come al polo antartico, i ghiacciai si sciolgono a ritmo vertiginoso e ‘noi’ continuiamo a ripetere vecchi ritornelli del ‘bel tempo che fu’: “lo spirito è, questa assoluta sostanza la quale, nella perfetta libertà e indipendenza della propria opposizione, ossia di autocoscienze diverse per sé essenti, costituisce l’unità loro: Io che è Noi, e Noi che è Io” (Hegel, Fenomenologia dello Spirito). Leopardi aveva perfettamente ragione a sottolineare e a contestare: E gli uomini vollero le tenebre, piuttosto che la luce..!!! Chiuse le porte e le finestre, non ‘vogliamo’ sapere nulla e ‘continuiamo’ a cantare in coro ... e a prepararci alla guerra: Dio è amore!!! Ma cosa c’è di diverso nella “caritas” di Ratzinger-Benedetto XVI dallo spirito di Hegel: “L’amore è divino perché viene da Dio e ci unisce a Dio e, mediante questo processo unificante, ci trasforma in un Noi che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola, fino a che, alla fine, Dio sia tutto in tutti”(pf. 18)?! La Chiesa di Ratzinger come lo Stato di Hegel: “La Chiesa è la famiglia di Dio nel mondo” (pf. 25)?! Ma, dopo Auschwitz, non è meglio porsi qualche domanda?! Non sentiamo ancora nelle nostre orecchie l’urlo del “Dio lo vuole!”, “Dio è con Noi!”??! Di quale Chiesa’, di quale famiglia, di quale Dio, e di quale mondo si tratta? Di quale famiglia ?! Ma dov’ è nostra ‘madre’ e dov’è nostro ‘padre’ e dove sono i nostri ‘fratelli’ e le nostre ‘sorelle’?! Maria e Giuseppe, talvolta, si chiedevano: dov’è Gesù?! Ma’noi’, ‘noi’ che pensiamo di essere tutti e tutte figli e figlie di Maria e fratelli e sorelle di Gesù, quando ce lo chiederemo: dov’è Giuseppe, lo sposo di nostra madre e nostro padre?! E, ancora, da padri e madri, quando ci sveglieremo e ci chiederemo dove sono i nostri figli e dove sono le nostre figlie?! ... Chi?, che cosa?! Stai zitto e prega!!! Deus caritas est : questo è il ‘logo’ del ‘nostro’ tempo!!! Dormi! Continua a dormire ... fuori del tutto non c’è nulla!!! (Federico La Sala, 06.03.2006)
- RETTIFICARE I NOMI: UNA LEZIONE DI CONFUCIO. Un giorno un giovane discepolo gli fece questa domanda: «Maestro, se vi fosse affidato un regno da governare secondo i vostri principi, che fareste per prima cosa?». Confucio rispose: «Per prima cosa rettificherei i nomi». A questa risposta il discepolo rimase molto perplesso: «Rettificare i nomi? Con tante cose gravi e urgenti che toccano a un governante voi vorreste sprecare il vostro tempo con una sciocchezza del genere? È uno scherzo?». Confucio dovette spiegare: «Se i nomi non sono corretti, cioè se non corrispondono alla realtà, il linguaggio è privo di oggetto. Se il linguaggio è privo di oggetto, agire diventa complicato, tutte le faccende umane vanno a rotoli e gestirle diventa impossibile e senza senso. Per questo il primo compito di un vero uomo di Stato è rettificare i nomi».
 DEUS CHARITAS EST
DEUS CHARITAS EST
 [I Ioannes 4]: Biblia Sacra: Epistola Joannis Prima - Vulgatae Editionis
Sixti V et Clementis VIII.
[I Ioannes 4]: Biblia Sacra: Epistola Joannis Prima - Vulgatae Editionis
Sixti V et Clementis VIII.
 4:1 Charissimi, nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus si ex Deo sint: quoniam multi pseudoprophetæ exierunt in mundum.
4:1 Charissimi, nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus si ex Deo sint: quoniam multi pseudoprophetæ exierunt in mundum.
 4:2 in hoc cognoscitur spiritus Dei: omnis spiritus qui confitetur Iesum Christum in carne venisse, ex Deo est:
4:2 in hoc cognoscitur spiritus Dei: omnis spiritus qui confitetur Iesum Christum in carne venisse, ex Deo est:
 4:3 et omnis spiritus, qui solvit Iesum, ex Deo non est, et hic est Antichristus, de quo audistis quoniam venit, et nunc iam in mundo est.
4:3 et omnis spiritus, qui solvit Iesum, ex Deo non est, et hic est Antichristus, de quo audistis quoniam venit, et nunc iam in mundo est.
 4:4 Vos ex Deo estis filioli, et vicistis eum, quoniam maior est qui in vobis est, quam qui in mundo.
4:4 Vos ex Deo estis filioli, et vicistis eum, quoniam maior est qui in vobis est, quam qui in mundo.
 4:5 Ipsi de mundo sunt: ideo de mundo loquuntur, et mundus eos audit.
4:5 Ipsi de mundo sunt: ideo de mundo loquuntur, et mundus eos audit.
 4:6 Nos ex Deo sumus. Qui novit Deum, audit nos: qui non est ex Deo, non audit nos: in hoc cognoscimus Spiritum veritatis, et spiritum erroris.
4:6 Nos ex Deo sumus. Qui novit Deum, audit nos: qui non est ex Deo, non audit nos: in hoc cognoscimus Spiritum veritatis, et spiritum erroris.
 4:7 Charissimi, diligamus nos invicem: quia charitas ex Deo est. Et omnis, qui diligit, ex Deo natus est, et cognoscit Deum.
4:7 Charissimi, diligamus nos invicem: quia charitas ex Deo est. Et omnis, qui diligit, ex Deo natus est, et cognoscit Deum.
 4:8 Qui non diligit, non novit Deum: quoniam Deus charitas est.
4:8 Qui non diligit, non novit Deum: quoniam Deus charitas est.
 4:9 In hoc apparuit charitas Dei in nobis, quoniam Filium suum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum.
4:9 In hoc apparuit charitas Dei in nobis, quoniam Filium suum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum.
 4:10 In hoc est charitas: non quasi nos dilexerimus Deum, sed quoniam ipse prior dilexit nos, et misit Filium suum propitiationem pro peccatis nostris.
4:10 In hoc est charitas: non quasi nos dilexerimus Deum, sed quoniam ipse prior dilexit nos, et misit Filium suum propitiationem pro peccatis nostris.
 4:11 Charissimi, si sic Deus dilexit nos: et nos debemus alterutrum diligere.
4:11 Charissimi, si sic Deus dilexit nos: et nos debemus alterutrum diligere.
 4:12 Deum nemo vidit umquam. Si diligamus invicem, Deus in nobis manet, et charitas eius in nobis perfecta est.
4:12 Deum nemo vidit umquam. Si diligamus invicem, Deus in nobis manet, et charitas eius in nobis perfecta est.
 4:13 In hoc cognoscimus quoniam in eo manemus, et ipse in nobis: quoniam de Spiritu suo dedit nobis.
4:14 Et vos vidimus, et testificamur quoniam Pater misit Filium suum Salvatorem mundi.
4:13 In hoc cognoscimus quoniam in eo manemus, et ipse in nobis: quoniam de Spiritu suo dedit nobis.
4:14 Et vos vidimus, et testificamur quoniam Pater misit Filium suum Salvatorem mundi.
 4:15 Quisquis confessus fuerit quoniam Iesus est Filius Dei, Deus in eo manet, et ipse in Deo.
4:15 Quisquis confessus fuerit quoniam Iesus est Filius Dei, Deus in eo manet, et ipse in Deo.
 4:16 Et nos cognovimus, et credidimus charitati, quam habet Deus in nobis. Deus charitas est: et qui manet in charitate, in Deo manet, et Deus in eo.
4:16 Et nos cognovimus, et credidimus charitati, quam habet Deus in nobis. Deus charitas est: et qui manet in charitate, in Deo manet, et Deus in eo.
 4:17 In hoc perfecta est charitas Dei nobiscum, ut fiduciam habeamus in die iudicii: quia sicut ille est, et nos sumus in hoc mundo.
4:17 In hoc perfecta est charitas Dei nobiscum, ut fiduciam habeamus in die iudicii: quia sicut ille est, et nos sumus in hoc mundo.
 4:18 Timor non est in charitate: sed perfecta charitas foras mittit timorem, quoniam timor pœnam habet. qui autem timet, non est perfectus in charitate.
4:18 Timor non est in charitate: sed perfecta charitas foras mittit timorem, quoniam timor pœnam habet. qui autem timet, non est perfectus in charitate.
 4:19 Nos ergo diligamus Deum, quoniam Deus prior dilexit nos.
4:19 Nos ergo diligamus Deum, quoniam Deus prior dilexit nos.
 4:20 Si quis dixerit quoniam diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est. Qui enim non diligit fratrem suum quem vidit, Deum, quem non vidit, quomodo potest diligere?
4:20 Si quis dixerit quoniam diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est. Qui enim non diligit fratrem suum quem vidit, Deum, quem non vidit, quomodo potest diligere?
 4:21 Et hoc mandatum habemus a Deo: ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum.
4:21 Et hoc mandatum habemus a Deo: ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum.
DIO E’ AMORE *
 1 Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo.
1 Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo.
 2 Da questo potete riconoscere lo spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio;
2 Da questo potete riconoscere lo spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio;
 3 ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito dell’anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel mondo.
3 ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito dell’anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel mondo.
 4 Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto questi falsi profeti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo.
4 Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto questi falsi profeti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo.
 5 Costoro sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il mondo li ascolta.
5 Costoro sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il mondo li ascolta.
 6 Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi; chi non è da Dio non ci ascolta. Da ciò noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell’errore.
6 Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi; chi non è da Dio non ci ascolta. Da ciò noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell’errore.
 7 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio.
7 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio.
 8 Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
8 Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
 9 In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui.
9 In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui.
 10 In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
10 In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
 11 Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
11 Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
 12 Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi.
12 Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi.
 13 Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito.
13 Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito.
 14 E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo.
14 E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo.
 15 Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio.
15 Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio.
 16 Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.
16 Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.
 17 Per questo l’amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio; perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo.
17 Per questo l’amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio; perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo.
 18 Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore.
18 Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore.
 19 Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo.
19 Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo.
 20 Se uno dicesse: "Io amo Dio", e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede.
20 Se uno dicesse: "Io amo Dio", e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede.
 21 Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.
21 Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.
* PRIMA LETTERA DI GIOVANNI. - SACRA BIBBIA (Liber Liber).
- OGGI, COME IERI (CONTRO I "DUE SOLI" DELLA "MONARCHIA" DI DANTE), IL GIOCO "ETERNO" DELLA DIALETTICA ("SOLE E LUNA"): "IUSTITIA DUCE, CARITATE COMITE"! GAUDIUM ET SPES ( Paolo VI, 7 dic. 1965)):
 "69. De bonorum terrestrium ad universos homines destinatione.
"69. De bonorum terrestrium ad universos homines destinatione.
 Deus terram cum omnibus quae in ea continentur in usum universorum hominum et populorum destinavit, ita ut bona creata aequa ratione ad omnes affluere debeant, iustitia duce, caritate comite [...]" ("69. I beni della terra e loro destinazione a tutti gli uomini. Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità [...]")
Deus terram cum omnibus quae in ea continentur in usum universorum hominum et populorum destinavit, ita ut bona creata aequa ratione ad omnes affluere debeant, iustitia duce, caritate comite [...]" ("69. I beni della terra e loro destinazione a tutti gli uomini. Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità [...]")
Per la novella di Pirandello, cfr.,
Sugli altri temi, cfr.:
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- L’IMPERATORE COSTANTINO, LA "PAROLA" DI "DIO", E LA FIGURA DI "MICHELE" - OGGI: [...] San Michele. Voi sapete che cosa vuol dire Michele? È un nome prettamente orientale, ebraico, che vuol dire: “Quis ut Deus?”, “Chi è come Dio?”. Questa parola è parola che ha vinto, parola vincente nel grande scontro tra il bene e il male. Questa parola - Michele, “Chi è come Dio?” - ha vinto [...] “Quis ut Deus?”. E questa parola vince, vince come una volta l’imperatore romano Costantino ha vinto nella Croce: “in hoc signo”, in questo segno vincerai. Vi auguro questa vittoria (GIOVANNI PAOLO II, "Visita Pastorale alla parrocchia di Santa Maria Assunta e San Michele a Castel Romano", 13 febbraio 1994).
- EPISTOLA ENCYCLICA - MIRAE CARITATIS SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS PAPAE XIII. DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA
- MIRAE CARITATIS. LETTERA ENCICLICA DI SUA SANTITÀ LEONE PP. XIII. LA SANTA EUCARESTIA
- "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" (Giovanni Paolo II, 2003)
- Il Papa:"Vorrei che la Chiesa mostrasse l’amore di Dio"
 Francesco riceve i partecipanti a un convegno organizzato da Cor Unum nel decimo anniversario dell’enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est.
Francesco riceve i partecipanti a un convegno organizzato da Cor Unum nel decimo anniversario dell’enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est.
|
GRECIA - Una sede della "Caritas greca". |
 MESSAGGIO EV-ANGELICO E SANTO PADRE?! ABUSO DEL TITOLO E MENZOGNA. L’ERRORE DI RATZINGER.
MESSAGGIO EV-ANGELICO E SANTO PADRE?! ABUSO DEL TITOLO E MENZOGNA. L’ERRORE DI RATZINGER.
 FARE COME GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II: RESTITUIRE L’ANELLO A GIUSEPPE!!!
FARE COME GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II: RESTITUIRE L’ANELLO A GIUSEPPE!!!
- Il Papa:"Vorrei che la Chiesa mostrasse l’amore di Dio"
 Francesco riceve i partecipanti a un convegno organizzato da Cor Unum nel decimo anniversario dell’enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est.
Francesco riceve i partecipanti a un convegno organizzato da Cor Unum nel decimo anniversario dell’enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est.
Federico La Sala
Forum
-
> FILOLOGIA ("LOGOS"), STORIA, E STORIOGRAFIA. "IL BUON DIO STA NEL DETTAGLIO" (ABY WARBURG): IL DIAVOLO FA LE PENTOLE, MA NON I COPERCHI.19 agosto 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA ("LOGOS")
E
"MAGNA CHARTA LIBERTATUM":
"IL BUON DIO STA NEL DETTAGLIO" (ABY WARBURG):
IL DIAVOLO FA LE PENTOLE, MA NON I COPERCHI.
"Dio" non imbroglia e non confonde "amore" ("CHARITAS") con "mammona" ("CARITAS").
-
> "Deus caritas est" (2006). --- In principio era il Logos (dell’Efeso di #Eraclito e dell’evangelista Giovanni, non il logo dello "apostolo" Paolo di Tarso) e uscire dall’inferno (#Dantedì, #25marzo 2024) è possibile!16 marzo 2024, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: L’ HAMLETICA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (SHAKESPEARE, 1600; KANT, 1800) E LA "INTRODUZIONE DEL 1857" (K. MARX).
- "VECCHIE" NOTE PER CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TEOLOGIA DI MAMMONA... *
Con Il lungo processo storico che in Europa e nel mondo, almeno dal XVIII secolo, ha innescato la contrapposizione delle diverse forme del contesto sociale all’individuo come un puro strumento per i suoi scopi privati, non solo «Dio è morto» (#Nietzsche) ma anche l’#Uomo (#MichelFoucault) della #tradizione edipico-androcentrica (platonica, paolina, hegeliana, ed heideggeriana):
- "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il #capo è Cristo, e capo della #donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «#uomo»], e capo di Cristo è Dio" (Paolo di Tarso, 1 Cor. 11, 1-3).
EARTHRISE (1968). In principio era il Logos (dell’Efeso di #Eraclito e dell’evangelista Giovanni, non il logo dello "apostolo" Paolo di Tarso) e uscire dall’inferno (#Dantedì, #25marzo 2024) è possibile!
*
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! --- Cacciari: «Ratzinger intellettuale europeo in confronto con la modernità». Intervista di Simone Paliaga.7 gennaio 2023, di Federico La Sala
Il filosofo.
Cacciari: «Ratzinger intellettuale europeo in confronto con la modernità»
di Simone Paliaga (Avvenire, venerdì 6 gennaio 2023)
- Secondo il filosofo, Benedetto XVI ritiene necessario «rapportarsi con il logos, immanente all’atto di fede e che con esso deve tendere alla verità»
«Ratzinger è un intellettuale europeo al mille per cento»: così Massimo Cacciari, uno tra i filosofi più noti in Italia e in Europa, che non ha mai esitato a confrontarsi con i grandi temi della filosofia e della teologia, parla di Benedetto XVI.
In quale relazione si trova il pensiero di Benedetto XVI con il pensiero moderno?
La sua posizione sull’eterno problema del rapporto tra fede e ragione è evidente fin dai primi studi sulla filosofia medievale e su san Bonaventura. L’attenzione a questo rapporto lo caratterizza in modo fondamentale rispetto alle correnti del pensiero e della teologia contemporanei, che da una parte negano la possibilità di porlo positivamente e dall’altra lo risolvono in modo compromissorio. Mentre per Ratzinger è proprio della fede rapportarsi con il logos, immanente all’atto di fede e che deve tendere alla verità esattamente come l’atto di fede. Quando Gesù dice “io sono la verità”, la questione non si risolve ripetendo quanto lui dice ma indagando che cosa lui tende a dire.
Quindi la verità è centrale in Benedetto XVI?
Aletheia è la parola chiave, che distingue Ratzinger da Bultmann e da tanta teologia. Per Ratzinger è legittimo e giusto il legame che si opera fin dai primi secoli del cristianesimo tra la filosofia greca e il Vangelo. È un legame che non si è sovrappone al Vangelo ma che in qualche modo nasce dal Vangelo stesso, che si impone a partire da quel messaggio. Questo è il discorso intorno a cui dibatte la teologia e dell’Otto e Novecento a partire dall’idealismo tedesco, cioè tutta quella tradizione a cui Ratzinger appartiene anima e corpo».
Quale ruolo recita allora la ragione?
La filosofia svolge la sua missione nella misura in cui interroga la fede ed esige che renda ragione di sé. È una funzione critica positiva: ma deve essere una filosofia interessata al programma della verità. La filosofia contemporanea per Ratzinger tende invece a una deriva relativistica e svolge una funzione di critica della teologia e della fede in senso negativo, ritenendo a priori che l’atto di fede non abbia più alcuna significato nel mondo della scienza e della tecnica.
In questa concezione che funzione gioca la Chiesa?
Per lui “nulla salus extra ecclesiam”. La Chiesa non è una forma politica, perché ha una missione fondamentale, e la cristianità non sarebbe concepibile senza di lei. Quella esaltata da Schmitt e da tanti altri pensatori conservatori è una visione della Chiesa ridotta alla funzione di religio civilis che serve solo a tenere in forma questo mondo senza religio. La Chiesa per Ratzinger, invece, non è un katechon, non è ciò che trattiene il male e che tiene in forma questo mondo. Essa ha una missione evangelizzatrice in senso proprio, cioè deve mostrare il Cristo e interrogarsi sulla verità che Cristo manifesta.
E la speranza?
Quando Ratzinger parla di speranza parla di una virtù teologale. Per caprine la riflessione, oltre alla fede, occorre capire che, come Wojtyla, ha elaborato la propria teologia in un’epoca storica in cui il marxismo era forza vivente, come movimento culturale oltre che storico. L’uno scrive le sue opere fondamentali con la Germania divisa in due, l’altro con la Polonia occupata. La speranza di Ratzinger si fonda sulla fede, perché altrimenti sarebbe vuota; non ha nulla a che fare con la speranza di chi non crede. Perché a un certo momento Benedetto XVI scrive i libri su Gesù? Perché comunica che per sperare bisogna guardare a Lui, solo allora la speranza ha senso. Ci sono discrimini profondi con le marmellate sentimental-patetiche dove i termini valgono in maniera indistinta. In Ratzinger la Chiesa deve chiamare a una conversione, questa è la sua Chiesa necessaria. Che non è, appunto, katechon. Che chiede costantemente la conversione a questa speranza. Che non è fondata finché non si pone sulla via della verità. Il grande teologo - e l’uomo che ha alle spalle quella storia di cui parlavo - chiede distinzione e discriminazione, chiede di comprendere bene i termini che si usano.
E per la carità?
Valgono le stesse considerazioni. La misericordia non è semplicemente fare la carità, la misericordia è partecipazione esistenziale, carnale con il prossimo: nel senso che il prossimo sei tu quando ti approssimi. Questa è la dinamica della caritas: non si tratta di schiacciare il bottoncino e dare l’euro quando te lo chiede il presentatore. Non è questa la misericordia di cui la Chiesa deve farsi testimone. Bisogna distinguere per non confondere, non per condannare, perché la Chiesa non può condannare nessuno, non spetta a lei esprimere il giudizio. È un grande tema francescano che all’inizio mi sembrava fosse la novità centrale anche di papa Francesco, quando invitava ad andare ovunque a predicare il verbo ma senza giudicare, perché il giudizio spetta ad Altri.
Occorre dunque evangelizzare?
L’evangelizzazione dell’Europa è un compito impossibile. Ecco perché Ratzinger, come Wojtyla, è una figura tragica. In entrambi vibrava l’attesa che, caduto il comunismo, iniziasse una nuova evangelizzazione per l’Europa. Ma è un’aspettativa delusa perché le potenze della secolarizzazione la rendono impossibile. Per questo tutti i termini che abbiamo usato finora possono essere soltanto declinati in termini etico-morali: in una chiave diversa non verrebbero ascoltati.
Quale eredità lascia?
Con Wojtyla lasciano la testimonianza della loro esperienza e della loro intelligenza a tenersi aperti al confronto con le correnti filosofiche contemporanee e le altre fedi, e qui si apre tutto il discorso dell’ecumenismo, ma tenendo la posizione senza generare confusione. Sono stati cattolici senza cedimento, e questa è la loro forza.
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! --- Il nuovo Messale Romano, il libro liturgico curato dalla Cei, diventa obbligatorio (di G. Gambassi).3 aprile 2021, di Federico La Sala
Liturgia.
La Pasqua porta il nuovo Messale nelle parrocchie italiane
Dal giorno della Risurrezione diventa obbligatorio il libro liturgico curato dalla Cei. Il vescovo Maniago: segno di speranza e di ripartenza. Le revisioni? Già accolte senza difficoltà
di Giacomo Gambassi (Avvenire, venerdì 2 aprile 2021)
- [Foto] Il nuovo Messale Romano sull’altare di una parrocchia italiana
Tutti lo chiamano il nuovo Messale Romano. Ufficialmente è la traduzione in italiano della terza edizione tipica latina del libro per celebrare l’Eucaristia che la Santa Sede ha varato nel 2002. Da domenica 4 aprile il testo si aprirà sugli altari di tutte le parrocchie della Penisola. Perché, come ha stabilito la Cei che ha guidato un percorso durato quasi diciotto anni, il volume diventerà obbligatorio nell’intero Paese dal giorno di Pasqua. E non solo scandirà le celebrazioni in Italia, ma anche quelle presiedute in italiano da Francesco in Vaticano. Messale per la Penisola ma anche “del Papa”. E poi esempio per le traduzioni nelle diverse lingue nazionali dell’edizione tipica latina.
Certo, il rinnovato libro liturgico è già utilizzato da alcuni mesi in numerose diocesi o parrocchie. Molte regioni ecclesiastiche avevano indicato nell’Avvento il periodo per il “debutto” locale. E anche il Pontefice celebra con il nuovo Messale. Resta il fatto che con la solennità della Risurrezione finisce definitivamente in archivio la precedente edizione datata 1983 che, quindi, per quasi quarant’anni ha segnato la vita liturgica nel Paese.
 «La scelta della Pasqua ha un preciso significato», spiega il vescovo di Castellaneta, Claudio Maniago, che da presidente della Commissione episcopale Cei per la liturgia ha curato l’ultima e più complessa fase della realizzazione del Messale. «Nella vita della Chiesa - prosegue - il giorno della Risurrezione rimanda all’inizio di un tempo rinnovato. Ecco, con il volume pubblicato lo scorso settembre la Chiesa italiana è chiamata a scrivere un nuovo capitolo del suo cammino».
L’esordio solenne avviene in un frangente ancora marcato dalla pandemia, con le limitazioni e i “ritocchi” ai riti imposti dalle misure anti-Covid. Non è sicuramente la Pasqua di un anno fa, senza le Messe a porte aperte. Però le liturgie risentono dell’effetto coronavirus.
«La scelta della Pasqua ha un preciso significato», spiega il vescovo di Castellaneta, Claudio Maniago, che da presidente della Commissione episcopale Cei per la liturgia ha curato l’ultima e più complessa fase della realizzazione del Messale. «Nella vita della Chiesa - prosegue - il giorno della Risurrezione rimanda all’inizio di un tempo rinnovato. Ecco, con il volume pubblicato lo scorso settembre la Chiesa italiana è chiamata a scrivere un nuovo capitolo del suo cammino».
L’esordio solenne avviene in un frangente ancora marcato dalla pandemia, con le limitazioni e i “ritocchi” ai riti imposti dalle misure anti-Covid. Non è sicuramente la Pasqua di un anno fa, senza le Messe a porte aperte. Però le liturgie risentono dell’effetto coronavirus.
 «Potrebbe apparire penalizzante l’uscita di un nuovo libro liturgico in un tempo come l’attuale - afferma Maniago -. Tuttavia la pubblicazione del Messale è stata giustamente interpretata come un segno di speranza che può aiutare le comunità a concentrarsi su quanto è davvero essenziale. E l’Eucaristia è fonte e culmine della vita cristiana, è celebrare in ogni istante della storia la Pasqua del Signore. Direi che il nuovo volume è uno sprone per tornare a gustare con maggiore intensità e partecipazione ciò che nei mesi scorsi ci era stato tolto nella sua pienezza o ciò che ancora oggi è condizionato da vincoli che per motivi sanitari siamo doverosamente tenuti a rispettare».
«Potrebbe apparire penalizzante l’uscita di un nuovo libro liturgico in un tempo come l’attuale - afferma Maniago -. Tuttavia la pubblicazione del Messale è stata giustamente interpretata come un segno di speranza che può aiutare le comunità a concentrarsi su quanto è davvero essenziale. E l’Eucaristia è fonte e culmine della vita cristiana, è celebrare in ogni istante della storia la Pasqua del Signore. Direi che il nuovo volume è uno sprone per tornare a gustare con maggiore intensità e partecipazione ciò che nei mesi scorsi ci era stato tolto nella sua pienezza o ciò che ancora oggi è condizionato da vincoli che per motivi sanitari siamo doverosamente tenuti a rispettare».- [Foto] La liturgia di Pasqua nel nuovo Messale Romano curato dalla Cei
Un test sul nuovo Messale - con le illustrazioni dell’artista Mimmo Paladino - c’è già stato nelle comunità che lo stanno impiegando dall’autunno. «Si è trattato di un tempo congruo per far sì che dopo la pubblicazione del volume si potesse avere una fase di sperimentazione e di prova necessarie», sottolinea il vescovo. E il primo bilancio che la Cei ha stilato è più che positivo.
 «L’accoglienza è stata buona - racconta Maniago -. Da una parte, è stata accompagnata da una sana dose di curiosità, consapevoli comunque che le novità non stavano in una diversa struttura della celebrazione ma piuttosto in miglioramenti e revisioni dei testi con anche significative variazioni che intendono rendere più vicino alla sensibilità contemporanea quanto viene pronunciato. D’altro canto, le novità sono state recepite senza particolari fatiche: penso a quelle che toccano l’assemblea, come le modifiche del “Padre Nostro” o del “Gloria”. Inoltre i sacerdoti, che sono i primi utilizzatori del Messale, hanno potuto confrontarsi con formule ed espressioni nuove, come quelle nelle Preghiere eucaristiche: il linguaggio adoperato ha richiesto un adattamento di fronte a passaggi divenuti così familiari che potevano quasi essere recitati a memoria. L’unica difficoltà riscontrata è stata quella relativa alla veste editoriale: il carattere del libro ha creato in qualche prete più avanti con l’età un disagio alla prima lettura ma poi non è stato problematico abituarsi al diverso formato».
«L’accoglienza è stata buona - racconta Maniago -. Da una parte, è stata accompagnata da una sana dose di curiosità, consapevoli comunque che le novità non stavano in una diversa struttura della celebrazione ma piuttosto in miglioramenti e revisioni dei testi con anche significative variazioni che intendono rendere più vicino alla sensibilità contemporanea quanto viene pronunciato. D’altro canto, le novità sono state recepite senza particolari fatiche: penso a quelle che toccano l’assemblea, come le modifiche del “Padre Nostro” o del “Gloria”. Inoltre i sacerdoti, che sono i primi utilizzatori del Messale, hanno potuto confrontarsi con formule ed espressioni nuove, come quelle nelle Preghiere eucaristiche: il linguaggio adoperato ha richiesto un adattamento di fronte a passaggi divenuti così familiari che potevano quasi essere recitati a memoria. L’unica difficoltà riscontrata è stata quella relativa alla veste editoriale: il carattere del libro ha creato in qualche prete più avanti con l’età un disagio alla prima lettura ma poi non è stato problematico abituarsi al diverso formato». -
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! --- Charidád ("Diccionario de Autoridades", 1729).8 marzo 2020, di Federico La SalaCHARIDAD. s. f. Virtud Theologál, y la tercera en el orden. Hábito infuso, qualidad inherente en el alma, que constituye al hombre justo, le hace hijo de Dios, y heredero de su Gloria. Viene del Griego Charitas. Pronúnciase la ch como K: y aunque se halla freqüentemente escrito sin h, diciendo Caridád, debe escribirse con ella. Lat. Charitas. PARTID. 1. tit. 5. l. 42. La primera Charidád, que quiere tanto decir como amor de Dios mäs que de otra cosa, è de sí, è de su Christiano. NIEREMB. Aprec. lib. 1. cap. 1. El Angélico Doctor con mäs acierto dice, que aunque no es el mismo Dios, ni es infinita la Charidád, hace efecto infinito, juntando al alma con Dios. CORNEJ. Chron. lib. 1. cap. 38. Uno de los principales exercicios era por este tiempo la assisténcia à los Hospitáles, donde desahogassen los fervores de su inflamada Charidád ("Diccionario de Autoridades" - Tomo II, 1729).
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! --- All’INSR (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento), presentazione volume "Laurentii Valle Sermo de mysterio Eucharistie".21 febbraio 2020, di Federico La Sala
Presentazione volume - Laurentii Valle Sermo de mysterio Eucharistie, a cura di Clementina Marsico, con un saggio di Marco Bracali. Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, II, Opere religiose, 3, Firenze, Polistampa 2019
Lunedì 24 febbraio, alle ore 11.00, verrà presentato il volume Laurentii Valle Sermo de mysterio Eucharistie, a cura di Clementina Marsico, con un saggio di Marco Bracali. Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, II, Opere religiose, 3, Firenze, Polistampa 2019.
Interverranno:
Alberto Melloni, Segretario della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII
Antonio Manfredi, Scrittore latino della Biblioteca Apostolica Vaticana
Daniele Conti, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento
Sarà presente la curatrice del volume.
L’incontro - aperto a tutti gli interessati - si terrà nella Sala dei Seminari dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento.
-
> "Deus caritas est" (2006). --- Oikonomia: "Il capitalismo non è, in primo luogo, un sistema economico di distribuzione di possesso, ma un sistema complessivo di cultura e di vita" (Max Scheler).19 gennaio 2020, di Federico La Sala
Oikonomia /2.
È quel poco che vale davvero
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 18 gennaio 2020)
- Il capitalismo non è, in primo luogo, un sistema economico di distribuzione di possesso, ma un sistema complessivo di cultura e di vita
- Max Scheler, L’avvenire del capitalismo
Il pensiero economico di Karl Marx è ancora un passaggio obbligato per chi voglia indagare la natura sacrale del nostro capitalismo. Le sue domande - meno le sue risposte - sono ancora capaci di aprirci squarci profondi sull’economia del nostro tempo, farci intravedere orizzonti alti ancora troppo poco esplorati, soprattutto da quando, una trentina di anni fa, con il crollo del comunismo reale si pensò di far crollare anche Marx, come se un autore non sia eccedente rispetto alla traduzione storica del suo stesso pensiero. Sia Walter Benjamin sia Marx nella loro analisi della religione capitalistica attribuiscono un ruolo centrale ai prodotti: alle merci. Marx nel "Capitale" pone all’inizio del suo ragionamento il tema del carattere feticistico delle merci, uno dei pilastri metodologici della sua critica. Carattere feticistico, cioè la merce come feticcio.
Il feticcio è un elemento del mondo sacro, tipico degli stadi originari e primitivi della religiosità umana. È un oggetto inanimato, cui le comunità e le singole persone attribuiscono proprietà magiche o soprannaturali. La parola portoghese (feitiço) venne usata dai navigatori moderni per indicare amuleti e totem che trovavano nei popoli africani, e più tardi fu parzialmente estesa anche a oggetti religiosi di tipo sacrale, a immagini di forze soprannaturali.
 Quando Marx ricorre a questa espressione per caratterizzare le merci nel capitalismo, il suo riferimento alla religione era molto esplicito e intenzionale. Scriveva infatti: «Per trovare un’analogia, dobbiamo involarci nella regione nebulosa del mondo religioso. Quivi, i prodotti del cervello umano paiono figure indipendenti, dotate di vita propria, che stanno in rapporto fra di loro e in rapporto con gli uomini. Così, nel mondo delle merci, fanno i prodotti della mano umana. Questo io chiamo il feticismo che s’appiccica ai prodotti del lavoro appena vengono prodotti come merci, e che quindi è inseparabile dalla produzione delle merci». (Il capitale, Libro 1). Come dirà in una nota, citando l’economista italiano Ferdinando Galiani, «il valore è un rapporto tra persone, celato nel guscio di un rapporto tra merci».
Quando Marx ricorre a questa espressione per caratterizzare le merci nel capitalismo, il suo riferimento alla religione era molto esplicito e intenzionale. Scriveva infatti: «Per trovare un’analogia, dobbiamo involarci nella regione nebulosa del mondo religioso. Quivi, i prodotti del cervello umano paiono figure indipendenti, dotate di vita propria, che stanno in rapporto fra di loro e in rapporto con gli uomini. Così, nel mondo delle merci, fanno i prodotti della mano umana. Questo io chiamo il feticismo che s’appiccica ai prodotti del lavoro appena vengono prodotti come merci, e che quindi è inseparabile dalla produzione delle merci». (Il capitale, Libro 1). Come dirà in una nota, citando l’economista italiano Ferdinando Galiani, «il valore è un rapporto tra persone, celato nel guscio di un rapporto tra merci».Per Marx le merci sono feticci perché sono realtà inanimate che rimandano a qualcosa di vivo: ai rapporti tra persone. Nei sistemi di produzione passata, era immediato legare la merce al suo produttore, ma nel sistema capitalistico noi attribuiamo alle merci una esistenza autonoma, quasi magica o arcana.
 Ecco allora la definizione di merce che ci dà Marx: «A prima vista, una merce sembra una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi, risulta che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici. ... Appena si presenta come merce, il tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta coi piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare».
Ecco allora la definizione di merce che ci dà Marx: «A prima vista, una merce sembra una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi, risulta che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici. ... Appena si presenta come merce, il tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta coi piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare».
 Le merci acquistano dunque una esistenza propria rispetto agli uomini e alle donne che le hanno prodotte (e alle macchine e ai robot): qui sta quello che Marx chiama l’arcano. Inoltre, per Marx, è evidente che questo potere religioso si attiva solo nel capitalismo: «Appena ci rifugiamo in altre forme di produzione, scompare subito tutto il misticismo del mondo delle merci, tutto l’incantesimo e la stregoneria che circondano di nebbia i prodotti del lavoro sulla base della produzione di merci».
Le merci acquistano dunque una esistenza propria rispetto agli uomini e alle donne che le hanno prodotte (e alle macchine e ai robot): qui sta quello che Marx chiama l’arcano. Inoltre, per Marx, è evidente che questo potere religioso si attiva solo nel capitalismo: «Appena ci rifugiamo in altre forme di produzione, scompare subito tutto il misticismo del mondo delle merci, tutto l’incantesimo e la stregoneria che circondano di nebbia i prodotti del lavoro sulla base della produzione di merci».Misticismo, incantesimo, stregoneria.
In realtà, se prendiamo sul serio l’immagine forte della merce come feticcio, ci accorgiamo subito che il nome più adatto per il capitalismo sarebbe idolatria, essendo i feticci gli abitanti del tipico ambiente sacro dei culti idolatrici, non delle religioni, tanto meno quella ebraico-cristiana.
 Ma che cos’è l’idolatria? E perché la Bibbia l’ha tanto combattuta, e i profeti in particolare ne hanno fatto il loro principale nemico (insieme ai falsi profeti)? Perché dietro la loro battaglia teologica ce n’è una antropologica che vi si aggiunge: tutte le volte che un uomo inizia ad adorare un oggetto, diventa meno uomo; perché quando qualcuno rappresenta Dio in oggetti o immagini, non riuscirà mai a eguagliare la sola immagine vera e lecita di Dio sulla terra: l’uomo e la donna, creati "a sua immagine". Tutte le altre immagini della divinità sono scarabocchi teologici e antropologici. Dietro la lotta anti-idolatrica c’è dunque un grande umanesimo.
Ma che cos’è l’idolatria? E perché la Bibbia l’ha tanto combattuta, e i profeti in particolare ne hanno fatto il loro principale nemico (insieme ai falsi profeti)? Perché dietro la loro battaglia teologica ce n’è una antropologica che vi si aggiunge: tutte le volte che un uomo inizia ad adorare un oggetto, diventa meno uomo; perché quando qualcuno rappresenta Dio in oggetti o immagini, non riuscirà mai a eguagliare la sola immagine vera e lecita di Dio sulla terra: l’uomo e la donna, creati "a sua immagine". Tutte le altre immagini della divinità sono scarabocchi teologici e antropologici. Dietro la lotta anti-idolatrica c’è dunque un grande umanesimo.Questa stessa battaglia ha portato la Bibbia a criticare radicalmente anche tutte le presenze "naturali" di Dio nel mondo, arrivando a cancellare dai suoi racconti anche le tracce di riti religiosi agricoli, come i canti di lutto per l’ultimo covone o per l’ultimo grappolo d’uva, dove i contadini, piangendo, chiedevano loro perdono di doverli "uccidere", e li pregavano di "risorgere" ancora nella nuova stagione. In alcune culture si inumava l’ultimo covone, si recitava il credo e si attendeva che "risorgesse".
 Non dobbiamo dimenticare che le prime intuizioni di una vita che potesse continuare oltre la morte naturale, gli esseri umani l’hanno imparata dal ciclo di morte-resurrezione dei campi. E non a caso molti padri della Chiesa e molti vescovi hanno continuato a recitare queste preghiere naturali e agricole, intrecciandole con quelle cristiane. Come in un Paternoster medio alto-tedesco del XIII secolo, citato da Ernesto de Martino, dove si legge che Cristo fu «seminato dal Creatore, germogliò, venne a maturazione, fu mietuto, legato in un covone, trasportato nell’aia, trebbiato, vagliato, macinato, chiuso nel forno, e infine dopo tre giorni tratto fuori e mangiato come pane». Non sarà perfetta teologia, ma è Padrenostro splendido e vero come la nostra gente povera delle campagne.
Non dobbiamo dimenticare che le prime intuizioni di una vita che potesse continuare oltre la morte naturale, gli esseri umani l’hanno imparata dal ciclo di morte-resurrezione dei campi. E non a caso molti padri della Chiesa e molti vescovi hanno continuato a recitare queste preghiere naturali e agricole, intrecciandole con quelle cristiane. Come in un Paternoster medio alto-tedesco del XIII secolo, citato da Ernesto de Martino, dove si legge che Cristo fu «seminato dal Creatore, germogliò, venne a maturazione, fu mietuto, legato in un covone, trasportato nell’aia, trebbiato, vagliato, macinato, chiuso nel forno, e infine dopo tre giorni tratto fuori e mangiato come pane». Non sarà perfetta teologia, ma è Padrenostro splendido e vero come la nostra gente povera delle campagne.Ricordo ancora, bambino, i miei bisnonni recitare improbabili preghiere meticce di latino-dialetto-italiano, durante i tempi del raccolto o nei lutti. Non conoscevano i dogmi trinitari, avevano idee molto vaghe sulla differenza ontologica tra Gesù e la Madonna. Quando prendevano la comunione non sapevano nulla della "sostanza" e degli "accidenti". Ma sapevano che quel pane era pane, e quindi era già sacro perché da esso dipendeva la vita e la morte; e capivano che quel pane della Messa era un pane diverso, e per questo accostarsi alla comunione aveva per loro una solennità e una densità teologica che io prego sempre di ritrovare, un giorno, fosse anche l’ultimo.
 Certo, troveremo sempre teologi e scribi capaci di fini ragionamenti con in mano pezze d’appoggio in documenti del magistero per condannare i canti del lutto del covone e le preghiere dei miei nonni, per separarsi da quel mondo di ignoranza e di feticci. Ma se c’è un paradiso - e deve esserci, e i poveri lo devono abitare - insieme ai salmi degli angeli vi ritroveremo anche i canti della vendemmia e del raccolto, perché impastati di carne e di sangue, e quindi più veri di molti canti polifonici cantati senza poveri e senza dolore.
Certo, troveremo sempre teologi e scribi capaci di fini ragionamenti con in mano pezze d’appoggio in documenti del magistero per condannare i canti del lutto del covone e le preghiere dei miei nonni, per separarsi da quel mondo di ignoranza e di feticci. Ma se c’è un paradiso - e deve esserci, e i poveri lo devono abitare - insieme ai salmi degli angeli vi ritroveremo anche i canti della vendemmia e del raccolto, perché impastati di carne e di sangue, e quindi più veri di molti canti polifonici cantati senza poveri e senza dolore.Ed ecco perché la stessa Bibbia, mentre ha combattuto duramente i riti e i simboli della fertilità insieme a quelli astrali, nelle sue pagine poetiche e sapienziali ci dona meravigliose parole sulla luna, le stelle, sui cieli "che narrano la gloria di Dio", sulla bellezza degli animali (Giobbe), sull’eros e sulla vita (Cantico). L’uomo biblico vede Dio (senza vederlo), lo sente nel tempio, lo ascolta nei profeti, lo vede e lo sente nell’uomo e nella donna, ma lo vede e lo sente anche nella "nube", nella "colonna di fuoco", nel fuoco di Elia, "nella leggera brezza del silenzio". Per affermare la sua vera diversità in un mondo dominato da una religione naturale, la Bibbia ha dovuto assolutizzare la sua critica alla dimensione religiosa delle cose, alla natura, agli alberi, alla creazione. Ma non l’ha mai cancellata, perché era vera.
 Credo che un profeta biblico avrebbe almeno capito la frase che Ismaele dice parlando del suo compagno idolatra, Queequeg, in Moby Dick, il capolavoro (anche teologico) di Melville: «Come potevo allora unirmi a questo selvaggio idolatra nell’adorazione del suo pezzo di legno? Ma che cos’è adorare? Credi davvero, Ismaele, che il magnanimo Dio del cielo e della terra - pagani e tutti quanti inclusi - possa mai essere geloso di un insignificante pezzo di legno nero? Impossibile! Allora, che cos’è adorare?». Non sarebbe possibile nessun dialogo vero con il mondo delle religioni animiste, né con l’induismo, se non pensassimo qualcosa di simile a quanto dice Ismaele.
Credo che un profeta biblico avrebbe almeno capito la frase che Ismaele dice parlando del suo compagno idolatra, Queequeg, in Moby Dick, il capolavoro (anche teologico) di Melville: «Come potevo allora unirmi a questo selvaggio idolatra nell’adorazione del suo pezzo di legno? Ma che cos’è adorare? Credi davvero, Ismaele, che il magnanimo Dio del cielo e della terra - pagani e tutti quanti inclusi - possa mai essere geloso di un insignificante pezzo di legno nero? Impossibile! Allora, che cos’è adorare?». Non sarebbe possibile nessun dialogo vero con il mondo delle religioni animiste, né con l’induismo, se non pensassimo qualcosa di simile a quanto dice Ismaele.Non a caso né per sbaglio il cattolicesimo ha sviluppato e coltivato una visione sacramentale della realtà, dove le "cose" possono contenere segni e messaggi che dicono qualcosa su Dio, senza essere Dio. L’incarnazione ha dato sostanza spirituale alla storia, e quindi alle sue cose, al lavoro umano, ai suoi manufatti. Quel giovane albero del bosco di Gerusalemme, lavorato da un falegname di patiboli, non poteva saperlo ma è entrato, con i chiodi, nel seno della Trinità, per sempre.
 Farebbe solo sorridere, se non fosse drammatico, vedere grandi difensori della fede autentica che oggi si scagliano contro l’idolatria (vedi Sinodo per l’Amazzonia) a motivo dei sincretismi che i poveri hanno sempre fatto e fanno, mentre non sono affatto turbati dall’idolatria del capitalismo, che in genere applaudono. In realtà, l’idolatria del capitalismo è molto più vicina, nello spirito, a quella combattuta dalla Bibbia. Perché, diversamente dai riti della campagna dei nostri antenati, che sentivano nelle cose la presenza vera dello stesso Dio, sotto le merci del nostro consumismo c’è lo stesso hevel (nulla) degli spaventapasseri-idoli criticati da Geremia.
Farebbe solo sorridere, se non fosse drammatico, vedere grandi difensori della fede autentica che oggi si scagliano contro l’idolatria (vedi Sinodo per l’Amazzonia) a motivo dei sincretismi che i poveri hanno sempre fatto e fanno, mentre non sono affatto turbati dall’idolatria del capitalismo, che in genere applaudono. In realtà, l’idolatria del capitalismo è molto più vicina, nello spirito, a quella combattuta dalla Bibbia. Perché, diversamente dai riti della campagna dei nostri antenati, che sentivano nelle cose la presenza vera dello stesso Dio, sotto le merci del nostro consumismo c’è lo stesso hevel (nulla) degli spaventapasseri-idoli criticati da Geremia.Nel mondo della povertà, dentro le cose - nel pane, nel grano, nel vino, nelle piante, nei pochi oggetti... - si riesce a sentire il sacro buono anche perché attraverso quelle pochissime cose scorrevano la vita e la morte. Il nostro capitalismo moltiplica all’infinito le cose, ma non ne moltiplica il valore. Se possiedo un solo vestito buono, una sola penna buona, una sola bicicletta, un solo giocattolo e questi da uno diventano due, tre, dieci, il valore del primo vestito e della prima penna non aumentano ma si dimezzano, si riducono sempre più fino a scomparire se il numero (denominatore) diventa infinito. Il vestito buono ha un valore infinito proprio perché è unico. E quindi lo riparo, lo salvo, lo curo, e non lo "uso e getto". Nella povertà le cose hanno un grande valore, e la prima povertà dell’abbondanza è la scomparsa del valore dei beni che abbiamo, diventati tutti merci.
 Quando la vita ci occupa tutte le energie vitali per sopravvivere e far vivere i figli, spesso sappiamo anche pregare. E quando preghiamo usiamo solo le pochissime preghiere che ricordiamo e che amiamo perché ce li ha insegnate un genitore o una nonna, che hanno certificato la verità di quelle parole, non con la teologia ma con la loro carne donata. Nelle povertà anche le preghiere sono poche. Nessuna preghiera cristiana supera l’unico urlo inarticolato nell’altissima povertà del Golgota.
Quando la vita ci occupa tutte le energie vitali per sopravvivere e far vivere i figli, spesso sappiamo anche pregare. E quando preghiamo usiamo solo le pochissime preghiere che ricordiamo e che amiamo perché ce li ha insegnate un genitore o una nonna, che hanno certificato la verità di quelle parole, non con la teologia ma con la loro carne donata. Nelle povertà anche le preghiere sono poche. Nessuna preghiera cristiana supera l’unico urlo inarticolato nell’altissima povertà del Golgota. -
>RETTIFICARE I NOMI -- MESSAGGIO EVANGELICO, FILOLOGIA, ED ECUMENISMO. "Nicola. Protettore del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente" (di M. Liut).6 dicembre 2019, di Federico La Sala
VERSO "BARI 2020", "NICEA 2025": MESSAGGIO EVANGELICO, FILOLOGIA, ED ECUMENISMO. Quale "carità" (Kapitas o Xapitas, caritas o charitas)?! *
Nicola. Protettore del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente
di Matteo Liut (Avvenire, giovedì 6 dicembre 2018)
La carità è il "miracolo" più grande che nasce dalla fede: prendersi cura degli ultimi, del prossimo in genere, oggi è il messaggio più profetico e rivoluzionario che ci lascia san Nicola. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia, divenne vescovo di Mira in un tempo di persecuzione e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino nel 313.
Difensore dell’ortodossia, forse partecipò al Concilio di Nicea nel 325. La tradizione gli attribuisce un’attenzione particolare nei confronti dei bisognosi, come le due giovani ragazze che poterono sposarsi solo grazie al dono da parte del vescovo di una dote. Morto attorno all’anno 335, nel 1087 le sue reliquie arrivarono a Bari, dove è venerato come patrono e considerato un protettore anche del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente.
 Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
 Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
 Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.
Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.*
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
Commenti a Presicce, il suo patrono Sant’Andrea e la tela del suo martirio, opera del Catalano (Fondazione Terra d’Otranto).
- CHARITÉ: BERLINO RICORDA A PAPA RATZINGER IL NOME ESATTO DELL’ OSPEDALE E DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA.
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.Federico La Sala
-
> RETTIFICARE I NOMI --- PER IL CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DA ARCHIVIO SEGRETO VATICANO AD ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO (Papa Francesco).14 novembre 2019, di Federico La Sala
LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
PER IL CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE
DA
- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO
AD
- ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO *
L’esperienza storica insegna che ogni istituzione umana, sorta pure con le migliori tutele e con vigorose e fondate speranze di progresso, toccata fatalmente dal tempo, proprio per rimanere fedele a se stessa e agli scopi ideali della sua natura, avverte il bisogno, non già di mutare la propria fisionomia, ma di trasporre nelle diverse epoche e culture i propri valori ispiratori e operare quegli aggiornamenti che si rendono convenienti e a volte necessari.
Anche l’Archivio Segreto Vaticano, al quale i Romani Pontefici hanno sempre riservato sollecitudine e cura in ragione dell’ingente e rilevante patrimonio documentario che conserva, tanto prezioso per la Chiesa Cattolica quanto per la cultura universale, non sfugge, nella sua storia ormai più che quattro volte centenaria, a tali inevitabili condizionamenti.
Sorto dal nucleo documentario della Camera Apostolica e della stessa Biblioteca Apostolica (la cosiddetta Bibliotheca secreta) fra il primo e secondo decennio del XVII secolo, l’Archivio Pontificio, che cominciò a chiamarsi Segreto (Archivum Secretum Vaticanum) solo intorno alla metà di tale secolo, accolto in confacenti locali del Palazzo Apostolico, crebbe nel tempo in consistenza notevolissima e fin da subito si aprì alle richieste di documenti che pervenivano al Pontefice Romano, al cardinale Camerlengo e poi al cardinale Archivista e Bibliotecario da ogni parte dell’Europa e del mondo. Se è vero che l’apertura ufficiale dell’Archivio ai ricercatori di ogni Paese si avrà soltanto nel 1881, è vero anche che fra il XVII e il XIX secolo molte opere erudite si poterono pubblicare con l’ausilio di copie documentarie fedeli o autentiche che gli storici ottenevano dai custodi e dai prefetti dell’Archivio Segreto Vaticano. Tanto che il celebre filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm von Leibniz, il quale pure vi attinse, scrisse nel 1702 che esso poteva considerarsi in certo modo l’Archivio centrale dell’Europa (quod quodam modo totius Europae commune Archivum censeri debet).
Questo lungo servizio reso alla Chiesa, alla cultura e agli studiosi di tutto il mondo ha sempre guadagnato all’Archivio Segreto Vaticano stima e riconoscenza, tanto più crescenti da Leone XIII ai nostri giorni, sia in ragione delle progressive «aperture» della documentazione resa disponibile alla consultazione (che dal prossimo 2 marzo 2020, per mia disposizione, si estenderà fino al termine del pontificato di Pio XII), sia in ragione dell’aumento di ricercatori che sono quotidianamente ammessi all’Archivio medesimo e aiutati in ogni modo nelle loro ricerche.
Tale meritorio servizio ecclesiale e culturale, così apprezzato, bene risponde agli intenti di tutti i miei predecessori, che secondo i tempi e le possibilità hanno favorito le ricerche storiche in così vasto Archivio, dotandolo, secondo i suggerimenti dei cardinali Archivisti o dei prefetti pro tempore, di persone, di mezzi e anche di nuove tecnologie. In tal modo si è provveduto alla graduale crescita della struttura dell’Archivio stesso per il suo sempre più impegnativo servizio alla Chiesa e al mondo della cultura, mantenendo sempre fede agli insegnamenti e alle direttive dei Pontefici.
Vi è tuttavia un aspetto che penso possa essere ancora utile aggiornare, ribadendo le finalità ecclesiali e culturali della missione dell’Archivio. Tale aspetto riguarda la stessa denominazione dell’istituto: Archivio Segreto Vaticano.
Nato, come accennato, dalla Bibliotheca secreta del Romano Pontefice, ovvero dalla parte di codici e scritture più particolarmente di proprietà e sotto la giurisdizione diretta del Papa, l’Archivio si intitolò dapprima semplicemente Archivum novum, poi Archivum Apostolicum, quindi Archivum Secretum (le prime attestazioni del termine risalgono al 1646 circa).
Il termine Secretum, entrato a formare la denominazione propria dell’istituzione, prevalsa negli ultimi secoli, era giustificato, perché indicava che il nuovo Archivio, voluto dal mio predecessore Paolo V verso il 1610-1612, altro non era che l’archivio privato, separato, riservato del Papa. Così intesero sempre definirlo tutti i Pontefici e così lo definiscono ancora oggi gli studiosi, senza alcuna difficoltà. Questa definizione, del resto, era diffusa, con analogo significato, presso le corti dei sovrani e dei principi, i cui archivi si definirono propriamente secreti.
Finché perdurò la coscienza dello stretto legame fra la lingua latina e le lingue che da essa discendono, non vi era bisogno di spiegare o addirittura di giustificare tale titolo di Archivum Secretum. Con i progressivi mutamenti semantici che si sono però verificati nelle lingue moderne e nelle culture e sensibilità sociali di diverse nazioni, in misura più o meno marcata, il termine Secretum accostato all’Archivio Vaticano cominciò a essere frainteso, a essere colorato di sfumature ambigue, persino negative. Avendo smarrito il vero significato del termine secretum e associandone istintivamente la valenza al concetto espresso dalla moderna parola «segreto», in alcuni ambiti e ambienti, anche di un certo rilievo culturale, tale locuzione ha assunto l’accezione pregiudizievole di nascosto, da non rivelare e da riservare per pochi. Tutto il contrario di quanto è sempre stato e intende essere l’Archivio Segreto Vaticano, che - come disse il mio santo predecessore Paolo VI - conserva «echi e vestigia» del passaggio del Signore nella storia (Insegnamenti di Paolo VI, I, 1963, p. 614). E la Chiesa «non ha paura della storia, anzi la ama, e vorrebbe amarla di più e meglio, come la ama Dio!» (Discorso agli Officiali dell’Archivio Segreto Vaticano, 4 marzo 2019: L’Osservatore Romano, 4-5 marzo 2019, p. 6).
Sollecitato in questi ultimi anni da alcuni stimati Presuli, nonché dai miei più stretti collaboratori, ascoltato anche il parere dei Superiori del medesimo Archivio Segreto Vaticano, con questo mio Motu Proprio decido che:
da ora in poi l’attuale Archivio Segreto Vaticano, nulla mutando della sua identità, del suo assetto e della sua missione, sia denominato Archivio Apostolico Vaticano.
Riaffermando la fattiva volontà di servizio alla Chiesa e alla cultura, la nuova denominazione mette in evidenza lo stretto legame della Sede romana con l’Archivio, strumento indispensabile del ministero petrino, e al tempo stesso ne sottolinea l’immediata dipendenza dal Romano Pontefice, così come già avviene in parallelo per la denominazione della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Dispongo che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano L’Osservatore Romano, entrando in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, così da essere subito recepita nei documenti ufficiali della Santa Sede, e che, successivamente, sia inserita negli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 ottobre 2019, settimo del nostro Pontificato.
Francesco
* Fonte: http://w2.vatican.va/
-
> "Deus caritas est" (2006). -- L’Assemblea generale della Cei ha approvato la traduzione italiana della terza edizione del "Messale Romano", a conclusione di un percorso durato oltre 16 anni.15 novembre 2018, di Federico La Sala
IL PADRE NOSTRO: BIBBIA, INTERPRETAZIONE, E "LATINORUM" ...
Assemblea dei vescovi.
La Cei approva la nuova traduzione di Padre nostro e Gloria
Il documento finale dell’Assemblea generale straordinaria. Lotta alla pedofilia, nasce un Servizio nazionale per la tutela dei minori
di Redazione Internet (Avvenire, giovedì 15 novembre 2018)
L’Assemblea generale della Cei ha approvato la traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano, a conclusione di un percorso durato oltre 16 anni. In tale arco di tempo, si legge nel comunicato finale dell’Assemblea generale straordinaria della Cei (12-15 novembre), vescovi ed esperti hanno lavorato al miglioramento del testo sotto il profilo teologico, pastorale e stilistico, nonché alla messa a punto della Presentazione del Messale, che aiuterà non solo a una sua proficua recezione, ma anche a sostenere la pastorale liturgica nel suo insieme.
Il testo della nuova edizione sarà ora sottoposto alla Santa Sede per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre nostro («non abbandonarci alla tentazione») e dell’inizio del Gloria («pace in terra agli uomini, amati dal Signore»).
Riconsegnare ai fedeli il Messale Romano con un sussidio
Nell’intento dei vescovi, la pubblicazione della nuova edizione costituisce l’occasione per contribuire al rinnovamento della comunità ecclesiale nel solco della riforma liturgica. Di qui la sottolineatura, emersa nei lavori assembleari, relativa alla necessità di un grande impegno formativo. In quest’ottica «si coglie la stonatura di ogni protagonismo individuale, di una creatività che sconfina nell’improvvisazione, come pure di un freddo ritualismo, improntato a un estetismo fine a se stesso». La liturgia, hanno evidenziato i vescovi, coinvolge l’intera assemblea nell’atto di rivolgersi al Signore: «Richiede un’arte celebrativa capace di far emergere il valore sacramentale della Parola di Dio, attingere e alimentare il senso della comunità, promuovendo anche la realtà dei ministeri. Tutta la vita, con i suoi linguaggi, è coinvolta nell’incontro con il Mistero: in modo particolare, si suggerisce di curare la qualità del canto e della musica per le liturgie». Per dare sostanza a questi temi, si è evidenziata l’opportunità di preparare una sorta di «riconsegna al popolo di Dio del Messale Romano» con un sussidio che rilanci l’impegno della pastorale liturgica.
Nasce un Servizio nazionale per la tutela dei minori
Riguardo alla lotta alla pedofilia, dall’Assemblea generale emerge che le Linee guida che la Commissione della Cei per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili sta formulando «chiederanno di rafforzare la promozione della trasparenza e anche una comunicazione attenta a rispondere alle legittime domande di informazioni». La Commissione - che sottoporrà il risultato del suo lavoro alla valutazione della Commissione per la Tutela dei minori della Santa Sede e soprattutto della Congregazione per la dottrina della fede - ha l’impegno di portare le Linee guida all’approvazione del Consiglio permanente, per arrivare a presentarle alla prossima Assemblea generale.
 Si intende, quindi, portarle sul territorio, anche negli incontri delle Conferenze episcopali regionali per facilitare un’assimilazione diffusa di una mentalità nuova, nonché di un pensiero e una prassi comuni.
Si intende, quindi, portarle sul territorio, anche negli incontri delle Conferenze episcopali regionali per facilitare un’assimilazione diffusa di una mentalità nuova, nonché di un pensiero e una prassi comuni.I vescovi hanno approvato due proposte, che consentono di dare concretezza al cammino. È stata condivisa, innanzitutto, la creazione presso la Cei di un Servizio nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, con un proprio Statuto, un regolamento e una segreteria stabile, in cui laiche e laici, presbiteri e religiosi esperti saranno a disposizione dei vescovi diocesani. Il Servizio sosterrà nel compito di avviare i percorsi e le realtà diocesani - o inter-diocesani o regionali - di formazione e prevenzione. Inoltre, «potrà offrire consulenza alle diocesi, supportandole nei procedimenti processuali canonici e civili, secondo lo spirito delle norme e degli orientamenti che saranno contenuti nelle nuove Linee guida».
La seconda proposta approvata riguarda le Conferenze episcopali regionali. Si tratta di individuare, diocesi per diocesi, uno o più referenti, da avviare a un percorso di formazione specifica a livello regionale o interregionale, con l’aiuto del Centro per la tutela dei minori dell’Università Gregoriana.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
IL PADRE NOSTRO: BIBBIA, INTERPRETAZIONE, E DUEMILA ANNI DI "LATINORUM" CATTOLICO-ROMANO.
STORIA E (FENOMENOLOGIA DELLO) SPIRITO. Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è finito...
 IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO, HENRI DE LUBAC, E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO, HENRI DE LUBAC, E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.Federico La Sala
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! -- Filologia e libertà: "Storie di testi e tradizione classica".29 giugno 2018, di Federico La Sala
Canfora, la filologia è libertà
Il volume curato da Rosa Otranto e Massimo Pinto (Edizioni di Storia e Letteratura)
di Livia Capponi (Corriere della Sera, 29.06.2018)
Come lavoravano gli autori greci e latini? Nel suo lungo e intenso magistero, Luciano Canfora, a cui gli allievi Rosa Otranto e Massimo Pinto dedicano il volume collettivo Storie di testi e tradizione classica, ha insegnato ad affrontare ogni testo a partire dalla sua storia, reinventando la filologia come disciplina in grado di leggere non solo i testi giunti fino a noi, ma anche le cicatrici, i tagli, i contorni invisibili di ciò che è stato modellato da un censore, da un copista, dal gusto di un’epoca.
Diversamente da Isocrate, famoso per la sua lentezza nel comporre, e da Pitagora, che preferiva depositare la sua dottrina nei libri più sicuri, cioè nella memoria degli alunni, Canfora, la cui bibliografia conta 843 opere, è più simile a Demostene, che cesellava ogni rigo o a Fozio, patriarca bizantino che salvò il patrimonio letterario antico, aiutato da un’affezionata cerchia di studenti.
Nei contributi qui raccolti, l’erudizione è messa al servizio di una coinvolgente ricerca della verità, intesa come integrità testuale, storica ed etica. Sono toccati i temi prediletti, come l’analisi critica della democrazia, la storia della tolleranza e della libertà di parola, la schiavitù e i perseguitati politici e religiosi da Atene ai giorni nostri, attraverso lo studio di storiografia, archivi, biblioteche e pubblicistica d’ogni epoca. Il tutto condito da empatia e indipendenza di giudizio, in grado di far rivivere gli antichi con grande vivacità: Cesare è ritratto mentre elabora il primo sistema crittografico per l’intelligence romana; Fozio nell’atto di divorare romanzi d’amore greci (per poi censurarli). Coerentemente con la lezione canforiana, lo studio dei classici diventa motivo di apertura mentale perché aiuta a capire il presente e noi stessi.
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! - «Pasquillus extaticus» e «Pasquino in estasi»: Pasquino nel cielo papistico (di Massimo Firpo).15 aprile 2018, di Federico La Sala
Pasquino nel cielo papistico
Un nuovo studio sul bestseller del primo ’500: sotto accusa la corruzione della Chiesa cattolica e l’armamentario di vuote pratiche devozionali
di Massimo Firpo (Il Sole-24 Ore, Domenica, 15.04.2018)
- Celio Secondo Curione, «Pasquillus extaticus» e «Pasquino in estasi», Edizione storico-critica commentata, a cura di Giovanna Cordibella e Stefano Prandi, Olschki, Firenze, pagg. 314, € 38
Sempre apparso anonimo, il Pasquillus extaticus fu un vero e proprio best seller dei primi anni quaranta del Cinquecento, come testimoniano tre edizioni in latino con numerose varianti e tre in italiano (in due diverse versioni), destinate alla circolazione europea le prime e al proselitismo riformato al di qua delle Alpi le altre. Di queste esistono anche numerosi manoscritti che ne documentano ulteriormente la larga diffusione, attestata anche da una coeva traduzione tedesca e una più tarda traduzione olandese. A scriverlo e a raccogliere i testi che vi compaiono fu Celio Secondo Curione, un letterato piemontese convertitosi alla Riforma e rifugiatosi nel 1542 dopo varie peripezie in Svizzera, a Basilea, dove si sarebbe infine avvicinato a dottrine radicali, sempre più distanti dall’ortodossia calvinista.
È merito di questo studio aver stabilito con buona certezza che il testo latino fu pubblicato per la prima volta a Basilea nel 1541, quando il suo autore non aveva ancora preso la via della fuga oltralpe, all’indomani della quale fu stampata a Venezia la prima edizione italiana, che fu quindi successiva. Sono queste due editiones principes ad essere qui pubblicate con introduzioni storiche e testuali, note di commento e apparato critico. Non stupisce che il Sant’Ufficio romano giudicasse «perniciosissimo» il libello constatandone il successo nell’ambito dei gruppi e movimenti filoriformati in Italia.
 Con il Beneficio di Cristo, l’Alfabeto cristiano, la Tragedia del libero arbitrio, la Medicina dell’anima, testi anch’essi apparsi negli anni quaranta del secolo, sullo sfondo delle prime convocazioni del concilio di Trento, il libro fu uno dei più presenti sui piccoli scaffali clandestini di cui si nutriva una nuova identità religiosa sempre più costretta agli artifici della dissimulazione.
Con il Beneficio di Cristo, l’Alfabeto cristiano, la Tragedia del libero arbitrio, la Medicina dell’anima, testi anch’essi apparsi negli anni quaranta del secolo, sullo sfondo delle prime convocazioni del concilio di Trento, il libro fu uno dei più presenti sui piccoli scaffali clandestini di cui si nutriva una nuova identità religiosa sempre più costretta agli artifici della dissimulazione.In quelle pagine, infatti, la pungente satira delle pasquinate romane dei primi decenni del secolo si spersonalizzava, non investiva più singoli personaggi, ma un’intera istituzione, la Chiesa cattolica, passando dalla beffa morale alla polemica religiosa per denunciarne la corruzione e arricchire l’arsenale delle armi con cui combattere la battaglia per l’abbattimento dell’Anticristo papale.
Non più versi satirici fatti di insulti e più o meno triviali allusioni, ma un dialogo umanistico e pedagogico tra Pasquino e Marforio, sulla base di evidenti modelli erasmiani, che si propone come «una grandiosa ricapitolazione secolare in grado di mostrare al lettore come i tempi della rovina definitiva della Chiesa romana fossero ormai maturi» (p. 23).
Un’opera militante, dunque, in cui il racconto fatto da Pasquino di un viaggio nel cielo papistico (un demoniaco e infernale cielo alla rovescia) offre lo spunto per investire di una critica feroce frati e monache, confessori e martiri, scalzando dalle radici l’imponente edificio della Chiesa visibile e l’infausto armamentario di pratiche sacramentali, liturgiche e devozionali da essa proposto ai fedeli, spingendoli nell’abisso di una pietà farisaica e superstiziosa. -Venerazione delle immagini, purgatorio, voti, pellegrinaggi, digiuni, celibato ecclesiastico, messe di suffragio, indulgenze, miracoli, tutto veniva triturato nella macchina antipapale del Pasquillus curioniano, che investiva non solo e non tanto i comportamenti, ma soprattutto le dottrine erronee che li legittimavano, sì da configurare il discorso come una sintesi della teologia riformata.
Per esempio, se la denuncia dei «fratacci» che, anziché fuggire il mondo «lo portano seco ne’ monasterii, [...] dove non si vede già altro che passioni d’animo e mere pazzie, con che cercano di scacciarsi l’un l’altro o di innalzarsi» (p. 212), poteva rifarsi all’erasmiano «monachatus non est pietas», è evidente il magistero della Riforma laddove si criticavano coloro che preferivano lasciare il monopolio delle cose sacre ai presunti «gran teologi», perché credere «semplicemente» non significa credere «ignorantemente» e ogni cristiano ha il dovere di conoscere la Scrittura (p. 217).
 Se la denuncia del cielo papale come un empio «mercato» simoniaco (p. 230) ripropone antiche invettive anticuriali, di chiara matrice eterodossa sono gli strali contro il culto dei santi (vero e proprio pantheon neopagano), i «novi e orribili riti» e le infinite superstizioni popolari di cui si nutriva, per esortare invece a porre ogni speranza di salvezza solo e soltanto nella fede in Cristo (pp. 232-33), unico «advocato nostro» (p. 244), senza «tanti miracoli fatti a mano, tante fraterie, tanti publichi mercati di meriti e buone opere» (p. 237).
Se la denuncia del cielo papale come un empio «mercato» simoniaco (p. 230) ripropone antiche invettive anticuriali, di chiara matrice eterodossa sono gli strali contro il culto dei santi (vero e proprio pantheon neopagano), i «novi e orribili riti» e le infinite superstizioni popolari di cui si nutriva, per esortare invece a porre ogni speranza di salvezza solo e soltanto nella fede in Cristo (pp. 232-33), unico «advocato nostro» (p. 244), senza «tanti miracoli fatti a mano, tante fraterie, tanti publichi mercati di meriti e buone opere» (p. 237).Un cielo tuttavia, quello papistico, sempre più gravemente insidiato da moderni guastatori, «bravi uomini», in massima parte tedeschi, ma anche «assaissimi italiani et franzesi» che ne preparavano il definitivo crollo scavandone le malcerte fondamenta, fatte di «cappucci, rosari, vesti succide, capelli tagliati, veli di monache e mille fogge di vesti, mille di scarpe, mille di berette, mille di colori, [...] pesci fradici, erbaggi, ligumi, lasagne, mitre pontificali», e sostenute dai muri ormai pericolanti della Superstizione, della Persuasione, dell’Ignoranza e dell’Ipocrisia (pp. 229-30).
I tempi stavano cambiando rapidamente, scriveva Curione, evocando con grande violenza verbale quanti avevano ormai «comminciato a caccar nei capucci, a forbirsi il culo coi rosarii, a farsi beffe dei pelegrinaggi, ad aver a scherzo quelle putanesche astinenze e ad aver in somma abominazione tutte le superstizioni» (p. 235).
 Una violenza che scaturiva dal suo sentirsi schierato in prima linea nella guerra in corso tra verità ed errore, Riforma e papismo, evocata anche dai nomi di numerosi personaggi che compaiono in queste pagine, illustri riformatori come Zwingli, Melantone, Butzer e non meno illustri cardinali come Sadoleto, Aleandro, Carafa, o grandi sovrani europei in guerra tra loro.
Una violenza che scaturiva dal suo sentirsi schierato in prima linea nella guerra in corso tra verità ed errore, Riforma e papismo, evocata anche dai nomi di numerosi personaggi che compaiono in queste pagine, illustri riformatori come Zwingli, Melantone, Butzer e non meno illustri cardinali come Sadoleto, Aleandro, Carafa, o grandi sovrani europei in guerra tra loro.
 Tra di essi figura anche Erasmo da Rotterdam, rappresentato come una vela esposta a ogni vento perché «non si seppe mai, né dai suoi scritti si può sapere, s’ei s’appressasse più al ciel divino o al papistico» (p. 268). Un giudizio severo dal quale lo stesso Curione non tarderà a prendere le distanze, ispirandosi al De immensa Dei misericordia per il suo scritto più celebre, il De amplitudine beati regni Dei, pubblicato nel 1554.
Tra di essi figura anche Erasmo da Rotterdam, rappresentato come una vela esposta a ogni vento perché «non si seppe mai, né dai suoi scritti si può sapere, s’ei s’appressasse più al ciel divino o al papistico» (p. 268). Un giudizio severo dal quale lo stesso Curione non tarderà a prendere le distanze, ispirandosi al De immensa Dei misericordia per il suo scritto più celebre, il De amplitudine beati regni Dei, pubblicato nel 1554. -
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! -- "De Officiis ministrorum". Sant’Ambrogio e il motto episcopale del Vescovo Ausiliare di Roma.21 marzo 2018, di Federico La Sala
IL "LOGOS" E LA "CHARITAS". Sul Vaticano, e su Roma, il "Logo" del Grande Mercante. Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
- SANT’AMBROGIO - AMBROSIUS, In Epistolam Beati Pauli Ad Corinthios Primam, Caput XIII, Vers. 4-8: "Charitas Deus est" (I Joan. 4,8).
- Ambrosius, De Officiis ministrorum, Liber 2, Caput XXX, 155: "Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil charitate dulcius, nihil pace gratius"()
Il motto dello stemma episcopale del Vescovo Ausiliare di Roma, S.E.R. Mons. Angelo De Donatis
- NIHIL CARITATE DULCIUS (Ambrosius “De Officiis ministrorum” Liber 2, Caput XXX, 155)
Le parole scelte da Don Angelo per il proprio motto episcopale sono tratte dal “De officiis ministrorum” di Sant’Ambrogio laddove dice “Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil caritate dulcius,nihil pace gratius...”(“Sia tra di voi la pace che supera ogni sentimento. Amatevi gli uni gli altri. Nulla è più dolce dell’amore, nulla più gradevole della pace”) *
*
Fonte: http://www.sanmarcoevangelista.it (ripresa parziale).
Federico La Sala
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! - UN ESEMPIO DI LATINO MODERNO (di Luciano Canfora).12 febbraio 2013, di Federico La Sala
Un esempio di latino moderno
di Luciano Canfora (Corriere della Sera, 12 febbraio 2013)
Il testo originale del comunicato con cui Benedetto XVI ha annunciato le sue dimissioni è scritto, come è ovvio, in un latino costruito con prestiti ricavati da autori delle più diverse epoche. È una specie di mosaico che abbraccia quasi due millenni di latinità: dal ciceroniano «ingravescente aetate» al disinvolto «ultimis mensibus» che figura in scritti ottocenteschi (addirittura del calvinista Bachofen), fino al «portare pondus» che ricorre in Flavio Vegezio, Epitoma rei militaris, ma più frequentemente in autori quali Raimondo Lullo (Ars amativa boni), Tommaso da Kempis o anche nei sermoni di Bernardo di Chiaravalle.
Spicca come prelievo dal dotto e audace Rufino traduttore di Origene, l’espressione «incapacitatem meam». Per altro verso solide attestazioni di epoca classica, da Quintiliano a Plinio, sorreggono la frase più importante di tutto il testo e cioè: «declaro me ministerio renuntiare» («dichiaro di rinunciare al mio ruolo di Papa»).
Peccato però che, per una svista imputabile a qualche collaboratore turbato dalla gravità dell’annunzio, proprio nella frase cruciale sia stata inferta una ferita alla sintassi latina, visto che al dativo ministerio viene collegato l’intollerabile accusativo commissum («incombenza affidatami»). Avrebbe dovuto esserci, per necessaria concordanza, il dativo commisso.
Come consolarsi di questo lapsus? Pensando per esempio ai rari ma disturbanti errori di latino che macchiavano le Quaestiones callimacheae di un grande filologo come Giorgio Pasquali, rettificate però nella ristampa realizzata poi dal bravissimo Giovanni Pascucci, grammatico fiorentino. Ma non è impertinente comparare un filologo laico con un Pontefice regnante? L’errore - si sa - si insinua sempre. Come il periodo tedesco, così il periodo latino è «ein Bild» (un quadro), in cui ogni tassello ha un suo posto e la ferita inferta alle concordanze risulta tanto più dolorosa.
Analogo incidente è avvenuto addirittura nella frase di apertura, dove il Pontefice dice ai «fratelli carissimi» che li ha convocati «per comunicare una decisione di grande momento per la vita della Chiesa»: ma si legge pro ecclesiae vitae laddove avremmo desiderato pro ecclesiae vita.
Sia stato il turbamento o sia stata la fretta, resta il disagio per le imperfezioni di un testo destinato a passare alla storia. È bensì vero che il latino dei moderni riflette la ricchezza e la novità della lingua dei moderni, ma alcuni pilastri della sintassi non possono, neanche in omaggio al «nuovo che avanza», essere infranti.
-
> "Deus caritas est" (2006)... il "Logo" del Grande Mercante!!! --- La struttura segreta del Vaticano. Immobili a Londra con i soldi di Mussolini (di Enrico Franceschini)22 gennaio 2013, di Federico La Sala
 La struttura segreta del Vaticano
La struttura segreta del Vaticano
 Immobili a Londra con i soldi di Mussolini
Immobili a Londra con i soldi di Mussolini Una società off-shore custodisce un patrimonio da circa 650 milioni di euro. Per conto della Santa Sede, che ha raggranellato prestigiosi locali ed edifici nella capitale britannica. Grazie ai soldi che Mussolini diede al papato con i Patti Lateranensi
Una società off-shore custodisce un patrimonio da circa 650 milioni di euro. Per conto della Santa Sede, che ha raggranellato prestigiosi locali ed edifici nella capitale britannica. Grazie ai soldi che Mussolini diede al papato con i Patti Lateranensi dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *LONDRA - A chi appartiene il locale che ospita la gioielleria Bulgari a Bond street, più esclusiva via dello shopping nella capitale britannica? E di chi è l’edificio in cui ha sede la Altium Capital, una delle più ricche banche di investimenti di Londra, all’angolo super chic tra St. James Square e Pall Mall, la strada dei club per gentiluomini? La risposta alle due domande è la stessa: il proprietario è il Vaticano. Ma nessuno lo sa, perché i due investimenti fanno parte di un segretissimo impero immobiliare costruito nel corso del tempo dalla Santa Sede, attualmente nascosto dietro un’anonima società off-shore che rifiuta di identificare il vero possessore di un portfolio da 500 milioni di sterline, circa 650 milioni di euro. E come è nata questa attività commerciale dello Stato della Chiesa? Con i soldi che Benito Mussolini diede in contanti al papato, in cambio del riconoscimento del suo regime fascista, nel 1929, con i Patti Lateranensi.
A rivelare questo storia è il Guardian, con uno scoop che oggi occupa l’intera terza pagina. Il quotidiano londinese ha messo tre reporter sulle tracce di questo tesoro immobiliare del Vaticano ed è rimasto sorpreso, nel corso della sua inchiesta, dallo sforzo fatto dalla Santa Sede per mantenere l’assoluta segretezza sui suoi legami con la British Grolux Investment Ltd, la società formalmente titolare di tale cospicuo investimento internazionale. Due autorevoli banchieri inglesi, entrambi cattolici, John Varley e Robin Herbert, hanno rifiutato di divulgare alcunché e di rispondere alle domande del giornale in merito al vero intestatario della società.
Ma il Guardian è riuscito a scoprirlo lo stesso attraverso ricerche negli archivi di Stato, da cui è emerso non solo il legame con il Vaticano ma anche una storia più torbida che affonda nel passato. Il controllo della società inglese è di un’altra società, chiamata Profima, con sede presso la banca JP Morgan a New York e formata in Svizzera. I documenti d’archivio rivelano che la Profima appartiene al Vaticano sin dalla seconda guerra mondiale, quando i servizi segreti britannici la accusarono di "attività contrarie agli interessi degli Alleati". In particolare le accuse erano rivolte al finanziere del papa, Bernardino Nogara, l’uomo che aveva preso il controllo di un capitale di 65 milioni di euro (al valore attuale) ottenuto dalla Santa Sede in contanti, da parte di Mussolini, come contraccambio per il riconoscimento dello stato fascista, fin dai primi anni Trenta. Il Guardian ha chiesto commenti sulle sue rivelazioni all’ufficio del Nunzio Apostolico a Londra, ma ha ottenuto soltanto un "no comment" da un portavoce.
-
>Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- NATALE A LONDRA: LA SOLIDARIETA’-PANETTONE DI BENEDETTO XVI E IL "FINANCIAL TIMES". Il testo di Benedetto XVI e una nota di Sergio Cesaratto21 dicembre 2012, di Federico La Sala
 Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ... e un cattolicesimo che ha sempre confuso "Erode" con Cesare e Dio ("Charitas") con Mammona ("Caritas")!!!
Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ... e un cattolicesimo che ha sempre confuso "Erode" con Cesare e Dio ("Charitas") con Mammona ("Caritas")!!!
 NATALE A LONDRA: LA SOLIDARIETA’-PANETTONE DI BENEDETTO XVI E IL "FINANCIAL TIMES". Il testo di Benedetto XVI e una nota di Sergio Cesaratto
NATALE A LONDRA: LA SOLIDARIETA’-PANETTONE DI BENEDETTO XVI E IL "FINANCIAL TIMES". Il testo di Benedetto XVI e una nota di Sergio Cesaratto
-
> Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- Dalla chiesa dei poveri alla chiesa dei manager (di Massimo Faggioli)21 dicembre 2012, di Federico La Sala
Dalla chiesa dei poveri alla chiesa dei manager
di Massimo Faggioli (”L’Huffington Post”, 21 dicembre 2012)
Non è chiaro cosa sarà dell’impegno politico di alcuni notabili cattolici italiani a favore di una “Lista Monti”. Vista dall’America, l’evoluzione del quadro politico italiano con l’agglomerarsi di una lista di centro fatta di industriali, tecnocrati e cattolici neo-liberisti non sorprende per nulla: è frutto non solo della crisi italiana, ma anche dell’onda lunga del reaganismo cattolico, che in America ha fatto di molte curie episcopali delle succursali del Partito repubblicano.
Dal punto di vista della cultura teologica del cattolicesimo contemporaneo, la svolta si era compiuta già da qualche anno, iniziata in modo silenzioso durante e nonostante il pontificato del papa operaio, Giovanni Paolo II, e consumatasi con Benedetto XVI e il crescente americanismo della cultura cattolica prodotta in Vaticano. Siamo passati da una chiesa che cinquant’anni fa proclamava di voler essere “la chiesa dei poveri” ad una chiesa che opera per i poveri ma parla sempre meno dei poveri (per tacer degli operai), che non crede nella politica schiava della “dittatura del relativismo”, e che si affida ai tecnici.
Che la “Lista Monti” sia contornata da esponenti del “cattolicesimo sociale” italiano non deve essere visto come elemento di bilanciamento all’identità “padronale”, ma come conferma di quella identità. Il “cattolicesimo sociale” ha sempre vissuto, dalla fine dell’ottocento dall’enciclica Rerum novarum di Leone XIII in poi, all’ombra di un magistero che rigettava il conflitto di classe: ma allora, e fino a pochi anni fa, rigettava anche la religione del mercato e i costi umani e sociali di un sistema economico e produttivo che allora veniva percepito nei suoi aspetti disumanizzanti. Da qualche tempo invece, in documenti del magistero cattolico forgiati all’ombra di teologi moralisti americani che si occupano di business ethics, la questione principale sembra essere quella di formare business leaders e managers eticamente sensibili ad un’idea di “bene comune” assai vaga e a un’idea di “solidarietà coi poveri” molto più vicina alle opere di carità individuale che alla giustizia sociale.
Parte del cattolicesimo percepisce lo “stato di eccezione” in cui da tempo vive l’Italia come un dato imposto dall’esterno e da cui uscire a tempo dovuto; un’altra parte del cattolicesimo americanizzante vede invece questo “stato di eccezione” come occasione per regolare i conti con una delle eredità più importanti della cultura del concilio Vaticano II. Il ralliement di parte del cattolicesimo italiano alla tecnocrazia ha il sapore di una resa incondizionata del pensiero sociale cattolico nei confronti del Moloch. I preti operai non sono mai stati molto popolari in Vaticano; i manager sembrano invece godere di molta più fiducia.
-
-
> "Deus caritas est" (2006). ---- De caritate ministrandA (2012). Il motu proprio del papa chiude il cerchio (di Eletta Cucuzza - "Adista").10 dicembre 2012, di Federico La Sala
SI SCRIVE CARITÀ, SI LEGGE ACCENTRAMENTO: IL MOTU PROPRIO DEL PAPA CHIUDE IL CERCHIO *
36960. CITTÀ DEL VATICANO-ADISTA. Attenzione da dove vengono e attenzione a dove vanno, i soldi, perché tutto si può dire ma non che pecunia non olet, né che ogni spesa, per quanto presuntamente a fin di bene, sia una spesa ben fatta. Saranno considerazioni banali, ma non è mai male ripeterle e soprattutto non è mai vano disporre di strumenti giuridici per vigilare che non siano commessi abusi. Ovvio che valga anche per le opere di carità, tanto che Benedetto XVI ha sentito il bisogno di mettere intorno ad esse dei paletti alquanto elettrificati e guardiani armati di responsabilità con il motu proprio De caritate ministranda, datato 21 novembre e reso pubblico qualche giorno dopo, il 2 dicembre.
Siccome al servizio della carità la Chiesa è chiamata anche a livello comunitario, dalle piccole comunità locali alle Chiese particolari, fino alla Chiesa universale; e poiché, rileva il papa citando la sua enciclica Deus caritas est, «il Codice di Diritto Canonico, nei canoni riguardanti il ministero episcopale, non tratta espressamente della carità come di uno specifico ambito dell’attività episcopale», è giunto il momento di «colmare» un «lacuna normativa in modo da esprimere adeguatamente, nell’ordinamento canonico, l’essenzialità del servizio della Carità nella Chiesa ed il suo rapporto costitutivo con il ministero episcopale, tratteggiando i profili giuridici che tale servizio comporta nella Chiesa, soprattutto se esercitato in maniera organizzata e col sostegno esplicito dei pastori».
Perciò i 15 articoli del motu proprio stabiliscono che tutte le organizzazioni caritative sono innanzitutto «tenute a seguire nella propria attività i principi cattolici e non possono accettare impegni che in qualche misura possano condizionare l’osservanza dei suddetti principi»; «i principi ispiratori e le finalità dell’iniziativa, le modalità di gestione dei fondi, il profilo dei propri operatori, nonché i rapporti e le informazioni da presentare all’autorità ecclesiastica competente» dovranno essere espressi già nei loro statuti; si può ricorrere alla «denominazione di “cattolico” solo con il consenso scritto dell’autorità competente», ovvero del «vescovo diocesano del luogo dove l’ente abbia la sua sede principale». Il quale deve «vigilare affinché nell’attività e nella gestione di questi organismi siano sempre osservate le norme del diritto universale e particolare della Chiesa», curare che «le loro attività mantengano vivo lo spirito evangelico» e che gli operatori scelti dalle entità caritative siano «persone che condividano, o almeno rispettino, l’identità cattolica di queste opere».
Il vescovo, ma anche il parroco per competenza su un’attività parrocchiale, «dovranno impedire che attraverso le strutture parrocchiali o diocesane vengano pubblicizzate iniziative che, pur presentandosi con finalità di carità, propongano scelte o metodi contrari all’insegnamento della Chiesa». Ed inoltre - aggiunge il motu proprio - il vescovo diocesano «deve evitare» che gli organismi di carità siano «finanziati» o «accettino contributi» da «enti o istituzioni che perseguono fini in contrasto con la dottrina della Chiesa». In tal caso interverrà «proibendo l’uso del nome “cattolico” ed adottando i provvedimenti pertinenti ove si profilassero responsabilità personali».
Quando le attività caritative fossero poi «di ambito internazionale, sia consultato preventivamente il competente dicastero della Santa Sede», ovvero il Pontificio Consiglio Cor Unum, che «ha il compito di promuovere l’applicazione di questa normativa e di vigilare affinché sia applicata a tutti i livelli».
Blindata sotto Cor Unum è già finita la Caritas Internationalis, quando nel maggio scorso sono stati approvati i suoi nuovi statuti (v. Adista Notizie n. 19/12), secondo i quali «qualunque testo di contenuto o orientamento dottrinale o morale, emanato da Caritas Internationalis, deve sempre essere sottoposto alla preventiva approvazione del Pontificio Consiglio» e la nomina delle cariche deve avere «l’approvazione preventiva» del papa. Spuntata l’arma dell’autonomia voluta dal Concilio Vaticano II alla benemerita e più autorevole organizzazione caritativa, non rimaneva che provvedere al controllo stretto delle sue emanazioni nazionali e diocesane, troppo vicine ai poveri e perciò a rischio di attività sensibili alla lotta alle strutture socio-economiche ingiuste.
In particolare negli Stati Uniti, De caritate ministranda avrà anche una conseguenza diretta su tutti gli altri organismi caritativi che, avvalendosi del lavoro di propri dipendenti, si trovano nel dovere di rispettare la riforma sanitaria di Obama, in base alla quale i “datori di lavoro”, ovviamente al di là di qualsiasi credo cui appartengano, devono pagare ai dipendenti anche l’assistenza per l’aborto. Quelli che non si opporranno a tale dettato legislativo, decisamente contrario alla dottrina cattolica, verranno depennati - con la conseguenza di vedersi chiusi anche i rubinetti degli aiuti economici ecclesiali - dall’elenco di enti cattolici? (eletta cucuzza)
* Adista Notizie n. 45 del 15/12/2012
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Quello a "motu proprio"? "Sàpere aude!". Faccia come insegna CONFUCIO. Provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ (Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.13 ottobre 2012, di Federico La Sala
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- In Germania, altolà della Chiesa cattolica: niente sacramenti senza l’8x100023 settembre 2012, di Federico La Sala
Germania/ Altolà della Chiesa cattolica: niente sacramenti senza l’8x1000
 "Affari italiani",, Venerdì, 21 settembre 2012 *
"Affari italiani",, Venerdì, 21 settembre 2012 *Chi non versa l’8 per mille alla Chiesa non è più cattolico e non puo’ avere accesso ai sacramenti, compreso il funerale religioso: è la dura presa di posizione assunta dalla Conferenza episcopale della Germania con l’avallo del Vaticano in risposta alla fuga dei cattolici tedeschi dal pagamento del contributo. A partire da lunedì prossimo chiunque dichiarerà la sua uscita dalla comunita’ ecclesiastica di appartenenza, risparmiandosi così il pagamento dell’8 per mille, si porrà al di fuori della Chiesa cattolica.
Nel documento reso noto a Berlino si sottolinea che l’uscita formale dalla Chiesa costituisce "una grave mancanza nei riguardi della comunità ecclesiale". "Chi per qualunque motivo dichiara davanti all’autorità civile la propria uscita dalla Chiesa", e’ scritto nel documento, "viene meno all’obbligo di appartenenza alla comunità ecclesiastica e a quello di consentire alla Chiesa con il suo contributo finanziario di assolvere alle proprie mansioni".
Chi non paga l’8 per mille non verrà più considerato cattolico e non potrà dunque più avere accesso ai sacramenti, come la confessione, l’eucarestia, ne’ potra’ piu’ essere padrino di battesimo. In caso di morte, poi, gli verra’ negato il funerale religioso, anche se non verra’ automaticamente scomunicato. Con questa misura la Chiesa cattolica cerca di arginare il crescente rifiuto di contribuire al suo sostentamento, ai quali basta una semplice dichiarazione alla cancelleria di un tribunale per essere esentati dal pagamento.
Negli ultimi tempi il fenomeno ha assunto grazie alla crisi una dimensione sempre piu’ considerevole, anche per i credenti di fede evangelica, che per risparmiare decidono di uscire dalla Chiesa di appartenenza. Finora le conseguenze sul piano ecclesiastico erano praticamente nulle, mentre adesso chi esce si vedra’ rifiutare ogni tipo di sacramento. Dal 1990 in poi oltre 100mila tedeschi all’anno hanno voltato le spalle alla Chiesa cattolica, mentre nel 2011 e’ stato toccato il record di 126.488 autoesclusioni. Per tentare di arginare il fenomeno la Chiesa cattolica intende agire in futuro anche in maniera attiva, inviando a chiunque ha dichiarato al tribunale la propria uscita una lettera di invito a parlarne con il proprio parroco. Nel colloquio si cerchera’ di convincere l’eventuale pecorella smarrita a ripensarci e a tornare all’ovile.
* http://affaritaliani.libero.it/cronache/germania-chiesa-cattolica-sacramenti210912.html?refresh_ce
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- e del grande "Cortile dei Gentili". Missione in Svezia del Cardinale Ravasi per cercare di fare affari e nuovi "acqusiti".11 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> "Deus caritas est" (2006). ---- La "Porta delal Fede" di Bendetto XVI. Un chiarimento di Giovanni Paolo II.14 agosto 2012, di Federico La Sala
-
> "Deus caritas est" (2006). ---- Nuovo ordine mondiale e magistero di Papa Benedetto XVI: "Dio è valore"!!! Basta con il cristianesimo: la cattedra di san Pietro è una cattedra di economia politica.10 agosto 2012, di Federico La SalaNuovo ordine mondiale: "Dio è valore" ("Deus caritas est"). Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
 CATTOLICESIMO (E CRISTIANESIMO) OGGI, 2012: LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA.
CATTOLICESIMO (E CRISTIANESIMO) OGGI, 2012: LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA.
-
> "Deus caritas est" (2006). ---- "Dio è valore"!!! Mercanteggiare, mercanteggiare, e mercanteggiare per i secoli dei secoli.12 agosto 2012, di Federico La Sala
Mai mercanteggiare
di Enrico Peyretti
dell’11 agosto 2012 *
Mai «mercanteggiare » sui valori cristiani, dice il card. Bagnasco. Bene. Non è un valore (anche) cristiano il "non uccidere"? Eppure su questo la chiesa cardinalizia "mercanteggia" con la ragion di stato nel giustificare la guerra (chiamata pace), in casi che praticamente al 100% non sono quei singoli rari casi tragicamente estremi in cui uccidere per non lasciar uccidere può diventare una orrenda necessità (un male, ma meno grave di quello che si cerca di evitare, come fu la collaborazione di Bonhoeffer al complotto contro Hitler).
Praticamente sempre le guerre di oggi (ora lasciamo stare il passato), terribilmente predisposte con la gigantesca e piratesca economia di rapina e di guerra, non sono contrastate con "parresia" evangelica dalla chiesa. E così la pena di morte inflitta per legge (e anche contro la legge) dagli stati con cui la chiesa vuole restare amica, secondo il magistero di Costantino, da 1700 anni.
E così l’economia dell’ingiustizia sistematica, a cui le strutture ecclesiastiche non di rado partecipano.
E così, non è stato un vero "mercanteggiare" con Berlusconi e i suoi misfatti politici quello della chiesa gerarchica italiana per tanti anni, in cambio di vantaggi materiali?
Cosa tutta diversa dal mercanteggiare è la mediazione politica, per la quale, se non si ottiene libero consenso democratico legale sulla maggiore giustizia, nella società pluralistica, si accettano dei passi intermedi, nella direzione giusta, ma senza mai cessare di dichiarare, ricordare e proporre il valore evangelico intero, come la pace e la giustizia, negando la collaborazione dei cristiani alla guerra e all’offesa pianificata della vita e della dignità umana.
* Fonte: Incontri di "Fine settimana"
-
-
> "Deus caritas est" (2006).----- Dio è un "tesoro" per molti, non per tutti! Per Benedetto XVI, Dio è uno strumento per fare soldi, una eucarestia (= buona-carestia)30 aprile 2012, di Federico La Sala
Messale di San Pio V:
(...) Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti: mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Haec quotiescúmque fecéritis, in mei memóriam faciétis.
(Questo infatti è il calice del mio sangue, del nuovo ed eterno testamento: Mistero della fede: che per voi e per molti sarà sparso in remissione dei peccati. Tutte le volte che farete questo, lo farete in memoria di me)
Messale di Paolo VI
(...) Prendete e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Messale ambrosiano
(....) Prendete e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo lo farete in memoria di me: predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo.
LA GRAZIA DEL DIO DI GESU’ E’ "BENE COMUNE" DELL’INTERA UMANITA’,
MA IL VATICANO LA GESTISCE COME SE FOSSE UNA SUA PROPRIETA’.
Bruno Forte fa una ’predica’ ai politici, ma non ancora a se stesso e ai suoi colleghi della gerarchia. Una sua nota, con appunti
-
> CARO BENEDETTO XVI ... LA DITTATURA DELLA FINANZA : ABBIAMO TRADITO IL VANGELO (di Alex Zanotelli).23 marzo 2012, di Federico La Sala
APPELLO ALLE COMUNITA’ CRISTIANE
LA DITTATURA DELLA FINANZA : ABBIAMO TRADITO IL VANGELO?
di Alex Zanotelli *
In questo periodo quaresimale sento l’urgenza di condividere con voi una riflessione sulla ‘tempesta finanziaria’ che sta scuotendo l’Europa , rimettendo tutto in discussione :diritti, democrazia, lavoro....In più arricchendo sempre di più pochi a scapito dei molti impoveriti.Una tempesta che rivela finalmente il vero volto del nostro Sistema: la dittatura della finanza. L’Europa come l’Italia è prigioniera di banche e banchieri. E’ il trionfo della finanza o meglio del Finanzcapitalismo come Luciano Gallino lo definisce :“Il finanzcapitalismo è una mega-macchina ,che è stata sviluppata nel corso degli ultimi decenni, allo scopo di massimizzare e accumulare sotto forma di capitale e insieme di potere, il valore estraibile sia del maggior numero di esseri umani sia degli eco-sistemi.”
Estrarre valore è la parola chiave del Finanzcapitalismo che si contrappone al produrre valore del capitalismo industriale, che abbiamo conosciuto nel dopoguerra. E’ un cambiamento radicale del Sistema!
Il cuore del nuovo Sistema è il Denaro che produce Denaro e poi ancora Denaro. Un Sistema basato sull’azzardo morale, sull’irresponsabilità del capitale , sul debito che genera debito.E’ la cosidetta “Finanza creativa” , con i suoi ‘pacchetti tossici’ dai nomi più strani(sub-prime, derivati,futuri, hedge-funds...) che hanno portato a questa immensa bolla speculativa che si aggira, secondo gli esperti, sul milione di miliardi di dollari! Mentre il PIL mondiale si aggira sui sessantamila miliardi di dollari. Un abisso separa quei due mondi:il reale e lo speculativo. La finanza non corrisponde più all’economia reale. E’ la finanziarizzazione dell’economia.
Per di più le operazioni finanziarie sono ormai compiute non da esseri umani, ma da algoritmi, cioè da cervelloni elettronici che, nel giro di secondi, rispondono alle notizie dei mercati. Nel 2009 queste operazioni, che si concludono nel giro di pochi secondi, senza alcun rapporto con l’economia reale, sono aumentate del 60% del totale. L’import-export di beni e servizi nel mondo è stimato intorno ai 15.000 miliardi di dollari l’anno. Il mercato delle valute ha superato i 4.000 miliardi al giorno: circolano più soldi in quattro giorni sui mercati finanziari che in un anno nell’economia reale. E’ come dire che oltre il 90% degli scambi valutari è pura speculazione.
Penso che tutto questo cozza radicalmente con la tradizione delle scritture ebraiche radicalizzate da Gesù di Nazareth.Un insegnamento, quello di Gesù, che ,uno dei nostri migliori moralisti,don Enrico Chiavacci, nel suo volume Teologia morale e vita economica , riassume in due comandamenti, validi per ogni discepolo:” Cerca di non arricchirti “ e “Se hai, hai per condividere.”
Da questi due comandamenti , Chiavacci ricava due divieti etici: “divieto di ogni attività economica di tipo eslusivamente speculativo” come giocare in borsa con la variante della speculazione valutaria e ” divieto di contratto aleatorio”.Questo ultimo ,Chiavacci lo spiega così :” Ogni forma di azzardo e di rischio di una somma, con il solo scopo di vederla ritornare moltiplicata, senza che ciò implichi attività lavorativa, è pura ricerca di ricchezza ulteriore.” Ne consegue che la filiera del gioco, dal ‘gratta e vinci’ al casinò ,è immorale.
Tutto questo , sostiene sempre Chiavacci ,“ cozza contro tutta la cultura occidentale che è basata sull’avere di più. Nella cultura occidentale la struttura economica è tale che la ricchezza genera ricchezza”.
Noi cristiani d’Occidente dobbiamo chiederci cosa ne abbiamo fatto di questo insegnamento di Gesù in campo economico-finanziario. Forse ha ragione il gesuita p.John Haughey quando afferma :”Noi occidentali leggiamo il vangelo come se non avessimo soldi e usiamo i soldi come se non conoscessimo nulla del Vangelo.” Dobbiamo ammettere che come chiese abbiamo tradito il Vangelo , dimenticando la radicalità dell’insegnamento di Gesù :parole come ” Dio o Mammona,”o il comando al ricco:”Và, vendi quello che hai e dallo ai poveri”.
In un contesto storico come il nostro, dove Mammona è diventato il dio-mercato, le chiese, eredi di una parola forte di Gesù, devono iniziare a proclamarla senza paura e senza sconti nelle assemblee liturgiche come sulla pubblica piazza.
L’attuale crisi finanziaria “ha rivelato comportamenti di egoismo, di cupidigia collettiva e di accaparramento di beni su grande scala-così afferma il recente Documento del Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace( Per una riforma del Sistema finanziario e monetario internazionale). Nessuno può rassegnarsi a vedere l’uomo vivere come ‘homo homini lupus’ ”.
Per questo è necessario passare, da parte delle comunità cristiane, dalle parole ai fatti, alle scelte concrete, alla prassi quotidiana:”Non chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’ entrerà nel Regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio”.(Matteo, 7,21)
Come Chiese,dobbiamo prima di tutto chiedere perdono per aver tradito il messaggio di Gesù in campo economico-finanziario, partecipando a questa bolla speculativa finanziaria( il grande Casinò mondiale).
Ma pentirsi non è sufficiente, dobbiamo cambiare rotta, sia a livello istituzionale che personale.
A livello istituzionale(diocesi e parrocchie):
 promuovendo commissioni etiche per vigilare sulle operazioni bancarie ;
promuovendo commissioni etiche per vigilare sulle operazioni bancarie ;
 invitando tutti al dovere morale di pagare le tasse;
invitando tutti al dovere morale di pagare le tasse;
 ritirando i propri soldi da tutte le banche commerciali dedite a fare profitto sui mercati internazionali;
ritirando i propri soldi da tutte le banche commerciali dedite a fare profitto sui mercati internazionali;
 investendo i propri soldi in attività di utilità sociale e ambientale, rifiutandosi di fare soldi con i soldi ;
investendo i propri soldi in attività di utilità sociale e ambientale, rifiutandosi di fare soldi con i soldi ;
 collocando invece i propri risparmi in cooperative locali o nelle banche di credito cooperativo;
collocando invece i propri risparmi in cooperative locali o nelle banche di credito cooperativo;
 privilegiando la Banca Etica, le MAG (Mutue auto-gestione) o le cooperative finanziarie.
privilegiando la Banca Etica, le MAG (Mutue auto-gestione) o le cooperative finanziarie.
 rifiutando le donazioni che provengono da speculazioni finanziarie, soprattutto sul cibo, come ha detto recentemente Benedetto XVI nel suo discorso alla FAO.
rifiutando le donazioni che provengono da speculazioni finanziarie, soprattutto sul cibo, come ha detto recentemente Benedetto XVI nel suo discorso alla FAO.A livello personale ogni cristiano ha il dovere morale di controllare:
 in quale banca ha depositato i propri risparmi;
in quale banca ha depositato i propri risparmi;
 se è una” banca armata”, cioè investe soldi in armi;
se è una” banca armata”, cioè investe soldi in armi;
 se partecipa al grande casinò della speculazione finanziaria;
se partecipa al grande casinò della speculazione finanziaria;
 se ha filiali in qualche paradiso fiscale;
se ha filiali in qualche paradiso fiscale;
 se ottiene i profitti da ‘derivati’ o altri ‘pacchetti tossici’.
se ottiene i profitti da ‘derivati’ o altri ‘pacchetti tossici’.“Le banche ,che dopo aver distrutto la nostra economia, sono tornate a fare affari- scrive il pastore americano Jim Wallis- devono ricevere un chiaro messaggio che noi troviamo la loro condotta inaccettabile.Rimuovere i nostri soldi può fare loro capire quel messaggio.”
Ha ragione don Enrico Chiavacci ad affermare:”Questa logica dell’avere di più e della massimizzazione del profitto si mantiene attraverso le mille piccole scelte ,frutto di un deliberato condizionamento. Le grandi modificazioni strutturali, assolutamente necessarie, non potranno mai nascere dal nulla:occorre una rivoluzione culturale capillare. Se è vero che l’annuncio cristiano portò all’abolizione della schiavitù, non si vede perché lo stesso annuncio non possa portare a una paragonabile modificazione di mentalità e quindi di strutture. Il dovere di testimonianza, per chi è in grado di sfuggire a una presa totale del condizionamento,è urgente.”
Buona Pasqua di Risurrezione a tutti!
Alex Zanotelli
Napoli,22 marzo 2012
* Il Dialogo, Venerdì 23 Marzo,2012
-
> Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- Éric Jaffrain: «La fede non è un prodotto come gli altri». Intervista a Éric Jaffrain, a cura di Nadia Henni-Moulaï29 dicembre 2011, di Federico La Sala
Éric Jaffrain: «La fede non è un prodotto come gli altri»
intervista a Éric Jaffrain, a cura di Nadia Henni-Moulaï
in “www.temoignagechretien.fr” del 28 dicembre 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)
 Lei parla della Chiesa come un “prodotto”. Che cosa significa?
Lei parla della Chiesa come un “prodotto”. Che cosa significa?Da diversi anni, la Chiesa (cattolica) presenta la religione come si presenta un prodotto di consumo, usando l’approccio nato dal marketing commerciale. A mio avviso, si tratta di un errore strategico fondamentale: la Chiesa non deve vendere se stessa, ma il suo prodotto centrale. Non si vende la fede come uno spazzolino da denti.
 La Chiesa sarebbe quindi un’azienda...
La Chiesa sarebbe quindi un’azienda...Assolutamente! Ma che manca di chiarezza nella sua visione, nella sua missione e nei suoi prodotti. La sua strategia d’impresa è troppo legata alla propria marca, in quanto cerca di venderla come prodotto centrale. Oggi, la Chiesa difende più la propria azienda che Dio, nel senso che il packaging (riti, forme di devozione, atmosfera, gerarchia) diventa il modo di consumo inaggirabile. In questo, l’istituzione si è sostituita alla figura divina: prima di tutto, non siete credenti, ma cattolici.
 Perché?
Perché?Perché il pensiero collettivo viene prima della devozione personale. Se un prete, ad esempio, desidera esprimersi in maniera diversa dalle procedure stabilite, la sua iniziativa verrà limitata, se non bloccata dalla gerarchizzazione. Ogni dignitario cattolico dipende dai suoi “superiori”, così come l’individuo membro di questo movimento.
Ma possiamo dire che anch’essa ha avuto i suoi “indignati” fin dagli anni ’80, con il movimento carismatico (le Renouveau), che ha obbligato a maggiore libertà, come molti secoli prima hanno fatto i gesuiti o i domenicani. Questi ultimi, recuperati dall’istituzione, hanno rafforzato il suo potere dirigenziale.
 Questo marketing molto speciale non è alla base di una forma di proselitismo?
Questo marketing molto speciale non è alla base di una forma di proselitismo?Ad un certo livello sì. I numeri recenti lo indicano. Nel mondo, il cattolicesimo mostra una tendenza alla diminuzione, contrariamente al protestantesimo e all’islam. Tutta la strategia marketing consiste nel riconquistare “le parti di mercato” perdute, con il sostegno di campagne di comunicazione, per dare un’immagine giovanile e new look dell’istituzione. Da qui deriva una vera strategia di marketing dispiegata nei confronti degli individui. Una religione che vuole conservare le sue parti di mercato adotta una linea di conquista, come le aziende concorrenti.
 Quindi si parla di modo di consumo e di religione...
Quindi si parla di modo di consumo e di religione...Questo è il rischio. La Chiesa, come ogni altra religione, che vende se stessa piuttosto che rendere la spiritualità accessibile, prende il posto di Dio. Anche se non si parla direttamente di marketing commerciale, i metodi sono estremamente simili: la religione, per mantenere la sua leadership moltiplicherà i modi di consumo: quasi inevitabilmente arriverà a proporre dei prodotti di richiamo, populisti, che attraggono o che obbligano, per valorizzare l’istituzione a scapito del consumo del prodotto centrale, cioè della fede.
Ma forse le cose stanno mutando, e obbligheranno le religioni al cambiamento: il cittadino cerca di allontanarsi dall’istituzione per essere più vicino a un Dio che rivendica essere il suo prima di essere quello dell’istituzione. Il prodotto reclamato non è più la Chiesa, ma la fede, Dio, Gesù. La società civile si appropria del religioso, che diventa “ecologico”.
Non dimentichiamo che il valore di un prodotto è dato da colui che lo consuma e non da colui che lo vende. Un prodotto è “buono” solo se, consumato, migliora l’opinione o il benessere del consumatore. Lo stesso vale per la religione: non è lei che cambia interiormente l’essere umano, ma ciò che viene dall’alto. Se la religione non è un “buon prodotto dall’alto”, ha solo legittimità per se stessa; di fatto, la si rifiuterà e con essa tutta la spiritualità.
 E l’islam in tutto questo?
E l’islam in tutto questo?Anche se l’islam non ha una gerarchia come la Chiesa cattolica, certi movimenti musulmani, o lacultura islamica di certi paesi, hanno la stessa tendenza a vendere la loro ideologia come elemento centrale, inaggirabile, per il cittadino, il che dà la sensazione che anche l’islam difenda il proprio ambito d’influenza. E come in Francia prima del 1905 (data della separazione della Chiesa e dello Stato) sembra voler dettare le regole dei cittadini secondo le proprie regole.
Da qui derivano le polemiche che l’islam suscita in Francia e in Europa. La paura di veder sorgere uno Stato religioso spiega gli irrigidimenti nei confronti di questa religione. Se una ideologia politica, una religione, o perfino una certa economia, tenta di imporsi nella società civile, creerà o conflitti o diffidenza. Il religioso, o più “ecologicamente”, lo spirituale, è necessario alla società, come la laicità. E anche se verticale e orizzontale non hanno gli stessi fondamenti, possono incrociarsi. L’islam ha forse questo approccio, ma l’Europa non l’ha inteso così. Allora questa religione deve rassicurare e affermare che le libertà sono rispettate.
In questo, penso che l’islam potrebbe fare un vero marketing. In compenso, certi movimenti o eventi islamici mi fanno pensare agli stessi comportamenti cattolici, che assumono un marketing di conquista, piuttosto che un marketing del dono.
 Molte persone deplorano l’aspetto unicamente commerciale del Natale. Lei è d’accordo?
Molte persone deplorano l’aspetto unicamente commerciale del Natale. Lei è d’accordo?Sì, Natale è diventato un business prima di essere una festa religiosa; e questo per due ragioni. Innanzitutto, la Chiesa è responsabile di questo stato di fatto. Come ho già spiegato precedentemente, poiché la Chiesa non è più legittima, non lo sono più neanche i suoi prodotti, tra cui il Natale. Inoltre, essendo il Natale un riferimento storico e culturale molto popolare, è stato conservato dalla religione... commerciale, che cerca di aumentare il suo giro d’affari. Oggi la gente vive questa festa senza veramente metterla in relazione a Cristo. Eppure, la ricerca di spiritualità diventa una tendenza pesante: si cerca Dio, ma non in chiesa.
 Sì, ma i credenti hanno comunque il loro libero arbitrio...
Sì, ma i credenti hanno comunque il loro libero arbitrio...Infatti, è per questa ragione che è ingiusto sentire la Chiesa dire al mondo secolare: “Voi avete buttato fuori Gesù.” Perché la Chiesa ha protetto il suo ambito d’influenza, rendendo inaccessibile la figura di Cristo e la fede. Poiché tutti i consumi devono passare dall’istituzione, questo sopprime la libertà di credere. Accettando Natale come una festa commerciale, il cittadino non manifesta necessariamente un rifiuto a credere, ma una reazione a un potere.
 Il marketing religioso è quindi a servizio di interessi non spirituali?
Il marketing religioso è quindi a servizio di interessi non spirituali?In effetti può esserlo. È una delle ragioni per cui il mio concetto di marketing è fondato sul dono, e non sul profitto né sulla performance. Lo spirituale, come il secolare, può essere legittimato ad andarsene dal momento che non contribuisce all’economia totalitaria che abbiamo attualmente. Gli industriali hanno imposto al grande pubblico un modo di acquistare e di consumare. L’obsolescenza programmata dei prodotti ne è un buon esempio. Tutto è fatto per spingerci al consumo: il cittadino, prima di essere un umano, deve essere un consumatore e un oggetto di risorsa per l’impresa.
Pur usando parole diverse, la religione può comportarsi nello stesso modo: reclutare dei praticanti della sua ideologia, e non rispondere alla ricerca di spiritualità, di libertà e di felicità. La società è in grave crisi e si cerca. Ha bisogno di guarigione per i suoi cittadini in maniera olistica, cioè nelle sue quattro componenti: quella fisiologica, quella sociale, quella emozionale e quella spirituale. E la componente religiosa può essere di aiuto, in quanto lavora alla riconciliazione dell’uomo con se stesso, con l’altro e con il divino.
(articolo pubblicato anche sul n° 33 di Salamnews, dicembre 2011)
* Consulente in marketing non commerciale, ha creato il concetto di “gift economy”, l’economia del dono. Autore di La Guérison de l’économie (Éd. Jouvence), che sarà pubblicato nel 2012.
-
> Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! --- ALLARME DI JONATHAN SACKS: LA FINANZA E IL VITELLO D’ORO. È per questo che vengo a Roma. I leader politici europei si incontrano per salvare l’euro e l’Unione europea. Lo stesso dovrebbero fare i leader religiosi.9 dicembre 2011, di Federico La Sala
 Per riscoprire i valori religiosi alla base dell’economia di mercato
Per riscoprire i valori religiosi alla base dell’economia di mercato La finanza
e il vitello d’oro
La finanza
e il vitello d’oro di JONATHAN SACKS *
di JONATHAN SACKS *- Rabbino capo delle Congregazioni ebraiche unite del Commonwealth e membro della Camera dei Lord
 I leader politici europei si incontrano per salvare l’euro e l’Unione europea. Lo stesso dovrebbero fare i leader religiosi. È per questo che vengo a Roma: per discutere delle nostre preoccupazioni comuni durante l’udienza con il Papa e nel corso di colloqui presso l’Università Gregoriana.
I leader politici europei si incontrano per salvare l’euro e l’Unione europea. Lo stesso dovrebbero fare i leader religiosi. È per questo che vengo a Roma: per discutere delle nostre preoccupazioni comuni durante l’udienza con il Papa e nel corso di colloqui presso l’Università Gregoriana.
L’idea potrebbe apparire assurda. Cosa ha a che fare la religione con l’economia o la spiritualità con le istituzioni finanziarie? La risposta è che l’economia di mercato ha radici religiose. Essa è infatti emersa in un’Europa permeata di valori ebraico-cristiani.
Come ha evidenziato l’economista di Harvard, David Landes, fino al XV secolo, la Cina era molto progredita in una vasta gamma di tecnologie rispetto all’Occidente. Tuttavia, la Cina non ha creato un’economia di mercato, non ha visto la nascita della scienza moderna né la rivoluzione industriale. Come afferma Landes, essa non possedeva l’insieme di valori che l’ebraismo e il cristianesimo hanno dato all’Europa.
L’economia di mercato è profondamente coerente con i valori esposti nella Bibbia ebraica. La prosperità materiale è una benedizione divina. La povertà schiaccia lo spirito e il corpo, e alleviarla è un compito sacro. Il lavoro è una nobile vocazione. "Vivrai - recita il Salmo - del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene".
La competizione alimenta il fuoco dell’inventiva: "La rivalità fra gli scribi aumenta la sapienza". Dio ci invita - dicevano i rabbini - a essere suoi collaboratori nell’opera della creazione. I diritti di proprietà privata sono fondamentali per la libertà. Quando il ruolo di guida di Mosè viene messo in discussione, egli afferma: "Io non ho preso da costoro neppure un asino". Elia sfida re Acab per la confisca della vigna di Nabot. Oltre a ciò, afferma Landes, la Bibbia introduce il concetto del tempo lineare, rifiutando l’idea che il tempo sia un ciclo in cui, in definitiva, nulla cambia.
I primi strumenti finanziari del capitalismo moderno furono sviluppati nel XIV secolo dalle banche nelle città cristiane di Firenze, Pisa, Genova e Venezia. Max Weber ha tracciato i collegamenti fra l’etica protestante e lo spirito del capitalismo moderno. Michael Novak ha fatto la stessa cosa per il cattolicesimo. Gli ebrei, pur essendo solo lo 0,2 per cento della popolazione mondiale, sono stati insigniti di più del 30 per cento dei premi Nobel per l’economia. Quando ho chiesto all’economista dello sviluppo Jeffrey Sachs che cosa motivava il suo lavoro, ha risposto senza esitare, tikkun olam, l’imperativo ebraico di "risanare un mondo disgregato". La nascita dell’economia moderna è inseparabile dalle sue radici ebraico-cristiane.
Tuttavia, non si tratta di un equilibrio stabile. Il mercato mina i valori stessi che gli hanno dato origine. La cultura consumistica è profondamente antitetica alla dignità umana. Accende il desiderio, mina la felicità, indebolisce la capacità di rinviare la soddisfazione dei propri istinti e ci rende ciechi di fronte alla distinzione, di vitale importanza, fra il prezzo delle cose e il loro valore.
Gli strumenti finanziari al centro della crisi attuale, mutui subprime e cartolarizzazione del rischio, sono così complessi che i governi, le autorità normative e, a volte, persino i banchieri stessi non sono riusciti a comprenderli nella loro estrema vulnerabilità. Quanti hanno incoraggiato le persone ad accendere mutui che poi non sono in grado di pagare, si sono resi colpevoli di ciò che la Bibbia definisce mettere "inciampo davanti al cieco".
La creazione di un debito personale e collettivo in America e in Europa dovrebbe aver inviato segnali di allarme a chiunque abbia familiarità con le istituzioni bibliche degli anni sabbatici e giubilari, indetti proprio a causa del pericolo che le persone venissero intrappolate dal debito.
Questi sono sintomi di un fallimento più ampio: considerare il mercato come un mezzo e non come un fine. La Bibbia offre un’immagine vivida di cosa accade quando le persone smettono di vedere l’oro come mezzo di scambio e cominciano a considerarlo come oggetto di culto. Chiama questo il vitello d’oro. Il suo antidoto è il sabato: un giorno su sette in cui né lavorare né dare lavoro, né vendere né comprare. È un tempo dedicato a cose che hanno un valore, non un prezzo: famiglia, comunità e rendimento di grazie a Dio per ciò che abbiamo, invece di preoccuparci di quel che ci manca. Non è una coincidenza che in Gran Bretagna, la domenica e i mercati finanziari siano stati deregolati più o meno nello stesso momento.
Stabilizzare l’euro è una cosa, guarire la cultura che lo circonda è un’altra. Un mondo in cui i valori materiali sono tutto e i valori spirituali sono nulla, non genera né uno Stato stabile né una buona società. È giunto il momento di riscoprire l’etica ebraico-cristiana della dignità umana a immagine di Dio. L’umanità non è stata creata per servire i mercati. I mercati sono stati creati per servire l’umanità.
* ©L’Osservatore Romano 9-10 dicembre 2011
- Rabbino capo delle Congregazioni ebraiche unite del Commonwealth e membro della Camera dei Lord
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- Il capitalismo divino: la mistica del capitalismo (di Roberto Esposito)6 dicembre 2011, di Federico La Sala
LA MISTICA DEL CAPITALISMO
di Roberto Esposito (la Repubblica, 06.12.2011)
«Nel capitalismo può ravvisarsi una religione, vale a dire, il capitalismo serve essenzialmente alla soddisfazione delle medesime ansie, sofferenze, inquietudini, cui un tempo davano risposta le cosiddette religioni». Queste fulminanti parole di Walter Benjamin - tratte da un frammento del 1921, pubblicato adesso nei suoi Scritti politici, a cura di M. Palma e G. Pedullà per gli Editori Internazionali Riuniti - esprimono la situazione spirituale del nostro tempo meglio di interi trattati di macroeconomia. Il passaggio decisivo che esso segna, rispetto alle note analisi di Weber sull’etica protestante e lo spirito del capitalismo, è che questo non deriva semplicemente da una religione, ma è esso stesso una forma di religione. Con un solo colpo Benjamin sembra lasciarsi alle spalle sia la classica tesi di Marx che l’economia è sempre politica sia quella, negli stessi anni teorizzata da Carl Schmitt, che la politica è la vera erede moderna della teologia.
Del resto quel che chiamiamo "credito" non viene dal latino "credo"? Il che spiega il doppio significato , di "creditore" e "fedele", del termine tedesco Gläubiger. E la "conversione’’ non riguarda insieme l’ambito della fede e quello della moneta? Ma Benjamin non si ferma qui. Il capitalismo non è una religione come le altre, nel senso che risulta caratterizzato da tre tratti specifici: il primo è che non produce una dogmatica, ma un culto; il secondo che tale culto è permanente, non prevede giorni festivi; e il terzo che, lungi dal salvare o redimere, condanna coloro che lo venerano a una colpa infinita. Se si tiene d’occhio il nesso semantico tra colpa e debito, l’attualità delle parole di Benjamin appare addirittura inquietante. Non soltanto il capitalismo è divenuto la nostra religione secolare, ma, imponendoci il suo culto, ci destina ad un indebitamento senza tregua che finisce per distruggere la nostra vita quotidiana.
Già Lacan aveva identificato in questa potenza autodistruttiva la cifra peculiare del discorso del Capitalista. Ma lo sguardo di Benjamin penetra talmente a fondo nel nostro presente da suscitare una domanda cui la riflessione filosofica contemporanea non può sottrarsi. Se il capitalismo è la religione del nostro tempo, vuol dire che oltre di esso non è possibile sporgersi? Che qualsiasi alternativa gli si possa contrapporre rientra inevitabilmente nei suoi confini - al punto che il mondo stesso è "dentro il capitale", come suona il titolo di un libro di Peter Sloterdijk (II mondo dentro il capitale, Meltemi 2006)?
Oppure, al di la di esso, si può pensare qualcosa di diverso - come si sforzano di fare i numerosi teorici del postcapitalismo? Intorno a questo plesso di questioni ruota un intrigante libro, originato da un dibattito tra filosofi tedeschi, ora tradotto a cura di Stefano Franchini e Paolo Perticari, da Mimesis, col titolo Il capitalismo divino. Colloquio su denaro, consumo, arte e distruzione.
Da un lato esso spinge l’analisi di Benjamin più avanti, per esempio in merito all’inesorabilità del nuovo culto del brand. Tale è la sua forza di attrazione che, anche se vi è scritto in caratteri cubitali che il fumo fa morire, compriamo lo stesso il pacchetto di sigarette. Come in ogni religione, la fede è più forte della evidenza. Dior, Prada o Lufthansa garantiscono per noi più di ogni nostra valutazione. Le azioni cultuali sono provvedimenti generatori di fiducia cui non possibile sfuggire. Non a caso anche i partiti politici dichiarano "Fiduia nella Germania" a prescindere, non diversamente da come sul dollaro è scritto "In God we trust". Ma, allora, se il destino non è, come credeva Napoleone, la politica, ma piuttosto l’economia; se il capitale, come tutte le fedi, ha i suoi luoghi di culto, i suoi sacerdoti, la sua liturgia - oltre che i suoi eretici, apostati e martiri quale futuro ci attende?
Su questo punto i filosofi cominciano a dividersi. Secondo Sloterdijk, con l’ingresso in campo del modello orientale - nato a Singapore e di lì dilagato in Cina e in India - si va rompendo la triade occidentale di capitalismo, razionalismo e liberaldemocrazia in nome di un nuovo capitalismo autoritario. In effetti oggi si assiste a un curioso scambio di consegne tra Europa e Asia. Nel momento stesso in cui, a livello strutturale, la tecnologia europea, e poi americana, trionfa su scala planetaria, su quello culturale il buddismo e i diversi "tao" invadono l’Occidente. La tesi di Zizek è che tra i due versanti si sia determinato un perfetto (e perverso) gioco delle parti. In un saggio intitolato Guerre stellari III. Sull’etica taoista e lo spirito del capitalismo virtuale (ora incluso nello stesso volume), egli individua nel buddismo in salsa occidentale l’ideologia paradigmatica del tardo capitalismo. Nulla più di esso corrisponde al carattere virtuale dei flussi finanziari globali, privi di contatto con la realtà oggettiva, eppure capaci di influenzarla pesantemente. Da questo parallelismo si può trarre una conseguenza apologetica o anche una più critica, se riusciamo a non identificarci interiormente col giuoco di specchi, o di ombre cinesi, in cui pure ci muoviamo. Ma in ciascuno dei casi restiamo prigionieri di esso.
E’ questa l’ultima parola della filosofia? Diverremo tutti, prima o poi, officianti devoti del culto capitalistico, in qualsiasi versione, liberale o autoritaria, esso si presenti? Personalmente non tirerei questa desolata conclusione. Senza necessariamente accedere all’utopia avveniristica del Movimento Zeitgeist o del Venus Project - entrambi orientati a sostituire l’attuale economia finanziaria con un’organizzazione sociale basata sulle risorse naturali -, credo che l’unico grimaldello capace di forzare la nuova reli¬gione del capitale finanziario sia costituito dalla politica. A patto che anch’essa si liberi della sua, mai del tutto dismessa, maschera teologica. Prima ancora che sul terreno pratico, la battaglia si gioca sul piano della comprensione della realtà. Nel suo ultimo libro, Alla mia sinistra (Mondadori, 2011), Federico Rampini percorre lo stesso itinerario - da Occidente a Oriente e ritorno - ma traendone una diversa lezione. All’idea di "mondo dentro il capitale" di Sloterdijk è possibile opporre una prospettiva rovesciata, che situi il capitale dentro il mondo, vale a dire che lo cali dentro le differenze della storia e della politica. Solo quest’ultima può sottrarre l’economia alla deriva autodissolutiva cui appare avviata, governandone i processi ed invertendone la direzione.
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- Don Luigi Maria Verzè. Perché la Chiesa non condanna don Verzè4 dicembre 2011, di Federico La Sala
Perché la Chiesa non condanna don Verzè
risponde Corrado Augias (la Repubblica, 04.12.2011)
 Gentile Corrado Augias,
Gentile Corrado Augias,leggo di Don Verzè e della scandalosa gestione del San Raffaele. Oltre al delirio di onnipotenza che lo ha portato a commissionare una cupola in acciaio da milioni di euro, avere yacht, opzionare un’inutile flotta di aeroplani, tutte spese folli passate inosservate, univa questi comportamenti lussuosi ad un fare da vero capobastone mafioso. Un malinteso senso della missione ecumenica? Ne dubito fortemente. Quando si gestiscono conti correnti all’estero, misteriose società, e si riesce a comandare anche sulla finanza, organo statale, dirottandolo a proprio piacimento sui vicini che gli impediscono ulteriori acquisizioni (e sfracelli ?), siamo di fronte ad una vera associazione a delinquere. O no? Cosa attendono allora le alte gerarchie d’Oltretevere a sanzionare il ras del San Raffaele con una santa scomunica? La tristezza nel notare tanto garbato silenzio da parte della Chiesa dilapida ulteriormente quel poco di credibilità che stentatamente il Papa cerca di ritrovare. Come mai certi comportamenti laicamente inaccettabili sono religiosamente consentiti?
 Marco Bernardi
Marco BernardiDon Luigi Maria Verzè è nato nel 1920 e ha dunque superato i 90 anni di vita dando prova ininterrotta di un’energia e di una capacità di visione straordinarie. A mio parere bisogna partire da questo per tentare di spiegarsi la serie di catastrofici errori, compreso l’ultimo imperdonabile e ridicolo di paragonare le sue disavventure giudiziarie alla passione di Gesù.
Il signor Bernardi si chiede che cosa aspettino le gerarchie vaticane a scomunicarlo. Da osservatore esterno ricordo che il Vaticano, a prescindere da ogni effettiva dimostrazione di colpevolezza, procede sempre con prudenza in casi del genere, sulla base del noto principio "quietare sopire" che si è spesso rivelato il più efficace. I fatti si succedono velocemente, nuovi eventi fanno scomparire nell’oblio i precedenti.
Basta pensare a tutto ciò che non venne fatto quando scoppiò lo scandalo di monsignor Marcinkus nella gestione della banca vaticana (il famigerato Ior) o del tempo che è stato necessario perché il Papa si decidesse a intervenire di fronte all’altro scandalo mondiale dei preti pedofili.
O ancora del silenzio prudente con cui giorni addietro è stata accolta la notizia che il boss mafioso calabrese Giulio Lampada era stato nominato cavaliere dell’Ordine di san Silvestro papa.
Ciò che a noi maggiormente interessa non è però l’eventuale scomunica di don Verzè ma i comportamenti di stampo mafioso di un uomo che aveva dato vita ad un ospedale e ad un’università di ottimo livello, e che si è perso dietro la sua megalomania, causando immenso dolore e la morte di un suo collaboratore. Di questo don Verzè dovrebbe chiedere perdono invece del suo vaniloquio su Gesù.
-
> "Deus caritas est" (2006). ---- LA TEOLOGIA DEL "LATINORUM" DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA DI BENEDETTO XVI. ---- E IL "MODELLO CRISTOLOGICO" DI DON VERZE’.3 dicembre 2011, di Federico La Sala
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- «Non assistenza, ma giustizia» invocava con fervore monsignor Luigi Di Liegro. "La Caritas compie 40 anni: ha cambiato la presenza dei cattolici nella società" (di Roberto Monteforte). .24 novembre 2011, di Federico La Sala
La Caritas compie 40 anni: ha cambiato la presenza dei cattolici nella societàdi Roberto Monteforte (l’Unità, 24 novembre 2011)
Grandi emergenze sociali. Cataclismi e disastri naturali. Ma anche le difficoltà quotidiane da fronteggiare quando si è all’estremo. Quando si è stretti nella morsa degli usurai o quando improvvisamente ci si scopre poveri. Quando si è persa la casa e gli affetti e con loro la dignità e l’umanità. Per chi vive queste situazioni drammaticamente «consuete» in questi tempi di crisi, incontrare la Caritas significa trovare un ricovero, una risposta al bisogno immediato, avere di fronte qualcuno disposto con competenza di ascoltare e prendersi cura. È un’occasione per risalire la china dell’emarginazione sociale. E stato così per tanti in questi anni. Qualcosa di più della semplice assistenza e di diverso dall’elemosina. Un presidio di umanità. Sia per chi ha usufruito dei servizi, sia per quell’esercito di volontari che hanno arricchito di senso loro vita.
LA SCELTA DEI POVERI
È un merito della Chiesa italiana. La Caritas è un suo organismo. Sono trascorsi 40 anni, era il 28 settembre 1972, da quando Papa Paolo VI, la istituì. Il mandato era preciso. «Al di sopra dell’aspetto puramente materiale della vostra attività, deve emergere la sua prevalente funzione pedagogica» chiedeva il pontefice. Era così che papa Montini dava applicazione al Concilio Vaticano II. Così la Chiesa rimodulava il suo rapporto con la società italiana per affermare anche nel campo della politica e del sociale, le ragioni del servizio all’uomo. Con un profilo preciso. La Caritas non accetta nessuna delega sulle problematiche sociali, né dalle istituzioni ecclesiali, né da quelle pubbliche. Funzione pedagogica vuole dire agire perché si faccia contagiosa la vicinanza agli ultimi.
Fino a segnare i comportamenti sociali e le scelte politiche. Compresa la sensibilità della Chiesa, anch’essa da «convertire». Un compito sicuramente scomodo in tempi come questi, segnati dall’«egoismo sociale». Lo ha ricordato nei giorni scorsi a Fiuggi al 35˚ Congresso nazionale delle Caritas diocesane nel 40˚ della fondazione il vescovo di Lodi, monsignor Giuseppe Merisi, presidente di Caritas Italiana, di fronte ai 600 delegati delle 220 strutture diocesane. Tanto è oggi ramificata la Caritas sul territorio.
Una presenza spesso scomoda per il potere e per le istituzioni. Un testimone straordinario di questa fedeltà al Vangelo e all’uomo è stato nella Roma degli anni ‘80 monsignor Luigi Di Liegro. Il primo direttore della Caritas diocesana era in prima linea dove scoppiavano le emergenze: tra i senza casa che avevano occupato i locali abbandonati della Pantanella, tra i malati di Aids, tra i poveri e i barboni cui assicurava un tetto, un pasto caldo, assistenza sanitaria e accoglienza. Di Liegro invitava a guardare alle cause del disagio, alle ingiustizie che offendevano l’uomo. Senza timore ha denunciato chi speculava sulle aree e sul lavoro. Perché considerava la fedeltà al Vangelo più forte del potere economico e politico, della difesa degli interessi dei potenti.
«Non assistenza, ma giustizia» invocava con fervore. Ha pagato il prezzo dell’incomprensione e dell’isolamento, ma la sua testimonianza ha reso credibile la Chiesa di Roma e ha dato frutto. Ha consentito che maturasse una nuova consapevolezza dell’impegno sociale e politico del credente. Si è rotto con il collateralismo con la Dc. La Caritas si è ramificata nelle parrocchie. Ha operato nelle zone di frontiera più difficili. Giovani, minori, immigrati, donne in difficoltà, anziani soli ed oggi sempre più i «nuovi poveri»: «gente normale», di ceto medio, precipitata improvvisamente nel disagio.
Sono le nuove emergenze che da tempo Caritas Italia denuncia con i suoi dossier: quello sull’imigrazione realizzato con Migrantes dal 1991 e il Rapporto sulle povertà realizzato con la Fondazione Zancan.Emerge un paese sempre più povero anche di diritti. Sono materiale prezioso per affrontare i nodi del disagio sociale. È il frutto di un lavoro capillare realizzato dalle 220 Caritas diocesane con i «centri di ascolto», gli «Osservatori delle povertà» e i «laboratori» delle parrocchie e gli oltre 14 mila servizi socio-sanitari. Oltre a registrare i dati si denunciano responsabilità. Lo scontro con la politica, come con la Lega, si fa anche diretto quando sono messi in discussione i diritti fondamentali dell’individuo.
-
> "Deus caritas est" (2006).... un tragico "lapsus" (Sigmund Freud) --- OOPS! IL CASO DEL MINI-CATECHISMO, "YOUCAT" (di Mirella Camera)14 aprile 2011, di Federico La Sala
oops!
di Mirella Camera
in “a latere...” (http://alatere.myblog.it) del 13 aprile 2011 *
Annunciato con squilli di tromba in tutto il mondo cattolico, Youcat (furbo acronimo di Youth catechism), il mini-catechismo che Benedetto XVI vuole dedicare ai giovani, dopo essere apparso per pochi giorni in libreria è stato ritirato in fretta e furia. Motivo? Un “errore” di traduzione nella versione italiana, che alla domanda 420: "Può una coppia cristiana fare ricorso ai metodi anticoncezionali?" risponde: "Sì, una coppia cristiana può e deve essere responsabile nella sua facoltà di poter donare la vita".
Nella versione originale non si parla di “anticoncezionali” ma di “controllo del numero dei figli”. Detto a latere, questo è il secondo errore di traduzione che mette in imbarazzo la gerarchia: l’altro era relativo, guarda caso, all’uso del condom da parte di “una prostituta” che poi nell’originale dell’intervista al papa si è rivelato essere “un prostituto”. Si vede che la lingua batte dove il dente duole.
Ma andiamo avanti. Questo mostra, ancora una volta, la distanza siderale che c’è tra l’insegnamento dottrinale e la vita reale delle persone.
L’intenzione e la volontà di pianificare il numero di figli è definita dalla Chiesa cattolica nei suoi documenti ufficiali “paternità responsabile”. Ci sarebbe da chiedersi perché non “maternità responsabile”, che sarebbe molto più logico, vista la parte che ha la donna nella faccenda. O, meglio ancora, “genitorialità responsabile” in modo che siano ben chiari i soggetti della decisione. Comunque sia, questa volontà è ritenuta cosa responsabile, quindi buona e giusta.
E’ sui mezzi che scatta una feroce idiosincrasia, come se questi fossero di per sé molto più importanti dell’intenzione stessa. La spirale no, e fin qui possiamo capire: agisce sulle cellule già fecondate, quindi sarebbe una sorta di proto-aborto. Ma la pillola neanche, perché "distorce la natura e gli obiettivi del sesso". E il preservativo, innocuo aggeggio di lattice che ha solo una funzione di barriera meccanica e che più povero di così non potrebbe essere? Nemmeno quello, perché banalizza la sessualità. Anzi, contro il preservativo la Chiesa ha scatenato una vera guerra come se fosse uno strumento del diavolo, visto che lo vieta persino in caso di Aids fra coniugi.
Salvo, a sorpresa, sentirsi dire dal papa stesso che può essere concesso in un rapporto omosessuale a pagamento. Forse perché in quel caso l’intenzione di regolare le nascite proprio non si pone?
Al posto di tutti questi mezzi, normalmente usati con efficacia dai non osservanti, la Chiesa propone solo l’astinenza sessuale, magari guidata dai cosiddetti “metodi naturali”; che in realtà sono metodi molto macchinosi, di gestione a volte irrealizzabile nella vita reale di una famiglia e per nulla sicuri (metodi Billings, Ogino-Knaus, temperatura basale).
Che si tratti di catechismo per i giovani o di quello degli adulti, su questo tema, sulla sessualità in genere e su moltissimi altri argomenti la Chiesa cattolica dovrebbe fare un profondo ripensamento. Di forma ma soprattutto di contenuto. Se ne parla da anni e lo chiedono in molti, non certo eretici o secolarizzati persi. Ma la risposta è sempre un arroccamento nella Dottrina.
Se il papa pensa che presentando un catechismo in formato quiz con una simpatica copertina gialla si venga incontro alle domande dei credenti di nuova generazione, sbaglia di grosso. Sarà infallibile ma sbaglia. Per passare il testimone della fede ai ragazzi non gli si dà in mano una sorta di manuale d’uso, come se dovessero mettere in moto la loro fede alla maniera di un frullatore o di un microonde. Manuale oltretutto vecchio e datato, le cui affermazioni sono desunte da una logica filosofica tramontata da secoli (il tomismo) e che non risponde più alle domande di oggi.
Tra i primi atti di Benedetto XVI c’è stata la consegna del Compendio, un catechismo "leggero" cheevidentemente lui considera strumento imprescindibile per un credente. Ora la replica con i giovani. Ma non sarebbe molto meglio dare il Vangelo?
* Fonte: Fine settimana.org
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!!
 Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907
Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907
- EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!!
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! --- SUL CROCIFISSO, LA CORTE EUROPEA HA DETTO LA SUA PAROLA DEFINITIVA: E’ "UN SIMBOLO ESSENZIALMENTE PASSIVO", IRRILEVANTE! Per la Santa Sede e il Ministro Gelmini, al contrario, è una grande vittoria - per tenere in piedi la loro alleanza "mammonica"!19 marzo 2011
 EUROPA, COSTITUZIONE, E MESSAGGIO EVANGELICO. LA ’CROCE’ (lettera alfabeto greco = X) DI CRISTO NON HA NIENTE A CHE FARE CON IL CROCIFISSO DELLA TRADIZIONE COSTANTINIANA E CATTOLICO-ROMANA ...
EUROPA, COSTITUZIONE, E MESSAGGIO EVANGELICO. LA ’CROCE’ (lettera alfabeto greco = X) DI CRISTO NON HA NIENTE A CHE FARE CON IL CROCIFISSO DELLA TRADIZIONE COSTANTINIANA E CATTOLICO-ROMANA ...
 CHE SCHIAFFO AL VATICANO E AL GOVERNO ITALIANO! SUL CROCIFISSO, LA CORTE EUROPEA HA DETTO LA SUA PAROLA DEFINITIVA: E’ "UN SIMBOLO ESSENZIALMENTE PASSIVO", IRRILEVANTE! Per la Santa Sede e il Ministro Gelmini, al contrario, è una grande vittoria - per tenere in piedi la loro alleanza "mammonica"! Rassegna stampa ...
CHE SCHIAFFO AL VATICANO E AL GOVERNO ITALIANO! SUL CROCIFISSO, LA CORTE EUROPEA HA DETTO LA SUA PAROLA DEFINITIVA: E’ "UN SIMBOLO ESSENZIALMENTE PASSIVO", IRRILEVANTE! Per la Santa Sede e il Ministro Gelmini, al contrario, è una grande vittoria - per tenere in piedi la loro alleanza "mammonica"! Rassegna stampa ...
 (...) Per il governo italiano e il fronte pro-crocefisso è una vittoria a tutto campo. Nel motivare la sua decisione la Corte afferma come il margine di manovra dello Stato in questioni che attengono alla religione e al mantenimento delle tradizioni sia molto ampio (...)
(...) Per il governo italiano e il fronte pro-crocefisso è una vittoria a tutto campo. Nel motivare la sua decisione la Corte afferma come il margine di manovra dello Stato in questioni che attengono alla religione e al mantenimento delle tradizioni sia molto ampio (...)
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! --- Dalla cattedra dei non credenti al cortile dei gentili. Una nota di Piero Stefani3 marzo 2011, di Federico La Sala
 DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! PER IL CARDINALE RAVASI E’ LO STESSO!!! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi corigerete")?!
DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! PER IL CARDINALE RAVASI E’ LO STESSO!!! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi corigerete")?!
 PROPAGANDA RATZINGERIANA A PARIGI: IL CORTILE DEL TEMPIO APERTO AL DIALOGO TRA MERCANTI ATEI E DEVOTI. Dalla cattedra dei non credenti al cortile dei gentili. Una nota di Piero Stefani
PROPAGANDA RATZINGERIANA A PARIGI: IL CORTILE DEL TEMPIO APERTO AL DIALOGO TRA MERCANTI ATEI E DEVOTI. Dalla cattedra dei non credenti al cortile dei gentili. Una nota di Piero Stefani
 In luogo della «cattedra dei non credenti», la Chiesa universale ora lancia un’iniziativa chiamata «cortile dei gentili». Affidata al Pontificio Consiglio della Cultura (prefetto card. Ravasi), il «cortile» è stato preinaugurato un paio di settimane fa a Bologna; mentre l’avvio ufficiale avverrà a Parigi verso fine marzo.
In luogo della «cattedra dei non credenti», la Chiesa universale ora lancia un’iniziativa chiamata «cortile dei gentili». Affidata al Pontificio Consiglio della Cultura (prefetto card. Ravasi), il «cortile» è stato preinaugurato un paio di settimane fa a Bologna; mentre l’avvio ufficiale avverrà a Parigi verso fine marzo.
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! --- I GUASTI DEL DENARO, ULTIMO TOTEM. Il libro di Vittorino Andreoli, Il denaro in testa, fa ripensare al peso di questo fattore, nefasto ma sempre mutevole (di Salvatore Bragantini).19 febbraio 2011, di Federico La Sala
I guasti del denaro, ultimo totem
di Salvatore Bragantini (Corriere della Sera, 19 febbraio 2011)
Il libro di Vittorino Andreoli, Il denaro in testa (Rizzoli), fa ripensare al peso di questo fattore, nefasto ma sempre mutevole. Tutta la storia dell’uomo narra le violenze fatte e le angherie subite, nel nome dei suoi grandi totem: il denaro e le religioni. Dio e Mammona hanno sempre trovato nel potere i loro modi di sontuosa convivenza; nel reciproco interesse. Alla fine, Andreoli elenca i bisogni veri dell’uomo: la sicurezza, l’amore, la continuità della vita attraverso i figli, la serenità e la gioia (più necessarie della libertà, scrive, e viene in mente l’arringa a Gesù del Grande Inquisitore) e così via.
«Per nessuno di questi bisogni serve il denaro, semmai aiuta a soddisfarli meglio». È questo, però, il problema. Certo, le società moderne sono tanto disossate da far dire a Margaret Thatcher (che ci ha messo del suo): «La società non esiste». Non credo però che, neanche in quell’era dorata che ci pare il nostro Rinascimento, si vivesse come in un’orchestra nella quale, «se tutti sono adeguatamente coordinati e danno il loro contributo all’insieme, la vita può diventare l’esecuzione della Nona sinfonia di Beethoven».
Da tempo, certo, il denaro deborda ben oltre i limiti propri di una convivenza ordinata. Da quando la società anonima ha circoscritto le responsabilità degli investitori, sono partite innovazioni che hanno rivoluzionato la vita; la ricchezza mobiliare fa a meno della terra, onde l’aristocrazia traeva potere e ricchezza. Ciò aumenta il numero dei ricchi, quindi la paura di diventare poveri; è chi sta male a sperare di stare meglio. I guadagni sono celati, le perdite lamentate in pubblico.
La finanza ha messo il turbo ai guadagni privati e alle perdite che le crisi finanziarie addossano al contribuente; se si può anticipare l’incasso anche di anni lontani, la tentazione di vendersi il vitello in pancia alla vacca mina il futuro. Ma il passato, aureo o no, non tornerà. Fra il 1950 e la metà degli anni Settanta gli eccessi del denaro non erano così visibili e dannosi. Le disuguaglianze erano minori. Le paghe dei megamanager avevano un rapporto con il loro lavoro, erano cinquanta volte quelle dei loro dipendenti, non cinquecento o mille; la deontologia professionale reggeva. Ciò costava nell’immediato, ma la reputazione era fonte di guadagni futuri; gli auditor non certificavano bilanci falsi per tenersi il cliente, le banche - settore sonnolento - non concedevano mutui farlocchi da rifilare a sprovveduti, vogliosi di strappare un lacerto di carne. La fine dello spauracchio comunista allentò le difese del capitalismo, mostrandone il volto peggiore; gli incassi immediati contarono più della reputazione.
I giudizi di Andreoli su finanzieri e imprenditori paiono a volte troppo tranchant; se (quasi tutti) sono mossi dalla maledetta fame di denaro, accostarli ai criminali è un po’ forte. E magari non è il mondo a essere mutato, ma la maggior esperienza di vita a mettere a nudo la realtà. Poco praticabili sono poi alcune sue ricette: sarebbe sì desiderabile che la psicologia dettasse all’economia la «giusta distribuzione dei compiti e dei mezzi... tenendo conto delle differenze, degli impegni e delle necessità di ognuno».
I tanti tentativi in tal senso della politica, tuttavia, pur ispirati alle migliori intenzioni, dicono che l’economia di mercato è il peggior allocatore delle risorse, a parte gli altri sistemi: come quella democrazia che con lei si è sviluppata, ma che dai suoi eccessi è messa a rischio. Ignoriamo gli esiti di una grave crisi che di quelle disuguaglianze s’è nutrita e deve ancora dispiegare le sue conseguenze economiche, sociali e politiche; la difesa, coltello fra i denti, della ricchezza impaurita ci darà forse brutte sorprese.
La direzione presa dal sistema negli ultimi trent’anni - più economia di business che di mercato - può farci tornare al punto di partenza; con la democrazia che conserva le forme ma trasmuta in aristocrazia, non della terra ma del denaro. Se per essere eletti servono troppi soldi, vince il più ricco o chi meglio si vende ai vested interest; con l’aiuto, troppo ignorato, di una tv che ha prima unito l’Italia, poi sfibrato gli italiani.
Le parole di Andreoli evocano nel lettore la sapienza laica - per cui è sventurato l’uomo che non dona e muore ricco - e religiosa: dalla «preghiera semplice» di Francesco - «È dando che si riceve» - al Vangelo: «Eppure vi dico che nemmeno Salomone in tutto il suo splendore fu mai vestito come i gigli del campo». Se hai bisogno di aiuto, si dice, chiedilo a un povero, lui ti aiuterà.
La ricchezza ci chiude, invece di aprirci al dono; fortunato chi per la cruna dell’ago sfugge a questa morsa. La povertà oggi diviene peccato, dice l’autore; peggio, il governo la considera spesso reato. Chi nasce povero ha più probabilità di restarlo oggi che nello scorso secolo breve.
La meta dell’uguaglianza dei punti di partenza, topos della democrazia liberale, che è morta con la tassa di successione, va risuscitata; deve però cessare l’atomizzazione dei saperi, deprecata dall’autore, per cui gli intellettuali più non leggono i libri di economia. Le colpe sono equamente ripartite, ma ricordiamolo: Adam Smith insegnava filosofia morale, non econometrica.
-
> "Deus caritas est" (2006). Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- Diiritti d’autore e "Luce del mondo". Il benvenuto alla “Ratzinger Academy” (di Philippe Clanché).21 dicembre 2010, di Federico La Sala
Il benvenuto alla “Ratzinger Academy”
di Philippe Clanché
in “www.temoignagechretien.fr” del 21 dicembre 2010 (traduzione: www.finesettimana.org)
Luce del mondo, il libro-intervista di Benedetto XVI con il giornalista tedesco Peter Seewald è già un successo di libreria. La sua prima apparizione a La Procure di Parigi, sabato 27 novembre, si è esaurita in poche ore. Bayard éditions annuncia una tiratura di 63 000 copie.
Trattandosi di un successo planetario, alcuni osservatori si sono chiesti quale uso avrebbe fatto Benedetto XVI dei suoi diritti d’autore. La vita austera e laboriosa dei papi moderni non offre loro molte possibilità di spendere i loro soldi in cose futili.
Le persone vicine al papa hanno trovato la risposta. La metà dei guadagni di questo libro, così come dei precedenti - ossia già 2,5 milioni di euro - sarà destinata alle opere di carità del pontefice. L’altra metà servirà per una struttura cui è stato dato avvio in marzo e che è stata annunciata il 26 novembre: la Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI (1). La sua finalità sarà quella di sostenere gli studi sul pensiero del teologo divenuto pontefice.
Il comitato scientifico della Fondazione, presieduto dal cardinale Camillo Ruini (ex vicario di Roma ed ex presidente della conferenza episcopale italiana) avrà tre competenze: “Determinare gli obiettivi annuali e pluri-annuali, nonché i suoi criteri di funzionamento, in seguito fissare le regole di eccellenza per i premi da attribuire agli studenti selezionati per i loro lavori, organizzare infine iniziative culturali e scientifiche” (2).
Il cardinal Ruini, che in febbraio avrà 80 anni, ha detto di volersi dedicare in modo particolare all’attribuzione dei “Premi Ratzinger”, a partire, spera, dal 2011. Il prelato ha espresso, imprudentemente, l’idea di una sorta di “Premio Nobel di teologia”. Dopo tutto, l’insieme dei campi della ricerca accademica non è interamente coperto dagli esperti del Comitato Nobel. Si parla effettivamente della celebre medaglia Fields come di un Premio Nobel di matematica.
È comunque interessante ricordare ciò che rappresentava fino a poco tempo fa il nome di Joseph Ratzinger per la ricerca teologica. Si sa che il prelato tedesco ha diretto con fermezza per un quarto di secolo la Congregazione per la Dottrina della fede.
Dal 1981, è stato quindi lui a provvedere affinché le idee che si allontanavano poco o tanto dalla linea ufficiale romana fossero marginalizzate. È stato lui a proibire l’insegnamento e/o la pubblicazione delle opere di alcune decine di teologi considerati sovversivi.
Insomma, non è esagerato dire che la sua concezione della parola “ricerca” non era necessariamente quella comunemente accettata nel mondo accademico. Ma non faremo qui l’elenco di tutte le vittime di questo venerabile censore, che fu forse per Giovanni Paolo II ciò che Fouché fu per Talleyrand. Gli interessati possono fin d’ora immaginare le tematiche di ricerca privilegiate dalla nuova fondazione. Progetti tipo “Dalla fine del nascondimento alla nuova evangelizzazione, il ritorno di Dio contro la secolarizzazione” saranno indubbiamente sostenuti più di altri.
Ma non si sa mai. Dato che siamo ottimisti, proponiamo allo studio alcuni temi su cui i nostri futuri “Nobel” di teologia potranno indagare: “Monaco 1978-1981 ovvero le tribolazioni di un valente insegnante nella sua dura missione di pastore diocesano”, “La normalizzazione delle teologie alternative negli anni ’80”, “L’accusa di marxismo e l’assassinio delle teologie della liberazione”, “Clericalismo: la piaga romana”, “Tommaso d’Aquino, studio di una totemizzazione teologica”...
 (1) Esiste già a Monaco un’altra “Fondazione Joseph Ratzinger-Benedetto XVI”.
(1) Esiste già a Monaco un’altra “Fondazione Joseph Ratzinger-Benedetto XVI”. (2) Il comitato scientifico comprenderà anche i cardinali Bertone e Amato, nonché i segretari
delle Congregazioni per l’Educazione cattolica e per la Dottrina della fede.
(2) Il comitato scientifico comprenderà anche i cardinali Bertone e Amato, nonché i segretari
delle Congregazioni per l’Educazione cattolica e per la Dottrina della fede. -
> "Deus caritas est" (2006). ---- Denaro e Paradiso. Il Papa riceve il presidente dello Ior. Per Gotti Tedeschi, "Attestazione di stima e di fiducia".26 settembre 2010, di Federico La Sala
DENARO E PARADISO: AGLI INIZI DEL MODERNO - A BOLOGNA, NEL 1257, IL DENARO SERVIVA PER RESTITUIRE LA LIBERTA’ AI SERVI E ALLE SERVE DELLA GLEBA, OGGI A ROMA SERVE PER ASSERVIRE BAMBINI E BAMBINE, UOMINI E DONNE LIBERE. Cfr.:
 VATICANO
VATICANO
 Il Papa riceve il presidente dello Ior
Il Papa riceve il presidente dello Ior
 "Attestazione di stima e di fiducia"
"Attestazione di stima e di fiducia"Fonti della Santa Sede riferiscono di un "incontro al baciamano, davanti a molti testimoni", e lo definiscono "un modo per sottolineare pubblicamente la vicinanza e il sostegno del Pontefice". Gotti Tedeschi -insieme al direttore dello Io, Cipriani- è indagato dalla Procura di Roma per omissioni legate alla normativa anti-riciclaggio
CITTA’ DEL VATICANO - Viene interpretato dai più in Vaticano come una "evidente attestazione di stima e fiducia" da parte del Papa per il presidente dello Ior Ettore Gotti Tedeschi 1, in questi giorni sotto inchiesta 2, il breve incontro che i due hanno avuto questa mattina. "L’incontro al baciamano, davanti a molti testimoni - osservano fonti riservate - è stato chiaramente un modo per sottolineare pubblicamente, a soli cinque giorni dalla notizia dell’indagine avviata dalla Procura di Roma, la vicinanza e il sostegno da parte del Pontefice all’economista e banchiere scelto pochi mesi fa per guidare l’Istituto Opere religiose 3 in un percorso di totale e irreversibile trasparenza".
Benedetto XVI ha ricevuto Gotti Tedeschi dopo la preghiera dell’Angelus a Castelgandolfo. L’economista era accompagnato dalla moglie e ha presentato al Pontefice il libro Denaro e paradiso. I cattolici e l’economia globale, da lui scritto con Rino Cammilleri con una prefazione del segratario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone.
Il presidente dello Ior e il direttore, Paolo Cipriani, massimi responsabili della banca vaticana, sono indagati dalla Procura di Roma per omissioni legate alla normativa antiriciclaggio. A loro si contesta di non aver fornito indicazione sulla tipologia di due movimentazioni di danaro, 20 milioni di euro destinati all’istituto di credito tedesco J.P. Morgan Frankfurt e 3 milioni alla Banca del Fucino, depositato in un conto presso la sede romana del Credito Agricolo.
In sostanza, lo Ior non avrebbe comunicato per conto di chi (ossia se in proprio o per terzi) avrebbe disposto il trasferimento di quelle somme. Ciò, in base ad una normativa antiriciclaggio del 2007, configura una violazione. Sulla vicenda, sono stati ascoltati alcuni esponenti del Credito Artigiano la cui segnalazione ha messo in moto l’Unità di informazione finanziaria (Uif), con la sospensione delle operazioni, definite "sospette", per cinque giorni, e successivamente la Procura della repubblica.
Gotti Tedeschi "è tranquillissimo", riferiscono le stesse fonti, e "attende serenamente di essere ascoltato in Procura", il che accadrà "entro la settimana".
* la Repubblica, 26 settembre 2010
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- Non è il Dio in cui credo (di Nandino Capovilla).12 settembre 2010, di Federico La Sala
Non è il Dio in cui credo
di Nandino Capovilla (Adista/Notizie, n. 64, 31 luglio 2010)
Tra catechismi e compendi, guide e sussidi, le nostre librerie non riescono nemmeno ad esporre tutta la produzione di tentativi per ridurre, semplificare e sminuzzare l’unico testo veramente consigliabile, la Parola di Dio. Tutti questi Bignami vogliono spiegarci chi è Dio e come rapportarci con lui, ma spesso esco sconcertato dalla libreria col dubbio che quello non sia il Dio in cui credo.
Tutti vorrebbero insegnarmi a pregare Dio, ma non credo vada trascurata anche la testimonianza di Raymond Devos che dice di aver incontrato, in un villaggio della Lozerè, Dio che stava pregando. "Mi son detto: chi prega? Non prega certo se stesso. Non lui, non Dio. Pregava l’uomo! Egli mi pregava. Pregava me! Metteva in dubbio me come io avevo messo in dubbio lui. Diceva: ’O uomo, se tu esisti, dammi un segno’. Ho detto: ’Dio mio sono qui’. Lui ha detto: ’Miracolo! Un’apparizione umana’". Ogni giorno, allora, cerco di "dare un segno" a Dio dalla mia giornata affannata, sapendo che Lui mi ha preceduto e mi precede sempre, che non ho bisogno di cercare le prove della sua esistenza, ma casomai purificare costantemente l’immagine di Dio che mi sta davanti.
Mi basterebbe in realtà tornare più frequentemente a quelle pagine intrise di lacerante sofferenza e gioiosa consolazione con cui Luca ci racconta chi è il nostro Dio attraverso il suo amarci e il suo ostinato legame con ogni uomo. Altro che Dio come l’assoluto che sa tutto e non è giustificato da nulla, imperscrutabile nella sua dimora divina e praticamente micidiale per l’uomo! Il Dio che racconta Gesù, l’unico che vale la pena di ascoltare, non è l’entità che sa tutto e può tutto, ma l’appassionato Padre che ci ama indipendentemente dalla nostra risposta. La grandezza del mio Dio non ha bisogno di spiegarsi perché io ne accetti l’esistenza, visto che da sempre lui stesso si è definito in rapporto a noi uomini e che dalla prima passeggiata nel giardino si è messo in agitazione per cercare Adamo e, in lui, anche me.
Così, ogni giorno e in ogni tempo, Dio ha cercato di convincerci della sua misericordia, della sua enorme bontà e assoluta inermità di fronte al nostro rifiuto. Il Padre prodigo di amore percorre tutti i giorni le strade di tutti gli uomini: cerca, bussa, chiede trafelato e stanco di essere ascoltato e capito nella sua paternità. È evidente che i due figli della parabola non hanno capito il loro padre. Uno ribelle e l’altro servo, non hanno saputo cogliere che il dono più grande è la libertà dei figli. Tra perdita e ritrovamento, il Padre si ritrova col cuore in gola finché non vede il figlio minore arrivare in fondo alla strada. Questo Dio è dunque sempre più altro rispetto a quello che i poteri politici e le ragioni di Stato stanno costantemente utilizzando.
Aspettiamo il giorno in cui la Chiesa, che si sente depositaria e custode della fede, alzerà forte la voce per fermare coloro che bestemmiano il nome di Dio confiscandolo a loro uso e consumo e facendo della sua storia una consuetudine popolare, una tradizione e una cultura.
Significativo è il modo in cui Luca introduce le tre parabole della misericordia: "Si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: ‘Costui riceve i peccatori e mangia con loro’”. Lo scandalo continua oggi, se siamo fedeli nel mostrare questo volto di Dio che fa saltare gli schemi e le norme acquisite solo col suo amore totalmente gratuito.
Perché allora non ci scuote la sofferenza di tanti per la rigidità di una Chiesa che giudica senza ascoltare, minaccia senza accogliere, condanna senza perdonare? E quanta strada dobbiamo fare per assomigliare a quel Padre che corse verso suo figlio "quando era ancora lontano"? Certo, abbiamo smesso di etichettare mezzo mondo con la categoria dei "lontani" ma non abbiamo ancora tolto il baricentro di questa ipotetica "vicinanza" a Dio dalla nostra Chiesa cattolica, e invece di andare noi verso i fratelli aspettiamo tranquilli che si convertano a noi e arrivino fin sulla porta a bussare.
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- L’iniziativa di "Famiglia Cristiana". la "Paroladidio" in versione rap. "Così la Bibbia entrerà in ogni casa" (di Orazio La Rocca).14 settembre 2010, di Federico La Sala
ATTUALITA’
 Internet, autogrill, versetti in rap
Internet, autogrill, versetti in rap
 "Così la Bibbia entrerà in ogni casa"
"Così la Bibbia entrerà in ogni casa"L’iniziativa di "Famiglia Cristiana". In distribuzione un milione di copie in formato tascabile con alcuni fra i più famosi brani dell’Antico e Nuovo testamento che si potranno ascoltare alla radio e sul web
di ORAZIO LA ROCCA *
CITTÀ DEL VATICANO - La Bibbia in rap. Non tutta la Bibbia. Ma solo alcuni tra i più famosi brani dell’Antico e del Nuovo Testamento che - su iniziativa del settimanale dei Paolini, Famiglia Cristiana - si potranno sentire nelle radio e via internet in una singolarissima versione rap dal titolo Paroladidio per il lancio della Bibbia Pocket, l’edizione tascabile del Libro dei Libri, che da giovedì prossimo, al prezzo di 7,90 euro, si potrà acquistare col settimanale in edicola. Ma la mini Bibbia (570 grammi appena) si troverà anche nelle librerie (sia laiche che religiose), nei supermercati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, negli autogrill, grazie ad una mega distribuzione che punterà a diffondere entro Natale oltre un milione di Bibbie.
AUDIO - ASCOLTA LA BIBBIA RAP
Una grande operazione editorial-commerciale ideata per celebrare i 50 anni di una analoga iniziativa fatta nel 1960 dal fondatore della Congregazione dei Paolini, il beato Giacomo Alberione, il quale per la prima volta promosse la diffusione del testo sacro con "La Bibbia a 1000 lire" allegata al settimanale. Dopo mezzo secolo l’operazione si ripete, spiega don Vito Fracchiolla, amministratore delegato del Gruppo editoriale San Paolo, ma con mezzi e modi assai diversi, a partire dall’uso di Internet, dagli spot radiofonici e dal "provocatorio" rap composto ed eseguito da anonimi professionisti in ossequio agli altrettanto anonimi autori delle Sacre Scritture.
La Bibbia, dunque, torna a proporsi al grande pubblico ad appena 2 anni dal successo centrato dalla "Lettura della Bibbia giorno e notte", ideata dallo storico vaticanista del Tg1 Giuseppe De Carli, recentemente scomparso, e trasmessa in diretta dalla Rai con l’intervento di Benedetto XVI lettore del primo libro della Genesi. Con la Bibbia rap non si prevedono benedizioni papali, ma - assicurano in Vaticano - l’operazione viene vista con "interesse e simpatia" con la speranza che l’iniziativa, oltre a coinvolgere le famiglie italiane, serva ad avvicinare in particolare i giovani, magari tramite proprio quel pezzo rappeggiante che, a prima vista, potrebbe far storcere la bocca a tradizionalisti e benpensanti. Eppure - assicura don Fracchiolla - "tutta l’operazione è stata fatta con scrupolo e serietà col preciso scopo di contribuire a diffondere un testo tanto importante, non solo per i credenti, come è la Bibbia".
Scrupolo e serietà con cui - giurano alla San Paolo - è stato fatto anche il pezzo rap che in apertura presenta il famoso incipit del Libro dell’Esodo "Io sono colui che sono/Questo è il mio nome per sempre/e questo è il mio ricordo...". Seguito da uno dei versi più poetici della Bibbia, il Salmo 64: "Hanno bocca e non parlano/hanno occhi e non vedono...". Non potevano mancare citazioni notissime e comunemente considerate in sintonia proprio con i ritmi rappeggianti come "Chi mi offende distrugge se stesso/tutti coloro che mi amano, amano la morte!" (Libro dei Proverbi), "O vanità immensa, o vanità immensa/tutto è vanità./ Una generazione va e una generazione viene....(Ecclesiaste). Per passare dal Prologo del Vangelo di Giovanni "La vita era la luce degli uomini, e le tenebre non la compresero". Testi biblici, in passato, ampiamente usati anche da grandi esponenti della musica pop come Bob Dylan, Bruce Springsteen, Bono degli U2, più volte ricordati dal ministro della Cultura del Vaticano, l’arcivescovo Gianfranco Ravasi, nell’incontro di papa Ratzinger con gli artisti del 2009.
-
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- "Il mercato di Dio. La matrice economica di ebraismo, cristianesimo ed islam" di Philippe Simonnot (di Tobia Zevi - Cristianesimo, la religione «monopolio di Stato»).23 agosto 2010, di Federico La Sala
Cristianesimo la religione «monopolio di Stato»
di Tobia Zevi (l’Unità, 22 agosto 2010)
È lecito parlare di Dio con le categorie della scienza economica? Secondo Adam Smith, il primo teorico del capitalismo moderno, sì. Nella Ricchezza delle nazioni (1776), il filosofo scozzese applica la teoria del mercato alla Chiesa, spingendosi a ritenere che questa si trovi in condizione di «monopolista». Ad un costo maggiore per i credenti e con una qualità peggiore del «prodotto». Smith considera la religione cristiana l’unica degna di fiducia, ma ritiene di poter compiere un’operazione che molti non esitano a definire blasfema.
Il terreno è evidentemente scivoloso, tanto che la pubblicazione de Il mercato di Dio - La matrice economica di ebraismo, cristianesimo ed islam (Fazi Editore, euro 18,50, pp. 338) di Philippe Simonnot ha provocato accese discussioni. L’autore chiarisce che «non si tratta affatto di pretendere di spiegare la religione attraverso l’economia» ma «più modestamente di mettere a disposizione della scienza religiosa gli strumenti dell’analisi economica», e tuttavia il suo approccio si attira necessariamente l’accusa del massimo relativismo culturale possibile. Il volume rilegge dunque i testi sacri delle tre religioni monoteistiche e interpreta i fatti con i principi della scienza economica.
Per l’Ebraismo, nella quasi totale assenza di fonti storiografiche, prevale la prima componente. Per il Cristianesimo e per l’Islam le fonti sono più numerose e ciò rende la teoria più chiara. Il punto di partenza è questo: le religioni sono un bene di «credenza» potenzialmente inesauribile.
L’utente non ne può verificare la correttezza, giacché la Verità si trova necessariamente al di fuori dell’esperienza umana, e pertanto la chiave del successo di una confessione è la sua credibilità, cioè la sua capacità di attrarre più fedeli possibile. Solo lo Stato può garantire il monopolio di una religione, contrattando con essa l’entità delle donazioni che può essere sottratta alla tassazione pubblica.
Abramo è il primo ebreo. Secondo Simonnot, la sua storia testimonia la necessità di controllare il bene più prezioso, la terra. La circoncisione, sugello del patto tra Dio ed Abramo, serve esattamente allo scopo: la proprietà fondiaria è limitata e l’accesso va dunque riservato ad un gruppo ben definito, il popolo eletto, così come la gran quantità di matrimoni tra membri della stessa famiglia riduce le contese territoriali. L’Ebraismo ha bisogno di accreditarsi di una tradizione precedente, e per questa ragione s’impadronisce dei santuari delle più antiche divinità cananee.
Quando il «prodotto» ebraico mostra segnali di crisi, ecco la comparsa del Cristianesimo che fa propria la figura di Abramo, mostrandosi contemporaneamente molto antico e molto nuovo. Inoltre i seguaci di Gesù mirano alla conquista di Roma, e per ottenerla rinunciano alla circoncisione e alle rigide normative alimentari ebraiche.
Se il Tempio di Gerusalemme era stato il centro religioso, statale ed economico della nazione ebraica, i cristiani impiegheranno tre secoli per conquistare la capitale dell’Impero. Grazie all’esaltazione della castità, del tutto inedita, la Chiesa si arricchisce di una gran quantità di patrimoni che perdono i loro eredi naturali.
L’Islam, infine, si richiama anch’esso ad Abramo, dichiarandosi discendente di Ismaele anziché di Isacco. L’identificazione tra la umma, la comunità dei fedeli, e lo Stato è assolutamente immediata, e a tutti coloro che non vogliono convertirsi viene imposto un tributo di protezione.
Pur non elaborando un sistema fiscale paragonabile alla decima ebraica poi mutuata dal Cristianesimo, l’Islam considera l’elemosina - essenziale per il suo sostentamento - una componente fondamentale della vita del fedele. Se la conquista di Gerusalemme, con l’edificazione della Moschea, fu la vittoria principale riportata dall’Islam nei confronti dei due contendenti, la mancata conquista di Costantinopoli prima del quindicesimo secolo costituì a lungo un punto di debolezza.
Un’analisi di questo tipo, lungi dall’esaurire il discorso sulla religione, ha però il merito di proporre una visione innovativa con un tono mai provocatorio, soffermandosi su aspetti in gran parte poco conosciuti.
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- E Re Mida li rese tutti somari (di Laura Pariani).5 agosto 2010, di Federico La Sala
E Re Mida li rese tutti somari
«La festa della Gloriosa Asinità vide nella capitale un grande tripudio di folla festante. In testa ognuno esibiva copricapi di lunghe orecchie frementi»
di LAURA PARIANI (Avvenire, 05.08.2010) *
I giunchi degli stagni frigi cantavano: «Re Mida ha le orecchie d’asino». Il vento ne acchiappò la voce e propagò la notizia tra i boschi di olivi e di mandorli dolci, nei giardini di rose che emanavano la loro fragranza sotto la stella luminosa della sera. Per tutto il paese ormai non c’era persona che non sapesse il motivo per cui re Mida in pubblico si mostrasse sempre con un copricapo frigio dalle alte punte.
«Il re ha le orecchie d’asino» dicevano le serve nei mercati, mentre riempivano i panieri di focacce con le olive; e ridacchiavano pensando alle orecchie d’asino che i maestri mettono in testa agli scolari che difettano di comprendonio. «Re Mida è un asino» ghignavano i vecchi seduti all’ombra del grande fico della piazza, scuotendo il capo perché mettersi contro un dio potente come Apollo era stata proprio un’asinata che poteva meritare solo quella punizione.
E qualcuno si azzardava perfino a dire che pure quel tal barbiere, che non era riuscito a tenere il segreto per sé e aveva pensato di liberarsene scavando una buca e confidando alla sua profondità la verità scoperta sulla testa del re Mida, era stato un campione di asineria, per cui giustamente aveva pagato con la morte il poco senno.
«La gente ride di me, hi ha hi ha ...» ripeteva disperato re Mida nel chiuso delle sue lussuose stanze, agitando invano gli aliossi per cacciare i cattivi pensieri. I lacrimatoi d’oro massiccio traboccavano dei suoi pianti. Finché, una notte di mezzaluna, gli venne un’ispirazione... Di buon mattino mandò a chiamare il capo della società mercantile, il sommo sacerdote, la tenutaria del bordello più famoso e il comandante delle sue guardie. La riunione con i quattro personaggi gli portò via molte ore, ma al sopraggiungere della sera gli occhi di re Mida brillavano di una fredda luce di vendetta.
«Popolo mio» disse quella notte affacciandosi al buio dal suo balcone, «ricordati che di un re, hi ha hi ha, non si ride». L’indomani mattina nel tempio, all’ora in cui i fedeli erano intenti alle loro preghiere offrendo alle divinità crateri di vino, giare di latte e corone di rose, il sommo sacerdote tenne ai devoti questo discorso: «Lunga vita a re Mida che onora il tempio con la sua protezione, nonché con offerte di cera vergine e di arredi preziosi».
E, nel dire questo, mostrò gli anelloni d’oro che il re aveva quel mattino stesso inviato perché reggessero intorno all’ara sacra le grandi torce di pino. «Re Mida ha le orecchie d’asino. E questo è un prodigio da vantare, non da tenere nascosto. Sappiamo tutti quanto il cane sia adulatore, il gatto infido, il lupo crudele, la volpe opportunista, la colomba lasciva, il leone prepotente. Ben venga dunque la testa coronata dell’asino, animale mite e contemplativo... Con ciò arrivo a auspicare che tutti gli uomini pii dovrebbero porsi l’obiettivo di varcare la santa soglia dell’asinità. Che tutti ponderino le mie parole e nessuno sia fiero delle sue piccole orecchie».
Un’ora dopo, mentre i soldati effettuavano il cambio della guardia davanti al palazzo reale, il comandante della guarnigione fece suonare le trombe d’oro e lesse personalmente un proclama alla folla che sempre si riuniva ad ammirare la parata:
 «Lunga vita a re Mida, valoroso difensore di questa città e del suo popolo. Che Re Mida abbia le orecchie d’asino, è un grande orgoglio per noi soldati. Infatti quale cosa è più degna del fatto che un maschio inasinisca? Solida è l’asinità, possente il suo raglio: hi ha, hi ha, una manifestazione sonora ruvida, viscerale, inconfondibilmente virile: tuono di gran patria... Per non parlare della forza micidiale del calcio e del morso asinino».
«Lunga vita a re Mida, valoroso difensore di questa città e del suo popolo. Che Re Mida abbia le orecchie d’asino, è un grande orgoglio per noi soldati. Infatti quale cosa è più degna del fatto che un maschio inasinisca? Solida è l’asinità, possente il suo raglio: hi ha, hi ha, una manifestazione sonora ruvida, viscerale, inconfondibilmente virile: tuono di gran patria... Per non parlare della forza micidiale del calcio e del morso asinino».E facendo schioccare per aria la lunga frusta di cuoio che portava legata alla cintura, il comandante scandì lentamente la conclusione: «Che tutti ponderino le mie parole e nessuno sia fiero delle sue piccole orecchie».
Al mercato, nell’ora rovente in cui i cuochi arrostivano su graticci fegatelli col miele, tordi alla salvia e cosciotti di capretto lardellati, il capo dei mercanti della capitale parlò ai suoi compari, dopo aver offerto a tutti i convenuti formaggini freschi freschi, che recavano ancora i segni dei canestrini di vimini, accompagnati da vino di Samo conservato in otri odorosi di pelle di capra.
«Lunga vita a re Mida» disse, «che onora i mercanti difendendo le invenzioni locali come quelle del nostro Marsia, contro i prodotti stranieri. Lunga vita al re che mi ha onorato della sua amicizia». E nel dire questo mostrò come sulla sua tunica di lana bianca ricamata di fili d’oro e d’argento splendesse un’onorificenza nuova di zecca.
«Re Mida ha le orecchie d’asino. È questo il segno della fortuna del suo governo. Sappiamo tutti quanto gli asini siano affidabili nel trovare la strada giusta, tanto più che a quanto dicono ce ne sono alcuni che sanno perfino cacare oro. Insomma, l’asino è il socio ideale per noi mercanti. Che tutti ponderino le mie parole e che nessuno sia fiero delle sue piccole orecchie».
Appena scesa la notte, mentre si aprivano le porte del maggior bordello della città, la tenutaria riunì intorno a sé le venditrici d’amore e tenne loro questo discorso: «Lunga vita al re che apprezza le suonatrici di flauto dalle labbra succulenti, le giovani danzatrici dai seni sodi come mele cotogne, i giovanotti profumati di lavanda e coronati di viole. Lunga vita al re che sa essere generoso con chi sa offrire notti felici e cosce depilate per il piacere del tatto o della vista».
E, sollevato il lembo della tunica di porpora di Tiro e la sottoveste di garza trasparente mostrò una cavigliera d’oro che mostrava lo stemma regale. «Re Mida ha le orecchie d’asino. È pregio da vantare, non da tenere nascosto...Felici noi, se tutti i nostri uomini, toccati dall’alito di Afrodite, mostrassero gli stessi attributi. Che tutti ponderino le mie parole e che nessuno sia fiero delle sue piccole orecchie».
La festa della Gloriosa Asinità, proclamata da re Mida nella settimana successiva, vide nella capitale un grande tripudio di folla festante. In testa, al posto delle solite corone di mirto o di lauree fronde, ognuno esibiva copricapi di lunghe orecchie frementi: intrecciate di paglia bionda per i popolani, di cuoio rosso persiano per i padroni di botteghe, di stoffa tinta di croco per le ragazze più avvenenti. Il tutto tra danze sfrenate, punta tacco punta tacco, e voci squillanti in un delirio: «Lunga vita a re Mida, hi ha, hi ha!».
*
IL MITO
Re Mida è legata a due miti, quello più conosciuto, che racconta della sua straordinaria capacità di trasformare tutto in oro, dono effimero e «scomodo»; e un secondo che racconta della punizione ricevuta da Apollo, il quale gli fa crescere le orecchie d’asino, perché durante una gara musicale con il dio Pan non lo nomina vincitore. È solo il barbiere del re a conoscere questo segreto, che però non deve rivelare a nessuno, pena guai seri. Ma il barbiere, non potendo parlare con nessuno, decide di confidare il segreto alla terra. Scava una buca cui confida ciò che sa. Il resto lo fanno le canne che crescono dove il segreto è sepolto, così che il vento lo sussurra e lo fa sapere a tutti. Il primo a parlare di Re Mida è Erodoto, ma questa figura approda anche tra i romani: Ovidio racconta i due miti nelle «Metamorfosi».
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! --- LA NUOVA ALLEANZA, L’ALLEANZA ATEO-DEVOTA. Chiesa-politica-denaro (di don Aldo Antonelli - Ménage à trois).15 giugno 2010, di Federico La Sala
Ménage à trois
di don Aldo Antonelli
"Quando in un dato Paese o in dato momento della storia, vedo che gli applausi piovono, che la Religione è onorata da tutti e che Dio come la Chiesa hanno un grande successo, ogni spirito prudente e veramente ispirato dalla fede sarà non già tranquillo, come sovente siamo stati, ma inquieto, temendo che sia qualche specie d’idolo che si adora al posto del vero Dio, e che sia qualche deformazione della religione ad avere un tale successo"! Così il card. John H.Newman già negli anni del secondo ottocento (Pensées sur l’eglise). Chissà cosa direbbe oggi...!
Fatto sta che se il dio di Bossi e di Berlusconi è un idolo (e lo è!) allora la chiesa che lo ostenta e che convive con la Lega e il Pdl non è una chiesa ma una setta.
E i cristiani che essa genera benedice e difende più che cittadini del mondo, quali dovrebbero essere i veri figli di Dio, sono semplicemente adepti di una setta, come i massoni o gli iscritti alla P2.
Culto del capo, obbedienza cieca e ritualità fine a se stessa sono i pilastri cardine di questo nuovo modo di essere cristiani e di fare politica. Il tutto abbondantemente annaffiato da pioggia di danaro e propagandado dalle reti uniticate raimediaset.
In questo ménage à trois (chiesa-politica-denaro) Berlusconi ruba, Bagnasco assolve e il bottino viene equamente diviso.
Il popolo bue guarda, ammira e plaude.
Aldo
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ... RETTIFICARE I NOMI. --- «M»ILLION, NON «B»ILLION. Wall Street, il crollo del Dow Jones, per colpa di un refuso in un ordine.7 maggio 2010, di Federico La Sala
 APERTA UN’INDAGINE INTERNA
APERTA UN’INDAGINE INTERNA Wall Street, il crollo del Dow Jones
Wall Street, il crollo del Dow Jones
 per colpa di un refuso in un ordine
per colpa di un refuso in un ordine Un operatore avrebbe digitato una «b» di billion al posto di una «m» di million. Chiusura: Dow Jones -3,26% *
Un operatore avrebbe digitato una «b» di billion al posto di una «m» di million. Chiusura: Dow Jones -3,26% *NEW YORK - Possibile che Wall Street bruci nel giro di quindici minuti i guadagni accumulati in oltre un anno di contrattazioni? Possibile. Ma soltanto per poco: 15 minuti di paura che rischiavano di costare carissimi agli equilibri della finanza mondiale, già fin troppo scossi in questi giorni. Il crack non era vero. O meglio, il crollo era vero, reale e stava per essere fatale. Ma non c’era motivo perché avvenisse. La causa, infatti, era in un errore di trascrizione, o trasmissione di un dato.
«M»ILLION, NON «B»ILLION - Alla fine Wall Street ha tirato un sospiro di sollievo, ma con una prova della propria fragilità che può far tremare i polsi. L’indice Dow Jones, infatti, in quei 15 minuti ha perso ben 700 punti, crollando 100 punti sotto i 10mila. Per le statistiche, sarebbe stato il crollo più forte dal 2008. Sarebbe stato, perché, mentre il panico si scatenava tra gli operatori , qualcuno è riuscito a capire che quella folle corsa a vendere era stata causata da un «refuso», un errore di scrittura di un trader nell’ordine di vendita. Lo spiega la Cnbc, secondo cui l’operatore distratto avrebbe digitato una «b» di billion al posto di una «m» di million mandando in tilt il sistema ma, soprattutto, facendo scattare il panico sui mercati di tutto il mondo.
Secondo alcune fonti, CitiGroup avrebbe aperto un’inchiesta interna sull’accaduto, cosa che fa pensare che sia un operatore di quel gruppo a causare il costosissimo errore. Il Nasdaq ha avviato una sua inchiesta interna per stabilire eventuali errori negli scambi fra le ore 14.40 e le 15.00 di new York. Le conseguenze dell’episodio, dal punto di vista delle procedure, saranno da valutare. Dal punto di vista del mercato, per fortuna, glin operatore, tirato un sospiro di sollievo, hanno subito quasi riassestato l’indice della Borsa Usa: dalle 15 alle 15.20, il Dow Jones ha recuperato 600 punti. Non abbstanza però per non ristentire del contraccolpo: la chiusura ha fatto segnare un -3,26%.
 Redazione online
Redazione online* Corriere delal Sera, 06 maggio 2010 (ultima modifica: 07 maggio 2010)
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- La bandiera vaticana (di Adriano Prosperi).23 marzo 2010, di Federico La Sala
La bandiera vaticana
di ADRIANO PROSPERI *
Le elezioni sono alle porte e la Chiesa italiana ha parlato: o meglio, ha parlato la Cei per bocca del cardinal Bagnasco. La precisazione è d’obbligo: è possibile che una sola voce riesca ad esprimere la quantità e la qualità delle posizioni che si muovono nella realtà del mondo cattolico?
Ci si chiede anche se le elezioni amministrative siano un’occasione di tale importanza da imporre che si levi in modo speciale la voce di un’autorità morale e spirituale come la Chiesa nella sua espressione gerarchica, obbligata dalla sua stessa natura a essere al di sopra delle parti . E non intendiamo levare la pur sacrosanta protesta di chi chiede che le autorità ecclesiastiche si astengano dalla lotta politica: anche se si potrebbe - e forse si dovrebbe, visti i tempi - ricordare ai vescovi che ci sono tante occasioni di urgenze grosse e di scandali clamorosi davanti ai quali la loro voce dovrebbe trovare il coraggio di levarsi. Lo stato morale del Paese è disastroso. C’è una corruzione che ha invaso - partendo dall’alto - anche i più remoti angoli dove si dà esercizio del potere. È cosa recentissima la pubblicazione del rapporto annuale dell’agenzia internazionale per il monitoraggio dello stato dei diritti umani nel mondo: e lì abbiamo letto note ben poco confortanti per il nostro Paese. Che cosa può fare un vescovo in questa situazione?
I modelli di vescovi che hanno saputo affrontare senza paura i potenti per esercitare il loro compito di pastori di anime e di guide di coscienze non mancano certo nella millenaria storia della Chiesa: il gesto di ripulsa e di condanna di Sant’Ambrogio davanti all’imperatore Teodosio fondò il diritto del vescovo di Milano a guidare il suo popolo. Non sono più tempi così drammatici, penserà qualcuno. Eppure l’appello del cardinal Bagnasco ha un tono di una certa drammaticità. Anche se nel suo discorso sono stati toccati diversi problemi, nella sostanza uno domina su tutti gli altri. Gli elettori sono stati invitati a seguire nella scelta elettorale la bussola della questione dell’aborto.
Ora, la domanda che si pone è se questo è veramente il problema dei problemi, quello per cui sta o cade la società. Si dice che questa funzione è quella che prima di tutte le altre appartiene alla Chiesa: la difesa della vita. Bandiera nobile, se altre ce ne sono. La vita umana va difesa. Su questo siamo tutti d’accordo. Ma allora bisogna essere conseguenti e andare fino in fondo. Prendiamo un caso: sono passati appena pochi giorni da un episodio gravissimo: una madre ha partorito in una stazione di sport invernali dove lavorava, sulla neve dell’Abetone. Aveva un permesso di soggiorno legato al suo posto di lavoro. Ha nascosto il parto, il neonato è morto soffocato. Un’immigrata non può avere figli senza rischiare di perdere il lavoro: è l’effetto di una legge approvata da un governo di centrodestra che si vanta di avere il consenso degli italiani. E l’appoggio della Chiesa a questo governo produce ogni giorno effetti devastanti.
Noi non sappiamo quanti siano gli aborti clandestini che si praticano in Italia. Fu per affrontare la piaga dell’aborto clandestino che fu varata la legge 194. E l’effetto si è visto. Era un modo civile di affrontare una piaga antica, ben nota alle autorità ecclesiastiche. Per secoli l’arma della scomunica non ha impedito che nel segreto delle famiglie si eliminassero i figli indesiderati laddove le ferree catene del bisogno imponevano di non aumentare le bocche e di non avere figlie femmine. Allora la scomunica non colpiva i colpevoli della iniqua distribuzione delle risorse. E ancora oggi la condanna ecclesiastica non colpisce coloro che hanno varato quella legge che provoca lutti e dolori, che impedisce alle donne immigrate di avere figli. Né colpisce le forze politiche che non hanno a cuore la tutela della famiglia e che dedicano tutta la loro forza a sottrarre alla legge un presidente del Consiglio invece di varare una riforma fiscale che introduca il quoziente famiglia. Invece basta un normale appuntamento elettorale perché si ripeta ancora lo stanco spettacolo di un’autorità ecclesiastica che si schiera a favore di una parte politica contro un’altra. È un rito vecchio, logorato dall’uso, ripetitivo, facilmente decifrabile. Siamo a una scadenza elettorale resa inquieta dal silenzio della televisione di Stato, assurdamente determinata a lasciare i cittadini in una condizione di dubbio e di perplessità. Sono semplici elezioni amministrative. Non è in gioco la sorte del governo. Si tratta di scegliere i candidati più credibili per affidare loro l’amministrazione di regioni e città. Ci aspettavamo di essere messi in grado di scegliere serenamente sulla base dei profili dei candidati e del contenuto dei loro programmi. Ma di programmi è stato molto difficile parlare.
Il confronto è stato oscurato dall’episodio della clamorosa incapacità del più potente partito italiano di mettere insieme una lista di candidati e di farla pervenire alla scadenza dovuta davanti all’ufficio competente. Una manifestazione di piazza ha costruito lo spettacolo televisivo per raggiungere in un colpo solo tutti gli elettori. Ma forse anche questo spettacolo rischiava di non essere efficace. E allora, che altro si poteva fare per dare una mano al Pdl e combattere la candidatura di Emma Bonino nel Lazio?
© la Repubblica, 23 marzo 2010
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ----- IL "PANE QUOTIDIANO" DEL "PADRE NOSTRO" VENDUTO SEMPRE PIU’ A "CARO-PREZZO"("CARITAS"), DA PAPA BENEDETTO XVI E DA TUTTI I VESCOVI DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA.6 novembre 2009, di Federico La Sala
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ----- IL MERCATO DI DIO. LA MATRICE ECONOMICA DI EBRAISMO, CRISTIANESIMO, ISLAM (di Philippe Simonnot - rec. di Paolo Mieli).13 gennaio 2010, di Federico La Sala
Le fedi come le aziende aspirano al monopolio
di Paolo Mieli (Corriere della Sera, 12 gennaio 2010)
In principio fu Adam Smith con il suo celeberrimo trattato di economia politica La ricchezza delle nazioni (1776). Il filosofo economista scozzese per primo analizzò la Chiesa come un’entità economica e applicò ad essa le categorie che traeva dalla propria disciplina, in particolare quella di monopolio, cioè quel regime che inevitabilmente produce un aumento del prezzo e un abbassamento della qualità per il solo fatto che il mercato non è stimolato dalla concorrenza.
Discorso che vale anche per la Chiesa. Una religione «ben costituita», secondo il padre fondatore dell’economia politica, non sfugge alla regola: il prezzo del «prodotto» è più elevato e la sua qualità minore di quel che sarebbero se ci fosse libera competizione. Di più. In genere il clero «non ha altra risorsa che rivolgersi al magistrato civile perché persegua, distrugga o scacci i suoi avversari come disturbatori della pace pubblica». Fu così, osserva Adam Smith, «che il clero cattolico romano si rivolse al magistrato civile per perseguitare i protestanti; la Chiesa d’Inghilterra per incalzare i dissidenti; e che in generale ogni setta religiosa, una volta goduta per uno o due secoli la sicurezza di una istituzione legale, si è trovata incapace di difendersi efficacemente contro qualsiasi nuova setta decisa ad attaccare la sua dottrina o disciplina».
È da questo passo che prende le mosse un libro assai interessante di Philippe Simonnot, Il mercato di Dio. La matrice economica di ebraismo, cristianesimo, islam che, nella buona traduzione di Giuliano Gasparri, l’editore Fazi si accinge a mandare in libreria di qui a qualche giorno.
Nella prefazione al volume, Marco Aime avverte che l’approccio «per nulla scontato» di Simonnot può comportare accuse di vilipendio o addirittura di blasfemia che però l’autore - pur procedendo sul terreno scivoloso di un’analisi solo e soltanto economica della genesi e del consolidamento delle tre grandi religioni monoteiste del mondo mediterraneo- ha saputo evitare stando bene attento a non cedere mai al gusto della provocazione.
«A scanso di equivoci», scrive Simonnot, «qui non si tratta affatto di pretendere di spiegare la religione attraverso l’economia, né di riciclare le teorie dell’oppio dei popoli, ma più modestamente di mettere a disposizione della scienza religiosa gli strumenti dell’analisi economica». Un po’ quel che, in campo sociologico, fece August Comte nell’Ottocento. Senza aver la pretesa, ovviamente, di paragonare Comte a Simonnot.
E se L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber ha esaminato l’incidenza della religione sull’economia o la dottrina economica implicitamente o esplicitamente sottesa a una credenza, «almeno altrettanto istruttivo», afferma l’autore, «è studiare l’economia propriamente detta della religione, ossia prendere la religione come un qualcosa suscettibile di analisi economica». Così la religione viene presentata come un’«azienda» che offre «beni di credenza», la cui qualità si basa sulla fiducia riposta in chi li produce dal momento che il risultato della pratica religiosa- cioè la salvezza eterna - non è, per sua natura, né verificabile né falsificabile. E poiché il «valore» di un bene di credenza riposa interamente sulla credibilità del suo fornitore, se ne può dedurre «che difficilmente quest’ultimo tollererà la presenza di un concorrente rivale, il quale vorrà per forza mettere in dubbio la sua credibilità per affermare la propria». Ad un tempo, per entrare nel «mercato», una religione «deve apparire come molto nuova, naturalmente, per attrarre nuovi "clienti", ma anche molto antica, per rassicurarli, dato che la longevità sembra essere una garanzia di qualità di questo ramo... Così il cristianesimo del I secolo, pur essendo nuovo, ha sostenuto la propria anteriorità rispetto all’ebraismo, ricollegandosi direttamente ad Abramo; e l’islam ha fatto esattamente la stessa cosa sei secoli più tardi».
Ma perché Simonnot si concentra in questo libro sui tre monoteismi venuti da Abramo? «Quel che colpisce subito uno sguardo privo di pregiudizi», risponde lui stesso, «è che un Dio unico funziona più facilmente da mediatore finanziario per coloro che lo servono rispetto a una moltitudine di Dei che si fanno concorrenza. In primo luogo perché il Dio unico permette di risolvere più facilmente il problema centrale di ogni religione, cioè quello della sua credibilità. Certo il Dio che appare nella Bibbia si mostra spesso crudele, terribile, parziale e geloso, ma è meno imprevedibile, più affidabile degli Dei capricciosi e immorali che si trovano nello stesso momento sul "mercato". Forse era ragionevole offrire di tanto in tanto agli altari pagani dei sacrifici di cui i sacerdoti prendevano una parte, ma si poteva scegliere tra molte divinità e, se non si otteneva ciò che si desiderava, si poteva cambiare culto.
Nel monoteismo, invece, si ha a che fare sempre con lo stesso Dio. Un Dio, per giunta, universale, il cui sguardo vi può seguire dappertutto sulla terra... Per di più gli Dei non sembrano preoccuparsi degli affari umani se non in funzione dei propri interessi, mentre il Dio della Bibbia si occupa del suo popolo in modo costante».
Ma veniamo all’analisi specifica di Simonnot. A suo dire si applica bene alla religione la legge di Metcalf (da Robert Metcalf, un imprenditore statunitense, inventore di Ethernet, secondo il quale il valore di una rete di computer cresce in proporzione all’aumento dei computer connessi): il valore che un consumatore attribuisce a un bene - nel nostro caso un credo religioso - dipende anche dal numero di utenti di questo bene: una religione ha tanto più «valore» per il credente, è cioè tanto più credibile, quanto più grande è il numero dei suoi fedeli.
Per quel che riguarda, poi, il reperimento delle risorse «vi sarebbe, soggiacente a ogni società, un giacimento finanziario costituito da somme, piccole o grandi, che brave persone sono pronte a donare per la salvezza della propria anima, per la propria sanità mentale o per qualsiasi altro obiettivo; dato che la divisione del lavoro aiuta, si costituiscono "compagnie" per esplorare, trivellare e sfruttare questo giacimento. Ciò presuppone che l’economia interessata sia in grado di sviluppare un surplus. Il giacimento non è estensibile all’infinito, anche se, a condizione di non toccare il capitale, è indefinitamente rinnovabile. Ogni luogo di culto, anche la più umile parrocchia, può dunque essere considerato come una torre di trivellazione... Ogni religione cerca di allacciarsi a questo giacimento favoloso e, se ci riesce, di assicurarsene il monopolio su un dato territorio».
Ma il flusso delle donazioni non è regolabile e spesso nella storia delle religioni si nota che esso genera un’eccedenza. Mosè, secondo la Bibbia, dovette mettere fine alla colletta promossa per costruire il santuario di Yahweh dal momento che il popolo portava «molto di più» di quel che era necessario per eseguire l’opera voluta dal Signore; sulla parete sud del tempio funerario di Ramsete II a Medinat Habu (in Egitto) compare un elenco di offerte che dovevano essere portate nei diversi momenti dell’anno in quantità tale che è impossibile pensare venissero ammucchiate sull’altare.
Ed è ancora Adam Smith a osservare che «il clero non poteva trarre vantaggio da questa immensa eccedenza se non impiegandola nella più prodiga ospitalità e nella più grande carità». Stando a Smith, dunque, le due più importanti istituzioni della Chiesa nel Medioevo erano dovute non tanto a virtù evangeliche quanto alla necessità di smaltire un surplus di donazioni.
Ma torniamo al tema di partenza, che è quello del monopolio. Il monopolio, scrive Simonnot, non può esistere senza l’intervento diretto o indiretto dello Stato, il quale dispone della forza per mettere barriere all’ingresso di un mercato, «e di fatto, nella storia, ogni monopolio religioso si è appoggiato all’autorità pubblica, oppure se ne è appropriato». Ma quando, ciò che è inevitabile, il monopolio che poggia sullo Stato abuserà della propria posizione, sorgeranno dei concorrenti sia all’interno della Chiesa - chiamati riformatori, scismatici o eretici (i protestanti nel cristianesimo del XVI secolo) - sia all’esterno con la comparsa di nuove religioni: ad esempio l’islam nel VII secolo.
Di qui si potrebbe anche immaginare una sorta di «ciclo» religioso che si riproduce all’infinito: «In un mercato aperto alla concorrenza, una religione tende al monopolio; questo monopolio non può che poggiare sullo Stato; una volta che poggia sullo Stato, abusa della propria posizione; il prodotto scade; compaiono altre religioni con il che si torna alla situazione di concorrenza». E di qui riparte il ciclo. Il papato, puntellato dall’impero, in alcuni momenti della storia è stato di fatto una delle più grandi potenze finanziarie del mondo, che attirava i banchieri più influenti, scrive Simonnot: i Medici, i Fugger, i Rothschild. Per la legge di cui sopra questo gigantesco monopolio è stato, però, contestato e messo in crisi; con il che il «mercato» religioso è tornato successivamente ad essere pienamente aperto alla concorrenza.
C’è un momento, inoltre, in cui l’influenza economica dell’istituzione religiosa entra in concorrenza con quella dello Stato. Anche di questo aveva parlato Adam Smith: «L’entrata di ogni chiesa costituita», scrisse, «è una parte dell’entrata generale dello Stato che viene così distratta per uno scopo molto diverso da quello della sua difesa. La decima ad esempio è una vera imposta fondiaria che impedisce ai proprietari terrieri di contribuire alla difesa dello Stato nel modo generoso che sarebbe loro altrimenti consentito. Tuttavia secondo alcuni la rendita della terra è l’unico fondo e secondo altri il fondo principale con il quale in tutte le grandi monarchie si deve fare fronte alle esigenze dello Stato. Evidentemente quanto più di questo fondo viene dato alla Chiesa, tanto meno può essere riservato allo Stato. Si può benissimo affermare come massima certa che, a parità delle altre condizioni, quanto più ricca è la Chiesa, tanto più poveri devono essere necessariamente il sovrano da un lato e il popolo dall’altro; e, in tutti i casi, tanto meno lo Stato sarà in grado di difendersi».
Simonnot colloca il momento in cui inizia la concorrenza tra Stato e Chiesa nel XII secolo, cioè quando si stabilisce una relazione diretta tra tasse pagate al fisco e decime per la Chiesa: tanto più alte sono le prime, tanto minori saranno le seconde e viceversa. A suo avviso, «una sorta di legge fisica faceva dunque prevedere con otto secoli di anticipo quel che sarebbe avvenuto al fisco dello Stato quando le rendite del papato si sarebbero ridotte al minimo».
Se è vero che nel XX secolo il fisco ha lasciato alla Chiesa solo una porzione «congrua», si può in qualche modo asserire che lo Stato-provvidenza ha preso il posto della carità cristiana. A questo punto il potere pubblico comincia a vedere nelle Chiese e nelle sette dei rivali in materia di direzione delle anime ma anche (e, forse, soprattutto) dei concorrenti fiscali. Lo Stato, in questa nuova situazione, preferisce di gran lunga avere a che fare con «cartelli» religiosi o con un monopolio con cui può stabilire un modus vivendi piuttosto che con una moltitudine di sette incontrollabili. Ed è di qui che nascono le politiche concordatarie.
Per parte sua un monopolio religioso, se vuole durare, ha un disperato bisogno di appoggiarsi allo Stato «in quanto difficilmente può soddisfare la "domanda" di religione in tutte le sue sfaccettature». Se, proviamo a supporre, «il grosso della "clientela" è soddisfatto di una qualità media a un prezzo medio, alle estremità della scala delle preferenze religiose si trovano in "alto" dei "consumatori" molto devoti che sarebbero disposti a pagare molto più caro un prodotto di migliore qualità e in basso, al contrario, dei "clienti" che si accontenterebbero di un prodotto mediocre a un prezzo più contenuto. Questa diversità di gusti e di esigenze obbliga il monopolio, se vuole durare, ad ampliare la gamma dell’offerta per soddisfare tutti».
Così fu per la Chiesa cattolica quando si trovò in condizioni di monopolio: severi e rigorosi ordini monastici permettevano di rispondere ai clienti più esigenti, mentre i «parrocchiani della domenica» potevano limitarsi a fare la comunione a Pasqua. Ma quando l’appoggio dello Stato venne meno e il «mercato» religioso si aprì alla concorrenza, «allora questa vasta gamma fu più difficile da coprire e il vecchio monopolio venne attaccato alle due estremità». E da allora il fenomeno si è riprodotto più volte: in basso «vaghe credenze cercano di recuperare i "parrocchiani della domenica" con religioni o filosofie da ciarlatani»; in alto, «alcune sette giungono a offrire nuovi "prodotti" più rigorosi che riescono a vendere ad alto prezzo e questo prezzo, ovvero i sacrifici richiesti in tempo e denaro, diventano persino una sorta di garanzia di qualità».
In seguito le sette, «una volta piazzate nella propria nicchia cercheranno di ampliare la "clientela" abbassando insieme il prezzo e le proprie esigenze; non tutte ci riescono, naturalmente; ma quelle che arrivano ad estendersi diventano a loro volta Chiese, cercando di approfittare delle tendenze monopolistiche dell’economia locale».
Le espressioni di Simonnot sono volutamente quelle che si usano nel linguaggio economico e l’autore tiene a ripetere che in esse non c’è - o quantomeno non vuole esserci - niente di offensivo o riduttivo. Neanche quando scrive che «la nascita del cristianesimo è avvenuta, se così possiamo dire, conformemente a questo business model; la setta è diventata una Chiesa». Per poi aggiungere: «Possiamo anche immaginare che delle Chiese tornino ad essere sette, abbandonando le frange più lassiste della propria "clientela" e concentrandosi sui propri membri integralisti». Un discorso che ha molte implicazioni. Per la storia ma anche per l’oggi.
-
> "Deus caritas est". ---- Visita alla Sinagoga: Indietro non si torna. Benedetto XVI: “se riusciremo ad unire i nostri cuori e le nostre mani per rispondere alla chiamata del Signore, la sua luce si farà più vicina per illuminare tutti i popoli della terra”.18 gennaio 2010, di Federico La Sala
VATICANO - Benedetto XVI in visita alla Comunità Ebraica di Roma: “se riusciremo ad unire i nostri cuori e le nostre mani per rispondere alla chiamata del Signore, la sua luce si farà più vicina per illuminare tutti i popoli della terra” *Città del Vaticano (Agenzia Fides) - “Cristiani ed Ebrei hanno una grande parte di patrimonio spirituale in comune, pregano lo stesso Signore, hanno le stesse radici, ma rimangono spesso sconosciuti l’uno all’altro. Spetta a noi, in risposta alla chiamata di Dio, lavorare affinché rimanga sempre aperto lo spazio del dialogo, del reciproco rispetto, della crescita nell’amicizia, della comune testimonianza di fronte alle sfide del nostro tempo, che ci invitano a collaborare per il bene dell’umanità in questo mondo creato da Dio, l’Onnipotente e il Misericordioso”. E’ l’esortazione del Santo Padre Benedetto XVI pronunciata nella Sinagoga di Roma, nel corso della visita alla Comunità ebraica romana, domenica 17 gennaio.
Il Pontefice ha ricordato la precedente visita di Papa Giovanni Paolo II, il 13 aprile 1986, che “intese offrire un deciso contributo al consolidamento dei buoni rapporti tra le nostre comunità, per superare ogni incomprensione e pregiudizio”. Quindi l’evento conciliare “ha dato un decisivo impulso all’impegno di percorrere un cammino irrevocabile di dialogo, di fraternità e di amicizia”. “Anche io - ha proseguito Benedetto XVI -, in questi anni di Pontificato, ho voluto mostrare la mia vicinanza e il mio affetto verso il popolo dell’Alleanza... La Chiesa non ha mancato di deplorare le mancanze di suoi figli e sue figlie, chiedendo perdono per tutto ciò che ha potuto favorire in qualche modo le piaghe dell’antisemitismo e dell’antigiudaismo. Possano queste piaghe essere sanate per sempre!”
Tra le tragedie del ventesimo secolo il Pontefice ha quindi citato “il dramma singolare e sconvolgente della Shoah” che “rappresenta, in qualche modo, il vertice di un cammino di odio che nasce quando l’uomo dimentica il suo Creatore e mette se stesso al centro dell’universo”. Ricordando gli Ebrei romani strappati dalle loro case e “lo sterminio del popolo dell’Alleanza di Mosè, prima annunciato, poi sistematicamente programmato e realizzato nell’Europa sotto il dominio nazista”, Benedetto XVI ha proseguito: “Purtroppo, molti rimasero indifferenti, ma molti, anche fra i Cattolici italiani, sostenuti dalla fede e dall’insegnamento cristiano, reagirono con coraggio, aprendo le braccia per soccorrere gli Ebrei braccati e fuggiaschi, a rischio spesso della propria vita, e meritando una gratitudine perenne. Anche la Sede Apostolica svolse un’azione di soccorso, spesso nascosta e discreta. La memoria di questi avvenimenti deve spingerci a rafforzare i legami che ci uniscono perché crescano sempre di più la comprensione, il rispetto e l’accoglienza.”
Evidenziando quanto unisce le due comunità, il Pontefice ha citato la Sacra Bibbia come “il fondamento più solido e perenne, in base al quale veniamo costantemente posti davanti alle nostre radici comuni, alla storia e al ricco patrimonio spirituale che condividiamo”. Dalla Legge e dai Profeti derivano numerose implicazioni per entrambi. In particolare il Decalogo, definito “un faro e una norma di vita nella giustizia e nell’amore, un ‘grande codice’ etico per tutta l’umanità”, propone vari campi di collaborazione e di testimonianza, tra cui il Papa ha citato i più urgenti: “risvegliare nella nostra società l’apertura alla dimensione trascendente, testimoniare l’unico Dio”, “testimoniare insieme il valore supremo della vita contro ogni egoismo”, “testimoniare che la famiglia continua ad essere la cellula essenziale della società e il contesto di base in cui si imparano e si esercitano le virtù umane.” Inoltre Ebrei e Cristiani sono chiamati ad esercitare “una generosità speciale verso i poveri, le donne, i bambini, gli stranieri, i malati, i deboli, i bisognosi... Con l’esercizio della giustizia e della misericordia, Ebrei e Cristiani sono chiamati ad annunciare e a dare testimonianza al Regno dell’Altissimo che viene”.
Il Pontefice ha infine esortato a “compiere passi insieme, consapevoli delle differenze che vi sono tra noi, ma anche del fatto che se riusciremo ad unire i nostri cuori e le nostre mani per rispondere alla chiamata del Signore, la sua luce si farà più vicina per illuminare tutti i popoli della terra”. A conclusione del discorso Benedetto XVI ha invocato dal Signore “il dono prezioso della pace in tutto il mondo, soprattutto in Terra Santa”.(SL)
Ma indietro non si torna
di Giancarlo Zizola (la Repubblica, 18 gennaio 2010)
Indietro non si torna. Parola di Papa. La dottrina del Concilio Vaticano II sugli Ebrei costituisce - ha detto in Sinagoga - un punto fermo irreversibile. Di più, ha impegnato la Chiesa cattolica in questo solco. Una chiamata in causa che ricade come una sconfessione sulle correnti ostinatamente antisemite del lefebvrismo ultracattolico, troppo frettolosamente perdonato. L’assicurazione filoconciliare di Benedetto XVI introduce una variante nella disputa sulla continuità del Vaticano II rispetto alla tradizione della Chiesa. Se c’è un punto del Concilio in cui la critica alla tradizione di molti secoli è indubitabile, questo è la dichiarazione "Nostra Aetate" sugli Ebrei e le altre religioni non cristiane.
L’impegno contratto dal Papa si traduce in un riconoscimento del valore permanente delle deliberazioni conciliari, tanto più ragguardevole in un’ora in cui vengono raggiunte da processi involutivi. Significa anche ammettere che la tradizione della Chiesa è fatta non solo di ripetizioni del passato, ma anche di ricerca di forme veritative più autentiche ed ampie di quelle precedenti. Questa Sinagoga bis del papato prova che il dialogo ebraico-cristiano si radica nella struttura istituzionale del mondo ebraico e della Chiesa romana. Certe diffidenze ebraiche sono motivate dalla storia, che mette in scena una continua alternanza fra persecuzione e meno larghi periodi di tolleranza. Ora il fatto che da Giovanni XXIII al Papa attuale siano già cinque i Papi favorevoli al dialogo con l’ebraismo, dovrebbe assicurare i timorosi che questa opzione non è congiunturale, ma si fonda sulla messa in valore di elementi fondamentali comuni anteriormente eclissati.
Certo, Ratzinger mostra di preferire il tavolo teologico a quello politico. Come fa leva nel suo magistero sulla formazione biblica e teologica di un cattolicesimo troppo a lungo distratto o illuso dalle massificazioni wojtyliane, così punta sulla rieducazione di ebrei e cattolici per migliorare una conoscenza reciproca, che sembra generalmente carente. E ha risolto positivamente - non c’era da dubitarne - la questione della salvezza promessa per sempre al Popolo dell’Alleanza. Ma se avesse scelto di lasciare in guardaroba le cautele diplomatiche e seguire Riccardo Pacifici sui carboni ardenti dei silenzi di Pio XII e della politica anti-israeliana dell’Iran, non gli sarebbe stato difficile ricordare che furono i persiani a liberare gli ebrei dall’esilio babilonese, a riportarli a Gerusalemme e ricostruire il Tempio.
Una visita "teologica" ha saputo paradossalmente individuare un progetto di collaborazione. I partner hanno preferito discutere delle cose da fare insieme piuttosto che misurarsi sulle rispettive visioni identitarie. Ciò che manca alle religioni monoteistiche non è generalmente la loro reciproca fraternità. Essa giace dentro ciascuna di esse, come il cuore che pulsa segretamente e fa vivere. Ciò che manca a questi mondi religiosi è l’audacia di farsi Arca di Alleanza fra loro perché il mondo viva e l’arca della pace appaia nel futuro del mondo.
Sia il Papa che il rabbino hanno squarciato il velo su questo futuro inedito: la persuasione comune è che la vera Terra Promessa è al di là delle terre già raggiunte, è la Terra che è stata promessa non ad una religione particolare ma all’Uomo come tale, perché - ha suggerito Di Segni - «l’Uomo è santo», non la terra. Una intuizione decisiva per laicizzare le derive teocratiche nazionalistiche e i fondamentalismi incombenti.
A sua volta il Papa ha chiesto di trasformare la fede comune nell’Unico Dio in atto critico dei nuovi dei e vitelli d’oro, - la razza, lo Stato - che mettono a repentaglio l’identità stessa dell’Uomo. Un invito familiare al linguaggio dell’Ebreo Errante, mai quieto nelle logiche e interessi costituiti, preoccupato di salvare la differenza dai processi di omologazione per non abbandonare la storia ai suoi despoti. Ha chiesto alleanza nell’impegno di tradurre la Torah in un impegno etico globale sulla dignità della vita, la famiglia, l’ecologia, la pace. Infine, il tempo delle religioni monoteistiche è il tempo dell’Uomo: non avrebbero significato, in un mondo secolarizzato, se fossero appena interessate ciascuna alla propria sopravvivenza e se si accanissero a lottare fra loro, immemori dello scopo comune. Il solo significato possibile che resta loro è di lavorare perché questa Terra sia salvaguardata e la promessa di Dio così adempiuta.
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ----- Padre Amorth rivela:"Il Diavolo abita anche in Vaticano" (di Marco Ansaldo) - Il Papa e il Diavolo (di G. Zizola).10 marzo 2010, di Federico La Sala
 "Il Diavolo abita anche in Vaticano"
"Il Diavolo abita anche in Vaticano"
 Padre Amorth, l’esorcista più famoso del mondo, racconta la sua lotta contro il maligno. -E rivela: "Si è infiltrato anche in Vaticano"
Padre Amorth, l’esorcista più famoso del mondo, racconta la sua lotta contro il maligno. -E rivela: "Si è infiltrato anche in Vaticano"di Marco Ansaldo (la Repubblica, 10.03.2010)
Beelzebul, Zago, Astarot, Asmodeo, Jordan. Quanti sono i nomi e le trasformazioni del Maligno? La stanza del mistero è spoglia. L’atmosfera fredda. Però padre Gabriele Amorth, l’Esorcista con la "e" maiuscola, settantamila casi affrontati in nemmeno 25 anni, sorride serafico. Lui è abituato a porte che sbattono, sedie che si rovesciano, occhi che roteano, bestemmie che volano. Ma parlare di demonio nella casa del Papa mette i brividi lo stesso. Anche se l’Esorcista non si tira indietro di fronte all’Avversario. E il Santo Padre? «Oh, Sua Santità crede in pieno nella pratica dell’esorcismo. Perché il diavolo alberga in Vaticano. Naturalmente è difficile trovare le prove. Ma ho confidenze di persone che lo confermano. E, del resto, se ne vedono le conseguenze. Cardinali che non credono in Gesù, vescovi collegati con il demonio. Quando si parla di "fumo di Satana" nelle Sacre stanze è tutto vero. Anche queste ultime storie di violenze e di pedofilia».
Beelzebul, Zago, Astarot, Asmodeo, Jordan. Quanti sono i nomi e le trasformazioni del Maligno? La stanza del mistero è spoglia. L’atmosfera fredda. Però padre Gabriele Amorth, l’Esorcista con la "e" maiuscola, settantamila casi affrontati in nemmeno 25 anni, sorride serafico. Lui è abituato a porte che sbattono, sedie che si rovesciano, occhi che roteano, bestemmie che volano. Ma parlare di demonio nella casa del Papa mette i brividi lo stesso. Anche se l’Esorcista non si tira indietro di fronte all’Avversario.
Ha guardato in faccia il diavolo. O almeno le sue incarnazioni terrene. Padre Gabriele Amorth ha affrontato 70 mila indemoniati (veri o presunti) in 24 anni di esercizio. "Il Papa crede in questa pratica" assicura. Anche perché "il Maligno alberga in Vaticano, e se ne vedono le conseguenze" Un esempio? Le ultime storie di pedofilia Il sacerdote, che lavora a Roma, è il più famoso "liberatore di anime" al mondo "Il nostro compito principale è affrancare l’uomo, soprattutto dalla paura di Satana" "Il 90 per cento delle vessazioni diaboliche è la conseguenza di malefici" "La notte di Natale il Nemico ha provato a colpire Ratzinger cercando di buttarlo a terra"
E il Santo Padre? «Oh, Sua Santità crede in pieno nella pratica della liberazione dal Male. Perché il diavolo alberga in Vaticano. Ho confidenze di persone che lo confermano. Naturalmente è difficile trovare le prove. E, comunque, se ne vedono le conseguenze. Cardinali che non credono in Gesù, vescovi collegati con il demonio. Quando si parla di "fumo di Satana" nelle Sacre stanze è tutto vero. Anche queste ultime storie di violenze e di pedofilia. Anche la vicenda di quella povera guardia svizzera, Cedric Tornay, trovata morta con il suo comandante, Alois Estermann, e la moglie. Hanno coperto tutto. Subito. Lì si vede il marcio».
Tutti lo conoscono come l’Esorcista. Molti ne chiedono l’assistenza. Perché Gabriele Amorth, sacerdote paolino nato a Modena, laureato in Giurisprudenza, ex partigiano, medaglia al valor militare, democristiano di scuola dossettiana ed ex direttore del giornale mariano Madre di Dio, è il più famoso liberatore del demonio al mondo.
Ma a 85 anni settantamila casi si fanno sentire. E don Amorth è appena convalescente. «Da un improvviso crollo», dice lui. «Un qualcosa di inspiegabile», rivela confidenzialmente l’amico don Francesco che, a 90 anni, don Gabriele considera come «il bastone della mia vecchiaia». Sebbene sia in pigiama, attorniato dalle medicine sul tavolo, da immagini della Madonna, da una copia di Avvenire che accenna al suo nuovo libro da poco in libreria ("Memorie di un esorcista", intervista di Marco Tosatti, edito da Piemme), lo sfidante di Satana mostra un piglio energico. Osserva la propria foto in copertina ed esclama: «Che faccia da bulldozer. Invece, quando sono tranquillo, i tratti del mio volto si distendono e divento un altro. Forza, parliamo, che di là ho dei casi che mi aspettano».
Padre Amorth, com’è il diavolo? «È puro spirito, invisibile. Ma si manifesta con bestemmie e dolori nelle persone di cui si impossessa. Può restare nascosto. O parlare lingue diverse. Trasformarsi. Oppure fare il simpatico. A volte mi prende in giro. Io però sono un uomo felice del mio lavoro, una nomina inaspettata giunta 25 anni fa dal cardinale Poletti. E né gli indemoniati, che a volte sei o sette dei miei assistenti devono tener fermi, né i chiodi o i vetri che escono dalla bocca dei posseduti, e conservo in questo sacchetto, mi spaventano. So che è il Signore a servirsi di me».
Il Maligno può manifestarsi con violenza. Nella stanza prescelta - padre Amorth ha girato 23 sedi diverse, cacciato ovunque perché i confratelli erano stufi di sentire urla fino a tarda sera, finché non ha trovato stabile dimora nel quartier generale delle edizioni San Paolo - c’è un lettino con le corde per legare l’indemoniato. E una poltrona per le persone che non urlano, e stanno tranquillamente sedute durante le preghiere di esorcismo. «Dalla bocca può uscire di tutto - racconta - pezzi di ferro lunghi come un dito, ma anche petali di rosa. Certi posseduti hanno una forza tale che nemmeno sei uomini riescono a trattenerli. Così vengono legati. Mi aiutano i miei assistenti laici, che pregano con me. Quando gli ossessi sbavano, e allora bisogna pulire, lo faccio anch’io. Vedere la gente vomitare non mi dà nessun fastidio».
Sulla pratica dell’esorcismo, dentro la Chiesa, esistono opinioni diverse. Diffidenze. Resistenze. Dubbi. «Ma il Papa ci crede - ribadisce padre Amorth - tanto è vero che in un discorso pubblico ha incoraggiato e lodato il nostro lavoro. Gli ho scritto, e mi ha promesso che chiederà alla Congregazione per il Culto divino un documento per raccomandare che i vescovi abbiano almeno un esorcista in ogni diocesi, come minimo. Ho avuto modo di parlargli più volte anche quando era prefetto alla Congregazione per la Dottrina della fede, ci ricevette proprio come Associazione degli esorcisti. E non scordiamo che, sia del diavolo sia delle pratiche per allontanarlo, parlò moltissimo lo stesso Wojtyla». Alcuni, addirittura, ricordano ancora la dichiarazione fatta nel 1972 da Papa Montini, quando Paolo VI parlò del "fumo di Satana", cioè delle sètte sataniche, entrato nelle Sacre stanze. Una frase che creò un caso, seguito da un nuovo discorso papale tutto incentrato sul demonio.
Ma il Maligno può colpire anche il Pontefice? «Ci ha già provato. Lo fece nel 1981, con l’attentato a Giovanni Paolo II, lavorando su coloro che armarono la mano di Ali Agca. E anche adesso, la notte di Natale, con quell’ultima matta che ha buttato per terra Benedetto XVI. In fondo, è quel che accadde a Gesù attraverso Giuda, Ponzio Pilato, il Sinedrio». Don Amorth si fa serio. Riflette in silenzio per qualche secondo, alza la testa e dice gravemente: «Altroché. Altroché se il demonio alberga nella Santa Sede. C’è un volume, "Via col vento in Vaticano" (Kaos edizioni, ndr), che parla appunto delle lotte di potere in Curia e del "fumo di Satana". Bene, il 99 per cento di quel che è scritto lì è vero. I vescovi non parlano per timore di critiche di altri vescovi. E sì che su questo tema le Sacre scritture sono le più salate, perché i comandi di Gesù appaiono molto chiari: "Andate, predicate il Vangelo, cacciate i demoni". Secondo me, quando un vescovo non nomina l’esorcista commette un peccato mortale».
Tante le figure di santi che, senza esserne investiti, erano noti come liberatori dal demonio. San Benedetto, che era un monaco. Santa Caterina da Siena, di cui si narrano effetti portentosi. Padre Pio, che secondo i fedeli liberava dall’influenza del maligno. Pure Don Bosco occasionalmente si prestava. «Io lavoro sette giorni su sette, Natale e Pasqua compresi - dice don Gabriele - e non posso materialmente correre ovunque mi chiamano. Perciò spiego a tutti che anche i laici possono operare esorcismi con successo. È scritto in Marco, XVI, 17: "Coloro che credono in me cacceranno i demoni". Ci sono formule ufficiali. Si può dire: "Satana, vattene". Ma c’è anche molta libertà, con preghiere semplici: il Padre Nostro - che contiene già in sé un esorcismo: "e liberaci dal Male" - l’Ave Maria, il Salve Regina, il Credo. Poi raccomando le orazioni quotidiane, la messa, il rosario, la confessione, la comunione, il digiuno».
Un tema, quello della figura antitetica al Messia, che per altri aspetti muove fior di scienziati. L’altro ieri a Roma, nei locali della Sapienza prima e in quelli dell’Università Roma Tre più tardi, si è svolto un convegno dal titolo "L’ultimo nemico di Dio". Cioè l’Anticristo, il personaggio che incarna l’avversario della divinità, presente nell’immaginario giudaico e cristiano relativo agli ultimi tempi del mondo. Approccio scientifico, impronta storica, studiosi di calibro internazionale: Enrico Norelli, Jean-Daniel Kaestli, Marco Rizzi, Gian Luca Potestà, Alberto D’Anna.
«Il ruolo della figura dell’Anticristo - spiegava al pubblico la docente Emanuela Valeriani, una dei coordinatori dell’evento - a prescindere dalle diverse posizioni assunte dagli studiosi, è senza dubbio un tassello tematico fondamentale all’interno del grande mosaico degli studi relativi all’identità cristiana. L’attenzione alla strana e, diciamo pure, spettacolare fisionomia dell’Anticristo è un tema ben rappresentato nelle apocalissi cristiane di epoca più tarda, contribuendo all’elaborazione anche leggendaria di questa figura escatologica. La prima testimonianza si trova in un’opera del III secolo, "Il Testamento siriaco del nostro Signore Gesù Cristo". Ma se, in linea generale, il terribile aspetto dell’Anticristo si può ricondurre alla tradizione precedente al cristianesimo, che identifica l’avversario escatologico con esseri mostruosi, nel caso specifico del nostro testo, esso assume una rilevanza teologica derivante dal confronto con la visione di Dio. Se prendiamo la sezione degli "Acta Iohannis", un testo scritto probabilmente nel secondo secolo, vediamo che lì si afferma che Gesù può essere visto sotto diverse forme (bambino, giovane adulto, vecchio) e apparire contemporaneamente anche a più testimoni».
Nella sua stanza al terzo piano della sede paolina, padre Amorth si prepara ad affrontare il Nemico nell’ennesimo caso difficile. Ma il diavolo chi sceglie di colpire? «Non lo sappiamo - risponde - eppure al 90 per cento le vessazioni diaboliche sono conseguenze di malefici, cioè sono causate da persone che per vendetta o per rabbia si rivolgono a maghi e occultisti legati a Satana i quali, pagati profumatamente, si attivano per far intervenire il maligno. È dunque la cattiveria degli uomini a chiamare il Male. Un’ultima cosa: il diavolo non è così diffuso. Quando c’è, è doloroso. E noi interveniamo. Ma il compito principale dell’Esorcista è uno solo: liberare l’uomo, soprattutto dalla paura del demonio».
 Il Papa e il diavolo
Il Papa e il diavolo
 I cristiani e il potere del male
I cristiani e il potere del male
 di Giancarlo Zizola (la Repubblica, 10.03.2010)
di Giancarlo Zizola (la Repubblica, 10.03.2010)Negli ultimi anni la dottrina cattolica sull’esistenza del diavolo è stata messa in dubbio da più di un teologo. Urs Von Balthazar diceva di credere nell’Inferno ma anche che lo riteneva vuoto. E Borges azzardava che forse i teologi, che avevano esagerato i vantaggi del Paradiso non essendoci mai stati, non avrebbero potuto giurare che i reprobi all’Inferno fossero sempre infelici: come immaginare che una fabbrica così sadica, vendicativa e inarrestabile di tortura dei dannati, una Auschwitz eterna possa essere compatibile con l’idea cristiana di un Dio misericordioso? Il minimo che si esigeva dalla teologia era di rimodellare l’idea della Geenna, destinata ai malvagi.
Soprattutto tenendo in maggiore considerazione il ruolo di salvezza assegnato alla figura di Gesù: i Vangeli raccontano le sue lotte contro i demoni, ma anche le loro disfatte e le guarigioni operate sugli indemoniati. Il Credo cristiano dice che dopo morto egli scese tre giorni agli Inferi con altrettanta potenza liberatoria ma una lettura pigra di quell’evento sembra trattenerlo agli Inferi per molto più tempo.
La maggior parte dei biblisti pensa che non sia possibile, o comunque sia piuttosto rischioso, negare l’esistenza di spiriti maligni. Molti temono che una cerimonia troppo disinvolta di addio al diavolo potrebbe far parte della sua tattica. Citano Baudelaire: "L’astuzia più raffinata del diavolo è di persuadervi che non esiste". Il licenziamento teologico del diavolo produrrebbe l’insignificanza del male nei contemporanei ma questa censura non sembra abbia l’effetto di porre fine al suo evidente successo.
Nel 1972 Paolo VI è il primo a lamentare che il "fumo di Satana" si sia infiltrato da qualche fessura anche «nel tempio di Dio». Si rompe l’incantesimo post-conciliare su un approccio indiscriminato della Chiesa al mondo moderno. Il Papa reagisce a una interpretazione del dialogo con la cultura dei Lumi che potrebbe risolversi in una liquidazione delle soglie critiche della coscienza cristiana di fronte al mondo e dunque in una omologazione della Chiesa ai "poteri del male". Sulla stessa linea Wojtyla lancia dal Monte Gargano, mitico luogo di lotte anti-demoniache, la sfida ai cattolici a sguainare di nuovo la spada di San Michele Arcangelo «contro il dragone, il capo dei demoni, vivo e operante nel mondo».
I suoi segni non sono più le corna, il piede caprino, l’odore dantesco di zolfo ma «consumismo, sfruttamento disordinato delle risorse naturali, voglia sfrenata di divertimento, individualismo esasperato». Negli stessi anni il cardinale Ratzinger ricorda «a certi teologi superficiali» che il diavolo è per la fede cristiana «una presenza misteriosa ma reale, personale, non simbolica, una realtà potente, una malefica libertà sovrumana opposta a quella di Dio». Rivendica al cristianesimo di avere introdotto in Occidente «la libertà dalla paura dei demoni» ma teme che «se questa luce redentrice di Cristo dovesse spegnersi il mondo con tutta la sua tecnologia ricadrebbe nel terrore e nella disperazione». Segnali di ritorno di forze oscure, secondo il futuro Papa, sono i culti satanici in aumento nel mondo secolarizzato, l’espansione del mercato della pornografia e della droga, «la freddezza perversa con cui si corrompe l’uomo, l’infernale cultura che persuade la gente che il solo scopo della vita siano il piacere e l’interesse privato».
Sono i primi tentativi della dottrina cattolica per far uscire la descrizione del diavolo da un linguaggio tradizionale ormai incomprensibile dalla stragrande maggioranza dei contemporanei. Il diavolo esiste ma assume le nuove forme delle ingiustizie e delle alienazioni. Il suo teatro non è solo il cuore umano ma anche la struttura sociale. Un teologo come Bernard Haring raccomandava molta cautela considerando il modo fantasioso con cui era stata riprodotta la dottrina sul diavolo: «Oggi lo psichiatra si mostra competente nella maggior parte dei casi nei quali si usava far intervenire l’esorcista - dice -. La Scrittura non conosce quel tipo di discorso alienante sul diavolo che è stato coltivato nei secoli dai cristiani delle diverse Chiese sotto l’influsso di culture in cui si realizzava una spaventosa alienazione». E Karl Barth rispondeva a chi chiedeva se dubitasse del diavolo: «Esiste pure quella bestia. Ma quando interviene la fede in Cristo mette la coda tra le gambe e non si fa più vedere».
-
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- E’ ufficiale: il Vaticano presenterà l’enciclica del papa ’Caritas in Veritate’ il prossimo 7 luglio 2009, prima della nascita di Cristo!1 luglio 2009, di Federico La Sala
Ansa» 2009-07-01 13:09
Enciclica "Caritas in Veritate" verrà presentata il 7 luglio
CITTA’ DEL VATICANO - E’ ufficiale: il Vaticano presenterà l’enciclica del papa ’Caritas in Veritate’ il prossimo 7 luglio.
L’enciclica sarà presentata in una conferenza stampa dal card. Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio consiglio Giustizia e Pace, dal card. Josef Cordes, presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum, da mons. Giampaolo Crepaldi, segretario del Pontificio consiglio Giustizia e Pace e dall’economista Stefano Zamagni. Si tratta di tutti personaggi che hanno contribuito alla stesura del testo pontificio.
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ----- Caritas in Veritate - in ritardo, colpa del latino (di Orazio La Rocca).27 giugno 2009, di Federico La Sala
 Gli esperti del Vaticano sono in difficoltà e non riescono a finire
Gli esperti del Vaticano sono in difficoltà e non riescono a finire
 L’ultimo termine era stato fissato per lunedì prossimo
L’ultimo termine era stato fissato per lunedì prossimo L’Enciclica in ritardo, colpa del latino
L’Enciclica in ritardo, colpa del latino
 E’ troppo difficile, slitta la consegna
E’ troppo difficile, slitta la consegna di Orazio La Rocca *
di Orazio La Rocca *CITTA’ DEL VATICANO - Slitta la pubblicazione della nuova enciclica papale per colpa del latino e delle difficoltà legate alla complessità e delicatezza del testo ratzingeriano. L’atteso documento, che Benedetto XVI ha dedicato ai problemi sociali, del lavoro e della globalizzazione, avrebbe dovuto vedere la luce lunedì prossimo.
Ma la data è stata rinviata perché i prelati addetti alle traduzioni sono pochi e, quel che è peggio, sono ancora meno quelli che padroneggiano la lingua latina, malgrado le recenti aperture di Ratzinger. Inevitabile che nelle riservatissime stanze vaticane, dove sono all’opera i monsignori incaricati di tradurre i documenti papali, si respiri imbarazzo. A fare le spese di lentezze e difficoltà è proprio uno dei più attesi testi di questi giorni, la nuova enciclica di Benedetto XVI, la prima a carattere sociale, dal titolo Caritas in veritate (Amore nella verità) che tarda a vedere la luce "a causa delle difficoltà con la traduzione in latino, e la complessità del testo", si sussurra in Curia.
C’è chi lamenta, Oltretevere, che l’idioma di Cicerone sia diventato molto ostico tra i prelati pur essendo da sempre la lingua ufficiale della Chiesa cattolica e quella prediletta dal Papa: sono passati ormai due anni da quando Ratzinger l’ha rilanciato col Motu Proprio che ha liberalizzato la Messa preconciliare in latino tanto cara a lefrebvriani e tradizionalisti. "Nessun problema con inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, ma col latino sono dolori: ormai anche qui sono in pochi a conoscerlo bene", si vocifera nei palazzi pontifici, dove sull’equipe di traduttori ufficiali vigila un ristrettissimo comitato di controllo che risponde direttamente al Papa formato dall’arcivescovo Paolo Sardi e da Ingrid Stampa, la storica segretaria che Ratzinger anche da Papa ha voluto portare con sé in Vaticano.
Si allungano, dunque, i tempi della pubblicazione della terza enciclica del pontificato ratzingeriano iniziato il 19 aprile 2005, dopo le prime due del 25 dicembre 2005 (Deus Caritas Est) e del 30 novembre 2007 (Spe Salvi). L’atteso documento potrebbe ora essere presentato ufficialmente tra il 6 ed il 7 luglio, anche se la firma di Benedetto XVI porterà comunque la data del 29 giugno.
È stato Ratzinger in persona a pretendere che la versione ufficiale dell’enciclica da inviare a tutti i vescovi del mondo e alle nunziature apostoliche, fosse rigorosamente in latino, mentre con i suoi predecessori la versione nella lingua di Cicerone arrivava solo in un secondo momento. La scelta, al di là delle difficoltà di traduzione, ha comportato un superlavoro caduto interamente sulle spalle di un piccolo numero di addetti alle traduzione. Risultato: ancora ieri i testi da stampare non erano stati portati nella tipografia della Libreria Editrice Vaticana.
La terza enciclica era stata annunciata più volte nei mesi scorsi dalle autorità pontificie per il prossimo 29 giugno. Anche lo stesso Ratzinger ne ha fatto cenno in più occasioni. L’ultima volta, il 13 giugno scorso parlando ai membri della Fondazione "Centesimus Annus", organismo che si ispira ad una delle più popolari encicliche di Giovanni Paolo II.
* la Repubblica, 27 giugno 2009
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- la sua nuova enciclica sarà "Caritas in veritate".13 giugno 2009, di Federico La Sala
Ansa» 2009-06-13 14:45
CRISI: PAPA CONFERMA ENCICLICA, FISSERA’ PRINCIPI E VALORI
CITTA’ DEL VATICANO - Papa Benedetto XVI ha confermato che presto verrà pubblicata la sua nuova enciclica dedicata al "vasto tema dell’economia e del lavoro" e che in essa traccerà "i valori da difendere instancabilmente " per realizzare una convivenza umana "veramente libera e solidale". La data indicata in Vaticano per la firma del prossimo testo pontificio è quella del 29 giugno, festa di San Pietro e Paolo.
Benedetto XVI è tornato a parlare della crisi economica mondiale incontrando oggi la Fondazione ’Centesimus Annus’, organismo cattolico che si occupa di studi sociali. "In effetti, la crisi finanziaria ed economica che ha colpito i Paesi industrializzati, quelli emergenti e quelli in via di sviluppo, mostra in modo evidente come siano da ripensare certi paradigmi economico-finanziari che sono stati dominanti negli ultimi anni", ha spiegato il pontefice. "Come sapete, verrà prossimamente pubblicata la mia Enciclica dedicata proprio al vasto tema dell’economia e del lavoro: in essa verranno posti in evidenza quelli che per noi cristiani sono gli obbiettivi da perseguire e i valori da promuovere e difendere instancabilmente, al fine di realizzare una convivenza umana veramente libera e solidale", ha aggiunto. L’enciclica si intitolerà "Caritas in veritate" e verrà pubblicata e presentata subito dopo la firma, ai primi di luglio.
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! --- Dell’economia e perciò anche della crisi e delle sue vittime il Papa pubblicherà presto un’enciclica sociale, "Caritas in veritate" (di Filippo Ceccarelli - I peccati della Chiesa).17 marzo 2009, di Federico La Sala
 Il libro scritto da Claudio Rendina fa sembrare Dan Brown un principiante
Il libro scritto da Claudio Rendina fa sembrare Dan Brown un principiante Un’istituzione bimillenaria raccontata nel suo lato peggiore
Un’istituzione bimillenaria raccontata nel suo lato peggiore La "santa Casta" non va in paradiso
La "santa Casta" non va in paradiso I peccati della Chiesa
I peccati della Chiesa Ma sulla questione dell’Olocausto l’autore sostiene che Pio XII fece salvare 600 ebrei
Ma sulla questione dell’Olocausto l’autore sostiene che Pio XII fece salvare 600 ebrei In una storia così lunga, per ogni infamia c’è però sempre una virtù
In una storia così lunga, per ogni infamia c’è però sempre una virtù
 Il caleidoscopio di nequizie ecclesiastiche è ricco di esempi
Il caleidoscopio di nequizie ecclesiastiche è ricco di esempidi Filippo Ceccarelli (la Repubblica, 17.03.2009)
A proposito di odio, morsi, divoramenti in Vaticano e dentro la Chiesa: eh, figurarsi, non è mica la prima volta, da quelle parti la storia offre molto di peggio. E dunque, tenendosi larghi e vaghi, per non dire indulgenti: stragi, avvelenamenti, saccheggi, roghi, torture, idolatrie, simonie, traffici, nepotismi, incesti, pedofilia, riesumazione e vilipendio di cadaveri, con tanto sacri paramenti indosso, e a lungo si potrebbe continuare, secolo dopo secolo, con il soccorso di una imponente documentazione.
A chi invoca a tutto spiano il premiato binomio Radici & Tradizione contro le magagne del presente relativismo; a chi vede la speranza o addirittura intravede la salvezza nel passato trionfale dell’autorità pontificia, forte di valori antichi e inflessibile nella vera fede, si raccomanda vivamente di buttare un occhio su quest’ultimo volume di Claudio Rendina, instancabile erudito che con la consueta asciuttezza si misura questa volta su La Santa Casta della Chiesa (Newton Compton, pagg. 383, euro 12,90). Inevitabilmente suggestivo il sottotitolo: "Duemila anni di intrighi, delitti, lussurie, inganni e mercimonio tra papi, vescovi, sacerdoti e cardinali". Così è, d’altra parte: e continua pure.
Sarebbe ingiusto adesso sminuire il dramma anche personale di Benedetto XVI sulla conduzione della Chiesa. E tuttavia, "nella consapevolezza del lungo respiro che essa possiede", come si legge nella lettera da lui pubblicata l’altro giorno sull’Osservatore romano, occorrerà riconoscere che ad alcuni predecessori di Joseph Ratzinger è andata decisamente peggio; così come altri papi assai più di lui certamente fallirono, o nel modo più spaventoso vennero consigliati, altro che mancata consultazione "mediante l’internet". Il campionario di Rendina, le cui diverse cronologie e gli approfondimenti di storia pontificia si trovano pur sempre nelle librerie intorno alla Santa Sede, offre in questo senso una rimarchevole varietà di esempi: papi eletti tre volte, papi saliti sul sacro trono a suon di quattrini, papi mezzi atei o interamente pagani, papi davvero molto attaccati alle loro famiglie, tanto da battezzare il "nepotismo", papi assassini, bruti, spergiuri, ladroni, perversi, dementi e biscazzieri. Ce n’è uno, Giovanni XII, probabile record-man dei secoli bui, che nominò vescovo il suo amante, un ragazzino di 10 anni, e che scoperto a letto con l’amica, venne poi buttato giù dalla finestra. Ce n’è un altro ben più famoso, Alessandro VI, della famiglia Borgia, che ne fece a tal punto di cotte e di crude, pure la corrida sotto il Cupolone, che nei santini distribuiti "in solemnitate pascali" lo scorso anno nella basilica di San Pietro, e recanti l’immagine de La Resurrezione di Cristo del Pinturicchio, ecco, quel papa lì, che per giunta era il committente dell’opera, ecco, risulta cancellato dal quadro, come nelle foto della nomenklatura sovietica dopo le purghe.
E saranno anche vicende che si perdono nella notte dei tempi, cosa ovvia per un’istituzione bimillenaria. Ma insomma, prima di Rendina, il peccato che sin dall’inizio grava sulla Chiesa ha del resto ispirato la più alta poesia e letteratura, da Iacopone a Dante, da Petrarca fino al Belli, e oltre.
Tutto però sembra oggi rimosso dal discorso pubblico e in particolare dall’armamentario teo-con - secondo l’antica pratica, peraltro evangelica, della pagliuzza e della trave. Dai primissimi commerci di loculi e reliquie nelle catacombe alla controversa carriera dell’odierno comandante delle Guardie Svizzere; dalle torture dell’Inquisizione alle turpi pratiche del fondatore dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel, su degli innocenti; dalle cortigiane che nella Curia cinquecentesca si comportavano come autentiche "papesse" fino alle speculazioni edilizie post-risorgimentali, il libro di Rendina certamente si presenta come un caleidoscopio di nequizie ecclesiastiche, un prontuario di immoralità vaticana da far sembrare Dan Brown uno sprovveduto principiante.
Ma al dunque si può e forse addirittura si dovrebbero leggere, queste pagine, come un saggio storico sulla genealogia e gli sviluppi imprevisti di un potere che più di ogni altro sulla faccia della terra costringe degli uomini con la mantella bianca a fare i conti con l’essenza del sacro e al tempo stesso con le inesorabili necessità del profano; e quanto più tale sovranità si concentra sulla materia, sui corpi, sul denaro, sulle apparenze, tanto più automaticamente ne risente lo spirito o lo Spirito, se si preferisce. E sebbene anche per Santa Romana Chiesa i tempi sono quelli che sono, tempi di paure, di ritorni, di sbarramenti, sarebbe sbagliato liquidare questa torbida rievocazione come parte del solito complotto laicista. E non solo perché l’autore è fuori dai giri e anzi, per dire, sulla questione delle responsabilità di Pio XII nell’Olocausto sposa la tesi opposta, sostenendo che la Santa Sede mise in salvo 600 mila ebrei "con un impegno finanziario non indifferente". Ma soprattutto perché da una lettura distaccata e senza pregiudizi appare chiarissimo come in una storia così lunga e così umana per ogni infamia c’è sempre un’eroica virtù; e quindi a ogni mascalzone della Santa Casta corrisponde un santo, a ogni sacro carnefice o barattiere un Francesco d’Assisi, a ogni Borgia un Filippo Neri, a ogni Marcinkus una Madre Teresa di Calcutta.
Questa necessitata ambivalenza si meriterebbe forse una maggiore umiltà. Adesso, per dire, c’è la crisi. Quando se ne videro i primi effetti, nell’autunno scorso, un intelligente uomo di banca, nonché autorevole editorialista dell’Osservatore romano, Ettore Gotti Tedeschi, già segnalatosi per aver consigliato ai manager di fare gli esercizi spirituali, ha spiegato grosso modo in un’intervista che alle origini del disastro finanziario c’è l’etica dei banchieri protestanti, mentre i nostri uomini di finanza, cioè cattolici, "sono in grandissima parte seri, trasparenti e dotati di visione etica".
E meno male che c’è da stare tranquilli! Però poi subito viene da pensare ai bacetti di Fiorani al pio governatore Fazio, o al crack Parmalat e al mega-cattolico Tanzi che scarrozzava cardinali con il suo aeroplano; ed è un peccato che non si possa sentire al riguardo Nino Andreatta, che fu ministro del Tesoro ed ebbe il suo da fare ai tempi dello scandalo Ior; per non dire Sindona e Calvi, poveri morti ammazzati, entrambi a suo tempo "banchieri di Dio".
Che invece Iddio non ne avrebbe tanto bisogno, di banchieri personali o nazionali, a differenza del Vaticano, che invece sono duemila anni che si accanisce e si avvilisce appresso a Mammona in forma di tariffe penitenziali, vendita d’indulgenze, proficue crociate, fabbricazione di giubilei, peripezie valutarie, funambolismi azionari e finanziari. E che magari adesso, in qualche missione "sui iuris" alle Cayman, qualche titoletto tossico nel portafoglio se lo potrebbe anche ritrovare, come del resto è già capitato nelle migliori famiglie della finanza.
Dell’economia e perciò anche della crisi e delle sue vittime il Papa, che ha già detto tante buone parole, pubblicherà presto un’enciclica sociale, "Caritas in veritate". Il titolo suona piuttosto impegnativo, ma certo un gesto simbolico non guasterebbe. Nel frattempo, rispetto a odio, morsi, divoramenti e umane debolezze, vale comunque il salmo 129: "Si iniquitates observaveris, Domine, quis sustinebit?". Se consideri solo le colpe, o Signore, chi mai potrà esistere?
-
> "Deus caritas est"?!!! ---- Per il bene della Chiesa sarebbe opportuno che il papa Benedetto XVI rassegnasse le sue dimissioni (di Paolo Farinella - Appello)..6 febbraio 2009, di Federico La Sala
Nessuno tocchi il Concilio Vaticano II
Appello ai cattolici contro la revoca della scomunica ai lefebvriani
di Paolo Farinella - Genova
Come cattolico che rappresenta solo se stesso, ed eventualmente anche chi volesse firmare questa dichiarazione, desidero esprimere tutta la mia preoccupazione e il mio sconcerto per le scelte che papa Benedetto XVI sta mettendo in atto per riportare la chiesa al tempo prima del concilio e anche oltre. L’autorizzazione generalizzata della Messa preconciliare, sottratta all’autorità dei vescovi, costituì, come oggi appare evidente, la premessa per giungere all’abolizione della scomunica ai quattro vescovi consacrati da mons. Marcel Lefebvre senza mandato apostolico.
E’ buona cosa ristabilire l’unità della e nella Chiesa, ma nessun papa può togliere una scomunica se non vengono rimossi i motivi per cui un altro papa l’ha dichiarata. Dalle dichiarazioni pubbliche degli interessati e dei loro seguaci risulta che essi leggono il gesto unilaterale del papa come un’ammissione della validità delle loro posizioni e quindi come un risarcimento dovuto. Dichiarano, inoltre, che nessuna condizione gli è stata posta, tanto meno una dichiarazione di accettazione del concilio Vaticano II che ritengono non compatibile con la tradizione. I lefebvriani, infatti, affermano di essere disposti a dare il sangue per la Chiesa, ma di non potere accettare il concilio Vaticano II «diverso dagli altri» (leggi: eretico) per cui la loro fedeltà si ferma al Vaticano I.
Togliere la scomunica senza porre la condizione della previa adesione al magistero del concilio Vaticano II, è un atto immorale, causa di scandalo per tutti coloro che per fedeltà ad esso hanno sofferto, sono stati emarginati, ridotti al silenzio, perseguitati, privati dell’insegnamento, ridotti allo stato laicale. Senza una previa accettazione del concilio Vaticano II, togliere la scomunica appare ai semplici come complicità con gli scismatici, facendo apparire il papa come papa di parte e non papa cattolico.
Il caso del vescovo lefebvriano, Richard Williamson, che nega l’Olocausto, non può suscitare sdegno o meraviglia, perché l’antisemitismo è parte integrante della teologia lefebvriana che è quella della chiesa preconciliare ed è uno dei motivi per cui essi non accettano il concilio di papa Giovanni XXIII. La loro teologia giudica gli Ebrei colpevoli di «deicidio» e quindi reprobi dell’umanità. Il papa sapeva e sa qual è la posta in gioco: i lefebvriani negano l’ecumenismo, la libertà di coscienza, la libertà religiosa come è sancita nei documenti conciliari, firmati da un papa e da oltre due mila vescovi di tutto il mondo. Tutti i tentativi per ridurre il danno delle dichiarazioni blasfeme e ignobili di Williamson sono patetici e portano in grembo conseguenze che ancora non possiamo immaginare. Il papa ha sbagliato e diffonde confusione tra i fedeli, incrinando la credibilità dei cattolici nel mondo, mettendo a rischio l’ortodossia stessa che tanto gli sta a cuore.
Se il papa è giusto deve applicare stessa «compassione» e lo stesso trattamento di accoglienza privilegiato e senza condizioni, riservato ai lefebvriani; e con le stesse modalità e la stessa tempistica lo deve estendere alle teologhe e teologi della teologia della liberazione dell’America Latina, dell’Asia, dell’Africa, dell’India, ai teologi degli Usa e dell’Europa; ai laici e religiosi allontanati dall’insegnamento o dalle attività pastorali; a coloro che sono stati umiliati, angariati e costretti al silenzio; a tutti quelli che hanno la colpa di avere lavorato per una Chiesa più evangelica, alla luce degli insegnamenti della Pentecoste del concilio ecumenico Vaticano II; a tutte le comunità di base del continente latinoamericano, rigogliosissimo frutto della Pentecoste conciliare, che sono state considerate scismatiche, mentre erano solo fedeli al vangelo e al Vaticano II.
Nessuno tocchi il concilio Vaticano II! Chiediamo che i vescovi gridino con la forza del sacramento davanti al papa, in ginocchio ma con la schiena dritta il loro «non possumus». Noi li seguiremo, altrimenti saremo costretti anche andare da soli, come stiamo già facendo. Per il bene della Chiesa sarebbe opportuno che il papa Benedetto XVI rassegnasse le sue dimissioni.
Genova 04 febbraio 2009
Paolo Farinella - Genova
Per sottoscrivere l’appello, clicca su: Firma anche tu!
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- Per le parole negazioniste del vescovo lefebvriano Williamson, la Germania critica Benedetto XVI, ministro israeliano minaccia rottura relazioni con il Vaticano-31 gennaio 2009, di Federico La Sala
 Ancora polemiche per le parole negazioniste del vescovo lefebvriano Williamson
Ancora polemiche per le parole negazioniste del vescovo lefebvriano Williamson
 dopo che Papa Ratzinger ha ritirato la scomunica per i tradizionalisti
dopo che Papa Ratzinger ha ritirato la scomunica per i tradizionalisti Ministro israeliano minaccia
Ministro israeliano minaccia
 rottura relazioni col Vaticano
rottura relazioni col Vaticano La Germania critica Benedetto XVI. Il presidente del Bundestag Lammert
La Germania critica Benedetto XVI. Il presidente del Bundestag Lammert
 "A rischio il dialogo con le organizzazioni ebraiche, irrinunciabile"
"A rischio il dialogo con le organizzazioni ebraiche, irrinunciabile"BERLINO - Nuove tensioni fra Israele e il Vaticano dopo la riabilitazione del vescovo lefebvriano negazionista Richard Williamson. A evocare una rottura dei rapporti diplomatici tra Israele e la Santa sede è il ministro israeliano per le Questioni religiose, Yitzhak Cohen il quale, sul settimanale tedesco Der Spiegel, raccomanda di "interrompere completamente i rapporti con un’istituzione di cui fanno parte negazionisti dell’Olocausto e antisemiti".
Critiche alla decisione di Papa Benedetto XVI di revocare la scomunica ai seguaci di Lefevbre sono giunte anche dalla Germania. In un’intervista sempre al settimanale di Amburgo, il vice presidente della Comunità ebraica tedesca, Salomon Korn, giudica la decisione del Papa "un ritorno ai secoli passati", per aver "reso presentabile un negazionista dell’Olocausto". Korn giudica l’atto del Papa "imperdonabile", poiché con esso Benedetto XVI "mette in discussione la riconciliazione con gli ebrei, portata avanti dal suo predecessore".
Dura anche la posizione del presidente del Bundestag, il cristiano-democratico Norbert Lammert. Sempre su Der Spiegel, Lammert ha dichiarato che la negazione dell’Olocausto da parte di Williamson e la sua riammissione nella Chiesa "mettono a rischio il dialogo con le organizzazioni ebraiche, definito espressamente irrinunciabile dal Papa attuale e dal suo predecessore".
Lammert aggiunge di comprendere perfettamente "le irritazioni e lo sconcerto" della comunità ebraica, mentre l’ex segretario della Cdu, Heiner Geissler, critica la visione conservatrice di Benedetto XVI. Secondo l’esponente cristiano-democratico, il Papa dal punto di vista teologico si isola "nei confronti delle donne, dei credenti di altre religioni, dei divorziati e degli omosessuali".
Sulla revoca della scomunica a Williamson si è espresso da parte israeliana anche Meir Lau, ex rabbino capo di Israele e sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald. "Come può un tale negazionista - spiega - ottenere la protezione e la riabilitazione dal capo della Chiesa cattolica?".
Non mancano anche all’interno della Chiesa cattolica posizioni critiche: il cardinale francese Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione, ha dichiarato che le scuse presentate dal vescovo negazionista Richard Williamson al Papa Benedetto XVI sono "assolutamente insufficienti. Non c’è stata alcuna ritrattazione", ha precisato il cardinale francese Barbarin alla radio Rtl. Le dichiarazioni negazioniste "rappresentano delle parole riprovevoli, scandalose, rivoltanti sia nei confronti degli ebrei che per i cattolici, cosa che ha detto anche il Papa", ha concluso l’arcivescovo.
* la Repubblica, 31 gennaio 2009
-
> "Deus caritas est". --- INFAME NEGARE LA SHOAH. Renzo Gattegna chiede una esplicità presa di distanza del Vaticano dalle tesi negazioniste sulla Shoah.26 gennaio 2009, di Federico La Sala
 Dura presa di poszione del presidente dell’Unione delle comunità italiane Renzo Gattegna
Dura presa di poszione del presidente dell’Unione delle comunità italiane Renzo Gattegna
 "Ci auguriamo che prenda una decisione sul vescovo antisemita"
"Ci auguriamo che prenda una decisione sul vescovo antisemita" Gli ebrei: "Infame negare la Shoah
Gli ebrei: "Infame negare la Shoah
 la Chiesa deve intervenire" *
la Chiesa deve intervenire" *ROMA - La remissione della scomunica dei vescovi lefebvriani "è una questione che deve essere tenuta separata dalle opinioni storiche. La prima è un fatto interno alla chiesa su cui non abbiamo niente da dire, sulle tesi negazioniste, invece, abbiamo molto da dire perchè sono un’infamia". Il presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane Renzo Gattegna torna sulla polemica tra Vaticano e mondo ebraico suscitata dalla decisione di Papa Benedetto xvi di riabilitare quattro vescovi lefebvriani. Nei giorni scorsi la comunità ebraica aveva parlato di una Chiesa "contaminata" da affermazioni antisemite, oggi Gattegna rincara la dose e chiede una esplicità presa di distanza del Vaticano dalle parole di monsignor Williamson (uno dei riabilitati) che ha sostenuto tesi negazioniste sulla Shoah.
"In questo momento - spiega Gattegna - siamo attenti osservatori delle decisioni che la chiesa prenderà in merito a chi sostiene tesi negazioniste. Ci auguriamo che ci sia una smentita di queste tesi che chiarisca ogni dubbio a riguardo".
Critico anche il presidente della comunità ebraica di Milano, Leone Soued. "Il ritiro della sua scomunica - dice Soued - porta a un momento di riflessione ma la Chiesa ha immediatamente chiarito che è un reintegro soltanto nella sua veste religiosa e non tanto con riguardo alle sue idee personali, prima fra tutte la negazione della Shoah". La decisione, comunque, "deve portare - sottolinea Soued - a una profonda riflessione nei rapporti con la Chiesa, che ultimamente sono stati difficili ma devono assolutamente continuare".
* la Repubblica, 26 gennaio 2009
-
> "Deus caritas est". --- RABBINI, CON RATZINGER CANCELLATI 50 ANNI DI DIALOGO...Nessuna partecipazione alla prossima Giornata sull’ebraismo, indetta per il 17 gennaio dalla Confrenza episcopale italiana.13 gennaio 2009, di Federico La Sala
Ansa» 2009-01-13 18:32
RABBINI, CON RATZINGER CANCELLATI 50 ANNI DI DIALOGO
ROMA, 13 GEN - Con Benedetto XVI, la Chiesa sta cancellando i suoi ultimi "cinquanta anni di storia" nel dialogo tra ebraismo e cattolicesimo: a lanciare la critica è il rabbino capo di Venezia, Elia Enrico Richetti, che - in un editoriale per il mensile dei gesuiti "Popoli", ha spiegato i motivi che hanno portato il rabbinato italiano a non partecipare alla prossima Giornata sull’ebraismo, indetta per il 17 gennaio dalla Confrenza episcopale italiana.
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- TUTTO IL POTERE AL DENARO. Il berlusconismo all’esame dei cattolici (di Mario Pancera).30 ottobre 2008, di Federico La Sala
TUTTO IL POTERE AL DENARO
di Mario Pancera
Fascismo e berlusconismo all’esame dei cattolici *
Affarismo ed egoismo sono i due elementi principali, o almeno i più vistosi, del berlusconismo come si è sviluppato nella politica italiana in questi ultimi dieci anni. Sono d’accordo sacerdoti, giornali e opinionisti cattolici. Per quanto appare da parole e azioni, si tratta di un egoismo individuale e di gruppo. Questo porta molti a considerare il berlusconismo una sorta di fascismo, ben diverso, naturalmente, da quello mussoliniano, che pur essendo dispotico agitava un’ideologia di grandeur nazionale, che nel secolo scorso incontrò molti consensi.
Il sociologo e psicanalista austriaco Wilhelm Reich, a differenza di quel che era il comune sentire, sosteneva nel 1933 che «”il fascismo” è l’atteggiamento emozionale fondamentale dell’uomo autoritariamente represso dalla civiltà delle macchine e della sua concezione meccanicistico mistica della vita». E aggiungeva: «Il carattere meccanicistico mistico degli uomini del nostro tempo crea i partiti fascisti e non viceversa». È un errore considerare il fascismo prodotto di una etnia o di un popolo o di «una piccola cricca reazionaria»: è un fenomeno «internazionale che corrode tutti i gruppi della società umana di tutte le nazioni».
Ben conscio della responsabilità di queste affermazioni, lo studioso sottolineava gli aggettivi «internazionale» e «tutte», affermando tra l’altro che il fascismo «non è un movimento puramente reazionario, ma costituisce un amalgama tra emozioni “ribelli” e idee sociali reazionarie». Lasciamo naturalmente al sociologo, che spiegava la sua teoria in «Psicologia di massa del fascismo», la sua intera responsabilità, ma alcuni elementi, anche in questo rapido riassunto, sono evidenti anche oggi.
Il fascismo mussoliniano aveva, in effetti, un Credo; si basava su giuramenti; propugnava una sua mistica; aveva parole d’ordine come credere, obbedire, combattere, ed aveva divise, emblemi e riti che colpivano l’immaginazione e i sentimenti popolari (ovvero quelle masse di individui che secondo Reich hanno già il fascismo dentro di sé: ribelli e reazionari insieme). Il berlusconismo è diverso? È un fatto che, negli ultimi decenni, a partire dagli anni in cui ancora non era movimento politico ma solo un insieme di società di affari, ha avuto ed ha ancor oggi copiosi consensi, ha ottenuto i voti di vere masse di elettori.
Può essere che abbia in sé ribellione (non rivoluzione, che è cosa diversa) e insieme idee sociali reazionarie? L’egoismo e l’affarismo - in pratica, tutto il potere al denaro - appaiono chiaramente attraverso i mass media, peraltro aggrediti ogni giorno con l’accusa di essere prezzolati, mentitori e pregiudizialmente ostili.
Le espressioni berlusconiane «Forza Italia» e «Popolo della libertà» non indicano due partiti o movimenti con una ideologia fondante, sia pure di tipo mussoliniano, ma sono slogan adattabili a realtà diverse che vanno dallo sport al qualunquismo ovvero al mercato. È sempre più usata la frase «favorire i consumi». Il cervello, l’intelligenza, lo studio sono ai margini: si lavora e si è pagati per consumare. Altro che figli di Dio. La vita è la vita del consumatore, non dell’uomo pensante oltre che consumante. Lo spirito non è nemmeno ai margini: non se ne parla affatto. Intendo lo spirito sia in senso laico, sia religioso.
Perfino i colori dei seguaci di questi movimenti sono indicativi della mistica del berlusconismo: gli azzurri (che richiamano gli sport e quindi grandi masse di manovra) e la bandiera biancorossoverde attraversata dal loro slogan; ma anche il continuo riferimento alla «gente» in maniera indeterminata e l’inno «Forza Italia» cantato con la destra sul petto come in un rito religioso. Rari e d’occasione i richiami ai lavoratori, al popolo, ai cittadini, che erano invece d’obbligo nei partiti tradizionali, democristiano, socialista, comunista, repubblicano e liberale.
Il berlusconismo si manifesta quindi come ribelle e nello stesso tempo con idee sociali reazionarie? La spinta a spendere, non a lavorare per emanciparsi, cioè non a lavorare per essere ma a lavorare per consumare (che è un subdolo attacco ai valori del cristianesimo); le affermazioni del tipo «meno libertà in cambio di più sicurezza»; l’avversione per la democrazia parlamentare (lo notano anche eminenti politologi cattolici), il tentativo di restringere sempre più il numero dei partiti dell’opposizione, di limitare la libertà di cronaca dei mass media e di non concedere ai cittadini il diritto di scelta sulle schede elettorali: tutto questo è fascismo?
Mario Pancera
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA?7 novembre 2008, di Maria Paola Falqui
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- dopo la "Deus caritas est", la “Caritas in veritate” che secondo alcune voci dovrebbe uscire prima di Natale; e che invece secondo altre fonti potrebbe subire un ulteriore ritardo.11 dicembre 2008, di Federico La Sala
BXVI anticipa l’Enciclica
di Marco Tosatti *
Nel suo Messaggio per la Pace il Papa nega che la globalizzazione sia di per sé capace di costruire la pace, anzi è creatrice di nuovi conflitti.
Benedetto XVI anticipa i temi e i contenuti della sua prima enciclica sociale, la “Caritas in veritate” che secondo alcune voci dovrebbe uscire prima di Natale; e che invece secondo altre fonti potrebbe subire un ulteriore ritardo.
L’enciclica, focalizzata su temi di grande attualità, quasi la globalizzazione e il problema del rapporto fra uomo e ambiente, è stata più volte rimandata dal Pontefice ai soi collaboratori e consultori, perché non la giudicava soddisfacente su vari punti. Ed è stata poi inviata anche alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che l’ha passata al pettine fitto da un punto di vista dottrinale su aspetti riguardanti la dottrina sociale, il diritto di proprietà e i suoi limiti, e l’equità distributiva dei prodotti della terra.
Ma oggi, rendendo noto il suo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, papa Ratzinger già mette in rilievo alcuni di quelli che saranno temi di grande rilievo nel suo futuro documento. "Una finanza appiattita sul breve e brevissimo termine diviene pericolosa per tutti, anche per chi riesce a beneficiarne durante le fasi di euforia finanziaria" dice il Papa, aggiungendo che "la recente crisi dimostra come l’attivita’ finanziaria sia a volte guidata da logiche puramente autoreferenziali e prive della considerazione, a lungo termine, del bene comune". Inoltre "L’appiattimento degli obiettivi degli operatori finanziari globali sul brevissimo termine - osserva il Pontefice - riduce la capacita’ della finanza di svolgere la sua funzione di ponte tra il presente e il futuro, a sostegno della creazione di nuove opportunita’ di produzione e di lavoro nel lungo periodo".
Il suo Messaggio sara’ consegnato dai nunzi apostolici a tutti i capi di Stato e di Governo. Il Papa rileva che "la funzione oggettivamente piu’ importante della finanza, quella cioe’ di sostenere nel lungo termine la possibilita’ di investimenti e quindi di sviluppo, si dimostra oggi quanto mai fragile" in quanto "subisce i contraccolpi negativi di un sistema di scambi finanziari, a livello nazionale e globale, basati su una logica di brevissimo termine, che persegue l’incremento del valore delle attivita’ finanziarie e si concentra nella gestione tecnica delle diverse forme di rischio".
Ma la critica alla speculazione liberistica non significa una condanna a priori del liberismo o del capitalismo, né affidarsi a quella che si può definire una malintesa solidarieta’; anzi dice il Papa "non si puo’ negare che le politiche marcatamente assistenzialiste siano all’origine di molti fallimenti nell’aiuto ai Paesi poveri". E inoltre "va sgomberato il campo dall’illusione che una politica di pura ridistribuzione della ricchezza esistente possa risolvere il problema in maniera definitiva". "In un’economia moderna, infatti, il valore della ricchezza dipende in misura determinante dalla capacita’ di creare reddito presente e futuro. La creazione di valore risulta percio’ un vincolo ineludibile, di cui - consiglia il Pontefice - si deve tener conto se si vuole lottare contro la poverta’ materiale in modo efficace e duraturo".
Benedetto XVI già nella sua “Deus Caritas est”aveva avuto parole severe verso la globalizzazione, che ripete oggi: “La globalizzazione da sola e’ incapace di costruire la pace e, in molti casi, anzi, crea divisioni e conflitti", continua il Papa, sottolinenando che la globalizzazione ha bisogno di "essere orientata verso un obiettivo di profonda solidarieta’ che miri al bene di ognuno e di tutti". "In questo senso - scrive - va vista come un’occasione propizia per realizzare qualcosa di importante nella lotta alla poverta’ e per mettere a disposizione della giustizia e della pace risorse finora impensabili".
Per il Pontefice, "l’allargamento della questione sociale alla globalita’ va considerato nel senso non solo di un’estensione quantitativa, ma anche di un approfondimento qualitativo sull’uomo e sui bisogni della famiglia umana".
-
-
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! Caro BENEDETTO XVI ... --- «Sapienti sat» - «questo basta a chi capisce» - solevano dire gli antichi romani. Chi conosce la situazione della Chiesa non ha bisogno di ulteriori spiegazioni (di Hans Kung).22 luglio 2008, di Federico La Sala
Il Papa e Bush uniti negli errori
di HANS KÜNG (La Stampa, 22/7/2008)
In aprile Benedetto XVI festeggiò i suoi 81 anni con George W. Bush alla Casa Bianca. Curioso: il Papa, ambasciatore di pace e verità, che brinda con un presidente di guerra che, anche agli occhi di molti americani, con le bugie e la propaganda ha trascinato una grande democrazia in una guerra brutale, senza apparenti strategie per uscirne.
Secondo un sondaggio recente, l’80 per cento degli americani è convinto che gli Stati Uniti sono «sulla strada sbagliata». Di qui lo slogan di questa campagna elettorale per la Casa Bianca: «Cambiamento». E il Papa? A parte una tardiva ammissione di colpa per gli innumerevoli casi di pedofilia tra il clero cattolico, non ha praticamente detto una sola parola di cambiamento nella chiesa e nella società.
George W. Bush e Joseph Ratzinger sono diversi per carattere, istruzione e modo di parlare come possono esserlo un cowboy del Texas e un prelato romano. Bush non ha mai mascherato il suo atteggiamento anti-intellettuale. La sua conoscenza della storia è limitata tanto quanto la sua conoscenza della geografia, della lingue straniere e della filosofia. Una raccolta delle sue famigerate gaffe linguistiche e logiche («Bushism») ha prodotto molte risate. La sua visione del mondo è racchiusa nel modello manicheo dell’opposizione tra bene («noi») e male («loro»). All’opposto, Benedetto XVI ha goduto di un’eccellente istruzione classica e ha imparato alcune lingue straniere. Il suo pensiero è sottile, il linguaggio raffinato, le azioni prudenti. Per un quarto di secolo ha osservato attentamente le cose del mondo dalle finestre del Vaticano. Nel decidere si lascia guidare dalle usanze centenarie della Curia romana, il corpo amministrativo della Chiesa cattolica romana.
I due però hanno anche molto in comune. Entrambi amano le apparizioni pompose, siano esse su un aereo o davanti alle masse in piazza San Pietro. In occasione della visita del Papa, il Presidente tentò di competere con il cerimoniale imperiale del pontefice romano ricorrendo a una guardia d’onore e una salva con 21 cannoni. Sia il Presidente sia il Papa condividono un atteggiamento conservatore, soprattutto quando si tratta di controllo delle nascite, morale familiare, esibita devozione cristiana. Nel caso del presidente, questo atteggiamento sembra piuttosto fondamentalista; nel caso del Papa, sovraccarico di tradizione. Ovviamente, entrambi ritenevano che tutta questa ostentazione di fondamenta morali condivise avrebbe fatto guadagnare punti con il pubblico americano.
Nel suo recente viaggio di commiato nelle capitali europee, era evidente che il Presidente, che ha incontrato solo fiacca indifferenza anziché dimostrazioni ostili, è stato cancellato come un’anatra zoppa. Imperterrito, ha ripetuto il suo discorso sulla lotta per la libertà e la democrazia, per la «sicurezza» e la pace. In questo modo ha mostrato la sua personale versione di infallibilità, che lo rende incapace di imparare alcunché e gli impedisce di cogliere una qualunque occasione per ammettere la sua colpa di fronte all’immenso disastro che le sue azioni hanno creato nel mondo.
Il Papa, invece, non è un’anatra zoppa. E anche se lui, secondo una più recente dottrina romana, ha ancora una certa «infallibilità nelle questioni di fede e morale», è però capace di imparare. Dopo tutto ha concesso a me, suo critico, un’amichevole conversazione di quattro ore nella residenza estiva di Castel Gandolfo, nel corso della quale ha mostrato una sorprendente capacità di fare passi avanti nelle sue riflessioni. E nel viaggio in Turchia del 2006 ha corretto - con una visita fuori programma a una moschea e una chiara espressione di alta considerazione per l’Islam - le controverse osservazioni sull’Islam come religione di violenza, fatte qualche mese prima in Germania, all’Università di Ratisbona.
Il Papa è in carica da soli tre anni. Non potrebbe imparare, mi chiedo, dai fallimenti del presidente Bush? Alla sua grande intelligenza e alla sua sensibilità storica non possono sfuggire i segnali ammonitori per il futuro del suo pontificato.
Ne segnalo cinque:
1. Con la reintroduzione del tradizionale rito latino nella Messa, abolito dal Concilio Vaticano II e da Paolo VI in favore di una liturgia più accessibile nella lingua vernacolare, si è attirato molte critiche nell’episcopato e tra i pastori.
2. Nell’incontro con il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, a Istanbul, il Papa non ha dato segni di compromesso sui diritti legali romani medievali sulle chiese ortodosse e così non ha fatto nemmeno un passo avanti verso la riunificazione tra Est e Ovest.
3. Con le apparizioni pubbliche in sontuose vesti liturgiche nello stile di Leone X, che voleva gustare il pontificato in tutti i suoi agi e che porta la responsabilità principale per il «no» di Roma alle richieste di riforma di Lutero, Benedetto XVI ha confermato l’idea di molti protestanti che il Papa non conosce in profondità la Riforma.
4. Mantenendo rigidamente la legge medievale del celibato per il clero occidentale, porta la principale responsabilità del declino del sacerdozio cattolico in molti Paesi e del crollo delle tradizionali strutture della cura pastorale nelle sempre più numerose comunità rimaste senza prete.
5. Insistendo sulla perniciosa enciclica Humanae vitae contro qualunque forma di controllo delle nascite, il Papa condivide la responsabilità della sovrappopolazione, soprattutto nei Paesi più poveri, e dell’ulteriore diffusione dell’Aids.
Quella che il giornalista Jacob Weisberg chiama «la tragedia di Bush» non dovrebbe indurre Benedetto XVI a pensare più attentamente alle sue azioni? Mal consigliato dai neoconservatori e tenacemente appoggiato da media compiacenti, Bush voleva portare il suo Paese in una «nuova era americana». Ora finisce la sua carriera da fallito, a stento rispettato dal suo stesso partito.
«Sapienti sat» - «questo basta a chi capisce» - solevano dire gli antichi romani. Chi conosce la situazione della Chiesa non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! --- Don Primo Mazzolari e la differenza tra il Deus CHARITAS del messaggio evangelico e il Deus CARITAS di Ratzinger (e non solo) - la carità pelosa (di don Aldo Antonelli).10 luglio 2008, di Maria Paola Falqui
La Carità Pelosa
di Aldo Antonelli *
Così si chiamava, dalle nostre parti, l’amore prigioniero del gesto pietoso e cieco della responsabilità adulta: "Carità Pelosa".
L’espressione mi è tornata in mente di fronte all’uscita geniale del Tremonti che reistaura, in chiave moderna, la vecchia "tessera annonaria"...in piena linea con la cultura fascista e con la morale doppiopettista della destra.
Sì: carità pelosa!
Si tratta di un sentimento epidermico di compassione emotiva che però, oltre alle distanze dalla miseria, mantiene anche le cause che la generano. Si tratta dell’ipocrisia propria di chi ti fa dono del superfluo dopo averti rapinato del necessario.
"La Carità, ebbe a scrivere il grande Paul Ricoeur, non è forzatamente là dove la si esibisce...essa è molto spesso il senso nascosto del sociale".
Nel primo dopoguerra, nel febbraio del 1950, ad una "pia donna" scandalizzata per la durezza del suo linguaggio contro le facili e inutili elemosine, don Primo Mazzolari rispondeva lapidariamente:
"Ma cos’è la Carità? La prego a non voler rimpicciolire fino alla pusillanimità più meschina questo termine sacro. La Carità è anche violenza (violenza d’amore), la Carità è anche rampogna. Legga S.Paolo, legga S.Girolamo, legga santa Caterina da Siena o rilegga semplicemente - ma più attentamente - il Vangelo. Quando Cristo dice "guai a voi", "ipocriti", "sepolcri imbiancati" era mosso da carità come quando guariva i lebbrosi o sbendava Lazzaro richiamato dal sepolcro. La carità esige anche le parole dure, quando sono necessarie. Altrimenti, col bruciarci l’incenso l’un l’altro, finiremo con l’accecarci di più. Non si scandalizzi dunque, brava signora, delle parole forti, della carità che grida. Si scandalizzi piuttosto del quieto e sonnolente conformismo che ci sta prendendo...".
Segno di questo "sonnolente e quieto conformismo" è anche il silenzio che ha accompagnato la grande trovata del ministro Tremonti nel voler reintrodurre la "Poverty Card". Non vi pare?
Contro questo imbecille silenzio, ho trovato interessante un articolo di Roberta Carlini sull’ultimo numero di Rocca.
Scrive, tra l’altro:
«C’è molto del ministro Tremonti, in questa "poverty card": un certo clima emergenziale da economia di guerra, un grande fiuto per le politiche di immagine, una forte spregiudicatezza nel vendere la propria merce politica (in fondo, di ben pochi soldi si tratta nel bilancio familiare di un anno, e anche nel bilancio pubblico italiano). E soprattutto, c’è una concezione del welfare che salta a pié pari il Novecento per tornare all’Ottocento: la carità, sentimento privato che si fa politica pubblica e cancella i diritti dei cittadini per riconoscere solo, in modo compassionevole e discrezionale, i bisogni dei poveretti. Le dame di San Vincenzo assunte dallo Stato e infilate in un chip elettronico».
In allegato l’articolo per intero.
Aldo
Dietro la Politica del Consenso Facile
(Roberta Carlini - Rocca 14/2008)
In alcune catene di supermercati in Italia già esiste il giorno del nonno. Un giorno - a volte due - a settimana, durante i quali i pensionati fanno la spesa con lo sconto. Gli strateghi del marketing di quei supermercati non hanno messo tetti di reddito o carte di identificazione: sanno che difficilmente un manager in pensione si metterà in coda per comprare pasta e scatolame col 10% di sconto. E comunque quel che a loro interessa è attrarre il cliente, non è che hanno tra i loro scopi quello di fare giustizia sociale. Forse Giulio Tremonti, ministro dell’Economia, si è ispirato al marketing della grande distribuzione più che ai ricordi delle tessere annonarie del passato, quando ha introdotto nella manovra economica del governo la «card» per la spesa dei pensionati poveri. 400 euro di spesa l’anno, per un milione e duecentomila pensionati. Nessun aumento di pensioni troppo basse, nessun intervento su prezzi impazziti: ma soldi, in contanti o meglio in moneta elettronica, da spendere in beni di prima necessità. Seguiranno accordi con la grande distribuzione per promozioni ulteriori. Ma intanto il marchio commerciale della manovra è impresso: carità per i poveri.
Ritorno all’ 800
«La manovra approvata in soli 9 minuti dal consiglio dei ministri ha lanciato un messaggio eloquente e forte: non esiste più uno stato sociale; d’ora in poi esisteranno solo politiche di soccorso per i bisognosi», ha scritto Nadia Urbinati su La Repubblica all’indomani dell’annuncio della «tessera di povertà». La controprova più evidente è nella rassicurazione, fatta dallo stesso governo, sul fatto che la tessera sarà distribuita dalle Poste con garanzie di riservatezza. Eh già: a nessuno piace esporre l’etichetta di «povero» sul portone della propria dignitosa abitazione o sul bavero della propria vecchia giacca. Soprattutto se a questa condizione di povertà si è giunti dopo una vita di lavoro duro. Ma questo fa la tessera: dà la qualifica burocratica al povero, che, privacy o non privacy, dovrà tirarla fuori al supermercato per pagare il pacco di pasta. E difficilmente la camufferà porgendola alla cassiera con disinvoltura insieme alla carta di credito.
C’è molto del ministro Tremonti, in questa «poverty card»: un certo clima emergenziale da economia di guerra, un grande fiuto per le politiche di immagine, una forte spregiudicatezza nel vendere la propria merce politica (in fondo, di ben pochi soldi si tratta nel bilancio familiare di un anno, e anche nel bilancio pubblico italiano). E soprattutto, c’è una concezione del welfare che salta a pié pari il Novecento per tornare all’Ottocento: la carità, sentimento privato che si fa politica pubblica e cancella i diritti dei cittadini per riconoscere solo, in modo compassionevole e discrezionale, i bisogni dei poveretti. Le dame di San Vincenzo assunte dallo Stato e infilate in un chip elettronico.
Populismo al governo
Però piace, si dice. Quei pensionati che avranno la carta magari cercheranno di andare a fare la spesa in orari non di punta per non farsi vedere, ma saranno contenti di risparmiare qualcosa. Così come piace - si dice - la voce grossa del ministro con petrolieri e banche. E piace, certo che piace, l’eliminazione della tassa sulla prima casa. Tutti pezzi singoli di un quadro più generale di politica del consenso facile, della quale poco si studiano e si sanno gli effetti di medio periodo ma si esaltano quelli di brevissimo periodo: l’indice di popolarità del governo cresce. È il populismo, bellezza. Ma poiché non tutti si accontentano degli annunci, e c’è molta gente desiderosa di andare a guardare dentro i contenuti delle politiche - al di là dell’effetto immediato sui propri portafogli, e al di là dei titoli acritici dei Tg -, sarà meglio cercare di capire, misura per misura, cosa c’è sotto l’abito scin-tillante del populismo al governo.
Una piccola mancia
La Carta per i poveri, per cominciare. Suo scopo è quello di alleviare la situazione economica delle famiglie con anziani, di fronte al crescente carovita. È chiaro che all’origine del problema di quelle famiglie c’è la combinazione di due fattori: pensioni troppo basse, prezzi che crescono troppo. Alle prime non ha posto rimedio nessuna riforma delle pensioni delle tante che si sono succedute negli ultimi decenni, né ovviamente porrà riparo la carta elettronica. Quanto ai prezzi, la ripresa dell’inflazione degli ultimi mesi è dovuta alla combinazione di fattori esterni - lo choc mondiale dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime - e interni. Tra questi ultimi, la catena della produzione e distribuzione in Italia, che ha speculato sulle tensioni internazionali aumentando i prezzi assai prima e assai più di quanto i costi lo giustificassero. Cose complicate, troppo lunghe da spiegare figuriamoci da risolvere. E infatti non ci si prova nemmeno, e in teoria la carta per i poveri - ove funzionasse a pieno, cioè fosse assai più estesa e consistente - potrebbe addirittura alimentare il meccanismo perverso delle speculazioni sui prezzi.
Ma il governo di destra stravittorioso alle elezioni non si limita a «dare» ai poveri una piccola mancia. Fa di più: dice che l’ha presa dai ricchi, dalle categorie più odiate del momento, ossia petrolieri e banchieri. I primi, perché identificati con i beneficiari di tutti i soldi che paghiamo quando facciamo il pieno. I secondi, perché stanno strozzando tante famiglie italiane con mutui a tassi crescenti. Della tassa sul petrolio si aspetta di capire quando e quanto sarà trasferita sui prezzi.
Un grosso regalo
Quanto alla velleità di tagliare le unghie alle banche, più che di un dispetto pare si sia trattato di un manicure. Dopo i primi fumi - che hanno garantito una giornata di grande pubblicità per il governo, che pareva avesse con una bacchetta magica riportato le rate del mutuo ai livelli di due-tre anni fa. In realtà, l’unica novità che le famiglie indebitate si sono trovate davanti - anzi si troveranno, perché ancora l’annuncio si deve tradurre in realtà - è una nuova offerta commerciale da parte della propria banca. Un’offerta standard per rinegoziare il mutuo: abbassando la rata e allungando la durata. Così, la banca mette al sicuro un credito a rischio e il cliente diluisce il problema negli anni. Ma alla fine paga di più. Dal punto di vista individuale, può essere un’offerta di quelle che non si possono rifiutare: chi non ha i soldi per pagare accetta la rinegoziazione non perché la trova conveniente ma per necessità. Ma dal punto di vista collettivo, l’aver inventato una convenzione-standard, una megasoluzione uguale per tutti ha salvato le banche da effetti spiacevoli di quella strana bestia chiamata concorrenza. Quella per cui, magari, può arrivare un’altra banca a sostituirti il vecchio mutuo con un altro a condizioni migliori. Quella che le banche non si sono fatte nel momento delle vacche grasse, e grazie all’accordo col governo non si faranno adesso.
Tutti i giornali, che fossero a favore o contro, e prima ancora di sapere esattamente cosa ci fosse dentro, hanno accettato di battezzare come «Robin tax» la nuova tassa sui profitti dei petrolieri. Altrettanto hanno fatto tg e radio. Certo quella di Robin Hood è un’immagine forte, e simpatica anche. E i tempi cambiano, e anche i comportamenti umani, per cui è perfettamente possibile che il fiscalista dei ricchi diventi il loro rapinatore (fiscale). Però è strana, la fretta e la unanimità con cui si è accettata quest’immagine, invece di andare a indagare sull’esatto contenuto del «furto» di Robin Tremonti ai «ricchi». E invece di chiedersi come mai i «poveri» sono tornati così ufficialmente tra noi, cessando di fare scandalo per diventare poveri di Stato.
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- L’appello del Papa ai leader del G8. -"Si occupino di poveri e deboli".6 luglio 2008, di Maria Paola Falqui
Benedetto XVI da Castel Gandolfo: "Mettano al centro delle deliberazioni le necessità delle popolazioni più bisognose. Basta speculazioni sui prezzi di alimenti ed energia"
 L’appello del Papa ai leader del G8
L’appello del Papa ai leader del G8
 "Si occupino di poveri e deboli"
"Si occupino di poveri e deboli""Occorre rilanciare un equo processo di sviluppo integrale a tutela della dignità umana"
CASTEL GANDOLFO - Il papa si appella ai capi di Stato e di governo dei paesi membri del G8, che si apre domani in Giappone, perché "al centro delle loro deliberazioni mettano i bisogni delle popolazioni più deboli e più povere" ed esorta la comunità internazionale "a prendere decisioni atte a rilanciare un equo processo di sviluppo integrale, a salvaguardia della dignità umana".
Recitando l’Angelus dalla residenza estiva sulle pendici del lago di Albano, Benedetto XVI ha salutato prima la comunità di Castel Gandolfo, "che mi riserva sempre, durante il mio soggiorno, una cordiale e premurosa accoglienza", per poi occuparsi del vertice economico che si apre nell’isola di Hokkaido in Giappone lunedì.
"In questi giorni si sono alzate numerose voci, tra cui quelle dei presidenti delle Conferenze episcopali delle citate nazioni - ha detto il papa - per chiedere che si realizzino gli impegni assunti nei precedenti appuntamenti del G8 e si adottino coraggiosamente tutte le misure necessarie per vincere i flagelli della povertà estrema, della fame, delle malattie, dell’analfabetismo, che colpiscono ancora tanta parte dell’umanità. Mi unisco anch’io - ha detto Ratzinger - a questo pressante appello alla solidarietà".
"Mi rivolgo quindi ai partecipanti all’incontro di Hokkaido, affinché al centro delle loro deliberazioni mettano i bisogni delle popolazioni più deboli e più povere, la cui vulnerabilità è oggi accresciuta a causa delle speculazioni e delle turbolenze finanziarie e dei loro effetti perversi sui prezzi degli alimenti e dell’energia. Auspico - ha concluso - che generosità e lungimiranza aiutino a prendere decisioni atte a rilanciare un equo processo di sviluppo integrale, a salvaguardia della dignità umana".
* la Repubblica, 6 luglio 2008.
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ----- Una delle idee più radicate nella cultura occidentale è quella per cui la proprietà privata sia un «diritto naturale», qualcosa di tanto spontaneo da motivare perfino un bambino: «Questo gioco è mio!». (di Ugo Mattei).27 marzo 2008, di Federico La Sala
I conquistadores dell’intelletto generale
di Ugo Mattei ( il manifesto, 26 marzo 2008)
I brevetti legittimano le «enclosures» del sapere operate dalle multinazionali. Allo stesso tempo favoriscono la biopirateria delle virtù nutrizionali e terapeutiche di alcune piante L’appropriazione della conoscenza è giustificata attraverso le opere di John Locke, laddove il filosofo britannico parla del beneficio generale derivato dall’occupazione della «terra nullius». Oggi come allora il privato è sinonimo di innovazione e creatività, mentre il pubblico è il regno della pigrizia
Una delle idee più radicate nella cultura occidentale è quella per cui la proprietà privata sia un «diritto naturale», qualcosa di tanto spontaneo da motivare perfino un bambino: «Questo gioco è mio!». Se da molto tempo ormai abbiamo smesso di interrogarci sulle ragioni per cui certi individui «hanno» mentre altri «non hanno», ciò è dovuto principalmente al fatto che abbiamo interiorizzato l’ideologia sui caratteri «naturali» e virtuosi del diritto di proprietà private indipente dalla sua distribuzione. In questo siamo oggi tutti un po’ lockiani, perchè abbiamo «risolto» il problema di una società divisa fra possidenti e non possidenti voltandoci all’indietro, con una semplice teoria fondata sulle origini remote della proprietà privata e sulla catena dei trasferimenti fondata su una nozione di «giusto titolo» originario, che prescinde quindi dall’analisi della distribuzione odierna.
Come noto, il filosofo britannico John Locke fondava la propria giustificazione della proprietà privata individuale sulla naturale attività di occupazione di risorse comuni non ancora privatizzate e legittimava il fatto che il governo civile tutelasse (con risorse di tutti, quali la polizia o le corti di giustizia) tale occupazione individuale per due ordini di ragioni: da un lato, sostenendo che l’occupante immette il proprio lavoro, e quindi in parte se stesso, nella cosa bruta, rendendola così fruttifera e quindi benefica per tutti. D’altra parte, il filosofo considerava la naturale occupazione individuale legittima soltanto nella misura in cui rimanessero comuni (e quindi libere per l’occupazione altrui) altre risorse di simile natura e qualità. Con il tempo e l’affollarsi della società, questa seconda specificazione è stata dimenticata e fa oggi quasi sorridere se applicata agli immobili. Essa tuttavia mantieneun immutato potere legittimante criptico. Certo, non esiste (quasi) più terra nullius da occupare, almeno in Occidente, e gli esempi di scuola sull’acquisto della proprietà privata per occupazione sono ormai limitati alle conchiglie sul lido del mare.
Economia dell’innovazione
Nondimeno, gran parte dell’«economia dell’innovazione» ci ha quasi ipnotizzati convincendoci che grazie al progresso tecnologico, la «crescita» possa continuare in eterno sicchè le dimensioni della torta (Pil, il prodotto interno lordo) siano la sola cosa di cui valga la pena di preoccuparsi: «Finirà il petrolio? Inventeremo la fusione fredda!». La presente generazione continui felice a bruciarlo alla guida dei suoi Suv perchè continuando a crescere l’economia, le prossime generazioni inventeranno nuove «risorse comuni» da privatizzare. Della distribuzione non vale la pena di preoccuparsi. Il benessere di tutti seguirà, automatico, alla diffusione geografica dello sviluppo e della tecnologia occidentale.
La teoria «naturalistica» dell’occupazione che lega la proprietà private al lavoro, all’ innovazione e alla stessa identità dell’individuo, non giustifica quindi oggi soltanto attività bucoliche e economicamente marginali quali la raccolta delle conchiglie, dei funghi, o magari la caccia e la pesca. Essa continua a offrire una potente legittimazione ideologica a favore del privato rispetto al pubblico, descrivendo soltanto il primo come luogo virtuoso in cui l’individuo mette in gioco se stesso, lavora, rischia, investe, crea, innova. In questa luce, il pubblico è il luogo della pigrizia, della scarsa o nulla produzione di valore aggiunto, delle risorse abbandonate a se stesse e non «messe in valore» perchè nessun individuo, se la privatizzazione non è consentita, vi introduce lavoro ed investimento identitario. L’imagine è suggestiva e profondamente legata all’idea forte, protoilluminista, per cui sia un bene che l’uomo domi la natura, in particolare la terra. La virtù della terra privatizzata è simboleggiata dalle campagne inglesi, successive alle enclosures ben arate e con confini perfettamente tracciati. La terra non domata dalla proprietà private sarà invece selvatica, boscosa, piena di sterpaglia, «inutile».
Tale ideologia, oltre ad essere primitiva ed etnocentrica, risulta infantile nel suo individualismo di fondo, perchè si basa su irreealistiche premesse filosofiche, quale quelle del Robinson Crosue discusso dal teorico libertario Robert Nozick (la verità è invece che un uomo solo, in natura, lungi dall’occupare, muore perchè soltanto la cooperazione di specie ha consentito la sopravvivenza originaria e quindi la proprietàin origine non poteva che essere del gruppo).
Lo spettacolo della ricchezza
L’ideologia della proprietà privata si basa su una concezione riduttiva e semplificata del rapporto fra individuo proprietario (il soggetto) e l’oggetto del suo possesso. Essa, già poco adatta a cogliere la complessità del rapporto fra un individuo ed un bene materiale e tangibile (la terra, un libro, un piatto di spaghetti) mostra i suoi limiti teorici di fondo, ma al contempo la sua potenza suggestive ed ideologica nel momento in cui viene utilizzata per descrivere e gestire rapporti sociali del mondo che stiamo vivendo. Oggi infatti la forma della ricchezza appropriabile è sempre meno quella di beni tangibili e sempre più quella delle immagini, dell’informazione, degli strumenti finanziari complessi, delle idee innovative, in una parola della «ricchezza spettacolo» piuttosto che di quella tangibile. Ma la retorica e gli strumenti intellettuali che ne giustificano il controllo esclusivo in capo ad alcuni privati piuttosto che il loro godimento in commune non sono mutati affatto.
A chi appartiene la mitica foto scattata il 16 ottobre del 1968 a Città del Messico e ritraente Tommie Smith e John Carlos con il pugno guantato delle black panthers dopo il trionfo nei 200 piani? al fotografo? agli atleti? al nostro immaginario collettivo? Chi ha «inventato» l’uso igienico della pianta di neem considerate da generazioni di indiani la «farmacia del villaggio»? I ricchi proventi che le multinazionali del dentifricio derivano dal suo brevetto in Florida a chi dovrebbero appartenere? Alla comunità che utilizzava la pianta per igiene orale e che oggi non può più permettersela perchè i prezzi sono saliti alle stelle? O ai ricercatori che hanno «scoperto» questo antico uso? E che dire della pianta di Maca, da secoli utilizzata delle popolazioni andine e che oggi contende (appositamente brevettato) una fetta del ricco mercato dei prodotti erettili maschili vantando la propria naturalezza? Chi ha inventato la tradizione di ricerca matematica di base, indispensabile radice di tanti miracoli dell’informatica moderna che, brevettati, riempiono le tasche di Bill Gates? E che dire delle nuove frontiere di Internet, quei domain names che si possono «naturalmente» occupare pagando «appena» venti dollari (lo stipendio mensile di qualche miliardo di persone) e connettendosi in rete (un privilegio di un’infima minoranza degli umani)?
Aborigeni e Wto
Sono, queste, domande ormai assai semplici per il mainstream giuridico economico e politico del mondo globale che, grazie alla vecchia ideologia individualistica, fondata su una nozione apparentemente naturale, minima e virtuosa di proprietà privata, come fonte della creatività e laboriosità individuale, trova nelle regole della «proprietà intellettuale» codificate negli accordi Trips («Trade Related Aspects of Intellectual Property») collegati all’Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) la risposta ad ogni dubbio su chi sia o debba essere il «proprietario» dotato del potere di escludere tutti gli altri. Colpisce l’uso della medesima retorica del progresso, che legittimò giuridicamente il saccheggio delle terre nullius, che gli Amerindiani sfruttavano collettivamente ed in modo ecologicamente compatibile, non conoscendo l’idea che la terra possa appartenere all’uomo. Gli Amerindiani, infatti, credevano infatti che, insieme a tutte le altre specie animali e vegetali, appartenevano alla terra, così come ad essa ancor oggi appartengono i vari lignaggi africani in cui i viventi ricevono dagli avi il mandato a mantenere la terra nell’interesse delle generazioni future. Il rapporto fra soggetto ed oggetto può presentarsi capovolto e non è affatto detto che capovolto non debba essere anche il rapporto fra privato e publico, se soltanto si sposasse una logica un po’ più attenta al lungo periodo e non una dettata dalle scadenze elettorali o dal rendiconto trimestrale con cui le corporations comunicano con gli azionisti.
Proprio come allora i conquistadores consideravano prova della natura selvaggia delle popolazioni aborigine il non conoscere la proprietà privata, oggi la comunità internazionale esercita pressioni poderose a favore dell’appropriabilità privata della terra in Africa e delle idee in Cina. La retorica utilizzata dagli apparati politici ed ideologici dell’Occidente dominante è anche oggi, come allora, quella dell’innovazione, del progresso e dello sviluppo. Molti africani tradizionali resistono o cercano di resistere alla vendita dei loro campi alla Monsanto, che corrompe il sistema per acquistarli e sperimentare l’innovazione «creativa» degli Ogm, che le consentirà di escludere pratiche collettive antichissime quali la selezione e lo scambio delle sementi. Similmente, molti cinesi sembrano ancora credere nella massima confuciana per cui «rubare un libro è una violazione elegante», non concependo l’idea che la cultura, prodotta da tutti, possa essere racchiusa in uno strumento accessibile soltanto a chi possa pagare per possederlo.
Saccheggio oligopolistico
Tali concezioni culturali, diverse dal «naturale» e virtuoso appetito acquisitivo lockiano che fonda l’intera scienza economica dominante, (inclusa la sua teoria della proprietà intellettuale come «monopolio virtuoso») secondo cui nessun individuo creerebbe se non incentivato dalla speranza di una compensazione materiale per il proprio sforzo di creatività, sono ben documente dalla letteratura antropologica. Etnie recessive ma assai sagge quali i Kayapo dell’Amazzonia, non credono che la conoscenza sia il prodotto dell’uomo ma della natura. Inoltre, secondo loro, la conoscenza è sempre intergenerazionale non potendo mai appartenere soltanto alla generazione presente. Essa è sempre ricevuta liberamente e va liberamente tramandata di generazione in generazione. Certo non può esser proprietà privata di un individuo che, anche qualora intelligentissimo ed intuitivo, deve al gruppo la sua intelligenza e a beneficio di questo devono ricaderne i frutti che del resto non sarebbe esistiti se qualcuno non gli avesse insegnato le basi.
Ma il rozzo semplicismo delle teoriche dominanti sulla proprietà intellettuale viene smascherato anche dalle frontiere della conoscenza tecnologica, dove prodotti come l’enciclopedia Wikipedia o il software Linux confutano senza appello le basi motivazionali della teoria lockiana della proprietà.
Una domanda sorge spontanea: se è stato così facile trasferire la retorica della proprietà privata dal mondo materiale a quello delle idee, non dovrebbe essere altrettanto facile tornare indietro, facendo tesoro delle contraddizioni teoriche che l’individualismo proprietario mostra quando esteso al mondo delle idee al fine di travolgerne la funzione di legittimazione della proprietà privata mal distribuita in tutte le sue forme?
Forse allora si capirebbe che la privatizzazione, lungi dal garantire creatività, virtù ed ordine giuridico altro non è che una forma, assai poco sofisticata di saccheggio oligopolistico degli spazi pubblici, per la semplice ragione che un mercato competitivo fra pari non esiste, nè potrà mai esistere, se non nella retorica incolta di qualche promessa elettorale.
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- PAPA, SARA’ ’CARITAS IN VERITATE’ LA SUA NUOVA ENCICLICA (di Nina Fabrizio, Ansa).12 marzo 2008, di Federico La Sala
Ansa» 2008-03-12 20:31
PAPA, SARA’ ’CARITAS IN VERITATE’ LA SUA NUOVA ENCICLICA
(di Nina Fabrizio)
"Caritas in veritate": sarà questo il titolo della prossima enciclica di Benedetto XVI, la terza del suo pontificato, dedicata ai temi sociali. Attesa già prima della precedente enciclica del Papa, la "Spe Salvi", l’enciclica sociale era stata momentaneamente accantonata da Ratzinger in favore di quella sulla Speranza. Ora, dopo essere stata rivista dai diversi dicasteri che hanno collaborato alla sua elaborazione, la "Caritas in veritate" (in italiano "Carità" o "Amore nella verità") è pronta per essere pubblicata anche se sulla data c’é ancora incertezza. Avrebbe dovuto essere il primo maggio, festa di San Giuseppe Lavoratore, ma potrebbe slittare a causa del tempo necessario per le traduzioni.
La lettera del Papa sarà diffusa infatti per la prima volta fin dall’inizio anche in cinese, per la volontà di Benedetto XVI di far arrivare il suo messaggio anche ai cattolici di Pechino, e forse in arabo. L’atteso documento papale, che sarà diviso in quattro capitoli, nella sua parte iniziale sarà celebrativo di altre due precedenti encicliche. La "Populorum progressio", del 1967, di papa Paolo VI, di cui sono stati celebrati i quaranta anni dalla pubblicazione, e la "Sollicitudo rei socialis", di Giovanni Paolo II, pubblicata invece nel 1987, che Ratzinger ha voluto richiamare, ritenendo anch’essa un fondamentale riferimento sui temi sociali. Nelle parti successive viene sviluppato il tema di quanto sia stata profetica la "Populorum progressio", ma il documento di Benedetto XVI esprime soprattutto la visione della Chiesa rispetto ai cambiamenti sociali che sono avvenuti a partire proprio dai tempi dell’enciclica montiniana.
L’analisi di Ratzinger riguarderà quindi i problemi posti dal processo di globalizzazione e la necessità di un umanesimo che concili lo sviluppo sociale ed economico con il rispetto dovuto alla persona umana e con un giusto rapporto tra le categorie sociali, attenuando le eccessive disparità tra ricchi e poveri. Povertà, pace, cooperazione internazionale, disarmo, guerre su fonti energetiche e ambiente, globalizzazione, divario digitale, microcredito: sono tutti temi che verranno toccati nel documento, piuttosto corposo, che potrebbe ancora subire qualche correzione dell’ultima ora da parte di Benedetto XVI. La pubblicazione di una terza enciclica a così breve distanza dalle precedenti è fatto piuttosto eccezionale che testimonia quanto i temi sociali siano cari a Benedetto XVI e a tutta la Chiesa cattolica. Una enciclica sociale, infatti, era già stata oggetto della discussione delle riunioni del collegio cardinalizio durante la sede vacante, prima del conclave che ha eletto Joseph Ratzinger e sul tema c’era stata anche, più volte, l’attenzione di Wojtyla che lo riteneva prioritario per la Chiesa del futuro.
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Quello a "motu proprio"? "Sàpere aude!". Faccia come insegna CONFUCIO. Provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ (Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.17 febbraio 2008, di Maria Paola Falqui
Se il prete è un Assassino
di Maurizio Chierici (l’Unità, 11/02/200) *
C’È un prete assassino condannato all’ergastolo che per la Chiesa è ancora prete. La gerarchia tace e aspetta, ma cosa? Quando un sacerdote tradisce le regole che guidano la missione, la Chiesa lo isola dai fedeli: sospeso a divinis. Ancora nessuna sospensione per il sacerdote Christian Von Wermich chiuso nel carcere penale di Buenos Aires: testimoni e documenti hanno provato la sua responsabilità in 7 omicidi, 42 arresti illegali, 31 casi di tortura. Anni della dittatura militare. «Non odiate chi vi sta torturando. Volontà di Dio» erano le sue parole di conforto distribuite dal padre consacrato nelle quattro prigioni segrete attorno a Buenos Aires.
I militari lo invitavano a spiare e Von Wernich usava la confessione per far parlare quei prigionieri che non si arrendevano alla tortura. Per dire cosa, poi? Nomi di compagni di scuola scandalizzati dalla violenza dei generali P2; chiacchiere tra studenti. Von Wermich confessava con la doppia morale di un malandrino. Li sollecitava ad abbandonarsi al perdono di Dio, e se l’abbandono interessava la polizia, riferiva, e altre persone sparivano. Quattro mesi fa guardavo Von Wernich nel maxischermo che ne allargava il volto davanti tribunale di La Plata. Indifferente mentre i giudici leggevano la condanna. Appena un sorriso di scherno, come per dire «in qualche modo ne uscirò». Negli appunti ritrovo pagine che il silenzio della Chiesa obbliga a ricordare per far capire cosa non sta succedendo.
Hector Timerman, console generale dell’Argentina a New York, riferisce ciò che il padre - Jacobo Timerman, direttore di un giornale indipendente - ha raccontato e scritto a proposito del sacerdote. «Era presente ai miei interrogatori e quando la benda che fasciava gli occhi si abbassava per effetto delle scariche elettriche, vedevo Von Wermich seduto accanto al capo della polizia di Buenos Aires, Ramon Camps. Mi guardavano come si guarda un cane che sta morendo». Nei verbali del tribunale la commozione di Maria Mercedes Molina Galarza: è nata in una prigione segreta, Von Wermich l’ha battezzata promettendo a Maria Mercedes e ad altri sei ragazzi, tranquilli, vi accompagnerò al confine. La vostra pena sarà l’esilio. Von Wermich ha consegnato la bambina ai nonni: molto devoti, gli si erano rivolti per sapere qualcosa della figlia scomparsa. «Si farà viva lei, forse fra un anno, forse da un altro paese. Non posso dire di più». Con la piccola fra le braccia, il cuore dei nonni si è aperto. Hanno preparato una valigia, vestiti, qualche soldo. «Ne avrà bisogno. Gliela consegno personalmente. Mi raccomando, silenzio...». Ma il viaggio della ragazza madre (Liliana Galarza) e dei suoi compagni, è stato un viaggio breve. Julio Emilio Emmended, poliziotto condannato per sette delitti, racconta come è finito. «Padre Christian Von Wernich benedice i sovversivi ammanettati e mi raggiunge nell’automobile dove aspettavo assieme a Jorge Bergés, medico della polizia segreta. ’Adesso sono vostri’. Allora scendo con la pistola in mano e quando i sovversivi vedono la pistola cercano di disarmarmi ma hanno le mani legate. Colpisco col calcio dell’arma, li stordisco. Interviene il medico: due iniezioni per uno, sempre nel cuore. Il liquido è rosso, veleno. Sconvolto, li vedo morire ma padre Von Wermich mi rincuora. ’L’hai fatto perché la patria. Dio sa che hai agito per il bene del paese’. Avevo le mani sporche di sangue. E del sangue dei ragazzi era macchiato l’abito del padre ...».
Le voci sono tante, i documenti precisi. Crolla la dittatura e Von Wernich sparisce. Passa dal Brasile, lo ritrovano in Cile: un settimanale di Santiago lo fotografa mentre distribuisce la comunione non lontano dalla capitale. Il nome era falso, nessuno poteva sospettare. Possibile che la Chiesa cilena avesse affidato la cura di una parrocchia ad un sacerdote argentino senza voler sapere da Buenos Aires ’come mai è qui?’. Mistero che si perde nella rete dei cappellani militari.
Cinque minuti dopo la condanna, il comunicato della Commissione Episcopale argentina. Perché cinque minuti dopo e non quattro anni prima quando i delitti di Von Wermich erano da anni documentati? Martin de Elizaide, vescovo della diocesi della quale Von Wermich era sacerdote chiede che il religioso «venga assistito affinché riesca a comprendere e riparare il danno arrecato con scelte personali che non coinvolgono le istituzioni». Lascia capire che la procedura necessaria alla Chiesa per prendere una decisione sarà lunga: non ne fissa il tempo. In fondo, è solo uno dei tanti sacerdoti che hanno abbracciato gli ideali fascisti della dittatura. Le trame del piano Condor allargano le complicità ai cappellani militari delle squadre della morte: America Centrale, Brasile, Cile, Uruguay, Paraguay. Con quale abbandono si sono rivolti a Dio mentre davano una mano agli assassini?
Quattro mesi fa la sentenza e la Chiesa non ha più parlato. Bisogna dire che i rapporti diplomatici tra Vaticano e Argentina sono congelati dal braccio di ferro che divide l’ex presidente Kirchner e la nuova presidente- moglie, dalla burocrazia diplomatica di Roma. Tre anni fa Kirchner nomina ambasciatore in Vaticano un ex ministro: Alberto Juan Bautista Iridarne, signore squisito ma divorziato e risposato come quattro milioni e mezzo di argentini.
Come Berlusconi, Fini e Casini considerato dal monsignor Ruini «esempio di cattolico in politica». Il Vaticano non accetta chi ha infranto il sacramento del matrimonio e un paese borghese e devoto viene rappresentato nel grigiore della routine di un incaricato d’affari. Comunicazione non interrotta, ma evanescente proprio nel momento in cui il congresso di Buenos Aires decide la dissoluzione del vescovado castrense, pastore guida dei cappellani militari.
Il passato continua ad impaurire il presente. I cappellani in divisa hanno accompagnato il golpe obbedendo ai vescovi che appoggiavano la dittatura dei generali.Von Wernich è il primo caso risolto dal tribunale, ma i nomi sono tanti, si annunciano altri processi. L’essere divorziato e l’essersi risposato non viene messo sullo stesso piano delle colpa di chi si è servito della confessione per far sparire ragazzi senza colpa, ma la soluzione è fulminea: no e subito all’ambasciatore; vediamo cosa fare per il prete assassino. Il clero argentino è diviso. Vescovi rigidi contro il governo e vescovi alla ricerca della soluzione.
Monsignor Casaretto, segretario della commissione episcopale, genovese di nonni e presidente della Caritas che ha sfamato milioni di affamati nei mesi bui della crisi economica non smette di dialogare. Intanto, nell’istituto penale dove è rinchiuso Von Wernich sono stati trasferiti militari e poliziotti arrestati dopo che il presidente Krichner ha annullato le due leggi (Punto Final e Obbedienza Dovuta) imposte dalle forze armate per consentire «la pacificazione nazionale». Molti di loro avevano atteso il processo in prigioni soffici come grandi alberghi. Camere con Tv, aria condizionata, palestre per tenersi in forma. Una certa libertà. Adesso si sono ritrovati dove dovevano essere dal primo giorno. Von Wernich li raccoglie in angoli non frequentati con l’aria di un confessore. Celebra la messa della sera e riceve la considerazione che è abitudine verso i religiosi nelle carceri argentine. Il silenzio della Chiesa continua. Forse i vescovi credono all’intrigo al quale Von Wernich si aggrappa dichiarandosi vittima di complotti senza prove mentre le prove e i racconti dei sopravissuti gli passavano sotto gli occhi in tribunale.
A Buenos Aires e in Vaticano la gerarchia cattolica è impegnata a difendere il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale. Questo diritto alla vita prevede la condanna di chi brucia la vita con torture e delitti? Passa il tempo e si aggrava il profilo morale di un assassino che ostenta dignità di sacerdote mentre la gerarchia medita dubbiosa sull’orrore delle colpe certificate dalla giustizia civile. La sopravvivenza sacerdotale di Von Wernich è lo sbalordimento che avvilisce non solo i credenti. E il mistero dei vescovi senza parole insinua nella fede dei cattolici il sospetto di uno scandalo istituzionale.
Solo qualche vescovo ha chiesto perdono alle vittime. Ma non basta mentre la memoria di un passato doloroso scuote ogni comunità: dal ricordo dell’Olocausto, alla Spagna impegnata a rileggere i crimini della guerra civile. Impossibile immaginare per Von Wermich la dolcezza di una esclusione senza sospensione a divinis che ha accompagnato la fine di Marcial Maciel, fondatore dei Legionari di Cristo. «Ussari di una Chiesa combattente alla conquista mondo». È morto negli Stati Uniti quattro giorni fa, l’Osservatore Romano ne ha rimpicciolito la memoria. Sarà sepolto nel suo Messico dove i Legionari si mescolano alla politica del governo conservatore. Nel 1968 è stato accusato da 30 seminaristi; li aveva insidiati facendo pesare l’autorità di un generale intoccabile.
Il quotidiano messicano La Jornada ne ha ricostruito i peccati con una precisione che è valsa il premio nazionale di giornalismo. Ma Roma non se ne è accorta e il Vaticano non gli è mancato di rispetto accogliendo le raccomandazioni del nunzio apostolico in Messico, monsignor Girolamo Prigione, dell’arcivescovo Norberto Rivera e dei vescovi Onesimo Cepeda ed Emilio Berlié, estremisti della destra religiosa in America Latina.
Nel dogma di un integralismo esasperato, Marcial Maciel ha aperto a Roma l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. I Legionari controllano 150 collegi, dispongono di una serie di piccoli seminari, da Monterrey a San Paolo Brasile, attorno ai campus degli Stati Uniti, si aprono scuole nell’ex impero sovietico: 550 sacerdoti, 2500 novizi, 60 mila laici raccolti in una specie di terz’ordine, il Regno di Cristo.
Dopo aver ignorato per dieci anni le accuse largamente provate, nel 2004, il cardinale Ratzinger finalmente prende in esame il caso, e nel 2006 Marcial Marcel viene comandato a lasciare la guida dell’ordine per dedicarsi ad una vita di preghiera e penitenza. Nessun processo canonico per «l’età avanzata», solo la proibizione di dire messa e parlare in pubblico. Punizione veniale per i semplici credenti, ma terribile per il padre dei Legionari: sperava d’essere beatificato con la velocità del Balaguer fondatore Opus Dei. Vanità rinviata all’eternità e senza un santo protettore nel suo ordine si allungano le ombre. Marcial Marcel aveva 87 anni, Von Wermich 69. I fedeli argentini non hanno voglia aspettare diciotto anni per sapere se la Chiesa ha deciso di allontanarsi da un prete così.
mchierici2@libero.it
Pubblicato su l’Unità http://www.unita.it
-
> "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!! ---- L’Istituto Opere Religiose è la banca del Vaticano. SCANDALI, AFFARI E MISTERI. TUTTI I SEGRETI DELLO IOR (di Curzio Maltese)..26 gennaio 2008, di Maria Paola Falqui
 L’Istituto Opere Religiose è la banca del Vaticano. In deposito 5 miliardi di euro
L’Istituto Opere Religiose è la banca del Vaticano. In deposito 5 miliardi di euro
 Ai correntisti offre rendimenti record, impermeabilità ai controlli e segretezza totale
Ai correntisti offre rendimenti record, impermeabilità ai controlli e segretezza totale Scandali, affari e misteri
Scandali, affari e misteri
 tutti i segreti dello Ior
tutti i segreti dello Iordi CURZIO MALTESE *
LA CHIESA cattolica è l’unica religione a disporre di una dottrina sociale, fondata sulla lotta alla povertà e la demonizzazione del danaro, "sterco del diavolo". Vangelo secondo Matteo: "E’ più facile che un cammello passi nella cruna dell’ago, che un ricco entri nel regno dei cieli". Ma è anche l’unica religione ad avere una propria banca per maneggiare affari e investimenti, l’Istituto Opere Religiose.
La sede dello Ior è uno scrigno di pietra all’interno delle mura vaticane. Una suggestiva torre del Quattrocento, fatta costruire da Niccolò V, con mura spesse nove metri alla base. Si entra attraverso una porta discreta, senza una scritta, una sigla o un simbolo. Soltanto il presidio delle guardie svizzere notte e giorno ne segnala l’importanza. All’interno si trovano una grande sala di computer, un solo sportello e un unico bancomat. Attraverso questa cruna dell’ago passano immense e spesso oscure fortune. Le stime più prudenti calcolano 5 miliardi di euro di depositi. La banca vaticana offre ai correntisti, fra i quali come ha ammesso una volta il presidente Angelo Caloia "qualcuno ha avuto problemi con la giustizia", rendimenti superiori ai migliori hedge fund e un vantaggio inestimabile: la totale segretezza. Più impermeabile ai controlli delle isole Cayman, più riservato delle banche svizzere, l’istituto vaticano è un vero paradiso (fiscale) in terra. Un libretto d’assegni con la sigla Ior non esiste. Tutti i depositi e i passaggi di danaro avvengono con bonifici, in contanti o in lingotti d’oro. Nessuna traccia.
Da vent’anni, quando si chiuse il processo per lo scandalo del Banco Ambrosiano, lo Ior è un buco nero in cui nessuno osa guardare. Per uscire dal crac che aveva rovinato decine di migliaia di famiglie, la banca vaticana versò 406 milioni di dollari ai liquidatori. Meno di un quarto rispetto ai 1.159 milioni di dollari dovuti secondo l’allora ministro del Tesoro, Beniamino Andreatta. Lo scandalo fu accompagnato da infinite leggende e da una scia di cadaveri eccellenti. Michele Sindona avvelenato nel carcere di Voghera, Roberto Calvi impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra, il giudice istruttore Emilio Alessandrini ucciso dai colpi di Prima Linea, l’avvocato Giorgio Ambrosoli freddato da un killer della mafia venuto dall’America al portone di casa.
Senza contare il mistero più inquietante, la morte di papa Luciani, dopo soli 33 giorni di pontificato, alla vigilia della decisione di rimuovere Paul Marcinkus e i vertici dello Ior. Sull’improvvisa fine di Giovanni Paolo I si sono alimentate macabre dicerie, aiutate dalla reticenza vaticana. Non vi sarà autopsia per accertare il presunto e fulminante infarto e non sarà mai trovato il taccuino con gli appunti sullo Ior che secondo molti testimoni il papa portò a letto l’ultima notte.
Era lo Ior di Paul Marcinkus, il figlio di un lavavetri lituano, nato a Cicero (Chicago) a due strade dal quartier generale di Al Capone, protagonista di una delle più clamorose quanto inspiegabili carriere nella storia recente della chiesa. Alto e atletico, buon giocatore di baseball e golf, era stato l’uomo che aveva salvato Paolo VI dall’attentato nelle Filippine. Ma forse non basta a spiegare la simpatia di un intellettuale come Montini, autore della più avanzata enciclica della storia, la Populorum Progressio, per questo prete americano perennemente atteggiato da avventuriero di Wall Street, con le mazze da golf nella fuoriserie, l’Avana incollato alle labbra, le stupende segreterie bionde e gli amici di poker della P2.
Con il successore di papa Luciani, Marcinkus trova subito un’intesa. A Karol Wojtyla piace molto quel figlio di immigrati dell’Est che parla bene il polacco, odia i comunisti e sembra così sensibile alle lotte di Solidarnosc. Quando i magistrati di Milano spiccano mandato d’arresto nei confronti di Marcinkus, il Vaticano si chiude come una roccaforte per proteggerlo, rifiuta ogni collaborazione con la giustizia italiana, sbandiera i passaporti esteri e l’extraterritorialità. Ci vorranno altri dieci anni a Woytjla per decidersi a rimuovere uno dei principali responsabili del crac Ambrosiano dalla presidenza dello Ior. Ma senza mai spendere una parola di condanna e neppure di velata critica: Marcinkus era e rimane per le gerarchie cattoliche "una vittima", anzi "un’ingenua vittima".
Dal 1989, con l’arrivo alla presidenza di Angelo Caloia, un galantuomo della finanza bianca, amico e collaboratore di Gianni Bazoli, molte cose dentro lo Ior cambiano. Altre no. Il ruolo di bonificatore dello Ior affidato al laico Caloia è molto vantato dalle gerarchie vaticane all’esterno quanto ostacolato all’interno, soprattutto nei primi anni. Come confida lo stesso Caloia al suo diarista, il giornalista cattolico Giancarlo Galli, autore di un libro fondamentale ma introvabile, Finanza bianca (Mondadori, 2003). "Il vero dominus dello Ior - scrive Galli - rimaneva monsignor Donato De Bonis, in rapporti con tutta la Roma che contava, politica e mondana. Francesco Cossiga lo chiamava Donatino, Giulio Andreotti lo teneva in massima considerazione. E poi aristocratici, finanzieri, artisti come Sofia Loren. Questo spiegherebbe perché fra i conti si trovassero anche quelli di personaggi che poi dovevano confrontarsi con la giustizia. Bastava un cenno del monsignore per aprire un conto segreto".
A volte monsignor De Bonis accompagnava di persona i correntisti con i contanti o l’oro nel caveau, attraverso una scala, in cima alla torre, "più vicino al cielo". I contrasti fra il presidente Caloia e De Bonis, in teoria sottoposto, saranno frequenti e duri. Commenta Giancarlo Galli: "Un’aurea legge manageriale vuole che, in caso di conflitto fra un superiore e un inferiore, sia quest’ultimo a soccombere. Ma essendo lo Ior istituzione particolarissima, quando un laico entra in rotta di collisione con una tonaca non è più questione di gradi".
La glasnost finanziaria di Caloia procede in ogni caso a ritmi serrati, ma non impedisce che l’ombra dello Ior venga evocata in quasi tutti gli scandali degli ultimi vent’anni. Da Tangentopoli alle stragi del ’93 alla scalata dei "furbetti" e perfino a Calciopoli. Ma come appare, così l’ombra si dilegua. Nessuno sa o vuole guardare oltre le mura impenetrabili della banca vaticana.
L’autunno del 1993 è la stagione più crudele di Tangentopoli. Subito dopo i suicidi veri o presunti di Gabriele Cagliari e di Raul Gardini, la mattina del 4 ottobre arriva al presidente dello Ior una telefonata del procuratore capo del pool di Mani Pulite, Francesco Saverio Borrelli: "Caro professore, ci sono dei problemi, riguardanti lo Ior, i contatti con Enimont...". Il fatto è che una parte considerevole della "madre di tutte le tangenti", per la precisione 108 miliardi di lire in certificati del Tesoro, è transitata dallo Ior. Sul conto di un vecchio cliente, Luigi Bisignani, piduista, giornalista, collaboratore del gruppo Ferruzzi e faccendiere in proprio, in seguito condannato a 3 anni e 4 mesi per lo scandalo Enimont e di recente rispuntato nell’inchiesta "Why Not" di Luigi De Magistris. Dopo la telefonata di Borrelli, il presidente Caloia si precipita a consulto in Vaticano da monsignor Renato Dardozzi, fiduciario del segretario di Stato Agostino Casaroli. "Monsignor Dardozzi - racconterà a Galli lo stesso Caloia - col suo fiorito linguaggio disse che ero nella merda e, per farmelo capire, ordinò una brandina da sistemare in Vaticano. Mi opposi, rispondendogli che avrei continuato ad alloggiare all’Hassler. Tuttavia accettai il suggerimento di consultare d’urgenza dei luminari di diritto. Una risposta a Borrelli bisognava pur darla!". La risposta sarà di poche ma definitive righe: "Ogni eventuale testimonianza è sottoposta a una richiesta di rogatoria internazionale".
I magistrati del pool valutano l’ipotesi della rogatoria. Lo Ior non ha sportelli in terra italiana, non emette assegni e, in quanto "ente fondante della Città del Vaticano", è protetto dal Concordato: qualsiasi richiesta deve partire dal ministero degli Esteri. Le probabilità di ottenere la rogatoria in queste condizioni sono lo zero virgola. In compenso l’effetto di una richiesta da parte dei giudici milanesi sarebbe devastante sull’opinione pubblica. Il pool si ritira in buon ordine e si accontenta della spiegazione ufficiale: "Lo Ior non poteva conoscere la destinazione del danaro".
Il secondo episodio, ancora più cupo, risale alla metà degli anni Novanta, durante il processo per mafia a Marcello Dell’Utri. In video conferenza dagli Stati Uniti il pentito Francesco Marino Mannoia rivela che "Licio Gelli investiva i danari dei corleonesi di Totò Riina nella banca del Vaticano". "Lo Ior garantiva ai corleonesi investimenti e discrezione". Fin qui Mannoia fornisce informazioni di prima mano. Da capo delle raffinerie di eroina di tutta la Sicilia occidentale, principale fonte di profitto delle cosche. Non può non sapere dove finiscono i capitali mafiosi. Quindi va oltre, con un’ipotesi. "Quando il Papa (Giovanni Paolo II, ndr) venne in Sicilia e scomunicò i mafiosi, i boss si risentirono soprattutto perché portavano i loro soldi in Vaticano. Da qui nacque la decisione di far esplodere due bombe davanti a due chiese di Roma". Mannoia non è uno qualsiasi.
E’ secondo Giovanni Falcone "il più attendibile dei collaboratori di giustizia", per alcuni versi più prezioso dello stesso Buscetta. Ogni sua affermazione ha trovato riscontri oggettivi. Soltanto su una non si è proceduto ad accertare i fatti, quella sullo Ior. I magistrati del caso Dell’Utri non indagano sulla pista Ior perché non riguarda Dell’Utri e il gruppo Berlusconi, ma passano le carte ai colleghi del processo Andreotti. Scarpinato e gli altri sono a conoscenza del precedente di Borrelli e non firmano la richiesta di rogatoria. Al palazzo di giustizia di Palermo qualcuno in alto osserva: "Non ci siamo fatti abbastanza nemici per metterci contro anche il Vaticano?".
Sulle trame dello Ior cala un altro sipario di dieci anni, fino alla scalata dei "furbetti del quartierino". Il 10 luglio dell’anno scorso il capo dei "furbetti", Giampiero Fiorani, racconta in carcere ai magistrati: "Alla Bsi svizzera ci sono tre conti della Santa Sede che saranno, non esagero, due o tre miliardi di euro". Al pm milanese Francesco Greco, Fiorani fa l’elenco dei versamenti in nero fatti alle casse vaticane: "I primi soldi neri li ho dati al cardinale Castillo Lara (presidente dell’Apsa, l’amministrazione del patrimonio immobiliare della chiesa, ndr), quando ho comprato la Cassa Lombarda. M’ha chiesto trenta miliardi di lire, possibilmente su un conto estero".
Altri seguiranno, molti a giudicare dalle lamentele dello stesso Fiorani nell’incontro con il cardinale Giovanni Battista Re, potente prefetto della congregazione dei vescovi e braccio destro di Ruini: "Uno che vi ha sempre dato i soldi, come io ve li ho sempre dati in contanti, e andava tutto bene, ma poi quando è in disgrazia non fate neanche una telefonata a sua moglie per sapere se sta bene o male". Il Vaticano molla presto Fiorani, ma in compenso difende Antonio Fazio fino al giorno prima delle dimissioni, quando ormai lo hanno abbandonato tutti. Avvenire e Osservatore Romano ripetono fino all’ultimo giorno di Fazio in Bankitalia la teoria del "complotto politico" contro il governatore. Del resto, la carriera di questo strano banchiere che alle riunioni dei governatori centrali non ha mai citato una volta Keynes ma almeno un centinaio di volte le encicliche, si spiega in buona parte con l’appoggio vaticano. In prima persona di Camillo Ruini, presidente della Cei, e poi di Giovanni Battista Re, amico intimo di Fazio, tanto da aver celebrato nel 2003 la messa per il venticinquesimo anniversario di matrimonio dell’ex governatore con Maria Cristina Rosati.
Naturalmente neppure i racconti di Fiorani aprono lo scrigno dei segreti dello Ior e dell’Apsa, i cui rapporti con le banche svizzere e i paradisi fiscali in giro per il mondo sono quantomeno singolari. E’ difficile per esempio spiegare con esigenze pastorali la decisione del Vaticano di scorporare le Isole Cayman dalla naturale diocesi giamaicana di Kingston, per proclamarle "missio sui iuris" alle dirette dipendenze della Santa Sede e affidarle al cardinale Adam Joseph Maida, membro del collegio dello Ior.
Il quarto e ultimo episodio di coinvolgimento dello Ior negli scandali italiani è quasi comico rispetto ai precedenti e riguarda Calciopoli. Secondo i magistrati romani Palamara e Palaia, i fondi neri della Gea, la società di mediazione presieduta dal figlio di Moggi, sarebbero custoditi nella banca vaticana. Attraverso i buoni uffici di un altro dei banchieri di fiducia della Santa Sede dalla fedina penale non immacolata, Cesare Geronzi, padre dell’azionista di maggioranza della Gea. Nel caveau dello Ior sarebbe custodito anche il "tesoretto" personale di Luciano Moggi, stimato in 150 milioni di euro. Al solito, rogatorie e verifiche sono impossibili. Ma è certo che Moggi gode di grande considerazione in Vaticano. Difeso dalla stampa cattolica sempre, accolto nei pellegrinaggi a Lourdes dalla corte di Ruini, Moggi è da poco diventato titolare di una rubrica di "etica e sport" su Petrus, il quotidiano on-line vicino a papa Benedetto XVI, da dove l’ex dirigente juventino rinviato a giudizio ha subito cominciato a scagliare le prime pietre contro la corruzione (altrui).
Con l’immagine di Luciano Moggi maestro di morale cattolica si chiude l’ultima puntata dell’inchiesta sui soldi della Chiesa. I segreti dello Ior rimarranno custoditi forse per sempre nella torre-scrigno. L’epoca Marcinkus è archiviata ma l’opacità che circonda la banca della Santa Sede è ben lontana dallo sciogliersi in acque trasparenti. Si sa soltanto che le casse e il caveau dello Ior non sono mai state tanto pingui e i depositi continuano ad affluire, incoraggiati da interessi del 12 per cento annuo e perfino superiori. Fornire cifre precise è, come detto, impossibile. Le poche accertate sono queste. Con oltre 407 mila dollari di prodotto interno lordo pro capite, la Città del Vaticano è di gran lunga lo "stato più ricco del mondo", come si leggeva nella bella inchiesta di Marina Marinetti su Panorama Economy. Secondo le stime della Fed del 2002, frutto dell’unica inchiesta di un’autorità internazionale sulla finanza vaticana e riferita soltanto agli interessi su suolo americano, la chiesa cattolica possedeva negli Stati Uniti 298 milioni di dollari in titoli, 195 milioni in azioni, 102 in obbligazioni a lungo termine, più joint venture con partner Usa per 273 milioni.
Nessuna autorità italiana ha mai avviato un’inchiesta per stabilire il peso economico del Vaticano nel paese che lo ospita. Un potere enorme, diretto e indiretto. Negli ultimi decenni il mondo cattolico ha espugnato la roccaforte tradizionale delle minoranze laiche e liberali italiane, la finanza. Dal tramonto di Enrico Cuccia, il vecchio azionista gran nemico di Sindona, di Calvi e dello Ior, la "finanza bianca" ha conquistato posizioni su posizioni. La definizione è certo generica e comprende personaggi assai distanti tra loro. Ma tutti in relazione stretta con le gerarchie ecclesiastiche, con le associazioni cattoliche e con la prelatura dell’Opus Dei. In un’Italia dove la politica conta ormai meno della finanza, la chiesa cattolica ha più potere e influenza sulle banche di quanta ne avesse ai tempi della Democrazia Cristiana.
(Hanno collaborato Carlo Pontesilli e Maurizio Turco)
* la Repubblica, 26 gennaio 2008
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Quello a "motu proprio"? Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ (Un "Goj") di Luigi Pirandello ... --- VENERDI 30.11.2007 LA PUBBLICAZIONE DELLA NUOVA ENCICLICA ("Spe salvi").28 novembre 2007, di Federico La Sala
VENERDÌ LA PUBBLICAZIONE DELLA NUOVA ENCICLICA
Immagini di speranza così care a Papa Benedetto
di ELIO GUERRIERO (Avvenire, 28.11.2007).
 Dopo «Dio è carità» è stata annunciata l’enciclica sulla speranza. È facile, di conseguenza, immaginare che il Papa voglia dedicare un’enciclica a ciascuna delle virtù teologali, così come Giovanni Paolo II ne dedicò tre a ciascuna delle persone della Trinità.
Dopo «Dio è carità» è stata annunciata l’enciclica sulla speranza. È facile, di conseguenza, immaginare che il Papa voglia dedicare un’enciclica a ciascuna delle virtù teologali, così come Giovanni Paolo II ne dedicò tre a ciascuna delle persone della Trinità.
 L’interrogativo a questo punto verte sul motivo per cui Papa Benedetto XVI abbia voluto iniziare dalla carità, anziché dalla fede, secondo l’ordine del catechismo. A sostegno della sequenza scelta dal Papa vi è la decisione di partire non dall’uomo, sia pure credente, bensì dal saldo fondamento dell’amore di Dio. Ha scritto Benedetto XVI: «Dio è in assoluto la sorgente originaria di ogni essere; ma questo principio creativo di tutte le cose è al contempo un amante con tutta la passione di un vero amore» ( Deus caritas est,
n. 10).
L’interrogativo a questo punto verte sul motivo per cui Papa Benedetto XVI abbia voluto iniziare dalla carità, anziché dalla fede, secondo l’ordine del catechismo. A sostegno della sequenza scelta dal Papa vi è la decisione di partire non dall’uomo, sia pure credente, bensì dal saldo fondamento dell’amore di Dio. Ha scritto Benedetto XVI: «Dio è in assoluto la sorgente originaria di ogni essere; ma questo principio creativo di tutte le cose è al contempo un amante con tutta la passione di un vero amore» ( Deus caritas est,
n. 10). Di qui l’origine della speranza cristiana, la virtù teologica definita nel modo più convincente da san Paolo nella Lettera ai Romani: chi fa esperienza dell’amore di Dio vive secondo lo Spirito; ha la promessa sicura di essere figlio di Dio e la speranza certa della vita eterna. A questo serrato ragionamento teologico hanno attinto la letteratura (Dante), l’arte figurativa e la musica per edificare un universo simbolico presente nelle chiese e nella cultura del nostro Paese e del mondo.
Di qui l’origine della speranza cristiana, la virtù teologica definita nel modo più convincente da san Paolo nella Lettera ai Romani: chi fa esperienza dell’amore di Dio vive secondo lo Spirito; ha la promessa sicura di essere figlio di Dio e la speranza certa della vita eterna. A questo serrato ragionamento teologico hanno attinto la letteratura (Dante), l’arte figurativa e la musica per edificare un universo simbolico presente nelle chiese e nella cultura del nostro Paese e del mondo.
 Radicate nell’intimo dell’esperienza e della fede cristiana, le immagini di speranza hanno generato una «millenaria foresta di simboli» (Baudelaire).
Radicate nell’intimo dell’esperienza e della fede cristiana, le immagini di speranza hanno generato una «millenaria foresta di simboli» (Baudelaire). La prima immagine cara a Papa Benedetto, che l’ha voluta riprodotta nel Compendio del Catechismo, è quella dell’albero della vita, o trionfo della Croce, rappresentato nel mosaico absidale della basilica di san Clemente a Roma. Attorno al Cristo sofferente vi sono dodici colombe che simboleggiano i dodici apostoli, ai piedi della croce stanno Maria e Giovanni. Un cespo di acanto cresce alla base della croce e dà origine all’albero lussureggiante della redenzione. Ai piedi dell’albero sgorga una sorgente d’acqua zampillante, che dà vita a quattro rivoli, che simboleggiano i Vangeli, ai quali si dissetano i fedeli.
La prima immagine cara a Papa Benedetto, che l’ha voluta riprodotta nel Compendio del Catechismo, è quella dell’albero della vita, o trionfo della Croce, rappresentato nel mosaico absidale della basilica di san Clemente a Roma. Attorno al Cristo sofferente vi sono dodici colombe che simboleggiano i dodici apostoli, ai piedi della croce stanno Maria e Giovanni. Un cespo di acanto cresce alla base della croce e dà origine all’albero lussureggiante della redenzione. Ai piedi dell’albero sgorga una sorgente d’acqua zampillante, che dà vita a quattro rivoli, che simboleggiano i Vangeli, ai quali si dissetano i fedeli.
 Un’altra immagine di speranza molto cara a Benedetto XVI è quella della natività.
Un’altra immagine di speranza molto cara a Benedetto XVI è quella della natività.
 Nella tradizione francescana essa ha dato origine al presepe con lo scopo di rendere ogni volta contemporanei le persone e gli eventi che accompagnarono la nascita di Gesù. Nel presepe vi è un bambino che «si è fatto così vicino a noi che possiamo dargli tranquillamente del tu e accedere direttamente al cuore di Dio». Vi sono poi Maria e Giuseppe, i pastori e i magi, i primi della schiera dei poveri, dei miti, e dei perseguitati cui sono rivolte le beatitudini di Gesù, questi sanno di non poter attendere giustizia dai potenti e dai giudici del mondo, perciò sperano nella misericordia di Dio che ricolma di beni gli affamati. Vi sono poi il bue e l’asino che, secondo la profezia di Isaia, rappresentano il mondo animale che riconosce l’avvento del Messia, mentre il popolo si rifiuta di capire. Con la sensibilità contemporanea possiamo riconoscervi l’anelito del cosmo a sua volta in attesa di salvezza.
-La terza immagine è quella dell’Agnello mistico raffigurata nel modo più compiuto dal pittore fiammingo Jan van Eyik nella cattedrale di san Bavone a Gand. È l’immagine della Gerusalemme celeste nella quale martiri e confessori, chierici e laici, dotti e semplici rendono onore, gloria e benedizione a Dio Padre e a Cristo che ha redento gli uomini con il suo sangue. A lui sono affidate le chiavi della storia.
Nella tradizione francescana essa ha dato origine al presepe con lo scopo di rendere ogni volta contemporanei le persone e gli eventi che accompagnarono la nascita di Gesù. Nel presepe vi è un bambino che «si è fatto così vicino a noi che possiamo dargli tranquillamente del tu e accedere direttamente al cuore di Dio». Vi sono poi Maria e Giuseppe, i pastori e i magi, i primi della schiera dei poveri, dei miti, e dei perseguitati cui sono rivolte le beatitudini di Gesù, questi sanno di non poter attendere giustizia dai potenti e dai giudici del mondo, perciò sperano nella misericordia di Dio che ricolma di beni gli affamati. Vi sono poi il bue e l’asino che, secondo la profezia di Isaia, rappresentano il mondo animale che riconosce l’avvento del Messia, mentre il popolo si rifiuta di capire. Con la sensibilità contemporanea possiamo riconoscervi l’anelito del cosmo a sua volta in attesa di salvezza.
-La terza immagine è quella dell’Agnello mistico raffigurata nel modo più compiuto dal pittore fiammingo Jan van Eyik nella cattedrale di san Bavone a Gand. È l’immagine della Gerusalemme celeste nella quale martiri e confessori, chierici e laici, dotti e semplici rendono onore, gloria e benedizione a Dio Padre e a Cristo che ha redento gli uomini con il suo sangue. A lui sono affidate le chiavi della storia.
 Per questo i suoi discepoli e gli uomini tutti possono riporre in Lui la loro speranza.
Per questo i suoi discepoli e gli uomini tutti possono riporre in Lui la loro speranza. -
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Quello a "motu proprio"? Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! .... Annunciata una seconda enciclica: "Spe salvi".23 novembre 2007, di Maria Paola Falqui
Ansa» 2007-11-23 13:05
SECONDA ENCICLICA DI BENEDETTO XVI
CITTA’ DEL VATICANO - Sarà pubblicata il 30 novembre la seconda enciclica di Benedetto XVI, intitolata "Spe salvi". Lo annuncia la sala stampa vaticana. Confermato che il titolo della seconda enciclica di papa Ratzinger sarà "Spe salvi" ("salvi grazie alla speranza"), la nota precisa che il testo pontificio verrà presentato in Vaticano alle 11,30 del 30 novembre dal pro-teologo emerito della casa pontificia cardinale Georges Cottier e dal cardinale Albert Vanhoye, professore emerito di esegesi del nuovo testamento al Pontificio Istituto Biblico. Il testo dell’enciclica è sottoposto a embargo fino alle ore 12 del 30 novembre.
Il cardinale Tarcisio Bertone aveva annunciato ieri che l’enciclica sarebbe stata firmata il 30 novembre, ma non aveva precisato la data di pubblicazione. La prima enciclica di Benedetto XVI, "Deus caritas est" è stata pubblicata il 25 gennaio del 2006; si attende inoltre una terza enciclica ratzingeriana, dedicata ai temi sociali, che potrebbe uscire agli inizi del 2008, forse entro Pasqua. Le encicliche, che ricavano il titolo dalle prime parole del testo in latino, sono lettere papali indirizzate al clero e al popolo cattolico su un tema dottrinale che i pontefici vogliano approfondire, o su un argomento che considerano rilevante.
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Quello a "motu proprio"? Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! .... Annunciata una seconda enciclica: "Spe salvi".2 dicembre 2007, di Rosario Amico Roxas
L’enciclica “SPE SALVI” di Benedetto XVI: una prima lettura
di Rosario Amico Roxas
L’enciclica “SPE SALVI” di Benedetto XVI si dibatte in un dedalo di involuzioni che nulla aggiunge alle domande che crescono dal mondo cristiano. Emerge, in prima lettura, la grande erudizione del pontefice, la sua documentata conoscenza filosofica, l’attenta analisi teologica. E’ un itinerario frammentato, discontinuo, mancante di omogeneità che si dibatte tra filosofia e teologia, riferimenti storico-filosofici che spaziano da Sant’Agostino a Bacone, per citare poi Marx, Engels, Horkheimer, in una confusione di idee che non rende giustizia alla chiarezza. La “Speranza” è l’elemento catalizzante del cristiano, insieme alla “Fede” e alla “Carità”, che dovrebbe contrapporsi al crollo delle ideologie, alle pretese della scienza, al fallimento dell’Illuminismo e alle limitazioni del relativismo. Tutto ciò rientra più nella sfera delle ovvietà che nello slancio di comprensione dei fenomeni che caratterizzano questo pianeta, in questa epoca, in questa storia. Appare piuttosto come un invito al regresso, chiudendo le porte al fascino del nuovo e dell’attuale, sottraendosi alla sfida. Non basta leggere questa enciclica se la si estranea dall’intera storia culturale di Ratzinger prima e di Benedetto XVI poi. Il panorama, nella sua interezza, mostra i segni inequivocabili della contraddizione che emerge dagli scritti. La condanna del progresso, che ha portato l’uomo “dalla fionda alla megabomba” , implicita la condanna della violenza e delle guerre, ma non fa rima con il Nuovo Catechismo del 1994, redatto da Ratzinger come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, che finisce con l’accettare l’ipotesi di “violenze giuste” e di “guerre giuste” . La speranza che deve animare gli esclusi, che deve indirizzare i poveri del pianeta, gli esclusi, i discriminati alla ricerca del divino per riceverne conforto, non combacia con il dispositivo di condanna emesso da Ratzinger nei confronti della teologia della Liberazione e del suo massimo rappresentante, P. Jon Sobrino. Leggiamo , infatti, in quel dispositivo la motivazione di base che condiziona l’intero processo:
“Egli non nega il carattere normativo delle formulazioni dogmatiche ma, complessivamente, non riconosce ad esse un valore al di fuori dell’ambito culturale in cui sorsero”.
E’ il relativismo culturale che ha proposto in quel Salvador martoriato e in tutta l’America Latina un Cristo vero, genuino, aderente alle attese del popolo dei credenti, un Cristo lacero, mendico, affamato, assetato, negro, discriminato, ma colmo d’Amore per i suoi simili; il Cristo di Sobrino non si circonda di armigeri in abiti cinquecenteschi, non sviluppa la sua esistenza tra gli affreschi di Michelangelo, non dispone di tesori più o meno nascosti, ma partecipa alla vita sofferta, portando la Sua Croce, insegnando ai suoi “figli diletti” la vera Speranza, quella che sta “dopo” le sofferenze e che si attualizza nelle Beatitudini della Montagna. Emerge ancora, in questa ultima enciclica, una condanna rivolta alla giustizia terrena, quella che premia il più forte, quella che redige le pagine della storia scritta dai vincitori; affermazione giusta, comprensibile e vera, ma che si colloca fuori dalla storia della Chiesa se non viene rinnovata nello spirito; quella Chiesa che ha scritto la Sua storia, giustificandola nei contenuti, anche quando è stata fautrice dell’Inquisizione, delle Crociate, del potere temporale, dei tribunali che comminavano il rogo; quella storia che ha negato la speranza, privilegiando il rogo. L’invito al “mea culpa” che dovrebbe recitare il cristianesimo moderno per l’inadeguatezza di fronte al progresso della tecnologia, è piuttosto il “mea culpa” delle gerarchie vaticane che non riescono a seguire le disordinate evoluzioni dei tempi e a dare loro un senso compiuto, comprendendone le esigenze mutate; con l’invito ad un radicalismo medievale la Chiesa si allontana dal popolo dei credenti che non trova risposte adeguate alle domande nuove. L’invito che si può rivolgere è quello di rileggere l’enciclica “Spe Salvi” alla luce di una rilettura del volumetto “Senza radici” di Pera- Ratzinger , dove l’intervento dell’allora cardinale, fece da avallo alle affermazioni razziste del prof. Pera; la richiesta di imporre le “radici cristiane” all’Europa, trasformava il cristianesimo da religione universale a fenomeno antropologico, caratterizzante la cultura occidentale, che pretenderebbe accaparrarsi il primato culturale a fronte delle altre religioni e delle altre cultura, all’insegna della negazione del relativismo culturale che impone il rispetto per tutte le culture e ne promuove l’incontro e il dialogo. E ancora si invita rileggere l’enciclica “Spe Salvi” in contemporanea al volume “Gesù di Nazaret” di Ratzinger-Benedetto XVI, quando, già dalla premessa, dice:
“Se dunque la storia, la fatticità, in questo senso appartiene essenzialmente alla fede cristiana, quest’ultima deve esporsi al metodo storico. E’ la fede stessa che lo esige”
Così la fede diventa “metodo storico”, e diventerebbe anche epistemologia dello spirito, quindi scienza anch’essa Ma la scienza è un dono dell’intelletto, mentre la fede è un dono di Dio. Dio stesso, in questo itinerario dialettico, non diventerebbe un dono dell’intelletto umano ?
Rosario Amico Roxas
-
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Quello a "motu proprio"? Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! .... La doppia identità del Vaticano - di Rosario Amico Roxas.4 settembre 2007, di Federico La Sala
Politica - Il dibattito sugli sconti fiscali al Vaticano
La doppia identità del Vaticano
di Rosario Amico Roxas *
La volontà di confondere le idee e creare confusione domina sovrana il panorama delle opinioni; tutto ciò serve solo ai mestatori che profittano sempre delle situazioni di incertezza per imporre le proprie opinioni. Il riferimento attuale riguarda la richiesta di chiarimenti da parte della UE circa i rapporti tra lo Stato italiano e il Vaticano, con particolare riferimento ai privilegi che lo Stato italiano concede attraverso sgravi fiscali, esenzioni, favoritismi.
Ovviamente di ciò profittano i nuovi difensori del Vaticano spinti dalla speranza di cogliere al volo l’occasione di carpire i consensi dei cattolici, indignati per quello che viene presentato come un attacco alla Chiesa. Necessita mettere in chiaro che il Vaticano esercita un doppio ruolo, né si riesce a capire quale dei due abbia il primato. Il ruolo istituzionale sarebbe quello confessionale, religioso, di sostegno alle opere caritatevoli e assistenziali, ma c’è il secondo ruolo che incombe, ed è quello burocratico di uno Stato assoluto, continuatore di un assolutismo vecchio e superato che l’avvento delle democrazie, nelle varie forme ed espressioni, ha ridotto al rango di reperto di archeologia politica.
Lo Stato Città del Vaticano miscela in un unico calderone il suo duplice aspetto, secondo la convenienza e l’opportunità della situazione, trasferendo gli aspetti che coinvolgono l’identità statale in quella confessionale, senza distinzione di ruoli.
L’UE chiede chiarimenti circa i privilegi che lo Stato italiano concede allo Stato Città del Vaticano, che si ritrova, così, in condizione di vantaggio nei confronti di altri concorrenti nei medesimi interessi. Il patrimonio immobiliare dello Stato Città del Vaticano è fra i più consistenti del pianeta, ma viene presentato come una riserva economica per favorire le opere assistenziali. Falso.
Gli immobili vengono ceduti in affitto a prezzi di mercato, senza sconti o occhi di riguardo anche per i casi in cui la Chiesa dovrebbe manifestare maggiore sensibilità.
Si tratta di un patrimonio in costante crescita in quanto i proventi vengono ulteriormente investiti in successive operazioni immobiliari; le eccedenze vanno a finire presso l’Istituto per le Opere Religiose, meglio noto come IOR, una vera e propria banca che opera nel circuito dell’alta finanza, e non sempre con la chiarezze e la trasparenze che il nome originario imporrebbe.
Tutto ciò mi ricorda lo scandalo del burro che travolse il Vaticano negli anni 60, quando ingenti quantitativi di burro attraversavano le frontiere dai paesi produttori verso l’Italia, dirette a un non meglio identificato “Istituto per gli Italiani all’estero e ai popoli infedeli”, che avrebbe avuto, in Italia, tutta una serie di asili nido, dove i bambini sarebbe stati nutriti esclusivamente a base di burro; in realtà all’indirizzo dei vari asili corrispondevano le aziende dolciarie che utilizzavano il burro esentato dalle tasse doganali in quanto “destinato ad opere di beneficenza”, il tutto con la connivenza vaticana che lucrava sulle eccedenze.
Me ne occupai personalmente con un lungo e documentato articolo (Dacci oggi il nostro burro quotidiano) pubblicato su una rivista a carattere universitario “Nuove Dimensioni”, che allora provocò lo scombussolamento di tali operazioni. La storia si ripete: il patrimonio dello Stato Città del Vaticano viene gabellato come riserva economica per le opere assistenziali, pretendendo e ottenendo il trattamento fiscale riservato a tali opere; la realtà è ben diversa, si tratta di operazioni economiche mirate ad incrementare il medesimo patrimonio, a mantenere la burocrazia di uno Stato autonomo e indipendente, nel quale l’aspetto confessionale esercita un ruolo marginale, essendo trattato, prevalentemente, da oscuri personaggi che dedicano la loro vita ad alleviare le sofferenze altrui, senza alcun intervento da parte di quello Stato Città del Vaticano, che per tali opere gode dei tanti privilegi, dei quali, adesso, l’UE chiede spiegazioni.
Non è un “attacco alla Chiesa”, bensì una richiesta legittima di esaurienti motivazioni, circa i privilegi accordati allo Stato Città del Vaticano, che deve, finalmente, decidere la sua definitiva identità.
Rosario Amico Roxas
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Quello a "motu proprio"? Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! ... Charitas: un piccolo sforzo di verità !!!31 agosto 2007, di Federico La Sala
POLEMICA
Un pamphlet del docente americano Harry G. Frankfurt attacca duramente la cultura postmoderna che elude il senso del vero
Cari filosofi, ritornate alla verità
«La gente ama ciò che possa aiutarla a vivere e a diventare se stessa in modo più pieno». Ma nell’attuale sfiducia dei pensatori verso il problema del giusto e dello sbagliato si nasconde solo l’insidiosa dittatura del relativismo
Di Lorenzo Fazzini (Avvenire, 31.08.2007)
Possiamo vivere senza preoccuparci della verità? Impossibile. Anzi, per restare nel campo semantico del vero e del falso, a chi afferma che, dopo tutto, «la verità non è poi così importante», qualcuno risponde che «questo sarebbe un errore deplorabile». A sostenerlo è Harry G. Frankfurt, docente emerito di Filosofia alla Princeton University, di cui Rizzoli manda in libreria il saggio filosofico Il piccolo libro della verità. Un testo breve nelle dimensioni (90 pagine tascabili, euro 9), anche perché Frankfurt a tali proporzioni è abituato: ancora più ridotto fu il suo bestseller On Bullshit, che in pochi mesi registrò 400 mila copie negli Stati Uniti. Orbene, dopo qualche anno, Frankfurt è tornato - l’edizione originale è del 2006 - ad affrontare il tema della menzogna in via «costruens«, occupandosi della verità. Con piglio decisamente anticonformista: come affermato in un’intervista al New York Times,
Frankfurt scrive un saggio che è pure un pamphlet contro i postmoderni. «Insegnavo a Yale - dichiarò il filosofo al quotidiano americano - che un tempo fu un centro della teoria letteraria postmoderna. C’era Derrida, c’era Paul de Man. All’inizio scrissi il mio saggio sulle menzogne a Yale, e un professore di fisica mi disse che era appropriato che quel saggio fosse scritto a Yale perché, dopo tutto, sosteneva lui, Yale è la capitale mondiale delle menzogne». E nel suo breve scritto, in effetti, Frankfurt attacca con forza i postmoderni: «Numerosi scettici e cinici riguardo all’importanza della verità (...) si trovano tra gli autori da best seller o tra i vincitori dei maggiori premi, tra coloro che scrivono per i giornali più quotati, e pure tra rispettati storici, biografi, memorialisti, teorici della letteratura, scrittori ed anche tra i filosofi».
La sferzata del nostro è durissima verso i «minimalisti« del senso: «Questi svergognati nemici del senso comune - i membri di un certo emblematico sottogruppo di loro si fanno chiamare "postmoderni" - in maniera ribelle e autosoddisfatta negano che la verità possegga una qualsiasi realtà oggettiva». E invece per il pensatore di Princeton la verità è questione ineludibile e necessaria, sia a livello sociale che personale: sembra qui riecheggiare il pericolo di quella «dittatura del relativismo» denunciato da Benedetto XVI all’inizio del suo ministero petrino. E non è un caso che il passaggio più interessante del saggio di Frankfurt sia laddove analizza la comprensione spinoziana della verità: usando termini che - guarda caso - spesso ricorrono nel lessico ratzingeriano (amore e gioia), l’autore del Piccolo libro annota, sulla scia di Spinoza, che la gente «ama ciò che essa crede la aiuti a continuare la propria esistenza e a diventare più pienamente se stessa». Detto altrimenti, la sfiducia postmoderna rispetto al vero viene vinta dalla «debolezza» dell’amore per la verità: «Praticamente tutti noi amiamo la verità, sia che siamo coscienti di farlo sia che non lo siamo».
Certo, il contributo di Frankfurt - inficiato dalla brevità di scrittura - non rappresenta un lavoro epocale per la storia della filosofia. Ma gli va ascritto il merito di aver proposto, con un testo accessibile a tutti, il problema filosofico della verità, della necessità di riporre il nodo del vero e del falso, del giusto e dello sbagliato. In un panorama filosofico che troppo spesso sembra un laboratorio scientifico, dove ciascun pensatore pare concentrato sulla minuscola monade della propria specialità e resta alieno dalla comprensione di un dato generale, merita un plauso chi - forse troppo «all’americana», con tratto leggero e talvolta un po’ generico - ripropone il quesito che fu di Ponzio Pilato: «Quid est veritas?».
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Quello a "motu proprio"? Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ (Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.5 agosto 2007, di Federico La Sala
Ahi Costantin di quanto mal fu madre
di EUGENIO SCALFARI *
Tra le tante questioni che affliggono il nostro paese, insolute da molti anni e alcune risalenti addirittura alla fondazione dello Stato unitario, c’è anche quella cattolica. Probabilmente la più difficile da risolvere. Personalmente penso anzi che resterà per lungo tempo aperta, almeno per l’arco di anni che riguardano le tre o quattro generazioni a venire. Roma e l’Italia sono luoghi di residenza millenaria della Sede apostolica e perciò si trovano in una situazione anomala rispetto a tutte le altre democrazie occidentali. Se guardiamo agli spazi mediatici che la Santa Sede, il Papa, la Conferenza episcopale hanno nelle televisioni e nei giornali ci rendiamo conto a prima vista che niente di simile accade in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, in Olanda, in Scandinavia e neppure nelle cattolicissime Spagna e Portogallo per non parlare degli Usa, del Canada e dell’America Latina dove pure la popolazione cattolica ha raggiunto il livello di maggiore densità.
Da noi le reti ammiraglie di Rai e di Mediaset trasmettono sistematicamente ogni intervento del Papa e dei Vescovi. L’"Angelus" è un appuntamento fisso. Le iniziative e le dichiarazioni dei cattolici politicamente impegnati ingombrano i giornali, il presidente della Repubblica, appena nominato, sente il bisogno di inviare un messaggio di "presentazione" al Pontefice, cui segue a breve distanza la visita ufficiale. Tutto ciò va evidentemente al di là d’una normale regola di rispetto e dipende dal fatto che in Italia il Vaticano è una potenza politica oltre che religiosa. Ciò spiega anche la dimensione dei finanziamenti e dei privilegi fiscali dei quali gode il Vaticano, la Santa Sede e gli enti ecclesiastici; anche questi senza riscontro alcuno negli altri paesi.
Infine il rapporto di magistero che la gerarchia ecclesiastica esercita sulle istituzioni ovunque vi sia una rappresentanza di cattolici militanti e la funzione di guida politica che di fatto orienta i partiti di ispirazione cattolica e quindi cospicui settori del Parlamento.
La questione cattolica è dunque quella che spiega più d’ogni altra la diversità italiana. Spiega perché noi non saremo mai un "paese normale". Perché una parte rilevante dell’opinione pubblica, della classe politica, dei mezzi di comunicazione, delle stesse istituzioni rappresentative, sono etero-diretti, fanno capo cioè e sono profondamente influenzati da un potere "altro". Quello è il vero potere forte che perdura anche in tempi in cui la secolarizzazione dei costumi ha ridotto i cattolici praticanti ad una minoranza. "Ahi Costantin, di quanto mal fu madre...".
La questione cattolica ha attraversato varie fasi che non è questa la sede per ripercorrere. Basti dire che si sono alternate fasi di latenza durante le quali sembrava sopita, e di vivace ed aspra riacutizzazione.
Il mezzo secolo della Prima Repubblica, politicamente dominato dalla Democrazia cristiana, fu paradossalmente una fase di latenza. La maggioranza era etero-diretta dal Vaticano e dagli Stati Uniti, il Pci era etero-diretto dall’Unione Sovietica. Entrambi i protagonisti accettavano questo stato di cose, insultandosi sulle piazze e dai pulpiti, ma assicurando, ciascuno per la sua parte, un sostanziale equilibrio. Quando qualcuno sgarrava, veniva prontamente corretto.
Ma la fase attuale non è affatto tranquilla, la questione cattolica si è riacutizzata per varie ragioni, la prima delle quali è l’emergere sulla scena politica dei temi bioetici con tutto ciò che comportano.
La seconda ragione deriva dalla linea assunta da Benedetto XVI che ritiene di spingere il più avanti possibile le forme di protettorato politico-religioso che il Vaticano esercita in Italia, per farne la base di una "reconquista" in altri paesi a cominciare dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Baviera, dall’Austria e da alcuni paesi cattolici dell’America meridionale. Le capacità finanziarie dell’episcopato italiano forniscono munizioni non trascurabili per sostenere questo disegno che ha come obiettivo l’esportazione del modello italiano laddove ne esistano le condizioni di partenza.
A fronte di quest’offensiva le "difese laiche" appaiono deboli e soprattutto scoordinate. Si va da forme d’intransigenza che sfiorano l’anticlericalismo ad aperture dialoganti ma a volte eccessivamente permissive verso i diritti accampati dalla "gerarchia". Infine permane il sostanziale disinteresse della sinistra radicale, che conserva verso il laicismo l’antica diffidenza di togliattiana memoria.
Si direbbe che il solo dato positivo, dal punto di vista laico, sia una più acuta sensibilità autonomistica che ha conquistato una parte dei cattolici impegnati nel centrosinistra. Ma si tratta di autonomia a corrente variabile, oggi rimesso in discussione dalla nascita del Partito democratico e dai vari posizionamenti che essa comporta per i cattolici che ne fanno parte. Con un’avvertenza di non trascurabile peso: secondo recenti sondaggi nell’ultimo decennio i cattolici schierati nel centrosinistra sarebbero discesi dal 42 al 26 per cento. Fenomeno spiegabile poiché gran parte dell’elettorato ex Dc si trasferì fin dal 1994 su Forza Italia; ma che certamente negli ultimi tempi ha accelerato la sua tendenza.
* * *
Un fenomeno degno di interesse è quello del recente associazionismo delle famiglie. Non nuovo, ma fortemente rilanciato e unificato dal "forum" che scelse come organizzatore politico e portavoce Savino Pezzotta, da poco reduce dalla lunga leadership della Cisl e riportato alla ribalta nazionale dal "Family Day" che promosse qualche mese fa in piazza San Giovanni il raduno delle famiglie cattoliche.
Da allora Pezzotta sta lavorando per trasformare il "forum" in un movimento politico. "Non un partito" ha precisato in una recente intervista "ma un quasi-partito; insomma un movimento autonomo che potrà eventualmente appoggiare qualche partito di ispirazione cristiana che si batta per realizzare gli obiettivi delle famiglie. Sia nei valori che sono ad esse intrinseci sia per i concreti sostegni necessari a realizzare quei valori".
L’obiettivo è ambizioso e fa gola ai partiti di impronta cattolica, ma Pezzotta amministra con molta prudenza la sigla di cui è diventato titolare. Dico sigla perché al momento non sappiamo quale sia la sua realtà organizzativa e la sua effettiva spendibilità politica.
Sembra difficile che il nascituro movimento delle famiglie possa praticare una sorta di collateralismo rispetto ai settori cattolici militanti nel Partito democratico: la piazza di San Giovanni non sembrava molto riformista, le voci che l’hanno interpretata battevano soprattutto su rivendicazioni economiche ma non basterà riconoscergliele per acquistarne il consenso e il voto. A torto o a ragione le famiglie e le sigle che le rappresentano ritengono che quanto chiedono sia loro dovuto. Il voto elettorale è un’altra cosa e non sarà Pezzotta a guidarlo. Ancor meno i vari Bindi, Binetti, Bobba nelle loro differenze. Voteranno come a loro piacerà, seguendo altre motivazioni e inclinazioni, influenzate soprattutto dai luoghi in cui vivono e dai ceti sociali e professionali ai quali appartengono.
* * *
Un elemento decisivo della questione cattolica e dell’anomalia che essa rappresenta è costituito dalla dimensione degli interessi economici della Santa Sede e degli enti ecclesiastici, del loro "status" giuridico e addirittura costituzionale (il Trattato del Laterano è stato recepito in blocco con l’articolo 7 della nostra Costituzione) e dei privilegi fiscali, sovvenzioni, immunità che fanno nel loro insieme un sistema di fatto inattaccabile. Basti pensare che la Santa Sede rappresenta il vertice di un’organizzazione religiosa mondiale e fruisce ovviamente d’un insediamento altrettanto mondiale attraverso la presenza dei Vescovi, delle parrocchie, degli Ordini religiosi, delle Missioni. Ma, intrecciata ad essa c’è uno Stato - sia pure in miniatura - che gode d’un tipo di immunità e di poteri propri di uno Stato e quindi di una soggettività diplomatica gestita attraverso i "nunzi" regolarmente accreditati presso tutti gli altri Stati e presso le organizzazioni internazionali.
Questa doppia elica non esiste in nessun’altra delle Chiese cristiane ed è la conseguenza della struttura piramidale di quella cattolica e della base territoriale da cui trasse origine lo Stato vaticano e il potere temporale dei Papi. Non scomoderemo Machiavelli e Guicciardini, Paolo Sarpi e Pietro Giannone per ricordare quali problemi ha sempre creato il potere temporale nella storia della nazione italiana, nell’impossibilità di realizzare l’unità nazionale quando gli altri paesi europei avevano già da secoli raggiunto la loro ed infine lo scarso senso dello Stato che gli italiani hanno avuto da sempre e continuano abbondantemente a dimostrare. Sarebbe storicamente scorretto attribuire unicamente al potere temporale dei Papi questo deficit di maturità civile degli italiani, ma certo esso ne costituisce uno dei principali elementi.
Purtroppo il temporalismo è una tentazione sempre risorgente all’interno della Chiesa; sotto forme diverse assistiamo oggi ad un tentativo di resuscitarlo che si esprime attraverso la presenza politica diretta dell’episcopato nelle materie "sensibili" il cui ventaglio si sta progressivamente ampliando.
Negli scorsi giorni l’atmosfera si è ulteriormente riscaldata a causa di una frase di Prodi che esortava i sacerdoti a sostenere la campagna del governo contro le evasioni fiscali e lamentava lo scarso contributo della Chiesa ad un tema così rilevante.
Credo che Prodi, da buon cattolico, abbia pronunciato quella frase in perfetta buonafede ma, mi permetto di dire, con una dose di sprovveduta ingenuità. Lo Stato non rappresenta un tema importante per i sacerdoti e per la Chiesa. Ancorché i preti e i Vescovi siano cittadini italiani a tutti gli effetti e con tutti i diritti e i doveri dei cittadini italiani, essi sentono di far parte di quel sistema politico-religioso che a causa della sua struttura è totalizzante. La cittadinanza diventa così un fatto marginale e puramente anagrafico; salvo eccezioni individuali, il clero si sente e di fatto risulta una comunità extraterritoriale. Pensare che una delle preoccupazioni di una siffatta comunità sia quella di esortare gli italiani a pagare le tasse è un pensiero peregrino. Li esorta - questo sì - a mettere la barra nella casella che destina l’otto per mille del reddito alla Chiesa. Un miliardo di euro ha fruttato all’episcopato italiano quell’otto per mille nel 2006. Ma esso, come sappiamo, è solo una parte del sostegno dello Stato alla gerarchia, alle diocesi, alle scuole, alle opere di assistenza.
* * *
Come si vede la pressione cattolica sullo Stato "laico" italiano è crescente, si vale di molti mezzi, si manifesta in una pluralità di modi assai difficili da controllare e da arginare.
Le difese laiche - si è già detto - sono deboli e poco efficaci: affidate a posizioni individuali o di gruppi minoritari ed elitari contro i quali si ergono "lobbies" agguerrite e perfettamente coordinate da una strategia pensata altrove e capillarmente ramificata. Quanto al grosso dell’opinione pubblica, essa è sostanzialmente indifferente. La questione cattolica non fa parte delle sue priorità. La gente ne ha altre, di priorità. È genericamente religiosa per tradizione battesimale; la grande maggioranza non pratica o pratica distrattamente; i precetti morali della predicazione vengono seguiti se non entrano in conflitto con i propri interessi e con la propria "felicità". In quel caso vengono deposti senza traumi particolari.
Perciò sperare che la democrazia possa diventare l’"habitus" degli italiani è arduo. Gli italiani non sono cristiani, sono cattolici anche se irreligiosi. Questo fa la differenza.
* la Repubblica, 5 agosto 2007
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ (Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.30 luglio 2007, di Federico La Sala
Libro sulla restaurazione del Messale tridentino
di Paolo Farinella *
Care Amiche e Amici,
 Vi chiedo scusa per l’invadenza e anche a quelli che ricevono in doppio o triplo.
Vi chiedo scusa per l’invadenza e anche a quelli che ricevono in doppio o triplo.
 Vi comunico che è in libreria il mio ultimo libretto (Paolo Farinella, Ritorno all’antica Messa. Nuovi problemi e interrogativi, Prefazione di P. Rinaldo Falsini, Il Segno dei Gabrielli Editori, pp. 80, euro 10,00), scritto di getto e pubblicato contro ogni criterio economico in piena estate.
Vi comunico che è in libreria il mio ultimo libretto (Paolo Farinella, Ritorno all’antica Messa. Nuovi problemi e interrogativi, Prefazione di P. Rinaldo Falsini, Il Segno dei Gabrielli Editori, pp. 80, euro 10,00), scritto di getto e pubblicato contro ogni criterio economico in piena estate.Il libro si compone di 80 pagine, appassionato e a tratti veemente è un grido di opposizione al tentativo di restaurazione della Chiesa che questo papato persegue. Restaurando il vecchio messale del 1570 per venire incontro ad un gruppo di irriducibili nostalgici, il papa non esita a sconfessare il concilio, nonostante le sue intenzioni.
Per la prima volta un prete si dichiara "obiettore di coscienza" a fronte di un documento papale che cerca di riportare la chiesa indietro di cinque secoli.
Il libro ha valore anche per la straordinaria prefazione di P. Rinaldo Falsini, straordinario liturgista e vivente testimone della commissione conciliare della Liturgia di cui fu il verbalista ufficiale.
Paolo Farinella, prete
A tutti coloro che sono interessati a proseguire e sviluppare le riforme e le intuizioni del concilio Vaticano II e a contrastare l’involuzione della chiesa, rivolgo l’invito di scrivere una lettera personale al proprio vescovo di questo tenore:
 Al vescovo ________________
Al vescovo ________________
 Via/Piazza ________________
Via/Piazza ________________
 Cap. Città ________________
Cap. Città ________________ Sig. Vescovo,
Sig. Vescovo,Ripristinando il messale preconciliare, il Papa riporta la chiesa indietro di 5 secoli, sconfessando così il concilio Vaticano II. Desidero fare giungere al papa il mio atto di fedeltà al concilio che il papa stesso dovrebbe chiedere a quanti ne denigrano lo spirito e le riforme, usando la Messa preconciliare come arma di ricatto. Pertanto non condivido né posso accogliere il motu proprio del papa come vincolante la mia coscienza.
Chi vuole può aggiungere, se ha letto e condiviso:
Condivido gli argomenti contrari al documento pontificio descritti nel libro "Ritorno all’antica Messa. Nuovi problemi e interrogativi" di Paolo Farinella, Il Segno dei Gabrielli Editore, 2007 e ne partecipo l’obiezione di coscienza.
 Cordiali saluti
Cordiali saluti
 Data
Data
 Firma
Firma L’invito è rivolto anche ai non credenti perché il ritorno alll’indietro è una tragedia che tocca tutti: dietro questa restaurazione che una visione fondamentalista del cristianesimo che ha ripercussioni sulla politica, sullo Stato di diritto e sul rapporto chiesa-mondo. Questo documento è il primo passo nella direzione di una "santa alleanza" tra fondamentalismo cattolico/cristiano e islamico: dicono le proiezioni che fra 30 anni saranno le due religioni dominanti in Europa e alleate insieme sapranno imporre agli Stati politiche generali e sociali, creando uno Stato sottomesso, nelle forme formali della democrazia, al potere delle religioni. Altro che Stato etico!!!!!!. Questo, a mio parere è l’obiettivo finale di Benedetto XVI e il ritorno alla Messa del Concilio di Trento ne è solo il primo gradino o tassello.
L’invito è rivolto anche ai non credenti perché il ritorno alll’indietro è una tragedia che tocca tutti: dietro questa restaurazione che una visione fondamentalista del cristianesimo che ha ripercussioni sulla politica, sullo Stato di diritto e sul rapporto chiesa-mondo. Questo documento è il primo passo nella direzione di una "santa alleanza" tra fondamentalismo cattolico/cristiano e islamico: dicono le proiezioni che fra 30 anni saranno le due religioni dominanti in Europa e alleate insieme sapranno imporre agli Stati politiche generali e sociali, creando uno Stato sottomesso, nelle forme formali della democrazia, al potere delle religioni. Altro che Stato etico!!!!!!. Questo, a mio parere è l’obiettivo finale di Benedetto XVI e il ritorno alla Messa del Concilio di Trento ne è solo il primo gradino o tassello.Quei cattolici e non credenti che riducono la questione ad un fatto interno alla Chiesa o peggio ad una questione di Messa in latino o in italiano, non colgono la dimensione drammatica della strategia religiosa che dominerà ogni questione per i il prossimo.
Cordialmente
Paolo prete
* Il dialogo, Lunedì, 30 luglio 2007
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! - LA LINGUA DEI VINCITORI di Ettore Masina (inviata da don Aldo Antonelli)25 luglio 2007
Se vi ricordate,
a suo tempo ebbi a dire che il problema serio del motu proprio con il quale il Papa reistaurava la Messa in latino non era la lingua, ma quello che vi sta dietro, in particolare l’ecclesiologia anti e anteconciliare e la "politica" ratzingeriana...!
Leggetevi queste bellissime riflessioni di Ettore Masina.
Un abbraccio a tutti
Aldo [don Antonelli]
La lingua dei vincitori
Ettore Masina luglio 2007
1
Dal suo letto d’ospedale, una mattina del febbraio 1975, Gigi Ghirotti vide che nella notte era completamente fiorito un albero che egli aveva adottato come amico. Quel tripudio di colori in un inverno non ancora concluso lo estasiò: lui, uno dei migliori giornalisti italiani, stava morendo, di cancro, ma quella mattina sentì che la sua vicenda, incomprensibile e dolorosa, era inserita nel mistero di una vita che ostinatamente si esprime oltre ogni limite. Forse pensò al verso di Quasimodo in cui Dio viene chiamato “Dio del cancro e Dio del fiore rosso”, certo, come narrò egli stesso, desiderò di poter cantare l’immensità e la forza del processo creativo. Dai ricordi dell’adolescenza sentì emergere la bellezza di un inno latino medievale, il “Veni, Creator Spiritus (Vieni, o Spirito Creatore)”, e si accinse a recitarlo accanto a quella finestra; ma tristemente si accorse di non ricordarne più le parole. Gigi poteva ancora scendere dal letto e lo fece; e cominciò a domandare a pazienti, medici, suore e visitatori se qualcuno di loro poteva aiutarlo, ma tutti, un po’ sorpresi, scuotevano la testa. Soltanto a fine mattina incontrò un seminarista americano, studente a Roma, che visitava i malati per non dimenticare le sofferenze dell’uomo. Alla domanda del giornalista sorrise e disse che sì, quell’inno lui lo aveva studiato a memoria, in ginnasio e, sì, lo ricordava ancora; ma aggiunse, arrossendo un poco, che non ne comprendeva più il significato: la sua conoscenza del latino era ormai svanita. Allora, insieme, l’uomo che comprendeva la sostanza del messaggio ma non poteva leggerlo nella sua autenticità e quello che ne conosceva soltanto la formulazione pregarono, quasi aiutandosi l’un l’altro a decifrare un antico manoscritto.
2
Ho ripensato a quest’episodio quando ho letto il motu proprio con il quale Benedetto XVI concede, di fatto, a chi vuole, il diritto (non il permesso) di celebrare la Messa secondo il rito di Pio V, in vigore dal 1570 sino alla riforma liturgica del 1963. E ho pensato che sarebbe bello che i nostalgici del latino e coloro che vivono il vangelo senza avere una cultura classica si aiutassero fra loro per una maggiore pienezza di vita ecclesiale; ma so bene, purtroppo, che non a questo provvede il documento papale; e so anche meglio perché e per chi papa Ratzinger ha sancito il diritto a celebrare la Messa pre-conciliare. Questo “perchè” e questo “per chi” stanno non già nel fatto che vi sono persone le quali vedono nel latino una lingua tradizionalmente “cattolica”, segno di unità fra i credenti di tutte le nazioni, ma nel fatto che alcune centinaia di migliaia di individui (dunque una men che minima parte di quel miliardo e 200 milioni di persone che gli statistici calcolano battezzate nella Chiesa cattolica) dietro questo sentimento mascherano (ma neppure troppo) l’odio per la primavera conciliare e il desiderio di perpetuare una serie di privilegi personali e di classe. E’ un vecchio clericalismo quello cui Benedetto XVI concede ora la vittoria: il clericalismo del prete solo all’altare, avanti a tutti come un generale, intento a pronunziare formule incomprensibili a chi lo ascolta (e dunque magiche) in una lingua che soltanto pochi “signori” conoscono; e in quella lingua misteriosa proclama persino le Scritture rendendole messaggio castale; un celebrante separato, nelle antiche basiliche, da un’area vuota e soprelevata chiamata presbiterio: la quale sembra oggi, dove non è stata “corretta”, una profonda ferita inferta all’unità dell’assemblea eucaristica. E la messa, “quella” messa, è infatti legata al singolo sacerdote, per cui la stessa idea di “concelebrazione” appare negata, con risultati che oggi appaiono persino comici. Ricordo la chiesa di un collegio straniero a Roma, visitata prima del Concilio: una grande sala circolare con una dozzina di cappelle laterali, in ciascuna delle quali un prete celebrava la “sua” messa mentre due poveri chierichetti si affannavano a correre dall’uno all’altro altare, qui porgendo ampolline e là rialzando pianete, a pochi metri di distanza scampanellando per annunziare la Consacrazione o recitando ad alta voce il confiteor... .
Era, quella di Pio V, una Messa resa affascinante nella solennità delle cattedrali, dallo sfolgorio di paramenti, dalla virtuosità di superbi cori, di musiche sconvolgenti (non sempre il gregoriano, anzi, ben più spesso, il barocco del dopo-Riforma); spettacolo talvolta indimenticabile nella sua teatralità ma sempre difficile da seguire con la preghiera; e ridotto spesso, nella pratica feriale delle più modeste parrocchie, a una sorta di borbottìo di un prete raggelato dalla sua anche simbolica solitudine. I fedeli, del resto venivano esortati ad “assistere “ alla Messa ed era normale sentirli dire: “Ho preso la Messa”, come qualcosa che era soltanto dono da ricevere e non atto consapevole.
3
Ma c’è anche di peggio ed è la composizione “sociale” dei gruppi cui Benedetto XVI ha steso la sua mano improvvisamente prodiga. Per quarant’anni Lèfebvre e i suoi fedelissimi hanno apertamente e fieramente avversato i documenti (e più lo spirito) del Concilio (che, non lo si dimentichi, è la massima espressione ecclesiale: i vescovi di tutta la Terra riuniti intorno al Papa), Attribuendo all’assise ecumenica le cause dello sfacelo del mondo e della Chiesa, i lefebvriani sono contro la libertà religiosa, contro l’ecumenismo, contro la democrazia, contro lo Stato di diritto, contro la laicità dello Stato e perciò hanno offerto e offrono una sponda religiosa alle peggiori formazioni politiche del nostro tempo. Basterebbe ricordare un altro vescovo che fu accanto al francese, il brasiliano Proença Sigaud: fondatore di un’associazione chiamata “Tradizione, Famiglia, Proprietà”, di fatto una specie di cappellania per latifondisti persecutori dei poveri e per generali delle dittature latino-americane. Non per niente i lefebvriani celebrano Pio V come il Santo della vittoria dei cristiani sull’Islam, quella battaglia di Lepanto che secondo loro andrebbe ripresa, non soltanto contro i musulmani ma contro tutto il mondo moderno. Per loro il latino è la lingua dei vincitori.
4
Raggelanti mi paiono anche le motivazioni portate da papa Ratzinger sulla sua decisione, notoriamente in contrasto con il parere della maggior parte dell’episcopato. La sua decisione sarebbe nata, egli dice, dalla preoccupazione per un eccesso di creatività (disordinata) da parte dei fedeli conciliari e dalla sofferenza che da esso scaturirebbe per molti, anche giovani
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ (Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.14 luglio 2007, di Federico La Sala
LA MESSA DI PIO V
Come precisa bene l’amico Paolo Farinella, il problema non è la "Messa in Latino" come volgermente la stampa di corte la vuole far passare, ma l’ecclesiologia che c’è dietro, la considerazione del "Mondo" e i rapporti "Chiesa/Mondo" che vi sottendono.
Le parole me le ha rubate don Paolo, per cui vi incollo semplicemente la lettera da lui scritta e che io sottoscrivo a quattro mani.
Aldo [don Antonelli]
MESSA TRIDENTINAdi Paolo Farinella
Dispiace che una delle «teste ordinate e ben fatte» come don Balletto abbia fatto cilecca d’un colpo, scrivendo dotte considerazioni filosofiche sul «Messa in latino» e sull’estetica della lingua latina. Questo modo di presentare il documento pontificio « Summorum Pontificum» è deformante, falso e purtroppo ci cascano tutti forse perché è un modo innocuo per far passare scelte destabilizzanti, mistificatorie e sbagliate.
No, caro don Antonio Balletto! Io non ci sto a questo irenismo di un colpo al cerchio e uno alla botte proposto alla fine dell’articolo. Il motu proprio di Benedetto XVI non restaura la «messa in latino», ma autorizza i fedeli a chiedere la celebrazione della «Messa tridentina», detta di Pio V, ritoccato più volte da Clemente VIII, Urbano VIII, Pio X, Benedetto XV e Pio XII.
E’ una questione totalmente differente. Che la Messa di Pio V sia in latino o in greco o in siriano o in genovese è ininfluente perché puramente accidentale, ciò che invece è tragico, antistorico e dubbio da un punto di vista dottrinale, riguarda la restaurazione pura e semplice della teologia e della ecclesiologia che sottostanno al rito tridentino. Teologia ed ecclesiologia che configgono con il magistero successivo (potrei portare in qualsiasi sede ampia facoltà di prova) e specialmente con il magistero di Giovanni XXIII, Paolo VI e del Concilio, la cui Messa riformata da sempre si può dire in latino, se occorre la necessità. Io stesso l’ho utilizzata con amici polacchi.
I nostalgici lefebvriani hanno fatto della Messa la loro bandiera, ma dietro c’è un esercito di motivi teologici che essi contestano. Essi rifiutano a piè di lista il concilio ecumenico Vaticano II, definiscono Paolo VI papa demoniaco, i papi da Paolo VI a Giovanni Paolo II papi scismatici e senza autorità. Hanno formulato negli anni ’80 la tesi teologica detta di «Cassiaciacum» con cui dimostrano che questi papi pur essendo stati eletti legittimamente, non hanno ricevuto la potestà apostolica per cui non hanno autorità sulla chiesa. I fedeli non sono tenuti ad ubbidirgli, altro che latino!
Il papa non si limita a concedere «la Messa in latino», ma concede il «messale di Pio V», contrabbandato come «messale di Giovanni XXIII» che è un falso storico, dal momento che questi si è limitato ad aggiungere il nome di San Giuseppe nel canone e a togliere l’espressione «pro perfidis Iudaeis», editando il messale precedente in tutto e per tutto perché ancora non era giunta la riforma conciliare. Accanto al messale tridentino concede l’uso del «sacramentario» cioè la celebrazione dei sacramenti (battesimo, cresima, matrimonio, ecc.) secondo i riti preconciliari. Addirittura a chi ne ha l’obbligo concede l’uso dell’antico breviario, azzerando in un solo colpo la riforma di Paolo VI che parlava di «Novum Messale» e di «Liturgia delle Ore».
Non è una questione banale di lingua che non interessa nessuno, è uno scontro titanico di culture e di teologie. Dietro Pio V c’è la teologia della Chiesa senza popolo: attore del culto divino è solo il prete che parla da solo come e scandisce in forma magica le parole consacratorie; c’è l’antigiudaismo viscerale, c’è la visione del mondo come «cristinairìtà», ecc.. Dietro Paolo VI c’è la chiesa popolo di Dio che è il soggetto celebrante, c’è la Chiesa «nel mondo»; c’è il popolo ebraico «fratello maggiore»; c’è la coscienza come termine ultimo di decisione, ecc.
Dietro a tutto vi sono due ecclesiologie, due modi di concepire il mondo, l’uomo, le relazioni con gli Stati, la libertà religiosa e di coscienza. Altro che latino, lingua bella e formatrice di teste pensanti! Se questi sono i risultati, significa che il latino ha costruito teste fragili e pensieri deboli e sensibilità bambine
Don Balletto vuole la prova? Il Capo degli scismatici lefebvriani: Bernard Fellay ha già dichiarato che questo è solo l’inizio perché ora si tratta di affrontare tutti i problemi che stanno dietro la Messa di Pio V e cioè i problemi dottrinali incompatibili con il Vaticano II.
Questo motu proprio, un vero blitz del papa tedesco contro il parere della quasi totalità dei vescovi e dei cardinali, è solo l’inizio di una valanga. Infatti, coerentemente, ad esso è seguito l’ultimo documento della Congregazione della fede che ancora una volta sconfessa Paolo VI e il Concilio e chiude definitivamente il dialogo ecumenico. Non mi meraviglia questo secondo documento perché è in pieno nella logica della teologia e dell’ecclesiologia tridentina espressa nel messale di Pio V, sia che sia in latino sia che sia in genovese.
Il papa è ossessionato dal concilio e intende metterlo in soffitta. Non ci riuscirà perché anche i papi sbagliano e questo cammino antistorico all’indietro gli si ritorcerà contro, come sta già avvenendo.
La Lega di Bossi ha già mobilitato i suoi xenofobi a pretendere dai parroci la «Messa del passato» e il ritorno alla teologia di ieri, l’abolizione del concilio e il ripristino del magistero di sempre. Don Balletto è servito anche in lingua padana.
Per quanto mi riguarda in quanto prete io mi dichiaro obiettore di coscienza in nome e per conto di Paolo VI e per fedeltà al Concilio ecumenico vaticano II.
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ ( Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.13 luglio 2007, di Federico La Sala
 Il dibattito sulla messa in latino
Il dibattito sulla messa in latino
 Concilium Vaticanum IIum, vale!
Concilium Vaticanum IIum, vale!di FRANK K. FLINN
(Traduzione di Stefania Salomone) *
Così non si tratta semplicemente di usare il Latino nella Messa al posto del vernacolare. Si tratta di ritornare al rito del 1570. Questo significa:

 L’altare rivolto di nuovo verso la parete del santuario.
L’altare rivolto di nuovo verso la parete del santuario.
 L’eliminazione della messa vespertina del Sabato per la Domenica
L’eliminazione della messa vespertina del Sabato per la Domenica
 Re-installazione delle ringhiere per la fila per la comunione
Re-installazione delle ringhiere per la fila per la comunione
 Le donne indosseranno il copricapo a Messa
Le donne indosseranno il copricapo a Messa
 La comunione solo per via orale (n.d.r. nel senso che non si potrà più prendere l’ostia con le mani ma sarà il solo sacerdote a imboccare i fedeli)
Eliminazione della comunione sotto e due specie
La comunione solo per via orale (n.d.r. nel senso che non si potrà più prendere l’ostia con le mani ma sarà il solo sacerdote a imboccare i fedeli)
Eliminazione della comunione sotto e due specie
 L’attuale repertorio di canti sostituito da quello in gregoriano
L’attuale repertorio di canti sostituito da quello in gregoriano
 Servizio femminile all’altare eliminato
Servizio femminile all’altare eliminato
 Digiuno dalla mezzanotte per la comunione della domenica
Digiuno dalla mezzanotte per la comunione della domenica
 Liturgia per i bambini in latino
Liturgia per i bambini in latino
 Diletto dei latinisti
Diletto dei latinisti
 I seminari saranno di nuovo pieni di leggi/norme/regolamenti che imporranno ai giovani di indossare la tonaca
I seminari saranno di nuovo pieni di leggi/norme/regolamenti che imporranno ai giovani di indossare la tonaca
 I preti, religiosi, laici nel mondo che hanno portato avanti le lotte per i diritti umani, la giustizia sociale saranno fermati e soffocati
I preti, religiosi, laici nel mondo che hanno portato avanti le lotte per i diritti umani, la giustizia sociale saranno fermati e soffocati
 La chiesa accelererà il suo declino e divverà ancor più irrilevante in questi tempi cruciali di tumulti sociali nel mondo.
La chiesa accelererà il suo declino e divverà ancor più irrilevante in questi tempi cruciali di tumulti sociali nel mondo.
 Jay Leno farà un intero monologo inLatino. L’indice di ascolto di ETWN salirà alle stelle.
Jay Leno farà un intero monologo inLatino. L’indice di ascolto di ETWN salirà alle stelle. Don Campbell
Don Campbell
 il vostro corrispondente canadese
il vostro corrispondente canadeseL’articolo che segue è del Boston Globe di oggi.
 Boston Globe
Boston Globe FRANK K. FLINN
FRANK K. FLINN
 Concilium Vaticanum IIum, vale!
Concilium Vaticanum IIum, vale!10 luglio 2007
I cattolici nel mondo non devono farsi illusioni. La recente decisione di Papa Benedetto XVI di incoraggiare un più largo uso della messa Tridentina in Latino è l’ultima mossa della sua campagna per bloccare la riforma liberale nelle pratiche religiose dei cattolici dal 1960.
La mossa potrà facilmente dare l’avvio ad uno scisma liturgico in tutto il mondo.
Il vecchio rito della Messa fu promulgato da Papa Paolo V col Messale Romano nel 1570. In questo rito il prete celebra da un altare rialzato, di spalle alla assemblea e balbettando le parti principali della liturgia in Latino.
La Messa Tridentina rimase fino alla nuova formula promulgata nel 1969 da Papa Paolo VI al Concilio Vaticano II (1962-65). Tornando alle antiche tradizioni di culto, la nuova Eucarestia fu tradotta nelle lingue locali. Il prete ora celebrava di fronte all’assemblea. Con l’espandersi del canto liturgico nel mondo venne inclusa anche la musica gospel, canti africani e tamburi, le band mariachi messicane, la musica fold e perfino dei ritmi pop. Immediatamente i cattolici conservatori attaccarono il nuovo rito, ma Paolo VI replicò che il vangelo sarebbe andato perduto se la gente non avesse conservato il proprio linguaggio e i propri costumi.
Le critiche continuarono da parte di una minoranza tradizionalista. Nel 1968 l’ex arcivescovo francese Marcel LeFebvre condusse una piccola minoranza di cattolici attraverso uno scisma col quale egli e i suoi seguaci dichiararono eretica la "Messa di Paolo VI". I lefebvriani non solo rifiutarono la nuova liturgia, ma rigettarono la dottrina chiave del Vaticano II in materia di ecumenismo, libertà religiosa e collegialità. La collegialità era il concetto fondamentale che ha mosso il Vaticano II. La durezza dell’opposizione dei tradizionalisti nei confronti delle novità del Vaticano II era e rimane sbalorditiva.
Dall’altra parte nella chiesa, i progressisti volevano portare avanti le aperture iniziate col Vaticano II, non solo in ambito liturgico, ma sull’ecumenismo, il coinvolgimento dei laici, le attività cristiane a sfondo sociale (teologia della liberazione, femminismo, ecologia) e argomenti etici (celibato, controllo delle nascite). Paolo VI iniziò a porre le basi, ma Papa Giovanni Paolo II e il Cardinale Joseph Ratzinger, il suo nuovo Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, continuarono verso una completa opera di ostruzionismo.
Hanno voluto sempre contrastare la parte progressista della chiesa. Negli anni ’80 hanno messo a tacere il teologo della liberazione Leonardo Boff, hanno rimosso lo svizzero Hans Küng e l’americano Charles Curran dalle loro cattedre, e senza scrupoli hanno arbitrariamente scomunicato l’indiano Tissa Balasuriya. (Tale atto fu annullato). Proprio quest’anno il papa ha censurato il teologo della liberazione salvadoregno Jon Sobrino usando la vecchia tattica vaticana del mettere insieme le sue citazioni tacciandole di essere fuori da ogni contesto.
In contrasto, il papato rimane inspiegabilmente indulgente verso gli scismatici lefebvriani nonostante essi continuassero a disprezzare lo stesso Vaticano. Infatti negli anni ’80 il Cardinale Ratzinger riservo loro delle ammonizioni. Nella prefazione di un trattato liturgico egli accusò la Messa moderna di essere uno modello capriccioso e di cattiva fabbricazione. Continuò a tenere a esempio i riti dell’Est, ortodossi, indicandoli come "liturgia eterna". Si potrebbe parlare di pregiudizio eurocentrico nelle sue valutazioni.
Il papa non ha mai delegato aspetti della gestione dele varie branche della chiesa cattolica. Ha semplicemente capitolato sui lefebvriani, che continuano a guardare in dall’alto in basso i parrocchiani cattolici che gradiscono in rito nella propria lingua col prete di fronte. Il fascino della "liturgia eterna" è falso. Le liturgie delle chiese antiche era sia multiforme che multilingue, nella prima generazione spaziava dall’aramaico, al greco, al siriano. La prima chiesa conosciuta, ritrovata recentemente a Megiddo in Israele, non ha un altare elevato e separato dal cuore della comunità. Un vero tradizionalista abbraccerebbe con gioia i molti llinguaggi e culture del mondo come accadeva nelle prime comunità.
Perché dico addio al Vaticano II? Una delle basi del concilio era il movimento liturgico che durò fino alla metà del secolo. I riformisti della liturgia erano convinti che la liturgia era del popolo, dal popolo e per il popolo di Dio, a prescindere se laico o religioso. La parola "liturgia" in greco significa "il lavoro del popolo". Questa nozione racchiude il principio della collegialità, la chiave teologica promulgata nel Vaticano II. La Messa Tridentina è lavoro del prete. Rimettendo indietro l’orologio liturgico a distanza dalla creativa molteplicità delle prime comunità cristiane, ma verso l’età d’oro dell’Inquisizione, della monarchia papale di Trento, Papa Benedetto XVI sta abbandonando il principio di collegialità che abbraccia tutti i vescovi, tutti i preti, tutti i diaconi e i laici intesi come comunità di fedeli. Questo dice "addio" al Vaticano II!.
 Frank K. Flinn,
Frank K. Flinn,
 professore ausiliario di studi religiosi alla Washington University di St. Louis,
professore ausiliario di studi religiosi alla Washington University di St. Louis,
 autore della "Enciclopedia del Cattolicesimo"
autore della "Enciclopedia del Cattolicesimo"
 © Copyright 2007 The New York Times Company
© Copyright 2007 The New York Times Company*Il Dialogo, Venerdì, 13 luglio 2007 (ripresa parziale - senza il testo originale)
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ ( Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.12 luglio 2007, di Federico La Sala
Editoriale *
Ci stanno rubando ogni ben di Dio
di Sebastiano B. Caix
L’aria a Milano, le spiagge sulle coste, la terra e l’acqua nel Sud. Tutto per una parola: liberalizzazione. Non sembra vero: ora la usano anche gli ex comunisti
I problemi gravi e vistosi di guerre e di politica sono tanti e tutti ne discutono, parlerò di alcuni piccoli ma che, messi insieme, hanno un loro senso. La terra, l’acqua, l’aria, la vita sono di tutti: tutti abbiamo diritto di lavorare la terra, di bere l’acqua, di respirare l’aria. Tutto quello che era prima dell’uomo appartiene a Dio, che l’ha donato a tutti gli uomini ovvero a tutta l’umanità. Nessuno - ricorda don Primo Mazzolari in un suo scritto - può dire questo è mio e non di altri. Se Mazzolari era un cristiano, questa è un’affermazione cristiana. Le leggi regolano questi diritti.
Le cose però non stanno così. La voce della saggezza e del diritto è stata nei secoli schiacciata dalla forza che, ai vincoli della ragione, ha sostituito quelli della violenza e della prevaricazione. Il più forte dice: «Questo è mio» e toglie ai deboli un loro diritto. Così oggi ci troviamo di fronte a un intrico di leggi sempre più fitto e confuso che, alla fine, difende sempre più la forza dei forti che i diritti dei deboli. Respiriamo aria inquinata, beviamo acqua inquinata, mangiamo cibi inquinati. Perché? Non sembra vero: per dare più armi di violenza a quelli che ci tolgono i nostri diritti con la violenza.
L’Italia è l’esempio che abbiamo sotto gli occhi: ma come avere il coraggio di ripetere ciò che viene detto, e inascoltato, ogni giorno? Milano è inquinata dalle autovetture? Basta pagare un biglietto «antinquinamento» ed ecco che i cittadini elettori, invece di cambiare regime, si tranquillizzano. Si autoinquinano pagando una tassa di più. Vivaci proteste popolari? No, qualche borbottio, poi su tutto (e sugli immani guadagni dei politici e dei loro accoliti) cala il silenzio perfino dei partiti all’opposizione. Sulle spiagge non si può prendere liberamente il sole o fare il bagno, perché i litorali sono stati venduti ai privati? Qualche polemica sui mass media, poi tutto si soffoca, si attutisce: i fiumi di denaro e le connivenze mettono a tacere gli amministratori e le opposizioni.
Montagne di rifiuti fumanti in numerose città del sud? I turisti stranieri invitati ad andarsene dalle loro stesse rappresentanze diplomatiche? Grida mediatiche, scambi di responsabilità (responsabilità!), montagne di denaro alle varie mafie e camorre, a esponenti di amministrazioni pubbliche e private, a personaggi d’ogni risma e partito che allignano perfino nelle istituzioni incaricate di proteggere i diritti contro i soprusi, ed ecco che tutto si sopisce, si ferma, l’ingiustizia scompare. Non che tornino ordine, pulizia, onestà: no, le bocche sono cucite dai soldi e dalla paura, il silenzio è d’oro.
La stampa dà notizia di una pericolosa discarica abusiva su un’area di 12 chilometri sulla tangenziale di Bari, e dice «scoperta» dall’autorità tutoria. Quest’area è da mesi scavata, preparata e tenuta in attività con camion e ruspe alle porte di un capoluogo di regione. Cosa vuol dire: scoperta? Scoprire una discarica illegale di 12 chilometri quadrati è come a Pisa «scoprire» la torre di Pisa. In alcuni capoluoghi di provincia, come a Taranto, manca l’acqua: è stata liberalizzata. Questa la grande trovata truffaldina: la «liberalizzazione» di elementi vitali che appartengono a tutti. Qui dovrebbe esserci un sommovimento mondiale, invece no. Perfino gli ex comunisti parlano di liberalizzazione, liberalizzano. Ma che cosa si liberalizza, quello che «deve» essere libero? Quello che è già per natura un dono di Dio a tutti?
La forza del denaro rende ciechi e muti coloro che dovrebbero parlare in difesa di chi denaro non ne ha. Con la liberalizzazione dell’acqua (la cui distribuzione dovrebbe essere organizzata e difesa dalla comunità) i cittadini hanno perduto il diritto di bere, di lavarsi, di tenere puliti se stessi e le loro città: pagano di più e sono peggio organizzati. Aprono i rubinetti ed esce la corruzione. Dal Nord al Sud, il ladrocinio non cambia. Perfino i preti più coraggiosi se ne devono andare e i cattolici più fedeli si sentono abbandonati in questo deserto.
Sebastiano B. Caix
* Il Dialogo, Giovedì, 12 luglio 2007
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ ( Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.7 luglio 2007, di Federico La Sala
 Emanato il "motu proprio" che entrerà in vigore il 14 settembre
Emanato il "motu proprio" che entrerà in vigore il 14 settembre
 Benedetto XVI: "Non intaccherà l’Autorità del Concilio Vaticano II"
Benedetto XVI: "Non intaccherà l’Autorità del Concilio Vaticano II" Il Papa difende la messa in latino
Il Papa difende la messa in latino
 "Per ritrovare l’unità della Chiesa"
"Per ritrovare l’unità della Chiesa"I lefebvriani: "Clima migliore, ma siamo ancora sotto scomunica" *
CITTA’ DEL VATICANO - La messa in latino piace ai fedeli e unisce la Chiesa. Lo afferma Benedetto XVI nella lettera ai vescovi con cui accompagna il motu proprio "Summorum Pontificum" pubblicato oggi, che stabilisce nuove regole sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970.
Più che di un ritorno alla messa in latino, il Papa preferisce parlare di "un uso duplice dell’unico medesimo rito", visto che il Messale del ’62 non fu mai giuridicamente abrogato e di conseguenza e in linea di principio, restò sempre permesso".
"Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962." Così si stabilisce nell’articolo 5 del motu proprio.
Il motu proprio entrerà in vigore il 14 settembre e da quel giorno il parroco potrà autorizzare la messa in latino mentre ai vescovi resterà il compito di vigilare sull’applicazione, di segnalare eventuali difficoltà alla commissione vaticana "Ecclesia Dei" e, tra tre anni, di fare rapporto alla Santa Sede sull’applicazione di queste norme. Secondo le nuove norme il parroco che lo riterrà necessario potrà organizzare una "parrocchia personale" per le messe con rito straordinario, se ci sia un numero consistente di fedeli che lo desiderino.
Negli anni successivi alla riforma del 1970, "non furono pochi i casi di celebrazione" - rileva Benedetto XVI - "legati a questo uso del rito romano", e accenna qui al movimento di mons. Marcel Lefebvre. "Nel movimento guidato dall’arcivescovo Lefebvre, la fedeltà al Messale antico divenne un contrassegno esterno; le ragioni di questa spaccatura, che qui nasceva, si trovavano però più in profondità".
Il tentativo è quello di recuperare lo scisma dei tradizionalisti. E monsignor Bernard Fellay, Superiore generale dei lefebvriani, sottolinea insieme alla gratitudine a Ratzinger anche il fatto che la lettera che accompagna il Motu Proprio "non nasconde tuttavia le difficoltà che ancora sussistono". E ora la Fraternità San Pio X "auspica che il clima favorevole instaurato dalle nuove disposizioni della Santa Sede permetta - dopo il ritiro della scomunica che colpisce ancora i suoi vescovi - di affrontare con più serenità i punti dottrinali in questione"
Benedetto XVI in ogni caso ritiene infondato "il timore" che con il motu proprio che liberalizza la messa in latino "venga intaccata l’Autorità del Concilio Vaticano II e che una delle sue decisioni essenziali, la riforma liturgica, venga messa in dubbio".
* la Repubblica, 7 luglio 2007
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! ... IL "SACROSANTUM CONCILIUM", IL NUOVO MESSALE ROMANO E LO SMANTELLAMENTO SISTEMATICO DEL CONCILIO (di Michael G. Ryan - "America").27 gennaio 2010, di Federico La Sala
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! --- I Custodi della Tradizione ("Traditionis custodes") e la difesa della "civiltà occidentale". E l’ateo libertino «murò» il mattone del latino (altrui). Una nota (di Massimo Borghesi).27 luglio 2021, di Federico La Sala
Sulla Messa.
E l’ateo libertino «murò» il mattone del latino (altrui)
di Massimo Borghesi (Avvenire, martedì 27 luglio 2021)
Nel quadro delle infuocate critiche da parte di alcuni settori ’tradizionalisti’ a seguito della pubblicazione di Traditionis custodes spicca un particolare: il filosofo francese Michel Onfray, campione dell’ateismo libertino consegnato nel suo Trattato di ateologia, è divenuto il portabandiera della destra cattolica. Il noto intellettuale, famoso per il suo tono dissacrante verso la religione, si è infatti espresso a favore della vecchia messa in latino e ciò è bastato per elevarlo a santo protettore di quanti si oppongono, da tempo, al pontificato di Francesco.
Al pari dei teoconservatori americani degli anni passati, l’ateo Onfray giustifica la sua scelta a partire dalla difesa della ’civiltà occidentale’. Come l’autore ha affermato, in una intervista pubblicata su ’Il Foglio’, («Habemus papam Onfray», 24 luglio 2021), la opzione per il rito tridentino dipende dal fatto che: «Sono un puro prodotto di questa civiltà che cristallizza e armonizza Saulo, Pericle, Cesare e Costantino. Non credo in Yahweh, Zeus, Giove o Gesù Cristo. Ma vibro con tutta questa civiltà che ha generato geni in filosofia, arte, architettura, agronomia, teologia, poesia, letteratura, storia, tecnologia, medicina, farmacia, astronomia, astrofisica, politica».
Lo scettico, il miscredente, ’vibra’ per la civiltà europea. Al modo di Charles Maurras, il fondatore dell’Action française, il movimento cattolico di destra francese sconfessato da Pio XI negli anni Venti, anch’egli è un ateo devoto, un conservatore che ama l’ordine ’antico’. Non per sé, si badi bene, ma per gli altri, per il popolo.
 «Sono stato uno di quelli che ha lavorato alla costituzione di un’etica post-cristiana. Ho pubblicato diversi libri a favore di questo progetto, nessuno dei quali rinnego - dal Traité d’athéologie a La Sculpture de soi a Théorie du corps amoureux o Féeries anatomiques. Questi libri rimangono la mia etica, ma un’etica privata non è un’etica collettiva. Perché un’etica collettiva presuppone il sacro e il trascendente per imporsi con l’aiuto di un braccio armato: Gesù non sarebbe bastato a creare una civiltà se san Paolo non avesse creato un corpo di dottrina sviluppato in seguito dalla patristica e, soprattutto, se Costantino non avesse messo la forza dello Stato al servizio di questa morale». Al pari degli atei libertini del XVI secolo, Onfray distingue tra la morale privata, quella gaudente-irreligiosa riservata a lui e all’élite, e quella pubblica regolata dalla religione e dalla spada. Cristo senza Costantino sarebbe nulla, il sacro esiste solo grazie alla potenza dello Stato.
«Sono stato uno di quelli che ha lavorato alla costituzione di un’etica post-cristiana. Ho pubblicato diversi libri a favore di questo progetto, nessuno dei quali rinnego - dal Traité d’athéologie a La Sculpture de soi a Théorie du corps amoureux o Féeries anatomiques. Questi libri rimangono la mia etica, ma un’etica privata non è un’etica collettiva. Perché un’etica collettiva presuppone il sacro e il trascendente per imporsi con l’aiuto di un braccio armato: Gesù non sarebbe bastato a creare una civiltà se san Paolo non avesse creato un corpo di dottrina sviluppato in seguito dalla patristica e, soprattutto, se Costantino non avesse messo la forza dello Stato al servizio di questa morale». Al pari degli atei libertini del XVI secolo, Onfray distingue tra la morale privata, quella gaudente-irreligiosa riservata a lui e all’élite, e quella pubblica regolata dalla religione e dalla spada. Cristo senza Costantino sarebbe nulla, il sacro esiste solo grazie alla potenza dello Stato.Lo scettico Onfray è un tipico rappresentante della teologia politica di destra. Della messa in latino non importa nulla al nostro filosofo. Importa solo come blocco, mattone di un ordine che deve essere conservato affinché il ’popolo’ non si perda nell’anarchia. Strani compagni di strada quelli scelti dai cosiddetti cattolici tradizionalisti, cioè dagli anti-conciliari, per colpire il Papa. Criticati fino a ieri, per aver incarnato e promosso il libertinismo di massa dell’era della globalizzazione, oggi divengono, d’improvviso, gli apostoli della ’restaurazione’, i custodi della retta dottrina, gli amanti della verità.
Sono anni che questa destra cattolica si affida agli ’atei devoti’ per criticare il Papa e salvaguardare una ortodossia immaginaria. Il Papa sarebbe l’eterodosso e Onfray l’ortodosso. Una singolare contrapposizione che induce a riflettere sul profondo declino di certo pensiero cattolico contemporaneo.
LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU «PROPRIO» DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
«TRADITIONIS CUSTODES»
SULL’USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970
Custodi della tradizione, i vescovi, in comunione con il vescovo di Roma, costituiscono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari. [1] Sotto la guida dello Spirito Santo, mediante l’annuncio del Vangelo e per mezzo della celebrazione della Eucaristia, essi reggono le Chiese particolari, loro affidate. [2]
Per promuovere la concordia e l’unità della Chiesa, con paterna sollecitudine verso coloro che in alcune regioni aderirono alle forme liturgiche antecedenti alla riforma voluta dal Concilio Vaticano II, i miei Venerati Predecessori, san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno concesso e regolato la facoltà di utilizzare il Messale Romano edito da san Giovanni XXIII nell’anno 1962. [3] In questo modo hanno inteso «facilitare la comunione ecclesiale a quei cattolici che si sentono vincolati ad alcune precedenti forme liturgiche» e non ad altri. [4]
Nel solco dell’iniziativa del mio Venerato Predecessore Benedetto XVI di invitare i vescovi a una verifica dell’applicazione del Motu Proprio Summorum Pontificum, a tre anni dalla sua pubblicazione, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha svolto una capillare consultazione dei vescovi nel 2020, i cui risultati sono stati ponderatamente considerati alla luce dell’esperienza maturata in questi anni.
Ora, considerati gli auspici formulati dall’episcopato e ascoltato il parere della Congregazione per la Dottrina della Fede, desidero, con questa Lettera Apostolica, proseguire ancor più nella costante ricerca della comunione ecclesiale. Perciò, ho ritenuto opportuno stabilire quanto segue:
Art. 1. I libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l’unica espressione della lex orandi del Rito Romano.
Art. 2. Al vescovo diocesano, quale moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare a lui affidata, [5] spetta regolare le celebrazioni liturgiche nella propria diocesi. [6] Pertanto, è sua esclusiva competenza autorizzare l’uso del Missale Romanum del 1962 nella diocesi, seguendo gli orientamenti dalla Sede Apostolica.
Art. 3. Il vescovo, nelle diocesi in cui finora vi è la presenza di uno o più gruppi che celebrano secondo il Messale antecedente alla riforma del 1970:
§ 1. accerti che tali gruppi non escludano la validità e la legittimità della riforma liturgica, dei dettati del Concilio Vaticano II e del Magistero dei Sommi Pontefici;
§ 2. indichi, uno o più luoghi dove i fedeli aderenti a questi gruppi possano radunarsi per la celebrazione eucaristica (non però nelle chiese parrocchiali e senza erigere nuove parrocchie personali);
§ 3. stabilisca nel luogo indicato i giorni in cui sono consentite le celebrazioni eucaristiche con l’uso del Messale Romano promulgato da san Giovanni XXIII nel 1962. [7] In queste celebrazioni le letture siano proclamate in lingua vernacola, usando le traduzioni della sacra Scrittura per l’uso liturgico, approvate dalle rispettive Conferenze Episcopali;
§ 4. nomini, un sacerdote che, come delegato del vescovo, sia incaricato delle celebrazioni e della cura pastorale di tali gruppi di fedeli. Il sacerdote sia idoneo a tale incarico, sia competente in ordine all’utilizzo del Missale Romanum antecedente alla riforma del 1970, abbia una conoscenza della lingua latina tale che gli consenta di comprendere pienamente le rubriche e i testi liturgici, sia animato da una viva carità pastorale, e da un senso di comunione ecclesiale. È infatti necessario che il sacerdote incaricato abbia a cuore non solo la dignitosa celebrazione della liturgia, ma la cura pastorale e spirituale dei fedeli.
§ 5. proceda, nelle parrocchie personali canonicamente erette a beneficio di questi fedeli, a una congrua verifica in ordine alla effettiva utilità per la crescita spirituale, e valuti se mantenerle o meno.
§ 6. avrà cura di non autorizzare la costituzione di nuovi gruppi.
Art. 4. I presbiteri ordinati dopo la pubblicazione del presente Motu proprio, che intendono celebrare con il Missale Romanum del 1962, devono inoltrare formale richiesta al Vescovo diocesano il quale prima di concedere l’autorizzazione consulterà la Sede Apostolica.
Art. 5. I presbiteri i quali già celebrano secondo il Missale Romanum del 1962, richiederanno al Vescovo diocesano l’autorizzazione per continuare ad avvalersi della facoltà.
Art. 6. Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, a suo tempo eretti dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei passano sotto la competenza della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
Art. 7. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, per le materie di loro competenza, eserciteranno l’autorità della Santa Sede, vigilando sull’osservanza di queste disposizioni.
Art. 8. Le norme, istruzioni, concessioni e consuetudini precedenti, che risultino non conformi con quanto disposto dal presente Motu Proprio, sono abrogate.
Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, entrando subito in vigore e, successivamente, venga pubblicato nel Commentario ufficiale della Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Giovanni Laterano, il 16 luglio 2021 Memoria liturgica di Nostra Signora del Monte Carmelo, nono del Nostro Pontificato.
FRANCESCO
* Fonte: Vatican.va, 16 luglio 2021 (ripresa parziale).
-
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ ( Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.7 luglio 2007, di Federico La Sala
TRE ANNI DI PROVA PER LA MESSA IN LATINO
CITTA’ DEL VATICANO - Vinte le perplessità di molti episcopati nazionali e singoli vescovi, dato ascolto ai molti dubbi e obiezioni del suo gregge, dopo mille indiscrezioni e annunci smentiti, il Papa pubblicherà il motu proprio che liberalizza la messa in latino secondo il rito tridentino. Dal Concilio per celebrarla era necessario uno speciale "indulto" del vescovo, che Benedetto XVI abolisce, venendo incontro in questo modo alle aspirazioni dei cattolici più tradizionalisti. L’abbandono della messa in latino è stato, infatti, uno dei motivi di allontanamento dalla Chiesa cattolica di mons. Marcel Lefebvre e dei suoi seguaci, dichiarati scismatici da Roma. Il motu proprio "Summorum Pontificum cura", secondo indiscrezioni, dovrebbe entrare in vigore il 14 settembre per dare ai vescovi il tempo di organizzarsi per rispondere alle eventuali richieste dei fedeli di celebrazioni in latino, e sembra che, dopo tre anni, sarà chiesto ai vescovi di far giungere a Roma un resoconto sull’esperienza, indicando eventuali difficoltà. La pubblicazione dell’atteso documento è stata annunciata per domani da una nota della sala stampa vaticana.
La messa in latino secondo il rito tridentino, disposto dal papa san Pio V a seguito del Concilio di Trento (1542-1563), è rimasta in uso - con i successivi aggiornamenti - sino al 1970, anno in cui Paolo VI, dopo alcuni anni di sperimentazione, codificò nel nuovo messale la messa (in latino e nelle lingue moderne) secondo le indicazioni scaturite dalla costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. L’ultimo messale romano aggiornato del rito tridentino fu pubblicato per disposizione di Giovanni XXIII nel 1962, lo stesso anno che si aprì il Concilio Vaticano II. Con il motu proprio - che in questi mesi è stato ampiamente modificato e rimaneggiato, per la reazione fortemente negativa di alcuni episcopati, in particolare quello francese -, papa Ratzinger pubblicherà anche una lettera esplicativa in cui presumibilmente cercherà di chiarire le perplessità di quanti temono che queste disposizioni significhino un ritorno al passato e una negazione del Concilio. E per favorire la ricezione positiva di questo testo la scorsa settimana ha convocato una riunione di cardinali e vescovi di tutto il mondo per illustrarne contenuti e obiettivi. Alcuni episcopati temono infatti di essere scavalcati, non essendo più necessario l’"indulto" del vescovo per celebrare secondo il rito tridentino. Intanto la agenzia vaticana Fides ha ammonito che il motu proprio "andrebbe accolto in maniera molto favorevole da tutti poiché si tratta non di un provvedimento restrittivo, ma di un vero "allargamento delle possibilità, secondo l’ormai nota linea ratzingeriana dell"allargamento della ragioné".
"A nessuno - rimarca Fides - sarà impedito alcunché, al limite verrà impedito di impedire la celebrazione secondo il rito antico". "Non si comprende - aggiunge l’agenzia - perché molti, talora forieri delle più libertarie teorie in molti campi, oggi temano una maggiore libertà nella scelta del rito in cui celebrare la divina Eucaristia. Impressione, fondata, è che siano essi i medesimi forieri di quella perniciosa creatività liturgica che troppo spesso stravolge i riti impedendo ad essi di parlare realmente al Popolo di Dio. Chi ha paura della libertà? Speriamo nessuno". "Il Motu proprio - è la conclusione - è un atto della responsabilità personale del Papa che allarga la libertà nella Chiesa".
* Ansa» 2007-07-06 20:10
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ ( Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.5 luglio 2007, di Federico La Sala
GB: cattolici divisi, la messa in latino e’ antisemita
Fonte: http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/2006/rep_nazionale_n_2354458.html?ref=hpsbdx2 *
La decisione di Benedetto XVI di autorizzare l’ampio ricorso alla celebrazione della Messa in latino sta provocando serie perplessita’ tra i cattolici del Regno Unito, impegnati da anni in un cammino di riconciliazione e comprensione reciproca con gli anglicani e la comunita’ ebraica. Al centro dei dubbi l’espressione usata dalla liturgia preconciliare, il rito Tridentino, nei confronti del popolo ebraico, bollato nelle celebrazioni del Venerdi’ Santo come "i perfidi giudei". E’ dal 1969, anno in cui divenne effettiva la disposizione del Concilio Vaticano II sulla celebrazione della messa nelle lingue nazionali e sulla revisione di parte della liturgia, che un’espressione del genere non rimbomba piu’ tra le navate di una chiesa cattolica britannica.
La questione ha spinto il cardinal Cormac Murphy-O’Connor, primate della chiesa di Inghilterra e Galles, ad inviare gia’ la settimana scorsa una lettera in Vaticano per sottolineare come il cambiamento sia da considerarsi superfluo. Una presa di posizione che rispecchia l’andamento di un dibattito interno alla comunita’ cattolica britannica che dura da mesi, da quando cioe’ venne fatta trapelare per la prima volta l’intenzione papale di dare nuova legittimazione al rito tridentino.
* Il Dialogo, Giovedì, 05 luglio 2007
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! - LA CHIESA, L’OCCIDENTE E I TEOCON. Una nota di don Aldo Antonelli23 giugno 2007, di Federico La Sala
LA CHIESA, L’OCCIDENTE E I TEOCON.
“Come mai in questo Occidente idolatrico e strutturalmente ateo, in cui ogni atto sembra viziato da una colpa irredimibile, i cristiani non sono perseguitati?”
Questa la domanda che anni fa un certo Marco Guzzi rivolse ad Enzo Bianchi.
Questa la risposta di Enzo Bianchi contenuta in un suo libretto: Ricominciare - Nell’anima, nella chiesa, nel mondo.
«L’urto tra lo Spirito di Cristo e mondanità è ineluttabile, e già si vede che l’ubriacatura consumistica e eroticizzata dell’Occidente provoca una senescenza precoce dei sensi, un abitare nelle terre del nonsenso, una bulimia del “tutto e subito” che soffoca. In tale contesto oggi i cristiani non solo non sono perseguitati, ma neppure osteggiati, anzi sono invocati. Noi oggi assistiamo addirittura a un diffuso atteggiamento di benevolenza nei confronti della chiesa, da parte dei Cesari di oggi soprattutto. Il titolo di un articolo di un periodico cattolico qualche mese fa diceva quasi orgogliosamente, con stupore ingenuo: “Questa chiesa serve!”. Ma serve a chi? A chi è utile? Questo significa che noi siamo omologati all’interno del grande orizzonte occidentale capitalista e che magari siamo invocati per fornire un fondamento etico alla società, per dare un’anima alla società.
Avvenuta ormai la crisi dell’ideologia, noi cristiani siamo invocati per cantare in coro, magari con più convinzione e più forte, “la cantata dei valori comuni”, quei valori formali che piacciono a tutti. [...] Sì, questa chiesa serve al mondo se e finché resta impegnata solo filantropicamente, ma guai se la chiesa si fa profetica, se annuncia l’Evangelo con il Sì! Sì! No! No!, guai se contraddice la morale laica, perché allora si scatena la saggezza dei dominatori di questo mondo, quelli che hanno crocifisso il Signore della gloria (cf 1Cor 2,8). [...] Io sono convinto che sul tema della pace, soprattutto oggi, la chiesa gioca la sua fedeltá al Signore; su questo tema la sua scelta: o essere l’Evangelo che grida nella debolezza e nella sapienza della croce o sedere tra i dominatori di questo mondo, ma non essere più la chiesa del Signore Gesù Cristo»....
E io aggiungerei "Guai se la Chiesa si permettesse di dire solo qualche parolina su questa economia assassina che è la causa prima della Guerra e di tutti i mali del mondo, il Peccato Originale di tutto, e si permattesse di mettere sotto inchiesta il pilastro reggente di questa economia che è l’antievangelico "Diritto di Proprietà"!
Che ne direbbero i vari Bush/Berluschini/Casini/Fini e i loro chierichetti Teocon?
Noi cristiani saremmo tutti decapitati, come San Giovanni che domani festeggeremo.
Buona Domenica.
Aldo [don Antonelli]
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ ( Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.16 giugno 2007, di Federico La Sala
 IL TEOLOGO JOSÉ CASTILLO LASCIA LA COMPAGNIA DI GESÙ.
IL TEOLOGO JOSÉ CASTILLO LASCIA LA COMPAGNIA DI GESÙ.
 PER "IGIENE MENTALE" *
PER "IGIENE MENTALE" *33930. GRANADA-ADISTA. “Mi sento felice, sono in pace, e ho ora più speranze che mai. Continuerò a lavorare al mio compito, il compito del Vangelo. Per questo sono uscito dai gesuiti. Perché vedo che, così come sta oggi la Chiesa, se si è intrappolati, controllati, censurati in una istituzione dominata dalla Curia Vaticana, non si può godere della libertà indispensabile per far conoscere Gesù. In una simile ‘Chiesa’ non c’è salvezza”.
Così si è espresso il teologo spagnolo José María Castillo, 78 anni, dopo la pubblicazione della notizia del suo abbandono della Compagnia di Gesù, in una lettera ai membri del Comitato Oscar Romero del Cile (pubblicata sul sito della rivista cilena “Reflexión y Liberación”), in risposta a un loro messaggio “di solidarietà, di umanità, di fusione in uno stesso progetto e in una stessa vita”. Era stato il portale Periodista digital, in un articolo apparso il 19 maggio, a rendere nota la decisione del teologo - già raggiunto in passato dai provvedimenti del Vaticano (che, nel 1988, gli revocò l’idoneità all’insegnamento) - di lasciare la Compagnia di Gesù (ma non il sacerdozio), “stanco delle pressioni e degli attacchi del settore più conservatore della gerarchia”. “Castillo - affermava nell’articolo il suo amico e teologo Luis Alemán - vuole recuperare la sua libertà per poter respirare, perché stava soffocando. Non tanto nella Compagnia quanto nel clima attuale della Chiesa spagnola, in cui si sente perseguitato dai vescovi e dai gruppi più conservatori”.
Secondo Alemán, “tre gocce hanno fatto traboccare il vaso”: “la recente ammonizione vaticana a Jon Sobrino, la proibizione della gerarchia alla pubblicazione del libro Espiritualidad para insatisfechos da parte della casa editrice Sal Terrae dei gesuiti, e i continui attacchi che riceveva dal programma di informazione religiosa della emittente radiofonica Cope La linterna de la Iglesia”. “Non se ne va - concludeva - irritato contro la Compagnia. Se ne va per igiene mentale. È un nuovo caso Boff. Come lui, Castillo ha subito talmente tante pressioni da decidere di rompere con tutto per salvaguardare la sua libertà”.
All’interno della Compagnia di Gesù, la voce di Castillo è stata sempre una delle più coraggiose e profetiche. Fino a mettere in discussione la credibilità stessa della Compagnia, la sua fedeltà alla missione di difendere la giustizia nel mondo. Come si può vivere - si interrogava nel 2006 sulle pagine di Promotio Iustitiae (la pubblicazione del Segretariato per la Giustizia Sociale della Curia Generalizia dei gesuiti; v. Adista n. 80/06) - ben integrati nel sistema economico dominante e pretendere di essere credibili nell’impegno di “denunciare, mettere in discussione e modificare questo sistema”? “Se i poteri di questo mondo - sottolineava - ci apprezzano e ci valorizzano, ciò vuol dire che tali poteri non si sentono scomodati, né tanto meno messi in discussione da noi”. (claudia fanti)
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ ( Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.6 giugno 2007, di Federico La Sala
Deporre i poveri dalla croce: cristologia della liberazione
di ADISTA *
Importante iniziativa di Adista che ha tradotto e messo a disposizione gratuitamente il libro "Deporre i poveri dalla croce: cristologia della liberazione" edito dalla Commissione Teologica Internazionale della ASETT, Associazione Ecumenica dei Teologi/ghe del Terzo Mondo, in risposta alla notificazione vaticana sulle opere di Jon Sobrino.
Care lettrici, cari lettori,
segnaliamo un’importante novità sul nostro sito. Si può leggere finalmente anche in italiano, scaricandolo gratuitamente dalla home page di www.adista.it, il libro digitale "Bajar de la cruz a los pobres: cristología de la liberación" ("Deporre i poveri dalla croce: cristologia della liberazione") della Commissione Teologica Internazionale della ASETT, Associazione Ecumenica dei Teologi/ghe del Terzo Mondo.
La traduzione italiana, curata da Adista, dell’originale spagnolo (che, insieme alla traduzione in inglese, è disponibile agli indirizzi www.eatwot.org/TheologicalCommission e http://www.servicioskoinonia.org/LibrosDigitales) è presentata dal teologo Carlo Molari e presenta due contributi in più: di Aloysius Pieris e dello stesso Molari (è possibile leggere l’originale )
Il libro della Asett è la risposta di circa 40 teologi della liberazione alla Notificazione vaticana sulle opere di Jon Sobrino (autore dell’epilogo del libro), ma non solo: è una difesa, appassionata e potente, della cristologia della liberazione, quella che Leonardo Boff, nel prologo, definisce "una teologia militante che lotta per ’far scendere dalla croce i poveri’".
È questa voce potente quella che è oggi offerta anche al pubblico italiano, attraverso un nuovo metodo che l’Asett ha voluto sperimentare: quello di un libro digitale, libero e gratuito, che, scrive José María Vigil, coordinatore della Commissione Teologica Internazionale della Asett/Eatwot, "può essere regalato e inviato da chiunque per posta elettronica e che potrà anche essere stampato su carta mediante il procedimento della "stampa digitale", un metodo che permette di stampare su carta quantità minime di esemplari (5, 10, 20...), a un prezzo praticamente uguale a quello di un libro normale".
Per scaricare il libro, clicca qui
* IL DIALOGO, Mercoledì, 06 giugno 2007
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ ( Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.2 giugno 2007, di Maria Paola Falqui
La parola ci interpella
Il Vangelo delle chiavi
di Mario Mariotti *
Il discorso delle chiavi del Regno è il fulcro del cristianesimo tradotto in religione, e di conseguenza in potere. Il Signore avrebbe delegato a Pietro il potere di legare o di slegare, di perdono o di non-perdono dei peccati e l’avrebbe costituito Suo vicario in terra, in questo mondo. Da qui anche il potere del Papa, che non può sbagliare perché vicario di Dio in terra. Siccome i cattolici hanno fatto proprie queste convinzioni, che la salvezza della propria anima e resurrezione del proprio corpo passino per la mediazione del Papa e della gerarchia, ecco il grande potere, la grande autorevolezza di S. R. Chiesa, che ha condizionato in senso negativo e condiziona tutt’ora in senso negativo enormi moltitudini di persone, che si autotranssustanziano in pecore credenti e fedeli. Queste, a loro volta, condizionano l’evoluzione della storia umana in senso evolutivo, regressivo, reazionario ed alienante. Non ho bisogno di ribadire il mio pensiero sulla Chiesa e sulla gerarchia che la guida (probabilmente tutte le religioni hanno questi difetti). Essa si è sempre appropriata del soggettivo positivo della base, e l’ha strumentalizzato a vantaggio dei ricchi, dei potenti e di se stessa, diventando ricca e potente.
La simbiosi Tempio-Impero iniziò con Costantino, e prospera tutt’ora. Se oggi non siamo ancora ai tempi di Innocenzo III, non è per merito della evoluzione democratica della gerarchia, ma perché pian piano lo Spirito è riuscito a liberarsi dalle sue ragnatele, si è fatto spazio con l’Illuminismo, la Rivoluzione francese, il marxismo, il socialismo, ed è riuscito ad esplicitare il valore evangelico della laicità, se connotata di solidarietà e condivisione. Questa rivoluzione però, è sempre a rischio: S. R. Chiesa, dopo aver contribuito a sfottere l’utopia della fratellanza, del socialismo, oggi cerca di approfittare della scarsa lucidità dei laici per rimettere in discussione lo stesso Illuminismo. Dato che essa vorrebbe imporsi, dopo la crisi delle ideologie, quale autorità, guida teologica e morale di tutto e di tutti, prima che arrivi anche a mangiarsi anche le scuse le scuse fatte a Galileo, e che torni a condannarlo sempre postumo, sarà opportuno, da parte di coloro che non sono ancora rincoglioniti del tutto, cercare di darsi una mossa.
Ecco il mio piccolo contributo:
È vero che, nel Vangelo c’è il discorso del Signore a Pietro che gli riconosce di essere ispirato da Dio e quindi gli affida le chiavi del Regno dei cieli, ma questo significa che l’affidamento di questo potere dipende dal fatto e dalla condizione di essere ispirati dal Padre, e quindi nella logica dell’Amore, dal Servizio, dalla Condivisione, e non del potere. Se uno, infatti, si prende il disturbo di proseguire la lettura del Vangelo, scoprirà che appena Pietro non fa propria la logica di Dio e ragiona in quella sua propria, (rifiuta la sofferenza per la Verità), il Signore prende le distanze da lui e lo definisce Satana, cioè Divisore. Già questa parola sarebbe più che sufficiente per far capire che il potere delle chiavi è tale se e solo quando non è potere, ma incarnazione dello Spirito, incarnazione della volontà di Dio, che è progetto di amore, servizio, lavoro onesto e professionale per tutti gli altri e condivisione.
Inoltre appare fuori da ogni logica, sia umana che divina, questo messaggio che caratterizzerebbe un Dio che delega i propri poteri all’uomo, il quale si troverebbe nella condizione di essere Dio stesso, ma coi limiti dell’uomo; la qual cosa è semplicemente assurda, dato che l’uomo, pur non potendo conoscere completamente Dio, si troverebbe a gestire il potere, di un Dio che ci è stato rivelato con Amore, e non come potere. Ma quest’ultima considerazione potrebbe venir interpretata come una lettura dell’evento viziata di laicità, e allora a me sembra il caso che il chiarimento definitivo del problema, e quindi il depotenziamento sostanziale dell’enunciato dell’affidamento delle chiavi a Pietro, si possa trovare sempre nella Parola e precisamente in quella che definisce il giudizio finale al quale Dio sottoporrà gli uomini.
La discriminante, il criterio, il fondamentale è la qualità del nostro rapporto col prossimo, con gli altri viventi e con più precisione il nostro rapporto con l’affamato e l’assetato, cioè coi bisogni dei viventi. Dio non ci chiederà se credevamo in Lui, se credevamo nel Papa e nella sua infallibilità, se ubbidivamo ai comandamenti e ai precetti della Chiesa. Saremo giudicati sul tipo di risposta che abbiamo dato alle necessità dell’affamato e dell’assetato, e inoltre anche sulla qualità, sulla trasparenza e sulla gratuità del nostro rapporto positivo col nostro prossimo. Questa Lettura allude ad una gratuità che viene vissuta da soggetti che sono laici o anche atei, i quali esulano da un rapporto di dare-avere con Dio specifico della concezione religiosa di Dio stesso, e saziano e dissetano il loro prossimo semplicemente perchè fanno a lui ciò che vorrebbero ricevere da lui, se essi stessi avessero fame e sete.
Qui il potere delle chiavi va a farsi benedire, come l’assurdità dell’uomo vicario di Dio stesso, la sua infallibilità e tutto l’armamentario liturgico e orante col quale la Chiesa riesce ad alienare i fedeli-credenti, deviandoli dalle proprie responsabilità fondamentali di mani di Dio. Se ci pensiamo bene, anche la necessità della gratuità nel nostro rapporto positivo con gli altri viventi è fondamentale, é strutturale. Essendo noi il "corpus Domini", cioè i terminali di uno Spirito che ci è stato caratterizzato come Amore gratuito e incondizionato (quello del padre per il figliuol prodigo), nel momento che diciamo “si” e amiamo e condividiamo, stiamo materializzando quello Spirito che è Amore gratuito ed incondizionato. Queste qualità sono degli indicatori preziosi della nostra condizione di tralci: stimo agendo come se Dio non ci fosse, possiamo anche pensare di essere atei, ma in quel momento lo Spirito opera attraverso di noi e lavora a costruire il Regno servendosi delle nostre mani.
Voglio fermarmi qui, facendo rilevare come la caratterizzazione del giudizio finale secondo il Vangelo si colloca a distanza siderale da un discorso di potere. Storicamente, purtroppo, gli uomini, invece di fare di sé stessi strumenti di Verità e mani amorose che condividono, si sono determinati come iene della Verità e mani rapaci, per tradurla, la Verità, in potere, in ricchezza, in superbia, in zelante servizio al principe di questo mondo, a sua maestà Mammona.
Dentro a questo peccato S. R. Chiesa ha preso residenza stabile dal tempo di Costantino, prostituendo l’Amore in potere, persiste nella propria simbiosi con l’Impero, bruciando tesori di soggettivo positivo, espressi da tutti coloro che sono in buona fede, a favore dello strutturale maligno, il capitalismo privato, il mercato, la competizione, il beati gli indefinitamente ricchi della cultura occidentale USA-dipendente.
Considerando la cosa da questo punto di vista e guardando ai misfatti del “cristianesimo reale”, appare chiaro che le chiavi hanno sbagliato serratura. Noi le abbiamo adattate alle porte della Geenna, dove sarà pianto e stridore di denti, e dove pavimento e pareti saranno rivestite non dalle pelli delle pecore, ma da quelle dei pastori. Per le pecore però sarà una magrissima consolazione....
Mario Mariotti
* IL DIALOGO, Sabato, 02 giugno 2007
-
> "Deus caritas est": la verità recintata!!! Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ ( Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.29 maggio 2007, di Federico La Sala
RIFLESSIONE
Nel libro «Gesù di Nazaret» di Benedetto XVI la proposta di una rinnovata amicizia fra ebrei e cristiani in nome dell’unico Dio
L’unica alleanza
Il dialogo a distanza con il rabbino americano Jacob Neusner, che si pone sinceramente la domanda sulla divinità di Cristo
di Elio Guerriero (Avvenire, 29.05.2007)
Le molte religioni e l’unica alleanza, l’uomo alla ricerca del sacro e la rivelazione di Dio, le vie molteplici delle religioni e Dio che si rivela al Sinai, anzi scende dal cielo per porre la sua tenda tra gli uomini. Sto parlando dell’introduzione a Gesù di Nazaret di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI che la critica ha finora passato sotto silenzio. In essa il Papa accenna alla via delle religioni che in Mesopotamia, in Egitto o nel mondo indoeuropeo hanno aiutato l’uomo a scoprire la sua dignità, sono state all’origine della formazione della società, della costruzione della polis.
All’apice di questo percorso, Dio si manifesta ad Abramo. Cominciava, allora, il tempo della Rivelazione. Come scrive Julien Ries: «Alla lunga ricerca dell’uomo, Dio risponde con la sua manifestazione». Da questo momento, ha inizio il cammino della promessa che, come la stella dei Magi, sostiene il viaggio delle generazioni: «Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te... un profeta pari a me, a lui darete ascolto» (18,5). Il Nuovo Testamento, di conseguenza, si apre con l’annuncio che l’antica promessa si è avverata, che sul Nuovo Sinai, la Montagna delle beatitudini, siede ora il nuovo Mosè, che insegna non come un rabbi che arriva all’incarico dopo lunga preparazione, ma come l’inviato di Dio. Più di Mosè che vide Dio solo di spalle, egli può parlare del Padre, perché « Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio Unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato» (Gv 1,18).
Questo permette al Papa di affermare che non solo vi è concordia tra Antico e Nuovo Testamento, ma che l’alleanza stretta al Sinai e quella proclamata da Gesù sul monte delle beatitudini è unica. Gesù è venuto per portare a compimento, a pienezza l’alleanza. Così hanno insegnato quei personaggi umili e grandi (il Magnificat) che hanno adempiuto la Legge e segnato il passaggio dall’Antico al Nuovo Testamento. Il Papa pensa anzitutto alla Vergine Maria, ma poi anche a Giuseppe, Zaccaria ed Elisabetta, a Simeone ed Anna e agli apostoli tutti. Pii israeliti, essi non smisero di osservare la Legge e conservarono il cuore puro, che li predispose alla chiamata di Colui che è più grande. Per questo sono immagine tipo di tutti i discepoli di Gesù.
Si inserisce a questo punto il dialogo, che ha suscitato scalpore, tra il Papa e il rabbino ortodosso americano Jacob Neusner. Autore di un volume dal titolo Disputa immaginaria tra un rabbino e Gesù, Neusner pone due importanti quesiti nella sua opera. Egli immagina di essere contemporaneo di Gesù e di recarsi, piacevolmente sorpreso dalla fama che precede il giovane Rabbi della Galilea, a sentire il discorso della Montagna. Non trova, tuttavia, alcunché di nuovo nella Torah di Gesù. Tutto gli era già noto dall’Antico Testamento e dalle tradizioni rabbiniche fissate nella Mishnah e nel Talmud. E’ inevitabile, allora, la domanda: perché è venuto Gesù, quale è il senso della sua Torah rispetto a quella di Mosè? Risponde il Papa: «Israele non esiste semplicemente per se stesso, per vivere nelle "eterne" disposizioni della Legge, esiste per diventare la luce dei popoli». Con il passare dei secoli era divenuto sempre più evidente che il Dio di Israele era Dio di tutti i popoli e di tutti gli uomini. Gesù è venuto per annunciare l’eudochìa di Dio, il suo beneplacito verso gli uomini tutti. Del resto una delle immagini più care alla tradizione cristiana è quella dei Magi, venuti a Gerusalemme per adorare il re dei Giudei (Mt 2,2). «Alla luce messianica della stella di Davide, cercano in Israele colui che sarà il re delle nazioni» (Catechismo della Chiesa Cattolica n. 528) Ricordato nell’epifania, una delle grandi feste cristiane, l’episodio manifesta il senso della venuta di Gesù: la realizzazione della promessa fatta ad Abramo per la quale la grande massa delle genti entra nella famiglia dei patriarchi e ottiene la dignità israelitica.
L’altra domanda sollevata da Neusner riguarda la divinità di Gesù. Egli legge con interesse l’episodio del giovane ricco e come il Maestro di Nazaret guarda a lui con simpatia. Ma perché il Maestro non si accontenta del suo rispetto della Legge, perché gli chiede di vendere tutto e seguirlo? Non si pone, così, allo stesso livello di Dio? San Giovanni e il Concilio di Nicea che hanno proclamato la divinità di Gesù non si sono sbagliati. Gesù chiede veramente di essere riconosciuto come Dio. Per questo il rabbino americano si allontana, mentre: «Con tanta cortesia e gentilezza, egli mi saluta con un cenno del capo e va via, per la sua strada. Senza "se" o "ma"...; proprio da amici». Al distacco, tuttavia, segue un ultimo gesto di comunione, che è particolarmente significativo per il rapporto fra ebrei e cristiani: alla sera nella sinagoga: «Noi offriamo la nostra preghiera serale al Dio vivente. E in alcuni villaggi lungo la valle, così fecero Gesù e i suoi discepoli e tutto l’eterno Israele».
La pubblicazione di Gesù di Nazaret di Benedetto XVI è stata affidata a un editore laico, forse un segnale rivolto agli uomini di cultura perché si rendano conto della portata del dialogo ebreo-cristiano. L’invito, tuttavia, è rivolto soprattutto agli ebrei. Come dicono il Papa e Neusner qui non si tratta affatto di un dibattito per stabilire la superiorità di una religione sull’altra ma di ritrovarsi nella discendenza di Abramo e di Mosè, per coltivare l’amicizia e la fraternità nel riconoscimento dell’unico Dio.
-
> "Deus caritas est". Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ ( Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.8 novembre 2006, di Federico La Sala
PER UNA CAMPAGNA DI VERITA’ - VIVA L’ITALIA !!!
Della casa dei nostri padri e delle nostre madri hanno fatto una spelonca di ladri !!!
di Federico La Sala *
Chi governa oggi la Chiesa Cattolica e chi governa oggi l’Italia, alleati, stanno mettendo sempre più chiaramente in evidenza il senso della catastrofe verso cui ci avviamo e ci stanno portando, sia sul piano della ‘gestione’ del messaggio evangelico sia della ‘gestione’ del messaggio costituzionale della repubblica italiana. La gerarchia della Chiesa Cattolica sta sempre più facendosi scudo e “partito” della cattolicità (- dell’universalità) della sua stessa ragione di essere e chi oggi governa l’Italia sta sempre e ancor più facendo scudo e “partito” dell’Italia.... e, insieme, stanno portando tutta la comunità della Chiesa e tutta la società dello Stato ad una catastrofe senza più ritorno!!! La volontà e l’abuso del loro potere sta continuando sempre più a devastare coscienze e società - civile e religiosa, e non solo le chiese sono diventate addirittura cimiteri di banditi e mafiosi ma anche il parlamento (quasi e ormai) un covo di ladri!!! Il partito di “forza Chiesa” e il partito “forza Italia”.... contro tutti e tutte!!! Ma dov’è la Chiesa e dove l’Italia? E chi lo sa?! Per il momento .... i capi dei due “partiti” gozzovigliano e si divertono alla grande, nella Casa dei nostri padri e delle nostre madri !!! Meno male che, al di sopra di tutto, brilla la luce del Quirinale, del nostro Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. VIVA LA COSTITUZIONE !!! VIVA L’ITALIA !!!
* www.ildialogo.org, Lunedì, 26 settembre 2005
-
> "Deus caritas est". Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ ( Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.7 dicembre 2006e tu dovresti imparare un pò di latino. Caritas significa Amore! quindi: "Dio è Amore" non fermarti alla superficie delle cose, IGNORANTE!!!!!!!!!!
-
> "Deus caritas est". Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!! E ri-mediti sulla ’sollecitazione’ ( Un "Goj") di Luigi Pirandello ... a Benedetto XV.25 maggio 2007, di Federico La Sala
Lettera al presidente della Cei, Mons. Angelo Bagnasco arcivescovo di Genova
di Paolo Farinella, prete
Riceviamo da don Paolo Farinella, prete genovese, questa lettera a mons. Bagnasco che molto volentieri pubblichiamo. Chi volesse esprimere il proprio parere può farlo usando gli appositi link in fondo a questa pagina.
Nell’inviare questa lettera don Paolo ha premesso la seguente spiegazione del perchè essa è stata resa pubblica che anche rendiamo noto ai nostri lettori. *
«Care Amiche e amici,
invio questa lettera spedita al mio vescovo, nonché Presidente della Cei prima privatamente e dando una settimana di tempo per un eventuale incontro di approfondimento. Non ho avuto alcun riscontro per cui mi sento libero di renderla pubblica. Molte altre cose avrei voluto dire, ma dovevo restare entro una pagina. Sarà per la prossima lettera d’amore.
Il giornale L’Unità mi aveva contattato per pubblicarla, ho aspettato due giorni, ma visto che non anche lì non ne fanno nulla (visti i tempi e le fascine di legna accatastate alla bisogna!!!!), la metto in rete. Lo scopo non è di discutere, ma solo di offrire una opinione personale. Può essere condivisa o no. Non attendo risposte, ma solo il rispetto che si deve alla buona fede.
Se volete divulgarla attraverso i vostri mezzi, fate pure. Io sono tranquillo con la mia coscienza e davanti a Dio, come si conviene ad un credente che non può tacere di fronte all’immondo mercimonio a cui è sottoposta la religione ai nostri giorni. Forse ad alcuni arriverà in doppio, forse ad altri non arriverà punto, forse qualcuno è finito nella mia rubrica per opera divina, insomma... chi vuole essere cancellato me lo dica.
Un abbraccio a tutte e a tutti
Paolo Farinella, prete Genova»
Lettera al presidente della Cei, Mons. Angelo Bagnasco arcivescovo di Genova
Sig. Presidente,
Il 12 maggio in piazza S. Giovanni a Roma al raduno organizzato dalla Presidenza della Cei attraverso le aggregazioni laicali cattoliche, è accaduto un fatto grave che come presidente dei Vescovi italiani non può lasciare senza risposta. Silvio Berlusconi, notoriamente divorziato e felicemente convivente, ha dichiarato che i cattolici coerenti non possono stare a sinistra, asserendo con questo che devono stare a destra, cioè con lui e con il suo liberismo che coincide sempre con i suoi interessi e mai col «bene comune».
Non è questa la sede per stabilire i confini di «destra» e «sinistra». Una sola annotazione: da tutta la letteratura documentale del magistero, da Leone XIII al «Compendio» pubblicato nel 2004 da Giovanni Paolo II, risalta che i programmi della «sinistra», presi nella loro globalità e alla luce della categoria dirimente del «bene comune o generale» sono molto più vicini alla «dottrina sociale della Chiesa» di quelli della «destra», che, al di là delle parole ossequiose e strumentali, sono la negazione di quella dottrina nei suoi principi essenziali (bene comune, democrazia, legalità, stato sociale, ecc.). Alcide De Gasperi, già negli anni ’50, definiva la DC «un partito di centro che guarda a sinistra».
Benedetto XVI ad Aparecida in Brasile ha detto che la scelta preferenziale dei poveri è costitutiva della Chiesa e ha dichiarato la fine del marxismo (forse intendeva dire del marxismo ideologico e storico come realizzato nel sovietismo) e il fallimento del capitalismo. Silvio Berlusconi è il rappresentante più retrivo del capitalismo speculativo e senza regole, appena condannato dal papa, perché egli adora un solo dio e ha una sola religione: il mercato. A condizione però che il mercato faccia gli interessi dei ricchi, i quali, si sa, sono capaci di sprazzi di «compassione» ed elargiscono elemosine ai poveri, magari davanti alla tv, conquistandosi anche il paradiso e risolvendo il rebus del cammello e della cruna dell’ago. Con le sue tv commerciali, egli guida e gestisce il degrado morale del nostro popolo, imponendo modelli e stili di vita che sono la negazione esplicita e totale di tutti i «valori» cristiani che il raduno del Family Day voleva affermare.
E’ notizia di oggi (14 maggio 2007) che Berlusconi ha comprato la società Endemol, la fabbrica del vacuo, dei grandi fratelli e del voyeurismo amorale e anti-famiglia che fornisce anche la tv di Stato che così viene ad essere, a livello di contenuti, totalmente nelle sue mani. Il conflitto di interessi ora è totale. La sua presenza ad un raduno di cattolici manifestanti a favore della famiglia è strutturalmente incompatibile. Egli non può stare nemmeno nei paraggi del cattolicesimo che di solito ossequia subdolamente e di cui si serve con qualsiasi strumento economico o di potere. Mi fa ottima compagnia P. Bartolomeo Sorge S.J. che ha dimostrato con ampia facoltà di prova sulla scorta del magistero ordinario nei memorabili editoriali di Aggiornamenti Sociali, l’incompatibilità del berlusconismo con la dottrina sociale della Chiesa e ancora di più con i principi esigenti del cristianesimo.
Un altro campione di famiglia cattolica, pontificante al raduno, fu il deputato Pierferdinando Casini. O tempora! O mores! Il 19 ottobre 2005, all’inaugurazione dell’anno accademico nella Università del Papa, la Lateranense, il Gran Cancelliere, Mons. Rino Fisichella, ebbe l’ardire di presentarlo come esempio di persona che «forte della sua esperienza trentennale di vita politica e sostenuto da una forte coscienza cristiana, può offrire a noi tutti un chiaro esempio di come la fede possa ispirare comportamenti politici liberi e coerenti nella ricerca del bene comune». Parole di un vescovo, Gran Cancelliere nell’Università del Papa, ad un cattolico praticante, divorziato e felicemente convivente con prole.
Tutto ciò crea disorientamento, scandalo e sconcerto nei cristiani che faticano ogni giorno a fare conciliare l’esigenza della fede con il peso delle situazioni della vita, a volte insopportabili. Ad un uomo divorziato che, di fronte a queste dichiarazioni, affermava il suo diritto di «fare la comunione», non ho potuto dare torto, perché non potevo contestare l’autorevolezza di un vescovo e Gran Cancelliere del Papa: ho dovuto dirgli che aveva ragione e che sulla coscienza e responsabilità di Mons. Fisichella, del deputato Pierferdinando Casini e di Silvio Berlusconi, divorziati e conviventi, paladini difensori della «famiglia tradizionale», dell’indissolubilità del matrimonio, poteva andare tranquillo. Rilevo di passaggio che sia Casini che Berlusconi, in quanto parlamentari, usufruiscono «già» per i loro conviventi di tutti i benefici che contestano al progetto di legge sui «DICO».
O la Chiesa è coerente fino allo spasimo, fino al martirio, sapendo distinguere i falsi profeti per difendere le pecorelle dal sopruso e dalla sudditanza di avventurieri senza scrupoli, o la Chiesa si riduce ad una lobby che intrallazza interessi materiali con chiunque può garantirglieli. E’ una questione «di verità» per usare un’espressione a lei cara. Sulla stampa (la Repubblica 14-05-2007, p. 9) all’interno di una intervista, mons. Giuseppe Anfossi, responsabile Cei per la famiglia, ha dichiarato che Berlusconi si assume la responsabilità di ciò che ha detto. Non parlava però a nome della Cei che, credo, abbia l’obbligo di fare chiarezza e prendere le distanze da simili individui che non fanno onore né alla chiesa, né alla politica (nella concezione espressa da Paolo VI), né al popolo italiano. Se non vi sarà una chiarificazione ufficiale da parte della presidenza della Cei resterà un «vulnus» che ne appannerà la credibilità.
Sulla stampa sono stati pubblicati i capitoli dell’8 per mille che hanno cofinanziato il raduno del Family Day, suscitando in larghi strati del popolo cattolico una reazione a devolvere altrove la quota della Chiesa, generando ancora una volta una scollatura più grande tra popolo di Dio e Gerarchia che ormai sembrano camminare su sentieri diversi. Mi auguro che lei abbia il coraggio necessario, adeguato alla situazione.
E’ mia intenzione nella giornata di lunedì 21 maggio 2007, rendere pubblica questa lettera di credente ferito che si dissocia dalle parole per nulla cristiane di Silvio Berlusconi e anche dal silenzio pesante della Presidenza della Cei. Nessuna pretesa, solo una testimonianza «nunc pro tunc».
Genova 14 maggio 2007
Paolo Farinella, prete
* IL DIALOGO, Venerdì, 25 maggio 2007
-
-
> "Deus caritas est". Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!30 ottobre 2006, di Federico La Sala
AGAPE, EUCHARISTIA, Eu-CHARITAS, "il dono spirituale, l’amore di Dio" - Jesus "Charitas" ..... (fls)
"[...] Proseguendo la riflessione sul Mistero eucaristico, cuore della vita cristiana, oggi vorrei porre in luce il legame esistente tra l’Eucaristia e la carità. "Carità" - in greco agape, in latino caritas - non significa prima di tutto l’atto o il sentimento benefico, ma il dono spirituale, l’amore di Dio che lo Spirito Santo effonde nel cuore umano e che lo muove a donarsi a sua volta a Dio stesso e al prossimo (cfr Rm 5,5). L’intera esistenza terrena di Gesù, dal concepimento alla morte in croce, è stata un unico atto d’amore, tanto che possiamo riassumere la nostra fede in queste parole: Jesus Caritas, Gesù Amore. Nell’Ultima Cena, sapendo che "era giunta la sua ora" (Gv 13,1), il divino Maestro offrì ai discepoli l’esempio supremo di amore lavando loro i piedi e affidò ad essi la sua più preziosa eredità, l’Eucaristia, in cui è concentrato tutto il mistero pasquale, come ha scritto il venerato Papa Giovanni Paolo II nell’Enciclica Ecclesia de Eucharistia [...]". *
* Cit. ripresa dal testo dell’ANGELUS di BENEDETTO XVI (Castel Gandolfo, Domenica, 25 settembre 2005)
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2005/documents/hf_ben-xvi_ang_20050925_it.html
-
> "Deus caritas est". Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!20 ottobre 2006, di Federico La Sala
NEL TEMPO DELLA MANCANZA (carestìa)) E DELL’ACCAPARRAMENTO DEI BENI DI PRIMA NECESSITA’, VA FORTE IL CARO-PREZZO (LA "CARI-TAS"): NON C’E’ PIU’ NESSUN DONO DI AMORE ("CHARITAS") E NESSUN RINGRAZIAMENTO ("EU-CHARIS-TIA") !!! Una nota del 2003, in occasione dell’enciclica sulla EU-CHARIS-TIA *
"Ubuntu": una parola da e per non dimenticare.
Una nota a margine della Lettera enciclica SULL’ EUCARISTIA (del 17.04.2003) .
di Federico La Sala
Il personale è teologico-politico e il teologico-politico è personale. Gli uomini della Chiesa cattolico-romana non sanno più quello che fanno ... e subito si danno da fare a cancellare le tracce e a costringere a dimenticare. Dato i tempi che corrono è meglio ricordare e riflettere ("Il ministero dei sacerdoti che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine [...] manifesta che l’Eucaristia, da loro celebrata, è un dono che supera radicalmente il potere dell’assemblea ed è comunque insostituibile per collegare validamente la consacrazione eucaristica al sacrificio della Croce e all’Ultima Cena": pf. 29) ... sulla figura del sacerdote e, ovviamente, di Gesù e della stessa Chiesa. Riprendiamo: riapriamo il caso!
La storia sembra finita: la Chiesa non permette a Milingo di essere sposato. .. e Maria promette di seguirlo nella sua missione. Che peccato e che confusione! A questo punto credo che sia necessario e doveroso mettere in evidenza il terreno e le radici da cui è nato e nasce lo scandalo. La questione ruota intorno alla parola-chiave padre o, se si vuole, abate (cfr. l’omonima voce del Dizionario filosofico di Voltaire), e mette in gioco non tanto e solo la vita interna della Chiesa ma la libertà e la dignità di tutti gli uomini e di tutte le donne in carne ed ossa. Il cardinale Milingo è stato quello che è stato ed è quello che è, ma ora e in questo caso il suo Partito, quello dell’Uomo-Dio, se ha vinto un’altra battaglia, ha perso la faccia e la guerra. E per gli uomini dell’Apparato le parole di Voltaire saranno ancora e sempre più all’ordine del giorno: "badate che non venga il giorno della ragione".
Chiariamo. Milingo non è un uomo qualsiasi, è un prete, un padre, un cardinale della Chiesa cattolico-romana. E’ come il Papa e il Papa è come Milingo. E ogni sacerdote, pur se non è Milingo, è vicino a lui e gioca (appena vuole e può) al ’mi-linko’ e peggio. Dov’è il bubbone? A mio parere, il problema sta nel modo in cui la chiesa farisaico-paolina, cattolico-romana, ha concepito la sacra famiglia: ha accettato la maternità di Maria ma ha sempre n e g a t o la paternità di Giuseppe.... per assicurare direttamente all’Uomo (cioè solo al Papa e ai preti) il diritto di essere Figlio di Dio e di Maria e nello stesso tempo Dio Padre in persona. Questa è la Fides et Ratio della questione!
La dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio ("Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio": La Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35) non è uno scherzo o una battuta: dice semplicemente ciò che l’Istituzione ha sempre creduto (fatto credere), pensato (fatto pensare), e voluto (fatto volere), che Edipo fosse il re e il padre-padrone della regina-madre-chiesa-città del Vaticano... altro che Cristo!
La peste e la morte si diffonde sempre di più. E non a Tebe. Il medioevo non è finito! Ma non è finito nemmeno l’Illuminismo! E Kant, Feuerbach, come Marx (cfr. La sacra famiglia, scritta insieme con Engels), Nietzsche (il cattolicesimo: un platonismo per il popolo), Freud e tutti gli altri non sono cani morti! Essi sono stati degli edipo che volevano e osavano sapere, per liberarsi dal male...
La Chiesa Cattolica non sarà mai cattolica-universale, e sarà sempre solidale (in gioco è la proprietà e il monopolio del potere) con lo s p i r i t o (di Hegel e) del Capitalismo, se non ha il coraggio di aprire le porte a ogni Maria e ogni Giuseppe, di riconoscere il loro liberissimo patto di alleanza d’Amore e di Amicizia e - a pieno titolo - la loro completa e personale maternità e paternità dei figli e delle figlie del loro amore e dell’Amore che muove il Sole e le altre stelle. Sulla Terra nessuno è straniero e nessuno è figlio di Nessuno - nemmeno Ulisse. E noi, uomini e donne di tutta la Terra, non siamo più esseri ciclopici... con un solo occhio e con un solo genitore, e per di più zoppi. Siamo figli e figlie dell’unione di Due IO, non della sola madre e dello spirito di Dio, ma della madre e del padre e dello Spirito di Dio (=Amore)! Le parole non sono innocenti: la chiesa-istituzione farisaico-romana non è una sacra famiglia e non è una democrazia, è un partito-azienda (molto più grande, ma quanto diverso da quello del rev. Moon?) che deve conservare, accrescere, e trasmettere il proprio patrimonio e il proprio potere, non costruire la casa degli uomini e delle donne umanamente e liberamente uniti dal patto e dallo spirito di Amore e di Amicizia...
Tuttavia, nonostante Milingo abbia abbandonato l’Africa , è da dire che è proprio dall’Africa e, in particolare, dal Sudafrica di Mandela, De Klerk e Tutu, che è venuta alla luce una grande novità - la fine dell’apartheid e la fondazione di una nuova repubblica democratica, e ci viene una bella indicazione. In occasione della giornata ONU alla memoria in onore dei milioni e milioni di esseri umani ridotti in schiavitù, Desmond Tutu ha ricordato a tutti e a tutte che nella lingua del Sudafrica hanno da sempre una parola-bussola per non perdersi nella disumanità e nella barbarie: ubuntu - le persone diventano persone attraverso altre persone. Forse vale la pena fissarla per sempre.
Così sapremo orientarci sia nel pensiero sia nel mondo, ed evitare a noi stessi e a noi stesse come ai vari Milingo e alle varie Marie di vendere la propria anima, di rinnegare il rinnegamento della propria dignità di esseri umani, e costruire una società - come esortava don Milani - che sappia dire ai suoi giovani e alle sue giovani che sono tutti e tutte sovrani e sovrane o, che è lo stesso, figli e figlie del Dio di Maria e di Giuseppe.... non figli e figlie di Nessuno! Non cè alcuno che è sapiente o buono come Dio, così ha insegnato Socrate e così ha insegnato Gesù: perché continuare a confondere le idee e impedire il dialogo ... e l’eucaristia tra tutti gli esseri umani?
*
www.ildialogo.org/filosofia, Mercoledì, 30 aprile 2003
-
> "Deus caritas est". Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!19 ottobre 2006, di Federico La Sala
SATIRA. Il "van-gélo della preziosi-tà"
Novità clamorose in arrivo nella Chiesa Cattolica
“ite missa est, BMW, VOLVO, VOLKSWAGEN are the best”
di Sergio Grande *
Dal nostro inviato a Verona. La visita del Papa a Verona, al di la dei discorsi ufficiali, sarà foriera di importanti novità per la Chiesa Cattolica italiana e non solo italiana. La Chiesa Cattolica si appresta a fare importanti cambiamenti che la metteranno al passo con i tempi.
Archiviati oramai da tempo i mezzi di locomozione evangelici, quali asinelli o muli, si opterà decisamente per le berline di classe superiore, meglio se SUV e meglio ancora se corazzate e superaccessoriate. Al classico corteo di asini, muli o cammelli verrà sostituito quello di auto, ognuna delle quali con un dignitario di corte a bordo. A Verona è questo lo schieramento che è stato presentato al mondo: in testa l’auto papale per eccellenza, con targa CV1, con a bordo il papa in trono e i suoi due più stretti collaboratori. Dietro cinque auto tutte nere delle più note case automobilistiche. Infine un pullman dove prendono posto i supporters, pronti ad applaudire ogni discorso del papa. Tutti intorno quelli che indubitabilmente sono guardie del corpo pronte a qualsiasi bisogna. Schema simile dovranno assumere anche i vescovi ed i parroci.
Con tali novità il Vaticano intende contrastare il cosiddetto “vangelo della prosperità” di origine protestante. Le chiese e i “pastori” sostenitori di tale “vangelo” proveniente dal nordamerica, sono noti per le loro auto lunghe dieci metri per tre, per gli abiti extralusso che indossano, per le adunate oceaniche che riescono ad organizzare, per le donne patinate che li accompagnano e per i soldi che riescono a spremere dai loro “fedeli” ai quali elargiscono, in abbondanza, la promessa di “cospicue benedizioni dall’alto” che renderanno loro altrettanti soldi e successo. Campa cavallo!
Anche la Chiesa Cattolica intende perseguire tale strada per evitare lo svuotamento delle chiese e soprattutto delle casse vaticane. Ma la novità più interessante riguarderà la liturgia. Per realizzare il “vangelo della prosperità” la Chiesa Cattolica ha deciso di aprirsi agli sponsor, come fanno le squadre di calcio che, dopo gli evangelicali nordamericani, sono la religione concorrente più temibile oggi presente sul mercato. E quando si tratta di sponsor non si può andare troppo per il sottile, come è successo con la giornata mondiale dei giovani tenuta ultimamente in Germania dove gli sponsor furono alcune banche che pochi loschi individui accusano di essere finanziatrici di industrie belliche e sostenitrici di guerre in giro per il mondo. Largo dunque alle “Banche armate”, che sono le più ricche di soldi. Si sa sono i soldi che fanno la guerra e viceversa.
Ma largo anche alle industrie automobilistiche. Il Papa in persona ha dato l’esempio prestandosi a fare da testimonial per auto extralusso. E allora ecco che a qualcuno in vaticano è venuto in mente una innovazione “liturgica” che mette d’accordo tradizione e modernità.
Come è noto verrà reintrodotta la possibilità di dire la messa in lingua latina. Come i pochi superstiti di tali riti forse ricordano, le messe in latino finivano con la formula “ite missa est”. Ebbene questa formula sarà modificata con l’aggiunta del nome dello sponsor della specifica messa. Ogni parrocchia o diocesi avrà il suo sponsor e potrà esercitare il proprio “discernimento” nella selezione delle aziende. I parroci avranno la possibilità di sponsorizzare prodotti ed aziende locali. Le diocesi aziende e prodotti provinciali. Sarà emanato un rigido elenco di regole per evitare concorrenze illecite fra i vari livelli ecclesiali. Così per le messe celebrate direttamente dal Papa, e vista la sua spiccata predilezione per le auto, verrà usata la formula “ite missa est, BMW, SAAB, VOLKSWAGEN are the best”, con un miscuglio di latino ed inglese che unisce passato e presente della chiesa. Formule simili potranno essere adottate dai vescovi o dai parroci. E così i nostalgici del Concilio Vaticano II e del Vangelo sono serviti.
___ *
www.ildialogo.org, Giovedì, 19 ottobre 2006
-
> "Deus caritas est". Caro BENEDETTO XVI ... Messa in latino? Ma quale latino?! Faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!18 ottobre 2006, di Federico La Sala
CHIESA DOMINATA DALLA PAROLA
AL CONVEGNO PAROLE FREMENTI
di Gianfranco Ravasi (Avvenire, 18.10.2006)
Ci sono parole che vengono maneggiate in modo antitetico: c’è chi se le strappa quasi dalle viscere e le getta davanti agli altri ancora frementi e c’è chi le tira fuori dalla tasca della giacca come se fossero un regalino da mettere sul tavolo per una festicciola. Il monaco Franco Mosconi ieri a Verona ha tratto dalla sua meditazione tre parole facendole serpeggiare in mezzo all’uditorio come se fossero lingue di fuoco. Eppure sono vocaboli che condiscono spesso le prediche e il linguaggio ecclesiale, risultando alla fine inoffensive.
La prima parola è speranza, e sperare nel cristianesimo vuol dire avere fisso «un orizzonte escatologico», significa lasciar cadere tante sovrastrutture, gli stereotipi spirituali, la melassa devozionale e rischiare sul sentiero d’altura dei «valori essenziali del Vangelo quali la gratuità, l’amore, la povertà, la piccolezza», in opposizione a ciò che ormai siamo stati convinti a considerare come veramente primari, cioè «la potenza, il successo, la ricchezza, la forza dei numeri e dei mezzi». Senza questa essenzialità il cristianesimo si stinge in un impegno pur nobile ma col solo debole respiro della storia.
Se si rimane in questa valle senza «levare il capo verso la liberazione vicina», come diceva Gesù, si è «bloccati dai paludamenti delle nostre menti che sono le nostre paure, le nostre angosce, i nostri sospetti». Le comunità si appesantiscono, si inflaccidiscono, cedono stancamente, ingrigite come la tiepida e sazia Chiesa di Laodicea, rigettata dal Cristo dell’Apocalisse.
Ed ecco, allora, la seconda parola che dom Mosconi ha estratto dalla sua lettura del testo della Prima Lettera di Pietro, la santità. Un termine ormai relegato tra gli incensi e spogliato della sua carica originaria fatta di trascendenza e di esistenza intrecciate tra loro. «Santità, infatti, significa costruire la propria maturità umana come Dio la sogna, guardando il Figlio». Nella santità la creatura col suo limite e la sua colpa non si dissolve in una sorta di aura sacrale ma si libera e si ri-crea.
Ma sulle due parole della "speranza" e della "santità" si erge come vertice e stella polare proprio il terzo vocabolo decisivo, Parola di Dio, vocabolo tipico della Chiesa post-conciliare. Ma la domanda del monaco nella sua brutalità cade come una sferzata: «Cosa ne abbiamo fatto della Parola a quarant’anni dalla Dei Verbum?» Questo arco di tempo - che per la Bibbia è il segno di un’intera generazione - quanto è stato inquietato e trasformato dalla Parola? La Parola divina non la si deve conservare solo come una pietra preziosa da collocare in un reliquiario: essa è come un mare in cui si ci deve immergere, bagnare, avvolgere. «Uno diventa la Parola che ascolta. Uno si assimila alla Parola che medita quotidianamente e diventa narratore di speranza».
Le nostre comunità sono state attraversate veramente da questa Parola? Chi, come me e come tanti presbiteri e vescovi della Chiesa italiana, aveva al tempo del Concilio venti o trent’anni, che cosa scopre guardando al fluire degli ultimi decenni? Nelly Sachs, una poetessa ebrea tedesca, Nobel nel 1966, in una sua ballata sui profeti si domandava: «Se i profeti irrompessero per le nostre porte della notte incidendo ferite nei campi dell’abitudine, se i profeti irrompessero cercando un orecchio come patria, orecchio degli uomini ostruito di ortiche, sapresti ascoltare?». Dobbiamo riconoscere e non sminuire quello che si è fatto di importante per la Bibbia - sarà non a caso tema del prossimo Sinodo episcopale - ma dobbiamo anche chiederci perché spesso la Parola divina non incide ferite nella placida superficialità dei nostri giorni e le ortiche delle cose secondarie o vane continuano a ottundere il nostro ascolto. Per questo è stato necessario far risuonare con vigore a Verona quelle tre parole in tutto il loro ardore.
-
> Caro BENEDETTO XVI ... faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!15 ottobre 2006, di Federico La Sala
«Deus caritas est», la prima enciclica di Ratzinger è a pagamento
di red (www.unita.it, 25.01.2006)
«Dio è amore, chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui». «Solo il matrimonio riflette l’amore di Dio» e «uno Stato senza la giustizia è una banda di ladri». Della prima enciclica di papa Ratzinger (Deus caritas est) che parla dell’amore di Dio e del concetto di carità cristiana nel mondo d’oggi, forse è prudente non citare molto più. È infatti coperta da copyright e la Libreria Editrice Vaticana ne detiene tutti i diritti, come li detiene su tutte le parole scritte dal papa.
Secondo le norme emanate dal Segretario di Stato Angelo Sodano qualche mese fa (volute fortemente da Ratzinger) qualunque altro editore voglia pubblicare questa o un’altra enciclica (oppure un’esortazione apostolica, o un discorso) deve pagare. Anzi deve presentare prima un progetto di edizione alla Lev (il rapporto fra testo dell’enciclica e commento dovrebbe essere di 1 a 2: 1/3 del volume occupato dal documento e 2/3 dal commento teologico/filosofico) e poi deve pagare. E neppure poco: dal 3% al 5% del prezzo di copertina di ogni copia venduta con anticipo da concordare caso per caso in base alla tiratura. Fatti i calcoli, le parole del papa più costose sono proprio quelle scritte nelle encicliche, le meno costose quelle pronunciate nei discorsi, Angelus, catechesi del mercoledì, allocuzioni varie.
Ma non è tutto. Il copyright che fa delle parole di papa Benedetto XVI delle vere e proprie merci a pagamento ha anche un valore retroattivo. Secondo le norme della Santa Sede «sono sottoposti a copyright tutti gli scritti, i discorsi e le allocuzioni del Papa. Sia di quello felicemente regnante che dei predecessori, fino a 50 anni addietro».
E a questo punto la domanda che sorge spontanea è quella relativa ai diritti d’autore sulle parole del precedessore di Ratzinger, Giovanni Paolo II. Solo in lingua inglese sono 2.770 i titoli di libri che portano la sua firma, oltre mille in lingua spagnola, intorno ai 370 quelli in italiano. Per queste innumerevoli edizioni e traduzioni verranno reclamati nuovi diritti d’autore? In Vaticano, a quanto pare, nessuno lo sa o nessuno vuol dirlo.
«Ci verrebbe voglia di chiedere al Vaticano i danni economici per tutti i libri posti all’indice e dei quali è stata impedita la diffusione, a cominciare dal Dialogo dei Massimi Sistemi di Galileo - ha commentato con ironia l’antropologa Ida Magli - La retroattività vale soltanto per i Papi?’.
Comunque sia gli effetti del copyright voluto da Ratzinger hanno già dato i primi risultati economici per la Santa Sede. Alla casa editrice Baldini & Castoldi, che aveva usato in un’antologia un testo di Papa Ratzinger (tra l’altro di trenta righe e precedente alla sua elezione a Pontefice), è già arrivata l’ingiunzione a pagare 15 mila euro per i diritti di copyright a cui dovranno aggiungere la percentuale sul prezzo di copertina per ogni copia venduta dell’antologia.
-
> Caro BENEDETTO XVI ... faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!13 ottobre 2006, di Federico La Sala
Il Papa richiama all’identità cristiana e corregge un’espressione del testo. Il dialogo va proseguito ma ci vogliono «forza, chiarezza, coraggio»
Errata corrige. Stavolta Ratzinger è prudente e cancella la parola “provocazione”
di Fulvio Fania (www.liberazione.it, 12.10.2006)
Città del Vaticano.Una “provocazione” di meno. Papa Ratzinger ci ha ripensato e stavolta ha corretto il discorso prima di pronunciarlo. Dopo il gran frastuono provocato nel mondo musulmano dalla sua lezione all’università di Ratisbona, che ha imposto una defatigante serie di “rammarichi”, spiegazioni, rassicurazioni agli ambasciatori, note a margine e restiling del testo, non era il caso di rischiare altri “fraintendimenti”. E così Benedetto XVI durante l’udienza generale in piazza San Pietro ha limato la propria catechesi. Nelle pagine già consegnate alla stampa c’era scritto che l’identità cristiana richiede «la forza, la chiarezza e il coraggio della provocazione che sono propri della fede». Ma al momento di parlare davanti ai 35 mila fedeli, Benedetto XVI ha preferito tagliare la parola provocazione limitandosi ad osservare che l’identità cristiana «richiede forza, chiarezza e coraggio di fronte alle contraddizioni del mondo nel quale viviamo». Come ad ammettere che il coraggio delle idee non comporta necessariamente delle provocazioni, sia pure di carattere culturale. Puntualmente il sito on line del Vaticano ha aggiornato i testi mentre Radiovaticana ha trasmesso la registrazione dell’importante brano che, già di per sé, non era certo una predica scontata e all’acqua di rosa.
Al contrario si tratta di un cavallo di battaglia di papa Ratzinger, quel suo approccio “identitario” alle altre culture e religioni che sta rendendo più tormentato il suo pontificato. Per Benedetto XVI «la via dell’indulgenza e del dialogo che il Concilio Vaticano II ha felicemente intrapreso» è un’ottima cosa e «va sicuramente proseguita con ferma costanza», però - insiste il Papa - bisogna stare attenti a non smarrire la verità cristiana. «Non si deve dimenticare - ha ribadito infatti Ratzinger - il dovere di ripensare e di evidenziare con altrettanta forza le linee maestre e irrinunciabili della nostra identità cristiana».
Capita spesso che il Papa cambi i suoi discorsi aggiungendo frasi a braccio e saltandone altre. Ma in questi giorni naturalmente anche le virgole hanno un significato. Tanto più per il fatto che ancora una volta Ratzinger era alle prese con la storia, come gli era accaduto a Regensburg citando le antiche controversie dell’imperatore Manuele II Paleologo. In questo caso l’ambito era evangelico, riguardando l’apostolo Giuda Taddeo e le sue invettive contro chi «travia i fratelli con insegnamenti inaccettabili» e divide la Chiesa. «Empi, sobillatori pieni di acredine, angeli decaduti»: i dissidenti del tempo non avevano scampo secondo Taddeo e, di fronte a tanta virulenza, Ratzinger chiosa: «Oggi non siamo forse più abituati a usare un linguaggio così polemico» ma non per questo si può tacere ciò che è «incompatibile» con il cristianesimo.
Nei confronti di alcuni “eretici” tuttavia papa Benedetto si mostra morbido. E’ il caso dei tradizionalisti nostalgici della messa tridentina, preconciliare, quella celebrata in latino, anche se non è questa la differenza fondamentale perché il latino è consentito sempre ed anzi Ratzinger lo ha raccomandato. A distinguere la messa di Pio X è soprattutto la distanza tra celebranti e fedeli, tra rito e assemblea. Monsignor Lefebrvre ne fece la bandiera dello scisma contro il Concilio, Wojtyla concesse ai vescovi la facoltà di autorizzare su richiesta qualche messa vecchio stile. Ora invece Ratzinger sta per varare un “Motu proprio” per allargare decisamente le maglie. E’ un tentativo di recupero dei lefebvriani secondo una linea che il Vaticano sta particando da tempo: o si decidono a rientrare ufficialmente o rischiano di non trovare più argomenti per giustificare la separazione.
-
> Caro BENEDETTO XVI ... faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!19 ottobre 2006, di Federico La Sala
ERRATA CORRIGE PAPALE. IL VATICANO PUBBLICA LA VERSIONE "CORRETTA" DEL DISCORSO DI RATISBONA *
33585. ROMA-ADISTA. Non tenete conto dei discorsi del papa, seppur pronunciati in diretta televisiva, ma aspettate qualche settimana per conoscerne il testo riveduto e corretto. Parola di Benedetto XVI. Infatti, con una decisione della quale è difficile trovare precedenti Oltretevere, il testo della "lezione" che il pontefice tenne il 12 settembre all’università di Regensburg (Ratisbona) - dove toccò il tema dell’islam in modo ritenuto offensivo da molti musulmani - è stato modificato in un punto sostanziale nelle versione che, dai primi di ottobre, si può leggere sul sito vaticano, appunto cambiata rispetto a quella che vi si trovava da tre settimane.
È ben nota (v. Adista nn. 65 e 68/06) l’ondata di reazioni negative suscitata dal discorso di papa Ratzinger che era sembrato fare suoi - citandoli nel discorso - i giudizi molto aspri contro Maometto, dati nel 1391 dall’imperatore bizantino Manuele II detto il Paleologo in una controversia con un dotto musulmano persiano. Per tentare di sedare le proteste montanti, la sala stampa della Santa Sede aveva messo nel sito il discorso però seguito - novità, anche questa, nella prassi vaticana - da una postilla: "Nota: di questo testo il Santo Padre si riserva di offrire, in un secondo momento, una redazione fornita di note. L’attuale stesura deve quindi considerarsi provvisoria". Dunque, era annunciato che lo stesso discorso sarebbe stato provvisto di note. D’altronde, in successive precisazioni, lo stesso Benedetto XVI aveva cercato di spiegare che cosa egli intendesse davvero dire sull’islam, ma non aveva parlato di modifiche del testo. Invece proprio questo è successo, come si può constatare consultando il testo inserito nel sito vaticano il 9 ottobre.
Il testo "rivisto" riporta le note preannunziate, tredici in tutto, delle quali due dedicate ad esplicite prese di distanza dalle dure affermazioni dell’imperatore. Ma - in alcuni passaggi - cambia anche il testo pronunciato in Baviera davanti al corpo accademico dell’università, alla stampa, e ripreso in diretta tv. Due i cambiamenti sostanziali: il primo è quella che riguarda la datazione della sura 2, 256 del Corano: "Nessuna costrizione nelle cose di fede".
Il papa aveva attribuito questo passo al periodo iniziale della predicazione di Maometto alla Mecca; nella stesura definitiva mette invece in forse tale datazione, accogliendo i rilievi che una parte del mondo musulmano, tra cui - autorevolmente - anche il professor Khaled Fouad Allam, che su Repubblica del 13 settembre aveva precisato che quella Sura fa parte di quelle che Maometto avrebbe scritto nel periodo medinese, in un periodo successivo quindi a quello trascorso alla Mecca: non si tratta di una querelle filologica. Dire che Maometto aveva scritto quella Sura quando "era senza potere e minacciato" per una parte del mondo islamico era capzioso, perché poteva sottintendere che Maometto, raggiunta una posizione più forte in seno alla sua comunità, si sarebbe invece messo a predicare la guerra Santa. Il discorso del papa, integrato con le parti da noi segnalate in corsivo, nella stesura definitiva sostiene ora che la sura 2,256: "È probabilmente una delle sure del periodo iniziale, dice una parte degli esperti, in cui Maometto stesso era ancora senza potere e minacciato".
Il secondo rilevante cambiamento operato sul testo pronunciato il 12 settembre riguarda il passaggio della lectio in cui il papa aveva citato l’imperatore Manuele II detto il Paleologo: «[Manuele II], in modo sorprendentemente brusco, brusco al punto da essere per noi inaccettabile, si rivolge al suo interlocutore semplicemente con la domanda centrale sul rapporto tra religione e violenza in genere, dicendo: ‘Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava’". L’inciso segnalato in corsivo non esisteva nel testo pronunciato a Regensburg. E, come si può ben vedere, non si tratta di un dettaglio, ma di una integrazione sostanziale. Cioè di quella presa di distanza dal pensiero dell’imperatore bizantino che, se ci fosse stata il 12 settembre, avrebbe evitato il sorgere di molti malintesi.
Questo passaggio cruciale del discorso di Regensburg, nella versione definitiva del discorso è corredato anche da una nota, la numero 3, che recita: "Questa citazione, nel mondo musulmano, è stata presa purtroppo come espressione della mia posizione personale, suscitando così una comprensibile indignazione. Spero che il lettore del mio testo possa capire immediatamente che questa frase non esprime la mia valutazione personale di fronte al Corano, verso il quale ho il rispetto che è dovuto al libro sacro di una grande religione. Citando il testo dell’imperatore Manuele II intendevo unicamente evidenziare il rapporto essenziale tra fede e ragione. In questo punto sono d’accordo con Manuele II, senza però far mia la sua polemica".
Nella sua "lezione", il papa, ancora, citava un’altra frase di Manuele II per sostenere che la violenza è in contrasto con la natura di Dio e la natura dell’anima: "Per convincere un’anima ragionevole non è necessario disporre né del proprio braccio, né di strumenti per colpire né di qualunque altro mezzo con cui si possa minacciare una persona di morte". E Ratzinger precisava: "L’affermazione decisiva in questa argomentazione contro la conversione mediante la violenza è: non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio". E qui, nel nuovo testo, vi è il rinvio ad un’altra nota, la numero 5, che dice: "Solamente per questa affermazione ho citato il dialogo tra Manuele e il suo interlocutore persiano. È in quest’affermazione che emerge il tema delle mie successive riflessioni".
Le altre note rinviano soprattutto ad opere teologiche, di vari autori, e dello stesso Ratzinger, su questioni di esegesi biblica e di indagine storica legate ai molti altri problemi, islam a parte, toccati dal pontefice nella sua "lezione" di Regensburg.
*http://www.adistaonline.it/?op=articolo&id=24871
-
> Caro BENEDETTO XVI ... faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!2 dicembre 2006, di Federico La Sala
L’Occidente preoccupa Benedetto
Con il suo viaggio in Turchia il Papa sembra aver chiuso l’incidente di Ratisbona. Ma il comune avversario delle Chiese non è l’Islam, è la «secolarizzazione, il nichilismo, il relativismo» occidentali, come dice la dichiarazione congiunta dei due capi
di GIAN ENRICO RUSCONI (La Stampa, 02.12.2006)
Ce l’ha fatta Benedetto XVI. Con il suo viaggio in Turchia sembra aver accontentato tutti. Sono soddisfatti i cattolici interessati all’intensificazione dei rapporti con la Chiesa ortodossa; i religiosi e i laici preoccupati del dialogo politico e culturale con l’Islam nella versione turca, che è la più accettabile secondo i criteri europei. Sono contenti i politici di Ankara che volevano dimostrare all’Europa di saper controllare l’estremismo religioso del loro Paese. Hanno trasformato in successo politico quella che alla vigilia sembrava una operazione rischiosissima. Non da ultimo esce rafforzata la figura di papa Ratzinger con la sua specifica personalità. Certo, rimane il dubbio che questo viaggio abbia soltanto rimosso alcune difficoltà preliminari, abbia corretto errori commessi in precedenza. Abbia posto cioè semplicemente le premesse per un lavoro tutto da inventare. Bilancio positivo, comunque, se misurato ai timori della vigilia, e che ora ci consente di guardare con occhio più sereno a un complesso di problemi che rimangono molto seri.
Cominciamo dalla figura del Papa, finalmente emancipato dalla figura del suo predecessore e mentore. Non è certamente un caso che Ratzinger abbia ripetuto le parole semplici e forti di un altro suo predecessore (Giovanni XXIII): «Io amo i turchi». Queste parole, con altri gesti e immagini (prima fra tutte la fotografia del Papa sorridente accanto alla grande bandiera nazionale turca) hanno colpito l’opinione pubblica turca, che spesso coltiva il complesso di vittima della malevolenza occidentale. Dobbiamo riconoscere che il Pontefice è stato particolarmente attento ad accentuare i gesti simbolici, all’altezza della comunicazione mediatica. A cominciare dalla discesa dell’aereo quando non portava in evidenza il crocifisso sulla veste bianca. Diplomazia e coerenza ideologica. Questo atteggiamento è stato più importante che l’augurio (forzatamente interpretato) che la Turchia possa raggiungere il suo obiettivo di entrare nella Unione Europea. Il Papa infatti offre una garanzia autorevole che l’Islam, in versione turca, non è incompatibile con i valori europei. È un punto molto importante, quando si affronta il dibattito sulla specificità della Turchia nel mondo islamico.
Reciprocamente l’atteggiamento di Ratzinger rende più coerente ed efficace la sua insistenza sulla «libertà religiosa» che è un principio ineludibile per un autentico Stato laico. Se le autorità politiche di Ankara si decidessero a formalizzare e a dare attuazione in modo inequivocabile a questo principio, manderebbero un segnale decisivo ai molti che sono contrari all’entrata della Turchia nell’Unione europea perché è inadempiente su alcuni principi democratici fondamentali. Detto questo, avanzo l’ipotesi che sarà più facile ottenere il riconoscimento formale della libertà religiosa dallo Stato turco che non registrare significativi progressi nei rapporti tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Anche qui si sono visti grandi simpatici segnali simbolici. Compresa la fotografia dei due capi della rispettive Chiese che alzano le braccia congiunte in un gesto di riconoscimento paritario reciproco, anche se in realtà ricorda le foto mondane degli sportivi o dei politici nei grandi compressi di partito. Ma anche qui siamo davanti alla logica mediatica.
Quello che invece ha colpito è la mancata partecipazione alla comunione eucaristica. Storici e teologi spiegano in tutti i dettagli perché il Papa non poteva farlo. Come laico potrei ingenuamente essere scandalizzato, dopo aver letto tante parole solenni. Ma so che qui tocchiamo una questione dogmatica essenziale quanto quella del riconoscimento dell’autorità papale, nel cui merito non entro. Ma l’impressione (non positiva) che se ne trae, allora, è che la riapertura del dialogo tra le Chiese avviene fondamentalmente su posizioni difensive verso il comune avversario che - si badi - non è affatto l’Islam ma «la secolarizzazione, il relativismo e il nichilismo in particolare nel mondo occidentale», come dice la dichiarazione congiunta dei due Capi delle Chiese. Siamo cosi tornati a un punto critico dell’intera strategia ratzingeriana. Era già evidente nell’importante lezione di Ratisbona, che ha provocato tanti equivoci a proposito dell’infelice citazione su Maometto. A questo proposito l’incidente comunicativo sembra chiuso, proprio anche grazie alla visita in Turchia. Ora è chiaro più che mai che il vero avversario rimane in Occidente.
-
> Caro BENEDETTO XVI ... faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!7 dicembre 2006, di Federico La Sala
“Santità, il Paleologo diceva di Maometto un’altra cosa...” *
Domanda tutt’altro che oziosa: l’imperatore bizantino Manuele II Paleologo ha detto davvero quella frase che - citata da Benedetto XVI a Ratisbona - ha fatto da miccia all’incendio che si sa?
Ricapitoliamo. Questa è la frase così come il papa l’ha riportata nella sua lezione, in tedesco:
“Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, daß er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten”.
Nella versione italiana ufficiale diffusa dal Vaticano la frase suona così:
“Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava”.
Entrambe le versioni, sia la tedesca che l’italiana, ricalcano quella di Théodore Khoury, il curatore francese dei dialoghi di Manuele II Paleologo con un dotto musulmano di Persia, pubblicati nella collezione “Sources Chrétiennes”:
“Car montre-moi que Mahomet ait rien institué de neuf: tu ne trouverais rien que de mauvais et d’inhumain, tel ce qu’il statue en décrétant de faire progresser par l’épée la croyance qu’il prêchait”.
Il guaio è che l’originale greco della frase di Manuele II Paleologo non dice esattamente così.
È quanto ha notato don Silvio Barbaglia, biblista della diocesi di Novara. Il quale ha pensato bene di recapitare a Benedetto XVI una lettera per avvertirlo dell’imprecisione.
Nella lettera don Barbaglia scrive tra l’altro:
“Santità, ritengo che vada segnalata una traduzione errata dal testo greco in francese ad opera di Théodore Khoury e, conseguentemente, in tutte le altre lingue moderne.
“Dal contesto che precede la frase in oggetto si evince che Manuele II Paleologo stia procedendo entro una logica di confronto tra la Legge di Mosè e Maometto: quest’ultimo difeso dal persiano come profeta e nuovo legislatore, con una pretesa di ‘novità’ rispetto all’ebraismo e al cristianesimo. Ovvero, ci troviamo nella tipica disputa per cogliere quale sia la religione superiore, culmine della rivelazione dell’unico Dio.
“Se tale è il contesto, allora la traduzione dell’aggettivo greco ‘cheiron’ - tradotto in francese da Khoury con ‘mauvais’, in tedesco con ‘Schlechtes’ e in italiano con ‘cose cattive’ - non è corretta. Osservando la lingua greca questo è un aggettivo comparativo di ‘kakos’, ovvero si colloca in una comparazione logica tra un insieme e un altro. Per questo, è certamente più adeguata una traduzione che dia il senso di ‘peggiore di’ oppure di ‘minore di’. Dire che Maometto ‘ha portato soltanto delle cose cattive e disumane’ significa fare un’affermazione assoluta, cioè slegata da ogni comparazione, mentre qui il problema è esattamente quello di comprendere il rapporto tra ebraismo, cristianesimo e islam. La tesi del Paleologo sarebbe quella secondo cui Maometto non avrebbe portato nulla di nuovo rispetto a ciò che c’era e le ‘novità’ pretese dal persiano non erano che peggioramenti se paragonati a quelli originari di Mosè e di Cristo.
“Inoltre, il secondo aggettivo ‘apanthropotaton’ appare in una forma di superlativo che a sua volta può essere inteso come assoluto o come relativo. Essendo in un contesto di comparazione andrebbe accolta la forma del superlativo relativo. Il termine fa pensare a un ‘allontanamento’ (‘apo’) da una immagine di uomo (‘anthropos’), quindi a un’azione ‘disumanizzante’ quale è la violenza per imporre la fede: la cosa ‘più disumanizzante’ di tutte.
“Dunque la frase potrebbe essere tradotta così:
“‘Mostrami infatti quale novità è stata istituita da lui (Maometto), ma non vi troverai se non cose peggiori e le più disumanizzanti, come l’avere comandato di diffondere, per mezzo della spada, la fede che egli predicava’.
“Credo che così impostata la traduzione renda maggior ragione del pensiero di Manuele II Paleologo”.
SETTIMO CIELO di Sandro Magister, Postato in General il 6 Dicembre, 2006
-
-
-
> Caro BENEDETTO XVI ... faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!11 ottobre 2006, di Federico La Sala
Sulle orme del Poverello, Abd-el-Jalil, musulmano convertito al cristianesimo, spiega com’ è possibile dialogare con l’ islam
Il Corano di Francesco
di Jean-Mohammed Abd-El-Jalil (Avvenire, 11.10.2006)
Jean-Mohammed Abd-el-Jalil (1904-1979) nato in Marocco e cresciuto nella religione islamica ricoprì cariche importanti nel suo Paese, fino a quando, convertendosi al cristianesimo si fa francescano. Come padrino ebbe uno dei maggiori orientalisti cristiani, Louis Massignon. Il volume «Testimone del Corano e del Vangelo» edito da Jaca Book (pagine 154, euro 15), da cui abbiamo prelevato il brano pubblicato in questa pagina, è una sorta di autobiografia spirituale che ripercorre il cammino di padre Jean-Mohammed tramite i suoi scritti e le testimonianze di chi l’ha incontrato. Anziché rompere con il mondo islamico, egli dedica la sua vita e il suo insegnamento all’Institut Catholique di Parigi a far comprendere l’esperienza religiosa e le aspirazioni spirituali dei musulmani. Diviene così un testimone del messaggio del Corano e del Vangelo, convinto che amare la verità non sia aderire a una dottrina, ma aderire alla persona di Cristo, che è la verità salvifica per tutti. Padre Jean-Mohammed diviene per gli uomini del suo tempo, intellettuali laici e autorità ecclesiastiche, il testimone di un abbraccio tra culture che egli ha vissuto con la sua stessa vita. Il volume è stato realizzato sotto la direzione di padre Maurice Borrmans del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (Pisai).
Non portiamo l’ululato dei lupi ma il grido del Vangelo per tutti
È nel momento di maggior difficoltà, quando si infiammano le passioni umane, che il mondo si attende che i cristiani «non ululino insieme con i lupi», ma che «gridino il Vangelo in tutta la loro vita», secondo le parole di padre De Foucauld.
L’Africa settentrionale, malgrado le caratteristiche che le sono proprie, si sente solidale con la comunità musulmana intera, e in particolare con il «nocciolo» di questa comunità, il mondo arabo. La storia può aver creato a questa parte dell’Africa dei nuovi legami con l’Occidente moderno, in particolar modo con la Francia, ma ciò non cambi a il senso profondo di solidarietà di lingua, pensiero, cultura, religione che i nordafricani hanno con i loro fratelli arabi e musulmani, i quali, per reciprocità, non possono disinteressarsi della sorte dell’Africa settentrionale e trattare i suoi abitanti come estranei con i quali non hanno niente da spartire.
È come se l’Africa settentrionale si trovasse su di un pianerottolo a due porte, l’una che si apre sull’Oriente musulmano, attraverso l’Egitto moderno, l’altra sull’Occidente cosiddetto «cristiano», attraverso la Francia. Voler murare una di queste due porte sarebbe fatale. Saperle aprire entrambe secondo i bisogni reali, e trovare la conveniente delicatezza di tatto, è cosa terribilmente difficile, che si presta alle interpretazioni più ingiuste perché superficiali e spesso interessate.
Agli occhi dei cristiani l’atteggiamento dei musulmani - malgrado gli urti e le mancanze della storia - è un’attesa, una speranza. Questa speranza si radica nel Libro sacro dell’Islam, nel Corano stesso, e nell’insegnamento religioso che ne deriva. I musulmani sanno quali sono i segni dai quali si possono riconoscere i veri discepoli di Cristo: l’umiltà, la mansuetudine, la vita perfetta liberamente praticata dai monaci, che crea una spinta verso la perfezione nell’insieme dei credenti. Nella pratica il clero e i laici devono dunque manifestare la perfezione del Vangelo. Ciò non significa domandare più di quel che domanda il Cristo: «Imparate da me a essere dolci e umili di cuore» e «Siate perfetti com’è perfetto il vostro Padre che è nei Cieli».
I figli e le figlie di san Francesco non si sentono forse chiamati in modo particolare a rispondere a questa attesa, a soddisfare questa speranza? Essi dovranno dunque sforzarsi di spezzare la catena della paura e del risentimento ogni qual volta che il suo strofinio glaciale li fa sussultare o minaccia la loro libertà di movimento, spezzare quella catena e ricominciare da capo a comprendere e ad amare il prossimo, qualunque s ia questo prossimo. Se occorrerà, dovranno comprendere e amare per due, e per tutto il tempo che sarà necessario, fino al giorno in cui questo sforzo instancabile di comprensione e d’amore faccia accendere la stessa scintilla nel prossimo.
Anche la saggezza popolare e i testi sacri islamici invitano i musulmani alla cooperazione con gli altri, persino con i nemici. Gli arabi ripetono spesso questo proverbio: «Comprendimi e uccidimi!». Morirei senza rimpianto se tu, mio avversario, facessi prima lo sforzo di comprendermi! Forse in questo proverbio c’è anche un’insinuazione maliziosa: un avversario che comprende non uccide, ma favorisce l’intesa e la cooperazione. Sarebbe un’ingiustizia gratuita supporre da parte araba un’esigenza a senso unico; essi, che desiderano essere compresi, cercheranno di comprendere.
Nel Corano vi è un insegnamento che non viene messo sufficientemente in luce. Ecco uno dei testi in cui esso è contenuto: «Il male e il bene non sono uguali; rifiuta il male per quel che c’è di meglio, e allora colui che l’inimicizia separa da te diventerà per te come un amico fedele». È stato un esponente nazionalista marocchino (oggetto, per molti anni, di misure repressive) a citare per primo questo testo e a sottolinearne la portata nell’ambito dei rapporti tra Francia e Africa settentrionale. Comprendere. Rendere il bene per il male. Aumentare il bene, a prezzo di sacrifici generosi. Tutto ciò può far arretrare le reazioni disperate e la tentazione al peggio. Occorre che noi, i figli del Poverello, pregando con ardore e senza risparmiare alcun possibile sforzo, facciamo rivivere ai nostri tempi l’esempio datoci da nostro Padre in terra d’Islam, in tempi di violenza e di ostilità. Non lasciamoci vincere dalla paura e dal risentimento.
-
> Caro BENEDETTO XVI ... faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!4 ottobre 2006, di Federico La Sala
RADICI CRISTIANE ... EU-ANGELICHE, non ’cattolico’-romane!!!
Dal 1939 la festa odierna è occasione propizia per riscoprire l’attualità del Poverello Padre Coli: ci insegna la libertà interiore per diventare autentici costruttori di pace
La profezia di Francesco «illumina» l’Italia
Oggi Assisi cuore delle celebrazioni per il santo patrono del nostro PaeseQuest’anno il 4 ottobre cade nell’8° centenario della conversione Dal 2005 è anche giornata nazionale del dialogo
Da Assisi Romano Carloni (Avvenire, 04.10.2006)
Francesco rimane un punto di riferimento anche in questi tempi, così difficili. Perché di fronte allo sfrenato consumismo nel mondo occidentale con l’abuso delle realtà create, il santo invita alla sobrietà, alla essenzialità per poterci ancora stupire ed essere creativi e pensare responsabilmente alle generazioni future. Ecco il senso del messaggio dei frati minori conventuali nella giornata di san Francesco, patrono d’Italia, che si celebra oggi.
«Di fronte ad una soggettività radicale, presente nella cultura ed anche nei comportamenti più semplici - ha detto padre Vincenzo Coli, custode del Sacro Convento - Francesco esalta la grandezza dell’uomo e proclama che sua vera misura è Dio, invitandoci così a lasciar cadere tutte le maschere e le finzioni. Occorre recuperare la capacità di relazioni autentiche e di dialogo. Insieme a Francesco, per essere costruttori di pace, bisogna contestare gli assoluti terreni per tornare interiormente liberi». La celebrazione di quest’anno cade nell’ottocentesimo anniversario della conversione di Francesco. «Si tratta di un limpido invito per noi tutti a riconsiderare opzioni e comportamenti di vita - ha detto padre Coli - alla luce di una conferma della propria fede». Quest’anno è la Calabria a rendere omaggio alla tomba del santo con l’accensione della lampada votiva dei Comuni d’Italia da parte del sindaco di Catanzaro, Rosario Olivo. È una tradizione che si rinnova ogni anno, dal 1939, quando Papa Pio XII proclamò Francesco patrono d’Italia.
Sarà l’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, Vittorio Mondello, a presiedere la funzione religiosa che si svolgerà alle 10 nella Basilica superiore di San Francesco, con diretta televisiva su Raiuno. Poi toccherà ai sindaci di Assisi, Claudio Ricci, e di Catanzaro, Rosario Olivo, rivolgere un breve saluto. Seguiranno gli interventi del ministro generale dell’ordine dei frati minori conventuali, padre Joachim Giermek, del presidente della giunta regionale calabrese, Agazio Loiero , e del vicepremier Francesco Rutelli, in rappresentanza del governo, a leggere il «messaggio all’Italia».
Dallo scorso anno la giornata del 4 ottobre, festa di san Francesco di Assisi, è stata dichiarata, da parte del Parlamento, giornata nazionale del dialogo, per favorire la convivenza e la fratellanza tra persone di diverso credo religioso ma anche tra credenti e non credenti. In questo senso si tengono nella giornata odierna lezioni nelle scuole per rafforzare le esperienze di dialogo interreligioso e vengono trasmessi servizi televisivi su questi argomenti.
Francesco rappresenta l’esempio del dialogo ma anche il fondamento di parte rilevante della cultura e dell’identità dell’Europa. In questa prospettiva è nata la proposta del sindaco di Assisi - d’intesa con la Commissione europea - di ospitare durante le festività francescane del prossimo anno, oltre che una regione italiana, anche una nazione europea, come simbolo delle comuni radici cristiane, spirituali e culturali.
-
> Caro BENEDETTO XVI ... faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!12 ottobre 2006, di Federico La Sala
Torna la messa in latino. Al documento manca solo la firma del Papa*
Il testo è pronto, manca solo la firma del Papa. Il documento in questione è un "motu proprio" papale, che potrebbe essere pubblicato già entro la fine del 2006 e che "riabiliterebbe" la messa detta di San Pio V, ovvero quella celebrata in latino. Il testo agevolerebbe l’utilizzo del messale pre-conciliare, in uso fino al 1969, e darebbe la possibilità ai fedeli di chiedere la celebrazione dell’antica messa senza che i vescovi delle diocesi locali possano rifiutarsi, come invece accade oggi. La messa in latino, che non è mai stata dichiarata decaduta, tornerebbe ad avere con questo documento piena cittadinanza, così come quella di altri riti cattolici, dal bizantino, al mozarabico o al sirio-antiocheno.
Già in qualità di cardinale, Ratzinger aveva a cuore le sorti della liturgia e lamentava una serie di modifiche «avventurose e spettacolari» al rito, sottolineando che per la messa tridentina (quella in latino, appunto) non vi era la medesima tolleranza. «Personalmente ritengo - aveva dichiarato allora - che si dovrebbe essere più generosi nel consentire l’antico rito a coloro che lo desiderano. Non si vede proprio cosa debba esserci di pericoloso o inaccettabile.» «Una comunità - aveva aggiunto Ratzinger - mette in questione se stessa, quando considera improvvisamente proibito quello che fino a poco tempo prima le appariva sacro e quando ne fa sentire riprovevole il desiderio. Perché le si dovrebbe credere ancora? Non vieterà forse domani, ciò che oggi prescrive?».
La questione della messa tridentina è stata in seguito oggetto di una consultazione all’interno del collegio cardinalizio al concistoro dello scorso febbraio, quando venne assegnato a tre congregazioni l’incarico di procedere per definire i termini del documento: la Congregazione per il Culto Divino, quella della Dottrina della Fede e del Clero, il cui attuale responsabile, il cardinale Dario Castrillon Hoyos da anni è impegnato a tessere i fili per una ricomposizione dello scisma lefebvriano.
In un’intervista al periodico 30 Giorni, anche monsignor Malcom Ranjith, segretario della Congregazione per il culto divino, ha ribadito che la messa tridentina «non è una proprietà privata dei lefebvriani» ma «un tesoro della Chiesa e di noi tutti. Come il Papa ha detto l’anno scorso non è un momento di rottura, ma di rinnovamento nella continuità. Non sibutta via il passato, ma si cresce su di esso».
Il decreto, che ha tuttavia incontrato non poche resistenze dentro e fuori la curia, prevede un tetto minimo di fedeli richiedenti, inizialmente fissato in 100 firme e in seguito ridotto a 30 ed il fatto che la Santa Sede abbia recentemente approvato a Bordeaux l’istituzione di una società di vita apostolica di diritto pontificio, significa, secondo monsignor Ranjith «in modo inequivocabile che la messa di San Pio V non può essere considerata come abolita dal nuovo messale di Paolo VI». Cresce, quindi, l’attesa per la pubblicazione del "motu proprio", che dovrebbe facilitare anche raggiungimento della piena comunione con i lefebvriani della fraternità di San Pio X.
*www.unita.it, Pubblicato il: 11.10.06 Modificato il: 11.10.06 alle ore 17.34
-
> Caro BENEDETTO XVI ... faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!30 ottobre 2006, di Federico La Sala
Anche un premio giornalistico tra le iniziative adottate
Vaticano: no a declino studi latino e greco
La Santa Sede vuole mobilitare anche i media: «sono in pericolo studi storici, filologici, filosofici, teologici» *
CITTÀ DEL VATICANO - A chi viaggia per lavoro può accadere, in ambito internazionale, di rimanere «male» constatando che l’inglese parlato, per esempio , da tedeschi, è in media largamente migliore del nostro. Per il buon motivo che è materia meglio studiata a scuola. Ma (ancora più umiliante), può accadere anche che perfino la loro conoscenza del latino sia migliore della nostra. Ovvia l’obiezione:pazienza, l’inglese serve, il latino no. Ma non tutti la pensano così, e se in alcuni Stati esteri il valore formativo delle lingue classiche è ancora tenuto in gran conto, nel nostro Paese, che dovrebbe essere la culla naturale perlomeno del latino, è invece in calo. E a preoccuparsene è, ancora, uno Stato estero, cioè Città del Vaticano, che teme che , in generale, il declino dello studio di greco e latino porterà a un impoverimento degli studi non solo storici, ma anche filologici, filosofici e teologici e a un «decadimento della ricerca seria in quei settori». Per arginare questo interesse declinante la Santa Sede vuole porre il problema non solo in ambito accademico e scolastico, anche attraverso i media, «nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica» e per «sensibilizzare» le autorità nazionali e «sovranazionali preposte alle scelte educative».
PREMIO GIORNALISTICO - A questo scopo il Pontificio comitato di scienze storiche ha deciso di promuovere un «premio giornalistico» per articoli su quotidiani o periodici dedicati a «attualità e significato delle lingue classiche per lo sviluppo scientifico e culturale»; «importanza delle lingue classiche sul piano pedagogico»; «politiche sviluppate dagli Stati al fine di favorire lo studio delle lingue classiche». Il dicastero pontificio da sempre dà spazio al sostegno e all’incremento delle discipline umanistiche per una maggiore valorizzazione della storia e intende contribuire alla promozione delle lingue classiche nelle scuole e università europee e nei paesi di cultura euorpea. Il premio è alla sua seconda edizione e valuterà articoli dal 31 ottobre 2006 al 30 aprile 2007. «Nonostante le deludenti politiche scolastiche adottate in questo settore negli ultimi decenni - spiega il dicastero vaticano - occorre ribadire con forza, e a tutti i livelli istituzionali, l’importanza delle lingue classiche per una cultura che è alla base non solo dell’Europa presente e futura e di Paesi che risentono di queste radici culturali, ma che, in ultima analisi, rappresenta un patrimonio culturale per l’intera umanità». 30 ottobre 2006
* www.corriere.it, 30.10.2006
-
> Caro BENEDETTO XVI ... faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!27 gennaio 2007, di Federico La Sala
«Deus caritas est» un anno dopo
Ha avuto un’eco vastissima
di Rino Fisichella (Avvenire, 27.01.2007)
Un anno fa veniva resa pubblica la prima enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est. Portava la data significativa del 25 dicembre, giorno in cui il mistero dell’amore di Dio si rende evidente nel suo farsi uomo per rivelare a tutti la vocazione più alta e carica di senso: amare ed essere amati. Si era creata giustamente molta attesa fin dai mesi precedenti su questo documento. Nella sua prima enciclica, infatti, ogni papa rende noto il suo "programma" di pontificato e pone i principi su cui orientare la sua linea pastorale. Con Deus caritas est, Benedetto XVI non eludeva le aspettative; anzi, affermava che il suo programma era quello che la Chiesa persegue da duemila anni, dare testimonianza dell’amore e vivere di esso.
L’effetto che l’enciclica ha provocato è stato a valanga. È sufficiente verificare la sua ricezione nel corso di pochi mesi per comprendere quanto Benedetto XVI non solo abbia colto nel segno, ma sia stato efficacemente compreso da tutti. Deus caritas est è stata fatta oggetto di lettura, di studio, di riflessione e dibattito nei diversi ambiti: dalle comunità cristiane agli ambienti della cultura laica. Il testo è stato preso tra le mani da cattolici, ortodossi, riformati; ognuno ha colto la valenza ecumenica e ne dato una personale lettura, apportando un contributo di notevole interesse. Per tutti, valga quanto il famoso teologo di Tübingen, Eberahrd Jüngel, ha scritto in proposito: «È con certa diffidenza che normalmente i teologi protestanti leggono le encicliche papali. Sono un teologo protestante, quindi rientro in questa regola. Non c’è regola, tuttavia, senza eccezioni. Ho letto la prima enciclica di Benedetto XVI più di una volta. Il testo mi ha toccato, non da ultimo perché ha evocato nel lettore evangelico una sintonia che sgorga da un profondo consenso di vasta portata ecumenica». Nessuna espressione di galateo in queste parole, ma la convinzione che in quelle pagine trovano spazio contenuti ch e hanno una vitalità che supera le incomprensioni, i confini e le contraddizione che ci portiamo dentro.
Deus caritas est, nel linguaggio semplice e catechetico a cui Benedetto XVI ci ha abituato con i suoi interventi, soprattutto nelle catechesi del mercoledì e nelle varie omelie, contiene temi che hanno bisogno di grande riflessione per entrare nei comportamenti e diventare a pieno titolo cultura e stile di vita. Si pensi al grande tema dell’amore cristiano che va oltre ogni forma di mito disincarnato, mentre nella persona di Gesù Cristo entra direttamente nella storia e diventa paradigma per quanti sono alla ricerca di un amore genuino, gratuito e veritiero che dia risposta di senso definitivo alla propria esistenza. Non va sottovalutata, d’altra parte, la grande sfida culturale che emerge da quelle pagine soprattutto per l’occidente. Sempre più frammentato in una sorta di apatia tale da perdere l’orientamento e con esso l’identità conquistata, questo mondo antico è provocato a comprendere che senza il recupero delle proprie radici non ha vero futuro dinanzi a sé. L’enciclica spinge ancora a considerare il tema della corporalità come superamento di una parziale e strumentale visione che limita l’amore alla passione e rende merce il corpo per il solo gusto del divertimento sguaiato e senza regole. Davanti a diversi fatti di cronaca di questi giorni, che fanno emergere in maniera drammatica la verità di queste parole, non è inutile riprendere tra le mani l’insegnamento di Papa Benedetto in proposito. Diventa prezioso quanto egli prospetta per giungere a costruire un’unità profonda in ogni persona. Solo così si recupera la vera armonia che consente di vivere in quell’equilibrio mai ovvio di spirito e corpo, di ragione e sentimenti, di eros e agape.
Dopo le migliaia di interventi che la stampa mondiale ha dedicato all’enciclica, a un anno di distanza si cominciano a contare sempre più numerosi i commenti teologici e le pubblicazioni più ragionate. È sol o l’inizio di un lungo cammino che non potrà fermarsi presto, perché la ricezione di questo primo testo del magistero di Benedetto XVI possa portare i suoi frutti. Se fin d’ora, ci si sente toccati da queste pagine e si riesce ad offrire un’intelligenza profonda dell’amore, allora è proprio vero che il cristianesimo non è primariamente una teoria ma l’incontro con il mistero di una persona che merita di essere frequentata per tutta la vita.
-
> Caro BENEDETTO XVI ... faccia come insegna CONFUCIO: provveda a RETTIFICARE I NOMI. Segua FRANCESCO !!!13 febbraio 2007, di Federico La Sala
Nel Messaggio per la Quaresima 2007 Benedetto XVI è tornato sui temi della sua prima enciclica, la "Deus caritas est"
Il Papa: "L’amore di Dio è anche eros. Gesù ne è la rivelazione più sconvolgente" *
CITTA’ DEL VATICANO - "L’amore di Dio è anche eros: nell’Antico Testamento il Creatore dell’Universo mostra verso il popolo che si è scelto una predilezione che trascende ogni umana motivazione": lo sottolinea Benedetto XVI, nel Messaggio per la Quaresima 2007. Un tema già affrontato dal Papa nella sua prima enciclica la "Deus caritas est", nella quale si distinguevano le due componenti dell’amore: l’agape che "indica l’amore oblativo di chi ricerca esclusivamente il bene dell’altro", e l’eros che "denota invece l’amore di chi desidera possedere ciò che gli manca ed anela all’unione con l’amato".
Nel documento pubblicato oggi, Benedetto XVI ribadisce che se "l’amore con cui Dio ci circonda è senz’altro agape", c’è anche una "passione divina" che la Bibbia descrive "con immagini audaci come quella dell’amore dell’uomo per una donna adultera". "Questi testi biblici - afferma - indicano che l’eros fa parte del cuore stesso di Dio: l’Onnipotente attende il sì delle sue creature come un giovane sposo quello della sua sposa".
"Purtroppo - osserva però il Pontefice - fin dalle sue origini l’umanità, sedotta dalle menzogne del Maligno, si è chiusa all’amore di Dio, nell’illusione di una impossibile autosufficienza".
"Ripiegandosi su se stesso - scrive ancora Joseph Ratzinger - Adamo si è allontanato da quella fonte della vita che è Dio stesso, ed è diventato il primo di quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la vita".
Nel suo messaggio, il Papa teologo ricorda che "Dio, però, non si è dato per vinto, anzi il no dell’uomo è stato come la spinta decisiva che l’ha indotto a manifestare il suo amore in tutta la sua forza redentrice". "
"E’ Gesù - conclude - la rivelazione più sconvolgente dell’amore di Dio, un amore in cui eros e agape, lungi dal contrapporsi, si illuminano a vicenda. Sulla Croce è Dio stesso che mendica l’amore della sua creatura: Egli ha sete dell’amore di ognuno di noi".
* la Repubblica, 13 febbraio 2007
-
> COPYRIGHT !!! Latino: "DEUS CARITAS" = Italiano: "DIO CARO-PREZZO"!!! ... LA DONAZIONE DI COSTANTINO !!!13 febbraio 2007, di Federico La Sala
Vaticano
Il papa con il copyright *
Il vaticano sta lavorando a un provvedimento con il quale si intende tutelare con il diritto d’autore testi, fotografie, immagini e registrazioni della voce dei papi, e gli atti della Santa sede. La notizia è apparsa ieri sul «Sole 24 Ore». Il quotidiano scrive che nel testo, pronto tra un paio di mesi e scritto rifacendosi alla legge dello stato italiano, sarà previsto che per utilizzare libri, immagini e registrazioni audio, salvo eccezioni stabilite nel regolamento, servirà un’autorizzazione e sarà possibile esigere il pagamento delle royalties. Della stesura del provevdimento si sta occupando la Libreria editrice vaticana.
* il manifesto, 11.02.2007.
-
> COPYRIGHT !!! Latino: "DEUS CARITAS" = Italiano: "DIO CARO-PREZZO"!!! ... LA DONAZIONE DI COSTANTINO !!!13 marzo 2007, di Federico La Sala
NTERVISTA
«Benedetto XVI con la sua enciclica ha inteso correggere la sconnessione che spesso viene operata fra i due termini». Parla il teologo Giuseppe Angelini, autore di un saggio sull’argomento
Eros e agape, oltre l’alternativa
Da Milano Paolo Lambruschi (Avvenire, 13.03.2007)
La prima enciclica di papa Ratzinger Deus caritas est ha avuto grande successo. Il teologo morale Giuseppe Angelini, docente della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, torna con il volume Eros e Agape. Oltre l’alternativa, edito da Glossa sui temi antropologici del testo, quelli che segnano l’esperienza quotidiana dell’amore.
Monsignor Angelini, partiamo dall’alternativa del titolo. Benedetto XVI nell’enciclica la respinge: l’amore di Dio per l’uomo è anche eros. Qual è la portata di questa innovazione in campo teologico?
«L’alternativa è stata formulata in termini perentori nel 1930 da Anders Nygren, in un’opera di grande e immeritato successo; Nygren era teologo luterano; nella sua ottica l’opposizione tra eros e agape assumeva la figura di rinnovata affermazione del teorema che oppone la fede alle opere, il divino all’umano. L’eros inteso quale desiderio umano, addirittura costitutivo dell’identità dell’umano, sarebbe senza proporzione con agape, l’amore che Dio rivolge in maniera incondizionata a ogni sua creatura. Di questo secondo amore l’uomo si approprierebbe mediante la sola fede, indipendentemente dalle opere. La correlazione positiva e dinamica tra eros e agape affermata da Benedetto XVI assume in tal senso anzitutto il valore di una rinnovata affermazione dell’originaria alleanza tra Dio e l’uomo, creato a immagine del suo Verbo. Pur senza usare il lessico di eros e agape, la sconnessione tra amor concupiscentiae e amor benevolentiae attraversa però largamente la stessa tradizione cattolica. Essa sancisce la separazione tra le forme psicologiche del desiderio spontaneo dell’uomo e le forme solo spirituali della caritas. Appunto tale sconnessione Benedetto XVI intende correggere, introducendo l’affermazione sorprendente che Dio stesso ha un desiderio nei confronti della sua creatura».
Perché si è creata nella nostra morale questa alternativa tra amore spirituale e passione?
«Effettivamente l’uomo è esposto alla tentazione di ridurre il bene alla figura passiva della saturazione del proprio desiderio. Non è solo una tentazione, ma è la forma radicale del peccato universale. Realizzato in questa forma, l’eros diventa in effetti alternativo all’agape. Illusoria è però l’idea che alla tentazione si possa porre rimedio semplicemente separando amore spirituale e passione; al contrario, soltanto attraverso le originarie forme passive, o affettive, dell’esperienza l’uomo può accedere alla verità della promessa, che sola apre il cammino della sua vita».
E nel campo della morale quotidiana, cosa significa proporre all’uomo contemporaneo questo amore divino?
«Per proporre all’uomo contemporaneo la figura dell’amore divino, manifestato attraverso la passione di Gesù Cristo, occorre mostrare come la vicenda di Gesù effettivamente manifesti la verità da sempre nascosta in ogni forma umana dell’amore, ma rimossa. Occorre in tal senso passare dalle forme correnti del discorso cattolico - oscillante tra le formule scolastiche del catechismo e la semplice citazione delle parole evangeliche e bibliche in genere - a un’attenta fenomenologia delle relazioni umane tutte, a procedere da quelle elementari, dalla relazione tra uomo e donna e tra genitori e figli. Soltanto sulla base di tale attenzione al concreto sarebbe possibile mostrare come la rivelazione di Dio nella storia interpreti e insieme giudichi le forme dell’amore raccomandate dalla tradizione della cultura».
Come l’enciclica rinsalda il valore dell’amore matrimoniale?
«È troppo poco dire che essa rinsalda; essa porta alla luce il valore originario che l’eros sponsale assume in ordine alla comprensione del desiderio di Dio nei confronti degli umani, e quindi anche della sua "vulnerabilità", resa manifesta dalla croce. Non si tratta solo di rinsaldare, ma di configurare un eros che, nelle forme in cui esso è vissuto e celebrato, appare come una filastrocca banale. Per suggerire solo un’applicazione più concreta, occorre correggere l’immagine romantica dell’amore, che ha costituito la forma dominante nell’epopea civile moderna; quella forma ha fatto dell’amore quasi una nuova religione (vedi L’allegoria dell’amore dello scrittore Clive Staples Lewis), e certo una diversa da quella evangelica».
Lei parla a lungo del commiato della modernità dalla religione ecclesiastica. L’amore elaborato dall’individualismo e dalla laicità in cosa si differenzia dall’amore cristiano?
«La responsabilità della concezione moderna dell’amore, quella romantica, nasce da un sistema civile, quello secolare della modernità. Esso condanna la coscienza individuale alla clandestinità; su questo sfondo trova terreno propizio di cultura la figura immaginaria e sognante dell’amore. Essa si affida a immagini esoteriche, remote dalle forme effettive della pratica quotidiana di vita. La figura di amore che ne risulta fugge dalla responsabilità, dalla memoria e dalla promessa; cancella il nesso, obiettivo e innegabile, tra amore e generazione; sequestra il rapporto tra uomo e donna dal rapporto di generazione, quindi anche dal compito dell’educazione. Questa è ridotta alla figura irreale di una puericultura».
Un tema delicato nella seconda parte dell’enciclica, quella cosiddetta politica, è la "caritas". Lei sostiene che la compassione e l’amore per gli ultimi sono la forma in cui è stato ridotto l’amore cristiano dalla società post ideologica. Mentre addirittura nel Vangelo di Giovanni non v’è accenno alla compassione di Gesù per i poveri e gli ultimi. Qual è oggi il senso del comandamento dell’amore? Chi è il prossimo da amare?
«Ricordo anzitutto che alla domanda "Chi è il mio prossimo?" Gesù stesso risponde raccontando una storia, quella del buon samaritano; essa è una parabola che dice dell’amore di Gesù stesso; non si può dire chi è il prossimo se non raccontando la storia che me lo rende tale. Preciso poi che l’amore comandato da Gesù ha sempre la figura della ripresa di una prossimità, che in prima battuta si realizza a monte rispetto alla consapevolezza e alla scelta dell’uomo. In tal senso, concorrono a disegnare la figura dell’amore cristiano anzitutto l’amore tra uomo e donna, e poi quello tra genitori e figli. A procedere da queste forme occorre intendere le stesse forme tipiche dell’agape del nuovo testamento: il perdono dei nemici, il servizio degli amici e certo anche la compassione per chi è nel bisogno».
E’ ancora attuale la frase di Paolo VI: la politica è la più alta forma di carità?
«Certo. Chiede, però, che sia pensata la figura della politica, correggendo le concezioni moderne, che la riducono a discorso sulle forme dell’uso legittimo del potere. Occorre ripensare la politica come forma della alleanza umana e non solo come esercizio del potere».
-
> COPYRIGHT !!! Latino: "DEUS CARITAS" = Italiano: "DIO CARO-PREZZO"!!! ... LA DONAZIONE DI COSTANTINO !!!5 aprile 2007, di Federico La Sala
Il monito durante la cerimonia della lavanda dei piedi in San Giovanni che ricorda l’ultima cena di Gesù. Ratzinger lo aveva già detto nel 2005 negli ultimi giorni del pontificato di Wojtyla
 Il Papa: "Vincere la sporcizia della propria vita
Il Papa: "Vincere la sporcizia della propria vita
 è possibile solo amando e servendo" *
è possibile solo amando e servendo" *ROMA - La prima cosa da imparare è l’amore, per vincere la "sporcizia della propria vita" ed imitare veramente Gesù. E questo vale soprattutto per i sacerdoti. Per la vigilia del venerdì della passione di Cristo, Benedetto XVI concentra il proprio messaggio sulla "sporcizia" nella Chiesa che può essere superata solo amando e servendo. Ratzinger lo dice e lo ripete, ripetendo il gesto di Gesù nell’ultima cena, mentre lava i piedi a dieci uomini, in San Giovanni in Laterano per la messa in Coena Domini nella quale la Chiesa ricorda l’ultima cena di Gesù con i discepoli, a Gerusalemme.
La "sporcizia" era stata al centro anche della riflessione del mattino in San Pietro quando Ratzinger ha ammonito che senza amore non si entra nel regno dei cieli e la veste bianca richiesta da Dio è la veste dell’amore verso Dio stesso e verso i fratelli. Gli abiti del sacerdote, poi, "sono una profonda espressione simbolica di ciò che il sacerdozio significa", del dover "parlare e agire in persona Christi". Ma proprio celebrando, osserva il Papa, "ci accorgiamo tutti quanto siamo lontani da lui, quanta sporcizia esiste nella nostra vita".
Davanti al Papa, sia nella messa del mattino che in quella del pomeriggio, è sfilato quasi tutto il collegio cardinalizio e una miriade di vescovi e sacerdoti. E’ a loro, quindi, che ha voluto ricordare il comandamento dell’amore, i rischi della caduta, della sporcizia, appunto. Un concetto che, pur molto forte e scomodo, Ratzinger deve sentire molto. Già nel 2005, durante le meditazioni della via crucis alla fine del pontificato di Wojtyla, disse: "Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a lui. Quanta superbia, quanta autosufficienza".
Un’autocritica coraggiosa che in quelle settimane di due anni fa ha ripetuto anche quando condannò la "dittatura del relativismo" nella missa pro eligendo pontifice in apertura di conclave. Stigmatizzò le "correnti ideologiche" che hanno agitato "la piccola barca dei cristiani": "marxismo, liberalismo, libertinismo, collettivismo, individualismo radicale, vago misticismo religioso, agnosticismo, sincretismo...". Non faceva sconti il cardinale bavarese. E forse proprio questa franchezza spinse molti, il giorno successivo, ad eleggerlo Papa.
La condanna della sporcizia nella Chiesa è una lettura spirituale, le cui ricadute sul modo di governarla di papa Ratznger si potranno valutare in tempi più lunghi degli attuali due anni di regno. Comunque il tema è presente costantemente alla sua riflessione, come dimostra l’omelia di questa mattina.
Per far rivivere anche drammaticamente l’amore di Gesù per i discepoli e invitare allo spirito di servizio, Benedetto XVI, nella cattedrale di Roma gremita di fedeli, ecclesiastici, membri del corpo diplomatico stasera ha dunque ripetuto la lavanda dei piedi a 12 uomini in rappresentanza dei gruppi laici della diocesi di Roma.
* la Repubblica, 5 aprile 2007
-
> COPYRIGHT !!! Latino: "DEUS CARITAS" = Italiano: "DIO CARO-PREZZO"!!! ... LA DONAZIONE DI COSTANTINO !!!10 aprile 2007, di Federico La Sala
IL TEMA
L’incredulità di Tommaso e lo scandalo del dolore innocente ci aiutano a «purificare ogni falsa concezione di Dio»: lo ha detto Ratzinger nel suo messaggio pasquale, denunciando le guerre, il terrorismo e le ingiustizie del nostro tempo
Il Papa: nel Risorto ferito il vero volto del Signore
«Nelle sue piaghe vediamo le pene d’ogni essere umano»
Fratelli e sorelle del mondo intero, uomini e donne di buona volontà! Cristo è risorto! Pace a voi! Si celebra oggi il grande mistero, fondamento della fede e della speranza cristiana: Gesù di Nazareth, il Crocifisso, è risuscitato dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture. L’annuncio dato dagli angeli, in quell’alba del primo giorno dopo il sabato, a Maria di Magdala e alle donne accorse al sepolcro, lo riascoltiamo oggi con rinnovata emozione: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato!» (Lc 24,5-6).
Non è difficile immaginare quali fossero, in quel momento, i sentimenti di queste donne: sentimenti di tristezza e sgomento per la morte del loro Signore, sentimenti di incredulità e stupore per un fatto troppo sorprendente per essere vero. La tomba però era aperta e vuota: il corpo non c’era più. Pietro e Giovanni, avvertiti dalle donne, corsero al sepolcro e verificarono che esse avevano ragione. La fede degli Apostoli in Gesù, l’atteso Messia, era stata messa a durissima prova dallo scandalo della croce. Durante il suo arresto, la sua condanna e la sua morte si erano dispersi, ed ora si ritrovavano insieme, perplessi e disorientati. Ma il Risorto stesso venne incontro alla loro incredula sete di certezze. Non fu sogno, né illusione o immaginazione soggettiva quell’incontro; fu un’esperienza vera, anche se inattesa e proprio per questo particolarmente toccante. «Venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!"» (Gv 20,19).
A quelle parole, la fede quasi spenta nei loro animi si riaccese. Gli Apostoli riferirono a Tommaso, assente in quel primo incontro straordinario: sì, il Signore ha compiuto quanto aveva preannunciato; è veramente risorto e noi lo abbiamo visto e toccato! Tommaso però rimase dubbioso e perplesso. Quando Gesù venne una seconda volta, otto giorni dopo nel Cenacolo, gli disse: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!». La risposta dell’Apostolo è una commovente professione di fede: «Mio Signore e mio Dio!» (Gv 20,27-28).
«Mio Signore e mio Dio»! Rinnoviamo anche noi la professione di fede di Tommaso. Come augurio pasquale, quest’anno, ho voluto scegliere proprio le sue parole, perché l’odierna umanità attende dai cristiani una rinnovata testimonianza della risurrezione di Cristo; ha bisogno di incontrarlo e di poterlo conoscere come vero Dio e vero Uomo. Se in questo Apostolo possiamo riscontrare i dubbi e le incertezze di tanti cristiani di oggi, le paure e le delusioni di innumerevoli nostri contemporanei, con lui possiamo anche riscoprire con convinzione rinnovata la fede in Cristo morto e risorto per noi. Questa fede, tramandata nel corso dei secoli dai successori degli Apostoli, continua, perché il Signore risorto non muore più. Egli vive nella Chiesa e la guida saldamente verso il compimento del suo eterno disegno di salvezza.
Ciascuno di noi può essere tentato dall’incredulità di Tommaso. Il dolore, il male, le ingiustizie, la morte, specialmente quando colpiscono gli innocenti - ad esempio, i bambini vittime della guerra e del terrorismo, delle malattie e della fame - non mettono forse a dura prova la nostra fede? Eppure paradossalmente, proprio in questi casi, l’incredulità di Tommaso ci è utile e preziosa, perché ci aiuta a purificare ogni falsa concezione di Dio e ci conduce a scoprirne il volto autentico: il volto di un Dio che, in Cristo, si è caricato delle piaghe dell’umanità ferita. Tommaso ha ricevuto dal Signore e, a sua volta, ha trasmesso alla Chiesa il dono di una fede provata dalla passione e morte di Gesù e confermata dall’incontro con Lui risorto. Una fede c he era quasi morta ed è rinata grazie al contatto con le piaghe di Cristo, con le ferite che il Risorto non ha nascosto, ma ha mostrato e continua a indicarci nelle pene e nelle sofferenze di ogni essere umano.
«Dalle sue piaghe siete stati guariti» (1 Pt 2,24), è questo l’annuncio che Pietro rivolgeva ai primi convertiti. Quelle piaghe, che per Tommaso erano dapprima un ostacolo alla fede, perché segni dell’apparente fallimento di Gesù; quelle stesse piaghe sono diventate, nell’incontro con il Risorto, prove di un amore vittorioso. Queste piaghe che Cristo ha contratto per amore nostro ci aiutano a capire chi è Dio e a ripetere anche noi: «Mio Signore e mio Dio». Solo un Dio che ci ama fino a prendere su di sé le nostre ferite e il nostro dolore, soprattutto quello innocente, è degno di fede.
Quante ferite, quanto dolore nel mondo! Non mancano calamità naturali e tragedie umane che provocano innumerevoli vittime e ingenti danni materiali. Penso a quanto è avvenuto di recente in Madagascar, nelle Isole Salomone, in America Latina e in altre regioni del mondo. Penso al flagello della fame, alle malattie incurabili, al terrorismo e ai sequestri di persona, ai mille volti della violenza - talora giustificata in nome della religione -, al disprezzo della vita e alla violazione dei diritti umani, allo sfruttamento della persona. Guardo con apprensione alla condizione in cui si trovano non poche regioni dell’Africa: nel Darfur e nei Paesi vicini permane una catastrofica e purtroppo sottovalutata situazione umanitaria; a Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo, gli scontri e i saccheggi delle scorse settimane fanno temere per il futuro del processo democratico congolese e per la ricostruzione del Paese; in Somalia la ripresa dei combattimenti allontana la prospettiva della pace e appesantisce la crisi regionale, specialmente per quanto riguarda gli spostamenti della popolazione e il traffico di armi; una grave crisi attanaglia lo Zimbabwe, per la quale i ve scovi del Paese, in un loro recente documento, hanno indicato come unica via di superamento la preghiera e l’impegno condiviso per il bene comune.
Di riconciliazione e di pace ha bisogno la popolazione di Timor Est, che si appresta a vivere importanti scadenze elettorali. Di pace hanno bisogno anche lo Sri Lanka, dove solo una soluzione negoziata porrà fine al dramma del conflitto che lo insanguina, e l’Afghanistan, segnato da crescente inquietudine e instabilità. In Medio Oriente, accanto a segni di speranza nel dialogo fra Israele e l’Autorità palestinese, nulla di positivo purtroppo viene dall’Iraq, insanguinato da continue stragi, mentre fuggono le popolazioni civili; in Libano lo stallo delle istituzioni politiche minaccia il ruolo che il Paese è chiamato a svolgere nell’area mediorientale e ne ipoteca gravemente il futuro. Non posso infine dimenticare le difficoltà che le comunità cristiane affrontano quotidianamente e l’esodo dei cristiani dalla Terra benedetta che è la culla della nostra fede. A quelle popolazioni rinnovo con affetto l’espressione della mia vicinanza spirituale.
Cari fratelli e sorelle, attraverso le piaghe di Cristo risorto possiamo vedere questi mali che affliggono l’umanità con occhi di speranza. Risorgendo, infatti, il Signore non ha tolto la sofferenza e il male dal mondo, ma li ha vinti alla radice con la sovrabbondanza della sua Grazia. Alla prepotenza del Male ha opposto l’onnipotenza del suo Amore. Ci ha lasciato come via alla pace e alla gioia l’Amore che non teme la morte. «Come io vi ho amato - ha detto agli Apostoli prima di morire -, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34).
Fratelli e sorelle nella fede, che mi ascoltate da ogni parte della terra! Cristo risorto è vivo tra noi, è Lui la speranza di un futuro migliore. Mentre con Tommaso diciamo: «Mio Signore e mio Dio!», risuoni nel nostro cuore la parola dolce ma impegnativa del Signore: «Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà» (Gv 12,26). Ed anche noi, uniti a Lui, disposti a spendere la vita per i nostri fratelli (cfr 1 Gv 3,16), diventiamo apostoli di pace, messaggeri di una gioia che non teme il dolore, la gioia della Risurrezione. Ci ottenga questo dono pasquale Maria, Madre di Cristo risorto. Buona Pasqua a tutti!
© Copyright 2007 Libreria Editrice Vaticana
-
> COPYRIGHT !!! Latino: "DEUS CARITAS" = Italiano: "DIO CARO-PREZZO"!!! ... LA DONAZIONE DI COSTANTINO !!!11 aprile 2007, di Federico La Sala
Preti pedofili
Chi ha deciso in Vaticano di sottrarre i preti pedofili alla magistratura
di Pino Nicotri
Sorpresa: ecco chi, come e quando ha deciso in Vaticano di sottrarre i preti pedofili alla magistratura. Non lo indovinereste mai... *
Prima si sono rivolti con fiducia alla Chiesa, anziché ad avvocati e tribunali, inviando fin dal gennaio 2004 alla curia di Firenze esposti e memoriali sulle violenze sessuali ai danni di minori consumate per anni dal parroco Lelio Cantini, titolare della parrocchia Regina della Pace. Con la complicità di una donna, la solita “veggente” di turno le cui visioni di Gesù servivano alla selezione degli “eletti”, Cantini ha imperversato per anni e anni imponendo violenze, psicologiche e fisiche, fra cui quella sistematicamente rivolta a ragazzine di dieci, quindici, diciassette anni, di avere rapporti sessuali con lui, come forma, diceva, di “adesione totale a Dio”, facendo credere a ognuno e a ognuna di essere il prescelto e intimando il segreto assoluto pena il “castigo divino”. A furia di insistere, le vittime di Cantini hanno ottenuto qualche incontro con l’allora arcivescovo Silvano Piovanelli, con l’arcivescovo Ennio Antonelli e con l’ausiliare Claudio Maniago. Ma tutto quello che sono riusciti a ottenere è stato il trasferimento del parroco mascalzone in un’altra parrocchia della stessa diocesi nel settembre 2005, cioè ben 20 mesi dopo gli esposti, motivato ufficialmente “per motivi di salute”, vale a dire senza che venisse né denunciato alla magistratura né svergognato in altro modo né privato dell’abito talare con la sospensione “a divinis”.
Deluse, le vittime e i loro familiari si sono allora rivolti al papa, con una lettera del 20 marzo 2006 recante in allegato i dettagliati memoriali di dieci tra le almeno venti vittime di abusi. “Non vogliamo sentirci domani chiedere conto di un colpevole silenzio”, hanno spiegato al papa il 13 ottobre 2006 con una nuova, nella quale parlano di “iniquo progetto di dominio sulle anime e sulle esistenze quotidiane” e lamentano come a “quasi due anni” dall’inizio delle denunce dalla Chiesa fiorentina non fosse ancora arrivata né “una decisa presa di distanza” dai personaggi coinvolti nella vicenda né “una scusa ufficiale” e neppure “un atto riparatore autorevole e credibile”.
Alla loro missiva ha risposto il cardinale Camillo Ruini, ma in un modo francamente incredibile, di inaudita ipocrisia e mancanza di senso della responsabilità. Il famoso cardinale, tanto impegnato nella lotta incessante contro la laicità dello Stato italiano, a fronte alle porcherie del suo sottoposto si rivela quanto mai imbelle, omertoso e di fatto complice: tutta la sua azione si riduce a una lettera agli stuprati per ricordare loro che il parroco criminale il 31 marzo ha lasciato anche la diocesi e per augurare che il trasferimento “infonda serenità nei fedeli coinvolti a vario titolo nei fatti”. Insomma, fuor dalle chiacchiere e dall’ipocrisia, Ruini si limita a raccomandare che tutti si accontentino della rimozione di Cantini e se ne stiano pertanto d’ora in poi zitti e buoni, paghi del fatto che il prete pedofilo e stupratore sia stato spedito a soddisfare le sue brame carnali altrove. Come a dire che i parenti delle vittime della strage di piazza Fontana o del treno Italicus si sentano rispondere dal Capo dello Stato non con il dovuto processo ai colpevoli, bensì con una letterina buffetto sulle guance che annuncia, magno cum gaudio, che i colpevoli anziché andare in galera sono stati trasferiti in altri uffici e che pertanto augura, cioè di fatto ordina, “serenità” tra i superstiti e i parenti delle vittime. Un simile comportamento oggi non ce l’hanno neppure gli Stati Uniti: è vero che non permettono a nessuno Stato estero di giudicare i propri soldati quali che siano i crimini da loro commessi, da Mai Lay al Cermis, da Abu Graib a Guantanamo e Okinawa, ma è anche vero che gli Usa anziché stendere il velo omertoso del segreto li processa pubblicamente in patria e non sempre in modo compiacente.
Come sempre la Chiesa si comporta in tutto il mondo come uno Stato nello Stato, con la pretesa non solo di intervenire - come è particolarmente evidente in Italia - contro l’autonomia della politica, ma per giunta di sottrarre il proprio personale alla magistratura competente. Il dramma però è che Ruini ai fedeli fiorentini che hanno subìto quello che hanno subìto non poteva rispondere altrimenti, perché - per quanto possa parere incredibile - a voler imporre il silenzio, anzi il “segreto pontificio” sui reati gravi commessi dai religiosi, compresi gli stupri di minori, è stato proprio l’attuale papa, Ratzinger. Con una ben precisa circolare inviata ai vescovi di tutto il mondo il 18 maggio 2001 e che più avanti riproduciamo per intero, l’allora capo della Congregazione per la dottrina della fede, come si chiama oggi ciò che una volta era la “Santa” (!) Inquisizione e poi il Sant’Ufficio, non solo imponeva il segreto su questi orribili argomenti, ma avvertiva anche che a volere una tale sciagurata direttiva era il papa di allora in persona. Vale a dire, quel Wojtyla che più si ha la coda di paglia e più si vuole sia fatto “santo subito”, in modo da sottrarlo il più possibile alle critiche per i suoi non pochi errori.
Da notare che per quell’ordine scritto diramato a tutti i vescovi assieme all’allora suo vice, cardinale Tarcisio Bertone (oggi ancor più potente perché scelto dal papa tedesco come nuovo Segretario di Stato, cioè ministro degli Esteri del Vaticano), Ratzinger nel 2005 è stato incriminato negli Stati Uniti per cospirazione contro la giustizia in un processo contro preti pedofili in quel di Houston, nel Texas. Per l’esattezza, presso la Corte distrettuale di Harris County figurano imputati il responsabile della diocesi di Galveston Houston, arcivescovo Joseph Fiorenza, i sacerdoti pedofili Juan Carlos Patino Arango e William Pickand, infine anche l’attuale pontefice. Questi è accusato di avere coscientemente coperto, quando era prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, i sacerdoti colpevoli di abusi sessuali su minori. Da notare che l’omertà e la complicità di fatto garantita dalla circolare Ratzinger-Bertone ha danneggiato non solo la giustizia di quel processo, ma anche dei molti altri che hanno scosso il mondo intero scoperchiando la pentola verminosa dei religiosi pedofili negli Stati Uniti (dove la Chiesa ha dovuto pagare centinaia di milioni di dollari in una marea di risarcimenti) e in altre parti del mondo. Un porporato che si è visto denunciare dalle vittime un folto gruppo di preti, anziché punire i colpevoli li ha protetti facendoli addirittura espatriare nelle Filippine, in modo da sottrarli per sempre alla giustizia.
Sono emersi casi imbarazzanti anche in Austria e Polonia, con l’aggravante che si trattava delle massime cariche ecclesiastiche, tra le quali l’arcivescovo di Cracovia pedofilo Julius Paetz, la cui pedofilia era nota fin da quando lavorava in Vaticano nell’anticamera del papa suo connazionale, Wojtyla, e proprio negli anni in cui è “misteriosamente” scomparsa la ragazzina cittadina vaticana Emanuela Orlandi. Ma a scorrere le cronache dei giornali locali si scopre che anche in Italia le condanne di religiosi per pedofilia abbondano, solo che - pur essendo gli stupratori scoperti solo la punta dell’iceberg - vengono tenute accuratamente nascoste. E perché vengano nascoste lo si capisce finalmente bene, e in modo dimostrato, leggendo il testo della circolare emanata dall’ex Sant’Ufficio.
A muovere l’accusa contro l’attuale pontefice, documenti vaticani alla mano, è l’agguerritissimo avvocato Daniel Shea, difensore di tre vittime della pedofilia dei religiosi di Galveston Houston. E Ratzinger sarebbe stato trascinato in tribunale, forse in manette data la gravità del reato, se non fosse nel frattempo diventato papa. Nel settembre 2005 infatti il ministero della Giustizia, su indicazione di Bush e Condolezza Rice, ha bloccato il processo contro Ratzinger accogliendo la richiesta dell’allora segretario di Stato del Vaticano, Angelo Sodano, di riconoscere anche al papa, in quanto capo dello Stato pontificio, il diritto all’immunità riconosciuto non solo dagli Stati Uniti per tutti i capi di Stato. A questo punto è doveroso e niente affatto scandalistico porsi una domanda, decisamente scomoda: quanto ha pesato nella scelta di eleggere papa proprio Ratzinger la necessità di sottrarlo alla giustizia americana e di difenderlo per avere in definitiva eseguito la volontà del pontefice precedente? C’è anche un altro particolare: di solito non si riesce a portare in tribunale anche i superiori dei preti stupratori perché in un modo o nell’altro evitano di ricevere l’atto di accusa, specie se risiedono sia pure solo ufficialmente in Vaticano. Ratzinger invece l’atto di citazione ha accettato di riceverlo: si può escludere lo abbia fatto per obbligare i suoi colleghi cardinali ad eleggerlo papa quando Wojtyla - sempre più malato - fosse venuto a mancare?
Come che sia, Shea però non demorde. Due anni fa è venuto a Roma per protestare in piazza S. Pietro assieme ai radicali in occasione della Giornata mondiale contro la pedofilia. E oggi si dice pronto a ricorrere fino alla Suprema Corte di Giustizia degli Stati Uniti per evitare che i firmatari della circolare vaticana che protegge i sacerdoti pedofili la facciano del tutto franca. Intanto dobbiamo constatare con sbigottimento che i tre nomi più impegnati nella lotta contro la laicità dello Stato italiano e del suo parlamento, vale a dire Ratzinger, Ruini e Bertone, sono stati colti con le mani nel sacco della sottrazione alla magistratura dei preti pedofili e strupratori di minori.
Ecco il testo integrale tradotto dal latino dell’ordine impartito per iscritto da Ratzinger e Bertone:
«LETTERA inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e prelati interessati, circa I DELITTI PIU’ GRAVI riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001
Per l’applicazione della legge ecclesiastica, che all’art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: “[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”, era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l’esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica.
Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare “i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiché l’istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant’Offizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici.
Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l’hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.
I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:
 I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’eucaristia, cioè:
I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’eucaristia, cioè:1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate:
2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima;
3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;
4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica;
 Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo;
2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso;
3° la violazione diretta del sigillo sacramentale;
 Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.
Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione.
Ogni volta che l’ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all’ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.
Si deve notare che l’azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.
Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l’istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.
Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell’uno e dell’altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.
Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati prelci sia una sollecita cura pastorale.
Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.
Joseph card. Ratzinger, prefetto.
Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario»
::::::::::::
Come avrete notato, lo scippo della pedofilia alla magistratura civile e penale di tutti gli Stati dove viene consumata è nascosto tra molte parole che parlano di tutt’altro. E il ruolo “giudiziario”, cioè di fatto omertoso, della Congregazione ex Sant’Ufficio è comunque confermato in pieno dalla vicenda fiorentina. A difendere i fedeli violati sono scesi in campo anche i locali preti ordinari e a causa delle loro insistenze il cardinale Antonelli il 17 gennaio ha scritto alle vittime di Cantini che al termine di un “processo penale amministrativo” tutto interno alla curia e sentita per l’appunto la Congregazione per la dottrina della fede, l’ex parroco “non potrà né confessare, né celebrare la messa in pubblico, né assumere incarichi ecclesiastici, e per un anno dovrà fare un’offerta caritativa e recitare ogni giorno il Salmo 51 o le litanie della Madonna”. Tutto qui! Di denuncia alla magistratura, neppure l’ombra, e del resto il “segreto pontificio” non lascia scampo. Per uno che per anni e anni se l’è fatta da padrone anche con il sesso di ragazzine di soli 10 anni - e di 17 le più “vecchie” - senza neppure scomodarsi con un viaggio nella Thailandia paradiso dei pedofili, si tratta di una pena piuttosto leggerina.... Da far felice qualunque pedofilo incallito! Quanto alle vittime, Antonelli ha anticipato l’ineffabile Ruini: visto che “il male una volta compiuto non può essere annullato”, il cardinale invita le pecorelle struprate a “rielaborare in una prospettiva di fede la triste vicenda in cui siete stati coinvolti”, e a invocare da Dio “la guarigione della memoria”.
Ma a guarire, anche dai troppi condizionamenti opportunistici della memoria, deve essere semmai il Vaticano. E infatti i fedeli fiorentini, che hanno letto la missiva del cardinale con “stupore e dolore”, hanno deciso di non fermarsi. Finora non hanno fatto nemmeno causa civile, ma d’ora in poi, dicono, “nulla è più escluso”. I preti schierati dalla loro parte chiedono al papa - nella lettera inviata tramite la Segreteria di Stato oggi retta proprio da Bertone! - “un processo penale giudiziario”, che convochi testimoni e protagonisti, e applichi “tutte le sanzioni previste dall’ordinamento ecclesiastico”. Chiedono inoltre che Cantini, colpevole di avere rovinato non poche vite, sia “privato dello stato clericale” anche “a tutela delle persone che continuano a seguirlo”.
Però, come avrete notato, neppure i buoni preti fiorentini si sognano di fare intervenire la magistratura dello Stato italiano. I panni sporchi si lavano in famiglia... Che è il modo migliore di continuare a non lavarli. Come per la scomparsa di Emanuela Orlandi. 08.04.2007.
Pino Nicotri
Nella foto, Pino Nicotri giornalista investigativo del settimanale “L’Espresso” e autore di importanti libri inchiesta tra i quali “Mistero Vaticano - La scomparsa di Emanuela Orlandi” Kaos Edizioni.
Fonte e commenti:
* IL DIALOGO, Martedì, 10 aprile 2007
-
> COPYRIGHT !!! Latino: "DEUS CARITAS" = Italiano: "DIO CARO-PREZZO"!!! ... LA DONAZIONE DI COSTANTINO !!!12 aprile 2007, di Federico La Sala
 Il nunzio assente alla cerimonia per la Shoah
Il nunzio assente alla cerimonia per la Shoah
 E’ polemica tra Israele e il Vaticano
E’ polemica tra Israele e il VaticanoMons. Franco non sarà alla commemorazione. Protesta per una foto di Pio XII sotto la quale è scritto che fu personalità controversa in relazione al genocidio. Gelida la Livni: "Ciascuno segue la sua coscienza" *
 L’ambasciatore della Santa Sede a Gerusalemme contesta la decisione di esporre
L’ambasciatore della Santa Sede a Gerusalemme contesta la decisione di esporre
 la foto di papa Pacelli con una didascalia che ne condanna la "posizione ambigua"
la foto di papa Pacelli con una didascalia che ne condanna la "posizione ambigua" Protesta del nunzio apostolico in Israele
Protesta del nunzio apostolico in Israele
 contro biasimo verso Pio XII sulla Shoah
contro biasimo verso Pio XII sulla ShoahIl ministro degli Esteri Livni: "Ciascuno si comporti secondo la propria coscienza" *
CITTA’ DEL VATICANO - Il nunzio apostolico in Israele, monsignor Antonio Franco, non parteciperà all’annuale cerimonia di commemorazione della Shoah, alla quale presenzia tutto il corpo diplomatico, che si terrà la settimana prossima allo Yad Vashem (il museo dell’Olocausto a Gerusalemme, ndr), per protestare contro la decisione di esporre una foto di Pio XII nel memoriale della Shoah, con una didascalia che condanna la posizione del Pontefice, ritenuta ambigua, sullo sterminio degli ebrei.
"Ho scritto - spiega il nunzio - una lettera al direttorato dello Yad Vashem spiegando che già l’anno scorso avevamo fatto presente la nostra difficoltà. Nella risposta alla mia lettera che vedo oggi su alcuni giornali israeliani si dice che non si può cambiare la verità storica. I fatti non si possono cambiare ma di questi si è data un’interpretazione contraria anche a molte altre verità storiche e soprattutto a tutta un’altra storiografia che interpreta in altro modo".
"Mi fa male andare allo Yad Vashem e vedere Pio XII così presentato e questo ho fatto presente nella lettera - ha detto ancora monsignor Franco - Certamente il Papa non può essere messo in mezzo a uomini che dovrebbero vergognarsi per quanto compiuto contro gli ebrei. Pio XII non dovrebbe vergognarsi per tutto quello che ha fatto per la salvezza degli ebrei, messo in risalto da fonti storiche".
"La cerimonia allo Yad Vashem ha il fine di onorare la memoria delle vittime della Shoah - ha commentato il ministro degli Esteri israeliano Tzipi Livni - l’evento più traumatico nella storia del popolo ebreo e tra i più traumatici nella storia dell’Umanità. Per quanto riguarda la partecipazione alla cerimonia, ciascuno si comporti secondo ciò che gli dice la sua coscienza".
* la Repubblica, 12 aprile 2007
-
> COPYRIGHT !!! Latino: "DEUS CARITAS" = Italiano: "DIO CARO-PREZZO"!!! ... LA DONAZIONE DI COSTANTINO !!!13 aprile 2007, di Federico La Sala
"Il Papa rinuci all’ermellino"
Appello che la Lega Antivivisezione a Benedetto XVI: rinunci alla pelliccia
ROMA. In occasione dell’evento che si terrà il 22 aprile presso l’Università di Pavia, durante il quale Papa Benedetto XVI benedirà l’Ateneo, la Lav chiede al Pontefice di «rinunciare a indossare la pelliccia di ermellino», richiesta dalla sartoria vaticana all’atelier di Riccardo Ravizza ’Annabellà, che dovrebbe ornare la mantellina del Santo Padre. Lo si legge in un comunicato della stessa Lega antivivisezione.
«Nel rispetto della sacralità della vita di ogni specie vivente, invitiamo il Santo Padre a compiere una scelta di alto valore religioso ed etico rinunciando in questa occasione, e per il futuro, a indossare capi realizzati in pelliccia», dichiara Roberto Bennati, vicepresidente della Lav. «Sarebbe un lodevole esempio di carità cristiana, tanto più significativo in quanto compiuto dalla massima autorità ecclesiastica. Ricordiamo che Giovanni Paolo II, parlando del ’soffio divinò presente anche negli animali e non soltanto nell’uomo, aveva ridato a queste creature valore e dignità».
* La Stampa, 13/4/2007 (17:8)
-
> COPYRIGHT !!! Latino: "DEUS CARITAS" = Italiano: "DIO CARO-PREZZO"!!! ... LA DONAZIONE DI COSTANTINO !!!14 aprile 2007, di Federico La Sala
NAZARET senza acca ...... e "Deus caritas est" . anche, purtroppo, e da secoli!!!
-
> COPYRIGHT !!! Latino: "DEUS CARITAS" = Italiano: "DIO CARO-PREZZO"!!! ... LA DONAZIONE DI COSTANTINO !!!5 maggio 2007, di Federico La Sala
INTERVISTA Ha ragione il Papa: solo eros e agape rendono possibile la conoscenza, anzi fanno dell’altro una persona. Parla il filosofo Marion
Senza amore non si pensa
«Da Galileo in poi, gli affetti appaiono secondari in filosofia rispetto alla ragione. Invece non sono soltanto passioni dell’animo, bensì costituenti originari dell’ego»
Da Parigi Daniele Zappalà (Avvenire, 05.05.2007)
«
L’amore è molto più che una passione o un affetto. In un certo senso, è molto più di una conoscenza. È ciò che rende possibile la stessa conoscenza». Lo sostiene è il filosofo francese Jean-Luc Marion, successore di Emmanuel Lévinas alla Sorbona e di Paul Ricoeur all’Università di Chicago. Il Fenomeno Erotico, appena tradotto in Italia per Cantagalli (pp. 288, euro 18,50), ha già suscitato forti reazioni in Francia.
Professore, lei denuncia l’indifferenza della filosofia moderna verso l’amore. Come la spiega?
«Dall’epoca di Galileo in poi, gli affetti appaiono secondari in filosofia rispetto al pensiero teoretico, la cui analisi si basa sulla conoscenza e la rappresentazione. Soprattutto, si comincia a parlare di odio, amore e dei diversi affetti solo sulla base di un ego già costituito. L’amore, in altri termini, è visto come una passione dell’animo e non come un costituente originario dell’ego. Ciò che cerco di mostrare, invece, è che l’amore e l’odio precedono lo stesso ego e giungono in vista della sua costituzione».
Può farci qualche esempio?
«L’ego si esprime, per così dire, sotto forma di figure o stadi amorosi. Innanzitutto, la situazione di voler essere amati. Poi, voler amare a condizione di essere amati. In seguito, prendere la decisione di amare senza essere amati».
Il pensiero contemporaneo è attraversato dal tema dell’angoscia verso la complessità delle relazioni sociali. Esistono oggi maggiori ostacoli al desiderio di amare?
«Questa cosiddetta angoscia, soprattutto rispetto alle relazioni sociali, diventa comprensibile a mio avviso come una manifestazione dell’amore. L’angoscia non esisterebbe se il nostro rapporto col mondo fosse esclusivamente d’interesse, di conoscenza e di rappresentazione. Questo rapporto col mondo è in realtà fin dall’inizio permeato dall’amore, erotizzato in senso lato. Ciò è vero, del resto, anche per la stessa attività filosofica. Fin dall’origine, la filosofia è amor e della saggezza e non saggezza. Prima della conoscenza, esiste l’amore della conoscenza».
Comunemente, l’amore è immaginato come una pura emozione slegata da solidi appigli razionali. Che ne pensa?
«In un certo senso, l’amore è una forma di conoscenza. È solo amandola o odiandola che posso avere davvero accesso a una persona. La pura emozione, il puro piacere, il puro odio diventano significativi all’interno di questo processo di accesso all’altro o a se stessi. A mio avviso, è decisivo comprendere che esiste sempre un itinerario fra due soggetti, un itinerario che obbedisce a una propria logica».
Una logica che include il dono...
«Questo legame fra amore e dono appare in una situazione: quando l’individuo comprende chiaramente che è impossibile amare solo a condizione che l’altro ami. Una forma, o se vogliamo uno stadio, molto comune di amore consiste nell’esser pronti ad amare a condizione che l’altro ci ami. Ma questa reciprocità in realtà rende impossibile l’amore, riducendolo come a una forma di contratto. Un contratto, soprattutto, che non può essere rispettato. Se per amare attendo che l’altro mi ami, dovrò attendere molto a lungo e, in ogni caso, amerò molto poco. Per amare, occorre in realtà far sempre il primo passo. Se l’amore è visto come uno scambio e non come un dono, esso non supererà mai un certo stadio di maturazione e rischierà sempre di precipitare».
Amare significa anche veder emergere l’altro come persona?
«Direi che l’altro diventa persona all’interno di un processo d’amore. Nella vita di tutti i giorni, in genere non incontriamo gli altri in qualità di persone, ma in una funzione sociale che altri potrebbero ricoprire al loro posto. Siamo una persona se amiamo o siamo amati. In caso contrario, rischiamo di restare esseri umani in un senso più spersonalizzato». Internet e le comunicazioni a distanza creano talora l’impressione di forme di passione interpersonale, di «amore», senza mediazione del volto. Ciò è davvero possibile? «Solo il linguaggio, compreso quello del volto, può creare una situazione di amore. Una relazione sessuale senza la parola non è erotica. Mentre una relazione non sessuale con la parola può spesso divenire erotica in senso lato. Anche il volto parla, è essenzialmente una parola o un principio di parola».
In che senso l’amore umano può divenire trascendente?
«L’amore fra esseri umani è trascendente perché trascende l’individualità di chi ama in direzione di chi è amato. Da un punto di vista cristiano, i comandamenti dell’amore verso Dio e verso il prossimo corrispondono a un unico imperativo. Per questo, le regole dell’amore di Dio e dell’amore dell’altro possono essere confrontate».
Che impressione le ha lasciato la prima enciclica di Papa Benedetto XVI dedicata all’amore?
«Trovo molto positivo che l’insegnamento del Magistero si concentri sul centro della rivelazione cristiana. È strano, in proposito, che quest’enciclica sia apparsa a qualcuno come un’originalità. Trovo che la distinzione fra eros e agape sia molto utile, soprattutto per ritrovare l’origine comune e l’unità dell’amore. Tale distinzione non dovrebbe invece mai lasciar pensare che esistono due tipi di amore e credo si tratti di uno dei punti più forti dell’enciclica. Trovo perfettamente giusto e come un’innovazione il fatto di ricordare questa verità della filosofia e, credo, anche della teologia spirituale. L’amore ha una propria razionalità, unica ed universale. Una razionalità che non esige la ricerca della reciprocità».
-
> COPYRIGHT !!! Latino: "DEUS CARITAS" = Italiano: "DIO CARO-PREZZO"!!! ... LA DONAZIONE DI COSTANTINO !!!5 maggio 2007, di Federico La Sala
IN LUNGHE CATENE DIFFICILI DA SPEZZARE
di AUGUSTO CAVADI *
Per diventare misogino, essere cattolico non e’ necessario. Ma aiuta. Non e’ necessario: infatti i rudimenti della concezione della donna come maschio quasi perfetto me li ha impartiti un padre miscredente, laico, socialista (pre-craxiano: nenniano). Ma aiuta: infatti, quando - con stupore e disappunto da parte dei miei genitori - sono entrato nell’associazionismo cattolico, ho ben presto misurato la distanza fra la rivoluzionarieta’ di certe asserzioni ed il conservatorismo della pratica quotidiana. Da una parte il papa scriveva che l’essere umano puo’ considerarsi "imago Dei" solo in quanto coppia; dall’altra, si dava (e si da’) per scontato che una persona di sesso femminile non possa presiedere una comunita’ celebrante. Il mio esodo - progressivo, ma inarrestabile - dalla cultura cattolica passo’ per un episodio preciso. Un prete piu’ anziano di me - peraltro tra i piu’ preparati della sua generazione - volendo esprimere con forza il suo dissenso da una mia opinione, trovo’ spontaneo apostrofarmi con un inequivoco: "Ma hai proprio un cervello da femmina!". Obiettai solo, con un sorriso amaro, che speravo di averne meta’ femminile e meta’ maschile: in modo che, junghianamente, sarei potuto essere "completo".
So che certe distinzioni risultano fastidiose o, per lo meno, farraginose. Ma non sempre si possono evitare. Per esempio, quella suggerita da un’acuta fucilata di Nietzsche (recentemente definito da Rene’ Girard il piu’ grande teologo dopo san Paolo): c’e’ stato un solo cristiano ed e’ morto sulla croce. Che, tradotto in altri termini, significa: una cosa e’ stata la "buona notizia" annunziata dal maestro nomade di Galilea ed un’altra la dottrina cattolica (e, piu’ in generale, cristiana) che si e’ sviluppata a partire da quel seme. La psicanalista e teologa protestante Hanna Wolff lo ha spiegato in uno dei quattro o cinque libri che mi hanno cambiato la vita (Gesu’, la maschilita’ esemplare, Queriniana, Brescia 1985): il Nazareno (per quanto possiamo cogliere da un’esegesi accurata dei quattro vangeli) ha saputo accettare il femminile dentro di se’ e, proprio per questo, non aver paura del femminile fuori di se’. Egli ha dunque rotto con la tradizione patriarcale precedente, ma la sua rottura e’ stata tanto eclatante che i discepoli non sono riusciti a reggerla: e, subito dopo la sua morte, hanno attivato processi di normalizzazione. Col risultato che, dopo la breve parentesi gesuana, l’antifemminismo ha ripreso vigore, si e’ fatto senso comune e ha improntato di se’ l’occidente cristiano.
Se ci chiediamo se questa mentalita’ della disparita’ ontologica e psicologica fra maschi e femmine (dura a destrutturarsi persino oggi, dopo decenni di femminismo teorico e militante) spieghi, da sola, l’impressionante catena di violenza contro le donne, non possiamo che rispondere negativamente. Che cosa, allora, trasforma una cultura maschilista in pratiche prevaricatrici? Ho l’impressione che entri in gioco non questo o quell’altro fattore, bensi’ un groviglio - difficilmente solubile - di fattori. Tra cui primeggia una connotazione peculiare dell’immagine femminile agli occhi di noi uomini: la diversita’. Sin da bambino, il pianeta-donna ha esercitato nei miei confronti una duplice, contraddittoria, forza: di attrazione e di paura, di curiosita’ e di diffidenza, di desiderio e di minaccia. Per ragioni varie, che solo in minima parte potrei attribuire a meriti miei, maturare come persona ha significato - tra l’altro - sciogliere questa ambiguita’ e lasciar prevalere, di fronte ad ogni diversita’ (le donne, ma anche gli omosessuali, gli immigrati di colore, i portatori di handicap fisici e psichici...), il sapore della familiarita’ rispetto al sentimento di estraneita’. Ovviamente, familiarita’ non equivale ad omologazione. Avvertire cio’ che, in radice, accomuna non implica cecita’ riguardo alle differenze che interpellano le nostre certezze.
Qui, forse, uno dei bivi decisivi. C’e’ chi accetta la sfida della diversita’ (e, nel caso di maschi, del femminile come metafora di ogni diversita’) per mettersi in gioco, per riaffermare alcune convinzioni ma anche liberarsi da pregiudizi e da errati giudizi; e c’e’ chi non la regge e, per quanto sta in lui, tenta di sopprimerla. Non e’ un caso che, di solito, le idiosincrasie s’inanellino in lunghe catene difficili da spezzare: misoginia, omofobia, razzismo... E’ di per se’ evidente che questa mentalita’ sia - gia’ a livello ideologico - violenta. Ma, poiche’ in genere il diverso e’ piu’ debole (fisicamente, economicamente, militarmente...), il pensiero omologante ha mille occasioni per farsi gesto prepotente: stupro, derisione, schiavizzazione... Quando un soggetto allergico alla diversita’ si impossessa - sessualmente o socialmente - dell’altro, ha la sensazione di aver risolto molti problemi in un solo colpo: da una parte ha soddisfatto attrazione, curiosita’, desiderio; dall’altra ha cancellato dal proprio orizzonte ogni fonte di paura, di diffidenza, di minaccia. Ma, proprio nella misura in cui riesce a fagocitare e a spazzar via ogni alterita’, egli desertifica il piccolo mondo che lo circonda e costruisce da se’ la prigione dell’isolamento. Ecco un punto nevralgico: chi progetta ed esercita violenza, nonostante le intenzioni, si condanna alla solitudine. Come i signorotti medievali, deve scavare fossati sempre piu’ profondi per distanziarsi dagli estranei: ma, con cio’, trasforma in gabbie dorate il suo stesso castello. Sara’ proprio perche’ amo la solitudine come opzione, ma la detesterei se la sperimentassi in tempi e modi non programmati, che mi viene abbastanza facile sottrarmi alla tentazione di usare violenza. Cio’ non significa, purtroppo, che di fatto non sia stato troppe volte violento - nel corso della vita - con persone diverse da me per indole, formazione e prospettive (quali, per esempio, delle donne con cui ho condiviso tratti di strada importanti): ma ogni volta che non ho saputo gestire il conflitto, provocando nell’altro/a la decisione di fuggire, l’ho considerata - nonostante le apparenze - una mia sconfitta.
* Fonte: NOTIZIE MINIME DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO Numero 80 del 5 maggio 2007 - articolo apparso su "Mezzocielo", anno XV, n. 1, 2007, dal titolo originale "Un uomo davanti al pianeta donna"
-
> COPYRIGHT !!! Latino: "DEUS CARITAS" = Italiano: "DIO CARO-PREZZO"!!! ... LA DONAZIONE DI COSTANTINO !!!13 maggio 2007, di Federico La Sala
Il Papa parla Conferenza degli alti prelati del continente, denunciando i rischi della globalizzazione e rilegittimando "l’opzione preferenziale per i poveri"
 Benedetto XVI ai vescovi latinoamericani
Benedetto XVI ai vescovi latinoamericani
 "Falliti Marx e capitalismo, serve Gesù" *
"Falliti Marx e capitalismo, serve Gesù" *APARECIDA - Da più di cinque secoli il cristianesimo, integrandosi con le etnie indigene, ha creato in America latina "una grande sintonia pur nella diversità di culture e lingue". E oggi, anche se "l’identità cattolica" del continente è minacciata, il cristianesimo resta decisivo per la dignità e lo sviluppo integrale di uomini e donne. E questo tanto più davanti al fallimento di marxismo e capitalismo, con la loro promessa di creare strutture sociali "giuste" che avrebbero automaticamente "promosso la moralità comune".
E’ il messaggio di Benedetto XVI ai vescovi latinoamericani, riuniti nel santuario di Aparecida per la loro quinta Conferenza generale. Il Papa dichiara la "continuità" tra questa e le precedenti riunioni, parla di situazione cambiata in questi anni, a causa dei risvolti negativi della globalizzazione, e denuncia il "rischio" che i grandi monopoli trasformino "il lucro in valore supremo". Rilegittima inoltre la "opzione preferenziale per i poveri", cara alla Teologia della liberazione, dichiarandola "implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi".
Davanti a 266 vescovi - 162 membri effettivi, 81 invitati, 8 osservatori e 15 periti - che da domani e fino al 31 maggio si interrogheranno su come costruire il futuro della Chiesa, insidiata da secolarizzazione e sette, nel più grande continente cattolico del mondo - Benedetto XVI si pone in una prospettiva diversa rispetto a Giovanni Paolo II, che parlò di luci e ombre dell’introduzione del cristianesimo in America latina, riconoscendo che alcuni cristiani portarono la fede, ma anche forme di crudele colonizzazione. Il cristianesimo, sottolinea invece il papa-teologo, si è integrato nelle etnie, ha creato unità e non è estraneo a nessuna cultura e persona.
Non hanno dunque senso certe tendenze indigeniste: "L’utopia di tornare a dare vita alle religioni precolombiane, separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, non sarebbe un progresso, bensì un regresso, una involuzione". Il cristianesimo sa invece affermare che "i popoli latinoamericani e dei Caraibi hanno diritto a una vita piena", "con alcune condizioni più umane", senza "fame e ogni forma di violenza".
Benedetto Xvi spiega inoltre che "la Chiesa non fa proselitismo. Si sviluppa per attrazione": probabilmente, un modo per sottolineare in maniera indiretta le differenze, rispetto alle sette pentecostali molto presenti in America Latina.
E con la presenza ad Aparecida, il viaggio in Brasile del Pontefice volge alla fine. Nella notte italiana, è previsto il volo di ritorno, verso il Vaticano.
* la Repubblica, 13 maggio 2007
-
> COPYRIGHT !!! Latino: "DEUS CARITAS" = Italiano: "DIO CARO-PREZZO"!!! ... LA DONAZIONE DI COSTANTINO !!!7 luglio 2007, di Federico La Sala
AL SERVIZIO DEL MONDO
In attivo i conti del Vaticano
A finanziare le attività degli uffici della Curia, che non producono ricavi, provvedono Conferenze episcopali, diocesi e istituti religiosi: le loro offerte sono aumentate nel 2006 passando da 73,9 a 86 milioni di euro
Da Roma Salvatore Mazza (Avvenire, 07.07.2007)
Si è chiuso in attivo, per il terzo anno consecutivo, il bilancio consolidato della Santa Sede. Entrate per 227 milioni 815 mila euro, e uscite per 225 milioni e 409 mila euro, con un saldo positivo di poco oltre i 2,4 milioni di euro. Una «buona notizia», dunque, come ha sottolineato ieri mattina il cardinale Sergio Sebastiani, presidente della Prefettura degli Affari economici, nella conferenza stampa convocata per presentare e "spiegare" i numeri del bilancio consolidato 2006, anticipati qualche giorno fa.
Un «risultato positivo», l’attivo conseguito, pur se «rappresenta il valore meno elevato» dopo quelli registrati nel 2005 (+9,7 milioni) e nel 2004 (+3,1 milioni). Nel bilancio sono conteggiati i costi «di tutte le Amministrazioni pontificie, oltre alle 118 Sedi di rappresentanza pontificia sparse in tutto il mondo e le nove Sedi presso gli organismi internazionali». Nel corso dell’incontro, introdotto dal direttore della Sala Stampa padre Federico Lombardi, e presenti monsignor Franco Croci, segretario della Prefettura degli Affari economici, e il ragioniere generale Paolo Trombetta, sono state passate in esame le diverse voci iscritte a bilancio. A iniziare ovviamente dalle attività istituzionali, ossia quelle svolte dai Dicasteri e gli Uffici della Curia Romana, ovvero dagli «organismi che assistono da vicino il Santo Padre nella missione di pastore universale a servizio delle Chiese locali, come anche a beneficio dell’umanità, come operatori di pace», e che «non producono ricavi - ha sottolineato Sebastiani - e per questo sono soggetti alla prescrizione canonica 1271 che invita i vescovi a venire incontro liberamente alle attività della Santa Sede».
Il canone richiamato è quello che invita Conferenze episcopali, diocesi, istituti religiosi, fedeli ed Enti ecclesiastici vari a farsi carico, a seconda delle proprie possibilità, dell’esercizio apostolico della Santa Sede. Ebbene, nel 2006 le offerte raccolte attraverso questa disposizione sono aume ntate, rispetto all’anno precedente, da 73,9 milioni di euro a 86 milioni nel 2006.
Quanto ai costi, sempre per l’attività istituzionale, l’aumento è stato di quasi 5 milioni, da 121,3 a 126,2 milioni di euro, variazione dovuta sia ai costi aggiuntivi per il personale, sia all’aumento delle spese generali e amministrative (da 13,4 a 15,3 milioni), e di quelle per il mantenimento di rappresentanze e nunziature (da 19,6 a 20,6 milioni). Riguardo all’attività finanziaria, l’incremento dei contributi ha permesso di assorbire il calo molto pronunciato dell’avanzo netto che è stato nel 2006 di 13,7 milioni contro 43,3 milioni nel 2005. Ciò, ha spiegato Sebastiani, in base al «principio della prudenza» che guida questo settore, per cui gran parte degli investimenti sono obbligazioni statali anziché azioni, che sono a maggior rischio.
Sempre nel 2006, il settore immobiliare ha registrato un netto di 32,3 milioni (22,4 nel 2005). Negativo, al contrario, il saldo delle "istituzioni collegate" - Radio Vaticana, Tipografia vaticana, Osservatore Romano, Centro televisivo vaticano e Libreria Editrice vaticana: il disavanzo è di 12,8 milioni di euro, in massima parte dovuti alla Radio (che però non ha entrate) e all’Osservatore.
Obolo di San Pietro: anno record
Grazie a donazioni eccezionali superata quota 100 milioni di euro
Da Roma Salvatore Mazza (Avvenire, 07.07.2007)
Ha largamente superato i 100 milioni di euro, nel 2006, il gettito dell’Obolo di San Pietro. Un risultato dovute alle donazioni «eccezionali» che si sono registrate nel corso dell’anno passato. E che mentre va - ovviamente - visto nel suo valore, non deve far immagine che si tratti di un risultato facilmente ripetibile.
Non poteva passare sotto silenzio il dato anticipato qualche giorno fa da una nota della Segreteria di Stato, che informava che la raccolto dell’Obolo aveva raggiunto nel 2006 la cifra di ben 101 milioni e 900 mila dollari. E infatti ieri, nel corso della conferenza stampa per la presentazione del bilancio consolidato 2006 della Santa Sede, è stato chiesto dai giornalisti un commento su questa straordinaria performance.
«È un fatto - ha risposto il direttore della Sala Stampa vaticana padre Federico Lombardi - che quest’anno ci sono state delle offerte eccezionali. Questo però è bene dirlo, perché non ci si aspetti che ogni anno ci siano. Puoi avere un anno in cui uno ti fa una grandissima offerta e questo fa salire molto l’entrata, ma se l’anno dopo quest’offerta eccezionale non c’è, tu non puoi contarci e non te ne puoi neanche stupire».
A comporre la somma che va sotto la voce dell’Obolo concorrono tutte le offerte liberali in arrivo dalle Chiese locali, dagli Istituti religiosi, dalle Fondazioni e dai singoli fedeli. La cifra non rientra dunque nel bilancio della Santa Sede, ma viene iscritta in quello del Governatorato del Città del Vaticano.
In cima alla lista dei Paesi donatori sono ancora gli Stati Uniti, e ciò «nonostante» il peso «degli scandali» che di recente hanno investito quella Chiesa locale con la vicenda dei preti pedofili, come ha rilevato il cardinale Sergio Sebastiani. Germania e Italia seguono al secondo e terzo posto.
-
> BENEDETTO XV, LA "SOLLECITAZIONE" DI PIRANDELLO, E I PREPARATIVI ... PER "LA GRANDE GUERRA" DI OGGI?!!1 agosto 2007, di Federico La Sala
Benedetto XV, magistero di pace
Oggi su «L’Osservatore Romano» un articolo dello storico Danilo Veneruso rilegge la «Nota alle potenze belligeranti» del 1° agosto 1917 (Avvenire, 01.08.2007)
La «Nota alle potenze belligeranti» del 1° agosto 1917, in cui la Prima guerra mondiale viene bollata «inutile strage», non è l’esito d’una discontinuità di analisi, magistero o iniziativa. Fin dal giorno della sua elezione «il 3 settembre 1914, Benedetto XV è stato instancabile, prima ancora di parlare di pace, nel presentare il carattere e le prospettive funeste» del conflitto. Così scrive lo storico Danilo Veneruso in un articolo pubblicato oggi su «L’Osservatore Romano» nel 90° anniversario della nota di papa Giacomo della Chiesa - ricordata il 22 luglio scorso all’Angelus da Benedetto XVI. Veneruso ripercorre l’evoluzione del quadro internazionale, politico e culturale, che sfocerà nella «grande guerra», considerata «necessaria» dai governi e dalle élite del tempo «per porre ordine alla modernità». Proprio contro l’idea diffusa che le sfide complesse della modernità potessero essere risolte solo con le armi e la violenza, puntò il dito Benedetto XV. Lo fece con chiarezza d’analisi e linguaggio, come testimonia la celebre espressione «inutile strage», che in un primo momento - annota Veneruso - era apparsa eccessiva ai collaboratori del Papa, rispetto agli standard del bon ton diplomatico. Il magistero di pace di Benedetto XV non restò senza frutti: tra i più significativi - scrive ancora Veneruso - la nascita nel 1919 della «Lega per la pace» dei cattolici tedeschi, nel cui statuto si afferma che «il precetto evangelico dell’amore» deve valere nei rapporti fra le persone come in quelli fra gli Stati e i popoli, nell’economia e nella vita sociale.
-
> BENEDETTO XV, LA "SOLLECITAZIONE" DI PIRANDELLO, E I PREPARATIVI ... PER "LA GRANDE GUERRA" DI OGGI?!! --- si tratta della decisione tra egoismo e amore, tra giustizia e disonestà, in definitiva tra Dio e Satana!!!23 settembre 2007, di Maria Paola Falqui
Messa del Pontefice a Velletri: "Incrementa la sproporzione tra poveri e ricchi, come pure un rovinoso sfruttamento del pianeta"
 Papa: "Condivisione, non profitto
Papa: "Condivisione, non profitto
 è come Dio contro Satana" *
è come Dio contro Satana" *CITTA’ DEL VATICANO - "La logica del profitto, se prevalente, - ammonisce il Papa - incrementa la sproporzione tra poveri e ricchi, come pure un rovinoso sfruttamento del pianeta". "Quando invece - commenta - prevale la logica della condivisione e della solidarietà, è possibile correggere la rotta e orientarla verso uno sviluppo equo, per il bene comune di tutti". "In fondo - per il Papa - si tratta della decisione tra egoismo e amore, tra giustizia e disonestà, in definitiva tra Dio e Satana".
Benedetto XVI lo ha detto nell’omelia della messa celebrata a Velletri, sua sede titolare prima di essere eletto Papa, dove si trova per una breve visita. "Mi sento a casa tra voi - ha detto prima di cominciare la messa".
"Se amare Cristo e i fratelli non va considerato come qualcosa di accessorio e di superficiale, ma piuttosto lo scopo vero e ultimo di tutta la nostra esistenza, - ha aggiunto - occorre saper operare scelte di fondo, essere disposti a radicali rinunce, se necessario al martirio. Oggi, come ieri, la vita del cristiano esige il coraggio di andare contro corrente, di amare come Gesù".
E se d’altra parte "si trova gente pronta ad ogni tipo di disonestà pur di assicurarsi un benessere materiale pur sempre aleatorio quanto più noi cristiani dovremmo preoccuparci di provvedere alla nostra eterna felicità con i beni di questa terra" ha osservato ancora papa Ratzinger, rilevando che "l’unica maniera di far fruttificare per l’eternità le nostre doti e capacità personali come pure le ricchezze che possediamo è di condividerle con i fratelli".
Il Papa ha poi ricordato che la Bibbia "stigmatizza uno stile di vita tipico di chi si lascia assorbire da una egoistica ricerca del profitto in tutti i modi possibili e che si traduce in una sete di guadagno, in un disprezzo dei poveri e in uno sfruttamento della loro situazione a proprio vantaggio".
"Il cristiano - ha rimarcato - deve respingere con energia tutto questo, aprendo il cuore, al contrario, a sentimenti di autentica generosità". Per giungere a questo, il Papa ha invitato alla preghiera e ha ricordato che già san Paolo nella prima lettera a Timoteo "invita in primo luogo a pregare per quelli che rivestono compiti di responsabilità nella comunità civile, perchè, egli spiega, dalle loro decisioni, se tese al bene comune, derivano conseguenze positive, assicurando la pace e ’una vita calma e tranquilla con tutta pieta’ e dignita" per tutti".
* la Repubblica, 23 settembre 2007.
-
> BENEDETTO XV, LA "SOLLECITAZIONE" DI PIRANDELLO, E I PREPARATIVI ... PER "LA GRANDE GUERRA" DI OGGI?!! --- si tratta della decisione tra egoismo e amore, tra giustizia e disonestà, in definitiva tra Dio e Satana!!!29 settembre 2007
 L’otto per mille, le scuole, gli ospedali, gli insegnanti di religione e i grandi eventi
L’otto per mille, le scuole, gli ospedali, gli insegnanti di religione e i grandi eventi
 Ogni anno, dallo Stato, arrivano alle strutture ecclesiastiche circa 4 miliardi di euro
Ogni anno, dallo Stato, arrivano alle strutture ecclesiastiche circa 4 miliardi di euroI conti della Chiesa ecco quanto ci costa
di CURZIO MALTESE *
"Quando sono arrivato alla Cei, nel 1986, si trovavano a malapena i soldi per pagare gli stipendi di quattro impiegati". Camillo Ruini non esagera. A metà anni Ottanta le finanze vaticane sono una scatola vuota e nera. Un anno dopo l’arrivo di Ruini alla Cei, soltanto il passaporto vaticano salva il presidente dello Ior, monsignor Paul Marcinkus, dall’arresto per il crack del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. La crisi economica è la ragione per cui Giovanni Paolo II chiama a Roma il giovane vescovo di Reggio Emilia, allora noto alle cronache solo per aver celebrato il matrimonio di Flavia Franzoni e Romano Prodi, ma dotato di talento manageriale. Poche scelte si riveleranno più azzeccate. Nel "ventennio Ruini", segretario dall’86 e presidente dal ’91, la Cei si è trasformata in una potenza economica, quindi mediatica e politica. In parallelo, il presidente dei vescovi ha assunto un ruolo centrale nel dibattito pubblico italiano e all’interno del Vaticano, come mai era avvenuto con i predecessori, fino a diventare il grande elettore di Benedetto XVI. Le ragioni dell’ascesa di Ruini sono legate all’intelligenza, alla ferrea volontà e alle straordinarie qualità di organizzatore del personaggio. Ma un’altra chiave per leggerne la parabola si chiama "otto per mille". Un fiume di soldi che comincia a fluire nelle casse della Cei dalla primavera del 1990, quando entra a regime il prelievo diretto sull’Irpef, e sfocia ormai nel mare di un miliardo di euro all’anno. Ruini ne è il dominus incontrastato. Tolte le spese automatiche come gli stipendi dei preti, è il presidente della conferenza episcopale, attraverso pochi fidati collaboratori, ad avere l’ultima parola su ogni singola spesa, dalla riparazione di una canonica alla costruzione di una missione in Africa agli investimenti immobiliari e finanziari.
Dall’otto per mille, la voce più nota, parte l’inchiesta di Repubblica sul costo della chiesa cattolica per gli italiani. Il calcolo non è semplice, oltre che poco di moda. Assai meno di moda delle furenti diatribe sul costo della politica. Il "prezzo della casta" è ormai calcolato in quattro miliardi di euro all’anno. "Una mezza finanziaria" per "far mangiare il ceto politico". "L’equivalente di un Ponte sullo Stretto o di un Mose all’anno".
Alla cifra dello scandalo, sbattuta in copertina da Il Mondo e altri giornali, sulla scia di La Casta di Rizzo e Stella e Il costo della democrazia di Salvi e Villone, si arriva sommando gli stipendi di 150 mila eletti dal popolo, dai parlamentari europei all’ultimo consigliere di comunità montane, più i compensi dei quasi trecentomila consulenti, le spese per il funzionamento dei ministeri, le pensioni dei politici, i rimborsi elettorali, i finanziamenti ai giornali di partito, le auto blu e altri privilegi, compresi buvette e barbiere di Montecitorio.
Per la par condicio bisognerebbe adottare al "costo della Chiesa" la stessa larghezza di vedute. Ma si arriverebbe a cifre faraoniche quanto approssimative, del genere strombazzato nei libelli e in certi siti anticlericali.
Con più prudenza e realismo si può stabilire che la Chiesa cattolica costa in ogni caso ai contribuenti italiani almeno quanto il ceto politico. Oltre quattro miliardi di euro all’anno, tra finanziamenti diretti dello Stato e degli enti locali e mancato gettito fiscale. La prima voce comprende il miliardo di euro dell’otto per mille, i 650 milioni per gli stipendi dei 22 mila insegnanti dell’ora di religione ("Un vecchio relitto concordatario che sarebbe da abolire", nell’opinione dello scrittore cattolico Vittorio Messori), altri 700 milioni versati da Stato ed enti locali per le convenzioni su scuola e sanità. Poi c’è la voce variabile dei finanziamenti ai Grandi Eventi, dal Giubileo (3500 miliardi di lire) all’ultimo raduno di Loreto (2,5 milioni di euro), per una media annua, nell’ultimo decennio, di 250 milioni. A questi due miliardi 600 milioni di contributi diretti alla Chiesa occorre aggiungere il cumulo di vantaggi fiscali concessi al Vaticano, oggi al centro di un’inchiesta dell’Unione Europea per "aiuti di Stato". L’elenco è immenso, nazionale e locale. Sempre con prudenza si può valutare in una forbice fra 400 ai 700 milioni il mancato incasso per l’Ici (stime "non di mercato" dell’associazione dei Comuni), in 500 milioni le esenzioni da Irap, Ires e altre imposte, in altri 600 milioni l’elusione fiscale legalizzata del mondo del turismo cattolico, che gestisce ogni anno da e per l’Italia un flusso di quaranta milioni di visitatori e pellegrini. Il totale supera i quattro miliardi all’anno, dunque una mezza finanziaria, un Ponte sullo Stretto o un Mose all’anno, più qualche decina di milioni.
La Chiesa cattolica, non eletta dal popolo e non sottoposta a vincoli democratici, costa agli italiani come il sistema politico. Soltanto agli italiani, almeno in queste dimensioni. Non ai francesi, agli spagnoli, ai tedeschi, agli americani, che pure pagano come noi il "costo della democrazia", magari con migliori risultati.
Si può obiettare che gli italiani sono più contenti di dare i soldi ai preti che non ai politici, infatti se ne lamentano assai meno. In parte perché forse non lo sanno. Il meccanismo dell’otto per mille sull’Irpef, studiato a metà anni Ottanta da un fiscalista all’epoca "di sinistra" come Giulio Tremonti, consulente del governo Craxi, assegna alla Chiesa cattolica anche le donazioni non espresse, su base percentuale. Il 60 per cento dei contribuenti lascia in bianco la voce "otto per mille" ma grazie al 35 per cento che indica "Chiesa cattolica" fra le scelte ammesse (le altre sono Stato, Valdesi, Avventisti, Assemblee di Dio, Ebrei e Luterani), la Cei si accaparra quasi il 90 per cento del totale. Una mostruosità giuridica la definì già nell’84 sul Sole 24 Ore lo storico Piero Bellini.
Ma pur considerando il meccanismo "facilitante" dell’otto per mille, rimane diffusa la convinzione che i soldi alla Chiesa siano ben destinati, con un ampio "ritorno sociale". Una mezza finanziaria, d’accordo, ma utile a ripagare il prezioso lavoro svolto dai sacerdoti sul territorio, la fatica quotidiana delle parrocchie nel tappare le falle sempre più evidenti del welfare, senza contare l’impegno nel Terzo Mondo. Tutti argomenti veri. Ma "quanto" veri?
Fare i conti in tasca al Vaticano è impresa disperata. Ma per capire dove finiscono i soldi degli italiani sarà pur lecito citare come fonte insospettabile la stessa Cei e il suo bilancio annuo sull’otto per mille. Su cinque euro versati dai contribuenti, la conferenza dei vescovi dichiara di spenderne uno per interventi di carità in Italia e all’estero (rispettivamente 12 e 8 per cento del totale). Gli altri quattro euro servono all’autofinanziamento. Prelevato il 35 per cento del totale per pagare gli stipendi ai circa 39 mila sacerdoti italiani, rimane ogni anno mezzo miliardo di euro che il vertice Cei distribuisce all’interno della Chiesa a suo insindacabile parere e senza alcun serio controllo, sotto voci generiche come "esigenze di culto", "spese di catechesi", attività finanziarie e immobiliari. Senza contare l’altro paradosso: se al "voto" dell’otto per mille fosse applicato il quorum della metà, la Chiesa non vedrebbe mai un euro.
Nella cultura cattolica, in misura ben maggiore che nelle timidissime culture liberali e di sinistra, è in corso da anni un coraggioso, doloroso e censuratissimo dibattito sul "come" le gerarchie vaticane usano il danaro dell’otto per mille "per troncare e sopire il dissenso nella Chiesa". Una delle testimonianze migliori è il pamphlet "Chiesa padrona" di Roberto Beretta, scrittore e giornalista dell’Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Al capitolo "L’altra faccia dell’otto per mille", Beretta osserva: "Chi gestisce i danari dell’otto per mille ha conquistato un enorme potere, che pure ha importantissimi risvolti ecclesiali e teologici". Continua: "Quale vescovo per esempio - sapendo che poi dovrà ricorrere alla Cei per i soldi necessari a sistemare un seminario o a riparare la cattedrale - alzerà mai la mano in assemblea generale per contestare le posizioni della presidenza?". "E infatti - conclude l’autore - i soli che in Italia si permettono di parlare schiettamente sono alcuni dei vescovi emeriti, ovvero quelli ormai in pensione, che non hanno più niente da perdere...".
A scorrere i resoconti dei convegni culturali e le pagine di "Chiesa padrona", rifiutato in blocco dall’editoria cattolica e non pervenuto nelle librerie religiose, si capisce che la critica al "dirigismo" e all’uso "ideologico" dell’otto per mille non è affatto nell’universo dei credenti. Non mancano naturalmente i "vescovi in pensione", da Carlo Maria Martini, ormai esiliato volontario a Gerusalemme, a Giuseppe Casale, ex arcivescovo di Foggia, che descrive così il nuovo corso: "I vescovi non parlano più, aspettano l’input dai vertici... Quando fanno le nomine vescovili consultano tutti, laici, preti, monsignori, e poi fanno quello che vogliono loro, cioè chiunque salvo il nome che è stato indicato". Il già citato Vittorio Messori ha lamentato più volte "il dirigismo", "il centralismo" e "lo strapotere raggiunto dalla burocrazia nella Chiesa". Alfredo Carlo Moro, giurista e fratello di Aldo, in uno degli ultimi interventi pubblici ha lanciato una sofferta accusa: "Assistiamo ormai a una carenza gravissima di discussione nella Chiesa, a un impressionante e clamoroso silenzio; delle riunioni della Cei si sa solo ciò che dichiara in principio il presidente; i teologi parlano solo quando sono perfettamente in linea, altrimenti tacciono".
La Chiesa di vent’anni fa, quella in cui Camillo Ruini comincia la sua scalata, non ha i soldi per pagare gli impiegati della Cei, con le finanze scosse dagli scandali e svuotate dal sostegno a Solidarnosc. La cultura cattolica si sente derisa dall’egemonia di sinistra, ignorata dai giornali laici, espulsa dall’universo edonista delle tv commerciali, perfino ridotta in minoranza nella Rai riformata. Eppure è una Chiesa ancora viva, anzi vitalissima. Tanto pluralista da ospitare nel suo seno mille voci, dai teologi della liberazione agli ultra tradizionalisti seguaci di monsignor Lefebrve. Capace di riconoscere movimenti di massa, come Comunione e Liberazione, e di "scoprire" l’antimafia, con le omelie del cardinale Pappalardo, il lavoro di don Puglisi a Brancaccio, l’impegno di don Italo Calabrò contro la ’ndrangheta. Dopo vent’anni di "cura Ruini" la Chiesa all’apparenza scoppia di salute. È assai più ricca e potente e ascoltata a Palazzo, governa l’agenda dei media e influisce sull’intero quadro politico, da An a Rifondazione, non più soltanto su uno. Nelle apparizioni televisive il clero è secondo soltanto al ceto politico. Si vantano folle oceaniche ai raduni cattolici, la moltiplicazione dei santi e dei santuari, i record di audience delle fiction di tema religioso. Le voci di dissenso sono sparite. Eppure le chiese e le sagrestie si svuotano, la crisi di vocazioni ha ridotto in vent’anni i preti da 60 a 39 mila, i sacramenti religiosi come il matrimonio e il battesimo sono in diminuzione.
Il clero è vittima dell’illusoria equazione mediatica "visibilità uguale consenso", come il suo gemello separato, il ceto politico. Nella vita reale rischia d’inverarsi la terribile profezia lanciata trent’anni fa da un teologo progressista: "La Chiesa sta divenendo per molti l’ostacolo principale alla fede. Non riescono più a vedere in essa altro che l’ambizione umana del potere, il piccolo teatro di uomini che, con la loro pretesa di amministrare il cristianesimo ufficiale, sembrano per lo più ostacolare il vero spirito del cristianesimo". Quel teologo si chiamava Joseph Ratzinger.
(Hanno collaborato Carlo Pontesilli e Maurizio Turco)
* la Repubblica, 28 settembre 2007
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
