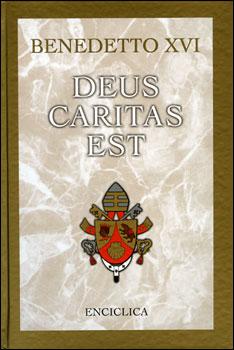
"Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")!!! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. Una straordinaria lezione di Arturo Paoli, sull’amore ( "charitas") evangelico - a c. di Federico La Sala
domenica 15 ottobre 2006.
- [...] Le varie spiritualità cattoliche seguite dai laici nel tempo attuale sembrano non includere la responsabilità del mondo. Sono restate agganciate al dualismo greco, anima e corpo, anima che vive soprannaturalmente quasi estranea alla materia, corpo fatalmente esposto allo provvisorietà, al relativismo, senza considerare che il relativismo è diventato assoluto. Invano il Concilio ecumenico Vaticano II ha solennemente e infallibilmente proclamato che il centro della predicazione di Gesù è il Regno: “regno di giustizia, di amore e di pace” che deve avvenire nel tempo per l’impegno e la responsabilità dell’uomo, chiamato a renderne conto il giorno della seconda venuta di Cristo, alla Fine dei tempi [...]
- [...] come ci dice il filosofo argentino Dussel, chi per primo ha previsto e denunziato l’idolatria è stato Carlo Marx e non la Chiesa. Le sue intuizioni, seppellite nelle professioni di ateismo piuttosto storico che filosofico, manifestano oggi di essere profetiche [...]
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
L’IDOLATRIA TRIONFANTE NELL’OCCIDENTE CRISTIANO
di Arturo Paoli *
(...) Il cristianesimo nel mondo greco è stato sfidato dalla domanda sul senso del vivere, piuttosto che dalla domanda di un progetto reale dell’esistenza. Nel nostro tempo stiamo scoprendo lo squilibrio che vivono i seguaci di Cristo, fra una proposta di fede intesa come ragione, e la debolez¬za di un’etica capace di opporsi al consumismo dilagante, causa diretta di quella povertà-maledizione che è vera schiavitù del maggior numero di esistenze umane. (...)
Oggi la Chiesa cattolica è impegnata nel difendere la vita umana e si scontra con tecniche di manipolazione della vita. Ma questa discesa in campo, vista dello parte dei poveri, lascia freddi e perplessi. Perché noi tutti individui e istituzioni siamo coinvolti nell’idolatria di mercato, causa di una quotidiana distruzione della vita in misure mai raggiunte per estensione e profondità.
La campagna portata avanti con tutti i mezzi, mentre il continente africano agonizza, l’America Latina è paralizzata nel suo sviluppo, la gioventù dell’occi¬dente cristiano è sempre più dominata dall’idolatria, ci fa pensare all’ironia evangelica che colpisce chi sputa il moscerino e inghiotte una trave. Oggi abbondano scrittori e scritti che mettono a nudo il funzionamento dell’idolatria di mercato e i suoi attentati allo vita.
Anche senza fare lunghi studi in economia, un piccolo libro ci informa a sufficienza su questa guerra infinito che falcia milioni di esseri umani condannando alla fame, escludendo giovani forze dal lavoro perché “ridondanti e dunque da eliminare”. (AA.VV., Economia come teologia?, Ed. L’Altrapagina, Città di Castello - PG). I Filosofi si sono svegliati scoprendo che i grandi progetti di organizzare le comunità politiche, pensati lontano dai reali bisogni umani, una volta calati nella realtà diventano assassini come il sistemo liberale degenerato in liberismo del mercato.
Le varie spiritualità cattoliche seguite dai laici nel tempo attuale sembrano non includere la responsabilità del mondo. Sono restate agganciate al dualismo greco, anima e corpo, anima che vive soprannaturalmente quasi estranea alla materia, corpo fatalmente esposto allo provvisorietà, al relativismo, senza considerare che il relativismo è diventato assoluto. Invano il Concilio ecumenico Vaticano II ha solennemente e infallibilmente proclamato che il centro della predicazione di Gesù è il Regno: “regno di giustizia, di amore e di pace” che deve avvenire nel tempo per l’impegno e la responsabilità dell’uomo, chiamato a renderne conto il giorno della seconda venuta di Cristo, alla Fine dei tempi.
Oggi autori molto letti e fecondi come Bauman, mediante analisi acute e profonde della società, mettono allo scoperto la nostra responsabilità. Nel piccolo libro accennato sopra il teologo Enrico Chiavacci riprende la Gaudium et Spes: “Con la venuta di Cristo tutta la storia non è altro che il faticoso cammino della storia verso la pienezza del Regno. il Regno non riguarda l’aldilà ma l’oggi, in cui la basilica di Dio si sta sviluppando. Dunque la presenza del cristiano, nella complessa e strutturata realtà sociale della famiglia umana, è un tema prettamente umano e attinente alla salvezza” (pag. 52).
Oggi, grazie a questa svolta del pensiero filosofico e parallelamente alle indicazioni dello Spirito Santo che appaiono molto chiare negli atti conciliari del Vaticano II, il cattolicesimo si trova di fronte ad una alternativa: o vivere la fede come adesione al suo contenuto di verità manifestato negli articoli del Credo e resa accessibile attraverso i vari catechismi che rendono pedagogicamente accettabile un catechismo ufficiale edito dal centro della chiesa e come obbedienza ai sacramenti. O vivere la fede come donazione di sé al progresso del regno di Dio nella storia. In questa seconda la prima non è esclusa; piuttosto a partire da quella il cristiano sincero, aprendosi all’azione dello Spirito Santo, giunge a convincersi che il senso vero della propria esistenza è quello di impegnarla integralmente per un mon¬do di giustizia, di fraternità, di pace. Nella prima maniera di vivere la fede invece non è inclusa la seconda.
Se non vogliamo vivere nell’illusione, o nella paura di essere segnalati come cattolici guastafeste e marginali, si può constatare che i cattolici della prima maniera sono una schiacciante maggioranza, e anche recentemente hanno manifestato una agitazione sproporzionata, delirante contro esperimenti scientifici di manipolazione della vita, scoprendo impietosamente la complicità silenziosa e l’accettazione degli innamorati di Cristo che per ingenuità o malafede contrastano in tutti i modi la realizzazione del progetto di Gesù, che Egli definisce regno di Dio, cioè la vera unica glorificazione del Padre.
Mettendo al centro il Regno di Dio, come ha chiesto lo Spirito santo nel Concilio, appare evidente quel relativismo cristiano che recentemente è stato citato dal cardinale Martini nell’omelia pronunciata nel duomo di Milano 18 maggio scorso. Il regno di Dio si realizza nel fluire della storia che presenta varie provocazioni all’impegno dell’uomo nella società del suo tempo. Questo impegno è la ragione d’essere di ogni esistenza umana, Gesù la contempla alla luce di Dio.
 Il cardinale Martini nelle sue parole sembra indicare un’istanza superiore alla Chiesa: “sarà allora quando verrà il Signore che finalmente sapremo. Allora si compirà il giudizio sulla storia e sapremo chi aveva ragione. Allora le opere degli uomini appariranno nel loro vero valore e tutte le cose si chiariranno, si illumineranno, si pacificheranno”.
Il cardinale Martini nelle sue parole sembra indicare un’istanza superiore alla Chiesa: “sarà allora quando verrà il Signore che finalmente sapremo. Allora si compirà il giudizio sulla storia e sapremo chi aveva ragione. Allora le opere degli uomini appariranno nel loro vero valore e tutte le cose si chiariranno, si illumineranno, si pacificheranno”.
Il cristiano non ha una marcia in più degli altri, dovrebbe averla perché la sua fede dovrebbe averlo portato a dissetarsi direttamente alla fonte dell’amore, ma spesso non dona questo amore, lo ritiene per sé impaludandolo. -Allora viene alla mente spontanea la parabola del Samaritano che trasmette la vita a un morto, mentre i due trascurano il fratello in preda alla morte per non perdere il diritto di approssimarsi alla Fonte dello vita. I segni dei tempi sono relativi perché legati al tempo, eppure Gesù li mostrò come necessari per il nostro impegno nel divenire del Regno.
La profezia è la capacità di leggere il relativo, di vedere che la giustizia è un valore di tutti i tempi per tutti gli uomini ma è solo la profezia che consegna alla giustizia la realtà di un volto che sanguina o che è solcato di rughe per fame e per fatica. Nella mia lunga vita ho avuto la possibilità di vivere un periodo a Roma dove ci scontrammo con dei valori umani che si dibattono su un piano strettamente logico e razionale, anche se destinati a entrare nel tempo e quindi nella relatività, come la conciliazione tra l’obbedienza e la libertà, la difesa dello spazio della laicità dallo spazio del sacro e del religioso.
Il ricorso costante allo Spirito di Dio mi apparve e mi pare ancora oggi indispensabile per vivere quella vicenda senza perdere unità di un progetto di vita che avevo scelto con una coscienza chiara e libera. La vita con i poveri mi ha avvicinato ad una religiosità incarnata che mi ha portato a riconoscere la teologia della liberazione, le varie filosofie fenomenologiche fra cui distinguo il pensiero di Levinas, come il filo rosso del regno di Dio.
E oggi penso che non si sveleranno mai tutti i sensi che contiene lo parola conciliare di povertà della Chiesa e nella Chiesa, se non cogliendo questi avvenimenti come profezia cioè come presenza dello Spirito di Dio nella storia. In questa luce storica appare in tutta la sua evidenza il Gesù dei Vangeli che si identifica con il progetto Regno di Dio che chiarisce nelle parole più vicine all’uomo: “sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).
La parola vita torna quasi ad ogni capitolo del vangelo di Giovanni. E la vita per un ebreo è la vita umana nella sua totalità. E il vangelo narra che Gesù realizza il progetto andando incontro a tutte le carenze di vita negli esseri umani che incontra. E non si limita a prestare questo aiuto ma alza la sua voce contro coloro che attentano alla vita, anche se in nome della legge che discende dal Padre al pari della vita.
Oggi non è possibile pensare a un mondo diverso, se non partendo dalle vittime di quelli che tolgono la vita. La forma concreta di togliere lo vita a una parte sempre più estesa di esseri umani consiste nel fatto che l’economia Finanziaria si sviluppa senza nessun legame con l’economia reale, in poche parole esiste denaro che trasmette vita, e denaro che trasmette morte perché è denaro che produce denaro, spogliato del suo essere simbolico che è quello di alimentare la vita.
C’è un parallelismo impressionante tra questo senso del denaro simbolo di vita e di morte e l’Eucarestia nella quale uno attinge la vita o la morte. Chi mangia il pane del Signore e beve il suo sangue in modo indegno si rende colpevole del corpo e del sangue del Signore (I Cor 11) e questo indegnamente è rappresentato nella scenetta del ricco che viene all’incontro eucaristico (l’agape) con dei cibi costosi, e se li mangia prima che arrivi il povero, invece di dividerli.
Ora come ci dice il filosofo argentino Dussel, chi per primo ha previsto e denunziato l’idolatria è stato Carlo Marx e non la Chiesa. Le sue intuizioni, seppellite nelle professioni di ateismo piuttosto storico che filosofico, manifestano oggi di essere profetiche per l’avvento dell’idolo mercato. La Chiesa non trova oggi sul fronte avversario le eresie che sono letture di alcuni dogmi definiti dalla chiesa, che finalmente, secondo l’opinione di Agostino, favoriscono il progresso dello fede, ma l’idolatria trionfante nell’occidente cristiano. E questa non si può combattere con argomenti razionali, perché non è un fenomeno del pensiero, ma il frutto di una scelta puramente materialistica come l’accumulazione del denaro. Il denaro è sottratto al bisogno ed è relazionato al desiderio, e da simbolo di vita diventa simbolo di morte.
Attraverso il meccanismo della globalizzazione che significa liberare il denaro dalla sua funzione di soddisfare i desideri reali di tutti gli esseri umani, per farne oggetto di accumulazione in mano di pochi nascosti nell’anonimato delle banche e questo denaro cresce creando e stimolando desideri. Una gran parte di questo denaro va nella pubblicità che si fa sempre più spettacolo. Quando la TV annunzia pubblicità, ci si attende di vedere un breve spettacolo molto geniale e attraente che ci convince immediatamente che il detersivo infallibile per far sparire le macchie è quello della marca che appare nella scena mentre elimina una goccia di grosso caduta inavvertitamente sulla giacca di un avventore seduto al tavolo di un grande e vistoso ristorante. E la Fantasia dei creatori di pubblicità non ha limiti. Così i desideri dei ricchi seguono questa insonne e infinita produzione che stimola la nascita e la crescita dei desideri che sottrae il denaro dedicato ai bisogni reali. Questo meccanismo non l’ho mai trovato nei libri di teologia morale, e nemmeno di spiritualità.
Ma ricordo un libro scritto da una donna, Agnes Heller, che mi ha illuminato sui bisogni reali e sui desideri, concetti molto semplici portatori di conseguenze gravissime. Ho sentito il bisogno di informarmi per la straziante evidenza della morte che circola nelle favelas di cui constato la presenza nel volto dei bambini denutriti e mi viene continuamente raccontata dalle donne che portano con sé la tragedia quotidiana di questo furto della vita i cui autori le sono ignoti.
Impossibile non interrogarsi a fondo, non cercare di chiarire la causa di questa morte sempre più avida di vittime umane, senza sentire l’assoluta falsità delle nostre parole consolatorie e il vero autentico relativismo dei programmi di studio dei futuri pastori che vengono preparati in lunghi anni di separazione dalla vita reale, a respirare in colonie asettiche, lontane dalla concretezza quotidiana dove appare evidente il senso vero del mondo nella lotta impari tra la morte e la vita. E qui, in questo tragico mondo reale, si rinnova lo spezzarsi del velo del tempio e il senso vero del povero e giusto che agonizza sulla croce. E quanto lussuoso infantilismo si nasconde nel nostro stile di vivere la nostra fede.
In opposizione alla idolatria del mercato appare sempre più chiaro che bisogna abbandonare lo spazio della metafisica senza paura. Allora noi cristiani ci ricorderemo che per liberare gli ebrei dalla schiavitù del Faraone che si presenta come un dio, il Dio vero scese al lamento del popolo e strinse con lui l’alleanza-matrimonio. Il Dio sceso nella carne dell’uomo Gesù significa, secondo il filosofo Natoli, l’abbattimento degli idoli e mostra che tutti gli idoli sono battibili. Sicuro che non tarderà la fine dell’ultimo, il mercato.
Contro l’opinione che abbandonando il metodo metafisico si cade nel caos e nella confusione delle idee, ho trovata una pagina di Tagore: «A mezzanotte, lo pseudoasceta annunziò: “E’ ora che io lasci la mia casa, e ricerchi Dio. Chi mi ha trattenuto tanto tempo nell’illusione?”. Dio mormorò: “Io”, ma l’uomo aveva le orecchie chiuse.., il bimbo gridò nel sonno e si strinse alla madre. Dio comandò: “Fermati, sciocco; non lasciar la tua casa”. Ma l’uomo neppure allora udì. Dio sospirò e disse: “Perché il mio servo mi abbandona per andare in cerca di me? ».
*
Fonte: “Oreundici” e “Pretioperai”, n. 66, Sett. 2005
Ringraziamo don Aldo Antonelli per averci messo a disposizione questa relazione sulla idolatria del denaro di Arturo Paoli tenuta qualche anno fa, nel convegno annuale che gli amici di "Oreundici" tengono in quel di Trevi nell’Umbria. Questa relazione è stata pubblicata nell’’ultimo numero della rivista "Pretioperai"
IL DIALOGO, Sabato, 01 ottobre 2005
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
 LA VERITA’ NON E’ NEGOZIABILE.
LA VERITA’ NON E’ NEGOZIABILE.
fls
Forum
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")!!! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. -- Verso una nuova finanza («Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones»): il cammino ora è segnato (di Stefano Zamagni)..13 giugno 2018, di Federico La Sala
TEOLOGIA, ECONOMIA, E STORIA ..... *
Il documento vaticano.
Verso una nuova finanza: il cammino ora è segnato
Il testo della Congregazione per la Dottrina della Fede «Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones» offre spunti per un discernimento etico sul sistema attuale e offre soluzioni per il bene comune
di Stefano Zamagni (Avvenire, martedì 12 giugno 2018)
«Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones» (Opq) è un documento - reso di dominio pubblico il 17 maggio 2018 - originale e intrigante.
Originale per il taglio espositivo e soprattutto perché è la prima volta che la Congregazione per la Dottrina della Fede - la cui competenza copre anche le questioni di natura morale - interviene su una materia di Dottrina Sociale della Chiesa. Il lavoro congiunto tra Congregazione e Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è già di per sé qualcosa che non può passare inosservato e che lascerà il segno.
Opq è poi un contributo intrigante per il modo e per lo spessore con cui affronta una tematica che, come quella della nuova finanza, è oggi al centro delle preoccupazioni della Chiesa e della società in generale. (Papa Francesco ha approvato il Documento che entra pertanto nel Magistero ordinario). Come recita il sottotitolo («considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario» - corsivo aggiunto), non ci troviamo di fronte ad una sorta di esortazione apostolica o ad un testo di taglio pastorale. Piuttosto, vi si legge un’analisi, scientificamente fondata, delle cause remote dei disordini e dei guasti che l’architettura dell’attuale sistema finanziario va determinando.
Si legge al n. 5: «La recente crisi finanziaria poteva essere l’occasione per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria, neutralizzandone gli aspetti predatori e speculativi (sic!) e valorizzandone il servizio all’economia reale. Sebbene siano stati intrapresi molti sforzi positivi... non c’è stata però una reazione che abbia portato a ripensare quei criteri obsoleti che continuano a governare il mondo».
 A scanso di equivoci, è bene precisare che il documento non parla affatto contro la finanza, di cui riconosce la rilevanza e anzi la necessità (e non potrebbe essere diversamente, se si considera che la finanza moderna nasce entro l’alveo del pensiero economico francescano). Esso prende piuttosto posizione nei confronti di una realtà efficacemente descritta dal seguente dato: nel 1980, l’insieme degli attivi finanziari a livello mondiale era pressoché eguale al Pil sempre mondiale; nel 2015 la prima variabile era diventata dodici volte superiore alla seconda.
A scanso di equivoci, è bene precisare che il documento non parla affatto contro la finanza, di cui riconosce la rilevanza e anzi la necessità (e non potrebbe essere diversamente, se si considera che la finanza moderna nasce entro l’alveo del pensiero economico francescano). Esso prende piuttosto posizione nei confronti di una realtà efficacemente descritta dal seguente dato: nel 1980, l’insieme degli attivi finanziari a livello mondiale era pressoché eguale al Pil sempre mondiale; nel 2015 la prima variabile era diventata dodici volte superiore alla seconda.Il punto centrale dell’argomento sviluppato nel Documento è l’affermazione del principio secondo cui etica e finanza non possano continuare a vivere in sfere separate. Ciò implica il rigetto della tesi del Noma (Non Overlapping Magisteria) per primo formulata in economia nel 1829 da Richard Whateley, cattedratico all’Università di Oxford e vescovo della Chiesa Anglicana.
 Secondo questa tesi, la sfera dell’economia va tenuta separata sia dalla sfera dell’etica sia da quella della politica, se si vuole che l’economia ambisca a vedersi riconosciuto lo statuto di disciplina scientifica. E così è stato, almeno fino a tempi recenti, quando si è cominciato a parlare con Amartya Sen e altri, di economia e etica.
Secondo questa tesi, la sfera dell’economia va tenuta separata sia dalla sfera dell’etica sia da quella della politica, se si vuole che l’economia ambisca a vedersi riconosciuto lo statuto di disciplina scientifica. E così è stato, almeno fino a tempi recenti, quando si è cominciato a parlare con Amartya Sen e altri, di economia e etica.
 I paragrafi 7-12 di Opq si soffermano con grande incisività a descrivere come dall’accettazione del principio del Noma sia derivato l’accoglimento dell’assunto antropologico (di ascendenza Hobbesiana) dell’homo homini lupus, posto a fondamento della figura dell’homo oeconomicus.
I paragrafi 7-12 di Opq si soffermano con grande incisività a descrivere come dall’accettazione del principio del Noma sia derivato l’accoglimento dell’assunto antropologico (di ascendenza Hobbesiana) dell’homo homini lupus, posto a fondamento della figura dell’homo oeconomicus.Ben diverso è l’assunto antropologico da cui parte il paradigma dell’economia civile - fondato da Antonio Genovesi nel 1753 a Napoli - che, rifiutando esplicitamente il Noma, riconosce che homo homini natura amicus. («L’uomo è per natura amico dell’altro uomo»).
Seconda novità di rilievo del Documento è la rilevanza attribuita al principio della responsabilità adiaforica, di cui quasi mai si fa cenno. Il par. 14 recita: «Ad li là del fatto che molti operatori siano singolarmente animati da buone e rette intenzioni, non è possibile ignorare che oggi l’industria finanziaria, a causa della sua pervasività e della sua inevitabile capacità di condizionare e di dominare l’economia reale, è un luogo dove gli egoismi e le sopraffazioni hanno un potenziale di dannosità della collettività che ha pochi eguali».
È questo un esempio notevole di struttura di peccato, come la chiamò, per primo nella Dottrina Sociale della Chiesa, Giovanni Paolo II nella sua Sollecitudo Rei Socialis (1987). Non è il solo operatore di borsa, o banchiere o uomo d’affari ad essere responsabile delle conseguenze delle azioni che pone in atto. Anche le istituzioni economiche, se costruite su premesse di valore contrarie ad un’etica amica dell’uomo, possono generare danni enormi a prescindere dalle intenzioni di coloro che in esse operano. Per meglio comprendere la ragione di ciò, conviene fissare l’attenzione su tre caratteristiche specifiche della nuova finanza.
La prima è l’impersonalità dei contesti di mercato, la quale oscura il fatto che da qualche parte vi è sempre un qualcuno sull’altro lato dell’affare. La seconda caratteristica è la complessità della nuova finanza che fa sorgere problemi di agentività indiretta: il principale si riconosce moralmente disimpegnato nei confronti delle azioni poste in essere dal suo ’ingegnere finanziario’, cioè dall’esperto cui affida il compito di disegnare un certo prodotto, il quale a sua volta si mette il cuore in pace perché convinto di eseguire un ordine.
Accade così che ognuno svolge il suo ruolo separando la propria azione dal contesto generale, rifiutandosi di accettare che, anche se solo amministrativamente, era parte dell’ingranaggio. Infine, la nuova finanza tende ad attrarre le persone meno attrezzate dal punto di vista etico, persone cioè che non hanno scrupoli morali e soprattutto molto avide. Riusciamo così a comprendere perché il problema non risiede unicamente nella presenza di poche o tante mele marce; ma è sulla stessa cesta delle mele che si deve intervenire.
Il Documento in questione, infine, prende definitiva ed esplicita posizione contro la tesi della doppia moralità - purtroppo diffusa anche tra alcune organizzazioni di tipo finanziario che dichiarano di ispirarsi alla Dottrina Sociale della Chiesa. Per capire di che si tratta conviene partire dal saggio di Albert Carr, ’Is business bluffing ethical?’ pubblicato sulla prestigiosa Harvard Business Review nel 1968. È questo il saggio che, più di ogni altro, ha guidato fino ad oggi la riflessione etica nel mondo degli affari. Vi si legge che l’uomo d’affari di successo deve essere guidato da «un diverso insieme di standars etici», poiché «l’etica degli affari è l’etica del gioco [d’azzardo], diversa dall’etica religiosa». Assimilando il business al gioco del poker, il noto economista americano conclude che «gli unici vincoli di ogni mossa nel business sono la legalità e il profitto.
Se qualcosa non è illegale in senso stretto (sic!) ed è profittevole allora è eticamente obbligante che l’uomo d’affari lo realizzi». I paragrafi dal 22 al 34 di Opq si soffermano sul faciendum: che fare per cercare di invertire la situazione? Parecchie le proposte - tutte realizzabili - che vengono avanzate. Dal sostegno a istituti che praticano la finanza non speculativa, come le Banche di Credito Cooperativo, il microcredito, l’investimento socialmente responsabile, alle tante forme di finanza etica. Dalla chiusura della finanza offshore e dalle forme di cannibalismo economico di chi, con i credit default swaps, specula sul fallimento altrui, alla regolamentazione dello shadow-banking, soggetti finanziari non bancari che agiscono come banche ma operando al di fuori di ogni quadro normativo ufficiale.
L’obiettivo da perseguire è quello di assicurare una effettiva biodiversità bancaria e finanziaria. Di speciale interesse è inoltre la proposta di affiancare ai Cda delle grandi banche Comitati Etici costituiti da persone moralmente integre oltre che competenti - così come già accade nei grandi policlinici. Nell’aprile 2015 la ’Dutch Banking Association’ (l’Associazione di tutte le banche olandesi) stabilì di esigere dai dipendenti delle banche (circa 87.000 persone) il ’Giuramento del Banchiere’, stilato sulla falsariga del giuramento ippocratico per i medici.
Il giuramento consta di otto impegni specifici. Ne indico solamente un paio: «Prometto e giuro di mai abusare delle mia conoscenze»; «Prometto e giuro di svolgere le mie funzioni in modo etico e con cura, adoperandomi di conciliare gli interessi di tutte le parti coinvolte: clienti, azionisti; occupati; società». Si opera dunque a favore di tutte le classi di stakeholder e non solamente di quella degli azionisti. Sarebbe bello se sull’esempio dell’Olanda - un Paese non certo sprovveduto né arretrato in materia finanziaria - anche l’Italia volesse seguirne la traccia.
Delle tre principali strategie con le quale si può cercare di uscire da una crisi di tipo entropico - quale è l’attuale - e cioè quella rivoluzionaria, quella riformista, quella trasformazionale, il Documento Opq sposa, in linea con il Magistero di papa Francesco, la terza. Si tratta di trasformare - non basta riformare - interi blocchi del sistema finanziario che si è venuto formando nell’ultimo quarantennio per riportare la finanza alla sua vocazione originaria: quella di servire il bene comune della civitas che, come ci ricorda Cicerone, è la «città delle anime», a differenza dell’urbs che è la «città delle pietre». È questa la strategia che vale, ad un tempo, a scongiurare il rischio sia di utopiche palingenesi sia del misoneismo, che è l’atteggiamento tipico di chi detesta la novità e osteggia l’emergenza del nuovo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA. Tutti a scuola in Vaticano, per aggiornamenti. Materiali per approfondire
STORIA D’ITALIA. INTELLETTUALI E SOCIETA’....
 VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggere
VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggereGUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")!!! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. --- Difendere Cristo dal cristianesimo. una sua intervista. Addio ad Arturo Paoli (di "Nigrizia").14 luglio 2015, di Federico La Sala
Addio ad Arturo Paoli
Difendere Cristo dal cristianesimo
Lo affermava fratel Arturo, morto ieri al Lucca, a 102 anni. Un uomo mite e coraggioso, un religioso determinato e radicale che ha segnato il nostro tempo. Ha collaborato a lungo con Nigrizia. Lo ricordiamo riproponendo una sua intervista del maggio 2000.
di Redazione (Nigrizia, 14.07.2015)
Si svolgeranno domani alle ore 18.00, nella cattedrale di Lucca, il funerali di Arturo Paoli, sacerdote e Piccolo Fratello del Vangelo (della famiglia spirituale di Charles de Foucauld), morto ieri nella sua abitazione presso la canonica della parrocchia di San Martino in Vignale. Aveva 102 anni. Sarà sepolto, secondo la sua volontà, nel piccolo cimitero di San Martino in Vignale.
Nato a Lucca nel 1912, si laurea in Lettere nel 1936 e ordinato sacerdote nel 1940. Partecipa alla Resistenza e aiuta gli ebrei perseguitati dal nazismo. Nel 1949 è viceassistente della Gioventù di Azione Cattolica ed è tra coloro che affermano l’autonomia dei laici nelle scelte politiche, posizione riconosciuta legittima solo molti anni dopo, con il concilio Vaticano II.
Incontrata la congregazione religiosa ispirata a Charles de Foucault, a metà degli anni ’50 vive a Orano in Algeria. Rientra in Italia nel 1957, ma viene allontanato dalle gerarchie vaticane che non gradiscono le sue critiche. La sua esperienza continua in America Latina (Argentina, Venezuela, Brasile) fino al 2005. Sulle pagine di Nigrizia ha tenuto, negli anni ’80 e ’90 una rubrica: Lettera dall’America Latina.
- Nell’intervista che segue, raccolta da Bruna Sironi e pubblicata da Nigrizia nel maggio del 2000, dice con chiarezza qual è il suo sogno di Chiesa.
Lei ha ripetuto in varie occasioni che la cultura cristiana è responsabile dei mali del mondo. Qual è il senso della sua affermazione?
Il mondo occidentale cristiano è il luogo da cui partono tutti i comandi di morte, da cui si organizzano le guerre, in cui si realizza l’accumulazione che toglie il pane a milioni di persone. E non c’è caduto per disgrazia, in quest’avventura di essere il centro del male del mondo. È una conseguenza logica e fatale della sua cultura. Abbiamo sempre pensato che il centro di tutto è l’io, l’essere, il soggetto, e abbiamo proiettato questa filosofia su tutte le strutture politiche ed economiche che abbiamo creato.
Anche la globalizzazione non è venuta a caso, ma è la conseguenza di un cammino filosofico di secoli, che ha affermato questo principio di unificazione dando origine alla necessità di un soggetto unico, dominatore. E ha prodotto il mercato, la dittatura, il partito. Creazioni astratte, unificanti, dominanti il mondo e la storia, che hanno intrinseca la tendenza alla negazione, alla soppressione dell’altro. Ci siamo vantati di portare al mondo la civiltà, ma aveva questo veleno dentro: la necessità di sopprimere l’altro, di non riconoscergli la sua cultura, la sua religione, la sua vita. Dobbiamo assumerci questa responsabilità.
Giovanni Paolo II ha chiesto perdono per le responsabilità della Chiesa...
È molto commovente, ma è come un’aspirina per una persona che sta morendo di cancro. Il papa ha detto di aprire le porte a Cristo, ma a quale Cristo? Quello solenne, dominatore, o quello povero fra i poveri? Perciò non ha fatto altro che caricare di responsabilità il mondo cristiano.
Ci manca un’etica. Abbiamo perso il senso della giustizia. Se accettiamo la sponsorizzazione di pellegrinaggi da parte di multinazionali che conoscono solo l’etica del profitto, come possiamo dire di no alla clonazione? Dobbiamo essere integrali, coerenti, completi. La nostra etica deve partire dai diritti degli offesi, degli oppressi. È solo su questa base che possiamo pensare un nuovo mondo.
Come deve essere una Chiesa nuova?
Dobbiamo difendere Cristo dal cristianesimo, dalla cultura cristiana. Cristo ha predicato la fraternità, la giustizia. A partire dai poveri, dalle vittime dell’ingiustizia. Non ha fatto mai teoria, non ha mai parlato neanche di Dio, si è semplicemente messo accanto ai poveri. Cristo è essenzialmente liberatore, e liberatore dei poveri.
Lei torna spesso sulla teologia della liberazione fiorita negli anni ’70...
È stata una rivoluzione culturale in quanto vedeva possibile la conoscenza di Dio attraverso la discesa tra gli uomini, per realizzare la giustizia, l’uguaglianza, la fraternità; temi spesso dibattuti ma che non possono essere risolti senza un cambiamento totale della nostra cultura. Doveva essere un messaggio felice per i poveri, ma non poteva non suscitare la reazione dell’Erode e della Gerusalemme religiosa del tempo.
Il rapporto tra il missionario e il denaro?
La missione, come tale, non dovrebbe esistere. Lo dice Gesù stesso. Basta leggere il capitolo 10 del Vangelo di Luca. Si deve andare tra i poveri come amici, senza nulla, e farsi accogliere. Bisogna invertire la posizione: non sono io, ricco, che vado al povero, ma devo andarci povero, alla pari con lui. È il concetto stesso di missione che bisogna cambiare. Se c’è una disuguaglianza di partenza non si può mai creare una vera amicizia.
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")!!! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano --- Eredità di un missionario. L’Amico di Arturo (di Alex Zanotelli)16 luglio 2015, di Federico La Sala
Eredità di un missionario
L’Amico di Arturo
Oggi alle ore 18.00, nella cattedrale di Lucca, il funerali di Arturo Paoli, Piccolo Fratello del Vangelo. È morto lunedì all’età di 102 anni. Nigrizia lo saluta, tornando sulle sue parole.
di Alex Zanotelli (Nigrizia, 15 luglio 2015)
Abbiamo perso tutti un amico. Che è andato, come amava dire, a trovare l’Amico.
Per chi l’ha conosciuto, Arturo Paoli è stato un grande stimolo a camminare con i poveri e gli oppressi, e a battersi contro tutti poteri forti che schiacciano e uccidono.
Ci ha indicato un cammino con la sua vita e con i suoi scritti. Grazie Arturo.
Grazie perché sei sempre stato per me un amico personale, soprattutto nei momenti difficili della mia vita. Grazie perché sei stato un compagno di viaggio anche per coloro che hanno lavorato a Nigrizia, con le tue lettere dall’America Latina.
Ringrazio il Signore per questi tuoi cento anni di testimonianza alla Verità.
Credo sia importante ricordare fratel Arturo, rileggendo un suo scritto, una Lettera dall’America Latina, così si chiamava la sua rubrica mensile su Nigrizia, pubblicata nel giugno del 1990.
Il dolore donna Faustina
Oggi l’ultima a venire alla fraternita è donna Faustina: sessant’anni, due figlie ammalate, quattro nipotini da tirar su; con che? Dalla sua bocca scendono sommessamente, soavemente parole crudeli: il bambino si è abituato a non protestare; che ci sia da mangiare o non ci sia, per lui e lo stesso; non piange, non grida, non abbiamo nulla in casa, e così è. In questo barrio bisogna abituarsi a convivere col dolore, dice un amico italiano arrivato da poco. La frase mi ha colpito ed è calata nella mia preghiera; pensavo che ogni uomo dovesse abituarsi a convivere col dolore; ma qui il dolore viene in visita ogni giorno, non ha stagioni di letargo come il dolore che ciascuno porta con sé.
Si può convivere col dolore, ho detto al mio amico, quando il dolore è legato alla speranza e non annega mai nell’amarissimo mare delta disperazione. L’apprendistato che il nuovo arrivato fa del dolore ci ha offerto l’occasione di dialogare sul tema: non credo di aver fatto più luce sul mistero del dolore, ma ho visto il perché di quegli squarci di gioia e di quello sfondo permanente di felicità che accompagna la nostra vita di immigrati su una terra apparentemente disertata dalla felicità.
Ci sono tanti motivi di sofferenza, episodi che senza retorica si possono definire drammatici, eppure c’è nell’aria una felicità diffusa, come delle variazioni continue che non si sentono nella lussuosa immobilità dei quartieri ricchi. Credo che il vero rimedio contro il dolore sia quello di non confinarlo nel privato. La sofferenza senza orizzonti di donna Faustina e di altri che oggi sono venuti alla fraternità, si stende come una nube leggera nel cielo, è il grande dolore della storia. E quel gemito che Paolo sentiva in tutta la creazione come aspirazione a una fraternità costantemente ostacolata da un gettito permanente di progetti umani ispirati dall’intento di proteggere ostinatamente una privatezza egoistica.
Di questo dolore ci ha trasmesso una figurazione pittoresca il vangelo di Giovanni: «La donna, quando partorisce, prova tristezza perché è venuta la sua ora. Ma quando ha partorito il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è nato un uomo al mondo» (Gv. 16,21).
La vita con i poveri in America Latina ci offre questo tipo di sapienza per convivere col dolore e perché il dolore non intristisca la nostra vita, ma le dia rigoglio, forza, fecondità: scoprirlo come gemito, aspirazione, energia motrice della storia. E da questa esperienza interiore si scopre una sola immagine del Dio unico, il Dio dell’alleanza.
II dolore di donna Faustina ci apre a uno spazio politico, perché non esisterebbe questa periferia dissanguata, anemica se non esistesse un centro che beve avidamente sangue e si alimenta della distruzione dei miei vicini di casa, che oso chiamare fratelli. In questa tappa della mia vita, la preghiera che gestivo con una certa sicurezza e forse con un pizzico di orgoglio, mi ha abbandonato e ha ceduto il posto alla relazione: mi dirigo meno a Gesù, ma partecipo più intimamente al suo progetto.
II tipo di preghiera cui ero abituato rassomigliava a una telefonata che si apriva e si chiudeva; la relazione invece è una comunicazione permanente, è partecipazione a un progetto che faticosamente si sta realizzando nella storia. Da questo stato esistenziale vedo con ottimismo e speranza il momento storico che mi è stato concesso di vivere. Il centro di potere economico e politico celebra trionfalmente l’annessione di nuove province, mentre la periferia si fa sempre più anemica. II sistema economico-politico ed ecclesiastico funzionano con una simmetria eccezionale. La partecipazione popolare, esigenza affiorata nella evoluzione delle ideologie dell’epoca moderna, è illusa con la distribuzione di cariche senza potere, perché il centro possa decidere senza disturbi e pensare il suo progetto senza interventi estranei.
II potere si è condensato in un centro imperialistico, senza curare la periferia languente. Eppure il sistema della lontananza è una decisione dove vedo splendere la sapienza dello Spirito Santo. Né il sistema economico-politico né il sistema ecclesiastico possono intuire il mondo nuovo e le nuove identità che nascono in periferia.
Mi sento nell’epoca della venuta di Cristo: quando Gerusalemme pullulava di dottori della legge e di servitori di un potere unico che aveva la sua sede a Roma, alla periferia, sulle rive del Giordano, un profeta scarno convocava la gente a prepararsi a un grande avvenimento, visibile per loro, sconosciuto al centro: quelli del centro non avrebbero mai potuto capirlo perché l’interesse della legge e la preoccupazione di difendere il potere li aveva distratti dalla persona e resi incapaci di leggere i segni dei tempi. Le decisioni che vengono dal centro sono assolutamente vuote di popolo, non sanno nulla delle sue necessità, della sua cultura, delle sue aspirazioni e, in fondo, della sua relazione concreta col Dio dell’alleanza.
Questa estraneità mi ha fatto disperare molto tempo; ora mi dà gioia, perche vedo che questa distanza è necessaria a far rispuntare una cultura e una identità che parevano distrutte dalle invasioni del quindicesimo secolo; ma non e vero, hanno resistito al tempo, sono rimaste intatte sotto la cenere degli incendi. Bisogna attendere che donna Faustina asciughi le lacrime per vedere balzare davanti a noi la splendida vergine, la speranza. Forse non vedrò cambi rivoluzionari nelle relazioni dentro la Chiesa e dentro la società politica; ma so che nella storia è rinchiusa una energia indistruttibile che aumenta progressivamente: «Quando queste cose cominceranno ad accadere, drizzatevi e alzate la testa perché la vostra liberazione e vicina» (Lc. 21,28).
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")!!! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. Una straordinaria lezione --- Arturo Paoli, morto l’ultimo profeta. "Giusto tra le Nazioni", era lo Schindler di Lucca: aveva 102 anni.14 luglio 2015, di Federico La Sala
Arturo Paoli, morto l’ultimo profeta. Era lo Schindler di Lucca: aveva 102 anni
Da giovanissimo salvò centinaia di ebrei durante la seconda guerra mondiale (e infatti era Giusto tra le Nazioni), poi affiancò i minatori sardi negli anni Cinquanta e infine finì nelle favelas argentine, dove il regime militare mise una taglia sulla sua testa
di Ilaria Lonigro (Il Fatto, 13 luglio 2015)
Se ne va l’ultimo grande “profeta” italiano, fratello Arturo Paoli. Avrebbe compiuto 103 anni il 30 novembre. Si è spento nella notte tra domenica e lunedì nella sua abitazione di San Martino in Vignale, sulle colline di Lucca, dove negli ultimi anni riceveva decine di giovani in cerca di un consiglio o del senso della vita. Quello che lui aveva trovato camminando con gli indifesi. Prima in Italia, dove giovanissimo salvò centinaia di ebrei durante la seconda guerra mondiale (e infatti era Giusto tra le Nazioni), poi in Sardegna, al fianco dei minatori negli anni Cinquanta, quindi - “esiliato” dal Vaticano - nelle favelas argentine, fino alla condanna a morte da parte del regime militare, che lo portò a girare l’America del Sud fino al 2005, anno del ritorno in Italia.
Lo Schindler di Lucca, Giusto per Israele
Nel 1937 entra in seminario a Lucca, sua città natale. Sei anni dopo diventa il principale referente lucchese della rete Delasem, la Delegazione per l’assistenza degli emigranti ebrei di Giorgio Nissim. Con l’aiuto di altre persone, nasconde i perseguitati negli edifici del vecchio seminario in via del Giardino Botanico a Lucca. “Quanti ebrei ho salvato? Non lo so, non sono stato a contarli...” risponderà negli ultimi anni della sua vita a chi gli chiederà le cifre del suo coraggio. Che sarà riconosciuto soltanto nel 2006 con la medaglia d’oro al valore civile dal presidente della Repubblica. Nel 1999 Israele gli attribuisce l’onorificenza di Giusto tra le Nazioni, che Paoli, anche se senza polemica, non ritira.
“Esiliato”, diventa Piccolo Fratello della congregazione di de Foucault
Nel 1949 si trasferisce a Roma, come vice assistente nazionale della Gioventù cattolica. Le sue idee, così simili a quelle di sinistra, infastidiscono i vertici dell’organizzazione. Nel 1954 viene mandato “in esilio”, a fare da cappellano tra i migranti italiani in una nave diretta in Argentina. Una misura punitiva che però diventa la sua salvezza. Durante il viaggio, Arturo assiste un religioso della congregazione dei Piccoli fratelli in punto di morte. Il prete ne resta colpito e decide di voler entrare nella congregazione fondata da Charles de Foucault, che ordina di camminare coi poveri.
Per farlo, la tappa obbligatoria è il noviziato. Da eremita, nel deserto algerino. Arriva a El-Abiodh nell’ottobre 1954, portando con sé la fama di intellettuale che arriva da Roma. Un’aura insopportabile per il maestro dei novizi, Fratel Milad, che decide di sfidarlo. A lui e solo a lui vieta di leggere e scrivere per tutto il tempo del noviziato, 13 mesi. Una misura per capire quanto sia capace di rinunciare a se stesso. Dopo il deserto, “era morto un Arturo e ne era nato un altro”, racconterà Paoli. Solo da eremita riesce a liberarsi di quella che definirà “la terribile malattia che si chiama il non senso della vita”. “Passare dalla pazienza del nulla è un’esperienza che rende lieti tutta la vita: dopo non esistono più egoismi né cinismi” spiegherà.
Come Piccolo Fratello, deve lavorare. E non lavori qualsiasi, ma duri, umili. Nel 1957 viene mandato in Sardegna, per stare tra i minatori. Viene assunto per la manutenzione delle strade. In più scrive le lettere per gli abitanti, perlopiù analfabeti, da recapitare ai parenti emigrati in America. Ancora visto di cattivo occhio dalle gerarchie vaticane, viene invitato a lasciare l’Italia.
E’ il 1960, ha 48 anni. Non senza sofferenza, parte per l’Argentina. Raccolta del cotone, taglio della legna: Arturo fa i lavori più umili e intanto incita le donne delle favelas a emanciparsi, a rendersi indipendenti. A Buenos Aires conosce anche un giovane Bergoglio. Gli piacerà, nelle vesti di Papa. “Lui non c’entra nulla con i dittatori, non era ancora vescovo: era un sacerdote gesuita, è sempre andato nelle bidonville” avrà a dire in sua difesa durante le polemiche mediatiche sul passato di Papa Francesco. I due si vedranno di nuovo, nel 2014, il 18 gennaio, a Santa Marta, in un lungo incontro, rigorosamente privato, alla maniera dei colloqui ordinati da Foucault.
La taglia della dittatura sulla sua testa
In Argentina Arturo Paoli trova molti amici e una nuova patria. Ma nel 1974 è costretto ancora a partire: la dittatura militare ha posto una taglia sulla sua testa. Le sue foto sono appese per le strade. E’ al secondo posto tra i ricercati. Ripara in Venezuela, poi in Brasile, lavorando con gli ultimi e contro i potenti, sempre secondo lo spirito della Teologia della liberazione, così a lungo condannata dalla Chiesa. Nel 1984 Joseph Ratzinger, ancora cardinale, scrive che “le teologie della liberazione procedono a un pericoloso amalgama tra il povero della Scrittura e il proletariato di Marx” (Libertatis Nuntius del 6 agosto 1984).
Nel 2005, all’età di 93 anni, abbandona dopo mezzo secolo le favelas e fa ritorno in Italia. Va a vivere lontano dalla città, in un luogo isolato, circondato dai boschi, nella casa diocesana di San Martino in Vignale, sulle colline sopra Lucca, intitolata al Beato Charles de Foucauld. Con sé, la fidata Silvia Pettiti, sua segretaria personale dal 2001 e dal 2005, che lo ha seguito durante i viaggi in Brasile e che ha firmato, tra gli altri, Arturo Paoli. Ne valeva la pena (edizioni San Paolo, 2010).
Il testamento di Arturo Paoli
Non era mai stato un giorno a letto per malattia, Arturo Paoli, che, oltre al suo esempio, lascia come testamento molti libri. Demonizzava il concetto del “ce la faccio da solo” e invitava soprattutto i giovani a riscoprire i valori della lentezza e della comunità, ad abbandonare il mito dei soldi e della solitudine. Sempre calato nell’attualità, Paoli ne La rinascita dell’Italia. Messaggio ai giovani (Maria Pacini Fazzi, Ed. 2011, col contributo di Fondazione Banca del Monte di Lucca), scriveva: “Berlusconi è stato il segno più convincente che il popolo italiano si è allontanato dall’ideale di mantenere al mondo la stima di un popolo serio, lavoratore, capace di solidarietà, soprattutto di popolo maturo. Che questo vuoto sia stato colmato da un uomo che ha il merito di comprare belle ragazze per il consumo, ci dovrebbe umiliare profondamente come Italiani”. Non risparmiava accuse all’Europa, così dedita al “capitalismo” e alla “morte del prossimo”. Arturo Paoli ha inseguito un unico grande progetto: “amorizzare il mondo”. “Se riflettiamo - scriveva in Cent’anni di fraternità (Chiarelettere) - la grande e unica ricchezza della vita è l’amore”.
-
> AD ARTURO PAOLI, PER I SUOI 100 ANNI --- Il secolo (lunghissimo) di Arturo Paoli (di Marco Giorgetti)4 dicembre 2012, di Federico La Sala
Il secolo (lunghissimo) di Arturo Paoli
di Marco Giorgetti (“popoli”, dicembre 2012)
«Sono contento della mia vita, perché molte volte ho visto chiaramente l’intervento del Signore, posso dire con serenità che è stata una vita interamente guidata dalla mano di Dio». Parola di Arturo Paoli, 100 anni il prossimo 30 novembre, quasi tutti trascorsi al servizio degli «ultimi» in varie aree del mondo.
Il corpo tradisce gli inevitabili acciacchi di chi arriva a questa età, ma la mente e lo spirito sono in gran forma. Siamo andati a trovarlo sulle colline lucchesi dove ora risiede e da dove molti anni fa iniziò, appena dopo la sua ordinazione sacerdotale (avvenuta nel giugno 1940), il suo cammino insieme ai poveri e ai perseguitati. Era da poco passato l’8 settembre 1943 e, partecipando attivamente alla resistenza, Arturo Paoli collabora con la rete clandestina Delasem (Delegazione per l’assistenza degli emigranti ebrei), diretta da Giorgio Nissim, per l’assistenza agli ebrei perseguitati.
 «Sono stati anni duri - ricorda -. Il mondo cattolico lucchese era una grande rete clandestina per
l’aiuto ai fratelli ebrei. Suore, sacerdoti, monaci, erano tutti impegnati in modi diversi per la loro
salvezza. Molti hanno pagato con la vita; ricordo la strage della Certosa di Farneta (12
monaci trucidati dalle Ss, ndr) e molti altri preti furono assassinati successivamente».
«Sono stati anni duri - ricorda -. Il mondo cattolico lucchese era una grande rete clandestina per
l’aiuto ai fratelli ebrei. Suore, sacerdoti, monaci, erano tutti impegnati in modi diversi per la loro
salvezza. Molti hanno pagato con la vita; ricordo la strage della Certosa di Farneta (12
monaci trucidati dalle Ss, ndr) e molti altri preti furono assassinati successivamente».Per questo suo impegno nel 1999 lo Stato di Israele lo ha insignito dell’onorificenza di «Giusto delle Nazioni» e nel 2006 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo ha premiato con la medaglia d’oro al valore civile.
 «Sinceramente non mi aspettavo questi riconoscimenti, mi hanno
fatto piacere, anche se a me basta sapere di avere servito bene il Signore e i fratelli in vicende
difficili, il resto sono cose di uomini».
«Sinceramente non mi aspettavo questi riconoscimenti, mi hanno
fatto piacere, anche se a me basta sapere di avere servito bene il Signore e i fratelli in vicende
difficili, il resto sono cose di uomini».Dopo la guerra, nel 1949 viene chiamato a Roma da mons. Giovanni Battista Montini (allora pro-segretario di Stato e futuro papa Paolo VI), e inizia l’impegno in Azione cattolica come vice-assistente nazionale.
 «Erano gli anni della rinascita
dell’Italia, furono anni belli e intensi. Ho un bellissimo ricordo di monsignor Montini, un uomo
che mi è stato profondamente amico, con il quale ho condiviso grandi progetti, non solo
nell’Azione cattolica. Ma non voglio negare anche il difficile rapporto con Luigi Gedda (presidente
della stessa Ac) e con i suoi comitati civici, che sono stati a mio parere la rovina della
Democrazia cristiana. Si verificarono continue divergenze che in poco tempo mi portarono a
lasciare “forzatamente” l’Italia».
«Erano gli anni della rinascita
dell’Italia, furono anni belli e intensi. Ho un bellissimo ricordo di monsignor Montini, un uomo
che mi è stato profondamente amico, con il quale ho condiviso grandi progetti, non solo
nell’Azione cattolica. Ma non voglio negare anche il difficile rapporto con Luigi Gedda (presidente
della stessa Ac) e con i suoi comitati civici, che sono stati a mio parere la rovina della
Democrazia cristiana. Si verificarono continue divergenze che in poco tempo mi portarono a
lasciare “forzatamente” l’Italia».RINASCERE NEL DESERTO
Dopo un periodo come assistente spirituale agli emigranti sulle navi dirette verso il continente americano, Arturo Paoli affronta un’esperienza che cambierà la sua vita: il deserto algerino.
 «Nel deserto sono morto e risuscitato. Ho rischiato di perdere totalmente la fede, senza la quale
per me rimaneva solo il suicidio. Fu un periodo tremendo, non avevo desiderio di vita, davanti
a me solo il nulla. Ma, proprio nel deserto, Dio si è fatto sentire nitidamente. La mia
resurrezione è avvenuta attraverso un pellegrinaggio di 600 chilometri, a piedi. Il Signore
camminava con me, sentivo forte la sua presenza e una frase che ripetutamente mi
risuonava dentro: “Non siete voi che amate me, ma sono io che amo voi”».
«Nel deserto sono morto e risuscitato. Ho rischiato di perdere totalmente la fede, senza la quale
per me rimaneva solo il suicidio. Fu un periodo tremendo, non avevo desiderio di vita, davanti
a me solo il nulla. Ma, proprio nel deserto, Dio si è fatto sentire nitidamente. La mia
resurrezione è avvenuta attraverso un pellegrinaggio di 600 chilometri, a piedi. Il Signore
camminava con me, sentivo forte la sua presenza e una frase che ripetutamente mi
risuonava dentro: “Non siete voi che amate me, ma sono io che amo voi”».Dopo l’ingresso nella congregazione religiosa dei Piccoli Fratelli di Gesù, ispirata a Charles de Foucauld, il sacerdote toscano cerca di rientrare in Italia, ma le numerose pressioni politiche esercitate da Gedda in Vaticano lo portano nuovamente lontano. Sceglie l’Argentina e il Sudamerica, dove rimarrà circa 45 anni.
Qui, oltre a fondare diverse comunità dei Piccoli Fratelli, si impegna nell’assistenza ai parenti dei desaparecidos, nelle lotte a fianco dei campesinos sfruttati dai latifondisti, nell’assistenza a ragazze madri e a bambini abbandonati.
Nel 1969 Arturo Paoli aderisce alla Teologia della liberazione, un’esperienza perlopiù osteggiata dalle gerarchie, ma su cui Paoli non ha dubbi.
 «La Teologia della liberazione è stata vittima di
numerosi equivoci. Volutamente strumentalizzata dai suoi avversari, da chi aveva paura di perdere
privilegi, è stata prima accostata a teorie marxiste e poi a derive di lotta armata. Ma non
c’entra niente con queste falsità. È solo un cammino cristiano di liberazione dalla miseria e di
presa di coscienza dei propri diritti. Oggi ci sono molti gruppi, soprattutto in Brasile, che stanno
riprendendo quel cammino».
«La Teologia della liberazione è stata vittima di
numerosi equivoci. Volutamente strumentalizzata dai suoi avversari, da chi aveva paura di perdere
privilegi, è stata prima accostata a teorie marxiste e poi a derive di lotta armata. Ma non
c’entra niente con queste falsità. È solo un cammino cristiano di liberazione dalla miseria e di
presa di coscienza dei propri diritti. Oggi ci sono molti gruppi, soprattutto in Brasile, che stanno
riprendendo quel cammino».Gli anni Settanta, in America latina, sono anche quelli del golpe cileno, della dittatura militare in Argentina e delle guerre civili in America centrale.
 «In Argentina ho visto cose inenarrabili - racconta padre Arturo -, a partire da una Chiesa quasi
totalmente connivente con il regime militare. Se l’episcopato argentino (come quello cileno, peraltro)
si fosse opposto fermamente alla repressione, sono sicuro che le gerarchie militari non avrebbero
osato fare quello che hanno commesso; lo ha confessato recentemente anche lo stesso generale
Arturo Videla. Ben diversamente andarono le cose in America centrale. Anche lì sono stati pagati
enormi tributi di sangue, ma la posizione della Chiesa è stata diversa. Basti ricordare Oscar
Romero e la grande testimonianza dei gesuiti salvadoregni, oppure l’esperienza del governo
sandinista in Nicaragua nel 1979, al cui interno c’erano quattro religiosi con cariche ministeriali.
Credo sia stato giusto da parte loro portare un contributo diretto, il Nicaragua si stava
rialzando dopo una guerra civile cruenta».
«In Argentina ho visto cose inenarrabili - racconta padre Arturo -, a partire da una Chiesa quasi
totalmente connivente con il regime militare. Se l’episcopato argentino (come quello cileno, peraltro)
si fosse opposto fermamente alla repressione, sono sicuro che le gerarchie militari non avrebbero
osato fare quello che hanno commesso; lo ha confessato recentemente anche lo stesso generale
Arturo Videla. Ben diversamente andarono le cose in America centrale. Anche lì sono stati pagati
enormi tributi di sangue, ma la posizione della Chiesa è stata diversa. Basti ricordare Oscar
Romero e la grande testimonianza dei gesuiti salvadoregni, oppure l’esperienza del governo
sandinista in Nicaragua nel 1979, al cui interno c’erano quattro religiosi con cariche ministeriali.
Credo sia stato giusto da parte loro portare un contributo diretto, il Nicaragua si stava
rialzando dopo una guerra civile cruenta».PER USCIRE DALLA CRISI
Cosa pensa, chiediamo, della situazione attuale dell’America Latina?
 «Il continente ha fatto passi
enormi da quei tempi. Oggi credo che il Brasile possa rappresentare un punto di riferimento
importante in quell’area, grazie anche alle scelte fatte sotto la presidenza Lula, che hanno
sviluppato una rete di collaborazioni privilegiate, su vari settori, con altri Stati sudamericani, più
che con le solite superpotenze. Questa scelta politica rappresenta la via per l’effettiva emancipazione
del Sud del mondo: allearsi tra simili, cercando l’indipendenza dai soliti “giganti” del Nord».
«Il continente ha fatto passi
enormi da quei tempi. Oggi credo che il Brasile possa rappresentare un punto di riferimento
importante in quell’area, grazie anche alle scelte fatte sotto la presidenza Lula, che hanno
sviluppato una rete di collaborazioni privilegiate, su vari settori, con altri Stati sudamericani, più
che con le solite superpotenze. Questa scelta politica rappresenta la via per l’effettiva emancipazione
del Sud del mondo: allearsi tra simili, cercando l’indipendenza dai soliti “giganti” del Nord».Ma quello di Arturo Paoli è uno sguardo lungo un secolo, che non si concentra solo sulle vicende latinoamericane. Viene spontaneo allora chiedergli qualche parola anche sulla crisi, non solo economica, in cui siamo immersi.
 «Dobbiamo uscire dall’idolatria del “mercato”. La politica si
è sottomessa da tempo ai dettami economici che creano, direttamente o indirettamente, migliaia
di morti e molta sofferenza. L’uomo deve riprendere le redini della propria esistenza, uscire dalle
ipocrisie che si è creato da solo; il precariato, grandissima piaga sociale, viene chiamato “flessibilità”.
Ci siamo creati, da soli, dogmi economici che non osiamo mettere in discussione, anche se è
evidente che stiamo scivolando sempre di più in fondo al baratro. Viviamo una frammentazione
causata da un individualismo alimentato ad arte da una certa cultura. Abbiamo più mezzi di
comunicazione, ma siamo più isolati: tutto a vantaggio dei grandi « centri di potere economico
che ci manipolano mediaticamente a loro piacimento. Anche in questo la Chiesa ha
responsabilità, con le sue connivenze silenziose con governi dei potenti di turno».
«Dobbiamo uscire dall’idolatria del “mercato”. La politica si
è sottomessa da tempo ai dettami economici che creano, direttamente o indirettamente, migliaia
di morti e molta sofferenza. L’uomo deve riprendere le redini della propria esistenza, uscire dalle
ipocrisie che si è creato da solo; il precariato, grandissima piaga sociale, viene chiamato “flessibilità”.
Ci siamo creati, da soli, dogmi economici che non osiamo mettere in discussione, anche se è
evidente che stiamo scivolando sempre di più in fondo al baratro. Viviamo una frammentazione
causata da un individualismo alimentato ad arte da una certa cultura. Abbiamo più mezzi di
comunicazione, ma siamo più isolati: tutto a vantaggio dei grandi « centri di potere economico
che ci manipolano mediaticamente a loro piacimento. Anche in questo la Chiesa ha
responsabilità, con le sue connivenze silenziose con governi dei potenti di turno».Si torna sempre lì, a una Chiesa così amata, ma a cui don Arturo Paoli non risparmia critiche:
 «Io verifico da tempo, tra le tante cose, anche il precipitare delle vocazioni sacerdotali; i nostri
seminari e i nostri conventi sono vuoti. È una cosa che mi addolora profondamente: se fossimo
stati fedeli alle riforme del Concilio Vaticano II non ci troveremmo in questa condizione.
Dobbiamo interrogarci su cosa siamo chiamati a fare, come testimoni di Cristo, nel terzo millennio.
Dobbiamo uscire da una teologia astratta, da una fede dottrinale: dovremmo vivere più
concretamente il Vangelo, cercando anzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia».
«Io verifico da tempo, tra le tante cose, anche il precipitare delle vocazioni sacerdotali; i nostri
seminari e i nostri conventi sono vuoti. È una cosa che mi addolora profondamente: se fossimo
stati fedeli alle riforme del Concilio Vaticano II non ci troveremmo in questa condizione.
Dobbiamo interrogarci su cosa siamo chiamati a fare, come testimoni di Cristo, nel terzo millennio.
Dobbiamo uscire da una teologia astratta, da una fede dottrinale: dovremmo vivere più
concretamente il Vangelo, cercando anzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia».A 100 anni la morte fa meno paura?
 «Spero di incontrare presto il Padre di noi tutti, molto spesso prego perché
ciò si realizzi, ho atteso tutta una vita. Lo riconoscerò perché mi sorriderà, un Padre sorride
sempre con amore guardando i suoi figli».
«Spero di incontrare presto il Padre di noi tutti, molto spesso prego perché
ciò si realizzi, ho atteso tutta una vita. Lo riconoscerò perché mi sorriderà, un Padre sorride
sempre con amore guardando i suoi figli». -
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")!!! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. ---- Don Arturo Paoli, 100 anni molto scomodi (di Maurizio Chierici)1 dicembre 2012, di Federico La Sala
Don Arturo Paoli, 100 anni molto scomodi
di Maurizio Chierici (il Fatto Quotidiano, 30 novembre 2012)
Occhi allegri, capelli bianchi come Chaplin nella vecchiaia: Arturo Paoli compie 100 anni. Ha attraversato il secolo breve nei gironi dei senza nome. Parla a voce bassa, ma la voce rimbomba appena l’analisi umilia la vita degli altri. Batte l’indice sul tavolo per far capire di non sopportare la povertà dei poveri, spazzatura fastidiosa per la società degli affari. Quasi un miliardo di ombre.
Era ragazzo quando attorno alla sua Lucca le squadre nere bastonano a morte Giovanni Amendola, deputato liberale. Frequenta il ginnasio mentre Mussolini scioglie l’aula grigia del parlamento. Laurea in lettere a Pisa, la vocazione arriva l’anno dopo. A 34 anni rischia la vita per salvare un ebreo tedesco, Zvi Yaciov Gerstel, famoso per gli studi sul Talmud. Per Israele diventa un “giusto tra le nazioni”. La Resistenza continua e continua la paura, ma non si arrende. 800 ebrei rubati da un piccolo prete ai treni della morte.
Nel ’49 lo chiamano a Roma: vice assistente nazionale dell’Azione Cattolica, presidente Carlo Carretto. “A quel tempo i giovani cattolici dovevano solo voler bene e aiutare il papa...”. Contemplazione sterile fino a quando nel ’52 comincia “la seconda vita”, mescolamento che arriva ai nostri giorni “segnati dalla debolezza politica e incapacità di trasformare la storia per inseguire i sondaggi”. I
ntanto Luigi Gedda inventa i comitati civici che organizzano i credenti in macchine da guerra impegnate a distruggere le sinistre senza Dio. Papa Pacelli e la Confindustria benedicono l’operazione elettorale alla quale si sentono estranei giovani e non giovani che attribuiscono alla fede una speranza diversa.
Non ci stanno Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti, Davide Turoldo. Anche Paoli non è d’accordo. Fra loro, ragazzi che non hanno smesso di scrivere. “Anni fa ho ritrovato Umberto Eco. Leggeva soprattutto Maritain...”. Carretto si rifugia nella congregazione dei Piccoli Fratelli di Charles Foucault, uno dei tre beati proclamati da Ratzinger appena papa. I segni continuano a intrecciarsi. Viene esiliato nelle navi che portano gli italiani usciti dalle rovine della guerra nell’Argentina del benessere: assistente spirituale.
Incontra un Piccolo Fratello in agonia e decide di continuarne la vocazione. Il noviziato gli fa capire cosa lo aspetta: testimoniare la fede senza una parola, facchino attorno al deserto ad Algeri che insorge contro la colonia francese. “Era il 1954, avevo 42 anni. I ragazzi musulmani coi quali scaricavo le navi trattavano con rispetto il marabut, la persona religiosa. Prima di cominciare il lavoro mi baciavano la fronte. Non importa se il mio Dio aveva un nome diverso. Dalla finestra ho visto i legionari di Parigi calpestare la testa di un arabo quasi fosse un topo”.
Raggiunge Carretto nel deserto, esercizio di meditazione lungo 600 chilometri. Camminano per settimane in coda a carovane di cammelli: “È stata l’avventura spirituale più bella della vita. I venti portavano i semi dall’Olanda, nella sabbia fiorivano tulipani”.
Torna in Italia, minatore in Sardegna, ma la burocrazia vaticana si infastidisce e comincia l’avventura nell’altra America.
Boscaiolo in Argentina dove organizza i taglialegna in sindacato quando la multinazionale inglese chiude i cantieri. Diventa superiore (sorride nel ricordare la parola) dei Piccoli Fratelli dell’America Latina. Incontra un vescovo col quale discute “una teologia comprometida”, impegnata nel sociale: diventa la base sulla quale si forma la teologia della liberazione.
Il vescovo è Enrique Angelelli, voce critica dell’Argentina soffocata dai militari. Se ne liberano fingendo un incidente. Paoli va in Cile in quel ’73 del golpe di Pinochet. Come in Argentina, nei manifesti che il regime incolla lungo le strade il suo nome è il numero due fra i “ ricercati pericolosi”. Una volta ne ho parlato con l’ingegnere Augusto Pinochet junior, militare affogato in affari oscuri che l’hanno portato in galera. Sotto il ritratto del generale padre ne difendeva la memoria. “Paoli non era un terrorista...”, provo a dire. “Era il Che dei cattolici. Gli amici vaticani lo consideravano così”. Si rifugia in Brasile, nell’immensa favela di Boa Esperança attorno alle cascate di Iguaçu, miseria dei relitti che la disperazione raccoglie sotto le lamiere. 1987: trasforma la città degli stracci nella città della comprensione e della solidarietà attraverso una cultura che distribuisce nelle scuole costruite con l’ostinazione di chi bussa alle porte allungando la mano della carità.
Una volta, in Italia, legge su Repubblica la polemica tra Eugenio Scalfari e Pietro Citati a proposito del capitalismo e protesta col direttore: “Mi ha colpito il suo mettere in evidenza il mercato come elevato a divinità perché da anni ne denuncio l’idolatria... Questa visione per me è quotidianità quando, all’alba, apro la porta di casa e trovo nei vicoli della favela persone che gemono sotto le ruote del mercato. Sono la mia famiglia”.
Finalmente a Lucca, viceparroco di una chiesa sulle colline, ma la vita non cambia: come a Iguaçu, ogni giorno arrivano pentole e signore che mettono a tavola il prete che non si arrende. Scrive per Rocca, Cittadella di Assisi. Accende dibattiti a proposito dell’arroganza della società che massacra i diseredati. Nel 2005 il vescovo di Trento lo chiama ad accompagnare con le sue parole la marcia della pace organizzata da Pax Christi e riaffiora la diffidenza della Cei del cardinale Ruini. Non lo vogliono nel timore potesse strumentalizzare ideologicamente la manifestazione. “Se strumentalizzazione vuol dire solidarietà sono d’accordo”.
Censura annacquata dall’ipocrisia di un comunicato che annuncia: “Paoli non può perché non è di Trento”. L’ultimo libro è La pazienza del nulla, editore Chiarelettere, un’esplosione di gioia: la vecchiaia rende liberi. Nessun ricordo, nessun rimpianto (come nel Norberto Bobbio di De senectute). Il piccolo fratello vola lontano dal passato in un futuro che raggiunge la speranza
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")!!! L’idolatria del denaro ---- Fede e utopia del Regno di Dio (di Arturo Paoli) --- Arturo Paoli, una biografia (di Oreundici)29 novembre 2012, di Federico La Sala
Fede e utopia del Regno di Dio
di fratel Arturo Paoli (la Repubblica, 25 agosto 2012)
Egregio e caro Direttore,
ho provato un’emozione profonda nel leggere l’articolo di Pietro Citati del 12 agosto e il suo del 15. Sono un religioso cattolico, piccolo fratello di Charles di Foucauld, da 36 anni in America Latina. Torno in Italia ogni anno per incontrarmi con piccoli gruppi di cristiani che identificano la loro fede con l’utopia, con i quali cerco di illuminare la speranza del "Regno". L’allusione al "Regno di Dio", anche se fasciata d’ironia, non poteva non farmi vibrare.
Mi ha colpito il suo mettere in evidenza il mercato come "elevato a divinità" perché da anni denunzio l’idolatria del mercato. Ciò mi è stato spesso rinfacciato come prova d’ignoranza delle dottrine economiche. Sono cosciente della mia ignoranza ma, guardando l’idolatria del mercato nella prospettiva del "Regno", non vedo che "i milioni di persone stritolate sotto le ruote del mercato". Questa visione è per me quotidiana da quando, all’alba, apro la porta della mia casa e trovo subito nei vicoli della "favela" le persone che gemono sotto le ruote del mercato, e sono la mia famiglia...
La "distanza ironica" con cui lei e Citati hanno guardato il "Regno di Dio" non mi provoca ad una impennata apologetica perché sono d’accordo sulla pericolosità del concetto, e alla rievocazione dei fantasmi di Stalin e di Hitler aggiungerei gli integrismi religiosi, originati dall’utopia del "Regno". Ma, come credente, mi ha dolorosamente ricordato che la distanza ironica non è solamente di voi laici, ma è anche di noi cristiani. La nostra non si può definire ironica, perché forse è di qualità peggiore.
Nonostante la chiarezza con cui il Regno di Dio è stato messo al centro dell’azione della Chiesa, specificandone l’essenza di giustizia e di pace, e indicandone i limiti di estraneità da ogni realizzazione politica strutturale, l’utopia del "Regno" è rimasta estranea alla prassi della Chiesa cattolica. E’ evidente che Gesù di Nazareth non ha affidato l’utopia del "Regno" né a dittatori né a intellettuali della categoria dei pensatori liberali. Ma una parte di Chiesa non ha guardato la storia dalla prospettiva dei poveri come avrebbe voluto il discorso della montagna. Tuttavia non mancano pastori e discepoli del Maestro che pagano con la vita l’opposizione all’idolatria di mercato, vivendola come "ostaggi" dei poveri, come direbbe Lévinas.
Ho esultato leggendo i vostri articoli: Lei ha introdotto il suo richiamo all’articolo di Citati con la parola "speranza". Ci ha ricordato che l’umanità non può vivere senza ideali e vede l’ideale come una correzione storica dell’utopia. Questo può costituire un punto d’incontro fra noi credenti e voi laici. Se noi credenti abbiamo l’onestà di scoprire nel vostro linguaggio spregiudicato e ironico la profezia, cioè quel filo sottile che corre ininterrotto sotto le scoraggianti catastrofi della storia; e se voi laici avete l’onestà di pensare che noi credenti, almeno "il piccolo resto" rivolto all’attesa del "Regno", non ha nessuna ipoteca da pagare ma è solo impegnato nella solidarietà con "gli stritolati" sotto il carro dall’idolo, e riconosce nel Maestro nudo sulla croce il prezzo di questa solidarietà. In fondo l’amore, che laicamente possiamo chiamare altruismo, anche crocifisso, è la sola vera felicità dell’uomo, perché racchiude in sé il solo senso del vivere. fratello Arturo Paoli
Arturo Paoli, una biografia
di Oreundici (www.oreundici.org)
Arturo Paoli nasce a Lucca in via Santa Lucia il 30 novembre 1912, si laurea in Lettere a Pisa nel 1936, entra in seminario l’anno successivo e viene ordinato sacerdote nel giugno 1940. Partecipa tra il 1943 e il 1944 alla Resistenza e svolge la sua missione sacerdotale a Lucca fino al 1949, quando viene chiamato a Roma come vice-assistente della Gioventù di Azione Cattolica, su richiesta di Mons. Montini, poi papa Paolo VI. Qui si scontra con i metodi e l’ideologia di Luigi Gedda, presidente generale dell’Azione Cattolica e all’inizio del 1954 riceve l’ordine di lasciare Roma per imbarcarsi come cappellano sulla nave argentina "Corrientes", destinata al trasporto degli emigranti.
Arturo compie solo due viaggi. Sulla nave incontra un Piccolo fratello della Fraternità di Lima, Jean Saphores, che Arturo assisterà in punto di morte. A seguito di questo incontro decide di entrare nella congregazione religiosa ispirata a Charles de Foucauld e vive il periodo di noviziato a El Abiodh, al limite del deserto, in Algeria. Poi passa ad Orano dove, negli anni della lotta di liberazione algerina, svolge mansioni di magazziniere in un deposito del porto. Nel 1957 viene incaricato di fondare una nuova Fraternità a Bindua, zona mineraria della Sardegna, dove lavora manualmente: ma il suo rientro in Italia non viene ben visto dalle autorità vaticane.
Decide allora di trasferirsi stabilmente in America Latina e si trasferisce in Argentina a Fortin Olmos, tra i boscaioli - hacheros - che lavorano per una compagnia inglese del legname. Sarà questo uno dei periodi più duri dell’esperienza latino-americana. Quando la compagnia decide di abbandonare la zona ormai impoverita del prezioso legno quebracho, Arturo organizza una cooperativa per permettere ai boscaioli di continuare a vivere sul posto.
Nel 1969 viene scelto come superiore regionale della comunità latinoamericana dei Piccoli Fratelli, trasferendosi vicino a Buenos Aires. Qui vivono i novizi della fraternità e si comincia a delineare una teologia comprometida, preludio dell’adesione alla teologia della Liberazione. In questo periodo pubblica il suo secondo libro Dialogo della liberazione. Nel 1971 nasce un nuovo noviziato a Suriyaco, nella diocesi di La Rioja, una zona semidesertica, poverissima, dove Arturo si trasferisce e incontra un vescovo a cui sarà legato da una forte amicizia, Enrique Angelelli, la voce più profetica della Chiesa argentina nei tremendi anni della dittatura militare: un prelato che doveva morire tragicamente nel 1976 in uno strano incidente stradale che oggi nessuno dubita di qualificare come assassinio e su cui nessuno svolgerà inchieste, malgrado l’espressa richiesta di Paolo VI.
Con il ritorno di Peron in Argentina il clima politico si fa pesante e Arturo viene accusato di esercitare un traffico d’armi con il Cile. In quel momento in Cile governava Allende, destituito nell’apocalittica giornata dell’11 settembre 1973 dal colpo di stato di Pinochet. Nel 1974 appare sui muri di Santiago un manifesto con una lista di persone da eliminare da parte di "chiunque le incontri": il nome di Arturo è al secondo posto. Alcuni Piccoli fratelli vengono incarcerati e cinque di loro figureranno tra le migliaia di desaparecidos. Arturo in questo momento si trova in Venezuela, come responsabile dell’area latinoamericana dell’Ordine: avvertito da amici di non rientrare in Argentina perché ricercato vi tornerà solo nel 1985.
Inizia così l’esperienza venezuelana, prima a Monte Carmelo, poi alla periferia di Caracas, continuando, anzi intensificando, la sua produzione libraria: "Il presente non basta a nessuno", "Il grido della terra" e tanti, tanti altri...
Con l’allentarsi della dittatura militare, Arturo intensifica le sue missioni in Brasile, risiedendo dal 1983 a Sao Leopoldo ed entrando in contatto con la realtà delle prostitute, numerose nel suo quartiere.
Nel 1987 si trasferisce su richiesta del vescovo locale a Foz do Iguaçu: qui va a vivere nel barrio di Boa Esperança dove costituisce una comunità. Ma, ricorda fratel Arturo, "la condizione di estrema povertà della gente del quartiere mi tormentava e da questa angoscia nacque l’idea di creare l’Associazione Fraternità e Alleanza", un ente filantropico, senza fini di lucro, con progetti sociali rivolti al bene della comunità.
Sono seguiti 13 anni di duro e intenso lavoro per dare dignità a questa popolazione emarginata. Oggi AFA è una bella realtà, cui si è aggiunta nel 2000 la Fondazione Charles de Foucauld rivolta in maniera specifica ai giovani del proletariato e del sottoproletariato di Boa Esperança. Insieme i due enti portano avanti numerosi mini-progetti che coinvolgono direttamente oltre 2000 persone fra adulti, adolescenti e bambini: ludoteca, ambulatorio, doposcuola (raggruppati nel progetto denominato "bambini denutriti"), casa della donna, mensa, corale, corsi di musica, di informatica, attività sportive... Progetti mirati alla formazione umana e resi possibili dall’aiuto di tanti, tanti amici italiani che li finanziano nella loro quasi totalità.
Arturo dal 2004 con don Mario De Maio, presidente di Oreundici, ha lanciato il progetto "Madre Terra": una fattoria didattica (dell’estensione di circa 40 ettari), sempre nella periferia di Foz do Iguaçu, dove alcuni giovani (provenienti dalle case-famiglia già seguite e finanziate da "Oreundici"), hanno trovato un posto di lavoro, una "famiglia allargata", lo spazio e la possibilità per crescere e confrontarsi anche con i tanti amici italiani che seguono questo progetto e curano l’amicizia tra questi due popoli, sotto lo sguardo amirevole e paterno di Arturo. Oggi il progetto "Madre Terra" permette di accrescere questa amicizia, con il vivificante e salutare contatto con la bellezza aspra e affascinante della natura brasiliana.
Lontano ma presente, l’impegno religioso e sociale nel sud del mondo non ha impedito a fratel Arturo di vivere appassionatamente gli avvenimenti italiani e lucchesi. Nell’agosto 1995 interviene su "La Repubblica" dopo aver letto la corrispondenza fra Eugenio Scalfari, allora direttore del giornale, e lo scrittore Pietro Citati.
A Scalfari scrive una lettera che viene pubblicata con il titolo "Fede ed Utopia del Regno di Dio":
 "mi ha colpito il suo mettere in evidenza il mercato come elevato a divinità, perché da anni
denunzio l’idolatria del mercato. Ciò mi è stato spesso rinfacciato come prova di ignoranza delle
dottrine economiche. Sono cosciente della mia ignoranza, ma guardando l’idolatria del mercato
nella prospettiva del Regno non vedo altro che milioni di persone stritolate sotto le ruote del
mercato. Questa visione per me è quotidiana quando, all’alba, apro la porta della mia casa e trovo
subito nei vicoli della favela le persone che gemono sotto le ruote del mercato, e sono la mia
famiglia..."
"mi ha colpito il suo mettere in evidenza il mercato come elevato a divinità, perché da anni
denunzio l’idolatria del mercato. Ciò mi è stato spesso rinfacciato come prova di ignoranza delle
dottrine economiche. Sono cosciente della mia ignoranza, ma guardando l’idolatria del mercato
nella prospettiva del Regno non vedo altro che milioni di persone stritolate sotto le ruote del
mercato. Questa visione per me è quotidiana quando, all’alba, apro la porta della mia casa e trovo
subito nei vicoli della favela le persone che gemono sotto le ruote del mercato, e sono la mia
famiglia..."A Lucca nel 1995 il sindaco Giulio Lazzaroni gli consegna il Diploma di partigiano. In quell’occasione fratel Arturo pronuncia queste parole:
 "... la Resistenza non si è chiusa nell’ambito del 1945 e se noi non soffriamo fortemente di
appartenere ad una famiglia che fabbrica le armi, che manda le mine che straziano i corpi dei
bambini, se noi non pensiamo che il nostro benessere lo pagano milioni di affamati, se noi non
pensiamo che mandiamo bastimenti carichi di armi nell’Africa, nella vicina Jugoslavia, ecc... e se
noi non soffriamo nella nostra carne per questo scandalo vuol dire che la Resistenza è stata
un’azione valorosa, generosa o forse anche una manifestazione di coraggio, ma non è stato qualcosa
che ha aderito profondamente alla nostra anima, che è diventata legge della nostra vita... e perché
questa celebrazione non sia retorica... forse oggi più di ieri c’è bisogno di resistere".
Questo atteggiamento lo spinge a rifiutare la medaglia d’oro che annualmente la Camera di
Commercio assegna ai lucchesi che hanno onorato la città nel mondo. La lettera pubblicata suscitò
non poche polemiche:
"... la Resistenza non si è chiusa nell’ambito del 1945 e se noi non soffriamo fortemente di
appartenere ad una famiglia che fabbrica le armi, che manda le mine che straziano i corpi dei
bambini, se noi non pensiamo che il nostro benessere lo pagano milioni di affamati, se noi non
pensiamo che mandiamo bastimenti carichi di armi nell’Africa, nella vicina Jugoslavia, ecc... e se
noi non soffriamo nella nostra carne per questo scandalo vuol dire che la Resistenza è stata
un’azione valorosa, generosa o forse anche una manifestazione di coraggio, ma non è stato qualcosa
che ha aderito profondamente alla nostra anima, che è diventata legge della nostra vita... e perché
questa celebrazione non sia retorica... forse oggi più di ieri c’è bisogno di resistere".
Questo atteggiamento lo spinge a rifiutare la medaglia d’oro che annualmente la Camera di
Commercio assegna ai lucchesi che hanno onorato la città nel mondo. La lettera pubblicata suscitò
non poche polemiche:
 "Conosco personalmente alcuni di voi per non dubitare della vostra nobilissima intenzione, ma
permettetemi di rifiutare un premio come missionario cattolico. A parte il fatto di sapere che il solo
suggello che posso mettere sui quarant’anni di vita in America Latina è quello suggeritomi dal
Vangelo "sono un servo inutile", mi tormenta un’altra considerazione. Appartengo per nascita e
formazione all’occidente che globalmente si dice cristiano, dalle Montagne Rocciose agli Urali, ed è
incontestabile che questo mondo cristiano che si definisce Primo Mondo è al centro delle ingiustizie
che sono la causa della fame di milioni di esseri che il catechismo ci ha insegnato a chiamare
fratello: io torno in Brasile e non posso tornarvi ostentando sul petto una medaglia che premia la
mia attività di ’missionario’, rappresentante di una civiltà cristiana che spoglia della terra esseri
umani che vi vivono da secoli prima di Cristo. E questa spoliazione dura dal 1492".
"Conosco personalmente alcuni di voi per non dubitare della vostra nobilissima intenzione, ma
permettetemi di rifiutare un premio come missionario cattolico. A parte il fatto di sapere che il solo
suggello che posso mettere sui quarant’anni di vita in America Latina è quello suggeritomi dal
Vangelo "sono un servo inutile", mi tormenta un’altra considerazione. Appartengo per nascita e
formazione all’occidente che globalmente si dice cristiano, dalle Montagne Rocciose agli Urali, ed è
incontestabile che questo mondo cristiano che si definisce Primo Mondo è al centro delle ingiustizie
che sono la causa della fame di milioni di esseri che il catechismo ci ha insegnato a chiamare
fratello: io torno in Brasile e non posso tornarvi ostentando sul petto una medaglia che premia la
mia attività di ’missionario’, rappresentante di una civiltà cristiana che spoglia della terra esseri
umani che vi vivono da secoli prima di Cristo. E questa spoliazione dura dal 1492".Il 29 novembre 1999 a Brasilia, l’ambasciatore d’Israele gli consegna il più alto riconoscimento attribuito a cittadini non ebrei: ’Giusto tra le nazioni’, per aver salvato nel 1944 a Lucca la vita di Zvi Yacov Gerstel, allora giovane ebreo tedesco, oggi tra i più noti studiosi del Talmud, e sua moglie. Il nome di fratel Arturo, "salvatore non solo della vita di una persona, ma anche della dignità dell’umanità intera", sarà inciso nel Muro d’Onore dei Giusti a Yad Vashem.
Il 9 febbraio 2000 a Firenze la Regione Toscana, su iniziativa del suo Presidente Vannino Chiti, alla presenza del Cardinale di Firenze Silvano Piovanelli e del rabbino di Firenze Yoseph Levi, festeggia il sessantesimo anniversario di fratel Arturo. In questa circostanza fratel Arturo dirà: "Tutta la nostra cultura è una cultura di morte, l’occidente cristiano è il centro che ha organizzato la guerra, la carestia, l’accumulazione delle ricchezze nelle mani di pochi".
Il cardinale Piovanelli, dopo aver ricordato che don Paoli è stato un punto di riferimento importante nella sua formazione religiosa, sottolineerà:
 "Siamo sempre rimasti colpiti dalle sue parole, dai suoi libri, ma soprattutto abbiamo ammirato il
coraggio di una vita compromessa per stare dalla parte dei più deboli".
Il 25 aprile 2006, l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito la
Medaglia d’oro al valor civile. L’alto riconoscimento, andato ad Arturo e ad altri tre sacerdoti
lucchesi (don Renzo Tambellini, e gli scomparsi don Guido Staderini e don Sirio Niccolai), è
riferito all’impegno profuso nel salvare la vita ai perseguitati dai nazifascisti, in particolare ebrei,
con la seguente motivazione:
"Siamo sempre rimasti colpiti dalle sue parole, dai suoi libri, ma soprattutto abbiamo ammirato il
coraggio di una vita compromessa per stare dalla parte dei più deboli".
Il 25 aprile 2006, l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito la
Medaglia d’oro al valor civile. L’alto riconoscimento, andato ad Arturo e ad altri tre sacerdoti
lucchesi (don Renzo Tambellini, e gli scomparsi don Guido Staderini e don Sirio Niccolai), è
riferito all’impegno profuso nel salvare la vita ai perseguitati dai nazifascisti, in particolare ebrei,
con la seguente motivazione:«Nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, con encomiabile spirito cristiano e preclara virtù civica, collaborò alla costruzione di una struttura clandestina, che diede ospitalità ed assistenza ai perseguitati politici e a quanti sfuggirono ai rastrellamenti nazifascisti dell’alta Toscana, riuscendo a salvare circa 800 cittadini ebrei. Mirabile esempio di grande spirito di sacrificio e di umana solidarietà»
Oggi Arturo, tornato stabilmente in Italia dal 2006, vive nella Casa "Beato Charles de Foucauld" a san Martino in Vignale sulle colline di Lucca, dove accoglie le persone in un clima di amicizia, fraternità ed accoglienza, partecipa a convegni e incontri, pubblica nuovi libri, continua la consueta collaborazione con giornali e periodici, tra i quali i Quaderni mensili di Oreundici.
Il 3 dicembre 2011 è stato inaugurato il "fondo documentazione Arturo Paoli", una raccolta di immagini, video, scritti a testimonianze della sua vita. Il fondo ha sede nella Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino a Lucca è aperto al pubblico su prenotazione (info: http://www.fondazionebmlucca.it/attivita/propri/fap/fondopaoli.html).
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")!!! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. --- Ateismo, idolatria e capitalismo (di don Aldo Antonelli - una nota).16 marzo 2012
ATEISMO E IDOLATRIA
di don Aldo Antonelli
Questa notte è stata un pò lunga e, nel lungo vegliare, mi si è posta, impertinente, una domanda: "Aldo, ma perché ti danno tanto fastidio le credulità feticiste dei molti credenti, mentre provi solidarietà verso l’ateismo dei non-credenti?".
Mi sono tornate a mente le riflessioni che ho esposta a commento della XII stazione della Via Crucis che ho scritto e che è stata recentemente pubblicata dalle Edizioni Messaggero Padova.
«Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la regione sino alle tre dei pomeriggio. Alle tre Gesù gridò molto forte: "Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato7’» (Mc 15, 33,34).
Dopo queste parole di Cristo, gli atei, i cosiddetti senzadio non sono nostri nemici, ma sono coloro che sperimentano esattamente quel che Cristo ha sofferto in croce.
Non solo.
L’Ateismo, in quanto «destructio idolorum» e non erezione di nuovi idoli, la Fede lo conosce come momento interno a se stessa.
Ciò che si oppone alla Fede non è l’ateismo, ma l’idolatria.
«Io sono convinto che il progetto capitalista attuale sia una idolatria...Sono convinto che nessuna eresia dei secoli passati abbia nociuto tanto al cristianesimo quanto l’idolatria attuale» (Arturo Paoli).
Fin qui la citazione del libretto.
In effetti il maggior ostacolo per il credente lo si trova non nell’ateismo, ma nell’idolatria (per perversione del senso di Dio o sua sostituzione con altri dei) scoperta soprattutto nelle strutture di dominio. "L’idolatria - scrive Pablo Rchard - trasforma i soggetti (persone) in cose e le cose (merci, mercato, tecnologia) in soggetti. E’ la radice del peccato sociale".
Questo è quanto per oggi.
Piccola pubblicità! Chi fosse interessato ad acquistare il libretto della Via Crucis "La Croce e le croci", se di Avezzano può rivolgersi alla libreria cattolica. Diversamente è reperibile presso qualsiasi libreria cattolica o ordinarlo direttamente alle Edizioni Messaggero di Padova.
Aldo
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")!!! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. ----- la mistica del capitalismo e la teologia ratzingeriana della "caritas".6 dicembre 2011, di Federico La Sala
- DANTE (Monarchia): "(...) come la cupidigia, per quanto piccola sia, offusca l’abito della giustizia, così la carità, cioè il retto amore, lo rende più forte e più illuminato. Perciò, la persona che è capace di raggiungere il più alto grado di retto amore può attingere il massimo livello di giustizia".
 IL NOME DI DIO. L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
IL NOME DI DIO. L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
LA MISTICA DEL CAPITALISMOdi Roberto Esposito (la Repubblica, 06.12.2011)
«Nel capitalismo può ravvisarsi una religione, vale a dire, il capitalismo serve essenzialmente alla soddisfazione delle medesime ansie, sofferenze, inquietudini, cui un tempo davano risposta le cosiddette religioni». Queste fulminanti parole di Walter Benjamin - tratte da un frammento del 1921, pubblicato adesso nei suoi Scritti politici, a cura di M. Palma e G. Pedullà per gli Editori Internazionali Riuniti - esprimono la situazione spirituale del nostro tempo meglio di interi trattati di macroeconomia. Il passaggio decisivo che esso segna, rispetto alle note analisi di Weber sull’etica protestante e lo spirito del capitalismo, è che questo non deriva semplicemente da una religione, ma è esso stesso una forma di religione. Con un solo colpo Benjamin sembra lasciarsi alle spalle sia la classica tesi di Marx che l’economia è sempre politica sia quella, negli stessi anni teorizzata da Carl Schmitt, che la politica è la vera erede moderna della teologia.
Del resto quel che chiamiamo "credito" non viene dal latino "credo"? Il che spiega il doppio significato , di "creditore" e "fedele", del termine tedesco Gläubiger. E la "conversione’’ non riguarda insieme l’ambito della fede e quello della moneta? Ma Benjamin non si ferma qui. Il capitalismo non è una religione come le altre, nel senso che risulta caratterizzato da tre tratti specifici: il primo è che non produce una dogmatica, ma un culto; il secondo che tale culto è permanente, non prevede giorni festivi; e il terzo che, lungi dal salvare o redimere, condanna coloro che lo venerano a una colpa infinita. Se si tiene d’occhio il nesso semantico tra colpa e debito, l’attualità delle parole di Benjamin appare addirittura inquietante. Non soltanto il capitalismo è divenuto la nostra religione secolare, ma, imponendoci il suo culto, ci destina ad un indebitamento senza tregua che finisce per distruggere la nostra vita quotidiana.
Già Lacan aveva identificato in questa potenza autodistruttiva la cifra peculiare del discorso del Capitalista. Ma lo sguardo di Benjamin penetra talmente a fondo nel nostro presente da suscitare una domanda cui la riflessione filosofica contemporanea non può sottrarsi. Se il capitalismo è la religione del nostro tempo, vuol dire che oltre di esso non è possibile sporgersi? Che qualsiasi alternativa gli si possa contrapporre rientra inevitabilmente nei suoi confini - al punto che il mondo stesso è "dentro il capitale", come suona il titolo di un libro di Peter Sloterdijk (II mondo dentro il capitale, Meltemi 2006)?
Oppure, al di la di esso, si può pensare qualcosa di diverso - come si sforzano di fare i numerosi teorici del postcapitalismo? Intorno a questo plesso di questioni ruota un intrigante libro, originato da un dibattito tra filosofi tedeschi, ora tradotto a cura di Stefano Franchini e Paolo Perticari, da Mimesis, col titolo Il capitalismo divino. Colloquio su denaro, consumo, arte e distruzione.
Da un lato esso spinge l’analisi di Benjamin più avanti, per esempio in merito all’inesorabilità del nuovo culto del brand. Tale è la sua forza di attrazione che, anche se vi è scritto in caratteri cubitali che il fumo fa morire, compriamo lo stesso il pacchetto di sigarette. Come in ogni religione, la fede è più forte della evidenza. Dior, Prada o Lufthansa garantiscono per noi più di ogni nostra valutazione. Le azioni cultuali sono provvedimenti generatori di fiducia cui non possibile sfuggire. Non a caso anche i partiti politici dichiarano "Fiduia nella Germania" a prescindere, non diversamente da come sul dollaro è scritto "In God we trust". Ma, allora, se il destino non è, come credeva Napoleone, la politica, ma piuttosto l’economia; se il capitale, come tutte le fedi, ha i suoi luoghi di culto, i suoi sacerdoti, la sua liturgia - oltre che i suoi eretici, apostati e martiri quale futuro ci attende?
Su questo punto i filosofi cominciano a dividersi. Secondo Sloterdijk, con l’ingresso in campo del modello orientale - nato a Singapore e di lì dilagato in Cina e in India - si va rompendo la triade occidentale di capitalismo, razionalismo e liberaldemocrazia in nome di un nuovo capitalismo autoritario. In effetti oggi si assiste a un curioso scambio di consegne tra Europa e Asia. Nel momento stesso in cui, a livello strutturale, la tecnologia europea, e poi americana, trionfa su scala planetaria, su quello culturale il buddismo e i diversi "tao" invadono l’Occidente. La tesi di Zizek è che tra i due versanti si sia determinato un perfetto (e perverso) gioco delle parti. In un saggio intitolato Guerre stellari III. Sull’etica taoista e lo spirito del capitalismo virtuale (ora incluso nello stesso volume), egli individua nel buddismo in salsa occidentale l’ideologia paradigmatica del tardo capitalismo. Nulla più di esso corrisponde al carattere virtuale dei flussi finanziari globali, privi di contatto con la realtà oggettiva, eppure capaci di influenzarla pesantemente. Da questo parallelismo si può trarre una conseguenza apologetica o anche una più critica, se riusciamo a non identificarci interiormente col giuoco di specchi, o di ombre cinesi, in cui pure ci muoviamo. Ma in ciascuno dei casi restiamo prigionieri di esso.
E’ questa l’ultima parola della filosofia? Diverremo tutti, prima o poi, officianti devoti del culto capitalistico, in qualsiasi versione, liberale o autoritaria, esso si presenti? Personalmente non tirerei questa desolata conclusione. Senza necessariamente accedere all’utopia avveniristica del Movimento Zeitgeist o del Venus Project - entrambi orientati a sostituire l’attuale economia finanziaria con un’organizzazione sociale basata sulle risorse naturali -, credo che l’unico grimaldello capace di forzare la nuova reli¬gione del capitale finanziario sia costituito dalla politica. A patto che anch’essa si liberi della sua, mai del tutto dismessa, maschera teologica. Prima ancora che sul terreno pratico, la battaglia si gioca sul piano della comprensione della realtà. Nel suo ultimo libro, Alla mia sinistra (Mondadori, 2011), Federico Rampini percorre lo stesso itinerario - da Occidente a Oriente e ritorno - ma traendone una diversa lezione. All’idea di "mondo dentro il capitale" di Sloterdijk è possibile opporre una prospettiva rovesciata, che situi il capitale dentro il mondo, vale a dire che lo cali dentro le differenze della storia e della politica. Solo quest’ultima può sottrarre l’economia alla deriva autodissolutiva cui appare avviata, governandone i processi ed invertendone la direzione.
- DANTE (Monarchia): "(...) come la cupidigia, per quanto piccola sia, offusca l’abito della giustizia, così la carità, cioè il retto amore, lo rende più forte e più illuminato. Perciò, la persona che è capace di raggiungere il più alto grado di retto amore può attingere il massimo livello di giustizia".
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")!!! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. ---- Il coraggio di indignarsi (di Arturo Paoli).23 ottobre 2011, di Federico La Sala
Il coraggio di indignarsi
di Arturo Paoli (“oreundici”, n° 10, ottobre 2011)
Sentirei di mancare di amicizia se non parlassi della mia evoluzione in questo momento, che è la ragione per cui non ho svolto come tutti gli anni la meditazione mattutina strettamente religiosa. La mia vita è sempre stata un passaggio interno, che credo e spero dovuto alla devozione che ho scelto verso lo Spirito santo perché - questo è il fondamento della mia fede - sono convinto che sia lo Spirito santo a dirigere la storia e l’evoluzione dei tempi, pur rispettando la libertà dell’uomo. Ho sentito nitidamente come un suono di campana che tutto il Vangelo è condensato in una frase di Gesù: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Prima ancora della vostra devozione particolare, prima della preoccupazione di salvare l’anima: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. La seconda verità che ha battuto per molto tempo dentro di me è una frase di Paolo: fare la verità nell’amore. Non si possono disgiungere queste due qualità, l’amore e la verità. Con queste due verità sto vivendo questi ultimi anni della mia vita e credo che non mi lasceranno più, cercando sempre, come posso, di aiutare l’avveramento di queste due esigenze che sono dettate e rinnovate dallo Spirito santo. Questa è una costante della mia vita: tu lasciati tormentare, poi un giorno ti sarà chiaro, capirai.
Il giorno della chiarezza è venuto qualche mese fa quando, dopo aver ricevuto alcune persone, ho trovato sul mio tavolo un libro di dimensioni imponenti, con 650 pagine. Non voglio diventare pazzo, ho cercato di allontanarlo da me perché non mi venisse la tentazione, invece la tentazione mi è venuta il giorno dopo e ho cominciato a sfogliarlo per curiosità. L’autore Sergio Soave è il sindaco di una cittadina del Piemonte, Savigliano, e il titolo del libro è: Senza tradire, senza tradirsi. È la storia della vita politica in Europa dopo la guerra del 1915, epoca in cui le grandi forze popolari del socialismo e del comunismo suscitavano la ricerca di rinnovamento e di cambiamento. Il libro ricostruisce la storia di due personaggi, uno conosciuto per le sue opere letterarie, Ignazio Silone, e l’altro piemontese, a me sconosciuto fino ad ora, Angelo Tasca.
Progredendo nella lettura, che mi appassionava sempre di più, ho cercato di raggiungere l’autore, per dirgli che il suo libro risolve un problema che mi tormenta da tempo e che mi sarebbe piaciuto incontrarmi con lui. Dopo neanche una settimana questo sindaco è venuto da me, e abbiamo condiviso molti pensieri. Il problema che mi ha tormentato in questi ultimi anni, da quando sono rientrato definitivamente in Italia, e che continua a tormentarmi è questo: come facciamo noi cristiani a vivere in una società che è il tradimento totale dei precetti evangelici? Come facciamo? Noi cristiani dobbiamo interessarci singolarmente alla salvezza della nostra anima, e disinteressarci di vivere in una società che contraddice totalmente il vangelo? Allora perché Gesù ha detto cercate per primo il regno di Dio?
Vedo intorno a me l’insensibilità totale dei cattolici italiani che votano quasi dormendo, che siccome mangiano bene tre volte al giorno e possono soddisfare certe curiosità di consumo o della tecnica, allora dicono pazienza, perché interessarmi alla politica? lo mi arrangio da me. Al contrario ho sempre pensato e ancora penso che un cristiano non possa vivere in una società che smentisce completamente il vangelo, a cominciare dalla prima beatitudine: beati i poveri in spirito. Non ho mai pensato che il messaggio di Gesù sia una verità astratta: fare la verità dice Paolo, non credere in un dogma.
Il regno di Dio predicato e praticato da Gesù è mescolato ai poveri e per spiegarlo meglio ci ha lasciato una brevissima preghiera: venga il tuo regno sulla terra, come nel cielo. Il cielo si trasferisce sulla terra, in che cosa la terra può imitare il cielo? Nella giustizia, nell’amore, nel formare una famiglia umana che viva in una atmosfera di amore.
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")!!! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. ---- E Re Mida li rese tutti somari (di LAura Pariani).5 agosto 2010, di Federico La Sala
BENEDETTO XVI ("Deus caritas est", 2006). Così "il Dio del denaro" inganna Papa Ratzinger, e Papa Ratzinger inganna gli uomini.
E Re Mida li rese tutti somari«La festa della Gloriosa Asinità vide nella capitale un grande tripudio di folla festante. In testa ognuno esibiva copricapi di lunghe orecchie frementi»
di LAURA PARIANI (Avvenire, 05.08.2010) *
I giunchi degli stagni frigi cantavano: «Re Mida ha le orecchie d’asino». Il vento ne acchiappò la voce e propagò la notizia tra i boschi di olivi e di mandorli dolci, nei giardini di rose che emanavano la loro fragranza sotto la stella luminosa della sera. Per tutto il paese ormai non c’era persona che non sapesse il motivo per cui re Mida in pubblico si mostrasse sempre con un copricapo frigio dalle alte punte.
«Il re ha le orecchie d’asino» dicevano le serve nei mercati, mentre riempivano i panieri di focacce con le olive; e ridacchiavano pensando alle orecchie d’asino che i maestri mettono in testa agli scolari che difettano di comprendonio. «Re Mida è un asino» ghignavano i vecchi seduti all’ombra del grande fico della piazza, scuotendo il capo perché mettersi contro un dio potente come Apollo era stata proprio un’asinata che poteva meritare solo quella punizione.
E qualcuno si azzardava perfino a dire che pure quel tal barbiere, che non era riuscito a tenere il segreto per sé e aveva pensato di liberarsene scavando una buca e confidando alla sua profondità la verità scoperta sulla testa del re Mida, era stato un campione di asineria, per cui giustamente aveva pagato con la morte il poco senno.
«La gente ride di me, hi ha hi ha ...» ripeteva disperato re Mida nel chiuso delle sue lussuose stanze, agitando invano gli aliossi per cacciare i cattivi pensieri. I lacrimatoi d’oro massiccio traboccavano dei suoi pianti. Finché, una notte di mezzaluna, gli venne un’ispirazione... Di buon mattino mandò a chiamare il capo della società mercantile, il sommo sacerdote, la tenutaria del bordello più famoso e il comandante delle sue guardie. La riunione con i quattro personaggi gli portò via molte ore, ma al sopraggiungere della sera gli occhi di re Mida brillavano di una fredda luce di vendetta.
«Popolo mio» disse quella notte affacciandosi al buio dal suo balcone, «ricordati che di un re, hi ha hi ha, non si ride». L’indomani mattina nel tempio, all’ora in cui i fedeli erano intenti alle loro preghiere offrendo alle divinità crateri di vino, giare di latte e corone di rose, il sommo sacerdote tenne ai devoti questo discorso: «Lunga vita a re Mida che onora il tempio con la sua protezione, nonché con offerte di cera vergine e di arredi preziosi».
E, nel dire questo, mostrò gli anelloni d’oro che il re aveva quel mattino stesso inviato perché reggessero intorno all’ara sacra le grandi torce di pino. «Re Mida ha le orecchie d’asino. E questo è un prodigio da vantare, non da tenere nascosto. Sappiamo tutti quanto il cane sia adulatore, il gatto infido, il lupo crudele, la volpe opportunista, la colomba lasciva, il leone prepotente. Ben venga dunque la testa coronata dell’asino, animale mite e contemplativo... Con ciò arrivo a auspicare che tutti gli uomini pii dovrebbero porsi l’obiettivo di varcare la santa soglia dell’asinità. Che tutti ponderino le mie parole e nessuno sia fiero delle sue piccole orecchie».
Un’ora dopo, mentre i soldati effettuavano il cambio della guardia davanti al palazzo reale, il comandante della guarnigione fece suonare le trombe d’oro e lesse personalmente un proclama alla folla che sempre si riuniva ad ammirare la parata:
 «Lunga vita a re Mida, valoroso difensore di questa città e del suo popolo.
Che Re Mida abbia le orecchie d’asino, è un grande orgoglio per noi soldati. Infatti quale cosa è più degna del fatto che un maschio inasinisca? Solida è l’asinità, possente il suo raglio: hi ha, hi ha, una manifestazione sonora ruvida, viscerale, inconfondibilmente virile: tuono di gran patria...
Per non parlare della forza micidiale del calcio e del morso asinino».
«Lunga vita a re Mida, valoroso difensore di questa città e del suo popolo.
Che Re Mida abbia le orecchie d’asino, è un grande orgoglio per noi soldati. Infatti quale cosa è più degna del fatto che un maschio inasinisca? Solida è l’asinità, possente il suo raglio: hi ha, hi ha, una manifestazione sonora ruvida, viscerale, inconfondibilmente virile: tuono di gran patria...
Per non parlare della forza micidiale del calcio e del morso asinino».E facendo schioccare per aria la lunga frusta di cuoio che portava legata alla cintura, il comandante scandì lentamente la conclusione: «Che tutti ponderino le mie parole e nessuno sia fiero delle sue piccole orecchie».
Al mercato, nell’ora rovente in cui i cuochi arrostivano su graticci fegatelli col miele, tordi alla salvia e cosciotti di capretto lardellati, il capo dei mercanti della capitale parlò ai suoi compari, dopo aver offerto a tutti i convenuti formaggini freschi freschi, che recavano ancora i segni dei canestrini di vimini, accompagnati da vino di Samo conservato in otri odorosi di pelle di capra.
«Lunga vita a re Mida» disse, «che onora i mercanti difendendo le invenzioni locali come quelle del nostro Marsia, contro i prodotti stranieri. Lunga vita al re che mi ha onorato della sua amicizia». E nel dire questo mostrò come sulla sua tunica di lana bianca ricamata di fili d’oro e d’argento splendesse un’onorificenza nuova di zecca.
«Re Mida ha le orecchie d’asino. È questo il segno della fortuna del suo governo. Sappiamo tutti quanto gli asini siano affidabili nel trovare la strada giusta, tanto più che a quanto dicono ce ne sono alcuni che sanno perfino cacare oro. Insomma, l’asino è il socio ideale per noi mercanti. Che tutti ponderino le mie parole e che nessuno sia fiero delle sue piccole orecchie».
Appena scesa la notte, mentre si aprivano le porte del maggior bordello della città, la tenutaria riunì intorno a sé le venditrici d’amore e tenne loro questo discorso: «Lunga vita al re che apprezza le suonatrici di flauto dalle labbra succulenti, le giovani danzatrici dai seni sodi come mele cotogne, i giovanotti profumati di lavanda e coronati di viole. Lunga vita al re che sa essere generoso con chi sa offrire notti felici e cosce depilate per il piacere del tatto o della vista».
E, sollevato il lembo della tunica di porpora di Tiro e la sottoveste di garza trasparente mostrò una cavigliera d’oro che mostrava lo stemma regale. «Re Mida ha le orecchie d’asino. È pregio da vantare, non da tenere nascosto...Felici noi, se tutti i nostri uomini, toccati dall’alito di Afrodite, mostrassero gli stessi attributi. Che tutti ponderino le mie parole e che nessuno sia fiero delle sue piccole orecchie».
La festa della Gloriosa Asinità, proclamata da re Mida nella settimana successiva, vide nella capitale un grande tripudio di folla festante. In testa, al posto delle solite corone di mirto o di lauree fronde, ognuno esibiva copricapi di lunghe orecchie frementi: intrecciate di paglia bionda per i popolani, di cuoio rosso persiano per i padroni di botteghe, di stoffa tinta di croco per le ragazze più avvenenti. Il tutto tra danze sfrenate, punta tacco punta tacco, e voci squillanti in un delirio: «Lunga vita a re Mida, hi ha, hi ha!».
*
IL MITO
Re Mida è legata a due miti, quello più conosciuto, che racconta della sua straordinaria capacità di trasformare tutto in oro, dono effimero e «scomodo»; e un secondo che racconta della punizione ricevuta da Apollo, il quale gli fa crescere le orecchie d’asino, perché durante una gara musicale con il dio Pan non lo nomina vincitore. È solo il barbiere del re a conoscere questo segreto, che però non deve rivelare a nessuno, pena guai seri. Ma il barbiere, non potendo parlare con nessuno, decide di confidare il segreto alla terra. Scava una buca cui confida ciò che sa. Il resto lo fanno le canne che crescono dove il segreto è sepolto, così che il vento lo sussurra e lo fa sapere a tutti. Il primo a parlare di Re Mida è Erodoto, ma questa figura approda anche tra i romani: Ovidio racconta i due miti nelle «Metamorfosi».
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")?! ---- Il buon-messaggio ("Deus charitas est")... Il dono trasporta sempre un messaggio e talvolta questo messaggio è espresso molto meglio dal dono che da qualunque discorso (Interv. a .Jacques T. Godbout).28 ottobre 2008, di Federico La Sala
INTERVISTA. Dono, antidoto al capitalismo
Per il sociologo Jacques T. Godbout «la logica del regalo non può sostituire quella del mercato, però può riuscire a correggerla»
Dono, antidoto al capitalismo
 «L’atto del dare senza contropartita esprime la massima intensità dei legami sociali, poichè presuppone sempre la fiducia nell’altro»
«L’atto del dare senza contropartita esprime la massima intensità dei legami sociali, poichè presuppone sempre la fiducia nell’altro»
 «La sua semplicità apparente, la sua forza, la sua sincerità ricordano da vicino la nozione cristiana di ’stato di grazia’»
«La sua semplicità apparente, la sua forza, la sua sincerità ricordano da vicino la nozione cristiana di ’stato di grazia’»DA PARIGI DANIELE ZAPPALÀ (Avvenire, 28.10.2008).
« I regali e i doni circolano al servizio del legame sociale. Essi presuppongono sempre una fiducia nell’altro. E dunque un rischio. Sta in quest’incertezza il cuore affascinante dell’atto del donare». Ad esserne convinto è il sociologo canadese francofono Jacques T. Godbout, fra i maggiori esponenti del Mauss (Movimento antiutilitarista nelle scienze sociali). Di Godbout, Vita e Pensiero ha appena pubblicato in Italia il saggio Ciò che circola fra noi (pagine 392, euro 22,00), già al centro di tanti appassionati dibattiti in Francia e che sarà presentato oggi alla Libreria Vita e Pensiero della Cattolica di Milano (largo Gemelli, 1, ore 13.30) da Mauro Magatti, Pierangelo Sequeri e Stefano Zamagni. Anche in tempi di crisi finanziaria, Godbout non ritiene possibile che la logica del dono possa un giorno sostituirsi a quella di mercato. Ma per il sociologo, oggi più che mai è urgente riflettere sul valore insostituibile degli scambi senza un’immediata contropartita.
Professore, ciò che circola fra le persone resta ancora in parte un mistero per i sociologi?
«In parte, sì. E ciò che circola sotto la forma del dono resterà probabilmente sempre un po’ misterioso. Eppure, si tratta di ciò che esprime al più alto grado l’intensità dei legami sociali. Almeno rispetto agli altri legami, certo anch’essi importanti, che hanno per sfondo gli scambi di mercato e le politiche degli Stati».
La voglia di offrire sembra contraddire la frase attribuita a Sartre secondo cui l’inferno sarebbero gli altri...
«Dopo tanti anni di ricerche in diversi Paesi, sono giunto alla conclusione personale che la voglia di donare è connaturata all’uomo. Si tratta di un modo di far circolare qualcosa che impegna gli individui in prima persona. Certo, il dono può essere talora formalizzato e volto a uno scopo preciso, come nel caso dei regali che si scambiano nel mondo degli affari. Ma non è questa, a mio avviso, la forma di dono più interessante».
Perché?
«In questi casi, il dono è perlopiù un mezzo per propiziare nuovi affari. Al contrario, esistono doni che sono essi stessi un fine e che non richiedono direttamente una contropartita. Già lo stesso dono d’impresa acquista una certa autenticità quando è offerto con sincerità. Ovvero, per ringraziare l’altra parte ed esprimerle la propria stima. In questi casi, il dono entra in uno spazio ambiguo in cui è percepito al contempo come mezzo e come fine. E sta in fondo sempre in quest’ambiguità la natura paradossale del dono. Certi studiosi hanno cercato di forzare questo paradosso, spiegando che il dono ha sempre una contropartita. A mio avviso, invece, il paradosso del dono come mezzo o come scopo non ha una vera soluzione. Nel senso che questo paradosso definisce l’incertezza e il rischio sempre connaturati nell’atto del donare».
Chi cerca di spiegare il dono, impiega talora la nozione cristiana di ’stato di grazia’. Perché?
«Il dono trasporta sempre un messaggio e talvolta questo messaggio è espresso molto meglio dal dono che da qualunque discorso. Il dono può dunque funzionare anche come una semplificazione rispetto ad altri modi di gestire le relazioni sociali. E la sua semplicità apparente, la sua forza, il suo legame con la sincerità hanno in effetti spinto certi autori a riferirsi alla nozione di grazia».
Il dono è davvero una costante umana che si ritrova in tutte le culture?
«Personalmente, sono convinto di ciò, anche se nessuno potrà mai possedere gli elementi per dimostrarlo, dato che occorrerebbe passare in rassegna tutte le culture della storia dell’umanità. Ma quando si comincia ad intuire il meccanismo del dono, diventa difficile immaginare una società capace di privarsi di tale meccanismo. L’alternativa sarebbe un mercato assoluto e totalitario, oppure una ridistribuzione statale dello stesso tipo. Ma ciò escluderebbe ogni tipo di libertà e sembra apparentarsi più a una società di formiche che a una società di persone umane. Se tutto circolasse sotto forma di beni di mercato o di ridistribuzioni statali, forse non saremmo più umani».
Nelle culture rurali, esiste un legame fra l’atto del donare e il dono esemplare ricevuto dalla terra e dalla natura?
«Credo di sì. E sta qui il dramma forse più profondo dell’odierno tentativo di certe multinazionali di brevettare le sementi per estrarle così del tutto dalla sfera del dono ed immetterle in modo forzato nei circuiti di mercato. Beninteso, i rapporti di mercato sono indispensabili ed estremamente importanti a livello sociale. Ma le loro possibili prevaricazioni ai danni del dono possono avere conseguenze molto dolorose».
Esiste dunque oggi una certa tensione fra la socializzazione fondata sul dono e le logiche di mercato?
«Ciò avviene laddove il legittimo e naturale scambio di mercato è contaminato da forme di nevrosi produttiviste. In altri termini, dall’aspirazione folle di ridurre tutto ciò che circola fra gli individui a forme più o meno mascherate di comportamenti di mercato. Su grande scala, ciò diventa un’ideologia che considera il dono come un’azione inutile e anzi quasi dannosa. Si tratta di un’ideologia che vorrebbe strumentalizzare tutto, compresa la natura».
Il dono è anche associato a un’ideale di giustizia sociale e planetaria?
«Sì, quando entra in gioco un’altra logica non meno importante, che si osserva ad esempio nel dono a distanza. Si pensi al dono del sangue, di organi, alle donazioni in occasione di catastrofi naturali o a quelle verso istituzioni di solidarietà. In questi casi, l’idea di giustizia può entrare in gioco se pensiamo di dare a chi ha avuto dalla vita meno di noi, almeno a livello materiale. Ma la libertà e l’autonomia morale dell’individuo restano protagonisti, al punto che certe persone possono trovare in ciò pienamente il senso della propria vita».
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")?! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. Una straordinaria lezione di Arturo Paoli, sull’amore ( "charitas") evangelico ... una nota di don Aldo Antonelli23 giugno 2007, di Federico La Sala
LA CHIESA, L’OCCIDENTE, E I TEOCON
“Come mai in questo Occidente idolatrico e strutturalmente ateo, in cui ogni atto sembra viziato da una colpa irredimibile, i cristiani non sono perseguitati?”
Questa la domanda che anni fa un certo Marco Guzzi rivolse ad Enzo Bianchi.
Questa la risposta di Enzo Bianchi contenuta in un suo libretto: Ricominciare - Nell’anima, nella chiesa, nel mondo.
«L’urto tra lo Spirito di Cristo e mondanità è ineluttabile, e già si vede che l’ubriacatura consumistica e eroticizzata dell’Occidente provoca una senescenza precoce dei sensi, un abitare nelle terre del nonsenso, una bulimia del “tutto e subito” che soffoca. In tale contesto oggi i cristiani non solo non sono perseguitati, ma neppure osteggiati, anzi sono invocati. Noi oggi assistiamo addirittura a un diffuso atteggiamento di benevolenza nei confronti della chiesa, da parte dei Cesari di oggi soprattutto. Il titolo di un articolo di un periodico cattolico qualche mese fa diceva quasi orgogliosamente, con stupore ingenuo: “Questa chiesa serve!”. Ma serve a chi? A chi è utile? Questo significa che noi siamo omologati all’interno del grande orizzonte occidentale capitalista e che magari siamo invocati per fornire un fondamento etico alla società, per dare un’anima alla società.
Avvenuta ormai la crisi dell’ideologia, noi cristiani siamo invocati per cantare in coro, magari con più convinzione e più forte, “la cantata dei valori comuni”, quei valori formali che piacciono a tutti. [...] Sì, questa chiesa serve al mondo se e finché resta impegnata solo filantropicamente, ma guai se la chiesa si fa profetica, se annuncia l’Evangelo con il Sì! Sì! No! No!, guai se contraddice la morale laica, perché allora si scatena la saggezza dei dominatori di questo mondo, quelli che hanno crocifisso il Signore della gloria (cf 1Cor 2,8). [...] Io sono convinto che sul tema della pace, soprattutto oggi, la chiesa gioca la sua fedeltá al Signore; su questo tema la sua scelta: o essere l’Evangelo che grida nella debolezza e nella sapienza della croce o sedere tra i dominatori di questo mondo, ma non essere più la chiesa del Signore Gesù Cristo»....
E io aggiungerei "Guai se la Chiesa si permettesse di dire solo qualche parolina su questa economia assassina che è la causa prima della Guerra e di tutti i mali del mondo, il Peccato Originale di tutto, e si permattesse di mettere sotto inchiesta il pilastro reggente di questa economia che è l’antievangelico "Diritto di Proprietà"!
Che ne direbbero i vari Bush/Berluschini/Casini/Fini e i loro chierichetti Teocon?
Noi cristiani saremmo tutti decapitati, come San Giovanni che domani festeggeremo.
Buona Domenica.
Aldo [don Antonelli]
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")?! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. Una straordinaria lezione di Arturo Paoli, sull’amore ( "charitas") evangelico2 giugno 2007, di Federico La Sala
La parola ci interpella
Il Vangelo delle chiavi
di Mario Mariotti *
Il discorso delle chiavi del Regno è il fulcro del cristianesimo tradotto in religione, e di conseguenza in potere. Il Signore avrebbe delegato a Pietro il potere di legare o di slegare, di perdono o di non-perdono dei peccati e l’avrebbe costituito Suo vicario in terra, in questo mondo. Da qui anche il potere del Papa, che non può sbagliare perché vicario di Dio in terra. Siccome i cattolici hanno fatto proprie queste convinzioni, che la salvezza della propria anima e resurrezione del proprio corpo passino per la mediazione del Papa e della gerarchia, ecco il grande potere, la grande autorevolezza di S. R. Chiesa, che ha condizionato in senso negativo e condiziona tutt’ora in senso negativo enormi moltitudini di persone, che si autotranssustanziano in pecore credenti e fedeli. Queste, a loro volta, condizionano l’evoluzione della storia umana in senso evolutivo, regressivo, reazionario ed alienante. Non ho bisogno di ribadire il mio pensiero sulla Chiesa e sulla gerarchia che la guida (probabilmente tutte le religioni hanno questi difetti). Essa si è sempre appropriata del soggettivo positivo della base, e l’ha strumentalizzato a vantaggio dei ricchi, dei potenti e di se stessa, diventando ricca e potente.
La simbiosi Tempio-Impero iniziò con Costantino, e prospera tutt’ora. Se oggi non siamo ancora ai tempi di Innocenzo III, non è per merito della evoluzione democratica della gerarchia, ma perché pian piano lo Spirito è riuscito a liberarsi dalle sue ragnatele, si è fatto spazio con l’Illuminismo, la Rivoluzione francese, il marxismo, il socialismo, ed è riuscito ad esplicitare il valore evangelico della laicità, se connotata di solidarietà e condivisione. Questa rivoluzione però, è sempre a rischio: S. R. Chiesa, dopo aver contribuito a sfottere l’utopia della fratellanza, del socialismo, oggi cerca di approfittare della scarsa lucidità dei laici per rimettere in discussione lo stesso Illuminismo. Dato che essa vorrebbe imporsi, dopo la crisi delle ideologie, quale autorità, guida teologica e morale di tutto e di tutti, prima che arrivi anche a mangiarsi anche le scuse le scuse fatte a Galileo, e che torni a condannarlo sempre postumo, sarà opportuno, da parte di coloro che non sono ancora rincoglioniti del tutto, cercare di darsi una mossa.
Ecco il mio piccolo contributo:
È vero che, nel Vangelo c’è il discorso del Signore a Pietro che gli riconosce di essere ispirato da Dio e quindi gli affida le chiavi del Regno dei cieli, ma questo significa che l’affidamento di questo potere dipende dal fatto e dalla condizione di essere ispirati dal Padre, e quindi nella logica dell’Amore, dal Servizio, dalla Condivisione, e non del potere. Se uno, infatti, si prende il disturbo di proseguire la lettura del Vangelo, scoprirà che appena Pietro non fa propria la logica di Dio e ragiona in quella sua propria, (rifiuta la sofferenza per la Verità), il Signore prende le distanze da lui e lo definisce Satana, cioè Divisore. Già questa parola sarebbe più che sufficiente per far capire che il potere delle chiavi è tale se e solo quando non è potere, ma incarnazione dello Spirito, incarnazione della volontà di Dio, che è progetto di amore, servizio, lavoro onesto e professionale per tutti gli altri e condivisione.
Inoltre appare fuori da ogni logica, sia umana che divina, questo messaggio che caratterizzerebbe un Dio che delega i propri poteri all’uomo, il quale si troverebbe nella condizione di essere Dio stesso, ma coi limiti dell’uomo; la qual cosa è semplicemente assurda, dato che l’uomo, pur non potendo conoscere completamente Dio, si troverebbe a gestire il potere, di un Dio che ci è stato rivelato con Amore, e non come potere. Ma quest’ultima considerazione potrebbe venir interpretata come una lettura dell’evento viziata di laicità, e allora a me sembra il caso che il chiarimento definitivo del problema, e quindi il depotenziamento sostanziale dell’enunciato dell’affidamento delle chiavi a Pietro, si possa trovare sempre nella Parola e precisamente in quella che definisce il giudizio finale al quale Dio sottoporrà gli uomini.
La discriminante, il criterio, il fondamentale è la qualità del nostro rapporto col prossimo, con gli altri viventi e con più precisione il nostro rapporto con l’affamato e l’assetato, cioè coi bisogni dei viventi. Dio non ci chiederà se credevamo in Lui, se credevamo nel Papa e nella sua infallibilità, se ubbidivamo ai comandamenti e ai precetti della Chiesa. Saremo giudicati sul tipo di risposta che abbiamo dato alle necessità dell’affamato e dell’assetato, e inoltre anche sulla qualità, sulla trasparenza e sulla gratuità del nostro rapporto positivo col nostro prossimo. Questa Lettura allude ad una gratuità che viene vissuta da soggetti che sono laici o anche atei, i quali esulano da un rapporto di dare-avere con Dio specifico della concezione religiosa di Dio stesso, e saziano e dissetano il loro prossimo semplicemente perchè fanno a lui ciò che vorrebbero ricevere da lui, se essi stessi avessero fame e sete.
Qui il potere delle chiavi va a farsi benedire, come l’assurdità dell’uomo vicario di Dio stesso, la sua infallibilità e tutto l’armamentario liturgico e orante col quale la Chiesa riesce ad alienare i fedeli-credenti, deviandoli dalle proprie responsabilità fondamentali di mani di Dio. Se ci pensiamo bene, anche la necessità della gratuità nel nostro rapporto positivo con gli altri viventi è fondamentale, é strutturale. Essendo noi il "corpus Domini", cioè i terminali di uno Spirito che ci è stato caratterizzato come Amore gratuito e incondizionato (quello del padre per il figliuol prodigo), nel momento che diciamo “si” e amiamo e condividiamo, stiamo materializzando quello Spirito che è Amore gratuito ed incondizionato. Queste qualità sono degli indicatori preziosi della nostra condizione di tralci: stimo agendo come se Dio non ci fosse, possiamo anche pensare di essere atei, ma in quel momento lo Spirito opera attraverso di noi e lavora a costruire il Regno servendosi delle nostre mani.
Voglio fermarmi qui, facendo rilevare come la caratterizzazione del giudizio finale secondo il Vangelo si colloca a distanza siderale da un discorso di potere. Storicamente, purtroppo, gli uomini, invece di fare di sé stessi strumenti di Verità e mani amorose che condividono, si sono determinati come iene della Verità e mani rapaci, per tradurla, la Verità, in potere, in ricchezza, in superbia, in zelante servizio al principe di questo mondo, a sua maestà Mammona.
Dentro a questo peccato S. R. Chiesa ha preso residenza stabile dal tempo di Costantino, prostituendo l’Amore in potere, persiste nella propria simbiosi con l’Impero, bruciando tesori di soggettivo positivo, espressi da tutti coloro che sono in buona fede, a favore dello strutturale maligno, il capitalismo privato, il mercato, la competizione, il beati gli indefinitamente ricchi della cultura occidentale USA-dipendente.
Considerando la cosa da questo punto di vista e guardando ai misfatti del “cristianesimo reale”, appare chiaro che le chiavi hanno sbagliato serratura. Noi le abbiamo adattate alle porte della Geenna, dove sarà pianto e stridore di denti, e dove pavimento e pareti saranno rivestite non dalle pelli delle pecore, ma da quelle dei pastori. Per le pecore però sarà una magrissima consolazione....
Mario Mariotti
* IL DIALOGO, Sabato, 02 giugno 2007
-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")?! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. Una straordinaria lezione di Arturo Paoli, sull’amore ( "charitas") evangelico7 aprile 2007, di Federico La Sala
Uno studio di Andrea Zhok denuncia: «La pratica monetaria erode pilastri come individualità,comunità e ambiente»
Denaro, tarlo della società
«I soldi non sono bene o male in sé, ma solo il frutto di processi storici. Alla base degli scambi resta però la logica del dono»
di Iacopo Guerriero (Avvenire, 07.04.2007)
Il progetto è ambizioso, è il tentativo di una nuova critica allo "spirito del denaro". Una speculazione che va oltre i termini di liberismo, capitalismo, mercato. Questo è il problema, perché «a prescindere dal gioco dell’idolatria o demonizzazione di Marx, il punto è che ad un secolo e mezzo di distanza il primo resoconto del significato storico del capitalismo rimanga quello più comprensivo. La mia ambizione iniziale era innanzitutto quella di collocare l’oggetto di quell’analisi in una cornice storica ed antropologica più ampia».
Andrea Zhok, docente di Filosofia della storia all’Università di Milano, ha scritto un saggio, Lo spirito del denaro e la liquidazione del mondo, diviso in tre parti: analisi della logica della mediazione in denaro, ragioni della nascita della pratica monetaria, studio dell’infrazione delle diverse identità determinate dalla pratica stessa.
Professore, lei utilizza antropologia, storia economica e sociale per approfondire nascita ed evoluzione dello "spirito del denaro". Ripercorriamo le tappe dello sviluppo.
«Innanzitutto si tratta di vedere se e come lo scambio sia una dimensione essenziale nella natura umana. Lo scambio, nel senso di una transazione che mira ad ottenere un vantaggio oggettivo individuale, si mostra come un prodotto tardo e secondario. Esso presuppone una dimensione diversa, che non mira ad un vantaggio oggettivo individuale, bensì ad un riconoscimento intersoggettivo. Questa seconda dimensione la richiamo con l’espressione di ‘‘economia di dono’’. Le transazioni di dono sono e rimangono il basamento senza cui gli scambi in senso stretto non possono sussistere. Parlando di ‘‘dono’’ non si intende qualcosa di sublime o altruistico: il dono è ad esempio la dimensione tipica in cui avvengono le transazioni nella società omerica, dove certo non mancano ambizione o violenza».
E poi?
«L’analisi storica cerca di vedere l’emergere del meccanismo dello scambio ed il suo impatto. Protagonista di questo passaggio è il dena ro, o meglio, visto che il denaro non è una ‘‘cosa’’ ma un modo di operare, è la ‘‘pratica monetaria’’. Ho scelto esempi storici per esporre al meglio alcuni passaggi fondamentali nella storia del denaro: la sua nascita (Mesopotamia), la nascita della sua dimensione sovranazionale (Atene), la prima grande prova storica della sua capacità di dissolvimento della cultura di dono (Roma tardo repubblicana e tardo imperiale) ed infine la sua trasformazione in ‘‘capitale’’ (Rivoluzione industriale in Inghilterra). In ciascuno di questi momenti assistiamo ad alcune costanti nella pratica monetaria, come la capacità di conferire potere e di logorare le radici, ma vediamo anche di volta in volta un rinascere della pratica monetaria in forme differenti».
Perché definisce «frutto alla lunga velenoso» la mancanza di limiti per le transazioni monetarie?
«Ne parlo come di un frutto naturale ed al tempo stesso velenoso. Naturale, nel senso che non è il prodotto né di un errore, né di una cospirazione: il denaro nasce dall’interazione di esigenze operative e tendenze assiologiche ineludibili nell’uomo. È un’illusione (spesso percorsa nella storia) quella di pensare di poter senz’altro abolire il denaro: esso riemerge sempre dalle sue ceneri, non appena viene meno l’esplicita volontà di sopprimerlo. E tuttavia è un frutto che lasciato alla sua maturazione spontanea diviene velenoso, in quanto è mosso da una logica (quella dello scambio concorrenziale) che tende ad estendersi indefinitamente, e che quanto più si estende tanto più acquista potere per estendersi ulteriormente».
Quali sono gli orientamenti pericolosi per il nostro contesto sociale e privato?
«Ciò che opera la distruzione non è il denaro in senso generale, ma una variabile di cui tento una determinazione tecnica, e cioè il potere del denaro all’interno di una certa società. Per effettuare scelte razionali un soggetto deve avere un’identità stabile, relazioni comunitarie ed istituzionali prevedibili e deve operare le scelte in un ambiente circostante relativamente stabile nel tempo. La pratica monetaria, per ragioni costitutive, erode sistematicamente tutti e tre questi pilastri: rende fragili le identità personali, crea le condizioni per una crescente inaffidabilità della cornice comunitaria ed istituzionale, produce una sistematica erosione dell’ambiente circostante (ecologico, ed urbanistico). Ergo, tende a rendere insensata la funzione di scelta razionale su cui pretende di basarsi».
La secolarizzazione e il relativismo possono essere anche come un collante ideologico per le tensioni macroeconomiche che lei critica?
«Il relativismo non è un ‘‘errore morale’’ ma innanzitutto una pratica di vita (o di sopravvivenza) in un contesto storico informato dalla pratica monetaria. L’impatto sul relativismo del razionalismo scientifico sarebbe insignificante se non s’incardinasse, attraverso la tecnologia, nella dimensione di mercato. C’è un senso in cui il relativismo (insieme agli altri fattori di ‘‘liquidazione’’) non è solo effetto del potere del denaro, ma lo nutre a sua volta, ed è in quanto fattore che accresce l’insicurezza (in tutti i sensi del termine). La crescita del potere del denaro dissolve comunità, ambienti; tale dissoluzione genera insicurezza e in un sistema di scambio concorrenziale all’insicurezza si fa fronte cercando di aumentare il cuscinetto monetario tra sé e ciò che genera insicurezza. Ciascuno cerca di collocarsi in una posizione abbastanza alta da non dover temere lo tsunami, se e quando dovesse avvenire».
Esistono rimedi?
 «Questo libro ha l’ambizione di produrre una nuova diagnosi, in parte una prognosi, non ancora una terapia. Anche se il tempo è maturo per tentare di proporre un modello transattivo alternativo, esso va pensato fino in fondo e nei dettagli. Il problema di fronte a cui si trova il nostro tempo non è quello di un attacco proditorio del male, ma quello della placidità un po’ lamentosa, ma sostanzialmente imbelle, con cui ci stiamo dirig endo ad occhi aperti verso un baratro».
«Questo libro ha l’ambizione di produrre una nuova diagnosi, in parte una prognosi, non ancora una terapia. Anche se il tempo è maturo per tentare di proporre un modello transattivo alternativo, esso va pensato fino in fondo e nei dettagli. Il problema di fronte a cui si trova il nostro tempo non è quello di un attacco proditorio del male, ma quello della placidità un po’ lamentosa, ma sostanzialmente imbelle, con cui ci stiamo dirig endo ad occhi aperti verso un baratro». Andrea Zhok
Andrea Zhok
 Lo spirito del denaro
e la liquidazione
del mondo
Lo spirito del denaro
e la liquidazione
del mondo
 Jaca Book. Pagine 377. Euro 26,00
Jaca Book. Pagine 377. Euro 26,00-
> "Deus" è "caritas" ("caro-prezzo")?! L’idolatria del denaro nell’Occidente cristiano. Una straordinaria lezione di Arturo Paoli, sull’amore ( "charitas") evangelico30 aprile 2007, di Federico La Sala
«Che cosa avrà mai da dire sull’amore e su una vita da vivere in pienezza un teologo?», si chiede Jürgen Moltmann. «Non dovrebbe, il teologo, assumere atteggiamento distaccato da questo mondo e dalle sue gioie, per dedicarsi interamente alla ricerca di Dio?» Per nulla, risponde. Perché l’amore per Dio e l’amore per la vita sono due facce della stessa esperienza
 Moltmann
Moltmann
 Inno alla vita
Inno alla vitaUna vita non vissuta è quanto di più orribile ci possa accadere. È vita morta. E si tratta di esperienze negative che a tutti capitano. Ciò che importa è non subirle, ma elaborarle, per affrontare con rinnovato coraggio questa vita che merita di essere accettata ed amata. Ciò che rende umano il vivere dell’uomo è questo interesse per la vita che noi chiamiamo «amore»
di Jürgen Moltmann (Avvenire, 30.04.2007)
Che cosa avrà mai da dire sull’amore e su una vita da vivere in pienezza un teologo? Non dovrebbe, il teologo, assumere atteggiamento distaccato da questo mondo e dalle sue gioie, per dedicarsi interamente alla ricerca di Dio? Come potrebbe amare la vita e vivere l’amore, quando dovrebbe essere totalmente preso dall’amore per Dio? E se quel teologo fosse poi un prete, non ci attenderemmo da lui più una saggezza pastorale che conoscenze nell’arte di amare? Io comunque sono un teologo evangelico, da cinquant’anni felicemente sposato, con quattro figli e cinque nipoti.
Sono arrivato alla fede in Dio ed allo studio della teologia dopo aver attraversato le esperienze di morte della guerra e le depressioni dei campi di concentramento, quando iniziai ad amare di nuovo la vita. Quando, nella notte profonda di morte, confidai in Dio, io mi sentii rivivere. Quando mi risollevai da quella tenebrosa tristezza e ricominciai a vedere i colori, ad ascoltare le melodie ed a percepire nuovamente la vita, a fiutarla, a gustarla, io trovai anche Dio. Per me l’amore per Dio e l’amore per la vita sono due facce della stessa esperienza. Ed è proprio questa la tesi che ora vorrei motivare in chiave teologica e filosofica, partendo dalle esperienze che noi della vita facciamo.
La mia vuol essere anche una critica a quelle dissociazioni che si sono venute via via affermando a partire da Agostino e che ci sono ormai così familiari: tra amor e caritas, tra eros e agape, tra vitalità e spiritualità, tra amore carnale e amore spirituale, in breve: tra al di qua e aldilà. Quel Dio di cui intendo parlare per me è la forza dell’al di qua, non un punto di fuga nell’aldilà. Nel Dio creatore noi non rileviamo alcuna traccia di negazione della vita ma soltanto un’affermazione, la più intensa, della vita stessa. Dio è presente nel cuore della vita e noi ne avvertiamo la sua vicinanza con tutti i nostri sensi. Noi sentiamo Dio quando sentiamo la vita, e quando amiamo davvero la vita su questa terra a miamo Dio stesso.
Stando alle esperienze di Dio narrateci nella Bibbia, la benedizione divina intensifica ancor più lo slancio vitale, non attenua il piacere di vivere. Chi sperimenta la vicinanza dell’Eterno impara ad amare di più questa vita limitata e mortale, non a disprezzarla. Lo Spirito, nel quale Dio si rende presente, è la forza vitale delle sue creature, lo spazio in cui esse si possono sviluppare in tutte le dimensioni. E nello Spirito di Cristo si fa esperienza della forza vitale della risurrezione, di un amore che è più forte della morte e di una vita che la morte sconfigge. Nella benedizione di Dio e nella forza della risurrezione di Cristo la nostra vita, tanto limitata, fragile, malata e mortale, conosce una vitalità senza fine, una realtà degna di essere amata senza limiti [...].
È difficile definire la vita umana, se per vita dell’uomo non intendiamo soltanto il funzionamento dei suoi organi, il bios dunque, ma anche il carattere specificamente umano del vivere, la zoe. Ogni definizione, proprio perché tale, circoscrive l’uno ed emargina l’altro: Come circoscrivere la vita umana senza emarginare interi ambiti vitali? Proviamoci.
La vita umana non dev’essere soltanto generata e messa al mondo, ma anche accettata, affermata, amata dai genitori e dai nostri simili. Una vita generata può svilupparsi nella sua umanità soltanto nelle sfere sociali dell’accoglienza, dell’affermazione e dell’amore. Facile la controprova: i bambini non accettati, non affermati, non amati intristiscono, si ammalano, muoiono presto o non sviluppano mai correttamente il loro potenziale vitale.
Vita umana non è semplicemente quella vissuta per se stessi e alla giornata. Umanamente si è vivi nella misura in cui si è interessati alla vita e si partecipa all’altrui vita, la si accetta ed afferma, ci si apre ad essa disponibili a sperimentarla con tutti i propri sensi. E più ameremo la vita senza riserve, appassionatamente, usciremo da noi stessi e ci esporremo alle esperien ze che la vita ci offre, più saremo anche capaci di provare felicità, ma più intensamente proveremo anche i dolori del vivere, le delusioni, le preoccupazioni, le afflizioni, la morte. L’uno non è mai disgiunto dall’altro: più vitale è la gioia di vivere, più letale sarà anche la pena del morire. È il paradosso insolubile della vita umana: amare di più comporta fare esperienze più intense di entrambi: del gioire e del patire, del vivere e del morire. Controprova. Quando non si ama più, neanche se stessi, non ci si lascia coinvolgere in nulla, e tutto si appiattisce, si rimane indifferenti anche alla vita ed alla morte. Non si provano più dolori, preoccupazioni, afflizioni, certo, ma nemmeno si vive, irrigiditi dentro un corpo che pur continua a vivere.
Quando la speranza di vivere subisce continue delusioni, alla fine si rivolta contro il deluso e lo scarnifica. Quando si perde ogni prospettiva di lavoro, di amore, di una vita che valga la pena di essere vissuta, ci si dispera, si prova un moto di odio per se stessi e per tutti. Quando muore la speranza di vivere, s’incomincia ad uccidere. La disperazione e la violenza brutale che si mette in atto contro i più deboli, perfino contro se stessi, non sono che le due facce della stessa esperienza di vita non amata. La gioia di vivere si rovescia nell’autodistruzione che Sigmund Freud chiamava pulsione di morte.
Ma questa disperazione non si legge soltanto sul volto deformato del violento. La vita non amata si mostra anche nel silenzio, nella mancanza di un senso del vivere. Boujour tristesse! Ciò che della vita ancor rimane, allora, è quel disgusto che troviamo nei ricchi e belli di questo mondo. Taedium vitae: una vita vuota, priva di senso, capace soltanto d’intrattenersi in qualche modo con se stessa. «Voglio divertirmi», dicono, ma in realtà intendendo trastullarsi prima di morire, perché la vita è diventata per loro insipida, non offre più stimoli. È la "società del divertimento" che si sta affermando negli strat i sociali più agiati della nostra società. La vita ha perso ormai ogni suo senso e quindi si sente il bisogno continuo di intrattenimento. E così la vita si rende ancor più vuota, da trascorrere nelle noiose conversazioni di una sala d’aspetto. Ma questa vita meravigliosa può davvero scorrere come una conversazione senza senso in una sala d’aspetto?
La situazione peggiore, comunque, è quella che si determina in chi vorrebbe vivere ma non può, perché non ne ha le possibilità. Ciò che unicamente conta nelle società moderne è la prestazione, il successo. Chi è in grado di dare ciò che da lui ci si aspetta conta qualcosa, vale, e chi non ne è capace non conta nulla, è considerato un "fallito" (looser). E la pressione sociale in tal senso oggi è così forte che porta l’individuo ad identificarsi con la sua prestazione: io sono ciò che sono capace di fare, e proprio perché faccio qualcosa mi posso permettere qualcosa, ad esempio viaggiare in Alfa Romeo o in Mercedes, perché tutti vedano chi sono. È praticamente impossibile sfuggire alla pressione che ci porta a condividere il sistema di valori della società in cui viviamo. E così chi non ha un lavoro è convinto di non contare più nulla e che la sua vita non meriti più di essere vissuta. Come uscire da queste autocommiserazioni?
Il primo passo da fare è quello di aprire gli occhi sulla realtà di fatto. Il secondo è rompere il silenzio e parlarne. A Berlino si è costituita un’interessante associazione di disoccupati, il «Club dei perdenti», tutti individui che si danno una mano per rimettersi in carreggiata. L’ultimo passo è quello di ritrovare fiducia in se stessi e vincere le paure di un nuovo fallimento. È la volontà di sfruttare le possibilità che la vita ci offre, ovunque siano. E non necessariamente deve trattarsi di un’attività lavorativa, perché c’è vita anche oltre il lavoro.
Ma nelle esperienze negative della vita è possibile fare anche esperienze di Dio di segno positivo. Tutto il cristianesimo non è altro c he una testimonianza di esperienze della vicinanza di Dio fra le tenebre della morte, di esperienze della grazia in mezzo alle oppressione della colpa, di esperienze di rigenerazione alla speranza in mezzo alla disperazione, di esperienze di consolazione fra le tante preoccupazioni, di esperienze di grandi accoglienze in un mondo che ogni giorno nega la vita, e infine di esperienze di sentirsi amati fin dall’eternità pur in una vita che non si sente amata né rispettata.
La vita umana vive quando si sa affermata, riconosciuta, amata, e muore quando si sente negata, umiliata, resa insignificante. La donna forte del film Il mondo di Antonia dice: «Bisogna viverlo». Una vita non vissuta è quanto di più orribile ci possa accadere. È vita morta. E si tratta di esperienze negative che a tutti capitano. Ciò che importa è non subirle, ma elaborarle, per affrontare con rinnovato coraggio questa vita che nonostante le sofferenze che l’accompagnano merita di essere accettata ed amata. Ciò che rende umano il vivere dell’uomo è appunto questo interesse per la vita che noi chiamiamo «amore» [...].
Concludiamo con uno sguardo alla vita eterna. Ciò che nella tradizione cristiana s’intende per "vita eterna" non è una vita "dopo la morte" ma una vita contro la morte. È una vita talmente possente che è in grado di vincere - l’apostolo Paolo dice «annientare» - la stessa morte. Una "vita dopo la morte" può coesistere con la morte e con questa nostra vita mortale. Ma una vita eterna, scaturita dalla risurrezione dei morti, rende questa nostra vita mortale immortale e questo mondo transeunte imperituro, e bandisce la morte dal creato. Nella speranza personale della risurrezione dei morti e della vita eterna, come si confessa nel Credo apostolico, rientra pure l’aspettativa cosmica della «vita del mondo futuro» (Credo niceno). Entrambe si trovano riassunte nell’ultima, grandiosa visione biblica dell’Apocalisse (21, 4-5):
 Dio tergerà ogni lacrima dai loro
occhi;
Dio tergerà ogni lacrima dai loro
occhi;
 non ci sarà più la morte,
non ci sarà più la morte,
 né lutto, né lamento, né affanno,
né lutto, né lamento, né affanno,
 perché le cose di prima sono passate.
perché le cose di prima sono passate.
 E Colui che sedeva sul trono disse:
E Colui che sedeva sul trono disse:
 «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose».Ma creature finite e morali riescono a concepire una vita nuova, eterna, soltanto se sono in Dio e Dio è in loro, soltanto dunque se la sorgente eterna della vita e l’Essere eterno, l’Essere che si autoconferma, è in mezzo a loro, dove le differenze che pur esistono tra la sorgente della vita e le forze della vita, come tra l’Essere eterno e l’essere temporale, scompaiono e l’uno si mostra nell’altro. Ed allora tutte le creature partecipano dell’eternità del loro Creatore, ogni vivente partecipa della vita divina, ogni esistente sussiste nella forza dell’Essere eterno. È quella che noi chiamiamo eternità relativa, o partecipata. Ed è anche la grandiosa visione che di Dio la Bibbia delinea:
 Ecco la dimora di Dio con gli uomini!
Ecco la dimora di Dio con gli uomini!
 Egli dimorerà tra di loro
Egli dimorerà tra di loro
 Ed essi saranno suo popolo
Ed essi saranno suo popoloAll’interno di questa inabitazione cosmica di Dio nel suo creato tutto ora diventa "nuovo". Nella nuova creazione tutte le creature partecipano, in massima spontaneità e pienezza, alla vitalità eterna di Dio. La pienezza della vita ora abita in mezzo ad esse. È questa la gioia infinita che Dio prova, o, secondo un’antica visione, è questo «il regno della gloria». È qui che si vivono tutti gli istanti di vita pienamente vissuta. E gli sguardi che in quella vita s’incrociano sono come i primi raggi dell’aurora del giorno di Dio che viene, per rimanere per sempre.
E la vita del nostro qui ed ora non varrebbe dunque la pena di essere infinitamente amata, di essere vissuta senza condizioni né riserve?!
-