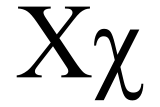
PER CARITÀ!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!! L’amore evangelico è "charitas", non "caritas"!!! Alcune note - a cura di Federico La Sala
lunedì 1 febbraio 2010.
- [...] Credo che l’ultima enciclica che Giovanni Paolo II avrebbe scritto, se fosse sopravvissuto, sarebbe stata proprio quella sull’amore. E giustamente la prima enciclica di Benedetto XVI si intitola Deus caritas est. Penso che questa sia la migliore prova delle precise intenzioni di Benedetto XVI di voler fermamente proseguire, con il suo pontificato, sulla linea spirituale e morale del suo grande predecessore [...]
- ECCLESIA DE EUCHARISTIA vivit (Giovanni Paolo II, 2003).
IDEE.
 La continuità tra Giovanni Paolo II e Benedetto XVI nell’analisi dell’amore tra Creatore e creatura. Una riflessione di Giovanni Reale
La continuità tra Giovanni Paolo II e Benedetto XVI nell’analisi dell’amore tra Creatore e creatura. Una riflessione di Giovanni Reale
Eros e agape secondo Wojtyla
 Scriveva il papa polacco nel «Fratello del nostro Dio», con provocatorio spirito poetico: «Lasciati plasmare dall’amore»
Scriveva il papa polacco nel «Fratello del nostro Dio», con provocatorio spirito poetico: «Lasciati plasmare dall’amore»
 Già Agostino aveva descritto il desiderio «donativo», dove l’agape include un eros ampliato rispetto a quello ellenico
Già Agostino aveva descritto il desiderio «donativo», dove l’agape include un eros ampliato rispetto a quello ellenico
di GIOVANNI REALE *
Il noto filologo tedesco Wilamowitz Moellendorff affermava senza mezzi termini che l’eros platonico e l’amore come agape «non hanno nulla a che fare l’uno rispetto all’altro». E precisava che Platone e Paolo non avrebbero potuto comprendersi a vicenda: «Per la verità hanno inteso cose completamente differenti, anche se avessero usato la medesima parola: l’uno non sapeva nulla dell’eros, l’altro non sapeva nulla dell’agape; naturalmente avrebbero potuto apprenderlo l’uno dall’altro, ma così come essi erano, non avrebbero potuto farlo».
Ma anche non pochi filosofi e teologi, soprattutto nell’area della cultura tedesca hanno insistito sulla inconciliabilità dei due paradigmi, e hanno rimproverato coloro che hanno tentato una loro mediazione, in quanto tale mediazione comporterebbe in sostanza un rinnegamento dell’agape.
In realtà, così non è: l’agape può includere l’eros inteso in una nuova luce, come ora vedremo. Agostino è stato uno dei primi che ha mediato i due concetti di amore in modo assai forte, puntando proprio sul ’desiderio’ che ha l’uomo di Dio, su quel sentimento particolare dell’uomo, che non trova pace fino a quando non trova riposo in Lui. Secondo Anders Nygren si tratterebbe di una indebita ripresa del concetto platonico di eros come ’desiderio’ (orexis), e pertanto di un fallace tentativo, che comprometterebbe a fondo la natura stessa dell’agape, in quanto ne capovolgerebbe il senso: l’amore come agape, che proviene dall’alto al basso, ossia da Dio all’uomo, tornerebbe a essere un amore dal basso all’alto, caratterizzato appunto dal desiderio, e quindi proveniente non da Dio ma dall’uomo stesso.
In realtà, la posizione assunta da Agostino non implica affatto un fallace compromesso fra le due interpretazioni dell’amore, in quanto imprime al desiderio un significato nuovo e trasfigurato [...].
Tale ampliamento del desiderio avviene nella dimensione dell’amore donativo. Ben si può dire che il ’desiderio’ viene inserito da Agostino in modo perfetto in quel nesso strutturale dell’’amore donativo’ di Dio per l’uomo: Dio, avendoci amato per primo, ci ha dato come dono il desiderio e la possibilità di amarlo, e, precisamente, di amare Lui, così come Lui ha amato noi. Oltre al paradigma dell’agape come donazione inteso in senso restrittivo ed escludente in toto il precedente incentrato sul desiderio, si impone, quindi, un terzo modello interpretativo dell’amore, inteso come agape inclusiva dell’eros.
Va comunque ben messo in rilievo e ribadito il fatto che questo terzo paradigma implica una amplificazione e una trasfigurazione di alcuni dei caratteri essenziali dell’eros ellenico (a cominciare da quello del ’desiderio’), e una loro valorizzazione proprio nella dimensione dell’agape, ossia nell’ottica della concezione di Dio come Amore donativo in assoluto.
Molto significativa è l’immagine biblica con cui Benedetto XVI, nella sua prima enciclica (Deus caritas est, 7) illustra la mediazione dei due paradigmi. Egli scrive: «In realtà eros e agape - amore ascendente e amore discendente - non si lasciano mai separare completamente l’uno dall’altro. Quanto più ambedue, pur in dimensioni diverse, trovano la giusta unità nell’unica realtà dell’amore, tanto più si realizza la vera natura dell’amore». E precisa: «I Padri hanno visto simboleggiata in vari modi, nella narrazione della scala di Giacobbe, questa connessione inscindibile di ascesa e discesa, tra l’eros che cerca Dio e l’agape che trasmette il dono ricevuto».
Nella Genesi 27 si legge: «Giacobbe fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa». La metafora del sogno di Giacobbe può ben essere intesa come immagine che illustra in modo perfetto il nesso dinamico-relazionale fra i due paradigmi, in cui l’uno è incluso nell’altro: gli angeli che scendono sono immagine dell’agape, ossia dell’amore donativo che Dio dà all’uomo, mentre quelli che salgono sono l’immagine dell’eros, ossia dell’amore come desiderio dell’uomo per Dio [...].
Karol Wojtyla - che oggi qui onoriamo - ha posto al centro non solo del suo pensiero teologico e pastorale, ma anche della sua filosofia e della sua poesia proprio l’amore. Nel dramma Geremia Wojtyla scriveva: «Ai piedi della verità bisogna mettere l’amore, / bisogna collocarlo agli angoli, per terra, per terra, / metterà radici anche là dove non ci sono strade - / e costruirà, eleverà, trasformerà». Nel Canto del Dio nascosto, precisava: «L’amore mi ha spiegato ogni cosa, / l’amore ha risolto tutto per me - / perciò ammiro questo Amore / dovunque Questo di trovi».
Nel Fratello del nostro Dio scriveva con provocatorio spirito poetico: «Lasciati plasmare dall’amore». E in una lettera privata del 6 gennaio 2002 mi scriveva, in riferimento alla pubblicazione da me curata di Tutte le opere letterarie: «Illustre Professore, Le sono riconoscente per aver sottolineato come proprio l’amore sia la sintesi - nell’essere e nell’esprimersi - di ciò che l’uomo cerca sulle vie della creazione artistica e su quelle della riflessione razionale. Del resto ’Dio è amore’ osserva l’apostolo Giovanni (1 Gv 4,8. 16) e la persona umana, creata a sua immagine, è chiamata a crescere e a realizzarsi nell’amore».
Credo che l’ultima enciclica che Giovanni Paolo II avrebbe scritto, se fosse sopravvissuto, sarebbe stata proprio quella sull’amore. E giustamente la prima enciclica di Benedetto XVI si intitola Deus caritas est. Penso che questa sia la migliore prova delle precise intenzioni di Benedetto XVI di voler fermamente proseguire, con il suo pontificato, sulla linea spirituale e morale del suo grande predecessore.
*
L’ANTICIPAZIONE
Lublino commemora il pontefice
In occasione di quello che avrebbe dovuto essere l’ottantottesimo compleanno di Karol Wojtyla, l’Università di Lublino ha invitato Giovanni Reale a tenere la «lectio magistralis» «Eros e agape», che sarà letta lunedì prossimo presso l’ateneo polacco e della quale anticipiamo alcuni stralci in queste colonne.
* Avvenire, 17.05.2008
Sul tema, nel sito e in rete, si cfr::
- ECCLESIA DE EUCHARISTIA vivit (Giovanni Paolo II, 2003).
Federico La Sala
Forum
-
> PER CARITÀ!!! L’amore evangelico è "charitas", non "caritas"!!! --- Charidád ("Diccionario de Autoridades", 1729).2 aprile 2020, di Federico La SalaCHARIDAD. s. f. Virtud Theologál, y la tercera en el orden. Hábito infuso, qualidad inherente en el alma, que constituye al hombre justo, le hace hijo de Dios, y heredero de su Gloria. Viene del Griego Charitas. Pronúnciase la ch como K : y aunque se halla freqüentemente escrito sin h, diciendo Caridád, debe escribirse con ella. Lat. Charitas. PARTID. 1. tit. 5. l. 42. La primera Charidád, que quiere tanto decir como amor de Dios mäs que de otra cosa, è de sí, è de su Christiano. NIEREMB. Aprec. lib. 1. cap. 1. El Angélico Doctor con mäs acierto dice, que aunque no es el mismo Dios, ni es infinita la Charidád, hace efecto infinito, juntando al alma con Dios. CORNEJ. Chron. lib. 1. cap. 38. Uno de los principales exercicios era por este tiempo la assisténcia à los Hospitáles, donde desahogassen los fervores de su inflamada Charidád ("Diccionario de Autoridades" - Tomo II, 1729).
-
> PER CARITÀ!!! - «Pensiero occidentale». Così Reale recuperò i Greci (di Donatella Di Cesare).25 novembre 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA, ARITMETICA, E ANTROPOLOGIA. I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE ... *
Discussioni
Il lato matematico di Platone
Così Reale recuperò i Greci
Esce una raccolta di studi del grande antichista italiano, difensore dei classici contro la visione scientista e il disprezzo diffuso per la teoria. La concezione delle idee come principi numerici, il primato della dottrina non scritta
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, La Lettura, 25.11.2018, p. 11)
- Nel Fedone Socrate si mostra assai deluso dall’indagine rivolta ai fenomeni naturali. Teme che pretendere di cogliere le cose con i cinque sensi finisca per accecare l’anima Qui si compie il passaggio decisivo dal sensibile all’intellegibile, dal sapere che si accontenta dell’apparenza a quello che si innalza ai concetti
Nel corso degli anni Novanta, quando la filosofia analitica, quella che si concepisce come analisi logico-formale, aveva raggiunto il suo apice, c’era chi aveva cominciato a gettare discredito sul pensiero antico, nonché ovviamente sullo studio della lingua greca e di quella latina. A che pro studiare quel capitolo chiuso e concluso? Perché perdere tempo con Platone anziché risolvere i problemi attuali?
In quel delicato frangente, che ha lasciato segni evidenti altrove, Giovanni Reale (scomparso nel 2014) ha svolto in Italia un ruolo decisivo a difesa della filosofia classica. Ne è testimonianza il volume Storia della filosofia greca e romana che, appena pubblicato da Bompiani, raccoglie gli studi del grande antichista in un percorso suggestivo che va dai primi frammenti, risalenti almeno al VI secolo a.C., fino al decreto con cui l’imperatore bizantino Giustiniano chiuse nel 529 d.C. tutte le scuole dell’Impero guidate da pagani. Oltre mille anni di storia della filosofia narrati con perizia, sapienza, semplicità.
 Reale ha lavorato a quest’opera per quattro decenni, intendendola quasi come un commento e un supporto alla fortunata collana del «Pensiero occidentale», dove sono usciti in edizione italiana, con testo a fronte, numerosissimi classici.
Reale ha lavorato a quest’opera per quattro decenni, intendendola quasi come un commento e un supporto alla fortunata collana del «Pensiero occidentale», dove sono usciti in edizione italiana, con testo a fronte, numerosissimi classici.Il richiamo a Martin Heidegger è significativo. L’inizio greco non è destinato ad essere superato in grandezza dalle altre epoche. Al contrario: la filosofia dei Greci è la più grande. E la filosofia è prettamente greca. Perciò è peculiarità dell’Occidente; non esiste in altre tradizioni nulla di paragonabile. Da un canto Reale punta l’indice contro lo scientismo, che pretenderebbe di misurare la filosofia con i criteri della scienza, dall’altro denuncia il dilagante disprezzo per la «teoria» che non servirebbe alla vita pratica. Occorre guardare alla filosofia greca dove la teoria è una forma di prassi. Come sostiene Aristotele nella Politica, attivi al più alto grado sono coloro che esercitano un’attività di pensiero; tanto più che theoreîn non significa solo «vedere», ma anche «partecipare».
 Reale si riconosce nell’ermeneutica di Hans-Georg Gadamer che, rilanciando l’insegnamento di Heidegger, ribadiva l’attualità del pensiero greco. Erano gli anni in cui il conflitto con la filosofia analitica veniva letto secondo il paradigma: «Noi greci, loro moderni». Ma la ripresa della riflessione antica non è antiquaria. Se la filosofia è indissolubilmente legata alla sua storia, questa storia non segue la freccia del progresso. Ecco perché, nell’apertura circolare di un dialogo, ammette e, anzi, sollecita la partecipazione. Al contrario di quel che avviene nella scienza, le domande della filosofia sono sempre le medesime, solo poste in modo differente. In tal senso l’incontro con la filosofia greca è «l’incontro con noi stessi».
Reale si riconosce nell’ermeneutica di Hans-Georg Gadamer che, rilanciando l’insegnamento di Heidegger, ribadiva l’attualità del pensiero greco. Erano gli anni in cui il conflitto con la filosofia analitica veniva letto secondo il paradigma: «Noi greci, loro moderni». Ma la ripresa della riflessione antica non è antiquaria. Se la filosofia è indissolubilmente legata alla sua storia, questa storia non segue la freccia del progresso. Ecco perché, nell’apertura circolare di un dialogo, ammette e, anzi, sollecita la partecipazione. Al contrario di quel che avviene nella scienza, le domande della filosofia sono sempre le medesime, solo poste in modo differente. In tal senso l’incontro con la filosofia greca è «l’incontro con noi stessi».Nata nelle vie e nelle piazze della pólis, dove il cittadino è chiamato alla vita politica, la filosofia si sviluppa lungo il filo conduttore del lógos, del discorso, dell’argomentazione, della ragione. Ma per Reale ciò che contraddistingue la tradizione greca è la metafisica, quel modo di pensare oltre i dati sensibili della realtà presente. Ne scorge le tracce già nell’orfismo, in quella iniziale religiosità ascetica, che per la prima volta parla di un che di «divino», che alberga nel corpo umano, cioè l’anima, la psyché. La morte è una liberazione dalla prigione del corpo, un ritorno all’origine dopo le sofferenze patite in terra. Questa potente dottrina della trasmigrazione delle anime, scaturita dalla fantasia orfica, capace di dischiudere l’aldilà, si sarebbe poi innestata nel cristianesimo.
Protagonista del volume è Platone, in cui Reale riconosce il «vertice del pensiero antico». È stato infatti il primo filosofo a guardare la realtà con «nuovi occhi», quelli dell’anima. Reale ricorda la «seconda navigazione» descritta da Platone nel dialogo Fedone. A parlare è Socrate, deluso dall’indagine sui fenomeni naturali; il suo timore è che, seguendo coloro che si volgono immediatamente alle cose, pretendendo di coglierle con i cinque sensi, finisca per accecare la propria anima. Si prepara allora alla «seconda navigazione», metafora del linguaggio marinaresco, che indicava il caso in cui, non essendoci più vento, la nave poteva essere spinta solo dai remi.
 Questo è il passaggio decisivo dal sensibile all’intellegibile, dalla conoscenza che si accontenta dei sensi a quella che si innalza alle idee, intese da Platone come le «forme» delle cose. In questo varco metafisico sta per Reale il vero inizio della filosofia. Le idee sono principi formali, numerici, sono anzi numeri ideali.
Questo è il passaggio decisivo dal sensibile all’intellegibile, dalla conoscenza che si accontenta dei sensi a quella che si innalza alle idee, intese da Platone come le «forme» delle cose. In questo varco metafisico sta per Reale il vero inizio della filosofia. Le idee sono principi formali, numerici, sono anzi numeri ideali.Vale la pena ricordare che Reale aderì alla Scuola di Tubinga, le cui figure più significative furono Konrad Gaiser, Hans Krämer, e in seguito Thomas A. Szlezák. L’insegnamento di Platone non può essere confinato agli scritti, ma va ricercato piuttosto nella dottrina «non scritta» trasmessa, fra gli altri, anche da Aristotele.
 Ne risulta una filosofia sistematica e fortemente matematizzata, dove assume rilievo la riflessione sull’uno, ma soprattutto sul due - che cosa significa due? - sulla diade infinita, «principio e radice della molteplicità degli esseri». -Anche chi non ne condivida i contenuti, dovrà ammettere che questa interpretazione, di cui Reale è stato il maggior esponente in Italia, ha aperto nuove vie di ricerca.
Ne risulta una filosofia sistematica e fortemente matematizzata, dove assume rilievo la riflessione sull’uno, ma soprattutto sul due - che cosa significa due? - sulla diade infinita, «principio e radice della molteplicità degli esseri». -Anche chi non ne condivida i contenuti, dovrà ammettere che questa interpretazione, di cui Reale è stato il maggior esponente in Italia, ha aperto nuove vie di ricerca.L’ammirazione per Platone, il grande pioniere del soprasensibile, non impedisce a Reale di scrivere pagine eccellenti su Aristotele, dalla fisica all’etica, dalla logica alla poetica, ricostruendo la portata epocale del suo pensiero. Ma a segnare una cesura, capace di ripercuotersi sulla filosofia, è il tramonto definitivo della pólis nel tempo di Alessandro Magno. Al cittadino subentra il suddito e, mentre vengono meno le antiche passioni, ciascuno è rinviato a se stesso e alla propria individualità in un mondo dove l’etica si scinde dalla politica, come attestano le scuole filosofiche successive.
Il volume contiene un’ultima parte in cui, da Filone d’Alessandria ad Agostino d’Ippona, viene delineato l’incontro fra tradizione ebraica e filosofia platonica, da cui sarebbe scaturito il cristianesimo. Particolare risalto assumono anche le figure di Plotino e di Proclo.
 Viene prospettata allora una «terza navigazione», quella che non si ferma all’oltresensibile delle idee, alle forme immutabili, ma si apre agli imponderabili misteri della fede.
Viene prospettata allora una «terza navigazione», quella che non si ferma all’oltresensibile delle idee, alle forme immutabili, ma si apre agli imponderabili misteri della fede.
 Si legge qui in filigrana il cammino sia intellettuale sia autobiografico di Reale, molto improntato, in particolare negli ultimi anni, a un’ispirazione religiosa. L’oltre della metafisica, che riteneva di non trovare più nel mondo attuale, ha improntato la vita contemplativa di questo grande maestro.
Si legge qui in filigrana il cammino sia intellettuale sia autobiografico di Reale, molto improntato, in particolare negli ultimi anni, a un’ispirazione religiosa. L’oltre della metafisica, che riteneva di non trovare più nel mondo attuale, ha improntato la vita contemplativa di questo grande maestro.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- PER CARITÀ!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!! L’amore evangelico è "charitas", non "caritas"!!!
- UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
LA VIA DI KANT: USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”. Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> PER CARITA’!!! L’amore evangelico è "charitas", non "caritas"!!! --- La "Storia della filosofia greca e romana" di Giovanni Reale.1 novembre 2018, di Federico La Sala
Ma che bella storia d’amore
Filosofia antica. Torna in libreria l’opera di Giovanni Reale: non è un arido manuale ma il resoconto di un’avventura, il diario di un’appassionata ricerca durata una vita
di Maria Bettetini (Il Sole-24 Ore, Domenica, 28.10.2018)
Giovanni Reale, Storia della filosofia greca e romana, Bompiani, Milano, pagg. 2.816, € 70
«Anche in questo i Greci sono stati e restano maestri: si è filosofi solo se e finché si è totalmente liberi, ossia solo se e finché, in assoluta libertà, si contempla o si cerca il vero come tale, senza ulteriori ragioni predeterminanti». Qualcuno forse giudicherà ingenua questa affermazione, tratta da uno dei saggi che accompagnano la Storia della filosofia greca e romana di Giovanni Reale, soprattutto leggendo il seguito: «Conoscendo in modo disinteressato, l’uomo si accosta alla verità, e in questa maniera realizza la sua natura razionale al più alto grado, e di conseguenza raggiunge la felicità».
In uno dei miei primi interventi in pubblico, tanti anni fa, pronunciai parole simili, libertà, felicità, verità. Ricordo alcuni sguardi ironici, e perfino una voce che componeva una poesiola, taratà taratà verità. Ero di certo ingenua nell’esposizione, incapace del giusto pathos. Ma avevo alle spalle anni di frequentazione con l’uomo più entusiasta mai conosciuto per la ricerca filosofica, il maestro che aveva trasformato studi da «museo archeologico», come usava dire, in ricerca appassionata, anzi, «innamorata». Come tutti i grandi, aveva le sue idiosincrasie, ma il dono di trasformare pagine antiche in questioni di vita o di morte è stato incredibilmente fecondo. Per questo, quando si è pensato di pubblicare la sua Storia della filosofia greca e romana in un unico volume nella collana da lui fondata, il Pensiero Occidentale, nessuno ha sollevato obiezioni.
Perché non si tratta di una storia della filosofia, piuttosto del resoconto di un’avventura, del diario di una ricerca. Senza nulla togliere all’attenzione filologica e ai rimandi bibliografici, chi leggesse questo libro come si affronta un arido manuale perderebbe molto. Giovanni Reale infatti, nell’opera per cui è più conosciuto nel mondo non solo accademico, ha lasciato traccia dei suoi studi, certo, ma anche della sua stessa vita.
Mi sono innamorato della filosofia, così aveva intitolato l’ultima delle sue fatiche e così dichiarava con fierezza quando gli si chiedeva da dove fosse partita la sua avventura. Proprio questo amore lo aveva condotto a una passione non secondaria, la divulgazione, la trasmissione dei testi e dei contenuti lasciati dai grandi pensatori. La riproposizione della Storia della Filosofia Greca e Romana vuole essere quindi un omaggio al suo ideatore e infaticabile sostenitore.
Da ragazzo, Giovanni Reale voleva dedicarsi alla filosofia contemporanea, ma il suo maestro Francesco Olgiati lo inviò invece a Marburgo per studiare quella antica, intuendo l’importanza del mondo greco e romano per la cultura italiana. Se il motto del neokantismo era stato «Torniamo a Kant», l’imperativo per il giovane Reale fu «Torna ad Atene!»: un’espressione che gli piaceva molto ricordare e ripetere.
I primi lavori furono dedicati ai seguaci di Parmenide, poi venne la fatica della Metafisica di Aristotele, in polemica con chi voleva fare dello Stagirita un autore destrutturato, già quasi postmoderno. La vis che poi percorrerà tutti i lavori di Reale è già in ogni pagina del commento alla Metafisica, le idee di fondo sono pedagogicamente riproposte, la scrittura vivace cattura il lettore. Tutto questo si ritroverà fin dalle prime edizioni delle diverse storie della filosofia, dove emergerà il personaggio centrale, il protagonista di quello che si rivela sempre più un romanzo piuttosto che un manuale. «Sembra di leggere un giallo», mi diceva ai tempi dell’università una compagna di studi: in attesa dell’arrivo di Platone, tutto è come sospeso, dopo di lui, le sue tracce brillano da Aristotele agli ultimissimi neoplatonici. Platone, l’autore della «seconda navigazione»lo scopritore del soprasensibile, colui che ha aperto al mondo la via di un «oltre», di un mondo che è altro rispetto alla materia. Come chi fatica con i remi, felice si abbandona alla forza del vento se impara a usare le vele, passando dalla prima alla seconda navigazione (la metafora è nel Fedone), così al pensatore si spalanca il respiro dell’oltresensibile, che gli permette di comprendere senza fatica tanti perché. Gli anni Ottanta vedranno poi sorgere passione nella passione, con la grande battaglia per il «Platone non scritto», testimoniata anche in questo volume.
La passione platonica vira poi verso le opere del Santo vescovo di Ippona, Agostino. Siamo alla «terza navigazione», l’oltresensibile ancora studiato dalla ragione si apre agli aspetti dell’imponderabile, di ciò che può essere oggetto solo di fede. In verità, nella vita degli uomini, così come nelle opere di Agostino, non tutto è così chiaramente definibile e individuabile come materia, logos, misteri della fede. Ma l’avventura di Reale segue invece queste tappe con precisione matematica, e mentre difende il suo Platone non scritto, in contatto con la Scuola di Tubinga, con Hans-Georg Gadamer, con i traduttori ormai in arrivo da tutti i continenti, inizia a dedicare tempo e attenzione solo al vescovo di Ippona, in compagnia del quale desidera trascorrere gli ultimi anni della vita.
Anni incredibilmente fecondi: da Rusconi, che chiude l’attività editoriale di filosofia, al volgere del millennio le collane di Reale arrivano in Bompiani, e pubblicano in meno di quindici anni più di trecento libri mentre ne preparano decine tra contratti e lettere di intenti. Inoltre, Reale accanto alla cura per centinaia di titoli scriveva e pubblicava di arte, di Platone, di Agostino e della filosofia, la sua innamorata. Ora la Storia della Filosofia Greca e Romana troverà certo il favore delle migliaia di lettori che lo hanno incontrato al liceo, in università, o dopo, come studiosi, cultori, appassionati, curiosi. Benvenuti dunque in questa avventurosa storia d’amore.
Saggezza antica e moderna
di Armando Massarenti (Il Sole-24 Ore, Domenica, 28 novembre 2004)
Con la sua Storia della filosofia greca e romana Giovanni Reale ripropone per Bompiani, in una forma editoriale del tutto inedita, una revisione e un aggiornamento della sua classica Storia della filosofia antica (Vita e pensiero). Ottima l’idea di riproporla in dieci singoli volumi, uniti in cofanetto ma disponibili anche singolarmente a un prezzo contenuto: 9 euro l’uno. L’ipotesi enunciata nell’introduzione è assai forte: in Grecia è nato il pensiero filosofico, e non ci sono possibilità di ritrovarlo in nessun’altra civiltà. E l’atteggiamento speculativo, tipico dei greci, è frutto del dialogo. Oggi però l’atteggiamento dialogico potrebbe forse apparire in contrasto con quello speculativo, che tende a proporre teorie filosofiche in sé compiute?
«Direi di no - risponde Reale -, perché la “dialettica”, l’introduzione dell’”oralità dialettica”, sostituisce la precedente oralità che era “mimetico-poetica”, la ripetizione del poema in versi nel contesto di una cultura fatta per immagini e miti. I primi filosofi, quando hanno usato lo scritto, lo hanno fatto con pochi fogli di papiro su cui nasceva una discussione, il dialeghein: non un ripetere cose, ma il modo di arrivare alla determinazione di un concetto. Prendiamo Socrate. Uno dava una risposta a un certo problema e lui diceva “non basta quello che dici. Non potresti esprimermelo meglio?” E questo turbava moltissimo. Prima di allora bastava come risposta il verso di un poeta. Quando Socrate chiedeva “cos’è il bello?” e gli si rispondeva “una bella ragazza, un bell’uomo”, lui replicava: “no, non ti ho chiesto degli esempi, ma cos’è il bello”. Per arrivare a una determinazione del concetto, il dialogo è necessario».
La discussione era un vero e proprio costume per i greci, un costume filosofico che - come sostiene Pierre Hadot - era anche un modo di vivere. Secondo lei, proprio rispetto al dialogo, c’è una continuità fra la filosofia greca classica e quella delle “scuole” successive: stoici, scettici, ecc.? «Sì. All’interno delle scuole si coltivava il dialogo. E le varie scuole si confrontavano tra loro. Il caso più tipico di opposizione paradigmatica è quella fra epicurei e stoici».
Però mentre in Platone e Aristotele è più marcato l’atteggiamento speculativo, l’amore disinteressato per la conoscenza, invece per le “scuole” è l’aspetto etico ad assumere un’importanza decisiva: anche la logica, la fisica, la cosmologia ne sono subordinate. «Per il filosofo greco - aggiunge Reale - il problema di fondo era: come essere felice? L’eudaimonia è il motivo del suo impegno. Naturalmente l’eudaimonia è qualcosa di molto più forte ci ciò oggi si intende per felicità. Niente a che vedere col benessere. Per il greco, tu puoi essere felice se capisci il cosmo, se capisci chi sei e di conseguenza ti collochi in quel cosmo. Platone e Aristotele davano più peso concettuale alla struttura. Gli altri invece puntavano prevalentemente sull’effetto. Perché? Perché fino ad Aristotele c’era la polis, che per il greco era la struttura del vivere anche morale. Con Alessandro è stata distrutta la struttura in cui l’uomo greco viveva. C’è stato un ribaltamento di valori tale per cui andava tutto ricostruito. Per la prima volta la vita del singolo diventa emergente. Per Aristotele l’uomo è un animale politico. Non sei uomo se non sei nella polis. Poi al legame che una città stabilisce con gli uomini si sostituì il concetto di amicizia. É la dimensione soggettiva degli uomini che porta i problemi dell’individuo in primo piano. Fino ai primi del Novecento questo fatto spingeva ad avere una visione negativa di queste filosofie. Poi le cose sono cambiate. Io difendo anche Epicuro. La felicità per lui era assenza di dolore. Però diceva anche: “A colui a cui non basta ciò che è necessario, nulla mai basterà. E sarà un infelice”. Ciò indica la dinamica in cui si deve entrare per trovare la felicità».
In questo, in realtà, assomiglia molto agli stoici. «Certo. Gli stoici sono antitetici agli epicurei, ma dicono cose simili. Per esempio che ogni essere può essere felice anche dentro la più terribile macchina di tortura che un tiranno aveva inventato. La felicità in quest’ottica, non dipende dalle cose, ma dai rapporti in cui si pone nei confronti delle cose».
Questa idea della sopportazione paziente del dolore segna una continuità con il cristianesimo. Il concetto di eudaimonia, invece, non è in contrasto con esso? A contatto con il cristianesimo l’etica si allontana dall’eudaimonismo, come ha sostenuto Bentham fondando una forma di eudaimonismo molto diverso da quello degli antichi. «Diciamo che nella storia è cambiato anche il concetto di felicità - dice Reale -. Si è dimenticato che la felicità dipende da te, e non dalle cose. Felicità in greco si dice eudaimonia, deriva da eu-daimon, è felice colui a cui è toccato in sorte un buon demone. I presocratici rovesciano il punto di vista: il demone te lo scegli tu. Platone lo dice nella Repubblica: sei tu che scegli il tuo demone e la virtù non ha padroni. E non è difficile trovare alcune convergenze con il cristianesimo. Il concetto di felicità così come i greci lo hanno determinato è: tu sei felice se riesci a essere te stesso. Tutta la storia del platonismo dice tu non sei te stesso se non ti metti in rapporto con Dio».
Dunque, in che modo oggi possiamo dialogare con i classici del pensiero greco? «Oggi la filosofia si sta distruggendo con una formula di autofagia. Si ritira in una sorta di metalivello, indaga solo le caratteristiche formali facendo astrazione dal loro contesto. Invece con i greci la filosofia si chiedeva: come devi vivere per vivere bene».
É ciò che ha sostenuto anche un grande filosofo inglese, Bernard Williams: se oggi vogliamo avere una filosofia all’altezza dei problemi morali che la gente si pone, dobbiamo tornare ai greci e alla domanda su «come vivere». Però sostiene anche un’altra tesi, su cui lei probabilmente non è d’accordo: il motivo per cui si dovrebbe tornare ai greci non è che la gente oggi riflette di meno, ma che, al contrario, riflette di più. Le scelte di vita - negli studi, nel lavoro, nella vita affettiva - non sono più date per scontate come nelle generazioni precedenti. Prima la vita dell’individuo era in ampia misura predeterminata. Oggi invece in qualunque tappa della vita si è costretti a prendere delle decisioni, a porsi appunto la domanda di Socrate: come devo vivere? «Purtroppo oggi si pensa con la categoria del particolare - sostiene Reale -. Si è dimenticata la visione tipica della Grecia che era l’intero. La problematica dell’intero è quella che ti dà la cornice dei problemi. Oggi molti partono dal particolare e con il particolare colloquiano. Ma il particolare non ha la cornice dell’universale. Il problema difficile per i giovani è quello di elevarsi a questo livello. Quello che mi preoccupa nei giovani oggi è che non affrontano i problemi legati a questa dimensione più elevata. A me pare che con tutte le soddisfazioni che l’uomo di oggi ha, anziché sentirsi pieno si sente vuoto. Perché emerge ciò che manca. Molti dicono che è la scoperta della sofferenza ciò da cui si scappa di più. Gadamer dice che i giovani si drogano per quello. Nell’ultimo libro della Repubblica si parla già di sofferenza e di scelta delle altre vite possibili. La scelta delle vite successive peggiori è fatta da anime che non hanno sofferto».
Ma così sembra proprio che ci allontaniamo dall’eudaimonia. «No. Tu attraverso la sofferenza cresci. Non è lei che diventa padrona, ma tu di quella e arriverai al sapere. Al sapere non si accede se non soffrendo. Non è la felicità banale o edonistica del piacere, ma quella dello spirito dell’uomo che è capace di essere sofferente anche dentro. La cultura scientifica di oggi ti insegna a fare cose, quella umanistica aveva un altro scopo. Ti insegnava a diventare uomo. Marco Aurelio diceva: “Quando al mattino ti svegli e sei stanco devi dire a te stesso: alzati per compiere il tuo mestiere di uomo”. Il messaggio della mia opera è questo: guarda che la scienza ti insegna tante cose ma non a fare il mestiere di uomo».
Oggi però, se lei ha ragione, i giovani non solo non studiano il mestiere per diventare uomini, ma a quanto pare non si iscrivono neppure alle facoltà scientifiche. «Ai giovani abbiamo dato tutto tranne la capacità di affrontare i problemi. Alcuni hanno capito per intuizione che dalla scienza non viene la soluzione dei problemi. Io adoravo la matematica. Passavo le vacanze a risolvere i problemi del libro di algebra. Che la scienza sia uno degli strumenti più potenti che l’uomo ha messo in atto è fuor di dubbio. I giovani devono usarla in “giusta misura”, come i greci insegnavano. Ma la scienza non risolve tutti i problemi. Di certo non quelli ultimativi, che oggi vanno riproposti». E crede che i filosofi possano risolverli? «Sì».
-
>Giovanni Reale una vita nel segno di Platone. Lo storico che insegnò la filosofia dei classici a intere generazioni è morto ieri all’età di 83 anni (di Antonio Gnoli)16 ottobre 2014
Lo storico che insegnò la filosofia dei classici a intere generazioni è morto ieri all’età di 83 anni
Giovanni Reale una vita nel segno di Platone
di Antonio Gnoli (la Repubblica, 16.10.2014)
SEMBRAVA un uomo di altri tempi. Pingue, loquace, cerimonioso. Un’eleganza antica. Cappello compreso, immancabile su una testa calva, dalla fronte spaziosa. Innamorato del proprio mestiere di storico della filosofia. Quando ci vedemmo l’ultima volta, circa un anno fa, in un albergo romano, per parlare di sé e della meravigliosa impresa editoriale dei suoi classici della filosofia (raccolti e pubblicati da Bompiani), mi sembrò che fosse cresciuta in lui la consapevolezza di un lavoro indispensabile. L’idea che avesse realizzato qualcosa di importante per la cultura di questo paese: sia sul piano del pensiero (soprattutto filosofico), sia su quello dell’arte (spesso, negli ultimi tempi, in coppia con Elisabetta Sgarbi).
Giovanni Reale è morto abbastanza repentinamente, a 83 anni, per non lasciarci in qualche modo disorientati. Restano i suoi lavori. Quelli di manualistica, realizzati in parte con Dario Antiseri; i commenti - spesso magistrali - alle opere dell’antichità, in particolare a Platone il suo filosofo di riferimento. Da buon cattolico egli difese le ragioni della vita. Nel dialogo, intenso, che svolse da credente con Umberto Veronesi, lo scienziato non credente, (Responsabilità della vita è il libro frutto del loro confronto) si coglie il desiderio dialettico di capire e di entrare nelle convinzioni dell’altro, con civiltà e ragione.
Negli ultimi anni l’accademico di vaglia - che aveva insegnato in varie università europee, ma prevalentemente alla Cattolica di Milano - lasciò uno spazio crescente alla riflessione più attuale, legata ai temi urgenti: come pensare il fine vita e come difenderlo dai pregiudizi ideologici. Di qui le tormentate considerazioni e il rispetto con cui sentiva di dover affrontare i casi di Welby e di Eluana. Significative furono a questo riguardo - in una lettera inviata a Mina Welby - le ragioni, in qualche modo laiche, di un credente che respingeva l’accanimento terapeutico e lasciava al malato la decisione di come morire.
Sospetto che in quella maturazione si affacciasse il bisogno di tornare ad alcuni motivi della filosofia antica: le virtù del bene e del bello, l’armonia, l’eros inteso come slancio verso un ordine superiore, e l’assoluto come principio da imitare nella consapevolezza che mai l’umano potrà pienamente soddisfare.
Per questo tra Aristotele e Platone egli scelse Platone. Sia come guida spirituale, che come pratica etica e conoscitiva. Amava Platone da platonico, quale in fondo riteneva di essere. Non che Aristotele non fosse altrettanto fondamentale. Ricordo infatti la sua traduzione e il commento alla Metafisica, dove venivano colte le intenzioni sistematiche dello stagirita. Per ogni studente che si avventurava, con qualche dubbio, nella selva di quel testo, Reale era un saldo punto di riferimento filologico. Come lo fu sull’intera filosofia antica. Eppure, era Platone il filosofo al quale sempre tornava.
Reale aveva in qualche modo sposato l’interpretazione fornita dalla “scuola di Tubinga”, secondo la quale il filosofo andava letto e interpretato soprattutto alla luce delle dottrine non scritte. Quel mondo misterioso, impalpabile, iniziatico che Platone costituì sotto il nome di Accademia, affascinò il pensiero di Reale. Quasi che nella scena che si profilava si potesse leggere lo scontro drammatico tra la scrittura e la vivente dialettica. Non era questa, in fondo, la misura stessa con cui Socrate aveva esaltato la forza della parola orale contro quella scritta?
Certo, diverse e fondate furono le critiche a quel metodo di lavoro che privilegiava un inse- gnamento non scritto, forse perfino segreto, ma del quale restano poche e indimostrabili tracce. Ma ad affascinare Reale contribuì la constatazione che Platone fosse al centro di una rivoluzione epocale che in qualche modo coinvolgeva perfino le nostre esistenze. Anche noi, come lui, dentro un’epocale trasformazione.
Per quanto riguarda Platone c’era il passaggio tutt’altro che indolore da una civiltà orale, fondata sul mito e l’immagine, a una civiltà della scrittura sorretta dall’argomentazione razionale. Cosa avrebbe guadagnato e perso l’uomo greco con questa rivoluzione? Si sarebbe staccato dalla seduzione del fantastico e dalla bellezza, anche tragica, dell’epico per abbracciare qualcosa che, con la forza del solo Logos, avrebbe segnato l’intero Occidente. Una vittoria che poteva vestire i panni della sconfitta o viceversa: una sconfitta che si sarebbe potuto leggere come una vittoria.
Questa era la scena. Platone ne fu pienamente consapevole e sebbene non volle rinunciare del tutto a ciò che si stava abbandonando, al tempo stesso, dovette farsi interprete di quel nuovo mondo che avanzava e che prese il nome di metafisica. I suoi scritti decretarono che si potesse e dovesse pensare non più per immagini ma per concetti. La sua teoria delle idee fu, secondo Reale, l’approdo naturale a un modo nuovo di affrontare il tema della verità.
Platone colse i limiti della scrittura, come alcuni interpreti hanno dichiarato rifacendosi alla Lettera VII. Dopo lunghe discussioni, quel testo fu attribuito a Platone ed è considerato - insieme al Fedro - il documento più esplicito circa i dubbi che Platone formulò nei riguardi della parola scritta, incapace di esprimere tutta la profondità del pensiero filosofico. Peccato che quelle cose Platone le abbia pensate e dette scrivendo. Fu una delle obiezioni forti mosse sia alla scuola di Tubinga che a Reale. Quest’ultimo non se ne preoccupò più di tanto, continuando a pensare che i due volti di Platone - il corpus degli scritti e l’accademia dove trionfò l’oralità della dialettica - fossero entrambi indispensabili per comprenderne il messaggio filosofico.
Reale è stato un curioso metafisico nel tempo del tramonto della metafisica. Negli ultimi anni, si interessò alla filosofia di Martin Heidegger. C’è bisogno di idee forti, altro che pensiero debole, aveva sostenuto, vedendo crescere l’interesse attorno alla figura di questo controverso pensatore. Contrariamente a quello che in genere si pensa, e cioè che Heidegger sia un antimetafisico, Reale sostenne che egli sia stato uno dei più grandi metafisici della storia del pensiero occidentale.
Anche sulla religiosità Reale intuì il profondo coinvolgimento di Heidegger. Non so quanto fosse la sincera e tormentata passione del credente e non piuttosto il tentativo di ricondurre la teologia alla filosofia, ma è certo che in quella lettura, a nostro avviso poco plausibile, ci fosse una sintonia profonda, quasi un sovrapporsi di identità. La stessa, anche se in misura più lieve, che per tutta la vita ha riguardato la sua relazione ventriloqua con Platone.
Mi chiedo se quest’uomo affabile, cerimonioso e non privo di una qualche punta di vanità non abbia con la sua lettura dato vita, involontariamente, a una specie di “Zelig” della filosofia, tanto più efficace quanto più capace di adattare quel sistema complesso di idee platoniche al mondo contemporaneo. Naturalmente non c’è una risposta. Ogni uomo è la sua terra. Ed è giusto rendere omaggio alla sua fedeltà all’antico. E al suo sogno platonico.
-
> PER CARITA’!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!! --- La dittatura culturale del marxismo (di Giovanni Reale) )6 gennaio 2014, di Federico La Sala
-
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa
La dittatura culturale del marxismo
di Giovanni Reale (Corriere della Sera, 06.01.2014)
Caro direttore, dopo l’intervista che ho dato ad Armando Torno (Corriere della sera del 3 gennaio) e la replica, firmata da Antonio Carioti che registrava le tesi di Mario Vegetti (4 gennaio), desidero aggiungere alcune precisazioni. I marxisti, nel secondo dopoguerra, anche se non hanno mai vinto le elezioni, si sono imposti ad alto livello, instaurando una sorta di dittatura culturale. La Democrazia cristiana, inoltre, ha commesso molti errori proprio in campo culturale, al punto che il ministro della Pubblica istruzione Riccardo Misasi ha proposto il «sei politico», una promozione garantita a tutti. Con ironia gli antichi dicevano: nel caso in cui vengano a mancare cavalli e restino solo asini, si stabilisca per legge che tutti gli asini siano detti e considerati cavalli. E così siamo giunti alla situazione della scuola di oggi.
Io sono stato avversato dall’Accademia non solo di recente per la mia interpretazione di Platone, ma da sempre, a cominciare dai lavori su Aristotele degli anni Sessanta del secolo scorso, in cui denunciavo gli errori di ermeneutica del grande filologo Werner Jaeger, oggi da tutti riconosciuti. Ma allora sono stato accusato (da marxisti e da altri) di sostenere quelle tesi in quanto cattolico, e addirittura tomista (non lo sono mai stato). Inoltre, quando stavo per pubblicare la traduzione con commento della Metafisica di Aristotele, un potentissimo accademico di allora minacciò di rovinarmi la carriera se l’avessi data alle stampe.
Alla pubblicazione della mia Storia della filosofia antica in 5 volumi (allora da «Vita e pensiero»; oggi, in 10, da Bompiani), un giornalista disse al direttore di «Vita e Pensiero» che nessun quotidiano l’avrebbe recensita, perché scritta da un cattolico e per una casa cattolica. E da alcuni colleghi è stata proibita, in quanto giudicata «non scientifica».
Anche i miei allievi sono stati avversati. Maurizio Migliori si è in certo senso salvato, in quanto legato al gruppo vicino al «manifesto». Ma è stato più volte invitato a lasciarmi, in quanto cattolico. Ma Migliori credeva nel mio metodo, e giudicava le ricerche scientifiche come meta-politiche. Roberto Radice è stato addirittura bocciato al primo concorso (non ammesso neppure agli orali). E, in risposta, ha tradotto tutti gli Stoici antichi e poi le Enneadi di Plotino. E vinta la cattedra, ha creato la collana dei Lessici, con programma elettronico, dei filosofi antichi.
Le più forti opposizioni dei marxisti si sono verificate in occasione della pubblicazione dell’opera Il pensiero occidentale , che ho scritto con Dario Antiseri, per l’Editrice La Scuola. Ma inaspettatamente proprio dalla Russia è venuta la smentita dei detrattori nostrani. La traduzione russa ha avuto grande successo. Raissa Gorbaciova, professoressa di filosofia, ne ha fatto grandi elogi, e l’Università Statale di Mosca ha premiato Antiseri e me con il titolo di «Professor honoris causa». Nella giornata del premio, un professore ci ha elogiati, dicendo che, con la nostra opera, abbiamo insegnato «che cos’è la democrazia in filosofia», facendo capire che cosa dice ogni filosofo e perché lo dice, di qualsiasi tendenza sia.
L’opera ha avuto varie traduzioni, l’ultima delle quali è venuta dal Kazakistan, promossa dal ministero della Pubblica istruzione, ed è in corso la trattativa per la traduzione in cinese. Il Corriere della Sera ha di recente promosso un’edizione dell’opera in 14 volumi, con un imponente apparato iconografico ideato da Mario Andreose, con cui ho collaborato con entusiasmo (da giovane amavo dipingere, e tuttora scrivo libri sull’arte con Elisabetta Sgarbi, convinto che l’arte sia una delle vie attraverso le quali l’uomo ricerca la verità).
Al marxismo si è oggi sostituito un laicismo estremista, che è una forma di Illuminismo integralista, anticattolico e antireligioso, non meno pericoloso, in quanto dimentica una sacrosanta verità, espressa in modo perfetto da Edgar Morin: i lumi della ragione non vedono le ombre all’interno della loro chiaroveggenza; essi «per non accecare, hanno bisogno d’ombra; dobbiamo riconoscere il mistero della realtà, della vita, dell’essere umano».
Ai giovani, per concludere, vogliamo inviare un messaggio di fiducia. Dalle situazioni, anche le più difficili, come abbiamo più volte verificato di persona, è sempre possibile uscire, se si crede in ciò che si fa, e se ci si impegna a fondo, cercando di evitare ogni compromesso. E ricordiamo la splendida massima di Eraclito, il più profondo filosofo presocratico, che ci ha molto aiutato: «Se uno non spera, non potrà mai trovare l’insperabile, perché esso è difficile da trovare e impervio».
-
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! Un’inchiesta e una mappa
-
> PER CARITA’!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!! ---- Le "Confessioni" di Agostino un’opera che per Reale non va letta con il criterio biografico (di Armando Torno - Maria Zambrano: Sant’Agostino erede di Platone)7 dicembre 2012, di Federico La Sala
 Maria Zambrano
Maria Zambrano
 Sant’Agostino erede di Platone
Sant’Agostino erede di Platone di Armando Torno (Corriere della Sera, 7.12.2012)
di Armando Torno (Corriere della Sera, 7.12.2012)Maria Zambrano, la filosofa spagnola scomparsa nel 1991, sosteneva una tesi semplice e sconvolgente al tempo stesso: la cultura europea è nata con le Confessioni di Agostino. In esse non si scopre soltanto un uomo che si converte ma come e perché cambia un’epoca.
Giovanni Reale in questi ultimi anni sta studiando soprattutto Agostino. Dopo il Commento al Vangelo di Giovanni, ora firma la nuova traduzione - testo a fronte, monografia introduttiva di 350 pagine, note esplicative e apparato di cinque indici - delle Confessioni (Bompiani, «Il pensiero occidentale», pp. 1406, 30).
La sua ricerca parte da una certezza: è un errore interpretarlo come un filosofo medievale, giacché va letto con gli strumenti del pensiero antico; o meglio: con l’aiuto del neoplatonismo. Tra le novità di questa sua edizione, c’è la «tarsia letteraria», stile basato sulle citazioni che Agostino prende dalla Bibbia. Di tarsia, va precisato, se ne parla solitamente in arte; qui si entra in una nuova dimensione in cui l’ornamento cede il passo alle esigenze di ricerca della verità.
Non è, per intenderci, un mosaico con tante fessure; assomiglia piuttosto a quelle tarsie del legno che non lasciano spazio tra l’elemento introdotto e la base in cui sono inserite. Tutto questo per dire che le parole di Agostino nelle Confessioni non avrebbero senso senza gli inserti: non sono ripetizioni retoriche ma locuzioni che ribadiscono un concetto forte, atomi fonetici che egli vede giungere dal Logos incarnato. Si prenda, per esempio, il XIII libro, dove si legge l’interpretazione allegorica della creazione: ha più citazioni che altro e presenta la ri-creazione dell’uomo, la medesima resa possibile dal Logos, dalla Parola, che assume appunto sembianze di carne.
Nelle Confessioni ci si accorge più che in altre opere che i termini della Bibbia sono quelli di Dio. Il lavoro della tarsia lo evidenzia. Kierkegaard osservava che per fidarsi di una persona si chiede la sua parola, ma nota che questo semplice atto Dio l’ha compiuto in Cristo. «Io sono la verità» asserì Gesù: è possibile fidarsi dell’affermazione perché la Parola è stata data in garanzia a ogni uomo.
Siamo dinanzi a un’opera che per Reale non va letta con il criterio biografico. Presenta due livelli: uno orizzontale e uno verticale. Nel secondo caso Agostino rimanda continuamente al suo rapporto con Dio. È come se dicesse: tutto quello che ho fatto e che ora vedo o continuo a compiere ha senso solo nel mio ostinato colloquio con Lui. La confessione, insomma, la chiede Lui. La relazione che si instaura è particolarmente forte: l’io si trasforma in un rapporto con il Tu, con Dio.
La Zambrano ha colto un altro aspetto di cui Reale fa tesoro: le Confessioni non hanno dei precedenti letterari se non nel Libro di Giobbe, dove si vive un continuo confronto con il Signore. Ma così come non è biografia Giobbe, allo stesso modo non lo sono le Confessioni: la logica che le governa non è empirico-storica ma quella di un uomo che evoca il significato di alcuni momenti della sua vita, punti topici ripensati attraverso la psiche.
Per questo e per altri motivi Reale coglie in esse un’unità. Non ci sono i primi o gli ultimi libri, non c’è per lo studioso un’aggiunta o una digressione sfuggita alla penna: Agostino affronta con un solo respiro quello che è stato o ha pensato, ma anche quello che fu in quel momento, saltando anni, senza mai accantonare la tensione che lo lega al colloquio con l’assoluto.
Certo, verso la fine, soprattutto nei libri XI e XII, entrano in gioco dei concetti fondamentali: la creazione dal nulla, l’eternità, il tempo. Per Agostino, così come per la Chiesa e per i Padri in genere, la stessa materia non è coeterna a Dio ma viene dal nulla. La differenza tra tempo ed eterno incanta ancora il lettore. Si può così comprendere che è domanda senza senso chiedersi cosa facesse Dio prima della creazione, perché il tempo nasce insieme al cosmo, e non c’era un prima e un poi: soltanto dopo l’intervento di Dio la questione si presenta. Platone nel Timeo si interrogò sulla nascita del tempo e delle cose, Agostino risponde aggrappandosi al Creatore. E cos’altro poteva fare? Passano i secoli e anche noi siamo ancora qui, con lui, tra una riga e l’altra delle Confessioni.
-
> PER CARITA’!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!! ---- una nuova edizione del "Commento al Vangelo di Giovanni" di Agostino (di Armando Torno - Agostino, padre di Europa).12 febbraio 2011, di Federico La Sala
Premessa sul tema. Una nota:
Del "Commento al Vangelo di Giovanni" di Agostino, Giovanni Reale ha curato una ’nuova’ edizione, basandosi sul classico testo dei Maurini, in cui è dato al Nome del Dio di Giovanni ("Deus charitas est) il nome della tradizione del "latinorum":"Deus caritas est".... E così - per la gloria del sacro e romano cattolicesimo - fa scomparire la traccia greca della Grazia e delle Grazie e celebra le "radici cristiane" dell’Europa!!!
Agostino, padre dell’Europa
Parte da lui il pensiero di Schelling, Hegel e Kierkegaard
di Armando Torno (Corriere della Sera, 12.02.2011)
Quindici anni di lavoro, forse più. Centoventiquattro discorsi, dei quali una abbondante cinquantina furono prediche proferite a braccio e messe per iscritto dai tachigrafi, mentre i restanti vennero dettati e poi letti da terzi. In cifre e schemi si possono così riassumere le pagine che Agostino ha lasciato sul quarto Vangelo, quello di Giovanni, nel quale la rivelazione cristiana abbraccia e trasfigura il messaggio della cultura greca. Un insieme di chiose e di considerazioni imponente, ma allo stesso tempo inquietante, sconvolgente, tra i più ispirati del santo.
Giovanni Reale ne ha curato una nuova edizione, basandosi sul classico testo dei Maurini, cercando di ricostruire e riprodurre il ritmo del parlato, i possibili silenzi, le riprese della voce. Ha posto titoli a ogni capitolo e ai paragrafi, intervenendo su un’opera che si presenta magmatica, concepita sovente di getto da una mente che piegava la sintassi e le regole retoriche ai propri bisogni. In tal modo, è riconsegnato ai lettori uno dei momenti più alti del lascito di Agostino, quel Commento al Vangelo di Giovanni (Bompiani, 2 volumi in cofanetto, pp. 3.278, e 50) che corre come un filo rosso nella cultura occidentale. L’ariosità restituita ai discorsi li rende comprensibili, quasi in grado di evocare gli accenti che li hanno plasmati.
Nel saggio introduttivo si esaminano la struttura logica, i fondamenti metodologici, filosofici e teologici dell’opera e si evidenzia in cosa consista il sovvertimento del pensiero filosofico antico pagano qui attuato; e per quali ragioni, come ha sostenuto Maria Zambrano, Agostino debba essere considerato il padre spirituale dell’Europa (e, aggiungiamo, uno dei massimi riferimenti per l’arte, come prova il primo volume dell’Iconografia agostiniana. Dalle origini al XIV secolo, appena pubblicato da Città Nuova).
Ma cosa trova il lettore di oggi, impigrito da una letteratura inconsistente, in questo universo di considerazioni su Giovanni? Il testo rivela il bisogno di amore e la necessità di capire il mondo, di trovare un senso alla morte. Con il Commento si chiarisce il metodo di Agostino e si intuisce un’ulteriore chiave di lettura dell’ultimo libro delle Confessioni. La tarsia di citazioni, dove è riunita tutta la Bibbia, mostra come il santo cercasse di cogliere dal punto di vista allegorico il mistero della creazione attraverso la Parola rivelata.
C’è qualcosa di rivoluzionario in queste pagine? Certo, basta leggere le parti sulle domande che non hanno ancora una risposta e le considerazioni sull’amore, giacché quello cristiano ha bisogno della carne, non è un mero fatto spirituale. Di carne si riveste Dio, con la carne dialoga il Cristo e di carne necessita la resurrezione. «Questo è il mio corpo» contrasta con il platonico «tutto ciò che è umano non è degno di molta considerazione...» . Dal momento in cui sull’Acropoli di Atene si scoprì che c’è una realtà oltre quella tangibile, nacque il desiderio di trovare un mediatore che in essa conduca e la illustri. Platone lo individuò nell’eros, vedendolo non come dio ma come demone.
Nel Commento a Giovanni, Agostino tenta di più spiegando come Dio stesso diventi il demone-mediatore, facendosi uomo. La novità rispetto agli altri vangeli? Questo Commento ricorda che i sinottici hanno mostrato soprattutto l’umanità di Gesù, leggendo Giovanni il santo capisce che è tempo di ritoccare le prospettive: in ogni momento della vita di Cristo, anche nei particolari, si vede Dio. Perché Dio abita in ogni azione di Cristo e il Figlio diventa il contemporaneo di ogni uomo (lo ripeterà Kierkegaard).
Agostino, che ha avuto una prima conversione con i platonici, ora ha smesso di credere che Dio sia corpo infinito, ma è tale in spirito. Leggendo Plotino e Porfirio si è accorto che l’aldilà c’è veramente e che per raggiungerlo occorre attraversare un mare. Comprende che solo il lignum crucis fa superare queste acque: non mostra l’aldilà, ma in esso conduce. Già, lignum crucis: emblematica sintesi della totalità delle sofferenze dell’uomo.
Ci sono poi delle intuizioni accecanti che Reale evidenzia, presenti anche in Hegel (Filosofia della religione) e in Schelling (Filosofia della rivelazione): Cristo ha preso su di sé la morte e, accettandola, l’ha uccisa. Sulla croce, quindi, la morte di Cristo segna la morte della morte. Per questo non ha abbandonato il legno del supplizio: rimanendovi l’ha sconfitta, solo restando appeso poteva divorarla. Kierkegaard dirà che se fosse sceso avrebbe negato di essere il Figlio di Dio, diventando un pagliaccio.
Per Platone l’amore mette le ali all’anima, rendendola in grado di volare sempre più in alto; inoltre, il cocente sentimento è tanto grande quanto lo è l’oggetto che si ama. Il messaggio cristiano che Agostino urla nel Commento capovolge la prospettiva: l’amore è tanto più grande quanto più è piccolo l’oggetto amato. Da acquisitivo si fa donativo. Per questo Dio ama l’uomo sino a indossarne la carne e a morire per lui. Credere in Cristo - quest’opera cerca di spiegare il modo in cui gli uomini devono farlo - significa portare il logos dei filosofi greci sino a Dio, quindi toccarlo quando si fa carne e infine, seguendo disegni lontani dalla ragione, vederlo immolarsi per amore.
-
> PER CARITA’!!! Prof. Giovanni Reale ... prof. Antiseri si svegli dal sonno dogmatico!!! ---- La natura come dono (di Dario Antiseri - Il metodo giusto per battere la tecnocrazia? È già scritto nel «Cantico delle creature»).27 gennaio 2011, di Federico La Sala
Note sul tema:
 Federico La Sala
Federico La Sala
Il metodo giusto per battere la tecnocrazia? È già scritto nel «Cantico delle creature»La modernità del pensiero francescano si conferma nella visione della natura come dono, concezione che si oppone a un consumo senza rispetto delle cose
DI DARIO ANTISERI (Avvenire, 27.01.2011)
Che il passato, cioè la tradizione, consista in un cumulo di pregiudizi, di errori da cui prendere sistematicamente le distanze, è - come ribadito, tra altri, da Hans-Georg Gadamer - un oscuro pregiudizio illuminista. La tradizione, infatti, può essere anche fonte di verità. Un solo esempio dalla storia della scienza: Copernico portò a nuova vita, traendola fuori dall’«immondezzaio della storia» in cui era stata sepolta, la teoria eliocentrica difesa nel V secolo a.C. da Iceta di Siracusa e Filolao e, un secolo dopo, da Eraclide Pontico ed Ecfanto il Pitagorico. E, con maggior frequenza che nella scienza, la stessa cosa capita in filosofia, come - tra molteplici altri - è il caso delle risposte che il pensiero francescano è in grado di offrire ad urgenti domande dei nostri giorni.
La difesa dei diritti e del primato della fede nei confronti delle presunzioni di una ragione che, ergendosi a dea-Ragione, calpesta la «creaturalità» dell’essere umano e la conseguente apertura all’esperienza religiosa; l’insistenza, all’interno del volontarismo di Scoto, sull’onnipotenza e libertà di Dio e insieme sull’autonomia e libertà dell’individuo; la difesa della libertà e responsabilità della persona umana da parte di Ockham contro quell’onnipresente tentazione liberticida che è diretta conseguenza della reificazione dei concetti collettivi; la consapevolezza, soprattutto da parte di Pier di Giovanni Olivi, relativa ai benefici effetti di un’economia di mercato - sono, questi, quattro filoni di pensiero che rendono fortemente attuale la tradizione del pensiero francescano.
Attualità su cui, con grande impegno e competenza, torna uno dei più noti esperti di filosofia medioevale, e cioè Orlando Todisco, con La libertà creativa. La modernità del pensiero francescano (Edizioni Messaggero Padova, pp. 590, euro 40). «’In principio la libertà’. È nella libertà la grandezza di Dio come la nobiltà dell’uomo». Questa, che è la tesi di fondo del libro, è un’idea centrale del volontarismo francescano, dove «sia il mondo che la storia sono l’uno frutto della libertà di Dio, l’altra dell’uomo». In tal modo, «muovendo dalla libertà, divina e umana, la vita acquista un altro colore e un’altra rilevanza. Siamo fuori del ’motore immobile’ che muove senza ’commuoversi’ ». Ma se tutto ciò che è - il mondo, noi, qualunque creatura - poteva non essere, se le cose sono in un certo modo perché qualcuno le ha volute, allora «la percezione dell’essere come dono» esige uno sguardo di gratitudine, di ammirazione e di rispetto.
È questo, fa presente Todisco, lo sguardo del Cantico delle creature - uno sguardo distante, anzi incommensurabile con la prospettiva di chi si pone di fronte alla realtà con l’intento di appropriarsene e di utilizzarla senza alcun freno, secondo le sue voglie. Significativo, a tal proposito, è un passo del Discorso del metodo di Cartesio: «Conoscendo la forza e le azioni del fuoco, dell’acqua, dell’aria, delle stelle, del cielo e di tutti gli altri corpi che ci circondano, con la stessa chiarezza con cui conosciamo i diversi mestieri dei nostri artigiani, potremmo, allo stesso modo, impiegare quei corpi in tutti i loro usi particolari e diventare così padroni e possessori della natura». Qui - commenta Todisco - c’è tutto, meno quel tipo di «illuminazione’ della realtà insito nei termini ’sorella’ e ’fratello’ con cui Francesco chiama tutte le creature.
Una visione, questa, di estrema attualità politica - ma, prima che politica, morale -, una decisa inversione di tendenza in un mondo dove, in nome della potenza della tecnica per cui, da più parti, si arriva a sostenere che è lecito fare tutto quello che è tecnicamente possibile fare. Ed esattamente puntando l’attenzione sulle disastrose e disumane conseguenze di siffatta concezione si è levato più volte il monito di Benedetto XVI: «L’uomo sa fare tanto e sa fare sempre di più; e se questo saper fare non trova la sua misura in una norma morale, diventa, come possiamo già vedere, potere di distruzione».
-
> PER CARITA’!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!! --- Il Commento al Vangelo di Giovanni in una nuova traduzione di Giovanni Reale (di Francesco Tomatis - Agostino e l’agape).4 gennaio 2011, di Federico La Sala
Agostino e l’agape, marchio dell’Europa dopo i Greci
Nel pieno della stesura delle opere maggiori, il santo di Ippona commenta il Vangelo più spirituale. Illuminando così il dogma dell’«homoousía»
di Francesco Tomatis (Avvenire, 04.01.2011)
Il Commento al Vangelo di Giovanni accompagnò sant’Agostino d’Ippona a lungo nella sua vita teologica, all’incirca dal 406 al 421, quindi parallelamente alla composizione del De Trinitate, avviata successivamente alle Confessioni, e all’altra grande opera agostiniana, il De civitate Dei, terminata qualche anno dopo. Ne propone una nuova traduzione italiana, corredata di una ampia e illuminante monografia introduttiva, nonché dell’edizione maurina del testo originale in latino, il massimo studioso vivente del pensiero antico, Giovanni Reale, che, grazie alla sua profondissima conoscenza della filosofia greca, classica e tardoantica, della Bibbia e dei Padri della Chiesa, riesce in questa edizione dei discorsi agostiniani sul Vangelo di Giovanni a ricostruirne struttura interpretativa, visione metafisica, messaggio di fede (Il libro è edito da Bompiani, pagine 2368 + 928, euro 50,00).
Reale sottolinea come il Commento al Vangelo di Giovanni sia affiancabile a pieno titolo, per profondità e importanza, alle altre tre opere agostiniane ritenute comunemente principali: le Confessiones , il e Trinitate e il De civitate Dei.
In esso per eccellenza abbiamo infatti il principale risultato teologico della credente esegesi di sant’Agostino, cioè la comprensione che Dio sia amore. Come scrive Giovanni nella sua Prima lettera, «Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui». Inoltre proprio in questi discorsi, frutto di esposizione orale, trascritta dal discorso vivo o redatta per iscritto tramite dettatura diretta dell’autore a tachigrafi, di un completo commentario al Vangelo giovanneo, Agostino formula le proprie principali linee teologiche interpretando direttamente il più speculativo, e al tempo stesso realissimo, dei Vangeli, vera metafisica vivente, ricorrendo ad una sua continua, puntuale contestualizzazione rispetto ad altri scritti biblici, secondo una tecnica ad intarsio, richiamata ed evidenziata nella propria edizione da Reale, la quale va oltre il mero ricorso a citazioni scritturistiche, per giungere attraverso i suoni e le parole all’aiuto del Signore nella comprensione della sua autorivelazione.
Che Dio sia amore, agápe, è per il cristianesimo rivelato attraverso l’incarnazione di Dio in Gesù Cristo. Reale riesce finemente a ricostruire la distinzione agostiniana dell’amore cristiano dall’éros greco, non mancando tuttavia di documentare anche quanto Agostino riesca a far proprio dello stesso pensiero greco. Esemplare è poi la ripresa dell’interpretazione porfiriana dell’essere come Uno, nella sua distinzione dall’ente. In Agostino, come Reale mostra evidenziando la sua reinterpretazione, alla luce della rivelazione biblica, della filosofia greca, vengono delineate le fondamenta di quello che saranno il pensiero e la civiltà europei. L’idea di persona, ad esempio, sarebbe inconcepibile senza la sua fondazione cristiana nel personale rapporto con Dio, egli stesso trinitario rapporto interpersonale.
Accostandosi ad udire la voce di quella immane vetta spirituale, dell’elevatissima anima che è Giovanni, Agostino illumina esemplarmente il dogma dell’homoousía, della uguaglianza di essenza o natura fra Dio Padre e Dio Figlio, centro dell’incarnazione cristiana e conseguentemente della comprensione e fede in Dio come amore, come relazione fra diverse persone in unitaria armonia, identificazione, comunione: secondo il pluralismo e l’unitarietà assieme. «Tu, dunque, devi dire quello che dice il Vangelo: io e il Padre siamo una cosa sola. Quindi non siamo una cosa diversa, in quanto siamo ’una cosa sola’; non una persona sola, perché noi ’siamo’».
-
> PER CARITA’!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!! ---- "MISERIA DELLA FILOSOFIA" DELLA "SACRA FAMIGLIA". Dario Antiseri, grazie a Del Noce, riesce a vedere la pagliuzza nell’occhio di Marx, ma non la trave nell’occhio della tradizione cattolico-ratzingeriana (contrabbandata come cristiana).11 agosto 2010, di Federico La Sala
-
> PER CARITA’!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!! ---- Senza "charité", Dario Antiseri sulle orme di Reale (non di Pascal).1 dicembre 2010, di Federico La Sala
La lezione di Pascal. Genio della scienza, paladino della fede. La scommessa su Dio e il valore del Vangelo
«Riconoscere i limiti della ragione umana».
di Dario Antiseri Corriere della Sera 1.12.10
«C’era un uomo che a dodici anni, con delle sbarre e dei tondi, aveva creato le matematiche, che a sedici aveva fatto il più dotto trattato sulle coniche che si fosse visto dall’antichità; che a diciannove ridusse in una macchina una scienza che esiste tutt’intera nell’intelletto; che a ventidue anni dimostrò i fenomeni dell’aria e debellò uno dei grandi errori dell’antica fisica; a quell’età in cui gli altri uomini incominciano appena a crescere, avendo compiuto il ciclo delle scienze umane, si avvide del loro nulla e rivolse i suoi pensieri alla religione; che da quel momento fino alla morte, giunto al trentanovesimo anno, sempre infermo e sofferente, fissò la lingua che parlarono Bossuet e Racine, diede il modello della più perfetta arguzia come del ragionamento più forte; che, infine, nei brevi intervalli dei suoi mali, risolvette per distrazione uno dei più alti problemi della geometria, e gettò sulla carta dei pensieri che hanno tanto del Dio quanto dell’uomo: quello spaventoso genio si chiamava Blaise Pascal». Così René de Chateaubriand.
Dio e l’uomo. E il Dio di Pascal non è «il Dio dei filosofi e dei sapienti», ma è «il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». Contrario a Cartesio «inutile e incerto», lontano dalla illusoria presunzione razionalistica degli Scolastici, Pascal tiene distinta la sfera della ragione da quella della fede: «La fede è un dono di Dio. Non crediate che diciamo che è un dono del ragionamento. (...) La fede è differente dalla dimostrazione: questa è umana, quella è un dono di Dio». D’altro canto, «perché una religione sia vera, è necessario che abbia conosciuto la nostra natura. Bisogna che ne abbia conosciuto la grandezza e la miseria. (...) E chi, tranne la religione cristiana, l’ha conosciuta?». La corruzione della natura umana e l’opera redentrice di Gesù Cristo: questi, dice Pascal, sono i due soli principi della fede cristiana. In Cristo scopriamo Dio e, davanti a Lui, non copriamo la nostra miseria. L’uomo non è un costruttore di senso, è un mendicante di senso: «È bene sentirsi stanchi e affaticati dell’inutile ricerca del vero bene, al fine di tendere le mani al Liberatore».
Sull’esistenza o non esistenza di Dio la ragione tace, «non può determinare nulla», e tuttavia la ragione può mostrare che scegliere Dio è tutt’altro che follia. Ed è qui che Pascal innesca il grande tema della «scommessa»: «Scommettere bisogna: non è una cosa che dipende dal vostro volere, ci siete impegnato. Che cosa sceglierete, dunque? (...) Pesiamo il guadagno e la perdita, nel caso che scommettiate in favore dell’esistenza di Dio. Valutiamo questi due casi: se vincete, guadagnate tutto; se perdete, non perdete nulla. Scommettete, dunque, senza esitare che Egli esiste».
Se Dio non scende nell’animo umano sulla scala dei nostri sillogismi, si dà anche che tutti i nostri «lumi» non sono in grado di farci conoscere la vera giustizia: «Nulla, in base alla pura ragione, è per sé giusto. (...) Tre gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza; un meridiano decide della verità; nel giro di pochi anni le leggi fondamentali cambiano; il diritto ha le sue epoche. (...) Singolare giustizia che ha come confine un fiume! Verità di qua dei Pirenei, errore di là». Nel campo dell’etica la ragione si lascia piegare per ogni verso. E, difatti, è facile constatare che «il furto, l’incesto, l’uccisione dei figli o dei padri, tutto ha trovato posto tra le azioni virtuose». Ma, allora, dov’è che la morale potrà trovare il suo porto? Lo trova - dice Pascal - nella fede: la vera giustizia è quella «secondo a Dio piacque di rivelarcela».
La vera giustizia è, dunque, la norma evangelica: «Senza la fede l’uomo non può conoscere né il vero né la giustizia». Una soluzione, questa, che - se da una parte spinge il non credente a riflettere, in un campo dove la logica non aiuta, su quanto l’Occidente deve al messaggio antropologico ed etico del Cristianesimo -, dall’altra pone il credente davanti ad un ineludibile interrogativo: il cristiano ciò che è Bene e ciò che è Male lo sa dal Vangelo o dalla ragione? Da quale ragione?
«Il più grande scrittore cristiano, più grande dello stesso Newman»: così T.S. Eliot ha definito Pascal. Ma intanto: Pascal è un «fideista» che umilia la ragione, o è piuttosto un «iperrazionalista» che ha messo e pone in guardia contro gli abusi della ragione?
-
-
> PER CARITA’!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!! ---- SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA: "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE"!!!1 febbraio 2010, di Federico La Sala
-
> PER CARITA’!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!! ---- Cristiani sull’orlo dell’ateismo (di Giovanni reale).15 febbraio 2010, di Federico La Sala
Cristiani sull’orlo dell’ateismo
di Giovanni Reale (Corriere della Sera, 14 febbraio 2010)
Molti credono di sapere che cosa significhi essere «credenti» e essere «atei», ma in realtà i più in materia hanno idee tutt’altro che chiare e distinte. Un famoso giornalista si presentò a un uomo di grande statura spirituale per fargli una intervista su Dio dicendogli che, però, lui si considerava ateo. E si sentì subito rispondere: «Guardi che chi sia veramente credente e chi sia veramente ateo lo sa solo Dio». Dostoevskij pensava che, in un certo senso, l’ateo si trova al primo gradino della strada che porta a Dio, in quanto sente il problema.
La situazione è oggi assai più complessa e forse solo oggi si manifesta l’ateo nel senso pieno della parola. Hanno iniziato i Neopositivisti viennesi con l’affermazione che la parola «Dio» andrebbe eliminata dal lessico scientifico, in quanto sarebbe totalmente priva di senso. Ma questo modo di pensare è condiviso anche da alcuni giovani, da cui mi sono sentito dire che per loro quello di Dio è uno pseudoproblema, anzi un «non problema». La figura dell’ateo più ambigua è però quella del sedicente credente, che si nasconde sotto la maschera della fede, e che contrae la dimensione del religioso in quello che- sotto molti aspetti - è il suo contrario.
Il libro di Marco Vannini, Prego Dio che mi liberi da Dio - La religione come verità e come menzogna (Bompiani, pp. 159, € 16) affronta il problema in modo provocatorio (e in certi punti con paradossi e iperboli), ma assai efficace. La religione viene spesso trasformata in una teologia sociale, mondana, progressista, anticristiana. In effetti, «nel suo connubio col sociale, col politico, la religione genera vincoli di unione parziale, di gruppo e di conseguente separatezza dall’universale».
Perciò, dice Vannini: «Il regno di Dio non è di questo mondo; non adeguarsi al mondo, è il vero modo di amarlo». Agostino precisava che il regno di Dio è già entrato con Cristo «in» questo mondo, ma non è «di» questo mondo, in quanto opera non amando ciò che ama il mondo e in questo senso aiuta il mondo stesso.
I due assi portanti del libro sono, a mio avviso, i seguenti. In primo luogo, Vannini rivendica l’importanza del pensiero platonico nella formazione del pensiero cristiano, con l’affermazione del primato dell’interiorità, mediante la conversione spirituale e l’imitazione di Dio. E trae le seguenti conclusioni: «Privato dell’eredità platonica, il cristianesimo è tutto accomodato al sociale, ovvero al "grosso animale", all’io e soprattutto al noi, con la correlata immagine idolatrica di Dio. Rivolto ai beni terreni - la pace, la giustizia sociale, la salvezza ( salus) diviene salute, politicamente corretto, liberale, democratico ecc. - è ormai una banalità accettabile da tutti, in quanto autoaffermativa, senza conversione, senza distacco, senza spirito: di fatto, un sostanziale ateismo».
Si tenga presente che è stato proprio Platone a introdurre, oltre che il termine di «teologia», anche l’immagine di «conversione», ossia il «voltarsi» per intero dalle tenebre della caverna alla luce del sole, ossia del Bene. I primi cristiani l’hanno fatta propria e consacrata, in quanto esprime in modo metaforico il concetto del «metanoein», del cambiare modo di pensare con l’aiuto della grazia.
In secondo luogo, Vannini punta sul concetto di «spirito», come rapporto dialettico fra uomo e Dio, con al centro la divinità di Cristo, più che sul concetto di anima. Va ricordato che il concetto di anima (psyché) è una creazione dei greci. Si pensi che Platone usa il termine 1.143 volte, Plotino 1.509, Aristotele 785. Nei Vangeli il termine psyché è usato poche volte, ma con il prevalente significato di «vita» ed è un errore ermeneutico caricarlo dei significati metafisici ed escatologici ellenici. Il concetto cardine del Cristianesimo è quello della incarnazione di Cristo e della risurrezione della carne, che è in distonia con la concezione greca dell’anima (Plotino diceva che non si deve parlare di risurrezione della carne, ma di risurrezione dalla carne, ossia della liberazione dell’anima dal carcere del corpo).
Il richiamo del concetto di spirito che fa Vannini «capace di tenere insieme, senza confusione, finito e infinito, umano e divino», al di sopra di quello di psyché, è assai stimolante. L’essere o la sostanza dell’anima, in effetti, non è riducibile al puro elemento psicologico, ma consiste proprio in quel nesso strutturale dinamico-relazionale fra uomo e Dio e viceversa. E, ispirandosi a Meister Eckhart (da cui è tratto anche il titolo dell’opera), Vannini precisa: «Il fondo dell’anima non è un facoltà, una "potenza" dell’anima, ma in esso opera la grazia increata, Dio stesso che "opera con l’anima tanto da liberarla da se stessa, in quanto creatura, in modo che non resti niente, se non Dio e l’anima stessa, senza mediazione"».
-
> PER CARITÀ!!! --- NEL 2022 DOPO CRISTO, ANCORA NEL’OFFICINA DI PLATONE: "ECCE HOMO" (NIETSCHE, 1888)!9 novembre 2022, di Federico La Sala
IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS ("CHARITAS"): E IL LOGOS SI FECE CARNE... ECCE HOMO!
COME NASCONO I BAMBINI. Al di là della natività edipico platonica... *
***
IN NOME DEL LOGOS. «Egli (Cristo), ha detto: “Io sono la verità” (Gv 14,6); del diavolo invece ha detto: “Non rimase nella verità, poiché in lui non c’è verità” (Gv 8,44). Ora, Cristo è talmente la verità che tutto in Lui è vero: Egli è il vero Verbo, Dio uguale al Padre, vera anima (vera anima), vera carne (vera caro), vero uomo (verus homo), vero Dio; vera è la sua nascita (vera nativitas), vera la sua passione ( vera passio), vera la sua morte (vera mors), vera la sua risurrezione (vera resurrectio). Se neghi una sola di queste verità, entra il marcio nella tua anima, il veleno del diavolo genera i vermi della menzogna e nulla rimarrà integro in te» (Agostino, Joh. Ev. tr. 8, 5-7);
IL FIGLIO. «Quegli che con le sue mani tocca il Verbo può farlo unicamente perché “il Verbo s’è fatto carne e abitò fra noi” (Gv 1,14). Questo Verbo fatto carne sino a potersi toccare con le mani cominciò a essere carne nel seno della Vergine Maria (Hoc autem Ver bum quod caro factum est ut manibus tractaretur coepit esse caro ex Virgine Maria)» (Agostino, In Joh. Ep. 1,1);
MARIA E GIUSEPPE SPOSI NELLO SPIRITO DEL LOGOS ("CHARITAS"). «L’utero della Vergine fu la stanza (del Verbo), poiché è là che si sono uniti lo sposo e la sposa, il Verbo e la carne (et illius sponsì thalamus fuit uterus Virginis, quia in ilio utero virginali coniuncti sunt duo, sponsus et sponsa, sponsus Verbum et sponsa caro). Poiché sta scritto (Gn 2,24): “E saranno i due una sola carne” (et erunt duo in carne una). E anche il Signore dice nel Vangelo (Mt 19,6): “Dunque non sono due, ma una sola carne” (igitur iam non duo, sed una caro)» (Agostino, In Joh. Ep. 1, 2).
PAROLA DEL "VULCANICO" PLATONE. PARLA EFESTO: "NON PIU’ DUE, MA UN’ANIMA SOLA"!
"ARISTOFANE: [...] queste persone che passano la loro vita gli uni accanto agli altri non saprebbero nemmeno dirti cosa s’aspettano l’uno dall’altro. Non è possibile pensare che si tratti solo delle gioie dell’amore: non possiamo immaginare che l’attrazione sessuale sia la sola ragione della loro felicità e la sola forza che li spinge a vivere fianco a fianco. C’è qualcos’altro: evidentemente la loro anima cerca nell’altro qualcosa che non sa esprimere, ma che intuisce con immediatezza. Se, mentre sono insieme, EFESTO si presentasse davanti a loro con i suoi strumenti di lavoro e chiedesse: "Che cosa volete l’uno dall’altro?", e se, vedendoli in imbarazzo, domandasse ancora: "Il vostro desiderio non è forse di essere una sola persona, tanto quanto è possibile, in modo da non essere costretti a separarvi né di giorno né di notte? Se questo è il vostro desiderio, io posso ben unirvi e fondervi in un solo essere, in modo che da due non siate che uno solo e viviate entrambi come una persona sola. Anche dopo la vostra morte, laggiù nell’Ade, voi non sarete più due, ma uno, e la morte sarà comune. Ecco: è questo che desiderate? è questo che può rendervi felici?" A queste parole nessuno di loro - noi lo sappiamo - dirà di no e nessuno mostrerà di volere qualcos’altro. Ciascuno pensa semplicemente che il dio ha espresso ciò che da lungo tempo senza dubbio desiderava: riunirsi e fondersi con l’altra anima. Non più due, ma un’anima sola.
 La ragione è questa, che la nostra natura originaria è come l`ho descritta. Noi formiamo un tutto: il desiderio di questo tutto e la sua ricerca ha il nome di amore. Allora, come ho detto, eravamo una persona sola; ma adesso, per la nostra colpa, il dio ci ha separati in due persone, come gli Arcadi lo sono stati dagli Spartani. Dobbiamo dunque temere, se non rispettiamo i nostri doveri verso gli dèi, di essere ancora una volta dimezzati, e costretti poi a camminare come i personaggi che si vedono raffigurati nei bassorilievi delle steli, tagliati in due lungo la linea del naso, ridotti come dadi a metà.
La ragione è questa, che la nostra natura originaria è come l`ho descritta. Noi formiamo un tutto: il desiderio di questo tutto e la sua ricerca ha il nome di amore. Allora, come ho detto, eravamo una persona sola; ma adesso, per la nostra colpa, il dio ci ha separati in due persone, come gli Arcadi lo sono stati dagli Spartani. Dobbiamo dunque temere, se non rispettiamo i nostri doveri verso gli dèi, di essere ancora una volta dimezzati, e costretti poi a camminare come i personaggi che si vedono raffigurati nei bassorilievi delle steli, tagliati in due lungo la linea del naso, ridotti come dadi a metà.
 Ecco perché dobbiamo sempre esortare gli uomini al rispetto degli dèi: non solo per fuggire quest’ultimo male, ma anche per ottenere le gioie dell’amore che ci promette EROS, nostra guida e nostro capo. A lui nessuno resista - perché chi resiste all’amore è inviso agli dèi. Se diverremo amici di questo dio, se saremo in pace con lui, allora riusciremo a incontrare e a scoprire l’anima nostra metà, cosa che adesso capita a ben pochi." (Platone, Simposio).
Ecco perché dobbiamo sempre esortare gli uomini al rispetto degli dèi: non solo per fuggire quest’ultimo male, ma anche per ottenere le gioie dell’amore che ci promette EROS, nostra guida e nostro capo. A lui nessuno resista - perché chi resiste all’amore è inviso agli dèi. Se diverremo amici di questo dio, se saremo in pace con lui, allora riusciremo a incontrare e a scoprire l’anima nostra metà, cosa che adesso capita a ben pochi." (Platone, Simposio).***
NEL 2022, ANCORA NEL’OFFICINA DI PLATONE: "ECCE HOMO" (NIETSCHE, 1888)! Chi parla e promette di fare di due un’anima sola, nel racconto di Aristofane, è Efesto (Vulcano), il dio dei fabbri, ed Eros, è il dio dell’amore/desiderio cieco e avido: questi colpisce con le sue frecce e l’altro costruisce le catene per rimettere insieme le due metà! "Disagio della civiltà" (S. Freud, 1929): non è meglio cambiare registro e rileggersi insieme Dante ("Divina Commedia") e Nietzsche ("Crepuscolo degli idoli")?!
FLS
-
-