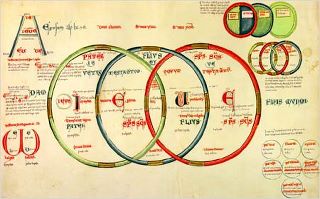
DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE ("charitas"). Per una rilettura del "De Vulgari Eloquentia" e della "Monarchia" - di Federico La Sala
- [...] Con la Monarchia***, “opera ardua e superiore” alle sue forze, pur non confidando nelle sue capacità “quanto nella luce di quel Dispensatore che dà a tutti abbondantemente e non lo rinfaccia mai” e tuttavia includendosi tra gli uomini “che la natura superiore ha reso inclini all’amore della verità”, Dante vuole consegnare al futuro - ai “posteri, perché la posterità possa servirsi del frutto” delle sue fatiche (I, i) - il suo ideale e il suo testamento teologico-politico. Con esso, convinto che “la conoscenza della Monarchia Universale [temporalis Monarchie] è particolarmente utile, ma pochissimo nota e da nessuno ricercata perché non offre un guadagno immediato”(l, i), due contributi decisivi e fondamentali vuole offrire [...]
- "Declino del simbolismo. [...] Ecco un esempio: per indicare il rapporto fra l’autorità spirituale e quella temporale il Medioevo si serviva costantemente di due similitudini simboliche[...] La forza del simbolo è tale da intralciare l’indagine sullo sviluppo storico dei due poteri. Dante, avendo riconosciuto la necessità e il valore decisivo di tale indagine, si vede costretto, nel suo Monarchia, a spezzare prima la forza del simbolo, contestando la sua applicabilità, ed aprendosi così la strada alla ricerca storica" (Johan Huizinga, "L’autunno del Medio Evo" [1919, 1921, 1928]. Introduzione di Eugenio Garin, Sansoni Editore, Firenze 1940 (prima edizione italiana).
Pace, giustizia, e libertà nell’aiuola dei mortali
DANTE. ALLE ORIGINI DEL MODERNO*
di Federico La Sala
I
- Ogni età è moderna per quanti la vivono. Nel caso del Medio Evo, la sua modernità doveva essere denunciata dagli Umanisti come decadenza; ma per gli uomini che l’hanno vissuta, in special modo per gli uomini del XIII e XIV secolo, quest’età fu sentita come un’età di innovazione in tutti i campi della cultura, una modernità in progresso. Ètienne Gilson
- L’uomo si sforza ancora di riacquistare quei doni di cui la sua colpa l’ha privato, e come ha reagito alla prima maledizione universale con l’invenzione di tutte le arti, alla seconda maledizione universale, che fu la confusione delle lingue, ha cercato di opporsi con l’arte della grammatica. Francesco Bacone
Verso l’Eden. - Tra il 1304 e il 1308 Dante scrive, più o meno contemporaneamente al Convivio, il De vulgari eloquentia**: lo scopo di quest’opera, come dell’altra, entrambe lasciate incompiute, è pur nella differenza lo stesso, pedagogico e “illuministico”. Quello del Convivio - la prima opera in volgare in Italia in cui sotto forma di commento a canzoni “sì d’amore che di virtù materiate” si affrontano complessi problemi dottrinali (configurazione dei cieli, scienze del trivio e del quadrivio, nobiltà, Impero) - è imbandire un banchetto di sapienza per tutti coloro che non conoscono il latino (“volgari e non letterati”) e che non possono saziare l’umano desiderio di sapere perché impediti o dalla “cura familiare e civile” o dal vivere in un luogo “da ogni Studio non solamente privato, ma da gente studiosa lontano”. Quello del De vulgari eloquentia è “illuminare in qualche modo il discernimento di coloro che vagano come ciechi per le piazze” e “giovare alla lingua della gente illetterata” (I, i, l).
Proposito primo di tale opera, essendo scritta in latino e destinata pertanto ai “letterati” (a quelli che conoscono il latino), è, però, “insegnare la teoria dell’eloquenza volgare” (I, xix, 2). Cosa che per Dante significa non solo indicare la via e il modo per elaborare “da tanti vocaboli rozzi che usano gli Italiani, da tante costruzioni intricate, da tante desinenze erronee, da tanti accenti campagnoli” quel volgare italiano che è “cosi nobile, cosi limpido cosi perfetto e cosi urbano come mostrano”, (I, xvii, 3) Cino da Pistoia e il suo amico (Dante stesso), ma anche e soprattutto “chi riteniamo degno di usarlo, e per quali materie, e, come, nonché dove, e quando, e a chi vada rivolto” (I, xix, 2). Cioè, semplicemente, la trattazione dell’eloquenza volgare vuol essere al contempo una trattazione dell’intellettuale volgare.
Col De vulgari eloquentia ai “letterati” italiani (in particolare a quelli che sono o vogliono essere “versificatori in volgare”, perché - nonostante “il volgare illustre italiano può legittimamente manifestarsi sia in prosa che in versi” - “il volgare che è stato organizzato in poesia sembra rimanere come modello ai prosatori, e non viceversa») Dante vuole indicare decisamente quale spazio si è aperto, e, quali prospettive e quali compiti si vengono a porre nella realtà del tempo; e, ancora, come tutto questo ruoti intorno al nodo dell’eloquenza volgare. Ciò che egli propone, di fronte alle vaste ed eccezionali trasformazioni della realtà contemporanea, - si tenga presente che tra il secolo XI e il XIII “nell’Occidente cristiano avviene una rivoluzione economica e sociale, di cui lo sviluppo urbano è il sintomo più lampante, e la divisione del lavoro l’aspetto più importante”, che “nuovi mestieri nascono e si sviluppano, nuove categorie professionali appaiono o prendono corpo, gruppi socio-professionali nuovi, forti del loro numero, del loro ruolo, reclamano e conquistano una stima, ossia un prestigio adeguati alla loro forza” (1); e, che, ad es., la popolazione di Firenze, “di appena 6000 abitanti nella prima metà del secolo XII, saliva nel 1300 a molto di più di 30.000, e, pochi decenni dopo, a quasi 100.000”(2), - non è una prospettiva né un compito affatto semplice: cambiare registro linguistico e forgiarne uno nuovo e più degno.
Abbandonare il latino (“usato sole”) che ormai dà “lo suo beneficio a pochi” e mettersi al lavoro dentro quel processo già in atto di formazione della lingua più decorosa d’Italia, la lingua illustre - la lingua che sarà, scrive Dante nel Convivio, “luce nuova, sole nuovo, lo quale surgerà là dove l’usato tramonterà e darà lume a coloro che sono in tenebre e in oscuritate” - comporta tanto impegno quanto una radicale trasformazione della figura del dotto, richiede innanzi tutto uomini capaci di essere all’altezza della situazione, di schierarsi a fianco di quanto sta emergendo nella realtà politica e sociale italiana: “ognuno - scrive Dante - affronti con cautela e discernimento ciò di cui parliamo [...] è qui che sta l’impresa e la fatica, perché non è cosa che possa darsi senza vigore d’ingegno e assidua frequentazione della tecnica e possesso della cultura [...]. E allora resti dimostrata e svergognata la stoltezza di coloro che, privi di capacità tecnica e di cultura, fidando nel solo ingegno, si precipitano sui sommi temi che vanno cantati in forma somma; e la smettano con una simile presuntuosità e, se la natura o la fannullaggine li ha fatti oche, non pretendano di imitare l’aquila che si slancia verso gli astri” (Il, iv, 9-11).
Nel momento storico in cui viene a sgretolarsi la realtà economica e sociale del mondo feudale e si va invece consolidando fortemente la realtà delle città, e lo stesso volgare si sta evolvendo in modo vertiginoso, Dante giunge a percepire in tutta la sua importanza quel processo che sta portando gli individui a essere sempre più dominati da astrazioni e sempre più bisognosi (“quest’arte dell’eloquenza volgare è necessaria a tutti - tant’è vero che ad essa tendono non solo gli uomini, ma anche le donne e i bambini, per quanto lo consente la natura”) della lingua di secondo grado (“definiamo lingua volgare quella che riceviamo imitando la nutrice, senza bisogno di alcuna regola. Abbiamo poi un’altra lingua di secondo grado, che i Romani chiamarono grammatica. Questa lingua seconda la possiedono pure i Greci e altri popoli, non tutti però”), - cioè di un volgare regulato, - e sollecita i dotti a farsi carico di tale problema, perché, se è vero che l’arte dell’eloquenza “è necessaria a tutti”, è altrettanto vero che “sono pochi quelli che pervengono al suo pieno possesso, poiché non si riesce a farne nostre le regole se non in tempi lunghi e con uno studio assiduo” (I, i). E, in questo, li sollecita a muoversi nella direzione sua e di Cino da Pistoia, perché essi hanno conseguito ottimi risultati nello sforzo di elaborazione della lingua regulata, e li hanno conseguiti proprio perché nel loro fare poetico “mostrano di appoggiarsi maggiormente alla grammatica che è comune a tutti” (I, x, 2), vale a dire a quella “ben determinata forma di linguaggio” che “in una con la prima anima fu creata da Dio” (I, vi, 4) e che fu propria a tutti gli uomini fino alla costruzione della torre di Babele (3).
Le ragioni del programma e della proposta politico-culturale esposte nel De vulgari eloquentia sono da ritrovare nella scoperta che Dante fa nella realtà storico sociale del tempo - e per di più nel giardino dell’Impero, in Italia - di una tensione ontologica verso l’Universale, e nella consapevolezza che egli mostra della necessità di collocarsi in questo spazio se si vuole cogliere quella tensione stessa e regolarla. Infatti l’ipotesi-guida nella ricerca dell’oggetto, della lingua illustre tra i vari volgari, e, insieme, nell’opera “di sradicamento o di estirpazione che dir si voglia” di “cespuglia aggrovigliati e rovi” per la selva italica (I, xi, 2) è il punto di vista logico e politico dell’Universalità o, come egli la chiama, della curialità: “la curialità non è altro che una norma ben soppesata delle azioni da compiere; e siccome la bilancia capace di soppesare in questo modo si trova d’abitudine solo nelle curie più eccelse, ne viene che tutto quanto nelle nostre azioni è soppesato con esattezza viene chiamato curiale» (I, xviii, 4). Ed è questo punto di vista che, sollecitando - una volta che dall’indagine spedita e “spietata” delle principali varietà di volgari non si è salvato alcuno, né regionale né municipale alla destra come alla sinistra del “giogo dell’Appennino”; chi si è salvato sono solo alcuni poeti “che si sono espressi in modo raffinato, trascegliendo nelle loro canzoni, i vocaboli più degni della curia” (I, xii, 8), che si sono sforzati “di distaccarsi dal volgare materno e di tendere a quello curiale” (I, xiv, 7) - a proseguire la ricerca con strumenti più adeguati, diviene l’oggetto da cui partire, il punto di partenza stesso: “Dopo che abbiamo cacciato per monti boscosi e pascoli d’Italia e non abbiamo trovato la pantera che bracchiamo, per poterla scovare proseguiamo la ricerca con mezzi più razionali, sicché, applicandoci con impegno, possiamo irretire totalmente coi nostri lacci la creatura che fa sentire il suo profumo ovunque e non si manifesta in nessun luogo” (I, xvi, 1).
Per catturare finalmente la pantera (la lingua illustre) “che fa sentire il suo profumo ovunque e non si manifesta in nessun luogo” sono necessari, dunque, mezzi più razionali. Tra questi lo strumento più idoneo è il principio che “in ogni genere di cose ce ne deve essere una in base alla quale paragoniamo e soppesiamo tutte le altre che appartengono a quel genere, e ne ricaviamo l’unità di misura”, o, detto altrimenti, potendosi tale principio applicare “a qualsiasi predicamento, anche alla sostanza”, “ogni cosa insomma è misurabile, in quanto fa parte di un genere, in base a ciò che vi è di più semplice in quel dato genere”. “Perciò nelle nostre azioni, nella misura in cui si dividono in specie, occorre trovare - prosegue Dante - l’elemento specifico sul quale anch’esse vengono misurate”. E dopo aver declinato tale principio - «in quanto operiamo in assoluto come uomini, c’è la virtù (intendendola in senso generale), secondo la quale infatti giudichiamo un uomo buono o cattivo; in quanto operiamo come uomini di una città, c’è la legge, secondo la quale un cittadino è definito buono o cattivo; in quanto operiamo come uomini dell’Italia, ci sono alcuni semplicissimi tratti, di abitudini e di modi di vestire e di lingua, che permettono di soppesar e misurare le azioni degli Italiani. Ma le operazioni più nobili fra quante ne compiono gli Italiani non sono specifiche di nessuna città d’Italia, bensì comune a tutte; e fra queste si può a questo punto individuare quel volgare di cui sopra andavamo in caccia, che fa sentire il suo profumo in ogni città, ma non ha la sua dimora in alcuna. E tuttavia può spargere il suo profumo più in una città che in un’altra, come la sostanza semplicissima, Dio, dà sentore di sé più nell’uomo che nella bestia, più nell’animale che nella pianta, più in questa che nel minerale...” - così conclude: “Ecco dunque che abbiamo raggiunto ciò che cercavamo: definiamo in Italia volgare illustre, cardinale, regale e curiale quello che è di ogni città italiana e non sembra appartenere a nessuna, e in base al quale tutti i volgari municipali degli Italiani vengono misurati e soppesati e comparati” (I, xvi, 2-6).
In un’epoca in cui profonde trasformazioni hanno dato luogo a nuove realtà sociali e molteplici spinte sollecitano a ristrutturare le vecchie forme di potere, Dante mostra di essere bene attento a quel movimento che agli albori aveva già fatto dire a Eraclito che “è necessario che coloro che parlano adoperando la mente si basino su ciò che è comune a tutti, come la città sulla legge, ed in modo ancora più saldo. Tutte le leggi umane infatti traggono alimento dall’unica legge divina: giacché essa domina tanto quanto vuole e basta per tutte le cose e ne avanza per di più” (4), e che nel futuro invece porterà Hegel ad affermare - in riferimento a quell’evento cruciale che fu la Rivoluzione Francese, per esser divenuta la società borghese Soggetto politico - che “all’improvviso, il pensiero, il concetto del diritto, si fece valere e il vecchio edifico di iniquità non gli poté resistere. Allora, nel pensiero del Diritto, si costruì una costituzione, mentre ormai tutto doveva poggiare su questa base. Da quando il sole ruota nel firmamento, e i pianeti intorno a lui, non si era mai visto l’uomo mettersi con la testa in basso, cioè fondarsi sull’Idea e costruire la realtà partendo da essa [...]. Questa dunque è un’alba stupenda. Tutti gli esseri hanno celebrato questo tempo. Allora regnava una sublime emozione, l’entusiasmo dello spirito ha fatto fremere il mondo, come se, solo allora, si fosse arrivati alla vera conciliazione del divino col mondo”(5). E altrettanto mostra che la cattura della lingua - pantera - nel momento stesso in cui in Italia dai vari volgari sta emergendo il volgare curiale - e questo sta emergendo come un al di là degli stessi volgari - è possibile solo partendo dall’ Universale, cioè involandosi nella regione nebulosa del mondo religioso ed eguagliando il rapporto tra Volgare e volgari con il rapporto Dio e mondo.
L’orizzonte ideologico entro cui Dante si muove (6) rende nel contempo forte, perché gli permette di intuire e cogliere il legame che corre tra processi sociologici e politici e religione, e, debole, perché gli impedisce di cogliere quale realtà sollecita a tale connessione. Egli comprende misticamente che il vincolo sociale come il vincolo linguistico tra gli uomini va ponendosi e sviluppando come oltremondano, cioè che il vincolo stesso - l’unità linguistica e sociale - va acquistando un’esistenza propria e indipendente, e che bisogna collocarsi decisamente su questo piano, il piano dell’Universale; e ne trae tutte le conseguenze, coerentemente.
Il suo punto di vista, non a caso, gli consente di elaborare un modello di lingua e di intellettuale di grande densità ideologica e politica. Gli attributi (illustre, cardinale, regale e curiale) della lingua più decorosa d’Italia, infatti, non dicono solo l’intrinseca qualità della lingua illustre, ma delineano anche i tratti della figura del nuovo dotto: “quando usiamo il termine illustre, intendiamo qualcosa che diffonde luce e che, investito dalla luce, risplende su tutto: ed è a questa stregua che chiamiamo certi uomini illustri, o perché illuminati dal potere diffondono sugli altri una luce di giustizia e carità, o perché depositari di un alto magistero, sanno altamente ammaestrare [...] Ora il volgare di cui stiamo parlando è investito da un magistero e da un potere che lo sollevano in alto, e solleva in alto i suoi con l’onore e la gloria [...] Forse che chi è al suo servizio non supera in fama qualunque re, marchese, conte e potente? E quanto renda ricchi di gloria i suoi servitori, noi stessi lo sappiamo bene, noi che per la dolcezza di questa gloria ci buttiamo dietro le spalle l’esilio [...]. E non è senza ragione che fregiamo questo volgare illustre del secondo attributo, per cui ciò,è si chiama cardinale. Come infatti la porta intera va dietro il cardine, in modo da volgersi anch’essa nel senso in cui il cardine si volge [...] così l’intero gregge dei volgari municipali si volge e rivolge, si muove e si arresta secondo gli ordini di questo, che si mostra un vero e proprio capofamiglia. Non strappa egli ogni giorno i cespugli spinosi dalla selva italica? Non innesta ogni giorno germogli e trapianta pianticelle? A che altro sono intenti i suoi giardinieri se non a togliere e a inserire, come si è detto? [...]. Quanto poi al nome di regale che gli attribuiamo, il motivo è questo, che se noi Italiani avessimo una reggia, esso prenderebbe posto in quel palazzo. Perché se la reggia è la casa comune di tutto il regno, l’augusta reggitrice di tutte le sue parti, qualunque cosa è tale da esser comune a tutti senza appartenere in proprio a nessuno, deve abitare necessariamente nella reggia e praticarla, e non vi è altra dimora degna di un cosi nobile inquilino [...]. Infine quel volgare va definito a buon diritto curiale [...] poiché è stato soppesato nella curia più eccelsa degli italiani [...]. Ma dire che è stato soppesato nella più eccelsa curia degli italiani sembra una burla, dato che siamo privi di una curia. Ma è facile rispondere. Perché se è vero che in Italia non esiste una curia, nell’accezione di curia unificata - come quella del re di Germania - tuttavia non fanno difetto le membra che la costituiscono; e come le membra di quella curia traggono la loro unità dalla persona unica del Principe, cosi le membra di questa sono state unite dalla luce di grazia della ragione. Perciò sarebbe falso sostenere che gli italiani mancano di curia, anche se manchiamo di un Principe, perché in realtà una curia la possediamo, anche se fisicamente dispersa» (I, xvii-xviii).
La proposta di Dante non vuole essere affatto né semplicemente poetica né politicamente ambigua. Con la sua opera egli vuole indicare non solo come sia possibile superare la natura “saussuriana” del segno linguistico - “fenomeno sensibile in quanto è suono; fenomeno razionale in quanto ciò che significa, lo significa evidentemente a nostro arbitrio” (I, iii, 3) - e quale lavoro occorra per elaborare una lingua naturale-universale, ma anche e soprattutto come e quanto profondamente siano legati tra di loro nuova lingua e nuovo dotto, e, a quale grande funzione sono entrambi chiamati: “Questo volgare esige in verità persone che gli assomigliano, come avviene per tutti gli altri nostri atteggiamenti morali e modi di vestire: cosi la magnificenza esige persone capaci di grandi azioni, la porpora individui nobili; e allo stesso modo anche il volgare in questione cerca coloro che eccellono per ingegno e cultura, e disprezza tutti gli altri [...]. E dato che la lingua è lo strumento necessario di ciò che concepiamo non altrimenti che il cavallo lo è per il cavaliere, e ai migliori cavalieri convengono i migliori cavalli, come si è detto, alle concezioni più alte converrà la lingua migliore” (II, i, 5-8).
A ben vedere, la genialità di Dante non è inferiore a quella di Platone. Egli giunge a riscoprire quello stesso processo che in un’analoga congiuntura economica e sociale aveva indotto Platone ad attribuire ai filosofi - “poiché filosofi sono coloro che riescono ad arrivare a ciò che sempre permane invariabilmente costante, mentre coloro che non ci riescono, ma si perdono nella molteplicità del variabile non sono filosofi” - la funzione direttiva dello Stato (La Repubblica, VI, 484a). Cosi come è la filosofia, o, meglio, l’amore per la Sapienza (“Beatrice, loda di Dio vera, ché non soccorri quel che t’amò tanto / che uscì per te de la volgare schiera?” -Inf. II, 103-5) ad aprirgli la strada alla contemplazione de ”la gloria di colui che tutto move” - quella gloria che “per l’Universo penetra, e risplende / in una parte piu e meno altrove” (Par., I, 1-4) - e a fargli conseguire quell’alto magistero e quel potere che lo innalzano a guida e a giudice del suo tempo.
Fatto da vivo l’itinerarium in Deum e raggiunta “la felicità della vita eterna, la quale consiste nel godimento della visione di Dio (alla quale l’uomo non può elevarsi da sé senza il soccorso della luce divina) ed è raffigurata nel paradiso celeste”, egli è degno di indicare “la diritta via” per raggiungere “la felicità di questa vita” che è “raffigurata nel paradiso terrestre” (Monarchia, IlI, xv). Il De vulgari eloquentia, benché sia di poco precedente alla stesura della Commedia, s’iscrive entro questo orizzonte: vuoI essere un programma politico e culturale per la riconquista del Regno, non solo d’Italia - per l’instaurazione della monarchia temporale o, che è lo stesso, dell’Impero. La lingua d’Amore della Vita Nuova (XXIV, 3), divenuta lingua di Salvezza Amore e Virtù (Salus Venus e Virtus), nel De vulgari eloquentia vuol essere infatti - proprio perché ha reso possibile il recupero di quella “ben determinata forma di linguaggio” creata da Dio, di cui “farebbero uso tutti i parlanti nella loro lingua, se essa non fosse stata smembrata per colpa dell’umana presunzione” (I, vi, 4) - la restaurata lingua prebabelica (7).
L’orizzonte ideologico del tempo non può far vedere (né tanto meno nominare) a Dante come alle forze sociali emergenti il nuovo per cui essi lottano. Nel momento in cui la società borghese comincia a prendere coscienza di sé e lotta per i propri obiettivi, non può farlo se non con gli strumenti a disposizione, come attesta questo documento del 1257:
Quest’ atto ricorda la manomissione effettuata dal comune di Bologna di servi e serve della gleba: lo si deve chiamare giustamente Paradiso.
Dio onnipotente piantò un piacevole Paradiso (giardino) e vi pose l’uomo, il cui corpo ornò di candida veste donandogli una libertà perfettissima ed eterna. Ma l’ uomo, misero, immemore della sua dignità e del dono divino, gustò del frutto proibito contro il comando del Signore. Con questo atto tirò se stesso e i suoi posteri in questa valle di lagrime e avvelenò il genere umano legandolo con le catene della schiavitù al Diavolo; cosi l’ uomo da incorruttibile divenne corruttibile, da immortale mortale, sottoposto a una gravissima schiavitù. Dio vedendo tutto il mondo perito (nella schiavitù) ebbe pietà e mandò il Figlio suo unigenito nato, per opera dello Spirito Santo, dalla Vergine madre affinché con la gloria della Sua dignità celeste rompesse i legami della nostra schiavitù e ci restituisse alla pristina libertà. Assai utilmente agisce perciò chi restituisce col beneficio della manomissione alla libertà nella quale sono nati, gli uomini che la natura crea liberi e il diritto delle genti sottopone al giogo della schiavitù.
Considerato ciò, la nobile città di Bologna, che ha sempre combattuto per la libertà, memore del passato e provvida del futuro, in onore del Redentore Gesù Cristo ha liberato pagando in danaro, tutti quelli che ha ritrovato nella città e diocesi di Bologna astretti a condizione servile; li ha dichiarati liberi e ha stabilito che d’ora in poi nessuno schiavo osi abitar nel territorio di Bologna affinché non si corrompa con qualche fermento di schiavitù una massa di uomini naturalmente liberi.
Al tempo di Bonaccorso di Soresina, podestà di Bologna, del giudice ed assessore Giacomo Grattacello, fu scritto quest’ atto, che deve essere detto Paradiso, che contiene i nomi dei servi e delle serve perché si sappia quali di essi hanno riacquistato la libertà e a qual prezzo: dodici libbre per i maggiori di tredici anni, e per le serve: otto libbre bolognesi per i minori di anni tredici [...] (8).
Alla luce di questo atto di manomissione (9) molte cose si fanno più chiare. Il progetto di una restaurata lingua prebabelica, la collocazione del simbolo dell’Impero nel paradiso terrestre, la connessa profezia di Beatrice sul rapporto Chiesa e Impero (“Non sarà tutto tempo sanza reda / l’aguglia che lasciò le penne al carro, / per che divenne mostro e poscia preda; / ch’ io veggio certamente, e però il narro, / a dame tempo già stelle propinque, / secure d’ogni intoppo e d’ ogni sbarro, / nel quale un cinquecento dieci e cinque, / messo di Dio, anciderà la fuia / con quel gigante che con lei delinque” - Purg. XXXIII, 37-45), cosi come l’accostamento di fede-moneta che San Pietro fa nell’esaminare Dante - ”indi soggiunse: Assai bene è trascorsa / d’ esta moneta già la lega e il peso; / ma dimmi se tu l’hai ne la tua borsa. / Ond’io: sì, l’ho, sì lucida e sì tonda / che nel suo conio nulla mi s’inforsa» (Par., XXIV, 83-7) - appaiono meno metaforici e simbolici di quanto sembrino. Esprimono la connessione tra orizzonte ideologico e processi socio-politici propri del tempo, e insieme indicano la profonda complementarità che si va instaurando tra nascente capitalismo e Cristianesimo, tra processi economico-politici e religione. Dante come le nuove forze sociali del tempo lottano si per la riconquista del paradiso terrestre, ma lottano soprattutto - non sanno di farlo, ma lo fanno - per il paradiso politico della società borghese, di cui essi sono già espressione.
In un’epoca in cui la Chiesa ha ancora un enorme potere politico e ideologico (specie in Italia), in un’epoca in cui le città affrancano “pagando in danaro” i servi della gleba (10) dai loro padroni e si pongono esse stesse come paradiso, Dante - pur tra le molteplici mediazioni della sua coscienza - coglie tutta la portata del nuovo e si colloca decisamente su tale terreno: in ciò sono la sua forza, il suo genio e il suo dramma.
Chi per primo si scoprì e si pose come persona dell’Universale - mostrandosi profeta di quel processo che porterà Hegel a concepire “l’elevatissimo concetto appartenente all’età moderna e alla sua religione”, l’Assoluto come Spirito (11) - non poteva non avere altra sorte che quella di andare “peregrino, quasi mendicando”, per l’Italia, a mostrare contro sua voglia “la piaga della fortuna, che suole ingiustamente al piagato essere imputata” (Convivio).
Lo stesso De vulgari eloquentia non doveva avere migliore sorte: smarrito, e recuperato agli inizi del ‘500, fu continuamente frainteso fino a Manzoni. Del resto il tortuoso e intricato percorso socio-politico che la realtà italiana doveva fare per giungere al suo paradiso politico non permise altrimenti. Ancora nel 1816 nella Lettera semiseria di Crisostomo, Giovanni Berchet, riecheggiando (e a destra, per cosi dire) Dante, scriveva: “E se noi non possediamo una comune patria politica [...] chi ci vieta di crearci intanto, a conforto delle umane sciagure, una patria letteraria comune?”.
Solo Gramsci intuirà che “il De Vulgari Eloquio di Dante sia da considerare come essenzialmente un atto di politica culturale-nazionale (nel senso che nazionale aveva in quel tempo e in Dante), come un aspetto della lotta politica è stata sempre quella che viene chiamata ‘la quistione della lingua’” (12). E non a caso, la sua ottica ancora e in parte democratico-borghese lo induce a concepire i propri problemi all’interno del paradigma elaborato da Dante e al fondo di tutta la cultura moderna. Come non a caso - nel momento stesso che la configurazione imperniata su Dio (Universale), Intellettuale, Lingua e Politica, è andata disarticolandosi ed è stata messa in crisi - è possibile rendersi conto oggi di quanto moderna fosse la ‘visione’ di Dante.
II
- Con tutti i suoi limiti, il De Monarchia appartiene allo stesso genere letterario della Politica, del Leviatano e del Contratto Sociale. W. H. V. Reade
- L’ aspirazione rivoluzionaria a realizzare il regno di Dio è il punto elastico della cultura progressiva e il principio della storia moderna. Friedrich Schlegel
Un paradigma per i posteri. - Con la Monarchia***, “opera ardua e superiore” alle sue forze, pur non confidando nelle sue capacità “quanto nella luce di quel Dispensatore che dà a tutti abbondantemente e non lo rinfaccia mai” e tuttavia includendosi tra gli uomini “che la natura superiore ha reso inclini all’amore della verità”, Dante vuole consegnare al futuro - ai “posteri, perché la posterità possa servirsi del frutto” delle sue fatiche (I, i) - il suo ideale e il suo testamento teologico-politico. Con esso, convinto che “la conoscenza della Monarchia Universale [temporalis Monarchie] è particolarmente utile, ma pochissimo nota e da nessuno ricercata perché non offre un guadagno immediato”(l, i), due contributi decisivi e fondamentali vuole offrire: sottrarre all’oscurità e alla confusione il problema appunto della monarchia e nel contempo-sempre“sorretto dal braccio di Colui che ci liberò col suo sangue dal potere delle tenebre” - scacciare “dal campo, in faccia al mondo, l’empio e il bugiardo” (III, i), in particolare (“essenzialmente tre categorie di persone ”si accaniscono contro la verità “a cui vogliamo arrivare”) il sommo Pontefice (è la prima delle tre, le altre due sono quelli “la cui ostinata cupidigia ha spento il lume della ragione” - cioè quelli che strumentalmente e per i loro guadagni sostengono le tesi ierocratiche - e i decretalisti, cioè quelli che si basano “caparbiamente” solo sugli atti della Curia pontificia, le Decretali appunto) che si «oppone forse per zelo delle chiavi» (III, iii).
Con audacia straordinaria, l’audacia di un laico che ha fatto grazie al suo amore per la Sapienza (Beatrice) l’itinerarium in Deum, e, dall’interno della Chiesa, Dante specie nel III libro impugna e mette in radicale discussione i capisaldi di quella dottrina ierocratica che da Bonifacio VIII era stata formulata nel modo più esplicito e tracotante, che nella “Chiesa e nel suo potere ci sono due spade, una spirituale, cioè, ed una temporale”; che “ambedue sono in potere della Chiesa, la spada spirituale e quella materiale” e che “una invero deve essere impugnata per la Chiesa, l’altra dalla Chiesa; la seconda dal clero, la prima dalla mano di re o cavalieri, ma secondo il comando e la condiscendenza del clero, perché è necessario che una spada dipenda dall’altra e che l’autorità temporale sia soggetta a quella spirituale”; e, infine, di enorme rilevanza, che, “se erra il supremo potere spirituale, questo potrà essere giudicato solamente da Dio e non dagli uomini” e che “chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio si oppone ai comandi di Dio, a meno che non pretenda, come Manichei, che ci sono due principii”(13).
Contro ogni pretesa ierocratica (senza essere per questo partigiano dell’imperatore) come contro le pretese ghibelline e realistiche, e contro la secolare concezione che voleva in contraddizione la vita terrena e la vita celeste, Dante lotta strenuamente e da cristiano (senza essere per questo partigiano del papa) per rivendicare e fondare “in un difficile ed arduo equilibrio, il nuovo senso dell’autonomia mondana dell’ordine politico e la fedeltà ad una visione assolutamente spirituale e religiosa della storia umana consegnata ai due ‘ideali’ dell’unico Impero e dell’unica Chiesa» (14).
Troppo spesso, dimenticando tutto questo, e, portando all’assoluto particolari estratti da vari contesti, si è finito con l’appiattire la posizione di Dante nell’orbita del mondo medievale - a quella di un uomo nostalgico del passato e reazionario o a un ghibellino tout court - annullandone cosi la specificità (guelfo bianco), che è quella di muoversi con grande lucidità e per equilibrio instabile dentro il suo orizzonte logico-storico, verso il moderno.
Il suo progetto politico (da non dimenticare, teologico), senza far violenza, anzi schierandosi a fianco, al nuovo emergente ed emerso nella realtà sociale - nella profonda convinzione morale (ma con forte valenza ontologica) e religiosa che “l’esser uno è la radice dell’esser buono, mentre la molteplicità è invece la radice dell’esser male”, che «peccare non è altro che disprezzare l’uno per tendere al molteplice»(I, xv) - è quello di ripristinare e salvaguardare il nesso onto-teo-logico tra particolare e Universale, e di conservare tale nesso nel suo fondamento, Dio stesso.
Nel momento in cui in Europa nascono e si affermano unità cittadine e nazionali autonome, sovrane nel loro territorio, Dante non prospetta affatto una restaurazione pura e semplice dell’Impero. La sua posizione, teologica e razionale insieme, è molto più articolata e complessa. Egli nel porre con grande e vera originalità il fondamento della società umana nel diritto e nel postulare l’identità di questo con la volontà divina ((“siccome in Dio la volontà e la cosa voluta si identificano, ne consegue ulteriormente che la volontà divina è lo stesso diritto, e ancora, che, nel mondo, il diritto non è altro che un’immagine della volontà divina”, II, ii), con l’idea di monarchia temporale vuole ripristinare, salvare e custodire proprio l’unità onto-teo-logica tra Universale e particolare, senza sopprimerne la differenza ma difendendola.
Per Dante, infatti, le nazioni, i regni e le città, avendo caratteristiche proprie, “devono essere regolate da leggi diverse” (I, xiv), ma, affinché non restino nel loro isolamento e possano realizzare le aspirazioni universali, quelle comuni a tutto il genere umano, devono essere rette e guidate da uno solo, dal Monarca “secondo una regola universale” (I, xiv) alla pace, alla libertà e alla giustizia.
Nel coniugare aristotelismo e teologia, ciò che anima Dante - quest’uomo che dice di sé: “sono quel che sono non grazie alle ricchezze, ma per grazia di Dio e ‘lo zelo della sua casa mi divora’” (Epistola XI) - è una tensione inaudita: all’interno dell’orizzonte cristiano e di una realtà piena di lacerazioni e contrasti enormi, con la sua idea di Monarchia vuol indicare il modo per porre e mantenere le innumerevoli molteplicità, che sempre più nascono e premono nel tessuto sociale dell’Europa del ’300, sulla diritta via. Riconquistare il paradiso terrestre è l’obiettivo che egli pone - in sintonia con le più avanzate forze sociali economiche e politiche contemporanee - all’umanità del suo tempo. È in questo obiettivo che la teoria dei due poteri trova la sua necessità e la sua funzione, storico-politica e salvifica insieme; “se l’uomo fosse rimasto nello stato di innocenza in cui fu creato da Dio”, di questi due poteri (papa e imperatore) l’umanità non “avrebbe avuto bisogno; questi poteri sono dunque rimedi contro l’infermità ! derivata dal peccato» (III, iv).
Con lucidità e coerenza egli sviluppa la sua argomentazione. Premesso che “la Monarchia temporale, detta anche ‘Impero’, è fra le istituzioni che si trovano in una prospettiva temporale, l’unico principato - superiore a tutti gli altri principati nel tempo” e, prima di affrontarne i tre nodi ritenuti cruciali - “se l’istituzione sia necessaria al benessere del mondo”; “se il popolo romano si sia assunto a buon diritto la funzione di Monarca”; “se l’autorità del monarca dipenda direttamente da Dio o da qualcun altro vicario o ministro di Dio” (I, ii) - definisce ambito, finalità e modi della ricerca:
 a) “l’argomento in esame è di carattere politico, ed anzi riguarda la fonte e il principio di ogni retto ordinamento politico”;
a) “l’argomento in esame è di carattere politico, ed anzi riguarda la fonte e il principio di ogni retto ordinamento politico”;
 b) la politica, al contrario delle realtà “matematiche, fisiche e divine” che non sono in nostro potere e che “possono essere per noi soltanto oggetto di speculazione e non di attività pratica”, dipende da noi e, come tale, “risponde a finalità innanzitutto pratiche” (e interne allo stesso ambito della ricerca);
b) la politica, al contrario delle realtà “matematiche, fisiche e divine” che non sono in nostro potere e che “possono essere per noi soltanto oggetto di speculazione e non di attività pratica”, dipende da noi e, come tale, “risponde a finalità innanzitutto pratiche” (e interne allo stesso ambito della ricerca);
 c) “la presente trattazione è sostanzialmente una ricerca sillogistica”, cioè impostata in modo ipotetico deduttivo (“è necessario, in ogni ricerca sillogistica, aver preliminare cognizione di un principio a cui poter ricorrere deduttivamente a sostegno di tutte le proposizioni successive”).
c) “la presente trattazione è sostanzialmente una ricerca sillogistica”, cioè impostata in modo ipotetico deduttivo (“è necessario, in ogni ricerca sillogistica, aver preliminare cognizione di un principio a cui poter ricorrere deduttivamente a sostegno di tutte le proposizioni successive”).
E chiarita questa mobile e circolare connessione metodologica - “dato che nella pratica principio e causa di ogni azione è il fine ultimo che spinge l’agente ad operare, ne viene di conseguenza che il motivo di tutte le azioni che convergono al raggiungimento di un fine, sia rintracciato dallo stesso fine [...]. Perciò, se vi è qualcosa che costituisce il fine dell’universale consorzio umano, questo sarà il principio su cui tutte le nostre successive argomentazioni fonderanno la propria validità” (I, ii) - si muove a determinare il “principio direttivo” della ricerca.
Per Dante, sulla scorta del commento di Averroè al De Anima di Aristotele, la potenza specifica dell’intera umanità è “l’essere capace di apprendere per mezzo dell’intelletto possibile, capacità che invero non compete a nessun altro che all’uomo, né al di sopra né al di sotto di lui” (I, ii): e il singolo non può attuare la sua potenza specifica se non e solo insieme con tutto il genere umano (“altrimenti bisognerebbe ammettere una potenza separata, il che è impossibile”).
Per questo il fine (“quel fine, migliore di tutti gli altri, per il quale l’eterno Dio dà l’esistenza a tutto il genere umano, servendosi della sua arte, che è la natura”) di tutta l’umana società così come “l’attività specifica del genere umano, preso nella sua totalità, consiste nell’attuare sempre tutta la potenza dell’intelletto possibile, in primo luogo nella direzione della speculazione, in secondo luogo, per estensione, nella direzione dell’attività pratica in funzione del1a speculazione” (I, iv).
Ciò che egli postula, entro il suo orizzonte teologico razionale, è una circolarità che si pone e vuole essere, in teoria e in pratica (o, meglio, in potenza e in atto), unitariamente e articolatamente onto-teo-logica: “La potenza intellettiva di cui parlo non è rivolta soltanto alle forme universali o specie, ma anche, per estensione, alle forme particolari, per cui si suol dire che l’intelletto speculativo diventa, per estensione, pratico, ed il suo fine è l’agire e il fare. E mi riferisco all’agire che è regolato dall’esperienza politica, e al fare che è regolato dall’arte: l’uno e l’altro sono strumento della speculazione, che è il fine più alto per il quale la Prima Bontà ha dato l’esistenza al genere umano” (I, iii).
Ora se “l’intento di Dio è che ogni cosa creata sia simile a Lui, nei limiti, s’intende, delle possibilità della propria natura”, è evidente che “il genere umano raggiunge la perfezione quando attua tutta la rassomiglianza con Dio, secondo la possibilità della propria natura” (I, viii). E poiché “Dio è la sola vera unità”, l’umanità perviene al grado massimo di somiglianza con Dio quando raggiunge il suo più alto grado di unità. E dal momento che “l’uomo è termine medio tra le cose corruttibili e le incorruttibili” e, quindi, “partecipa dell’una e dell’altra natura” (III, xv), risulta evidente tanto la necessità che l’uomo “sia ordinato a due fini ultimi, ad uno in quanto corruttibile, all’altro in quanto incorruttibile)) (III, xv) tanto che questi due fini come le due guide abbiano il loro fondamento in Dio.
Questa è la diritta via che Dante indica: il genere umano può attuare tutta la rassomiglianza con Dio, secondo la possibilità della propria natura, solo movendosi all’interno e a partire dall’Identità e insieme salvando e rispettando la Differenza. E questo è l’orizzonte entro cui egli stesso si muove con estrema lucidità, e che gli permette di combattere la sua battaglia con strenua intransigenza logica e morale senza essere né partigiano dell’imperatore né del papa né tanto meno un eretico:
Due fini pertanto l’ineffabile Provvidenza ha posto dinanzi all’uomo come mete da raggiungere: la felicità di questa vita, che consiste nella piena attuazione delle sue capacità, ed è raffigurata nel Paradiso terrestre; e la beatitudine della vita eterna, la quale consiste nel godimento della visione di Dio - a cui le capacità proprie dell’uomo non possono elevarsi da sé senza l’aiuto della luce divina - ed è raffigurata nel Paradiso celeste. A queste beatitudini, come a termini diversi, bisogna giungere con mezzi diversi. Infatti arriviamo alla prima per mezzo degli insegnamenti filosofici, purché li seguiamo effettivamente operando secondo le virtù morali e intellettuali; arriviamo invece alla seconda per mezzo degli ammaestramenti dello spirito, che trascendono l’umana ragione, purché li seguiamo operando secondo le virtù teologiche, cioè la fede, la speranza e la carità [et karitatem]. Queste mete, e i mezzi per raggiungerle, ci sono state indicate rispettivamente dalla ragione umana, che i filosofi ci hanno reso interamente palese, e dallo Spirito Santo, il quale, per mezzo dei profeti e degli agiografi nonché per mezzo di Gesù Cristo, figlio di Dio a Lui coetaneo e dei suoi discepoli, ci ha rivelato la verità soprannaturale a noi necessaria (III, xv).
Per questo, dato che, “quando più elementi sono ordinati ad un unico fine, è necessario che uno di essi diriga e gli altri siano diretti” (I, v) - a riguardo dello specifico ordinarsi del genere umano “bisogna sapere che il fondamento primo della nostra libertà è la libertà d’arbitrio, che molti hanno sulle labbra, ma pochi comprendono” (I, xii), e, nello stesso tempo, che la cupidigia umana “farebbe dimenticare mete e mezzi se gli uomini, come cavalli erranti in preda alla loro bestialità, non fossero raffrenati nel loro cammino terreno ‘con la briglia e il morso’” - l’uomo ha “bisogno di due guide in vista del suo duplice fine: il sommo Pontefice, che, seguendo le verità rivelate, [guidi] il genere umano alla vita eterna e l’Imperatore che, seguendo invece gli insegnamenti della filosofia, lo [indirizzi] alla felicità temporale. E siccome - prosegue Dante - a questo porto della felicità terrena, nessuno o pochi - e questi con estrema difficoltà - possono giungere se il genere umano, calmati i tempestosi allettamenti della cupidigia, non riposi libero nella tranquillità della pace, ecco che questo è la meta alla quale soprattutto deve mirare il tutore del mondo, che si chiama Principe Romano: far sì, cioè, che in questa aiuola dei mortali si viva in pace e in libertà” (III, xv).
L’Imperatore, però, per poter “applicare utilmente gli insegnamenti della libertà e della pace in modo adatto ai luoghi e ai tempi” - dato che “l’ordinamento di questo mondo è in rapporto con la rotazione dei cieli”, - è necessario che “sia ordinato da Colui che vede direttamente la totale disposizione dei Cieli”; e “questi può essere soltanto Colui che l’ha preordinata”, Dio stesso: “solo Dio elegge, solo Dio conferma”. Cioè, “l’autorità del Monarca temporale deriva, senza alcun intermediario, dalla Fonte stessa di ogni autorità”.
E, per evitare ogni ulteriore equivoco a riguardo, Dante spiega e conclude: questa soluzione non va “interpretata così alla lettera da escludere assolutamente che il Principe Romano soggiaccia in qualcosa al Sommo Pontefice, perché questa nostra felicità terrena è ordinata in certo qual modo in funzione della felicità eterna. Cesare usi dunque verso Pietro quella riverenza che il figlio primogenito deve al padre, affinché irraggiato dalla luce della grazia paterna, illumini con maggiore efficacia il mondo al quale è stato preposto da Quello che è il reggitore di tutte le cose spirituali e temporali” (III, xv).
Per Dante questa è la via: i due poteri - l’uno e l’altro indispensabile per porre rimedio all’infermità derivata dal peccato - devono cooperare in modo unitario ma distinto e in consonanza con la volontà divina, da cui deriva la loro stessa autorità; solo così essi possono contribuire a ristabilire il giusto rapporto dell’uomo con Dio e a riconquistare ciò che è stato perduto, il paradiso terrestre innanzitutto e, con esso, il paradiso celeste. Ed è questo l’orizzonte che gli permette non solo di postulare la distinzione e l’autonomia dell’agire politico dalla dimensione spirituale, ma soprattutto di restituire al presente un valore di temporalità salvifica, o, che è lo stesso, di coniugare in modo attivo e articolato - contro una tradizione negativa e (tendenzialmente) dualistica - il tempo con l’Eternità e il particolare con l’Universale.
La soluzione dantesca, anche se può apparire poco rigorosa e instabile, è tuttavia una soluzione ancora oggi “praticamente viva e operante; il che dimostra che, se Dante loico è in difetto, il politico aveva intuito felice» (15). Anzi, alla luce di quanto è emerso, si può dire che Dante è “alle soglie di un’odissea culturale altamente segnata da un Machìavelli, da un Guicciardini, da un Vico, da un Gramsci - l’avo della riflessione politica in Italia” (16).
Inoltre, il sogno di un’aiuola dei mortali dove si potesse vivere secondo giustizia in pace e in libertà era sì impraticabile e utopistico per il suo tempo, ma non per questo fu abbandonato o trascurato; dopo aver attraversato secoli ed essere stato l’asse portante dell’ideologia borghese, non ha forse attraversato e attraversa ancora il nostro presente? Non è stato ed è forse anche il nostro massimo sogno?
E, in questa prospettiva, oggi, il nostro problema più complesso - in un orizzonte segnata dalla ‘morte di Dio’ e insieme dall’esplosione di innumerabili identità - non è forse lo stesso affrontato da Dante, quello della costruibilità di un nesso tra particolare e generale? E, ancora, se per questo nodo passa la nostra stessa “possibilità di mantenere la problematica ereditata da Marx” (17), non è forse necessario tenere nel debito conto che Marx è “il solo che citi Dante come momento cardine del calendario per lui pensabile”?(18).
NOTE:
* Per non dimenticare la lezione di Dante, ripropongo qui un piccolo lavoro del 1982. Esso è stato pubblicato in Èuresis, Notizie e scritti di varia indole del Liceo classico “M.Tullio Cicerone” di Sala Consilina, Boccia editore, Salerno 1988.
I
** Per il De vulgari eloquentia è stato utilizzato il testo curato e tradotto da P.V. Mengaldo, in Dante Alighieri, Opere Minori a cura di P.V. Mengaldo, B. Nardi, A. Frugoni, G. Brugnoli, E. Cecchini, F. Mazzoni, V, 2, Milano-Napoli, Ricciardi, 1979. Dei passi citati sono stati dati in parentesi il libro, il capitolo e il capoverso.
1. J. Le Goff, Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Torino, Einaudi, 1977, p. 59.
2. G. Luzzatto, Dai servi della gleba agli albori del capitalismo, Bari, Laterza, 1966, p. 447.
3. Sui problemi connessi alla “forma di linguaggio” (forma locutionis), cfr. il prezioso contributo di M. Corti, Dante a un nuovo crocevia, Firenze, Libreria Commissionaria Sansoni, 1981, specie le pp. 46-52.
4. Eraclito: fr. 114. Cfr. I Presocratici, a cura di G. Giannantoni, Bari, Laterza, 1981, p. 219.
5. G.W.F. Hegel, Lezioni sulla Filosofia della Storia, Firenze, La Nuova Italia, 1966, IV, pp. 204-5.
6. Su questo, precisazioni importanti sono in M. Corti, op. cit., pp. 9-31.
7. A riguardo, cfr. M. Picone, Vita Nuova e tradizione romanza, Padova, Liviana editrice, 1979, specie pp. 14 ss.; e, ancora, M. Corti, op. cit., pp. 70 ss.
8. Per il testo originale, in latino, cfr. P. Vaccari, Le affrancazioni collettive dei servi della gleba, Milano, ISPI, 1939, pp. 45-7; la traduzione qui riportata è ripresa da F. Gaeta - G. Villani, Documenti e testimonianze, Milano, Principato, 1978, I, pp. 214-5.
9. Si è preferito riportare l’Atto del Comune di Bologna, sia perché è uno dei primi di questo genere (quelli di Firenze saranno di alcuni anni dopo, a partire dal 1289) sia perché estremamente esemplare dal punto di vista ideologico. Per gli Atti fiorentini di affrancazione, cfr. P. Vaccari, op. cit., pp. 58 e ss.
10. Al primo posto, in ordine di tempo, di questo processo di affrancamento dei servi della gleba sono Bologna e Firenze, ma presto e a ruota seguono Siena, Lucca, Pisa, Reggio Emilia, Parma, Perugia, Ravenna, Pistoia, Vercelli, Genova (cfr. P. Vaccari, op. cit., pp. 21-55.).
11. G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, “Prefazione”, Firenze, La Nuova Italia, 1970, p. 19.
12 A. Gramsci, Quaderni del carcere, Torino, Einaudi, 1975, III, p. 2350.
II.
*** Per la Monarchia (non De Monarchia, titolo estraneo alla tradizione manoscritta) è stata utilizzata la traduzione condotta sul testo dell’edizione nazionale da L. Adamo, cfr. Dante Alighieri, Tutte le opere, a c. di L. Blasucci, Firenze, Sansoni, 1965, pp. 247-316. Dei passi citati si sono dati in parentesi il libro e il capitolo.
13. Le citazioni sono riprese dalla bolla Unam Sanctam data da Bonifacio VIII in Laterano nel novembre 1302; cfr. Gaeta - Villani, Documenti e testimonianze, cit., I, pp. 242-4.
14. C. Vasoli, La Filosofia Medievale, Milano, Feltrinelli, 1961, p. 409.
15. S. A. Chimenz, Dante, in “Letteratura Italiana. I Maggiori”, Milano, Marzorati, I, p. 45.
16. P. Renucci, La cultura, in “Storia d’Italia”, Torino, Einaudi, 1974, 2/II, p. 1178.
17. P. A. ROVATTI, Contro la separazione, in “aut aut”, 186, Firenze, La Nuova Italia, 1981.
18. Ph. Sollers, Io e Dante, in “Spirali», 30, 1981.
* http://www.ildialogo.org/filosofia/danteorigini08072005.htm
- "Declino del simbolismo. [...] Ecco un esempio: per indicare il rapporto fra l’autorità spirituale e quella temporale il Medioevo si serviva costantemente di due similitudini simboliche[...] La forza del simbolo è tale da intralciare l’indagine sullo sviluppo storico dei due poteri. Dante, avendo riconosciuto la necessità e il valore decisivo di tale indagine, si vede costretto, nel suo Monarchia, a spezzare prima la forza del simbolo, contestando la sua applicabilità, ed aprendosi così la strada alla ricerca storica" (Johan Huizinga, "L’autunno del Medio Evo" [1919, 1921, 1928]. Introduzione di Eugenio Garin, Sansoni Editore, Firenze 1940 (prima edizione italiana)
 Su Dante, si cfr.:
Su Dante, si cfr.:
- LA FORZA DELL’INTELLETTO RAZIONALE E IL DONO DIVINO DEL LIBERO ARBITRIO: "Ma l’ignoranza del volgo formula giudizi senza discernimento; e come conclude che il sole sia di larghezza nel diametro d’un piede, così per quel che riguarda i costumi è tratta in inganno dalla sciocca credulità. Ma noi a cui è stato concesso di aver coscienza del meglio ch’è in noi, non dobbiamo calcare le orme delle pecore, ché anzi siamo tenuti a correggere le loro deviazioni. Quelli infatti che sono coscienti della forza dell’intelletto razionale e del dono divino del libero arbitrio non possono essere obbligati da nessuna consuetudine; né c’è da meravigliarsene, se è vero che non essi dalle leggi, ma le leggi da essi prendon norma" (Dante, Ep. XIII, II, 7).
- L’Arca dell’Alleanza del Logos e il codice di Melchisedech.
 La Fenomenologia dello Spirito... dei “Due Soli”. Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”.
La Fenomenologia dello Spirito... dei “Due Soli”. Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”.
 Su Bacone, si cfr.:
Su Bacone, si cfr.:
Testi:
A. LA CARITA’ O IL RETTO AMORE
Monarchia, I. 11:
[...] ora il Monarca non ha più nulla da desiderare, poiché la sua giurisdizione è limitata soltanto dall’oceano (il che non si verifica per gli altri prìncipi i cui dominii confinano con altri dominii, come, per es., quello del re di Castiglia, che confina con quello del re di Aragona); quindi il Monarca, tra tutti gli uomini, è il soggetto di giustizia più esente da ogni cupidigia.
Inoltre, come la cupidigia, per quanto piccola sia, offusca l’abito della giustizia, così la carità, cioè il retto amore, lo rende più forte e più illuminato. Perciò, la persona che è capace di raggiungere il più alto grado di retto amore può attingere il massimo livello di giustizia; ora, questa persona è il monarca; quindi, con il monarca si instaura, o può instaurarsi, il massimo di giustizia. Che poi il retto amore produca tali effetti si può dedurre dal fatto che la cupidigia, spregiando il Bene supremo degli uomini, cerca altri beni, mentre la carità, spregiando tutti gli altri beni, cerca Dio e l’uomo, e di conseguenza il vero bene dell’uomo.
E siccome, fra tutti i beni dell’uomo, grandissimo è quello di vivere in pace, come si è detto sopra, e questo bene si raggiunge principalmente ed essenzialmente attraverso la giustizia, questa riceverà grandissimo vigore dalla carità, e tanto più quanto più quest’ultima sarà intensa. Che poi nel monarca debba trovarsi in sommo grado il retto amore degli uomini si dimostra nel modo seguente: ogni oggetto amabile è tanto più amato quanto più è vicino a chi l’ama; ora gli uomini sono più vicini al monarca che agli altri principi; quindi essi sono o debbono essere amati dal monarca più che da ogni altro.
La premessa maggiore è evidente se si considera la natura degli agenti e dei pazienti; la minore è dimostrata dal fatto che agli altri prìncipi gli uomini sono vicini solo in parte, al monarca invece nella loro totalità. Si aggiunga che gli uomini si avvicinano agli altri prìncipi attraverso il monarca e non viceversa, e quindi la cura del monarca verso tutti gli uomini è originaria ed immediata, mentre quella degli altri prìncipi passa attraverso la mediazione del monarca in quanto deriva dalla sua cura suprema. Inoltre, quanto più una causa è universale, tanto più è causa (la causa inferiore infatti non è causa se non in forza di quella superiore, come risulta dal libro «Delle cause»), e quanto più una causa è causa, tanto più ama il suo effetto, poiché tale amore è conseguenza diretta dell’essere causa; ora, il monarca è, tra gli uomini, la causa più universale del loro ben vivere (mentre gli altri prìncipi sono causa attraverso la mediazione del monarca, come si è detto); quindi il monarca ama il bene degli uomini più di ogni altro.
[Per il secondo punto], chi potrebbe mettere in dubbio che il monarca abbia il massimo potere per attuare la giustizia se non colui che non intende che cosa significhi quel nome? Se egli infatti è effettivamente monarca, non può avere nemici. E così è stata sufficientemente dimostrata la premessa minore del sillogismo principale, e pertanto è certa la conclusione che la monarchia è necessaria per un perfetto ordinamento del mondo. (trad. di Pio Gaja)
- - -
 [...] 12. Sed Monarcha non habet quod possit optare: sua nanque iurisdictio terminatur Occeano solum: quod non contingit principibus aliis, quorum principatus ad alios terminantur, ut puta regis Castelle ad illum qui regis Aragonum. Ex quo sequitur quod Monarcha sincerissimum inter mortales iustitie possit esse subiectum.
[...] 12. Sed Monarcha non habet quod possit optare: sua nanque iurisdictio terminatur Occeano solum: quod non contingit principibus aliis, quorum principatus ad alios terminantur, ut puta regis Castelle ad illum qui regis Aragonum. Ex quo sequitur quod Monarcha sincerissimum inter mortales iustitie possit esse subiectum.
 13. Preterea, quemadmodum cupiditas habitualem iustitiam quodammodo, quantumcunque pauca, obnubilat, sic karitas seu recta dilectio illam acuit atque dilucidat. Cui ergo maxime recta dilectio inesse potest, potissimum locum in illo potest habere iustitia; huiusmodi est Monarcha: ergo, eo existente, iustitia potissima est vel esse potest.
13. Preterea, quemadmodum cupiditas habitualem iustitiam quodammodo, quantumcunque pauca, obnubilat, sic karitas seu recta dilectio illam acuit atque dilucidat. Cui ergo maxime recta dilectio inesse potest, potissimum locum in illo potest habere iustitia; huiusmodi est Monarcha: ergo, eo existente, iustitia potissima est vel esse potest.
 14. Quod autem recta dilectio faciat quod dictum est, hinc haberi potest: cupiditas nanque, perseitate hominum spreta, querit alia; karitas vero, spretis aliis omnibus, querit Deum et hominem, et per consequens bonum hominis. Cumque inter alia bona hominis potissimum sit in pace vivere - ut supra dicebatur - et hoc operetur maxime atque potissime iustitia, karitas maxime iustitiam vigorabit et potior potius.
14. Quod autem recta dilectio faciat quod dictum est, hinc haberi potest: cupiditas nanque, perseitate hominum spreta, querit alia; karitas vero, spretis aliis omnibus, querit Deum et hominem, et per consequens bonum hominis. Cumque inter alia bona hominis potissimum sit in pace vivere - ut supra dicebatur - et hoc operetur maxime atque potissime iustitia, karitas maxime iustitiam vigorabit et potior potius.
 15. Et quod Monarche maxime hominum recta dilectio inesse debeat, patet sic: omne diligibile tanto magis diligitur quanto propinquius est diligenti; sed homines propinquius Monarche sunt quam aliis principibus: ergo ab eo maxime diliguntur vel diligi debent. Prima manifesta est, si natura passivorum et activorum consideretur; secunda per hoc apparet: quia principibus aliis homines non appropinquant nisi in parte, Monarche vero secundum totum.
15. Et quod Monarche maxime hominum recta dilectio inesse debeat, patet sic: omne diligibile tanto magis diligitur quanto propinquius est diligenti; sed homines propinquius Monarche sunt quam aliis principibus: ergo ab eo maxime diliguntur vel diligi debent. Prima manifesta est, si natura passivorum et activorum consideretur; secunda per hoc apparet: quia principibus aliis homines non appropinquant nisi in parte, Monarche vero secundum totum.
 16. Et rursus: principibus aliis appropinquant per Monarcham et non e converso; et sic per prius et immediate Monarche inest cura de omnibus, aliis autem principibus per Monarcham, eo quod cura ipsorum a cura illa supprema descendit.
16. Et rursus: principibus aliis appropinquant per Monarcham et non e converso; et sic per prius et immediate Monarche inest cura de omnibus, aliis autem principibus per Monarcham, eo quod cura ipsorum a cura illa supprema descendit.
 17. Preterea, quanto causa est universalior, tanto magis habet rationem cause, quia inferior non est causa nisi per superiorem, ut patet ex hiis que De causis; et quanto causa magis est causa, tanto magis effectum diligit, cum dilectio talis assequatur causam per se.
17. Preterea, quanto causa est universalior, tanto magis habet rationem cause, quia inferior non est causa nisi per superiorem, ut patet ex hiis que De causis; et quanto causa magis est causa, tanto magis effectum diligit, cum dilectio talis assequatur causam per se.
 18. Cum igitur Monarcha sit universalissima causa inter mortales ut homines bene vivant, quia principes alii per illum, ut dictum est, consequens est quod bonum hominum ab eo maxime diligatur.
18. Cum igitur Monarcha sit universalissima causa inter mortales ut homines bene vivant, quia principes alii per illum, ut dictum est, consequens est quod bonum hominum ab eo maxime diligatur.
 19. Quod autem Monarcha potissime se habeat ad operationem iustitie, quis dubitat nisi qui vocem hanc non intelligit, cum, si Monarcha est, hostes habere non possit?
19. Quod autem Monarcha potissime se habeat ad operationem iustitie, quis dubitat nisi qui vocem hanc non intelligit, cum, si Monarcha est, hostes habere non possit?
 20. Satis igitur declarata subassumpta principalis, quia conclusio certa est: scilicet quod ad optimam dispositionem mundi necesse est Monarchiam esse.
20. Satis igitur declarata subassumpta principalis, quia conclusio certa est: scilicet quod ad optimam dispositionem mundi necesse est Monarchiam esse.
B. IL SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS"
Monarchia (III. 11):
Gli avversari portano poi un argomento di ragione.
Utilizzando infatti un principio del decimo libro della Metafisica, essi argomentano così:
 tutti gli esseri appartenenti ad uno stesso genere si riconducono ad uno, che è misura di tutti gli altri inclusi in quel genere;
tutti gli esseri appartenenti ad uno stesso genere si riconducono ad uno, che è misura di tutti gli altri inclusi in quel genere;
 ora tutti gli uomini appartengono allo stesso genere;
ora tutti gli uomini appartengono allo stesso genere;
 quindi vanno ricondotti ad uno come misura di tutti quanti.
quindi vanno ricondotti ad uno come misura di tutti quanti.
Se questa conclusione è vera, il Sommo Pontefice e l’Imperatore, essendo uomini, vanno ricondotti ad un solo uomo. Ma poiché non è possibile ricondurre il Papa ad altri, resta che l’Imperatore, insieme a tutti gli altri uomini, deve essere ricondotto al Papa come misura e regola; e così anche con questo ragionamento arrivano alla conclusione da essi voluta.
Per confutare tale ragionamento, ammetto come vera la loro affermazione che «tutti gli esseri appartenenti allo stesso genere debbono ricondursi ad un essere di quel genere, che, nell’ambito di questo, costituisce la misura»; come pure è vera l’affermazione che tutti gli uomini appartengono ad un medesimo genere; ed è vera altresì la conclusione ricavata da tale premessa, che cioè tutti gli uomini vanno ricondotti ad un’unica misura nell’ambito del loro genere. Ma quando da questa conclusione essi inferiscono la conseguenza applicativa nei confronti del Papa e dell’Imperatore, incorrono nella fallacia dell’accidente [40].
Per afferrare bene questo bisogna tener presente che una cosa è essere uomo e un’altra essere Papa, come d’altra parte una cosa è essere uomo e un’altra essere Imperatore, così come una cosa è essere uomo e un’altra essere padre e signore.
L’uomo infatti è quello che è per la sua forma sostanziale, in forza della quale rientra in una specie e in un genere, ed è posto nella categoria della sostanza; il padre invece è tale per una forma accidentale che è la relazione, per la quale rientra in una specie e in un genere particolari, ed è posto nella categoria dell’«ad aliquid», cioè della «relazione». Se così non fosse, tutto si ricondurrebbe - ma ciò è falso - alla categoria della sostanza, dal momento che nessuna forma accidentale può sussistere per se stessa senza il supporto di una sostanza sussistente.
Pertanto Papa e Imperatore essendo ciò che sono in forza di certe relazioni (quelle appunto dell’autorità papale e dell’autorità imperiale, la prima delle quali rientra nell’ambito della paternità e l’altra nell’ambito del dominio), è chiaro che Papa e Imperatore, in quanto tali, devono essere posti nella categoria della relazione e quindi essere ricondotti ad un elemento rientrante in tale categoria. Quindi affermo che altra è la misura cui debbono essere ricondotti in quanto uomini, ed altra in quanto Papa e Imperatore.
Infatti, in quanto uomini, vanno ricondotti all’uomo perfetto (che è misura di tutti gli altri e, per così dire, loro modello ideale, chiunque esso sia), come a quello che è sommamente uno nel suo genere, come si può rilevare dai capitoli finali dell’Etica a Nicomaco. Invece, in quanto sono termini di relazione, allora, com’è evidente, o vanno ricondotti l’uno all’altro (se l’uno è subalterno all’altro o se sono accomunati nella specie per la natura della relazione), oppure ad un terzo elemento come alla loro comune unità.
Ora, non si può affermare che uno sia subalterno all’altro, poiché, in tale caso, l’uno si predicherebbe dell’altro, il che è falso (noi infatti non diciamo che l’Imperatore è Papa e nemmeno viceversa); e neppure si può affermare che siano accomunati nella specie, in quanto l’essenza formale di Papa è diversa da quella di Imperatore in quanto tale. Quindi si riconducono a qualcos’altro, in cui devono trovare la loro unità.
A questo proposito bisogna tener presente che i soggetti delle relazioni stanno tra di loro come le rispettive relazioni. Ora quelle particolari relazioni d’autorità che sono il Papato e l’Impero vanno ricondotte ad una [suprema] relazione d’autorità, da cui quelle discendono con le loro determinazioni particolari; quindi i soggetti di quelle relazioni, cioè il Papa e l’Imperatore, andranno anch’essi ricondotti a qualche soggetto unitario che realizzi la relazione d’autorità nella sua essenza formale, al di fuori di ogni determinazione particolare.
E questo soggetto unitario sarà o Dio stesso, in cui tutte le relazioni particolari trovano la loro unificazione assoluta, oppure una qualche sostanza inferiore a Dio, nella quale la relazione d’autorità, che proviene da quella relazione assoluta, si particolarizza attraverso una differenziazione nel grado d’autorità. E così diventa chiaro che Papa e Imperatore, in quanto uomini, vanno ricondotti ad un elemento comune, mentre, in quanto formalmente Papa e Imperatore, ad un elemento comune diverso. Attraverso questa distinzione si risponde all’argomento di ragione [portato dagli avversari].
MONARCHIA, III. 11:
Ratione vero sic arguunt. Summunt etenim sibi principium de decimo Prime phylosophie dicentes: omnia que sunt unius generis reducuntur ad unum, quod est mensura omnium que sub illo genere sunt; sed omnes homines sunt unius generis: ergo debent reduci ad unum, tanquam ad mensuram omnium eorum.
Et cum summus Antistes et Imperator sint homines, si conclusio illa est vera, oportet quod reducantur ad unum hominem. Et cum Papa non sit reducendus ad alium, relinquitur quod Imperator cum omnibus aliis sit reducendus ad ipsum, tanquam ad mensuram et regulam: propter quod sequitur etiam idem quod volunt.
Ad hanc rationem solvendam dico quod, cum dicunt «Ea que sunt unius generis oportet reduci ad aliquod unum de illo genere, quod est metrum in ipso», verum dicunt. Et similiter verum dicunt dicentes quod omnes homines sunt unius generis; et similiter verum concludunt cum inferunt ex hiis omnes homines esse reducendos ad unum metrum in suo genere.
Sed cum ex hac conclusione subinferunt de Papa et Imperatore, falluntur «secundum accidens». Ad cuius evidentiam sciendum quod aliud est esse hominem et aliud est esse Papam; et eodem modo aliud est esse hominem, aliud esse Imperatorem, sicut aliud est esse hominem, et aliud est esse patrem et dominum.
Homo enim est id quod est per formam substantialem, per quam sortitur spetiem et genus, et per quam reponitur sub predicamento substantie; pater vero est id quod est per formam accidentalem, que est relatio per quam sortitur spetiem quandam et genus, et reponitur sub genere «ad aliquid», sive «relationis». Aliter omnia reducerentur ad predicamentum substantie, cum nulla forma accidentalis per se subsistat absque ypostasi substantie subsistentis: quod est falsum.
Cum ergo Papa et Imperator sint id quod sunt per quasdam relationes, quia per Papatum et per Imperiatum, que relationes sunt altera sub ambitu paternitatis et altera sub ambitu dominationis, manifestum est quod Papa et Imperator, in quantum huiusmodi, habent reponi sub predicamento relationis, et per consequens reduci ad aliquod existens sub illo genere.
Unde dico quod alia est mensura ad quam habent reduci prout sunt homines, et alia prout sunt et Papa et Imperator Nam, prout sunt homines, habent reduci ad optimum hominem, qui est mensura omnium aliorum, et ydea ut dicam quisquis ille sit ad existentem maxime unum in genere suo: ut haberi potest ex ultimis ad Nicomacum. In quantum vero sunt relativa quedam, ut patet, reducenda sunt vel ad invicem, si alterum subalternatur alteri vel in spetie comunicant per naturam relationis, vel ad aliquod tertium, ad quod reducantur tanquam ad comunem unitatem.
Sed non potest dici quod alterum subalternetur alteri, quia sic alterum de altero predicaretur: quod est falsum; non enim dicimus «Imperator est Papa», nec e converso. Nec potest dici quod comunicent in spetie, cum alia sit ratio Pape, alia Imperatoris, in quantum huiusmodi: ergo reducuntur ad aliquid in quo habent uniri.
Propter quod sciendum quod, sicut se habet relatio ad relationem, sic relativum ad relativum. Si ergo Papatus et Imperiatus, cum sint relationes superpositionis, habeant reduci ad respectum superpositionis, a quo respectu cum suis differentialibus descendunt, Papa et Imperator, cum sint relativa, reduci habebunt ad aliquod unum in quo reperiatur ipse respectus superpositionis absque differentialibus aliis.
Et hoc erit vel ipse Deus, in quo respectus omnis universaliter unitur, vel aliqua substantia Deo inferior, in qua respectus superpositionis per differentiam superpositionis a simplici respectu descendens particuletur. Et sic patet quod Papa et Imperator, in quantum homines, habent reduci ad unum; in quantum vero Papa et Imperator, ad aliud: et per hoc patet ad rationem.
NOTA [40]. Il sofisma della fallacia accidentis si ha quando ciò che si dice di un soggetto si fa valere anche per il suo accidente (o viceversa), mentre non necessariamente vale per questo, in quanto sostanza e accidente non sono identici nella loro essenza formale, pur riferendosi allo stesso soggetto. Aristotele fa questo esempio: A è uomo; ora B è diverso da A; quindi B non è uomo, ove la diversità nelle proprietà accidentali individuali (es. uno è biondo, l’altro è bruno) viene erroneamente trasferita alla loro essenza specifica, che invece è identica.
Dante prospetta diffusamente il caso inverso di un’identità essenziale (papa e imperatore in quanto uomini sono identici nella specie) che si vorrebbe trasferire ai loro rispettivi accidenti quali sono le funzioni di papa e imperatore, che invece sono relationes diverse e specificamente contrarie, e quindi non mediabili e non riducibili ad unum o riferibili ad una stessa sostanza, per cui chi li identifica o li assoggetta l’uno all’altro va contro la legge di non-contraddizione e cade nella fallacia accidentis. (traduzione e nota di Pio Gaja)
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
IL "GRANDE RACCONTO" EDIPICO DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA E’ FINITO
 L’APOSTOLO ASTUTO MENTITORE, SENZA GRAZIA ("CHARIS") E SENZA AMORE ("CHARITAS")! UNA NOTA SULL’OPERAZIONE DI SAN PAOLO:
L’APOSTOLO ASTUTO MENTITORE, SENZA GRAZIA ("CHARIS") E SENZA AMORE ("CHARITAS")! UNA NOTA SULL’OPERAZIONE DI SAN PAOLO:
- (...) non equivochiamo! Qui non siamo sulla via di Damasco,
nel senso e nella direzione di Paolo di Tarso, del
Papa, e della Gerarchia Cattolico-Romana: “[... ] noi
non siamo più sotto un pedagogo. Non c’è più giudeo
né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo
né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù”
(Galati: 3, 25-28).
 Nella presa di distanza, nel porsi sopra
tutti e tutte, e nell’arrogarsi il potere di tutoraggio
da parte di Paolo, in questo passaggio dal noi siamo al
voi siete, l’inizio di una storia di sterminate conseguenze,
che ha toccato tutti e tutte.
Nella presa di distanza, nel porsi sopra
tutti e tutte, e nell’arrogarsi il potere di tutoraggio
da parte di Paolo, in questo passaggio dal noi siamo al
voi siete, l’inizio di una storia di sterminate conseguenze,
che ha toccato tutti e tutte.
 Il persecutore accanito dei cristiani, “conquistato da Gesù Cristo”, si
pente - a modo suo - e si mette a “correre per conquistarlo”
(Filippesi: 3, 12): come Platone (con tutto il carico di
positivo e di negativo storico dell’operazione, come ho
detto), afferra l’anima della vita evangelica degli apostoli,
delle cristiane e dei cristiani, approfittando delle
incertezze e dei tentennamenti di Pietro, si fa apostolo
(la ‘donazione’ di Pietro) dei pagani e, da cittadino romano,
la porta e consegna nelle mani di Roma.
Nasce la
Chiesa ... dell’Impero Romano d’Occidente (la ‘donazione’
di Costantino).
La persecuzione dei cristiani, prima e degli stessi ebrei
dopo deve essere portata fino ai confini della terra e fino
alla fine del mondo: tutti e tutte, nella polvere, nel deserto,
sotto l’occhio del Paolo di Tarso che ha conquistato
l’anima di Gesù Cristo, e la sventola contro il vento
come segno della sua vittoria... Tutti e tutte sulla romana
croce della morte.
Il persecutore accanito dei cristiani, “conquistato da Gesù Cristo”, si
pente - a modo suo - e si mette a “correre per conquistarlo”
(Filippesi: 3, 12): come Platone (con tutto il carico di
positivo e di negativo storico dell’operazione, come ho
detto), afferra l’anima della vita evangelica degli apostoli,
delle cristiane e dei cristiani, approfittando delle
incertezze e dei tentennamenti di Pietro, si fa apostolo
(la ‘donazione’ di Pietro) dei pagani e, da cittadino romano,
la porta e consegna nelle mani di Roma.
Nasce la
Chiesa ... dell’Impero Romano d’Occidente (la ‘donazione’
di Costantino).
La persecuzione dei cristiani, prima e degli stessi ebrei
dopo deve essere portata fino ai confini della terra e fino
alla fine del mondo: tutti e tutte, nella polvere, nel deserto,
sotto l’occhio del Paolo di Tarso che ha conquistato
l’anima di Gesù Cristo, e la sventola contro il vento
come segno della sua vittoria... Tutti e tutte sulla romana
croce della morte.
- Egli, il vicario di Gesù Cristo, ha vinto: è Cristo stesso, è Dio, è il Dio del deserto... Un cristo-foro dell’imbroglio e della vergogna - con la ‘croce’ in pugno (e non piantata nella roccia del proprio cuore, come indicava Gesù) - comincia a portare la pace cattolico-romana nel mondo. Iniziano le Crociate e la Conquista. Il Dio lo vuole: tutti i popoli della Terra vanno portati nel gelo eterno - questo è il comando dei Papi e dei Concili, cioè delle massime espressioni dell’intelligenza astuta (quella del Dio di Ulisse e della vergine Atena, non del Dio di Giuseppe e di Maria) del Magistero della Chiesa, alle proprie forze armate... fino a Giovanni Paolo II, al suo cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e alla Commissione teologica internazionale, che ha preparato il documento “Memoria e riconciliazione: la Chiesa e le colpe del passato”.
- Uno spirito e un proposito lontano mille miglia, e mille
anni prima di Cristo, da quello della “Commissione
per la verità e la riconciliazione”, istituita in Sudafrica
nel 1995 da Nelson Mandela, per curare e guarire le ferite
del suo popolo. Il motto della Commissione bello,
coraggioso, e significativo è stato ed è: “Guariamo la
nostra terra”!
 (Si cfr.: Federico La Sala, L’enigma della Sfinge e il segreto della Piramide, Ripostes, Roma-Salerno 2001, pp.24-25).
(Si cfr.: Federico La Sala, L’enigma della Sfinge e il segreto della Piramide, Ripostes, Roma-Salerno 2001, pp.24-25).
Forum
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. --- UN "VIAGGIO IN SICILIA" CON DANTE, SAUSSURE, E FREUD. NOTE A MARGINE del libro "Sicilia isola continentale. Psicoanalisi di una identità" di Franco Lo Piparo.28 ottobre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, LINGUISTICA, E PSICOANALISI:
SULLE ALI PARADIGMATICHE DI UN MATRIMONIO, UN "VIAGGIO IN SICILIA" (GOETHE) CON DANTE, SAUSSURE, E FREUD.
- Una nota di commento a margine del lavoro del prof. Franco Lo Piparo
A NON SOTTOVALUTARE l’importanza del lavoro di Franco Lo Piparo, "Sicilia isola continentale. Psicoanalisi di una identità" (Sellerio 2024), forse, è opportuno tenere presente il punto di vista (e di partenza) e l’oggetto (il punto di arrivo, il risultato) della ricerca, che riesce a riannodare strutturalmente e magistralmente (senza ricadere dentro lo "strutturalismo") insieme #lingua #istituzioni e #società.
IL SEGNAVIA è una formula di #matrimonio in volgare siciliano scritta in caratteri greci, forse, degli anni 1259/1266, durante il #regno di Manfredi di Svevia. Un percorso illuminante, a mio parere.
Per non sprecare questa occasione "storica", credo che sia opportuno non lasciarsi accecare (edipicamente) dal legame (per lo più giocastico) con la propria "santissima" #Mamma, la "Madre mediterranea", e accogliere al meglio cio’ che appare essere una straordinaria "risposta" di un "alunno" alle lezioni dei suoi "maestri" (a cominciare da Renato Guttuso, da Tullio De Mauro, e da Umberto Eco->), e, in particolare, una sollecitazione (da un "alunno" diventato "maestro", a pieno titolo) a ri-leggere antropologicamente il "Corso di Linguistica Generale" di Ferdinand de #Saussure, riprendendo il filo dal "circuito della #parole": "Siano, dunque, due persone che discorrono: A e B."!.
- NOTE:
- PITTURA #SESSUALITA’ #LINGUISTICA E #ANTROPOLOGIA. A NON SPRECARE LA RIEVOCAZIONE DELLA #LEZIONE DEL MAESTRO #GUTTUSO “Al giovane Lopiparo ricordo di Guttuso, Roma 9-6-64” (cfr. Franco Lo Piparo, "GUTTUSO «DIPINGEVA CON IL PENE»", 20 Ottobre, 2021), forse, non è bene richiamare sia il lavoro degli amici e dei maestri (da #TullioDeMauro a #UmbertoEco) del prof. Franco Lo Piparo sia il lavoro del #pittore René #Magritte e del filosofo #MichelFoucault sui quadri relativi al problema della #rappresentazione riflettendo ancora sul quadro "QUESTA PIPA NON E’ UNA #PIPA" e rimettere in movimento le #idee relative al "circuito fallico", al circuito sessuale, e, finalmente, al circuito della #parole (alla #Saussure), di #due "soggetti sovrani" (come da #Costituzione teologico-politica italiana, e, da "#Canticodeicantici", nel blu dipinto di blù, alla #Totò), e passare, finalmente, agli "atti linguistici" di un regime non più segnato da un #androcentrismo teologico-politico tragico a un’antropologia all’altezza della famosa "#dignità dell’uomo" e della "#divinacommedia" (#Dante)!?!
- FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E GENERE UMANO: CARLA LONZI (1931-1982). MA A CHE #GIOGO SI CONTINUA A #GIOGARE, ANCORA A QUELLO DEL "SAPIENTE" (1510) DEL FILOSOFO #BOVILLUS (Charles de #Bovelles): LA DONNA DEFINITA IN RAPPORTO ALL’UOMO? UNA DOMANDA (UNA #QUESTION #HAMLETICA): MA DOVE SONO I FILOSOFI E LE FILOSOFE, OGGI!? Nonostante tutta la sapienza accumulata nei secoli, e, dopo la scoperta dei "#buchineri" e della formidabile ipotesi relativa allesistenza dei "#buchibianchi", nel pensiero e nelle Istituzioni ancora non si corre ai ripari e non si procede a correggere "un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#FrancaOngaro #Basaglia, 1978). O, per cecità e necessità, si preferisce continuare a vivere come "sapienti e contenti" nella tragica #cosmoteandria platonico-hegeliana? Forse è bene rileggersi una breve sintesi "storico-poetica" della #fenomenologiadellospirito dal XII al XIX secolo (e oltre) di #Baudelaire e riflettere sulla storia dello “chátiment de l’#orgueil” (“L’orgoglio punito” di “Les Fleurs du Mal”) del poeta e filosofo Charles Baudelaire e portarsi fuori da interi millenni di labirinto. Se non ora, quando?!
- STORIA E LETTERATURA LINGUISTICA PSICOANALISI E PSICHIATRIA: "LOUIS WOLFSON. CRONACHE DA UN PIANETA INFERNALE". "[...] Con qualche rara eccezione, oggi la formazione “psy” va così. Si studiano fino alla nausea i paradigmi scientisti alla moda e non si legge una virgola della vasta letteratura schizofrenica. L’accademia deride l’idea di una schizocultura, non crede al monito foucaultiano secondo cui è la follia a detenere la verità della psicologia. Il più lungimirante si avvede della condizione di tecnico alienato, solleva le spalle, guarda altrove e può incontrare il testo di Louis Wolfson. [...] In ciò che Gilles Deleuze in prefazione al romanzo definisce come un procedimento schizologico, il nostro antieroe, di nazionalità statunitense, è costantemente impegnato a difendersi dall’invasività della lingua materna, o peggio, della lingua della madre, primo e più potente dispositivo di assoggettamento. [...] Da psicologo, non ho potuto non notare la domanda che emerge inevitabilmente dallo sfondo del testo: che cos’è la psichiatria? Se lo chiedono da tempo i curatori, il cui lavoro è in tal senso orientato, qui come altrove, a depatologizzare e strappare dalle mani della confisca psichiatrica filosofie, arti e letterature " (cfr. la Recensione del libro "Louis Wolfson. Cronache da un pianeta infernale", a cura di Pietro Barbetta e Enrico Valtellina, Manifestolibri 2014, di Alessandro Siciliano.).
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. Per una rilettura del "De Vulgari Eloquentia" e della "Monarchia" --- Tutto l’amore di Eliot per l’universo dantesco (di Giovanni D?alessandro).14 giugno 2021, di Federico La Sala
Riletture.
Tutto l’amore di Eliot per l’universo dantesco
Il poeta inglese lo riteneva inarrivabile, superiore a Shakespeare e Milton, capace di dire in una sola opera «tutto ciò che l’uomo è capace di sperimentare»
di Giovanni D’Alessandro (Avvenire, domenica 13 giugno 2021).
- [Foto] T.S. Eliot
A tributare un entusiastico omaggio a Dante in Inghilterra non è il Medioevo - in tempi in cui, pure, Chaucer e gli scholars guardavano con ammirazione alla cultura italiana; non è il Rinascimento, che riversa nella produzione drammaturgica di un Marlowe, di uno Shakespeare, di un Jonson e di altri tutta una soggettistica, anche minore, di narrazione per la scena, coltivata nelle corti della nostra penisola; non sono neppure il secondo Seicento e il Settecento quando l’isola al di là della Manica comincia ad assumere dimensioni, ignote al mondo, di potenza commerciale lanciata sui mari, mentre il suo popolo di servi della gleba prende ad affrancarsi dalla secolare servitù ai landlords per diventare un “popolo sulle navi” e l’alta voce di Milton a farsene anima.
Per tutti questi secoli Dante rimane un fenomeno italiano e le forzature che periodicamente vengono tentate da chi cerca d’intravvederne l’immensa statura poetica dappertutto, vengono smentite dall’assenza di mutuazioni dantesche tra i maggiori poeti e scrittori inglesi dal XIV al XVIII secolo. Sono invece l’Ottocento e il Novecento, per un percorso particolarissimo, a far deflagrare Dante oltre Manica.
Nei primi decenni dell’Ottocento l’Inghilterra è ormai un’irraggiungibile entità economica che si avvia a controllare un quarto del pianeta. E per vie misteriose Dante assurge a riferimento ineludibile per più correnti e più filoni della poesia, della critica, del pensiero, della figurazione e di ogni espressione artistica. Non solo episodici traduttori, ma grandi poeti s’ispirano a lui, quali Shelley, Keats, Byron (senza dimenticare le illustrazioni del poeta/artista Blake) nell’Ottocento; e, nella prima metà del Novecento, Pound ed Eliot. Ed è soprattutto con Thomas Stearns Eliot (18881965) che si raggiunge un ineguagliato punto di lucidità sulla grandezza di Dante; con l’autore di La terra desolata e dei Quartetti la rappresentazione morale dantesca della condizione umana e la sua proiezione dalla finitudine all’infinito vengono ricollocati al centro di ogni indagine su di essa.
Cosa scrive Eliot di Dante? Lo commenta e cita, anche in italiano, moltissime volte dedicandogli anche i saggi Dante I (del 1920, che precede di due anni la pubblicazione di La terra desolata); il corposo Dante II (del 1929) e Cosa significa Dante per me (del 1950, testo dell’intervento di Eliot all’Istituto italiano di cultura di Londra). Converrà attingere a questo terzo scritto, stilato da Eliot un anno e mezzo dopo il conferimento del Nobel per la Letteratura, non solo perché è più diretto e personale, ma perché è più tardo rispetto agli altri e quindi meglio riassume i modi e i toni di un amore durato una vita, a partire da quando ne era stato conquistato da ragazzo: «Considero la sua poesia come quella che ha avuto l’influenza più duratura e profonda sui miei versi».
A sedurlo è la «assoluta precisione» di ogni verso e di ogni singola parola, che fa di Dante «il più accorto studioso dell’arte della poesia», «il più serio, attento e scrupoloso professionista del mestiere di poetare», nel quale nessun poeta inglese può essergli comparato, neppure Shakespeare o Milton, «in quanto poeti a lui inferiori, e anche tecnici a lui inferiori nel mestiere».
Dante per Eliot non è soltanto il maieuta del volgare, o italiano comunemente parlato, nel senso che non l’aiuta a venire al mondo, lo genera, proprio; è... madre della sua “madrelingua”; e senza di lui «il linguaggio corrente non sarebbe quello che è, si tratti del linguaggio di un poeta, di un filosofo, di uno statista o di un facchino delle ferrovie ». Ovviamente nessuno parla oggi la lingua di Dante - conclude - ma non importa che non abbia eredi; conta l’universale operazione di aver indicato ai posteri le possibilità d’espansione della resa del pensiero e del “sentire”, propri nella Divina Commedia della volgare eloquenza usata dal suo popolo ma, in differenti favelle, anche da tutti gli altri popoli.
Dante infatti, prima che a parlare, insegna a sentire: «La Commedia esprime nell’ambito dell’emozione tutto ciò che, compreso tra la disperazione della depravazione e la visione della beatitudine, l’uomo è capace di sperimentare » e senza di essa l’uomo non avrebbe verbo per dare nome e forma al suo stesso sentire.
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA -- PER I 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE, L’APPELLO DEL MINISTRO DARIO FRANCESCHINI (Ansa).10 gennaio 2020, di Federico La Sala
PER I 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE.... *
- Con Dante, già da oggi (10.01.2020), guardare l’Italia (e la Terra) dallo spazio, come da indicazione del Presidente dellaRepubblica (messaggio di fine anno).
Dante, l’appello di Franceschini alle imprese
"Poste finanzia, altri li seguano". La Rai rilanci all’estero
(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Grazie a Poste Italiane, che hanno offerto il loro sostegno per le celebrazioni, nel 2021, dei 700 anni dalla morte di Dante", ma "vorrei che quello di Poste fosse un esempio per le altre imprese italiane che non si possono sottrarre a fare qualcosa per Dante". Il ministro di Cultura e Turismo Dario Franceschini presenta a Roma, insieme con il presidente del Comitato per i 700 anni dalla morte di Dante, Carlo Ossola e con la presidente Maria Bianca Farina e l’ad Matteo Del Fante di Poste Italiane un progetto di valorizzazione che coinvolgerà decine di comuni italiani (70 al momento ma potrebbero diventare di più) e approfitta per lanciare un appello al mondo delle imprese: "Dante è di tutti - dice - tutte le nostre imprese quando vanno all’estero hanno dietro il supporto dell’Italia e Dante per noi italiani è identitario.
 Tutti dovrebbero fare qualcosa". E aggiunge: "Vorrei vedere Dante sui treni, sui voli Alitalia, dappertutto". Non solo: "Vorrei che la Rai , so che ci sono ragionamenti aperti in questo senso, producesse cose da far circolare non solo in Italia ma nel mondo". Un appello, quello del ministro Pd, rivolto in ultima analisi al Paese a tutto tondo: "Dante è di tutti, è identitario, coinvolge, è stato anche uno dei primi ad aver parlato di Europa. - sottolinea il capo delegazione Pd al governo - Celebrare i 700 anni dalla sua morte è lavorare per l’unità e il nostro Paese ha molto bisogno di unità. E’ anche orgoglio e il Paese ha bisogno di orgoglio". (ANSA).
Tutti dovrebbero fare qualcosa". E aggiunge: "Vorrei vedere Dante sui treni, sui voli Alitalia, dappertutto". Non solo: "Vorrei che la Rai , so che ci sono ragionamenti aperti in questo senso, producesse cose da far circolare non solo in Italia ma nel mondo". Un appello, quello del ministro Pd, rivolto in ultima analisi al Paese a tutto tondo: "Dante è di tutti, è identitario, coinvolge, è stato anche uno dei primi ad aver parlato di Europa. - sottolinea il capo delegazione Pd al governo - Celebrare i 700 anni dalla sua morte è lavorare per l’unità e il nostro Paese ha molto bisogno di unità. E’ anche orgoglio e il Paese ha bisogno di orgoglio". (ANSA).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE ("charitas"). Per una rilettura del "De Vulgari Eloquentia" e della "Monarchia"
Federico La Sala
-
> DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE ("charitas"). -- COSMOLOGIA, TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE COSMOTEANDRICO.3 gennaio 2020, di Federico La Sala
“DE DOMO DAVID”?! GIUSEPPE, MARIA, E L’IMMAGINARIO “COSMOTEANDRICO” (COSMOLOGIA, TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA!) DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINANA... *
- Nota di commento a margine di "De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò" (cfr. "Fondazione Terra d’Otranto", 10.11.2019).
CARDINALE CASTRILLON HOYOS: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio”(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
PAPA FRANCESCO: “«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana! [...]” (LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, Omelia di papa Francesco, Basilica Vaticana, Mercoledì, 1° gennaio 2020).
*
A) - La costruzione del ’presepe’ cattolico-romano .... e la ’risata’ di Giuseppe!!!
 MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;B) Il magistero della Legge dei nostri Padri e delle nostre Madri Costituenti non è quello di “Mammona” (“Deus caritas est”, 2006)! EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA “NON CLASSIFICATA”!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907.
C) GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di “pensare un altro Abramo”.
Federico La Sala
-
> DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE ("charitas"). --- MARIA, GIUSEPPE, E IL MISTERO DELL’INCARNAZIONE. SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE: "ADMIRABILE SIGNUM", LA LETTERA APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO..1 dicembre 2019, di Federico La Sala
 LETTERA APOSTOLICA
LETTERA APOSTOLICA
 Admirabile signum
Admirabile signum
 DEL SANTO PADRE
DEL SANTO PADRE
 FRANCESCO
FRANCESCO
 SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE *
SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE *1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata.
2. L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da cui presepe.
 Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana.
Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana.
 Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia.
Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia.
 Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. -La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.[2]
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero.
Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. -La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.[2]
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero.
 Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e toccante s’aggiunse anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia Gesù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia».[3]
Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e toccante s’aggiunse anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia Gesù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia».[3]3. San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità. D’altronde, il luogo stesso dove si realizzò il primo presepe esprime e suscita questi sentimenti. Greccio diventa un rifugio per l’anima che si nasconde sulla roccia per lasciarsi avvolgere nel silenzio.
 Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.
Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.
 Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali.
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali.
 In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).
In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).4. Mi piace ora passare in rassegna i vari segni del presepe per cogliere il senso che portano in sé. In primo luogo, rappresentiamo il contesto del cielo stellato nel buio e nel silenzio della notte. Non è solo per fedeltà ai racconti evangelici che lo facciamo così, ma anche per il significato che possiede. Pensiamo a quante volte la notte circonda la nostra vita. -Ebbene, anche in quei momenti, Dio non ci lascia soli, ma si fa presente per rispondere alle domande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza: chi sono io? Da dove vengo? Perché sono nato in questo tempo? Perché amo? Perché soffro? Perché morirò? Per dare una risposta a questi interrogativi Dio si è fatto uomo. La sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e rischiara quanti attraversano le tenebre della sofferenza (cfr Lc 1,79).
 Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte del presepe e che spesso rappresentano le rovine di case e palazzi antichi, che in alcuni casi sostituiscono la grotta di Betlemme e diventano l’abitazione della Santa Famiglia. Queste rovine sembra che si ispirino alla Legenda Aurea del domenicano Jacopo da Varazze (secolo XIII), dove si legge di una credenza pagana secondo cui il tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando una Vergine avesse partorito. Quelle rovine sono soprattutto il segno visibile dell’umanità decaduta, di tutto ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito. Questo scenario dice che Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro splendore originario.
Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte del presepe e che spesso rappresentano le rovine di case e palazzi antichi, che in alcuni casi sostituiscono la grotta di Betlemme e diventano l’abitazione della Santa Famiglia. Queste rovine sembra che si ispirino alla Legenda Aurea del domenicano Jacopo da Varazze (secolo XIII), dove si legge di una credenza pagana secondo cui il tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando una Vergine avesse partorito. Quelle rovine sono soprattutto il segno visibile dell’umanità decaduta, di tutto ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito. Questo scenario dice che Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro splendore originario.5. Quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre collochiamo nel presepe le montagne, i ruscelli, le pecore e i pastori! In questo modo ricordiamo, come avevano preannunciato i profeti, che tutto il creato partecipa alla festa della venuta del Messia. Gli angeli e la stella cometa sono il segno che noi pure siamo chiamati a metterci in cammino per raggiungere la grotta e adorare il Signore.
 «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene nella semplicità della descrizione. -A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe.
«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene nella semplicità della descrizione. -A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe.6. Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante statuine simboliche. Anzitutto, quelle di mendicanti e di gente che non conosce altra abbondanza se non quella del cuore. Anche loro stanno vicine a Gesù Bambino a pieno titolo, senza che nessuno possa sfrattarle o allontanarle da una culla talmente improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano affatto. I poveri, anzi, sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi.
 I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. -Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato.
Spesso i bambini - ma anche gli adulti! - amano aggiungere al presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere che in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che giocano...: tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina.
I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. -Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato.
Spesso i bambini - ma anche gli adulti! - amano aggiungere al presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere che in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che giocano...: tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina.
 7. Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbedienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” Maria diventava madre del Figlio di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica (cfr Gv 2,5).
7. Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbedienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” Maria diventava madre del Figlio di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica (cfr Gv 2,5).
 Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ed emigrare in Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.
Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ed emigrare in Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.8. Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, eppure è così: in Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque.
 La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti al loro figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe che guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita.
La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti al loro figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe che guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita.
 «La vita infatti si manifestò» (1 Gv 1,2): così l’apostolo Giovanni riassume il mistero dell’Incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a partire dal quale anche si ordina la numerazione degli anni, prima e dopo la nascita di Cristo.
Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché sembra impossibile che Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. -Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri schemi. Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo della vita.
«La vita infatti si manifestò» (1 Gv 1,2): così l’apostolo Giovanni riassume il mistero dell’Incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a partire dal quale anche si ordina la numerazione degli anni, prima e dopo la nascita di Cristo.
Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché sembra impossibile che Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. -Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri schemi. Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo della vita.9. Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si collocano nel presepe le tre statuine dei Re Magi. Osservando la stella, quei saggi e ricchi signori dell’Oriente si erano messi in cammino verso Betlemme per conoscere Gesù, e offrirgli in dono oro, incenso e mirra. Anche questi regali hanno un significato allegorico: l’oro onora la regalità di Gesù; l’incenso la sua divinità; la mirra la sua santa umanità che conoscerà la morte e la sepoltura.
 Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con concrete azioni di misericordia.
Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con concrete azioni di misericordia.
 I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Davanti al Re Bambino li pervade una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel loro Paese, avranno raccontato questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti.
I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Davanti al Re Bambino li pervade una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel loro Paese, avranno raccontato questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti.10. Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Questi ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è stato fatto trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la stessa esperienza. Non è importante come si allestisce il presepe, può essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi.
Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli.
Dato a Greccio, nel Santuario del Presepe, 1° dicembre 2019, settimo del pontificato.
FRANCESCO
 [1] Tommaso da Celano, Vita Prima, 84: Fonti francescane (FF), n. 468.
[1] Tommaso da Celano, Vita Prima, 84: Fonti francescane (FF), n. 468.
 [2] Cf. ibid., 85: FF, n. 469.
[2] Cf. ibid., 85: FF, n. 469.
 [3] Ibid., 86: FF, n. 470.
[3] Ibid., 86: FF, n. 470.
 [01938-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[01938-IT.01] [Testo originale: Italiano]
* Fonte: Lettera apostolica. Papa Francesco a Greccio: ecco il vero significato del presepe di Mimmo Muolo, Avvenire, 30.11.2019 (ripresa parziale).
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE ("charitas"). --- UNA "ITALIA SENZA NAZIONE", L’ITALIAN TOUGHT, E BRUNETTO LATINI (di A. Montefusco).28 giugno 2019, di Federico La Sala
ITALIA SENZA NAZIONE
di Antonio Montefusco (Le parole e le cose, 24 giugno 2019)
- [E’ appena uscito per Quodlibet Italia senza nazione. Lingue, culture, conflitti tra Medioevo ed età contemporanea, a cura di Antonio Montefusco. Ne presentiamo l’introduzione].
- “La storia ha di meglio da fare che essere la serva della filosofia e raccontare la nascita necessaria della verità e del valore; deve essere la conoscenza differenziale delle energie e dei cedimenti, delle sommità e dei crolli, dei veleni e degli antidoti. Deve essere la scienza dei rimedi” (Foucault 1977, pp. 29-54)
Il libro Italia senza nazione ha l’ambizione di indagare, seppure parzialmente, il «non filosofico» che, secondo la ricostruzione di Roberto Esposito, costituisce il proprium dell’indagine filosofica della tradizione italiana: una «propensione» che è sentita come «singolare», quindi costitutiva di tale tradizione. L’origine di questa pratica di estroflessione del pensiero italiano deriva da due elementi: la connessione tra vita, politica e storia, da una parte e l’esigenza insopprimibile di evocare un’origine in ogni discorso sull’attualità, dall’altra. (Esposito 2010) Si può dire, dunque, che essa abbia una naturale e specifica vocazione alla genealogia; e che in questa genealogia, nei suoi gangli più o meno pieni, più o meno mancanti, essa cerchi naturalmente i caratteri principali, non filosofici appunto, della sua estroflessione. [...] Mario Tronti ha icasticamente riassunto che l’Italian Thought si identifica con “un pensiero che si è radicato in questo Paese, in questa ‘forma-nazione’, ancor prima che diventasse una vera e propria nazione o uno Stato.” (Lisciani-Petrini - Strummiello 2017, p. 41) Questa specificità del pensiero italiano, del suo quadro, diciamo così, debolmente istituzionale, imprime già una direzione precisa alla nostra indagine, perché, a guardare allo specifico della storia italiana, è facile, a tutta prima, sottolineare come, in assenza di istituzioni politiche forti e consolidate, sia stato il discorso linguistico e letterario a costruire, immaginare, depositare elementi di identità ben prima che un processo, più culturale che politico-sociale come il Risorgimento (Banti 1991), portasse alla formazione di quella particolare comunità immaginata (Anderson 1991) che è stata chiamata “nazione italiana”. Se un libro-fondatore questa immaginata nazione può rivendicare, questo è un libro di letteratura: o meglio, di storia della letteratura. Ed è la Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis (1996). Ne consegue, dunque, abbastanza chiaramente che sia il “letterario” a poter rivendicare un primato, un certo tipo di primato, se non come oggetto, certamente come spazio di esercizio della estroflessione dell’Italian Thought. Con delle avvertenze, tuttavia, e più d’una.
«Dante che dovea essere il principio di tutta una letteratura, ne fu la fine». Questa frase di De Sanctis rappresenta il carattere paradossale di un diagramma che si pretende ascendente - dalla fondazione di un canone linguistico-letterario con le “tre corone” alla creazione di uno stato - ma che è intimamente mosso da una decadenza e da un continuo chiaroscuro dovuta a scissioni molteplici. Gli storici della letteratura più acuti ne hanno assunto questo dato in senso letteralmente progressivo, e a ragione. Uno per tutti: Alberto Asor Rosa, che, introducendo l’impresa einaudiana della Letteratura italiana, affermava:
- “è vero: si tratta di una letteratura di scarsissima coscienza nazionale, che oscilla, combinandoli insieme con sapienza estrema, tra comunalismo e cosmopolitismo (come le rimproverava, infatti, il descanctisiano Gramsci). Ma, ove non si sia accecati dalla prospettiva della storia politico-ideologica della nazione italiana, non si può fare a meno di vedere che proprio questa misconoscenza del dato nazionale consente ai letterati italiani di questa lunga fase la brillantezza e la modernità dei risultati raggiunti. [...] La debolezza delle istituzioni politiche e le carenze del ceto politico-intellettuale stimolano nel letterato italiano una vocazione alla supplenza, che spesso però, come s’è detto, non esclude la persistenza nell’uso di codici estremamente sofisticati ed élitari. Si potrebbe dire che, paradossalmente, il letterato italiano pretende di fare il politico senza rinunziare ad essere retore.” (Asor Rosa 1982, p. 23, 27)
Per non dire di Carlo Dionisotti, che in un articolo d’avanguardia (del 1951!) mise in discussione, di quel diagramma, anche l’unico centro linguistico-culturale, e cioè la Toscana, proponendo prima un paradigma doppio, in cui il primato toscano risultava in conflitto con centri antagonisti (uno alla volta: Dionisotti 1967); optando pochi anni dopo (nel 1971) per un sistema ancora più complesso, che
- “in parte e fino a un certo segno è regionale, e in parte, al di sotto del Po e in tutta l’Italia centrale, serba ancora, semplificata, la vecchia struttura municipale, in parte, al sud, mantiene intatta la l’originaria struttura della monarchia feudale, passata di mano in mano dai Normanni agli Svevi, agli Angioini di Francia e finalmente agli Aragonesi di Spagna. Resta insomma un sistema, per la sua complessità e per la sua disparità, delicato e fragile nell’insieme e nelle singole parti, ma per ciò stesso un sistema aperto alla sperimentazione e collaborazione letteraria. Anche e in specie alla collaborazione letteraria. ” (Dionisotti 2009, p. 449)
I due nomi - Carlo Dionisotti e Alberto Asor Rosa - di due critici letterari valgano come particolarmente esemplari anche di una traiettoria critica e di un punto di vista originali: il primo formulato a distanza, dall’estero, perché Dionisotti lasciò l’Italia e sviluppò la sua carriera perlopiù a Londra; il secondo tipicamente operaista, quindi coscientemente estraneo all’eredità gramsciana (passata al vaglio della vulgata togliattiana) e storicista. Vale la pena di ricordare questi elementi di biografia intellettuale e politica perché ci servono anche a misurare l’innovazione che soprattutto Esposito ha dato alla direzione del dibattito. In Dionisotti e Asor Rosa il riconoscimento dell’eccezione italiana giunge nella fase matura di un percorso che tendeva a vedere quei caratteri come fortemente regressivi se comparati alle grandi tradizioni nazionali, soprattutto francese e inglese. Il caso di Scrittori e popolo di Asor Rosa, pubblicato poco più di 50 anni fa, è particolarmente significativo: la letteratura contemporanea italiana era travolta quasi interamente da un vizio d’origine, il “populismo”, la cui ombra si dilungava dai grandi risorgimentali a Gramsci. La provocazione verso un’intera generazione di intellettuali cresciuti all’ombra della “via italiana al socialismo” con il suo corollario gramsciano, più malinteso che reale, del nazional-popolare, era evidente. Esposito sposta evidentemente l’ago della bilancia del ragionamento, quando riassume:
- “diversamente da culture filosofiche fin dall’inizio segnate dal rapporto con un’istituzione politica già forte e consolidata, come l’Inghilterra di Hobbes, ma anche la Francia di Cartesio; diversamente anche da tradizioni di pensiero impegnate nella costruzione di un sapere dello Stato, come la Germania di Hegel, l’Italia pensa la politica nella sua dimensione prestatale e anche, a volte, di resistenza allo stato.” (Esposito 2010, p. 22)
In altri termini, l’Italian thought non contribuisce a definire o irrigidire una identità italiana. E questo non solo perché, come è stato ampiamento chiarito (Esposito 2016) esso non può risolversi in un tutto che neutralizza le differenze al suo interno; per non dire, che, se così fosse, saremmo di fronte a una dogmatica più che a una theory, che invece si deve caratterizzare per una programmatica deterritorializzazione. Il motivo principale sta nel fatto che questa tendenza all’estroflessione e al “fuori” non possono che disfare un discorso di identità (italiana o altra che sia). L’Italian Thought, come theory in lingua italiana, si ritaglia uno spazio differente sia dalla brandizzazione dell’italianità (con il Made in Italy) sia dal ripiegamento identitario: entrambi processi risultanti, evidentemente, dalla globalizzazione, alla quale il pensiero italiano si presenta costitutivamente alternativo.
 Ne risulta un sistema simbolico in tensione, in cui confliggono in maniera eclatante l’auto-percezione negativa che deriva dall’immagine del paese «mancato», maggioritario nel discorso più o meno pubblico nonché nella storiografia letteraria, e una costruzione positiva, al limite dell’apologetico, diffusa fuori dei confini nazionali. Di tale contrasto paradossale è “figura” - in senso biblico - il personaggio del «cervello in fuga», dell’intellettuale esiliato ed apolide che trova fuori d’Italia lo spazio per sviluppare il proprio talento, illuminando a ritroso il capitale culturale di partenza, che risulta impossibile da contenere nello spazio del paese, essenzialmente in ragione delle conseguenze di quello «sviluppo senza progresso» mostrato da Pasolini all’alba di quello che, un tempo, si era chiamato «neocapitalismo». [...]
Ne risulta un sistema simbolico in tensione, in cui confliggono in maniera eclatante l’auto-percezione negativa che deriva dall’immagine del paese «mancato», maggioritario nel discorso più o meno pubblico nonché nella storiografia letteraria, e una costruzione positiva, al limite dell’apologetico, diffusa fuori dei confini nazionali. Di tale contrasto paradossale è “figura” - in senso biblico - il personaggio del «cervello in fuga», dell’intellettuale esiliato ed apolide che trova fuori d’Italia lo spazio per sviluppare il proprio talento, illuminando a ritroso il capitale culturale di partenza, che risulta impossibile da contenere nello spazio del paese, essenzialmente in ragione delle conseguenze di quello «sviluppo senza progresso» mostrato da Pasolini all’alba di quello che, un tempo, si era chiamato «neocapitalismo». [...]Nel suo andirivieni, tra ricezione fuori d’Italia e sua rielaborazione all’interno dei confini nazionali, l’Italian Thought supera questa dicotomia, assume l’oscillazione continua di questo sistema simbolico tra origine e storia, mettendo continuamente in discussione il presente e assumendo un’ottica di contestazione; Daniele Balicco ha recentemente trascinato questa oscillazione sul lato più scivoloso, se si vuole, ragionando sul Made in Italy con spregiudicatezza, sottraendolo all’univocità della già ricordata brandizzazione neoliberale e infine mostrandone la potenziale narrazione contro-egemonica che si sottrae alla performatività con la godibilità (Balicco 2016). [...]
 Nel libro, si è interrogato questo sistema simbolico in tensione rinunciando programmaticamente a dare centralità agli autori “maggiori”, non solo perché essi (in special modo Dante e Leopardi) sono stati già scandagliati in questo senso; si è voluto, piuttosto, verificare e dare spessore a linee convergenti di contestazione che sono la cifra caratteristica sia del momento genetico della tradizione letteraria, nell’età di Dante, sia della sua vicenda specificamente moderna e contemporanea. In tutte queste indagini, emerge il nodo che evocavo all’inizio: quella predisposizione alla genealogia che, nell’Italian Thought, si intreccia in maniera fortissima con quella persistenza del mito nella storia, dell’arcaicità che destruttura l’attualità; questa genealogia qui finalmente si allarga: Machiavelli, che è quasi un problematico “fondatore”, non solo qui è assente, ma la genealogia si confonde forzosamente con la ricerca di un’origine, o meglio di una genesi.
Nel libro, si è interrogato questo sistema simbolico in tensione rinunciando programmaticamente a dare centralità agli autori “maggiori”, non solo perché essi (in special modo Dante e Leopardi) sono stati già scandagliati in questo senso; si è voluto, piuttosto, verificare e dare spessore a linee convergenti di contestazione che sono la cifra caratteristica sia del momento genetico della tradizione letteraria, nell’età di Dante, sia della sua vicenda specificamente moderna e contemporanea. In tutte queste indagini, emerge il nodo che evocavo all’inizio: quella predisposizione alla genealogia che, nell’Italian Thought, si intreccia in maniera fortissima con quella persistenza del mito nella storia, dell’arcaicità che destruttura l’attualità; questa genealogia qui finalmente si allarga: Machiavelli, che è quasi un problematico “fondatore”, non solo qui è assente, ma la genealogia si confonde forzosamente con la ricerca di un’origine, o meglio di una genesi.Ci porta a questo la scelta di un fuori letterario, che esige soprattutto il definirsi di uno spazio linguistico autonomo, che i filologi chiamano “volgare”, che sarà l’italiano. In questo senso, sullo sfondo del volume, resta sottinteso, ma fortemente presente, il nesso con la tormentata “questione della lingua”, sempre legata, per richiamare di nuovo Gramsci, alla “formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale” (Gramsci 1975, 2346). Si tratta di un paesaggio esso stesso tipicamente in tensione, di tipo spiccatamente italianistico e che dà conto dello svolgersi delle peculiarità dell’Italian Thought: dallo sforzo di teorizzazione di Dante alla discussione sulla lingua cortigiana in Machiavelli, l’ossessione dello scrittore è meno l’italiano e più chi lo possa misurare, permettere, sviluppare. Più del linguistico, conta il politico. Non sorprenderà, dunque, che lo stesso concetto di italiano in senso moderno si trovi usato, per la prima volta, da Brunetto Latini (nella generazione precedente a Dante) in francese, in particolare per intendere la politica “selonc les usages as Ytaliens” (“secondo gli usi degli italiani”.) Siamo negli anni ’60 del ‘200: a significare anche che, se spazio per l’Italian Thought ci può essere, esso debba essere concepito anzitutto in maniera linguistica all’italiana, cioè in senso ospitale e plurilingue (Montefusco 2016).
Riferimenti bibliografici
Anderson, Benedict
1991, Comunità immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi, Roma-Bari, Laterza.
Asor Rosa, Alberto
1982, Letteratura italiana, I. Il letterato e le istituzioni, Torino, Einaudi.
2015 Scrittori e popolo 1965. Scrittori e massa 2015, Torino, Einaudi.
Balicco, Daniele
2016 Made in Italy e cultura. Indagine sull’identità italiana contemporanea, Palumbo, Palermo.
Banti, Aldo Maria
2011 Nel nome dell’Italia, Rome-Bari, Laterza.
De Sanctis, Francesco
1996 Storia della letteratura italiana, a cura di N. Gallo, intr. di G. Ficara, Torino, Einaudi-Gallimard.
Dionisotti, Carlo
1967 Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi.
2009, Scritti di storia della letteratura italiana. II 1963-1971, éd. par T. Basile, V. Fera, S. Villari, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura.
Esposito, Roberto
2010 Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino.
2016 Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Torino, Einaudi.
Foucault, Michel
1977 Microfisica del potere, Einaudi, Torino.
Gentili, Dario
2012 Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, il Mulino, Bologna.
Gentili, Dario - Stimilli, Elettra (a cura di)
2015 Differenze italiane, Roma, DeriveApprodi.
Gramsci, Antonio
1975, Quaderni dal carcere, Torino, Einaudi
Montefusco, Antonio
2016 Dal plurilinguismo all’ospitalità. Appunti sull’italiano (neo-epico e no), in “Nuova Rivista Letteraria”, vol. 4, pp. 43-49.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
SPIRITO CRITICO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ...
 IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO.
IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO.Federico La Sala
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE ("charitas"). --- BRUNETTO LATINI E UNA "ITALIA SENZA NAZIONE" (di Antonio Montefusco).28 giugno 2019, di Federico La Sala
ITALIA SENZA NAZIONE
di Antonio Montefusco (Le parole e le cose, 24 giugno 2019)
- [E’ appena uscito per Quodlibet Italia senza nazione. Lingue, culture, conflitti tra Medioevo ed età contemporanea, a cura di Antonio Montefusco. Ne presentiamo l’introduzione].
- “La storia ha di meglio da fare che essere la serva della filosofia e raccontare la nascita necessaria della verità e del valore; deve essere la conoscenza differenziale delle energie e dei cedimenti, delle sommità e dei crolli, dei veleni e degli antidoti. Deve essere la scienza dei rimedi” (Foucault 1977, pp. 29-54)
Il libro Italia senza nazione ha l’ambizione di indagare, seppure parzialmente, il «non filosofico» che, secondo la ricostruzione di Roberto Esposito, costituisce il proprium dell’indagine filosofica della tradizione italiana: una «propensione» che è sentita come «singolare», quindi costitutiva di tale tradizione. L’origine di questa pratica di estroflessione del pensiero italiano deriva da due elementi: la connessione tra vita, politica e storia, da una parte e l’esigenza insopprimibile di evocare un’origine in ogni discorso sull’attualità, dall’altra. (Esposito 2010) Si può dire, dunque, che essa abbia una naturale e specifica vocazione alla genealogia; e che in questa genealogia, nei suoi gangli più o meno pieni, più o meno mancanti, essa cerchi naturalmente i caratteri principali, non filosofici appunto, della sua estroflessione. [...] Mario Tronti ha icasticamente riassunto che l’Italian Thought si identifica con “un pensiero che si è radicato in questo Paese, in questa ‘forma-nazione’, ancor prima che diventasse una vera e propria nazione o uno Stato.” (Lisciani-Petrini - Strummiello 2017, p. 41) Questa specificità del pensiero italiano, del suo quadro, diciamo così, debolmente istituzionale, imprime già una direzione precisa alla nostra indagine, perché, a guardare allo specifico della storia italiana, è facile, a tutta prima, sottolineare come, in assenza di istituzioni politiche forti e consolidate, sia stato il discorso linguistico e letterario a costruire, immaginare, depositare elementi di identità ben prima che un processo, più culturale che politico-sociale come il Risorgimento (Banti 1991), portasse alla formazione di quella particolare comunità immaginata (Anderson 1991) che è stata chiamata “nazione italiana”. Se un libro-fondatore questa immaginata nazione può rivendicare, questo è un libro di letteratura: o meglio, di storia della letteratura. Ed è la Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis (1996). Ne consegue, dunque, abbastanza chiaramente che sia il “letterario” a poter rivendicare un primato, un certo tipo di primato, se non come oggetto, certamente come spazio di esercizio della estroflessione dell’Italian Thought. Con delle avvertenze, tuttavia, e più d’una.
«Dante che dovea essere il principio di tutta una letteratura, ne fu la fine». Questa frase di De Sanctis rappresenta il carattere paradossale di un diagramma che si pretende ascendente - dalla fondazione di un canone linguistico-letterario con le “tre corone” alla creazione di uno stato - ma che è intimamente mosso da una decadenza e da un continuo chiaroscuro dovuta a scissioni molteplici. Gli storici della letteratura più acuti ne hanno assunto questo dato in senso letteralmente progressivo, e a ragione. Uno per tutti: Alberto Asor Rosa, che, introducendo l’impresa einaudiana della Letteratura italiana, affermava:
- “è vero: si tratta di una letteratura di scarsissima coscienza nazionale, che oscilla, combinandoli insieme con sapienza estrema, tra comunalismo e cosmopolitismo (come le rimproverava, infatti, il descanctisiano Gramsci). Ma, ove non si sia accecati dalla prospettiva della storia politico-ideologica della nazione italiana, non si può fare a meno di vedere che proprio questa misconoscenza del dato nazionale consente ai letterati italiani di questa lunga fase la brillantezza e la modernità dei risultati raggiunti. [...] La debolezza delle istituzioni politiche e le carenze del ceto politico-intellettuale stimolano nel letterato italiano una vocazione alla supplenza, che spesso però, come s’è detto, non esclude la persistenza nell’uso di codici estremamente sofisticati ed élitari. Si potrebbe dire che, paradossalmente, il letterato italiano pretende di fare il politico senza rinunziare ad essere retore.” (Asor Rosa 1982, p. 23, 27)
Per non dire di Carlo Dionisotti, che in un articolo d’avanguardia (del 1951!) mise in discussione, di quel diagramma, anche l’unico centro linguistico-culturale, e cioè la Toscana, proponendo prima un paradigma doppio, in cui il primato toscano risultava in conflitto con centri antagonisti (uno alla volta: Dionisotti 1967); optando pochi anni dopo (nel 1971) per un sistema ancora più complesso, che
- “in parte e fino a un certo segno è regionale, e in parte, al di sotto del Po e in tutta l’Italia centrale, serba ancora, semplificata, la vecchia struttura municipale, in parte, al sud, mantiene intatta la l’originaria struttura della monarchia feudale, passata di mano in mano dai Normanni agli Svevi, agli Angioini di Francia e finalmente agli Aragonesi di Spagna. Resta insomma un sistema, per la sua complessità e per la sua disparità, delicato e fragile nell’insieme e nelle singole parti, ma per ciò stesso un sistema aperto alla sperimentazione e collaborazione letteraria. Anche e in specie alla collaborazione letteraria. ” (Dionisotti 2009, p. 449)
I due nomi - Carlo Dionisotti e Alberto Asor Rosa - di due critici letterari valgano come particolarmente esemplari anche di una traiettoria critica e di un punto di vista originali: il primo formulato a distanza, dall’estero, perché Dionisotti lasciò l’Italia e sviluppò la sua carriera perlopiù a Londra; il secondo tipicamente operaista, quindi coscientemente estraneo all’eredità gramsciana (passata al vaglio della vulgata togliattiana) e storicista. Vale la pena di ricordare questi elementi di biografia intellettuale e politica perché ci servono anche a misurare l’innovazione che soprattutto Esposito ha dato alla direzione del dibattito. In Dionisotti e Asor Rosa il riconoscimento dell’eccezione italiana giunge nella fase matura di un percorso che tendeva a vedere quei caratteri come fortemente regressivi se comparati alle grandi tradizioni nazionali, soprattutto francese e inglese. Il caso di Scrittori e popolo di Asor Rosa, pubblicato poco più di 50 anni fa, è particolarmente significativo: la letteratura contemporanea italiana era travolta quasi interamente da un vizio d’origine, il “populismo”, la cui ombra si dilungava dai grandi risorgimentali a Gramsci. La provocazione verso un’intera generazione di intellettuali cresciuti all’ombra della “via italiana al socialismo” con il suo corollario gramsciano, più malinteso che reale, del nazional-popolare, era evidente. Esposito sposta evidentemente l’ago della bilancia del ragionamento, quando riassume:
- “diversamente da culture filosofiche fin dall’inizio segnate dal rapporto con un’istituzione politica già forte e consolidata, come l’Inghilterra di Hobbes, ma anche la Francia di Cartesio; diversamente anche da tradizioni di pensiero impegnate nella costruzione di un sapere dello Stato, come la Germania di Hegel, l’Italia pensa la politica nella sua dimensione prestatale e anche, a volte, di resistenza allo stato.” (Esposito 2010, p. 22)
In altri termini, l’Italian thought non contribuisce a definire o irrigidire una identità italiana. E questo non solo perché, come è stato ampiamento chiarito (Esposito 2016) esso non può risolversi in un tutto che neutralizza le differenze al suo interno; per non dire, che, se così fosse, saremmo di fronte a una dogmatica più che a una theory, che invece si deve caratterizzare per una programmatica deterritorializzazione. Il motivo principale sta nel fatto che questa tendenza all’estroflessione e al “fuori” non possono che disfare un discorso di identità (italiana o altra che sia). L’Italian Thought, come theory in lingua italiana, si ritaglia uno spazio differente sia dalla brandizzazione dell’italianità (con il Made in Italy) sia dal ripiegamento identitario: entrambi processi risultanti, evidentemente, dalla globalizzazione, alla quale il pensiero italiano si presenta costitutivamente alternativo.
 Ne risulta un sistema simbolico in tensione, in cui confliggono in maniera eclatante l’auto-percezione negativa che deriva dall’immagine del paese «mancato», maggioritario nel discorso più o meno pubblico nonché nella storiografia letteraria, e una costruzione positiva, al limite dell’apologetico, diffusa fuori dei confini nazionali. Di tale contrasto paradossale è “figura” - in senso biblico - il personaggio del «cervello in fuga», dell’intellettuale esiliato ed apolide che trova fuori d’Italia lo spazio per sviluppare il proprio talento, illuminando a ritroso il capitale culturale di partenza, che risulta impossibile da contenere nello spazio del paese, essenzialmente in ragione delle conseguenze di quello «sviluppo senza progresso» mostrato da Pasolini all’alba di quello che, un tempo, si era chiamato «neocapitalismo». [...]
Ne risulta un sistema simbolico in tensione, in cui confliggono in maniera eclatante l’auto-percezione negativa che deriva dall’immagine del paese «mancato», maggioritario nel discorso più o meno pubblico nonché nella storiografia letteraria, e una costruzione positiva, al limite dell’apologetico, diffusa fuori dei confini nazionali. Di tale contrasto paradossale è “figura” - in senso biblico - il personaggio del «cervello in fuga», dell’intellettuale esiliato ed apolide che trova fuori d’Italia lo spazio per sviluppare il proprio talento, illuminando a ritroso il capitale culturale di partenza, che risulta impossibile da contenere nello spazio del paese, essenzialmente in ragione delle conseguenze di quello «sviluppo senza progresso» mostrato da Pasolini all’alba di quello che, un tempo, si era chiamato «neocapitalismo». [...]Nel suo andirivieni, tra ricezione fuori d’Italia e sua rielaborazione all’interno dei confini nazionali, l’Italian Thought supera questa dicotomia, assume l’oscillazione continua di questo sistema simbolico tra origine e storia, mettendo continuamente in discussione il presente e assumendo un’ottica di contestazione; Daniele Balicco ha recentemente trascinato questa oscillazione sul lato più scivoloso, se si vuole, ragionando sul Made in Italy con spregiudicatezza, sottraendolo all’univocità della già ricordata brandizzazione neoliberale e infine mostrandone la potenziale narrazione contro-egemonica che si sottrae alla performatività con la godibilità (Balicco 2016). [...]
 Nel libro, si è interrogato questo sistema simbolico in tensione rinunciando programmaticamente a dare centralità agli autori “maggiori”, non solo perché essi (in special modo Dante e Leopardi) sono stati già scandagliati in questo senso; si è voluto, piuttosto, verificare e dare spessore a linee convergenti di contestazione che sono la cifra caratteristica sia del momento genetico della tradizione letteraria, nell’età di Dante, sia della sua vicenda specificamente moderna e contemporanea. In tutte queste indagini, emerge il nodo che evocavo all’inizio: quella predisposizione alla genealogia che, nell’Italian Thought, si intreccia in maniera fortissima con quella persistenza del mito nella storia, dell’arcaicità che destruttura l’attualità; questa genealogia qui finalmente si allarga: Machiavelli, che è quasi un problematico “fondatore”, non solo qui è assente, ma la genealogia si confonde forzosamente con la ricerca di un’origine, o meglio di una genesi.
Nel libro, si è interrogato questo sistema simbolico in tensione rinunciando programmaticamente a dare centralità agli autori “maggiori”, non solo perché essi (in special modo Dante e Leopardi) sono stati già scandagliati in questo senso; si è voluto, piuttosto, verificare e dare spessore a linee convergenti di contestazione che sono la cifra caratteristica sia del momento genetico della tradizione letteraria, nell’età di Dante, sia della sua vicenda specificamente moderna e contemporanea. In tutte queste indagini, emerge il nodo che evocavo all’inizio: quella predisposizione alla genealogia che, nell’Italian Thought, si intreccia in maniera fortissima con quella persistenza del mito nella storia, dell’arcaicità che destruttura l’attualità; questa genealogia qui finalmente si allarga: Machiavelli, che è quasi un problematico “fondatore”, non solo qui è assente, ma la genealogia si confonde forzosamente con la ricerca di un’origine, o meglio di una genesi.Ci porta a questo la scelta di un fuori letterario, che esige soprattutto il definirsi di uno spazio linguistico autonomo, che i filologi chiamano “volgare”, che sarà l’italiano. In questo senso, sullo sfondo del volume, resta sottinteso, ma fortemente presente, il nesso con la tormentata “questione della lingua”, sempre legata, per richiamare di nuovo Gramsci, alla “formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale” (Gramsci 1975, 2346). Si tratta di un paesaggio esso stesso tipicamente in tensione, di tipo spiccatamente italianistico e che dà conto dello svolgersi delle peculiarità dell’Italian Thought: dallo sforzo di teorizzazione di Dante alla discussione sulla lingua cortigiana in Machiavelli, l’ossessione dello scrittore è meno l’italiano e più chi lo possa misurare, permettere, sviluppare. Più del linguistico, conta il politico. Non sorprenderà, dunque, che lo stesso concetto di italiano in senso moderno si trovi usato, per la prima volta, da Brunetto Latini (nella generazione precedente a Dante) in francese, in particolare per intendere la politica “selonc les usages as Ytaliens” (“secondo gli usi degli italiani”.) Siamo negli anni ’60 del ‘200: a significare anche che, se spazio per l’Italian Thought ci può essere, esso debba essere concepito anzitutto in maniera linguistica all’italiana, cioè in senso ospitale e plurilingue (Montefusco 2016).
Riferimenti bibliografici
Anderson, Benedict
1991, Comunità immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi, Roma-Bari, Laterza.
Asor Rosa, Alberto
1982, Letteratura italiana, I. Il letterato e le istituzioni, Torino, Einaudi.
2015 Scrittori e popolo 1965. Scrittori e massa 2015, Torino, Einaudi.
Balicco, Daniele
2016 Made in Italy e cultura. Indagine sull’identità italiana contemporanea, Palumbo, Palermo.
Banti, Aldo Maria
2011 Nel nome dell’Italia, Rome-Bari, Laterza.
De Sanctis, Francesco
1996 Storia della letteratura italiana, a cura di N. Gallo, intr. di G. Ficara, Torino, Einaudi-Gallimard.
Dionisotti, Carlo
1967 Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi.
2009, Scritti di storia della letteratura italiana. II 1963-1971, éd. par T. Basile, V. Fera, S. Villari, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura.
Esposito, Roberto
2010 Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino.
2016 Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Torino, Einaudi.
Foucault, Michel
1977 Microfisica del potere, Einaudi, Torino.
Gentili, Dario
2012 Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, il Mulino, Bologna.
Gentili, Dario - Stimilli, Elettra (a cura di)
2015 Differenze italiane, Roma, DeriveApprodi.
Gramsci, Antonio
1975, Quaderni dal carcere, Torino, Einaudi
Montefusco, Antonio
2016 Dal plurilinguismo all’ospitalità. Appunti sull’italiano (neo-epico e no), in “Nuova Rivista Letteraria”, vol. 4, pp. 43-49.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
SPIRITO CRITICO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ...
 IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO.
IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO.Federico La Sala
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA -- Come sapevano bene Dante, Machiavelli e Leopardi. Ma quale Patria? Si chiama Matria ed è la nostra lingua. (di M. Cacciari).7 maggio 2019, di Federico La Sala
L’OCCUPAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LINGUA ITALIANA: L’ITALIA E LA VERGOGNA.... *
Ma quale Patria? Si chiama Matria ed è la nostra lingua
Dalla nostalgia di Enea per la terra perduta alle radici dell’Europa la vera appartenenza è nell’idioma. Come sapevano bene Dante, Machiavelli e Leopardi. Una dimora che va difesa da chi oggi la vuole ridurre a chiacchiera
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 07.05.2019)
Dove trovare la Patria? Dove porre sede e finalmente cessare di inseguirla? È questa la domanda di Enea da cui si origina l’Europa - domanda forse ormai totalmente dimenticata. Gli dèi hanno decretato che per l’eroe sarà l’Italia questa patria. Ma l’Italia gli fugge sempre. All’eroe fuggitivo risponde l’Italia che fugge. Come agli eroi avvenire fuggirà l’Europa: Dove essa inizia? Dove finisce? Quante nazioni la abitano? Quali radici la sostengono? O il suo demone consiste proprio nel non averle, nel non potersi su nulla radicare? Aveva, sì, Patria Enea, anzi: la Patria, Troia. Ilio sacra è l’immagine della città perfetta, governata dal Re giusto e buono, abitata da chi ritiene massima virtù morire per la sua salvezza.
Enea avrebbe desiderato rimanere sulle sue rovine piuttosto che affrontare il destino di inseguire l’Italia. Anche le macerie di Troia sarebbero state per lui "più" Patria di qualsiasi altra futura. Ma la Patria è stata distrutta dagli Achei, dal potente connubio di astuzia e violenza che ne caratterizza l’esercito, una massa sradicata dai propri paesi, da anni lontana da ogni domestico affetto. Molti di loro non faranno ritorno, il più grande muore esule sotto le mura di Ilio; chi li ha guidati a costo di sacrificare la figlia viene assassinato appena mette piede in quella che pensava essere la propria dimora. Sciagurati eroi.
Con la fine di Ilio quella idea di Patria tramonta per sempre. Enea, tuttavia, fonda la nuova città mosso dalla nostalgia per essa, che lo domina. Senza la forza di tale nostalgia Roma non sarebbe mai sorta. Ma Roma non sarà Ilio, non ne conserverà la lingua, non sarà mai la città compiuta in sé, armoniosamente contenuta nei propri limiti; sarà invece la città-che-cresce, la città che-si-muove, Civitas augescens, Civitas mobilis, la città insaziabile, l’impero sine fine, la urbs che vuol farsi mondo. Anche Roma crolla - e anche di Roma dura la nostalgia, per la sua lingua, per il suo diritto, per le sue arti. Anche Roma diviene la Patria che manca. Come se vere Patrie apparissero sempre i luoghi che abbiamo perduto.
Nessuno ama la Patria più dell’esule da essa. Lo dice il coro delle donne troiane, che la prepotenza del vincitore trascina via schiave. Lo dice l’Ecuba euripidea, la grande accusatrice della follia dei mortali. Nel modo più tremendo lo mostra la straniera, la barbara, Medea. Sono le donne a soffrire inguaribilmente la distruzione o la perdita della Patria. Come se fossero strappate dal proprio stesso grembo. I maschi, invece, Enea, sono costretti a cercare altre terre e a convincersi che la Patria possa rinnovarsi. Ma anche per loro la nostalgia di Patria è tanto più forte e dolorosa quanto più l’avvertono smarrita. Tremendo è quando la nostalgia per la Patria che il destino ci ha rapito si combina con quella per un’altra impossibile. Fortunato Enea che alla fine la raggiunge, per quanto essa sia tale da non poter mai davvero sostituire l’antica. Vi è chi, invece, deve eternamente inseguire l’Italia che fugge.
Sventura tipica, sembra, delle nostre genti. Dante ha perduto la sua Firenze, che tanto più ama quanto più ne disprezza i nuovi padroni e costumi - e anela a un’Italia che sempre più gli appare irrealizzabile. Penoso è quando la terra che ti ha generato è stata distrutta o, peggio, ti è diventata straniera, e un’altra ne immagini, come anche salvezza della prima, continuamente contraddetta dalla realtà, fino ad apparire impossibile. La sorte di Dante si ripete in Machiavelli. E in quanti altri lungo tutta la nostra storia: il luogo della nostra origine è perduto, è divenuto irriconoscibile, oppure (Leopardi) è stato per noi sempre come un esilio, e la Patria, l’Italia, che abbiamo immaginato, sperato, pensato, resta ancora sempre da fare, un avvenire eterno. Ecco, quante volte la sua idea è sembrata realizzarsi, e subito dopo naufragare di nuovo.
Non resta forse altra vera Patria che la lingua. Lo dicono, in fondo, tutti i poeti esuli (Thomas Mann, ad esempio) nel tempo in cui le più grandi miserie si abbattono sui loro paesi. Abitare la lingua con tutta la cura possibile, questo ci è dato, coltivarla, arricchirla nel dialogo con altre, renderla sempre più capace di tradurle in sé. La lingua tanto più è ricca quanto più accoglie.
Cosi dovrebbe essere anche la Patria. Come la Patria non è un mezzo, uno strumento a nostra disposizione per perseguire i nostri, particolari fini, cosi non è un mezzo la lingua per informarci di questo o di quello. È pensiero, storia, cultura, e noi dobbiamo essere coloro che la trasformano custodendola.
La lingua è Matria, però, assai più che Patria; la lingua è materna. Dire che la nostra autentica Patria è la lingua significa affermare che nessuna Patria dovrà più essere a immagine del Padre Potente, della civiltà dominata dalla figura dell’onnipotenza del Padre Padrone. Sì, nella lingua è possibile dimora anche allorché naufraga la Patria.
Tuttavia anch’essa è dimora fragilissima. E, a differenza della Patria, i barbari che la minacciano stanno sempre all’interno dei suoi confini: sono coloro che la parlano facendone strame, che la riducono a frase e a chiacchiera, a strumento facilmente manipolabile, pronto per l’uso. Se resiste la Matria, la Patria non sarà mai impossibile, per quanto possa sempre apparire fuggitiva. Ma se la Madre lingua è perduta, allora la lingua che parleremo sarà comunque straniera e la vita un esilio.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI TROIA: L’ANALISI DI CARLO LEVI.
- TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
L’OCCUPAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LINGUA ITALIANA: L’ITALIA E LA VERGOGNA.
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza"
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE. Per una rilettura del "De Vulgari Eloquentia" e della "Monarchia" - "Io sono la mia lingua italiana" (di Pierfranco Bruni)..26 febbraio 2019, di Federico La Sala
"Lo scrittore ha il dovere di abitarsi nella propria lingua"
"Io sono la mia lingua italiana"
di Pierfranco Bruni (Portale Letterario, 26/02/2019)
La lingua italiana é l’espressione della cultura italiana. Così come ogni cultura é l’espressione di una lingua. Il percorso della lingua è un interfacciarsi con modelli di civiltà. Ormai è accertato che la lingua italiana occupa la quarta posizione tra le lingue del mondo. Un fatto non relativo e altamente positivo in un tempo in cui si cerca di recuperare anche la forma dialettale delle lingue, creando delle contaminazioni.
La lingua italiana, nata da un contaminato di linguaggi, diventa un punto fermo all’interno di quei processi culturali in cui la comunicazione del linguaggio è comunicazione antropologica, sociologica, linguistica, arrivando ad occupare un’interrelazione all’interno del contesto mondiale significativo.
Ho attraversato diversi percorsi visitando molti paesi, portando la lingua italiana nel mondo dal Sud America ai Paesi balcanici e mi sono reso conto che c’è stata sempre una forte simpatia e vicinanza non solo alla lingua italiana, ma soprattutto alla cultura italiana. Ciò significa che il modello greco-latino occidentale, sul piano culturale e linguistico, non solo è conosciuto ma studiato attentamente.
La storia di un popolo, di una civiltà, di una visione identitaria ha permesso di leggere tutta una realtà storica e linguistica. La realtà storica si forma sui processi culturali che, a loro volta, nascono da visioni e da interpretazioni linguistiche.
La lingua è comunicazione. Attraversare una lingua significa attraversare e conoscere una cultura.
La conoscenza di una lingua, o l’apparentamento nei confronti di una lingua, ci porta ad approfondire le radici di quella determinata lingua. Le radici della lingua italiana sono all’interno di un processo profondamente occidentale. La lingua italiana, al di là del dibattito sul “De vulgari eloquentia”, che ha permesso di sviluppare un percorso tra la lingua latina e la lingua volgare, ha dato il segno tangibile di come una lingua possa svilupparsi all’interno di una dimensione storica.
Il dibattito sulla lingua in Italia ha sempre tracciato e lasciato dei segni indelebili, dal 1200 - 1300 fino al percorso bembiano. Il Rinascimento nasce all’interno di una civiltà delle culture, ma anche attraverso il dibattito di Bembo sulla questione della centralità della lingua. Un processo che è possibile verificare anche nei secoli successivi.
La lingua barocca, che ha avuto origine all’interno del contesto lessicale semantico barocco, ha come dimensione le culture barocche che si sviluppano dal Regno di Napoli fino a tutta l’Europa e in seguito anche in Brasile. Si pensi al barocco brasiliano che parla il linguaggio che era del Regno di Napoli, fino ad arrivare al grande dibattito leopardiano sulla lingua contestualizzata nella temperie tra Leopardi e Manzoni.
Con Manzoni si unifica un concetto di lingua omogenea che non resterà mai tale, perché sono i dialetti che insistono. Ecco perché ho sempre sostenuto che la lingua italiana è il concentrato dei dialetti, quando il dialetto assume l’identità di una comunità.
L’attuale discussione sulla lingua italiana come quarta realtà comunicativa del mondo, lascia intendere che questa realtà ha assorbito tutte le dimensioni storiche, politiche di un Occidente che è stato un Occidente Mediterraneo italiano. Quando Cristoforo Colombo va nelle Americhe si porta dietro il dialetto genovese, il dialetto ligure, il dialetto veneziano e tutto un contesto pre-rinascimentale della cultura umanistica. Quindi, dentro questo rapporto tra cultura umanistica rinascimentale, porta nelle Americhe una storia che è quella della civiltà dell’Occidente e del Mediterraneo italiano.
Oggi si riscopre questa visione della lingua italiana e si riscopre, accanto alla lingua italiana, la cultura italiana. Si pensi alla letteratura. Alle grandi personalità che hanno disegnato la geografia culturale mondiale. Da Dante a Machiavelli. Da Machiavelli a D’Annunzio. Personalità che hanno parlato la lingua italiana pur attraverso le dimensioni del dialetto e si sono innescate all’interno di quelle realtà e nazioni che hanno avuto la volontà, la possibilità e la capacità di approfondire una comparazione o una contaminazioni di culture.
Non mi meraviglio affatto che la lingua italiana sia considerata la quarta lingua. Anzi, ritengo che possa essere considerata anche la seconda o terza lingua, perché la lingua non viaggia mai da sola, ma sempre accanto a delle definizioni a delle contestualizzazioni culturali. Dante è studiato in tutto il mondo, esattamente come Manzoni.
Queste particolarità sono parti integranti di un processo di civiltà. La cultura latina la troviamo dappertutto. Ovidio, per esempio, è la personalità che ha disegnato una dimensione ben definita all’interno di una visone culturale. Bisogna ragionare su questi aspetti e promuovere sempre più la cultura italiana nel mondo. È un dovere per uno scrittore rappresentare la propria appartenenza. Io mi caratterizzo attraverso la lingua che parlo.
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. --- Il dio greco dell’amore, nella mitologia, è quello più tragico in assoluto: non si capisce se sia un essere angelico oppure un demone (papa Francesco)21 febbraio 2019, di Federico La Sala
Catechesi sul “Padre nostro”: 7. Padre che sei nei cieli
di Papa Francesco *
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
L’udienza di oggi si sviluppa in due posti. Prima ho fatto l’incontro con i fedeli di Benevento, che erano in San Pietro, e adesso con voi. E questo è dovuto alla delicatezza della Prefettura della Casa Pontificia che non voleva che voi prendeste freddo: ringraziamo loro, che hanno fatto questo. Grazie.
Proseguiamo le catechesi sul “Padre nostro”. Il primo passo di ogni preghiera cristiana è l’ingresso in un mistero, quello della paternità di Dio. Non si può pregare come i pappagalli. O tu entri nel mistero, nella consapevolezza che Dio è tuo Padre, o non preghi. Se io voglio pregare Dio mio Padre incomincio il mistero. Per capire in che misura Dio ci è padre, noi pensiamo alle figure dei nostri genitori, ma dobbiamo sempre in qualche misura “raffinarle”, purificarle. Lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice così: «La purificazione del cuore concerne le immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella nostra storia personale e culturale, e che influiscono sulla nostra relazione con Dio» (n. 2779).
Nessuno di noi ha avuto genitori perfetti, nessuno; come noi, a nostra volta, non saremo mai genitori, o pastori, perfetti. Tutti abbiamo difetti, tutti. Le nostre relazioni di amore le viviamo sempre sotto il segno dei nostri limiti e anche del nostro egoismo, perciò sono spesso inquinate da desideri di possesso o di manipolazione dell’altro. Per questo a volte le dichiarazioni di amore si tramutano in sentimenti di rabbia e di ostilità. Ma guarda, questi due si amavano tanto la settimana scorsa, oggi si odiano a morte: questo lo vediamo tutti i giorni! E’ per questo, perché tutti abbiamo radici amare dentro, che non sono buone e alle volte escono e fanno del male.
Ecco perché, quando parliamo di Dio come “padre”, mentre pensiamo all’immagine dei nostri genitori, specialmente se ci hanno voluto bene, nello stesso tempo dobbiamo andare oltre. Perché l’amore di Dio è quello del Padre “che è nei cieli”, secondo l’espressione che ci invita ad usare Gesù: è l’amore totale che noi in questa vita assaporiamo solo in maniera imperfetta. Gli uomini e le donne sono eternamente mendicanti di amore, - noi siamo mendicanti di amore, abbiamo bisogno di amore - cercano un luogo dove essere finalmente amati, ma non lo trovano. Quante amicizie e quanti amori delusi ci sono nel nostro mondo; tanti!
Il dio greco dell’amore, nella mitologia, è quello più tragico in assoluto: non si capisce se sia un essere angelico oppure un demone. La mitologia dice che è figlio di Poros e di Penía, cioè della scaltrezza e della povertà, destinato a portare in sé stesso un po’ della fisionomia di questi genitori. Di qui possiamo pensare alla natura ambivalente dell’amore umano: capace di fiorire e di vivere prepotente in un’ora del giorno, e subito dopo appassire e morire; quello che afferra, gli sfugge sempre via (cfr Platone, Simposio, 203). C’è un’espressione del profeta Osea che inquadra in maniera impietosa la congenita debolezza del nostro amore: «Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all’alba svanisce» (6,4). Ecco che cos’è spesso il nostro amore: una promessa che si fatica a mantenere, un tentativo che presto inaridisce e svapora, un po’ come quando al mattino esce il sole e si porta via la rugiada della notte.
Quante volte noi uomini abbiamo amato in questa maniera così debole e intermittente. Tutti ne abbiamo l’esperienza: abbiamo amato ma poi quell’amore è caduto o è diventato debole. Desiderosi di voler bene, ci siamo poi scontrati con i nostri limiti, con la povertà delle nostre forze: incapaci di mantenere una promessa che nei giorni di grazia ci sembrava facile da realizzare. In fondo anche l’apostolo Pietro ha avuto paura e ha dovuto fuggire. L’apostolo Pietro non è stato fedele all’amore di Gesù. Sempre c’è questa debolezza che ci fa cadere. Siamo mendicanti che nel cammino rischiano di non trovare mai completamente quel tesoro che cercano fin dal primo giorno della loro vita: l’amore.
Però, esiste un altro amore, quello del Padre “che è nei cieli”. Nessuno deve dubitare di essere destinatario di questo amore. Ci ama. “Mi ama”, possiamo dire. Se anche nostro padre e nostra madre non ci avessero amato - un’ipotesi storica -, c’è un Dio nei cieli che ci ama come nessuno su questa terra ha mai fatto e potrà mai fare. L’amore di Dio è costante. Dice il profeta Isaia: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (49,15-16).
 Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio.
Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio.Nella fame d’amore che tutti sentiamo, non cerchiamo qualcosa che non esiste: essa è invece l’invito a conoscere Dio che è padre. La conversione di Sant’Agostino, ad esempio, è transitata per questo crinale: il giovane e brillante retore cercava semplicemente tra le creature qualcosa che nessuna creatura gli poteva dare, finché un giorno ebbe il coraggio di alzare lo sguardo. E in quel giorno conobbe Dio. Dio che ama.
L’espressione “nei cieli” non vuole esprimere una lontananza, ma una diversità radicale di amore, un’altra dimensione di amore, un amore instancabile, un amore che sempre rimarrà, anzi, che sempre è alla portata di mano. Basta dire “Padre nostro che sei nei Cieli”, e quell’amore viene.
Pertanto, non temere! Nessuno di noi è solo. Se anche per sventura il tuo padre terreno si fosse dimenticato di te e tu fossi in rancore con lui, non ti è negata l’esperienza fondamentale della fede cristiana: quella di sapere che sei figlio amatissimo di Dio, e che non c’è niente nella vita che possa spegnere il suo amore appassionato per te.
*
PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE -Aula Paolo VI
 Mercoledì, 20 febbraio 2019 (ripresa parziale).
Mercoledì, 20 febbraio 2019 (ripresa parziale). -
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. --- CON IL "DIO DI AMORE" DI OVIDIO E BRUNETTO LATINI AL"L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE".20 febbraio 2019, di Federico La Sala
-
>DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. --- Scoperta una nuova lettera di Dante che riscrive il suo esilio (di Anna Maria Liguori).17 ottobre 2018, di Federico La Sala
Scoperta una nuova lettera di Dante che riscrive il suo esilio
Trovata dal docente dell’università di Verona Paolo Pellegrini. Sarebbe stata scritta da lui la missiva che Cangrande della Scala inviò a Enrico VII. Quindi il sommo poeta era a Verona già nel 1312
di ANNA MARIA LIGUORI (la Repubblica, 17 ottobre 2018)
LA LETTERA che, nell’agosto del 1312, Cangrande della Scala, signore di Verona, inviò al novello imperatore Enrico VII, con altissima probabilità fu opera della mente di Dante Alighieri. La scoperta potrebbe non solo portare al pubblico un nuovo scritto dantesco, che andrebbe ad arricchire il corpus delle sue opere, ma dimostrerebbe che Dante rimase a Verona molto più a lungo di quanto si pensasse, rendendo la città scaligera la dimora in cui il Sommo Poeta soggiornò più a lungo, dopo Firenze.
L’intuizione è di Paolo Pellegrini, docente di Filologia e linguistica italiana all’università di Verona. "La lettera, che era già stata pubblicata un paio di volte in passato - spiega Pellegrini - proviene da una raccolta di testi, presi come esempio del buon scrivere, che il notaio e maestro di ars dictaminis (ossia l’arte di scrivere lettere) Pietro dei Boattieri, attivo a Bologna tra Due e Trecento, aveva incluso in un codice confluito più tardi in un manoscritto, oggi conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze (il Magliabechiano II IV 312)". Scoperta una nuova lettera di Dante che riscrive il suo esilio
"In essa Cangrande della Scala denunciava all’imperatore Enrico VII i gravi dissensi sorti all’interno dei sostenitori dell’Impero: Filippo d’Acaia, nipote dell’imperatore e vicario imperiale di Pavia, Vercelli e Novara, e Werner von Homberg, capitano generale della Lombardia, erano venuti alle mani e solo il tempestivo intervento dei presenti aveva evitato un tragico epilogo. Cangrande manifestava all’Imperatore tutta la propria preoccupazione, invitandolo a riportare la pace e la concordia prima che altre membra del corpo imperiale si sollevassero le une contro le altre armate". Si trattava dunque di una missiva delicatissima, la cui stesura Cangrande non avrebbe certo affidato a chiunque, era logico che si servisse della migliore penna a disposizione. Poteva questa essere quella di Dante, tanto amico del signore di Verona, al punto di riservagli un altissimo elogio nel canto XVII del Paradiso?
"Da un’attenta analisi del testo della lettera, dei suoi riferimenti e degli stilemi linguistici, appare evidente come la probabilità che l’abbia scritta Dante sia altissima - prosegue Pellegrini - In essa è inserito un richiamo ai passi di due Variae di Cassiodoro che Dante aveva già utilizzato più di una volta. Nell’arenga del 1306, nell’epistola "Ai signori d’Italia" e più ancora nell’esordio di un atto di pace stipulato nell’ottobre del 1306 in Lunigiana che vede il poeta comparire in prima persona, in qualità di procuratore dei Malaspina".
"E infine, ma si potrebbe continuare, nella lettera di Cangrande, i malvagi responsabili delle discordie imperiali vengono definiti "vasa scelerum", sintagma che non ha sostanziale riscontro nella latinità medievale indicizzata ma che non può non richiamare il "vasel d’ogni frodà" affibbiato a frate Gomita in Inferno XXII. Certo, nessun filologo ignora che le Variae di Cassiodoro era testo molto diffuso nel Medioevo.
Certo, la consistenza dei richiami intertestuali dovrà accompagnarsi a capillari verifiche sulle concordanze dantesche e sui più ampi corpora della latinità medievale; controlli doverosi andranno compiuti sul ritmo della prosa; soprattutto occorrerà procurare una nuova edizione della lettera riesaminando il manoscritto. È materia che darà lavoro nei prossimi mesi. Ma a mio avviso tutto ciò non farà altro che confermare quanto appare chiaro sin da questi primi assaggi: dovendo scrivere una lettera delicatissima all’imperatore Enrico VII, il suo vicario Cangrande della Scala si affidò alla penna di Dante Alighieri, l’unico che in quel momento a Verona poteva produrre uno stile tanto elevato".
Dante a Verona
Il recupero della lettera produce, inoltre, una serie di conseguenze rilevanti sul piano biografico, dimostrando che Dante abbia soggiornato a Verona per un lungo periodo, dal 1312 al 1320.
"Cadono in un colpo solo le ipotesi - formulate forse un pò troppo frettolosamente - che tra 1312 e il 1316 volevano Dante a Pisa o in Lunigiana, o addirittura lo immaginavano negli attendamenti imperiali tutto preso dalla stesura della Monarchia. Nell’estate del 1312 Dante si trovava già a Verona e se la Monarchia fu scritta a quest’epoca, fu scritta sotto l’occhio vigile di Cangrande. Andrà riesaminato il profilo culturale dello stesso Cangrande - prosegue Pellegrini, - eccessivamente appiattito, negli interventi più recenti, su una prospettiva che ne valorizza soprattutto i risvolti amministrativi e militari, a scapito forse di altri aspetti ugualmente importanti".
"Acquistano nuovo rilievo le affermazioni dell’umanista Leonardo Bruni, l’ultimo ad avere maneggiato autografi di Dante: nella biografia del poeta, Bruni affermava chiaramente che Dante non si trovava in Toscana allorché Enrico VII preparò l’assedio di Firenze, nel settembre 1312; di più, citava di prima mano lettere di Dante spedite da Verona e c’è da chiedersi da dove traesse tale l’indicazione se non proprio dalle lettere medesime. E poiché nel gennaio del 1320 Dante era a Verona per pronunziarvi la Questio de aqua et terra, ci sarà da chiedersi se il soggiorno non durasse proprio da quel lontano 1312, il che spiegherebbe l’altissimo elogio riservato a Cangrande nel Paradiso, l’encomio più nobile dedicato dal poeta a un vivente. Insomma, un capitolo intero della biografia dantesca avrà bisogno di una robusta riscrittura", conclude.
"Ma c’è di più. All’invocazione della pace, che peraltro attraversa anche molti altri scritti danteschi, segue, nell’epistola di Cangrande, l’esplicito richiamo all’ammonimento di Gesù secondo il quale ’Ogni regno diviso in se stesso va in rovina’ (Mt 12,25; Le 11,17). Anche nella Monarchia (I v 8) Dante additò la necessità di un unico re ai fini di una pacifica convivenza. Tornano dunque le parole chiave del "regnum" e della "tranquillitas" in sequenza con la citazione evangelica. Ma il binomio pace e tranquillità compariva già - quasi un’ossessione che perseguitasse il poeta nel suo penoso esilio - nell’epistola prima, che Dante scrisse a nome dei fuoriusciti fiorentini nella primavera del 1304".
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE -- CINA, La fortuna della "Divina Commedia" a Pechino: parla l’italianista Wen Zheng (di Leonetta Bentivoglio).10 settembre 2018, di Federico La Sala
Così Dante Alighieri entrò nel Pantheon di Mao Zedong
La fortuna della "Divina Commedia" a Pechino: parla l’italianista Wen Zheng
Nato a Pechino nel 1974, Wen Zheng è docente di lingua e letteratura italiana all’Università di Studi Internazionali di Pechino (BFSU) e ha tradotto in cinese, fra gli altri, Boccaccio, Calvino ed Eco. A Ravenna interverrà mercoledì 12 settembre
Intervista di Leonetta Bentivoglio (la Repubblica, 10.09.2018)
Per la neonata Cina comunista, Dante Alighieri rappresentò un vessillo ideologico e culturale. Formula quest’affermazione, che ai non-esperti richiede un salto acrobatico di prospettive geografiche e temporali, il grande italianista cinese Wen Zheng, il quale esporrà la tesi nel corso di un intervento su «Dante e le sue opere in Cina» dopodomani a Ravenna, in apertura della manifestazione "Dante2021".
Nato a Pechino nel 1974, Wen Zheng è docente di lingua e letteratura italiana all’Università di Studi Internazionali di Pechino e ha tradotto in cinese Boccaccio, Calvino ed Eco. In un libro su Lu Xun (1881-1936), fondatore della lingua cinese moderna, Wen Zheng dimostra come, anche attraverso la diffusione che ne fece Lu Xun, Dante sia entrato nel pensiero cinese d’inizio Novecento. Wen Zheng accetta di anticipare da Pechino i punti-chiave della sua conferenza.
Può spiegare il ruolo di Lu Xun nella letteratura cinese moderna e il suo nesso con Dante?
«Lu Xun è stato un sommo scrittore. Dalla fine dell’Impero al conflitto cino-giapponese e alle guerre civili che portarono alla Repubblica popolare, visse momenti cruciali della nostra storia e seppe trasformarli in vicende allegoriche. Ma soprattutto nel Diario di un pazzo, 1918, usò il cinese volgare detto baihua rigettando per la prima volta la lingua classica, così come a suo tempo Dante abbandonò il latino per la lingua volgare».
Si nutre di quest’analogia la relazione di Lu Xun con l’autore della "Commedia"?
«Sì. Nel saggio Sulla forza della poesia di Mára, Lu Xun esalta i poeti del romanticismo europeo e indica la centralità di Dante nella cultura italiana. Proprio mentre la Cina stava cercando una nuova identità, Lu Xun esprimeva l’idea che la creazione della lingua italiana da parte di Dante avesse costruito l’anima stessa del suo popolo».
È in quest’ottica che Dante condiziona la Cina del primo Novecento?
«Esatto. All’alba del secolo gli intellettuali cinesi cominciano a occuparsi del pensiero politico di Dante e del suo vigoroso spirito riformatore. Oltre a Lu Xun, coglie spunti da Dante lo scrittore Hu Shi (1891-1962), di posizione politica opposta rispetto a Lu Xun (Hu Shi emigrò negli Usa). In Proposte per la riforma della letteratura, del 1917, Hu Shi sostiene che la Cina, imitando l’Italia del quattordicesimo secolo, dovrebbe adottare la lingua volgare e generare un corpus di opere vive contro la letteratura classica ormai morta. Il suo riferimento è l’opera di Dante De vulgari eloquentia ».
Lu Xun fu il solo scrittore legittimo durante la Rivoluzione culturale. Perché?
«Era in linea con le concezioni di Mao Zedong, che in Discorsi su Lu Xun, del 1937, manifestava un pieno apprezzamento nei suoi confronti. La stima di Mao lo rese il grande letterato del proletariato cinese e si diceva che le sue opere fossero "un giavellotto e un pugnale lanciati verso i nemici". Oggi è stato ridimensionato il giudizio su di lui. Un tempo Lu Xun era un antidoto necessario contro le resistenze verso il sistema, ma nella società contemporanea il clima è cambiato e non ce n’è più bisogno».
Dante è conosciuto in Cina?
«Da fine Ottocento si è parlato di lui in libri cinesi ed è entrato nei nostri orizzonti. Sia la rivoluzione borghese del 1898, che portò al crollo della monarchia feudale, sia il "Movimento della nuova cultura del 4 Maggio del 1919", hanno tratto da Dante un supporto fondamentale. Sembra incredibile che un poeta occidentale abbia influito su un remoto Paese orientale cinque o sei secoli dopo essere morto, ma è successo. Tuttavia nel primo quarantennio del Novecento nessun cinese aveva letto La Divina Commedia per intero».
Non circolavano traduzioni complete?
«No. Nel 1921 Qian Daosun (1887-1966) tradusse i primi tre canti dell’Inferno per il Mensile di narrativa e in seguito propose in cinese altri due canti, apparsi nel ’29 insieme ai primi tre sulla rivista Rassegna critica. Usò lo schema metrico dei Canti di Chu di oltre 2200 anni fa, e sebbene la sua traduzione si sia applicata solo su cinque canti è considerata a tutt’oggi la migliore. Due versioni intere uscirono negli anni Quaranta, una in prosa e l’altra in poesia moderna, senza rime. -Con la nascita della Cina comunista (1949), la fama di Dante s’intensificò grazie a Friedrich Engels, che nella prefazione italiana al Manifesto del Partito Comunista lo aveva definito l’ultimo poeta medioevale e il primo della modernità, e questa valutazione è riportata nel manuale di Storia dei nostri licei.
 In Cina La Divina Commedia è stata vista come simbolo di abbattimento del feudalesimo ed esaltazione di unità nazionale: Dante riflette gli interessi del popolo e svela i crimini della vecchia macchina statale. Alla fine della Rivoluzione culturale sono riprese le traduzioni e una delle più notevoli è stata quella che della Commedia fece Tian Dewang (1909-2000), che all’impresa votò gli ultimi diciott’anni della sua vita».
In Cina La Divina Commedia è stata vista come simbolo di abbattimento del feudalesimo ed esaltazione di unità nazionale: Dante riflette gli interessi del popolo e svela i crimini della vecchia macchina statale. Alla fine della Rivoluzione culturale sono riprese le traduzioni e una delle più notevoli è stata quella che della Commedia fece Tian Dewang (1909-2000), che all’impresa votò gli ultimi diciott’anni della sua vita». -
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. -- "Due chiavi", il papa, e il capo dei clavigeri.30 gennaio 2017, di Federico La Sala
"Due chiavi" e il capo dei clavigeri
 "DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!
"DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
- DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
L’uomo che apre le porte dei capolavori vaticani: “Ho le chiavi del paradiso”
Gianni Crea è il capo dei clavigeri dei musei della Santa sede. "Ogni mattina, quando entro nella Cappella Sistina, mi sento un privilegiato"
di PAOLO RODARI (la Repubblica, 29 gennaio 2017)
CITTÀ DEL VATICANO. "L’alba è il momento più magico. Entro nel bunker che custodisce le 2797 chiavi dei musei vaticani. Quando non ci sono gli addetti della sagrestia pontificia, tocca a me prelevare l’unica chiave che non ha numero né copie. È un modello antico come la porta che apre, quella della Cappella Sistina. Giro la serratura della Cappella, quella stessa che sigilla i cardinali in conclave, per pochi istanti mi sento investito da una meraviglia che non è facile spiegare. M’inginocchio, mi segno, e dico una preghiera in solitudine. Chiedo che tutti i visitatori che di lì a poco entreranno possano provare il medesimo stupore. Sono un privilegiato, ne sono consapevole. E so che di questo privilegio devo esserne sempre degno".
Gianni Crea, 45 anni, romano ma originario di Melito di Porto Salvo, in provincia diReggio Calabria, è capo clavigero dei musei vaticani. In sostanza, ha il compito di aprire e chiudere tutte le porte e le finestre, 500 in tutto, 300 del percorso dei visitatori e 200 dei vari laboratori collegati. A vent’anni il parroco della chiesa che frequentava sulla via Appia gli chiese se voleva lavorare nella basilica vaticana come custode ausiliario. La Fabbrica di San Pietro in cambio avrebbe contribuito ai suoi studi. Accettò.
Qualche anno dopo, giovane studente di giurisprudenza con il sogno di diventare magistrato, partecipò a un concorso per diventare a tutti gli effetti custode. Per un anno lo osservarono, per valutare se fosse idoneo: puntualità, discrezione e serietà le principali doti richieste. Venne preso: "Da adesso - gli dissero - devi sempre ricordare dove ti trovi. Lavori nel centro della cristianità. I dieci comandamenti devono diventare il tuo secondo vestito". Una richiesta "non da poco", dice. "Tuttavia sono contento di non disattenderla".
Più immaginifica fu, invece, la consegna che gli fece Antonio Paolucci, fino a poche settimane fa direttore dei musei, quando da semplice clavigero venne nominato capo. "Adesso sei tu ad avere simbolicamente in mano le porte del Paradiso", gli disse per fargli comprendere la responsabilità a cui era chiamato. Con lui, infatti, collaborano altri dieci clavigeri che si dividono il lavoro in due turni, una metà dalle 5.30 del mattino alle due del pomeriggio. Gli altri fino a sera tardi. "Da quel momento il Vaticano è diventata la mia seconda casa - dice - Conosco le chiavi come le mie tasche. Ogni porta apre un mondo per me e per tutti i clavigeri familiare. Dietro ogni porta c’è un odore particolare, un profumo, riconoscibile soltanto da noi".
L’apertura e la chiusura di porte e finestre sono momenti entrambi delicati. Alle 5.30 la Gendarmeria di Porta Sant’Anna toglie l’allarme e il clavigero di turno procede con un lungo giro che dura quasi un’ora e mezzo. Dopo ogni apertura c’è il controllo che ogni cosa sia in ordine. "Se ad esempio si rompe un tubo dell’acqua - racconta - spesso tocca a me chiamare l’idraulico". Negli ultimi anni i visitatori dei musei sono parecchio aumentati, 28mila le sole presenze giornaliere in Sistina. Tutto deve essere perfetto. "Ma anche la chiusura non è facile. Bisogna controllare che nessuno rimanga all’interno. Gli imprevisti sono sempre possibili. Una sera chiudemmo tutto e di colpo suonò l’allarme. Accorremmo nella stanza nella quale veniva segnalata una presenza. Per fortuna era soltanto un passerotto rimasto dentro".
Il clavigero è l’erede delle chiavi del Maresciallo del Conclave, colui che fino al 1966 doveva sigillare le porte intorno alla Cappella quando i cardinali si riunivano per eleggere il Pontefice. La sua chiave non è l’unica a essere preziosa: c’è, ad esempio, la chiave numero 1, quella che apre il portone monumentale su viale Vaticano, che oggi è il portone d’uscita dei visitatori dei musei.
 E poi c’è la 401, una delle più antiche: apre il portone d’entrata dei musei e pesa mezzo chilo. "Due chiavi decussate, cioè incrociate a X, appaiono negli stemmi ed emblemi dei papi - scrive Tiziana Lupi su "Il mio Papa" - Sono una d’oro (potere spirituale) e una d’argento (potere temporale); hanno i congegni traforati a croce e sono unite da un cordone, simbolo del legame tra i due poteri ". I musei sono divisi in quattro aree. Ad ogni area corrispondono dei numeri a cui le chiavi si riferiscono. Le chiavi con il numero 100 sono del museo etnologico, quelle col 200 sono del Gregoriano, eccetera...
E poi c’è la 401, una delle più antiche: apre il portone d’entrata dei musei e pesa mezzo chilo. "Due chiavi decussate, cioè incrociate a X, appaiono negli stemmi ed emblemi dei papi - scrive Tiziana Lupi su "Il mio Papa" - Sono una d’oro (potere spirituale) e una d’argento (potere temporale); hanno i congegni traforati a croce e sono unite da un cordone, simbolo del legame tra i due poteri ". I musei sono divisi in quattro aree. Ad ogni area corrispondono dei numeri a cui le chiavi si riferiscono. Le chiavi con il numero 100 sono del museo etnologico, quelle col 200 sono del Gregoriano, eccetera..."La gioia più grande in questi anni - dice ancora Crea - l’ho avuta pochi anni fa. Prima che morisse mia madre ha potuto assistere a una messa del mattino a Casa Santa Marta. Ha ricevuto una carezza dal Papa. Un piccolo gesto che per me ha significato molto".
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA - IL RICHIAMO A DANTE E A VICO. «Umanisti italiani. Pensiero e destino» (di Massimo Natale)..11 dicembre 2016, di Federico La Sala
- DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. Per una rilettura del "De Vulgari Eloquentia" e della "Monarchia"
- VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"! E CON SHAFTESBURY, CON LA "TAVOLA DELLE COSE CIVILI"! VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova".
Questo canone così tragico e mosso
«Umanisti italiani», Millennio per Einaudi. Da Petrarca a Valla, da Pico a Machiavelli, l’Umanesimo rivisitato in chiave contemporanea da Ebgi e Cacciari
di Massimo Natale (il manifesto, Alias, 11.12.2016)
Se torniamo a certe pagine di Eugenio Garin - per esempio quelle affidate a un agevole libello come La cultura del Rinascimento, uscite in prima battuta nella Propyläen-Weltgeschichte edita nel 1964 - vi leggiamo che una tale epoca è segnata anzitutto dalla «coscienza della nascita di un’età nuova, con caratteri opposti a quelli dell’età precedente», una «coscienza polemica» la cui cifra è la «volontà precisa di ribellione, un programma di distacco da un mondo vecchio per instaurare altre forme di educazione e di convivenza, un’altra società e diversi rapporti tra uomo e natura».
Lontanissimo da ogni presentimento di una «bella età de l’oro» e da ogni rappresentazione oleografica dei secoli della prima modernità, il mondo rinascimentale si presenta allora, per Garin, «più enigmatico e inquieto che limpido e armonioso», un cosmo nel quale «il senso tragico della vita e una religiosità scavata» si precepiscono anzitutto «nella grandezza delle forme michelangiolesche».
Virate o estese alla cultura propriamente umanistica fra Tre e Quattrocento - a ulteriore conferma della loro efficacia - queste parole potrebbero fare da ottimo viatico anche a chi sfogli Umanisti italiani Pensiero e destino, a cura di Raphael Ebgi, con un saggio di Massimo Cacciari (Einaudi «I millenni», pp. CVI-558, € 85,00).
Il volume è approntato in forma di antologia, disposta per temi fondamentali - otto sentieri, dal rapporto fra Vita activa e Vita contemplativa alla Metaphysica alla Teologia poetica - di volta in volta preparati da un cappello introduttivo, storico-interpretativo. Si compone così una sorta di breviario umanistico, che spazia da Machiavelli a Pico, da Bessarione a Giorgio di Trebisonda, da Landino a Poliziano, non avvalendosi peraltro soltanto di stralci di opere già a loro agio nel canone, ma anche di glosse, appunti o pagine di diario (con l’aggiunta preziosa di un paio di trouvailles inedite, fra cui un brano latino di Pico in calce a una lettera a Battista Guarini, ritrovato da Franco Bacchelli nel codice Capponiano della Biblioteca Apostolica Vaticana).
In partenza Garin e Vasoli
A orientare scelte e intenzioni ermenutiche è comunque, da subito, l’articolato studio di Cacciari - che prende non a caso le mosse proprio dal nome di Garin e da quello di Cesare Vasoli - con l’obiettivo di Ripensare l’umanesimo. A cominciare dalla necessità di limitare o sorpassare senz’altro le «riserve, diffidenze e incomprensioni, quando non aperte critiche», che la filosofia contemporanea ha riservato a questo periodo della storia europea.
L’intervento di Cacciari si potrebbe in effetti leggere in buona parte - libro dentro il libro - come il tentativo di ripercorrere la lunga parabola di una mislettura profonda, secondo la quale Umanesimo implicherebbe - essenzialmente ed erroneamente - uno «spirito conservatore», una «visione essenzialmente antitragica» dell’esistente e un ideale di «paideia totalizzante-armonica». Per capire quanto sia diverso, qui, lo sguardo gettato sui nostri umanisti, basterebbe considerare come venga servito fra gli altri, da Cacciari e Ebgi, un Petrarca. Immediatamente scelto per aprire il primo capitolo antologico - dal titolo molto eloquente di «Umanesimo tragico» - ecco il Petrarca di una lettera a Ludwig van Kempen, impegnato a riconoscere, con maturo disincanto, la potenza di Fortuna: «occorre lasciare che la fortuna faccia i suoi giochi (...). Per vincerla, nessun’arma è migliore della sopportazione (...). Nessuna speranza di quiete si trova in questo capo di fatiche, giacché la vita dell’uomo non è solo milizia, ma guerra, e chiunque viene in questo mondo, viene in un campo di battaglia».
Saremmo cioè, già con Petrarca, di fronte a uno fra i primi diagnosti della finitezza e debolezza dell’individuo (un Petrarca con il quale inizia peraltro, secondo Cacciari, il «canto-threnos di Europa: ed ecco allora il poeta dei Fragmenta, con il suo sguardo sul Passato, accostato nientemeno che allo Schicksalslied dell’Hyperion di Hölderlin).
Ciò che probabilmente più affascina, nell’ampia ricostruzione proposta, è la scelta di riavvicinarsi all’Umanesimo tenendo un punto di osservazione saldamente ‘contemporaneo’. Autori, opere e nodi non sono affrontati per medaglioni, quanto piuttosto per linee: non sono ritratti in istantanea, ma immagini in movimento. E infatti il risultato non è tanto un magari nuovo e però statico quadro della cultura umanistica, ma una vera e propria genealogia del moderno.
Lo si capisce bene se si guarda, anzitutto, alla questione del rapporto fra linguaggio e pensiero: «asse portante», annota Cacciari, «dei momenti più alti» della speculazione umanistica, nella prima e precoce coscienza che ogni argomentare e ogni teoresi è anche un problema di «prassi linguistica» (ben in anticipo su certe non distanti riflessioni, ormai novecentesche).
Il richiamo a Dante
Qui è un altro il padre di ogni discorso sull’Umanesimo italiano, ovvero il Dante del De vulgari eloquentia. Il quale - pur non presente nella scelta antologica del volume - è più volte richiamato nelle pagine introduttive, ed evocato anzi come il punto di partenza necessario per ogni ritorno agli umanisti (un punto di partenza anteriore, dunque, al più scontato ‘proto-umanesimo’ di Petrarca o Boccaccio e dintorni, e indispensabile tanto più se si osserva l’epoca dalla specola di una filosofia del linguaggio). Certo, il De vulgari eloquentia è un primo atlante di dialettologia volgare: ma è, anche più, la sanzione dell’uscita del linguaggio poetico dalla sua condizione limitante di cognitio minor, di pensiero imperfetto o favola falsa. Il moderno sta insomma imparando, già a quest’altezza, la «piena rilevanza cognitiva» di un pensiero diverso, poetico, per immagini.
Si intravede già, in fondo al percorso, Leopardi: un altro nome che Cacciari spende a più riprese, laddove vuole per esempio ricordarci come esperienza e immanenza siano alla radice del pensiero di un Guicciardini (ed ecco sfruttati i leopardiani Pensieri: lì Guicciardini «è forse il solo storico tra i moderni, che abbia conosciuto molto gli uomini, e filosofato attenendosi alla cognizione della natura umana).
Ma Leopardi è nome talmente consustanziale - e non da oggi - alla riflessione di Cacciari, che lo si può anche criptocitare nel definire la filosofia di Lorenzo Valla - certamente uno dei perni del volume - una «filosofia dolorosa, ma vera» (così il leopardiano Dialogo di Tristano e di un amico, nelle Operette); o si veda infine la suggestiva «amicizia stellare» che legherebbe insieme Leopardi e Alberti, all’insegna di un comune pessimismo per così dire agonista. Speziare l’Umanesimo col moderno si può, forse anzi si deve, se non si vuole perderne alcuni tratti fondamentali, mantenendolo - con Nietzsche: anche lui spesso chiamato in causa - sempre in bilico fra attuale e inattuale.
Galleria iconografica
E si potrebbero indicare molti altri annunci, presentimenti di futuro consegnatici dal pensiero umanista: limitiamoci a scomodare almeno il suo carattere sempre fortemente civile, nel suo porre costantemente al centro una comune educazione, un dialogo duraturo fra Filosofia, Filologia ed Ermete (e allora il nome da fare sarà, stavolta, quello di Aby Warburg, nel cui segno si pone la splendida galleria iconografica che arricchisce il volume, e che accompagna il lettore da Bosch a Benozzo Gozzoli, a Giorgione ecc., suggestivamente commentati). Oppure, a come già tra Ficino e Pico - con il supporto della Lettera ai Romani di San Paolo - tramonti ogni possibile teodicea, nell’eventuale annullamento del libero arbitrio umano da parte della volontà divina. O a come, in ultima analisi, tra Machiavelli e Valla ogni azione umana sembri rivelare il proprio vero fine nella più nostra, nella più moderna delle ragioni: la ricerca della felicità, ovvero il principio di piacere.
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. -- GEOPOLITICA DELL’ITALIANO. Quarta lingua studiata nel mondo (di Aldo Giannuli).15 febbraio 2016, di Federico La Sala
Geopolitica dell’Italiano
di Aldo Giannuli *
Fra le molte sciocchezze che capita di sentire a proposito dell’Italiano, c’è quella per la quale esso sarebbe quasi una lingua morta, parlata da quattro gatti e, pertanto, destinata a scomparire ineluttabilmente nel mondo globalizzato. Ovviamente, i primi sostenitori di questa fesseria sono gli anglomani, per i quali l’inglese basta e avanza per tutti gli usi e tutte le altre lingue possono sparire.
Qualche dato può servire a formare una visione più realistica della situazione. Secondo Wikipedia l’italiano è diffuso in Argentina, Australia, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Canada, Cile, Croazia, Egitto, Eritrea, Francia, Germania, Israele, Libia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paraguay, Filippine, Porto Rico, Romania, San Marino, Arabia Saudita, Slovenia, Somalia, Sud Africa, Svizzera, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Uruguay, Venezuela, Stato Vaticano. Una irradiazione amplissima, che la colloca ai primi posti nel mondo.
Wikipedia colloca l’Italiano al 21° posto nella graduatoria mondiale dei parlanti, dopo cinese, spagnolo, inglese, hindi, arabo, portoghese, bengalese, russo, giapponese, tedesco, giavanese, punjab, coreano, wu, francese, telugu, turco, marhati, tamil, vietnamita.
Ma lo fa su criteri “ufficiali”, cioè sommando i parlanti di madre lingua a quelli di seconda lingua dei residenti di ciascun paese, per cui l’inglese è al terzo posto ed il francese al 15°, il che non appare molto realistico. La graduatoria di Wiki non tiene conto:
a- dei discendenti di immigrati che hanno conservato l’uso della lingua e che spesso non sono censiti
b- dei flussi di migranti che apprendono la lingua nel paese di immigrazione e che spessissimo non sono censiti
c- dei parlanti di “professione” spesso non considerati: ad esempio, nella finanza quasi tutti gli operatori, in qualsiasi parte del mondo, comunicano in inglese. Molti operatori culturali parlano inglese o francese anche se appartenenti ad altri paesi. La Chiesa Cattolica ha come sua lingua ufficiale l’italiano, conosciuto da molti religiosi e da tutti i vescovi che lo usano nelle loro comunicazioni ecc.
d- quanti apprendono una lingua per motivi di studio e che la classifica di Wiki non prende in considerazione (ovviamente è molto più facile che ci siano studenti arabi, indiani, cinesi ecc. in una università europea o americana, di quanti ce ne siano di europei in università indiane, cinesi o arabe; così come è più facile che ci siano studiosi della letteratura inglese, francese, italiana in Cina o in Bangladesh di quanti studino quelle letterature in Inghilterra, Francia o Italia),
e- di quanti apprendono la lingua come turisti, ed è ovvio che ci siano più turisti asiatici in Europa che europei in Asia
Peraltro, la graduatoria su dati ufficiali può risultare insidiosa anche per altre ragioni: l’indonesiano è la lingua ufficiale dell’Indonesia, con i suoi 300 milioni di abitanti, ma in effetti è la prima lingua solo di un quinto della popolazione, ed è la seconda di una ulteriore parte che non copre più della metà degli abitanti; l’arabo scritto è lo stesso in ogni paese arabo, ma quello parlato cambia da pese a paese e non è affatto sicuro che un parlante marocchino riesca ad intendersi con uno yemenita.
Tenendo conto di queste variabili, la graduatoria cambia sensibilmente. In occasione degli “stati generali della Lingua Italiana” (svoltisi a Firenze nello scorso ottobre), abbiamo saputo che: ci sono 4,5 milioni di italiani all’estero (senza contare i trasferimenti temporanei come gli Erasmus), nella sola città di Barcellona c’è una comunità di italiani di quasi 50.000 persone. Inoltre abbiamo saputo nella stessa occasione che l’italiano è l’ottava lingua usata nel web, che gli italodiscendenti sono circa 80 milioni (per dimensioni è la seconda diaspora al mondo dopo quella cinese) e che il bacino degli italofoni è di 250 milioni di persone, al nono posto nella graduatoria mondiale (dopo inglese, francese, spagnolo, portoghese, hindi, cinese, arabo, russo). Può sorprendere non trovare il tedesco, che, in effetti è di pochissimo meno parlato dell’Italiano -praticamente alla pari-, ma occorre tener presente che, anche se tedeschi, austriaci e svizzeri tedeschi, insieme alla minoranze tedesche disseminate in Europa, ammontano complessivamente al doppio degli abitanti dell’Italia, però i germano discendenti (nipoti di emigrati) sono molto meno degli italo discendenti. Anche il Giapponese parte da una base nazionale più consistente di quella italiana, ma ha una diaspora linguistica molto meno ampia dell’italiano.
Dunque, almeno su una cosa possiamo stare tranquilli: l’italiano non è una lingua morta ed è fra principali dieci lingue parlate nel mondo.
Certo, se continua come sta andando, fra un po’ ci saranno più italo parlanti all’estero che in Italia, dove la lingua più diffusa sarà una sorta di basic english con forti innesti padani, ma, almeno per ora, sembra che questo disastro sia prossimi.
Vice versa, studiando bene questi dati, si capisce che l’italiano è una lingua con un forte potenziale geopolitico sia per l’ampiezza dei paesi in cui è diffuso, sia per il numero di parlanti o di persone che lo usano nel web. Se l’Italia vorrà pesare qualcosa nel mondo globalizzato, non è grazie alla finanza o al suo peso militare che ci riuscirà. Il suo strumento di influenza principale non potrà essere che la sua cultura, che significa arte, musica, letteratura, gastronomia ecce cc. E questo sarà una risorsa fondamentale anche per il rilancio delle esportazioni italiane. Vorrei ricordare che, quando l’ italian style significava qualcosa, l’Olivetti lettera 32 era esposta al museo di arte moderna nella fifth avenue di New York e l’Olivetti rappresentava circa l’8% del mercato mondiale di settore. Un caso?
Ma il bagaglio storico della cultura italiana non è separabile dalla sua lingua (sarebbe l’unico caso al mondo di un patrimonio culturale servito in una lingua diversa dalla propria) e, dunque, un rilancio di questo paese non è separabile dalla difesa della sua lingua.
*
Aldo Giannuli (22.05.2015).
L’Italiano è la quarta lingua studiata nel mondo: gli unici a sorprendersi sono gli italiani.
di Aldo Giannuli *
Un paio di settimane fa, la stampa italiana dava, con un certo stupore, la notizia che l’Italiano è la quarta lingua studiata nel mondo, dopo inglese, spagnolo e cinese, non riuscendo a spiegarsene il perchè.
Le prime tre sono abbastanza logiche: l’inglese è la lingua di un miliardo e mezzo di persone (mettendo nel conto anche gli indiani) ed è la principale (ma non l’unica) lingua franca del Mondo. Lo spagnolo è la lingua di mezzo miliardo di parlanti ed è in rapida espansione negli Usa; quanto al cinese, non solo è la prima lingua di un miliardo e mezzo di parlanti, ma è la lingua del principale paese emergente (forse è meglio dire ”Emerso”) e seconda potenza mondiale. Sin qui tutto spiegabile.
Invece, inspiegabile è che sia quarta l’Italiano, lingua di poco più di sessanta milioni di parlanti (forse settanta se ci mettiamo dentro eritrei, albanesi, somali che lo conoscono e un po’ di italiani all’estero), di un paese relativamente piccolo ed in decisa decadenza, ignorato dalle grandi potenze e ridicolizzato dai suoi piccoli politici passati e presenti.
Precede lingue come il francese, il tedesco, il russo, il portoghese, il giapponese, come si spiega? Il guaio è che i giornalisti italiani sono molto ignoranti e, quel che è peggio, non fanno nessuna ricerca prima di scrivere.
Allora vediamo qualcosa che può spiegare questo strano fenomeno. Prima di tutto, si dimentica che l’italiano è la lingua franca di uno dei principali soggetti geopolitici mondiali: la Chiesa Cattolica. La lingua ufficiale della Chiesa, come si sa, è il latino, ma quella in uso fra i prelati (e spesso anche i semplici preti) di nazioni diverse è soprattutto l’Italiano che è parlato correntemente in Vaticano ed usata prevalentemente dal Papa, vescovo di Roma, anche se non si tratta più di un italiano da quasi quaranta anni. Ed anche in ordini religiosi con i salesiani o i gesuiti, la lingua corrente è l’italiano.
Poi c’è da considerare che l’Italia è uno dei paesi che ha avuto una cospicua emigrazione nell’ultimo secolo: circa 40 milioni di persone sparse soprattutto in Argentina, Usa, Canada, Australia, Germania, Francia e Belgio e non pochi figli e nipoti si sono mantenuti bilingui. Fra l’altro (la cosa non ci inorgoglisce ma deve essere registrata su un piano avalutativo) l’Italiano è spesso usato fra gli uomini di Cosa Nostra o fra gli ‘ndranghetisti sparsi per il mondo ea altre organizzazioni criminali come i colombiani. E anche questo è un fenomeno sociale.
C’è poi l’importanza dell’Italiano sul piano culturale ed anche qui si sono dimenticate troppe cose. In primo luogo si dimentica che l’italiano è la lingua principale del melodramma e nel mondo ci sono tanti melomani che apprezzano molto la nostra musica lirica, basti pensare al successo mondiale avuto da Pavarotti dagli anni ottanta in poi.
Poi la letteratura italiana è sicuramente una delle primissime a livello mondiale; non mi interessa stabilire se sia la prima in assoluto (anche se non mi stupirebbe affatto constatarlo), mi basta sottolineare come essa abbia uno sviluppo continuo nel tempo da XIII secolo in poi, con capolavori di livello mondiale, in tutti i secoli. Quello che non mi pare si possa dire allo stesso livello delle letterature di Inghilterra, Francia, Germania, Spagna e Russia che presentano maggiore discontinuità.
Chi voglia avere una idea del “peso” della letteratura italiana, può consultare la monumentale collana di testi della Ricciardi, ma ripeto che non ha senso stare a stabilire se si tratti della prima in assoluto, basti considerare che certamente è fra le primissime. E non sorprende che ci siano autori italiani (da Petrarca a Gramsci o Leopardi) più amati e letti all’estero che in Italia. Ma qui c’è il ruolo della scuola, il cui principale scopo è far odiare agli studenti tutto quello che fa loro studiare.
Del peso dell’arte italiana, in particolare del Rinascimento, ma non solo, non è il caso di dire e questo spiega (altra cosa non sufficientemente considerata) che l’Italia sia una delle principali mete turistiche nel Mondo.
E, infine (anche la cultura “materiale”, ha il suo peso) tanto la gastronomia quanto la moda nel Mondo parlano spesso italiano.
Che morale possiamo ricavare da questa terribile sproporzione fra l’apprezzamento che la cultura e la lingua italiana riscuotono nel mondo e la pochezza dell’autostima degli italiani? Semplicemente che gli italiani del tempo presente sono impari rispetto al patrimonio culturale che li sovrasta. Peccato.
Aldo Giannuli (11.02.2015).
-
>DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. --- Brunetto Latini, maestro di Dante, fu un faro del tempo: il suo Tesoretto è davvero un tesoro.11 gennaio 2016, di Federico La Sala
Esce dall’Inferno Brunetto Latini : il suo Tesoretto è davvero un tesoro
L’alter ego dell’autore si perde in una «valle scura» che anticipa la «selva oscura»
Maestro di Dante che però lo relegò tra i violenti contro natura, fu un faro del tempo
di Paolo Di Stefano (Corriere della Sera, 11.01.2016)
Il notaio, politico, traduttore, poeta, divulgatore, intellettuale di fama internazionale Brunetto Latini fu maestro di Dante: il quale lo collocò all’Inferno pur rendendo omaggio alla sua «cara e buona imagine paterna» che gli insegnò «come l’uom s’etterna», cioè come si acquista fama imperitura grazie al retto operare. Un maestro che l’Alighieri non ripudiò, ma che per certi versi sentì superato (da se stesso in primo luogo).
Brunetto era nato circa quarant’anni prima di Dante, era stato ambasciatore guelfo presso il re di Castiglia Alfonso X, fu esule in Francia in seguito alla sconfitta di Montaperti e tornò nella sua città l’indomani della rivincita guelfa a Benevento, ricoprendo incarichi politici sempre più importanti fino alla morte, avvenuta nel 1293. Il cronista trecentesco Giovanni Villani lo definì «sommo maestro in rettorica, tanto in bene saper dire come in bene dittare», cioè nell’arte dell’oratoria e nell’epistolografia ufficiale, ma soprattutto lo considerò guida politica e culturale dei fiorentini. Un faro del suo tempo.
Nel canto XV, l’incontro del pellegrino Dante con l’anima del notaio, vagante - come gli altri violenti contro natura - per un deserto di fuoco, si apre con un interrogativo di stupore, quasi un sussulto di spavento dell’ex allievo: «Siete voi qui, ser Brunetto?». Quel «voi» è il segno della massima reverenza, ma lo sbalordimento è il segno della familiarità e dell’affetto (del resto ricambiato nel sentirsi chiamare «figliol mio» dal vecchio maestro).
Dunque, perché Dante lo caccia all’Inferno, infliggendogli la terribile pena dell’ustione eterna? Se n’è discusso all’infinito, ipotizzando la blasfemia e l’eterodossia (religiosa e politica), ma il sospetto più accreditato è che Brunetto fosse colpevole di sodomia, anche se nei documenti dell’epoca non ci sono elementi che ne confermino l’omosessualità, «vizio» caratteristico di «letterati e cherchi» dell’epoca.
Quel che conta però, al di là dei peccati erotici veri o presunti, è che Dante più di chiunque altro riconobbe al suo maestro un ruolo intellettuale e morale esemplare, anche se come poeta lo sentì complessivamente inadatto ai tempi. Resta, comunque, un debito di riconoscenza anche al poeta, che si palesa non solo nelle dichiarazioni esplicite, ma negli echi più o meno occulti disseminati dentro la Commedia.
Lo dimostra bene Stefano Carrai nella bella e lucida introduzione e nel commento alle Poesie di Brunetto che, per sua cura, escono da Einaudi. In realtà si tratta di un corpus poetico esiguo, composto dal Tesoretto, un poemetto didattico incompiuto in distici di settenari a rima baciata (circa 3.000), cui di solito si accompagna il Favolello, un breve componimento nello stesso metro (160 versi) sul tema dell’amicizia; e una modesta canzone d’amore.
Scrittore prevalentemente in prosa, autore in lingua francese del Tresor, «la prima enciclopedia volgare in senso proprio» (Segre) e compilatore del trattato della Rettorica sul modello ciceroniano, il poeta Brunetto non ha avuto quel che meritava. Carrai ricorda il parere di Hans Robert Jauss, secondo il quale pesa sul Tesoretto «un pregiudizio estetico non dichiarato» che ha contribuito a svalutarne il significato storico e le indubbie qualità poetiche. Scritto a Firenze dopo gli anni dell’esilio francese, si configura come una sorta di aggiornamento e di versione minore in versi del Tresor , rispetto al quale è ormai accertato il rapporto di dipendenza (si ricordi, tra parentesi, che il Tresor è stato riproposto, nel 2007, sempre da Einaudi, nei Millenni).
Che cosa narra il racconto visionario-allegorico del Tesoretto? L’alter ego dell’autore attraversando la piana di Roncisvalle, dove viene a sapere della sconfitta di Montaperti, smarrisce la strada e si addentra (pre-dantescamente) in una foresta, dove incontra la personificazione della Natura che evoca gli episodi della creazione, degli angeli ribelli, le vicende di Adamo ed Eva e del peccato originale, offre una visione dei quattro elementi e del disegno astronomico, la descrizione dei principali fiumi, da est a ovest, e delle bellezze delle terre attraversate e dei mari, con elementi di lapidario e di bestiario. Alla lezione di filosofia naturale seguono un’immersione nel Regno delle Virtù e poi una puntata nel territorio di Amore, in cui Ovidio farà da guida. Il viaggio di redenzione giunge infine a Montpellier, dove il pellegrino trova riparo in un convento per espiare i propri peccati e riprendere il percorso verso l’Olimpo.
Il progetto originario brunettiano, ricorda Carrai, era più ambizioso e più ampio. Avrebbe dovuto trattarsi di un prosimetrum (opera mista di rime e di prose) , se è vero che l’intenzione, accennata qua e là, era quella di sciogliere in inserti prosastici i luoghi che sarebbero stati più impervi e meno comprensibili se consegnati ai versi. Si incontrano infatti alcune promesse di ampliamenti futuri: ma la prevista «sinergia», o struttura a più strati che affiancava il racconto didattico-allegorico con uno svolgimento in prosa adatto a un pubblico più vasto (non solo ai colti capaci di avvicinarsi al francese del Tresor ), non si realizzerà forse per il subentrare di imprevisti impegni politici, forse perché il piano iniziale non appariva più convincente allo stesso autore. Fatto sta che l’operetta riuscì a imporsi, fra Tre e Quattrocento, anche nella forma incompiuta che conosciamo, se ebbe, come pare dai manoscritti superstiti, una circolazione non marginale. Non va escluso, tra l’altro, che il Tesoretto incompiuto possa intendersi come «anello di congiunzione» verso i ben più illustri prosimetri danteschi (la Vita nova e il Convivio ).
Tornando alla Commedia, Carrai vi individua numerosi echi del Tesoretto, come certe coincidenze di sintagmi (la «valle scura» di Brunetto e la «selva oscura» dantesca), di punti di vista (la messa in scena di un personaggio che parla di sé in terza persona), di certi stilemi rari in rima (epa - crepa), di immagini e movenze (flagrante la somiglianza tra il volgersi e il sorridere della Natura e quello del personaggio di Matelda in Dante).
Ma al di là delle occorrenze minime, sarebbe la concezione complessiva del viaggio di Dante nell’aldilà a subire l’influsso del programma pensato da Brunetto: lo smarrimento dentro la foresta e l’incontro di una guida sul cammino di rigenerazione. Certo, quando poi Dante deve decidere quale guida scegliere per il proprio viaggio, troverà in Virgilio il «maestro di bello stile senza condizioni, elargitore di un insegnamento imperituro», relegando il vecchio Brunetto, con i suoi settenari cantilenanti, al ricordo riconoscente di una «cara e buona imagine paterna». C’era ben altro maestro, Virgilio, a indicargli la via verso le sue sperimentazioni metriche e visionarie.
-
> DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. --- Brunetto Latini. Chi fu davvero il raffinato intellettuale duecentesco (di M. Cucchi)23 febbraio 2016, di Federico La Sala
Brunetto innamorato non merita l’Inferno
Chi fu davvero il raffinato intellettuale duecentesco condannato al girone dei sodomiti
di Maurizio Cucchi (La Stampa, 21.02.2016)
È un’emozione e un piacere tenere tra le mani il piccolo libro senza età che raccoglie le Poesie di Brunetto Latini. E dunque il Tesoretto, ampio poemetto in volgare incompiuto di quasi tremila versi, e poi il breve Favolello (165 versi) e la canzone «S’eo son distratto inamoratamente», dove ser Brunetto si mostra anche poeta lirico. Tutti sappiamo che Brunetto fu maestro di Dante, il quale lo colloca all’Inferno, nel canto XV, benché ne riconosca «la cara e buona imagine paterna», quella di un uomo e di un sapiente di centrale risalto, in quanto, aggiunge il grande allievo, «m’insegnavate come l’om s’etterna».
Brunetto fu un intellettuale di prim’ordine nella Firenze del suo tempo, nel cuore del Duecento (nato verso il 1220, morì nel 1294), e rappresenta la figura del poeta al suo livello più alto, vale a dire autore di versi ma anche coltissimo letterato, oltreché studioso e uomo di pensiero. La stima di cui poteva godere lo portò anche ad onori e viaggi: fu in Spagna, ambasciatore ad Alfonso X re di Castiglia. Ma tornando da quel viaggio, dopo la vittoria ghibellina a Montaperti (1260), fu costretto all’esilio. Riparò allora in Francia, dove rimase sei anni e dove scrisse, non in latino, ma in francese (lingua allora più avanzata, strutturata e culturale rispetto al toscano), una delle sue opere maggiori, o forse la maggiore in assoluto il Tresor, che riappare oggi, con traduzione in italiano, nella bellissima edizione dei Millenni. Una summa dell’intero sapere, nelle sue varie forme, fino al medioevo dell’autore, un’opera di compilazione enciclopedica, anzi, una sorta di prima enciclopedia in volgare, di evidente impronta e orientamento etico-politico, dove troviamo filosofia teorica e pratica, logica, retorica e appunto politica.
D’altra parte, anche nella sua poesia, Brunetto non ebbe essenzialmente obiettivi estetici, ma piuttosto di carattere didattico e pedagogico, come altri poeti dell’epoca, e di provenienze diverse: al nord Bonvesin, Patecchio, Giacomino, Uguccione. Come loro egli fu un precursore di Dante, nel senso della costruzione di un viaggio morale attraverso le forme del bene e del male nell’uomo.
Tornato a Firenze, dopo la vittoria dei guelfi a Benevento, riprese la sua posizione di pubblico rilievo (fu anche priore, nel 1287) e scrisse in volgare il Tesoretto e il Favolello. Entrambi i poemetti sono composti in settenari monorimi e l’intento essenziale è quello di dirigerne le coscienze, di ammaestrare. Il che non esclude affatto esiti estetici, impennate poetiche, magari all’interno di argomentazioni lineari o prosastiche e a tratti riconoscibili come poetiche solo grazie alla versificazione e alla rima. Questi felici stacchi avvengono in genere in sentenze quasi epigrammatiche, in constatazioni del tipo: «E vidi [...] / che ogni creatura / ch’avea cominciamento / veni’ a finimento», o in elencazioni di elementi o figure della realtà naturale: «E vidi turba magna / di diversi animali, / che non so ben dir quali: / ma omini e moglieri, / bestie, serpent’e fiere, / e pesci a grandi schiere, / e di molte maniere / uccelli voladori, / ed erbi e frutti e fiori, / e pietre e margarite, / e altre cose tante». Non secondario elemento a favore di una lettura o rilettura di ser Brunetto è, appunto, l’importanza del suo insegnamento a Dante, che, - lo rileva puntualmente Stefano Carrai, ottimo e meritorio curatore di questo libro - presenta nella sua opera non pochi riecheggiamenti del maestro. Già molto evidente da questi versi: «Perdei il gran cammino / e tenni a la traversa / d’una selva diversa». O da questi altri: «e io presi andamento, / quasi per Aventura, / per una valle scura».
Ma un’indicazione forte era venuta a Dante, per la forma prosimetro della sua Vita nova, dalla Rettorica, dove Brunetto aveva tradotto Cicerone. Tutto questo, trattandosi del grandissimo Dante, non fa che aumentare l’importanza complessiva del suo maestro. A proposito del quale resta anche aperta la questione del peccato per il quale viene cacciato nell’Inferno.
Carrai elenca le ipotesi in proposito, a partire dalla più semplice e resistente, quella di omosessualità. Seguita peraltro da quella, piuttosto cervellotica, di blasfemia, o dal suo mancato riconoscimento della sacra autorità dell’Impero. E ancora: eterodossia religiosa, sesso praticato con mogli contro natura. Ma quello che ci resta, per fortuna, è l’opera, un’opera varia, con una cifra interna lirica, non sempre visibilissima ma ben presente. Lo si vede nella canzone di endecasillabi e settenari che chiude questa importante raccolta ma che anche la apre in copertina con questi versi: «S’eo son distretto / inamoratamente / e messo in grave affanno / assai più ch’io non possa soferire, / non mi dispero né smago neiente, / membrando che mi danno / una buona speranza di martire, / com’eo deggia guarire: / ché lo bon soferente / riceve usatamente / buon compimento de lo suo desire». Ed è appagante inoltrarsi nella selva della sua lingua, un volgare ancora antico, fluido e ruvido insieme, e in prodigioso movimento.
-
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE --- Più di un poeta: diede un’unica voce agli italiani e un’identità nazionale. Storia della letteratura italiana (Enrico Malato)27 dicembre 2015
La lingua di Dante nata a tavolino
Più di un poeta: diede un’unica voce agli italiani e, attraverso quella, un’identità nazionale
di Ida Bozzi (Corriere della Sera, 27.12.2015)
Non sono soltanto motivi di ovvia cronologia a porre Dante Alighieri (1265-1321) al principio di un’organica storia della letteratura italiana. Nell’anno del 750° anniversario della nascita, pare necessario ricordare che Dante non è stato solamente in senso stretto il primo grande poeta italiano: il valore storico della sua figura si affianca a quello linguistico, decisamente irripetibile, e a quello simbolico, che è stato non meno importante, specie in particolari momenti di svolta che il Paese ha conosciuto.
Insomma, l’Alighieri ha fatto così tanto per la nostra letteratura, ma anche per la nostra identità culturale, che il primo posto gli spetterebbe in ogni caso di diritto: e infatti proprio con il volume dedicato al grande fiorentino si apre la collana di Storia della letteratura italiana che accompagnerà nelle prossime settimane in edicola il «Corriere della Sera».
Ce ne parla Enrico Malato, grande studioso e specialista dantesco che ha ideato il progetto complessivo di questa Storia, monumentale opera critica originariamente composta per Salerno editore e ora proposta in una collana divisa per monografie che parte appunto con Dante e via via presenta personalità e temperie di tutta la nostra storia letteraria, fino ai Pascoli e ai Carducci dell’altroieri e ai Gadda e Calvino di ieri.
«Intanto va detto che questa Storia della letteratura italiana - spiega Malato - nasce come un affresco complessivo che propone tutto il tessuto culturale dei diversi momenti storici. È un’opera realizzata secondo un castelletto ben preciso: ogni curatore ha avuto una scaletta rigorosissima alla quale si è dovuto attenere, in un progetto concepito quindi unitariamente. Per ciascun autore o momento letterario, infatti, prima di tutto bisogna illuminare il contesto storico. Poi occorre definire il profilo biografico della personalità analizzata, quindi focalizzare l’analisi sulle diverse opere. In questo modo si dà conto della civiltà letteraria, perché io preferisco parlare di civiltà che di cultura letteraria, che è il tratto davvero identificante del nostro Paese».
Al poeta fiorentino della Commedia è dedicato il primo volume, curato appunto da Enrico Malato: qui si illustra il quadro complessivo dell’epoca, si analizzano la vita e l’opera nel suo complesso, si illustrano gli elementi fondamentali del contesto, ed emerge l’importanza della figura dantesca. Bisogna pensare che la grande attenzione riversata in questi anni sulla Commedia, con le letture, i reading e le maratone nei teatri, nelle piazze e in televisione, mettono in luce soprattutto il nostro legame emotivo con il grande poema, la bellezza della sua poesia, il suo peso teologico e filosofico, l’immaginazione senza limiti, la perfezione dello schema. Ma c’è altro per cui amare il sommo poeta.
«La cosa geniale di Dante - chiarisce Malato - è che lui ha l’intuizione della lingua italiana che verrà. Era una scommessa e l’ha vinta, e ha visto molto lontano. Bisogna pensare che all’epoca già si scriveva in volgare, ma soltanto le piccole cose, le novellette, qualche poesia. Il volgare non pareva una lingua in grado di concepire grandi opere del sapere. La costruisce lui. Costruisce la lingua italiana praticamente a tavolino, inventandola passo per passo, e tra l’altro coniando centinaia e centinaia di neologismi».
Ne fa una lingua, insomma, e una lingua capace in sostanza di ogni complessità: del tono basso, degli argomenti medi della vita quotidiana, così come della poesia più sublime e delle altezze vertiginose del pensiero più alto. La crea e la plasma.
«Ma in più - aggiunge il curatore - la rende anche unica in Europa. Perché? Bisogna pensare a tutte le altre lingue europee: nelle aree che poi saranno l’Inghilterra, la Francia, la Spagna, il volgare che diventa lingua nazionale lo fa in tutt’altro modo, e cioè attraverso l’imposizione, sotto la pressione di una conquista militare o strategica, e quando nel Cinquecento le lingue nazionali subiranno una grande trasformazione, noi saremo già trecento anni avanti! La lingua italiana è l’unica plasmata sostanzialmente a tavolino, e imposta non per la pressione militare o la conquista, o per il prevalere di una dinastia sull’altra, di un volgare sull’altro, ma perché il prestigio e la fortuna dell’opera dantesca erano veramente enormi. Dante vide giusto, con consapevolezza, per il futuro: nel De vulgari eloquentia Dante parla già (in latino) di una “casa degli italiani”, in un’epoca in cui sul territorio del nostro Paese c’erano 300 staterelli e stati, alcuni grandi come regioni, altri piccoli come città. Lui capisce che c’è una comunità di sentimento».
Ecco perché costruire una storia della letteratura italiana significa dare una definizione della nostra identità culturale, prosegue Malato: «La lingua è il nostro tratto identificativo, e la dobbiamo a Dante».
Poi la storia della letteratura continua, e le vicende della civiltà italiana sono un caleidoscopio di scoperte. «Pensiamo a Petrarca. Se Dante ha scritto il grande poema, e nonostante i molti imitatori resta inimitabile, anche Petrarca ha avuto un’importanza grandissima nella nostra letteratura: ha avuto dietro al suo Canzoniere uno sciame di almeno 300 anni tra imitatori e influenze sulla poesia. E il Quattrocento? È l’epoca in cui torna in auge quale lingua culturale il latino, lingua dell’Umanesimo ma anche, in parte, lingua della scienza. E così via. I curatori dei singoli volumi di questa storia della letteratura sono tutti massimi specialisti di ciascun autore, e offrono in modo molto aperto e molto ampio una visione complessiva dell’epoca considerata. In modo da spiegare che cosa noi siamo oggi, da dove sorge la nostra identità».
Un’identità fortemente incarnata però proprio nella figura d’apertura, nel primo poeta italiano, come conclude il docente: -«Proprio quest’anno abbiamo celebrato il 750° anniversario della nascita di Dante. Ma ci fu un momento in cui queste celebrazioni ebbero un potente significato simbolico: l’Unità d’Italia si compì nel 1860-61 ma, quando nel 1865 si celebrò l’anniversario della nascita del poeta, Trieste, Trento, Verona e altre città erano ancora in mano agli austriaci. E così partecipare in quelle città alle grandi celebrazioni dantesche significava celebrare l’Italia. E perfino oggi, non è finita qui: l’Alighieri è tuttora uno dei poeti più studiati al mondo, la cosa incredibile è che a 750 anni dalla nascita, ancora escono su di lui e le sue opere circa 1.000-1.500 libri all’anno, io stesso sto lavorando a un saggio in cui, ancora, qualcosa di nuovo sul poeta viene scoperto».
Tante parole come tanti fiumi dove naufragar ci è dolce
In principio sta il monte del Purgatorio che galleggia in un mare immenso. Poi le invenzioni: la vitalità di Boccaccio, il cinema di Manzoni, il futuro di Leopardi. E noi
di Aurelio Picca (Corriere della Sera, 27.12.2015)
È scolastico sapere che le Civiltà sono nate lungo i grandi e piccoli fiumi (l’Egizia il Nilo; Romana il Tevere). Come forse è altrettanto facile intuire che le lingue le quali rendono possibile le letterature sono anch’esse fiumi che vanno al mare, cioè all’Opera. Siccome l’Italia è nata da cento lingue (come i popoli che l’hanno abitata), la nostra letteratura è, e resterà, il grembo di tutte le letterature occidentali. È inutile riandare al latino e alla sua frantumazione, così come è pleonastico ripercorrere le tappe dei volgari e della loro secolare incubazione e sviluppo. Si è sempre, con troppa leggerezza, bollato la mancanza di una tradizione romanzesca per ragioni storiche e sociali rispetto alla letteratura francese o inglese. Invece «lo spezzettamento» dello Stivale, con i suoi tanti volgari da convergere a Firenze, è stata la fortuna dei nostri scrittori e dunque della nostra letteratura.
Intanto va ricordato che Francesco d’Assisi è il primo poeta. Storto quanto un pezzo di legno e con una lingua (volgare umbro) altrettanto storta, in possesso di una manciata di vocaboli ancora deformati come ossa artritiche, inventa la creaturalità che irradia molta della letteratura a venire: da Dante a Petrarca, da Pascoli a d’Annunzio (basti La sera fiesolana ), a Ungaretti.
Di Dante non vedo Farinata degli Uberti e Costanza d’Altavilla, bensì godo del monte del Purgatorio galleggiare su un mare immenso; in su un cielo zaffiro e nell’acqua l’Arcangelo Nocchiero che a velocità «digitale» giunge ammantato di luce. Il Purgatorio, di preghiera e pazienza, è materia dell’oggi. Anche se il meccanicismo aristotelico non rimanda al libero arbitrio ma alla ineluttabilità del destino umano.
Francesco Petrarca non è stato il cortigiano come asseriva il De Sanctis: che dava vantaggio ai moderni, al «realismo», a una letteratura «morale» (comunque imprescindibile la sua Storia della letteratura ). Petrarca, con il Canzoniere , ha raggiunto una purezza perfino proibita al Manzoni che ne I promessi sposi accumula e salda lingue e trame diverse (altro che passaggio dal lombardo al fiorentino!). Petrarca fu la corona di alloro tradotto nel mondo e venerato; Alessandro Manzoni scrive per il cinema (notare come presenta Fra’ Cristoforo, l’Innominato...), per i pedanti (la sterminata notarilità delle «grida»), per i filologi, per i linguisti e per noi poveri lettori. Eppure Le tragedie , con il loro retrogusto giansenista, zavorrano appunto alla tragedia le illusioni della storia, concedendoci tombe monumentali.
Boccaccio è figlio bastardo di Firenze. Forse privato dell’esperienza napoletana non avrebbe scritto il Decameron, che invoglia la poesia alla vitalità e alla giovinezza del narrare, in un talamo di sensi, mentre a Firenze impazza la peste, cioè la tragedia. Ariosto e Tasso inventano i due grandi poemi moderni. L’ Orlando furioso è «inconscio puro» al servizio di incubi, voli astrali e pittori. La Gerusalemme liberata è «inconscio d’oro» (ambedue prima di Freud; in Tasso l’oro è Gerusalemme: l’unico inconscio collettivo dell’umanità). Machiavelli scrive Il Principe con sveltezza e cinismo. È padrone della corazza di Cesare e della lingua del vulgo. Il Principe è la favola del gioco del potere. Guicciardini pare soccombere a tanta abilità, invece grazie all’essere uno scrittore autentico sa pensare ai dettagli del corpo di un popolo, come un antico clinico romano. Se il «povero» Parini, nato in una casa popolare, l’incorruttibile estensore de Il giorno, è il gigante morale dei giovani che verranno (Leopardi, Foscolo), Vittorio Alfieri sarà il gigante eroico di quella generazione illuministico-romantica. In Vita scritta da esso si assommano le ragioni del suo titanismo o superlativo, giacché «Esso» sta per il Sé junghiano, e «Vita» per la vita che si stacca dal protagonista per assumere i connotati di tutte le vite. In questa tensione centrifuga, all’interno dell’autobiografia, scocca l’attrazione titanica per Colui che scrisse il primo romanzo italiano.
Nella borghesia che scalpita infastidita dall’orticaria delle «regole» troneggia Carlo Goldoni. Il suo teatro è la commedia, punto. Vi rumoreggia la strada. Del resto è un veneziano non un siciliano come Luigi Pirandello che studia e si forma in Germania. Infatti Pirandello trucca la sua opera di commedia per farla esplodere in dramma e follia. Che paradosso: Pirandello, isolano di Sicilia, ha struttura nordica, mentre Italo Svevo, triestino, legge Verga e La coscienza di Zeno gli viene comico: brogliaccio per la neo-avanguardia. Senilità è il romanzo che chiude ogni boheme, è un film di residuati umorali: un triste, indimenticabile amore in grigio, odor di naftalina, color di perle tarlate.
Leopardi nello Zibaldone ripropone le molte lingue e i molti pensieri della nostra letteratura. E quando gioca con i settenari, i novenari, gli endecasillabi è un piacere per l’orecchio. Le Operette morali sono una vetta da poema futuro, spalancato al futuro. Foscolo scrisse il primo romanzo italiano scritto da un ragazzino (l’ Ortis , no?). Eccetera. Cari insegnanti, fatelo imparare a memoria ai vostri studenti. Verga ha inciso novelle fulminanti, poi Eva , Tigre reale ... E una massa di cordame intrecciato che fa de I Malavoglia una furia della natura (Gli si deve baciare la mano da morto). Senza Carducci, quercia antica e «parnassiana» (vedasi Pianto antico ) non avremmo avuto Pascoli e d’Annunzio. Il primo: primo poeta del Novecento che, con Myricae , inventa il nuovo Canzoniere; d’Annunzio già con il suo corpo e i suoi mille gesti ripropone le lingue in nostro possesso. Fenoglio è fedele alla lingua; Calvino la tradisce per una neutra: questo è il suo successo.
Montale è Ossi di seppia (rimandiamo agli ultimi studi montaliani di Andrea Gareffi), un nonno gelido. Ungaretti è l’ Allegria di un nonno felice. Gadda è un concentrato di morbosità. Non è vero che la sua è una partitura complessa. Mentre Levi è Auschwitz: la memoria più semplice e complicata da capire quando gli uomini si fanno mostri.
-
> DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. --- Re e regina: i due corpi di Elisabetta I d’Inghilterra. Come una rergina inventò la rappresentazione della politica al femminile (di Nadia Fusini)29 maggio 2015, di Federico La Sala
Così una regina cambiò sesso alla parola potere
Come Elisabetta I d’Inghilterra inventò la rappresentazione della politica al femminile
di Nadia Fusini (la Repubblica, 28.05.2015)
- IL CONVEGNO A PISA Domani alla Scuola Normale Superiore di Pisa (ore 10) Donne e sovrane . Interverranno oltre a Nadia Fusini, di cui anticipiamo l’intervento, Lina Bolzoni, Monica Centanni, Benedetta Craveri, Manuela Fraire, Bahiyyih Nakhjavani, Victoria Rimell, Massimo Stella, Andrea Torre
NELLA storia e nel mito, nella realtà e nella leggenda, le donne sono state sovrane, hanno stretto nelle loro mani i simboli del potere. Ma hanno inventato un nuovo gesto? Una donna al comando si ispira a modelli diversi rispetto a un uomo? E oggi che alle donne sono aperti i luoghi del potere, le donne che vi giungono sanno di portare con sé una differenza, non singolare, ma di genere? Elisabetta I Tudor lo sa. Lo dimostra nel modo della costruzione del suo corpo simbolico, come ad esempio nel “ritratto dell’Armada”, in cui si celebra il trionfo sulla Spagna.
Quando dall’alto della costa dell’Essex, a Tilbury, Elisabetta vide la possente e magnifica flotta di Filippo II veleggiare in mare aperto, pronta a perpetrare quello che nella sua esaltazione della verginità, lei viveva come uno stupro, ebbe paura, forse. Però era lì, rivestita di una posticcia armatura guerresca, a cavallo di un bianco destriero.
Elisabetta era venuta tra il suo popolo in armi; senza esitazione s’era lanciata nel campo di battaglia, sito privilegiato della storia patriarcale. Come il padre Enrico VIII anni prima aveva assicurato al Parlamento che avrebbe in ogni cosa “messo in gioco” la sua persona, allo stesso modo Elisabetta ora è pronta a rischiare “il sangue regale”. Non nasconde la sua differenza, anzi, la denuncia: «so di avere un corpo di donna fragile e delicato», poi fa una pausa, di indubbia efficacia retorica, e aggiunge: «ma ho lo stomaco e il cuore di un re, e di un re d’Inghilterra ». Nomina due organi, il cuore, sede del coraggio, e lo stomaco, e cioè la pancia, come se lì si collocasse la capacità biologica, neutra - una potenza d’organo, capace di digerire e tenere fronte agli eventi. Non dice “grembo”, termine più femminile per indicare l’addome; dice appunto “stomaco”, che è assai virile.
Quand’ecco che un uragano arruffa le onde, e quelle tramutano in pareti d’acqua, che inghiottono i sontuosi vascelli. Si leva una tempesta - propizia per la sua causa e per il suo popolo, e l’Invincibile Armata sparisce tra i flutti. È la conferma del credo che nessuno mai potrà violare il corpo dell’isola, né quello della regina, che si fondono nella stessa iniziale, la Edi Elizabeth valendo come la E iniziale di England - lettera che la regina ha fatto miniare con lo stesso identico ricamo sulle sue vesti.
Come altrimenti interpretare la provvidenziale tempesta, se non come la prova provata dell’impenetrabilità dell’isola? È un fatto che se all’immagine dell’isola Elisabetta ha sempre associato un’idea di purezza, di non contaminazione, di perfetto e assoluto controllo dei confini, dopo Tilbury il motivo diventerà un tema profondo della sua regalità, una immagine sacra, quasi un ta- lismano magico.
Elisabetta diventa nell’immaginazione popolare la stessa cosa della terra su cui regna, l’isola impenetrabile che il mare difende, quasi fosse un vallo, dall’invidia delle nazioni meno felici, perché “non elette”. Così recita la propaganda, e la parola fa da spia all’orgoglio della fede riformata, che si rappresenta in Elisabetta Rex.
Se nei ritratti, nelle medaglie, nelle incisioni volte a diffondere all’epoca la fede nella efficacia del simbolo regale, la magnificenza del padre Enrico VIII è esaltata nella potenza muscolare del maschio; se, come nel celebre ritratto di Holbein, il diritto di Enrico a regnare è confermato dalla virilità della gonfia brachetta, il diritto di Elisabetta sempre più si confonde con la sua sessualità mistica, verginale. Al posto della gonfia brachetta, il ritratto dell’Armada esibisce una perla gigantesca. Alla base del triangolo che dal seno e dalla vita scende sul grembo, lo sguardo è condotto sulla perla della regina. Le perle sono dappertutto; chiudono la veste, stringono il corpetto, decorano la fronte. Ma sulla fronte e sul sesso spiccano le più grandi: enormi gemme che definiscono Elisabetta Rex come una creatura impermeabile, impenetrabile, potente perché inviolabile. Una donna al potere genera angoscia, una donna sul trono non fa parte delle idee condivise, che si sostengono alla tradizione. Secondo una immagine paolina, molto attestata nelle letture bibliche della religione riformata, e secondo una pratica intesa al sesso riproduttivo, l’unico giustificato sempre dallo stesso punto di vista, la donna deve stare sotto, non sopra.
Il miracolo di Elisabetta è che una volta sul trono, riuscirà in un paradosso: si creerà una “persona”, e cioè una maschera che incorpora il “corpo politico” idealizzato del padre, senza però nascondere i propri attributi femminili. Compone così un ibrido, è Re e regina insieme, è due in uno. Vede chiaramente il suo ruolo di governante come un ruolo maschile, che però, proprio perché un ruolo, anche lei, che è donna, può recitare - allo stesso modo delle eroine delle commedie shakespeariane, Porzia del Mercante, Viola nella Dodicesima notte . Non ha il principe un corpo doppio? un corpo sessuale e un corpo simbolico? un corpo fisico e un corpo metafisico? un corpo di carne e sangue e un corpo spirituale, come un arto fantasma? Non è forse il corpo del re questa meraviglia di un costrutto biosimbolico capace di trascendenza? di metamorfosi? o transustanziazione?
Se questo valeva per il corpo infantile di Edoardo, e prima ancora per il corpo gracile di Riccardo II, principe con il quale Elisabetta sente una strana consonanza, perché non può valere per il suo corpo naturale, che è quello fragile di una donna? Elisabetta è coraggiosa come un leone, scaltra come una volpe e soprattutto è una incomparabile teatrante. E sa sostenere lo sguardo sul mistero del potere: chiunque lo detenga, uomo o donna che sia, il potere sempre ha bisogno della mistificazione e dell’inganno. Diventa nell’immaginazione popolare la stessa cosa della terra su cui regna, l’isola impenetrabile che il mare difende.
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. ---- IN PRAECLARA SUMMORUM. ENCICLICA di BENEDETTO XV (1921) PER IL VI CENTENARIO DELLA MORTE -DI DANTE ALIGHIERI8 novembre 2014, di Federico La Sala
Diletti figli, salute e Apostolica Benedizione.
Nella illustre schiera dei grandi personaggi, che con la loro fama e la loro gloria hanno onorato il cattolicesimo in tanti settori ma specialmente nelle lettere e nelle belle arti, lasciando immortali frutti del loro ingegno e rendendosi altamente benemeriti della civiltà e della Chiesa, occupa un posto assolutamente particolare Dante Alighieri, della cui morte si celebrerà tra poco il sesto centenario. Mai, forse, come oggi fu posta in tanta luce la singolare grandezza di questo uomo, mentre non solo l’Italia, giustamente orgogliosa di avergli dato i natali, ma tutte le nazioni civili, per mezzo di appositi comitati di dotti, si accingono a solennizzarne la memoria, affinché questo eccelso genio, che è vanto e decoro dell’umanità, venga onorato dal mondo intero.
Noi pertanto, in questo magnifico coro di tanti buoni, non dobbiamo assolutamente mancare, ma presiedervi piuttosto, spettando soprattutto alla Chiesa, che gli fu madre, il diritto di chiamare suo l’Alighieri.
Quindi, come al principio del Nostro Pontificato, con una lettera diretta all’Arcivescovo di Ravenna, Ci siamo fatti promotori dei restauri del tempio presso cui riposano le ceneri dell’Alighieri, così ora, quasi ad iniziare il ciclo delle feste centenarie, Ci è parso opportuno rivolgere la parola a voi tutti, diletti figli, che coltivate le lettere sotto la materna vigilanza della Chiesa, per dimostrare ancor meglio l’intima unione di Dante con questa Cattedra di Pietro, e come le lodi tributate a così eccelso nome ridondino necessariamente in non piccola parte ad onore della fede cattolica.
In primo luogo, poiché il nostro Poeta durante l’intera sua vita professò in modo esemplare la religione cattolica, si può dire consentaneo ai suoi voti che questa commemorazione solenne si faccia, come si farà, sotto gli auspici della religione; e che se essa avrà compimento in San Francesco di Ravenna, s’inizi però a Firenze, in quel suo bellissimo San Giovanni, a cui negli ultimi anni di sua vita egli, esule, con intensa nostalgia ripensava, bramando e sospirando di essere incoronato poeta sul fonte stesso dove, bambino, era stato battezzato.
Nato in un’epoca nella quale fiorivano gli studi filosofici e teologici per merito dei dottori scolastici, che raccoglievano le migliori opere degli antichi e le tramandavano ai posteri dopo averle illustrate secondo il loro metodo, Dante, in mezzo alle varie correnti del pensiero, si fece discepolo del principe della Scolastica Tommaso d’Aquino; e dalla sua mente di tempra angelica attinse quasi tutte le sue cognizioni filosofiche e teologiche, mentre non trascurava nessun ramo dell’umano sapere e beveva largamente alle fonti della Sacra Scrittura e dei Padri. Appreso così quasi tutto lo scibile, e nutrito specialmente di sapienza cristiana, quando si accinse a scrivere, dallo stesso mondo della religione egli trasse motivo per trattare in versi una materia immensa e di sommo respiro.
In questa vicenda si deve ammirare la prodigiosa vastità ed acutezza del suo ingegno, ma si deve anche riconoscere che ben poderoso slancio d’ispirazione egli trasse dalla fede divina, e che quindi poté abbellire il suo immortale poema della multiforme luce delle verità rivelate da Dio, non meno che di tutti gli splendori dell’arte.
Infatti tutta la sua Commedia, che meritatamente ebbe il titolo di divina, pur nelle varie finzioni simboliche e nei ricordi della vita dei mortali sulla terra, ad altro fine non mira se non a glorificare la giustizia e la provvidenza di Dio, che governa il mondo nel tempo e nell’eternità, premia e punisce gli uomini, sia individualmente, sia nelle comunità, secondo le loro responsabilità. Quindi in questo poema, conformemente alla rivelazione divina, risplendono la maestà di Dio Uno e Trino, la Redenzione del genere umano operata dal Verbo di Dio fatto uomo, la somma benignità e liberalità di Maria Vergine Madre, Regina del Cielo, e la superna gloria dei santi, degli angeli e degli uomini. Ad esso si contrappone la dimora delle anime che, una volta consumato il periodo di espiazione previsto per i peccatori, vedono aprirsi il cielo davanti a loro. Ed emerge che una sapientissima mente governa in tutto il poema l’esposizione di questi e di altri dogmi cattolici.
Se il progresso delle scienze astronomiche dimostrò poi che non aveva fondamento quella concezione del mondo, e che non esistono le sfere supposte dagli antichi, trovando che la natura, il numero e il corso degli astri e dei pianeti sono assolutamente diversi da quanto quelli ne pensavano, non venne meno però il principio fondamentale, che l’universo, qualunque sia l’ordine che lo sostiene nelle sue parti, è opera del cenno creatore e conservatore di Dio onnipotente, il quale tutto muove, e la cui gloria risplende in una parte più, e meno altrove; questa terra che noi abitiamo, quantunque non sia il centro dell’universo, come un tempo si credeva, tuttavia è sempre stata la sede della felicità dei nostri progenitori, e testimone in seguito della loro miserrima caduta, che segnò per essi la perdita di quella felice condizione che fu poi restituita dal sangue di Gesù Cristo, eterna salvezza degli uomini. Perciò Dante, che aveva costruito nel proprio pensiero la triplice condizione delle anime, immaginando prima del giudizio finale sia la dannazione dei reprobi, sia l’espiazione delle anime pie, sia la felicità dei beati, deve essere stato ispirato dalla luce della fede.
In verità Noi riteniamo che gl’insegnamenti lasciatici da Dante in tutte le sue opere, ma specialmente nel suo triplice carme, possano servire quale validissima guida per gli uomini del nostro tempo. Innanzi tutto i cristiani debbono somma riverenza alla Sacra Scrittura e accettare con assoluta docilità quanto essa contiene. In ciò l’Alighieri è esplicito: « Sebbene gli scrivani della divina parola siano molti, tuttavia il solo che detta è Dio, il quale si è degnato di esprimerci il suo messaggio di bontà attraverso le penne di molti » [1]. Espressione splendida e assolutamente vera! E così pure la seguente: « Il Vecchio e il Nuovo Testamento, emessi per l’eternità, come dice il Profeta » contengono « insegnamenti spirituali che trascendono la ragione umana », impartiti « dallo Spirito Santo, il quale attraverso i Profeti, gli Scrittori di cose sacre, nonché attraverso Gesù Cristo, coeterno Figlio di Dio, e i suoi discepoli rivelò la verità soprannaturale e a noi necessaria » [2]. Pertanto Dante dice giustamente che da quell’eternità che verrà dopo il corso della vita mortale « noi traiamo la certezza che viene dall’infallibile dottrina di Cristo, la quale è Via, Verità e Luce: Via, perché attraverso essa giungiamo senza ostacoli alla beatitudine eterna; Verità, perché essa è priva di qualsiasi errore; Luce, perché ci illumina nelle tenebre terrene dell’ignoranza » [3]. Egli onora di non minore rispetto « quei venerandi Concìli principali, ai quali tutti i fedeli credono senza alcun dubbio che Cristo abbia partecipato ». Oltre a questi, Dante tiene in grande stima « le scritture dei dottori, di Agostino e di altri ». In proposito, egli dice: « Chi dubita che essi siano stati aiutati dallo Spirito Santo, o non ha assolutamente visto i loro frutti o, se li ha visti, non li ha mai gustati » [4].
Per la verità, l’Alighieri ha una straordinaria deferenza per l’autorità della Chiesa Cattolica e per il potere del Romano Pontefice, tanto che a suo parere sono valide tutte le leggi e tutte le istituzioni della Chicaa che dallo stesso sono state disposte. Da qui quell’energica ammonizione ai cristiani: dal momento che essi hanno i due Testamenti, e contemporaneamente il Pastore della Chiesa dal quale sono guidati, si ritengano soddisfatti di questi mezzi di salvezza. Perciò, afflitto dai mali della Chiesa come fossero suoi, mentre deplora e stigmatizza ogni ribellione dei cristiani al Sommo Pontefice dopo il trasferimento dell’Apostolica Sede da Roma [ad Avignone], così scrive ai Cardinali Italiani: «Noi, dunque, che confessiamo il medesimo Padre e Figliuolo: il medesimo Dio e uomo, e la medesima Madre e Vergine; noi, per i quali e per la salvezza dei quali fu detto a colui che era stato interrogato tre volte a proposito della carità: “ Pasci, o Pietro, il sacrosanto ovile ”; noi che di Roma (cui, dopo le pompe di tanti trionfi, Cristo con le parole e con le opere confermò l’imperio sul mondo, e che Pietro ancora e Paolo, l’Apostolo delle genti, consacrarono quale Sede Apostolica col proprio sangue), siamo costretti con Geremia, facendo lamenti non per i futuri ma per i presenti, a piangere dolorosamente, di essa, quale vedova e derelitta; noi siamo affranti nel vedere lei così ridotta, non meno che il vedere la piaga deplorevole delle eresie » [5].
Dunque egli definisce la Chiesa Romana quale «Madre piissima » o « Sposa del Crocifisso », e Pietro quale giudice infallibile della verità rivelata da Dio, cui è dovuta da tutti assoluta sottomissione in materia di fede e di comportamento ai fini della salvezza eterna. Pertanto, quantunque ritenga che la dignità dell’Imperatore venga direttamente da Dio, tuttavia egli dichiara che « questa verità non va intesa così strettamente che il Principe Romano non si sottometta in qualche caso al Pontefice Romano, in quanto la felicità terrena e in un certo modo subordinata alla felicità eterna » [6]. Principio davvero ottimo è sapiente, che se fosse fedelmente osservato anche oggi recherebbe certamente copiosi frutti di prosperità agli Stati.
Ma, si dirà, egli inveì con oltraggiosa acrimonia contro i Sommi Pontefici del suo tempo. È vero; ma contro quelli che dissentivano da lui nella politica e che egli credeva stessero dalla parte di coloro che lo avevano cacciato dalla patria. Tuttavia si deve pur compatire un uomo, tanto sbattuto dalla fortuna, se con animo esulcerato irruppe talvolta in invettive che passavano il segno, tanto più che ad esasperarlo nella sua ira non furono certo estranee le false notizie propalate, come suole accadere, da avversari politici sempre propensi ad interpretare tutto malignamente. Del resto, poiché la debolezza è propria degli uomini, e « nemmeno le anime pie possono evitare di essere insudiciate dalla polvere del mondo » [7], chi potrebbe negare che in quel tempo vi fossero delle cose da rimproverare al clero, per cui un animo così devoto alla Chiesa, come quello di Dante, ne doveva essere assai disgustato, quando sappiamo che anche uomini insigni per santità allora le riprovarono severamente?
Tuttavia, per quanto si scagliasse nelle sue invettive veementi, a ragione o a torto, contro persone ecclesiastiche, però non venne mai meno in lui il rispetto dovuto alla Chiesa e la riverenza alle Somme Chiavi; per cui nella sua opera politica intese difendere la propria opinione « con quell’ossequio che deve usare un figlio pio verso il proprio padre, pio verso la madre, pio verso Cristo, pio verso la Chiesa, pio verso il Pastore, pio verso tutti coloro che professano la religione Cristiana, per la tutela della verità » [8].
Pertanto, avendo egli basato su questi saldi principi religiosi tutta la struttura del suo poema, non stupisce se in esso si riscontra un vero tesoro di dottrina cattolica; cioè non solo il succo della filosofia e della teologia cristiana, ma anche il compendio delle leggi divine che devono presiedere all’ordinamento ed all’amministrazione degli Stati; infatti l’Alighieri non era uomo che per ingrandire la patria o compiacere ai prìncipi potesse sostenere che lo Stato può misconoscere la giustizia e i diritti di Dio, perché egli sapeva perfettamente che il mantenimento di questi diritti è il principale fondamento delle nazioni.
Indicibile, dunque, è il godimento che procura l’opera del Poeta; ma non minore è il profitto che lo studioso ne ricava, perfezionando il suo gusto artistico ed accendendosi di zelo per la virtù, a condizione però che egli sia spoglio di pregiudizi, ed aperto alla verità. Anzi, mentre non è scarso il numero dei grandi poeti cattolici che uniscono l’utile al dilettevole, in Dante è singolare il fatto che, affascinando il lettore con la varietà delle immagini, con la vivezza dei colori, con la grandiosità delle espressioni e dei pensieri, lo trascina all’amore della cristiana sapienza; né alcuno ignora che egli apertamente dichiara di aver composto il suo poema per apprestare a tutti vitale nutrimento. Infatti sappiamo che alcuni, anche recentemente, lontani sì, ma non avversi a Cristo, studiando con amore la Divina Commedia, per divina grazia, prima cominciarono ad ammirare la verità della fede cattolica e poi finirono col gettarsi entusiasti tra le braccia della Chiesa.
Quanto abbiamo esposto fino ad ora è sufficiente per dimostrare quanto sia opportuno che, in occasione di questo centenario che interessa tutto il mondo cattolico, ciascuno alimenti il suo zelo per conservare quella fede che sì luminosamente si rivelò, se in altri mai, nell’Alighieri, quale fautrice della cultura e dell’arte. Infatti, in lui non va soltanto ammirata l’altezza somma dell’ingegno, ma anche la vastità dell’argomento che la religione divina offerse al suo canto. Se la natura gli aveva fornito un ingegno tanto acuto, affinato nel lungo studio dei capolavori degli antichi classici, maggiore acutezza egli trasse, come abbiamo detto, dagli scritti dei Dottori e dei Padri della Chiesa, che consentirono al suo pensiero di elevarsi e di spaziare in orizzonti ben più vasti di quelli racchiusi nei limiti ristretti della natura. Perciò egli, quantunque separato da noi da un intervallo di secoli, conserva ancora la freschezza di un poeta dell’età nostra; e certamente è assai più moderno di certi vati recenti, esumatori di quell’antichità che fu spazzata via da Cristo, trionfante sulla Croce. Spira nell’Alighieri la stessa pietà che è in noi; la sua fede ha gli stessi sentimenti, e degli stessi veli si riveste « la verità a noi venuta dal cielo e che tanto ci sublima ». Questo è il suo elogio principale: di essere un poeta cristiano e di aver cantato con accenti quasi divini gli ideali cristiani dei quali contemplava con tutta l’anima la bellezza e lo splendore, comprendendoli mirabilmente e dei quali egli stesso viveva. Conseguentemente, coloro che osano negare a Dante tale merito e riducono tutta la sostanza religiosa della Divina Commedia ad una vaga ideologia che non ha base di verità, misconoscono certo nel Poeta ciò che è caratteristico e fondamento di tutti gli altri suoi pregi.
Dunque, se Dante deve alla fede cattolica tanta parte della sua fama e della sua grandezza, valga solo questo esempio, per tacere gli altri, a dimostrare quanto sia falso che l’ossequio della mente e del cuore a Dio tarpi le ali dell’ingegno, mentre lo sprona e lo innalza; e quanto male rechino al progresso della cultura e della civiltà coloro che vogliono bandita dall’istruzione ogni idea di religione. È, infatti, assai deplorevole il sistema ufficiale odierno di educare la gioventù studiosa come se Dio non esistesse e senza la minima allusione al soprannaturale. Poiché sebbene in qualche luogo il « poema sacro » non sia tenuto lontano dalle scuole pubbliche e sia anzi annoverato fra i libri che devono essere più studiati, esso però non suole per lo più recare ai giovani quel vitale nutrimento che è destinato a produrre, in quanto essi, per l’indirizzo difettoso degli studi, non sono disposti verso la verità della fede come sarebbe necessario.
Volesse il cielo che queste celebrazioni centenarie facessero in modo che ovunque si impartisse l’insegnamento letterario, che Dante fosse tenuto nel dovuto onore e che egli stesso pertanto fosse per gli studenti un maestro di dottrina cristiana, dato che egli, componendo il suo poema, non ebbe altro scopo che « sollevare i mortali dallo stato di miseria », cioè del peccato, e « di condurli allo stato di beatitudine », cioè della grazia divina [9].
E voi, diletti figli, che avete la fortuna di coltivare lo studio delle lettere e delle belle arti sotto il magistero della Chiesa, amate e abbiate caro, come fate, questo Poeta, che Noi non esitiamo a definire il cantore e l’araldo più eloquente del pensiero cristiano. Quanto più vi dedicherete a lui con amore, tanto più la luce della verità illuminerà le vostre anime, e più saldamente resterete fedeli e devoti alla santa Fede.
Quale auspicio dei celesti favori ed a testimonianza della Nostra paterna benevolenza, impartiamo con affetto a voi tutti, diletti figli, l’Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 30 aprile 1921, nell’anno settimo del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
[1] Mon. III, 4.
[2] Mon. III, 3, 16.
[3] Conv. II, 9.
[4] Mon. III, 3.
[5] Epist. VIII.
[6] Mon. III, 16.
[7] S. Leo M., Serm. 4 de Quadrag.
[8] Mon. III, 3.
[9] Epist. X, 15.
-
> Per una rilettura del "De Vulgari Eloquentia" e della "Monarchia" ---- Per i Papi e gli Imperatori di oggi, serve una «teologia fatta in ginocchio» (di Papa Francesco - Indicazione)..29 giugno 2014, di Federico La Sala
Ecumenismo
Papa: serve una «teologia fatta in ginocchio»
di Alessandro Gisotti - Radio Vaticana (Avvenire, 28 giugno 2014)
Bisogna lasciarsi guidare dallo Spirito Santo per avanzare verso l’unità dei cristiani. E’ l’esortazione levata da Papa Francesco nell’udienza alla Delegazione ecumenica del Patriarcato di Costantinopoli, ricevuta alla vigilia della Solennità dei Santi Patroni di Roma, Pietro e Paolo. Il Pontefice ha sottolineato che anche partendo da prospettive diverse, attraverso una “teologia fatta in ginocchio” si può arrivare ad un cammino di unità.
Condividere la gioia di essere fratelli. Papa Francesco si è rivolto alla delegazione della “Chiesa sorella di Costantinopoli” rivolgendo innanzitutto il pensiero al Patriarca ecumenico Bartolomeo I, “amato fratello” con il quale ha vissuto insieme l’esperienza del pellegrinaggio in Terra Santa e poi la Preghiera per la pace nei Giardini Vaticani.
Il Papa ha ricordato l’abbraccio tra Paolo VI e Atenagora. Un gesto profetico, ha osservato, che ha dato “impulso ad un cammino” che “non si è più arrestato”: “Il Signore ci ha donato queste occasioni di incontro fraterno, nelle quali abbiamo avuto la possibilità di manifestare l’uno all’altro l’amore in Cristo che ci lega, e di rinnovare la volontà condivisa di continuare a camminare insieme sulla strada verso la piena unità”.
Sappiamo bene, ha aggiunto, che “questa unità è un dono di Dio” ed ha ribadito che grazie alla “forza dello Spirito Santo” possiamo “guardarci gli uni gli altri con gli occhi della fede”, “riconoscerci per quello che siamo nel piano di Dio” e “non per ciò che le conseguenze storiche dei nostri peccati ci hanno portato ad essere”:
 “Se impareremo, guidati dallo Spirito, a guardarci sempre gli uni gli altri in Dio, sarà ancora più spedito il nostro cammino e più agile la collaborazione in tanti campi della vita quotidiana che già ora felicemente ci unisce”.
“Se impareremo, guidati dallo Spirito, a guardarci sempre gli uni gli altri in Dio, sarà ancora più spedito il nostro cammino e più agile la collaborazione in tanti campi della vita quotidiana che già ora felicemente ci unisce”.Questo sguardo teologale, ha proseguito, “si nutre di fede, di speranza, di amore”. Esso, è stata la sua riflessione, “è capace di generare una riflessione teologica autentica”, che è in realtà “partecipazione allo sguardo che Dio ha su se stesso e su di noi”. Una riflessione, ha affermato, “che non potrà che avvicinarci gli uni agli altri, nel cammino dell’unità, anche se partiamo da prospettive diverse”:
 "Confido pertanto, e prego, affinché il lavoro della Commissione mista internazionale possa essere espressione di questa comprensione profonda, di questa teologia “fatta in ginocchio”.
"Confido pertanto, e prego, affinché il lavoro della Commissione mista internazionale possa essere espressione di questa comprensione profonda, di questa teologia “fatta in ginocchio”.La riflessione sui concetti di primato e di sinodalità, sulla comunione nella Chiesa universale, sul ministero del Vescovo di Roma, non sarà allora un esercizio accademico né una semplice disputa tra posizioni inconciliabili.
“Abbiamo tutti bisogno di aprirci con coraggio e fiducia all’azione dello Spirito Santo - ha soggiunto - di lasciarsi coinvolgere nello sguardo di Cristo sulla Chiesa” nel cammino di un “ecumenismo spirituale rafforzato dal martirio” di tanti cristiani che “hanno realizzato l’ecumenismo del sangue”.
-
>L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. --- "Maps of Paradise": un lavoro di Alessandro Scafi (di Claudio Gallo - Paradiso in terra dove sia qualcun lo sa) - L’Impero come un Paradiso (di Massimo Cacciari)20 dicembre 2013, di Federico La Sala
Paradiso in terra dove sia qualcun lo sa
di Claudio Gallo (La Stampa, 16 dicembre 2013)
«Immagina che non ci sia nessun paradiso, provaci, non è poi così difficile, immagina che non ci sia nessun inferno sotto di noi». Così cantava John Lennon nel 1971, con la sua Imagine, proponendo di abolire il paradiso mentre, per l’ineludibile dialettica delle cose, ne proponeva una nuova versione. Si può vivere senza un altrove? Sembrerebbe di no, perché, anche nelle menti più scettiche, l’idea o l’immagine emerge puntualmente dal pozzo tenebroso da cui sorge la coscienza. Non ci credo, ma lo immagino.
Gli antichi, che vedevano il mondo con occhi diversi dai nostri, non si ponevano il problema della sua esistenza ma s’interrogavano sul dove. Una raffinata scienza cartografica si sviluppò lungo i secoli per indicare dove il paradiso terrestre fosse situato. Una «scienza» cangiante che si è prefissata l’obiettivo di spiegare l’inspiegabile e che è riuscita a sopravvivere anche all’era delle misurazioni esatte.
Segue il suo percorso affascinante, che è allo stesso tempo una mappa della nostra mente, lo storico Alessandro Scafi, docente al Warburg Institute di Londra, nel suo Maps of Paradise , appena pubblicato in Gran Bretagna (dalla British Library) e in Nord America (dalla University of Chicago Press) e in attesa di traduzione italiana. Il libro traccia la storia della cartografia di una specifica forma di paradiso: il Giardino dell’Eden descritto nel libro della Genesi . Il termine usato nella versione ebraica è «Gan Eden», Giardino dell’Eden.
La parola persiana da cui deriva il termine paradiso adottato nelle versioni greche e latine della Genesi, «pairi-daeza», indicava all’inizio (nell’epoca achemenide, tra il ’600 e il ’300 a.C.) uno spazio chiuso da un muro. Quando i traduttori greci e latini dell’originale ebraico scelsero il termine paradiso trasformarono il luogo perfetto di Adamo ed Eva in un giardino recintato. È interessante che per tutta l’antichità l’ideale di perfezione fosse rigorosamente uno spazio finito. L’idea di un infinito illimitato, che a un filosofo greco avrebbe fatto orrore, è un dono della modernità, con le sue dimensioni disumane. Il paradiso socialista, di cui Marx profetizzava l’avvento sulla terra, nasceva proprio dalla negazione dell’accumulazione illimitata delle ricchezze per tornare al limite naturale del rapporto umano. Ciò che i greci chiamavano «metron» e mettevano alla base di ogni convivenza sociale.
Dall’inizio dell’era cristiana fino al Rinascimento le mappe del mondo situavano il Paradiso a Oriente perché così era indicato in alcune traduzioni della Genesi . «Infatti, in molte mappe medievali - ha spiegato Scafi presentando il libro all’Istituto italiano di cultura di Londra - il paradiso è localizzato a Est. Le moderne misurazioni geografiche non rappresentano che luoghi. Ma prima del Rinascimento, prima della riscoperta della geografia tolemaica, prima dell’uso di longitudine e latitudine, le mappe del mondo erano narrazioni storiche piuttosto che rappresentazioni geografiche».
Niente di più distante da Google Maps delle mappe medievali (anche se Google Earth ha cominciato a inserire una dimensione storica). Nelle antiche carte si compendiava la storia del mondo: il dramma dell’umanità si rivelava attraverso la geografia. Si poteva vedere il mondo di ieri ma anche il mondo di domani che, coincidendo con la fine dei tempi, era al di fuori del tempo e dello spazio: uno stato rappresentabile ma non pensabile.
«In Armenia - ha detto Scafi, illustrando il mappamondo di Hereford - vediamo l’Arca di Noè, in Mesopotamia la Torre di Babele, tra il Sinai e il Mar Rosso l’esodo del popolo d’Israele; a Gerusalemme la crocifissione di Gesù Cristo; a Creta il labirinto di Minosse; in Asia il Vello d’oro degli Argonauti. Nel Medioevo si credeva che lo spazio fosse inestricabilmente legato al tempo, una cosa tornata ovvia agli occhi dei fisici del ’900».
Il paradiso terrestre in quelle mappe è fissato nel momento topico in cui Adamo ed Eva commisero il peccato originale, come la finestra di un’altra dimensione affacciata sul presente. Così il giardino dell’Eden esiste e non esiste allo stesso tempo, è geograficamente localizzabile sulla terra ma rimane inaccessibile. Un luogo che è contemporaneamente dentro e fuori del mondo, sulla terra ma non della terra. Lo spazio diventa una semplice convenzione: mentre i cristiani medievali immaginavano un paradiso a Oriente, i loro contemporanei buddisti guardavano al paradiso d’Occidente.
Profondi cambiamenti nella teologia e nella cartografia hanno poi trasformato la visione medievale di un giardino ancora esistente in un Oriente misterioso nell’idea moderna di un paradiso perduto, i cui resti sono stati identificati con precisione in vari luoghi del mondo conosciuto. Nei modi più vari e ingegnosi cartografi e teologi hanno tentato per due millenni di situare il loro paradiso.
Nessuno più di Dante ha cercato di spiegare perché il paradiso non si può spiegare: «Nel ciel che più de la sua luce prende / fu’ io, e vidi cose che ridire / né sa né può chi di là su discende / perché appressando sé al suo disire / nostro intelletto si profonda tanto / che dietro la memoria non può ire»
Una nuova edizione del “Monarchia”
Quando Dante immaginava l’Impero come un Paradiso
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 17.12.2013)
- Monarchia di Dante Alighieri, a cura di P. Chiesa e A. Tabarron,i Salerno, pagg. 600 euro 49
L’edizione del Monarchia di Dante, a cura di Paolo Chiesa e Andrea Tabarroni, recentemente pubblicata come IV° volume della nuova edizione commentata delle Opere, coordinata da Enrico Malato, non si segnala soltanto per la ricchezza di note e apparati, per alcuni interventi migliorativi del testo-base, per l’ampia introduzione generale e quelle, essenziali, alle singole parti del volume.
Ma è notevole anche per la presenza di alcuni importantissimi “documenti” riguardanti la fortuna dello scritto dantesco, tra i quali il De reprobatione di Guido Vernani, radicale e filosoficamente nient’affatto sprovveduto attacco al Monarchia da parte del frate domenicano; il Commentarium al Monarchia di Cola di Rienzo, testimonianza della sua passione per la gloria di Roma, di un “culto” che Dante definisce nella sua portata teorica e da lì, anche proprio attraverso Cola, trapassa nell’Umanesimo; infine il “volgarizzamento” del Monarchia, steso dal grande Ficino, alla fine degli anni ’60 del ’400, non solo in funzione anti-repubblicana, ma per rivendicare Dante alla pia philosophiae cioè alla “catena aurea” del platonismo.
Interpretazioni o “fra-intendimenti” diversissimi, che non nascono soltanto dalle posizioni spesso incompatibili dei loro autori, ma proprio dalla novità e complessità dell’opera di Dante, soprattutto se letta insieme alla Commedia (come appare necessario fare, poiché certamente essa viene scritta in anni nei quali Dante è già tutto immerso, mente e cuore, nella stesura del poema).
Della sua novità ,come per le altre sue opere, Dante è “superbamente” consapevole - e così dello scandalo che essa è destinata a suscitare. Malgrado le numerose citazioni da Agostino, riguardanti essenzialmente questioni intorno al metodo dell’esegesi, Dante non poteva non avvertire l’abisso tra la sua concezione della civitas hominis, la sua idea di Roma e di Impero, e quelle dell’intera tradizione patristica e dello stesso “aristotelismo” tomista.
Da remedium o addirittura semplice solacium per l’infermità della nostra natura vulnerata dal peccato, in Dante l’Impero (e cioè la forma provvidenzialmente destinata a unire politicamente il genere umano), la cui idea stessa viene da lui proposta in termini puramente filosofico-scientifici, esclusivamente per philosophica documenta, è chiamato a assicurare autentica felicità terrena, a edificare l’autentico Paradiso terrestre. Da Babilonia, quale era per Agostino, Roma si trasforma in Roma celeste!
Ma nella Commedia questo Fine appare davvero ancora garantito dall’opera del solo Impero, nella razionale autonomia della sua forma? Questo l’enigma, su cui Chiesa e Tabarroni invitano ancora a riflettere. Virgilio, la prima guida di Dante, si arresta alla soglia del Paradiso terrestre, non vi entra e tantomeno potrebbe spiegarne i simboli; stupisce e basta sullo spettacolo che gli si rivela. È Beatrice a “far entrare” il poeta, e solo dopo che egli ha bevuto tutto l’amaro calice della confessione e del pentimento. L’architettura della Commedia, nei nessi costitutivi rappresentati dalle guide del poeta, segna una profonda discontinuità con quella del Convivio e del Monarchia.
Come spiegarla? Amara delusione e disincanto dopo il fallimento delle ultime speranze, che ancora avrebbero animato l’opera politica? Ma il Monarchia è tutto fuorché uno scritto “militante”; provvidenziale appare a Dante il corso della storia, ed egli vuol esserne il profeta. In questo schema è inserita la gloria di Roma, modello di perfetto potere politico, di Impero. Ma è la forza ideal-eterna di questo disegno che finisce col rendere contraddittorio il famoso simbolo dei due Soli, Chiesa e Impero, perfettamente distinti nei rispettivi domini e nelle rispettive missioni. Se, infatti, il perfetto potere politico è concepibile soltanto in quanto voluto ab origine dal Signore, in quanto provvidenziale nel senso più proprio e più forte, la felicitas che esso promette è necessariamente subordinata a quella ultima, alla beatitudo celeste. E sembra essere questa, alla fine, l’indicazione che emerge dalla Commedia.
Dante rompe definitivamente con la teologia politica patristica e medievale, ma non è affatto anacronisticamente leggibile nel senso di Marsilio da Padova e della filosofia politica moderna successiva. L’Impero di Dante non sono i regna, o ormai potremmo dire gli Stati, che ha in mente Marsilio. Dante segna la grandiosa soglia tra due epoche - quella di un’idea del Politico che, pur nel rivendicare la propria razionale autonomia, lotta per non perdere ogni fondamento sacrale, e quella che ne risolve il significato e la missione nella immanente potenza delle sue leggi, nella positività del suo diritto. Per quest’ultima, che il Giustiniano imperatore di Dante trovi posto, e vera pace, solo in Paradiso diverrà il simbolo di un’epoca per sempre tramontata.
-
> L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. --- "Il Paradiso in terra". Ecco i luoghi del Paradiso terrestre.22 dicembre 2013, di Federico La Sala
LA MAPPA
Ecco i luoghi del Paradiso terrestre
di Roberta Beretta (Avvenire, 3 giugno 2012)
Che bel posto! È un paradiso... Tra il deserto e il Polo Nord, Gerusalemme e Bristol, ci sono almeno una ventina di luoghi al mondo che potrebbero sostenere la nomea letteralmente parlando; nel senso che sono stati identificati come ubicazione geografica del paradiso. Terrestre, sì; però sempre tale. Ma come: non si trattava, per l’Eden, di un luogo mitico, simbolico, leggendario e dunque assolutamente impossibile da localizzare?
Beh, qualunque serio esegeta abbozzerebbe oggi un sorrisetto di compatimento alla richiesta di indicare sul mappamondo il paradiso terrestre; però è altrettanto vero che la storia è zeppa di appassionati che hanno tentato di farlo.
Ne produce ora un censimento l’atlante di Brook Wilensky-Lanford Il paradiso ritrovato. Sulle tracce del giardino dell’Eden (Edt, pp. 328, euro 20) - ma analoga impresa era confluita anni fa pure in una mostra internazionale e poi nel libro di Alessandro Scafi Il paradiso in terra (Bruno Mondadori). Ecco dunque un elenco di tentativi serissimi oppure folli, elaborati a tavolino con astrusi calcoli ovvero perseguiti sul campo in avventurose spedizioni, per scoprire dove è finito il paradiso perduto.
UN GIARDINO TRA I FIUMI
La prima responsabile di questa ricorrente ossessione è del resto la Genesi stessa; la quale, al capitolo 2 versetti 8-14, descrive con precisione le coordinate del luogo: «Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente... Un fiume usciva... di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c’è l’oro... Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d’Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate». Non è un caso dunque se la maggior parte degli Indiana Jones del paradiso terrestre si sia buttato sulle uniche indicazioni identificabili con sicurezza: quelle del Tigri e dell’Eufrate.
Intorno alla Mesopotamia ruotano infatti le più numerose ipotesi di localizzazione dell’Eden: da quella di Calvino, che nel suo commentario biblico incluse una mappa in cui l’Eden era collocato «a est di Babilonia», alle ben più recenti dell’egittologo David Rohl (1995; per lui il primo paradiso è la valle del vulcano spento nonché sacro Sahand, a 10 chilometri da Tabriz) o del cacciatore di misteri Michael Sanders (2001: a suo avviso il paradiso sta sui monti dell’oriente turco, giusto dove nascono Tigri ed Eufrate). A Qurna del resto - città che però sta molto a valle, alla confluenza tra i due grandi fiumi iracheni - fino ai primi decenni del Novecento viveva un «Albero della conoscenza» assai apprezzato dai turisti.
DALL’INDIA ALLA CINA
Appunto un assirologo, il tedesco Friedrich Delitzsch, trovando all’inizio del Novecento sopra un sigillo babilonese una (presunta) raffigurazione di Adamo ed Eva, ritenne di aver «risolto» la questione dei 4 fiumi nella Genesi: i due meno noti sarebbero stati in realtà dei canali d’irrigazione. Geniale! Con un problema, però: chi li avrebbe scavati, quei canali, se l’Eden era abitato soltanto da Adamo ed Eva? Altri - primo tra tutti lo storico giudeo-latino Flavio Giuseppe - tentarono piuttosto l’identificazione dei due misteriosi corsi d’acqua con grandi fiumi più o meno vicini: il Pison sarebbe così il Gange, mentre il Ghicon coinciderebbe col Nilo (anche l’esploratore David Livingstone si diceva certo che l’Eden si trovasse alle sorgenti di tale fiume, che però lui allungava fino allo Zambia).
La Genesi era d’altronde chiara: il giardino si trovava «in oriente». L’Eden è in Asia, sosteneva appunto era nel VII secolo, di poco preceduto dal vescovo siriano Severiano: al quale sembrava teologicamente inappuntabile che l’uomo fosse nato laddove sorge anche il sole. In una carta geografica dell’VIII secolo, conservata alla Vaticana, il «paradisus» confina appunto con l’India. A Oriente, dunque; ma fino a giungere in Cina? Perché proprio questo sosteneva Tse Tsan Tai, l’uomo d’affari di Hong Kong che nel 1914 pubblicò la sua teoria secondo cui il luogo d’origine del primo rappresentante della nostra specie (ovviamente un cinese) era un’oasi nello sperduto deserto mongolo. Nella quale peraltro lui non era mai stato...
SUL MONTE O SOTTO I MARI
E se invece di guardarci intorno, dovessimo alzare gli occhi verso l’alto? Che il paradiso terrestre sia in cima a una montagna è pure un’ipotesi assai frequentata. Per esempio dal filosofo medievale Duns Scoto, ma anche dal poeta John Milton nel suo Paradise Lost, per non parlare del buon vecchio Dante che lo collocò in cima al monte del Purgatorio. Cristoforo Colombo, incrociando nel suo terzo viaggio le maestose foci dell’Orinoco, favoleggiò che quel flusso immane sgorgasse come latte da un alto seno della Terra, il medesimo che aveva albergato il primo paradiso; ma per principio si rifiutò di esplorarlo, in quanto Dio stesso nella Bibbia aveva esplicitamente proibito all’uomo di tornarvi. Secondo vari pareri, l’Eden doveva trovarsi in zona elevata anche per un altro semplice motivo: solo così avrebbe potuto sottrarsi al diluvio universale, che tutto aveva sommerso.
E infatti non mancano teorie che collocano la dimora dei progenitori sott’acqua: nel Mediterraneo, precisamente ad ovest di Creta (è l’opinione della stravagante e spiritista «chiesa» di Urantia), oppure nel Golfo Persico. Ingegnoso fu Archibald Henry Sayce, oxfordiano autore di una grammatica assira, quando nel 1882 mise la retromarcia ai 4 fiumi biblici: il testo della Scrittura intendeva in realtà riferirsi alla marea che periodicamente invadeva il Tigri e l’Eufrate e un paio di altri corsi vicini, risalendo dalla foce verso nord. Teoria ripresa e corretta un secolo più tardi dall’archeologo Juris Zarins, il quale poté però avvalersi anche delle foto riprese dal satellite.
LA TERRA DELLE ORIGINI
Ma non manca neppure chi ha fatto un ragionamento storico più che esegetico: se l’Eden è stato la culla del primo uomo, è dove si concretamente si rinvengono i resti degli ominidi che bisogna andare a cercarlo. Così nel 1896 l’antropologo Henry Seton-Karr, avendo scoperto molti utensili preistorici nel deserto della Somalia, non esitò ad annunciare di aver trovato pure l’ubicazione del Giardino della Genesi. In effetti la maggior parte dei paleo-antropologi oggi propende per l’origine della nostra specie nel continente nero; e tuttavia la Wilensky-Lanford nota che «quasi tutti coloro che cercavano l’Eden avevano trascurato l’Africa. Perché questo divario?». Forse per razzismo culturale, si risponde... In effetti nemmeno la valle etiopica di Awash - dove pure nel 1974 furono scoperti i resti di Lucy, il più antico ominide conosciuto - venne mai presa in seria considerazione come possibile dimora di Adamo ed Eva.
MEGLIO IL POLO NORD...
Restano infine le ipotesi più fantasiose. William Fairfiled Warren, professore universitario americano nonché pastore metodista, nel 1885 identificò con straordinario successo l’Eden nel Polo Nord, ovviamente in un’era geologica nella quale il pianeta doveva essere assai più caldo di oggi. Il connazionale e collega accademico George C. Allen fu pronto ad accodarsi, ma con un’importante precisazione: il Polo si muoveva sulla crosta terrestre e dunque al momento il primo paradiso si trovava più o meno nell’Ohio (qualcun altro, forse influenzato dalla natura dei luoghi, corresse: no, è nella valle di Santa Clara in California); sempre nell’Ohio, del resto, si trova anche Serpent Mound, un terrapieno a forma di rettile costruito dai nativi americani e che all’inizio del Novecento sembrò al reverendo battista americano Edmund Landon West un lampante segnale lasciato da Dio per indicare la località in cui aveva creato i nostri antenati...
...O LE SEYCHELLES?
Il generale inglese Charles Gordon identificò infine le caratteristiche del paradiso biblico con quelle dell’isola di Praslin, la maggiore delle Seychelles: abbondanza di serpenti, pianta del bene del male (l’albero del pane) nonché clima e paesaggio paradisiaci. Certamente si sbagliava, ma siamo sinceri: chi oggi avrebbe il coraggio di dirlo ai beati turisti che lì si godono il sole?
Roberto Beretta
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. ---" Dante al cospetto di Dio". Il sommo poeta e le sue opere (di Giulio Ferroni).12 dicembre 2013, di Federico La Sala
Il sommo poeta e le sue opere
Sono in preparazione otto tomi Un corpus complesso e definitivo
Alighieri pensava alla grande politica universale, orientata verso la realizzazione della conoscenza e della felicità
di Giulio Ferroni (l’Unità, 12.12.2013)
- Molti progetti per il settimo centenario della morte di Dante, i più interessanti vengono curati dal centro Pio Rajna per Salerno Editrice. E vale la pena di citare almeno la nuova edizione di «Monarchia»
CENTENARI E RICORRENZE DI VARIO GENERE PORTANO ALLA RIBALTA SITUAZIONI DEL PASSATO, capolavori delle arti e della letteratura, che spesso, passate quelle ricorrenze, tornano nellombra: al sistema delle celebrazioni culturali si potrebbe riferire ciò che Leopardi, in una delle prime pagine dello Zibaldone, dice della sensazione data dagli anniversari. Questi danno l’illusione «che quelle tali cose che son morte per sempre né possono più tornare, tuttavia rivivano e sieno presenti come in ombra, cosa che ci consola infinitamente allontanandoci l’idea della distruzione e annullamento che tanto ci ripugna e illudendoci sulla presenza di quelle cose che vorremmo presenti effettivamente».
Davvero sempre più spesso capita che certe ricorrenze offrano una piccola vita provvisoria a forme e modelli culturali sempre più lontane dall’orizzonte pubblico: cultori, eredi, concittadini di questo e di quello si danno un po’ da fare per portare sulla scena come «presenti effettivamente» nomi e opere spesso note solo a pochi specialisti. Lo sa bene chi si occupa di letteratura e nella sua vita ha avuto modo di seguire (anche partecipandovi) centenari, cinquantenari o altro...
Ci sono però pochi autori la cui presenza si impone al di là di ogni spirale celebrativa: per essi i centenari, visti e preparati da lontano, possono suscitare un particolare fervore di iniziative, capaci di dare nuova intensità a una presenza pervicacemente resistente pur nel quadro di un mondo che sembra sempre più allontanarsi dalla letteratura. Così accade per il più grande di tutti, quello che è davvero il «padre» della nostra lingua, Dante: in vista del settimo centenario della morte (2021) sono in atto vari progetti, tra cui si impongono quelli del Centro Pio Rajna, diretto da Enrico Malato, che hanno al centro una nuova edizione commentata delle Opere di Dante, che raccoglie tutto il frutto dell’immenso lavorio del precedenti commenti e offre una fitta serie di apparati, di strumenti di lettura, e anche di testi collaterali a quelli danteschi.
Si tratterà di otto volumi in più tomi (Salerno editrice), il cui insieme ambisce a venire in porto appunto nel 2021 (ma c’è anche una tappa intermedia, con la ricorrenza nel 2015, dei 750 anni dalla nascita di Dante), e che ha già visto nel 2012 l’uscita del volume III (De vulgari eloquentia), del primo tomo del VII (Fiore e Detti d’amore, opere di dubbia attribuzione), e ora del IV, Monarchia, a cura di Paolo Chiesa e Andrea Tabarroni con la collaborazione di Diego Ellero (pp. CLII-594, €.49,00).
PROSA MEDIEVALE
Tra le opere di Dante la Monarchia è quella più direttamente legata ai modelli della prosa scientifica medievale, in cui si esprime nel modo più netto l’affermazione della necessità di una monarchia universale (l’impero), destinata a instaurare la pace e la giustizia, guidando l’umanità verso la felicità terrena: negando ogni subordinazione dell’autorità imperiale a quella del papato, a cui invece spetta il compito di guidare l’umanità verso la vita eterna.
Questa edizione collega a un’introduzione che offre un’ampia sintesi storica, critica, filologica una fittissima annotazione del testo latino (con traduzione italiana a fronte) e una serie di altri materiali di grande interesse: da scritti polemici di parte papale del secolo XIV contro le tesi centrali dell’opera di Dante (del resto nel 1329 il libro fu fatto bruciare a Bologna e nel Cinquecento fu messo nell’Indice dei libri proibiti), al Commentarium che ad essa dedicò con fervida adesione Cola di Rienzo, al volgarizzamento che nel 1468 ne fece Marsilio Ficino.
Pur strettamente iscritta in un orizzonte tutto «medievale», la Monarchia ha alimentato nei secoli una prospettiva di tipo «laico», con la sua determinante separazione tra potere politico e autorità religiosa, nel quadro di una legittima aspirazione umana ad una «felicità» tutta terrena: essa identifica questa felicità secondo una prospettiva aristotelica, come piena attuazione di tutte le possibilità dell’intelletto umano, di una conoscenza capace di tradursi in azione e di realizzare il bene.
La sua argomentazione fa leva su di un profondo senso della responsabilità della scrittura, del suo necessario rivolgersi verso la ricerca di una «verità» rivolta al bene degli esseri umani: in una visione dell’unità del genere umano e della necessità di un potere universale, il solo capace di rendere possibile pace e giustizia. E certo se oggi siamo tanto lontani dal suo orizzonte storico, filosofico, linguistico, questo richiamo ad una grande politica universale, orientata verso la realizzazione della conoscenza, sola garanzia di felicità e di giustizia, resta determinante ancora per noi, di fronte ai pericoli di un mondo che procede ciecamente, che si affida all’esteriorità dell’apparenza e alla violenta indeterminatezza dell’economia finanziaria.
Non si deve dimenticare, d’altra parte, che con la sua poesia Dante mira ad andare «più in là» dello spazio finito dell’esistenza umana: con il suo grande poema guidato da una passione assoluta per una vita giusta e felice e nel contempo teso verso qualcosa che sfugge ad un controllo umano, fino alla visione di Dio in cui culmina il Paradiso.
All’ultimo canto del Paradiso, come parziale «campione» dell’edizione commentata della Commedia prevista per il centenario del 2021, Enrico Malato dedica ora un piccolo prezioso libretto, Dante al cospetto di Dio (Salerno editrice,2013,pp.92,€.7.90), che conduce il lettore entro la sfida dantesca all’indicibile, nella vertigine di quella visione «impossibile». Vi si nota, tra l’altro, l’audacia della scelta di Dante di aggirare «il divieto biblico ed evangelico della visione di Dio», di attribuirsi il privilegio di esservi giunto «addirittura con il proprio corpo», fino a collocarsi alla fine in «coincidenza o sintonia con la ruota dell’universo, mossa dall’amor divino». In questo approdo supremo trova la sua massima manifestazione quella tensione del grande poeta verso un punto di vista “universale”, che si svolge in tutta la sua opera e che, sul più circostanziato piano politico, agisce con spregiudicatezza nella Monarchia.
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. --- E Dante immaginò il potere globale. L’utopia moderna di Dante (di Luciano Canfora)7 ottobre 2013, di Federico La Sala
L’utopia moderna di Dante
E Dante immaginò il potere globale
Immaginava un impero universale come garanzia di pace
di Luciano Canfora (Corriere della Sera, 07.10.2013)
- Nella Monarchia, la più compiuta e moderna delle sue opere dottrinali, Dante si schierava contro l’ingerenza della Chiesa nei confronti del potere laico e proclamava l’uguaglianza delle due autorità. Il suo cuore batteva per l’impero.
La Monarchia, che non è solo la più compiuta delle opere dottrinali di Dante, ma anche la più moderna, fu messa dalla Chiesa all’Indice dei libri proibiti, nel primo «indice» elaborato dal Sant’Uffizio nel 1559. La ragione di ciò è molto semplice: ad una lettura disincantata appare evidente che il grande poeta cristiano del Medioevo, che aveva messo la teologia in poesia allo stesso modo in cui Lucrezio aveva messo in poesia la fisica epicurea, si schierava - col suo trattato politico - contro l’ingerenza della Chiesa nei confronti del potere laico e proclamava la totale uguaglianza e parità delle due autorità.
Pur consapevoli del rischio di frettolosi cortocircuiti, possiamo ben collocare quel trattato al vertice di una nobile, ma non folta tradizione rappresentata emblematicamente dalla formula cavouriana «libera Chiesa in libero Stato». Quel celebre e davvero memorabile discorso parlamentare di Cavour, malvisto dal sanfedismo del tempo suo, era in realtà sommamente rispettoso della dignità e della libertà della Chiesa. È storia nota come la Chiesa abbia impiegato moltissimo tempo a comprendere questo e a prenderne atto e ad agire di conseguenza: agevolata in ciò dalla definitiva perdita del potere temporale, ma rallentata in tale processo dal diverso e spesso altalenante orientamento dei pontefici volta a volta regnanti. I quali - in quanto sovrani assoluti e depositari perciò di poteri vastissimi - possono imprimere rapide e radicali inversioni di rotta. Come vediamo ancora oggi.
Resta il fatto che il cuore di Dante batte per l’impero (si passi l’espressione metaforica).
 Nel primo libro di questo trattato sulla monarchia, Dante dimostra che la monarchia universale è necessaria al benessere terreno in quanto permette, tramite la pace universale che ne è il portato, il fine supremo: l’attuazione e il pieno dispiegamento dell’intelletto in ambito speculativo e in ambito pratico.
Nel primo libro di questo trattato sulla monarchia, Dante dimostra che la monarchia universale è necessaria al benessere terreno in quanto permette, tramite la pace universale che ne è il portato, il fine supremo: l’attuazione e il pieno dispiegamento dell’intelletto in ambito speculativo e in ambito pratico.
 Nel secondo libro rivendica, come già nel Convivio, al popolo romano il diritto all’impero.
Nel secondo libro rivendica, come già nel Convivio, al popolo romano il diritto all’impero.
 Nel terzo affronta il tema più delicato: la monarchia universale trae il suo diritto e la sua legittimità direttamente da Dio, non attraverso la mediazione papale, non ha cioè bisogno del «Vicario».
Nel terzo affronta il tema più delicato: la monarchia universale trae il suo diritto e la sua legittimità direttamente da Dio, non attraverso la mediazione papale, non ha cioè bisogno del «Vicario».
 E la nota ancora più audace, che dà il tono e il senso all’intero trattato, consiste nel proclamare che il fine naturale dell’uomo - cioè la perfetta moralità sorretta dalla filosofia - è autonomo rispetto al fine soprannaturale che a sua volta consiste nella felicità eterna, verso cui l’uomo è guidato dalla «rivelazione». Come l’impero è autonomo dalla Chiesa, così la ragione lo è rispetto alla fede.
E la nota ancora più audace, che dà il tono e il senso all’intero trattato, consiste nel proclamare che il fine naturale dell’uomo - cioè la perfetta moralità sorretta dalla filosofia - è autonomo rispetto al fine soprannaturale che a sua volta consiste nella felicità eterna, verso cui l’uomo è guidato dalla «rivelazione». Come l’impero è autonomo dalla Chiesa, così la ragione lo è rispetto alla fede.Questo impianto teorico spiega bene perché a Giustiniano, cioè all’imperatore cesaropapista per eccellenza, venga riservato un posto di così grande spicco nel Paradiso di Dante e a lui tocchi di tessere l’esaltante elogio di Giulio Cesare. Elogio che stride con il privilegiato trattamento ammirativo riservato al nemico implacato di Cesare, cioè Catone Uticense, quale guardiano del Purgatorio.
Ma soprattutto non sfuggirà la forte carica utopica che è racchiusa in tutto il trattato: l’idea di una pace universale conseguente all’unico governo universale. Tale governo però viene concepito non già come sostitutivo dei molteplici poteri statali e comunali già esistenti, ma è sovraordinato ad essi. Non si tratta di «un governo di tutti i popoli fusi in un solo Stato, ma di una suprema giurisdizione, fatti salvi gli Stati particolari con proprie leggi e propri governi» (Luigi Russo). Non è chi non veda in tale concezione l’utopia anticipatrice di una istanza che sempre fu viva, e che al tempo nostro è antidoto indispensabile all’arroganza di singole potenze inclini ad attribuirsi unilateralmente il ruolo di gendarmi del mondo.
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. --- IL BENE DEL MONDO E LA CHIESA (di Vito Mancuso))4 ottobre 2013, di Federico La Sala
Il bene del mondo e la Chiesa
di Vito Mancuso (la Repubblica, 04.10.2013)
Inizierà davvero una nuova epoca per la Chiesa, e quindi inevitabilmente anche per la società, come prefigurava Scalfari a conclusione dell’intervista a papa Francesco? Ciò che sorprende nelle risposte del Papa è il punto di vista assunto, un inedito sguardo extra moenia o “fuori le mura” che non pensa il mondo a partire dalla fortezza-Chiesa, ma, esattamente all’opposto, pensa la Chiesa a partire dal mondo. Nei suoi ragionamenti non c’è traccia della consueta prospettiva ecclesiastica centrata sul bene della Chiesa e la difesa a priori della sua dottrina, della sua storia, dei suoi privilegi e dei suoi beni così spesso oggetto di cura gelosa da parte degli ecclesiastici di ogni tempo (un monumento del pensiero cattolico quale il Dictionnaire de Théologie Catholique dedica 9 pagine alla voce “Bene” e 18 alla voce “Beni ecclesiastici”!).
C’è al contrario un pensiero che ha di mira unicamente il bene del mondo e per questo il Papa può dire che il problema più urgente della Chiesa è la disoccupazione dei giovani e la solitudine dei vecchi. Non le chiese, i conventi e i seminari semivuoti; non il relativismo culturale; non il sentire morale del nostro tempo così difforme dalla morale cattolica; non la minaccia alla vita e al modello tradizionale di famiglia. No, la disoccupazione dei giovani e la solitudine degli anziani.
L’aver assunto il bene del mondo quale punto di vista privilegiato ha condotto il Papa alle seguenti due affermazioni capitali: 1) la Chiesa non è preparata al primato della dimensione sociale, anzi c’è in essa una prospettiva vaticanocentrica che produce una nociva dimensione cortigiana («la corte è la lebbra del papato»); 2) storicamente essa non è quasi mai stata libera dalle commistioni con la politica - e a questo proposito la Chiesa italiana di Ruini e Bagnasco dovrebbe recitare non pochi mea culpa per non aver denunciato l’immoralità pubblica e privata di chi per anni governava l’Italia, di cui al contrario si è giunti persino a contestualizzare benignamente le pubbliche bestemmie.
Ma l’azione del papa e la nuova epoca per la Chiesa che prefigura può non avere effetti anche sul mondo laico? Dei mali della Chiesa e delle riforme di cui necessita si è detto, ma penso sia saggio domandarsi se non esista anche qualcosa nella mente laica che occorre riformare. È solo la Chiesa che deve cambiare, oppure il cambiamento e la riforma interessano anche chi si dichiara laico e non credente? Naturalmente sotto queste insegne si ritrovano gli ideali più vari, dall’estrema destra all’estrema sinistra, e io qui mi limito a discutere il pensiero laico progressista rappresentato da Scalfari.
Alla domanda del Papa sull’oggetto del suo credere, Scalfari ha risposto dicendo «io credo nell’Essere, cioè nel tessuto dal quale sorgono le forme, gli Enti», e poco dopo ha precisato che «l’Essere è un tessuto di energia, energia caotica ma indistruttibile e in eterna caoticità», attribuendo a combinazioni casuali l’emergere delle forme tra cui l’uomo, «il solo animale dotato di pensiero, animato da istinti e desideri», ma che contiene dentro di sé anche «una vocazione di caos». Insomma Scalfari si è professato, come già nei suoi libri, discepolo di Nietzsche.
Ma cosa manca a questa visione del mondo? Trattandosi di un’eredità di colui che volle andare “al di là del bene e del male”, manca ovviamente la possibilità di fondare l’etica in quanto primato incondizionato del bene e della giustizia. Per Nietzsche infatti l’Essere è un “mostro di forza, senza principio, senza fine, una quantità di energia fissa e bronzea”, il mondo “è la volontà di potenza e nient’altro”.
Ma se il mondo è questo, ne consegue che il liberismo, in quanto volontà di potenza che vuole solo incrementare se stessa, ne è la più logica conseguenza. Perché mai quindi si dovrebbe lottare nel nome della giustizia, della solidarietà, dell’uguaglianza? Come non dare ragione a Nietzsche che considerava questi ideali solo un trucco vigliacco dei deboli, incapaci di lottare ad armi pari coi forti? Se l’essere è solo caos e forza, l’azione che ricerca la pace e la giustizia è destinata inevitabilmente a rimanere senza fondamento.
Da tempo vado pensando che la cultura progressista viva la grande aporia dell’incapacità di fondare teoreticamente la propria stessa idea-madre, cioè la giustizia. Darwin ha sostituito Marx, e Nietzsche (attento lettore di Darwin) è diventato il punto di riferimento per molti. Il risultato è Darwin + Nietzsche, ovvero “l’eterno ritorno della forza”, cioè una cupa e maschilista visione del mondo secondo cui la forza e la lotta sono la logica fondamentale della vita.
Se è giunto il tempo di una Chiesa che dia più spazio al femminile, è altresì tempo di un pensiero laico altrettanto capace di ospitare il femminile, intendendo con ciò una visione del mondo e della natura che fa dell’armonia e della relazionalità il punto di vista privilegiato. Da Aristotele a Spinoza a Nietzsche, la sostanza è sempre stata pensata come prioritaria rispetto alla relazione: prima gli enti e poi le relazioni tra essi.
Oggi la scienza ci insegna (questo è il senso filosofico della scoperta del bosone di Higgs) che è vero il contrario, che prima c’è la relazione e poi la sostanza, nel senso che tutti gli enti sono il risultato di un intreccio di relazioni e tanto più consistono quanto più si nutrono di feconde relazioni. Questo è il pensiero femminile, un pensiero del primato della relazione, di contro al pensiero maschile basato sul primato della sostanza, e va da sé che pensiero femminile non significa necessariamente pensiero delle donne, perché ogni essere umano contiene la dimensione femminile e vi sono donne che pensano e agiscono al maschile (si consideri per esempio Margaret Thatcher, per tacere di alcune politiche italiane), mentre vi sono uomini che pensano e agiscono al femminile (si pensi per esempio a Gandhi e prima ancora al Buddha o a Gesù).
Io penso che il nostro tempo abbia veramente bisogno di un nuovo paradigma della mente, di una ecologia della mente nel senso etimologico di riscopertadellogosche informa oikos,il termine greco per “casa” da cui viene la radice “eco” e che rimanda alla natura. Scalfari nel suo credo insiste sul caos e non sbaglia, perché il caos è una dimensione costitutiva della natura; non è la sola però, c’è anche il logos, alla cui azione organizzatrice si deve l’emersione dalla polvere cosmica primordiale degli enti e della loro meraviglia, tra cui la mente e il cuore dell’uomo.
I grandi sapienti dell’umanità l’hanno sempre compreso, chiamando il logos anche dharma, tao, hokmà ecc. a seconda della loro tradizione. Cito volutamente un pensatore non cristiano, il pagano Plotino: «Più di una volta mi è capitato di riavermi, uscendo dal sonno del corpo, e di estraniarmi da tutto, nel profondo del mio io; in quelle occasioni godevo della visione di una bellezza tanto grande quanto affascinante che mi convinceva, allora come non mai, di fare parte di una sorte più elevata, realizzando una vita più nobile: insomma di essere equiparato al divino, costituito sullo stesso fondamento di un dio» (Enneadi IV, 8, 1).
L’unione di logos + caos è la dinamica dentro cui il mondo si muove ed evolve. Essa ci fa comprendere che la verità non è un’esattezza, una formula, un’equazione, un dogma o una dottrina, insomma qualcosa di statico; la verità è la logica della vita in quanto tesa all’armonia, quindi è un processo, una dinamica, un flusso, un’energia, un metodo, una via. La verità è il bene in quanto armonia delle relazioni. In questo senso Gesù diceva “io sono la via, la verità e la vita”, non intendendo certo con ciò innalzare il suo ego in un supremo narcisismo cosmico, ma prefigurando il suo stile di vita basato sull’amore come ciò che al meglio serve l’Essere. Ne viene una visione del mondo nella quale l’ontologia cede il primato all’etica, nella quale cioè il vero non si può attingere se non passando attraverso i sentieri del bene, e l’amore diviene la suprema forma del pensare. Amor ipse intellectus,insegnava il mistico medievale Guglielmo di Saint-Thierry.
I credenti sono chiamati a rinnovarsi e penso che con umiltà sotto la guida di questo papa straordinario in molti stiano iniziando a farlo; anche i non credenti però sono chiamati a rinnovare la loro mente alla luce dell’Essere non solo caos ma anche logos, cioè relazionalità originaria a livello fisico che fonda il bene a livello etico. Forse così l’ideale della giustizia e dell’uguaglianza al centro del pensiero progressista mondiale sarà distolto dalle nebbie del buonismo dei singoli e radicato su una più armoniosa visione del mondo.
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE ---- L’io e il mondo Un’interpretazione di Dante di Marco Santagata (di Carlo Albarello - L’io «super» di Dante, non solo autore anche personaggio).21 febbraio 2012, di Federico La Sala
L’io «super» di Dante, non solo autore anche personaggio In un corposo saggio di Marco Santagata un’interpretazione dell’opera del sommo poeta tra storia, testi e autobiografia
- Focus sulla «tessitura» dantesca
 L’io e il mondo Un’interpretazione di Dante di Marco Santagata pagine 448 euro 36,00 Il Mulino
L’io e il mondo Un’interpretazione di Dante di Marco Santagata pagine 448 euro 36,00 Il Mulino
 Un’interpretazione complessiva dell’opera di Dante che mette in luce i tratti essenziali, la raffinata tecnica di costruzione dei personaggi e la fitta trama di rimandi tessuta dal poeta. E soprattutto l’io dantesco, autore, narratore e personaggio insieme.
Un’interpretazione complessiva dell’opera di Dante che mette in luce i tratti essenziali, la raffinata tecnica di costruzione dei personaggi e la fitta trama di rimandi tessuta dal poeta. E soprattutto l’io dantesco, autore, narratore e personaggio insieme.
di Carlo Albarello (l’Unità, 21.02.2012)
Se l’uomo per Dante è un essere singolare, libero nelle sue scelte e nei suoi giudizi, non meno lo è Dante per Marco Santagata. Uso a significative incursioni nelle belle lettere italiane, con L’io e il mondo. Un’interpretazione di Dante (Il Mulino), Santagata offre un singolare esempio di come si possano offrire nuove prospettive di lettura su un monumento della letteratura universale, ribadendone l’attualità. E diciamo subito che sarebbe ingiusto mettere in ombra di questo professore, che insegna letteratura italiana all’Università di Pisa, l’attività di scrittore e tra parentesi anni di lavoro dedicati al Canzoniere di Petrarca. Ma la verità è che il personaggio Dante è, di tutte le sue ricerche, almeno in un senso ideale, il naturale esito.
UNA FIGURA PREMODERNA
In effetti, Santagata ha composto questo volume curando parallelamente l’edizione delle Opere dell’Alighieri (Rime, Vita Nova, De vulgari eloquentia), il cui primo volume è tra i «Meridiani» (2011). Chi guardi oggi al tracciato di quelle pagine, può ristabilire in essenza, per quel tanto di fedeltà alle date di composizione che Santagata talora respinge, i tratti di un progetto unitario, un tutto coerentemente svolto, «imperniato su Dante stesso, sulla sua straordinaria autostima o, quanto meno, sulla sua convinzione di essere l’unico in grado di formularlo e di sostenerlo».
L’opera di Santagata restituisce così, in senso diagnostico, un Dante costantemente attento al proprio io e al mondo, scelti emblematicamente come titolo: una «figura premoderna» dalla «mente sistematica», ossessionato dall’idea di far tornare i conti del proprio personaggio. Da queste premesse derivano la predilezione per il contesto biografico e storico-culturale in cui nascono le opere, che anticipano il sacrato poema e le strette relazioni di continuità nell’ideale dantesco. Forte di anni di letture dantesche, l’autore svela le astuzie di Dante, attento a costruire i propri miti, Beatrice in primis. La Commedia, infatti, non è ancora all’orizzonte, Dante è semplicemente un poeta d’amore ma già è diverso dai rimatori coevi; ha «visioni, sogni, fantasticherie»: le propone come folgorazioni crisi epilettiche secondo l’autore che diventano segni di predestinazione dell’amore per una Beatrice «letteraria». Nella Vita nova «costantemente in bilico tra verità e menzogna» decide di raccontarne i momenti più significativi, piegando a questa bella invenzione rime scritte per altre. Ma anche se non avesse scritto la Commedia, Dante sarebbe passato alla storia per il progetto contenuto nel De vulgari eloquentia di fare, del volgare una lingua di cultura capace di infrangere il monopolio del latino.
Il continuo muoversi di Santagata tra storia, testi e autobiografia restituisce perfettamente anche il clima di quella stagione cruciale di impegno politico per Dante, che scrisse secondo lo studioso i primi canti della Commedia a Firenze per poi riprenderne la composizione nel 1306-07. Anche la Commedia è percepita come un organismo saldo, dal messaggio universale, percorso al suo interno da forti tensioni contingenti. Valga per tutte l’incontro con il capo indiscusso dei ghibellini, Farinata degli Uberti nel X canto dell’Inferno e quel «dialogo teso, a botta e risposta», per fare capire ai ghibellini di Firenze che la sua posizione politica nei loro confronti era cambiata.
Se i campioni minimi che abbiamo scelto sono scelti bene, dedurremo l’entusiasmo genuino con cui abbiamo scorso questo libro di Marco Santagata, che consente di leggere con luce nuova pagine di vita e di poesia che parevano acquisite e di non avanzare troppo larvati, ma con carte scoperte, anche nei territori di quell’«ultimo miracolo della poesia mondiale», quale è secondo Montale la Commedia, con nome e cognome dell’autore, ora disvelati: l’io e il mondo.
- Focus sulla «tessitura» dantesca
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. ---- E Dante creò una lingua meticcia. Come è nato e si è diffuso il nostro idioma (di Valerio Magrelli).16 maggio 2011, di Federico La Sala
Come è nato e si è diffuso il nostro idioma
E Dante creò una lingua meticcia
La fatica con cui lo leggiamo dipende dal fatto che ogni suo verso possiede un peso specifico immenso
di Valerio Magrelli (la Repubblica, 16.05.2011)
Fra le tante eccezioni di cui gode l’Italia, terra delle eccezioni, quella della lingua non è certo fra le più marginali. Come un unico fiume millenario, la sua letteratura deriva infatti da una sola sorgente, rappresentata da un singolo testo fondatore: La Divina Commedia. (Prendiamo per buona quest’approssimazione, sorvolando sulla scuola siciliana, toscana, bolognese, come su un autore quale Cavalcanti, e proviamo a sviluppare la metafora). Dalla cima di quell’opera somma, un autentico Everest europeo, scaturisce la lingua che irriga la nostra poesia, la nostra prosa, il nostro teatro.
Ma in cosa consiste il segreto di un simile capolavoro? Direi in una capacità di concentrazione e immagazzinamento sillabico senza precedenti. Dante, cioè, procede a un inaudito stoccaggio del senso. La fatica con cui lo leggiamo, dipende dal fatto che ogni suo verso possiede un peso specifico immenso, dovuto appunto alla spaventosa quantità di senso che contiene. Per ricorrere a un’altra analogia, siamo di fronte a una sorta di congelamento: ogni verso della Commedia reca in sé, sprofondata nel freddo, una massa di senso quasi intollerabile. Cosa fare, allora? Bisognerà passare questi versi al micro-onde del commento: il processo di comprensione richiede cioè di tradurre il cibo dell’autore in un nuovo stato fisico.
Altrimenti detto, all’interno di quest’opera il commento equivale a un percorso di riconversione. Da qui la lentezza del procedere: è come se ogni verso fosse un nodo, un algoritmo, un’equazione da risolvere. Sotto questo aspetto, la lingua di Dante suona straniera, talmente straniera che in certo modo solo uno straniero ha saputo coglierne fino in fondo il segreto. Penso ovviamente al grande Ospi Mandel’stam, che ne affrontò la lettura usando la penna «come il martelletto del geologo». Mille immagini sgorgano dal suo saggio, tra cui questa osservazione illuminante: «Il commento è parte integrante della Commedia [...] la Commedia, nave portento, esce dal cantiere con lo scafo già incrostato di conchiglie». Ma forse non è un caso che ad afferrare così bene la struttura dell’opera sia stato un poeta di un’altra lingua e di un’altra cultura, che amava sillabare Dante nei campi di prigionia, che usava Dante per resistere al silenzio della tirannia.
Ciò spiega quanto risulti profonda la sorgente della nostra letteratura, e aperta a chiunque voglia attingervi. Prodotta da quelle matrici latine, greche, provenzali, arabe, normanne che concorsero alla nascita del Dolce Stil Novo, la poesia, e dunque la lingua italiana, sorsero insomma meticce, e come tali sono pronte oggi a ricevere i lettori che giungono a noi da mondi lontani. È in questa prospettiva che va intesa la "funzione-Dante" descritta da un critico come Gianfranco Contini. Plurilinguismo, espressionismo, dinamicità, sono iscritti nel nostro testo fondatore come altrettante forme di accoglienza verso la parola dello straniero, l’ospite sacro venerato da Omero.
-
> Per una rilettura del "De Vulgari Eloquentia" e della "Monarchia" ---- In Africa la culla delle lingue... Apparteniamo anche a un’unica e vasta famiglia culturale.Quentin Atkinson, antropologo della University of Auckland, in Nuova Zelanda, sta mettendo sottosopra il micromondo dei linguisti (di Gabriele Beccaria).12 maggio 2011, di Federico La Sala
 Senza le parole l’uomo avrebbe colonizzato il Pianeta?
Senza le parole l’uomo avrebbe colonizzato il Pianeta? In Africa la culla delle lingue
In Africa la culla delle lingue Lo studio su “Science”: dai fonemi gli indizi di un’origine comune, tra 50 e 100 mila anni fa
Lo studio su “Science”: dai fonemi gli indizi di un’origine comune, tra 50 e 100 mila anni fa
 “I modelli matematici hanno svelato come i suoni obbediscano alla stessa logica dei geni”
“I modelli matematici hanno svelato come i suoni obbediscano alla stessa logica dei geni” Le origini C’è una radice comune alla Babele delle parole di oggi?
Le origini C’è una radice comune alla Babele delle parole di oggi? di Gabriele Beccaria (La Stampa TuttoScienze, 11.05.2011)
di Gabriele Beccaria (La Stampa TuttoScienze, 11.05.2011)Sono voci speciali quelle che risuonano nel Kalahari, tra i boscimani sempre più rari. Racchiudono come preziosi fossili i suoni arcaici della lingua primigenia, prima che l’umanità si condannasse alla deflagrazione babelica delle parole.
Sembra troppo bello per essere vero, eppure Quentin Atkinson, antropologo della University of Auckland, in Nuova Zelanda, sta mettendo sottosopra il micromondo dei linguisti con la sua teoria appena pubblicata sulla rivista «Science». Squarciando il velo su uno dei maggiori interrogativi di sempre, sostiene che è possibile andare indietro nel tempo e recuperare le tracce di ciò che si pensava irrimediabilmente perduto. Abbiamo inventato un idioma comune una sola volta - sostiene - e da quello, a cascata, sono sbocciati tutti gli altri, figli dei millenni e delle migrazioni.
Sapevamo di essere figli dell’Africa, dopo le prove multiple raccolte con le ossa e con il Dna, ma adesso appare non meno clamorosa la nuova ipotesi: la mitica «lingua dell’Eden» è esistita davvero e ha inventato il proprio vocabolario nell’area sudoccidentale del continente, tra 100 mila e 50 mila anni fa, poco prima dell’«uscita» dei sapiens e dei loro avventurosi spostamenti nell’attuale Medio Oriente.
L’arma segreta
La colonizzazione del resto del Pianeta - ragiona Atkinson - non avrebbe potuto essere tanto veloce ed efficace senza la nuova arma segreta, appena messa a punto nelle pianure e sugli altopiani africani: è il linguaggio ad averci trascinato verso l’ignoto, trasformandoci nella specie più invasiva e anche pericolosa, capace di moltiplicare quasi all’infinito abilità e risorse, nonostante le deficienze dell’organismo. Applicando le logiche matematiche e statistiche (non particolarmente gradite dai colleghi), il professore neozelandese ha dedotto un modello da 504 lingue parlate oggi nel mondo. Al centro ci sono i fonemi - i suoni-base che costituiscono le unità specifiche di ogni parlata e che permettono di costruire parole distinte - e le loro fluttuazioni: obbediscono tutti a una stessa legge e si riducono progressivamente tanto più ci si allontana dalla culla della nostra specie. Se la grande famiglia antica del khoisan (a cui appartengono anche i dialetti dei boscimani) si articola su un centinaio di «mattoncini» sonori - i fonemi, appunto - l’inglese e il tedesco ne hanno soltanto la metà, mentre il mandarino si ferma a 32, il filippino scende a 23, il giapponese cala a 20 e l’hawaiano si deve accontentare di appena 13.
La «diversità decrescente legata alla distanza» (è questa la formula gergale) sembra sovrapporsi alla perfezione a un altro criterio, riconosciuto dai biologi e dai genetisti: è quello della diminuzione della variabilità del Dna rispetto alla distanza dall’Africa. Il processo è noto tra gli specialisti come «effetto del fondatore». Una popolazione che si origina da un piccolo gruppo di individui, fuoriuscito da uno più grande, paga lo scotto della separazione con un evidente assottigliamento della complessità genetica. E, di conseguenza, anche della ricchezza evolutiva. Geni e fonemi - nell’interpretazione di Atkinson - conducono così un balletto in parallelo, soggetto a rigide regole di arricchimento e di impoverimento.
«Una delle questioni più controverse è se ci sia stata una singola origine del linguaggio oppure se questo sia emerso in parallelo in aree differenti - osserva Atkinson -. Adesso abbiamo raccolto una serie di evidenze che sia esistita un’unica fonte». Mentre gli altri studiosi del settore si arrovellano sull’idea (che - com’è evidente - è parecchio provocatoria) e in molti l’hanno già contestata (c’è chi ritiene irrealistico che un’archeologia delle parole possa indagare un’era più antica di 10 mila anni fa), lo studioso neozelandese insiste e suggerisce che dai mucchi di parole delle 6 mila lingue attuali sarà possibile ricostruire anche i percorsi della colonizzazione dei continenti: una provvisoria conclusione è che l’Asia sia stata visitata molto prima dell’Europa, mentre nelle Americhe le tribù dei progenitori sarebbero approdate in tempi decisamente recenti.
L’organo virtuale
La capacità di esprimerci è rapidamente diventata il nostro «organo virtuale», quello che ha scatenato, tra le altre, le rivoluzioni dell’arte rupestre e di sofisticate tecniche di caccia, e - spiega con enfasi Atkinson - è l’unica e autentica innovazione culturale che ci contraddistingue. «Gli umani moderni sono un’unica e vasta famiglia genetica con un singolo antenato comune - scrive -. Uno degli aspetti che più mi piace delle mie ricerche è che, se il linguaggio rappresenta una peculiare forma di identità, allora tutti apparteniamo anche a un’unica e vasta famiglia culturale».
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE ---- LA LINGUA NON E’ IL GIOCO DEL LEGO. IL LINGUISTA NUNZIO LA FAUCI RIPRENDE LA LEZIONE DI DANTE E DI SAUSSURE E SI PORTA OLTRE CHOMSKY (di Stefano Bartezzaghi - Se le parole non esistono. Quel linguista scettico che sfida Chomsky).6 maggio 2011, di Federico La Sala
 Se le parole non esistono
Se le parole non esistono
 Quel linguista scettico che sfida Chomsky
Quel linguista scettico che sfida Chomsky Scrive saggi e tiene un blog dove critica le star della disciplina: si chiama Nunzio La Fauci e sostiene che non c’è un lessico prima e fuori dalla sintassi. Ecco le sue tesi
Scrive saggi e tiene un blog dove critica le star della disciplina: si chiama Nunzio La Fauci e sostiene che non c’è un lessico prima e fuori dalla sintassi. Ecco le sue tesi
 La lingua non è una combinazione di elementi già dati. È il tutto che dà senso alle singole parti
La lingua non è una combinazione di elementi già dati. È il tutto che dà senso alle singole parti
 Da esperto ritiene presuntuoso l’intento tipico degli intellettuali italiani: rendere i parlanti migliori
Da esperto ritiene presuntuoso l’intento tipico degli intellettuali italiani: rendere i parlanti migliori di Stefano Bartezzaghi (la Repubblica, 06.05.2011)
di Stefano Bartezzaghi (la Repubblica, 06.05.2011)«Le parole non esistono». Fosse avanzata da un mistico, un artista figurativo o un politico (di quelli che possono usare espressioni come: «Le chiacchiere stanno a zero»), l’ipotesi non susciterebbe clamore. Ma l’ha detto un linguista e allora si è costretti a guardare alla possibile inesistenza delle parole con altri occhi.
Il linguista si chiama Nunzio La Fauci, il suo nome e il suo cognome sembrano voler riassumere le due principali funzioni della cavità orale. La Fauci insegna all’Università di Zurigo. Ha appena scritto un Compendio di sintassi italiana (Il Mulino) e ha raccolto i suoi saggi sotto un titolo, di perfetta ortodossia saussuriana e strutturale: Relazioni e differenze (Sellerio). Per divertirsi, osserva usi della lingua (e dei linguisti) in un blog raffinato e paradossale intitolato ad Apollonio Discolo, bel nome di un grammatico greco del II secolo d.C., con la cui dottrina La Fauci in realtà dissente.
I linguisti non amano i catastrofismi, in merito alla lingua. Smentiscono la morte del congiuntivo, ridimensionano l’allarme per l’invasione dell’inglese, impetrano misericordia verso coloro a cui sfuggono sgraziati «attimini» o deformi «piuttosto che». La Fauci fa di più. Quando l’ex calciatore Beppe Dossena ha usato il verbo «reazionare» nel commento di una telecronaca di calcio, su Repubblica se n’è occupata la rubrica «Lapsus», ricordando l’esistenza del verbo «reagire». Apollonio Discolo è insorto, non contro il calciatore ma contro il suo incauto critico, ricordando a quest’ultimo l’esistenza del verbo «sanzionare» (che sta a «sancire» esattamente come «reazionare» sta a «reagire»).
Attenzione, dice oggi il professore, «agli "errori" degli altri (e dei presunti incolti). Può capitare non solo che errori non siano ma anche che svelino cose più interessanti e gustose delle proposte di presunte correzioni». Apollonio Discolo ha poi aggiunto: «Amare l’espressione umana (come amare una persona) non è pretendere che sia conforme ai nostri desideri, alle nostre fisime, ai nostri gusti (peraltro mutevoli) ed è invece piegarsi con attenzione a comprendere (che non vuol dire necessariamente giustificare) anche le sue corbellerie (o, almeno, quelle che a noi paiono tali), eventualmente sorridendone. Magari accadrà infatti che un giorno diventeranno norma e parametro di buon gusto». Chi, oggi, penserebbe male dell’articolo "il"? Eppure: «inorridirono sicuramente certi nostri lontani antenati quando videro crescere nella loro lingua l’onda travolgente dell’illu destinato a diventare l’articolo determinativo romanzo».
Data la giusta dimensione e prospettiva storica agli errori dei presunti incolti, La Fauci si dedica agli errori dei presunti colti, a cui riserva furie staffilanti e ironie a volte criptate. Obiettivo polemico principale, la linguistica contemporanea, quella accademica e soprattutto quella più influenzata da Noam Chomsky. Il celebrato lingui-star americano ha il torto di rivestire di tecnicismi (esempio: «componente computazionale») le più tradizionali partizioni grammaticali, già dichiarate inservibili dal vecchio Saussure. Per Chomsky ogni parola ha una funzione grammaticale (sostantivo, verbo...), e funge da componente della frase, a cui preesiste.
Per La Fauci, seguendo Saussure, non c’è un lessico, prima e fuori da una sintassi. Chomsky vuole farci credere che la teoria linguistica abbia pressoché raggiunto la perfezione. La Fauci è agli antipodi dello scientismo, tanto che congeda il lettore del suo Relazioni e differenze con un’acre asserzione: «Il cammino verso la conoscenza della lingua e verso la conoscenza dell’uomo deve ancora essere intrapreso».
Si era aperto, quel libro, con un’indicazione di metodo: «rationabilius», «in modo più razionale». La parola viene dal De vulgari eloquentia, il trattato di Dante sull’identità linguistica italiana. In un saggio su questo stesso tema, tanto dibattuto quest’anno, La Fauci mostra come tale identità, linguistica e non linguistica, sia plurale: il carattere unitario sta nel collettivo e reciproco riconoscimento che i diversi italiani si danno l’un l’altro.
Cercando l’«odorosa pantera» di un sistema nell’estrema varietà degli idiomi presenti in Italia, Dante capisce all’improvviso che non deve descriverla in un trattato ma mostrarne le movenze: e scrive la Commedia. La Fauci raccoglie la lezione e fa teoria dove molti linguisti si accontentano di osservare le pratiche, e spiegarle sulla base di presupposti indimostrati; ma dove gli stessi si appellano alla teoria, La Fauci privilegia invece la pratica. Il suo Relazioni e differenze è una sorta di varietà linguistico: ci sono capitoli per specialisti (come quello che memorabilmente si intitola "Paradossi della paratassi") e capitoli che andrebbero letti da chiunque si occupi di discipline umanistiche, come i novanta secchi paragrafi finali intitolati "Faccette di linguistica razionale". Non sono emoticon, quelle faccette: compongono il vastissimo poliedro che è la lingua, per La Fauci.
La lingua non è il gioco del Lego, non è cioè una combinatoria di elementi già dati, con i mattoncini dei fonemi che formano il mattone della parola e i mattoni delle parole che formano il muro della frase e la casa del discorso. Nella costruzione linguistica è il tutto (il contesto, la "sintassi" come disposizione degli elementi, la relazione) che dà senso alle singole parti.
In questo, il ritorno di La Fauci allo spirito originario dello strutturalismo è tanto radicale da risultare pressoché ereticale. Le parole non esistono perché quello che chiamiamo "parola" è l’esito finale (non l’inizio!) di un procedimento analitico, per capirlo basta pensare a quanta fatica facciamo a individuare le singole parole ascoltando parlare una lingua che non conosciamo. Nulla di ontologico, che abbia valore in sé, esiste nella lingua: tutto sorge dalla relazione, anzi da un processo di correlazione, perché la lingua è sempre nel suo farsi.
La linguistica razionale auspicata da La Fauci rifiuta il programma - classico per ogni intellettuale italiano - di rendere i parlanti migliori, perché lo ritiene presuntuoso; poi rifiuta anche il programma di rendere migliori almeno gli intellettuali, perché lo ritiene impossibile. Scettici sulla possibilità di capire, privi di ogni certezza, non possiamo però neppure essere sicuri che interrogarsi sia inutile. È per quello che continuiamo a farlo. «A me», annuncia Nunzio, «l’esperienza umana (e la scienza, che ne è parte importante) pare l’esperienza di un "sebbene", non quella di un "perché" o di un "affinché"». Alla fine quelle cose che non esistono e si chiamano parole, infatti, le sa scegliere molto bene.
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE --- INTERVISTA A TULLIO DE MAURO.Un Paese paradosso il nostro. Solo più di mezzo millennio dopo la «Commedia» è diventato uno Stato. E’ la Lingua che ci ha fatto (esseri umani e) italiani.21 febbraio 2011, di Federico La Sala
L’OCCUPAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LINGUA ITALIANA: L’ITALIA E LA VERGOGNA.
Intervista a Tullio De Mauro«Dalla Patria alla Matria. Ecco perché è la lingua che ci ha fatto italiani»
Il linguista: Un Paese paradosso il nostro, cementato nelle pagine dei capolavori letterari. E solo più di mezzo millennio dopo la «Commedia» diventato uno Stato
di Maria Serena Palieri (l’Unità, 21.02.2011)
Massimo Cacciari dice che la sua devozione va non alla Patria, ma alla Matria. Cioè alla nostra madre lingua, l’italiano di Dante. E «il» linguista per antonomasia, Tullio De Mauro, stamattina al Quirinale parlerà appunto dell’Italia linguistica, dall’Unità alla Repubblica. Alla vigilia dell’incontro gli abbiamo rivolto alcune domande. A fronte dei 150 anni di Italia che festeggiamo oggi, ci sono, prima, sei secoli di storia di un popolo unito dalla lingua.
È un’eccezione tutta italiana? E da cosa nasce?
«La scelta del fiorentino scritto trecentesco a lingua che, sostituendo il latino, fosse lingua comune dell’Italia si andò affermando già nel secondo Quattrocento nelle nascenti amministrazioni pubbliche dei diversi stati in cui il paese era diviso e si consolidò poi tra i letterati nel XVI secolo quando sempre più spesso la lingua di Dante, Petrarca, Boccaccio cominciò a dirsi italiano e non più fiorentino o toscano. Spingeva in questa direzione l’aspirazione ad avere una lingua nazionale come già avveniva nei grandi stati nazionali europei. Rispetto alle altre parlate italiane, alcune già illustri come il veneziano o il napoletano, il fiorentino scritto aveva il vantaggio di una grande letteratura di rango europeo, il sostegno dell’attiva rete finanziaria e commerciale toscana, una assai maggiore prossimità al latino, che era la lingua dei colti. A questi soltanto, fuori della Toscana, e con la sola parziale eccezione della città di Roma, restò limitata la scelta. Mancarono ancora per secoli quelle condizioni di unificazione politica, economica e sociale e di sviluppo della scolarità elementare che altrove in Europa portavano i popoli a convergere verso l’uso effettivo delle rispettive lingue nazionali. Firenze e Roma a parte, l’uso dell’italiano restò riservato a occasioni più formali e solenni e alle scritture di quell’esigua parte di popolazione che poteva praticarle e leggerle. Tuttavia la tradizione letteraria dei colti fu un filo importante nella vicenda storica. Nell’Italia preunitaria, scrittori, politici, patrioti da Foscolo a Cattaneo e Manzoni, alla diplomazia piemontese, poterono additare a giustificazione storica della richiesta di unità e indipendenza dell’Italia l’esistenza di un’unica lingua nazionale. Ma non mancarono mai di sottolineare il fatto che l’uso dell’italiano era allora assai ridotto. È un tema ricorrente».
Quali sono le conseguenze di questa storia «al contrario»?
«Senza riferimento alla lingua nazionale la stessa idea di unificare il paese e rivendicarne l’indipendenza forse non sarebbe nata».
Il 1861 quale tipo di Paese certificò, dal punto di vista linguistico?
«Il 78% della popolazione risultò analfabeta. La scuola elementare era poco frequentata e mancava in migliaia di comuni. L’intera scuola postelementare era frequentata da meno dell’1% delle classi giovani. Secondo le stime la capacità di usare attivamente l’italiano apparteneva al 2,5% della popolazione. Un valoroso filologo purtroppo scomparso ha rivisto questa stima al rialzo, suggerendo che la capacità di capire l’italiano appartenesse all’8 o 9%».
E 150 anni dopo?
«La scolarizzazione avrebbe potuto modificare la situazione del 1861. Ma, diversamente da quanto avvenne per esempio in Giappone, che negli stessi anni si avviava alla modernità e aveva condizioni scolastiche peggiori delle nostre, le classi dirigenti italiane puntarono su esercito e ferrovie, non sulla scuola. Alla fine del secolo il Giappone aveva portato alla piena scolarità elementare quasi il 100% della popolazione: in Italia siamo arrivati a questo soltanto negli anni sessanta del ‘900. Solo nel periodo giolittiano, a inizio ‘900, cominciò una forte spinta popolare all’istruzione, come riflesso della grande emigrazione verso paesi in cui leggere e scrivere era normale, e come conseguenza diretta del costituirsi di associazioni operaie e contadine e del Partito Socialista.
 I governi Giolitti risposero positivamente, le spese per edilizia scolastica e stipendio dei maestri passarono dai comuni allo Stato. La scolarità cominciò a crescere e anche crebbe la quota di prodotto interno lordo destinato alla scuola. Ma il processo si bloccò prima per la Grande Guerra, poi, dal 1925 in poi, per tutto il periodo fascista.
-All’inizio del suo cammino la Repubblica italiana si ritrovò con il 59,2% di analfabeti e senza licenza elementare, con un indice di scolarità di tre anni a testa, a livello dei paesi sottosviluppati. E con il 64% di popolazione consegnata all’uso esclusivo di uno dei dialetti, mentre l’italiano era usato abitualmente da poco più del 10% della popolazione (inclusi i toscani e i romani) e in alternativa con i dialetti da un altro 20% o poco più. Uscire da questa situazione parve una necessità a persone com Pietro Calamandrei o Umberto Canotti Bianco, ma anche ai padri costituenti, chenel 1948 “costituzionalizzarono” l’obbligo scolsticon gratuito per almeno 8 anni (è l’art. 34 della Costituzione). Ma la scuola elementare e la media hanno stentato a decollare fino agli anni settanta.
I governi Giolitti risposero positivamente, le spese per edilizia scolastica e stipendio dei maestri passarono dai comuni allo Stato. La scolarità cominciò a crescere e anche crebbe la quota di prodotto interno lordo destinato alla scuola. Ma il processo si bloccò prima per la Grande Guerra, poi, dal 1925 in poi, per tutto il periodo fascista.
-All’inizio del suo cammino la Repubblica italiana si ritrovò con il 59,2% di analfabeti e senza licenza elementare, con un indice di scolarità di tre anni a testa, a livello dei paesi sottosviluppati. E con il 64% di popolazione consegnata all’uso esclusivo di uno dei dialetti, mentre l’italiano era usato abitualmente da poco più del 10% della popolazione (inclusi i toscani e i romani) e in alternativa con i dialetti da un altro 20% o poco più. Uscire da questa situazione parve una necessità a persone com Pietro Calamandrei o Umberto Canotti Bianco, ma anche ai padri costituenti, chenel 1948 “costituzionalizzarono” l’obbligo scolsticon gratuito per almeno 8 anni (è l’art. 34 della Costituzione). Ma la scuola elementare e la media hanno stentato a decollare fino agli anni settanta.
 La scuola ha fatto un lavoro enorme per sottrarre i figli e le figlie al destino di analfabetismo e mancata scolarità di padri e madri. Ha portato tutti i ragazzini alla licenza elementare negli anni settanta e ottanta, poi quasi tutti alla licenza media, infine, in questi anni, li ha portati per il 75% al diploma e alle porte dell’università. Ma non poteva cambiare da sola le strutture degli ambienti di provenienza degli allievi: la mancanza cronica di centri di pubblica lettura in oltre tre quarti dei comuni, la scarsa lettura di quotidiani, fermi, in percentuali di vendite, agli anni ‘50, la scarsa propensione alla lettura di libri. Per questa la parte femminile della popolazione, ha fatto moltissimo, assai più dei maschi, ma non basta». Nel gioco fra lingua e dialetti l’italiano è mai arrivato a essere “lingua di popolo”?
La scuola ha fatto un lavoro enorme per sottrarre i figli e le figlie al destino di analfabetismo e mancata scolarità di padri e madri. Ha portato tutti i ragazzini alla licenza elementare negli anni settanta e ottanta, poi quasi tutti alla licenza media, infine, in questi anni, li ha portati per il 75% al diploma e alle porte dell’università. Ma non poteva cambiare da sola le strutture degli ambienti di provenienza degli allievi: la mancanza cronica di centri di pubblica lettura in oltre tre quarti dei comuni, la scarsa lettura di quotidiani, fermi, in percentuali di vendite, agli anni ‘50, la scarsa propensione alla lettura di libri. Per questa la parte femminile della popolazione, ha fatto moltissimo, assai più dei maschi, ma non basta». Nel gioco fra lingua e dialetti l’italiano è mai arrivato a essere “lingua di popolo”?O è rimasto lingua d’élite?
«Oggi l’italiano è parlato dal 94% della popolazione, mai era stato tanto usato, solo il 6% resta ancorato all’uso esclusivo di uno dei dialetti. Ma la percentuale del 94% va sgranata e stratificata: il 45% parla abitualmente l’italiano anche tra le mura di casa, i l resto della popolazione lo usa in alternanza con uno dei dialetti o (per il 5%) delle lingue di minoranza. Ma attenzione, il multilinguismo, la persistenza di idiomi diversi non fa danno. Fa danno la dealfabetizzazione della popolazione adulta una volta uscita di scuola. Soltanto il 20% della popolazione ha gli strumenti minimi di lettura, scrittura e calcolo per orientarsi nella vita di una società moderna. La povera Mastrocola si agita per dire che dovremmo bloccare l’istruzione a 13 anni. Abbiamo invece bisogno di un grande sforzo collettivo di crescita culturale, qualche imprenditore comincia a capirlo, lo spiegano bene gli economisti e in un bel saggio recente Walter Tocci. Ma per ora la situazione è questa e un uso responsabile e sicuro della lingua è precluso a una gran parte del 94% che pure l’italiano ormai lo parla».
Dal 1954 in poi, l’italiano ce l’ha insegnato nostra maestra televisione. Oggi la tv sul piano linguistico e civile che effetti produce?
«Sì, con le grandi migrazioni interne, l’industrializzazione e la crescente scolarità delle fasce giovani, negli anni ‘50 l’ascolto televisivo fu decisivo per sentire l’italiano usato nel parlare. Dagli anni ‘90 la rincorsa alla pubblicità ha imbastardito le trasmissioni senza che vi siano sufficienti contrappesi, il calmiere di una informazione seria e diffusa, la lettura. Oggi lavoriamo molto nelle scuole per insegnare i ragazzi la regola della “presa di turno” nel parlare, Poi apri un qualsiasi talk show o il grande fratello e vedi che quella regola è calpestata senza ritegno». Che effetto fa al linguista una Minetti (laureata) che intercettata dice “Ne vedrai di ogni. Ti devo briffare”? «Studio le registrazioni solo per obiettivi professionali, quindi per campioni statistici, e quelle di Minetti non mi sono per ora capitate».
E che effetto ha fatto al linguista il Benigni che spiega l’Inno di Mameli?
«Un numero sterminato di anni fa, trenta, ricordo di avere cercato di spiegare che, come già per altri grandi comici, Totò anzitutto e Dario Fo, il comico di Benigni poggiava e poggia su una geniale intelligenza e una robusta, ampia base culturale. Benigni poi ci ha dato solo conferme. La sua “controlettura” dell’Inno di Mameli offre un modello raro e prezioso di come si debba e possa leggere la poesia, senza vibratini ed enfasi, come invece troppo spesso si fa. Di Benigni ricordo anche il memorabile discorso per l’avvio di pionieristici corsi di istruzione per gli adulti nel comune di Scandicci e la chiusa alta e paradossale, degna di Gramsci e don Milani: “Tutti vi dicono: fatti, non parole. E io vi dico invece: prima di tutto parole, parole, parole».
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. ---- "Paradiso e libertà". Il nuovo libro di Raniero La Valle (rec. di Carlo Molari - "Rocca").17 gennaio 2011, di Federico La Sala
Paradiso e libertà
di Carlo Molari (Rocca, n. 1, 1 gennaio 2011)
Il nuovo libro di Raniero La Valle «Paradiso e libertà» riassume e sviluppa in modo articolato due ideali fondamentali della sua esperienza di credente e di uomo pubblico: il coinvolgimento attivo nella politica come impegno per la libertà, distintivo essenziale della persona umana, e la tensione consapevole verso il traguardo del cammino comune: la divinizzazione dell’uomo o l’assunzione del «nome scritto nei cieli» (cfr. Lc. 10,20), il nome di figli di Dio.
I due aspetti sono collegati perché l’identità di figli di Dio è scritta nel cielo ma lo si costruisce solo sulla terra camminando insieme ai fratelli e vivendo consapevolmente la responsabilità per gli altri. «Non si salva l’anima se non si grida per gli oppressi». Ora «la politica altro non è che il consapevole vivere degli uomini insieme» (p. 164).
Il titolo «Paradiso e libertà» rievoca una curiosa terminologia della Bologna medioevale. Un decreto del 1257, che riscattava le 5856 persone ancora soggette a qualche forma di schiavitù venne chiamato «Libro Paradiso», «perché la conquista della libertà era percepita come un ritorno al Paradiso; il Paradiso è la libertà; data da Dio a lei si ritorna» (p. 116). Il termine ’Paradiso’, come è noto, può designare sia la condizione originaria dell’uomo secondo il mito della perfezione iniziale (Paradiso terrestre), sia il traguardo al quale ogni uomo è chiamato: «l’identità definitiva dei figli di Dio», secondo le parole di Gesù sulla croce «Oggi sarai con me in Paradiso» (Lc. 23, 43). Tra i due poli dell’inizio e della fine si intreccia l’esistenza storica dell’uomo che può svolgersi in un paradiso anticipato. Perché «ogni volta che sono stati liberati dei prigionieri, che è stata abolita la schiavitù, che sono state chiuse le Inquisizioni, che sono stati cacciati gli invasori, che sono stati arrestati gli usurai, che sono stati sconfitti i mafiosi, che hanno acquistato diritti gli operai, che sono uscite le donne dalle mani di padri e padroni, che si sono poste garanzie per i delitti e per le pene, e ogni volta che si sono scritte le Costituzioni, e si è dato mano ad attuarle, e le si sono difese contro i loro eversori, e quando il costituzionalismo ha fatto concepire anche altre, ulteriori conquiste, allora si è stabilito un pezzo di paradiso in terra; e ogni volta che questo accade, si accorciano le distanze tra i due paradisi» (p. 29).
L’ideale quando è vissuto inserisce una tensione nella storia e affida molte responsabilità agli uomini. «Forse un giorno questo paradiso, senza manicomi, senza carceri, senza ghetti, senza esclusioni, sarà possibile, qui in questo mondo. Forse le istituzioni, tutte le istituzioni, potranno assicurare la libertà, invece che toglierla... per costruire piuttosto un nuovo ordine di rapporti umani e vivere in un libero Paradiso in libera terra» (p. 120).
Il sottotitolo, «L’uomo quel Dio peccatore», riassume l’antropologia soggiacente alle scelte storiche e alle riflessioni proposte. L’uomo è l’unica creatura fatta «a immagine e a somiglianza di Dio» (cfr. Gen. 1,26 s) e lo è in virtù della libertà. La libertà dell’uomo, tuttavia, implica la possibilità di peccare, a differenza della libertà di Dio «che non può dissociarsi dalla propria immagine, non può non somigliare a se stesso, non può sdivinizzarsi» (p. 121). «Come la divinità è ciò che distingue l’uomo dagli animali, così il peccato è ciò che distingue l’uomo dagli animali e da Dio; e se Dio è l’essere divino che non pecca, l’uomo è l’essere divino che, peccando, viene meno alla sua divinità» (p. 121). È possibile però uscire dal peccato per entrare nell’ambito della grazia riconciliatrice. Questo è un aspetto essenziale del «buon annuncio» che è il Vangelo di Gesù: il peccato può essere redento, l’amore di Dio si esprime come misericordia per i peccatori. Dio entra nella terra sterminata del peccato, «vi entra per farsi uomo, l’uomo ne esce per farsi Dio» (p. 122).
Tutto ciò è possibile non in virtù della buona volontà dell’uomo o delle sue attuali capacità, bensì perché «nell’ uomo c’è una misteriosa energia divina; misteriosa non perché sia magica, ma perché è divina. E se Dio è amore... questa energia è l’amore. Come la libertà è nell’uomo l’immagine di Dio, così l’amore è Dio che ama attraverso l’uomo; di questo amore l’uomo è il vaso e il ministro, ne è la trasparenza e il filtro» (p. 175). D’altra parte lo stesso Concilio nel «Decreto sulle religioni non cristiane» aveva parlato «di quella forza arcana che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana» (Nostra Aetate n. 2).
Questa forza creatrice nell’uomo è giunta a fiorire come amore e conduce avanti la storia. Per questo: «l’antidoto al male e al peccato non è mai il Dio degli eserciti, del giudizio, della condanna, del potere, ma solo e sempre» (p. 186) il Dio dell’Amore misericordioso rivelato da Gesù. È la forza che consente di portare ilmale, di attraversare la sofferenza espressioni provvisorie della condizione imperfetta delle creature, per il momento ineliminabile. «C’è troppo dolore nel mondo, per pensare che esso non trovi né consolazione né fine» (p. 200).
Questa stessa forza dell’amore spinge il mondo verso il compimento, perché il Bene che la suscita e la muove è già esistente in forma piena e può far fiorire modalità inedite di fraternità e di giustizia. Questa tensione verso il Bene è essenziale alla prospettiva cristiana, ma è anche una leva di sconvolgimenti storici per cui «il cristianesimo che perda l’escatologia perde la sua anima, ma il mondo perde la rivoluzione» (p. 200). La missione della Chiesa in questa prospettiva è proclamare e difendere l’eccelsa dignità della persona umana; diffondere dinamiche di attesa, suscitare la tensione verso il compimento attraverso le sue anticipazioni. La Chiesa, in quanto struttura, non è l’unico ambito di salvezza nel mondo, ma è lo strumento perché tutta l’umanità diventi popolo di Dio. «Questo popolo di Dio, che sta nella Chiesa visibile ma non finisce nella Chiesa visibile, che sta in tutti i luoghi e in tutti i punti della storia, che è il soggetto in cui si gioca la salvezza, esistenzialmente, sociologicamente, politicamente è l’umanità tutta intera. E lei il corpo di cui Cristo è il capo: come dice la Mystici corporis, Cristo morendo in croce offrì al Padre se stesso quale capo di tutto il genere umano (p. 217).
Ciò che importa, in ogni caso, è mantenere alta la tensione verso il compimento, alimentare la speranza, perché solo questa consente di camminare anche quando tutto intorno è tenebroso. La città degli uomini può acquisire caratteristiche che anticipano e fanno presagire la città di Dio «e l’uomo, se è divino può trovarsi a suo agio in ambedue le città» (p. 29). Questi messaggi riassumono la intensa e ampia riflessione di Raniero La Valle, che ha indicato i criteri con cui riconoscere nella storia umana la sottile trama della salvezza offerta da Dio a tutti gli uomini. La conclusione è molto chiara: «il mondo non è da buttare. È il mondo di Dio, abitato da creature chiamate ad essere come Dei. E i demoni sempre infesti e sconfitti» (p. 220).
Raniero La Valle, Paradiso e libertà, Ponte alle Grazie, Milano 2010
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. ---- PARADISO E LIBERTA’ (di Raniero La Valle - Concilio e libertà).18 luglio 2010, di Federico La Sala
Concilio e libertà
di Raniero La Valle
Articolo pubblicato su Rocca *
Sta emergendo, negli osservatori esterni, un sentimento di tenerezza e compassione verso Benedetto XVI a causa della sua profonda afflizione per “il peccato penetrato nella Chiesa” ed esploso con i preti pedofili e qualche incidente di percorso dei suoi maggiori prelati. Da ciò a un giudizio generale sullo stato della Chiesa il passo è breve, e lo ha compiuto da ultimo Pietro Citati, che però usa categorie di giudizio che dimostrano quanto poco il rinnovamento del Concilio abbia modificato il modo in cui la Chiesa viene percepita dal mondo.
Dice infatti Citati che il problema non è il peccato, perché anzi senza l’angoscia del peccato il cristianesimo nemmeno potrebbe esistere; il rischio è invece che la Chiesa cessi di essere quell’“arca” nella quale la coscienza del peccato è compensata dalla gioia della grazia. Il rischio a suo parere è che la Chiesa cessi di essere “un’eccezione” rispetto al mondo che vive la sua avventura moderna. La Chiesa, secondo la visione un po’ giansenista (Pascal) espressa in questo articolo, non deve affatto essere moderna, anzi deve restare un residuo dei tempi antichi, il paradosso che contraddice la ragione, qualcosa di originario e straordinario che ignora le norme della società e della politica; e di conseguenza i suoi preti non devono essere “uomini come gli altri”, quasi fossero pastori protestanti, ma anzi devono riprodurre lo spirito degli antichi eremiti, e fare della castità e del celibato un segno di elezione, il segno della distanza, della differenza, dell’eccezione rispetto “al resto della vita”; cose di cui per fortuna, nonostante tutto, sussisterebbe qualche retaggio anche oggi.
Ora la domanda è: perché il mondo insiste su questa figura di Chiesa? Questa infatti è la figura sublimata della Chiesa professata prima del Concilio, a cui non corrispondeva affatto la Chiesa reale; e proprio Citati altra volta ha dato di quella Chiesa preconciliare una descrizione impietosa. Quello che ha fatto il Concilio non è stato certo di spegnere il paradosso o di togliere al Vangelo la sua forza di scandalo rispetto alle pratiche del mondo. Quello che ha fatto il Concilio è stato però di rimettere la Chiesa nel mondo e di riconoscere che questo paradosso e questo scandalo non vogliono affatto essere “un’eccezione rispetto al resto della vita”, ma vogliono essere precisamente questa vita; non dunque da riservarsi alla Chiesa come a un’arca sottratta alla rovina, ma da destinarsi all’umanità tutta intera oggetto dell’elezione di Dio.
A ben vedere, al di là di tutto il riformismo ecclesiastico (ciò in cui il Concilio non è riuscito), l’aggiornamento (cioè la rivisitazione nelle forme del pensiero “moderno”) promosso da Giovanni XXIII, ha riguardato proprio la riproposizione della fede come comprensione (o “ermeneutica”) del mondo e come possibilità offerta a tutti, e dunque compatibile con la vita reale.
E la prima cosa che ha fatto il Concilio è stata precisamente di liberare l’uomo dall’idea del peccato come destino, quale era percepito dentro le categorie.del peccato originale; e di fare invece della scelta tra il bene e il male un connotato della libertà, identico per l’uomo moderno come per il primo uomo, in quanto la libertà è e resta un “segno privilegiato” dell’immagine di Dio nell’uomo.
Il Concilio non fa alcun riferimento alle conseguenze devastanti che il primo peccato avrebbe avuto sull’intero genere umano, quasi attribuendo all’uomo una seconda e più inferma natura, ma dice che anche dopo la caduta Dio “non lo abbandonò”, non lo privò degli aiuti necessari alla salvezza e per conseguenza non lo scacciò da nessun giardino. E l’incarnazione non è narrata come un’operazione di riscatto per estrarre dall’umanità una porzione di eletti o di salvati intesi come Chiesa, ma come un dono di grazia e una vocazione per gli uomini tutti. Di conseguenza non c’è questa imparagonabilità della Chiesa col mondo, perché è proprio della totalità umana a lui unita nel Figlio, che Dio ha voluto fare il suo popolo. E qui, se vogliamo, sta il vero fondamento della laicità, non irreligiosa, del mondo.
Questo cerco di dire in un libro che uscirà il 16 settembre, intitolato “Paradiso e libertà; l’uomo, quel Dio peccatore”. Vi si racconta come una legge bolognese medioevale che aveva restituito ai servi la libertà fosse chiamata “Libro Paradiso”; il Paradiso è dunque il luogo dove gli uomini vengono a libertà. Ma guai se gli uomini fossero liberi solo in Paradiso, e se il mondo della fede fosse il “totalmente altro” dal resto del mondo. Se il Paradiso è libertà, perché lì abita Dio la cui immagine è la libertà, e se Dio è venuto in questo mondo, ogni volta che sono liberati dei prigionieri, che si chiudono le Inquisizioni, che sono sconfitti i mafiosi, che acquistano diritti gli operai, che escono le donne dalle mani di padri e padroni, e ogni volta che il mondo è amato così, si stabilisce un pezzo di paradiso in terra; e ogni volta che questo accade, si accorciano le distanze tra i due paradisi, e l’uomo, se è divino, può trovarsi a casa sua in ambedue le città.
Raniero La Valle
* Il Dialogo Sabato 17 Luglio,2010 Ore: 18:47
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. ---- LE RELIGIONI SI PREPARANO AL FUTURO? (di Sabino Acquaviva).3 marzo 2010, di Federico La Sala
LE RELIGIONI SI PREPARANO AL FUTURO?
di SABINO ACQUAVIVA (Avvenire, 03.03.2010)
Il futuro? Un nuovo mondo, molto diverso dal precedente, in cui ancora abitiamo. Ma si tratta di un futuro che ci affascina e ci fa paura. Il grattacielo di Dubai, con i suoi 818 metri e 162 piani, annuncia una società dominata da una selva di città verticali, capaci di ospitare 100.000 abitanti ciascuno e che si espanderà nello spazio di megalopoli di 20 o 30 milioni di abitanti. Nel 1950 soltanto New York era sopra i dieci milioni; nel 2001 le città che li superavano erano già 17, e il loro numero cresce continuamente. Ma se l’immagine del mondo di domani è differente da quella che ci offrivano ed offrono Venezia e Firenze, o le case dei contadini che un tempo abitavano le pianure europee, anche la figura umana cambia radicalmente nello spazio di un post-umanesimo fino a ieri imprevedibile.
Nanoscienze, informatica, biotecnologie, scienze cognitive e via dicendo, non cambiano soltanto gli spazi intellettivi e fisici in cui si muove la figura umana, forse rendono più attuale il sogno di Prometeo di dominare la natura. La vita continua ad allungarsi e la morte diventa qualcosa di molto diverso, anche perché la capacità di modificare geneticamente gli embrioni è destinata a mescolarsi a una trasformazione radicale della frontiera fra l’uomo e le macchine, che amplieranno nel nostro cervello i confini della memoria e dell’elaborazione cognitiva.
Per il corpo sono annunciati pezzi di ricambio e quindi la possibilità di rendere quasi senza confini la durata della vita. Culturalmente si finisce per mescolare fantascienza e realtà di un mondo futuro di cui molti finiscono per avere insieme paura e nostalgia. Paura perché ci si rende conto che molta parte del nostro passato sarà cancellato; nostalgia perché, figli di un’altra civiltà, non vedremo quasi nulla di questo futuro. Ma tali mutamenti finiscono per trasformare anche alcune sicurezze della nostra esistenza.
Ad esempio: l’universo di oggi, per il quale si parla di miliardi di stelle e nebulose, non è certamente quello di cui si occupava Galileo quando studiava i pianeti. E quindi si trasforma anche il suo significato. La natura? Cos’è la natura? Qualche filosofo sostiene che ne fa parte anche l’universo tecnologico di oggi, che invade ogni aspetto della vita. E Dio? È il Dio di sempre? O questo nuovo mondo richiede anche una maniera nuova e diversa di essere religiosi? Di credere nei simboli e nelle verità di sempre?
Come pensare religiosamente un universo milioni di volte più grande? Da questi interrogativi ne derivano altri. Ad esempio: le religioni e le Chiese come si possono adeguare al cambiamento? Fino a ieri parlare del passato e della sua cultura era soddisfacente, rasserenante; ad esempio era logico che si discutesse e scrivesse, anche polemicamente, di marxismo, di ateismo, eventualmente ricordando che Kierkegard pensava a due uniche certezze, l’infinito e l’eterno. Oggi l’orizzonte culturale sta cambiando.
Eppure il mondo delle megalopoli, di una quasi eternità fisica degli esseri umani, dello sconcertante postumanesimo che sembra voler modificare l’identità dell’uomo, non è quasi mai oggetto di dibattito religioso.
Eppure un tentativo di interpretare religiosamente la realtà è urgente e necessario, e dovrebbe affrontare il futuro così come la storia: perché un presepio in un paesino di campagna delle pianure europee non è uguale allo stesso presepio in un grattacielo alto un chilometro e abitato da centomila individui.
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA DEL RETTO AMORE. ---Politica e convivenza sociale in Dante.L’equilibrio di due felicità (di Lorenzo Ornaghi)24 agosto 2009, di Federico La Sala
Politica e convivenza sociale in Dante
L’equilibrio di due felicità
di Lorenzo Ornaghi *
Nella lettera apostolica Altissimi Cantus del 7 dicembre 1965, con la quale - in occasione del settimo centenario dalla nascita del poeta fiorentino - si istituiva la Cattedra di Studi danteschi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Paolo VI volle soffermarsi sulla "dottrina politica" di Dante Alighieri. Papa Montini sottolineò con forza il significato e l’importanza che Dante aveva attribuito al perseguimento, da parte del genere umano, della felicità terrena, accanto - e in subordine - a quella celeste: Chiesa e Impero, entrambe "al servizio della res publica christiana", erano chiamate, pur nella loro indipendenza, ad "aiutarsi reciprocamente" per permettere la vita buona dell’intera civiltà umana. L’idea dantesca - egli proseguiva - di "una potestà sovranazionale, che faccia vigere un’unica legge a tutela della pace e della concordia dei popoli", seppur concepita in termini medievali, manifestava non solo attualità, ma anche freschezza politica.
Pur implicitamente, Paolo VI si scostava dall’interpretazione del pensiero politico di Dante allora (e ancora oggi) assai diffusa. Secondo una tale interpretazione, Dante è sì un profeta, ma - per usare la celebre espressione di Friedrich Schlegel - un profeta rivolto all’indietro. E il suo sogno politico di un’autorità universale nient’altro riecheggerebbe se non l’ultima, nostalgica esaltazione dell’ideale del Sacro Romano Impero, che aveva orientato la civiltà medievale e che ora tramontava per lasciare definitivamente spazio al sistema delle comunità politiche particolari, alle idee di sovranità e di ragion di Stato, alla modernità e - con essa - ai molteplici processi di secolarizzazione.
La genesi del pensiero politico di Dante è strettamente legata all’esperienza del poeta non solo come cittadino della Firenze di quel tempo, ma anche e soprattutto alla sua (pur breve e travagliata) esperienza politica. Nella Firenze tra il XIII e il XVI secolo, la spietata "guerra civile" tra guelfi bianchi e neri, che dilania la città, non è lotta tra valori o principi, non ha finalità ideali. Come osserva Robert Davidsohn nella sua monumentale Storia di Firenze, in quel periodo ferveva "una lotta sorda per l’accaparramento del potere e le fazioni in tumulto stavano sovvertendo tutto l’ordine civile. Per ogni più futile pretesto si dava sfogo alle più selvagge passioni ed un’abominevole corruzione inquinava la cosa pubblica".
Il quadro non cambia, se si volge lo sguardo ai rapporti (o, per meglio dire, alle lotte) tra i comuni italiani. Ciò che Dante descrive nel Convivio è, dunque, una sorta precisa istantanea della situazione politica del suo tempo.
Oltre che dall’amore di Dante per l’indipendenza della patria fiorentina, la realizzazione - che egli invoca a gran voce - dell’humana civilitas e di un potere universale al di sopra di quelli particolari nascerebbe così, secondo Etienne Gilson, per soddisfare un’esigenza strettamente legata alla realtà politica del suo tempo: quella cioè di garantire alla sua città, e più in generale agli stati italiani, un protettore sufficientemente potente contro "l’opera usurpatrice della Chiesa". In realtà, la profondità, la passione e l’incisività degli argomenti, coi quali Dante negli anni dell’esilio condanna la volontà di dominio del Papa e difende l’autonomia del potere temporale da quello ecclesiastico, superano il nobile ma troppo angusto ambito dell’amor di patria.
Entra così in campo il "presunto" anticlericalismo di Dante. Nella Lettera ai Cardinali italiani - i quali durante l’aprile del 1314 erano riuniti in conclave in una piccola città della Provenza, all’indomani della morte di Clemente v - Dante infatti sostiene che, per la loro sete di potere, alcuni Pontefici sono stati causa dell’eclissi del papato e la cura degli interessi mondani che ha invaso la gerarchia ha condotto la Chiesa quasi alla rovina. Questo preteso anticlericalismo è divenuto il cuore delle interpretazioni che vedono in Dante un fermo sostenitore della separazione più netta tra potere temporale e spirituale. Anzi - quasi egli fosse profeta dell’autonomia della ragione umana e del fine naturale dell’uomo rispetto alla fede e a ogni fine soprannaturale - un precursore di quel separatismo radicale che, poco dopo, troverà in Marsilio da Padova uno dei primi e massimi esponenti. Secondo queste interpretazioni ancora oggi radicate, per Dante combattere le pretese teocratiche del Papa significherebbe salvare l’autonomia dell’imperatore, affinché la "imperiale maiestade" possa compiere quella missione del tutto immanente che Dante gli assegna: assicurare la pace e la felicità terrene alle quali tutti gli uomini per natura tendono. A questo fine terreno si aggiungerebbe anche quello ultramondano, che Dante certo non nega. Il primo, però, sarebbe del tutto autosufficiente rispetto al secondo. In tal modo, con la sua difesa dell’indipendenza dell’imperatore dal Papa, Dante si rivelerebbe l’anticipatore di un’idea del tutto nuova - "moderna", appunto - del rapporto tra potere temporale e potere spirituale: un rapporto di irreversibile separazione tra due realtà ormai dotate di piena autosufficienza.
Sulla dottrina politica di Dante avrebbero dunque "sbagliato" Paolo VI e, prima di lui, Benedetto XV, il quale - nella lettera enciclica In praeclara Summorum del 30 aprile 1921, scritta in occasione del sesto centenario della morte del poeta - affermava che Dante "professò in modo esemplare la religione cattolica", e sapeva perfettamente che "il principale fondamento delle nazioni" sono "la giustizia e i diritti di Dio".
Ma il quadro cambia se, al centro del pensiero politico di Dante, correttamente si mette non la critica al temporalismo del Papa, bensì il concetto di cupidigia e le conseguenze spirituali e materiali del suo trionfo. Per Dante, l’ordine e la pace terrene sono turbate dallo scatenamento di quella cupiditas che, in termini teologici, è la riduzione sul piano orizzontale dell’amor Dei per cui l’uomo non può in ultimo essere saziato da alcun bene finito. In termini temporali, la cupiditas è il contrario della giustizia: ossia è egoismo, volontà di sopraffazione e sete di potere. Come afferma Paolo VI, ancora nella Altissimi Cantus, secondo Dante l’agostiniana "tranquillità dell’ordine" - la pace che riguarda "i singoli, le famiglie, le nazioni, il consorzio umano, pace interna ed esterna, pace individuale e pubblica" - "è turbata e scossa, perché sono conculcate la pietà e la giustizia".
Del trionfo della cupidigia, il temporalismo di Bonifacio viii è certo una manifestazione, ma non l’unica. La sua copia rovesciata, è infatti - come ha osservato molto acutamente Augusto Del Noce - il tentativo del re di Francia di avere potestà diretta sul piano spirituale. Da questa prospettiva, Dante afferma la distinzione degli ordini perché vuole combattere la cupiditas, perché avverte profonda l’esigenza di permeare compiutamente di religione la vita pubblica. E questa esigenza è condizione essenziale per il raggiungimento della beatitudine celeste e della felicità terrena.
Vi è dunque una sorta di unità-distinzione che caratterizza, in Dante, il rapporto tra potere spirituale e quello temporale, dal momento che entrambi sono chiamati, pur nella necessaria distinzione, a cooperare armoniosamente per il bene integrale degli uomini: ossia per la felicità terrena e, "insieme", per la salvezza delle anime, per la vita buona su questa terra, e "insieme" per la beatitudine celeste. Così, il fine naturale del genere umano - da perseguire con la ragione, e per raggiungere il quale è necessaria l’opera di un’autorità politica universale - non è in contrasto, bensì in armonia con il raggiungimento del fine soprannaturale e celeste, dettato dalla fede. Come scrive Dante stesso nell’ultima pagina del suo De Monarchia, proponendo un’affermazione sintetica della laicità dal punto di vista cattolico: "La felicità terrena è in un certo modo subordinata alla felicità eterna".
Suona dunque corretta e appropriata l’affermazione di Benedetto XV, quando egli sottolineava la consapevolezza di Dante che la giustizia e i diritti di Dio sono il più solido fondamento della famiglia umana e del sistema internazionale. Ce ne viene oggi un’ulteriore prova dalla recentissima enciclica Caritas in Veritate, in cui Benedetto XVI giustamente ci ricorda: "Talvolta l’uomo moderno è erroneamente convinto di essere il solo autore di se stesso, della sua vita e della società. È questa una presunzione, conseguente alla chiusura egoistica in se stessi, che discende - per dirla in termini di fede - dal "peccato delle origini". La sapienza della Chiesa ha sempre proposto di tenere presente il peccato originale anche nell’interpretazione dei fatti sociali e nella costruzione della società: "Ignorare che l’uomo ha una natura ferita, incline al male, è causa di gravi errori nel campo dell’educazione, della politica, dell’azione sociale e dei costumi"".
Appare pertanto sempre meno ragionevole concepire il pensiero politico di Dante semplicemente come quello - per dirla con Karl Vossler - dell’ultimo "cavaliere dell’ideale teocratico", o, al contrario, come quello di uno dei primi scultori del laicismo moderno. In Dante, semmai, ritroviamo gli elementi di una genuina e sana concezione di laicità. Una concezione che, sapendo armonizzare fede e ragione, è in grado di affermare e realizzare la necessità della dimensione pubblica della fede per il bene di tutti, credenti e non credenti.
* ©L’Osservatore Romano - 24-25 agosto 2009
Sul tema della Monarchia o del retto amore ("karitas", come scriveva Dante - che non conosceva il greco), e sulle cieche pretese ratzingeriane, nel sito, si cfr.:
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA D’AMORE. ---- Giotto. Il linguaggio e i gesti del moderno (di Antonio Pinelli).9 marzo 2009, di Federico La Sala
Esposti a Roma molti suoi capolavori (ma alcuni di dubbia attribuzione)
 oltre a opere di Cimabue, Cavallini, Martini, dei Lorenzetti e di Arnolfo.
oltre a opere di Cimabue, Cavallini, Martini, dei Lorenzetti e di Arnolfo.
 Dalla rassegna emerge il profilo rivoluzionario di una cultura figurativa
Dalla rassegna emerge il profilo rivoluzionario di una cultura figurativa Giotto. Il linguaggio e i gesti del moderno
Giotto. Il linguaggio e i gesti del moderno di Antonio Pinelli (la Repubblica, 09.03.2009)
di Antonio Pinelli (la Repubblica, 09.03.2009) Disegna spazi abitabili dentro i quali fa muovere figure dalla corposa fisicità
Disegna spazi abitabili dentro i quali fa muovere figure dalla corposa fisicità
 L’esperienza dell’antico gli fa superare le convenzioni bizantine
L’esperienza dell’antico gli fa superare le convenzioni bizantine
 In una "Canzone" polemizza con l’ideale francescano della povertà
In una "Canzone" polemizza con l’ideale francescano della povertàROMA. Giotto, non-Giotto è il titolo di un saggio, pubblicato nel 1939 sul Burlington Magazine, con cui l’autorevole storico dell’arte Richard Offner si schierò tra coloro che negano la paternità giottesca del celeberrimo ciclo con le Storie di San Francesco, affrescato sulle pareti della basilica superiore di Assisi.
Per la folgorante efficacia con cui sintetizza una disputa che ha fatto versare fiumi d’inchiostro - e chissà quanto ancora ne sarà versato, giacché tutt’oggi la querelle divide in due schiere contrapposte noi addetti ai lavori -, questo titolo dilemmatico mi è ronzato a lungo in testa mentre visitavo la grande mostra che ha aperto i battenti in questi giorni al Vittoriano («Giotto e il Trecento. "Il più Sovrano Maestro stato in dipintura"», a cura di Alessandro Tomei, fino al 29 giugno).
Per una duplice ragione: in primis, perché nel catalogo rigorosamente bipartisan compaiono saggi equamente divisi tra fautori dell’uno e dell’altro schieramento, e in secondo luogo perché, a dispetto degli squilli di tromba dei comunicati stampa che magnificano la presenza in mostra di ben «20 capolavori eseguiti da Giotto», chi voglia sincerarsi se tale affermazione risponde a verità, potrà constatare che almeno la metà di quei 20 capolavori pende, ahimè, verso il corno «non- Giotto» del dilemma.
Detto questo per amore di verità e in pacata polemica, non con il curatore, che non ne ha colpa (schede e cartellini registrano fedelmente tutti i dubbi attributivi), ma con la macchina mediatica del mostrificio, che sembra incapace di affrancarsi da questo genere di chiassoso imbonimento, non credo di smentirmi se affermo che lo sforzo compiuto dagli organizzatori è stato imponente e che la rassegna merita senz’altro di essere visitata.
Ne vale la pena innanzitutto per la quantità (più di 150) e la qualità delle opere esposte: oltre a quattro o cinque capolavori di Giotto, tra cui spicca il Polittico di Badia restaurato per l’occasione, basterà menzionare, tra le tante, opere insigni di Cimabue, Jacopo Torriti, Pietro Cavallini, Simone Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti, Nicola, Giovanni e Andrea Pisano, Arnolfo di Cambio.
Ma la mostra merita di essere apprezzata anche per il suo disegno innovativo, che mira a sottolineare l’importanza del ruolo svolto da Roma, con la sua cultura figurativa e i suoi antichi monumenti, nella formazione del linguaggio giottesco, e al contempo ambisce a illustrare con esempi prelevati ad hoc dai più svariati ambiti tecnici (miniatura ed arti suntuarie comprese) e dai più diversi contesti geografici (Firenze, Roma, Assisi, Rimini, Padova, Napoli, Milano..), quanto la rivoluzione operata da Giotto abbia segnato in profondità il panorama artistico del suo tempo e determinato, direttamente o attraverso i suoi seguaci, il corso dell’arte occidentale per secoli.
All’alba del ’400, Cennino Cennini coniò per tale sconvolgimento una definizione insuperabile: «Giotto rimutò l’arte di greco in latino, e la ridusse al moderno», spiegando l’essenza di un linguaggio che seppe riconquistare, sull’esempio dell’antico, la capacità di infondere all’immagine una tangibile concretezza, fisica e spaziale, abbandonando la piatta bidimensionalità e le astratte convenzioni grafiche della tradizione bizantina (la «maniera greca»): spazi «abitabili», entro cui si accampano figure con una propria corposa fisicità, modellate da un lume «vero» e indagate nella varietà di forme, gesti e fisionomie, che ne rappresentano la specificità individuale e la cangiante gamma espressiva dei sentimenti.
Che il geniale protagonista di questo nuovo corso sia nato e cresciuto a Firenze, dove da tempo si andava sviluppando una borghesia mercantile che badava al sodo ed aveva un concreto orizzonte terreno da coltivare ed ampliare a misura delle proprie ambizioni, non è certo un caso, così come non è un caso che Giotto abbia saputo rendere ottimo il proprio talento, organizzando con spirito imprenditoriale la propria bottega e facendola funzionare a pieno ritmo come una vera e propria manifattura (di qui l’ampiezza del problema attributivo «Giotto, non-Giotto»).
Ma non è tutto: copiose sono le testimonianze che ci parlano dei suoi accorti investimenti (telai affittati a lavoranti a domicilio, acquisto di terreni, poi dati in affitto agli antichi proprietari per spuntare pingui interessi aggirando le leggi contro l’usura); conosciamo perfino una sorprendente Canzone scritta di suo pugno, in cui si polemizza con l’ideale francescano della povertà, contestando il luogo comune della ricchezza come fonte di corruzione e definendo «cosa bestial» la miseria.
Ciò non mi induce a schierarmi tra coloro (per la verità, sempre meno) che giudicano non sue le Storie francescane di Assisi, ma mi persuade invece circa la perfetta aderenza di quelle Storie agli ideali revisionisti della corrente francescana dei «Conventuali», impegnata a polemizzare contro l’estremismo pauperista degli «Spirituali». Ma questo è solo uno dei tanti, affascinanti aspetti, su cui questa mostra - e il suo ottimo catalogo - offrono spunti di riflessione.
-
> DELLA LINGUA E DELLA POLITICA D’ITALIA. DANTE: L’UNIVERSALE MONARCHIA D’AMORE. --- "TUTTO DANTE"... Tutto esaurito e applausi alla prima francese ... Il tour mondiale di Benigni continuerà per tutto il 2009 dall’Europa agli Usa per finire in Argentina.7 marzo 2009, di Federico La Sala
 Tutto esaurito e applausi alla prima francese di "Tuttodante"
Tutto esaurito e applausi alla prima francese di "Tuttodante"
 Prossime tappe: Belgio e Germania, prima del salto negli Usa
Prossime tappe: Belgio e Germania, prima del salto negli Usa Benigni: "Dopo la Sardegna
Benigni: "Dopo la Sardegna
 Berlusconi vuole la Corsica"
Berlusconi vuole la Corsica"di LAURA PUTTI *
PARIGI - Benigni ha sopreso ancora. A coloro, la maggioranza, italiani, che aspettavano un tuttobenigni a ruota libera, ha invece porto un "Tuttodante", una vera serata sulla Divina Commedia e sul suo divino autore. Poco Berlusconi, poca situazione politica italiana, molta poesia.
E alla prima, ieri sera al Gran Rex (una delle più belle sale parigine, già teatro, oggi il cinema più grande d’Europa, quasi tremila posti), davanti a un pubblico molto attento - nelle prime file un piccolo "parterre de rois" con Renzo Piano, Giuseppe Bertolucci, Jane Birkin, Carole Bouquet, la moglie Nicoletta Braschi con mamma, tra gli altri - si è scaraventato sul palco accompagnato da una musica circense, poi è uscito di scena, è rientrato, ha detto che voleva abbracciare tutti uno a uno, e ha iniziato a parlare di poesia che avvicina a Dio.
"Perché Dio? Sono andato troppo in alto. E allora scendiamo in basso: Berlusconi" ed è venuto giù il teatro. Soprattutto perché i sottotitoli (annunciati) non c’erano e il suo francese è davvero esilarante: "Quando dico Berlusconi in Italia tutti ridono. E allora mi sono detto, vado all’estero e chissà se ridono. Non sono più in Italia, ho voglia di dire quello che mi pare, tanto poi posso dire che c’è stato un malinteso, che sono stato frainteso". Si rivolge alla Madonna: "Maria aiutami tu. Come? Neanche tu capisci il mio francese?". Cerca di spiegare la situazione politica italiana. "In Sardegna ci sono state le elezioni e ha vinto lui. Ma in realtà è interessato alla Corsica. È convinto che lì siano le sue radici come Napoleone, che pare avesse un figlio che si chiamava Piernapoleone". Ma nel Quinto Canto dell’Inferno Dante è nel girone dei lussuriosi. "L’amore, la lussuria. Berlusconi è stato fotografato in Sardegna con cinque donne sulle ginocchia, Viagra ortopedico". E ancora: "Berlusconi ha vinto due volte: la prima ha detto che a sinistra erano tutti gay; la seconda ha tolto il bollo dell’auto e quello del motorino e la tassa sulla prima casa e ha vinto un’altra volta".
I francesi ridono, come chi pensi l’abbia sparata grossa. Benigni racconta delle intercettazioni telefoniche con la celebre storia delle attricette da sistemare. E inizia una tirata piena di "gros mots" che in Italia sono espressioni correnti, qui molto meno. Ma il pubblico ride. Non parla del presidente francese e di sua moglie italiana. Se la prende piuttosto con il nostro re (che ha una nuora francese) "che un giorno è atterrato e ha chiesto una prostituta a buon mercato. Va bene la prostituta, ma ci pensate che avremmo un re che la vuole a buon mercato".
Da questo momento in poi l’attualità finisce e inizia Dante. Benigni parla del Medioevo e del Rinascimento italiano, racconta di Firenze che al tempo di Dante era una città corrotta e perduta, cita Gerard de Nerval "che ha provato a rifare la Vita Nova", Stendhal "che voleva essere italiano e che ha inventato la celebre sindrome", Voltaire "che detestava Dante che ne ha parlato talmente male che lo ha reso celebre in tutta Europa". Quando ha letto il Quinto Canto, il frastuono, il berciare, le risate, si sono mutati in silenzio. Infranto da caldissimi applausi finali. Il tour mondiale continuerà per tutto il 2009 dall’Europa agli Usa per finire in Argentina.
* la Repubblica, 7 marzo 2009