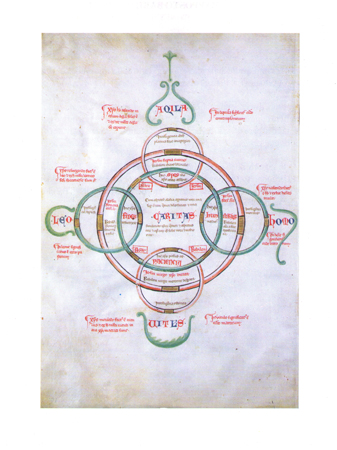PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". Gioacchino (con Dante) invita Benedetto XVI a correre ai ripari - di Federico La Sala
- [...]Il primo visse nell’ atmosfera del timore; il secondo in quella della fede; il terzo vivrà nella carità. Il primo segnò età dei servi; il secondo l’età dei figli; il terzo non conoscerà che amici [...].
|
Le Ruote (del carro) di Ezechiele |
Probabilmente figlio d’un notaio, nacque a Celico, nei pressi di Cosenza, intorno al 1130; compì un viaggio in Terrasanta, al cui ritorno si fece monaco cisterciense, entrando nel monastero della Sambucina, indi in quello di Santa Maria di Corazzo, di cui fu abate. A seguito d’una profonda crisi spirituale lasciò Corazzo, ritirandosi in un eremo a Pietralata, poi in altro eremo sulla Sila, ove raccolse una piccola comunità e costituì il cenobio di San Giovanni in Fiore (la comunità prese poi nome di Florense), e il nuovo ordine ebbe approvata la regola da papa Celestino III nel 1196. Perseguitato dai Cisterciensi, poté tuttavia godere l’appoggio dell’imperatore Enrico VI. Morì il 30 marzo del 1202. È autore di una nutrita serie di opere profetico-teologiche, la Concordia Novi ac Veteris Testamenti, la Expositio in Apocalypsim, il Psalterium decem chordarum, il Tractatus super quatuor Evangelia, il De Unitate seu essentia Trinitatis (ora perduto). Non suo, invece, ma compendio delle sue idee e delle sue profezie ad opera di qualche discepolo, è il Liber figurarum, che si disse aver influenzato Dante per la Divina Commedia. *
Dalla «Concordia Novi ac Veteris Testamenti» [1]
Debemus ergo in labore et gemitu in hiis sacris diebus resistere affligentes, ut scriptum est animas nostras quousque quadraginta dies, hoc est generationes totidem et duo quantum in maiori luctu et afflictione pertranseant: ut ad sacra illius Pasche solemnia pervenire possimus et cantare domino canticum novum quod nobis abstulit, ut iam diximus, primus septuagesimae dies canticum letitie quod est alleluia. Nec mirum si hec sacra mysteria clausa hactenus sub velamine nobis iunioribus tempore incipiunt aperiri. Cum illa generatio agatur in extremis quae designatur in sacro quadragesimo die. In quo velum illud mysteriale quod pendet a conspectu altaris tollitur a facie populi. Ut qui hactenus «per speculum in enigmate» amodum «facie ad faciem» videre incipiant veritatem: euntes ut ait Apostolus «de claritate in claritatem...».
Tres denique mundi status nobis ut iam scripsimus in hoc opere divine nobis pagine sacramenta commendant: primum in quo fuimus sub lege, secundum in quo fuimus sub gratia, tertium quod e vicino expectamus sub ampliori gratia...
Primus ergo status in scientia fuit, secundus in potestate sapientie, tertius in plenitudine intellectus. Primus in servitute servili, secundus in servitute filiali, tertius in libertate. Primus in flagellis, secundus in actione, tertius in contemplatione. Primus in timore, secundus in fide, tertius in charitate. Primus status servorum est, secundus liberorum, tertius amicorum. Primus senum, secundus iuvenum, tertius puerorum. Primus in luce siderum, secundus in aurora, tertius in perfecto die. Primus in hieme, secundus in exordio veris, tertius in estate. Primus protulit urticas, secundus rosas, tertius lilia. Primus herbas, secundus spicas, tertius triticum. Primus aquam, secundus vinum, tertius oleum. Primus pertinet ad septuagesimam, secundus ad quadragesimam, tertius ad festa paschalia.
Primus itaque status pertinet ad Patrem qui auctor est omnium... secundus ad Filium qui assumere dignatus est limum nostrum... tertius ad Spiritum Sanctum de quo dicit Apostolus: «Ubi spiritus domini, ibi libertas». Et primus quidem status significatus est in tribus illis hebdomadis que precedunt ieiunium quadragesimale, secundus in ipsa quadragesima, tertius in tempore solemni quod vocatur paschale.
Quocirca si mysterium veli positi inter populum et altare non segniter intuemur, intellegimus non absque circa die quadragesimo, in quo et conficitur sanctum chrisma, eicitur a conspectu altaris ut iam non videant fideles altare ipsum quasi per speculum in enigmate, sed magis facie ad faciem. Nimirum quia in tempore isto in quo agitur quadragesima generatio oportet auferri velamen litere a cordibus multorum.
***
In questi giorni sacri noi dobbiamo resistere nel lavoro e nel pianto, in attesa che si compia il ciclo quaresimale, si chiuda cioè il novero delle quarantadue generazioni del lutto e dell’afflizione, e noi possiamo essere introdotti nella sacra solennità dell’universale risurrezione, per cantare al Signore quel cantico nuovo di gioia, che è l’Alleluia. Nessuna meraviglia se tutto il significato profondo dei vecchi sacri misteri, fino a oggi celati, sotto il velame, agli occhi nostri, di noi, più giovani e più piccoli, si va dischiudendo. Dappoiché apparteniamo a quest’ultima generazione che è designata nell’ultimo sacro giorno della penitenziale quaresima: il giorno in cui si toglie dagli occhi del popolo il velario che tiene l’altare in lutto. Affinché quella verità che il popolo vide finora «in sullo specchio, in enigma», cominci a scorgere «faccia a faccia», passando, secondo l’assicurazione dell’Apostolo, «di chiarezza in chiarezza».
Tutti i simboli sacramentali contenuti nelle pagine della rivelazione di Dio ci instillano la convinzione dei tre stati. Il primo stato è quello durante il quale noi fummo sotto il dominio della Legge; il secondo è quello durante il quale noi fummo sotto il dominio della Grazia; il terzo è quello che noi attendiamo da un giorno all’altro, nel quale ci investirà una più ampia e generosa grazia.
Il primo stato visse di conoscenza; il secondo si svolse nel potere della sapienza; il terzo si effonderà nella plenitudine dell’intendimento. Nel primo regno il servaggio servile; nel secondo la servitù filiale; il terzo darà inizio alla libertà. Il primo stato trascorse nei flagelli; il secondo nell’azione; il terzo trascorrerà nella contemplazione. Il primo visse nell’ atmosfera del timore; il secondo in quella della fede; il terzo vivrà nella carità. Il primo segnò età dei servi; il secondo l’età dei figli; il terzo non conoscerà che amici. Il primo stato fu dominio di vecchi; il secondo di giovani; il terzo sarà dominio di fanciulli. Il primo tremò sotto l’incerto chiarore delle stelle; il secondo contemplò la luce dell’aurora; solo nel terzo sfolgorerà il meriggio. Il primo fu inverno; il secondo un palpitare di primavera; il terzo conoscerà la pinguedine dell’estate. Il primo non produsse che ortiche; il secondo diede le rose; solo al terzo appartengono i gigli. Il primo vide le erbe; il secondo lo spuntar delle spighe; il terzo raccoglierà il grano. Il primo ebbe in retaggio l’acqua; il secondo il vino; il terzo spremerà l’olio. Il primo stato fu tempo di settuagesima; il secondo fu tempo di quaresima; il terzo solo scioglierà le campane di Pasqua.
In conclusione: il primo stato fu reame del Padre, che è il creatore dell’universo; il secondo fu reame del Figlio, che si umiliò ad assumere il nostro corpo di fango; il terzo sarà reame dello Spirito Santo, dal quale dice l’Apostolo: «Dove è lo Spirito del Signore, ivi è libertà». E il primo stato è simboleggiato in quelle tre settimane che vanno innanzi al digiuno quaresimale; il secondo nella stessa quaresima; il terzo nel tempo solenne di Pasqua. Per cui se convenientemente interpretiamo il mistero del velo interposto fra il popolo e l’altare, comprendiamo come non è senza motivo che nel giorno di quaresima, in cui si consacra il sacro crisma, quel velo è tolto di mezzo, affinché i fedeli non veggano più l’altare quasi attraverso uno specchio, ma più tosto faccia a faccia. Il che per dire che in questo tempo, regnante la quarantesima generazione, occorre ritirare il velo della lettera dal cuore della massa.
(Trad. di E. BUONAIUTI, Gioacchino da Fiore, cit., pp. 227-231).
[1] Ediz. Venezia 1519, V, 84.
* Scrittori religiosi del Duecento di Giorgio Petrocchi
SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso)" vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- L’IMPERATORE COSTANTINO, LA "PAROLA" DI "DIO", E LA FIGURA DI "MICHELE" - OGGI: [...] San Michele. Voi sapete che cosa vuol dire Michele? È un nome prettamente orientale, ebraico, che vuol dire: “Quis ut Deus?”, “Chi è come Dio?”. Questa parola è parola che ha vinto, parola vincente nel grande scontro tra il bene e il male. Questa parola - Michele, “Chi è come Dio?” - ha vinto [...] “Quis ut Deus?”. E questa parola vince, vince come una volta l’imperatore romano Costantino ha vinto nella Croce: “in hoc signo”, in questo segno vincerai. Vi auguro questa vittoria (GIOVANNI PAOLO II, "Visita Pastorale alla parrocchia di Santa Maria Assunta e San Michele a Castel Romano", 13 febbraio 1994).
- "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" (Giovanni Paolo II, 2003)
- Ubuntu: una parola da e per non dimenticare. Una nota a margine della Lettera enciclica di Giovanni Paolo II SULL’ EUCARISTIA (del 17.04.2003)
AL DI LA’ DELLA "FALLACIA DELL’ACCIDENTE", UN NUOVO PARADIGMA. Due soli in Terra e il Sole del Giusto Amore (“Karitas seu recta dilectio”) in cielo. La nuova "unità" della "Monarchia" di Dante
IL GRANDE BALZO DI DANTE ALIGHIERI, NEL NOSTRO PRESENTE: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE.!!! AL DI LA’ DI PLATONE E DI ARISTOTELE, E DI HEGEL, SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO MA, IMPLICITAMENTE, ANCHE SUL PIANO ANTROPOLOGICO.
A. La Charitas o del giusto amore
Monarchia, I. 11:
 [...] 12. Sed Monarcha non habet quod possit optare: sua nanque iurisdictio terminatur Occeano solum: quod non contingit principibus aliis, quorum principatus ad alios terminantur, ut puta regis Castelle ad illum qui regis Aragonum. Ex quo sequitur quod Monarcha sincerissimum inter mortales iustitie possit esse subiectum.
[...] 12. Sed Monarcha non habet quod possit optare: sua nanque iurisdictio terminatur Occeano solum: quod non contingit principibus aliis, quorum principatus ad alios terminantur, ut puta regis Castelle ad illum qui regis Aragonum. Ex quo sequitur quod Monarcha sincerissimum inter mortales iustitie possit esse subiectum.
 13. Preterea, quemadmodum cupiditas habitualem iustitiam quodammodo, quantumcunque pauca, obnubilat, sic karitas seu recta dilectio illam acuit atque dilucidat. Cui ergo maxime recta dilectio inesse potest, potissimum locum in illo potest habere iustitia; huiusmodi est Monarcha: ergo, eo existente, iustitia potissima est vel esse potest.
13. Preterea, quemadmodum cupiditas habitualem iustitiam quodammodo, quantumcunque pauca, obnubilat, sic karitas seu recta dilectio illam acuit atque dilucidat. Cui ergo maxime recta dilectio inesse potest, potissimum locum in illo potest habere iustitia; huiusmodi est Monarcha: ergo, eo existente, iustitia potissima est vel esse potest.
 14. Quod autem recta dilectio faciat quod dictum est, hinc haberi potest: cupiditas nanque, perseitate hominum spreta, querit alia; karitas vero, spretis aliis omnibus, querit Deum et hominem, et per consequens bonum hominis. Cumque inter alia bona hominis potissimum sit in pace vivere - ut supra dicebatur - et hoc operetur maxime atque potissime iustitia, karitas maxime iustitiam vigorabit et potior potius.
14. Quod autem recta dilectio faciat quod dictum est, hinc haberi potest: cupiditas nanque, perseitate hominum spreta, querit alia; karitas vero, spretis aliis omnibus, querit Deum et hominem, et per consequens bonum hominis. Cumque inter alia bona hominis potissimum sit in pace vivere - ut supra dicebatur - et hoc operetur maxime atque potissime iustitia, karitas maxime iustitiam vigorabit et potior potius.
 15. Et quod Monarche maxime hominum recta dilectio inesse debeat, patet sic: omne diligibile tanto magis diligitur quanto propinquius est diligenti; sed homines propinquius Monarche sunt quam aliis principibus: ergo ab eo maxime diliguntur vel diligi debent. Prima manifesta est, si natura passivorum et activorum consideretur; secunda per hoc apparet: quia principibus aliis homines non appropinquant nisi in parte, Monarche vero secundum totum.
15. Et quod Monarche maxime hominum recta dilectio inesse debeat, patet sic: omne diligibile tanto magis diligitur quanto propinquius est diligenti; sed homines propinquius Monarche sunt quam aliis principibus: ergo ab eo maxime diliguntur vel diligi debent. Prima manifesta est, si natura passivorum et activorum consideretur; secunda per hoc apparet: quia principibus aliis homines non appropinquant nisi in parte, Monarche vero secundum totum.
 16. Et rursus: principibus aliis appropinquant per Monarcham et non e converso; et sic per prius et immediate Monarche inest cura de omnibus, aliis autem principibus per Monarcham, eo quod cura ipsorum a cura illa supprema descendit.
16. Et rursus: principibus aliis appropinquant per Monarcham et non e converso; et sic per prius et immediate Monarche inest cura de omnibus, aliis autem principibus per Monarcham, eo quod cura ipsorum a cura illa supprema descendit.
 17. Preterea, quanto causa est universalior, tanto magis habet rationem cause, quia inferior non est causa nisi per superiorem, ut patet ex hiis que De causis; et quanto causa magis est causa, tanto magis effectum diligit, cum dilectio talis assequatur causam per se.
17. Preterea, quanto causa est universalior, tanto magis habet rationem cause, quia inferior non est causa nisi per superiorem, ut patet ex hiis que De causis; et quanto causa magis est causa, tanto magis effectum diligit, cum dilectio talis assequatur causam per se.
 18. Cum igitur Monarcha sit universalissima causa inter mortales ut homines bene vivant, quia principes alii per illum, ut dictum est, consequens est quod bonum hominum ab eo maxime diligatur.
18. Cum igitur Monarcha sit universalissima causa inter mortales ut homines bene vivant, quia principes alii per illum, ut dictum est, consequens est quod bonum hominum ab eo maxime diligatur.
 19. Quod autem Monarcha potissime se habeat ad operationem iustitie, quis dubitat nisi qui vocem hanc non intelligit, cum, si Monarcha est, hostes habere non possit?
19. Quod autem Monarcha potissime se habeat ad operationem iustitie, quis dubitat nisi qui vocem hanc non intelligit, cum, si Monarcha est, hostes habere non possit?
 20. Satis igitur declarata subassumpta principalis, quia conclusio certa est: scilicet quod ad optimam dispositionem mundi necesse est Monarchiam esse.
20. Satis igitur declarata subassumpta principalis, quia conclusio certa est: scilicet quod ad optimam dispositionem mundi necesse est Monarchiam esse.
***
ora il Monarca non ha più nulla da desiderare, poiché la sua giurisdizione è limitata soltanto dall’oceano (il che non si verifica per gli altri prìncipi i cui dominii confinano con altri dominii, come, per es., quello del re di Castiglia, che confina con quello del re di Aragona); quindi il Monarca, tra tutti gli uomini, è il soggetto di giustizia più esente da ogni cupidigia.
Inoltre, come la cupidigia, per quanto piccola sia, offusca l’abito della giustizia, così la carità, cioè il retto amore, lo rende più forte e più illuminato. Perciò, la persona che è capace di raggiungere il più alto grado di retto amore può attingere il massimo livello di giustizia; ora, questa persona è il monarca; quindi, con il monarca si instaura, o può instaurarsi, il massimo di giustizia. Che poi il retto amore produca tali effetti si può dedurre dal fatto che la cupidigia, spregiando il Bene supremo degli uomini, cerca altri beni, mentre la carità, spregiando tutti gli altri beni, cerca Dio e l’uomo, e di conseguenza il vero bene dell’uomo.
E siccome, fra tutti i beni dell’uomo, grandissimo è quello di vivere in pace, come si è detto sopra, e questo bene si raggiunge principalmente ed essenzialmente attraverso la giustizia, questa riceverà grandissimo vigore dalla carità, e tanto più quanto più quest’ultima sarà intensa. Che poi nel monarca debba trovarsi in sommo grado il retto amore degli uomini si dimostra nel modo seguente: ogni oggetto amabile è tanto più amato quanto più è vicino a chi l’ama; ora gli uomini sono più vicini al monarca che agli altri principi; quindi essi sono o debbono essere amati dal monarca più che da ogni altro.
La premessa maggiore è evidente se si considera la natura degli agenti e dei pazienti; la minore è dimostrata dal fatto che agli altri prìncipi gli uomini sono vicini solo in parte, al monarca invece nella loro totalità. Si aggiunga che gli uomini si avvicinano agli altri prìncipi attraverso il monarca e non viceversa, e quindi la cura del monarca verso tutti gli uomini è originaria ed immediata, mentre quella degli altri prìncipi passa attraverso la mediazione del monarca in quanto deriva dalla sua cura suprema. Inoltre, quanto più una causa è universale, tanto più è causa (la causa inferiore infatti non è causa se non in forza di quella superiore, come risulta dal libro «Delle cause»), e quanto più una causa è causa, tanto più ama il suo effetto, poiché tale amore è conseguenza diretta dell’essere causa; ora, il monarca è, tra gli uomini, la causa più universale del loro ben vivere (mentre gli altri prìncipi sono causa attraverso la mediazione del monarca, come si è detto); quindi il monarca ama il bene degli uomini più di ogni altro.
[Per il secondo punto], chi potrebbe mettere in dubbio che il monarca abbia il massimo potere per attuare la giustizia se non colui che non intende che cosa significhi quel nome? Se egli infatti è effettivamente monarca, non può avere nemici. E così è stata sufficientemente dimostrata la premessa minore del sillogismo principale, e pertanto è certa la conclusione che la monarchia è necessaria per un perfetto ordinamento del mondo. trad. di Pio Gaja
B. La fallacia accidentis
MONARCHIA, III. 11:
Gli avversari portano poi un argomento di ragione.
Utilizzando infatti un principio del decimo libro della Metafisica, essi argomentano così:
 tutti gli esseri appartenenti ad uno stesso genere si riconducono ad uno, che è misura di tutti gli altri inclusi in quel genere;
tutti gli esseri appartenenti ad uno stesso genere si riconducono ad uno, che è misura di tutti gli altri inclusi in quel genere;
 ora tutti gli uomini appartengono allo stesso genere;
ora tutti gli uomini appartengono allo stesso genere;
 quindi vanno ricondotti ad uno come misura di tutti quanti.
quindi vanno ricondotti ad uno come misura di tutti quanti.
Se questa conclusione è vera, il Sommo Pontefice e l’Imperatore, essendo uomini, vanno ricondotti ad un solo uomo. Ma poiché non è possibile ricondurre il Papa ad altri, resta che l’Imperatore, insieme a tutti gli altri uomini, deve essere ricondotto al Papa come misura e regola; e così anche con questo ragionamento arrivano alla conclusione da essi voluta.
Per confutare tale ragionamento, ammetto come vera la loro affermazione che «tutti gli esseri appartenenti allo stesso genere debbono ricondursi ad un essere di quel genere, che, nell’ambito di questo, costituisce la misura»; come pure è vera l’affermazione che tutti gli uomini appartengono ad un medesimo genere; ed è vera altresì la conclusione ricavata da tale premessa, che cioè tutti gli uomini vanno ricondotti ad un’unica misura nell’ambito del loro genere. Ma quando da questa conclusione essi inferiscono la conseguenza applicativa nei confronti del Papa e dell’Imperatore, incorrono nella fallacia dell’accidente.
Per afferrare bene questo bisogna tener presente che una cosa è essere uomo e un’altra essere Papa, come d’altra parte una cosa è essere uomo e un’altra essere Imperatore, così come una cosa è essere uomo e un’altra essere padre e signore.
L’uomo infatti è quello che è per la sua forma sostanziale, in forza della quale rientra in una specie e in un genere, ed è posto nella categoria della sostanza; il padre invece è tale per una forma accidentale che è la relazione, per la quale rientra in una specie e in un genere particolari, ed è posto nella categoria dell’«ad aliquid», cioè della «relazione». Se così non fosse, tutto si ricondurrebbe - ma ciò è falso - alla categoria della sostanza, dal momento che nessuna forma accidentale può sussistere per se stessa senza il supporto di una sostanza sussistente.
Pertanto Papa e Imperatore essendo ciò che sono in forza di certe relazioni (quelle appunto dell’autorità papale e dell’autorità imperiale, la prima delle quali rientra nell’ambito della paternità e l’altra nell’ambito del dominio), è chiaro che Papa e Imperatore, in quanto tali, devono essere posti nella categoria della relazione e quindi essere ricondotti ad un elemento rientrante in tale categoria. Quindi affermo che altra è la misura cui debbono essere ricondotti in quanto uomini, ed altra in quanto Papa e Imperatore.
Infatti, in quanto uomini, vanno ricondotti all’uomo perfetto (che è misura di tutti gli altri e, per così dire, loro modello ideale, chiunque esso sia), come a quello che è sommamente uno nel suo genere, come si può rilevare dai capitoli finali dell’Etica a Nicomaco. Invece, in quanto sono termini di relazione, allora, com’è evidente, o vanno ricondotti l’uno all’altro (se l’uno è subalterno all’altro o se sono accomunati nella specie per la natura della relazione), oppure ad un terzo elemento come alla loro comune unità.
Ora, non si può affermare che uno sia subalterno all’altro, poiché, in tale caso, l’uno si predicherebbe dell’altro, il che è falso (noi infatti non diciamo che l’Imperatore è Papa e nemmeno viceversa); e neppure si può affermare che siano accomunati nella specie, in quanto l’essenza formale di Papa è diversa da quella di Imperatore in quanto tale. Quindi si riconducono a qualcos’altro, in cui devono trovare la loro unità.
A questo proposito bisogna tener presente che i soggetti delle relazioni stanno tra di loro come le rispettive relazioni. Ora quelle particolari relazioni d’autorità che sono il Papato e l’Impero vanno ricondotte ad una [suprema] relazione d’autorità, da cui quelle discendono con le loro determinazioni particolari; quindi i soggetti di quelle relazioni, cioè il Papa e l’Imperatore, andranno anch’essi ricondotti a qualche soggetto unitario che realizzi la relazione d’autorità nella sua essenza formale, al di fuori di ogni determinazione particolare.
E questo soggetto unitario sarà o Dio stesso, in cui tutte le relazioni particolari trovano la loro unificazione assoluta, oppure una qualche sostanza inferiore a Dio, nella quale la relazione d’autorità, che proviene da quella relazione assoluta, si particolarizza attraverso una differenziazione nel grado d’autorità. E così diventa chiaro che Papa e Imperatore, in quanto uomini, vanno ricondotti ad un elemento comune, mentre, in quanto formalmente Papa e Imperatore, ad un elemento comune diverso. Attraverso questa distinzione si risponde all’argomento di ragione [portato dagli avversari].(traduzione di Pio Gaja)
L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO: "AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" (Cantico dei cantici: 8.6).
AI CERCATORI DEL MESSAGGIO EVANGELICO. Una nota sulla "lettera" perduta.
FLS
Forum
-
> PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". --- Premio Gioacchino da Fiore ad Alexander Patschovsky. Intervista a Gian Luca Potestà (di Emiliano Morrone).2 dicembre 2022, di Federico La Sala
L’INTERVISTA
Premio Gioacchino da Fiore ad Alexander Patschovsky, Potestà: «È una figura luminosa»
Oggi a San Giovanni in Fiore il riconoscimento allo storico. Il presidente del comitato scientifico parla dei 40 anni di attività
di Emiliano Morrone (Corriere della Calabria, 02 dicembre 2022)
SAN GIOVANNI IN FIORE. Oggi pomeriggio lo storico del Medioevo Alexander Patschovsky riceverà il Premio Gioacchino da Fiore nell’Abbazia florense di San Giovanni in Fiore, per l’alto contributo dato agli studi sulle opere dell’abate calabrese, vissuto nel XII secolo. L’iniziativa inizierà alle ore 17, organizzata dal Centro internazionale di studi gioachimiti, che insieme festeggerà i 40 anni di attività, e patrocinata dal ministero della Cultura, dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Cosenza e dai Comuni di San Giovanni in Fiore, Carlopoli, Celico, Luzzi e Pietrafitta. La premiazione dell’accademico Patschovsky sarà preceduta dalla relativa laudatio di Gian Luca Potestà, professore ordinario di Storia del cristianesimo nell’Università Cattolica di Milano e presidente del comitato scientifico del Centro. Dopo la consegna del premio, il presidente del Centro, Riccardo Succurro, ne riassumerà i 40 anni di storia e verranno consegnati dei riconoscimenti a tutti i sindaci di San Giovanni in Fiore, ai dirigenti scolastici locali in servizio, ad alcuni fondatori dell’istituto culturale e ai suoi soci in carica per l’impegno profuso. Con Potestà, che ci ha rilasciato un’ampia intervista, abbiamo discusso dell’importanza e dell’attualità di Gioacchino da Fiore, del rapporto tra l’abate calabrese e Dante Alighieri, del lavoro scientifico di Patschovsky e del futuro del Centro, che ha sede a San Giovanni in Fiore.
Professore, come definisce Gioacchino da Fiore?
«Gioacchino è un tesoro della cultura, della spiritualità e della teologia italiane. Egli si inscrive bene in una linea di pensiero meridionale, cioè quello che, a partire da Platone, ha cercato di riflettere sulla storia. Se noi pensiamo a grandi pensatori che con il Mezzogiorno hanno avuto a che fare - da Gioacchino a Campanella, a Bruno, e poi, scendendo, a Labriola e anche a Croce -, in loro vediamo una costante preoccupazione di riflettere sulla storia, sul senso della storia e sulla direzione della storia».
Perché Gioacchino è importante?
«L’importanza di Gioacchino, detta in poche parole, sta nello scoprire il segno effettivo della Trinità nella storia degli uomini. Questo è un problema, perché la storia degli uomini viene normalmente concepita, in ambito cristiano, in un senso binario, cioè Antico Testamento e Nuovo Testamento. Invece, con Gioacchino abbiamo lo sforzo di leggerla in una prospettiva ternaria, cioè di trovare all’interno della storia non solo la traccia del Padre, l’Antico Testamento, ma anche quella del Figlio, Nuovo Testamento, e soprattutto quella dello Spirito. Ciò vuol dire inscriversi in una linea, che peraltro non era del tutto rara nel XII secolo, per così dire di revival dello Spirito Santo, inteso come forza che spinge in avanti la storia e che ad essa dà un impulso nuovo».
È dunque, quella dell’abate calabrese, una visione aperta della storia? Non di rado, poi, Gioacchino viene collegato ad Hegel e a Marx.
«Sì, l’abate ha una visione aperta della storia. In Gioacchino ci sono tanti aspetti; è un autore, potremmo dire, polimorfo. L’idea di fondo è, per semplificare, che i giochi non sono finiti, che il futuro è ancora davanti a noi e offre tanti elementi nuovi. Questo è, possiamo dire, il senso di Gioacchino. In epoca moderna le teologie della storia sono un po’ passate di moda. Noi troviamo grandi filosofie della storia - da Hegel a Comte, e in qualche modo anche Marx rientra dentro questo territorio - che non sono affatto derivate da Gioacchino, ma ci spiegano come, dentro un orizzonte secolarizzato, quelle grandi idee continuino a vivere».
Gioacchino e Dante, il secondo è un erede del primo?
«È un punto di attualità, perché l’anno scorso abbiamo celebrato il settimo centenario della morte di Dante. Su questo, mi permetta di dire, io andrei con cautela. A partire dal fatto che Gioacchino riceve un posto di rilievo nel Paradiso, ed è quella famosa terzina tante volte citata, si tende a mettere Dante nella scia di Gioacchino. Negli ultimi anni ho lavorato tanto sul profetismo e sulle concezioni escatologiche e apocalittiche di Dante. Il discorso sarebbe lungo, ma mi sono convinto che si debba essere cauti. Dante crea in realtà una propria apocalisse, che è perfettamente percepibile negli ultimi Canti del Purgatorio, nei quali egli mostra uno scenario della storia che a prima vista sembra debitore della visione gioachimita delle età. In realtà Dante riplasma completamente lo scenario, in relazione al proprio linguaggio, alla propria densità letteraria e ai propri fini».
Quindi non trova corretto legare Dante a Gioacchino?
«Per dirla in due parole, Dante conosce Gioacchino così come conosce il pensiero francescano della storia, gli spirituali francescani eccetera. Tuttavia, definire Dante gioachimita mi pare una forzatura. Gioacchino è tra le sue letture, ed è ovvio che lo sia. Forse noi immaginiamo Gioacchino come un pensatore un po’ marginale, ma si tratta di un autore straordinariamente letto e diffuso nel Medioevo. Dell’abate calabrese ho appena tradotto i primi quattro dei cinque libri della Concordia, che è una delle sue tre grandi opere, forse la più audace, in cui egli legge il passato della storia per trovarne una chiave di senso profetica volta verso il futuro. Ebbene, questa è un’opera che mostra una propria cifra della storia, una propria lettura della storia. È molto ambiziosa e quindi, direi, Dante ne è consapevole. Dante conosce Gioacchino come tanti altri intellettuali fra il XIII e il XIV secolo. La Concordia, pensi, è un’opera di cui ci sono rimasti più di 40 manoscritti. Inoltre, abbiamo notizia di almeno 15 manoscritti perduti. È un’enormità per un testo del Medioevo, è come se noi dovessimo moltiplicare per 100».
Il Centro di San Giovanni in Fiore compie 40 anni, è un’età.
«Oggi il Centro studi gioachimiti celebra in un certo senso sé stesso, perché ha voluto fissare una data importante, che è quella dei suoi 40 anni di vita. Credo che sia stata una grande scommessa. Nato a partire dall’intuizione, dall’entusiasmo, dalla passione di alcuni intellettuali di San Giovanni in Fiore, in particolare penso al professore Salvatore Oliverio, è riuscito a darsi una dimensione internazionale e una longevità straordinaria. È giusto, quindi, festeggiare i quarant’anni di età del Centro. Se ci arriveremo, festeggeremo anche i 50».
Il Premio Gioacchino da Fiore coincide, allora, con questo compleanno importante?
«Per celebrare degnamente questi quarant’anni, si è pensato di dare dei riconoscimenti a coloro che erano già attivi agli inizi e che ancora sono presenti sulla scena culturale della regione. Soprattutto, abbiamo voluto conferire un premio allo studioso che maggiormente ha fatto per Gioacchino negli ultimi decenni».
Così siete arrivati a Patschovsky?
«Qui il comitato scientifico, che io presiedo, è stato unanime nell’individuare la figura del collega professor Alexander Patschovsky. Più tardi terrò una laudatio nei suoi riguardi: in alcune cartelle cercherò di mostrare qual è il profilo scientifico dell’autore. Per dirla ora in due parole, Patschovsky è stato allievo di uno dei maggiori medievisti tedeschi: Herbert Grundmann, morto nel 1970. È stato l’ultimo suo allievo e di Grundmann ha raccolto l’eredità su due piani. Nei primi anni si è occupato soprattutto di inquisitori ed eretici. Poi, a partire dalla fine degli anni ’80 - ricordo, e lo ricorderò più tardi nell’Abbazia florense, una sua venuta a San Giovanni in Fiore per un congresso gioachimita - ha deciso di dedicarsi pienamente allo studio di Gioacchino. In questo senso, Patschovsky ha scritto dei saggi e soprattutto ha curato le edizioni critiche di moltissime opere di Gioacchino. Se non ci fosse stato lui, ben poco sarebbe stato pubblicato dell’abate calabrese».
- [Foto] Alexander Patschovsky
- È uno studioso indispensabile, insomma.
«Delle tre grandi opere di Gioacchino, Patschovsky ha pubblicato in proprio la Concordia, sta per pubblicare il Commento all’Apocalisse e infine ha revisionato a fondo il testo del Salterio a dieci corde, curato dal professor Selge. Quindi Patschovsky è una figura luminosa; è un autore che, già prima della pensione, e a maggior ragione dopo il pensionamento, avvenuto nel 2005, si è dedicato totalmente allo studio di Gioacchino. Questo può sembrare qualcosa di astruso, perché fare delle edizioni critiche vuol dire produrre dei testi latini e con apparati di commento che per un profano spesso non sono facilmente comprensibili».
Me ne rendo conto, seguo il suo ragionamento.
«In realtà, Patschovsky ha posto le basi per un lavoro su Gioacchino che a questo punto ha dei fondamenti estremamente solidi e non più incerti. Perché dico solidi? Lo dico perché, soprattutto per le grandi opere, Gioacchino ha lavorato producendo diverse redazioni delle sue opere. Lei pensi che alla Concordia Gioacchino ha lavorato per 15 anni, con continue revisioni. Ma intanto le prime copie del testo già circolavano. Quindi è stata enorme la difficoltà di arrivare a definire il testo di fronte a tradizioni manoscritte divergenti. Ecco, i testi ora sono stati fissati: si sono poste le basi per un lavoro scientifico di enorme rilevanza».
Adesso di che cosa vi state occupando come studiosi?
«Parallelamente, abbiamo cercato e stiamo cercando ancora di tradurre delle opere. Io stesso ho appena tradotto i primi quattro libri della Concordia in italiano, in modo da rendere Gioacchino accessibile al lettore che non sia iperspecialista. Così viene fuori la straordinaria ricchezza di questo autore, che non si lascia confinare dentro uno spazio isolato».
Il fascino dell’abate calabrese deriva anche dalla sua utopia, concepita tra i monti della Sila, del rinnovamento del mondo?
«Il fascino di Gioacchino è quello di un grande pensatore che nel contempo è stato un monaco, un abate, uno che ha concepito un’idea di riforma del mondo a partire da una località isolata, sperduta, sulla Sila, immaginando un grande sogno, forse anche la grande illusione che da lì sarebbe venuto fuori il rinnovamento del monachesimo e del mondo».
Qual è la sua impressione a proposito della percezione che gli studiosi calabresi hanno di Gioacchino da Fiore?
«In una rivista che ho diretto per parecchi anni e che ancora seguo, Annali di Scienze religiose, noi pubblichiamo ogni anno, da una dozzina d’anni, una bibliografia degli scritti, cioè di tutti gli studi che compaiono su Gioacchino da Fiore nel mondo. Si tratta di un elenco, brevemente commentato, di ciascun articolo, di ciascun libro, di ciascuna voce di enciclopedia. Diciamo che, per darle l’idea, ci sono tra i 20 e i 50 contributi all’anno che escono un po’ in tutto il mondo, prevalentemente in Europa, ma qualcuno anche in Paesi lontani: negli Stati Uniti, in America Latina eccetera. Dirle che c’è un contributo specifico di alto livello scientifico che venga dalla Calabria mi sembrerebbe in fondo una forzatura. Naturalmente ci sono degli studiosi calabresi che si occuopano di Gioacchino. Anche in passato ci sono stati degli studiosi calabresi; penso qui al padre Francesco Russo e credo che fosse calabrese pure Antonio Crocco, che insegnava all’Università di Salerno. Questi ed altri studiosi calabresi hanno lavorato molto sull’abate, ma direi in una fase - naturalmente non uso alcuna tonalità spregiativa - pionieristica, cioè in cui si trattava di aprire la strada su Gioacchino».
Ora qual è il contributo degli studiosi calabresi?
«Adesso, come un po’ dappertutto, il tecnicizzarsi e lo specializzarsi della ricerca fa sì che per fare un’edizione di Gioacchino ci debbano essere competenze paleografiche, filologiche, storiche eccetera, che non si trovano dietro l’angolo. Queste competenze potrebbero trovarsi in Calabria o potrebbero trovarsi, come è stato per il professor Patschovsky, tra Monaco di Baviera, dove lui ha esercitato parte della sua attività di ricerca nei primi anni, e l’Università di Costanza, in Germania, dove lui ha insegnato fino al pensionamento».
Non è, in qualche modo, un controsenso?
«Per quanto le ho già detto, non mi meraviglio che Gioacchino non sia particolarmente considerato, non sia particolarmente oggetto di studio in Calabria. Però proprio per questo sono grato, devo dirle, all’attività che il Centro studi gioachimiti ha fatto e fa. La trovo meritoria. Il Centro ha sempre rispettato il piano della ricerca scientifica, e in questo senso non ha mai posto argini, mai posto limiti alla ricerca degli studiosi che ha cercato di raccogliere intorno a sé un po’ in tutto il mondo, purché fossero bravi».
C’è anche bisogno di rendere Gioacchino da Fiore più alla portata di tutti?
«Il Centro ha messo in atto una grossa attività di carattere divulgativo a livello provinciale, ed anche regionale, che in qualche modo si avvale dei risultati della ricerca scientifica e li ripropone in una prospettiva pure più semplificata; innanzitutto per le scuole, per i centri di cultura, per le università della terza età, per le biblioteche».
Come vede il futuro del Centro internazionale di studi gioachimiti?
«L’ho detto diverse volte, lo dico anche a lei, nella speranza che questa riflessione possa essere raccolta: il Centro studi gioachimiti è una realtà che va ulteriormente potenziata, e ci sarebbero tanti modi per potenziarla. Certo, siamo ormai alla vigilia della conclusione delle edizioni di Gioacchino».
Questo, professore, che cosa significa?
«Che tante altre cose si possano progettare, perché Gioacchino è un personaggio che muore nel 1202 ma la sua impronta resta fino all’età contemporanea. Allora non si fa fatica, non si fa sforzo per trovare altre imprese».
Che cosa servirebbe, dunque, per ravvivare, rivitalizzare le attività del Centro?
«Occorrerebbero, credo, anche grandi finanziamenti. Più volte, mi sono augurato che il Centro studi gioachimiti possa fruire di finanziamenti maggiori, in modo tale da dare nuove prospettive e nuovi orizzonti rispetto a quelli delineati quarant’anni fa e che in parte stanno anche venendo a conclusione. Infatti, dopo che Patschovsky avrà pubblicato l’edizione del Commento all’Apocalisse, mancherà solo il Liber Figurarum, che è già stato preso in carico dal mio collega professor Marco Rainini, dell’Università Cattolica, e con Gioacchino avremmo finito».
La missione del Centro è quasi compiuta?
«Sì, però infiniti altri capitoli si possono aprire sotto il nome di Gioacchino, a partire dalle opere pseudogioachimite composte subito dopo la sua morte. Quindi io mi auguro che il Centro - il quale è, non so se il termine sia tecnicamente giusto, un’eccellenza in Calabria - possa essere ulteriormente valorizzato, sostenuto, finanziato, avvalendosi sempre anche dell’apporto degli studiosi che più tempo e più competenze hanno speso su Gioacchino».
-
>IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO --- CONVEGNO AD AMSTERDAM SU GIOACCHINO DA FIORE. Concluderà i lavori Giorgio Novello. Intervista (di Emiliano Morrone).24 novembre 2022, di Federico La Sala
L’INTERVISTA
L’influenza di Gioacchino da Fiore in un convegno ad Amsterdam. «Occasione per far conoscere la realtà calabrese agli olandesi»
Concluderà i lavori l’ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Giorgio Novello, conoscitore di Gioacchino e legato alla Calabria
di Emiliano Morrone (Corriere della Calabria, 24/11/2022)
COSENZA Al pensiero e all’influenza di Gioacchino da Fiore nella cultura europea è dedicato un importante convegno che si svolgerà ad Amsterdam venerdì 25 novembre, alle ore 18,30 nella chiesa protestante Keizersgrachtkerk. L’iniziativa è organizzata dal Comites Olanda insieme all’Istituto italiano di cultura di Amsterdam, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Fiore e della Provincia di Cosenza. Concluderà i lavori l’ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Giorgio Novello, profondo conoscitore di Gioacchino e legato alla Calabria da un affetto «basato su una molteplicità di radici». Al Corriere della Calabria il diplomatico ha rilasciato una lunga e particolare intervista, raccontando del suo incontro folgorante con la figura dell’abate florense, dei suoi sentimenti per la nostra regione e della propria disponibilità rispetto «ad ulteriori iniziative calabresi».
Ambasciatore Novello, il prossimo 25 novembre lei concluderà i lavori di un importante convegno, in programma ad Amsterdam, sul pensiero di Gioacchino da Fiore e sull’influenza che esso ebbe nella cultura olandese. Qual è, al riguardo, il suo punto di vista?
«Sono molto orgoglioso di questo convegno, che è assolutamente originale ed innovativo. I Paesi Bassi sono una nazione di grande cultura, con una fitta rete di università ed un’attenzione particolare alla filosofia e dalla teologia. Mi colpisce molto il fatto che ogni anno in Olanda venga nominato un teologo di Stato (oggi lo è un frate di origine tedesca). La stessa divisione storica tra olandesi di religione cattolica ed olandesi di religione protestante ha costituito a mio parere un motivo ulteriore di approfondimento di tematiche proprie anche di Gioacchino. Ma questo convegno consentirà anche di far conoscere di più la realtà calabrese agli amici olandesi nel quadro di un forte rilancio delle relazioni bilaterali, in particolare nel settore economico e scientifico, ma sempre sulla scorta del nostro grande ruolo come vera potenza culturale».
Qual è, a suo avviso, il punto di contatto tra il profetismo gioachimita e la cultura dei Paesi Bassi?
«Direi la proiezione verso il futuro e il sostanziale ottimismo. I Paesi Bassi sono nati in un territorio di per sé infelice, una distesa di paludi aperte alla furia del mare, e col duro lavoro di secoli sono diventati uno dei Paesi più importanti d’Europa ed uno dei più influenti anche a livello internazionale. Questi risultati si ottengono solo con attenta pianificazione e incrollabile ottimismo; quell’ottimismo che ritrovo in Gioacchino e nelle sue “dimostrazioni” dell’avvento di un’età dello spirito, età ancora ancorata nella storia ma dove dovrebbero venire riconciliate le controversie e risolte le sofferenze dell’umanità».
Lei conosce da molto tempo Gioacchino da Fiore e la Calabria, per averli frequentati nelle sue letture, nei suoi viaggi, nella sua vita. Quali sono i suoi sentimenti nel parlarne?
«Sono sentimenti di vero affetto. Mi rendo conto che la Calabria e la sua cultura costituiscono un filo che è stato costante in tutta la mia esistenza. Un affetto che, come credo tutti gli affetti solidi, coinvolge molteplici aspetti. Il punto culminante è stato probabilmente il mio lungo viaggio in bicicletta, con altri cinque ragazzi padovani, dalla nostra città di origine proprio a San Giovanni in Fiore: tre settimane e oltre 2000 chilometri di avventura e gioia pura, dormendo all’aperto o dove capitava e percorrendo tra 100 e 200 chilometri al giorno, spesso in salita. Ricordo la fatica di affrontare le rampe della Sila e finalmente l’arrivo a San Giovanni, meta simbolica e da noi così agognata. Ricordo le tante personalità calabresi incontrate nei miei studi appunto al liceo e più tardi all’università, da Pitagora di Samo a Tommaso Campanella, fino poi alla mia infatuazione letteraria per Corrado Alvaro».
L’Europa attraversa un periodo di grande difficoltà. Che senso può avere riportare nel nostro tempo la filosofia, la teologia della storia dell’abate Gioacchino e la sua spiritualità?
«Direi in due modi essenziali. In primo luogo, il suo ottimismo di fondo. La sua escatologia - con una dimostrazione “scientifica” che alle prime due età ne sarebbe succeduta una terza in cui i conflitti si sarebbero risolti ed appianati ed ogni uomo avrebbe avuto grandi possibilità di esprimersi veramente al meglio in una società ordinata - suona ancora oggi come un forte appello a guardare all’avvenire con fiducia, nonostante le difficoltà dell’ora presente. In secondo luogo, la terza età da lui indicata (come esegeta, non come profeta, come amava sostenere!) sarebbe stata un’età di libertà e non un’età di dominio della forma e della norma. Questo è un fortissimo appello a guardare alla sostanza, alla nostra interiorità, alla nostra ricchezza di esseri umani e non a quello che è meno importante, più superficiale e che fatalmente tende a dividerci».
Come incontrò l’opera e la figura di Gioacchino da Fiore?
«Al liceo, a 15 anni, sotto la guida di un mio straordinario professore al quale devo tanto anche per la mia scelta professionale: Federico Talami, straordinario esperto di Dante. Ricordo perfettamente la sua lezione quel lontanissimo giorno, credo del gennaio 1976, dedicata al canto 12º del paradiso, nel cielo del sole e cioè degli spiriti sapienti. Dante menziona una straordinaria quaterna di geni: Bonaventura da Bagnoregio, Tommaso d’Aquino, Rabano Mauro e appunto Gioacchino. Si tratta di pochissimi versi nei quali il sommo poeta mette assieme il più grande mistico del medioevo, il massimo pensatore cristiano razionalista, il maestro delle genti germaniche e appunto, per usare le sue parole, “Gioacchino di spirito profetico dotato”. Rimasi folgorato da quello che lessi sul metodo di Gioacchino: un’interpretazione comparata dei due alberi, il Vecchio e il Nuovo Testamento, per proiettare nel futuro un terzo albero, corrispondente all’età dello spirito. Questo sguardo d’aquila verso i secoli avvenire poteva facilmente incendiare la fantasia di un adolescente che stava elaborando e identificando le linee guida per il suo futuro, come ero io all’epoca. E questo accadde».
Come vede oggi la regione Calabria?
«Più che a darle una risposta, mi limito a citarle tre episodi. Il primo. Recentemente abbiamo parlato di Calabria con mio fratello Sergio, presidente e amministratore delegato di Sonepar Italia, il maggior distributore italiano di materiale elettrico, con un giro d’affari di oltre un miliardo di Euro. Sergio mi ha raccontato della recente estensione di Sonepar alla Calabria con l’apertura di cinque nuovi punti vendita e del fatto che il tasso di crescita societario in quella regione è il più elevato di Italia. Insomma, in questa importante azienda italiana la Calabria costituisce un mercato oggetto di studio e di ammirazione. Il secondo. Spesso parlando di Calabria emerge il tema della criminalità organizzata. Ma oggi emerge in modo diverso rispetto al passato: l’Italia è sempre più apprezzata per quanto fa nella lotta alla criminalità organizzata. Quello che noi facciamo in Italia, ad esempio, è seguito con estremo interesse qui nei Paesi Bassi. Un mio caro amico, il deputato olandese Ulisse Ellian, si è recato per ben due volte in Calabria per studiare da noi lo svolgimento dei maxiprocessi e l’azione meritoria delle istituzioni nazionali e regionali appunto in questo settore. La stessa ministra della giustizia olandese, a sua volta recatasi in Italia per studiare le nostre procedure, ha dichiarato alla stampa che la lotta al crimine organizzato è la nuova “esportazione di eccellenza” del nostro Paese. Il terzo. Durante le celebrazioni della festa nazionale, tenutosi anche in Olanda il 2 giugno scorso, uno dei nostri apprezzati sponsor è stato l’Amaro del Capo, prodotto da una nota azienda calabrese. Potrei citare ancora il mio prossimo viaggio a Groningen tra qualche settimana per una splendida mostra di Versace oppure la mia presentazione all’Università di Delft delle minoranze linguistiche italiane con particolare attenzione al Grecanico calabrese. Potrei citare quanto ho esposto circa le piste ciclabili della Sila, la grande mostra sul futurismo italiano qui in corso nei Paesi Bassi, come noto avviato da Umberto Boccioni nato in Calabria, o anche un ragazzo calabrese che avevo conosciuto tanti anni fa ad un congresso nazionale con una voce splendida che poi è diventato il celebre baritono Demetrio Colaci. Potrei citare il mitico terzino Silvio Longobucco, altro calabrese che svolse un ruolo importantissimo per la conquista della prima coppa Uefa della Juventus (come noi vecchi juventini ben sappiamo). Ma per mancanza di spazio mi devo fermare qui. Come vede il mio affetto per la Calabria è basato su una molteplicità di radici!».
Vicepresidente del Comites Olanda è Monica Spadafora, originaria di San Giovanni in Fiore. Che effetto le ha fatto incontrare una cittadina calabrese per un evento culturale sull’abate Gioacchino e il Paese di cui lei è ambasciatore d’Italia?
«Al mio primo incontro con Monica le ho chiesto quale fosse la sua regione di origine e mi è stato naturale menzionarle il mio viaggio in bicicletta a San Giovanni in Fiore. Con meraviglia e con gioia ho scoperto le sue origini proprio a San Giovanni e sono venuto a conoscenza del suo impegno culturale proprio sulle tematiche di Gioacchino. L’idea di organizzare un evento proprio su Gioacchino è stata spontanea».
Come dovrebbe muoversi la Calabria per promuovere e valorizzare le proprie risorse di natura e cultura?
«Direi innanzitutto che la Calabria dovrebbe maturare una maggiore consapevolezza dei propri grandi punti di forza. Ne ho menzionati alcuni, ma ce ne sono tantissimi altri. Basti pensare che il premio Nobel per la medicina Renato Dulbecco è nato a Catanzaro oppure che l’indimenticato presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro era di distinta famiglia calabrese; o che la musica pop italiana degli ultimi anni ha avuto tra i suoi protagonisti i calabresi Mino Reitano, Mia Martini e Loredana Bertè. Una sana consapevolezza della propria realtà significa rinnovare l’orgoglio delle proprie radici e poterlo quindi comunicare in modo costruttivo all’estero. In secondo luogo, rivolgendosi anche alla rete delle ambasciate e degli istituti italiani di cultura all’estero. Tra l’altro in molti di essi operano eccellenti miei colleghi di origine calabrese, tra i tanti diplomatici illustri di questa terra cito ad esempio Bruno Pasquino, oggi capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica che ha organizzato in modo impeccabile la visita di stato del presidente della Repubblica nei Paesi Bassi, conclusasi con grande successo una decina di giorni fa. Tra le varie ambasciate, chiedo agli amici calabresi di ricordarsi in particolare di quella da me diretta e dell’Istituto di cultura di Amsterdam, dove opera con particolare incisività la direttrice Paola Cordone. Io e Paola siamo disponibili e fortemente interessati ad ulteriori iniziative calabresi».
Pensa di ritornare in Calabria, magari per un altro appuntamento culturale su Gioacchino da Fiore?
«Temo possa essere difficile per me: soffro di sclerosi multipla che mi rende problematici i movimenti, anche se proprio questo costituisce per me un formidabile stimolo a dare sempre tutto me stesso nella mia professione e al servizio dei miei ideali, compresa la promozione dell’inclusione e del rispetto delle persone con disabilità. Anzi, resto a disposizione nel caso si pensasse in regione a qualche iniziativa a questo riguardo specifico. Ma la Calabria resta sempre vicina al mio cuore e ne seguo con crescente interesse lo sviluppo. Anche per questo auspico che, se io trovo oggi difficoltà ad andare in Calabria, tanti amici calabresi vengano a trovarmi all’Aja!».
-
> IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". --- LETTERA INASPETTATA Il papa emerito Benedetto XVI scrive a sorpresa al presidente del centro dedicato a Gioacchino da Fiore (di Franco Laratta).5 settembre 2022, di Federico La Sala
LETTERA INASPETTATA
Il papa emerito Benedetto XVI scrive a sorpresa al presidente del centro dedicato a Gioacchino da Fiore
Nella lettera si esprime un ringraziamento verso l’attività che sta portando avanti il Centro Studi con la pubblicazione delle opere dell’abate calabrese
di Franco Laratta (LaCNews", 5 settembre 2022)
Il papa emerito, Benedetto XVI, a sorpresa scrive al presidente del centro internazionale di studi gioachimiti, Riccardo Succurro: "Quando negli anni Cinquanta scrissi il mio lavoro sulla Teologia della storia di San Bonaventura dovetti utilizzare l’edizione del cinquecento, pubblicata nella Repubblica di Venezia. A quel tempo- scrive il papa emerito al presidente del Centro Studi - Gioacchino da Fiore era ancora considerato un sognatore sulla cui opera si preferiva tacere. Da allora l’opera di Gioacchino è stata al centro di ampi dibattiti e il silenzioso abate di Fiore si meraviglierebbe di tutto quello che oggi gli si attribuisce".
Nella sua analisi, Benedetto esprime un significativo apprezzamento verso l’operazione culturale più importante che sta svolgendo da quarant’anni il Centro Studi, la pubblicazione delle opere di Gioacchino da Fiore che consente di poter attingere al pensiero dell’abate calabrese e non alle interpretazioni e manipolazioni che ne hanno caratterizzato la lettura: "Per questo la pubblicazione di una moderna edizione critica dei suoi scritti rappresenta un’assoluta necessità, alla quale Lei ha corrisposto con il Suo Centro Internazionale di Studi Gioachimiti". Il papa emerito ha infine chiesto l’invio dei libri pubblicati dal Centro Studi di San Giovanni in Fiore.
Perché tutto questo interesse verso Gioacchino da Fiore da parte di uno dei più grandi intellettuali del ‘900? Per darsi una risposta bisogna andare indietro nel tempo, fino agli anni cinquanta, quando Ratzinger scrisse un lavoro molto importante: "San Bonaventura. La teologia della storia", pubblicato successivamente dalla Porziuncola nel 2008. Ratzinger ha approfondito il confronto tra la concezione della storia di Bonaventura e quella dell’abate di Fiore ed ha studiato l’influsso di Gioacchino su Bonaventura.
Secondo Ratzinger, san Bonaventura ha accolto la concezione gioachimita di Cristo "centro dei tempi", e non solo "fine dei tempi". Ratzinger sostiene che "l’idea di considerare Cristo l’asse dei tempi è estranea a tutto il primo millennio cristiano ed emerge solo in Gioacchino... che divenne, proprio nella Chiesa stessa, l’antesignano di una nuova comprensione della storia che oggi ci appare essere la comprensione cristiana in modo così ovvio da renderci difficile credere che in qualche momento non sia stato così."
C’è anche da sapere che il cardinale Ratzinger nel corso dei suoi studi e delle sue ricerche si è più volte confrontato con il pensiero dell’Abate Gioacchino. Durante il suo pontificato, che si è concluso con le clamorose dimissioni, è ripreso con maggiore vigore il processo di beatificazione di Gioacchino. Benedetto XVI con questa sua ultima lettera ha inteso sottolineare lo straordinario ruolo che da 14 anni svolge a livello internazionale il Centro Studi Gioachimiti, chiedendo quindi materiale e libri sul pensiero dell’Abate.
-
> PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". -- UNA "TRISTE GIOIA": PASQUA 2020 E IL COVID-19. Le lacrime sono il vino del godimento (di Enrico Spadaro).9 aprile 2020, di Federico La Sala
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
- DEUS CHARITAS EST (1 Gv 4, 12 ss.).
 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15, 9-11)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15, 9-11)
- DALLA "VECCHIA" ALLA "NUOVA" ALLEANZA. Dopo la "bella storia" di "Abramo e Isacco", arriva la "buona notizia" di "Dio" che «non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha offerto per tutti noi» (San Paolo, "Lettera ai Romani", 8.32)?!
Le lacrime sono il vino del godimento
di Enrico Spadaro (Ondaiblea, 09 aprile 2020)
- Pasqua 2020, una pasqua particolare, vissuta in casa per il "lockdown" dovuto all’emergenza Covid-19. Dopo le lacrime arriva il godimento, dopo la contrizione la gioia: con queste riflessioni del dott. Enrico Spadaro (dottore di ricerca in Letteratura inglese ad Aix-en-Provence/Marsiglia) auguriamo ai lettori di Ondaiblea una serena Pasqua, di ripartenza e voglia di vita, di resurrezione e speranza (sm)
È con sensazioni di triste gioia che sembra avvicinarsi questa Pasqua, in cui quasi tutti i cristiani non possono fisicamente partecipare ai riti della Settimana Santa. Sembra quasi un paradosso, un ossimoro pronunciare queste parole, “triste gioia”: “gioia” nell’imminente resurrezione di Cristo, “triste” perché forse non totalmente vissuta.
Eppure esiste un termine greco, che racchiude un concetto forse maggiormente conosciuto nel mondo cristiano ortodosso, “charmolypi” (χαρμολύπη), che esprime al tempo stesso sentimenti di gioia (hara) e di tristezza (lypi). Si ritrova tale termine negli scritti di San Giovanni Climaco (525/575-603/650), monaco che visse quasi tutta la vita presso il monastero del Sinai. Nella sua dottrina, e in particolare nel suo scritto più celebre, La Scala della divina ascesa, vengono prevalentemente esaltati coloro che dopo aver peccato si pentono, poiché i dolori patiti permettono loro - attraverso il pentimento - di accedere alla vera “gioia” del Paradiso. Questi peccatori redenti sembrano aver provato la morte per poi essere risorti come Cristo, sono stati abbandonati e infine salvati dal Padre. Le lacrime che hanno versato sono così benedette: “Beati i sofferenti, perché essi saranno consolati”. (Matteo 5,4).
Il concetto espresso da San Giovanni Climaco potrebbe rinviare ad un elemento essenziale delle fiabe secondo lo scrittore britannico J.R.R. Tolkien (1892-1973), vale a dire la consolazione del lieto fine, per cui l’autore, nel suo saggio Sulle Fiabe (1939) conia il termine “eucatastrofe”, l’improvviso capovolgimento felice degli eventi, “ed è in quanto tale un evangelium, che fornisce una visione fuggevole della Gioia, quella Gioia oltre le muraglie del mondo, intensa come il dolore”.[1]
 Con evangelium, Tolkien, fervente cattolico, non poteva che intendere il Vangelo, considerato come l’unica vera fiaba, e infatti continua il proprio saggio: “la Nascita di Cristo è l’eucatastrofe della storia dell’Uomo. La Resurrezione è l’eucatastrofe della storia dell’Incarnazione. Questa storia comincia e finisce nella gioia.”
Con evangelium, Tolkien, fervente cattolico, non poteva che intendere il Vangelo, considerato come l’unica vera fiaba, e infatti continua il proprio saggio: “la Nascita di Cristo è l’eucatastrofe della storia dell’Uomo. La Resurrezione è l’eucatastrofe della storia dell’Incarnazione. Questa storia comincia e finisce nella gioia.”L’immensa opera letteraria di Tolkien e soprattutto i due romanzi principali, Lo Hobbit (1937) e Il Signore degli Anelli (1954-55), sono pieni di momenti in cui si verifica un’eucatastrofe, ma forse uno di quelli più evocativi è rappresentato dagli istanti immediatamente successivi la distruzione dell’Unico Anello tra le fiamme del Monte Fato. Frodo e Sam si credono spacciati e svengono, ma vengono salvati dalle grandi aquile e si risvegliano a Gondor con Gandalf al loro capezzale.
 Tolkien descrive il momento attraverso le sensazioni di Sam:
Tolkien descrive il momento attraverso le sensazioni di Sam:- [...] Sam si rese conto di non aver udito ridere, di non aver udito la semplice espressione della letizia, per giorni e giorni senza fine. Suonava alle sue orecchie come l’eco di tutte le gioie vissute. E improvvisamente si mise a piangere. Poi, come il vento di primavera spazza via la pioggia perché il sole brilli con maggiore intensità, le sue lacrime cessarono ed egli scoppiò a ridere, e balzò ridendo dal letto.[2]
E qualche pagina dopo:
- E quando Sam lo udì, rise dalla gioia; poi si alzò in piedi ed esclamò: «O grande gloria e splendore! Tutti i miei desideri sono stati esauditi!». E pianse.
- E tutto l’esercito rise e pianse e in mezzo alla loro allegria e alle lacrime si alzò come argento la voce del menestrello e tutti tacquero. Ed egli cantò, a volte in Lingua Elfica, a volte dell’idioma dell’Ovest, finché i loro cuori, trafitti dalle dolci parole, traboccarono, e la loro gioia fu simile a spade, e il loro pensiero vagò nelle regioni ove delizie e dolori sono un’unica cosa e le lacrime sono il vino del godimento.[3]
Gioia e dolore sembrano fondersi e le lacrime sono la via che porta alla gioia, secondo la teorizzazione tolkieniana dell’eucatastrofe, ma anche secondo il concetto di “charmolypi” di San Giovanni Climaco. Inoltre, occorre sottolineare la data della distruzione dell’Anello, il 25 marzo, che è sì il giorno dell’Annunciazione a Maria, ma nella tradizione medievale era anche il giorno della crocifissione, il Venerdì Santo, un giorno di dolore che anticipava la gioia della Pasqua.
I momenti d’eucatastrofe in Tolkien non saranno forse l’espressione totale di beautitudine, ma potrebbero essere una rappresentazione di gioia e dolore, che preannuncia la “Gioia” finale del Paradiso.
Enrico Spadaro
Note
[1] Tolkien. Il medioevo e il fantastico. Milano, Bompiani, p. 225.
[2] Tolkien. Il Signore degli Anelli. Milano, Bombiani, p. 1136.
[3] Ibid., p. 1139.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
PASQUA: BUONA PASQUA DI RESURREZIONE E DI RISURREZIONE.
- DANTE : IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia"
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaFederico La Sala
- DEUS CHARITAS EST (1 Gv 4, 12 ss.).
-
> PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". -- GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE "CARITÀ", E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO.3 marzo 2018, di Federico La Sala
DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE “CARITÀ”, E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO. ..
"È nostro altissimo dovere tenere sempre presenti e diligentemente imitare i luminosi esempi della ammirabile carità ...": "Mirae caritatis. De sanctissima eucharistia", della "Ammirabile Carità. La santa eucarestia", così è intitolata e così è tradotta la "Lettera enciclica" di Leone XIII, del 1902:
- MIRAE CARITATIS. LETTERA ENCICLICA DI SUA SANTITÀ LEONE PP. XIII. LA SANTA EUCARESTIA
- EPISTOLA ENCYCLICA - MIRAE CARITATIS SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS PAPAE XIII. DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA.
Se si tiene presente che nel 1183, con grande chiarezza e consapevolezza, Gioacchino da Fiore nel suo "Liber de Concordia Novi ac Veteris Testamenti" così scriveva:
- "Primus ergo status in scientia fuit, secundus in potestate sapientie, tertius in plenitudine intellectus. Primus in servitute servili, secundus in servitute filiali, tertius in libertate. Primus in flagellis, secundus in actione, tertius in contemplatione. Primus in timore, secundus in fide, tertius in charitate"
 ("Il primo stato visse di conoscenza; il secondo si svolse nel potere della sapienza; il terzo si effonderà nella plenitudine dell’intendimento. Nel primo regno il servaggio servile; nel secondo la servitù filiale; il terzo darà inizio alla libertà. Il primo stato trascorse nei flagelli; il secondo nell’azione; il terzo trascorrerà nella contemplazione. Il primo visse nell’atmosfera del timore; il secondo in quella della fede; il terzo vivrà nella carità"),
("Il primo stato visse di conoscenza; il secondo si svolse nel potere della sapienza; il terzo si effonderà nella plenitudine dell’intendimento. Nel primo regno il servaggio servile; nel secondo la servitù filiale; il terzo darà inizio alla libertà. Il primo stato trascorse nei flagelli; il secondo nell’azione; il terzo trascorrerà nella contemplazione. Il primo visse nell’atmosfera del timore; il secondo in quella della fede; il terzo vivrà nella carità"),
si può ben pensare che le preoccupazioni di una tradizione e di una trasmissione corretta del messaggio evangelico e, con esso, del "luminoso esempio" dello stesso Gioacchino da Fiore, non siano state affatto al primo posto del magistero della Chiesa cattolico-romana, né ieri né oggi.
Di Gioacchino se si è conservato memoria del suo lavoro come del suo messaggio, lo si deve sicuramente alla sua "posterità spirituale" - è da dire con H. De Lubac, ma contro lo stesso De Lubac, che ha finito per portare acqua al mulino del sonnambulismo ateo-devoto dell’intera cultura ’cattolica’,.
Federico La Sala
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
 MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
- IL MAGISTERO DI MENZOGNA DELLA CHIESA CATTOLICA: IL "PADRE NOSTRO" CHE INDUCE IN TENTAZIONE. -- "Traduzione non è buona, Dio non ci induce in tentazione" (Papa Francesco).
-
> IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". -- La filosofia della storia di Michel Serres: “È cominciata l’era dolce dell’umanità!”.26 luglio 2017, di Federico La Sala
DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Ripartire dal nostro presente storico, a ri-attivare l’umana (di tutti e di tutte!!!) capacità di "gettare ponti" e a riprendere il cammino "eu-ropeuo" .... *
“È cominciata l’era dolce dell’umanità!”
di Francesco Bellusci ("doppiozero", 26 luglio 2017)
Qualche anno fa, in un breve e amichevole scambio a distanza con Michel Serres, il filosofo francese mi faceva notare la vicinanza geografica del mio paese di origine (lucano) con il rispettivo (calabrese) di Gioacchino da Fiore, confidandomi che in quel momento l’abate e teologo cistercense assorbiva i suoi interessi e le sue ore di studio nella biblioteca della prestigiosa Académie Française, fondata dal cardinale Richelieu, di cui Serres è membro da quasi trent’anni. Adesso, mi rendo conto che quella confidenza di circostanza mi avrebbe fornito la chiave segreta di accesso alla sua ultima fatica, appena edita in Italia (Darwin, Bonaparte e il Samaritano. Una filosofia della storia, Bollati Boringhieri, Torino).
 Infatti, la “filosofia della storia” che Serres presenta in questo libro, ricalca lo schema dell’interpretazione storico-allegorica di Gioacchino da Fiore basata sul processo di compimento progressivo della Rivelazione e soprattutto sulla divisione in tre età o epoche (l’età del Padre, l’età del Figlio e l’età dello Spirito santo), che nel libro di Serres diventano: l’era dell’inizio, l’era dura e l’era dolce.
Infatti, la “filosofia della storia” che Serres presenta in questo libro, ricalca lo schema dell’interpretazione storico-allegorica di Gioacchino da Fiore basata sul processo di compimento progressivo della Rivelazione e soprattutto sulla divisione in tre età o epoche (l’età del Padre, l’età del Figlio e l’età dello Spirito santo), che nel libro di Serres diventano: l’era dell’inizio, l’era dura e l’era dolce.Non si tratta di una novità assoluta. In passato e sempre in una versione secolarizzata, lo schema era stato mutuato e riproposto, per esempio, da Lessing nell’Educazione del genere umano o da Nietzsche nelle “tre metamorfosi” (cammello, leone, fanciullo) del Così parlò Zarathustra.
È lo stesso Serres che, in alcuni punti del libro, rivela la matrice “cristiana” della griglia alla base della sua filosofia della storia, che rimane tuttavia estranea al modello escatologico di quella matrice. La confidenza evoca oggi un’ulteriore coincidenza e analogia. Tra i più ferventi aderenti alla visione di Gioacchino da Fiore ci fu il teologo e francescano parigino Gerardo di Borgo San Donnino, che in un libro intitolato Liber introductorius ad Evangelium aeternum del 1254 preconizzò l’imminente avvento dell’“età nuova” o ordine dello Spirito Santo profetizzata da Gioacchino (per l’esattezza nel 1260), con la scomparsa conseguente della Chiesa gerarchizzata sostituita da una comunità monastica di santi.
Ma San Bonaventura metterà a tacere immediatamente i fervori gioachimiti nel suo ordine, bollandoli di eresia, e il teologo parigino sarà condannato alla prigione a vita. Entrati nel terzo millennio, diverse e inquietanti nubi e minacce sembrano addensarsi e oscurare il nostro tempo: dal terrorismo globale alle guerre asimmetriche, dalle catastrofi ecologiche o umanitarie legate ai grandi flussi migratori dal Terzo Mondo alla criminalità organizzata che avvelena l’economia e la politica di alcuni Stati, in non poche parti del mondo.
Eppure, un filosofo, ancora una volta francese, di nome Michel Serres, ancora una volta, in quest’ultimo libro, ne parla come di fenomeni molto circoscritti e regressivi, enfatizzati solo dai “mercanti” del pessimismo e del catastrofismo che si annidano non a caso nel sistema delle comunicazioni di massa, e annuncia, nell’incredulità generale, che abbiamo fatto da poco il nostro ingresso nell’età più dolce dell’umanità.
È, quindi, il caso di addentrarci di più nel testo di Serres, al quale già di recente la collana “Riga” sui grandi innovatori del Novecento ha dedicato una ricca antologia critica (Michel Serres, a cura di G. Polizzi e M. Porro, Marcos y Marcos, Milano 2014) e sul quale, il prossimo ottobre, la Casa della Cultura di Milano si appresta ad offrire un seminario a più voci al pubblico italiano, per accompagnarlo nel modo in cui il nuovo maître à penser francese, che parteciperà in videoconferenza, c’invita a cambiare lo sguardo sul mondo contemporaneo.
Se, come si è detto, Gioacchino da Fiore gli fornisce la tela, la tavolozza dei colori che Serres utilizza per dipingere il suo affresco ambizioso include alcune coppie concettuali-chiave: bene e male, virtuale e attuale, caos e necessità, sacro e santo, rideclinate a partire dai pensatori e scienziati che lo hanno ispirato profondamente e costantemente: Simone Weil, Henri Bergson, Jacques Monod, René Girard.
Questi riferimenti e intercessori non vanno ovviamente confusi con i “personaggi concettuali” fatti assurgere da Serres a simboli delle tre età o ere che vede succedersi nella storia e che danno il titolo al libro: Darwin, Napoleone e il Samaritano.
Il libro inizia con la precisazione di un nuovo modo di intendere e definire i confini della storia, la cui profondità temporale assume in Serres una dimensione colossale. Non è solo la storia “storica”, la storia centrata sugli uomini, la storia che ha inizio con l’invenzione della scrittura. Paradossalmente questa Storia ha una memoria corta, cortissima, anzi è un ammasso di oblii, perché dimentica e mette ai margini della storia gli ominidi o i popoli primitivi privi di scrittura, gli altri viventi, le cose inerti, il pianeta, l’universo. La storia di cui Serres vuole proporre una filosofia, infatti, ha l’estensione cronologica vertiginosa del “Grande Racconto” delle scienze, dal momento che risale fino al Big Bang, cioè a circa quattordici miliardi di anni fa.
È il racconto che unifica in un’unica serie temporale le durate che ogni singola scienza (etnologia, biologia evolutiva, fisica del globo, astrofisica, cosmologia) ha ricostruito e aggiorna con sempre maggiore esattezza per i propri oggetti, in cui è inclusa la storia degli storici. L’enciclopedia delle scienze diventa una cronopedia e scienze naturali e scienze umane si uniscono, perché, anche se raccontano cose diverse, si basano sulla stessa struttura del tempo. Questa storia, chiarisce Serres, non ha più scopo o direzione e tantomeno sono gli uomini il fine o la fine di questo racconto, che è fatto di caos e biforcazioni impreviste, è un insieme eterogeneo di paesaggi e ritmi temporali differenti, ma che si può sempre ripercorrere da valle a monte secondo il “movimento retrogrado della verità” di bergsoniana memoria, ricostruendone così catene causali e direzioni di marcia. E Serres vi scorge la successione di tre ere.
La prima era va dalla formazione dell’Universo e del nostro pianeta fino alla comparsa e allo sviluppo delle forme viventi pre-umane. È l’era “darwiniana”, segnata dal duello energia-entropia, che governa il mondo fisico, e da quello vita-morte, che governa la galassia dei viventi e che si rideclina in pace-guerra con la comparsa dell’Homo sapiens, il rappresentante dell’unica specie vivente a introdurre la violenza e l’omicidio intra-specie. Ha inizio adesso l’“era dura” segnata da tre morti: la morte procurata col sacrificio, prima umano poi animale, ritualizzato nelle religioni arcaiche, che coagulava e rendeva coese così le comunità col sacro e col sangue, fino a quando il cristianesimo lo sostituirà con il rito “dolce” e simbolico dell’eucarestia, per denunciare l’innocenza di ogni vittima sacrificale; la morte procurata dalle armi letali della guerra, che è apparsa perpetua lungo tutta la storia “umana”, a cominciare dalla madre di tutte le guerre, quella combattuta tra gruppi nomadi e gruppi sedentari; la morte indotta o minacciata dal meccanismo economico del prestito e del debito, regolato ma sempre impastato di violenza. L’era dura culmina nella rivoluzione industriale e si chiude con l’esplosione di Hiroshima, che inaugura la prima “globalizzazione”, perché proietta la minaccia di morte per la prima volta non più sull’individuo, sui gruppi umani o sulle civiltà bensì sull’intera specie umana, ma è contestuale all’evento che gli fa da contraltare e che apre il sipario dell’era dolce: la scoperta della penicillina.
La neghentropia, l’informazione, la cura della vita, hanno sempre opposto, infatti, resistenza alla “tanatocrazia” dell’era dura e creato le condizioni per l’avvento dell’era dolce. Le stesse rivoluzioni dolci, come quelle concernenti i segni e la comunicazione (dall’oralità alla scrittura, dalla scrittura alla stampa, dalla stampa al digitale) hanno avuto un impatto più duraturo e diffuso sull’organizzazione sociale rispetto alle rivoluzioni dure, come quella scientifico-tecnico-industriale.
L’era dolce comincia poco più di mezzo secolo fa e si connota per tre componenti: la pace, la medicina, il digitale. La pace, nuova, dura almeno in Europa ininterrottamente da settant’anni; la guerra e il terrorismo sono precipitati all’ultimo posto come causa di mortalità nel mondo; all’immensa maggioranza degli uomini ripugna uccidere, violentare, distruggere opere d’arte e stigmatizza le minoranze che adottano ancora questi comportamenti; la protezione sociale dei deboli ha capovolto il darwinismo sociale dell’era dura. Questa pace è stata la condizione principale della golden age del secondo dopoguerra, dello sviluppo economico impetuoso che ha accresciuto il benessere, l’inurbamento, e della medicina che ha aumentato considerevolmente la speranza di vita, modificando il nostro rapporto col corpo, che non soffre più i dolori quotidiani di chi viveva già fino alla metà del secolo scorso.
Nell’era dolce, il medico rimpiazza il guerriero, la pietà del buon Samaritano succede alla spietatezza di Napoleone: “Nell’era antica, che possiamo definire ‘hegeliana’, a volte gli eserciti in battaglia trascinavano dietro degli sparuti chirurghi, mal equipaggiati, con poche infermiere munite di bende sparse in un ambiente insozzato dai combattimenti. Le grandi epidemie spesso erano la conseguenza dei carnai successivi allo scontro. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un giorno queste retroguardie avrebbero sostituito in prima linea i soldati, un tempo vittime; che l’ospedale, dove hanno luogo le sfide all’ultimo sangue per il trionfo della vita, avrebbe rimpiazzato il conflitto; che i governi, abbandonando il servizio militare, avrebbero deciso per una politica della salute; che dopo le ferite ci sarebbero state le cure; che l’assistenza sanitaria pubblica avrebbe sostituito il quartier generale e le sue strategie di morte; che l’OMS avrebbe potuto orientare la geopolitica. Ma questa utopia ha avuto luogo”.
Dopo aver letto fiumi di inchiostro sul lato oscuro e pervertibile della biopolitica moderna, Serres c’invita a coglierne il lato irenico e benigno, se ci poniamo adeguatamente dal punto di vista della lunghissima durata del “Grande Racconto”. D’altra parte, il profilo antropologico emergente dell’umanità “dolce” è convergente con quello tratteggiato già nel frammento postumo del 1887 da Nietzsche, per il quale proprio il contesto di vita reso meno insicuro e insensato e quindi addolcito dallo sviluppo della scienza e dalla tecnica, rende più ‘forti’ gli uomini più ‘moderati’, che non hanno bisogno, per rassicurarsi, di ricorrere a fedi estreme o a visioni essenzialiste e metafisiche dell’uomo.
Il motore della storia non sarà più la lotta tra servo e padrone, vinta da chi è disposto a rischiare la vita e a soggiogare quella altrui con la minaccia di morte, ma la legge del buon samaritano che s’inchina e si prende cura della vita, perché ci consentirà non solo di progredire ma di sopravvivere: “Dalla pietra tagliata alle armi nucleari, dai cacciatori-raccoglitori agli sventramenti del mondo, l’era storica contraddistinta dalle forze dure è al termine. Non può andare oltre senza avvelenare gli uomini e distruggere le cose”. E arriviamo così alle tecnologie dolci di Internet, che hanno innanzitutto il pregio di liberare la potenza del numero: tutti accedono virtualmente a tutto e a tutti.
Serres è positivamente impressionato dalla capacità di Internet di decentralizzare e democratizzare il sapere, in una misura non comparabile con quella delle altre rivoluzioni della “coppia supporto-messaggio” (scrittura e stampa) e in attesa di dispiegare ancora il suo ventaglio di effetti e opportunità per l’accesso al potere e alle istituzioni, per l’organizzazione dell’opposizione a regimi oppressivi, per nuovi modi di apprendere, di conoscere e di liberare la mente all’invenzione, per creare nuove appartenenze.
Se, come diceva Lutero, ogni uomo è Papa con una Bibbia in mano, cosa sarà l’uomo con uno smartphone in mano, cioè con il mondo intero in mano? Una molteplicità immensa e crescente è entrata in scena e in contatto in uno spazio non più cartesiano e metrico, bensì virtuale e topologico. Certo non è detto che questa possibilità incommensurabilmente accresciuta di contatto e scambio generi automaticamente, sempre e in modo più esteso comunità e pace.
Nuove forme di violenza possono essere veicolate nella e con l’uso della Rete e i più pessimisti prefigurano addirittura la fagocitazione del dolce da parte del duro con le cyberguerre. Ma al futuro dell’età dolce Michel Serres consegna l’utopia concreta di una pace universale che discenderà dalla coscienza della comune appartenenza all’equipaggio del vascello-Terra e dei rischi di affondare che esso corre: “È vero, abbiamo messo la mano sul mondo, ma il mondo tiene la sua mano su di noi. Noi lo teniamo virtualmente; lui ci tiene realmente. Noi lo teniamo realmente; lui ci tiene virtualmente. Lo teniamo grazie al facile accesso; e lui ci tiene per le nostre condizioni di esistenza - respirazione, nutrimento, salute, spostamenti... Mi sembra prevedibile che un giorno la mano del mercato dovrà adeguare la sua potenza relazionale a quella concreta del mondo, e forse adeguarvisi, cioè obbedire alla sua legge. Entriamo in un periodo in cui si gioca un mano a mano decisivo per la nostra sopravvivenza, tra l’uomo individuale o globale e l’intero pianeta. Questo mio libro sulla storia e la storia stessa tornano al punto di partenza: partiti dal mondo, vi fanno ritorno”.
Per lungo tempo oggetto ostracizzato dalla scena del discorso filosofico contemporaneo, per aver alimentato in modo sotterraneo le ideologie totalitarie (come tale è stata smascherata o messa all’indice da Hannah Arendt o Karl Popper), Serres è determinato nel riportare la filosofia della storia in auge come l’orizzonte o la bussola imprescindibile per la politica e i decision makers, che oggi, in questo inizio di secolo, se ne scoprono drammaticamente orfani, nel momento in cui necessitano di essere più lungimiranti.
E una filosofia della storia allargata e inglobante le durate colossali dell’Universo, della Terra, dell’evoluzione del vivente, oltre alla storia delle collettività umane, non è affatto un mero esercizio interdisciplinare, né solamente il frutto di quel che Serres chiamava, già alcuni decenni fa, programmaticamente “il passaggio a Nord-Ovest” tra saperi umanistici e saperi scientifici.
Risponde all’esigenza di evitare ad ogni costo l’opposizione natura/storia, il cui superamento è ormai condizione stessa della nostra sopravvivenza. I nostri nonni sapevano di avere alle loro spalle solo circa tremila anni di storia. Le “Pollicine” del futuro, i giovani dell’era dolce, sapranno di avere alle loro spalle quattordici miliardi di anni di storia e di essere entrati nell’era dell’antropocene. Questa coscienza non potrà non avere effetti sulla mentalità, sulla politica, sul diritto, sul modo di produrre. In definitiva, sul nostro essere-nel-mondo. Serres ancora una volta è ottimista: “Ecco che ne è dell’essere-nel-mondo: dolce verso il mondo, l’età dura era dura verso gli uomini; poi, dolce per gli uomini, l’età dolce è diventata dura verso il mondo. Dobbiamo lavorare per un futuro in cui i nostri comportamenti saranno dolci verso gli uomini e verso il mondo”.
- EU-ANGELO, COSTITUZIONE... "CARESTIA" E VIOLENZA!!! "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1 Gv., 4. 1-8). «Et nos credidimus Charitati...»!!!!
 RENE’ GIRARD INSISTE: DIO NON E’ VIOLENTO. MA CONFONDE IL PADRE NOSTRO (DEUS CHARITAS EST) CON IL DIO DEL CATTOLICISMO PLATONICO-ROMANO DI RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006) E RICADE NELLE BRACCIA DI "MAMMASANTISSIMA". UN’ INTERVISTA DI FRANÇOIS D’ALANÇON
RENE’ GIRARD INSISTE: DIO NON E’ VIOLENTO. MA CONFONDE IL PADRE NOSTRO (DEUS CHARITAS EST) CON IL DIO DEL CATTOLICISMO PLATONICO-ROMANO DI RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006) E RICADE NELLE BRACCIA DI "MAMMASANTISSIMA". UN’ INTERVISTA DI FRANÇOIS D’ALANÇON
L’ART DES PONTS. HOMO PONTIFEX. Louis De Courcy e Guillaume Goubert intervistano Michel Serres.
 Una forte sollecitazione ad uscire dal "neolitico" e, ripartendo dal nostro presente storico, a ri-attivare l’umana (di tutti e di tutte!!!) capacità di "gettare ponti" e a riprendere il cammino "eu-ropeuo"!!!
Una forte sollecitazione ad uscire dal "neolitico" e, ripartendo dal nostro presente storico, a ri-attivare l’umana (di tutti e di tutte!!!) capacità di "gettare ponti" e a riprendere il cammino "eu-ropeuo"!!!EU-ANGELO E COSTITUZIONE . "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1 Gv., 4. 1-16).
 SENZA LO "SPIRITO" DI GIOACCHINO DA FIORE, NON SI DA’ IL "TERZO PARADISO". Un omaggio critico a Michelangelo Pistoletto
SENZA LO "SPIRITO" DI GIOACCHINO DA FIORE, NON SI DA’ IL "TERZO PARADISO". Un omaggio critico a Michelangelo PistolettoDELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Pace, giustizia, e libertà nell’aiuola dei mortali
 DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia"
DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia""CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
- EU-ANGELO, COSTITUZIONE... "CARESTIA" E VIOLENZA!!! "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1 Gv., 4. 1-8). «Et nos credidimus Charitati...»!!!!
-
>IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". Gioacchino (con Dante) -- La Porziuncola. Il sogno di una Terra Santa «serafica» (di Franco Cardini)5 agosto 2016, di Federico La Sala
- DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Pace, giustizia, e libertà nell’aiuola dei mortali
- DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI.
La Porziuncola: storia e tradizione
Il sogno di una Terra Santa «serafica» in Umbria
di Franco Cardini (Avvenire, 4 agosto 2016)
La celebre indulgenza plenaria di Santa Maria degli Angeli in Assisi, o della Porziuncola - il piccolo oratorio caro a Francesco che oggi è inglobato nell’immensa basilica barocca sotto quella che Giosué Carducci chiamò «la cupola bella del Vignola» -, è molto cara alla devozione popolare ma vanta una tradizione storico- filologica tra le più tormentate: e la recente mostra Il Perdono d’Assisi. Storia, agiografia ed erudizione destinata a celebrarne l’ottavo centenario ne dà conto - come testimonia il catalogo curato da Stefano Brufani (Spoleto, Medioevo Francescano, 2016) - con pacata, spietata acribìa storica e filologica.
In effetti, la tradizione secondo la quale nel 1216 papa Onorio III avrebbe concesso a Francesco un’allora inusitata indulgenza plenaria - l’unico esempio di questo tipo ad essa precedente è la celebre indulgenza per l’Iter hierosolymitanum, la Crociata che risalirebbe al 1095 ma che i Pontefici successivi hanno regolarmente confermato - non risulta attestata da alcun documento coevo. Tra 1279 e 1285 il teologo provenzale Pietro di Giovanni Olivi dedicava al tema un’attenta quaestio nella quale ammetteva che, al riguardo, sussisteva una straordinaria incertezza all’interno dell’Ordine e che molti Frati Minori non esitavano ad affermare che non esisteva alcun privilegio confortato da bulla pontificia che ne assicurasse l’autenticità.
Ma Pietro di Giovanni era una presenza assai “chiacchierata” nell’Ordine a causa delle sue posizioni teologiche. Alcuni decenni più tardi il cronista francescano Francesco Venimbeni da Fabriano, che sarebbe scomparso nel 1322, non esitava nelle sue memorie a parlare del 1216 come data sicura della concessione. La que- stione si trascinò comunque per i successivi sei secoli: e in occasione del VII centenario, nel 1916, padre Egidio Maria Giusto non poteva tacere - proprio nella prima nota dell’articolo che apriva la rivista L’Oriente serafico - che annalisti ed eruditi, francescani e no, erano straordinariamente discordi quanto alla data d’avvio della tradizione.
Comunque fosse, la memoria minoritica del documento è affidata alla summa di Francesco di Bartolo d’Assisi: da lì. Attraverso compendi, versioni anche in idioma volgare e manifesti vari si giunse al Liber e all’edizione a stampa, uscita nel 1470 a Trevi e prima opera minoritica mai uscita dai torchi messi a punto dal grande Gutenberg. Sul Perdono si continuò peraltro a discutere, alimentando l’ampio contenzioso esistente tra i Minori di Santa Maria degli Angeli e i Conventuali del Sacro Convento.
Certo, un problema di fondo sul piano storico si pone subito. Onorio III era succeduto a Innocenzo III, che nel 1215 con il Concilio Lateranense IV si era fatto araldo e garante di una Crociata che ormai - problematicamente riuscita nel 1099 e quindi sempre fallita, ben tre volte di seguito nell’arco di poco più di un secolo, sotto la guida dei principi secolari - si configurava come una delle principali causae della Chiesa, insieme con quella (eterna?) della sua reformatio. Per Innocenzo, l’Iter hierosolymitanum aveva un vero e proprio valore “pasquale” - e se n’era ricordato appunto nel suo sermone di apertura del Concilio -, il senso di un nuovo Esodo: la riconquista della Terra Santa, ormai da quasi trent’anni ricaduta nelle mani degli infedeli, avrebbe aperto nella storia della cristianità un’era nuova alla quale il Pontefice assegnava un autentico valore escatologico.
Vero è che Innocenzo era sceso nel sepolcro pochi mesi dopo aver pronunziato quel sermone: ma la memoria della Chiesa intera era satura del suo magistero, che Onorio III s’impegnava a proseguire. E difatti una nuova Crociata, agli ordini del legato apostolico cardinal Pelagio Galvani, si sarebbe mossa non troppi mesi più tardi per raggiungere il delta del Nilo, secondo una scelta tattico- strategica ch’era parsa geniale (si pensava che il sultano ayyubide al-Malik al-Kamil, che governava l’Egitto e custodiva Gerusalemme, avrebbe volentieri ceduto la Città Santa ai cristiani pur di non compromettere i ricchi affari dei porti nilotici). Com’è noto, a quella Crociata prese parte anche Francesco, i cui fratelli si trovavano già in Terra Santa.
Ma, proprio per questo motivo, è verosimile e credibile che Onorio concedesse appunto alla vigilia della partenza di un nuovo esercito crociato un’indulgenza simile a quella che, dal punto di vista religioso, costituiva la principale ragione di partecipazione all’impresa, ma diversa e alternativa nello scopo? Si può concepire che, mentre la Chiesa chiamava alle armi, essa accordasse un simile vantaggio spirituale a chi avesse compiuto un pellegrinaggio a non troppe decine di miglia da Roma, nella bella valle spoletina?
Tuttavia, post eventum, collegare l’indulgenza della Porziuncola a quegli anni, e proprio a Francesco alla vigilia di partire per l’Oriente, poteva sembrare un’occasione troppo affascinante. E spiritualmente troppo significativa. Era in gioco l’affermazione di Assisi come Terra Sancta seraphica, la translatio della sacralità da Gerusalemme ai luoghi nei quali l’alter Christus aveva vissuto la sua Passione. Il Liber di Francesco di Bartolo, l’inventio dell’Indulgenza rientrano in questa strategia legittimatrice. Forse la storia parla un linguaggio un po’ diverso rispetto alla tradizione. Forse non è né giusto né opportuno né possibile mettere a tacere l’autorevole ancorché scomoda voce di Pietro di Giovanni Olivi.
Fin qui la storia documentaria. Che ha le sue ragioni e che nessuno può permettersi di ignorare. D’altronde la tradizione, come è stato spesso dimostrato, conosce a sua volta strade difficili e pur esse stesse praticabili verso la verità. Teniamoci stretti all’una e all’altra: confidiamo nella ragione e nella scienza, rispettiamo e approfondiamo la tradizione.
-
> PASQUA --- La redenzione riguarda tutti gli esseri umani. È estranea alle parole di Gesù l’idea che solo chi crede possa rialzarsi dalla caduta (di Vito Mancuso)26 marzo 2016, di Federico La Sala
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
- UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
 UNA MEMORIA DI "VECCHIE" SOLLECITAZIONI. Il cardinale Martini, dalla “città della pace”, lo sollecita ancora!!!
UNA MEMORIA DI "VECCHIE" SOLLECITAZIONI. Il cardinale Martini, dalla “città della pace”, lo sollecita ancora!!!
Cristiani o no, siate giusti e sarete salvi
Il senso vero della Pasqua è che la redenzione riguarda tutti gli esseri umani ed è legata al bene e all’amore
È estranea alle parole di Gesù l’idea che solo chi crede possa rialzarsi dalla caduta
di Vito Mancuso (la Repubblica, 26.03.2016)
«La Chiesa è rimasta indietro di 200 anni», dichiarò il cardinal Martini nell’ultima intervista, ma io penso che tale ritardo ecclesiastico sia l’espressione di un più preoccupante ritardo del cristianesimo in quanto tale, sempre più incapace di sostenere il suo annuncio fondamentale. Fa problema il centro stesso della fede cristiana, cioè la salvezza. Come pensarla? Qual è la sua specificità? Roger Haight, gesuita americano, descrive così la situazione: «Il significato della salvezza rimane elusivo; ogni cristiano impegnato sa che cos’è la salvezza finché non gli si chiede di spiegarla ». Non c’è religione senza salvezza, ci sono religioni senza Dio, nessuna senza salvezza.
Per il cristianesimo la salvezza scaturisce dalla Pasqua di Cristo, al cui riguardo si legge nel Catechismo cattolico: «Vi è un duplice aspetto nel Mistero pasquale: con la sua morte Cristo ci libera dal peccato, con la sua Risurrezione ci dà accesso ad una nuova vita» (art. 654). Questo è il centro del messaggio: la salvezza come redenzione operata da Cristo.
Il concetto di redenzione è sconosciuto alle altre religioni: Mosè, Buddha, Confucio, Maometto sono legislatori, maestri, profeti, saggi, non redentori, non sono cioè essi a dare la salvezza, che è invece ottenuta dai fedeli seguendo i loro insegnamenti. Il cristianesimo si distingue perché ritiene l’umanità corrotta dal peccato originale e incapace di meriti spirituali, e quindi annuncia la salvezza come operata gratuitamente da Dio mediante la redenzione ottenuta da Cristo.
Ogni anno la Pasqua è la solenne celebrazione di questo evento. Esaminando la storia di tale dottrina si vede che il primo a formularla fu San Paolo. Egli scrive: «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue» ( Romani 3, 23-25). Paolo afferma che la morte di Cristo è stata voluta direttamente da Dio e altrove aggiunge: «Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore» ( 2 Corinzi 5,21).
Leggendo i suoi scritti in ordine cronologico si scopre però che non sempre San Paolo la pensava così. Nella sua lettera più antica infatti egli non parla della morte-risurrezione di Cristo come di un atto redentivo, né dell’evento salvifico come già avvenuto. Al contrario per lui la salvezza deve ancora attuarsi. Ecco come: «Il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell’arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo; quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore» ( 1Tessalonicesi 4,16-17).
Paolo scrive che Cristo è morto «per noi», ma non fa dipendere la salvezza da quella morte, prova ne sia che non ritiene quest’ultima voluta da Dio (come invece sosterrà in seguito) ma dagli ebrei, come appare da queste parole destinate nei secoli ad alimentare l’antisemitismo: «I giudei hanno persino messo a morte il Signore Gesù e i profeti, e hanno perseguitato anche noi; essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini » (2,15-16). Qui non c’è un piano di Dio che manda il Figlio a morire, c’è piuttosto l’inimicizia degli ebrei che hanno ucciso Gesù, il quale però è stato risuscitato da Dio a chiara dimostrazione della mutazione della storia che si realizzerà con il suo imminente ritorno. La stessa impostazione si ritrova in 1 Corinzi.
San Paolo cambia presto prospettiva ed è facile capire il perché: la mancata venuta di Cristo lo induce a porre il centro focale non più nel futuro ma nel passato, Cristo è il salvatore non perché tornerà vittorioso ma perché è morto offrendosi al Padre e riconciliandoci a lui con il suo sangue. Cristo diviene così il redentore crocifisso. È in questa luce che vent’anni dopo vengono composti i Vangeli. Essi però, riportando anche il pensiero di Gesù, permettono di sollevare la questione decisiva: Gesù pensava la salvezza come redenzione oppure, da ebreo osservante, la legava al responsabile esercizio della libertà?
Vi sono testi evangelici in linea con la teologia della redenzione, per esempio quando Gesù dice di essere venuto per «dare la propria vita in riscatto per molti» ( Marco 10,45) o quando nell’ultima cena pronuncia le note parole: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati » ( Matteo 26,28).
Nei Vangeli però vi sono molti altri testi che presentano la salvezza legata non a un evento esterno ma alle azioni liberamente poste, secondo la tradizionale concezione ebraica della salvezza come esito della fedeltà all’alleanza, cioè come giustizia.
Io penso anzi che a Gesù la dottrina della redenzione non sarebbe piaciuta per nulla, c’è tutto il Discorso della montagna a dimostrarlo, a partire dalle parole del Padre Nostro sul ruolo attivo della libertà: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Gesù prosegue: «Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdone- rà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe» ( Matteo 6,12-15). La mossa decisiva spetta alla libertà umana, la quale per Gesù è in grado di operare anche il bene perché non è irrimediabilmente corrotta, come invece dirà San Paolo e più radicalmente Sant’Agostino.
L’idea di una libertà efficace in ordine alla salvezza si ritrova in molti altri passi evangelici tra cui: «Col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati» ( Matteo 7,2). Il principio salvifico è quindi legato alla prassi responsabile: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» ( Matteo 7,21). Il Discorso della montagna, cuore del messaggio di Gesù, è un appello alla libertà quale via efficace per il conseguimento della salvezza.
A questo punto appare evidente la problematicità della successiva costruzione teologica cristiana basata sulla redenzione, da cui la difficoltà nel rispondere alle seguenti questioni:
 1) In cosa consiste propriamente la redenzione operata da Cristo?
1) In cosa consiste propriamente la redenzione operata da Cristo?
 2) L’atto redentivo vero e proprio è la morte di croce o è la risurrezione?
2) L’atto redentivo vero e proprio è la morte di croce o è la risurrezione?
 3) Qual è la sorte di chi non vi partecipa?
3) Qual è la sorte di chi non vi partecipa?
 4) Da cosa si viene redenti: dalla morte, dal Diavolo, dall’egoismo, dal mondo, dal castigo di Dio, dalla Legge, dal peccato, o da tutto questo messo insieme?
4) Da cosa si viene redenti: dalla morte, dal Diavolo, dall’egoismo, dal mondo, dal castigo di Dio, dalla Legge, dal peccato, o da tutto questo messo insieme?La radice dell’aporia risiede a mio avviso nell’idea di una specificità cristiana della salvezza in quanto legata a un determinato evento storico, cioè nell’impostazione data al cristianesimo da san Paolo ed estranea a Gesù. In realtà occorre pensare che la salvezza è sempre stata disponibile agli esseri umani, a qualunque religione o non-religione appartengano, perché è legata al bene e alla giustizia.
È il Vangelo ad affermarlo: «Venite, benedetti dal Padre mio, riceverete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito» ( Matteo 25,34-36).
Nel Libro dei Morti dell’antico Egitto vi sono parole analoghe: «Ho soddisfatto Dio con ciò che ama: ho dato pane all’affamato, acqua all’assetato, vestiti all’ignudo, una barca a chi non ne aveva» (cap. 125). Il testo risale a 1500 anni prima di Cristo e dicendo le stesse cose mostra il vero senso della salvezza, che mai mancò al genere umano, ben prima del cristianesimo storico: la liberazione dall’ego e l’apertura al bene, all’amore, alla giustizia. Io ritengo non implausibile pensare che, in chi pratica questo stile di vita, possa generarsi una peculiare disposizione della sua energia costitutiva (ciò che tradizionalmente si chiama anima) in grado di vincere la curvatura dello spazio-tempo.
-
> PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". -- La fede senza consolazione del buon cristiano Quinzio (di Gianni vattimo).23 marzo 2016, di Federico La Sala
- IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA. “Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 DISTRUGGERE IL CRISTIANESIMO: IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT.
DISTRUGGERE IL CRISTIANESIMO: IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT.
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
Vent’anni fa moriva uno dei teologi più originali del dopoguerra. Nell’ultimo libro scrisse di un Papa che chiude la Chiesa per fallimentoLa fede senza consolazione del buon cristiano Quinzio
di Gianni Vattimo (La Stampa, 22.03.2016)
Possiamo considerare provvidenziale il fatto che ci tocchi celebrare il ventennale della morte di Sergio Quinzio (scomparso il 22 marzo 1996) proprio all’inizio della Settimana Santa? Il fatto è che il centro di tutta la meditazione di Quinzio, fin da quando cominciava a pubblicare i suoi scritti mentre era ancora ufficiale della Guardia di Finanza, è stato il mistero della resurrezione. Quella di Cristo, anzitutto, narrata nei Vangeli, così intensamente commentati nelle sue opere; e poi quella promessa agli uomini dopo il giudizio finale.
Né l’una né l’altra di queste resurrezioni, quella accaduta a Gerusalemme e quella promessa a tutti noi per il futuro, sono mai state per lui oggetto di una meditazione consolatoria e «edificante» nel senso più comune. Come il mistero della Croce, la resurrezione è un punto inquietante, di frizione, nella fede di Quinzio, e più in generale nella sua visione della Chiesa. I titoli delle sue opere più note, da La fede sepolta (1978) a La Croce e il nulla (1984) a Mysterium iniquitatis (1995), alludono a una concezione del cristianesimo improntata alla coscienza acuta di un fallimento, insomma il contrario di ogni trionfalismo e di ogni senso di positività esistenziale e storica.
Paradossalmente, è proprio con la resurrezione che ha a che fare questo complessivo angosciante senso di fallimento. Se anche gli apostoli hanno visto Gesù risorto (ma anche: «beati quelli che hanno creduto senza vedere») la trasformazione del mondo, la parusia, ossia il ritorno del Messia nella sua gloria che essi credevano imminente, non si è verificato. Il primo fallimento del Cristianesimo è stato questo, i nuovi cieli e la nuova terra che Gesù aveva promesso, credendo anche lui nella loro imminente realizzazione, non sono venuti, e anche dopo la sua risurrezione i suoi discepoli hanno dovuto fare i conti con questo inspiegabile ritardo. Che ha segnato in modo indelebile lo sviluppo della dottrina e della spiritualità cristiana.
Perfino il modo cristiano di considerare e vivere la sessualità ha le sue remote radici qui: il ritardo della parusia è il primo responsabile della progressiva tendenza spiritualizzante che si impose nella interpretazione del messaggio di Gesù, insieme allo scandalo che suscitava nel mondo greco l’idea che i morti potessero risorgere. La vita eterna venne sempre più considerata come riservata all’anima, che del resto la filosofia greca aveva già ritenuto immortale, mentre il corpo era destinato a perire: anche una volta risuscitati nell’ultimo giorno i fedeli salvati non avrebbero più goduto delle felicità terrene, «neque nubent neque nubentur» (Matt. 22, 30), cioè non avrebbero più avuto rapporti carnali e tutta la felicità del Paradiso si sarebbe risolta nella contemplazione di Dio. Non era però la nostalgia per i piaceri della carne che muoveva Quinzio, ma l’idea che la verità più caratteristicamente cristiana, la fede nella risurrezione, si era consumata fino a sparire sempre più dall’orizzonte della Chiesa in un processo di secolarizzazione.
È eloquente, in questo senso, soprattutto l’ultimo libro di Quinzio, Mysterium iniquitatis, in cui egli immagina di scrivere le due encicliche dell’ultimo Papa, che secondo una famosa profezia medievale sarebbe stato eletto alla fine del secondo milllennio. Anche questa profezia, fortunatamente o no, non si è realizzata, per ora. Tuttavia il tempo che viviamo, pensa Quinzio, è quello del trionfo dell’anticristo di cui parla l’Apocalisse, lo scatenarsi del male assoluto (Auschwitz e oltre!) a cui seguirà finalmente la parusia, il ritorno glorioso del Cristo giudice che farà nuove tutte le creature, asciugherà tutte le lacrime e raddrizzerà tutte le ingiustizie della storia.
È questo il cristianesimo capace di salvarci, anche se non è tenero e consolante come vorremmo che fosse? Non sarà esso stesso troppo «spirituale», troppo monastico e pessimista sulla possibilità di opporre qualche sia pur debole resistenza al dilagare del male che moltiplica le vittime nell’apparente silenzio di Dio, e spesso anche dei suoi ministri? E poi: potrebbe essere stata segnata da uno spirito «quinziano» la decisione di Benedetto XVI, di dimettersi dalla sua carica? O addirittura, come pensano probabilmente molti integralisti, non sarà proprio Francesco, con le sue riforme e la sua dissoluzione di tante tradizioni consolidate, l’ultimo papa della storia? Domande che ci portano pericolosamente vicino a Dan Brown e ai suoi gialli religiosi, che certo Quinzio non amava. Ciò che rimane di lui è forse descrivibile come la testimonianza di un Giobbe che non si lascia tanto facilmente convincere di avere torto, e prende in parola le promesse divine con una ostinazione di cui la fede non può fare a meno.
- IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA. “Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
-
>IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". --- Ecumenismo. Papa Francesco: serve una «teologia fatta in ginocchio» (di Alessandro Gisotti)28 giugno 2014, di Federico La Sala
Ecumenismo
Papa: serve una «teologia fatta in ginocchio»
di Alessandro Gisotti - Radio Vaticana (Avvenire, 28 giugno 2014)
Bisogna lasciarsi guidare dallo Spirito Santo per avanzare verso l’unità dei cristiani. E’ l’esortazione levata da Papa Francesco nell’udienza alla Delegazione ecumenica del Patriarcato di Costantinopoli, ricevuta alla vigilia della Solennità dei Santi Patroni di Roma, Pietro e Paolo. Il Pontefice ha sottolineato che anche partendo da prospettive diverse, attraverso una “teologia fatta in ginocchio” si può arrivare ad un cammino di unità.
Condividere la gioia di essere fratelli. Papa Francesco si è rivolto alla delegazione della “Chiesa sorella di Costantinopoli” rivolgendo innanzitutto il pensiero al Patriarca ecumenico Bartolomeo I, “amato fratello” con il quale ha vissuto insieme l’esperienza del pellegrinaggio in Terra Santa e poi la Preghiera per la pace nei Giardini Vaticani.
Il Papa ha ricordato l’abbraccio tra Paolo VI e Atenagora. Un gesto profetico, ha osservato, che ha dato “impulso ad un cammino” che “non si è più arrestato”: “Il Signore ci ha donato queste occasioni di incontro fraterno, nelle quali abbiamo avuto la possibilità di manifestare l’uno all’altro l’amore in Cristo che ci lega, e di rinnovare la volontà condivisa di continuare a camminare insieme sulla strada verso la piena unità”.
Sappiamo bene, ha aggiunto, che “questa unità è un dono di Dio” ed ha ribadito che grazie alla “forza dello Spirito Santo” possiamo “guardarci gli uni gli altri con gli occhi della fede”, “riconoscerci per quello che siamo nel piano di Dio” e “non per ciò che le conseguenze storiche dei nostri peccati ci hanno portato ad essere”:
 “Se impareremo, guidati dallo Spirito, a guardarci sempre gli uni gli altri in Dio, sarà ancora più spedito il nostro cammino e più agile la collaborazione in tanti campi della vita quotidiana che già ora felicemente ci unisce”.
“Se impareremo, guidati dallo Spirito, a guardarci sempre gli uni gli altri in Dio, sarà ancora più spedito il nostro cammino e più agile la collaborazione in tanti campi della vita quotidiana che già ora felicemente ci unisce”.Questo sguardo teologale, ha proseguito, “si nutre di fede, di speranza, di amore”. Esso, è stata la sua riflessione, “è capace di generare una riflessione teologica autentica”, che è in realtà “partecipazione allo sguardo che Dio ha su se stesso e su di noi”. Una riflessione, ha affermato, “che non potrà che avvicinarci gli uni agli altri, nel cammino dell’unità, anche se partiamo da prospettive diverse”:
 "Confido pertanto, e prego, affinché il lavoro della Commissione mista internazionale possa essere espressione di questa comprensione profonda, di questa teologia “fatta in ginocchio”.
"Confido pertanto, e prego, affinché il lavoro della Commissione mista internazionale possa essere espressione di questa comprensione profonda, di questa teologia “fatta in ginocchio”.La riflessione sui concetti di primato e di sinodalità, sulla comunione nella Chiesa universale, sul ministero del Vescovo di Roma, non sarà allora un esercizio accademico né una semplice disputa tra posizioni inconciliabili.
“Abbiamo tutti bisogno di aprirci con coraggio e fiducia all’azione dello Spirito Santo - ha soggiunto - di lasciarsi coinvolgere nello sguardo di Cristo sulla Chiesa” nel cammino di un “ecumenismo spirituale rafforzato dal martirio” di tanti cristiani che “hanno realizzato l’ecumenismo del sangue”.
-
> PASQUA IN ARRIVO. --- FRANCESCO E BENEDETTO XVI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! IL "DEUS CARITAS EST" O IL "DEUS CHARITAS EST"?!30 marzo 2013, di Federico La Sala
 FRANCESCO, IL NUOVO PAPA, OLTRE IL MAGISTERO EQUIVOCO DI BENEDETTO XVI: DAL "DEUS CARITAS EST" AL "DEUS CHARITAS EST"?
FRANCESCO, IL NUOVO PAPA, OLTRE IL MAGISTERO EQUIVOCO DI BENEDETTO XVI: DAL "DEUS CARITAS EST" AL "DEUS CHARITAS EST"?
 DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?! Un resoconto dell’incontro, con note
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?! Un resoconto dell’incontro, con note
-
> PASQUA IN ARRIVO. --- L’APOSTOLO DELLE CALABRIE SULLA STRADA DELLA CARITA’ ("CHARITAS") DI GIOACCHINO DA FIORE E FRANCESCO DI PAOLA6 aprile 2012, di Federico La Sala
CAMPANIA E CALABRIA. STORIA E MEMORIA:
SULLA STRADA DELLA CARITA’ ("CHARITAS") EVANGELICA, E NON DELLA CARITA’ ("CARITAS") MAMMONICA E "AFFARAONICA"!
L’APOSTOLO DELLE CALABRIE.
-
> PASQUA IN ARRIVO. ---- MICHELANGELO, IL SOGNO DI TERESA D’AVILA E GIOVANNI DELLA CROCE, E UNA "CAPPELLA SISTINA" IN ROVINA.6 aprile 2012, di Federico La Sala
-
> PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". --- Recitare o essere? Pensieri tra Quaresima e Pasqua (di don Angelo Casati)30 marzo 2012, di Federico La Sala
Recitare o essere? Pensieri tra Quaresima e Pasqua
di don Angelo Casati (“Viandanti” : www.viandanti.org, 30 marzo 2012
Mi succede - qualcuno la ritiene una mia ossessione - di avere in sospetto ogni parola che, poco o tanto, sembra recitata, ogni atteggiamento che, poco o tanto, sembra studiato. Si recita una parte.
A volte mi sorprendo a guardarmi. E mi chiedo: "Stai recitando? Stai celebrando o recitando? Stai pregando o recitando? Stai predicando o recitando? Stai parlando o recitando?". Nella recita non ci sei. C’è una parte che indossi. Che non è la tua.
Gesù incantava
Gesù non recitava. Forse per questo o anche per questo, incantava. Era autentico, aderente la vita, non a una parte da recitare. E la gente lo sentiva vero. A differenza di altri. A differenza, per esempio, di una certa frangia - non tutti! - di farisei che "recitavano": "Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini. Allargano i loro filatteri, allungano le frange; amano posti d’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare rabbì dalla gente"(Mt.23,5-7).
Qualcuno, anche nel mondo ecclesiastico, sconcertato dalla calda umanità di Gesù, tende a presentarla come se il Signore stesse recitando, quasi non gli fosse consentito, in quanto Dio, di crescere, di essere stanco, di non sapere, di amare i banchetti, di desiderare la tenerezza di un bacio o il profumo dell’unguento, di provare paura e solitudine. Quasi recitasse, in tutto ciò una parte non sua. Gesù non ha mai recitato. Era.
Dominante è il ruolo
C’è il pericolo - lo avverto sempre più acutamente e il racconto delle tentazioni di Gesù, all’inizio della Quaresima, lo segnalava - che anche la religione diventi spettacolo, luogo in cui si recita. Strano verbo, questo "recitare", che abbiamo nel nostro linguaggio religioso legato al pregare! Si "recita" una Ave Maria o un Padre Nostro, si "recita" il rosario. È in agguato la recita. La avverti. A volte è nell’aria. A tradirla è un tono affettato, artefatto, poco naturale, studiato.
Aria strana.
L’aria di certi raduni ecclesiastici. Volti impassibili, non tradiscono la benché minima emozione. Ci si parla di errori, di cedimenti o di smarrimenti, sono sempre quelli degli altri. L’inquietudine non esiste. Esiste la sicurezza. Si recita la parte di Dio. Mai uno che dica: "Ho peccato". Lo si dice nella Messa, ma per modo di dire. Nessuno che abbia mai fatto un errore. E che lo riconosca. Domina il ruolo. L’impassibilità del ruolo. Impenetrabili, drappeggiati, diplomatici. E senti la distanza. E come se mancasse gente vera. Non sono i volti che cerchi, quelli che ti incantano fuori le mura, volti che non mascherano le stanchezze e le emozioni, volti che confessano l’inquietudine e la lontananza.
Scrive Carlo Maria Martini: "Non di rado mi spavento sentendo o leggendo tante frasi che hanno come soggetto "Dio" e danno l’impressione che noi sappiamo perfettamente ciò che Dio è e ciò che egli opera nella storia, come e perché agisce o in un modo e non in un altro. La Scrittura è assai più reticente e piena di mistero di tanti nostri discorsi pastorali".
Come figli di Dio
Comunità alternativa si diventa vivendo il Vangelo, non recitando la parte del "perfetto". Alternativi diventiamo non mascherandoci dietro il ruolo o dietro il titolo, ma dando trasparenza ai rapporti. Incontrandoci come persone. Come figli di Dio. Questa la più grande dignità che ci è toccata. Non esiste, per un vero credente, altra tanto grande.
Essere Papa, essere Vescovo, essere prete, non vale l’essere figli di Dio. E, se figli, liberi, e quindi non soffocati, non mascherati, non misurati da titoli e da ruoli.
Quando Papa Giovanni, poco dopo la sua elezione, si accorse che l’ Osservatore Romano introduceva le sue parole con questa formula di rito: "Come abbiamo potuto raccoglierle dalle auguste labbra di Sua Santità", chiamò il capo redattore e gli disse: "Lasciate perdere queste sciocchezze e scrivete semplicemente: Il Papa ha detto".
La grande sfida
Quale perdita per la società, se la Chiesa, che nel mondo dovrebbe apparire come lo spazio dove risplende la libertà e l’umanità dei rapporti, diventasse luogo di relazioni puramente formali, deboli e fiacche, non sincere e intense.
Rischierebbe l’insignificanza. Verrebbe meno alla grande sfida, all’opportunità che oggi le si offre di tessere in una società ampiamente burocratizzata rapporti autentici e profondi. E non sarà che alla Chiesa di oggi, e quindi a ciascuno di noi, Dio chieda meno protagonismo, meno organizzazione, meno recite e più vicinanza, più sincerità?
Alla mente ritorna una pagina folgorante dello scrittore Ennio Flaiano, là dove abbozzava un ipotetico ritorno di Gesù sulla terra, un Gesù, infastidito da giornalisti e fotoreporter, come sempre invece vicino ai drammi e alle fatiche dell’esistenza quotidiana: "Un uomo" - scrive - "condusse a Gesù la figlia ammalata e gli disse: "Io non voglio che tu la guarisca, ma che tu la ami". Gesù baciò quella ragazza e disse: "In verità questo uomo ha chiesto ciò che io posso dare". Così detto, sparì in una gloria di luce, lasciando le folle a commentare quei miracoli e i giornalisti a descriverli".
-
>"TERTIUS IN CHARITATE". ----- Per un «ripensamento della carità nella società secolarizzata». "Essere cristiani oggi" di Giovanni Ferretti (di Enzo Bianchi - Se tramonta la trascendenza).26 novembre 2011, di Federico La Sala
Se tramonta la trascendenza
di Enzo Bianchi (La Stampa, 26 novembre 2011)
Titolo essenziale quello scelto da Giovanni Ferretti per una sua organica raccolta di saggi: Essere cristiani oggi (LDC, pp. 184, € 11,50) affronta infatti con profondità e immediatezza «il “nostro” cristianesimo nel moderno mondo secolare», come recita il sottotitolo. Sono considerazioni che l’autore già docente di filosofia teoretica all’Università di Macerata, di cui è stato anche rettore - ha avuto modo di elaborare in questi ultimi anni facendo tesoro di un dialogo fecondo tra filosofia e fede cristiana, in cui il suo essere presbitero della diocesi di Torino non ha costituito un ostacolo ma anzi un prezioso arricchimento. Cogliendo «la crisi ormai irreversibile della cristianità» come uno dei più significativi «segni dei tempi» che i cristiani dovrebbero sapientemente discernere e affrontare anziché negare, Ferretti ne analizza le radici e le manifestazioni, trasformandolo da rassegnata constatazione a stimolo virtuoso per un modo nuovo eppur antico di porsi dei cristiani nella società. Già l’interrogativo che pone in apertura - «tramonto o trasfigurazione del cristianesimo?» - è eloquente sull’approccio offerto dal volume. Se infatti il «tramonto della trascendenza» è una tendenza culturale e sociologica ben più vasta della minor rilevanza di alcune tradizioni cristiane nella società contemporanea, questo può aprire nuove prospettive alla comprensione e all’annuncio di Gesù Cristo e del suo Vangelo: l’uomo Gesù che ha saputo narrare il volto del Padre non costituisce «alcuna opposizione alla piena fioritura dell’uomo, bensì la massima vicinanza e il massimo impegno alla sua più compiuta umanizzazione», come paradossalmente ricorda il teologo protestante Paolo Ricca: «Dio si è fatto uomo perché noi non eravamo ancora uomini».
Proprio per questo il discorso offerto da Ferretti non riguarda solo i cristiani ma anche - e direi forse soprattutto - chi cristiano non è o tale non si ritiene più: «ripensare la risurrezione» in modo anche critico rispetto a un certo immaginario cristiano non è mero esercizio teorico, ma la possibilità di coglierla come «permanenza in Dio, anche dopo la morte, della nostra “identità personale”», come meta finale di ogni essere umano e riscatto di ogni faticosa ricerca di comunione e di gioia condivisa.
Ma la convincente riflessione di Ferretti non si ferma agli aspetti più «rivelativi» della fede cristiana e del suo coniugarsi con l’oggi della storia: passando attraverso un «ripensamento della carità nella società secolarizzata», affronta con lucidità il difficile dialogo con il mondo «laico» sui valori, sulla loro relatività o assolutezza, sulla loro genesi e condivisione, sulle minacce che li sovrastano e le potenzialità anche e soprattutto civili che essi contengono. Decisiva in questo ambito delicato è la dialettica tra «l’assoluto della verità» e «il carattere inviolabile della libertà umana». Per l’autore è quindi evidente che «valori non negoziabili o irrinunciabili non significa e non deve significare “non argomentabili” e tanto meno imponibili all’altro con la forza e la violenza». Un’evidenza che purtroppo non sempre è riconosciuta da tutti, ma che appare indispensabile per una sana crescita di una società civile libera e democratica.
-
> Gioacchino invita Benedetto XVI a correre ai ripari ---- Un papato immobile. La solitudine di Benedetto XVI (di Marco Politi).8 ottobre 2011, di Federico La Sala
Un papato immobile. La solitudine di Benedetto XVI
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 08.10 2011)
- Pubblichiamo un brano del libro “Joseph Ratzinger. Crisi di un papato”, in uscita la prossima settimana
Le polemiche sull’affare Williamson (il vescovo lefebvriano negazionista cui Benedetto XVI toglie nel 2009 la scomunica insieme ad altri tre presuli scismatici) mette in discussione esplicitamente il modo con cui Benedetto XVI governa la Chiesa. Gli osservatori denunciano una curia allo sbando, un papa chiuso nel suo palazzo e costretto a fronteggiare una bufera che l’Osservatore Romano definisce senza esempi in tempi recenti.
Sono giorni in cui un veterano di curia confida off record: “Benché sia stato in Vaticano per più di un ventennio in qualità di prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Ratzinger non conosce affatto la curia. Ieri era chiuso nella sua stanza nel Sant’Uffizio, oggi è chiuso nel suo studio di pontefice. Lui è un teologo, non è uomo di governo. Passa metà della giornata a occuparsi dei problemi della Chiesa e l’altra metà concentrato sulle sue ricerche su Gesù”. Certo esistono intorno a lui i fedelissimi. In testa il cardinale segretario di Stato, Bertone. Ma la fedeltà non basta.
Le avvisaglie che qualcosa non funziona sul ponte di comando in Vaticano si sono intraviste presto. Se il conflitto con il mondo islamico esploso a Regensburg poteva essere ancora considerato un incidente dai più indulgenti, le cose cambiano nel 2007: allorchè va in scena a Varsavia la nomina senza precedenti - e poi la precipitosa revoca - di un vescovo informatore dei servizi segreti comunisti, l’opinione pubblica avverte l’assenza di una leadership sicura. Commentano sull’Herald Tribune gli inviati Craig S. Smith e Ian Fisher: “Sebbene la sua grande esperienza in dottrina e teologia sia indiscussa, qualche critico afferma che (a papa Benedetto) manchi una piena padronanza dell’abilità politica necessaria ad un’organizzazione così vasta e complessa come la Chiesa cattolica... C’è chi suggerisce che il papa non sia ben coadiuvato dai suoi consiglieri oppure abbia la tendenza a prendere importanti decisioni principalmente di testa sua”.
Benedetto XVI studia attentamente i dossier, che gli vengono sottoposti, però il suo modo di lavorare è tendenzialmente solitario. I contatti con i suoi collaboratori si concentrano prevalentemente nelle cosiddette “udienze di tabella”, i regolari incontri settimanali con il segretario di Stato, il Sostituto, il ministro degli esteri, i prefetti delle Congregazioni per la dottrina della fede e dei vescovi. Solo due volte l’anno si tiene la riunione collegiale dei responsabili di tutte le congregazioni. Come se il capo di stato o di governo di una potenza internazionale riunisse il consiglio dei ministri unicamente ogni sei mesi. Giovanni Paolo II riceveva singolarmente ogni due anni gli ambasciatori papali per avere il polso della situazione internazionale. Benedetto XVI concede loro un’udienza di protocollo in occasione del trasferimento ad una nuova sede.
Nessuna guida politica
Benedetto XVI non utilizza nemmeno i pranzi di lavoro, strumento di cui approfittava largamente Giovanni Paolo II. “Wojtyla governava ascoltando”, commenta lo storico Andrea Riccardi leader della comunità di sant’Egidio, e “non mangiava mai da solo”.
Così si è creato in Vaticano un clima, la cui caratteristica dominante è di “non disturbare il manovratore”. Sostiene un cardinale del Nordeuropa che Benedetto XVI “è timido, ma si impunta nel difendere le proprie idee”. Quindi è difficile fargliele cambiare. Il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato, non può o non riesce a ovviare a questo complesso di fattori. Sin dal momento della sua nomina è stato considerato dalla curia un outsider e tale continua ad essere percepito. In curia lo si ritiene responsabile di non avere mano politica (nel senso tecnico del termine) nella conduzione del governo della Santa Sede. Molti curiali hanno nostalgia del pugno di ferro dell’ex segretario di Stato Sodano e rimpiangono l’era wojtyliana in cui “c’era una linea, una visione, orgoglio di fare e parole d’ordine precise”.
Bertone è giudicato con perplessità per avere coinvolto eccessivamente il suo ruolo nei giochi della politica italiana. È ricordata la sua partecipazione ad una cena, organizzata l’8 luglio 2010 da Bruno Vespa. La presenza del cardinale finisce per avallare un favore del conduttore televisivo all’ospite principe della serata, il premier Silvio Berlusconi che tenta di convincere il commensale Pier Ferdinando Casini, leader dell’ Udc, ad entrare nel suo governo. Sapere che il massimo collaboratore del pontefice accetta (finisce) per fare da cornice ad un tete a tete squisitamente politico, suscita parecchi malumori in curia.
Il teologo che non ascolta
A Benedetto XVI si riconosce un’intelligenza particolarmente acuta, uno stile di vita austero, una vasta formazione teologica, un rifiuto di qualsiasi familismo di cordata. L’osservazione, che gli viene rivolta, è di affrontare i problemi esclusivamente secondo un’impostazione teologica. Un problema essenziale, che mette a nudo le difficoltà del governo centrale della Chiesa, riguarda l’insufficiente dibattito sulle decisioni da prendere. Rispetto alle dimensioni della comunità cattolica mondiale e allo scenario internazionale, in cui opera la Santa Sede, la discussione è praticamente asfittica. Più di un cardinale sostiene l’urgenza di lasciare che i “vescovi parlino liberamente, ascoltando cosa dicono”. Un’altra critica riguarda l’instaurarsi di un clima di eccessiva apologia del pontefice.
Lo storico Giovanni Miccoli rileva: “È come se non ci fosse chi tiene in mano il timone del governo. Papa Ratzinger scrive libri, documenti, discorsi, si concentra sul rapporto tra fede e ragione”. Il sociologo cattolico Franco Garelli soggiunge: “Si avverte una debolezza del governo istituzionale. Spesso più del consenso prevale l’ossequio”.
Teoricamente Ratzinger ha avuto presente fin dall’inizio l’esigenza di non vincolare la Chiesa nel terzo millennio al modello assolutistico. “Una Chiesa dalle dimensioni mondiali, ed in questa situazione del pianeta, non può essere governata in modo monarchico”, garantì cinque mesi prima di essere eletto. Non è stato così. In sei anni si sono tenute soltanto tre riunioni plenarie del collegio cardinalizio.
Una cattolicità divisa
Il papa ottantaquattrenne viaggia, pubblica documenti, fa i suoi interventi, ma al di là di queste attività molti fedeli percepiscono una situazione di immobilismo. Nel frattempo si approfondisce all’interno della comunità cattolica la frattura fra due grandi tendenze. Coloro che si arroccano nella riaffermazione dell’ “identità cattolica” e coloro che si aspettano una Chiesa capace di misurarsi con le tematiche nuove. Ai vertici ecclesiastici si finge di non vedere la realtà di una cattolicità divisa, dove si moltiplicano fedeli, che in tema di fede, morale, dottrina e rapporto con la società contemporanea hanno approcci lontani dal magistero pontificio. Dopo una prima fiammata di consensi, l’attrazione per papa Ratzinger è scesa. Il calo è iniziato al terzo anno di pontificato. L’Italia, con la sua copertura giornalistica quasi quotidiana, resta un caso a parte. Nell’arena internazionale Ratzinger continua ad essere percepito come personalità di alto profilo che colpisce le élites culturali. Però è diminuita la risonanza planetaria del papato.
È soprattutto la concezione del rapporto tra Chiesa e società ad aprire interrogativi sull’attuale pontificato. Questo mondo così multiforme nelle sue credenze, così secolarizzato, così irriducibile al vecchio schema di “una fede - un popolo - un’autorità di Chiesa”, e al tempo stesso così vitale nelle sue pulsioni religiose, appare alla Chiesa ratzingeriana sotto la maschera del nemico.
Benedetto XVI intravvede nello scenario contemporaneo una “multiforme azione tesa a scardinare le radici cristiane della civiltà occidentale”. A volte la situazione attuale gli sembra simile - e lo dice apertamente - al tramonto dell’impero romano. Un programma di governo Ratzinger non lo ha maipresentato. Con gli anni questa impostazione - l’aver spostato l’accento dalla progettualità alla predicazione - pesa. Papa Wojtyla ha creato il suo progetto strada facendo. Paolo VI si era posto la missione di portare a termine il concilio Vaticano II e completarlo con i documenti e le istituzioni necessari. Pio XII, dopo la seconda guerra mondiale, aveva il chiaro obiettivo di riorganizzare la “società cristiana”, modernizzandola nelle sue forme d’azione. Benedetto XVI, al fondo, è rimasto un pensatore più che un uomo di governo.
-
> Gioacchino invita Benedetto XVI a correre ai ripari ---- ALLARME DI HANS KUNG: BENEDETTO XVI NON VEDE IL MONDO, VEDE SOLO IL (VITELLO D’ORO DEL) VATICANO6 ottobre 2011, di Federico La Sala
-
> IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE"..... “Credo nello Spirito Santo”: con questo titolo, in una serie intitolata “Une brassée de confessions de foi”, per iniziativa di Henri Fesquet, “Le Monde” del 10 luglio 1978 ha pubblicato questo testo di Monsignor Guy-Marie Riobé, vescovo di Orléans (membro dell’Union fondata da Charles de Foucauld). Otto giorni prima della sua morte.19 giugno 2011, di Federico La Sala
Lo Spirito, secondo Monsignor Riobé
di Guy-Marie Riobé
in “www.baptises.fr” del 10 e 12 giugno 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)
- “Credo nello Spirito Santo”: con questo titolo, in una serie intitolata “Une brassée de confessions de foi”, per iniziativa di Henri Fesquet, “Le Monde” del 10 luglio 1978 ha pubblicato questo testo di Monsignor Guy-Marie Riobé, vescovo di Orléans (membro dell’Union fondata da Charles de Foucauld). Otto giorni prima della sua morte.
Quando potremo allora, liberati dalle nostre formule esangui e dalle nostre astrazioni, confessare la nostra fede nello Spirito Santo con una parola capace di andare da cuore a cuore, come una fiamma ne chiama un’altra?
Credere nello Spirito, è credere nella vita, è credere che ogni vita avrà in Lui, definitivamente, vittoriosamente, l’ultima parola su tutte le fatalità di disgregazione, di immobilismo e di morte.
Credere nello Spirito, è credere nella storia come storia di salvezza, storia di liberazione dell’uomo, di tutti gli uomini. Credo allo Spirito Santo non come ad una porta aperta per evadere, ma come alla sola speranza che possa, in definitiva, animare la storia degli uomini.
Credo nello Spirito che anima oggi le grandi spinte di liberazione che tendono verso una universalità umana concreta, diversa, capace quindi di comunione fatta attraverso l’uguale dignità e il libero incontro dell’uomo e della donna, delle etnie, delle culture.
Credo nello Spirito che vibra nelle grida del Terzo Mondo come un appello alla condivisione dei beni della terra, al rispetto dei popoli a lungo disprezzati, al dialogo delle civiltà riconosciute nelle loro differenze e nella loro originalità.
Ogni uomo è mio fratello perché siamo tutti figli di uno stesso amore. Ogni uomo è sacro per me perché ogni uomo è figlio di Dio. E Credo nello Spirito che nello stesso tempo fa crescere nei nostri paesi, in maniera talvolta selvaggia, sconcertante, una grande sete di senso.
È fuori dalle nostre Chiese, lo so, che molti uomini cercano quel Dio d’amore che solo lo Spirito può farci conoscere ed amare. Mi dispiace, ma li capisco. Tutte le istituzioni, tutti i segni, anche i più sacri, si degradano se non accettano ad ogni primavera di cambiar pelle, a qualsiasi costo, anche a costo di accettare lacerazioni e sofferenze. Le nostre comunità, come tutte le istituzioni, non sfuggono al tempo e alla sua usura.
La Chiesa, in diversi momenti della sua storia, ha avuto paura dello Spirito, ha smesso di essere mistica e creatrice per diventare giuridica e moralizzatrice. Allora le burrasche dello Spirito hanno soffiato alla sua periferia e a volte contro di lei in una grande esigenza di vita creatrice, di giustizia e di bellezza. “Ci sono atei che grondano parola di Dio”, diceva Péguy, ed è tuttora vero.
Credo che Dio ci accompagni tutti nella nostra avventura umana e che solo la sua presenza sia eterna, e non le strutture, le parole, le immagini che, a poco a poco, nel corso dei secoli, abbiamo adottato per dire a noi stessi la sua presenza tra noi. La nostra Chiesa non ha nulla da temere dalle critiche che le vengono da altri, se sa ascoltarle come un appello di Dio.
Essa non può sprangare le porte per disporre più sicuramente di se stessa. Essa riceve ad ogni istante da Dio per essere continuamente inviata, immersa nel mondo, povera, modesta, fraterna, messaggera di gioia, prestando la sua voce ai poveri, agli uomini che vengono torturati o uccisi, a tutti coloro che ci gridano silenziosamente il Vangelo. È questa per la Chiesa, e per ogni cristiano, la necessità, talvolta l’urgenza, di discernere e di fondare la ragione dei propri atteggiamenti, delle proprie reazioni davanti a tutti i grandi movimenti della storia. Discernere senza spegnere o contristare il libero sgorgare dello Spirito e della vita che suscita.
Così potremo ritrovare l’attualità di quei grandi risvegli umani, venuti dal cuore dell’uomo comedelle pentecoste successive. È Dio che, attraverso tutta quella corrente che chiamiamo profetica, difende la sua opera, impedisce che sia mutilata o paralizzata. In questo, e negli aspetti più quotidiani della vita, c’è un vero dono dello Spirito in tanti veri viventi che non cessano di reinventare l’amore e la gioia profonda di essere. Scaturisce a volte alla superficie della storia, come un Dom Helder Camara, ad esempio. La Chiesa deve di nuovo lasciare che la parola di Dio fecondi la storia.
...
In queste contingenze necessarie, la mia fede cerca sempre al di là. Mi auguro che tra cristiani, di nuovo divisi, possiamo essere capaci di celebrare insieme, nella fede più pura, il nostro amore per Gesù Cristo che superi le nostre dispute di un tempo.
Mi auguro che tra credenti, alla ricerca del nostro unico Dio d’amore, sia possibile riunirci qualche volta, anche se nel silenzio delle nostre preghiere differenti, nell’unità dello stesso e solo Spirito che ci fa gridare Abba, Padre.
Mi auguro che tra uomini possiamo mettere in comune tutte le nostre forze d’amore perché i giovani di domani conoscano la fine dell’ingiustizia e dell’odio
Così sono in comunione con la speranza di tutti coloro che sono convinti che una terra di rispetto, di giustizia, di uguaglianza e di amicizia è possibile.
Mi sento solidale con coloro che ne hanno fatto la lotta della loro vita.
E mi rallegro per il fatto che attualmente molti giovani si siano prefissi il compito di ricostruire questa terra.
Abbiamo tutti appuntamento con questo amore sconosciuto che non possiamo o non osiamo nominare per paura di rinchiuderlo nei limiti del nostro tempo. A età diverse della propria vita, ciascuno lo accoglie e lo dice a modo suo. In momenti diversi del risveglio spirituale dell’uomo, ogni civiltà lo riceve e lo esprime nella propria cultura.
Perché è proprio l’umanità intera che ha appuntamento con Dio: alla sua nascita? In certi momenti della storia? All’apogeo della sua evoluzione? Che importa, è il segreto di Dio, non il mio, ma credo che lui è e sarà presente, in maniera inattesa, agli appuntamenti della storia umana, come è e sarà presente agli appuntamenti di ciascuna delle nostre storie personali. Mi basta ritrovare in questa speranza una gran parte del Vangelo.
È a questo punto che mi ricordo di Gesù di Nazareth. Lo ritrovo oggi nel cuore di tutto questo popolo di cercatori di Dio. Sì, credo che Gesù è vivo, sorgente dello Spirito, che è una persona presente, che può essere amico degli uomini, e che questa amicizia può essere lo scopo di tutta una vita. Essere cristiani, dopo tutto, non è accettare di ricevere se stessi continuamente da Cristo, come ci si riceve da ogni sguardo d’amore? Tutti i giorni, mi sembra di incontrare Cristo per la prima volta.
Mi basta credere che, tornando al Padre dopo la resurrezione, Cristo ci ha reso liberi attraverso il dono del suo Spirito e che ha aperto alla nostra responsabilità, fino a che Egli venga e perché venga, il cantiere della storia.
In questa scia di libertà creatrice, non avremo mai finito di camminare da responsabili davanti a Dio, di imparare a vivere e a morire.
-
> PASQUA IN ARRIVO. ---- SCOPERCHIARE I SEPOLCRI. Le parole del profeta Ezechiele sono queste: «Io apro i vostri sepolcri e vi riconduco nel vostro paese». E’ resurrezione! (di Ernesto Balducci).9 aprile 2011, di Federico La Sala
SCOPERCHIARE I SEPOLCRI
di Ernesto Balducci *
Più vado avanti e più mi rendo conto che le grandi parole, quelle che sono all’altezza dei nostri desideri più profondi, dei nostri concetti pin elevati, sono anche le parole pin fraudolente, portano dentro di loro un’insidia quasi invincibile. Capisco perché nel popolo ebraico c’era la prescrizione di non nominare il nome di Dio. Il nome di Dio è una di queste parole che dovrebbe essere custodita nel silenzio e noi invece ne abbiamo fatto una parola da pronunciare dovunque, a tutti gli usi, a tutti gli scopi. Capisco perché Gesù, spesso, quando parlava della resurrezione o compiva opere mirabili, faceva prescrizione ai suoi di non parlarne a nessuno perché le cose, gli eventi che sono al livello alto, che toccano perciò le fibre più profonde delle nostre attese, possono, nella promiscuità con le altre parole, deturparsi e cambiare senso.
A questa legge appartengono parole come «resurrezione», come «vita» ed io sento che ogni volta che dobbiamo parlarne, dobbiamo con cautela disciogliere questa consegna del silenzio ed impegnarci a capire il perché di questa indecifrabilità, di questa impronunciabilità. Me lo dicevo proprio in questi giorni. Noi gridiamo dai microfoni, dai video, parole che sono di quelle di cui parlavo e che rimbalzando nelle masse, attraverso i mass-media, diventano profane ed equivoche.
Da una parte l’annuncio va gridato, dall’altra va taciuto. Perché questo? Proviamoci intanto a raccogliere il messaggio di oggi che è, come avete ascoltato, il messaggio della resurrezione, il messaggio della vita, di una vita che non conosce la barriera irreparabile della morte. Questo messaggio nasconde in sé una frode. La frode è che noi appoggiamo a questo messaggio tutti i nostri desideri inappagati, le nostre frustrazioni, i nostri punti di vista magari animati dal lievito impuro dell’egoismo. Esso ci da soddisfazione e noi crediamo; però tutto sta a sapere se questa fede non sia un prolungamento in più del nostro egoismo, una nuova frontiera della nostra carnalità o sia autentica fede. Come possiamo risponderci? Intanto rispettiamo le leggi interne di questo messaggio.
La parola «vita», lo sappiamo, in questi tempi rimbalza in ogni ambiente con sensi diversi e con cariche normative diverse. Chi non è per la vita? Tutti sono per la vita e però molti sono per la vita in modo mortale e molti difendono accanitamente la vita spargendo sangue. E’ una parola pericolosa. Io intanto devo prendere atto che la resurrezione di cui si parla in queste pagine è una resurrezione globale che non può essere intesa se non mantenuta nella sua indivisibile unità e globalità. Nella prima lettura si parla di una liberazione di un popolo intero dal sepolcro della sua schiavitù.
Le parole del profeta Ezechiele sono queste: «Io apro i vostri sepolcri e vi riconduco nel vostro paese». E’ resurrezione! Qualcuno direbbe che è politica, in realtà è resurrezione. Anche la politica può produrre resurrezioni. La parola di Dio mi dice che c’è una politica secondo il sepolcro e una secondo la vita. Là dove invece ci si preoccupa di distinguere attentamente una lettura individualistica della resurrezione da quella sociale e politica si cade in una frode, si spezza l’unità del messaggio il quale non può essere ricondotto in modo piatto e ideologico dentro i parametri delle nostre concettualizzazioni, va mantenuto nella sua trascendente ed unitaria realtà. Se non rispetto questa legge non sono più in grado di parlare della resurrezione secondo la prospettiva consueta, quella individuale, che è certo giusta, ma purché non venga scissa dalla totalità. (...)
Il sepolcro non è il nostro sbocco ultimo. Questa verità è certamente motivo di gioia, ma è una verità che non va mai scissa da tutte le altre verità che nell’insieme trascendono il senso particolaristico e si confondono con lo stesso mistero di Dio che è vita e amante della vita e il cui Spirito, come ci è ripetuto, è la forza che spezza i sepolcri.
Nella mia prospettiva di liberazione c’è un punto d’appoggio che è la fede in questa potenza che noi chiamiamo Spirito e che è Dio in quanto agisce nel mondo e che, come spezzò il sepolcro di Cristo fratello nostro, spezzerà i sepolcri delle sue creature. Tuttavia, per entrare in questa certezza senza violarne il mistero, senza appiattirla in funzioni indebite, devo, come dicevo or ora, applicarla all’intero perimetro dove l’impero della morte avanza e ci assale. Questo perimetro è immenso. La dittatura è un sepolcro ed è un sepolcro l’inedia, il vivere senza il necessario ed è morte la solitudine, l’amore senza risposta è morte. La parola morte è una parola sintetica che abbraccia in se tutte le forme in cui l’esistenza è in deficit su se stessa, e vive la parabola del proprio estinguersi, o è ferita in legittime attese.
Vorrei che il termine non rimanesse nell’astratta concettualizzazione e che lo percepiste nella sua multilaterale realtà concreta: siamo accerchiati. La vita ha la stessa dimensione. Dobbiamo stare molto attenti a pronunciare questa parola, che ha l’ampiezza delle speranze possibili dell’uomo, per legittimare i sepolcri, per giustificare i domini, le autorità oppressive, per vincolare le coscienze nel timore. Questa nobiltà di intenzioni, se è solo formale, fa da schermo ad un’operazione di morte. Questo il dramma. (....)
Ci vuole un di più di serietà, di autocontrollo, di spirito critico e quindi ci vuole, come dicevo agli inizi, il rispetto delle grandi parole, dei grandi messaggi. Il rispetto non significa evidentemente lasciarle nel silenzio, lasciarle nella loro intangibile santità, ma significa fare i conti con le esigenze che esse esprimono quando osiamo pronunciarle. Quando osiamo pronunciarle, siamo coinvolti. Non siamo dei predicatori che vanno da un luogo all’altro a dirle, lasciando poi la gente nelle sue tribolazioni appena si è spento il fuoco della momentanea illusione. Ogni volta che le pronunciamo, quelle parole ci coinvolgono. Se io vado tra i poveri a portare una parola di consolazione e poi riparto lasciandoli ai loro guai, cosa ho fatto? Ho manipolato la disponibilità che ha il povero a sperare in un miracolo, ma forse ho contratto un debito di fronte all’umanità e di fronte a Dio.
Sono riflessioni sparse che riconduco ad una conclusione, quella che ci viene proposta poi dal messaggio di oggi; la nostra speranza nella resurrezione deve attraversare l’intero ventaglio dei nostri impegni morali, sociali e politici che caratterizzano la nostra presenza nel mondo di oggi.
Dopo tutto quello che ho detto credo di poter ripetere la parola senza scadere nella frode: noi dobbiamo essere dalla parte della vita, noi dobbiamo dichiarare guerra ai sepolcri e a tutti coloro che li costruiscono e che obbediscono ad una strategia di morte. Io sono convinto - e ogni giorno l’esperienza allarga ed arricchisce la lezione - che ogni volta che noi scegliamo la logica del potere, le sue astute diplomazie che si allargano fino ad acquistare sembianze di umanità e di bontà e legittimiamo l’oppressione di una sola coscienza, il terrorizzare una sola coscienza - fosse pure di un bambino -, noi siamo dalla parte della morte. Questo è tanto più vero oggi, perché il confronto tra due potenze - morte e vita - si è fatto radicale e si è esteso dovunque. Allora abbiamo anche il diritto - se posso dir così - di lasciare illuminare di una Luce il sepolcro personale che abbiamo in prospettiva. Ma questa speranza dobbiamo custodirla nel segreto e nel pudore. Per poterla gridare dobbiamo pagarla attraverso tutti i giorni della nostra vita. Allora possiamo dire: «resusciterò», ma dopo che avremo in concreto lottato contro ogni opera di morte.
 (Gli ultimi tempi - pp. 161-165 - Borla editore)
(Gli ultimi tempi - pp. 161-165 - Borla editore)*
 Di certo accade anche a voi.
Di certo accade anche a voi.
 Ci sono delle parole pronunciate nell’oggi, dei discorsi proclamati nella contemporaneità degli accadimenti, che purtuttavia sanno di muffa: sembrano appartenere ad un mondo passato e risultano aver perso ogni mordente sulla raltà che viviamo.
Ci sono delle parole pronunciate nell’oggi, dei discorsi proclamati nella contemporaneità degli accadimenti, che purtuttavia sanno di muffa: sembrano appartenere ad un mondo passato e risultano aver perso ogni mordente sulla raltà che viviamo.
 Discorsi e parole d’altri tempi, inerti e mute, che non denunciano nulla, nulla annunciano e non mordono né risvegliano le coscienze.
Discorsi e parole d’altri tempi, inerti e mute, che non denunciano nulla, nulla annunciano e non mordono né risvegliano le coscienze.
 Al contrario, capita di leggere parole scritte nel passatoremoto dei tempi e che ciononostante risultano attuali, svelano il segreto delle ipocrisie e risvegliano le coscienze all’urgenza di presenze combattive.
Al contrario, capita di leggere parole scritte nel passatoremoto dei tempi e che ciononostante risultano attuali, svelano il segreto delle ipocrisie e risvegliano le coscienze all’urgenza di presenze combattive.
 E’ il caso di queste parole di padre Balducci, a commento delle letture di domani, quinta domenica di Quaresima.
E’ il caso di queste parole di padre Balducci, a commento delle letture di domani, quinta domenica di Quaresima.
 Ve ne allego una sintesi. Pensate! Questa cose Padre Badlucci le ha dette nel 1986!
Ve ne allego una sintesi. Pensate! Questa cose Padre Badlucci le ha dette nel 1986!
 Buona domenica.
Buona domenica.Aldo [don Antonelli]
-
> PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". Gioacchino invita Benedetto XVI a correre ai ripari ---- ad aprire porte e finestre in Vaticano (di don Enzo Mazzi).22 marzo 2010, di Federico La Sala
-
> Gioacchino invita Benedetto XVI a correre ai ripari ---- Pensare per figure. Dai simboli la forza nascosta del credere (di Maria Bettetini).6 febbraio 2011, di Federico La Sala
Dai simboli la forza nascosta del credere
di Maria Bettetini (Il Sole-24 ore, 30 gennaio 2011 Come gli occhi del cieco nato dell’episodio evangelico, i nostri occhi della mente saranno aperti dal «fango» delle figure, strumento per acquistare la vista dell’intelletto, quindi la comprensione. Così Gioacchino da Fiore, il «calavrese abate Giovacchino, di spirito profetico dotato» del Paradiso dantesco, oggetto da qualche tempo di grande attenzione sia per l’innovativa lettura delle immagini, sia per la più nota visione apocalittica della storia.
Gioacchino è un uomo della Sila, nasce a Celico intorno al 1130, studia ed esercita da notaio a Cosenza e Palermo, viaggia da pellegrino in Terra Santa, si ritira da eremita sulle pendici dell’Etna, entra nell’abbazia benedettina di Corazzo di cui è abate poco più che trentenne. Poi viaggia ancora: l’abbazia di Casamari, nel Lazio, per ottenere l’affiliazione ai cistercensi e per studiare; Roma, le corti di Verona e Palermo, fino a ottenere nel 1189 Jure vetere, una località che chiamerà Fiore e dove fonderà una congregazione di monaci detta florense: perché il fiore è il simbolo della nascita della natura e dello spirito.
La fine giunge a San Martino di Canale intorno ai settant’anni, nel 1202. Fino a quel momento considerato un santo e profeta, spesso consultato dai papi, Gioacchino sarà condannato da un Concilio nel 1215, a causa delle sue posizioni sulla Trinità. Diventerà ispiratore esoterico dei Francescani spirituali, di Dante, forse del Michelangelo della Cappella Sistina, molto amato in Messico e Sudamerica e dai conterranei calabresi, mai santo ufficiale.
Bernard McGinn, nato a New York e studioso del cristianesimo medievale, ha da poco esplorato l’ambiente storico e culturale che circonda Gioacchino e le prime reazioni teologiche al suo pensiero in grandi dottori della Chiesa, Bonaventura da Bagnoregio e Tommaso d’Aquino. McGinn parla di teologia simbolica, anche se il Liber figurarum ha indotto gli studiosi a utilizzare addirittura il termine di teologia figurativa, come si comprende dai testi di Marco Rainini e dagli atti dell’ultimo congresso internazionale di studi gioachimiti.
Il Libro delle figure è infatti una raccolta di immagini non destinate a decorare le pagine come se fossero miniature; nemmeno a meglio spiegare i concetti scritti, come le tavole dei testi scientifici. Sono disegni che presentano un pensiero, senza bisogno della parola scritta, tranne il caso di qualche breve didascalia, un pensiero teologico detto per immagini, grazie a una visione di un mondo in cui tutto è collegato e concatenato, senza soluzioni di continuità.
L’universo di Gioacchino è una macchina perfetta, contenuta nella Rivelazione così come nelle sue parti. Le ere del mondo corrispondono a quelle della vita umana, alle sezioni dell’anno liturgico, alle persone della Trinità, e alla parola e al segno della mano dell’uomo. Pertanto è opportuno disegnare una figura delle cose dette, da porre davanti agli occhi della carne, affinché «gli occhi della mente, al di fuori del fango apposto, si aprano alla conoscenza».
 Bernard McGinn, l’abate calabrese. gioacchino da fiore nella storia del pensiero occidentale, Marietti 1820, Genova - Milano pagg. 266|€ 23,00
Bernard McGinn, l’abate calabrese. gioacchino da fiore nella storia del pensiero occidentale, Marietti 1820, Genova - Milano pagg. 266|€ 23,00 pensare per figure. diagrammi e simboli in gioacchino da fiore
pensare per figure. diagrammi e simboli in gioacchino da fiore
 a cura di Alessandro Ghisalberti
a cura di Alessandro Ghisalberti
 Atti del VII congresso internazionale di studi gioachimiti, Viella, Roma pagg. 376|€ 40,00
Atti del VII congresso internazionale di studi gioachimiti, Viella, Roma pagg. 376|€ 40,00
-
-
> PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". ---- VUOTO DELLA POLITICA E PALINGENESI: "REINVENTARE LA VITA" (di Enzo Mazzi).15 gennaio 2010, di Federico La Sala
Il vuoto della politica
di Enzo Mazzi (il manifesto, 15 gennaio 2010)
Vale anche per i fatti di Rosarno l’affermazione di Luigi Pintor richiamata domenica da Valentino Parlato: la sinistra «non deve vincere domani, ma operare ogni giorno e invadere il campo. Il suo scopo è reinventare la vita in un’era che ce ne sta privando in forme mai viste». Non bastano le denunce e i fiumi di lacrime versate da politici, media, chiese e associazioni. Bisogna «reinventare la vita».
I fatti di Rosarno sono il sintomo di un malessere profondo che soffoca la società ormai a livello mondiale, sono quasi l’ecografia del cancro che divora la vita di tutti noi nell’intimo.
La moderna schiavitù senza regole, lo sfruttamento bestiale degli immigrati e le condizioni inumane di vita che sono loro riservate, il dominio sempre più invadente delle mafie, il nuovo squadrismo in salsa leghista, la politica dominate che fomenta le paure e le xenofobie degli autoctoni, sono realtà da denunciare e contrastare con tutte le poche forze che ci restano in questo sfascio della sinistra di rappresentanza. Ma non basta. Il tema che deve emergere con forza è la reinvenzione della vita, della politica, della economia, della cultura e perché no della religione.
Dall’inferno di Rosarno alla palingenesi? È un sogno impossibile che ci distoglie dalle cose possibili? E quali sono le cose possibili? Non avvertite tutta l’impotenza di denunce, manifestazioni e lacrime? E il vuoto della politica? Non c’è che ripartire dal quotidiano, dall’operare ogni giorno, dall’invasione di campo.
Ormai siamo tutti stranieri a noi stessi. Nella società fondata sul dominio assoluto del danaro siamo tutti neri. È il danaro, nuova divinità, che si è impossessato delle nostre anime e dei nostri corpi e ci ha privato della nostra vita e della stessa terra.
La società del benessere è ridotta a una fortezza assediata. Ma è una illusione alzar mura, installare body scanner, e rovesciar barconi. Il nemico che ci assedia non è l’immigrazione. Siamo noi nemici a noi stessi. La crisi è dentro la struttura stessa della città. Un nuovo umanesimo s’impone. Ma il suo centro non è più la città. Anzi presuppone il crollo delle mura e lo prepara. È la vendetta del sangue di Remo. Il fondamento di un nuovo patto non può che trovarsi nell’essere umano in quanto tale, indipendentemente dal luogo di nascita e dal colore della pelle. Il risveglio di una tale consapevolezza non è né facile né indolore. Ed è qui che si apre uno spazio significativo e caratterizzante non solo per la politica ma per il volontariato e più in generale per l’associazionismo. Purtroppo la strada più facile è quella dell’assistenzialismo. Ma è una strada scivolosa. L’assistenzialismo, comunque rivestito, non crea parità di diritti.
Chi ha a cuore l’obbiettivo dell’affermazione dei diritti di cittadinanza per tutti, come diritto pieno, comprensivo dei diritti sociali, e come diritto inalienabile della persona, non può fare a meno di impegnarsi sia sui tempi brevi della mediazione politica, per raggiungere il raggiungibile, qui e ora, sia sui tempi lunghi della trasformazione culturale, in mezzo alla gente, facendo cose concrete.
E direi che l’associazionismo più che tappar buchi e metter toppe, dovrebbe imboccare più decisamente proprio la strada della trasformazione culturale. Tendere a smontare i paradigmi culturali, ideologici e anche religiosi, che sono all’origine della discriminazione. Con pazienza infinita e con umiltà, senza tirare la pianticella per lo stelo. Ma anche con tanta coerenza e fermezza. Senza vendere mai tutto sul mercato dell’emergenza e senza sacrificare mai tutto sull’altare della mediazione politica. Ha ragione ancora una volta il nostro Pintor: l’utopia della palingenesi è l’unica realtà possibile e la stella polare di un cammino che abbia senso e che dia senso ad ogni più piccolo passo.
-
> PASQUA IN ARRIVO. ---- IL TERZO PARADISO (di Michelangelo Pistoletto)29 marzo 2009, di Federico La Sala
Il Terzo Paradiso (2003)
Che cos’è il Terzo paradiso? E’ la fusione tra il primo ed il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui la vita sulla terra è totalmente regolata dall’intelligenza della natura.
Il secondo è il Paradiso Artificiale, quello sviluppato dall’intelligenza umana attraverso un processo lentissimo che ha raggiunto nel corso degli ultimi secoli una dimensione sempre più invasiva.
Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che continua a crescere degradando e inquinando il pianeta naturale. Il pericolo di una tragica collisione tra queste due sfere è ormai annunciato in ogni modo.
Di fronte all’universale bisogno di sopravvivenza del genere umano si concepisce il progetto globale del Terzo paradiso che consiste nel condurre l’artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l’arte e la cultura a restituire vita alla Terra. Questo non può che realizzarsi attraverso un passaggio evolutivo nel quale l’intelligenza umana trova il modo di sviluppare una creatività responsabile per convivere con l’intelligenza della natura.
Il Terzo paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo passaggio epocale.
Il riferimento biblico non ha finalità religiose, ma è assunto come messaggio per dare senso e forza al concetto di trasformazione sociale responsabile e per motivare un grande ideale che unisca in un solo impegno le arti, le scienze, l’economia, la spiritualità e la politica
----Sull’Autore, in rete, si cfr.:
MICHELANGELO PISTOLETTO (Wikipedia)
-
> PASQUA IN ARRIVO. ---- Papa equivocato o equivoco? ... Sostanzialmente il Papa lamenta di essere stato mal interpretato, come un Berlusconi qualsiasi (di Maria Novella Oppo)..13 marzo 2009, di Federico La Sala
Fronte del video
Papa equivocato o equivoco?
di Maria Novella Oppo (l’Unità, 13.03.2009)
Forse noi atei non devoti eravamo rimasti gli ultimi a credere, anzi a non credere, nel dogma della infallibilità pontificia. Fatto sta che è stato abbastanza scioccante sentire nei tg stralci del documento in cui Benedetto XVI° interviene ancora una volta sulla vicenda dei vescovi paranazisti cui ha tolto la scomunica. Sostanzialmente il Papa lamenta di essere stato mal interpretato, come un Berlusconi qualsiasi. Comunque, la riammissione tra le braccia della Chiesa di negazionisti e altri destrorsi sarebbe stata solo un atto di carità cristiana e in nessun modo una concessione alle loro teorie.
Il papa, insomma, si sarebbe trovato, pure lui, stritolato nel Girmi della comunicazione e costretto a precisazioni e smentite. Ma quello che ci ha lasciato davvero di sasso è il passo in cui Benedetto XVI° lamenta la guerra che gli verrebbe fatta da qualcuno (coi baffi?) dentro il Vaticano stesso. Caspita, stavolta il Papa parla come Veltroni. È già un passo avanti.
-
> PASQUA IN ARRIVO. ---- CITTA DEL VATICANO - Una Curia allo sbando, un Papa chiuso nel suo palazzo e costretto a fronteggiare una bufera che l’Osservatore Romano definisce senza esempi in tempi recenti (di Marco Politi).13 marzo 2009, di Federico La Sala
Dopo lo scontro sui lefebvriani Ratzinger scrive una lettera in cui parla di "odio senza timore" E a 4 anni dall’elezione alza il velo su una crisi cruciale all’interno della Curia Il Papa e la guerra del Vaticano "Ostilità pronte all’attacco" di MARCO POLITI
CITTA DEL VATICANO - Una Curia allo sbando, un Papa chiuso nel suo palazzo e costretto a fronteggiare una bufera che l’Osservatore Romano definisce senza esempi in tempi recenti. E fughe di notizie che l’organo vaticano bolla come "miserande". Quattro anni dopo la sua elezione Benedetto XVI sperimenta una crisi cruciale del suo pontificato. Ferito e solo, ha scritto parole amare ed aspre ai vescovi di tutto il mondo, lamentando che - per la vicenda della scomunica condonata ai quattro vescovi lefebvriani e specie per il caso Williamson - proprio ambienti cattolici gli abbiano mostrato un’"ostilità pronta all’attacco". Persino arrivando a trattarlo, lui dice, con "odio senza timore e riserbo".
C’è qualcosa che traballa nella gestione della Curia. Se ne avevano segnali da tempo, ma la rivolta di alcuni grandi episcopati - in Germania, Austria, Francia e Svizzera - contro la decisione papale di graziare i vescovi lefebvriani scomunicati senza ottenere preventivamente una loro leale adesione al concilio Vaticano II, ha messo in luce una disfunzione più generale. Per due volte decisioni papali, che attendevano di essere rese note attraverso la sala stampa, sono state fatte filtrare all’esterno in anticipo causando clamore e polemiche. È successo con il decreto di revoca delle scomuniche, è capitato di nuovo con le indiscrezioni sulla lettera papale ai vescovi. Giovanni Maria Vian, direttore dell’Osservatore, fustiga in un corsivo le "manipolazioni e strumentalizzazioni" anche all’interno della Curia romana, ammonendo che la Curia è "organismo storicamente collegiale e che nella Chiesa ha un dovere di esemplarità".
Sferzata inedita e dura a chi nel palazzo apostolico non si è attenuto alla linea del riserbo e dell’obbedienza. Ma l’impaccio e le disfunzioni della macchina curiale vanno al di là della vicenda lefebvriana.
Benedetto XVI è solo. Ma non perché ci sia un partito che gli rema contro. Bensì per il suo di governo solitario, che non fa leva sulla consultazione e non presta attenzione ai segnali che vengono dall’esterno. Meno che mai quando provengono dal mondo dei media, considerato a priori con sospetto. "Benché sia stato più di un ventennio in Vaticano al tempo in cui era prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede - spiega off record un monsignore - Ratzinger non conosce affatto la Curia. Era chiuso ieri nella sua stanza nell’ex Sant’Uffizio ed è chiuso oggi nel suo studio da papa. Lui è un teologo, non è un uomo di governo. Passa metà della giornata a occuparsi dei problemi della Chiesa e l’altra metà concentrato sui suoi scritti: sul secondo volume dedicato a Gesù". Monsignore si ferma e soggiunge: "Non è detto che un grande teologo abbia con precisione il polso della realtà così come è".
Certo, esiste in Curia un pugno di fedelissimi. Il cardinale Bertone in primis. O il suo successore alla Congregazione per la Dottrina della fede, Levada. O il nuovo responsabile del dicastero del Culto divino, lo spagnolo Canizares. Parlano il suo stesso linguaggio i cardinali Grocholewski, responsabile del dicastero dell’Educazione cattolica, o Rodè, titolare della Congregazione dei religiosi. E fra i presidenti delle conferenze episcopali è in prima a linea a solidarizzare con il pontefice il cardinale Bagnasco, che prontamente ieri ha espresso "gratitudine" per le chiarificazioni del Papa. Ma la fedeltà non basta. "Ciò che si avverte - spiega un altro frequentatore dei sacri palazzi - è l’assenza di una guida lineare della macchina curiale". Macchina complessa, che va condotta con mano ferma dal Papa, dai suoi segretari di Stato e qualche volta da alcuni segretari particolari molto attivi dietro le quinte: come Capovilla per Giovanni XXIII, Macchi per Paolo VI, Dziwisz per Giovanni Paolo II.
Mons. Gaenswein, ed è un suo pregio caratteriale, non ama giocare a fare il braccio destro (occulto) del Papa. Ma contemporaneamente pesa il fatto che larga parte della macchina curiale non riconosce il Segretario di Stato Bertone come "uno dei suoi". Bertone non viene dalla diplomazia pontificia. Non ha fatto la trafila dei monsignori che hanno cominciato da minutanti in un ufficio della Curia e poi sono saliti crescendo nella rete di contatti, passando magari attraverso l’esperienza di un paio di nunziature all’estero. Bertone è un outsider. Scelto da Ratzinger perché suo primo collaboratore al Sant’Uffizio e perché di provata sintonia e fedeltà. Ma alla fin fine il mondo curiale non si sente sulla stessa lunghezza d’onda con il "salesiano".
Non è una posizione facile la sua. Da un lato finisce per essere in qualche modo separato dalla macchina curiale, dall’altro non può influire sulla direzione di marcia che di volta in volta Benedetto XVI intraprende. Abile nel controllare e riparare i danni, quando si verificano, il Segretario di Stato può tuttavia intervenire soltanto dopo. Perché in ultima analisi Ratzinger si esercita in uno stile di monarca solitario. Nella lettera ai vescovi il Papa riconosce che portata e limiti del suo decreto sui vescovi lefebvriani non siano stati "illustrati in modo sufficientemente chiaro" al momento della pubblicazione. Adesso finalmente la commissione Ecclesia Dei, guidata dal cardinale Castrillon Hoyos (fino a ieri titolare esclusivo dei negoziati con la Fraternità Pio X), verrà inquadrata nel lavoro della Congregazione per la Dottrina della fede e in tal modo - garantisce il Papa - nelle decisioni da prendere sulle trattative con i lefebvriani verranno coinvolti i cardinali capi-dicastero vaticani e i rappresentanti dell’episcopato mondiale partecipanti alle riunioni plenarie dell’ex Sant’Uffizio.
Il rimedio adottato ora rappresenta la confessione che Benedetto XVI nella vicenda non ha coinvolto nessuno, non ha informato nessuno e ha lasciato mano libera al cardinale Castrillon Hoyos, che non lo ha nemmeno informato esaurientemente sui trascorsi negazionisti di Williams, noti da più di un anno per la loro impudenza. I filo-lefebvriani di Curia in questa partita hanno giocato spregiudicatamente la carta delle indiscrezioni per dare per scontato un riavvicinamento ancora tutto da costruire. "Papa Ratzinger - confida un vescovo che ben conosce il sacro palazzo - è stato in fondo generoso nell’assumersi ogni responsabilità senza dare la colpa a nessun collaboratore. Ma nel suo modo di governare c’è un problema: parte sempre dall’assunto che quando è stabilita la verità di una linea, allora si deve andare avanti e basta. Non mette in conto le conseguenze esterne del suo ruolino di marcia e nella sua psicologia non crede nemmeno che gli uomini di Curia siano all’altezza di dargli veri consigli".
Non è casuale allora che siano stati i grandi episcopati d’Europa e del Canada a ribellarsi all’idea che con l’improvvisa mano tesa ai lefebvriani apparisse annacquata l’indispensabile fedeltà della Chiesa contemporanea ai principi del Vaticano II. Persino un intimo di Ratzinger come il cardinale di Vienna Schoenborn è stato costretto a denunciare le "insufficienti procedure di comunicazione nel Vaticano". Un modo elegante per evitare di criticare direttamente il Papa. Ma proprio in Austria si è giocato un altro evento senza precedenti nella storia dei pontificati moderni. Un vescovo ausiliare scelto dal pontefice è stato respinto dall’episcopato intero di una nazione, costringendo Benedetto XVI a un’ennesima marcia indietro.
Questo gli uomini di Curia non l’avevano mai visto.
* la Repubblica, 13 marzo 2009
-
> PASQUA IN ARRIVO. IL TERZO SARA’ REGNO DELLO SPIRITO SANTO: "TERTIUS IN CHARITATE". ---- «8 marzo: una bambina, una donna, senza chiesa» (Brasile. Riflessione della Comunità “Evangelho è Vida” del Bairro Rio Vermelho di Goiás - a cura di Paolo Farinella, prete).8 marzo 2009, di Federico La Sala
«8 marzo: una bambina, una donna, senza chiesa»
a cura di Paolo Farinella, prete
Ricevo dagli amici della Comunità “Evangelho è Vida” del Bairro Rio Vermelho di Goiás (Brasile), datata «Giorno per giorno» 6 marzo 2009, questa amara riflessione sulla bambina di 9 anni violata e il vescovo spietato. Ve la comunico senza commenti come antidoto alla stupidaggine dell’8 marzo, un altro inganno per le donne che ci cascano anche. Il titolo in cima è mio. (Paolo Farinella)
Carissimi,
“Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna” (Mt 5, 20-22). Parole severe quelle di Gesù. Non dissimili da quelle di alcuni maestri del suo tempo, che ricordavano: il comandamento è di non spargere il sangue, ora, chiunque umilia il suo prossimo, chiunque lo fa arrossire di vergogna, è come se ne spargesse il sangue, è perciò lui stesso omicida.
La mattina, alla preghiera, noi non siamo molti, sei, sette, otto persone al massimo. Che oggi, quando, in apertura, si è fatta la memoria della vita, erano tutte, tra lo smarrito e l’indignato. Perché noi non siamo abituati a pastori così. Come quello che è entrato, alla stregua di un carro armato, in una storia, già di per sé fin troppo dolorosa, triste e drammatica.
La storia parla di una bambina di nove anni che, assieme alla sorella quattordicenne (handicappata psichica), era costretta da tre anni a subire le violenze del giovane patrigno. Tali violenze si sono tradotte negli ultimi tempi in una gravidanza gemellare per la bambina più piccola, un fuscello di trentasettechili di peso. Che sua madre, il giorno in cui questa accusa forti dolori al ventre, porta in ospedale a Recife. E lì viene fuori la verità, amarissima. Con tutto ciò che ne segue. L’arresto del patrigno e la decisione di interrompere la gestazione della bimba.
La storia potrebbe anche chiudersi qui, con in più, soltanto, il rispetto, il silenzio, l’abbraccio umano di quanti sono ancora capaci di voler bene. Tra cui, sperabilmente la gente di chiesa. Per alleviare, se mai fosse possibile, l’eccesso del dolore. E invece. Invece arriva fuori lui, il pastore, che da Gesù dovrebbe aver imparato il primato della misericordia, l’invito a non giudicare, la generosità fino al dono della vita. Ma che, sfortunatamente, “mica tutti ne sono capaci”. E così lui sale in cattedra, non sia mai per denunciare i potenti, ma per umiliare e schiacciare i poveri e chi si è fatto toccare dall’enormità della loro sofferenza. E scomunica quanti, per altro, hanno agito nel rispetto della legge: la direzione dell’ospedale dove si è svolto l’intervento, l’equipe medica che lo ha realizzato, la madre che lo ha autorizzato. La bambina non ha invece potuto formalmente scomunicarla, ma solo perché è minorenne.
Fosse stato per lui, chissà! Del resto lui è lo stesso “pastore” inviato nel 1985 all’archidiocesi di Olinda e Recife, per sostituire dom Helder Câmara, normalizzare quella chiesa, demolire sistematicamente il lavoro pastorale del profetico arcivescovo dei poveri.
Il medico che ha coordinato l’intervento, il dott. Rivaldo Mendes de Albuquerque, cattolico, ha dichiarato: “Non riceviamo un solo centesimo per questo tipo di operazioni. Lo facciamo per il rispetto che una donna (in questo caso una bambina!) vittima di violenza merita, e che l’arcivescovo, sfortunatamente, tratta senza nessuna misericordia. È curioso che chi ci ha condannato alla scomunica non ha proferito una sola parola diretta all’uomo che ha stuprato questa bambina. Per dom José Cardoso Sobrinho, l’unica cosa che conta è il Diritto Canonico. Gli manca il cuore. Ho compassione del nostro arcivescovo, che non ha saputo essere misericordioso con una bambina innocente”.
Ha ragione il dott. Rivaldo: non smarrimento, non indignazione, solo compassione. Chissà che domani, salendo all’altare quel vescovo riesca a ricordare la frase di Gesù: “Se presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono” (Mt 5, 23-24), e magari, tutto paramentato, vada a cercare quella madre e le sue bimbe, e gli si inginocchi davanti e chieda loro perdono. Per intanto facciamolo noi, ci sarà rimasto qualche cristiano nella chiesa di Olinda e Recife, vero?
Il Postino della Comunità del Bairro