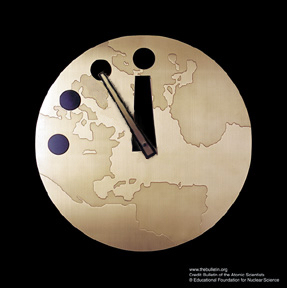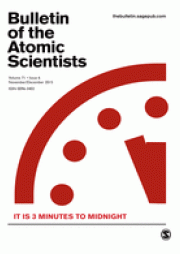
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA, DANTESCA, KANTIANA, E MARXIANA - a cura del prof. Federico La Sala
|
L’orologio dell’Apocalisse |
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. Commento apocalyptico di scuola gioachimita, dantesca, kantiana, e marxiana
 Roma soggiogò la Grecia,
Roma soggiogò la Grecia,
 la Grecia soggiogò Troia,
la Grecia soggiogò Troia,
 ma Troia soggiogò la Grecia,
ma Troia soggiogò la Grecia,
 soggiogò Roma,
soggiogò Roma,
 e tutta la Terra.
e tutta la Terra.
 Non sarà niente di previsto!
Non sarà niente di previsto!
 Hitler, il Vietnam saranno niente a confronto.
Hitler, il Vietnam saranno niente a confronto.
 La violenza subita e immagazzinata da secoli
La violenza subita e immagazzinata da secoli
 nel nostro corpo - terrestre!,
nel nostro corpo - terrestre!,
 tenuta a bada da catene sempre più solide,
tenuta a bada da catene sempre più solide,
 infine eromperà.
infine eromperà.
 L’inimmaginabile!
L’inimmaginabile!
 Chi sogna l’età dell’oro? Chi dello Spirito?
Chi sogna l’età dell’oro? Chi dello Spirito?
 Occorre prima liberare la bestia legata
Occorre prima liberare la bestia legata
 nel buio sotterraneo della storia.
nel buio sotterraneo della storia.
 Quale follia tenerla in eterno legata
Quale follia tenerla in eterno legata
 nel più profondo degli abissi.
nel più profondo degli abissi.
 Esploderà e disintegrerà l’universo dal più profondo ...
Esploderà e disintegrerà l’universo dal più profondo ...
 fino all’Altissimo.
fino all’Altissimo.
 Nessuna maschera servirà più. La follia esploderà
Nessuna maschera servirà più. La follia esploderà
 immensa.
immensa.
 Solo allora e solo allora l’alba di un nuovo giorno.
Solo allora e solo allora l’alba di un nuovo giorno.
 BRUCERANNO DIECIMILA TROIA.
BRUCERANNO DIECIMILA TROIA.
 E NON SARANNO STATI I GRECI A DARLE FUOCO.
E NON SARANNO STATI I GRECI A DARLE FUOCO.
 Quasi-Sole sarà la Terra. Nessuno potrà nascondersi.
Quasi-Sole sarà la Terra. Nessuno potrà nascondersi.
 Le fiamme arderanno e bruceranno tutte
Le fiamme arderanno e bruceranno tutte
 le miserie dei millenni.
le miserie dei millenni.
 Il calore fonderà un altro essere.
Il calore fonderà un altro essere.
 Un oltre
essere umano allieterà la Terra.
Un oltre
essere umano allieterà la Terra.
 Chi riuscirà a traversare il fuoco?
Chi riuscirà a traversare il fuoco?
 Chi si lascerà traversare dal fuoco?
Chi si lascerà traversare dal fuoco?
 Una freccia di fuoco illumina il mondo.
Una freccia di fuoco illumina il mondo.
 Virgilio, Gioacchino, Francesco...
Virgilio, Gioacchino, Francesco...
 Dante ha già capito ed è andato oltre.
Dante ha già capito ed è andato oltre.
 Oltre la preistoria, oltre la tragedia.
Oltre la preistoria, oltre la tragedia.
Federico La Sala (1977)
|
Cometa McNaught |
- QUADRO GENERALE. Carta di Laura Canali, 2016: IL NUCLEARE NEL MONDO
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- CONTRATTO ORIGINARIO E PACE PERPETUA: "Primo articolo definitivo per la pace perpetua: «La costituzione civile di ogni Stato dev’essere repubblicana».
- La costituzione fondata: 1) sul principio della libertà dei membri di una società (come uomini); 2) sul principio della dipendenza di tutti da un’unica comune legislazione (come sudditi); 3) sulla legge dell’uguaglianza di tutti (come cittadini) - e, cioè l’unica costituzione che derivi dall’idea del contratto originario, sul quale la legislazione di ogni popolo deve fondarsi - è la costituzione repubblicana (I. Kant, Per la pace perpetua. Un progetto filosofico, 1795).
- GUARDARE IN BOCCA A CAVAL DONATO!!! MITO E STORIA. All’origine della tradizione europea, c’è la guerra di Troia e, per comprendere la guerra di Troia, c’è da ricordare Elena e "il giudizio di Paride": la mela d’oro di Eris (dea della discordia), con l’iscrizione "alla più bella", è consegnata da Paride non ad Era, né ad Atena, ma ad Afrodite, e Afrodite "regala" Elena a Paride. A questo "dono", c’è da collegare l’altra e complementare tradizione, quella biblica, altrettanto a fondamento della tradizione europea: la "donazione" da parte di Dio di Eva ad Adamo e di Eva che dà la "mela" ad Adamo!!!
- QUESTO "NODO" MITICO non sollecita, forse, a meglio riflettere sulla nostra umanissima vicenda e sulla sua più che tragica situazione?! Non sollecita, forse, ad uscire da questo vecchio (ormai "delirante") orizzonte "preistorico", troiano e biblico?!
- Se non si vuol fare la fine di Troia... è meglio, forse, cercare di guardare in bocca a ogni cavallo che ci vien donato, e uscire - come consigliava G. Bateson, in una sua riflessione del 1967 - dalla logica "dialettica" della "liberazione":
- "Noi abbiamo bisogno di capire i lati patologici e peculiari dell’intero sistema romano-palestinese. Questo è ciò di cui mi interessa parlare [...] considerare la dinamica di tutto il processo patologico tradizionale in cui siamo ancora irretiti e in cui rimarremo presi fintanto che continueremo a lottare all’interno di quell’antico conflitto; ci dibattiamo ancora nei termini delle vecchie premesse"(Gregory Bateson, "L’azione umana contro l’equilibrio naturale", in: Aa.Vv.: "Dialettica della liberazione", Torino, Einaudi, 1969)!?. FLS
- GREGORY BATESON E IL PROBLEMA DEL "NOSTRO SISTEMA GLOBALE": "Dice il proverbio che quelli che abitano in una casa di vetro, soprattutto se vi abitano con altri, dovrebbero pensarci bene prima di tirarsi dei sassi; e penso che sia opportuno ricordare a tutti gli occidentali che leggeranno questo saggio che essi vivono in una casa di vetro insieme con la professione medica, con la religione cristiana, con la rivoluzione industriale e con il sistema educativo di cui gli altri sono un prodotto. In altre parole, noi tutti abbiamo in comune un groviglio di presupposizioni, molte delle quali hanno origini antiche. A mio parere, i nostri guai affondano le radici in questo groviglio di presupposizioni, molte delle quali sono insensate. Invece di puntare il dito contro questa o quella parte del nostro sistema globale (i dottori malvagi, gli industriali malvagi, i professori malvagi), dovremmo esaminare le basi e la natura del sistema"(G. Bateson, "Sintomi, sindromi e sistemi", 1978), in Una sacra unità. Altri passi verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 1997, pp. 439).
- "Che i dominanti non si pentano d’aver lasciato le folle in uno stato di ignoranza e di ferocia quali sono adesso!" (Antonio Gramsci, Scritti politici 1910-1926)).
 PIANETA TERRA. ONU: Sevem Suzuki la ragazzina che zitti il mondo per 6 minuti (1992) (YouTube)
PIANETA TERRA. ONU: Sevem Suzuki la ragazzina che zitti il mondo per 6 minuti (1992) (YouTube)
 RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO"...
RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO"...
- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).
- I. Kant, "Idea per una storia universale in un intento cosmopolitico" (trad. di Maria C. Pievatolo).
FLS
Forum
-
> TROIA, L’OCCIDENTE ---- IL POMO DELLA DISCORDIA, IL GIUDIZIO DI PARIDE, L’AMORE COSMOGONICO DI DANTE, E UNA OPERAZIONE (1+1=1) EDIPICA DA RISOLVERE.10 gennaio 2024, di Federico La Sala
MITO, ANTROPOLOGIA, STORIA, LETTERATURA, E STORIOGRAFIA: IL POMO DELLA DISCORDIA...
LA TERRA, L’AMORE COSMOGONICO DI DANTE ALIGHIERI, IL "CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI" DI ITALO CALVINO, E LA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO" DEI "DUE SOLI".
- RITORNO AL FUTURO, 11. IN MEMORIA DI OVIDIO E DI VIRGILIO...
- Una nota a margine di una riflessione su "LA TERRA SPOSATA O LE DISAVVENTURE DI EROS", proposta dal prof. Flavio Piero Cuniberto.
UNA QUESTIONE "COSMICOMICA", A QUANTO PARE, SEGNATA DALLA "#PAURA" (E DALLA CONSEGUENTE "CADUTA" in una "SELVA OSCURA", in uno"stato di minorità" ) E’ DIVENTATA "BIBLICAMENTE" COSMOTRAGICA: ""Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto" (Gn "3, 8").
Probabilmente, aveva ragione #GiordanoBruno nell’avanzare la teoria che si trattava di un tempo "fuori dai cardini", che era un problema di ordine cosmico, di riforma cosmologica ("Lo spaccio della bestia trionfante") e dopo, al contempo, #Lessing, nel porre all’ordine del giorno la questione di #educazione del genere umano.
Kant, da parte sua, riprendendo il discorso e riannodando insieme il "cielo stellato" e la "legge morale", dice che è soprattutto una questione di maturità, e a chi non vuole sentire ragioni, risponde con determinazione, con e come #Orazio: "#sàpere aude!" (risolviti ad assaggiare"), esci dal tuo personale "stato di minorità", e fà un buon uso della tua propria facoltà di giudizio, senza avere di nuovo e ancora paura: "Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Ecco ciò che è tuo!".(Mt. 24-25).
FORSE "LA TAVERNA DEI DESTINI INCROCIATI" (CALVINO) E I "DUE SERPENTI" DEL #CADUCEO (DI ERMES/MERCURIO), con i DUE SOLI di Dante Alighieri, ripensati con "IL #MULINO DI AMLETO" (di Giorgio Diaz de Santillana e Hertha von Dechend), e, non ultimo, con lo stesso "AMLETO" (di William #Shakespeare), possono aiutare a focalizzare meglio l’orizzonte spazio-temporale cosmico e le "regole del gioco" entro cui si danno "le disavventure di Eros".
DA considerare e non dimenticare che la memoria di #Demetra -#Cerere (Eleusi) è più viva che mai (se pure in gran pericolo) e che le sue "disavventure" sono iniziate proprio da un intervento voluto da #Afrodite-#Venere e da #Eros - #Cupìdo che, come ha ben visto Dante, ha un suo orrizzonte cosmicomico: "è l’amore che muove il sole e le altre stelle".
NOTA
- ARCHEOLOGIA ICONOGRAFIA E FILOLOGIA: IL POMO DELLA DISCORDIA. Nel "Giudizio di Paride" (https://it.wikipedia.org/wiki/Giudizio_di_Paride ), nella rappresentazione fattane nellla società etrusca e ritrovata in una tomba a Cerveteri, all’interno della sequenza in cui "Paride riceve Hermes che guida Atena, Era e Afrodite, 560-550 AC."), degna di particolare attenzione è l’immagine dell’asta in mano ad Hermes con al vertice un toro (allusione al "vitello d’oro"?) e la figura di Afrodite, con in mano un ramo di pianta di melograno (che "disegna" con molta approssimazione la figura della "Menorah", il candelabro con sette bracci della tradizione religiosa ebraica).
#Eleusis2023 #Buon2024...
ALL’ORIGINE DELLA "GUERRA DI TROIA", LA STESSA "STORIA" DEL "GIOCASTOLAIO" EDIPO:
- PARIDE. Figlio di Priamo e di Ecuba, detto anche Alessandro.
- La sua nascita fu accompagnata da un prodigio: la madre sognò, prima di metterlo al mondo, di dare alla luce una torcia. Esaco, altro figlio di Priamo, interpretando il sogno, predisse che il nascituro avrebbe causato la rovina di Troia e consigliò di metterlo a morte. Fu invece esposto sul monte Ida e poté sopravvivere, a seconda delle tradizioni, o perché raccolto dai pastori, o perché nutrito da un’orsa e poi ritrovato da Agelao.
- Divenuto grande, accadde che un servo di Priamo fosse incaricato di portar via un toro dal branco custodito dallo stesso P., da assegnare come premio al vincitore dei giochi indetti per onorare la memoria del figlio ormai creduto morto. P. seguì il servo, partecipò ai giochi e vinse, riottenendo, dopo il riconoscimento, il posto che gli competeva nella casa del padre. Avvenne poi che durante le nozze di Tetide e Peleo, mentre tutti gli dei erano riuniti in assemblea, Eride, la dea della discordia, lanciò un pomo destinato alla più bella tra Atena, Era e Afrodite.
- Zeus si rifiutò di decidere e incaricò Ermete di condurre le tre dee sul monte Ida, eleggendo ad arbitro della contesa P. che aggiudicò il pomo ad Afrodite, che gli aveva promesso di fargli sposare la donna più bella del mondo, suscitando così contro i Troiani l’odio di Era e di Atena, che gli avevano promesso rispettivamente potenza e sapienza.
- Successivamente P. fu ospite a Sparta (o secondo altri ad Argo) di Menelao, al quale rapì, con l’aiuto di Afrodite, la consorte Elena, provocando così la spedizione contro Troia, decisa dai due Atridi per vendicare l’oltraggio subito da Menelao.[...]" (Cfr. Antonio Martina, "Paride", Enciclopedia Dantesca, Treccani)
MATEMATICA, ANTROPOLOGIA, E ARCHEOLOGIA FILOLOGICA E FILOSOFICA: 1+1=1.....
- RITORNO AL FUTURO, 12. IN MEMORIA DI GIAMBATTISTA VICO, DI JEAN-JACQUES ROUSSEAU, E DI ENZO PACI...
DA UNA ENCICLOPEDICA "VOCE " DI "DONNA": "[...] Un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, 1979),
UNA #HAMLET-ICA #DOMANDA. CHI HA SCRITTO il "#Discorso sull’origine e i fondamenti dell’#ineguaglianza tra gli uomini" ("Discours sur l’origine et les fondements de l’#inégalité parmi les hommes")?
NON è il "caso" di ripensare il "Problema Jean-Jacques #Rousseau" e interrogarsi di nuovo e ancora su "#comenasconoibambini" (come da sollecitazione di un protagonista della "#ScuoladiMilano", #EnzoPaci, che ben conosceva l’opera del napoletano #GiambattistaVico) e dare il via a una "#ScienzaNuova"?
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA, ECOLOGICA E COSMOLOGICA: LA POTENZA POETICA DEGLI AILANTI E LO "SCUDO DI ACHILLE" (OMERO).12 ottobre 2023, di Federico La Sala
LA POTENZA POETICA DEGLI AILANTI ILLUMINA L’ORIZZONTE DELLA “PREISTORIA” (MARX) E SOLLECITA A SVEGLIARSI DAL “SONNO DOGMATICO”: ANTROPOLOGIA, ECOLOGIA, E “STORIA UNIVERSALE DELLA NATURA E TEORIA DEL CIELO” (KANT)!
- “L’epochè degli ailanti. Terza natura e democrazia del vivente”. Una nota a margine dell’articolato e complesso contributo proposto da Italo Testa in “”Ecologia e lavoro. Dialoghi interdisciplinari” (Mimesis 2023, pp. 259-275)
RIPRENDENDO IL FILO DALL’INIZIO:
- “Dipendenza vitale. Riflettendo sulla natura del lavoro sociale, Karl Marx aveva messo in luce la dimensione ecologica delle comunità umane, mostrando come il lavoro sia la forma specifica attraverso cui si realizza il ricambio organico (Stoffwechsel), il metabolismo tra società e ambiente naturale[1]. In questa prospettiva la dimensione ecologica non è un elemento ulteriore, che si aggiunga ai concetti classici dell’economia e della politica. L’ecologia non investe meri fenomeni locali o marginali, ma aspetti centrali, costitutivi per la produzione e la riproduzione delle nostre società. Non si tratta quindi solo di una questione attuale, legata alla crisi ecologica in corso, e ai rischi catastrofici connessi - esaurimento delle risorse, inabitabilità del pianeta, inaridimento, innalzamento del livello degli oceani, spillover. La consapevolezza legata agli aspetti di questa crisi porta infatti in luce un implicito, che riguarda anche le civiltà del passato, e che ci tocca oggi in un senso più ampio di quello della mutazione in corso. [...]”
 ( “Le parole e le cose”, 5 ottobre 2023: https://www.leparoleelecose.it/?p=47776),
( “Le parole e le cose”, 5 ottobre 2023: https://www.leparoleelecose.it/?p=47776),
PROPORREI PER MEGLIO “ORIENTARSI NEL PENSIERO” (KANT) E NON PERDERSI NELLA “FORESTA” COSMICA (QUESTIONE COSMOLOGICA), DI SERVIRSI DELLA “MAPPA CONCETTUALE”, PRESENTE NELL’ “ILIADE” DI OMERO, DALLA DESCRIZIONE DELLO “SCUDO DI ACHILLE” (VV. 664-843), UNA “LAVAGNA” DIDATTICA SU CUI IN UNA SINCRONICA SINTESI VISIVA SONO RAPPRESENTATI LE VARIE ARTICOLAZIONI DEL PROBLEMA “ECOLOGICO” , E, AL CONTEMPO, RIAPRIREI LA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, A PARTIRE PROPRIO DAL MARXIANO CONCETTO DEL “LAVORO IN GENERALE”, E, IN PARTICOLAR MODO, DAL CONNESSO CONCETTO DI “RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE IN GENERALE”.
 Sul tema, mi sia lecito, si cfr.:
Sul tema, mi sia lecito, si cfr.:“CHI” SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE, in: Federico La Sala, “L’enigma della Sfinge e il segreto della Piramide. Considerazioni attuali sulla fine della preistoria, in forma di lettera aperta - a Primo Moroni, a Karol Wojtyla, e p. c., a Nelson Mandela, Edizioni Ripostes, Roma-Salerno 2001 (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4198).
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- Ettore L’uomo, l’eroe, raccontato da Rachel Bespaloff (Un estratto da “L’eternità nell’istante”).25 marzo 2023, di Federico La Sala
L’impossibile possibile
Ettore
L’uomo, l’eroe, raccontato da una grande filosofa che ce lo mostra come non lo avevamo mai visto: forte perché debole, eroico perché umano.
di RACHEL BESPALOFF ("LUCY sulla scrittura", 23 Marzo 2023)
Ettore ha subito di tutto, e ha perduto tutto fuorché se stesso. Nella schiera abbastanza mediocre dei figli di Priamo, lui solo è principe, fatto per regnare.
Né superuomo, né semidio, né simile agli dèi, ma uomo, e principe tra gli uomini. A proprio agio in questa nobiltà senza ricercatezza che non deve inorgoglirsi nel rispetto di sé, né umiliarsi nel rispetto degli dèi. Ha molto da perdere perché appagato, e sempre al di sopra di ciò che lo appaga, a causa del suo anelito a sfidare il destino. Protetto da Apollo, protettore d’Ilio, difensore di una città, di una donna, di un bambino, Ettore è il custode di beni perituri. La passione della gloria lo esalta senza accecarlo, lo sostiene quando la speranza lo abbandona.
“Io lo so bene questo dentro l’anima e il cuore: giorno verrà che Ilio sacra perisca”. Ma ha imparato “a esser forte sempre, a combattere in mezzo ai primi Troiani”, tale è il suo privilegio di principe. Per quanto teneramente lo implori, Andromaca non può far sì che egli vi rinunci. E certo, egli è tutt’altro che insensibile al suo lamento. È per Andromaca, più ancora che per il suo popolo, per suo padre e i suoi fratelli, che la preoccupazione del futuro lo attanaglia. La sola idea della sorte brutale che la attende gli fa augurare la morte: “Morto però m’imprigioni la terra su me riversata, prima che io le tue grida, il tuo rapimento conosca”. Alla vigilia della guerra, Ettore abbraccia con un ultimo sguardo i veri beni della vita, all’improvviso esposti nella loro nudità di bersagli. Lo sconforto dell’addio non indebolirà la decisione già presa: “Alla guerra penseran gli uomini”, Ettore per primo tra i nati di Ilio.
- “Ettore è il custode di beni perituri. La passione della gloria lo esalta senza accecarlo, lo sostiene quando la speranza lo abbandona”.
Achille non ha niente da perdere, Ettore ha tutto da perdere. Eppure non è Ettore, ma Achille, sempre pieno d’astio nonostante i suoi trionfi, che non cessa di “saziarsi di pianto”. L’uomo del risentimento, nell’Iliade, non è il debole, ma al contrario l’eroe che ha saputo piegare tutto alla propria forza. In Ettore la volontà di grandezza non contrasta mai la volontà di felicità. Quel poco di vera felicità, che conta più di tutto perché coincide con la verità della vita, meriterà di essere difeso fino al sacrificio della vita stessa, al quale avrà dato misura, forma e valore.
Anche vinto, il coraggio di Ettore non si cancella dinanzi all’eroismo di Achille, nutrito di malcontento e d’irritata inquietudine. Ma la disposizione alla felicità, che ricompensa lo sforzo delle civiltà feconde, frena lo slancio del difensore rendendolo più sensibile all’enormità del sacrificio che esigono gli dèi della guerra. Essa non si sviluppa se non quando si è placato l’appetito di felicità che muove verso la preda l’aggressore più aspro mettendogli nell’animo “una forza infinita di combattere e guerreggiare senza tregua”.
Morire, per Ettore, è abbandonare a una dolorosa distruzione tutto ciò che ama; tirarsi indietro è rinnegare ciò che lo oltrepassa: quella “gloria”, oggetto di un canto futuro, che risusciterà Troia nei secoli a venire. Davanti alle mura dove si appresta a incontrare Achille, scosso da presentimenti di sconfitta, dalle suppliche di Priamo e di Ecuba, Ettore ha un’esitazione suprema. Perché non preservare “la pace nella dignità” promettendo ad Achille il ritorno di Elena, la spartizione di tutte le ricchezze di Troia?
- “L’uomo del risentimento, nell’Iliade, non è il debole, ma al contrario l’eroe che ha saputo piegare tutto alla propria forza”.
Ma subito si riprende: Achille non decide la guerra, è la guerra a decidere. Egli non potrebbe essere ammansito dalle promesse, calmato dai ragionamenti, piegato a sentimenti d’umanità più di quanto potrebbe esserlo un ciclone. “Meglio scagliarsi di nuovo nella lotta al più presto, vediamo a chi dei due darà gloria l’Olimpo”. Per la prima volta, forse, Ettore si sente affidato alla sua sola debolezza. Ma appena scorge l’aitante avversario, non riesce più a controllare il proprio terrore. Lui, l’intrepido, che tante volte ha riportato la vittoria nel suo campo, che si è misurato con Aiace e i più prodi tra gli Achei, “si lasciò dietro le porte e fuggì”. Omero l’ha voluto uomo tutto intero e non gli ha risparmiato il tremore dello spavento, né l’umiliazione della viltà. “Un forte fuggiva davanti e lo inseguiva uno molto più forte”. E questa fuga, per quanto poco duri, si eternizza come un incubo.
- Come uno nel sogno non può arrivare un fuggiasco,
 questi non può sfuggire, l’altro non può arrivarlo;
questi non può sfuggire, l’altro non può arrivarlo;
 così non poteva correndo Achille afferrarlo, né l’altro salvarsi.
così non poteva correndo Achille afferrarlo, né l’altro salvarsi.
Omero qui tocca, attraverso il racconto, l’essenza dell’orrore che non conosce soluzione né redenzione. Non è intorno alle mura di Troia, è nel recinto del Cosmo che l’inseguimento del predatore e la fuga della preda si protraggono indefinitamente. “Tutti gli dèi li guardavano”. Con uno sforzo che dovremmo dire sovrumano - se non fosse la misura e la pienezza dell’umano - Ettore finalmente si domina e affronta il nemico. “Non fuggo più davanti a te, figlio di Peleo, [...] debba io vincere o essere vinto”.
Quel che lui ha fuggito, quel che ora affronta, non è “Achille gigante”, è il proprio destino, l’ora fissata in cui sarà gettato in pasto all’Ade. Per lo meno, non morirà senza aver lottato, né senza gloria. Morendo, implora un’ultima volta Achille di non dare il suo corpo in pasto ai cani. Per l’ultima volta, il vincitore, ebbro di crudeltà, si ostina nel rifiuto. Achille, in quell’istante, è cosciente di non essere più un uomo, e lo confessa: “Non v’è fida alleanza fra uomo e leone [...] così mai potrà darsi che ci amiamo io e te”. Nell’abbandono dell’agonia, Ettore riconosce infine il suo errore, si arrende contemporaneamente alla verità e alla morte: “Va’, io ti conosco guardandoti! Io non potevo persuaderti, no certo, ché in petto hai un cuore di ferro”. Assente Dio, è la fatalità a diventare strumento della retribuzione.
Ettore paga l’uccisione poco gloriosa di Patroclo come Achille, più tardi, pagherà la morte di Ettore. “Ares è imparziale, e uccide chi ha ucciso”. Nell’eccitazione della carneficina, anche Ettore cessa di rispettare il codice dell’onore. Insultare e finire il nemico a terra non gli ripugna più di quanto ripugni al suo rivale. L’uno e l’altro, spingendo la vendetta fino all’empietà, profanano il corpo della vittima per ucciderne persino l’anima. C’è un rigoroso parallelismo tra queste due scene di oltraggio nei confronti del vinto. Patroclo annuncia a Ettore “la morte e il destino invincibile”, come Ettore predice ad Achille la morte “sopra le porte Scee”. La guerra consuma le differenze fino all’umiliazione totale dell’unico; che si chiami Achille o Ettore, il vincitore somiglia a tutti i vincitori, il vinto a tutti i vinti.
Omero non ci risparmia questo spettacolo. E tuttavia l’emulazione guerriera, generatrice dell’energia individuale e delle virtù virili della collettività, rimane ai suoi occhi il principio e la molla dell’azione creatrice. È attraverso di essa che l’amore della gloria si impadronisce degli individui e dei popoli e si trasforma in desiderio d’immortalità. Ma è anche l’orgoglio dell’onnipotenza ad attirare su di sé, ovunque nell’Iliade, le rappresaglie del destino. Al di fuori di ogni sanzione di ordine morale, di ogni imperativo di origine divina, la vendetta della Nemesi antica fa apparire retrospettivamente colpevole l’atto che non rientrava nella categoria di peccato. Nell’istante in cui il Padre degli dèi dispone la sua bilancia d’oro per leggervi la decisione della fatalità, l’Uccisore può compiere la sua missione sacra: è sotto la protezione degli Immortali. Ma appena ha compiuto questa sua missione, ancora padrone della sua forza intatta, egli ridiviene una creatura vulnerabile.
La forza non si riconosce e non gode di se stessa se non nell’abuso in cui abusa di se stessa, nell’eccesso in cui si prodiga. Quel balzo supremo, quella folgorazione omicida in cui il calcolo, la fortuna e la potenza si fanno tutt’uno nello sfidare la condizione umana - in una parola, la bellezza della forza, nessuno (salvo la Bibbia, che la canta e la loda soltanto in Dio) ce la rende più palpabile di Omero. Non è per idealizzare o stilizzare i suoi personaggi che egli celebra la bellezza dei suoi guerrieri: Achille è bello, Ettore è bello, perché la forza è bella, e perché solo la bellezza dell’onnipotenza, divenuta onnipotenza della bellezza, ottiene dall’uomo questo consenso totale alla propria distruzione, al proprio annientamento, quella prosternazione assoluta che lo consegna alla forza nell’atto dell’adorazione.
In tal modo, la forza ci appare nell’Iliade contemporaneamente come la suprema realtà e la suprema illusione dell’esistenza. Omero divinizza in essa la sovrabbondanza di vita che rifulge nello spregio della morte, nell’estasi del sacrificio, e al tempo stesso denuncia la fatalità che la muta in inerzia: quel cieco impulso che la fa giungere fino al punto supremo del proprio sviluppo, fino all’annullamento di se stessa e dei valori che essa ha generato. Per mostrare l’istupidimento che l’illusione dell’onnipotenza produce, Omero non sceglie Achille o Aiace, ma il principe della saggezza. Inebriato da una momentanea vittoria, Ettore perde d’improvviso la facoltà di riflettere, il dono della misura e il senso del limite.
Rifiuta con veemenza i prudenti consigli di Polidamante, che addirittura minaccia di morte accusandolo di avere propositi disfattisti. E, senza dubbio, Polidamante non ha torto quando accusa Ettore di non accettare alcuna contestazione in consiglio così come in guerra: “Certo non bisogna parlare contro di te [...], ma solo il tuo prestigio far crescere”. Dunque, mai l’eroe (nemmeno Achille) si mantiene al di sopra della condizione umana: non c’è nulla in Ettore - coraggio, nobiltà, saggezza - che non sia assoggettato e lordato dalla guerra, niente se non quel rispetto di sé che lo rende uomo, che gli permette di riprendersi di fronte all’ineluttabile, e che gli dona la suprema lucidità nell’istante della morte.
Ettore, quindi, ha perduto tutto fuorché quella gloria il cui racconto “anche ai futuri perverrà”. E questa gloria, per il guerriero di Omero, non è un’illusione ingannevole, una vana ciarla, ma l’equivalente di ciò che rappresenta per i cristiani la redenzione: una certezza d’immortalità, al di là della storia, nel distacco supremo della poesia.
Achille si accanisce sulle spoglie di Ettore. Ogni giorno, fin dall’alba, si dedica ai suoi esercizi di vendetta, trascina tre volte di seguito il corpo del suo sventurato rivale attorno alla tomba di Patroclo e lo lascia là, disteso nella polvere. Il suo insaziabile rancore si scatena contemporaneamente sull’uccisore di Patroclo e sul vinto ormai fuori tiro, che gli richiama l’inutilità della sua vittoria e la morte vicina. Ma se gli dèi hanno tolto tutto a Ettore, non possono né vogliono sottrargli la bellezza che sopravvive alla forza sconfitta. Steso faccia a terra, egli rimane bello - “Apollo teneva lontano ogni sconcio dal corpo”, “i cani li teneva lontani la figlia di Zeus, Afrodite, di giorno e di notte” -, ed è in questa sua bellezza intatta di giovane guerriero morto che sarà restituito a Priamo. Quando questi, prima di incontrare Achille, interroga ansiosamente la sua guida, Ermes lo rassicura:
- E tu, anche adesso, accostandoti,
 vedresti com’è fresco, e il sangue è tutto lavato,
vedresti com’è fresco, e il sangue è tutto lavato,
 non c’è lordura, son chiuse tutte le piaghe
non c’è lordura, son chiuse tutte le piaghe
 quante n’ebbe; molti il bronzo gli affondarono dentro.
quante n’ebbe; molti il bronzo gli affondarono dentro.
 Così hanno cura gli dèi beati del figlio tuo
Così hanno cura gli dèi beati del figlio tuo
 benché morto, perché di cuore lo amavano.
benché morto, perché di cuore lo amavano.
Non è dunque l’ira di Achille, ma il duello di Achille ed Ettore, il confronto tragico dell’eroe della vendetta con l’eroe della resistenza, a costituire il vero motivo centrale dell’Iliade e a comandarne insieme l’unità e lo sviluppo. Nonostante gli dèi e la necessità, resta un barlume sufficiente di libertà perché lo spettacolo non appaia regolato in anticipo ai nostri occhi, né a quelli di Zeus, lo spettatore divino. Seguendo il ritmo dei combattimenti, la foga degli invasori e la vigilanza degli assediati si equilibrano al punto da ricreare senza sosta, in ciascuno degli avversari, l’incertezza del futuro. Ma non per questo Achei e Troiani cessano di valutare, con incerta lucidità, le rispettive fortune, in quella “serie infinita di duelli”, il cui insieme compone la guerra di Troia. Qualunque cosa accada loro, i reucci assalitori non perdono mai la fede nella loro invincibilità, mentre, anche sull’orlo di una vittoria, i principi di Ilio non possono sfuggire al presentimento della sconfitta.
Quando Ettore osa affrontare Achille senza disperare di vincerlo, ha già usato il meglio delle sue energie a vincere se stesso. La missione di Achille è di rinnovare nelle devastazioni le fonti e le risorse dell’energia vitale, quella di Ettore è di salvare, con il dono di sé, il patto sacro la cui salvaguardia garantisce al divenire la sua continuità profonda. Ma è soltanto nell’istante del combattimento decisivo che la maturazione del coraggio fino alla ripresa del pieno controllo in Ettore e l’esaltazione dell’ira fino all’estasi omicida in Achille acquistano il loro vero significato. In questa luce, i destini di Achille e di Ettore si rivelano solidali nella lotta, nella morte e nell’immortalità.
Dove la storia non mostra che baluardi e frontiere, la poesia scopre, al di là dei conflitti, la misteriosa predestinazione che rende degni l’uno dell’altro gli avversari chiamati a un incontro inesorabile. Omero, dunque, non chiede riparazione se non alla poesia, che rapisce alla bellezza riconquistata il segreto della giustizia vietato alla storia. Essa sola restituisce al mondo oscurato la fierezza offuscata dall’orgoglio dei vincitori, dal silenzio dei vinti. Altri se la prendano con Zeus, si stupiscano che egli permetta
- di mettere sullo stesso piano i cattivi e i buoni, quelli il cui animo si volge verso la giustizia e quelli che, obbedendo all’iniquità, si abbandonano alla violenza.
Omero no, non si stupisce né si indigna, e non spera in alcuna risposta. Dove sono, nell’Iliade, i buoni? Dove sono i cattivi? Non si vedono che uomini in affanno, guerrieri in lotta che trionfano o soccombono. La passione per la giustizia non si esprime che nel lutto della giustizia, e nella confessione del silenzio. Condannare o assolvere la forza vorrebbe dire condannare o assolvere la stessa vita. E la vita, nell’Iliade (come nella Bibbia e in Guerra e pace), è essenzialmente ciò che non si lascia giudicare, misurare, condannare o giustificare dal vivente. Non giudica se stessa se non nel prendere coscienza della propria indicibilità.
- “Dove sono, nell’Iliade, i buoni? Dove sono i cattivi? Non si vedono che uomini in affanno, guerrieri in lotta che trionfano o soccombono”.
Questa accettazione senza irrigidimento interiore, consustanziale all’esistenza, resta molto lontana dalle esibizioni stoiche. Figlia dell’amarezza, la filosofia dell’Iliade bandisce il risentimento. Essa è anteriore al divorzio tra natura ed esistenza. Qui, il Tutto non è un montaggio di pezzi rotti e rincollati alla meglio dalla ragione, ma il principio attivo della compenetrazione reciproca di tutti gli elementi che lo compongono. Lo svolgersi dell’inevitabile ha per teatro, insieme, il cuore dell’uomo e il Cosmo. All’eterna cecità della storia si oppone la lucidità creatrice del poeta, che indica alle generazioni future eroi più divini degli dèi, più uomini degli umani.
-
>PER LA PACE PERPETUA. --- CAINO E LO STADIO DELLO SPECCHIO: LA CRITICA DEL "CAPITALISMO COME RELIGIONE" (FRANZ KAFKA, WALTER BENJAMIN, GEORGE GROSZ).6 febbraio 2023, di Federico La Sala
LA CRITICA DEL "CAPITALISMO COME RELIGIONE" (FRANZ KAFKA, WALTER BENJAMIN, GEORGE GROSZ).
- CAINO E LO STADIO DELLO SPECCHIO. Una nota a margine di "Caino o Hitler all’inferno" (George Grosz, 1944).
STORIA E MEMORIA. Nel 1944, nello stesso anno dei militari italiani internati nel Lager di Wietzendorf, George Grosz, nel periodo americano, realizza il quadro "Caino o Hitler all’inferno".
ARTE E LETTERATURA. KAFKA Intorno al 1920, nel commentare un volume con i disegni di Grosz, esprime una opinione precisa sui limiti della teoria del rispecchiamento, della rappresentazione artistica: "Il capitalismo è un sistema di dipendenze: dall’interno verso l’esterno, dall’esterno verso l’interno, dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto. Tutto è dipendente, tutto è concatenato. Il capitalismo è uno stato del mondo e dell’anima." (cfr. G. Janouch, "Colloqui con Kafka", in F. Kafka, «Confessioni e diari», Milano 1972). *
"THE TIME IS OUT OF JOINT" (Shakespeare). Come a dire, ciò di cui "invito" a prendere atto non è tanto il cosiddetto "tramonto dell’#Occidente" (di cui parla Spengler), ma è qualcosa di più radicale, di globale (riguarda tutta la società) ed epocale (riguarda un lungo periodo storico, quasi una "preistoria"); è, per dirla in "sintesi", un orizzonte spazio-temporale che tocca tutto e tutto il genere umano: è un problema biblico, di #caduta.
DISAGIO DELLA CIVILTA’ (S. Freud, 1929). Alla luce della considerazione di Kafka (una traccia di riflessione sul "capitalismo come religione" molto prossima a quella che svilupperà di lì a poco, quasi in contemporanea, Walter Benjamin), l’opera di Grosz del 1944 mostra tutto il suo lato infernale e denuncia il più che millenario #letargo (v. Dante Alighieri) in cui continuiamo a vivere e sognare: il nostro Padre e il nostro Fratello è Caino, il Mentitore, e, Giocasta è la nostra Madre e la nostra Sposa, come Edipo (v. Sigmund Freud).
- Europa 2023: Eleusis 2023).
* La cit. è anche presente nel mio lavoro: si cfr. Federico LA Sala, "Della Terra, brillante colore", 2013, p. 94).
-
>PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- LA MALEDIZIONE DELLA NOCE MOSCATA. INTERVISTA AD AMITAV GOSH (di Edoardo Vigna).30 novembre 2022, di Federico La Sala
Amitav Ghosh: «Tutto è cominciato con il colonialismo, quando iniziammo a far violenza alla Terra»
di Edoardo Vigna (Corriere della Sera / Pianeta20, 30 nov 2022)
Amitav Ghosh, oggi lo scrittore indiano più importante, ha scritto spesso della devastazione della Terra: il fatto di vivere da tanti anni fra New York e la sua Calcutta gli permette di essere anche un osservatore di facce diverse del fenomeno. Nei suoi romanzi (pubblicati in Italia da Neri Pozza) - tra cui la “trilogia dell’oppio” - ha raccontato l’origine del sacco dell’Occidente nei confronti delle ex colonie fra Asia e Africa. Nel nuovo libro, La maledizione della noce moscata, segue la lunga parabola del colonialismo, considerato con la sua furia devastatrice alla base delle conseguenze irreversibili che vediamo oggi sul pianeta rispetto al clima.
Che cosa è la maledizione della noce moscata, e perché l’ha scelta come punto di partenza?
«Avrei potuto scegliere la storia di mille cose diverse che stavano accadendo nello stesso momento. Ma la peculiare storia della noce moscata davvero presentava un’analogia chiara con ciò che avviene oggi. Gli abitanti dell’isola Banda, tra l’Oceano Indiano e il Pacifico, all’inizio del 1600 avevano questa pianta incredibile che ha portato loro ricchezze e prosperità, fino a quando un giorno ha portato il loro sterminio (ad opera degli olandesi della Compagnia delle Indie orientali, ndr). Allo stesso modo, noi abbiamo questo meraviglioso pianeta, che ci ha anche dato ricchezze di tipi diversi. Ma invece abbiamo seguito un modello economico che ci spinge tutti alla distruzione».
Quando ha scoperto quanto accaduto a Banda?
«Ho letto storie sull’Oceano Indiano per molto tempo, sapevo già ciò che era successo là. Ma andare sulle isole e vedere cosa era avvenuto mi ha fatto riunire le idee in forma narrativa».
Lei cita scrittori e filosofi provenienti da culture diverse, libri più o meno noti di epoche differenti, con cui ha costruito un nuovo modo di vedere lo sviluppo storico.
«Tutto ciò a cui pensavo da anni ha preso forma a causa della pandemia. Mia madre era malata e poi è mancata, e così anche i miei suoceri. New York era simile a Milano e Bergamo. A pochi isolati da casa mia c’era un ospedale con camion frigoriferi per le vittime. Uno sconvolgimento mai visto, che però ci stava dicendo qualcosa sul futuro».
Che cosa?
«Ci ha mostrato che gli impatti sul cambiamento climatico, i loro effetti sulla società, saranno assai diversi da ciò che ci è stato detto. La narrazione consolidata, in Occidente, è che la crisi sarà terribile per i più poveri, “non-bianchi”. Invece sarà sì molto negativo per la povera gente, ma colpirà anche i Paesi ricchi, in modi diversi, con effetti altrettanto devastanti. E penso che se c’è una lezione che dobbiamo imparare da questa esperienza è che le megacrisi richiedono una risposta collettiva. Che non si è manifestata ovunque. L’Italia resta una nazione con una cultura comune, una lingua comune: quando è stato chiesto di fare sacrifici, la gente ha risposto. Non così negli Stati Uniti, che hanno avuto pessimi risultati. E tuttora vivono fra disagio sociale, sfiducia e polarizzazione politica. Idem il Regno Unito. In America la società ha una fede enorme nella tecnologia come fonte di salvezza. Pensavano che il vaccino li avrebbe salvati. Ma dopo che il vaccino è diventato disponibile, la diffidenza sociale ha preso il sopravvento, e ancora oggi la sfiducia è il vettore principale».
Lei retrodata la riflessione sul presente al colonialismo, con l’idea che l’imperialismo, con le sue armi, venga prima del capitalismo come causa della devastazione del pianeta.
«Negli ultimi anni, l’intero discorso sul cambiamento climatico è stato focalizzato sul capitalismo come il principale motore del disastro che stiamo attraversando. Certo, c’è molta verità in questo. Ma allo stesso tempo il nostro capitalismo non è nato da sé, è venuto fuori dal colonialismo che lo ha reso possibile. Le disuguaglianze, specie quelle geopolitiche, sono simili a ciò che esisteva nel XVII secolo. Il dominio globale dell’Europa d’allora corrisponde a quello odierno dell’Occidente».
Quale è stato il momento chiave?
«Quello in cui l’Europa ha conquistato le Americhe. Un evento che ha comportato una violenza su una scala mai vista prima, con la soppressione di 80-90 milioni di persone. Quella violenza ha creato una nuova società. Con l’eliminazione di decine di milioni di persone, ma anche con l’idea di sostituirli con africani schiavi. Un intervento demografico su quella scala non era mai avvenuto, mai».
Una riflessione in tal senso su questo argomento non è ancora avvenuta del tutto.
«Da qui la tentazione di attribuire la realtà d’oggi a sistemi astratti come il capitalismo, compresa la violenza che ha creato quel sistema».
Collegata c’è l’idea che il genocidio dei nativi americani e degli schiavi fosse giustificato dalla convinzione che non fossero completamente umani, e che quindi l’uomo bianco potesse fare di loro ciò che voleva. Proprio come avviene nei confronti della natura. Siamo superiori e padroni: ecco è il pilastro su cui tutto è costruito.
«Se oggi queste idee vivono è grazie all’esperienza coloniale delle Americhe. Poche centinaia di bianchi violentissimi dell’Estremadura scoprirono di poter sterminare centinaia di migliaia di nativi. Così è entrata in testa l’idea di esser simili a Dio, padroni del mondo. Che tutto esista per servirli».
Dove poggia sul piano culturale e filosofico?
«L’Illuminismo è di sicuro legato a questa esperienza. L’idea che gli esseri umani siano al di sopra di tutto. Penso, quindi sono. È da qui che discende quell’incredibile violenza. E infatti diversi pensatori chiave del tempo erano connessi strettamente al colonialismo. Cartesio ha trascorso gran parte della sua vita in Olanda quando questa era il perno del dominio globale. Il filosofo inglese Locke investiva nelle piantagioni e comprava schiavi. Anche Hegel ripeteva che gli africani erano inferiori, senza storia. Mentre parlava di libertà dello spirito».
Nel libro ritroviamo Cristoforo Colombo, che sbarcato nelle Americhe commette atrocità.
«Era un uomo violento e selvaggio, un puro sadico. So che gli italiani non lo ricordano. I nativi delle Americhe invece sì. Il fatto è che gran parte della storia che viene insegnata serve a far sembrare belli l’Europa e gli occidentali».
Lei ricorda anche come dare il nome alle cose, come facevano gli scienziati del ‘700, fosse uno dei modi per dominarle.
«Il sistema con cui Linneo battezzò animali, piante e minerali deriva interamente dal colonialismo. L’idea era avere un sistema che potesse oggettivare le risorse che il mondo offriva. E il sistema linneano ha trionfato non perché fosse il migliore ma perché l’impero spagnolo l’adottò».
A proposito di nessi causali, lei sottolinea come il riscaldamento globale non sia un accidente, ma è la conseguenza centrale del comportamento degli esseri umani.
«Credo sia chiaro come il global warming segua questi modelli. Una delle caratteristiche più marcate del colonialismo è ciò che si potrebbe chiamare “violenza per omissione”. Permettere alle malattie di fare strage. O agli interventi sull’ambiente di provocare disastri contro i popoli nativi».
Noi abbiamo l’idea che i conquistadores non avessero colpa per la diffusione di malattie che hanno sterminato le civiltà americane.
«I nativi-americani sanno da sempre la verità».
Discendiamo dall’Impero Romano, che controllava la Terra conosciuta. Vede un’idea di dominio nella psicologia dell’uomo bianco?
«I romani riconoscevano il potere della natura su di loro. Non se ne consideravano i padroni».
È un problema di potere. Potere politico, rappresentato anche dal potere sull’energia.
«L’energia diventa il perno della geopolitica globale alla fine del XVIII secolo, quando i combustibili fossili che gli inglesi cominciano a usare diventano centrali nelle loro strategie imperiali. E i combustibili fossili sono divenuti importanti perché - a differenza dell’energia dei mulini - potevano essere portati ovunque, quindi controllati».
Cosa le fa pensare che le fonti rinnovabili - a gestione diffusa - possano arrivare a sostituirle? Per le élite significa rinunciare al potere.
«I modelli che ho indicato nel libro, possiamo vederli all’opera oggi. Questa guerra Russia-Ucraina è così centrata sull’energia che l’energia stessa diventa un’arma di guerra da entrambe le parti. Se avessimo rinnovabili su larga scala, il gas russo conterebbe poco, ma questo varrebbe anche per il gas Usa. E non dimentichiamo che esiste il petrodollaro ( il sistema per cui il petrolio è pagato in dollari, ndr): Saddam è stato uno dei primi a iniziare a non commerciare in dollari, e guardi com’è finito. Il Venezuela di Chavez anche, ed è morto per un misterioso tumore. Russia e Cina che si scambiano combustibili fossili non sul dollaro diventano una minaccia per la sua egemonia».
Lei scrive che nei Paesi ricchi si pensa che la crisi climatica sia una preoccupazione tecnica con effetti economici, mentre in quelli poveri è un problema di disuguaglianza e giustizia.
«Se chiede a chiunque in Occidente qual è la posta in gioco con il clima tutti risponderanno che si tratta di ridurre l’impronta di carbonio. Di soluzioni tecniche. Nel Sud globale, se dite a qualcuno cosa pensa di fare al riguardo? La risposta sarà sempre: “Perché dovrei far qualcosa? La nostra impronta pro-capite è ancora piccola rispetto a quella dell’Occidente! Tocca a loro agire. Sono diventati ricchi quando eravamo poveri, a nostre spese. La percezione è di profonda ingiustizia».
Quindi, come se ne esce? Come si può arrivare alla decarbonizzazione necessaria al pianeta?
«C’è solo un modo: che l’Occidente riduca le emissioni cambiando stile di vita. Fino a quando ciò non accadrà qui, non accadrà da nessun’altra parte. È la cruda realtà».
Lo ritiene davvero possibile?
«L’abbiamo visto in Cina, con l’enorme calo della domanda dei consumatori. Lì, come in India, la gente ancora ricorda com’è vivere in modo più frugale. Toccherà agli occidentali imparare a farlo».
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- METATEATRO E TEATRO. EURIPIDE A SIRACUSA (2019): "ELENA" E "TROIANE" (di Alberto Giovanni Biuso).22 novembre 2022, di Federico La Sala
Euripide a Siracusa
di Alberto Giovanni Biuso [2019] *
Conversando con Eckermann il 28 marzo del 1827 Goethe affermò che «wenn ein moderner Mensch wie Schlegel an einem so großen Alten Fehler zu rügen hätte, so sollte es billig nicht anders geschehen als auf den Knien», ‘se un moderno come Schlegel avesse da rimproverare un così grande antico per qualche errore, gli dovrebbe essere consentito farlo soltanto in ginocchio’1. Il ‘großen Alten’ al quale Goethe si riferisce è Euripide.
La profondità del giudizio di Goethe è stata confermata dal ritorno quest’anno del poeta a Siracusa con due tragedie: Τρώαδεςe Ἑλένη. A metterle in scena, rispettivamente, Muriel Mayette-Holtz e Davide Livermore. Regie assai diverse tra di loro, le quali hanno mostrato quanto rizomatici, labirintici, cangianti, imprevedibili siano i percorsi del mito e degli dèi. Il politeismo greco è infatti anche libertà rispetto a ogni monoteismo ermeneutico, a ogni unicità del divino, a ogni identità immutabile del dio.
Elena
Elena rappresenta un’evidente dimostrazione di tutto questo. Si tratta infatti di un personaggio diverso dalla Elena omerica, che è la più nota, con l’universale biasimo che l’accompagna. Eccezione significativa rispetto alla generale condanna verso questa donna fu Gorgia, che su di lei pronuncia invece parole del tutto plausibili di encomio. Contemporaneo di Gorgia, Euripide disegna un’Elena fatta di saggezza e di misura. Ci voleva coraggio nel far questo, visto che «l’azzeramento delle responsabilità di Elena equivale all’azzeramento della tradizione omerica»2.
Racconta Euripide che Elena non è mai arrivata a Troia, che mentre i guerrieri a Ilio si scannavano, lei venne portata in Egitto, dove la troviamo sulla tomba di Proteo, a difendere se stessa dal figlio di lui che vorrebbe farla propria. Elena narra che «Era, incollerita per non avere vinto le altre dee, mandò in fumo il connubio ad Alessandro: non diede me, ma un simulacro vivo, che compose di cielo a somiglianza di me, al figliolo del re Priamo: e lui ebbe l’idea d’avermi - vana idea che non m’ebbe» (pp. 534-535)3. Decisa a uccidersi piuttosto che andare in sposa a Teoclimeno, il caso o gli dèi - sono la stessa cosa - fanno approdare sulle coste egizie il naufrago Menelao, che crede di portare con sé Elena conquistata a Ilio. Non crede quindi ai propri occhi quando vede e riconosce quest’altra Elena. Tra i due gioca la dinamica di realtà e illusione. Gli antichi sposi decidono di ingannare il nuovo re egizio, fargli credere Menelao morto e chiedere di onorare la sua fine in mare. Ottenuta da Teoclimeno la nave, tornano a Sparta, vincitori.
Anche i percorsi della Wirkungsgeschichte, delle interpretazioni della tragedia e dei suoi effetti, sono molteplici. Non esiste, ovviamente, alcuna regia o messa in scena ‘corretta’ delle opere teatrali, tanto meno di quelle greche. Chi difende la ‘tradizione’ difende in realtà le interpretazioni novecentesche o persino del XIX secolo. La domanda da porsi è invece questa: quanto di greco c’è in questa regia? Nel caso della Elena di Davide Livermore c’è molto, per numerose ragioni.
La prima è che abbiamo assistito a una Gesamtkunstwerk, un’opera d’arte totale, fatta di parole ma anche di musica, di danza e di immagini. I primi tre elementi erano costitutivi del teatro greco, l’ultimo li rende vivi attraverso un grande schermo che fa da sfondo alla scena creando di volta in volta immagini degli dèi, degli umani, del mare, delle stelle, del fuoco. La suggestione e l’enigma ne vengono moltiplicati in una sorta di arcaismo elettronico che, insieme ai tanti specchi e all’acqua nella quale la scena è immersa, rende visibile il doppio, la dissoluzione dell’identità nell’aria e nel tempo. Nell’acqua sono immersi la tomba di Proteo, l’obelisco di Teoclimeno, il relitto della nave di Menelao.
Le musiche vanno dal barocco rivisitato al minimalismo, dalla musica leggera al Fandango del Quintetto IV in Re Maggiore G. 448 di Boccherini, che restituisce il ritmo dell’eros, del tradimento, del gioco. Musica che coniuga dissonanza e redenzione, la Dissonanza come immersione nel Nulla della vana immagine di Elena; dei guerrieri morti per un ologramma; della natura enigmatica del dio. L’etica dei Greci sta qui, nella loro ontologia, nella radicalità con la quale esistono e comprendono l’esistere.
Troiane
Muriel Mayette-Holtz ha preferito invece imprimere alla sua regia delle Troiane un carattere etico che ha contribuito a banalizzare questa che è una delle più radicali, davvero terribili, tragedie greche. In essa Atena e Poseidone osservano i vinti e i vincitori. E stabiliscono di portare a compimento la fine di Troia ma di dare anche amaro ritorno agli Achei. Nessun amore per gli umani in questi dèi. E basta esistere e vedere il mondo per comprendere che nessun amore proviene per gli umani dal divino. Ecuba lo sa, ora che la città, la casa, i figli, persino il nipote Astianatte vanno morendo e sono alla rovina. Ecuba sa e dice che «di quelli che sono fortunati non stimate felice nessuno mai, prima che muoia» (p. 439). La fortuna, il caso, gli dèi danzano infatti sulle vite individuali e sulla storia miserrima della specie che si crede grande e per la quale meglio sarebbe stato invece non venire al mondo. «Io dico», afferma Andromaca, «che non nascere equivale a morire. Ma d’una vita triste è meglio morte. Sofferenza non c’è per chi non sente il male» (p. 444).
Il male della storia e il male dell’individuo. Quello della storia perché «folle è il mortale che distrugge le città. Getta nello squallore templi e tombe, sacro asilo d’estinti; ma poi finisce per perire lui» (p. 426), afferma Poseidone; il male dell’individuo immerso in passioni antiche, nuove, pervadenti. Nell’uno e nell’altro caso i Greci appaiono in questa tragedia feroci e disumani, sino ad accettare il consiglio dell’implacabile Odisseo di togliere la vita ad Astianatte affinché il figlio di Ettore non abbia, crescendo, a vendicarsi. Il bambino viene gettato giù dalle mura della città in fiamme.
Prorompe dentro la distruzione Cassandra. Lucida e invasata, lucida perché invasata, sa che ad Agamennone che se l’è presa come concubina lei porterà ogni sciagura, vede «la lotta matricida che le mie nozze desteranno, e lo sterminio della famiglia d’Atreo» (p. 435), esulta sapendo che «vittoriosa giù fra i morti arriverò: / che la casa dei carnefici, degli Atridi, spianterò» (p. 438). Il momento nel quale irrompe Cassandra sulla scena, con la sua torcia con il suo canto, il momento nel quale appare questa potenza struggente, luminosa e dionisiaca, è il più alto della messa in scena, l’unico nel quale appaiano in essa i Greci. Per il resto, infatti, è uno spettacolo sobrio sino alla piattezza; con un Paolo Rossi del tutto fuori ruolo, che interpreta il personaggio chiave di Taltibio come se recitasse in un cabaret milanese; e soprattutto con i cori di Euripide cancellati e sostituiti da canzonette leggere e sentimentali, accompagnate da una chitarra. Si può e si deve interpretare un testo greco come si ritiene più consono ma non lo si può sostituire - o, peggio, ‘sintetizzare’- con testi melensi.
Euripide tra Nietzsche e la Gnosi
Nietzsche aveva ancora una volta ragione, anche se forse non per le ragioni che credeva: davanti al male della storia, davanti al male che è il respiro, Euripide enuncia il disincanto che alla tragedia greca pone fine. Il poeta fa pronunciare infatti a Ecuba una preghiera che trascolora i nomi degli dèi, persino quello di Zeus, nella forza senza fine e senza senso della materia agra: «ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχω νἕδραν, / ὅστις ποτ᾽εἶ σύ, δυστόπαστος εἰδέναι, /Ζεύς, εἴτ᾽ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶν, / προσηυξάμην σε: πάντα γὰρ δι᾽ἀψόφου / βαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτ᾽ἄγεις», ‘Tu che sostieni il mondo e che nel mondo hai dimora, chiunque tu sia, Zeus, inconcepibile enigma, che tu sia necessità della natura o pensiero degli uomini, io ti prego: tutte le cose mortali le governi secondo giustizia, procedendo in silenzio lungo il tuo percorso’4.
In questa magnifica preghiera panteistica una donna e una regina al culmine della disperazione riconosce con dolorosa intelligenza che tutto è giusto ciò che agli umani accade, anche che «la gran città / non più città s’è spenta e non c’è più» (p. 461). Nella tragedia che porta il suo nome, Ecuba arriva a dire di se stessa «έθνηκ᾽ἔγωγε πρὶν θανεῖν κακῶν ὕπο», ‘io sono morta prima di morire’5.
L’innocente causa di tutto questo, Elena, appare davanti a Menelao e si fa avvocata formidabile di se stessa, somigliando le sue parole a quelle argomentate e profonde con le quali Gorgia tesse l’elogio di questa creatura bellissima e fatale. Persino le donne troiane che la odiano ammettono che l’argomentare di Elena è convincente. Come nella tragedia a lei specificatamente dedicata, Euripide coniuga l’indicibile bellezza a una intelligenza raffinata e superiore. Elena sostiene infatti che preferendo lei -e non i doni che offrivano Era e Atena- Alessandro Paride risparmiò ai Greci la sconfitta contro i Troiani. Scegliendo lei nell’impeto di un totale desiderio, Paride fu asservito da Afrodite mentre di Afrodite decretava la vittoria. E quindi, afferma Elena rivolgendosi a Menelao, «la dea devi punire, devi farti superiore a Zeus, che regna sì sugli altri dèi, ma di quella è uno schiavo» (p. 452).
Se schiavo è Zeus di Afrodite, quanto più gli umani lo saranno. Lo sa bene anche Ecuba, sa che il nome di questa invincibile dea è simbolo e sintesi della fragilità di tutti: «Ogni follia per l’uomo s’identifica con Afrodite» (p. 453). Fino a dire parole che sembrano nostre, di noi disincantati ma sempre persi umani del futuro: «οὐκἔστ᾽ἐραστὴςὅστιςοὐκἀεὶφιλεῖ», ‘colui che amò una volta ama per sempre’6.
La predilezione di Euripide per il personaggio di Elena ha molte ragioni, le quali affondano nella critica socratico-platonica al modo troppo umano con il quale le figure e i comportamenti degli dèi vengono rappresentati già da Omero ed Esiodo. Ma a questo elemento razionalistico si coniuga qualcosa di assai profondo nella storia mediterranea e greca. L’Elena di Euripide -opera per molti versi sconcertante- è accenno, filigrana e metafora anche della tradizione orfica, che si compie nella visione gnostica del mondo. Elena è infatti un simbolo orfico di nascondimento e rinascita, una gemella di Dioniso, un itinerario che gli gnostici presero a modello di gettatezza e riscatto, disvelante le apparenze e volto verso la luce. L’uovo dal quale nacque Elena, dopo che sua madre Leda venne fecondata da Zeus in forma di cigno, divenne un simbolo della Gnosi, un’allegoria dell’esistere redento.
Tra le forme della verità che appare e si dissolve ci sono le strutture che i Greci raccolgono sotto il nome di Afrodite. Di lei, come di Dioniso, Elena è figura. Anche per questo può osare definire la dea πολυκτόνος Κύπρις, vale dire «la Cipride omicida»7, riconoscendone però sempre la dolcezza, insieme alla potenza. Rivolta ad Afrodite infatti Elena dice: «Avessi la misura! Per il resto, oh non dico di no, tu sei per gli uomini, certo, di tutti i numi la più dolce» (p. 572). La regia di Livermore ha reso visibile questa potenza di Elena/Afrodite, la sua bellezza, i modi e le parole.
Più di ogni altra forma, anche la vicenda iniziatica, tragica e inquietante di Elena è espressione di Ἀνάγκη: «λόγος γάρ ἐστιν οὐκ ἐμός, σοφὸν δ᾽ἔπος, / δεινῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἰσχύειν πλέον» ‘Non è sentenza mia, ma dei sapienti: della necessità nulla è più forte’ afferma Menelao8. Ed è questa necessità ad aver generato Elena, la sua dionisiaca bellezza, la sua storia che si conclude, e in altro modo non potrebbe, con la divinizzazione profetizzata dai suoi fratelli, i Dioscuri: «ὅταν δὲ κάμψῃς καὶ τελευτήσῃς βίον, / θεὸς κεκλήσῃ» ‘Quando poi verrà la svolta e finirà per te la vita, sarai dea’9.
È questo che a Siracusa si è compiuto nel rosso conclusivo che intride la scena, le immagini, le acque, mentre tutti intorno a lei muoiono - come sempre nel divenire del mondo - ed Elena rimane invece viva, trasfigurata, gnostica nel pianto e nella luce.
[...]
Teatro Greco - Siracusa, 2019
Elena (Ἑλένη)
 Traduzione di Walter Lapini
Traduzione di Walter Lapini
 Con: Laura Marinoni (Elena), Sax Nicosia (Menelao), Simonetta Cartia (Teonoe), Giancarlo Judica Cordiglia (Teoclimeno), Viola Marietti (Teucro), Mariagrazia Solano (una vecchia), Maria Grazia Centorami (Primo Messaggero), Linda Gennari (Messaggero di Teoclimeno), Federica Quartana (Corifea)
Con: Laura Marinoni (Elena), Sax Nicosia (Menelao), Simonetta Cartia (Teonoe), Giancarlo Judica Cordiglia (Teoclimeno), Viola Marietti (Teucro), Mariagrazia Solano (una vecchia), Maria Grazia Centorami (Primo Messaggero), Linda Gennari (Messaggero di Teoclimeno), Federica Quartana (Corifea)
 Regia di Davide Livermore
Regia di Davide LivermoreTroiane (Τρώαδες)
 Traduzione di Alessandro Grilli
Traduzione di Alessandro Grilli
 Con: Maddalena Crippa (Ecuba), Marial Bajma Riva (Cassandra), Elena Arvigo (Andromaca), Viola Graziosi (Elena), Paolo Rossi (Taltibio), Graziano Piazza (Menelao), Francesca Ciochhetti (Atena), Massimo Cimaglia (Poseidone), Riccardo Scalia (Astianatte), Clara Galante (Corifea), Elena Polic Greco (capocoro), Fiammetta Poidomani (chitarrista)
Con: Maddalena Crippa (Ecuba), Marial Bajma Riva (Cassandra), Elena Arvigo (Andromaca), Viola Graziosi (Elena), Paolo Rossi (Taltibio), Graziano Piazza (Menelao), Francesca Ciochhetti (Atena), Massimo Cimaglia (Poseidone), Riccardo Scalia (Astianatte), Clara Galante (Corifea), Elena Polic Greco (capocoro), Fiammetta Poidomani (chitarrista)
 Regia di Muriel Mayette-Holtz
Regia di Muriel Mayette-Holtz* Fonte: Vita pensata, 27 Luglio 2019 (ripresa senza immagini e senza note).
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- RIPARTIRE DA TROIA. DANTE, #FREUD, E LA #DISCESA ALL’#INFERNO.13 novembre 2022, di Federico La Sala
#ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, FILOLOGIA, E #PSICOANALISI.
#DANTE, #FREUD, E LA #DISCESA ALL’#INFERNO...
LA #DIVINACOMMEDIA NON È UNA #TRAGEDIA (UNA "#BRUTTA #DIPINTURA", ALLA #GIAMBATTISTAVICO).
RIPARTIRE DA TROIA. "L’Interpretazione dei Sogni" (1899) ha il suo legame con l’#Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo") di #Virgilio e "L’uomo Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’«In exitu Isräel de Aegypto» della #Commedia di #DanteAlighieri (Pg. II, 46-48):
LA #MONARCHIA DEI #DUESOLI. #DanteAlighieri non cantò i #mosaici dei #Faraoni, ma l’amore che muove il Sole e le altre stelle... e la fine del cattolicesimo imperial-costantiniano!
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "DIVINA COMMEDIA" E "NASCITA DELLA #TRAGEDIA": DANTE E NIETZSCHE, OGGI.14 novembre 2022, di Federico La Sala
"DIVINA COMMEDIA" E "NASCITA DELLA #TRAGEDIA": DANTE E NIETZSCHE, OGGI.
FILOLOGIA, LETARGO STORIOGRAFICO, E CREPUSCOLO DEGLI IDOLI. In memoria di Edoardo Sanguineti... *
CON MARX E FREUD, NUOVO REALISMO E "GAIA SCIENZA" (NIETZSCHE):
“SI DEVE IMPARARE ANCHE L’AMORE. Si deve imparare ad amare. Ecco quel che ci accade nella musica: si deve prima imparare a udire una sequenza e una melodia in genere, a enuclearla nell’ascolto e a distinguerla isolandola e delimitandola come se avesse una vita propria; quindi bisogna sforzarci e impiegare la nostra buona volontà per sopportarla, malgrado la sua estraneità, bisogna fare un esercizio di pazienza di fronte al suo sguardo e alla sua espressione, considerare con benevolenza quel che c’è di inusitato in essa - finalmente arriva un momento in cui ne abbiamo preso l’abitudine, in cui l’attendiamo, in cui si ha il presentimento che ne sentiremmo la mancanza, se non ci fosse più; e così essa continuamente dispiega la sua violenta suggestione e il suo incantesimo, finché non si sia diventati i suoi umili ed estasiati amanti, per cui non v’è più niente di meglio da chiedere al mondo se non la melodia e ancora la melodia.
 Questo ci accade però non soltanto con la musica: proprio in questo modo abbiamo imparato ad amare tutte le cose che oggi amiamo. In definitiva, siamo sempre ricompensati per la nostra buona volontà, per la nostra pazienza, equità, mitezza d’animo verso una realtà a noi estranea, quando lentamente essa depone il suo velo e si manifesta come una nuova inenarrabile bellezza: è questo il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. Anche chi ama se stesso, lo avrà appreso per questa strada: non ce ne sono altre. Si deve imparare anche l’amore. (F. Nietzsche, “La gaia scienza”, af. 334, Adelphi 1991).
Questo ci accade però non soltanto con la musica: proprio in questo modo abbiamo imparato ad amare tutte le cose che oggi amiamo. In definitiva, siamo sempre ricompensati per la nostra buona volontà, per la nostra pazienza, equità, mitezza d’animo verso una realtà a noi estranea, quando lentamente essa depone il suo velo e si manifesta come una nuova inenarrabile bellezza: è questo il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. Anche chi ama se stesso, lo avrà appreso per questa strada: non ce ne sono altre. Si deve imparare anche l’amore. (F. Nietzsche, “La gaia scienza”, af. 334, Adelphi 1991).*Nota a margine dell’articolo su "Il Dante di tutti. O quasi” di Marco Grimaldi (cfr. "Le parole e le cose", 11.11.2022).
-
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "LA MALATTIA DELL’EUROPA": FRANCO FORNARI (1981) E "LA SETTIMANA DELLA PACE DI GINEVRA 2022" (DI "SPI").3 novembre 2022, di Federico La Sala
LA MALATTIA DELL’EUROPA, FRANCO FORNARI (1981) E... L’EDUCAZIONE ALLA "PACE PERPETUA" *
***
Franco Fornari sviluppò la sua ricerca a partire dalla convinzione che la psicoanalisi potesse aiutare l’uomo a risolvere non solo i conflitti intrapsichici ma anche quelli interpersonali, istituzionali e sociali. Il suo progetto di educare alla pace lo in portò ad indagare i meccanismi inconsci che alimentano la guerra fra i popoli.
 A questo dedicò numerosi libri: Psicoanalisi della guerra atomica
(1964), Psicoanalisi della guerra (1966) e La malattia dell’Europa (1981). Il suo pensiero ricevette
una grande attenzione internazionale alla Conferenza dell’ONU sulla pace a New York e il suo
impegno lo portò a diventare membro del Comitato Mondiale di ricerca sulla pace.
A questo dedicò numerosi libri: Psicoanalisi della guerra atomica
(1964), Psicoanalisi della guerra (1966) e La malattia dell’Europa (1981). Il suo pensiero ricevette
una grande attenzione internazionale alla Conferenza dell’ONU sulla pace a New York e il suo
impegno lo portò a diventare membro del Comitato Mondiale di ricerca sulla pace.- In occasione della “Settimana della pace di Ginevra 2022” proponiamo le ultime pagine del suo libro “LA MALATTIA DELL’EUROPA”, edito da Feltrinelli.
“Giunto così in modo un po’ concitato alla fine della mia ricerca sulla malattia dell’Europa, vorrei darle un nome. Poiché i processi patologici che ho individuato sono molteplici e intricati, anziché elencarli in una lunga perifrasi, vorrei condensarli con il mito di Tieste.
Questo mito racconta che tra i due fratelli Atreo e Tieste, correva un’inimicizia mortale.
Il nome di Atreo rimanda agli Atridi: Agamennone e Menelao, appunto, quelli della guerra di Troia. Poiché Agamennone, il capo dei greci, è figlio di Atreo, la sua genealogia rimanda ad una struttura perversa del potere familiare, che sembra dare una luce sinistra alla guerra di Troia, la prima grande guerra.
Dice dunque il mito che i due fratelli Atreo e Tieste si odiavano a morte. Un giorno però Atreo propose al fratello la riconciliazione e la coesistenza pacifica. Venuto il giorno della pace, Atreo offrì al fratello Tieste un banchetto imbandito con la carne dei suoi bambini, sgozzati davanti all’altare. La guerra di Troia ha dunque nella sua genealogia l’odio tra fratelli.
Ricordando Tieste, propongo di chiamare “Tiestopa” la malattia dell’Europa. Come nel mito greco, gli accordi di Yalta dicono di un odio mortale tra americani e russi, i fratelli vincitori della Seconda guerra mondiale. La divisione dell’Europa dice che a Yalta c’è stato un banchetto, nel quale le due grandi potenze, vincitrici, fingendo la pacificazione, si sono costituite come pseudogenitori dell’Europa, e hanno messo in atto un’intesa apparente, dandosi reciprocamente da mangiare i popoli europei, come simulazione di pace. Il mito dice dunque che gli accordi di Yalta sono un signum mali ominis: un segno di cattivo auspicio. Nel mito possono essere letti i presupposti di una nuova guerra di Troia, in era nucleare: dell’ultima grande guerra dell’Occidente.
La malattia dell’Europa è sospesa tra la Seconda e la Terza guerra mondiale. Questo significa che la cura della malattia dell’Europa è essenziale per evitare la Terza guerra mondiale e può essere fatta solo attraverso la liberazione dell’Europa dalla sovversione perversa e crociata degli Usa e dell’Urss in una rivoluzione culturale pacifica che è la condizione necessaria e sufficiente per evitare al mondo la maledizione dei discendenti di Atreo.” (Fornari F., 1981 pag 203-204)
* Fonte: Società Psicoanalitica Italiana
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
 TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.fls
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- FILOLOGIA DENDROLOGIA E STORIA: DAI RUNA DI AVILA (AMAZZONIA). Come pensano le foreste. Un nuovo approccio all’essere umani (di Dafne Crocella).5 ottobre 2022, di Federico La Sala
FILOLOGIA DENDROLOGIA E STORIA: "PER UN’ ANTROPOLOGIA OLTRE L’ UMANO". *
- "Se avessi scritto questo libro per i Runa di Ávila... non gli avrei dato lo stesso titolo" (E. Khon).
Come pensano le foreste. Un nuovo approccio all’essere umani
- Siamo sicuri di essere gli unici esseri in grado di pensare? Eduardo Kohn, professore alla McGill University di Montreal, sfida i fondamenti dell’antropologia, mettendo in discussione i presupposti dell’antropocentrismo. Per una nuova logica dell’essere umani, non distinti da tutte le altre forme di vita
di Dafne Crocella **
- Titolo: Come pensano le foreste
- Autore: Eduardo Kohn
- Editore: Nottetempo
- Anno: 2021
«Dormi a faccia in su. Se arriva un giaguaro vedrà che anche tu puoi guardarlo e non ti disturberà». È da questo consiglio, dato all’antropologo Eduardo Kohn da un uomo del villaggio runa di Avila nell’Amazzonia equadoregna, che si apre la riflessione sul modo in cui gli altri generi di esseri viventi ci percepiscono, ci guardano, ed effettivamente e più generalmente pensano. Eduardo Kohn è professore associato di antropologia alla McGill University di Montreal ed ha incentrato buona parte della sua ricerca etnografica sulla popolazione runa dell’Alta Amazzonia. Questo libro nasce da una profonda e prolungata conoscenza del villaggio di Avila, immerso nella Foresta Amazzonica. La prima visita di Kohn risale al 1992, a questa sono seguiti 4 anni, dal 1996 al 2000, di ripetuti ritorni. Il libro How Forests Think nasce dopo una permanenza nel 2010 ed è stato pubblicato per la prima volta nel 2013. L’opera, dopo aver vinto nel 2014 il Gregory Bateson Prize, è stata tradotta in oltre 10 lingue e dal 24 giugno è disponibile anche in Italia con il titolo Come pensano le foreste, edita dalla casa editrice Nottetempo e tradotta da Alessandro Lucera e Alessandro Palmieri.
- Ripensare l’umano
Un libro che è una rivoluzione di cui abbiamo effettivo bisogno. Un nuovo approccio copernicano pronto a mettere in discussione la centralità dell’antropos rispetto agli altri abitanti del Pianeta.
Il pensiero non è più appannaggio esclusivo del genere umano, non è il tratto che ci contraddistingue dagli altri esseri viventi, siano essi piante, animali o interi ecosistemi. Per spiegarci tutto questo e mettere in discussione i nostri parametri di approccio logico razionale, Kohn utilizza proprio i principi cardine del pensiero occidentale rifacendosi alla mitologia greca, alla filosofia classica, alla letteratura, all’ambito delle scienze e ovviamente all’antropologia culturale.
Impossibile dunque liquidare questo lavoro come una sorta di decostruzione psico-metafisica più vicina ai testi di carattere spirituale che a quelli scientifici. Ci troviamo di fronte a un pensiero logico razionale occidentale in grado di interrogarsi davanti a una foresta, mettersi in discussione e riscoprirsi. «Questo libro è un tentativo di meditare sull’enigma della Sfinge (quella che nel mito greco Edipo incontra sulla strada per Tebe), attraverso un approccio etnografico a una serie di incontri amazzonici altro-che-umani. Indagare le nostre relazioni con questi esseri che esistono in qualche modo oltre l’umano ci spinge a mettere in discussione le nostre abituali risposte sull’umano. L’obiettivo qui non è né sbarazzarsi dell’umano né conferirgli una nuova posizione, ma aprirlo». Kohn definisce tale approccio “antropologia oltre l’umano”.
- Esta selva selvaggia
Apre il primo capitolo introduttivo l’esergo dantesco a noi italiani particolarmente noto: «Ahi quanto a dir qual’era è cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte»: ci stiamo inoltrando in un percorso di autoconoscenza che avrà come controparte il mondo selvaggio. E per farlo dobbiamo inevitabilmente, proprio come fece il padre della nostra lingua, tener presente la semiotica, la creazione e l’interpretazione di segni per comunicare. Kohn a questo riguardo chiarisce subito che «Il primo passo per capire come pensano le foreste è abbandonare i nostri preconcetti su cosa significhi avere una rappresentazione di qualcosa». Siamo abituati a considerare le rappresentazioni come linguaggi in quanto la nostra rappresentazione linguistica si basa su segni convenzionali collegati agli oggetti a cui si riferiscono. Ma non tutti i processi semiotici hanno queste proprietà. Dobbiamo superare l’approccio dualistico «in cui gli umani vengono descritti come separati dai mondi che rappresentano, per andare verso un approccio monista, nel quale i modi in cui gli umani si rappresentano i giaguari e i modi in cui i giaguari si rappresentano gli umani possano essere intesi come parti integranti, sebbene non interscambiabili, di un’unica storia senza fine. Date le sfide poste dalla necessità di imparare a vivere con una varietà sempre più grande di forme di vita - siano esse animali domestici, erbe infestanti, parassiti, organismi commensali, nuovi agenti patogeni, animali ‘selvatici’ o ‘mutanti’ tecno-scientifici - non solo è di cruciale importanza, ma è anche urgente sviluppare una precisa maniera di analizzare quanto l’umano sia distinto da, e allo stesso tempo in continuità con, tutto ciò che si trova al di là di esso».
- Sumak Kawsay
In kichwa, la lingua dei runa, esiste il termine “sumak kawsay” ed esprime un concetto legato all’importanza del vivere in equilibrio con la foresta. Si tratta di un modo di prestare attenzione alle proprietà della vita nelle sue varie forme. È un orientamento etico che proviene dall’osservazione e l’interrelazione con il mondo naturale e prende forma quando l’essere umano riesce a pensare con la foresta. Kohn, attraverso diversi esempi e approfondimenti, giunge alla deduzione che una foresta pensi attraverso immagini che possiedono la qualità ontologica delle totalità semplici, ossia sono autosufficienti e complete, iconiche. Per connettersi a questi pensieri silvestri anche l’essere umano deve pensare attraverso immagini, per questo motivo i runa prestano particolare attenzione alle suggestioni che arrivano dal mondo onirico.
** Fonte: "Sapere Ambiente", 6 Luglio 2021 (ripresa parziale).
Nota
FILOLOGIA #DENDROLOGIA #STORIA:
 "COME PENSANO LE FORESTE. PER UN’#ANTROPOLOGIA OLTRE L’UMANO.
"COME PENSANO LE FORESTE. PER UN’#ANTROPOLOGIA OLTRE L’UMANO.
 Eduardo #Khon: "Se avessi scritto questo libro per i #Runa di #Ávila... non gli avrei dato lo stesso titolo"
Eduardo #Khon: "Se avessi scritto questo libro per i #Runa di #Ávila... non gli avrei dato lo stesso titolo"Federico La Sala
-
>PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA --- GUERRA E OSCURANTISMO. Cambiare il paradigma obsoleto del principio “si vis pacem para bellum” (di Pasquale Pugliese).30 giugno 2022, di Federico La Sala
Per non perdersi nell’oscurantismo
di Pasquale Pugliese *
1. Tracce di etica e politica
Di fronte al reiterato ribaltamento logico, mai forte come adesso, per cui la pace costruita con mezzi di pace - seppur retoricamente invocata - viene ancora relegata al regno dell’utopia, mentre l’ossimoro della pace attraverso la guerra - nonostante le continue smentite della storia - continua ad essere alimentata e meticolosamente preparata, meglio ricordare che c’è un ampio e importante filone di scienza della politica che fonda invece - direttamente o indirettamente - il realismo della costruzione della “pace con mezzi pacifici” (Johan Galtung) su solide basi etiche e razionali. Scienziati della politica non sempre legati direttamente al pensiero “pacifista”, ma accomunati dall’uso della responsabilità e della razionalità, in particolare nell’approccio ai conflitti. Facciamone qui un rapido - incompleto e limitato - excursus, a partire dal ‘900. Come tracce luminose sul sentiero da percorrere per non perdersi nell’oscurantismo e salvare l’umanità.
- Max Weber e Hans Jonas
Alla fine della prima guerra mondiale, nel 1919, Max Weber tenne una lezione all’università di Monaco in cui, affrontando il rapporto tra etica e politica, pose la fondamentale distinzione nella politica contemporanea, tra «etica dei principî» ed«etica della responsabilità»”. Nell’etica dei principi, o dell’intenzione, ci preoccupiamo di avere la coscienza a posto rispetto all’obiettivo da conseguire, qualunque esso sia, e quindi ogni strumento appare legittimo per raggiungere il fine, senza pre/occuparci delle conseguenze. L’etica della responsabilità, al contrario, si chiede e cerca di prevedere e valutare le conseguenze del proprio agire. Qui entra in gioco il tema decisivo del rapporto tra i mezzi e i fini nell’agire politico, che Weber esplicita così: “Nessuna etica al mondo può mostrare quando e in che misura lo scopo eticamente buono «giustifichi» i mezzi eticamente pericolosi e le sue possibili conseguenze collaterali”.
Di fronte ai progressi “spaventosi” della tecnica ed al loro impatto sull’eco-sistema, e dunque sulla stessa sopravvivenza dell’umanità, nel 1979 sarà Hans Jonas a fondare sul “Principio responsabilità” l’etica del futuro, “un’etica per la civiltà tecnologica”, ancorata ad un nuovo imperativo categorico: “agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la sopravvivenza di un’autentica vita umana sulla terra”.
- Mohandas Gandhi e Aldo Capitini
Nello stesso anno della lezione di Weber, Mohandas K. Gandhi, nel pieno della lotta per l’auto-governo dell’India, formulò la regola aurea della nonviolenza sul rapporto mezzi-fini: “i mezzi possono essere paragonati al seme, e il fine all’albero; tra i mezzi e il fine vi è lo stesso inviolabile rapporto che esiste tra il fine e l’albero”. Ovvero i mezzi usati nell’agire politico devono essere coerenti con il fine da raggiungere, tanto come principio etico fondamentale, quanto come efficace pratica rispetto alla realizzazione dello scopo. Tanto più, scriverà, nel 1947 dopo Hiroshima e Nagasaki “la morale che si può trarre dalla spaventosa tragedia provocata dalla bomba atomica è che una bomba non può essere distrutta da un’altra bomba, come la violenza non può essere distrutta dalla violenza”. Anche Aldo Capitini, in Italia - ispirato da Gandhi - ribadirà più volte questo concetto fondamentale: “nella grossa questione del rapporto tra mezzi e fini, la nonviolenza porta il suo contributo in quanto indica che il fine dell’amore non può realizzarsi che attraverso l’amore, il fine dell’onestà con mezzi onesti, il fine della pace non attraverso la vecchia legge di effetto tanto instabile se vuoi la pace prepara la guerra, ma attraverso un’altra legge: durante la pace, prepara la pace”
- Dwight David Eisenhower
Il 17 gennaio 1961, il 34° presidente USA Eisenhower - che conosceva bene la guerra e il sistema militare in quanto era stato comandante in capo delle Forze alleate nel Mediterraneo durante la seconda guerra mondiale - nel discorso di addio alla nazione mise in guardia la democrazia statunitense, e di conseguenza tutte le democrazie, con estrema lucidità e chiarezza, dall’enorme potere che stava acquisendo la saldatura dell’industria degli armamenti con gli apparati della difesa: “Questa congiunzione tra un immenso corpo di istituzioni militari e un’enorme industria di armamenti è nuova nell’esperienza americana. L’influenza totale nell’economia, nella politica, anche nella spiritualità è sentita in ogni città, in ogni organismo statale, in ogni ufficio del governo federale. [...] Nei concili di governo dobbiamo guardarci dall’acquisizione di influenze che non diano garanzie, sia palesi che occulte, esercitate dal complesso militare-industriale. Il potenziale per l’ascesa disastrosa di poteri che scavalcano la loro sede e le loro prerogative esiste ora e persisterà in futuro. Non dobbiamo mai permettere che il peso di questa combinazione di poteri metta in pericolo le nostre libertà o processi democratici. Non dobbiamo presumere che nessun diritto sia dato per garantito”.
- Hannah Arendt
Qualche anno dopo, nel 1964, Hannah Arendt ne La banalità del male, indicava la resistenza danese all’occupazione nazista come esempio da studiare in tutte le università. La Danimarca è l’unico paese europeo nel quale il governo decise di non contrapporre alla potenza di fuoco della wehrmacht il piccolo esercito ed il popolo organizzò una grande e significativa resistenza civile e non armata. “A quel che si sa” - spiega la Arendt - “fu questa l’unica volta che i nazisti incontrarono una resistenza aperta, e il risultato fu a quanto pare che quelli di loro che vi si trovarono coinvolti cambiarono mentalità. Non vedevano più lo sterminio di un intero popolo come una cosa ovvia. Avevano urtato in una resistenza basata su saldi principi, e la loro durezza si era sciolta come ghiaccio al sole permettendo il riaffiorare, sia pur timido, di un po’ di vero coraggio. (...). Su questa storia” - che salvò, unico paese in Europa, il 98% degli ebrei danesi (ndr), continua Arendt - “si dovrebbero tenere lezioni obbligatorie in tutte le università ove vi sia una facoltà di scienze politiche, per dare un’idea della potenza enorme della nonviolenza e della resistenza passiva, anche se l’avversario è violento e dispone di mezzi infinitamente superiori”.
- Alex Langer
Alex Langer da capogruppo dei Verdi al Parlamento europeo, nel 1995, elaborò il documento “Per la creazione di un corpo civile di pace europeo” che poneva la necessità di non lasciare al solo generoso volontariato l’onere della costruzione delle alternative alla guerra. Nel pieno del conflitto armato fratricida nell’ex Jugoslavia, Langer immaginava una vera e propria forza disarmata, costituita “dall’Unione Europea sotto gli auspici dell’ONU”, inizialmente composta da professionisti e volontari, formati ed equipaggiati per intervenire nei conflitti internazionali prima dell’esplosione della violenza e capaci di rimanervi efficacemente anche durante la fase acuta. Il corpo di pace, scriveva tra l’altro Langer “agirà portando messaggi da una comunità all’altra. Faciliterà il dialogo all’interno della comunità al fine di far diminuire la densità della disputa. Proverà a rimuovere l’incomprensione, a promuovere i contatti nella locale società civile. Negozierà con le autorità locali e le personalità di spicco. Promuoverà l’educazione e la comunicazione tra le comunità. Combatterà contro i pregiudizi e l’odio. Incoraggerà il mutuo rispetto fra gli individui. Cercherà di restaurare la cultura dell’ascolto reciproco...”. Non è difficile, in questo senso, immaginare oggi il ruolo positivo di mediazione e de-escalation tra le parti in conflitto - coerente con il ripudio costituzionale della guerra e di costruzione della pace con mezzi pacifici - che un Corpo civile di pace europeo avrebbe potuto svolgere nelle auto-proclamate repubbliche del Donbass ucraino fin dal 2014 - anche per monitorare il rispetto o meno dei “protocolli di Minsk” - invece dell’arrivo di armi Nato da un lato e russe dall’altro, con i relativi consulenti ed addestratori di guerra che hanno preparato l’escalation in corso.
2. Tracce di scienza e filosofia
In particolare dopo la seconda guerra mondiale, che si concluse con la sperimentazione della violenza delle bombe atomiche statunitensi su Hiroshima e Nagasaki - non necessaria a chiudere la Seconda guerra mondiale, ma a definire la supremazia assoluta tra i suoi vincitori - anche gli scienziati propriamente detti, quelli che indagano le leggi della natura, cominciano a segnalare, sempre più spesso, insieme ad alcuni filosofi, l’irrazionalità della guerra e a promuovere la ricerca di soluzioni alternative per affrontare e risolvere i conflitti. Per fare il salto di civiltà necessario alla sopravvivenza dell’umanità. Anche qui un rapido sguardo ad alcune tracce luminose.
- Manifesto Einstein-Russell
Il Manifesto Einstein-Russell, reso noto nel luglio 1955, chiedeva ai governi del mondo il disarmo atomico e la ricerca di “mezzi pacifici per la soluzione di tutti i loro motivi di contesa”. E’ frutto dell’impegno comune del filosofo inglese Bertrand Russell e del fisico tedesco Albert Einstein e del fitto carteggio preparatorio - nel quale il primo scriveva al secondo «penso che eminenti uomini di scienza dovrebbero fare qualcosa di spettacolare per aprire gli occhi ai governi sui disastri che possono verificarsi» - che diede vita al Manifesto, firmato da eminenti scienziati ed intellettuali del tempo, tra i quali anche i premi Nobel Max Born e Linus Pauling. E’ un manifesto di grande attualità, nel quale Einstein e Russell pongono il tema cruciale per la loro come per la nostra generazione: “Dobbiamo imparare a pensare in modo nuovo. Dobbiamo imparare a domandarci non già quali misure adottare affinché il gruppo che preferiamo possa conseguire una vittoria militare, poiché tali misure ormai non sono più contemplabili; la domanda che dobbiamo porci è: Quali misure occorre adottare per impedire un conflitto armato il cui esito sarebbe catastrofico per tutti?”
- Tesi sull’età atomica di Günther Anders
Negli stessi anni ed in quelli successivi ribadiva ad approfondiva lo stesso concetto anche uno dei massimi pensatori dello stato dell’umanità nell’epoca della possibilità dell’apocalisse nucleare: Günther Anders, autore di opere fondamentali per comprendere il nostro precario stare al mondo di quelli-che-esistono-ancora. Tra i suoi scritti, fondamentali sono Le Tesi sull’età atomica , un testo “improvvisato” di Anders nel 1960 dopo un dibattito sui problemi morali dell’età atomica con gli studenti dell’Università di Berlino, dove sono esposte in maniera limpida ed essenziale le caratteristiche, inedite e inaudite, dell’epoca atomica. Nella quale bisogna trovare “il coraggio di aver paura” perché la paura è segno di consapevolezza ed ha perciò un valore euristico, cioè di strumento di conoscenza della realtà: “La tesi apparentemente plausibile che nell’attuale situazione politica ci sarebbero (fra l’altro) anche armi atomiche, è un inganno. Poiché la situazione attuale è determinata esclusivamente dall’esistenza di armi atomiche, è vero il contrario: che le cosiddette azioni politiche hanno luogo entro la situazione atomica”. E di questa devono gli attori politici necessariamente tenere conto, razionalmente e responsabilmente.
- Bollettino degli scienziati atomici
Le lancette del Doomsday clock, l’Orologio dell’Apocalisse, sono l’indicatore simbolico del pericolo nucleare per l’umanità, messo a punto dal Bollettino degli scienziati atomici fin dal 1947, ideato dai fisici Eugene Rabinowitch e Hyman Goldsmith - che erano fissate a 2 minuti dalla mezzanotte quando Einstein e Russell stesero il loro Manifesto - hanno guadagnato tempo negli anni immediatamente successivi all’abbattimento del Muro di Berlino, e ne hanno perso drammaticamente dei decenni successivi, fino ad arrivare ai 100 secondi dalla mezzanotte nella quale è stato fissato ancora, il 20 gennaio scorso, per il terzo anno consecutivo. “L’Orologio rimane più vicino di quanto sia mai stato all’apocalisse della fine della civiltà, perché il mondo rimane bloccato in un momento estremamente pericoloso”, hanno scritto gli scienziati del Bollettino, rendendo nota l’ultima posizione delle lancette.
- Dividendo di pace
In questo scenario, già lo scorso dicembre più di cinquanta tra scienziati premi Nobel internazionali, prevalentemente fisici, chimici, medici, e presidenti di Accademie delle scienze - tra i quali gli italiani Giorgio Parisi, Carlo Rubbia, Carlo Rovelli - hanno firmato un appello inviato al Segretario generale delle Nazioni Unite ed ai presidenti dei cinque governi componenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu (USA, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna) nel quale chiedono un tagliocomune del 2% delle loro spese militari annuali, proponendo che la cifra così annualmente risparmiata venga dirottata su un fondo globale per la lotta contro la crisi sistemica globale in corso: cambiamento climatico, pandemie, povertà. Nel periodo 2025-2030, il “dividendo di pace” generato da questa proposta - pur modesta nella percentuale richiesta - supererebbe mille miliardi di dollari: un importo paragonabile al totale degli investimenti in energia rinnovabile in tutto il mondo, e sei volte maggiore dei fondi disponibili per la ricerca e il trattamento di cancro, HIV/AIDS, TBC e malaria messi insieme. Una proposta realista e razionale
3. Le ragioni della pace contro l’ideologia della guerra
Nonostante la razionalità politica e scientifica continuino ad indicare la via del disarmo e della costruzione di strumenti umani, alternativi alla guerra, per affrontare, gestire e risolvere i conflitti tra gli Stati, e liberare preziose risorse per far fronte alla crisi sistemica globale, che è contemporaneamente climatica, pandemica, energetica, idrica, alimentare e bellica, i governi - apparentemente alieni alla ragione, in preda ad una sorta di oscurantismo ideologico pre-scientifico - continuano a preparare, organizzare e finanziare, con costi crescenti per tutti, la monocultura della guerra nelle relazioni internazionali. Una vera e propria credenza magica dilagante che si auto-alimenta della sua narrazione ideologica e favolistica... se già il presidente Eisenhower non ne avesse spiegato le “ragioni” profonde. Eccone alcuni dati:
- I dati dell’oscurantismo
 dal 2001 al 2020 le spese militari globali sono raddoppiate, grazie ai vent’anni di illegale e fallimentare occupazione militare in Iraq e Afghanistan, che non hanno risolto nessuno dei problemi per le quali erano state formalmente avviate, ma li hanno aggravati tutti, facendo centinaia di migliaia di vittime civili e alimentando l’instabilità globale e il terrorismo internazionale, (come abbiamo spiegato qui).
dal 2001 al 2020 le spese militari globali sono raddoppiate, grazie ai vent’anni di illegale e fallimentare occupazione militare in Iraq e Afghanistan, che non hanno risolto nessuno dei problemi per le quali erano state formalmente avviate, ma li hanno aggravati tutti, facendo centinaia di migliaia di vittime civili e alimentando l’instabilità globale e il terrorismo internazionale, (come abbiamo spiegato qui). Come certifica il SIPRI, le spese militari sono aumentate ancora nel 2021 in piena pandemia globale, abbattendo il muro dei 2000 miliardi di dollari giungendo all’incredibile cifra di 2.113 miliardi di dollari: ossia 5,8 miliardi al giorno. Che è cifra maggiore del budget di un anno delle Nazioni Unite (3,2 miliardi) e del budget di un anno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (3,5 miliardi).
Come certifica il SIPRI, le spese militari sono aumentate ancora nel 2021 in piena pandemia globale, abbattendo il muro dei 2000 miliardi di dollari giungendo all’incredibile cifra di 2.113 miliardi di dollari: ossia 5,8 miliardi al giorno. Che è cifra maggiore del budget di un anno delle Nazioni Unite (3,2 miliardi) e del budget di un anno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (3,5 miliardi). Dall’avvio dell’invasione russa dell’Ucraina, approfittando dell’onda emotiva generata, molti Parlamenti europei, compreso quello italiano - su pressante indicazione della NATO - hanno deliberato l’aumento al 2% del Pil delle spese militari strutturali dei bilanci degli stati. In Italia ciò comporterà il passaggio dai circa 26 miliardi di euro a circa 40 miliardi di euro all’anno di risorse pubbliche usate per preparare altre guerre, sottratte agli investimenti civili e sociali.
Dall’avvio dell’invasione russa dell’Ucraina, approfittando dell’onda emotiva generata, molti Parlamenti europei, compreso quello italiano - su pressante indicazione della NATO - hanno deliberato l’aumento al 2% del Pil delle spese militari strutturali dei bilanci degli stati. In Italia ciò comporterà il passaggio dai circa 26 miliardi di euro a circa 40 miliardi di euro all’anno di risorse pubbliche usate per preparare altre guerre, sottratte agli investimenti civili e sociali. Circa 13.000 testate nucleari di nuovissima generazione - la cui minaccia era stata rimossa dalla coscienza dell’umanità dopo l’abbattimento del Muro di Berlino - sono puntate contro le nostre teste, di cui dall’inizio della guerra in Ucraina si minaccia nuovamente e irresponsabilmente l’utilizzo (come abbiamo raccontato qui).
Circa 13.000 testate nucleari di nuovissima generazione - la cui minaccia era stata rimossa dalla coscienza dell’umanità dopo l’abbattimento del Muro di Berlino - sono puntate contro le nostre teste, di cui dall’inizio della guerra in Ucraina si minaccia nuovamente e irresponsabilmente l’utilizzo (come abbiamo raccontato qui). L’Università di Uppsala monitora l’esistenza di oltre 160 conflitti armati (di bassa, media e alta intensità) in corso nel pianeta, con 100.000 morti all’anno e milioni di profughi. Oltre alla guerra e ai profughi ucraini,
L’Università di Uppsala monitora l’esistenza di oltre 160 conflitti armati (di bassa, media e alta intensità) in corso nel pianeta, con 100.000 morti all’anno e milioni di profughi. Oltre alla guerra e ai profughi ucraini,L’obsolescenza paradigmatica del principio “si vis pacem para bellum”
Questi dati dimostrano, nel loro insieme - se ce ne fosse ulteriore bisogno - l’obsolescenza paradigmatica del principio “si vis pacem para bellum”, se vuoi la pace prepara la guerra, che fonda ancora le relazioni internazionali sull’oscurantismo bellico, perché:
- a. è palesemente falso: con l’enormità di queste spese militari, mai raggiunte prima d’ora, la guerre dovrebbero essere un ricordo del passato e invece dilagano, perfino nel cuore dell’Europa;
- b. è pura credenza magica: quel paradigma ha avuto infinite e clamorose smentite in tutto il corso della storia, ed è rigettato dalla razionalità etica e scientifica;
- c. è predatorio di risorse economiche sempre crescenti dai bilanci degli Stati, sottratte agli investimenti di cura dell’ecosistema, dell’umanità e della civiltà;
- d. nell’età atomica, è il più irresponsabile dei paradigmi, perché prepara e alimenta incredibilmente uno dei corni del dilemma posto da Einstein e Russell, a discapito dell’altro: “metteremo fine al genere umano oppure l’umanità saprà rinunciare alla guerra?”
Il paradigma nuovo
Dunque, per non perdersi nell’oscurantismo, salvare l’umanità dall’olocausto nucleare e liberare risorse per affrontare la crisi sistemica globale, non c’è che una cosa da fare immediatamente: cambiare il paradigma obsoleto con il paradigma nuovo, passare da “se vuoi la pace prepara la guerra” e se vuoi la pace prepara la pace. E farne discendere politiche attive di pace coerenti, razionali e responsabili per affrontare e risolvere i conflitti: disarmo, riconversione sociale delle spese militari, riconversione civile dell’industria bellica, proibizione delle armi nucleari, approntamento della difesa civile, non armata, nonviolenta e dei corpi civili di pace, educazione preventiva e sistematica alla pace ed alla trasformazione nonviolenta dei conflitti dalla dimensione micro a quella macro. Secondo realismo e razionalità.
*
- Titolo originale - “Si vis pacem para bellum”: obsolescenza di un paradigma fondato sul pensiero magico. Tracce di critica realista e razionale
*
Fonte: Comune-Info, 26 Giugno 2022.
-
>PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- UNA QUESTIONE ANTROPO-LOGICA "La corona della pace. Dall’Antico Testamento ai nostri giorni" (di Piero Stefani).5 maggio 2022, di Federico La Sala
KANT E LA DOMANDA ANTROPO-LOGICA: CHI SONO "IO"? *
- «Il campo della filosofia in significato cosmopolitico si può ricondurre alle seguenti domande:
1) Che cosa posso sapere? 2) Che cosa devo fare? 3) Che cosa mi è lecito sperare?
4) Che cosa è l’uomo?
 Alla prima domanda risponde la metafisica, alla seconda la morale, alla terza la religione
e alla quarta l’antropologia.
In fondo, si potrebbe ricondurre tutto all’antropologia, perché le prime tre domande fanno riferimento all’ultima.» (I. Kant, Logica [1800], Laterza, Bari 1984).
Alla prima domanda risponde la metafisica, alla seconda la morale, alla terza la religione
e alla quarta l’antropologia.
In fondo, si potrebbe ricondurre tutto all’antropologia, perché le prime tre domande fanno riferimento all’ultima.» (I. Kant, Logica [1800], Laterza, Bari 1984).
- "L’Io è il mistero profondo", "e non dell’io in senso psicologico"(L. Wittgenstein, Quaderni 1914-1916).
La corona della pace
Dall’Antico Testamento ai nostri giorni
di Piero Stefani (Il Regno/Attualità, 6/2022, 15/03/2022)
Nel rito preconciliare della messa in latino, non di rado il Vangelo iniziava con questa formula: «In illo tempore Iesus dixit...». Anche ora, quando non si è nelle condizioni di riportare l’ambientazione precisa dell’episodio, si ricorre a: «In quel tempo Gesù disse...». È una clausola che riguarda il passato. Di contro, nei profeti d’Israele l’espressione «in quel giorno (ba-yom ha-hu)» si proietta verso l’avvenire (cf. Zc 14,20); lo stesso vale per «Ecco, verranno giorni» (Ger 31,31). Vi è però una formula ancor più radicale: «Alla fine dei giorni (be‘aharit ha-yamin)», ed è proprio quest’ultima a contraddistinguere l’oracolo di pace presente, in termini identici, in due diversi profeti: Isaia e Michea.
Soltanto alla fine dei giorni un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo; solo allora si smetterà di fare guerra (cf. Is 2,2-4; Mi 4,1-3). La filologia si impegna a precisare il senso dell’espressione; resta fuor di dubbio che essa riguarda il futuro. La fine dei giorni non può essere mai declinata al presente. Dunque, finché ci sono i nostri giorni, non è dato sperare nella venuta di «quei giorni»?
Sperare comporta guardare in avanti; a volte conviene però voltarsi anche indietro per comprendere i modi in cui si è concepita questa porta dischiusa verso il futuro. Per pensare bisogna avere fiducia nella ragione, per farlo in modo maturo occorre individuarne i limiti. Questo procedere si definisce critico. Esso, a fine Settecento, raggiunse il proprio vertice con Kant, il filosofo vissuto a Königsberg, l’attuale Kaliningrad, enclave russa tra Lituania e Polonia.
Per Kant le questioni fondamentali di tutta la nostra esistenza si riducono a tre: che cosa posso sapere, che cosa debbo fare, in che cosa ho il diritto di sperare. Le domande, formulate in modo semplice, ricevono tutte e tre un trattamento filosofico molto articolato; tuttavia tra esse la questione più complessa è quella relativa alla speranza. La prima domanda infatti è solo teorica e speculativa, la seconda solo pratica, mentre la terza si collega a entrambe le componenti.
Per sperare non basta sapere semplicemente come vanno le cose, né è sufficiente impegnarsi nell’agire in modo giusto: è necessario trovare il punto di tangenza tra essere e dover essere. Secondo Kant, mentre il sapere giunge alla conclusione che qualcosa è poiché qualcosa accade, la speranza conclude che qualcosa sia poiché qualcosa deve accadere.
La speranza non può appoggiarsi solo sulla descrizione della realtà e non si limita neppure a prospettare il dovere: essa è indirizzata verso un dover essere chiamato a diventare reale in virtù di una forza non totalmente sottoposta al nostro controllo. Anche se la si pensa come un progetto, la speranza non è paragonabile ai programmi la cui realizzazione dipende dall’azione di chi ora li sta mettendo in pratica. Il farsi della speranza non è paragonabile al processo che porta la materia prima a diventare manufatto. La clausola in base alla quale qualcosa sarà perché qualcosa deve accadere sta a indicare la presenza di questo salto qualitativo.
Il progetto è, ovviamente, sulla carta e non ancora nella realtà. Il passaggio dal virtuale al reale è intrinsecamente esposto a rischi; tuttavia, il più delle volte, esso è connesso a quanto si fa e non già a quel che deve accadere. La speranza ha invece bisogno di appoggiarsi a una realtà - piccola o grande che sia - posta al di là della sfera del nostro agire.
La speranza si situa nello spazio posto tra l’agire e la meta che l’opera si prefigge di conseguire. Quando questo salto è molto grande il fine può apparire utopico. Non ci è dato di controllare la forza in grado di garantire che quanto deve essere effettivamente sia. Per questa ragione la pace messianica, allorché, secondo le parole di Isaia e Michea, le armi saranno convertite negli strumenti del buon operare umano, è apparsa ai più un’utopia. La storia parla il linguaggio della guerra o al più delle tregue, non quello di una pace che non conosce tramonto.
L’ideale della pace perpetua
Nel 1795, quando l’Europa era scossa dai sussulti della Rivoluzione francese, mentre Russia, Impero asburgico e Prussia si spartivano la Polonia ed erano in incubazione le grandi guerre del periodo napoleonico, Immanuel Kant scrisse l’opuscolo Progetto per una pace perpetua. Quelle pagine non si limitano a individuare le modalità per conseguire tregue prolungate in grado di garantire una tranquilla convivenza tra gli stati; esse prospettano un esito più alto in cui la pace sarà condizione normale e permanente per tutta l’umanità.
Il libretto assume la veste di progetto fornendo regole per fondare un diritto cosmopolitico (noi diremmo internazionale) in grado di garantire a tutti una pacifica convivenza. Nelle ultime righe dell’opera si legge: «Se è un dovere, ed anche una fondata speranza, realizzare uno stato di diritto pubblico,1 anche se solo con una approssimazione progressiva all’infinito, allora la pace perpetua, che succederà a quelli che sono stati sino a ora falsamente denominati trattati di pace (propriamente, armistizi), non è idea vuota. Ed anzi sarà un compito che, assolto per gradi, si avvicinerà sempre più velocemente al suo adempimento (perché è sperabile che i periodi di tempo in cui avverranno tali progressi si faranno sempre più brevi)».
Dovere e fondata speranza assumono l’aspetto di tangenza all’infinito: non li si raggiungerà mai, ma ci si può avvicinare sempre. La vera meta diviene così un continuo camminare. In termini consoni agli addetti ai lavori, si dovrebbe parlare di uso noumenico regolativo dell’idea di pace. L’aver definito «progetto» il trattato conferma il carattere laico del pensare di Kant. In questo ambito concettuale non si spera nell’irruzione dall’esterno di un evento messianico. L’operare umano non può andare al di là di un’approssimazione all’infinito. La pace perpetua conserverà sempre l’aspetto di un ideale ancora da realizzare. Non si arriverà mai a una pace definitiva; tuttavia la tensione per giungervi avvicinerà sempre più gli armistizi a veri e propri trattati di pace.
Come stanno le cose ai nostri giorni? Le attuali guerre hanno perso le connotazioni giuridiche un tempo a esse consuete. Oggi, in pratica, non è più dato pensare a trattati che pongano fine a guerre dichiarate perché queste ultime non esistono più.
Semplicemente si fanno guerre senza prendersi la briga di dichiararle. Per alludere a Ugo Grozio e al suo capolavoro De jure belli ac pacis, è arduo stabilire le regole della pace là dove non ci sono più le regole della guerra. La guerra civile sembra essere diventata il modello di ogni tipo di scontro bellico. Nei nostri giorni, quando le armi perdono di virulenza, a prolungarsi a tempo indeterminato sono, spesso, guerre condotte «a bassa intensità» (il Donbass ha molti, crudeli parenti in giro per il mondo).
La pace messianica
Se è lecito avere nostalgia, oltre che dei grandi ideali kantiani, anche delle regole della guerra e della pace, che dire della pace messianica di cui parlò il filosofo neo-kantiano Hermann Cohen? Egli, mentre l’Europa era sconvolta dalla Prima guerra mondiale, ripensò, alla fine della sua vita, alla propria origine ebraica e scrisse un’opera - uscita postuma nel 1918 - dal titolo che evoca a un tempo sia Kant (cf. La religione nei limiti della semplice ragione) sia l’antica sapienza d’Israele: La religione della ragione dalle fonti dell’ebraismo.
Essa si conclude parlando di pace; lo fa però in termini messianici e non già noumenici. La pace è il fine assoluto che non può essere mai reso puro mezzo: «La pace in quanto fine dell’uomo è il Messia, che libera gli uomini e i popoli da ogni dissidio, che appiana il dissidio nell’uomo stesso e produce infine per l’uomo la riconciliazione con il suo Dio. (...) Il messianismo è e rimane la forza fondamentale della coscienza ebraica. E il Messia è il principe della pace (...) Qual è il compendio della vita umana nello spirito della Bibbia? È la pace. Tutto il senso, tutto il valore della vita risiede nella pace. Essa è l’unità di tutte le forze vitali, il loro equilibrio, è l’appianamento di tutti i contrasti. La pace è la corona della vita».2
«Corona della vita», l’espressione ebraica shalom ‘alekhem (al pari della sua forma sorella araba) resa alla lettera significa «pace su di voi». La pace è una realtà che scende dall’alto e si posa sul capo.
Il libro di Hermann Cohen termina con queste parole: «La pace è l’emblema dell’eternità, è la parola d’ordine della vita umana, tanto nel suo comportamento individuale quanto nell’eternità della sua missione storica. In questa eternità storica si compie la missione di pace dell’umanità messianica».3 In un mondo irredento solo la speranza in una pace messianica, di cui nei momenti felici è dato gustare già qualche anticipazione (la tradizione ebraica parla del sabato come di un sessantesimo del mondo avvenire), può, forse, reggere di fronte alla catastrofe.
In un mondo lacerato dalle guerre, la sfida lanciata dalla speranza messianica ebraica al Messia cristiano definito anch’esso «principe della pace» continua, questa volta senza alcun «forse», a stagliarsi all’orizzonte. Sta alla comunità dei credenti in Gesù Cristo cercare i modi per rispondervi.
1 Vale a dire l’esistenza di un effettivo diritto internazionale.
2 H. Cohen, La religione della ragione dalle fonti dell’ebraismo, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994, 636-638.
3 Ivi, 640.
*
NOTA:
ANTROPOLOGIA E CRISTOLOGIA ("ECCE HOMO").
- Bibbia, Vangeli, e Cristologia: "Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli" (Piero Stefani, “Bibbia e Corano, un confronto”, Letture).
Al vertice del "cristianesimo" (cattolicesimo costantiniano), in realtà, non ci sono - come sostiene Piero Stefani - i "quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi)", ma - fondamentalmente - le lettere (e l’interpretazione "andrologica" della figura di Cristo) di Paolo di Tarso: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
Questo è il problema...
Federico La Sala
- «Il campo della filosofia in significato cosmopolitico si può ricondurre alle seguenti domande:
1) Che cosa posso sapere? 2) Che cosa devo fare? 3) Che cosa mi è lecito sperare?
4) Che cosa è l’uomo?
-
>PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "Se in Ucraina non cessa il fuoco e l’Europa non inverte la rotta imboccando la strada della smilitarizzazione, il conflitto si estenderà in modo imprevedibile (di Ida Dominjanni - Il nuovo conflitto di civiltà)..4 marzo 2022, di Federico La Sala
Il nuovo scontro di civiltà
di Ida Dominijanni (CRS, 4 Marzo 2022)
All’alba del nono giorno di guerra l’attacco delle truppe russe alla centrale nucleare Zaporizhzhia rende meglio di qualunque altro dettaglio quale sia la posta della partita globale, biopolitica prima che geopolitica, che si sta giocando in Ucraina. E il peggio deve ancora venire, ha comunicato Macron cui Putin ha fatto presente che non intende fermarsi finché non avrà conquistato l’intero paese. Le regioni russe dell’est e del sud con gli accessi al mare sono ormai in mano ai russi, a Mariupol mezzo milione di abitanti sono intrappolati senza acqua e senza cibo, a nord-ovest Leopoli è piena di profughi in fuga, più donne e bambini che uomini perché gli uomini restano a combattere una battaglia di resistenza già persa.
 L’esile negoziato in corso a Brest ha deciso l’apertura di corridoi umanitari per favorire l’esodo dei civili, mentre la colonna di 60 kilometri di carri russi continua la sua lenta ma inesorabile avanzata su Kiev lungo il corso del Dnepr che in futuro potrebbe dividere l’Ucraina fra un est russo e un ovest occidentale, com’era un tempo la Germania: le stesse cose ritornano sempre, nella storia, come il rimosso nell’inconscio. Dev’essere per questo che tutti definiscono questa in Ucraina “la prima guerra nel cuore dell’Europa dopo più di settant’anni”, dimenticando clamorosamente che in Europa la guerra era già tornata negli anni Novanta, in quella ex Jugoslavia che ha anticipato e prefigurato tutte le guerre successive a base etnico-nazionalista sparse per il mondo. -Forse che la Jugoslavia non era il cuore ma la periferia dell’Europa? O non sarà piuttosto che nell’immaginario europeo, il cuore dell’Europa resta sempre lì, al confine fra l’ex impero sovietico e l’Occidente democratico? Lì, dove secondo gli stessi che nell’89 decretavano “la fine della storia” oggi la storia riprenderebbe in grande, quasi che in mezzo non ci fosse stato niente. Lì, dove si sono convocati tutti i fantasmi che fino a ieri l’altro vagavano per l’est e per l’ovest, e che ora muovono questa terribile resa dei conti di un trentennio cominciato male e finito peggio. Che è la vera posta in gioco, reale e simbolica, della tragedia che si sta consumando.
L’esile negoziato in corso a Brest ha deciso l’apertura di corridoi umanitari per favorire l’esodo dei civili, mentre la colonna di 60 kilometri di carri russi continua la sua lenta ma inesorabile avanzata su Kiev lungo il corso del Dnepr che in futuro potrebbe dividere l’Ucraina fra un est russo e un ovest occidentale, com’era un tempo la Germania: le stesse cose ritornano sempre, nella storia, come il rimosso nell’inconscio. Dev’essere per questo che tutti definiscono questa in Ucraina “la prima guerra nel cuore dell’Europa dopo più di settant’anni”, dimenticando clamorosamente che in Europa la guerra era già tornata negli anni Novanta, in quella ex Jugoslavia che ha anticipato e prefigurato tutte le guerre successive a base etnico-nazionalista sparse per il mondo. -Forse che la Jugoslavia non era il cuore ma la periferia dell’Europa? O non sarà piuttosto che nell’immaginario europeo, il cuore dell’Europa resta sempre lì, al confine fra l’ex impero sovietico e l’Occidente democratico? Lì, dove secondo gli stessi che nell’89 decretavano “la fine della storia” oggi la storia riprenderebbe in grande, quasi che in mezzo non ci fosse stato niente. Lì, dove si sono convocati tutti i fantasmi che fino a ieri l’altro vagavano per l’est e per l’ovest, e che ora muovono questa terribile resa dei conti di un trentennio cominciato male e finito peggio. Che è la vera posta in gioco, reale e simbolica, della tragedia che si sta consumando.Hanno suscitato indignazione e scandalo i due discorsi del 21 e del 24 febbraio con cui Putin ha annunciato prima il riconoscimento ufficiale delle repubbliche separatiste del Donbass e poi la sua “operazione militare speciale”, come l’ha chiamata lui, in Ucraina. Ne consiglierei tuttavia la lettura integrale (il testo è facilmente reperibile in rete), ammesso che sia ancora lecito cercare di capire perché accade quello che accade senza essere tacciati di connivenza con il nemico. Liquidati dai più come una litania del risentimento, o come il delirio paranoico da sindrome di accerchiamento di un uomo solo al comando provato dalla fobia del Covid, i due discorsi inanellano alcuni dati di fatto incontrovertibili sull’estensione a est della Nato, sulle guerre di aggressione perpetrate dall’Occidente dagli anni novanta in poi (Kosovo, Iraq, Siria, Libia), e, più in generale, sullo “stato di euforia da superiorità assoluta, una sorta di assolutismo di tipo moderno, per di più sullo sfondo di un basso livello di cultura generale” che si è impossessato del campo dei vincitori della Guerra fredda.
 Ma al di là di questo merito, nonché della ricostruzione delle cause di lungo periodo della rinascita dei nazionalismi, a Est dopo la fine dell’Urss, ciò che colpisce nelle parole di Putin è la rivendicazione della dimensione storica come sfondo ineludibile del discorso politico. Precisamente lo sfondo che manca al discorso politico occidentale, che di spessore storico sarebbe supposto essere il più dotato. E che invece risponde all’aggressione di Putin usando - mirabile sintesi di un cinquantennio di ideologia neoliberale - solo il linguaggio dell’economia e della sicurezza: sanzioni e riarmo, nell’oblio - perfino teorizzato, come nel discorso alle camere di Mario Draghi - del passato che ha costruito, mattone dopo mattone, il presente.
Ma al di là di questo merito, nonché della ricostruzione delle cause di lungo periodo della rinascita dei nazionalismi, a Est dopo la fine dell’Urss, ciò che colpisce nelle parole di Putin è la rivendicazione della dimensione storica come sfondo ineludibile del discorso politico. Precisamente lo sfondo che manca al discorso politico occidentale, che di spessore storico sarebbe supposto essere il più dotato. E che invece risponde all’aggressione di Putin usando - mirabile sintesi di un cinquantennio di ideologia neoliberale - solo il linguaggio dell’economia e della sicurezza: sanzioni e riarmo, nell’oblio - perfino teorizzato, come nel discorso alle camere di Mario Draghi - del passato che ha costruito, mattone dopo mattone, il presente.Sia chiaro: lo sfondo e l’uso della storia non giustificano in alcun modo la mossa di Putin. L’invasione di uno Stato sovrano e confinante viola le basi del diritto internazionale, resuscita, a proposito di storia lunga, tutti i mostri del passato europeo, e si configura per di più, nelle stesse motivazioni che Putin ne dà, come una sorta di preemptive war, una guerra preventiva contro il pericolo eventuale di un’aggressione alla Russia da parte della Nato (i nemici assoluti sono spesso segretamente gemelli, e Putin evidentemente ha imparato qualcosa da George W. Bush).
 Nessuna ragione di lungo periodo esenta di un grammo di responsabilità la decisione con cui il presidente russo ha portato il mondo sull’orlo del precipizio. Ma pare assai improbabile che dal precipizio le democrazie occidentali possano uscire senza aprire al proprio interno tre linee di ripensamento autocritico di un passato prossimo che invece tendono solo a rimuovere o a riconfermare.
Nessuna ragione di lungo periodo esenta di un grammo di responsabilità la decisione con cui il presidente russo ha portato il mondo sull’orlo del precipizio. Ma pare assai improbabile che dal precipizio le democrazie occidentali possano uscire senza aprire al proprio interno tre linee di ripensamento autocritico di un passato prossimo che invece tendono solo a rimuovere o a riconfermare.La prima linea riguarda l’atroce sequenza di guerre con cui l’Occidente ha insanguinato l’epoca di pace che aveva annunciato alla fine della Guerra fredda, e che rischiano di costituire i precedenti formali, non solo le concause politiche, dello scenario che si va prefigurando in Europa. Dovrebbe balzare agli occhi l’analogia agghiacciante fra le motivazioni addotte da Putin a sostegno della minoranza russa in Ucraina e quelle che mossero il cosiddetto intervento umanitario della Nato a sostegno della minoranza kosovara in Serbia, con relativo bombardamento di Belgrado: e invece non un cenno se ne sente in specie nel Pd, erede del partito che fu il principale regista italiano di quella guerra, oggi abitato da una classe dirigente che sembra del tutto ignara della drammaticità di quella stagione e del tutto conforme alla narrativa trionfale del dopo-’89.
 Dovrebbe risuonare come un monito sullo stato delle democrazie occidentali la madre di tutte le fake news e di tutte le post-truth politics, ovvero la gigantesca menzogna sulle presunte armi di distruzione di massa possedute da Saddam Hussein che giustificò la “guerra preventiva” in Iraq. Soprattutto, dovrebbe portare un grammo di senno, questo sì preventivo, sullo scenario europeo prossimo venturo la scia di guerre civili, regimi instabili ed esodi migratori biblici lasciata dietro di sé dall’intera sequenza delle guerre post-89, tutte caratterizzate dall’intreccio micidiale di rivendicazioni nazional-sovraniste e rivendicazioni etnico-regionali che si ripropone oggi in Ucraina e rischia di riproporsi in un teatro europeo più vasto di quello ucraino. E invece è proprio nella ripetizione nevrotica di quella dinamica che ci stiamo infilando, con il corredo sinistro di un soccorso armato alla resistenza ucraina fatto di contractors, appalti, privatizzazione dell’uso della forza - un film, anche questo, già visto in Iraq e in Siria, con le conseguenze che sappiamo.
Dovrebbe risuonare come un monito sullo stato delle democrazie occidentali la madre di tutte le fake news e di tutte le post-truth politics, ovvero la gigantesca menzogna sulle presunte armi di distruzione di massa possedute da Saddam Hussein che giustificò la “guerra preventiva” in Iraq. Soprattutto, dovrebbe portare un grammo di senno, questo sì preventivo, sullo scenario europeo prossimo venturo la scia di guerre civili, regimi instabili ed esodi migratori biblici lasciata dietro di sé dall’intera sequenza delle guerre post-89, tutte caratterizzate dall’intreccio micidiale di rivendicazioni nazional-sovraniste e rivendicazioni etnico-regionali che si ripropone oggi in Ucraina e rischia di riproporsi in un teatro europeo più vasto di quello ucraino. E invece è proprio nella ripetizione nevrotica di quella dinamica che ci stiamo infilando, con il corredo sinistro di un soccorso armato alla resistenza ucraina fatto di contractors, appalti, privatizzazione dell’uso della forza - un film, anche questo, già visto in Iraq e in Siria, con le conseguenze che sappiamo.La seconda linea di riflessione autocritica riguarda lo stato delle democrazie occidentali e quello connesso della costruzione europea. Oggi siamo tutti dalla parte dell’Ucraina, vittima di un’aggressione inammissibile, e da questa parte bisogna restare finché i carri armati russi resteranno in campo. Ma nella retorica monotonale occidentale l’Ucraina è diventata in pochi attimi la trincea della difesa della democrazia tout court, anzi, per dirla con le parole di Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell’Unione, la trincea del conflitto fondamentale del nostro tempo, che sarebbe quello fra democrazia e autocrazia. Le élite democratiche americane sono impegnate da tempo a costruire questo frame narrativo, opposto e speculare all’attacco alla liberaldemocrazia occidentale portato avanti dalla concezione putiniana della cosiddetta “democrazia sovrana”. E se nella politica interna americana questo frame è servito a sconfiggere Trump, in politica estera è destinato a prendere il posto di quello sullo “scontro di civiltà” fra Occidente e Islam che ha tenuto banco per tutto il ventennio della war on terror successivo all’11 settembre. Ma dopo Trump, gli americani non possono non sapere che la linea di confine fra democrazie e autocrazie è diventata molto esile, e può essere scavalcata dagli autocrati che crescono all’interno delle democrazie occidentali, non soltanto al di fuori di esse.
 E noi europei non possiamo non sapere che le tentazioni autocratiche e sovran-populiste sono cresciute, soprattutto ma non solo nei paesi ex-sovietici dell’est, parallelamente ai processi di crisi e de-democratizzazione dei paesi dell’ovest, e sovente per reazione alla delusione di un allargamento a est dell’Unione rivelatosi più un’annessione alla religione del mercato che un’integrazione del mosaico di culture e tradizioni del vecchio continente. Anche da questa parte dell’oceano, il pericolo autocratico non viene solo dall’esterno, e la democrazia non può essere impugnata come una bandiera senza macchia e senza peccato.
E noi europei non possiamo non sapere che le tentazioni autocratiche e sovran-populiste sono cresciute, soprattutto ma non solo nei paesi ex-sovietici dell’est, parallelamente ai processi di crisi e de-democratizzazione dei paesi dell’ovest, e sovente per reazione alla delusione di un allargamento a est dell’Unione rivelatosi più un’annessione alla religione del mercato che un’integrazione del mosaico di culture e tradizioni del vecchio continente. Anche da questa parte dell’oceano, il pericolo autocratico non viene solo dall’esterno, e la democrazia non può essere impugnata come una bandiera senza macchia e senza peccato.Questo nodo lega il trentennio che abbiamo alle spalle al presente e al futuro dell’Unione europea e della sua collocazione nello scacchiere globale. Il rilancio dell’atlantismo da parte di Joe Biden appariva molto ambivalente già all’indomani della sua elezione: mentre riavvicinava le due sponde dell’Atlantico che Trump aveva allontanato, innalzava un nuovo muro fra l’Europa e le autocrazie orientali, chiamando la Ue a posizionarsi nettamente contro di esse. Già allora le voci più consapevoli spinsero infatti per un’Unione atlantista ma aperta verso Est e capace di porsi come ponte fra gli Stati uniti, la Russia e la Cina. Complice la fine del cancellierato di Angela Merkel, nonché verosimilmente l’insediamento del governo Draghi in Italia, le cose hanno preso purtroppo un’altra piega.
 E oggi è più che inquietante il coro mainstream di soddisfazione che si leva per un compattamento europeo che fa propria la parola d’ordine americana del nuovo scontro di civiltà fra Occidente e Oriente, e avviene tutto sotto l’insegna della Nato, di sanzioni durissime che colpiranno Putin ma affosseranno la transizione energetica europea, di una politica di pura potenza, di un riarmo di cui la Germania si fa protagonista e che travolge persino la neutralità storica di paesi come la Finlandia.
E oggi è più che inquietante il coro mainstream di soddisfazione che si leva per un compattamento europeo che fa propria la parola d’ordine americana del nuovo scontro di civiltà fra Occidente e Oriente, e avviene tutto sotto l’insegna della Nato, di sanzioni durissime che colpiranno Putin ma affosseranno la transizione energetica europea, di una politica di pura potenza, di un riarmo di cui la Germania si fa protagonista e che travolge persino la neutralità storica di paesi come la Finlandia.Se si rafforza in questo modo, dopo aver clamorosamente mancato tutte le possibilità preventive di disinnescare politicamente la miccia che Putin stava accendendo, l’Unione europea finirà col fare le spese del ridisegno dell’ordine globale che si sta giocando nella guerra fra l’imperialismo russo e il nazionalismo ucraino.
 Se in Ucraina non cessa il fuoco e l’Europa non inverte la rotta imboccando la strada della smilitarizzazione, il conflitto si estenderà in modo imprevedibile e i tempi si faranno durissimi per la specie umana. Se le democrazie si compatteranno al loro interno sulla base dell’ennesima proclamazione dello stato d’emergenza, come già sta avvenendo in Italia, la credibilità della democrazia subirà un ennesimo e fatale colpo. Come sempre e mai come oggi, per incidere sullo scacchiere geopolitico il pacifismo deve alimentarsi di un conflitto politico aspro dentro casa, in primo luogo contro la militarizzazione del dibattito pubblico.
Se in Ucraina non cessa il fuoco e l’Europa non inverte la rotta imboccando la strada della smilitarizzazione, il conflitto si estenderà in modo imprevedibile e i tempi si faranno durissimi per la specie umana. Se le democrazie si compatteranno al loro interno sulla base dell’ennesima proclamazione dello stato d’emergenza, come già sta avvenendo in Italia, la credibilità della democrazia subirà un ennesimo e fatale colpo. Come sempre e mai come oggi, per incidere sullo scacchiere geopolitico il pacifismo deve alimentarsi di un conflitto politico aspro dentro casa, in primo luogo contro la militarizzazione del dibattito pubblico. -
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA --- LA GUERRA DI TROIA NON E’ MAI FINITA. Il ruolo di "Elena" e il potere delle parole maiuscole: Simone Weil tra storia e profezia.1 marzo 2022, di Federico La Sala
LA GUERRA DI TROIA NON E’ MAI FINITA: SIMONE WEIL TRA STORIA E PROFEZIA. Il potere delle "parole maiuscole"
- «La pulizia filosofica della religione cattolica non è mai stata fatta; per farla, bisognerebbe essere al contempo dentro e fuori» (Simone Weil tra storia e profezia, Avvenire, 27.02.202).
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- "NON RICOMINCIAMO LA GUERRA DI TROIA": "[...] per i nostri contemporanei il ruolo di Elena è svolto da parole adorne di maiuscole.
- [...] Le parole che hanno un contenuto e un senso non sono omicide. Ma si mettano le maiuscole a parole vuote di significato e, per poco che le circostanze spingano in questa direzione, gli uomini verseranno fiumi di sangue senza poter mai ottenere effettivamente qualche cosa che a queste parole corrisponda; niente di reale potrà mai corrispondere, perché non vogliono dire niente. Il successo si definisce allora esclusivamente attraverso l’annientamento dei gruppi umani che sostengono parole nemiche.” (SIMONE WEIL, 1937)
- A PROPOSITO DELLE MAIUSCOLE E DI "ELENA"... SIMONE WEIL CON J.-J. ROUSSEAU E CON KARL MARX. Una prima traccia è nell’atto "primordiale" (che prima di essere materiale è linguistico) della recinzione: "Il primo che, dopo aver recintato un terreno, pensò di dire questo è mio, e trovò altri tanto ingenui da credergli, fu il fondatore della "societàcivile"("Discorso sull’origine della disuguaglianza", 1750"); la seconda è nella denuncia marxiana (nella "Sacra Famiglia") dell’inversione soggetto-predicato (il problema della mele, delle pere, e delle fragole... del Mentitore) e della "fanciulla straniera e la civetta hegeliana" (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 190-197)"!
- SENZA KANT, SENZA LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA RELIGIONE, NON SI ESCE DALL’INFERNO (DANTE 2021).
Novecento. Simone Weil tra storia e profezia
Continua a suscitare interesse la filosofa, della quale tornano in libreria saggi e testimonianze Forte in lei il rifiuto del potere, violento tradimento dell’ideale
di Roberto Righetto (Avvenire, domenica 27 febbraio 2022)
- [Foto] La filosofa Simone Weil (1909-1943)
È sempre l’ora di Simone Weil. Anche in Italia si continuano a pubblicare, o ripubblicare, le sue opere. La casa editrice Eleuthera propone, nel volume Incontri libertari a cura di Maurizio Zani (pagine 272, euro 18,00) alcuni suoi scritti giovanili su marxismo e nazismo ove trapela l’ostilità della pensatrice francese verso ogni forma di Stato. Erano gli anni in cui la Weil decideva di andare a lavorare in fabbrica per condividere la sorte degli operai e in cui maturava l’idea di porre in atto un’opera di sensibilizzazione culturale dei ceti popolari, consapevole - come sarebbe stato anni dopo don Milani - che solo l’istruzione avrebbe potuto infondere nei lavoratori e nelle lavoratrici la coscienza dei propri diritti. Anni in cui Simone si recò in Germania per verificare l’operato dei partiti di sinistra e dei sindacati e in cui ospitò a Parigi Trockij, col quale però litigò perché l’esponente comunista, pur rivale di Stalin, giudicava ancora positivamente l’esperimento sovietico e qualificava come “operaio” lo Stato russo.
In quei primi anni Trenta la Weil maturò un giudizio complessivamente negativo verso la forma statale, ritenuta sinonimo di oppressione. Aveva in mente le degenerazioni autoritarie del comunismo in Russia e presentiva quanto stava germinando in Germania con l’affermarsi del nazismo. Anche a livello di filosofia della storia, criticava Marx e le sue teorie viziate da un «riduzionismo esasperato», che riconduce solo agli elementi economici e ai rapporti di produzione i movimenti storici fondamentali, ignorando l’apporto degli individui e dei fattori psicologici e culturali.
Delusa dai partiti comunisti e socialdemocratici che vede all’opera in terra tedesca, «la Weil - scrive Zani - avverte un sensibile isolamento rispetto a tutte quelle forze intellettuali e politiche che sembrano incapaci di cogliere le minacce incombenti in Europa e che porteranno alla tragedia della Seconda guerra mondiale». Spirito inquieto e sinceramente ribelle, Simone Weil, dopo l’infelice esperienza della Guerra civile spagnola, lasciò cadere a poco a poco i suoi interessi verso la politica e si indirizzò verso temi più filosofici e religiosi.
Come risulta evidente da un altro volume che Mimesis ora ripropone, Simone Weil come l’abbiamo conosciuta di Joseph-Marie Perrin e Gustave Thibon (pagine 170, euro 16,00), che raccoglie le testimonianze delle due figure che più la introdussero alla fede cristiana assieme a padre Marie-Alain Couturier, quest’ultimo incontrato dopo aver lasciato la Francia per gli Stati Uniti, nel luglio 1942. Non a caso scrisse proprio a lui queste parole nella Lettera a un religioso: «Quando leggo il Nuovo Testamento, i mistici, la liturgia, quando vedo celebrare la messa, avverto quasi la certezza che questa fede è la mia, o più esattamente sarebbe mia senza la distanza che la mia imperfezione ha posto tra me e lei».
A Couturier l’aveva presentata il confratello domenicano Perrin, che Simone aveva frequentato a Marsiglia a partire dal 1941. Con quest’ultimo, impegnato nella Resistenza, era diventato amico e a lungo avevano discusso del cristianesimo, anche animatamente. Ma la filosofa aveva preferito non ricevere il battesimo.
 Pur manifestando la sua adesione alla figura di Cristo, rimanevano in lei numerose perplessità sulla Chiesa cattolica. Che emergono in tutta evidenza nel volume Attesa di Dio, pubblicato postumo nel 1949 proprio su iniziativa di padre Perrin.
Pur manifestando la sua adesione alla figura di Cristo, rimanevano in lei numerose perplessità sulla Chiesa cattolica. Che emergono in tutta evidenza nel volume Attesa di Dio, pubblicato postumo nel 1949 proprio su iniziativa di padre Perrin.Non sopportava la Chiesa cattolica come organizzazione e collettività, e poi l’incapacità che riscontrava a quel tempo di valorizzare le altre culture e religioni e il mondo dei non credenti (non c’era ancora stato il Concilio), manifestatasi con la violenza più volte nel corso della storia. Infine, pesava il suo sentirsi inadeguata a essere accolta dalla Chiesa. Per questo partecipava alla Messa ma non voleva ricevere l’ostia.
Anche in un altro saggio, I catari e la civiltà mediterranea, che opportunamente Marietti rimanda in libreria, emerge la sua critica alla politica centralizzatrice della Chiesa che avrebbe aperto la strada all’Inquisizione, fermando anche la spinta per un modello pacifico che veniva dall’Umbria, con san Francesco. Allo stesso modo, il gotico avrebbe cancellato il romanico.
Come racconta nel volume ripubblicato da Mimesis Gustave Thibon, il filosofo-contadino che Simone frequentò in Provenza fra il 1941 e il ’42, l’ostacolo intellettuale verso la Chiesa rimase insormontabile. Di qui la sua simpatia verso il manicheismo e il catarismo e la sua ripetuta condanna delle degenerazioni totalitarie del cattolicesimo nel corso della storia.
La sua preferenza andava ai vinti, a coloro che avevano - e hanno - saputo resistere al male prendendo su di sé il dolore degli altri. Thibon ne riporta un aforisma: «La pulizia filosofica della religione cattolica non è mai stata fatta; per farla, bisognerebbe essere al contempo dentro e fuori».
Ma nonostante tutto, così conclude la sua testimonianza: «Tutto ciò che sappiamo di Simone Weil ci fa intuire che appartiene a quella Chiesa dei santi la cui vita è nascosta in Dio. Simone Weil ha appassionatamente amato l’anima della Chiesa; se ne è nutrita, vi ha attinto le sue più alte ragioni di vita: il suo solo errore è stato di dimenticare che quest’anima si portava dietro un corpo, con la sua miseria e le sue esigenze. E non solo ha vissuto di Chiesa, ma ha desiderato morire per essa».
Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- ARCHEOLOGIA. In Inghilterra, scoperto un mosaico romano con l’episodio della battaglia tra Achille ed Ettore dell’Iliade.27 novembre 2021, di Federico La Sala
PIANETA TERRA, EUROPA, E MEMORIA DELLA GUERRA DI TROIA. INTERPRETAZIONE DEI SOGNI (FREUD, 1900) E DANTE 2021...
- RICORDARE L’OPERA DI OMERO E DI VIRGILIO E LA LEZIONE DI DANTE ALIGHIERI (1321-2021). Con Ulisse, oltre: "Io non Enea, io non Paulo sono" (Inferno II, 32). E LA SCOPERTA DEL LAOCOONTE (1506) E IL "TONDO DONI" DI MICHELANGELO (1506).
Archeologia
Straordinaria scoperta in Inghilterra: il primo mosaico con un episodio dell’Iliade
di Redazione (Finestre sull’Arte, 26/11/2021)
- Straordinaria scoperta archeologica in Inghilterra: in un campo agricolo è stato scoperto un mosaico romano con l’episodio della battaglia tra Achille ed Ettore dell’Iliade. È il primo mosaico di questo genere trovato nel Regno Unito.
È una scoperta straordinaria quella che è avvenuta in un campo delle East Midlands in Inghilterra: e questa volta l’aggettivo “straordinario” si può utilizzare sul serio, perché niente di simile era mai stato trovato prima d’ora in Gran Bretagna. Gli archeologi infatti degli Archaeological Services dell’Università di Leicester hanno infatti scoperto un raro mosaico romano con un episodio dell’Iliade di Omero a seguito di uno scavo condotto nelle campagne nella contea di Rutland. Il mosaico è stato subito dichiarato “scheduled monument”, ovvero bene d’interesse culturale, da parte del Dipartimento per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport (omologo del nostro ministero della cultura), dietro suggerimento di Historic England, istituto governativo che ha competenza sul patrimonio e sulla tutela dei monumenti antichi, con alcuni compiti simili a quelli delle nostre soprintendenze.
È stata proprio Historic England a dare ieri la notizia del ritrovamento, anche se la scoperta iniziale del mosaico risale al 2020, per merito di Jim Irvine, figlio del proprietario terriero Brian Naylor, che si è accorto dei resti in uno dei suoi campi e ha contattato il team archeologico del Leicestershire County Council, consulenti del patrimonio dell’autorità locale, per comunicare quanto ritrovato. Data la natura “eccezionale” (così definita dagli esperti) di questa scoperta, Historic England ha potuto ottenere finanziamenti per indagini archeologiche urgenti del sito da parte dell’Università di Leicester nell’agosto 2020. Ulteriori scavi che hanno coinvolto personale e studenti della School of Archaeology and Ancient History dell’Università di Leicester hanno esaminato il sito più a fondo nel settembre 2021.
I resti del mosaico misurano 11 metri per quasi 7 metri e rappresentano parte della storia di Achille, ovvero il suo scontro con Ettore alla fine della guerra di Troia. È una raffigurazione di cui sopravvivono pochi esempi in Europa, ed è l’unica nota nel Regno Unito. L’opera costituisce il pavimento di quella che gli archeologi pensano sia stata una grande sala da pranzo o una zona dove i proprietari della dimora si rilassavano. La stanza dove si trovava il mosaico infatti fa parte di una grande villa che fu abitata in epoca tardoimperiale, tra il III e il IV secolo d.C. La villa è inoltre circondata da una serie di altri edifici rivelati da un’indagine geofisica e da uno studio archeologico, tra cui quelli che sembrano fienili, strutture circolari e forse anche uno stabilimento termale, il tutto all’interno di una serie di fossati di confine. È probabile che il complesso fosse proprietà di un individuo facoltoso, che aveva conoscenze di letteratura classica.
[FOTO]:
 Una parte del mosaico scoperto
Una parte del mosaico scoperto
 Una parte del mosaico scoperto.
Una parte del mosaico scoperto.
 Lo studioso David Neal sul sito della scoperta
Lo studioso David Neal sul sito della scoperta
 Il mosaico nella sua interezza
Il mosaico nella sua interezza
 Archeologa al lavoro sul mosaico
Archeologa al lavoro sul mosaico
 Archeologo al lavoro sul mosaico
Archeologo al lavoro sul mosaico
 Veduta aerea del sito
Veduta aerea del sitoSegni di fuoco e rotture nel mosaico suggeriscono che il sito sia stato successivamente riutilizzato. Sono stati scoperti nel sito anche resti umani: si pensa che queste sepolture siano state eseguite dopo che l’edificio non era più occupato. Sebbene la loro età precisa sia attualmente sconosciuta, sono posteriori al mosaico ma posti in relazione alla villa, suggerendo una datazione tardo romana o altomedievale per il riuso di questa struttura. La loro scoperta fornisce un’idea di come il sito possa essere stato utilizzato durante questo primo periodo storico post-romano, relativamente poco conosciuto. I reperti recuperati nel sito saranno ora analizzati dagli Archaeological Services dell’Università di Leicester e da specialisti tra cui David Neal, il principale esperto di mosaici antichi del paese.
Il sito è stato accuratamente esaminato ed è stato ora ricoperto, come da prassi, per proteggerlo. Il complesso della villa è stato trovato all’interno di un campo dove i resti archeologici poco profondi erano stati disturbati dall’aratura e da altre attività agricole. Historic England sta ora collaborando con il proprietario del terreno per elaborare schemi di utilizzo agricolo compatibili con la tutela dei resti archeologici. Inoltre, in collaborazione con l’Università di Leicester e altre parti interessate, Historic England sta pianificando ulteriori scavi sul sito per il 2022. Sono in corso discussioni con il Consiglio della contea di Rutland per valutare l’opportunità di un’indagine fuori sede del complesso della villa e dei suoi reperti. Il metodo e la portata di questo lavoro saranno stabiliti dai futuri scavi. Il sito si trova all’interno di un terreno privato e non accessibile al pubblico, e per il momento ancora non si parla di apertura ai visitatori. Ad ogni modo, la scoperta della villa di Rutland e le riprese della scoperta del mosaico saranno proposti al pubblico in un documentario su BBC Two all’inizio del 2022.
“Una passeggiata nei campi con la famiglia si è trasformata in un’incredibile scoperta”, ha dichiarato Jim Irvine, autore della scoperta. “Trovare delle ceramiche insolite tra il grano ha suscitato il mio interesse e ha stimolato un ulteriore lavoro di indagine. Più tardi, guardando le immagini satellitari ho notato un segno molto chiaro, come se qualcuno avesse disegnato sullo schermo del mio computer con un pezzo di gesso! Questo è stato davvero il momento ’wow’ e l’inizio della storia. Questa scoperta archeologica ha occupato la maggior parte del mio tempo libero nell’ultimo anno. Tra il mio lavoro normale e questo sono stato molto impegnato, ed è stato un viaggio affascinante. L’ultimo anno è stata una vera emozione essere stato coinvolto e collaborare con gli archeologi e gli studenti sul sito, e posso solo immaginare cosa verrà portato alla luce dopo!”.
“È straordinario aver scoperto un mosaico così raro di queste dimensioni, così come una villa attorno”, sottolinea Duncan Wilson, ad di Historic England. “Scoperte come questa sono davvero importanti per aiutarci a ricostruire la nostra storia. Tutelando questo sito siamo in grado di continuare a imparare, e non vediamo l’ora di sapere cosa potrebbero insegnarci le indagini future sulle persone che vissero lì oltre 1.500 anni fa”.
NOTA:
TROIA, ATENE, GERUSALEMME, ROMA, L’EUROPA.... Archeologia, storia, antropologia e immaginario: uno storico presente!
Sulla base di questa significativa emergenza omerica dal terreno del passato, avvenuta nel Regno Unito, forse, vale la pena riprendere l’indicazione dei vecchi come dei giovani e lavorare, ognuno e ognuna, "per la pace perpetua" (Kant, 1795) e, finalmente, uscire da un orizzonte di millenaria cecità (Saramago) antropologica e di una guerra civile sempre più planetaria.
Federico La Sala
- RICORDARE L’OPERA DI OMERO E DI VIRGILIO E LA LEZIONE DI DANTE ALIGHIERI (1321-2021). Con Ulisse, oltre: "Io non Enea, io non Paulo sono" (Inferno II, 32). E LA SCOPERTA DEL LAOCOONTE (1506) E IL "TONDO DONI" DI MICHELANGELO (1506).
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "Non si tratta di salvare il Pianeta, ma di salvare noi stessi". Lezione del Nobel Giorgio Parisi: "Non credo che il Pianeta sia in pericolo, ma noi lo siamo" (di Giacomo Talignani).17 novembre 2021, di Federico La Sala
La lezione del Nobel Giorgio Parisi: "Non credo che il Pianeta sia in pericolo, ma noi lo siamo"
Il premio Nobel per la Fisica in collegamento: "Noi scienziati impegnati a capire le incertezze della crisi climatica, ma ormai sappiamo a cosa andiamo incontro. Serve un mondo più equo e sostenibile"
di Giacomo Talignani (la Repubblica, 16 Novembre 2021)
Nonostante qualche linea di febbre, il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi è estremamente lucido e chiaro quando parla ai ragazzi: "Non si tratta di salvare il Pianeta, ma di salvare noi stessi". Collegato per la sua prima speciale lezione in "DAD", dedicata agli studenti presenti al summit di Green&Blue e tutti coloro che l’hanno seguita in streaming, il professor Parisi sprona i giovani alla "consapevolezza sulla crisi climatica, informatevi" e preme perché sia lo "Stato, il governo" a orientarsi verso un’economia "più sostenibile". Definisce deludente l’accordo preso alla Cop26 e spiega come sia necessario agire ora per tentare di limitare l’incertezza sul futuro delle nostre vite, un tentativo che dovrà essere più equo e solidale, anche con scelte drastiche se necessario. Green&Blue Open Summit, il Nobel Parisi agli studenti: "Dite a nonni e genitori di votare chi si batte per il clima"
- Qui l’audio integrale:
Accolto da un applauso, Parisi spiega subito che "spesso non viene capito che quando si parla di scienze esatte bisogna tener conto che queste includono incertezza nei risultati. Nella scienza la maggior parte del lavoro è capire queste incertezze. Immaginate di avere un metro da sarto e misurare un corridoio di 15 metri: lo misurate più volte e avete un risultato, ma ci sarà comunque incertezza. Potete vedere se tirate un po’ di più il metro e cambia qualcosa, ma resta incertezza. Il grosso lavoro degli scienziati sta proprio nello stabilire quali sono i limiti, i margini dell’incertezza. Questo vale per tutte le scienze, anche i modelli climatici. Quarant’anni fa le previsioni davano dei valori, con incertezze, ma non molto diverse da ora sull’aumento della temperatura. Dunque da 40 anni sappiamo che c’è questo aumento legato alla CO2 e il grosso del lavoro fatto dagli scienziati è cercare di quantificare l’incertezza del modello, verificare le ipotesi, capire discrepanze e errori. Un lavoro delicato andato avanti per decenni per arrivare a queste previsioni, scientifiche proprio perché contengono incertezza. Così come c’è incertezza sugli scenari sui vari gradi".
Parisi apre la fondamentale parentesi sull’incertezza per arrivare a spiegare come "il problema del cambiamento climatico ha tanti aspetti ancora non compresi. Per esempio sappiamo che una parte sostanziale di emissioni gas serra non rimane in atmosfera ma viene assorbita oceano. Ma esattamente come e dove? Per quanto tempo? Sono problemi molto delicati, a cui lavorano gli scienziati che vanno in giro per oceani a misurare quantità di anidride carbonica per cercare di capire quanto questo meccanismo funzionerà ancora". Anche su questo c’è dubbio: "Se si inceppa il meccanismo, se l’oceano diventa incapace di assorbire i gas serra, si avrà un notevole aumento di CO2".
Viene dunque da chiedersi, queste previsioni, questi scenari, sono affidabili? Secondo Parisi "lo sono per il minimo, per la previsione più ottimistica, ma potrebbe capitare che non lo siano per il massimo, la previsione più pessimistica. In questo caso c’è la possibilità nell’evoluzione della temperatura che si incontrino eventi non prevedibili, i tipping point, catastrofi non più facilmente recuperabili".
Per chiarezza, fa un esempio. "Oggi molta CO2 viene immagazzinata nelle foreste, dall’Amazzonia agli Usa, Canada, Artico. Ma se ci fossero una serie di anni uno dopo l’altro molto sfortunati, secchezza, poca umidità, oppure siccità prolungata, eventi estremi, si potrebbe immaginare che queste foreste brucino in maniera terribile con un danno enorme per biodiversità e emettano quantità enormi di CO2 nell’aria che aumenterebbe l’effetto serra e così via. Oppure, si squagliano le banchise polari: quanto questo cambierà le circolazioni dell’acqua negli oceani? Accelererà i cambiamenti climatici? Ugualmente per il permafrost in Siberia che rilascia metano. Tutti questi eventi fanno parte di una incertezza che include che le cose possano andare ancora peggio di quanto succede ora".
Se dunque già oggi - mentre osserviamo gli eventi estremi che ci colpiscono - possiamo avere il senso di queste incertezze, è tempo di renderci conto che "noi non dobbiamo salvare il Pianeta, ma noi stessi. Il Pianeta ha cinque miliardi d’anni, ha grandi animali da mezzo miliardo d’anni, è sopravvissuto alla caduta di asteroidi e altri cambiamenti climatici. Quindi io non credo che il Pianeta sia in pericolo, ma noi lo siamo. Tutta la nostra civilizzazione è basata su risorse agricole estremamente delicate da gestire con il cambio della temperatura. Immaginiamoci se si fermano i monsoni nell’oceano indiano: cesserebbe di piovere nel sud est asiatico e miliardi di persone nell’Asia, senza cibo, vorrebbero emigrare altrove. Ecco perché la situazione è estremamente difficile".
Il punto, ricorda il premio Nobel, è comprendere che le risorse del nostro Pianeta - dalle terre rare e i minerali che stiamo esaurendo sino a quelle agricole o l’acqua - non sono infinite, ma limitate. "Dobbiamo davvero capire la nostra impronta ecologica: dobbiamo diventare una società sostenibile se vogliamo vivere per millenni e per farlo dobbiamo puntare più su risorse rinnovabili che su tutte le risorse del Pianeta".
Per questo G20 e Cop26 sono stati eventi "deludenti", perché va bene decidere di impegnarsi per mantenere il Pianeta entro un grado e mezzo, ma non è possibile farlo "senza una scaletta precisa dei provvedimenti: serve una quantità di provvedimenti urgenti subito, è ridicolo parlare di limitare l’aumento - come dire mezzo etto in più o in meno dal macellaio - senza un impegno preciso". Per esempio quelli "più seri che servirebbero per fermare il carbone. Ad oggi non c’è vero accordo per fermarlo nel 2050, viste le posizioni di Cina e India".
Questo perché esiste "un enorme problema politico: è completamente velleitario risolvere il problema clima se non si capisce prima il costo di questo accordo su chi deve gravare. E’ chiaro che bloccare le emissioni comporterà costi pesi e difficoltà enormi, ma da qualche parte dobbiamo cambiare livello di vita" spiega Parisi.
E fa un esempio: "Pensiamo alle temperature delle case? Non possiamo sempre credere di tenerle alle temperature che vogliamo tutto l’anno. Dobbiamo abituarci al freddo nelle case, magari mettendoci due maglioni. Ma questa cosa dovrebbe essere imposta, dai governi. E nel farlo - così come i costi della ristrutturazione industriale - non bisognerebbe scaricare sempre su parte della popolazione più povera. Non possiamo pensare di diminuire per esempio il consumo di benzina aumentando le tasse sulla benzina: servono politiche sulla redistribuzione dei costi".
E’ un po’ come il discorso di Usa e India: "Le emissioni di CO2 di un americano corrispondono a nove volte quelle di un indiano e anche l’Europa è cinque volte sopra India. All’India viene chiesto di bloccare il carbone, ma se dovesse farlo subito avrebbe un impatto enorme sull’economia indiana, che sarebbe minore rispetto a quello che potrebbe avere per esempio sugli Stati Uniti. Io non sono d’accordo con gli indiani, ma capisco il loro punto di vista che dicono voi avete inquinato per un secolo e mezzo e ora tocca anche a loro poterlo fare. Dunque il punto è questo: non è pensabile che ci possa essere un accordo sincero fra economie così diverse come Usa, Cina, India e Europa senza che non ci sia un accordo economico enorme per la suddivisione dei costi di questa operazione. Un accordo che dovrebbe essere più equo e solidale".
"Se non si prende un punto di vista equo e solidale fra le varie nazioni - continua Parisi - sarà estremamente difficile un accordo sul clima. Gli interessi locali delle singole nazioni tendono ad avere il sopravvento. Bisogno quindi entrare in un altro meccanismo, con una solidarietà fatta in maniera tale che i sacrifici necessari vengano suddivisi" spiega, sostenendo che per quanto necessario l’ipotesi di 100 miliardi dai paesi più ricchi a quelli più poveri vada bene, ma dovrebbero essere molti di più, perché quella cifra sono solo "noccioline" per quanto in realtà servirebbe.
Il problema è che l’azione dovrebbe essere - con tanto di scaletta - immediata. I cambiamenti climatici infatti "vanno avanti senza badare ai nostri problemi politici e gli effetti tendono a diventare sempre più forti. Negli ultimi cinquant’anni c’è stato il rallentamento della corrente Golfo: se si fermasse avremmo per l’Europa una situazione tragica con un calo di temperature di cinque-otto gradi, e rimetterla in moto sarebbe estremamente complicato. Quindi è necessario che vengano presi provvedimenti davvero efficaci e immediati per fermare il clima, con impegni precisi, altrimenti rischiamo di mitigare un po’ la crescita della crisi ma semplicemente rimandando solo di qualche anno possibili catastrofi. Più peggiora la situazione, più tempo passa, meno tempo abbiamo per fare nuove tecnologie e soluzioni innovative contro la crisi" chiosa il professore.
Su invito di Riccardo Luna, rispondendo alle domande dei ragazzi, il premio Nobel si congeda con un consiglio diretto alle giovani generazioni.
"Voi ragazzi siete i più colpiti dal cambiamento climatico. Serve consapevolezza di cosa sta accadendo, cercare di capirlo, recuperare informazioni di alta qualità e cercare di convincere adulti, genitori, nonni, che è fondamentale che il tema cambiamento climatico entri dentro la politica. Quando si vota alle elezioni generali questo tema dovrà essere fondamentale per la scelta delle posizioni. Quindi dovete insistere, insistere, insistere sull’importanza del cambiamento climatico, cercando di convincere chi vota e gli adulti. Le decisioni sono in mano ai governanti e i giovani devono spingere perché se ne occupino".
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- G20. Il presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato il suo grido d’allarme: "Il momento è questo. Gli occhi di miliardi di persone, di interi popoli, sono puntati su di noi e sui risultati che sapremo conseguire".30 ottobre 2021, di Federico La Sala
Mattarella: ’Non c’è più tempo, il mondo ci guarda’
’Dobbiamo assicurare un futuro ai giovani’. Per i leader a cena al Quirinale le prelibatezze del Made in Italy
di Fabrizio Finzi (Ansa, 30.10.2021)
Il mondo ci guarda, miliardi di persone attendono risposte: è il tempo di agire.
Con questo appello ai leader del mondo si chiude la prima giornata del G20 sotto la presidenza italiana.
ROMA. Non poteva essere più solenne il contesto nel quale il presidente della Repubblica ha lanciato il suo grido d’allarme. Fuori dai tecnicismi che toccano ai leader, il capo dello Stato dal Quirinale ha voluto toccare le corde più profonde dei capi di Stato e di Governo, tutti riuniti nel Salone delle Feste, con un discorso semplice e diretto: "Il momento è questo. Gli occhi di miliardi di persone, di interi popoli, sono puntati su di noi e sui risultati che sapremo conseguire. Sono fiducioso che i nostri Paesi risponderanno all’appello che viene dall’opinione pubblica mondiale. Ne saremo all’altezza se riusciremo a ritrovare il filo della collaborazione e il senso della responsabilità che l’odierna e crescente interdipendenza tra popoli e nazioni del pianeta ci impone", ha detto Mattarella poco prima di un’affollatissima cena al Quirinale che ha visto due tavolate (in due saloni diversi) ospitare i capi di Stato e di governo.
"Non dobbiamo consegnare a chi verrà dopo di noi un pianeta solcato da conflitti, le cui risorse siano state dilapidate, il cui ecosistema sia stato compromesso per l’egoismo di chi è stato incapace di coniugare la legittima aspirazione alla crescita economica e sociale con l’esigenza di tutelare ciò che non ci appartiene. Perché a nostra volta l’abbiamo ricevuto dalle precedenti generazioni. Tocca a noi l’impresa di imprimere una svolta decisiva per superare questi fardelli", ha detto il presidente della Repubblica rivolgendosi ai leader del G20 riuniti al Quirinale per una cena.
Si chiude quindi al Quirinale la già intensa giornata dei leader e delle delegazioni che in serata hanno potuto ammirare stupiti il concentrato di opere d’arte raccolte nel Palazzo che fu anche dei papi, un magnifico compendio della storia d’Italia degli ultimi cinque secoli. In questo scenario Sergio Mattarella ha accolto i tanti ospiti nella sala di rappresentanza, salutandoli uno ad uno in un’interminabile sfilata che ha messo a dura prova il cerimoniale e la sicurezza.
Oltre 120 gli ospiti della cena offerta dal presidente della Repubblica. Tanti che, in era di pandemia e distanziamento, sono stati distribuiti in due sale e due enormi tavolate. Circa 60 i leader e le first lady (ma anche due first gentlemen, Joachim Sauer, marito della cancelliera Angela Merkel, e Heiko von der Leyen, sposo della presidente della Commissione Europea, Ursula) seduti nel salone delle Feste; gli altri 60, in prevalenza ministri degli Esteri e delle Finanze, accomodati nella sala del Bronzino che prende il nome dall’importante gruppo di arazzi che ornano le pareti, alcuni dei quali tessuti su disegno del celebre pittore fiorentino Agnolo Bronzino.
Dopo il breve saluto di Mattarella, i big del mondo si sono potuti concentrare su altre prelibatezze del Made in Italy: salmone marinato all’aneto con polvere di olive come antipasto.
Risotto alla zucca per primo e filetti di spigola con verdure provenienti dalla tenuta di Castelporziano come secondo. Sfoglia di pomodoro, sedano di rapa e cuori di carciofo con patate farcite, per contorno. Una crema di mandarino al vapore per chiudere con un tocco squisitamente mediterraneo.
-
> PER LA PACE PERPETUA. --- COSTITUENTE TERRA. La proposta al G20. Una Costituzione della Terra per diffondere pace e giustizia.30 ottobre 2021, di Federico La Sala
La proposta al G20.
Una Costituzione della Terra per diffondere pace e giustizia
Illustrissimi Signori e Signore del G20, con grande gioia vi accogliamo a Roma dove siete convenuti per la vostra riunione del vertice dei Grandi che ha all’ordine del giorno la salvezza del mondo...
- [Foto] Costituente Terra
Illustrissimi Signori e Signore del G20,
con grande gioia vi accogliamo a Roma dove siete convenuti per la vostra riunione del vertice dei Grandi che ha all’ordine del giorno, per dirla con una sola parola, la salvezza del mondo.
Non vogliamo darvi suggerimenti riguardo alla vostra agenda. Vogliamo solo ricordarvi le due ispirazioni fondamentali che potete ricavare dal fatto di riunirvi questa volta a Roma.
La prima è quella che deriva dalla stessa origine leggendaria di Roma, di cui si dice che i suoi due fondatori, Romolo e Remo, fossero stati allattati e allevati da una lupa. Questo ci ricorda che l’uomo e la donna, una volta messi al mondo, sono presi in carico dalla Natura che li nutre e li cura e ne assicura la vita nella sua identità umana senza eguali ma anche in relazione con tutti gli animali. Tocca ora a voi, che siete capi di Stato e di governo, di restituire alla Natura questo dono e pagare questo debito, adottando decisioni e politiche globali capaci di rispondere al gemito della Terra con ben altra radicalità e urgenza rispetto a quelle adottate fin qui. Anche qui, per dirla con una sola parola, non solo occorre uscire dai combustibili fossili, ma ricostruire l’integrità devastata del mondo vivente e dare lunga vita alla Terra.
La seconda ispirazione è senza dubbio quella che viene dall’aver Sede a Roma il Papa, primo vescovo della Chiesa romana e vorremmo aggiungere, assumendo come è proprio della politica, la contemporaneità di questo Papa che si chiama Francesco. L’ispirazione che oggi ne può venire è universale e includente sia per il riconoscimento operato dal Concilio Vaticano II dei doni di Dio profusi come semi in tutte le religioni e le culture, sia per l’affermazione di fraternità tra tutti gli uomini che papa Francesco ha condiviso con ogni religione. Questa ispirazione può pertanto essere oggi tale da incoraggiare tutti i responsabili della vita sulla Terra a perseguire l’unità umana e ad adottare un’ecologia integrale.
Vogliamo informarvi, inoltre, che a Roma è stata da poco istituita una Scuola che promuove il pensiero e cerca le vie per dar luogo alla stesura e all’adozione per tutto il mondo di una Costituzione della Terra. Sarebbe bello che fra voi sorgessero persone, iniziative e politiche che facessero proprio questo progetto, lo includessero nelle tematiche presenti nella comunità delle Nazioni e lo portassero a buon fine, in modo che la Terra intera possa aver la sua Costituzione: una Legge fondamentale che garantisca diritti e doveri a tutti gli uomini e le donne del pianeta e che con il supporto di efficaci garanzie giuridiche e istituzionali assicuri che la Terra sia salva, la vita sia prospera e la storia continui.
Contro ogni giusto allarme riguardo al rischio di poteri invasivi, vogliamo sottolineare che una Costituzione del mondo non è un governo del mondo, ma è una regola che nella pluralità e autonomia dei regimi politici e degli ordinamenti istituisca la sovranità del diritto su tutti i poteri pubblici e privati del mondo; le Costituzioni hanno offerto molte volte e per molto tempo le più alte esperienze di giustizia e di pace nei nostri singoli Stati, sicché si può pensare che il modello costituzionale esteso sul piano globale possa mantenere analoghe promesse per tutti i Paesi. Anche la sfida della pandemia conduce nella stessa direzione, suggerendo di instaurare una politica dei beni comuni dell’umanità che non si possano né comprare né vendere, che siano fuori commercio e messi a disposizione di tutti da un’economia di liberazione, a cominciare dalla decisione della non brevettabilità dei vaccini contro il Covid e dei farmaci salvavita.
Che tale proposta non sia mai stata formulata fin qui non depone contro la sua attuabilità, ma deriva piuttosto dal fatto che finora la Terra è apparsa frammentata e divisa e il corso storico si è andato svolgendo attraverso contrapposizioni etniche, religiose, culturali e politiche via via apparse come insormontabili, sicché una Costituzione di tutta la Terra sembrava impensabile; ma oggi la Terra può essere osservata dall’alto come un tutto globale e anzi un poliedro, come dice il Papa, e come si sa al mutamento del punto di vista corrisponde il mutamento delle cose; oggi in realtà le divisioni identitarie, pur feconde e inviolabili nel loro ordine, non sono più tali da precludere unità più costruttive e più vaste. Con i più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro Costituente Terra
Questo testo è una sintesi dell’integrale pubblicato su www.costituenteterra.it
*
-
>PIANETA TERRA --- UNA PALLA DI NEVE ALL’INFERNO (Gregory Bateson, 1970) E LA DIREZIONE SBAGLIATA (Antonio Guterres, 2021).22 settembre 2021, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: "UNA PALLA DI NEVE ALL’INFERNO". Fine della Storia o della Preistoria?!
- "Il mondo non è mai stato più minacciato o più diviso, siamo sull’orlo di un abisso e ci muoviamo nella direzione sbagliata" (A. Guterres, segretario generale dell’Onu, 21 settembre 2021)
QUAL è questa "direzione sbagliata"?! IN UNA CONFERENZA DEL 9 GENNAIO 1970, GREGORY BATESON, in una brillante sintesi, così riassume la visione del nostro rapporto storico con la natura:
"[...] Se mettete Dio all’esterno e lo ponete di fronte alla sua creazione, e avete l’idea di essere stati creati a sua immagine, voi vi vedrete logicamente e naturalmente come fuori e contro le cose che vi circondano. E nel momento in cui vi arrogherete tutta la mente, tutto il mondo circostante vi apparirà senza mente e quindi senza diritto a considerazione morale o etica. L’ambiente vi sembrerà da sfruttare a vostro vantaggio. La vostra unità di sopravvivenza sarete voi e la vostra gente o gli individui della vostra specie, in antitesi con l’ambiente formato da altre unità sociali, da altre razze e dagli animali e dalle piante.
 Se questa è l’opinione che avete sul vostro rapporto con la natura e se possedete una #tecnica progredita, la probabilità che avete di sopravvivere sarà quella di una palla di neve all’inferno.
Voi morrete a causa dei sottoprodotti tossici del vostro stesso odio o, semplicemente, per il sovrappopolamento e l’esagerato sfruttamento delle riserve. Le materie prime del mondo sono limitate.
Se io sono nel giusto, allora il nostro atteggiamento mentale rispetto a ciò che siamo e a ciò che sono gli altri dev’essere ristrutturato. Non si tratta di uno scherzo, e non so quanto tempo abbiamo ancora prima della fine"
Se questa è l’opinione che avete sul vostro rapporto con la natura e se possedete una #tecnica progredita, la probabilità che avete di sopravvivere sarà quella di una palla di neve all’inferno.
Voi morrete a causa dei sottoprodotti tossici del vostro stesso odio o, semplicemente, per il sovrappopolamento e l’esagerato sfruttamento delle riserve. Le materie prime del mondo sono limitate.
Se io sono nel giusto, allora il nostro atteggiamento mentale rispetto a ciò che siamo e a ciò che sono gli altri dev’essere ristrutturato. Non si tratta di uno scherzo, e non so quanto tempo abbiamo ancora prima della fine"
 (cfr. G. Bateson, "Verso un’ecologia della mente", Adelphi, Milano 976, p. 480).
(cfr. G. Bateson, "Verso un’ecologia della mente", Adelphi, Milano 976, p. 480). -
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Clima, Guterres, il segretario generale dell’Onu : “Il mondo mai così diviso e minacciato: siamo sull’orlo dell’abisso”.21 settembre 2021, di Federico La Sala
Clima, Guterres: “Il mondo mai così diviso e minacciato: siamo sull’orlo dell’abisso”
Il segretario generale dell’Onu apre con un appello i lavori dell’Assemblea: «Ci muoviamo in direzione sbagliata» *
NEW YORK. «Il mondo non è mai stato più minacciato o più diviso, siamo sull’orlo di un abisso e ci muoviamo nella direzione sbagliata. Sono qui per dare l’allarme, il mondo deve svegliarsi». Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres aprendo il dibattito della 76esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro. «Stiamo affrontando la più grande serie di crisi della nostra vita», ha continuato, citando la pandemia di Covid, il riscaldamento climatico, gli sconvolgimenti dall’Afghanistan all’Etiopia allo Yemen, l’ondata di sfiducia e disinformazione.
Il Covid e la crisi del clima «hanno messo in luce profonde fragilità come società e come pianeta - ha proseguito Guterres -. le persone che serviamo e rappresentiamo possono perdere fiducia non solo nei loro governi e nelle istituzioni, ma nei valori che animano il lavoro dell’Onu da oltre 75 anni». Secondo il segretario generale «un crollo della fiducia sta portando a un crollo dei valori. Le promesse, dopo tutto, sono inutili se le persone non vedono risultati nella loro vita quotidiana». A suo parere ci sono sei aree di divisione, dei Grand Canyon che bisogna «colmare ora»: «In primo luogo dobbiamo colmare il divario della pace, quindi quello climatico, quello tra ricchi e poveri (dentro e tra i Paesi), e quello di genere. Poi, ripristinare la fiducia e ispirare speranza significa colmare il divario digitale, e infine dobbiamo colmare il divario tra le generazioni».
E a proposito di divario: «La maggioranza del mondo più ricco si è vaccinata, oltre il 90% degli africani sta ancora aspettando la prima dose. Questo è un atto d’accusa morale contro lo stato del nostro mondo, è un’oscenità», tuona Guterres. «Da un lato vediamo vaccini sviluppati in tempi record - ha proseguito - dall’altro vediamo quel trionfo annullato dalla tragedia della mancanza di volontà politica, dall’egoismo e dalla sfiducia».
Su vaccini e clima gli Stati membri delle Nazioni Unite «devono fare la loro parte e non aspettare prima le mosse degli altri», chiede Guterres. «Sarà impossibile affrontare drammatiche sfide economiche e di sviluppo mentre le più grandi economie del mondo saranno l’una contro l’altra».
-
> PER LA PACE PERPETUA. --- «PERFORMANCE STUDIES». Per pensare il vivente il «metodo» è l’amore. Grande e soddisfacente è la lettura di un testo quando sa aprire i battenti e fa circolare correnti (di Giovamnna Ferrara).7 settembre 2021, di Federico La Sala
Per pensare il vivente il «metodo» è l’amore
ITINERARI CRITICI. «Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista», di Ilenia Caleo per Bulzoni. Dagli studi postcoloniali alla filosofia poststrutturalista, dalle rinnovate riflessioni sul teatro ai femminismi plurali, fuori dai comuni steccati disciplinari
di Giovanna Ferrara (il manifesto, 04.09.2021)
- «Kiss» di Silvia Calderoni e Ilenia Caleo a Santarcangelo (2019) foto di Sara Lorusso
Quello che è stato scritto è un continente di domande ed esperienze, nel rifiuto dei recinti. Di un andare nel mondo implacabile e ostinato. È la storia unica di intensità diverse (arte e filosofia, teatro e femminismi) che nell’attivismo politico hanno interagito liberandosi della menzogna burocratica delle settorialità di interesse. Il volume di Ilenia Caleo, Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista (Bulzoni editore, pp. 228, euro 20) abita lo spiano di una verità incarnata: tutto è politico e il politico è continua intersezione. La contiguità come metodo, e gli affetti come strada, sono il responso oracolare di questo lavoro, che abbatte tutto quello che interrompe la molteplicità dell’orizzonte: dal margine si vede meglio. Che non può esserci separazione se si intende confezionare uno stare nella vita libero e germogliativo, rispettoso della sua inevitabile irriducibilità.
NON È UN CASO che lo smontaggio degli steccati cominci a partire dalla riflessione sul corpo, massacrato dalla dualità soffocante in cui lo ha respinto chi lo oppone al pensiero. Che idiozia è stato ignorare che il concetto nasce anche da quello che sento quando tocco o quando vengo toccato, dallo spazio che abito a quello che subisco. «Pensare è sempre pensare per concetti, oppure per funzioni, oppure per sensazioni», ci avvertiva Deleuze, dialogando naturalmente con il rifiuto marxista del tranello messianico e di quello accumulativo, entrambi orchestrati per togliere «valore» all’immanenza della vita. Ma di questi avvertimenti la produzione teorica insorgente, il lavoro nelle accademie, quello più ampiamente cognitivo, ne ha tenuto conto?
I «PERFORMANCE STUDIES», di cui Caleo dà conto in maniera ragionata e ampia, superano questa domanda, cosi come fanno i femminismi afroamericani e lesbici, così come le pratiche attoriali che pensano mentre si danno, così come le occupazioni politiche che non sono di nessun mestiere ma di tutti. In questo la performance come centro di pensiero (del corpo, del movimento) ci abitua all’idea che qualsiasi lingua è una lingua straniera, che la conoscenza è esplorazione di altri, che il sapere «immobile» non è altro che il soprammobile sul comò di un passato mummificato.
Grande e soddisfacente è la lettura di un testo quando sa aprire i battenti e fa circolare correnti. Dagli studi postcoloniali alla filosofia poststrutturalista, dalle rinnovate riflessioni sul teatro ai femminismi plurali, ci sentiamo di essere dentro il crocevia dei diversi piani del vivente, lì dove solo si può trovare la leva da agire per avere un mondo nuovo, senza confini concettuali, senza recinzioni da identità fisse. Sembra che scorrendo le pagine l’intuizione della «intersezione» si faccia esistenziale, pratica continua di liberazione. Ogni pagina un vestito in meno, una struttura in meno, una oppressione in meno.
I generi non esistono come agenti isolanti dagli altri tratti che ci riguardano; i diritti non sono mai da pensarsi come scatole chiuse. Sono membrane aperte ad accogliere il non ancora arrivato così come ce la raccontava Rodotà, il giurista stellare che non dava alcuna dignità all’inattaccabile fossato che hanno scavato per dividere la legge dalla non legge, rifiutando la mobilità intrinsecamente permeabile della giustizia.
Viste così le occupazioni smettono di essere anomalie da correggere, le fluidità di genere novità eccentriche, le arti non sono riserve indiane, noi smettiamo di essere un noi pieno di fibrosi che producono impossibilità all’espansione. Tutto questo c’è, ad esempio, nel disorientamento innestato dallo spettacolo di Xavier Le Roy, descritto da Ilenia Caleo come evidenza della sua tesi che l’arte non oggettivizza un pensiero, ma lo «pensa». In quella performance smette di esistere il sopra e il sotto, non c’è lato: il disorientamento fa splendere una nuova riterritorializzazione che non ha niente di automatico e a cui nessuno può dettare regole.
ALLA MANIERA di certi architetti che rifiutano di vivere il passato come feticcio e la teoria come mondo altro, Caleo ci fa stare di continuo sulle soglie di un futuro impellente. E prosegue cambiando sempre il passo, come quando dalla sua prismatica esperienza di esistente (ricercatrice, artista, performer e militante) passa alla trattazione storiografica di come sono state rielaborate le esclusioni del femminile dai dispostivi maggioritari del sapere. Una cartografia dei femminismi, completa di cadute e resurrezioni. Un libro affettivo, infine. Che ragiona su quel manuale di felicità che ci ha regalato Spinoza. E che per questo abbatte anche quella divisione tra pubblico e privato che troppo spesso è stato il burrone dove andavano a finire i nostri sogni. Un libro sull’amore, amore-metodo, amore-soggetto, amore-oggetto. Amore ovunque.
-
>PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- IL MARE SI STA ALZANDO. La mia domanda per il convegno era sbagliata: non abbiamo sprecato tanti anni, li abbiamo usati nel modo peggiore! (di Enzo Pranzini - Task force Lavoro natura).30 agosto 2021, di Federico La Sala
Il mare si sta sollevando, quanti anni abbiamo sprecato?
Attenti ai dinosauri. Il 5° Rapporto IPCC del 2019 ha fissato, per la fine del XXI secolo, un innalzamento del livello del mare compreso tra 43 cm e 84 cm. Anche se non volessimo attuare strategie basate sul principio di precauzione, che ci porterebbe a pianificare lo sviluppo delle aree costiere sulla base degli scenari peggiori, avremmo potuto da decenni gestire le nostre coste con almeno la consapevolezza che il livello del mare si stava innalzando, bloccando ogni nuova costruzione in prossimità del mare e decidendo in quali tratti costieri era opportuno e possibile scegliere una difesa ad oltranza della costa
di Enzo Pranzini Task force Lavoro natura *
Stavo scrivendo le conclusioni di una presentazione che avrei poi fatto a Lecce, alla Conferenza Nazionale dei Paesaggi Costieri (Legambiente, 15-16 luglio scorso), alla quale ero stato chiamato per parlare del rischio a cui sono esposti gli insediamenti presenti lungo le nostre coste per l’erosione e l’innalzamento del livello del mare. L’iniziativa era stata fissata in piena estate, perché certamente tutti quelli che sarebbero stati già in vacanza sulle spiagge avrebbero seguito con maggiore attenzione i problemi delle coste.
Le parole mi venivano fuori con estrema facilità, come se le avessi già dette un milione di volte. Mi sono preoccupato: da quanti anni ripeto le stesse cose? La preoccupazione non era per il mio cervello, ma per il nostro futuro!
Sono andato a cercare cose scritte in passato e sono arrivato ad un articolo che avevo pubblicato nel luglio 1986 sulla pagina scientifica de Il Messagero. Ho così ho inserito nella presentazione la foto di una parte dell’articolo, seguita dalla scritta: “Quanti anni abbiamo sprecato?” Eccola: [ ]
Nonostante questo in Italia e nel mondo si sta ancora edificando in vicinanza del mare e progettando difese costiere la cui vita è certamente inferiore ai 50 anni, ma che rafforzano l’illusione di poter opporsi in modo drastico all’avanzata del mare e non favoriscono invece soluzioni di arretramento. Questo dovrebbe essere imposto almeno nei casi in cui il valore di ciò che si va a difendere è inferiore ai costi previsti per la protezione stessa su tempi più lunghi
Nell’articolo riportavo i dati sulla previsioni dell’innalzamento del livello del mare prodotti dall’EPA (Environmental Protection Agency, USA) che erano gli unici a cui si potesse fare riferimento in quegli anni: 56 cm nello scenario più ottimistico e 345 cm in quello più pessimistico.
Ricordavo anche che l’innalzamento del livello del mare potrebbe comportare una migrazione dei sedimenti dalle spiagge verso il largo, che amplificherebbe l’erosione marina, e inoltre che molte aree costiere si stanno abbassando, sia per la compattazione dei sedimenti recenti, sia per l’estrazione di acqua e di idrocarburi dal sottosuolo. Ecco perché bisognava cominciare a pensare ad un arretramento strategico.
Con l’istituzione dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, UN) nel 1988, sono i vari Report che questo gruppo produce ad essere il riferimento per ‘quasi’ tutti gli scienziati e per chi dovrebbe prendere le decisioni. I parametri di riferimento sono cambiati, anche dopo il 1988, il metodo di previsione è piuttosto complesso (ovviamente) e gli ‘scenari’ analizzati si basano su dati di difficile comprensione per i non esperti.
Non a caso, i Report scientifici sono accompagnati da una Sintesi per i decisori politici, ed è stato pubblicato un Manuale per spiegare agli scienziati come divulgare i propri risultati. Nonostante ciò, la lettura dei Report non è facile, anche per l’eccessivo uso degli acronimi (cosa che sta innalzando sempre più il muro fra gli addetti ai lavori e il normale cittadino, in tutti i settori!)
Sta di fatto che per un po’ di anni i valori di innalzamento del livello del mare previsto (per tutti ormai SLR - Sea Level Rise) si sono progressivamente abbassati, tanto che io a lezione dicevo, ovviamente scherzando, che ‘il valore dell’innalzamento del livello del mare si riduce, e se continua così finirà che prevederemo un abbassamento’.
La previsione ottimista era tuttavia il risultato di una raccolta di dati molto più affidabile di quelle precedenti, anche perché nel frattempo era stata attivata un’osservazione da satellite su tutti gli oceani. Poi sono arrivati studi su processi non considerati in precedenza, come ad esempio il rilascio di CO2 e Metano dallo scioglimento del permafrost nell’Artico; una migliore comprensione degli scambi termici atmosfera - oceano; e le dinamiche alla base della calotta glaciale antartica. E così i valori hanno ripreso a crescere.
Il 5° Rapporto IPCC, uscito nel 2019, ha fissato, per l’anno 2100, valori più probabili pari a 43 cm (dato ottimistico) e 84 (pessimistico). Nell’ultimo rapporto, il 6° con data 2021, si spiegano le basi fisiche dei fenomeni su cui si baseranno tutte le altre valutazioni.
Ancora non abbiamo le previsioni sul SLR, ma già ci dicono che livelli estremi, che oggi hanno un tempo di ritorno di 100 anni, alla fine di questo secolo potrebbero colpirci ogni anno.
Morale della favola: il livello del mare nel 2100 non dovrebbe essere così alto come previsto dallo scenario peggiore dell’EPA (345 cm) ma il suo innalzamento è in accelerazione e tutto quanto scopriamo ogni giorno va a peggiorare gli scenari fin qui previsti. Infatti, raramente si scoprono processi che portano a sperare in un rallentamento del fenomeno.
L’innalzamento continuerà con ritmi accelerati anche dopo il 2100 (almeno fino al 2300; oltre le previsioni non vanno, ma forse non ci sarà nessuno a misurarlo!).
Anche se non volessimo attuare strategie basate sul principio di precauzione, che ci porterebbe a pianificare lo sviluppo delle aree costiere sulla base degli scenari peggiori, avremmo potuto da decenni gestire le nostre coste con almeno la consapevolezza che il livello del mare si stava innalzando, bloccando ogni nuova costruzione in prossimità del mare e decidendo in quali tratti costieri era opportuno e possibile scegliere una difesa ad oltranza della costa.
Purtroppo, abbiamo invece usato questo tempo per continuare a costruire sul mare, rendendo ogni strategia futura di adattamento all’innalzamento del livello del mare più difficile e costosa, sia in termini economici che sociali ed ambientali.
La mia domanda per il convegno era sbagliata: non abbiamo sprecato tanti anni, li abbiamo usati nel modo peggiore!
* il manifesto, 31.08.2021 (ripresa parziale - senza immagini).
-
>PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- EUROPA. Clima: «Un evento così estremo non sarebbe avvenuto in condizioni preindustriali». Parla Antonello Pasini, climatologo del Cnr (di Serena Tarabini).17 luglio 2021, di Federico La Sala
Europa
Il climatologo: «Un evento così estremo non sarebbe avvenuto in condizioni preindustriali»
Intervista. Parla Antonello Pasini, climatologo del Cnr. "Questi eventi saranno la norma". "Il fatto che la fonte del riscaldamento della temperatura globale è umana deve essere considerata una buona notizia, se fosse naturale non ci potremmo fare niente"
di Serena Tarabini (il manifesto, 17 luglio 2021).
Dopo settimane di precipitazioni che avevano già saturato i suoli, circa 150 mm di pioggia in una giornata hanno innescato la piena. Un disastro la cui entità evoca scenari da Sud Est asiatico, quando invece ci troviamo in Germania. Un episodio dovuto alla persistenza per giorni sulla stessa area geografica di una specifica condizione metereologica, coerente con i cambiamenti climatici in corso e l’inadeguatezza dei territori verso fenomeni sempre più estremi. Antonello Pasini fisico climatologo del Cnr, insegna fisica del clima e sostenibilità ambientale.
Dal suo punto di vista di climatologo e studioso dei fenomeni atmosferici che cosa è successo in Germania tale da provocare un’alluvione di simile intensità e durata? Si tratta di qualcosa senza precedenti a quelle latitudini?
Innanzitutto eravamo reduci da un anticiclone che ha invaso il Nord Europa determinando una situazione in cui il mare era molto caldo, una problematica diventata abbastanza tipica con il riscaldamento globale che porta più energia in atmosfera e che ha di fatto esteso verso Nord una circolazione di tipo tropicale, quindi questi anticicloni ora riescono ad arrivare anche a latitudini elevate. In questo caso c’è stata quella che noi chiamiamo “goccia fredda”, una grande quantità di aria più fresca che è calata da Nord per controbilanciare l’aria calda proveniente da Sud, e che si è istallata sulla Germania. Inoltre noi a queste latitudini siamo abituati a vedere la circolazione atmosferica che va da ovest verso est, dei treni di onde in transito che portano a giorni di tempo buono, poi un po’ di variabilità, poi due giorni di tempo meno buono etc. Quanto accaduto in invece è dovuto a delle onde molto più lunghe che si innalzano dai poli verso l’equatore e viceversa; quando sono così lunghe le onde si fermano e fanno permanere sul territorio una situazione come questa anche per giorni. È quella che noi chiamiamo una situazione di “blocco” che può riguardare anche il fenomeno opposto, quello delle ondate di calore che sono molto forti e molto lunghe. Sicuramente al disastro avvenuto in Germania concorrono anche altri tipi di fattori, ma dal punto di vista climatico si è trattato di un fenomeno impressionante.
Il collegamento con il cambiamento climatico è ormai dato per certo, si tratta semmai di stabilire in che misura. Quali sono i segnali inequivocabili, se ci sono, della determinante antropica sulle condizioni del clima e le sue conseguenze?
La scienza del clima lavora in modo particolare. Noi analizziamo i fenomeni attraverso dei modelli metereologici e climatici con cui sostanzialmente ricostruiamo un evento. Una volta fatto ciò, cambiamo delle cose nel modello, per es. se stiamo studiando un evento caratterizzato da un’ondata di calore molto forte in aria o nel mare, riportiamo le temperature dell’acqua e dell’aria alle condizioni della normalità climatica, magari del secolo scorso. Il modello fatto “correre” alle nuove condizioni ci consente di capire se questo evento sarebbe avvenuto ugualmente, in che misura, con qual valori di precipitazione o calore dell’acqua. C’è un gruppo di ricercatori che si occupa di attribuzione degli eventi estremi al cambiamento climatico che ha già studiato l’ondata di calore avvenuta in Canada e con questo metodo hanno visto che è stata eccezionale ma che non sarebbe mai avvenuta in condizioni preindustriali: oggi invece è stata possibile e lo sarà anche in futuro se la temperatura continuerà a salire. Nel passato la frequenza di eventi di questo tipo si calcolava fosse di uno ogni 20.000 anni. Nelle condizioni attuali si calcola potrebbe avvenire ogni 400 anni. Ma se la temperatura aumenta di due o tre gradi, può succedere anche ogni 20 anni.
Quali sono le zone del pianeta più esposte? O che vedono incrementare maggiormente la percentuale di rischi legata ai cambiamenti del clima?
Il nostro bacino Mediterraneo è un luogo sensibile. Una volta era dominato dall’anticiclone delle Azzorre che lasciava passare le perturbazioni a nord e teneva fermo il caldo africano sull’Africa, ora l’arrivo di questi anticicloni africani e flussi di aria fredda che arrivano quando l’anticiclone si ritira, hanno determinato una indubbia estremizzazione del clima. Dopodiché i rischi che un territorio corre sono il risultato di un insieme di fattori. Nel libro L’equazione dei disastri. Cambiamenti climatici su territori fragili utilizzo appunto un’equazione per individuare i fattori che determinano i danni ambientali. C’è un fattore sicuramente climatico, ma poi bisogna guardare alla fragilità del territorio e della società, il livello di esposizione di risorse e persone. Chiaro che nel mondo, a parità di cambiamento climatico, l’impatto di un fenomeno estremo è maggiore laddove le condizioni di sicurezza sono inferiori, o il welfare è meno strutturato.
Della Germania colpisce l’entità del disastro in una zona i cui standard non la fanno ritenere fra le più fragili. Siamo a un punto di svolta? O comunque ci sono delle nuove fragilità da prendere maggiormente in considerazione?
Anche la Germania non è stata esente da errori come l’eccesso di cementificazione e di estrazione e la natura si riprende i suoi spazi. In questo caso si sono rotti degli argini e i fiumi sono esondati, quindi dei manufatti umani sono risultati non adeguati a quelli che sono i cambiamenti del clima e le sue conseguenze. Quando progettiamo e costruiamo un’opera evidentemente i calcoli che facciamo non possono più fare riferimento alle statistiche del passato, bisogna tenere conto degli scenari climatici futuri, legati a una situazione che evolve verso una deriva climatica.
Questi fenomeni eccezionali sono destinati a diventare la norma?
Purtroppo sì se non facciamo nulla per limitare l’aumento della temperatura globale. Quello che dico sempre è che il fatto che la fonte di questo riscaldamento è umana deve essere considerata una buona notizia, se fosse naturale non ci potremmo fare niente. Conosciamo le cause: aumento gas serra, deforestazione, agricoltura e allevamento non sostenibili, possiamo quindi fare qualcosa affinché gli effetti dannosi di queste attività vengano ridotti. Dal punto di vista di principio anche politicamente in Europa ci stiamo muovendo in un modo senza precedenti. L’influenza di determinate lobby è ancora forte e mette dei limiti a quella che deve essere una vera e propria transizione ecologica globale, non solo energetica.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Le pandemie del terzo millennio? Un’altra strada è ancora possibile, ma bisogna agire ora (di Sofia Belardinelli).3 giugno 2021, di Federico La Sala
Le pandemie del terzo millennio? Saranno causate dall’uomo
L’emergere di nuove malattie zoonotiche sarà sempre più probabile, a causa del nostro insostenibile rapporto con la Terra. Gli scienziati ci avvertono da tempo, la pandemia da COVID-19 lo ha dimostrato. Un’altra strada è ancora possibile, ma bisogna agire ora.
di Sofia Belardinelli (MicroMega, 3 Giugno 2021)
SARS-CoV-2, il virus che da circa sedici mesi tiene sotto scacco l’umanità, ha colto il mondo impreparato. Molte sono ancora le incertezze sulla “tempesta perfetta” che questo microrganismo ha saputo scatenare, sulle quali sarà necessario fare chiarezza. Vi è, però, un’evidenza incontestabile: l’elevato valore simbolico di questa pandemia, la prima del mondo globalizzato. Una pandemia che, con ogni probabilità, non sarà l’ultima di quest’epoca.
Da decenni, infatti, gli studiosi avvertono che l’espansione umana nella biosfera, apparentemente inarrestabile da alcuni secoli a questa parte, ma avanzata a grandi passi soprattutto a partire dalla Grande Accelerazione degli anni ’50 dello scorso secolo, aumenta in modo esponenziale il rischio di zoonosi. La deforestazione, la conversione di habitat naturale in terreni ad uso agricolo o zootecnico, le imponenti masse di animali allevati con metodi intensivi, il commercio - legale e illegale - di specie selvatiche, l’urbanizzazione incontrollata sono tutte attività che favoriscono il contatto diretto tra uomini e animali, contribuendo così a creare ambienti ideali perché avvenga il famigerato spillover, il salto di specie.
Questa pandemia, dunque, già prevista nel 2012 dal giornalista scientifico David Quammen, sulla base degli studi condotti in vista della pubblicazione del suo libro Spillover, avrebbe potuto essere prevenuta. Così non è stato, lo sappiamo e ne abbiamo pagato le conseguenze. Ma dagli errori si può imparare: dunque, in vista delle future possibili pandemie, è bene vigilare con attenzione.
Fra i sorvegliati speciali vi è proprio la famiglia dei coronavirus, alla quale appartengono virus come quello che ha causato, nel 2003-2004, l’epidemia di SARS, nonché diversi virus poco patogenici, che causano nell’uomo i comuni raffreddori stagionali. Ad oggi, i coronavirus umani noti sono sette: quattro comuni e tre più letali (SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2). Ne esistono poi molti altri - la famiglia dei Coronaviridae è piuttosto numerosa - che hanno come serbatoio altri animali, perlopiù mammiferi.
La ricerca si concentra proprio sui coronavirus non umani, monitorandoli per cercare di prevenire o anticipare il possibile salto di specie. Di recente la rivista scientifica Science ha riportato la notizia della scoperta, in Malesia, di un nuovo coronavirus, rintracciato in otto bambini affetti da polmonite, che potrebbe essersi evoluto nei cani, prima di passare all’uomo. Non vi sono ancora evidenze che questo nuovo coronavirus possa trasmettersi da uomo a uomo, ma - sostengono i ricercatori che da anni si dedicano alla ricerca di coronavirus in pazienti affetti da polmonite - «Più cerchiamo, più ci rendiamo conto che i salti di specie compiuti da questi virus sono pressoché all’ordine del giorno». Questo nuovo coronavirus canino appartiene al genere alpha della famiglia, considerato meno pericoloso (ad esso appartengono due coronavirus umani del raffreddore) del genere beta, al quale appartengono i virus di SARS, MERS e COVID-19; tuttavia, avvertono i ricercatori coinvolti nello studio, «non è un gran sollievo, nel mondo selvaggio dei virus».
Infatti un altro studio, il cui pre-print è stato pubblicato lo scorso marzo, riporta le prime evidenze di un altro genere di coronavirus (il delta) in grado di infettare gli esseri umani: esso è stato rintracciato in tre bambini haitiani che, tra il 2014 e il 2015, erano stati ricoverati per polmoniti sospette. Si tratta di una novità relativamente inaspettata: inizialmente, infatti, si riteneva che i coronavirus del genere delta infettassero solo gli uccelli; nel 2012, invece, è stata rilevata a Hong Kong la prima infezione da delta coronavirus in maiali. Anche le infezioni riscontrate ad Haiti, infatti, rimandano a un coronavirus suino.
Simili ricerche mostrano con chiarezza quanto poco sappiamo, ancora oggi, sulle traiettorie evolutive di questi virus, che sembrano essere molto più rapidi e adattabili di quanto si pensasse.
Tale rapidità dipende anche da noi: molte attività umane, infatti, creano le condizioni ideali per la rapida evoluzione e la diffusione di malattie zoonotiche, causate cioè da patogeni che si trasmettono da altri animali all’uomo. Un esempio lampante di questo legame tra l’attuale modello di produzione industriale e l’elevato rischio di epidemie è l’allevamento intensivo di animali - in terra e in acqua -a scopo alimentare. Le pessime condizioni igieniche in cui gli animali sono tenuti, ad esempio, espongono intere popolazioni di capi allevati alla diffusione di malattie. Ma non finisce qui: uno studio di Science Advances evidenzia come l’acquacoltura intensiva dei salmoni faciliti in maniera esponenziale la diffusione di agenti patogeni anche nelle popolazioni selvatiche di salmoni, come sta accadendo per il virus PRV-1, (Piscine ortheovirus 1), che infetta diverse specie di salmone del Pacifico. Tali specie svolgono un ruolo essenziale all’interno degli ecosistemi marini (sono foundation species), e la loro riduzione - o addirittura estinzione - potrebbe determinare finanche un collasso ecosistemico. Spiegano i firmatari della ricerca: «L’incremento dell’acquacoltura ha causato un cambiamento ecologico che favorisce l’emergere e la diffusione di malattie infettive marine. Le nostre analisi forniscono diverse evidenze che mostrano come l’acquacoltura sia implicata nell’emergere di patogeni virali su scala sia globale che locale, evidenziando il potenziale per l’introduzione di agenti infettivi nelle popolazioni selvatiche».
La diagnosi, dunque, è piuttosto chiara: l’attuale sistema di produzione non solo è insostenibile dal punto di vista ambientale, come è ormai dimostrato dalle evidenze più varie, ma pone anche seri rischi per la salute umana. Il mondo scientifico ha mostrato da tempo la correlazione fra zoonosi e allevamenti intensivi: tra le tante cassandre possiamo annoverare, ad esempio, un articolo pubblicato su PNAS nel 2013, il cui eloquente titolo recita “L’insorgenza di zoonosi è legata all’intensificazione dell’agricoltura e al cambiamento climatico”. Il COVID-19, dunque, è stato un disastro annunciato, che si sarebbe dovuto prevedere e prevenire.
Ora, possiamo solamente raccogliere i pezzi ed imparare dai nostri errori: ad esempio affrontando seriamente, in questi nove anni che ci separano dal fatidico 2030, anno fissato dall’Accordo di Parigi come data limite per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di mitigazione, la crisi climatica i cui effetti si manifestano con crescente rapidità ed estensione; e ripensando coraggiosamente, una volta per tutte, l’attuale modello di produzione e consumo, che attualmente va ben oltre le soglie di sostenibilità. Si tratta di adottare un approccio One Health, in cui la salute dell’uomo e la salute del pianeta non siano scisse, ma riconosciute come un’unica questione e affrontate congiuntamente.
Si tratta, insomma, di superare l’annosa separazione fra uomo e natura: riconoscere che noi siamo parte di essa è il primo passo per tutelarla - e, dunque, per tutelare noi stessi.
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. ---- "The Doomsday Book: Can the World Survive?": La Società Suicida - Requiem per un Pianeta Infetto? ( Gordon Rattray Taylor)15 maggio 2021, di Federico La Sala
Scheda sul libro di Gordon Rattray Taylor *
***
La Società Suicida - Requiem per un Pianeta Infetto?
Titolo originale: The Doomsday book [The Doomsday Book: Can the World Survive? (1st ed. : 1970 / ed.1972)]
Autore/i: Taylor Gordon Rattray
Editore: Arnoldo Mondadori Editore
terza edizione, traduzione di Angelo Francesco Lucchesi.
pp. 384, Milano [I ed., 1971]
Gordon Rattray Taylor è l’autore di La bomba biologica (Mondadori, 1968), best-seller della saggistica in tutto il mondo. Nato nel 1911, ha studiato scienze naturali al Trinity College di Cambridge. Si è specializzato negli studi degli orientamenti scientifici e delle loro implicazioni sociopsicologiche. Fra le altre sue opere: Economics for Exasperated, Conditions for Happiness, Are Workers Human?, Sex in History.
Pochi batteri in una provetta, con nutrimento e ossigeno, prolificano rapidamente. Raddoppiano di numero ogni venti minuti circa, fino a diventare una massa visibile e solida. La proliferazione si ferma quando i microbi cominciano a venire avvelenati dai loro stessi prodotti di rifiuto: al centro della massa si forma un nucleo di batteri morti o morenti, tagliati fuori dal nutrimento e dall’ossigeno dell’ambiente dalla compatta barriera dei loro vicini. Il numero dei microbi viventi si riduce pressoché a zero se le materie di rifiuto non vengono eliminate.
L’umanità si trova oggi in una situazione simile. Gli abitanti del pianeta Terra, che nel 1850 erano un miliardo, nel 1975 saranno quattro volte tanto e nel 2000 raggiungeranno i sette miliardi. La specie umana aumenta, per ora, alla velocità di 100 individui al minuto. La nuova tecnologia favorisce la moltiplicazione degli esseri umani, ma i suoi residui inquinanti, che avvelenano il suolo, l’aria e l’acqua, minacciano direttamente l’esistenza stessa di tutte le creature viventi.
La società suicida è una documentatissima, allucinante messa a punto dei problemi della sovrappopolazione, dell’inquinamento, dell’alterazione della natura in rapporto con le sempre più diffuse applicazioni della tecnologia.
Gli uomini vanno preparando la morte del pianeta. Il mondo possiede risorse che possono esaurirsi. Molti hanno lanciato messaggi di avvertimento che preannunciano un disastro di proporzioni immani: il pianeta Terra sta raggiungendo il limite delle sue capacità. Gordon Rattray Taylor ha riunito e ordinato in un unico mosaico i dati statistici, le indagini, le opinioni isolate e i rapporti ufficiali sull’argomento. Che fare? Grande numero, inquinamento, radioattività, mutamenti già in atto e a lungo termine che l’uomo provoca su geografia, atmosfera e clima, sono conseguenze di un’irreversibile spinta tecnologica.
L’umanità è giunta a una svolta decisiva della sua storia: l’utopia di una futura e perfetta civiltà delle macchine diventa un pauroso incubo tecnologico che nel giro di trent’anni può rendere inabitabile il mondo: La società suicida è un grido d’allarme contro l’ottimismo dei tecnocrati, un richiamo alla responsabilità dei politici, un invito all’uomo della strada affinché prenda coscienza dei pericoli che lo minacciano.
Sorridere sulle «profezie apocalittiche» è un grosso rischio: il futuro è già cominciato, il mondo desolato in cui la flora e la fauna sono morte per avvelenamento non è una profezia: è la realtà che circonda le nostre metropoli industriali. È già concreta la prospettiva di un pianeta infetto sul quale la vita diventa impossibile per i figli della razza umana d’oggi.
- Indice:
L’uomo, questo microbo
 Parole di ammonimento
Parole di ammonimento
 La «nave spaziale» terra
La «nave spaziale» terra
 Inquinamento e super-inquinamento
Inquinamento e super-inquinamento
 Il problema demografico
Il problema demografico
 Una vittoria di Pirro
Una vittoria di PirroGli ingegneri planetari
 Opere idriche
Opere idriche
 Gli artefici di terremoti
Gli artefici di terremoti
 I bulldozer nucleari
I bulldozer nucleari
 Lo scioglimento delle calotte polari
Lo scioglimento delle calotte polari
 Risparmiate quell’albero!
Risparmiate quell’albero!Era glaciale o morte da calore?
 Acqua sul fuoco
Acqua sul fuoco
 Prospettive nuvolose
Prospettive nuvolose
 Sbalzi di clima
Sbalzi di clima
 La morte da calore
La morte da caloreLa natura replica
 Esplosioni demografiche
Esplosioni demografiche
 Il controllo dei parassiti delle piante e suoi rischi
Il controllo dei parassiti delle piante e suoi rischi
 Animali in via d’estinzione
Animali in via d’estinzione
 Bacini idrici e relativi errori
Bacini idrici e relativi errori
 I grandi cicli
I grandi cicli
 Il nitrato che corrode
Il nitrato che corrode
 I gas tossici
I gas tossiciL’ultimo anelito
 Corona di spine
Corona di spine
 Le maree rosse
Le maree rosse
 Il mare, uno scarico che ha i suoi limiti
Il mare, uno scarico che ha i suoi limiti
 Una zaffata di nafta
Una zaffata di nafta
 La crisi dell’ossigeno
La crisi dell’ossigenoSostanze inquinanti all’ultima moda
 L’amianto come sostanza inquinante - DDT - DDT, sesso e cancro
L’amianto come sostanza inquinante - DDT - DDT, sesso e cancro
 Controlli biologici
Controlli biologici
 Che cosa è successo alle aquile?
Che cosa è successo alle aquile?Limitatevi a espirare
 La minaccia del piombo
La minaccia del piombo
 Il piombo che respiriamo
Il piombo che respiriamo
 Il più letale dei metalli
Il più letale dei metalli
 Vita breve e allegra?
Vita breve e allegra?Il quinto fattore
 Il problema dei rifiuti radioattivi
Il problema dei rifiuti radioattivi
 Cripto e tritio
Cripto e tritio
 Esistono i livelli di sicurezza?
Esistono i livelli di sicurezza?
 La concentrazione biologica
La concentrazione biologica
 Le dosi accettabili
Le dosi accettabili
 Il cancro e la dose accettabile
Il cancro e la dose accettabile
 Il rischio di incidenti
Il rischio di incidenti
 Darla a bere o menar per il naso
Darla a bere o menar per il naso
 Conclusione
ConclusioneIl limite della popolazione
 L’energia solare in-deficit
L’energia solare in-deficit
 Carestia e sovrabbondanza?
Carestia e sovrabbondanza?
 È lecito credere alle previsioni di espansione demografica?
È lecito credere alle previsioni di espansione demografica?
 Le proteine
Le proteine
 L’erosione
L’erosione
 I problemi che ci attendono
I problemi che ci attendonoLo sfacelo demografico: quando?
 La congestione dell’abitato umano
La congestione dell’abitato umano
 Le condizioni nelle grandi città
Le condizioni nelle grandi città
 Il sovraffollamento negli animali
Il sovraffollamento negli animali
 Natura e sobborghi
Natura e sobborghi
 L’optimum demografico
L’optimum demograficoNon fate male alla terra!
 WEW e GEO?
WEW e GEO?
 Sforzi personali
Sforzi personali
 Già si paga
Già si paga
 Che cosa si é fatto finora?
Che cosa si é fatto finora?
 Quelli che hanno l’autorità
Quelli che hanno l’autorità
 Punti oscuri
Punti oscuriL’incubo tecnologico
 Sotterfugi tecnici
Sotterfugi tecnici
 La crisi dei comuni
La crisi dei comuni
 La bancarotta dell’economia
La bancarotta dell’economia
 Le schiavitù tecnologiche
Le schiavitù tecnologiche
 I paladini della tecnologia
I paladini della tecnologia
 L’amore per la natura
L’amore per la natura
 Triplice crisi
Triplice crisi Ringraziamenti
Ringraziamenti
 Note bibliografiche
Note bibliografiche
 Indice analitico
Indice analitico
* FONTE: Libreria Editrice Ossidiane
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Immaginare mondi, risignificare spazi. "La casa vivente" di Andrea Staid: cercare altrove nuovi paradigmi (di Beatrice La Tella).29 aprile 2021, di Federico La Sala
Immaginare mondi, risignificare spazi
Nel suo libro l’antropologo Andrea Staid redige una mappatura dei diversi modi in cui è possibile abitare la Terra, raccontando come la casa del futuro passi dall’ibridazione e non dagli standard urbani occidentali.
di Beatrice La Tella (Futura-Network, 27.04.2021)
In molti idiomi vivere e abitare sono sinonimi, vicini a livello di campo semantico e di concetto. Questa simmetria non esiste nella lingua italiana, e la sua assenza è forse spia di un atteggiamento schizofrenico, comune al pensiero Occidentale, che ha avuto come conseguenze più disagi (quando non disastri) che benefici.
L’antropologo Andrea Staid pubblica il suo La casa vivente per Add Editore, proprio a partire dalla necessità di un decentramento, prospettico e fisico. Il volume si apre non a caso con una brevissima introduzione all’etnografia: non studio egemonico-quantitativo - lo sguardo di superiorità della civiltà (presunta) evoluta che osserva bonariamente società (presunte) arretrate - ma, al contrario, ricerca di stampo qualitativo fondata sullo scambio e il confronto alla pari. Conversando con le più diverse popolazioni nel corso dei suoi viaggi in Asia, Staid si è trovato spesso innanzi a visioni rovesciate delle nostre certezze (un esempio semplice quanto immediato: la paura di dormire con la porta chiusa piuttosto che con la porta aperta). Da questi raffronti è sorta la necessità impellente di rimettere in questione tanto il concetto quanto il potere stesso di abitare.
Occorre partire dall’idea che “la casa è un processo”: dimorare implica una presa in cura, un’azione sempre relazionale e continuativa. L’abitazione è un nodo e sprigiona contemporaneamente esigenze pratiche e funzioni simboliche che si muovono dallo spazio ristretto al paesaggio più ampio. Il modo in cui si occupa un luogo sottende una visione del mondo, una precisa struttura identitaria che non ha una norma fissa. Dimorare in un posto, infatti, non corrisponde necessariamente a stanziarvisi: “Abitare il mondo non vuol dire soltanto radicarsi, ma anche valicare confini”. L’abitare nomade, dunque, non è meno abitare di quello sedentario, anzi, mostra una diversa relazione tra l’uomo e il suo ambiente, dalla quale, sostiene Staid, si può trarre più di una lezione.
Può sembrare strano che si guardi a tende di pelle continuamente assemblate e smontate in mezzo al deserto in termini di futuribilità, eppure, proprio in queste usanze che a chi vive nei nostri condomini sembrano preistoriche, si possono rintracciare i semi di un modo più armonico di popolare il pianeta.
Per l’autore è fondamentale chiamarsi fuori dalla prospettiva industriale occidentale in favore di un approccio ecologista decoloniale. L’atto stesso della costruzione non deve più essere delegato: riappropriarsi dell’abitare significa, innanzitutto, conoscere i luoghi quanto i materiali che consentono l’edificazione e aprirsi inoltre alla possibilità di scoprirne di nuovi e insospettabili. Costruire, d’altronde, è un “atto immaginativo”, non un accumulo di materia inerte ma un’azione artigiana itinerante, ogni volta diversa, adattiva, che non può avere modelli prestampati cui obbedire ciecamente. La materia stessa è stata erroneamente avvertita nei secoli come passiva: oggi sappiamo invece che ha una propria agentività (agency), le cui ripercussioni si propagano anche nel sociale.
 Su questi argomenti, la studiosa di Scienza e Nanotecnologia dei materiali Laura Tripaldi scrive nel suo recente Menti parallele (effequ): “Forse in un futuro potremmo trovarci a vivere in case fluide, capaci di cambiare forma insieme a noi come il guscio di una chiocciola, o in città capaci di disassemblarsi e scomparire per ricostruirsi spontaneamente altrove. Finché queste prospettive fantascientifiche resteranno inaccessibili, possiamo accontentarci di sapere che le nanotecnologie odierne ci forniscono tutti gli strumenti per costruire e studiare sistemi capaci di organizzarsi, riprodursi e modificarsi in autonomia su diverse scale, mostrandoci che è possibile immaginare e progettare attivamente altre forme di vita e nuove menti”. La materia ha un’intelligenza ed è protagonista di importanti e costanti mutamenti: conoscerla è fondamentale per ripensare i nostri rapporti con essa e le infinite possibilità che ci dischiude.
Su questi argomenti, la studiosa di Scienza e Nanotecnologia dei materiali Laura Tripaldi scrive nel suo recente Menti parallele (effequ): “Forse in un futuro potremmo trovarci a vivere in case fluide, capaci di cambiare forma insieme a noi come il guscio di una chiocciola, o in città capaci di disassemblarsi e scomparire per ricostruirsi spontaneamente altrove. Finché queste prospettive fantascientifiche resteranno inaccessibili, possiamo accontentarci di sapere che le nanotecnologie odierne ci forniscono tutti gli strumenti per costruire e studiare sistemi capaci di organizzarsi, riprodursi e modificarsi in autonomia su diverse scale, mostrandoci che è possibile immaginare e progettare attivamente altre forme di vita e nuove menti”. La materia ha un’intelligenza ed è protagonista di importanti e costanti mutamenti: conoscerla è fondamentale per ripensare i nostri rapporti con essa e le infinite possibilità che ci dischiude.Nel mondo del Capitalocene, termine che Staid ritiene più centrato di Antropocene per indicare gli influssi devastanti e trasformativi dell’uomo sul pianeta, l’unica possibilità che ci è data come specie è vivere - e dunque, abitare - alleggerendo l’impatto umano. Lasciandosi alle spalle l’etnocentrismo, l’antropologo preferisce guardare al dimorare indigeno come possibile maestro di un diverso stare al mondo, fatto di ibridazione e connessioni (non a caso nel testo l’autore cita direttamente Chthulucene di Donna Haraway, che fa del legame - letteralmente kin, “parentela” - il fulcro del suo pensiero). Osservando varie comunità, Staid ha scoperto case che sono spazi sociali potenzialmente illimitati, non individualizzanti, spesso con un proprio ciclo di vita - case che nascono, crescono e muoiono dissipandosi secondo le leggi naturali dello spazio in cui sorgono.
 Il libro propone dunque una serie di esempi di “architettura spontanea”: dalla goahti dei sami all’izba russa, dal tulou cinese alla tolek africana, Staid esplora case vive costruite in armonia con l’ambiente circostante, case mobili, orti galleggianti, dimore fatte di scale che finiscono sugli alberi, in una rassegna breve ma allo stesso tempo ricca e suggestiva.
Il libro propone dunque una serie di esempi di “architettura spontanea”: dalla goahti dei sami all’izba russa, dal tulou cinese alla tolek africana, Staid esplora case vive costruite in armonia con l’ambiente circostante, case mobili, orti galleggianti, dimore fatte di scale che finiscono sugli alberi, in una rassegna breve ma allo stesso tempo ricca e suggestiva.- “Oggi è chiara la necessità di uscire dalla bolla eurocentrica, di costruire in modo differente; abbiamo bisogno di progettisti, autocostruttori visionari, capaci di immaginare altri mondi per risignificare il modo in cui abitiamo i nostri spazi”.
Se la casa è un “dispositivo cognitivo”, che si muove non solo in senso spaziale ma anche culturale, Staid ritiene che questo dispositivo vada espanso, e per farlo è necessario muovere altrove il nostro sguardo. Ciò non significa però soffermarsi solo su realtà distanti: è sufficiente scoprire anche proposte poco note sorte in Italia, come A.R.I.A. Familiare, cantieri di autocostruzione sorti ad Amatrice dopo il sisma.
 L’Occidente come sistema di pensiero avversa da sempre queste pratiche di autogoverno, anteponendo l’efficienza (spesso presupposta) ai meccanismi di condivisione e la burocrazia all’immaginazione. Si tende a favorire l’intorpidimento dell’homo comfort a scapito della manualità dell’homo faber. “È importante ricordare che la casa è un bene d’uso, non un bene di consumo”, sottolinea Staid e in questo senso fornisce esempi di progetti, come Pianeta U.M.A.N.A. & C., che sono scuole-cantiere volte proprio a istruire alle pratiche di autocostruzione familiare.
L’Occidente come sistema di pensiero avversa da sempre queste pratiche di autogoverno, anteponendo l’efficienza (spesso presupposta) ai meccanismi di condivisione e la burocrazia all’immaginazione. Si tende a favorire l’intorpidimento dell’homo comfort a scapito della manualità dell’homo faber. “È importante ricordare che la casa è un bene d’uso, non un bene di consumo”, sottolinea Staid e in questo senso fornisce esempi di progetti, come Pianeta U.M.A.N.A. & C., che sono scuole-cantiere volte proprio a istruire alle pratiche di autocostruzione familiare.
 In un’epoca di kit di case da montare proposti da Ikea, in cui la standardizzazione crea lotti malsani identici a se stessi, questo tipo di realtà mostra che altre direzioni sono possibili. Se la rivoluzione urbana, con i suoi condomini iperindividualizzanti, con la sua riduzione di spazi comunitari e la sua omogeneizzazione del paesaggio, genera un disagio abitativo dai volti molteplici, è evidente che urge una controrivoluzione.
In un’epoca di kit di case da montare proposti da Ikea, in cui la standardizzazione crea lotti malsani identici a se stessi, questo tipo di realtà mostra che altre direzioni sono possibili. Se la rivoluzione urbana, con i suoi condomini iperindividualizzanti, con la sua riduzione di spazi comunitari e la sua omogeneizzazione del paesaggio, genera un disagio abitativo dai volti molteplici, è evidente che urge una controrivoluzione.In questo senso Staid sottoscrive lo stretto legame che intercorre - o dovrebbe intercorrere - tra ecologia e lotta sociale: non riconoscere che le logiche capitaliste siano la causa principale della crisi ambientale significa mantenere uno sguardo parziale e insufficiente. “L’abitare deve diventare un progetto politico anticapitalista”, afferma in maniera diretta, proponendo poi un abecedario di buone pratiche basilari che passano dalla mobilità sostenibile alla riduzione dei rifiuti. È fondamentale ridimensionare l’umano e lasciare maggiore respiro al paesaggio, riportandoci al di fuori di quel centro in cui ci siamo storicamente auto collocati.
 Per comprendere questo scarto è sufficiente considerare che l’uomo rappresenta lo 0,01% della biomassa, contro le piante che corrispondono invece all’80%. È proprio alle altre specie che bisogna guardare per salvaguardare anche la nostra: un esempio è la fabbrica dell’aria realizzata dal botanico Stefano Mancuso, un sistema di filtraggio degli ambienti chiusi che si basa proprio sulla fotosintesi delle piante e la loro capacità di assorbire e degradare gli agenti inquinanti. Bisogna “pensare la fine dell’antropocene senza la fine della vita di noi animali umani sul pianeta”. Il primo passo è allo stesso tempo semplice e arduo: ammettere che il modo in cui abbiamo sempre abitato - infestato - il nostro pianeta possa non essere il migliore e cercare altrove nuovi paradigmi.
Per comprendere questo scarto è sufficiente considerare che l’uomo rappresenta lo 0,01% della biomassa, contro le piante che corrispondono invece all’80%. È proprio alle altre specie che bisogna guardare per salvaguardare anche la nostra: un esempio è la fabbrica dell’aria realizzata dal botanico Stefano Mancuso, un sistema di filtraggio degli ambienti chiusi che si basa proprio sulla fotosintesi delle piante e la loro capacità di assorbire e degradare gli agenti inquinanti. Bisogna “pensare la fine dell’antropocene senza la fine della vita di noi animali umani sul pianeta”. Il primo passo è allo stesso tempo semplice e arduo: ammettere che il modo in cui abbiamo sempre abitato - infestato - il nostro pianeta possa non essere il migliore e cercare altrove nuovi paradigmi.L’etnografia è un’esperienza di spaesamento, un approccio per cui ogni viaggio è scambio costante, attività transculturale contro ogni gerarchia e struttura verticale. L’obiettivo è progettare un abitare intraspecie, simile alle parentele auspicate da Haraway, che elimini ogni idea di ‘permesso calato dall’alto’ e riconosca pari dignità a tutto il vivente, concependo ogni specie come entità politica. Una volta superato il mito tossico della crescita e dello sviluppo infiniti sarà forse possibile smettere di infestare la Terra e cominciare ad abitarla e viverla, senza più separare i due concetti.
Risignificare l’abitare è risignificare l’umano: Staid invita a superare la paura che il mettersi in discussione reca sempre con sé e iniziare a concepirci diversamente come specie, agendo di conseguenza. Il suo invito, come la sua scrittura, è chiaro e privo di fronzoli: dobbiamo “immettere futuro nelle cose che si fanno nel presente”, azzardare nuovi immaginari perché la casa smetta di essere soltanto un edificio e ritrovi una più vasta rete di possibilità e significati.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Antropologia e Costituzione. Quale missione per gli architetti?
 ARCHITETTURA E DEMOCRAZIA. A margine del Congresso mondiale e della Biennale di Venezia [2008], un intervento-appello di Franco La Cecla.
ARCHITETTURA E DEMOCRAZIA. A margine del Congresso mondiale e della Biennale di Venezia [2008], un intervento-appello di Franco La Cecla.
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE (2005).
 (...) il “nuovo mondo” che abbiamo costruito dimostra quanto presto abbiamo dimenticato la ‘lezione’ delle foreste, dei mari, dei deserti, e dei fiumi e delle montagne!!!
(...) il “nuovo mondo” che abbiamo costruito dimostra quanto presto abbiamo dimenticato la ‘lezione’ delle foreste, dei mari, dei deserti, e dei fiumi e delle montagne!!!Federico La Sala
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- La pandemia e l’emergenza climatica due fenomeni in stretto collegamento (di Lucia Capuzzi).1 aprile 2021, di Federico La Sala
Ambiente.
La deforestazione e il Covid si nutrono a vicenda e corrono
La pandemia e l’emergenza climatica due fenomeni in stretto collegamento
di Lucia Capuzzi (Avvenire, giovedì 1 aprile 2021)
- [Foto] La devastazione degli spazi verdi è una delle cause della diffusione del virus nelle comunità locali
Immaginiamo di osservare la mappa dell’Europa. Per scoprire, d’un tratto, che dal profilo del Continente è sparita l’Olanda. Fino a un anno prima era là, incastonata tra Belgio e Germania. E ora niente: Amsterdam con i suoi canali, Rotterdam e l’intero Paese sono stati cancellati. O, meglio, divorati dal «Nulla», come nel celebre romanzo di Micheal Ende. Una simile scomparsa creerebbe stupore, rabbia, quanto meno sconcerto nell’opinione pubblica globale, assuefatta, invece, alla perdita di analoghi “pezzi” di mondo, purché collocati nella periferia geopolitica del pianeta.
Eppure un’area estesa quanto i Paesi Bassi è stata cancellata dal planisfero nel corso del 2020 quando sono stati distrutti 4,2 milioni di ettari di foreste primarie tropicali. Ovvero il “magazzino” naturale di una quantità di CO2 pari alle emissioni di 570 milioni di auto che, non più stoccate dagli alberi, finiscono nell’atmosfera. Con i ben noti effetti in termini di riscaldamento globale e cambiamenti climatici. A dare l’allarme è il nuovo studio elaborato dal World resources institute in base ai dati raccolti dell’Università del Maryland e dal Global forest watch e diffuso in occasione della riunione preparatoria ieri di Cop26, il vertice Onu sull’ambiente in programma a novembre a Glasgow.
- Nel 2020 è stata cancellata una foresta grande come l’Olanda. Nei Paesi del Sud del mondo la crisi sanitaria sta colpendo le risorse naturali e le popolazioni indigene
Inizialmente previsto nel 2020 e rinviato a causa del Covid, il summit rappresenta un momento cruciale di rilancio dell’accordo di Parigi, messo a dura prova dalla defezione degli Stati Uniti nell’era Trump. Ora il quadro internazionale è mutato. E la Casa Bianca di Joe Biden sembra decisa a rimettere la questione al centro dell’agenda globale, soprattutto in tempi brevi. Retorica a parte, però, non sarà facile convincere i Grandi a rispettare gli impegni presi a Parigi per tagliare le emissioni e mantenere l’aumento della temperatura entro gli 1,5 gradi centigradi. Appelli alla comunità internazionale a «trovare un’intesa efficace» e «di lungo periodo» alla crisi ecologica sono arrivati anche da papa Francesco negli ultimi mesi.
«Non è solo l’essere umano ad essere malato, lo è anche la nostra Terra», ha detto nell’incontro con il corpo diplomatico dello scorso febbraio il Pontefice della Laudato si’, a cui la Santa Sede ha voluto dedicare l’anno in corso, il quinto dalla pubblicazione dell’Enciclica. I media scozzesi hanno anche ventilato un possibile intervento del vescovo di Roma al vertice, eventualità al momento non confermata dalla Sala stampa vaticana. Anche perché non si può escludere che l’appuntamento subisca un nuovo slitta- mento a causa dell’emergenza Covid, pur se fonti del governo britannico lo negano. La pandemia in effetti rischia di aggravare ulteriormente la crisi ambientale. Non è un caso che l’anno appena trascorso - come sottolinea il World resource institute - abbia visto un drastico incremento della deforestazione: +12%, il terzo risultato peggiore in due decenni.
Lockdown e restrizioni alla mobilità hanno ridotto la possibilità di verifiche sul campo. Il peggio, tuttavia, potrebbe verificarsi nel prossimo futuro. Come effetto collaterale della recessione post-virus, i governi - soprattutto i grandi esportatori di materie prime - potrebbero decidere di risparmiare sui meccanismi di controllo e tutela ambientale. E di intensificare lo sfruttamento delle risorse per aumentare il Pil.
 È quanto già in atto nel Brasile di Jair Bolsonaro, dove il disboscamento è stato più feroce nel 2020, con la distruzione di 1,5 milioni di ettari di Amazzonia e 200mila ettari di Pantanal, la superficie umida più vasta al mondo: il 25% in più dell’anno precedente.
È quanto già in atto nel Brasile di Jair Bolsonaro, dove il disboscamento è stato più feroce nel 2020, con la distruzione di 1,5 milioni di ettari di Amazzonia e 200mila ettari di Pantanal, la superficie umida più vasta al mondo: il 25% in più dell’anno precedente.
 Il caso brasiliano è particolarmente eloquente perché il Paese era riuscito a conseguire una drastica riduzione della deforestazione agli inizi degli anni Duemila. Le sforbiciate agli enti di tutela, però, hanno favorito l’inversione di tendenza, alimentata dalla “fame” di risorse del Nord del pianeta. Un esempio è la filiera della carne, come dimostrato da nuova indagine di Greenpeace International che ha identificato quindici aziende agricole legate agli incendi dello scorso ottobre nel Pantanal, i cui prodotti - attraverso una complessa rete di transazioni - vengono esportati in tutto il mondo. Inclusa l’Italia, al primo posto nell’Ue e al sesto nel mondo per acquisti di carne, per un valore di 96 milioni di dollari.
Il caso brasiliano è particolarmente eloquente perché il Paese era riuscito a conseguire una drastica riduzione della deforestazione agli inizi degli anni Duemila. Le sforbiciate agli enti di tutela, però, hanno favorito l’inversione di tendenza, alimentata dalla “fame” di risorse del Nord del pianeta. Un esempio è la filiera della carne, come dimostrato da nuova indagine di Greenpeace International che ha identificato quindici aziende agricole legate agli incendi dello scorso ottobre nel Pantanal, i cui prodotti - attraverso una complessa rete di transazioni - vengono esportati in tutto il mondo. Inclusa l’Italia, al primo posto nell’Ue e al sesto nel mondo per acquisti di carne, per un valore di 96 milioni di dollari.Di recente, le associazioni Hutukara e Wanassedume, espressioni degli indigeni Yanomami, con il supporto dell’Instituto socioambiental (Isa), hanno denunciato un incremento del 30% delle miniere illegali sul proprio territorio, al confine tra Brasile e Venezuela. L’invasione di 20mila cercatori d’oro clandestini ha provocato la distruzione di 2.400 ettari di foresta, un’estensione equivalente a 500 campi da calcio. Oltre a diffondere il contagio fra gli indios, incluso il popolo in isolamento volontario dei Moxihatëtëma, che vivono sulle rive del fiume Catrimani e sono particolarmente fragili di fronte ai virus esterni.
 La questione è tutt’altro che marginale. Più di 45mila delle 310mila vittime brasiliane del Covid sono concentrate in territorio amazzonico, come confermato dall’ultima rilevazione della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam). E proprio da Manaus proviene la variante responsabile della strage in atto in queste settimane nel Gigante del Sud.
La questione è tutt’altro che marginale. Più di 45mila delle 310mila vittime brasiliane del Covid sono concentrate in territorio amazzonico, come confermato dall’ultima rilevazione della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam). E proprio da Manaus proviene la variante responsabile della strage in atto in queste settimane nel Gigante del Sud.- In un anno è stato «bruciato» il magazzino naturale di una quantità di CO2 pari alle emissioni di 570 milioni di auto. E, non più stoccata dagli alberi, l’anidride carbonica finisce nell’atmosfera
Il legame tra disboscamento e diffusione dei virus è stata sottolineato fin dall’inizio. E ribadito da una recente ricerca del Centre national de la recherche scientifique (Cnrs) in Francia e dell’Università Kasetsart in Thailandia, secondo cui, un’analisi dei dati tra il 1990 e il 2016, ha evidenziato senza alcun dubbio una «forte correlazione tra la devastazione delle foreste e lo sviluppo di focolai infettivi » in territori del Brasile, Perù, Bolivia, Repubblica democratica del Congo, Camerun, Indonesia, Myanmar e Malaysia. Gli stessi Paesi citati dal World resource institute. Il Congo è la seconda nazione più colpita dalla deforestazione con 490mila ettari in meno, seguita da Bolivia, Indonesia, Perù, Colombia, Camerun, Laos, Malaysia, Messico e Cambogia. Nonostante lo scenario allarmante, però, qualcosa si muove. L’Indonesia, ad esempio, è riuscita a diminuire le aggressioni ai suoi boschi negli ultimi sei anni grazie alla massiccia campagna di prevenzione lanciata dal governo dopo i roghi del 2015.
Particolarmente significativo il calo nella provincia di Kalimatan, le cui autorità hanno siglato un accordo con la Banca mondiale per 110 milioni di dollari di investimenti in cambio di un impegno nella lotta alle emissioni. La strategia degli incentivi è quella proposta dagli esperti del World resource institute. Centrale, in tal senso, l’alleanza con le comunità locali, soprattutto indigene definite dall’Onu le più efficienti «sentinelle del pianeta». La terra affidata alla loro gestione è la meglio conservata. Poiché - affermava la Laudato si’ già nel 2015 - per loro «la terra non è un bene economico, ma un dono di Dio e degli antenati che in essa riposano, uno spazio sacro con il quale hanno il bisogno di interagire per alimentare la loro identità e i loro valori più profondi. Quando rimangono nei loro territori, sono quelli che meglio se ne prendono cura».
-
> IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Contro la pandemia bisogna cambiare il rapporto col mondo. Nessun cambiamento di paradigma all’orizzonte(di Antonella Cilento).7 marzo 2021, di Federico La Sala
La lente azzurra
Contro la pandemia bisogna cambiare il rapporto col mondo
di Antonella Cilento (la Repubblica/Napoli, 07 Marzo 2021).
Nessun cambiamento di paradigma all’orizzonte: tutte le cose, urgentissime, che ci sarebbero da fare, non sono in programma.
Chiudere gli allevamenti intensivi che sono causa e humus della pandemia in corso e di quelle future (lo ha raccontato molto bene una puntata di "Indovina chi viene a cena" su Rai Tre), dare istruzione sulle abitudini alimentari, interrompere l’abuso farmacologico umano, agricolo e animale, fermare l’inquinamento chimico ed elettromagnetico (che ha già provocato danni a un’intera fascia di popolazione e che in questi giorni ha visto una condanna storia del professor Alexander Lerchl, docente di Biologia ed Etica della Scienza all’Università di Brema, da parte della Corte d’Appello Anseatica di Brema per aver supportato la diffusione massiva del 5 G: "tesi false che negano il potenziale genotossico della radiazioni elettromagnetiche"), introdurre abitudini mediche integrate e naturali: niente di tutto questo sta accadendo.
Non è accaduto per i numeri del cancro, non accade per il clima oltre la soglia di non ritorno, non accade neppure per la pandemia eterna che ci siamo, con le nostre stesse mani, organizzati. Nessuno guarda la luna, tutti il dito: il vaccino.
Certo: meglio usare i soldi pubblici europei per i laboratori farmaceutici, meglio sprecare energie per fare propaganda, per spingere una parte della popolazione ad accusarne un’altra.
Manon Aubry, eurodeputata di 31 anni, ha accusato in questi giorni Ursula Von Der Leyen di aver abdicato ogni potere ai laboratori farmaceutici privati, costruendo un gigantesco giro d’affari che rende i vaccini la leva con cui si può sollevare il mondo. I capi d’imputazione sono molti: contratti non chiari, consensi informati pieni di buchi, mancanza di garanzie. Ha chiesto di togliere la proprietà intellettuale sui brevetti, proprio in un momento in cui ci sarebbe necessità di produrre grandi quantità di vaccini su scala mondiale per uscire dalla crisi.
Ci sono segnalazioni di morti improvvise post vaccino (in Campania, in Alto Adige, in Norvegia, in Portogallo, in Francia): indagini in corso. Crescono i casi di effetti collaterali (l’Italia ha il primato europeo). Nessuna risposta per gli effetti su chi ha comunissime malattie autoimmuni (basta avere la diffusissima tiroidite di Hashimoto, regalino di Chernobyl per intere generazioni), nessuna risposta ai dubbi di una larga parte di popolazione, che è composta da persone che leggono e studiano, da medici, oncologi e scienziati di fama mondiale. Dopo il vaccino c’è chi non ha nessun effetto collaterale immediato. Le verifiche finali si faranno nel 2023: però questo non si fa a spese dei contribuenti.
Né si può parlare di obbligo vaccinale o passaporti vaccinali: la salute è un bene comune e sull’impossibilità di stabilire l’obbligo nelle scorse settimane si è espresso chiaramente il Consiglio Europeo.
Ci siamo fatti togliere molte libertà, in un anno, perché la paura conduce nel buio, ma non riusciamo con altrettanta forza a chiedere che vengano messe in opera politiche ambientali alternative che cambino il nostro rapporto col pianeta ma, è chiaro, queste politiche non sono un affare.
E allora affidiamoci alla letteratura: chissà che a leggere il bellissimo libro di Benjamín Labatut, "Quando abbiamo smesso di capire il mondo" (Adelphi) qualche dubbio sui comportamenti etici degli scienziati non venga. Romanzo della Storia, il genere che accomuna Sebald a una messe di scrittori contemporanei, i racconti intrecciati di Labatut narrano di come lo stesso elemento chimico può produrre il colore del manto delle madonne e il famigerato Zyklon B, di come i padri della fisica moderna abbiano alzato il velo della morte, di come siamo tutti esposti e abbiamo bisogno di etica e non di religioni della percezione.
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- SULLA STRADA DI UNA COSTITUZIONE GLOBALE. “La sovranità oltre lo Stato” di Enzo Cannizzaro ("Letture").22 gennaio 2021, di Federico La Sala
Intervista
“La sovranità oltre lo Stato” di Enzo Cannizzaro *
Prof. Enzo Cannizzaro, Lei è autore del libro La sovranità oltre lo Stato edito dal Mulino: quali forme assume il dibattito contemporaneo sul concetto di «sovranità»?
Il dibattito sulla sovranità è polarizzato fra la prospettiva del ritorno allo Stato sovrano e le tendenze utopiche di uno Stato mondiale.
La prima tendenza si nutre dell’idea che la comunità nazionale, il popolo, debba riprendere in mano il proprio destino, sottrattogli da procedure decisionali tecnocratiche, prese in luoghi remoti e inaccessibili all’uomo della strada, prive di legittimazione democratica. Pur se, talvolta animate dal genuino intento di ripristinare i processi democratici, tali tendenze appaiono però antistoriche, alla luce dei processi di internazionalizzazione sul piano economico e sociale.
La seconda tendenza, che prospetta la necessità di un governo sovranazionale, se non addirittura mondiale, pecca di astrattismo e di elitismo, e non considera la forte coesione delle comunità nazionali, che condividono valori, tradizioni e modelli di vita.
Quali trasformazioni ha subito la sovranità?
Dalle sue origini, la sovranità è mutata radicalmente nel corso della storia. Sorta inizialmente per fornire legittimazione all’assolutismo regio, essa si è via via adeguata all’evoluzione del costume sociale e delle forme della politica.
La sovranità ha prestato una dottrina politica alle forme di Stato e ai regimi più diversi: alle monarchie costituzionali e ai rivoluzionali borghesi e poi socialisti, ai regimi liberali ai moderni regimi costituzionali, dai regimi democratici a quelli totalitari del Novecento. A questa trasformazione “politica” ha corrisposto una sorta di rarefazione della sovranità. Inizialmente identificata con la persona del sovrano, la sovranità è stata via via identificata nel popolo, nell’ordinamento giuridico, nel potere costituente, fino ad essere identificata come la forma di garanzia esterna all’ordinamento giuridico e politico della comunità.
Eppure, paradossalmente, la sovranità è rimasta eguale a sé stessa. Ancora oggi, la sovranità si esprime, come ai tempi di Hobbes, nel potere assoluto di una comunità di darsi un ordinamento giuridico e politico. Questa assolutezza affascina e atterrisce al tempo stesso. Può esservi, nelle nostre società democratiche, un potere assoluto, non legittimato e non regolamentato che da sé stesso?
Qual è l’impatto dei processi di internazionalizzazione sullo Stato sovrano?
Dire che i processi di internalizzazione premono sullo Stato ed evidenziano l’insufficienza del potere di governo dello Stato sovrano appare un luogo comune. Tuttavia, i luoghi comuni corrispondono spesso alla realtà. Oggi appare illusorio pensare di poter governare i fenomeni economici e sociali attraverso i meccanismi dello Stato sovrano. Nessun Stato, per quanto potente, può agire da solo nel disordine del mondo.
Occorre tuttavia identificare più precisamente cosa si intenda per “processi di internazionalizzazione”. Questa formula è sovente intesa in senso deteriore, come i processi economici e finanziari che, attraverso le libertà di circolazione, sfuggono agli Stati, creando forme di ricchezza sottratte ai sistemi fiscali e redistributivi nazionali. A propria volta, tali processi creano una comunità di individui che se ne avvalgono e costituiscono una sorta di comunità transnazionale ed elitaria che gode di separata da quelle nazionali e privilegiata.
Questa descrizione risponde a verità. Accanto ad essa, tuttavia, ve ne è un’altra, di segno molto diverso. Essa è data proprio dalla esistenza di masse di individui spinte fuori dalla concentrazione di potere e di ricchezza degli Stati nazionali, che si muovono per sfuggire a guerre, carestie, devastazione degli ambienti tradizionali di vita.
Or bene, l’una e l’altra di queste forme di internazionalizzazione premono contro i confini, fisici e giuridici, dello Stato nazionale; l’una e l’altra esprimono il bisogno di un governo dei fenomeni sociali che vada ben oltre lo Stato sovrano; l’una e l’altra - o, per meglio dire, le une e le altre - costituiscono comunità embrionali, in cerca di forme di organizzazione politiche oltre la sovranità.
Come si esprime la sovranità fuori dallo Stato?
La sovranità fuori dallo Stato si è espressa, finora, in forme di organizzazioni internazionali la quali hanno stabilito forme parziali di governo, a livello globale o a livello continentale. L’esempio migliore su base mondiale è dato dalle Nazioni Unite; quello su base continentale è dato dall’Unione europea.
Si tratta di modelli ben diversi. Le Nazioni Unite sono state istituite per sottrarre l’uso della forza agli Stati e per stabilire una forma di amministrazione centralizzata della forza. Con le debite proporzionali, si tratta di quel che ha fatto, con successo, lo Stato sovrano il quale si è gradualmente affermato come il monopolista dell’uso della forza entro i propri confini. Le Nazioni Unite, quindi, si sono proposte un obiettivo ambizioso: quello di sottrarre agli Stati la prerogativa principale della sovranità. In una espressione colorita, hanno teso ad abolire la guerra.
Di converso, l’Unione europea si è posta l’obiettivo esattamente opposto: quello di governare i fenomeni economici e sociali, lasciando, per lo meno formalmente, le prerogative della sovranità in capo agli Stati, nella convinzione che, una volta attuata l’integrazione dei popoli europei, le prerogative sovrane sarebbero spontaneamente venute meno.
Ambedue questi progetti di “esternalizzazione” sono sostanzialmente falliti. Il motivo di questo fallimento appare, paradossalmente, analogo. Esso risiede nel fatto che gli Stati si sono impadroniti delle procedure decisionali delle due organizzazioni, piegandole alle proprie logiche di potere. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Ambedue le organizzazioni sono incapaci di affermare un indirizzo politico se non su impulso degli Stati. Ambedue sollevano aspettative di una forma di governo di una comunità transnazionale, le quali sovente, rimangono irrealizzate.
Che rapporti hanno i diversi modelli di organizzazione politica «oltre lo Stato» con il principio di democrazia?
Il rapporto fra sovranità e democrazia e ambivalente. Nonostante il nobile tentativo di “idealizzare” la sovranità come garante della democrazia e dei diritti dell’uomo, la sovranità non ha bisogno della democrazia. Essa, anzi, ha prosperato - ed esprime le sue potenzialità più perverse - proprio in assenza di democrazia. D’altronde, la storia dimostra che i valori più nobili dell’età moderna, la democrazia e il costituzionalismo, non sono, di per sé, un antidoto alle derive illiberali del potere sovrano.
Tuttavia, oggi possiamo percepire, pur fra molte difficoltà, l’esistenza di una democrazia “oltre lo Stato”. Ciò è possibile proprio in virtù del tramonto dell’idea di comunità quale insieme di individui legati da vincoli etnici, religiosi o culturali, che distinguono una comunità da tutte le altre. Oggi sappiamo che esistono comunità parziali, legate da valori, interessi e da modelli di vita che non hanno la valenza totalizzante ed escludente che caratterizza la comunità chiusa, come immaginavano i primi teorici della sovranità. E queste comunità parziali hanno sviluppato, se pur ancora solo embrionalmente, forme di democrazia transnazionali, che filtrano la legittimazione democratica della propria comunità di riferimento al di là dello Stato sovrano.
Ma gli Stati - monopolisti della democrazia come lo erano dell’uso della forza - guardano a queste nuove forme di organizzazione con grande diffidenza. Lo Stato, sovrano democratico verso l’interno, tende a porsi come l’unico garante della democrazia e della legittimazione politica nell’ambito delle forme transnazionali di governo. In altri termini, la sovranità statale si esternalizza nell’ambito delle dinamiche politiche al di fuori di esso.
La sfida per la democrazia, quindi, è la sfida per l’affermazione di forme di legittimazione e di democrazia fuori dallo Stato. È una sfida difficile, dato che ancora oggi gli Stati sono gli attori “forti” nel panorama delle relazioni internazionali. Ma questa è la sfida che la storia ci propone: Le forme di governo fuori dallo Stato potranno rappresentare una alternativa alla sovranità solo a condizione che esse si dota di una dottrina della democrazia e della legittimazione politica transnazionale.
Quale futuro per la sovranità?
La sovranità non è destinata a sparire. Non vi sono le condizioni affinché ciò avvenga. Non, certamente, in un arco prevedibile di tempo. Se un mondo senza sovranità è difficilmente immaginabile, è però altrettanto difficile immaginare che la sovranità possa per sempre occupare l’orizzonte politico dell’umanità.
La pretesa di governare attraverso la sovranità un mondo sempre più complesso, sempre più interdipendente e sempre più ingiusto, appare illusoria. Piuttosto che inseguire l’impossibile restaurazione dello Stato sovrano conviene quindi volgere l’attenzione verso la costruzione di nuovi modelli di legittimazione e democrazia nelle comunità transnazionali, capaci di governare i fenomeni che sfuggono alla capacità dello Stato sovrano e di incanalare le esigenze di giustizia sociale che emergono a livello globale.
Se le tendenze storiche non ingannano, tuttavia, si può pensare che la sovranità sia destinata a perdere le prerogative di esclusività e di assolutezza che l’hanno caratterizzata fino ad ora. E, con esse, lo Stato sovrano sarà privato della pretesa di esaurire al proprio interno le dinamiche politiche di una comunità composita ed eterogenea. Esso non sarà più il monopolista delle istanze di legittimazione e di democrazia. Né esso sarà l’unico garante degli equilibri sociali. Allo Stato sovrano si dovranno affiancare, in una sorta di poliarchia globale, forme di organizzazione rappresentative di valori e di interessi di una comunità transnazionale e dotate delle competenze parziali necessarie a soddisfarli.
Enzo Cannizzaro è professore ordinario di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea presso l’Università Sapienza di Roma. Ha insegnato in qualità di visiting professor in varie Università europee e negli Stati Uniti. Dirige la rivista European Papers. A Journal on Law and Integration; è membro dei Comitati direttivi delle riviste European Journal of International Law, Rivista di diritto internazionale, Il diritto dell’Unione europea. Collabora frequentemente con la stampa periodica su questioni giuridiche e di politica internazionale.
* Fonte: Letture. org
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Una guerra contro la vita - e un "Calendario della fine del mondo! (di Paolo Cacciari)22 dicembre 2020, di Federico La Sala
Una guerra contro la vita
di Paolo Cacciari *
- Le attività umane hanno trasformato tre quarti degli ambienti naturali terrestri. La pandemia è una conseguenza della guerra contro la vita. «Dovrebbe essere tutto chiaro su come l’umanità che ha un’impronta ecologica superiore alla media dovrebbe comportarsi: ritrarsi in buon ordine quel tanto che basta a lasciare campo libero alla natura affinché possa rigenerarsi, e noi con lei; riconoscere umilmente la nostra dipendenza dai sistemi naturali e rispettare le soglie insuperabili dei confini planetari...». E invece siamo convinti che la soluzione dei nostri guai non potrà venire che dalla tecnoscienza. Una volta George Bush senior ha detto che «il tenore di vita degli americani non è negoziabile». Aveva ragione lui. «In molti preferiscono vivere con la mascherina piuttosto che rinunciare allo shopping di Natale...» Tratta da unsplash.com
Tutti si sono ipocriticamente indignati di quel poveretto Domenico Guzzini, industriale da Macerata, che considera “qualche morto in più” un prezzo da pagare per fare andare avanti l’economia. Come se non si sapesse che è proprio il rischio (Ulrich Beck, La società del rischio, 1986) le regola aurea del meccanismo della crescita economica. In suo nome mettiamo in pericolo sistematicamente e quotidianamente le vite nostre e altrui, al lavoro, nelle strade, in casa nell’alimentazione. Il rischio è quotato in borsa attraverso le società di assicurazione e di riassicurazione. Anche le catastrofi hanno un prezzo e un costo.
 Razmig Keucheyan (La natura è un campo di battaglia, 2014, Ombre corte) ci faceva notare che “le recenti pandemie influenzali, suina (2009) e aviaria (dal 2003), hanno portato all’emissione di obbligazioni catastrofiche, che coprono gli assicuratori in casi di forte mortalità”. Pagare i premi conviene piuttosto che prevenire ed evitare i danni. Predisporre piani pandemici - ci hanno spiegato - costava troppo. Così la ricerca sui vaccini Sars.
Razmig Keucheyan (La natura è un campo di battaglia, 2014, Ombre corte) ci faceva notare che “le recenti pandemie influenzali, suina (2009) e aviaria (dal 2003), hanno portato all’emissione di obbligazioni catastrofiche, che coprono gli assicuratori in casi di forte mortalità”. Pagare i premi conviene piuttosto che prevenire ed evitare i danni. Predisporre piani pandemici - ci hanno spiegato - costava troppo. Così la ricerca sui vaccini Sars.Ma nessuno si indigna se a giocare sulla nostra pelle sono Goldman Sachs, Credit Suisse, Axa Investment. I Cat (catastrophe) Bond sono regolarmente valutati da agenzie di rating come la Standard and Poor’s, Fich e Mody’s. Titoli che probabilmente sono stati infilati nel portafoglio del nostro fondo pensionistico integrativo o in qualche altro prodotto finanziario confezionato dalla nostra banca. E allora perché prendersela col minus sapiens Guzzini se dice quello che nell’anonimato del capitalismo della “mano invisibile” è una prassi generale del sistema? È solo una questione di “percezione”, non scomodiamo i principi etici. L’accettazione psicologica della soglia di rischio, come si sa, è molto elastica, manipolabile dalle circostanze e dalle compensazioni. Lasciamo quindi perdere, per piacere, la morale. Chiediamoci piuttosto da dove viene il suo adombramento.
Mario Pezzella, in un recente seminario nella sua università a Pisa, ci invita a riscoprire Ernesto De Martino (La fine del mondo, 1977). Non ci accorgiamo della catastrofe ecologica, perché viviamo una “apocalisse culturale”. Abbiamo perduto la percezione del reale perché si è sgretolato attorno a noi l’ordine simbolico abituale. Abbiamo perso i punti di riferimento etici, oltre che le relazioni solidali interpersonali. L’umano si è perduto nel tecnico e nell’economico. Siamo convinti che la soluzione dei nostri guai non potrà venire che dalla tecnoscienza. In attesa dei prossimi mirabolanti risultati (il vaccino, l’energia pulita, l’economia circolare, la quarta rivoluzione digitale...) dobbiamo alimentare la ricerca e depositare tanti più brevetti possibili, lavorare e produrre sempre di più. Con qualche danno collaterale “inevitabile”. L’esempio, del resto, lo dà il governo nostrano emettendo il bonus accreditato automaticamente sullo smatphone per chi spenderà di più allo shopping natalizio. Non basta, ci sarà anche l’estrazione a premi. Ludopatia di stato.
Non ci sono altre spiegazioni. È da una vita, da Primavera silenziosa di Rachel Carson (1962), almeno, che una schiera di scienziati di ogni campo - come Cassandre - ci mostrano i segni della catastrofe ecologica. È stato scritto un Calendario della fine del mondo (un volume di Pacilli, Pizzo, Sullo, Intra Moenia, 2011) che scandisce il biocidio in corso. Ma ci eravamo sbagliati. Pensavamo che il pericolo principalmente venisse dall’alto, dal Sole che surriscalda una atmosfera intossicata dai gas sprigionati dalla combustione di carburanti fossili. Invece la nostra morte è venuta dall’interno del corpo vivo della Terra e nostro.
Virus e batteri sono i precursori e i supporti di ogni forma di vita. Il virologo Guido Silvestri (Il virus buono, Rizzoli, 2019) ci spiega che “viviamo tutti, letteralmente, dentro un mare di virus”. Gianfranco Bologna (Il grande insegnamento della natura indica cosa fare dopo la pandemia) ricorda i risultati delle ultime ricerche: in un corpo umano di 70 chilogrammi vi sono 38 mila miliardi di cellule batteriche e 30 mila miliardi di cellule umane. Nei mari la massa dei virus è dieci volte quella dei batteri. Ogni forma di vita è in simbiosi con i cicli biogeofisici della Terra.
Ha scritto Vandana Shiva (Il programma mondiale di Bill Gates e come possiamo resistere alla sua guerra contro la vita, mondalisation.org):
- “In realtà la pandemia non è una guerra. La pandemia è una conseguenza della guerra. Una guerra contro la vita”.
Le attività umane hanno trasformato il 75% degli ambienti naturali terrestri e il 66% degli ecosistemi marini. L’impatto antropico (estrazione di risorse non rinnovabili ed immissione di scarti non metabolizzabili) supera la carring capacity del sistema Terra. Scrisse Barry Commoner (Il cerchio da chiudere, 1972): “La prima legge dell’ecologia: ogni cosa è connessa con qualsiasi altra”.
 Un programma del 2019 della agenzia ambientale delle Nazioni Unite è titolato Healthy planet, healthy people (2019). Da ultimo papa Bergoglio, a Pasqua nella Piazza San Pietro deserta, ha detto: “Non illudiamoci di poter vivere in salute in un pianeta malato”. Scienziati e profeti parlano la stessa lingua.
Un programma del 2019 della agenzia ambientale delle Nazioni Unite è titolato Healthy planet, healthy people (2019). Da ultimo papa Bergoglio, a Pasqua nella Piazza San Pietro deserta, ha detto: “Non illudiamoci di poter vivere in salute in un pianeta malato”. Scienziati e profeti parlano la stessa lingua.Dovrebbe quindi essere tutto chiaro su come l’umanità che ha un’impronta ecologica superiore alla media dovrebbe comportarsi: ritrarsi in buon ordine quel tanto che basta a lasciare campo libero alla natura affinché possa rigenerarsi, e noi con lei; riconoscere umilmente la nostra dipendenza dai sistemi naturali e rispettare le soglie insuperabili dei confini planetari (Planetary Boundaries, Johan Rockström); vivere con ciò che si ha a disposizione, senza sottrarlo ad altri e senza negarlo a chi verrà dopo di noi. Questo dovrebbe essere l’insegnamento che viene dalla sindemia da Covid-SARS-2. Chi ce lo impedisce?
Una volta il presidente ultraliberista George Bush senior (1989) affermò che “il tenore di vita degli americani non è negoziabile”. Aveva ragione lui. In molti preferiscono vivere con la mascherina piuttosto che rinunciare allo shopping di Natale. Del resto non saprebbero come occupare altrimenti il loro tempo.
* Fonte: Comune-info, 18 Dicembre 2020 (ripresa parziale).
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "PANDEMIC FATIGUE": "SPIRAGLI NON SOLO DAL VACCINO". L’arcobaleno nella tempesta Covid. Intervista a Ilaria Capua (di Giulia Belardelli)17 novembre 2020, di Federico La Sala
Ilaria Capua: "Spiragli non solo dal vaccino, ora scongiurare il contagio animale"
La virologa ad Huffpost: "Se Covid 19 diventa panzoozia e colpisce tante specie animali ne perdiamo il controllo"
di Giulia Belardelli (Huffpost, 17/11/2020)
“Contro la pandemic fatigue non ci sono pozioni magiche: ciascuno di noi è chiamato ad alzare il proprio tollerometro. Stiamo vivendo una fase di trasformazione epocale: accanto a tutte le difficoltà, abbiamo l’occasione di abbandonare alcuni percorsi obsoleti e provare nuove mappe mentali. C’è un arcobaleno alla fine della tempesta Covid, tra le nuvole possiamo già intravederne i colori...”. Ilaria Capua, direttrice del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, ha sempre esortato a guardare la pandemia da una prospettiva più ampia, includendo anche l’ambiente e il mondo animale. Perché è in questa trama di relazioni che si intrecciano i rischi e le opportunità di domani.
Dottoressa Capua, il caso visoni in Danimarca ha acceso i riflettori sul rischio che il virus si diffonda incontrollatamente in altre specie animali. Quanto è concreto questo rischio?
“È una prospettiva che il mio gruppo di ricerca aveva già segnalato in tempi non sospetti, prima che scoppiasse il caso in Danimarca e altrove. In un articolo pubblicato a maggio scrivevamo che questo rischia di essere il primo virus pandemico che diventa una panzoozia, cioè che colpisce anche tante specie animali; in un’altra pubblicazione uscita a settembre osservavamo che i mustelidi (la famiglia dei visoni e dei furetti, per intenderci) sono animali che possono diventare serbatoio per questo fenomeno panzootico. Ad oggi sappiamo che i mustelidi sono molto ricettivi - ci sono stati casi anche in Olanda e negli Stati Uniti - e non abbiamo dati sui mustelidi selvatici”.
Quali sono i pericoli per l’uomo di un’ampia circolazione del virus tra altre specie animali?
“È tutto molto complicato. Il rischio che il virus circoli negli animali, e soprattutto negli animali selvatici, è che si perda definitivamente il controllo dell’infezione. È impensabile fare sorveglianza e andare a controllare le donnole o le faine nel loro habitat naturale. Il virus chiaramente potrebbe mutare in un’altra specie animale e questo potrebbe minare le nostre possibilità di controllare la pandemia. Le parole d’ordine non possono che essere flessibilità e attenzione, perché il virus sta facendo esattamente ciò che ci si aspetta da lui: si sta endemizzando in tutte le specie ricettive, compresi i mustelidi”.
In che modo queste mutazioni possono minare le nostre strategie di contenimento del coronavirus? I pericoli maggiori vengono dagli allevamenti intensivi o dagli animali selvatici?
“È un virus completamente nuovo quindi non lo sappiamo. Di certo però gli allevamenti intensivi sono controllati, gli animali selvatici molto meno”.
L’ultima copertina dell’Economist mostra una chiara luce in fondo al tunnel. “Suddenly, hope”, è il titolo. Il riferimento è alle notizie incoraggianti che arrivano sul fronte dei vaccini. È davvero così? Si vede la luce in fondo al tunnel?
“La luce alla fine del tunnel c’è e c’è sempre stata. Da questi fenomeni epocali l’umanità è sempre sopravvissuta, anche quando non c’erano i vaccini, i monoclonali, gli antibiotici. Pensiamo alla Spagnola, cent’anni fa: era un virus influenzale, molto più aggressivo di questo e che colpiva i giovani. Eppure, nonostante tutto, siamo qui. Oggi, a circa un anno dall’emersione di questo virus, sappiamo alcune cose, a cominciare dal fatto che eravamo del tutto impreparati”.
Nell’attesa di un vaccino e cure più efficaci, le misure di contenimento restano l’unico strumento per frenare la corsa del virus. Quella luce in fondo al tunnel però è bene raccontarla. Proviamo?
“Il tasso di letalità oggi è molto più basso rispetto alla scorsa primavera. Questo perché adesso la luce in fondo al tunnel è più chiara e fatta di molti elementi. Non parlo solo del vaccino, ma di una serie di vaccini che avranno caratteristiche diverse e andranno a unirsi a un armamentario di strumenti che abbiamo collezionato in questi mesi: una migliore comprensione della malattia, protocolli di intervento precoce, trattamenti come la sieroterapia, farmaci come gli antivirali e i cortisonici, e poi addirittura una terapia miracolosa come quella basata sugli anticorpi monoclonali”.
Una terapia che però è impensabile usare per tutti, giusto?
“È una terapia efficace se si fa entro un certo periodo: l’anticorpo monoclonale blocca la replicazione del virus, quindi se una persona sta già male e il virus ha fatto i suoi danni, non serve più. Sono delle proteine di sintesi, degli anticorpi fatti in laboratorio che però si producono in volumi bassissimi e dunque hanno un costo molto alto. Non è pensabile che questo sia il farmaco che possa essere dato a tutti per girare liberamente. Magari fosse così! È un trattamento che non si riesce a produrre in grandi quantità, è come la pappa reale, che è l’alimento destinato all’ape regina. Ne abbiamo visto gli effetti su Donald Trump, la cui cura è costata centinaia di migliaia di dollari”.
Questo fatto fa comprensibilmente un po’ rabbia, un sentimento che non aiuta ad assumere un atteggiamento costruttivo...
“I costi, purtroppo, sono pazzeschi anche per un normale ricovero in terapia intensiva. È per questo che ciascuno di noi deve cercare di non ammalarsi. Noi per primi - le persone che non devono essere in prima linea o svolgere lavori ad alto rischio - dobbiamo dimostrare che tenendosi lontani dal virus è possibile non prenderselo. Se proprio ci si deve ammalare, più tardi avviene, meglio è: se oggi, a un anno dalla scoperta, vediamo la luce grazie a 5-6 protocolli che funzionano, tra un mese potremmo averne 20”.
Torniamo ai vaccini, volutamente al plurale. Qual è il vantaggio di averne diversi? Quali le sfide?
“Siamo di fronte a una situazione unica. È per questo che bisogna organizzarsi per avere dei piani di distribuzione che tengano conto delle specificità dei diversi vaccini che verranno approvati. Ce ne potrebbero essere alcuni che funzionano meglio su determinate categorie di persone, altri che danno una protezione più immediata, magari con una sola dose; alcuni andranno conservati a -70, altri a -20... Bisognerà tenere conto non solo delle caratteristiche del prodotto ma anche delle esigenze della distribuzione e della somministrazione. Bisognerà mettere in campo un mix di organizzazione e flessibilità”.
Secondo uno studio dell’Istituto Tumori di Milano, il virus circolava in Italia già a settembre 2019. Cosa ne pensa? La storia dell’epidemia è ancora tutta da scrivere?
“Questo dovrebbe essere un dato confermato da altri studi europei. Non c’è ragione per credere che il virus sia arrivato in Italia mesi prima rispetto ad altri Paesi europei. Se questo dato verrà confermato da studi analoghi fatti in Germania, Francia, Spagna, allora vorrà dire che il virus è circolato per molto tempo sotto traccia: saremmo di fronte a un fallimento clamoroso del meccanismo di sorveglianza, un fatto gravissimo. C’è da augurarsi che si siano sbagliati; nell’attesa di conferme, meglio essere cauti”.
A fine aprile ci raccontava in anteprima del progetto concepito insieme a Fabiola Gianotti del Cern per “battere il Covid con le intelligenze collettive”. A che punto siete?
“Il progetto sta andando avanti, si chiama Circular Health. Abbiamo aggiunto diversi gruppi tra cui la Fondazione ISI di Torino e l’Universita’ Bicocca di Milano. Stiamo lavorando su molte tematiche interdisciplinari, dall’impatto della diversità di sesso e genere sul virus alla comorbidità (quali sono le patologie intercorrenti con le quali si è più a rischio), dalla resilienza della natura a quella urbana. Esattamente un anno fa, prima della pandemia, lanciavamo Beautiful Science, una campagna sul senso d’orgoglio per i propri scienziati: credo che l’Italia debba veramente ricordare quanto è importante avere dei team di ricercatori e ricercatrici che ogni giorno, nonostante tutto, si alzano e vanno a lavorare per proteggere e preservare la nostra salute”.
In questa seconda ondata si parla molto di pandemic fatigue, una sensazione di stanchezza diffusa che può generare meccanismi psicologici anche molto diversi, dalla depressione fino al negazionismo. Come far fronte a questa “fatica”?
“Innanzitutto riconoscerne l’esistenza è già tanto. Bisogna capire che esiste, che ci rende tutti molto più fragili e rende ancora più complessa la gestione di un fenomeno come questo, perché le persone mollano. La pandemic fatigue è proprio questo: quando le persone non ce la fanno più e dicono ‘basta’. È una resa alimentata anche dal fatto che arrivano messaggi contraddittori o segnali di grande speranza, che poi ovviamente vengono subito ridimensionati. Un tale zig zag emozionale - gioia / disastro - provoca per forza questo meccanismo psicologico. Ci si sente disorientati, stanchi, impotenti di fronte a un caos soverchiante. Aumenta il nervosismo, si litiga di più, si inizia a dire: ‘basta, me lo prendo il COVID e succeda quello che deve succedere’. Sta accadendo ovunque nel mondo, a livello delle istituzioni, delle strutture sanitarie, dei ragazzini che devono andare a scuola. Tutti sono stanchi e affaticati.
 L’unica cosa che posso dire è: alziamo ciascuno il proprio tollerometro perché siamo in una situazione eccezionale, tiriamo fuori il nostro senso di gregge, secondo il quale se un lupo mangia la mamma pecora - gli agnellini li allatta un’altra mamma pecora. Diventiamo comprensivi, troviamo spazio per l’ascolto ma non per gli attacchi e lasciamo cadere le provocazioni. Alzare il tollerometro, mettere la mascherina e dare il buon esempio è tutto ciò che possiamo fare”.
L’unica cosa che posso dire è: alziamo ciascuno il proprio tollerometro perché siamo in una situazione eccezionale, tiriamo fuori il nostro senso di gregge, secondo il quale se un lupo mangia la mamma pecora - gli agnellini li allatta un’altra mamma pecora. Diventiamo comprensivi, troviamo spazio per l’ascolto ma non per gli attacchi e lasciamo cadere le provocazioni. Alzare il tollerometro, mettere la mascherina e dare il buon esempio è tutto ciò che possiamo fare”.Nel suo libro “Il dopo” spiega come il virus ci ha costretti a cambiare mappa mentale. Mentre le difficoltà sono evidenti a tutti, sulle opportunità si fa più fatica. Qual è la “cornice d’argento” di questo nuvolone in cui ci troviamo immersi?
“Ho addirittura aggiornato la cornice d’argento facendola diventare un arcobaleno. Ho scritto un editoriale che uscirà tra qualche giorno su una rivista del gruppo Lancet intitolato “L’arcobaleno nella tempesta Covid”. Credo che questa sia una grande opportunità: vivevamo lungo percorsi obsoleti che non possiamo più riprendere. Alcuni sistemi sono saltati: i trasporti, così com’erano, per un certo numero di anni non potranno più essere. Dobbiamo trovare il modo di continuare a fare quello che facevamo in epoca pre-Covid aggiornando i nostri sistemi. Dobbiamo confrontarci con un desiderio di mobilità che è completamente cambiato. Alcuni modelli basati sul turismo di massa non erano più sostenibili.
 L’arcobaleno è la nostra possibilità di ripartire in un modo più sostenibile.
L’arcobaleno è la nostra possibilità di ripartire in un modo più sostenibile.È tempo di occuparci della nostra salute in maniera circolare, cioè capendo che siamo dipendenti da tutto quello che succede dall’altra parte del mondo. In tempi recenti avevamo avuto molte avvisaglie: ci sono stati Ebola, Zika, l’influenza suina, la Sars... sono cose che succedono, le altre sono state fermate, questa no. Su un punto siamo tutti d’accordo: non possiamo permetterci un’altra emergenza come questa. Cambiare non è una scelta: è una necessità”.
La risonanza di teorie complottiste dimostra uno scetticismo diffuso attorno alla cultura scientifica e al pensiero razionale. È un fallimento della scienza? Del mondo della scuola? Come si rimedia?
“Uno dei pezzi dell’arcobaleno è che bisogna partire con un’alfabetizzazione scientifica maggiore. La pandemia è proprio l’occasione giusta perché ora tutti vogliono capire. Il mio invito è: prendiamo quello che di buono la pandemia ci lascia - consapevolezze, abitudini, comportamenti, la speranza di poter andare in una direzione in cui un fenomeno del genere, con questa gravità, non potrà più accadere.
 “Ti conosco mascherina”, il libro che ho scritto per spiegare la pandemia ai bambini, contiene le 400 parole di sanità pubblica che spero abbiano più impatto di tutto ciò che ho scritto in questi anni. È un libro che va letto in famiglia: serve per normalizzare questo virus e far partire delle discussioni all’interno della famiglia su come lavorare insieme, come sviluppare insieme queste mappe mentali. Senza queste diventeremo obsoleti personaggi ‘vintage’ che rappresenteranno ai giovani di domani come era la vita prima della Grande Pandemia. Quella del 2020. ”.
“Ti conosco mascherina”, il libro che ho scritto per spiegare la pandemia ai bambini, contiene le 400 parole di sanità pubblica che spero abbiano più impatto di tutto ciò che ho scritto in questi anni. È un libro che va letto in famiglia: serve per normalizzare questo virus e far partire delle discussioni all’interno della famiglia su come lavorare insieme, come sviluppare insieme queste mappe mentali. Senza queste diventeremo obsoleti personaggi ‘vintage’ che rappresenteranno ai giovani di domani come era la vita prima della Grande Pandemia. Quella del 2020. ”. -
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Un piano d’azione per le persone, il Pianeta e la prosperità. È l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni unite, tra cui l’Italia (ASviS).19 ottobre 2020, di Federico La Sala
L’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile *
Un piano d’azione per le persone, il Pianeta e la prosperità. È l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni unite, tra cui l’Italia, per condividere l’impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo abitano.
L’Agenda globale definisce 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell’acronimo inglese) da raggiungere entro il 2030, articolati in 169 Target, che rappresentano una bussola per porre l’Italia e il mondo su un sentiero sostenibile. Il processo di cambiamento del modello di sviluppo viene monitorato attraverso i Goal, i Target e oltre 240 indicatori: rispetto a tali parametri, ciascun Paese viene valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali.
L’Agenda 2030 porta con sé una grande novità: per la prima volta viene espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale, superando in questo modo definitivamente l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e affermando una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.
- Leggi il testo dell’Agenda 2030
- È l’unico piano che abbiamo, per salvare l’unico Pianeta che abbiamo.
- Scarica gli SDGs
- Le 17 icone degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Le cinque "P" dello sviluppo sostenibile
L’Agenda 2030 è basata su cinque concetti chiave:
- Persone. Eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e uguaglianza.
- Prosperità. Garantire vite prospere e piene in armonia con la natura.
- Pace. Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive.
- Partnership. Implementare l’Agenda attraverso solide partnership.
- Pianeta. Proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.
- “La nuova Agenda è una promessa da parte dei leader a tutte le persone in tutto il mondo. È un’Agenda per le persone, per sradicare la povertà in tutte le sue forme, un’Agenda per il Pianeta, la nostra casa". (Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite)
Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono tutti collegati tra loro
Garantire un’istruzione di qualità, equa e inclusiva (Goal 4) vuol dire anche offrire pari opportunità a donne e uomini (Goal 5); per assicurare salute e benessere (Goal 3), occorre vivere in un Pianeta sano (Goal 6, 13, 14 e 15); un lavoro dignitoso per tutti (Goal 8) richiede l’eliminazione delle disuguaglianze (Goal 10). Gli SDGs sono fortemente interconnessi.
L’Agenda 2030 lancia una sfida della complessità: poiché le tre dimensioni dello sviluppo (economica, ambientale e sociale) sono strettamente correlate tra loro, ciascun Obiettivo non può essere considerato in maniera indipendente ma deve essere perseguito sulla base di un approccio sistemico, che tenga in considerazione le reciproche interrelazioni e non si ripercuota con effetti negativi su altre sfere dello sviluppo. Solo la crescita integrata di tutte e tre le componenti consentirà il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.
- "È la prima volta che i leader mondiali si impegnano in uno sforzo e in un’azione comune attraverso un’agenda politica così vasta e universale". (Onu, Agenda 2030)
Tutti sono chiamati a contribuire
Gli SDGs sono universali, rimandano cioè alla presenza di problemi che accomunano tutte le nazioni. Per questo motivo, tutti i Paesi sono chiamati a contribuire alla sfida per portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo. Ciò vuol dire che ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli SDGs e a rendicontare i propri risultati all’Onu.
Non solo. All’interno dei Paesi serve un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura: per abbracciare lo sviluppo in ogni sua parte è fondamentale l’impegno di tutti.
- "Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Nell’intraprendere questo grande viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà lasciato indietro". (Onu, Agenda 2030)
E tu, come puoi contribuire al cambiamento?
Tutti siamo parte del cambiamento per un domani migliore, tutti ne siamo responsabili. E sono le nostre azioni che influenzeranno il futuro dei nostri figli e delle prossime generazioni. Stili di vita corretti e azioni individuali fanno la differenza. Informati sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e interrogati su quel che puoi fare per contribuire al loro raggiungimento, condividi buone pratiche, partecipa alle campagne, racconta il tuo contributo alla realizzazione dell’Agenda 2030 sui social. Consulta i materiali di educazione allo sviluppo sostenibile, scopri come collaborare, chiunque può fare la sua parte!
Consulta i materiali per informarti e contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030 [...]
* Fonte: ASviS (ripresa parziale).
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Radici in fiamme (di Pier Paolo Tarsi).28 agosto 2020, di Federico La Sala
SALENTO...
Radici in fiamme
di Pier Paolo Tarsi (Fondazione Terra d’Otranto, 28.08.2020)
Oggi mi sono concesso una lunga camminata con Tris ripercorrendo lo stesso tragitto che tempo fa, all’inizio dell’estate, mi permise di notare che un giovane uomo aveva preso a curare un uliveto non distante da casa mia e da tempo abbandonato a se stesso. Mi rallegrò molto constatare allora che qualcuno aveva ripreso a lottare, a sperare e resistere nel suo piccolo metro quadrato di civiltà ereditata. Un appezzamento con una trentina d’alberi non ancora fortemente intaccati dalla xylella.
Mi illudevo, evidentemente. Ripassando di là mi si è presentata oggi una scena orribile che non riesco a togliermi ancora dagli occhi e dalla mente. Quell’uomo stava caricando sul suo camioncino gli ultimi pezzi di legna, calmo, serafico, fischiettando al tramonto. La metà di quell’uliveto era stato ridotto a brandelli, pezzi buoni per il camino nell’inverno alle porte; quel che restava di ogni albero, un tronco mozzato qua e là e radici inabissate nella terra, era in fiamme. Anni fa, quando ancora la gente credeva che la xylella fosse un frutto esotico ed io ancora credevo nella mia gente, dalle pagine di un giornale locale scrivevo che perdendo gli ulivi questa terra avrebbe perso tutto. E fui profetico. Tentavo di spiegare che noi siamo un popolo di terra, non gente di mare, come molti, anche salentini, erroneamente pensano, confusi forse dai cataloghi per le vacanze altrui.
Non che si dovesse malinconicamente ed erroneamente tentar di perpetuare un dato passato, pretendere stupidamente di arrestare il flusso della nostra storia. Solo che avremmo dovuto ben guardarci dall’interromperla, tranciando legami e radici. Da allora quasi niente. Da una parte un fronte scientista che ad oggi non ha saputo proporre che far quanto prima il deserto; dall’altra qualche santone verboso. In mezzo tante chiacchiere da politicanti di tutti i colori, nessuno escluso. E tanta, tantissima ignoranza. Quella vera, quella che niente ha a che fare con l’analfabetismo o con ciò che si può imparare all’università.
A un uomo si può insegnare in modo relativamente facile a scrivere, a risolvere una complicata equazione o a programmare la più strepitosa delle app. Queste sono competenze che non ci fanno uomini o donne, sono cose che ci rendono semplicemente delle scimmie particolarmente abili in qualche ambito.
Quel che è difficile davvero da insegnare a delle scimmie per farle diventare uomini e donne è il sentire il valore delle cose ricevute e il valore di ciò che lega le nostre effimere vite agli altri e all’eterno fluire dei tempi. Difficile davvero non è far apprendere a delle scimmie il secondo principio della termodinamica ma portarle a chiedersi cosa implica per loro stesse il compiere una data azione, o ancora portarle a domandarsi del mistero della propria identità. Forse ha ragione Briatore. Bisognerebbe affidare questa terra ormai immemore e senza speranza a quelli come lui per farne finalmente un colorato non-luogo, insignificante forse ma pieno di traffici e soldi, di fregna con cui mirare i tramonti dai lidi attrezzatissimi ubicati tra un gasdotto e l’altro.
Beati, abbronzati e con in mano una frisa deluxe o un mojito, da sorseggiare prima di rientrare nei deserti edificati da faraonici villaggi turistici in cui far trenini fino all’alba. Pensateci: Belen tra noi tutto l’anno e non solo per una notte.
Caro il mio Tris, per noi nemmeno un sentiero di campagna da attraversare in santa pace. Le radici bruciano, il deserto avanza, fuori e dentro di noi. E non è colpa della xylella stavolta. Andremo a fare due passi da qualche altra parte, prima o poi bisognerà rassegnarsi e cambiare aria una volta per tutte.
___
NOTA:
LA TERRA ALL’INTERNO DELL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA...
“Le radici bruciano, il deserto avanza, fuori e dentro di noi”. E “cambiare aria una volta per tutte” non è più nemmeno sognabile! Al di là della Luna, l’unica via d’uscita è quella che porta al pianeta Marte, alla “casa” del dio della guerra?! Non è proprio possibile uscire per altra via dall’orizzonte della “caduta”, dal letargo “infernale”, e venir fuori ad ammirare il “cielo stellato”?! Boh e bah!?
-
>PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- APPELLO. lettera aperta che Pax Christi invia alla Cei: «Abolire subito le armi nucleari, anche l’Italia firmi il trattato» (Giacomo Gambassi)).5 agosto 2020, di Federico La Sala
Pax Christi.
«Abolire subito le armi nucleari, anche l’Italia firmi il trattato»
di Giacomo Gambassi (Avvenire, mercoledì 5 agosto 2020)
«Immorali». Non aveva usato mezzi termini papa Francesco in Giappone lo scorso novembre per condannare gli armamenti nucleari e il loro potere distruttivo che hanno lasciato un segno indelebile ad Hiroshima e Nagasaki dove il 6 e il 9 agosto 1945 vennero sganciate le bombe atomiche americane.
Le parole del Pontefice, la sua «condanna» della minaccia nucleare, la denuncia dell’«affronto mortale» che mina non solo il benessere della terra ma anche il rapporto con Dio tornano nella lettera aperta che Pax Christi invia alla Cei in occasione del 75° anniversario dei bombardamenti atomici in Giappone dove sollecita i vescovi italiani a chiedere al Governo di firmare il trattato sul bando totale delle armi atomiche approvato dall’Onu nel 2017.
- 13.410 le testate nel mondo. Usa e Russia hanno il 90% delle testate:
- 5.800 quelle Usa (di cui 1.750 dispiegate), 6.375 quelle russe (1.570 pronte all’uso)
Il testo «ha un sempre più crescente sostegno mondiale», scrivono il vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, Giovanni Ricchiuti, e don Renato Sacco, rispettivamente presidente nazionale e coordinatore nazionale di Pax Christi. Tuttavia, aggiungono, «per diventare effettivo c’è bisogno di altre firme per superare la soglia necessaria di cinquanta Stati. Il Vaticano lo ha da tempo ratificato e le Conferenze dei vescovi cattolici di Giappone e Canada hanno chiesto ai loro esecutivi di fare altrettanto».
In Italia, invece, il tema sta passando sotto silenzio. «Nel nostro Paese - racconta don Sacco ad Avvenire - esistono due siti che ospitano ordigni nucleari: Aviano, in provincia di Pordenone, e Ghedi, nel Bresciano. Non sappiamo quanti siano ma il loro potenziale è di gran lunga più elevato di quello impiegato nel 1945. E, come dice il Papa, non va censurato solo l’uso ma anche il possesso».
Don Sacco ricorda il cartoncino fatto distribuire da Bergoglio a fine 2017 con la foto di un bambino di 10 anni che trasportava sulle spalle il cadavere del fratellino ucciso dalla bomba a Nagasaki. «Il Papa aveva scritto: “Il frutto della guerra...”. La tragedia avvenuta in Giappone è un monito per l’oggi, un grido sempre più attuale».
- 9 gli Stati che fanno parte del «club atomico»:
- Stati Uniti, Russia, Israele, Francia, Gran Bretagna, Cina, Pakistan, India, Corea del Nord
La lettera del Movimento cattolico per la pace prende spunto dall’emergenza Covid per riflettere sulla piaga atomica. «Le conseguenze dannose della pandemia impallidiscono rispetto a quelle che sarebbero capitate alla famiglia umana, e alla terra stessa, in caso di guerra nucleare», affermano Ricchiuti e Sacco. E spiegano che, mentre si cerca un vaccino al virus, «stiamo sperimentando come investire centinaia di miliardi di dollari per lo sviluppo, la fabbricazione, i test e lo spiegamento di armi nucleari non solo non è riuscito a renderci sicuri, ma ha privato la comunità umana delle risorse necessarie per il raggiungimento della vera sicurezza umana: sufficienza alimentare, alloggio, lavoro, formazione scolastica, accesso all’assistenza sanitaria».
- 12 milioni è la cifra (in dollari) che viene spesa ogni ora per mantenere in sicurezza gli arsenali, che richiedono una manutenzione continua
Ancora. «Di fronte al coronavirus le speranze di sopravvivenza nelle nostre comunità si sono fondate sul sacrificio in prima linea dei soccorritori. Eppure, ammonisce la Croce Rossa internazionale, tali soccorritori non ci sarebbero in caso di un attacco nucleare: i medici, gli infermieri e le infrastrutture sanitarie sarebbero essi stessi cancellati».
Ecco il richiamo. «La cosiddetta “sicurezza” offerta dalle armi nucleari si basa sulla nostra volontà di annientare i nostri nemici e la loro volontà di annientarci. A 75 anni dagli avvenimenti di Hiroshima e Nagasaki è giunto il tempo per rifiutare questa logica di reciproca distruzione e costruire una vera sicurezza».
Pax Christi chiarisce che in caso di una guerra nucleare, «anche se limitata», la vita sul pianeta «sarebbe messa in grave pericolo». Serve allora eliminare gli armamenti atomici. «Ma - conclude il movimento - la finestra temporale che ci resta potrebbe essere troppo breve. Se non riusciamo ad agire adesso e con decisione, giochiamo pericolosamente non solo con la pandemia ma anche con l’estinzione totale».
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- Un’ipotesi diventa certezza. Louis Godart riscrive leggenda omerica: A Troia fu guerra civile (di Paolo Martini).2 luglio 2020, di Federico La Sala
CULTURA
A Troia fu guerra civile: Godart riscrive leggenda omerica
(di Paolo Martini) *
Dagli ultimi scavi sulla collina di Hissarlik, in Turchia, un’ipotesi diventa certezza: a Troia non furono due popolazioni diverse a scontrarsi, molto più semplicemente fu una ’guerra civile’. Gli Achei venuti dalla Grecia combatterono contro gli Achei che si erano già insediati in città. Lo sostiene uno dei massimi studiosi delle civiltà egee, il professore Louis Godart, in un articolo che esce sul nuovo numero della rivista "Archeologia Viva" (Giunti Editore).
"Greci e Troiani parlavano la stessa lingua, avevano le stesse credenze, stessi usi e costumi, stesso tipo di armamento. Omero lo dice chiaramente nella sua Iliade. Oggi la conferma arriva dall’archeologia che aiuta a riscrivere un’intera pagina di storia, decisamente la più nota e popolare": così sintetizza la scoperta lo storico e archeologo Louis Godart, che ha insegnato Civiltà egee all’Università ’Federico II’ di Napoli ed è stato consigliere per la conservazione del patrimonio artistico presso la Presidenza della Repubblica italiana ed è membro dell’Accademia dei Lincei, dell’Institut de France e dell’Accademia di Atene.
"Le ricerche condotte a Troia dalla missione archeologica dell’Università tedesca di Tubinga abbinate a una riflessione sullo studio dei testi delle tavolette in lineare B scritte nel dialetto acheo dei Greci micenei - dichiara Godart - cambiano radicalmente le nostre prospettive sulla storia dell’Anatolia nord-occidentale e dell’Egeo alla fine del II millennio, in particolare tra il 1200 e il 1180 a.C.".
È a questo periodo che risale la cosiddetta Troia VIi (secondo le numerazione che gli archeologi hanno dato ai vari strati della lunga vita della città), in quel momento la città più importante dell’Anatolia e del Vicino Oriente, dove la gente si rifugiò all’interno delle mura sistemando nel suolo grandi vasi per lo stoccaggio di derrate alimentari (rinvenute dagli archeologi) per poter sostenere il lungo assedio che poi si concluse con la caduta della città, come lasciano intendere i resti umani e le tracce dei combattimenti rinvenuti nello strato di distruzione dell’insediamento.
Achei e Troiani, due facce dello stesso popolo. In Omero Achei e Troiani non sono mai differenziati in modo netto. Secondo l’Iliade, i due popoli pregavano gli stessi dèi, ai quali tributavano gli stessi sacrifici. Parlavano la stessa lingua e i troiani avevano nomi greci. Non vi sono mai problemi di comunicazione tra Achei e Troiani e anche il nome Ettore non era un nome barbaro per i greci, spiega sempre Godart. Vi era un culto di Ettore a Tebe; a Taso, isola vicina alla costa della Tracia, una divisione della città portava il nome di Priamides. In una serie di tavolette in lineare B (la scrittura dei Micenei) di Pilo, è stato identificato l’antroponimo ’e-ko-to’ che corrisponde al greco ’Hector’, mentre in un altro testo rinvenuto sempre nel palazzo di Nestore, c’era il patronimico ’e-ko-to-ri-jo’, ’Hectorio’s, ’figlio di Ettore’.
"Il nome Ettore è quindi un nome acheo, anche se nell’Iliade indica il grande campione troiano - illustra sempre Godart - Poiché i nomi degli eroi troiani sono greci, Omero, facendo parlare una stessa lingua agli Achei e ai Troiani, non fa altro che rispecchiare la situazione che vigeva sull’acropoli di Troia alla fine del XIII secolo a.C.".
"Sarei assolutamente propenso, come sostengo nel mio articolo su ’Archeologia Viva’ e nel mio libro ’Da Minosse a Omero’ (Einaudi) - spiega Godart - a ritenere che sia stata un’aristocrazia micenea a comandare a Troia nella fase VII che ispirò Omero. L’abbondante ceramica micenea rinvenuta sul sito di Troia negli strati del XIII secolo a.C. conforta indubbiamente una simile ipotesi. Se è davvero così e se Priamo era un re acheo, dovremmo ritenere che la guerra di Troia cantata da Omero sia stata una guerra civile in cui implacabilmente si opposero gli Achei del continente, delle isole e di Creta a altri Achei".
Louis Godart è autore di importanti pubblicazioni presso Einaudi: "Il disco di Festo. L’enigma della scrittura", "L’invenzione della scrittura", "L’oro di Troia. La vera storia del tesoro scoperto da Schliemann" (con Gianni Cervetti), e il recente "Da Minosse a Omero. Genesi della prima civiltà europea".
-
> PIANETA TERRA --- Coronavirus: per una governance globale democratica e federale (Appello).26 maggio 2020, di Federico La Sala
Coronavirus: per una governance globale democratica e federale*
- La pandemia del Coronavirus ha provocato una crisi sanitaria ed economica mondiale che richiede soluzioni globali. Tuttavia, gli Stati nazionali e le organizzazioni internazionali non sono in grado di fornire una risposta adeguata.
 Pensatori di tutto il mondo hanno firmato un documento chiedendo ai leader politici e alle istituzioni internazionali di rafforzare le Nazioni Unite, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la debole struttura internazionale odierna, applicando a livello globale i principi del federalismo e della democrazia. È possibile aderire all’appello a questo link.
Pensatori di tutto il mondo hanno firmato un documento chiedendo ai leader politici e alle istituzioni internazionali di rafforzare le Nazioni Unite, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la debole struttura internazionale odierna, applicando a livello globale i principi del federalismo e della democrazia. È possibile aderire all’appello a questo link.
- [English version below] *
L’attuale crisi legata al Coronavirus richiede una cooperazione globale e soluzioni che il sistema politico nazionale/internazionale odierno non è in grado di offrire. Sette miliardi di esseri umani vivono oggi in un mondo globalizzato dall’economia e dalla tecnologia ma diviso in 200 Stati nazionali che adottano separatamente misure con scarso coordinamento ed efficacia. La pandemia di Covid19 mostra che ognuno di loro dà priorità alla propria visione e ai propri interessi, e ciò causa danni inutili all’economia mondiale e alla società globale e costa migliaia di vite umane.
Per definizione, gli Stati nazionali non sono in grado di affrontare questioni globali. I loro fallimenti non riguardano solo i loro cittadini, ma hanno effetti di ricaduta su tutti gli abitanti di questo piccolo pianeta iperconnesso, danneggiando i beni comuni globali. Un coordinamento globale e politiche globali sono urgentemente necessari per difendere l’ecosistema e la salute pubblica mondiali, e per proteggere economia e occupazione in tutto il pianeta. Naturalmente, la sovranità nazionale deve continuare ad essere rispettata per gli affari nazionali, ma è anche necessario un efficace meccanismo decisionale globale per proteggere il benessere e la sopravvivenza dell’umanità nel suo complesso.
Per affrontare efficacemente pandemie come quella di Covid19, abbiamo bisogno di azioni concrete e vincolanti a livello globale, come sistemi di allerta precoce, condivisione delle informazioni, consegna e applicazione delle norme, gestione della trasmissione attraverso le frontiere e ricerca sul trattamento dei vaccini. Tuttavia, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha il mandato di svolgere queste funzioni a livello globale, si rileva una carenza di fondi e di meccanismi di applicazione.
Ad oggi, infatti, 127 Stati membri dell’ONU non li hanno ancora pienamente rispettati per mancanza di volontà politica e di finanziamento, e l’OMS non può vincolare i paesi che non si conformano ai Regolamenti Sanitari Internazionali, e le misure di controllo delle malattie esistenti a livello globale quali PEF, CEF e GHSA costituiscono una strategia frammentata, con finanziamenti disarticolati, politiche non integrate e debole autorità. La crisi dimostra che tutto l’attuale sistema sanitario nazionale/internazionale è impreparato ad affrontare pandemie globali come Covid19, così come questioni mondiali quali la resistenza agli antimicrobici e le emergenze legate al riscaldamento globale.
Noi firmatari di questo documento - noi che siamo solo alcuni dei sette miliardi di cittadini del mondo chiediamo urgentemente ai leader nazionali e alle istituzioni internazionali di imparare dalla lezione della crisi del Coronavirus. Lavoriamo insieme per consentire una migliore integrazione del sistema politico del XXI secolo, rafforzando le istituzioni regionali, riformando le Nazioni Unite e rendendo ogni livello di governance più rappresentativo ed efficace; per esempio, attraverso la creazione di un’Assemblea Parlamentare delle Nazioni Unite in grado di emanare norme sanitarie mondiali, il potenziamento di una Corte Penale Internazionale capace di sanzionare eventuali violazioni, e la costruzione di un’Organizzazione Mondiale della Sanità attrezzata per rispondere alle sfide sanitarie globali.
Noi firmatari non proponiamo uno Stato o governo mondiale. Gli Stati nazionali sono necessari per gestire i problemi nazionali, ma è necessario un sistema di governance globale potenziato per affrontare questioni globali come questa pandemia. In caso contrario, il panico generato da risposte nazionali insufficienti alle ricorrenti crisi globali continuerà a far crescere il discontento e la rabbia, erodendo le democrazie nazionali e rafforzando nazionalismo e populismo, con le loro semplicistiche risposte "sovraniste" a questioni globali complesse, e la loro minaccia alla sopravvivenza umana.
L’umanità è diventata una vera e propria comunità di destino. Sperabilmente, la pandemia del Coronavirus ci ha insegnato quanto sia piccola la Terra e quanto siamo vicini gli uni agli altri. È giunto il momento di applicare i principi del federalismo e della democrazia su scala globale. Sovranità condivisa, coordinamento e cooperazione a livello globale o populismo nazionale. Una struttura politica più federale e democratica in grado di regolare la globalizzazione o ulteriori crisi e caos. Questo è il dilemma che ci troviamo di fronte.
 Saskia Sassen, Columbia University
Saskia Sassen, Columbia University
 Fernando Savater, Universidad Complutense de Madrid
Fernando Savater, Universidad Complutense de Madrid
 Richard Sennett, London School of Economics
Richard Sennett, London School of Economics
 Susan George, Transnational Institute
Susan George, Transnational Institute
 Fernando Iglesias, Cátedra Spinelli - World Federalist Movement
Fernando Iglesias, Cátedra Spinelli - World Federalist Movement
 Daniel Innerarity, University of the Basque Country European University Florence
Daniel Innerarity, University of the Basque Country European University Florence
 Daniele Archibugi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, University of London
Daniele Archibugi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, University of London
 Fernando Dalla Chiesa, Universitá degli Studi di Milano
Fernando Dalla Chiesa, Universitá degli Studi di Milano
 Luigi Ferrajoli, University of Rome
Luigi Ferrajoli, University of Rome
 Michele Fiorillo, Scuola Normale Superiore CIVICO Europa
Michele Fiorillo, Scuola Normale Superiore CIVICO Europa
 Lucio Levi, Universitá di Torino
Lucio Levi, Universitá di Torino
 Lorenzo Marsili, European Alternatives
Lorenzo Marsili, European Alternatives
 Raffaele Marchetti, Libera Università Guido Carli (Luiss)
Raffaele Marchetti, Libera Università Guido Carli (Luiss)
 Guido Montani, University of Pavia
Guido Montani, University of Pavia
 Nathalie Tocci, Istituto Affari Internazionali (IAI)
Nathalie Tocci, Istituto Affari Internazionali (IAI) Abdullahi A AnNaim, Universidad Emory
Abdullahi A AnNaim, Universidad Emory
 Sabrina Ajmechet, University of Buenos Aires
Sabrina Ajmechet, University of Buenos Aires
 Bertrand Badie, Science Po Paris
Bertrand Badie, Science Po Paris
 Manu Bhagavan, Hunter College
Manu Bhagavan, Hunter College
 Garret Brown, University of Leeds
Garret Brown, University of Leeds
 Andreas Bummel, Democracy Without Borders
Andreas Bummel, Democracy Without Borders
 Mary Burton, University of Cape Town
Mary Burton, University of Cape Town
 Raimondo Cagiano de Azevedo, University of Rome
Raimondo Cagiano de Azevedo, University of Rome
 Richard Falk, Princeton University - Queen Mary University
Richard Falk, Princeton University - Queen Mary University
 Dena Freeman, London School of Economics and Political Science
Dena Freeman, London School of Economics and Political Science
 Elver Hilal, UN Special Rapporteur on Right to Food
Elver Hilal, UN Special Rapporteur on Right to Food
 Gurutz Jáuregui, University of the Basque Country
Gurutz Jáuregui, University of the Basque Country
 Santiago Kovadloff, Academia Argentina de Letras
Santiago Kovadloff, Academia Argentina de Letras
 Tim Murithi, University of Cape Town
Tim Murithi, University of Cape Town
 Nissim Otmazgin, The Hebrew University of Jerusalem
Nissim Otmazgin, The Hebrew University of Jerusalem
 Gabriel Palumbo, Universidad de Buenos Aires
Gabriel Palumbo, Universidad de Buenos Aires
 Erna Paris, Université La Sorbonne
Erna Paris, Université La Sorbonne
 Heikki Patomäki, University of Helsinki
Heikki Patomäki, University of Helsinki
 Clara Riveros, CPLATAM Colombia
Clara Riveros, CPLATAM Colombia
 Luis Alberto Romero, Academia Argentina de Historia
Luis Alberto Romero, Academia Argentina de Historia
 Teivo Teivainen, University of Helsinki
Teivo Teivainen, University of Helsinki
 Theo van Boven, Maastricht University
Theo van Boven, Maastricht University
 Loris Zanatta, Universitá di Bologna
Loris Zanatta, Universitá di Bologna(Versione italiana dall’inglese a cura di Michele Fiorillo)
CORONAVIRUS: FOR A GLOBAL DEMOCRATIC AND FEDERAL GOVERNANCE
The coronavirus pandemic has caused a global health and economic crisis that requires global solutions. However, the nationalinternational structure is unable to offer an adequate response to it. Thought leaders around the world have signed this document demanding to political leaders and international institutions to strengthen the UN system, the World Health Organization and the international existing weak structure as well, applying the principles of federalism and democracy worldwide.
The current coronavirus crisis requires global cooperation and solutions which the existing national/international political system is incapable of delivering. Seven billion human beings are now living in a world globalized by the economy and technology but divided into almost 200 national states which adopt separate measures with scarce coordination and effectiveness. The Covid19 pandemic shows each of them prioritizing their own vision and interests, which causes unnecessary damage to the world economy and the global society, and costs thousands of human lives.
By definition, national states are unable to deal with global issues. Their failures don’t just affect their own citizens but have spillover effects on all the inhabitants of this small hyperconnected planet, damaging global commons. Global coordination and policies are urgently needed to defend the global ecosystem and world public health, and to protect the economy and employment all over the planet. Of course, national sovereignty must continue to be respected for national affairs, but effective global decision making is also necessary to protect the welfare and survival of humanity as a whole.
To effectively tackle pandemics such as Covid19, we need concrete binding action at the global level, such as early warning systems, information sharing, delivery and enforcement of norms, management of transmission across borders and vaccinetreatment research. Yet, while the World Health Organization (WHO) is mandated to deliver these functions at the global level, it lacks funds and enforcement mechanisms. Nowadays, 127 UN member states have still not fully complied with them due to a lack of financing and political will, the WHO can’t tackle countries that do not comply with the International Health Regulations and existing global disease control measures such as PEF, CEF and GHSA constitute a globally fragmented strategy, with disjointed funding, disintegrated policies and weak authority. The crisis shows that all the current health national/international system is unprepared to tackle global pandemics as Covid19, as well as world issues such as antimicrobial resistance and global warming related emergencies.
We the signatories of this document, some few of the seven billion world citizens, urgently ask national leaders and international institutions to take lessons from the Coronavirus crisis. Let’s work together to enable a better integrated 21st Century political system, reinforcing regional institutions, reforming the United Nations and making each level of governance more representative and effective; for example, through the creation of a UN Parliamentary Assembly able to deliver world health norms, the empowerment of an International Criminal Court capable of sanctioning eventual violations, and the building of a World Health Organization equipped to respond to global health challenges.
We the signatories don’t propose a world state or government. National states are needed to manage national problems, but an enhanced global governance system is needed to tackle global issues such as this pandemic. Otherwise, the panic generated by insufficient national responses to recurrent global crises will continue growing discontent and anger, eroding national democracies and strengthening nationalism and populism, with their simplistic “sovereigntist” responses to complex global affairs, and their threat to human survival.
Humanity has become a real community of fate. Hopefully, the coronavirus pandemic has taught us how small the Earth is and how close we are to each other. The time of applying the principles of federalism and democracy to the global scale has come. Shared sovereignty, coordination and cooperation at the global level or national populism. A more federal and democratic political structure able to regulate globalization or further crises and chaos. That’s the question we face.
- [...]
- La pandemia del Coronavirus ha provocato una crisi sanitaria ed economica mondiale che richiede soluzioni globali. Tuttavia, gli Stati nazionali e le organizzazioni internazionali non sono in grado di fornire una risposta adeguata.
-
> IL PIANETA TERRA--- Lo stato del pianeta visto «come un tutto».... Un pensiero sbagliato, che ha dato origine a un paradigma socio-economico distorto, e a uno stile di vita insensato (di Marco Revelli)26 maggio 2020, di Federico La Sala
La pandemia impone una verifica dei doveri e dei poteri
Fragilità dell’Antropocene. «Niente di questo mondo ci risulta indifferente». È un passo nell’enciclica «Laudato si’» ed è anche il titolo di un libro straordinario (in uscita nelle Edizioni Interno4)
di Marco Revelli (il manifesto, 26.05.2020)
La pandemia ci obbliga a un ripensamento globale e radicale. Perché ci ha toccato ferocemente «nell’osso e nella pelle», dice il Libro di Giobbe, richiede un’impietosa verifica dei doveri e dei poteri.
Tanto più ora quando, almeno qui in Italia e in Europa, par di vedere la fine del tunnel. E la verifica, per essere efficace, non potrà che avvenire all’insegna di un principio semplice e impegnativo: «Niente di questo mondo ci risulta indifferente».
È un passo nell’enciclica Laudato si’ (che compie esattamente in questi giorni cinque anni), collocato proprio all’inizio, nel secondo paragrafo dove si dà voce al pianto della terra devastata dall’uomo ammonendo: «Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora».
Ed è anche il titolo di uno straordinario libro (in uscita nelle Edizioni Interno4) dalla cui copertina un babbuino ci guarda perplesso sotto il motto «La normalità era il problema».
Libro «straordinario» - cioè che ci solleva al di sopra dell’ordinarietà - per due buone ragioni.
La prima riguarda il modo con cui è nato, è stato pensato e scritto: in tanti, a più e più mani, da decine di studiosi, competenti, militanti delle più varie associazioni, credenti e laici, facenti capo all’associazione «Laudato si’», che per mesi si sono riuniti, hanno discusso, verificato e confrontato le proprie idee, spesso discordanti, le hanno rielaborate, rese compatibili, ricondotte all’unitarietà di un discorso articolato e condiviso, come si dovrebbe fare sempre, tra chi partecipa del medesimo orizzonte di valori e soprattutto avverte l’urgenza del tempo.
LA SECONDA RAGIONE riguarda il contenuto: finalmente un approccio davvero «totale» ai mali che ci affliggono e alle necessarie soluzioni.
Lo stato del pianeta visto «come un tutto», in cui devastazione ambientale e devastazione sociale, catastrofe ecologica e diseguaglianza economica, non solo s’intrecciano ma appaiono aspetti dello stesso problema: disprezzo per la terra e disprezzo per gli uomini, persino disprezzo per sé e il proprio futuro sono il prodotto della stessa radice e dello stesso errore.
Un pensiero sbagliato, che ha dato origine a un paradigma socio-economico distorto, e a uno stile di vita insensato.
Il libro era stato elaborato prima, ma lo tzunami del coronavirus che ha segnato i tre mesi che hanno preceduto la pubblicazione ne ha prodotto la «cerchiatura del cerchio», confermandone la visione e rafforzandone il messaggio.
Come scrive Daniela Padoan, la curatrice, nel saggio Al tempo del contagio, che apre il volume: «Davanti alla pandemia, il titanismo della nostra cultura è costretto a imparare la lezione dell’essere in balia», spiegando come l’esperienza che stiamo vivendo - nel suo carattere totale e globale - sia in qualche modo «una figurazione» delle argomentazioni contenute nel testo.
Da essa abbiamo imparato, nel dolore, la fragilità strutturale dell’Antropocene, di questo mondo costruito a immagine e somiglianza del suo ospite umano.
Abbiamo avuto modo di vedere, messa a nudo, «la società spettrale del management totalitario», per dirla col filosofo canadese Alain Deneault citato dalla curatrice.
Di capire (per chi volesse capire) quanto fallace, e ingannatrice, sia quella razionalità strumentale che avevamo elevato a statuto dell’universo - garanzia della sua perfezione - e che invece si rivela mortifera, incapace di previsione e di prevenzione, foriera di disordine e caduta, pericolosa per il vivente.
E quanta hybris - quanta arroganza, nella nostra sfida cieca al cielo - ci fosse nel culto del fare, e nel mito di un’efficienza che nell’esaltare un solo aspetto dell’esistenza (quello economico e tecnico) sacrifica tutto il resto. Ovvero il tutto.
NEL LIBRO, dalla diagnosi dei mali emerge un programma, realistico, di risposta: sul Clima, alla «radiografia della catastrofe» si affianca il principio per cui «la giustizia climatica è giustizia sociale».
Sulla «Depredazione ambientale» la necessità di una lotta contro l’«agricoltura 4.0» che minaccia «i diritti umani, sociali e della natura».
Sulle migrazioni all’affermazione secondo cui «Migrare è un diritto» segue il dovere di denuncia della «morte in mare» come «vera emergenza».
Alla descrizione delle dimensioni della povertà s’intreccia la denuncia dell’«economia dello scarto» come anima del paradigma egemonico contemporaneo, drammaticamente visibile anche nella gestione dell’emergenza sanitaria.
Su «Finanza e debito» la definizione, forte, del «Capitale finanziario globale come forma di criminalità organizzata» si affianca alla valorizzazione dell’«economia del dono».
E poi il Lavoro: dall’affermazione perentoria che «non c’è libertà nel vendere la propria forza-lavoro» alla messa a nudo delle «molteplici solitudini delle lavoratrici e del lavoratori».
E poi l’Ecofemminismo: «Liberazione delle donne, della natura e del vivente». La Cultura del limite. E tanto altro.
Un vademecum perfetto per chi voglia inoltrarsi nel territorio nuovo che il virus ci lascia, nel lutto.
CON UNA CONSAPEVOLEZZA forte: che eravamo già malati prima che il Covid-19 arrivasse. Molto prima.
«Non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato», ha detto papa Francesco in quella Piazza San Pietro metafisica e irreale, deserta e lucida di pioggia, il 27 marzo.
Dovremo pure ascoltare, oggi, quelle tante voci, e altre che si sono aggiunte, se non vogliamo ritrovarci infine a brancolare nel buio alla fine del tunnel.
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Una costituzione mondiale: da utopia a realtà? Ritorna di attualità il tema di un governo mondiale (di Vittorio Possenti).22 aprile 2020, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: L’ILLUMINISMO, OGGI. UNA COSTITUZIONE PER IL MONDO... *
Dibattito.
Una costituzione mondiale: da utopia a realtà?
Ritorna di attualità il tema di un governo mondiale, sorto subito dopo la guerra: il bene comune universale non può essere assicurato da una responsabilità politica frammentata. Un cammino però arduo
di Vittorio Possenti (Avvenire, mercoledì 22 aprile 2020)
Le gravi difficoltà planetarie, che non si riducono a quelle attuali della pandemia, e che sono messe impietosamente allo scoperto dal processo di globalizzazione dominato da tecnica e finanza, fanno affiorare il tema assolutamente primario di un governo politico della famiglia umana, in nome della comune umanità che non tollera discriminazioni, rifiuto della solidarietà e della fratellanza. Riemergono le questioni dell’unità politica mondiale, della pace perpetua, di istituzioni comuni aventi responsabilità a raggio mondiale. Tra innumerevoli ostacoli avanza la consapevolezza di un bene comune planetario dell’umanità e di beni comuni, che devono esseri assicurati allo stesso livello: è l’immensa questione di un’autorità politica mondiale o, come anche si dice, di una costituzione mondiale.
Pochi mesi fa si è formata in Italia l’associazione “Costituente terra” che persegue tale obiettivo. Domenica 5 aprile l’inserto “La lettura” del “Corriere” ha ospitato un articolo di Sabino Cassese dal titolo “Il sogno di una costituzione mondiale”, in cui l’attenzione si rivolge in specie al tragitto politico e intellettuale di Giuseppe Antonio Borgese, che dall’Italia si trasferì in Usa negli anni ’30.
Borgese fece parte sin dall’inizio del comitato per la redazione di una costituzione mondiale, presieduto dal presidente dell’università di Chicago, Robert Maynard Hutchins, e composto da poco più di dieci membri che lavorò dal novembre 1945 al luglio 1947, preparando il progetto di una costituzione mondiale. Il gruppo tenne rapporti con persone esterne tra cui Jacques Maritain e Luigi Sturzo. Il testo fu pubblicato in varie lingue, e in italiano dalla Mondadori nel 1949, ma non ebbe grande accoglienza: era già cominciata l’epoca della guerra fredda.
Il lavoro non fu però inutile. Nel 1949 Maritain tenne alcune lezioni presso l’università di Chicago che formarono poi L’uomo e lo Stato, uno dei classici del pensiero politico novecentesco. In quest’opera l’autore dedica un capitolo a “Il problema dell’unificazione politica del mondo” che si riassume negli obiettivi di una pace permanente, nel superamento della sovranità degli Stati (severamente criticata) e nella formazione di un’autorità politica mondiale, garante della pace e della giustizia tra i popoli.
Non presento qui l’elaborazione maritainiana, che si differenzia alquanto da quella kantiana sulla pace perpetua. Mi interessa un altro elemento d’immenso rilievo: nel promulgare nell’aprile 1963 l’enciclica Pacem in Terris, Giovanni XXIII dedica profonda attenzione alla messa in opera di Poteri pubblici e Istituzioni a raggio planetario. Nella parte IV del testo il papa scrive: «Il bene comune universale pone ora problemi che non possono essere adeguatamente affrontati e risolti che ad opera di Poteri pubblici aventi ampiezza, strutture e mezzi delle stesse proporzioni; di Poteri pubblici cioè che siano in grado di operare in modo efficiente su piano mondiale. Lo stesso ordine morale quindi domanda che tali Poteri vengano istituiti».
La prospettiva è stata rilanciata da Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in veritate (2009). È impensabile che la soluzione ai problemi globali che sono ulteriormente cresciuti possa essere trovata senza un grande progetto che conduca ad un’autorità politica globale: «Urge la presenza di una vera Autorità politica mondiale, quale è stata già tratteggiata dal mio Predecessore, il Beato Giovanni XXIII. Una simile Autorità dovrà essere regolata dal diritto, attenersi in modo coerente ai principi di sussidiarietà e di solidarietà, essere ordinata alla realizzazione del bene comune, impegnarsi nella realizzazione di un autentico sviluppo umano integrale ispirato ai valori della carità nella verità. Tale Autorità inoltre dovrà essere da tutti riconosciuta, godere di potere effettivo per garantire a ciascuno la sicurezza, l’osservanza della giustizia, il rispetto dei diritti». Essa, che oltrepassa ma non cancella il livello dello Stato e/o quello di unioni politiche regionali, è necessaria in quanto esiste un bene comune universale che non può essere assicurato da una responsabilità politica frammentata.
Questo dislivello strutturale è forse la più grave causa del disordine mondiale. Il cammino verso un’autorità politica mondiale, da non intendersi come un Superstato e ancor meno come un impero mondiale, ma ricorrendo ai principi di sussidiarietà e solidarietà, è un itinerario lungo e arduo. Nonostante tutto dovrebbe imporsi se l’umanità globalizzata per il bene e il male, intenderà sopravvivere.
 Intanto un certo cammino può essere compiuto, e già lo è stato, mediante la creazione di organismi mondiali in campi fondamentali quali l’economia, la salute, il commercio, il cibo: Fmi, Banca Mondiale, Wto, Oms, Fao ne sono esempi, mentre sull’ambiente bisognerebbe procedere a istituirlo. Non ci si inganni però, in quanto tali organismi spesso sono indirizzati dalle potenze dominanti. Il loro arrancante e precario funzionamento, in specie durante le crisi più gravi, è uno dei motivi della paura e della chiusura che colpiscono popoli e nazioni, conducendoli al nazionalismo e al sovranismo sotto la spinta di capi politici incapaci di guardare oltre.
Intanto un certo cammino può essere compiuto, e già lo è stato, mediante la creazione di organismi mondiali in campi fondamentali quali l’economia, la salute, il commercio, il cibo: Fmi, Banca Mondiale, Wto, Oms, Fao ne sono esempi, mentre sull’ambiente bisognerebbe procedere a istituirlo. Non ci si inganni però, in quanto tali organismi spesso sono indirizzati dalle potenze dominanti. Il loro arrancante e precario funzionamento, in specie durante le crisi più gravi, è uno dei motivi della paura e della chiusura che colpiscono popoli e nazioni, conducendoli al nazionalismo e al sovranismo sotto la spinta di capi politici incapaci di guardare oltre.Su questi nuclei il compito dell’Europa dovrebbe essere primario e l’appello di papa Francesco il giorno di Pasqua è chiaro. L’Europa è risorta dopo il 1945 grazie a un intento di unione per superare le rivalità passate: «È quanto mai urgente, soprattutto nelle circostanze odierne, che tali rivalità non riprendano vigore, ma che tutti si riconoscano parte di un’unica famiglia e si sostengano a vicenda. Oggi l’Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero».
Da anni le ragioni del multilateralismo e dell’universalismo si sono gravemente indebolite. Alcune frasi del discorso del presidente Trump all’assemblea generale dell’Onu (24 settembre 2019) rappresentano il clima che si diffonde: «Il futuro non appartiene ai globalisti. Il futuro appartiene ai patrioti. Il futuro appartiene alle nazioni sovrane e indipendenti», chiaro invito a far pesare la propria forza sulle ragioni dell’equilibrio, e rilancio del primato dello Stato nazionale. È dunque ancor più necessario riprendere il progetto di un “costituzionalismo globale”, capace di creare istituzioni sovranazionali, e infine mondiali, di garanzia. Esse avrebbero il compito di controllare l’implementazione dei patti internazionali e del relativo diritto in ambiti vitali come l’ambiente, la corsa agli armamenti, l’istruzione, i diritti sociali, la lotta alle diseguaglianze, il contrasto alla tratta di esseri umani e alla criminalità internazionale. Qualcosa di analogo ai compiti svolti dall’Oms e dalla Fao nei loro campi rispettivi.
Jürgen Habermas ha parlato di “politica interna del mondo” e in Italia Luigi Ferrajoli ha sostenuto che il costituzionalismo ha un futuro solo se allargato oltre lo Stato. Le istituzioni di garanzia perseguono infatti fini universali nei modi prestabiliti dalla legge e dal diritto internazionali, e contribuiscono a limitare i poteri assoluti. Ma è proprio in questo campo che il cammino è più arduo, poiché mancano quasi completamente leggi di attuazione e di controllo, e il vecchio dogma della sovranità è lungi dall’essere superato.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana".
LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
"ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi".
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
Una Costituzione per il mondo: l’utopia concreta di Borgese contro i sovranismi (di Valter Vecellio).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Earth Day. La Giornata mondiale della Terra: dai 20 milioni in strada nel 1970 alla maratona virtuale planetaria di oggi imposta dal coronavirus.22 aprile 2020, di Federico La Sala
Internazionale
La terra è malata, una quarantena lunga mezzo secolo
Earth Day. La Giornata mondiale della Terra: dai 20 milioni in strada nel 1970 alla maratona virtuale planetaria di oggi imposta dal coronavirus. L’esortazione del direttore generale dell’Onu Guterres: cambiare rotta, investire sul verde Attivisti contro i cambiamenti climatici a New York
di Marinella Correggia (il manifesto, 22.04.2020)
«È surreale, come se fosse un pianeta completamente diverso»: così il cosmonauta russo e i due astronauti statunitensi si sono espressi il 17 aprile al loro ritorno a casa dopo sei mesi nello spazio.
E nella quarantena mondiale, completamente diversa è anche la Giornata mondiale della Terra: l’evento compie 50 anni spostandosi completamente sul digitale.
QUELLO STORICO 22 APRILE 1970, invece, mobilitò 20 milioni di statunitensi (il 10% della popolazione dell’epoca) determinando un cambiamento anche politico e normativo.
Come Giorgio Nebbia ricordava sul manifesto tre anni fa, «le persone scoprirono l’ecologia, l’economia della natura», che diventò la «bandiera di una nuova contestazione del potere economico e militare, della violenza della società dei rifiuti, degli sprechi e delle armi - le merci oscene, con la richiesta di nuovi diritti, nuovi modi e processi di produzione, senza ignorare le domande delle classi e dei popoli poveri ed esclusi».
Come nasce l’Earth Day? Nel 1969, dopo una grave fuoriuscita di petrolio in California, il senatore Gaylord Nelson si propone di unire l’energia dei movimenti contro la guerra nel Vietnam con l’emergente consapevolezza ambientale. Recluta un attivista per organizzare eventi a partire dai campus.
La mobilitazione avviene il successivo 22 aprile. La Cbs parla di «giornata unica nella storia degli Stati uniti». Successo incredibile, strade, parchi, sale conferenze colmi di gente ed eventi. Manifestazione per la Giornata della Terra il 22 aprile del 1970
Gruppi impegnati contro fabbriche inquinanti, discariche tossiche, pesticidi velenosi, inquinamento idrico da petrolio, perdita della biodiversità marciano insieme.
Un po’ è anche il primo «sciopero per il clima»: le scuole non vengono chiuse ma molte annunciano che le assenze sono giustificate. In un intento eco-pax, a New York compaiono i poster di un personaggio dei fumetti che raccoglie i rifiuti lasciati da una manifestazione esclamando: «Il nemico siamo noi» (sottinteso: e non i vietcong).
LA PRIMAVERA ECOLOGISTA è sbocciata. Pochi mesi dopo negli Usa nasce l’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Epa) e in seguito si approvano leggi importanti (anche se poi poco rispettate) per l’aria, l’acqua, la biodiversità, il lavoro: il Clean Air Act, l’Occupational Safety and Health Act, l’Endangered Species Act, norme sull’uso dei pesticidi e il Clean Water Act.
Nel 1972 si svolge a Stoccolma la Conferenza delle Nazioni unite sull’ambiente umano. Solo nel 1990 l’Earth Day diventa mondiale. Vengono raggiunti in vario modo 200 milioni di persone in 141 paesi. Dopo due anni, Rio de Jaineiro ospita la Conferenza delle Nazioni unite su ambiente e sviluppo.
Con il nuovo millennio il focus della Giornata si sposta sui cambiamenti climatici, mentre inizia l’era digitale. Nel 2010 sono coinvolte 75.000 organizzazioni in 192 paesi. Secondo le stime, negli ultimi anni le iniziative della Giornata sono arrivate ad almeno un miliardo di persone. Nel frattempo cresce il movimento dei giovani per il clima.
2020: L’EARTH DAY DIVENTA digitale obtorto collo. Un virus riconducibile all’invasione e alla distruzione degli ecosistemi a opera degli umani ha rinchiuso in casa questi ultimi, mentre gli altri esseri della Terra hanno ripreso un po’ di spazio.
Cosa avverrà dopo questi mesi inediti? Per la Giornata, il segretario generale dell’Onu António Guterres ha proposto un programma in vari punti: investire fondi in posti di lavoro verdi, usare la leva fiscale per il passaggio dall’economia grigia a quella verde, porre fine ai sussidi ai combustibili fossili, introdurre il principio del chi inquina paga, incorporare i rischi climatici nel sistema finanziario e nelle politiche pubbliche.
Moltissimi gli eventi virtuali della Giornata, indicati sul sito www.earthday.org. Da Haiti dove il gruppo Fineste propone l’appuntamento di in-form-azione Sauvons la planète, agli Emirati dove un ospedale pediatrico infantile pianta tre alberi nel cortile, affigge poster nell’atrio e trasmette video sul tema; dall’India dove la tradizionale Veglia verde si trasferisce sui social media, a New York dove l’organizzazione dei parchi propone lezioni di pollice verde indoor; dalla Cina dove si muove la China Biodiversity Conservation, alla Svezia che organizza incontri digitali improntati su «quello che avete cercato di fare per l’ambiente e non ha funzionato».
IN ITALIA, FRA L’ALTRO, la maratona virtuale #onepeopleoneplanet sul canale Rai Play dalle 8 alle 20, il flashmob virtuale di Legambiente #abbracciamola, il dibattito a Brescia in streaming (con studenti, docenti, esperti, cittadini) su Covid e sostenibilità prima, durante e dopo l’emergenza.
E mentre i Fridays for Future preparano lo sciopero digitale, il Forum nazionale salviamo il paesaggio, al quale aderiscono centinaia di organizzazioni e migliaia di cittadini, propone una «preghiera civile: Mai più come prima».
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- RITORNO AL FUTURO. Cara Italia, ascolta questo silenzio. Lettera aperta (di "Fridays for Future - Italia").17 aprile 2020, di Federico La Sala
Lettera aperta
Ascoltiamo questo silenzio
- La nostra normalità è stata stravolta e ci siamo svegliati in un incubo, ma adesso, cara Italia, sei di fronte a un bivio della tua storia. Immagina, le tue città saranno verdi e libere dal traffico. Non perché saremo ancora costretti in casa, ma perché ci muoveremo grazie a un trasporto pubblico efficiente e accessibile a tutte e tutti. Con un grande piano nazionale rinnoveremo edifici pubblici e privati, abbattendo emissioni e bollette. Restituiremo dignità alle tue infinite bellezze, ai tuoi parchi e alle tue montagne. Potremo fare affidamento sull’aria, sull’acqua, e sui beni essenziali che i tuoi ecosistemi naturali, sani e integri, ci regalano. Produrremo il cibo per cui siamo famosi in tutto il mondo in maniera sostenibile. Fridays for Future italia Italia scritto una splendida lettera aperta
di Fridays for future Italia (Comune-info, 16 Aprile 2020)
Cara Italia,
ascolta questo silenzio.
La nostra normalità è stata stravolta e ci siamo svegliati in un incubo. Ci ritroviamo chiusi nelle nostre case, isolati e angosciati, ad aspettare la fine di questa pandemia. Non sappiamo quando potremo tornare alla nostra vita, dai nostri cari, in aula o al lavoro. Peggio, non sappiamo se ci sarà ancora un lavoro ad attenderci, se le aziende sapranno rialzarsi, schiacciate dalla peggiore crisi economica dal dopoguerra.
Forse avremmo potuto evitare questo disastro?
Molti studi sostengono che questa crisi sia connessa all’emergenza ecologica. La continua distruzione degli spazi naturali costringe infatti molti animali selvatici, portatori di malattie pericolose per l’uomo, a trovarsi a convivere a stretto contatto con noi. Sappiamo con certezza che questa sarà solo la prima di tante altre crisi - sanitarie, economiche o umanitarie - dovute al cambiamento climatico e ai suoi frutti avvelenati. Estati sempre più torride e inverni sempre più caldi, inondazioni e siccità distruggono già da anni i nostri raccolti, causano danni incalcolabili e vittime sempre più numerose. L’inesorabile aumento delle temperature ci porterà malattie infettive tipiche dei climi più caldi o ancora del tutto sconosciute, rischiando di farci ripiombare in una nuova epidemia
Siamo destinati a questo? E se invece avessimo una via d’uscita? Un’idea in grado di risolvere sia la crisi climatica sia la crisi economica?
Cara Italia, per questo ti scriviamo: la soluzione esiste già.
L’uscita dalla crisi sanitaria dovrà essere il momento per ripartire, e la transizione ecologica sarà il cuore e il cervello di questa rinascita: il punto di partenza per una rivoluzione del nostro intero sistema. La sfida è ambiziosa, lo sappiamo, ma la posta in gioco è troppo alta per tirarsi indietro. Dobbiamo dare il via a un colossale, storico, piano di investimenti pubblici sostenibili che porterà benessere e lavoro per tutte e tutti e che ci restituirà finalmente un Futuro a cui ritornare, dopo il viaggio nell’oscurità di questa pandemia
Un futuro nel quale produrremo tutta la nostra energia da fonti rinnovabili e non avremo più bisogno di comprare petrolio, carbone e metano dall’estero. Nel quale smettendo di bruciare combustibili fossili, riconvertendo le aziende inquinanti e bonificando i nostri territori devastati potremo salvare le oltre 80.000 persone uccise ogni anno dall’inquinamento atmosferico.
Immagina, cara Italia, le tue città saranno verdi e libere dal traffico. Non perché saremo ancora costretti in casa, ma perché ci muoveremo grazie a un trasporto pubblico efficiente e accessibile a tutte e tutti. Con un grande piano nazionale rinnoveremo edifici pubblici e privati, abbattendo emissioni e bollette. Restituiremo dignità alle tue infinite bellezze, ai tuoi parchi e alle tue montagne. Potremo fare affidamento sull’aria, sull’acqua, e sui beni essenziali che i tuoi ecosistemi naturali, sani e integri, ci regalano. Produrremo il cibo per cui siamo famosi in tutto il mondo in maniera sostenibile.
In questo modo creeremo centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro ben retribuiti, in tutti i settori.
Questo Futuro è davvero possibile, cara Italia, ne siamo convinti. Per affrontare questa emergenza sanitaria stiamo finalmente ascoltando la scienza. Ed è proprio la scienza ad indicarci chiaramente la rotta da percorrere per sconfiggere la crisi climatica. Stavolta sappiamo quanto tempo ci rimane per agire: siamo già entrati nel decennio cruciale. Il momento del collasso dell’unico ecosistema in cui possiamo vivere, il superamento di 1,5°C di riscaldamento globale, già si staglia all’orizzonte. La folle curva di emissioni va capovolta già da quest’anno, e per sempre. Solo se ci riusciremo costruiremo un paese e un mondo più giusto, più equo per tutte e tutti, non a spese dei più deboli, ma di quei pochi che sulla crisi climatica hanno costruito i loro profitti.
Cara Italia, sei di fronte ad un bivio della tua storia, e non dovranno esserci miopi vincoli di bilancio o inique politiche di austerity che ti impediscano di realizzare questa svolta.
Cara Italia, tu puoi essere d’esempio. Puoi guidare l’Europa e il mondo sulla strada della riconversione ecologica.
Non a tutte le generazioni viene data la possibilità di cambiare davvero la storia e creare un mondo migliore - l’unico in cui la vita sia possibile.
Questa è la nostra ultima occasione. Non possiamo permetterci di tornare al passato. Dobbiamo guardare avanti e preparare il nostro Ritorno al Futuro!
Gli attivisti e le attiviste di Fridays for Future Italia - www.ritornoalfuturo.org
Friys for Future Italia PS: questo è solo l’inizio. Oggi comincia una grande campagna per la rinascita del nostro paese, che ci porterà fino al lancio di una serie di proposte concrete, in occasione del global #DigitalStrike, il 24 aprile. E non saremo soli.
con il supporto di:
Armaioli Nicola - Chimico, Dirigente di Ricerca presso CNR
Balzani Vincenzo - Chimico, Professore emerito presso l’Università di Bologna
Banfi Luca - Direttore dipartimento di Chimica Università di Genova
Barbante Carlo - Paleoclimatologo, Università Venezia
Barbera Filippo - Docente di sociologia economica, Università di Torino
Bardi Ugo - Docente di Chimica e Fisica, Università di Firenze
Bartoletti Antonella - medico, socio dell’ISDE e dei GUFI
Bartolini Stefano - Docente di Economia Politica, Università di Siena
Belligni Silvano - sociologo, Università degli Studi di Torino
Bellini Alberto - Coordinatore Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, delegato KIC
Bergamini Giacomo - Professore presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna
Bigano Andrea - Economista, scienziato del CMCC
Blanchard Guido - Dottore Forestale
Bosetti Valentina - Docente di economia dell’ambiente
Budroni Marilena - Docente di Microbiologia Agraria, Uni Sassari
Bonapace Elena - economista, Italian Action Network
Buizza Roberto - Docente di Fisica, Sant’Anna di Pisa
Cagnoli Paolo - Resp. Osservatorio Energia Emilia Romagna, Docente di Energetica
Campanella Luigi - Docente di Chimica, già presidente Società Chimici Italiana
Caserini Stefano - Docente di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici, PoliMilano
Cacciamani Carlo - fisico, dipartimento Protezione Civile Nazionale
Cassardo Claudio - Docente di fisica del clima, Università di Torino
Castellari Sergio - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Ceroni Paola - Chimica, Università di Bologna
Comanducci Paolo - Rettore dell’Università di Genova
Gagliasso Elena - Docente di Logica e Filosofia della scienza, La Sapienza
Filpa Andrea - architetto, Università Roma Tre, Comitato scientifico WWF Italia
Fuzzi Sandro - Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, CNR
Gentilini Patrizia - medico oncologo-ematologo, comitato scientifico ISDE - Medici per l’Ambiente
Giacomin Serena - climatologa, presidente di Italian Climate Network
Grosso Mario - Docente PoliMi, fondatore Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio
Gullino Maria Lodovica - Docente di Patologia vegetale e direttore del Centro Agroinnova
Guzzetti Luca - Docente di Scienze della Comunicazione, UniGe
Iannelli Marirosa - presidente Water Grabbing Observatory
Lantschner Norbert - fondatore di CasaClima, presidente di ClimAbita Foundation
Lombroso Luca - Meteorologo AMPRO e divulgatore ambientale
Marletto Vittorio - fisico, responsabile Osservatorio clima Arpae Emilia-Romagna
Palazzi Elisa - Docente di Fisica del clima e ricercatrice presso ISAC CNR
Papini Alessio - Docente di Biologia, Università di Firenze
Pasini Antonello - Ricercatore presso IIA CNR
Piombino Aldo - Docente di geologia
Poggiali Elisa - ingegnere Ambiente e Territorio, membro di 100Esperte.it
Poggio Alberto - Ricercatore in Sistemi per l’Energia, Politecnico di Torino
Riccobon Angela - biologa, ISDE Forli-Cesena
Ridolfi Ruggero - Oncologo Endocrinologo, Coordinatore ISDE (Medici per l’Ambiente) sezione Forlì-Cesena
Rovelli Carlo - fisico e saggista,
Ruggieri Gianluca - Docente di Tecnologie per la Sostenibilità, UniInsubria
Tartaglia Angelo - Docente di Ingegneria e Fisica, Università di Torino
Trecroci Carmine - Docente di Macroeconomia e Finanza, Università di Brescia
Vacchiano Giorgio - Ricercatore in gestione e pianificazione forestale, Università di Milano
Ventura Francesca - Docente di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Presidente AIAM - Italian Association of AgroMeteorology
Venturi Margherita - Docente di Chimica, Università di Bologna
-
> IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- La società del virus tra Stato di polizia e isteria della sopravvivenza (di Byung-Chul Han).7 aprile 2020, di Federico La Sala
Scenari.
La società del virus tra Stato di polizia e isteria della sopravvivenza
In Asia e soprattutto in Cina la lotta al Covid-19 passa per il controllo totale dei singoli attraverso il digitale. Una biopolitica digitale che va di pari passo con una psicopolitica digitale
di Byung-Chul Han (Avvenire, martedì 7 aprile 2020)
.***Nato a Seul e docente di Filosofia e Studi Culturali alla Universität der Künste di Berlino, Byung-Chul Han è considerato uno dei più importanti filosofi contemporanei. Di recente Nottetempo ha pubblicato la nuova edizione di uno dei suioi saggi più noti, Eros in agonia (pagine 96, euro 13,00).
Covid-19 è un test di sistema. Pare che l’Asia stia gestendo l’epidemia molto meglio dell’Europa. A Hong Kong, Taiwan e Singapore ci sono pochissimi contagiati. Taiwan ne dichiara 215, Hong Kong 386, il Giappone 1.193. In Italia invece si sono già infettate oltre centomila persone in un arco di tempo molto inferiore. Anche la Corea del Sud si è lasciata il peggio alle spalle. Idem per il Giappone. Persino il paese da cui si è originata l’epidemia, la Cina, sta tenendo la situazione sotto controllo. Né Taiwan né la Corea hanno vietato di uscire di casa o chiuso negozi e ristoranti.
Nel frattempo è iniziato l’esodo degli asiatici dall’Europa e dagli Stati Uniti. I cinesi e i coreani vogliono tornare in patria perché là si sentono più sicuri. I prezzi dei voli sono schizzati alle stelle. È ormai impossibile trovare un biglietto aereo per la Cina o la Corea del Sud. L’Europa incespica. I numeri dell’infezione aumentano esponenzialmente. Sembra che l’Europa non riesca a controllare l’epidemia. In Italia muoiono ogni giorno centinaia di persone. I pazienti più anziani vengono staccati dai respiratori per aiutare i più giovani. Si osserva inoltre un vuoto azionismo. La chiusura delle frontiere è ormai un’espressione disperata di sovranità. È come essere tornati all’epoca della sovranità. Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione. Sovrano è chi chiude le frontiere.
Si tratta tuttavia di un vacuo spettacolo di sovranità che non risolve nulla. Un’intensa collaborazione all’interno della Ue sarebbe molto più utile della cieca chiusura dei confini. La Ue intanto ha proclamato un divieto d’ingresso per gli stranieri, gesto completamente insensato visto che nessuno, al momento, vuole venire in Europa. Sarebbe più logico, semmai, un divieto di espatrio degli europei per proteggere il mondo dall’Europa, che in questo preciso momento è il fulcro dell’epidemia.
L’Asia sotto stretta sorveglianza
Di quali vantaggi sistemici dispone l’Asia rispetto all’Europa, tali da fare la differenza nella lotta all’epidemia? Contro il virus, i paesi asiatici fanno massiccio ricorso alla sorveglianza digitale. Credono cioè di trovare nei Big Data un enorme potenziale contro l’epidemia. Si potrebbe dire che in Asia le epidemie non vengono combattute solo da virologi o epidemiologi, ma anche e soprattutto da informatici e specialisti di Big Data. Un cambio di paradigma che l’Europa non ha ancora preso in considerazione. I Big Data salvano vite umane, direbbero a gran voce gli apologeti della sorveglianza digitale.
In Asia la coscienza critica nei confronti della sorveglianza digitale è pressoché inesistente. Della protezione dei dati non si parla quasi più, persino in paesi liberali come il Giappone o la Corea del Sud. Nessuno si oppone alla furiosa raccolta dati da parte delle autorità. La Cina nel frattempo ha introdotto un sistema di punteggio sociale impensabile per l’europeo medio, che consente una valutazione a tutto tondo dei cittadini. Ciascun individuo deve essere coerentemente valutato in base al proprio comportamento sociale. In Cina, nessun momento della quotidianità passa inosservato. Si controlla ogni clic, ogni acquisto, ogni contatto, ogni attività sui social. Chi passa col rosso, chi frequenta persone critiche nei confronti del regime o posta commenti critici sui social perde punti. E allora la vita può diventare davvero dura. Chi invece compra cibi sani via internet o legge giornali vicini al partito conquista punti. Chi dispone di un congruo punteggio ottiene un visto di viaggio o mutui a condizioni vantaggiose. Chi invece precipita sotto un certo livello rischia di perdere il lavoro.
In Cina questa sorveglianza sociale è resa possibile da un incessante scambio di dati tra i provider internet e di servizi mobili e le autorità. In pratica non vi è alcuna protezione dei dati personali. Il concetto di privacy non rientra nel vocabolario dei cinesi. In Cina ci sono duecento milioni di videocamere di sorveglianza, a volte dotate di efficientissimi dispositivi di riconoscimento facciale che captano persino i nei. Impossibile sfuggirvi. Queste videocamere animate dall’intelligenza artificiale sono in grado di osservare e valutare ciascun cittadino nei luoghi pubblici, nei negozi, per le strade, nelle stazioni e negli aeroporti. L’intera infrastruttura della sorveglianza digitale si sta ora rivelando molto efficace nell’arginare l’epidemia. Chi arriva alla stazione ferroviaria di Pechino viene automaticamente ripreso da una videocamera che misura la temperatura corporea. E in caso di valori allarmanti vengono informati via cellulare tutti coloro che hanno condiviso il vagone con quella persona. Del resto il sistema sa benissimo chi ha viaggiato insieme a chi.
Sui social si parla addirittura di droni impiegati a fini di sorveglianza della quarantena. Chi esce di nascosto viene intimato da un drone volante di tornare in casa. E magari il robot stampa anche una multa che svolazza sulla testa del malcapitato, chissà. Una situazione distopica per gli europei, che tuttavia in Cina non incontra alcuna resistenza. Non solo in Cina ma anche in altri stati asiatici come la Corea del Sud, Hong Kong, Singapore, Taiwan e il Giappone non vi è alcuna coscienza critica nei confronti della sorveglianza digitale o dei Big Data.
La digitalizzazione è una sorta di ebbrezza collettiva. C’è anche un motivo culturale. In Asia domina il collettivismo. Manca uno spiccato individualismo. E l’individualismo si differenzia dall’egoismo, che ovviamente abbonda anche in Asia. I Big Data sono in tutta evidenza più efficaci nella lotta al virus rispetto alla chiusura delle frontiere, ma in Europa, per via della protezione dei dati personali, un’analoga lotta al virus non è praticabile. I provider cinesi di servizi internet e mobili condividono i dati sensibili dei clienti con le autorità sanitarie e di pubblica sicurezza. Lo stato sa quindi dove mi trovo, chi incontro, cosa faccio e dove mi dirigo. In futuro anche la temperatura corporea, il peso, i valori glicemici ecc. saranno probabilmente controllati dallo stato. Una biopolitica digitale che va di pari passo con una psicopolitica digitale, influenzando emozioni e pensieri.
A Wuhan sono state formate migliaia di squadre di investigazione digitale che si mettono alla ricerca di potenziali contagiati solo sulla base di dati tecnologici. Solo grazie ai Big Data scoprono chi sono i potenziali infetti, chi continuare a osservare e chi va messo in quarantena. Anche in termini epidemiologici, il futuro è nelle mani della digitalizzazione. Forse dovremmo persino ridefinire la sovranità alla luce dell’epidemia. Sovrano è chi dispone dei dati.
L’Europa fa ancora affidamento su vecchi modelli di sovranità quando dichiara lo stato di emergenza o chiude le frontiere. Non solo in Cina, ma anche in altri stati asiatici vi è un impiego massiccio della sorveglianza digitale per arginare l’epidemia. In Taiwan o in Corea del Sud lo stato invia in contemporanea a tutti i cittadini un sms per rintracciare contatti o informare circa i luoghi e gli edifici frequentati da persone infette. Taiwan ha tempestivamente incrociato dati di diversa natura per rintracciare i contagiati sulla base degli spostamenti. In Corea, chi si avvicina a un edificio in cui si è trattenuta una persona contagiata riceve un avvertimento tramite una “corona app” che registra tutti i luoghi visitati dagli infetti.
Si fa poco caso alla protezione dei dati o alla privacy. In Corea del Sud le videocamere di sorveglianza sono installate in ogni edificio, a ogni piano, in ciascun ufficio o negozio. È praticamente impossibile muoversi in pubblico senza essere captati da una videocamera. Questo, insieme ai dati del telefonino, consente la ricostruzione integrale degli spostamenti di una persona contagiata. Dettagli che sono anche resi pubblici - con buona pace delle relazioni clandestine.
La risurrezione del nemico
Il panico nei confronti dell’epidemia di Covid-19 è smisurato. Nemmeno la spagnola, dalla letalità molto superiore, ebbe conseguenze così devastanti sull’economia. Qual è il motivo? Come mai il mondo reagisce così a un virus? Tutti parlano di guerra, di un nemico invisibile da sconfiggere. Abbiamo forse a che fare col RITORNO DEL NEMICO? L’influenza spagnola scoppiò durante la Prima guerra mondiale. A suo tempo erano tutti circondati da nemici. Nessuno avrebbe paragonato l’epidemia a una guerra o a un nemico. Ma oggi viviamo in una società molto diversa. Abbiamo vissuto a lungo senza un nemico. La Guerra Fredda è finita da un pezzo. Anche il terrorismo islamico è grossomodo scomparso all’orizzonte. Esattamente dieci anni fa, col saggio La società della stanchezza, ho sostenuto questa tesi: viviamo in un’epoca in cui non vale più il paradigma immunologico che scaturisce dalla negatività del nemico.
La società organizzata in chiave immunologica è contraddistinta, come ai tempi della Guerra Fredda, da confini e steccati che impediscono però la circolazione accelerata delle merci e del capitale. La globalizzazione abbatte tutte queste soglie immunologiche allo scopo di spianare la strada al capitale. Anche la promiscuità, la permissività generalizzata che oggi investe tutti gli ambiti della vita contribuisce ad abbattere la negatività dell’estraneo o del nemico. Oggigiorno i pericoli non emanano dalla negatività del nemico, bensì dall’eccesso di positività che si esprime in forma di sovrapprestazione, sovrapproduzione e sovracomunicazione. La negatività del nemico non appartiene alla nostra società sconfinatamente permissiva. La repressione perpetrata dagli altri cede il passo alla depressione, lo sfruttamento esterno all’autosfruttamento volontario e all’auto-ottimizzazione. Nella società della prestazione la guerra la si fa prima di tutto a se stessi.
Ora, d’improvviso, il virus irrompe in una società assai indebolita dal capitalismo globale. In reazione allo spavento, ecco che le soglie immunologiche vengono di nuovo alzate e si chiudono le frontiere. Il nemico è di nuovo tra noi. La guerra non la facciamo più con noi stessi, bensì contro un nemico invisibile che viene da fuori. Il panico sconfinato dinanzi al virus è una reazione immunitaria sociale, globale a un nuovo nemico. Una reazione immunitaria di rara intensità poiché abbiamo vissuto molto a lungo in una società senza nemici, in una società della positività. Ora il virus viene percepito come terrore permanente.
Vi è anche un ulteriore motivo per questo panico smodato. E ha di nuovo a che vedere con la digitalizzazione. La digitalizzazione smonta la realtà. La realtà la si esperisce tramite la resistenza, che può anche far male. La digitalizzazione, tutta la cultura del mi piace elimina la negatività della resistenza. E nell’epoca post-fattuale delle fake news o dei deep fake nasce un’apatia nei confronti della realtà. Ora il virus reale, quindi non informatico, scatena uno shock. La realtà, la resistenza, torna a farsi sentire nella forma di un virus ostile. La reazione di panico violenta ed esagerata va ricondotta a questo shock di realtà.
La società della sopravvivenza
Il timor panico dinanzi al virus rispecchia soprattutto la nostra società della sopravvivenza in cui tutte le energie vengono impiegate per allungare la vita. La preoccupazione per il viver bene cede il passo all’isteria della sopravvivenza. La società della sopravvivenza è peraltro avversa al piacere. La salute rappresenta il valore più alto. L’isteria del divieto di fumare è in fin dei conti isteria della sopravvivenza. La reazione di panico di fronte al virus svela questo fondamento esistenziale della nostra società. Se la sopravvivenza è minacciata, ecco che sacrifichiamo volontariamente tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta.
La strenua lotta per la sopravvivenza subisce ora un inasprimento virale. Ci pieghiamo allo stato di eccezione senza opporre resistenza. La limitazione dei diritti fondamentali viene accettata senza colpo ferire. L’intera società si trasforma in una quarantena, variante liberale del lager in cui imperversa la nuda vita. Oggi il campo di lavoro si chiama home office. È solo l’ideologia della salute e della sopravvivenza a distinguerlo dai campi di lavoro del passato.
Nel corso dell’epidemia virale, la società della sopravvivenza mostra un volto inumano. L’Altro è prima di tutto un potenziale portatore di virus da cui bisogna prendere le distanze. Vicinanza e contatto significano contagio. Il virus aggrava la solitudine e la depressione. I coreani chiamano “corona blue” la depressione provocata dall’attuale società della quarantena. Alla lotta per la sopravvivenza va invece contrapposta la preoccupazione per il viver bene. Altrimenti la vita dopo l’epidemia sarà ancora più orientata alla sopravvivenza. E allora finiremo per essere come il virus, questo non morto che si limita a moltiplicarsi, a sopravvivere senza vivere.
La reazione di panico dei mercati finanziari all’epidemia è inoltre espressione di un terrore che cova già dentro di loro. Gli estremi fenomeni di rigetto tipici dell’economia globale la rendono molto vulnerabile. Malgrado il costante aumento degli indici borsistici negli ultimi anni, la rischiosa politica monetaria delle banche ha prodotto una forma di panico represso che attende uno sfogo. Il virus è forse solo la goccia che fa traboccare il vaso. Il panico dei mercati finanziari mette in rilievo, più che la paura del virus, la paura di se stessi. Il crash avrebbe potuto verificarsi anche senza virus. Forse il virus è solo l’avvisaglia di un crash ancora più grande.
Ci sarà una rivoluzione virale?
Žižek sostiene che il virus stia assestando un colpo mortale al capitalismo, ed evoca un oscuro comunismo. Crede persino che il virus condurrà alla caduta del regime cinese. Žižek si sbaglia. Tutto questo non accadrà. Ora la Cina venderà anche il proprio stato di polizia digitale come modello di successo nella lotta all’epidemia. La Cina dimostrerà con rinnovato orgoglio la superiorità del proprio sistema. Dopo l’epidemia, il capitalismo proseguirà con foga ancora maggiore. E i turisti continueranno a calpestare a morte il pianeta.
Il virus non rallenta il capitalismo, lo trattiene soltanto. Ci troviamo in uno stato di sospensione nervosa. Il virus non può sostituire la ragione. Inoltre, è possibile che in occidente finiremo per beccarci anche lo stato di polizia digitale su modello cinese. Come ha sostenuto Naomi Klein, lo shock è un momento propizio per il consolidamento di un nuovo sistema di potere. Dall’installazione del neoliberismo sono spesso scaturite crisi che hanno prodotto degli shock. S’è visto in Corea del Sud e in Grecia. Dopo questo shock virale è auspicabile che l’Europa non metta in piedi un regime di sorveglianza digitale alla cinese. In quel caso lo stato di eccezione, come teme Giorgio Agamben, diventerebbe la norma. Il virus riuscirebbe nella missione che il terrorismo islamico non è riuscito a portare a termine.
Il virus non sconfiggerà il capitalismo. La rivoluzione virale non avrà luogo. Nessun virus può fare una rivoluzione. Il virus ci isola. Non produce nemmeno un forte senso di comunità. Ora ognuno è preoccupato per la propria sopravvivenza. La solidarietà di prendere le distanze gli uni dagli altri non è solidarietà. Non possiamo lasciare la rivoluzione al virus. Speriamo invece che dopo il virus arrivi una rivoluzione umana. Tocca a NOI ESSERI UMANI dotati di BUONSENSO ripensare e limitare drasticamente il capitalismo distruttivo e anche la nostra devastante mobilità senza confini - per salvare noi stessi, il clima e il nostro bellissimo pianeta.
(© Byung-Chul Han - Traduzione di Simone Buttazzi)
-
> PER LA PACE PERPETUA. --- Doomsday clock, 100 secondi alla mezzanotte, alla fine del mondo. Ma non è colpa del coronavirus (di Filippo Mastroianni).7 aprile 2020, di Federico La Sala
Doomsday clock, cento secondi alla fine del mondo. Ma non è colpa del coronavirus
di Filippo Mastroianni (Il Sole-24 Ore, 7 aprile 2020)
L’umanità non è mai stata così vicina alla mezzanotte. Un’ora simbolica che ci mette in guardia sui nostri comportamenti. Ricordandoci quanto siamo vicini a distruggere il mondo che conosciamo con tecnologie pericolose di umana produzione o, semplicemente, con i nostri comportamenti.
Mancano solo 100 secondi alla mezzanotte.
I motivi sono diversi. E no, non è colpa del coronavirus. Bando ai catastrofismi. Prima di raccontare cos’è esattamente il Doomsday clock anticipiamo una fondamentale informazione. Non è scienza esatta. È una metafora, un promemoria dei pericoli che dobbiamo affrontare e prendere sul serio se vogliamo sopravvivere ancora molte ere sull’amato pianeta Terra. Innanzitutto, perché ognuno di noi si informi e prenda coscienza di problematiche che sembrano così lontane dalla nostra esperienza quotidiana o al di fuori dal nostro controllo. Conoscere ma anche condividere discussioni su temi importanti. In terzo luogo, essere tutti partecipi della vita del nostro paese e delle tematiche che i rappresentanti dei governi dovrebbero affrontare.
Il Doomsday Clock è tornato a muoversi a inizio 2020. Ancora il mondo era all’oscuro di quello che sarebbe arrivato. O forse chiudeva gli occhi illudendosi che tutto sarebbe stato contenuto in Cina. A oltre settant’anni dalla sua creazione, da parte degli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists dell’Università di Chicago, le lancette si sono portate altri 20 secondi più vicine alla mezzanotte. Un orario che nelle intenzioni della sua creatrice, l’artista americana Martyl Langsdorf, simboleggiava la fine del mondo. Motivi principali dell’ulteriore spostamento il continuo riarmo nucleare e la mancanza di azione da parte delle grandi potenze nel contrastare i cambiamenti climatici. Un tema che, prima del covid-19, era tornato prepotentemente alla ribalta riassunto nella figura della giovane Greta Thunberg. Quanto quello che sta avvenendo sia legato anche ai nostri comportamenti sarà tutto da dimostrare nei prossimi studi scientifici sulle cause e le origini del virus. Quello che molti studi riportano è che due terzi dei virus umani sono di origine zoonotica. Ecco perché molti ritengono che esista un legame tra la devastazione ambientale e l’emergere di nuove malattie infettive.
Dal 2021, dopo l’evento tragico ed epocale che sta colpendo il mondo nella sua interezza, ci si aspetta un ulteriore spostamento delle lancette verso il Doomsday.
Oggi l’orologio segna le 23, 58 minuti e 40 secondi. Si tratta dell’orario più vicino all’Apocalisse dal 1953, quando lo sviluppo della bomba a idrogeno da parte di Stati Uniti e Russia aveva convinto gli scienziati che il mondo stesse avvicinandosi alla sua fine. Il risultato rappresenta ancora oggi un record. Mai le lancette saranno in seguito così vicine alla mezzanotte.
Le Motivazioni
Tra le principali motivazioni espresse nello Science and Security Board Bulletin of the Atomic Scientists del 2020, compaiono, come anticipato, la questione del riarmo nucleare e i cambiamenti climatici. Aggravati da molteplici altre minacce, tra cui la guerra informatica e la questione della cyber-security che deve tornare al centro del dibattito.
Poi il nucleare. I leader nazionali hanno posto fine o minato diversi importanti trattati e negoziati sul controllo degli armamenti nel corso dell’ultimo anno, creando un ambiente favorevole a una rinnovata corsa agli armamenti nucleari, alla proliferazione delle armi nucleari e alla riduzione degli ostacoli alla guerra nucleare. I conflitti politici inerenti i programmi nucleari in Iran e in Corea del Nord rimangono irrisolti e, semmai, stanno peggiorando. La cooperazione USA-Russia sul controllo degli armamenti e sul disarmo è ormai quasi inesistente.
Il pericolo di un olocausto nucleare è da sempre il motivo principale su cui si basano gli spostamenti delle lancette del Doomsday Clock. Nel 2007, per la prima volta, sono state citate tra le motivazioni non solo i pericoli derivanti dal nucleare, ma anche dai mutamenti climatici in atto nel nostro pianeta.
La consapevolezza dell’opinione pubblica sulla crisi climatica è certamente cresciuta nel corso del 2019. In gran parte grazie alle proteste di massa da parte dei giovani di tutto il mondo. Allo stesso tempo va però registrata un’azione governativa sui cambiamenti climatici non ancora all’altezza della grande sfida da affrontare. Alle riunioni del clima delle Nazioni Unite dello scorso anno, i delegati nazionali hanno tenuto discorsi eccellenti, senza presentare piani concreti per limitare ulteriormente le emissioni di biossido di carbonio che stanno sconvolgendo il clima. Una limitata risposta politica arrivata nell’anno in cui gli effetti dei cambiamenti climatici causati dall’uomo si sono manifestati nella forma di uno degli anni più caldi della storia, con estesi incendi e lo scioglimento più rapido del previsto dei ghiacci.
I dati e la grafica
La grafica riassume schematicamente i cambiamenti registrati dal 1947 ad oggi sul Doomsday Clock. Il quadro generale è fornito dalla radar chart, che mostra i singoli spostamenti, anno per anno. Gli anni in cui è stato più vicino alla mezzanotte, prima del 2020, sono quelli compresi tra il 1953 e il 1960. L’orologio segnava le 23 e 58 minuti, a soli 2 minuti dalla fine del mondo. Sono 17 gli spostamenti negativi, per un totale di 35 minuti e 20 secondi. Solo 8 quelli positivi, per un totale di 30 minuti. Il cambiamento più significativo è quello datato 1991. Un +7 che rappresenta anche il momento in cui le lancette hanno raggiunto la massima distanza dalla mezzanotte. Dopo la firma del trattato per la riduzione delle armi strategiche e la caduta dell’URSS, il Doomsday Clock si è infatti fermato alle 23 e 43 minuti.
L’ultimo spostamento tocca le 23, 58 minuti e 20 secondi per la prima volta dalla nascita dell’orologio. Il 2017 aveva segnato una grossa novità introdotta dagli scienziati del Bullettin. Mai le lancette si erano spostate prima di soli 30 secondi , ma sempre di interi minuti. Oggi altri 20 secondi ci avvicinano alla mezzanotte.
Cosa aspettarsi dal 2021? Certamente ulteriori secondi verso la mezzanotte, che tengano conto della grave pandemia che sta colpendo il mondo intero. Le speranze? Doverne aggiungere solo una manciata. Poter leggere nella relazione 2021 degli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists non solo un aggiornamento che racconti il dramma del coronavirus. Anche la sua soluzione. Una cura, un vaccino.
-
> PER LA PACE PERPETUA. --- UN CAMBIO RADICALE DI PARADIGMA. Guardarci dalle metafore che informano il nostro sentire! Un immaginario diverso (di Franco Lorenzoni)..7 aprile 2020, di Federico La Sala
Un immaginario diverso
di Franco Lorenzoni *
Trovo profondamente errato e fuorviante il continuo riferimento alla guerra che si fa in queste settimane. Contrastare una pandemia e combattere una guerra sono due azioni che non hanno nulla a che vedere. La guerra, qualsiasi guerra, si fonda sull’assassinio e la soppressione del nemico, il contrasto a un virus letale può contare solo sulla cura, la ricerca scientifica, comportamenti coerenti che fermino il contagio. Inoltre, come ha giustamente notato un ragazzo, “ai nostri nonni e bisnonni, un secolo fa, veniva imposto di partire per il fronte e finire carne da macello in trincea, a noi si chiede solo di stare chiusi in casa su un divano: c’è una bella differenza”.
Di comune c’è solo la presenza di donne e uomini che rischiano la vita, anche se in guerra affrontano il pericolo per uccidere nemici e bombardare innocenti, mentre in ospedale o visitando pazienti, infermieri e medici rischiano prendendosi cura e cercando di salvare più vite possibili.
Questa metafora, sbagliata e abusata, non la dobbiamo tuttavia dimenticare. Quando si dovrà decidere come e cosa ricostruire per uscire da una crisi economica che si annuncia devastante, dovremo ricordare con lucidità che per difenderci da possibili e probabili nuove pandemie, per affrontare le gravissime conseguenze del surriscaldamento globale che provoca già oggi milioni di profughi e vittime per siccità, inondazioni e fame, sarà necessario mettere al centro di ogni rinascita futura la necessità e il valore della cura reciproca, della ricerca scientifica, dell’arte e della cultura intese nel senso più ampio. Dovremo ricordare che le spese militari e i soldi per acquistare armi sono del tutto inutili per affrontare le enormi sfide che abbiamo di fronte, perché delle forze armate abbiamo constatato che le uniche armi utili sono gli ospedali da campo montati dagli alpini e da altri reparti militari.
Ancora una volta è parso evidente che dell’esercito può essere utile solo ciò che non è esercito: infermieri e medici militari che, invece di addestrarsi a usare armi per ferire, si sono formati per curare ferite.
 È tempo di ripensare con radicalità a ciò che davvero ci può difendere, riprendendo le intuizioni di Alexander Langer riguardo alla formazione in Europa di corpi civili di pace. Un solo sommergibile costa più di 5.000 posti letto di terapia intensiva, ha giustamente ricordato Gino Strada, che di guerre e ospedali ne sa qualcosa.
È tempo di ripensare con radicalità a ciò che davvero ci può difendere, riprendendo le intuizioni di Alexander Langer riguardo alla formazione in Europa di corpi civili di pace. Un solo sommergibile costa più di 5.000 posti letto di terapia intensiva, ha giustamente ricordato Gino Strada, che di guerre e ospedali ne sa qualcosa.Abbiamo sicuramente bisogno di più posti letto e ospedali migliori in ogni regione del nostro paese, dunque non potremo più tollerare tagli alla sanità pubblica. Abbiamo bisogno di più scienza e ricerca, quindi migliori università e ricercatori pagati degnamente, abolendo ogni numero chiuso per l’accesso alle facoltà. Abbiamo bisogno di una scuola più ricca, aperta e di qualità, con insegnanti in continua ricerca e formazione per riuscire finalmente a dare a tutte le ragazze e ragazzi la possibilità di terminare con successo i loro studi. Dovremo cercare di aumentare considerevolmente il numero dei laureati, che ha percentuali ridicole nel nostro paese, e affrontare di petto la ferita sociale della dispersione scolastica perché la povertà educativa, che è drammatica fonte di discriminazione sociale, va contrastata con politiche coerenti e l’impegno di ciascuno in ogni campo - dall’educazione alla formazione, all’arte e alla cultura diffusa nel territorio - perché la scuola da sola non ce la può fare (leggi anche il Manifesto dell’educazione diffusa, ndr)..
Lo sconcerto planetario di fronte a una tragedia della pandemia, che sta coinvolgendo miliardi di esseri umani, offre una straordinaria lezione a tutti noi e ci ricorda che l’alternativa è, davvero, tra istruzione e distruzione, tra scienza, conoscenza lungimirante, capacità di cura reciproca e passiva rassegnazione a modi di produrre, accumulare ricchezze, costruire e abitare che portano alla distruzione del territorio e dei fragili equilibri del pianeta che abitiamo. Naomi Klein sostiene che
- “solo una crisi reale o percepita produce un vero cambiamento”. A una condizione, tuttavia: “Quando una crisi si verifica, le azioni che vengono intraprese dipendono dalle idee che circolano”.
E allora è alle idee che circolano che dobbiamo prestare tanta attenzione quanta ne stiamo prestando al virus letale che attenta alle nostre vite. Ciascuno di noi - in particolare chi insegna - dovrebbe fare ogni sforzo per mantenere viva l’attenzione al linguaggio. Possedere un linguaggio per narrare questo tempo straordinario, tanti linguaggi per ragionare e provare a capire ciò che sta accadendo, è il più grande dono che la scuola deve tentare di offrire (anche a distanza) a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi che stanno vivendo momenti che ricorderanno tutta la vita. Questo tempo straordinario non sarà dimenticato, ma non lo si può comprendere davvero senza matematica e statistica, senza intendere qualcosa di biologia e di chimica.
Stiamo assistendo a eventi inimmaginabili e spaventosi e, come tutto ciò che è spaventoso, porta in sé elementi sconcertanti ed eccitanti. Chi ha mai visto le strade di New York deserte? Chi ha mai visto la propria città vuota e silenziosa? E allora cercare e affinare linguaggi che ci permettano di vivere con intensità e pensare con coscienza e profondità questo tempo che stiamo vivendo è più che mai necessario per nutrire la nostra memoria. E la memoria è tutto. Noi siamo la nostra memoria.
Guardarci dalle metafore che informano il nostro sentire ci aiuta non solo a fare esperienza con maggiore consapevolezza, ma anche a provare a immaginare una società capace di contrastare le malattie e catastrofi che ci attendono.
Nessuno avrebbe immaginato, solo due anni fa, che la cocciuta coerenza di una ragazza quindicenne avrebbe potuto scatenare una protesta giovanile mondiale per il clima, che non ha ancora prodotto risultati ma ha scosso le coscienze, ricordandoci quanto sia necessario rivedere la categoria dell’impossibile.
 Solo allargando il nostro immaginario e cimentandoci in un cambio radicale di paradigma possiamo ritrovare le radici della speranza.
Solo allargando il nostro immaginario e cimentandoci in un cambio radicale di paradigma possiamo ritrovare le radici della speranza.* Comune-info, 05 Aprile 2020 (ripresa parziale).
-
> PER LA PACE PERPETUA. --- LA SOVRANITA’ DEL “VIRUS”, LA RISATA DI KANT, E RIFLESSIONI SULLA PESTE.31 marzo 2020, di Federico La Sala
LA SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL “VIRUS”, LA “PACE PERPETUA”, E LA RISATA DI KANT. Nota ... *
- Riflessioni sulla peste
- di Giorgio Agamben Quodlibet,27 marzo 2020
- Le riflessioni che seguono non riguardano l’epidemia, ma ciò che possiamo capire dalle reazioni degli uomini ad essa. Si tratta, cioè, di riflettere sulla facilità con cui un’intera società ha accettato di sentirsi appestata, di isolarsi in casa e di sospendere le sue normali condizioni di vita, i suoi rapporti di lavoro, di amicizia, di amore e perfino le sue convinzioni religiose e politiche. Perché non ci sono state, come pure era possibile immaginare e come di solito avviene in questi casi, proteste e opposizioni? L’ipotesi che vorrei suggerire è che in qualche modo, sia pure inconsapevolmente, la peste c’era già, che, evidentemente, le condizioni di vita della gente erano diventate tali, che è bastato un segno improvviso perché esse apparissero per quello che erano - cioè intollerabili, come una peste appunto. E questo, in un certo senso, è il solo dato positivo che si possa trarre dalla situazione presente: è possibile che, più tardi, la gente cominci a chiedersi se il modo in cui viveva era giusto.
- E ciò su cui occorre non meno riflettere è il bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo. È come se il bisogno religioso, che la Chiesa non è più in grado di soddisfare, cercasse a tastoni un altro luogo in cui consistere e lo trovasse in quella che è ormai di fatto diventata la religione del nostro tempo: la scienza. Questa, come ogni religione, può produrre superstizione e paura o, comunque, essere usata per diffonderle. Mai come oggi si è assistito allo spettacolo, tipico delle religioni nei momenti di crisi, di pareri e prescrizioni diversi e contraddittori, che vanno dalla posizione eretica minoritaria (pure rappresentata da scienziati prestigiosi) di chi nega la gravità del fenomeno al discorso ortodosso dominante che l’afferma e, tuttavia, diverge spesso radicalmente quanto alle modalità di affrontarlo. E, come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l’altra e impone le sue misure.
- Un’altra cosa che dà da pensare è l’evidente crollo di ogni convinzione e fede comune. Si direbbe che gli uomini non credono più a nulla - tranne che alla nuda esistenza biologica che occorre a qualunque costo salvare. Ma sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata.
- Per questo - una volta che l’emergenza, la peste, sarà dichiarata finita, se lo sarà - non credo che, almeno per chi ha conservato un minimo di lucidità, sarà possibile tornare a vivere come prima. E questa è forse oggi la cosa più disperante - anche se, com’è stato detto, «solo per chi non ha più speranza è stata data la speranza».
* Nota:
LA SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL “VIRUS”, LA “PACE PERPETUA”, E LA RISATA DI KANT...
CONSIDERATO, PURTROPPO, CHE ” Le riflessioni” di Agamben non riguardano l’epidemia del CORONAVIRUS, “ma ciò che possiamo capire dalle reazioni degli uomini ad essa”, ACCOLTA “L’ipotesi [...] che in qualche modo, sia pure inconsapevolmente, la peste c’era già [...]”
 E CONDIVISA L’IDEA CHE BISOGNA RIFLETTERE SUL “[...] bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo [...]”
E CONDIVISA L’IDEA CHE BISOGNA RIFLETTERE SUL “[...] bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo [...]”
 E, ANCORA, CHE “come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l’altra e impone le sue misure. [....] sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata” (cf. G. Agamben, “Riflessioni...” : https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessioni-sulla-peste),
E, ANCORA, CHE “come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l’altra e impone le sue misure. [....] sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata” (cf. G. Agamben, “Riflessioni...” : https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessioni-sulla-peste),
 PER NON PERDERE IL “FILO” DI “SOFIA” E, CON ESSA, ANCHE LA VITA E LA “SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL SUO “SAPERE AUDE!”, IO RIPRENDEREI IL DISCORSO dalla citazione evangelica, utilizzata anche dallo stesso Agamben in “Pilato e Gesù” (nottetempo 2013), relativa al problema dell’ ECCE HOMO (cfr. RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO ... http://www.leparoleelecose.it/?p=37854#comment-426632) e dalla LEZIONE DI KANT sull’UOMO SUPREMO DI EMANUEL SWEDENBORG (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5028) E SULLA “fine di tutte le cose” (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5026). O no?! Boh e bah?!
PER NON PERDERE IL “FILO” DI “SOFIA” E, CON ESSA, ANCHE LA VITA E LA “SOVRANITA’ (LA “CORONA”) DEL SUO “SAPERE AUDE!”, IO RIPRENDEREI IL DISCORSO dalla citazione evangelica, utilizzata anche dallo stesso Agamben in “Pilato e Gesù” (nottetempo 2013), relativa al problema dell’ ECCE HOMO (cfr. RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO ... http://www.leparoleelecose.it/?p=37854#comment-426632) e dalla LEZIONE DI KANT sull’UOMO SUPREMO DI EMANUEL SWEDENBORG (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5028) E SULLA “fine di tutte le cose” (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5026). O no?! Boh e bah?!Federico La Sala
-
> PER LA PACE PERPETUA. --- COLLASSO. LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova".28 marzo 2020, di Federico La Sala
PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria" ?
CORSI E RICORSI STORICI: CIVILTA’ AL COLLASSO.
Uno studio della Nasa : l’Occidente è destinato a crollare come Roma antica e gli altri grandi imperi del passato.
PER UN’ALTRA EUROPA E PER UN’ALTRA ITALIA. Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni ... L’ITALIA AL BIVIO : VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova"
Federico La Sala
-
> PER LA PACE PERPETUA. --- UNA CARTA PER LO SVILUPPO UMANO RESPONSABILE. Il riscaldamento globale al tempo del coronavirus.25 marzo 2020, di Federico La Sala
Il riscaldamento globale al tempo del coronavirus
di GIUSEPPE DI CAPUA e SILVIA PEPPOLONI*
Il coronavirus (Covid19) ha eclissato la comunicazione e il dibattito nei media sul riscaldamento globale, i cambiamenti climatici, l’economia verde, le minacce antropiche agli ecosistemi, l’inquinamento da plastiche negli oceani, ed altro ancora.
Il dato aggiornato al 16 gennaio 2020 del livello di CO2 atmosferica, misurato al Mauna Loa Observatory nelle Hawaii, segna un nuovo incremento, raggiungendo il valore di 413 parti per milione.
Il mondo è giustamente spaventato dal coronavirus e dalle conseguenze sanitarie di una pandemia rapida e ancora parzialmente ignota. L’economia globale è entrata in una fase di crisi che potrebbe addirittura avere conseguenze superiori alla grande crisi del 2007-2009. Le catene di approvvigionamento mondiali in grado di spostare rapidamente enormi flussi di energia e materia da una parte all’altra del pianeta si sono bruscamente interrotte o hanno ridotto la loro capacità operativa. Crolla il prezzo del petrolio per ragioni legate anche a strategie economiche e geopolitiche guidate dal alcune nazioni produttrici: questo renderà il greggio una fonte energetica ancora più appetibile per far ripartire l’economia nel breve futuro, ricordandoci ancora una volta che la storia energetica dell’umanità non è fatta di transizioni, ma di addizioni energetiche (Bonneuil e Fressoz, 2019) e che nei prossimi anni occorrerà aspettarsi una modifica del mix energetico utilizzato dalle società umane (con un incremento delle fonti rinnovabili di energia), piuttosto che un completo abbandono delle fonti fossili.
L’unica notizia di rilievo, ripresa ampiamente dai social media e dai media tradizionali in tema ambientale, è la riduzione dell’inquinamento in Cina da biossido di azoto (NO2), un gas prodotto dalla combustione ad alta temperatura che provoca forte irritazione polmonare. La riduzione sembrerebbe essere dovuta in larga parte al blocco delle attività industriali e alla drastica riduzione del trasporto veicolare per effetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid19. Anche nella Pianura Padana, area tra le più inquinate d’Europa, la riduzione dell’inquinamento da NO2 per il rallentamento dell’economia mostra una chiara evoluzione.
Il riscaldamento globale e tutti gli effetti associati sono quasi scomparsi dai media. Eppure non c’è da essere meno preoccupati della pandemia in corso, come fa notare il meteorologo Luca Mercalli in una recente intervista. Mario Tozzi su La Stampa collega l’epidemia in atto ai danni ambientali antropogenici. Allo stesso modo fa Simona Re sulla rivista Micron per la quale “clima e salute viaggiano in tandem” rifacendosi a quanto afferma il direttore dell’Istituto di Genetica molecolare del CNR-IGM di Pavia per spiegare la maggiore frequenza delle epidemie negli ultimi decenni. Del resto sempre Simona Re fa notare che “la sovrappopolazione e la crescente frequenza e rapidità dei nostri spostamenti sono fattori di rischio per lo scatenarsi di un’epidemia”.
Una cosa è certa: nella comune percezione il riscaldamento globale in questo momento non è un problema. D’altro canto, su La Stampa Jacopo Pasotti riflette sulle differenze nella risposta umana alla crisi ambientale e a quella sanitaria per pandemia, affermando che “dopo decenni di indifferenza”, l’emergenza climatica “sta forse cominciando a generare una comunque tiepida preoccupazione”.
In ogni caso, l’odierno atteggiamento generale delle persone verso l’emergenza climatica è del tutto comprensibile, viste anche le differenti scale temporali su cui gli effetti del coronavirus (da pochi giorni a qualche mese) e del riscaldamento globale (da qualche anno ad alcuni decenni) si sviluppano.
Ma come scrive Francesca Mancuso su greenMe, richiamandosi alle affermazioni di Antonio Guterres, Segretario Generale dell’ONU, e di Petteri Taalas (segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale) per i quali i cambiamenti climatici sono mortali, più del coronavirus, “Sembra incredibile agli occhi di un italiano, costretto a casa per paura del contagio, eppure il riscaldamento globale ci riguarda da vicino e può mettere a repentaglio la nostra vita e quella delle generazioni future”.
Di certo l’emergenza del Covid19 insegna, o meglio conferma, alcune riflessioni già emerse da alcuni anni nell’ambito della geoetica (etica per la gestione dell’interazione tra gli esseri umani ed il sistema Terra) (Peppoloni e Di Capua, 2020), utili proprio per affrontare la crisi ambientale in corso:
1) I comportamenti individuali fanno la differenza nell’affrontare anche le crisi globali. Alla base della catena di azioni che una società deve mettere in atto per risolvere i suoi problemi, c’è sempre il singolo individuo, chiamato a confrontarsi con il senso di responsabilità verso se stesso, gli esseri umani più prossimi, la società come comunità ampia delle relazioni umane.
2) Le responsabilità personali, inter-personali e verso la società sono fondamentali per vivere in salute e sicurezza in una società globalizzata, fortemente interconnessa.
3) La responsabilità di ciascuno verso il sistema Terra, implica il rispetto dei sistemi socio-ecologici (Berkes e Folke, 1998; Ostrom, 2009). La disattenzione e l’azione umana violenta nei confronti degli ecosistemi hanno l’effetto di accrescere l’esposizione e quindi il rischio di tutte le comunità umane a fenomeni imprevedibili che possono mettere a repentaglio l’attuale strutturazione della società globalizzata, portandola ad un collasso sistemico.
Da queste riflessioni, derivano alcune considerazioni etiche e sociali generali:
a) L’individuo non può sottrarsi dal confrontarsi con il proprio senso di responsabilità articolabile nei quattro domini etici dell’esperienza umana: il sé, la relazione prossimale con gli altri nelle comunità sociali di riferimento, la società per esteso, il sistema Terra da intendersi come aggregato complesso di sistemi socio-ecologici. Il comportamento irresponsabile anche di un solo individuo può generare nel tempo una crisi sistemica planetaria.
b) Le catene di approvvigionamento globale devono essere riprogettate per aumentare la resilienza in caso di shock. Una loro ridefinizione non può prescindere dall’intervento di “progettisti”/operatori capaci di pensare in modo sistemico e provvisti di una cultura del rischio non solo di tipo economico. La vulnerabilità dei sistemi integrati non è questione affrontabile semplicemente in termini ingegneristici, poiché si alimenta di fattori imprevedibili che sono noti, studiati e valutati da numerose discipline, tra cui la medicina e le geoscienze (o scienze della Terra). Una pandemia o un disastro innescato da un fenomeno naturale non sono imponderabili fenomeni della natura, ma eventi di cui è possibile quantificare incertezza e probabilità di accadimento e di impatto. L’approccio multidisciplinare alle questioni globali è una prassi da attuare con urgenza.
c) La creazione di una governance internazionale, chiara e strutturata preventivamente in campo sanitario e ambientale, non è più procrastinabile, ma impone scelte politiche all’interno degli stati nazionali e tra essi per favorire l’integrazione delle decisioni che impattano un sistema umano ormai globalizzato, a dispetto di azioni che si riferiscano solo a localismi e particolarismi. La diversità va tutelata, ma non totemizzata. Non si può continuare a posticipare una governance necessaria per affrontare una possibile grande crisi sistemica globale che in un non lontano futuro potrà interessare tutto il pianeta, se le attuali generazioni umane non saranno state in grado di prendere decisioni drastiche ed efficaci per ridurre gli impatti globali antropogenici.
d) Per la prima volta nella storia, l’umanità è chiamata a realizzare un quadro di riferimento di principi e di valori comuni che sappiano andare oltre la Carta dei Diritti dell’Uomo per diventare una Carta per lo Sviluppo Umano Responsabile, in grado di integrare in uno stesso orizzonte ideale la dimensione individuale e sociale della responsabilità umana e farsi prassi attraverso un sentimento di comune appartenenza di specie.
e) La modifica dei paradigmi economici, sociali e politici richiesti per dare una concreta ed efficace risposta ai problemi antropogenici globali ha bisogno di un cambiamento anche culturale nella società. Non è solo con leggi e provvedimenti che verrà impostato il cambiamento necessario. Occorre rendere i cittadini consapevoli e responsabili con un’azione sul piano educativo. Questo significa che nei prossimi anni gli investimenti nei sistemi scolastici, oltre che nella ricerca, dovranno costituire un obiettivo prioritario dell’azione dei governi. Il diritto non può sostituirsi all’educazione in una civiltà avanzata, specie se democratica.
f) Merito e competenza sono valori che devono essere messi al centro di un nuovo patto sociale tra i cittadini. Mai come in questo momento di emergenza sanitaria, chiunque esige risposte affidabili ed autorevoli da coloro che conoscono i problemi da un punto di vista scientifico, pur con incertezza e lacune, e da coloro che devono prendere di conseguenza delle decisioni difficili per la collettività. Allo stesso modo, affrontare il riscaldamento globale e tutti i problemi ecologici planetari esige competenza, studio, aggiornamento professionale, cooperazione onesta, confronto leale, apertura al dialogo, e decisioni politiche che siano scientificamente fondate e attentamente soppesate attraverso il parere di scienziati e tecnici.
Il tempo dell’improvvisazione e del pressappochismo sta per finire.
*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Riferimenti
Berkes F. and Folke C. (Eds.) (1998). Linking Social and Ecological Systems. Cambridge University Press, Cambridge.
Bonneuil C. e Fressoz J-B. (2019). La Terra, la storia e noi - L’evento Antropocene. Trad.: A. Accattoli e A. Grechi. Istituto della Enciclopedia Italiana, pag. XVII-367. ISBN: 978-8812007363.
Ostrom E. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. Science, vol. 325, pp. 419-422. doi:10.1126/science.1172133.
Peppoloni S. e Di Capua G. (2020). Geoetica e impatti globali antropogenici. In: Matione G. e Romanelli E. (a cura di): Il Corpo della Terra: La Relazione Negata. Castelvecchi Editore, Roma. ISBN 8832828715.
-
> PER LA PACE PERPETUA. --- UNA CARTA PER LO SVILUPPO UMANO RESPONSABILE. --- «Questo virus è più pericoloso di Ebola e Sars». Intervista a D. David Quammen (di Stella Levantesi).26 marzo 2020, di Federico La Sala
Europa
David Quammen: «Questo virus è più pericoloso di Ebola e Sars»
L’intervista. L’autore di «Spillover» (Adelphi, 2014) spiega il nesso tra uomini e pipistrelli. E perché la pandemia dipende soprattutto da noi
di Stella Levantesi (il manifesto, 25.03.2020)
Otto anni fa, nel 2012, il divulgatore scientifico e autore David Quammen ha scritto nel suo libro Spillover (Adelphi, 2014), una storia dell’evoluzione delle epidemie, che la futura grande pandemia («the Next Big One») sarebbe stata causata da un virus zoonotico trasmesso da un animale selvatico, verosimilmente un pipistrello, e sarebbe venuto a contatto con l’uomo attraverso un «wet market» in Cina.
Ma non si tratta di una profezia, Quammen è arrivato a queste conclusioni attraverso ricerche, inchieste e interviste accompagnate dai dati scientifici degli esperti.
Dalla sua casa in Montana, Quammen ci aiuta a comprendere meglio la pandemia di coronavirus, la sua genesi e il suo sviluppo.
Come avviene lo «spillover»?
Spillover è il termine che indica quel momento in cui un virus passa dal suo «ospite» non umano (un animale) al primo «ospite» umano. Questo è lo spillover. Il primo ospite umano è il paziente zero. Le malattie infettive che seguono questo processo le chiamiamo zoonosi.
Una delle sezioni del suo libro si chiama «Tutto ha un’origine», in che modo la distruzione della biodiversità da parte dell’uomo e l’interferenza dell’uomo nell’ambiente creano le condizioni per la comparsa di nuovi virus come il coronavirus?
Nei nostri ecosistemi si trovano molti tipi diversi di specie animali, piante, funghi, batteri e altre forme di diversità biologica, tutte creature cellulari. Un virus non è una creatura cellulare, è un tratto di materiale genetico all’interno di una capsula proteica e può riprodursi solo entrando all’interno di una creatura cellulare.
Molte specie animali sono portatrici di forme di virus uniche. Ed eccoci qui come potenziale nuovo ospite. Così i virus ci infettano. Così, quando noi umani interferiamo con i diversi ecosistemi, quando abbattiamo gli alberi e deforestiamo, scaviamo pozzi e miniere, catturiamo animali, li uccidiamo o li catturiamo vivi per venderli in un mercato, disturbiamo questi ecosistemi e scateniamo nuovi virus.
Poi siamo così tanti - 7,7 miliardi di esseri umani sul pianeta che volano in aereo in ogni direzione, trasportano cibo e altri materiali - e se questi virus si evolvono in modo da potersi trasmettere da un essere umano all’altro, allora hanno vinto la lotteria. Questa è la causa alla radice dello spillover, del problema delle zoonosi che diventano pandemie globali.
La distinzione tra zoonosi e non zoonosi aiuta in qualche modo a spiegare perché l’uomo ha sconfitto certe malattie e non altre? In altre parole, è più difficile “curare” le zoonosi? E se sì, perché?
Sì, è così. Il 60% delle malattie infettive umane sono zoonosi, cioè il virus è stato trasmesso da un animale in tempi relativamente recenti. L’altro 40% delle malattie infettive proviene da altro, da virus o altri agenti patogeni che si sono lentamente evoluti nel tempo insieme all’uomo.
Quindi possiamo sradicare le non zoonosi, il cui virus si è adattato solo a noi e non vive in altri animali. Il caso più famoso è il vaiolo, che abbiamo sradicato e ora esiste solo nei laboratori e non circola nella popolazione umana. Siamo riusciti a farlo perché non vive anche negli animali.
Se il vaiolo vivesse in un pipistrello o in una specie di scimmia, allora non potremmo liberarcene nella popolazione umana se non ce ne liberassimo anche in quell’animale, dovremmo uccidere tutti quei pipistrelli o curare anche loro dal vaiolo.
Ecco perché possiamo sradicare una malattia come il vaiolo ed è per questo che alla fine non potremo mai sradicare una zoonosi, a meno che non uccidiamo gli animali in cui vive.
Quindi, se un virus ci arriva dai pipistrelli, qual è la soluzione? Dovremmo uccidere tutti i pipistrelli?
No, la soluzione è lasciare i pipistrelli in pace, perché i nostri ecosistemi hanno bisogno dei pipistrelli.
Riguardo ai pipistrelli, il fatto che siano mammiferi come gli esseri umani rende più facile la trasmissione del virus da loro a noi? È proprio perché siamo entrambi mammiferi che lo «spillover» è più probabile?
Sì, è così. Molti dei virus che hanno causato le zoonosi negli ultimi 60 anni hanno trovato il loro ospite nei pipistrelli. Sono mammiferi come noi e i virus che si adattano a loro hanno più probabilità di adattarsi a noi rispetto a un virus che è in un rettile o in una pianta, per esempio.
La seconda ragione è che i pipistrelli rappresentano un quarto di tutte le specie di mammiferi sul pianeta, il 25%. È naturale, quindi, che sembrino sovra rappresentati come fonti di virus per l’uomo.
Ci sono un altro paio di cose oltre a questo che rendono i pipistrelli ospiti più probabili, vivono a lungo e tendono a rintanarsi in enormi aggregazioni. In una grotta, potrebbero esserci anche 60.000 pipistrelli e questa è una circostanza favorevole per far circolare i virus.
C’è un’altra cosa che gli scienziati hanno scoperto da poco: il sistema immunitario dei pipistrelli è più tollerante ad «estraneità» presenti nel loro organismo rispetto ad altri sistemi immunitari.
Da quanto ho capito le epidemie della storia non sono indipendenti l’una dall’altra ma, in qualche modo, sono collegate e ricorrenti per i motivi di cui abbiamo parlato prima, quindi dove vanno a finire i virus quando non presentano una minaccia diretta agli esseri umani?
Questa epidemia è talmente diffusa che potrebbe non scomparire del tutto, ma provo a fare un esempio diverso: l’Ebola nel 2014 in Africa occidentale. Non conosciamo ancora l’ospite con certezza ma sospettiamo che si tratti di pipistrelli. Si scatena un’epidemia che uccide migliaia di persone, medici e scienziati rispondono alla minaccia e finalmente rallentano l’epidemia che poi sparisce. Dove va a finire il virus? Se ne va? No, è ancora nell’ospite.
I virus non tornano dall’essere umano all’ospite ma il virus continua a risiedere nell’ospite. E questo è ciò che accade con la maggior parte di queste epidemie. Arrivano, colpiscono gli esseri umani, le persone soffrono, muoiono, gli esperti sanitari rispondono, l’epidemia viene messa sotto controllo, l’epidemia scompare e poi passano diversi anni prima che si ripeta. Dov’è il virus nel frattempo? È nell’ospite.
C’è una correlazione tra l’aumento del tasso di inquinamento in alcune zone e un impatto più forte del virus sulla popolazione di quella zona?
Sì, penso che ci possa essere una correlazione tra l’inquinamento dell’aria e i danni ai polmoni e alle vie respiratorie delle persone e quindi la loro suscettibilità a questo particolare virus. Credo che questa sia una domanda importante. Non abbiamo ancora risposte certe ma è una domanda che merita ricerca e attenzione.
È del tutto possibile che il danno ai polmoni delle persone, anche quando non si nota in circostanze normali, possa essere presente e sufficiente a renderle più vulnerabili a questo virus.
Un altro aspetto è che i sintomi arrivano più tardi del contagio. Quindi non c’è nessun allarme da parte dell’organismo che dice: «Sei infetto». Questo può rendere il Covid-19 più pericolosa di altre malattie che mostrano i sintomi prima?
Sì, la rende più pericolosa. Credo di aver scritto in Spillover che siamo stati fortunati con la Sars perché era un virus molto pericoloso: si diffondeva facilmente da un essere umano all’altro e aveva un alto tasso di mortalità, quasi il 10%, eppure, sarebbe stato peggio se le persone fossero state contagiose ancor prima di manifestare i sintomi. E ho scritto: «Dio non voglia che avremo a che fare con un virus grave come la Sars che si diffonde dalle persone prima che si vedano i sintomi». In questo momento abbiamo esattamente questo caso di virus.
Dicono che quando un proiettile ti colpisce non senti mai il colpo, perché il proiettile arriva prima e poi il suono arriva dopo. Questo virus funziona così.
Ho notato che la disinformazione scientifica che riguarda il coronavirus ha molti punti di contatto con le dinamiche della disinformazione climatica. Qual è la sua opinione al riguardo? E quanto è importante affrontare la disinformazione scientifica?
È estremamente importante affrontare la disinformazione scientifica. C’è sicuramente una sovrapposizione rispetto al cambiamento climatico. Ci sono persone che sono impazienti, arrabbiate e poco informate. Ricevono notizie da fonti inaffidabili e hanno appetito per una forma negativa di eccitazione. Hanno più interesse per le cospirazioni che per la scienza. La disinformazione si diffonde facilmente.
Dov’è la soglia limite tra l’offerta di notizie accurate, credibili, trasparenti e accessibili a tutti e il bombardamento continuo di “notizie” sul virus?
Esiste un limite e di informazione può essercene troppa. Viviamo in un mondo dove i media sono attivi 24 ore su 24 e vogliono aggiornamenti e occhi. Vogliono che la gente consulti la loro piattaforma perché hanno qualcosa un minuto prima di un’altra. È un tipo di competizione che non fa bene a nessuno - a parte agli azionisti della piattaforma stessa. Quindi penso che noi, come consumatori di notizie, dobbiamo resistere all’ossessione di sapere quale sia l’ultimo dato, l’ultimo caso, l’ultima notizia dell’ultima ora.
Dobbiamo seguire l’informazione sul virus, prestare attenzione al problema ma abbiamo bisogno anche di altre cose. Abbiamo bisogno di una copertura sul coronavirus che approfondisca le cause e gli effetti, ma anche di storie che non riguardino il coronavirus. Abbiamo bisogno di musica, di comicità, di arte, di persone che parlano di libri - e non solo del mio.
Che ruolo ha il sentimento di paura nelle dinamiche di comportamento collettivo durante una pandemia?
La paura è umana ed è naturale. Ma non è utile. Dobbiamo imparare di più su questo virus e prendere misure adeguate per controllarlo. Dobbiamo stare attenti, poi, che l’allontanamento sociale e l’autoisolamento non portino all’allontanamento emotivo e non cominciamo a vedere l’altro come una minaccia o un nemico. Quindi distanza sociale sì, ma con una connessione emotiva.
Cosa possiamo imparare da questa pandemia?
Prima di tutto possiamo imparare che le zoonosi possono essere molto pericolose e costose e dobbiamo essere preparati nell’affrontarle. Dobbiamo spendere molte risorse e molta attenzione nella preparazione.
Più posti letto in ospedale, più unità di terapia intensiva, più ventilatori, più mascherine, più formazione del personale sanitario, più formazione degli scienziati. Studiare piani di emergenza a livello locale, regionale, nazionale e tutto questo costa denaro.
L’altra cosa che dobbiamo imparare è che il modo in cui viviamo su questo pianeta ha delle conseguenze, delle conseguenze negative. Noi dominiamo questo pianeta come nessun’altra specie ha mai fatto. Ma ci sono conseguenze e alcune prendono la forma di una pandemia da coronavirus. Non è una cosa che ci è capitata. È il risultato delle cose che facciamo, delle scelte che prendiamo. Tutti ne siamo responsabili.
Ovviamente nessuno conosce davvero la risposta a questa domanda, ma come vede il mondo dopo il coronavirus? Cosa pensa che cambierà per le società e per la vita delle persone?
Spero che alla fine anche persone come Donald Trump imparino a prendere sul serio queste cose. Dobbiamo fare degli aggiustamenti. Potrebbe essere che inizieremo a ridurre il nostro impatto in termini di clima, di tutti i combustibili fossili che bruciamo, in termini di distruzione della diversità biologica, di invasione dei diversi ecosistemi. Forse cominceremo ad avere un passo più attento e più leggero su questo pianeta. Questo è quello che spero, ed è l’unico bene che può venire da questa esperienza.
Il sito dell’autrice è stellalevantesi.com. Sul manifesto in edicola il 25 marzo 2020 è stata pubblicata una versione ridotta di questa intervista. La versione in inglese è sul manifesto global.
-
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- CORONAVIRUS E CVILTA’. Enea che porta Anchise sulle spalle, san Cristoforo che porta il Bambino, e l’indicazione di Dante.24 marzo 2020, di Federico La Sala
CORONAVIRUS E CIVILTA’: ENEA, SAN CRISTOFORO, E DANTE - OGGI:
- A
La civiltà è Enea che porta Anchise sulle spalle
di Laura Marchetti (il manifesto, 24.03.2020)
«L’Italia vede decimata la generazione anziana, punto di riferimento per i giovani e per gli affetti». Le parole dette ieri dal presidente della Repubblica italiana, in maniera solenne e commovente, sembrano così voler far scudo contro quell’aberrante e diffusa convinzione, espressa in maniera più o meno sotterranea, che le morti così numerose non siano state poi così importanti perché riguardavano i vecchi, per di più già malati. Mattarella al contrario ci ricorda quale patrimonio siano i vecchi, come siano indispensabili per i bambini, proprio in quanto “rimbambiti”, ovvero anche loro bambini, disposti a giocare, a divagare, a trasgredire.
E come siano importanti per i giovani, per la possibilità che hanno di trasmettere loro antichi saperi, valori vissuti, comunitarie tradizioni, forme diverse di presa dello spazio e di percezione dei tempi. E come, in definitiva, siano importanti per ognuno di noi, perché nel tempo dell’effimero e dell’oblio, di fronte agli spettacoli e ai consumi, mostrano il valore degli affetti teneri, dei ricordi, della memoria e del compianto.
Le parole del presidente sono dunque dense di significato educativo ed esistenziale ma hanno anche un impatto politico radicale perché, per la prima volta, interrompono la filosofia eugenetica che è la pratica e lo spirito di questi insani tempi. Dal documento degli anestesisti spagnoli alla teorizzazione dell’immunità di gregge degli inglesi, fino alla sottrazione forzata dell’assistenza sanitaria accaduta in certi ospedali italiani, si teorizza la necessità, per la “medicina delle catastrofi”, di scegliere fra i vecchi e i giovani, come fra i deboli e i forti. Una scelta dovuta allo stato di eccezione e alla situazione estrema, tesa a sottrarre responsabilità alla coscienza personale, che porta però con sé la traccia indelebile di un giudizio di qualità dato alla vita, come se una vita - la più forte, la più abile - fosse solo per questo degna di essere mantenuta, mentre un’altra con più facilità dovrebbe essere rottamata.
In tale scelta gerarchica - che, perdurando lo stato di eccezione, potrebbe essere estesa anche a tutti i disabili e a tutti i fragili - si conserva il segreto del potere totalitario e della società “tanatologica”, la società di massa del ‘900 che si fonda su un continuo commercio con la morte.
Lo dice Elia Canetti in un libro magnifico e terribile scritto in anni bui e insani quasi come questi (Masse e Potere). In questa società tanatologica, potente diviene sia il capo, che acquisisce potere di morte, sia chi si distingue dalla morte sopravvivendo. La sopravvivenza è di per se stessa acquisizione di potere.
Chi è morto giace, sta per terra; chi sopravvive sta in piedi. Già solo questa collocazione spaziale rende “l’istante del sopravvivere, l’istante della potenza”, anche perché inconsciamente insorge la convinzione di una vera e propria “elezione”, una emozione comparativa che non risparmia nessun rapporto, nemmeno quello più affettivo, nemmeno quello con i figli o i genitori o i fratelli. Su questo senso di elezione si fonda dunque il totalitarismo, secondo Canetti. Ma, potremmo aggiungere, anche il capitalismo in quanto tale trasforma in Pil la sopravvivenza, poiché miglior produttori sono i vivi, cioè gli abili, i giovani, i forti.
C’è nel potere contemporaneo quindi, il persistere di una barbarie di fondo, una inciviltà. La civiltà si fonda invece al contrario e nasce quando Enea in fuga dall’incendio, porta con se il vecchio padre sulle spalle e, per mano, il giovane figlio. La pietà, che è la sua qualità esistenziale e la sua qualità sociale, lo spinge nell’aiutare, includere tutti, curare tutti, anche a scapito della propria sopravvivenza, del proprio potere.
Quella pietà è anche l’intelligenza della specie, in quanto la specie sopravvive, sottolineano i biologi della complessità, non nella lotta ma perché la madre continua ad allattare il figlio e perché gli uomini, anche quando vivono rintanati, non sono topi che si distruggono ma anzi si prestano soccorso.
Noi, nell’agenda delle cose che dobbiamo mettere in campo quando finirà la guerra e vorremmo fare il mondo nuovo, dovremmo mettere in campo la pietà. Fin da ora, in quanto già ora abbiamo due problemi. Il primo è quello di non morire, ma il secondo è quello di vivere civili.
- B
UN CAMBIAMENTO DI ROTTA FONDAMENTALE, UNA METANOIA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA URGENTE, PER QUANTI PRETENDONO DI ESSERE "PORTATORI DI CRISTO" DA UNA RIVA ALL’ALTRA DEL FIUME DEL TEMPO... *
Caro don Santino Bove Balestra
Vista la tensione e la passione personali che animano la sua Lettera "a san Cristofaro al tempo del Coronavirus" e, al contempo, sollecitato dalle sue stesse associazioni collegate a questa figura di gigante buono («Ti hanno fatto - forse un po’ abusivamente - diventare il patrono degli automobilisti (dopo essere stato più propriamente il protettore dei facchini): oggi dovresti ispirare chi dall’automobile passa alla bicicletta, al treno o all’uso dei propri piedi!»), il discorso fatto appare essere una forma implicita di autocritica "istituzionale" (cioè, da parte dell’intera Istituzione Chiesa paolina-costantiniana) della propria capacità di "portare Cristo" in giro, di qua e di là, avanti e indietro - e, della totale e più generale cecità antropologica e pedagogica, nei confronti del "Bambino" (che ognuno e ognuna di noi, tutti e tutte, è)!
SE,OGGI, AL TEMPO DEL CORONAVIRUS *, VALE l’esortazione “Restiamo tutti a casa!”, altrettanto sicuramente, domani, vale la consapevolezza che “Nulla sarà più come prima!” e, ancor di più, se vogliamo veramente cambiare rotta, che la “conversione eco-logica” (la ristrutturazione della nostra stessa "casa" !) è già "oggi necessaria", ora e subito ! Non c’è alcun tempo da perdere.
Portar-si il "bambino" sulle proprie spalle, « suprema fatica e suprema gioia », è impresa ancora tutta da tentare - e non ha nulla a che fare con il "sacrificio" e con la "messa in croce" di alcun "Bambino" ! O no?! -- *Federico La Sala
- C
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaFederico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Coronavirus. L’Organizzazione mondiale della Sanità: «Un test per l’umanità» (di Elena Molinari).17 marzo 2020, di Federico La Sala
Coronavirus.
Trump cede: crisi fuori controllo. L’Oms: «Un test per l’umanità»
L’Organizzazione mondiale della Sanità: «Allerta per il Sud del mondo La pandemia colpisce i più poveri. Muoiono anche i giovani»
Elena Molinari, New York (Avvenire, martedì 17 marzo 2020)
"E’ la crisi che segna la nostra epoca. I prossimi mesi saranno un test per la nostra risolutezza e la nostra fiducia nella scienza. Crisi come questa di Covid-19 tendono a far emergere il meglio e il peggio dell’umanità". Le parole del direttore dell’Organizzazione mondiale per la sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hanno risuonato come una tragica profezia negli Usa, dove ieri molti Stati hanno adottato misure drastiche di isolamento sociale, ma dove in molte città la vita continuava surrealmente nella normalità, come se i casi di coronavirus non stessero aumentando in modo esponenziale. «Se si guarda alle proiezioni - ha spiegato Jerome Adams, ossia il capo esecutivo del Public Health Service Commissioned Corps e portavoce delle questioni di salute pubblica all’interno del governo federale - ci sono tutte le possibilità di diventare come l’Italia».
Il bilancio dei contagi ieri negli Stati Uniti ha superato i 4mila, con 70 morti, e sono concentrati soprattutto sulle due coste. L’amministrazione di San Francisco ha ordinato ai 6,7 milioni di residenti di restare a casa: è la misura più severa presa finora. A New York, dove ieri i casi confermati sono balzati a 950 dai 729 di domenica, hanno chiuso bar, ristoranti e scuole. Vietato pure l’accesso alla statua della Libertà così come gli assembramenti di più di 50 persone (questo anche nei vicini Connecticut e New Jer- sey). Il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, ha implorato Donald Trump di fare di più a livello federale, per armonizzare un approccio che, a detta anche di molti esperti, è stato lasciato troppo all’iniziativa delle singole amministrazioni locali. Un esempio clamoroso sono le elezioni primarie, che oggi si terranno come previsto in Florida, Illinois, Ohio e Arizona, mentre Lousiana e Georgia. hanno già di rimandato il loro appuntamento con le urne e New York prevede di fare altrettanto, sebbene nello Stato non si voti fino al 28 aprile. I risultati del voto di oggi potrebbero permettere all’ex vicepresidente Joe Biden di ipotecare la nomination democratica, facendo tramontare definitivamente le speranze presidenziali del rivale Bernie Sanders. Il presidente Usa anche ieri ha ribadito che la scelta spetta ai singoli. Ma - ha aggiunto - «il rinvio non sarebbe una buona cosa».
Eppure, almeno a parole, il capo della Casa Bianca è sembrato ricredersi sull’emergenza. «È una crisi davvero brutta» ha affermato sottolineando che l’epidemia negli Usa si fermerà a luglio o ad agosto. E, dopo aver a lungo minimizzato l’emergenza, ha ammesso: «La situazione non è sotto controllo». La Casa Bianca intende dispiegare almeno 800 miliardi di aiuti nelle prossime settimane per sostenere l’economia Usa e tra le priorità vi sono il rinvio del pagamento delle tasse, prestiti agevolati o pagamenti diretti alle compagnie aeree, all’industria dell’ospitalità e alle piccole e medie aziende colpite dall’emergenza.
Più forte e coordinata la reazione del Canada, dove i casi sono per ora 324. Il Paese ieri ha chiuso le frontiere a tutti i non canadesi, con l’eccezione, per ora, dei cittadini americani, e chiesto alla popolazione di rimanere in casa. È il tipo di precauzioni che il direttore dell’Oms ha invitato ieri tutti i Paesi a prendere, per proteggere la loro popolazione ma anche il resto del mondo, in un test globale di solidarietà. «Fate i test, fate i test, fate i test», ha implorato Tedros che si è detto profondamente preoccupato per l’arrivo dell’epidemia nel Sud del mondo. «Con il coronavirus che si sposta nei Paesi a basso reddito, siamo profondamente preoccupati per l’impatto che potrebbe avere sulle popolazioni a molto alta prevalenza di Hiv o sui bambini malnutriti. Non dimentichiamo che muoiono anche i giovani e i piccoli», ha precisato. Nella conferenza stampa a Ginevra, il direttore ha ringraziato i medici e le infermiere all’opera, e detto di essersi emozionato nel vedere i video delle persone che applaudono gli operatori sanitari dai loro balconi o dalle storie di persone che si offrono di fare la spesa per gli anziani della comunità.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- L’ “8 SETTEMBRE”, LA “CORONA-VIRUS”, E IL "CAPRO ESPIATORIO" - OGGI.11 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ “8 SETTEMBRE”, LA “CORONA-VIRUS”, E UNA “PACE PERPETUA”. Ora il “capro espiatorio” siamo noi, l’intero genere umano ...
ALLA LUCE DEL FATTO che i “vescovi fiorentini hanno vietato di scambiarsi il segno della pace durante il rito della messa”, che a “Lourdes hanno chiuso l’accesso alle acque miracolose”, “per CARITA’, UN LAICO ILLUMINISTA” (cfr. Mario Pezzella, “Sarà un 8 settembre?, "Le parole e le cose”, 11 marzo 2020) può pure compiacersi di “quanto la fede religiosa sia diventata un gadget turistico, che non regge di fronte a uno stato di necessità”, MA NON PUO’ CONTINUARE A “DORMIRE”, A PENSARE COME SE FOSSE TUTTO COME “PRIMA” E RIPROPORRE LA STESSA “MINESTRA”:
- “[....] Afferma Umberto Galimberti in una intervista televisiva che l’angoscia di fronte a un pericolo indeterminato è talmente insopportabile che si cerca il più presto possibile di incarnarlo in un capro espiatorio tangibile e concreto [...] Ora l’incarnazione del male siamo diventati noi. [...] Allo stato d’animo dell’angoscia, dovrebbe sostituirsi quello che Leopardi nella Ginestra, dinanzi alla potenza incombente del Vesuvio, definisce “vero amor”, e cioè la capacità di sostenersi reciprocamente “negli alterni perigli e nelle angosce della guerra comune” [....]” (Mario Pezzella, “Sarà un 8 settembre?”, cit.).
SE NON SAPPIAMO ANCORA che cosa significa “pensare dentro l’emergenza”, forse, è bene CON BENJAMIN (NON AGAMBEN), RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO E RIASCOLTARE IL SUO “ECCE HOMO”, E CERCARE DI CAPIRE COSA VA SIGNIFICANDO NEL TEMPO LA SUA LEZIONE.
A DISTANZA DI SECOLI, e dopo Marx, dopo Nietzsche, dopo Freud, e dopo Lacan e dopo Foucault (il Foucault di “Che cosa è l’Illuminismo?”, 1983/1984), continuiamo a non capire che il “capro espiatorio” non è un caprone (cfr. “La crisi dell’Europa. Note per una riflessione storiografica”), ma un montone, un ariete, venuto a portarci in salvo (cfr.: “Guarire la nostra Terra. Necessità di “pensare un altro Abramo”), non a “sacrificarsi” per noi!!! Al contrario, oggi, l’intero genere umano, “noi stessi” ci apprestiamo a fare da “capro espiatorio” - e, pronti per la “pace perpetua” (cfr. Fine della Storia o della “Preistoria”?), abbiamo già messo sulla “nostra” testa la “corona” del sacrificio! O no?!
Federico La Sala
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- GIORNATA DEI GIUSTI E RESPONSABILITA’ GLOBALE: UNA GRANDE SFIDA ETICA.5 marzo 2020, di Federico La Sala
Etica e potere.
I Giusti e quel virus di libertà che si radica in noi
Il 6 marzo è la Giornata di tutti coloro che hanno agito per salvare i perseguitati nella storia moderna. Vicende che accadono quando chi è a capo delle comunità si mostra irresponsabile
di Gabriele Nissim (Avvenire, , giovedì 5 marzo 2020)
- [Foto] Il Giardino dei Giusti al Parco di Monte Stella a Milano
Stiamo vivendo un momento storico in cui i meccanismi dell’odio alimentano la rassegnazione e la paura. In questi giorni è ancora più evidente. Dobbiamo mettere a tacere chi è tentato, nell’agone politico, di usare questa emergenza per una resa dei conti ai propri fini di parte.
 Oggi si tratta prima di tutto di sentirsi tutti responsabili di fronte a delle scelte che si fanno giorno per giorno e il primato della ragione e della competenza dovrebbe guidare l’azione politica.
Oggi si tratta prima di tutto di sentirsi tutti responsabili di fronte a delle scelte che si fanno giorno per giorno e il primato della ragione e della competenza dovrebbe guidare l’azione politica.
 Ogni cittadino dovrebbe essere chiamato a bloccare chi utilizza il coronavirus per lanciare messaggi di odio e di contrapposizione. Per questo la Giornata dei Giusti, che sarà celebrata domani, è una grande sfida etica per il nostro Paese.
Ogni cittadino dovrebbe essere chiamato a bloccare chi utilizza il coronavirus per lanciare messaggi di odio e di contrapposizione. Per questo la Giornata dei Giusti, che sarà celebrata domani, è una grande sfida etica per il nostro Paese.Istituita nel 2012 dal Parlamento europeo su proposta di Gariwo e recepita da quello italiano nel 2017, la ricorrenza ha dato all’Italia l’opportunità di diventare messaggero universale delle storie dei Giusti nel mondo. Più di centotrenta Giardini dei Giusti sono nati in Italia, in Europa e nel Medio Oriente perché si avverte il bisogno di riportare alla luce grandi e piccole vicende che mostrano la possibilità del singolo individuo di incidere con la propria responsabilità in contesti difficili dove sembrerebbe impossibile cambiare il corso degli avvenimenti.
 Quest’anno il messaggio della Giornata dei Giusti è quello della responsabilità globale a cui sono chiamati tutti gli abitanti del nostro pianeta: la realtà di questi giorni sta smentendo l’illusione che ognuno possa salvarsi da solo. La vicenda del coranavirus ne è un esempio clamoroso.
Quest’anno il messaggio della Giornata dei Giusti è quello della responsabilità globale a cui sono chiamati tutti gli abitanti del nostro pianeta: la realtà di questi giorni sta smentendo l’illusione che ognuno possa salvarsi da solo. La vicenda del coranavirus ne è un esempio clamoroso.Ha fallito il presidente cinese quando nei primi giorni dell’epidemia ha cercato di nascondere al mondo la gravità della situazione; ma hanno fallito anche tutti coloro che pensavano che il problema riguardasse solo i cinesi, lasciando crescere forme di intolleranza fortunatamente per ora sotto controllo.
 Oggi è chiaro a tutti che la malattia può essere affrontata solo con una concertazione internazionale sul piano scientifico e che ogni inditi viduo è chiamato ad evitare che la paura generata da questa epidemia si riversi nelle relazioni quotidiane. È un virus che può colpire non solo la fragilità dei nostri corpi, ma anche incrinare le nostre relazioni, se viene a mancare un principio di solidarietà.
Oggi è chiaro a tutti che la malattia può essere affrontata solo con una concertazione internazionale sul piano scientifico e che ogni inditi viduo è chiamato ad evitare che la paura generata da questa epidemia si riversi nelle relazioni quotidiane. È un virus che può colpire non solo la fragilità dei nostri corpi, ma anche incrinare le nostre relazioni, se viene a mancare un principio di solidarietà.
 La stessa problematica si presenta di fronte ai cambiamenti climatici che se non adeguatamente affrontati a livello internazionale attraverso la conoscenza - e non con una colpevole rimozione - rischiano di portare molto prima di quanto si pensi un clima che ricorda l’affondamento del Titanic, quando per salvarsi i passeggeri rifiutarono di cooperare e diedero l’assalto alle scialuppe, cercando la propria salvezza a spese della vita di un altro.
La stessa problematica si presenta di fronte ai cambiamenti climatici che se non adeguatamente affrontati a livello internazionale attraverso la conoscenza - e non con una colpevole rimozione - rischiano di portare molto prima di quanto si pensi un clima che ricorda l’affondamento del Titanic, quando per salvarsi i passeggeri rifiutarono di cooperare e diedero l’assalto alle scialuppe, cercando la propria salvezza a spese della vita di un altro.La stessa memoria dei genocidi del passato e di chi ha provato ad arrestarli si presenta nei nostri giorni come una questione globale. In questo contesto globale l’individuo, indipendentemente della posizione che occupa o del Paese in cui vive, è chiamato ad una responsabilità che probabilmente non esisteva in nessuna epoca storica precedente.
 È chiamato, come direbbe Shakespeare, a raddrizzare non solo casa sua, ma il tempo globale in cui gli è capitato di nascere, perché ogni aspetto della sua vita è intimamente legato al resto del mondo. Per questo motivo Gariwo ha impostato in modo diverso la Giornata dei Giusti di quest’anno.
È chiamato, come direbbe Shakespeare, a raddrizzare non solo casa sua, ma il tempo globale in cui gli è capitato di nascere, perché ogni aspetto della sua vita è intimamente legato al resto del mondo. Per questo motivo Gariwo ha impostato in modo diverso la Giornata dei Giusti di quest’anno.
 Ecco perché ricorderemo lo scienziato Wallace Broecker che è stato il primo negli anni 70 del secolo scorso a studiare i cambiamenti climatici e ad ammonire l’opinione pubblica sugli effetti devastanti dei combustibili fossili per il futuro del pianeta. «Stiamo giocando alla roulette russa con il clima», scrisse in un articolo del 1987.
Ecco perché ricorderemo lo scienziato Wallace Broecker che è stato il primo negli anni 70 del secolo scorso a studiare i cambiamenti climatici e ad ammonire l’opinione pubblica sugli effetti devastanti dei combustibili fossili per il futuro del pianeta. «Stiamo giocando alla roulette russa con il clima», scrisse in un articolo del 1987.
 Ed ecco perché onoreremo un’altra figura di estrema attualità: il chimico Valerij Legasov, che incurante delle radiazioni dopo l’incidente nucleare di Chernobyl si prodigò per salvare il maggior numero di persone andando contro l’ostilità del potere sovietico che cercava di minimizzare i rischi per la popolazione e per resto il mondo.
Ed ecco perché onoreremo un’altra figura di estrema attualità: il chimico Valerij Legasov, che incurante delle radiazioni dopo l’incidente nucleare di Chernobyl si prodigò per salvare il maggior numero di persone andando contro l’ostilità del potere sovietico che cercava di minimizzare i rischi per la popolazione e per resto il mondo.La sua storia sembra riproporsi nuovamente in quella del medico cinese Li Wenliang che nel mese di dicembre 2019 osservando dei malati gravi di polmonite si accorse che c’era il rischio di una epidemia sconosciuta e lanciò l’allarme sui social. Le autorità, invece di allertarsi per verificare quell’allarme, lo accusarono di diffondere notizie false che turbavano l’ordine pubblico e lo costrinsero al silenzio. Morto il 7 febbraio, le autorità cercarono persino di censurare la sua morte per non ammettere le loro responsabilità.
 Sono due esempi di uomini che sfidano la censura di regimi totalitari per assumersi una responsabilità globale.
Sono due esempi di uomini che sfidano la censura di regimi totalitari per assumersi una responsabilità globale.
 Con Chernobyl è cominciata la crisi del totalitarismo sovietico per merito di scienziati coraggiosi come Legasov (come ha ammesso recentemente in una intervista lo stesso Gorbaciov), la stessa cosa potrebbe oggi accadere in Cina per merito dei medici coraggiosi che per salvare delle vite hanno lanciato al mondo l’allarme del coronavirus e hanno costretto il regime a dire la verità. È inevitabile che si riapra in Cina, dopo le storiche manifestazioni di Tienanmen, un nuovo movimento nella società per la libertà di stampa e la democrazia.
Con Chernobyl è cominciata la crisi del totalitarismo sovietico per merito di scienziati coraggiosi come Legasov (come ha ammesso recentemente in una intervista lo stesso Gorbaciov), la stessa cosa potrebbe oggi accadere in Cina per merito dei medici coraggiosi che per salvare delle vite hanno lanciato al mondo l’allarme del coronavirus e hanno costretto il regime a dire la verità. È inevitabile che si riapra in Cina, dopo le storiche manifestazioni di Tienanmen, un nuovo movimento nella società per la libertà di stampa e la democrazia. -
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Greta Thunberg a Bruxelles: ’Con questa legge l’Ue ammette la resa’. Decisione zero emissioni nel 2050: "Se la tua casa brucia, non aspetti qualche altro anno prima" di spegnere l’incendio.4 marzo 2020, di Federico La Sala
Greta Thunberg a Bruxelles: ’Con questa legge l’Ue ammette la resa’
Decisione zero emissioni nel 2050. Greenpeace e l’attivista bocciano la Commissione
di Redazione ANSA *
"Se la tua casa brucia, non aspetti qualche altro anno prima" di spegnere l’incendio, mentre è proprio "questo quello che la Commissione sta proponendo oggi. Nel momento in cui l’Ue presenta questa legge sul clima, con le emissioni zero entro 2050, indirettamente ammettete la resa: rinunciate agli accordi di Parigi, alle vostre promesse e alla possibilità di fare tutto il possibile per dare un futuro sicuro per i vostri figli". Così l’attivista svedese Greta Thunberg, intervenendo di fronte alla commissione Ambiente (Envi) del Parlamento Ue. Quando con le proteste sul clima "i vostri figli hanno fatto scattare ’l’allarme anti-incendio’, voi siete usciti, avete annusato l’aria e vi siete resi conto che era tutto vero: la casa stava bruciando, non era un falso allarme", ha detto Thunberg. "Poi però siete rientrati, avete finito la vostra cena e siete andati a dormire senza neanche chiamare i vigili del fuoco. Mi dispiace, ma questo non ha alcun senso", ha aggiunto. Secondo Greta, il testo presentato dalla Commissione Ue sul clima "manda il forte segnale che un’azione reale è in atto, quando in realtà non è così. La dura verità è che non ci sono né le politiche né la consapevolezza necessaria. Siamo nel pieno di una crisi che non viene trattata come tale. Avremmo moltissime soluzioni eccellenti", ha continuato Thunberg sottolineando che ci sono anche "tante persone pronte a fare il possibile per aiutare. Quello che manca - ha concluso - sono la consapevolezza, la leadership e soprattutto il tempo".
La Commissione europea ha proposto la "legge sul clima" che prevede emissioni nette azzerate entro il 2050, entro settembre una proposta per aumentare il taglio della CO2 al 2030, ampi poteri alla Commissione per aggiustare la ’traiettoria’ di riduzione delle emissioni ogni 5 anni (come richiesto dal trattato di Parigi), con il 2021 come orizzonte per proporre modifiche ai regolamenti europei sul clima, dal mercato Ets all’efficienza energetica, dalle rinnovabili alle emissioni in agricoltura e trasporti.
La Commissione europea ha anche avviato una consultazione pubblica per un ’patto sul clima’ per coinvolgere regioni, comunità locali, società civile, scuole, imprese e cittadini nell’impresa di tagliare le emissioni. La legge sul clima dovrà essere esaminata dal Consiglio e dall’Europarlamento prima di diventare legalmente vincolante. L’Italia e altri undici Paesi hanno scritto alla Commissione per accelerare i tempi sull’aumento del taglio delle emissioni al 2030, mentre il presidente della commissione ambiente dell’Eurocamera, Pascal Canfin, ha già indicato che si batterà per ottenere vincoli a livello nazionale.
"I cambiamenti climatici li abbiamo creati noi quindi sta a noi agire, la legge climatica guiderà ogni nostra azione per i prossimi 30 anni, ci dà gli strumenti per misurare i progressi verso l’obiettivo" di un’Europa a zero emissioni entro il 2050, ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen presentando la prima legge climatica europea. "Il testo della legge climatica è corto e semplice ma ci impegna verso azioni fondamentali: obbliga la Ue a inserire gli obiettivi ambientali in tutte le future legislazioni, è vincolante, offre prevedibilità e certezza a investitori, autorità pubbliche, è quello che ci chiedono", ha aggiunto. La presidente ha anche assicurato che la Ue è "pronta a proteggere le imprese", mettendole al riparo dalla concorrenza di chi non ha gli stessi standard ambientali. "Dobbiamo assicurare un terreno di gioco equo per le nostre imprese", ha detto.
Sull’ambiente "l’Unione europea deve essere capofila: avete l’obbligo morale di farlo, oltre all’opportunità" di essere "il vero leader sul clima" ha aggiunto Greta Thunberg. "La natura non scende a patti", ha sottolineato l’attivista svedese. "Non potete fare compromessi con la fisica" e "noi non vi consentiremo di rinunciare al vostro futuro". Al termine del suo intervento Greta è stata salutata da una standing ovation di circa un minuto dalla maggior parte dell’aula.
"L’analisi di Greta sulla nostra proposta è basata sull’approccio del bilancio di carbonio, secondo cui gli obiettivi di riduzione dovrebbero essere più alti. Io ho provato a spiegarle che noi usiamo un altro approccio e siamo più ottimisti di lei sulle tecnologie emergenti. Ma se non ci fosse stata lei e il modo in cui ha mobilitato due generazioni di giovani probabilmente oggi non staremmo neanche discutendo una legge sul clima". Così il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. L’impegno a ridurre le emissioni e ad adattarsi ai cambiamenti climatici, ha aggiunto Timmermans, "non serve a salvare il pianeta, che si salva da solo, ma a salvare l’umanità".
L’attivista svedese era stata accolta in mattinata dalla presidente Ursula von der Leyen, e dal vicepresidente esecutivo Frans Timmermans, al suo arrivo alla Commissione europea, dove partecipa al collegio dei commissari Ue. Durante la riunione è prevista l’adozione di una nuova proposta di legge sul Clima.
La Commissione europea ha avviato i lavori sul futuro meccanismo di adeguamento del prezzo del carbonio alle frontiere e la revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia, come strumenti del Green Deal europeo. "La tassazione avrà un ruolo chiave perché può incoraggiare comportamenti responsabili e compensare i costi della transizione", ha detto il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. "Dobbiamo salvaguardare le aziende che spostano la produzione in parti del mondo in cui gli standard sul clima sono meno rigorosi, è qui che entra in gioco il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio. Tuttavia, prima di presentare qualsiasi proposta, le varie opzioni devono essere attentamente valutate, in particolare per quanto riguarda le norme Wto e altri impegni internazionali", ha aggiunto.
"Senza obiettivi al 2030 basati sulla scienza, né misure per porre fine ai sussidi ai combustibili fossili, ci stiamo preparando al fallimento. Il momento di agire è ora, non tra 10 anni". Così il responsabile delle politiche per il clima di Greenpeace Europa Sebastian Mang si unisce al coro di critiche piovute addosso alla ’legge sul clima’ Ue ancora prima della sua presentazione.
Oltre a Greenpeace, il Climate Action Network, Friends of the Earth Europa e, in una lettera aperta, Greta Thunberg e altri 34 attivisti per il clima hanno mosso rilievi sostanziali alla proposta che fissa per legge un obiettivo Ue di azzeramento delle emissioni nette al 2050, perché non in linea con le raccomandazioni del panel intergovernativo dell’Onu sui cambiamenti climatici.
-
>PER LA PACE PERPETUA. --- COSTITUZIONALISMO GLOBALE. «Costituente Terra», la scuola che vuole salvare la specie umana (di Giansandro Merli).22 febbraio 2020, di Federico La Sala
Politica
«Costituente Terra», la scuola che vuole salvare la specie umana
Diritto. Un progetto per immaginare gli strumenti politico-giuridici necessari ad affrontare i problemi del nostro tempo nella giusta scala
di Giansandro Merli *
«Per la prima volta nella storia esiste un interesse pubblico e generale assai più ampio e vitale di tutti i diversi interessi pubblici del passato: la sopravvivenza dell’umanità e l’abitabilità del pianeta». Luigi Ferrajoli, giurista e filosofo del diritto, pronuncia queste parole in piedi, circondato dai tomi antichi della splendida Biblioteca Vallicelliana, al centro di Roma.
L’occasione è la presentazione della scuola «Costituente Terra», che si è tenuta ieri. Poco prima avevano parlato Paola Paesano, direttrice dell’istituzione ospitante che in un raffinato intervento ha sottolineato le tensioni universalistiche che nel corso della storia hanno attraversato le biblioteche pubbliche, e un altro importante promotore del progetto, Raniero La Valle, giornalista, intellettuale ed ex senatore.
Sostenere l’esigenza di un costituzionalismo globale ai tempi dei rigurgiti sovranisti potrebbe sembrare un’azione fuori fuoco. E invece, sostengono i promotori, sono proprio quelle dinamiche a validare un simile sforzo. Le parole che La Valle e Ferrajoli mettono in fila sono come uno spillo che infrange la bolla di conoscenze acquisite e strumenti interpretativi che trasformano alcune contingenze nella forma del realismo. Lo sguardo è oltre la cronaca, così l’unico realismo diventa la consapevolezza che la politica ancorata agli Stati nazionali è impotente e inadeguata ad affrontare le sfide del nostro tempo.
L’alternativa possibile alle catastrofi cui essa va incontro e anzi produce, però, esiste. Sarà forse politicamente improbabile, almeno per ora, ma si può pensare. A ciò ambisce «Costituente Terra», al fine di revisionare il pensiero che ha portato l’umanità sull’orlo del baratro. Per farlo vuole espandere il costituzionalismo lungo tre direttrici: sovrastatualità; diritto privato; beni fondamentali. A esse corrispondono tre questioni cui occorre trovare risposte su scala planetaria: catastrofe ecologica; guerre; povertà e disuguaglianze. La loro soluzione passa per l’immaginazione politico-giuridica di istituti di garanzia dei diritti fondamentali a livello globale. È questo uno degli obiettivi della scuola, che però sarà anche anti-scuola. «Una scuola trasmette i saperi da una generazione all’altra per riprodurre la società come l’abbiamo ricevuta - dice La Valle - Invece noi dovremmo trasmettere un sapere che ancora non c’è, perché col sapere che c’è la società ricevuta non solo non va bene, ma nemmeno può continuare».
* Fonte: il manifesto, 22.02.2020 (ripresa parziale).
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Il sogno. Un Giubileo ecumenico per salvare il Pianeta (di Alex Zanotelli - direttore "Mosaico di Pace).31 gennaio 2020, di Federico La Sala
Il sogno.
Un Giubileo ecumenico per salvare il Pianeta
di Alex Zanotelli (Avvenire, venerdì 31 gennaio 2020)
Caro direttore,
la situazione ambientale Cdel Pianeta è sempre più grave (gli orrendi fuochi in Australia e altrove ne sono una riprova) e i governi del mondo sempre più incapaci a trovare soluzioni.
Il fallimento della Cop25 di Madrid, che ha visto coinvolti tutti i governi del mondo per oltre due settimane dello scorso dicembre, è un brutto segnale per l’umanità. Ha vinto il petrolio, ha vinto il carbone! Ha perso la Politica: i governi sono prigionieri dei poteri economico- finanziari. La colpa è soprattutto degli Usa di Trump, del Brasile di Bolsonaro, dell’Australia di Morrison: è la vittoria del sovranismo ambientale.
Da Madrid ne escono invece sconfitti i Paesi impoveriti che subiranno il maggior danno del surriscaldamento, causato al 90% dai Paesi ricchi. Purtroppo questi ultimi si sono rifiutati di aumentare il Fondo per aiutare i Paesi impoveriti ad affrontare i disastri climatici. È il trionfo dell’eco-razzismo. Tutto questo è uno schiaffo ai movimenti ambientalisti di Fridays for Future, ai Sunrisers Usa, agli Extinction Rebellion, ai milioni di persone scese in piazza, a papa Francesco, così impegnato in questo campo con la Laudato si’ e il Sinodo per l’Amazzonia. Per questo, vista la gravità della situazione ambientale e l’arroganza dei Paesi sovranisti, noi chiediamo a papa Francesco un altro regalo: un Giubileo per salvare il Pianeta. È quanto chiede la nota economista inglese, Ann Pettifor, che ha diretto la vittoriosa campagna del Giubileo 2000 per la remissione dei debiti ai Paesi del sud del mondo. Lei fa notare nel suo recente libro The case for the Green New Deal che, se vogliamo guarire questo nostro eco-sistema malato, dobbiamo riordinare la finanza mondiale.
E allora un Giubileo potrebbe essere provvidenziale, in un momento così critico. Il Giubileo nasce dal concetto biblico del settimo giorno: il sabato, che significa riposare. È il principio sabbatico di riposo per gli uomini, per gli animali, per la terra, ma anche per i sistemi economicofinanziari.
 Il principio sabbatico è basato sul concetto del limite: non siamo Dio, siamo esseri limitati. Ed ecco il Giubileo biblico dei sette anni di sabati e poi di sette per sette anni di sabati, il grande Giubileo, che prevedeva la remissione dei debiti, la restituzione della terra, la liberazione degli schiavi e il riposo della terra. Gesù ha iniziato il suo ministero nella Galilea dei disperati, annunciando l’«anno di grazia», il Giubileo.
Il principio sabbatico è basato sul concetto del limite: non siamo Dio, siamo esseri limitati. Ed ecco il Giubileo biblico dei sette anni di sabati e poi di sette per sette anni di sabati, il grande Giubileo, che prevedeva la remissione dei debiti, la restituzione della terra, la liberazione degli schiavi e il riposo della terra. Gesù ha iniziato il suo ministero nella Galilea dei disperati, annunciando l’«anno di grazia», il Giubileo.Quello del 2000 ha finalmente ripreso questa dimensione sociale, affermando che ci sono limiti allo sfruttamento dei debitori da parte dei creditori. Così abbiamo ottenuto la remissione di tanti debiti dei Paesi impoveriti. Oggi abbiamo bisogno di un altro Giubileo che sappia coniugare la dimensione finanziaria con quella ecologica: il riposo della terra. «Non possiamo infatti affrontare la crisi del nostro eco-sistema - afferma sempre Pettifor - senza riformare il sistema economico-finanziario. Una linea diretta collega il credito emesso dalle banche, che aprono il rubinetto della liquidità, senza preoccuparsi dell’utilizzo che viene fatto di quel denaro, e la spinta verso un sistema basato sull’iperconsumo e sull’iperproduzione e quindi sulle emissioni di gas serra».
Perché questo possa avvenire - sostiene ancora Pettifor - il sistema finanziario globale deve di nuovo essere controllato dall’autorità pubblica, mentre oggi la finanza è controllata da autorità private ( Wall Street, City di Londra...). «Fintanto che la finanza non regolata - scrive il gesuita ed economista francese Gaël Giraud nel suo libro ’Transizione ecologica’ - prometterà un rendimento del 15% l’anno, il risparmio non potrà essere investito in un programma di industrializzazione verde, che potrà essere redditizia solo nel lungo periodo. Spetta dunque a noi, in seno alla società civile, nelle nostre Chiese, esigere dalla politica che adotti le misure che si impongono per regolare i mercati finanziari ». Il Sogno giubilare, che dovremo inseguire, secondo Giraud, è quello che «denaro e credito diventino beni comuni ».
Ecco perché in questo momento storico sarebbe importante un Giubileo che aiuti le comunità cristiane a ritrovare il ’Gran sogno di Dio’ espresso nelle tradizioni giubilari e radicalizzato da Gesù. Sarebbe straordinario se le Chiese cristiane, riunite nel Consiglio Mondiale delle Chiese-Wcc, dimenticando le polemiche passate sui Giubilei, si accordassero per proclamare un Giubileo ecumenico! Il Giubileo dovrebbe portare le Chiese a «una conversione ecologica - come afferma papa Francesco nella Laudato si’ - che comporta il lasciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda. Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana».
Sacerdote, missionario comboniano e direttore di ’Mosaico di Pace’
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "Per più di 30 anni la scienza è stata di una chiarezza cristallina. Con che coraggio osate continuare a girarvi dall’altra parte". Il discorso di Greta Thunberg alle Nazioni unite.28 gennaio 2020, di Federico La Sala
Editoriale
PER LA CRITICA DELLA RAGIONE "OLIMPICA" .... *
Il discorso di Greta Thunberg alle Nazioni unite
di Greta Thunberg (il manifesto, 27.9.2019)
New York. E’ tutto sbagliato. Io non dovrei essere qui di fronte a voi. Dovrei essere a scuola dall’altra parte dell’oceano. Eppure venite tutti da me per avere speranza? Ma come osate! Voi avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre vuote parole. Eppure io sono una persona fortunata.
Le persone soffrono. Le persone stanno morendo. Interi ecosistemi stanno crollando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa. E tutto ciò di cui riuscite a parlare sono i soldi e le favole della crescita economica infinita. Come osate!
Per più di 30 anni la scienza è stata di una chiarezza cristallina. Con che coraggio osate continuare a girarvi dall’altra parte e venire qui assicurando che state facendo abbastanza, quando la politica e le soluzioni necessarie non sono ancora nemmeno all’orizzonte.
Dite che “ci ascoltate” e che comprendete l’urgenza. Ma non importa quanto io sia triste e arrabbiata, non voglio crederci. Perché se comprendeste davvero la situazione e continuaste a non agire, allora sareste malvagi. E mi rifiuto di crederci.
L’idea più diffusa sul dimezzare le nostre emissioni in 10 anni ci dà solo il 50% di probabilità di rimanere al di sotto di 1,5 ° C e disinnescare così reazioni a catena irreversibili al di fuori del controllo umano.
Forse il 50% di probabilità è accettabile per voi. Ma questi numeri non includono i punti di non ritorno, la maggior parte dei circuiti di feedback, il riscaldamento aggiuntivo nascosto dall’inquinamento atmosferico tossico o gli aspetti di giustizia e di equità. Fanno anche affidamento sull’ipotesi che la mia generazione e quella dei miei figli riuscirà a risucchiare centinaia di miliardi di tonnellate di CO2 dall’atmosfera con tecnologie che oggi esistono a malapena.
Quindi un rischio del 50% non è semplicemente accettabile per noi - noi che dobbiamo convivere con le conseguenze.
Per avere una probabilità del 67% di rimanere al di sotto di un aumento della temperatura globale di 1,5 ° C - le migliori probabilità stimate dal Pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici - il 1 ° gennaio 2018 il mondo aveva solo 420 gigatonnellate di anidride carbonica da poter rilasciare nell’atmosfera.
Oggi questa cifra è già sotto le 350 gigatonnellate. Come osate far finta che questo problema possa essere risolto con le solite soluzioni economiche e tecniche. Con i livelli di emissione odierni, la quantità di CO2 a disposizione sarà completamente sparita in meno di otto anni e mezzo.
Non ci saranno soluzioni o piani presentati secondo i dati di oggi. Perché questi numeri sono troppo scomodi. E voi non siete ancora abbastanza maturi per dire le cose come stanno.
Ci state deludendo e tradendo. Ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento. Gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi. E se sceglierete di fallire, vi dico che non vi perdoneremo mai.
Non vi lasceremo andare via come se nulla fosse. Proprio qui, proprio adesso, è dove tracciamo la linea. Il mondo si sta svegliando. E il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no.
* Testo del discorso all’Assemblea generale delle Nazioni unite di New York del 23 settembre 2019 (traduzione dall’inglese a cura di Matteo Bartocci).
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- PIANETA TERRA. Tracce per una svolta antropologica...
- MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours").
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINCINQUE SECOLI” DI LETARGO: "SE NON RIDIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI" (Mt. 18, 3).
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaGUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE (LA LEZIONE DI NELSON MANDELA).
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Michel Serres e la "la thanatocratie". Il dovere morale di preservare i valori moderni (di Francesco Bellusci).25 gennaio 2020, di Federico La Sala
GIORNO DELLA MEMORIA, PERCHÉ GLI EBREI?
Il dovere morale di preservare i valori moderni
di Francesco Bellusci (Casa della cultura, 24.01.2020)
“Perché gli ebrei?”. È questa la domanda che spesso giunge dal pubblico in coda alle manifestazioni del Giorno della Memoria, a scuola o in altri contesti, oppure rimane taciuta nel retro-pensiero, difficile da esternare, come se la sua imbarazzante e sconcertante semplicità, più che ad appagare una sete di conoscenza, sia diretta a placare l’angoscia che accompagna l’inevitabile senso di “colpa metafisica”, come l’avrebbe chiamata Karl Jaspers[1], cioè la colpa di essere “sopravvissuti” a loro, di avere goduto il privilegio della vita, ingiustamente e violentemente negata ai nostri simili, pur essendo, noi, lontani ed estranei ai soggetti direttamente imputabili della colpa politica o giuridica o morale di quel crimine spaventoso. Perché gli ebrei e non un’altra minoranza etnica o religiosa, allora? Perché la scelta del comodo capro espiatorio su cui polarizzare il risentimento e le frustrazioni di un popolo sconfitto in guerra e sconvolto dalla crisi economica è caduta sugli ebrei? Perché le ideologie del fascismo e del nazismo hanno fatto leva sull’antisemitismo e sulle leggi razziali contro gli ebrei per la loro cinica propaganda?
Hitler o Mussolini non hanno inventato il male, tantomeno l’antisemitismo. Certamente, però, in Germania, un’impressionante e contingente reazione favorita da enzimi ideologici (nazionalismo, darwinismo sociale, scientismo, xenofobia, razzismo), politici (la competizione accesa per il consenso in democrazie “giovani”, con istituzioni nascenti o fragili messe da subito a dura prova dalle conseguenze sociali ed economiche della Grande Guerra e, poi, dalle ripercussioni mondiali del primo “crac” della nuova potenza economica globale: gli Stati Uniti) e materiali e tecnologici (la disponibilità di burocrazie più efficienti, la sperimentazione di nuove armi letali) fece sì che dall’odio, dal disprezzo, dalla discriminazione nei confronti dell’ebreo si arrivasse, per la prima volta, al progetto efferato di un genocidio, concepito come un assassinio industrializzato di massa. E ha portato altri regimi fascisti come l’Italia o la Repubblica di Vichy a collaborarvi. Ma con la fine del nazifascismo, Hiroshima annunciava che l’irrazionale, la psicosi del potere, non si erano affatto ritirati dal mondo, subito piombato nella corsa agli armamenti e sempre sull’orlo dell’apocalisse nucleare. Un mondo dove la macchinazione tanatocratica di governi, laboratori scientifici e industria militare, in sinergia tra loro, sembravano preparare stavolta l’olocausto dell’umanità, al punto da far dire, provocatoriamente, al filosofo e storico della scienza Michel Serres, in un memorabile pamphlet:
- “Mi pare dimostrato che Hitler abbia vinto la guerra. Come si diceva dei Greci, che l’avevano vinta contro i Romani, dopo la loro disfatta. La sua paranoia, che non era individuale, ma storica, ha conquistato tutti gli Stati, investito la loro politica estera, e senza alcuna eccezione. Nessun capo di Stato si comporta, oggi, diversamente da lui, sul piano della strategia, della politica di armamento, della cecità completa rispetto ai fini perseguiti per mezzo di questi stocks. Nessuno di loro si comporta diversamente da lui rispetto all’abuso della scienza per scopi di morte”[2].
La fine del mondo bipolare, con la disintegrazione dell’Unione Sovietica, ha per fortuna allontanato la minaccia di un olocausto della specie umana, ma se, come ricordava Serres nel suo saggio, la paranoia di Hitler era storica, e non individuale, rimane da chiedersi ancora perché le vittime di quella paranoia, e dell’unico olocausto sinora avvenuto, siano state proprio gli ebrei. -Diventa interessante farlo tanto più che la risposta a questa domanda ci costringe a risalire a un periodo storico, l’ultimo quarto di secolo dell’Ottocento, con il quale secondo il politologo David Runciman[3], il momento storico attuale con il suo strisciante rigetto diffuso della democrazia liberale, del cosmopolitismo, della multietnicità, intrattiene più analogie.
Allora si consumò, infatti, il più pericoloso cortocircuito culturale della modernità, con il rischio di un inabissamento della civiltà europea stessa, e coincise con il periodo d’incubazione dell’ideologia fascista, che, solo nelle circostanze critiche del dopoguerra, si sarebbe poi trasformata in un movimento politico di estrema destra organizzato e combattivo. Questa pista ci viene acutamente suggerita dagli importanti studi storici di Zeev Sternhell[4]. In quel periodo, infatti, germina e cresce rapidamente un rifiuto dell’Illuminismo, espresso da vari rivoli della cultura europea, che si declina come rifiuto del principio di uguaglianza naturale degli uomini, dell’universalismo, del razionalismo, dell’idea di progresso e che culmina nella scomunica di “materialismo”, indirizzata indistintamente a democrazia, liberalismo, socialismo, con le loro dottrine egualitarie e utilitaristiche, concepito come la malattia europea che era necessario sradicare, quella che più di altre minava l’“organismo vivo” della nazione. Il fascismo e il nazismo, pertanto, non sono tanto figli della reazione al bolscevismo e al comunismo, quanto l’emergenza più vistosa, aggressiva e radicale di quel rifiuto. Il che ne spiega l’appeal che esercitò sia sulle masse sia sull’élite intellettuale.
Si comprende allora la scelta del capro espiatorio ebraico. La “questione ebraica”, ovvero il tema della tolleranza e dell’emancipazione della minoranza ebraica da secoli discriminata o ghettizzata, si era affermata proprio con l’Illuminismo e gli illuministi l’avevano imposta già nell’agenda politica dei “sovrani illuminati”, per essere riconfermata nelle rivoluzioni liberali della prima metà dell’Ottocento (non a caso, La questione ebraica è il titolo di un libro fondamentale nella produzione di Marx, del 1843, dove ai sostenitori dell’emancipazione politica attraverso l’estensione universale dei diritti civili, anche agli ebrei, Marx replica denunciando i limiti intrinseci dell’emancipazione politica, a fronte dello scarto tra gli eguali diritti proclamati in astratto e le concrete condizioni di diseguaglianza presenti nella società).
 Questo tema sarà ricorrente per tutto il XIX secolo in Europa, anche se maggiormente in Francia e in Germania rispetto ad altri Paesi europei, e, quindi, uno dei modi migliori per dichiarare morte ai valori dell’Illuminismo sarebbe stato proprio scagliarsi contro gli ebrei e archiviare, con il tema dell’emancipazione degli ebrei, il simbolo essenziale dell’Illuminismo. La presenza nella coscienza collettiva e nel dibattito intellettuale del nesso tra illuminismo e questione ebraica trova peraltro conferma in un articolo[5] di Hannah Arendt, pubblicato sulla Zeitschrift für Geschichte der Juden in Deutschland, alcuni mesi prima della nomina a cancelliere della Repubblica federale di Adolf Hitler, in cui la giovane filosofa ripercorreva il modo in cui gli stessi intellettuali ebrei (Lessing, Mendelssohn, Dohm) si collocavano nella tradizione illuminista, oscillando tra l’invito a mantenere la religione ebraica come “religione della ragione” o a rinunciarvi per una piena “naturalizzazione” e assimilazione nella società tedesca e europea. E certamente, come ci ricorda André Glucksmann, nel suo controverso libro-manifesto dei nouveaux philosophes[6], giocò nella scelta degli ebrei anche l’immagine di “nemico interno” costruita filosoficamente dagli idealisti tedeschi, che vi videro i rappresentanti o di uno “Stato nello Stato” (Fichte), nutrito e compattato dall’ostilità per il resto del genere umano, o peggio ancora, di un “anti-Stato” (Hegel), esempio aberrante di comunità che scardina l’equazione tra popolo, nazione, Stato e, quindi, ancora più inquietante agli occhi un movimento culturale politico come quello fascista e nazista, esplicitamente nazionalista, illiberale e razzista.
Questo tema sarà ricorrente per tutto il XIX secolo in Europa, anche se maggiormente in Francia e in Germania rispetto ad altri Paesi europei, e, quindi, uno dei modi migliori per dichiarare morte ai valori dell’Illuminismo sarebbe stato proprio scagliarsi contro gli ebrei e archiviare, con il tema dell’emancipazione degli ebrei, il simbolo essenziale dell’Illuminismo. La presenza nella coscienza collettiva e nel dibattito intellettuale del nesso tra illuminismo e questione ebraica trova peraltro conferma in un articolo[5] di Hannah Arendt, pubblicato sulla Zeitschrift für Geschichte der Juden in Deutschland, alcuni mesi prima della nomina a cancelliere della Repubblica federale di Adolf Hitler, in cui la giovane filosofa ripercorreva il modo in cui gli stessi intellettuali ebrei (Lessing, Mendelssohn, Dohm) si collocavano nella tradizione illuminista, oscillando tra l’invito a mantenere la religione ebraica come “religione della ragione” o a rinunciarvi per una piena “naturalizzazione” e assimilazione nella società tedesca e europea. E certamente, come ci ricorda André Glucksmann, nel suo controverso libro-manifesto dei nouveaux philosophes[6], giocò nella scelta degli ebrei anche l’immagine di “nemico interno” costruita filosoficamente dagli idealisti tedeschi, che vi videro i rappresentanti o di uno “Stato nello Stato” (Fichte), nutrito e compattato dall’ostilità per il resto del genere umano, o peggio ancora, di un “anti-Stato” (Hegel), esempio aberrante di comunità che scardina l’equazione tra popolo, nazione, Stato e, quindi, ancora più inquietante agli occhi un movimento culturale politico come quello fascista e nazista, esplicitamente nazionalista, illiberale e razzista.
 Bisogna aggiungere che, in questo attacco all’Illuminismo, che venne quasi naturalmente a combinarsi con l’attacco agli ebrei, il nazismo, rispetto al fascismo, con il suo dogma del Blut und Boden, si spinse oltre, fino a colpire la concezione dell’uomo ereditata dalla tradizione giudaico-cristiana, come aveva intuito Emmanuel Lévinas, in un articolo pubblicato nel 1934 sulla rivista Esprit: “L’essenza dell’uomo non è più nella libertà, ma in una sorta di incatenamento. Essere veramente se stessi, non significa risollevarsi al di sopra delle contingenze, sempre estranee alla libertà dell’Io: ma, al contrario, prendere coscienza dell’incatenamento originale, ineluttabile, unico al nostro corpo, significa soprattutto accettare questo incatenamento (...) Da questa concretizzazione dello spirito deriva immediatamente una società a base consanguinea (...) Incatenato al suo corpo, l’uomo si vede rifiutare il potere di sfuggire a se stesso”[7]. Un attacco, quindi, non solo all’Illuminismo e ai suoi valori (l’autonomia, la finalità umana delle nostre azioni, l’universalità morale e giuridica, senza distinzioni di razza, di ceto, di religione), ma anche alle radici spiritualiste da cui quei valori scaturivano nella loro distillazione secolarizzata.
Bisogna aggiungere che, in questo attacco all’Illuminismo, che venne quasi naturalmente a combinarsi con l’attacco agli ebrei, il nazismo, rispetto al fascismo, con il suo dogma del Blut und Boden, si spinse oltre, fino a colpire la concezione dell’uomo ereditata dalla tradizione giudaico-cristiana, come aveva intuito Emmanuel Lévinas, in un articolo pubblicato nel 1934 sulla rivista Esprit: “L’essenza dell’uomo non è più nella libertà, ma in una sorta di incatenamento. Essere veramente se stessi, non significa risollevarsi al di sopra delle contingenze, sempre estranee alla libertà dell’Io: ma, al contrario, prendere coscienza dell’incatenamento originale, ineluttabile, unico al nostro corpo, significa soprattutto accettare questo incatenamento (...) Da questa concretizzazione dello spirito deriva immediatamente una società a base consanguinea (...) Incatenato al suo corpo, l’uomo si vede rifiutare il potere di sfuggire a se stesso”[7]. Un attacco, quindi, non solo all’Illuminismo e ai suoi valori (l’autonomia, la finalità umana delle nostre azioni, l’universalità morale e giuridica, senza distinzioni di razza, di ceto, di religione), ma anche alle radici spiritualiste da cui quei valori scaturivano nella loro distillazione secolarizzata.E per avere la sensazione di quale potesse essere la condizione psicologica di un ebreo nel clima plumbeo e “anti-illuminista” in cui la crisi di civiltà europea era precipitata, basterà rileggere il passo di una delle lettere, scritte tra il 1920 e il 1923, di Franz Kafka a Milena Jesenská, che morirà nel 1944 nel campo di concentramento di Ravensbrück: “Per me tutto avviene all’incirca come per qualcuno che, ogni volta che uscisse, dovesse non soltanto lavarsi, pettinarsi ecc. - il che è già abbastanza faticoso - ma venendogli a mancare tutto una volta di più, ogni volta, dovesse anche cucirsi un vestito, fabbricarsi delle scarpe, confezionarsi un cappello, tagliarsi un bastone ecc. Naturalmente non tutto gli riuscirebbe bene, le cose reggerebbero per una strada o due (...) Alla fine, in via del Ferro, si imbatterebbe in una folla che sta dando la caccia agli ebrei”. Ecco, il Giorno della Memoria deve servire anche a ricordarci il dovere morale di preservare i valori moderni che permettono di costruire una società in cui nessuno si senta manchevole per essere uomo, come i suoi simili, e in cui nessuno venga considerato mai un “uomo di troppo”.
[1] Vedi: U. Galimberti, La casa di psiche. Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica, Feltrinelli, Milano 2005, cap. 25
 [2] M. Serres, Trahison: la thanatocratie (1972), in: M. Serres, Hermès III. La traduction, Le Minuit, Paris 1974, p. 74
[2] M. Serres, Trahison: la thanatocratie (1972), in: M. Serres, Hermès III. La traduction, Le Minuit, Paris 1974, p. 74
 [3] D. Runciman, Così finisce la democrazia. Paradossi, presente e futuro di un’istituzione imperfetta, Bollati Boringhieri, Torino 2019.
[3] D. Runciman, Così finisce la democrazia. Paradossi, presente e futuro di un’istituzione imperfetta, Bollati Boringhieri, Torino 2019.
 [4] Storico israeliano di origine polacca, professore di Scienza politica presso la Hebrew University di Gerusalemme, autore di numerosi saggi, tra cui: Nascita dell’ideologia fascista, Baldini & Castoldi, Milano 1993; La destra rivoluzionaria, Corbaccio, Milano 1997; Né destra, né sinistra, Baldini & Castoldi, Milano 1997.
[4] Storico israeliano di origine polacca, professore di Scienza politica presso la Hebrew University di Gerusalemme, autore di numerosi saggi, tra cui: Nascita dell’ideologia fascista, Baldini & Castoldi, Milano 1993; La destra rivoluzionaria, Corbaccio, Milano 1997; Né destra, né sinistra, Baldini & Castoldi, Milano 1997.
 [5] H. Arendt, Illuminismo e questione ebraica, Cronopio, Napoli 2007
[5] H. Arendt, Illuminismo e questione ebraica, Cronopio, Napoli 2007
 [6] A. Glucksmann, I padroni del pensiero, Garzanti, Milano 1977
[6] A. Glucksmann, I padroni del pensiero, Garzanti, Milano 1977
 [7] E. Lévinas, Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 2005, pp. 32, 34
[7] E. Lévinas, Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 2005, pp. 32, 34
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA --- L’ELOGIO DI "ELENA" DEL SOFISTA GORGIA E L’IMMAGINARIO "COSMOTEANDRICO" DA "SACRO IMPERO ROMANO" DELL’EUROPA, OGGI.4 gennaio 2020, di Federico La Sala
"ECCE HOMO": (ANTROPOLOGIA, NON "ANDROPOLOGIA" O "GINECO-LOGIA")!!! USCIRE DALL’ORIZZONTE COSMOTEANDRICO DA "SACRO ROMANO IMPERO"... *
- Dio creò l’uomo ("homo") ... e lo fece maschio ["masculum"] e femmina [" foeminam "] (Genesi, I.27).
- “Chi tene ‘a lingua, va ’n Sardegna" (antico proverbio campano)
La parola può tutto
di Ivano Dionigi (Avvenire, venerdì 3 gennaio 2020)
«Chiamo uomo chi è padrone della sua lingua». In questa sentenza fulminante di don Lorenzo Milani (Lettera a Ettore Bernabei 1956), ispirata a un deciso afflato di giustizia sociale, trovo il più bel commento al passo in cui Aristotele (Politica 1253 a) riconosce nella parola (logos) la marca che caratterizza l’uomo e lo distingue dagli animali, che ne sono privi (tà zóa á-loga). La parola: il bene più prezioso, la qualità più nobile, il sigillo più intimo. A una persona, a un gruppo, a un popolo puoi togliere averi, lavoro, affetti: ma non la parola. Un divario economico si ripiana, un’occupazione si rimedia, una ferita affettiva si rimargina, ma la mancanza o l’uso ridotto della parola nega l’identità, esclude dalla comunità, confina alla solitudine e quindi riduce allo stato animale. «La parola - continuava il profetico prete di Barbiana - è la chiave fatata che apre ogni porta»; tutto può, come già insegnava la saggezza classica: «spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione» (Gorgia, Elogio di Elena 8). Ma essa è di duplice segno, nella vita privata come in quella pubblica: con i cittadini onesti e i governanti illuminati si fa simbolica (syn-bállein), e quindi unisce, consola, salva; confiscata dai cittadini corrotti e dai demagoghi si fa diabolica (dia-bállein), e quindi divide, affanna, uccide.
- ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS - NON IL "LOGO"! La questione della "Parola" e della "Lingua".
- RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!!
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
- OBIEZIONE DI COSCIENZA !!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
“DE DOMO DAVID”?! GIUSEPPE, MARIA, E L’IMMAGINARIO “COSMOTEANDRICO” (COSMOLOGIA, TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA!) DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA... *
- Nota di commento a margine di "De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò" (cfr. "Fondazione Terra d’Otranto", 10.11.2019).
CARDINALE CASTRILLON HOYOS: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio”(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
PAPA FRANCESCO: “«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana! [...]” (LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, Omelia di papa Francesco, Basilica Vaticana, Mercoledì, 1° gennaio 2020).
*
A) - La costruzione del ’presepe’ cattolico-romano .... e la ’risata’ di Giuseppe!!!
 MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;B) Il magistero della Legge dei nostri Padri e delle nostre Madri Costituenti non è quello di “Mammona” (“Deus caritas est”, 2006)! EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA “NON CLASSIFICATA”!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907.
C) GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di “pensare un altro Abramo”.
Federico La Sala
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Appello per un nuovo costituzionalismo globale, una bussola etica e politica per salvare il mondo e i suoi abitanti dalla distruzione.26 dicembre 2019, di Federico La Sala
«Perché la storia continui». Appello per una Costituzione della Terra
Proposte. Appello per un nuovo costituzionalismo globale, una bussola etica e politica per salvare il mondo e i suoi abitanti dalla distruzione.
di Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, Raffaele Nogaro, Paolo Maddalena, Mariarosaria Guglielmi, Riccardo Petrella (il manifesto, 26.12.2019)
Nel pieno della crisi globale, nel 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, il vescovo Nogaro, Riccardo Petrella e molti altri lanciano il progetto politico di una Costituzione per la Terra e promuovono una Scuola, «Costituente Terra», che ne elabori il pensiero e prefiguri una nuova soggettività politica del popolo della Terra, «perché la storia continui». Pubblichiamo le parti essenziali del documento che esce domani, in data 27 dicembre 2019.
L’Amazzonia brucia e anche l’Africa, e non solo di fuoco, la democrazia è a pezzi, le armi crescono, il diritto è rotto in tutto il mondo. «Terra! Terra!» è il grido dei naufraghi all’avvistare la sponda, ma spesso la terra li respinge, dice loro: «i porti sono chiusi, avete voluto prendere il mare, fatene la vostra tomba, oppure tornate ai vostri inferni». Ma «Terra» è anche la parola oggi più amata e perduta dai popoli che ne sono scacciati in forza di un possesso non condiviso; dai profughi in fuga per la temperatura che aumenta e il deserto che avanza; dalle città e dalle isole destinate ad essere sommerse al rompersi del chiavistello delle acque, quando la Groenlandia si scioglie, i mari son previsti salire di sette metri sull’asciutto, e a Venezia già lo fanno di un metro e ottantasette. «Che si salvi la Terra» dicono le donne e gli uomini tutti che assistono spaventati e impotenti alla morte annunciata dell’ambiente che da millenni ne ospita la vita.
Ci sono per fortuna pensieri e azioni alternative, si diffonde una coscienza ambientale, il venerdì si manifesta per il futuro, donne coraggiose da Greta Thunberg a Carola Rackete fanno risuonare milioni di voci, anche le sardine prendono la parola, ma questo non basta. Se nei prossimi anni non ci sarà un’iniziativa politica di massa per cambiare il corso delle cose, se le si lascerà in balia del mercato della tecnologia o del destino, se in Italia, in Europa e nelle Case Bianche di tutti i continenti il fascismo occulto che vi serpeggia verrà alla luce e al potere, perderemo il controllo del clima e della società e si affacceranno scenari da fine del mondo, non quella raccontata nelle Apocalissi, ma quella prevista e monitorata dagli scienziati.
Il cambiamento è possibile
L’inversione del corso delle cose è possibile. Essa ha un nome: Costituzione della terra. Il costituzionalismo statuale che ha dato una regola al potere, ha garantito i diritti, affermato l’eguaglianza e assicurato la vita degli Stati non basta più, occorre passare a un costituzionalismo mondiale della stessa autorità ed estensione dei poteri e del denaro che dominano la Terra.
La Costituzione del mondo non è il governo del mondo, ma la regola d’ingaggio e la bussola di ogni governo per il buongoverno del mondo. Nasce dalla storia, ma deve essere prodotta dalla politica, ad opera di un soggetto politico che si faccia potere costituente. Il soggetto costituente di una Costituzione della Terra è il popolo della Terra, non un nuovo Leviatano, ma l’unità umana che giunga ad esistenza politica, stabilisca le forme e i limiti della sua sovranità e la eserciti ai fini di far continuare la storia e salvare la Terra.
Salvare la Terra non vuol dire solo mantenere in vita «questa bella d’erbe famiglia e d’animali», cantata dai nostri poeti, ma anche rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo di tutte le persone umane.
 Il diritto internazionale è già dotato di una Costituzione embrionale del mondo, prodotta in quella straordinaria stagione costituente che fece seguito alla notte della seconda guerra mondiale e alla liberazione dal fascismo e dal nazismo: la Carta dell’Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, i due Patti internazionali del 1966 e le tante Carte regionali dei diritti, che promettono pace, sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri umani. Ma non sono mai state introdotte le norme di attuazione di queste Carte, cioè le garanzie internazionali dei diritti proclamati. Non è stato affatto costituito il nuovo ordine mondiale da esse disegnato. È come se un ordinamento statale fosse dotato della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di tribunali, di scuole e di ospedali che «di fatto la realizzino».
Il diritto internazionale è già dotato di una Costituzione embrionale del mondo, prodotta in quella straordinaria stagione costituente che fece seguito alla notte della seconda guerra mondiale e alla liberazione dal fascismo e dal nazismo: la Carta dell’Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, i due Patti internazionali del 1966 e le tante Carte regionali dei diritti, che promettono pace, sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri umani. Ma non sono mai state introdotte le norme di attuazione di queste Carte, cioè le garanzie internazionali dei diritti proclamati. Non è stato affatto costituito il nuovo ordine mondiale da esse disegnato. È come se un ordinamento statale fosse dotato della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di tribunali, di scuole e di ospedali che «di fatto la realizzino».È chiaro che in queste condizioni i diritti proclamati sono rimasti sulla carta, come promesse non mantenute. Riprendere oggi il processo politico per una Costituzione della Terra vuol dire tornare a prendere sul serio il progetto costituzionale formulato settant’anni fa e i diritti in esso stabiliti. E poiché quei diritti appartengono al diritto internazionale vigente, la loro tutela e attuazione non è soltanto un’urgente opzione politica, ma anche un obbligo giuridico in capo alla comunità internazionale e a tutti noi che ne facciamo parte.
Qui c’è un’obiezione formulata a partire dalla tesi di vecchi giuristi secondo la quale una Costituzione è l’espressione dell’«unità politica di un popolo»; niente popolo, niente Costituzione. E giustamente si dice che un popolo della Terra non c’è; infatti non c’era ieri e fino ad ora non c’è.
La novità è che adesso può esserci, può essere istituito; lo reclama la scena del mondo, dove lo stato di natura delle sovranità in lotta tra loro non solo toglie la «buona vita», ma non permette più neanche la nuda vita; lo reclama l’oceano di sofferenza in cui tutti siamo immersi; lo rende possibile oggi la vetta ermeneutica raggiunta da papa Francesco e da altre religioni con lui, grazie alla quale non può esserci più un dio a pretesto della divisione tra i popoli: «Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno» - hanno detto ad Abu Dhabi - non vuole essere causa di terrore per nessuno, mentre lo stesso «pluralismo e le diversità di religione sono una sapiente volontà divina con cui Dio ha creato gli esseri umani»; non c’è più un Dio geloso e la Terra stessa non è una sfera, ma un poliedro di differenze armoniose.
Per molti motivi perciò è realistico oggi porsi l’obiettivo di mettere in campo una Costituente della Terra, prima ideale e poi anche reale, di cui tutte le persone del pianeta siano i Padri e le Madri costituenti.
Una politica dalla parte della Terra
Di per sé l’istanza di una Costituzione della Terra dovrebbe essere perseguita da quello strumento privilegiato dell’azione politica che, almeno nelle democrazie, è il partito - nazionale o transnazionale che sia - ossia un artefice collettivo che, pur sotto nomi diversi, agisca nella forma partito. Oggi questo nome è in agonia perché evoca non sempre felici ricordi, ma soprattutto perché i grandi poteri che si arrogano il dominio del mondo non vogliono essere intralciati dal controllo e dalla critica dei popoli, e quindi cercano di disarmarli spingendoli a estirpare le radici della politica e dei partiti fin nel loro cuore. È infatti per la disaffezione nei confronti della politica a cui l’intera società è stata persuasa che si scende in piazza senza colori; ma la politica non si sospende, e ciò a cui comunque oggi siamo chiamati è a prendere partito, a prendere partito non per una Nazione, non per una classe, non “prima per noi”, ma a prendere partito per la Terra, dalla parte della Terra.
Ma ancor più che la riluttanza all’uso di strumenti già noti, ciò che impedisce l’avvio di questo processo costituente, è la mancanza di un pensiero politico comune che ne faccia emergere l’esigenza e ne ispiri modalità e contenuti.
Non manca certamente l’elaborazione teorica di un costituzionalismo globale che vada oltre il modello dello Stato nazionale, il solo nel quale finora è stata concepita e attuata la democrazia, né mancano grandi maestri che lo propugnino; ma non è diventato patrimonio comune, non è entrato nelle vene del popolo un pensiero che pensi e promuova una Costituzione della Terra, una unità politica dell’intera comunità umana, il passaggio a una nuova e rassicurante fase della storia degli esseri umani sulla Terra.
Eppure le cose vanno così: il pensiero dà forma alla realtà, ma è la sfida della realtà che causa il pensiero. Una “politica interna del mondo” non può nascere senza una scuola di pensiero che la elabori, e un pensiero non può attivare una politica per il mondo senza che dei soggetti politici ne facciano oggetto della loro lotta. Però la cosa è tale che non può darsi prima la politica e poi la scuola, né prima la scuola e poi la politica. Devono nascere insieme, perciò quello che proponiamo è di dar vita a una Scuola che produca un nuovo pensiero della Terra e fermenti causando nuove soggettività politiche per un costituzionalismo della Terra. Perciò questa Scuola si chiamerà «Costituente Terra».
«Costituente Terra»: una Scuola per un nuovo pensiero
Certamente questa Scuola non può essere pensata al modo delle Accademie o dei consueti Istituti scolastici, ma come una Scuola disseminata e diffusa, telematica e stanziale, una rete di scuole con aule reali e virtuali. Se il suo scopo è di indurre a una mentalità nuova e a un nuovo senso comune, ogni casa dovrebbe diventare una scuola e ognuno in essa sarebbe docente e discente. Il suo fine potrebbe perfino spingersi oltre il traguardo indicato dai profeti che volevano cambiare le lance in falci e le spade in aratri e si aspettavano che i popoli non avrebbero più imparato l’arte della guerra. Ciò voleva dire che la guerra non era in natura: per farla, bisognava prima impararla. Senonché noi l’abbiamo imparata così bene che per prima cosa dovremmo disimpararla, e a questo la scuola dovrebbe addestrarci, a disimparare l’arte della guerra, per imparare invece l’arte di custodire il mondo e fare la pace.
Molte sarebbero in tale scuola le aree tematiche da perlustrare:
1) le nuove frontiere del diritto, il nuovo costituzionalismo e la rifondazione del potere;
2) il neo-liberismo e la crescente minaccia dell’anomia;
3) la critica delle culture ricevute e i nuovi nomi da dare a eventi e fasi della storia passata;
4) il lavoro e il Sabato, un lavoro non ridotto a merce, non oggetto di dominio e alienato dal tempo della vita;
5) la «Laudato sì» e l’ecologia integrale;
6) il principio femminile, come categoria rigeneratrice del diritto, dal mito di Antigone alla coesistenza dei volti di Levinas, al legame tra donna e natura fino alla metafora della madre-terra;
7) l’Intelligenza artificiale (il Führer artificiale?) e l’ultimo uomo;
8) come passare dalle culture di dominio e di guerra alle culture della liberazione e della pace;
9) come uscire dalla dialettica degli opposti, dalla contraddizione servo-signore e amico-nemico per assumere invece la logica dell’ et-et, della condivisione, dell’armonia delle differenze, dell’ «essere per l’altro», dell’ «essere l’altro»;
10) il congedo del cristianesimo dal regime costantiniano, nel suo arco «da Costantino ad Hitler», e la riapertura nella modernità della questione di Dio;
11) il «caso Bergoglio», preannuncio di una nuova fase della storia religiosa e secolare del mondo.
Naturalmente molti altri temi potranno essere affrontati, nell’ottica di una cultura per la Terra alla quale nulla è estraneo d’umano. Tutto ciò però come ricerca non impassibile e fuori del tempo, ma situata tra due kairòs, tra New Delhi ed Abu Dhabi, due opportunità, una non trattenuta e non colta, la proposta di Gorbaciov e Rajiv Gandhi del novembre 1986 per un mondo libero dalle armi nucleari e non violento, e l’altra che ora si presenta di una nuova fraternità umana per la convivenza comune e la salvezza della Terra, preconizzata nel documento islamo-cristiano del 4 febbraio 2019 e nel successivo Comitato di attuazione integrato anche dagli Ebrei, entrato ora in rapporto con l’ONU per organizzare un Summit mondiale della Fratellanza umana e fare del 4 febbraio la Giornata mondiale che la celebri.
Partecipare al processo costituente iscriversi al Comitato promotore
Pertanto i firmatari di questo appello propongono di istituire una Scuola denominata «Costituente Terra» che prenda partito per la Terra, e a questo scopo hanno costituito un’associazione denominata «Comitato promotore partito della Terra». Si chiama così perché in via di principio non era stata esclusa all’inizio l’idea di un partito, e in futuro chissà. Il compito è oggi di dare inizio a una Scuola, «dalla parte della Terra», alle sue attività e ai suoi siti web, e insieme con la Scuola ad ogni azione utile al fine «che la storia continui»; e ciò senza dimenticare gli obiettivi più urgenti, il risanamento del territorio, la rifondazione del lavoro, l’abolizione del reato di immigrazione clandestina, la firma anche da parte dell’Italia del Trattato dell’ONU per l’interdizione delle armi nucleari e così via.
I firmatari propongono che persone di buona volontà e di non perdute speranze, che esponenti di associazioni, aggregazioni o istituzioni già impegnate per l’ecologia e i diritti, si uniscano a questa impresa e, se ne condividono in linea generale l’ispirazione, si iscrivano al Comitato promotore di tale iniziativa all’indirizzo progettopartitodellaterra@gmail.com versando la relativa quota sul conto BNL intestato a “Comitato promotore del partito della Terra”, IBAN IT94X0100503206000000002788 (dall’estero BIC BNLIITRR).
La quota annua di iscrizione, al Comitato e alla Scuola stessa, è libera, e sarà comunque gradita. Per i meno poveri, per quanti convengano di essere tra i promotori che contribuiscono a finanziare la Scuola, eventuali borse di studio e il processo costituente, la quota è stata fissata dal Comitato stesso nella misura significativa di 100 euro, con l’intenzione di sottolineare che la politica, sia a pensarla che a farla, è cosa tanto degna da meritare da chi vi si impegna che ne sostenga i costi, contro ogni tornaconto e corruzione, ciò che per molti del resto è giunto fino all’offerta della vita. Naturalmente però si è inteso che ognuno, a cominciare dai giovani, sia libero di pagare la quota che crede, minore o maggiore che sia, con modalità diverse, secondo le possibilità e le decisioni di ciascuno.
Nel caso che l’iniziativa non riuscisse, le risorse finanziarie mancassero e il processo avviato non andasse a buon fine, l’associazione sarà sciolta e i fondi eventualmente residui saranno devoluti alle ONG che si occupano dei salvataggi dei fuggiaschi e dei naufraghi nel Mediterraneo.
Un’assemblea degli iscritti al Comitato sarà convocata non appena sarà raggiunto un congruo numero di soci, per l’approvazione dello Statuto dell’associazione, la formazione ed elezione degli organi statutari e l’impostazione dei programmi e dell’attività della Scuola.
Roma, 27 dicembre 2019, 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana.
PROPONENTI E PRIMI ISCRITTI. Raniero La Valle, giornalista (Roma), Luigi Ferrajoli, filosofo del diritto (Roma), Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale, Raffaele Nogaro, ex vescovo di Caserta, Paolo Maddalena, già vicepresidente della Corte Costituzionale, Mariarosaria Guglielmi, Segretaria generale di Magistratura Democratica, Riccardo Petrella, ecologo, promotore del Manifesto dell’acqua e dell’identità di “Abitante della Terra”, Domenico Gallo, magistrato, Francesco Carchedi, sociologo (Roma), Francesco Di Matteo, Comitati Dossetti per la Costituzione, Anna Falcone. avvocata, Roma, Pippo Civati, Politico, Piero Basso (Milano), Gianpietro Losapio, cooperatore sociale, direttore del Consorzio NOVA, Giacomo Pollastri, studente in Legge (Roma), Francesco Comina, giornalista (Bolzano), Roberto Mancini, filosofo (Macerata), Francesca Landini, informatica (Roma), Giancarlo Piccinni e la Fondazione don Tonino Bello (Alessano), Grazia Tuzi, antropologa, autrice di “Quando si faceva la Costituzione. Storia e personaggi della comunità del porcellino” (Roma), Guido Innocenzo Gargano osb cam., monaco (Roma), Felice Scalia, s. J, (Messina), Marina Graziosi, docente (Roma), Agata Cancelliere, insegnante, (Roma), Raul Mordenti, storico della critica letteraria, Politico (Roma), Salvatore Maira, scrittore (Roma), Marco Malagola, francescano, missionario, (Torino), Norma Lupi (Roma), Andrea Cantaluppi, sindacalista (Roma), Enrico Peyretti (Torino), Nino Mantineo, università di Catanzaro, Giacoma Cannizzo, già sindaca di Partinico, Filippo Grillo, artista (Palermo), Nicola Colaianni, già magistrato e docente all’Università di Bari, Stefania Limiti, giornalista (Roma), Domenico Basile (Merate, Lecco), Maria Chiara Zoffoli (Merate), Luigi Gallo (Bolzano), Antonio Vermigli, giornalista (Quarrata, Pistoia), Renata Finocchiaro, ingegnere (Catania), Liana D’Alessio (Roma), Lia Fava, ordinaria di letteratura (Roma), Paolo Pollastri, musicista (Roma), Fiorella Coppola, sociologa (Napoli), Dario Cimaglia, editore, (Roma), Luigi Spina, insegnante, ricercatore (Biella), Marco Campedelli, Boris Ulianich, storico, Università Federico II, Napoli, Gustavo Gagliardi, Roma, Paolo Scandaletti, scrittore di storia, Roma, Pierluigi Sorti, economista, Roma, Vittorio Bellavite, coordinatore di “Noi siamo Chiesa”, Agnés Deshormes, cooperatrice internazionale, Parigi, Anna Sabatini Scalmati, psicoterapeuta, Roma, Francesco Piva, Roma, Sergio Tanzarella, storico del cristianesimo, Tina Palmisano, Il Giardino Terapeutico sullo Stretto, Messina, Luisa Marchini, segretaria di “Salviamo la Costituzione”, Bologna, Maurizio Chierici, giornalista. Angelo Cifatte, formatore, Genova, Marco Tiberi, sceneggiatore, Roma, Achille Rossi e l’altrapagina, Città di Castello, Antonio Pileggi, ex Provveditore agli studi e dir. gen. INVALSI, Giovanni Palombarini, magistrato, Vezio Ruggieri, psicofisiologo (Roma) Bernardetta Forcella (insegnante (Roma), Luigi Narducci (Roma), Laura Nanni (Albano), Giuseppe Salmè, magistrato, Giovanni Bianco, giurista, Roma.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. COMMENTO APOCALYPTICO --- La danza della pioggia in ascensore Franco Berardi Bifo13 dicembre 2019, di Federico La Sala
La danza della pioggia in ascensore
di Franco Berardi Bifo (Comune-info, 10 Dicembre 2019)
Un tempo si faceva la danza della pioggia. Lo sciamano si vestiva con paramenti sgargianti, ululava, ballava e girava in tondo. Dopo di che talvolta pioveva talvolta no, ma non dipendeva da lui, almeno credo. Rituali propiziatori, esorcismi... Oggi c’è la politica che svolge la stessa funzione del tutto irrilevante ai fini di fermare la catastrofe ambientale, lo scioglimento dei ghiacciai, l’aumento della temperatura, ma anche ai fini di rilanciare la crescita, superare la stagnazione eccetera eccetera.
Non è sempre stato così, intendiamoci: per qualche secolo fu possibile decidere in modo collettivo, in forma democratica oligarchica o monarchica, e la decisione poteva determinare qualcosa (non tutto, non molto, ma qualcosa) nella sfera dell’esistenza comune. Ora non più. Mi duole dirlo, ma la politica non è più in grado di scalfire la superficie degli eventi, perché è diventato impossibile decidere in tempo a causa della velocità infinita dei flussi di comunicazione, ed è diventato impossibile determinare il corso degli eventi, perché la complessità delle relazioni economiche, sociali e psichiche è divenuta tale che nessuna decisione potrebbe in ogni caso dominarle. E perché la macchina tecnica connettiva ha incorporato nelle relazioni linguistiche automatismi cui non è possibile sottrarsi.
C’è qualcosa di patetico, di struggente nella frenetica accelerazione della politica contemporanea. Come un poveraccio che si trovi chiuso in un ascensore che precipita a tutta velocità verso l’inferno, il cittadino contemporaneo schiaccia impazzito pulsanti con su scritto: destra, sinistra democrazia, nazione, popolo e altre parole che non significano niente, ma che offrono ancora (sempre meno) l’illusione di poter salvare noi stessi e le nostre famiglie dal destino inquietante che vediamo ogni giorno più chiaramente, e comincia ormai a farci paura.
Non dico, intendiamoci, che se vince la destra non cambia niente: cambia la truculenza delle parole, la crudeltà dell’esecuzione e la ridicola ferocia delle facce. Tutto qui. La vittoria di Trump ha enormemente peggiorato la qualità del discorso pubblico, esasperato l’efferatezza delle dichiarazioni contro i migranti. Ma Trump ha deportato 80.000 migranti, mentre il gentilissimo bellissimo coltissimo Obama ne aveva deportati 120.000. E tutti abbiamo tirato un respiro di sollievo quando l’orrendo Matteo Salvini è stato scalzato dal serafico Zingaretti. Ma il decreto sicurezza non è stato neppure scalfito (anche se tutti dicono oddio che brutto), la legge dello jus soli non è neppure stata proposta al parlamento, (anche se molti si vergognano e promettono che prima o poi). E la tassa sulla plastica nelle confezioni, un ovvio tentativo di contrastare la trasformazione degli oceani in putridi immondezzai, è stata messa da parte perché altrimenti Bonaccini perde le elezioni (scusa, ma chi è Bonaccini?). Certo Salvini gode ogni volta che un centinaio di africani annegano nel mar Mediterraneo, ma la legge che gli permetteva di giustiziare gli “invasori” l’aveva fatta il civilissimo Marco Minniti.
Dobbiamo concludere che i politici sono tutti bugiardi e mascalzoni? Può darsi che lo siano, ma il problema non è affatto questo. La loro volontà (e la nostra volontà democraticamente espressa) è come la danza della pioggia. La volontà umana conta soltanto quando non deve affrontare processi immensamente veloci, infinitamente complessi, e soprattutto disgraziatamente irreversibili. Come quelli che stanno provocando l’estinzione della civiltà (se non del genere umano). E la politica è l’espressione della volontà umana, che purtroppo oggi non possiede più alcuna potenza.
E allora che occorre fare? Naturalmente non lo so. Forse occorre raccogliersi in meditazione e prepararsi all’estinzione che in fondo non è altro che un evento naturale al quale nel tempo nessuna creatura può sfuggire. O forse inventare una tecnica di trasformazione del rapporto tra la sfera umana e l’universo circostante che non si fondi sulla volontà ma sulla coscienza.
Ma qua si apre un discorso difficile, che dobbiamo affrontare con calma, anche se l’ascensore precipita sempre più rapido verso l’inferno.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "Non ricominciamo la guerra di Troia": Simone Weil: la forza, la grazia (di Matteo Marchesini).5 dicembre 2019, di Federico La Sala
Simone Weil: la forza, la grazia
di Matteo Marchesini (Doppiozero, 23.10.2019)
«Non resta / che far torto, o patirlo», diceva l’Adelchi morente di Manzoni. Aggiungendo subito, a chiosa, che «Una feroce / forza il mondo possiede, e fa nomarsi / dritto». Il «mondo» rifiutato da Cristo è interamente sottoposto alle leggi della sopraffazione. Niente e nessuno ne è immune, e chi si illude di esserlo sta tirando una coperta ideologica sulla nuda realtà dei fatti. Il massimo che possiamo fare è sospendere a tratti il dominio di questa fisica bruta, trovare un geometrico equilibrio tra le forze e tenere ferme le tensioni contrarie in un’ascesi contemplativa. Non si può cancellare la ferocia che ci governa, solo esercitarsi ad arrestarne provvisoriamente l’azione. Ma la sua natura è così travolgente che anche per fare questo occorre un miracolo. Bisogna venire investiti dalla grazia. La forza, la grazia: sono i due poli intorno a cui ruotano i saggi più importanti di Simone Weil. Qualche mese fa, sotto il titolo Il libro del potere e con una nota di Mauro Bonazzi, Chiarelettere ne ha riuniti tre: L’Iliade o il poema della forza, Non ricominciamo la guerra di Troia, L’ispirazione occitana.
Succede spesso, negli ultimi anni, che editori più o meno piccoli ripropongano queste pagine scarne e perentorie composte subito prima e subito dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale; e non penso sia un caso. Da quando è sfumata la speranza diffusa in una palingenesi sociale (e non importa qui discutere la sua fondatezza, negata dalla Weil con argomenti decisivi), ci ritroviamo davanti a un puro potere che può mostrarsi senza pudori, ma al tempo stesso fingere che il suo ordine coincida con la giustizia. Siccome tutti, nessuno escluso, siamo condizionati dalle credenze che la vita comune infonde giorno per giorno in ognuno, questa pedagogia priva di alternative ci persuade col suo ghigno che al di là dell’esistente restano appena velleità, fantasmi, chiacchiere. Così, come sappiamo da mezzo secolo, meno sembra possibile una rivoluzione o un mutamento radicale, più la Storia si traveste da immodificabile Natura. E allora, chi alle leve del potere è più vicino si convince che se è in quella posizione non lo deve anche a un intreccio di combinazioni imperscrutabile, ma soltanto ad alcune caratteristiche eccezionali che lo distinguono, appunto per natura, da chi si trova in basso ed è schiacciato dalla sventura; la quale a sua volta, per usare le parole weiliane, apparirà non il frutto di una serie di casi e di fatalità mai del tutto riconducibili a progetti o a doti umane, bensì qualcosa di molto simile a una «vocazione innata». In una società che, non importa quanto fantasiosamente, ritiene possibile un altro mondo storico, chi in quello presente non riesce a integrarsi può essere considerato come un’avanguardia, una prefigurazione monca del futuro; in una società dove questa fiducia evapora è solo uno sfigato - termine in cui, significativamente, la sfortuna diventa una qualità negativa del soggetto che la subisce.
Vivere sottoposti al regno della forza implica prima di tutto rimuovere verità del genere. Se infatti questo regno è così potente, è anche perché in fasi storiche come la nostra accorrono a fornirgli giustificazioni ideologiche molte delle intelligenze migliori, più attendibili e più scrupolose; mentre a ricordare che esiste uno iato, sebbene quasi invisibile, tra le differenze di natura e le differenze imposte dal potere, rimangono o un pugno di acrobati della dialettica o una vasta platea di retori davvero velleitari, di chiacchieroni e utopisti da bar o da tastiera. Questo però, come sapevano qualche decennio fa a Francoforte, contrariamente a ciò che si crede non dice nulla sulla legittimità dell’esigenza che balena nella loro oratoria degradata, perché la sua apparenza ridicola e deforme è la veste nella quale sempre vengono imprigionate le istanze sconfitte. Quando la pressione della forza è enorme, chi in quel momento è portato in alto dalla sua onda può scegliersi l’avversario a sua immagine, e sconciarlo fino a farne un relitto kitsch o un involontario comico da sagra. Ma specularmente, intanto, le intelligenze impegnate a ripeterci i loro inesauribili “se è così c’è una ragione, sveglia!”, non possono non rivelare al fondo l’ingenuità propria di tutti i cinici, che si illudono di poter calcolare e controllare ciò che non si controlla e non si calcola: cioè la realtà, che per definizione coincide con l’imprevedibile, con l’inatteso, e che prima o poi li prende in contropiede (sotto il cuscino dei perdenti si scopre spesso una copia del Principe, diceva Brancati).
Capire perché le cose stanno come stanno è bene, e sfuggire a questa comprensione è segno di infantilismo; ma tessere l’apologia di ciò a cui va reso solo l’onore di riconoscergli che “è ciò che è”, trasformandolo in un “è perché deve essere”, asseconda un bisogno di rassicurazione altrettanto infantile. Chi vuole far tornare i conti con uno stridulo Gott mit uns dimentica quello che, secondo la Weil, il poeta dell’Iliade ha espresso nel modo più puro descrivendo la guerra, la situazione per eccellenza in cui il potere si mostra nella sua aperta crudeltà: ossia il fatto che nessuna diversità essenziale separa vincitori e vinti. La forza, anche quando li rende simili a tempeste in apparenza inarrestabili, non è mai un possesso dei guerrieri, ma una corrente che passa dal campo troiano a quello acheo, e viceversa, svilendo gli uomini a «cose» - fulmini gli uni, tronchi mozzati gli altri. E quando agli eroi capita la parte del tronco, della preda, «tremano» tutti, persino il grande Ettore. Eppure basta che la forza torni a sollevarli, ed ecco che la sua droga cancella dalla loro mente questo dato elementare. Allora si sentono di nuovo invulnerabili, oltrepassano il limite della tracotanza e sono punti dalla Nemesi - un concetto che, osserva la Weil, l’Occidente moderno non ha nemmeno più parole per esprimere.
Dunque lo sguardo omerico è supremamente equo perché non veste di ragioni ciò che non lo merita. Nel poema, l’efferatezza di chi sta vincendo una battaglia non è mai soffusa di una luce apologetica, e nel lamento disperato di chi soccombe non si vede mai il tratto distintivo di un «essere spregevole». Come poi la tragedia attica, e come la cultura occitana (provenzale, romanica, catara) spazzata via nel XIII secolo dalle crociate, l’Iliade ci mostra secondo la Weil una civiltà eccezionalmente consapevole del dominio della forza, e insieme indisponibile a identificare questo dominio con la giustizia. «Solo se si conosce l’imperio della forza e se si è capaci di non rispettarlo è possibile amare» ed essere giusti, conclude la pensatrice francese. Il contrario della forza è l’amore, che nei versi omerici avvolge tutto ciò che è vulnerabile e minacciato dall’annientamento. Ma accedere a questa forma di amore, come si è detto, richiede una capacità sovrumana: appunto perché il mondo umano appartiene alla forza, che quando ci innalza ci acceca, additandoci il miraggio di una realtà senza ostacoli e illudendoci di essere onnipotenti, mentre quando ci schiaccia giù a terra, in una servitù da cui sembra impossibile immaginare una liberazione, ci strappa la «vita interiore» e cancella in noi ogni sentimento.
In questi saggi la Weil si sofferma anche su un altro punto cruciale, che riguarda proprio la copertura ideologica dei rapporti di forza. Siccome il potere si posa sull’uno o sull’altro uomo con un’ampia dose di arbitrio, rendendo radicalmente diversi i destini di individui radicalmente simili, chi vuole mantenerlo senza suscitare rivolte deve saper occultare questo arbitrio e razionalizzarlo. È così che intorno alla forza, fingendosi sua causa, si diffonde l’aura illusoria del «prestigio», che gli uomini scambiano per qualità innata mentre è l’effetto di un contesto determinato, di un provvisorio gioco di luci i cui riflessi tendono però a moltiplicarsi illimitatamente. Qui forse non è inutile ricordare la nazionalità di Simone Weil, dato che la Francia è stata nel mondo moderno il paese più socializzato, quello dove i fantasmi impalpabili ma pervasivi delle identità pubbliche sono penetrati in ogni spiffero dell’esistenza. Né è certo un caso che sia stato un altro francese, pochi anni prima di lei, a eternare letterariamente questi fantasmi nella mappa più ramificata e ricca d’implicazioni che ci sia mai stata fornita. «Solo chi è incapace di scomporre, nella percezione, ciò che a prima vista sembra indivisibile, crede che la situazione faccia corpo con la persona», ha scritto Marcel Proust, che attraverso i molti strati della sua Recherche avvicina all’esperienza quotidiana le essenze platoniche weiliane.
L’analisi dello snobismo, cioè, secondo il critico americano Lionel Trilling, dell’«orgoglio a disagio» di chi non è mai sicuro della propria identità, è appunto l’analisi degli equivoci creati dal «prestigio». In un universo come quello borghese, dove non esistono più ruoli fissi e garantiti da ordini aristocratici o da fedi soprannaturali, questa precarietà è fisiologica; e il romanzo, col suo dinamismo, è nato per rappresentarla. Ma di solito i romanzieri, anche i più estremisti, portano gli equivoci a uno scioglimento: o sotto la loro superficie abbagliante si rivela una certezza solida, inconfutabile, oppure questa superficie diventa il segno di una metafisica, arcana indecifrabilità, cioè in fondo di un’altra certezza, seppure di segno negativo. Proust, invece, dimostra che l’equivoco è la sostanza stessa, la stoffa onirica e fantastica di cui è fatta la pretesa identità di ognuno: una sagoma destinata inevitabilmente a variare a seconda delle luci che il luogo, ma soprattutto il tempo, l’immaginazione e i sentimenti personali o collettivi le proiettano sopra. L’ambiguità, in questo senso, è senza fine. La magia dei nomi trasfigura di continuo la materia, e la materia fa cadere a un tratto il sipario di una convenzione, di una magia effimera. La gelosia stabilisce ragnatele finissime, e non si sa mai se abbia occhi straordinariamente acuti o se straveda. Ogni gesto, ogni parola, ogni episodio racchiudono un gomitolo di equivoci che si intrecciano e si divaricano nel tempo. Volgarità e finezza, bontà e perfidia, onorabilità e impresentabilità, prosaicità e fascino esclusivo, provincialismo grottesco e talento supremo, filisteismo e regalità si scambiano ovunque le parti, e toccano tutti i principali caratteri di questo romanzo di romanzi: Saint-Loup, i Verdurin, Morel, Charlus, Swann, i Guermantes, Rachel, Odette, Bergotte, Albertine, Vinteuil, Cottard, Elstir... e ovviamente il narratore.
Col prestigio, col potere e con i ruoli di vittime e carnefici, questi personaggi cambiano la loro stessa pelle. Ma se è così, non hanno ragione i lodatori di ciò che appare, di ciò che è in quanto s’impone? Non basta, per approvarli senza riserve, imprimere un po’ di mobilità eraclitea al loro troppo statico sistema panglossiano, al loro hegelismo mummificato e andato a male? Quale identità nuda o profonda ci resterebbe in mano da difendere, al di là delle mutevoli maschere sociali? Esiste forse là dietro un volto, un noumeno che non sia un’astratta, umanistica petizione di principio? Difficile crederci: soprattutto oggi che siamo tutti più socializzati dei vecchi francesi, essendo social e tendendo a una assai più totalitaria indistinzione di intimità e pubblicità.
 In quel vorticoso primo Novecento, tra Proust e Weil, un altro francese ha messo in bocca a un suo personaggio teatrale una risposta disinvoltamente contraddittoria. «Non state confondendo la gloria e l’amore? Amereste Giocasta se non regnasse?», chiede Tiresia a Edipo nella Macchina infernale di Cocteau. «Domanda stupida e ripetuta mille volte», ribatte il marito e figlio della regina di Tebe. «Giocasta mi amerebbe se fossi vecchio, brutto, se non sbucassi dall’ignoto? Credete che non ci si possa buscare il mal d’amore toccando l’oro e la porpora?». Ma poi aggiunge che «I privilegi di cui parlate non sono la sostanza stessa di Giocasta e aggrovigliati così strettamente ai suoi organi da non poterli disunire». La scena è interessante anche perché qui, come altrimenti in Proust, la politica, cioè il campo per eccellenza del potere, fa tutt’uno con l’amore.
In quel vorticoso primo Novecento, tra Proust e Weil, un altro francese ha messo in bocca a un suo personaggio teatrale una risposta disinvoltamente contraddittoria. «Non state confondendo la gloria e l’amore? Amereste Giocasta se non regnasse?», chiede Tiresia a Edipo nella Macchina infernale di Cocteau. «Domanda stupida e ripetuta mille volte», ribatte il marito e figlio della regina di Tebe. «Giocasta mi amerebbe se fossi vecchio, brutto, se non sbucassi dall’ignoto? Credete che non ci si possa buscare il mal d’amore toccando l’oro e la porpora?». Ma poi aggiunge che «I privilegi di cui parlate non sono la sostanza stessa di Giocasta e aggrovigliati così strettamente ai suoi organi da non poterli disunire». La scena è interessante anche perché qui, come altrimenti in Proust, la politica, cioè il campo per eccellenza del potere, fa tutt’uno con l’amore.Ma non è, s’intende, l’amore soprannaturale che per la Weil sta sull’altro piatto della bilancia rispetto alla forza. Eppure anche di questo amore è fatto l’amore umano. Chi, che cosa amiamo dunque davvero? È il nostro amore separabile dal prestigio? All’alba della modernità, in una Russia infranciosata, il romantico e ironico Aleksandr Puškin ha lasciato nell’Onegin una immagine memorabile della divaricazione tra società e verità su cui è fiorita la nostra cultura. «In quel tempo, in quel deserto, / Lontano dal pettegolezzo, / Io non vi piacqui: questo è certo... / E dunque mi inseguite adesso? / Che cosa a voi mi pone in vista? / Non forse il fatto ch’io apparisca / Per il mio rango in società; / L’esser di ricca nobiltà; / O il marito che in guerra è stato / Ferito e alla corte è in favore? / Non forse che il mio disonore / Da tutti sarebbe osservato, / A voi nel bel mondo recando / Un lusinghevole vanto?», domanda malinconicamente Tatiana a Eugenio verso la fine del poema, dopo che lui l’ha prima tenuta affettuosamente a distanza, moderando il suo dongiovannismo, quando era una semplice ragazza di campagna, e poi l’ha ardentemente corteggiata quando l’ha vista muoversi da dama impeccabile tra i ricevimenti pietroburghesi.
Non so chi potrebbe rispondere alla domanda di Tatiana. Quanto è grande, specie in un mondo più che mai socializzato, la dose di desiderio mimetico che ci entra in circolo? Quanto influisce sui nostri atti il prestigio, questo vestito imperiale della forza? Se esistessero confini visibili o palpabili tra un’essenza e un’apparenza, combattere sotto l’insegna di una delle due riuscirebbe relativamente facile. Sarebbe lecito pensare a una lotta di princìpi, confidare in un mutamento progressivo che a poco a poco conduca a esiliare dal mondo la forza magnetica e menzognera del prestigio contrabbandato per cosa salda. Invece il mondo è strutturalmente suo. Perciò una tale etica è ritenuta insufficiente dalla platonica Simone Weil, e contemporaneamente anche dalla sensuale Etty Hillesum. Solo il riconoscimento di questa realtà, la sua accettazione senza risarcimenti e la contemplazione della forza possono sospenderla, tenere in miracoloso equilibrio la bilancia.
E sì: noi siamo anche i nostri privilegi, gli ori e le porpore di cui non potremmo mai dire, senza apparire tracotanti di fronte al fato, di esserceli guadagnati da soli. Eppure, c’è chi alle origini della nostra civiltà ci ha mostrato uomini spogliati di tutto ciò: uomini ridotti a cose passive, resi schiavi o annientati da uomini ridotti a cose ciecamente attive come catastrofi naturali. Chi amerà questi nudi? Chi rimarrà vicino a un corpo, a una voce, a un volto totalmente privati di prestigio e di potere? Chi sopporterà di stringere esseri che basta un soffio a cancellare dalla scena, e che non sembrano avere più alcuna dignità umana? Noi tendiamo a immaginare la sventura in chiave eroico-hollywoodiana, a incastonarla in una sequenza in cui lo sconfitto mantiene intatto il suo fascino, la sua forma socializzabile di uomo. Ma proviamo a immaginare invece la vera sventura, cioè una condizione in cui tutte le nostre coordinate vacillano come nel Vangelo vacillarono i discepoli durante la Passione. Immaginiamo una situazione dove ogni circostanza sembra dare ragione al mondo che umilia lo sventurato. Immaginiamo il momento in cui la sventura arriva a toccare l’ultimo strato dell’identità della persona che diciamo di amare - il momento in cui, senza che questa persona si sia inconfutabilmente macchiata di una colpa, le sue attrattive si mutano in un motivo di imbarazzo, di smarrimento o di nausea, in una specie di vergogna senza nome. Immaginiamo tutto questo, e la domanda ci farà tremare.
Forse di una tale figura nuda, senza protezioni sociali e senza neppure il marchio di una minoranza esclusa ma riconosciuta, non si può predicare nulla. Forse si può dire solo che l’uomo è più di tutto il suo prestigio, di tutte le qualità in cui i «privilegi» si mescolano ambiguamente agli «organi». Ma questo più non si può descrivere. Come l’anima, si può cogliere solo con un atto di fede. E proprio dalla fessura che lascia tra sé e il resto passa la grazia. È da lì che soffia l’amore trascendente, incondizionato, assoluto: l’amore senza il quale, diceva Denis De Rougemont occupandosi dei provenzali negli anni della Weil e in modi per molti versi opposti, siamo destinati a cadere in un romanticismo calcolatore che non troverà mai un oggetto su cui fermarsi, perché ci sarà sempre qualcosa di più attraente a meritare l’innamoramento.
Solo una decisione mai giustificabile, che è poi il contrario di una facoltà d’opzione, può arrestare questa fuga nell’illimitato. Un decennio prima, montando le tessere del suo discorso sulle Affinità elettive e il matrimonio, Walter Benjamin lasciava intravedere una prospettiva molto simile.
Credo che il saggio della Weil sull’Iliade sia uno dei due massimi capolavori della saggistica filosofica del Novecento. L’altro, non unilaterale e spoglio ma tormentosamente dialettico, va sotto il titolo di Minima moralia. Negli aforismi della raccolta adorniana si trova una frase che può stare accanto alla conclusione weiliana: «Sei amato solo dove puoi mostrarti debole senza provocare in risposta la forza». Il mondo, però, ci consegna un’ingiustizia ulteriore. Di solito si aderisce alla forza là dove la pressione collettiva è troppo intensa rispetto alle convinzioni che potrebbero farci resistere alla sua piena: cioè quando a propria volta, come carnefici, ci si trova in una condizione di debolezza, quando non si è abbastanza sicuri della propria comprensione delle cose da poter rimanere saldi in mezzo alla tempesta insieme a chi è rimasto nudo (la pressione consiste spesso in un sottile gioco di suggestioni atmosferiche incrociate, ma chi voglia vederne rappresentati i tratti più elementari e irresistibili può pensare al Bube di Cassola spinto a picchiare il prete Ciolfi, o al giovane ufficiale Eric Blair, alias George Orwell, accerchiato dalla folla birmana che esige di vederlo abbattere un elefante). Non è questa l’ultima ragione per cui il mondo ci chiude la bocca impedendoci di dire a ogni passo “non è giusto”, e quasi assimilando il nostro comportamento a un fatto di natura. Ma appunto, quasi. Resta quella fessura. Di cui nessuno si può appropriare senza tradirla, ma che nessuna forza può ridurre a sé.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- NON PRENDIAMOCI IN GIRO: VENEZIA. Onda di marea (di Paolo Cacciari)15 novembre 2019, di Federico La Sala
Onda di marea
di Paolo Cacciari (Comune-info, 14 Novembre 2019)
- Il punto più profondo dell’Alto Adriatico si trova nella laguna di Venezia. È una fossa profonda 50 metri creata a causa dell’erosione dei fondali provocata dalla creazione del “canale dei petroli” per fare entrare le navi commerciali sempre più grandi. Quel primato aiuta a capire come la distruzione della laguna venga da lontano, spiega Paolo Cacciari, da scelte economiche che continuano anche ora che i cambiamenti climatici rendono tutto più complicato.
- In nome del profitto si è ristretta la laguna e si sono approfonditi i canali marittimi che regolano i flussi innescando l’erosione dei fondali: per questo non c’è più la lenta crescita dell”acqua alta” ma fiumi in piena. E ora? Il Mose era sbagliato anche prima di diventare un’opera corruttiva: servono la creazione di un parco nazionale naturale, l’immediata fuoriuscita delle navi dalla laguna, la bonifica di Porto Marghera
Non prendiamoci in giro. Il riscaldamento climatico globale è un flagello epocale, ma non usiamolo come paravento per coprire una storia che ha ben determinate responsabilità locali. La distruzione della laguna di Venezia - e quindi della città insulare storica che con la laguna vive in simbiosi - viene da lontano e deriva da precise scelte di politiche economiche e di pianificazione territoriale che continuano imperterrite. L’aumento delle numero e della forza delle maree è provocato solo in parte dall’eustatismo (aumento del livello medio del mare). Il resto è tutta opera nostra!
La laguna ha una superficie di 550 chilometri quadrati. È uno straordinario ecosistema formato da bassi fondali (barene, velme, ghebi, valli ecc.) che reggono, avvolgono e proteggono le isole edificate dagli eventi marini esterni. Le colossali opere idrauliche costruite nei secoli dalla Repubblica di Venezia (deviazione dei fiumi a monte e “murazzi” a mare) hanno sempre seguito questo criterio: non esporre Venezia alle mareggiate ed evitare gli interramenti.
Con l’avvento dell’era industriale e il prevalere degli interessi portuali, che dura fino ai nostri giorni con il business della crocieristica, si è fatto esattamente il contrario: si è ristretta la laguna e si sono approfonditi i canali marittimi che regolano i flussi mare/laguna innescando una erosione dei fondali (mezzo milione di metri cubi di sedimenti all’anno) che ha trasformato la laguna in un braccio di mare. Il punto più profondo dell’Alto Adriatico lo si trova in laguna, al Faro Rocchetta: una fossa profonda più di cinquanta metri in cui si pescano ostriche!
Le conseguenze le abbiamo viste anche nella drammatica notte tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre. Non siamo più in presenza di “acqua alta” (che cresce lentamente), ma di una violenta onda di marea. L’acqua sospinta dal vento di scirocco non trova più ostacoli lungo il suo percorso (bassi fondali e terre emerse) in entrata in laguna attraverso le tre bocche di porto (Lido, Malamocco e Chioggia) e diventa un fiume in piena che si infrange sulle fragili rive, sulle fondamenta e delle fondazioni della città.
Il Mose era sbagliato anche prima di diventare un’opera corruttiva (e proprio per questo motivo aveva bisogno di corrompere gli organi tecnici e politici dello stato). La scelta progettuale derivava dal fatto di non disturbare gli interessi dei traffici marittimi e di consentire a navi sempre di grandi di entrare in laguna.
Gli ambientalisti lo dicono da sempre: la prima opera di “adattamento” volta ad aumentare la “resilienza” dell’ecosistema veneziano dovrebbe essere il piano morfologico di rinaturalizzazione della Laguna di Venezia, la creazione di un parco nazionale naturale (che il sindaco Luigi Brugnaro ha abrogato), la immediata fuoriuscita delle navi dalla laguna, la bonifica di Porto Marghera.
Ciò che sta accadendo a Venezia
Tutto questo era evitabile,Fridays for future Venezia
Sul Mose torna una marea di bugie, Armando Danella
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- La lotta dei giovani: "Clima, il mondo può cambiare" (di Aldo Masullo).11 novembre 2019, di Federico La Sala
Napoli, la lotta dei giovani: "Clima, il mondo può cambiare"
Le riflessioni del grande filosofo Aldo Masullo: "La reazione dei ragazzi non è puerilmente emotiva, semplice paura, ma razionale, meditata decisione di lotta"
di ALDO MASULLO (La Repubblica/Napoli, 10 novembre 2019)
Hannah Arendt durante la bufera nazista descrisse la vita del profugo senza né lavoro, né casa, né parenti, soprattutto senza diritti. Più tardi rivendicò con forza «il diritto di avere diritti». Nella seconda metà del Novecento il coro internazionale proclamò più volte solennemente i diritti dell’uomo. Il che vuol dire l’universale condanna della loro violazione. Non v’è “ragione di Stato” che tenga, nessuno per nessuna ragione ha diritto di violare i diritti dell’uomo.
Con qual diritto dunque sempre di nuovo si gettano sulle disperate strade della fuga, esposte alla sofferenza e alla morte, tra il grandinare delle bombe e il crepitio delle mitragliatrici, moltitudini di persone magari già duramente provate dalle atrocità di qualche anno prima?
Con quale diritto pacifiche popolazioni vengono strappate alle propria civile sicurezza per un incerto destino di profughi? Con qual diritto soprattutto si strappano il vecchio al suo letto abituale, il ragazzo alla sua scuola, lo studioso alla sua biblioteca, la donna al suo ordine domestico, l’ uomo e la donna al lavoro, gettati tutti nella polvere dell’estrema miseria, ognuno dall’umiliazione strappato a se stesso?
Nella lunga storia umana fatti come questi, e anche peggiori, molte volte sono accaduti. Ma non ancora erano stati solennemente proclamati i diritti e sancito il sacrosanto diritto di avere diritti. Sempre nel mondo è serpeggiata la violenza dell’uomo sull’uomo. Ma nell’età moderna, nell’età dei diritti dell’uomo, la violenza stessa ha assunto il governo del mondo.
Mi spiego. Nel secolo XVII muove i suoi primi passi la “nuova scienza”, che interroga la natura attraverso la verifica sperimentale delle sue risposte. Si tratta di un cammino conoscitivo che da Galilei in poi non si è più fermato. I risultati della scienza sperimentale non sono soltanto pure conoscenze, gratuita ricchezza dell’intelletto, ma anche, anzi soprattutto, applicazioni pratiche sempre più rilevanti per la vita dell’uomo. Così all’antica tecnica, che consentì agli Egizi di costruire le Piramidi e ai Romani di mettere in opera gl’imponenti acquedotti, ne succede una nuova, sempre più complessa e raffinata. Con essa s’instaura un crescente potere dell’uomo sulla natura, in genere al servizio dell’uomo, ma spesso anche un diseguale potere di alcuni uomini su molti altri. Cresce smisuratamente la competitività tra gl’individui e tra gli Stati e si sviluppano formidabili mezzi di distruzione di massa.
Innegabilmente la tecnica ha consentito la nascita di un modo nuovo di produzione, grazie alle macchine mosse non più dalla limitata forza muscolare ma dall’illimitata potenza di motori alimentati da energie fisiche. All’inizio tali macchine sono manovrate da masse di lavoratori poco istruiti e malpagati, di cui via via, sempre grazie agli avanzamenti tecnici, si riduce il bisogno. La nuova forma di produzione arricchisce i produttori, che però hanno ogni volta bisogno di denaro fresco per rilanciare il ciclo e ricorrono perciò al credito.
Ogni anello della spirale ascensionale della modernità gioca dunque su due inseparabili poli: l’estensione tecnica della scienza e l’investimento finanziario, insomma la coppia tecnica-capitale. Il mondo moderno è essenzialmente il mondo del capitale, non importa se in mani private o pubbliche.
Tecnica e capitale sono stretti nel dinamismo di un circolo, in cui ognuno dei due fattori impone incessantemente all’altro di crescere. Intanto, senza più vincoli interiori di alcun genere, aumenta smisuratamente quell’ “amor proprio”, quella frenesia competitiva che, nel bel mezzo del secolo XVIII, J.J. Rousseau denunciava come il male devastante della vita sociale.
Ora, se ogni individuo o ogni gruppo vede nell’altro un avversario da battere e magari perfino un nemico da sopprimere, a cosa può tra l’altro spingere il dinamismo del circolo tecnica-capitale, se non alla produzione di armi, sempre più sofisticate e potenti, per primeggiare a tutti i costi nella guerra continua, guerreggiata e non, che accompagna inesorabilmente la modernità?
Così la tecnica nella inarrestabilità del suo sviluppo chiede al capitale sempre maggiori investimenti, e il capitale nel suo insopprimibile impulso alla crescita pretende dalla tecnica sempre nuovi strumenti di produzione e di offesa. Il mondo moderno così è sempre più stretto in una inesorabile tenaglia. Mentre nell’antico un re non sempre era costretto dalle circostanze a prendere certe decisioni, nella modernità invece non v’è alcuna scelta politica che non sia condizionata direttamente o indirettamente dall’insieme delle forze coinvolte nella dinamica complessiva del mondo, cioè del duopolio tecnica-capitale.
Se il capitalismo apprezza la tecnica solo come potenziamento della produzione e del profitto, inevitabilmente tutti i soggetti, individui e gruppi, che ne condividono il modo, ognuno inteso perciò al potenziamento della sua produzione e all’incremento del suo profitto, sono ciecamente competitivi, fino alla guerra.
Chi scatena la guerra non si cura affatto dei suoi “effetti collaterali”, cioè delle distruzioni delle città e soprattutto degl’innumerevoli innocenti coinvolti. Che importa, se le migrazioni forzate delle popolazioni colpite minacciano di stravolgere la vita d’interi continenti?
Nessun sentimento può fermare la strutturale violenza, che governa oggi il mondo, la diabolica combinazione di sviluppo tecnico e di cupidigia economica e che inesorabilmente la porta verso una finale catastrofe. Certamente non possono fermarla né le condanne morali né l’appello alla comune salvezza.
Negli ultimi tempi però proprio la scienza e le sue tecniche sembrano offrire un’impensata occasione di salvezza. Un drammatico allarme echeggia in ogni angolo. Gli scienziati avvertono che, se l’aumento della temperatura media globale continua con l’attuale ritmo, si scateneranno processi naturali irreversibili, come già mostra lo scioglimento dei ghiacciai. A quel punto nessun intervento umano sarà più possibile. È dunque necessario agire subito. Le emissioni di C02 entro il 2030 vanno dimezzate e nel 2050 dovranno essere azzerate. Gli enormi interessi consolidati tendono a ignorare o svalutare le notizie ostili, tutto dunque finirebbe con qualche comunicato scientifico che nessuno legge. Ma qui entrano in campo i giovanissimi, coloro che più, anzi quasi tutto, hanno da perdere dal disastro climatico globale.
A Napoli come in altre città italiane ci sono già stati cortei e manifestazioni. La reazione dei ragazzi non è puerilmente emotiva, semplice paura, ma razionale, meditata decisione di lotta. Se essi vincono, il mondo si salva ma non sarà più lo stesso. Innanzitutto sarà spezzato il vecchio legame di capitale e tecnica. Saremo usciti dalla modernità. Allora forse i diritti dell’uomo saranno rispettati.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Ognuno riconosce i suoi. Poesia, politica, società (di Guido Mazzoni).29 ottobre 2019, di Federico La Sala
LETTERATURA, FILOLOGIA, E POESIA DELLA CAVERNA. Ognuno riconosce i suoi...
- "[...] Ma che cos’è la lirica? Storicamente il termine ha due significati. Nella poetica greca e latina, è lirica la poesia cantata al suono della lira e, per estensione, degli strumenti a corda; poi, quando il rapporto con la musica si perde, il termine finisce per designare il genere lirico per eccellenza, l’ode, il suo elemento caratteristico, il pathos di stile alto. La seconda accezione emerge a metà del Cinquecento, quando la categoria estende il proprio spettro semantico e viene usata per designare una delle tre grandi forme (l’epica, il dramma e la lirica) in cui viene diviso lo spazio testuale che all’epoca si chiamava ancora ‘poesia’, come nella cultura greca e latina, e che, a partire dalla seconda metà del Settecento, si sarebbe chiamato ‘letteratura’. La tripartizione nasce in Italia e si estende alle altre culture europee, ma diventa egemone solo col Romanticismo. In questa accezione è lirico qualunque testo in versi, o in prosa poetica, che parli di argomenti personali in uno stile che vuole essere personale, cioè distante dal grado zero della comunicazione ordinaria [...]";
- Il compito della letteratura non è educare: è dire la verità. Educazione e verità sono attività opposte: la prima occulta le pulsioni che dobbiamo nascondere perché ci sia civiltà e società, la seconda le rivela. Per me è sempre vero, ma lo è soprattutto quando si parla della poesia moderna. In questa forma simbolica c’è qualcosa di profondamente antisociale - per due ragioni: perché il genere divide il singolo dal senso comune e perché favorisce la divisone del mondo in mondi. La «protesta della soggettività che risuona nella lirica» non si rivolge contro la società reificata, come dice Adorno; la protesta della poesia moderna, lirica e non-lirica, si rivolge contro la società in generale: contro le menzogne che ci diciamo per vivere insieme fra estranei ripetendo parole che non ci appartengono davvero, contro il disagio della civiltà.
- Detto in modo frontale e senza aloni: si rivolge contro la società alienata nella misura in cui ogni società, dal punto di vista dell’io, implica qualcosa di alieno: una limitazione della soggettività, un’uscita da sé. La poesia moderna è il luogo di un conflitto radicale fra la parte e il tutto: lascia parlare l’inappartenenza, il desiderio di non usare le parole della tribù. -***L’universale che la poesia moderna cerca di cogliere attraverso un’individuazione senza riserve ha un valore utopico solo per chi accetta la metafisica e la metapolitica di Adorno, perché in sé la poesia moderna esprime solo la volontà della parte di ottenere un riconoscimento senza dover uscire da sé, senza mediare. D’altra parte la letteratura rimane un atto di comunicazione; i suoi gesti di rottura, come le scenate dei temperamenti melodrammatici, non vanno presi alla lettera.
- Alla fine la poesia rinuncia alle parole della tribù ma si rifugia nelle parole di un piccolo clan. La anima il desiderio di parlare a chi condivide certi presupposti, il desiderio di stare con chi ci assomiglia. Ciò che Montale scrive in uno dei suoi emistichi più belli e terribili è per la poesia moderna vero alla lettera: ognuno riconosce i suoi" (cfr. Guido Mazzoni, "Ognuno riconosce i suoi. Poesia, politica, società", "Le parole e le cose", 28.10.2019).
APPUNTI SUL TEMA. Con "Ulisse" - al di là della "dialettica dell’illuminismo" e della "dialettica della liberazione", per una "seconda rivoluzione copernicana" (T. W. Adorno)! Si cfr.:
 "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE;
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE;
 CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico;
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico;
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica;
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica;
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 - E DELL ’89.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 - E DELL ’89.Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- UMBRIA. Dice Bruce Springsteen: “Che ne è di un sogno che non si avvera? Diventa una bugia, una maledizione - o qualcosa di peggio?” Appunto (di Alessandro Portelli).30 ottobre 2019, di Federico La Sala
Commenti
Dalle lotte operaie fallite alla folla solitaria di Terni
Umbria. Non sarà un caso se quindici anni di lotte cominciate con l’epico sciopero generale del 2004 in questa città storicamente rossa si concludono con la destra al 57% e la Lega vicina al 40% e la fabbrica sempre più ridimensionata e isolata
di Alessandro Portelli (il manifesto, 30.10.2019)
Nel 1970, nel pieno del movimento di lotta per la casa, intervistai un operaio che aveva fatto almeno cinque occupazioni, e ogni volta che lo avevano cacciato era tornato insieme agli altri a occupare. Una storia di dignità, combattività, coscienza. Poi, a microfono spento, aggiunse: ho una figlia brava a scuola ma non ho i mezzi per farla studiare; conosci qualcuno per farla entrare in un collegio o qualcosa del genere?
Non conoscevo nessuno che potesse aiutarlo, non potevo fare niente per loro, e non so se poi lui ha auto la casa e lei un diploma. Ma questa storia non ha smesso di tornarmi in mente e di farmi capire qualche cosa dell’abisso in cui siamo precipitati. Per farla breve: per migliorare la propria vita e quella dei suoi cari, l’operaio con cui parlavo stava, per così dire, puntando su due ruote.
Da un lato, la lotta collettiva, la solidarietà, il cambiamento dei rapporti di potere. Dall’altro, la soluzione individuale attraverso il più simbolico degli strumenti della subalternità e della dipendenza dai potenti, la raccomandazione. Se non ce la faceva insieme con tutti gli altri, non restava che provare a farcela da solo. Saltiamo di mezzo secolo, a Terni, Umbria, 2014. Un durissimo sciopero di tre mesi contro i licenziamenti alle acciaierie ThyssenKrupp si risolve infine quando quattrocento operai, uno per uno, accettano di dimettersi “volontariamente” in cambio di una buonuscita di qualche decina di migliaia di euro. Molti lo fanno con sofferenza (lo racconta un bellissimo romanzo, Inox, di Eugenio Rampi, ex operaio TK), ma hanno la convinzione di non avere scelta. Hanno preso parte alla lotta collettiva, non ce l’hanno fatta, non ci credono più - non per ideologia, credo, ma perché troppe volte è andata male.
Non sarà un caso se quindici anni di lotte cominciate con l’epico sciopero generale del 2004 in questa città storicamente rossa si concludono con la destra al 57% e la Lega vicina al 40% e la fabbrica sempre più ridimensionata e isolata. Devono cavarsela da soli.
La filmmaker ternana Greca Campus ha intitolato un film su queste vicende Lotta senza classe. Qui sta il punto. Da un lato, i rapporti di potere: da almeno due o tre generazioni, le lotte collettive non la spuntano contro il potere invisibile e ferreo del capitale finanziario e della globalizzazione, e le trasformazioni nel modo di produzione sottraggono le basi materiali dell’identità di classe. Dall’altro, l’offensiva ideologica: la classe non esiste, l’unica solidarietà è la beneficenza, non esiste la società ma solo gli individui (Mrs. Thatcher), bisogna farsi “imprenditori di se stessi” come dicevano negli anni’80, il “merito” individuale è la sola misura dell’umanità, la classe retrocede a folla.
E’ la lezione che ripete ancora il liberalismo clintoniano e renziano e che culmina con “uno vale uno” dei cinque stelle (con la patetica parodia Pd del “tu vali tu”).
E’ diventato senso comune, peraltro falso e bugiardo, perché in una società sempre più diseguale è sempre meno vero che uno è uguale a uno. Uno significa semplicemente sei solo, siamo davvero una folla solitaria, in cui sono molto flebili e sempre meno convinte le voci che provano a ricordarci che noi insieme valiamo più della somma dei nostri uno.
Un tempo lo sapevamo. C’è un episodio epico nella storia di Terni, la grande rivolta popolare del 1953 contro i tremila licenziamenti alle acciaierie. A quel tempo, una canzone del poeta operaio Dante Bartolini trasformava la lotta difensiva in una speranza di futuro: “Non è lontana la grande vittoria”, cantava: “lavoratori avanti così”. Già nel 2004 mi accorgevo che le forme della lotta erano le stesse, a volte anche più dure, ma la visione del futuro era scomparsa, la nuova generazione operaia non lottava per liberarsi e andare avanti ma per non andare indietro e non affondare.
Delle due alternative su cui puntava il mio compagno operaio romano, ne resta a portata di mano una sola. Perciò mi addolora ma non mi sorprende vedere che, scomparsa la speranza di liberarsi tutti insieme, chi ha paura di affondare si abbandona subalterno all’affido ai potenti e indirizza le proprie frustrazioni verso capri espiatori alternativi.
Il sogno del sol dell’avvenire è dissolto e insozzato e non siamo stati capaci di sognarne un altro. Dice Bruce Springsteen: “Che ne è di un sogno che non si avvera? Diventa una bugia, una maledizione - o qualcosa di peggio?” Appunto.
-
> PER LA PACE PERPETUA -- «La Terra brucia e non possiamo spegnere l’incendio con una pistola ad acqua. Dobbiamo agire in fretta con un piano globale, radicale. Già i prossimi undici anni saranno decisivi» (Naomi Klein).2 ottobre 2019, di Federico La Sala
La terra brucia - intervista con Naomi Klein
di Alessia Rastelli (Corriere della Sera, "La Lettura" 15.09.2019)
- Il 19 settembre uscirà per Feltrinelli Il mondo in fiamme. Contro il capitalismo per salvare il clima l’ultimo libro di Naomi Klein.
- «La Terra brucia e non possiamo spegnere l’incendio con una pistola ad acqua. Dobbiamo agire in fretta con un piano globale, radicale. Già i prossimi undici anni saranno decisivi». Naomi Klein, l’attivista canadese che nel 2000 scrisse No Logo - il saggio nel quale denunciava lo strapotere delle multinazionali, divenuto manifesto del movimento no global - è impegnata da almeno un quindicennio a combattere la crisi ambientale e a sostenere la sua correlazione con il sistema economico.
 A «la Lettura» parla in occasione dell’uscita del nuovo libro, Il mondo in fiamme. Contro il capitalismo per salvare il clima (Feltrinelli). Per spegnere l’incendio, scrive, è necessaria «una guerra a tutto campo», non solo all’inquinamento ma anche «alla povertà e al razzismo e al colonialismo e alla disperazione, tutto d’un colpo». Un Green New Deal, un piano verde che smantelli «un sistema economico basato sul consumo illimitato e sullo sfruttamento di individui e natura», contando sulla spinta dei movimenti dal basso e di una nuova generazione di politici.
A «la Lettura» parla in occasione dell’uscita del nuovo libro, Il mondo in fiamme. Contro il capitalismo per salvare il clima (Feltrinelli). Per spegnere l’incendio, scrive, è necessaria «una guerra a tutto campo», non solo all’inquinamento ma anche «alla povertà e al razzismo e al colonialismo e alla disperazione, tutto d’un colpo». Un Green New Deal, un piano verde che smantelli «un sistema economico basato sul consumo illimitato e sullo sfruttamento di individui e natura», contando sulla spinta dei movimenti dal basso e di una nuova generazione di politici.
Perché i prossimi undici anni saranno già determinanti?
«Non lo dico io ma un rapporto del 2018 del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’Onu, l’Ipcc. Il 2030 è l’anno limite per tagliare la metà delle emissioni mondiali, poi si dovrà eliminarle del tutto entro il 2050. Solo così possiamo sperare di mantenere l’aumento del riscaldamento globale rispetto all’era pre-industriale sotto gli 1,5 °C. Abbiamo già riscaldato la Terra di un grado e questo ha portato l’Amazzonia al punto di non ritorno, ha provocato lo scioglimento dei ghiacci dell’Artico e la morte della Grande barriera corallina, un cimitero subacqueo. Il pianeta è al collasso. Non possiamo andare oltre».
Come spiega allora l’atteggiamento negazionista di alcuni leader come Donald Trump e Jair Bolsonaro?
«Penso che in realtà credano nella scienza. Ma che si sentano al sicuro: confidano che il denaro li tutelerà dal cambiamento climatico. Inoltre sono imbevuti di una visione del mondo nella quale potere e ricchezza, soprattutto maschili, controllano il pianeta e la maggior parte dei suoi abitanti. La battaglia per il pianeta richiede un enorme investimento nella sfera pubblica e il divieto per le aziende di fare ciò che vogliono, che si tratti delle società di combustibili fossili a Houston, in Texas, o degli allevatori di bestiame in Brasile. Gruppi ai quali, invece, i due presidenti hanno fatto promesse. Ecco perché licenziano gli studiosi e chiudono i dipartimenti dedicati alla crisi ambientale: la lotta per la Terra non può coesistere con la loro visione del mondo. Ancora più inquietante è vedere leader progressisti che predicano l’ambientalismo e agiscono al contrario».
A chi si riferisce?
«Emmanuel Macron in Francia e il premier canadese Justin Trudeau, ad esempio, hanno criticato Bolsonaro sull’Amazzonia ma ricoprono di sovvenzioni i giganti degli idrocarburi. Il problema è che la crisi climatica pone una profonda sfida al progetto economico neoliberista. Così come al culto del “centrismo”, incarnato da Trudeau e da molti leader europei ed esponenti democratici americani. “Siamo la via di mezzo tra gli estremismi, non facciamo nulla di troppo veloce e radicale”, rassicurano. Ma di fronte all’emergenza la risposta deve essere radicale. In linea, piuttosto, con il Green New Deal proposto negli Stati Uniti da Bernie Sanders, tra i candidati democratici alle primarie: investimenti per oltre 16 mila miliardi di dollari che servirebbero tra l’altro per le energie rinnovabili e per trasformare l’agricoltura, creando anche nuovi posti di lavoro».
In che cosa consiste esattamente il Green New Deal che lei stessa sostiene?
«La definizione s’ispira al New Deal di Franklin Delano Roosevelt, al suo imponente pacchetto di misure per uscire dalla crisi del 1929. Del Green New Deal esistono però diverse versioni, sia in Europa sia negli Stati Uniti, dove appunto i vari candidati democratici stanno elaborando le proprie. E già nel 2009 all’Onu la negoziatrice boliviana Angélica Navarro Llanos usò un altro paragone storico quando chiese “un Piano Marshall per la Terra”. L’idea sottesa a tutte queste iniziative è un programma mondiale che affronti l’emergenza climatica e la povertà allo stesso tempo, che cambi il sistema economico per combattere tutte le diseguaglianze, incluse quelle razziali e di genere. Le crisi planetarie, di tipo finanziario, umanitario, sociale, ecologico, sono interrelate e vanno affrontate in modo olistico. Il capitalismo moderno, fondato sul consumo illimitato, nacque d’altra parte già con gli africani strappati alla loro terra e con gli espropri alle popolazioni indigene: gli stessi individui divennero materia prima da sfruttare, così come le foreste, i fiumi, gli animali. Le fiamme dell’Amazzonia ci mostrano tuttavia che siamo interconnessi e vulnerabili. Un punto che uomini-bambini come Trump e Bolsonaro faticano forse ad accettare».
Quali provvedimenti andrebbero presi nel nuovo corso verde?
«Negli ultimi tre decenni, cioè da quando hanno iniziato a incontrarsi con gli scienziati per discutere la riduzione delle emissioni, i governi sono stati condizionati dal neoliberismo. Le rinnovabili sono finite nelle mani di società private, con l’effetto di aumentare i costi dell’energia per la classe operaia mentre scendevano le tasse per i milionari. Rispetto al passato, il Green New Deal dice chiaramente che la nostra economia non aiuta la maggioranza dei cittadini, che dobbiamo creare occupazione e migliorare i servizi e che dobbiamo farlo riducendo drasticamente le emissioni e creando milioni di posti di lavoro “verdi”. Potremmo ad esempio finanziare del tutto l’assistenza sanitaria e fare in modo che si realizzi con basse emissioni».
Per i critici è una linea utopistica, che comporterebbe una spesa pubblica insostenibile.
«Va ridefinito il concetto stesso di ciò che è possibile. Certo si tratta di una trasformazione difficile, ma è l’unica opportunità di abitare il futuro. E definirà anche il modo in cui lo abiteremo. Il clima, ad esempio, è - e diventerà sempre più - una delle cause della migrazione di massa, che a sua volta viene usata dalla destra xenofoba per aumentare i consensi. Dunque sì, siamo di fronte a una sfida difficile, ma l’alternativa è terrificante. Il neoliberismo ci ha abituato all’idea che il cambiamento collettivo non sia possibile, ci ha imprigionato nell’eredità di Margaret Thatcher. Ma la storia ci viene appunto in soccorso: la mobilitazione durante e dopo la Seconda guerra mondiale, quando cambiarono la produzione nelle fabbriche, la coltivazione del cibo, le politiche degli aiuti, così come l’esperienza del New Deal, testimoniano che si può cambiare, e in fretta».
Naomi Klein nel 2000 interpretò le aspirazioni del movimento no global. Ora condivide con «la Lettura» i temi del suo impegno, affidati al nuovo libro: una rivoluzione verde, un «Green New Deal» tanto ambizioso quanto ineludibile.
«Abbiamo bisogno di leader e l’Europa non ha saputo darceli. Trump e Bolsonaro sono come dei bambini, Macron e Trudeau si dicono ambientalisti ma fanno il contrario. Non bisogna lasciare soli i ragazzi, si deve scioperare ovunque. Utopia? No, va ridefinito quel che è possibile»
Se abbiamo undici anni per dimezzare le emissioni, quanto le presidenziali americane del 2020 saranno cruciali anche per il futuro del pianeta?
«Saranno decisive. Ecco perché mi sono trasferita per tre anni negli Stati Uniti. Resterò fino al 2020 perché voglio fare il possibile per non far vincere Trump. Sono figlia di americani, potrò votare».
Chi è il suo candidato?
«La prima scelta è Bernie Sanders perché il suo Green New Deal è appunto il più ambizioso. Prevede anche di aiutare i Paesi in via di sviluppo a convertirsi all’energia verde e a combattere il cambiamento climatico, il che è pure un modo per non costringere a migrare chi non lo vorrebbe. Il contrario di Trump, che ha tagliato milioni di dollari in fondi all’America Centrale, inclusi quelli ai contadini colpiti dalla siccità. Anche Elizabeth Warren ha un piano verde, in ogni caso chiunque vinca le primarie democratiche va sostenuto. Incluso Joe Biden, pure lui un neoliberista del quale non sono una fan, ma che aiuterei comunque, sperando che poi un forte movimento dal basso lo spinga al Green New Deal».
Lei ha fiducia nei movimenti dal basso. Possono davvero cambiare le cose?
«Devono trovare un’espressione politica. Negli Stati Uniti c’è una donna, la più giovane mai eletta al Congresso, Alexandria Ocasio-Cortez: nata nel 1989, l’anno scorso ha preso le idee dei giovani nelle strade e le ha trasformate in una proposta di legge per un Green New Deal. Oggi quelle idee sono entrate nella maggioranza dei programmi dei candidati alle primarie democratiche. Il cambiamento può avvenire in fretta se c’è una vera leadership. Ocasio-Cortez non può partecipare alle presidenziali, servono 35 anni, ma ha rifiutato di seguire la linea del partito e ha ridisegnato la mappa politica a una velocità incredibile. Il cambiamento, inoltre, avviene pure a livello locale: le città possano fare da modello».
Oggi l’emergenza ambientale riempie le piazze. Effetto Greta Thunberg?
«Il principale motivo è che il mondo è in fiamme. L’Italia ha ospitato alcune tra le proteste più partecipate. Il prossimo passo è non lasciare soli i ragazzi, scioperare in fabbrica, nei porti, nei municipi».
L’Europa può giocare un ruolo nella lotta per il pianeta?
«Abbiamo bisogno della leadership dell’Europa, deve fare da modello, ma finora non è accaduto. Il vostro ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, incarnava piuttosto quella che io chiamo “barbarie climatica”: le ideologie tossiche che si scatenano a seguito dei flussi migratori, dovuti come abbiamo detto anche al clima. Di fronte a questo, Salvini e altre forze di destra pensano solo al proprio Paese e lasciano morire i più deboli. È ciò che accade nel Mediterraneo e lo stesso Trump si è ispirato a Salvini. Non credo che questa politica rispecchi il sentire della maggioranza degli italiani. Il vostro Paese ha bisogno della sua rivoluzione politica, del suo Bernie Sanders».
Nel libro lei riconosce il coraggio di Papa Francesco nel «rinfacciare ai governi l’indifferenza ecologica» ma non nasconde una certa delusione.
«Ho grande rispetto per il Pontefice, in ambiti come clima e migranti è l’unico leader globale. Ma il Vaticano non ha dato finora una risposta forte sugli abusi sessuali. La profonda crisi del nostro tempo va affrontata su tutti fronti».
A quasi vent’anni da «No Logo» la destra si è appropriata della critica alla globalizzazione. Che cosa è successo?
«In Europa e Nord America quel movimento ha iniziato a crollare dopo l’11 settembre, mentre l’agenda contro cui protestavamo è andata avanti. Anzi, la crisi finanziaria ha compromesso ancora di più la sicurezza economica. Il punto non è che le nostre idee vengano usate dalla destra, ma che il centrosinistra non abbia saputo dare risposte. Si è creato un vuoto e lì si è inserita la destra».
La Rete è utile nella battaglia per la Terra?
«Perdiamo tempo prezioso a guardare i social, eccellenti per trovarsi rapidamente ma pessimi per capire che cosa fare dopo. I giovani che scioperano li usano ma poi fanno bene a vedersi faccia a faccia, a radunare i loro corpi. Meglio cercare un meccanismo democratico per prendere decisioni insieme che usare algoritmi programmati per scatenare invidia e rabbia. La crisi climatica smaschera ancora di più la crisi tecnologica».
Se tutto è in crisi, c’è speranza?
«Si conquista con il lavoro. Bisogna meritarsela. E tutti dobbiamo impegnarci, perché la posta in gioco è altissima».
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- «LA NOSTRA CASA E’ IN FIAMME». Global strike, niente sarà più come prima.1 ottobre 2019, di Federico La Sala
Global strike, niente sarà più come prima
di Guido Viale (il manifesto, 28.09.2019)
Ieri, nel giorno conclusivo della settimana di mobilitazione contro la crisi climatica e ambientale, quasi due milioni di studenti sono scesi in piazza a protestare in diversi paesi del mondo (e in Italia più che in tutti gli altri).
Portando così a quasi sei milioni (quattro volte quelli dello scorso 15 marzo; ma a questo punto i numeri contano poco: al prossimo global strike, a novembre, saranno ancora di più) le persone che hanno risposto alla chiamata allo sciopero di Greta Thunberg.
Non è che l’inizio: da oggi non solo le piazze, ma anche e soprattutto le redini di ogni discussione sensata, la ragione, la politica (quella vera, che decide della vita di tutti) si sono trasferite nelle loro mani, lasciando politici di professione, impresa e finanza, mondo del lavoro (e soprattutto le sue rappresentanze) e quello accademico (con l’eccezione dei climatologi e di pochi altri) a girare a vuoto intorno ai loro totem: la «crescita», le Grandi opere, i decimi di punto di Pil e di deficit, ecc. «La nostra casa va a fuoco», gridano gli studenti. E se l’establishment non se ne è accorto, per ignoranza, perché troppo preso dai suoi affari, per paura di dover cambiar troppo «l’ordine delle cose», la paura del disastro, che Greta non è ancora riuscita a instillargli con i suoi interventi, comincerà ora a provarlo nei confronti di quei ragazzi e quelle ragazze che scendono in piazza contro di loro, cominciando a tagliare sotto i piedi l’erba del business as usual. Ci metteranno un po’, quei signori, a capire che il loro mondo è finito - che sta precipitando nel caos - e che per salvare la specie umana, cioè tutti loro insieme ai loro figli e nipoti, occorre metter mano a una svolta radicale: che loro non sanno nemmeno concepire e meno che mai progettare e realizzare: perché si sono cullati - tutti, maggioranze e opposizioni - nell’illusione di un eterno presente che la crisi climatica e ambientale ha dissolto per sempre.
Ma è ora di smettere di svalutare le nuove generazioni accusandole di consumismo, di aver perso il senso del limite e della «legge del padre»; magari perché i loro padri sono «evaporati».
Meno male, c’è da dire, che sono evaporati: sono stati loro a mettere in mano ai loro figli merendine, abiti firmati, smartfone e altri gadget. E adesso non capiscono perché si muovano così in tanti per tutt’altro. È una fiammata che si spegnerà da sola, dicono alcuni, ma non è così: ora sappiamo che il movimento continuerà a crescere.
E che essuno dei partiti, dei sindacati o delle associazioni dei loro “padri” riescirà più a portarne in piazza tanta gente se non unendosi a loro. E che nessuno ha collegamenti internazionali così solidi.
Adesso i più accorti tra i membri della “classe dirigente” si metteranno a scuola dai giovani di Fridays for future e degli scienziati con a cui hanno dato ascolto e con cui stanno tessendo rapporti stretti, mentre loro, i ”padri”, li hanno ignorati.
Altri si aggrapperanno al proprio ruolo cercando di mandare avanti «la macchina» finché non dovranno prendere atto del fatto che non li ascolta più nessuno.
Ma i piú tra di loro rischiano di andare ad aggregarsi, magari sotto spoglie diverse, al nucleo duro delle destre negazioniste, che hanno idee chiare su come affrontare l’emergenza climatica che pure negano: respingendo con la guerra i profughi ambientali che la crisi è destinata a moltiplicare; reprimendo con decreti liberticidi le rivolte contro la miseria e i disagi che la crisi ambientale e la stagnazione economica non mancherà di aggravare; e mandando avanti lo sfruttamento dei fossili fino all’ultima goccia di petrolio; perché dopo di loro ci sarà«il diluvio».
Possiamo imboccare un’altra strada; ma occorre prendere, tutti, la situazione sul serio, cominciando col dire la verità. Non la conosce quasi nessuno; tutti sanno, ormai, che un grande cambiamento climatico è in corso, ma quasi nessuno ha una percezione del disastro, per noi e i nostri figli, a cui ci sta trascinando. E pochi hanno la percezione del poco tempo che rimane a disposizione per invertire rotta.
Per questo si continua a scavare tunnel, posizionare gasdotti, costruire aeroporti e centri commerciali che forse nessuno potrà utilizzare (o a indire Olimpiadi senza più neve, progettare stadi senza più campionati, cementificare spazi senza più alberi) invece di destinar tutte le risorse, fisiche, finanziarie e intellettuali, a prevenire un disastro altrimenti certo. È ora che tutti costoro lascino un po’ di spazio a chi si è reso conto che davvero «la nostra casa è in fiamme».
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "Salviamo il pianeta". Perché il pianeta non vuole essere salvato (di Maurizio Corrado).12 settembre 2019, di Federico La Sala
Perché il pianeta non vuole essere salvato
di Maurizio Corrado (Doppiozero, 11 settembre 2019)
Uno dei mantra consolatori più ricorrenti di questi anni è: Salviamo il pianeta. Tutto viene fatto per salvare il pianeta, dalla scelta del balsamo per capelli a non stirare i vestiti per non contribuire al riscaldamento globale, un’idea degna del miglior Woody Allen prima maniera. C’è un effetto gratificante notevole nell’idea di salvare un pianeta. Nell’immaginario comune, fino a pochi anni fa, solo i supereroi potevano riuscirci. Ora è in atto una massificazione del supereroe, chiunque, con piccoli gesti quotidiani, può salvare il pianeta e quindi essere supereroe. Basta chiedere un cappuccino alla soia e il gioco è fatto.
Chiunque voglia salvare il pianeta non ha che da andare in rete e avrà in una manciata di secondi intere serie di missioni alla portata di tutti: volare di meno, mangiare meno carne rossa, fare la raccolta differenziata, riciclare, andare in bicicletta, smettere di stirare i vestiti, chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti o ti insaponi sotto la doccia, fare meno la doccia e mai il bagno, bere l’acqua di rubinetto anziché quella in bottiglia, lasciare l’auto a casa due giorni a settimana, al supermercato scegliere il prodotto con il packaging più sostenibile, fare il compost in casa, cambiare le vecchie lampadine, acquistare elettrodomestici a risparmio energetico, fare una spesa intelligente, ridurre i rifiuti, ridurre la plastica, usare borse di tela, usare detersivi alla spina e prodotti sfusi, usare la carta riciclata, non stampare mail o altri documenti, tirare lo sciacquone il meno possibile, acquistare mobili di legno certificato, scegliere cosmetici e detersivi ecologici, stendere il bucato, usare pannolini riciclabili, mangiare frutta e verdura, prediligere gli spazzolini in legno riciclabile, non usare la Vespa.
C’è un problema, però. In questa ansia di salvataggio, che nasconde la vera ansia, il terrore dell’estinzione di massa che si profila in un orizzonte sempre più vicino, a nessuno è venuto in mente di chiedersi se al pianeta importi di essere salvato o se ne ha realmente bisogno, perché anche facendo un paio di banalissime considerazioni, sembrerebbe proprio che lui, che noi ormai consideriamo alla stregua di un moribondo, non sia minimamente interessato ai nostri sforzi e non abbia neanche lontanamente l’idea di essere in pericolo, nonostante fra i potenti della terra ultimamente vada molto la fiaba del piccolo fiammiferaio e si scatenino in Sudamerica, Africa e dalle parti del Polo, dove ormai il gas imprigionato nel permafrost non aspetta altro che liberarsi nell’atmosfera.
Quante volte durante la sua vita, oltre quattro miliardi di anni, il pianeta ha avuto temperature estreme, sconvolgimenti, condizioni proibitive per qualsiasi forma di vita o almeno vita concepibile da noi umani? Quante volte una forma di vita è arrivata, si è sviluppata e quindi estinta? I dinosauri sono stati specie dominante per 160 milioni di anni, in questa scala temporale i trecentomila anni di Homo Sapiens sono un tempo risibile ma sufficiente a gonfiarci d’orgoglio e continuare a considerarci in cima a una scala evolutiva che abbiamo ideato noi stessi. Neanche oggi, a un passo dalla fine, abbiamo perso la vecchia abitudine di vederci al centro dell’universo e ci divertiamo a dare alle ere geologiche il nostro nome, orgogliosi, anche se in negativo, di aver cambiato l’aspetto del luogo in cui siamo comparsi.
Hildegard von Bingen, mistica tedesca del XII secolo, nella sua opera Ordo Virtutum fa dire ad uno dei personaggi: “Dio ha creato il mondo e io voglio goderne, senza recargli offesa.” Qui sta un pensiero che oltrepassa in altezza e profondità ogni ecopalliativo consolatorio e coincide con la posizione di Ivan Illich che, in un libro-intervista del 1992 a cura di David Cayley, ci invita a “essere in grado di celebrare il presente e di celebrarlo usandone il meno possibile, perché è bello e non perché è utile a salvare il mondo.” In entrambi è totalmente assente l’idea di sacrificio e punizione che fa da substrato a tutte le azioni che vengono sistematicamente proposte per il presunto salvataggio del pianeta, anzi, vive l’idea opposta, Hildegard parla chiaramente della volontà di godere del mondo, Illich parla di celebrare, che è un’azione che ha a che fare con la meraviglia e la bellezza. Di bellezza parla anche James Hillman in contrapposizione al sacrificio.
Ovviamente tutti sanno che quello che stiamo distruggendo non è il pianeta, che continuerà serenamente la propria esistenza con o senza di noi, ma solo le condizioni che ci permettono di viverci sopra, ma è molto più soddisfacente pensarci come supereroi impegnati a salvare non noi, ma qualcun altro, ancor meglio se l’intero pianeta. Meglio dimenticare che siamo noi a non poter sopravvivere se la temperatura generale si alza di anche solo di tre gradi. Quello che per noi può rappresentare la fine, per altre forme di vita può essere l’inizio di una nuova fase di prosperità. In altre parole, al pianeta non importa nulla di trasformarsi ulteriormente, siamo solo noi a rischiare grosso.
 Questa insistenza su Salviamo il pianeta è una forma di esorcismo, una maschera dell’oblio, una rimozione della paura, il rifiuto della consapevolezza di essere arrivati alla fine della prateria, oltre, ci aspetta la scogliera. Abbiamo un solo modo per proseguire: imparare a volare.
Questa insistenza su Salviamo il pianeta è una forma di esorcismo, una maschera dell’oblio, una rimozione della paura, il rifiuto della consapevolezza di essere arrivati alla fine della prateria, oltre, ci aspetta la scogliera. Abbiamo un solo modo per proseguire: imparare a volare. -
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Il tempo è ora. L’Amazzonia brucia, liberando milioni di tonnellate di CO2. La Siberia brucia, emettendo altro CO2 e immense quantità di metano. I ghiacci della Groenlandia si sciolgono.. (Guido Viale).27 agosto 2019, di Federico La Sala
Il tempo è ora
di Guido Viale (*)
L’Amazzonia brucia, liberando milioni di tonnellate di CO2. La Siberia brucia, emettendo altro CO2 e immense quantità di metano. I ghiacci della Groenlandia si sciolgono a ritmo vertiginoso e così anche la banchisa polare, le calotte glaciali dell’Artico e dell’Antartico e tutti i ghiacciai del mondo. In India, in preda alla siccità, muoiono di sete migliaia di persone e in tutto il mondo, Mediterraneo e Italia compresi, si moltiplicano i fenomeni metereologici estremi: ondate di calore, tempeste tropicali, gelate fuori stagione. Sono tutti effetti della crisi climatica in corso e al tempo stesso cause del suo rapido aggravamento.
Di tutto questo non c’é alcun riflesso nel Parlamento italiano né nelle manovre per formare un nuovo governo. Le istituzioni del nostro paese non si sono solo allontanate dai cittadini (e viceversa). Sono ormai lontane mille miglia dalla realtà (come lo sono i media che si occupano delle loro vicende). Ma è così anche in quasi tutto il resto del mondo.
C’è però in Italia e in tutto il mondo un “popolo” che quei fatti li ha messi al centro dell’attenzione, delle sue preoccupazioni e della sua iniziativa: i giovani di Fridays for future, che è un movimento mondiale la cui crescita non si fermerà più; la rete di Extinction Rebellion; i tanti movimenti contadini che difendono un’agricoltura sostenibile come Via campesina che riunisce 400 milioni di agricoltori; i popoli indigeni in lotta contro la devastazione dei loro habitat, in particolare l’Amazzonia, oggi sotto attacco, ma che sarà al centro di un sinodo voluto da Papa Francesco.
È statisticamente quasi impossibile che tra i mille parlamentari italiani non ce ne sia nemmeno uno che non si renda conto di quanto sia criminale ignorare la crisi climatica. Se anche in pochi, approfittando della visibilità che avrebbero in questo momento, formassero un raggruppamento interpartitico, non per “mettersi alla testa” dei movimenti già attivi in questo campo, magari con mire egemoniche (non ne avrebbero alcun titolo), ma per porre la crisi climatica e ambientale al centro delle loro preoccupazioni, potrebbero gettare un pesante masso nello stagno delle trattative per la formazione del nuovo governo e tutto il quadro politico potrebbe venirne scompaginato anche nel caso di eventuali elezioni.
Si tratterebbe di mettere all’ordine del giorno, non solo del Parlamento, che su questo tema per ora è sordo, ma del pubblico più vasto possibile, non l’inserzione dell’ambiente come una postilla in programmi inconcludenti e di facciata, ma la necessità inderogabile di una svolta radicale: abbandonare al più presto i progetti, le attività e i consumi responsabili delle maggiori emissioni climalteranti per promuovere ovunque impianti, sistemi e consumi a emissioni basse o nulle. Molte misure da assumere sono impopolari e per molti inaccettabili. Ma, di fronte all’evidenza dei fatti, questi atteggiamenti non dureranno a lungo anche perché i movimenti in campo per esigere un cambiamento radicale delle politiche cresceranno mano a mano che la crisi climatica farà sentire i suoi effetti.
Inoltre quei movimenti sono già fortemente intersecati dalle altre correnti di pensiero e di azione impegnate sulla prospettiva di un mondo diverso: il movimento delle donne contro il patriarcato e le sue tante manifestazioni, la solidarietà contro l’abbandono e respingimento dei migranti, le mobilitazioni contro la devastazione di territori e comunità in nome di progetti senza avvenire come NoTav o NoTap, i movimenti contro la guerra e le armi.
Certamente più difficile, nell’immediato, sarà raccogliere adesione e rivendicazioni di chi oggi lotta o vorrebbe lottare per difendere reddito o posto di lavoro, contro disoccupazione e precariato, per la casa, la salute, l’istruzione. C’è ancora da battere una cultura - negata a parole, ma confermata dalle scelte di tutte le forze politiche - che continua a contrapporre tutte queste cose alla difesa dell’ambiente; ma è e sarà sempre più chiaro che quelle rivendicazioni non avranno più alcuna possibilità di realizzarsi nella prospettiva di una generale catastrofe climatica.
Dalla capacità di affrontare qui e ora la questione della crisi climatica, senza aspettare che a muoversi siano altri paesi e altri Governi, ma con la convinzione che l’esempio ha un effetto trascinante e che chi la affronta prima si troverà in vantaggio mano a mano che gli effetti della crisi si faranno più pesanti, dipende alla fine anche la possibilità di ricondurre la politica al suo significato originario, che è quello di autogoverno. Cosa che non potrà mai realizzare una manovra chiusa nel quadro dell’attuale sistema politico, tutto legato al mito fasullo e ormai palesemente devastante della “crescita”. Il tempo per agire è ora. E se non ora, quando?
(*) https://www.guidoviale.it/il-tempo-e-ora/, 27.08.2019.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- INCENDI ED ESTINTORI. Salvare la foresta amazzonica e riconoscere le proprie colpe (di Gianfranco Pellegrino).27 agosto 2019, di Federico La Sala
INCENDI, ESTINTORI, E ... LANCIAFIAMME!!! Amazzonia... *
- [...] Su che cosa è stato edificato il “nuovo” mondo? Genocidi e stemini. Chi ha dato il nome a questo nuovo mondo? Un Vespucci (in verità non lui direttamente, ma ricordiamoci dei ragni e delle formiche di Bacone). Chi ha chiamato così l’Amazzonia? E. chi così il Brasile? A Napoli, sì sempre a “Nea-polis”, questo nome ricorda la brace, il braciere, persone intorno a un fuoco che riscalda, un cerchio familiare che si apre e accoglie chi ha freddo - non la devastazione e il deserto di chi cieco e folle si mette a distruggere tutto: *Edipo con in mano il lancia-fiamme a volontà - Platone, il Tecno-crate*. Di fronte alla Foresta gli uomini ciechi e folli di potenza (ma qui si parla anche delle donne amazzoni) vedono nulla e ... faranno il Brasile? (cfr. Federico La Sala, Le “regole del gioco” dell’Occidente e il divenire accogliente della mente, in “La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica”, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 180-181).
Incendi ed estintori. Salvare la foresta amazzonica e riconoscere le proprie colpe
di Gianfranco Pellegrino (Le parole e le cose, 27.08.2019)
Le foreste dell’Amazzonia stanno bruciando. Sappiamo molte cose su questi incendi: sappiamo che sono dolosi, sappiamo che chi li appicca è interessato a sfruttare commercialmente il terreno libero che si otterrà dalla distruzione degli alberi, sappiamo che il presidente Bolsonaro si è mostrato, sino a pochissimo tempo fa, acquiescente nei confronti degli speculatori, sappiamo che il venir meno di larghe parti della foreste pluviali avrà effetti pericolosi nel futuro - in termini di aumento del cambiamento climatico, di decremento della produzione di ossigeno, di aumento della quantità di biossido di carbonio nell’atmosfera (qui la catena causale è indiretta: meno foreste significa minore capacità di assorbimento di biossido di carbonio, e quindi maggiore percentuale di biossido di carbonio che rimane nell’atmosfera), di estinzione di specie animali e vegetali e di cancellazione di ecosistemi e nicchie ecologiche. Sappiamo pure che gli incendi sono in aumento. E, sappiamo che, pure se non fossero in aumento, man mano che ci spingiamo lungo la china del cambiamento climatico quel che non causava effetti nocivi o irreversibili prima può diventare un fattore che ci conduce al di là di punti di non ritorno.
 A parte pochi negazionisti climatici - alcuni purtroppo piazzati in posti di potere -, nessuno nega (almeno apertamente) fatti del genere. E cominciano an che a diminuire quelli che rimangono indifferenti. Anche per chi disprezza o dileggia l’attivismo di Greta Thunberg o le dottrine della Laudato Si’ l’alzata di spalle o il silenzio diventano sempre più difficili. Il dileggio è una forma d’attenzione, per quanto contorta e involontaria. Sappiamo, infine, che la sparizione delle foreste condanna all’estinzione anche civiltà indigene che di quegli ambienti hanno fatto la propria nicchia culturale.
A parte pochi negazionisti climatici - alcuni purtroppo piazzati in posti di potere -, nessuno nega (almeno apertamente) fatti del genere. E cominciano an che a diminuire quelli che rimangono indifferenti. Anche per chi disprezza o dileggia l’attivismo di Greta Thunberg o le dottrine della Laudato Si’ l’alzata di spalle o il silenzio diventano sempre più difficili. Il dileggio è una forma d’attenzione, per quanto contorta e involontaria. Sappiamo, infine, che la sparizione delle foreste condanna all’estinzione anche civiltà indigene che di quegli ambienti hanno fatto la propria nicchia culturale.Ma, paradossalmente, i fatti importanti non sono questi. Proprio perché sulla descrizione di quel che accade ed accadrà non ci sono più dubbi condivisi, è ora di volgerci con maggiore attenzione alla prescrizione, cioè ai principi etici e ai paradigmi di azione politica che dovrebbero guidare le nostre azioni in frangenti del genere.
Il 5 agosto, su Foreign Policy, Stephen Walt di Harvard ha scritto un breve articolo chiedendosi se gli incendi e la deforestazione dell’Amazzonia potrebbero costituire motivo per un intervento - armato o sotto forma di sanzioni - dell’ONU o della comunità internazionale nei confronti del Brasile (vedi qui: https://foreignpolicy.com/2019/08/05/who-will-invade-brazil-to-save-the-amazon/). Walt è un teorico delle relazioni internazionali di orientamento neo-realista, famoso per il suo scetticismo nei confronti dell’interventismo americano e della presunta base morale di tali interventi. Con l’atteggiamento caratteristico di questo genere di studiosi - presunta neutralità assiologica che nasconde scelte morali di fondo (peraltro spesso ovvie e condivisibili) -, Walt mostra che la prospettiva di muovere guerra o comminare sanzioni ai paesi che più sono responsabili dell’aumento delle emissioni di gas serra - paesi come Cina, India, Stati Uniti e Russia - è del tutto assurda, per quanto possa essere una tentazione. Per Walt, peraltro, la sovranità nazionale, per quanto limitata, rimane un limite alle ingerenze della comunità internazionale. E non è chiaro se l’impatto che le condotte interne di uno Stato può avere sui destini di tutti possa giustificare interventi e intromissioni così drastiche. Ciò che è chiaro è che la comunità degli Stati non permetterebbe mai che si stabilisca un precedente simile. Quindi, in un certo senso secondo questo tipo di prospettiva dovremmo lasciare tutto alla forza di persuasione degli attivisti, o alle politiche felpate di alcuni capi di Stato come Macron, all’interno di organismi come il G7.
Questo modo di procedere si basa sull’idea che ci siano solo due possibili punti di vista per considerare un problema come quello della deforestazione dell’Amazzonia. O si ha un paradigma puramente sovranista, per così dire - l’etichetta è volutamente vaga e suggestiva -, in cui la sovranità nazionale implica che chi detiene il potere politico abbia ipso facto potere sulle risorse naturali e di altro genere presenti nel territorio governato. Oppure si ha un paradigma internazionalista, o globalista, in cui c’è un potere politico globale che può porre limiti al controllo sovrano delle risorse. Entrambe le forme di potere sono soggette al gioco democratico, per molti. La scelta è fra la sovranità nazionale, o interna, di singoli elettorati, o un demos globale.
Se ci fossero solo questi due paradigmi, saremmo alle prese con due strade egualmente bloccate. Da un lato, ipotizzare che un ipotetico governo mondiale, o una comunità internazionale, privi gli elettori brasiliani del potere di scegliere come usare le risorse naturali del loro territorio sembra contrario a qualsiasi principio ovvio di autodeterminazione. Anche se ci fosse veramente un governo mondiale, o una comunità internazionale ben più forte di quel che abbiamo, e non esistessero Stati nazionali, e i principi dell’intervento umanitario coprissero anche le catastrofi ecologiche, che una parte del mondo decidesse, a maggioranza, che uso si dovrebbe fare delle risorse naturali che potrebbero favorire lo sviluppo economico di un’altra parte del mondo apparirebbe comunque una forma di tirannia della maggioranza. D’altra parte, l’impatto della progressiva deforestazione dell’Amazzonia ricadrà sul mondo intero, e lasciare del tutto la scelta ai brasiliani, o al loro governo, significherebbe rassegnarsi a una tirannia della minoranza.
Ma forse questo modo di impostare le cose trascura alcuni aspetti normativi che invece sono rilevanti. Il peggior effetto della deforestazione, come già detto, riguarda la percentuale di biossido di carbonio nell’atmosfera. Deforestare fa aumentare questa percentuale, e ciò aumenta, o rende più probabili, i cambiamenti climatici nel futuro. Deforestare aumenta la percentuale di biossido di carbonio perché fa venir meno gli alberi, che hanno la capacità di assorbire questo gas a effetto serra. Bruciare alberi impedisce che una parte del biossido di carbonio in eccesso venga assorbito. L’effetto della deforestazione, quindi, è nocivo non in assoluto, ma relativamente alle condizioni in cui ci troviamo - relativamente al fatto che, in virtù delle passate emissioni, c’è un eccesso di biossido di carbonio, e altri gas simili, nell’atmosfera.
Sostenere che la deforestazione dell’Amazzonia aumenti il cambiamento climatico, e quindi autorizzi interventi o pressioni, è come dire che chi danneggia un estintore causa un incendio, e quindi va punito come il piromane. Chi danneggia un estintore, o lo sottrae, quando ci sia un incendio in corso è certamente colpevole di qualcosa, ma chi ha appiccato l’incendio non può arrogarsi il diritto di punirlo, o nascondere le sue colpe.
L’eccesso di biossido di carbonio nell’atmosfera è responsabilità del mondo occidentale. La deforestazione dell’Amazzonia peggiora una situazione che è stata resa grave dall’industrializzazione del Primo mondo. Si potrebbe dire questo: in molti casi recenti, Stati che hanno invaso altri Stati, e hanno subito per questo interventi armati, venivano da faticosi processi di decolonizzazione e subivano le conseguenze di molte azioni dei governi occidentali. Ciò non ha reso meno necessari e fondati gli interventi. (Qui la materia è delicata, e dipende dalle convinzioni politiche di ognuno - e il giudizio può cambiare se si pensa al Kosovo degli anni Novanta o alla prima o alla seconda guerra del Golfo). E tuttavia il nesso causale nel caso della deforestazione è più stretto ed evidente. Se non fossimo in una condizione di cambiamento climatico antropogenico galoppante è ovvio che la perdita di alcune foreste sarebbe meno grave.
Quindi, imputare tutta la responsabilità a Bolsonaro e ai brasiliani è un atto di arroganza, anche se questo non vuol dire che bisognerebbe assistere inerti agli incendi. Forse bisognerebbe distinguere fra due risorse naturali. Da un lato, ci sono le foreste, dall’altro c’è la capacità del sistema terrestre di assorbire emissioni di biossido di carbonio senza che il clima muti. Nelle condizioni in cui ci troviamo, le due risorse sono direttamente connesse, ma non lo sarebbero in altre condizioni. In un mondo privo di cambiamento climatico antropogenico, le foreste potrebbero diminuire senza che la capacità della Terra di assorbire biossido di carbonio diminuisca a tal punto da far mutare il clima. Si potrebbe pensare che la prima risorsa, le foreste, sia oggetto della sovranità nazionale del Brasile, mentre le seconda sia una specie di patrimonio comune dell’umanità, che non si può lasciare alle decisioni di un solo governo nazionale - e, forse, dati gli impatti nel futuro, non si può lasciare alla decisione delle sole generazioni presenti.
Ma, una volta che si consideri questa risorsa globale, è difficile dimenticarsi delle responsabilità di chi ha sfruttato nei secoli passati gran parte di essa a proprio beneficio - cioè dei paesi che hanno goduto dell’industrializzazione. Alla luce di tutto questo, la reazione nei confronti degli incendi in Brasile non può essere quella di scegliere fra intervento armato o acquiescenza. Il comportamento dei brasiliani, o almeno del governo brasiliano, dovrebbe indurre la comunità internazionale a proporre vie di sviluppo economico alternative rispetto alla deforestazione. Il fatto che Bolsonaro abbia negato la natura antropogenica del cambiamento climatico e gli interessi economici evidenti di chi appacca gli incendi in Amazzonia non sono sufficienti a diminuire le responsabilità dei paesi che hanno una lunga storia di emissioni in eccesso. Questi paesi dovrebbero pagare il loro debito a chi ha lasciato intatto sin qui uno dei principali serbatoi di assorbimento del biossido di carbonio e garantire l’integrità dell’Amazzonia assumendosi ulteriori oneri. La questione principale, in altri termini, non è la democrazia e la sovranità nazionale, ma la giustizia distributiva e le compensazioni dovute a chi non ha tratto beneficio dall’industrializzazione e rischia di subirne solo gli effetti più negativi - paesi in via di sviluppo e generazioni future.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE “EU-ROPEUO”. Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una “memoria” (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=901)
Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Amazzonia. Gli incendi stanno devastando quasi 150 terre indigene. Allarme per le tribù non contattate.25 agosto 2019, di Federico La Sala
Brasile.
Gli indios dell’Amazzonia: «Non fateci bruciare vivi»
Gli incendi stanno devastando quasi 150 terre indigene. Allarme per le tribù non contattate. I vescovi brasiliani: basta deliri, azioni urgenti. In fiamme anche Bolivia e Paraguay
di Lucia Capuzzi (Avvenire, sabato 24 agosto 2019)
- [Foto] Indigeni in Amazonas, Ansa
«Andarcene? Dove? È la nostra terra, è parte di noi. Lotteremo. Siamo abituati a farlo. Come abbiamo resistito alle invasioni, ora resisteremo al fuoco». Eric, 23 anni, indigeno Karipuna, è uno dei 23 abitanti del villaggio Panorama, sulle rive del fiume Ji-Paraná, affluente del Rio delle Amazzoni. «In realtà, i Karipuna, in totale, siamo 58, ma più della metà vive in città, a Porto Velho, per ragioni di studio o lavoro». Panorama, nel Rondônia, è sulla “linea del fuoco”, come tutta la fascia del Brasile centro-occidentale, devastata da oltre 33mila incendi nell’ultimo mese. Un sesto di questi è avvenuto nello Stato che, inoltre, ha la maggior concentrazione di roghi per chilometro quadrato.
«Ora va un po’ meglio: ieri ha piovuto e le fiamme si sono arrestate. Ma oggi il fuoco potrebbe riprendere ad avanzare. Da soli non possiamo affrontarlo. Chiediamo al mondo di non voltarsi dall’altra parte. Il mio popolo, i Karipuna, ha rischiato di estinguersi per le violenze e le malattie portate dai conquistatori nei secoli passati. Siamo rimasti in 58. Altre tribù sono state cancellate. Lo sterminio prosegue nel presente: i cacciatori di risorse ci considerano un ostacolo. Chiediamo solo di poter continuare a esistere come indigeni. Non lasciate che veniamo ridotti in cenere», dice Eric, con la voce carica di commozione.
Il giovane non parla solo per il suo popolo: gli oltre 900mila indios brasiliani sono a rischio. Secondo gli ultimi dati dell’Instituto socioambiental (Isa), almeno 3.500 roghi stanno devastando 148 terre indigene, concentrate - oltre che in Rondônia -, in Mato Grosso, Tocantins, Acre e Pará. Zone in cui si sono rifugiati anche molte tribù in isolamento volontario. I traumi del passato, cioè, hanno spinto alcuni gruppi nativi a rifiutare il contatto con l’esterno, rintanandosi negli angoli più remoti della foresta. In Brasile, se ne contano un centinaio, secondo la Ong Survival, in prima linea nella difesa dei nativi. Nella terra Karipuna, legalmente restituita agli indios nel 1998, i Karipuna ne hanno individuato due. «Non sappiamo più nulla di loro da quando c’è stata l’ultimo blitz dei trafficanti di legname, due mesi fa. Ora rischiano di restare intrappolati nelle fiamme. Nessuno sa nemmeno che esistono. Per questo, noi Karipuna abbiamo il dovere di levare la voce in difesa dei nostri fratelli isolati. Il governo faccia qualcosa». Anche la Conferenza episcopale brasiliana ha chiesto «azioni urgenti», di fronte agli «assurdi incendi». «Non è il momento di deliri», hanno affermato i vescovi e aggiunto: «È ora di parlare, scegliere e agire con equilibrio e responsabilità, perché tutti si assumano la nobile missione di proteggere l’Amazzonia, rispettando l’ambiente, i popoli autoctorni, di cui siamo fratelli»
Il presidente Jair Bolsonaro, entrato in carica a gennaio, è considerato da più parti come parte del problema per le sue controverse affermazioni sulla necessità di «rendere produttiva» l’Amazzonia. Boutade concretizzate in una serie di proposte - ancora nel limbo - per diminuire le aree protette, consentire l’affitto dei terreni indigeni o aprirli allo sfruttamento minerario.
 Tale politica - accusano esperti e attivisti - avrebbe spinto i latifondisti a incrementare le “queimadas”: incendi per “pulire” il terreno da parte dei latifondisti e “sgomberarlo” di eventuali residenti. Il 5 agosto, il giornale locale “Novo Progresso”, in Pará, ha diffuso la notizia di un singolare evento organizzato, cinque giorni dopo, dagli agricoltori locali: “il giorno del fuoco”. I grandi proprietari - sostiene il quotidiano - avrebbero esortato a bruciare ampie porzioni di foresta per «dimostrare la propria volontà di lavorare al presidente Jair Bolsonaro».
Tale politica - accusano esperti e attivisti - avrebbe spinto i latifondisti a incrementare le “queimadas”: incendi per “pulire” il terreno da parte dei latifondisti e “sgomberarlo” di eventuali residenti. Il 5 agosto, il giornale locale “Novo Progresso”, in Pará, ha diffuso la notizia di un singolare evento organizzato, cinque giorni dopo, dagli agricoltori locali: “il giorno del fuoco”. I grandi proprietari - sostiene il quotidiano - avrebbero esortato a bruciare ampie porzioni di foresta per «dimostrare la propria volontà di lavorare al presidente Jair Bolsonaro».Informazione verificata o fake news, fatto sta che quel 10 agosto nel municipio di Altamira, in Pará, ci sono stati 431 roghi, altri 327 a Novo Progresso, per un totale di 1.457 incendi in meno di 48 ore. Se una regia unica è improbabile, è verosimile, però, che qua e là sia “scappata la mano”. Deforestazione e siccità avrebbero, poi, favorito la propagazione delle fiamme a tempo di record. Affermazioni smentite dal leader che, invece, ha puntato il dito sulle Ong.
 Di fronte al coro di critiche internazionali e alla minaccia di ritorsioni economiche - tra cui il congelamento dell’accordo Ue-Mercosur -, Bolsonaro ha schierato 44mila militari sul fronte del fuoco. Poi ha cercato di spegnere le fiamme della polemica con un intervento in diretta tv, in cui ha affermato: «Gli incendi esistono in tutto il mondo. Non possono diventare il pretesto per le sanzioni».
Di fronte al coro di critiche internazionali e alla minaccia di ritorsioni economiche - tra cui il congelamento dell’accordo Ue-Mercosur -, Bolsonaro ha schierato 44mila militari sul fronte del fuoco. Poi ha cercato di spegnere le fiamme della polemica con un intervento in diretta tv, in cui ha affermato: «Gli incendi esistono in tutto il mondo. Non possono diventare il pretesto per le sanzioni».
 In effetti, i roghi devastano anche Bolivia e Paraguay. Anche qui il fuoco non sembra una fatalità. Il presidente di La Paz, Evo Morales, ha abolito, a luglio, il divieto di bruciare i campi per “pulirli”. Asunción ha tra i maggiori indici di deforestazione.
In effetti, i roghi devastano anche Bolivia e Paraguay. Anche qui il fuoco non sembra una fatalità. Il presidente di La Paz, Evo Morales, ha abolito, a luglio, il divieto di bruciare i campi per “pulirli”. Asunción ha tra i maggiori indici di deforestazione.Quest’ultima è cresciuta esponenzialmente anche in Brasile: negli ultimi otto mesi sono andati perduti tremila chilometri quadrati di foresta. Il governo, inoltre, ha tagliato del 24 per cento i fondi all’Istituto brasiliano per l’ambiente (Ibama), braccio operativo del ministero dell’Ambiente. Quest’ultimo ha iniziato a ridurre le operazioni. In parallelo, sono calate le sanzioni per i crimini ecologici in Amazzonia di oltre un terzo. «Risultato: le invasioni sono diventate quotidiane - conclude Eric Karipuna -. I cacciatori di risorse si sentono spalleggiati. E lo sono: continuiamo a denunciare, ma nessuno interviene».
-
>IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- L’ERA DI GRETA. Dobbiamo cominciare a contare gli anni a partire da prima e dopo Greta (di Guido Viale)..16 luglio 2019, di Federico La Sala
L’era di Greta
di Guido Viale *
- La priorità assoluta dell’era segnata dal grido di Greta, scrive Guido Viale, è fare informazione e aprire un dibattito vero in tutte le sedi - scuole, università, fabbriche, aziende, quartieri, istituzioni - capace di inserire i problemi e le aspirazioni della vita quotidiana di ognuno dentro l’orizzonte spaziale (il pianeta tutto) e temporale (non più di 10-15 anni) del cambiamento climatico. Dobbiamo però prendere atto - a partire da ora - che quest’anno, l’anno di Greta, non può non essere un vero spartiacque che separa ciò che si è fatto finora da ciò che si deve fare da ora in poi
Dobbiamo cominciare a contare gli anni a partire da prima e dopo Greta. Non che Greta Thunberg sia morta; è più viva che mai e speriamo che continui ad accompagnarci e guidarci nel nostro viaggio contro il cambiamento climatico, fino a una vera svolta. E nemmeno è necessario sostituire una nuova numerazione a quella di prima e dopo Cristo: va bene quella che c’è. Dobbiamo però prendere atto - a partire da ora, l’anno di Greta - di uno spartiacque che separa ciò che si è fatto finora da ciò che si deve fare da ora in poi.
I risultati della ricerca scientifica a cui Greta fa riferimento ci avvertono che “la nostra casa è in fiamme”. O quei risultati li contestiamo, non si sa su che basi, o ne prendiamo atto: la minaccia che incombe sulle nostre vite e sul nostro pianeta non è fantascienza e bisogna correre ai ripari. E subito. E non è poco: tutto o quasi quello che è stato fatto nel corso degli ultimi decenni o che è stato avviato o anche solo progettato nel corso degli ultimi anni va dismesso o ridisegnato radicalmente nel più breve tempo possibile. E tutto ciò che può consentire, in questo nuovo assetto dell’economia, il mantenimento di uno standard di vita decente - o la sua estensione a chi non lo ha mai avuto - va messo subito in campo. Di tutte le produzioni che dipendono direttamente o indirettamente dall’estrazione e dall’utilizzo dei combustibili fossili - pozzi, miniere, gasdotti e oleodotti, flotte, raffinerie, centrali termoelettriche, mezzi di trasporto di terra, mare e cielo - va programmata la dismissione in un numero di non più di dieci anni o la loro trasformazione, ove possibile, in soluzioni che possono essere alimentate con fonti energetiche rinnovabili. Le quali vanno promosse, insieme alla massima efficienza energetica, senza continuare ad alimentare un regime di spreco come quello in atto oggi. Edilizia e assetto dei territori vanno resi resilienti e meno energivori. La mobilità di cose e persone va riorganizzata integrando trasporto di massa e sistemi flessibili condivisi. L’agricoltura va ricondotta alla sostenibilità con l’adozione di sistemi naturali che restituiscano al suolo fertilità e capacità di assorbire carbonio. E si possono aggiungere (pare) mille miliardi di nuovi alberi ai tremila miliardi già esistenti; ovviamente, senza più deforestare.
Tutta la popolazione, o la maggioranza di essa, dovrà essere coinvolta in questi processi e i lavoratori il cui impiego verrà meno dovranno essere ricollocati nei settori della transizione - dove ci sarà posto per tutti, occupati e disoccupati di oggi - in modo che quel trasferimento sia una promozione economica e sociale. E’ una transizione tecnica, economica e sociale, ma soprattutto culturale e, ovviamente, psicologica, che non ha precedenti nella storia dell’umanità, anche se spesso viene citato - giustamente - come termine di paragone lo sforzo bellico intrapreso allo scoppio della Seconda guerra mondiale nella riconversione dell’industria degli Stati Uniti.
E’ facile e quasi ovvio manifestare un forte scetticismo di fronte a queste prospettive: uno scetticismo che dipende dal fatto che ben pochi, soprattutto in Italia, sono informati della gravità della situazione, ma soprattutto dal fatto che la radicalità e l’estensione dei cambiamenti da realizzare spaventano e paralizzano, spingendo i più all’inerzia. Ma presto cambieranno idea, e dobbiamo adoperarci perché non lo facciano troppo tardi. Se le rilevazioni hanno ormai messo in rotta i “negazionisti climatici” in tutta la comunità scientifica (a dire il vero, non sono mai stati un gran che, anche se di recente anche Franco Piperno ha voluto aggiungere il suo nome a quello del prof. Antonino Zichichi, che capeggia la squinternata pattuglia italiana dei negazionisti climatici), pullulano però nel mondo della “politica” e dell’informazione coloro che considerano la minaccia del cambiamento climatico niente altro che un’arma di “distrazione di massa” rispetto ai problemi sociali ed economici che incombono; esattamente come si sta facendo da tempo, soprattutto “a sinistra”, nei confronti delle migrazioni. Che costituiscono invece, nonostante il calo drastico degli arrivi (gli altri, quelli che “non arrivano più” e non sono ancora annegati, sono tutti rinchiusi, a milioni, nei lager libici o nelle bidonville turche e degli altri paesi di transito, in attesa che quei regimi facciano “libera tutti” per ricattare l’Europa), il principale problema sociale, il maggiore terreno di scontro politico e culturale e, verosimilmente, il fronte più radicale del conflitto di classe del nostro tempo; anche se esso non si svolge più nelle forme tradizionali del movimento operaio. Ma dal modo in cui viene affrontata “la questione migranti” dipende l’esito di tutti gli altri conflitti sociali che interessano la nostra epoca: in fabbrica, sul lavoro, nel territorio, nella cultura.
Ma la questione migranti è a sua volta indissolubilmente legata alla lotta contro il cambiamento climatico, sotto il cui ombrello si raccolgono tutti gli altri problemi: quelli relativi all’oggetto di tutti i conflitti, che è la giustizia sociale e la riappacificazione della specie umana con la Terra che la ospita, e quelli relativi ai “soggetti”, ovvero agli attori, di quei conflitti: perché se si dimentica - si lascia indietro, o si considera un ingombro - l’esistenza di milioni di esseri umani cacciati dalle loro terre dalla prepotenza del sistema economico a cui tutti siamo soggetti, è veramente difficile anche solo pensare di poterne venire a capo.
E’ evidente allora qual è la priorità assoluta dell’era Greta: fare informazione e aprire un dibattito vero in tutte le sedi - scuole, università, fabbriche, aziende, quartieri, istituzioni - capace di inserire i problemi e le aspirazioni della vita quotidiana di ognuno dentro l’orizzonte spaziale (il pianeta tutto) e temporale (non più di 10-15 anni) del cambiamento climatico.
* Comune-info, 11 Luglio 2019 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA --- Fine della Storia o della "Preistoria"? "L’alba dell’era solare" di Prem Shankar Jha. Note.12 luglio 2019, di Federico La Sala
Fine della Storia o della "Preistoria"? *
A qualcuno piace caldodi Maurizio Corrado (Doppiozero, 11 luglio 2019)
La buona notizia è che non è vero che i combustibili fossili si stanno esaurendo, la cattiva è che non è una fake news, continueremo a riversare tonnellate di veleno nell’aria come non ci fosse un domani. Mentre fra le sabbie arabe e negli altri pozzi che bucherellano la terra si continuava a estrarre l’oro nero alla vecchia maniera, nel 2008 è stata messa a punto una nuova tecnologia chiamata fracking. L’idea è semplice: immaginate di appoggiare uno smisurato martello pneumatico alla crosta terrestre e di accenderlo in modo che, al posto dell’asfalto, frantumi la crosta rocciosa del pianeta sparando “un cocktail di prodotti chimici mescolati a grandi volumi d’acqua ad altissima pressione” riuscendo a raggiungere le sabbie bituminose sottostanti, intrise di petrolio di roccia, tigh oil, e gas naturale. Quando si è visto che il metodo funzionava, il mondo delle multinazionali ha tirato un grosso sospiro di sollievo, già si stavano quasi rassegnando a doversi convertire a metodi di produzione d’energia più puliti e meno remunerativi, visto che ormai era chiaro che mancavano una manciata di anni alla fine delle riserve. Invece no, improvvisamente la nuova tecnologia apre altri orizzonti.
 Gli Stati Uniti scoprono, insieme a Regno Unito, Cina e Russia, di avere delle riserve in casa, iniziano a diminuire le importazioni di petrolio e gas, e già dai tempi dell’amministrazione Obama qualcuno inizia a parlare di autosufficienza, con l’immancabile contorno di milioni di nuovi posti di lavoro, costo basso dell’energia e conseguente ripristino della minacciata supremazia statunitense nella politica mondiale, idee ereditate dalla nuova dirigenza americana a cui piacciono tanto anche perché aiutano a ignorare le innumerevoli ricerche scientifiche che danno sempre meno anni di vita alla vita stessa su questo pianeta.
Gli Stati Uniti scoprono, insieme a Regno Unito, Cina e Russia, di avere delle riserve in casa, iniziano a diminuire le importazioni di petrolio e gas, e già dai tempi dell’amministrazione Obama qualcuno inizia a parlare di autosufficienza, con l’immancabile contorno di milioni di nuovi posti di lavoro, costo basso dell’energia e conseguente ripristino della minacciata supremazia statunitense nella politica mondiale, idee ereditate dalla nuova dirigenza americana a cui piacciono tanto anche perché aiutano a ignorare le innumerevoli ricerche scientifiche che danno sempre meno anni di vita alla vita stessa su questo pianeta.Di questo e altro parla L’alba dell’era solare di Prem Shankar Jha, uscito a maggio 2019 per Neri Pozza. Classe 1938, Prem Shankar Jha è un economista indiano che ha studiato filosofia, con una lunga carriera di consulente per le Nazioni Unite e il governo indiano, di corrispondente per varie testate fra cui il Financial Express e il Times of India e di docente nelle Università della Virginia, alla Haward University e all’Institut d’études politiques di Parigi.
 Il libro parte da una domanda semplice: come mai, nonostante fin dai primi anni Settanta la comunità scientifica ripeta che il mondo si trova in una situazione di forte pericolo, chi può fare concretamente qualcosa continua a non fare nulla? Prem Shankar Jha indica nella santificazione del mercato la risposta. Quando i governi seguono esclusivamente le indicazioni del mercato, diventa pressoché impossibile proporre soluzioni che non siano quelle già esistenti. Con analisi precise e piene d’informazioni analizza diversi casi mostrando come alcune delle soluzioni più efficaci siano state affossate, denigrate e infine messe da parte esclusivamente per ragioni di convenienza commerciale di pochi grandi gruppi economici.
Il libro parte da una domanda semplice: come mai, nonostante fin dai primi anni Settanta la comunità scientifica ripeta che il mondo si trova in una situazione di forte pericolo, chi può fare concretamente qualcosa continua a non fare nulla? Prem Shankar Jha indica nella santificazione del mercato la risposta. Quando i governi seguono esclusivamente le indicazioni del mercato, diventa pressoché impossibile proporre soluzioni che non siano quelle già esistenti. Con analisi precise e piene d’informazioni analizza diversi casi mostrando come alcune delle soluzioni più efficaci siano state affossate, denigrate e infine messe da parte esclusivamente per ragioni di convenienza commerciale di pochi grandi gruppi economici.
 Non è la prima volta che si alza una voce di questo genere, la differenza con anche solo qualche anno fa sta nell’inquietante urgenza che assumono i temi sul tappeto ogni ora, ogni minuto, ogni secondo che passa. Proprio mentre state leggendo queste parole, ci stiamo dirigendo verso quello che già alla fine degli anni Settanta lo scienziato inglese James Lovelock chiamava il punto di non ritorno.
Non è la prima volta che si alza una voce di questo genere, la differenza con anche solo qualche anno fa sta nell’inquietante urgenza che assumono i temi sul tappeto ogni ora, ogni minuto, ogni secondo che passa. Proprio mentre state leggendo queste parole, ci stiamo dirigendo verso quello che già alla fine degli anni Settanta lo scienziato inglese James Lovelock chiamava il punto di non ritorno.Uno dei dati più inquietanti sta nell’ormai innegabile scioglimento dei ghiacci polari. Ma qui non si parla di orsi bianchi denutriti, di foche e trichechi che perdono il loro ambiente naturale, non si parla neppure della distruzione degli Inuit, che hanno subito la medesima sorte di ogni popolo che ha incontrato la nostra cultura addomesticata, cioè l’estinzione, culturale e fisica. C’è un problema sotto il ghiaccio. Agli inizi dell’ultima era glaciale, circa trentamila anni fa, un’immensa massa di resti vegetali si sono congelati formando quello che viene chiamato permafrost, uno strato della crosta terrestre che circonda il polo Nord, si estende sotto il mar Glaciale Artico ed è profondo da alcuni metri a più di tre chilometri. Il problema è che al suo interno sono intrappolati da 1,3 a 1,7 trilioni di tonnellate di carbonio sotto forma di resti vegetali in decomposizione. È una quantità che supera di almeno duemila volte l’annuale emissione prodotta dall’uomo. A questi si aggiungono i cosiddetti clatrati, o idrati di metano, un composto solido in cui una cospicua quantità di metano è come intrappolata in una struttura cristallina simile al ghiaccio. Un chilo di clatrato può contenere fino a 168 litri di gas metano.
 Detto in termini semplici, sotto i ghiacci del Polo c’è una quantità di gas intrappolato che se venisse liberato produrrebbe una catastrofe di proporzioni inimmaginabili, qualcosa di simile a quanto succede ne La nube purpurea, un romanzo di Matthew Shiel del 1901, dove una immissione di gas venefico proveniente dal mare provoca lo sterminio completo di tutta l’umanità a parte il protagonista e una ragazza che si salva perché sempre vissuta in una grotta.
Detto in termini semplici, sotto i ghiacci del Polo c’è una quantità di gas intrappolato che se venisse liberato produrrebbe una catastrofe di proporzioni inimmaginabili, qualcosa di simile a quanto succede ne La nube purpurea, un romanzo di Matthew Shiel del 1901, dove una immissione di gas venefico proveniente dal mare provoca lo sterminio completo di tutta l’umanità a parte il protagonista e una ragazza che si salva perché sempre vissuta in una grotta.E proprio dal mare può arrivare un’altra reazione che ci potrebbe scaraventare oltre il punto di non ritorno. Anche qui, non è tanto ciò su cui è concentrata l’attenzione mediatica, cioè l’inquinamento con la plastica, ma il fatto che gli oceani assorbono due terzi di tutta l’anidride carbonica trattenuta dalla natura attraverso le alghe e il fitoplancton. Quando la temperatura degli oceani supera una certa soglia, l’acqua in superficie smette di scendere e quella più fredda in profondità smette di salire, il fitoplancton non riesce più a vivere, l’equilibrio si spezza, l’anidride carbonica non viene più assorbita e cresce andando a incrementare il riscaldamento globale. Ecco un’altra formula che, reiterata all’infinito, si è scolorita perdendo il vero significato a favore di ciò di cui la riempiono i media quotidianamente, comprese le azioni della bimba svedese che ha trascinato con sé le nuove generazioni verso una ribellione contro il mondo degli adulti, colpevole di aver trascinato il mondo sull’orlo del baratro, ottenendo come effetto secondario che quel mondo relega questo genere di preoccupazioni fra le bagatelle da ragazzi, da bimbi, appunto, mentre gli adulti hanno ben altro a cui pensare.
Qual è la soluzione? Prem Shankar Jha sostiene che siamo ancora in tempo. Dobbiamo non solo smettere di produrre anidride carbonica, ma mettere a punto i sistemi che ci permettono di estrarla dall’atmosfera. Per l’autore indiano uno dei noccioli della questione sta nei trasporti, nel trovare un’alternativa valida alla benzina, alternativa che non solo è già disponibile da tempo, ma che ha avuto anche modo di essere già sapientemente affossata dai grandi gruppi economici. -Produrre energia dai rifiuti generici delle città e dagli scarti delle lavorazioni agricole, le biomasse, attraverso processi non inquinanti e convenienti è già una realtà in molti paesi, si tratta di indirizzare le lavorazioni verso la produzione di metanolo. Nel ’43, in piena Seconda Guerra Mondiale, la Germania aveva iniziato a usarlo come carburante su larga scala, dagli anni Cinquanta in due paesi lontani fra loro geograficamente e politicamente, Sudafrica e California, il metanolo veniva mischiato alla benzina con risultati eccellenti dato che la miscela aumenta le potenzialità del motore. Il problema della diffusione del metanolo non sta solo nella rete di distribuzione che deve attrezzarsi, ma soprattutto nella lobby agricola che ha spinto l’etanolo che, prodotto dall’amido di mais, ne provoca l’aumento di prezzo e mette a rischio larghe fasce di popolazione. Negli Stati Uniti, “secondo un rapporto del dipartimento dell’Energia, il metanolo era stato sconfitto dall’etanolo perché non aveva il sostegno di una lobby organizzata.”
Prem Shankar Jha analizza a fondo eolico, fotovoltaico ed etanolo mostrando come, essendo tutte soluzioni scarsamente efficaci, proprio per questo sono spinte dal sistema che non le teme, mentre le soluzioni che potrebbero rivoluzionare veramente la produzione di energia sono combattute e messe in condizioni di non nuocere. Tra queste, quella che più ritiene valida è l’energia solare termodinamica sviluppata dagli impianti a concentrazione solare, Concentrating Solar Power, CSP. Contrariamente al fotovoltaico, per la loro costruzione non si usano materiali rari ma essenzialmente acciaio e specchi. Il principio è molto simile a quello usato da Archimede per bruciare le navi romane durante l’assedio di Siracusa, una serie di specchi che dirigono la luce e il calore del sole in un punto centrale.
 Il 5 febbraio 2016 si è inaugurato a Ouarzazate in Marocco l’impianto a concentrazione solare più grande del mondo. L’azienda è spagnola, la volontà di costruirlo è del governo marocchino che non vuole più dipendere dalle importazioni per il fabbisogno energetico. Il risultato è che da quando l’impianto è in funzione la dipendenza energetica del Marocco è passata dal 97% al 58%.
Il 5 febbraio 2016 si è inaugurato a Ouarzazate in Marocco l’impianto a concentrazione solare più grande del mondo. L’azienda è spagnola, la volontà di costruirlo è del governo marocchino che non vuole più dipendere dalle importazioni per il fabbisogno energetico. Il risultato è che da quando l’impianto è in funzione la dipendenza energetica del Marocco è passata dal 97% al 58%.Dalle analisi di Prem Shankar Jha emerge con chiarezza la grande resistenza che ha il mondo economico nell’abbandonare i metodi di produzione dell’energia attuali soprattutto perché garantiscono la continuità della concentrazione del potere dov’è ora. Spostare la produzione dell’energia verso i paesi del sud del mondo significherebbe spostare a sud anche l’asse economico e questo, solo questo, evidentemente non è sostenibile.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
 J. Chirac, alla conferenza dei «Cittadini della Terra»: «Siamo alla soglia dell’irreversibile» (2007).
J. Chirac, alla conferenza dei «Cittadini della Terra»: «Siamo alla soglia dell’irreversibile» (2007).RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- "L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE", L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO8 maggio 2019, di Federico La Sala
NEL REGNO DI EDIPO: "L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE", L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO... *
- APPELLO DI DONNE CRISTIANE CONTRO IL CONGRESSO MONDIALE DELLE FAMIGLIE ( Il paese delle donne on line - Rivista, 25.03.2019).
- "A me e a voi, suppongo, è chiaro che prima della famiglia, comunque intesa, c’è la diade formata da una donna e dalla creatura che lei ha concepito e portato al mondo" (Luisa Muraro, "Appello di una femminista alle donne cristiane che sono contro il Congresso mondiale delle famiglie", "www.libreriadelledonne.it", 29.03 2019)
Appello di una femminista alle donne cristiane che sono contro il Congresso mondiale delle famiglie
di Luisa Muraro (Libreria delle donne, 29 Marzo 2019) *
Care amiche, vorrei sottoscrivere il vostro Appello contro il Congresso delle famiglie a Verona. Sono d’accordo con quello che dite, in primo luogo che la famiglia non è un’entità naturale ma un’istituzione culturale, che quasi sempre mostra una forte impronta patriarcale.
A me e a voi, suppongo, è chiaro che prima della famiglia, comunque intesa, c’è la diade formata da una donna e dalla creatura che lei ha concepito e portato al mondo. È un rapporto molto speciale, che precede i dualismi tipici della cultura maschile: la donna che accetta di entrare nella relazione materna, alla sua creatura dà la vita e insegna a parlare, le due cose insieme. Ed è un “insieme” che si tende, come un ponte insostituibile, sopra l’abisso della schizofrenia umana.
Vorrei ma non posso sottoscrivere il vostro Appello perché, nella difesa delle nuove forme familiari, non c’è una critica di quelle che si costituiscono da coppie che, sfortunatamente o naturalmente sterili, invece di adottare, si fanno fare la creatura a pagamento.
Da donne cristiane, mi aspettavo una calorosa difesa dell’adozione e un’energica richiesta della sua estensione a persone e coppie finora escluse dalla legge. Ma, ancor più, essendo voi donne, mi aspettavo una difesa della relazione materna libera e responsabile così come oggi è diventata possibile. Invece, parlate solo di genitorialità, usate cioè una parola tipica del linguaggio neutro-maschile. E a voi che parlate del corpo femminile come luogo di spiritualità incarnata, chiedo: che famiglia è mai quella che nasce con il programma esplicito, messo nero su bianco, di cancellare la relazione materna che si sviluppa con la gestazione in un intimo scambio biologico e affettivo?
Voi, a differenza di tanti cattolici, leggete la Bibbia e sapete che la cosiddetta gravidanza per altri, ossia la donna che partorisce senza diventare madre, corrisponde pari pari ad antiche usanze del patriarcato, usanze che sembravano superate. Le ultime pagine del Contratto sessuale di Carole Pateman, parlano proprio di questo sostanziale arretramento. Detto alla buona, ci sono “nuove” famiglie che di nuovo hanno solo la tecnologia.
A proposito: che cosa pensano di tutto questo gli uomini vicini a voi, i vostri compagni di fede e d’impegno politico? Perché non compaiono nel vostro Appello? Mi è venuto un sospetto, di ritrovarmi davanti a quel noto comportamento maschile che è di nascondersi dietro a una o più donne quando si vuol far passare pubblicamente qualcosa che è contro le donne. Devo portare degli esempi? Ma, se questo non fosse vero, scusatemi.
* www.libreriadelledonne.it, 29 marzo 2019
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. COME NASCONO I BAMBINI? - E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?!
Cultura e civiltà. L’ordine simbolico della madre.....
 NEL REGNO DI EDIPO. L’ordine simbolico di "mammasantissima"
NEL REGNO DI EDIPO. L’ordine simbolico di "mammasantissima""L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE": L’ALLEANZA CATTOLICO-"EDIPICA" DEL FIGLIO CON LA MADRE!!!
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
DOC.
APPELLO DI DONNE CRISTIANE CONTRO IL CONGRESSO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Le donne presenti all’incontro nazionale sul tema “I nostri corpi di donne, da luogo del dominio patriarcale a luogo di spiritualità incarnata” (Roma dal 22 al 24 marzo 2019 - Casa Internazionale delle donne), manifestano il profondo sconcerto per il sostegno che alcune Istituzioni politiche e religiose hanno dato al Congresso mondiale delle famiglie, che vuole riportarci su posizioni retrograte e omofobe.
Siamo donne che da molti anni hanno intrapreso un percorso per liberarsi dalle gabbie di un sistema religioso, sociale e politico, impregnato di patriarcato.
Quanto lavoro per uscire da un mondo di istituzioni, di segni, di linguaggi che continuamente riproducono una immagine stereotipata della donna “sposa e madre”, una disparità di poteri, di diritti, di autorevolezza.
Che tristezza adesso constatare che alcune Istituzioni pubbliche patrocinano un Congresso mondiale sulla famiglia impropriamente definita “naturale”.
C’è ben poco di naturale in questa istituzione sociale fondata sul matrimonio nata come forma di contratto sociale e religioso, in un determinato contesto storico.
La famiglia “naturale” non esiste, esiste una struttura familiare che ha dato molto alla società, ma che ora è in crisi e in cambiamento. Non serve uno sguardo nostalgico al passato, serve il coraggio di dire che possono esistere vari modelli di famiglia che sperimentano forme anche nuove di solidarietà, genitorialità basate sull’amore e il rispetto reciproci.
Denunciamo che gli slogan utilizzati e gli obiettivi proposti sono la quint’essenza del dominio patriarcale, responsabile della violenza sulle donne, di cui ci siamo liberate e di cui non vogliamo il ritorno.
Chiediamo quindi che le istituzioni pubbliche non finanzino e non diano il patrocinio a iniziative discriminatorie e intolleranti.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- LE ASTUZIE DELL’ INTELLIGENZA, ELENA DI TROIA, E FAUST. ERNST R. CURTIUS AVEVA RAGIONE (HAROLD BLOOM).18 aprile 2019, di Federico La Sala
P. S. 7 - “LE ASTUZIE DELL’ INTELLIGENZA NELL’ANTICA GRECIA”, I “TOPOI” DELLA “RETORICA ANTICA”, E “LA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE”... *
ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO. Se Curtius avesse seguito il filo (etico e metodologico) rintracciato nell’analisi dell’opera di Marcel Proust (il “relazionismo”, poi, proposto da Mannheim in “Ideologia e utopia” ) e, al contempo, esplorato di più e meglio i “topoi” della «retorica antica» (R. Barthes), forse, avrebbe condiviso con Marcel Detienne “la divertita scoperta che nella Grecia della geometria e della logica, le dicerie avevano una loro dea, «Femé»” (Paolo Fabbri), sarebbe stato molto più critico nei riguardi della “Fama” di Goethe, più attento nei confronti del lavoro di Karl Mannheim e del vincitore del “Premio Goethe” dell’anno 1930 (Sigmund Freud) e meno fiducioso in una prospettiva di “individuazione” (Carl G. Jung) ancora segnata dalla figura di Edipo.
SU COME E QUANTO CURTIUS avesse ragione, però, è da dire che Harold Bloom lo ha ben chiarito nel capitolo dedicato al «Faust: seconda parte di Goethe: il poema controcanonico» nel suo “Canone occidentale”, richiamando “[...] la straordinaria fantasticheria su Elena, meravigliosa quanto oltraggiosa trasposizione della Germania in Grecia”:
“Con la solita audacia, Goethe - così prosegue Bloom - parodizza Omero e le tragedie ateniesi per offrirci uno dei più singolari poemi mai scritti: la resurrezione di Elena di Troia, la sua unione con Faust, la nascita e morte del loro figlio Euforione, e il ritorno di Elena tra le ombre. Al pari della notte di Valpurga classica, e al pari dei cori celestiali che concludono la «Seconda parte», la Elena che Goethe ci offre è un poema controcanonico, una impensabile revisione di Omero, Eschilo ed Euripide, come se la Notte di Valpurga classica rivoltasse come un guanto le origini della mitologia greca, e i cori conclusivi parodiano il Paradiso di Dante con una verve sottilmente crudele”.
CURTIUS - scrive Bloom - “aveva ragione: Goethe ha messo fine a un aspetto della tradizione. [...] è davvero l’ultimo grande scrittore dell’età inaugurata da Dante. Per scrivere un epos controcanonico o un dramma cosmologico come «Faust, Seconda parte», occorre un intimo rapporto con il Canone di cui nessun’altro, dopo Goethe, ha sofferto (o goduto). Ciò conferisce particolare pregnanza al decesso di Faust, perché a morire è ben più che non il personaggio Faust” (cfr. H. Bloom, “Il canone occidentale. I libri e le scuole delle età”, Milano 1994, pp. 208-209).
Sul tema, infine (mi sia lecito), si cfr. «L’homunculus di Goethe è il simbolo di quella che Husserl denuncia come “crisi delle scienze”» di Enzo Paci (dal “Diario fenomenologico”) , e le mie note sul suo dialogo “Nicodemo o della nascita”.
- * Riprendo qui UNA delle note allegate all’articolo di Paolo Fabbri, "Marcel Detienne: memorie felici e concetti indelebili", apparso su "Alfabeta-2", 31.03.2019).
-
> IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. - CLIMA. L’onda verde di una generazione può cambiare il mondo (di Aldo Masullo).22 marzo 2019, di Federico La Sala
Clima, Aldo Masullo: "L’onda verde dei giovani che sferza la politica"
L’analisi del grande filosofo dopo le recenti manifestazioni per l’ambiente, contro il riscaldamento globale del pianeta
di ALDO MASULLO (la Repubblica/Napoli, 22 marzo 2019)
Il mondo umano è divenuto, per dirla con Leopardi, "stretto", troppo stretto, strettissimo. Nelle catastrofi geologiche le placche continentali, premute l’una contro l’altra dai cedimenti tettonici, si accavallano deformandosi. Così il mondo che noi siamo, globalizzandosi, si è oggi compresso, schiacciato su se stesso, ha perso ogni porosità, è divenuto un blocco rigido. Tutti i suoi vuoti si sono riempiti. I buchi in cui si scaricavano i residui dei metabolismi, che toccava poi al tempo lungo distruggere, ora sono ostruiti, e il corpo del mondo, riempito dai suoi stessi escrementi, mostruosamente si gonfia. La sempre più capillare lotta tra le varie forze umane, che in se stesse senza sosta scomponendosi irresistibilmente accrescono gli scontri, non ha spazi per sia pur brevi pause. Le comunicazioni di massa e le affollate piazze elettroniche sempre più velocemente si rinviano segnali senza senso, cioè senz’altri significati che se stessi. Non c’è respiro.
In un mondo così ridotto una sola funzione lavora alla grande: la centrifugazione. L’enorme macchina mondo non fa altro che dall’immensa massa solida e opaca dei più separare la lucida liquidità dei pochissimi che hanno raggiunto il nuovo Olimpo, cioè la ricchezza e il potere, o almeno l’effimera celebrità. Le parti che la centrifugazione ha separate, restando chiuse entro la medesima strettezza, per l’inevitabile ruvidità dei loro contatti fanno attrito, e la tensione si accresce. Il bisogno senza soddisfazione possibile si fa brama rabbiosa.
Ad ogni individuo l’altro appare come una minaccia, contro cui non s’immagina difesa che non sia l’aggressione. Nessuno sopporta il suo prossimo. In tutti, anche nei mansueti, domina l’insofferenza, il cui aumento totale ancor più gonfia il mondo d’ira e di odio. Come sempre, non v’è vizio o disgrazia o pericolo, che non siano ottime occasioni per affaristi. Non mancano dunque persone e gruppi che profittano dell’ira e dell’odio per farsene supporto di potere politico. Così sulla febbre del mondo si getta acqua bollente.
Ma la febbre dipende essenzialmente dalla percezione del pericolo globalizzato. Non c’è luogo né tempo in cui poter immaginare di rifugiarsi. Crescono l’oscuro avvertimento del pericolo in agguato d’ogni parte e il presentimento di un futuro sempre peggiore. La sensazione di fondo, angosciosa, è che non c’è scampo. Peraltro, se si vuole, come si deve, ignorando le emozioni considerare lo stato delle cose con freddo giudizio, si è costretti a riconoscere che le emozioni non hanno torto.
Globale infatti è il dominio per cui si preparano a scontrarsi le massime potenze continentali; globale è il potere tecnologico a cui si mira; globale è la distruttività degli armamenti che non si cessa di accumulare; globale è lo sconvolgimento che lo sviluppo produttivo selvaggio opera nel delicato equilibrio dell’ecosistema. Sono tutti processi molto difficilmente reversibili, anzi oltre un certo limite, oltre un punto di non ritorno, irreversibili. E sono tutte minacce globali. Ma il dissesto dell’ecosistema è la minaccia che per gl’inauditi furori e i devastanti effetti del mutamento climatico è immediatamente percepibile. A questo stato d’insicurezza globale le generazioni che hanno finora gestito il mondo, sempre più impigliate negl’ingranaggi del loro sfrenato attivismo, ci hanno portati, e non sono capaci neppur di cominciare a porvi riparo.
L’allarme intanto risuona sempre più forte. Qualche giorno fa il Presidente della Repubblica ha con autorevole saggezza denunciato i rischi della "crisi climatica globale". Ma chi potrebbe fronteggiare la minaccia globale che, a partire dalla crisi climatica, incombe sul mondo, se non una forza globale, moralmente intatta, capace di ragionare in modo nuovo? In questi giorni la speranza si è accesa. "L’onda verde di una generazione può cambiare il mondo". Lo ha notato, tra gli altri, il sociologo Ilvo Diamanti a commento delle manifestazioni che venerdì scorso hanno accomunato un milione e mezzo di giovani in ogni praticabile piazza del mondo. Si tratta di una generazione "global" perché, "per quanto cresciuta in un contesto "no-global", di critica alla globalizzazione", essa di fatto si è "affermata oggi in prospettiva "globale"", "guardando "avanti", per necessità e per vocazione".
Soprattutto, nota il sociologo, i giovani nell’abbraccio di tutti con tutti hanno rotto la loro solitudine digitale, si sono sottratti alle "relazioni senza empatia", hanno rifiutato l’autosequestro nel bozzolo elettronico. Sarà forse quest’immensa onda verde giovanile un’iridescente bolla di sapone destinata in breve a dissolversi contro il potere dell’ottusità globalizzata? Eppure non si scherza! L’allarme degli scienziati è drastico: se le emissioni di CO2 continuano al ritmo attuale, nel 2030, cioè tra 11 anni!, si produrrà con l’aumento della temperatura una situazione globale di irreversibile disastrosità.
Dunque per i ragazzi di oggi ne va della maggior parte della vita che hanno da vivere. Ancor più ne va per la vita delle generazioni successive, per la sopravvivenza dell’umanità stessa. In effetti nella minaccia climatica si riassumono tutte le minacce globali.
Capire ciò, capirlo sul serio, cioè agendo, è porsi in una prospettiva globale del tutto nuova: significa nel proprio vivere levarsi all’altezza del come è necessario pensare, affinché la storia umana continui. In ogni modo, il fatto che questa generazione di ragazzi si sia messa in movimento comporta da subito, nei giorni del nostro mondo tutto "stretto" nella sua globalità soffocante, la boccata d’aria frizzante di curiose inversioni generazionali: giovani che precedono lungimiranti gli adulti, insegnanti che imparano dagli allievi le buone pratiche, padri a cui i figli additano la via della salvezza. Un tal paradosso mette allegria prima ancora che speranza.
D’un tratto sembra possibile che la globalizzazione significhi un mondo non più "stretto" ma, ancor nel linguaggio leopardiano, più "largo": non bloccato in una soffocante pienezza, dove le varie moltitudini si riducono ad altrettante fobiche identità pressate l’una contro l’altra, bensì ricchezza di spazi aperti per incontri pacifici d’innumerevoli diversità, tutte libere, insomma un universo elastico di umanità in espansione.
-
> PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- #Strike4Climate. Greta Thunberg: "Non c’è più tempo, anche gli adulti devono agire", dice la ragazzina e fa appello ai suoi coetanei: "Mobilitiamoci tutti per cambiamenti reali".15 marzo 2019, di Federico La Sala
LA TERRA AL "CAPOLINEA". Manifestazioni in tutto il mondo per il salvare il pianeta...
Sciopero clima: in Italia 182 piazze da nord a sud
Gli organizzatori,no a simboli di partito o bandiere identitarie
di Redazione Ansa *
Migliaia di studenti scenderanno in piazza oggi, in 150 Paesi, per lo "Strike4Climate", manifestazione che sostiene la battaglia in difesa del clima dell’attivista 16enne svedese Greta Thunberg, promotrice delle marce di giovani in tutta Europa. La giovane è stata proposta da tre parlamentari norvegesi per il premio Nobel per la Pace. "Non c’è più tempo, anche gli adulti devono agire", dice la ragazzina e fa appello ai suoi coetanei: "Mobilitiamoci tutti per cambiamenti reali". E già decine di migliaia di giovani sono scesi in piazza in 50 città di Australia e Nuova Zelanda.
Piccole, medie e grandi città italiane per un totale 182 piazze in cui oggi i giovani daranno vita allo sciopero per il clima. Non ci saranno simboli di partito o bandiere identitarie almeno questa è la richiesta degli organizzatori, ma solo cartelli e striscioni sul tema dei cambiamenti climatici. ROMA: nella Capitale partiranno mini-cortei da scuole medie inferiori e licei e istituti, mentre dagli atei i manifestanti si muoveranno in bicicletta. Un corteo partirà dalla fermata metro Colosseo alle 10.30 per arrivare nella vicina piazza Madonna di Loreto, a pochi passi da piazza Venezia, dove alle 11 inizieranno gli interventi sui gradini. Unico adulto al microfono il geologo Mario Tozzi, poi 7 interventi di studenti delle elementari, medie, licei e università, dai 9 ai 24 anni.
MILANO: i giovanissimi attivisti attraverseranno la città con una marcia per il clima che partirà alle 9,30 da largo Cairoli e arriverà a piazza della Scala,davanti alla sede del Comune dove, dalle 11 alle 13, è prevista la manifestazione. Alle 18 un’altra manifestazione, a cui aderiscono associazioni ambientaliste come Greenpeace, partirà sempre da largo Cairoli per un corteo in difesa dell’ambiente. Sempre in città la scuola media di primo grado Pertini ha organizzato una marcia per il clima in collaborazione con Legambiente, alla quale parteciperà anche il sindaco, Giuseppe Sala, a fianco degli studenti.
 VIDEO. Manifestazioni in tutto il mondo per il salvare il pianeta
VIDEO. Manifestazioni in tutto il mondo per il salvare il pianeta*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
MASSIMO ALLARME TERRA: IL DOVERE DELLA PAURA. CINQUE MINUTI A MEZZANOTTE. Cambia il clima del pianeta, cambieranno i nostri modi di vivere, ed è sperabile che anche la politica cambi. Un’analisi di Barbara Spinelli
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- SULLE TRACCE DI EUROPA. ARACNE, PENELOPE, E "UN FALSO MITO".12 febbraio 2019, di Federico La Sala
SULLE TRACCE DI EUROPA. ARACNE, PENELOPE, E "UN FALSO MITO"... *
- IL MITO DI ARACNE (Publio OVIDIO Nasone, Metamorfosi, VI, 1-145 (trad. a cura di Bernardini Marzolla P., Einaudi, Torino 1994)
Pàllade, la dèa del Tritone, aveva seguito con attenzione il racconto. Elogiò il canto delle dee d’Aònia, e trovò giusta la loro ira. Ma poi, tra sé: “Lodare va bene, ma anche io voglio essere lodata, nemmeno io permetterò che si disprezzi la mia divinità impunemente!” E decise di rovinare Aracne della Meònia, la quale - le era giunta voce - non intendeva considerarsi inferiore a lei nell’arte di lavorare la lana. Costei, non per ceto o lignaggio era famosa, ma perché era un’artista. Suo padre, Idomone di Colofonie, tingeva la lana spugnosa con porpora di Focèa; la madre era morta, ma anch’essa era una popolana, della stessa condizione del marito. Malgrado ciò, Aracne con la sua attività si era fatta n gran nome per le città della Lidia, benché, nata appunto da umile famiglia, abitasse nell’umile Ipèpe.
Per vedere i suoi meravigliosi lavori, spesso le ninfe del Timolo lasciarono i loro vigneti, le ninfe del Pactòlo lasciarono le loro acque. E non soltanto meritava vedere i tessuti finiti, ma anche assistere a quando li faceva, poiché era un vero spettacolo. Sia che agglomerasse la lana greggia nelle prime matasse, sia che lavorasse di dita e sfilacciasse uno dopo l’altro con lungo gesto i fiocchi simili a nuvolette, sia che con l’agile pollice facesse girare il liscio fuso, sia che ricamasse, si capiva che la sua maestria veniva da Pàllade. Ma Aracne sosteneva di no, e invece di essere fiera di una così grande maestra, diceva impermalita: “Che gareggi con me! Se mi vince potrà fare di me quello che vorrà”.
Pàllade si traveste da vecchia, si mette sulle tempie una finta capigliatura bianca e prende anche un bastone che sorregga le membra piene di acciacchi. Poi comincia a parlare così: “Non tutto è male nell’età avanzata. Più si invecchia più cresce l’esperienza. Dài retta a me: ambisci pure ad essere la più grande tessitrice, tra i mortali; ma non voler competere con la dèa,e chiedile con voce supplichevole di perdonarti per quello che hai detto, o temeraria; chiediglielo, e non ti rifiuterà il perdono”.
Aracne le lancia una torva occhiata, lascia andare i fili già cominciati e a stento trattenendosi dal percuoterla, con una faccia che tradisce l’ira, così dice di rimando a Pàllade che ancora non si è palesata: “O scimunita, smidollata dalla lunga vecchiaia, vivere troppo eccome se rovina! Queste cose valle a dire a tua nuora, valle a dire a tua figlia, se ne hai una! Io mi so regolare benissimo da me, e perché tu non ti creda di aver combinato qualcosa con i tuoi ammonimenti, sappi che io la penso come prima. Perché non viene qui? Perché non accetta la sfida?”
Allora la dèa: “È venuta!”, dice, e si spoglia della figura di vecchia e si rivela - Pàllade. Le ninfe e le donne della Lidia si prostrano dinnanzi alla divinità; soltanto la vergine non si spaventa. Tuttavia trasalisce, e un improvviso rossore le dipinge suo malgrado il viso e poi ridilegua, come l’aria s’imporpora al primo comparire dell’aurora e dopo breve tempo s’imbianca, quando sorge il sole. Insiste sulla via che ha preso, e per insensata bramosia di gloria corre verso la propria rovina.
E infatti la figlia di Giove non rifiuta, e non l’ammonisce più, e nemmeno rinvia più la gara. Subito si sistemano una da una parte, l’altra dall’altra, e con gracile filo tendono ciascuna un ordito. L’ordito in alto è legato al subbio, il pettine di canna tiene distinti i fili, la spola appuntita inserisce la trama, con l’aiuto delle dita, e i denti intagliati nel pettine, dando un colpo, comprimono la trama passata tra un filo e l’altro.
Lavorano tutte e due di lena, e liberate le spalle dalla veste muovono le braccia esperte, con tanto impegno che non sentono fatica. Mettono nel tessuto porpora che ha conosciuto la caldaia a Tiro, e sfumature delicate, distinguibili appena: così, quando la pioggia rifrange i raggi solari, l’arcobaleno suole tingere con grande curva, per lungo tratto, il cielo, e benché risplenda di mille diversi colori, pure il passaggio dall’uno all’altro sfugge all’occhio di chi guarda, tanto quelli contigui si assomigliano, sebbene gli estremi differiscano. Anche intridono i fili di duttile oro, e sulla tela si sviluppa un’antica storia.
Pàllade effigia il colle di Marte nella città della di Cècrope [ATENE] e l’antica contesa sul nome da dare alla contrada. Sei dèi più sei, e Giove nel mezzo, siedono con aria grave e maestosa su scanni eccelsi: ciascuno ha come impressa in volto la propria identità; l’aspetto di Giove è quello di un re. Poi disegna il dio del mare, mentre colpisce col lungo tridente il macigno di roccia e da questo squarciato fa balzare un cavallo indomito, perché la città gli venga aggiudicata. A sé stessa assegna uno scudo, un’asta dalla punta acuminata, un elmo e l’egida per proteggere il capo e il petto; e rappresenta la terra che percossa dalla sua lancia genera l’argentea pianta dell’ulivo con le sue bacche; e gli dei che guardano stupefatti; infine la propria vittoria. Ma perché la rivale capisca da qualche esempio cosa dovrà aspettarsi per così folle ardire, aggiunge ai quattro angoli quattro altre sfide, vivaci nei colori, ma nitide nei tratti minuti. In un angolo si vedono Ròdope di Tracia ed Emo, ora gelidi monti, un tempo esseri mortali, che avevano usurpato il nome degli dei maggiori. Dall’altra parte la sorte pietosa della madre dei Pigmei: avendola vinta in una gara, Giunone impose che diventasse una gru e s’azzuffasse col suo popolo. Poi effigia Antigone, che una volta osò competere con la consorte del grande Giove e che dalla regale Giunone fu mutata in uccello: né Ilio né il padre Laomedonte poterono impedire che, spuntatele le penne, come candida cicogna applaudisse sé stessa battendo il becco. Nell’angolo che rimane Cìnira, perdute le figlie, abbraccia i gradini di un tempio, già carne della sua carne, e, accasciato sulla pietra, si staglia in lacrime.
 Contorna i bordi con rami d’olivo, segno di pace, e con la pianta che le è sacra conclude l’opera sua.
Contorna i bordi con rami d’olivo, segno di pace, e con la pianta che le è sacra conclude l’opera sua.Aracne invece disegna Europa ingannata dalla falsa forma di toro: diresti che è vero il toro, vero il mare; la si vede che alle spalle guarda la terra e invoca le compagne, e come, per paura d’essere lambita dai flutti che l’assalgono, ritragga timorosa le sue gambe. E raffigura Asterie che ghermita da un’aquila si dibatte, raffigura Leda che sotto le ali di un cigno giace supina; e vi aggiunge Giove che sotto le spoglie di un satiro ingravida di due gemelli l’avvenente figlia di Nicteo; che per averti, Alcmena di Tirinto, si muta in Anfitrione; che trasformato in oro inganna Dànae, in fuoco la figlia di Asopo, in pastore Mnemosine, in serpe screziato la figlia di Cerere. Effigia anche te, Nettuno, mentre in aspetto di torvo giovenco penetri la vergine figlia di Eolo, mentre come Enìpeo generi gli Aloìdi, e inganni come ariete la figlia di Bisalte; te, che la mitissima madre delle messi dalla bionda chioma conobbe destriero, che la madre con serpi per capelli del cavallo alato conobbe uccello e Melanto delfino. Ognuno di questi personaggi è reso a perfezione e così l’ambiente. E c’è pure Febo in veste di contadino, e le volte che assunse penne di sparviero o pelle di leone, e che in panni di pastore ingannò Isse, figlia di Macareo. C’è come Libero sedusse Erìgone trasformandosi in uva, come Saturno in cavallo generò il biforme Chirone.
 Tutto intorno alla tela corre un fine bordo, con fiori intreccisti a rami d’edera flessuosi.
Tutto intorno alla tela corre un fine bordo, con fiori intreccisti a rami d’edera flessuosi.Neppure Pàllade, neppure la Gelosia poteva trovar qualcosa da criticare in quell’opera. Ma la bionda dèa guerriera ci rimase malissimo e fece a brandelli la tela che illustrava a colori le colpe degli dèi, e trovandosi in mano la spola di legno del Citoro, tre e quattro volte colpì con quella sulla fronte Aracne, figlia di Idmone. La poveretta non lo tollerò, e corse impavida a infilare il collo in un cappio.
Vedendola pendere, Pàllade ne ebbe compassione e la sorresse, dicendo così: “Vivi pure, ma penzola, malvagia, e perché tu non stia tranquilla per il futuro, la stessa pena sia comminata alla tua stirpe e a tutti i tuoi discendenti!” Detto questo, prima di andarsene la spruzzò di erbe infernali, e subito al contatto del terribile filtro i capelli scivolarono via, e con essi il naso e gli orecchi; e la testa diventa piccolissima, e tutto il corpo d’altronde s’impicciolisce. Ai fianchi rimangono attaccate esili dita che fanno da zampe. Tutto il resto è pancia: ma da questa, Aracne riemette del filo e torna a rifare - ragno - le tele come una volta.
NOTE...
RIANDANDO CON LA MEMORIA alla “poesia” della RAGAZZA e del RAGNO, della “TARANTATA”, di Pellegrino Scardino di San Cesario, e, RICORDANDO CHE il mito di ARACNE raccontato da OVIDIO (Metamorfosi, VI, 1-145) "narra della sfida tra Athena ed Aracne sull’arte della tessitura. E’ proprio Aracne a lanciare la sfida, e ne pagherà le tragiche conseguenze: non solo ha osato sfidare la dea, ma la rabbia che suscita in Athena è nel fatto che le sue tele si mostrano addirittura superiori a quelle della dea stessa. L’ira che la fanciulla provocherà in Athena sarà tale da costringerla al tentativo di suicidarsi: non poteva reggere difatti il peso della rabbia divina. Ma la dea fermerà il tentativo di suicidio di Aracne e la trasformerà in ragno" e, ANCORA, che sul tema - come ha ricordato lo stesso Gianfranco Mele (ARACNE, LE TARANTATE, E UN FALSO MITO - il prof. Armando Polito ha offerto brillanti contributi di approfondimenti iconografici, credo sia opportuno invitare ancora e di nuovo a una lettura attenta dell’intera narrazione ovidiana, per cercare possibili ragioni del "falso mito".
CONTRARIAMENTE a quanto si è pensato e si continua a pensare, c’è un filo doppio che lega Athena e Aracne - una identità speculare (uguale e opposta) che emerge chiara dal confronto della loro situazione "familiare" e e della loro “ideologia” emergente dalle "immagini" dei loro arazzi: quello di Athena che celebra la fondazione di Atene, sé stessa, e la punizione di chi osa sfidare soprattutto la sposa di Zeus, e, quello di Aracne che celebra le "avventure" di Zeus (e di altri déi) con donne mortali, a partire dal famoso "ratto di Europa" ...
ENTRAMBE, rimaste senza madre (quella di Aracne è morta, quella di Athena l’ha "ingoiata" Zeus) ed entrambe al "servizio" dei loro "Padri", SONO tutte e due collegate nelle varianti del mito a Penelope, come da scena di una xilografia del XVI sec.: Pallade e Penelope con le ancelle e Aracne indignata a tessere la tela - in attesa di un... Ulisse/Zeus, partito per le sue avventure “europee”. O, dato che ormai l’Europa è sulla via del tramonto, anche questa "variante" è da ritenersi "un falso mito"? O, in altro modo, che Athena, Aracne, Penelope, e la stessa Arianna tentano di offrire ancora la chiave per saper riconoscere un falso mito e riprendere il cammino? O no?
Federico La Sala
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
 TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. -- Elena e "Il sogno della Bellezza". La guerra dei primordi è la perversione di un sogno (di Roberto Mussapi).30 gennaio 2019, di Federico La Sala
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. In principio era il Logos ... *
Il sogno della Bellezza
di Roberto Mussapi (Avvenire, mercoledì 30 gennaio 2019)
«Un tempo mi stupivo perché una guerra così lunga/ d’Europa e d’Asia davanti a Pergamo/ fosse stata causata da una donna./ Adesso vi comprendo, siete stati saggi,/ Paride e Menelao, tu a rivolerla, / Paride a non volerla cedere. / Fu così bella che valse la pena// che in suo onore Achille morisse, / e Priamo lodasse le cause della guerra.»
Molteplici le cause delle guerre. Spesso economiche, a volte mascherate da valori civili, patriottici o religiosi. Qui però non ci riferiamo a una delle tante tragiche guerre storiche, ma alla prima, che, anche se realmente avvenuta, diviene mito di fondazione del nostro mondo. Troia esiste e fu assalita e arsa dalla lega dei greci.
Ma pur se storica, quella vicenda è mitica, oltre il tempo della storia e del calendario: un poeta, Properzio, il primo ma non l’unico, intuisce il mistero e il segreto di quella terribile contesa: Elena, moglie di un nobile greco, fuggita con un principe troiano: Elena sarà dell’uno e dell’altro, e mai di nessuno definitivamente. È la bellezza assoluta, irraggiungibile, che nessuno potrà mai definitivamente possedere.
La guerra dei primordi è la perversione di un sogno umanamente comprensibile: ognuno di noi vuole la Bellezza, e non comprende che non può essere solo sua. Ci preesiste.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
 TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
L’EUROPA, LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE, E LA LEZIONE DI NIETZSCHE.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
- Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
-
> IL PIANETA TERRA -- Nell’era del «nuovo anormale». Doomsday Clock: 2 minuti a mezzanotte - Bulletin of the Atomic Scientists.29 gennaio 2019, di Federico La Sala
L’orologio dell’Apocalisse segna 2 minuti alla catastrofe
dii Cecilia Butini (La Stampa, 29.01.2919)
La società del bollettino degli scienziati atomici di Washington ha spostato l’orologio della fine del mondo, il cosiddetto Doomsday Clock, a due minuti prima della mezzanotte, citando il rischio di una guerra nucleare e soprattutto il cambiamento climatico come i due fattori che più avvicinano il genere umano al proprio annientamento. «Il futuro della civiltà umana è più sicuro o più a rischio di com’era l’anno scorso? Ed è più sicuro o più a rischio di com’era nei sette decenni in cui è esistito l’orologio?». Sono alcune delle domande che gli scienziati si sono posti prima di annunciare la posizione delle lancette quest’anno, ha spiegato la presidente della società, Rachel Bronson.
Il rischio estinzione
Dall’anno di invenzione dell’orologio, il 1947, le lancette non sono mai state più vicine di così alla mezzanotte: l’umanità, cioè, pare non essere mai stata così a rischio estinzione.Tra il 2018 e il 2019 in realtà le lancette non sono state spostate, ma per gli scienziati non c’è da festeggiare: siamo comunque nell’era del «nuovo anormale».
L’orologio dell’Apocalisse fu pensato dall’americano Bulletin of the Atomic Scientists per dare al mondo una misura della probabilità di una catastrofe provocata dalle azioni umane in un momento in cui la guerra agli armamenti da parte di Usa e Urss era una minaccia reale. Fu impostato inizialmente a sette minuti a mezzanotte. Nel corso dei successivi 72 anni la lancetta dei minuti è stata mossa avanti e indietro 23 volte, raggiungendo la distanza massima di 17 minuti nel 1991 e quella minima di due minuti nel 1953 (quando l’Unione Sovietica testò la bomba a idrogeno), nel 2018 e nel 2019.
Se agli albori del Doomsday Clock e durante i successivi anni della Guerra Fredda la minaccia nucleare era considerata il fattore di rischio numero uno, negli ultimi anni si è aggiunto il cambiamento climatico. La decisione dell’amministrazione Trump di abbandonare l’accordo di Parigi sul clima è vista dagli scienziati come un fattore che ha contribuito al fallimento - definito «vergognoso» - delle politiche climatiche in tutto il mondo.
Ma non solo: nella concezione del Bollettino, a queste minacce misurabili scientificamente si affiancano ora fattori come la «guerra di informazione atta a indebolire la democrazia nel mondo». Come a dire: se la verità viene manipolata con disinvoltura, specialmente dalla politica, «la nostra abilità di distinguere la verità dalla fiction viene distrutta», ha detto Rachel Bronson. «E non c’è niente di normale in questo».
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. - L’orologio dell’Apocalisse segna 2 minuti alla mezzanotte (Ansa).29 gennaio 2019, di Federico La Sala
L’orologio dell’Apocalisse segna 2 minuti alla mezzanotte
Armi nucleari e clima le prime minacce
di Redazione ANSA *
- [Foto]Rappresentazione artistica dell’orologio dell’Apocalisse, proposto dalla Federazione degli scienziati atomici per scandire il tempo a disposizone per evitare la catastrofe del pianeta (fonte: University of Rochester illustration / Michael Osadciw) © ANSA/Ansa
Segnano due minuti alla mezzanotte le lancette dell’orologio dell’Apocalisse, ideato nel 1945 dalla Federazione degli scienziati atomici per scandire il tempo che l’umanità ha davanti a sé per evitare una catastrofe dovuta alle armi nucleari o ai cambiamenti climatici.
A partire dal 1947 questo orologio ideale è aggiornato ogni anno e il 24 gennaio scorso il consiglio di 20 esperti chiamati a regolarlo ha deliberato che all’umanità restano appena due minuti, proprio come era accaduto nel 2018 e nel 1953. "E’ la terza volta che l’orologio è stato impostato così vicino a una catastrofe globale", ha osservato Rachel Bronson, presidente e direttore esecutivo dell’organizzazione, in una conferenza stampa a Washington.
E’ accaduto per la prima volta nel 1953 al culmine della guerra fredda, con i test nucleari condotti da Unione Sovietica e Stati Uniti; la seconda volta è stata nel 2018, dopo le notizie sui test nucleari della Corea del Nord e in seguito alle crescenti preoccupazioni relative al cambiamento climatico.
Nella prima indicazione, del 1947, l’avvio della guerra fredda aveva fatto spostare le lancette a 7 minuti alla mezzanotte: nel 1949 le lancette erano slittate in avanti di quattro minuti per l’aggravarsi della situazione in seguito con l’acquisizione delle armi nucleari da parte dell’URSS.
"Nel corso degli anni - ha osservato Alessandro Pascolini, dell’università di Padova - l’orologio si è allontanato e avvicinato alla mezzanotte. Il momento più sicuro si è avuto nel 1991 alla fine della guerra fredda, quando l’orologio ha segnato 17 minuti alla mezzanotte". Poi, ha aggiunto, la situazione è peggiorata "di fronte all’incapacità del mondo politico internazionale di superare il confronto nucleare e affrontare le problematiche legate al cambiamento climatico globale".
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "La grande accelerazione. Storia ambientale dell’Antropocene dopo il 1945". Abbiamo ancora un futuro? (di Michela Dall’Aglio)18 gennaio 2019, di Federico La Sala
Abbiamo ancora un futuro?
di Michela Dall’Aglio (Doppiozero, 17 gennaio 2019)
Ogni giorno, da più parti, si levano voci autorevoli ad avvertire che siamo giunti a un momento cruciale e unico nella storia del nostro pianeta; il suo futuro è nelle nostre mani, perché l’attività umana può renderlo inabitabile o, nell’ipotesi migliore, desolato. Tutto dipenderà dalle scelte che l’umanità intera, soprattutto i Paesi più ricchi, faranno non domani, ma oggi. Il punto di non ritorno, quello in cui avremo messo in moto una macchina che non potremo più fermare è veramente alle soglie. Sapremo essere all’altezza di una simile responsabilità? Alexis de Tocqueville, parlando della fine delle società aristocratiche, sosteneva che la ragione fondamentale della loro caduta fosse stata il fatto che gli aristocratici non erano più degni di governare. In realtà pensava che questo fosse vero a un livello più generale e che il potere si perde quando non si è più degni - non semplicemente capaci - di esercitarlo. La sua osservazione mi pare molto appropriata a una riflessione sulla situazione odierna, infatti è molto probabile che l’umanità avrà un futuro solo se dimostrerà di meritarselo. Se non agiremo con saggezza, lungimiranza e responsabilità il nostro pianeta non potrà più ospitarci, ci caccerà via, come si fa con quegli ospiti per i quali si è preparata e addobbata una bella dimora e questi, per tutto ringraziamento, la vandalizzano lasciando dietro di sé solo rovine.
In un bel saggio di alcuni anni fa, Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere (Einaudi), Jared Diamond s’interrogava sulla scomparsa di alcune società un tempo fiorenti proponendo di guardare alla loro storia come a una «sorta di grande banca dati da cui ... trarre lezioni utili per continuare a far prosperare le nostre società». Perché alcune società sono crollate, si chiedeva, mentre altre, pur avendo affrontato crisi durissime hanno resistito, talvolta tornando a prosperare di nuovo? Dalle loro vicende pensava, giustamente, che anche le nostre società, per quanto ricche e tecnologicamente avanzate, avrebbero potuto imparare qualcosa.
Nessuna società è mai crollata per una sola causa, sostiene Diamond, ma piuttosto per un concatenamento di eventi, spesso provocati in successione l’uno dall’altro con inevitabile consequenzialità.
L’inizio normalmente era imputabile a una crisi del sistema ecologico, per lo più configurabile con questa successione: deforestazione e distruzione dell’habitat, gestione sbagliata del suolo (con conseguente erosione, salinizzazione e perdita di fertilità del terreno), cattiva gestione delle risorse idriche, eccesso di caccia e/o di pesca, introduzione di specie nuove, crescita della popolazione umana, aumento dell’impatto sul territorio di ogni singolo individuo. Per le società contemporanee a questi pericoli se ne aggiungono altri quattro, tipicamente moderni: i cambiamenti climatici dovuti all’intervento umano, l’accumulo di sostanze chimiche tossiche nell’ambiente, la carenza di risorse energetiche e l’esaurimento della capacità fotosintetica della Terra. La prospettiva, laddove non si tenti di far fronte energicamente a questi pericoli, è per Diamond non tanto una distruzione totale del nostro ambiente, ma piuttosto quella di un radicale abbassamento degli standard attuali di vita delle società più avanzate senza che vi sia, per altro, un miglioramento delle condizioni per i paesi più poveri. E, soprattutto, una crisi sostanziale di quelli che, fino ad oggi, consideriamo i valori irrinunciabili dei nostri sistemi, come la libertà, i diritti umani, la democrazia politica, la pace e la giustizia. Lo stesso pericolo lo ha denunciato con chiarezza anche papa Francesco nella sua enciclica Laudato sii, che ha raccolto ampi consensi in tutto il mondo al di là delle confessioni religiose. «Il degrado ambientale e il degrado umano ed etico - affermava - sono intimamente connessi».
Jared Diamond scriveva solo dieci anni fa, e oggi è evidente che stiamo velocemente percorrendo la brutta strada da lui descritta, tanto che adesso la sua prospettiva sembra addirittura ottimista. La possibilità di una vera distruzione di gran parte degli habitat della Terra è diventata ormai una minaccia realistica e incombente, a dispetto dei tentativi, sempre più smaccatamente pretestuosi e disonesti, di chi vuole negare gli effetti distruttivi dell’azione umana sull’ambiente, soprattutto per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Nonostante tutto, Diamond si dichiarava cautamente ottimista sulla possibilità che l’umanità avrebbe saputo prendere le decisioni giuste per evitare una catastrofe ambientale, per due motivi sostanzialmente: la sensibilizzazione crescente delle popolazioni mondiali riguardo alle problematiche ambientali e l’altrettanto crescente attenzione che ad esse riservavano i leader delle potenze economiche più avanzate. Riferendosi agli Stati Uniti, che riteneva «il paese più ricco e potente del mondo, con abbondanti risorse ambientali, guidato da leader illuminati, fornito di alleati leali e disturbato solo da pochi nemici deboli e insignificanti», non pensava che avrebbero dovuto temere di trovarsi sull’orlo di un baratro. Per lo meno non per le stesse ragioni che avevano messo in crisi le civiltà antiche da lui analizzate.
Ma le cose possono cambiare in fretta, soprattutto per quanto concerne i leader illuminati, e oggi non potremmo esprimere la stessa fiducia perché la classe politica, a livello mondiale, spesso fa temere di non essere all’altezza dei problemi che deve affrontare. L’ha detto, senza soggezione e con una schiettezza tipicamente giovanile, Greta Thunberg, una ragazzina svedese di quindici anni, nel discorso alla Conferenza delle Parti sul Clima (COP24) tenutasi a Katowice, in Polonia, lo scorso dicembre. Le sue parole hanno fatto il giro del mondo: «Voi parlate... solo di andare avanti con le stesse idee sbagliate che ci hanno messo in questo casino... quando la cosa più sensata da fare sarebbe tirare il freno a mano. Non siete abbastanza maturi da dire le cose come stanno, lasciate persino questo fardello a noi ragazzi... Dobbiamo lasciare i combustibili fossili sotto terra e dobbiamo concentrarci sull’equità. E se le soluzioni sono tanto impossibili da trovare, forse dovremmo cambiare il sistema. Non siamo venuti qui per pregare i leader mondiali di occuparsene. Ci avete ignorati in passato e ci ignorerete ancora. Non ci sono più scuse e non c’è più tempo. Siamo qui per farvi sapere che il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no...» Insomma, la Terra brucia e il tempo non è più dalla nostra parte (cfr. M. Mann, T. Toles, La Terra brucia, Hoepli).
La complessità che l’ecologia planetaria, il cambiamento climatico e l’uso delle risorse energetiche mettono in gioco è tale che l’opinione pubblica può essere facilmente male informata e manipolata, soprattutto in momenti in cui la scienza è messa in discussione dall’ignoranza. L’unico possibile rimedio è che, al di là delle prese di posizione ideologiche e strumentali, ognuno cerchi di capire i termini della questione per farsi un’idea realistica del reale impatto delle attività umane sul sistema Terra. A tal fine può essere molto utile la lettura di un saggio, La grande accelerazione. Storia ambientale dell’Antropocene dopo il 1945, scritto a due mani dagli storici J.R McNeill e P. Engelke, il primo docente alla Georgetown Univeristy, il secondo senior fellow dell’Atlantic Council’s Scowcroft Center on Strategy and Security. Essi condividono l’ipotesi di Paul Crutzen, premio Nobel per la chimica nel 1995 per i suoi studi sulla riduzione dello strato di ozono nell’atmosfera, secondo il quale possiamo considerare ormai finito l’Olocene (epoca che comprende più o meno gli ultimi dodicimila anni) e iniziato l’Antropocene, epoca in cui il genere umano esercita «un’influenza decisiva sull’ecologia globale». Questo cosa significa? In pratica, affermano gli autori, vuol dire che le azioni dell’uomo interferiscono con i sistemi fondamentali che governano la vita e l’evoluzione del nostro pianeta. Gli inizi di questo fenomeno possono essere fatti risalire alla fine del XVIII secolo, quando la prima rivoluzione industriale diede inizio a un sempre più massiccio utilizzo dei combustibili fossili e la popolazione umana cominciò a crescere a ritmi senza precedenti. In seguito, a partire dalla metà del Novecento, entrambi i fenomeni hanno assunto dimensioni tali da cambiare radicalmente i «rapporti tra la nostra specie e la biosfera in una storia lunga 200.000 anni». La qual cosa, proseguono, «dovrebbe renderci piuttosto scettici riguardo al fatto che le tendenze attuali siano destinate a durare a lungo». Soprattutto perché il pianeta non è più in grado di sopportarlo. Banalmente, se volete, non c’è più abbastanza materiale da usare: acqua, dolce e salata, foreste, petrolio...
Nonostante una maggiore sensibilità globale e una generale riduzione dei tassi di fertilità, se qualche catastrofe naturale non ci fermerà il dominio dell’uomo e la sua spropositata influenza sull’ambiente continueranno. «Quello che è certo - avvertono gli autori - è che quanto è stato fatto finora dall’uomo, principalmente tra 1945 e oggi, lascerà un segno del nostro passaggio sul pianeta, sul suo clima, sul suo ecosistema, sull’acidificazione degli oceani e altrove ancora, che resterà indelebile nei millenni a venire». E nel considerare la fame d’energia del nostro mondo, è bene ricordare che non deriva solo dal funzionamento delle industrie, dei trasporti e dal mantenimento del confort cui siamo abituati in Occidente, ma anche dalla semplice necessità di alimentare una massa enorme di persone. Gli allevamenti intensivi, i disboscamenti, l’irrigazione e così via contribuiscono in maniera determinante a sconvolgere gli equilibri naturali in una catena di cause e conseguenze dettagliatamente riferita dagli autori. Si tratta, insomma, di una storia economica del mondo negli ultimi sessant’anni raccontata dal punto di vista dell’ambiente, con dati e cifre talvolta veramente impressionanti, come ad esempio il fatto che la popolazione mondiale è triplicata dal 1945 al 2015, che l’uso di combustibili fossili era di 3 milioni di tonnellate nel 1750 e di 9500 milioni di tonnellate nel 2015 o che «una certa percentuale, forse un quarto del totale, dei trecento miliardi di tonnellate di carbonio rilasciati nell’atmosfera tra il 1945 e il 2015, vi rimarrà per alcune centinaia di migliaia di anni».
Eppure c’è ancora speranza, concludono, perché il futuro, se è già scritto lo è solo in parte ed è possibile, seppure lentamente, cambiare leggermente rotta al grande transatlantico del mondo. Oggi, infatti, la discussione sul cambiamento climatico non è più confinata entro le mura della comunità scientifica; l’argomento è entrato nelle agende politiche di vari Paesi e ne sono seguite, pur tra difficoltà e marce avanti e indietro, convenzioni e accordi che potrebbero portare a fondamentali miglioramenti. D’altra parte, le recentissime decisioni di alcune potenze fanno temere che molti ostacoli si frappongano ancora a un uso più corretto e lungimirante delle risorse del pianeta. Sui giornali se ne parla quasi quotidianamente, e ne sono un esempio l’uscita voluta da Trump degli USA dagli accordi di Parigi sul clima stipulati nel 2015 tra quasi 200 paesi del mondo - ma va detto che molti governatori di vari stati dell’unione si sono opposti con decisione alle scelte del presidente americano dichiarando che tali accordi resteranno in vigore nei propri territori (cfr. il documentario della National Geographic, L’America che si ribella a Trump, pubblicato su YouTube) -, la decisione del Giappone di riprendere la caccia alle balene o le dichiarazioni del neo-eletto presidente del Brasile Bolsonaro di volere continuare o addirittura incrementare lo sfruttamento della foresta amazzonica (della quale erano stati già distrutti in soli dodici mesi quasi 8000 kmq).Che fare dunque? Tutti concordano che il problema ineludibile è l’innaturale, eccessivamente rapido cambiamento climatico e che pertanto è prioritario agire in questo ambito riducendo drasticamente l’uso di combustibili fossili e rimpiazzandoli al più presto con energie rinnovabili. Ma, soprattutto, tutti concordano sul fatto che il problema che l’umanità si trova ad affrontare oggi è essenzialmente etico prima e più ancora che economico o politico, e che lo si potrà risolvere soltanto decidendo insieme di ridurre drasticamente i consumi energetici. Dobbiamo chiederci seriamente cosa significhi il comandamento “non uccidere” quando «un venti per cento della popolazione mondiale consuma risorse in misura tale da rubare alle nazioni povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere». Se lo sono chiesti i vescovi della Nuova Zelanda nella loro Conferenza Episcopale, citata nell’enciclica Laudato sii; e papa Bergoglio conclude: «Non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo. Non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia».
E a chi pensa che i costi economici necessari a riconvertire il sistema sarebbero spaventosi, J.R. McNeill e P. Engelke obiettano: «il valore di un pianeta è il suo costo di sostituzione. Dal momento che, attualmente, sappiamo che nessun pianeta è in grado di ospitare la vita, il costo per sostituire la Terra è infinito. Quindi qualsiasi valutazione economica del costo dei danni causati dal cambiamento climatico sarà una stima in difetto». E concludono che «è possibile avere davanti un altro futuro... in cui scegliamo come obiettivo quello di un’esistenza planetaria sostenibile». È questo l’unico futuro possibile, non ce n’è un altro.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- SCAFFALE: «L’infamia originaria» e «Il desiderio dissidente». "L’esorbitante scoperta della dipendenza" e "il presente della politica".4 dicembre 2018, di Federico La Sala
Cultura
L’esorbitante scoperta della dipendenza
SCAFFALE. «L’infamia originaria», di Lea Melandri. Dopo 40 anni, rieditato uno dei testi storici del femminismo italiano
di Ambrogio Cozzi (il manifesto, 04.12.2018)
«Il problema della dipendenza, oltre a essere più che mai attuale, è come se si rivelasse ora carico di implicazioni complesse e profonde. Di fronte a un ordine che sta franando, lo sforzo di saldare le spaccature e di coprire le voci dissonanti risponde a un bisogno di conservazione non meno materiale della conservazione fisica in senso stretto. Le stesse persone che auspicano lo sfaldamento della piramide capitalistica non sempre riescono a sottrarsi alla tentazione di rinsaldare i vertici di altre organizzazioni solo apparentemente alternative». La citazione è tratta dalle prime pagine del volume L’infamia originaria, di Lea Melandri, appena ripubblicato per manifestolibri (pp. 144, euro 15) e costituisce una sorta di filo conduttore di tutto il testo.
IN ANNI in cui si esaltava il concetto di autonomia Melandri, controcorrente, invitava a riflettere sulla dipendenza, contrapponendo quindi a una rappresentazione ideale dell’agire politico la materialità di una sopravvivenza che esorbitava l’ideale e che nell’ideale non si lasciava ricomprendere. Questa eccedenza indicava la sopravvivenza di qualcosa di arcaico che il politico aveva espulso e che forse nel politico non poteva essere ricompreso. Contro le reificazioni che risolvevano il problema attribuendo concretezza a entità astratte, ricercava le linee di frattura che indicavano un oltre, le esperienze quotidiane che mostravano come le magnifiche sorti e progressive fossero afflitte da scorie che non potevano essere eliminate a priori, pena il loro riemergere sotto altre forme, mostrando nella ripetizione, nel loro ritorno la persistenza di un rimosso che comunque voleva emergere.
INTRAVEDEVA allora nel «miserabilismo di sinistra» un elemento di critica a chi riduceva l’esistenza all’economico, alla critica dell’economico, il resto sarebbe arrivato. La sua analisi dell’occupazione delle case di via Tibaldi metteva in luce un altro aspetto della dipendenza che si creava tra gli occupanti e coloro che organizzavano l’occupazione. «La dipendenza accresceva quindi anche la competizione tra le famiglie e l’aspettativa nei confronti dei compagni. Lo sviluppo dell’autonomia richiede un estremo impegno da parte di tutti perché ci sia effettivamente la responsabilizzazione e la partecipazione attiva di tutta la collettività». Il richiamo alla responsabilità andava allora inteso come richiamo alla capacità di rispondere, di assumersi il peso di una risposta che evitasse di eludere il problema della dipendenza che non interrogata, accantonata, si riproponeva come presente e pervasiva.
Un discorso coraggioso, che indicava quel che non si voleva vedere, che cercava di includere nell’oggi quel che dello ieri continuava a sopravvivere, la parte oscura, perché la dipendenza attraversava le storie di ciascuno, il come ognuno ci aveva fatto i conti, soprattutto apriva alle relazioni tra uomo e donna, alle relazioni tra donne e tra uomini, alla vita quotidiana che non poteva essere interamente nel politico, ma necessitava comunque di parole che potessero dirla, connotarla, darle un senso che non poteva nascere ex novo se non faceva i conti con un passato che la segnava come pesante zavorra. «Se la politica è così carica a nostra insaputa delle situazioni personali, allora anche la politica va ripensata a partire da tutto il cumulo del non detto, del negato che c’è dentro».
NEL NON DETTO rientrava la paura, le paure che accompagnavano le esistenze e che facevano da sfondo o tessevano le trame di scelte che venivano giustificate in termini ideologici per garantire la sopravvivenza dell’ideale. L’ideale esaltava l’autonomia senza fare i conti con le paure che l’accompagnavano e che riproponevano nuove dipendenze, che venivano agite proprio perché non dette. In questo vicina a tutto il lavoro del gruppo de «L’erba voglio» che cercava di problematizzare quel che veniva dato per scontato. Il darsi le leggi si risolveva spesso nell’accettazione di nuove leggi, a volte più coartanti perché si faceva coincidere idealmente lo scegliere con il subire. Contro queste coincidenze il lavoro di Lea Melandri cercava di svelare i nessi che venivano facilmente saltati, denunciando una presunta oggettività che faceva coincidere l’oggettivo con il naturale liquidando il problema, ma anche trovando che il nesso tra natura e cultura andava affrontato, non in cerca della soluzione ma in un lavoro che ne tenesse conto.
MA OGGI ripubblicare questo lavoro non può risolversi in un lamento su ciò che poteva essere e non è stato. Oggi quando per dirla con Scurati si sta trasformando la paura in odio, il richiamo alla responsabilità è ancora più urgente. Il testo allora può essere riletto come un invito a poter dare parola alle paure, un sobrio richiamo alle difficoltà che ci attraversano per fermare la caduta verso l’odio, un rifiuto di facili schematismi che indicano sempre nell’altro la fonte delle paure per riconoscerle invece come nostre, come una formazione di compromesso che ci appartiene e con la quale occorre fare i conti. «C’era la smentita continua della dipendenza nel senso che la risposta magari non veniva dalla persona da cui la si aspettava, ma da un’altra». In questa frase riferita a un lavoro in un gruppo di donne troviamo un’apertura alla parola dell’altro, al saper ascoltare come indicazione di una strada in cui la parola non ricopre certo tutto, ma il dire aiuta a fermare l’odio.
«L’erba voglio» e il presente della politica
SCAFFALE. «Il desiderio dissidente», un volume a cura di Lea Melandri edito per DeriveApprodi
«La rivoluzione, come il desiderio, è inevitabile e imprevenibile, e non finirà mai di sconvolgere i custodi del terreno dei bisogni»; così Elvio Fachinelli nel suo volume Il bambino dalle uova d’oro (1974) restituiva in un breve passaggio alcune questioni cruciali che in quegli anni attraversavano pratiche politiche e discussioni pubbliche. E se la rivoluzione atteneva al fulgore di una esperienza «esclusiva» come quella del ’68, vi era qualcosa che era stato lasciato fuori e che, ormai da qualche tempo, era stato riammesso alla «dignità» di menzione: Il desiderio dissidente, luminosa sintesi che lo stesso Fachinelli nel ’68 ha dato in riferimento al movimento studentesco, e che oggi è il titolo di un volume tanto prezioso quanto attuale. Per le cure di Lea Melandri, si tratta di una antologia (edita da DeriveApprodi, pp. 249, euro 19) che raccoglie alcuni interventi pubblicati tra il 1971 e il 1977 nei ventotto numeri della rivista «L’erba voglio». Antiautoritarismo, scuola, femminismo, antipsichiatria, molti sono stati i temi esplosi in quegli anni, detonando ciò che era rimasto a latere dell’intransigenza. Antimilitarismo, lotte operaie, atomizzazione del lavoro, controinformazione, la «sfinge della psicoanalisi».
A fare da contrappunto erano esperienze e intelligenze tra le più brillanti e irriverenti di quegli anni, non solo della scena milanese. Aprire a corpi, sessualità, vita affettiva, senza sconti, è stata la scommessa per creativi e appassionati nodi, interrogati sì che poi sarebbero riemersi e che, a ben guardare, hanno senso ancora oggi. È in questa direzione che Melandri ha operato una scelta di ciò che può risultare ancora oggi urgente, preferendo alcune tra le firme più efficaci. Il desiderio dissidente ospita dunque Luisa Muraro - in un affilato testo del 1972 - e la sua riflessione sulla politica mutilata là, in quella «zona d’ombra», dove si sono trovate le donne sia rispetto alla storia collettiva che alle teorie rivoluzionarie.
Così ancora Elvio Fachinelli sulle connessioni tra sogno e apparato di dominio; infine Giovanni Losi, Valentina Degano, Mario Casari, e ancora Caterina Guerra, Antonio Prete, Antonella Nappi e altri, compresa la stessa Lea Melandri e il suo contributo del 1975 intitolato «L’infamia originaria» (due anni più tardi diventerà il titolo di un libro importante per la storia del femminismo italiano) in cui, nella crepa tra la coercizione e il suo fantasma, tra la delega e l’autonomia, si annida il sorriso di Franti. Fuori dall’ortodossia, dentro il sovvertimento e l’anomalia di cui anche «L’erba voglio» ha fatto parte.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- Il quanto illuminismo e "Le origini della creatività".29 ottobre 2018, di Federico La Sala
Il quarto illuminismo
di Mauro Bonazzi (Corriere della Sera, La Lettura, 28.10.2018)
- Edward G. Wilson, Le origini della creatività, a cura di Telmo Pievani, trad. di Allegra Panini, Raffaello Cortina, pagine 188, e. 19
Quando era ancora giovane, all’inizio di una carriera che si sarebbe rivelata folgorante, Edward Wilson, il futuro padre della sociobiologia, andò in visita da un eminente collega di Harvard. Era un entomologo ancora poco conosciuto fuori dagli ambienti accademici, di nome faceva Vladimir Nabokov. Parlarono a lungo, di farfalle, soprattutto di quelle sconosciute, e di tutto quello che ancora attende di essere scoperto nell’universo. Anche Aristotele, il filosofo per eccellenza, si accalorava per ragioni analoghe: «Non si deve nutrire un infantile disgusto verso lo studio dei viventi più umili», scriveva, «in tutte le realtà naturali c’è qualcosa di meraviglioso». Non sembrano argomenti particolarmente intriganti. In realtà sono questioni di vitale importanza, se solo si capisce che cosa c’è in gioco. La spiegazione, comunque, era già nelle farfalle, quelle ancora da scoprire e quelle che svolazzano davanti a noi tutti i giorni.
«Effimero» è l’aggettivo che viene usato per descriverle. È una parola greca, letteralmente significa «di un giorno». Così sono le farfalle, belle nella loro fragilità, che dura lo spazio di un momento prima di rieclissarsi nel nulla da cui sono emerse. Qual è il senso, o il valore, dell’esistenza di una farfalla nella storia dell’universo che si dispiega davanti a noi? È lo scandalo della morte, che toglie colore a tutto.
I Greci, però, quell’aggettivo non lo riferivano alle farfalle. Lo usavano per parlare di noi, i mortali per eccellenza. Di fronte al precipitare dei secoli, in questi spazi infiniti che mai potremo percorrere, quale sarebbe la differenza rispetto alle farfalle? Forse nessuna. O forse sì, qualche differenza c’è. Diversamente dalle farfalle possiamo pensare, ad esempio, porci domande, cercare di capire e conoscere. Magari le cose non sono come sembrano, magari il tutto che ci circonda non è così privo di senso come sembra. Il desiderio di conoscere non è la semplice curiosità di alcuni personaggi eccentrici che un po’ di erudizione basterà a soddisfare. Conoscere è un bisogno: scoprire il senso della nostra esistenza - nella convinzione che un senso c’è. Non è vero che la nostra vita è priva di valore e che noi passeremo invano. È una ricerca che non accomuna solo scienziati e filosofi. Anche il monaco sperduto nel deserto era in cerca delle stesse risposte, seppur per altre vie: scoprire il disegno che dà bellezza a tutto, che per lui si chiamava Dio.
Niente di sorprendente per il padre della biologia e della scienza, il solito Aristotele: anche per lui l’obiettivo ultimo, il fine più alto, era arrivare a vedere il mondo con gli occhi di Dio. Non è una vita umana quella di chi non si chiede che cosa sia nato a fare. Vedere con gli occhi di Dio significa comprendere che c’è un posto per noi in questa immensità: il disordine era solo apparente, intorno si dispiega un disegno ordinato, in cui tutto (persino la farfalla, persino noi) ha un suo valore. La morte, che vuole togliere senso a tutto, è sconfitta. La felicità è tutta qui, nella consapevolezza che quello per cui viviamo, combattiamo o soffriamo ha valore, merita di essere perseguito.
«I fisici hanno conosciuto il peccato, ed è una conoscenza che non potranno perdere». Lo ha detto uno dei più grandi fisici del Novecento, Julius Oppenheimer. L’allusione riguarda Adamo ed Eva: anche loro, in fondo, desideravano la conoscenza, quando avevano colto la mela. Il serpente, oggi, è la scienza: difficile esprimere meglio i cambiamenti che hanno investito il nostro mondo. Muovendo dalle stesse esigenze e dagli stessi bisogni, scienza, filosofia e religione hanno sempre cercato di conquistare il centro della scena, intrecciando tra di loro relazioni complicate. Il posto centrale, in questi ultimi anni, è occupato dai saperi scientifici, in forza di successi incontrovertibili che hanno spinto molti a sostenere che ormai alla filosofia resta solo da accodarsi, se vuole conservare qualche speranza di sopravvivere, e sulla religione non c’è quasi più nulla da dire.
Con la rivoluzione scientifica del Seicento, che alcuni chiamano oggi il secondo illuminismo (contrapposto al primo illuminismo greco, di Socrate, Platone e Aristotele) la nostra comprensione dell’universo e di noi stessi è radicalmente cambiata. C’era l’universo ordinato di Platone e Aristotele, che ogni lettore di Dante conosce, con la Terra al centro di tutto e l’uomo al centro della Terra, osservatore privilegiato di questo spettacolo divino. E c’è l’universo degli scienziati moderni e contemporanei, infinito e tumultuante, in cui la Terra occupa una posizione assolutamente marginale e la vita degli uomini è il risultato di una fortunata coincidenza e di millenni di evoluzione. Sarebbe difficile, in effetti, o meglio assurdo, continuare come se nulla fosse cambiato. Ma i problemi rimangono.
Oppenheimer pronunciò quella frase durante gli esperimenti sulla bomba atomica. È una frase angosciante, ed è la descrizione perfetta della condizione moderna. Conoscere per Aristotele e Dante voleva dire contemplare Dio, vedere il mondo con i suoi occhi, comprendere il disegno che tiene tutto insieme. Ma non era solo quello, come aveva spiegato Platone e avrebbero chiarito ancora meglio i grandi arabi, Avicenna ad Averroè, esponenti anch’essi di un illuminismo che, dal punto di vista cronologico, risulta quindi il secondo: chissà perché ci dimentichiamo sempre di chi non è europeo o americano. Il punto decisivo era che, conoscendo ciò che è, si sarebbe conosciuto anche ciò che è bene e ciò che è male. Dio, il creatore del cielo e della terra, l’arbitro del bene e del male. Il primo «illuminismo», quello di Platone e Aristotele, per usare le categorie di Wilson, e il secondo illuminismo arabo portavano direttamente a Dio (il che spiega tra l’altro l’uso che Ratzinger faceva dell’espressione: in questi termini è legittimo parlare persino di illuminismo cristiano), e alla conoscenza del bene.
Nell’universo di Oppenheimer, derivante dal terzo illuminismo di matrice scientifica, ci sono solo particelle che si fondono. E mentre prendeva forma il progetto della bomba, se ne chiariva la portata mostruosa. Dubbi e perplessità tra gli scienziati non mancarono. Ma la gioia di scoprire i misteri profondi dell’universo, l’atomo e le sue proprietà, era qualcosa di ancora più grande e travolgente. Questo significava l’allusione al peccato: il desiderio di conoscere, che prendeva il sopravvento sulle preoccupazioni etiche. Ecco la verità del serpente: una conoscenza quasi divina, nessun fondamento possibile per il bene e il male. Perché i filosofi platonici dovessero governare è chiaro: conoscendo l’essere (le idee, Dio) conoscevano il bene. Chi stabilisce cosa è bene e cosa è male nel mondo di Oppenheimer?
È la sfida dei nostri giorni. Dalla genetica all’intelligenza artificiale, dall’astrofisica alla sociobiologia, le conoscenze a cui siamo arrivati significano una potenza inimmaginabile fino a poco tempo fa, ma che ancora non sappiamo come usare. Il problema non è la scienza di per sé - il desiderio di conoscere è quanto di più umano ci possa essere - ma l’uso che se ne fa, e la tendenza degli uomini a cercarsi nuovi idoli quando quelli vecchi sono scomparsi. Chi deciderà se vi sono limiti e quali, che cosa è giusto fare e cosa no, cosa è bene e cosa male? Sembrano domande astruse, per chi, come un medico o uno scienziato, è impegnato a sviluppare una tecnica che migliorerà la vita di qualcuno. Sono problemi immensi nel momento in cui queste stesse tecniche possono modificare in modo radicale quello che siamo (o pensiamo di essere).
In effetti viviamo in un’epoca paradossale. L’ambizione della scienza era di arrivare a conoscere quello che siamo, la nostra natura, che è il risultato di una storia lunghissima. E adesso che siamo così vicini a svelarne il mistero, ecco che le nuove tecniche genetiche ci rivelano che siamo in grado di modificare questa natura profonda (il Dna). L’intelligenza artificiale, intanto, sembra preparare un futuro in cui condivideremo alcune delle nostre caratteristiche fondamentali (il pensiero, e magari la coscienza) con esseri, le macchine, che difficilmente potremmo considerare «umani». Ma allora chi, che cosa, siamo?
Insomma: impossibile prescindere dai risultati delle scienze. Confrontandosi con questi saperi, la filosofia e la religione troveranno nuovi stimoli e impulsi. Inaugurando un nuovo illuminismo, che a questo punto sarebbe il quarto, come auspica Wilson nel libro Le origini della creatività (Raffaello Cortina)? Magari. Non è detto però che tutte le risposte di cui siamo in cerca possano venire dalla scienza soltanto - anzi. Il problema della sua tesi, per quanto interessante, è che tende a relegare i saperi umanistici nel regno dell’immaginazione (la creatività) o della divulgazione, riservando alla scienza l’indagine seria sulla realtà. Davvero i saperi umanistici come la filosofia (o la letteratura) non hanno niente da dire sul mondo, quando usano il loro linguaggio e seguono le loro strade? Perché non tenere aperti altri modi di pensare e cercare, che aiutano comunque a chiarire la portata dei problemi? Del resto, da dove vengano la vita o il pensiero non lo sappiamo. Molto resta da fare.
Nel 384 d.C. Quinto Aurelio Simmaco rivolse un discorso appassionato all’imperatore Valentiniano, che aveva deciso di rimuovere dal Senato romano l’altare dedicato alla dea della Vittoria, pagana. Per l’imperatore la verità era solo cristiana: per questo l’altare pagano andava rimosso. La verità? «Non si può seguire una sola strada per raggiungere un mistero così grande» replicò Simmaco. Difficile dargli torto. Un po’ di confusione male non fa.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
SIMMACO, PREFETTO DI ROMA, E AMBROGIO, VESCOVO DI MILANO. IL "LOGOS" E LA "CHARITAS" NON SI CAPISCONO E SI SCAMBIANO LE PARTI, IERI COME OGGI.
L’EPOCA D’ORO DELLA SCIENZA ARABA. Prima di Galileo e Newton la rivoluzione dimenticata.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- Nelle “viscere della storia” non c’è solo la barbarie o la disumanità. Ci sono anche “prospettive impensate” (di Lea Melandri).14 settembre 2018
Nelle viscere della storia
Lea Melandri | 13 settembre 2018 |
di Lea Melandri*
Nelle “viscere della storia” non c’è solo la barbarie o la disumanità. Ci sono anche “prospettive impensate”, “tesori di cultura”. Basta cercarli. È questa la lezione della rivista “L’erba voglio”.
Il pericolo che molti vedono incombere sulla democrazia nel nostro Paese raramente viene associato alla crisi, più generale e più datata della politica: la modificazione lenta ma inarrestabile dei confini che per secoli hanno circoscritto e confuso lo spazio pubblico con il suo governo, le sue istituzioni, le sue leggi, i suoi linguaggi, e, prima ancora, con il dominio di un sesso solo.
Se la nostra cultura non si fosse dimostrata finora così ottusamente refrattaria ad accogliere analisi attente ai nessi tra corpo e politica, tra virilità e costruzione storica della sfera pubblica, risulterebbe evidente che la norma e la trasgressione, l’ordine e la perdita di controllo, la legge e la sua sistematica violazione, il bene collettivo e l’egoismo individuale, la civiltà e la barbarie, non hanno mai smesso di affrontarsi e confondersi nello spazio pubblico, sotto la spinta di contesti economici e politici mutevoli, ma ubbidendo nel medesimo tempo a quella “invariante” della storia che è l’identificazione dell’umano perfetto con la maschilità, e tutte le contrapposizioni che ha prodotto tra l’amico e il nemico, il cittadino e lo straniero
L’irruzione del “femminile” nella vita pubblica - inteso non solo come presenza quantitativa delle donne nel luogo da cui sono state tradizionalmente escluse, ma come protagonismo e rivalsa di tutto ciò che è stato identificato col “sesso debole” - non poteva non intaccare i fondamenti della politica, mettere in discussione i concetti di libertà, democrazia, uguaglianza, fraternità, diritto, ridefinire in modo meno astratto la figura del cittadino.
Se l’occasione di portare al centro della responsabilità collettiva la vita nella sua interezza si sta trasformando in “antipolitica” - rovesciamento dei rapporti tra ordine e caos, realtà e immaginario, ragione e sentimenti - è perché si continuano ad ignorare i percorsi di liberazione e di allargamento dell’impegno politico aperti dalle culture alternative degli anni Settanta, in particolare dal femminismo, e oggi dalle associazioni di uomini che si interrogano sulla storia dal punto di vista del sesso che ne è stato protagonista.
Quello che molti di noi scoprirono allora, come insegnanti, operatori sociali, studenti, operai, nel momento in cui si abbandonavano gli strumenti tradizionali del controllo e della repressione, avrebbe dovuto allarmare molto più delle forze conservatrici che ci fecero guerra.
Le pratiche non autoritarie nella scuola, negli asili autogestiti, nelle assemblee autonome sorte all’interno delle fabbriche, che generalmente vengono additate da destra e da sinistra come la causa remota del degrado attuale, sono state, al contrario, il primo svelamento della massificazione precoce, la denuncia del caos che si cela dietro i sistemi istituzionali di controllo e sicurezza.
- “Eludendo la figura dell’adulto - annotava Elvio Fachinelli in Masse a tre anni (L’erba voglio, Einaudi, 1971) -, astrattamente considerata ‘autoritaria’, si vede sorgere una gerarchia di ferro, basata sulla forza e la prepotenza, che impronta di sé i rapporti dei bambini tra loro (...) sembra di trovarsi in una società violenta, tra il fascista e il mafioso”.
Erano segnali piccoli ma inequivocabili, portati allo scoperto dalla consapevolezza delle mutilazioni che si era inflitta la politica, e dall’idea che bisognasse partire da lì, da quei corpi che arrivano all’asilo “già rattrappiti e coartati”, per trovare nuove forme d’amore e di convivenza umana.
La crisi dell’autorità paterna nell’ambito famigliare, e il declino delle istituzioni della vita pubblica, avrebbero poi subìto un’accelerazione imprevista sotto l’urto della società dei consumi, della sua potenza invasiva e divorante, della sua indifferenza per norme e limiti di ogni specie. Così è accaduto che, quando ancora le donne muovevano i primi passi da cittadine sotto tutti gli effetti, a farla da vincitore fosse il “femminile” costruito dall’uomo, la visceralità che la storia si è portata dietro e che insidia da sempre il suo processo di incivilimento.
Oggi si scopre che l’inconscio collettivo, che si è espresso “democraticamente” nel voto della maggioranza, è reazionario. Non era poi così difficile da immaginare: tutto ciò che è stato sepolto nella zona più oscura della vita dei singoli, identificato con la natura o con la parola rivelata di un Dio, per potersi modificare ha bisogno innanzi tutto di essere riconosciuto, narrato e analizzato, restituito alla cultura e alla politica con cui è sempre stato in rapporto, sia pure un rapporto alienato, strumentale, distruttivo della politica stessa e delle sue conquiste democratiche.
L’“immensa esperienza negativa” che si è accumulata nelle “viscere della storia” nel corso dell’ultimo secolo, come conseguenza del fatto che sono stati considerati condizione quasi esclusiva del cambiamento i rapporti di produzione, oggi esce allo scoperto attraverso la retorica populista delle destre occidentali. Ma, se non ne abbiamo paura e, soprattutto se non abbiamo fretta di cancellarla o imitarla, forse è l’occasione per dare finalmente cittadinanza a “esperienze essenziali del vivere umano”.
L’esperienza della rivista “L’erba voglio” ha significato fare cultura attraverso tutto ciò che la cultura tradizionale considera “rifiuti”, “scarti”, “tabù”, prendere distanza dalla continuità del “noto”, dal rapporto ottimistico che la cultura occidentale ha intrattenuto con le sue mete tecno scientifiche, non aver paura di addentrarsi nel “caotico mondo dell’antiragione”, aprirsi a “prospettive impensate”.
Prima che la barbarie, come ritorno a forme arcaiche di violenza, prenda il sopravvento, dovremmo tentare - come è stata per la generazione “imprevista” di giovani e donne nel Sessantotto -, a farci noi “barbari”, estranei e creativi, rispetto a una civiltà esaurita e sempre più disumanizzante.
*Insegnante, giornalista, scrittrice e saggista, riferimento per il movimento delle donne italiano. Tra i suoi libri: L’infamia originaria; Come nasce il sogno d’amore; Le passioni del corpo. La vicenda dei sessi tra origine e storia; La perdita; Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà. Altri suoi articoli sono leggibili qui.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- IL SENNO DI POI E "IL PILOTA AUTOMATICO". Tutti i disastri «irreparabili» (di Maurizio Fiasco).22 agosto 2018, di Federico La Sala
IL "FARE IL PROPRIO DOVERE", I DISASTRI "IRREPARABILI", E IL SENNO DI PRIMA....
- (...) assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può» (Maurizio Fiasco, "Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima", Avvenire, 18.08.2018)).
- "Non ho fatto che obbedire. Ho fatto solo il mio dovere" (Adolf Eichmann).
- Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto (don Lorenzo Milani),
Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima
Dopo il ragionamento è il solito, col senno di poi: come è stato possibile che nessuno vedesse e capisse prima dell’irreparabile fatto?
di Maurizio Fiasco (Avvenire, sabato 18 agosto 2018)
- Il balletto delle responsabilità inizia sempre dopo, col senno di poi. Il senno di prima è ignoto (Fotogramma)
Come accadono i disastri? C’è un’espressione, all’apparenza banale ma ricorrente, quando siamo sconcertati per un evento dai costi umani incalcolabili. «Col senno di poi». Che equivale: come è stato possibile che nessuno vedesse e capisse prima dell’irreparabile fatto? Quel che ha condotto al precipitare di una situazione - fisica, come un ponte, oppure comportamentale come una battaglia, un volo, il funzionamento di uno stabilimento industriale - aveva già emesso dei segnali.
 I disastri - risulta quasi sempre agli investigatori ex post - hanno avuto una incubazione, più o meno lunga. Incubazione tutt’altro che muta, o col bavaglio, anzi spesso visibile per un complesso di segnali. Come ha insegnato, quarant’anni fa un illuminato e inascoltato Barry Turner, non sono prevenuti - ovvero fermati da decisioni pragmatiche - per le patologie della comunicazione tra gli attori di un sistema. Industriale, amministrativo, finanziario, politico: non importa la scala di grandezza. Le incompetenze si strutturano e agiscono come un sistema.
I disastri - risulta quasi sempre agli investigatori ex post - hanno avuto una incubazione, più o meno lunga. Incubazione tutt’altro che muta, o col bavaglio, anzi spesso visibile per un complesso di segnali. Come ha insegnato, quarant’anni fa un illuminato e inascoltato Barry Turner, non sono prevenuti - ovvero fermati da decisioni pragmatiche - per le patologie della comunicazione tra gli attori di un sistema. Industriale, amministrativo, finanziario, politico: non importa la scala di grandezza. Le incompetenze si strutturano e agiscono come un sistema.I segnali sono sfuggiti a un apparato cognitivo, a una mente capace di connetterli e perciò di abbattere le barriere che inibiscono il giudizio. È mancata la responsabilità di contrastare la universale ottusità dei sistemi, di tutti i sistemi organizzativi. Che squalificano la coscienziosità di chi abbia colto il segnale e si sia posto in modo attivo per spingere al provvedere.
 Egli finisce per scontrarsi con la gerarchia, con i muri levati su dai rituali dell’organizzazione, per impattare con la squalificazione che si replica davanti all’umile operatore che sta sul terreno e lì ’vede’ qualcosa che non va. Oppure c’è il feticcio della responsabilità di vertice. Chi è in alto - pensa il testimone dei segnali che il disastro sta inviando - lo capirà più e meglio di me.
Egli finisce per scontrarsi con la gerarchia, con i muri levati su dai rituali dell’organizzazione, per impattare con la squalificazione che si replica davanti all’umile operatore che sta sul terreno e lì ’vede’ qualcosa che non va. Oppure c’è il feticcio della responsabilità di vertice. Chi è in alto - pensa il testimone dei segnali che il disastro sta inviando - lo capirà più e meglio di me.Ma il superiore guarda al consenso e alle conferme di chi siede ancora più in alto di lui. E quest’ultimo rivolge la sua mente al mandato di chi è il supremo detentore di quel bene, di quella situazione, di quel dato potere. E tutto questo complesso di fattori cambia la prospettiva, perché il conformismo è più potente della psicologia della responsabilità.
 A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può».
A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può».Insomma, la responsabilità, invece di essere ispirata a valori trascendenti, si attesta alla procedura, al ’di fronte’, a quel che le regole gerarchiche - per esempio il mandato degli azionisti - hanno assegnato. E così si scambia la diversa posizione ricoperta nella piramide organizzativa con la diversità di valori etici e professionali di quanti operano in una struttura complessa: che invece, a rigore, sono unici e universali. Cioè per tutti. Nelle forze armate, dal piantone al generale; nelle autostrade, dall’operaio che passa il bitume all’amministratore delegato della infrastruttura. Unitarietà dei valori e trasparenza della comunicazione sono la speranza del «senno di prima». Potremmo dire l’intelligenza del Buon Samaritano che si prende carico della complessità della situazione e non trascura alcuna variabile.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- MEMORIA DELLA MEMORIA OMERICA: UNA PICCOLA "ODISSEA". La strega e me stessa (di Saverio Strati).30 luglio 2018, di Federico La Sala
TRAMA E ORDITO: UNA PICCOLA "ODISSEA"...
ULISSE, POLIFEMO, PENELOPE E ... “LE PENE DEL LINO”! *
La strega e “me stessa”
di Saverio Strati *
Nei tempi molto antichi, c’erano le streghe che di solito vivevano nei valloni dei pressi del paese. Appena calava la notte, esse andavano in cerca di cristiani da stregare. Una sera, una strega, mentre passava vicino a casa, sentì che due comari facevano questo discorso:
 “Cosicché domani mattina chiamatemi presto, comare, diceva l’una all’altra.”
“Cosicché domani mattina chiamatemi presto, comare, diceva l’una all’altra.”
 “Sì, comare. Vi chiamerò verso le quattro. Così potremo lavare i panni prima che il sole sia troppo forte.”
“Sì, comare. Vi chiamerò verso le quattro. Così potremo lavare i panni prima che il sole sia troppo forte.”La strega, sentite queste parole, si disse che aveva buona caccia da fare quella notte. Verso l’una infatti andò a chiamare la comare che aveva parlato per prima. Questa si alzò, si mise la cesta con i panni in testa e uscì.
 “Andiamo, comare!” le disse la strega che sapeva far la voce precisa dell’altra comare.
“Andiamo, comare!” le disse la strega che sapeva far la voce precisa dell’altra comare.
 S’incamminarono.
S’incamminarono. Anche la strega, si capisce, aveva la cesta piena di panni sporchi in testa.
Anche la strega, si capisce, aveva la cesta piena di panni sporchi in testa.
 La notte era limpida e la luna illuminava la terra come se ci fosse il sole.
La notte era limpida e la luna illuminava la terra come se ci fosse il sole.
 “Portate molti panni da lavare?” domandò la donna alla strega.
“Portate molti panni da lavare?” domandò la donna alla strega.
 “Molti, comare mia.”
“Molti, comare mia.”Non si udiva alcun rumore nella vasta campagna.
 “Mi pare molto presto!” osservò a un tratto la donna che già incominciava ad aver paura. Come se il cuore gliel’avvertisse.
“Mi pare molto presto!” osservò a un tratto la donna che già incominciava ad aver paura. Come se il cuore gliel’avvertisse.
 “No, comare mia! Fra poco sarà l’alba”, disse la strega.
“No, comare mia! Fra poco sarà l’alba”, disse la strega.
 “Ho paura delle streghe. Dicono che laggiù al vallone ce ne sono”.
“Ho paura delle streghe. Dicono che laggiù al vallone ce ne sono”.
 “Sono dicerie, comare mia.”
“Sono dicerie, comare mia.”
 “Forse!” esclamò la donna. Ma i suoi occhi, senza volerlo, andarono ai piedi della finta comare.Vide che invece di piedi aveva zoccoli come gli asini. Si sentì gelare il sangue, la poveretta; si sentì sciogliere le ossa. “Gesù, Gesù!” si disse e si fece il segno della croce, per scongiurare il pericolo. Avrebbe voluto scappare, ma per andare dove, sola com’era a quell’ora di notte? Si affidò alla volontà di Dio.
“Forse!” esclamò la donna. Ma i suoi occhi, senza volerlo, andarono ai piedi della finta comare.Vide che invece di piedi aveva zoccoli come gli asini. Si sentì gelare il sangue, la poveretta; si sentì sciogliere le ossa. “Gesù, Gesù!” si disse e si fece il segno della croce, per scongiurare il pericolo. Avrebbe voluto scappare, ma per andare dove, sola com’era a quell’ora di notte? Si affidò alla volontà di Dio.Arrivarono al torrente giù al vallone e cominciarono a lavare i panni e a dire cose. La strega attaccò a parlare, a parlare, per incantare la donna; la quale fra sé pregava Dio che arrivasse presto l’alba. Giacché dopo l’alba le streghe non hanno più potere di stregare. Diceva sempre di sì e fingeva di non aver capito che la compagna era una strega. Si faceva coraggio, ma già la strega la stava addormentando, con quel suo cicalio fitto fitto che non terminava mai. Si scosse, la donna, si fece forza e si diede a parlare delle pene del lino.
“Ah, comare, a raccontare le pene del lino, canta il gallo e fa mattino!” diceva. “Bisogna zappare la terra e seminarvi il lino fitto fitto in modo che un seme tocchi l’altro seme. Il lino spunta e cresce. Ma bisogna mettere un pupazzo in mezzo, altrimenti i passeri se lo mangiano... Ah, comare, a raccontare le pene del lino, canta il gallo e fa mattino!...”
 La strega sentiva che il suo potere diminuiva, a queste parole, e diceva:
La strega sentiva che il suo potere diminuiva, a queste parole, e diceva:
 “Oh, lasciate stare il vostro discorso e ascoltate me che voglio raccontarvi una storia...”
“Oh, lasciate stare il vostro discorso e ascoltate me che voglio raccontarvi una storia...”
 “... E poi bisogna pulire il lino dalle erbacce... Ah,comare, a raccontare delle pene del lino, canta il gallo e fa mattino!...” continuava a ripetere la donna, proprio col coraggio dei disperati.
“... E poi bisogna pulire il lino dalle erbacce... Ah,comare, a raccontare delle pene del lino, canta il gallo e fa mattino!...” continuava a ripetere la donna, proprio col coraggio dei disperati.Al ripetere: Canta il gallo e fa mattino, la strega fremeva e si sentiva diventare sempre più impotente. La donna lo capiva e a vele gonfie proseguiva:
 “Cresce, il lino, e diventa verde e col fiorellino azzurro. A maggio quando c’è bel tempo, il lino ingiallisce e bisogna raccoglierlo... Ah, comare, a raccontare le pene del lino, canta il gallo e fa mattino...”
“Cresce, il lino, e diventa verde e col fiorellino azzurro. A maggio quando c’è bel tempo, il lino ingiallisce e bisogna raccoglierlo... Ah, comare, a raccontare le pene del lino, canta il gallo e fa mattino...”“Lasciatemi dire, fatemi raccontare qualcosa anche a me”, fece la strega sempre però con voce più debole.
“Dopo che lo raccogliamo, lo stendiamo, il lino, nel campo e ve lo lasciamo per giorni e giorni al sole; poi lo mettiamo ad ammollare nell’acqua corrente, quando non c’è la luna... Ché il lino, se c’è la luna, nell’acqua si sfà... Poi lo ristendiamo al sole che lo cuoce, lo matura; e infine lo maciulliamo, lo cardiamo... Ah, comare, a raccontare le pene del lino, canta il gallo e fa mattino!...”
“Oh, sentite, comare, cosa m’è successo a me ieri...”
“... E dopo che lo cardiamo, il lino, lo filiamo e incominciamo a tessere i lenzuoli e il resto della biancheria. Tutto il corredo ci tessiamo col lino... Ah, comare, a raccontare le pene del lino, canta il gallo e fa mattino...”
Ed ecco il canto del primo gallo. La donna mandò un sospiro di sollievo. Ora che l’alba era prossima, la strega non aveva più alcun potere sulla donna.
“Ora ti aggiusto io per le feste!” si disse questa che era mezza morta per lo sforzo che aveva dovuto fare a vincere l’incantesimo. Accese il fuoco per preparare la liscivia e, quando l’acqua della caldaia cominciò a bollire, disse alla strega:
 “Comare, venite a vedere se è al punto giusto per versare la cenere dentro l’acqua”.
“Comare, venite a vedere se è al punto giusto per versare la cenere dentro l’acqua”.La strega che a quell’ora cominciava ad essere stolta si avvicinò alla caldaia e si curvò per guardare. La donna lesta lesta la prese dal sedere e ve la infilò dentr, dicendo:
 “E se qualcuno ti chiede chi ti ha buttata dentro, digli che è stata Me Stessa. Così mi chiamo io,”
“E se qualcuno ti chiede chi ti ha buttata dentro, digli che è stata Me Stessa. Così mi chiamo io,”
 La strega urlava in modo feroce. Alle sue grida una schiera di streghe le domandarono a gran voce dall’altra parte del vallone:
La strega urlava in modo feroce. Alle sue grida una schiera di streghe le domandarono a gran voce dall’altra parte del vallone:
 “Che ti è successo che gridi così?”
“Che ti è successo che gridi così?”
 “Correte, ché Me Stessa mi sta bruciando viva”
“Correte, ché Me Stessa mi sta bruciando viva”
 “E se tu ti stai bruciando da te stessa perché dobbiamo venire?
“E se tu ti stai bruciando da te stessa perché dobbiamo venire?
 “Non sono io, ma Me Stessa che mi brucia. Aiuto!”
“Non sono io, ma Me Stessa che mi brucia. Aiuto!”La donna intanto scappava per la salita.
 “Accorrete ad ammazzare Me Stessa!” gridava la strega già mezza morta.
“Accorrete ad ammazzare Me Stessa!” gridava la strega già mezza morta.
 “Tu sei pazza stamattina!” le dissero le compagne e non si curarono più di lei che morì di lì a poco.
“Tu sei pazza stamattina!” le dissero le compagne e non si curarono più di lei che morì di lì a poco.
 La donna però ebbe una fifa che le durò per tutta la vita. Figuratevi che per otto giorni ebbe un febbrone da cavallo; e che per sempre non parlò d’altro che della strega e di Me Stessa.
La donna però ebbe una fifa che le durò per tutta la vita. Figuratevi che per otto giorni ebbe un febbrone da cavallo; e che per sempre non parlò d’altro che della strega e di Me Stessa.* Saverio Strati è uno dei grandi narratori italiani del ‘900. Nato a Sant’Agata del Bianco (RC) il 16 agosto 1924 è morto a Scandicci, Firenze il 9 aprile 2014 ("Trama e ordito").
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
Armando Polito, "Dialetti salentini: Li pene ti lu linu (Le pene del lino)", "Fondazione Terra d’Otranto", 29.07.2018.
GLI ESEMPI TAROCCATI DI BARICCO E DI SCALFARI E L’ITALIA STRETTA NELL’ABBRACCIO MORTALE DEL "CAVALEONTICO" ULISSE DI ARCORE.
IN UNO "STATO" SONNAMBOLICO, IL CONTINUO RITORNELLO DEGLI INTELLETTUALI ITALIANI. DALL’ILIADE ALL’ODISSEA: ALESSANDRO BARICCO, IL CIECO OMERO DEL "CAVALEONTICO" ULISSE DI ARCORE.
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria".
Federico La Sala
-
> PER LA PACE PERPETUA. -- Walter Benjamin e le pietre dell’apocatastasi. La salvezza di tutti gli esseri attraverso il ritorno allo stato originario.21 luglio 2018, di Federico La Sala
ALIAS
Walter Benjamin e le pietre dell’apocatastasi
Ultraoltre. La salvezza di tutti gli esseri attraverso il ritorno allo stato originario
- [Foto] Schema alchemico del V.I.T.R.I.O.L.
di Raffaele K. Salinari (il manifesto, 21.07.2018)
Ad un certo punto del folgorante saggio sull’opera di Nikolaj Leskov, Walter Benjamin ci introduce alla sua originalissima idea di apocatastasi: la salvezza universale attraverso il ritorno di tutti gli esseri alla pienezza originaria. Il sentiero che invita a percorrere da quel momento è, come spesso nel suo stile, notturno e sotterraneo: pieno di oscure analogie minerali e necriche metafore che però, alla fine, seguendo la mappa tracciata dal suo immaginario messianico, ci porteranno alla luce di una splendente verità.
Come guida naturale del tortuoso cammino, Benjamin staglia dai racconti di Leskov quella particolarissima figura che egli chiama «il giusto». Incarnazione complessa perché estremamente sfaccettata, maschera di volta in volta diversa - il buffone, lo scemo del villaggio, il viaggiatore, l’artigiano, il briccone - il giusto ha, però, un’essenza costante che si trasmette di personaggio in personaggio come in quelle Pathosformel che Warburg cercò di incasellare nel suo favoloso atlante Mnemosyne.
Per distillare questa essenza Benjamin parte da Bloch - che come lui aveva difficili rapporti con i francofortesi - citandone l’interpretazione del mito di Filemone e Bauci, nel quale si descrive la figura del giusto come colui, o colei, che portando con sé un tocco gentile, lo fa amico di tutte le cose. La madre di Leskov stesso ad esempio «che non poteva infliggere una sofferenza a nessuno, neppure agli animali. Non mangiava carne né pesce, tanta era la sua compassione per le creature viventi». Il giusto, conclude Benjamin, è allora il portavoce delle creature ed insieme la sua più alta incarnazione. E così vediamo che la sua essenza immutabile è quella di un essere «favolosamente scampato alla follia del mondo» e che, proprio mercé questa sua caratteristica, è in grado, attraverso i suoi racconti, di portare un annuncio di salvezza, di apocatastasi.
«Apocatastasi» è un termine dalle molteplici accezioni a seconda degli ambiti in cui viene usato. Letteralmente significa «ritorno allo stato originario», oppure «reintegrazione». Nella filosofia stoica, ad esempio, si collega alla «dottrina dell’eterno ritorno»: quando gli astri assumeranno la stessa posizione che avevano all’inizio dell’universo. Per il neoplatonismo, invece, l’apocatastasi è qualcosa di più spirituale, cioè il ritorno dei singoli enti all’unità originaria, all’Uno indifferenziato da cui l’intero insieme delle cose manifestate proviene; è ciò che gli gnostici chiamerebbero il Pleroma. Questa idea si inserisce appieno all’interno del tema, prettamente religioso, della Caduta: l’allontanamento dell’uomo dalla sua originaria comunione con l’Assoluto, col Divino, ma anche di un suo possibile ritorno alla pienezza edenica originaria. Nella teologia dei primi Padri della Chiesa il suo teorico è Origene.
Dice allora Benjamin: «Una parte importante, in questa dogmatica [della chiesa greco-ortodossa], è svolta, com’è noto, dalle teorie di Origene, respinte dalla chiesa romana, sull’apocatastasi: l’ingresso di tutte le anime in paradiso. Leskov era molto influenzato da Origene. Egli si proponeva di tradurre la sua opera Sulle cause prime. In armonia con la fede popolare russa, egli interpretava la resurrezione più che come una trasfigurazione, come la liberazione da un incantesimo, in senso affine a quello della favola». Benjamin, dunque, è qui teso a mettere in rilievo, anzi diremmo a dispiegare pienamente, non tanto il senso teologico, escatologico, del termine, quanto il suo potenziale immaginale, evocativo, metaforico, grazie al quale egli può farci vedere, nei personaggi della narrativa leskoviana, «l’apogeo della creatura» ed allo stesso tempo «un ponte fra il mondo terreno e ultraterreno», costruito attraverso l’atto creativo, poietico, del racconto.
Ma, per la nota verità metafisica secondo cui «ciò che è in alto è come ciò che è in basso», «il giusto» collega sia le vette, gettando un ponte tra il modo terreno e quello ultraterreno, sia le voragini nascoste nelle viscere della terra con ciò che avviene in superficie. «La gerarchia creaturale, che ha nel giusto la sua cima più alta, sprofonda in gradini successivi nell’abisso dell’inanimato. Dove bisogna tener presente un fatto particolare. Tutto questo mondo creaturale non si esprime tanto, per Leskov, nella voce umana, ma in quella che si potrebbe chiamare, col titolo di uno dei suoi racconti, la voce della natura». E dunque eccolo presentarci una di quelle intuizioni che collegheranno la figura del giusto, inteso come interprete della «voce della natura» e della salvezza, alle sue rappresentanze più elementari e sotterranee. «Quanto più Leskov discende lungo la scala della creature, tanto più chiaramente la sua concezione si avvicina a quella dei mistici». Ed a questo punto, con uno dei suoi scarti spettacolari, Benjamin passa a parlare del racconto di una pietra che racchiuderebbe una profezia: l’Alessandrite.
L’Alessandrite e la pulce di acciaio
Il racconto di Leskov citato da Benjamin, si intitola come la pietra che ne è protagonista. Narra di un tagliatore di pietre di nome Wenzel che ha raggiunto nel suo lavoro vette eccelse, paragonabili a quelle degli argentieri di Tule che ferrarono la famosa «pulce di acciaio» capitata nelle mani dello zar Nicola I. Qui una breve digressione è d’obbligo poiché questa pulce, questa «ninfosoria» come viene definita nel racconto, caricabile a molla e di grandezza naturale, pare esista davvero e sarebbe ammirabile nel Museo delle armi in città. Uno scrittore italiano contemporaneo dice di averla vista.
 Chi ama Tolstoj conosce Tule, dato che la sua famosa residenza, Jasnaja Poljana e la sua tomba, si trovano da quelle parti. La storia è semplice ma suggestiva: il fratello della zar Nicola I, Aleksàndr Pàvlovic, riceve in dono dagli «inghilesi» questo manufatto, una «ninfosoria» appunto, fatta di acciaio brunito che, mercé una piccola chiavetta inserita nella pancia, può essere caricata e dunque muoversi come una vera. Alla morte del fratello la pulce meccanica passa all’Imperatrice vedova Elisavéta Alekséevna che però, stretta nel suo lutto inconsolabile, decide di inoltrarla al nuovo sovrano. Il novello zar Nicolàj Pàvlovic in un primo tempo la trascura, per impellenti questioni di stato, poi si impunta e cerca di trovare il modo di eguagliare, o meglio, superare la bravura degli odiati «inghilesi». E dunque ordina ad un suo uomo di fiducia di raggiungere i famosi argentieri di Tule, rinomati per la loro maestria, e vedere cosa potessero fare per surclassare l’arte britannica. Dopo qualche tempo la ninfosoria di acciaio brunito torna a palazzo. In apparenza è immutata e lo zar si adira ma, ad una più attenta osservazione microscopica, ecco apparire il prodigio tecnologico: su ogni zampetta della pulce di acciaio è stato addirittura apposto come un ferro di cavallo e, su ognuno, è inciso il nome del mastro argentiere che l’ha forgiato!. L’orgoglio russo è salvo.
Chi ama Tolstoj conosce Tule, dato che la sua famosa residenza, Jasnaja Poljana e la sua tomba, si trovano da quelle parti. La storia è semplice ma suggestiva: il fratello della zar Nicola I, Aleksàndr Pàvlovic, riceve in dono dagli «inghilesi» questo manufatto, una «ninfosoria» appunto, fatta di acciaio brunito che, mercé una piccola chiavetta inserita nella pancia, può essere caricata e dunque muoversi come una vera. Alla morte del fratello la pulce meccanica passa all’Imperatrice vedova Elisavéta Alekséevna che però, stretta nel suo lutto inconsolabile, decide di inoltrarla al nuovo sovrano. Il novello zar Nicolàj Pàvlovic in un primo tempo la trascura, per impellenti questioni di stato, poi si impunta e cerca di trovare il modo di eguagliare, o meglio, superare la bravura degli odiati «inghilesi». E dunque ordina ad un suo uomo di fiducia di raggiungere i famosi argentieri di Tule, rinomati per la loro maestria, e vedere cosa potessero fare per surclassare l’arte britannica. Dopo qualche tempo la ninfosoria di acciaio brunito torna a palazzo. In apparenza è immutata e lo zar si adira ma, ad una più attenta osservazione microscopica, ecco apparire il prodigio tecnologico: su ogni zampetta della pulce di acciaio è stato addirittura apposto come un ferro di cavallo e, su ognuno, è inciso il nome del mastro argentiere che l’ha forgiato!. L’orgoglio russo è salvo.Alla stessa dinastia zarista è invece legata la vicenda, anche questa in bilico tra storia e leggenda, dell’Alessandrite. Qui si tratta della scoperta di una pietra singolare che prende il nome dal futuro zar Alessandro II, figlio di Nicola I. La pietra venne, infatti, cavata per la prima volta il giorno della sua nascita, nel 1818. Questo è lo zar dell’epoca in cui si svolge il romanzo Anna Karenina di Tolstoj, un periodo burrascoso e denso di avvenimenti storici rilevanti. Ecco che allora la caratteristica peculiare di questa pietra diviene una sorta di profezia sulla vita e la morte dell’omonimo sovrano. Essa, infatti, è verde alla luce del sole e rossa a quella artificiale. Il fenomeno è dovuto alle inclusioni di cromo, presenti anche nel corindone e nello smeraldo. Ora, nel racconto di Leskov, la casuale scoperta della pietra nel giorno natale del futuro zar, e le sue caratteristiche cromatiche, fanno intessere al narratore la profezia che la vuole metafora della vita di Alessandro II. Verde alla luce del mattino, dunque nella giovinezza e nella maturità dell’imperatore di tutte le Russie, essa diviene color sangue al calar delle tenebre, simboleggiando così la tragica fine che, effettivamente, subì il sovrano.
Il 13 marzo del 1881, infatti, lo Zar si disse disposto a prendere in considerazione le modalità dell’abolizione della servitù della gleba. Ma era già troppo tardi. Lo stesso giorno alcuni cospiratori guidati da Sofja Perovskaja misero in atto un astuto piano per eliminarlo. Alessandro II era già sfuggito più volte alla morte per attentato, ma quella volta il disegno riuscì. Mentre faceva ritorno al Palazzo d’Inverno, la sua carrozza fu colpita da una bomba lanciata da Nikolaj Rysakov, ma egli rimase illeso. Sceso per accertarsi dei danni fu investito dall’esplosione di una seconda bomba. Lo scoppio lo colpì ferendolo mortalmente. La profezia dell’Alessandrite si era avverata.
V.I.T.R.I.O.L.
Ma la poetica di questi elementi naturali, secondo la visione di Benjamin, emana ancor più potentemente da ciò che rimane nella profondità della terra, dando loro addirittura il potere di ricombinare il destino dei vivi con quello dei morti, di salvare eternamente e al tempo stesso gli uni e gli altri. E d’altronde il pensiero dell’eternità non ha sempre avuto la sua fonte principale nella morte? Per attivare questa operazione favolosa egli utilizza allora come Prima Materia del suo athanor immaginale uno degli autori preferiti l’«indimenticabile Johann Peter Hebel». «La morte è la sanzione di tutto ciò che il narratore può raccontare» afferma icasticamente e aggiunge, «dalla morte egli attinge la sua autorità. O, in altre parole, è la storia naturale in cui si situano le sue storie». La morte dunque è l’origine del racconto, la matrice della sua eternità. Come non vedere in questa affermazione la sanzione dell’opera al nero, primo gradino del processo alchemico?
Per Benjamin allora la pietra filosofale, cioè l’incanto salvifico della narrazione, la sua funzione come strumento di una vera e propria apocatastasi, nasce nel crogiolo della storia naturale formandosi da un compost affatto speciale. Ecco l’atmosfera nella quale ci vengono presentati i due grandi protagonisti del racconto di Hebel Insperato incontro: il tempo che dissolve i corpi, ed il suo comprimario che qui, paradossalmente, li coagula, il vetriolo.
La parola vetriolo, dal latino vetriolum, compare per la prima volta intorno al VII-VIII secolo d.C., e deriva dal classico vitreolus. Con questa radice etimologica possiamo pensare che il nome trovi origine dall’aspetto vetroso assunto dai solfati di rame e di ferro cristallizzati. Per quelli di rame è di colore azzurro intenso (per questo detto anche vetriolo azzurro o di Cipro o di Venere, la dea portata verso l’isola dalle azzurre onde del mare, ma anche il pianeta di riferimento del rame) mentre nel solfato di ferro è di colore verde azzurro (vetriolo verde o marziale, perché Marte è il pianeta di riferimento del ferro). Sarà quest’ultimo, lo vedremo tra poco, il vetriolo protagonista del racconto.
Sia il vetriolo di rame che il vetriolo di ferro erano conosciuti ed utilizzati dagli Egizi e dai Greci, anche se non sotto questo nome. Forse il famoso natron, che serviva ad imbalsamare i corpi, ne conteneva una certa quantità. L’immancabile Plinio il Vecchio, nella sua Historia Naturalis, menziona una sostanza che chiama «vetriolo« e ne descrive l’estrazione «dalle acque ramifere». Questo nome comprende, e confonde, in realtà, una vera e propria famiglia di composti. Ecco allora che bisogna chiamare in causa anche l’alchimia poiché esso, chiamato vetriolo filosofico, indica nulla di meno che il Solvente Universale, e cioè tutti quei composti chimici che consentono di avviare la procedura condensata nella nota formula «solve et coagula». Per questo le sue origini si perdono nella notte dei tempi, essendo indicato come tale, ma anche con tantissimi altri nomi, in tutti i trattati di Arte Regia. La prima sintesi del vetriolo come Solvente Universale, cioè come acido solforico, la si deve all’alchimista islamico Ibn Zakariya al-Razi che lo ottenne per distillazione a secco di minerali contenenti ferro e rame.
Per completezza simbolica bisogna citare anche l’acronimo, V.I.T.R.I.O.L., che compare nell’opera Azoth del 1613 dell’alchimista Basilio Valentino. Il suo svolgimento è: «Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem», cioè «Visita l’interno della terra, operando con rettitudine troverai la pietra nascosta». La frase simboleggia la discesa all’interno dell’essere per operare con rettitudine alla ricerca del proprio gioiello interiore.
E allora concludiamo la parabola dell’apocatastasi benjaminiana, con il bel racconto di Hebel di cui il vetriolo marziale è protagonista. Siamo a Falun, in Svezia, presso le miniere di ferro. Due giovani sono innamorati e presto si sposeranno. Lui però è un minatore ed un giorno non torna più: la miniera è crollata. Passano gli anni e la fidanzata gli rimane fedele. Dopo decenni, in cui il tempo lavora sulla materia vivente, ecco che dalla vecchia miniera riemerge il corpo del minatore: è intatto poiché il vetriolo lo ha imbalsamato nel momento della giovinezza. Mentre lo seppellisce esclama: «Dormi in pace adesso, un giorno ancora o forse dieci, in questo fresco letto nuziale, e non ti sembri lungo il tempo. Mi restano soltanto poche cose da fare, e presto verrò, presto sarà di nuovo giorno. Ciò che la terra ha già una volta reso, una seconda non lo tratterrà». Tutto è giusto e perfetto.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Noi, oggi, alla fine della storia. Trent’anni dopo Francis Fukuyama torna sul tema del suo celebre saggio. E lo difende.1 luglio 2018, di Federico La Sala
Noi, oggi, alla fine della storia
Trent’anni dopo Francis Fukuyama torna sul tema del suo celebre saggio. E lo difende
- L’anticipazione Il testo del politologo statunitense in uscita sulla rivista «Vita e Pensiero»: qui ne pubblichiamo un estratto
di Francis Fukuyama (Corriere della Sera, 01.07.2018)
È dal 1989 che mi viene ripetuta sempre la stessa domanda: «E allora? La fine della storia?... X non smentisce forse la sua tesi?». X può essere un evento della politica internazionale, come un colpo di Stato in Perù o gli attentati dell’11 settembre, oppure una crisi finanziaria a Wall Street. Di solito, la domanda proviene da chi non ha capito il senso di fine della storia e non ha letto il mio libro La fine della storia e l’ultimo uomo, pubblicato nel 1992 (Rizzoli; edizione originale 1992).
Sono sempre convinto che il concetto rimane essenzialmente valido, anche se indubbiamente la fase attuale della politica mondiale non è più la stessa di quando scrivevo il mio articolo. Sarebbe strano che quasi trent’anni non avessero modificato il mio modo di pensare il mondo. Cionondimeno, è importante distinguere tra le critiche ragionevoli e quelle stupide, o fondate su una semplice mancanza di comprensione.
Cominciamo dal titolo dell’articolo originale La fine della storia?, pubblicato dalla rivista statunitense «The National Interest» e in francese da «Commentaire» nell’estate del 1989. Vi si utilizzano altri termini per descrivere il fenomeno che oggi sarebbe definito piuttosto «sviluppo» o «modernizzazione». La «fine» della storia indicava lo scopo o l’obiettivo, più che non la sua conclusione; la «fine della storia» poneva quindi la questione della finalità o del punto terminale dello sviluppo umano o del processo di modernizzazione.
L’espressione «la fine della storia» non era mia; è stata originariamente utilizzata in questo senso dal grande filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel è stato il primo filosofo della storia, nel senso che non credeva possibile penetrare il pensiero o le società umane senza comprendere il contesto storico in cui esse s’inscrivono e il processo evolutivo che le ha prodotte.
 Karl Marx, autore della versione più celebre della fine della storia, ha ripreso lo stesso quadro storicista. Sosteneva che le società si modernizzano, evolvendo da uno stadio primitivo verso il capitalismo borghese passando per il feudalesimo. Per Marx, la fine della storia era lo stadio finale di tale processo, un’utopia comunista. Io mi accontentavo di sostenere, nel 1989, che non sembrava che saremmo un giorno pervenuti allo stadio finale del comunismo. Mikhail Gorbaciov, che aveva lanciato la perestrojka e la glasnost, stava trasformando l’Unione Sovietica in qualcosa di sempre più simile a una democrazia. In conseguenza, se fine della storia doveva esserci, sarebbe stata simile piuttosto a una democrazia liberale collegata a un’economia di mercato.
Karl Marx, autore della versione più celebre della fine della storia, ha ripreso lo stesso quadro storicista. Sosteneva che le società si modernizzano, evolvendo da uno stadio primitivo verso il capitalismo borghese passando per il feudalesimo. Per Marx, la fine della storia era lo stadio finale di tale processo, un’utopia comunista. Io mi accontentavo di sostenere, nel 1989, che non sembrava che saremmo un giorno pervenuti allo stadio finale del comunismo. Mikhail Gorbaciov, che aveva lanciato la perestrojka e la glasnost, stava trasformando l’Unione Sovietica in qualcosa di sempre più simile a una democrazia. In conseguenza, se fine della storia doveva esserci, sarebbe stata simile piuttosto a una democrazia liberale collegata a un’economia di mercato.Il motore della modernizzazione descritto nel mio libro del 1992 era una versione molle della teoria della modernizzazione. Le società umane si sono sviluppate, ma tale processo non è una sorta di ascensore che va automaticamente verso l’alto. I progressi dipendono dalle contingenze e dal fattore umano; niente è inevitabile né predeterminato.
 Sostenevo tuttavia che la modernizzazione è un processo coerente che sembra fondamentalmente non differire da una cultura umana all’altra. Questo ha a che vedere con la natura della tecnica o con ciò che io chiamavo «il meccanismo». A un dato stadio della storia dell’umanità, le forme dominanti della tecnica determinano una frontiera delle possibilità di produzione che modellano la natura della vita economica. La forma dominante di organizzazione economica ha allora degli effetti critici sull’organizzazione sociale e finisce per plasmare le forme dell’organizzazione politica stessa. È così accaduto, per esempio, che le tecnologie di produzione del carbone, dell’acciaio e delle industrie di grande scala hanno stravolto l’antico ordine agricolo e imposto l’urbanizzazione e, al tempo stesso, livelli di istruzione più elevati. Le prime fasi della rivoluzione dell’informazione hanno messo termine al monopolio dell’informazione, che era nelle mani di diverse gerarchie, e favorito la mobilitazione orizzontale. L’aumento dei livelli di reddito ha allora generato un ceto medio che voleva partecipare alla vita politica. Questo spiega la correlazione relativamente stretta tra la ricchezza e la democrazia nel mondo.
Sostenevo tuttavia che la modernizzazione è un processo coerente che sembra fondamentalmente non differire da una cultura umana all’altra. Questo ha a che vedere con la natura della tecnica o con ciò che io chiamavo «il meccanismo». A un dato stadio della storia dell’umanità, le forme dominanti della tecnica determinano una frontiera delle possibilità di produzione che modellano la natura della vita economica. La forma dominante di organizzazione economica ha allora degli effetti critici sull’organizzazione sociale e finisce per plasmare le forme dell’organizzazione politica stessa. È così accaduto, per esempio, che le tecnologie di produzione del carbone, dell’acciaio e delle industrie di grande scala hanno stravolto l’antico ordine agricolo e imposto l’urbanizzazione e, al tempo stesso, livelli di istruzione più elevati. Le prime fasi della rivoluzione dell’informazione hanno messo termine al monopolio dell’informazione, che era nelle mani di diverse gerarchie, e favorito la mobilitazione orizzontale. L’aumento dei livelli di reddito ha allora generato un ceto medio che voleva partecipare alla vita politica. Questo spiega la correlazione relativamente stretta tra la ricchezza e la democrazia nel mondo.Il decollo dell’Asia orientale è l’esempio più palese di uno sviluppo economico che conduce a una convergenza sociale. Dal Giappone alla Corea, da Taiwan alla Cina, è un’intera regione che si è industrializzata. In ciascuno di questi casi, le trasformazioni sociali prodotte da questo processo hanno comportato una convergenza con i Paesi occidentali: si è verificato un massiccio esodo rurale, abbiamo assistito a maggiori investimenti nell’istruzione e nel know-how, allo sviluppo di una classe media urbana e a una divisione del lavoro più complessa e interdipendente. Nel caso del Giappone, della Corea del Sud e di Taiwan, c’è stata anche una convergenza politica. Con l’andare del tempo, ognuno di questi Paesi è diventato una democrazia liberale; gli ultimi due hanno operato la loro transizione negli anni Ottanta, allorché le rispettive società, che erano soprattutto agricole, sono diventate urbane e industriali.
Il modello non è però universale. Singapore ha raggiunto un Pil pro capite superiore, in termini di potere d’acquisto, a quello degli Stati Uniti, ma è restato un’autocrazia elettorale liberale. La Cina ha conseguito adesso un livello di reddito paragonabile a quello di Taiwan e della Corea del Sud degli anni Ottanta, e sotto Xi Jinping è evoluta non verso una democrazia, ma verso una forma di dittatura più repressiva.
A parte il caso cinese, in questo quadro mancavano diversi elementi, che oggi comprendo molto meglio che nei primi anni Novanta. Il primo consiste nel sapere in quale modo la crescita economica si mette in moto. Una volta che ti trovavi nell’ascensore che saliva, andavi incontro a conseguenze sociali e politiche prevedibili; molte parti del mondo, però, sembravano sprofondare nella povertà, senza una realistica speranza di riprodurre il processo di crescita di Giappone, Corea e Cina.
Se questo genere di crescita non è diventato maggiormente universale, è a motivo dell’assenza di istituzioni, in particolare a motivo dell’assenza di uno Stato moderno. Se le società dell’Asia orientale si sono così bene sviluppate economicamente nel corso delle due generazioni precedenti, è perché si erano dotate di Stati moderni prima di confrontarsi con l’Occidente e non hanno così dovuto creare questo genere di istituzioni, mentre si dedicavano ai loro progetti di modernizzazione. Il secondo problema della mia formulazione del 1992 è strettamente connesso alla difficoltà di dar vita a Stati moderni: essi possono tanto svilupparsi quanto declinare, ossia regredire verso qualcosa di meno moderno.
La terza sfida è collegata al problema del peso delle élite nelle istituzioni dello Stato. In molte democrazie liberali contemporanee è largamente diffusa l’idea che le élite esistenti abbiano truccato il sistema a loro beneficio e vi si siano radicate talmente in profondità che la politica democratica ordinaria non basta più a snidarle. L’inerzia o l’impasse politica che ne risulta inducono allora a reclamare un leader forte, capace di affrontare tali élite, anche a costo di scalzare il quadro istituzionale che definisce la democrazia liberale.
La quarta sfida alla mia ipotesi è quella sollevata da Samuel Huntington: la democrazia liberale è il prodotto della cultura occidentale e non un elemento inevitabile del processo di modernizzazione. In proposito, la Cina è di gran lunga la più grossa sfida alla narrazione della fine della storia, poiché si è modernizzata economicamente rimanendo una dittatura.
Ci si è domandati, per un certo tempo, se una simile società fosse veramente capace di innovare e non si sarebbe accontentata di copiare e inseguire le economie mondiali di testa. Ma oggi, con il suo immenso settore tecnologico in espansione, la Cina sorpassa i rivali occidentali in molti settori.
 Resta la domanda sulla sostenibilità del modello. Nessuna società può essere giudicata sulle sue performance a breve termine e ci sono ragioni per credere che su questo Paese incombano delle gravi sfide per i prossimi anni. -Esso ha potuto conservare gli elevati livelli di crescita degli ultimi anni facendo un largo ricorso all’indebitamento; se la Cina ha un tasso di risparmio ragguardevole, il suo debito netto non è però sostenibile. Il suo modello di crescita, basato su alti livelli di sviluppo delle infrastrutture, segna il passo; viene da domandarsi se tale modello possa essere esportato attraverso la nuova Via della Seta. La Cina ha privilegiato così a lungo la crescita economica da avvelenare il proprio ambiente naturale; se il governo ora tenta di disinquinare, non è sicuro che sarà in grado di risolvere l’insieme di questi problemi mantenendo lo stesso tasso di crescita.
Resta la domanda sulla sostenibilità del modello. Nessuna società può essere giudicata sulle sue performance a breve termine e ci sono ragioni per credere che su questo Paese incombano delle gravi sfide per i prossimi anni. -Esso ha potuto conservare gli elevati livelli di crescita degli ultimi anni facendo un largo ricorso all’indebitamento; se la Cina ha un tasso di risparmio ragguardevole, il suo debito netto non è però sostenibile. Il suo modello di crescita, basato su alti livelli di sviluppo delle infrastrutture, segna il passo; viene da domandarsi se tale modello possa essere esportato attraverso la nuova Via della Seta. La Cina ha privilegiato così a lungo la crescita economica da avvelenare il proprio ambiente naturale; se il governo ora tenta di disinquinare, non è sicuro che sarà in grado di risolvere l’insieme di questi problemi mantenendo lo stesso tasso di crescita.Per finire, la legittimità del Partito comunista rimane molto dipendente dai suoi risultati. Il Paese non ha conosciuto gravi recessioni dal 1978, ma è inevitabile che vada incontro a pesanti difficoltà economiche, nella misura in cui cercherà di passare allo statuto di economia ad alto reddito. Come reagirà la nuova classe media dinanzi al perdurare della dominazione del partito durante una lunga recessione economica? Se nei prossimi anni la crescita della Cina proseguirà, serbando il suo posto di prima potenza economica del mondo, allora ammetterò che la mia tesi del 1992 sarà stata definitivamente confutata.
 (traduzione di Pier Maria Mazzola)
(traduzione di Pier Maria Mazzola) -
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- L’«Iliade». Una nuova, personalissima versione, con denso commento di Franco Ferrari. Note di Federico Condello e Maria Grazia Ciani.1 luglio 2018, di Federico La Sala
Alias domenica
L’«Iliade» plurilingue di Franco Ferrari
Classici ritradotti. Negli Oscar una nuova, personalissima versione, con denso commento
di Federico Condello (il manifesto, 01.07.2018)
«Non si è autori che a partire dalla seconda opera», diceva il Lejeune del Patto autobiografico. Aurea regola, dalla quale viene una formula tra le più fortunate del nostro marketing librario: «dallo stesso autore di...». Segue, naturalmente, menzione di uno o più bestseller anteriori. Ma cosa accadrebbe se volessimo applicare la regola, e la pubblicità che ne deriva, all’autore primo e principe, cioè a Omero? Il gioco funzionerebbe ancora? O invece Omero fa eccezione, ed è nato autore fin dalla sua prima opera, che è per noi la prima di tutte le opere a venire? L’«Oscar» omerico che si discute in queste pagine (Iliade, a cura di Franco Ferrari, pp. 1232, € 14,00) esibisce placidamente questa réclame: «di Omero negli Oscar: Iliade, Odissea». E però bisogna ammettere che la dicitura suona piuttosto spiazzante, se applicata al cieco di Chio, al poeta dei poeti. «Iliade, Odissea»: che altro mai dovrebbe esserci? «Di Omero»: siamo sicuri? E «di Omero» in che senso? Omero è forse un autore come un altro?
Eppure, a suo modo, la regola di Lejeune funziona anche per l’autore dell’Iliade e dell’Odissea. «Omero» - il suo nome, il suo mito - è decisamente posteriore ai poemi che del suo nome e del suo mito si alimentarono: appropriarsi di quei poemi, e diffonderli sotto la paternità di un proto-poeta leggendario, fu una geniale operazione di marketing letterario avvenuta nel corso del VI sec. a.C. Gli aedi che la promossero, oltre a tutelare se stessi dietro un comodo anonimato, diedero impulso a una dilagante attività pubblicitaria in virtù della quale «tutta la poesia epica, intorno al 500 a.C., è poesia di Omero» (Wilamowitz): tutta l’epica perduta che noi oggi leggiamo a brandelli. Finché essa circolò sotto il nome di Omero, fu salvaguardata. Poi si perse. Così, se dapprima «Omero» trasse lustro dall’Iliade, di lì a breve l’Iliade trasse lustro da «Omero»; e con essa l’Odissea, poema programmaticamente epigonale con cui inizia davvero «la letteratura», diceva Vincenzo Di Benedetto; e con l’Iliade e l’Odissea ogni altro epos di età arcaica a vocazione panellenica: tutti poemi provenienti a qualche titolo da Omero, cioè «dallo stesso autore di...».
E oggi? Oggi Omero è più che mai «Omero», perché la sua canonizzazione moderna - un fenomeno tutto sommato recente, di pretta età romantica - ne fa un autore più che mai anonimo, più che mai collettivo. Diciamoci la verità: situare Omero nel tempo e nello spazio non solo non ci interessa, ma ripugnerebbe al nostro gusto, e ci parrebbe lesa maestà. Semmai, ci interessa sapere chi lo traduce per noi.
In effetti, fra le infinite patenti di classicità che vanno riconosciute a Omero, una si deve sottolineare, perché la si nota di rado: Omero è l’unico «autore» classico di cui importa sapere chi sia il suo traduttore. Nessuno se lo chiede, fuori dagli specialisti, per Senofonte o Cicerone, per Seneca o Plutarco, e nemmeno per Platone o Aristotele. Omero è diverso. «Voglio rileggere Omero», oppure «mia figlia deve leggere Omero, che traduzione mi consigli?»: ecco una domanda che i classicisti si sentono porre da amici e conoscenti con la stessa frequenza con cui i medici si sentono interpellare su questo o quell’acciacco. E improvvisamente i classicisti si scoprono utili: anche se quasi mai riescono a dare una risposta secca.
D’ora in poi, per l’Iliade, la risposta risulterà forse più facile. Sì, perché a Ferrari riesce qualcosa che ai traduttori omerici riesce di rado: emanciparsi, nella misura in cui è possibile e legittimo, dal canone traduttivo anteriore. Ora, si sa che l’Omero novecentesco è indiscutibilmente quello di Rosa Calzecchi Onesti: la portentosa traduttrice forgiò nel 1950 l’italo-omerico contemporaneo; liberarsi del suo modello si è rivelato per lo più un’impresa impossibile, anche quando la si è lucidamente perseguita. Fra le rare eccezioni, il coraggioso Omero in prosa di Maria Grazia Ciani; e l’ispida, laboriosa, genialmente cervellotica Odissea del citato Di Benedetto.
Ferrari, con questa sua Iliade, si colloca da par suo fra le eccezioni. La sua Iliade viene dopo l’Odissea da lui tradotta quasi vent’anni fa; e viene dopo tanti altri classici - lirici, tragici, prosatori - volgarizzati per le maggiori case editrici italiane: se a Ferrari applicassimo la formula «dallo stesso traduttore di...», l’elenco sarebbe lunghissimo.
 Con l’Iliade, però, egli compie un’operazione speciale, costata anni e anni di lavoro: il traduttore cerca un ritmo e un tono che siano solo suoi; e solo sue sono tante singole soluzioni che innovano, oltre al ron-ron formulare, tutto il campionario lessicale del poema. Ne esce una stupenda Iliade plurilingue: accanto al registro aulico, c’è il colloquiale; accanto alla vaghezza lirica, c’è il vocabolario tecnico; accanto all’epiteto stereotipato - atto d’ossequio dell’aedo alla sua tradizione, che impone al traduttore un analogo tradizionalismo - c’è l’imprevisto guizzo della nominazione inedita, esatta, illuminante.
Con l’Iliade, però, egli compie un’operazione speciale, costata anni e anni di lavoro: il traduttore cerca un ritmo e un tono che siano solo suoi; e solo sue sono tante singole soluzioni che innovano, oltre al ron-ron formulare, tutto il campionario lessicale del poema. Ne esce una stupenda Iliade plurilingue: accanto al registro aulico, c’è il colloquiale; accanto alla vaghezza lirica, c’è il vocabolario tecnico; accanto all’epiteto stereotipato - atto d’ossequio dell’aedo alla sua tradizione, che impone al traduttore un analogo tradizionalismo - c’è l’imprevisto guizzo della nominazione inedita, esatta, illuminante.Un’Iliade nuova è una novità davvero. Le novità sono qui figlie di dottrina, non solo di felicità espressiva: quasi ogni scelta è una meditata presa di posizione esegetica. E infatti l’introduzione, la nota filologica, il densissimo commento sono fra i migliori contributi omerici recenti. La profondità si abbina a una chiarezza superba, di cui pochi sarebbero stati capaci.
«Voglio rileggere l’Iliade...». Bene: questa traduzione si può caldeggiare con ottimi motivi.
Picchi di intensità per il ritmo di Achille ed Ettore
Classici ritradotti. L’esametro greco viene trasformato in una sequenza sillabica scandita con enfasi contenuta e discreta, che spesso gioca sulla sospensione precipitando nel verso successivo
di Maria Grazia Ciani (il manifesto, 01.07.2018)
Nonostante la mole, la nuova Iliade di Franco Ferrari (Oscar «Classici», testo greco a fronte) è estremamente maneggevole e soprattutto ha il pregio di cogliere tutti gli aspetti relativi a un capolavoro antico, restituendolo nella sua complessità ma sciogliendo al tempo stesso quei nodi tecnici che tendono a rendere di difficile comprensione i testi classici. L’introduzione è fondata sulla questione dell’oralità e della redazione scritta del poema. Qui Ferrari chiarisce la «scoperta» di Parry e Lord inserendola in un quadro più ampio che si rivela a una lettura molto attenta del poema, a quei particolari considerati come «incidenti» sui quali facilmente il lettore sorvola, e che fanno pensare a una «precoce redazione scritta del poema» (come documento da conservare), tesi sostenuta dai numerosi esempi di riprese omeriche - sia pure elaborate e variate - da parte di autori posteriori a Omero, quali Simonide, Stesicoro, Alceo, Alcmane... Esistevano quindi esemplari scritti anteriori alla cosiddetta redazione pisistratea e il poema - come del resto osservava Wilamowitz - era già «pronto» quando pervenne agli Ateniesi.
Nonostante ciò o forse proprio per questo, il testo dei poemi omerici rimase a lungo «liquido e cangiante nel dettato e nel numero dei versi», e qui il curatore interviene sulla figura degli aedi (quali Femio e Demodoco nell’Odissea) , che rappresentano una sorta di archeologia del canto epico e in un certo senso precedono i rapsodi, che si esibivano per lo più nelle feste recitando pezzi staccati dell’epopea e si davano il cambio, raccogliendo l’uno il testimone dell’altro.
Ma l’osservazione più interessante - al di là di altri particolarità su cui sorvolo - è, a mio parere, quella sulla concezione dell’Iliade stessa, poema di guerra, ma fino a un certo punto, in quanto si basa innanzitutto sull’ideologia del dono e dell’onore per poi trasformarsi in una visione allargata della vita e del destino dei singoli, mentre la guerra, pur nella ferocia delle descrizioni, diventa lo sfondo necessario ma non fondamentale del racconto.
In conclusione: un’introduzione originale, concreta, che si sofferma su particolari in genere tralasciati, ignorati, poco analizzati - i quali invece mettono in luce la frastagliata realtà di questi poemi che in genere si leggono e studiano tenendo conto delle parti più poetiche, dimenticando che la filologia, quando è applicata con chiarezza e ariosità, apre scenari inattesi e svela minuti e affascinanti misteri.
Asciutto ed essenziale il commento, variegato in quanto unisce rilievi tecnici e informazioni necessarie senza dilungarsi in interpretazioni fantasiose: modello da imitare specie trattando opere così vaste e complesse. E lo stesso dicasi della «Nota filologica», che ci presenta un tratto della storia della filologia interessante come un romanzo, sfatando una volta di più l’idea che questi argomenti siano la morte della poesia.
Abituale asciuttezza
Infine, la traduzione, cioè l’argomento che più ci interessa e incuriosisce. E incominciamo da quanto lo stesso Franco Ferrari ci dice in poche paginette con l’abituale asciuttezza. La posizione di Ferrari è categorica ma non è facile comprendere la sua esposizione se non si possiede un concetto chiaro e una conoscenza approfondita della metrica in generale e della sua evoluzione, perché è su questa che si basa la scelta del traduttore. Risalendo al blank verse e al gioco di fusione tra la ritmica delle sillabe (italiano e lingue romanze) e quella degli accenti (lingue germaniche), Ferrari opta per lo «statuto sillabico forte della lingua italiana» (senza peraltro attenersi a una polarità secca sillaba/accento, ma a uno spettro allargato di tendenze secondo l’orientamento di Franco Fortini) - il quale fa sì che «una cadenza legata a picchi di intensità si risolva... in un ritmo scandito con enfasi contenuta e discreta, più adatto del martellante esametro barbaro pascoliano a riverberare le inflessioni dell’esametro greco». Se la comprensione di quanto viene affermato non è facile, veniamo alla traduzione per la quale ho pensato di prendere in considerazione alcuni brani noti del poema omerico.
«Canta, Musa, l’ira...»
Ineludibile l’inizio del primo canto: «Canta, Musa, l’ira di Achille Pelide, / l’ira sciagurata che lutti innumerevoli impose / agli Achei precipitando alla casa dei morti molte / anime forti di eroi e facendo dei loro corpi / la preda di cani, il banchetto di rapaci: si attuava / il piano di Zeus da quando, scontratisi, si separarono / l’Atride capo di genti e Achille divino».
Non credo sia dovuto a suggestione il fatto che - in luogo della resa dell’esametro ad verbum, che suscita la sensazione di un racconto ininterrotto, di una specie di prosa spezzata - qui si avverta un ritmo il quale, facendo leva sulla lingua d’arrivo, «traveste», secondo l’espressione stessa del traduttore, l’esametro greco e lo trasforma in una sequenza scandita, nella quale gli enjambement - invece di scomporre l’ordito - lo rafforzano, sottolineando una sospensione che precipita nel verso seguente, in un alternarsi di pieni e di vuoti, di pause e di riprese che trascinano il lettore concentrando l’attenzione proprio sul «travestimento». Una nuova proposta di traduzione, profondamente studiata e rispettosa del testo greco senza essere né libera né pedissequa, ma originale soprattutto nella resa del «passo epico», grazie appunto all’adozione dello «statuto sillabico».
Citerò un passo del Catalogo delle navi (libro II): «Lo seguivano gli agili Abanti chiomati sulla nuca, / guerrieri avidi di squarciare con le aste protese / di frassino le corazze attorno al petto dei nemici. / Venivano con lui quaranta navi scure».
La ripetizione del ritornello, reso molto felicemente (venivano quaranta o ottanta navi scure) e la versione sincopata della rassegna rendono la misura del terrore - la forza marinara dell’intera Ellade schierata all’orizzonte, archetipo di un’Operazione Overlord ante litteram.
La bellezza di alcuni passi
Sfogliando il poema, anziché leggerlo puntigliosamente da cima a fondo, è più facile cogliere la bellezza di alcuni passi, come questi del libro IX: «Ma anche a voi altri vorrei consigliare di far vela verso casa / Perché ormai non vi accadrà di vedere la fine / Di Ilio scoscesa: stese la sua mano a proteggerla / Zeus tonante, la sua gente ha ripreso fiducia» (vv. 417-420); «Nulla per me vale il soffio della vita: non le ricchezze / Che dicono ospitasse la popolosa città di Ilio / In tempo di pace, prima che arrivassero i figli degli Achei, / né quelle che chiude al suo interno la soglia marmorea / di Febo Apollo l’arciere di Pito rupestre. / Buoi e grasse pecore si possono razzziare, bacili / E cavalli dalle fulve criniere si possono acquistare: il soffio / Della vita non si può, per farlo tornare indietro, né rubare / Né comprare una volta che abbia varcato la barriera dei denti» (vv. 401-409).
E alcuni versi tratti dalle scene di morte di Sarpedonte e Patroclo nel libro XVI: «Cadde simile a quercia o a pioppo o a pino / Svettante che calafati tagliano sui monti con scuri / Appena affilate per farne scafo di nave: / così quello giaceva disteso davanti ai cavalli / e al cocchio rantolando e stringendo la polvere insanguinata» (Sarpedonte, vv. 482-486); «Si troncò di netto nelle mani di Patroclo l’asta / Dalla lunga ombra, pesante, poderosa, dalla punta / Di bronzo e gli cadde dalle spalle con la sua cinghia lo scudo / Ben orlato. Gli slegò la corazza Apollo sovrano / Figlio di Zeus. Cecità gli invase la mente, si sfaldarono / I suoi splendidi arti, si fermò sbalordito...» (Patroclo, vv. 801-806);
Dal libro XXIV - da molti ritenuto un’aggiunta postuma - ricorderò almeno due passi significativi di quel risvolto umano della guerra che Ferrari ha sottolineato nell’introduzione: «Achille prende tra le sue braccia il cadavere di Ettore per deporlo sul carro: / Dopo che le serve lavarono e unsero il corpo / E lo avvolsero in un telo pregiato e in una tunica Achille / Lo sollevò di persona e lo depose su un letto e insieme / Con lui i compagni lo issarono sul lucido carro» (vv. 587-590); e la mirabile scena della «contemplazione»: «Allungavano prontamente le mani sui cibi imbanditi, / ma quando ebbero saziato il desiderio di bevanda e di cibo / Priamo Dardanide guardava Achille ammirandone / L’imponenza e la bellezza tanto somigliava agli dei / E Achille guardava Priamo Dardanide ammirandone / La nobile figura e porgendo ascolto alle sue parole» (vv. 627-632).
Considerata l’arte della traduzione nel suo insieme, pur citando solo pochissimi esempi, vorrei dire ancora due parole sull’uso e la resa delle formule fisse e degli epiteti. Regola aurea della tradizione epica è - si dice - il rispetto di tutti quegli elementi «fissi» che costituiscono i punti di appoggio per i cantori itineranti. A tal proposito Ismail Kadaré, rievocando in un suo docu-romanzo la scoperta dell’oralità da parte di Parry-Lord, rammenta che nei Balcani era prassi consueta la conservazione delle leggende per via orale e che esistevano gilde di cantori molto chiuse, che si trasmettevano le loro leggende col divieto assoluto di alterare alcunché, con una fissità dura e ostinata da portare alla follia (Ismail Kadare-Jusuf Vrioni, Le dossier H., Fayard, 1989).
La traduzione di Franco Ferrari rispetta l’antica regola, con qualche leggera variante peraltro giustificata dalla fluidità del poema da lui stesso sottolineata. Quindi Apollo è sempre «arciere» o «signore dell’arco», Ettore «sterminatore», gli Achei «dalle forti gambiere», Zeus «adunatore di nembi», Aiace «baluardo degli Achei», Andromaca e Era «dalle candide braccia» (confesso che la variante «candida di braccia» mi piace meno, e così «bella di guance» e simili). Trovo estremamente efficaci le formule «di morte», nelle loro lievi variazioni, che peraltro rispondono alle variazioni del testo («Lo catturò tenebra odiosa», «Morte lo avvolse», «Livida notte avvolse i suoi occhi», «La notte calò sui suoi occhi» ecc.).
 Qualche altra soluzione, specie degli epiteti, mi piace meno e eviterò di citarle perché è solo un mio parere, ma non posso fare a meno di confessare che là dove sono rimasta delusa è nella traduzione degli epiteti degli eroi maggiori. Non mi riconosco in un Achille «scattante di piede» o anche semplicemente «scattante», e soprattutto in Ettore «domesticatore di puledri», siano o non siano questi termini quelli più esatti per rendere il greco.
Qualche altra soluzione, specie degli epiteti, mi piace meno e eviterò di citarle perché è solo un mio parere, ma non posso fare a meno di confessare che là dove sono rimasta delusa è nella traduzione degli epiteti degli eroi maggiori. Non mi riconosco in un Achille «scattante di piede» o anche semplicemente «scattante», e soprattutto in Ettore «domesticatore di puledri», siano o non siano questi termini quelli più esatti per rendere il greco.
 Per entrambi gli eroi l’epiteto è importante, li caratterizza in modo assoluto e inoltre l’Ettore domesticatore di puledri chiude il poema - musicalmente parlando - in minore. Certo, anche questo dimostra come sia difficile tradurre l’epiteto che in sé racchiude tutta una storia, a volte ci vorrebbe un verso intero, come ha fatto quello scrittore che , citando l’ultimo verso dell’Iliade, scriveva: «Questi furono gli onori funebri resi a Ettore, a Ettore che quando era vivo, amava domare i cavalli». Bello, certo, ma non è possibile forzare e snaturare in questo modo il severo anche se fluido esametro. D’altronde quello che conta è l’insieme di questa nuova traduzione che appare diversa dalle altre e avvincente per il ritmo trascinante di quello «statuto sillabico forte» che si dimostra una scelta estremamente felice e che rende la lettura sorprendentemente scorrevole e «nuova». Una bellissima Iliade.
Per entrambi gli eroi l’epiteto è importante, li caratterizza in modo assoluto e inoltre l’Ettore domesticatore di puledri chiude il poema - musicalmente parlando - in minore. Certo, anche questo dimostra come sia difficile tradurre l’epiteto che in sé racchiude tutta una storia, a volte ci vorrebbe un verso intero, come ha fatto quello scrittore che , citando l’ultimo verso dell’Iliade, scriveva: «Questi furono gli onori funebri resi a Ettore, a Ettore che quando era vivo, amava domare i cavalli». Bello, certo, ma non è possibile forzare e snaturare in questo modo il severo anche se fluido esametro. D’altronde quello che conta è l’insieme di questa nuova traduzione che appare diversa dalle altre e avvincente per il ritmo trascinante di quello «statuto sillabico forte» che si dimostra una scelta estremamente felice e che rende la lettura sorprendentemente scorrevole e «nuova». Una bellissima Iliade.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"PREFACE TO PLATO"(Eric A. Havelock, 1963): "CULTURA ORALE E CIVILTA’ DELLA SCRITTURA. Da Omero a Platone".
 RILEGGERE HAVELOCK PER RICOMPRENDERE (ANCORA E MEGLIO) PLATONE - E NOI.
RILEGGERE HAVELOCK PER RICOMPRENDERE (ANCORA E MEGLIO) PLATONE - E NOI. -
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- Israele, 200 armi nucleari puntate sull’Iran. Israele ha la Bomba, non l’Iran (di Manlio Dinucci)..15 maggio 2018, di Federico La Sala
Israele, 200 armi nucleari puntate sull’Iran
di Manlio Dinucci (il manifesto, 15.05.2018)
La decisione degli Stati uniti di uscire dall’accordo sul nucleare iraniano - stipulato nel 2015 da Teheran con i 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu più la Germania - provoca una situazione di estrema pericolosità non solo per il Medio Oriente.
Per capire quali implicazioni abbia tale decisione, presa sotto pressione di Israele che definisce l’accordo «la resa dell’Occidente all’asse del male guidato dall’Iran», si deve partire da un fatto ben preciso: Israele ha la Bomba, non l’Iran.
Sono oltre cinquant’anni che Israele produce armi nucleari nell’impianto di Dimona, costruito con l’aiuto soprattutto di Francia e Stati Uniti. Esso non viene sottoposto a ispezioni poiché Israele, l’unica potenza nucleare in Medioriente, non aderisce al Trattato di non-proliferazione delle armi nucleari, che invece l’Iran ha sottoscritto cinquant’anni fa.
Le prove che Israele produce armi nucleari sono state portate oltre trent’anni fa da Mordechai Vanunu, che aveva lavorato nell’impianto di Dimona: dopo essere state vagliate dai maggiori esperti di armi nucleari, furono pubblicate dal giornale The Sunday Times il 5 ottobre 1986.
Vanunu, rapito a Roma dal Mossad e trasportato in Israele, fu condannato a 18 anni di carcere duro e, rilasciato nel 2004, sottoposto a gravi restrizioni. Israele possiede oggi (pur senza ammetterlo) un arsenale stimato in 100-400 armi nucleari, tra cui mini-nukes e bombe neutroniche di nuova generazione, e produce plutonio e trizio in quantità tale da costruirne altre centinaia.
Le testate nucleari israeliane sono pronte al lancio su missili balistici, come il Jericho 3, e su cacciabombardieri F-15 e F-16 forniti dagli Usa, cui si aggiungono ora gli F-35. Come confermano le numerose ispezioni della Aiea, l’Iran non ha armi nucleari e si impegna a non produrle sottoponendosi in base all’accordo a stretto controllo internazionale. Comunque - scrive l’ex segretario di stato Usa Colin Powell il 3 marzo 2015 in una email venuta alla luce - «quelli a Teheran sanno bene che Israele ha 200 armi nucleari, tutte puntate su Teheran, e che noi ne abbiamo migliaia».
Gli alleati europei degli Usa, che formalmente continuano a sostenere l’accordo con l’Iran, sono sostanzialmente schierati con Israele. La Germania gli ha fornito quattro sottomarini Dolphin, modificati così da poter lanciare missili da crociera a testata nucleare. Germania, Francia, Italia, Grecia e Polonia hanno partecipato, con gli Usa, alla più grande esercitazione internazionale di guerra aerea nella storia di Israele, la Blue Flag 2017.
L’Italia, legata a Israele da un accordo di cooperazione militare (Legge n. 94, 2005), vi ha partecipato con caccia Tornado del 6° Stormo di Ghedi, addetto al trasporto delle bombe nucleari Usa B-61 (che tra non molto saranno sostituite dalle B61-12). Gli Usa, con F-16 del 31st Fighter Wing di Aviano, addetti alla stessa funzione.
Le forze nucleari israeliane sono integrate nel sistema elettronico Nato, nel quadro del «Programma di cooperazione individuale» con Israele, paese che, pur non essendo membro della Alleanza, ha una missione permanente al quartier generale della Nato a Bruxelles. Secondo il piano testato nella esercitazione Usa-Israele Juniper Cobra 2018, forze Usa e Nato arriverebbero dall’Europa (soprattutto dalle basi in Italia) per sostenere Israele in una guerra contro l’Iran.
Essa potrebbe iniziare con un attacco israeliano agli impianti nucleari iraniani, tipo quello effettuato nel 1981 a Osiraq in Iraq. In caso di rappresaglia iraniana, Israele potrebbe far uso di un’arma nucleare mettendo in moto una reazione a catena dagli esiti imprevedibili.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. - La lancetta dell’«Orologio dell’Apocalisse»: «Guerra Nucleare. Il giorno prima».20 febbraio 2018, di Federico La Sala
Da Hiroshima a oggi, la corsa agli armamenti
«Guerra Nucleare. Il giorno prima» di Manlio Dinucci, edito da Zambon. È la storia di una potenza distruttiva tale da cancellare la specie umana e quasi ogni altra forma di vita dalla faccia della Terra, sconvolgendone l’intero ecosistema
di Tommaso Di Francesco (il manifesto, 20.02.2018)
La lancetta dell’«Orologio dell’Apocalisse» - il segnatempo che sul Bollettino degli Scienziati Atomici statunitensi indica a quanti minuti siamo dalla mezzanotte della guerra nucleare - è stata spostata da 3 a mezzanotte nel 2015 a 2 minuti nel 2018. Tale fatto passa però inosservato o, comunque, non suscita particolari allarmi.
Sembra di vivere in un film, in particolare in The Day After (1983), in quella cittadina del Kansas dove la vita scorre tranquilla accanto ai silos dei missili nucleari, con la gente che il giorno prima ascolta distrattamente le notizie sul precipitare della situazione internazionale, finché vede i missili lanciati contro l’Urss e poco dopo spuntare i funghi atomici delle testate nucleari sovietiche.
Questa la presentazione (e motivazione) del libro di Manlio Dinucci Guerra Nucleare. Il giorno prima (Zambon Editore, pp.304, euro 15). Il testo, molto documentato e allo stesso tempo di agevole lettura, ricostruisce la storia della corsa agli armamenti nucleari dal 1945 ad oggi, sullo sfondo dello scenario geopolitico mondiale, contribuendo a colmare il vuoto di informazione su questo tema di vitale importanza.
UNA STORIA, quella della Bomba, che potrebbe mettere fine alla Storia: per la prima volta è stata creata nel mondo una potenza distruttiva tale da cancellare la specie umana e quasi ogni altra forma di vita dalla faccia della Terra, sconvolgendone l’intero ecosistema. Dal 1945, l’anno in cui con il bombardamento atomico Usa di Hiroshima e Nagasaki inizia la corsa agli armamenti nucleari, al 1991, l’anno in cui la disgregazione dell’Unione Sovietica segna la fine della guerra fredda, vengono fabbricate circa 125mila testate nucleari con una potenza complessiva equivalente a quella di oltre un milione di bombe di Hiroshima. In stragrande parte dagli Stati uniti e dall’Unione sovietica, il resto da Francia, Gran Bretagna, Cina, Pakistan, India, Israele e Sudafrica (l’unico paese che rinuncerà in seguito a tali armi). Più volte si corre il rischio di una guerra nucleare per errore, mentre i test nell’atmosfera e le fuoriuscite di radioattività provocano enormi danni ambientali e sanitari.
Con la fine della guerra fredda, i trattati vengono sempre più svuotati di reale contenuto fondamentalmente a causa del tentativo degli Stati uniti di accrescere il loro vantaggio strategico sulla Russia. E mentre la Nato si espande fin dentro il territorio dell’ex Urss, e le forze statunitensi e alleate passano di guerra in guerra presentata ai subalterni governati e teleguidati spesso come «umanitaria» (Iraq, Jugoslavia, Afghanistan, Libia e altre), la corsa agli armamenti nucleari, trainata dagli Stati uniti, si sposta sempre più dal piano quantitativo a quello qualitativo, ossia sul tipo di piattaforme di lancio (da terra, dal mare, dall’aria e probabilmente anche dallo spazio esterno) e sulle capacità offensive delle testate nucleari. Nel frattempo si aggiunge alle potenze nucleari la Corea del Nord.
SI ARRIVA COSÌ alla fase odierna, resa ulteriormente pericolosa dalla nuova dottrina nucleare degli Stati uniti. Dalla strategia della «mutua distruzione assicurata» (il cui acronimo Mad equivale alla parola inglese «pazzo») - adottata durante la guerra fredda quando ciascuna delle due superpotenze sapeva che, se avesse attaccato l’altra con armi nucleari, sarebbe stata a sua volta distrutta - il Pentagono passa alla strategia del first strike (primo colpo), cercando di acquisire la capacità di disarmare la Russia con un attacco di sorpresa. Grazie alle nuove tecnologie - scrive Hans Kristensen della Federazione degli scienziati americani - la capacità distruttiva dei missili balistici Usa si è triplicata.
ARMI NUCLEARI, sistemi spaziali, aerei robotici e cyber-armi vengono sempre più integrati, insieme ai mezzi di guerra elettronica e allo «scudo anti-missili», installato ormai in Polonia e con riarmo atlantico di tutti i Paesi dell’est, vale a dire dell’ex Patto di Varsavia che si è da tempo sciolto, nel 1995, mentre la Nato non solo non si estingue ma diventa sempre più l’unica sede della politica estera dell’inesistente Unione europea. Come contromisura la Russia sta rimuovendo sempre più i missili balistici intercontinentali dai silos, vulnerabili da un first strike, installandoli su lanciatori mobili tenuti costantemente in movimento per sfuggire ai satelliti militari e a un eventuale attacco missilistico di sorpresa.
Nel crescente confronto nucleare l’Italia - che sembra vivere nella «tranquilla» cittadina del Kansas del film Day after - è in prima fila, avendo sul proprio territorio bombe statunitensi B-61 che, dal 2020. saranno rimpiazzate dalle ancora più pericolose B61-12.
OCCORRE BATTERSI in campo aperto perché l’Italia cessi di violare il Trattato di non-proliferazione, imponendo agli Stati uniti di rimuovere immediatamente le loro armi nucleari dal nostro territorio nazionale, e contemporaneamente perché l’Italia, liberandosene, aderisca al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari. Questo è l’unico modo concreto che abbiamo in Italia per contribuire alla eliminazione delle armi nucleari dalla faccia della Terra. A proposito: c’è qualcuno che nei programmi elettorali ha questo all’ordine del giorno? Sarebbe, tra le poche l’unica promessa accettabile. Finché siamo in tempo, il giorno prima.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
-
>TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA - "Stato d’innocenza. Adamo, Eva e la filosofia politica medievale". Poteri ispirati dal peccato, alle origini della politica (di Massimo Firpo).26 novembre 2017, di Federico La Sala
Alle origini della politica
Poteri ispirati dal peccato
I teologi del Medioevo si interrogarono a lungo
su Adamo ed Eva, e sulla necessità di leggi e strutture sociali dopo la cacciata dall’Eden
di Massimo Firpo (Il Sole-24 Ore, Domenica, 26.11.2017)
- Gianluca Briguglia, Stato d’innocenza. Adamo, Eva e la filosofia politica medievale , Carocci, Roma, pagg. 158, € 17
Narrata all’inizio del Genesi, la disobbedienza di Adamo ed Eva nel mangiare il frutto proibito assunse un significato cruciale nel cristianesimo, che individuò in essa il peccato originale, evento fondante del percorso di redenzione del genere umano dalla perfezione edenica alla caduta, dal vecchio al nuovo Testamento. Ma per secoli i teologi ne sottolinearono anche il ruolo decisivo nella storia terrena dell’umanità, perché proprio dalla corruzione provocata dalla caduta avrebbero avuto origine la proprietà, il diritto, l’esigenza di norme, poteri, istituzioni, strutture sociali chiamate a mettere un freno alla violenza, a regolare i conflitti, a reprimere i delitti, a mantenere la pace: ebbe cioè origine la storia, e con essa la politica.
Fu su questo presupposto che sant’Agostino costruì il grandioso disegno del De civitate Dei, fondato sulla dicotomia tra città divina e città terrena, affrontando specificamente la questione del peccato originale nei commenti al Genesi, in cui spiegava come esso avesse reso «inevitabile la jacquerie di tutte le debolezze, le passioni, le violenze e le sopraffazioni che assediano la natura umana e che fanno di ogni individuo al tempo stesso uno schiavo e un tiranno», uno schiavo del suo brutale egoismo e un tiranno nell’imporlo agli altri. Oltre a esporlo alla fame, alla fatica, alla malattia, alla morte, il suo disordine ontologico lo rende incapace «di perseguire il bene, che pure in certa misura vorrebbe». Per questo egli ha bisogno di un potere che freni le forze distruttive del male che è in lui e imponga le norme di una convivenza civile, che nascono quindi da quel male ma al tempo stesso ne costituiscono un rimedio. Ha bisogno per esempio di governare quella concupiscenza che secondo Agostino ha trascinato la riproduzione nel gorgo di una sessualità aggressiva e viziosa, della quale la famiglia rappresenta un pur precario strumento di controllo e regolamentazione.
Molte del resto erano le inquietanti domande che si collegavano a quella primigenia rottura. Perché Adamo ed Eva, pur creati a immagine e somiglianza di Dio, avevano peccato? Perché ai loro figli e discendenti era stata addebitata una colpa di cui non erano responsabili? Tale corruzione ereditaria era totale e assoluta o qualcosa di buono era restato, consentendo quindi agli uomini l’esercizio del libero arbitrio e le scelte morali che ne conseguivano, oppure le loro possibilità di salvarsi dipendevano solo dagli insondabili decreti della predestinazione? E quale sarebbe stata la società umana se i primi progenitori non avessero mangiato il frutto proibito?
«Quando Adamo zappava e Eva filava dov’erano i nobili?», si chiedevano i contadini inglesi in rivolta nel ’300. Quando e perché era nata la servitù? Ed era lecito combatterla e liberarsene? Quale era il fondamento del diritto di coercizione? Quesiti tutt’altro che oziosi, tali da suggerire una ricostruzione alternativa - “controfattuale” - della storia umana, volta a recuperare una razionalità perduta e a indicare una strada da seguire, una meta cui tendere, un obiettivo da raggiungere.
Su tali quesiti, spesso frammisti alle più varie leggende, si interrogarono grandi teologi e canonisti del Medioevo, consapevoli «del nesso produttivo tra immaginazione e ragione» che essi generavano. Di essi, e dell’implicito realismo politico che ne conseguiva, la ricerca di Briguglia ricostruisce con analisi sottili i percorsi tutt’altro che univoci, inoltrandosi con dotta perizia in una selva oscura di Summae e trattati che affrontavano quel garbuglio di problemi.
Dalla lucida «fenomenologia del potere» di Agostino si passa alle distinzioni scolastiche nel definire le origini, gli ambiti di legittimità, le forme di esercizio del potere, e alla raffinata riflessione di san Tommaso, secondo il quale già nell’Eden esistevano differenze tra le creature: tra uomo e donna anzitutto, tra complessioni fisiche diverse, tra gradi disomogenei di bellezza, santità, attitudini, capacità. Differenze che non inficiavano la libertà di ciascuno (anzi, nascevano proprio da essa), ma creavano distinzioni e con ciò davano vita a spazi di azione politica tali da smentire che quest’ultima fosse solo una conseguenza del peccato originale. Anche il mondo edenico, insomma, sarebbe stato un mondo da governare e governato, e pertanto «la politica non è frutto del peccato», ma scaturisce da un ordine divino delle cose.
Il fatto che ogni autorità, ogni istituzione e forma di governo, ogni diritto di punire, ogni dovere di obbedienza derivi dalla corruzione e dal disordine prodotti dal peccato originale, non significa legittimare la tirannia, poiché nella tutela dell’ordine sociale il potere politico deve pur sempre rispettare criteri di razionalità. Anch’esso nasce da Dio, insegna san Paolo (Rom. XIII, 1). Per questo gli uomini devono accettarlo non solo per paura o mancanza di libertà, ma «con un’adesione interiore», cui solo in rari casi di iniqua tirannia è lecito sottrarsi.
Ci si poteva quindi chiedere se fosse possibile restaurare la politica che aveva retto gli uomini prima della caduta, abbandonare il diritto positivo per ristabilire nella sua pienezza il diritto naturale. Secondo i teologi francescani, per esempio, la vocazione alla povertà del loro ordine era un modo per tornare al primitivo stato di innocenza di cui anche Cristo e gli apostoli erano stati un esempio.
«Idee incendiarie», a ben vedere, dal momento che davano vita a una contestazione radicale della Chiesa come corpo giuridico e struttura di potere quale si era venuta costituendo in Occidente. E ancor più incendiarie furono quelle espresse a metà Trecento da John Wyclif, che dalla restaurazione della grazia per tramite della fede giungeva alla definizione della vera Chiesa come comunità dei predestinati, dalla quale anche il papa poteva essere escluso.
Idee poi riprese dalla Riforma protestante, mentre le grandi scoperte geografiche imponevano di interrogarsi sulle misteriose origini dei nuovi popoli al di là degli oceani, che sembravano mandare in pezzi la monogenesi biblica. E infine Robert Filmer che nel suo trattato Patriarca, o del potere naturale dei re, apparso postumo nel 1680, affermava contro Francisco Suarez e la seconda scolastica l’idea di un Adamo che non era stato solo padre ma anche re della sua discendenza, e quindi archetipo dell’intangibile diritto divino dei sovrani.
 Fu contro di lui che John Locke scrisse il primo dei Due trattati sul governo, con i quali - sviluppando il contrattualismo hobbesiano - avrebbe costruito le fondamenta di un potere assoluto che scaturiva dal basso e non proveniva più da Dio. L’era di Adamo ed Eva era ormai finita per sempre.
Fu contro di lui che John Locke scrisse il primo dei Due trattati sul governo, con i quali - sviluppando il contrattualismo hobbesiano - avrebbe costruito le fondamenta di un potere assoluto che scaturiva dal basso e non proveniva più da Dio. L’era di Adamo ed Eva era ormai finita per sempre.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
ADAMO, EVA ... E L’EDEN? Archeologia, preistoria, e storia
L’ITALIA, LA CHIESA CATTOLICA, I "TESTICOLI" DELLE DONNE E LA "COGLIONERIA" DEGLI UOMINI OVVERO ANCHE LE DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560!!! E CHE COSA SIGNIFICA ESSERE CITTADINI E CITTADINE D’ITALIA!!!
"GENESI" E GENERE SESSUALE. MUTAMENTI "BIBLICI" IN CORSO.
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Pace, giustizia, e libertà nell’aiuola dei mortali DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI.
Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- La geopolitica dell’intelligenza artificiale (di Pierre Haski).20 settembre 2017, di Federico La Sala
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
La geopolitica dell’intelligenza artificiale
di Pierre Haski, L’Obs, Francia *
Vladimir Putin ha almeno una qualità, parla senza peli sulla lingua. La settimana scorsa ha detto chiaro e tondo quello che la maggior parte del mondo mormora sottovoce: “Il paese che sarà leader nel campo dell’intelligenza artificiale, dominerà il mondo”.
Di solito l’intelligenza artificiale (Ia) è evocata nell’ambito di cambiamenti positivi, per esempio nella sanità o nella regolazione del traffico, o negativi, come il suo impatto sull’occupazione o la possibilità che l’Ia sviluppi un giorno una “coscienza” capace di imporsi ai suoi creatori, gli esseri umani.
Ma è raro che se ne parli in termini geopolitici come ha fatto in modo così diretto il presidente russo. La cosa più strana è il contesto di questa dichiarazione: non una grande conferenza strategica come quella di Monaco - dove nel 2007 Putin aveva denunciato “l’unilateralismo americano” - ma una teleconferenza seguita da più di un milione di studenti russi in occasione dell’inizio dell’anno scolastico!
Dopo questa dichiarazione Elon Musk, il padrone di Tesla e di SpaceX, ha subito postato un tweet: “Si comincia...”.
E ha continuato affermando che “la competizione per la superiorità nazionale in materia di Ia sarà la causa più probabile della terza guerra mondiale”.
Se fosse necessario aggiungere altro, possiamo fare riferimento a quello che ha detto Yuval Noah Harari, storico israeliano e autore di successo, che si trovava a Parigi per il lancio dell’edizione francese del suo nuovo libro Homo Deus. Una breve storia del futuro.
Harari dice che gli sviluppi dell’intelligenza artificiale e delle biotecnologie rischiano di produrre un livello di “superuomini aumentati” che domineranno il mondo e di trasformare il resto dell’umanità in una “classe inutile”. Una dimostrazione sostenuta da molti esempi tratti dai progressi tecnologici e dai cambiamenti che implicano.
La nuova religione
Durante una presentazione del suo libro davanti a un folto gruppo di invitati, tra cui la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager che ha sfidato i Gafa (Google-Amazon-Facebook-Apple), Harari ha predetto che questi progressi scientifici produrranno delle disuguaglianze senza precedenti nella storia dell’umanità, tanto all’interno delle società quanto tra gli stati. Il divario tra chi controllerà queste tecnologie e chi non vi avrà accesso non sarà solo maggiore di quello che ha caratterizzato i paesi industriali e gli altri nel diciannovesimo e nel ventesimo secolo, ma soprattutto non potrà essere colmato.
Secondo Harari, la materia prima del futuro saranno i dati, i nostri dati personali raccolti da chi ne ha la capacità. I padroni di questi dati saranno i grandi sacerdoti della nuova religione, il “dataismo”.
Le idee di questo autore, che ha avuto un successo mondiale con il suo libro precedente Sapiens, hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto incontrarlo.
La dichiarazione di Putin sull’intelligenza artificiale ha avuto almeno il merito di rendere comprensibile il dibattito anche al grande pubblico: il capo del Cremlino ragiona in termini di dominazione e di sottomissione, sia sull’Ia sia sul resto.
L’Ia quindi non è solo un obiettivo di grande interesse economico che prende la forma (non così insignificante) di Alexa, l’assistente digitale di Amazon che risponde a tutte le vostre esigenze domestiche e che fa anche ripassare le tabelline delle moltiplicazioni ai vostri figli. Può anche essere uno strumento di dominio.
Non è un caso infatti se i maggiori investimenti in intelligenza artificiale sono quelli dei due grandi giganti del ventunesimo secolo, gli Stati Uniti e la Cina, con un probabile vantaggio dei cinesi in termini di fondi investiti.
Esigenze militari
Tutti conoscono Google, Microsoft e Amazon, le enormi aziende statunitensi alle quali tutti ricorriamo quotidianamente; alcuni conoscono Alibaba, il gigante del commercio elettronico cinese fondato dal molto mediatico Jack Ma; ma pochi europei conoscono Baidu o Tencent, due aziende cinesi altrettanto importanti delle loro controparti americane, che investono massicciamente nell’intelligenza artificiale.
Senza contare poi i centri di ricerca legati ai sistemi di difesa, che nei principali paesi del mondo sono oggi molto apprezzati, e valorizzati. Israele per esempio, al di là della start-up nation che ha prodotto l’applicazione di navigazione Waze e altri prodotti per il grande pubblico, ha creato un ecosistema di ricerca che parte prima di tutto dalle sue esigenze militari.
In un editoriale sul sito della Cnn il ricercatore americano Gregory C. Allen, autore di uno studio sull’”intelligenza artificiale e il problema della sicurezza nazionale”, afferma che se si esclude il settore delle armi oggi la Russia di Putin non è all’avanguardia nella ricerca sull’Ia:
- Nonostante le grandi ambizioni di Putin il tentativo russo di predominare nell’intelligenza artificiale non si realizzerà attraverso le innovazioni tecnologiche. Gli Stati Uniti e la Cina hanno industrie digitali molto più importanti, più sofisticate e con un ritmo di crescita molto più forte di quelle russe. In compenso la Russia potrebbe ben presto diventare leader nella militarizzazione dell’Ia per raggiungere il suo obiettivo strategico, che è quello di mettere fine all’egemonia americana nel sistema internazionale e di ristabilire l’influenza russa nella vecchia sfera sovietica. La Russia non è mai stata leader nelle tecnologie legate a internet, tuttavia ha sviluppato un gruppo importante di hackers capace di mettere in crisi gran parte della rete elettrica ucraina, di infiltrarsi negli impianti nucleari statunitensi, e di seminare il panico nelle elezioni americane del 2016.
Si può ancora impedire questa militarizzazione dell’Ia e questa corsa nazionale al suo dominio che ha tanto allarmato Musk? Difficile che possa succedere nell’attuale clima internazionale di nuova guerra fredda, che ha spazzato gli scrupoli etici come era successo mezzo secolo fa con la rivalità est-ovest.
In tutto ciò l’Europa è drammaticamente assente o molto in ritardo, sia nella battaglia sui dati condotta da imprese che sono raramente europee, sia nel perseguimento di questo obiettivo strategico sempre più importante. Forse per una volta bisognerebbe prendere Putin alla lettera e rendersi conto che si tratta veramente di un obiettivo di vitale importanza.
(Traduzione di Andrea De Ritis)
* Internazionale, 20 settembre 2017 (ripresa parziale).
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- LA GUERRA CONTRO LE DONNE: UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!18 settembre 2017, di Federico La Sala
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO ... *
- L’ormai enorme letteratura femminista ha messo in luce, tra le altre cose, l’identificazione delle donne, dei loro corpi, della loro capacità riproduttiva con la “comunità”, il “territorio”, la tradizione, l’identità (etnica, nazionale) e dunque il futuro. Di qui l’esigenza di dominare e controllare le “nostre” donne, nonché lo sconcerto e il disagio maschili di fronte alla libertà rivendicata e agita dalle donne (Tamar Pitch).
Una guerra contro le donne
di Tamar Pitch (Il Mulino, 18 settembre 2017)
Chi stupra è sempre l’Altro: i neri per i bianchi, i poveri per i ricchi, gli stranieri per gli autoctoni, e viceversa. Lo stupro è ciò che distingue “il noi”, gli uomini che sposiamo, da “gli altri”, gli uomini che stuprano. Lo stupro, nonché l’accusa di stupro, segna un confine. Un confine, tuttavia, tra gli uomini: noi e loro si riferisce infatti al modo prevalente, sia nell’immaginario sia nelle pratiche e nelle norme, con cui lo stupro è visto e vissuto dagli uomini. E da alcune donne, certo, visto che partecipiamo di questa cultura. Da cui si evince che misoginia e sessismo sono sempre intrecciate a razzismo e xenofobia.
L’ormai enorme letteratura femminista ha messo in luce, tra le altre cose, l’identificazione delle donne, dei loro corpi, della loro capacità riproduttiva con la “comunità”, il “territorio”, la tradizione, l’identità (etnica, nazionale) e dunque il futuro. Di qui l’esigenza di dominare e controllare le “nostre” donne, nonché lo sconcerto e il disagio maschili di fronte alla libertà rivendicata e agita dalle donne.
Stupri e femminicidi vengono così raccontati diversamente a seconda di chi sono gli autori e le loro vittime. Orrore e scandalo quando una di “noi” (ossia una che è ritenuta appartenere al gruppo dei maschi autoctoni, o comunque di quelli cui la “comunità” si riferisce) è violentata o uccisa da uno di “loro”. Perplessità e incredulità quando è uno di “noi” a stuprare e uccidere. In ambedue i casi, il vissuto e la soggettività delle donne sono ignorate. O ci si erge a protettori e vendicatori di chi ha osato mettere le mani su una “cosa” nostra (e dunque in qualche modo le vere “vittime” non sono le donne, ma questi “noi”) oppure “quella se l’è cercata”, ci ha “sfidato”, e in fondo dunque si merita quello che le è capitato. È singolare come questo tipo di narrazione sia ancora così presente, nei nostri media, tradizionali e nuovi, quando invece la vita, l’esperienza e la soggettività femminili sono tanto mutate. Ciò che infatti manca a questa narrazione sono precisamente le voci delle donne, che, interrogate, racconterebbero, tutte, l’onnipresenza della violenza maschile: per strada, al lavoro, ma ancor di più dentro le sicure mura di casa. Se c’è un confine che lo stupro traccia, è quello tra gli uomini e le donne (o chi è “ridotto” nella posizione femminile). Non tutti gli uomini sono stupratori, ma tutti gli stupratori sono uomini, diceva già trent’anni fa Ida Dominjanni.
Stupri e femminicidi avvengono ovunque nel mondo, e nella maggior parte dei casi ad opera di uomini che le donne conoscono bene, mariti fidanzati padri fratelli amici e così via. Poi ci sono gli stupri invisibili, quelli di cui poco o niente si sa e si dice, quelli che non vengono riconosciuti come tali, a danno delle sex workers o, ancor peggio, delle ragazzine prostituite sulle nostre strade, da parte dei suddetti mariti e padri (di altre). Nonché degli uomini delle forze dell’ordine (su cui c’è un’ampia letteratura) che si avvalgono del loro potere di ricatto e dell’omertà diffusa. Perché le sex workers non sono per definizione proprietà di alcun uomo ( a parte il loro eventuale protettore, ma di questo parlo più avanti) e sono quindi di tutti: loro sì, se vengono violentate o uccise, “se la sono cercata”. E gli integerrimi italiani che vanno con le ragazzine, sempre più spesso minorenni, vittime di tratta, non sono forse, per le nostre stesse leggi, violentatori seriali?
Una vittima, per essere riconosciuta tale, deve avere caratteristiche e comportamenti che rispondono allo stereotipo della donna o ragazza “perbene”, ma deve anche essere violentata, meglio in strada e di giorno, da uno (se di più, meglio) sconosciuto, meglio se povero e scuro di pelle. E meglio ancora se questa vittima urla o viene visibilmente ferita. Sembra incredibile quanto questo sia vero, per i media, a quasi quarant’anni dal documentario Processo per stupro e dopo le mille battaglie femministe e la nuova ondata rappresentata dal movimento Nonunadimeno, che riprende l’analogo movimento nato in Argentina e poi diffusosi in tutta l’America Latina.
 Insomma, le donne si muovono ormai a livello globale contro violenze e sopraffazioni di uomini singoli o in gruppo e contro le istituzioni che fanno poco per contrastare queste violenze o addirittura le legittimano. I contesti sociali, culturali, politici sono diversi e questa diversità va presa in considerazione per capire le differenze quantitative e qualitative della violenza maschile contro le donne, ma sempre di patriarcato si dovrebbe parlare: ossia di un sistema complesso di potere e dominio maschili onnipervasivi, per battere il quale non bastano certo parità e pari opportunità (negli anni Settanta dicevamo che no, non era metà della torta che volevamo, ma una torta del tutto diversa). Questo sistema è in crisi per via del fatto che sempre più donne gli negano consenso e complicità, cosa che in certi casi può esacerbare violenza e ferocia.
Insomma, le donne si muovono ormai a livello globale contro violenze e sopraffazioni di uomini singoli o in gruppo e contro le istituzioni che fanno poco per contrastare queste violenze o addirittura le legittimano. I contesti sociali, culturali, politici sono diversi e questa diversità va presa in considerazione per capire le differenze quantitative e qualitative della violenza maschile contro le donne, ma sempre di patriarcato si dovrebbe parlare: ossia di un sistema complesso di potere e dominio maschili onnipervasivi, per battere il quale non bastano certo parità e pari opportunità (negli anni Settanta dicevamo che no, non era metà della torta che volevamo, ma una torta del tutto diversa). Questo sistema è in crisi per via del fatto che sempre più donne gli negano consenso e complicità, cosa che in certi casi può esacerbare violenza e ferocia.Si ha l’impressione che sia in corso una guerra contro le donne, e tra uomini, per il controllo delle donne e dei loro corpi. È una guerra combattuta con le armi e con gli stupri e, oggi, anche con e su i social media. Difficile, se non impossibile, sconfiggere il patriarcato (soltanto) con il diritto penale. Del quale ci si può e ci si deve servire, naturalmente, ma sempre sapendo che la giustizia penale, a sua volta, è connotata da sessismo, razzismo e classismo. I decreti sicurezza (da ultimo quello firmato Minniti) parlano appunto questa lingua: non sono solo razzisti e classisti, sono anche sessisti, laddove è del tutto ovvio che il soggetto standard di questi decreti è maschio, adulto, non troppo povero. Berlusconi proponeva di mettere un poliziotto a fianco di ogni bella donna (le brutte si arrangiassero). Magari meglio una poliziotta...
Le politiche e le retoriche della sicurezza tendono a una specie di sterilizzazione del territorio urbano, mirano a rendere invisibili povertà e disagio, a recintare più o meno simbolicamente lo spazio dei perbene a difesa dai permale. Ma, benché esse si avvalgano spesso dell’evocazione del femminile (bisogna proteggere donne, vecchi, bambini: i cosiddetti soggetti vulnerabili), sono del tutto cieche e inutili, se non controproducenti, rispetto al contrasto delle violenze contro le donne. Le quali, come dicevo, non avvengono solo e nemmeno soprattutto negli angoli bui delle vie cittadine. Ho detto e scritto più volte che, se seguissimo fino in fondo la logica delle politiche di sicurezza, allora, per proteggere le donne, dovremmo cacciare tutti gli uomini da ogni casa, città, Paese, continente, universo mondo.
Una città, un Paese, un continente sono “sicuri” per tutti se le donne, tutte le donne, possono attraversarli liberamente, di giorno, di notte, vestite come vogliono, ubriache o sobrie. La libertà, per le donne, è un esercizio ancora difficile e contrastato, praticamente ovunque. Ci muoviamo, più o meno consapevolmente, con prudenza, ci neghiamo, più o meno consapevolmente, molte delle libertà di cui gli uomini godono senza rendersene conto. Gesti, atteggiamenti, parole, comportamenti maschili ci ricordano tutti i giorni che dobbiamo stare attente (non serve proprio che ce lo ribadiscano sindaci, ministri, poliziotti), l’aggressione e la violenza sono sempre in agguato. Però, è esattamente il contrario che serve: ai tempi si diceva “riprendiamoci la notte”, e anche adesso andiamo per le strade per dire che vogliamo andare e fare ciò che più ci piace, senza protettori.
Già, il termine protettore. In italiano ha un’ambivalenza significativa: il protettore delle donne che si prostituiscono è precisamente la figura simbolo della protezione maschile, una protezione che implica soggezione e acquiescenza, pena non solo l’abbandono ma la punizione. Sottrarsi alla protezione, sia reale sia introiettata, è invece un passo necessario per affermare la propria libertà. Ed è ciò che le donne, singolarmente e collettivamente, stanno facendo.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- CIVILTA’ DELL’AMORE E VOLONTA’ DI GUERRA. DOPO GIOVANNI PAOLO II, IL VATICANO SOPRA TUTTO E CONTRO TUTTI. Il "peccato originale" e la "mala fede" antropo-teo-logica di Papa Ratzinger.
- DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". Dalla democrazia della "volontà generale" alla democrazia della "volontà di genere". L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. -- AMBIENTE E APOCALISSE. Papa Francesco e Bartolomeo I: che Dio ci aiuti a salvare la sua creazione (di Gianni Valente).2 settembre 2017, di Federico La Sala
Francesco e Bartolomeo: che Dio ci aiuti a salvare la sua creazione
Il Papa e il Patriarca ecumenico di Costantinopoli firmano insieme il messaggio in occasione della Giornata di preghiera per la Salvaguardia del creato. Ricordano che i primi a pagare le devastazioni ambientali sono «i popoli più vulnerabili» e quelli che vivono in povertà «in ogni angolo del mondo». Appello ai potenti: non ci può essere soluzione alla crisi ecologica se la risposta non è concertata e collettiva
- [Foto] Papa Francesco e il patriarca Bartolomeo
di Gianni Valente (La Stampa, 01/09/2017)
Città del Vaticano. La terra ci è stata affidata dal Creatore come un dono mirabile. Ma lo «scenario moralmente decadente» che segna la storia del mondo si è manifestato anche nel nostro «insaziabile desiderio di manipolare e controllare le limitate risorse del pianeta», cedendo all’ingordigia per i «profitti illimitati» promessi dal mercato. Così ci siamo allontanati dal «disegno originale della creazione», e i primi a fare le spese di questo tradimento del disegno di Dio sono quelli che «vivono poveramente in ogni angolo del globo». Per questo serve pregare Dio per ringraziarlo del dono della Creazione, ma anche per chiedere a lui di sostenere l’impegno per la cura e la protezione del Creato. E occorre anche che chi ha responsabilità politiche, economiche e sociali ascolti «il grido della terra» e la supplica dei milioni che implorano la guarigione del «creato ferito».
Non è un semplice manifesto green, ma un vero grido di preghiera il messaggio che Papa Francesco e il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I hanno sottoscritto insieme per chiedere a «tutte le persone di buona volontà» di dedicare tempo a pregare per l’ambiente venerdì 1° settembre, Giornata mondiale di preghiera per la Cura del Creato. Il testo, che del primo settembre porta anche la data, era stato anticipato ieri in una traduzione italiana curata dall’agenzia Asia News, rilanciata quasi integralmente dall’Ansa.
 Il Successore di Pietro e il Successore di Andrea invitano a riconoscere che le vicende del mondo si intrecciano col mistero della creazione e col mistero della natura umana, ferita dal peccato originale. E nel contempo - e forse proprio per questo - suggeriscono anche uno sguardo critico originale sul modello di sviluppo trionfante e sulle responsabilità di ha il potere.
Il Successore di Pietro e il Successore di Andrea invitano a riconoscere che le vicende del mondo si intrecciano col mistero della creazione e col mistero della natura umana, ferita dal peccato originale. E nel contempo - e forse proprio per questo - suggeriscono anche uno sguardo critico originale sul modello di sviluppo trionfante e sulle responsabilità di ha il potere.Un dono tradito
La Sacra Scrittura - sottolineano Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo nelle prime righe del loro messaggio - rivela che fin dal principio Dio volle che l’umanità cooperasse nelle custodia e nella protezione del creato. «All’inizio, come leggiamo in Genesi (2,5), “nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c’era uomo che lavorasse il suolo”. La terra ci venne affidata come un dono sublime e come eredità della quale tutti condividiamo la responsabilità finché, “alla fine”, tutte le cose in cielo e in terra saranno ricapitolate in Cristo».
Ma a dispetto di questo disegno buono, la storia del mondo ha fatto emergere uno contesto diverso, segnato da «uno scenario moralmente decadente», dove l’attitudine degli uomini verso il creato ha progressivamente oscurato la vocazione degli uomini a essere «collaboratori di Dio». La pulsione a spezzare i «delicati ed equilibrati ecosistemi del mondo», l’insaziabile desiderio «di manipolare e controllare le limitate risorse del pianeta, l’avidità nel trarre dal mercato profitti illimitati: tutto questo ci ha alienato dal disegno originale della creazione». Adesso - proseguono Bartolomeo e Papa Francesco - «non rispettiamo più la natura come un dono condiviso; la consideriamo invece un possesso privato. Non ci rapportiamo più con la natura per sostenerla; spadroneggiamo piuttosto su di essa per alimentare le nostre strutture».
Pagano i poveri
Le conseguenze di questo processo di alienazione - si legge nel messaggio sottoscritto da Papa Bergoglio e dal Patriarca ecumenico - sono «tragiche e durevoli. L’ambiente umano e quello naturale si stanno deteriorando insieme, e tale deterioramento del pianeta grava sulle persone più vulnerabili. L’impatto dei cambiamenti climatici si ripercuote, innanzitutto su quanti vivono poveramente in ogni angolo del globo. Il nostro dovere a usare responsabilmente dei beni della terra - scrivono Papa e Patriarca - implica il riconoscimento e il rispetto di ogni persona e di tutte le creature viventi. La chiamata e la sfida urgenti a prenderci cura del creato costituiscono un invito per tutta l’umanità ad adoperarsi per uno sviluppo sostenibile e integrale ».
Il Signore e il cuore dei potenti
Davanti allo scenario descritto, i due pastori cristiani, uniti anche «dalla medesima preoccupazione per il creato di Dio, e riconoscendo che la terra è un bene in comune», invitano con fervore tutte le persone di buona volontà «a dedicare, il 1° settembre, un tempo di preghiera per l’ambiente». Una preghiera per ringraziare «il benevolo Creatore per il magnifico dono del Creato», ma anche per chiedergli di sostenere un rinnovato impegno per la cura e la preservazione di quel dono: «Alla fine, sappiamo che ci affatichiamo invano se il Signore non è a nostro fianco».
A Dio, Bartolomeo e Papa Francesco chiedono di cambiare il modo con cui gli uomini si relazionano con il mondo. E la preghiera rivolta a Dio, affinché tocchi i cuori di tutti, è implicitamente connessa all’appello che Papa Francesco e Bartolomeo, nel loro messaggio, rivolgono a chi gestisce il potere: « Noi rivolgiamo, a quanti occupano una posizione di rilievo in ambito sociale, economico, politico e culturale» scrivono i due pastori «un urgente appello a prestare responsabilmente ascolto al grido della terra e ad attendere ai bisogni di chi è marginalizzato, ma soprattutto a rispondere alla supplica di tanti e a sostenere il consenso globale perché venga risanato il creato ferito. Siamo convinti - aggiungono - che non ci possa essere soluzione genuina e duratura alla sfida della crisi ecologica e dei cambiamenti climatici senza una risposta concertata e collettiva, senza una responsabilità condivisa e in grado di render conto di quanto operato, senza dare priorità alla solidarietà e al servizio».
La sollecitudine del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli per la cura del creato si è accresciuta con manifestazioni più accentuate a partire dalla fine dagli anni Ottanta del secolo scorso. È la prima volta che Papa e Patriarca co-firmano una dichiarazione comune sull’ambiente, ma il Patriarcato di Costantinopoli già nel 1989 ha fissato al 1° settembre la Giornata di Preghiera per la salvaguardia della natura. Anche per questo appare fuori luogo ogni lettura dell’appello di Papa Francesco e Bartolomeo come strumento di polemiche politiche di corto respiro.
 Nel settembre 1995, intervenendo al simposio internazionale su “Apocalisse e Ambiente”, organizzato dallo stesso Patriarcato ecumenico e dal Wwf, Bartolomeo già aveva invitato uomini di Chiesa e scienziati a dialogare sulla questione ambientale, pur ribadendo che su questo terreno «le esortazioni moraleggianti in nome del bene comune hanno scarsa utilità». Nella sensibilità ortodossa, oggi abbracciata con tanto entusiasmo da Papa Francesco, anche la devastazione del creato è un segno della generale dimenticanza del Mistero che fa tutte le cose. Così come l’amore vero ai doni della creazione appare connaturale a chi «diviene una nuova creatura in Cristo»
Nel settembre 1995, intervenendo al simposio internazionale su “Apocalisse e Ambiente”, organizzato dallo stesso Patriarcato ecumenico e dal Wwf, Bartolomeo già aveva invitato uomini di Chiesa e scienziati a dialogare sulla questione ambientale, pur ribadendo che su questo terreno «le esortazioni moraleggianti in nome del bene comune hanno scarsa utilità». Nella sensibilità ortodossa, oggi abbracciata con tanto entusiasmo da Papa Francesco, anche la devastazione del creato è un segno della generale dimenticanza del Mistero che fa tutte le cose. Così come l’amore vero ai doni della creazione appare connaturale a chi «diviene una nuova creatura in Cristo»
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL. Un’intervista a John Chryssavgis di Chiara Santomiero
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL. Un’intervista a John Chryssavgis di Chiara SantomieroDoomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
 TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -
> IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- SCENARIO. "Joint Research Centre": Con global warming più frequenti ondate di caldo a 55 gradi.10 agosto 2017, di Federico La Sala
Con global warming più frequenti ondate di caldo a 55 gradi
Studio, picchi record potrebbero diventare normalità in Europa
di Redazione ANSA *
L’estate bollente di questi giorni potrebbe diventare la normalità, anche in Europa. Senza freni al riscaldamento globale, secondo uno studio a guida italiana pubblicato su Scientific Reports, in futuro potremo subire regolarmente ondate di caldo record anche di 55 gradi. Lo scenario scaturisce da un’analisi condotta dal Joint Research Centre della Commissione europea, guidata da Simone Russo, ricercatore dell’Ispra, sull’interazione tra umidità e calore. La proiezione non riguarda quindi solo la temperatura, ma anche quella percepita in base all’umidità.
Secondo i ricercatori ondate di caldo oltre 40 gradi, amplificate da un’alta umidità, potrebbero verificarsi anche ogni due anni, con seri rischi per la salute dell’uomo, soprattutto nell’Asia orientale e nella costa orientale americana. Questo è lo scenario previsto con un aumento di 2 gradi della temperatura del globo rispetto ai livelli preindustriali, obiettivo dell’accordo sul clima di Parigi. Ma se la "febbre" del pianeta continuasse a galoppare, i ricercatori stimano che con un aumento di 4 gradi potrebbero verificarsi regolarmente in molte parti del mondo, Europa compresa, delle super ondate di calore anche di 55 gradi.
-
>IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- ITALIA. Il cambiamento climatico è già realtà (di Davide Michielin -10 agosto 2017, di Federico La Sala
Il cambiamento climatico è già realtà
Non è questione di giorni particolarmente caldi, né di millimetri di pioggia. Si tratta di abituarci a una diversa normalità
di Davide Michielin *
- Cambiamento climatico, cosa c’è da sapere
- Riscaldamento globale: mai così rapido da 66 milioni di anni
- Grandi muraglie verdi, c’è chi ci ripensa
- Calamità naturali, la classifica 2016 di rischio per nazione
Non è tanto il caldo, perché l’aumento della temperatura si sente ma non si vede. Ciò che colpisce l’immaginario collettivo è l’assenza di acqua lì dove c’è sempre stata. In questi mesi l’Italia ha scoperto uno dei possibili effetti del cambiamento climatico, per troppo tempo trascurato: una devastante siccità. Incendi che si propagano con velocità allarmante nel sottobosco secco, laghi ridotti a pozzanghere mentre gli alvei dei grandi fiumi emergono in tutto il loro candore. Anche il sistema delle dighe alpine è allo stremo; esasperata in molti casi da una gestione personalistica dei consorzi di bonifica, da una rete di acquedotti storicamente ridotta a colabrodo e da sistemi di irrigazione anacronistici che disperdono più di quanto innaffino, la siccità colpisce severamente agricoltura e allevamento, con danni che Coldiretti stima attorno ai 2 miliardi di euro.
Due terzi delle Regioni sono a secco e in almeno dieci si attende il riconoscimento dello stato di calamità; in Veneto, dove i volumi teorici a disposizione dell’agricoltura comprendono tuttora - e incredibilmente - l’invaso del Vajont, la giunta ha emesso in questi mesi ben tre ordinanze allo scopo di contingentare l’acqua mentre nel Lazio il lago Bracciano è sotto di 1.63 metri rispetto allo zero idrometrico e prossimo al punto di non ritorno.
Secondo i ricercatori dell’Istituto di Ricerca sulle Acque (Irsa) del CNR, un ulteriore abbassamento di circa 40 centimetri comporterebbe elevati rischi di ripercussioni sull’ecosistema e sulla falda circumlacuale. Compresa la cessazione della naturale capacità di autodepurazione del lago che renderebbe necessario il trattamento delle acque del lago prima di poterle utilizzare.
Il rapporto ISPRA
Nei giorni scorsi, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) ha pubblicato il consueto aggiornamento del rapporto “Gli indicatori del clima in Italia” che illustra l’andamento nel corso dell’anno appena trascorso e aggiorna la stima delle variazioni climatiche negli ultimi decenni. Rispetto al trentennio di riferimento (1961-1990), il 2016 ha fatto registrare un aumento della temperatura media di 1.35°C, leggermente superiore all’incremento di +1.31°C di quella globale. A differenza di quest’ultima, che per il terzo anno consecutivo ha stabilito un nuovo record, il 2016 è il sesto anno più caldo della serie storica italiana, il cui primato è stato stabilito nel 2015. Eccetto il mese di ottobre nelle regioni settentrionali tutti i mesi del 2016 sono stati più caldi della norma. Se durante l’estate non si sono verificate ondate di calore particolarmente intense o durature, la stagione invernale è stata caratterizzata da anomalie termiche piuttosto marcate, con un aumento della temperatura media pari a +2.15°C.
In altre parole, a cambiare non è tanto la stagione estiva quanto l’inverno, caratterizzato da un numero minore di giorni freddi e temperature più alte. Tuttavia, l’aspetto più rilevante del 2016 è stato proprio la persistenza di condizioni di siccità; la seconda metà dell’anno è stata caratterizzata da periodi prolungati di carenza o addirittura assenza di piogge in diverse regioni, che a fine anno hanno portato le risorse idriche a livelli mediamente molto bassi.
Le precipitazioni annuali sono state complessivamente inferiori alla media di circa il 6%: il carattere prevalentemente secco del 2016 è confermato dal valore medio nazionale di umidità relativa, che con un’anomalia media di -2.4% rappresenta il quarto valore più basso dal 1961. Al contempo, non sono mancati gli eventi estremi anche di forte intensità e durata che hanno colpito particolarmente la Liguria e il Piemonte alla fine di novembre.
Quale clima?
Il cambiamento climatico non è un evento ipotetico che appartiene a un futuro remoto ma un fenomeno attuale e sfuggente con cui dobbiamo imparare a convivere. “Le osservazioni sull’aumento dei gas serra sono consistenti, mentre le altre spiegazioni proposte per spiegare il cambiamento dei parametri atmosferici insoddisfacenti” ricorda il climatologo Antonio Navarra, presidente del Centro Euro-mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC).
 Il Mediterraneo è posto sul bordo di transizione tra due zone climatiche, con caratteristiche molto diverse. A seconda delle oscillazioni stagionali il confine si sposta: in inverno la nostra penisola è perlopiù compresa nella fascia temperata, in estate in quella subtropicale, caratterizzata da una spiccata siccità.
Il Mediterraneo è posto sul bordo di transizione tra due zone climatiche, con caratteristiche molto diverse. A seconda delle oscillazioni stagionali il confine si sposta: in inverno la nostra penisola è perlopiù compresa nella fascia temperata, in estate in quella subtropicale, caratterizzata da una spiccata siccità.
 L’intensificarsi del cambiamento climatico promuove lo spostamento verso nord della cella di Hadley e con essa dell’anticiclone africano che si traduce nel rischio di desertificazione per le regioni più meridionali del Paese e nella tropicalizzazione delle rimanenti. Non è questione di alcuni giorni particolarmente caldi o dei millimetri di pioggia caduti.
L’intensificarsi del cambiamento climatico promuove lo spostamento verso nord della cella di Hadley e con essa dell’anticiclone africano che si traduce nel rischio di desertificazione per le regioni più meridionali del Paese e nella tropicalizzazione delle rimanenti. Non è questione di alcuni giorni particolarmente caldi o dei millimetri di pioggia caduti.“Sarebbe sbagliato correlare il singolo evento anomalo al cambiamento climatico. Sono fenomeni che hanno scala temporale molto diversa, è come se volessimo spiegare la vibrazione del tavolino di casa con un terremoto avvenuto molto lontano” prosegue Navarra. Il cambiamento climatico è un gioco di statistiche e le risposte sono fornite in base alle probabilità. Ciò che c’è di certo, è che sta avvenendo. Lo scenario elaborato dalla Divisione Modelli Regionali e Impatti al Suolo del CMCC relativo al trentennio 2021-2050 delinea per il nostro Paese un aumento dei periodi di siccità e in più in generale una diminuzione delle piogge, in particolare di quelle estive anche del 20% rispetto al clima attuale. Ecco perché è il momento di cambiare passo. “Oggi nessuna politica è scritta appositamente per il cambiamento climatico ma allo stesso modo nessuna ignora il fenomeno” conclude Navarra. Perché il cambiamento climatico è qui e ora. E dovremo imparare a conviverci.
* NATIONAL GEOGRAPHIC - ITALIA, 27 luglio 2017 (ripresa parziale).
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. -- "FINNEGANS WAKE" E "FAKESNEWS": DOMANDE, SAPERE, E POTERE.30 luglio 2017, di Federico La Sala
UNA LEZIONE DI JOYCE ... *
L’URLO ("HOWL") DI FINNEGANS: "WAKE", "SVEGLIARSI"!
DOMANDE, SAPERE, E POTERE (TEOLOGICO POLITICO PEDAGOGICO E SESSUALE): ...
“FAQ”, “FAKE”, “FUCK”: ATTENZIONE A QUESTE TRE PAROLE ormai di uso comune. Facendo interagire la loro scrittura, la loro pronuncia, e i loro significati, viene alla luce un prezioso invito ad “avere il coraggio di servirsi della propria intelligenza” (Kant) e a porre “domande su tutto!” (Confucio).
Alle "domande poste frequentemente" (“Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ - pronuncia, in inglese: “F”, “A”, “Q”), CHI risponde (?!), se SA, dà le risposte che sa (fa il suo dovere, e si ferma!), ma, se NON sa e pretende di sapere (come spesso accade - in un abuso di autorità permanente e, ovviamente, di non rispetto di CHI pone le domande), dà solo risposte “false e bugiarde” (FAKE - parola inglese, pronuncia “feik”, che sta a significare "falso", "contraffatto", "alterato". Nel gergo di internet, un fake è un utente che falsifica in modo significativo la propria identità), che cercano solo di ingannare, fregare, fottere in tutti i sensi ( FUCK - parola inglese, pronuncia “fak” - "fach", " faq!": come interiezione equivale all’italiano - cazzo!, come sostantivo: scopata, come verbo: scopare, fottere!).
Non è meglio sapere CHI siamo e cercare di uscire dalla caverna - con Polifemo, Ulisse e compagni (come con il Minotauro, Teseo e Arianna) - senza "fottere" Nessuno e senza mandare Nessuno a farsi “fottere”! O no? La tragedia è finita da tempo!
Federico La Sala
*
A) James Joyce, Finnegans Wake (Libro Primo V-VIII, Oscar Mondadori, Milano 2001, pp. 195-195 bis).:
"He lifts the lifewand and the dumb speak
 Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq"
Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq""Egli brandisce la bacchetta della vita e i muti parlano
 Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq" *
Quoiquoiquoiquoiquoiquoiquoiq" *- vale a dire (fls):
Quoì-quoì-quoì-quoì-quoì-quoì-quoì...
 Quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà...
Quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà-quà...B) Gesù - nel messaggio evangelico, cfr. Marco 7, 31-37:
 Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.
Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.
 E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano.
E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano.
 E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!».
E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!».
 E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.
E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.
 E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!».
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!».C) KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
D) A SCUOLA CON JOYCE. LEGGERE E RILEGGERE FINNEGANS WAKE.
E) "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO.
Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- «Rompiamo il silenzio sull’Africa». Appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti italiani.28 luglio 2017, di Federico La Sala
Appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti: «Rompiamo il silenzio sull’Africa»
Rilanciamo l’appello che il missionario Comboniano, direttore della rivista Mosaico di Pace, rivolge alla stampa italiana. «Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli stanno vivendo», scrive.
di Alex Zanotelli*
Scusatemi se mi rivolgo a voi in questa torrida estate, ma è la crescente sofferenza dei più poveri ed emarginati che mi spinge a farlo. Per questo come missionario uso la penna (anch’io appartengo alla vostra categoria) per far sentire il loro grido, un grido che trova sempre meno spazio nei mass-media italiani. Trovo infatti la maggior parte dei nostri media, sia cartacei che televisivi, così provinciali, così superficiali, così ben integrati nel mercato globale.
So che i mass-media , purtroppo, sono nelle mani dei potenti gruppi economico-finanziari, per cui ognuno di voi ha ben poche possibilità di scrivere quello che vorrebbe. Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli stanno vivendo.
Mi appello a voi giornalisti/e perché abbiate il coraggio di rompere l’omertà del silenzio mediatico che grava soprattutto sull’Africa. (Sono poche purtroppo le eccezioni in questo campo!)
È inaccettabile per me il silenzio sulla drammatica situazione nel Sud Sudan (il più giovane stato dell’Africa) ingarbugliato in una paurosa guerra civile che ha già causato almeno trecentomila morti e milioni di persone in fuga.
È inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto da un regime dittatoriale in guerra contro il popolo sui monti del Kordofan, i Nuba, il popolo martire dell’Africa e contro le etnie del Darfur.
È inaccettabile il silenzio sulla Somalia in guerra civile da oltre trent’anni con milioni di rifugiati interni ed esterni.
È inaccettabile il silenzio sull’Eritrea, retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di giovani in fuga verso l’Europa.
È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica che continua ad essere dilaniato da una guerra civile che non sembra finire mai.
È inaccettabile il silenzio sulla grave situazione della zona saheliana dal Ciad al Mali dove i potenti gruppi jihadisti potrebbero costituirsi in un nuovo Califfato dell’Africa nera. È inaccettabile il silenzio sulla situazione caotica in Libia dov’è in atto uno scontro di tutti contro tutti, causato da quella nostra maledetta guerra contro Gheddafi.
È inaccettabile il silenzio su quanto avviene nel cuore dell’Africa , soprattutto in Congo, da dove arrivano i nostri minerali più preziosi.
È inaccettabile il silenzio su trenta milioni di persone a rischio fame in Etiopia, Somalia , Sud Sudan, nord del Kenya e attorno al Lago Ciad, la peggior crisi alimentare degli ultimi 50 anni secondo l’ONU.
È inaccettabile il silenzio sui cambiamenti climatici in Africa che rischia a fine secolo di avere tre quarti del suo territorio non abitabile.
È inaccettabile il silenzio sulla vendita italiana di armi pesanti e leggere a questi paesi che non fanno che incrementare guerre sempre più feroci da cui sono costretti a fuggire milioni di profughi. (Lo scorso anno l’Italia ha esportato armi per un valore di 14 miliardi di euro!).
Non conoscendo tutto questo è chiaro che il popolo italiano non può capire perché così tanta gente stia fuggendo dalle loro terre rischiando la propria vita per arrivare da noi.
Questo crea la paranoia dell’“invasione”, furbescamente alimentata anche da partiti xenofobi. Questo forza i governi europei a tentare di bloccare i migranti provenienti dal continente nero con l’Africa Compact , contratti fatti con i governi africani per bloccare i migranti.
Ma i disperati della storia nessuno li fermerà.
Questa non è una questione emergenziale, ma strutturale al sistema economico-finanziario. L’ONU si aspetta già entro il 2050 circa cinquanta milioni di profughi climatici solo dall’Africa. Ed ora i nostri politici gridano: «Aiutiamoli a casa loro», dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a farlo con una politica economica che va a beneficio delle nostre banche e delle nostre imprese, dall’ENI a Finmeccanica.
E così ci troviamo con un Mare Nostrum che è diventato Cimiterium Nostrum dove sono naufragati decine di migliaia di profughi e con loro sta naufragando anche l’Europa come patria dei diritti. Davanti a tutto questo non possiamo rimane in silenzio. (I nostri nipoti non diranno forse quello che noi oggi diciamo dei nazisti?).
Per questo vi prego di rompere questo silenzio-stampa sull’Africa, forzando i vostri media a parlarne. Per realizzare questo, non sarebbe possibile una lettera firmata da migliaia di voi da inviare alla Commissione di Sorveglianza della RAI e alla grandi testate nazionali? E se fosse proprio la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) a fare questo gesto? Non potrebbe essere questo un’Africa Compact giornalistico, molto più utile al Continente che non i vari Trattati firmati dai governi per bloccare i migranti? Non possiamo rimanere in silenzio davanti a un’altra Shoah che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Diamoci tutti/e da fare perché si rompa questo maledetto silenzio sull’Africa.
*Alex Zanotelli è missionario italiano della comunità dei Comboniani, profondo conoscitore dell’Africa e direttore della rivista Mosaico di Pace.
* FONTE: FNSI, 18.07.2017
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA -- FILOSOFIA E FILOLOGIA: IL MITO DELLA ROMANITÀ E DELLA GRECITÀ.28 luglio 2017, di Federico La Sala
IL MITO DELLA ROMANITÀ E DELLA GRECITÀ: LA PUNTA DI UN ICEBERG. Molti filologi, storici, archeologi e filosofi italiani e tedeschi si prestarono a favorire questa operazione ...*
Nazisti antiquari, non filologi
di Roberto M. Danese (Alfabeta-2, 27 luglio 1917)
- Johann Chapoutot, Il nazismo e l’Antichità, traduzione di Valeria Zini, Einaudi 2017, 523 pp., € 34
Nel 2008 esce in Francia il volume di Johann Chapoutot Le national-socialisme et l’Antiquité per le edizioni PUF. Nel 2012 il libro viene ripubblicato in edizione rivista con il titolo Le nazisme et l’Antiquité. È quest’ultima versione che esce ora in Italia come Il nazismo e l’Antichità. La differenza nel titolo non è secondaria. Se vogliamo trovare infatti un limite in quest’opera, è il tono generale un po’ troppo apertamente irridente nei confronti dei nazisti, a partire dalla scelta di sostituire nel titolo l’originario national-socialisme con il più polemico nazisme usato negli anni Venti dagli oppositori di Hitler.
Chapoutot è un brillante storico del Terzo Reich, che ha voluto riservare specifica attenzione a un fenomeno già piuttosto noto e indagato, ma comunque bisognoso di una nuova analisi scientifica. La necessità di un libro come questo, molto ben documentato e altrettanto ben costruito, è data non solo dall’interesse per un aspetto importante della politica culturale nazista, ma anche dall’impatto che uno studio del genere può avere sul nostro tempo.
Chapoutot dimostra con grande abilità che il nazismo non si è limitato a mistificare la cultura greca e romana, ma ha fatto di questa mistificazione una base fondamentale per la giustificazione ideologica del proprio agire politico e uno strumento formidabile di indottrinamento per il popolo tedesco. Insomma, ben più di quanto fece il fascismo con il folclorico riutilizzo della romanità. Hitler (e in qualche modo Himmler) prima crearono, grazie alla connivenza di studiosi tedeschi proni al dettato ideologico del Reich, una base scientifica che sancisse in modo indiscutibile l’origine germanica delle grandi civiltà greca e romana, quindi utilizzarono questa - per loro - incontrovertibile verità per rivendicare a sé tutti i migliori frutti di quelle antiche culture, a cominciare dalle città e dalle opere d’arte.
Non fu purtroppo solo un gioco propagandistico, ma una delle giustificazioni principali per l’espansionismo tedesco e per il progressivo irrobustirsi della politica razziale: proclamandosi eredi e insieme padri delle civiltà di Pericle e Augusto (entrambi, per loro, di sangue nordico), si arrogarono il diritto di proclamare inferiori, corrotte e corruttrici tutte quelle razze e quelle culture che non rientravano in questa netta linea genealogica, arruolando come campioni della razziologia autori quali Tirteo oppure Orazio.
Sulla reviviscenza di quegli antichi valori modellarono poi il loro inquietante programma ideologico: superiorità della razza nordica, eliminazione delle razze degenerate di origine negroide-semitica, una institutio nazionale che unisse cura del corpo e della mente, fede nell’irrazionalismo e nello Stato sociale contro il razionalismo di matrice umanistica, opposizione fra l’uomo “totale” ariano e l’uomo “scisso” di ascendenza cristiana.
Il libro di Chapoutot è molto dettagliato e complesso, ma di lettura agevole e avvincente, soprattutto chiaro nel mettere a fuoco gli obiettivi che il nazismo perseguiva nell’utilizzo dell’antichità classica. Sarebbe interessante analizzare molti aspetti di questo saggio, ma ne sceglierò solo un paio per cercare di mostrarne l’utilità e l’attualità. Nel 1933 Hitler volle una grande riforma scolastica che contribuisse a formare sin dall’infanzia il vero uomo tedesco.
Molti filologi, storici, archeologi e filosofi tedeschi si prestarono a favorire questa operazione, che voleva inculcare nei ragazzi i grandi ideali “nordici” della Grecia e di Roma, senza però farli riflettere troppo sui testi. Chapoutot documenta molto bene il dibattito che si accese in merito fra politica, classicisti e insegnanti di scuola: bisognava esaltare l’affinità di sangue e di cultura con gli antichi, ma bisognava anche diminuire le ore di greco e di latino nelle scuole, privilegiando gli studi storico-ideologici a discapito di quelli linguistico-grammaticali.
Se guardiamo al dibattito oggi in atto in Italia e in Europa sugli studi classici, non possiamo non accorgerci che si stanno usando simili argomentazioni per limitare il ruolo e lo studio delle lingue antiche, in vista del perseguimento di una cultura del fare più che del pensare.
Scrive Chapoutot sul programma educativo nazista: “Il sapere è legittimo solo nella misura in cui è immediatamente utile alla comunità del popolo e allo Stato”. E poi: “Il sapere specializzato consacrato dal regime è un sapere tecnico, pratico, immediatamente disponibile e utilizzabile, che dunque esclude ogni meditazione e quella libertà disinteressata che è propria del pensiero”.
Leggete gli attacchi contemporanei verso il liceo classico e verso lo studio del greco e del latino sui nostri giornali e sul web, considerate la filosofia di accreditamento degli Atenei da parte delle Agenzie per la Valutazione dell’Università e della Ricerca, quindi provate a fare un confronto con la cultura del fare esaltata dal regime nazista e messa alla base di ogni suo progetto formativo. Alla fine anche Heidegger aveva capito che tutto ciò era pericoloso, molto pericoloso...
Veniamo poi al marcato antifilologismo di tanti intellettuali al servizio del Führer. Chapoutot ci racconta che Hitler volle un aumento di attenzione verso l’antichità classica ma un’attenuazione del suo studio dal punto di vista veramente scientifico.
È qualcosa di simile a quello che sta succedendo oggi, in un quadro di crescente attenzione per l’antichità classica: nelle università ci sono sempre più archeologi che non sanno una parola di greco o di latino, modernisti che non riusciranno mai a leggere Stazio o Virgilio in latino, latinisti e grecisti che considerano un fastidio fare edizioni critiche e lavorare su testi ecdoticamente fondati. Non parliamo di quello che succede nei licei.
Lo studio delle grammatiche e della prassi filologica per l’antichità classica insegna a non dar mai per scontato nulla di fronte a un testo, insegna a interrogarsi sempre su ciò che una sequenza di parole o di immagini vuol veramente dire, insegna a capire le retoriche.
Questo per i nazisti non solo era inutile, ma anche dannoso: la verità sul significato dei testi antichi su cui si fondava la loro ideologia la diceva il regime stesso, quindi perché fornire allo studente i mezzi per cercare di comprendere da solo quei testi, rischiando di fargli nascere nella testa idee “sbagliate”?
La filologia è invece un bene prezioso perché, come ci hanno mostrato i primi grandi umanisti, raffina l’arte del dubbio: e anche oggi non dobbiamo dimenticare quanto si debba stare in guardia nei confronti di chi subdolamente bolla come inutile al progresso e perditempo colui che indugia nel lento esercizio della perplessità e della riflessione.
Il libro di Chapoutot non è dunque solo interessante, ma anche assai utile e la sua lettura dovrebbe essere consigliata a molti, se è vero che historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriæ, magistra vitæ, nuntia vetustatis.
*
SUL TEMA, SI CFR.:
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
- UNA LEZIONE DI JOYCE (da "FINNEGANS WAKE")
- L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova"
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. -
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- La buona novella di Michel Serres: “È cominciata l’era dolce dell’umanità!”.26 luglio 2017, di Federico La Sala
DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Ripartire dal nostro presente storico, a ri-attivare l’umana (di tutti e di tutte!!!) capacità di "gettare ponti" e a riprendere il cammino "eu-ropeuo" .... *
“È cominciata l’era dolce dell’umanità!”
di Francesco Bellusci ("doppiozero", 26 luglio 2017)
Qualche anno fa, in un breve e amichevole scambio a distanza con Michel Serres, il filosofo francese mi faceva notare la vicinanza geografica del mio paese di origine (lucano) con il rispettivo (calabrese) di Gioacchino da Fiore, confidandomi che in quel momento l’abate e teologo cistercense assorbiva i suoi interessi e le sue ore di studio nella biblioteca della prestigiosa Académie Française, fondata dal cardinale Richelieu, di cui Serres è membro da quasi trent’anni. Adesso, mi rendo conto che quella confidenza di circostanza mi avrebbe fornito la chiave segreta di accesso alla sua ultima fatica, appena edita in Italia (Darwin, Bonaparte e il Samaritano. Una filosofia della storia, Bollati Boringhieri, Torino).
 Infatti, la “filosofia della storia” che Serres presenta in questo libro, ricalca lo schema dell’interpretazione storico-allegorica di Gioacchino da Fiore basata sul processo di compimento progressivo della Rivelazione e soprattutto sulla divisione in tre età o epoche (l’età del Padre, l’età del Figlio e l’età dello Spirito santo), che nel libro di Serres diventano: l’era dell’inizio, l’era dura e l’era dolce.
Infatti, la “filosofia della storia” che Serres presenta in questo libro, ricalca lo schema dell’interpretazione storico-allegorica di Gioacchino da Fiore basata sul processo di compimento progressivo della Rivelazione e soprattutto sulla divisione in tre età o epoche (l’età del Padre, l’età del Figlio e l’età dello Spirito santo), che nel libro di Serres diventano: l’era dell’inizio, l’era dura e l’era dolce.Non si tratta di una novità assoluta. In passato e sempre in una versione secolarizzata, lo schema era stato mutuato e riproposto, per esempio, da Lessing nell’Educazione del genere umano o da Nietzsche nelle “tre metamorfosi” (cammello, leone, fanciullo) del Così parlò Zarathustra.
È lo stesso Serres che, in alcuni punti del libro, rivela la matrice “cristiana” della griglia alla base della sua filosofia della storia, che rimane tuttavia estranea al modello escatologico di quella matrice. La confidenza evoca oggi un’ulteriore coincidenza e analogia. Tra i più ferventi aderenti alla visione di Gioacchino da Fiore ci fu il teologo e francescano parigino Gerardo di Borgo San Donnino, che in un libro intitolato Liber introductorius ad Evangelium aeternum del 1254 preconizzò l’imminente avvento dell’“età nuova” o ordine dello Spirito Santo profetizzata da Gioacchino (per l’esattezza nel 1260), con la scomparsa conseguente della Chiesa gerarchizzata sostituita da una comunità monastica di santi.
Ma San Bonaventura metterà a tacere immediatamente i fervori gioachimiti nel suo ordine, bollandoli di eresia, e il teologo parigino sarà condannato alla prigione a vita. Entrati nel terzo millennio, diverse e inquietanti nubi e minacce sembrano addensarsi e oscurare il nostro tempo: dal terrorismo globale alle guerre asimmetriche, dalle catastrofi ecologiche o umanitarie legate ai grandi flussi migratori dal Terzo Mondo alla criminalità organizzata che avvelena l’economia e la politica di alcuni Stati, in non poche parti del mondo.
Eppure, un filosofo, ancora una volta francese, di nome Michel Serres, ancora una volta, in quest’ultimo libro, ne parla come di fenomeni molto circoscritti e regressivi, enfatizzati solo dai “mercanti” del pessimismo e del catastrofismo che si annidano non a caso nel sistema delle comunicazioni di massa, e annuncia, nell’incredulità generale, che abbiamo fatto da poco il nostro ingresso nell’età più dolce dell’umanità.
È, quindi, il caso di addentrarci di più nel testo di Serres, al quale già di recente la collana “Riga” sui grandi innovatori del Novecento ha dedicato una ricca antologia critica (Michel Serres, a cura di G. Polizzi e M. Porro, Marcos y Marcos, Milano 2014) e sul quale, il prossimo ottobre, la Casa della Cultura di Milano si appresta ad offrire un seminario a più voci al pubblico italiano, per accompagnarlo nel modo in cui il nuovo maître à penser francese, che parteciperà in videoconferenza, c’invita a cambiare lo sguardo sul mondo contemporaneo.
Se, come si è detto, Gioacchino da Fiore gli fornisce la tela, la tavolozza dei colori che Serres utilizza per dipingere il suo affresco ambizioso include alcune coppie concettuali-chiave: bene e male, virtuale e attuale, caos e necessità, sacro e santo, rideclinate a partire dai pensatori e scienziati che lo hanno ispirato profondamente e costantemente: Simone Weil, Henri Bergson, Jacques Monod, René Girard.
Questi riferimenti e intercessori non vanno ovviamente confusi con i “personaggi concettuali” fatti assurgere da Serres a simboli delle tre età o ere che vede succedersi nella storia e che danno il titolo al libro: Darwin, Napoleone e il Samaritano.
Il libro inizia con la precisazione di un nuovo modo di intendere e definire i confini della storia, la cui profondità temporale assume in Serres una dimensione colossale. Non è solo la storia “storica”, la storia centrata sugli uomini, la storia che ha inizio con l’invenzione della scrittura. Paradossalmente questa Storia ha una memoria corta, cortissima, anzi è un ammasso di oblii, perché dimentica e mette ai margini della storia gli ominidi o i popoli primitivi privi di scrittura, gli altri viventi, le cose inerti, il pianeta, l’universo. La storia di cui Serres vuole proporre una filosofia, infatti, ha l’estensione cronologica vertiginosa del “Grande Racconto” delle scienze, dal momento che risale fino al Big Bang, cioè a circa quattordici miliardi di anni fa.
È il racconto che unifica in un’unica serie temporale le durate che ogni singola scienza (etnologia, biologia evolutiva, fisica del globo, astrofisica, cosmologia) ha ricostruito e aggiorna con sempre maggiore esattezza per i propri oggetti, in cui è inclusa la storia degli storici. L’enciclopedia delle scienze diventa una cronopedia e scienze naturali e scienze umane si uniscono, perché, anche se raccontano cose diverse, si basano sulla stessa struttura del tempo. Questa storia, chiarisce Serres, non ha più scopo o direzione e tantomeno sono gli uomini il fine o la fine di questo racconto, che è fatto di caos e biforcazioni impreviste, è un insieme eterogeneo di paesaggi e ritmi temporali differenti, ma che si può sempre ripercorrere da valle a monte secondo il “movimento retrogrado della verità” di bergsoniana memoria, ricostruendone così catene causali e direzioni di marcia. E Serres vi scorge la successione di tre ere.
La prima era va dalla formazione dell’Universo e del nostro pianeta fino alla comparsa e allo sviluppo delle forme viventi pre-umane. È l’era “darwiniana”, segnata dal duello energia-entropia, che governa il mondo fisico, e da quello vita-morte, che governa la galassia dei viventi e che si rideclina in pace-guerra con la comparsa dell’Homo sapiens, il rappresentante dell’unica specie vivente a introdurre la violenza e l’omicidio intra-specie. Ha inizio adesso l’“era dura” segnata da tre morti: la morte procurata col sacrificio, prima umano poi animale, ritualizzato nelle religioni arcaiche, che coagulava e rendeva coese così le comunità col sacro e col sangue, fino a quando il cristianesimo lo sostituirà con il rito “dolce” e simbolico dell’eucarestia, per denunciare l’innocenza di ogni vittima sacrificale; la morte procurata dalle armi letali della guerra, che è apparsa perpetua lungo tutta la storia “umana”, a cominciare dalla madre di tutte le guerre, quella combattuta tra gruppi nomadi e gruppi sedentari; la morte indotta o minacciata dal meccanismo economico del prestito e del debito, regolato ma sempre impastato di violenza. L’era dura culmina nella rivoluzione industriale e si chiude con l’esplosione di Hiroshima, che inaugura la prima “globalizzazione”, perché proietta la minaccia di morte per la prima volta non più sull’individuo, sui gruppi umani o sulle civiltà bensì sull’intera specie umana, ma è contestuale all’evento che gli fa da contraltare e che apre il sipario dell’era dolce: la scoperta della penicillina.
La neghentropia, l’informazione, la cura della vita, hanno sempre opposto, infatti, resistenza alla “tanatocrazia” dell’era dura e creato le condizioni per l’avvento dell’era dolce. Le stesse rivoluzioni dolci, come quelle concernenti i segni e la comunicazione (dall’oralità alla scrittura, dalla scrittura alla stampa, dalla stampa al digitale) hanno avuto un impatto più duraturo e diffuso sull’organizzazione sociale rispetto alle rivoluzioni dure, come quella scientifico-tecnico-industriale.
L’era dolce comincia poco più di mezzo secolo fa e si connota per tre componenti: la pace, la medicina, il digitale. La pace, nuova, dura almeno in Europa ininterrottamente da settant’anni; la guerra e il terrorismo sono precipitati all’ultimo posto come causa di mortalità nel mondo; all’immensa maggioranza degli uomini ripugna uccidere, violentare, distruggere opere d’arte e stigmatizza le minoranze che adottano ancora questi comportamenti; la protezione sociale dei deboli ha capovolto il darwinismo sociale dell’era dura. Questa pace è stata la condizione principale della golden age del secondo dopoguerra, dello sviluppo economico impetuoso che ha accresciuto il benessere, l’inurbamento, e della medicina che ha aumentato considerevolmente la speranza di vita, modificando il nostro rapporto col corpo, che non soffre più i dolori quotidiani di chi viveva già fino alla metà del secolo scorso.
Nell’era dolce, il medico rimpiazza il guerriero, la pietà del buon Samaritano succede alla spietatezza di Napoleone: “Nell’era antica, che possiamo definire ‘hegeliana’, a volte gli eserciti in battaglia trascinavano dietro degli sparuti chirurghi, mal equipaggiati, con poche infermiere munite di bende sparse in un ambiente insozzato dai combattimenti. Le grandi epidemie spesso erano la conseguenza dei carnai successivi allo scontro. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un giorno queste retroguardie avrebbero sostituito in prima linea i soldati, un tempo vittime; che l’ospedale, dove hanno luogo le sfide all’ultimo sangue per il trionfo della vita, avrebbe rimpiazzato il conflitto; che i governi, abbandonando il servizio militare, avrebbero deciso per una politica della salute; che dopo le ferite ci sarebbero state le cure; che l’assistenza sanitaria pubblica avrebbe sostituito il quartier generale e le sue strategie di morte; che l’OMS avrebbe potuto orientare la geopolitica. Ma questa utopia ha avuto luogo”.
Dopo aver letto fiumi di inchiostro sul lato oscuro e pervertibile della biopolitica moderna, Serres c’invita a coglierne il lato irenico e benigno, se ci poniamo adeguatamente dal punto di vista della lunghissima durata del “Grande Racconto”. D’altra parte, il profilo antropologico emergente dell’umanità “dolce” è convergente con quello tratteggiato già nel frammento postumo del 1887 da Nietzsche, per il quale proprio il contesto di vita reso meno insicuro e insensato e quindi addolcito dallo sviluppo della scienza e dalla tecnica, rende più ‘forti’ gli uomini più ‘moderati’, che non hanno bisogno, per rassicurarsi, di ricorrere a fedi estreme o a visioni essenzialiste e metafisiche dell’uomo.
Il motore della storia non sarà più la lotta tra servo e padrone, vinta da chi è disposto a rischiare la vita e a soggiogare quella altrui con la minaccia di morte, ma la legge del buon samaritano che s’inchina e si prende cura della vita, perché ci consentirà non solo di progredire ma di sopravvivere: “Dalla pietra tagliata alle armi nucleari, dai cacciatori-raccoglitori agli sventramenti del mondo, l’era storica contraddistinta dalle forze dure è al termine. Non può andare oltre senza avvelenare gli uomini e distruggere le cose”. E arriviamo così alle tecnologie dolci di Internet, che hanno innanzitutto il pregio di liberare la potenza del numero: tutti accedono virtualmente a tutto e a tutti.
Serres è positivamente impressionato dalla capacità di Internet di decentralizzare e democratizzare il sapere, in una misura non comparabile con quella delle altre rivoluzioni della “coppia supporto-messaggio” (scrittura e stampa) e in attesa di dispiegare ancora il suo ventaglio di effetti e opportunità per l’accesso al potere e alle istituzioni, per l’organizzazione dell’opposizione a regimi oppressivi, per nuovi modi di apprendere, di conoscere e di liberare la mente all’invenzione, per creare nuove appartenenze.
Se, come diceva Lutero, ogni uomo è Papa con una Bibbia in mano, cosa sarà l’uomo con uno smartphone in mano, cioè con il mondo intero in mano? Una molteplicità immensa e crescente è entrata in scena e in contatto in uno spazio non più cartesiano e metrico, bensì virtuale e topologico. Certo non è detto che questa possibilità incommensurabilmente accresciuta di contatto e scambio generi automaticamente, sempre e in modo più esteso comunità e pace.
Nuove forme di violenza possono essere veicolate nella e con l’uso della Rete e i più pessimisti prefigurano addirittura la fagocitazione del dolce da parte del duro con le cyberguerre. Ma al futuro dell’età dolce Michel Serres consegna l’utopia concreta di una pace universale che discenderà dalla coscienza della comune appartenenza all’equipaggio del vascello-Terra e dei rischi di affondare che esso corre: “È vero, abbiamo messo la mano sul mondo, ma il mondo tiene la sua mano su di noi. Noi lo teniamo virtualmente; lui ci tiene realmente. Noi lo teniamo realmente; lui ci tiene virtualmente. Lo teniamo grazie al facile accesso; e lui ci tiene per le nostre condizioni di esistenza - respirazione, nutrimento, salute, spostamenti... Mi sembra prevedibile che un giorno la mano del mercato dovrà adeguare la sua potenza relazionale a quella concreta del mondo, e forse adeguarvisi, cioè obbedire alla sua legge. Entriamo in un periodo in cui si gioca un mano a mano decisivo per la nostra sopravvivenza, tra l’uomo individuale o globale e l’intero pianeta. Questo mio libro sulla storia e la storia stessa tornano al punto di partenza: partiti dal mondo, vi fanno ritorno”.
Per lungo tempo oggetto ostracizzato dalla scena del discorso filosofico contemporaneo, per aver alimentato in modo sotterraneo le ideologie totalitarie (come tale è stata smascherata o messa all’indice da Hannah Arendt o Karl Popper), Serres è determinato nel riportare la filosofia della storia in auge come l’orizzonte o la bussola imprescindibile per la politica e i decision makers, che oggi, in questo inizio di secolo, se ne scoprono drammaticamente orfani, nel momento in cui necessitano di essere più lungimiranti.
E una filosofia della storia allargata e inglobante le durate colossali dell’Universo, della Terra, dell’evoluzione del vivente, oltre alla storia delle collettività umane, non è affatto un mero esercizio interdisciplinare, né solamente il frutto di quel che Serres chiamava, già alcuni decenni fa, programmaticamente “il passaggio a Nord-Ovest” tra saperi umanistici e saperi scientifici.
Risponde all’esigenza di evitare ad ogni costo l’opposizione natura/storia, il cui superamento è ormai condizione stessa della nostra sopravvivenza. I nostri nonni sapevano di avere alle loro spalle solo circa tremila anni di storia. Le “Pollicine” del futuro, i giovani dell’era dolce, sapranno di avere alle loro spalle quattordici miliardi di anni di storia e di essere entrati nell’era dell’antropocene. Questa coscienza non potrà non avere effetti sulla mentalità, sulla politica, sul diritto, sul modo di produrre. In definitiva, sul nostro essere-nel-mondo. Serres ancora una volta è ottimista: “Ecco che ne è dell’essere-nel-mondo: dolce verso il mondo, l’età dura era dura verso gli uomini; poi, dolce per gli uomini, l’età dolce è diventata dura verso il mondo. Dobbiamo lavorare per un futuro in cui i nostri comportamenti saranno dolci verso gli uomini e verso il mondo”.
- EU-ANGELO, COSTITUZIONE... "CARESTIA" E VIOLENZA!!! "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1 Gv., 4. 1-8). «Et nos credidimus Charitati...»!!!!
 RENE’ GIRARD INSISTE: DIO NON E’ VIOLENTO. MA CONFONDE IL PADRE NOSTRO (DEUS CHARITAS EST) CON IL DIO DEL CATTOLICISMO PLATONICO-ROMANO DI RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006) E RICADE NELLE BRACCIA DI "MAMMASANTISSIMA". UN’ INTERVISTA DI FRANÇOIS D’ALANÇON
RENE’ GIRARD INSISTE: DIO NON E’ VIOLENTO. MA CONFONDE IL PADRE NOSTRO (DEUS CHARITAS EST) CON IL DIO DEL CATTOLICISMO PLATONICO-ROMANO DI RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006) E RICADE NELLE BRACCIA DI "MAMMASANTISSIMA". UN’ INTERVISTA DI FRANÇOIS D’ALANÇON
L’ART DES PONTS. HOMO PONTIFEX. Louis De Courcy e Guillaume Goubert intervistano Michel Serres.
 Una forte sollecitazione ad uscire dal "neolitico" e, ripartendo dal nostro presente storico, a ri-attivare l’umana (di tutti e di tutte!!!) capacità di "gettare ponti" e a riprendere il cammino "eu-ropeuo"!!!
Una forte sollecitazione ad uscire dal "neolitico" e, ripartendo dal nostro presente storico, a ri-attivare l’umana (di tutti e di tutte!!!) capacità di "gettare ponti" e a riprendere il cammino "eu-ropeuo"!!!EU-ANGELO E COSTITUZIONE . "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1 Gv., 4. 1-16).
 SENZA LO "SPIRITO" DI GIOACCHINO DA FIORE, NON SI DA’ IL "TERZO PARADISO". Un omaggio critico a Michelangelo Pistoletto
SENZA LO "SPIRITO" DI GIOACCHINO DA FIORE, NON SI DA’ IL "TERZO PARADISO". Un omaggio critico a Michelangelo PistolettoDELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Pace, giustizia, e libertà nell’aiuola dei mortali
 DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia"
DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia""CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
- EU-ANGELO, COSTITUZIONE... "CARESTIA" E VIOLENZA!!! "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1 Gv., 4. 1-8). «Et nos credidimus Charitati...»!!!!
-
>PER LA PACE PERPETUA. -- Bio-storie troppo umane: "Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine" (Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro).29 giugno 2017, di Federico La Sala
KANT (1784), FOUCAULT (1984), E "LA FINE DI TUTTE LE COSE" ( KANT, 1794). Una nota ... *
- "PER LA PACE PERPETUA" (I. KANT, 1795). Se questa iscrizione satirica sull’insegna di quell’oste olandese sulla quale era dipinto un cimitero, riguardi generalmente gli esseri umani...
- Nell’ottobre 1974, in una conferenza sulla progressiva medicalizzazione della società tenuta presso l’Università di Stato di Rio de Janeiro, Foucault introduce il concetto di «bio-storia» per sottolineare che «la storia dell’uomo e la vita sono profondamente intrecciate», dal momento che «la storia dell’uomo» è in grado di modificare, almeno «fino a un certo punto», il «processo» della vita [...]
 Che ci piaccia o meno, grazie alle sempre più continue e terrificanti irruzioni bio-storiche di Gaia «il nostro mondo sta smettendo di essere kantiano». La forza di Gaia nell’arena politica ha definitivamente mandato fuor di sesto «Dio, Anima e Mondo», le «tre grandi idee trascendentali» di Kant (p. 36), destituendole di senso e facendole girare a vuoto: non siamo di fronte a «una “crisi”nel tempo e nello spazio, ma [a] una feroce corrosione del tempo e dello spazio» (p. 52) [...]
Che ci piaccia o meno, grazie alle sempre più continue e terrificanti irruzioni bio-storiche di Gaia «il nostro mondo sta smettendo di essere kantiano». La forza di Gaia nell’arena politica ha definitivamente mandato fuor di sesto «Dio, Anima e Mondo», le «tre grandi idee trascendentali» di Kant (p. 36), destituendole di senso e facendole girare a vuoto: non siamo di fronte a «una “crisi”nel tempo e nello spazio, ma [a] una feroce corrosione del tempo e dello spazio» (p. 52) [...]
 L’ingombrante presenza di Gaia impone infatti un’altra e ancora più decisiva urgenza: il ripensamento radicale delle categorie politiche che ci hanno portato qui dove siamo, nel tempo dell’orrore più estremo, urgenza questa ben più difficilmente digeribile dalle logiche dell’impresa tecno-capitalista. Urgenza più resistente perché libera dal fardello narcisistico dell’antropocentrismo, perché sostenuta dalla consapevolezza che, come sostiene Kojève, «la scomparsa dell’Uomo alla fine della Storia non è [...] una catastrofe cosmica: il Mondo naturale resta quello che è da tutta l’eternità. E non è nemmeno una catastrofe biologica: l’Uomo resta in vita come animale [...].
L’ingombrante presenza di Gaia impone infatti un’altra e ancora più decisiva urgenza: il ripensamento radicale delle categorie politiche che ci hanno portato qui dove siamo, nel tempo dell’orrore più estremo, urgenza questa ben più difficilmente digeribile dalle logiche dell’impresa tecno-capitalista. Urgenza più resistente perché libera dal fardello narcisistico dell’antropocentrismo, perché sostenuta dalla consapevolezza che, come sostiene Kojève, «la scomparsa dell’Uomo alla fine della Storia non è [...] una catastrofe cosmica: il Mondo naturale resta quello che è da tutta l’eternità. E non è nemmeno una catastrofe biologica: l’Uomo resta in vita come animale [...].
 Ciò che scompare è l’Uomo propriamente detto [...] [e] il Soggetto opposto all’Oggetto [...]. Tutto il resto può mantenersi indefinitamente; l’arte, l’amore, il gioco, ecc.; insomma, tutto ciò che rende l’uomo felice»5. E questa, ovviamente, è tutta un’altra bio-storia, un mondo a venire che, forse per gli ultimi istanti, sta ancora aspettando un atto di creazione."(Massimo Filippi, "Bio-storie troppo umane", rec. di Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine di Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, nottetempo, 2017, 289 pp., € 17 - Alfabeta2, 26.06.2017).
Ciò che scompare è l’Uomo propriamente detto [...] [e] il Soggetto opposto all’Oggetto [...]. Tutto il resto può mantenersi indefinitamente; l’arte, l’amore, il gioco, ecc.; insomma, tutto ciò che rende l’uomo felice»5. E questa, ovviamente, è tutta un’altra bio-storia, un mondo a venire che, forse per gli ultimi istanti, sta ancora aspettando un atto di creazione."(Massimo Filippi, "Bio-storie troppo umane", rec. di Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine di Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, nottetempo, 2017, 289 pp., € 17 - Alfabeta2, 26.06.2017).
NONOSTANTE LA SOLLECITAZIONE DI FOUCAULT (1984) A ESSERE GIUSTI CON KANT E A RISTUDIARE E A RIPENSARE LA SUA OPERA E LA SUA LEZIONE A PARTIRE DALLA "RISPOSTA ALLA DOMANDA: CHE COSA E’ L’ILLUMINISMO?" (1784), IL LAVORO DELLA GRANDE RESTAURAZIONE IDEALISTICA PRIMA E MATERIALISTICA POI CONTRO LA VIA DELLA “CRITICA” E LA SUA “RIVOLUZIONE COPERNICANA” CONTINUA FEROCE, CALPESTANDO OGNI DECENZA STORIOGRAFICA E ADDIRITTURA IGNORANDO NON SOLO LE OPERE DELLA FASE COSIDDETTA "PRE-CRITICA" (cfr.: Note per una rilettura della “Storia universale della natura e teoria del cielo”) MA ANCHE LE OPERE DELLA FASE "CRITICA" (cfr. I. Kant, "La fine di tutte le cose", 1794 - e in particolare la seconda nota, dove chi si sbizzarrisce in paragoni ripugnanti per rappresentare il nostro mondo terreno, "senza degnare di attenzione la disposizione al bene che vi è nella natura umana, raffigurando la nostra dimora terrena con grande disprezzo: 1) come una locanda - o un caravanserraglio ... 2) come un penitenziario... 3) come un manicomio... 4) come una cloaca, che raccoglie tutti i rifiuti espulsi dagli altri mondi")!!!
*
SU KANT (e Freud e la banalità del male), mi sia consentito, si cfr. ALCUNE MIE "NOTE PER UNA RILETTURA": https://www.academia.edu/12356078/KANT_FREUD_E_LA_BANALITA_DEL_MALE.
Federico La Sala
- Bio-storie troppo umane
 di Massimo Filippi (Alfabeta-2, 26 giugno 2017)
di Massimo Filippi (Alfabeta-2, 26 giugno 2017)
- Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro
 Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine
Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine
 nottetempo, 2017, 289 pp., € 17
nottetempo, 2017, 289 pp., € 17
- Non si può dire con più chiarezza
 che il mondo per davvero
che il mondo per davvero
 creato è senza scopo, o invece,
creato è senza scopo, o invece,
 se scopo esiste mai
se scopo esiste mai
 non siamo noi.
non siamo noi.
 Josif Brodskij
Josif Brodskij
1. Nell’ottobre 1974, in una conferenza sulla progressiva medicalizzazione della società tenuta presso l’Università di Stato di Rio de Janeiro, Foucault introduce il concetto di «bio-storia» per sottolineare che «la storia dell’uomo e la vita sono profondamente intrecciate», dal momento che «la storia dell’uomo» è in grado di modificare, almeno «fino a un certo punto», il «processo» della vita 1. Da allora, a seguito dell’«intrusione di Gaia» - per usare un’espressione di Stengers -, la bio-storia ha assunto una fisionomia molto differente.
Il recente Esiste un mondo a venire? di Danowski e Viveiros de Castro 2 non lascia dubbi al proposito: l’immensa crisi ecologica in corso esercita un tale impatto sulla «storia dell’uomo» da avere definitivamente messo in crisi, oltre all’impianto sociale e allo stile di vita egemoni a livello planetario, una delle più classiche tra le dicotomie su cui si fonda la teologia politica occidentale, quella tra natura e cultura. Come affermano la filosofa e l’antropologo brasiliani, la nostra specie si è trasformata «in forza geologica», «in un oggetto “naturale”» e il «Sistema Terra» in «un agente politico», in «una persona morale» (p. 45).
Il vettore della bio-storia, insomma, non è unidirezionale: se è certo che la “nostra specie” continua a manipolare i processi naturali su scale forse neppure immaginabili fino a poco tempo fa, altrettanto certa è la capacità della storia naturale di sconvolgere a fondo i processi umani; tanto che oggi non è più possibile parlare seriamente di politica senza tenere conto del ruolo politico della “natura”.
Che ci piaccia o meno, grazie alle sempre più continue e terrificanti irruzioni bio-storiche di Gaia «il nostro mondo sta smettendo di essere kantiano». La forza di Gaia nell’arena politica ha definitivamente mandato fuor di sesto «Dio, Anima e Mondo», le «tre grandi idee trascendentali» di Kant (p. 36), destituendole di senso e facendole girare a vuoto: non siamo di fronte a «una “crisi”nel tempo e nello spazio, ma [a] una feroce corrosione del tempo e dello spazio» (p. 52).
2. Esiste un mondo a venire?, allora, non è «solo» un’accurata revisione delle evidenze empiriche della catastrofe in cui siamo già immersi e degli effetti a lunghissimo termine che comunque comporterà. Revisione, sia detto per inciso, sicuramente necessaria vista «la recente e ignominiosa elezione del negazionista Donald Trump» (p. 13) e considerato che - per parafrasare Žižek - un conto è sapere che qualcosa può accadere e un altro è credere che stia accadendo.
Esiste un mondo a venire? è anche, e soprattutto, il tentativo di portare alla luce il clamoroso non dettodelle più recenti narrazioni occidentali - filosofiche, letterarie e cinematografiche; utopiche o distopiche - della fine del mondo: la ripetizione acritica della «dualità mitica “umanità/mondo”» (p. 55). Aspetto questo tutt’altro che trascurabile dal momento che la rigida separazione Uomo/Mondo ha contribuito a forgiare - quantomeno legittimandola - la potenza operativa dell’impresa tecno-scientifica occidentale, principale causa dell’attuale disastro planetario. Anche se a prima vista sembrano contrapporvisi, le «nostre» mitologie della fine del mondo, sia che prevedano «un mondo senza noi» o, all’opposto, «un noi senza mondo», non si smarcano dalla logica più profonda del dualismo gerarchizzante e sezionante che si cela dietro l’«ottimismo “umanista”» (p. 22).
Semplificando molto e senza seguirne le molteplici ramificazioni - che i due autori descrivono in dettaglio e criticano con acume sia che guardino al passato o al futuro, sia che si inseriscano in paradigmi di «sinistra» o di «destra», sia che si presentino come «apocalittiche» o come «integrate» -, ciò che conta è che nessuna di queste visioni ha preso congedo dall’«allucinazione narcisistica» (p. 79) dell’antropocentrismo.
Che il «mondo senza noi» sia inteso come una sorta di mitico giardino dell’Eden prima della Caduta o come il risultato finale della catastrofe ecologica, e che il «noi senza mondo» assuma le tinte fosche di un annientamento su scala globale o quelle deliranti di un’umanità capace di trascendersi riassorbendo il mondo in se stessa, il «mondo che finisce» è sempre «il “nostro” mondo» (p. 98) e il “noi”, che sta parlando e di cui si parla, è sempre «l’“Umano, che lo si chiami Homo sapiens o Dasein» (p. 57).
Detto altrimenti, le «nostre» bio-storie della fine del mondo sono ancora umane, troppo umane, poiché ribadiscono sia l’esteriorità e la singolarità del «mondo» - che servono a naturalizzare la cosmogonia scientifica occidentale - sia l’universalità del «noi» - che in questo caso opera come dispositivo di occultamento del fatto che la crisi ecologica non è attribuibile indistintamente a tutta la specie umana e che i suoi effetti deleteri si estendono, e si estenderanno sempre di più, ben oltre i confini della nostra specie.
3. Come è noto, esistono altre bio-storie oltre alla «nostra», bio-storie meno violente e distruttive che enfatizzano l’intrinseca relazionalità del vivente. Tra queste, Danowski e Viveiros de Castro si concentrano sul prospettivismo amerindio in quanto propone una concezione del «noi» e del «mondo» - ammesso che si possa continuare a usare questa terminologia - diametralmente opposta a quella della modernità umanista.
Per il prospettivismo amerindio all’inizio «tutto era umano» (p. 148) e tutto resta tale anche dopo che i non umani si sono differenziati morfologicamente nel tempo delle trasformazioni. Da un lato, allora, «l’umanità [è] una moltitudine polinomica» che «si presenta [...] nella forma di una molteplicità interna» da cui, solo in un secondo momento, si originano altri individui e altre specie in una sorta di darwinismo invertito (non sono gli umani a evolversi dagli animali, ma gli animali a travestirsi da umani).
E dall’altra il mondo, «quello che noi chiamiamo mondo naturale, o “mondo” in generale, è [...] una molteplicità di molteplicità intrinsecamente connesse. Gli animali e le altre specie sono [...] entità politiche». In breve, «gli amerindi pensano che, tra il cielo e la terra, esistano molte più società [...] di quante ne sognino la nostra antropologia e filosofia. Ciò che noi chiamiamo “ambiente” è per loro una società di società, un’arena internazionale, una cosmopoliteia» (pp. 150-151).
Quest’altra bio-storia che, malgrado tutto, è riuscita a sopravvivere alla fine del suo «mondo» conseguente all’invasione coloniale, permette agli autori, di declinare la crisi ecologica nei termini di una «guerra civile» (p. 195) tra «Umani» e «Terreni», guerra che non coincide con la linea di divisione tra la nostra specie e le altre, poiché non solo è certo, come gli autori affermano, che non tutti gli umani sono «Umani» ma anche che - e questo aspetto non pare essere sufficientemente sottolineato - che la maggioranza dei «Terreni» sono animali.
4. Nella bio-storia di Danowski e Viveiros de Castro gli animali - che sperimentano quotidianamente la fine dei loro mondi - continuano a rivestire un ruolo politico ancora troppo marginale. Sebbene non esitino a definire «l’“eccezionalità umana” [...] un autentico stato d’eccezione ontologico» che legittima «l’immagine prometeica dell’Uomo che conquista la Natura» (pp. 73-74) e a ridicolizzare l’idea secondo cui saremmo animali dotati di un «supplemento spirituale che è “il proprio dell’uomo” - la preziosa proprietà privata della specie» (p. 144), i due autori non riescono a liberarsi completamente dall’antropocentrismo che percorre indisturbato anche il pensiero più critico 3.
Testimonianza di questa tenace persistenza è l’idea discutibile secondo cui antropocentrismo (occidentale) e antropomorfismo (amerindio) rappresentino visioni del mondo diametralmente contrapposte: se è vero, infatti, che «dire che tutto è umano è come dire che gli umani non sono una specie speciale» (p. 155), altrettanto vero è che l’affermazione “tutto è umano” nasconde - volenti o nolenti - un’operazione di appropriazione colonizzante dei mondi non umani. In altri termini, l’umano continua ad essere l’operatore centrale, seppur depotenziato, anche nel caso dell’ antropomorfismo.
Non a caso, allora, pur usando una terminologia corretta per descrivere le loro condizioni di detenzione («La spaventosa legione di animali confinati e torturati in campi di sterminio per l’estrazione di proteine»), i due autori annoverano gli «animali da reddito» tra gli «alleati» degli Umani in quanto «potenti fabbriche di metano» (p. 211) e non esitano a domandarsi: «Quando esauriremo le scorte di pesci?» (p. 243).
Con queste premesse, risulta difficile capire come sia possibile lasciarsi alle spalle le nozioni sezionanti di «Umano-in-sé» e di «Animale-in-sé» (p. 156), passo che Danowski e Viveiros de Castro sembrano considerare necessario per pensare la tanto auspicata «decivilizzazione» (p. 205), per mettersi all’ascolto « dell’eccezionalismo terrestre» (p. 188), per rendersi finalmente «responsabili dinanzi ai Terreni» (p. 235).
5. Pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che il motto andino « Vivir bien e no mejor» (p. 163) debba costituire il fine a cui, nel tempo della fine, della «mancanza di scelta» (p. 246), dovrebbe tendere la resistenza dei Terreni alla «logica assolutamente non addomesticabile del capitalismo» (p. 235). Meno certo è invece come tale fine possa trasformarsi in una politica a venire all’altezza dei tempi e del tempo che resta.
Basta il generico «becoming with» di Haraway (p. 237) o il troppo locale «ridivenire-indio» degli autori? O, forse, per trasformare lo «shock» in «evento» (p. 252) è necessario radicalizzare questi divenire nel deleuziano divenire animale? Non è, infatti, il concetto di specie e l’opposizione Umano/Animale l’operatore più tagliente che sta al centro dei meccanismi materiali e simbolici che hanno costruito proprio quella società degli Umani che si vorrebbe combattere?
6. Nel 1955, Deleuze afferma che «L’uomo è un animale che si sta spogliando della specie» 4. L’irruzione di Gaia ha inverato questa intuizione. La questione oggi è come pensare e agire per far sì che questo spogliarsi non si traduca - come finora è accaduto - in spoliazione, ma in esitazione potenziante, gioiosa e creativa. La crisi ecologica in corso, infatti, non è caratterizzata esclusivamente, come pensano i più, dall’urgenza materiale di ridurre, per quanto possibile, i danni - urgenza che, tra l’altro, potrebbe spingere in direzione di un’ulteriore e più salda presa dell’Umano e pertanto «mascherare una grandiosa espansione del vangelo diabolico dello “sviluppo”» (p. 249).
L’ingombrante presenza di Gaia impone infatti un’altra e ancora più decisiva urgenza: il ripensamento radicale delle categorie politiche che ci hanno portato qui dove siamo, nel tempo dell’orrore più estremo, urgenza questa ben più difficilmente digeribile dalle logiche dell’impresa tecno-capitalista. Urgenza più resistente perché libera dal fardello narcisistico dell’antropocentrismo, perché sostenuta dalla consapevolezza che, come sostiene Kojève, «la scomparsa dell’Uomo alla fine della Storia non è [...] una catastrofe cosmica: il Mondo naturale resta quello che è da tutta l’eternità. E non è nemmeno una catastrofe biologica: l’Uomo resta in vita come animale [...]. Ciò che scompare è l’Uomo propriamente detto [...] [e] il Soggetto opposto all’Oggetto [...]. Tutto il resto può mantenersi indefinitamente; l’arte, l’amore, il gioco, ecc.; insomma, tutto ciò che rende l’uomo felice» 5. E questa, ovviamente, è tutta un’altra bio-storia, un mondo a venire che, forse per gli ultimi istanti, sta ancora aspettando un atto di creazione.
 1 Michel Foucault, Crisi della medicina o crisi dell’antimedicina?, in Id., Il filosofo militante. Archivio Foucault 2, Milano, Feltrinelli, 2017, p. 210.
1 Michel Foucault, Crisi della medicina o crisi dell’antimedicina?, in Id., Il filosofo militante. Archivio Foucault 2, Milano, Feltrinelli, 2017, p. 210.
 2 Le pagine da cui sono tratte le citazioni sono riportate nel testo tra parentesi.
2 Le pagine da cui sono tratte le citazioni sono riportate nel testo tra parentesi.
 3 Un esempio recente di questa forclusione è il volume di Olivier Razac, Storia politica del filo spinato, Verona, ombre corte, 2017. Il saggio, per altri versi estremamente interessante, si dimentica infatti di porre nella giusta prospettiva il ruolo politico della reclusione degli animali, nonostante il filo spinato sia tuttora uno dei dispositivi di compartimentalizzazione dello spazio centrale nella gestione della vita dei non umani.
3 Un esempio recente di questa forclusione è il volume di Olivier Razac, Storia politica del filo spinato, Verona, ombre corte, 2017. Il saggio, per altri versi estremamente interessante, si dimentica infatti di porre nella giusta prospettiva il ruolo politico della reclusione degli animali, nonostante il filo spinato sia tuttora uno dei dispositivi di compartimentalizzazione dello spazio centrale nella gestione della vita dei non umani.
 4 Gilles Deleuze, Istinti e istituzioni, Milano-Udine, Mimesis, 2014, p. 32.
4 Gilles Deleuze, Istinti e istituzioni, Milano-Udine, Mimesis, 2014, p. 32.
 5 Alexandre Kojève, Introduzione alla lettura di Hegel, Milano, Adelphi, 1996, p. 541.
5 Alexandre Kojève, Introduzione alla lettura di Hegel, Milano, Adelphi, 1996, p. 541. -
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- "CASSANDRA MUTA. Intellettuali e potere nell’Italia senza verità" (Tomaso Montanari)17 maggio 2017, di Federico La Sala
Cassandra muta
Intellettuali e potere nell’Italia senza verità
di Tomaso Montanari *
Quando Cassandra parla, dice la verità: ma è giudicata un intralcio, una sacerdotessa del no. Quando Cassandra tace è perché sta sul carro del potere: e poco cambia che ci sia salita volontariamente, o che sia stata portata in catene. Il risultato è lo stesso: il tradimento degli intellettuali, e cioè il silenzio della critica. Lo vediamo ogni giorno: nel conformismo dei giornali e dell’università, nella trasformazione della cultura in intrattenimento, nello svuotamento della scuola. Qual è il ruolo, quale lo spazio, del pensiero critico nel suo rapporto con il potere, con la comunità della conoscenza, con la comunicazione, con la scuola, con quella che chiamiamo “cultura”? Costruire una società critica, una società del dissenso, è la condizione vitale per il futuro della democrazia. Dire la verità lega alla politica, intesa come arte del costruire la polis, la comunità: ma, al tempo stesso, non si può fare politica attiva dicendo la verità.
 Price: 12,00 €
Price: 12,00 €Tomaso Montanari (Firenze 1971) insegna Storia dell’arte moderna all’Università di Napoli Federico II. Prende parte al discorso pubblico sulla democrazia e sui beni comuni. È presidente di Libertà e Giustizia. Tra i suoi libri: Le pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l’arte e la storia delle città italiane (Minimum fax, 2013), Privati del patrimonio (Einaudi, 2015), La libertà di Bernini. La sovranità dell’artista e le regole del potere (Einaudi, 2016).
*
Edizioni GRUPPO ABELE (Scheda editoriale).
SUL TEMA, EL SITO, SI CFR.:
L’ITALIA (1994-2016), TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA"
-
> PER LA PACE PERPETUA. -- Come smettere di sentirsi insignificanti. “La Terra avrà ancora grandi potenzialità dopo che l’avremo distrutta” (di O. Burkeman).11 aprile 2017, di Federico La Sala
Come smettere di sentirsi insignificanti
di Oliver Burkeman, The Guardian, Regno Unito *
Se il pianeta Terra fosse un essere umano, ho saputo qualche giorno fa, avrebbe circa 40 anni, sarebbe cioè a metà della sua aspettativa di vita. “L’ho scoperto quando avevo sei anni e mi ha praticamente sconvolto”, ha scritto su Twitter un insegnante di chimica, che si chiama Keith Karraker. In proporzione, gli esseri umani usano gli attrezzi da appena dieci giorni, e hanno lasciato l’Africa otto ore fa (un’analogia più famosa è quella secondo cui il mondo è cominciato ieri a quest’ora e gli esseri umani sono arrivati solo un secondo fa).
Di solito la gente fa questo tipo di paragoni come avvertimento: siamo qui da così poco tempo e già stiamo per rovinare tutto, con il cambiamento climatico, le estinzioni di massa, o il prurito nucleare al dito del presidente statunitense. Ma ultimamente, sto trovando questo cambiamento di prospettiva stranamente consolante.
Cambiare metro di misura
Provate a considerarlo come una terapia dell’insignificanza: quando gli eventi nel nel mondo sembrano travolgerci, quale consolazione migliore potremmo avere se non quella di ricordarci che adottando una scala temporale diversa quella marea di eventi diventa indistinguibile dal nulla?
Credo che vi suonerà più o meno rassicurante a seconda della vostra personalità. Il filosofo Bryan Magee nel suo recente libro Ultimate questions, fa un’ipotesi: se dividessimo la storia in fette di cento anni, e a ogni fetta facessimo corrispondere la vita di una persona, che effetto ci farebbe sapere che Gesù è vissuto solo venti vite fa? E che tra noi e Giulio Cesare ce ne sono 21? Ci sentiremmo spaventati o rassicurati? “Dieci ci riporterebbero alla conquista normanna”, scrive Magee. “E per il rinascimento basterebbe una mezza dozzina di persone”.
- Nello schema generale delle cose siamo tutti neonati
In questo modo ci rendiamo improvvisamente conto che la vita umana ci sembra lunga perché la paragoniamo alla nostra esperienza dei minuti, delle settimane e degli anni. Ma perché usare questo metro di misura?
Se proviamo a vedere le cose in modo più obiettivo, ci rendiamo conto che la nostra idea di tempo è “irragionevolmente provinciale”, come dice Magee: siamo ossessionati dal nostro angoletto come se fosse l’eternità. A volte mi sconvolge l’idea che adesso in casa nostra c’è un esserino che (per esempio) non ha mai conosciuto il mese di giugno. Ma è anche vero che, in proporzione a tutto il tempo dell’universo, non ho molta più esperienza di lui. Nello schema generale delle cose, siamo tutti neonati.
Tra gli psicologi è opinione diffusa che sentirsi insignificanti è motivo di angoscia. Ma quasi sempre intendono essere insignificanti rispetto agli altri: celebrità, genitori eccezionali, amici che hanno sfondato. Ma se pensiamo all’insignificanza cosmica, tutte queste differenze svaniscono. E non c’è neanche motivo di tormentarsi tanto per le grandi decisioni della vita, perché non sono veramente importanti. Come potrebbero esserlo?
Il trucco consiste nel trovare consolazione in questo senza diventare nichilisti, nel vedere la fugacità di questo angolo di tempo come motivo per preoccuparci di più delle persone e di quello che ci succede intorno, invece di disimpegnarci. In un modo o nell’altro, comunque, andrà tutto bene purché scegliamo un punto di osservazione abbastanza alto. Anche se l’umanità non ci sarà più. “In fondo quello che voglio dire è... pazienza”, conclude Karraker. “La Terra avrà ancora grandi potenzialità dopo che l’avremo distrutta”.
(Traduzione di Bruna Tortorella)
Questo articolo è stato pubblicato dal quotidiano britannico The Guardian.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- GENOVA. Per il ciclo “Miti senza tempo”, "La guerra di Troia". Lectio magistralis di Massimo Cacciari.2 febbraio 2017, di Federico La Sala
Palazzo Ducale - Fondazione per la Cultura - Genova
La guerra di Troia
8 febbraio 2017, ore 17.45
Sala del Maggior Consiglio
Lectio magistralis
di Massimo Caccciari
chair Nicla Vassallo
Per il ciclo “Miti senza tempo”, a cura di Eva Cantarella e Nicla Vassallo, Massimo Cacciari riflette sulla guerra di Troia, un evento che nel nostro immaginario oscilla tra storia e letteratura, in un incontro dedicato a uno degli episodi più eclatanti del mondo classico. Non si tratta di un vero e proprio mito (perlomeno nel senso platonico del termine), bensì di una delle narrazioni più avvincenti, che in sé contiene molti miti e mitologie, e che non può, né deve essere venire utilizzata con qualche sedativa faciloneria predatoria delle cosiddette scienze umane, sempre che scienze siano, bensì rivisitato e rilanciato cogli strumenti e le metodologie razionali, serrate e agibili della filosofia, filosofia che, tra l’altro, vicino a Troia è nata. Chi ha goduto della “buona sorte” di visitare Troia può comprendere ancor meglio, chi non la avuta comprenderà Troia, il suo “mito” e la costante ricerca attraverso la lezione magistrale di Massimo Cacciari, accompagnato da una chair d’eccezione, Nicla Vassallo, che a Troia vi è stata più volte per amore della comprensione di quel mondo di allora, che oggi viene messo brutalmente in discussione.
Bio ineludibili
Massimo Cacciari si è laureato a Padova in Filosofia, con una tesi sulla “Critica del Giudizio” di Kant. Dopo la laurea è stato assistente di Dino Formaggio presso la Cattedra di Estetica di Padova. Dall’anno accademico 1970-1971 ha avuto un incarico di Letteratura artistica presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia ed è iniziata in quegli anni la sua amicizia e collaborazione con Manfredo Tafuri. Nel 1980 è diventato associato di Estetica e nel 1985 ordinario della stessa materia. Nel 2002 fonda con Don Luigi M. Verzé la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e ne diviene primo Preside. Attualmente è collocato a riposo. Nell’ottobre 2012 riceve dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo il titolo di Professore emerito. E’ stretto collaboratore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e del Collége de Philosophie di Parigi.
Nicla Vassallo (http://www.niclavassallo.net) si è specializzata al King’s College London, è ordinario di Filosofia Teoretica all’Università di Genova e associato dell’ISEM-CNR. Tra i suoi interessi scientifici: epistemologia, filosofia della conoscenza, metafisica, gender studies. Autrice, coautrice, curatrice di ben oltre centocinquanta pubblicazioni, della sua produzione scientifica, in italiano e in inglese, ricordiamo i volumi più recenti: Filosofia delle donne (Laterza 2007), Teoria della conoscenza (Laterza 2008), Knowledge, Language, and Interpretation (Ontos Verlag 2008), Donna m’apparve (Codice Edizioni 2009), Piccolo trattato di epistemologia (Codice Edizioni 2010), Terza cultura (il Saggiatore 2011), Per sentito dire (Feltrinelli 2011), Conversazioni (Mimesis 2012), Reason and Rationality (Ontos Verlag 2012), Frege on Thinking and Its Epistemic Significance (Lexington-Rowman & Littlefield 2015), Il matrimonio omosessuale è contro natura: Falso! (Laterza 2015), Breve viaggio tra scienza e tecnologia con etica e donne (Orthotes 2015), Meta-Philosophical Reflection on Feminist Philosophies of Science (Springer, New York 2016). Sta al presente lavorando sul problema dell’ignoranza conoscitiva, sulle sue cause, i suoi modi per porvi rimedio. Ha vinto il premio di filosofia “Viaggio a Siracusa” nel 2011. Ha pubblicato due raccolte di poesie, Orlando in ordine sparso (Mimesis 2013) e Metafisiche insofferenti per donzelle insolenti (Mimesis 2017).
http://www.palazzoducale.genova.it/massimo-cacciari-2/
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
 TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -- A DUE PASSI DALLA MEZZANOTTE (Bulletin of the Atomic Scientists -DoomsdayClock)26 gennaio 2017, di Federico La Sala
Orologio dell’Apocalisse più vicino alla mezzanotte con Trump
Le lancette del Doomsday Clock nato nel 1947 all’Università di Chicago avanzano: mancano soltanto due minuti e mezzo all’ipotetica fine del mondo. Lo annunciano gli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists, fra cui quindici premi Nobel
dalla nostra inviata ANNA LOMBARDI *
Orologio dell’Apocalisse più vicino alla mezzanotte con TrumpNEW YORK - Due minuti a mezzanotte. È l’ora che da oggi segna il Doomsday Clock, l’orologio dell’Apocalisse, le cui lancette, oggi, sono state spostate avanti di 30 secondi dagli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientist. Il Bulletin è la rivista dell’Università di Chicago fondata nel 1945 dai fisici del Progetto Manhattan - quelli che realizzarono la prima atomica - sulla scia del dibattito successivo al bombardamento di Hiroshima e Nagasaki. Furono loro a creare, nel 1947, il Doomsday: un orologio simbolico dove la mezzanotte segna la fine del mondo. All’epoca il pericolo distava 7 minuti. Oggi, poco più di due.
Per carità, nel tempo, le lancette del Doomsday sono già andate avanti e indietro diverse volte, a secondo delle tensioni nel mondo: ma il 2017 promette di essere uno degli anni peggiori. Lo ha spiegato il fisico teorico e cosmologo Lawrence Krauss che guida il gruppo di scienziati responsabili dell’orologio. Parlando della scelta di avanzare le lancette ha infatti detto: "Mai prima d’ora le sorti del mondo sono così strettamente dipese da due persone al potere, Putin e Trump".
Dopo aver fatto un diretto accenno alle interferenze di hacker russi nelle elezioni americane, ha infine concluso: "Siamo molto preoccupati di quanti governi - amministrazione americana compresa - siano scettici nei confronti di conclusioni scientificamente provate, che ignorano nei loro processi decisionali". Una chiara allusione allo scetticismo nei confronti del surriscaldamento globale del nuovo presidente americano che ha chiamato un negazionista a capo dell’Agenzia per l’ambiente.
- BulletinOfTheAtomic @BulletinAtomic
- Read the 2017 Doomsday Clock Statement: http://ow.ly/4fRp308nsou #DoomsdayClock
Dunque guerre, riscaldamento climatico, tensioni globali e l’elezione di un presidente controverso come Donald Trump potrebbero accelerare i rischi di una fine del mondo. Nella storia solo un’altra volta si era andati così vicini alla mezzanotte: nel 1953, quando i russi testarono la potentissima bomba ad idrogeno. E pensare che per anni, le lancette erano state portate parecchio indietro: nel 1969, dopo la firma del Trattato di non proliferazione si era scesi a dieci minuti. Poi dimezzati dall’invasione russa dell’Afghanistan del 1981, ma ampiamente recuperati nel 1991con l’accordo fra Russia e Stati Uniti per ridurre l’arsenale militare che portò le lancette ben 17 minuti indietro.
Nel 2001 l’attacco alle Torri gemelle del settembre precedente e la diffusa paura del terrorismo globale aveva riportato le lancette a ’’orari’’ allarmanti: sette minuti come nell’immediato dopoguerra. Da allora, la distanza si è ristretta sempre di più: cinque minuti nel 2007, dopo il primo test nucleare nordcoreano. Tre minuti nel 2015, in piena presidenza Obama: in parte a causa della nascita dello Stato Islamico, in parte per colpa del surriscaldamento globale.
Oggi, con Trump alla presidenza, che sta facendo saltare vecchi equilibri fra stati e ha già detto di non voler proseguire le politiche contro il surriscaldamento del Pianeta, le cose, secondo gli scienziati sembrano andare peggio che mai. D’altronde sono in molti a temere che la valigetta nucleare non debba restare nelle mani di Trump: due politici democratici, il senatore Ed Markey e il deputato Ted Lieu, hanno addirittura depositato una proposta di legge per impedire a The Donald di scatenare una guerra nucleare senza l’esplicita dichiarazione di guerra del Congresso: visto che oggi schiacciare il bottone rosso dell’Apocalisse è prerogativa assoluta del Presidente. Ma difficilmente i repubblicani, anche i più preoccupati delle intemperanze del loro capo, accetteranno di diminuirne i poteri. Con buona pace delle tensioni globali, a due minuti dalla mezzanotte.
* la Repubblica, 26 gennaio 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> TROIA, L’OCCIDENTE... PER LA PACE PERPETUA. -- MIGRANTI. Onu, un fallimento annunciato. Il commissario ai diritti umani: «Abbiamo fallito verso milioni di persone»21 settembre 2016, di Federico La Sala
- PIANETA TERRA: LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986). Tracce per una svolta antropologica
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Assemblea Onu, un fallimento annunciato
Migranti. Il vertice Onu sui migranti voluto da Ban Ki moon si chiude senza neanche una dichiarazione comune di intenti e con gli Stati. Il commissario ai diritti umani: «Abbiamo fallito verso milioni di persone»
di Marina Catucci (il manifesto, 20.08.2016)
NEW YORK Come gestire 65,3 milioni di sfollati? Il problema è al centro della discussione iniziata ieri al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite con i leader di tutto il mondo arrivati a New York per il primo vertice dedicato a rifugiati e migranti. Il summit apre la settimana dell’Assemblea generale dell’Onu che sarà l’ultima per il sudcoreano Ban ki moon e l’ultima per Barack Obama.
Ma come si risolve una crisi del genere? Le Nazioni Unite devono affrontare il problema del più grande movimento di persone della Storia, dopo la fine della seconda guerra mondiale, quindi «si terranno riunioni, conferenze, tavole rotonde, si produrranno documenti finali, discorsi, promesse, maledizioni e vilipendi. Poi a fine giornata, si andrà a casa», ha amaramente dichiarato PassBlue, pubblicazione indipendente che si occupa di diritti umani attraverso la lente delle Nazioni Unite. PassBlue è un progetto fondato nel 2011 dal Ralph Bunche Institute per gli Studi Internazionali presso il Graduate Center dell’Università della Città di New York, non legato finanziariamente o in altro modo alle Nazioni Unite, e sono tutti molto scettici sull’esito di questo summit.
La conferenza su rifugiati e migranti è, comunque, senza precedenti per le Nazioni Unite, i capi di Stato e di governo, i leader delle Nazioni Unite e gli esperti della società civile, dovranno intervenire e cercare di trovare un soluzione per i 65 milioni di uomini, donne e bambini che nel 2015 sono stati costretti ad abbandonare la propria casa. Per il momento hanno partorito un documento, dal titolo la Dichiarazione di New York, non vincolante, con principi e impegni da cui partire per ottenere, entro il 2018, la firma di un Global Compact, un trattato che indichi come affrontare la crisi migratoria.
«È molto interessante - ha dichiarato all’Associated Press Filippo Grandi, alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati - e se saremo in grado di tradurre questo documento in una risposta concreta, in cui si impegnano molti attori politici, si potranno risolvere davvero molti problemi riguardanti situazioni di emergenza o coinvolgenti rifugiati a lungo termine, come per la situazione siriana».
Gli argomenti di discussione comprendono i modi in cui si affrontano le cause profonde dei flussi dei migranti, la futura cooperazione internazionale sul problema, le responsabilità derivanti dal diritto internazionale e la vulnerabilità dei migranti mentre tentano di raggiungere le loro destinazioni. Nel corso dei lavori saranno toccate anche le questioni dei diritti umani e l’attuazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.
I risultati al momento sembrano deludenti, viste le difficoltà a raggiungere anche solo una dichiarazione di intenti condivisi. «L’amara verità è che questo vertice è stato indetto perché abbiamo in gran parte fallito - ha detto Zeid Ra’ad al-Hussein, l’alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani - Non siamo riusciti a porre fine alle sofferenze delle persone in Siria, a porre fine alla guerra al suo esordio. Abbiamo fallito, nei confronti di milioni di migranti che meritano molto di più di vite segnate, dalla culla alla tomba, da umiliazione e disperazione».
Un fallimento ancora più evidente se si considera quello che in origine, era l’ambizioso progetto che Ban Ki moon voleva realizzare: ovvero dividere tra gli Stati membri delle Nazioni unite una quota annua pari al dieci per cento profughi. Per il segretario generale delle Nazioni unite si trattava di un modo per gestire finalmente in maniera ordinata un fenomeno drammatico come quello di chi fugge da guerre, persecuzioni e catastrofi climatiche, riuscendo così a segnare anche la fine del suo mandato. Gli Stati però, non lo hanno permesso.
Da settimane nel Palazzo di Vetro si sapeva che nessun impegno preciso sarebbe stato assunto per quanto riguarda un’eventuale spartizione dei profughi. Un rifiuto conseguenza anche del vuoto vissuto non solo all’interno delle Nazioni unite - visto che Ban è praticamente scaduto e il suo successore ancora non è neanche prevedibile - ma anche alla Casa Bianca dove il nome del futuro inquilino è segnato da altrettanta imprevedibilità. E per di più con uno dei due candidati che non perde occasione per dimostrare la sua ostilità nei confronti di profughi e migranti.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. -- «ELENA» DI EURIPIDE: AL VELIATEATRO 2016 L’ALTRA VERSIONE DEL MITO DELLA GUERRA DI TROIA.4 agosto 2016, di Federico La Sala
- IL PUTTANESIMO DELLO SPIRITO: LA DIPINTURA TUTTA CONTRARIA. LA LEZIONE IGNORATA DI GIAMBATTISTA VICO.
«ELENA» DI EURIPIDE: AL VELIATEATRO 2016 L’ALTRA VERSIONE DEL MITO DELLA GUERRA DI TROIA
LA XIX EDIZIONE DEL FESTIVAL È DEDICATA ALLA MEMORIA DEL GRANDE FILOLOGO E GRECISTA MARIO UNTERSTEINER
Comunicato Stampa *
Una delle figure più intriganti della mitologia greca, Elena, vista attraverso l’occhio del più grande tragediografo antico. Sul palco di VeliaTeatro 2016, sabato 6 agosto (ore 21), nella serata inaugurale della XIX edizione del festival di teatro antico sull’acropoli dell’antica Elea-Velia, debutta «Elena» di Euripide. La tragedia è rappresentata da «Kerkís. Teatro Antico In Scena», in collaborazione con il Corso di Alta Formazione Teatro Antico in Scena dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con la direzione artistica di Antonio Calenda. La regia è di Christian Poggioni, la direzione drammaturgica è di Elisabetta Matelli, docente di Storia del teatro greco e latino all’Università Cattolica di Milano e presidente dell’associazione «Kerkís. Teatro Antico In Scena», che introduce l’allestimento con una breve presentazione.
Lo spettacolo affronta un filone alternativo del mito della guerra di Troia, che Euripide riprese nella tragedia andata in scena nelle Grandi Dionisie del 412 a.C. La vera Elena, la seduttrice fatale che nel racconto omerico fu causa del rovinoso ed epico conflitto, non è mai fuggita con il principe Paride. È invece condotta dalla dea Era in Egitto presso il re Proteo e al suo posto va a Troia una «nuvola», una sua immagine (eidolon). Il dramma si apre nel momento in cui, morto Proteo, suo figlio Teoclimeno diventa re e pretende di sposare Elena.
Contemporaneamente, Menelao naufraga proprio in Egitto, convinto di aver trascinato sua moglie via da Troia, ma trovandosi davanti un’altra a lei del tutto simile.
L’intrigo che ne deriva si risolve con il lieto fine di una rocambolesca fuga dei due sposi, dopo una rincorsa di situazioni, in cui agli elementi tragici si aggiungono effetti comici. Euripide fa emergere l’ambigua confusione tra apparenza e realtà. Anticipando temi contemporanei, come la possibilità di scambiare tragicamente il virtuale con il reale, il poeta muove anche una scaltra accusa alla guerra in generale, negli anni in cui Atene paga il suo tributo di vittime nello scontro con Sparta: se Greci e Troiani soffrirono innumerevoli pene fu solo «per una nuvola», per cause inconsistenti e inutili.
Le musiche sono a cura di Adriano Sangineto, le scenografie di Dino Serra, i costumi di Salvatore Averzano ed Elena Adamou, assistente alla regia è Ermelinda Çakalli. Gli interpreti sono: Giulia Quercioli, Federico Salvi, Stefano Rovelli, Livia Ceccarelli, Federica Scazzarriello, Federica Gurrieri, Simone Mauri, Stefano Begalli, Vito Marco Sisto, Vincenzo Politano, Marta Banfi, Federica Dagonese, Annachiara Fanelli, Eleonora Fedeli, Susanna Folegatti. Tutti attori di «Kerkís. Teatro Antico In Scena», associazione fondata da docenti, studenti ed ex studenti dell’Università Cattolica di Milano, per dare impulso alla messinscena di teatro classico greco e latino, contemperando la ricerca e la competenza artistica.
La XIX edizione di VeliaTeatro è dedicata alla memoria di Mario Untersteiner (1899-1981), insigne filologo e studioso della filosofia eleatica e del teatro antico. Il ricordo dell’illustre antichista e la riscoperta della sua opera, sono celebrati, in accordo con il Laboratorio Dionysos dell’Università di Trento, diretto dal professore Giorgio Ieranò, con il Comune e la Biblioteca Civica “Girolamo Tartarotti” di Rovereto, dove Untersteiner nacque, e con l’Università Statale di Milano e il Liceo Classico “Giovanni Berchet” di Milano, in cui lo stesso insegnò.
Nel corso della serata, a 35 anni esatti dalla scomparsa dello studioso, la sua opera, in particolare in relazione ai due temi che più lo avvicinano a VeliaTeatro, ovvero gli studi sulla filosofia eleatica e quelli sulla tragedia, viene brevemente illustrata da Alice Bonandini, ricercatrice dell’Università di Trento e curatrice del Progetto “Il Fondo Untersteiner” presso la Biblioteca Civica “Girolamo Tartarotti” di Rovereto.
Tra le iniziative volte a evidenziare l’importanza di un personaggio di grande rilievo per la cultura classica in Italia e in Europa, la proposta di valorizzare il cospicuo materiale del Fondo Untersteiner, donato alla Biblioteca Civica “Girolamo Tartarotti” di Rovereto e comprendente la preziosa biblioteca, i manoscritti inediti e l’epistolario dello studioso.
Agli spettatori della prima serata è distribuita in omaggio una raffinata pubblicazione, contenente la presentazione dell’opera e della figura di Mario Untersteiner, i contributi di personaggi delle istituzioni e il programma di sala di VeliaTeatro 2016, con le schede degli spettacoli in cartellone e gli interventi di importanti studiosi. A corredo del volume, anche alcune pregevoli foto di scena firmate da Michele Calocero per VeliaTeatro.
*
INFO: veliateatro.it
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. -- Graphic Novel. "L’eta del bronzo" di Eric Snanower, un attentissimo lavoro filologico14 maggio 2016, di Federico La Sala
La guerra di Troia, tra mito e storia
Graphic Novel. Eric Snanower, "L’eta del bronzo", un attentissimo lavoro filologico, in cui le invenzioni, le variazioni sono poste al vaglio dei testi e della credibilità storica e letteraria
di Giancarlo Mancini (il manifesto, 14.05.2016)
Non sono poche le riscritture a fumetti di personaggi storici, fatti più o meno misteriosi, delitti di stato e infine anche di classici della letteratura. E se la riscrittura è una delle pratiche dominanti dell’età moderna che riprende in mano i testi del passato per plasmarli in una nuova veste, questa riscrittura di Eric Shanower, L’età del bronzo (Magic press, € 15) è interessante da più punti di vista.
L’oggetto è la guerra di Troia, un qualcosa che oggi nel nostro immaginario è in bilico tra storia e letteratura, ovvero tra quanto tramandano gli storici dell’epoca e quanto invece ne possiamo desumere attraverso la lettura dell’Iliade omerica. Shanower spiega nelle note la sua lunga passione per queste vicende e questi personaggi, avvolti per metà dal mito e per metà dalle rievocazioni.
Se nelle molte riscritture a fumetti di questi anni la dominante è sempre l’ironia e uno spirito di intromissione “goliardica” nei meandri della letteratura cosiddetta alta (ammesso che questi recinti significhino ancora qualcosa oggi), per lui la faccenda è tremendamente seria.
Filo rosso di questi sette volumi dedicati allo scontro tra troiani ed Achei è una sorta di tentativo sincretico, di trovare cioè una strada intermedia, tra le vicende raccontate da Omero e quelle invece raccontate dagli storici.
Questo ha implicato tutta una serie di scelte, da un lato volte a dare una coerenza e una compattezza narrativa al lungo racconto, dall’altro per dirimere alcune delle questioni che da sempre attanagliano sia i critici che gli scrittori.
Solo per fare un esempio, Paride, il personaggio da cui tutto, in un certo senso ha origine, essendo materialmente l’uomo che si occupa del rapimento di Elena, moglie di Menelao re di Sparta, invece di essere un pastore qui è un vaccaio e non solo perché alcune fonti come le Eroidi di Ovidio e il Ratto di Elena di Colluto, presentano altresì un Paride dedito alla cura di tori e vacche. Ma soprattutto perché nel sogno con cui incontriamo Paride nella vignetta d’apertura, l’autore preferisce dissolvere il volto della dea Afrodite sul muso di una mucca anziché su quello di una pecora “perché nell’antichità gli occhi bovini erano ritenuti simbolo di bellezza e Paride, in sogno, aveva appena eletto Afrodite come la più bella tra le dee. Ma l’idea del Giudizio interpretato come sogno iniziò a svilupparsi in maniera diversa. La mucca, però, rimase per evidenziare la familiarità di Paride con i bovini, aggiungendo credibilità alla sua decisione di riottenere il toro.”
Oppure c’è l’utilizzo del cane Argo, che nella versione omerica caratterizza uno dei passi più struggenti dell’Odissea, quando ormai vecchio e malato riconosce Ulisse al ritorno a casa travestito da mercante. Nell’opera di Shanower lo incontriamo quasi subito, per drammatizzare la scena della pazzia di Odisseo e azzannare uno di quelli venuti assieme ad Agamennone per portarlo in battaglia, cioè lontano da casa.
Insomma siamo davanti ad una delle manifestazioni più mature e consapevoli del fumetto contemporaneo, senza alcun tipo di remora o di sudditanza rispetto a nomi altisonanti come quello di Omero, o anche solo per restare sul campo storico, della guerra di Troia.
Il lavoro di Shanowe, lo dimostra la ricchissima bibliografia posta alla fine del primo volume, dimostra un attentissimo lavoro filologico, in cui le invenzioni, le variazioni sono poste al vaglio dei testi e della credibilità storica e letteraria.
Per chiarire ancora di più le ragioni da cui scaturisce questa lunga e spaventosa guerra egli fa ricorso alle ragioni poetiche quanto a quelle politiche.
Le prime fanno capo ancora una volta ad Elena, mitiche, la donna più bella del mondo, colei in cui Paride vede incarnata la premonizione fattagli tempo addietro nel bosco. Poi ci sono i motivi d’onore, il patto tra i re delle varie città stato greche, in primis Agamennone.
Poi però c’è anche la geopolitica, l’occasione serve infatti al re miceneo per forzare la mano contro quella importante città stato posta in una dislocazione geografica invidiabile, alle porte dello stretto dei Dardanelli, quello che nell’antichità era chiamato l’Ellesponto.
La scelta più radicale rispetto alla struttura dell’epica omerica riguarda gli Dei che se lì erano parte integrante dello scontro tra le due fazioni, prendendo parte per l’una o per l’altra, portandosi dietro tutte i loro bizzosi criteri, qui sono posto interamente fuori dal racconto e dal recinto dove le cose accadono.
“Ho scelto di ridimensionare l’elemento soprannaturale per aver modo di enfatizzare quello umano. I soli elementi fantastici che ho conservato sono i sogni e le visioni. Che, a ben pensarci, non sono necessariamente soprannaturali in toto. Tutti noi sogniamo. Alcuni soffrono di allucinazioni. Altri sono convinti di avere delle visioni. In ogni parte del mondo ci sono persone che ritengono di potere comunicare con gli dei attraverso le preghiere. Così sogni e visioni fanno parte dell’opera... hanno un carattere abbastanza umano, dopo tutto.”
Nato a key West, in Florida, nel 1963, Eric Shanower inizia a dedicarsi al disegno e alla scrittura delle storie a soli 6 anni, per proseguire, a modo suo I libri di Oz di Frank Baum.
Con l’età del bronzo, iniziato nel 1991 ha vinto l’Eisner Award come miglior scrittore e miglior sceneggiatore nel 2001 e nel 2003.
Nell’età del bronzo Shanower dimostra non solo le sue qualità di sceneggiatore e di disegnatore ma anche, su una prospettiva più ampia, quanto in questi ultimi anni il fumetto sia diventato, o tornato ad essere dipende dai punti di vista, una delle forme espressive più pregnanti di quest’epoca.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
DALL’ILIADE ALL’ODISSEA: ALESSANDRO BARICCO (...)
 Oggi, e finalmente, abbiamo un’Iliade (quella riscritta da Baricco: bravissimo, ha colto perfettamente nel segno), all’altezza del nostro tempo e della nostra civiltà. Un’iliade senza più gli Dei e senza più le Dee: è proprio quella che dice bene di noi stessi e di noi stesse - quella del tempo che viviamo e che meritiamo, non quella dei Greci e dei Troiani (federico la sala)
Oggi, e finalmente, abbiamo un’Iliade (quella riscritta da Baricco: bravissimo, ha colto perfettamente nel segno), all’altezza del nostro tempo e della nostra civiltà. Un’iliade senza più gli Dei e senza più le Dee: è proprio quella che dice bene di noi stessi e di noi stesse - quella del tempo che viviamo e che meritiamo, non quella dei Greci e dei Troiani (federico la sala) -
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Il cavallo di Troia? Era una nave fenicia, Hippos: il vascello dopo la storica presa cadde in disuso (di T. Bendinelli)29 aprile 2016, di Federico La Sala
Sfatato il mito della presa
Il cavallo di Troia? Era una nave fenicia: la scoperta di un archeologo
Era già stato letto da alcuni studiosi come una nave sacra. Il bresciano Francesco Tiboni l’ha identificata nella Hippos. Dopo la storica presa, il vascello dopo cadde in disuso
di Thomas Bendinelli (Corriere della Sera/Brescia, 28.04.2016)
Il cavallo di Troia? Una nave fenicia dal nome Hippos. Sembra semplice, quasi l’uovo di Colombo, eppure la scoperta dell’arcano è merito di Francesco Tiboni, archeologo subacqueo 39enne nato e cresciuto a Vobarno, provincia di Brescia da tre anni ricercatore all’università di Aix en Provence. La tesi del cavallo che in realtà è una nave, frutto di quasi due anni di studi e dopo essere passata sotto la scure dei comitati di valutatori, verrà illustrata in modo divulgativo sul prossimo numero di «Archeologia Viva» e in modo scientifico e dettagliato nell’edizione estiva di «Archaeologia maritima mediterranea. An International Journal of Nautical Archeology».
Da Omero a Tiboni: «Nessun cavallo per la presa di Troia»
Il guizzo geniale nasce una sera a casa, in famiglia. Francesco Tiboni si sta dilettando con un testo di Pausania, scrittore greco del II secolo dopo Cristo e incappa in questa frase: «Che quello realizzato da Epeo fosse un marchingegno per abbattere le mura e non un cavallo, lo sa bene chiunque non voglia attribuire ai Frigi un’assoluta dabbenaggine. Tuttavia, la leggenda ci dice che è un cavallo». Il tarlo del dubbio si insinua nella mente del ricercatore. Manifesta il suo pensiero alla moglie Laura. Che lo guarda come un pazzo ma poi lo aiuta e contribuisce con entusiasmo alla ricerca. Tiboni si occupa di archeologia marina, conosce le navi antiche come le tabelline, e si chiede: «Stai a vedere che il cavallo è un Hippos, una nave fenicia». L’idea non è del tutto originale o, meglio, già nell’Ottocento alcuni studiosi avevano decifrato il cavallo omerico come una nave sacra. Tiboni fa un passo in più e non solo dà un nome alla nave, Hippos appunto, ma dimostra anche che Omero in realtà non aveva mai parlato di cavalli. Un inciso, a proposito: Omero non cita l’episodio del Cavallo nell’Iliade e lo fa solo marginalmente nell’Odissea. Chi si dilunga nei dettagli è invece Virgilio nell’Eneide. In mezzo c’è qualche secolo.
«Diffidenza tra i giovani ricercatori e più apertura tra i vecchi»
Tiboni non entra nel merito nella questione omerica o nella giungla delle verità o meno degli episodi narrati da Omero, si sofferma sul cavallo. Fa analisi del testo, intreccia le parole omeriche e di Virgilio con quelle di tecnologia navale. La pancia del cavalo diventa una stiva, le ruote e le lunghe funi con i quali il cavallo fu trasportato sotto le mura di Troia assomigliano al modo in cui, secondo le più recenti ricerche, le navi mercantili venivano tirate con forza. Il cavallo prende forma, si deforma, e si trasforma in nave, in un Hippos. «Una nave che cadde in disuso nei secoli successivi - spiega Tiboni - e chi tradusse in seguito non ne era proprio a conoscenza dell’esistenza. Ma Omero, nei suoi versi, è invece preciso nel suo linguaggio marinaresco». Il lavoro di Tiboni inizia a girare per mesi tra alcuni addetti ai lavori. C’è incredulità, talvolta scetticismo, alla fine convincimento. «Ho trovato più diffidenza tra i giovani ricercatori - osserva -, mentre ho raccolto più attenzione e sostegno tra gli studiosi della vecchia scuola».
I soldati? «Erano nella stiva della nave, non nella pancia dell’equino»
Lo studio, una volta pubblicato sulla rivista di Archeologia marina, diventerà di dominio pubblico. Non cambierà le sorti della guerra di Troia ma un bel dibattito si aprirà, partendo però dal presupposto che i soldati si nascondono meglio dentro una grande nave che non nella pancia di un equino di legno. Si continuerà a dire Cavallo di Troia? «Immagino di sì - sorride Tiboni - ma è anche giusto che la scienza faccia il suo percorso e che, in questo caso, l’archeologia navale possa sanare l’equivoco plurisecolare». La vera storia del Cavallo di Troia diventerà anche un libro, questo almeno è l’intento di Tiboni. Il quale, fosse anche solo per competenza di studi, nulla dirà invece per smentire la leggenda sull’uovo di Colombo .
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Un mito fondativo: il tradimento del profugo Enea (di Guido Crainz).28 aprile 2016, di Federico La Sala
- TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA ....
 L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI TROIA: L’ANALISI DI CARLO LEVI.
L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI TROIA: L’ANALISI DI CARLO LEVI.
Il tradimento del profugo Eneadi Guido Crainz (la Repubblica, 28.04.2016)
HANNO il significato di un simbolo le scelte dell’Austria sul Brennero, un simbolo che fa inevitabilmente riaffiorare fantasmi del passato. E rende ineludibili i nodi già emersi nei mesi scorsi assieme ai muri eretti in molte forme da differenti Paesi.
ASSIEME a quei muri: la dolente e straziata popolazione dei profughi ha reso solo evidenti questioni più profonde. Certo, sulle decisioni austriache influiscono oggi ragioni e tensioni elettorali ma non è inevitabile che i peggiori nazionalismi facciano vincere le elezioni (né che i socialdemocratici inseguano gli avversari sul loro terreno nel vano tentativo di non perderle): sul perché si è giunti a questo è dunque necessario continuare a interrogarsi.
Non c’è dubbio, l’ipotesi di chiudere il Brennero è una resa dell’Europa, è contro la storia e contro il futuro: non c’è nulla da aggiungere a quel che hanno detto il presidente Renzi e la presidente Boldrini. Quell’ipotesi tocca da vicino il nostro vissuto, ci richiama alla mente il sofferto percorso con cui abbiamo superato lacerazioni drammatiche: la generazione cresciuta negli anni Cinquanta e Sessanta ha ancora memoria viva, ad esempio, delle tensioni connesse al nodo del Sudtirolo, per non evocare più antichi traumi e tragedie. Abbiamo memoria, anche, della stella polare che ci ha aiutati a superare quelle lacerazioni ed è proprio quella stella polare, l’Europa, ad essere oggi a rischio. Con questo ci stiamo misurando. Poco tempo fa, su Repubblica, Giorgio Napolitano ha ricordato al presidente austriaco le speranze del 1998, quando «da ministro dell’Interno fui al Brennero con il mio omologo ministro austriaco per rimuovere insieme la barriera al confine tra i nostri due Paesi». Non è immaginabile che si torni indietro, ha concluso giustamente Napolitano, ma è proprio l’inimmaginabile a fare paura. Molte altre barriere sono cadute poi in tutta Europa nel dicembre del 2007, superando ferite storiche: sembrava ancor più impossibile tornare indietro eppure sta succedendo. Di questo si tratta e con questo dobbiamo misurarci, assieme all’obbligo di dare al dramma dei profughi la risposta che i Paesi civili sono tenuti a dare.
Toccandoci da vicino, dunque, le scelte che riguardano il Brennero ci precludono definitivamente le rimozioni in cui troppe volte abbiamo cercato rifugio. Destre aggressive e nazionalismi xenofobi erano apparsi già prima di quel gioioso 2007: dall’esplosione del movimento di Jean Marie Le Pen, nel 2002, al diffondersi di movimenti non dissimili in diverse aree europee; dai pronunciamenti referendari della Danimarca e della Svezia contro l’euro a quello della Francia e dei Paesi Bassi contro la Costituzione europea. Ben prima delle dilaganti esplosioni dell’ultimissimo periodo.
Sottovalutammo questi e altri segnali, e sottovalutammo quel che Carlo Azeglio Ciampi aveva annotato nei suoi diari già molto prima, al momento stesso del varo dell’euro: è necessario ora, scriveva, un rinnovamento complessivo capace di investire anche la cultura, i costumi, gli stili di vita. È stato inevitabile, aggiungeva allora Ezio Mauro, avviare l’unificazione «attraverso l’unico comun denominatore oggi possibile, quello della moneta » ma è ormai urgente «dare un contesto istituzionale, culturale e politico a questa moneta. Perché rappresenti l’Europa e non soltanto undici Paesi comandati da una banca».
A questa sfida siamo mancati: è mancata la politica e più ancora - è necessario dirlo - è mancata la cultura: ad essa in primo luogo spettava costruire ponti (lo aveva scritto da sempre Alex Langer), delineare orizzonti e utopie comuni, ragioni di fratellanza e di comunità. Non è successo, o è successo troppo, troppo poco.
Non è responsabilità solo della politica dunque se, lontana ormai la stagione delle speranze, i cittadini europei vivono oggi in una Unione priva di strumenti istituzionali efficaci e in un continente quasi sconosciuto.
Ignari più di prima dei processi in corso al suo interno, esposti alle pulsioni nazionaliste e al tempo stesso incapaci di comprenderne le radici. E incapaci di dare risposte civili ai «dannati della terra» che cercano rifugio in Europa e in Italia. Quell’Italia che in fondo, ci ha ricordato un bel libro di Fabio Finotti, ha il suo mito fondativo nel profugo Enea.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Un mito fondativo: in principio c’è Enea. La Patria è mobile (di Mirella Serri)28 aprile 2016, di Federico La Sala
- RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
La Patria è mobileUn concetto mutevole nel tempo e nello spazio
Come spiega Fabio Finotti in un saggio che attraversa la storia della cultura italiana, da quella alta alla pop
di Mirella Serri (La Stampa, 14/03/2016)
Carissimo, mi trovo «prigioniero in quela Signora bruta Italia» in «barache, già lo sai anche tu, che sono barache di Italiani internati». Chi scrive, con lessico a dir poco zoppicante, è il signor G., un italiano fedele suddito degli Asburgo durante la Prima guerra mondiale: è finito prigioniero di altri italiani da sempre disprezzati e considerati così fastidiosi che «non lasciano in pace nemmeno le mosche». L’ostilità del detenuto si rafforza dal momento che in quella coabitazione coatta con i connazionali finisce con l’avvertire di essere anche lui un «italiano» ovvero di far parte di quella mala genìa con cui non ha mai voluto aver niente da spartire.
Una percezione analoga (ma di segno opposto, dove il sentirsi italiano assume una valenza positiva) la proverà più di 25 anni dopo un altro internato, nel Lager di Auschwitz: «Lo jiddish era di fatto la seconda lingua del campo (sostituita più tardi dall’ungherese). Non solo non la capivo», spiega Primo Levi, «ma sapevo solo vagamente della sua esistenza... Gli ebrei polacchi, russi, ungheresi erano stupiti che noi italiani non lo parlassimo: eravamo degli ebrei sospetti, da non fidarsene». Non c’è dubbio: gli ebrei provenienti dalla Penisola riescono a comunicare molto di più con gli aguzzini nazisti (è il caso di Levi) che con i correligionari non italiani, proprio perché sono profondamente assimilati e radicati in Italia.
In principio c’è Enea
Nonostante dunque i due reclusi, il signor G. e Primo Levi, provengano da culture e abitudini assai diverse da quelle del resto dello Stivale, entrambi hanno dentro di sé la consapevolezza di un’appartenenza comune. Da dove viene questa certezza quasi subliminale, la scoperta di questo spazio interiore circoscritto dalla parola «patria», uno spazio che quasi non si sa di possedere, che stupisce e coglie di sorpresa tanto l’incolto filo-asburgico quanto il dotto futuro scrittore?
Se lo vogliamo capire, buttiamo a mare le nostre più tradizionali convinzioni: il termine patria non coincide interamente con l’etimo «terra dei padri»: è qualcosa di molto diverso e muta nel tempo e nello spazio. A spiegarci tutte le accezioni di questo singolare e a volte inafferrabile concetto è il bellissimo excursus di Fabio Finotti, che in Italia. L’invenzione della patria (Bompiani, pp. 569, € 28) attraversa tutta la cultura italiana, da quella alta a quella pop, da Dante a Petrarca, da Machiavelli a Manzoni, da Pasolini a Rossellini, dall’iconografia del Vittoriano a quella di miss Italia, da Altiero Spinelli all’avvento dell’era tv.
Docente presso la Pennsylvania University di Philadelphia, dove dirige il Center for Italian Studies, Finotti ci spiega che alle radici dell’immaginario che nutre e definisce la parola «patria» c’è l’avventura di Enea, l’eroe classico che, diversamente da Ulisse, non rientra a casa, non torna a Troia ma porta la casa originaria con sé cercando di ritrovarla e rifondarla altrove. Lo fa proprio approdando sulle coste italiane: la dimora per eccellenza, l’abitazione del cuore e dell’anima per Enea non è dunque un luogo certo, ma è qualcosa che si muove con lui. Scrittori e artisti italiani hanno poi dato forma e concretezza alla nostra mutevole identità, plasmandola e riplasmandola più volte, passando, per esempio, attraverso la nozione di Impero come insieme di diversità propria di Carlo Magno, oppure l’idea romantica di nazione di Foscolo e di Manzoni per arrivare alla «patria viaggiante» delle novecentesche migrazioni cantate da Pascoli.
Le radici in viaggio
I contadini e gli operai che agli inizi del secolo superavano confini e oceani in cerca di fortuna erano pronti a radicarsi nelle nuove terre alla maniera di Enea, portando la patria con sé. Monumenti, architettura, riti e ricette: i nostri emigranti hanno dato vita a tante Little Italy sparse per il mondo. E proprio per la varietà e la molteplicità delle loro esperienze, paradossalmente, hanno sempre coltivato un forte senso delle radici.
La storia della Penisola come patria ha così molto da insegnare all’Europa: in Italia, per esempio, gli ebrei, per secoli, non furono costretti a rinunciare alla loro peculiarità etnico-religiosa ma si sentirono - lo ricordava il poeta Umberto Saba - «figli». Oggi questo senso di appartenenza contraddistingue spesso anche coloro che approdano nel nostro paese: come documentano anche libri e testimonianze, l’Italia è percepita come una «casa» accogliente e composita, un’etnia fatta da stirpi diverse, «un tappeto dai mille colori», tutti racchiusi entro un’unica cornice. In un momento come questo, in cui tutta l’Europa è assediata da imponenti flussi migratori, il libro di Finotti si pone come un fondamentale vademecum: ci incoraggia a rimodellare senza drammi il nostro ruolo e lo stesso concetto di accoglienza e di convivenza proprio ricordandoci la nostra identità multicolore, non stabile ma «mobile» e mutevole nei secoli.
- TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA ....
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Il 30esimo anniversario della catastrofe di Cernobil. Nota di M. Gorbaciov.26 aprile 2016, di Federico La Sala
Così Cernobil ha cambiato la nostra vita
di MIKHAIL GORBACIOV (La Stampa, 26/04/2016)
Quasi 70 anni fa un gruppo di scienziati del Progetto Manhattan, dopo aver constatato il potere distruttivo del nucleare, progettò quello che venne chiamato il Doomsday Clock. Un meccanismo concepito per avvisare il mondo della minaccia di un’imminente catastrofe globale. Quest’anno le lancette dell’«orologio dell’apocalisse» si sono fermate a tre minuti dalla mezzanotte dell’umanità.
La stessa posizione in cui si trovavano al culmine della Guerra Fredda. Perché? A livello globale, il numero di testate nucleari ha ripreso a crescere; oltre trenta Paesi sono in possesso di armi nucleari o possono disporne rapidamente; la Corea del Nord manda pericolosi segnali; il furto da parte dell’Isis non è una cosa priva di fondamento. A tutto questo si aggiungono i rischi e gli impatti di una futura Cernobil o Fukushima; gli incidenti all’interno dei siti di stoccaggio o quelli legati alla lavorazione e al trasporto dei materiali nucleari; i cambiamenti climatici, che interessano tutti gli organismi viventi.
Quest’anno ricorre il 30esimo anniversario della catastrofe di Cernobil: il peggior disastro con cui il genere umano si sia mai dovuto confrontare, legato all’incapacità di scienziati e ingegneri di prevedere come problemi apparentemente piccoli possano tramutarsi in disastri di scala quasi inimmaginabile.
A mio parere Cernobil rimane uno dei più tragici incidenti del nostro tempo. Dal momento in cui venni informato telefonicamente - alle 5 del mattino di quel fatidico 26 aprile 1986 - che un incendio era divampato nel Reattore 4 della centrale nucleare di Cernobil, la mia vita non è stata più la stessa. Sebbene in quel momento non si conoscesse la reale entità del disastro, fu subito evidente che stava accadendo qualcosa di orribile.
Le questioni sollevate da Cernobil e ribadite da Fukushima sono oggi più attuali che mai, e sono ancora senza risposta. Come possiamo essere sicuri che le nazioni che possiedono energia nucleare per scopi civili o militari si atterranno alle necessarie misure e norme di protezione? Come possiamo ridurre il rischio che grava sulle generazioni future? Non sarà che stiamo evitando di dare le risposte a queste domande quando tronchiamo il dibattito invocando ragioni di «sicurezza nazionale» o il nostro bisogno illimitato di energia?
Contrariamente a quanto affermano i sostenitori dell’energia nucleare, secondo cui ci sono stati solo due incidenti importanti, se si quantifica la gravità degli incidenti includendo sia la perdita di vite umane sia significativi danni alle strutture, emerge un quadro molto diverso.
Dal 1952 si sono verificati in tutto il mondo almeno 99 incidenti nucleari, che rientrano in questa definizione, con danni che ammontano a oltre 20,5 miliardi di dollari. Vale a dire più di un incidente nucleare ogni anno e danni per 330 milioni di dollari. Tutto questo dimostra che esistono molti rischi non gestiti o regolamentati in modo inadeguato, una cosa che è a dir poco preoccupante, data la gravità dei danni che anche un singolo incidente può provocare.
È fondamentale che qualsiasi discussione sull’energia nucleare venga affrontata sotto tutti i punti di vista e nella sua complessità. Gli impianti nucleari non rappresentano solo un problema di sicurezza, di ambiente o di energia. Ma tutte queste cose insieme. E come Green Cross International sostiene da anni, si tratta di aspetti del medesimo problema che vanno dibattuti nel loro complesso.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA --- A ciascuno la sua Elena. Alle radici del mito il motivo folklorico della “bella moglie rapita”7 dicembre 2015, di Federico La Sala
A ciascuno la sua Elena
Alle radici del mito il motivo folklorico della “bella moglie rapita”, diffuso dall’Europa all’India e alla Cina: l’indagine di un filologo
di Giorgio Ieranò (La Stampa, 7.12.2015)
Forse è morta impiccata a un albero nell’isola di Rodi. Forse ha attraversato i secoli e, trasmigrando di corpo in corpo, per successive reincarnazioni, è diventata una prostituta in un bordello fenicio. O forse abita in un’isola incantata, ai confini del mondo: un paradiso degli eroi, dove è la sposa di Achille e trascorre le notti in un banchetto perenne.
Sono solo alcune delle storie che gli autori antichi raccontavano intorno a Elena di Troia. Storie bizzarre e, spesso, in contrasto tra loro. Archetipo della femme fatale, icona di bellezza e di morte, Elena è donna dai molti destini. Per Omero, è l’adultera per eccellenza, la «cagna» che, abbandonando il marito Menelao, provoca la guerra di Troia. Ma altri poeti, da Stesicoro a Euripide, sostenevano che Elena non era mai andata a Troia: gli dei dell’Olimpo avevano dato in ostaggio a Paride solo un suo fantasma, fatto di nuvole e d’aria. Lei, invece, si sarebbe nascosta in Egitto. E lì sarebbe rimasta, mentre sulle rive dello Scamandro scorreva il sangue di achei e troiani, e Achille ed Ettore morivano per un fantasma.
Sacra e adultera
Già gli antichi tentavano di attribuirle una psicologia. Ma Elena non ha una biografia, non è una Madame Bovary dell’età del bronzo: è un fascio di immagini che si rincorrono attraverso i secoli come in un gioco di specchi. Lowell Edmunds, filologo classico e professore emerito della Rutgers University, prova ora a mettere ordine nel caos del mito. Lo fa con un libro appena uscito negli Stati Uniti (Stealing Helen, letteralmente «Rubando Elena», Princeton University Press, pp. 430, $ 49,50) che propone un’ipotesi suggestiva: la figura di Elena si spiegherebbe innanzitutto alla luce del motivo folklorico della «bella moglie rapita».
Scavando in leggende indiane, africane, cinesi, irlandesi, bulgare, e anche in favole italiane già catalogate da Italo Calvino, Edmunds compone una curiosa galleria di spose rubate: tutte donne di bellezza sovrumana, segnate da una nascita straordinaria (come Elena, che secondo il mito era uscita da un uovo), rapite e poi riscattate dai loro mariti con imprese in cui si combinano forza e astuzia. Il motivo è universale e si riflette anche nell’epopea indiana del Mahabharata. Certo, queste leggende non sono del tutto sovrapponibili al mito omerico: non sempre il ratto della moglie si risolve con una guerra come quella troiana. Ma in questa messe di racconti, che fa pensare a un’antichissima tradizione indoeuropea, s’intravede lo schema essenziale della figura di Elena.
Elena sarebbe dunque approdata all’Iliade uscendo da questo mare di racconti. E non, invece, dal mondo arcano di una primitiva religione mediterranea. Si è spesso sostenuto che in origine Elena era una divinità della vegetazione, poi trasfigurata in personaggio dell’epica e in figura romanzesca. Ma le tracce di questa originaria natura divina sono evanescenti.
È vero, a Sparta e a Rodi c’erano santuari in cui l’eroina era venerata come «signora dell’albero» o «signora del platano». L’Elena sacra ha però sempre dovuto convivere con il suo doppio, l’Elena adultera. Ad Atene, nel borgo di Decelea, si facevano sacrifici in suo onore. Ma intanto, nel teatro alle pendici dell’Acropoli, i poeti la trattavano da sgualdrina.
Nel Ciclope di Euripide, un coro di satiri irriverenti interroga Odisseo, reduce da Troia: «Dimmi, presa la giovane Elena, non ve la siete ripassata a turno, visto che a lei piace avere tanti amanti? Che spergiura! Alla vista di un paio di brache colorate su cosce maschili perse la testa e piantò Menelao, un omino così per bene!». Le brache sono quelle del troiano Paride che, come tutti i barbari, portava i calzoni e non la tunica dei Greci.
L’ennesima maschera
Elena combatte da sempre per uscire dal recinto dell’epopea e del folklore, per trasfigurarsi in sogno metafisico. Le sette gnostiche la consideravano l’incarnazione della Sophía, della Sapienza suprema, imprigionata dalle potenze cosmiche inferiori in un corpo femminile e costretta a subire ogni oltraggio. Simon Mago, leggendario fondatore dello gnosticismo, l’avrebbe cercata per secoli, riscattandola infine da un bordello di Tiro.
Poi Elena ha sconfinato anche nel mito di Faust. Come ricorda Edmunds, ben prima di Goethe, la regina di Sparta compare già nella Storia del dottor Faust, mago e negromante, pubblicata nel 1587 da Johann Spies. Qui, davanti a un gruppo di studenti, la domenica di Pasqua, Faust evoca dagli inferi Elena, che appare «in uno stupendo vestito nero e purpureo, gli occhi nerissimi, le labbra rosse come ciliegie».
Il libro di Edmunds si ferma alle soglie del Novecento. Ma si vorrebbe aggiungere ai molti volti di Elena quello delineato dal poeta greco Ghiannis Ritsos nel 1970: il volto di una donna vecchia e stanca, sopravvissuta alla sua leggenda. L’eco delle antiche guerre si è ormai spenta. Ed Elena si consuma nella penombra, tra un armadio e una specchiera, con le verruche che le spuntano sul viso. È il crepuscolo di un mito. O forse è solo l’ennesima maschera dell’inafferrabile Elena.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- CLIMA E NON SOLO! Tre minuti a mezzanotte (di Giorgio nebbia)2 dicembre 2015, di Federico La Sala
Tre minuti a mezzanotte
di Giorgio Nebbia (Eddyburg, 30 Novembre 2015)
Settanta anni sono un periodo lunghissimo; chi ha oggi venti anni ha, della seconda guerra mondiale, finita nel 1945, lo stesso ricordo che io potevo avere, quando avevo venti anni, delle guerre di Indipendenza, cioè niente. Con la differenza che le guerre di indipendenza dell’Italia avevano lasciato conseguenze soltanto politiche, amministrative e sociali, mentre la seconda guerra mondiale coinvolge, a loro insaputa, i ventenni di oggi e quelli che verranno, per molte generazioni, con l’eredità politica e ecologica della bomba atomica.
Per conservare questo ricordo proprio nel dicembre di settanta anni fa, pochi mesi dopo il bombardamento americano delle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, un gruppo di scienziati, colpiti dalla grande tragedia generata dalla “bomba” che loro stessi avevano contribuito a fabbricare, decisero di fondare un “bollettino” di informazioni, il Bulletin of the Atomic Scientists. Il fine era di avvertire il pubblico di quello che avrebbero potuto aspettarsi, nel male e nel bene, dalla scoperta dell’enorme energia che si libera dalla fissione del nucleo atomico. Per settanta anni, ogni mese, il Bulletin parla dei problemi delle armi nucleari ma anche delle conseguenze delle scoperte scientifiche che influenzano la vita dei terrestri, 2,3 miliardi di persone nel 1945, 7,2 miliardi di persone oggi.
A partire dal 1947 l’avvertimento dei pericoli è espresso con la immagine di un orologio, che appare sulla copertina di ogni numero, con le lancette che indicano i minuti, prima della mezzanotte dell’umanità, il giorno-della-fine-del-mondo, che restano se non si prendono provvedimenti. In mancanza dei quali l’umanità davvero rischia l’annientamento per la radioattività liberata dalla possibile esplosione di bombe atomiche, o per guerre, o per fame, o per catastrofi dovute agli sessi terrestri.
All’inizio la lancetta è stata messa a sette minuti a mezzanotte quando solo gli Stati Uniti possedevano le bombe atomiche; si avvicinò a tre minuti a mezzanotte nel 1949 quando anche l’Unione Sovietica dimostrò di possedere “la bomba”. La lancetta segnò due minuti a mezzanotte nel 1953, dopo l’esplosione della bomba H americana, e tornò indietro a dodici minuti a mezzanotte quando, nel 1963, Stati Uniti e Unione Sovietica decisero di far cessare le esplosioni nucleari sperimentali nell’atmosfera, limitandole alle esplosioni nel sottosuolo; negli anni successivi ci furono alterni rapporti fra le potenze nucleari “ufficiali” che erano diventate cinque: Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Unione sovietica e Cina, con l’aggiunta del misterioso arsenale nucleare di Israele. Nel 1991, dopo la distensione seguita al crollo dell’Unione Sovietica, l’orologio segnò diciassette minuti a mezzanotte, una boccata di speranza di pace, ben presto vanificata dall’entrata di India e Pakistan fra i paesi dotati di bombe nucleari.
I primi quindici anni del Ventunesimo secolo hanno visto nuovi pericoli di instabilità per la popolazione umana, anche se lentamente la Russia e gli Stati Uniti hanno deciso di smantellare una parte delle “vecchie” bombe nucleari. Si tratta di delicate operazioni tecniche che liberano grandi quantità degli esplosivi plutonio e uranio arricchito, in parte utilizzati come combustibili per le centrali nucleari commerciali, in parte esposti a incidenti, e a furti da parte di criminali e terroristi. Dalle sessantamila bombe nucleari esistenti nel mondo all’apice delle crisi internazionali, nel 1987, oggi esistono nel mondo “soltanto” circa 10.000 bombe nucleari, alcune delle quali in stato permanente di allerta.
Le bombe nucleari si deteriorano col tempo e le due principali potenze nucleari continuano ad aggiornare i loro arsenali; adesso i collaudi delle bombe non richiedono più esplosioni sperimentali ma possono essere fatti con altri metodi. Di recente è stato annunciato che le bombe nucleari a fusione americane B61, alcune delle quali sono depositate anche in Italia a Ghedi (Brescia) e ad Aviano (Pordenone), saranno perfezionate nel modello B61-12 con una spesa di dieci miliardi di dollari; così si allontana ancora di più la speranza che gli stati nucleari rispettino l’impegno, da loro sottoscritto col Trattato di non proliferazione nucleare, che impone, all’articolo VI, l’avvio di trattative per il disarmo nucleare totale.
Eppure un disarmo atomico sarebbe possibile; si è riusciti, pur dopo anni di dibattiti, a vietare le armi chimiche e quelle biologiche, perché non si dovrebbero vietare quelle nucleari? Il denaro risparmiato fermando le attività nucleari militari, centinaia di miliardi di dollari ogni anno nel mondo, permetterebbe di affrontare e risolvere almeno una parte dei problemi di miserie, di ingiustizie e di sottosviluppo, di fame e di mancanza di acqua e di suoli inariditi, che sono la vera radice della violenza internazionale.
Altre nuvole tempestose hanno infatti affollato il cielo rendendo possibili disastri, anch’essi planetari, dovuti al riscaldamento globale, e anche per questo l’orologio del Bulletin si è avvicinato, di recente, di nuovo a tre minuti dalla mezzanotte dell’umanità. Vedremo che cosa uscirà dal dibattito iniziato a Parigi per attenuare i peggioramenti del clima dovuti alla nuova “bomba atomica”: i gas inquinanti, figli dei nostri processi produttivi e dei nostri consumi e sprechi di energia, di minerali, di prodotti agricoli e di merci.
Mi piacerebbe che di questi problemi si parlasse nelle scuole, nelle Università, nei partiti e, magari, nel Parlamento, al di là delle dichiarazioni di buona volontà. Miseria, migrazioni, disperazione, le madri del terrorismo, sono alle porte e non basta chiuderle. Bisogna aprire piuttosto, con coraggio, come raccomanda il Papa Francesco, le porte dei nostri cuori alla giustizia che è l’unica mamma della pace.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "HOMO SUM" (XIV edizione de “I Classici” -Bologna). La pia ipocrisia di Enea eroe di regime (di G. Zagrebelsky)14 maggio 2015, di Federico La Sala
PIETAS e CHARITAS. SIAMO sinceri! Enea non ci piace....
Note su un testo di G. Zagrebelsky *
- LA LEZIONE DI CARLO LEVI - OGGI:
 "La prima di esse [delle guerre nazionali] è quella di Enea. Una storia mitologica deve avere delle fonti mitologiche; e in questo senso, Virgilio è un grande storico. I conquistatori fenici, che venivano da Troia, portavano con sé tutti i valori opposti a quelli della antica civiltà contadina. Portavano la religione e lo Stato, la religione dello Stato. (...) Poi venne Roma, e perfezionò la teocrazia statale e militare dei suoi fondatori troiani, che, vincitori, avevano però dovuto accogliere la lingua e il costume dei vinti. E Roma si urtò anch’essa nella difesa contadina, e la lunga serie delle guerre italiche fu il più duro ostacolo al suo cammino"; e, ancora, fino ad illuminare il suo presente storico, scrive con lucidità e spirito critico: "(...) La quarta guerra nazionale dei contadini è il brigantaggio. Anche qui, l’umile Italia storicamente aveva torto, e doveva perdere. Non aveva armi forgiate da Vulcano, né cannoni, come l’altra Italia. E non aveva dèi: che cosa poteva fare una povera Madonna dal viso nero contro lo Stato Etico degli hegeliani di Napoli" (C. Levi, Cristo..., cit., pp. 123-125).
"La prima di esse [delle guerre nazionali] è quella di Enea. Una storia mitologica deve avere delle fonti mitologiche; e in questo senso, Virgilio è un grande storico. I conquistatori fenici, che venivano da Troia, portavano con sé tutti i valori opposti a quelli della antica civiltà contadina. Portavano la religione e lo Stato, la religione dello Stato. (...) Poi venne Roma, e perfezionò la teocrazia statale e militare dei suoi fondatori troiani, che, vincitori, avevano però dovuto accogliere la lingua e il costume dei vinti. E Roma si urtò anch’essa nella difesa contadina, e la lunga serie delle guerre italiche fu il più duro ostacolo al suo cammino"; e, ancora, fino ad illuminare il suo presente storico, scrive con lucidità e spirito critico: "(...) La quarta guerra nazionale dei contadini è il brigantaggio. Anche qui, l’umile Italia storicamente aveva torto, e doveva perdere. Non aveva armi forgiate da Vulcano, né cannoni, come l’altra Italia. E non aveva dèi: che cosa poteva fare una povera Madonna dal viso nero contro lo Stato Etico degli hegeliani di Napoli" (C. Levi, Cristo..., cit., pp. 123-125).
- "PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA ... VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITA’ POMPOSA. Alcune note su un testo del Muratori
La pia ipocrisia di Enea eroe di regime
Una rilettura del personaggio virgiliano dall’abbandono di Didone al mito di Augusto
di Gustavo Zagrebelsky (la Repubblica, 14.05.2015)
- L’intervento di Zagrebelsky che in parte anticipiamo verrà letto stasera a Bologna (ore 21, aula magna di Santa Lucia, via Castiglione 36) nell’ambito della XIV edizione de “I Classici”, intitolata “Homo sum” Gli altri incontri sono il 21, con Massimo Cacciari, e il 28, con Ivano Dionigi
SIAMO sinceri! Enea non ci piace. Se dovessimo fare una graduatoria tra i personaggi dell’epopea troiana, in cima metteremmo probabilmente non lo spocchioso Achille, ma “il domator di cavalli Ettorre” dell’ Iliade. In fondo alla graduatoria, metteremmo proprio Enea il “pio”. In mezzo, l’astuto e inquieto Ulisse. Questo nostro atteggiamento ci dice che sono mutati i paradigmi. Ciò che piaceva allora, oggi infastidisce. E, in primo luogo, non ci piace la poesia al servizio del potere. Neppure Virgilio, infatti, ci è mai troppo piaciuto, perché fece della sua arte strumento di persuasione politica. Scrive bene, è levigato. Ma non riusciamo a dimenticare che è stato un poeta di regime, stipendiato dal committente interessato a farsi tessere panegirici «di natura quasi mussoliniana» (Canfora). Il suo eroe letterario è Enea, ma l’eroe politico è Augusto, il destinatario del mito. Instauratore il primo; restauratore, il secondo, dopo i torbidi delle guerre civili e il disfacimento della Repubblica. Non una poesia civile, ma una poesia interessata, dunque, e, perciò malsana.
“Pio” è Enea, anzi di più: la pietas è la ragione della sua esistenza. Questa pietas è ciò che Virgilio propone come la virtù del principe. Gli Dei sono sensibili alle prove di pietas e rispondono con due prodigi archetipici, il fuoco che non brucia e la stella cometa. Entrambi riguardano il piccolo Ascanio e lo consacrano come il capostipite della gens di Augusto. Dentro Ascanio c’è dunque il futuro di Roma.
Ma, sulla strada accidentata verso la nuova patria, Enea incontra la contraddizione maggiore: eros. Eros e pietas sono nemici. Eros impone la sosta; pietas , la partenza. È la storia con Didone, cui è attribuito uno spazio capitale nell’architettura del poema. Anche Ulisse, nel ritorno verso la “petrosa Itaca”, incontra l’amore. È la storia di Calipso. Dopo la caduta di Troia, tutti e due hanno una missione, ma molto diversa: il ritorno alla casa di Itaca; la fondazione di un regno nel Lazio. La differenza è grande.
L’ Odissea è l’epopea delle radici; l’Eneide, della potenza politica. Odisseo deve ritornare per ricostruire la sua casa e trovare la sua pace. Il disegno di Enea è fondare un regno guerriero, sulle rovine d’altri regni. Di più: il ritorno a Itaca è il compito che Ulisse dà a se stesso da se stesso. Per Enea è diverso: egli, “profugo del fato”, ma salvato dagli Dei, è portatore d’un destino che gli è imposto dalla sentenza di Zeus. La sua pietas è la soggezione fedele a questo destino. Basta mettere a confronto l’Ulisse nell’isola di Calipso e l’Enea nella città di Didone. Dopo sette anni di amori, Ulisse è preso dalla nostalgia della sua casa che Calipso non era riuscita a fargli dimenticare. Una forza irresistibile nasce dentro di sé, che lo chiama alla partenza. “Dentro di sé”: Ulisse è artefice delle sue proprie fortune e sfortune. Piange, Ulisse, in preda a vivo dolore, come quando la scelta sembra impossibile.
Ben diverso il distacco tragico e lacerante dell’eroe da Didone. Enea è costretto a lasciare Cartagine e la fuga, che a Didone appare come la crudele ricompensa del bene ricevuto, non può che essere da lei tacciata di perfidia: «La lealtà non è più al sicuro», dice la regina. Ma Virgilio ci fa sentire anche la voce di Enea; e lo fa in un verso emblematico: «Arde di andarsene via e di lasciare quelle amate regioni». Nella prima metà del verso vediamo Enea con gli occhi di Didone: un uomo che non vede l’ora di andarsene; nella seconda metà del verso, vediamo invece Enea con gli occhi di Enea stesso: ne è spia un aggettivo, «amate ( dulcis) regioni», che Virgilio usa tutte le volte che deve esprimere lo strazio dell’abbandono. Partire, dunque, non è la sua vera volontà, e l’Italia, checché ne dicano gli Dei, potrà essere la sua nuova patria, ma non sarà mai veramente il suo amor. E qui sta la pietas come virtù che sacrifica il singolo e i suoi sentimenti. Il desiderio di Enea sarebbe un altro, però, e lo dice, cercando di giustificarsi con Didone viva («non inseguo di mia volontà l’Italia») e con Didone morta: nell’ultimo e impossibile dialogo con l’ombra della regina, Enea dirà: «Dalla tua terra, regina, sono partito contro la mia volontà».
Aleggia, su questa storia, l’ombra dell’ipocrisia. In verità, Enea è dipinto con i tratti del codardo, al quale importa soltanto di salvare la faccia: vuole consolare “con giuste parole”, mostra grande amore, dice che non è colpa sua. Non segue di sua volontà l’Italia. Però, di nascosto fa preparare la flotta per partire. Sarà pure per evitare ch’ella faccia bruciare le navi: resta il fatto che è Didone che lo affronta e, forse, se non l’avesse fatto, se ne sarebbe andato alla chetichella.
La dedizione totale al fato si accompagna al cinismo verso chi ama. Piacerebbe poter pensare che nell’episodio di Didone sia nascosto un messaggio a non esagerare nella pietas spietata di cui Enea è campione: un messaggio rivolto ai potenti dell’Impero.
Didone è solo la prima vittima di una lunga serie di ammazzamenti. Il progetto della Roma fondata dai discendenti dei Troiani si scontra con l’ordine dei Latini, ed è la guerra; una guerra che, in certo senso, è una guerra civile ante litteram, perché i due popoli sono destinati a fondersi. Il poema si chiude con l’uccisione di Turno, il re dei Rutuli, rivale di Enea. Turno, vicino a essere ucciso, ricorda a Enea il suo vecchio padre Anchise. Ed Enea sembra quasi rinunciare a sferrare il colpo fatale: Turno, infatti, è subiectus, sottomesso; e l’indicazione che Enea ha ricevuto da Anchise è di «avere pietà di chi si sottomette». Poi però qualcosa trasforma Enea: l’ultima immagine che ne riceviamo è quella di lui che, «infiammato di rabbia furibonda» per avere visto il bàlteo, la cintura di cuoio che era stata di Pallante, il suo alleato, pendere dalla spalla del suo nemico, l’uccide. Il pio Enea non rifugge dalla vendetta, dall’inutile crudeltà.
Alla fine, siamo dunque consapevoli del potenziale di violenza che la fedeltà assoluta alla propria patria, ai propri dei, ai propri penati implica: una pietas empia per chi sta fuori di quelle cerchie. E che l’apologeta cristiano del III secolo Lattanzio rimprovera senza mezzi termini a Virgilio: «Non sapevi che cosa fosse la pietas, e hai ritenuto che proprio ciò che quello ha compiuto in modo disumano e odioso fosse un dovere imposto dalla pietà. Chi potrebbe dunque attribuire a Enea anche un briciolo di valore, lui che si è acceso di rabbia come paglia dimenticando lo spirito del padre, nel cui nome veniva supplicato, non è stato capace di tenere a freno l’ira? Non è affatto pius chi uccide qualcuno che non solo ha deposto le armi, ma gli rivolge una preghiera. La pietas è quella di chi non conosce guerre, di chi è in armonia con tutti, di chi è amico anche dei propri nemici, di chi ama tutti gli uomini come fratelli». Così, entriamo in un nuovo mondo segnato dalla fratellanza universale, un mondo in cui alla pietas imperiale si contrappone la charitas cristiana.
* Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- CRISTO SI É FERMATO A OVEST (di U. Galimberti)27 luglio 2015, di Federico La Sala
CRISTO SI É FERMATO A OVEST
RISPONDE Umberto Galimberti (La Repubblica - D, 24.07.2015)
Molte sono le ragioni storiche che hanno fatto dell’Occidente la culla della religione cristiana. E una è la conseguenza: un destino comune
- Mi chiedo perché
il cristianesimo, o se vogliamo la tradizione giudaico-cristiana, abbia attecchito esclusivamente
in quella parte di mondo
che definiamo occidentale
e che all’epoca era caratterizzata dall’essere
di matrice ellenico-romana,
e non altrove? Certo, poi il cristianesimo è stato esportato, ma questo riguarda dinamiche affatto diverse. Quindi non possiamo sentirci autorizzati
a pensare che, il cristianesimo stesso fosse "congruente"
col substrato culturale ove
si è poi effettivamente annidato,
non riuscendo a impiantarsi
in modo significativo là dove questa possibilità era assente? «Cristianesimo e Occidente sono nati insieme, hanno avuto nel bene e nel male la stessa storia, avranno perciò lo stesso destino»: parole, le sue,
che mi sento di condividere;
allo stesso modo, tuttavia, potremmo dire che non
solo l’Occidente deve alla cristianità i suoi valori fondanti, ma che il cristianesimo
deve all’Occidente la sua
stessa sopravvivenza.
 Valentino Signorini
Valentino Signorini
 signorinivalentino@virgilio.it
signorinivalentino@virgilio.it
Le ragioni per cui il cristianesimo è nato nell’area mediterranea che possiamo considerare la culla dell’Occidente sono diverse e tra loro convergenti:
 1. La prima è che il cristianesimo è una variante dell’ebraismo. Come dice più esplicitamente Nietzsche, un’«eresia ebraica». Con tale matrice il cristianesimo rimane confuso, agli occhi di Roma, almeno fino al 111 d. C. quando Plinio il Giovane, in qualità di Governatore di Bitinia e Ponto, chiede all’imperatore Traiano come si deve comportare nei confronti di una setta che non si definisce ebrea, ma cristiana. Quindi anche tutte le persecuzioni che prima di quella data i cristiani si attribuiscono, sono in realtà persecuzioni degli ebrei, la cui religione, accanto a quella ellenico-romana, era la più diffusa nel Mediterraneo.
1. La prima è che il cristianesimo è una variante dell’ebraismo. Come dice più esplicitamente Nietzsche, un’«eresia ebraica». Con tale matrice il cristianesimo rimane confuso, agli occhi di Roma, almeno fino al 111 d. C. quando Plinio il Giovane, in qualità di Governatore di Bitinia e Ponto, chiede all’imperatore Traiano come si deve comportare nei confronti di una setta che non si definisce ebrea, ma cristiana. Quindi anche tutte le persecuzioni che prima di quella data i cristiani si attribuiscono, sono in realtà persecuzioni degli ebrei, la cui religione, accanto a quella ellenico-romana, era la più diffusa nel Mediterraneo.
 2. Il cristianesimo si allargò oltre l’ebraismo, nel mondo pagano, dopo l’accesa contesa al Concilio di Gerusalemme verso il 50 d.C., tra Paolo di Tarso e Pietro che, contro il parere del primo, voleva estendere ai pagani convertiti l’applicazione della legge mosaica. Paolo, che parlava ebraico, greco e latino, fu il primo, con le lettere, a gettare le basi teologiche del cristianesimo e secondo Nietzsche - e non solo - fu il vero fondatore del cristianesimo, che altrimenti si sarebbe estinto con la morte dei discepoli di Gesù.
2. Il cristianesimo si allargò oltre l’ebraismo, nel mondo pagano, dopo l’accesa contesa al Concilio di Gerusalemme verso il 50 d.C., tra Paolo di Tarso e Pietro che, contro il parere del primo, voleva estendere ai pagani convertiti l’applicazione della legge mosaica. Paolo, che parlava ebraico, greco e latino, fu il primo, con le lettere, a gettare le basi teologiche del cristianesimo e secondo Nietzsche - e non solo - fu il vero fondatore del cristianesimo, che altrimenti si sarebbe estinto con la morte dei discepoli di Gesù.
 3. Sempre nella culla del Mediterraneo si era diffusa la religione gnostica, che fondeva in una visione tragico-nichilista di un Dio dimentico delle sue creature motivi delle religioni misteriche e dello zoroastrismo e credenze religiose pre-cristiane e giudaiche, successivamente composte con la filosofia platonica e neoplatonica. La gnosi, con le sue scuole, i suoi maestri, le sue accademie, l’ultima delle quali fu chiusa nel 529 da Giustiniano, era diffusa nell’area che va dalla Persia all’Egitto, passando per le terre babilonesi, turche, siriache, greche.
3. Sempre nella culla del Mediterraneo si era diffusa la religione gnostica, che fondeva in una visione tragico-nichilista di un Dio dimentico delle sue creature motivi delle religioni misteriche e dello zoroastrismo e credenze religiose pre-cristiane e giudaiche, successivamente composte con la filosofia platonica e neoplatonica. La gnosi, con le sue scuole, i suoi maestri, le sue accademie, l’ultima delle quali fu chiusa nel 529 da Giustiniano, era diffusa nell’area che va dalla Persia all’Egitto, passando per le terre babilonesi, turche, siriache, greche.
 4. Per combattere la Gnosi i Padri della Chiesa ritennero di dover dare un fondamento teologico al cristianesimo, almeno altrettanto solido quanto quello di cui disponeva la Gnosi. E allo scopo adottarono la filosofia di Platone, che per la sua concezione dualistica di un cielo iperuranico e un mondo sensibile che a quel cielo doveva adeguarsi, meglio si prestava alla concezione cristiana che prevedeva una città terrena e una celeste (come vuole l’opera di Agostino d’Ippona, che spostò l’asse della filosofia di Platone dal registro della conoscenza al registro della salvezza). Il recupero della filosofia di Aristotele avvenne mille anni dopo con Tommaso d’Aquino e ancora oggi la teologia cristiana è ricalcata sul modello della filosofia platonico-aristotelica che non ha alcuna relazione col messaggio evangelico che parla d’amore e carità.
4. Per combattere la Gnosi i Padri della Chiesa ritennero di dover dare un fondamento teologico al cristianesimo, almeno altrettanto solido quanto quello di cui disponeva la Gnosi. E allo scopo adottarono la filosofia di Platone, che per la sua concezione dualistica di un cielo iperuranico e un mondo sensibile che a quel cielo doveva adeguarsi, meglio si prestava alla concezione cristiana che prevedeva una città terrena e una celeste (come vuole l’opera di Agostino d’Ippona, che spostò l’asse della filosofia di Platone dal registro della conoscenza al registro della salvezza). Il recupero della filosofia di Aristotele avvenne mille anni dopo con Tommaso d’Aquino e ancora oggi la teologia cristiana è ricalcata sul modello della filosofia platonico-aristotelica che non ha alcuna relazione col messaggio evangelico che parla d’amore e carità.
 5. Il resto è storia nota. Nel 391, con Teodosio, il Cristianesimo diventa religione di Stato, e nel 476, quando l’Impero Romano d’Occidente cade definitivamente, la Chiesa cristiana, che nel frattempo aveva ereditato la cultura giuridica e amministrativa dell’Impero Romano, prende a governare materialmente e spiritualmente l’Occidente, diffondendo quei valori di libertà («non devono più esserci né schiavi né padroni»), di uguaglianza («siamo tutti figli di Dio») e di fraternità («ama il prossimo tuo come te stesso»), mai attuati nella storia governata dalla Chiesa, ma riproposti in versione laica dalla Rivoluzione francese e tuttora in via di faticosa attuazione. Possiamo allora concludere con Baget Bozzo che Occidente e cristianesimo, per essere nati l’uno con l’altro, avranno ineluttabilmente lo stesso destino.
5. Il resto è storia nota. Nel 391, con Teodosio, il Cristianesimo diventa religione di Stato, e nel 476, quando l’Impero Romano d’Occidente cade definitivamente, la Chiesa cristiana, che nel frattempo aveva ereditato la cultura giuridica e amministrativa dell’Impero Romano, prende a governare materialmente e spiritualmente l’Occidente, diffondendo quei valori di libertà («non devono più esserci né schiavi né padroni»), di uguaglianza («siamo tutti figli di Dio») e di fraternità («ama il prossimo tuo come te stesso»), mai attuati nella storia governata dalla Chiesa, ma riproposti in versione laica dalla Rivoluzione francese e tuttora in via di faticosa attuazione. Possiamo allora concludere con Baget Bozzo che Occidente e cristianesimo, per essere nati l’uno con l’altro, avranno ineluttabilmente lo stesso destino. - Mi chiedo perché
il cristianesimo, o se vogliamo la tradizione giudaico-cristiana, abbia attecchito esclusivamente
in quella parte di mondo
che definiamo occidentale
e che all’epoca era caratterizzata dall’essere
di matrice ellenico-romana,
e non altrove? Certo, poi il cristianesimo è stato esportato, ma questo riguarda dinamiche affatto diverse. Quindi non possiamo sentirci autorizzati
a pensare che, il cristianesimo stesso fosse "congruente"
col substrato culturale ove
si è poi effettivamente annidato,
non riuscendo a impiantarsi
in modo significativo là dove questa possibilità era assente? «Cristianesimo e Occidente sono nati insieme, hanno avuto nel bene e nel male la stessa storia, avranno perciò lo stesso destino»: parole, le sue,
che mi sento di condividere;
allo stesso modo, tuttavia, potremmo dire che non
solo l’Occidente deve alla cristianità i suoi valori fondanti, ma che il cristianesimo
deve all’Occidente la sua
stessa sopravvivenza.
- LA LEZIONE DI CARLO LEVI - OGGI:
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Il Doomsday Clock, l’Orologio della Apocalisse, per il 2015, indica che mancano solo 3 minuti alla mezzanotte (di Gino Strada)23 febbraio 2015, di Federico La SalaNel 1947 il Bulletin of the Atomic Scientists di Chicago, rivista fondata due anni addietro da scienziati del calibro di Einstein, Oppenheimer, Bohr, Russell, propone un orologio virtuale per indicare quanto tempo separa l’umanità dalla catastrofe globale, dall’inverno nucleare: è il Doomsday Clock, l’Orologio della Apocalisse.
 Allora, due anni dopo le bombe di Hiroshima e Nagasaki, le lancette dell’orologio furono fissate alle 23 e 53 minuti. Solo sette minuti a quella mezzanotte cui non sarebbe seguito un nuovo giorno.
Allora, due anni dopo le bombe di Hiroshima e Nagasaki, le lancette dell’orologio furono fissate alle 23 e 53 minuti. Solo sette minuti a quella mezzanotte cui non sarebbe seguito un nuovo giorno.
 Gli scienziati atomici ogni anno “aggiornano” l’orologio: per il 2015 hanno scritto “L’orologio indica che mancano solo 3 minuti alla mezzanotte perché i leaders internazionali non adempiono al loro compito fondamentale, quello di assicurare e preservare la salute e la possibilità di vita della civiltà umana”. (Gino Strada)
Gli scienziati atomici ogni anno “aggiornano” l’orologio: per il 2015 hanno scritto “L’orologio indica che mancano solo 3 minuti alla mezzanotte perché i leaders internazionali non adempiono al loro compito fondamentale, quello di assicurare e preservare la salute e la possibilità di vita della civiltà umana”. (Gino Strada)
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- LA LEZIONE DI CARLO LEVI - OGGI. Un invito alla ri-lettura di "Cristo si è fermato ad Eboli".21 gennaio 2015, di Federico La Sala
LA LEZIONE DI CARLO LEVI - OGGI. Un invito alla ri-lettura di "Cristo si è fermato ad Eboli".
di Federico La Sala
ALLA LUCE del nostro tempestoso presente storico (e della "barbarie ritornata"), non è male (mia opinione e mio invito) rileggere il ricco e complesso lavoro sociologico-politico (altro che "romanzo"!) di Carlo Levi, “Cristo si è fermato ad Eboli”, e soffermarsi - in particolare - sul passaggio relativo alla “Ditta Renzi - Torino”, alle tasse, e alle capre (pp. 40-42, Einaudi, Torino 2010 - in rete):
- ALIANO (MATERA). "Dopo la piazza, la strada risaliva, superava un costone, e ridiscendeva in un’altra minuscola piazzetta, circondata di case basse. In mezzo alla piazza si ergeva uno strano monumento, alto quasi quanto le case, e, nell’angustia del luogo, solenne ed enorme. Era un pisciatoio: il più moderno, sontuoso, monumentale pisciatoio che si potesse immaginare; uno di quelli di cemento armato, a quattro posti, con il tetto robusto e sporgente, che si sono costruiti soltanto in questi ultimi anni nelle grandi città. Sulla sua parete spiccava come una epigrafe un nome familiare al cuore dei cittadini: "Ditta Renzi - Torino".
 Quale bizzarra circostanza, o quale incantatore o quale fata poteva aver portato per l’aria, dai lontani paesi del nord, quel meraviglioso oggetto, e averlo lasciato cadere, come un meteorite, nel bel mezzo della piazza di questo villaggio, in una terra dove non c’è acqua né impianti igienici di nessuna specie, per centinaia di chilometri tutto attorno?
Quale bizzarra circostanza, o quale incantatore o quale fata poteva aver portato per l’aria, dai lontani paesi del nord, quel meraviglioso oggetto, e averlo lasciato cadere, come un meteorite, nel bel mezzo della piazza di questo villaggio, in una terra dove non c’è acqua né impianti igienici di nessuna specie, per centinaia di chilometri tutto attorno?
 Era l’opera del regime, del podestà Magalone. Doveva essere costato, a giudicare dalla sua mole, le entrate di parecchi anni del comune di Gagliano.
Era l’opera del regime, del podestà Magalone. Doveva essere costato, a giudicare dalla sua mole, le entrate di parecchi anni del comune di Gagliano.
 Mi affacciai al suo interno: da un lato un maiale stava bevendo l’acqua ferma nel fondo del vaso, dall’altro due ragazzi ci buttavano barche di carta.
Mi affacciai al suo interno: da un lato un maiale stava bevendo l’acqua ferma nel fondo del vaso, dall’altro due ragazzi ci buttavano barche di carta.
 Nel corso di tutto l’anno non lo vidi mai adibito ad altra funzione, né abitato da altri che non fossero maiali, cani, galline, o bambini; se non la sera della festa della Madonna di settembre, in cui alcuni contadini si arrampicarono sul suo tetto per meglio godere, da quell’altezza, lo spettacolo dei fuochi artificiali.
Nel corso di tutto l’anno non lo vidi mai adibito ad altra funzione, né abitato da altri che non fossero maiali, cani, galline, o bambini; se non la sera della festa della Madonna di settembre, in cui alcuni contadini si arrampicarono sul suo tetto per meglio godere, da quell’altezza, lo spettacolo dei fuochi artificiali.
 Una sola persona lo usò spesso per l’uso per cui era stato costruito; e quella persona ero io: e non l’usavo, debbo confessarlo, spinto dal bisogno, ma mosso dalla nostalgia.
Una sola persona lo usò spesso per l’uso per cui era stato costruito; e quella persona ero io: e non l’usavo, debbo confessarlo, spinto dal bisogno, ma mosso dalla nostalgia.
 A un angolo della piazzetta, dove quasi giungeva l’ombra lunga del monumento, uno zoppo, vestito di nero, con un viso secco, serio, sacerdotale, sottile come quello di una faina, soffiava come un mantice nel corpo di una capra morta. Mi fermai a guardarlo (...)".
A un angolo della piazzetta, dove quasi giungeva l’ombra lunga del monumento, uno zoppo, vestito di nero, con un viso secco, serio, sacerdotale, sottile come quello di una faina, soffiava come un mantice nel corpo di una capra morta. Mi fermai a guardarlo (...)".
Il ’passaggio’ offre un ‘cortocircuito’ tra la "Ditta Renzi" di ieri (1935-1936) e la "Ditta Renzi" di oggi (1994-2014), una sintesi eccezionale della "cecità" di lunga durata delle classi "dirigenti" del nostro Paese, e ricorda a tutti e a tutte come e quanto, ieri come oggi, ” (...) quello che noi chiamiamo questione meridionale non è altro che il problema dello Stato (...) (p. 220, cit.). E non solo: "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010)!
Il discorso è di lunga durata e investe le strutture stesse dellla cultura europea e planetaria: nel Cristo si è fermato a Eboli, c’è "la scoperta prima di un mondo nascente e delle sue dimensioni, e del rapporto di amore che solo rende possibile la conoscenza" (C. Levi, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia, "Introduzione" [1955], Einaudi, Torino 1978).
A mio parere, il lavoro (non solo questo! Si veda almeno anche "Paura della libertà", scritto in Francia nel 1939 - dopo il confino in Basilicata - e pubblicato nel 1946, dopo la scrittura nel 1942-1943 e la pubblicazione nel 1945 del suo capolavoro) di Carlo Levi, è ancora tutto da leggere e da rimeditare - assolutamente; è nell’ottica di una visione inaudita e inedita della storia, per molti versi (per intendersi e orientarsi) vicina a Giambattista Vico* e a Walter Benjamin*.
- WALTER BENJAMIN. "Noi oggi capiremmo ben poco di quelle pagine [cioè, di Paura della libertà] se non le collocassimo in un contesto complesso. Quando Levi stende le sue note in una sorta di finis terrae che potrebbe accomunarlo alla condizione di Benjamin, la scena del mondo è estremamente confusa. Lo spazio della critica e della riflessione autonoma a sinistra è di fatto azzerato. Sono i mesi del patto Molotov-Ribbentrop, della criminalizzazione di Paul Nizan, da parte del Pcf per il suo rifiuto di aderire alla svolta staliniana del patto tedesco-sovietico, delle lacerazioni tra cultura della pace e necessità della guerra" (cfr. David Bidussa, Prima di Eboli. La riflessione civile e politica di Carlo Levi negli anni del fascismo e dei totalitarismi, in: Carlo Levi, Scritti politici, a c. di D. Bidussa, Einaudi, Torino 2001, p. xxvi, senza le note).
- GIAMBATTISTA VICO. "1939 settembre-dicembre. Costretto a fuggire in Francia, è a La Baule, presso St. Nazaire in Bretagna. Qui scrive in compagnia di Vico e della Bibbia, Paura della libertà" (cfr. Gigliola De Donato - Sergio D’Amaro, Un torinese del sud: Carlo Levi. Una biografia, Baldini e Castoldi, Milano 2001, p. 353). *
Al di là dei vari storicismi idealistici o materialistici, con grande consapevolezza filosofica e teologico-politica, in un passaggio sul nodo della civiltà contadina e delle sue guerre ("le sue guerre nazionali") e della storia "di quello che non si svolge nel tempo: la sola storia di quello che è eterno e immutabile, una mitologia", così scrive, contro lo Stato Etico degli hegeliani di Napoli (come di Torino):
"La prima di esse [delle guerre nazionali] è quella di Enea. Una storia mitologica deve avere delle fonti mitologiche; e in questo senso, Virgilio è un grande storico. I conquistatori fenici, che venivano da Troia, portavano con sé tutti i valori opposti a quelli della antica civiltà contadina. Portavano la religione e lo Stato, la religione dello Stato. (...) Poi venne Roma, e perfezionò la teocrazia statale e militare dei suoi fondatori troiani, che, vincitori, avevano però dovuto accogliere la lingua e il costume dei vinti. E Roma si urtò anch’essa nella difesa contadina, e la lunga serie delle guerre italiche fu il più duro ostacolo al suo cammino"; e, ancora, fino ad illuminare il suo presente storico, scrive con lucidità e spirito critico: "(...) La quarta guerra nazionale dei contadini è il brigantaggio. Anche qui, l’umile Italia storicamente aveva torto, e doveva perdere. Non aveva armi forgiate da Vulcano, né cannoni, come l’altra Italia. E non aveva dèi: che cosa poteva fare una povera Madonna dal viso nero contro lo Stato Etico degli hegeliani di Napoli" (C. Levi, Cristo..., cit., pp. 123-125).
- MADONNA DI VIGGIANO E ROOSEVELT. "Ma quello che ogni volta mi colpiva (ed ero stato ormai nella maggior parte delle case) erano gli sguardi fissi su di me, dal muro sopra il letto, dei due inseparabili numi tutelari. Da un lato c’era la faccia negra e aggrondata e gli occhi larghi e disumani della Madonna di Viggiano: dall’altra, a riscontro, gli occhietti vispi dietro gli occhiali lucidi e la gran chiostra dei denti aperti nella risata cordiale del Presidente Roosevelt, in una stampa colorata. Non ho mai visto, in nessuna casa, altre immagini: né il Re, né il Duce, né tanto meno Garibaldi, o qualche altro grand’uomo nostrano, e neppure nessuno dei santi, che pure avrebbero avuto qualche buona ragione per esserci: ma Roosevelt e la Madonna di Viggiano non mancavano mai. (...) A volte, una terza immagine formava, con quelle due, una sorta di trinità: un dollaro di carta, l’ultimo di quelli portati di laggiù, o arrivato in una lettera del marito o di un parente, stava attaccato al muro con una puntina sotto alla Madonna o al Presidente o tra l’uno e l’altro, come uno Spirito Santo, o un ambasciatore del cielo nel regno dei morti.
 Per la gente di Lucania, Roma non è nulla (...) Non Roma o Napoli, ma New York sarebbe la vera capitale dei contadini di Lucania, se mai questi uomini senza Stato potessero averne una" (op. cit., pp. 107-108,).
Per la gente di Lucania, Roma non è nulla (...) Non Roma o Napoli, ma New York sarebbe la vera capitale dei contadini di Lucania, se mai questi uomini senza Stato potessero averne una" (op. cit., pp. 107-108,).
Detto diversamente, egli ha ben compreso - come scrive all’editore Einaudi nel 1963 - non solo "la Lucania che è in ciascuno di noi", ma anche "tutte le Lucanie di ogni angolo della terra". Nato a Torino (29 novembre 1902) e morto a Roma (4 gennaio 1975), ora riposa nel cimitero di Aliano, nella sua Terra. A suo onore e memoria, possono valere (in un senso molto prossimo) le stesse parole del "Finnegans Wake" di Joyce, riferite a Giambattista Vico (che pure aveva vissuto molti anni, a Vatolla, ai margini della grande foresta lucana, dell’"ingens sylva"): "Prima che vi fosse un uomo in Irlanda, c’era un lord in Lucania".
Come Vico e con Vico, Carlo Levi aveva capito da dove ripartire, per affrontare da esseri umani la "Paura della libertà" (cfr. Carlo Levi, Scritti politici, cit., pp. 132-209). Una lettura meditata e criticamente assimilata della vichiana "Scienza Nuova" (a partire da quella del 1725, "che tutta incominciammo - come scrive lo stesso Vico - da quel motto: A Iove principium musae, ed ora la chiudiamo con l’altra parte: Iovis omnia plena") è alla base di questo suo primo lavoro (ripetiamo: scritto dopo il confino a Grassano e ad Aliano, e prima della scrittura - cinque anni dopo - di "Cristo si è fermato ad Eboli").
Il suo omaggio a Vico non si riduce e non è riducibile solo alle allusioni già evidenti nei titoli dei capitoli (Ab Jove principium, Sacrificio, Amor sacro e profano, Schiavitù, Le muse, Sangue, Massa, Storia sacra):
- "Ab Jove principium. E anche noi dovremmo cominciare di là, da quel punto inesistente d cui nasce ogni cosa: ma il nostro Giove non dovremo cercarlo nei cieli, ma là dove sta, nei luoghi più terrestri e oscuri, negli abissi umidi e materni. Esso assomiglia assai più a un verme che a un’aquila; ma troverà ben presto le sue aquile araldiche, e le predilegerà su ogni altro balcone o insegna, perché questo gli consentirà di non essere divorato, una volta per sempre, dalle aquile vere.
 Fuor di metafora, non potremo intendere nulla di umano se non partiremo dal senso del sacro: il più ambiguo e profondo e doppio e vermaquilino dei sensi, l’oscura continua negazione della libertà e dell’arte, e, insieme, per contrasto, il generatore continuo della libertà e dell’arte. Né potremo intendere nulla di sociale se non partiremo dal senso del religioso, questo figlio poco rispettoso del sacro" (C. Levi, Scritti politici, cit., p. 132);
Fuor di metafora, non potremo intendere nulla di umano se non partiremo dal senso del sacro: il più ambiguo e profondo e doppio e vermaquilino dei sensi, l’oscura continua negazione della libertà e dell’arte, e, insieme, per contrasto, il generatore continuo della libertà e dell’arte. Né potremo intendere nulla di sociale se non partiremo dal senso del religioso, questo figlio poco rispettoso del sacro" (C. Levi, Scritti politici, cit., p. 132);
- "Una foresta, al principio dei tempi, era, secondo il racconto, sulla faccia della terra, e copriva la faccia della terra. Quella stessa prima foresta informe e piena di germi e di terrore, nera nasconditrice di ogni volto, portiamo in noi: da essa cominciò il viaggio; la ritroviamo a mezzo cammino, con la sua paura: selva giovanile di possibilità illimitate. Fuori della creatrice libertà, ogni attività, ogni determinazione di quella infinita potenza, è una limitazione, un dolore, una fatica immensa, e il senso di una perdita irrevocabile - perché ogni religione è sacrificio e abbandono. Vagavano, secondo il mito, i primi uomini nella selva senza forma, finché si fermarono in certi luoghi, amarono certe donne, e adorarono certi dèi. Vagano tuttora gli uomini nella eterna selva, e cercano una certezza che si paga con servitù e con morte" (op. cit., p. 144).
- "Ab Jove principium Musae - dal religioso non nasce il linguaggio né la poesia, ma le divinità del linguaggio e della poesia, i simboli e i rituali dell’arte, i generi letterari, le Muse. Ma i tempi veri di libertà, nel loro passare fuggevole, foggiano la lingua e l’arte della felicità; e rimandano in cielo, con tutti gli dèi, le Muse sorelle, a celarsi in quel Padre, che tutti gli uomini hanno, allora, innocentemente dimenticato" (op. cit., p. 172)
- "Il peccato che deve finire è l’adorazione da parte dell’uomo di una cosa umana, di un idolo bestiale, che è animale araldico, mostro adorato, religione statale, guerra e schiavitù" (op. cit., p. 203);
- "Che la poetica, e così vera (ma vera soltanto nella sempre ripetuta, infinita esperienza) vicenda della Cacciata e della Redenzione e dell’Apocalisse, del sorgere cioè della religione umana e del suo liberaqrsi e finire potesse essa stessa, nella sua lettera, dogma, legge, religione, non è che una prova della profondità del racconto e della verità della sua interpretazione: poiché gli uomini incapaci di libertà non possono reggere al terrore del sacro, che agli occhi aperti si manifesta - e debbono trasformare in mistero, nascondere, adorare come un simbolo incomprensibile la rivelazione stessa, che è chiara luce di verità" (op. cit., p. 204).
Come vincere la paura della libertà, come convivere con la ingens sylva? L’incredibile è che, nel 1939, quando "un vento di morte e di oscura religione sconvolgeva gli antichi stati d’Europa" e "la bandiera tedesca fu alzata sulla torre Eiffel", Giambattista Vico è a fianco di Carlo Levi, come nel 1944, nel Lager di Wietzendorf, è a fianco di Enzo Paci - e ha aiutato entrambi a non perdere la strada e a riprendere il cammino della giustizia e della libertà.
- ENZO PACI. “Negli anni passati in Germania, in un campo di concentramento, la grande ombra di Vico venne a trovarmi e mi sembrò di sentire che tutta la sua opera era stata una lotta eroica contro la ingens sylva della barbarie (...)” (cfr.: Lettere di carteggio di Enzo Paci con B. Croce e F. Nicolini, a c. di A. Vigorelli, “Rivista di storia di filosofia”, I, 1986, p. 103).
Nel gennaio 1946, nella "Prefazione alla prima edizione" di Paura della libertà, Carlo Levi così parla (cfr. Scritti politici, cit ., pp. 218-219) della sua "confessione" (definita poi "breve poema", nel 1964, e "poema filosofico" nel 1971): "Quello che avevo scritto era all’incirca la parte introduttiva dell’opera progettata, la prefazione: ma tutti gli svolgimenti particolari che avevo avuto in animo di fare vi erano impliciti (...) mi parve che il libro contenesse già tutto quello che intendevo dire, e che non occorresse più squadernarlo esplicitamente. C’era una teoria del nazismo, anche se il nazismo non è una sola volta chiamato per nome; c’era una teoria dello Stato e della libertà; c’era una estetica, una teoria della religione e del peccato, ecc. Il libro rimase qual era, senza seguito. Lo portai con me nel ’41, di nascosto in Italia; e molti amici mi consigliarono di stamparlo subito (...) non ho cambiato neppure una parola della stesura primitiva (...) mi è parso che convenisse lasciare a questo piccolo libro (Così diverso dal mio Cristo si è fermato a Eboli, scritto cinque anni dopo) il suo tempo, che è forse il suo valore di espressione".
Federico La Sala (07.09.2014)
*
SUL PROBLEMA VICO, NEL SITO, SI cfr.:
- STORIA D’ITALIA. INTELLETTUALI E SOCIETA’....
 VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggere
VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggere
SU WALTER BENJAMIN, NEL SITO, SI cfr.:
SUL TEMA, IN GENERALE, SI cfr.:
- ALIANO (MATERA). "Dopo la piazza, la strada risaliva, superava un costone, e ridiscendeva in un’altra minuscola piazzetta, circondata di case basse. In mezzo alla piazza si ergeva uno strano monumento, alto quasi quanto le case, e, nell’angustia del luogo, solenne ed enorme. Era un pisciatoio: il più moderno, sontuoso, monumentale pisciatoio che si potesse immaginare; uno di quelli di cemento armato, a quattro posti, con il tetto robusto e sporgente, che si sono costruiti soltanto in questi ultimi anni nelle grandi città. Sulla sua parete spiccava come una epigrafe un nome familiare al cuore dei cittadini: "Ditta Renzi - Torino".
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- LA LEZIONE E L’OPERA DI CARLO LEVI TUTTA DA RIMEDITARE.30 luglio 2014, di Federico La Sala
Sul tema, mi permetto di invitare a rileggere il ricco e complesso lavoro sociologico-politico (altro che "romanzo"!) di Carlo Levi, “Cristo si è fermato ad Eboli”, e a soffermarsi - in particolare - sul passaggio relativo al tema della civiltà contadina e delle sue guerre ("le sue guerre nazionali") e della storia "di quello che non si svolge nel tempo: la sola storia di quello che è eterno e immutabile, una mitologia (...) (pp. 123, ed. Einaudi: testo integrale disponibile al link: http://lnx.polocorese.it/phpnuke/upload/ebook/Carlo-Levi-CRISTO-SI-E’-FERMATO-A-EBOLI.pdf).
E, poco oltre, così prosegue: "La prima di esse [delle guerre nazionali] è quella di Enea. Una storia mitologica deve avere delle fonti mitologiche; e in questo senso, Virgilio è un grande storico. I conquistatori fenici, che venivano da Troia, portavano con sé tutti i valori opposti a quelli della antica civiltà contadina. Portavano la religione e lo Stato, la religione dello Stato. (...) Poi venne Roma, e perfezionò la teocrazia statale e militare dei suoi fondatori troiani, che, vincitori, avevano però dovuto accogliere la lingua e il costume dei vinti. E Roma si urtò anch’essa nella difesa contadina, e la lunga serie delle guerre italiche fu il più duro ostacolo al suo cammino (pp. 123-124, cit.); e, ancora, fino ad illuminare il suo presente storico, scrive con lucidità e spirito critico: "(...) La quarta guerra nazionale dei contadini è il brigantaggio. Anche qui, l’umile Italia storicamente aveva torto, e doveva perdere. Non aveva armi forgiate da Vulcano, né cannoni, come l’altra Italia. E non aveva dèi: che cosa poteva fare una povera Madonna dal viso nero contro lo Stato Etico degli hegeliani di Napoli" (p. 125)
Al di là dei vari storicismi idealistici o materialistici, a mio parere, il lavoro (non solo questo! Si veda almeno "Paura della libertà", scritto - dopo il confino - nel 1939 e pubblicato da Einaudi nel 1946) di Carlo Levi, è ancora da leggere e da rimeditare, oggi! - assolutamente profetico; è nell’ottica di una visione inaudita e inedita della storia, per molti versi (per intendersi e orientarsi) vicina a Giambattista Vico* e a Walter Benjanin*.
Federico La Sala
*
SUL PROBLEMA VICO (E, IN PARTICOLARE, SULL’INTERPRETAZIONE DI BENEDETTO CROCE DELL’OPERA DI VICO), SI VEDA NEL SITO:
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5737
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5737 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?
id_article=5634
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?
id_article=5634SULLA CONCEZIONE DELLA STORIA DI WALTER BENJAMIN, SI VEDA NEL SITO:
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/IMG/pdf/IMG-13.pdf
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/IMG/pdf/IMG-13.pdf -
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- Il cavallo di Troia era Enea. Una riscrittura marchia come traditore l’eroe di Virgilio (di Luciano Canfora)20 aprile 2014, di Federico La Sala
Il cavallo di Troia era Enea
Una riscrittura marchia come traditore l’eroe di Virgilio
di Luciano Canfora (Corriere della Sera - La Lettura, 20.04.2014)
Nel mondo greco e romano, cristiano e bizantino, la continuazione di un’opera storiografica precedente fu la norma. Così si venne costituendo un vero e proprio «ciclo» storico, di cui sono giunti a noi soltanto singoli spezzoni. Ma in realtà tutto incomincia con Omero. Nel caso dell’Iliade i problemi si complicano. Intorno al grande poema - che tratta di un periodo brevissimo, e neanche conclusivo, della guerra dei Greci contro la grande potenza microasiatica di Troia (XI secolo a.C.) - fiorì, ben più tardi, una serie di poemi che ne completavano il racconto: ad esempio con l’arrivo di Pentesilea e delle sue Amazzoni sopraggiunte in aiuto dei Troiani dopo la morte di Ettore. Altri poemi raccontavano altri «ritorni» meno famosi di quello di Odisseo.
Non ci si avventurava però a raccontare con pari ampiezza i presupposti dell’Iliade , che infatti comincia in medias res, quando ormai i Greci hanno alle spalle ben nove anni di guerra logorante. A ricostruire l’intera vicenda, risalendo addirittura a una prima guerra di Troia condotta dai Greci contro il padre di Priamo e seguitando oltre l’Iliade fino alla cattura proditoria e alla distruzione di Troia, provvide un simpatico falsario (forse databile all’inizio della nostra era) che si celò dietro il nome di Darete Frigio.
Darete, sacerdote di Efesto e padre di due combattenti troiani sgominati dal greco Diomede all’inizio del V libro dell’Iliade , costituiva un’ottima «copertura» per suggerire ai lettori che questa narrazione proveniva addirittura da un contemporaneo, testimone diretto dei fatti narrati, diversamente da Omero, vissuto secoli dopo.
Un altro celebre falsario, Tolomeo Chenno (I d.C.), è il primo a far cenno a una «Iliade Frigia». A noi è giunta in versione latina una Daretis Phrygii De excidio Troiae historia , citata per la prima volta da Isidoro di Siviglia (VI d.C.) e forse nata non molto prima.
Per gabellarsi come antica, l’opera è preceduta da una lettera di Cornelio Nepote a Sallustio, recante l’inverosimile notizia della scoperta dell’autografo di Darete! Nel Medioevo latino ebbe un successo enorme, a giudicare dai molti manoscritti del X secolo.
Nel XIII secolo fa capolino addirittura una versione più ampia, scoperta da Courtney nel 1955. Ora, per Castelvecchi editore, l’opera appare ritradotta con brillantezza e qua e là compendiata da Luca Canali (Storia della distruzione di Troia ); segue un ottimo corredo di note a cura di Nicoletta Canzio.
Naturalmente il cosiddetto Darete non sa nulla dei nove anni non narrati da Omero. Perciò il suo racconto è straripante di dettagli per quel che attiene agli antefatti della guerra, è poverissimo sui nove anni che precedono l’Iliade , è rapido nel riassumere quanto narrato nell’Iliade ed è invece originalissimo, oltre che fantasioso, per quel che riguarda il finale della vicenda, antitetico rispetto a quanto racconta Virgilio nel II libro dell’Eneide .
L’originalità del libro di Darete, a suo modo un antenato del romanzo storico, consiste nell’andare controcorrente rispetto alla tradizione. Per lui, le ragioni dei Troiani sono molto forti; il ratto di Elena era ben poca cosa rispetto ai torti dei Greci, già responsabili di una prima devastazione di Troia; Priamo non fu per nulla scontento dell’arrivo a corte di Elena (di cui l’autore segnala le bellissime gambe); spiritosi i vari ritratti dei personaggi femminili (Briseide era «deliziosa, ma pudica», Andromaca era «alta, casta, ma gradevole», Cassandra «di statura media e bocca alquanto rotonda», Polissena, figlia di Priamo, della quale si invaghirà Achille con esiti fatali, era «la più attraente di tutte le sorelle e di tutte le amiche»); strabico invece e anche balbuziente era Ettore, così come balbuziente era Neottolemo, figlio di Achille. Agamennone buono e saggio, Menelao un mediocre. Inverosimilmente le riunioni decisive dei Greci si tengono ad Atene.
Priamo è un bellicista: ostile a ogni compromesso, egli si ostina nel protrarre una guerra ormai perdente. Di qui discende il prodursi del fatto più clamoroso e palesemente anti-virgiliano del racconto di Darete: il tradimento di Enea.
Enea, coadiuvato dal padre e da Antenore, decide, per porre termine alle guerra, di aprire le porte al nemico: tutti e tre in combutta con Sinone agli ordini di Agamennone. Persino la leggenda del cavallo viene fatta a pezzi. Per Darete si trattava di una protome equina, scolpita sulle porte Scee, attraverso le quali Enea e i suoi complici fanno entrare i Greci.
E non basta. Enea vorrebbe restare nella città vinta e ridotta a poche migliaia di abitanti, ma ha chiesto con insistenza ad Agamennone la salvezza di Ecuba e di Elena; Agamennone gliela concede, ma gli ordina di togliersi dai piedi e di andarsi a cercare un’altra terra dove sopravvivere. Così l’Eneide viene annichilita.
Ci si può interrogare sul senso di questo strano racconto. In assenza di qualunque plausibile notizia sul vero autore, si possono solo formulare ipotesi. L’intento appare parodico, i ritratti dei personaggi sembrano confermarlo e fanno pensare ad un’altra celebre parodia storiografica, la Storia vera di Luciano di Samosata. Si può inoltre pensare - e le due ipotesi non sono in contrasto - a una consapevole dissacrazione dell’epopea romana, incentrata sul pio Enea, antico progenitore. Qui Enea diventa il traditore incallito e consapevole, alla fine maltrattato dallo stesso nemico al cui servizio si è posto.
Nella temperie augustea e post-augustea, impregnata di rivendicazione occidentalistica e anti-ellenistica, si levarono voci di dissenso: ad esempio Timagene di Alessandria, che Augusto scacciò dalla sua casa, in quanto maldicente antiromano. Dopo Azio e la fine dell’ultimo regno ellenistico, questi Greci sollevavano ad esempio la questione: se Alessandro Magno si fosse rivolto a Occidente che brutta fine avrebbe fatto Roma.
E Livio, intellettuale organico augusteo, si affrettò a scrivere pagine e pagine per dimostrare che Roma avrebbe sconfitto Alessandro, perché disponeva di validi consoli! In questo clima di insofferenza verso l’asfissiante conformismo augusteo, il cui prodotto più indigesto è il VI libro dell’Eneide , forse bene si inquadra l’impennata iconoclastica dell’altrimenti ignoto Darete Frigio.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- Il 6 aprile ’94, il genocidio ruandese (di Domenico Quirico - Ruanda vent’anni dopo))6 aprile 2014, di Federico La Sala
 l’anniversario
l’anniversario Ruanda vent’anni dopo
Ruanda vent’anni dopo Il 6 aprile ’94 l’aereo del presidente hutu venne abbattuto
Il 6 aprile ’94 l’aereo del presidente hutu venne abbattuto Poche ore dopo iniziò la caccia ai tutsi: e fu genocidio
Poche ore dopo iniziò la caccia ai tutsi: e fu genocidio di Domenico Quirico (La Stampa, 06/04/2014)
di Domenico Quirico (La Stampa, 06/04/2014)Venti anni fa tutto cominciò con un delitto di Stato. Il Falcon del presidente del Ruanda Juvenal Habyarimana, reduce da un vertice di capi di Stato in Tanzania con equipaggio francese e a bordo il presidente del Burundi Ntaryamira, fu colpito da un missile quando era ormai in fase di atterraggio a Kigali. Nessuno si salvò. Passarono poche ore e tutto il Ruanda cominciò a grondare sangue. Negli spasimi di una lunga tragedia etnica i fratelli nemici hutu e tutsi si sbranavano da secoli per un paradiso terrestre. La morte del presidente, un hutu, fu come il segnale atteso della ennesima resa dei conti. Perché tutto era stato preparato con metodo: gli elenchi di chi doveva essere ucciso, i magazzini con le armi comprate grazie a un sollecito prestito di una banca francese (Parigi era la grande alleata degli hutu al potere), gli estremisti huti erano in attesa dell’ordine, pronti, frementi, gonfi di birra e di odio.
Sul Paese scese il tempo di Caino, come una febbre maligna che annullava e travolgeva le coscienze. Un esercito tutsi, armato dall’Uganda e dagli americani, stava avanzando: erano i figli di un altro genocidio che cercavano la rivincita. La France Afrique, gli americani: anche stavolta c’erano sullo sfondo potenti burattinai. Le bande dei manovali della morte, che si facevano chiamare «i compagni’», andarono nelle caserme per ricevere machete fucili e bombe a mano. I rayban sul naso, ruttando alcool e ferocia, strinsero Kigali e i villaggi e le città in un laccio di posti di blocco. Sui documenti di identità la definizione etnica, sciagurato retaggio coloniale, era il corrispettivo della stella gialla degli ebrei, divideva chi aveva diritto alla vita dagli Altri, «gli scarafaggi» da schiacciare.
Avevano con sé le radioline, una voce infarinata di odio leggeva senza tregua gli elenchi interminabili di nomi, indirizzi di abitazioni, numeri di targa di auto dei tutsi da eliminare. Fu una notte di san Bartolomeo che durò cento giorni. Poco a poco gli assassini cominciarono a scarseggiare di pallottole, allora tirarono fuori i coltelli le lance i «masu», i bastoni cosparsi di chiodi. Si videro assassini che braccavano le vittime impugnando un cacciavite, un martello, il manubrio di una bicicletta. Un massacro autarchico e ferocemente minuzioso, fino all’ultima goccia di sangue. Vicini di casa che fino alla sera prima incontravano le vittime per i piccoli riti della quotidianità, un saluto un dono un pettegolezzo, suonarono all’uscio e cominciarono a colpire con i machete. Miti insegnanti andarono alla ricerca dei colleghi colpevoli di essere tutsi e li massacrarono con la furia di killer professionisti.
I mucchi di cadaveri cominciarono a crescere, di ora in ora. Il sindaco di Kigali, che neppure in quell’infamia perse i modi di persona educata, arruolò i detenuti, fece loro scavare in periferia enormi fosse comuni per gettarvi le vittime, non voleva le epidemie, diamine!
Da quando huti e tutsi hanno cominciato a scambiarsi massacri, le vittime hanno sempre cercato rifugio nelle chiese. Qui l’odio si era sempre fermato, la mano degli assassini sollevata come in un sussulto di misericordia. Venti anni fa non fu così. I soldati gettarono bombe nelle navate dove le vittime, insieme a preti e missionari, si facevano coraggio cantando inni e preghiere. I miliziani preferirono l’arma bianca. Sgozzarono squartarono prolungarono con tecnica consumata il martirio. Quelli che fino al giorno prima erano buoni parrocchiani coprirono gli altari e le statue dei santi con il sangue di coloro che fino al giorno prima erano inginocchiati al loro fianco per la comunione. Nelle famiglie miste ed erano migliaia, gli hutu dovettero scegliere tra l’uccidere la moglie o il marito o morire a loro volta. Molti furono gli eroi per forza, molti di più, troppi, purtroppo gli obbedienti.
Romeo Delaire era un generale canadese, comandava il piccolo, impotente contingente dei caschi blu a Kigali. Vide l’attentato all’aereo del presidente alla Cnn seduto nel suo bungalow nella capitale. Sulla scrivania i telegrammi disperati che aveva inviato nelle settimane precedenti alla segreteria delle Nazioni unite per avvertire che si stava preparando qualcosa di orribile formavano una pila alta. Li aveva ricevuti il suo superiore, l’uomo che dirigeva il dipartimento per le operazioni di mantenimento della pace. Era un africano. Delaire era sicuro che sarebbe stato sensibile al rischio di una altro genocidio nel «suo» continente. Aveva chiesto soldati per sequestrare i depositi di armi per il massacro: non era un mistero, tutti i vicoli della capitale ne parlavano. Ricevette un telegramma con un no secco e sgarbato. La firma: Kofi Annan.
Ottocentomila morti ha lasciato dietro di sé il genocidio ruandese. A cui bisogna aggiungere quelli della vendetta dei tutsi arrivati dal Ruanda. Altre decine di migliaia, nessuno li ha mai contati, i loro scheletri sono nelle foreste del vicino Congo dove avevano, invano, cercato rifugio. Su di loro scese un secondo colpevole silenzio.
Perché per fermare quell’orrore non bastarono le parole. Ci vollero le immagini. Per farci capire. Ancora una volta, un’altra volta. L’occidente, filisteo, mellifuo, fece scorrere i giorni del massacro, gli avvertimenti, le urla di aiuto: sono africani, poveracci, hanno solo coltelli e bastoni per confezionare un genocidio ci vuole altro, il taylorismo della morte, l’industrializzazione dell’omicidio, l’asettica efficienza delle camere a gas dove assassino e vittima non si toccano, non si vedono, si schiacciano bottoni anonimi, si manovrano leve apparentemente neutre.
E invece il segno sicuro del materializzarsi di questa terribile invenzione semantica, genocidio, è il senso oscuro che l’uomo ha superato la frontiera del Bene e del Male e si era avventurato su sentieri senza ritorno: ovvero gli assassini erano completamente privi di rimorsi e le vittime non si ribellavano, gli uni lavoravano di coltello sulla carne dei loro simili senza che nulla li turbasse e gli altri offrivano il collo alla lama come se fosse da tempo immemorabile nel loro destino. Venti anni dopo le immagini di quella tragedia non sono ricordi ma figure che davanti a noi si muovono, vive, presenti, la realtà così come è, tremenda, in ogni secondo, e con i più la risultanza, il grumo, la verità, la farina passata al sottile setaccio di tanti anni.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- CHE COSA E’ IL PUTTANESIMO DELLO SPIRITO? LA LEZIONE IGNORATA DI GIAMBATTISTA VICO.3 marzo 2014
 "PRINCIPI DI SCIENZA NUOVA": UNA CHIAVE DI ACCESSO AL CAPOLAVORO (1744) DI GIAMBATTISTA VICO
"PRINCIPI DI SCIENZA NUOVA": UNA CHIAVE DI ACCESSO AL CAPOLAVORO (1744) DI GIAMBATTISTA VICO
 CHE COSA E’ IL PUTTANESIMO DELLO SPIRITO? LA LEZIONE IGNORATA DI GIAMBATTISTA VICO. Alcune note
CHE COSA E’ IL PUTTANESIMO DELLO SPIRITO? LA LEZIONE IGNORATA DI GIAMBATTISTA VICO. Alcune note
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- 1914-2014 Gli ultimi giorni dell’Europa. Secondo dopoguerra. L’Europa in un abisso di sangue e vendetta12 gennaio 2014, di Federico La Sala
1914-2014. Gli ultimi giorni dell’Europa
di Vittorio Zucconi (la Repubblica, 12.01.2014)
«Dall’alto della propria torre orgogliosa la Morte guardò il suicidio dell’isola nel mare ai suoi piedi». Fu questo verso di Poe che la storica Barbara Tuchman scelse per narrare il secolo del suicidio europeo cominciato nel 1914, l’anno fatale nel quale il continente più prospero, colto, sviluppato, civile, più egemone che il mondo avesse mai conosciuto, decise, per ragioni ancora inspiegabili, di autodistruggersi. L’Europa fu il Cavallo di Troia di se stessa. Implose - senza invasioni né attacchi, né orde di barbari - spalancando le porte della storia al Secolo Americano.
È difficile, per noi che abbiamo conosciuto soltanto l’Europa della miracolosa, e ora claudicante rinascita un secolo dopo quel 1914, comprendere quanto assoluta fosse la supremazia del nostro continente sul pianeta. E quanto improbabile apparisse in quell’anno la «marcia dei sonnambuli» - secondo la definizione di Christopher Clark a Cambridge - verso l’abisso. Chi lamenta la globalizzazione di oggi, non sa quanto già globale fosse il mondo della Belle Époque e profonda l’interdipendenza fra le nazioni del Vecchio Continente. Basteranno due cifre per dare la misura dello strapotere europeo: il 67 per cento della produzione industriale mondiale veniva da qui; l’80 per cento delle flotte militari e commerciali batteva bandiere europee.
Una guerra fra le corone, tutte posate sulla testa di parenti, cugini e cognati, e l’unica grande repubblica del tempo, la Francia, appariva anche più assurda di quanto possa sembrare oggi alle legioni di ragazzi che sciamano da un’università all’altra sotto il segno di Erasmo, ai turisti che salgono e scendono da voli low cost e treni superveloci, che passeggiano lungo le rive del Reno, della Mosa, della Vistola dopo avere attraversato frontiere di garitte vuote o bunker ormai coperti di edera.
In un best seller del tempo, il Nobel per la pace sir Norman Angell poteva scrivere nel 1910 che la devastazione del credito e della finanza avrebbero impedito lo scoppio di una guerra o ne avrebbe reso brevissima la durata, nella solita fiaba del “tutti a casa per Natale”. Ironicamente, il titolo del suo saggio, La grande illusione, sarebbe divenuto un indimenticabile film contro la guerra. Ma Angell non avrebbe potuto immaginare che la rivoltella di un allucinato nazionalista serbo-bosniaco, Gavrilo Princip, contro l’erede al trono degli Asburgo Francesco Ferdinando a Sarajevo avrebbe messo in moto «la marcia dei sonnambuli» destinata a durare per l’intero «secolo breve», come lo chiamò Eric Hobsbawm.
La stampa Usa, di fronte al clamore suscitato da quell’assassinio, si concesse addirittura qualche ironia. L’Heralddi New York scrisse che «con tutti i duchi e gli arciduchi che hanno in Europa, uno in meno non può fare grande differenza». Cento anni dopo, e ben più di cento milioni di morti direttamente o indirettamente attribuibili a quell’«arciduca in meno», storici della guerra come John Keegan si chiedono addirittura se non sia stata la farraginosità e la lentezza delle comunicazioni fra Cancellerie, non ancora adeguata alla velocità del telegrafo, dei telefoni già esistenti in cavi sottomarini, della neonata radio, a scatenare la reazione a catena.
Ma ciò su cui nessuno ha dubbi è il meccanismo di azioni e reazioni, catastrofi e vendette, conti di sangue lasciati in sospeso, che avrebbe prodotto la Guerra dei Trent’anni europea, chiusa soltanto nel maggio di trentun anni dopo per poi congelare il continente nella glaciazione del conflitto ideologico fra Est e Ovest. Tutto quello che sarebbe accaduto nella Seconda guerra, e nel lungo Dopoguerra che ancora tocca con le proprie dita gelide i rapporti fra Russia e Occidente, ha le proprie radici in quelle giornate di agosto 1914.
Le mostruose tecnologie di morte usate nella Seconda guerra hanno il Dna nella Prima, i bombardamenti aerei, i tentativi di estendere la sofferenza alle popolazioni civili colpendo Parigi con supercannoni dalla gittata di 130 chilometri, i panzer, i primi rudimentali missili usati per abbattere palloni aerostatici e dirigibili. E i gas letali che dalle trincee sarebbero passati direttamente alle camere dello sterminio nazista e, ancora oggi, sostanzialmente identici, ai massacri in Siria.
Molti, se non tutti, i protagonisti, della Seconda guerra, erano figli della Prima. Churchill, Lord dell’Ammiragliato fino al 1915; Gamelin, vincitore della prima battaglia della Marna nel 1914 e poi disastroso comandante supremo dell’Armée francese nel 1940; Hitler, reduce rancoroso e ferito nelle trincee del fronte occidentale; Zhukov, il conquistatore di Berlino, decorato sui campi del 1915 contro le armate del Kaiser; Badoglio, vincitore del Sabotino e poi Capo di Stato Maggiore per la sciagurata offensiva contro la Grecia del 1940. E naturalmente Mussolini, ferito sul Carso da una bomba durante un’esercitazione.
Insieme con il cumulo di macerie, cadaveri, di immensi danni economici che dimezzarono le capacità industriali di nazioni come la Germania e divorarono una generazione di giovani uomini che in Francia lasciarono, nel 1918, una proporzione di sei donne per quattro maschi e centinaia di migliaia diinvalides,l’eredità più sottilmente velenosa di quel 1914 fu quella che John Keegan definì «la militarizzazione della politica».
Nei totalitarismi prodotti dalla guerra, dove le ideologie e i partiti erano stati messi in divisa restò, e ancora sotto pelle sopravvive, «il morso dell’odio per il nemico e quel risentimento - scrive sempre Keegan - che è sempre veloce nell’azzannare e lentissimo nel lasciare la preda ». Dovette essere l’America, due volte strappata al sonno del suo isolazionismo, a impedire alla Terra Madre di precipitare in un abisso senza ritorno.
Oggi quel campo della morte che fu l’Europa è silenzioso. Ma la Signora di Edgar Allan Poe, alta sulla propria gigantesca torre, osserva l’isola nel mare ai suoi piedi e aspetta paziente.
 Secondo dopoguerra
Secondo dopoguerra
 L’Europa in un abisso di sangue e vendetta
L’Europa in un abisso di sangue e vendetta di Vittorio Emanuele Parsi (Il Sole 24 Ore/Domenica, 12.01.2014)
di Vittorio Emanuele Parsi (Il Sole 24 Ore/Domenica, 12.01.2014)- Keith Lowe, Il continente selvaggio. L’Europa alla fine della Seconda guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari, pagg. 518, € 25,00
«L’immediato dopoguerra è uno dei periodi più importanti della nostra storia recente. Se la Seconda guerra mondiale distrusse il vecchio continente, il primo dopoguerra fu il caos proteiforme da cui si formò la nuova Europa». È dedicato esattamente allo studio di «questo tempo violento e vendicativo» nel quale «molte delle nostre speranze, aspirazioni, pregiudizi e risentimenti presero forma», il volume di Keith Lowe, che assai tempestivamente esce in edizione italiana, Il continente selvaggio. L’Europa alla fine della Seconda guerra mondiale. È un colossale, impressionante affresco delle condizioni europee tra il 1944 e il 1949, gli anni in cui per diversi Paesi europei si concluse la II guerra mondiale, senza che però si esaurissero le tante guerre locali (civili, di classe ed etniche) che ne intrecciarono il corso, alimentandola ed essendone a loro volta alimentate.
Il libro, magistralmente scritto da Keith Lowe, uno storico non accademico che dimostra tutte le qualità di scrupoloso ricercatore e di suggestivo narratore di Niall Ferguson, è diviso in quattro parti. La prima, dedicata all’eredità della guerra con il suo carico di distruzione fisica e morale, descrive con lucidità il paesaggio di un continente devastato dalla scomparsa di popoli interi, caratterizzato da una fame che sarebbe oggi inconcepibile associare all’Europa, da spostamenti forzosi e violenti di milioni di persone in uno scenario di caos totale, in cui città rase al suolo e infrastrutture devastate hanno riportato la condizione umana ai tempi più bui del Medioevo.
L’Europa tutta era un continente senza legge né ordine, in cui il sangue sarebbe cessato di scorrere solo mesi e talvolta anni dopo l’8 maggio del 1945, data della capitolazione tedesca. La sete di sangue rinfocolata o scatenata dalla brutalità senza precedenti con cui venne condotta la guerra, provocò una volontà di vendetta che attraversò l’intera Europa. Ed è proprio alle forme della vendetta che è dedicata la seconda parte del libro, e ne fa il primo studio generale sul ruolo che la vendetta giocò all’indomani della guerra, colmando un vero e proprio vuoto storiografico, finora prevalentemente oggetto di pamphlet partigiani e superficiali.
Dalla questione della sorte dei prigionieri di guerra germanici allo sfruttamento schiavistico delle minoranze tedesche in Polonia, Cecoslovacchia, a quello delle epurazioni nei confronti dei collaborazionisti: ogni singolo aspetto della vendetta sui vinti è preso in considerazione e indagato con scrupoloso rigore, compresi i temi scomodi delle violenze degli ex internati ebrei e dei deportati nei confronti dei propri carcerieri e della popolazione tedesca più in generale, oltre a quello, particolarmente odioso, della vendetta su donne colpevoli di avere "fraternizzato" con gli occupanti e sui bambini frutto di quelle unioni.
La terza parte considera la gigantesca questione della pulizia etnica che, iniziata da Hitler nei confronti degli ebrei, venne poi proseguita da polacchi, cechi, magiari, romeni trasformando l’Europa centro-orientale in qualcosa di radicalmente diverso da quel caleidoscopio etnico e religioso che era sempre stata.
L’ultima parte, infine, è dedicata alla lotta per fare dell’esito della II guerra mondiale la piattaforma per la diffusione della rivoluzione in tutta Europa, contrassegnata dalle scelte democratico-parlamentari delle dirigenze comuniste in Italia e Francia, dalla tremenda guerra civile greca, dall’assoggettamento al potere comunista di tutti i Paesi occupati dall’Armata Rossa e dall’eroica resistenza opposta per oltre un lustro dalle forze partigiane in Ucraina e nei Paesi Baltici.
Quello di Lowe è un libro mai banale e sempre documentatissimo, che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica, e che, soprattutto, ci aiuta a ricordare in quale abisso d’orrore era scivolata la "civilissima" Europa così da poter meglio apprezzare la grandiosità politica e morale della sua attuale unificazione politica.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA.2 gennaio 2014SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. A scuola di Dante, Bruno, Galilei, Kant ... e Kurt H. Wolff
 DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. Materiali
DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. Materiali
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "La rivelazione greca" di Simone Weil. Così l’Iliade parla di oggi (di Pietro Citati)11 gennaio 2014, di Federico La Sala
- DUE PAPI E UNA SOLA CATENA, "UNA CATENA DI GRAZIA": IL BATTESIMO NELLA CATECHESI DI PAPA FRANCESCO.
Sotto il tallone della forza
Così l’Iliade parla di oggi
Il viaggio di Simone Weil alle fonti della violenza
di Pietro Citati (Corriere della Sera, 11.01.2014)
La rivelazione greca di Simone Weil (pubblicata dalla Adelphi, con eccellente traduzione e commento di Maria Concetta Sala e Giancarlo Gaeta) è un libro senza paragoni. La parola Grecia ha un’estensione quale non aveva mai avuto nella storia, assai più che nell’Umanesimo e nel Rinascimento. Comprende l’Iliade , i testi orfici, pitagorici, Eschilo, Sofocle, Platone, i platonici; e Cristo e i Vangeli e la tradizione cristiana dove è più pura. Una frase di Platone risuona sulle labbra di Cristo; un detto di Cristo spiega una pagina o un dialogo di Platone; l’Iliade avvolge tutte le cose come una grande coltre materna; un tessuto fittissimo di risonanze e di echi colma secoli di vita, che a Simone Weil appaiono miracolosi.
Questa vita non è scomparsa: la Grecia non è una civiltà meravigliosa e irrimediabilmente finita, come appare anche ai più appassionati studiosi. La Grecia è viva, attuale: è il nostro irradiante presente; se immaginiamo una tragedia che parli al nostro cuore, dobbiamo pensare all’Antigone o all’Edipo re di Sofocle; se sogniamo un poema che comprenda la vita e la morte, il destino di chi vince e di chi è sconfitto, solo l’Iliade soddisfa i nostri desideri. Il primo e centrale di questi scritti, composti tra il 1936 e il 1943, è l’Iliade, poema della forza .
Il 4 dicembre 1934 Simone Weil era entrata in fabbrica, come ouvrière sur presses . Non vi era entrata per ragioni umanitarie o politiche: ma per provare sulla sua carne, con quel coraggio furibondo che non l’abbandonò mai, cosa fosse la mossa ferrea della necessità. Là dominava la macchina, senza rivali: come nei versi di Baudelaire, regnava la sventura moderna, dei grandi occhi muti; lei voleva fissare lo sguardo in quella orribile apparizione.
Conobbe la costrizione assoluta, la sinistra ripetizione, l’umiliazione profonda. Qualcuno le diceva all’orecchio, di minuto in minuto, senza che lei potesse rispondere: «Tu non sei nulla qui. Tu non conti. Tu sei qui per piegarti, subire tutto e tacere». Imparò cosa significa ciò che aveva letto nei libri: diventare una cosa, un pezzo di legno o di ferro.
Quelle esperienze di fabbrica diventarono, grandiosamente trasformate, l’esperienza di lettura dell’Iliade , dove scoprì la prima apparizione scritta della forza nel mondo. Nell’Iliade , la forza ha due aspetti, secondo che la si veda con gli occhi di chi la subisce o di chi la impone.
La forza fa di chiunque le sia sottomesso una cosa: cadavere e oggetto. Se egli è vivo, ha l’anima; e tuttavia è una cosa. Ci sono esseri sventurati che, senza morire, sono diventati cose per tutta la vita. Nelle loro giornate, non c’è alcun margine, alcun vuoto, alcun campo libero, per un soffio che venga da loro stessi. Non sono uomini che vivono più duramente di altri: si tratta di una diversa specie umana, un compromesso tra l’uomo e il cadavere.
Chi ferisce, violenta, uccide, comanda, impone non è più libero dalla forza di chi ne è distrutto. Egli non la possiede: vi fa troppo affidamento e ne è inebriato, travolto dalla propria hybris . Va al di là di ciò di cui dispone. Va inevitabilmente al di là, perché ignora cosa è limitazione e misura: viene abbandonato senza rimedio al caso, e le vicende non gli obbediscono più.
La storia greca aveva avuto inizio con un crimine atroce: Troia era stata distrutta e arsa; nella notte i guerrieri troiani erano stati massacrati, i bambini sfracellati contro le rocce; le donne prese prigioniere e portate in esilio. Allora, era nato un immenso rimorso, che aveva pesato su tutta la civiltà greca e, come suggerisce la Weil, su tutta la storia che gli uomini fabbricarono dopo di allora. Le lacrime di Andromaca dopo la morte di Ettore sono le lacrime che piangiamo su noi stessi come attori e vittime della storia.
* * *
La creazione del mondo non è stata - secondo la Weil - un atto di pienezza, di espansione e dilatazione di Dio, come racconta la Genesi. È stata una follia. Per darci spazio, Dio ha rinunciato a se stesso; si è limitato; si è nascosto negli abissi più remoti; si è ritirato dall’universo, come diceva Itzhak Luria. Nel luogo vuoto, che prima della creazione occupava, egli ha lasciato lo schermo tremendo della necessità: le leggi meccaniche dell’universo, il male, la miseria, l’angoscia, il lavoro, la guerra e la forza dell’Iliade , la morte violenta, la malattia, l’oggettività mostruosa della fabbrica moderna. Come uno schiavo, Dio si è incatenato con le catene della necessità, sulla quale non interviene.
Ora, nel mondo, non c’è alcuna traccia di misericordia divina; e questa assenza è il segno di Dio. A causa di questa rinuncia, egli non è più l’Uno, come i filosofi troppo ottimisti avevano creduto. È lacerato tra i suoi due volti opposti e contradditori, che tuttavia costituiscono il suo unico volto: diviso tra bene e necessità, come noi siamo. Nessuno, mai, nemmeno uno gnostico, aveva portato la lacerazione e la follia, che sono cose proprie dell’uomo, così addentro il volto segreto di Dio.
Il mondo è la conseguenza di questo paradosso divino. Da un lato Dio perduto, lontano, assente dalla sua creazione, dove possiamo rintracciare soltanto qualche lievissimo barlume di lui. Ma, d’altro lato, egli è onnipresente nella creazione, come nei Salmi. Tutte le cose sono una metafora e un riflesso multicolore della sua presenza. Egli è dovunque: nella bellezza, nell’ordine e nell’armonia del mondo, schiave della necessità, che la Weil celebra con gli accenti di una stoica o di una cristiana del quarto secolo. Egli è presente in ogni cosa che avviene nell’universo: nei fatti mostruosi che sono accaduti, nei fatti orribili che stanno per compiersi, i quali per l’uomo sono tutti carezze delicate e discrete della mano di Dio.
L’incarnazione e la passione rappresentano il culmine della follia e dello strazio di Dio. Appena parla di Cristo, ogni traccia gnostica e manichea scompare dalla mente della Weil: Cristo è colui che si è incarnato e ha patito con un reale corpo umano. Ma in lei non c’è nemmeno una traccia del Cristo salvatore e trionfatore della tradizione cristiana: Cristo non salva nessuno. Come Osiride, è il Dio fatto a pezzi, simbolo «dello spirito disperso attraverso lo spazio e la materia». Sulla croce, egli viene abbandonato da Dio, che verso di lui diventa gelido come la necessità; non c’è parola nei Vangeli che abbia tanto colpito la Weil quanto il grido di disperazione del Dio abbandonato. Come diceva Eschilo, «mediante la sofferenza e la conoscenza». «La croce del Cristo - ribadisce la Weil - è l’unica forza della conoscenza». Il solo pensiero umano degno di questo nome è lacerato, contradditorio, aguzzo, aforistico, come i due pezzi di legno levati inutilmente contro il cielo.
La tragedia della croce si ripete nella sventura - l’esperienza essenziale che ogni uomo fa di se stesso. Non c’è nessuna sensazione o sentimento che la Weil abbia espresso con tanta lucidità e intensità, con tanta appassionata partecipazione e orrore e riconoscenza come se per tutta la vita, malgrado le dolcezze discese dal cielo e gli sguardi innamorati alla natura, non fosse stata che «un poco di carne nuda, inerte e sanguinante, abbandonata senza nome sull’orlo di un fossato».
La sventura è una di quelle presse che la Weil aveva conosciuto in fabbrica: un meccanismo freddo, metallico e implacabile che domina il corpo, ostacola l’immaginazione, incatena il pensiero, ghiaccia tutti coloro che tocca. Come con un ferro rosso, imprime nello sventurato il disprezzo, il disgusto, la repulsione di sé, una sensazione di colpa e di lordura più grave di quella che suscita il delitto. Lo rende succube e complice, inietta un veleno di inerzia, si fa amare e desiderare, uccide le parole che potrebbero esprimerla; martella l’anima, la degrada, la riduce a una cosa, l’annienta. In quei momenti di desolazione, Dio abbandona chi soffre, come aveva abbandonato Giobbe e Cristo: «Egli è più assente di un morto, più assente della luce in un carcere completamente tenebroso».
Ma, subito dopo aver descritto con parole terrificanti la sventura, grazie a uno di quei capovolgimenti totali che costituiscono la chiave del suo pensiero - la Weil intona l’elogio della sventura. Con una specie di empietà nella voce, afferma che a causa della sofferenza «l’uomo è superiore agli dei». «Dio ha dovuto incarnarsi e soffrire per non essere inferiore all’uomo». «Se in questo mondo non ci fosse sventura, potremmo crederci in paradiso, orribile possibilità». Se sappiamo scendere in fondo alla sventura, come Omero e Sofocle, senza cercare consolazioni o illusioni, senza parole vane e bugiarde - lì, proprio in fondo all’abisso, in quelle profondità dove stanno le cose supreme, ritroveremo la sofferenza redentrice, la verità, la bellezza, la misericordia e l’amore di Dio.
- DUE PAPI E UNA SOLA CATENA, "UNA CATENA DI GRAZIA": IL BATTESIMO NELLA CATECHESI DI PAPA FRANCESCO.
-
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. ---- DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Parmenide... e la domanda antropologica (segnalazione).18 luglio 2013
segnalazione...
 DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE
DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE PARMENIDE, UNA "CAPPELLA SISTINA" CARMELITANA, LE XILOGRAFIE DI FILIPPO BARBERI E LA DOMANDA ANTROPOLOGICA. Un lavoro di Federico La Sala, con pref. di Fulvio Papi
PARMENIDE, UNA "CAPPELLA SISTINA" CARMELITANA, LE XILOGRAFIE DI FILIPPO BARBERI E LA DOMANDA ANTROPOLOGICA. Un lavoro di Federico La Sala, con pref. di Fulvio Papi
 Le Sibille di Contursi hanno parentele più celebri nella cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel Tempio Malatestiano di Rimini, nella Cappella Sistina di Michelangelo. La pittura disegna l’eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale ...
Le Sibille di Contursi hanno parentele più celebri nella cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel Tempio Malatestiano di Rimini, nella Cappella Sistina di Michelangelo. La pittura disegna l’eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale ... -
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. --- IN PRINCIPIO FU TROIA? NON SCHERZIAMO CON LA GUERRA E IL FUOCO! Una breve sintesi di Paolo Mieli sulla vecchia tradizione storiografica30 ottobre 2012, di Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Rapporto shock sui danni provocati dall’uso di armi segrete nel conflitto lanciato da Israele (di U. De Giovannangeli - «La guerra di Gaza causò mutazioni genetiche»).14 maggio 2010, di Federico La Sala
"JCALL": PER IL FUTURO DI ISRAELE E PER UNA PACE GIUSTA, EBREI D’EUROPA APPELLO SU "LE MONDE". ________________________________________________________________________
 Rapporto shock sui danni provocati dall’uso di armi segrete nel conflitto lanciato da
Rapporto shock sui danni provocati dall’uso di armi segrete nel conflitto lanciato da
 Israele. Sui corpi feriti trovati metalli tossici e sostanze cancerogene
Israele. Sui corpi feriti trovati metalli tossici e sostanze cancerogene«La guerra di Gaza causò mutazioni genetiche»
 Le analisi. Condotte dai ricercatori di tre Università, coinvolta anche Roma
Le analisi. Condotte dai ricercatori di tre Università, coinvolta anche Roma
 Mezzi sperimentali. Non hanno lasciato schegge o frammenti sui corpi colpiti
Mezzi sperimentali. Non hanno lasciato schegge o frammenti sui corpi colpitidi Umberto De Giovannangeli (l’Unità, 14.05.2010)
«La guerra di Gaza non ha curato la ferita che avevamo disperatamente bisogno di medicare. Al contrario, ha rivelato ancor più i nostri errori di rotta, tragici e ripetuti, e la profondità della trappola in cui siamo imprigionati». Così scriveva David Grossman riflettendo sulle conseguenze dell’operazione Piombo Fuso scatenata da Israele nella Striscia di Gaza. Quella ferita continua a sanguinare e come un tragico Vaso di Pandora da quella prigione a cielo aperto e isolata dal mondo che è Gaza, continuano a uscire notizie raccapriccianti.
Come la storia che l’Unità ha deciso di raccontare dopo aver compiuto i necessari riscontri. Una storia sconvolgente. Metalli tossici ma anche sostanze carcinogene, in grado cioè di provocare mutazioni genetiche. È quanto individuato nei tessuti di alcune persone ferite a Gaza durante le operazioni militari israeliane del 2006 e del 2009. L’indagine ha riguardato ferite provocate da armi che non hanno lasciato schegge o frammenti nel corpo delle persone colpite, una particolarità segnalata più volte dai medici di Gaza e che indicherebbe l’impiego sperimentale di armi sconosciute, i cui effetti sono ancora da accertare completamente.
La ricerca, che ha messo a confronto il contenuto di 32 elementi rilevati dalle biopsie attraverso analisi di spettrometria di massa effettuate in tre diverse università, La Sapienza di Roma, l’Università di Chalmer (Svezia) e l’Università di Beirut (Libano) è stata coordinata da New Weapons Research Group (Nwrg), una commissione indipendente di scienziati ed esperti basata in Italia che studia l’impiego delle armi non convenzionali per investigare i loro effetti di medio periodo sui residenti delle aree in cui vengono utilizzate. La rilevante presenza di metalli tossici e carcinogeni, riferisce la commissione in un comunicato, indica rischi diretti per i sopravvissuti ma anche di contaminazione ambientale. I tessuti sono stati prelevati da medici dell’ospedale Shifa di Gaza City, che hanno collaborato a questa ricerca e classificato il tipo di ferita delle vittime. L’analisi è stata realizzata su 16 campioni di tessuto appartenenti a 13 vittime.
I campioni che fanno riferimento alle prime quattro persone risalgono al giugno2006, periodo dell’ operazione «Piogge estive». Quelli che appartengono alle altre 9 sono state invece raccolti nella prima settimana del gennaio 2009, nel corso dell’operazione Piombo Fuso.
Tutti i tessuti sono stati esaminati in ciascuna delle tre università. Inglobare schegge o respirare micropolveri di tungsteno, metallo pesante e notoriamente cancerogeno, non potrà che provocare nella popolazione sopravvissuta o che vive nei dintorni un aumento della frequenza di insorgenze tumorali.
Sono stati individuati quattro tipi di ferite: carbonizzazione, bruciature superficiali, bruciature da fosforo bianco e amputazioni. Gli elementi di cui è stata rilevata la presenza più significativa, in quantità molto superiore a quella rilevata nei tessuti normali, sono: alluminio, titanio, rame, stronzio, bario, cobalto, mercurio, vanadio, cesio e stagno nei campioni prelevati dalle persone che hanno subito una amputazione o sono rimaste carbo- nizzate; alluminio, titanio, rame, stronzio, bario, cobalto e mercurio nelle ferite da fosforo bianco; cobalto, mercurio, cesio e stagno nei campioni di tessuto appartenenti a chi ha subito bruciature superficiali; piombo e uranio in tutti i tipi di ferite; bario, arsenico, manganese, rubidio, cadmio, cromo e zinco in tutti i tipi di ferite salvo che in quelle da fosforo bianco; nichel solo nelle amputazioni. Alcuni di questi elementi sono carcinogeni (mercurio, arsenico, cadmio, cromo nichel e uranio), altri potenzialmente carcinogeni (cobalto, vanadio), altri ancora fetotossici (alluminio, mercurio, rame, bario, piombo, manganese). I primi sono in grado di produrre mutazioni genetiche; i secondi provocano questo effetto negli animali ma non è dimostrato che facciano altrettanto nell’uomo; i terzi hanno effetti tossici per le persone e provocano danni anche per il nascituro nel caso di donne incinte: sono in grado, in particolare l’alluminio, di oltrepassare la placenta e danneggiare l’embrione o il feto. Tutti i metalli trovati, inoltre, sono capaci anche di causare patologie croniche dell’apparato respiratorio, renale e riproduttivo e della pelle. La differente combinazione della presenza e della quantità di questi metalli rappresenta una «firma metallica».
«Nessuno - spiega Paola Manduca, che insegna genetica all’Università di Genova, portavoce del New Weapons Research Group - aveva mai condotto questo tipo di analisi bioptica su campioni di tessuto appartenenti a feriti. Noi abbiamo focalizzato lo studio su ferite prodotte da armi che non lasciano schegge e frammenti perché ferite di questo tipo sono state riportate ripetutamente dai medici a Gaza e perché esistono armi sviluppate negli ultimi anni con il criterio di non lasciare frammenti nel corpo. Abbiamo deciso di usare questo tipo di analisi per verificare la presenza, nelle armi che producono ferite amputanti e carbonizzanti, di metalli che si depositano sulla pelle e dentro il derma nella sede della ferita”. «La presenza - prosegue - di metalli in queste armi che non lasciano frammenti era stata ipotizzata, ma mai provata prima. Con nostra sorpresa, anche le bruciature da fosforo bianco contengono molti metalli in quantità elevate. La loro presenza in tutte queste armi implica anche una diffusione nell’ambiente, in un’area di dimensioni a noi ignote, variabile secondo il tipo di arma. Questi elementi vengono perciò inalati dalla persona ferita e da chi si trovava nelle adiacenze anche dopo l’attacco militare. La loro presenza comporta così un rischio sia per le persone coinvolte direttamente, che per quelle che invece non sono state colpite». L’indagine fa seguito a due ricerche analoghe del Nwrg. La prima, pubblicata il 17 dicembre 2009, aveva individuato la presenza di metalli tossici nelle aree di crateri prodotti dai bombardamenti israeliani a Gaza, indicando una contaminazione del suolo che, associata alle precarie condizioni di vita, in particolare nei campi profughi, espone la popolazione al rischio di venire in contatto con sostanze velenose.
La seconda ricerca, pubblicata il 17 marzo scorso, aveva evidenziato tracce di metalli tossici in campioni di capelli di bambini palestinesi che vivono nelle aree colpite dai bombardamenti israeliani all’interno della Striscia di Gaza. Una conferma viene anche da attendibili fonti mediche palestinesi indipendenti a Gaza City contattate dall’Unità. Tra queste, Thabet El-Masri, primario del reparto di terapia intensiva presso l’ospedale Shifa di Gaza, il dottor Ashur, direttore dello Shifa Hospital e il dottor Bassam Abu Warda direttore della struttura medica attiva a Jabalya, il più grande campo profughi della Striscia (300mila persone). «L’occupazione di Gaza - riflette Gideon Levy, una delle firme del giornalismo israelianoha semplicemente assunto una nuova forma: un recinto al posto delle colonie. I carcerieri fanno la guardia dall’esterno invece che all’interno». Ed è una «guardia» spietata.❖
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- entro il duemilatrenta l’uomo deve assolutamente andare su Marte. Ci viene un dubbio: lo ha detto per desiderio scientifico o sta preparando un’arca di Noè? (di Stefano Benni - Vi prego, salvate la Miosfera).20 aprile 2010, di Federico La Sala
ALLEGRETTO
Vi prego, salvate la Miosfera
di STEFANO BENNI
UN preistorico vulcano islandese erutta e tutto il modernissimo traffico aereo è bloccato. Ma l’Italia sembra far parte di un’altra galassia e pensa solo alle sue piccole beghe. Il fifone schiva-processi dice che la mafia è un’invenzione dei media e Dell’Utri è un cartone animato. Bossi dà la colpa della nube alla crisi monetaria islandese e reclama le banche del Polo Nord.
Bertone è alla ricerca di un’analogia tra i crateri e i sodomiti. Bersani dice, si sciolgano pure i ghiacciai, basta che non si vada al voto. E alla fine il ministro Matteoli se ne esce con una proposta geniale: nessuno viaggi. Abbiamo capito perché è ministro.
Il terremoto di Haiti dopo una settimana è sparito dai media, ma al suo posto impazza una catastrofe ben peggiore: Minzolini e colleghi che si accapigliano sul milione di telespettatori perduti. Intanto abbiamo nuovi sismi in Nuova Guinea Afghanistan e Cina, ma l’argomento è logoro, non interessa più. E dire che di problemi ambientali ne abbiamo anche noi. La penisola italica sembra snella ma è obesa. Con l’Alta Velocità possiamo schizzare da Roma a Milano in tre ore e due pacchetti di biscottini. Ma attraversarla per il largo da Roma a Cesena è come affrontare il Sahara. I cantieri della Salerno-Reggio Calabria sono patrimonio archeologico, al posto degli autogrill potrebbero avere dei nuraghi. Le autostrade a pagamento sfavillano di asfalto drenante, ma quando piove un terzo delle strade normali frana o è inagibile.
L’acqua sarà il business del futuro, è già pronta la privatizzazione con relativa spartizione. Ci sarà l’acqua Padana, metà Po metà Tevere, perché la Lega ha il cuore a nord ma l’esofago a Roma. Poi avremo Pidiella, l’acqua che combatte la renella e gli avvisi di garanzia. L’Acquafini che fa digerire i magoni e ripristina l’obbedienza. L’acqua Centrorosso, con lieve percentuale alcolica per far finta che le elezioni siano state un trionfo. Infine l’Acqua del sud, che essendo la mafia un’invenzione televisiva, sarà imbottigliata da Maria De Filippi.
In quanto all’aria le nostre città sono avvelenate dallo smog ma è tutto un fiorire di Ecomaratone, Vivilabici, Corricheseisano, Domenica Respira. Una o due volte all’anno migliaia di cittadini in tuta e scarpette testimoniano la loro volontà di sopravvivere. Ma il giorno dopo Domenica Respira c’è già Lunedì Ansima e poi Martedì Strozzati. È uscito anche un decalogo "per attraversare bene una città", come a dire, la colpa non è dell’inquinamento, ma dei cittadini idioti che non sanno respirare. In quanto alla Fiat, ha le auto elettriche pronte ma finché c’è il petrolio mancano le prolunghe.
E tra poco riavremo il nucleare. Verranno costruite solo centrali della moderna terza generazione. Vuole dire che ci devono guadagnare almeno tre grosse industrie. Nessuno ha proposto di costruire una nuova generazione di edifici scolastici, non si guadagna abbastanza.
Tutto questo testimonia che, di fronte a un emergenza ambientale senza precedenti, l’Italia continua a mostrare scarsissima conoscenza e coscienza ecologica. Ci sono singoli parlamentari, associazioni benemerite, comitati di cittadini, qualcuno come Grillo o Vendola che ci sta provando. Ma il partito verde italiano è sempre stata la cenerentola dei partiti verdi europei.
Tutti sentiamo parlare di pale eoliche e pannelli solari, ma le pale restano ferme, e sul fotovoltaico c’è un caos di leggi, di certificazioni improvvisate e di confusione sui costi. Sui nostri tetti l’unica cosa che trionfa è la parabolica.
Camion e navi con rifiuti tossici non hanno smesso un istante di attraversare i nostri territori e il nostro mare. Basta pagare una multa e si riparte. E la nostra prevenzione incendi è al livello di quella degli eschimesi. Forse c’è una spiegazione. Forse l’Italia si è affezionata all’immagine di qualcosa di sporco, franante, disordinato, e guasto. Le nostre bellezze devono avere un contrappunto fetente, per venire incontro alle aspettative ai turisti. Che infatti fotografano con la stesso interesse i nostri quadri e la spazzatura per strada.
Eppure la parola "pulito" salta fuori in ogni nuovo slogan, iniziativa, e palingenesi. Berlusconi si è promozionato ripulendo una parte di Napoli, poco importa che adesso tutto stia tornando come prima. Le gallerie ferroviarie "ecostabili" della Roma-Bologna hanno distrutto i torrenti dell’Appennino, ma non sentirete mai un’amministrazione rossa protestare per questo scempio. Andate sullo Jonio e vedrete che per un ecomostro abbattuto, un altro sta spuntando.
Chi ci difende da questo massacro mafioso-cementizio? I geologi, i sismologi, i metereologi sono ormai post-esperti. Nel senso che vengono ascoltati solo dopo i disastri. Sarebbe bellissima una trasmissione televisiva in prima serata col titolo "Io l’ho visto" in cui si denunciano i pericoli e i guasti del dissesto idrogeologico e si indica come intervenire subito. Ma i disastrologi devono constatare, non inquietare. E i più furbi tra loro hanno un argomento rassicurante, che garantisce un nuovo passaggio in televisione: dicono "è vero, è un disastro ma è già successo nel 1937".
Verrebbe voglia di farsi trovare a letto con la loro moglie dicendo "quello che lei pensa è vero ma non si arrabbi, è già successo nel 1998".
Il vulcano, dicono gli scienziati, non è una malvagia anomalia, ma un motore della biosfera. In questo caso il prefisso "bio" viene usato seriamente: ma ormai non c’è prodotto che non esibisca queste tre lettere come pennacchio. Da biogas si è passati a bioyogurt, biomassaggio, biodentifricio e anche biopannolino per bioculi grandi e piccini. Quando si tratta di vendere, sono tre lettere magiche. Quando però si parla di biosfera, cioè di un organismo che non si può vendere, ma che si dovrebbe difendere dalla sfrenatezza economica, il discorso cambia. Ogni istanza ecologica diventa biochiacchiera apocalittica. E i giapponesi con cinica serietà scientifica ci informano che la crisi totale della biosfera è già in atto, e scommettono chi sul 2013 chi sul 2050. Non è un dubbio cosmico come "chi vincerà lo scudetto", ma varrebbe la pena di rifletterci.
Fortunatamente per i dirigenti italiani le tre lettere sacre non sono bio, ma "mio", la miosfera del privilegio e dell’impunità. Quel vulcano è un rompiballe, che probabilmente ha dentro al cratere un ritratto di Che Guevara. Dimentichiamolo in fretta.
Recentemente Obama ha detto che entro il duemilatrenta l’uomo deve assolutamente andare su Marte. Ci viene un dubbio: lo ha detto per desiderio scientifico o sta preparando un’arca di Noè? Sarebbe bello se l’inevitabile nube islandese ci spingesse a pensare alle nubi evitabili del nostro futuro. Ma la fine del mondo sembra ormai l’ultimo grande spettacolo che ci è rimasto. Non conviene rinviarla, abbiamo già venduto tutti i biglietti.
* © la Repubblica, 20 aprile 2010
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. ---- L’ITALIA, SEDOTTA E MASSACRATA, MUORE COME UNA "TROIA"!!!15 settembre 2009, di Federico La Sala
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- BAN KI-MOON, AGIRE PRIMA DI CADERE IN ABISSO.3 settembre 2009, di Federico La Sala
Ansa» 2009-09-03 20:08
UNIVERSITA’ ARIZONA: MANO UOMO NEL RISCALDAMENTO PIANETA
ROMA - C’é la mano dell’uomo nel rapido surriscaldamento del pianeta cominciato nello scorso secolo. Lo prova il primo studio che descrive dettagliatamente le temperature artiche negli ultimi duemila anni e che sarà pubblicato su Science. Lo studio è stato condotto da un gruppo di ricerca internazionale coordinato da Darrell Kaufman della Northern Arizona University, grazie a documenti geologici e biologici prelevati dai laghi artici, a carote di ghiaccio, agli anelli degli alberi e a simulazioni. Queste informazioni hanno permesso di ricostruire la storia delle temperature della superficie artica negli ultimi duemila anni, decade per decade.
Questa cartina ha svelato un trend delle temperature artiche che é andata verso il raffreddamento fino al ventesimo secolo ma poi improvvisamente negli anni ’50 l’andamento si è invertito. L’evento di raffreddamento, spiegano i ricercatori, è coinciso con la riduzione dell’insolazione solare generata dal cambiamento dell’orbita della Terra, ma nonostante l’insolazione sia rimasta costante, negli ultimi 50 anni, in concomitanza con l’accumulo dei gas serra in atmosfera, si è verificato un aumento delle temperature artica di 0,7 gradi, centigradi con relativo processo di scioglimento dei ghiacci. "Una incongruità - osserva Kaufman - che fornisce evidenze dell’influenza dell’uomo sul cambiamento climatico".
Dallo studio, che è durato cinque anni fra la raccolta dei campioni e l’elaborazione dei dati, è emerso che sono gli ultimi dieci anni ad essere i più caldi da duemila anni a questa parte, con temperature più alte di 1,4 gradi rispetto a quelle che ci sarebbero dovute essere se il trend di raffreddamento non si fosse interrotto. In particolare l’Artico, osserva uno degli autori, Jonathan Overpeck dell’Università dell’Arizona a Tucson, "é molto sensibile ai cambiamenti climatici causati dall’uomo e il nostro studio lo dimostra". Inoltre, aggiunge, qui, "appena le temperature salgono e il ghiaccio si scioglie il surriscaldamento accelera perché c’é meno ghiaccio a riflettere energia solare nello spazio e la terra nuda assorbe i raggi solari facendo aumentare ulteriormente le temperature".
BAN KI-MOON, AGIRE PRIMA DI CADERE IN ABISSO - Monito del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon sui cambiamenti climatici: ’’Abbiamo il piede sull’acceleratore e ci stiamo dirigendo verso l’ abisso’’, ha detto Ban Ki-moon in un intervento alla Terza Conferenza mondiale sul clima, in corso a Ginevra sotto l’egida dell’Organizzazione metereologica mondiale (Omm). Il responsabile delle Nazioni Unite ha esortato i governi all’azione: abbiamo bisogno di politiche che fissino il costo delle emissioni di Co2, programmi per l’energia rinnovabili, soluzioni per salvare la foresta e politiche che facilitino il trasferimento di tecnologia.
’’Abbiamo scatenato forze potenti ed imprevedibili, il cui impatto e’ gia’ visibile. L’ho osservato con i miei occhi’’, ha aggiunto Ban Ki-moon reduce da una missione all’Artico, regione che si sta riscaldando piu’ rapidamente di ogni altra regione della Terra. Purtroppo - ha deplorato - c’e’ ancora ’’inerzia’’ e nelle discussioni internazionali sulla lotta ai cambiamenti climatici ’’osserviamo solo progressi limitati’’. ’’Non possiamo permetterci il lusso di progressi limitati. Abbiamo bisogno di rapidi progressi’’, ha insistito il responsabile dell’Onu esortando i Paesi a raggiungere un’intesa al Vertice climatico sul dopo-Kyoto in programma a Copenaghen ’’tra tre mesi’’. ’’Non possiamo fallire’’, ha aggiunto Ban Ki-moon rivolto ai capi di Stato e ministri dei numerosi Paesi (soprattutto in via di sviluppo) giunti a Ginevra per la Conferenza mondiale sul clima. Ban Ki-moon ha dato appuntamento ai leader del mondo il prossimo 22 settembre a New York per un Vertice sul clima: ’’Spero che l’incontro possa fornire la necessaria leadership politica’’ per guidare i negoziatori e preparare il successo di Copenaghen in questoni chiave come i tagli alle emissioni nocive e l’appoggio finanziario e tecnologico ai Paesi in via di sviluppo affinche’ possano adattarsi e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ha detto Ban Ki-moon.
La Conferenza di Ginevra - cominciata lunedi’ scorso ed in programna fino a domani - non tratta delle riduzioni delle emissioni nocive o di altri temi che saranno discussi a Copenaghen, ma e’ un processo complementare, piu’ tecnico. Oggi, i partecipanti hanno approvato la creazione di un ’Quadro globale per i servizi climatici’, una rete che consentira’ alle informazioni sul clima raccolte dagli esperti di essere usate al meglio dai responsabili dei numerosi settori esposti ai cambiamenti climatici, dall’agricoltura al turismo e dalla pesca alla salute. Per il Segretario generale dell’Omm Michel Jarraud si tratta di un ’’giorno importante’’ per il sempre piu’ cruciale accesso alle informazioni sul clima. L’obiettivo del Quadro globale e’ di migliorare la produzione, l’accesso e l’utilizzo delle informazioni scientifiche sul clima, ha spiegato. Una task force di alto livello sara’ incaricata di definire gli elementi chiavi del ’Global Framework for Climate Services’ affinche’ possa fornire previsioni e informazioni sul clima a tutti i settori socioeconomici per porli in grado di gestire le variabilita’ e i cambiamenti climatici. Il rapporto della task force sara’ all’esame del Congresso dell’Omm del 2011.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- "Nel 2010 vicini all’estinzione".13 giugno 2009, di Federico La Sala
 PARLA "L’ECOLOGISTA ERETICO" JAMES LOVELOCK
PARLA "L’ECOLOGISTA ERETICO" JAMES LOVELOCKL’ultimo miliardo di uomini
 James Lovelock, 90 anni, è un medico, chimico e biologo inglese
James Lovelock, 90 anni, è un medico, chimico e biologo inglese Il padre della teoria di Gaia sul riscaldamento globale: "Nel 2010 vicini all’estinzione"
Il padre della teoria di Gaia sul riscaldamento globale: "Nel 2010 vicini all’estinzione" di STEPHEN LEAHY
di STEPHEN LEAHYTORONTO. Man mano che il clima si riscalda e aumenta la concentrazione di carbonio nell’atmosfera, il futuro appare funesto, molto più delle peggiori previsioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC)». Parola di James Lovelock. Chimico, medico e biofisico, Lovelock è il padre della teoria di Gaia, che descrive il pianeta come un organismo vivente, un complesso sistema in cui tutti i componenti della biosfera e dell’atmosfera interagiscono per regolare e sostenere la vita. Personaggio dalle idee spesso controverse, Lovelock gode di ampio riconoscimento presso la comunità scientifica. Come inventore, è titolare di almeno 50 brevetti, tra cui i primi apparecchi per individuare i clorofluorocarburi, i gas responsabili dell’assottigliamento della cappa di ozono, e i residui di pesticidi nell’ambiente.
Mr. Lovelock, perché critica il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico?
«Non che non possa contare su scienziati eccellenti. Ma i suoi modelli informatici non rendono conto della risposta della biosfera all’aumento della temperatura causata dal riscaldamento globale, né registrano la risposta delle foreste o degli oceani alla maggiore concentrazione di biossido di carbonio. E non sono ancora in grado di tracciare un modello dell’autoregolazione della Terra. L’osservazione dei dati rivela che l’aumento del livello dei mari è di molto superiore e che lo scioglimento dell’Artico procede ad un ritmo molto più elevato rispetto alle previsioni dell’IPCC».
La Terra ha già raggiunto il punto climatico più critico?
«Sì, la Terra si sta già muovendo verso una fase più calda, in risposta ai cambiamenti che abbiamo provocato trasformando gran parte della superficie del pianeta, e aggiungendo CO2 nell’atmosfera. Non dimentichiamo poi che un tempo la Terra era già ricoperta quasi interamente di foreste, che erano una parte importante del sistema regolatore della vita del pianeta. Secondo la teoria di Gaia, prima o poi in futuro si produrrà un cambiamento repentino verso un nuovo clima, che potrà essere di 5 o 6 gradi Celsius più caldo di oggi. Secondo le mie stime potremmo avere circa 20 anni per prepararci».
Come sarà il nuovo clima?
«Le aree tropicali e subtropicali saranno troppo calde e secche per coltivare cibo o mantenere la vita umana. La gente sarà costretta ad emigrare verso i poli, verso luoghi come il Canada. Entro la fine del secolo ci sarà meno di un miliardo di persone. La mia speranza è che a quell’epoca saremo ormai civilizzati, e che gli abitanti del Nord del pianeta accetteranno di ospitare una quantità inimmaginabile di “rifugiati climatici”».
Lei dipinge un quadro funesto per il futuro. Davvero non ci sono speranze?
«Siamo sopravvissuti all’ultima era interglaciale, quando il ghiaccio ricopriva gran parte dell’America del Nord e dell’Europa, e il livello dei mari era di 120 metri più alto rispetto ad oggi. Il primo passo è smettere di credere ciecamente che l’unica cosa che possiamo fare sia ridurre la nostra impronta di carbonio, e cominciare i preparativi per adattarci a quello che verrà».
Lei sta dicendo che non dovremmo cercare di ridurre le emissioni di carbonio?
«Non sto dicendo che non possiamo far nulla. Dico che molte delle alternative “verdi”, come l’energia eolica, non hanno che un valore simbolico. La Germania è leader mondiale (dopo gli Stati Uniti) quanto all’energia eolica, eppure le sue emissioni di carbonio sono aumentate. Ciò che dovremmo fare è proteggere tutte le foreste che restano, riportare buona parte delle terre coltivabili allo stato naturale, utilizzare gli oceani per catturare carbonio e ricavare il cibo da una qualche forma di biosintesi».
L’energia nucleare è un’alternativa migliore rispetto all’energia eolica o solare?
«Il nucleare è l’unica fonte di energia pratica e a basso tenore di carbonio. La protesta degli ecologisti è insensata. Il biossido di carbonio è molto più pericoloso, come stiamo cominciando a capire. L’energia nucleare è più sicura di altre, e le preoccupazioni sullo smaltimento delle scorie sono infondate. In Francia, le scorie radioattive di 25-30 anni sono immagazzinate in un’area ben protetta, delle dimensioni di una piccola sala concerti».
Cosa pensa della geoingegneria, che manipola il clima della Terra per neutralizzare gli effetti del riscaldamento globale?
«Credo che valga la pena prendere in esame soluzioni come quella dell’immissione di aerosol di zolfo nella stratosfera per riflettere parte del calore solare verso lo spazio, per poter raffreddare il pianeta».
Come siamo finiti in una situazione così critica, in cui tutte le specie sono in pericolo?
«È come la calma prima della seconda guerra mondiale, in Gran Bretagna, quando ero giovane. Nessuno ha fatto niente, finché non sono cominciate a cadere le bombe. In realtà non ci rendiamo conto del cambiamento climatico, che la maggior parte di noi considera solo una teoria. Spero che quando ci sarà il primo grande disastro climatico resteremo uniti, come se stessero invadendo il nostro paese».
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. ------- CLIMA, WORLD WATCH: O SI CAMBIA SVILUPPO O SI MUORE15 gennaio 2009, di Federico La Sala
Ansa» 2009-01-14 13:34
CLIMA, WORLD WATCH: O SI CAMBIA SVILUPPO O SI MUORE
WASHINGTON - O il mondo entro il 2050 ridurrà in modo drastico la sua attuale capacità di inquinare il pianeta, e in particolare l’attuale emissione nell’atmosfera di biossido di carbonio, oppure andrà incontro a catastrofi epocali: questa la conclusione dell’annuale Rapporto dell’organismo internazionale ’Worldwatch Institute’, che ogni anno raccoglie gli interventi di 47 tra i principali studiosi al mondo sui cambiamenti climatici. Secondo il rapporto, intitolato ’2009 - Lo stato del mondo - Verso un mondo piu’ caldo’, la situazione negli ultimi anni è ulteriormente peggiorata, ed è assolutamente necessario arrivare a un nuovo modello di sviluppo basato su produzione e consumo di energia eco-sostenibile. Nello stesso tempo però, sottolinea lo studio, non mancano le opportunità per intraprendere - oggi - iniziative che faranno sentire i loro benefici effetti nei prossimi decenni. "Abbiamo il privilegio di vivere in un momento della storia in cui possiamo ancora evitare una catastrofe climatica che trasformerebbe il pianeta in un ambiente ostile per lo sviluppo degli esseri umani" ha detto il vicepresidente di Worldwatch, Robert Engelman, che ha co-diretto il Rapporto 2009.
(di Luciano Clerico)
O si cambia o si muore. Perché un dato è certo: il mondo così come è se continua a svilupparsi secondo i criteri energetici seguiti finora è destinato ad andare incontro "a una catastrofe". Il grido d’allarme viene in questo caso del WorldWatch Institute, organismo internazionale che ogni anno raccoglie in un suo Rapporto ufficiale lo stato di salute del pianeta. Nel rapporto 2009, reso noto a Washington, la conclusione è questa: o il mondo sarà in grado entro il 2050 di ridurre in modo drastico la sua attuale capacità di inquinare il pianeta, abbassando in particolare le attuali emissioni di biossido di carbonio, oppure andrà incontro a catastrofi epocali. A questa conclusione sono giunti 47 tra i principali studiosi al mondo sui cambiamenti climatici.
Secondo il rapporto, intitolato ’2009 - Lo stato del mondo - Verso un mondo piu’ caldò, la situazione negli ultimi anni per quanto riguarda il cosiddetto ’global warming’ è ulteriormente peggiorata, ed è assolutamente necessario arrivare a un nuovo modello di sviluppo basato su produzione e consumo di energia eco-sostenibile. Nello stesso tempo però, sottolinea lo studio, non mancano le opportunità per intraprendere - oggi - iniziative che faranno sentire i loro benefici effetti nei prossimi decenni. Avranno un costo complessivo altissimo in termini monetari, gli studiosi stimano la potenziale spesa per la riconversione della produzione di energia alternativa compresa tra i mille e i 2.500 miliardi di dollari all’anno. "Tuttavia - si legge nel rapporto - gli eventuali costi derivanti da mancati interventi sarebbero, col tempo, ancora più alti".
Per il Worldwatch Institute è tempo di agire e di bisogna farlo subito. "Abbiamo il privilegio di vivere in un momento della storia in cui possiamo ancora evitare una catastrofe climatica che trasformerebbe il pianeta in un ambiente ostile per lo sviluppo degli esseri umani - ha detto il vicepresidente di Worldwatch, Robert Engelman, co-direttore del Rapporto 2009. Per Engelman "’non ci e’ rimasto molto tempo". "Varare un patto globale per salvare il clima del globo richiederà un supporto pubblico di enorme portata - ha sottolineato - e una volontà politica condivisa a livello globale di spostarsi verso l’energia rinnovabile, nuovi modi di vivere, e una scala di valori umani capace di adeguarsi ai limiti della atmosfera". Non c’é altra via.
Stando a Worldwatch, è ormai accertato in modo scientifico che il pianeta Terra si è mediamente riscaldato di circa 0,8 gradi dall’inizio della Rivoluzione Industriale a oggi, e il riscaldamento è in buona parte da attribuire alle attività dell’uomo. Un ulteriore grado medio di riscaldamento è potenzialmente prevedibile come conseguenza degli attuali consumi. Per questo secondo i climatologi bisogna correre ai ripari, e fare in modo che il picco di emissioni venga raggiunto prima del 2020, per poi ridurle entro il 2050 per almeno l’85% al di sotto dei livelli del 1990.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- The Story of Stuff. Un breve filmato che spiega di che lagrime e di che sangue gronda quello che chiamano "sviluppo".7 gennaio 2009, di Federico La Sala
Lo "sviluppo" spiegato com’è
Un breve filmato che spiega di che lagrime e di che sangue gronda quello che chiamano "sviluppo"
Vi raccomando la visione di un interessante documentario: The Story of Stuff, che si trova su youtube anche in versione italiana, doppiata o sottotitolata. Utile per spieare in termini molto semplici (un semplice cartone animato, con un testo parlato con chiarezza) le conseguenze del ciclo lineare estrazione > produzione > commercializzazione > consumo > smaltimento sulle nostre vite e sul pianeta. Qui sotto il link alle tre parti del documentario, nell’edizione doppiata in italiano.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. ---- Castro è il primo approdo di Enea. I riferimenti nell’Eneide di Virgilio e in un’antica cartina, la Tabula Peutingeriana.17 giugno 2008, di Maria Paola Falqui
I riferimenti nell’Eneide di Virgilio e in un’antica cartina, la Tabula Peutingeriana
Castro è il primo approdo di Enea. E il sindaco vuole ridarle il suo antico nome
Il ritrovamento di una statua di Atena confermerebbe che la cittadina in provincia di Lecce è il luogo in cui è sbarcato il giovane troiano. Il primo cittadino: ’’I tempi sono molto lunghi, ma vogliamo che torni a chiamarsi Castrum Minervae’’
Roma, 16 giu - (Ign) - Di ’Castrum Minervae’ parla nei suoi scritti lo storico Dionigi di Alicarnasso. E con lui anche alcuni commentatori di Virgilio sono concordi nell’indicare in un’antica città cretese, che si specchia nel mare del Salento, il primo approdo di Enea in Italia. Per anni storici e archeologici si sono interrogati su quale fosse, di preciso, il luogo in cui sbarcò il giovane troiano. E, per anni, città e paesi del Salento si sono contese la paternità di quell’approdo. Oggi il sindaco di Castro, Luigi Carrozzo, è sicuro che la sua città sia l’antica Castrum Minervae e, supportato da ritrovamenti archeologici e antiche cartine, ha tutte le intenzioni di ridarle il suo nome latino.
’’E’ una storia che inizia da molto lontano - racconta il primo cittadino a Ign, testata on line del gruppo GMC-Adnkronos -, che passa dall’origine del nome della città (Castro viene da castrum che in latino vuol dire fortificazione ndr), da un’antica cartina latina, la Tabula Peutingeriana, che indica Castrum Minervae come il punto di arrivo di una prosecuzione della via Appia che giunge all’attuale Castro, per arrivare ad una statuetta in bronzo della dea Atena, risalente al IV secolo a.C. e ritrovata qui solo pochi giorni fa, che, secondo l’archeologo Francesco D’Andria, rimanda chiaramente a Enea e al suo primo approdo’’.
Nell’Eneide, il poeta latino racconta di un tempio dedicato alla dea Minerva che Enea scorse avvicinandosi alle coste italiche. Un tempio edificato su una rocca alta a dominio del mare e che coincide perfettamente con il tempio antico di Castro. ’’Vorremmo ridare a Castro - continua il sindaco - il suo nome orginario, ridandole quel legame con il suo passato e la sua storia che hanno mantenuto città come Paestum. Ma sappiano che i tempi sono molto lunghi e che si tratta di un iter complesso e che comporta anche grossi problemi’’.
Al di là infatti di un atto del consiglio comunale necessario per avviare le procedure, cambiare il nome di un paese portà con sé numerose conseguenze. Significa cambiare le cartine, i dati anagrafici dei suoi abitanti, i codici fiscali, le piante del catasto e tante altre cose. Chissà dunque se Castro riuscirà a riavere il suo antico nome.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. --- Kivalina, l’isoletta tra i ghiacci destinata a scomparire entro 15 anni.27 novembre 2007, di Maria Paola Falqui
 Si trova a circa 140 chilometri dal circolo polare artico
Si trova a circa 140 chilometri dal circolo polare artico
 I ghiacci non la proteggono quasi più, il mare se la sta mangiando
I ghiacci non la proteggono quasi più, il mare se la sta mangiando Kivalina, l’isoletta tra i ghiacci
Kivalina, l’isoletta tra i ghiacci
 destinata a scomparire entro 15 anni
destinata a scomparire entro 15 anni I quattrocento abitanti, sempre più depressi e litigiosi, se ne vogliono andare
I quattrocento abitanti, sempre più depressi e litigiosi, se ne vogliono andare
 ma non è chiaro dove né chi pagherà i costi del trasferimento
ma non è chiaro dove né chi pagherà i costi del trasferimentodi LUIGI BIGNAMI *
SOTTO il plumbeo cielo artico un nuovo camion arriva sulla spiaggia dell’isola. In pochi secondi scarica decine di sacchetti pieni di sabbia raccolta a poche decine di metri dalla riva. E’ l’ultimo tentativo di salvare un’isola che sta lentamente scomparendo sotto il mare. Nell’ottobre del 2006 venne terminata una muraglia di rocce che costò 3 milioni di dollari e che avrebbe dovuto difendere l’isola, ma, a quanto pare, l’acqua salata è riuscita a sgretolare anche la muraglia stessa.
Due sono i fattori che stanno aggredendo Kivalina, questo il nome dell’isola, entrambi riconducibili all’aumento della temperatura terrestre. Da un lato vi è l’erosione delle onde del mare. In questi ultimi anni, infatti, l’isola vive per un lungo periodo dell’anno completamente libera dai ghiacci che un tempo la circondavano per quasi nove mesi su dodici. In tal modo le onde del mare agiscono più a lungo sulle sue coste e durante le tempeste l’azione distruttiva è molto intensa. Dall’altro vi è l’azione dell’aumento del livello del mare, che nelle zone artiche è più incisivo che mai.
Nel 1838, quando alcuni esploratori fecero un primo rilievo dell’isola essa risultava 3 volte più grande di oggi. Secondo l’Army Corps of Engineers, come spiega il Los Angeles Times, Kivalina potrà resistere al mare per non più di 10-15 anni, poi sarà completamente, sgretolata dalle onde dell’oceano
Gli abitanti dell’isola sono circa 400. Ora la domanda è: dove andranno a vivere e come vivranno? Già da alcuni anni i responsabili della comunità stanno litigando con le autorità governative perché nessuno vuole prendersi l’impegno di sborsare i circa 250 milioni di dollari necessari per concretizzare il piccolo esodo. E tra l’altro gli stessi abitanti non sono d’accordo dove andare: alcuni vorrebbero vivere sulle coste dell’Alaska , dove poter ritornare alla pesca come un tempo, altri verso l’interno del Paese, per non doversi muovere di nuovo se le acque saliranno ancor di più.
Kivalina si trova a circa 140 chilometri dal Circolo Polare Artico. Un tempo era un campo occasionale utilizzato durante le battute di caccia da parte degli Eschimesi, che si spostavano verso nord alla continua ricerca di foche, pesce e caribou. Nal 1905 il Governo americano pensò di costruire un villaggio per rendere più ospitale l’area e fu costruita anche una scuola. Quindi pian piano nacquero varie case, fino ad una settantina, ma molte di esse non hanno servizi e acqua corrente. Alcuni abitanti hanno continuato la caccia, altri hanno preferito lavorare in una vicina miniera di zinco. Molti si dedicano alla caccia per rifornire di carne fresca le baleniere che passano spesso vicino all’isola.
Ma ora le cose stanno precipitando e la gente non riesce più a sopportare la situazione: l’anno scorso tre persone si sono suicidate, altre tre hanno ucciso dei vicini. La vita sta diventando un inferno.
Forse presto Kivalina scomparirà dalle carte geografiche. Non sarebbe la prima, né l’ultima isola a finire così la sua storia. E’ già successo per un’isola posta tra il Gange e il Bramaputra obbligando circa 10.000 persone ad andarsene e decine di altre sono a rischio un po’ in tutti i mari del mondo.
* la Repubblica, 27 novembre 2007.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA, DANTESCA, KANTIANA, E MARXIANA - --- AL GORE:"E’ solo un cinico interessato ai soldi alla propria gloria e alla bella vita, con curriculum da ambientalista assai dubbio" (Robert Redford).26 novembre 2007, di Federico La Sala
IL CASO
Redford: Gore sei finto
Spietato il giudizio della stella di Hollywood: "E’ solo un cinico interessato ai soldi alla propria gloria e alla bella vita, con curriculum da ambientalista assai dubbio"
di Maurizio Molinari *
INVIATO A WASHINGTON
Un cinico, interessato ai soldi, alla propria gloria ed alla bella vita ma con un curriculum ambientalista assai dubbio: a tracciare questo spietato ritratto di Al Gore non è il conduttore di talk show ultraconservatore né il portavoce di un’azienda petrolifera ostile al Protocollo di Kyoto ma un’icona dei liberal d’America come Robert Redford.
Il popolare attore è un noto portabandiera della sinistra democratica e nel film «Lions for Lambs», appena uscito nelle sale d’America, è il protagonista di una dura denuncia della guerra in Iraq e di chi l’ha voluta scatenare. Proprio nella cornice della presentazione del messaggio di «Lions for Lambs» Redford ha rilasciato al periodico britannico «New Statesman» un’intervista a tutto campo, nella quale parla di se stesso, dei suoi valori, della sua storia e attacca frontalmente Al Gore.
L’ex vicepresidente americano premiato con il Nobel per la Pace per l’impegno ambientalista contro il surriscaldamento del clima viene descritto da Redford alla stregua di un’ecologista dell’ultimora, che sfrutta una battaglia giusta per fini propri. «Non era facile essere a favore dell’ambiente agli albori del movimento - dice Redford parlando della sua militanza ecologista che risale al 1969 - perché quelli erano giorni nei quali i produttori di greggio e petrolio controllavano gran parte dello show della propaganda». L’attore ricorda bene quei tempi «quando parlare dell’energia solare significava essere tacciati di essere degli estremisti» per sottolineare come Al Gore non facesse parte di chi aveva capito sin dall’inizio l’importanza di combattere l’inquinamento dell’atmosfera.
Di fronte alla campagna ambientalista dell’ex vicepresidente di Bill Clinton prevale in Redford uno scetticismo dai toni beffardi: «Gore sta facendo un sacco di soldi, è immerso nella sua belle époque, nel suo momento eroico». Alle spalle di tutto ciò per Redford c’è il fatto che «per Gore deve essere stato davvero duro soffrire la sconfitta alla elezioni presidenziali del 2000 e dunque ha scelto un’altra strada per tornare sotto i riflettori: l’ambiente». Insomma, l’ideatore del film «Una realtà sconveniente» - premiato con due premi Oscar - non sarebbe animato da sincera passione per la difesa della Terra ma piuttosto dalla vanità di tornare a essere protagonista della politica e del jet set internazionale. Ma non è tutto. Redford, 71 anni, va ben oltre e chiama in causa proprio la genesi del movimento antigas serra creato da Al Gore, spiegando che dietro tutto ciò altro non c’è che «i soldi dei Clinton». «Dietro ad Al Gore ci sono molti soldi perché nell’amministrazione Clinton girava tanto denaro ed è grazie a questo che Al Gore è riuscito a costruirsi la nuova campagna, facendo proprio il tema giusto al momento giusto» sono le parole consegnate dall’attore al «New Statesman».
L’atto di accusa contro Gore, che secondo alcuni analisti potrebbe ancora scegliere di candidarsi alle presidenziali, non è accompagnato dal sostegno a uno degli sfidanti per la nomination democratica del 2008. «Fino a questo momento non c’è nessuno in circolazione che mi ispira molto» dice, escludendo dunque un sostegno per Hillary Clinton, Barack Obama o John Edwards. Ed anche l’ipotesi di una sua discesa in campo è remota «perché non sono bravo a fare compromessi». Da qui la possibilità che Robert Redford decida di restare alla finestra durante la campagna elettorale, dando voce al ventre di una sinistra liberal scettica sui candidati democratici. Ma soprattutto diffidente nei confronti di Al Gore.
* La Stampa, 26/11/2007
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. ----- L ’Onu: «La Terra verso la catastrofe».26 ottobre 2007, di Maria Paola Falqui
 e entro il 2050 non si tagliano le emissioni di gas serra del 50%, mondo a rischio
e entro il 2050 non si tagliano le emissioni di gas serra del 50%, mondo a rischio
 L’Onu: «La Terra verso la catastrofe»
L’Onu: «La Terra verso la catastrofe»
 Tre i grandi mali del pianeta: riscaldamento, sovrappopolazione, fine della biodiversità
Tre i grandi mali del pianeta: riscaldamento, sovrappopolazione, fine della biodiversitàNAIROBI (KENYA) - La Terra è vicina al punto di non ritorno e il futuro dell’umanità è seriamente compromesso. Lo afferma l’ultimo allarmante studio intitolato «Global Environment Outlook» e presentato dallo «United Nations Environment Programme» (Unep), l’organismo delle Nazione Unite che ha sede a Nairobi e che si occupa della tutela ambientale. Lo studio, al quale hanno partecipato oltre 1400 scienziati, è stato pubblicato a 20 anni di distanza dal celebre rapporto «Il futuro di tutti noi», analisi della «Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo» nella quale per la prima volta fu formulato il concetto di «sviluppo sostenibile». Secondo il recente studio tre sono le cause che maggiormente mettono in pericolo la vita sul nostro pianeta: il riscaldamento climatico, il progressivo aumento numero delle specie in via d’estinzione e la rapida crescita della popolazione.
ATTIVITA’ UMANA - Gli scienziati hanno sottolineato che le attività umane ormai condizionano fortemente il clima della Terra e gli ecosistemi. La situazione può diventare ancora più catastrofica se, come stimano alcune proiezioni scientifiche, la popolazione umana raggiungerà gli 8 miliardi e 10 milioni di abitanti nel 2050. Negli ultimi venti anni, la popolazione mondiale infatti è aumentata di 1,7 miliardi di persone, passando da 5 a 6,7 miliardi di abitanti. «La popolazione umana adesso è così numerosa che l’ammontare delle risorse di cui ha bisogna per sopravvivere è superiore a quelle che la Terra riesce a produrre» afferma Achim Steiner, direttore esecutivo dell’Unep
CAUSE - Il riscaldamento climatico e la rapida crescita demografica sono le cause principali del gran numero di animali estinti o in via d’estinzione. Secondo le cifre presentate dall’Unep circa 30% degli anfibi, il 23% dei mammiferi e il 12% degli uccelli rischiano di scomparire, mentre tra i fiumi più grandi del mondo, uno su dieci, a causa dell’inquinamento e dello sfruttamento eccessivo della pesca, è sottoposto a profondo stress idrico e di anno in anno riduce sempre di più la sua portata d’acqua prima di raggiungere il mare.
AVVERTIMENTO E STIMOLO - Il rapporto, secondo gli scienziati, vuole essere allo stesso tempo sia un forte avvertimento sia uno stimolo al cambiamento. Se si vuole evitare una catastrofe, dichiara senza mezzi termini lo studio, entro il 2050 bisogna ridurre le emissioni di gas serra del 50% rispetto a quelle che erano prodotte nel 1990. Ciò significa che i paesi più industrializzati devono tagliare dal 60 all’80% le loro emissioni. Nel rapporto non mancano le note positive. Il direttore Steiner fa notare che i paesi dell’Europa occidentale hanno preso effettive misure per ridurre l’inquinamento atmosferico, mentre il Brasile ha fatto notevoli sforzi per combattere la deforestazione: «La vita sulla Terra potrebbe essere più semplice se non ci fossero questi tassi di crescita demografica. Ma costringere le persone ad avere meno figli è una soluzione semplicistica. La cosa migliore sarebbe accelerare il benessere dell’umanità e usare più razionalmente le risorse che il pianeta ci offre».
Francesco Tortora
SCHEDA. Lo stato di salute della Terra
* Corriere della Sera, 26 ottobre 2007
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA, DANTESCA, KANTIANA, E MARXIANA - a cura del prof. Federico La Sala14 aprile 2007, di Federico La Sala
Il film di Al Gore nelle scuole: un atto di bullismo?
di Liliana Gorini, presidente del Movimento Solidarietà
14 aprile 2007 - Da settimane veniamo tempestati anche in Italia da previsioni catastrofiche e dall’isteria della campagna sul riscaldamento globale, che è giunta all’apice con la pubblicazione del rapporto dell’IPCC, l’ente dell’ONU sul cambiamento del clima, e col film dell’ex vicepresidente americano Al Gore “Una scomoda verità”. “Il clima sta cambiando, i ghiacciai si sciolgono, il livello del mare salirà di sei metri, gli orsi polari annegheranno, ed è tutta colpa tua”: è questo, in sintesi, il messaggio terroristico del film di Gore, che attribuisce all’attività umana questi presunti cambiamenti climatici (ancora da dimostrare).
Benchè numerosi eminenti scienziati, e perfino alcuni autori del rapporto dell’IPCC, abbiano smentito clamorosamente i dati e i modelli climatici presentati dal film di Gore (ad esempio gli scienziati intervistati da una trasmissione di Channel 4 in Gran Bretagna dal significativo titolo “la grande truffa del riscaldamento globale”) anche in Italia si sta diffondendo l’isteria intorno a questo film, che forse dovrebbe meglio intitolarsi “la menzogna scomoda”. L’aspetto che più preoccupa in questa campagna, è che ora essa si rivolge alle scuole, con l’intento di terrorizzare studenti e scolari fin dai primi anni.
Il ministro Pecoraro Scanio ritiene che il film di Gore debba essere trasmesso in prima serata dalla RAI e già a fine marzo alcuni cinematografi ho hanno proiettato per le scuole superiori, pubblicizzando i dati falsi che propone come “una serie di dati scientifici inattaccabili” e facendo anche pagare l’ingresso agli studenti per poi uscire dal cinematografo terrorizzati e con sensi di colpa che si porteranno dietro per anni.
Mi metto nei loro panni: alla loro età vidi un documentario in televisione che prevedeva che per via dell’aumento demografico l’acqua sarebbe finita entro il 2000, e per molto tempo mi sentii in colpa ogni volta che bevevo un bicchier d’acqua. Naturalmente, siamo al 2007 e l’acqua non è finita, anzi, ora ci annunciano l’opposto, che inonderà il nostro continente trasformando le “case in collina” in case sul mare, come sostiene un ridicolo spot trasmesso da La7 ed MTV, che pur essendo una burla indica il livello di isteria a cui siamo arrivati.
Chi propone il film di Gore alle scuole non si è mai fermato a pensare agli effetti che avrà sugli studenti più sensibili? Non è forse anche questo un atto di bullismo, mirante a terrorizzare i ragazzi che prendono per oro colato tutte le affermazioni antiscientifiche che esso spaccia per “verità”?
I giovanissimi, che dovrebbero essere i più ottimisti, e che dovrebbero apprendere come la scienza possa risolvere tutti i problemi del mondo, la fame, le epidemie e (perché no?) anche l’inquinamento, imparano invece che il progresso e la tecnologia sono la causa di tutti i mali. Insegnanti e presidi non dovrebbero indottrinare gli studenti, ma dare loro gli strumenti per giudicare con la loro testa.
Se davvero verrà imposta la proiezione del film di Gore alle scuole, che almeno i provveditori, i presidi e gli insegnanti esigano che venga affiancata dalla proiezione della tesi opposta, contenuta nel film di Channel 4 in cui eminenti metereologhi, tra cui il Prof. Paul Reiter, dell’IPCC e dell’Istituto Pasteur, confutano le argomentazioni del film di Gore e dimostrano come si punti a creare tanta isteria sui mutamenti climatici non per migliorare le condizioni della terra ma per “uccidere il sogno dell’Africa e del terzo mondo: quello di svilupparsi”.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA, DANTESCA, KANTIANA, E MARXIANA - --- L’altro mondo di Gore (Barbara Spinelli).14 ottobre 2007, di Maria Paola Falqui
L’altro mondo di Gore
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 14/10/2007)
È significativo che Al Gore abbia fatto rinascere la politica e le abbia dato un nuovo tema oltre che un diverso modo di farla creandosi una specie di seconda patria nella rete internet: una patria-mondo, visto che il territorio internet è il mondo. Alle spalle aveva quel giorno infausto in cui vinse le presidenziali contro Bush, nel 2000, e che perse a seguito del verdetto di una Corte Suprema «eticamente compromessa», come scrive Michael Tomasky sul New York Review of Books dello scorso settembre. Molti narrano l’abbattimento che afflisse per mesi il candidato, ma pochi percepirono l’eccezionale itinerario che egli cominciò a percorrere: forte - sembrerebbe - di una sua segreta convinzione riguardante la nobiltà delle sconfitte. Fu un itinerario di esilio interiore e anche di conversione, di discussione e riscoperta di sé. Fu un distaccarsi dalla politica e al tempo stesso un riattaccarsi ad essa, un ripensarla da capo. Tale fu il suo migrare in altre patrie e nel mondo.
Una sua antica passione era tornata in superficie, sette anni fa: la cura dell’ambiente, la protezione della Terra come questione di pace e di guerra, l’idea di una responsabilità politica che oltrepassa non solo i confini della nazioni ma anche quelli delle generazioni, divenendo quella che Hans Jonas chiama responsabilità per il futuro dell’uomo. Era una passione che non trovava posto nello spazio pubblico, né in America né altrove. Fu allora che emigrò nel world wide web, allo stesso modo in cui De Gaulle scelse di incarnare la Francia migliore standosene fuori, a Londra, per combattere i collaborazionisti di Vichy. Così Al Gore: ritrovare la fortezza della politica non era possibile nello spazio pubblico esistente.
Non era possibile per il semplice fatto che tale spazio a suo parere s’è oggi striminzito, occupato com’è da poteri manipolatori che screditano l’arte del politico e la sua vocazione.
Le verità scomode, che son divenute l’emblema di Al Gore, possono esser dette solo allontanandosi da questi centri di potere (politici, mediatici) e riparando nelle terre del web. Senza quest’altra patria, estesa alla Terra, la sua influenza non sarebbe cresciuta sino a fare di lui un mito; il suo film sulla catastrofe climatica non avrebbe scosso i popoli; la giuria del Nobel non l’avrebbe nominato campione della pace assieme a quella straordinaria istituzione (l’Ipcc, Panel intergovernativo sul cambiamento climatico) che l’Onu creò nell’88, che è composta di 2500 scienziati non retribuiti, e che ha influenzato Al Gore.
Non importa sapere se il premiato profitterà del Nobel per rientrare in politica, armato di questi sette anni di esilio-resistenza. Molti ammiratori lo desiderano, invocando sul web la sua candidatura. Il blog più militante - www.draftgore.com - lo scrive ogni giorno e aggiunge una canzone di Paul Kaplan per incoraggiarlo, «Run Al Run», Corri Al, corri, che riprende il titolo di un libro (Run Boy Run) sulla fuga d’un ragazzo dal ghetto in fiamme di Varsavia. Al Gore è visto così: un ragazzo, con le sue cadute e metamorfosi. Un adolescente che continuamente muore e rinasce, come usano gli adolescenti. È l’intreccio che l’ha trasformato in politico-profeta, e non è detto che abbandoni questa sua immagine inusitata candidandosi come tanti altri.
Occuparsi prioritariamente del clima gli ha fatto scoprire un gran numero di cose, sulla malattia profonda della democrazia e dell’America. Una malattia che preesiste a Bush ma che Bush ha acuito enormemente. Gli ha fatto capire che la potenza Usa ha perduto con gli anni ogni attrattiva morale, che è forte solo della violenza, che la sua leadership globale è in frantumi dopo l’11 settembre. Ed è in frantumi perché imbacuccata nell’illusione di poter fronteggiare da sola, col vecchio Stato-nazione, mali comuni al pianeta come quello delle temperature in aumento. Il clima gli ha fatto scoprire che urge una coscienza collettiva per rispondere a minacce come il riscaldamento della Terra, l’innalzamento dei mari, la prospettiva di inondazioni e di milioni di rifugiati, le guerre già cominciate (l’Iraq è esemplare) attorno a risorse come acqua e petrolio, che sperperiamo o da cui perniciosamente dipendiamo.
Per questo è essenziale il web, che questa coscienza può accenderla più di altri mezzi, resuscitando al contempo la politica: il web e i blog che non disseminano verità - come fanno i giornali e soprattutto la televisione - ma la cercano instancabilmente (la distinzione tra disseminare e cercare è nell’ultimo libro di Al Gore, L’Assalto alla Ragione, che Feltrinelli pubblicherà in autunno).
La battaglia di Al Gore non è solo contro Bush, o contro politici che hanno supinamente accettato l’idea di una guerra «di più generazioni» contro il terrorismo, con l’abnorme accrescimento dei poteri presidenziali che tale guerra comporta, a scapito di libertà individuali e stato di diritto. Nell’Assalto alla Ragione l’ex candidato democratico dice che questi sono sintomi della malattia democratica e che le vere cause sono altrove: sono la scomparsa di un’autentica conversazione democratica pubblica, che crei nei cittadini fiducia nella politica e attaccamento a essa (il riferimento è esplicito alle teorie dell’attaccamento, sviluppate dagli psichiatri John Bowlby e Mary Ainsworth). Televisione e grandi giornali uccidono quotidianamente la conversazione, propinando dall’alto verità convenienti che nessuno lettore o telespettatore può mettere in questione, generando in questi ultimi un crescente senso d’impotenza, nascondendo i crudi fatti dietro velami ideologici.
La messa in questione è consentita tuttavia nei blog, nuovi strumenti di attaccamento alla politica e di conversazione «non a senso unico». Solo in internet si può entrare senza appartenere a lobby o corporazioni, senza titoli speciali e sovente abusati: dicendo la propria, e facendo della democrazia qualcosa di condiviso. Internet ha certo i suoi pericoli, che Al Gore enumera: insidiato dall’approssimazione, anch’esso può manipolare. Ma introdurre regole nel web ed evitare che le corporazioni se ne impossessino non è impossibile.
Le peripezie del dibattito sul clima sono significative. Giornali e tv si sforzano ogni volta di dare l’opinione contraria, quando espongono i dati a disposizione sui disastri della biosfera. Pretendono di farlo in nome del pluralismo, ma in realtà trasformano i fatti rivelati in opinioni, e falsano il dibattito mettendo tutto sullo stesso piano: idee e cifre, ideologie cucite sugli interessi e dati scientifici. Nel suo libro Una scomoda verità (Rizzoli), Al Gore lo spiega bene: giornali e tv danno alle opinioni contrarie un eguale peso, mentre praticamente nessun articolo scientifico sulla stampa specializzata contesta ormai i dati forniti da istituzioni come Ipcc e le responsabilità umane nel clima degradato.
Al Gore restituisce alla politica il primato che sta perdendo, reinventandola e riempiendo un vuoto come fece la socialdemocrazia nella seconda parte del XX secolo. In un primo tempo, il ’900 fu letale perché il conflitto fra mercato e democrazia era stato sottovalutato, e vinsero dottrine che fecero tesoro del risentimento e della paura nati dal conflitto. Oggi siamo a un bivio simile, e non a caso Al Gore cita quel che Churchill disse nel ’36: «Il periodo dei rinvii e delle mezze misure è finito (...) Adesso inizia il periodo delle conseguenze». E ancora: «Questo è un momento morale (...). Quando viene meno la visione, la gente perisce».
Anche oggi le forze del mercato tendono a ignorare il clima, mettendo da parte la politica, le regole, la visione. Molti politici son succubi di tali forze - anche a sinistra, dove son chiamati coraggiosi - e giungono sino a disfarsi dell’innovativo principio di precauzione, che impone cautela quando l’economia cresce in offesa alla terra (è il caso del francese Attali, cooptato da Sarkozy, che propone di eliminare il principio incorporato da Chirac nella costituzione). Ma i politici sono particolarmente succubi in Stati-nazione come l’America, e non a caso Jeremy Rifkin è del parere che l’Europa sia, su numerosi temi, più avanzata (la Repubblica, 13-10-07).
Ma anche in Europa occorrono figure profetiche, che escano dalla politica fossilizzata per rientrare in essa con idee non ortodosse. Rifkin cita Prodi, quando alla presidenza della Commissione europea si batté per il clima sfidando l’ottusa sordità di Washington. Anche lui, a suo modo, era un emigrato della politica italiana. Al Gore con le sue iniziative rifonda la politica, superando i limiti dello Stato-nazione e guardando il mondo con occhi spesso più europei che americani. Ripensa il rapporto fra informazione e partecipazione, fra monologo dei media dominanti e inedite pratiche di conversazione cittadina. È sperabile che il suo sguardo resti profetico, quale che sia il suo avvenire politico.
-
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA, DANTESCA, KANTIANA, E MARXIANA - a cura del prof. Federico La Sala6 aprile 2007, di Federico La Sala
 Dopo il primo, pubblicato a febbraio, l’Ipcc ha varato il secondo capitolo del documento.
Dopo il primo, pubblicato a febbraio, l’Ipcc ha varato il secondo capitolo del documento.
 Lo studio si concentra sulle drammatiche conseguenze del riscaldamento globale
Lo studio si concentra sulle drammatiche conseguenze del riscaldamento globale Clima, trovato l’accordo sul rapporto Onu
Clima, trovato l’accordo sul rapporto Onu
 "A rischio 20-30% specie vegetali ed animali"
"A rischio 20-30% specie vegetali ed animali"Tra le situazioni più a rischio, l’accesso all’acqua per milioni di persone e la tutela della biodiversità *
BRUXELLES - La scienza alla fine ha prevalso sulla politica, almeno per il momento. Dopo un temuto rinvio dovuto alle pressioni di Stati Uniti e Cina e Arabia Saudita, preoccupate per le conclusioni decisamente allarmanti, l’Ipcc, l’organismo delle Nazioni Unite che si occupa dei cambiamenti climatici, ha finalmente trovato l’accordo sul secondo capitolo del rapporto 2007. Dopo il primo capitolo sulla fisica dei cambiamenti, pubblicato nel febbraio scorso, quello attuale è il dossier che prende in esame le conseguenze pratiche dei mutamenti.
E sono conseguenze che fanno paura. Un innalzamento della temperatura media globale di 2-2,5 gradi rispetto al presente, si legge nel testo approvato, "potrà causare un forte aumento degli impatti" con spostamenti geografici di specie, perdite totali di biodiversità, riduzione della produttività agricola e delle risorse idriche in vaste aree. E questo determinerà un maggiore rischio di estinzione per circa 20-30% delle specie vegetali ed animali. In Australia e Nuova Zelanda le proiezioni climatiche stimano una forte perdita di biodiversità entro il 2020.
Gli impatti dei cambiamenti climatici, dicono gli esperti dell’Ipcc, "sono già in atto a livello globale e regionale e saranno più forti nel futuro". Inoltre, "molti sistemi naturali in tutto il pianeta sono stati già affetti da cambiamenti climatici regionali, in particolare da aumenti di temperature".
"Alla fine abbiamo un documento che spero attirerà l’attenzione in tutto il mondo", ha annunciato il presidente dell’Ipcc, Rajendra Pachauri. "Stiamo facendo le ultime correzioni della bozza - ha aggiunto - il lavoro non è facile ed è un documento complesso". Nella notte, tra mille tensioni, è stata fatta un’estenuante opera di limatura, correggendo alcuni aggettivi e alcune definizioni ("alto rischio" riferito al timore di perdita di biodiversità è divenuto ad esempio "crescente rischio"), ma la sostanza delle conclusioni messe insieme dallo staff di oltre duemila scienziati coordinato dall’Ipcc non è cambiata ed è la stessa anticipata dalla stampa nei giorni scorsi.
L’allarme per le conseguenze pratiche sulla vita umana e gli ecosistemi portate dal riscaldamento globale lanciato nel documento è pesantissimo. Stando alle previsioni basate su proiezioni scientifiche, già tra venti anni centinaia di milioni di persone rimarranno senza acqua a causa della siccità, mentre epidemie come la malaria si estenderanno anche in zone non tropicali. Nel 2050 l’Europa potrebbe perdere tutti i suoi ghiacciai e nel 2100 metà della vegetazione mondiale potrebbe essere estinta. Inoltre si ripeteranno ondate di calore anomalo in grado di uccidere migliaia di persone ed eventi climatici estremi come inondazioni e alluvioni.
Rispetto al precedente rapporto, pubblicato dall’Ipcc nel 2001, quello attuale è molto più allarmato e circostanziato e soprattutto affronta il riscaldamento globale non più come una vaga minaccia per un futuro lontano, ma come un fenomeno che sta già producendo i suoi effetti. "I cambiamenti climatici - spiega Neil Adger, uno dei leader della delegazione britannica nell’organismo Onu - non è qualcosa che riguarda il futuro, è già tra noi". Dopo l’estate l’Ipcc pubblicherà anche il terzo capitolo del suo rapporto 2007 nel quale vengono affrontati i possibili rimedi per contrastare il riscaldamento globale e mitigarne gli effetti.
* la Repubblica, 6 aprile 2007
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA, DANTESCA, KANTIANA, E MARXIANA - a cura del prof. Federico La Sala23 marzo 2007, di Federico La Sala
CLIMA: E’ ALLARME CO2, SIAMO IN UN NUOVO PIANETA
ROMA - Se l’uomo non corre ai ripari per abbassare la febbre del Pianeta, il rischio è che la nostra civiltà sia solo un interludio nella storia della Terra. E inoltre parlare di un generico aumento della temperatura non basta, perché quello in cui viviamo oggi è a tutti gli effetti "un nuovo Pianeta", a causa dei livelli di concentrazione di CO2.
L’allarme arriva da Vittorio Canuto, consigliere scientifico dell’Enea che da anni lavora negli Usa per il Goddard Space Flight Center della Nasa ed insegna alla Columbia University, in una conferenza tenuta al Circolo canottieri Tevere Remo a Roma, alla quale hanno partecipato anche il presidente dell’Enea, Luigi Paganetto e il direttore generale del ministero dell’Ambiente, Corrado Clini. "Il fatto che si parli di un aumento della temperatura non rende l’idea della realtà, che appare quasi piacevole - ha spiegato Canuto - e il termine effetto serra è quasi positivo. Bisognerebbe fare come i portoghesi, che parlano di effetto ’stufa’. Anidride carbonica e metano sono i colpevoli, quelli che fanno la parte del leone".
La responsabilità dell’immissione in atmosfera di questi gas é dell’uomo e spetta all’uomo curarsi prima che sia troppo tardi. "Mentre lo scambio di CO2 con l’atmosfera di vegetazione e oceani è in pareggio, quello delle emissioni umane, che provengono dai fondi geologici, invece non lo è, si tratta di un percorso a senso unico". Per questo sale la temperatura e di conseguenza la febbre del Pianeta.
Quali sono gli antifebbrili consigliati? "I ghiacciai, che però si stanno sciogliendo, e le foreste, che invece stiamo tagliando" ha spiegato l’esperto, che ha sottolineato il ruolo fondamentale degli oceani come spugne del 50% delle nostre emissioni. Una funzione che però sta venendo sempre meno a causa della crescita delle temperature, che scaldando l’acqua rallentano il rimescolamento con i nutrienti, alla base dei polmoni verdi sottomarini del Pianeta che effettuano la fotosintesi, le alghe. "Secondo i biologi il punto critico per le alghe sarà una concentrazione di CO2 di 500 parti per milione, quando oggi siamo già a 380 parti per milione, mentre nel 1860 erano 290 parti per milione" ha ricordato Canuto.
E poi c’é la questione dell’innalzamento del livello del mare: "Se il mare si scalda aumenta di volume, un fattore che va aggiunto allo scioglimento dei ghiacciai. Gli economisti - ha affermato l’esperto - stimano un numero di 40/50 milioni di rifugiati dovuti all’innalzamento del livello del mare: a quel punto il clima diventa anche un problema di sicurezza".
ANSA » 2007-03-23 16:44
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA, DANTESCA, KANTIANA, E MARXIANA - a cura del prof. Federico La Sala16 marzo 2007, di Federico La Sala
Clima, tre miliardi di persone resteranno senza acqua e cibo»
L’appello ai governi di tutto il mondo: agire subito. Presto l’Europa senza ghiacciai Nuovo rapporto Onu: nel 2100 sparirà metà della vegetazione mondiale
di Franco Foresta Martin (Corriere della Sera, 13.03.2007)
ROMA - Lo hanno ribattezzato «Il libro dell’apocalisse climatica» perché descrive, con un pessimismo senza precedenti, gli effetti devastanti del progressivo aumento delle temperature sugli ecosistemi e sull’uomo. Ci avverte che dobbiamo prepararci al peggio. Che alcuni segnali del riscaldamento, come gli inverni più miti o l’abbondanza di alcune produzioni agricole, potrebbero sembrare positivi. Ma è solo l’inizio di un cambiamento che volgerà presto in un incubo. Una ventina d’anni e il pianeta cambierà volto, con carestie, siccità, epidemie, inondazioni e estinzioni di massa.
QUARTO RAPPORTO ONU - Si tratta della seconda parte del Quarto Rapporto sui cambiamenti climatici, compilato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), il gruppo di 2.500 scienziati del clima incaricato dall’Onu di relazionare periodicamente ai governi su tutta questa complessa materia. La prima parte, come si ricorderà, è stata approvata a Parigi il 2 febbraio scorso e riguardava i «principi fisici di base» del cambiamento climatico, cioè le misure oggettive di concentrazioni di gas serra, temperature, estensione dei ghiacci, livello dei mari; e proiezioni di tutti questi parametri fino al 2100. Questa seconda parte tratta degli effetti sulla natura e sull’uomo; doveva restare segreta fino alla sua approvazione a Bruxelles il 6 aprile prossimo, ma è stata anticipata ieri da alcune agenzie di stampa statunitensi.
SCENARI BIBLICI - Con accenti apocalittici, da Antico Testamento, il rapporto Ipcc elenca le prevedibili piaghe che accompagneranno lo sconvolgimento climatico. Superato il limite di guardia di 2 gradi di aumento delle temperature medie rispetto ai primi del 1900 (ora siamo a +1˚),le crisi di siccità ricorrente renderanno inabitabili immense aree del Terzo mondo. Già entro 20 anni si prevedono centinaia di milioni di africani e decine di milioni di sudamericani in fuga o falciati dalle sete. Per contrasto, nelle latitudini medio- alte nell’emisfero Nord, ci sarà un aumento della produttività agricola e in alcune aree del Sud America un boom della soia e del riso. Ma sarà un’illusione di breve durata perché nel 2080, quando le temperature medie potrebbero essere cresciute da 4˚a 6˚,carestie e siccità dilagheranno nella maggior parte del globo, stremando da 1,1 a 3,2 miliardi di persone.
INONDAZIONI A CATENA - Con la metà dei ghiacciai montani e polari liquefatti, che andranno a gonfiare le acque dei mari - quelli dell’Europa saranno fra i primi a dissolversi -, decine di migliaia di chilometri di coste scompariranno e altre saranno inondate periodicamente. Ogni anno, stimano gli esperti delle Nazioni Unite, 100 milioni di persone saranno investite dalle inondazioni, soprattutto in Africa, Asia e nelle piccole isole degli oceani Pacifico e Indiano. Siccità, inondazioni e aumento delle temperature saranno il terreno ideale per le infezioni tropicali, che già oggi tendono a espandere la loro area di diffusione. Malaria, febbri emorragiche come la dengue, infezioni intestinali, dissenteria, diventeranno endemiche anche alle nostre latitudini.
ADDIO ORSI POLARI - La difficoltà di adattarsi alle mutate condizioni ambientali esporrà la metà delle specie animali e vegetali al rischio di estinzione. Fra i primi a scomparire ci saranno gli orsi polari, che non avranno più il supporto fisico su cui moltiplicarsi: i ghiacci del Polo Nord, già oggi ridotti del 25% rispetto a 30 anni fa, sono destinati a scomparire del tutto entro la fine del secolo. Negli oceani gonfiati dall’acqua dolce dei ghiacciai e acidificati per l’eccesso di anidride carbonica, le morie di pesci piccoli e grandi si ripercuoteranno negativamente sulla catena alimentare di tutto il pianeta.
ADATTARSI E RIDURRE I GAS - «Questa seconda parte del Rapporto sottolinea ancora di più la drammaticità degli effetti devastanti che stanno per abbattersi sul pianeta e lancia un appello pressante ai governi - commenta il rappresentante italiano dell’Ipcc Sergio Castellari, climatologo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia -. Negli ultimi 100 anni sono stati compiuti danni molto gravi a carico dell’atmosfera. A questo punto, le misure di mitigazione, ossia di riduzione delle emissioni di gas serra previste dal protocollo di Kyoto, non bastano più. Per salvarsi, bisogna andare avanti con riduzioni ancora più efficaci e ricorrere alle misure di adattamento, cioè ad azioni di difesa attiva, riducendo la vulnerabilità delle aree e delle strutture civili sensibili agli estremi climatici». Altri scienziati dell’Ipcc sono ancora più pessimisti e temono che sia stato superato il punto di non ritorno a causa della eccessiva concentrazione dei gas serra in atmosfera.
COINVOLGERE IL PROSSIMO G8 - L’anticipazione del Rapporto Ipcc ha avuto immediati contraccolpi nel governo italiano. Il ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio ha proposto di inserire la questione all’ordine del giorno del G8 Ambiente che inizierà giovedì prossimo a Postdam, aprendo un confronto con gli Usa e i Paesi di nuova industrializzazione per coinvolgerli nelle azioni di mitigazione e adattamento.
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. COMMENTO APOCALYPTICO15 febbraio 2007, di Federico la Sala
Una catastrofe a portata di click
«L’umanità al bivio» dello studioso Luigi Cortesi per Odradek. Un’appassionata e meditata analisi sul rapporto di causa ed effetto tra deregulation dell’attività economica e crisi ecologica
di Enrico Maria Massucci (il manifesto, 14.02.2007)
Il recente intensificarsi degli allarmi sulle incombenze climatiche che gettano ombre cupe sul destino dell’umanità è il segno inequivoco che anche all’interno di settori dell’establishment si fanno strada preoccupazioni non contingenti per lo stato fisico del pianeta. E anche se è evidente che lo zoccolo duro delle classi dirigenti continua imperterrito a perseguire una rotta di collisione mortale con gli interessi di lungo periodo dell’ecosistema (che sono quelli della comunità umana, se non si ragiona nell’ottica dell’individualismo neo-liberale), il ripetersi di lesioni ed eventi catastrofici nella biosfera sembra finalmente determinare nell’opinione più vasta un’attenzione meno superficiale ed episodica, facendo intravedere una volontà dal basso di porre argini all’uso irresponsabile di risorse e natura. Nella speranza, che si sia ancora in tempo per invertire pratiche e politiche, ma soprattutto, che l’interesse per la salvezza dell’ambiente esca dai minimalismi «emendativi» e dalle genericità «compatibiliste» (che si condensano nella risibile formula dello «sviluppo sostenibile»), per entrare nel merito dei dispositivi macroeconomici di produzione del rischio ambientale.
Una biosfera al limite
È infatti chiaro che il modello economico vigente ha intaccato in profondità le capacità «omeostatiche» della natura, cioè la sua attitudine ad assorbire in modo indolore le quantità esorbitanti di veleni prodotti, e che lo «scambio» con le attività umane vede infliggere all’ambiente «perdite secche» che comprometteranno irreversibilmente il futuro delle specie, quella umana inclusa, questa volta.
Proprio per queste ragioni, è doveroso segnalare attori e soggetti precoci della riflessione ecologistica, per i quali l’«emergenza ambientale» non è una scoperta occasionale o postuma, ma il terreno di un professionale approfondimento storico-scientifico di lunga lena. È il caso dello storico Luigi Cortesi, già impegnato nell’ambito della peace-research, da quando con l’installazione degli «euromissili» nel 1979, sviluppò un percorso di analisi sulla «condizione atomica» e sulla drammatica novità planetaria da essa imposta, sulla scia delle appassionate, «visionarie» e inascoltate meditazioni del Günther Anders di Diario di Hiroshima.
Studioso del movimento operaio, Cortesi individuava allora nella «nuova guerra fredda» reaganiana l’occasione per un ripensamento delle categorie della liberazione alla luce dello shifting globale del rischio di «distruzione totale», e ne deduceva la priorità assoluta della lotta per la pace. Beninteso, non nel senso querimonioso e flebile di una generica ed ecumenica composizione del conflitto tout-court, ma di un coinvolgimento critico nella denuncia dei dispositivi di produzione della guerra, nella varietà delle sue componenti, politiche e materiali.
Niente irenismi o piagnistei, dunque, ma un più forte impegno di lotta, di «pacifismo realista», che integrasse nei «vecchi» disegni di emancipazione di matrice socialista e comunista le nuove prospettive storico-politiche aperte dalle implicazioni distruttive dell’escalation nucleare (e dalla prepotenza e pervasività del complesso militar-industriale).
Ne era il frutto la fondazione della rivista «Giano» (1989), cui il contributo di Sebastiano Timpanaro (altro «solitario» della sinistra nostrana) avrebbe in seguito apportato (secondo le parole dello stesso Cortesi) un nuovo prezioso input ideale ed euristico, nel quale la lotta per la pace intercettava la novità assoluta del paradigma ecologico, colto ormai come il fronte decisivo di una riflessione e di una pratica che coniughi «liberazione» e «salvezza» . Ma anche come creativo recupero delle forti ragioni umanistiche di una sinistra in verticale crisi egemonica, contro il dilagare delle pulsioni più distruttive del capitalismo, che proprio nella sinergia «ecocida» ed «umanicida» esibisce l’anima più profonda e feroce.
Fecondissimo e drammaticamente urgente orizzonte di ricerca, oggi riproposto nell’ultimo libro dello storico (L’umanità al bivio. Il Pianeta a rischio e l’avvenire dell’uomo, Odradek, pp. 223, € 16,00), contenente anche una selezione dei principali «editoriali» della rivista, riflessioni sui più recenti eventi politici internazionali (a cominciare da quelli mediorientali) e un’appendice, che richiama l’altro, importante libro dell’autore, Storia e catastrofe, del 1984, ripubblicato da manifestolibri nel 2004. La cui coerenza e drammatica attualità possono anche positivamente impressionare, nella lucida e precoce individuazione delle tendenze di medio-lungo periodo e delle radici «eziologiche» della deriva attuale. Ma rappresentano la conferma della vitalità di alcuni strumenti d’analisi di «critica del presente», applicati a quel cruciale «rapporto tra prassi umana e natura», che solo oggi la grande stampa confusamente incorpora, dopo averlo stolidamente rimosso, ancora tuttavia glissando sulla sostanza del problema, come sulle sue ragioni causali.
Deregulation nichilista
Si tratta di una messa a punto del pensiero di Cortesi, che non deflette dalla denuncia del carattere sistemico del precipizio ambientale odierno, né pensa ingenuamente che esso sia contenibile e gestibile entro le coordinate di una governance continuista, implicando, al contrario, la rimessa in campo e l’attualizzazione di un’istanza trasformativa radicale. Forse risibile alle orecchie di chi si è riconciliato e comodamente installato nel cuore di questa modernità, ma non nelle coscienze di quanti percepiscono il carattere ultimativo e finale dei segnali più recenti della natura e la scelleratezza delle scelte autistiche dei gruppi dominanti, avvertendo l’urgenza della ribellione alla marxiana «comune rovina delle classi in lotta». Sono i frutti, avverte Cortesi, «di una rottura del patto con la natura (...) entro il quale si è svolta tutta la storia umana», della «potenza terribile di una prassi sregolata che ha come riferimenti il profitto e la crescita, l’avere e non l’essere».
Alla quale afferiscono parecchie complicità, non ultime quelle dei media che «non hanno comunque messo in chiaro la relazione tra deregulation dell’attività economica e deregulation dei rapporti con l’ambiente». E nella quale viene a tragica evidenza una costituiva e amorale attitudine ad un «uso inumano degli esseri umani» come della natura, dispiegata come rifiuto di qualsivoglia cultura del limite e cieca disponibilità ad un esito distruttivo generale.
E’ contro questo esito nichilista che occorre mobilitare l’altra parte dell’umanità, Ed è qui che «l’etica della responsabilità di Max Weber deve cedere il passo al "principio responsabilità" di Hans Jonas». Perché, come dice Cortesi, «l’uomo che si salva non è lo yesman del sistema, ma un ’apocalittico consapevole’ e quindi un ribelle».
-
> TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA, DANTESCA, KANTIANA, E MARXIANA - a cura del prof. Federico La Sala21 gennaio 2007, di Federico La Sala
Per il disarmo atomico
Cinque minuti a mezzanotte
di Giorgio Nebbia
Ringraziamo Giorgio Nebbia (per contatti: nebbia@quipo.it) per averci messo a disposizione questo suo articolo già pubblicato su "La Gazzetta del Mezzogiorno" (Bari), di venerdì 19 gennaio 2007. *
Chi, se non gli scienziati atomici, può meglio avvertire l’umanità dei pericoli associati alla diffusione delle bombe atomiche ? Il loro “Bollettino”, pubblicato negli Stati Uniti continuamente dal 1945, subito dopo i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, ogni mese informa i lettori dei progressi e degli insuccessi del disarmo nucleare pubblicando in copertina un “orologio” con la lancetta dei minuti che indica quanto siamo vicini ad una catastrofe nucleare planetaria. La lancetta era a sette minuti a mezzanotte quando solo gli Stati Uniti possedevano le bombe atomiche; si avvicinò a tre minuti a mezzanotte nel 1949 quando anche l’Unione Sovietica dimostrò di possedere tali bombe.
La lancetta si allontanò dalla mezzanotte quando le potenze nucleari (che nel 1968 erano diventate cinque: Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Unione sovietica e Cina) sembrarono accordarsi per una riduzione dei loro arsenali; si è riavvicinata alla mezzanotte dopo l’entrata dell’India e del Pakistan nel club nucleare; dal 2002 l’orologio segna sette minuti a mezzanotte, ma nel frattempo si sono verificati molti eventi. La Corea del Nord ha fatto esplodere una bomba atomica; l’Iran sta producendo uranio arricchito (a parole solo per le sue centrali elettriche); circolano notizie secondo cui Israele, che da decenni possiede bombe atomiche, potrebbe attaccare gli impianti nucleari iraniani; gli Stati Uniti si sono rifiutati di aderire al trattato contro le armi spaziali e stanno aggiornando e perfezionando l’arsenale delle proprie bombe nucleari. Gli Stati Uniti e la Russia hanno smantellato una parte delle “vecchie” bombe nucleari, ma i relativi “esplosivi” sono mal conservati e mal custoditi, esposti a incidenti e a furti e a tentativi di appropriazione da parte di criminali e terroristi, e comunque ci sono ancora nel mondo 27.000 bombe nucleari e duemila di queste sono pronte per essere lanciate nel giro di pochi minuti. Una ripresa della costruzione di centrali nucleari commerciali, proposte come alternative all’uso dei combustibili fossili, responsabili dei mutamenti climatici, potrebbe mettere in circolazione materiali utilizzabili per bombe atomiche. Si delinea, insomma, una “seconda era nucleare” e per questo i direttori del “Bulletin of the Atomic Scientists”, hanno deciso di spostare, proprio mercoledì 17 gennaio 2007, alle tre e mezza del pomeriggio, la lancetta dell’orologio del disastro atomico da sette a cinque minuti a mezzanotte, avvertendo così che tale disastro è più vicino.
La salvezza può essere cercata soltanto nel disarmo nucleare, imposto, fin dal 1968, dall’“articolo sei” del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, rimasto sempre lettera morta per l’opposizione degli Stati Uniti; così come è stata ignorata la sentenza della Corte Internazionale di giustizia del luglio 1996 che ha dichiarato illegale l’uso o la minaccia di uso delle armi nucleari. Il disarmo nucleare è stato invocato dai premi Nobel riuniti a Roma nell’ottobre scorso, dai “Medici contro la guerra atomica” (insigniti del Premio Nobel per la Pace), dagli appelli di tutti i Papi; anche nel discorso della “Giornata della pace 2007”, il primo gennaio di quest’anno, il Papa ha sollecitato i governi perché si impegnino a perseguire “la diminuzione e il definitivo smantellamento” delle armi nucleari. Ogni anno, nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, lo stesso impegno è votato da tutti i paesi membri, con l’opposizione degli Stati Uniti. Un nuovo appello per il disarmo nucleare è stato lanciato nei giorni scorsi in Italia da padre Alex Zanotelli, il missionario comboniano che non ha mai mancato di testimoniare a favore dei più poveri e della pace. Purtroppo tutte queste parole scivolano via come acqua fresca sulla disattenzione generale.
Eppure un disarmo atomico sarebbe possibile; si è riusciti, pur dopo anni di dibattiti, a vietare le armi chimiche e quelle biologiche, perché non si dovrebbero vietare quelle nucleari ? Diminuirebbe la sicurezza dell’Occidente ? Di certo no, anzi è proprio il possesso di armi nucleari da parte delle grandi potenze che spinge altri paesi a dotarsi anch’essi di tali armi. Il disarmo nucleare getterebbe nella miseria le industrie militari ? Neanche questo, perché anzi lo smantellamento delle bombe esistenti, il trattamento dei materiali radioattivi contenuti in tali bombe, la loro messa in sicurezza e sepoltura in cimiteri permanenti, comporterebbe un tale sforzo tecnico-scientifico e industriale da assorbire diecine di migliaia di lavoratori. Il denaro risparmiato fermando le attività nucleari militari --- centinaia di miliardi di euro ogni anno nel mondo --- permetterebbe di affrontare e risolvere almeno una parte dei problemi di miserie, di ingiustizie e di sottosviluppo che sono la vera radice della violenza internazionale. Nel prossimo marzo partirà una grande campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari. Mi permetto di rivolgermi con il cuore ai lettori: se ci informiamo e ne parliamo, possiamo allontanarci dalla mezzanotte della catastrofe che rischia di provocare inaudite sofferenze, di spazzare via milioni di vite umane. Diamoci da fare, vi prego, perché vinca la vita.
* www.ildialogo.org, Sabato, 20 gennaio 2007
-
> TROIA E L’OCCIDENTE. PER LA PACE PERPETUA. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA E DANTESCA - a cura del prof. Federico La Sala17 gennaio 2007, di Federico La Sala
Apocalisse nucleare: gli scienziati mettono avanti l’orologio
di Gaia Rau *
Attenzione, mancano cinque minuti alla mezzanotte. Non è la favola di Cenerentola ma la vicenda, ben più drammatica, dell’intera umanità: perché per mezzanotte si intende la catastrofe atomica, la fine del mondo, l’estinzione della razza umana. Ad annunciarlo è il Bollettino degli Scienziati Atomici, l’organizzazione non governativa statunitense che dal 1947 calcola il grado di rischio atomico dell’umanità trasponendolo sulle lancette di un quadrante simbolico che in tutto il mondo è conosciuto come il Doomsday Clock, l’Orologio dell’Apocalisse.
Dalle 15.30 (ora italiana) di mercoledì 17 gennaio, la fine del mondo è ufficialmente più vicina. Le lancette sono state spostate dalle 23.53 (dove erano posizionate dal 2004) alle 23.55. I due minuti in meno che ci separano dal disastro sono dovuti, secondo gli scienziati, alla minaccia di una «seconda era nucleare», ma anche a quella posta dal cambiamento climatico. Dunque i recenti esperimenti nucleari nord coreani e gli analoghi programmi iraniani, oltre che la mancata riduzione delle testate nucleari da parte di Russia e Stati Uniti (duemila di queste in stato di pronto al lancio), in un contesto storico-politico che non è certamente quello della guerra fredda, ma che vede pericolosamente ben più probabile un conflitto in scenari più limitati, ad esempio tra India e Pakistan. Ma anche i mutamenti climatici dovuti al surriscaldamento globale, e il loro effetto «a cascata» sull’intero ecosistema terrestre. A questo proposito, il noto astrofisico Stephen Hawking ha ricordato come i cambiamenti climatici costituiscano una minaccia ben più grave di quanto non lo sia il terrorismo: «in quanto cittadini del mondo, abbiamo il dovere di avvertire l’opinione pubblica dei rischi inutili con i quali dobbiamo convivere ogni giorno».
L’orologio venne avviato alle 23.53 nel 1947, durante la guerra fredda, e venne successivamente spostato avanti o indietro a seconda dello stato del mondo e della prospettiva di un conflitto nucleare. Il suo orario è stato regolato diciassette volte. Il periodo in cui le lancette sono state più vicine alla mezzanotte (due minuti) fu tra il 1953, con il test delle armi termonucleari da parte di Stati Uniti e Unione Sovietica, e il 1960. Quello più «sicuro» (23.43) è stato invece tra il 1991, quando entrò in vigore il trattato di riduzione degli armamenti atomici START, (Strategic Arms Reduction Treaty) e il 1995.
* l’Unità, Pubblicato il: 17.01.07, Modificato il: 17.01.07 alle ore 19.45
-
> TROIA E L’OCCIDENTE. COMMENTO APOCALYPTICO16 gennaio 2007, di Federico La Sala
TROIA E L’OCCIDENTE: PER LA PACE PERPETUA (I. Kant)
La minaccia ambientale che terrà unito l’Occidentedi Ulrich Beck (la Repubblica, 15 gennaio 2007)
A chi spetta il compito di arrestare il mutamento climatico? Qualche tempo fa sembrava che fosse una sfida nella quale tutti devono fare la loro parte, tutti in quanto individui. In questo modo la lotta contro il mutamento climatico si trasformò nel modello - molto irriso - di uno stile di vita "verde" (la bicicletta al posto dell’auto, andare in giro a casa propria anziché volare in vacanza). Ma attenzione: il mutamento climatico è evidentemente un problema troppo grande per essere risolto dai singoli individui riuniti - in base al motto "bus anziché auto" -. Esso chiama in causa i governi. Ma anche questi ultimi, se agiscono in modo "individualizzato", sono alquanto inermi.
Ormai tutti sanno che l’anidride carbonica non conosce confini e che qualsiasi tentativo che non venga intrapreso a livello transnazionale, ossia contemporaneamente sul piano locale e su quello globale, è destinato a fallire. Poiché potrebbe passare ancora un po’ di tempo prima che l’umanità riesca a mettere d’accordo l’umanità a questo fine, è necessaria una soluzione temporanea di medio periodo. Anche gli euroscettici più incalliti devono riconoscere che l’Ue rappresenta il soggetto ideale di una politica di contrasto al mutamento climatico e che ora il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ha colto questa opportunità prescrivendo ai Paesi europei una "rivoluzione postindustriale" - anche nell’intento di rilanciare l’utilità dell’Europa per gli interessi vitali dei suoi cittadini. Solo con il bilancio europeo di molti miliardi di euro si possono effettivamente avviare innovazioni tecnologiche, dalle energie alternative alle tecnologie per il risparmio energetico. Si può dar vita a una nuova alleanza tra gli Stati e l’economia. E, infine, l’Ue con i suoi strumenti giuridici può anche perseguire efficacemente coloro che peggiorano la situazione. A questo punto al lettore verrà un’idea eretica: i governi non sono affatto capaci di fare questo, perché da tempo non controllano più le decisioni economiche.
Naturalmente, si può confidare nella "virtù magica del mercato". Anche nel caso del più grande successo immaginabile tutto ciò avverrebbe assai lentamente. Il tempo, però, è dannatamente ridotto. A fissare la "deadline" - per usare la cruda espressione inglese - non sono i governi, ma la natura.
Giusto, non è possibile ritornare all’economia di piano, nemmeno nell’Ue. Ma non meno forte è la consapevolezza che se mai la "sovranità del mercato" ha rappresentato una minaccia mortale, ciò avviene ora - di fronte all’incombente collasso climatico e ai costi inimmaginabili che esso comporterebbe. Pertanto, i governi che si sottraessero al principio della nuova politica energetica e climatica per l’Europa evidenzierebbero una volta di più l’inadeguatezza dei singoli Stati nazionali a fronteggiare i pericoli globali e quindi anche nazionali.
Questa domanda sul ruolo dello Stato e del mercato nella civiltà globale del rischio comincia a scuotere anche l’autocomprensione americana dopo l’11 settembre 2001 e dopo le conseguenze dell’uragano Katrina del 2005, ma anche in seguito al dibattito riaccesosi sul mutamento climatico. Ciascuno di questi casi dà o ha dato luogo a una discussione in cui ci si chiede se queste esperienze e prospettive traumatiche siano da ritenersi una confutazione della concezione neoliberista dello Stato minimale. Si cristallizza un nuovo contrasto sinistra-destra: da una parte si sottolinea che è compito del governo federale americano ridurre al minimo le minacce e i rischi ai quali gli individui sono esposti; dall’altra, questa definizione dello Stato viene liquidata come sbagliata e fuorviante.
Ma, parallelamente al dibattito sulla politica climatica in Europa, anche negli Stati Uniti la politica verde viene scoperta come una nuova politica geostrategica: "Una delle ragioni per le quali il presidente Bush ha fallito nel tentativo di diventare la guida dell’Occidente", scrive Thomas L. Friedman, uno dei principali commentatori politici americani "sta nella sua incapacità di pensare e agire in verde, mentre ciò è diventato estremamente importante per tutti gli alleati dell’America. Dubito che negli ultimi due anni del suo mandato egli ridefinirà la politica americana. Ma l’importanza dei problemi legati al mutamento climatico e al risparmio energetico è cresciuta in modo tanto impressionante che è impossibile immaginare che il suo successore - chiunque egli sia - non li affronti e non li ponga al centro della propria politica. Se così fosse, sarebbe impossibile immaginare che il vivere, il pensare e l’agire in verde - anziché il combattere contro il rosso - non diventi il nuovo mastice dell’alleanza atlantica".
Una risoluta politica ambientale della Ue potrebbe effettivamente introdurre un cambiamento nell’autocomprensione dell’Occidente. Con il crollo del muro di Berlino sono sorti Stati senza nemici alla ricerca di nuovi spauracchi. Qualcuno teme o spera che lo spauracchio del "terrorismo" sostituisca lo spauracchio del "comunismo", per tenere unito l’Occidente. Ma questa illusione è svanita al più tardi con il fallimento della guerra in Iraq. Nello stesso tempo si profila un’alternativa storica: il mastice senza spauracchio che in futuro terrà assieme l’Occidente potrebbe essere costituito dalle sfide della crisi ecologica, che fondano la comunanza del pericolo. Infatti, non c’è minaccia più grande allo stile e alla qualità della vita occidentale che la combinazione tra il mutamento climatico, la distruzione dell’ambiente, l’approvvigionamento energetico e le guerre che ne possono derivare. Secondo la concisa formulazione del ministro degli Esteri tedesco Walter Steinmeier: «La sicurezza energetica determinerà in modo decisivo l’agenda della sicurezza del ventunesimo secolo». Qui si delinea il modello ultramoderno di una politica interna mondiale, che potrebbe sovrapporsi al modello ormai obsoleto della politica estera nazionale: postnazionale, multilaterale, acronimico, economico, superpacifico sotto tutti gli aspetti, esso predica le interdipendenze in ogni direzione, spinge a cercare amici ovunque, a non immaginare nemici in nessun luogo, solo spauracchi che è meglio cancellare. In questo mondo retorico gli "interessi nazionali" rimangono discretamente nascosti sotto un velo pesante, nel quale sono intessute le parole-chiave "mutamento climatico", "diritti umani" e "interventi per la pace". Kant non avrà avuto in mente proprio questo con il suo titolo dall’ironico doppio senso: "Per la pace perpetua?".
(Traduzione di Carlo Sandrelli)
-
> TROIA E L’OCCIDENTE. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA E DANTESCA - a cura del prof. Federico La Sala14 gennaio 2007, di Biasi
Che toni apocalittici !! Frequenti ultimamente qualche "Sala del Regno" geovista ?
Invece di cimentarti in simili visioni, perchè non tenti di elaborare qualche progetto per risolvere concretamente alcuni problemi della tua "Itaca" ?
Cordiali saluti. Biasi
-
> TROIA E L’OCCIDENTE. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA E DANTESCA - a cura del prof. Federico La Sala14 gennaio 2007, di Federico La Sala
Caro Biasi
eh sì - i toni sono da "apocalypto" occidentale e "universale-cattolico", non dei Maya (come vorrebbe Gibson e come vuoi anche tu)!!!
Ascolta il saggio Morrone - accogli l’invito del Direttore: parti!!! E - prima di tornare a San Giovanni in Fiore - rileggi ITACA di Kavafis e cerca di farti un bel giro per la devastata nostra Terra. Così capirai che significa essere cittadino d’ITALIA, di San Giovanni in Fiore, e "figlio" di GIOACCHINO e di DANTE - oltre che dei nostri Padri e delle nostre Madri COSTITUENTI !!!
Sveglia ... che è già primavera!!!
M. saluti ed eu-viaggio!!!
Federico La Sala
-
> TROIA E L’OCCIDENTE. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA E DANTESCA - a cura del prof. Federico La Sala15 gennaio 2007, di Biasi
 E io rinascerò
E io rinascerò
 cervo a primavera,
cervo a primavera,
 oppure diverrò
oppure diverrò
 gabbiano da scogliera
gabbiano da scogliera
 senza più niente da scordare,
senza più niente da scordare,
 senza domande più da fare
senza domande più da fare
 con uno spazio da occupare.
con uno spazio da occupare. E io rinascerò
E io rinascerò
 amico che mi sai capire
amico che mi sai capire
 e mi trasformerò
e mi trasformerò
 in qualcuno che non può più fallire
in qualcuno che non può più fallire
 una pernice di montagna,
una pernice di montagna,
 che vola eppur non sogna
che vola eppur non sogna
 in una foglia o una castagna.
in una foglia o una castagna. E io rinascerò
E io rinascerò
 amico caro amico mio
amico caro amico mio
 e mi ritroverò,
e mi ritroverò,
 con penne e piume senza io
con penne e piume senza io
 senza paura di cadere,
senza paura di cadere,
 intento solo a volteggiare
intento solo a volteggiare
 come un eterno migratore
come un eterno migratore E io rinascerò
E io rinascerò
 senza complessi e frustrazioni
senza complessi e frustrazioni
 amico mio ascolterò
amico mio ascolterò
 le sinfonie delle stagioni
le sinfonie delle stagioni
 con un mio ruolo definito,
con un mio ruolo definito,
 così felice di esser nato
così felice di esser nato
 tra cielo terra e l’infinito.
tra cielo terra e l’infinito.Caro Prof, lo sai che sono ignorante ! Chi è ’sto Kavafis ? Io conosco solamente Demis Roussos ("We shall dance") e Irene Papas (la "Penelope" di una lontana serie televisiva del 1968 dedicata al capolavoro di Omero). Però so ballare il Sirtaki !
Comunque, si rassegni (insieme a Kavafis): la tragedia greca è stata uccisa dalla credenza nell’inferno, tanta cara a noi cristiani ! Il dramma ha sostituito la tragedia. Giuda ha sostituito Sisifo.
Cordiali saluti
-
> TROIA E L’OCCIDENTE. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA E DANTESCA - a cura del prof. Federico La Sala15 gennaio 2007, di Federico La Sala
Troiani
di Konstantinos Kavafis [1863-1933]
 Sono, gli sforzi di noi sventurati,
Sono, gli sforzi di noi sventurati,
 sono, gli sforzi nostri, gli sforzi dei Troiani.
sono, gli sforzi nostri, gli sforzi dei Troiani.
 Qualche successo, qualche fiducioso
Qualche successo, qualche fiducioso
 impegno; ed ecco, incominciamo
impegno; ed ecco, incominciamo
 a prendere coraggio, a nutrire speranze.
a prendere coraggio, a nutrire speranze. Ma qualche cosa spunta sempre, e ci ferma.
Ma qualche cosa spunta sempre, e ci ferma.
 Spunta Achille di fronte a noi sul fossato
Spunta Achille di fronte a noi sul fossato
 e con le grida enormi ci spaura.
e con le grida enormi ci spaura. Sono, gli sforzi nostri, gli sforzi dei Troiani.
Sono, gli sforzi nostri, gli sforzi dei Troiani.
 Crediamo che la nostra decisione e l’ardire
Crediamo che la nostra decisione e l’ardire
 muteranno una sorte di rovina.
muteranno una sorte di rovina.
 E stiamo fuori, in campo, per lottare.
E stiamo fuori, in campo, per lottare. Poi, come giunge l’attimo supremo,
Poi, come giunge l’attimo supremo,
 ardire e decisione se ne vanno:
ardire e decisione se ne vanno:
 l’anima nostra si sconvolge, e manca;
l’anima nostra si sconvolge, e manca;
 e tutt’intorno alle mura corriamo,
e tutt’intorno alle mura corriamo,
 cercando nella fuga scampo.
cercando nella fuga scampo. La nostra fine è certa. Intonano, lassù;
La nostra fine è certa. Intonano, lassù;
 sulle mura, il corrotto.
sulle mura, il corrotto.
 Dei nostri giorni piangono memorie, sentimenti.
Dei nostri giorni piangono memorie, sentimenti.
 Pianto amaro di Priamo e d’Ecuba su noi.
Pianto amaro di Priamo e d’Ecuba su noi.-
> TROIA E L’OCCIDENTE. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA E DANTESCA - a cura del prof. Federico La Sala15 gennaio 2007, di Biasi
Professore, permettete, un pensiero poetico: "Siamo angeli, con un’ala soltanto, e possiamo volare solo restando abbracciati "...c’amma fa ?? (non lo so)
Gli uomini, come si sa, si dividono in uomini d’amore e uomini di libertà, a secondo se preferiscono vivere abbracciati l’uno con l’altro oppure preferiscono vivere da soli per non essere scocciati.
Come si fa, ora, a riconoscere se un uomo è o non è un uomo di libertà ? È semplicissimo: l’uomo di libertà preferisce l’albero di natale. L’uomo d’amore invece preferisce il presepe. Lei, professore, è "presepista" o "alberista" ?
Gli uomini di libertà amano farsi la doccia, gli uomini d’amore, invece, preferiscono farsi il bagno. La doccia è milanese, perchè : ci si lava meglio, consuma meno acqua e fa perdere meno tempo. Il bagno invece è napoletano: è un incontro coi pensieri, è un appuntamento con la fantasia...
Mi scusi questa mia breve parentesi. Continui pure...Saluti. Biasi
-
> TROIA E L’OCCIDENTE. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA ....22 gennaio 2007, di Federico La Sala
IL CIELO
La cometa McNaught: spettacolo per i 90 anni di Piero Tempesti
di PIERO BIANUCCI (La Stampa, 22/1/2007)
La cometa McNaught (foto) ha lasciato il nostro cielo per passare in quello australe, ma è così grande e luminosa da lasciarci ancora vedere, prima dell’alba, l’estremità della sua coda, benché il nucleo si trovi 20 gradi sotto l’orizzonte. Bisogna risalire alla cometa Ikeya-Seki del 1975 per trovare una cometa altrettanto brillante ed estesa.
Se ne rallegrerà un astronomo esperto di comete come Piero Tempesti, al quale questa settimana vorrei dedicare questa finestra di dialogo con gli Amici di lastampa.it.
Il motivo per farlo c’è. Nato a Firenze nel 1917, decano degli astronomi italiani, già direttore dell’Osservatorio di Collurania (foto) Piero Tempesti festeggia i novant’anni e gli sono intorno, in un brindisi ideale, tutti gli appassionati della scienza del cielo. Mi pare di vedere qualcosa di simbolico nel fatto che proprio alla vigilia di un così invidiabile compleanno, sia uscito uno dei suoi libri più belli, “Il calendario e l’orologio” (Gremese Editore), 200 pagine dedicate alla misura del tempo. Del quale, filosoficamente, sappiamo pochissimo, se non che passa: ma possiamo pur sempre affidarci alla fisica subnucleare per coltivare l’illusione della sua reversibilità, mentre sappiamo che la scala macroscopica è purtroppo tenacemente presidiata dalla seconda legge della termodinamica.
Dei novant’anni di Piero tempesti, 75 sono stati una convivenza stretta e fruttuosa con l’astronomia. Se ne appassionò quando era ancora studente di liceo a Firenze. Incominciò a coltivarla frequentando l’Osservatorio astrofisico di Arcetri, a due passi dal “Gioiello”, la villetta dove Galileo Galilei visse da confinato dell’Sant’Uffizio l’ultima e più buia parte della sua vita.
Pur senza mai perdere una visione d’insieme dell’astronomia, ben testimoniata dai sei volumi dell’enciclopedia a dispense “Astronomia” edita da Curcio nella prima metà degli Anni 80, le stelle doppie spettroscopiche e l’evoluzione stellare, in particolare le fasi di nova e supernova, diventarono presto i suoi interessi prevalenti nella ricerca: un filone molto fecondo, che nel corso del Novecento ha portato alla comprensione dei meccanismi di produzione di energia nelle stelle, alla scoperta della nucleosintesi degli elementi pesanti, alla descrizione delle diverse fasi della vita degli astri sotto la regia della loro massa, con fasi terminali che si manifestano ora con collassi in nane bianche dopo la fase di nova, ora con collassi in pulsar o in buchi neri. Non a caso alle stelle di neutroni Tempesti ha dedicato un libro (“Pulsar”, Biroma Editore, 1997) che ha colmato una lacuna nella divulgazione astronomica italiana di alto livello.
Comete e asteroidi, come ho già accennato, erano (e sono) l’altro interesse forte di Tempesti. Anche in questo campo - che nell’ultimo quarto di secolo ha attraversato una stagione emozionante grazie alle sonde spaziali - ha dato un contributo divulgativo con il libro “I segreti delle comete” (Curcio, 1984).
Di fotometria e di stelle doppie spettroscopiche il giovane Tempesti si occupò all’Osservatorio di Loiano, inaugurato sull’Appennino bolognese nel 1936, al tempo in cui vi lavoravano Luigi Jacchia (fino a quando per le leggi razziali non dovette emigrare ad Harvard), Leonida Rosino e più tardi Paolo Maffei. Tempesti era all’epoca assistente alla cattedra di astronomia dell’Università di Bologna. Gli stessi lavori riprese poi anche all’Osservatorio di Collurania, vicino a Teramo, dove arrivò succedendo al cuneese Giovanni Peisino, che aveva dovuto subire la soppressione della figura del direttore residente e il trasferimento della direzione a Napoli. Tempesti seppe guidare l’Osservatorio in questa fase difficile, riuscendo a difenderne la dignità scientifica fino al 1974. Sotto la sua gestione il rifrattore Cooke da 40 centimetri fu impegnato in accurate ricerche di fotometria fotoelettrica, portando contributi allo studio fisico degli asteroidi, mentre quindici studenti giunsero alla laurea in astronomia. Tempesti ha poi concluso la sua carriera all’Università di Roma “La Sapienza” come professore associato di Spettroscopia e ora vive a Treviso.
Proprio all’inizio degli Anni 70 risale il nostro incontro. Di tempo ne è passato, ma il ricordo è intatto. Tempesti mi venne incontro sulla scala che introduce alla palazzina dell’Osservatorio di Collurania. Sorridente e ospitale, mi condusse in una visita guidata che mi ha impresso nella mente l’elegante rifrattore Cooke reso famoso dagli studi su Marte di Vincenzo Cerulli, la bellissima cupola e un nido d’api incastonato tra una persiana e una finestra che Tempesti aveva rinunciato ad aprire per non disturbare quegli industriosi imenotteri.
Altro ricordo curioso: una lavatrice in demolizione nell’officina-laboratorio. Il motore - mi spiegò - grazie alle due velocità, una per il lavaggio e una per la centrifuga, con l’aggiunta di pochi ingranaggi si presta perfettamente a motorizzare un telescopio usando la prima velocità per l’inseguimento degli astri e la seconda per il puntamento rapido. La ricerca italiana ha sempre dovuto ricorrere all’arte di arrangiarsi.
-
> TROIA E L’OCCIDENTE. COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA .... Alla fine sarà una sorta di consunzione lenta, come una "morte vaporosa". Così morirà il pianeta Terra, e accadrà esattamente tra 7,59 miliardi di anni.11 marzo 2008, di Maria Paola Falqui
Ansa» 2008-03-11 20:40
LA TERRA MORIRA’ FRA 7,59 MILIARDI DI ANNI
di Luciano Clerico
WASHINGTON - Alla fine sarà una sorta di consunzione lenta, come una "morte vaporosa". Così morirà il pianeta Terra, e accadrà esattamente tra 7,59 miliardi di anni. A questa conclusione è arrivato uno studio, che sta per essere pubblicato sull’ inglese Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, condotto dai due astronomi Klaus Peter Schroeder e Robert Connon Smith e anticipato sulle pagine scientifiche del New York Times.
La Terra, conclude lo studio basandosi su un nuovo metodo di calcolo, morirà risucchiata da un sole divenuto nel frattempo sempre più grande, un sole gigante le cui dimensioni saranno 256 volte le attuali, un solo rosso e congestionato che porterà inesorabilmente il pianeta Terra fuori della sua orbita, condannandolo alla fine. Una fine che non prevede implosioni o esplosioni, ma una lenta, inesorabile ’cottura’ del pianeta o, per essere più precisi, una "morte vaporosa". "E’ una scoperta un po’ deludente" ha commentato il professor Smith, docente di astrofisica alla University of Sussex, "ma la possiamo sempre mettere in questo modo: può essere uno stimolo per l’umanità per cercare il sistema per lasciare il pianeta e colonizzare altre aree nella galassia".
Detto questo - ha ammonito l’astrofisico - è bene ricordare che l’impatto dell’ India con il continente asiatico che ha dato vita alla catena dell’Himalaya risale a una sessantina di milioni di anni fa. "Un battito di ciglia se paragonato ai miliardi di anni di cui stiamo parlando". Lo studio si è basato su nuovi sistemi di calcolo messi a punto da Schroeder e da Manfred Cuntz, della University of Texas. Grazie ad essi si è per così dire "ricalcolato" la attuale massa solare e quanto di essa si perderà nel tempo in seguito alla espansione del sole fondata su questa teoria: tra 5,5 miliardi di anni il sole sarà almeno 10 volte più luminoso di quanto non lo sia oggi, ma più leggero.
Perché si calcola che proprio per quel periodo terminerà il suo ’carburante’, cioé l’idrogeno del suo nucleo e per questo motivo comincerà ad alimentarsi con l’idrogeno dei suoi raggi. Questo comporterà una espansione gassosa di incredibili proporzioni. Mentre il nucleo si contrarrà, riducendo la massa, i raggi esterni si espanderanno fino a trasformare l’attuale motore del sistema solare in un gigante rosso 250 volte più grande di oggi. Sarà questa trasformazione a portare alla morte l’intero sistema solare. Terra compresa, naturalmente, che, uscendo dalla sua orbita, tra 7,59 miliardi di anni precipiterà verso una "morte vaporosa" tanto lenta quanto inesorabile.
luciano.clerico@ansa.it
-
-
-
-
-
-