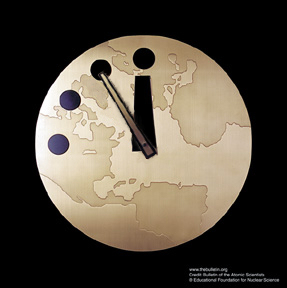
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE (2005). Una "memoria" - di Federico La Sala.
- Secondo quanto suggerisce Vitruvio (De architectura, 2,1,3) la struttura del tempio greco trasse la sua origine da primitivi edifici in argilla e travi di legno (Wikipedia)
- IL SEGRETO DI ULISSE: "[...] v’è un grande segreto /nel letto lavorato con arte; lo costruii io stesso, non altri./ Nel recinto cresceva un ulivo dalle foglie sottili,/rigoglioso, fiorente: come una colonna era grosso./Intorno ad esso feci il mio talamo [...]" (Odissea, Libro XXIII, vv. 188-192).
- EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" (AUFKLARUNG") NECESSARIO. FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
- IL "VANGELO" SECONDO LA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- PAOLO DI TARSO E COSTANTINO:"IN HOC SIGNO VINCES"!: «Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace.
 Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).
Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).
 TERRA!, TERRA!
TERRA!, TERRA!
 IL BRASILE DÀ UNA ‘LEZIONE’ ALL’EUROPA E ALLE SUE RADICI
IL BRASILE DÀ UNA ‘LEZIONE’ ALL’EUROPA E ALLE SUE RADICI
 Sul referendum brasiliano sulle armi - prima e dopo [2005].
Sul referendum brasiliano sulle armi - prima e dopo [2005].
 di Federico La Sala *
di Federico La Sala *
- Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. (Costituzione della Repubblica italiana).
“Su cosa è stato edificato il nuovo mondo? Genocidi e stermini. Chi ha dato il nome a questo nuovo mondo? Un Vespucci ((in verità non lui direttamente, ma ricordiamoci dei ragni e delle formiche di Bacone). Chi ha chiamato così l’Amazzonia? E, chi così il Brasile? A Napoli, sì sempre a Nea-polis, questo nome ricorda la brace, il braciere, persone intorno a un fuoco che riscalda, un cerchio familiare che si apre e accoglie chi ha freddo - non la devastazione e il deserto di chi cieco e folle si mette a distruggere tutto: Edipo con in mano il lancia-fiamme a volontà - Platone, il Tecno-crate. Di fronte alla Foresta gli uomini ciechi e folli di potenza (ma qui si parla anche delle donne-amazzoni) vedono nulla e fanno e ... faranno il Brasile?” (Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani Editore, Roma 1991, pp. 180-181)
Se vogliamo parlare di identità europea, oggi che dovremmo parlare di identità terrestre (siamo le generazioni che hanno visto e vedono la Terra dalla Luna, e dallo Spazio!!!), parliamone con più ampiezza, profondità, e altezza: reinterroghiamo il mito, antropologicamente!!!
Se ci muoviamo così, non è solo da “Europa” che dobbiamo partire, ma da chi l’ha rapita - da “Zeus” e da chi era “Zeus”. Così ci avvicinamo a Creta, a Minosse, a Pasifae, al Minotauro, al Labirinto, a Dedalo, Icaro, ad Arianna e Teseo, ecc. ecc. e arriviamo a Troia, a Omero, a Ulisse e ad Atena e ... Atene! Il problema è quello delle origini della Polis e del potere, del Potere armato di tecnica e di astuzia (Atena, figlia di Metis) - Zeus! La ‘civiltà’ del Logos armato e astuto: questo è il problema! Allora, forse, capiremo perché “Europa” non è più in Europa... e noi non sappiamo più chi siamo!!!.
La questione è da ‘peccato originale’: Eva è stata ‘rapita’ dal fascino di un serpente, Europa dal fascino di un toro. Tutte e due le ‘storie’ dicono del cadere in tentazione, della madre di tutti i viventi e della madre di tutti gli europei, tra le braccia di un ‘dio’ ingannatore, camuffato da animale - e l’obiettivo di tutti e due è negare e togliere “Dio” dal centro della vita sociale e politica degli esseri umani: così per il ‘serpente’, così per Zeus che, con l’aiuto della madre, aveva spodestato Chronos, che a sua volta aveva evirato e spodestato Urano - il Cielo.
Ora di che c’è da meravigliarsi, se (come figli e figlie di Europa) ci troviamo schiavi e senza parole in questo mondo dove regna l’armonia degli opposti e polemos è il padre di tutte le cose?! Di cosa ci si lamenta?! Che si vuole?! Zeus non abita più da noi, e nemmeno Europa: noi ‘europei’ non abbiamo più il fascino del ‘toro’ e nemmeno del ‘serpente’.... e nemmeno la bellezza di Europa.
Siamo diventati vecchi, e la nostra ‘bella’ Europa, insieme con i nostri “cervelli”, se ne è andata via!!! Europa, oggi, è stata di nuovo ‘rapita’, e vive (almeno per il momento!!!) a Washington.... Dobbiamo prenderne atto: non siamo più né Zeus né Europa!!! Zeus seduce continuamente la ‘nostra’ bella Europa e la ‘nostra’ bella Europa cade continuamente in estasi - rapita dal toro o dal serpente del momento. E “il giogo della Necessità” continua: che ‘bello’!!!
Quando eravamo giovani e forti, qualcuno ci ha detto che “chi di spada ferisce, di spada perisce”, ma nessuno l’ha voluto né ascoltare né capire. Eravamo tutti degli Zeus, a giocare il logos dell’eros e della guerra.... a caccia di ‘Europee’ da rapire. E, ora, di che ci lamentiamo? Cosa vogliamo? Diventare di nuovo Zeus o di nuovo Europa che Zeus viene a rapire? Boh e bah!? Non abbiamo imparato nulla? Che aspettiamo ancora?! Un altro “Zeus”?! Cosa aveva detto e ricordato Leopardi all’inizio della Ginestra? Non l’abbiamo capito e l’abbiamo dimenticato.... non sappiamo più né cosa è luce, né da dove viene la luce. Preferiamo il buio, e così continuiamo a dormire e a sognare sempre gli stessi sogni.
Che fare? Forse resta ancora un po’ di tempo: possiamo ritornare al di là delle origini e ... ri-nascere, in un libero mare e in un cielo puro!!! Solo il lieto-evento può portarci fuori dal tempo della tragedia (e del latinorum dei don Abbondio di tutti i tempi) - e, finalmente, ri-portarci la bella-notizia e nel tempo della Commedia e del parlar volgare di Dante, come di Francesco, come di Gioacchino da Fiore, ... come di tutti gli altri esseri umani di buona volontà del Pianeta Terra: non c’è nessun dio che ci può salvare, se non l’Amore - il Dio dei nostri padri (‘Giuseppe’) e delle nostre madri (‘Maria’). A partire da sé, e con i nostri ‘padri’ e con le nostre ‘madri’, cerchiamo di ri-nascere bene - e di non-morire, per sempre, con l’intera Terra!(Federico La Sala, www.ildialogo.org./editoriali, 22.10.2005)
****
“Lula, dopo la vittoria nelle elezioni presidenziali del 2002, aveva detto che per una volta «la speranza aveva vinto la paura». Domenica, tre anni dopo, è stata ancora una volta la paura a vincere sulla speranza. Non solo sulle armi da fuoco” (cfr. Maurizio Matteuzzi, “La libertà e la speranza. Le armi in Brasile”, il manifesto, 25.10.2005, p. 1). Il risultato è stato: 64% no, 34% sì.
Ma, nonostante questo, si continua a non capire: come Edipo, siamo diventati ciechi, ciechi psichicamente! Intanto peste e devastazione avanzano dappertutto - su tutta la Terra, come avanza la distruzione finale dell’ultima grande foresta, quella amazzonica. Il Brasile non è l’ ‘altro’ mondo, è il nostro stesso mondo allo specchio e non lo vogliamo né lo sappiamo riconoscere. Non abbiamo ancora capito - e continuiamo a non voler capire!
All’inizio, e su tutta la Terra, gli esseri umani sapevano, sapevano che cosa facevano, e che cosa dicevano! La foresta era la foresta, il deserto il deserto, e sia dall’una sia dall’altra, sapevano trarre energie per vivere, vivere - né morire né distruggere tutto. La foresta, come il deserto o la montagna e il mare, era la loro maestra e palestra di vita e di libertà (dopo millenni, J. J. Rousseau - il primo grande maestro del sospetto - aveva cominciato a capire!). Ed Europa non significava quello che si è voluto che significasse: tramonto, notte, occidente ... e morte!!!
In origine il nome “Europa” designò un territorio ristretto, forse la regione a nord dell’Egeo; in seguito i geografi indicarono con questo nome tutte le terre a nord del Mediterraneo. E, se ci fidiamo delle parole greche, significava e indicava un “buon” (gr.: “Eu”) luogo dove si poteva “far fascine”, “far legna” (gr.: “ropeuo”). Lì, i greci impararono a ‘orientarsi’ e a ‘leggere’: a ‘scegliere’, a ‘raccogliere’, a ‘legare’ e a ‘collegare’, cioè a “far legna”, e a “far fasci” ... ma non di tutte le erbe, né di tutta la legna!!!
Impararono, e impararono presto, divennero saggi (sofòi) e, infine, molto, troppo saggi (sofisti) ... e fu l’inizio della fine!. Nietzsche, che ha tentato di chiarire l’enigma, qualcosa aveva capito: se è vero che “la grecità fu la prima grande unificazione e sintesi di tutto il mondo orientale e appunto perciò l’inizio dell’anima europea, la scoperta del nostro ‘mondo nuovo’”, è anche vero che il “nuovo mondo” che abbiamo costruito dimostra quanto presto abbiamo dimenticato la ‘lezione’ delle foreste, dei mari, dei deserti, e dei fiumi e delle montagne!!!
Così Eu-ropa ed Eu-angelo hanno finito per condividere lo stesso ‘destino’ di cecità e di morte, e una sola parola: la volontà di potenza ha finito per accecare l’una e l’altro - e tutti e tutte abbiamo cancellato il “ben” (“eu”) dall’intelletto e dalle nostre Parole!!! E abbiamo esportato solo e sempre e ancora ..... ‘Fascismo’, e ‘Van-gelo’!!! Questo il nostro Logos?! Questo Logos era all’inizio?! Non scherziamo col fuoco: In principio era Eu-ropa.... ed Eu-angelo. Non dimentichiamolo! Sappiamo distinguere e dire quale Logos era in principio?! O no ... o non più?! (Federico La Sala, www.ildialogo.org/editoriali, 30.10.2005).
* www.ildialogo.org/filosofia, Lunedì, 30 ottobre 2005.
- La teologia romana dei secoli XIX e XX.
 Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità
(Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).
 MONETA DELL’ANTICA ATENE. La dea Atena con la civetta e il ramoscello di ulivo. |
- MONETA DELL’ANTICA ATENE. La dea Atena con la civetta e il ramoscello di ulivo.

MONETA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- CONTRATTO ORIGINARIO E PACE PERPETUA: "Primo articolo definitivo per la pace perpetua: «La costituzione civile di ogni Stato dev’essere repubblicana».
- La costituzione fondata: 1) sul principio della libertà dei membri di una società (come uomini); 2) sul principio della dipendenza di tutti da un’unica comune legislazione (come sudditi); 3) sulla legge dell’uguaglianza di tutti (come cittadini) - e, cioè l’unica costituzione che derivi dall’idea del contratto originario, sul quale la legislazione di ogni popolo deve fondarsi - è la costituzione repubblicana (I. Kant, Per la pace perpetua. Un progetto filosofico, 1795).
- IL "VANGELO" SECONDO LA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- PAOLO DI TARSO E COSTANTINO:"IN HOC SIGNO VINCES"!: «Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace.
 Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).
Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso)" vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- SACRO ROMANO IMPERO E QUESTIONI DI "PRECEDENZA": "L’Ordo Regum et Principum, redatto dai cerimonieri pontifici durante il pontificato di Giulio II, formalizzava la precedenza, dopo l’imperatore, alla Corte di Roma del re di Francia o del suo ambasciatore sul re di Spagna o sul suo rappresentante, fornendo così alla monarchia francese una possente arma giuridica che fu pesantemente giocata per rifiutare il ruolo di «cabeça de Europa» che la Spagna rivendicava.
 L’apertura, dopo l’abdicazione di Carlo V, da parte spagnola, di una dura vertenza sulla precedenza, in più luoghi, a Trento durante il Concilio, a Venezia, in Polonia, e soprattutto a Roma stessa, non modificò, anche dopo il mutamento dei rapporti di forza internazionali nella seconda metà del Cinquecento, la gerarchia fissata nel Cerimoniale Romano all’inizio del secolo.
L’apertura, dopo l’abdicazione di Carlo V, da parte spagnola, di una dura vertenza sulla precedenza, in più luoghi, a Trento durante il Concilio, a Venezia, in Polonia, e soprattutto a Roma stessa, non modificò, anche dopo il mutamento dei rapporti di forza internazionali nella seconda metà del Cinquecento, la gerarchia fissata nel Cerimoniale Romano all’inizio del secolo.
 Il discorso sulla precedenza nel XVI e XVII secolo si articolava, inoltre, intorno ad alcune categorie che erano giuridiche e storiche: la dignità, il privilegio, l’antichità (delle famiglie, delle stirpi, dei popoli) [...]" (cfr. Maria Antonietta Visceglia, Gli “humori” delle nazioni).
Il discorso sulla precedenza nel XVI e XVII secolo si articolava, inoltre, intorno ad alcune categorie che erano giuridiche e storiche: la dignità, il privilegio, l’antichità (delle famiglie, delle stirpi, dei popoli) [...]" (cfr. Maria Antonietta Visceglia, Gli “humori” delle nazioni).
- L’IMPERATORE COSTANTINO, LA "PAROLA" DI "DIO", E LA FIGURA DI "MICHELE" - OGGI: [...] San Michele. Voi sapete che cosa vuol dire Michele? È un nome prettamente orientale, ebraico, che vuol dire: “Quis ut Deus?”, “Chi è come Dio?”. Questa parola è parola che ha vinto, parola vincente nel grande scontro tra il bene e il male. Questa parola - Michele, “Chi è come Dio?” - ha vinto [...] “Quis ut Deus?”. E questa parola vince, vince come una volta l’imperatore romano Costantino ha vinto nella Croce: “in hoc signo”, in questo segno vincerai. Vi auguro questa vittoria (GIOVANNI PAOLO II, "Visita Pastorale alla parrocchia di Santa Maria Assunta e San Michele a Castel Romano", 13 febbraio 1994).
- USA (1630) - Come fare le cose con i testi: A Modell of Christian Charity di John Winthrop (Carla Vergaro - "L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA", 2017.)
- "PADRE NOSTRO"?!:ERASMO DA ROTTERDAM, Il lamento della pace, Einaudi, Torino, 1990, pp.51-55.
|
GRECIA - Una sede della "Caritas greca". |
FLS
L’EUROPA, LA SAGGEZZA STRANIERA, E L’ERRORE DEI GRECI (A. MOMIGLIANO). Nota
Forum
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- CRITICA DELLA RAGIONE "ASSOLUTA" SUL PIANETA TERRA: "HEGEL IN CANADA" E IL CORAGGIO DI SAPERE29 aprile 2025, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, #STORIA, #FILOSOFIA, #ANTROPOLOGIA, E #CRITICA DELLA #RAGIONE "ASSOLUTA" SUL #PIANETATERRA
IL CORAGGIO DEL "SAPERE AUDE!" DI KANT (1784) E LA COSTRUZIONE DI UNA SPLENDIDA CASA IN #CANADA (#29APRILE 2025). RIAPRIRE IL #CERCHIO DELLO #SPIRITO "#ASSOLUTO" E, CON #HEGEL, PORTARSI #OLTRE LO STESSO HEGEL, AL DI LA’ DELL’#IDEALISMO E DEL #MATERIALISMO ATEO-DEVOTO DELLA #COSMOTEANDRIA PLATONICO-COSTANTINIANA (#NICEA 325-2025):
- "[...] the Canadian Hegelian tradition does not focus overly much on using absolute as a noun. [...] We have the ideal of a total, coherent integration of reason and experience, of individual freedom and community, of the finite and the divine, of thought and reality. But that ideal is not an entity with a distinctive name. It is an ongoing dynamic, open towards the future’"(cfr. John W. Burbidge, "Hegel in Canada", 2018).
- NOTE:
- STORIOGRAFIA #LETTERATURA E #ANTROPOLOGIA TERRESTRE: #DIVINACOMMEDIA. RICORDANDO L’INDICAZIONE DELLA #SOLARE "#MONARCHIA" DI #DANTE ... e accogliendo, al contempo, l’invito dello storico #Remi #Brague a rimeditare la #saggezza (#wisdom) della #Romanitas ("IL FUTURO DELL’OCCIDENTE. Nel modello romano la #salvezza dell’#Europa", 1998), forse, è proprio "ora" e "qui" ("hegelianamente" e "cattolicamente") necessario e opportuno riprendere e portare avanti il filo antropologico-politico della lezione di #Cicerone a suo figlio #Marco: "Cum autem pulchritudinis duo genera sint, quorum in altero venustas sit, in altero dignitas, venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem." ("De officiis", I. 36). (#Dantedì, #25marzo 2025).
- CON "IL #PANTHEON SUL #PARTENONE", FATTO "SAN PIETRO DI ROMA" (#VICTOR #HUGO, 1831): #MICHELANGELO E IL #TRAMONTO DEL "#RINASCIMENTO" (O, DIVERSAMENTE, L’#INIZIO DEL "#CONTRORINASCIMENTO").
- In memoria di #Michelangelo Buonarroti, Marcel #Proust, e Walter #Benjamin....).
- FILOSOFIA DEL #LINGUAGGIO E #FILOLOGIA: IL #SEGNO DELLA #CROCE" ( "Signum Crucis"), L’#ANALFABETISMO ANTROPOLOGICO E TEOLOGICO-FILOSOFICO, E UNA #HAMLETICA QUESTIONE DI #GRAZIA (#Charis).
- In memoria di Walter Benjamin... *
- Una nota a margine di una riflessione di Flavio Piero Cuniberto sui tempi che corrono ... ).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! ---CULTURA E SOCIETÀ: RIPENSARE "COSTANTINO" (NICEA, 325-2025) E IL "SACRO ROMANO IMPERO" (PREMIO "CARLO MAGNO", 2016).21 aprile 2025, di Federico La Sala
CULTURA, #SOCIETÀ, #STORIA, E #METASTORIA:
RIPENSARE "COSTANTINO" (NICEA, 325-2025) E IL "SACRO ROMANO IMPERO" (PREMIO "CARLO MAGNO", 2016).
"SÀPERE #AUDE" (#ORAZIO-#KANT). ALLA LUCE DELLA SOLLECITAZIONE A RIFLETTERE SU "LA #GERMANIA SENZA #IDEE, VENTRE MOLLE D’#EUROPA" (cfr. Donatella Di Cesare, "Il Fatto Quotidiano", 16 aprile 2025), FORSE, è IL CASO DI USCIRE DAL #LETARGO (#DANTE ALIGHIERI) in cui "naviga" la "nave" europea, ripartire da #Kant ( e dal presente "legame" #Koenigsberg - #Kaliningrad), e, seguendo il filo "dimenticato" di Herman v. #Helmholtz, e, di #Marya #Sklodowska-#Curie ("cum grano salis", rileggere i paragrafi a loro dedicati da Friedrich #Heer, nel capitolo finale della sua "Europa, madre di rivoluzioni", il Saggiatore, 1968, vol. II, pp. 556-561, e pp. 580-589), cercare di recuperare il "#tempo #perduto" (#Marcel Proust).
A tal fine, non è male rileggere il "Discorso pronunciato dal presidente del Parlamento europeo Martin Schulz", in occasione della consegna del "Premio Carlo Magno", a Papa Francesco, il 6 maggio 2016 (cfr. "Il Sole-24 Ore", 6 maggio 2016) e, possibilmente, riprendere a lavorare "per la #pace #perpetua".
- NOTA:
- STORIA E #STORIOGRAFIA. "La formula di Friedrich #Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità" (di Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", Treccani 2013).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- "ANTROPOLOGIA" E STORIA DELLA "EUROPA, MADRE DELLE RIVOLUZIONI"18 aprile 2025, di Federico La Sala
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! DOPO DUEMILA ANNI DI CRISTIANESIMO COSTANTINIANO E PAOLINO, QUALE IDEA DI EUROPA ANCORA E’ POSSIBILE?!:
- La teologia romana dei secoli XIX e XX.
 Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- "CONFERIMENTO DEL PREMIO CARLO MAGNO. UNA CITAZIONE DAL "DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO. Sala Regia Venerdì, 6 maggio 2016":
- Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell’uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli?.
"ANTROPOLOGIA" E STORIA DELLA "EUROPA, MADRE DELLE RIVOLUZIONI". Lo storico Friedrich Heer chiude l’opera così intitolata, appunto "Europa, madre di rivoluzioni" (1964; ed. it., 2 voll.m Il Saggiatore, Milano 1968), con il capitolo finale riflettendo su "Il salto", cominciando con il paragrafo "il salto cifra per il XIX-XX secolo, Tutto è in movimento", e, concludendo con l’ultimo paragrafo, a "Marya Sklodowska-Curie", e così scrive: "[...] Marya Sklodowska-Curie appartiene agli uomini di una Nuova Era incipiente, i quali sanno che le battaglie sul fronte dell’uomo - contro la morte, l’assurdo, l’ingiusto, il male, la stupidità - devono essere combattute in nuove forme; richiedono l’intera vita; un pensiero rigoroso, autocritico, un sentimento puro [...]"; e, in nota, aggiunge e "insiste" (in modo "antropologicamente" e linguisticamente "cattolico"): "Nuove battaglie - sul fronte dell’uomo [...] Questo secolo (o per meglio dire: alcuni suoi uomini) ha cominciato a comprendere in modo nuovo, e a far propria, la parola oscura e profonda dell’apostolo Paolo: Noi uomini siamo gli eredi di Dio" (F. Heer, op. cit., II, p. 588 e p. 596).
Federico La Sala
- La teologia romana dei secoli XIX e XX.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- LA "SOLLECITAZIONE" DI#DANTE ALIGHIERI AD ANGELO GIUSEPPE RONCALLI, PAPA GIOVANNI XXIII, A PORTARSI OLTRE LO SPIRITO DELLA TRAGEDIA.15 aprile 2025, di Federico La Sala
LA STORIA, LA LETTERATURA, I "SEGNI DEI TEMPI", E LA "SOLLECITAZIONE" DI#DANTE ALIGHIERI AD ANGELO GIUSEPPE RONCALLI, PAPA #GIOVANNI XXIII, A PORTARSI OLTRE LO #SPIRITO DELLA #TRAGEDIA. Alcuni appunti sul tema...
A) - «DANTE E I #PAPI. L’influsso dell’Alighieri sul magistero di Giovanni XXIII: "[...] Dante è una delle fonti del pensiero teologico di Angelo Roncalli. Pertanto indichiamo tre cause, ma anche conseguenze, di questa affermazione: la formazione teologica e spirituale, la scelta del nome Giovanni XXIII, la ri-fondazione della cattedra di Teologia dantesca (a.a. 1961/1962), in coincidenza con la fase preparatoria del concilio. [...]"» (cfr. Gabriella M. Di Paola Dollorenzo, "Una delle fonti del pensiero teologico", L’Osservatore Romano, 14 dicembre 2020)
B) - UNA SVOLTA EPOCALE: DA "GIOVANNI XXII" (Jacques Duèze) A "GIOVANNI XXIII" (Angelo Giuseppe Roncalli ).
C) - I SEGNI DEI TEMPI: "L’espressione segni dei tempi fu usata per la prima volta ufficialmente nella bolla di Giovanni XXIII Humanae salutis (25.12.1961) con cui convocava il Concilio. Nell’enciclica Pacem in terris (11.4.1963) dello stesso Pontefice, diventa una categoria fondamentale. In modo chiaro, vengono in essa indicati #quattro segni dei tempi contemporanei: la socializzazione, l’emancipazione delle classi lavoratrici, l’ingresso della donna nella vita pubblica, la libertà dei popoli oppressi. [...]" (cfr. C. Floristán, "Dizionario sintetico di pastorale").
D) - ANTROPOLOGIA E CRISTIANESIMO, AL DI LÀ DEL PAOLINISMO: #DANTE #ALIGHIERI. «La #FenomenologiadelloSpirito... dei “#DueSoli”. Ipotesi di rilettura della “#DivinaCommedia”» (cfr. Federico La Sala, "IL DIALOGO/Quaderni di teologia", 24 luglio 2007).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ANTROPOLOGIA, “AGRICOLTURA”, E “DISAGIO DELLA CIVILTÀ” (S. FREUD, 1929): L’«URLO» DI «JUDITH SHAKESPEARE» (VIRGINIA WOOLF).9 aprile 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, “AGRICOLTURA”, E “DISAGIO DELLA CIVILTÀ” (S. FREUD, 1929):
L’«URLO» DI «JUDITH SHAKESPEARE».
- Un omaggio a “Phrasikleia” (Jesper Svenbro, 2024). *
A MEMORIA DI VIRGINIA WOOLF, a suo onore e gloria, forse, è bene rimeditare le sue stesse parole, “pronunciate” nella “conferenza” dedicata al tema di “Una stanza tutta per sé” (1929):
- “[...] sarebbe stato impossibile, completamente e interamente impossibile che una donna scrivesse nell’epoca di Shakespeare le opere di Shakespeare. Immaginiamo, giacché ci riesce così difficile conoscere la realtà, che cosa sarebbe successo se Shakespeare avesse avuto una sorella meravigliosamente dotata, chiamata Judith, diciamo.” (Virginia Woolf, “Romanzi e Altro”, Mondadori, Milano).
“TO BE, OR NOT TO BE - THAT IS THE QUESTION” (“HAMLET, III.1). Se si considera il luogo e la modalità della morte di Virginia Stephen Woolf, con i suoi particolari riferimenti (“appoggia il suo bastone da passeggio sull’argine dell’Ouse e poi si getta nelle acque del fiume”), data la dichiarata “sorellanza” di “Judith” con “William Shakespeare” e la sua “urlata” domanda amletica sul «Chi mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando rimane preso e intrappolato in un corpo di donna?», come non “registrare” (chissà se mai è stato fatto) la forte “consonanza” con il “racconto” della regina Gertrude sulla morte di Ofelia:
 “C’è un salice che cresce di traverso /a un ruscello e specchia le sue foglie /nella vitrea corrente; qui ella venne [...]” (“Amleto”, IV. 7)?!
“C’è un salice che cresce di traverso /a un ruscello e specchia le sue foglie /nella vitrea corrente; qui ella venne [...]” (“Amleto”, IV. 7)?!E, ancora, come non sollecitar-si a una rilettura delle opere degli “Shakespeare” e a una più ampia e profonda riflessione sulla “tragedia” della “zoppicante" e “cieca” questione antropologica, a partire dal “due”, dai “due soli” della "Monarchia” di Dante Alighieri e delle “tre corone” dello “Spaccio della bestia tropnfante” di Giordano Buno?!
*
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- COSMOLOGIA, FILOLOGIA E TEOLOGIA TEOCRITEA. "SÀPERE AUDE": L’UNIVERSO, PER IL FISICO ALAN GUTH E’ «IL PIU’ GRANDE DEI PRANZI #GRATIS».31 marzo 2025, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, FILOLOGIA E TEOLOGIA TEOCRITEA ("CHARITAS), E #MEMORIA DEL #CORAGGIO DI #ASSAGGIARE ("SÀPERE AUDE") (ORAZIO - KANT):
- L’UNIVERSO, PER IL FISICO ALAN GUTH E’ «IL PIU’ GRANDE DEI PRANZI GRATIS».
Una lezione di "recupero" di antropologia filosofica di Armando Massarenti ("Il Sole 24 Ore", 24 aprile 2011):
Sicuri che nessun pasto è gratis?
«Nessun pasto è gratis», fu la risposta che un re ebbe dai suoi consiglieri dopo aver a lungo insistito per sapere, in un sola frase, quale fosse il senso della scienza economica. #Michael #Brooks, già autore del best seller "13 cose che non hanno senso", nel volume sulla #Fisica nella collana "Le grandi domande", diretta da #Simon #Blackburn (Edizioni Dedalo) esordisce con queste parole: «La bellezza della fisica si riassume in un fatto semplicissimo: un #bambino può fare domande cui nessun professore può rispondere».
Una di queste è «Perché non esistono pranzi gratis?». Che, in fisica, ci spinge a dare risposte in termini di «energia, entropia e ricerca del moto perpetuo». #LeonardodaVinci fece un’analisi dettagliata di una famosa macchina che pretendeva di generare il moto perpetuo, e spiegò perché non poteva funzionare. «O ricercatori del moto perpetuo», concludeva, «quante idee sconclusionate avete concepito nel corso di questa ricerca. Sareste pronti per andare a fare gli alchimisti». Cioè a sognare altri pranzi gratis. Eppure un pasto gratis sembrerebbe esistere, ed sarebbe niente meno che il nostro stesso Universo.
Per il fisico Alan Guth è «il più grande dei pranzi gratis», e ciò è dovuto al concetto cosmologico di «inflazione»: «l’Universo e tutta l’energia che contiene si sarebbero sviluppati a partire da un grammo di materiale. Una frazione di secondo dopo il #BigBang, l’Universo era cento miliardi di volte più piccolo di un protone, ma nel giro di 10-34 secondi aveva già raggiunto una dimensione pari a 1025 volte quella di partenza - qualcosa di simile a una biglia» e da lì sì è espanso sempre più fino alle immensità attuali. Nel corso di questo processo l’energia interna dell’Universo è cresciuta di un fattore 1075, il che sembrerebbe violare il principio che impedisce di avere qualcosa in cambio di nulla.
Invece c’è un dettaglio che permette di restare nell’ambito delle leggi fisiche conosciute: una parte dell’energia è negativa, come mostra la teoria della relatività generale. «L’energia associata alla materia è positiva - riassume Brooks -, e la creazione continua di materia fece aumentare l’energia positiva in modo tale da compensare l’aumento dell’energia negativa. In questo modo l’energia totale può rimanere costante. Gli antichi Greci affermavano che nulla può essere creato dal nulla, ma l’inflazione si permette di non essere d’accordo». E di affermare dunque la totale #gratuità dell’Universo.
Sarà proprio così? Di certo, nella nostra vita, ahinoi, continua a vigere la dura legge degli #economisti.
- NOTA:
- UN "SOGNO" DI #TEOCRITO, LE GRAZIE ("#CHARITES"), E UNA QUESTIONE DI #GRATITUDINE: UNA #DOMANDA DI ARCHEOLOGIA, #LINGUISTICA, #FILOLOGIA, #FILOSOFIA, #TEOLOGIA, #ARTE, #SOCIOLOGIA E #PEDAGOGIA...
- In ricordo di #LorenzoValla e di #GiambattistaVico, una breve nota....
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ANTROPOLOGIA E MATEMATICA. RIPENSARE L’ UNO: LA BELLEZZA DELLA GRAZIA ("VENUSTAS") E DELLA DIGNITA’ ("DIGNITAS") DELL’UOMO E DELLA DONNA.19 marzo 2025, di Federico La Sala
MATEMATICA E ANTROPOLOGIA: DA #DANTE ALIGHIERI E #MICHELANGELO #BUONARROTI, UNA SOLLECITAZIONE A RIPENSARE L’ UNO (#ONU), AL DI LA’ DEL #PLATONISMO E DEL #PAOLINISMO.
ARTE E ARITMETICA: IL "QUADRATO" DEL "CERCHIO". IL "TONDO DONI" E QUATTRO PROFETI (2+2= 4). Per la "Galleria degli Uffizi" nella cornice, sono "raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti". Ma, per Michelangelo, non è la testa di Gesù Cristo e non sono le teste di due profeti e #due #sibille?!
Non è meglio ri-#contare? Oppure è da ritenersi la punta di un "iceberg", di una questione antropologico-teologica "eterna"?!
Questa la "question" (Shakespeare): una questione antropologica e teologico-politica. Ri-pensare #comenasconoibambini: ri-considerare la #Relazione di "#Giuseppe e #Maria" e ri-meditare la lezione di Michelangelo Buonarroti. Solo così, forse, è possibile capire cosa significa il "ritrovamento" del Laocoonte e, altrettanto, come sia possibile liberare OGNI "UNO", ogni INDIVIDUO ("1") dalla "solitudine" e dall’immaginario bellico ("Homo homini lupus") e uscire dalla polifemica e luciferina "caverna" della #tragedia. (#19marzo 2025).
- NOTE:
- Questione antropologica e #cosmoteandria (#filologia e #cristologia), oggi (#19marzo 2025): "chi è questo figlio dell’#uomo?" (Gv. 12, 34). Come mai il silenzio totale di tutte le Accademie "platoniche" sulla #declinazione antropologica del messaggio evangelico ("Ecce #Homo") in chiave andrologica e costantiniana ("Ecce #Vir")? Non è questo un "meccanismo di rimozione" profondissima (S. #Freud, "Disagio della civiltà", 1929), che ha finito per spezzare le reni alla #Grecia e fatto diventare l’antropologia una #andrologia e, addirittura, il #Logos di #Efeso, il #logo di una #fattoriadeglianimali?! A che gioco giochiamo?! (#Dantedì, #25marzo 2025).
- STORIOGRAFIA #LETTERATURA E #ANTROPOLOGIA TERRESTRE: #DIVINA COMMEDIA. RICORDANDO L’INDICAZIONE DELLA #SOLARE "MONARCHIA" DI #DANTE ... e accogliendo, al contempo, l’invito dello storico #Remi #Brague a rimeditare la #saggezza (#wisdom) della #Romanitas ("IL FUTURO DELL’OCCIDENTE. Nel modello romano la salvezza dell’Europa", 1998), forse, è proprio "ora" e "qui" ("hegelianamente" e "cattolicamente") necessario e opportuno riprendere e portare avanti il filo antropologico-politico della lezione di #Cicerone a suo figlio #Marco:
- "Ma poiché vi sono due specie di bellezza, delle quali una è la grazia, l’altra la dignità, dobbiamo considerare la grazia femminile e la dignità maschile" ("Cum autem pulchritudinis duo genera sint, quorum in altero #venustas sit, in altero #dignitas, venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem.": "De officiis", I. 130).
- (#Dantedì, #25marzo 2025).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- LA STORIA (TEATRO), L’ARATRO (TERRA), LO STILO (SCRITTURA ALFABETICA), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO (NICEA, 325 - 2025)17 marzo 2025, di Federico La Sala
LA STORIA (TEATRO), L’ARATRO (TERRA), LO STILO (SCRITTURA ALFABETICA), LO STORYTELLING ("GLOBE THEATRE"), E L’ ANTROPOLOGIA DELLA "INTELLIGENZA ARTIFICIALE" (AI=IA).
- In memoria di Immanuel Kant...
CONSIDERANDO la storia dell’ "agricoltura" e l’importanza dell’invenzione dell’aratro per la seminagione del grano e del suo mito fondante connesso al rapimento di Persefone/Proserpina, la figlia di Demetra /Cerere, da parte di Ade/Plutone, si comprende meglio quale "matrimonio" impone la Legge della antica Grecia e cosa "nasconde" la nascita della tragedia: "«non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (Eschilo, "Eumenidi", 657 ss.). #Shakespeare insegna: "The time is out of joint" ("Hamlet", I.5).
TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA. A reimpostare, antropologicamente e matematicamentre, la questione, è da dire che aveva ragione #Whitehead (con #BertrandRussell, autore dei "Principia Mathematica"): "Tutta la storia della filosofia occidentale non è che una serie di note a margine a #Platone".
Se è vero, come è stato scritto, che "un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, 1978), che fare, oggi, se non andare oltre l’antico programma, codificato nella "macchina" di "scrittura" della tragedia, e portarsi fuori dal rapporto sociale di produzione "cinematografico" platonico?
A mio parere, la "question" è epocalmente hamletica - alla Shakespeare (#Freud): antropologica. Il nodo è che la narrazione della intelligenza artificiale (AI = IA) di questa odierna "società elettronica" è fondata sul codice di una "immaginazione sociologica" (vale a dire, alla Karl #Marx e alla Charles Wright Mills, su un "rapporto sociale di produzione"), proprio e ancora di quello della tragedia (Eschilo, Sofocle, Euripide) della Grecia antica (cfr. Jesper Svenbro, "Phrasikleia, anthropologie de la lecture en Grèce ancienne", Paris 1988).
DIVINA COMMEDIA E CREATIVITA’. Il grande racconto cosmoteandrico di un "mondo come volontà e rappresentazione" di un #Autore - #Sovrano, a tutti i livelli, è finito, e, se non si vuole finire asfissiati nella sua "caverna", non si può non seguire #DanteAlighieri e cercare di ritrovare la "diritta via" della #Commedia!
Meglio riprendere con "Il Nome della rosa (#UmbertoEco), il filo del "maestro di color che sanno" (Inf., IV, 131), #Aristotele, rileggere criticamente "La sposa meccanica" (Marshall McLuhan), e, dopo millenni, uscire dallo storico inferno epistemologico e riequilibrare la teoria del campo cosmo-politico e antropologico: "il resto è silenzio" ("Amleto", V.2).
#Dantedì, #25marzo 2025
- NOTA:
- LA TERRA, LA #SCRITTURA ALFABETICA E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO (#Nicea, 325-2025): SAN BENEDETTO, “CON LA CROCE, CON IL #LIBRO E CON L’ #ARATRO”. Un invito a a riconsiderare, storiograficamente e antropologicamente. la “tenuta” dell’#architettura costituzionale della “casa comune” europea e terrestre ...
- Una nota in memoria di #Galileo #Galilei e di #Immanuel #Kant...
- CULTURA E SOCIETA’. SE NEL “LONTANO” 1610, #GALILEO #GALILEI PUBBLICA IL SUO “#MESSAGGERO #CELESTE” (“SIDEREUS NUNCIUS”), nel non troppo “recente” 1964, il 24 ottobre, nel secondo anno del suo Pontificato, papa Paolo VI, con la “Lettera apostolica”, intitolata “PACIS NUNTIUS” (“MESSAGGERO DI PACE”), proclama SAN BENEDETTO, PATRONO D’#EUROPA....
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- COME NASCE LO STATO? LA "REPUBBLICA ("POLITEIA") DI PLATONE E UNA "ROBINSONATA" DI UN "PLATONISMO" MILLENARIO.15 marzo 2025, di Federico La Sala
INDIVIDUO E SOCIETA’: COME NASCE LO STATO?
LA "ROBINSONATA" DI UN "PLATONISMO" DI MILLENNI: SOCRATE RISPONDE ALLA DOMANDA SUL COME NASCE LA SOCIETA’, MA NON ANCHE SUL COME NASCE L’INDIVIDUO.
UNA "CITAZIONE" DALL’OPERA DI PLATONE, "REPUBBLICA ["POLITEIA"]" (II, 368-371):
- SOCRATE AD ADIMANTO: "[...] Noi affermiamo che esiste una giustizia del singolo individuo e in certo senso anche quella di uno stato intero, no? - Senza dubbio, ammise. - Ora, uno stato non è maggiore di un individuo? - Maggiore, sí, rispose. - Ebbene, in un àmbito maggiore ci sarà forse piú giustizia e la si noterà piú facilmente. Perciò, se volete, [369 a] cerchiamo prima negli stati che cosa essa sia. Esaminiamola poi con questo metodo anche in ogni individuo e cerchiamo di cogliere nelle caratteristiche del minore la somiglianza con il maggiore. - Cosí va bene, mi sembra, rispose. - Ora, ripresi io, se non di fatto, ma a parole assistessimo al processo di nascita di uno stato, non vedremmo nascere pure la giustizia e l’ingiustizia? - Forse sí, ammise. - E se ciò avviene, non possiamo sperare di scorgere piú agevolmente il nostro obiettivo? - Molto [b] di piú, certo. - Ora, secondo voi, dobbiamo tentar di andare sino in fondo? Non la credo una impresa da poco, e quindi pensateci su! - Ci abbiamo già pensato, disse Adimanto. Via!, fa’ come hai detto.
- Secondo me, ripresi, uno stato nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso, ma ha molti bisogni. O con quale altro principio credi che si fondi uno stato? - Con nessun altro, rispose. - Cosí per un certo [c] bisogno ci si vale dell’aiuto di uno, per un altro di quello di un altro: il gran numero di questi bisogni fa riunire in un’unica sede molte persone che si associano per darsi aiuto, e a questa coabitazione abbiamo dato il nome di stato. Non è vero? - Senza dubbio. - Quando dunque uno dà una cosa a un altro, se gliela dà, o da lui la riceve, non lo fa perché crede che sia meglio per sé? - Senza dubbio. - Suvvia, feci io, costruiamo a parole uno stato fin dalla sua origine: esso sarà creato, pare, dal nostro bisogno. - Come no? - Ora, il primo e maggiore [d] bisogno è quello di provvedersi il nutrimento per sussistere e vivere. - Senz’altro. - Il secondo quello di provvedersi l’abitazione, il terzo il vestito e simili cose. - Sí, sono questi. - Ebbene, dissi, come potrà bastare lo stato a provvedere tutto questo? Non ci dovranno essere agricoltore, muratore e tessitore? E non vi aggiungeremo pure un calzolaio o qualche altro che con la sua attività soddisfi ai bisogni del corpo? - Senza dubbio. - Il nucleo essenziale dello stato sarà di quattro o cinque [e] persone. - È evidente. - Ebbene, ciascuna di esse deve prestare l’opera sua per tutta la comunità? Cosí, per esempio, l’agricoltore, che è uno, deve forse provvedere cibi per quattro e spendere quadruplo tempo e fatica per fornire il grano e metterlo in comune con gli altri? o deve evitarsi questa briga e produrre per sé soltanto un [370 a] quarto di questo grano in un quarto di tempo? e impiegare gli altri tre quarti del tempo uno a provvedersi l’abitazione, uno il vestito, uno le calzature? e non prendersi per gli altri i fastidi che derivano dai rapporti sociali, ma badare per conto proprio ai fatti suoi? Rispose Adimanto: - Forse, Socrate, la prima soluzione è piú facile della seconda.
 Nulla di strano, per Zeus!, io dissi. Le tue parole mi fanno riflettere che anzitutto ciascuno di noi nasce per natura completamente diverso da ciascun altro, [b] con differente disposizione, chi per un dato compito, chi per un altro. Non ti sembra? - A me sí. - Ancora: agirà meglio uno che eserciti da solo molte arti o quando da solo ne eserciti una sola? - Quando da solo ne eserciti una sola, rispose. - È chiaro d’altra parte, credo, che se uno si lascia sfuggire l’occasione opportuna per una data opera, questa opera è perduta. - È chiaro, sí. - L’opera da compiere non sta ad aspettare, credo, i comodi di chi la compie. E chi la compie deve starle [c] dietro, senza considerarla un semplice passatempo. - Per forza. - Per conseguenza le singole cose riescono piú e meglio con maggiore facilità quando uno faccia una cosa sola, secondo la propria naturale disposizione e a tempo opportuno, senza darsi pensiero delle altre. - Perfettamente.
Nulla di strano, per Zeus!, io dissi. Le tue parole mi fanno riflettere che anzitutto ciascuno di noi nasce per natura completamente diverso da ciascun altro, [b] con differente disposizione, chi per un dato compito, chi per un altro. Non ti sembra? - A me sí. - Ancora: agirà meglio uno che eserciti da solo molte arti o quando da solo ne eserciti una sola? - Quando da solo ne eserciti una sola, rispose. - È chiaro d’altra parte, credo, che se uno si lascia sfuggire l’occasione opportuna per una data opera, questa opera è perduta. - È chiaro, sí. - L’opera da compiere non sta ad aspettare, credo, i comodi di chi la compie. E chi la compie deve starle [c] dietro, senza considerarla un semplice passatempo. - Per forza. - Per conseguenza le singole cose riescono piú e meglio con maggiore facilità quando uno faccia una cosa sola, secondo la propria naturale disposizione e a tempo opportuno, senza darsi pensiero delle altre. - Perfettamente.
 Occorrono dunque, Adimanto, piú di quattro cittadini per provvedere quanto dicevamo: ché l’agricoltore, come sembra, non si costruirà lui stesso da solo l’aratro, se ha da essere un buon aratro, né la zappa né [d] gli altri attrezzi agricoli. Né d’altra parte si costruirà i propri arnesi il muratore: gliene occorrono molti. E cosí il tessitore e il calzolaio. No? - È vero. - Ecco dunque che carpentieri, fabbri e molti altri simili artigiani verranno a far parte del nostro staterello e lo renderanno popoloso. - Senza dubbio. - Ma non sarebbe ancora troppo grande se vi aggiungessimo bovai, pecorai e le altre categorie [e] di pastori: ciò perché gli agricoltori possano avere buoi per l’aratura, e i muratori servirsi, insieme con gli agricoltori, di bestie da tiro per i loro trasporti, e i tessitori e i calzolai disporre di pelli e di lane. - Ma con tutta questa gente, ribatté, non sarebbe neanche piccolo il nostro stato. - D’altra parte, ripresi io, è pressoché impossibile fondarlo in un luogo che renda superflue le importazioni. - Impossibile. - Occorreranno quindi altre persone ancora per portargli da un altro stato la roba che gli abbisogna. - Occorreranno, sí. - E se il nostro agente si presenta a mani vuote senza alcuno dei prodotti occorrenti a chi ci fornisce le merci d’importazione [371 a] necessarie per i nostri cittadini, se ne verrà via a mani vuote, non è vero? - Mi sembra di sí. - La produzione interna deve dunque non solo bastare ai cittadini stessi, ma anche rispondere per qualità e quantità alle esigenze di coloro dei quali i nostri cittadini possono avere bisogno. - Deve, sí. - Al nostro stato occorre perciò un maggiore numero di agricoltori e di altri artigiani. - Sí, un numero maggiore. - E anche di altri agenti, a mio avviso, destinati a importare e ad esportare le singole merci. Sono questi i commercianti, non è vero? - Sí. - Ci abbisogneranno dunque anche i commercianti. - Senza dubbio. - E se poi il commercio si svolge per mare, [b] occorreranno ancora molti altri, pratici del lavoro marittimo. - Molti altri, certo. [...]" (Platone, "Opere complete", 6, Laterza, Bari, 1971, pp. 85-87).
Occorrono dunque, Adimanto, piú di quattro cittadini per provvedere quanto dicevamo: ché l’agricoltore, come sembra, non si costruirà lui stesso da solo l’aratro, se ha da essere un buon aratro, né la zappa né [d] gli altri attrezzi agricoli. Né d’altra parte si costruirà i propri arnesi il muratore: gliene occorrono molti. E cosí il tessitore e il calzolaio. No? - È vero. - Ecco dunque che carpentieri, fabbri e molti altri simili artigiani verranno a far parte del nostro staterello e lo renderanno popoloso. - Senza dubbio. - Ma non sarebbe ancora troppo grande se vi aggiungessimo bovai, pecorai e le altre categorie [e] di pastori: ciò perché gli agricoltori possano avere buoi per l’aratura, e i muratori servirsi, insieme con gli agricoltori, di bestie da tiro per i loro trasporti, e i tessitori e i calzolai disporre di pelli e di lane. - Ma con tutta questa gente, ribatté, non sarebbe neanche piccolo il nostro stato. - D’altra parte, ripresi io, è pressoché impossibile fondarlo in un luogo che renda superflue le importazioni. - Impossibile. - Occorreranno quindi altre persone ancora per portargli da un altro stato la roba che gli abbisogna. - Occorreranno, sí. - E se il nostro agente si presenta a mani vuote senza alcuno dei prodotti occorrenti a chi ci fornisce le merci d’importazione [371 a] necessarie per i nostri cittadini, se ne verrà via a mani vuote, non è vero? - Mi sembra di sí. - La produzione interna deve dunque non solo bastare ai cittadini stessi, ma anche rispondere per qualità e quantità alle esigenze di coloro dei quali i nostri cittadini possono avere bisogno. - Deve, sí. - Al nostro stato occorre perciò un maggiore numero di agricoltori e di altri artigiani. - Sí, un numero maggiore. - E anche di altri agenti, a mio avviso, destinati a importare e ad esportare le singole merci. Sono questi i commercianti, non è vero? - Sí. - Ci abbisogneranno dunque anche i commercianti. - Senza dubbio. - E se poi il commercio si svolge per mare, [b] occorreranno ancora molti altri, pratici del lavoro marittimo. - Molti altri, certo. [...]" (Platone, "Opere complete", 6, Laterza, Bari, 1971, pp. 85-87).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA-POLITICA: RICORDANDO DANTE ALIGHIERI E I "DUE SOLI" DELLA SUA "MONARCHIA", -RIPENSARE L’UNO, ri-pensare l’ONU.10 marzo 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #STORIA D’#EUROPA (#8MARZO 2024 / #10MARZO 2025): RICORDANDO DANTE ALIGHIERI E I #DUESOLI DELLA SUA #MONARCHIA,
 RIPENSARE L’UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson) - e uscire dall’ orizzonte della #tragedia.
RIPENSARE L’UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson) - e uscire dall’ orizzonte della #tragedia."DIVINA COMMEDIA": CON #DANTE (#25MARZO 2025), OLTRE #VERSAILLES E OLTRE L’ ANDROCENTRISMO DI NAPOLEONE: LA #FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-#VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-#MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO "MAMMONICO" DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- A PARTIRE DA DUE "GIOVANNI BATTISTA DELLA PORTA", NELL’ITALIA DELLA FINE DEL CINQUECENTO E DELLA PRIMA META’ DEL SEICENTO. UN INVITO A RIGUARDARE LE LORO "STORIE".10 marzo 2025, di Federico La Sala
STORIA CRITICA E ARCHEOLOGIA FILOSOFICA: NELL’#ITALIA E NELL’#EUROPA DELLA FINE DEL #CINQUECENTO E DELLA PRIMA META’ DEL #SEICENTO, VIVONO
DUE "GIOVANNI BATTISTA DELLA PORTA".
- UN INVITO "STORIOGRAFICO" A RIGUARDARE LE LORO "STORIE" E A RIPENSARE IL LORO #TEMPO #STORICO #COMUNE:
- A) Giovanni Battista Della Porta (nato a #Porlezza, in provincia di Como, nel 1542, e morto a Roma, nel 1597), architetto e scultore ; e
- B) Giovanni Battista Della Porta (nato a #VicoEquense, il 1º novembre 1535, e, morto a Napoli, il 4 febbraio 1615), filosofo, alchimista, commediografo e scienziato.
La "COINCIDENZA" OFFRE UNA BUONA "SOLLECITAZIONE" A RI-CONSIDERARE MEGLIO L’ #ORIZZONTE STORICO-CULTURALE ENTRO CUI SONO VISSUTI NON SOLO I DUE (DIVERSI E DISTINTI) "DELLA PORTA", MA ANCHE #GIORDANOBRUNO, #TOMMASOCAMPANELLA, WILLIAM #SHAKESPEARE, MIGUEL #CERVANTES, #GALILEI, ECC. e, al contempo, a riflettere ancora e di nuovo sulla "Magiae Naturalis" di Giovan Battista della Porta (di cui è stata pubblicata l’edizione critica ( per i Tipi dell’ Edizione Scientifica Italiana di Napoli a cura di Alfonso Paolella ).
- NOTE:
- ROMANZO STORICO E #STORIOGRAFIA: A riprendere il filo dalla "storia" del XVII secolo, che prende il via da "quel ramo del lago di #Como" (Alessandro #Manzoni, "I #Promessi Sposi"), e dal fatto "straordinario" che, al centro di Milano, ci sia una strada breve e stretta, tra piazza Cairoli a via Dante, che si chiami "Via Porlezza" , forse, è possibile e facile risalire nel tempo e nello spazio e ricomprendere la "base" socio-culturale da cui è "partito" Il Giovanni Battista Della Porta, diventato poi architetto e scultore di notevole valore e fama, e, nello stesso tempo storico, il Giovanni Battista Della Porta, diventato altrettanto poi scienziato e filosofo di grande valore e fama.
- A PARTIRE DALLA MILANO E DALLA NAPOLI DEL QUATTROCENTO E DEL CINQUECENTO. Per orientarsi, e "ricollocarsi" nell’orizzonte spazio-temporale di vita dei due "Della Porta", è opportuno ripensare alla caduta di Costantinopoli (1453) e, in particolare, alla #Pace di #Lodi (1454): "Con questo documento Francesco Sforza e Alfonso d’Aragona furono riconosciuti rispettivamente #Duca di #Milano e #Re di #Napoli, la Repubblica di Venezia estese il suo dominio fino all’Adda e fu conclusa la Santissima Lega Italica contro i Turchi.".
 Ora, se si tiene presente che, in questi anni (a partire dal 1470), il signore di #Porlezza, è il condottiero di ventura, Ambrogino da Longhignana, un ghibellino, legato al clan familiare di Vitaliano #Borromeo e "agli stipendi del duca di Milano Francesco Sforza", si può cominciare a capire in quale ambiente socio- politico e culturale sia nato Giovanni Battista Della Porta (1542-1597).
Ora, se si tiene presente che, in questi anni (a partire dal 1470), il signore di #Porlezza, è il condottiero di ventura, Ambrogino da Longhignana, un ghibellino, legato al clan familiare di Vitaliano #Borromeo e "agli stipendi del duca di Milano Francesco Sforza", si può cominciare a capire in quale ambiente socio- politico e culturale sia nato Giovanni Battista Della Porta (1542-1597).
- ARTE, LETTERATURA, E #TEOLOGIA-#POLITICA: A #PORLEZZA SI COMBATTE PER "LA #PACE DELLA #FEDE" (NICCOLO’ #CUSANO, 1453) E SI RICORDA #CARLOMAGNO E LA "#STORIA" DEL #DUELLO TRA #ROLANDO E #FERRAU’. === "In località Bilate, nel comune di Carlazzo (Co), in Val Menaggio o Valle di Porlezza, come viene anche talvolta indicata, si trova un edificio [...] al cui interno era presente un ciclo di affreschi di soggetto cavalleresco databile tra la metà del Quattrocento e il 1480-1490. Noto come “Pretura” o “Prigione”, forse perché si trattava all’epoca di un ufficio giudiziario e/o di polizia [...] L’edificio si presenta affrescato anche sui muri esterni: sulla facciata principale è collocato un affresco che raffigura la Trinità; sulla parete nord, si trovava invece un affresco della Vergine Maria seduta su un trono, oggi non più visibile, eseguito utilizzando solo le tonalità del rosso.
L’affresco di soggetto cavalleresco che si trovava dentro l’edificio è incentrato sul duello tra Rolando e Ferraù presso Lazera (l’attuale Najèra), il cui racconto originario proviene dalla Cronaca dello pseudo-Turpino. Staccato dalle pareti dell’edificio nel 1961, messo su tela e restaurato, esso fa parte attualmente di una collezione privata milanese. [...]" (cfr. Serena Modena, "Didascalie nel ciclo di affreschi della “Pretura” di Bilate (Como)", RialFri, 15 marzo 2020).
 Per approfondimenti ulteriori sul tema del duello, molto interesanti, per capire meglio il persorso professionale e artistico dell’architetto e scultore Della Porta (che arriverà a lavorare intorno al 1570 nel Santuario di Loreto, nella casa della Natività), si cfr. l’illuminante lavoro di Marco Infurna, relativo alla figura di Ambrogio della Longhignana, signore di Porlezza, "Il duello di Rolando e Feraguto sul ponte in un affresco lombardo del Quattrocento" (“Par estude ou par acoustumance”. Saggi offerti a Marco Piccat per il suo 65° compleanno, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2016).
Per approfondimenti ulteriori sul tema del duello, molto interesanti, per capire meglio il persorso professionale e artistico dell’architetto e scultore Della Porta (che arriverà a lavorare intorno al 1570 nel Santuario di Loreto, nella casa della Natività), si cfr. l’illuminante lavoro di Marco Infurna, relativo alla figura di Ambrogio della Longhignana, signore di Porlezza, "Il duello di Rolando e Feraguto sul ponte in un affresco lombardo del Quattrocento" (“Par estude ou par acoustumance”. Saggi offerti a Marco Piccat per il suo 65° compleanno, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2016).
- Presso la Santa Casa di #Loreto vi sono dieci #Sibille e tre #profeti, e alla realizzazione ha lavorato e contribuito intorno al 1570 l’architetto e scultore Giovanni Battista #DellaPorta (#Porlezza, 1542 - #Roma, 1597).
- STORIA E #FILOSOFIA DELL’#EUROPA E DELL’#ITALIA (1440-1570). L’ ONDA LUNGA DELLA #TEOLOGIA-#POLITICA DELLA "#DOTTAIGNORANZA" (1440) E DEL "DE #PACE FIDEI" (1453) DI NICCOLO’ #CUSANO E LO #STENDARDO COSTANTINIANO CON IL SUO "IN HOC SIGNO VINCES" DEL 1570: LA BATTAGLIA DI #LEPANTO DEL 1571. #Michelangelo #Buonarroti è morto nel 1564... e la "storia" del "duello di Rolando e Ferraù" continua, all’esterno come all’interno dell’area europea e mediterranea.
- CULTURA, #SOCIETA’, E #FAMIGLIA (FONDATA SUL #DIRITTO DI #MAGGIORASCO). DAL DUCATO DI #MILANO A #PORLEZZA E DA PORLEZZA A #NAPOLI, NEL #REGNODINAPOLI (#VICEREAME SPAGNOLO): #MEMORIA DI CARLO GESUALDO (#Venosa, 8 marzo 1566 - Gesualdo, 8 settembre 1613) Per meglio tratteggiare la scena italiana (ed europea) in cui si colloca la vita del Della Porta architetto.scultore e del Della Porta scienziato-alchimista, è bene ricordare, con Ambrosino da Longhignana (che, per i suoi legami con la famiglia Borromeo, fu sepolto nella "Isola Bella", ad #Arona, sul Lago Maggiore), la figura dei cardinali #CarloBorromeo (1538-1584) e del suo cugino cardinale #FedericoBorromeo (1564 -1631) e della sorella di Carlo, #Geronima #Borromeo, madre di Carlo Gesualdo (1566-1613), il "Napoletanissimo" musicista e compositore, destinato "a intraprendere la carriera ecclesiastica", ma segnato dalla sorte e dal #diritto a ricoprire il ruolo di #primogemito: "Nel 1585, il fratello Luigi, all’epoca ventunenne e non ancora sposato né con eredi maschi, subì una caduta da cavallo e morì. Questo evento fece di Carlo, diciottenne, l’unico erede dei titoli e delle tenute paterne, ragion per cui ci si mosse in fretta per organizzare le sue nozze. La scelta finale ricadde su Maria d’Avalos, figlia di Carlo d’Avalos, marchese di Montesarchio, e cugina di primo grado dell’aristocratico, ragion per cui occorse una dispensa papale. Maria aveva già avuto precedentemente due mariti e dei figli". Un "segno dei tempi" dalle conseguenze catastrofiche, come ben visto agli inizi dell’#Ottocento da #Manzoni, quando, nei suoi "#Promessi Sposi" (IX), apre la "parentesi" sulla "storia" della "monaca di Monza": sulla base della lezione del nonno materno, #Cesare #Beccaria, egli aveva ben capito di che stava parlando (già, al di là di Hegel, e prima di Marx)!
- SCIENZA E MAGIA NEL #REGNODINAPOLI (XVI-XVII SEC.): IMPARARE A "LEGGERE" IL "LIBRO" DELLA #NATURA. Del filosofo, alchimista, e scienziato GIOVANNI BATTISTA DELLA PORTA (#VicoEquense, 1º novembre 1535 - #Napoli, 4 febbraio 1615), è da dire che la sua opera più famosa, "Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium" ( https://it.wikipedia.org/wiki/Magiae_naturalis_sive_de_miraculis_rerum_naturalium ), risale al 1558, ma fu accresciuta "fino a venti volumi, e fu compendiata in un volume unico nel 1584: questo compendio fu largamente diffuso e fu tradotto dal latino nelle principali lingue europee"; la sua grande erudizione e i suoi suggestivi principi esplicativi, sia empirici che filosofici, hanno dominato la scena culturale italiana nel delineare i tratti della nuova razionalità scientifica moderna, prima che Galileo salisse alla ribalta intorno al 1600. ( https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Della_Porta ). Accompagnato nell’opinione popolare dalla fama di mago, ma noto negli ambienti scientifici di tutta l’Europa per le sue sperimentazioni e per la molteplicità degli interessi, fu in rapporto epistolare e personale con gli studiosi più famosi del suo tempo. Invitato dall’imperatore del Sacro Romano Impero #RodolfoII d’Asburgo (1552 - 1612) a trasferirsi a #Praga, Della Porta progetta "un’opera per la quale aveva inventato il titolo di #Taumatologia e aveva indicato come dedicatarlo l’imperatore Rodolfo II, ma che per varie difficoltà, non riuscì a completare e mandare alla stampa": l’idea "è successivamente abbandonata e il dedicatario diventa #Federico #Borromeo, vescovo di #Milano. Tuttavia, nonostante l’impegno di Federico#Cesi, la Taumatologia non riceve l’imprimatur ecclesiastico e Della Porta abbandona il progetto" (#Donato Verardi, 2018).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- CULTURA E SOCIETA’ NELL’EUROPA DI SHAKESPEARE E HAENDEL: "UN SOGNO ACCAREZZATO IN EUROPA SIN DAI TEMPI DI DANTE" (FRANCES A. YATES, 1974).2 marzo 2025, di Federico La Sala
"UN SOGNO ACCAREZZATO IN EUROPA SIN DAI TEMPI DI DANTE" (FRANCES A. YATES, 1974): CULTURA E SOCIETA’ NELL’EUROPA DI SHAKESPEARE E HAENDEL.
TEATRO E #MUSICA NELL’ #INGHILTERRA DELLA #REGINA #ELISABETTA TUDOR, DI RE #GIACOMO I #STUART, E RE GIORGIO I (Giorgio Ludovico di #Hannover, asceso al trono con il nome di Giorgio I di Gran Bretagna), UN FILO CHE NON SI SPEZZA NONOSTANTE LA #GUERRA DEI TRENT’ANNI (1618-1648).
- Alcuni appunti sul tema:
A) "L’ILLUMINISMO DEI ROSA-CROCE" (FRANCES A. YATES). CONTRARIAMENTE A QUANTO generalmente si pensa, anche sul piano storiografico, senza il diffondersi dello spirito della #RiformaProtestante e della #Riforma #Anglicana in Inghilterra, probabilmente, a Londra, non solo #GiordanoBruno ma neanche Georg F. #Haendel vi sarebbe mai andato.
 Quando si scrive che, dopo le "felici intuizioni contenute nei primi lavori" di Frances A. #Yates, "poi abbandonate dalla studiosa negli successivi dominati da un eslusivo interesse per l’ermetismo" (Nuccio Ordine, 2006), non solo non si coglie tutta l’importanza del legame teologico-politico e culturale esistente, poi rinsaldato nel 1613 dal matrimonio della figlia di Giacomo I d’Inghilterra, Elisabetta [Stuart] (1596-1662), con #FedericoV (1596 -1632), principe elettore del #Palatinato e re di #Boemia, figlio dell’elettore Federico IV e di Luisa Giuliana d’Orange, ma si trascura (e si oscura) la lezione della stessa Yates su "Giacomo I e il Palatinato: un capitolo dimenticato nella storia delle idee" (tenuta a Oxford nel 1970, e, proseguita nel libro dedicato a "L’Illuminismo dei Rosa-Croce", 1974) e la continuità con l’importante lavoro dedicato a "Giordano Bruno e la tradizione ermetica" (1969).
Quando si scrive che, dopo le "felici intuizioni contenute nei primi lavori" di Frances A. #Yates, "poi abbandonate dalla studiosa negli successivi dominati da un eslusivo interesse per l’ermetismo" (Nuccio Ordine, 2006), non solo non si coglie tutta l’importanza del legame teologico-politico e culturale esistente, poi rinsaldato nel 1613 dal matrimonio della figlia di Giacomo I d’Inghilterra, Elisabetta [Stuart] (1596-1662), con #FedericoV (1596 -1632), principe elettore del #Palatinato e re di #Boemia, figlio dell’elettore Federico IV e di Luisa Giuliana d’Orange, ma si trascura (e si oscura) la lezione della stessa Yates su "Giacomo I e il Palatinato: un capitolo dimenticato nella storia delle idee" (tenuta a Oxford nel 1970, e, proseguita nel libro dedicato a "L’Illuminismo dei Rosa-Croce", 1974) e la continuità con l’importante lavoro dedicato a "Giordano Bruno e la tradizione ermetica" (1969).B) Georg Friedrich Händel (Halle, 23 febbraio 1685 - Londra, 14 aprile 1759):
"[...] in Italia [...] conobbe in Roma lo splendido Agostino Steffani, maestro celeberrimo il quale, in età ormai matura, era diventato arcivescovo e adesso faceva l’ambasciatore del Principe di Hannover [...] questo finissimo artista e diplomatico s’interessò molto al giovane Sassone e, [...] lo convinse a seguirlo nel suo ritorno ad Hannover. [...] Ma la combinazione di Hannover ebbe ben altra portata. Per via di parentele e di ragioni politiche, la Corte dell’Elettore era in stretti rapporti con la Corte inglese; Hannover si trovava sempre affollata di gentiluomini e di emissari britannici. Così, nel 1710, Giorgio Federico fu invitato a Londra allo scopo di comporvi un’opera e vi si recò con entusiasmo dopo aver ricevuto licenza dal Principe. [...] La regina Anna [Stuart] si compiacque molto dell’inviato speditole dal suo cugino di Hannover [...] Spentasi la regina Anna senza lasciare eredi al trono, la corona d’Inghilterra passò proprio al suo vecchio padrone, il Principe Elettore di Hannover." (Giulio Confalonieri, "Storia della musica", 1975).
C) Händel, "Giulio Cesare". Il «Giulio Cesare in Egitto» di Händel all’Opera di Roma (Dino Villatico: Alias - il manifesto, 1 ottobre 2023): "[...] L’opera - su libretto di Nicola Francesco Haym, che riscrive quello del 1677 di Gianfrancesco Bussarli - ebbe un immenso successo, non solo in Inghilterra. Si inserisce in un filone di riflessioni teatrali sulla storia: Shakespeare a Londra era sempre attuale e Händel era un assiduo frequentatore di teatri, ma anche un appassionato lettore, soprattutto del teatro francese. Come non pensare allora al Britannicus di Racine? Winton Dean, nella voce che dedica a Händel per il Grove Dictionary of Music and Musicians, sostiene che il compositore di Halle è la figura di drammaturgo musicale più complessa che incontriamo tra Monteverdi e Mozart, sia per varietà di caratteri e intensità espressiva, sia per forza e costruzione drammatica.[...]"(cit. ).
- NOTE:
- TEATRO, MUSICA, STORIA E #STORIOGRAFIA D’#EUROPA: IN #INGHILTERRA, DA #SHAKESPEARE E RE #GIACOMO I #STUART A #HAENDEL E RE #GIORGIO I (Giorgio Ludovico di Hannover, asceso al trono con il nome di Giorgio I di Gran Bretagna), UN FILO CHE NON SI SPEZZA NONOSTANTE LA GUERRA DEI TRENT’ANNI (1618-1648).
- UN "INVITO ALLA LETTURA" di un "vecchio" articolo di Vincent De Luise
- "IL SUBLIME, IL GRANDE, IL TENERO": LA STORIA DEL #MESSIA DI HANDEL: "Il capolavoro senza tempo del Messiah di Handel è un pilastro fondamentale del Canone occidentale" (Vincent De Luise).
- MUSICA E #SOCIETA’ NELL’#EUROPA DEL #SETTECENTO. #HAENDEL E #SCARLATTI: "[...] A Roma, secondo quel che riferisce Mainwaring, Händel dovette avere rapporti anche con il cardinale Pietro Ottoboni, al cui servizio erano a quel tempo Alessandro Scarlatti e Arcangelo #Corelli. Grazie al diario del principe tedesco Anton Ulrich di #Sassonia-Meiningen, che soggiornò a Roma negli stessi anni del musicista, sappiamo che Händel compose un’aria per un oratorio fatto eseguire da Ottoboni al palazzo della Cancelleria per la festa dell’Assunzione del 1707.
 Dallo stesso diario si apprende il musicista tedesco fu incaricato dal cardinale #Carlo #Colonna di comporre e dirigere le musiche nella chiesa di Santa Maria in #Montesanto [#NAPOLI] in occasione della festa della [Vergine del #Carmelo. [...]" (cit. ).
Dallo stesso diario si apprende il musicista tedesco fu incaricato dal cardinale #Carlo #Colonna di comporre e dirigere le musiche nella chiesa di Santa Maria in #Montesanto [#NAPOLI] in occasione della festa della [Vergine del #Carmelo. [...]" (cit. ).
 Nella Chiesa di Montesanto, nella cappella didicata a santa Cecilia, è sepolto anche "il grande compositore Alessandro Scarlatti, detto il Palermitano" (cit.).
Nella Chiesa di Montesanto, nella cappella didicata a santa Cecilia, è sepolto anche "il grande compositore Alessandro Scarlatti, detto il Palermitano" (cit.).
- STORIA E #STORIOGRAFIA D’#EUROPA: FEDERICO V DEL PALATINATO SPOSA LA FIGLIA DI RE GIACOMO I D’INGHILTERRA Il matrimonio con #Elisabetta #Stuart .... Il matrimonio si tenne il 14 febbraio successivo [1613] nella cappella reale del Palazzo di Whitehall [a #Londra, vicino a #Westminster]. Per l’occasione #John #Donne compose il suo capolavoro poetico, Epithalamion, or Mariage Song on the Lady Elizabeth, and Count Palatine being married on St. #ValentinesDay. ... La coppia fece il suo ingresso trionfale a #Heidelberg il 12 giugno 1613. [...]" (cit.)
-
>ARCHEOLOGIA E FILOLOGIA DELLA TRADIZIONE CULTURALE EUROPEA: CON SHAKESPEARE (DANTE ALIGHIERI E GIORDANO BRUNO). Una nota intorno al tema del "Giulio Cesare" (e dell’ "Amleto").16 febbraio 2025, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA E FILOLOGIA DELLA TRADIZIONE CULTURALE EUROPEA:
CON SHAKESPEARE (DANTE ALIGHIERI E GIORDANO BRUNO), PER UNA ANALISI CRITICA DEL"CESARICIDIO" E UNA COMPRENSIONE ANTROPOLOGICA DELLA #MONARCHIA DEI "#DUE SOLI" ("DIVINA COMMEDIA").
- Una nota intorno al tema del "Giulio Cesare" (e dell’ "Amleto").
CHE NELLA MODALITA’ IN CUI SHAKESPEARE PRESENTA LA "RESA" DI BRUTO ALLE ARGOMENTAZIONI DI #CASSIO (ALLA "SOCRATE") PER COINVOLGERLO (COME UN "ALCIBIADE") NELL’AVVENTURA DEL "CESARICIDIO", IN CUI APPARE evidente il rinvio critico al "gioco" narcisistico del guardarsi nell’occhio dell’altro per conoscere sé stesso del dialogo di #Platone ("Alcibiade primo", 132c - 133b ), è già ben chiaro che egli pensi al di là del #platonismo e del #paolinismo storico:
"BRUTO
 No, Cassio; perché l’occhio non vede se stesso
No, Cassio; perché l’occhio non vede se stesso
 se non di riflesso, attraverso altri oggetti.
se non di riflesso, attraverso altri oggetti.
 CASSIO
CASSIO
 È così;
È così;
 e ci si rammarica molto, Bruto, che tu non abbia
e ci si rammarica molto, Bruto, che tu non abbia
 specchi che volgano ai tuoi occhi il tuo valore
specchi che volgano ai tuoi occhi il tuo valore
 nascosto, così che tu possa vedere la tua immagine
nascosto, così che tu possa vedere la tua immagine
 riflessa. Ho sentito molte persone di alta reputazione
riflessa. Ho sentito molte persone di alta reputazione
 qui a Roma - eccetto l’immortale Cesare -
qui a Roma - eccetto l’immortale Cesare -
 che, parlando di Bruto, e gemendo sotto il giogo
che, parlando di Bruto, e gemendo sotto il giogo
 di questa epoca, hanno espresso il desiderio
di questa epoca, hanno espresso il desiderio
 che il nobile Bruto abbia occhi.
che il nobile Bruto abbia occhi.
 BRUTO
BRUTO
 In quali pericoli vorresti spingermi, Cassio,
In quali pericoli vorresti spingermi, Cassio,
 invitandomi a cercare in me stesso
invitandomi a cercare in me stesso
 quello che in me non c’è?
quello che in me non c’è?
 CASSIO
CASSIO
 Per questo, caro Bruto, preparati ad ascoltare.
Per questo, caro Bruto, preparati ad ascoltare.
 E poiché tu sai di non poterti vedere bene
E poiché tu sai di non poterti vedere bene
 se non per riflesso, io, il tuo specchio,
se non per riflesso, io, il tuo specchio,
 rivelerò con discrezione a te stesso
rivelerò con discrezione a te stesso
 quello che di te stesso tu ancora non conosci.
quello che di te stesso tu ancora non conosci.
 E non essere sospettoso con me, gentile Bruto.
E non essere sospettoso con me, gentile Bruto.
 Se io fossi un buffone qualsiasi, o fossi avvezzo
Se io fossi un buffone qualsiasi, o fossi avvezzo
 a svilire con volgari giuramenti il mio affetto
a svilire con volgari giuramenti il mio affetto
 al primo venuto che mi assicuri il suo; se ti risulta
al primo venuto che mi assicuri il suo; se ti risulta
 che scodinzolo con le persone e prima le abbraccio forte
che scodinzolo con le persone e prima le abbraccio forte
 e poi le calunnio; o se ti risulta
e poi le calunnio; o se ti risulta
 che, alle feste, io mi professo amico
che, alle feste, io mi professo amico
 di tutta la marmaglia, allora ritienimi pericoloso. "
di tutta la marmaglia, allora ritienimi pericoloso. "
 ("Giulio Cesare," Atto I, Scena 2).
("Giulio Cesare," Atto I, Scena 2).Shakespeare, nel solco e sul filo della lezione di Dante e di Bruno, sollecita la riflessione sul legame antropologico-politico e teologico dei "due soli" della "Monarchia" di Dante, e delle "#Tre corone" dello "Spaccio della bestia trionfante" di Giordano Bruno: sotto la spinta della #RiformaProtestante (1517) e Anglicana (1534) e della #Rivoluzionescientitica (#Copernico, 1543), egli insegna a "vedere" nella figura di "Giulio Cesare" (e di "Amleto") la unità e la unificazione - nelle mani e nella testa - non solo del sovrano ("cristiano") o della sovrana ("cristiana") ma di ogni "cristiano" e "cristiana", di ogni "cittadino" e di ogni "cittadina", del potere sia politico ("#sovranità universale") che religioso ("#sacerdotalità universale"): "Sàpere aude!" (#Kant, 1784).
#Dantedì, #25marzo 2025
- NOTE:
- PER USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA #COSMOTEANDRIA PLATONICA, E, AL CONTEMPO, DA UNA CAPACITA’ DI “#LETTURA” DIMEZZATA DELLA REALTA’ E UNA PARZIALE E ”#SPECULARE” #CONOSCENZA DI SE’, UN “INVITO” A RICONSIDERARE (ANCHE E ANCORA) LA SEGUENTE DISCUSSIONE TRA SOCRATE E ALCIBIADE ...
- DANTE E BRUTO E CASSIO. L’uso "comico" che Shakespeare fa della lezione socratico-platonica sul tema del "conosci te stesso" delfico, vale ovviamente (e dantescamente) come un deciso giudizio di condanna dell’operato sia di Cassio sia di Bruto, fondato su ragioni del tutto "umane, troppo umane".
- FINE DELLA STORIA: NON COMPRESA LA LEZIONE DI #DANTEALIGHIERI SUI #DUE #SOLI E DI GIORDANO BRUNO (#17febbraio1600) SULLE #TRE #CORONE, DUE CORONE IN TERRA E UNA IN CIELO (“Ultima coelo manet)”, SI VA ANCORA AVANTI CON LE REGOLE DEL GIOCO DELLE TRE CARTE (questa è quella che vince, questa quella che perde, ecc...) e l’espulsione (lo #spaccio) dal campo da gioco della BESTIA TRIONFANTE continua ad essere rinviata... USCIRE DAL #LETARGO E’ DIFFICILE. La Regola, il Logos, non è un "Logo"!
- CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA #COSMOTEANDRIA. Non sapendo affrontare e non volendo risolvere il problema di Jean Jacques #Rousseau (Discorso sull’origine della disuguaglianza: "Il primo uomo che, avendo recinto un terreno, ebbe l’idea di proclamare questo è mio, e trovò altri cosí ingenui da credergli, costui è stato il vero fondatore della società civile") come quello di Sigmund #Freud (Il disagio della civiltà: "Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comuni tà critiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori"), non ci resta che lavorare ... "PER LA PACE PERPETUA" (#KANT, 1795)!!!
- "SHAKESPEARE AND COMPANY" [...] La mia ipotesi è che #Shakespeare abbia capito il senso della propria #sovranità di #essereumano e, da questo "luogo", porta avanti il "proprio" discorso. In qualche modo Shakespeare è prossimo a #Dante e #dantealighieri è prossimo a Shakespeare: entrambi non sono né per il #papa (o la #papessa) né per l’#imperatore (o l’#imperatrice): entrambi sono per la #Monarchia dei #DueSoli e la #sovranità dell’#amore che non è "lo zimbello del #Tempo" (#Sonetto116) e "move il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145). A) RIPARTIRE DALLA GIARRETTIERA, DALL’ ORDINE DELLA GIARRETTIERA: "SIA SVERGOGNATO CHI NE PENSA MALE"! ).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA (2025): UNA QUESTIONE DI GRAZIA ("XAPIS"). DA ARIANNA E DA NASSO ("NAXOS"), UN FILO PER "RI-USCIRE" DAL LABIRINTO.7 febbraio 2025, di Federico La Sala
GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA (2025): UNA QUESTIONE DI GRAZIA ("XAPIS"). DA ARIANNA E DA NASSO ("NAXOS"), UN FILO PER "RI-USCIRE" DAL LABIRINTO DEI "GIOCHI DI PAROLE", E DALLA "PLATONICA" #CAVERNA "POLIFEMICA", E ANDARE INCONTRO ALLE GRAZIE E ALLA #PRIMAVERA CHE SI AVVICINA...
RICORDANDO CHE la parola "Naxos" va letta come "Nacsos", come la parola "Xenos", "Csenos", proprio per rispetto al suo etimo perché rimanda alla parola: ξένος «straniero, ospite». è bene non confondere "Nasso" con la parola "asso", e, la "Filo-xenia", con la Xeno-fobia"!
E’ BENE CHE IL SENSO E IL SUONO DELLA "ICS"("X") NON SIA CONFUSO CON QUELLO DEL "CHI" ("X"), ALTRIMENTI LA "Χαρά (#XAPA)" DIVENTA UNA "XAPA" (cioè, "CSARA") E... SI FINISCE PER PERDERE NON SOLO LA BUSSOLA, LA "XAPA" (cioè, "CHAPA"), E, ANCORA, "LEGGENDO" IN NAPOLETANO E "NEA-POLITANO" ("CHAPIS...ce a me"), PERSINO TUTTA LA PRIMAVERA CON LE SUE GRAZIE (#CHARITES) E LA STESSA GRAZIA!
MITO E #STORIA. "Naxos (detta anche Nasso), isola del mito di Arianna, è la più grande e la più fertile delle Cicladi. [...] Naxos (detta anche Hora, Chora o Naxos #Chora), capitale e porto principale dell’isola [...] Vi siete mai chiesti da dove deriva l’espressione “piantare in asso”? È una contrattura di “piantare in Nasso” e si riferisce alle vicende mitologiche di Arianna, la fanciulla che aiutò Teseo a fuggire dal labirinto del Minotauro.[...]" (v. NAXOS).
- NOTA:
COSMOTEANDRIA "POLIFEMICA": #ANDROCENTRISMO, #GEOCENTRISMO ED #ETNOCENTRISMO DI UNA " CHIARA ED EVIDENTE" #CAVERNA PLANETARIA...
- In #memoria di Immanuel #Kant, Hermann von #Helmholtz, e Marcel #Proust, e #FrancaOngaro #Basaglia...
PIANETATERRA (2025). Nell’inizio dell’anno del "#Serpente del #legno #verde", per auguri e in omaggio al lavoro di #Stefano #Mancuso e #Alessandra #Viola, "#Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale" (Giunti Editore, 2013, p. 19), riprendo (e ripropongo all’attenzione)
LA "PIRAMIDE DEI VIVENTI" DI BOVILLUS ( CHARLES DE BOVELLES), TRATTA DAL "LIBER DE #SAPIENTE" (1509-1510).
La generale "nostra considerazione" non solo del mondo della #natura e del mondo dell’#uomo (antropologico, sociologico, economico, politico, e teologico) è, a ben vedere, "ancora molto simile".
- BUON2025
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- L’ALLARME DI SHAKESPEARE: LA "TRAGEDIA" DEL PRINCIPE "AMLETO" E LA "COMMEDIA" DEGLI "IMBROGLI" DELLA "DODICESIMA NOTTE", PRIMA DELLA "EPIFANIA"3 febbraio 2025, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, ANTROPOLOGIA, E FILOLOGIA CRITICA DEL MESSAGGIO EVANGELICO NELLE OPERE DI #SHAKESPEARE:
"L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO (SONETTO116). *
- In memoria di #Dante #Alighieri, #GiordanoBruno, e #Galileo #Galilei...
Una nota a margine del lavoro in progress di Paul Adrian Fried ("San Paolo e la dodicesima notte", 02 febbraio 2025)
"AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" ("Cantico dei cantici", 8.6). Alla luce delle #ipotesi di lettura, proposte e fatte, dell’opere di Shakespeare, in particolare, dell’ "#Amleto" e di "La #dodicesima #notte"*, come già molti altri autorevoli interpreti (rileggere almeno i "#maestridelsospetto": a partire da #Rousseau e #Kant, #Marx, #Nietzsche, e #Freud) hanno spesso avanzato, l’interpretazione paolina del #cristianesimo appare essere storicamente come una forma e una prosecuzione del "compromesso olimpico" con la tradizione tragica socratico-platonica.
La linea di teologia-politica cosmoteandrica costantiniana (Concilio di #Nicea, 325 -2025) della Chiesa cattolico-paolina, se pure viene messa profondamente in discussione dalla "Prima Rinascita" (#GioacchinodaFiore, #FrancescodiAssisi, e #DanteAlighieri), trova un suo momento cruciale di riaffermazione del #platonismo della "dotta ignoranza" (1440) e della "pace della fede" (1453) del cardinale #Cusano: a #Lepanto (1571), non a caso, si andrà con lo stendardo con la scritta costantiniana "IN HOC SIGNO VINCES" (in "barba" a Gioacchino da Fiore, Francesco di Assisi, Dante Alighieri... e dello stesso #Virgilio).
Come aveva ben messo in evidenza Johan Huizinga, "L’#autunno del Medioevo" (1919), era finito e cominciava l’#inferno della cosiddetta #Modernità. Non è bene e meglio riprendere a leggere Shakespeare e riaprire la "divina commedia" di Dante Alighieri (#Dantedì, #25marzo 2025), e ammirare l’#alba della Terra: #Earthrise...
*
PIANETA TERRA: "IL NOME DELLA ROSA" E LA DEVASTAZIONE DEL "GIARDINO". LA "TRAGEDIA" DEL PRINCIPE "AMLETO" E LA "#COMMEDIA" DEGLI "IMBROGLI" DELLA "DODICESIMA NOTTE", PRIMA DELLA "EPIFANIA")
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE (2005). --- QUALE EUROPA PER UN "BUON 2025"? BUON ANNO.1 gennaio 2025, di Federico La Sala
QUALE EUROPA PER UN "BUON 2025"?: UNA #STORIA DI LUNGA DURATA E
UNA ORAZIANA SOLLECITAZIONE SUL "SAPERE AUDE!" (#KANT, KOENIGSBERG, 1784; KALININGRAD, 2024) DA RIPRENDERE...
RICORDANDO CHE “La guerra non si abolisce coi trattati, ma stimolando la riflessione e la cultura di tutti”, come sosteneva Gino Strada, forse, oggi alla fine del 2024, io renderei omaggio anche alla memoria di Enrico Berlinguer che, il 15 dicembre del 1981, dichiarò la fine della "spinta propulsiva" della rivoluzione sovietica, anticipando sia la svolta di #Gorbaciov sia la caduta e la fine del "comunismo" russo, e, con esso, del "muro di Berlino" (1989). Al contempo, e insieme, renderei allo stesso Michail Gorbaciov (cfr. foto, "vignetta" allegata, "Le Monde" 1989) e, ancora, ad Antonio Gramsci (1891-1937).
CULTURA E #SOCIETA’. Alla luce dell’avvio del #Giubileo2025 e delle celebrazioni dell’anniversario del #Primo #Concilio di #Nicea (325), una importante #analogia (carica di #teoria) sulla relazione tra il #cristianesimo e il #paolinismo e il #marxismo e il #leninismo, fatta da Gramsci:
"POSIZIONE DEL #PROBLEMA. [...] Marx è un creatore di Weltanschauung, ma quale è la posizione di Ilici? È puramente subordinata e subalterna? La spiegazione è nello stesso marxismo - scienza e azione -. Il passaggio dall’utopia alla scienza e dalla scienza all’azione (ricordare opuscolo relativo di Carlo Radek). La fondazione di una classe dirigente (cioè di uno Stato) equivale alla creazione di una Weltanschauung. [...] Marx inizia intellettualmente un’età storica che durerà probabilmente dei secoli, cioè fino alla sparizione della Società politica e all’avvento della Società regolata. Solo allora la sua concezione del mondo sarà superata (concezione della necessità, 〈superata〉 da concezione della libertà). Fare un parallelo tra Marx e Ilici per giungere a una gerarchia è stolto e ozioso: esprimono due fasi: scienza-azione, che 〈sono〉 omogenee ed eterogenee nello stesso tempo. Così, storicamente, sarebbe assurdo un parallelo tra Cristo e S. Paolo: Cristo-Weltanschauung, S. Paolo organizzazione, azione, espansione della Weltanschauung: essi sono ambedue necessarii nella stessa misura e però sono della stessa statura storica. Il Cristianesimo potrebbe chiamarsi, storicamente, cristianesimo-paolinismo e sarebbe l’espressione più esatta (solo la credenza nella divinità di Cristo ha impedito un caso di questo genere, ma questa credenza è anch’essa solo un elemento storico, non teorico)." (A. Gramsci, "Quaderno 7 § 33").
- #BUONANNO, #BUON2025!
- Nota:
- RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE (2005). Una "memoria"
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- STORIA, LETTETERATURA, E STORIOGRAFIA: CON "IL PANTHEON SUL PARTENONE", FATTO "SAN PIETRO DI ROMA" (VICTOR HUGO, 1831).27 dicembre 2024, di Federico La Sala
CON "IL PANTHEON SUL PARTENONE", FATTO "SAN PIETRO DI ROMA" (VICTOR HUGO, 1831):
MICHELANGELO E IL TRAMONTO DEL "RINASCIMENTO" (O, DIVERSAMENTE, L’INIZIO DEL "CONTRORINASCIMENTO").
- In memoria di #Michelangelo Buonarroti, Marcel #Proust, e Walter #Benjamin
L’ ARCHITETTURA E IL LIBRO: L’INVENZIONE DELLA STAMPA. Victor Hugo, in "Notre-Dame de Paris 1482", pubblicato nel 1831, in poche pagine sottolinea tutta l’importanza dell’#apertura di infiniti occhi, connessa al grande "occhio" che si apre nel #cielo culturale dell’#Europa #moderna con la invenzione di Gutenberg.
Nel cap. II del L. VII dell’opera, Hugo così inizia:
- "Le nostre lettrici ci scuseranno se ci fermiamo un momento per cercare quale potesse essere il pensiero che si celava sotto le enigmatiche parole dell’arcidiacono: Questo ucciderà quello. Il libro ucciderà l’edificio. A nostro avviso, quel pensiero aveva due facce. Era innanzitutto un pensiero da prete. Era il terrore del sacerdozio di fronte ad un elemento nuovo, la stampa. Era lo spavento e lo sbalordimento dell’uomo del santuario di fronte al torchio luminoso di Gutenberg. Erano la cattedra ed il manoscritto, la parola parlata e la parola scritta, che si allarmavano per la parola stampata [...].
- In effetti, dall’origine delle cose fino al quindicesimo secolo dell’era cristiana compreso, l’architettura è il grande libro dell’umanità, l’espressione principale dell’uomo ai suoi diversi stadi di sviluppo, sia come forza che come intelligenza.
- [...] Così, fino a Gutenberg, l’architettura è la scrittura principale, la scrittura universale. [...]
- [...] a partire dalla scoperta della stampa [...] a partire dal sedicesimo secolo, la malattia dell’architettura è visibile; essa ormai non esprime più in modo essenziale la società; si fa miserevolmente arte classica [...].
- È proprio questa decadenza che prende il nome di Rinascimento. È questo tramonto che noi scambiamo per un’aurora [...]
- Michelangelo, che fin dal sedicesimo secolo aveva senz’altro avvertito la sua morte, aveva avuto un’ultima idea, un’idea dettata dalla disperazione. Questo titano dell’arte aveva eretto il Pantheon sul Partenone e aveva fatto San Pietro di Roma. Morto Michelangelo, che fa questa miserabile architettura che sopravviveva a se stessa allo stato di spettro e di ombra? Prende San Pietro di Roma, lo ricalca, ne fa la parodia. È una mania. È una cosa pietosa. Ogni secolo ha il suo San Pietro di Roma; nel diciassettesimo secolo il tempio di Val-de-Grâce, nel diciottesimo Sainte-Geneviève. Ogni paese ha il suo San Pietro di Roma. Londra ha il suo. Pietroburgo ha il suo. Parigi ne ha due o tre. Testamento insignificante, ultimo vaneggiamento di una grande arte decrepita che rimbambisce prima di morire." (V. Hugo, cit.).
- Nota: "Cupola di San Pietro".
- NOTE:
- PIANETA TERRA: UN #PANTHEON DA RIPENSARE E IL #SOLSTIZIO D’#INVERNO. UNA TRACCIA PER UN "RIORIENTAMENTO GESTALTICO" E UNA "#SVOLTA_ANTROPOLOGICA": APRIRE LA "PORTA" DELLA "TERRA" ALLA LUCE DEL #SOLE... In memoria di Andrea #Vesalio, Niccolò #Copernico, #Galileo #Galilei ....
- PER LA #PACEPERPETUA. ALLA #RICERCA DEL #TEMPO PERDUTO....
 MICHELANGELO, PER UN RITRATTO A PROUST: UNA ILLUMINANTE INDICAZIONE DI WALTER BENJAMIN. Materiali sul tema ...
"Nel secolo scorso c’era a Grenoble un’osteria che si chiamava «Au temps perdu» (non so se ci sia ancora). Anche da Proust noi siamo avventori che sotto l’insegna oscillante varchiamo una soglia [...]".
MICHELANGELO, PER UN RITRATTO A PROUST: UNA ILLUMINANTE INDICAZIONE DI WALTER BENJAMIN. Materiali sul tema ...
"Nel secolo scorso c’era a Grenoble un’osteria che si chiamava «Au temps perdu» (non so se ci sia ancora). Anche da Proust noi siamo avventori che sotto l’insegna oscillante varchiamo una soglia [...]".
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- LA LOGICA DELL’ARATRO, L’ETIMOLOGIA DI ARTEMIDE (DIANA DI EFESO), E LA "CULTURA" DELLA"AGRICOLTURA" SECONDO LA TEOLOGIA POLITICA "PLATONICA" (E "PLUTONICA")19 dicembre 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA DELL’ARATRO: IL RATTO DI PERSEFONE (PROSERPINA, KORE), LA MEMORIA ETIMOLOGICA DI #ARTEMIDE (#DIANA DI #EFESO) E LA "CULTURA" DELLA"AGRICOLTURA" SECONDO LA TEOLOGIA POLITICA "PLATONICA" (E "PLUTONICA"). *
- "#ACHERONTA #MOVEBO" (En. VII, 312). In memoria di #Virgilio, #Dante, e #Freud... **
Nel "#Cratilo", #Platone, nella lezione sulle etimologie dei nomi degli dei e delle dee, così scrive e così fa dire al suo #Socrate, a proposito della #Diana Efesina:
"Ἄρτεμις" δὲ ‹διὰ› τὸ ἀρτεμὲς φαίνεται καὶ τὸ κόσμιον, διὰ τὴν τῆς παρθενίας ἐπιθυμίαν· ἴσως δὲ ἀρετῆς ἵστορα τὴν θεὸν ἐκάλεσεν ὁ καλέσας, τάχα δ’ ἂν καὶ ὡς τὸν ἄροτον μισησάσης τὸν ἀνδρὸς ἐν γυναικί· ἢ διὰ τούτων τι ἢ διὰ πάντα ταῦτα τὸ ὄνομα τοῦτο ὁ τιθέμενος ἔθετο τῇ θεῷ.
"Ad Artemide poi sembra che il nome sia stato posto per l’artemes (’l’integrità’) per l’ornatezza e per il suo desiderio di verginità. E probabilmente chi le assegnò il nome volle chiamarla esperta di virtù ("aretes histora") o forse anche perché detesta l’aratura ("ton aroton misesases") del maschio nella femmina: o per uno di questi motivi oppure per tutti questi insieme le pose questo nome colui che pose il nome alla dea" (406b).
- * Foto: "Il ratto di #Persefone da parte di #Plutone (#Ade, lo "Zeus degli inferi": ).
NOTE:
- #STORIA #LETTERATURA E #PSICOANALISI. Chiarimento di Freud sul significato di "Acheronta movebo".
- ARCHEOLOGIA #STORIA #POLITICA ED #ECONOMIA: UNA #IMMAGINE DELL’#ARATRO SU UNA MONETA DI "10 LIRE" (CONIAZIONE 1951-2001) DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
- ARCHEOLOGIA #ANTROPOLOGIA E #PSICOANALISI ("#COSTRUZIONI NELL’#ANALISI, 1937)", E #FILOLOGIA: «GRANDE E’ LA DIANA DEGLI EFESINI» (S. #FREUD, 1911): #EFESO, LA DEA MADRE, IL DIO FIGLIO, E L’#INTERPRETAZIONE PAOLINA DEL #MESSAGGIOEVANGELICO. Alcuni appunti...
- In memoria di #Eraclito e di #Shakespeare e ad #omaggio di #Eleusis2023...
- FILOLOGIA, #FILOSOFIA, E #PEDAGOGIA: UN "INVITO" A USCIRE DAL #LETARGO (Par. XXXIII, 94) E A RILEGGERE IL "CRATILO" DI PLATONE, A RIASCOLTARE "LA #VOCE DELLA SPOLA NEL #TEREO DI #SOFOCLE" (#ARISTOTELE), A #INSEGNARE E #IMPARARE A COME MEGLIO ["FARE LA SPOLA", E, ANTROPOLOGICAMENTE, A CONCEPIRE UN ALTRO MODO DI TESSERE IL RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE E RIPRODUZIONE, IN GENERALE...
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- FILOLOGIA CRITICA E STORIOGRAFIA (7 DICEMBRE 2024): RICORDANDO "I PROMESSI SPOSI" (MANZONI 1827), UN OMAGGIO ALL’ «ANANKE» DI "NOTRE-DAME PARIS 1482" (V. HUGO, 1831) E ALLA "FORZA DEL DESTINO" (G. VERDI, 1862).8 dicembre 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA CRITICA E STORIOGRAFIA EUROPEA. 7 DICEMBRE 2024: L’ «ANANKE» DI "NOTRE-DAME PARIS 1482" (VICTOR HUGO, 1831) E "LA FORZA DEL DESTINO" (GIUSEPPE #VERDI, 1862).
UN OMAGGIO A #PARIGI (A "NOTRE-DAME") E A #MILANO (A "LA SCALA"): #7DICEMBRE2024.
- Una nota in memoria di Victor Hugo e di Giuseppe Verdi...
Una #citazione dall’opera di #VictorHugo: "[...] Jean lo perse di vista dietro l’enorme schienale. Per qualche minuto vide solo il suo pugno convulsamente contratto su un libro. Ad un tratto si alzò, prese un compasso, e silenziosamente incise sulla parete a lettere maiuscole questa parola greca:
«ANANKE»
«Mio fratello è pazzo», disse Jean fra sé; «sarebbe stato assai più semplice scrivere "#Fatum". Non sono tutti tenuti a conoscere il greco».
L’arcidiacono andò a sedersi sulla poltrona e posò il capo sulle mani, come fa un malato con la fronte pesante e febbricitante.
Lo studente osservava suo fratello con sorpresa. [...] Lo studente rialzò risolutamente lo sguardo. «Monsignor fratello, vi piacerebbe che vi spiegassi in buon francese quella parola greca che è scritta là sul muro?».
«Quale parola?»
«’𝛢𝛮𝛢𝛤𝛫𝛨» [«ANANKE»]
Un leggero rossore venne a diffondersi sui gialli pomelli dell’arcidiacono, come lo sbuffo di fumo che preannuncia all’esterno i segreti scotimenti di un vulcano. Lo scolaro lo notò appena.
«Ebbene, Jean», balbettò il fratello maggiore sforzandosi, «cosa vuol dire questa parola?».
«#FATALITÀ».
Don Claude si fece di nuovo pallido, e lo studente continuò con noncuranza: «E quella parola che sta sotto, incisa dalla stessa mano, «Ἀναγνέια», significa #impurità. Vedete che conosco il greco?».
L’arcidiacono rimaneva silenzioso. Quella lezione di greco l’aveva reso pensieroso. [...]" (V. #Hugo, "Notre-Dame de Paris 1482", L.VII, cap. IV).
NOTE:
- STORIAELETTERATURA E #MUSICA: #GIUSEPPEVERDI, "LA FORZA DEL DESTINO".
- STORIA E LETTERATURA NELL’EUROPA DELL’OTTOCENTO: "UN UOMO E UNA DONNA SOLI NON PENSERANNO CERTO DI RECITARE IL PATER NOSTER". UNA CONCEZIONE DELL’AMORE, SECONDO LA LOGICA TRAGICA DI "ANANKE" (V. HUGO, "NOTRE-DAME DE PARIS 1482", 1831), RIPENSANDO ALLO "SCOMMETTIAMO" DEI "PROMESSI SPOSI" (A. MANZONI, 1827) E ALLA "FORZA DEL DESTINO" (1862) DI GIUSEPPE VERDI.
- STATO E CHIESA: "COME UN PRETE E UN FILOSOFO NON SIANO LA STESSA COSA". Un "invito alla lettura di "Notre-Dame de Paris 1842" (una "citazione" dal capitolo II del Libro VII):
"[...] Don Claude ascoltava in silenzio. All’improvviso il suo occhio infossato assunse un’espressione astuta e penetrante a tal punto che Gringoire si sentì, per così dire, frugato fino nel fondo dell’anima da quello sguardo.
 «Benissimo, mastro Pierre, ma per quale motivo siete ora in compagnia di quella
ballerina d’Egitto?».
«Benissimo, mastro Pierre, ma per quale motivo siete ora in compagnia di quella
ballerina d’Egitto?».
 «In fede mia», disse Gringoire, «il fatto è che ella è mia moglie ed io sono suo
marito».
«In fede mia», disse Gringoire, «il fatto è che ella è mia moglie ed io sono suo
marito».
 L’occhio tenebroso del prete si infiammò.
L’occhio tenebroso del prete si infiammò.
 «Avresti fatto questo, miserabile?», gridò afferrando con furore il braccio di
Gringoire; «saresti stato a tal punto abbandonato da Dio da mettere le mani su quella
fanciulla?».
«Avresti fatto questo, miserabile?», gridò afferrando con furore il braccio di
Gringoire; «saresti stato a tal punto abbandonato da Dio da mettere le mani su quella
fanciulla?».
 «Sulla mia parte di paradiso, monsignore», rispose Gringoire tremando in tutte le
sue membra, «vi giuro che non l’ho mai toccata, se è questo che vi preoccupa».
«Sulla mia parte di paradiso, monsignore», rispose Gringoire tremando in tutte le
sue membra, «vi giuro che non l’ho mai toccata, se è questo che vi preoccupa».
 «E allora, perché parli di marito e moglie?», disse il prete.
«E allora, perché parli di marito e moglie?», disse il prete.
 Gringoire si affrettò a raccontargli il più succintamente possibile tutto quello che il
lettore sa già, la sua avventura della Corte dei Miracoli e il suo matrimonio con la brocca
rotta. Sembrava del resto che questo matrimonio non avesse avuto ancora alcun esito, e
che ogni sera la zingara gli rifiutasse la sua notte di nozze come il primo giorno.
Gringoire si affrettò a raccontargli il più succintamente possibile tutto quello che il
lettore sa già, la sua avventura della Corte dei Miracoli e il suo matrimonio con la brocca
rotta. Sembrava del resto che questo matrimonio non avesse avuto ancora alcun esito, e
che ogni sera la zingara gli rifiutasse la sua notte di nozze come il primo giorno.
 «È una delusione», disse concludendo, «ma ciò deriva dal fatto che ho avuto la
sventura di sposare una vergine».
«È una delusione», disse concludendo, «ma ciò deriva dal fatto che ho avuto la
sventura di sposare una vergine».
 «Che volete dire?», domandò l’arcidiacono che si era andato gradatamente
calmando a quel racconto. [...]
«Che volete dire?», domandò l’arcidiacono che si era andato gradatamente
calmando a quel racconto. [...][...] nella sua anima e nella sua coscienza il filosofo non era molto sicuro di essere perdutamente innamorato della zingara. Amava quasi altrettanto la capra. Era un animale incantevole, dolce, intelligente, arguto, una capra sapiente. Niente di più comune nel Medio Evo di questi animali sapienti che suscitavano grande meraviglia e che frequentemente conducevano al rogo i loro istruttori. Comunque le stregonerie della capra dalle zampe dorate erano malizie molto innocenti. Gringoire le spiegò all’arcidiacono, che sembrava vivamente interessato a questi dettagli. Nella maggior parte dei casi, era sufficiente presentare alla capra il tamburello in un modo o in un altro per ottenere da lei il gioco che si desiderava. Era stata addestrata a far ciò dalla zingara, che aveva per queste finezze un talento così raro che le erano bastati due mesi per insegnare alla capra a scrivere con delle lettere mobili la parola Phoebus.
 «Phoebus?», disse il prete. «Perché Phoebus?».
«Phoebus?», disse il prete. «Perché Phoebus?».
 «Non lo so», rispose Gringoire. «Forse è una parola che ella crede dotata di qualche
virtù magica e segreta. La ripete spesso a mezza voce quando si crede sola».
«Non lo so», rispose Gringoire. «Forse è una parola che ella crede dotata di qualche
virtù magica e segreta. La ripete spesso a mezza voce quando si crede sola».
 «Siete sicuro», riprese Claude con il suo sguardo penetrante, «che è soltanto una
parola e non un nome?».
«Siete sicuro», riprese Claude con il suo sguardo penetrante, «che è soltanto una
parola e non un nome?».
 «Nome di chi?» disse il poeta.
«Nome di chi?» disse il poeta.
 «Che ne so?», disse il prete.
«Che ne so?», disse il prete.
 «Ecco quello che immagino, messere. Questi zingari sono un po’ Ghebri e adorano il
sole. Da ciò Phoebus».
«Ecco quello che immagino, messere. Questi zingari sono un po’ Ghebri e adorano il
sole. Da ciò Phoebus».
 «Non mi sembra chiaro come a voi, mastro Pierre».
«Non mi sembra chiaro come a voi, mastro Pierre».
 «Del resto non mi importa. Che borbotti il suo Phoebus quanto le piace. Di sicuro
c’è che Djali mi ama già quasi quanto ama lei». [...]
«Del resto non mi importa. Che borbotti il suo Phoebus quanto le piace. Di sicuro
c’è che Djali mi ama già quasi quanto ama lei». [...]«Chi è questa Djali?».
 «È la capra».
«È la capra».
 L’arcidiacono posò il mento sulla mano e sembrò per un momento pensieroso.
L’arcidiacono posò il mento sulla mano e sembrò per un momento pensieroso.
 Tutto ad un tratto si rivolse bruscamente verso Gringoire:
Tutto ad un tratto si rivolse bruscamente verso Gringoire:
 «E tu mi giuri che non l’hai toccata?».
«E tu mi giuri che non l’hai toccata?».
 «Chi?», disse Gringoire, «la capra?».
«Chi?», disse Gringoire, «la capra?».
 «No, questa donna».
«No, questa donna».
 «Mia moglie! Vi giuro di no».
«Mia moglie! Vi giuro di no».
 «E tu sei spesso solo con lei?».
«E tu sei spesso solo con lei?».
 «Tutte le sere, per un’ora buona».
«Tutte le sere, per un’ora buona».
 Don Claude aggrottò le sopracciglia.
Don Claude aggrottò le sopracciglia.- «Oh! oh! solus cum sola non cogitabuntur orare Pater noster».
- «Sulla mia anima, potrei dire il Pater, l’Ave Maria e il Credo in Deum patrem onnipotentem senza che ella facesse più attenzione a me che non una gallina ad una chiesa».
- «Giurami sul ventre di tua madre», ripeté l’arcidiacono con violenza, «che non hai sfiorato questa creatura nemmeno con la punta di un dito».
- «Lo giurerei anche sulla testa di mio padre, poiché le due cose hanno più di un rapporto. Ma, mio reverendo maestro, permettetemi a mia volta una domanda».
- «Parlate, signore».
- «Che ve ne importa?».
 Il pallido volto dell’arcidiacono divenne rosso come la guancia di una fanciulla.
Restò un momento senza rispondere, poi con visibile imbarazzo:
Il pallido volto dell’arcidiacono divenne rosso come la guancia di una fanciulla.
Restò un momento senza rispondere, poi con visibile imbarazzo:
 «Ascoltate, mastro Pierre Gringoire. Non siete ancora dannato, che io sappia. Mi
interesso a voi e vi voglio bene. Ora il minimo contatto con questa egiziana del demonio vi
renderebbe vassallo di satana. Sapete che è sempre il corpo che perde l’anima. Guai a voi
se vi avvicinate a quella donna. Ecco tutto».
«Ascoltate, mastro Pierre Gringoire. Non siete ancora dannato, che io sappia. Mi
interesso a voi e vi voglio bene. Ora il minimo contatto con questa egiziana del demonio vi
renderebbe vassallo di satana. Sapete che è sempre il corpo che perde l’anima. Guai a voi
se vi avvicinate a quella donna. Ecco tutto».
 «Ho tentato una volta», disse Gringoire grattandosi l’orecchio. «Era il primo giorno,
ma mi ci sono punto».
«Ho tentato una volta», disse Gringoire grattandosi l’orecchio. «Era il primo giorno,
ma mi ci sono punto».
 «Avete avuto questa sfrontatezza, mastro Pierre?».
«Avete avuto questa sfrontatezza, mastro Pierre?».
 E la fronte del prete si rabbuiò.
E la fronte del prete si rabbuiò.
 «Un’altra volta», continuò il poeta sorridendo, «prima di coricarmi ho guardato
attraverso il buco della sua serratura, e ho visto la più deliziosa dama in camicia che abbia
mai fatto cigolare le cinghie di un letto sotto il suo piede nudo».
«Un’altra volta», continuò il poeta sorridendo, «prima di coricarmi ho guardato
attraverso il buco della sua serratura, e ho visto la più deliziosa dama in camicia che abbia
mai fatto cigolare le cinghie di un letto sotto il suo piede nudo».
 «Vattene al diavolo!», gridò il prete con uno sguardo terribile e, spingendo per le
spalle Gringoire tutto stupito, sprofondò a grandi passi sotto le più oscure arcate della
cattedrale. "(Victor Hugo - Notre Dame de Paris).
«Vattene al diavolo!», gridò il prete con uno sguardo terribile e, spingendo per le
spalle Gringoire tutto stupito, sprofondò a grandi passi sotto le più oscure arcate della
cattedrale. "(Victor Hugo - Notre Dame de Paris). -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- RIMEDITARE LA LEZIONE DI ERACLITO DI EFESO. Una nota sul frammento 49.5 dicembre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA, ARCHEOLOGIA, E FILOLOGIA: L’HAMLETICA QUESTIONE DEL "#CORPO MISTICO" E DEL "#CAPO" DELLA "#POLIS" DI #EFESO AI TEMPI DI #ERACLITO...
- Una nota a margine e a commento del frammento 49: «Uno per me vale diecimila, se è il migliore» .
RICORDANDO LE PAROLE-CHIAVI DELLA hashtag#FILOSOFIA,"IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS" (Gv., 1.1), QUALE LA #DIFFERENZA TRA IL LINGUAGGIO RELATIVO AL "PRIMOGENITO" (IL PRIMO "UNO" DI ALTRI #MOLTI "UNO") E IL #METALINGUAGGIO "COSTITUZIONALE" (DEL "LOGOS" E) DEL SUO "UNIGENITO" E MIGLIORE CITTADINO DI EFESO?!
QUALE LA DIFFERENZA TRA IL "PRESEPE" DI FRANCESCO DI ASSISI E QUELLO DELLA CHIESA "PAOLINA", FONDATA DA COSTANTINO (NICEA 325 - 2025)?
- "Lezione" di Paolo di Tarso: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3):
Per non perdere la bussola (e non confondere la Logica della #Costituzione (il #Logos) con la "logica" settaria e proprietaria di un partito o di un’azienda (il #logo), forse, può essere utile tenere presente la seguente riflessione dell arcivescovo di Poitiers, Albert Rouet (2010): «È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"» (2010):
A) UNIGENITO: unigènito agg. [dal lat. tardo, eccles., unigenĭtus, comp. di uni- «uno solo» e genĭtus, part. pass. di gignĕre «generare»]. - Che è l’unico generato, l’unico figlio; riferito quasi esclusivam. a Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio secondo la teologia cattolica (anche s. m., l’U., Gesù Cristo). (Treccani)
B) PRIMOGENITO: primogènito agg. e s. m. (f. -a) [dal lat. tardo primogenĭtus, comp. di primo, avv., «dapprima» e genĭtus, part. pass. di gignĕre «generare»]. - 1. Detto di chi, tra più figli degli stessi genitori, è nato per primo: figlio p.; fratello p.; per estens., ramo p. (di una famiglia nobiliare), quello che ha per capostipite il figlio primogenito; come sost.: dei quattro figli, Alfredo è il p.; lo zio Alessandro era il primogenito. 2. fig. Che è venuto prima, più antico, e quindi più importante, o che tale per qualche motivo viene considerato (talora anche con il sign. di prediletto): la gramatica, primogenita del sapere e per ciò dagli antichi chiamata «arte prima» (V. Monti); la Francia è stata spesso chiamata la figlia p. della Chiesa. (Treccani)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- RIMEDITARE LA LEZIONE DI ERACLITO DI EFESO. --- STORIA E PSICOANALISI: CON ERODOTO, UNA RIFLESSIONE SULL’ ENIGMA DEL DESTINO.9 dicembre 2024, di Federico La Sala
L’ENIGMA DEL NOME, L’ENIGMA DEL SOGGETTO, L’ENIGMA DEL DESTINO ("ANANKE") E ... L’ENIGMA DI "DIO" ("CHARITAS") *
L’ENIGMA DEL DESTINO
di Gianfranco Ricci*
Lo storico Erodoto di Alicarnasso racconta nelle celebre opera “Storie” che nell’anno 499 a.C., Istieo, avventuriero e tiranno di Mileto, si trovava alla corte del re Dario I e non aveva modo di mettersi in contatto con il suo compatriota e tiranno della città Aristagora.
In quel tempo le città ioniche preparavano la grande ribellione contro il dominio persiano e Istieo voleva comunicargli che era il momento di dare il via alla sollevazione.
Alla fine ebbe un’idea: fece rasare la testa al suo schiavo più fedele e gli tatuò sul cuoio capelluto il messaggio che desiderava trasmettere, poi aspettò che i capelli ricrescessero, in modo da nascondere il messaggio.
Solo allora inviò lo schiavo a Mileto, dove gli rasarono nuovamente la testa e poterono leggere il messaggio. Il procedimento aveva diversi vantaggi, perché neppure il latore del messaggio ne conosceva il contenuto e pertanto non avrebbe potuto rivelarlo neanche se fosse stato sottoposto a interrogatorio o tortura.
Già Freud nello scritto “Isteria” (1888) aveva notato come i sintomi isterici seguissero una logica diversa da quella della mera anatomia. Tra il sintomo e la base organica non vi era un legame diretto, bensì l’emergere di una sorta di “dialetto”, di fenomeno linguistico.
Lacan porterà all’estremo la lettura freudiana, parlando di “crivellatura” del corpo per effetto del significante. Le parole, osserva Lacan, possono essere veri e propri “proiettili” che toccano, feriscono e perforano il corpo.
Abbiamo qui l’aspetto centrale della psicoanalisi: il rapporto fondamentale tra corpo e parola.
Il soggetto viene al mondo parlato dall’Altro, prima ancora di accedere direttamente al linguaggio.
Il primo significante che incontra è spesso il nome proprio, intraducibile per definizione, presente quindi nella sua dimensione di significante che si sgancia da ogni significato.
Tuttavia sappiamo bene che il significato è presente nel luogo dell’Altro e per questo può divenire come un “destino” per il soggetto che lo porta: il nome proprio può essere un destino.
Perché un certo nome? Perché non altri? Nel nostro nome e nelle parole che circolano nella nostra infanzia è evidente l’effetto di scrittura, di incisione che il significante opera su di noi.
Ciascuno di noi assomiglia quindi allo schiavo della storia di Erodoto: portiamo su di noi le tracce di un messaggio che non conosciamo e che ci resta enigmatico, misterioso, inaccessibile.
Compito dell’analisi è svelare questo messaggio inconscio: far emergere il discorso che l’Altro ha fatto per noi e su di noi, per assumere questo discorso e farlo nostro, riformularlo alla luce del nostro desiderio.
Sartre mostra l’importanza di questa operazione nel suo studio sulla vita di Jean Genet: l’intera opera di uno degli scrittori più discussi e controversi del Novecento si organizza intorno ad un significante che ha segnato per sempre la sua vita. Sartre ricostruisce infatti un episodio preciso dell’infanzia del piccolo Genet, quando, sorpreso dalla sua balia, viene ripreso con una parola: “ladro!”.
Come sottolinea Sartre nell’opera “Santo Genet, commediante e martire”, l’intera opera di Genet risponde ad una logica precisa: “il genio non è un dono, ma la via d’uscita che ci si inventa in casi disperati”.
- Per approfondire:
- Erodoto - Storie;
- Sartre - Santo Genet, commediante e martire;
- Massimo Recalcati - Ritorno a Jean Paul Sartre.
Il lavoro di Sartre ha indagato il ruolo della storia, dell’infanzia e dell’Altro nella vita dell’uomo.
In particolare, questo ambito di ricerca segna un punto di contatto con la pratica e la teoria analitica.
Sartre ha articolato il suo lavoro concentrandosi su due grandi figure dell’universo culturale francese: Jean Genet e Gustave Flaubert.
Entrambi, nella loro vita, sono stati segnati da un marchio indelebile; la storia di questi due autori rappresenta il tentativo singolare di riprendere questa iscrizione originaria, per trasformarla.
In particolare, se nel caso di Genet il significante padrone, S1, è “ladro!”, nella storia di Flaubert vi è “idiota”.
L’opera elefantiaca di Sartre dedicata a Gustave Flaubert si intitola proprio “L’idiota della famiglia”.
Terzo di tre figli, Flaubert si trova gettato, scartato tanto dal desiderio paterno, investito integralmente sul figlio maggiore (divenuto “copia” del padre), quanto di quello materno (destinato interamente alla figlia femmina, tanto voluta).
La sua “idiozia”, destino già scritto dall’Altro familiare, tradotto in un ritardo nell’acquisizione della parola, diviene base di una ripresa singolare, che porterà Flaubert a divenire, a suo modo, uno degli scrittori più importanti della letteratura francese.
*Cfr. Gianframco Ricci, 29 novembre 2023 (ripresa parziale - senza immagini).
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- DANTE E SAUSSURE: UNA SOLA TEORIA, QUELLA DEI "DUE SOLI". Ipotesi di lavoro
- PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006). "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- LA "SVOLTA DI SALERNO" (REGNO DI NAPOLI,1547-1548). Una nota storiografica in memoria di Mercurino Arborio di Gattinara.4 novembre 2024, di Federico La Sala
CAMBIARE ROTTA ("#SVOLTADISALERNO", 1944-1948): "NON E’ MAI TROPPO TARDI" (#ALBERTOMANZI, 1924-1997).
ALL’ORIGINE DEL "CONTRORINASCIMENTO" EUROPEO, LA "#SVOLTA DI #SALERNO" (REGNODINAPOLI,1547-1548).
- Una nota storiografica in memoria di Mercurino Arborio di Gattinara
LA "SVOLTA DI SALERNO": L’#IMPERATORE #CARLOV E DON #PEDRODITOLEDO, ALL’INTERNO DI UN ORIZZONTE EUROPEO E MEDITERRANEO BELLICOSO (CADUTA DI #COSTANTINOPOLI,1453) GIUNGONO A METTERE AL BANDO IL PRINCIPE FERRANTE SANSEVERINO (Luca Addante)] E DANNO IL VIA LIBERA ALLA #TEOLOGIA-#POLITICA DELLA #SPAGNA E DELLA #CHIESACATTOLICA #CONTRO LA #RIFORMA DI #LUTERO (1517) E LA RIFORMA #ANGLICANA DI #ENRICOVIII (1534). NEL SEICENTO IL "MARCIO NELLO STATO DI DANIMARCA" CRESCE SEMPRE DI PIU’(#Shakespeare, #Amleto, 1602): LA #GUERRA DEI TRENT’ANNI (1618-1648) E’ ALLE PORTE.
- NOTA:
#STORIA D’#ITALIA E #STORIOGRAFIA: "LE COLONNE DELLA #DEMOCRAZIA" (#LUCA #ADDANTE). SCHEDA EDITORIALE (Editori Laterza, 2024): "Negli anni della Rivoluzione francese i giacobini in Francia furono all’avanguardia nel reclamare la libertà e l’uguaglianza, la giustizia sociale e la sovranità popolare. Un programma fatto proprio da moltissimi italiani, confluiti in un movimento unitario che entrò in scena nel Triennio repubblicano (1796-1799), animando la nascita dell’associazionismo e del giornalismo politici.
 Il principale obiettivo del movimento era l’unificazione dell’Italia in un unico Stato repubblicano, democratico e costituzionale. Era la prima generazione del Risorgimento che avviava la sua lunga lotta, nel crogiolo politico e ideologico che vide forgiarsi le correnti protagoniste dei due secoli seguenti: il liberalismo, la democrazia, il repubblicanesimo, il socialismo, il comunismo, l’anticolonialismo, il femminismo.
Quel primo movimento politico italiano nascondeva al suo interno una società segreta, le Colonne della Democrazia, da cui sorse la misteriosa Società dei Raggi, la prima società segreta del Risorgimento sul cui tronco ne fiorirono altre, tra cui la più nota è la Carboneria.
Il libro racconta la nascita del movimento che diede avvio al Risorgimento, perseguendo un programma politico avanzatissimo attuato solo in parte con l’Unità d’Italia e più compiutamente - ma non appieno - realizzato dopo la Resistenza al nazi-fascismo e la Costituente." (cit.).
Il principale obiettivo del movimento era l’unificazione dell’Italia in un unico Stato repubblicano, democratico e costituzionale. Era la prima generazione del Risorgimento che avviava la sua lunga lotta, nel crogiolo politico e ideologico che vide forgiarsi le correnti protagoniste dei due secoli seguenti: il liberalismo, la democrazia, il repubblicanesimo, il socialismo, il comunismo, l’anticolonialismo, il femminismo.
Quel primo movimento politico italiano nascondeva al suo interno una società segreta, le Colonne della Democrazia, da cui sorse la misteriosa Società dei Raggi, la prima società segreta del Risorgimento sul cui tronco ne fiorirono altre, tra cui la più nota è la Carboneria.
Il libro racconta la nascita del movimento che diede avvio al Risorgimento, perseguendo un programma politico avanzatissimo attuato solo in parte con l’Unità d’Italia e più compiutamente - ma non appieno - realizzato dopo la Resistenza al nazi-fascismo e la Costituente." (cit.). -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- UN CONTRIBUTO DI GRAMSCI PER "ORIENTARSI NEL PENSIERO" (KANT) E TENTARE DI RIUSCIRE AD ABITARE UN #PIANETATERRA COMUNE (ERACLITO)1 novembre 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA E FILOSOFIA: CON KANT A EFESO, ALLA RICERCA DEL "LOGOS" PERDUTO...
- UN PARALLELO TRA #CRISTO E SAN #PAOLO, #MARX E #LENIN, E,UNA SOLLECITAZIONE A RITORNARE A #EFESO E A PORTARSI OLTRE I "#LOGO" DEI VARI "CATTOLICISSIMI" #PARTITI ATEI O DEVOTI.
Alcuni appunti a margine di UN CONTRIBUTO DI GRAMSCI PER "ORIENTARSI NEL PENSIERO" (#KANT) E TENTARE DI RIUSCIRE AD #ABITARE UN #PIANETATERRA COMUNE (ERACLITO): RI-PENSARE LA #QUESTIONEANTROPOLOGICA E #CRISTOLOGICA ("ECCE HOMO") E, AL CONTEMPO, LA #QUESTIONE TEOLOGICO-POLITICA DEL #CORPO MISTICO DELLA #COMUNITA’:
A) - "POSIZIONE DEL PROBLEMA: [...] Marx è un creatore di Weltanschauung, ma quale è la posizione di Ilici? È puramente subordinata e subalterna? La spiegazione è nello stesso marxismo - scienza e azione -. Il passaggio dall’utopia alla scienza e dalla scienza all’azione (ricordare opuscolo relativo di Carlo Radek). La fondazione di una classe dirigente (cioè di uno Stato) equivale alla creazione di una Weltanschauung. [...] Marx inizia intellettualmente un’età storica che durerà probabilmente dei secoli, cioè fino alla sparizione della Società politica e all’avvento della Società regolata. Solo allora la sua concezione del mondo sarà superata (concezione della necessità, 〈superata〉 da concezione della libertà). Fare un parallelo tra Marx e Ilici per giungere a una gerarchia è stolto e ozioso: esprimono due fasi: scienza-azione, che 〈sono〉 omogenee ed eterogenee nello stesso tempo. Così, storicamente, sarebbe assurdo un parallelo tra Cristo e S. Paolo: Cristo-Weltanschauung, S. Paolo organizzazione, azione, espansione della Weltanschauung: essi sono ambedue necessarii nella stessa misura e però sono della stessa statura storica. Il Cristianesimo potrebbe chiamarsi, storicamente, cristianesimo-paolinismo e sarebbe l’espressione più esatta (solo la credenza nella divinità di Cristo ha impedito un caso di questo genere, ma questa credenza è anch’essa solo un elemento storico, non teorico)." (A. Gramsci, "Quaderno 7, § 33").
B) - PAOLO DI TARSO, IL "CITTADINO ROMANO", DIVENTA "CRISTIANO", E COSTRUISCE LA "WELTANSCHAUUNG" DEL SUO "PARTITO", FA DI #CRISTO IL "RE" DELLA "COSMOTEANDRIA" DELLA SOCIETA’ DEL SUO TEMPO, E COMINCIA A LAVORARE ALLA CONQUISTA DELL’#EGEMONIA SUI VARI "PARTITI" DEGLI APOSTOLI. Alcune note dai testi evangelici:
- a) Dagli "Atti degli Apostoli" (19, 1-7): "Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell’altopiano, giunse a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?». Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?». «Il battesimo di Giovanni», risposero.
 Disse allora Paolo: «Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano. Erano in tutto circa dodici uomini." (cfr."La Parola - C.E.I.");
Disse allora Paolo: «Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano. Erano in tutto circa dodici uomini." (cfr."La Parola - C.E.I.");
- b) Dalla "Prima Lettera ai Corinzi" (1-13): "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3);
- c) Dalla "Lettera agli Efesini" (4. 1/11-13): "Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto [...] egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo [εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ], finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo [ἄνδρα] perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo." (cfr. Efesini, 4.1/11-13).
C) "IN PRINCIPIO ERA IL #LOGOS": STUDIANDO LE OPERE DI #SWEDENBORG, CON "I SOGNI DI UN VISIONARIO CHIARITI I SOGNI DELLA METAFISICA" (1766), PUR SE CON UN LAPSUS SIGNIFICATIVO DI "ARISTOTELISMO" RESIDUO, RISCOPRE LA LEZIONE DEL FILOSOFO DEL "LOGOS", #ERACLITO DI #EFESO ("Vegliando, noi abbiamo un mondo comune; ma sognando ciascuno ha il suo mondo") E INIZA A LAVORARE AL SUO PROGRAMMA DI CRITICA DELLA "RAGION "PURA, DELLA "RAGION PRATICA", E DELLA "CAPACITA’ DI GIUDIZIO" E,INFINE A RIFLETTERE SULLA "FINE DI TUTTE LE COSE" ( E SUL COSIDDETTO "CRISTIANESIMO") E, ANCORA, A RIPROPORRE E A RIAPRIRE LA QUESTIONE ANTROPOLOGICa ("LOGICA", 1800).
- NOTA:
- PSICOANALISI E #STORIA: "GRANDE E’ LA DIANA DEGLI EFESINI". La "memoria" di Freud (1911) sulla "propaganda fide" di Paolo di Tarso a #Efeso (a partire dalla narrazione degli "Atti degli Apostoli", XIX): "L’antica città greca di Efeso, in Asia Minore (a questo proposito dobbiamo essere grati alla nostra archeologia austriaca per l’esplorazione delle sue rovine), era particolarmente celebrata nell’antichità per lo splendido tempio dedicato ad Artemide (Diana). Gli invasori ionici, forse nell’ottavo secolo avanti Cristo, conquistarono la città, che da lungo tempo era abitata da popoli di razza asiatica, e quivi trovarono il culto di un’antica dea-madre, il cui nome era probabilmente Oupis, la quale fu da loro identificata con Artemide, divinità della loro patria di origine. Gli scavi hanno dimostrato che, nel corso dei secoli, parecchi templi furono eretti nello stesso luogo in onore della dea. [...]
 Attorno al 54 d.C. l’apostolo Paolo passò diversi anni ad Efeso. Quivi predicò, compì dei miracoli, trovando un largo seguito tra la popolazione. Perseguitato ed accusato dagli Ebrei, si staccò da questi, fondando una comunità cristiana indipendente. A cagione del diffondersi della sua dottrina, vi fu un calo del commercio degli orafi, che solevano fabbricare ricordi del luogo sacro (figurine di Artemide e modellini del tempio) per i fedeli e i pellegrini, che venivano da tutte le parti del mondo (Cfr. anche la poesia di Goethe.) Paolo era troppo rigido per tollerare che l’antica divinità sopravvivesse sotto diverso nome, per ribattezzarla come avevano fatto i conquistatori ionii con la dea Oupis, per cui i pii artigiani e artisti della città cominciarono a sentirsi preoccupati per la sorte della loro dea e anche per quella dei loro guadagni.
Attorno al 54 d.C. l’apostolo Paolo passò diversi anni ad Efeso. Quivi predicò, compì dei miracoli, trovando un largo seguito tra la popolazione. Perseguitato ed accusato dagli Ebrei, si staccò da questi, fondando una comunità cristiana indipendente. A cagione del diffondersi della sua dottrina, vi fu un calo del commercio degli orafi, che solevano fabbricare ricordi del luogo sacro (figurine di Artemide e modellini del tempio) per i fedeli e i pellegrini, che venivano da tutte le parti del mondo (Cfr. anche la poesia di Goethe.) Paolo era troppo rigido per tollerare che l’antica divinità sopravvivesse sotto diverso nome, per ribattezzarla come avevano fatto i conquistatori ionii con la dea Oupis, per cui i pii artigiani e artisti della città cominciarono a sentirsi preoccupati per la sorte della loro dea e anche per quella dei loro guadagni.
 Si ribellarono e, al grido senza fine ripetuto, di «Grande è la Diana degli Efesini», sciamarono lungo la via principale, detta «Arcadiana», fino al teatro, dove il loro capo, Demetrio, pronunciò un discorso infuocato, contro gli Ebrei e contro Paolo. Le autorità riuscirono con difficoltà a sedare il tumulto con l’assicurazione che la maestà della dea era intoccabile e fuori della portata di qualsiasi attacco (Atti, XIX.)
Si ribellarono e, al grido senza fine ripetuto, di «Grande è la Diana degli Efesini», sciamarono lungo la via principale, detta «Arcadiana», fino al teatro, dove il loro capo, Demetrio, pronunciò un discorso infuocato, contro gli Ebrei e contro Paolo. Le autorità riuscirono con difficoltà a sedare il tumulto con l’assicurazione che la maestà della dea era intoccabile e fuori della portata di qualsiasi attacco (Atti, XIX.)
 La chiesa, fondata da Paolo a Efeso, non gli rimase fedele a lungo. Cadde sotto l’influenza di un uomo chiamato Giovanni, la cui personalità è stata un serio problema per i critici. Potrebbe trattarsi dell’autore dell’Apocalisse, che abbonda in invettive contro l’apostolo Paolo. La tradizione lo identifica con l’apostolo Giovanni, al quale si attribuisce il quarto vangelo.
La chiesa, fondata da Paolo a Efeso, non gli rimase fedele a lungo. Cadde sotto l’influenza di un uomo chiamato Giovanni, la cui personalità è stata un serio problema per i critici. Potrebbe trattarsi dell’autore dell’Apocalisse, che abbonda in invettive contro l’apostolo Paolo. La tradizione lo identifica con l’apostolo Giovanni, al quale si attribuisce il quarto vangelo. - Secondo questo vangelo, quando Gesù era sulla croce gridò al discepolo favorito, accennando a Maria: «Ecco tua madre!», e da quel momento Giovanni prese Maria con sé. Quindi, quando Giovanni andò a Efeso, Maria lo accompagnava. Di conseguenza, accanto alla chiesa dell’apostolo a Efeso, fu eretta la prima basilica in onore della dea-madre dei cristiani. La sua esistenza è attestata fin dal quarto secolo. E allora la città ebbe di nuovo la sua grande dea e, salvo il nome, scarsi furono i mutamenti. Anche gli orefici ripresero il loro lavoro, consistente nel fabbricare modelli del tempio e immagini della dea per i nuovi pellegrini. Però la funzione di Artemide, espressa dall’attributo Kourotrophos. [che alleva i figli] fu assunta da S. Artemidoro, che si prendeva cura delle donne in travaglio. [,,,]" (cit.).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Antropologia e linguistica: ripartire dal Mediterraneo, dalla "Sicilia isola continentale. Psicoanalisi di una identità". Alcune note a margine del lavoro di Franco Lo Piparo.28 ottobre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, LINGUISTICA, E PSICOANALISI:
SULLE ALI PARADIGMATICHE DI UN MATRIMONIO, UN "VIAGGIO IN SICILIA" (GOETHE) CON DANTE, SAUSSURE, E FREUD.
- Una nota di commento a margine del lavoro del prof. Franco Lo Piparo
A NON SOTTOVALUTARE l’importanza del lavoro di Franco Lo Piparo, "Sicilia isola continentale. Psicoanalisi di una identità" (Sellerio 2024), forse, è opportuno tenere presente il punto di vista (e di partenza) e l’oggetto (il punto di arrivo, il risultato) della ricerca, che riesce a riannodare strutturalmente e magistralmente (senza ricadere dentro lo "strutturalismo") insieme #lingua #istituzioni e #società.
IL SEGNAVIA è una formula di #matrimonio in volgare siciliano scritta in caratteri greci, forse, degli anni 1259/1266, durante il #regno di Manfredi di Svevia. Un percorso illuminante, a mio parere.
Per non sprecare questa occasione "storica", credo che sia opportuno non lasciarsi accecare (edipicamente) dal legame (per lo più giocastico) con la propria "santissima" #Mamma, la "Madre mediterranea", e accogliere al meglio cio’ che appare essere una straordinaria "risposta" di un "alunno" alle lezioni dei suoi "maestri" (a cominciare da Renato Guttuso, da Tullio De Mauro, e da Umberto Eco->), e, in particolare, una sollecitazione (da un "alunno" diventato "maestro", a pieno titolo) a ri-leggere antropologicamente il "Corso di Linguistica Generale" di Ferdinand de #Saussure, riprendendo il filo dal "circuito della #parole": "Siano, dunque, due persone che discorrono: A e B."!.
- NOTE:
- PITTURA #SESSUALITA’ #LINGUISTICA E #ANTROPOLOGIA. A NON SPRECARE LA RIEVOCAZIONE DELLA #LEZIONE DEL MAESTRO #GUTTUSO “Al giovane Lopiparo ricordo di Guttuso, Roma 9-6-64” (cfr. Franco Lo Piparo, "GUTTUSO «DIPINGEVA CON IL PENE»", 20 Ottobre, 2021), forse, non è bene richiamare sia il lavoro degli amici e dei maestri (da #TullioDeMauro a #UmbertoEco) del prof. Franco Lo Piparo sia il lavoro del #pittore René #Magritte e del filosofo #MichelFoucault sui quadri relativi al problema della #rappresentazione riflettendo ancora sul quadro "QUESTA PIPA NON E’ UNA #PIPA" e rimettere in movimento le #idee relative al "circuito fallico", al circuito sessuale, e, finalmente, al circuito della #parole (alla #Saussure), di #due "soggetti sovrani" (come da #Costituzione teologico-politica italiana, e, da "#Canticodeicantici", nel blu dipinto di blù, alla #Totò), e passare, finalmente, agli "atti linguistici" di un regime non più segnato da un #androcentrismo teologico-politico tragico a un’antropologia all’altezza della famosa "#dignità dell’uomo" e della "#divinacommedia" (#Dante)!?!
- FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E GENERE UMANO: CARLA LONZI (1931-1982). MA A CHE #GIOGO SI CONTINUA A #GIOGARE, ANCORA A QUELLO DEL "SAPIENTE" (1510) DEL FILOSOFO #BOVILLUS (Charles de #Bovelles): LA DONNA DEFINITA IN RAPPORTO ALL’UOMO? UNA DOMANDA (UNA #QUESTION #HAMLETICA): MA DOVE SONO I FILOSOFI E LE FILOSOFE, OGGI!? Nonostante tutta la sapienza accumulata nei secoli, e, dopo la scoperta dei "#buchineri" e della formidabile ipotesi relativa allesistenza dei "#buchibianchi", nel pensiero e nelle Istituzioni ancora non si corre ai ripari e non si procede a correggere "un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#FrancaOngaro #Basaglia, 1978). O, per cecità e necessità, si preferisce continuare a vivere come "sapienti e contenti" nella tragica #cosmoteandria platonico-hegeliana? Forse è bene rileggersi una breve sintesi "storico-poetica" della #fenomenologiadellospirito dal XII al XIX secolo (e oltre) di #Baudelaire e riflettere sulla storia dello “chátiment de l’#orgueil” (“L’orgoglio punito” di “Les Fleurs du Mal”) del poeta e filosofo Charles Baudelaire e portarsi fuori da interi millenni di labirinto. Se non ora, quando?!
- STORIA E LETTERATURA LINGUISTICA PSICOANALISI E PSICHIATRIA: "LOUIS WOLFSON. CRONACHE DA UN PIANETA INFERNALE". "[...] Con qualche rara eccezione, oggi la formazione “psy” va così. Si studiano fino alla nausea i paradigmi scientisti alla moda e non si legge una virgola della vasta letteratura schizofrenica. L’accademia deride l’idea di una schizocultura, non crede al monito foucaultiano secondo cui è la follia a detenere la verità della psicologia. Il più lungimirante si avvede della condizione di tecnico alienato, solleva le spalle, guarda altrove e può incontrare il testo di Louis Wolfson. [...] In ciò che Gilles Deleuze in prefazione al romanzo definisce come un procedimento schizologico, il nostro antieroe, di nazionalità statunitense, è costantemente impegnato a difendersi dall’invasività della lingua materna, o peggio, della lingua della madre, primo e più potente dispositivo di assoggettamento. [...] Da psicologo, non ho potuto non notare la domanda che emerge inevitabilmente dallo sfondo del testo: che cos’è la psichiatria? Se lo chiedono da tempo i curatori, il cui lavoro è in tal senso orientato, qui come altrove, a depatologizzare e strappare dalle mani della confisca psichiatrica filosofie, arti e letterature " (cfr. la Recensione del libro "Louis Wolfson. Cronache da un pianeta infernale", a cura di Pietro Barbetta e Enrico Valtellina, Manifestolibri 2014, di Alessandro Siciliano.).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- INVERTIRE IL PRESENTE: "NON BASTA APRIRE LA FINESTRA". USCIRE DALLA TRAGICA E "LUCIFERINA" CAVERNA DI PLATONE17 settembre 2024, di Federico La Sala
INVERTIRE IL PRESENTE. CON FERNANDO PESSOA, SEGUENDO OMERO VIRGILIO E DANTE, RITORNO AL FUTURO: "NON BASTA APRIRE LA #FINESTRA".
- Un omaggio alla memoria di #ToniComello, fondatore di "Il Trebbo".
- FILOLOGIA E #POESIA: "#VIVAILGRECO". ALLA LUCE DEL "#NAUFRAGIO" DI #ULISSE E DEI PROBLEMI DI #COMUNICAZIONE ("#TRADUZIONE"), FORSE, E’ BENE RICORDARE COME E QUANTO #DANTE FACCIA "RISUONARE" IL #NOME DI #OMERO (negli occhi di chi legge in italiano e nelle orecchie delle #due persone della "fiamma cornuta" che ascoltavano in greco) LE PAROLE DI #VIRGILIO:
- «O voi che siete due dentro ad un foco,/s’iO MERItai di voi mentre ch’io vissi,/ s’iO MERItai di voi assai o poco // quando nel mondo li alti versi scrissi, / non vi movete; ma l’un di voi dica dove, per lui, perduto a morir gissi» (Inf. XXVI, 79-84).
CAMBIARE ROTTA E SVEGLIARSI DAL #SONNODOGMATICO (#KANT): INVERTIRE LA DIREZIONE (Carlo Rovelli) E USCIRE DALLA TRAGICA E "LUCIFERINA" #CAVERNA DI #PLATONE (E DI TUTTI I #PLATONISMI PER IL #POPOLO), DALLA #FILOSOFIA "COSMOTEANDRICA" DEL "MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE" DI OGNI #UOMOSUPREMO:
"Non basta aprire la finestra *
Non basta aprire la finestra
 per vedere la campagna e il fiume.
per vedere la campagna e il fiume.
 Non basta non essere ciechi
Non basta non essere ciechi
 per vedere gli alberi e i fiori.
per vedere gli alberi e i fiori.Bisogna anche non aver nessuna filosofia.
 Con la filosofia non vi sono alberi: vi sono solo idee.
Con la filosofia non vi sono alberi: vi sono solo idee.
 Vi è soltanto ognuno di noi, simile ad una spelonca.
Vi è soltanto ognuno di noi, simile ad una spelonca.C’è solo una finestra chiusa e tutto il mondo là fuori;
 E un sogno di ciò che potrebbe esser visto se la finestra si aprisse,
E un sogno di ciò che potrebbe esser visto se la finestra si aprisse,
 che ai è quello che si vede quando la finestra si apre.
che ai è quello che si vede quando la finestra si apre.- cfr. Fernando Pessoa, "Le poesie di Alberto Caerio", Passigli Editori 2005.
- NOTE:
- MEMORIA, #STORIA, #POESIA E #TEATRO: "IL #TREBBO" (FONDATO DA #TONI #COMELLO - MILANO).
- USCIRE DALLA CAVERNA, ALLALUCE DEL SOLE: UN ALTRO RINASCIMENTO E’ POSSIBILE, #OGGI. UNA "CITAZIONE" DAL DISCORSO DI #PAPA FRANCESCO ALL’ "INCONTRO INTERRELIGIOSO CON I GIOVANI": "[...] Una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani, di voi qui, è la capacità del dialogo interreligioso. E questo è molto importante, perché se voi incominciate a litigare: “La mia religione è più importante della tua...”, “La mia è quella vera, la tua non è vera...”. Dove porta tutto questo? Dove? Qualcuno risponda, dove? [qualcuno risponde: “La distruzione”]. È così. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono - faccio un paragone - come diverse lingue, diversi idiomi, per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. E poiché Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. “Ma il mio Dio è più importante del tuo!”. È vero questo? C’è un solo Dio, e noi, le nostre religioni sono lingue, cammini per arrivare a Dio. " (Discorso del Papa al “Catholic Junior College”, a Singapore, Venerdì, 13 settembre 2024).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- MEMORIA E STORIA: L’ARCO DI COSTANTINO E IL "VICISTI, GALILAEE". PER KEPLERO (1611), LA VITTORIA DI GALILEO NON SOLO E’ SCIENTIFICA, MA E’ ANCHE LA VITTORIA "RELIGIOSA" DEL "GALILEO".8 settembre 2024, di Federico La Sala
"VICISTI, GALILAEE" (L’IMPERATORE GIULIANO): STORIA, METASTORIA, E LAVORI STORIOGRAFICI IN CORSO.
- Una nota a margine degli eventi correnti della vita politica italiana...
CULTURA E SOCIETA’. Alla luce dell’approssimarsi del 17mo anniversario del I Concilio di Nicea (325 - 2025), guIdato dall’imperatore Costantino, FORSE, è BENE RICORDARE anche e unitariamente le "dimissioni" date dall’ultimo imperatore romano non cristiano, Flavius Claudius Julianus, ovvero Giuliano l’Apostata e riorganizzare e verificare le attuali "carte nautiche" per ben #navigare con il #PianetaTerra nell’#oceanoceleste, come da omaggio e "sollecitazioni" di #Keplero a #Galileo #Galilei (1611).
P. S. - SVEGLIARSI DAL SONNO DOGMATICO (#KANT, 1724-2024). "GALILEO, HAI VINTO" ("VICISTI, GALILAEE"): PER KEPLERO (1611), LA VITTORIA DI GALILEO NON SOLO E’ SCIENTIFICA, MA E’ ANCHE LA VITTORIA "RELIGIOSA" DEL "GALILEO" ("CRISTO") - CONTRO LA CHIESA ATEA E DEVOTA ("APOSTATA") DELL’#EUROPA DEL #TEMPO! «This was sometime a paradox, but now the time gives it proof» (#Shakespeare, "#Amleto", III. 1).
- NOTE:
- MALTEMPO. "Bomba d’acqua su Roma: fulmine danneggia l’Arco di Costantino, allagamenti in centro".
- MEMORIA E STORIA: L’ARCO DI COSTANTINO.
- FISICA METAFISICA, IMMAGINAZIONE SCIENTIFICA, E RIVOLUZIONE COPERNICANA: "GALILEO, HAI VINTO" (KEPLERO, 1611). Richard Buckminster Fuller, "Manuale operativo per Nave Spaziale Terra", Milano, il Saggiatore, 2018.
- GIULIANO IMPERATORE DI UTOPIA. Insofferente alla dottrina della Chiesa riportò in vita il paganesimo. Ma fu soprattutto un buon principe. Tanto da conquistare nei secoli a venire, una serie infinita di estimatori. Un saggio lo racconta senza ambiguità. (di Silvia Ronchey, La Repubblica - Robinson, 29/06/2019).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- IL #NODO DI GORDIO E ALESSANDRO MAGNO. Note su"La testura del sistema. La relazione nel pensiero di #GregoryBateson"(di Lucilla Ruffilli e Giulia Testi).28 agosto 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA (KANT), COSMOTEANDRIA, E "PREISTORIA" (#MARX): IL "NODO GORDIANO" DELLA STORIA D’EUROPA.
- IL #NODO DI #GORDIO (DEL RE MIDA), #ALESSANDROMAGNO (LA FIGURA DEL #SUPERUOMO, DELL’#UOMOSUPREMO, DEL #FIGLIO DI DIO "#AMMON" ("#ZEUS") E "#MAMMONA"), E I "#CATTOLICISMI" (ATEI E DEVOTI) DELLA #STORIA DELL’#EUROPA (#NICEA 325-2025): RICONSIDERARE TUTTO A PARTIRE DALLA LEZIONE (ANCHE DI #SOCRATE, #PLATONE, #ARISTOTETELE, #PAOLODITARSO, E #COSTANTINO IL GRANDE, MA SOPRATTUTTO) DI #DIOGENE DI SINOPE (E DALLA SUA "SOLARE" RISPOSTA AD ALESSANDRO MAGNO). SE NON ORA, QUANDO? (v. commenti).
"RIFLESSIONI SISTEMICHE" (AIEMS - Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche). Una nota a margine della ripresa lodevolissima di una sollecitazione batesoniana a ripensare criticamente il "patrimonio" (del "matrimonio" ) della "caduta" biblica e della "cronica" tradizione "olimpica".
"La testura del sistema. La relazione nel pensiero di #GregoryBateson"(cfr. Lucilla Ruffilli e Giulia Testi, "Riflessioni Sistemiche", N° 30 - "Relazioni e cura", giugno 2024):
"[...] Nel 1970 Bateson propone una idea forte, la ’flessibilità’. [...] Anche una cultura è un sistema adattativo, se una società sopravvive diciamo che la sua cultura è adattativa. Ma può darsi invece che la società vada verso l’autodistruzione. [...] Questo ci dovrebbe dar da pensare, suggerire di concentrarci non sul problema degli adattamenti immediati, ma sui cambiamenti a lunga scadenza. Chiederci se questo adattamento è davvero tale che lo possiamo sopportare. [...]. È adattativo abituarsi a sciogliere il nodo gordiano con la violenza del taglio?
 Scrive Nora #Bateson:
Scrive Nora #Bateson: - “La storia del Nodo Gordiano: è un mito che corre come una sorta di rete sotterranea di correnti circuitali, che affiora invisibilmente attraverso le decisioni e soluzioni degli ultimi 3000 anni di storia, permeando la politica e il linguaggio, l’eroismo e la filosofia, la tecnologia, la medicina, l’economia, l’architettura, l’agricoltura ecc...
 Le storie, i poemi, i miti, debbono essere rivisitati, e talvolta reinterpretati.
Le storie, i poemi, i miti, debbono essere rivisitati, e talvolta reinterpretati.
 Alessandro il Grande potrebbe aver combinato un grande pasticcio.
Alessandro il Grande potrebbe aver combinato un grande pasticcio.
 La storia è che re Mida aveva donato ai Frigi un cocchio che era legato a un palo. Il nodo che legava il cocchio non aveva una fine, un capo. Nessuno lo poteva sciogliere, e si sparse la fama che si trattava di un puzzle che solo un futuro grande capo avrebbe potuto risolvere.
La storia è che re Mida aveva donato ai Frigi un cocchio che era legato a un palo. Il nodo che legava il cocchio non aveva una fine, un capo. Nessuno lo poteva sciogliere, e si sparse la fama che si trattava di un puzzle che solo un futuro grande capo avrebbe potuto risolvere.
 Nel 333 A.C. Alessandro il Grande pose mano alla soluzione del puzzle, (perché avrebbe portato sfortuna non farlo), ma non riuscì a sciogliere il nodo. Alla fine chiese se rispetto a come farlo ci fossero delle regole, e risultò che non ce ne erano, così...
Nel 333 A.C. Alessandro il Grande pose mano alla soluzione del puzzle, (perché avrebbe portato sfortuna non farlo), ma non riuscì a sciogliere il nodo. Alla fine chiese se rispetto a come farlo ci fossero delle regole, e risultò che non ce ne erano, così...
 Con un solo colpo di spada Alessandro tagliò il nodo, liberò il cocchio e ingarbugliò il nostro modo di pensare. Compenso a breve termine, danno a lungo termine, e avidità al posto della curiosità (Bateson N., 2013 www.circolobateson.it).
Con un solo colpo di spada Alessandro tagliò il nodo, liberò il cocchio e ingarbugliò il nostro modo di pensare. Compenso a breve termine, danno a lungo termine, e avidità al posto della curiosità (Bateson N., 2013 www.circolobateson.it).
 Il mito è arrivato fino a noi, portato dalla sabbia del tempo, con il culto della Madonna che scioglie i nodi.
Il mito è arrivato fino a noi, portato dalla sabbia del tempo, con il culto della Madonna che scioglie i nodi.
 (statua della Madonna che scioglie i nodi nella basilica dei Santi Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio al Quirinale) [...]" (cfr. Lucilla Ruffilli e Giulia Testi, "Riflessioni Sistemiche", N° 30 - "Relazioni e cura", giugno 2024).
(statua della Madonna che scioglie i nodi nella basilica dei Santi Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio al Quirinale) [...]" (cfr. Lucilla Ruffilli e Giulia Testi, "Riflessioni Sistemiche", N° 30 - "Relazioni e cura", giugno 2024).- NOTE:
- Storia, #Filosofia, e #Storiografia: "Incontro tra #Diogene di #Sinope e #Alessandro Magno".
- ARTE, STORIA, E ANTROPOLOGIA: RICORDO DI FRANCESCO DI ASSISI E DEL SUO PRESEPE (GRECCIO, 1223).
- ANDROCENTRISMO E RINASCIMENTO DA "TRAGEDIA" (DI LUNGA DURATA): LA #SINTESI DELLA #TEORIA PLATONICO-ARISTOTELICA DEL "#SAPIENTE" (#BOVILLUS, 1510), #CRITICA-#MENTE AL CENTRO DEL LAVORO DI #STEFANOMANCUSO E #ALESSANDRAVIOLA, "#VERDEBRILLANTE. SENSIBILITà E INTELLIGENZA DEL MONDO VEGETALE" (Giunti Editore).
- GREGORY BATESON E IL PROBLEMA DEL "NOSTRO #SISTEMA GLOBALE": "Dice il proverbio che quelli che abitano in una casa di vetro, soprattutto se vi abitano con altri, dovrebbero pensarci bene prima di tirarsi dei sassi; e penso che sia opportuno ricordare a tutti gli occidentali che leggeranno questo saggio che essi vivono in una casa di vetro insieme con la professione medica, con la religione cristiana, con la rivoluzione industriale e con il sistema educativo di cui gli altri sono un prodotto. In altre parole, noi tutti abbiamo in comune un groviglio di presupposizioni, molte delle quali hanno origini antiche. A mio parere, i nostri guai affondano le radici in questo groviglio di presupposizioni, molte delle quali sono insensate. Invece di puntare il dito contro questa o quella parte del nostro sistema globale (i dottori malvagi, gli industriali malvagi, i professori malvagi), dovremmo esaminare le basi e la natura del sistema"(G. Bateson, "Sintomi, sindromi e sistemi", 1978)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- C’ERA UNA VOLTA IL "LOGOS" (IN "EUROPA", IN "DANIMARCA")": IL "VIAGGIO" DI DANTE E LA "SCOPERTA" DI SHAKESPEARE20 agosto 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E STORIOGRAFIA: LA LEZIONE DEL PRESEPE SUL "#COMENASCONOIBAMBINI" E LA "#DIVINACOMMEDIA".
 Una ipotesi di ri-lettura...
Una ipotesi di ri-lettura...Come MARIA: "FIGLIA DEL TUO FIGLIO", così GIUSEPPE: "FIGLIO DEL TUO FIGLIO"!!! Dante non "cantò" i "mosaici" dei "faraoni"...
- In memoria di Bernardo di Chiaravalle (#20agosto 2024).
MEMORIA, #STORIA, E #FILOSOFIA. SE DOPO "#VIRGILIO" E DOPO "#BEATRICE", DANTE ASSEGNA ALLA FIGURA DI BERNARDO DI CHIARAVALLE IL "COMPITO" DI "ORATORE" per chiedere l’intercessione a Maria, la madre di Cristo, perché egli possa fissare lo sguardo nella luce divina (vv. 40-66), la ’ragione’ è dovuta proprio al fatto che, dopo la luminosa lezione del presepe, sul "come nascono i cristiani" (#Greccio, 1223), vuole chiarirsi il "mistero" della #Trinità (vv. 109-126) e dell’#Incarnazione (vv. 127-138), sul come "Dio" diventa "essere umano".
C’ERA UNA VOLTA IL "LOGOS" (IN "EUROPA", IN "DANIMARCA")": IL "VIAGGIO" DI DANTE E LA "SCOPERTA" DI #SHAKESPEARE ("O MY #PROPHETIC #SOUL ! MY #UNCLE?": "#HAMLET", I.5). Per Dante, la lezione di Bernardo di Chiaravalle è accolta con "entusiasmo" all’interno della "solare" lezione di Francesco di Assisi, perché è ovviamente convinto che solo con "Maria e Giuseppe" è possibile una comprensione antropologica-mente chiara del messaggio evangelico e una uscita dall’orizzonte della "caduta" di "#Adamo ed #Eva". Altrimenti, come immediatamente succederà al tempo di Dante ancora vivo (ricordare non solo la Chiesa di Bonifacio VIII, ma anche di #GiovanniXXII), con la messa "in parentesi" della figura di "Giuseppe", tutta l’Europa si avvia a diventare uno "stato di Danimarca" (Shakespeare, "Amleto"): con la "dotta ignoranza" e la "pace della #fede" (1453) platonico-paolina e costantiniana, darà il via al giogo della "divina tragedia" su tutto il Pianeta (#Nicea 325-2025).
NOTA:
- MEMORIA, #STORIA, E MUSICA: FRANCESCO DI ASSISI. "Dal 2023 al 2026 ricorrono ben quattro centenari francescani. Nell’ordine: 2023 ottavo centenario della Regola francescana e del Natale di Greccio; 2024: ottavo centenario dell’impressione delle Stimmate, sul monte della Verna; 2025: ottavo centenario del Cantico delle creature; 2026: ottavo centenario della morte di Francesco. [...]" (cfr. Carlo Pulsoni, "Il canto come autentica via di preghiera. Dialogo con Fra Alessandro Giacomo Brustenghi")
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- LA GLOBALIZZAZIONE CATTOLICO-SPAGNOLA DEL SEICENTO EUROPEO, LA LEZIONE DI SHAKESPEARE, E LA "RIPENESS" DEL "NOSTRO TEMPO" (KANT, 1784).14 agosto 2024, di Federico La Sala
TEATRO METATEATRO E PIANETA TERRA:
IL "MULINELLO" DI SHAKESPEARE, LA GLOBALIZZAZIONE CATTOLICO-SPAGNOLA DEL #SEICENTO EUROPEO, LA #CRISI CONTEMPORANEA DELL’#IMPERO AMERICANO, OGGI: "SAPERE AUDE! (KANT, 1784), E LA "RIPENESS" DEL "NOSTRO TEMPO".
- Una nota a margine del lavoro di "archeologico" in progress ("Hamlet’s Bible") di Paul Adrian Fried.
CON L’ARTICOLO "Hamlet, Prince of #Denmark: Conspiracy Theorist for Our Times", Paul Adrian Fried propone un’ottima sintesi e un’aggiornata #analogia:
- "[...] The official government explanation in Shakespeare’s play claimed that King Hamlet died from a snake bite while napping in his garden. Some Danes may have believed this, but some may have been suspicious due to the hasty (and technically illegal) marriage of Queen Gertrude to King Hamlet’s brother Claudius.
- Prince Hamlet and the sentinels who claimed to see the ghost of King Hamlet would be considered "conspiracy theorists" today, and even if that phrase had pejorative connotations in past eras, it became even more since a certain CIA document from the 1960s related to the assassination of JFK. Hamlet quickly became the target of surveillance efforts by Claudius and Polonius, and they recruited Hamlet’s friends Rosencrantz and Guildenstern to help in their spying on the prince.
- Since long before Machiavelli, but especially so in the modern era, humanity has been living in an age of conspiracies. [...] Something was rotten in Denmark, and something is rotten in the US as well. We need conspiracy narratives like Hamlet to remind us of how power always corrupts, and that things are often not what they seem, or what we’re told to believe." (cit.).
ESSERE, O NON ESSERE: "RIPENESS IS ALL" ("KING LEAR", V.2). A mio parere, tuttavia, la #consapevolezza di #Amleto è da collocarsi (come Shakespeare sembra volere e come sembra che lo stesso autore voglia fare) a un livello più propriamente "biblico", storico e metastorico: vale a dire, sul piano della "#caduta" (antropologica e teologica), e sulla determinazione #critica di portarsi fuori dall’orizzonte teologico-politico del #Mentitore, del "#Serpente" - di uscire dall’infernale "vicolo cieco" e, possibilmente, riprendere la via per recuperare l’orizzonte del "#paradisoterrestre" e celeste (come da indicazione di Dante Alighieri). Si tratta di portarsi, accogliendo i vari "rimandi" evangelici dello stesso Shakespeare, fuori dallo "#stato di #minorità", e, al contempo, aver il #coraggio di servirsi della propria intelligenza" (Kant), non ci sono altre vie: “Che c’è, ancora cattivi pensieri? Gli uomini devono sopportare / la loro uscita dal mondo come la loro venuta; / la #maturità è tutto. Andiamo” (Shakespeare, "#ReLear", V. II).
EARTHRISE (L’ALBA DELLA MERAVIGLIA, IL "SORGERE DELLA TERRA"). Ciò che nel tempo presente, qui ed ora, appare essere importante e urgente (dal punto di vista di un possibile ONU = UNO o dI astronauti e di astronaute che guardano dall’esterno il Pianeta Terra), da una parte, capire che il "serpente" non è altro che un’#anguilla alla #ricerca dell’via di uscita per raggiungere l’#oceano e, dall’altra, comprendere che occorre alimentare al massimo la fiamma del desiderio di "seguir virtute e canoscenza" (Inf. XXVI, 119), di "rivedere le stelle" (Dante Alighieri, Inf. XXXIV, 139), e di riprendere la navigazione nell’oceano celeste (#Keplero a #Galileo #Galilei, 1611).
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- PER LA PACE PERPETUA" (795). Kant e la "nostalgia di qualcosa di diverso, vale a dire di una speranza che smentisce e sbugiarda l’idea di un ordine globale fondato sulla guerra" (di Leonardo Ceppa)..3 agosto 2024, di Federico La Sala
PER LA PACE PERPETUA
di Leonardo Ceppa (Le parole e le cose, 2 Agosto 2024)
La società internazionale dei filosofi avrebbe voluto festeggiare a Königsberg i trecento anni della nascita di Kant. Sennonché quella città, a suo tempo strappata dagli Alleati ai nazisti, oggi si chiama Kaliningrad, ed è nelle mani di quel nuovo dittatore (Vladimir Putin) che, invadendo l’Ukraina, ha infranto due anni fa il diritto internazionale e riportato l’Apocalisse nel cuore dell’Europa. Così la società kantiana ha deciso di festeggiare il tricentenario riunendosi a Bonn nel prossimo settembre, cioè nella capitale provinciale della vecchia Repubblica federale tedesca.
Da parte sua, il cancelliere Olaf Scholz ha sottolineato l’attualità politica del saggio kantiano Per la pace perpetua (1795) in un notevole discorso del 23 aprile 2024 (si trova pubblicato nel Bulletin der Bundesregierung 37-4). Fondare politicamente la pace significa pensarla non come lo stato normale e naturale del diritto internazionale, bensì come una nuova situazione garantita dalla forza della democrazia. Dopo l’invasione della Ukraina e la guerra all’Occidente scatenata da Putin, Olaf Scholz parla di un punto di svolta (Zeitenwende) della politica mondiale: l’ordine internazionale dev’essere oggi difeso dalla forza militare, dal riarmo dell’esercito, dalle sanzioni economiche, dalla rinuncia alla collaborazione scientifica. Certo si deve, oggi come ieri, cercare la pace, ma non una pace a qualunque prezzo: a volte anche la guerra rientra nel prezzo con cui dobbiamo pagare la pace.
In questa prospettiva, la festa del tricentenario kantiano rischia di essere strumentalizzata dalla guerra in corso tra Est e Ovest, facendo rinascere la guerra fredda. A questo punto, un filosofo tedesco di 53 anni, Gunnar Hindrichs - docente a Basilea, già presidente della Società filosofica svizzera e vicepresidente della Associazione internazionale hegeliana - fa oggi uscire sull’ultimo numero di Merkur (luglio 2024, pp. 49-58) un saggio davvero fulminante che, ristabilendo il senso normativo della Pace perpetua kantiana, ne vieta qualsiasi lettura egoisticamente interessata.
 Tra parentesi ricordiamo che qualcosa di analogo aveva fatto anche Habermas nei confronti della interpretazione teologico-apologetica di Kant avanzata da Rudolf Langthaler in due convegni internazionali su “Fede e sapere” tenuti a Vienna nel marzo 2004 e nel settembre 2005 (cioè nel bicentenario della morte di Kant. Sul punto cfr. Leonardo Ceppa, Habermas. Le radici religiose del moderno, Morcelliana 2017, pp. 73-87). Il discorso del cancelliere tedesco e una celebrazione banale del tricentenario kantiano rischiano oggi di leggere la Pace perpetua come la rifondazione di un diritto alla guerra in difesa dell’ordine democratico. Vorrei qui cercare di riassumere le tesi di Gunnar Hindrichs, in quanto mi paiono di grande interesse.
Tra parentesi ricordiamo che qualcosa di analogo aveva fatto anche Habermas nei confronti della interpretazione teologico-apologetica di Kant avanzata da Rudolf Langthaler in due convegni internazionali su “Fede e sapere” tenuti a Vienna nel marzo 2004 e nel settembre 2005 (cioè nel bicentenario della morte di Kant. Sul punto cfr. Leonardo Ceppa, Habermas. Le radici religiose del moderno, Morcelliana 2017, pp. 73-87). Il discorso del cancelliere tedesco e una celebrazione banale del tricentenario kantiano rischiano oggi di leggere la Pace perpetua come la rifondazione di un diritto alla guerra in difesa dell’ordine democratico. Vorrei qui cercare di riassumere le tesi di Gunnar Hindrichs, in quanto mi paiono di grande interesse.Nessuno più di Kant era consapevole del tono bombastico e ironico della sua impresa normativa. Infatti la pace di cui intendeva trattare non era quella degli armistizi occasionali, separanti nella storia un conflitto dall’altro, laddove la dimensione satirica era benissimo espressa “sull’insegna di un certo oste olandese sulla quale era dipinto un cimitero” (Per la pace perpetua, in Kant, Scritti di storia, politica e diritto, a cura di Filippo Gonnelli, Laterza 1995, p. 163).
 Che il luogo della pace perpetua non dovesse ridursi alla metafora del camposanto fu la grande pretesa morale di tutto l’illuminismo, dall’Abbé de Saint-Pierre (1713) a Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Solo quest’ultimo intuì che la pace perpetua non doveva essere vista come un problema privato di uomini, prìncipi e filosofi, bensì come il problema pubblico dei popoli. Gli uomini - quel “legno storto” di cui parla Kant nel saggio sulla Religione - trovano effettivamente pace solo da morti, i prìncipi sono sempre “smaniosi di guerra” (Kriegslüstern è la bellissima parola kantiana), i filosofi non fanno altro che sognarla come utopia.
Che il luogo della pace perpetua non dovesse ridursi alla metafora del camposanto fu la grande pretesa morale di tutto l’illuminismo, dall’Abbé de Saint-Pierre (1713) a Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Solo quest’ultimo intuì che la pace perpetua non doveva essere vista come un problema privato di uomini, prìncipi e filosofi, bensì come il problema pubblico dei popoli. Gli uomini - quel “legno storto” di cui parla Kant nel saggio sulla Religione - trovano effettivamente pace solo da morti, i prìncipi sono sempre “smaniosi di guerra” (Kriegslüstern è la bellissima parola kantiana), i filosofi non fanno altro che sognarla come utopia.
 Nessuno è più realista di Kant nel disegnare questa triplice clausola ironica della pace: caducità dell’uomo, egoismo dei prìncipi, utopismo dei filosofi. L’idea trascendente e normativa contro questa clausola si chiama in Kant Friedensbund: lega di pace, foedus pacis, cosmopolitismo repubblicano. E nel saggio di Gunnar Hinrichs ne troviamo una brillante ricostruzione sul piano del diritto, della filosofia-della-storia, della filosofia-della-religione. Cerchiamo di riassumere.
Nessuno è più realista di Kant nel disegnare questa triplice clausola ironica della pace: caducità dell’uomo, egoismo dei prìncipi, utopismo dei filosofi. L’idea trascendente e normativa contro questa clausola si chiama in Kant Friedensbund: lega di pace, foedus pacis, cosmopolitismo repubblicano. E nel saggio di Gunnar Hinrichs ne troviamo una brillante ricostruzione sul piano del diritto, della filosofia-della-storia, della filosofia-della-religione. Cerchiamo di riassumere.Sul piano giuridico vale la contrapposizione di stato di natura e stato di legalità (o legittimità). Uomini e stati - quando risultano semplicementi motivati da interessi, bisogni e desideri particolari - infrangono qualunque armistizio e si autoconservano con la guerra. Quando invece risultano motivati dallo spirito-delle-leggi (Geist von Gesetzen) escono dallo stato di natura ed entrano in quell’ordine civile di cui aveva parlato Hobbes. E statu naturali exeundum esse. Allora la pace interstatale che ne deriva, lungi dall’essere un temporaneo armistizio, diventa un ordine cosmopolitico. E la pace perpetua come fine della storia, lungi dall’essere un obiettivo transitorio, diventa il senso filosofico sotteso a questa uscita dallo stato di natura, dunque il senso giuridico dell’intera traiettoria e parabola storica della specie. -Qui s’innesta per Kant una filosofia-della-storia che non si presenta né come Wunschgedanke né come empirica Feststellung, cioè né come utopia idealistica né come empirica constatazione. Si ricordino qui due magniloquenti tesi dalla Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (1784, in Scritti di storia politica e diritto, a cura di Filippo Gonnelli, cit. pp. 29-44). Tesi quinta: “Il massimo problema per il genere umano, alla cui soluzione la natura lo costringe, è il raggiungimento di una società civile che faccia valere universalmente il diritto” (p. 34, corsivo mio). Tesi ottava: “Si vede bene come qui anche la filosofia possa avere il proprio chiliasmo” - il proprio millenarismo, cioè l’attesa del regno di Cristo in terra - la cui attuazione, continua Kant, non ha più nulla di esaltato, come nella Apocalisse biblica, in quanto si limita a segnalare il possibile sviluppo di tutte le disposizioni dell’umanità. Il punto di vista dell’autoconservazione animale va inteso come l’accettazione di una finitezza umana che acquista il suo vero significato solo alla luce di un “Non ancora”, di un Noch nicht normativo.
 Dal punto di vista di una filosofia-della-religione, infine, la pace perpetua indicherebbe il raddrizzamento del legno storto dell’umanità, cioè la speranza di un chiliasmo non utopistico, né semplicemente morale, bensì addirittura metafisico: vale a dire il rifiuto di arrendersi alla visione realistica di una autoconservazione meramente animale. “Lasciate ogni speranza - scrive qui Gunnar Hindrichs citando Dante in italiano - non è infatti l’insegna del mondo di Dio, bensì dell’inferno” (Merkur, cit., p. 55).
Dal punto di vista di una filosofia-della-religione, infine, la pace perpetua indicherebbe il raddrizzamento del legno storto dell’umanità, cioè la speranza di un chiliasmo non utopistico, né semplicemente morale, bensì addirittura metafisico: vale a dire il rifiuto di arrendersi alla visione realistica di una autoconservazione meramente animale. “Lasciate ogni speranza - scrive qui Gunnar Hindrichs citando Dante in italiano - non è infatti l’insegna del mondo di Dio, bensì dell’inferno” (Merkur, cit., p. 55).Dunque, conclude Gunnar Hindrichs, celebrare Kant non significa oggi esaltare la guerra come una difesa della pace democratica contro i despoti asiatico-orientali. Certo, la istituzionalizzazione normativa della pace perpetua può anche suonare come una tesi kantiana esaltata, stravagante, eccentrica (verstiegen). In tal caso lasciamo perdere Kant e volgiamoci alle filosofie che legittimano l’idea di pace come esito di una guerra infinita. Antonio Negri e Michael Hardt, per esempio, esaltano la lotta tra impero e moltitudine, mentre Fracis Fukuyama vede la pace perpetua come il destino di un liberalismo capitalistico globale. Anche Peter Sloterdijk e Olaf Scholz continuano a intendere la pace kantiana come quell’area - interna al capitalismo democratico - che si tratta di difendere contro barbari, mafie e stati canaglia. Ma questa è, secondo Hindrichs, una torsione ideologica dell’idea kantiana. Il concetto kantiano è invece la nostalgia di qualcosa di diverso, vale a dire di una speranza che smentisce e sbugiarda l’idea di un ordine globale fondato sulla guerra.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- AD AMLETO, IL "PRESEPE" DELLO "STATO DI DANIMARCA" NON PIACE! SHAKESPEARE CERCA DI SVEGLIARE LA CULTURA DAL SONNO DOGMATICO DELL’EPOCA.17 luglio 2024
TEATRO E METATEATRO:
AD AMLETO, IL "PRESEPE" DELLO "STATO DI DANIMARCA" NON PIACE!
SHAKESPEARE, IL #MOSCHETTIERE DELL’INGHILTERRA DELLA REGINA ELISABETTA ("HONI SOIT QUI MAL Y PENSE", "Sia vituperato chi ne pensa male"), SULLE ALI DI #GIORDANO BRUNO E #TOMMASO #CAMPANELLA, IN UN ORIZZONTE ELIOCENTRICO, SOLARE E COPERNICANO, CERCA DI SOLLECITARE LA CULTURA EUROPEA AD #APRIREGLIOCCHI (#FREUD).
- Un omaggio alla memoria di Eduardo De Filippo...
STORIA E #METASTORIA. ALLA LUCE DELLA "RIVELAZIONE" DELLO #SPIRITO DEL #PADRE E #RE, il "programma" del Figlio e Principe Amleto ("moschettiere" della #Legge del Re Amleto e della #Regina #Gertrude), a ben riflettere in una #Europa segnata dalla #Riforma Protestante (e dal #matrimonio di Lutero e di Katharina von Bora) e della #Riforma Anglicana (e dal matrimonio di EnricoVIII e Anna Bolena), appare essere ("O my prophetic soul! My uncle?": I.5) uno straordinario corso di lezioni contro la "cattolica" Accademia di Platone (v. la "Scuola di Atene" di #Raffaello, 1509-1511; e, ancor più precisamente, la cosmoteandrica "piramide" del "Sapiente" di #Bovillus, 1509-1510): ad Amleto, il "presepe" non piace! Proprio per disinnescare la "trappola per i topi" ("The #Mousetrap") in terra (nello "stato di Danimarca") e in cielo (tra le "nuvole"), il Principe e il Figlio del "vecchio" Re ribalta il tavolo e rilancia con la sua rappresentazione-trappola ("L’assassinio di Gonzago", dove il #nipote uccide lo #zio), e, coraggiosamente, fa di tutto per rimettere il #tempo in sesto e riuscire a rendere possibile una conclusione positiva al "racconto di inverno" ("The Winter’s Tale", 1611).
NOTA:
STORIA, LETTERATURA, E TEATRO: EDUARDO DE FILIPPO, "NATALE IN CASA CUPIELLO... [...] Tommasino, alla domanda che suo padre gli rivolge in punto di morte, «Te piace ’o presepio?» ("Ti piace il presepe?"), alla quale egli in precedenza aveva sempre risposto di no con stizzita protervia, finalmente si "scioglie" e tra le lacrime gli sussurra un laconico sì, proprio mentre suo padre sembra entrare nella gioiosa allucinazione di un "enorme presepe nei cieli" [...]".
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- AL DI LA’ DEL MACHIAVELLISMO, A SCUOLA DI MACHIAVELLI, SHAKESPEARE E COLLODI; QUANDO IL "TOPO" DIVENTA UN "#GATTO" (UNA "GATTA") E SVELA IL "GOLPE" (DEL "LIONE").7 luglio 2024, di Federico La Sala
CON AMLETO (ED EDIPO), A SCUOLA DA MACHIAVELLI: TEATRO (FILOSOFIA) E METATEATRO (METAFILOSOFIA).
QUANDO IL "TOPO" DIVENTA UN "#GATTO" (UNA "GATTA") E SVELA IL "GOLPE" (DEL "LIONE"). Una traccia per una ri-lettura dell’opera di Shakespeare ...
- In memoria di Sigmund Freud e Marie Bonaparte...
SHAKESPEARE E COLLODI. Se è vero, come è stato detto da qualcuno, che "L’ Amleto è antiamletico come Pinocchio è antipinocchiesco; totalmente e quindi ambiguamente", c’è da chiarire e precisare che Amleto non diventa un "ragazzino per bene" (un "Pinocchio"), ma vince la sua battaglia (personale e politica), resta fedele a se stesso, alla Legge, e al ricordo del Padre-Re, e restituisce onorevolmente a "Fortebraccio" la #corona della "Danimarca".
UNA QUESTIONE DI #STATO: "IL PRINCIPE". Se la "sconfitta" di Pinocchio passa per la morte e l’impiccagione (cap. XV) prima e poi per la falsa "rinascita" finale (Geppetto: "quando i ragazzi cattivi diventano buoni", cap. XXXVI), al contrario, la "storia" di Amleto passa per il ribaltamento della posizione e la vittoria: "Stasera si recita in presenza del re:/ una scena del dramma s’avvicina ai fatti/che t’ho detto sulla morte di mio padre. /Ti prego, quando vedi cominciare quell’episodio /con tutto l’acume della tua anima osserva mio zio." (III. 2.85-90).
LA VOLPE E IL LEONE. "Sendo, dunque, uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il lione; perché il lione non si defende da’ lacci, la golpe non si defende da’ lupi. Bisogna, adunque, essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a sbigottire e’ lupi." (N. Machiavelli, "Il Principe", cap. XVIII).
EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA ATTIVA E CRITICA: UN GATTO ("THE MOUSETRAP") E UN ("SERPENTE" CAMUFFATO DA) "TOPO". Amleto, ben consapevole (come chiarisce a Orazio) del fatto che, «se la sua [del Re Claudio] colpa occulta non si stana a un certo discorso, è uno spettro dannato quello che noi abbiam visto» (III.2. 90-92), per chiarire a sé stesso e a tutti e a tutte i dubbi, da "cacciato" si fa "#cacciatore" e aziona la "trappola per topi" ("The Mousetrap"), per mostrare come chiarire gli "amletici" dubbi: "Questo dramma è la rappresentazione di un assassinio compiuto a Vienna. Gonzago è il nome del Duca, quello di sua moglie Battista. [...] l’assassino è un certo Luciano, #nipote del Re [...]. Lo avvelena nel #giardino per prendergli il #regno. Il suo nome è Gonzago. La storia è dei nostri giorni, e scritta in italiano scelto. Ora vedrete come l’assassino ottiene l’#amore della moglie di Gonzago" (III.2.247).
NOTE:
- STORIA FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA (KANT, 2024): CON LA EVANGELICA E FRANCESCANA "REGALITA’ ANTROPOCENTRICA DI #DANTE" ( * ), NON CON IL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO" DELL’ANDROCENTRISMO PLATONICO-PAOLINO DI FRANCESCO BACONE. CON IL RIFERIMENTO al tema del #giardino e del #serpente ("Amleto", III.2), Shakespeare colloca la "riflessione" di Amleto nell’orizzonte del suo tempo (ricordare la Riforma Protestante, la Riforma Anglicana, Giordano Bruno, e Tommaso Campanella, Elisabetta I d’Inghilterra sul trono e sull’altare) e, in consonanza, nel solco e in continuità con il programma antropologico e teologico di Dante: andare oltre la "#caduta" (di Eva e di Adamo) e restituire a "Maria" ("Gertrude") e "Giuseppe" ("Amleto") la loro regalità antropologica (non platonico-demiurgica e cosmoteandrica) e la loro genitorialità di ogni Bambino ("Amleto" /"Cristo") del loro "stato di Danimarca".
- * Cfr. E. H. #Kantorowicz, "I #duecorpi del re. L’idea di regalità nella #teologia politica medievale" (cap. "VIII. La regalità antropocentrica: Dante"), Einaudi.
- FRANCESCO BACONE, IL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO", E LA "VIRGINIA COMPANY". "#Francis #Bacon, latinizzato in Franciscus Baco (-onis) e italianizzato in Francesco Bacone (Londra, 22 gennaio 1561 - Londra, 9 aprile 1626), è stato un filosofo, politico, giurista e saggista inglese vissuto alla corte inglese, sotto il regno di Elisabetta I Tudor e di Giacomo I Stuart. [...] Dopo privatizzazione delle terre, come uomo politico concettualizzò la scienza del terrore assecondando e sostenendo le deportazioni di massa dei diseredati e dei poveri nelle colonie americane della #Virginia. Tra le altre cose è necessario ricordare che nel 1619 il Consiglio Privato, di cui a quel tempo Bacone faceva parte, violando apertamente la legge inglese, e per assecondare la volontà della Virginia Company, costrinse alla deportazione nelle colonie americane ben 165 bambini, provenienti dal Bridewell Palace. Di quei 165 bambini (di età compresa tra gli 8 e i 16 anni) nel 1625 a seguito dei maltrattamenti subiti nelle piantagioni ne rimasero in vita solo dodici. Le deportazioni continuarono coinvolgendo altri millecinquecento bambini nel 1627 e ulteriori quattrocento, di origine irlandese, nel 1653 [...]".
- INFANZIA, STORIA, E LETTERATURA. Carlo Collodi, "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1881-1883),Cap. 15
- AMLETO (#HAMLET): LA "TRAPPOLA PER TOPI" ("THE MOUSETRAP") E IL PRINCIPE MOSCHETTIERE ("THE MUSKETEER PRINCE") ...
- UN OMAGGIO AI "#TRE MOSCHETTIERI", AL CAPOLAVORO DI #ALEXANDRE #DUMAS: «Non credete ai denigratori. "I tre moschettieri" emana un vero profumo storico: non meno di "Guerra e Pace"; un #profumo che Dumas ricava con #astuzia e #grazia dalle memorie, dalle lettere e dai romanzi del primo #Seicento.».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- TEATRO E METATEATRO: "REMEMBER ME" (SHAKESPEARE, "HAMLET", I.5). PER AMLETO, LA "CASA DEL PADRE" E’ DIVENTATA UNA "PRISON" (PRIGIONE).2 luglio 2024, di Federico La Sala
TEATRO E METATEATRO: "REMEMBER ME" (SHAKESPEARE, "HAMLET", I.5). MEMORIA STORIA LETTERATURA E FILOLOGIA (2 LUGLIO 2024).
- RI-BILANCIA-RE IL "MONDO": "THE #TIME IS OUT OF JOINT" ("IL #TEMPO E’ FUORI DAI CARDINI": (SHAKESPEARE, "HAMLET", I.5).
PER AMLETO, LA "CASA DEL PADRE" (IL "RE DEL MONDO", L’ AMORE) CON LE SUE "MOLTE DIMORE" (Gv. 14, 2) E’ DIVENTATA UNA "PRISON" (PRIGIONE):
- "Hamlet: Denmark’s a prison.
 Rosencrantz: Then is the world one.
Rosencrantz: Then is the world one.
 Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." (II. 2. 242-245).
Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." (II. 2. 242-245).
PSICOANALISI E STORIOGRAFIA. COME IL #LOGOS DEL PRINCIPIO (#ARCHE’) DI #ERACLITO DI EFESO E DELL’APOSTOLO GIOVANNI (Gv. 1.1) DIVENNE UN #LOGO E LE #ENCLOSURES (RECINZIONI) SI DIFFUSERO SU TUTTA LA TERRA:
Sigmund Freud, che ha scavato a lungo, e continuò a scavare nei sotterranei della cultura greca, ebraica, e cattolico-romana fino alla morte (Londra, 1939), e conosceva molto bene non solo la "tragedia" di "Edipo Re" (Sofocle), ma anche del principe "Amleto" (Shakespeare), nel 1929, così scrive: "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’#amore #universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori" (S. Freud, "Disagio della civiltà", 1929).
ARTE E TEOLOGIA. Alla luce del sempre più "brillante" presente storico, forse, è bene tenere conto dell’analisi di Freud, rimeditare sulla hamlet-ica "Mousetrap" (III.2) di Shakespeare, e, al contempo, riflettere sulla enigmatica figura del futuro #padre di Gesù, #Giuseppe ("De domo David"), che prepara una "trappola per #topi" nello straordinario "Trittico di Mérode", dedicato al tema dell’#Annunciazione, di Robert Campin.
Nota:
- ANTROPOLOGIA E #COSMOTEANDRIA: L’IMMAGINARIO DEL CATTOLICESIMO-ROMANO:
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- RILEGGERE LA "MONARCHIA" DI DANTE ALIGHIERI E RIPENSARE LA "LETTURA DANTESCA E LETTURA UMANISTICA NELL’IDEA DI IMPERO" DI MERCURINO GATTINARA PROPOSTA DA GIUSEPPE GALASSO.24 giugno 2024, di Federico La Sala
RIPENSARE LA "LETTURA DANTESCA E LETTURA UMANISTICA NELL’IDEA DI IMPERO" DI MERCURINO GATTINARA PROPOSTA DA GIUSEPPE GALASSO, RICONSIDERANDO CON ATTENZIONE IL CLIMA TEOLOGICO POLITICO E SOCIALE DELLA NAPOLI E DELLA SALERNO ALL’EPOCA DEL PRINCIPE FERRANTE SANSEVERINO:
A) RICONSIDERARE LA FIGURA DI FERRANTE SANSEVERINO.
B) RIPRENDERE E RIPENSARE L’ANALISI DELLA "Lettura dantesca e lettura umanistica nell’idea di impero del Gattinara" DI GIUSEPPE GALASSO:
"«L’ideale imperiale» del Gattinara -affermó il Brandi- «non era stato diverso dal sogno imperiale di Dante». II giudizio del Brandi merita una considerazione particolare. E noto che la svolta fondamentale negli studi sul cancelliere di Carlo V è stata segnata dalle ricerche e dai lavori di Carlo Bornate tra la fine del secolo xix e i primi decenni del secolo xx. E anche noto, pero, che «i risultati del Bornate sarebbero passati inosservati, se non fosse stato per le ricerche di Karl Brandi, due decennii dopo, nella preparazione del suo grande studio su Carlo V», il cui primo volume apparve nel 1937 e il secondo, contenente appunto, con le note al primo volume, gli esiti di quelle ricerche, nel 1941. Eppure, l’importanza del Gattinara nell’ entourage di Carlo V fu ben nota agli stessi contemporanei’’. Sarebbe di grande interesse spiegare l’oblio al quale la sua figura storica appare consegnata fino a che, da Bornate e Brandi in poi, egli è riemerso come un punto di riferimento fondamentale nella storiografia su Carlo V per gli anni ’20 del lungo regno dell’Imperatore’. Qui noi ci vogliamo, pero, fermare piuttosto sull’idea di impero, per la quale si ha un consenso generale degli studiosi nel vedere in essa uno dei motivi piü importanti, se non proprio il piú importante, della sua influenza su Carlo V. [...]
[...] attraverso un’acuta riflessione sul mutare delle circostanze secondo il corso degli eventi; é nella centralita della posizione dinastica asburgica, perno di quella tradizione; che Gattinara maturo le convinzioni e le posizioni per cui esercitò su Carlo V, specialmente in alcuni momenti o su alcuni problemi, un’influenza notevole.
Ben poco c’entra, come si è visto, l’idea imperiale di Dante; e ben poco anche
l’Umanesimo, erasmiano o non erasmiano che fosse. Molto, invece, c’entrava il tipo di cultura giuridico-amministrativa, che fu suo; e molto anche O rápido assorbimento dei principii e delle spinte dell’ideologia e della politica asburgica: una restaurazione della maestà imperiale in tutto ñ suo prestigio, vigore, ampiezza, specialmente dacché, grazie ai matrimoni borgognoni e iberici, «la potenza mondiale della casa offriva a questeaspirazioni di dominio sopranazíonale una base moderna e concreta». Ed è, quindi, alla luce di queste considerazíoní che vanno letti anche gli indirizzi di politica italiana e imperiale di cui il Gattinara si fece interprete e propose all’attenzione del suo Imperatore, sulla base di valutazioni molto più realistiche, modeme, pregne di «ragion di
stato» e di Real-politik e molto meno ideologiche e volte al passato di quanto molti studiosi ancora ritengono. " (cfr. G. Galasso, "Lettura dantesca e lettura umanistica nell’idea di impero del Gattinara", pp. 93-114, - ripresa parziale, senza note).
C) RILEGGERE LA MONARCHIA DI DANTE ALIGHIERI, FOCALIZZANDO L’ATTENZIONE SULLA DOTTRINA DEI "DUE SOLI", E, IN PARTICOLARE, SULLA LETTERA DI MERCURINO GATTINARA AD ERASMO DI ROTTERDAM DEL MARZO DEL 1527 PER SOLLECITARLO A PROMUOVERE UNA EDIZIONE DELL’OPERA DI DANTE (cfr. Enrico Castelli, "Machiavellismo e Cristianesimo", in: E. Castelli," I presupposti di una teologia della storia", Padova 1968, p. 217).
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- UN "PENSIERO" E UN "RICORDO" PER RIPRENDERE IL CAMMINO: AMARE L’ITALIA E IMPARARE A CONTARE.14 giugno 2024, di Federico La Sala
ASPETTANDO IL "SORGERE DELLA TERRA" E UN NUOVO "GIOTTO", UN "PENSIERO" E UN "RICORDO" PER RIPRENDERE IL CAMMINO.
- Una nota di commento a margine degli eventi dell’attuale #presentestorico.
AMARE L’ITALIA E IMPARARE A CONTARE. SE per l’ Europa si vuole fare qualcosa, non si può non ricominciare dalla #memoria degli "eroi" della "prima rinascita" (da Francesco di Assisi, Gioacchino da Fiore, e Dante Alighieri) e riprendere ispirazione dai "Tre Moschettieri" di Alexandre Dumas, ricordare che la "storia" è sì la "storia" del #quarto ("#quattro"), ma che in verità il "quarto" è il #primo (Tre per #UNO e "#ONU" per Tre) e, sicuramente, il Sole splenderà e il "Fiore" rifiorirà.
NOTA:
- ANTROPOLOGIA #STORIA E #METASTORIA. Ricordando #Giotto: "[...] alla nascita di Cristo nella capanna semiaperta era subito presente il mondo intero, i pastori e i savi d’Oriente" (F. #Kafka, Lettera a Helli Hermann, autunno 1921).
- Storia e #Storiografia: "La prima #Rinascita: il profeta, Gioacchino da Fiore, il missionario, Francesco di Assisi, il cantore, Dante Alighieri" di Ernesto Buonaiuti (Dall’Oglio, 1977).
- CAMBIARE MENTE E PARADIGMA (ANDROCENTRISMO E GEOCENTRISMO): GUARDARE LA #TERRA DALL’ #OCEANOCELESTE (#KEPLERO, 1611), DALLO #SPAZIO. L’#alba della #meraviglia: il "Sorgere della Terra".
- ELEZIONI EUROPEE, 2024. "Che cosa potrebbero fare i #quattro parlamentari eletti (anche) in Calabria? Qualche appunto su Stato sociale, diritto alla salute e fondi europei per Lucano, Nesci, Princi e Tridico" (di Emiliano Morrone, Corriere della Calabria, 14/06/2024).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- GEOCENTRISMO, ELIOCENTRISMO, E COSTITUZIONE DEL "MONDO": L’EUROPA ANCORA NELLA CAVERNA DELL’ANDROCENTRISMO PLATONICO E PAOLINO4 giugno 2024, di Federico La Sala
GEOCENTRISMO, ELIOCENTRISMO, E COSTITUZIONE DEL "MONDO". SHAKESPEARE, IL NOME DI OFELIA, E SOLO IL SOLE IN CIELO, AL CENTRO.
L’EUROPA ANCORA NELLA CAVERNA DELL’ANDROCENTRISMO PLATONICO E PAOLINO E I POSSIBILI RIMANDI DELL’AMLETO "ELISABETTIANO" AL CONTESTO STORICO-POLITICO DELL’ EUROPA DELL’EPOCA, CARICO DI ATTESE DA PARTE DEL "POPOLO" DEI "SOLARI"...
- TEATRO (ASTRONOMIA), METATEATRO (FILOSOFIA), E COSTITUZIONE DEL "MONDO". Una nota di commento a margine del lavoro in progress di Paul Adrian Fried: "Part 47: Ophelia’s “O” and the Virtues of Nothingness" (May 28, 2024). *
"DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM" (COPERNICO, 1543): GEOCENTRISMO O ELIOCENTRISMO?!
 ACCETTANDO PER IPOTESI CHE IL NOME DI OFELIA ("O-felia" = "Peri-elio", intorno e vicino al Sole) è formalmente vicino al nome di #AFELIO ("A-felio" - lontano dal Sole), non è meglio pensare e collocare la figura dell’amletica Ofelia nell’orizzonte delle discussioni cosmologiche legate alla #centralità del #Sole nell’#Universo (sul filo del lavoro di Copernico, Keplero, e Giordano Bruno) e delle preoccupazioni teologico-politiche legate alla #consonanza con le attese apocalittiche dell’epoca (Tommaso Campanella e "la Città del Sole") e al richiamo diffuso della figura del profeta Elia)?! Se non ora, quando "lo Spaccio della Bestia trionfante" (G. Bruno, 1584)?!
ACCETTANDO PER IPOTESI CHE IL NOME DI OFELIA ("O-felia" = "Peri-elio", intorno e vicino al Sole) è formalmente vicino al nome di #AFELIO ("A-felio" - lontano dal Sole), non è meglio pensare e collocare la figura dell’amletica Ofelia nell’orizzonte delle discussioni cosmologiche legate alla #centralità del #Sole nell’#Universo (sul filo del lavoro di Copernico, Keplero, e Giordano Bruno) e delle preoccupazioni teologico-politiche legate alla #consonanza con le attese apocalittiche dell’epoca (Tommaso Campanella e "la Città del Sole") e al richiamo diffuso della figura del profeta Elia)?! Se non ora, quando "lo Spaccio della Bestia trionfante" (G. Bruno, 1584)?!*
- "OPHELIA: What does the name mean and imply? If the name of Marlowe’s character from Dr. Faustus, Mephistopheles, is said to mean “not-(me-)Faustus-(phisto-)love (pheles),” O-phelia suggests O-love, or Nothingness-love, love of emptiness, openness, humility, endless possibility. [...]" (Paul Adrian Fried).
NOTE:
- ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA, E #COSMOLOGIA: L’#ALLEANZA DI FUOCO ("#CHARITAS"), UNA #NEXOLOGIA CHIASMATICA, PIENA DI #GRAZIA ("#CHARIS", "gr. #XAPIS"). LA #STELLA DEL #CIELO CHE ILLUMINA LA #TERRA. DA #ORSANMICHELE ("L’ORTO DI SAN MICHELE ARCANGELO"-) ALLA "SACRA FAMIGLIA" DI MICHELANGELO BUONARROTI.
- "SÀPERE AUDE" (#ORAZIO - #KANT) E #PSICOANALISI. A partire da "me" con "me" (da "sé" con "sé"), per una #antropologia (al di là della "gioviale" #logica androcentrica, platonico-paolina e costantiniana) e per una chiasmatica e solare #nexologia (con un #nesso liberato dalla "x" dell’incognita del non-sapere, un "#nexus" chiaro, con il gr. "X", "Chi"), forse, non è meglio che in #cielo ci sia solo il #Sole, e si esca dalla #caverna dell’#egocentrismo e dal #geocentrismo tolemaico? Con un #inno alla freudiana "#Freude", senza "freudolenza"?!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- QUALE "NESSO" TRA IL MITO E LA STORIA DELL’EUROPA? INCARNAZIONE (#MENSCHWERDUNG), ANTROPOLOGIA, E #FILOLOGIA.3 giugno 2024, di Federico La Sala
QUALE "NESSO"* TRA IL MITO E LA STORIA DELL’EUROPA? UNA IPOTESI DI CHIARIMENTO A MARGINE DEI "SOGNI DI UN VISIONARIO CHARITI CON I SOGNI DELLA METAFISICA".
- Tracce per una svolta antropologica. A onore e in memoria di Immanuel Kant...
DEL #PIANETATERRA E DEL SUO BRILLANTECOLORE: IL #CORPOMISTICO DELL’#ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO DI PLATONE E COSTANTINO (#NICEA 325-2025) BLOCCA DA MILLENNI LA #NAVIGAZIONE NELL’#OCEANOCELESTE (#KEPLERO, 1611) DEL #GALILEO #GALILEI "CHE HA VINTO" SIA SUL PIANO CELESTE SIA SUL PIANO TERRESTRE E, ancora oggi (#2giugno2024) RENDE DIFFICILE CAPIRE UN’ #ACCA E PORTARSI FUORI DALL’ORIZZONTE DI #MAMMONA ("CARITAS").
"COME NASCONO I BAMBINI": INCARNAZIONE (#MENSCHWERDUNG), ANTROPOLOGIA, E #FILOLOGIA. Riprendendo il filo della "#Charitas" di #GioacchinodaFiore e #DanteAlighieri, forse, è meglio uscire dal "letargo" (Par. XXXIII, 94), e con il #Boehme della "De incarnatione Verbi" riflettere sulla "Charis" (gr. #Xapis") e sul Cristogramma.
NOTA: IL "TRATTATO" DEL "MASTRILLO" (#MAASTRICT), E LA "DIRITTA VIA" (DANTE ALIGHIERI). L’amicizia e l’amore della parola sono decisivi e fondamentali: senza filologia non si va da nessuna parte e non si comprende più il #nesso tra il #prima e il #dopo, si dimentica che "in #principio era il #Logos", e tutti gli erculei esseri umana finiscono per indossare le camicie con il "logo" di #NESSunO.
- STORIA E MEMORIA D’#EUROPA: MAASTRICHT. "[...]All’origine della città vi fu la costruzione di una fortificazione romana (castellum) nel 333 d.C. San Servazio, vescovo di Tongeren e Maastricht, morì nel 384 e fu tumulato in Maastricht. Accanto a lui c’è il sepolcro dell’ultimo re carolingio, Carlo I, duca della bassa Lorena (Lotaringia). Successivamente, verso la metà del VI secolo, la sede di diocesi di Tongres fu trasferita a Maastricht. Agli inizi dell’VIII secolo, Uberto di Liegi spostò la sede a Liegi, la città dove aveva subito il martirio il suo predecessore, San Lamberto di Maastricht.
 Durante il Medioevo Maastricht era già una città importante nei Paesi Bassi, governata in condominio dai Duchi di Brabante e dai Principi-vescovi di Liegi in quella che veniva chiamata Doppia Signoria di Maastricht. Il 29 giugno 1579 la città di Maastricht fu conquistata da Alessandro Farnese, al servizio della Spagna. Circa cinquant’anni più tardi, nel 1632, in seguito a nuovo assedio, la città passò sotto il controllo della Repubblica delle Sette Province Unite. Nel 1673 la città fu occupata dalle armate di Luigi XIV di Francia, venendo poi restituita agli olandesi con il Trattato di Nimega del 1678. Durante l’assedio di Maastricht, Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, comandante della compagnia di Moschettieri della Guardia chiamati "Moschettieri grigi", morì a Maastricht. [...]".
Durante il Medioevo Maastricht era già una città importante nei Paesi Bassi, governata in condominio dai Duchi di Brabante e dai Principi-vescovi di Liegi in quella che veniva chiamata Doppia Signoria di Maastricht. Il 29 giugno 1579 la città di Maastricht fu conquistata da Alessandro Farnese, al servizio della Spagna. Circa cinquant’anni più tardi, nel 1632, in seguito a nuovo assedio, la città passò sotto il controllo della Repubblica delle Sette Province Unite. Nel 1673 la città fu occupata dalle armate di Luigi XIV di Francia, venendo poi restituita agli olandesi con il Trattato di Nimega del 1678. Durante l’assedio di Maastricht, Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, comandante della compagnia di Moschettieri della Guardia chiamati "Moschettieri grigi", morì a Maastricht. [...]".
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ANTROPOLOGIA E STORIOGRAFIA: LA FESTA DELLA MAMMA, LA STORIA DELL’EUROPA, E IL "SAPERE AUDE!" (DI ORAZIO E DI KANT).12 maggio 2024, di Federico La Sala
LA FESTA DELLA MAMMA, LA STORIA DELL’EUROPA, E IL "SAPERE AUDE!" (DI ORAZIO E DI KANT).
- UN OMAGGIO ALLA "NOTRE-DAME DE PARIS" (A M_ARIANNA E A MARIA-BEATRICE, LA MADRE DI DANTE ALIGHIERI).
ANTROPOLOGIA, #LETTERATURA, E #STORIOGRAFIA: UNA INDICAZIONE DI JOHAN #HUIZINGA E UNA SOLLECITAZIONE A RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DAL 144O (#LORENZOVALLA), DAL 148O ("MARTIRI DI #OTRANTO") E DAL "6 GENNAIO 1482" (CHE "NON E’ PERO’ UN GIORNO CHE LA STORIA RICORDI ": #VICTOR #HUGO, "NOTRE-DAME DE PARIS").
J. HUIZINGA: "XVIII. L’ARTE NELLA VITA. La civiltà franco-borgognone del tardo Medioevo è generalmente nota oggigiorno per la sua arte, specialmente per la sua pittura. I fratelli Van Eyck, Ruggero van der Weyden e il Memlinc [Memling], insieme allo scultore Sluter, dominano nell’idea generale che noi ci facciamo di quell’epoca. Ma non fu sempre così. Cinquanta e più anni or sono , quando si scriveva ancora Hemlinc invece di Memlinc, il profano colto conosceva quell’epoca attraverso la storia [...] dall’Histoire des ducs de Bourgogne del De Barante, che si fondava su di essi. E forse per i più non era De Barante, bensì Victor Hugo a fornire, col suo Notre Dame de Paris, l’immagine di quei tempi." (J. Huizinga, "L’autunno del Medioevo", Introduzione di Eugenio Garin, Sansoni editore, I ed., Firenze 1940).
- Nota. Sul tema, mi sia lecito, si cfr. gli appunti su "DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica".
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, TEOLOGIA - POLITICA, E FILOLOGIA. Note a margine del tema "Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente" ("Dialoghi di Pistoia", XV Edizione).-9 maggio 2024, di Federico La Sala
STORIA, FILOLOGIA, E FILOSOFIA: L’ OPERA INCOMPIUTA DELL’EUROPA E IL PERDURARE DEL "SONNO DOGMATICO"
- DALLA #VENOSA DI #ORAZIO ("#SàPERE #AUDE") E DI #ROBERTO IL #GUISCARDO ("TERROR MUNDI"), ALLA #JESI DELLO "#STUPORMUNDI" (FEDERICO II DI SVEVIA), E ALLA #KOENIGSBERG DI #KANT ("LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI #GIUDIZIO", 1790), ALLA #KALININGRAD DELLA RUSSIA DI OGGI (2024).
Un piccolo invito "filologico" a riaprire la riflessione sulla domanda kantiana del "che cosa posso sapere?" e, possibilmente, cercare, mangiando sano e con gusto, di riprendere il cammino nell’#oceanoceleste (#Keplero, 1611)
- Una nota in memoria di Dante Alighieri, William Shakespeare, Immanuel Kant ...
SALUTE E SAPERE. L’aver dimenticato la lezione di Orazio ("Chi bene incomincia è già a metà dell’opera; risolviti a diventare saggio: incomincia [dimidium facti, qui coepit, habet: sàpere aude, incipe]") dice di una cosa terribile non solo a ogni persona e a ogni cittadino e a ogni cittadina della luminosa e solare Venosa (Basilicata, Potenza), ma dell’intera Europa (e del Pianeta Terra)!
ANTROPOLOGIA E PEDAGOGIA. "L’UOMO E’ CIO’ CHE MANGIA" (FEUERBACH), A TUTTI I LIVELLI. Materialmente e spiritualmente, è un cosiddetto segreto di "Pulcinella. Il filosofo che fu chiamato pazzo" (Romeo De Maio, 1989), non si sa più nemmeno mangiare e, cosa ancora più grave, non sapendo nemmeno più assaporare e "as-saggiare", si ignora che cosa mangia e "che cosa" sia (diventato) il cosiddetto "uomo", antropologicamente!
COSTITUZIONE, "RAPPORTO SOCIALE DI #PRODUZIONE", E CIBO. Non solo a Casa, ma nelle Scuole e nelle Università e nelle Accademie (atee e devote), cosa insegnano, cosa danno da "mangiare": "Prendete e mangiate", ma che cosa?! Non è il caso di suonare le campane a martello, uscire dal letargo, e decidersi a riprendere lo studio della filologia e della letteratura e della #storia e della filosofia e ad affrontare i lavori dell’Incompiuta, del "Complesso della Santissima Trinità"?!
- Note:
- ANTROPOLOGIA, STORIA, LETTERATURA, E FILOSOFIA: "PULCINELLA. IL FILOSOFO CHE FU CHIAMATO PAZZO" (ROMEO DE MAIO, 1989).
- ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (KANT), TEOLOGIA - POLITICA ("#CORPOMISTICO), E FILOLOGIA ( "#EUCHARISTIA"). PROGRAMMA Dialoghi di Pistoia, XV EDIZIONE (24-25-26 maggio 2024): "Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente".
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- RIPARTIRE DALL’INNO ALLA GIOIA ("FRUDE"): ΧΑΡΜΟΛΥΠΗ. Χαρμολυπη (kharmolúpē): χαρμολύπη (χάρμ(α) -ο- + λύπη]) - χάρμ(α) (chárm(a), “joy”).3 maggio 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA ETIMOLOGIA ANTROPOLOGIA FILOSOFIA, TEOLOGIA, ARTE, POESIA E #MUSICA.
Inno alla Gioia...
- ΧΑΡΜΟΛΥΠΗ, Χαρμολυπη (kharmolúpē): χαρμολύπη (χάρμ(α) -ο- + λύπη]). From χάρμ(α) (chárm(a), “#joy”)....
- XAPITAS - #CHARITAS - #CHARITY, #CHARITE’, #CHARIDAD... JOY, FREUDE, GIOIA.
NOTE:
- STORIA E MEMORIA D’EUROPA: INNO ALLA #GIOIA (FREUDE). "Flashmob di giovani a Vienna per i 200 anni dell’Inno alla gioia, Austria Vicina, 2 MAGGIO 2024: "[...] Benché il committente fosse la Società Filarmonica di Londra, la prima esecuzione ebbe luogo a Vienna, nel Theater am Kärntnertor, che si trovava all’inizio della Kärntner Strasse, dove oggi c’è l’hotel Sacher. Beethoven, ormai sordo, assistette al conserto. Si dice che al termine il contralto Caroline Unger si fosse avvicinata al compositore e lo avesse fatto voltare perché vedesse ciò che non riusciva a udire: l’ovazione del pubblico che lo applaudiva in piedi. Era la sera del #7maggio 1824. [...]".
- FILOLOGIA, #PSICOANALISI (S. FREUD), POESIA (F. SCHILLER) E MUSICA (L. v. BEETHOVEN): "INNO ALLA #GIOIA" ("FREUDE). Ripensando al lavoro ("L’uomo #Mosè e la religione monoteistica", 1938)", una vera e propria "#sinfonia londinese" di "#Sigismondo di #Vindobona" (#ItaloCalvino), un omaggio a #VIENNA (e all’Austria Vicina e a Marco Di Blas): "[...] Benché il committente fosse la Società Filarmonica di Londra, la prima esecuzione ebbe luogo a Vienna, nel Theater am Kärntnertor, che si trovava all’inizio della Kärntner Strasse, dove oggi c’è l’hotel Sacher." (Austria Vicina, 2maggio 2024).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- L’INNO ALLA GIOIA ("AN DIE FREUDE") E LA FILOLOGIA: SCHILLER, KANT, BEETHOVEN, FREUD, E ... LACAN2 maggio 2024, di Federico La Sala
L’INNO ALLA GIOIA ("AN DIE FREUDE") E LA FILOLOGIA: KANT, SCHILLER, BEETHOVEN, FREUD ... E LACAN.
- UE - EUROPA. L’inno europeo:
- "La melodia utilizzata per rappresentare l’UE è tratta dalla Nona sinfonia, composta nel 1823 da Ludwig van Beethoven, che ha messo in musica l’"Inno alla gioia", scritto da Friedrich von Schiller nel 1785.
- L’inno simbolizza non solo l’#Unioneeuropea, ma anche l’Europa in generale. L’Inno alla gioia esprime la visione idealistica di Schiller sullo sviluppo di un legame di fratellanza fra gli uomini, visione condivisa da Beethoven.
- Nel 1972 il Consiglio d’Europa ha adottato il tema dell’Inno alla gioia di Beethoven come proprio inno. Nel 1985 è stato adottato dai capi di Stato e di governo dei paesi membri come inno ufficiale dell’Unione europea. L’inno è privo di testo ed è costituito solo dalla musica. Nel linguaggio universale della musica, questo inno esprime gli ideali di libertà, pace e solidarietà perseguiti dall’Europa.
LA CULTURA EUROPEA, SIGMUND #FREUD, E L’INNO ALLA #GIOIA (F. #Schiller, "An die #Freude", 1785).
NEL "NOME DI FREUD", LA "PSICOANALISI" DEL «JOYOSO» JACQUES LACAN. Due brevi note a margine della seguente "dichiarazione":
- “I wish to begin by saying what, while appearing under Freud’s name, extends beyond the time of his appearance and conceals its truth even in its very unveiling - that Freud’s name signifies «joy»” (Jacques Lacan, «An address: Freud in the century», 1956).
MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA. A CHE GIOCO GIOCHIAMO?!
- "GIOIOSAMENTE, GIOCOSAMENTE: «FREUD ... E»
- Freud - letto in italiano come si scrive è quasi «fred-do»
- Freud - pronunciato in tedesco dà «Froid», che in-francesce-tradotto-in-italiano è ancora «freddo»
- Freud - più una «e» in tedesco equivale alla nostra «gioia»
- Freud - più la «e», pronunciata in tedesco su suolo italico dà «fro(i)de»
- (cit. da una mia relazione intitolata, "Cosa nasconde Freud a Freud? Cosa nascondiamo noi a noi stessi? Note da/per un seminario interdisciplinare sulla "Interpretazione dei sogni", all’ Università di Salerno, Sede di Via Irno - 30. 03. 1976).
FREUD O LACAN? "SÀPERE AUDE" (ORAZIO - KANT). Nella ricorrenza del XXI Congresso Nazionale della Societa’ Psicoanalitica italiana, RICORDANDO ELVIO FACHINELLI (con le parole di Francesco Marchioro: "Spirito curioso, ironico, indipendente e analista non ortodosso denuncia con forza una sorta di «freudolente» uso della terapia e accusa la sua stessa istituzione di praticare una “psicoanalisi della risposta”, nel senso che si limita a «dare ragione all’esistente, razionalizzare le irrazionalità, tamponare i conflitti», offrire una terapia dell’adattamento invece di essere una psicoanalisi interrogante, capace di sollevare domande radicali sullo statuto del soggetto e la sua relazione alla Lebenswelt, al mondo della vita.": Altoadige.it, 22.12.2019), non è il caso di svegliarsi dal sonno dogmatico e riprendere il filo da Kant (1724-2024), dalla interpretazione dei "sogni di un visionario" (1766), e riprendere coraggiosamente a "servirsi della propria intelligenza ("1784), e, insieme, far un so critico della propria facoltà di giudizio, come ha fatto e sollecitato a fare in prima persona Michel Foucault nel 1984?
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! ---ARTE E STORIA (j. HUIZINGA). "IL POLITTICO DELL’AGNELLO MISTICO": UN MANIFESTO DELLA TEOLOGIA-POLITICA DEL CATTOLICESIMO EUROPEO (NICEA 325-2025)..21 aprile 2024, di Federico La Sala
ARTE E STORIOGRAFIA: "IL POLITTICO DELL’AGNELLO MISTICO", UN MANIFESTO DELLA TEOLOGIA-POLITICA DEL CATTOLICESIMO EUROPEO.
- Una nota in memoria di Johan Huizinga
"Il Polittico dell’Agnello Mistico, o Polittico di #Gand, è un’opera monumentale di Jan van Eyck (e del misterioso Hubert van Eyck), dipinta tra il 1426 e il 1432 per la cattedrale di San Bavone a Gand, dove si trova tutt’oggi. Si tratta di un polittico apribile composto da dodici pannelli di legno di quercia, otto dei quali sono dipinti anche sul lato posteriore, in maniera da essere visibili quando il polittico è chiuso. La tecnica usata è la pittura a olio e le misure totali sono 375x258 cm da aperto. [...]" (https://it.wikipedia.org/wiki/Polittico_dell%27Agnello_Mistico ):
- "It’s easy to argue that the artwork is the most influential painting ever made: it was the world’s first major oil painting, and is laced with Catholic mysticism. It’s almost an A to Z of Christianity - from the annunciation to the symbolic sacrifice of Christ, with the «mystic lamb» on an altar in a heavenly field, bleeding into the holy grail." (cfr. Noah Charney,"The Ghent Altarpiece: the truth about the most stolen artwork of all time", The Guardian, 20.12. 2013).
Per una contestualizzazione di questo straordinario "testo", forse, è proprio necessario ri-#leggere il lavoro di Johan #Huizinga, "L’autunno del Medioevo" (Sansoni Editore, I ed. it. 1940): "Il desiderio di conoscere - egli scrive nella "Prefazione alla prima edizione dell’opera" del 1919 - un po’ meglio l’arte dei van Eyck e dei loro successori, in stretto rapporto colla vita di quel tempo, m’indusse a scrivere questo libro". Su quanto sia importante il risultato di tale sforzo, è bene ricordare gli anni della metà del Quattrocento con le sue tensioni riformistiche di tipo teologico-politico all’interno della Chiesa e i crescenti attacchi del mondo musulmano: del 1453 è la caduta di #Costantinopoli).
CORPO MISTICO DI #CRISTO. PER COGLIERE IL SENSO SIMBOLICO DEL #SACRIFICIO DELL’«AGNELLO MISTICO», occorre richiamare il tema (e il problema) delle #indulgenze (che darà il via alla #RiformaProtestante), e chiarire, con lo stesso Huizinga, "la dottrina del «thesaurus ecclesiae» o tesoro delle opere superogatorie di Cristo e dei santi. L’idea di tale tesoro, di cui è partecipe ogni credente, come membro del corpo mistico di Cristo, cioè della Chiesa, è molto antica, ma la dottrina che tali buone opere costituiscano una riserva inesauribile, che può essere distribuita dalla Chiesa e più precisamente dal papa, fa la sua comparsa solo nel secolo XIII. [...]. La dottrina si diffuse non senza opposizioni, finché trovò la sua perfetta enunciazione ed illustrazione nella bolla papale «Unigenitus» di Clemente VI nel 1343. In essa il tesoro è considerato come un capitale, che Cristo affidò a S. Pietro e ai suoi discepoli [...]".
NOTE:
- IL POLITTICO DI GAND (nella modalità "chiuso") di Jan van Eyck (e Hubert van Eyck). Storia.
- MEMORIA E STORIA DELL’#EUROPA: IL #CATTOLICESIMO DELL’#AUTUNNO DEL #MEDIOEVO E LA "SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO" ISTITUITA DA PIO XI (1925) NELLA #CHIESACATTOLICA DEL XX SECOLO.
- IL CATTOLICESIMO DI COSTANTINO (NICEA 325), LA "SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO), E L’#EUROPA DEL 2025: QUALE #CHIESA CATTOLICA, QUALE #CRISTIANESIMO? "Nel 325 si tiene il primo Concilio ecumenico nella città di Nicea in Asia Minore. In questa circostanza viene definita la divinità di Cristo contro le eresie di Ario: “Cristo è Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero”. 1600 anni più tardi, nel 1925, Pio XI proclama che il modo migliore per vincere le ingiustizie è il riconoscimento della regalità di Cristo. “Poiché le feste - scrive - hanno una efficacia maggiore di qualsiasi documento del magistero ecclesiastico, esse infatti istruiscono tutti i fedeli e non una sola volta ma annualmente, e raggiungono non solo lo spirito ma i cuori” (Enciclica Quas primas, 11 dicembre 1925). [...]".
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- In un momento storico segnato dal dilagare di conflitti che spingono i popoli verso il baratro di una terza guerra mondiale, la sollecitudine ecumenica vede come occasione propizia l’approssimarsi del 17° centenario del Concilio di Nicea, svoltosi nel 325 dopo Cristo.13 aprile 2024, di Federico La Sala
CONCILIO DI #NICEA (325 -2025), E IL PAPA DELLA CHIESA CATTOLICA, "#PATRIARCA D’#OCCIDENTE" (2024). La possibilità di "celebrare insieme i 17 secoli dal Concilio di Nicea, come per un nuovo inizio". ( https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-torna-a-essere-patriarca-d-occidente):
***
Santa Sede.
Il Papa torna a essere “patriarca d’Occidente”: che cosa vuol dire
di Redazione Catholica (Avvenire, giovedì 11 aprile 2024)
Il Papa torna a essere anche patriarca d’Occidente.
 Lo spiega l’agenzia Fides osservando come il titolo compaia nell’Annuario pontificio del 2024, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Tale definizione era scomparsa nel 2006 su disposizione di Benedetto XVI. Nel comunicato diffuso allora dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei cristiani si chiariva che il titolo di «patriarca d’Occidente» era stato adoperato nell’anno 642 da Papa Teodoro I. In seguito, il suo utilizzo aveva preso piede nel XVI e XVII secolo, «nel quadro del moltiplicarsi dei titoli del Papa» nell’’Annuario Pontificio esso era apparso per la prima volta nel 1863. Il termine “Occidente” - proseguiva il comunicato «non intende descrivere un territorio ecclesiastico né esso può essere adoperato come definizione di un territorio patriarcale». Quindi il titolo «patriarca d’Occidente» - prosegue Fides citando il comunicato del 2006 «descriverebbe la speciale relazione del Vescovo di Roma a quest’ultima, e potrebbe esprimere la giurisdizione particolare del Vescovo di Roma per la Chiesa latina». Tuttavia, la soppressione di tale titolo non sottintendeva “nuove rivendicazioni” papali rispetto alle Chiese d’Oriente, ma era espressione di un “realismo storico e teologico” che spingeva a mettere da parte un titolo considerato obsoleto.
Lo spiega l’agenzia Fides osservando come il titolo compaia nell’Annuario pontificio del 2024, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Tale definizione era scomparsa nel 2006 su disposizione di Benedetto XVI. Nel comunicato diffuso allora dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei cristiani si chiariva che il titolo di «patriarca d’Occidente» era stato adoperato nell’anno 642 da Papa Teodoro I. In seguito, il suo utilizzo aveva preso piede nel XVI e XVII secolo, «nel quadro del moltiplicarsi dei titoli del Papa» nell’’Annuario Pontificio esso era apparso per la prima volta nel 1863. Il termine “Occidente” - proseguiva il comunicato «non intende descrivere un territorio ecclesiastico né esso può essere adoperato come definizione di un territorio patriarcale». Quindi il titolo «patriarca d’Occidente» - prosegue Fides citando il comunicato del 2006 «descriverebbe la speciale relazione del Vescovo di Roma a quest’ultima, e potrebbe esprimere la giurisdizione particolare del Vescovo di Roma per la Chiesa latina». Tuttavia, la soppressione di tale titolo non sottintendeva “nuove rivendicazioni” papali rispetto alle Chiese d’Oriente, ma era espressione di un “realismo storico e teologico” che spingeva a mettere da parte un titolo considerato obsoleto.La scelta di papa Francesco di ripristinare il titolo di patriarca d’Occidente - prosegue ancora Fides - può essere collegata alla sua insistenza sulla importanza della sinodalità, e alla sollecitudine ecumenica che spinge a guardare sempre ai primi secoli del cristianesimo, quando tra le Chiese non c’erano lacerazioni di carattere dogmatico. Il titolo di patriarca d’Occidente richiama in qualche modo anche l’esperienza del Primo Millennio cristiano, quando le cinque sedi della cristianità antica (Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme), pur nella differenza delle rispettive storie e dei diversi accenti spirituali, rivestivano un rilievo particolare per il vincolo che le univa alla Tradizione apostolica. I rapporti di queste cinque sedi, nella comunione, apparivano strutturati nella prassi che gli studi di storia della Chiesa definiscono come “Pentarchia”.
In un momento storico segnato dal dilagare di conflitti che spingono i popoli verso il baratro di una terza guerra mondiale, la sollecitudine ecumenica vede come occasione propizia l’approssimarsi del 17° centenario del Concilio di Nicea, svoltosi nel 325 dopo Cristo. I cristiani - come ha suggerito Papa Francesco già il 6 maggio 2022 - hanno la possibilità di riunirsi e celebrare insieme i 17 secoli dal Concilio di Nicea, come per un nuovo inizio. E nel 2025, tutti i cristiani per coincidenze di calendario, tutti i cristiani celebreranno la Pasqua nello stesso giorno, domenica 20 aprile.
Dunque, nell’Annuario pontificio, i titoli del Papa sono: vicario di Gesù Cristo, successore del principe degli apostoli, Sommo Pontefice della Chiesa universale, patriarca d’Occidente, primate d’Italia, arcivescovo e metropolita della provincia romana, sovrano dello Stato della Città del Vaticano, servo dei servi di Dio.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- #KANT2024. “La legge morale in noi, e il cielo stellato sopra di noi. Kant!!!“ (L. v. Beethoven, "Konversations-Hefte").7 aprile 2024, di Federico La Sala
MUSICA, #FILOSOFIA, E #COSMOLOGIA:
#KANT2024.
"Beethoven nomina Kant due volte nei Konversations-Hefte. Una volta con noncuranza là dove egli commenta la noia delle lezioni universitarie tenute dal filosofo kantiano Johann Gottfried Kiesewetter (1766-1819). Un’altra volta con forte commozione, citando senza commento ma con evidenza anche grafica: “La legge morale in noi, e il cielo stellato sopra di noi. Kant!!!“. [...]" (https://www.lvbeethoven.it/biografia08/ ).
NOTA:
- Nel #cielostellato e nel #cerchiodellavita, l’#animale del #BuonMessaggio è un #Montone, non un #caproespiatorio (#ReneGirard): "in questa #primavera sempiterna/ che notturno #Ariete non dispoglia /perpetualemente ‘Osanna’ sberna"(#DanteAlighieri, Pd. XXVIII, 116-118)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA: LA GENTE DALLA DOPPIA TESTA" (#PARMENIDE), E IL "GLOBO IMPAZZITO" ("DISTRACTED GLOBE"). Un invito a ri-leggere Shakespeare.4 aprile 2024, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, #METATEATRO E #SPIRITO DELL’#EUROPA: L’#HAMLETICA QUESTIONE DEL #MENTITORE ("#SERPENT"), DEL FALSO #RESOCONTO "DELLA GENTE DALLA DOPPIA TESTA" (#PARMENIDE), E IL "GLOBO IMPAZZITO" ("DISTRACTED #GLOBE"). Un invito a ri-leggere #HAMLET (#Shakespeare):
"GHOST [...] Now, Hamlet, hear.
 ’Tis given out that, sleeping in my orchard,
’Tis given out that, sleeping in my orchard,
 A serpent stung me. So the whole ear of Denmark
A serpent stung me. So the whole ear of Denmark
 Is by a forgèd process of my death
Is by a forgèd process of my death
 Rankly abused. But know, thou noble youth,
Rankly abused. But know, thou noble youth,
 The serpent that did sting thy father’s life
The serpent that did sting thy father’s life
 Now wears his crown.
Now wears his crown.
 HAMLET O, my prophetic soul! My uncle!
HAMLET O, my prophetic soul! My uncle!
 GHOST [...] Adieu, adieu, adieu. Remember me. (He exits).
GHOST [...] Adieu, adieu, adieu. Remember me. (He exits).
 HAMLET [...] Remember thee?
HAMLET [...] Remember thee?
 Ay, thou poor ghost, whiles memory holds a seat
Ay, thou poor ghost, whiles memory holds a seat
 In this distracted globe. Remember thee?
In this distracted globe. Remember thee?
 Yea, from the table of my memory
Yea, from the table of my memory
 I’ll wipe away all trivial, fond records,
I’ll wipe away all trivial, fond records,
 All saws of books, all forms, all pressures past,
All saws of books, all forms, all pressures past,
 That youth and observation copied there,
That youth and observation copied there,
 And thy commandment all alone shall live
And thy commandment all alone shall live
 Within the book and volume of my brain,
Within the book and volume of my brain,
 Unmixed with baser matter. Yes, by heaven!
Unmixed with baser matter. Yes, by heaven!
 O most pernicious woman!
O most pernicious woman!
 O villain, villain, smiling, damnèd villain!
O villain, villain, smiling, damnèd villain!
 My tables-meet it is I set it down
My tables-meet it is I set it down
 That one may smile and smile and be a villain.
That one may smile and smile and be a villain.
 At least I am sure it may be so in Denmark.
At least I am sure it may be so in Denmark.
 He writes.
He writes.
 So, uncle, there you are. Now to my word.
So, uncle, there you are. Now to my word.
 It is “adieu, adieu, remember me.”
It is “adieu, adieu, remember me.”
 I have sworn ’t."
I have sworn ’t."
 (W. Shakespeare, Hamlet, I.5).
(W. Shakespeare, Hamlet, I.5)."SPETTRO, [...] E dunque ascolta, Amleto / S’è detto che, mentre dormivo nel mio giardino, / Mi morse un serpente. Così l’orecchio / Dell’intera Danimarca è stato ingannato/ turpemente con un falso resoconto /Della mia morte. Ma tu, nobile giovane, /Sappi che il serpente che morse la vita / Di tuo padre, ora ne indossa la corona.
 AMLETO Oh La mia anima profetica! Mio zio?
AMLETO Oh La mia anima profetica! Mio zio?
 SPETTRO [...] Addio, addio, addio. Ricordati di me!
SPETTRO [...] Addio, addio, addio. Ricordati di me!
 AMLETO [...] Sì, povero spettro, fino a quando / la memoria ha uno spazio in questo glo impazzito / Ricordarmi di te? Ecco, dalla tavola / Della mia memoriascancellerò ogni sciocca / Banale annotazione [...] e il tuo comandamento / Vivrà ds solo nel Libro della mia mente, / Senza essere mischiato a materis più vile. /Sì, per il Cielo. [...] Il mio quaderno... /Conviene mettere per iscritto che uno / Può sorridere, e sorridere, ed essere un criminale / O almeno sono sicuro che può essere così in Danimarca. (scrive) [...]
AMLETO [...] Sì, povero spettro, fino a quando / la memoria ha uno spazio in questo glo impazzito / Ricordarmi di te? Ecco, dalla tavola / Della mia memoriascancellerò ogni sciocca / Banale annotazione [...] e il tuo comandamento / Vivrà ds solo nel Libro della mia mente, / Senza essere mischiato a materis più vile. /Sì, per il Cielo. [...] Il mio quaderno... /Conviene mettere per iscritto che uno / Può sorridere, e sorridere, ed essere un criminale / O almeno sono sicuro che può essere così in Danimarca. (scrive) [...]
 (W. Shakespeare, "Amleto", I.5, trad. Agostino Lombardo, #Feltrinelli).
(W. Shakespeare, "Amleto", I.5, trad. Agostino Lombardo, #Feltrinelli).- NOTA: SE "IL TEMPO E’ FUORI DAI CARDINI" (#Amleto, I. 5), IL #NODO DA SCIOGLIERE (SUL PIANO PERSONALE, POLITICO, E TEOLOGICO) E’ UNA #QUESTION EPOCALITTICA (APOCALITTICA), DI #VITA E DI #MORTE, DI ESSERE E NON-ESSERE...
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- IL CATTOLICESIMO "COSTANTINIANO" (NICEA, 325-2025) E L’INDICAZIONE "ERETICA" DI DANTEALIGHIERI. Alcuni appunti.16 febbraio 2024, di Federico La Sala
STORIA, ANTROPOLOGIA, E STORIOGRAFIA:
LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DELLA FAMIGLIA E IL NEPOTISMO DEL CATTOLICESIMO DELL’ETA’ MODERNA.
- Una nota a margine del lavoro di Maria Antonietta #Visceglia,
- "Le donne dei papi in età moderna. Un altro sguardo sul nepotismo (1492-1655)", Viella Editrice, Roma 2023.
IL CATTOLICESIMO "COSTANTINIANO" (NICEA, 325-2025) E L’INDICAZIONE "ERETICA" DI #DANTEALIGHIERI: PARTENDO DALLA RICERCA SU "Le donne dei papi in età moderna. Un altro sguardo sul nepotismo (1492-1655)" di Maria Antonietta Visceglia (Viella Editrice, Roma 2023), FORSE, SI PUO’ OSSERVARE MEGLIO LA RADICALE SVOLTA "COSTANTINIANA" DELLA VITA DELLO "STATO" DELLA CHIESA CATTOLICA, GIA’ E SUBITO PRIMA DELLA #CADUTA DI #COSTANTINOPOLI (1453) IN MANO TURCA, CON IL SINTOMATICO PASSAGGIO DI NICCOLO’ #CUSANO ( L’AUTORE DIVENTATO CARDINALE, PER I MERITI DELLA POCO EVANGELICA "DOTTA IGNORANZA" DEL 1440 E DELLA "PACE DELLA #FEDE" DEL 1453) DA SOSTENITORE DEL "PARTITO" DELLA SOVRANITA’ DEL #CONCILIO A SOSTENITORE DEL POTERE SUPREMO DEL #PAPA, E, NELLO STESSO TEMPO, CON IL SILENZIAMENTO E LA NEUTRALIZZAZIONE DEL LAVORO CRITICO DI LORENZO VALLA SULLA FALSA "DONAZIONE DI COSTANTINO" (1440).
ALL’INTERNO DI QUESTO ORIZZONTE, MIO PARERE, SI COMPRENDE MEGLIO LA SPECULARE LOTTA DELLO STATO DELLA CHIESA CON LO STATO DELLA SPAGNA (DOPO LA RICONQUISTA DI #GRANADA, 1492) PER L’EGEMONIA TEOLOGICO-POLITICA EUROPEA; E, UNITARIAMENTE, L’INCAPACITA’ AD ACCOGLIERE LA "INAUDITA" ED "ERETICA" INDICAZIONE DELLA "#MONARCHIA" DEI "#DUESOLI" DI DANTE ALIGHIERI E, INFINE, LE SUCCESSIVE SOLLECITAZIONI TEOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE DELLA #RIFORMA PROTESTANTE (1517) PRIMA E DELLA RIFORMA ANGLICANA (1534) POI, ECC.
DANTE ALIGHIERI E MERCURINO ARBORIO DI GATTINARA. Sul tema, è bene ricordare, mi sia lecito, la lezione magistrale di #KarlBrandi che, a conclusione della sua "lettura" della biografia di "Carlo V" (1935), rievoca (con le seguenti testuali parole) la figura del "gran cancelliere Mercurino di Gattinara, il cui ideale imperiale non era stato diverso dal sogno imperiale di Dante; e aveva espresso la fede in un ordinamento del mondo retto dall’Impero e dal Papato, ciascuno nella sua sfera, l’uno e l’altro pienamente e sovranamente responsabili verso l’intera umanità" (Einaudi, Torino 2001); e, ancora, che Ernst H. #Kantorowicz, nel suo lavoro su "I due corpi del re" (1957), intitola e dedica l’intero ultimo capitolo a "La regalità antropocentrica: Dante" (Einaudi, Torino 2012).
P. S. - #MACHIAVELLI CON DANTE ALIGHIERI CONTRO IL #FAMILISMO TEOLOGICO-POLITICO. NICCOLO’ MACHIAVELLI, “DISCORSI SOPRA LA PRIMA DECA DI TITO LIVIO”:
"Della religione de’ Romani. (...) gli regni i quali dipendono solo dalla virtù d’uno uomo, sono poco durabili, perché quella virtù manca con la vita di quello e rade volte accade che la sia rinfrescata con la successione, come prudentemente Dante dice:
- Rade volte discende per li rami
- L’umana probitate; e questo vuole
- Quel che la dà, perché da lui si chiami. [Pg. VII, 121-123]
Non è, adunque, la salute di una republica o d’uno regno avere uno principe che prudentemente governi mentre vive; ma uno che l’ordini in modo, che, morendo ancora, la si mantenga. (...)" (“DISCORSI”, Libro I, cap. XI).
- Nota:
- BIBLIOGRAFIA. SUL TEMA (DANTESCO DEL #GIARDINO) DELL’#IMPERO E LA LOTTA NEL #CINQUECENTO PER "L’ITALIA DEL #PAPA" E PER "L’ITALIA DELL’#IMPERATORE", si cfr. il lavoro di Elena Bonora, "Waiting for the Emperor. Italian Princes, the Pope and Charles V" (Viella Editrice, 2022 ); Elena Bonora, ed. it., "Introduzione" (Einaudi, 2014).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- L’ARCHEOLOGIA E L’ANTROPOLOGICA DI PITTACO DI MITILENE E DI PROTAGORA E LA LOGICA DELLA COSMOTEANDRIA DELL’ OCCIDENTE.5 febbraio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, ARCHEOLOGIA, E #FILOLOGIA (PROTAGORA: "L’UOMO E’ LA #MISURA" ), FILOSOFIA TEOLOGIA E DEMIURGIA (PLATONE: #ZEUS, "IL DIO E’ LA MISURA"), E LA LOGICA DELLA COSMOTEANDRIA DELL’ #OCCIDENTE...
- Una nota a margine di un frammento di Pittaco di Mitilene (Diogene Laerzio, I. 4. 77) uno dei sette sapienti, citati da Platone, proprio nel dialogo dedicato a "Protagora" (per buttarne a mare la lezione antropologica):
- «ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσιν» (Diogene Laerzio, I. 4. 77). "Il principio ("arché") mostra l’uomo (nella sua particolarità, gr. "àndra", di "essere umano maschio", lat. "vir").
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA. Quando la filologia è in #letargo (Par. XXXIII, 94), perso il senso stesso del #principio antropologico e cosmologico di tutte le cose come di tutti gli esseri umani ("arché"), anche la possibilità filosofica di comprendere la semplice massima del sapiente #Pittaco di Mitilene viene meno:
 quando "uno dei due" dei componenti del "genere umano" assume il comando dell’uno e dell’#altro componente, mostra chiaramente la sua parzialità andrologica e androcentrica e, al contempo, permette di comprendere il trucco dell’operazione "zeus_ica" del demiurgo platonico e le radici stesse della teologia-politica costantiniana (Nicea 325) della in-segnatura rinascimenale della "Scuola di Atene" e del "Sapiente" di #Bovillus (1510).
quando "uno dei due" dei componenti del "genere umano" assume il comando dell’uno e dell’#altro componente, mostra chiaramente la sua parzialità andrologica e androcentrica e, al contempo, permette di comprendere il trucco dell’operazione "zeus_ica" del demiurgo platonico e le radici stesse della teologia-politica costantiniana (Nicea 325) della in-segnatura rinascimenale della "Scuola di Atene" e del "Sapiente" di #Bovillus (1510).- Note:
- A)
- DANTE2021 E #KANT2024: ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO. Quando la filologia è in letargo cosmoteandrico di almeno venticinquesecoli ... Meglio riconsiderare l’arché (il principio) e ri-leggere la Commedia e ripartire da #Beatrice, la #donna "#Beata e #Bella", e da #Vir_gilio (Inf. II, 53).
- B)
- ANTROPOLOGIA FILOSOFICA: LEZIONE DI #PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν #ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è #misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
- ANDROLOGIA TEOLOGICA: LEZIONE DI #PAOLINISMO (PAOLO DI TARSO). "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- KANT 2024: UN "INVITO" A PORTARSI FUORI DALLE ANTINOMIE DELLA DIALETTICA DI "SCILLA" E "CARIDDI".29 gennaio 2024, di Federico La Sala
COSMOLOGIA E CIVILTA’ (#KANT2024)*:
- CON #LETIZIA (gr. "XAPA") FILOLOGICA E #CARITÀ ( lat. #CHARITAS, gr.#XAPITAS) ANTROPOLOGICA,
UN "INVITO" A PORTARSI FUORI DALLE ANTINOMIE DELLA DIALETTICA DI #SCILLA E #CARIDDI E RIPRENDERE LA NAVIGAZIONE NELL’#OCEANOCELESTE (#KEPLERO A #GALILEO, 1611).
Charis -sima #EUROPA non è un buon tempo (gr. "#eu-#chronos)" questo per ripensare la #relazione chiasmatica (gr. "X") che lega il #genereumano a sé stesso, alla #Terra e al #Cielo, e rendere #onore alla #Lingua #greca e alle sue parole cariche di #Grazia (gr. #XAPIS)? Se non ora, quando?
- * PER #KANT, UNA "#MEMORIA" DI #FULVIOPAPI (1930-2022): “[...] inutile con Kant ricorrere a modelli storiografici che vogliano sceverare un’autenticità del suo pensiero e un piano ideale di natura operativa o tattica o politica tale che faccia nascere un insieme di questioni marginali, che però non corrispondono alla centrale linea speculativa. Quando, ad esempio, Engels nell’Antischelling sottolinea nella Storia generale della natura l’aspetto cosmologico, vedendone solo l’apporto di natura scientifica procede a una semplificazione che vede unilateralmente solo una faccia della problematica kantiana.
— ***Che dal punto di vista engelsiano questo modo di procedere fosse ovvio e che questa valutazione settorialmente scientifica sia stata fatta altre volte e anche con legittimità in quanto la cosmologia costituisce una zona obiettiva del sapere scientifico, non esclude che traducendo in un modello storiografico questo tipo di semplificazione e di riduzione non sia poi più possibile una ricostruzione della totalità filosofica del pensiero kantiano di questo periodo. - Ciò che interessa vedere è invece come il giovane Kant armonizzi in un discorso filosofico questa doppia esigenza, scientifica e religiosa, e nella delineazione di questo come è il compito di chi si proponga di mostrare la forma originale con cui Kant darà equilibrio speculativo al suo problema” (cfr. Fulvio Papi, "Cosmologia e civiltà. Due momenti del Kant precritco", Argalia Editore, Urbino 1969).
Ripropongo, qui ed ora, alcune "vecchie" note sul tema: "Ripensare l’Europa".
- Nota:
- STORIA FILOSOFIA E MEMORIA. Fulvio Papi, l’ultima voce della «scuola di Milano» (Fabio Minazzi).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- LINGUISTICA STORIOGRAFIA E ANTROPOLOGIA. Una domanda: Chi (gr. X) sono le cosiddette "Cariti".29 gennaio 2024, di Federico La Sala
LINGUISTICA STORIOGRAFIA E PSICOANALISI:
- UN "LAPSUS" DI LUNGA DURATA E UNA FILOLOGIA AL SERVIZIO DEL #LATINORUM.
RIFLETTENDO sul #nodo etimologico di #cuore e #cardine (in connessione con l’ #hamlet-ico tempo di #Shakespeare, "fuori dai cardini"), la memoria ha richiamato l’attenzione su una #immagine (qui, v. allegato) che continua a "#parlare" di un problematico #letargo di secoli (quantomeno a partire da #LorenzoValla, 1440), di uno strano "lapsus" storico e storiografico sul tema dell’#Amore per eccellenza: la #Carità, la #Charitas (gr. "#Xapitas"), e sulla famosa e falsa "donazione di Costantino".
IN PRINCIPIO ERA IL #LOGOS: CHARITAS (AMORE). Questa parola-chiave, la "password" del "regno dei cieli", è diventata nel tempo la Carità - #elemosina, la #Caritas (fatta derivare dal lat. "carus", "caro") e così, persa la "h" (l’#acca), anche in lingua greca (v. allegato) è diventata (addirittura) "#Kapitas" ( "Karitas").
"RIPENSARE #COSTANTINO"? NO! #DANTE2021? NO! RICORDARE L’ANNIVERSARIO DI #NICEA 325, 2025!
 OVVIAMENTE, così permanendo e stando le cose in tutte le Università e le Accademie del #PianetaTerra (con la loro forte segnatura culturale di epoca "rinascimentale"), il "sonno dogmatico" continua a tutti i livelli, sul piano non solo etimologico, ma filologico, antropologico, teologico e politico.
OVVIAMENTE, così permanendo e stando le cose in tutte le Università e le Accademie del #PianetaTerra (con la loro forte segnatura culturale di epoca "rinascimentale"), il "sonno dogmatico" continua a tutti i livelli, sul piano non solo etimologico, ma filologico, antropologico, teologico e politico.- P. S. - Per meglio capire la questione del disagio "filologico" della civiltà, forse, è bene riflettere sulle parole e al contempo sulle persone: Chi (gr. X) sono le cosiddette "Cariti": sono le "dame della Carità / Elemosina", o, al contrario, sono l’altrà metà del "genere umano", il cuore e il cardine della stessa vita sul Pianeta Terra?.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- METATEATRO E STORIOGRAFIA: SHAKESPEARE, CON IL ’MULINO’ DI "#AMLETO" (1602), SOLLECITA A PORTARSI OLTRE LA TRAGICA COSMOTEANDRIA CATTOLICA E PROTESTANTE.24 gennaio 2024, di Federico La Sala
L’EUROPA NEL "TEMPO FUORI DAI CARDINI":
- TEATRO, METATEATRO, E STORIOGRAFIA "IMPERIALISTICA".
SHAKESPEARE, CON IL ’MULINO’ DI "AMLETO" (1602), SOLLECITA A PORTARSI OLTRE "SCILLA E CARIDDI", OLTRE LA COSMOTEANDRIA CATTOLICA E PROTESTANTE.
- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E STORIA.
UN’IPOTESI DI LAVORO PER USCIRE DAL #LETARGO (DANTE ALIGHIERI, PAR. XXXIII, 94) E PER MEGLIO RIFLETTERE SULLA QUESTIONE TEOLOGICO-POLITICA (ENRICO VIII, 1534) E ANTROPOLOGICA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’EUROPA DEL SEICENTO (MA ANCORA IN PIEDI, SI PENSI A NICEA 2025) SEGNATA DAL CONFLITTO POLITICO-RELIGIOSO TRA SPAGNA E INGHILTERRA, FORSE, E’ OPPORTUNO NON DIMENTICARE LA LEZIONE DELLA "SORELLA" DELLO STESSO SHAKESPEARE, "JUDITH" (VIRGINIA WOOLF), E TENERE CONTO DELLO SPIRITO DI TERESA D’AVILA CHE SOFFIA FORTISSIMO NEL CAMPO CATTOLICO-SPAGNOLO E DEL "CORPO DI CRISTO" DELLA #REGINA E #PAPESSA, ELISABETTA I D’INGHILTERRA, CHE REGNA NEL CAMPO INGLESE E PROTESTANTE-ANGLICANO.
NOTE:
- ARTE, TRADIZIONE DEI CARMELITANI SCALZI, E QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA): MARIA E GIUSEPPE E TERESA D’AVILA.
- Un "racconto" di Francesco del Cairo (1640-1650, Parma), che dà da pensare: "Il quadro [...] Raffigura la Vergine e san Giuseppe che appaiono a Santa Teresa d’Avila, inginocchiata in preghiera con le mani incrociate sul petto, nell’atto di ricevere dalla Madonna che si sporge verso di lei una catena d’oro. Santa Teresa, vissuta tra 1515 e 1582, ebbe un ruolo primario nella dell’ordine del #CarmeloScalzo. Ella fu anche particolarmente devota a San Giuseppe, sposo di Maria e suo protettore, contribuendo alla diffusione del culto del santo e alla sua rappresentazione nell’arte devozionale. L’episodio raffigura una visione mistica che Teresa aveva avuto il 15 agosto 1561, giorno dell’#Assunzione, in cui la #Madonna e #Giuseppe comparivano insieme ponendole sulle spalle un manto bianco sfolgorante e al collo un ornamento d’oro con appesa una croce, segno dell’approvazione divina al suo progetto di fondazione di un monastero. [...] ".
- POLITICA, RELIGIONE, E STORIOGRAFIA. EUROPA,1534: UNA "STRANA" COINCIDENZA.
- Mentre a Londra, il re Enrico VIII, con l’Atto di Supremazia del 1534, si dichiara "Capo Supremo in terra della Chiesa d’Inghilterra" e apre la via alla Riforma Anglicana (e al trono ad Elibasetta, nata il 1533), nel Regno di Napoli, Vicereame spagnolo, il giureconsulto Giovanni Antonio #Pepi, sulle orme di #Cicerone (e del suo "De officiis") detto "#Piperone", dà alle stampe il "De Omni Vero Officio", traccia la linea di un programma teologico-politico per l’impero cattolico-spagnolo (cfr. "Piperonis De omni vero officio libri septem. Omnibus aeque ac aer ad vitam quo sine spirat nemo ad bene beateque viuendum necessarii. Authoris iniussu quisquam ne imprimito neue uspiam uendito").
- MEMORIA E #STORIA: #CARMELITANI SCALZI NEL #REGNO DI NAPOLI, VICEREAME SPAGNOLO. Dopo il #terremoto del 1980, ritrovato nella provincia di Salerno, a Contursi Terme, un "file" perduto del tardo #Rinascimento.
- STORIA D’EUROPA.
- Elisabetta I d’Inghilterra:"Elisabetta I Tudor (Greenwich, 7 settembre 1533 - Richmond upon Thames, 24 marzo 1603) è stata regina d’Inghilterra e d’Irlanda dal 17 novembre 1558 fino al 24 marzo 1603, giorno della sua morte [...]".
- METATEATRO E STORIOGRAFIA: SHAKESPEARE. La questione di #Amleto, come già quella del "giocastolaio" #Edipo, re di #Tebe, investe ogni #relazione (a tutti i livelli, dal più basso al più alto - da ogni "Adamo" e ogni "Eva" fino a "Dio" e al "corpo di "Cristo-Re"). Per #Shakespeare, non è solo un "gioco" (letterario) di interpretazione delle #sacre scritture, ma decisamente (e storicamente) una #question di "essere, o non essere": alle spalle, e nel suo presente, egli, con tutta la società inglese, e con la sua #Regina e #Papessa, ha ben #memoria dell’attacco della #Invincibile Armata (1588).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ENCLOSURES MATERIALI E IMMATERIALI DELL’UMANITÀ E DISAGIO DELLA CIVILTÀ: "A CHE GIOCO GIOCHIAMO", ANCORA?!15 gennaio 2024, di Federico La Sala
ENCLOSURES MATERIALI E IMMATERIALI DELL’UMANITÀ E DISAGIO DELLA CIVILTÀ: "A CHE GIOCO GIOCHIAMO", ANCORA?!
- KANT2024: NOTE PER UN CAMBIO DI #PARADIGMA ANTROPOLOGICO
STORIA, #CULTURA, #PSICOANALISI E #SOCIETÀ: ALCUNI APPUNTI A MARGINE DEL CONGRESSO MONDIALE DI #FILOSOFIA #ROMA2024 (#WCP2024 - XXV World Congress of #Philosophy).
RECINZIONI. Dopo la "storica" presa di coscienza di #Rousseau e di #Freud, del primo, sul piano della #critica dell’economia-politica, relativamente al problema delle "enclosures" (recinzioni) materiali della tradizione dei rapporti sociali fondati sulla #disuguaglianza
- ("Il primo che, recintato un terreno, ebbe l’idea di dire: Questo è mio, e trovò persone così ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, guerre, assassini, quante miserie ed orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i paletti o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi enclosuressimili: Guardatevi dall’ascoltare quest’impostore; siete perduti, se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno.");
e, del secondo, cioè di #SIGMUNDFREUD Freud, relativamente alle complementari recinzioni spirituali dell’ #androcentrismo edipico (platonico, paolino, ed hegelo-marxista e lacaniano):
- "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’#amore #universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema #intolleranza della #Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori; i Romani, che non avevano fondato la loro collettività statale sull’amore, non conobbero l’intolleranza religiosa",
 non è il caso di togliere i fiori dalle catene e uscire dalla #caverna? Se non ora, quando?!
non è il caso di togliere i fiori dalle catene e uscire dalla #caverna? Se non ora, quando?!- NOTA:
STORIA E LETTERATURA: PER ORIENTARSI SUL "PROBLEMA ROUSSEAU", RICORDARE ALESSANDRO MANZONI. Per lo spirito illuministico-cristiano (non cattolico-paolino) del figlio di Giulia Beccaria, pur se con cedimenti teologico-politici, all’immaginario napoleonico-costantiniano, da #SacroRomanoImpero ("Il #cinquemaggio"), vale il #principio che
- «I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi» ( "I Promessi Sposi", II).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- L’AMORE COSMOGONICO DI DANTE ALIGHIERI, LA GUERRA DI TROIA, E L’ALLARME "MATEMATICO" DI FRANCA ONGARO BASAGLIA.10 gennaio 2024, di Federico La Sala
MITO, ANTROPOLOGIA, STORIA, LETTERATURA, E STORIOGRAFIA: IL POMO DELLA DISCORDIA...
LA TERRA, L’AMORE COSMOGONICO DI DANTE ALIGHIERI, IL "CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI" DI ITALO CALVINO, E LA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO" DEI "DUE SOLI".
- RITORNO AL FUTURO, 11. IN MEMORIA DI OVIDIO E DI VIRGILIO...
- Una nota a margine di una riflessione su "LA TERRA SPOSATA O LE DISAVVENTURE DI EROS", proposta dal prof. Flavio Piero Cuniberto.
UNA QUESTIONE "COSMICOMICA", A QUANTO PARE, SEGNATA DALLA "#PAURA" (E DALLA CONSEGUENTE "CADUTA" in una "SELVA OSCURA", in uno"stato di minorità" ) E’ DIVENTATA "BIBLICAMENTE" COSMOTRAGICA: ""Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto" (Gn "3, 8").
Probabilmente, aveva ragione #GiordanoBruno nell’avanzare la teoria che si trattava di un tempo "fuori dai cardini", che era un problema di ordine cosmico, di riforma cosmologica ("Lo spaccio della bestia trionfante") e dopo, al contempo, #Lessing, nel porre all’ordine del giorno la questione di #educazione del genere umano.
Kant, da parte sua, riprendendo il discorso e riannodando insieme il "cielo stellato" e la "legge morale", dice che è soprattutto una questione di maturità, e a chi non vuole sentire ragioni, risponde con determinazione, con e come #Orazio: "#sàpere aude!" (risolviti ad assaggiare"), esci dal tuo personale "stato di minorità", e fà un buon uso della tua propria facoltà di giudizio, senza avere di nuovo e ancora paura: "Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Ecco ciò che è tuo!".(Mt. 24-25).
FORSE "LA TAVERNA DEI DESTINI INCROCIATI" (CALVINO) E I "DUE SERPENTI" DEL #CADUCEO (DI ERMES/MERCURIO), con i DUE SOLI di Dante Alighieri, ripensati con "IL #MULINO DI AMLETO" (di Giorgio Diaz de Santillana e Hertha von Dechend), e, non ultimo, con lo stesso "AMLETO" (di William #Shakespeare), possono aiutare a focalizzare meglio l’orizzonte spazio-temporale cosmico e le "regole del gioco" entro cui si danno "le disavventure di Eros".
DA considerare e non dimenticare che la memoria di #Demetra -#Cerere (Eleusi) è più viva che mai (se pure in gran pericolo) e che le sue "disavventure" sono iniziate proprio da un intervento voluto da #Afrodite-#Venere e da #Eros - #Cupìdo che, come ha ben visto Dante, ha un suo orrizzonte cosmicomico: "è l’amore che muove il sole e le altre stelle".
NOTA
- ARCHEOLOGIA ICONOGRAFIA E FILOLOGIA: IL POMO DELLA DISCORDIA. Nel "Giudizio di Paride" (https://it.wikipedia.org/wiki/Giudizio_di_Paride ), nella rappresentazione fattane nellla società etrusca e ritrovata in una tomba a Cerveteri, all’interno della sequenza in cui "Paride riceve Hermes che guida Atena, Era e Afrodite, 560-550 AC."), degna di particolare attenzione è l’immagine dell’asta in mano ad Hermes con al vertice un toro (allusione al "vitello d’oro"?) e la figura di Afrodite, con in mano un ramo di pianta di melograno (che "disegna" con molta approssimazione la figura della "Menorah", il candelabro con sette bracci della tradizione religiosa ebraica).
#Eleusis2023 #Buon2024...
ALL’ORIGINE DELLA "GUERRA DI TROIA", LA STESSA "STORIA" DEL "GIOCASTOLAIO" EDIPO:
- PARIDE. Figlio di Priamo e di Ecuba, detto anche Alessandro.
- La sua nascita fu accompagnata da un prodigio: la madre sognò, prima di metterlo al mondo, di dare alla luce una torcia. Esaco, altro figlio di Priamo, interpretando il sogno, predisse che il nascituro avrebbe causato la rovina di Troia e consigliò di metterlo a morte. Fu invece esposto sul monte Ida e poté sopravvivere, a seconda delle tradizioni, o perché raccolto dai pastori, o perché nutrito da un’orsa e poi ritrovato da Agelao.
- Divenuto grande, accadde che un servo di Priamo fosse incaricato di portar via un toro dal branco custodito dallo stesso P., da assegnare come premio al vincitore dei giochi indetti per onorare la memoria del figlio ormai creduto morto. P. seguì il servo, partecipò ai giochi e vinse, riottenendo, dopo il riconoscimento, il posto che gli competeva nella casa del padre. Avvenne poi che durante le nozze di Tetide e Peleo, mentre tutti gli dei erano riuniti in assemblea, Eride, la dea della discordia, lanciò un pomo destinato alla più bella tra Atena, Era e Afrodite.
- Zeus si rifiutò di decidere e incaricò Ermete di condurre le tre dee sul monte Ida, eleggendo ad arbitro della contesa P. che aggiudicò il pomo ad Afrodite, che gli aveva promesso di fargli sposare la donna più bella del mondo, suscitando così contro i Troiani l’odio di Era e di Atena, che gli avevano promesso rispettivamente potenza e sapienza.
- Successivamente P. fu ospite a Sparta (o secondo altri ad Argo) di Menelao, al quale rapì, con l’aiuto di Afrodite, la consorte Elena, provocando così la spedizione contro Troia, decisa dai due Atridi per vendicare l’oltraggio subito da Menelao.[...]" (Cfr. Antonio Martina, "Paride", Enciclopedia Dantesca, Treccani)
MATEMATICA, ANTROPOLOGIA, E ARCHEOLOGIA FILOLOGICA E FILOSOFICA: 1+1=1.....
- RITORNO AL FUTURO, 12. IN MEMORIA DI GIAMBATTISTA VICO, DI JEAN-JACQUES ROUSSEAU, E DI ENZO PACI...
DA UNA ENCICLOPEDICA "VOCE " DI "DONNA": "[...] Un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, 1979),
UNA #HAMLET-ICA #DOMANDA. CHI HA SCRITTO il "#Discorso sull’origine e i fondamenti dell’#ineguaglianza tra gli uomini" ("Discours sur l’origine et les fondements de l’#inégalité parmi les hommes")?
NON è il "caso" di ripensare il "Problema Jean-Jacques #Rousseau" e interrogarsi di nuovo e ancora su "#comenasconoibambini" (come da sollecitazione di un protagonista della "#ScuoladiMilano", #EnzoPaci, che ben conosceva l’opera del napoletano #GiambattistaVico) e dare il via a una "#ScienzaNuova"?
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- PER L’ EPIFANIA 2025 : ALCUNE NOTE SULLA "STORIA NOTTURNA" DELLA TRAGICA FIGURA DEL "GIOCASTOLAIO" (EDIPO) DEI MAGI.7 gennaio 2024, di Federico La Sala
PER L’ EPIFANIA 2025 : ALCUNE NOTE SULLA "STORIA NOTTURNA" DELLA TRAGICA FIGURA DEL "GIOCASTOLAIO" (EDIPO) DEI MAGI.
- In ricordo del lavoro di #DanteAlighieri, #GalileoGalilei, #SigmundFreud, #ThomasMann, e #ItaloCalvino...
STORIA E LETTERATURA E PSICOANALISI. Memoria di un evento epocale: i Magi erano sapienti e sapevano distinguere tra il #Bambino-re (#Gesù) e il #Re-bambinone (#Erode). Ma, oggi, dove sono i Magi?
- DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICO-ARTISTICA SULLA TRADIZIONE DEL PRESEPE (GRECCIO, 1223), DELLA FESTA DELL’ #EPIFANIA (ITALIA, 2024), E DELLE FIGURE DEI MAGI NELLA STORIA D’EUROPA...
- Un omaggio alla prof. di Etruscologia, Lea Cimino, per la segnalazione
Archeologia e Storiografia. Dopo papa Gregorio I, detto papa Gregorio Magno (Roma, 12 marzo 604), e dopo papa Bonifacio IV e l’imperatore bizantino Foca (609), alla "altezza" del tempo storico del "sarcofago dell’esarca Isacco (625 - 643 d.C.)", a quanto appare epifanicamente (oggi, 6 gennaio 2024), era già in grande diffusione e costruzione la ideologia costantiniana imperiale (con le sue radici paoline) della figura della "Theotókos" (Concilio di Efeso, 431), della immagine della "Madre di Dio", la Madre del Dio - Figlio (#Imperatore - Cristo), fino a portare con san Bernardo di Chiaravalle (come scriverà Dante) a celebrare la "Vergine Madre, figlia del tuo figlio" (Par. XXXIII, 1), e a mettere "fuori campo", anzi "dalla porta", la stessa figura di #Giuseppe (#padre di Gesù, il discendente "de domo David"): il passo è costante e troverà - al di là del presepe di Francesco e dello spirito di #Assisi (Greccio, 1223) e nella messa all’indice come eretica della "Monarchia" di Dante Alighieri (con la sua teoria dei "#dueSoli") - una sollecitazione decisiva nell’opera papa francescano #SistoIV della Rovere (intorno al 1477), nella costruzione della #CappellaSistina, il cammino prosegue, arriva fino ad oggi (Epifania 2024), ed oltre - alla prossima tappa, all’anno prossimo, al 2025, al Giubileo e alla celebrazione dell’anniversario del Concilio di #Nicea del 325.
- Nota:
- MAGI_A E #ARTE DEL "#RINASCIMENTO": TRE MAGI, ANZI, "I TRE FILOSOFI DI GIORGIONE". Alla fine del ’400 e ai primi anni del ’500, i Magi e i Filosofi camminavano insieme, e gioivano del #presepe (#Greccio, 1223), della #manifestazione epifanica, poi (sollecitati dai teologi e dai politici della #dottaignoranza, incapaci di pensare la "pace della fede", con tutte le religioni, caduta Costantinopoli) ruppero i rapporti e la guerra in nome della "vera religione" non è mai più finita.... a guardare la cosa con il #Galileo, dalla #Luna (1610)!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- E LA "NUOVA-CITTA" (LA "NEA-POLIS"). AL DI LA’ DEL FEUDALESIMO TEOLOGICO-POLITICO, UNA INDICAZIONE "MESSIANICA" DI GAETANO FILANGIERI3 gennaio 2024, di Federico La Sala
#RITORNO AL FUTURO, 4:
AL DI LA’ DELLA LUNGA DURATA DEL FEUDALESIMO TEOLOGICO-POLITICO (PLATONICO-PAOLINO) DELLA TRADIZIONE OCCIDENTALE.
- Una nota in memoria di #TommasoCampanella, di #MiguelVaaz (Conte di #Mola), di #GiambattistaVico. di #AntonioGenovesi, e di Ernst #Kantorowicz...
CITTADINANZA E #SOVRANITA’ NELLA #CITTA’ DEL #SOLE, COME SI DICE "NOI" NELLA #NAPOLI DI IERI, DI OGGI, E DI DOMANI. UNA INDICAZIONE "MESSIANICA" DI GAETANO #FILANGIERI:
- "Nella democrazia - scrive Gaetano Filangieri nella sua opera "La #Scienza della #Legislazione" (1781-88) - comanda il popolo, e ciaschedun cittadino rappresenta una parte della sovranità: nella concione [assemblea di tutto il popolo], egli vede una parte della corona, poggiata ugualmente sul suo capo che sopra quello del cittadino più distinto.
- L’oscurità del suo nome, la povertà delle sue fortune non possono distruggere in lui la coscienza della sua dignità. Se lo squallore delle domestiche mura gli annuncia la sua debolezza, egli non ha che a fare un passo fuori della soglia della sua casa, per trovare la sua reggia, per vedere il suo trono, per ricordarsi della sua sovranità" (Libro III, cap. XXXVI).
- PER UN #BUON2024", PER UNA BUONA #RICAPITOLAZIONE, UN "INVITO" A RIPARTIRE DA "CAPO", DAL #CAPO, FILOLOGICAMENTE LINGUISTICAMENTE, E ANTROPOLOGICAMENTE, E TEOLOGICAMENTE. In principio era il #Logos - non un logo...
#FILOLOGIA #ANTROPOLOGIA E #STORIOGRAFIA D’EUROPA. Alla "fine" della sua "storia" la "coscienza europea", imperterrita continua a mantenere in piedi la sua idea di regalità teo-androcentrica; e, a 800 anni dal #presepe di Greccio (1223), a 700 anni e più dalla lezione "cosmicomica" di teologia e antropologia di #DanteAlighieri sulla "Monarchia" dei #DueSoli, OLTRE CHE dalla sollecitazione della Riforma Protestante (1517), dalla Riforma Anglicana (1534), e dalla presenza del #corpomistico sul trono di Inghilterra di #Elisabetta I («Sono solo un corpo, dal punto di vista naturale, ma, con il permesso di Dio, un Corpo politico fatto per governare»), che l’ultimo capitolo (l’ottavo) dei "Due corpi del re" di Kantorowicz sia intitolato "La regalità antropocentrica: Dante" non sollecita alcuno a interrogarsi ancora e di nuovo sulla "Divina #Commedia" e sulla quarta #domanda, quella da cui tutto dipende, quella antropologica, posta da #Kant, nella sua "Logica", all’inizio del 1800. Che dire? Avanti tutta, titanic-amente.
- NOTA 1 - #FILOLOGIA #TEOLOGIA-#POLITICA E #STORIOGRAFIA: "#DIRITTI DELL’#UOMO E DEL #CITTADINO" (1789) E "UNITED STATES BILL OF RIGHTS (1791). RICORDANDO la "Dichiarazione dei diritti della #donna e della #cittadina" (Olympe de Gouges, 1791), forse, è bene sottolineare l’importanza dell’indicazione di #Filangieri. Il problema fondamentale, a mio parere, è proprio quello della #Costituzione e della "#regalità antropocentrica" (non androcentrica, e sul piano umano e sul piano teologico) su cui ha cercato di fare chiarezza Kantorowicz: il nodo (ateo e devoto) della figura del #Capo (Re-Cristo e Cristo-Re) e del suo #corpomistico (#Stato eo #Chiesa). Evidentemente, c’è da sapersi orientare sia nel pensiero sia nella realtà e #apriregliocchi (S. #Freud, 1899): c’è "Dio" e #Dio, c’è "Stato" e #Stato, e c’è Famiglia" e #Famiglia - una Costituzione di #Amore ("#Charitas") o di Mammona ("#Caritas")? Kantorowicz ha capito che, per uscire dall’#inferno platonico-costantiniano e dal #feudalesimo teandrico (ateo o devoto), è fondamentale "ricordarsi della #propria personale #sovranità" e ha sottolineato con chiarezza tutta la portata filosofica e storica della lezione di Dante Alighieri.
- NOTA 2 -
CRITICA DELLA "RELIGIONE ASSOLUTA" E "SÀPERE AUDE!" (KANT, 1784). La #question #Hamlet-ica è all’ordine del giorno: avendo interpretato il #Logos come un #logo, ancora dopo #Auschwitz, è chiaro che non si sa più nulla né di #filologia né di #antropologia e nemmeno di #teologia, e, si continua a ritenere che "Dio amore" (#charitas) sia identico a "Dio #mammona" (#caritas), e che l’essere sia uguale al "non essere". Se è così, e la storia fin qui percorsa lo evidenzia (una #caduta extraterrestre, poco terrestre), come può essere possibile uscire dall’#inferno cosmoteandrico, se non ricordandosi della propria personale #sovranità e diventare un #essereumano, un "cristiano" adulto ("Ecce Homo")!? #DanteAlighieri, con #Filangieri, #Kant, #Kantorowicz, non ha lavorato inutilmente e ha dato fondamentali indicazioni per riprendere la diritta via.... #Sàpere aude!, così si dice ancora oggi nella #Napoli di Filangieri, per invitare a fare uso della propria #facoltà di #giudizio: assaggia!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ANTROPOLOGIA E FILOLOGIA. Non è meglio ripartire dalla "caduta" ("donazione") di Costantino (Lorenzo Valla, 1440), per capire e andare oltre la "caduta di Costantinopoli" (1453) e oltre Nicea (325-2025)?!19 dicembre 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA STORIA FILOSOFIA ANTROPOLOGIA:
USCIRE DAL SONNO DOGMATICO (KANT). Chi di potenza ferisce, di potenza perisce. Queste le "regole del gioco" dell’Occidente? A quanto pare, l’#Europa è ancora ferma a Niccolò #Cusano e alla sua teologia-politica delle "congetture": con l’#astuzia paolina della "dotta ignoranza" (1440), quale "setaccio" ("cribratio") può fondare il #dialogo tra le religioni e la "pace della fede" (1453)? Non è meglio ripartire dalla "caduta" ("donazione") di #Costantino (#LorenzoValla, 1440), per capire e andare oltre la "caduta di #Costantinopoli" (1453) e, #oggi (nell’anno dell’#Incarnazione del #Natale2023), oltre #Nicea (325-2025)?! Se non ora, quando?
#STORIAELETTERATURA E #STORIOGRAFIA: LE “#REGOLEDELGIOCO" DELL’EUROPA (DI #IERI). A partire dal 1492: "Su cosa è stato edificato il nuovo mondo? Genocidi e stermini. Chi ha dato il nome a questo nuovo mondo? Un Vespucci (in verità non lui direttamente, ma ricordiamoci dei ragni e delle formiche di Bacone). Chi ha chiamato così l’Amazzonia? E, chi così il Brasile? A Napoli, sì sempre a Nea-polis, questo nome ricorda la brace, il braciere, persone intorno a un fuoco che riscalda, un cerchio familiare che si apre e accoglie chi ha freddo - non la devastazione e il deserto di chi cieco e folle si mette a distruggere tutto: Edipo con in mano il lancia-fiamme a volontà - Platone, il Tecno-crate. Di fronte alla Foresta gli uomini ciechi e folli di potenza (ma qui si parla anche delle donne-amazzoni) vedono nulla e fanno e ... faranno il Brasile?” (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani Editore, Roma 1991, pp. 180-181).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI, IL FALLIMENTO DELLA RICERCA DELLA PACE DELLA FEDE, E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (CRISTOLOGICA).16 dicembre 2023, di Federico La Sala
RINASCIMENTO. NASCERE E RINASCERE: LA "MADONNA DELLE GRAZIE" (Scuola Lombarda: Cappella della Vergine delle Grazie, S. Maria delle Grazie, Milano):
- "Nel 1460 il conte Gaspare Vimercati, comandante delle truppe sforzesche, donò ai padri domenicani del convento di Sant’Apollonia di Pavia un terreno situato a Milano.
 Qui si trovavano due modeste costruzioni: una ospitava le truppe del Vimercati, l’altra era una cappella decorata all’interno con un affresco che raffigurava la Madonna, detta delle Grazie.
Qui si trovavano due modeste costruzioni: una ospitava le truppe del Vimercati, l’altra era una cappella decorata all’interno con un affresco che raffigurava la Madonna, detta delle Grazie.
 I religiosi avrebbero dovuto edificare in quel punto una chiesa e un convento da intitolare a Santa Maria delle Grazie, così nel 1463 iniziarono i lavori di costruzione del complesso, sotto la guida di Guiniforte Solari. Il convento fu completato, almeno nelle sue parti essenziali, nel 1469, mentre la chiesa era terminata nel 1482."
I religiosi avrebbero dovuto edificare in quel punto una chiesa e un convento da intitolare a Santa Maria delle Grazie, così nel 1463 iniziarono i lavori di costruzione del complesso, sotto la guida di Guiniforte Solari. Il convento fu completato, almeno nelle sue parti essenziali, nel 1469, mentre la chiesa era terminata nel 1482."
Una nota a margine...
ARTE STORIOGRAFIA LETTERATURA E QUESTIONEANTROPOLOGICA (CRISTOLOGIA) - NELL’ANNO DELL’INCARNAZIONE DEL #NATALE2023 E DELL’ANNIVERSARIO DEL #PRESEPE DI #GRECCIO DEL 1223.
CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "CRISTIANI". A ben riflettere, LA "MADONNA DELLE GRAZIE", effettivamente, è un’opera che, con i suoi molti dettagli, sollecita a ri-fare luce e a rimeditare su un’epoca di grandissima rilevanza artistica e storica, non solo per il nostro #ieri ma anche per il nostro #oggi e per il nostro #domani.
PACE O GUERRA (DELLA FEDE)? L’opera si colloca immediatamente dopo la CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453), e il tentativo di una mediazione teologico-politica fallita con le altre religioni (in particolare, islam ed ebraismo), fatto da Niccolò Cusano (e da papa Pio II Piccolomini) con la "DOTTA IGNORANZA" (1440), LA "PACE DELLA FEDE" (1453), e IL "SETACCIO DEL CORANO" ("Cribatio Alkorani", 1461). Comincia la mobilitazione contro il mondo musulmano (e anche il mondo ebraico), come all’interno così all’esterno dell’Europa (la "riconquista di #Granada" è del 1492, con i suoi vari "editti").
CULTURA E POLITICA. Per approfondimenti specifici, mi sia permesso, si cfr. l’illuminante lavoro di Marco Infurna, relativo alla figura di Ambrogio della Longhignana, signore di Porlezza e al clima lombardo del tempo: "Il duello di Rolando e Feraguto sul ponte in un affresco lombardo del Quattrocento" (“Par estude ou par acoustumance”. Saggi offerti a Marco Piccat per il suo 65° compleanno, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2016).
- "Nel 1460 il conte Gaspare Vimercati, comandante delle truppe sforzesche, donò ai padri domenicani del convento di Sant’Apollonia di Pavia un terreno situato a Milano.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- L’EUROPA, "L’ELOGIO DELLA FOLLIA" (1511) E L’UTOPIA (1516). CULTURA E SOCIETÀ: "LA MONTAGNA INCANTATA" (1924) e "IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (1929).20 novembre 2023, di Federico La Sala
L’EUROPA, "L’ELOGIO DELLA FOLLIA" (1511) E L’UTOPIA (1516). CULTURA E SOCIETÀ: "LA MONTAGNA INCANTATA" (1924) e "IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (1929).
- In memoria di Ferrante Sanseverino (Principe di Salerno) e Girolamo Seripando (Arcivescovo di Salerno)
Una nota a margine di una "citazione" di una lettera di #Tommaso Moro a #Erasmo di Rotterdam:
«Non puoi immaginarti quanto ora io m’imbaldanzisca, quanto mi gonfi, quanto mi tenga più su. Immagino di continuo che i miei Utopiani mi vorranno eleggere loro sovrano perpetuo, tanto che mi vedo già incedere del diadema di frumento, mi vedo cospicuo nel paludamento francescano, mi vedo portare lo scettro venerabile di un covone di messi. Circondato da un’insigne accolta di cittadini di Amauroto, mi vedo, in pompa solenne, andare incontro agli ambasciatori e ai principi delle genti straniere, ben miseri al nostro confronto, pieni di sciocca superbia, perché ornati fanciullescamente, pieni di vanità femminile, carichi di disprezzabile oro, ridicoli per la porpora, per le gemme, per altre bazzecole.» (Cfr. E. Scelza, "LE CITAZIONI: il sogno ad occhi aperti di Tommaso Moro", "Gente e Territorio", 15 novembre 2023).
SE SI CONSIDERA CHE TOMMASO MORO (1478-1535) scrive quello che scrive ad ErasmodiRotterdam (1469-1536) il 4 dicembre 1516, e che, al contempo, Martin #Lutero (1483-1546) nell’ottobre del 1517 diffonde le sue #95Tesi, c’è da pensare che ognuno sognasse un proprio #sogno ad occhi aperti e non avessero affatto un #mondo "unico e comune" (#Eraclito) : questo spiega, soprattutto da parte di Erasmo e Moro, anche la loro presa di distanza dalle sollecitazioni di riforma della Chiesa da parte di Lutero.
Non è un caso che, pochi anni dopo (al tempo di Carlo V, dopo il Sacco di Roma nel maggio del 1527), la richiesta di un tentativo di edizione della "#Monarchia" di #DanteAlighieri, fatto da Alonzo de #Valdès (1490 - 1532) e Mercurino di #Gattinara (1465-1530), è lasciato cadere nel vuoto da Erasmo da Rotterdam (nel marzo del 1527), e, ancora e purtroppo, di lì a poco c’è la rottura di #EnricoVIII con Chiesa cattolica e l’avvio della Riforma Anglicana (1534).
All’indomani della Prima Guerra Mondiale, alla fine della sua "Montagna Incantata" (#Zauberberg, 1924), #ThomasMann scrive: "Chi sa se anche da questa mondiale sagra della morte, anche dalla febbre maligna che incendia tutt’intorno il cielo piovoso di questa sera, sorgerà un giorno l’amore?" (trad. di E. Pocar).
Nel 1929, in Italia, la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano sottoscrivono il "Concordato" (#PattiLateranensi, 11 febbraio 1929): a Vienna, intanto, #SigmundFreud porta avanti il suo lavoro e pubblica il risultato delle sue ricerche e delle sue riflessioni sul "Disagio della civiltà" (e nella civiltà).
P.S. - STATO ITALIANO E STATO PONTIFICIO (CHIESA CATTOLICA): LA QUESTIONE ROMANA E IL "#20SETTEMBRE 1870" (Festa della liberazione della capitale e dell’unificazione nazionale, abolita dal Fascismo). #BENEDETTOCROCE, NELLA "STORIA D’ITALIA DAL 1871 AL 1915" (1928), A PROPOSITO DEL PERSONAGGIO "LUDOVICO SETTEMBRINI" DELLA "MONTAGNA INCANTATA" ("DER ZAUBERBERG", 1924) DI THOMAS MANN, COSI’ SCRIVE:
- «Fu creduto, e io credetti, che con questo nome egli alludesse al nostro Luigi Settembrini; ma alcuni anni dopo, in un incontro col Mann in Germania, egli mi confessò di avere ignorato affatto l’esistenza di Luigi Settembrini, e di aver composto quel nome derivandolo dal “20 settembre”!» (cfr. #SantoMazzarino, "#Pirandello. La storia dell’Italia moderna e antica", a c. di Maria Adele Cavallaro, Roma 2022, p. 203).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- UNA NOTA SU.LA "CESURA" SEGNATA DAL LAVORO CRITICO "SULLA DONAZIONE DI COSTANTINO" DI LORENZO VALLA (1440) E DALLA CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453)..9 novembre 2023, di Federico La Sala
#STORIOGRAFIA D’#EUROPA, #FILOLOGIA, E #LETTERATURA:
LA "CESURA" STORICA E CULTURALE SEGNATA DAL LAVORO CRITICO "SULLA #DONAZIONE DI #COSTANTINO" DI #LORENZOVALLA (1440) E DALLA CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453). *
- Una nota a margine del "CONVEGNO INTERNAZIONALE:
 Al #crocevia del #Mediterraneo. La Monarchia umanistica aragonese nel contesto ideologico e culturale del Rinascimento",
Al #crocevia del #Mediterraneo. La Monarchia umanistica aragonese nel contesto ideologico e culturale del Rinascimento",
 Napoli. Palazzo Du Mesnil (via Chiatamone 61). 22-24 novembre 2023
Napoli. Palazzo Du Mesnil (via Chiatamone 61). 22-24 novembre 2023
 (Cesura #Aragona - Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese):
(Cesura #Aragona - Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese):
- Nel Quattrocento il Regno di Napoli costituisce uno snodo fondamentale nell’evoluzione del classicismo occidentale in ogni sua forma, con un’ampia circolazione di opere greche e latine, con la fondazione di una ricca e aggiornatissima biblioteca di corte, con la committenza di opere d’arte ed edifici monumentali, nonché una ricca produzione letteraria e filosofica, il tutto nella prospettiva della creazione di uno Stato solido incentrato sulla maiestas del sovrano. Quel regno fu, al tempo stesso, punto di approdo e di partenza: luogo di incontro che per essere pienamente compreso necessita di sguardi ampi e aperti a confronti e raffronti con quanto capitava in altre parti d’Italia e d’Europa. La sontuosa corte della capitale napoletana (punto di convergenza tra linee culturali e tradizioni antiche e nuove) fu connessa variamente non solo con le altre corti “minori” del Regno, ma anche con altri centri politici e culturali di tutta Europa.
- Il presente convegno intende sviluppare il concetto di “rete”, offrendo un modello interpretativo proficuo e funzionale, in quanto permette di spiegare in termini non gerarchici i movimenti di idee e modelli culturali veicolati da uomini e libri. Affiancandosi - senza sovrapporsi in maniera esclusiva - allo schema impostato sul confronto “centro-periferia”, permette di leggere in chiave più ampia i rapporti che intercorrono nel complesso e articolato sistema istituzionale e culturale sviluppato lungo l’ampio arco del Mediterraneo. Un Mediterraneo, che, almeno per la sua parte occidentale, era divenuto una sorta di “lago catalano”, in quegli anni in cui la traiettoria di espansione della Corona d’Aragona, iniziata già nel XIII secolo, era giunta alla sua massima espansione e Napoli (dopo la conquista di Alfonso il Magnanimo, nel 1442) era diventata, in qualche modo, uno snodo ineludibile dal punto di vista culturale, oltre che economico-commerciale.
- (Per ulteriori approfondimenti sul Convegno, cfr. Cesura #Aragona - Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese)
*
STORIOGRAFICAMENTE, forse, è ora di #capovolgere, il "tempo" proprio dell’#Umanesimo e del #Rinascimento: per la società e la cultura del cosiddetto "Medio Evo" degli "umanisti", l’epoca "fu sentita - così scrive E. #Gilson - come un’età di innovazione in tutti i sensi della cultura, una #modernità in progresso". A mio parere, il formidabile processo della "prima #rinascita" (E. #Buonaiuti) cominciata con #GioacchinodaFiore, #FrancescodiAssisi, e #DanteAlighieri trova il suo punto culminante nella "Monarchia umanistica aragonese" e, al contempo, comincia a imboccare un vicolo cieco, segnato dall’#orizzonte cusaniano della "#DottaIgnoranza" (1440) e della "#Pace della #fede" (1453) senza l’#Islam, nella caduta di Costantinopoli nelle mani di #Maometto II(1453), e, complementarmente, nella Guerra di #Granada, portata avanti dai Re Cattolici, Ferdinando II di Aragona e Isabella di Castiglia (1482-1492), contro gli ebrei e contro gli arabi. A partire dal 1517/1534 (#RiformaProtestante e Anglicana), inizia un lungo inverno per l’#Europa (#ConciliodiTrento, #Lepanto, #InvincibileArmata, #ElisabettaI d’Inghilterra); dopo il 1616 (morte di #Shakespeare, #Cervantes, e #Garcilaso El Inca de la Vega), prende il via la Guerra dei Trent’anni (1618-1648).
- Una nota a margine del "CONVEGNO INTERNAZIONALE:
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- STORIOGRAFIA E MITO: LA "MEMORIA DEL MONDO" E LA RICERCA DI ITALO CALVINO DI USCIRE "FUORI DEL SELF" DELLA TRADIZIONE SOFISTICA.3 novembre 2023, di Federico La Sala
LA "MEMORIA DEL MONDO", LA CELESTE "CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI" DI FOSCOLO (OMERO/ULISSE), E LA RICERCA DI ITALO CALVINO DI USCIRE "FUORI DEL SELF" DELLA TRADIZIONE SOFISTICA (IDEALISTICA E MATERIALISTICA), PER COMPRENDERE ANTROPOLOGICAMENTE (NON ANTROPOMORFICAMENTE) LE RADICI COSMICOMICHE DELLA INFINITA E COMPLESSA MOLTEPLICITÀ... *
CALVINO (OMERO/ULISSE): "IO HO ASCOLTATO IL CANTO DELLE SIRENE" ("La letteratura e la realtà dei livelli", 1978). Non dimentico della lezione di #DanteAlighieri, #Calvino cerca di trovare la via che lo possa portare al "punto di arrivo cui tendeva #Ovidio nel raccontare la continuità delle forme, il punto di arrivo cui tendeva #Lucrezio nell’identificarsi con la natura comune a tutte le cose" ( "Molteplicità", "Lezioni Americane").
I "LIVELLI DI REALTÀ" (Feltrinelli, Milano 1984) E LA PSICOANALISI. Una traccia, per orientarsi nell’attraversamento dei livelli di realtà delle opere di #Calvino100: ricordare il suo incontro ("Anch’io cerco di dire la mia"), nella "taverna dei destini incrociati", con "Sigismondo di #Vindobona", e ricordare il ruolo di #Venere (#Afrodite) e di #Eros (#Cupìdo) nella mitica versione di Ovidio del "Ratto di #Proserpina", di #Persefone, figlia di #Demetra (#Cerere), da parte di #Ade (#Plutone):
- "Plutone, re degli Inferi, preoccupato che i movimenti tellurici causati dal gigante Tifeo sepolto sotto la #Sicilia potessero far penetrare la luce nel suo oscuro regno, perlustrava quella regione quando Venere scortolo esortò Cupido ad estendere il proprio dominio anche sul regno infero, colpendo con una delle sue frecce il sovrano infernale. Nei pressi di un lago poco distante da #Enna, Proserpina, la giovane figlia di Cerere, coglieva fiori con le proprie compagne. Plutone, colpito dallo strale di Cupido, se ne invaghì e rapitala la condusse con sé negli Inferi. Al rapimento della fanciulla assistette la #ninfa #Ciane la quale, tentato invano di impedire il misfatto, si dissolse nella fonte che da lei prende nome. A seguito della scomparsa della figlia la dea Cerere disperata intraprese la sua #ricerca." (cfr. "Le metamorfosi di Ovidio").
#Eleusis2023
*
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- PSICOANALISI DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA: "LA NAVE DEI FOLLI", LA "STORIA DELLA FOLLIA" E LA PROPOSTA DI UN "SATANARIUM".15 ottobre 2023, di Federico La Sala
EUROPA, NAVE DEI FOLLI E STORIA DELLA FOLLIA. L’interpretazionedeisogni (S. Freud, 1899) è un’arte e una scienza molto difficile, a quanto pare: dall’orizzonte della tragedia, l’umanità è incapace di uscire? *
- LA NAVE DEI FOLLI
- di Pietro Barbetta (Doppiozero, 27 Febbraio 2013)
Una gita a Clusone e una a Pinzolo non guastano. La danza macabra di Borlone de Buschis di Clusone (1485) e quella di Simone Baschenis di Pinzolo (1539) segnano forse l’inizio e la fine di un periodo di comunità inconfessabile (Blanchot, 1983). Inconfessabile perché composta di trapassati, che, in quanto tali, già sono passati in giudicato, ingiudicabili. In molti accomunano questa comunità a un’altra, che potrebbe essere anche la medesima, chissà. Si tratta della Stultifera Navis. Cos’hanno in comune gli stolti e i morti? Il semplice fatto di non essere confessabili. Gli uni per il regno dei cieli, gli altri per la terra, sono inguaribili. Bosch e le illustrazioni a Brant di Dürer ne danno rappresentazione figurativa. Ecco una figura chiave, il centro del primo capitolo, della prima parte della Storia della follia di Foucault: Sebastian Brant (1458-1521). Vissuto tra l’opera del de Buschis e quella del Baschenis. Nel giugno 1984 Francesco Saba Sardi (1922-2012) ci regalò, in versi endecasillabi, la traduzione di Das Narrenschiff.
- [FOTO] Borlone de Buschis di Clusone
Narrenschiff uscì per la prima volta nel 1494, due anni dopo la scoperta dell’America. Prima di Brant abbiamo alcune opere importanti sull’argomento a partire dal 1360. Si immagina una sorta di confraternita delle persone strambe - le sole che possano esservi ammesse. Corporazione non chiusa per via di censo, particolari privilegi o saperi occulti. Bisognava essere, per esempio, un vescovo che aveva ipotecato il reddito per comprare il titolo religioso, un alchimista che aveva sciolto nel crogiolo le sue ricchezze.
La follia è ingiudicabile altrettanto quanto la morte, inguaribile. Questa caratteristica segna una linea di confine comunitaria, la nave è uno dei suoi contenitori. A quel tempo - successivo alla lebbra e alla peste, coevo di una nuova malattia giunta dalle Americhe, la sifilide - i folli venivano allontanati dalle città, imbarcati su navi per essere abbandonati altrove, ma il navigatore spesso le gettava a mare o le sbarcava in qualche landa desolata, dove morivano. Molti annegavano. Non è difficile immaginarlo oggi che abbiamo sotto gli occhi le immagini di uomini e donne morti alla deriva delle coste italiane. Unica differenza: allora giungevano dove nessuno stava, oggi invece si torce il collo altrove.
Gran satira grottesca o poema moralista? L’opera di Sabstian Brant ci lascia ancora nel dubbio. Quando Foucault ci parla della Stultifera Navis, qualunque opera scritta o figurativa ci venga in mente, dà un senso a quell’insieme indistinto di uomini e donne che ci entravano. Foucault distingue questo ammasso indifferenziato dalla follia così come viene identificata a partire dal secolo XVIII. Dal Settecento la follia diventerà regno del dominio medico, verrà diagnosticata e sistematicamente curata.
La nave dei folli non è che l’inizio di un processo che vedrà successive partizioni, da Erasmo fino a Pinel; è un crogiolo umano, un pleroma. Per alcuni Brant si confronta con l’avvento del Nuovo Mondo. La nave dei folli richiama le navi che iniziano a salpare verso le Americhe, fino al Seicento con la Mayflower, carica di puritani. Nave che navigò la luna, secondo i versi di Paul Simon. Anche loro inconfessabili, in quanto protestanti, spirito del capitalismo.
- [FOTO] Simone Baschenis di Pinzolo
Brant sarebbe il primo progressista dell’epoca moderna, sguardo disincantato verso il futuro imminente e immanente, fiducia nella città come luogo dell’innovazione e, per via dei commerci, luogo d’incontro multiculturale. La città è il centro dove ogni superstizione, credenza, invidia, odio saranno eliminati. Brant progressista. Invero sulla nave - destinata a Narragonia, che si dirige verso Cuccagna - non ci sono solo i folli contemporanei, bensì usurai, giocatori d’azzardo, adulteri, viziosi, prodighi, invidiosi, voluttuosi, ingrati, spergiuri, bestemmiatori. Tutta la follia premoderna raccolta dentro questa nave autorganizzata, autosufficiente, autopoietica. Brant moralista.
A voler ben guardare, la maggioranza del testo elenca, tra l’altro, la cupidigia, le nuove mode, il retto Catechismo, gli istigatori di discordia, le male costumanze, il dispregio delle Scritture, i galanti, la crapula e la gozzoviglia, le ciarle, i desideri superflui, gli studi inutili, le procrastinazioni, l’adulterio, la presunzione, la voluttà, l’ingratitudine, la bestemmia, l’usura.
- [FOTO] Albrecht Dürer
Come scritto, Albrecht Dürer illustra l’opera di Brant e Bosch crea una sua opera, sempre nel 1494. Nel frattempo altre comunità inconfessabili si muovono per via terrena, gli Ebrei, cacciati da Spagna e Portogallo, i Valdesi perseguitati ed erranti tra le valli montane fino alla Riforma.
Quanto l’opera si adatti all’ultimo ventennio, quanto sia attuale, quanto si stia trasformando nella Nemesi, lo vediamo dal momento in cui l’Europa è essa stessa, oggi, una nave di folli. Ci si aspetta solo un grande evento naturale, il distacco dagli Urali.
*
- STORIA E LETTERATURA, DANTE2021, E METASTORIA:
- LA PRIMA GUERRA MONDIALE, "UNA INUTILE STRAGE" (BENEDETTOXV, 1917), E LA PROPOSTA DI GEORG W. GRODDECK (1866-1934) DI UN "SATANARIUM".
A) - EUROPA (1914-1918): "[...] In occasione della prima guerra mondiale [Groddeck] fu richiamato in servizio nella sua qualità di medico militare. Poiché aveva cercato di dirigere anche l’ospedale da campo come fosse stato quello che spesso chiamava il suo #Satanarium (invece di #sanatorium) si attirò le antipatie di tutti, fino ad essere allontanato dal servizio nonostante l’intervento di autorevoli pazienti di un tempo, quali la stessa sorella del Kaiser e il marito.
 Fu nel maggio 1917 che Groddeck scrisse la sua prima lettera a Freud [...]" (cfr. Martin Grotjahn, "Georg Groddeck (1866-1934). L’analista indomito", in AA. VV., "Pionieri della Psicoanalisi", Feltrinelli, Milano 1971).
Fu nel maggio 1917 che Groddeck scrisse la sua prima lettera a Freud [...]" (cfr. Martin Grotjahn, "Georg Groddeck (1866-1934). L’analista indomito", in AA. VV., "Pionieri della Psicoanalisi", Feltrinelli, Milano 1971).- NOTA. Sul tema, si cfr. l’Intervista di Anna Cordioli relativa al libro a cura di Michele M. Lualdi, “Il re selvaggio. Georg Groddeck ai congressi psicoanalitici”.
B) - GEORG GRODDECK, "SATANARIUM" (il Saggiatore, MILANO 1996):
 SCHEDA EDITORIALE: "Siamo nel 1918. Il macello della guerra è in pieno corso. Groddek, che da anni dirige una clinica per malattie mentali, il #Sanatorio #Marienhohe, presso #BadenBaden, decide che il ruolo passivo dei suoi ospiti non è più sufficiente. Essi devono gridare ciò che li tormenta e li opprime, devono esprimere i loro desideri, manifestare le loro fantasie e, nel castello in aria del #Sanatorio, dedicarsi alla #ricostruzione dell’#Europa. "Mi propongo di dare all’uomo la possibilità di urlare il proprio tormento liberamente, senza timore né pudore. L’unico luogo in cui ciò è consentito mi pare essere l’#inferno; perciò chiamo questa rivista ’Satanarium’. Ne usciranno 23 numeri, tutti raccolti in questo volume che ricalca anche le caratteristiche grafiche degli originali." (https://www.ibs.it/satanarium-libro-georg.../e/9788842803928).
SCHEDA EDITORIALE: "Siamo nel 1918. Il macello della guerra è in pieno corso. Groddek, che da anni dirige una clinica per malattie mentali, il #Sanatorio #Marienhohe, presso #BadenBaden, decide che il ruolo passivo dei suoi ospiti non è più sufficiente. Essi devono gridare ciò che li tormenta e li opprime, devono esprimere i loro desideri, manifestare le loro fantasie e, nel castello in aria del #Sanatorio, dedicarsi alla #ricostruzione dell’#Europa. "Mi propongo di dare all’uomo la possibilità di urlare il proprio tormento liberamente, senza timore né pudore. L’unico luogo in cui ciò è consentito mi pare essere l’#inferno; perciò chiamo questa rivista ’Satanarium’. Ne usciranno 23 numeri, tutti raccolti in questo volume che ricalca anche le caratteristiche grafiche degli originali." (https://www.ibs.it/satanarium-libro-georg.../e/9788842803928). -
> RIPENSARE L’EUROPA! --- PIANETA TERRA: A CHE GIOCO GIOCHIAMO?, ANCORA, OGGI? AL GIOGO DELLA TERRA PROMESSA?10 ottobre 2023, di Federico La SalaPIANETA TERRA: A CHE GIOCO GIOCHIAMO?, ANCORA, OGGI? AL GIOGO DELLA TERRA PROMESSA? TERRA! TERRA! IL BRASILE DÀ UNA LEZIONE ALL’EUROPA E ALLE SUE RADICI. Una "memoria" (2005).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- MITOLOGIE "COSTANTINIANE" (NICEA 325 - 2025). Una nota a margine di un commento all’opera di Paolo Veronese, "Allegoria della battaglia di Lepanto, 1572-1573"6 settembre 2023, di Federico La Sala
L’EUROPA E LE MITOLOGIE "COSTANTINIANE" (NICEA 325 - 2025): STORIA, ARTE, E STORIOGRAFIA...
- Una nota a margine di un commento all’opera di Paolo Veronese, "Allegoria della battaglia di Lepanto, 1572-1573":
- "MITOLOGIE CRISTIANE. Nell’immagine: Paolo Veronese, Allegoria della battaglia di Lepanto, 1572-1573.
- Ma davvero i Senesi potevano pensare che la Vergine li avrebbe sostenuti nella battaglia di Montaperti (1260) ? Quasi che i Fiorentini fossero dei bruti luterani o peggio dei rozzi infedeli ignari della vera fede ? In ogni caso fu allora (prima della battaglia) che la città, in solenne processione, fu "dedicata" alla Vergine. E la mirabilissima Maestà di Duccio di Boninsegna verrà collocata in Duomo come Pala d’altare, nel 1311, per sostituire più degnamente la già venerata icona mariana ai tempi di Montaperti. [...].
- La combine celeste diventa un vero "concilio" nella tela che Veronese dedicherà alla vittoria di Lepanto (1572-1573): qui sono i santi, Pietro Paolo e Domenico, che chiedono alla Vergine il suo sostegno per Venezia nella battaglia decisiva, in un "incontro al vertice" sopra le nuvole e sopra il campo di battaglia, in stile neo-greco o meglio neo-mitologico. Una Vergine tuttofare, tirata per il manto dai Senesi, dai Veneziani, a difesa del proprio potere comunale o imperiale (un po’ come a Santa Maria sopra Minerva, cappella Carafa, dove uno zelante San Tommaso d’Aquino raccomanda alla Vergine il cardinalone Carafa, inginocchiato). Umano, troppo umano." (Flavio Piero Cuniberto).
IL RINASCIMENTO E LA MITOLOGIA DI "COME NASCONO I BAMBINI": "DOTTA IGNORANZA" (Cusano, 1440), CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453) E "DE PACE FIDEI" (Niccolò Cusano, 1453).
 LA BATTAGLIA DI LEPANTO (1572-1573) FU UNA "VITTORIA DI PIRRO":
CON LA MANCATA RISOLUZIONE DELLA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA) NON A CASO LA SPAGNA E LA "CATTOLICISSIMA" CHIESA" APRONO ALLA GUERRA CONTRO EBREI E CONTRO MUSULMANI (GRANADA, 1492), CONTRO LUTERO E LA RIFORMA PROTESTANTE (1517) E CONTRO LA RIFORMA ANGLICANA (1534), E PORTERANNO CON L’INVINCIBILE ARMATA L’ATTACCO ALLA GRAN BRETAGNA (1588) DI ELISABETTA I.
LA BATTAGLIA DI LEPANTO (1572-1573) FU UNA "VITTORIA DI PIRRO":
CON LA MANCATA RISOLUZIONE DELLA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA) NON A CASO LA SPAGNA E LA "CATTOLICISSIMA" CHIESA" APRONO ALLA GUERRA CONTRO EBREI E CONTRO MUSULMANI (GRANADA, 1492), CONTRO LUTERO E LA RIFORMA PROTESTANTE (1517) E CONTRO LA RIFORMA ANGLICANA (1534), E PORTERANNO CON L’INVINCIBILE ARMATA L’ATTACCO ALLA GRAN BRETAGNA (1588) DI ELISABETTA I.
 L’Europa "cattolica" comincia a portare la "pace" e a fare il "deserto" dappertutto, e a buttare le basi per una "generica" devastazione e una distruzione globale.
L’Europa "cattolica" comincia a portare la "pace" e a fare il "deserto" dappertutto, e a buttare le basi per una "generica" devastazione e una distruzione globale. -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- PLATONISMO, FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA). ELEUSIS 2023: RICOMINCIARE DA DIOTIMA DI MANTINEA (ELEUSIS 2023)11 luglio 2023, di Federico La Sala
HEGELISMO, PLATONISMO, FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA)*
- "SÀPEREAUDE! (KANT, 1784): "IO SONO L’ALFA E L’OMEGA, IL PRIMO E L’ULTIMO" (#APOCALISSE, 1.11).
- CON HEGEL, MA A RICOMINCIARE DA DIOTIMA DI MANTINEA, DANTE ALIGHIERI, GALILEO GALILEI, IMMANUEL KANT...
- ELEUSIS 2023.
"MENSCHWERDUNG" ("DIVENTARE UN ESSERE UMANO"). "Dio è amore" ("Deus charitas est"), condivido (è una questione di "h": "Charitas", gr. "Xapitas"). Hegel ha messo il dito nella piaga: "La vita di Dio e il conoscere divino potranno bene venire espressi come un gioco dell’#amore ["ein Spielen der Liebe"] con se stesso; questa idea degrada fino all’edificazione e addirittura all’insipidezza, quando mancano la serietà, il dolore, la pazienza e il travaglio ["Arbeit"] del negativo" ("Fenomenologia dello Spirito", §19).
 A ben "orientarsi nel pensiero" (Kant) e, al contempo, nel sollecitare una ri-considerazione unitaria della "Prefazione" ("Vorrede") della "Fenomenologia dello Spirito" di Hegel e la figura della profetessa di Mantinea, Diotima, a mio parere, emerge chiaramente il #nodo antropologico di fronte a cui Hegel si è trovato e che ha sciolto in modalità tragica, edipica e paolina, con tutta la "socratica" potenza di un #Napoleone (Alessandro Magno); non con lo spirito del #Logos (di Eraclito e dell’evangelista Giovanni) né della #Giustizia di Parmenide, egli ruba "alla #Platone" l’anima a Diotima ("Simposio") e ripropone una demiurgica e demogorgonica #cosmoteandria t(al)ebana: "[...] che il vero sia effettuale solo come sistema o che la sostanza sia essenzialmente soggetto ciò è espresso in quella rappresentazione che enuncia l’#assoluto come #spirito - elevatissimo concetto appartenente all’età moderna e alla sua #religione" (Fenom. d. spir., § 22).
A ben "orientarsi nel pensiero" (Kant) e, al contempo, nel sollecitare una ri-considerazione unitaria della "Prefazione" ("Vorrede") della "Fenomenologia dello Spirito" di Hegel e la figura della profetessa di Mantinea, Diotima, a mio parere, emerge chiaramente il #nodo antropologico di fronte a cui Hegel si è trovato e che ha sciolto in modalità tragica, edipica e paolina, con tutta la "socratica" potenza di un #Napoleone (Alessandro Magno); non con lo spirito del #Logos (di Eraclito e dell’evangelista Giovanni) né della #Giustizia di Parmenide, egli ruba "alla #Platone" l’anima a Diotima ("Simposio") e ripropone una demiurgica e demogorgonica #cosmoteandria t(al)ebana: "[...] che il vero sia effettuale solo come sistema o che la sostanza sia essenzialmente soggetto ciò è espresso in quella rappresentazione che enuncia l’#assoluto come #spirito - elevatissimo concetto appartenente all’età moderna e alla sua #religione" (Fenom. d. spir., § 22).
 A che gioco giochiamo, a che giogo vogliamo continuare a giocare? Non è meglio, forse, riprendere il filo proprio da Diotima e, con Dante Alighieri ("Due Soli") e portarsi fuori dalla tragedia dei "Tempi moderni" (Charlie Chaplin)?
A che gioco giochiamo, a che giogo vogliamo continuare a giocare? Non è meglio, forse, riprendere il filo proprio da Diotima e, con Dante Alighieri ("Due Soli") e portarsi fuori dalla tragedia dei "Tempi moderni" (Charlie Chaplin)?P. S. 1 - «Senza Hegel non sarebbe stato possibile neppure Darwin, afferma Nietzsche, e l’avrebbe potuto dire anche di se stesso; infatti chi si ammali una volta di hegelite - così mordacemente si era espresso un decennio prima - non ne guarirà mai del tutto. E che cosa sarebbe la critica alla religione di Fuerbach e di Marx, o anche quella odierna di Ernst Bloch e Georg Lukács senza Hegel?» (Hans Küng, "Incarnazione di Dio. Introduzione al pensiero teologico di Hegel, prolegomeni ad una futura cristologia", Queriniana, 1972).
P. S. 2 - EUROPA: CRISTIANESIMO CATTOLICESIMO COSTITUZIONE E SPIRITO DI ASSISI (1986). Quando Benedetto Croce pubblicò il suo «Perché non possiamo non dirci "cristiani"» (1942), don Giuseppe De Luca ’confessò’ al Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai: si è "rincristianito per dispetto". Come concordato...!!!
*
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- "Oriente e Occidente - scrive Nietzsche - sono tratti di gesso che qualcuno disegna davanti ai nostri occhi per beffarsi della nostra pavidità" ("Schopenhauer come educatore").9 luglio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E TEOLOGIA.
UN PIANETA TERRA DA RIPENSARE E UN IMMAGINARIO DA RISTRUTTURARE: PENSARE L’ EDIPO COMPLETO (S. FREUD). UNA QUESTIONE DI ILLUMINAZIONE (E DI ILLUMINISMO KANTIANO): "NOI ALUNNI DEL SOLE". In memoria di Italo Calvino.
- "Oriente e Occidente - scrive Nietzsche - sono tratti di gesso che qualcuno disegna davanti ai nostri occhi per beffarsi della nostra pavidità" ("Schopenhauer come educatore").
Appunti su un tema del "genere" (il Sole, l’astro del cielo, un dio o una dea?):
A) IL SOLE ("DIE SONNE") DI ZARATHUSTRA (NIETZSCHE):
"Quand’ebbe compiuto il trentesimo anno, Zarathustra lasciò la sua patria e il lago natìo, e si recò su la montagna. Là per dieci anni gioì, senza stancarsene, del suo spirito e della sua solitudine.
 Ma al fine il suo cuore si mutò; e un mattino egli si levò con l’aurora, s’avanzò verso il sole e così gli disse:
Ma al fine il suo cuore si mutò; e un mattino egli si levò con l’aurora, s’avanzò verso il sole e così gli disse:
 «Oh grande astro! Che sarebbe della tua felicità, se tu non avessi a chi splendere?
«Oh grande astro! Che sarebbe della tua felicità, se tu non avessi a chi splendere?
 Per dieci anni tu sei venuto alla mia caverna: ti saresti recato a noja la tua luce e il tuo cammino senza di me e del mio serpente.
Per dieci anni tu sei venuto alla mia caverna: ti saresti recato a noja la tua luce e il tuo cammino senza di me e del mio serpente.
 Ma noi ti attendevamo tutte le mattine, tu ci davi il tuo superfluo e ne avevi ricambio di benedizioni." ("Così parlò #Zarathustra/Parte prima/Prefazione");
Ma noi ti attendevamo tutte le mattine, tu ci davi il tuo superfluo e ne avevi ricambio di benedizioni." ("Così parlò #Zarathustra/Parte prima/Prefazione");- "Als Zarathustra dreissig Jahr alt war, verliess er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahr nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, - und eines Morgens stand er mit der Morgenröthe auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also:
 “Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest!
“Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest!
 Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange.
Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür.”.
Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange.
Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür.”.
B) MITOLOGIA NORRENA ("EDDA DI SNORRI"). LA SIGNORA DEL SOLE ("FRAU SUNNE"):
 "Sól era, nella mitologia norrena, la dea del Sole, figlia di Mundilfœri e moglie di Glenr.
Ogni giorno, Sól guida attraverso il cielo il suo carro, tirato da due cavalli, Árvakr e Alsviðr.
Così se ne parla nel Gylfaginning, la prima parte dell’Edda in prosa basso-medievale di Snorri Sturluson (circa 1220 d.C.) [...]
Sól era chiamata anche Sunna e Sunne, e inoltre Frau Sunne (Signora del Sole) [...]" (Sól);
"Sól era, nella mitologia norrena, la dea del Sole, figlia di Mundilfœri e moglie di Glenr.
Ogni giorno, Sól guida attraverso il cielo il suo carro, tirato da due cavalli, Árvakr e Alsviðr.
Così se ne parla nel Gylfaginning, la prima parte dell’Edda in prosa basso-medievale di Snorri Sturluson (circa 1220 d.C.) [...]
Sól era chiamata anche Sunna e Sunne, e inoltre Frau Sunne (Signora del Sole) [...]" (Sól);C) AMATERASU ("LA DEA DEL SOLE"):
 "Amaterasu-ō-mi-kami (天照大御神 lett. "Grande dea che splende nei cieli"?), generalmente abbreviato in Amaterasu, è la dea del Sole nello shintoismo giapponese. È considerata la mitica antenata diretta della famiglia imperiale giapponese.
Amaterasu è comunemente indicata come di genere femminile, nonostante il Kojiki, il più antico documento scritto della storia nipponica, dia pochi indizi riguardo al suo genere [...]" (Amaterasu);
"Amaterasu-ō-mi-kami (天照大御神 lett. "Grande dea che splende nei cieli"?), generalmente abbreviato in Amaterasu, è la dea del Sole nello shintoismo giapponese. È considerata la mitica antenata diretta della famiglia imperiale giapponese.
Amaterasu è comunemente indicata come di genere femminile, nonostante il Kojiki, il più antico documento scritto della storia nipponica, dia pochi indizi riguardo al suo genere [...]" (Amaterasu);D) QUESTIONE ANTROPOLOGICA E PSICOANALISI. L’ESISTENZA DEL "COMPLESSO EDIPICO COMPLETO" (S. FREUD, 1923);
 "[...] Vedere il caso del Giappone - nella cultura giapponese c’è la Dea in cielo, e l’imperatore sulla terra; ora-oggi!!!, dal momento che alla coppia imperiale è nata una bambina, si parla di cambiare la Costituzione per far sì che Lei possa accedere al trono ... ma il problema è più complesso - come si può ben immaginare - perché ... deve essere cambiata anche la Costituzione celeste dell’Impero del Sol Levante!!! Se no, l’Imperatrice con Chi si ’sposerà’?! Con la Dea?!!
"[...] Vedere il caso del Giappone - nella cultura giapponese c’è la Dea in cielo, e l’imperatore sulla terra; ora-oggi!!!, dal momento che alla coppia imperiale è nata una bambina, si parla di cambiare la Costituzione per far sì che Lei possa accedere al trono ... ma il problema è più complesso - come si può ben immaginare - perché ... deve essere cambiata anche la Costituzione celeste dell’Impero del Sol Levante!!! Se no, l’Imperatrice con Chi si ’sposerà’?! Con la Dea?!!
 Non è questa forse la ragione nascosta del “disagio della civiltà” dell’Oriente e dell’Occidente ..... e anche della sua fine, se non ci portiamo velocemente fuori da questo orizzonte edipico-capitalistico di peste, di guerra e di morte? [...]" (Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante).
Non è questa forse la ragione nascosta del “disagio della civiltà” dell’Oriente e dell’Occidente ..... e anche della sua fine, se non ci portiamo velocemente fuori da questo orizzonte edipico-capitalistico di peste, di guerra e di morte? [...]" (Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante). -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- EUROPA 1453-1614: IL SOGNO DELLA "PACE DELLA FEDE" (CUSANO, 1453) E UNA “SOPRAVVIVENZA” DELLE “DICERIE SACRE” (G. B. MARINO, 1614) IN UN LAVORO DI ANTONIO CANOVA.7 luglio 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, ARTE, FILOLOGIA, E STORIOGRAFIA.
- EUROPA 1453-1614: LA FINE DEL SOGNO DELLA "PACE DELLA FEDE" (CUSANO, 1453)
UNA “SOPRAVVIVENZA” DELLE “DICERIE SACRE” (G. B. MARINO, 1614) IN UN LAVORO IN CRETA DI ANTONO CANOVA (1757-1822). *
RI-LEGGENDO INSIEME LE “DICERIE SACRE” (1614) E IL POEMA “ADONE” (1623) di Giovan Battista Marino E RECUPERANDO (alla luce delle indicazioni date dal “professore con la rosa in mano”) il contesto ideologico del programma umanistico-rinascimentale della “prisca teologia” e della “docta religio”, e, AL CONTEMPO, RIPONENDO ATTENZIONE a un “modello in creta della dea Venere che abbraccia Adone morente”, realizzato da Antonio Canova, forse, non appare ("cum grano salis") ben visibile il filo che lega l’orizzonte storico-culturale di Michelangelo Buonarroti con quello di Giovan Battista Marino, e, infine, gli stessi Carmelitani scalzi di Contursi Terme (Salerno), che affrescano e dedicano (nel 1613) la loro Chiesa della Madonna del Carmine con la figure di 12 Sibille?
Qualche anno più tardi, dopo la morte di ShaKespeare, Cervantes, e Garcilaso El Inca de la Vega nel 1616, prenderà il via la Guerra dei Trentanni e tutti i sogni di una “pace della fede” (Niccolò Cusano, “De pace fidei”, 1453) vanno in fumo.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- LOGOS (LINGUA) E CHARITAS (AMORE) ED "ECCE HOMO" (QUESTIONE ANTROPOLOGICA). Una in memoria di Galileo Galilei e di Ferdinand de Saussure26 giugno 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA, "STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE" (MARSHALL MCLUHAN), E COSMOTEANDRIA: LOGOS (LINGUA) E CHARITAS (AMORE) ED "ECCE HOMO" (QUESTIONE ANTROPOLOGICA). In memoria di Galileo Galilei e di Ferdinand de Saussure
Una nota* a margine della seguente "biblica" riflessione di Franco Lo Piparo:
- «DIO DISSE: “SIA LA LUCE!”. E LA LUCE FU». È il primo atto creativo del mondo secondo il racconto biblico. Gli atti che seguono sono dello stesso tipo. Sono atti linguistici. Il racconto segue lo schema: “Dio disse ... e così fu”.
- Dio della Bibbia crea il mondo dicendolo. Nella Genesi il mondo non viene creato modellando una materia preesistente ma parlandone. Il Dio biblico non è un artigiano (artigiani e artisti erano gli dei creatori del mondo nella mitologia greca) ma un oratore. Crea con la parola.
- Nella terminologia della linguistica del novecento la parola divina è PERFORMATIVA: il suo dire è un creare. Esattamente come accade nell’atto istitutivo di una relazione matrimoniale: si diventa marito e moglie nel momento in cui un pubblico ufficiale pronuncia le parole “Vi dichiaro marito e moglie”. Non prima. I fatti che esistono in seguito a un atto linguistico sono tanti: “Prometto che ...” è tra i primi esempi che viene fatto agli studenti.
- Nella Genesi il potere di Dio coincide con il potere della Parola.
- L’attacco del Vangelo di Giovanni (Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος “In principio c’era il logos”) è la traduzione in lingua greca del racconto in lingua ebraica della Genesi.
*
QUESTIONE ANTROPOLOGICA ED "ECCE HOMO" (NIETZSCHE, 1888). Dopo il sussurro "elianico" del CLG ("Corso di Linguistica Generale"), a quanto pare, stentiamo ancora a capire l’alfa e l’omega della parola ("parole") e della lingua ("langue"), e, continuiamo a cadere dalla padella del Vasaio alla brace del Sofista, nella "polifemica" caverna del Mentitore istituzionalizzato (Platone), il "regista" dell’Occidente e dell’intero Pianeta Terra: "Il Dio biblico non è un artigiano (artigiani e artisti erano gli dei creatori del mondo nella mitologia greca) ma un oratore. Crea con la parola."(Franco Lo Piparo).
FISICA, METAFISICA, ED ETICA: NICEA (325 - 2025)?! Dopo la vittoria di Galileo (Keplero: "Vicisti, Galilaee", 1611), il canto alla luna, "alla nuova luna" (Salvatore Quasimodo, 1958 ->Maturità 2023) è, forse, un segnale per cambiare rotta, uscire con Dante dall’inferno, rinascere nell’Infinito (Giacomo Leopardi), e riprendere a comunicare bene, nel giardino terrrestre?!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA: UN "COMPROMESSO STORICO" DI LUNGA DURATA. Il Simbolo Niceno-costantinopolitano, "La pace della fede" ( Cusano, 1453), e Nicea 2025.5 giugno 2023, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA: SPIRITO CRITICO E AMORE CONOSCITIVO...
Alcune considerazioni a margine di una riflessione sul Simbolo Niceno-costantinopolitano (Nicea, 325) o Credo niceno-costantinopolitano (Symbolum Nicaenum Costantinopolitanum):
- "4 GIUGNO 2023. SS. TRINITÀ. PER UNA CRITICA E UNA CELEBRAZIONE DELLA DOTTRINA TRINITARIA". [...] Il Simbolo Niceno dice che il Figlio è «generato» dal Padre, utilizzando un lessico biologico («generato, non creato») che solo l’esperienza concreta della vita naturale può rendere comprensibile. Ma sul piano biologico non c’è paternità e non c’è generazione senza un elemento femminile che riceva l’azione paterna, fungendo poi da «matrice» della prole (l’elemento materno è passivo nell’essere fecondato, e attivo nel mettere alla luce).
 Di questo elemento per così dire femminile, indispensabile alla semantica del Padre e del Figlio, nella teologia trinitaria non SEMBRA esserci traccia (non è lo Spirito a svolgere questa funzione). Non a caso la metafisica idealistica, cripto-teologica, tenterà di uscire dall’impasse eliminando il lessico «parentale» e sostituendolo con un lessico «neutro»: l’Io pone nell’Io un Non-io eccetera (Fichte). Uno-due-tre. Un lessico «principiale» che aggira e sterilizza, con quel «porre» («setzen»), l’ostacolo insormontabile della «generazione» biologica.
Di questo elemento per così dire femminile, indispensabile alla semantica del Padre e del Figlio, nella teologia trinitaria non SEMBRA esserci traccia (non è lo Spirito a svolgere questa funzione). Non a caso la metafisica idealistica, cripto-teologica, tenterà di uscire dall’impasse eliminando il lessico «parentale» e sostituendolo con un lessico «neutro»: l’Io pone nell’Io un Non-io eccetera (Fichte). Uno-due-tre. Un lessico «principiale» che aggira e sterilizza, con quel «porre» («setzen»), l’ostacolo insormontabile della «generazione» biologica.
 Ma è fondamentale quel «sembra». Non si tratta infatti di smontare-decostruire l’idea trinitaria, quanto piuttosto di suggerirne il significato nascosto, nascosto e tuttavia presente in qualche modo nella sua stessa formulazione. Di portare alla luce ciò che la «dottrina» già contiene, e che per qualche ragione rimane fino a un certo punto - in realtà per quasi duemila anni, fino all’estrema consunzione - allo stato di latenza. [...]" (Flavio Piero Cuniberto).
Ma è fondamentale quel «sembra». Non si tratta infatti di smontare-decostruire l’idea trinitaria, quanto piuttosto di suggerirne il significato nascosto, nascosto e tuttavia presente in qualche modo nella sua stessa formulazione. Di portare alla luce ciò che la «dottrina» già contiene, e che per qualche ragione rimane fino a un certo punto - in realtà per quasi duemila anni, fino all’estrema consunzione - allo stato di latenza. [...]" (Flavio Piero Cuniberto).
UN "COMPROMESSO STORICO" DI LUNGA DURATA: LA TRAGEDIA. La grande instaurazione "olimpica", con le parole di Atena, parla chiara e tondo: «non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (Eschilo, Eumenidi).
DIVINA COMMEDIA (DANTE 2021). LA SCOPERTA DEL LAOCOONTE (1506) E LA MEMORIA DI TROIA (VIRGILIO, "ENEIDE"): LA "SACRA FAMIGLIA" ("TONDO DONI"). Michelangelo, con i suoi profeti e le sue sibille, cosa ha indicato a Firenze (1506-1508), come a Roma (nella Volta della Cappella Sistina, 1508-1512)?
RINASCIMENTO, OGGI: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE" (1996) ... purtroppo da millenni, si preferisce ’navigare’ nel mare della tragica "dotta ignoranza" (Niccolò Cusano), e seguire ancora la rotta del "sapiente" Bovillus, con la sua "piramide" androcentrica (cfr. Stefano Mancuso - AlessandraViola, "Verde brillante", Giunti 2013, p. 19)!!!
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)?!
- "4 GIUGNO 2023. SS. TRINITÀ. PER UNA CRITICA E UNA CELEBRAZIONE DELLA DOTTRINA TRINITARIA". [...] Il Simbolo Niceno dice che il Figlio è «generato» dal Padre, utilizzando un lessico biologico («generato, non creato») che solo l’esperienza concreta della vita naturale può rendere comprensibile. Ma sul piano biologico non c’è paternità e non c’è generazione senza un elemento femminile che riceva l’azione paterna, fungendo poi da «matrice» della prole (l’elemento materno è passivo nell’essere fecondato, e attivo nel mettere alla luce).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- COSMOTEANDRIA DEL XXI SECOLO. APPUNTI PER IL CONGRESSO MONDIALE DI FILOSOFIA ROMA 2024. TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA16 marzo 2023, di Federico La Sala
COSMOTEANDRIA DEL XXI SECOLO: IL MONDO COME VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE DELL’UOMO SUPREMO.
- ANTROPOLOGIA FILOSOFICA E VITA FUORI DALLA BILANCIA" ("LIFE OUT OF BALANCE").
- APPUNTI PER IL CONGRESSO MONDIALE DI FILOSOFIA ROMA 2024.
- TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA, PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA.
- In memoria di Immanuel #Kant...
PIANETA TERRA:
RIPENSARE COSTANTINO.
DOPO 1700 ANNI DAL PRIMO CONCILIO DI NICEA (325), DI "QUALE" ECUMENISMO, LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA E L’INTERA EUROPA (LAICA E RELIGIOSA) VUOLE FARE MEMORIA?
A) - NICEA 325. "Il concilio di Nicea, tenutosi nel 325, è stato il primo concilio ecumenico cristiano. Venne convocato e presieduto dall’imperatore #Costantino I, il quale intendeva ristabilire la pace religiosa e raggiungere l’unità dogmatica, minata da varie dispute, in particolare sull’arianesimo; il suo intento era anche politico, dal momento che i forti contrasti tra i cristiani indebolivano anche la società e, con essa, lo Stato romano. Con queste premesse, il concilio ebbe inizio il 20 maggio del 325. Data la posizione geografica di Nicea, la maggior parte dei vescovi partecipanti proveniva dalla parte orientale dell’Impero. [...]".
B) STORIA #STORIOGRAFIA ED ECUMENISMO: QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("CRISTOLOGICA") E ASSEDIO DI COSTANTINOPOLI (1453). Riprendendo il filo dalla "Dotta Ignoranza" (Niccolò Cusano, 1440), la "Donazione di Costantino" (Lorenzo Valla, 1440), e dalla caduta di Costantinopoli (1453) e il fallimento della proposta "cristologica" del "De pace fidei" (N. Cusano, "La pace della fede", 1453), non è forse tempo di corre ai ripari, di ristrutturare il campo e riequilibrare la bilancia antropologica e teologica?!
C) BILANCIA DELLA COSTITUZIONE, BILANCIA DELL’ETICA, E PACE PERPETUA. Una "foto" per riflettere non solo l’8 marzo 2023, ma anche l’ 8 marzo 2025...
#Earthrise #Metaphysics #Anthropology #Theology #Cosmology #InternationalWomensDay #Eleusis2023 #Roma2024
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE (2005). ---- Ricapitolazione e Costituzione: Unrgenza di uscire dalla narrazione cosmoteandrica della tradizione platonica.12 marzo 2023, di Federico La Sala
UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA DI "RICAPITOLAZIONE", SECONDO UMANITÀ ("ECCE HOMO"), NON SECONDO VIRILITÀ ("ECCE VIR"), E L’URGENZA DI USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA #COSMOTEANDRIA DELLA TRADIZIONE PLATONICA.
- UN #AUGURIO DI GRANDE #BUONLAVORO A PAPA FRANCESCO E A TUTTA LA CHIESA.
Una nota a margine dell’intervista, di Francesco Antonio Grana, apparsa su "il fatto quotidiano" (12 marzo 2023):
- "[...] Cosa si augura per la Chiesa?
- La Chiesa deve uscire, deve stare in mezzo alla gente. Penso a don Tonino Bello, un grande vescovo pugliese che stava in mezzo al suo popolo e ha lottato con tutte le sue forze per la pace. Un uomo non compreso nel suo tempo perché era molto avanti. Lo si sta riscoprendo oggi. Un profeta! È già venerabile ed è in cammino verso la beatificazione. Recentemente, hanno ripreso in una canzone anche una sua celebre frase: “Noi siamo angeli con un’ala sola. Per volare, abbiamo bisogno di restare abbracciati al fratello, cui prestiamo la nostra ala e da cui prendiamo l’altra ala, necessaria per volare”. Nessuno si salva da solo. Lo abbiamo visto anche con la pandemia. Sogno una Chiesa senza clericalismo. Lo diceva il cardinale Henri-Marie de Lubac nel suo celebre testo Méditation sur l’Église dove, per dire qual è la cosa più brutta che può accadere alla Chiesa, scriveva che la mondanità spirituale, che si traduce nel clericalismo di un prete, “sarebbe infinitamente più disastrosa di ogni mondanità semplicemente morale”. Il clericalismo è la cosa più brutta che possa accadere alla Chiesa, peggio ancora che ai tempi dei papi corrotti. Un prete, un vescovo o un cardinale che si ammalano di clericalismo fanno molto male alla Chiesa. È una malattia molto contagiosa. Ancora peggiori sono i laici clericalizzati: sono una peste nella Chiesa. Il laico deve essere laico." (Intervista, cit.).
***
MEMORIA E PROFEZIA. Considerando e accogliendo nel suo massimo valore la dichiarazione di Papa Francesco relativa a don Tonino Bello, "Lo si sta riscoprendo oggi. Un profeta!", forse, è cosa buona riconsiderare l’affermazione e mettere l’accento sull’appellativo "un #profeta".
Se non si vuole lasciar cadere il filo, bisogna, a mio parere, tornare, prima, nella Roma del XVI secolo, e poi tornare, nella Città del Vaticano del XXI secolo, nella #CappellaSistina, guardare in alto, e #apriregliocchi alla presenza delle #Sibille e dei #Profeti nella Volta, che camminano insieme nella storia della tradizione ebraica e della tradizione degli altri popoli, e, sulle basi delle indicazioni di #Michelangelo, riprendere il cammino, #oggi.
"LA SACRA FAMIGLIA". Già nel #TondoDoni, senza trascurare la #cornicelignea (con la testa di Cristo in alto, e con ai lati le teste di #due Sibille e due Profeti), è data la chiave di lettura della narrazione nella Volta della Cappella Sistina (sul filo della lezione del #presepe di Francesco d’Assisi e dei "#dueSoli" di #Dante), al di là di ogni #ricapitolazione androcentrica (da "dotta ignoranza" socratico-platonica): Michelangelo, come si sa, è stato anche un grande #anatomista. Che dire? Non è ora di cambiare #paradigma e uscire dall’#infernoepistemologico?! Se non ora, quando?!
#FILOLOGIA E #STORIA. Nella scheda della Galleria degli Uffizi, si scrive che nella cornice lignea sono "raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti".
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- "L’ISTINTO DI NARRARE. COME LE STORIE CI HANNO RESO UMANI" E "IL LATO OSCURO DELLE STORIE": "ILLUMINISMO ADESSO" (S. PINKER).20 febbraio 2023, di Federico La Sala
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana" (Federico La Sala, 2008). **
- "Illuminismo adesso. In difesa della ragione, della scienza, dell’umanesimo e del progresso (in inglese: Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress) è un libro scritto dallo scienziato cognitivo canadese Steven Pinker e pubblicato nel 2018, tradotto in Italia nel medesimo anno da Mondadori (...) (Wikipedia).
JONATHAN GOTTSCHALL
L’ISTINTO DI NARRARE
 COME LE STORIE CI HANNO RESO UMANI
COME LE STORIE CI HANNO RESO UMANI
 Traduzione di Giuliana Maria Olivero *
Traduzione di Giuliana Maria Olivero *L’uomo passa più tempo immerso in un universo di finzione che nel mondo reale. Nessun altro animale dipende dalla narrazione quanto l’essere umano, lo «storytelling animal». Questo strano comportamento, che ci porta a mettere al centro della nostra esistenza cose che non esistono, è innato e antichissimo. -Ma a che scopo? Jonathan Gottschall studia la narrazione da molti punti di vista e si muove tra biologia, psicologia, neuroscienze e letteratura, appoggiandosi alle ricerche più avanzate, ed evoca i tangibili vantaggi del mondo fantastico. Raccontando storie i bambini imparano a gestire i rapporti sociali; con le fantasie a occhi aperti esploriamo mondi alternativi che sarebbe troppo rischioso vivere in prima persona, ma che risulteranno utilissimi nella vita reale; nei romanzi e nei film cementiamo una morale comune che permette alla società di funzionare.
 Il potere universale della finzione è probabilmente la nostra caratteristica più distintiva, il segreto del nostro successo evolutivo, ciò che ha reso l’uomo un animale diverso dagli altri, permettendo a lui solo di vivere contemporaneamente molte vite, accumulare esperienze diverse e costruire il proprio mondo con l’incanto dell’invenzione.
Il potere universale della finzione è probabilmente la nostra caratteristica più distintiva, il segreto del nostro successo evolutivo, ciò che ha reso l’uomo un animale diverso dagli altri, permettendo a lui solo di vivere contemporaneamente molte vite, accumulare esperienze diverse e costruire il proprio mondo con l’incanto dell’invenzione.* Scheda editoriale: Bollati Boringhieri, 2018 - 13,00 €, 256 PAGINE
JONATHAN GOTTSCHALL
IL LATO OSCURO DELLE STORIE.
 COME LO STORYTELLING CEMENTA LE SOCIETÀ E TALVOLTA LE DISTRUGGE
COME LO STORYTELLING CEMENTA LE SOCIETÀ E TALVOLTA LE DISTRUGGE
 Traduzione di Giuliana Olivero *
Traduzione di Giuliana Olivero *- «Jonathan Gottschall non è solo il più profondo pensatore in circolazione sul potente ruolo delle storie nelle nostre vite, ma è anche uno scrittore vivace e spiritoso. Il lato oscuro delle storie offre molte intuizioni e molti piaceri».
- Steven Pinker, Harvard University, autore di "Illuminismo adesso" e "Razionalità". **
L’essere umano è l’animale che racconta storie. Jonathan Gottschall ha usato questa fortunata metafora in L’istinto di narrare, descrivendo magistralmente quell’ecosistema di finzione narrativa nel quale siamo immersi e che caratterizza in maniera così peculiare la nostra specie. Le storie creano la struttura delle nostre società, fanno vivere a ogni persona migliaia di vite, preparano i bambini alla vita adulta e formano i legami che ci consentono di convivere in pace.
 Ma tutto questo ha un lato oscuro che non possiamo più ignorare: le storie potrebbero anche essere la causa della nostra distruzione.
Ma tutto questo ha un lato oscuro che non possiamo più ignorare: le storie potrebbero anche essere la causa della nostra distruzione.
 Con questo libro Jonathan Gottschall torna sul tema della narrazione con tutto il bagaglio interdisciplinare delle sue conoscenze, attingendo alla psicologia, alla scienza della comunicazione, alle neuroscienze e alla letteratura per raccontarci fino a che punto le storie siano in grado di influenzare il nostro cervello e le nostre vite. E non sempre per il meglio.
Con questo libro Jonathan Gottschall torna sul tema della narrazione con tutto il bagaglio interdisciplinare delle sue conoscenze, attingendo alla psicologia, alla scienza della comunicazione, alle neuroscienze e alla letteratura per raccontarci fino a che punto le storie siano in grado di influenzare il nostro cervello e le nostre vite. E non sempre per il meglio.
 La narrazione ha agito nel corso della storia come collante delle società, certo, ma è anche la forza principale che disgrega le comunità: è il metodo più efficace che abbiamo per manipolare il prossimo eludendo il pensiero razionale. Dietro i più grandi mali della civiltà - il disastro ambientale, la demagogia, il rifiuto irrazionale della scienza, le guerre - c’è sempre una storia che confonde le menti. Le nuove tecnologie amplificano gli effetti delle campagne di disinformazione, e le teorie del complotto e le fake news rendono quasi impossibile distinguere i fatti dalla finzione, per cui la domanda che dobbiamo porci urgentemente è: «come potremo salvare il mondo dalle storie?».
La narrazione ha agito nel corso della storia come collante delle società, certo, ma è anche la forza principale che disgrega le comunità: è il metodo più efficace che abbiamo per manipolare il prossimo eludendo il pensiero razionale. Dietro i più grandi mali della civiltà - il disastro ambientale, la demagogia, il rifiuto irrazionale della scienza, le guerre - c’è sempre una storia che confonde le menti. Le nuove tecnologie amplificano gli effetti delle campagne di disinformazione, e le teorie del complotto e le fake news rendono quasi impossibile distinguere i fatti dalla finzione, per cui la domanda che dobbiamo porci urgentemente è: «come potremo salvare il mondo dalle storie?».* Scheda editoriale: Bollati Boringhieri, 2022 - 24,00 €, 274 PAGINE
**
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- LETTERATURA, FILOLOGIA, E STORIOGRAFIA: DANTE, LA DONAZIONE DI COSTANTINO, NICCOLO’ TOMMASEO, E GIACOMO LEOPARDI.11 febbraio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIOGRAFIA. OGGI (11 FEBBRAIO 2023).
- GIACOMO LEOPARDI, DANTE, LA DONAZIONE DI COSTANTINO, E NICCOLO’ TOMMASEO.
- Una nota in memoria di Lorenzo Valla e del suo "famoso" capolavoro (("La falsa Donazione di Costantino", 1440).
EUROPA 2023. Nella ricorrenza della giornata della firma dei PATTI LATERANENSI (11 Febbraio 1929), brillante la ripresa da parte del Centro documentazione Piero Delfino Pesce di questo articolo di Luca Mazzocchetti, dedicato a "Quella volta che Leopardi decise di arrabbiarsi ..." ("Terza web", 24 Novembre 2016).
DANTE 2021 E LA #MONARCHIA DEI "DUE SOLI". Al di là della polemica "personale" e "momentanea", nell’epigramma contro Niccolò #Tommaseo dell’agosto del 1836, ("poi però non reso pubblico" e poco conosciuto), nel richiamo al dantesco "Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre...", emerge con forza tutta la tempra eroica di Giacomo Leopardi e la sua consonanza con lo #spirito di #DanteAlighieri critico del potere temporale dei Papi e, anche e ancora, la sua #indignazione contro tutta la sudditanza della intera cultura italiana alla lettura storiografica tradizionale.
Giacomo Leopardi studioso di Dante Alighieri
Tra le pagine dello «Zibaldone» poesia filologica e fraterno incanto
di RITA ITALIANO (La Stampa, 22 Gennaio 2021
In occasione del suo celebrato anniversario si può anche cercare e trovare Dante in uno scrigno tra i più preziosi che il pensiero umano abbia mai offerto, lo «Zibaldone» di Giacomo Leopardi. Basta scorrere le occorrenze del nome di Dante Alighieri in quelle pagine accurate ed emozionanti, per schiudere le porte di un magico regno nel quale il rigore dell’analisi critica viaggia alle altitudini del genio. La lettura data da Giacomo Leopardi si fa poesia filologica, fraterno incanto.
 Originalissimo esame che della produzione di Dante registra il carattere, lo stile, la lingua, l’interesse per la filosofia, giungendo sino a cogliere le qualità peculiari de «La Divina Commedia». Scegliendo di soffermarsi attento soprattutto sulla rivoluzione linguistica che in questa è evidente. E illustrando le motivazioni che animarono il suo autore: «ebbe intenzione scrivendo, di applicar la lingua italiana alla letteratura. Il che si fa manifesto sì dal poema sacro, ch’egli considerava, non come trastullo, ma come impresa di gran momento».
Originalissimo esame che della produzione di Dante registra il carattere, lo stile, la lingua, l’interesse per la filosofia, giungendo sino a cogliere le qualità peculiari de «La Divina Commedia». Scegliendo di soffermarsi attento soprattutto sulla rivoluzione linguistica che in questa è evidente. E illustrando le motivazioni che animarono il suo autore: «ebbe intenzione scrivendo, di applicar la lingua italiana alla letteratura. Il che si fa manifesto sì dal poema sacro, ch’egli considerava, non come trastullo, ma come impresa di gran momento».
 Da tale svolta si avvia la possibilità di definire Dante «quasi il primo scrittore italiano». È infatti proprio il modo del tutto nuovo che egli ha dato al suo operare che ha avuto per conseguenza non dappoco d’essere «propriamente, com’è stato sempre considerato, e per intenzione e per effetto, il fondatore della lingua italiana». Inoltre, la disamina di Leopardi giudica che nel lavoro di Dante anche lo stile sia assai meritevole di ammirazione. A questo nodo dedica uno spazio di rilievo.
Da tale svolta si avvia la possibilità di definire Dante «quasi il primo scrittore italiano». È infatti proprio il modo del tutto nuovo che egli ha dato al suo operare che ha avuto per conseguenza non dappoco d’essere «propriamente, com’è stato sempre considerato, e per intenzione e per effetto, il fondatore della lingua italiana». Inoltre, la disamina di Leopardi giudica che nel lavoro di Dante anche lo stile sia assai meritevole di ammirazione. A questo nodo dedica uno spazio di rilievo.
 Con righe illuminanti. Si chiede: «Perché lo stile di Dante è il più forte che mai si possa concepire, e per questa parte il più bello e dilettevole possibile?» La risposta spiega con semplicità: «perché ogni parola presso lui è un’immagine». A Ovidio «bisogna una pagina per farci veder quello che Dante ci fa vedere in una terzina». E se «Ovidio descrive» e «Virgilio dipinge», è solo Dante che «non solo dipinge da maestro in due colpi, e vi fa una figura con un tratto di pennello; non solo dipinge senza descrivere [...] ma intaglia e scolpisce dinanzi agli occhi del lettore le proprie idee, concetti, immagini, sentimenti».
Con righe illuminanti. Si chiede: «Perché lo stile di Dante è il più forte che mai si possa concepire, e per questa parte il più bello e dilettevole possibile?» La risposta spiega con semplicità: «perché ogni parola presso lui è un’immagine». A Ovidio «bisogna una pagina per farci veder quello che Dante ci fa vedere in una terzina». E se «Ovidio descrive» e «Virgilio dipinge», è solo Dante che «non solo dipinge da maestro in due colpi, e vi fa una figura con un tratto di pennello; non solo dipinge senza descrivere [...] ma intaglia e scolpisce dinanzi agli occhi del lettore le proprie idee, concetti, immagini, sentimenti».Leopardi si sente forse prossimo a Dante Alighieri, ch’era autore e uomo dal temperamento «grave, passionato, ordinariamente (ai nostri tempi) malinconico, profondo nel sentimento e nelle passioni, e tutto proprio a soffrir grandemente della vita». Una sensibilità difficile e rara, in grado di infondere lo spirito della Storia nel mistero della dottrina. Infatti «il suo poema non è epico, ed è misto di narrativo e di dottrinale, morale». È sapere che diventa sapienza.
 Leopardi annota: «Omero e Dante per l’età loro seppero moltissime cose, e più di quelle che sappiano la massima parte degli uomini colti d’oggidì». Ma non basta. È chiaro che per la propria espressione poetica, tessuta alle vette più alte dell’arte compositiva, occorrevano a Dante, combinate e inestricabili, la rivoluzione dello stile e quella della lingua. Di quest’ultima Leopardi attesta l’enorme valore. Perché «Dante fra gli altri antichi aveva introdotto subito nel quasi creare la nostra lingua, la facoltà, il coraggio, ed anche l’ardire de’ composti» e aveva fatto «espressa professione di non voler restringere la lingua a veruna o città o provincia d’Italia, e per lingua cortigiana l’Alighieri, dichiarandosi di adottarla, intese una lingua altrettanto varia, quante erano le corti e le repubbliche e governi d’Italia in que’ tempi». La scrittura di Dante è ricca, screziata. La conoscenza che Leopardi ne ha, gli consente di parlarne senza esitazioni. «Dante è pieno di barbarismi, cioè di maniere e voci tolte non solo dal latino, ma dall’altre lingue o dialetti ch’avevano una tal qual dimestichezza o commercio colla nostra nazione».
Leopardi annota: «Omero e Dante per l’età loro seppero moltissime cose, e più di quelle che sappiano la massima parte degli uomini colti d’oggidì». Ma non basta. È chiaro che per la propria espressione poetica, tessuta alle vette più alte dell’arte compositiva, occorrevano a Dante, combinate e inestricabili, la rivoluzione dello stile e quella della lingua. Di quest’ultima Leopardi attesta l’enorme valore. Perché «Dante fra gli altri antichi aveva introdotto subito nel quasi creare la nostra lingua, la facoltà, il coraggio, ed anche l’ardire de’ composti» e aveva fatto «espressa professione di non voler restringere la lingua a veruna o città o provincia d’Italia, e per lingua cortigiana l’Alighieri, dichiarandosi di adottarla, intese una lingua altrettanto varia, quante erano le corti e le repubbliche e governi d’Italia in que’ tempi». La scrittura di Dante è ricca, screziata. La conoscenza che Leopardi ne ha, gli consente di parlarne senza esitazioni. «Dante è pieno di barbarismi, cioè di maniere e voci tolte non solo dal latino, ma dall’altre lingue o dialetti ch’avevano una tal qual dimestichezza o commercio colla nostra nazione».Leopardi spazia e approfondisce. Riconosce a Dante meriti che vivono nella letteratura e ne superano i confini, entrando nella Storia. Ricorda «quanto debbano a Dante, non pur la lingua italiana, come si suol predicare, ma la nazione istessa, e l’Europa tutta e lo spirito umano». Da qui l’attribuzione che a Dante spetta del serto d’alloro di un vero primato: «ardì concepire e scrisse un’opera classica e di letteratura in lingua volgare e moderna». Impresa temeraria e suprema che eleva «una lingua moderna al grado di lingua illustre» a dispetto dell’opinione corrente che sino a quel momento aveva ritenuto la lingua latina «unica capace di tal grado».
 Leopardi indaga la natura della «Commedia», vera pietra miliare della letteratura, e afferma che «non fu solo poetica, ma come i poemi d’Omero, abbracciò espressamente tutto il sapere di quella età, in teologia, filosofia, politica, storia, mitologia ecc». Classica da subito e per sempre: «non rispetto solamente a quel tempo, ma a tutti i tempi, e tra le primarie; né solo rispetto all’Italia ma a tutte le nazioni e letterature». Il passo di Dante in questo senso è stato dunque quello di un pioniere. La sua è stata la marcia risoluta di un apripista. In sostanza, «Dante diede l’esempio, aprì e spianò la strada, mostrò lo scopo, fece coraggio e col suo ardire e colla sua riuscita agl’italiani: l’Italia alle altre nazioni. Questo è incontrastabile».
Leopardi indaga la natura della «Commedia», vera pietra miliare della letteratura, e afferma che «non fu solo poetica, ma come i poemi d’Omero, abbracciò espressamente tutto il sapere di quella età, in teologia, filosofia, politica, storia, mitologia ecc». Classica da subito e per sempre: «non rispetto solamente a quel tempo, ma a tutti i tempi, e tra le primarie; né solo rispetto all’Italia ma a tutte le nazioni e letterature». Il passo di Dante in questo senso è stato dunque quello di un pioniere. La sua è stata la marcia risoluta di un apripista. In sostanza, «Dante diede l’esempio, aprì e spianò la strada, mostrò lo scopo, fece coraggio e col suo ardire e colla sua riuscita agl’italiani: l’Italia alle altre nazioni. Questo è incontrastabile».
 Nel prosieguo, lo studio condotto da Leopardi giunge a rimarcare quanta applicazione e quanta ponderazione stessero dietro al rivolgimento dantesco, «né il fatto di Dante fu casuale e non derivato da ragione e riflessione, e profonda riflessione. Egli volle espressamente sostituire una lingua moderna illustre alla lingua latina». Sentiva che i tempi erano ormai maturi, e che anzi esigevano la radicalità di un cambiamento di questa portata. Perciò «volle espressamente bandita la lingua latina dall’uso de’ letterati, de’ dotti, de’ legislatori, notari, ecc., come non più convenevole ai tempi». Un atto di grande perspicacia e ponderazione dal quale venne lo splendido frutto che nelle sue terzine custodisce, tra l’altro, la prova d’eccellenza della risolutezza encomiabile con la quale il poeta Dante Alighieri derivò i propri principi di stile «da proposito e istituto, e mirò ad uno scopo; e il proposito, l’istituto e lo scopo» furono quelli di un «acutissimo, profondissimo e sapientissimo filosofo».
Nel prosieguo, lo studio condotto da Leopardi giunge a rimarcare quanta applicazione e quanta ponderazione stessero dietro al rivolgimento dantesco, «né il fatto di Dante fu casuale e non derivato da ragione e riflessione, e profonda riflessione. Egli volle espressamente sostituire una lingua moderna illustre alla lingua latina». Sentiva che i tempi erano ormai maturi, e che anzi esigevano la radicalità di un cambiamento di questa portata. Perciò «volle espressamente bandita la lingua latina dall’uso de’ letterati, de’ dotti, de’ legislatori, notari, ecc., come non più convenevole ai tempi». Un atto di grande perspicacia e ponderazione dal quale venne lo splendido frutto che nelle sue terzine custodisce, tra l’altro, la prova d’eccellenza della risolutezza encomiabile con la quale il poeta Dante Alighieri derivò i propri principi di stile «da proposito e istituto, e mirò ad uno scopo; e il proposito, l’istituto e lo scopo» furono quelli di un «acutissimo, profondissimo e sapientissimo filosofo». -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA E ANATOMIA: IL PROBLEMA SOCRATE E IL RICORDO DI DIOTIMA (LA SACERDOTESSA DI MANTINEA).8 febbraio 2023, di Federico La Sala
EUROPA, FILOSOFIA, ED ELEUSIS 2023:
- IL PROBLEMA SOCRATE E IL RICORDO DI DIOTIMA (LA SACERDOTESSA DI MANTINEA).
METAPHYSICS ANTHROPOLOGY PSYCHOANALYS: APRIRE GLI OCCHI SUL SOCRATICO AMORE "CONVIVIALE" (EROS = CUPIDO), SUL DESIDERIO CIECO E VIOLENTO, E PORTARSI CON FREUD, FUORI DAL DISAGIO NELLA CIVILTA’, OLTRE LO STADIO DELLO SPECCHIO DEL TRAGICO PLATONISMO E PAOLINISMO ...
"SAPERE AUDE!". RICORDANDO, CON IL VENOSINO ORAZIO, LE INDICAZIONI DI KANT sul "coraggio di servirsi della propria intelligenza" e sulla necessità di reinterrogarsi sull’intero sapere, ripartendo dalla antropologia, dalla questione antropologica, forse, è il tempo opportuno uscire dal profondissimo letargo (Dante contava XXV secoli di sonno dogmatico) e re-interrogarsi non solo su "come nascono i sogni" e su "come nascono le idee", ma anche, e innanzitutto, come nascono i bambini, e soprattutto non continuare a ripetere vecchi e tragici ritornelli sull’amore di Platone: è una questione di filologia e di teologia-politica (Lorenzo Valla, "La falsa Donazione di Costantino", 1440).
"IL CREPUSCOLO DEGLI IDOLI" (NIETZSCHE). LA ’RISPOSTA’ DI DIOTIMA A SOCRATE: "Caro Socrate, tu sei come Eros - figlio di Ingegno (a sua voìta figlio di Metis. I’intelligenza astuta) e di Povertà - un perfetto #filosofo, perché non sei sapiente come gli dèi né del tutto ignorante come i comuni mortali: sei solo consapevole della tua ignoranza, ma tu sei cieco, cieco e brutto come un ... ciclope. Tu sai che non sai amare e vai in cerca di chi sa amare. Ma tu, caro Socrate. non capisci proprio nulla, né degli uornini, né delle donne. e neppure degli dei: tu sei solo cupìdo (un cieco saettante, avido e vioÌento). Come la rìsposta della Pizia, così la risposta di Diotima: eglì non capisce e va avanti ... a costringere chi ’solo il dio sa’ deve partorire. [...]" (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Roma 1991, p. 184).
CADUTA NELLA CAVERNA PLATONICA E COSMOTEANDRIA. Se non ci si sveglia e si continua a contrabbandare l’andrologia tragica di Socrate e Platone per antropologia e, dall’alto della "dotta ignoranza" (Niccolò Cusano,1440) dell’anatomia e della medicina, si spaccia #Vir per #Homo, dove si pensa di andare, se non all’inferno?!
ANATOMIA, ANTROPOLOGIA, E STORIOGRAFIA. Se si vuole ricominciare umana-mente e riprendere il cammino della rivoluzione copernicana e scientifica, bisogna ripartire quantomeno dalla sapienza di Michelangelo (riprendere il cammIno dei profeti e delle sibille del #TondoDoni, rilanciato alla grande nella narrazione della Volta della Cappella Sistina) e, poi, proseguire seguendo le lezioni di anatomia e di medicina di Realdo Colombo e, infine, leggendo il capitolo 15 del Libro III dell’ Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli della Donna” (p. 91).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- IL RICORDO DI DIOTIMA (LA SACERDOTESSA DI MANTINEA) E IL "CATTOLICESIMO" PLATONICO: IL PROGRAMMA DI DANTE ALIGHIERI E I PROFETI E LE SIBILLE DI MICHELANGELO.17 marzo 2024, di Federico La Sala
USCIRE DALL’#INFERNO DELLA #RIPETIZIONE E DAL #LETARGO DI MILLENNI (Par. XXX, III, 94).
 Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...
Storia, filosofia, filologia, #psicoanalisi: una nota su una "ignota" #svolta_antropologica in corso...IL PROGRAMMA DI #DANTEALIGHIERI ALL’ORDINE DEL GIORNO (#25MARZO 2024: #Dantedì).
Riprendere il cammino di "#Ulisse" e portarsi oltre il "Convivio", il #Simposio, di #Platone e del suo "socratico" #amore (#Eros), avido e cupìdo, #figlio nato dalla astuta alleanza (#Metis) dell’#uomo-#Ingegno (gr. #Poros) e della #donna-#Povertà (gr. #Penia). La lezione di Platone appare essere la chiara codificazione di una fenomenologia dello spirito della #tragedia e la sua parola una versione della #Legge del #Figlio di Dio (#Zeus) , #Apollo: "«non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (#Eschilo, #Eumenidi, 657 ss.): : un ’#cattolicesimo’ platonico.
- STORIAELETTERATURA, #FILOLOGIA E #CRITICA: #DIVINACOMMEDIA. Gianfranco #Contini: «[...] L’impressione genuina del postero, incontrandosi in Dante, non è d’imbattersi in un tenace e ben conservato sopravvissuto, ma di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui» (cfr. "Un’interpretazione di Dante", in Id., G. Contini, "Un’idea di Dante. Saggi danteschi", Torino, Einaudi, 2001, I ed. 1970, pp. 110-11).
ARTE, #ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA E #TEOLOGIA:
- MICHELANGELO BUONARROTI, I PROFETI E LE SIBILLE.
LA "STORICA" #LEZIONE ANTROPOLOGICA DELLA #CORNICE LIGNEA DEL #TONDODONI (E DELLA #NARRAZIONE DELLA #VOLTA DELLA #CAPPELLASISTINA: DUE PROFETI E #DUE SIBILLE "INDICANO" LO #SPAZIOTEMPO DELLA #NASCITA DEL #FIGLIO DI #MARIAEGIUSEPPE. Come mai gli esperti della #GalleriadegliUffizi "insistono" a sostenere che nella "cornice del Tondo [...] sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti"?!
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- ELEUSIS 2023: LA FATTORIA DI PLATONE, IL PIFFERAIO ALGORITMICO, E L’ ARCHEOLOGIA FILOSOFICA.28 gennaio 2023, di Federico La Sala
LA FATTORIA DI PLATONE, IL PIFFERAIO ALGORITMICO, E L’ ARCHEOLOGIA FILOSOFICA:
- TRACCE PER UNA SVOLTA_ANTROPOLOGICA.
- Una nota a margine di un lavoro del 1991 (*)
#STORIA E #MEMORIA. Al #tramonto dell’#Occidente e alla #fine della #storia, qualche musicista constata amaramente che oggi la più bella delle arie d’opera viene utilizzata per #pubblicizzare un profumo. Verissimo, ma questo cosa significa? Non è una "bellissima" realizzazione storica dello #Stato sognato dal pitagorico Platone, quello della famosa teoria del #re filosofo (#sofista) e del filosofo (sofista) re?
#FILOLOGIA E #ANTROPOLOGIA. Le #Muse, le #Grazie, le #Sibille, dove sono?! Non sono state rapite come #Persefone da #Plutone e sono tutte rinchiuse nel #Circo (della buon’anima) della #Moira di #Orfeo? Dov’è Diotima, dove Arianna? Non è ora di cambiare musica e uscire dall’Inferno (Dante 2021)?! Se non ora, quando?!
#Eleusis2023 #Earthrise
(*) La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- FILOLOGIA, FILOSOFIA, E COMMEDIA: UN LETARGO PROFONDO E IL "CREPUSCOLO DEGLI IDOLI".27 gennaio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA FILOSOFIA STORIA E DIVINA COMMEDIA (DANTE 2021):
QUANTE "NUVOLE" NEL CIELO DELLA "REPUBBLICA"!
UN LETARGO TEOLOGICO-POLITICO ANTROPOLOGICO E COSTITUZIONALE PROFONDO ha mandato in collasso tutte le istituzioni culturali e politiche di tutte le #Città.
Nelle #Università e nelle #Accademie laiche e devote si insegna ancora a credere che #Aristofane scherzasse su #Socrate! #Nietzsche ("#Crepuscolo degli #idoli") aveva ragione: la #filosofia del suo allievo #Platone contiene il segreto sul come rendere forte il discorso debole e debole il discorso forte, e sul come realizzare il #sogno del #sofista #re: egli ha truccato le "regole del gioco" dell’#Occidente e ha insegnato a una "parte" della intera umanità a come mettersi al di sopra di tutte le "parti", a un "partito" come mettersi al di sopra di tutti i "partiti", e a come imporre le proprie "olimpiche" demiurgiche "#Leggi" su tutta la #Fattoria! Un colpodistato più che millenario - al capolinea... #Giornatadellamemoria, #27gennaio 2023.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- MEMORIA DEL CONTE DI ORGAZ (1323 - 2023): DOPO LA RIFORMA PROTESTANTE (1517), IL CONCILIO DI TRENTO (1545-1563) E LA BATTAGLIA DI LEPANTO (1571), UNA ALLEANZA "CATTOLICISSIMA" TRA ALTARE E TRONO.24 gennaio 2023, di Federico La Sala
ARTE STORIA E STORIOGRAFIA:
NELL’EUROPA DEL XVI SECOLO, DOPO LA RIFORMA PROTESTANTE (1517), IL CONCILIO DI TRENTO (1545-1563) E LA BATTAGLIA DI LEPANTO (1571), UNA ALLEANZA "CATTOLICISSIMA" TRA ALTARE E TRONO:
a) FILIPPO II, ALLA VIGILIA DELL’ATTACCO ALL’INGHILTERRA, VIENE "IMMORTALATO" NELLA CERIMONIA FUNEBRE DELLA ARTISTICA CELEBRAZIONE DELLA "SEPOLTURA DEL CONTE DI ORGAZ" DA EL GRECO (TOLEDO 1586-1588).
b) QUADRO INGLESE DELLA CELEBRAZIONE DELLA DISFATTA DELLA FLOTTA SPAGNOLA NEL1588. "Il cosiddetto Ritratto dell’Armada, dipinto dopo il 1588 per commemorare la disfatta dell’Invincibile Armata. Elisabetta tiene la mano sul globo, simbolo di autorità, mentre sullo sfondo è raffigurato l’evento."
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- TOLEDO E LA MORTE DI D. GONZALO RUIZ DI TOLEDO, "SEÑOR DE ORGAZ (1323-2023)": "LA SEPOLTURA DEL CONTE DI ORGAZ" (1586-1588).23 gennaio 2023, di Federico La Sala
EUROPA 2023: ARTE, STORIA, ANTROPOLOGIA.
A 700 ANNI DALLA MORTE DI D. GONZALO RUIZ DI TOLEDO, "SEÑOR DE ORGAZ (1323-2023)", UNA BUONA OCCASIONE PER RI-ANALIZZARE E RI-PENSARE L’OPERA DI "EL GRECO": "LA SEPOLTURA DEL CONTE DI ORGAZ" (1586-1588)... E ANCHE IL NASCERE (IN TERRA) E IL RINASCERE (IN TERRA E IN CIELO) - OGGI
NELLA SPAGNA DI FILIPPO II, IN UNA EUROPA, SEGNATA GIA’ DALLA RIFORMA PROTESTANTE (WITTENBERG, 1517), DALLA RIVOLUZIONE DEI "CORPI TERRESTRI" IN ANATOMIA (Realdo Colombo, amico di Michelangelo Buonarroti e professore alla Sapienza, 1448; Andrea Vesalio, medico di Carlo V prima e di Filippo II poi, 1553; e Juan Valverde de Hamusco, medico del cardinale Giovanni di Toledo, 1556/1560) E DEI "CORPI CELESTI" IN ASTRONOMIA (Niccolò Copernico, "De revolutionibus orbium coelestium,1543), E, DOPO I LAVORI DEL CONCILIO DI TRENTO (1545-1563), E DOPO GLI ANNI DELLO STRAORDINARIO IMPEGNO RIFORMATORE DI TERESA D’ AVILA (1515-1582), A TOLEDO, NEGLI ANNI 1586-1588, L’ARTISTA DOMENICO THEOTOKOPULOS, DETTO "EL GRECO", PORTA A COMPIMENTO IL SUO CAPOLAVORO.
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- STORIA E LETTERATURA:"AMLETO". LA LEZIONE DI SHAKESPEARE AL "PRINCIPE" DELLA "EUROPA" DI OGGI, NATALE 2022.23 dicembre 2022, di Federico La Sala
L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO. STORIA E LETTERATURA:
"AMLETO", "BABBO NATALE", E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA.
LA LEZIONE DI SHAKESPEARE AL "PRINCIPE" DELLA "EUROPA" DI OGGI, NATALE 2022.
Appunti sul tema...
RIFORMA PROTESTANTE (1517), SCISMA ANGLICANO (1534), E LA SOVRANITA’ RELIGIOSA E POLITICA (1558-1603) DI ELISABETTA: "HAMLET. "REST, REST, PERTURBED SPIRIT" (I.5). "Calma, calma, spirito perturbato": Se si riflette sulla famosa risposta di Amleto alle rivelazioni dello spirito del Padre e Re, che "Il mondo è fuor di sesto" e che "è una sorte maledetta ch’io sia nato per rimetterlo a posto" (I.5), si potrebbe anche pensare che la vicenda di Amleto sia da Shakespeare messa consapevolmente e strategicamente in parallelo con quella evangelica di Gesù ("Padre, se vuoi, allontana da me questo calice!": Lc. 22. 42) e che il suo obiettivo metateatrale sia proprio quello di sollecitare l’intera cultura inglese (ed europea) a procedere a un ripensamento generale della intera questione antropologica e teologico-politica: partire da sé e rimeditare la figura del Padre Re - di "Babbo Natale"!
A CHE GIOCO SI GIOCA, NEL PIANETA "DANIMARCA": IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS O IL LOGO?! L’Arca di Noè o la Fattoria degli Animali?! Qual è il problema istituzionale e costituzionale che Shakespeare in "Amleto" pone ad ogni essere umano? Non è una domanda ("question") radicale quella posta sull’essere e sul non essere e, al contempo, non è un invito a svegliarsi dal sonno dogmatico e a "non lasciare che il letto regale / di Danimarca sia un giaciglio per la lussuria/ e il maledetto incesto" (I.5), cioè a non lasciarsi travolgere dallo spirito della menzogna e del tradimento, ad ogni livello?
L’EUROPA E LA CRISI DEL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO: IL PRESEPE (FRANCESCO D’ASSISI, 1223) LA "MONARCHIA" (DANTE, 1313) E LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453). Alla luce del lavoro di Michelangelo (1475 - 1564) e di Shakespeare (1564-1616), ampliando lo sguardo, forse, oggi è da ammirare e ripensare, la "vertiginosa" consonanza antropologica e teologico-politica che connota l’attività di Teresa d’Avila (1515 - 1582) e di Elisabetta I d’Inghilterra (1533 - 1603): la tradizione costantiniana è decisamente sotto attacco. Tra il Nord e il Sud dell’Europa, alla fine del Cinquecento e agli inizi del Seicento, c’è un’aria di ripresa e rilancio dello spirito dell’ecumenismo francescano e umanistico-rinascimentale (con papa Sisto IV della Rovere, prima, e Giulio II della Rovere, poi) che nella Volta della Cappella Sistina (1512) aveva rivisto profeti e sibille camminare insieme verso una terra e una società di pace e di giustizia: Giordano Bruno (1548-1600) e Tommaso Campanella (1568 - 1639), come si sa, sono gli ultimi alfieri di questo "programma".
 "Il disagio della civiltà" (S. Freud, 1929) e nella civiltà europea e nell’intero pianeta crescerà sempre di più, e, alla fine, si comincia ad ammettere quanto e "come spesso, nel corso della storia, la legge dell’occidente cristiano non sia stata l’imitazione di Gesù Cristo ma bensì l’imitazione dei suoi carnefici. Il corso della storia non è stato influenzato dai santi. Essi hanno agito sui cuori e sulle anime, ma la storia è rimasta criminale" (F. Mauriac, "Le fil de l’homme", 1958).
"Il disagio della civiltà" (S. Freud, 1929) e nella civiltà europea e nell’intero pianeta crescerà sempre di più, e, alla fine, si comincia ad ammettere quanto e "come spesso, nel corso della storia, la legge dell’occidente cristiano non sia stata l’imitazione di Gesù Cristo ma bensì l’imitazione dei suoi carnefici. Il corso della storia non è stato influenzato dai santi. Essi hanno agito sui cuori e sulle anime, ma la storia è rimasta criminale" (F. Mauriac, "Le fil de l’homme", 1958).SHAKESPEARE, SONETTO 116: "L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO".
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- RIPENSARE IL "CONCRETO VIVENTE", A PARTIRE DALLA "OPPOSIZIONE POLARE". La filosofia della pace di Romano Guardini (di Massimo Borghesi).11 dicembre 2022, di Federico La Sala
RIPENSARE IL "CONCRETO VIVENTE" A PARTIRE DALLA "OPPOSIZIONE POLARE" E DALL’USO DI UNA BILANCIA DELL’ESISTENZA ANTROPOLOGICAMENTE NON TRUCCATA NE’ DALL’ASTUZIA DELLLA RAGIONE HEGELIANA NE’ DALLO SPECCHIO DELLA FEDE PAOLINA.
Una indicazione filosofica di #Romano Guardini per ripensare la storia dell’Europa e del Cristianesimo *
La filosofia della pace di Romano Guardini
di Massimo Borghesi (insula europea, 10 dicembre 2022)
C’è un aspetto del pensiero di Romano Guardini (1885-1968) che torna oggi straordinariamente attuale: la sua filosofia della pace. Esattamente quella che difetta oggi al pensiero cattolico contemporaneo che, in buona misura, appare subordinato al manicheismo teologico-politico tornato in auge in relazione al dramma della guerra tra Russia e Ucraina.
A questa filosofia della pace Guardini ha offerto un contributo fondamentale con il suo volume del 1925, Der Gegensatz, dedicato all’opposizione polare. In esso la vita veniva compresa a partire da una serie di polarità opposte che devono mantenersi in tensione tra di loro senza degenerare in contraddizioni escludenti, manichee appunto. L’idea del cattolicesimo come coincidentia oppositorum veniva trasferita, dall’autore, sul piano antropologico, sociale, politico. Il risultato era un pensiero dialogico, con molte analogie con quello coevo di Martin Buber, per il quale la relazioni tra gli uomini e tra gli Stati obbedivano alla legge della coesistenza e del dialogo tra diversi. I pericoli da evitare erano l’uniformità, da un lato, e la contrapposizione frontale, dall’altro. L’unità nella differenza era il metodo che Guardini suggeriva, nel 1925, all’Europa uscita dalla prima guerra mondiale. Un pensiero della pace che troverà il suo riconoscimento all’indomani della seconda guerra, quella del 1939-1945, quando il pensatore italo-tedesco riceverà nel 1952 il Premio alla Pace da parte dei Librai tedeschi.
 In quell’occasione dirà: «Mi consentano di dire che l’attribuzione del Premio per la Pace mi ha dapprima sorpreso perché non ho scritto nulla sul problema della pace, a parte in alcune occasioni. Ma poi ho sentito che con questa onorificenza veniva toccato un motivo determinante per il mio lavoro. Mi ha sempre cioè occupato il problema: come mai possano affermarsi prese di posizioni così diverse degli uomini circa le questioni dell’esistenza e se non sia possibile di acquisire a tale diversità una forza costruttiva. Da queste riflessioni è nato a suo tempo un mio libro sulla “opposizione polare”, ed esse sono divenute importanti anche per i miei scritti di poi». Nel suo discorso Guardini connetteva la filosofia della pace al suo lavoro del 1925. Al centro del suo testo v’era la fondamentale distinzione tra opposizione e contraddizione. Il lavoro di coloro che promuovono la pace sta nel mantenere le opposizioni in sospensione, nell’impedire che si passi dalla diversità alla contraddizione.
In quell’occasione dirà: «Mi consentano di dire che l’attribuzione del Premio per la Pace mi ha dapprima sorpreso perché non ho scritto nulla sul problema della pace, a parte in alcune occasioni. Ma poi ho sentito che con questa onorificenza veniva toccato un motivo determinante per il mio lavoro. Mi ha sempre cioè occupato il problema: come mai possano affermarsi prese di posizioni così diverse degli uomini circa le questioni dell’esistenza e se non sia possibile di acquisire a tale diversità una forza costruttiva. Da queste riflessioni è nato a suo tempo un mio libro sulla “opposizione polare”, ed esse sono divenute importanti anche per i miei scritti di poi». Nel suo discorso Guardini connetteva la filosofia della pace al suo lavoro del 1925. Al centro del suo testo v’era la fondamentale distinzione tra opposizione e contraddizione. Il lavoro di coloro che promuovono la pace sta nel mantenere le opposizioni in sospensione, nell’impedire che si passi dalla diversità alla contraddizione.
 Come ribadirà nel ’52: «Ciò che esiste è la diversità dei punti di vista; la dialettica di formulazioni le quali per principio sono rapportate a vicenda e che perciò stanno l’una rispetto all’altra non in contraddizione esclusiva ma in opposizione feconda. Allora io posso dire: “Anche tu vedi qualcosa di giusto”, e si rende possibile una sintesi. Ma non appena appare non l’opposizione ma la contraddizione, non appena l’uno dice sì dove l’altro deve dire no, o l’uno giudica buono ciò che l’altro riconosce cattivo, allora non è più possibile nessuna sintesi, bensì soltanto aut-aut, e questo si chiama lotta».
Come ribadirà nel ’52: «Ciò che esiste è la diversità dei punti di vista; la dialettica di formulazioni le quali per principio sono rapportate a vicenda e che perciò stanno l’una rispetto all’altra non in contraddizione esclusiva ma in opposizione feconda. Allora io posso dire: “Anche tu vedi qualcosa di giusto”, e si rende possibile una sintesi. Ma non appena appare non l’opposizione ma la contraddizione, non appena l’uno dice sì dove l’altro deve dire no, o l’uno giudica buono ciò che l’altro riconosce cattivo, allora non è più possibile nessuna sintesi, bensì soltanto aut-aut, e questo si chiama lotta».
 La distinzione, feconda, sarà ripresa da Papa Francesco il quale non a caso in Fratelli tutti, il suo manifesto per la pace, citerà largamente Guardini utilizzando la sua antropologia polare. Come afferma il Papa in Ritorniamo a sognare, la sua conversazione con Austen Ivereigh: «Quello che vede le contrapposizioni come contraddizioni è un pensiero mediocre che ci allontana dalla realtà. Lo spirito cattivo - lo spirito di conflitto, che compromette il dialogo e la fraternità - cerca sempre di trasformare le contrapposizioni in contraddizioni, pretendendo che scegliamo e riducendo la realtà a semplici coppie di alternative. È questo che fanno le ideologie e i politici senza scrupoli». Il manicheismo teologico-politico è l’ideologia che si oppone alla pace. Ad esso Guardini, e con lui Bergoglio, oppone il suo pensiero dialogico. Lo ribadisce, con una punta di orgoglio, nel 1967, l’anno prima della sua morte.
La distinzione, feconda, sarà ripresa da Papa Francesco il quale non a caso in Fratelli tutti, il suo manifesto per la pace, citerà largamente Guardini utilizzando la sua antropologia polare. Come afferma il Papa in Ritorniamo a sognare, la sua conversazione con Austen Ivereigh: «Quello che vede le contrapposizioni come contraddizioni è un pensiero mediocre che ci allontana dalla realtà. Lo spirito cattivo - lo spirito di conflitto, che compromette il dialogo e la fraternità - cerca sempre di trasformare le contrapposizioni in contraddizioni, pretendendo che scegliamo e riducendo la realtà a semplici coppie di alternative. È questo che fanno le ideologie e i politici senza scrupoli». Il manicheismo teologico-politico è l’ideologia che si oppone alla pace. Ad esso Guardini, e con lui Bergoglio, oppone il suo pensiero dialogico. Lo ribadisce, con una punta di orgoglio, nel 1967, l’anno prima della sua morte. «Nella “Frankfurter Allgemeine Zeitung” - scrive - c’era un articolo del corrispondente dal Vaticano su un libro appena apparso del Prof. Guitton. Questi riassume il risultato di diversi colloqui con il papa Paolo VI e mostra il carattere spirituale e l’intenzione del Papa: non semplicemente governare, ma instaurare un dialogo con chi ogni volta rappresenta l’“altro”. L’essenza di questo procedimento consiste nel fatto che l’altro non appare come avversario, ma come “opposto”, e i due punti di vista, tesi e antitesi, vengono portati all’unità. Poi l’autore cita i nomi di personalità che sostengono lo stesso metodo, per la Germania cita il mio. Considerando l’importanza che oggi ha l’idea del dialogo, allora vede che è arrivato il momento giusto per il mio libro sull’Opposizione. L’abbiamo già detto anche esplicitamente. La teoria degli opposti è la teoria del confronto, che non avviene come lotta contro un nemico, ma come sintesi di una tensione feconda, cioè come costruzione dell’unità concreta».
«Nella “Frankfurter Allgemeine Zeitung” - scrive - c’era un articolo del corrispondente dal Vaticano su un libro appena apparso del Prof. Guitton. Questi riassume il risultato di diversi colloqui con il papa Paolo VI e mostra il carattere spirituale e l’intenzione del Papa: non semplicemente governare, ma instaurare un dialogo con chi ogni volta rappresenta l’“altro”. L’essenza di questo procedimento consiste nel fatto che l’altro non appare come avversario, ma come “opposto”, e i due punti di vista, tesi e antitesi, vengono portati all’unità. Poi l’autore cita i nomi di personalità che sostengono lo stesso metodo, per la Germania cita il mio. Considerando l’importanza che oggi ha l’idea del dialogo, allora vede che è arrivato il momento giusto per il mio libro sull’Opposizione. L’abbiamo già detto anche esplicitamente. La teoria degli opposti è la teoria del confronto, che non avviene come lotta contro un nemico, ma come sintesi di una tensione feconda, cioè come costruzione dell’unità concreta».
 Alla fine della sua vita Guardini proponeva il suo modello filosofico in antitesi a quello dialettico di Carl Schmitt fondato sull’antitesi tra amico e nemico. La filosofia della pace è un pensiero della mediazione che unifica i diversi mantenendoli nella loro differenza. Nel suo discorso del 28 aprile 1962, in occasione del Praemium Erasmianum ricevuto a Bruxelles, dal titolo Europa. Wirklichkeit und Aufgabe, Guardini assegnava all’Europa il compito di mediare tra i continenti e le potenze del mondo.
Alla fine della sua vita Guardini proponeva il suo modello filosofico in antitesi a quello dialettico di Carl Schmitt fondato sull’antitesi tra amico e nemico. La filosofia della pace è un pensiero della mediazione che unifica i diversi mantenendoli nella loro differenza. Nel suo discorso del 28 aprile 1962, in occasione del Praemium Erasmianum ricevuto a Bruxelles, dal titolo Europa. Wirklichkeit und Aufgabe, Guardini assegnava all’Europa il compito di mediare tra i continenti e le potenze del mondo.L’Europa veniva indicata come il katechon, il potere che poteva frenare i deliri di onnipotenza che la tecnica moderna rendeva possibili. L’America, l’Asia, l’Africa, non apparivano in grado, per motivi diversi, di rivestire tale ruolo. All’Europa spettava il compito di promuovere la pace. «Essa ha avuto tempo per perdere le illusioni». La sua storia è lunga, nel seno della sua cultura è germinato il sapere tecnico-scientifico, possibilità e rischi del medesimo sono stati da lei verificati in un modo tale che «all’Europa autentica è estraneo l’ottimismo assoluto, la fede nel progresso universale e necessario». Inoltre «i valori del passato sono ancora in essa così viventi che le permettono di capire cosa sta in gioco. Essa ha già visto rovinare tanto di irrecuperabile; è stata colpevole di tante lunghe guerre omicide, da essere capace di sentire le possibilità creatrici, ma anche il rischio, anzi la tragedia dell’umana esistenza. Nella sua coscienza c’è certamente la forma mitica di Prometeo, che porta via il fuoco dall’Olimpo, ma anche quella di Icaro, le cui ali non resistono alla vicinanza del sole e che precipita giù. Conosce le irruzioni della conoscenza e della conquista, ma in fondo non crede né a garanzie per il cammino della storia né a utopie sull’universale felicità del mondo. Essa ne sa troppo».
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EUROPA: TUBINGA, 4 NOVEMBRE 1945. LA ROSA BIANCA: "LA BILANCIA DELL’ESISTENZA". Commemorazione di Romano Guardini)
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- AMITAV GOSH: «Tutto è cominciato con il colonialismo, quando iniziammo a far violenza alla Terra». Intervista di Edoardo Vigna.30 novembre 2022, di Federico La Sala
Amitav Ghosh: «Tutto è cominciato con il colonialismo, quando iniziammo a far violenza alla Terra»
di Edoardo Vigna (Corriere della Sera / Pianeta20, 30 nov 2022)
Amitav Ghosh, oggi lo scrittore indiano più importante, ha scritto spesso della devastazione della Terra: il fatto di vivere da tanti anni fra New York e la sua Calcutta gli permette di essere anche un osservatore di facce diverse del fenomeno. Nei suoi romanzi (pubblicati in Italia da Neri Pozza) - tra cui la “trilogia dell’oppio” - ha raccontato l’origine del sacco dell’Occidente nei confronti delle ex colonie fra Asia e Africa. Nel nuovo libro, La maledizione della noce moscata, segue la lunga parabola del colonialismo, considerato con la sua furia devastatrice alla base delle conseguenze irreversibili che vediamo oggi sul pianeta rispetto al clima.
Che cosa è la maledizione della noce moscata, e perché l’ha scelta come punto di partenza?
«Avrei potuto scegliere la storia di mille cose diverse che stavano accadendo nello stesso momento. Ma la peculiare storia della noce moscata davvero presentava un’analogia chiara con ciò che avviene oggi. Gli abitanti dell’isola Banda, tra l’Oceano Indiano e il Pacifico, all’inizio del 1600 avevano questa pianta incredibile che ha portato loro ricchezze e prosperità, fino a quando un giorno ha portato il loro sterminio (ad opera degli olandesi della Compagnia delle Indie orientali, ndr). Allo stesso modo, noi abbiamo questo meraviglioso pianeta, che ci ha anche dato ricchezze di tipi diversi. Ma invece abbiamo seguito un modello economico che ci spinge tutti alla distruzione».
Quando ha scoperto quanto accaduto a Banda?
«Ho letto storie sull’Oceano Indiano per molto tempo, sapevo già ciò che era successo là. Ma andare sulle isole e vedere cosa era avvenuto mi ha fatto riunire le idee in forma narrativa».
Lei cita scrittori e filosofi provenienti da culture diverse, libri più o meno noti di epoche differenti, con cui ha costruito un nuovo modo di vedere lo sviluppo storico.
«Tutto ciò a cui pensavo da anni ha preso forma a causa della pandemia. Mia madre era malata e poi è mancata, e così anche i miei suoceri. New York era simile a Milano e Bergamo. A pochi isolati da casa mia c’era un ospedale con camion frigoriferi per le vittime. Uno sconvolgimento mai visto, che però ci stava dicendo qualcosa sul futuro».
Che cosa?
«Ci ha mostrato che gli impatti sul cambiamento climatico, i loro effetti sulla società, saranno assai diversi da ciò che ci è stato detto. La narrazione consolidata, in Occidente, è che la crisi sarà terribile per i più poveri, “non-bianchi”. Invece sarà sì molto negativo per la povera gente, ma colpirà anche i Paesi ricchi, in modi diversi, con effetti altrettanto devastanti. E penso che se c’è una lezione che dobbiamo imparare da questa esperienza è che le megacrisi richiedono una risposta collettiva. Che non si è manifestata ovunque. L’Italia resta una nazione con una cultura comune, una lingua comune: quando è stato chiesto di fare sacrifici, la gente ha risposto. Non così negli Stati Uniti, che hanno avuto pessimi risultati. E tuttora vivono fra disagio sociale, sfiducia e polarizzazione politica. Idem il Regno Unito. In America la società ha una fede enorme nella tecnologia come fonte di salvezza. Pensavano che il vaccino li avrebbe salvati. Ma dopo che il vaccino è diventato disponibile, la diffidenza sociale ha preso il sopravvento, e ancora oggi la sfiducia è il vettore principale».
Lei retrodata la riflessione sul presente al colonialismo, con l’idea che l’imperialismo, con le sue armi, venga prima del capitalismo come causa della devastazione del pianeta.
«Negli ultimi anni, l’intero discorso sul cambiamento climatico è stato focalizzato sul capitalismo come il principale motore del disastro che stiamo attraversando. Certo, c’è molta verità in questo. Ma allo stesso tempo il nostro capitalismo non è nato da sé, è venuto fuori dal colonialismo che lo ha reso possibile. Le disuguaglianze, specie quelle geopolitiche, sono simili a ciò che esisteva nel XVII secolo. Il dominio globale dell’Europa d’allora corrisponde a quello odierno dell’Occidente».
Quale è stato il momento chiave?
«Quello in cui l’Europa ha conquistato le Americhe. Un evento che ha comportato una violenza su una scala mai vista prima, con la soppressione di 80-90 milioni di persone. Quella violenza ha creato una nuova società. Con l’eliminazione di decine di milioni di persone, ma anche con l’idea di sostituirli con africani schiavi. Un intervento demografico su quella scala non era mai avvenuto, mai».
Una riflessione in tal senso su questo argomento non è ancora avvenuta del tutto.
«Da qui la tentazione di attribuire la realtà d’oggi a sistemi astratti come il capitalismo, compresa la violenza che ha creato quel sistema».
Collegata c’è l’idea che il genocidio dei nativi americani e degli schiavi fosse giustificato dalla convinzione che non fossero completamente umani, e che quindi l’uomo bianco potesse fare di loro ciò che voleva. Proprio come avviene nei confronti della natura. Siamo superiori e padroni: ecco è il pilastro su cui tutto è costruito.
«Se oggi queste idee vivono è grazie all’esperienza coloniale delle Americhe. Poche centinaia di bianchi violentissimi dell’Estremadura scoprirono di poter sterminare centinaia di migliaia di nativi. Così è entrata in testa l’idea di esser simili a Dio, padroni del mondo. Che tutto esista per servirli».
Dove poggia sul piano culturale e filosofico?
«L’Illuminismo è di sicuro legato a questa esperienza. L’idea che gli esseri umani siano al di sopra di tutto. Penso, quindi sono. È da qui che discende quell’incredibile violenza. E infatti diversi pensatori chiave del tempo erano connessi strettamente al colonialismo. Cartesio ha trascorso gran parte della sua vita in Olanda quando questa era il perno del dominio globale. Il filosofo inglese Locke investiva nelle piantagioni e comprava schiavi. Anche Hegel ripeteva che gli africani erano inferiori, senza storia. Mentre parlava di libertà dello spirito».
Nel libro ritroviamo Cristoforo Colombo, che sbarcato nelle Americhe commette atrocità.
«Era un uomo violento e selvaggio, un puro sadico. So che gli italiani non lo ricordano. I nativi delle Americhe invece sì. Il fatto è che gran parte della storia che viene insegnata serve a far sembrare belli l’Europa e gli occidentali».
Lei ricorda anche come dare il nome alle cose, come facevano gli scienziati del ‘700, fosse uno dei modi per dominarle.
«Il sistema con cui Linneo battezzò animali, piante e minerali deriva interamente dal colonialismo. L’idea era avere un sistema che potesse oggettivare le risorse che il mondo offriva. E il sistema linneano ha trionfato non perché fosse il migliore ma perché l’impero spagnolo l’adottò».
A proposito di nessi causali, lei sottolinea come il riscaldamento globale non sia un accidente, ma è la conseguenza centrale del comportamento degli esseri umani.
«Credo sia chiaro come il global warming segua questi modelli. Una delle caratteristiche più marcate del colonialismo è ciò che si potrebbe chiamare “violenza per omissione”. Permettere alle malattie di fare strage. O agli interventi sull’ambiente di provocare disastri contro i popoli nativi».
Noi abbiamo l’idea che i conquistadores non avessero colpa per la diffusione di malattie che hanno sterminato le civiltà americane.
«I nativi-americani sanno da sempre la verità».
Discendiamo dall’Impero Romano, che controllava la Terra conosciuta. Vede un’idea di dominio nella psicologia dell’uomo bianco?
«I romani riconoscevano il potere della natura su di loro. Non se ne consideravano i padroni».
È un problema di potere. Potere politico, rappresentato anche dal potere sull’energia.
«L’energia diventa il perno della geopolitica globale alla fine del XVIII secolo, quando i combustibili fossili che gli inglesi cominciano a usare diventano centrali nelle loro strategie imperiali. E i combustibili fossili sono divenuti importanti perché - a differenza dell’energia dei mulini - potevano essere portati ovunque, quindi controllati».
Cosa le fa pensare che le fonti rinnovabili - a gestione diffusa - possano arrivare a sostituirle? Per le élite significa rinunciare al potere.
«I modelli che ho indicato nel libro, possiamo vederli all’opera oggi. Questa guerra Russia-Ucraina è così centrata sull’energia che l’energia stessa diventa un’arma di guerra da entrambe le parti. Se avessimo rinnovabili su larga scala, il gas russo conterebbe poco, ma questo varrebbe anche per il gas Usa. E non dimentichiamo che esiste il petrodollaro ( il sistema per cui il petrolio è pagato in dollari, ndr): Saddam è stato uno dei primi a iniziare a non commerciare in dollari, e guardi com’è finito. Il Venezuela di Chavez anche, ed è morto per un misterioso tumore. Russia e Cina che si scambiano combustibili fossili non sul dollaro diventano una minaccia per la sua egemonia».
Lei scrive che nei Paesi ricchi si pensa che la crisi climatica sia una preoccupazione tecnica con effetti economici, mentre in quelli poveri è un problema di disuguaglianza e giustizia.
«Se chiede a chiunque in Occidente qual è la posta in gioco con il clima tutti risponderanno che si tratta di ridurre l’impronta di carbonio. Di soluzioni tecniche. Nel Sud globale, se dite a qualcuno cosa pensa di fare al riguardo? La risposta sarà sempre: “Perché dovrei far qualcosa? La nostra impronta pro-capite è ancora piccola rispetto a quella dell’Occidente! Tocca a loro agire. Sono diventati ricchi quando eravamo poveri, a nostre spese. La percezione è di profonda ingiustizia».
Quindi, come se ne esce? Come si può arrivare alla decarbonizzazione necessaria al pianeta?
«C’è solo un modo: che l’Occidente riduca le emissioni cambiando stile di vita. Fino a quando ciò non accadrà qui, non accadrà da nessun’altra parte. È la cruda realtà».
Lo ritiene davvero possibile?
«L’abbiamo visto in Cina, con l’enorme calo della domanda dei consumatori. Lì, come in India, la gente ancora ricorda com’è vivere in modo più frugale. Toccherà agli occidentali imparare a farlo».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- C’è un mondo vecchio, fondato sullo sfruttamento della natura madre, sul disordine della natura umana (di Anna Maria Ortese - "Corpo celeste").21 novembre 2022, di Federico La Sala
Corpo celeste
di Anna Maria Ortese *
"... Ecco, ho finito. Ho finito anche di essere uno scrittore - se mai lo sono stata -, ma sono lieta di averlo tentato. Sono lieta di aver speso la mia vita per questo. Sono lieta, in mezzo alle mie tristezze mediterranee, di essere qui. E dirvi com’è bello pensare strutture di luce, e gettarle come reti aeree sulla terra, perché essa non sia più quel luogo buio e perduto che a molti appare, o quel luogo di schiavi che a molti si dimostra - se vengono a occupare i linguaggi, il respiro, la dignità delle persone. A dirvi come sia buona la Terra, e il primo dei valori, e da difendere in ogni momento. Nei suoi paesi, anche nei suoi boschi, nelle sorgenti, nelle campagne, dovunque siano occhi - anche occhi di uccello o domestico o selvatico animale. Dovunque siano occhi che vi guardano con pace o paura, là vi è qualcosa di celeste, e bisogna onorarlo e difenderlo.
 So questo. Che la Terra è un corpo celeste, che la vita che vi si espande da tempi immemorabili è prima dell’uomo, prima ancora della cultura, e chiede di continuare a essere, e a essere amata, come l’uomo chiede di continuare a essere, e a essere accettato, anche se non immediatamente capito e soprattutto non utile. Tutto è uomo. Io sono dalla parte di quanti credono nell’assoluta santità di un albero e di una bestia, nel diritto dell’albero, della bestia, di vivere serenamente, rispettati, tutto il loro tempo. Sono dalla parte della voce increata che si libera in ogni essere - al di là di tutte le barriere - e sono per il rispetto e l’amore che si deve loro.
So questo. Che la Terra è un corpo celeste, che la vita che vi si espande da tempi immemorabili è prima dell’uomo, prima ancora della cultura, e chiede di continuare a essere, e a essere amata, come l’uomo chiede di continuare a essere, e a essere accettato, anche se non immediatamente capito e soprattutto non utile. Tutto è uomo. Io sono dalla parte di quanti credono nell’assoluta santità di un albero e di una bestia, nel diritto dell’albero, della bestia, di vivere serenamente, rispettati, tutto il loro tempo. Sono dalla parte della voce increata che si libera in ogni essere - al di là di tutte le barriere - e sono per il rispetto e l’amore che si deve loro.C’è un mondo vecchio, fondato sullo sfruttamento della natura madre, sul disordine della natura umana, sulla certezza che di sacro non vi sia nulla. Io rispondo che tutto è divino e intoccabile: e più sacri di ogni cosa sono le sorgenti, le nubi, i boschi e i loro piccoli abitanti. E l’uomo non può trasformare questo splendore in scatolame e merce, ma deve vivere e essere felice con altri sistemi, d’intelligenza e di pace, accanto a queste forze celesti.
 Che queste sono le guerre perdute per pura cupidigia: i paesi senza più boschi e torrenti, e le città senza più bmbini amati e vecchi sereni, e donne al disopra dell’utile. Io auspico un mondo innocente. So che è impossibile, perché una volta, in tempi senza tempo e fuori dalla nostra possibilità di storicizzare e ricordare, l’anima dell’uomo perse una guerra.
Che queste sono le guerre perdute per pura cupidigia: i paesi senza più boschi e torrenti, e le città senza più bmbini amati e vecchi sereni, e donne al disopra dell’utile. Io auspico un mondo innocente. So che è impossibile, perché una volta, in tempi senza tempo e fuori dalla nostra possibilità di storicizzare e ricordare, l’anima dell’uomo perse una guerra.
 Qui mi aiuta Milton, e tutto ciò che ho appreso dalla letteratura della visione e della severità. Vivere non significa consumare, e il corpo umano non è un luogo di privilegi. Tutto è corpo, e ogni corpo deve assolvere un dovere, se non vuole essere nullificato; deve avere una finalità, che si manifesta nell’obbedienza alle grandi leggi del respiro personale, e del respiro di tutti gli altri viventi. E queste leggi, che sono la solidarietà con tutta la vita vivente, non possono essere trascurate.
Qui mi aiuta Milton, e tutto ciò che ho appreso dalla letteratura della visione e della severità. Vivere non significa consumare, e il corpo umano non è un luogo di privilegi. Tutto è corpo, e ogni corpo deve assolvere un dovere, se non vuole essere nullificato; deve avere una finalità, che si manifesta nell’obbedienza alle grandi leggi del respiro personale, e del respiro di tutti gli altri viventi. E queste leggi, che sono la solidarietà con tutta la vita vivente, non possono essere trascurate.
 Noi, oggi, temiamo la guerra e l’atomica. Ma chi perde ogni giorno il suo respiro e la sua felicità, per consentire alle grandi maggioranze umane un estremo abuso di respiro e di felicità fondati sulla distruzione planetaria dei muti e dei deboli - che sono tutte le altre specie -, può forse temere la fine di tutto? Quando la pace e il diritto non saranno solo per una parte dei viventi, e non vorranno dire solo la felicità e il diritto di una parte, e il consumo spietato di tutto il resto, solo allora, quando anche la pace del fiume e dell’uccello sarà possibile, saranno possibili, facili come un sorriso, anche la pace e la vera sicurezza dell’uomo.
Noi, oggi, temiamo la guerra e l’atomica. Ma chi perde ogni giorno il suo respiro e la sua felicità, per consentire alle grandi maggioranze umane un estremo abuso di respiro e di felicità fondati sulla distruzione planetaria dei muti e dei deboli - che sono tutte le altre specie -, può forse temere la fine di tutto? Quando la pace e il diritto non saranno solo per una parte dei viventi, e non vorranno dire solo la felicità e il diritto di una parte, e il consumo spietato di tutto il resto, solo allora, quando anche la pace del fiume e dell’uccello sarà possibile, saranno possibili, facili come un sorriso, anche la pace e la vera sicurezza dell’uomo.Ecco, come sono venuta vado via; e vi ringrazio di avermi ascoltata; mi scuso se ho detto troppo o confusamente; e se ho detto poco, e se ho potuto dispiacervi. Come dicono i bambini: non l’ho fatto apposta. Vi auguro un buon giorno di pace e di comprensione. La vita è più grande di tutto, ed è in ogni luogo, e da tutte le parti - proprio da tutte le parti - chiede amicizia e aiuto. Non chiede che questo. E il valore di ogni buona risposta è immenso, se anche non dimostrabile. Amate e difendete il libero respiro di ogni paese, e di ogni vita vivente.
Questo invito, alla fine, calma e consola la mia stessa tristezza, e il senso di essere stata uno scrittore inutile. Ma non lo sono stata del tutto se, oltre il mio respiro, ho appreso a desiderare il libero respiro di ogni creatura e di ogni paese. È tutto, il respiro. È Dio stesso; ed è la cultura quando non fine a se stessa; quando, d’un tratto - voi non lo sapevate che era anche questo -, solleva e trasporta i popoli, come fa a volte, con le confuse onde del mare, un gran vento celeste."
19 febbraio 1980
Anna Maria Ortese, "Corpo celeste", Adelphi, Milano 1997, pp. 159, Lire 15.000
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- INTERPRETAZIONE DEI SOGNI (E DEI SEGNI): LA "MADONNA SALTING" DI ANTONELLO DA MESSINA (1460). Un segnavia per "arrivare" a Eleusis nel prossimo 2023.17 novembre 2022, di Federico La Sala
FILOLOGIA, STORIA, E INTERPRETAZIONE DEI SOGNI (E DEI SEGNI):
LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI (1453), IL "DE PACE FIDEI" DI NICCOLO’ CUSANO (1453), E LA "MADONNA SALTING" DI ANTONELLO DA MESSINA (1460).
Un segnavia per "arrivare" a Eleusis nel prossimo 2023.
ARTE E SOCIETÀ: LA MADONNA SALTING. A mio parere, l’influenza maggiore sulla produzione della "Madonna #Salting" di Antonello da Messina appare decisamente essere di scuola fiamminga. Tuttavia, essendo Antonello originario di Messina, forse, è da riguardare con particolare attenzione il senso simbolico della melagrana già aperta in mano al Bambino e, insieme, del cinturino annodato intorno al corpo del Figlio con i due fiocchetti (due piccole "#melagrana"), messi in una zona di chiara evidenza, che rimandano decisamente ai frutti del melograno in via di maturazione e alla fecondità della Madre, tutta vestita e "punteggiata" da infiniti "chicchi".
IPOTESI: QUESTIONE CRISTOLOGICA (ANTROPOLOGICA). Dato che il quadro è del 1460 circa, forse, potrebbe essere una "indicazione" di un discorso ancora sul nascere, di un dibattito all’ordine del giorno sul problema del Figlio, cioè sul tema decisivo dell’epoca (la caduta di Costantinopoli è del 1453 e il cardinale Niccolò Cusano cerca la via della pace della fede, nel 1453)": il nodo è proprio quello del Figlio (... e del "Presepe", e del "Natale"), quello dell’interpretazione teologico e antropologica della figura di Cristo (un tema ancora all’ordine del giorno), in un’ottica ecumenica.
CONSIDERATO CHE la "Dotta Ignoranza" di Cusano (1440) è del tutto segnata dalla tradizione filosofica e scientifica aristotelico-platonica (come sarà ancora per gli aristotelici dell’epoca di Galileo Galilei), la figura e il tema del bambino-homunculus è la parola chiave per comprendere non solo la teologia e l’anatomia dell’epoca, ma anche l’arte e l’antropologia, forse, è OPPORTUNO "RIPENSARE COSTANTINO": "IN HOC SIGNO VINCES". Proprio la caduta di Costantinopoli (1453), infatti, porterà l’Europa a svegliarsi dal letargo, a muoversi militarmente, e a prendere sotto la guida della Spagna la strada della riconquista (Granada,1492), della cacciata dei Mori e degli Ebrei (1492), della conquista dell’America (1492), e dell’avvio della prima globalizzazione teologico-politica del Pianeta Terra.
A) ANTONELLO DA MESSINA, "MADONNA SALTING".
B) BOSCH (1453-1516), ALL’ESCORIAL (1593). "Il Giardino delle delizie (o Il Millennio) è un trittico a olio su tavola (220×389 cm) di Hieronymus Bosch, databile 1480-1490 circa e conservato nel Museo del Prado di Madrid.[...]".
C) ELEUSIS 2023. Una delle capitali europee della cultura del 2023 è Eleusi: una buona opportunità storica per ripensare la figura della Terra-Madre, Demetra, della figlia, Persefone, e del tema dei misteri eleusini, e, al contempo, anche del melograno, e della melagrana, dell’agricoltura, delle stagioni, ecc.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA: "CERCATE L’ANTICA MADRE". NOTE PER ELEUSI (CAPITALE DELLA CULTURA 2023).8 novembre 2022, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA: "NOTE" PER ELEUSI 2023
KOENIGSBERG (1784), KALININGRAD (2022), E MISTERI ELEUSINI:
Dopo interi millenni di labirinto e di platonismo per il popolo (Nietzsche), con Hegel e Holderlin, andare oltre Hegel e Holderlin e prepararsi a ripensare la storia della Terra-Madre (Demetra), M->Arianna, e rendere omaggio a ELEUSI, CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2023.
***
STORIA, FILOSOFIA, E MEMORIA. HEGEL,
"A HOLDERLIN" [dalla lettera dell’agosto 1796]:
ELEUSI" *
"[...]
 Ah! Se da sole ora le porte del tuo santuario si spezzassero,
Ah! Se da sole ora le porte del tuo santuario si spezzassero,
 o Cerere, tu che in Eleusi avevi il trono!
o Cerere, tu che in Eleusi avevi il trono!
 Ebbro di entusiasmo, io proverei ora
Ebbro di entusiasmo, io proverei ora
 il fremito della tua vicinanza,
il fremito della tua vicinanza,
 comprenderei le tue rivelazioni,
comprenderei le tue rivelazioni,
 interpreterei l’alto senso delle immagini, udrei
interpreterei l’alto senso delle immagini, udrei
 gli inni nei banchetti degli dei,
gli inni nei banchetti degli dei,
 gli alti detti del loro consiglio -
gli alti detti del loro consiglio -
 Pure i tuoi atri sono ammutoliti, o dea!
Pure i tuoi atri sono ammutoliti, o dea!
 Il cerchio degli dei è fuggito dall’Olimpo
Il cerchio degli dei è fuggito dall’Olimpo
 degli altari consacrati,
degli altari consacrati,
 fuggito dalla tomba dell’umanità profanata
fuggito dalla tomba dell’umanità profanata
 il genio innocente, che qui li incantava! -
il genio innocente, che qui li incantava! -
 La saggezza dei tuoi sacerdoti tace; non un suono dalle sacre
La saggezza dei tuoi sacerdoti tace; non un suono dalle sacre
 iniziazioni si è salvato fino a noi [...]"
iniziazioni si è salvato fino a noi [...]"* Cfr. G. W. F. Hegel, "Eleusis, Carteggio. Il poema filosofico del giovane Hegel e il suo epistolario con Hölderlin", Mimesis edizioni 2014 - ripresa parziale).
***
***
"LETTERATURA EUROPEA" E "INTERPRETAZIONE DEI SOGNI": DEMETRA (LA TERRA-MADRE) ED ELEUSI 2023...
A) L’ORACOLO DI APOLLO AI TROIANI, A DELO: "[...] la #terra da cui traete origine,/ prima culla dei padri, vi vedrà ritornare/ nel suo seno materno, reduci. Su, cercate/ l’antica #madre! [...]" (Virgilio, Eneide, III, 114-117).
B) GIUNONE (E LA RICERCA DI FREUD): "Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo" (Virgilio, Eneide, VII, 312)
C) L’EDIPO COMPLETO (FREUD) E DEMETRA: ELEUSIS 2023. "[...] Rimane ancora aperta la questione della Madre, di cui oggi parlano in pochi. Non si tratta né di ruolo, né di funzione. Si tratta di codici. Perché la Legge del Padre si stabilisca nel modo giusto, è necessaria, a mio avviso, la fiducia nella persona, incarnata nel codice affettivo materno. Ciò che mantiene sempre il legame sociale, anche quando appare spezzato. Sembra che di ciò, in tutto questo importante discorso sui padri, ci si stia dimenticando." (Pietro Barbetta, "Presenza/Assenza del padre", Doppiozero 7 Gennaio 2014).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- TIESTOPA: "LA MALATTIA DELL’EUROPA". Un libro di Franco Fornari del 1981 e la “Settimana della pace di Ginevra 2022” (di "SPI").3 novembre 2022, di Federico La Sala
LA MALATTIA DELL’EUROPA, FRANCO FORNARI (1981) E... L’EDUCAZIONE ALLA "PACE PERPETUA" *
***
Franco Fornari sviluppò la sua ricerca a partire dalla convinzione che la psicoanalisi potesse aiutare l’uomo a risolvere non solo i conflitti intrapsichici ma anche quelli interpersonali, istituzionali e sociali. Il suo progetto di educare alla pace lo in portò ad indagare i meccanismi inconsci che alimentano la guerra fra i popoli.
 A questo dedicò numerosi libri: Psicoanalisi della guerra atomica
(1964), Psicoanalisi della guerra (1966) e La malattia dell’Europa (1981). Il suo pensiero ricevette
una grande attenzione internazionale alla Conferenza dell’ONU sulla pace a New York e il suo
impegno lo portò a diventare membro del Comitato Mondiale di ricerca sulla pace.
A questo dedicò numerosi libri: Psicoanalisi della guerra atomica
(1964), Psicoanalisi della guerra (1966) e La malattia dell’Europa (1981). Il suo pensiero ricevette
una grande attenzione internazionale alla Conferenza dell’ONU sulla pace a New York e il suo
impegno lo portò a diventare membro del Comitato Mondiale di ricerca sulla pace.- In occasione della “Settimana della pace di Ginevra 2022” proponiamo le ultime pagine del suo libro “LA MALATTIA DELL’EUROPA”, edito da Feltrinelli.
“Giunto così in modo un po’ concitato alla fine della mia ricerca sulla malattia dell’Europa, vorrei darle un nome. Poiché i processi patologici che ho individuato sono molteplici e intricati, anziché elencarli in una lunga perifrasi, vorrei condensarli con il mito di Tieste.
Questo mito racconta che tra i due fratelli Atreo e Tieste, correva un’inimicizia mortale.
Il nome di Atreo rimanda agli Atridi: Agamennone e Menelao, appunto, quelli della guerra di Troia. Poiché Agamennone, il capo dei greci, è figlio di Atreo, la sua genealogia rimanda ad una struttura perversa del potere familiare, che sembra dare una luce sinistra alla guerra di Troia, la prima grande guerra.
Dice dunque il mito che i due fratelli Atreo e Tieste si odiavano a morte. Un giorno però Atreo propose al fratello la riconciliazione e la coesistenza pacifica. Venuto il giorno della pace, Atreo offrì al fratello Tieste un banchetto imbandito con la carne dei suoi bambini, sgozzati davanti all’altare. La guerra di Troia ha dunque nella sua genealogia l’odio tra fratelli.
Ricordando Tieste, propongo di chiamare “Tiestopa” la malattia dell’Europa. Come nel mito greco, gli accordi di Yalta dicono di un odio mortale tra americani e russi, i fratelli vincitori della Seconda guerra mondiale. La divisione dell’Europa dice che a Yalta c’è stato un banchetto, nel quale le due grandi potenze, vincitrici, fingendo la pacificazione, si sono costituite come pseudogenitori dell’Europa, e hanno messo in atto un’intesa apparente, dandosi reciprocamente da mangiare i popoli europei, come simulazione di pace. Il mito dice dunque che gli accordi di Yalta sono un signum mali ominis: un segno di cattivo auspicio. Nel mito possono essere letti i presupposti di una nuova guerra di Troia, in era nucleare: dell’ultima grande guerra dell’Occidente.
La malattia dell’Europa è sospesa tra la Seconda e la Terza guerra mondiale. Questo significa che la cura della malattia dell’Europa è essenziale per evitare la Terza guerra mondiale e può essere fatta solo attraverso la liberazione dell’Europa dalla sovversione perversa e crociata degli Usa e dell’Urss in una rivoluzione culturale pacifica che è la condizione necessaria e sufficiente per evitare al mondo la maledizione dei discendenti di Atreo.” (Fornari F., 1981 pag 203-204)
* Fonte: SocieTà Psicoanalitica Italiana
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
 TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA, DANTESCA, KANTIANA, E MARXIANA
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -COMMENTO APOCALYPTICO DI SCUOLA GIOACHIMITA, DANTESCA, KANTIANA, E MARXIANAfls
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- TIESTOPA: "LA MALATTIA DELL’EUROPA" --- UN BANCHETTO MOSTRUOSO. Il mito di Tieste ha una forza e una esemplarità simile a quella del mito di Edipo (di Maurizio Bettini).10 novembre 2022, di Federico La Sala
ECCO, MANGIA I TUOI FIGLI
di MAURIZIO BETTINI *
Esistono storie così barbare che sembrano nate non solo fuori della cultura, ma addirittura fuori del linguaggio, tanto si stenta a dirne gli orrori. Per cui, quando vengono fatte rivivere su una scena è giusto che questo avvenga in luoghi rocciosi, da cui si contemplano solo distese di terra senza tracce di uomini. Al crepuscolo il vento solleva polvere, polvere vera, attorno alle urla di un personaggio che scopre di essersi macchiato di una colpa inespiabile: mentre il pubblico, attonito sui gradini di pietra, continua a domandarsi "ma cosa può spingere un uomo a uccidere i figli di suo fratello, per poi farglieli divorare in un banchetto mostruoso?".
Stiamo parlando del Tieste di Seneca, rappresentato al teatro greco di Segesta per l’ abituale appuntamento con l’ Istituto Nazionale del Dramma Antico. Una bella traduzione (fatta ex novo da Giusto Picone, latinista dell’ Università di Palermo) e una regia originale (di Walter Pagliaro) hanno fruttato uno spettacolo di grande ricchezza: forse perché in questo caso le invenzioni di regia non erano fondate, come purtroppo può accadere, su bizzarrie o su luoghi comuni, ma sulla collaborazione fra un uomo di teatro e uno studioso della tragedia di Seneca. Ragion per cui, quando un ignaro Tieste porta alle labbra la coppa riempita del sangue dei suoi figli - e il regista intelligentemente lascia che questo gesto indugi, a lungo, nel crepuscolo che nel frattempo ha invaso la scena - anche noi ci siamo chiesti: "ma cosa può spingere un uomo a uccidere i figli di suo fratello, per poi farglieli divorare in un banchetto mostruoso?".
La storia è nota. Atreo e Tieste sono figli di Pelope, a sua volta figlio di Tantalo: una stirpe sciagurata. Tieste ha sedotto la moglie di Atreo, Erope, ed ha in ogni modo insidiato il regno al fratello. Adesso Atreo decide di vendicarsi: chiama Tieste a Micene, finge di restituirlo agli antichi onori ma in realtà, nascosto nelle viscere del Palazzo, uccide i tre figli di Tieste e ne cucina le carni per il padre, che se ne ciba. Una delle storie più orribili che siano mai state immaginate. Una storia mostruosa, selvaggia. Eppure dietro a tanta barbarie c’ è una logica: perversa, fuori da ogni ordine della ragione, ma capace di spiegare lucidamente perché Atreo scelga proprio questa via - far divorare al padre i suoi figli - per vendicarsi dei torti subiti da Tieste.
Il fatto è che il Tieste è un dramma della paternità, e delle sue ossessioni. C’ è un pensiero che soprattutto tormenta Atreo: egli teme che i suoi figli non siano davvero suoi ma siano stati generati da Tieste, il quale ha commesso adulterio con sua moglie. Lo dice all’ inizio del dramma "niente della mia stirpe è immune dalle insidie di Tieste: la moglie sedotta, incerto il sangue della mia discendenza..."; lo dice trionfante alla fine del dramma, di fronte a un Tieste annientato dalla irrimediabile mostruosità di cui si sente invaso: "sì, ora nascono i miei figli, ora il letto nuziale è di nuovo certo e incontaminato...".
Dunque, nella perversa logica di Atreo, aver fatto divorare al seduttore Tieste i suoi propri figli è un mezzo per ridare "certezza" al suo sangue inquinato: per cancellare il dubbio che attanaglia la sua paternità. Quali possono essere le categorie antropologiche su cui si fonda un simile, mostruoso ragionamento?
 Perché proprio l’ atto di far divorare i figli a un padre comporta l’ immediato riscatto di una stirpe inquinata? Per comprendere la struttura profonda di questa (perversa) logica simbolica, bisogna rammentare che la famiglia è concepita come un unico organismo, il cui delicato funzionamento è garantito da un corretto equilibrio del "sangue" e degli altri liquidi vitali che scorrono nelle sue ramificazioni.
Perché proprio l’ atto di far divorare i figli a un padre comporta l’ immediato riscatto di una stirpe inquinata? Per comprendere la struttura profonda di questa (perversa) logica simbolica, bisogna rammentare che la famiglia è concepita come un unico organismo, il cui delicato funzionamento è garantito da un corretto equilibrio del "sangue" e degli altri liquidi vitali che scorrono nelle sue ramificazioni.Tieste ha alterato questo equilibrio, spargendo il suo seme (il suo "sangue", secondo i modelli della biologia antica) là dove non avrebbe mai dovuto spargerlo: egli si è unito con la cognata, ed ha turbato la discendenza di suo fratello. Adesso, perché l’ equilibrio sia ristabilito, occorre che Tieste riprenda dentro di sé la sua discendenza compensando, con una mostruosa riassimilazione della propria sostanza vitale, l’ eccesso che di questa medesima sostanza egli ha immesso nell’ organismo della parentela. Se il sangue di Atreo è "incerto", misto, inquinato, la sua purezza potrà essere riscattata solo al momento in cui Tieste accosterà alle labbra una coppa piena del suo proprio sangue, il sangue dei suoi figli. La regola invocata è quella di uno spietato contrappasso, che riporta dentro Tieste un liquido che il suo adulterio incestuoso aveva fatto indebitamente circolare fuori.
Il dramma è raccapricciante, così come lo è, notoriamente, il modo in cui Seneca si è compiaciuto di scriverlo. Eppure questa storia insegna moltissime cose non solo sull’ importanza dei vincoli di parentela, ma anche sul modo in cui essi venivano rappresentati. Il mito di Tieste ha una forza e una esemplarità simile a quella del mito di Edipo. Se per capire il significato culturale dell’ incesto bisogna recarsi alla reggia di Tebe, per comprendere il terrore dell’ adulterio e l’ ossessione per la purezza della stirpe è necessario raggiungere quella di Micene: là dove i modelli simbolici della parentela si ribaltano in cannibalismo, e il "sangue" della consanguineità familiare si trasforma in sangue versato e bevuto.
* Fonte: la Repubblica, 04.09.1991
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE (2005). ---- Brasile, 31 ottobre 2022: Lula vince il ballottaggio. E’ eletto presidente per la terza volta31 ottobre 2022, di Federico La Sala
Brasile: Lula vince il ballottaggio. E’ eletto presidente per la terza volta
Sconfitto di un soffio il candidato della destra Bolsonaro
Il leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) ha vinto il ballottaggio, ed é stato eletto presidente del Brasile per la terza volta.
Lula ha battuto l’attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro (Pl, destra), il primo presidente che ha fallito nel suo tentativo di rielezione.
Il Tribunale superiore elettorale ha ufficializzato la vittoria, col 98, 86% del totale delle sezioni scrutinate, Lula ha ottenuto il 50,83% dei voti (59.596.247), contro il 49,17% di Bolsonaro (57.675.427).
Scoppiano felicità e tristezza in tutto il Brasile al termine degli spogli per il ballottaggio delle presidenziali che ha dato la vittoria a Luiz Inacio Lula da Silva. Caroselli di auto e moto, grida dalle finestre degli appartamenti, suoni di clacson e bandiere al vento riempiono le strade delle principali città. Da una parte i sostenitori dell’ex sindacalista, in lacrime di gioia, dall’altra il silenzio di delusione dei fan di Jair Bolsonaro. In una nazione spaccata a metà, le elezioni più polarizzate della storia del Paese si riflettono negli umori dei suoi cittadini, divisi da opposte tifoserie come in una finale della nazionale di calcio. A Rio de Janeiro, la seconda metropoli più grande del gigante sudamericano, gli elettori in festa si sono riversati sulla spiaggia, inondando con la loro allegria il quartiere di Copacabana. Mentre anche dalle ’favelas’ sui morros (colline) partono fuochi di artificio a illuminare il cielo carioca.
*
Fonte: Ansa, 31 ottobre 2022
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- L’AMAZZONIA, I RUNA DI ÁVILA, E L’URGENZA DI "UN’ ANTROPOLOGIA OLTRE L’ UMANO". Come pensano le foreste. Un nuovo approccio (di Dafne Crocella).5 ottobre 2022, di Federico La Sala
FILOLOGIA DENDROLOGIA E STORIA: "PER UN’ ANTROPOLOGIA OLTRE L’ UMANO". *
- "Se avessi scritto questo libro per i Runa di Ávila... non gli avrei dato lo stesso titolo" (E. Khon).
Come pensano le foreste. Un nuovo approccio all’essere umani
- Siamo sicuri di essere gli unici esseri in grado di pensare? Eduardo Kohn, professore alla McGill University di Montreal, sfida i fondamenti dell’antropologia, mettendo in discussione i presupposti dell’antropocentrismo. Per una nuova logica dell’essere umani, non distinti da tutte le altre forme di vita
di Dafne Crocella **
- Titolo: Come pensano le foreste
- Autore: Eduardo Kohn
- Editore: Nottetempo
- Anno: 2021
«Dormi a faccia in su. Se arriva un giaguaro vedrà che anche tu puoi guardarlo e non ti disturberà». È da questo consiglio, dato all’antropologo Eduardo Kohn da un uomo del villaggio runa di Avila nell’Amazzonia equadoregna, che si apre la riflessione sul modo in cui gli altri generi di esseri viventi ci percepiscono, ci guardano, ed effettivamente e più generalmente pensano. Eduardo Kohn è professore associato di antropologia alla McGill University di Montreal ed ha incentrato buona parte della sua ricerca etnografica sulla popolazione runa dell’Alta Amazzonia. Questo libro nasce da una profonda e prolungata conoscenza del villaggio di Avila, immerso nella Foresta Amazzonica. La prima visita di Kohn risale al 1992, a questa sono seguiti 4 anni, dal 1996 al 2000, di ripetuti ritorni. Il libro How Forests Think nasce dopo una permanenza nel 2010 ed è stato pubblicato per la prima volta nel 2013. L’opera, dopo aver vinto nel 2014 il Gregory Bateson Prize, è stata tradotta in oltre 10 lingue e dal 24 giugno è disponibile anche in Italia con il titolo Come pensano le foreste, edita dalla casa editrice Nottetempo e tradotta da Alessandro Lucera e Alessandro Palmieri.
- Ripensare l’umano
Un libro che è una rivoluzione di cui abbiamo effettivo bisogno. Un nuovo approccio copernicano pronto a mettere in discussione la centralità dell’antropos rispetto agli altri abitanti del Pianeta.
Il pensiero non è più appannaggio esclusivo del genere umano, non è il tratto che ci contraddistingue dagli altri esseri viventi, siano essi piante, animali o interi ecosistemi. Per spiegarci tutto questo e mettere in discussione i nostri parametri di approccio logico razionale, Kohn utilizza proprio i principi cardine del pensiero occidentale rifacendosi alla mitologia greca, alla filosofia classica, alla letteratura, all’ambito delle scienze e ovviamente all’antropologia culturale.
Impossibile dunque liquidare questo lavoro come una sorta di decostruzione psico-metafisica più vicina ai testi di carattere spirituale che a quelli scientifici. Ci troviamo di fronte a un pensiero logico razionale occidentale in grado di interrogarsi davanti a una foresta, mettersi in discussione e riscoprirsi. «Questo libro è un tentativo di meditare sull’enigma della Sfinge (quella che nel mito greco Edipo incontra sulla strada per Tebe), attraverso un approccio etnografico a una serie di incontri amazzonici altro-che-umani. Indagare le nostre relazioni con questi esseri che esistono in qualche modo oltre l’umano ci spinge a mettere in discussione le nostre abituali risposte sull’umano. L’obiettivo qui non è né sbarazzarsi dell’umano né conferirgli una nuova posizione, ma aprirlo». Kohn definisce tale approccio “antropologia oltre l’umano”.
- Esta selva selvaggia
Apre il primo capitolo introduttivo l’esergo dantesco a noi italiani particolarmente noto: «Ahi quanto a dir qual’era è cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte»: ci stiamo inoltrando in un percorso di autoconoscenza che avrà come controparte il mondo selvaggio. E per farlo dobbiamo inevitabilmente, proprio come fece il padre della nostra lingua, tener presente la semiotica, la creazione e l’interpretazione di segni per comunicare. Kohn a questo riguardo chiarisce subito che «Il primo passo per capire come pensano le foreste è abbandonare i nostri preconcetti su cosa significhi avere una rappresentazione di qualcosa». Siamo abituati a considerare le rappresentazioni come linguaggi in quanto la nostra rappresentazione linguistica si basa su segni convenzionali collegati agli oggetti a cui si riferiscono. Ma non tutti i processi semiotici hanno queste proprietà. Dobbiamo superare l’approccio dualistico «in cui gli umani vengono descritti come separati dai mondi che rappresentano, per andare verso un approccio monista, nel quale i modi in cui gli umani si rappresentano i giaguari e i modi in cui i giaguari si rappresentano gli umani possano essere intesi come parti integranti, sebbene non interscambiabili, di un’unica storia senza fine. Date le sfide poste dalla necessità di imparare a vivere con una varietà sempre più grande di forme di vita - siano esse animali domestici, erbe infestanti, parassiti, organismi commensali, nuovi agenti patogeni, animali ‘selvatici’ o ‘mutanti’ tecno-scientifici - non solo è di cruciale importanza, ma è anche urgente sviluppare una precisa maniera di analizzare quanto l’umano sia distinto da, e allo stesso tempo in continuità con, tutto ciò che si trova al di là di esso».
- Sumak Kawsay
In kichwa, la lingua dei runa, esiste il termine “sumak kawsay” ed esprime un concetto legato all’importanza del vivere in equilibrio con la foresta. Si tratta di un modo di prestare attenzione alle proprietà della vita nelle sue varie forme. È un orientamento etico che proviene dall’osservazione e l’interrelazione con il mondo naturale e prende forma quando l’essere umano riesce a pensare con la foresta. Kohn, attraverso diversi esempi e approfondimenti, giunge alla deduzione che una foresta pensi attraverso immagini che possiedono la qualità ontologica delle totalità semplici, ossia sono autosufficienti e complete, iconiche. Per connettersi a questi pensieri silvestri anche l’essere umano deve pensare attraverso immagini, per questo motivo i runa prestano particolare attenzione alle suggestioni che arrivano dal mondo onirico.
** Fonte: "Sapere Ambiente", 6 Luglio 2021 (ripresa parziale).
Nota
FILOLOGIA #DENDROLOGIA #STORIA:
 "COME PENSANO LE FORESTE. PER UN’#ANTROPOLOGIA OLTRE L’UMANO.
"COME PENSANO LE FORESTE. PER UN’#ANTROPOLOGIA OLTRE L’UMANO.
 Eduardo #Khon: "Se avessi scritto questo libro per i #Runa di #Ávila... non gli avrei dato lo stesso titolo"
Eduardo #Khon: "Se avessi scritto questo libro per i #Runa di #Ávila... non gli avrei dato lo stesso titolo"Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!La buona-esortazione del BRASILE (2005). --- RIO DE JANEIRO. Brasile: Lula e Bolsonaro al ballottaggio il 30 ottobre 2022.3 ottobre 2022, di Federico La Sala
Brasile: Lula e Bolsonaro al ballottaggio il 30 ottobre
Sondaggi smentiti, il presidente di destra batte le aspettative
di Redazione ANSA*
RIO DE JANEIRO. Il Tribunale supremo elettorale (Tse) del Brasile ha diramato alle 2:15 (le 7:15 italiane) i risultati praticamente definitivi delle elezioni presidenziali da cui emerge la certezza di un ballottaggio il 30 ottobre prossimo fra i due candidati meglio piazzati.
Con lo scrutinio delle schede del 99,99% dei seggi, Luiz Inacio Lula da Silva (Pt, sinistra) ha ricevuto 57.254.672 voti, pari al 48,43%, mentre Jair Bolsonaro (Pl, destra) ne ha ottenuti 51.070.672, equivalenti al 43,20%.
Il terzo posto nella scelta degli elettori è andato a Simone Tebet (Mdb, centro-destra) con 4.915.217 voti (4,16%) e il quarto a Ciro Gomes (Pdt, sinistra) con 3.599.157 suffragi (3,04%).
Il Brasile resta in bilico. Il risultato elettorale non ha restituito una vittoria netta. La festa è rimandata al ballottaggio del 30 ottobre. Luiz Inacio Lula da Silva, 76 anni, icona della sinistra sudamericana, grande favorito ai sondaggi, non ha confermato i pronostici di vittoria della vigilia, che gli attribuivano fino al 51% di consensi già al primo turno. Quasi al termine degli scrutini il leader del Partito dei lavoratori (Pt) aveva totalizzato il 48,43% di voti, mentre il suo avversario, il presidente di destra uscente, Jair Bolsonaro (Pl), 67 anni, il 43,20%, battendo tutte le aspettative, e tallonando in un conteggio sul filo di lana. "La lotta continua fino alla vittoria finale". Il ballottaggio non è che una "proroga", ha commentato Lula al termine dello scrutinio, spronando i delusi. Tornato a San Paolo da San Bernardo do Campo, sua roccaforte elettorale dove in mattinata aveva votato, il leader di sinistra ha atteso il responso al Novotel Jaraguà, con la moglie Janja, il vice designato per il suo futuro governo, Geraldo Alckmin, e l’ex presidente Dilma Roussef. Al termine della serata ha raggiunto l’avenida Paulista, prenotata per il bagno di folla della svolta, e ridotta invece a teatro per un abbraccio con qualche decina di migliaia di sostenitori. "Abbiamo vinto sulle menzogne" dell’istituto di sondaggi "Datafolha". Ora "lavorerò per cambiare il voto della gente" ha promesso Bolsonaro, in giornata bersaglio di un attacco hacker alla pagina web. Anche lui è rientrato dalla trasferta per il voto, da Rio de Janeiro al Palacio da Alvorada, la sua residenza ufficiale a Brasilia, dove la recinzione attorno all’edificio è stata addirittura ampliata, per ospitare i suoi numerosi sostenitori.
Da ora alla fine di ottobre la partita è indubbiamente tutta aperta, e per il colosso verde-oro si annunciano giorni difficili, con una nuova appendice di campagna elettorale ad alta tensione. Il rischio è che Bolsonaro getti benzina sul fuoco, incendiando le piazze ed accelerando nei suoi attacchi senza tregua per screditare il Tribunale superiore elettorale (Tse) ed il suo presidente, il giudice Alexandre de Moraes, cuore delle procedure democratiche. Una deriva pericolosa, con i Paesi occidentali - Europa e Stati Uniti in testa - che nelle ultime settimane avevano inviato appelli richiamando al rispetto dello stato di diritto. E in questo periodo di transizione il presidente uscente potrebbe varare misure provvisorie ad effetto immediato (con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), per dare nuovo impulso alla liberalizzazione della vendita delle armi, accrescendo così il rischio di violenza politica. Una polarizzazione estrema che nei 46 giorni di campagna elettorale al veleno, dal 16 agosto all’apertura dei seggi elettronici del 2 ottobre, ha già fatto contare tre morti, e vari episodi di intimidazione. Secondo gli analisti, a pesare sul risultato sono stati gli indecisi, il tasso di astensione, e quanti hanno creduto di abbracciare la scelta del cosiddetto ’voto utile’ (quello cioè di chi avrebbe voluto vedere l’elezione chiusa al primo turno). Malgrado infatti il voto per i 156milioni di brasiliani chiamati alle urne sia obbligatorio, il tasso di astensione è salito dal 20,3% del 2018 all’attuale 20,94. E proprio Lula sarebbe stato il più danneggiato da questo incremento di assenze. Il primo turno è stato seguito anche dagli osservatori internazionali dell’Organizzazione degli Stati americani, su invito del Tse. Il gruppo - composto da 55 esperti provenienti da 17 Paesi - è stato dispiegato in 15 dei 26 Stati federativi e nel Distretto di Brasilia., certificando che tutto si è svolto in modo corretto, come ha dichiarato il capo della missione, Ma a sorvegliare sulle urne sono stati anche i militari dell’esercito, in un’iniziativa spinta da Bolsonaro, che come il suo avversario Lula ora medita le sue prossime mosse per la vittoria.
* Fonte: ANSA, 03 ottobre 2022
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Dal presidente della Cei un richiamo a un’Europa "che conti di più", che sia più unita e solidale soprattutto di fronte alle grandi sfide del nostro tempo (di Luca Mazza).17 settembre 2022, di Federico La Sala
Cei. Zuppi: «L’Europa è irrilevante e risulta antipatica perché vincono i nazionalismi»
Dal presidente della Cei un richiamo a un’Europa "che conti di più", che sia più unita e solidale soprattutto di fronte alle grandi sfide del nostro tempo
di Luca Mazza, inviato a Firenze (Avvenire, sabato 17 settembre 2022)
- [Foto] Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei - Ansa
È un richiamo a un’Europa "che conti di più", che sia più unita e solidale soprattutto di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, dalla lotta alle diseguaglianze alla necessità di un’ecologia integrale. Dal Festival dell’Economia Civile in corso a Firenze il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, invita l’Unione Europea a incidere maggiormente sulla scena internazionale senza far prevalere gli egoismi: "L’Europa è irrilevante, come hanno dimostrato le ultime crisi, perché vincono i nazionalismi, vince la piccola sovranità rispetto a una sovranità superiore. È irrilevante perché non c’è visione, quella che avevano i padri fondatori e tutti coloro che hanno vissuto la guerra, che avevano visione e consapevolezza che è indispensabile".
Ecco perché secondo Zuppi è urgente lavorare in modo diverso: "C’è bisogno di restituire all’Europa una grande prospettiva, altrimenti risulta antipatica e viene vista come un grande supermercato che non crede più a niente". In quest’opera di “rinnovamento” il presidente della Cei suggerisce di lasciarsi ispirare dai princìpi fondativi e dallo spirito con cui è nata l’Europa: "I nazionalismi - aggiunge Zuppi - sono l’opposto della bellezza dell’Europa che è una cosa straordinaria, è un dovere perché l’Europa nasce dalla sofferenza di milioni di persone che hanno perso la vita e non ci possiamo permettere di giocarci".
Citando più volte l’enciclica Fratelli tutti che "riassume perfettamente" la visione che bisogna avere per rispondere alle emergenze e ai nuovi bisogni, Zuppi sostiene che le disuguaglianze si combattono con "tanta solidarietà e tanta condivisione, e con la consapevolezza che se ne esce insieme, perché se restano perdiamo tutti".
Infine, sollecitato a dare un consiglio ai leader dei partiti italiani impegnati negli ultimi giorni di campagna elettorale, Zuppi evidenzia l’importanza di "evitare la tattica" e di non inseguire a tutti i costi temi e proposte "ad uso e consumo immediato".
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- MEMORIA E STORIA: CANADA. Viaggio del Papa. Parla il presidente della Conferenza episcopale canadese, Raymond Poisson25 luglio 2022
Viaggio in Canada. Il Papa è arrivato a Edmonton: la cerimonia di accoglienza / Video
- Al centro del programma gli incontri con gli indigeni in un viaggio di riconciliazione
Viaggio del Papa. «In Canada è tempo di riconciliazione, ripartiamo senza dimenticare»
Parla il presidente della Conferenza episcopale canadese, Raymond Poisson, vescovo di Saint Jerome-Mount Laurier
di Elena Molinari, Montreal sabato 23 luglio 2022*
Un passo nel cammino della riconciliazione con le popolazioni autoctone e un conforto per i cattolici canadesi turbati dalle notizie sulle scuole residenziali. Il presidente della Conferenza episcopale canadese, Raymond Poisson, vescovo di Saint Jerome-Mount Laurier, a pochi chilometri da Montreal, ha grandi attese per la visita del Papa che comincerà oggi ad Alberta.
- Eccellenza, ci aiuta a comprendere il significato di questa visita?
Il Pontefice ha accettato l’invito dei vescovi canadesi di venire nella nostra terra nel contesto della riconciliazione con le popolazioni indigene. Durante il suo incontro con i rappresentanti delle Prime Nazioni autoctone in Vaticano, si è scusato per la partecipazione della Chiesa cattolica nella gestione nelle scuole residenziali. Quando poi gli ho parlato di quanto sant’Anna sia importante per i canadesi, sia autoctoni che non, ha accettato con entusiasmo di venire a celebrare con loro la festa della madre di Maria.
- E per poterlo fare il Papa coprirà grandi distanze in sei giorni.
Il programma è stato deciso in collaborazione con i leader delle Prime Nazioni e sono state scelte una tappa nell’Est e una nell’Ovest, due realtà molto diverse. E poi una nel Grande Nord, terra d’origine della popolazione Inuit. Ad Alberta, dove Francesco atterrerà, è stato scelto un luogo di pellegrinaggio, il lago Sant’Anna, a Nord di Edmonton, un bellissimo luogo naturale. Chiamato Wakamne o lago di Dio dalla nazione Alexis Nakota Sioux e Manito Sahkahigan o Lago Spirito dai Cree, da oltre cent’anni è la destinazione di incontri spirituali unici in Nord America. Il Papa visiterà anche una scuola residenziale che è stata aperta dal 1916 al 1975. All’Est è stato scelto il Santuario di Sant’Anna de Beaupré, un’altra antica meta di pellegrinaggio che accoglie persone di ogni appartenenza etnica e sociale da oltre 350 anni. Da allora i Mi’kmaq onorano sant’Anna come un’anziana che guida con saggezza la comunità. Entrambi i siti faranno da sfondo a eventi ad ampia partecipazione di pubblico, che si alterneranno a momenti più privati, in particolare quello nel Nunavut, dove il Papa andrà a salutare gli Inuit a casa loro. Ad ogni tappa c’è stata un’enorme richiesta e i posti sono già tutti esauriti.
- Pensa che la visita avrà risultati concreti per rasserenare i rapporti fra la Chiesa e le popolazioni indigene canadesi?
Penso che ci permetterà di andare al di là delle scuse per cominciare a fare insieme dei gesti che permettano di avanzare insieme, senza dimenticare. Il primo è la venuta stessa del Papa, soprattutto nell’ottica della sua ridotta mobilità, che rivela il suo grande interesse. Inoltre i vescovi canadesi hanno creato un fondo di 30 milioni di dollari, che per la nostra Chiesa locale è stato difficile raccogliere, per progetti da realizzare in cinque anni insieme ai consigli delle bande e delle riserve, che approfondiscano la mutua conoscenza e costruiscano dei monumenti in memoria dei bambini morti nelle scuole residenziali. Sono già stati creati dei comitati congiunti a questo scopo.
- Che realtà cattolica trova il Papa in Canada?
In Quebec, da dove vengo e dove si trova la mia diocesi, siamo passati in relativamente poco tempo da una Chiesa che era un’istituzione sociale, all’interno della quale la pratica religiosa non era sempre vissuta in piena libertà a causa della pressione sociale, a una Chiesa che riunisce persone che decidono di pregare e di implicarsi nella vita comunitaria malgrado la pressione sociale che spinge in direzione contraria. Sono sempre sorpreso di vedere come questa tensione permane fra i fedeli. Il risultato è che la presenza alla Messa domenicale è molto bassa, ma ci sono molti segni che la fede e il bisogno di spiritualità sono forti, come si vedrà in occasione della visita del Santo Padre. Noto ad esempio che i giovani sono molto più interessati dei loro genitori, cresciuti all’indomani della cosiddetta rivoluzione tranquilla. Penso che il Papa saprà portare loro, in questo contesto, la conferma che la Parola di Gesù dà senso alla vita.
- Le notizie di abusi nelle scuole residenziali per bambini autoctoni hanno turbato i cattolici canadesi. Che cosa aspettano dall’arrivo del Papa?
Soprattutto dell’Ovest, dove la presenza e l’influenza delle scuole è stata molto più significativa, i cattolici hanno sofferto all’apprendere queste notizie. Io ho 74 anni e non ne avevo sentito parlare fino al 2015, quando è stato presentato il primo rapporto su queste scuole volute dal governo. Nel 2021, alla scoperta dei cimiteri, che sono già citati dal rapporto, l’emozione ha preso il sopravvento anche fra i cattolici. Il Papa porterà loro conforto e conferma della sua volontà di riconciliazione.
- Molti canadesi seguiranno la visita attraverso le reti sociali: lo vede come un bene?
Assolutamente. Diffonderemo al massimo ogni tappa sulle reti sociali per toccare più gente possibile. Questi mezzi sono nostri alleati e bisogna saperli utilizzare e relativizzare. E soprattutto collaborare con loro perché il Vangelo incontri l’uomo.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Presente storico e storia di lunga durata: il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II e il sogno del Re del mondo in Hegel.3 giugno 2022, di Federico La Sala
RISALIRE LA CORRENTE. Storia Filosofia, Antropologia, Psicoanalisi, e Costituzione (#2giugno 2022).
Europa e Giubileo di Platino di Elisabetta II d’Inghilterra. Presente storico e storia di lunga durata...
Per riflettere sull’idea di sovranità (e l’individualità dello Stato), oggi, associare (come ha fatto qualcuno) la figura della regina Elisabetta II con il testo della "Filosofia del diritto" (& 279) di Hegel è un ottimo invito a svegliarsi dal sonno dogmatico (Kant) e a riaprire la questione antropologica (e teologico-politica)!
Sollecita a ripensare la storia dell’Europa quanto meno dalla disfatta della Invincibile Armada, da Elisabetta I e da Shakespeare e, ancora, da Trafalgar e da Napoleone e, infine, dal successo di Hegel di proporsi (illuminato da Napoleone a Jena, 1806) come interprete della storia dell’ "anima del mondo", come figura del "Re del mondo"!
EDIPO, TEBE, E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (Freud, 1929). La questione antropologica e politica su cui si arrovella Shakespeare con il suo "Amleto" è ancora l’enigma della sfinge: "Che cos’è mai un uomo se del suo tempo non sa far altr’uso che per mangiare e dormire?" (Amleto, Atto IV, Sc. 4).
Federico La Sala
-
>Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE (2005) --- Storia, storiografia, e sonno dogmatico. Una nota margine di una lapide nella basilica di San Nicola di Bari.26 aprile 2022, di Federico La Sala
L’IMPERO E LA CHIESA (BARI, 1936). Storia, storiografia, e sonno dogmatico.
Una nota a margine di una segnalazione ... *
Il 9 maggio 1936, Mussolini celebra "dopo quindici secoli, la riapparizione dell’Impero sui Colli fatali di Roma". Il "5 settembre 1936", nella Basilica di San Nicola di Bari, è murata su una parete una lapide ben illuminata su cui è scritto:
- "QUI - NELLO STORICO TEMPIO - DEL SANTO MEDITERRANEO - IL COMUNE - RIEVOCA ED ONORA - TUTTI I FIGLI DI BARI - CHE IN TERRA SUI MARI E NEI CIELI - OFFRIRONO - L’EROICA PASSIONE DELLA LORO GIOVINEZZA - PER CONQUISTARE ALLA GRANDE PATRIA - SICURI CONFINI E AUREOLA DI POTENZA IMPERIALE - 5-SETT-MCMXXXVI". *
Per capire le ragioni politico-culturali di questo "documento" del Comune di Bari, collocato "nello storico tempio del santo mediterraneo", nella Chiesa di San Nicola di Bari, forse, è bene ampliare lo sguardo intorno alla data del "5-SETT-MCMXXXVI" (5 SETTEMBRE 1936) e quanto meno ricordare gli accordi sottoscritti tra il Regno d’Italia e la Santa Sede l’11 febbraio 1929 (Patti Lateranensi) e al contempo "riascoltare" e rileggere il "Discorso di proclamazione dell’Impero", tenuto da Mussolini dal balcone di piazza Venezia la sera del 9 maggio 1936:
- “[...] L’Italia ha finalmente il suo Impero. Impero fascista perché porta i segni indistruttibili della volontà e della potenza del Littorio romano; perché questa è la meta verso la quale durante quattordici anni furono sollecitate le energie prorompenti e disciplinate delle giovani, gagliarde generazioni italiane. [...] In questa certezza suprema levate in alto, legionari, le insegne, il ferro e i cuori a salutare, dopo quindici secoli, la riapparizione dell’Impero sui Colli fatali di Roma. Ne sarete voi degni?” (Benito Mussolini, "Discorso di proclamazione dell’Impero", 1936).
Il 1° marzo 1924, su "L’Ordine Nuovo", Antonio Gramsci aveva già scritto: "Roma non è nuova a questi scenari polverosi. Ha visto Romolo, ha visto Cesare Augusto e ha visto, al suo tramonto, RomoloAugustolo". Evidentemente gli ideologi imperiali avevano ignorato la lezione di Dante sulla Monarchia e sui "venticinque secoli" (Par. XXXIII, 95), come quella di Goethe sui "tremila anni" ("Libro del malumore", 1819).
* Una "lapide che lascia perplessi!", si cfr. la segnalazione di Nicola Fanizza.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ARCHEOLOGIA MEMORIA E STORIA. RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DAL "DE PACE FIDEI" (1454) E DELLO "SPIRITO DI ASSISI" (1986)4 aprile 2022, di Federico La Sala
L’Europa, la guerra, la pace, e il disagio della civiltà...
- IN RICORDO DI KAROL JOZEF WOJTYLA - PAPA GIOVANNI PAOLO II (morto il 2 aprile 2005) E DELL’INCONTRO INTERRELIGIOSO DI ASSISI DEL 27 OTTOBRE 1986, UNA SOLLECITAZIONE A RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DEL DIALOGO, DELL’ECUMENISMO, E DELLA PACE, A TUTTI I LIVELLI...
- "Chi di tremila anni / Non sa darsi conto, / Rimane all’oscuro inesperto, /Vuol vivere così di giorno in giorno" (J. W. Goethe, "Libro del malumore", 1819 ca.).
UNA QUESTIONE DI LUNGA DURATA: INIZIO DELLA FINE DEL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO (LORENZO vALLA, 1440), "LA DOTTA IGNORANZA" (NICCOLO’ CUSANO, 1440) E "LA PACE DELLA FEDE" (NICCOLO’ CUSANO, "De Pace Fidei",1454)...
GIORNI FA (IL 24 MARZO 2022) E’ STATO DATO CONTO DELLA SCOPERTA DI UNA EPIGRAFE DELLA VISITA, AVVENUTA NEL 1452 A SERMONETA (LATINA), DELL’IMPERATORE DEL SACRO ROMANO IMPERO, FEDERICO III D’ASBURGO (PADRE DI MASSIMILIANO I). DA RICORDARE CHE L’ANNO SUCCESSIVO, NEL 1453, CI FU L’ASSEDIO, LA CADUTA, E LA CONQUISTA DI COSTANTINOPOLI E, NEL 1492, IN SPAGNA, NON CI FU SOLO L’AVVIO DELL’AVVENTUROSA "SCOPERTA DELL’ AMERICA", MA ANCHE E SOPRATTUTTO LA FINE DELLA GUERRA DI GRANADA E DELLA RECONQUISTA...
BRUXELLES, 1477: “[...] Il Molinet paragona l’imperatore Federico [III d’Asburgo] che manda suo figlio Massimiliano a sposare Maria di Borgogna, con Dio Padre che manda suo figlio in terra, e non risparmia termini religiosi per descrivere il viaggio dello sposo. Quando più tardi Federico e Massimiliano entrarono a Bruxelles col giovane Filippo il Bello, i Brussellesi, narra Molinet, avrebbero detto colle lagrime agli occhi: «Veez-ci figure de la Trinité, le Père, le Fil et Sanct Spirit». Il Molinet stesso offre una corona di fiori a Maria di Borgogna, come alla degna immagine della Madonna, «a parte la verginità».
 «Non che io voglia deificare i principi», dice questo arcicortigiano. Può darsi che si tratti effettivamente di vuote frasi più che di venerazione realmente sentita, ma esse attestano ugualmente come l’uso quotidiano di termini sacri finisse per svalutarli. Del resto non sarebbe giusto rimproverare un poetastro di corte, quando un [Jean de] Gerson stesso attribuisce ai principeschi ascoltatori delle sue prediche speciali angeli custodi più elevati in grado di quelli degli altri mortali” (Johan Huizinga, “L’autunno del Medio Evo”, Sansoni Editore, Firenze 1978).
«Non che io voglia deificare i principi», dice questo arcicortigiano. Può darsi che si tratti effettivamente di vuote frasi più che di venerazione realmente sentita, ma esse attestano ugualmente come l’uso quotidiano di termini sacri finisse per svalutarli. Del resto non sarebbe giusto rimproverare un poetastro di corte, quando un [Jean de] Gerson stesso attribuisce ai principeschi ascoltatori delle sue prediche speciali angeli custodi più elevati in grado di quelli degli altri mortali” (Johan Huizinga, “L’autunno del Medio Evo”, Sansoni Editore, Firenze 1978).IL RINASCIMENTO, COME FINE DELL’AUTUNNO DEL MEDIO EVO
Mettendo insieme, con l’aiuto di Raffaello e Michelangelo, gli elementi dell’idea di famiglia di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi, il Rinascimento mostra essere un "canto del cigno" dell"autunno del Medio Evo (Johan Huizinga). Il 1517, con le 95 Tesi di Lutero, non è lontano...
Questo, il problema: nonostante la grandezza della concezione teologica ed artistica della sacra famiglia che sta alla base della stessa costruzione della Cappella Sistina (1475/1481) prima e della operazione di Michelangelo dopo (1508-1512), ciò che viene detto e comunicato anche con il riferimento nei disegni dietro i ritratti di Raffaello (Agnolo Doni e Maddalena Strozzi: 1504-1508) è una dottrina fondata sulla dotta ignoranza (Niccolo Cusano, 1440), fiammingamente ispirata, di come nascono i bambini (Diluvio, Deucalione e Pirra): il problema dell’incarnazione e della nascita del Messia è ancora letta dal cardinale Cusano come da teologi e teologhe di oggi secondo la lezione dell’antropologia tebana, del codice della tragedia greca (Socrate, Platone, e Aristotele)!
Che dire? Che fare? Per il Sorgere della Terra, una linea di fuga messianica è proprio nella cornice del Tondo Doni. Dare a Giuseppe ciò che è di Giuseppe e a Maria ciò che è di Maria. La storia non è fatta da quattro profeti, ma due sibille e due profeti...
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE (2005). Una "memoria" --- LA RIVOLUZIONE FRANCESE E HITLER. Una nota a margine della "strana disfatta" (Marc Bloch, 1940).29 marzo 2022, di Federico La Sala
LA RIVOLUZIONE FRANCESE, HITLER, E "LA STRANA DISFATTA". Una storia di lunga durata...
Marc Bloch così concludeva la sua riflessione sulla "strana disfatta": «Hitler diceva, un giorno, a Rausching: "Facciamo bene a speculare più sui #vizi che sulle virtù degli uomini. La Rivoluzione francese si richiamava alla virtù. Sarà meglio per noi fare il contrario". Si perdonerà a un Francese, cioè a un uomo civile - che è la stessa cosa - di preferire, a questo insegnamento, quello della Rivoluzione e di Montesquieu: "In uno Stato popolare è necessaria una forza, che è la virtù"»(Marc Bloch,"La strana disfatta. Testimonianza scritta nel 1940").
Appunti sul tema, nel sito, si cfr.
- "[...] Nel 1770 a Strasburgo, nei pressi del confine del Sacro Romano Impero con la Francia, Goethe “guarda un arazzo che narra le storie di Giasone, di Medea e di Creusa”, preparato “per le feste in onore dell’arrivo della sposa” di Luigi XVI di Borbone, Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena che si stava trasferendo a Versailles, e così commenta: «dunque un esempio del più infelice matrimonio»"!
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
FLS
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- DANTE E KANTOROWICZ: RIPENSARE COSTANTINO E LA TEOLOGIA POLITICA DELL’EUROPA.5 marzo 2022, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA E COSTITUZIONE:
RIPENSARE COSTANTINO E LA TEOLOGIA E LA POLITICA DELL’EUROPA.
Un omaggio a Beatrice Maria e Lucia (8 marzo) e a Dante Alighieri (25 marzo - Dantedì)...
USCIRE A RIVEDERE IL CIELO STELLATO. Non avendo sottratto alla teologia e alla logica dell’ Imperatore Costantino l’opera di Dante Alighieri (ridotto dalla Chiesa Cattolica di Giovanni XXII, prima che da Ugo Foscolo, a "ghibellino fuggiasco"), filosofi e storici hanno finito per banalizzare anche il lavoro di Ernst H. Kantorowicz! Si tenga presente, per capire bene e meglio l’uno e l’altro, che l’ultimo capitolo (l’ottavo) dei "Due corpi del re" è intitolato "La regalità antropocentrica: Dante" e, al contempo, che la regalità antropocentrica è da leggersi in senso antropologico (di ogni essere umano, "ecce homo"), non in senso di una andrologia costantiniana (di ogni essere umano-maschio, "ecce vir")!
COSTITUZIONE. La "Monarchia" dei "due Soli" non dice né della dittatura dell’Imperatore né della dittatura del Papa, ma indica che l’uno e l’altro, semplicemente (la cosa più difficile a farsi), dia a "Dio" (l’amor che muove il sole e le altre stelle) ciò che è di "Dio" e ognuno all’altro (entrambi sovrani - memoria di don Milani) ciò che tocca all’uno e all’altro - nel riconoscimento della sovranità di "Dio" stesso, della Legge dei nostri Padri Costituenti e delle nostre Madri Costituenti. Se in principio era la Costituzione (il Logos), "Quis Ut Deus?" ("Chi è come Dio")?!
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- IL NUOVO SCONTRO DI CIVILTA. Se in Ucraina non cessa il fuoco e l’Europa non inverte la rotta imboccando la strada della smilitarizzazione (di Ida Dominijanni).4 marzo 2022, di Federico La Sala
Il nuovo scontro di civiltà
di Ida Dominijanni (CRS, 4 Marzo 2022)
All’alba del nono giorno di guerra l’attacco delle truppe russe alla centrale nucleare Zaporizhzhia rende meglio di qualunque altro dettaglio quale sia la posta della partita globale, biopolitica prima che geopolitica, che si sta giocando in Ucraina. E il peggio deve ancora venire, ha comunicato Macron cui Putin ha fatto presente che non intende fermarsi finché non avrà conquistato l’intero paese. Le regioni russe dell’est e del sud con gli accessi al mare sono ormai in mano ai russi, a Mariupol mezzo milione di abitanti sono intrappolati senza acqua e senza cibo, a nord-ovest Leopoli è piena di profughi in fuga, più donne e bambini che uomini perché gli uomini restano a combattere una battaglia di resistenza già persa.
 L’esile negoziato in corso a Brest ha deciso l’apertura di corridoi umanitari per favorire l’esodo dei civili, mentre la colonna di 60 kilometri di carri russi continua la sua lenta ma inesorabile avanzata su Kiev lungo il corso del Dnepr che in futuro potrebbe dividere l’Ucraina fra un est russo e un ovest occidentale, com’era un tempo la Germania: le stesse cose ritornano sempre, nella storia, come il rimosso nell’inconscio. Dev’essere per questo che tutti definiscono questa in Ucraina “la prima guerra nel cuore dell’Europa dopo più di settant’anni”, dimenticando clamorosamente che in Europa la guerra era già tornata negli anni Novanta, in quella ex Jugoslavia che ha anticipato e prefigurato tutte le guerre successive a base etnico-nazionalista sparse per il mondo. -Forse che la Jugoslavia non era il cuore ma la periferia dell’Europa? O non sarà piuttosto che nell’immaginario europeo, il cuore dell’Europa resta sempre lì, al confine fra l’ex impero sovietico e l’Occidente democratico? Lì, dove secondo gli stessi che nell’89 decretavano “la fine della storia” oggi la storia riprenderebbe in grande, quasi che in mezzo non ci fosse stato niente. Lì, dove si sono convocati tutti i fantasmi che fino a ieri l’altro vagavano per l’est e per l’ovest, e che ora muovono questa terribile resa dei conti di un trentennio cominciato male e finito peggio. Che è la vera posta in gioco, reale e simbolica, della tragedia che si sta consumando.
L’esile negoziato in corso a Brest ha deciso l’apertura di corridoi umanitari per favorire l’esodo dei civili, mentre la colonna di 60 kilometri di carri russi continua la sua lenta ma inesorabile avanzata su Kiev lungo il corso del Dnepr che in futuro potrebbe dividere l’Ucraina fra un est russo e un ovest occidentale, com’era un tempo la Germania: le stesse cose ritornano sempre, nella storia, come il rimosso nell’inconscio. Dev’essere per questo che tutti definiscono questa in Ucraina “la prima guerra nel cuore dell’Europa dopo più di settant’anni”, dimenticando clamorosamente che in Europa la guerra era già tornata negli anni Novanta, in quella ex Jugoslavia che ha anticipato e prefigurato tutte le guerre successive a base etnico-nazionalista sparse per il mondo. -Forse che la Jugoslavia non era il cuore ma la periferia dell’Europa? O non sarà piuttosto che nell’immaginario europeo, il cuore dell’Europa resta sempre lì, al confine fra l’ex impero sovietico e l’Occidente democratico? Lì, dove secondo gli stessi che nell’89 decretavano “la fine della storia” oggi la storia riprenderebbe in grande, quasi che in mezzo non ci fosse stato niente. Lì, dove si sono convocati tutti i fantasmi che fino a ieri l’altro vagavano per l’est e per l’ovest, e che ora muovono questa terribile resa dei conti di un trentennio cominciato male e finito peggio. Che è la vera posta in gioco, reale e simbolica, della tragedia che si sta consumando.Hanno suscitato indignazione e scandalo i due discorsi del 21 e del 24 febbraio con cui Putin ha annunciato prima il riconoscimento ufficiale delle repubbliche separatiste del Donbass e poi la sua “operazione militare speciale”, come l’ha chiamata lui, in Ucraina. Ne consiglierei tuttavia la lettura integrale (il testo è facilmente reperibile in rete), ammesso che sia ancora lecito cercare di capire perché accade quello che accade senza essere tacciati di connivenza con il nemico. Liquidati dai più come una litania del risentimento, o come il delirio paranoico da sindrome di accerchiamento di un uomo solo al comando provato dalla fobia del Covid, i due discorsi inanellano alcuni dati di fatto incontrovertibili sull’estensione a est della Nato, sulle guerre di aggressione perpetrate dall’Occidente dagli anni novanta in poi (Kosovo, Iraq, Siria, Libia), e, più in generale, sullo “stato di euforia da superiorità assoluta, una sorta di assolutismo di tipo moderno, per di più sullo sfondo di un basso livello di cultura generale” che si è impossessato del campo dei vincitori della Guerra fredda.
 Ma al di là di questo merito, nonché della ricostruzione delle cause di lungo periodo della rinascita dei nazionalismi, a Est dopo la fine dell’Urss, ciò che colpisce nelle parole di Putin è la rivendicazione della dimensione storica come sfondo ineludibile del discorso politico. Precisamente lo sfondo che manca al discorso politico occidentale, che di spessore storico sarebbe supposto essere il più dotato. E che invece risponde all’aggressione di Putin usando - mirabile sintesi di un cinquantennio di ideologia neoliberale - solo il linguaggio dell’economia e della sicurezza: sanzioni e riarmo, nell’oblio - perfino teorizzato, come nel discorso alle camere di Mario Draghi - del passato che ha costruito, mattone dopo mattone, il presente.
Ma al di là di questo merito, nonché della ricostruzione delle cause di lungo periodo della rinascita dei nazionalismi, a Est dopo la fine dell’Urss, ciò che colpisce nelle parole di Putin è la rivendicazione della dimensione storica come sfondo ineludibile del discorso politico. Precisamente lo sfondo che manca al discorso politico occidentale, che di spessore storico sarebbe supposto essere il più dotato. E che invece risponde all’aggressione di Putin usando - mirabile sintesi di un cinquantennio di ideologia neoliberale - solo il linguaggio dell’economia e della sicurezza: sanzioni e riarmo, nell’oblio - perfino teorizzato, come nel discorso alle camere di Mario Draghi - del passato che ha costruito, mattone dopo mattone, il presente.Sia chiaro: lo sfondo e l’uso della storia non giustificano in alcun modo la mossa di Putin. L’invasione di uno Stato sovrano e confinante viola le basi del diritto internazionale, resuscita, a proposito di storia lunga, tutti i mostri del passato europeo, e si configura per di più, nelle stesse motivazioni che Putin ne dà, come una sorta di preemptive war, una guerra preventiva contro il pericolo eventuale di un’aggressione alla Russia da parte della Nato (i nemici assoluti sono spesso segretamente gemelli, e Putin evidentemente ha imparato qualcosa da George W. Bush).
 Nessuna ragione di lungo periodo esenta di un grammo di responsabilità la decisione con cui il presidente russo ha portato il mondo sull’orlo del precipizio. Ma pare assai improbabile che dal precipizio le democrazie occidentali possano uscire senza aprire al proprio interno tre linee di ripensamento autocritico di un passato prossimo che invece tendono solo a rimuovere o a riconfermare.
Nessuna ragione di lungo periodo esenta di un grammo di responsabilità la decisione con cui il presidente russo ha portato il mondo sull’orlo del precipizio. Ma pare assai improbabile che dal precipizio le democrazie occidentali possano uscire senza aprire al proprio interno tre linee di ripensamento autocritico di un passato prossimo che invece tendono solo a rimuovere o a riconfermare.La prima linea riguarda l’atroce sequenza di guerre con cui l’Occidente ha insanguinato l’epoca di pace che aveva annunciato alla fine della Guerra fredda, e che rischiano di costituire i precedenti formali, non solo le concause politiche, dello scenario che si va prefigurando in Europa. Dovrebbe balzare agli occhi l’analogia agghiacciante fra le motivazioni addotte da Putin a sostegno della minoranza russa in Ucraina e quelle che mossero il cosiddetto intervento umanitario della Nato a sostegno della minoranza kosovara in Serbia, con relativo bombardamento di Belgrado: e invece non un cenno se ne sente in specie nel Pd, erede del partito che fu il principale regista italiano di quella guerra, oggi abitato da una classe dirigente che sembra del tutto ignara della drammaticità di quella stagione e del tutto conforme alla narrativa trionfale del dopo-’89.
 Dovrebbe risuonare come un monito sullo stato delle democrazie occidentali la madre di tutte le fake news e di tutte le post-truth politics, ovvero la gigantesca menzogna sulle presunte armi di distruzione di massa possedute da Saddam Hussein che giustificò la “guerra preventiva” in Iraq. Soprattutto, dovrebbe portare un grammo di senno, questo sì preventivo, sullo scenario europeo prossimo venturo la scia di guerre civili, regimi instabili ed esodi migratori biblici lasciata dietro di sé dall’intera sequenza delle guerre post-89, tutte caratterizzate dall’intreccio micidiale di rivendicazioni nazional-sovraniste e rivendicazioni etnico-regionali che si ripropone oggi in Ucraina e rischia di riproporsi in un teatro europeo più vasto di quello ucraino. E invece è proprio nella ripetizione nevrotica di quella dinamica che ci stiamo infilando, con il corredo sinistro di un soccorso armato alla resistenza ucraina fatto di contractors, appalti, privatizzazione dell’uso della forza - un film, anche questo, già visto in Iraq e in Siria, con le conseguenze che sappiamo.
Dovrebbe risuonare come un monito sullo stato delle democrazie occidentali la madre di tutte le fake news e di tutte le post-truth politics, ovvero la gigantesca menzogna sulle presunte armi di distruzione di massa possedute da Saddam Hussein che giustificò la “guerra preventiva” in Iraq. Soprattutto, dovrebbe portare un grammo di senno, questo sì preventivo, sullo scenario europeo prossimo venturo la scia di guerre civili, regimi instabili ed esodi migratori biblici lasciata dietro di sé dall’intera sequenza delle guerre post-89, tutte caratterizzate dall’intreccio micidiale di rivendicazioni nazional-sovraniste e rivendicazioni etnico-regionali che si ripropone oggi in Ucraina e rischia di riproporsi in un teatro europeo più vasto di quello ucraino. E invece è proprio nella ripetizione nevrotica di quella dinamica che ci stiamo infilando, con il corredo sinistro di un soccorso armato alla resistenza ucraina fatto di contractors, appalti, privatizzazione dell’uso della forza - un film, anche questo, già visto in Iraq e in Siria, con le conseguenze che sappiamo.La seconda linea di riflessione autocritica riguarda lo stato delle democrazie occidentali e quello connesso della costruzione europea. Oggi siamo tutti dalla parte dell’Ucraina, vittima di un’aggressione inammissibile, e da questa parte bisogna restare finché i carri armati russi resteranno in campo. Ma nella retorica monotonale occidentale l’Ucraina è diventata in pochi attimi la trincea della difesa della democrazia tout court, anzi, per dirla con le parole di Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell’Unione, la trincea del conflitto fondamentale del nostro tempo, che sarebbe quello fra democrazia e autocrazia. Le élite democratiche americane sono impegnate da tempo a costruire questo frame narrativo, opposto e speculare all’attacco alla liberaldemocrazia occidentale portato avanti dalla concezione putiniana della cosiddetta “democrazia sovrana”. E se nella politica interna americana questo frame è servito a sconfiggere Trump, in politica estera è destinato a prendere il posto di quello sullo “scontro di civiltà” fra Occidente e Islam che ha tenuto banco per tutto il ventennio della war on terror successivo all’11 settembre. Ma dopo Trump, gli americani non possono non sapere che la linea di confine fra democrazie e autocrazie è diventata molto esile, e può essere scavalcata dagli autocrati che crescono all’interno delle democrazie occidentali, non soltanto al di fuori di esse.
 E noi europei non possiamo non sapere che le tentazioni autocratiche e sovran-populiste sono cresciute, soprattutto ma non solo nei paesi ex-sovietici dell’est, parallelamente ai processi di crisi e de-democratizzazione dei paesi dell’ovest, e sovente per reazione alla delusione di un allargamento a est dell’Unione rivelatosi più un’annessione alla religione del mercato che un’integrazione del mosaico di culture e tradizioni del vecchio continente. Anche da questa parte dell’oceano, il pericolo autocratico non viene solo dall’esterno, e la democrazia non può essere impugnata come una bandiera senza macchia e senza peccato.
E noi europei non possiamo non sapere che le tentazioni autocratiche e sovran-populiste sono cresciute, soprattutto ma non solo nei paesi ex-sovietici dell’est, parallelamente ai processi di crisi e de-democratizzazione dei paesi dell’ovest, e sovente per reazione alla delusione di un allargamento a est dell’Unione rivelatosi più un’annessione alla religione del mercato che un’integrazione del mosaico di culture e tradizioni del vecchio continente. Anche da questa parte dell’oceano, il pericolo autocratico non viene solo dall’esterno, e la democrazia non può essere impugnata come una bandiera senza macchia e senza peccato.Questo nodo lega il trentennio che abbiamo alle spalle al presente e al futuro dell’Unione europea e della sua collocazione nello scacchiere globale. Il rilancio dell’atlantismo da parte di Joe Biden appariva molto ambivalente già all’indomani della sua elezione: mentre riavvicinava le due sponde dell’Atlantico che Trump aveva allontanato, innalzava un nuovo muro fra l’Europa e le autocrazie orientali, chiamando la Ue a posizionarsi nettamente contro di esse. Già allora le voci più consapevoli spinsero infatti per un’Unione atlantista ma aperta verso Est e capace di porsi come ponte fra gli Stati uniti, la Russia e la Cina. Complice la fine del cancellierato di Angela Merkel, nonché verosimilmente l’insediamento del governo Draghi in Italia, le cose hanno preso purtroppo un’altra piega.
 E oggi è più che inquietante il coro mainstream di soddisfazione che si leva per un compattamento europeo che fa propria la parola d’ordine americana del nuovo scontro di civiltà fra Occidente e Oriente, e avviene tutto sotto l’insegna della Nato, di sanzioni durissime che colpiranno Putin ma affosseranno la transizione energetica europea, di una politica di pura potenza, di un riarmo di cui la Germania si fa protagonista e che travolge persino la neutralità storica di paesi come la Finlandia.
E oggi è più che inquietante il coro mainstream di soddisfazione che si leva per un compattamento europeo che fa propria la parola d’ordine americana del nuovo scontro di civiltà fra Occidente e Oriente, e avviene tutto sotto l’insegna della Nato, di sanzioni durissime che colpiranno Putin ma affosseranno la transizione energetica europea, di una politica di pura potenza, di un riarmo di cui la Germania si fa protagonista e che travolge persino la neutralità storica di paesi come la Finlandia.Se si rafforza in questo modo, dopo aver clamorosamente mancato tutte le possibilità preventive di disinnescare politicamente la miccia che Putin stava accendendo, l’Unione europea finirà col fare le spese del ridisegno dell’ordine globale che si sta giocando nella guerra fra l’imperialismo russo e il nazionalismo ucraino.
 Se in Ucraina non cessa il fuoco e l’Europa non inverte la rotta imboccando la strada della smilitarizzazione, il conflitto si estenderà in modo imprevedibile e i tempi si faranno durissimi per la specie umana. Se le democrazie si compatteranno al loro interno sulla base dell’ennesima proclamazione dello stato d’emergenza, come già sta avvenendo in Italia, la credibilità della democrazia subirà un ennesimo e fatale colpo. Come sempre e mai come oggi, per incidere sullo scacchiere geopolitico il pacifismo deve alimentarsi di un conflitto politico aspro dentro casa, in primo luogo contro la militarizzazione del dibattito pubblico.
Se in Ucraina non cessa il fuoco e l’Europa non inverte la rotta imboccando la strada della smilitarizzazione, il conflitto si estenderà in modo imprevedibile e i tempi si faranno durissimi per la specie umana. Se le democrazie si compatteranno al loro interno sulla base dell’ennesima proclamazione dello stato d’emergenza, come già sta avvenendo in Italia, la credibilità della democrazia subirà un ennesimo e fatale colpo. Come sempre e mai come oggi, per incidere sullo scacchiere geopolitico il pacifismo deve alimentarsi di un conflitto politico aspro dentro casa, in primo luogo contro la militarizzazione del dibattito pubblico. -
> RIPENSARE L’EUROPA!--- LA TRACCIA DI UNA ANTICA MEMORIA. Un "ricordo" di Menandro: "Quanto è affascinante un essere umano, quando è umano".3 marzo 2022, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA STORIA FILOSOFIA E FILOLOGIA.
LA SCOMPARSA DELLA "FANCIULLA STRANIERA" (F. Schiller, 1796) E DELL’AMORE (K. Marx, 1844) E IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ (S. Freud, 1929: "Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità [...]").
Una nota a margine di una memoria dell’antica commedia greca ...
- "[...] «’Ως χαρίεν ἐστ ̓ ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ἦι (fr. 707 K.-A.)
- "Quanto è affascinante un essere umano, quando è umano".
- Questa proverbiale frase di Menandro caratterizza probabilmente più di ogni altra cosa la sua arte drammatica: un essere umano non è umano, quando non si comporta con dolcezza, comprensione e bontà, quando non si mette rettamente nel mondo, nella società e nei suoi simili, quando si comporta come onnipotente e onnisciente con arroganza a causa del suo status sociale o della sua ricchezza, quando non riconosce, accetta e confessa i propri errori e non si pente, quando del resto non accetta i colpi del Destino riconoscendo la propria mortalità e che è destino di tutti gli esseri viventi condividere beni e disgrazie, e naturalmente della morte.
- Il γνῶθι σαυτόν «conosci te stesso» è di primaria importanza, come è importante il «conoscere gli altri». Il primo equivale a conoscere la propria situazione e ciò che dovrebbe essere fatto in ogni caso particolare, il secondo perché è molto più utile. La persona che ha queste caratteristiche è l’essere più affascinante, ma quando ne è privo è ἀπάνθρωπος (in-umano).» [...]"
- (cit. dalla relazione di A. Katsouris, "Methods of humanization and sympathy especially in reference to the traditional odd charachters", - per il testo originale, cfr. AA. VV, "Menandro e l’evoluzione della commedia greca"; a c. di Angelo Casanova, Firenze University Press 2014, p. 278 - senza note).
"HOMO HOMINI LUPUS" (Freud, 1929). Formidabile questa riflessione di Andreas Katsouris sulla frase di Menandro! A ben riflettere sulle parole (e, in particolare, sul legame tra la "grazia" ("charis") del χαρίεν ("charien") e "l’anthropos), si dovrebbe tentare di capire su come e quando è stata persa la memoria delle Grazie (greco: Χάριτες - Charites) ed è stata persa anche la traccia di ogni umanità e l’orizzonte culturale dell’Europa (e del Pianeta Terra) è diventato sempre più cosmoteandrico, edipicamente, con la stessa connivenza della filosofia, della filologia, e della psicoanalisi!
CRITICA DELLA VIOLENZA: J.-J. ROUSSEAU, K. MARX, W. BENJAMIN. Una prima traccia della "caduta" è nell’atto logico-storico ("primordiale", che prima di essere materiale è linguistico) della recinzione: "Il primo che, dopo aver recintato un terreno, pensò di dire questo è mio, e trovò altri tanto ingenui da credergli, fu il fondatore della società civile"("Discorso sull’origine della disuguaglianza", 1754"); la seconda è nella denuncia marxiana (nella "Sacra Famiglia") dell’inversione soggetto-predicato (il problema della mele, delle pere, e delle fragole... del Mentitore) e della "fanciulla straniera e la civetta hegeliana" (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 190-197)"!
A quando il sorgere della Terra?
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- L’ORIGINE DELLA DISUGUAGLIANZA E DELLA INTOLLERANZA E LE REGOLE DEL GIOCO DELLE "TRE CARTE".17 febbraio 2022, di Federico La Sala
DISUGUAGLIANZA, INTOLLERANZA, E PACE PERPETUA...
FINE DELLA STORIA: NON COMPRESA LA LEZIONE DI DANTE ALIGHIERI SUI DUE SOLI E DI GIORDANO BRUNO (17 febbraio1600) SULLE TRE CORONE, DUE CORONE IN TERRA E UNA IN CIELO (“Ultima coelo manet)”, SI VA ANCORA AVANTI CON LE REGOLE DEL GIOCO DELLE TRE CARTE (questa è quella che vince, questa quella che perde, ecc...) e l’espulsione (lo spaccio) dal campo da gioco della BESTIA TRIONFANTE continua ad essere rinviata... USCIRE DAL LETARGO. La Regola, il Logos, non è un "Logo"!
CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA COSMOTEANDRIA. Non sapendo affrontare e non volendo risolvere il problema di Jean Jacques Rousseau (Discorso sull’origine della disuguaglianza: "Il primo uomo che, avendo recinto un terreno, ebbe l’idea di proclamare questo è mio, e trovò altri cosí ingenui da credergli, costui è stato il vero fondatore della società civile") come quello di Sigmund Freud (Il disagio della civiltà: "Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comuni tà critiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori"), non ci resta che lavorare ... "PER LA PACEPERPETUA" (KANT, 1795)!!!
FLS
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- DIVINA COMMEDIA. CON GIASONE E ULISSE, DANTE OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE: "UN ALTRO TIFI, UN’ALTRA ARGO".14 febbraio 2022, di Federico La Sala
FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, MITO E STORIA.
- Le Grazie, Apollo, le Muse, l’Arcadia, la Sibilla Cumana...
DANTE 2021: OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE, UN PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO. Solo con Virgilio (e con Ovidio) e, soprattutto, con Beatrice (la madre! - Freud docet), Dante poteva e può rinascere (Par. XXXIII, 106-108: "Omai sarà più corta mia favella, /pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante/ che bagni ancor la lingua a la mammella"), uscire dal letargo (Par. XXXIII, 94) e, addirittura, riproporsi - in un’ottica arcadica e messianica (con la sua Divina Commedia) - come "un altro Tifi, un’altra Argo" (Virgilio, Ecl. IV, 34)!
- Statua di Ulisse sotto il montone (Fondazione Torlonia)
- Ulisse che sfugge a Polifemo nascosto sotto il ventre dell’ariete. Gruppo scultoreo, marmo, I-II sec. d.C. ca. Roma, Galleria Doria Pamphilj.
"Ulisse e la sua Odissea... chi non conosce il lungo peregrinare dell’eroe omerico? Ma forse pochi sanno che Ulisse era figlio d’arte: il padre Laerte, infatti, prese parte assieme ai cinquantadue valorosi greci noti col nome di Argonauti, a una mitica impresa che li vedrà solcare i mari fino a Oriente, oltre i confini conosciuti, alla conquista del vello d’oro (la pelle di un ariete dorato che era apparso in soccorso a due giovani Frisso e Elle e li aveva condotti in salvo al di là dei mari, in Colchide).
L’impresa degli Argonauti è una delle più affascinanti del mito greco anche perché il tema del viaggio sulla nave Argo si intreccia non solo con le mille avventure vissute, o la storia d’amore tra Giàsone e Medea, ma anche con temi che in qualche modo hanno a che vedere con la conquista di conoscenze tecnico-scientifiche. Intanto perché Argo è la primissima nave mai costruita, che segna l’inizio della navigazione, per la quale occorrevano conoscenze prima di allora appannaggio esclusivo degli Dei: conoscenze tecniche, geografiche e astronomiche.
 La spedizione degli argonauti ai confini orientali del mondo conosciuto si rivela così una spedizione altamente allegorica, in cui si narra di fatto non solo di una missione civilizzatrice ma anche dell’ incontro tra Occidente e Oriente, che aveva già elaborato un sapere astronomico e astrologico; ed è di fatto un’anticipazione di quel che ebbe luogo nella realtà documentata nel III sec. A.C.: il viaggio di Alessandro Magno in India da cui riportò avanzatissime conoscenze matematiche.
La spedizione degli argonauti ai confini orientali del mondo conosciuto si rivela così una spedizione altamente allegorica, in cui si narra di fatto non solo di una missione civilizzatrice ma anche dell’ incontro tra Occidente e Oriente, che aveva già elaborato un sapere astronomico e astrologico; ed è di fatto un’anticipazione di quel che ebbe luogo nella realtà documentata nel III sec. A.C.: il viaggio di Alessandro Magno in India da cui riportò avanzatissime conoscenze matematiche.
 Ma ci parla anche di un mito che persiste tutt’oggi: quello del viaggio verso l’ignoto, del desiderio di spingere sempre più avanti le frontiere dello scibile, che tanto caratterizza la ricerca scientifica." (Clara Caverzasio, "La spedizione argonautica, tra mito e scienza", Il Giardino di Albert (ReteDue), 30 maggio 2015)
Ma ci parla anche di un mito che persiste tutt’oggi: quello del viaggio verso l’ignoto, del desiderio di spingere sempre più avanti le frontiere dello scibile, che tanto caratterizza la ricerca scientifica." (Clara Caverzasio, "La spedizione argonautica, tra mito e scienza", Il Giardino di Albert (ReteDue), 30 maggio 2015)***
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaFederico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! ---- FILOLOGIA, FILOSOFIA, E COSMOTEANDRIA. “Da Copernico in poi l’uomo rotola dal centro verso una X” (nIETZSCHE).13 febbraio 2022, di Federico La Sala
Cosmologia, antropologia, cristianesimo e civiltà.
"IL FIGLIO DELL’UOMO": UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA E FILOLOGICA...
COSMOLOGIA. “Da Copernico in poi l’uomo rotola dal centro verso una X”. Così Nietzsche, nel 1886. Ma, per un filosofo nato filologo e, per di più, uno dei grandi maestri del sospetto, contrariamente a quanto si è sempre ripetuto in modo "umano, troppo umano", non è bene tornare a interrogarlo e cercare di avere ulteriori dati sulla destinazione "ignota"?
ANTROPOLOGIA. Nel 1888 pubblica "Ecce homo. Come si diviene ciò che si è": un Urlo contro la paolina religione del "Vir Dei", una critica radicale della cosmoteandria faraonica, e un aut aut epocale.
LA PUNTA DI UN ICEBERG BIMILLENARIO: PUGLIA (12 FEBBRAIO 2022). "Ecce Vir": il "caso serio" del quadro intitolato "Sabinus vir Dei".
Tracce per una seconda rivoluzione copernicana
- AL DI LÀ DELLA LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)
SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI E RINASCIMENTO, OGGI. Una ristrutturazione epocale e lo sgretolamento della cosmoteandria tradizionale (#cosmo, teologia/ #dio e #andrologia/uomo) è già da tempo in atto: la nascita di una antropologia annunciata già da Michelangelo nel suo "Tondo Doni", con le sue due sibille e i suoi due profeti - non "quattro profeti", come vuole la Galleria degli Uffizi, e da Galileo Galilei con il suo "Sidereus Nuncius" (1610), fondata sulla visione del sorgere della Terra, è già in cammino: un capovolgimento e una nuova ricapitolazione, una radicale inversione logico-storica!
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- VITA "EXTRATERRESTRE" E SGUARDO NUOVO: RINASCIMENTO, OGGI. Tracce per una svolta antropologica29 gennaio 2022, di Federico La Sala
VITA "EXTRATERRESTRE" E SGUARDO NUOVO. Tracce per una svolta_antropologica...
- Nota a margine dell’articolo di Martina Shalipour Jafari,
- Filosofia della scienza: un ritorno al passato per guardare al futuro
- In che modo un background filosofico può aiutarci ad essere scienziati migliori ("Future Brain", 28.01.2022).
IL PRESENTE. Come è possibile "guardare al futuro" se torniamo al passato? Grazie al "passato", siamo arrivati al "presente" ("futuro" del passato). Ma "un ritorno al passato", cosa può dirci di diverso da quanto già sappiamo, se ancora camminiamo e pensiamo come in "passato"?!
IL PASSATO. Un vento fortissimo viene dal passato e questo vento (ricordare Walter Benjamin) a noi, che siamo spinti sempre più avanti e che continuiamo a guardare ipnotizzati il "passato", quale "futuro" mostra? Un crescere oceanico di macerie e rifiuti...
Filosofia, Scienza, e DisagiodellaCiviltà (Freud, 1929). Il problema è proprio quello di liberare l’epistemologia dalla caverna platonica e ripartire da un ulteriore sguardo nel gorgo claustrofilico (Elvio Fachinelli, Claustrofilia, 1983) e soprattutto da un fatto inaudito e impensato: nascere, diventare un essere umano extraterrestre e aprire gli occhi sul ... SorgeredellaTerra.
Federico La Sala
MUSICA, MUSE, PROFETI E SIBILLE, ANTROPOLOGIA, E "MOS-ART" DI SALUTE E LIBERAZIONE:
- UNO STRAORDINARIO ESEMPIO DI EFETTO MOZART - DELLA "MOS-ART" ("arte di Mosè"):
- “THE SHAWSHANK REDEMPTION” (1994). Una breve sequenza dal #film “Le Ali della Libertà”, con
- "Sull’Aria..." da "Le Nozze di Figaro" .
DISAGIO DELLA CIVILTA’ (FREUD, 1929). Il problema, a mio parere, è che la ricerca e i risultati di Alfred A. Tomatis (Nizza, 1º gennaio1920 - Carcassonne, 25 dicembre2001) sono talmente innervati con la nostra non-volontà di sapere di sé che, pur comprendendo che già il solo "parlare è suonare il proprio corpo" (Alfred Tomatis), alle accademiche platoniche orecchie (cieche e sorde e zoppe, come quelle di Edipo) il messaggio non arriva o arriva assolutamente distorto.
DANTE 2021: MEMORIA DI APOLLO E DELLE MUSE
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE (2005). Una "memoria" - di Federico La Sala.20 gennaio 2022, di Federico La Sala
#PIANETA TERRA,
#COSMOTEANDRIA E #ANTROPOLOGIA.
L’#autodeterminazione, la #libertà
di disporre di sé,
è
dell’#uomo come della #donna,
ma l’#Europa pensa come se vivesse
in una #terra piatta, nel suo #mare nostrum.
Non ha ancora visto il #Sorgere della Terra?!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA. "Il problema è più simbolico che pratico, ma sappiamo benissimo quanto i simboli siano determinanti nel definire questioni politicamente delicate come quella dell’aborto" (Giulia Blasi).20 gennaio 2022, di Federico La Sala
L’elezione di Roberta Metsola è un segnale
Potrà non complicare il voto sui diritti riproduttivi, ma legittima le posizioni antiabortiste in Europa
di Giulia Blasi (La svolta, 19 gennaio 2022)
Per parlare dell’elezione di Roberta Metsola a Presidente del Parlamento Europeo non voglio partire da facili dicotomie buono/cattivo. Di Metsola si sta parlando molto perché oltre a essere una donna (con nome e cognome, non la solita Una Donna che per settimane sembrava dovesse diventare Presidente della Repubblica e adesso, come da copione, è sparita dal radar) è anche la più giovane presidente nella storia del Parlamento Europeo, e solo la terza a rompere la lunga teoria di volti maschili incorniciati nei corridoi dei palazzi di Bruxelles.
 La morte improvvisa di David Sassoli ha solo accelerato un processo che era già in corso da tempo per la ricerca di una figura all’interno delle fila del centrodestra, e Metsola - già presidente a interim e figura che gode di una grande stima fra i colleghi - è stata eletta anche con i voti del gruppo S&D, il gruppo dei socialisti e democratici guidato da Iratxe García Pérez, politica spagnola apertamente femminista. L’elezione di Metsola con i voti dell’S&D è stata frutto di un negoziato, come sempre succede in questi casi: in cambio del loro sostegno, i socialisti hanno chiesto e ottenuto una serie di nomine a cariche importanti.
La morte improvvisa di David Sassoli ha solo accelerato un processo che era già in corso da tempo per la ricerca di una figura all’interno delle fila del centrodestra, e Metsola - già presidente a interim e figura che gode di una grande stima fra i colleghi - è stata eletta anche con i voti del gruppo S&D, il gruppo dei socialisti e democratici guidato da Iratxe García Pérez, politica spagnola apertamente femminista. L’elezione di Metsola con i voti dell’S&D è stata frutto di un negoziato, come sempre succede in questi casi: in cambio del loro sostegno, i socialisti hanno chiesto e ottenuto una serie di nomine a cariche importanti.Tutto regolare, quindi, dal punto di vista della democrazia parlamentare e del suo funzionamento. Il motivo per cui l’elezione di Roberta Metsola sta facendo discutere è un altro: la neopresidente maltese è nota da tempo per le sue posizioni antiabortiste, espresse anche nel corso del suo mandato come europarlamentare, e Malta è l’unico paese dell’Unione europea ad avere reso la procedura abortiva del tutto illegale (l’ultimo intervento sul tema risale al 2005), senza eccezioni. Cosa che - come sempre accade lì dove l’accesso all’aborto è limitato o vietato - spinge le donne ad andare all’estero per poter interrompere una gravidanza. Quelle che non possono farlo cercano di procurarsi un aborto con altri metodi, non sempre sicuri. Il blocco dei voli in ingresso a marzo 2020 ha anche lasciato le donne maltesi sprovviste di contraccettivi, considerati “non essenziali” dal governo.
Non è certo l’elezione di Metsola a ricordarci che opporsi all’autodeterminazione delle donne non è ancora considerato un difetto invalidante per una figura politica di spicco: nel 2013 il rapporto Estrela, che fra le altre cose chiedeva il riconoscimento dell’accesso all’aborto come diritto umano, fu bocciato dal Parlamento Ue anche a causa dell’astensione di alcuni politici di centrosinistra, fra cui spiccano i nomi di Silvia Costa e Patrizia Toia, ma anche del compianto Sassoli. Anche l’ex presidente Antonio Tajani non ha mai fatto mistero delle sue posizioni antiabortiste. Se Metsola viene giudicata con maggiore severità non è perché ha difeso il diritto del governo maltese di ostacolare il diritto delle cittadine di decidere dei loro corpi, e nemmeno perché da una donna ci si aspetta che quel diritto sia disposta a difenderlo anche contro le sue personali convinzioni. Dal canto suo, la nuova presidente ha emanato vaghe rassicurazioni sulla sua intenzione di rispettare la volontà del Parlamento e la missione dell’Europa di proteggere i diritti di tutti, dichiarazioni che la storia ci insegna essere soggette ad ampia interpretazione.
Il problema è più simbolico che pratico, ma sappiamo benissimo quanto i simboli siano determinanti nel definire questioni politicamente delicate come quella dell’aborto. L’ennesima donna bianca, bionda, rassicurante e conservatrice nella stanza dei bottoni ci mostra che la faccia del potere cambia, ma di poco, e non in un modo che possa minacciare l’ordine costituito. Metsola, come tante prima di lei, si presta a fare da scudo con la sua femminilità a un’osservazione ricorrente di chi si batte per i diritti riproduttivi, vale a dire che la sottorappresentazione delle donne in politica rende più difficile il processo di restituire centralità all’esperienza femminile, in tutte le sue varianti. Metsola è una donna: la sua parola sull’aborto conta, perché viene da una persona con un utero, una persona che l’esperienza di vivere in un corpo femminile la fa ogni giorno, e se la sua parola è contro l’aborto, quella parola verrà assunta come finale da chi ritiene che interrompere una gravidanza sia una scelta aberrante, un crimine a cui opporsi con ogni mezzo, e non una decisione che spetta solo a chi quella gravidanza la ospita.
L’elezione di Roberta Metsola potrà non complicare o sbilanciare il voto sulle questioni legate ai diritti riproduttivi, ma è un segnale. Conferisce legittimità all’azione di quei governi che in Europa lavorano per sopprimere le libertà individuali, inclusa quella di scegliere se portare avanti una gravidanza. Perché l’aborto è, e sarà sempre, solo una questione di controllo dei corpi: la vita non c’entra, la natalità non c’entra, c’entra solo la volontà di sottrarre alle donne e alle persone che possono generare la libertà di disporre di sé.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- IL SORGERE DELLA TERRA E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA. L’Europa pensa come se vivesse in una "terra piatta", nel suo "mare nostrum"20 gennaio 2022, di Federico La Sala
#PIANETA TERRA,
#COSMOTEANDRIA E #ANTROPOLOGIA.
L’#autodeterminazione, la #libertà
di disporre di sé,
è
dell’#uomo come della #donna,
ma l’#Europa pensa come se vivesse
in una #terra piatta, nel suo #mare nostrum.
Non ha ancora visto il #Sorgere della Terra?!
-
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE (2005). - I «ladri di terre» si mangiano pezzi di Amazzonia brasiliana. Mentre le fazendas si ampliano, crescono violenza e deforestazione ((di Lucia Capuzzi).}17 gennaio 2022, di Federico La Sala
Il reportage.
I «ladri di terre» si mangiano pezzi di Amazzonia brasiliana
Boom delle occupazioni di aree protette e riservate alle comunità rurali negli ultimi anni. E mentre le fazendas si ampliano, crescono violenza e deforestazione
Lucia Capuzzi, inviata a Imperatriz (Brasile) (Avvenire, sabato 15 gennaio 2022)
- [Foto] Contadini brasiliani nello Stato di Santa Fe - Ansa
«L’ultima volta è stata nel marzo 2020: si sono presentati qui sventolando la loro “licenza ambientale”. Peccato che non mostrino mai i titoli di proprietà. Perché non ce li hanno. Tutti i permessi sono falsi». Ci avevano già provato tre anni prima, quando erano arrivati direttamente con le ruspe per abbattere alberi centenari, costruzioni e campi. E far posto al raddoppio della Br-135, l’autostrada che attraversa il Nord-Est brasiliano per oltre 2.500 chilometri, congiungendo gli Stati di Maranhão e Minas Gerais. Anacleta Pires da Silva li aveva visti da lontano. Si era piazzata di fronte alle scavatrici, sbarrando loro il passo con il suo corpo minuto. Altri abitanti del quilombo di Santa Rosa dos Pretos l’avevano seguita. E le autorità, promotrici del progetto di ampliamento, avevano dovuto cedere. Almeno temporaneamente. Sono ormai 38 anni che Anacleta combatte per difendere la propria casa dalla lingua d’asfalto che la lambisce a meno di trenta metri di distanza. Una dimora modesta ma molto curata. Lampade e monili appesi alle pareti rosa acceso rivelano l’abilità artigianale di Anacleta. Anche così questa donna di 54 anni, dalla pelle nerissima e il sorriso facile tramanda la memoria degli antenati strappati all’Africa e incatenati alle piantagioni del Brasile coloniale. Schiavi nel corpo ma non nello spirito, capaci di emanciparsi e creare oasi di libertà ai margini dell’Amazzonia.
 A differenza degli altri quilombos - comunità di africani fuggitivi nascoste della foresta tuttora esistenti e tutelate dalla Costituzione - quello di Santa Rosa nasce in modo “legale”. Fu lo stesso proprietario a donare, nel testamento, la fazenda (piantagione) agli ex schiavi alla fine dell’Ottocento.
A differenza degli altri quilombos - comunità di africani fuggitivi nascoste della foresta tuttora esistenti e tutelate dalla Costituzione - quello di Santa Rosa nasce in modo “legale”. Fu lo stesso proprietario a donare, nel testamento, la fazenda (piantagione) agli ex schiavi alla fine dell’Ottocento.Nemmeno il regolare lascito ha messo al riparo gli attuali 4mila abitanti dal rischio ciclico di sfratto per far posto a nuove piantagioni o grandi opere. Santa Rosa, nel cuore dello Stato del Maranhão, fa da cerniera tra le due frontiere dell’agrobusiness brasiliano: il Cerrado - savana tropicale fondamentale per la sopravvivenza della foresta limitrofa - e l’Amazzonia.
 Terre fertili e “disponibili” grazie alla rete di complicità che lega élite politica e latifondo. E che ha nel grilagem - falsificazione dei certificati di proprietà da parte dei fazendeiros con la complicità diretta o indiretta delle autorità - la sua espressione più drammatica.
Terre fertili e “disponibili” grazie alla rete di complicità che lega élite politica e latifondo. E che ha nel grilagem - falsificazione dei certificati di proprietà da parte dei fazendeiros con la complicità diretta o indiretta delle autorità - la sua espressione più drammatica.
 Un nodo storico in uno dei Paesi con maggiore concentrazione fondiaria del pianeta. Dal 2018, però, il “furto di terre” amazzoniche e pre-amazzoniche ha avuto un incremento esponenziale: + 56 per cento secondo il recente studio dell’Instituto socioambiental (Isa).
Un nodo storico in uno dei Paesi con maggiore concentrazione fondiaria del pianeta. Dal 2018, però, il “furto di terre” amazzoniche e pre-amazzoniche ha avuto un incremento esponenziale: + 56 per cento secondo il recente studio dell’Instituto socioambiental (Isa).Con la pandemia e l’attenzione concentrata sull’emergenza sanitaria, c’è stata un’escalation di occupazioni e violenze. La Commissione pastorale della terra (Cpt), legata alla Chiesa, ha registrato quasi due invasioni al giorno tra gennaio e agosto 2021, per un totale di 418. Il grilagem è cresciuto del 118 per cento. Una vera e propria corsa all’accaparramento di terra per allevamenti o coltivazioni intensive di prodotti da esportare, innescata dalla progressiva riduzione dei controlli.
 Questo spiega la crescita della deforestazione del 63 per cento tra 2018 e 2020. «La situazione potrebbe peggiorare nel prossimo futuro se fosse approvata la proposta di Luiz Antônio Nabhan García, responsabile delle Questioni fondiarie e uomo di fiducia del presidente Jair Bolsonaro, che dà ai grandi proprietari la facoltà di registrare la terra con una semplice autocertificazione», afferma Iriomar Lima, avvocato della rete Forum e cidadania, collegata alla (Cpt).
Questo spiega la crescita della deforestazione del 63 per cento tra 2018 e 2020. «La situazione potrebbe peggiorare nel prossimo futuro se fosse approvata la proposta di Luiz Antônio Nabhan García, responsabile delle Questioni fondiarie e uomo di fiducia del presidente Jair Bolsonaro, che dà ai grandi proprietari la facoltà di registrare la terra con una semplice autocertificazione», afferma Iriomar Lima, avvocato della rete Forum e cidadania, collegata alla (Cpt).
 Il Maranhão, con una legge statale ancora più permissiva di quella nazionale, è - insieme a Pará e Rondônia - al centro del saccheggio come dimostra l’esplosione di violenza record nell’ultimo anno. Nonché l’estendersi di coltivazioni di eucalipto, soja, miglio e riso. «Tra gennaio e novembre scorso, oltre un terzo dei 26 omicidi legati a conflitti agricoli è avvenuto in questo Stato», spiega Lenora Motta, responsabile della Cpt regionale.
Il Maranhão, con una legge statale ancora più permissiva di quella nazionale, è - insieme a Pará e Rondônia - al centro del saccheggio come dimostra l’esplosione di violenza record nell’ultimo anno. Nonché l’estendersi di coltivazioni di eucalipto, soja, miglio e riso. «Tra gennaio e novembre scorso, oltre un terzo dei 26 omicidi legati a conflitti agricoli è avvenuto in questo Stato», spiega Lenora Motta, responsabile della Cpt regionale.
 E proprio del Maranhão è la prima vittima del 2022: José Francisco Lopes Rodrigues, colpito il 3 gennaio dal proiettile di un anonimo killer che ha ferito anche la nipotina di dieci anni. «È morto cinque giorni dopo in ospedale. È un momento molto triste per tutti», prosegue Lenora. Francisco era uno dei leader della resistenza al grilagem di Ararí, costata la vita ad altri quattro contadini negli ultimi due anni. Il municipio di 40mila abitanti è all’interno della Baixada Maranhense, una pianura amazzonica solcata dai fiumi Mearim, Pindaré e Grajaú che, nella stagione delle piogge, esondano e la allagano, creando una distesa di isolotti multiformi.
E proprio del Maranhão è la prima vittima del 2022: José Francisco Lopes Rodrigues, colpito il 3 gennaio dal proiettile di un anonimo killer che ha ferito anche la nipotina di dieci anni. «È morto cinque giorni dopo in ospedale. È un momento molto triste per tutti», prosegue Lenora. Francisco era uno dei leader della resistenza al grilagem di Ararí, costata la vita ad altri quattro contadini negli ultimi due anni. Il municipio di 40mila abitanti è all’interno della Baixada Maranhense, una pianura amazzonica solcata dai fiumi Mearim, Pindaré e Grajaú che, nella stagione delle piogge, esondano e la allagano, creando una distesa di isolotti multiformi.Un ecosistema fragile su cui, in vari periodo dell’anno, si possono ammirare uccelli di specie rarissime. Per questo, l’area è protetta a livello internazionale dalla Convenzione di Ramsa: solo l’agricoltura familiare è consentita. Ciò non ha impedito che, nel 2017, fosse occupata da 4 fazendeiros che l’hanno recintata impedendo l’accesso ai contadini.
 I pascoli si sono riempiti di bufali, senza che le autorità muovessero un dito nonostante le segnalazioni delle 40 famiglie di Cedro, alla periferia di Ararí. -Esasperate dopo due anni di inerzia, queste ultime hanno iniziato a rimuovere le recinzioni, finendo denunciate a loro volta per «atti vandalici» e portate di fronte ai giudici. Insolitamente sollecite, le forze dell’ordine hanno subito dato il via a una sfilza di arresti.
I pascoli si sono riempiti di bufali, senza che le autorità muovessero un dito nonostante le segnalazioni delle 40 famiglie di Cedro, alla periferia di Ararí. -Esasperate dopo due anni di inerzia, queste ultime hanno iniziato a rimuovere le recinzioni, finendo denunciate a loro volta per «atti vandalici» e portate di fronte ai giudici. Insolitamente sollecite, le forze dell’ordine hanno subito dato il via a una sfilza di arresti.
 «Dal 2020 sono iniziati gli assassinii mirati. Prima è toccato a Celino e Wanderson Fernandes, padre e figlio, poi a Antônio Diniz e João de Deus Moreira», sottolinea Iriomar. Vittime senza colpevole. Come il 92 per cento delle quasi 2mila persone massacrate nel corso di conflitti per la terra dal 1985.
«Dal 2020 sono iniziati gli assassinii mirati. Prima è toccato a Celino e Wanderson Fernandes, padre e figlio, poi a Antônio Diniz e João de Deus Moreira», sottolinea Iriomar. Vittime senza colpevole. Come il 92 per cento delle quasi 2mila persone massacrate nel corso di conflitti per la terra dal 1985.Grilagem
Il «grilagem» è il sistema escogitato per falsificare i documenti per legalizzare il possesso di un determinato terreno, in genere pubblico o appartenente alle comunità locali. La parola deriva dal fatto che, in passato, i documenti fasulli venivano messi in una scatola con dei grilli per renderli gialli e rovinati, dunque antichi come si presumeva fossero gli originali. Il «grilagem» nasce con la legge del 1850 che aboliva le terre comuni, utilizzate dai contadini. I latifondisti ne hanno approfittato per incamerarle.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
TORNO PER SALVARE IL BRASILE. L’ex presidente Lula espone a «la Lettura» i suoi programmi per il futuro (di Nuccio Ordine).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- RIPENSARE COSTANTINO! L’IDEA DI "IMPERO" DI DANTE, L’ORDINE DELLA GIARRETTIERA E IL DISCORSO DEL RE (ENRICO V) IN SHAKESPEARE (M. Morini). .14 gennaio 2022, di Federico La Sala
Categoria: Il filosofo e la città
Il Discorso del Re
Con l’Enrico V Shakespeare completa il ritratto del nuovo principe machiavellico (non senza sottolineare le sue contraddizioni) e si prepara per i grandi drammi successivi.
di Maurizio Morini *
Enrico V viene annoverato tra i grandi re d’Inghilterra, colui che ha impresso lo slancio decisivo per la nascita dello Stato moderno inglese. Al centro della sua azione la teoria medievale del doppio corpo del re: quello naturale, soggetto alla morte, e quello mistico che non può morire. Una teoria che garantisce la continuità del sovrano riassunta in uno slogan che avrà fortuna: The king is dead, long live the King.
Nel dramma storico, questa retorica è rappresentata dal coro che, ad ogni atto, anticipando in modo solenne gli eventi, proclama le gesta e le virtù del re. Cosa che garantisce popolarità alla sua azione (Enrico è il sovrano che raccoglie i frutti di una piena legittimità) ma non l’autenticità di fronte al tribunale della storia: dopo ogni intervento del coro, Shakespeare colloca delle scene che, facendo da contrappunto a quanto raccontato, finiscono di fatto per rendere meno credibili gli eventi.
 Nel primo atto «la Musa di fuoco che si eleva al cielo più fulgido dell’immaginazione», è frustrata dai sotterfugi dei due vescovi che, per interessi economici, spingono il sovrano alla guerra; nel secondo, il racconto che tutta la gioventù d’Inghilterra è a fuoco e che l’ambizione dell’onore regna esclusiva nell’animo di ogni uomo, è contraddetto con un alterco da osteria; nel terzo, le vele spiegate della Marina inglese a Southampton in direzione della Francia, incontrano i desideri di alcune voci dell’equipaggio di tornare piuttosto in un’osteria a Londra; nel quarto, il regale capitano che passa in rassegna le sue truppe per infondere coraggio, le visita in incognito finendo pure per essere contestato; nel quinto, all’immagine di Enrico che torna trionfante in Inghilterra accolto dalle folle assiepate a Dover, si contrappone la realtà di un sovrano che finisce al capezzale di Caterina di Borgogna per chiederle la mano, riunire i regni e chiudere le ostilità.
Nel primo atto «la Musa di fuoco che si eleva al cielo più fulgido dell’immaginazione», è frustrata dai sotterfugi dei due vescovi che, per interessi economici, spingono il sovrano alla guerra; nel secondo, il racconto che tutta la gioventù d’Inghilterra è a fuoco e che l’ambizione dell’onore regna esclusiva nell’animo di ogni uomo, è contraddetto con un alterco da osteria; nel terzo, le vele spiegate della Marina inglese a Southampton in direzione della Francia, incontrano i desideri di alcune voci dell’equipaggio di tornare piuttosto in un’osteria a Londra; nel quarto, il regale capitano che passa in rassegna le sue truppe per infondere coraggio, le visita in incognito finendo pure per essere contestato; nel quinto, all’immagine di Enrico che torna trionfante in Inghilterra accolto dalle folle assiepate a Dover, si contrappone la realtà di un sovrano che finisce al capezzale di Caterina di Borgogna per chiederle la mano, riunire i regni e chiudere le ostilità.
 Una continua giustapposizione, tipica peraltro del filosofo inglese, tesa a marcare la differenza tra retorica e realtà, ideologia e verità effettuale, dover essere ed essere. Sicché, «ciò che è in questione non è la trasformazione del corpo politico bensì una serie di effetti politici, forse una serie di illusioni, operate attraverso mezzi politici mondani, in particolare attraverso la continua manipolazione retorica di Enrico» (Lake, 2016)
Una continua giustapposizione, tipica peraltro del filosofo inglese, tesa a marcare la differenza tra retorica e realtà, ideologia e verità effettuale, dover essere ed essere. Sicché, «ciò che è in questione non è la trasformazione del corpo politico bensì una serie di effetti politici, forse una serie di illusioni, operate attraverso mezzi politici mondani, in particolare attraverso la continua manipolazione retorica di Enrico» (Lake, 2016)L’irresponsabilità del sovrano e il fucile di legno
Al centro di questa manipolazione si colloca il dialogo che il re conduce in incognito con i suoi soldati e il successivo monologo sull’essenza del potere regale. Enrico V è un re che ha qualità che lo rendono particolarmente popolare, come l’abitudine di visitare i suoi soldati chiamandoli fratelli, amici e compatrioti. Ma si tratta di qualcosa di studiato, una parodia dice lo stesso coro, se il re sente il bisogno di visitare i suoi sudditi, mascherato da semplice soldato, per avere conoscenza dei suoi veri umori. Così, nel dialogo notturno che precede la battaglia, Enrico si aggira nel campo militare esibendo la vecchia giustificazione secondo la quale il re non è altro che un uomo, lamentando di non poter vivere una vita tranquilla. Sembra improvvisamente di assistere al dialogo di Senofonte tra il poeta Simonide e il tiranno Gerone sulla natura della tirannia. Ma, evidentemente, quello del re solitario non è argomento adatto per rincuorare dei soldati che, all’addiaccio, rischiano la propria vita mentre il re se ne sta nelle retrovie o nel caldo del suo palazzo.
Ecco allora che il discorso si sposta sulle cause della guerra. Ma anche in questo caso i soldati rispondono picche. A parte il fatto che il problema delle cause è qualcosa che va oltre quello che essi devono sapere, dimostrandosi più realisti del re nell’attenersi (in quanto sudditi) alla dottrina degli arcana imperii; il punto, come afferma uno di loro, è che «se la causa è ingiusta, l’obbedienza che dobbiamo al re cancella in noi la macchia di qualsiasi colpa». Infatti, prosegue un altro, «se la causa non è onesta, il re stesso sarà chiamato a una grave resa dei conti, quando tutte quelle gambe e braccia e teste tagliate in battaglia si riuniranno il giorno del giudizio (...) Ora, se questi uomini non fanno una buona morte, sarà un brutto affare per il re che li ha portati a quel passo, e disobbedire al quale sarebbe contrario a tutti i giusti doveri della sudditanza».
Ma il re respinge gli argomenti in merito alle responsabilità del sovrano: «Il re non è tenuto a rispondere della fine che fanno i suoi singoli soldati, né il padre del figlio, né il padrone del servitore», in quanto «solo la guerra è il suo ufficiale fustigatore, la guerra è l’esecutore della sua vendetta; sicché gli uomini vengono puniti ora, per la causa del re, perché hanno violato anteriormente le leggi del re. (...) Se dunque muoiono impreparati, il re non è colpevole della loro dannazione». Per cui, conclude Enrico, «l’obbedienza d’ogni suddito appartiene al re, ma l’anima appartiene al suddito».
 Da un punto di vista teologico si tratta di un principio ineccepibile che segna tuttavia l’assoluta irresponsabilità dei reggitori dello Stato per le proprie azioni. Viene così anticipato il principio di Hobbes secondo cui le azioni del sovrano non possono mai essere accusate di ingiustizia dai sudditi e il sovrano non può né essere messo a morte né essere punito dai suoi sudditi (Leviatano, cap.XVIII).
Da un punto di vista teologico si tratta di un principio ineccepibile che segna tuttavia l’assoluta irresponsabilità dei reggitori dello Stato per le proprie azioni. Viene così anticipato il principio di Hobbes secondo cui le azioni del sovrano non possono mai essere accusate di ingiustizia dai sudditi e il sovrano non può né essere messo a morte né essere punito dai suoi sudditi (Leviatano, cap.XVIII).I soldati sono quasi convinti dalle argomentazioni retoriche del re. Uno di loro però insiste con il suo scetticismo e finisce per innervosire il re mascherato il quale, rispondendo in modo goffo e ingenuo, non riesce di meglio che suscitare lo scherno dell’interlocutore. Così, una volta usciti, ecco un monologo del re in cui vi è una vera e propria difesa dei sovrani le cui ansie non sono nemmeno da paragonare alla tranquillità dei cittadini: di fatto, protesta Enrico, la pace che egli acquista per il contadino è pagato a prezzo di dolorose veglie notturne. Torna il Gerone di Senofonte ma questa volta con una differenza: il denaro che Enrico offre, volendo ricompensare il soldato per la coraggiosa franchezza della notte, viene rifiutato con uno sdegnato «non so che farmene». -Shakespeare è filosofo per il quale le esigenze dell’individuo vengono prima di quelle dello Stato; non disconosce quest’ultimo (perché sa che i rimproveri di un individuo contro un monarca sono pericolosi «quanto lo sparo di un fucile di legno») ma lo tiene costantemente sotto il controllo critico.
«We few, happy few, band of brothers» uniti dall’azione criminale
Secondo il giudizio di Churchill (ma non solo), la battaglia di Agincourt dell’ottobre del 1415 contro il ben più numeroso esercito francese, è la più eroica delle battaglie combattute dall’Inghilterra nella storia. Tuttavia, ricorda lo statista, quella vittoria (che pure fece di Enrico V il sovrano più celebre d’Europa) fu seguita da una delle più sanguinose guerre civili che l’Inghilterra abbia mai conosciuto e tale da controbilanciare gli apparenti successi. Il tentativo di trasferire all’estero i conflitti interni è risultato fallimentare, addirittura controproducente.
Shakespeare rappresenta questa verità attraverso la drammatizzazione. Nel quarto atto, il re chiama a raccolta i sudditi nel celebre discorso di San Crispino nel quale incoraggia allo scontro imminente attraverso la classica mozione degli affetti. «Noi pochi, pochi e felici eletti, banda di fratelli...» Ma anche in questo caso i fatti che seguono gettano discredito sulle parole. I soldati, piuttosto che combattere per la gloria, cercano non solo di assicurarsi un riscatto in denaro per i futuri prigionieri, ma pianificano la vita civile successiva al ritorno in Patria al pari di criminali dediti al furto. Il sovrano, piuttosto che dare prova di virtù e generosità, ordina di far sgozzare a freddo tutti i prigionieri francesi contravvenendo ad una consolidata regola morale e di diritto internazionale. È a questo punto che un soldato equipara il re ad Alessandro il grande: peccato però che (con abile stratagemma) la persona in questione ha un difetto di pronuncia (scambia la b con la p) e il re viene ribattezzato Alexander the pig, Alessandro il maiale.
Che cosa voleva comunicare Shakespeare con questa strategia drammaturgica? Prendendo a prestito Strauss, diremmo che la sua opera è impregnata di retorica socratica, strumento indispensabile per fronteggiare, da un parte, la minaccia della società e dei governanti, e, dall’altra, mezzo per condurre chi ne è capace alla filosofia. La retorica politica si combatte con la retorica filosofica: la cautela non è mai troppa. Diventa interessante a questo punto sapere o immaginare che cosa abbia potuto pensare il competente pubblico che assisteva ai drammi di Shakespeare e che ne decretò subito il più grande successo.
Lo specchio deformato dei re cristiani e il passaggio a quelli pagani
Enrico si crede lo specchio dei re cristiani. Prima di ogni sua azione, tanto privatamente quanto pubblicamente, egli invoca l’aiuto e la protezione di Dio come mai nessun re che lo aveva preceduto aveva fatto. Ma dopo la rottura dello specchio del principe, avvenuta con la fine del regno di Riccardo II, lo specchio di Enrico è completamente deformato: si tratta di un’altra contraddizione posta nel cuore di un regno per sua natura machiavellico che sa fare uso della religione per i suoi fini e finanche di addossare la colpa della guerra allo stesso clero se l’arcivescovo risponde al re che essa può ricadere sul suo capo. Agire senza portarne la responsabilità è il capolavoro politico più volte ripetuto da Enrico.
L’astro di Inghilterra (Star of England), come lo chiama il coro alla fine dell’opera, esce però presto di scena a causa della morte prematura. Il novello Cesare, come lo aveva definito Shakespeare, lascia spazio al vero Giulio Cesare la cui opera (siamo ormai nel 1599) comincia ad essere scritta proprio nel momento in cui si chiude quella dedicata al mitico quanto controverso sovrano inglese.
* Fonte: Ritiri Filosofici, 2 Gennaio 2022
*
NOTA: LA TEORIA MEDIEVALE DEL "DOPPIO CORPO DEL RE", LA "MONARCHIA" DI DANTE, E IL PROGETTO INGLESE DI PRENDERE LA FIACCOLA DELL’IMPERO DALLE MANI DELLA SPAGNA. Appunti per un’analisi dei drammi storici di Shakespeare:
a) Enrico V è un dramma storico di William Shakespeare composto tra il 1598 ed il 1599. Il dramma prende spunto dalle vicende di Enrico V d’Inghilterra, re che si distinse per aver conquistato la Francia ed aver vinto la battaglia di Azincourt. È l’opera conclusiva della tetralogia shakespeariana enrieide (o tetralogia maggiore); iniziata con Riccardo II e proseguita con Enrico IV, parte 1 e Enrico IV, parte 2.
b) La battaglia di Azincourt (o di Agincourt per gli inglesi) si svolse vicino l’omonima località nell’odierno dipartimento del Passo di Calais il 25 ottobre 1415 nell’ambito della guerra dei cent’anni, vedendo contrapporsi le forze del Regno di Francia di Carlo VI contro quelle del Regno d’Inghilterra di Enrico V.
c) Giarrettiera, ordine della(ingl. Order of the Garter) Supremo ordine cavalleresco inglese, istituito da Edoardo III nel 1349. [...] Come lo stesso nome suggerisce, lo stemma dell’Ordine è una giarrettiera che sormonta il motto Honi soit qui mal y pense (fr.: "Sia vituperato chi ne pensa male"), presente inoltre sul rovescio delle sterline in oro (sovereign) della serie 1817-1820 recanti sul dritto l’effigie di re Giorgio III. La Giarrettiera è indossata dai membri dell’Ordine durante le occasioni formali. Il motto Honi soit qui mal y pense è anche scritto sulla polena della nave ammiraglia HMS Victory, protagonista della battaglia di Trafalgar agli ordini di Horatio Nelson. [...] La più antica attestazione scritta dell’Ordine si trova in Tirant lo Blanch, un romanzo cavalleresco scritto in catalano dal valenciano Joanot Martorell che venne pubblicato nella prima edizione nel 1490. Nel romanzo si trova un intero capitolo dedicato alla leggenda della fondazione dell’Ordine. [...] Il primo straniero a essere insignito della Giarrettiera fu il duca di Urbino Federico da Montefeltro nel 1474 [...].
d)STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO... DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica.
e) RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- LA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE E L’ENIGMA DELLA SFINGE: ENZO PACI, IL PROBLEMA DELLA NASCITA, E "AUT AUT". Quel gesto fenomenologico che ha fatto cultura (di P. A. Rovatti).12 gennaio 2022, di Federico La Sala
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI. LA CRISI DELLE SCIENZE: ENZO PACI, "AUT AUT", E L’ENIGMA DEL SOGGETTO. *
- "ECCE HOMO. Come si diventa ciò che si è" (Nietzsche, 1888).
- Franz Brentano: "La filosofia possiede al massimo grado la dignità di una scienza teoretica, ma perde completamente questo privilegio, quando dall’ambito della sua conoscenza viene esclusa l’esistenza di Dio" ("La prova dell’esistenza di Dio", 1915).
- Enzo Paci: Nicodemo o della nascita, 1944/1973.
- L’antropologia non è una andrologia: Come "è stata possibile un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, "Donna", 1978 - "Una voce", 1982)?!
Quel gesto fenomenologico che ha fatto cultura
di Pier Aldo Rovatti *
Se mi chiedessero di dire in una battuta che cosa ha prodotto il settantennio di vita della rivista “aut aut”, messa al mondo nel 1951 dal filosofo Enzo Paci e oggi tutt’altro che estinta, risponderei senza esitazione: “il gesto fenomenologico”.
A tale atteggiamento o pratica di pensiero è stato dedicato anche il fascicolo della rivista attualmente in circolazione, in cui si guarda tanto al lunghissimo passato quanto a un futuro ancora da realizzare: sì, perché siamo ancora lontani dall’avere ben compreso questo gesto e dall’essere riusciti a metterlo in atto.
Di cosa si tratta? È un tentativo di dar corpo alla parola “critica”, forse più facile da collegare a quella cultura che voleva prendere distanza dai dogmatismi e dagli ideologismi del ventennio fascista di quanto sia riconoscibile oggi in una situazione nella quale tutti ci riempiamo la bocca di un’idea di democrazia alquanto superficiale e di tanti propositi culturali che spesso risultano vuoti e dai piedi di argilla. Parliamo infatti di pensiero critico, di responsabilità e di etica pubblica, ma non sembra proprio che riusciamo a dare troppo peso a quello che diciamo, come se dalla bocca di molti intellettuali uscisse soltanto un esile vapore, un flatus vocis che si disperde subito nell’aria.
Il gesto fenomenologico avrebbe invece la pretesa di tenere i piedi ben piantati sulla terra e di non consumarsi subito in una vacua cortina fumogena, come capita alla gran parte dei prodotti dell’attuale mondo della comunicazione, frettolosi e dunque superficiali. Questo gesto è invece qualcosa che ci coinvolge integralmente: non un semplice pensiero, qualcosa che ci passa per la testa e che comunque si riduce all’ambito del mentale, al contrario riguarda la nostra intera soggettività. È un atteggiamento “concreto” che concentra l’insieme delle nostre facoltà e ci mette completamente in gioco.
Detto altrimenti, questo gesto ci espone agli altri, non è una postura comprimibile nella privatezza, perciò ha sempre una dimensione pubblica, nel senso appunto dell’esposizione e del confronto. Siamo lontani dall’idea di una filosofia come disciplina a sé, dotata di una sua autorevolezza, piuttosto siamo vicini a un impegno di pensiero che ci chiederebbe di uscire dal bozzolo di un “io” separato, vale a dire di tentare di liberarci dalla presa di qualunque egoismo (egologia, egolatria) e dunque anche di sospettare di ogni pervasiva psicologia.
Perciò il gesto fenomenologico, così difficile da mantenere, così facile da inquinare e infrangere, dunque raro, è innanzi tutto un atteggiamento autocritico: ciascuno di noi, ogni “soggetto”, dovrebbe cominciare con il togliersi di dosso la camicia di forza dell’egoismo, tentare almeno di farlo, se vuole che il suo gesto agisca come un gesto critico. Non è certo lo scenario che vediamo ogni giorno perché, invece, abbiamo costantemente davanti una scena opposta in cui non si scorge quasi nessuna traccia di tale necessaria critica di sé stessi.
Ma cosa significa quel parolone, “fenomenologico”, che accompagna la parola “gesto”? Qui compare la specificità filosofica che caratterizza i settant’anni della rivista. È chiaro che il rimando è a Husserl e soprattutto alla sua ultima opera La crisi delle scienze. Si parte da una diagnosi di perdita di senso, cioè appunto di “crisi”, che non investe soltanto il mondo scientifico e la sua tecnicizzazione, come aveva fatto negli anni Trenta lo stesso Heidegger (peraltro, inizialmente discepolo di Husserl), ma investe per intero la cultura poiché riguarda lo stile di vita di ciascuno. Il titolo preciso di quest’opera di Husserl, che davvero ha fatto testo per comprendere un’epoca, certo non ancora conclusa, è: La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (in italiano è stata pubblicata dal Saggiatore, lo stesso editore di “aut aut”).
“Fenomenologia” e in più “trascendentale”? Non è poi così difficile arrivare al nocciolo di una frase che potrebbe giustamente allarmare i non addetti (tra i quali, in questo caso, vorrei potermi collocare a mia volta): quel “trascendentale” è lì per dirci che non dobbiamo confondere fenomenologia con fenomeno (o con qualcosa di semplicemente fenomenico) perché ciò che viene messo in gioco è l’idea di soggetto e di soggettività nella sua concretezza non superficiale.
Per mantenere o ritrovare il suo carattere fenomenologico, questa idea non dovrà essere soltanto la meno idealistica, categoriale, metafisica possibile, perché non basta che la concretezza equivalga a ciò che è empirico, ma dovrebbe riuscire a dar corpo a una soggettività che non è mai fissabile attraverso un’etichetta. Perciò il termine fenomenologia risulta essenziale per mettere in primo piano proprio il problema del soggetto.
Aggiungo, per far capire l’importanza di tale problema, che il soggetto che viene così evocato non è mai traducibile in un concetto chiuso, di cui si possa costruire una scienza comunemente intesa. È piuttosto, come diceva lo stesso Husserl, un “enigma” che non possiamo cessare di sondare e di rilanciare, qualcosa che ha a che fare con l’insieme dei nostri vissuti e con la nostra stessa vita.
Qualcosa che fa tutt’uno con lo stile di vita di ognuno di noi, come ha mostrato con chiarezza Paci nelle pagine del suo personale Diario fenomenologico (ora riedito da Orthotes). E proprio da qui discende l’intero corredo critico di “aut aut”, cioè - per indicarne solo qualche aspetto - l’importanza della “sospensione del giudizio” (la famosa epoché, rilanciata anche da Franco Basaglia nella sua critica alla psichiatria ufficiale), l’importanza di non isolare mai il sapere dall’etica con il rischio di svuotare il “gesto” facendolo diventare unicamente una tecnica di pensiero, o anche l’importanza di conservare a ogni costo l’apertura del dubbio e la possibilità del “sempre di nuovo”.
Perché questo gesto non può essere mai considerato un atteggiamento esclusivamente individuale? La tonalità “politica” della rivista, presente fin dal suo inizio, può ritrovarsi nella risposta a quest’ultima domanda, nel senso che non si dà soggettività senza intersoggettività, cioè che nel vissuto personale è sempre presente e attiva l’esperienza dell’“altro” ed è quindi comunque decisiva un’esperienza del noi.
Senza il compito dello stare assieme in una comunità possibile e necessaria di soggetti, il gesto fenomenologico perde il suo significato, letteralmente si annulla nel suo senso e nei suoi obiettivi. Siamo ancora lontani da questo telos, dall’impegnarci seriamente nella pratica di una simile finalità, e allora si comprende perché il tragitto che “aut aut” ha iniziato fin dal primo fascicolo non sia affatto esaurito.
[articolo uscito in versione ridotta su “La Stampa” il 20 settembre 2021]
*Fonte: Aut Aut, 23/09/2021
NOTA:
L’ENIGMA DEL SOGGETTO E LA PROVA DELL’ESISTENZA DI DIO. Note su un dialoghetto "platonico" diffuso in rete:
- Nel pancione di una mamma c’erano due bambini.
 Uno chiese all’altro: "Ma tu ci credi in una vita dopo il parto?"
Uno chiese all’altro: "Ma tu ci credi in una vita dopo il parto?"
 L’altro rispose: "Certo! Deve esserci qualcosa dopo il parto. Forse noi siamo qui per prepararci per quello che verrà più tardi". "Sciocchezze" disse il primo "non c’è vita dopo il parto! Che tipo di vita sarebbe quella?"
L’altro rispose: "Certo! Deve esserci qualcosa dopo il parto. Forse noi siamo qui per prepararci per quello che verrà più tardi". "Sciocchezze" disse il primo "non c’è vita dopo il parto! Che tipo di vita sarebbe quella?"
 Il secondo riprese: "Io non lo so, ma ci sarà più luce di qui. Forse potremo camminare con le nostre gambe e mangiare con le nostre bocche. Forse avremo altri sensi che non possiamo capire ora".
Il secondo riprese: "Io non lo so, ma ci sarà più luce di qui. Forse potremo camminare con le nostre gambe e mangiare con le nostre bocche. Forse avremo altri sensi che non possiamo capire ora".
 Il primo replicò: "Questo è assurdo. Camminare è impossibile. E mangiare con la bocca!? Ridicolo! Il cordone ombelicale è tutto quello di cui abbiamo bisogno...e poi è troppo corto. La vita dopo il parto è fuori questione".
Il primo replicò: "Questo è assurdo. Camminare è impossibile. E mangiare con la bocca!? Ridicolo! Il cordone ombelicale è tutto quello di cui abbiamo bisogno...e poi è troppo corto. La vita dopo il parto è fuori questione".
 Il secondo continuò ad insistitere: "Beh, io credo che ci sia qualcosa e forse diverso da quello che è qui. Forse la gente non avrà più bisogno di questo tubo".
Il secondo continuò ad insistitere: "Beh, io credo che ci sia qualcosa e forse diverso da quello che è qui. Forse la gente non avrà più bisogno di questo tubo".
 Il primo contestó: "Sciocchezze, e inoltre, se c’è davvero vita dopo il parto, allora, perché nessuno è mai tornato da lì? Il parto è la fine della vita e nel postparto non c’è nient’altro che oscurità, silenzio e oblio. Il parto non ci porterà da nessuna parte".
Il primo contestó: "Sciocchezze, e inoltre, se c’è davvero vita dopo il parto, allora, perché nessuno è mai tornato da lì? Il parto è la fine della vita e nel postparto non c’è nient’altro che oscurità, silenzio e oblio. Il parto non ci porterà da nessuna parte".
 "Beh, io non so" disse il secondo "ma sicuramente troveremo la mamma e lei si prenderà cura di noi".
"Beh, io non so" disse il secondo "ma sicuramente troveremo la mamma e lei si prenderà cura di noi".
 Il primo rispose: "Mamma? Tu credi davvero alla mamma? Questo si che è ridicolo. Se la mamma c’è, allora, dov’è ora?"
Il primo rispose: "Mamma? Tu credi davvero alla mamma? Questo si che è ridicolo. Se la mamma c’è, allora, dov’è ora?"
 Il secondo riprese: "Lei è intorno a noi. Siamo circondati da lei. Noi siamo in lei. È per lei che viviamo. Senza di lei questo mondo non ci sarebbe e non potrebbe esistere".
Il secondo riprese: "Lei è intorno a noi. Siamo circondati da lei. Noi siamo in lei. È per lei che viviamo. Senza di lei questo mondo non ci sarebbe e non potrebbe esistere".
 Riprese il primo: "Beh, io non posso vederla, quindi, è logico che lei non esiste".
Riprese il primo: "Beh, io non posso vederla, quindi, è logico che lei non esiste".
 Al che il secondo rispose: "A volte, quando stai in silenzio, se ti concentri ad ascoltare veramente, si può notare la sua presenza e sentire la sua voce da lassù".
Al che il secondo rispose: "A volte, quando stai in silenzio, se ti concentri ad ascoltare veramente, si può notare la sua presenza e sentire la sua voce da lassù".
 Questo è il modo in cui uno scrittore ungherese ha spiegato l’esistenza di Dio.
Questo è il modo in cui uno scrittore ungherese ha spiegato l’esistenza di Dio.
USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO” (KANT).
COSA PENSANO I due BAMBINI nella pancia della madre "della VITA DOPO IL PARTO"? Ma l’autore "scrittore" di questo "bel" testo (sopra) ha mai sollecitato i "due bambini" a pensare sul come sono ’arrivati’ là dove sono, su come nascono i bambini?, e ha mai visto il Sole? O vive ancora nel pancione della Mamma-Terra, nella caverna di Platone (ama il mondo chiuso e la claustrofilia) e, per il trauma della nascita, si è sempre rifiutato di aprire gli occhi alla luce del Sole e vedere la Terra dalla Luna, dallo spazio?!
"ACHERONTA MOVEBO" (IL "MUOVERE LE ACQUE INFERNALI" DI FREUD) E AFFRONTARE IL TRAUMA DELLA NASCITA (OTTO RANK): SAPERE AUDE! ("IL CORAGGIO DI SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA" DI KANT) !
Senza la critica di Kant del sogno dell’amore cieco e zoppo della ragion pura (di Socrate/Platone) non si può riconoscere a Diotima piena cittadinanza né nell’Accademia né nella Polis. La logica della tragedia (Edipo) porta davvero la peste!
 La Sibilla Delfica (dell’oracolo di Apollo) a Socrate disse la verità, ma la storiografia ha preferito credere al sogno della nascita del cigno e alla storia di Platone, figlio di Zeus / Apollo!
La Sibilla Delfica (dell’oracolo di Apollo) a Socrate disse la verità, ma la storiografia ha preferito credere al sogno della nascita del cigno e alla storia di Platone, figlio di Zeus / Apollo!
 Nietzsche perché ha scavato nella nascita della tragedia? Freud cosa cercava a Tebe?! Come Edipo, già a partire dal caso Dora, chiarirsi le idee sulla morte e uccisione del padre ("Interpretazione dei sogni") e sul desiderio incestuoso nei confronti della #madre, fare luce su "L’uomo #Mosè" e sull’esistenza di "Dio"! Con Dante e come Dante ha avuto il coraggio di agitare le acque infernali e uscirne: a Londra, è arrivato!
Nietzsche perché ha scavato nella nascita della tragedia? Freud cosa cercava a Tebe?! Come Edipo, già a partire dal caso Dora, chiarirsi le idee sulla morte e uccisione del padre ("Interpretazione dei sogni") e sul desiderio incestuoso nei confronti della #madre, fare luce su "L’uomo #Mosè" e sull’esistenza di "Dio"! Con Dante e come Dante ha avuto il coraggio di agitare le acque infernali e uscirne: a Londra, è arrivato!LA QUESTIONE DEL SOGGETTO, IL TRAUMA DELLA NASCITA, E LA VITA DOPO IL PARTO.
"OTTO RANK, IL DOPPIO E LA PSICOANALISI" (alcune mie note, in "Psicoterapia e Scienze Umane", 4, 1980, pp. 75-79) ). Se Freud osò agitare e rompere le acque infernali ("Acheronta movebo) e riuscì a portare alla luce la psicoanalisi, è da dire, però, che non fu altrettanto attento a riconoscere il trauma della nascita e a portarsi oltre le colonne d’Ercole dell’Edipo.
Andando in America, nel 1909, Freud era ancora fiducioso e ottimista nella possibilità della psicoanalisi di affrontare il diffondersi della peste; ma nel 1924, con la sua parziale comprensione del complesso di Edipo, non riesce ad accogliere la sollecitazione di Otto Rank a riflettere sul trauma della nascita e l’avvenire della sua stessa creatura comincia a oscurarsi.
Elvio Fachinelli (1928-1989) ha saputo vincere la Claustrofilia (1983), si è portato "Sulla spiaggia" (1985), ma l’ Accademia platonica della Filosofia come della Psicoanalisi ha continuato a chiudere un occhio su come nascono i bambini. E il platonismo continua a oscurare il cielo...
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---UNA QUESTIONE DI VOCABOLARIO: RICHIAMO ALL’ESSENZA. (di Riccardo Maccioni).7 dicembre 2021, di Federico La Sala
Il Papa, l’umanità, la civiltà europea. Richiamo all’essenza
Richiamo all’essenza
di Riccardo Maccioni (Avvenire, martedì 7 dicembre 2021)
È una questione di vocabolario, per chiamare l’orrore con il suo nome. Di braccia, che sollevano chi cade e tirano giù i muri. Di occhi, perché anche il cuore parla con il viso, e solo guardando insieme agli altri si può pensare e disegnare un futuro diverso. Il viaggio del Papa in Grecia e a Cipro è stato un richiamo all’essenza dell’umanità, dell’autentica civiltà europea, e a tutti modi che esistono per difenderla e farla crescere. Non solo l’ennesima denuncia della vergogna delle barriere contro i poveri, che pure c’è stata e forse mai con discorsi altrettanto perentori, ma un itinerario politico, nel senso più nobile del termine, che quando si sposa con il Vangelo esce dal recinto dell’ideologia per diventare servizio pastorale, cioè ricerca del bene comune declinato come carità, come amore.
La visita in fondo ha toccato un fazzoletto di poche centinaia di chilometri però il suo respiro ha abbracciato un continente intero. E un sogno comunitario, quello dell’Unione, sempre più a rischio fallimento. A minarlo sono le scorciatoie per aggirare la complessità dei rapporti tra nazioni e dentro le società. Le ricette facili, rassicuranti dei populismi, l’autoritarismo «sbrigativo», la paura che arma la difesa del privilegio. E, dall’altra parte, la rinuncia a se stessi, l’annacquamento della propria identità, in nome di un politicamente corretto che diventa l’olio su cui far scivolare i conflitti, nell’illusione che evaporino come le polveri sottili dopo un giorno di vento. E invece stanno lì, quasi rafforzati dalla scelta del rinvio, che peraltro sembra non pagare più neanche a livello elettorale. Da Atene Francesco lo ha denunciato con chiarezza, oggi la democrazia è messa in pericolo dalle polarizzazioni esasperate, dal ridurre il pensiero alto a miseri interessi di bottega, dall’accettazione finanche del ridicolo pur di blindare il consenso.
Una deriva cui il Pontefice ha opposto il passaggio dal parteggiare al partecipare, dal tifo urlato dal balcone allo sporcarsi le mani nel nome del dialogo. In fondo, è la ricetta dei padri dell’Europa, e non a caso il richiamo è andato a De Gasperi e al suo discorso di Milano, del 1949: «Si parla molto di chi va a sinistra o a destra, ma il decisivo è andare avanti» verso «la giustizia sociale». Che alla luce del Vangelo significa molto più della tolleranza, vuol dire solidarietà generosa, «di fatto» come diceva Robert Schuman e, in un crescendo virtuoso, consapevolezza dell’appartenenza a un’unica famiglia umana, fraternità, comunione.
Il sogno dell’Unione non è fallito, sembra suggerire il Pontefice, si tratta di aggiornarlo, di impegnarsi nella costruzione di un nuovo umanesimo che, citando il discorso del 2016 al conferimento del Premio Carlo Magno, si fonda su tre capacità: «capacità di integrare, di dialogare e di generare». La Chiesa, con i suoi figli e figlie, può, in questo. giocare un ruolo fondamentale, cominciando, com’è nel suo Dna, dal basso, dall’andare incontro alle ferite dell’uomo, dal circondare con il suo abbraccio di misericordia e di perdono chi compie un passo falso ma poi sa riconoscere il proprio errore.
Più che sognatori e maestri oggi servono davvero testimoni, oltre all’ardimento c’è bisogno di pazienza, e se un coraggio andiamo cercando è quello che fa rima con chiarezza, capace di chiamare bene il bene e male il male. Come i muri, le barriere, i ’lager’ costruiti sulle coste del Mediterraneo, che sono vernice nera sull’anima delle popolazioni civili, catastrofe del bene comune, «naufragio di civiltà». Ma la denuncia da sola non basta, servono braccia per sollevare chi fa fatica, servono mani unite nella preghiera, servono scarpe solide per incamminarsi sul sentiero, culturale prima e fisico poi, che porta ad abbattere le barriere, recuperando l’insegnamento di Elie Wiesel, il Nobel per la pace richiamato dal Papa a Lesbo: «Quando le vite umane sono in pericolo, quando la dignità umana è in pericolo, i confini nazionali diventano irrilevanti ».
A Cipro e in Grecia, quei fratelli recintati dalla miseria hanno come in ogni geografia della povertà, volti, storie, nomi. Sono le parole e il cuore di un’Europa che non può e non deve smarrire la sua vocazione di democrazia solidale. Sono la paura e la speranza di ogni uomo e ogni donna che chiede aiuto per non perdere la dignità di essere umani.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!!La buona-esortazione del BRASILE (2005). --- Cop 26. La Chiesa amazzonica: affrontate la radice del problema. Una numerosa delegazione di indigeni amazzonici a Glasgow (di Lucia Capuzzi)..6 novembre 2021, di Federico La Sala
l diario di Glasgow/ Giorno 6.
La Chiesa amazzonica: affrontate la radice del problema
L’appello di Repam e Ceama che hanno scritto ai leader internazionali per esprimere loro «sconcerto» e il «senso di impotenza» di fronte al caos che scuote la casa comune
Lucia Capuzzi (Avvenire, sabato 6 novembre 2021)
- [Foto] Papa Francesco accoglie gli indigeni in San Pietro all’apertura del Sinodo sull’Amazzonia nell’ottobre 2019 - Ansa
«Vogliamo pronunciarci pubblicamente e non restare in silenzio». La Chiesa dell’Amazzonia ha fatto arrivare la propria voce fino a Glasgow, dove è in corso il summit Onu sul clima (Cop26). La Rete ecclesiale pan amazzonica (Repam) e la Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia (Ceama) hanno scritto ai leader internazionali per esprimere loro «sconcerto» e il «senso di impotenza» di fronte al caos che scuote la casa comune.
La regione amazzonica, in particolare, ricca «di biodiversità ecologica e culturale, un luogo strategico per l’umanità e per il pianeta, è colpita drasticamente dal degrado ambientale e dalle conseguenze del cambiamento climatico causato dalle emissioni di gas serra». Il modello estrattivista - basato sullo sfruttamento intensivo delle risorse naturali per soddisfare la domanda dell’economia internazionale - divora la selva e i suoi abitanti. Non a caso, una numerosa delegazione di indigeni amazzonici ha affrontato enormi difficoltà logistiche per portare la propria testimonianza a Glasgow.
 La Chiesa si fa eco del loro grido d’aiuto. E lancia un forte appello a lottare per salvare un territorio che, come afferma papa Francesco in Querida Amazónia, «si mostra di fronte al mondo in tutto il suo splendore, il suo dramma, il suo mistero». A tal fine, «non valgono i pannicelli caldi, le promesse incompiute, gli impegni non rispettati né misure che non siano radicali».
La Chiesa si fa eco del loro grido d’aiuto. E lancia un forte appello a lottare per salvare un territorio che, come afferma papa Francesco in Querida Amazónia, «si mostra di fronte al mondo in tutto il suo splendore, il suo dramma, il suo mistero». A tal fine, «non valgono i pannicelli caldi, le promesse incompiute, gli impegni non rispettati né misure che non siano radicali».
 Viviamo - aggiungono Repam e Ceama - «in un mondo rotto. E’ necessario imparare ad agire in modo integrale per rispondere a questa realtà infernale, assumendo l’accordo di Parigi e ciò che comporta».
Viviamo - aggiungono Repam e Ceama - «in un mondo rotto. E’ necessario imparare ad agire in modo integrale per rispondere a questa realtà infernale, assumendo l’accordo di Parigi e ciò che comporta».«Speriamo che ascoltiate la nostra supplica unita a quella di molti popoli dell’Amazzonia, custodi millenari della terra», concludono. E affrontiate «in modo deciso e appropriato la radice dei problemi, perché non accada ciò che scriveva il Nobel della letteratura colombiano, Gabriel García Márquez nel capolavoro Cent’anni di solitudine: “Le stirpi condannate a cent’anni di solitudine non hanno una seconda opportunità sulla terra”».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- FILOLOGIA E STORIA: IL REGNO DELL’ HOMO "COSMOTEANDRICUS" E LA DOMANDA DI KANT. Note a margine del film di Audrey Diwan (di Federico La Sala).13 settembre 2021, di Federico La Sala
L’ORDINE SIMBOLICO DI MAMMASANTISSIMA: LA LUNGA MARCIA DI UNA CATASTROFE ANTROPOLOGICA IN CORSO.
Senza riandare indietro nel tempo, cosa che ha già fatto una grande tradizione critica (e da cui poco è stato appreso), ipnotizzati da concetti-specchio come patriarcato e matriarcato, ancora non è stato capito che cosa significa Edipo (Freud), tragedia (Dante, Nietzsche), e rapporto sociale di produzione (Marx). C’è solo da accogliere il film “L’événement” (Audrey Diwan, Leone d’oro, Venezia 2021) come una buona sollecitazione a ripensare questi problemi legati a mammane, mammona, cucchiai d’oro e moloch vari e riprendere il filo da quanto successo (in Europa) almeno (non solo a Granada nel 1492, ma anche) su "quel ramo del lago di Como" nel 1628 in un altro modo e in un’altra direzione. E così, possibilmente, buttare via l’acqua sporca e salvare la memoria di chi ha lottato da sempre per non restare all’inferno e vuole ri-nascere. O no?
DANTE 2021: LA DOMANDA ANTROPOLOGICA DI #KANT (""Che cos’è l’uomo?": "Logica", 1800), IL "FIGLIO DELL’#UOMO": UNA QUESTIONE DI PAROLA (LOGOS, NON LOGO!).
"Ecce #Homo" (gr. «idou ho #anthropos»): "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo ["Filius hominis", "ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]?»"(Gv. 12,34).
MESSAGGIO EVANGELICO E "DUE CRISTIANESIMI": "SEGUITEMI, VI FARO’ #PESCATORI DI UOMINI [piscatores hominun, ἁλιεῖς ἀνθρώπων] come da parola di Gesù (Mt. 4,19) o come da sollecitazione di Paolo di Tarso:"Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo... sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [lat. vir, gr. ἀνήρ]"(1 Cor. 11, 1-3)?!
11 SETTEMBRE 2011/2021, STORIA, E FILOLOGIA: "ECCE HOMO". Sempre a ripetere le famose parole dell’Ulisse di Dante (Inf. XXVI, 118-120: "Considerate la vostra semenza: /fatti non foste a viver come bruti,/ ma per seguir virtute e canoscenza"), ma ancora oggi (2021), dopo Dante e dopo Kant, tutta l’Europa e l’intero Pianeta è immerso in un letargo profondissimo! Alla questione antropologica ("Che cos’è l’uomo?": Kant,1800), si continua a rispondere truccando la Parola (il Logos) e a scambiarla (e a esportarla) come un Logo di un’azienda, proprietà di quegli uomini "più uguali degli altri" della orwelliana "Fattoria degli Animali"!
PREISTORIA (DI "VIRTUS" E "VIRUS"). La parola uomo (gr. anthropos, homo) vale solo come uomo-maschio (gr. anér/andròs, lat. vir/viri) e l’antropologia si coniuga solo al maschile, come andrologia: a tutti i livelli, immersi nel regno dell’Homo cosmo-te-andricus - nella "realtà" di una teologia ("Dio"), di una cosmologia ("Mondo") e di una antropologia "andrologica" ("Uomo"), la cosmoteandria del Pianeta Terra...
METANOIA: CAMBIARE MENTE! A che gioco giochiamo? Non è meglio uscire dall’orizzonte della cosmoteandria e dall’inferno (Inf. XXXIV, 90) e riprendere la navigazione nell’oceano celeste (Keplero a Galilei, 1611)?! O che?!
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, GEOLOGIA, E FILOLOGIA. Siamo tutti sulla stessa barca. Il rompicapo dell’antropocene (di Michela Dall’Aglio).5 settembre 2021, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, GEOLOGIA, E FILOLOGIA. L’arca di Noè e il rompicapo dell’antropocene.... *
- ANTROPOCENE. "Il termine deriva dalle parole in greco anthropos e kainos, che significano rispettivamente essere umano e recente, e almeno inizialmente non sostituiva il termine corrente usato per l’epoca geologica attuale, Olocene, ma serviva semplicemente ad indicare l’impatto che l’Homo sapiens ha sull’equilibrio del pianeta. Recentemente le organizzazioni internazionali dei geologi stanno considerando l’adozione del termine per indicare appunto una nuova epoca geologica e stabilire da dove cronologicamente farla iniziare in base a precise considerazioni stratigrafiche"(Wikipedia).
- SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA. "Qualcosa nei nostri tempi mi ricorda quelli del biblico Noè, quando, secondo il racconto, gli uomini conducevano la loro solita vita, mangiando, bevendo, commerciando e combinando matrimoni, e nessuno s’accorgeva del diluvio che si andava preparando sulle loro teste. Solo Noè lo aveva capito. Ma quelli erano tempi in cui ancora si sperava nell’aiuto di Dio" (Michela Dall’Aglio, Siamo tutti sulla stessa barca/Il rompicapo dell’antropocene, cit.).
- MESSAGGIO EVANGELICO E FIGLIO DELL’UOMO - "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]?»"(Gv. 12,34).
- LA LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
Siamo tutti sulla stessa barca /
Il rompicapo dell’antropocene
di Michela Dall’Aglio (Doppiozero, 09 aprile 2019)
La prua di una grande nave mercantile fende i ghiacci, parzialmente sciolti, di quello che possiamo immaginare essere il mitico passaggio a nord-ovest, che collega Atlantico e Pacifico nei periodi più caldi. Questa immagine, fortemente simbolica, ritorna come un leitmotiv nel film-documentario di Rudy Gnutti In the same boat, in cui diversi esperti - Zygmund Bauman, Tony Atkinson, Serge Latouche, Mariana Mazzucato, Mauro Gallegati, Erik Brynjolffson e l’ex presidente dell’Uruguay Jose Mujica - discutono di globalizzazione e progresso tecnologico. La questione centrale affrontata nel film è la situazione paradossale creata dal sistema attuale in cui, mentre diminuisce la sperequazione economica tra le nazioni, aumenta sempre più quella tra le classi sociali all’interno dei singoli paesi; di conseguenza dappertutto si constata una progressiva riduzione della classe media, da sempre elemento basilare di stabilità politica e giustizia sociale. Ne conseguono ricadute importanti sul lavoro, come la crescita della disoccupazione e, allo stesso tempo, l’insostenibilità dei ritmi lavorativi per chi, invece, ha un’occupazione. Tutto ciò mentre la crescita continua della ricchezza prodotta e della tecnologia utilizzata nella produzione aveva fatto ipotizzare - nel film a tal proposito si cita una previsione dell’economista John Maynard Keynes risalente agli anni ’40 - che oggi ci saremmo trovati a vivere mediamente tutti meglio e anche più liberi dal lavoro costrittivo.
Il problema, spiega il regista in un’intervista, è che «siamo capaci di creare un’enorme ricchezza, ma non abbiamo un sistema economico che consente di ’distribuirla’ al maggior numero possibile di persone; o almeno in una forma meno diseguale». E dunque, che fare? La buona notizia è che si può fare qualcosa. La cattiva notizia è che bisogna fare qualcosa al più presto per non cadere in un caos socio-politico. Nel film gli esperti avanzano alcune proposte, ricordando, a chi le ritenga utopistiche, che molte realtà di oggi, quali per esempio la democrazia, l’abolizione della schiavitù o l’uguaglianza tra i sessi, erano utopie solo pochi secoli fa. D’altra parte, per sapere se le azioni suggerite possono funzionare, non c’è altra via che provare a metterle in pratica.
Il messaggio del film è chiaro già dal titolo: siamo sulla stessa barca significa che siamo in una situazione pericolosa in cui o si agisce tutti insieme per salvarsi oppure si annega tutti insieme. Nessuno può sperare di salvarsi da solo e tutti soffriamo lo stesso mal di mare, aggiungeva Martin Luther King esortando all’empatia reciproca. Comunque, anche se fossimo egoisti e duri di cuore, ci sono circostanze nelle quali agire per il bene comune è l’unica cosa ragionevole da fare, a qualsiasi costo. Il problema per Zygmund Bauman è che non abbiamo né remi, né motori né una bussola per condurre velocemente la barca nella giusta direzione.
Continuando l’allegoria, è di vitale importanza porsi anche un altro obiettivo - in realtà deve essere il primo -, ossia tenere in funzione la barca, evitando falle irreparabili e conservandola in buone condizioni, soprattutto se è sovraccarica. Fuor di metafora, stiamo parlando del nostro pianeta e dei numerosi segnali d’indebolimento strutturale che ci sta dando. La Terra si sta modificando troppo velocemente e così radicalmente da far ritenere, a molti esperti, iniziata una nuova epoca geologica, cui si è dato il nome di Antropocene per sottolineare due fatti significativi. Innanzitutto, che abbiamo abbandonato le spiagge note (e relativamente sicure) dell’Olocene, il periodo interglaciale caldo iniziato circa dodicimila anni fa e in cui abbiamo vissuto finora; in secondo luogo, che questo cambio geologico non è stato determinato, come i precedenti, da fattori naturali, ma dalla presenza e dall’attività umana.
 Nel saggio Il pianeta umano. Come abbiamo creato l’Antropocene (Einaudi), Simon L. Lewis e Mark A. Maslin, studiosi inglesi esperti di questioni climatiche ed ecologia globale, spiegano come e quando reputano sia avvenuto questo cambio epocale. Alla fine di un esaustivo percorso tra geologia e storia economica le loro considerazioni, del tutto in linea con quelle espresse nel docu-film di Gnutti, si riassumono nel «rompicapo dell’Antropocene»: ci troviamo di fronte al compito, improrogabile e tuttavia molto arduo, di raggiungere un livello di uguaglianza globale tra i paesi del mondo nello sfruttamento delle risorse, e dobbiamo farlo restando entro «limiti ambientali sostenibili». Senza un’azione coordinata in tal senso sarà impossibile evitare il tracollo ambientale, cui inevitabilmente, ce lo insegna la storia, fanno seguito quelli economico e sociale. Oggi dobbiamo prendere atto di qualcosa del tutto inedito: una nuova forza della natura, una «superpotenza geologica» si è affiancata ai meteoriti e ai vulcani nel dare forma all’evoluzione della vita sulla Terra, ed è l’uomo. Ecco perché parliamo di Antropocene.
Nel saggio Il pianeta umano. Come abbiamo creato l’Antropocene (Einaudi), Simon L. Lewis e Mark A. Maslin, studiosi inglesi esperti di questioni climatiche ed ecologia globale, spiegano come e quando reputano sia avvenuto questo cambio epocale. Alla fine di un esaustivo percorso tra geologia e storia economica le loro considerazioni, del tutto in linea con quelle espresse nel docu-film di Gnutti, si riassumono nel «rompicapo dell’Antropocene»: ci troviamo di fronte al compito, improrogabile e tuttavia molto arduo, di raggiungere un livello di uguaglianza globale tra i paesi del mondo nello sfruttamento delle risorse, e dobbiamo farlo restando entro «limiti ambientali sostenibili». Senza un’azione coordinata in tal senso sarà impossibile evitare il tracollo ambientale, cui inevitabilmente, ce lo insegna la storia, fanno seguito quelli economico e sociale. Oggi dobbiamo prendere atto di qualcosa del tutto inedito: una nuova forza della natura, una «superpotenza geologica» si è affiancata ai meteoriti e ai vulcani nel dare forma all’evoluzione della vita sulla Terra, ed è l’uomo. Ecco perché parliamo di Antropocene.Nel loro libro Simon Lewis e Mark Maslin delineano quattro ambiti in cui la geologia del pianeta e la storia umana s’intersecano: la questione di se e come le attività umane abbiano causato (e stiano causando) cambiamenti ambientali tanto grandi da determinare «in misura crescente il futuro dell’unico pianeta che per quanto ne sappiamo ospita la vita»; la possibilità di individuare tracce concrete di questi cambiamenti nei sedimenti geologici - le future rocce, dispositivi naturali di registrazione di questa tipologia di dati -; siccome «l’Antropocene è l’intreccio fra la storia umana e la storia della Terra», propongono una reinterpretazione della storia dell’umanità «osservando[la] attraverso la lente della scienza del sistema Terra»; infine, dopo avere individuato quattro transizioni strutturali nella storia umana - due legate alla disponibilità di energia e due all’organizzazione sociale -, ciascuna delle quali ha prodotto effetti crescenti sul sistema Terra, espongono le loro tesi sul tempo attuale e alcune ipotesi sui provvedimenti possibili per il futuro.
La prima delle quattro transizioni da essi individuate è rappresentata dalla nascita dell’agricoltura (circa dodicimila anni fa) che permise agli uomini di utilizzare una maggiore quantità di energia solare attraverso il cibo, modificò i paesaggi e, col tempo, anche la composizione chimica dell’atmosfera, al punto da favorire «in tutto il pianeta condizioni eccezionalmente stabili, dando alle grandi civiltà il tempo di svilupparsi».
 La seconda fu invece di carattere organizzativo, e risale al XVI secolo quando gli Europei cominciarono a colonizzare il pianeta, dando inizio alla prima economia globalizzata della storia. «Le nuove rotte commerciali collegarono il mondo come mai prima d’allora. Piante da coltivare e animali da allevare, e molte specie che si trovarono a viaggiare insieme a loro, vennero trasferiti in altri continenti e in altri oceani. Questo scambio transoceanico di specie ... diede inizio a un riordinamento globale della vita sulla Terra che è ancora in atto», una nuova Pangea fatta dall’uomo.
La seconda fu invece di carattere organizzativo, e risale al XVI secolo quando gli Europei cominciarono a colonizzare il pianeta, dando inizio alla prima economia globalizzata della storia. «Le nuove rotte commerciali collegarono il mondo come mai prima d’allora. Piante da coltivare e animali da allevare, e molte specie che si trovarono a viaggiare insieme a loro, vennero trasferiti in altri continenti e in altri oceani. Questo scambio transoceanico di specie ... diede inizio a un riordinamento globale della vita sulla Terra che è ancora in atto», una nuova Pangea fatta dall’uomo.La terza transizione fu provocata dall’utilizzo sempre più massiccio di combustibili fossili (principalmente carbone), motore e conseguenza a un tempo della Rivoluzione industriale settecentesca. La quarta ha portato a un nuovo cambiamento organizzativo su scala mondiale, che gli autori definiscono "capitalismo di consumo" collocandone l’avvio attorno al 1945, con la grande accelerazione.
Il risultato di tutti questi passaggi è che nell’atmosfera di oggi si trova «una quantità di anidride carbonica tale da farle raggiungere il livello più alto in più di 3 milioni di anni», e di conseguenza le condizioni stabili che hanno permesso lo sviluppo delle società umane ci stanno lasciando. È in atto «un esperimento pericoloso con il futuro della civiltà umana», avvertono Lewis e Maslin, perché dopo milioni di anni di alternanza sostanzialmente ciclica di fasi glaciali fredde e fasi interglaciali calde, «nel corso del tempo le azioni umane sono arrivate a produrre ... il differimento di una nuova era glaciale e la creazione di un nuovo stato planetario, uno stato più caldo dei periodi interglaciali - un superinterglaciale.»
In quale di questi quattro momenti cruciali si può collocare la fine, ancora ipotetica, del relativamente tranquillo Olocene? E perché dovremmo nominare Antropocene l’eventuale nuova fase geologica della Terra? La scelta della denominazione può sembrare, a noi profani, una questione di lana caprina, ma Lewis e Maslin dedicano una parte del loro saggio a spiegarci perché, invece, è importante in quanto, spiegano, dai dati che si scelgono per stabilire se, da quando e perché ci sia stata una transizione epocale dipendono «le risposte politiche alla vita nell’Antropocene». È chiaro, infatti, che cambia parecchio il livello di preoccupazione e il genere di soluzioni proposte se si considera fattore determinante l’emissione di gas serra prodotti oggi oppure la rivoluzione agricola del Neolitico.
Per arrivare a stabilire una data d’inizio dell’Antropocene, i due studiosi propongono l’esame dei sedimenti geologici, esattamente come si è fatto per tutte le passate epoche della storia geologica, al fine di individuare un marcatore la cui presenza nei sedimenti indichi un cambio nella stratificazione terrestre. Con questo metodo si è potuto stabilire, ad esempio, quando sono cominciate le condizioni interglaciali calde attuali.
 Analizzando una carota di ghiaccio antartico, in corrispondenza degli inizi del XVII secolo è stata rilevata una riduzione breve, ma significativa, dell’anidride carbonica nell’aria. Quell’epoca segna il momento in cui gli effetti della colonizzazione delle Americhe hanno lasciato traccia nei sedimenti geologici:
Analizzando una carota di ghiaccio antartico, in corrispondenza degli inizi del XVII secolo è stata rilevata una riduzione breve, ma significativa, dell’anidride carbonica nell’aria. Quell’epoca segna il momento in cui gli effetti della colonizzazione delle Americhe hanno lasciato traccia nei sedimenti geologici:
 «Gran parte della diminuzione avvenne perché gli Europei portarono per la prima volta nelle Americhe il vaiolo e altre malattie, causando la morte di piú di 50 milioni di persone in pochi decenni. Il collasso di queste società portò alla riforestazione dei terreni agricoli in un’area tanto estesa che la quantità di anidride carbonica atmosferica assorbita dagli alberi in crescita fu sufficiente a raffreddare temporaneamente il pianeta - l’ultimo momento globalmente freddo prima dell’inizio del caldo durevole dell’Antropocene».
«Gran parte della diminuzione avvenne perché gli Europei portarono per la prima volta nelle Americhe il vaiolo e altre malattie, causando la morte di piú di 50 milioni di persone in pochi decenni. Il collasso di queste società portò alla riforestazione dei terreni agricoli in un’area tanto estesa che la quantità di anidride carbonica atmosferica assorbita dagli alberi in crescita fu sufficiente a raffreddare temporaneamente il pianeta - l’ultimo momento globalmente freddo prima dell’inizio del caldo durevole dell’Antropocene».A questo punto l’interrogativo naturale riguarda «il futuro dell’umanità nell’Antropocene. Vi sarà una quinta transizione a una nuova forma di società umana, forse in grado di mitigare i nostri impatti sull’ambiente e di migliorare la vita delle persone?» Oppure, come una colonia di batteri, ci moltiplicheremo fino a esaurire le risorse della Terra e poi moriremo tutti? Speriamo di saperci meritare alla fine il nome sapiens che ci siamo orgogliosamente attribuiti, ricordandoci che sapiens vuol dire ’saggio’ e non ’potente’. Qualcosa nei nostri tempi mi ricorda quelli del biblico Noè, quando, secondo il racconto, gli uomini conducevano la loro solita vita, mangiando, bevendo, commerciando e combinando matrimoni, e nessuno s’accorgeva del diluvio che si andava preparando sulle loro teste. Solo Noè lo aveva capito. Ma quelli erano tempi in cui ancora si sperava nell’aiuto di Dio.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- STORIA. Dal Milite Ignoto all’altare della Patria. Centenario della traslazione 4 novembre 1921- 4 novembre 2021 per ricordare tutti i caduti in guerra d’Europa (di Riccardo Radi).11 agosto 2021, di Federico La Sala
Storia /
Dal Milite Ignoto all’altare della Patria
Centenario della traslazione 4 novembre 1921- 4 novembre 2021 per ricordare tutti i caduti in guerra d’Europa.
di Riccardo Radi (FiloDiritto, 08 Luglio 2021)
- [Foto] Milite Ignoto
- Saranno molte le iniziative commemorative finalizzate alla valorizzazione storica, morale e sociale del centenario del Milite Ignoto, il Governo si è impegnato a organizzare un viaggio della memoria con un treno d’epoca, nella composizione più possibile fedele, che compia un identico percorso con le stesse tappe e gli stessi tempi del treno che portò il Milite Ignoto a Roma il 4 novembre del 1921.
 Il ricordo dei 651.000 caduti italiani del primo conflitto mondiale dovrebbe essere accompagnato da un ricordo comune con gli altri Militi Ignoti di Europa per un un abbraccio corale che ricordi l’unità raggiunta e i valori costituenti della pace e della fratellanza tra i popoli e tutti i caduti in guerra.
Il ricordo dei 651.000 caduti italiani del primo conflitto mondiale dovrebbe essere accompagnato da un ricordo comune con gli altri Militi Ignoti di Europa per un un abbraccio corale che ricordi l’unità raggiunta e i valori costituenti della pace e della fratellanza tra i popoli e tutti i caduti in guerra.
- La guerra non ci sarebbero più se i loro morti potessero tornare. (Stanley Baldwin)
Il 4 novembre 1921, anniversario della fine della Prima guerra mondiale, la bara del Milite Ignoto, portata a spalla da 12 decorati di Medaglia d’oro al valor militare ed accompagnata dalle bandiere di guerra dei 355 Reggimenti che avevano partecipato al conflitto, venne deposta nella cripta ai piedi della statua della Dea Roma, situata al monumento del Vittoriano di Roma e al caduto ignoto fu conferita la Medaglia d’oro al valor militare.
Il monumento del Milite Ignoto è dedicato ai 651.000 mila caduti italiani del Primo conflitto mondiale, in particolare a coloro dei quali non è stato possibile pervenire all’identificazione, al fine di dedicare loro una degna sepoltura e il riconoscimento di tutti gli onori.
Dei tantissimi giovani che persero la vita in quel conflitto, in un Paese agricolo come era l’Italia nei primi del Novecento, molti provenivano dalle campagne e dal Mezzogiorno, chiamati dalla coscrizione obbligatoria a combattere nel Nord d’Italia e con commilitoni che condividevano la comune cittadinanza italiana ma sovente lingue e idiomi diversi.
La legge 11 agosto 1921, n. 1075, recante “la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in Guerra”, all’articolo 1, disponeva, a cura dello Stato, la solenne tumulazione al Vittoriano della salma di un soldato sconosciuto caduto in combattimento nella guerra 1915-1918.
Un secolo dopo, il senso profondo del Milite Ignoto acquista nuovi contenuti ponendosi a monito per le nuove generazioni secondo l’articolo 11 della Costituzione che recita: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [...] promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Pertanto, anche lo stesso sorgere dell’Unione europea che ha unito i popoli che durante la Prima guerra mondiale si combatterono, rappresenta un lascito importante nel ricordo dei caduti nei due conflitti mondiali del nostro Continente.
La Commissione Difesa della Camera dei deputati ha approvato il 31 marzo 2021 la risoluzione n. 7-00604 che impegna il Governo a organizzare un viaggio della memoria con un treno d’epoca, nella composizione più possibile fedele, che compia un identico percorso con le stesse tappe e gli stessi tempi del treno che portò il Milite Ignoto a Roma.
Il ricordo del Milite Ignoto è un momento che accomuna tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Stati che, alla fine dei due conflitti mondiali che hanno segnato profondamente il Novecento, hanno rinunciato a una parte della loro sovranità a favore dell’Unione e hanno conferito a quest’ultima parte dei propri poteri, al fine di creare un contesto stabile e di pace.
La commemorazione del Milite Ignoto è diffusa tra i Paesi membri dell’Unione europea e Alleati. A partire dal 1920-21, la costruzione di tombe e monumenti per la commemorazione della figura del Milite Ignoto si diffuse anche all’estero. Sarebbe auspicabile un ricordo comune per tutti per i caduti del Primo conflitto mondiale unendo i Militi Ignoti d’Europa in un abbraccio corale che ricordi l’unità raggiunta e i valori costituenti della pace e della fratellanza tra i popoli, e tutti i caduti in guerra.
- “In pace i figli seppelliscono i padri, mentre in guerra sono i padri a seppellire i figli.” (Erodoto)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE (2005) --- “La conquista del Messico”: Tenochtitlan 13 agosto 1521. Conquistadores, la storia di un grande «desencuentro» (di Lucia Capuzzi).5 agosto 2021, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE... *
Tenochtitlan 13 agosto 1521. Conquistadores, la storia di un grande «desencuentro»
Forse quella dell’America non fu né scoperta né conquista, ma incontro mancato. C’è ancora tempo per un’altra modalità di relazione con l’alterità?
di Lucia Capuzzi (Avvenire, giovedì 5 agosto 2021)
- [Foto] “La conquista di Tenochtitlan”, dipinto anonimo del XVII secolo della serie “La conquista del Messico” conservata presso la Biblioteca del Congresso - Library of Congress/WikiCommons
«Il sole si alza dal tuo letto di ossa [...]. L’alba lacera la cortina. Città, pila di parole rotte». Cinquecento anni dopo la sconfitta dell’impero azteca con la caduta di Tenochtitlan, la lacerante attualità dei versi di Octavio Paz vibra nel corpo giunonico di Città del Messico. Un organismo vivente più che una città. La spugnosa carne coloniale copre viscere dell’antica capitale precolombiana, per essere a sua volta ricoperta da una sottile pelle ultra-moderna. Gli strati coesistono, a volte confliggono, sempre si alimentano a vicenda. In questo flusso incessante, la megalopoli palpita, respira, sussiste. Impossibile separarli senza ucciderla. Una consapevolezza che, però, la città è incapace di tradurre in parole, come dimostra la polarizzazione delle narrative per l’anniversario. Perché implica fare i conti con l’evento che l’ha generata. E che, in fondo, ha generato l’America Latina.
Più ancora del 12 ottobre 1492, fu l’entrata a Tenochtitlan dei conquistadores al seguito di Hernán Cortés a segnare la nascita del mondo nuovo. E con esso il principio dell’età moderna. Fu “scoperta” o fu “conquista”? Fu incontro o fu scontro? Di sicuro, come afferma Tzvetan Todorov, fu l’esperienza più radicale, estrema, intensa di «scoprimento dell’altro». A differenza degli africani o degli asiatici, gli indo-americani e la loro esistenza erano del tutto ignorati dagli europei. Il confronto, dunque, fu di forza inedita. Mai come allora, gli uni e gli altri dovettero affrontare dei “simili diversi”.
Quel 13 agosto 1521 diviene, dunque, in un certo senso, il “parto” - per parafrasare Amalia Podetti - del globo, inteso come totalità. E del nostro tempo. Con tutte le sue contraddizioni. Non per niente, secondo Todorov, nel XVI secolo si è perpetrato il più grande genocidio della storia umana. Il massacro fu inaudito, questo è incontestabile. La sua definizione aritmetica, invece, è oggetto di dibattito tra gli studiosi ma tutti parlano di decine di milioni di esseri umani ingoiati in un vortice di violenza, schiavitù, epidemie. Magari una simile proporzione non fu voluta e intenzionale. Magari la leggenda nera anglobritannica - non proprio neutrale e benintenzionata - ha esagerato dettagli e crudeltà. Magari numerosi leader politici hanno cavalcato e cavalcano la strage per opportunismo. In questo, l’enfasi posta dal presidente Andrés Manuel López Obrador sul cinquecentesimo come sconfitta dei «veri messicani» è emblematica. Peccato che il Messico è - nel bene e nel male - è figlio di Cortés quanto di Monteczuma. Non sono, tuttavia, gli intenti, più o meno raffinati, di minimizzazione ad accelerare l’uscita dall’impasse.
Oltre che oggetto di studio, la mattanza d’America è soggetto di una storia di dolore, impressa, tuttora, nella carne e nel sangue dei discendenti dei nativi. Per costoro gli abusi antichi non sono che l’eco di quelli presenti, poiché la discriminazione e il rifiuto non sono terminati con la colonizzazione né con l’indipendenza né con le rivoluzioni e controrivoluzioni del secolo scorso. Per questo, gli occhi degli attuali maya si sono velati di lacrime nell’ascoltare papa Francesco affermare, a San Cristóbal de las Casas, il 15 febbraio 2016: «Perdono, fratelli! Il mondo di oggi, spogliato dalla cultura dello scarto, ha bisogno di voi!». Curiosa, dunque, l’ostinata richiesta di López Obrador nel domandare delle “scuse” già fatte senza alcuna sollecitazione. Farsi carico della memoria ferita è la grande occasione offerta dall’anniversario. Non solo per riconciliare il passato. In fondo, cinque secoli dopo, l’essere umano si trova di fronte ancora l’enigma di Cortés. Esiste l’uguaglianza al di fuori dell’identità? C’è spazio per una differenza che non implichi la subordinazione? La distruzione di Tenochtitlan ci ha mostrato le conseguenze di una risposta negativa, come quella del conquistador.
Forse, più che scoperta o conquista, quella d’America fu un grande desencuentro, un incontro mancato. Eppure non è l’unica alternativa. Desencuentro, intraducibile in italiano come unica parola, contiene in se la dimensione dell’encuentro, l’incontro. Anche questo ci ha mostrato la storia del Continente. Dieci anni dopo la devastazione dell’impero azteca, non lontano dalle ceneri ancora fumanti di Tenochtitlan, a Tepeyac, una Madonna dalle fattezze indigene scelse il nativo Juan Diego come proprio testimone. Nello sguardo non assimilativo della Morenita si intuisce un’altra modalità di relazione possibile con l’alterità.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: «Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo» (Gal 1,11); "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- IL PROBLEMA DEL LATINO, I CUSTODI DELLA TRADIZIONE, E LA VIA DELLA "SETA" O DELLA "LANA"?!28 luglio 2021, di Federico La Sala
#EUROPA:
#QUESTIONE ANTROPOLOGICA
#FILOLOGICA
E
#ARCHEOLOGICA.
#IMPERATIVO CATEGORICO
E
#SONNO DOGMATICO:
E
#GATTUNGSWESEN.
#DIVINA COMMEDIA:
I #TRADITIONIS CUSTODES,
IL #LATINO,
#CARITAS (#KAPITAS)
O DELLA
#CHARITAS (#XAPITAS)?
***
#QUESTIONE ANTROPOLOGICA
#FILOLOGICA
E
#ARCHEOLOGICA:
#EUROPA.
#DIVINA COMMEDIA (#DANTE2021)
E #SONNO DOGMATICO:
IL PROBLEMA DEL #LATINO
E
I #CUSTODI DELLLA #TRADIZIONE CATTOLICO-ROMANA
(#TRADITIONIS CUSTODES),
QUELLA DELLA
#CARITAS (#KAPITAS)
O DELLA
#CHARITAS (#XAPITAS)?
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- "La storia perduta del Cristianesimo... Come è finita una civiltà" (di Philip Jenkins - con pref. di G. Bosetti)).25 luglio 2021, di Federico La Sala
Jenkins e la grande storia perduta del Cristianesimo tra Est e Ovest
di Giancarlo Bosetti (Reset, 14 Luglio 2016)
- Ripubblichiamo qui parte della prefazione di Giancarlo Bosetti all’edizione italiana de La storia perduta del Cristianesimo. Il millennio d’oro della Chiesa in Medio Oriente, Africa e Asia (V-XV sec.). Com’è finita una civiltà di Philip Jenkins (Editrice Missionaria Italiana, 2016)
Nell’Europa percorsa dagli incubi scatenati dalla “guerra mondiale a pezzi”, dai proclami folli e sanguinari dell’Islam radicale, dai massacri prima di Al Qaeda poi dell’Isis, dalle ondate di disperati che cercano riparo nelle nostre società, i lavori di Philip Jenkins giungono come un aiuto prezioso nella tempesta, per guardare con lucidità la vicenda passata e presente della cultura e della religione cristiana. L’invito è di straordinario interesse per tutti, perché per tutti è di fondamentale importanza sottrarsi a quel determinismo coatto che vorrebbe produrre il trionfo di un senso comune della paura. [...]
In questa Storia perduta del Cristianesimo l’esercizio anti deterministico di Jenkins, come accade a volte nelle pagine degli storici di valore, si applica a rompere molte idee correnti sul “centro di gravità” delle nostre visioni del mondo cui apparteniamo e della religione che tendiamo a identificare sbrigativamente con l’identità europea. La guerra, le persecuzioni e la fuga stanno cancellando i cristiani da tanta parte del Medio Oriente, la violenza si accanisce sui monasteri cristiani dalla Siria all’Iraq. I cristiani siriaci o nestoriani hanno alle spalle qui una presenza poderosa e millenaria, con enormi comunità - decine di metropoliti, centinaia di vescovi - che si irradiavano a Est, non meno che a Ovest, a partire dai luoghi dove questa religione “nazarena” è nata, e di cui Jenkins racconta le stagioni più gloriose, ridisegnando la geografia storica e soprattutto quella mentale del Cristianesimo: una volta esisteva un altro e più antico cristianesimo che per la maggior parte della sua storia è stato una religione tricontinentale, con potenti rappresentanze in Europa, Africa e Asia, tale rimanendo fino al XIV secolo inoltrato.
 Il carattere globalizzato del Cristianesimo sottolineato dal pontificato, non eurocentrico, di Francesco è la ripresa di una antica realtà. E altrettanto chiaro è, a chi per avventura abbia visitato i monasteri siriani prima della guerra civile del 2011, che una figura umana straordinaria e un martire del cattolicesimo siriano come Padre Paolo Dall’Oglio, non fosse un operatore “della periferia” cristiana, ma un protagonista di luoghi che sono centrali per la storia religiosa del mondo.
Il carattere globalizzato del Cristianesimo sottolineato dal pontificato, non eurocentrico, di Francesco è la ripresa di una antica realtà. E altrettanto chiaro è, a chi per avventura abbia visitato i monasteri siriani prima della guerra civile del 2011, che una figura umana straordinaria e un martire del cattolicesimo siriano come Padre Paolo Dall’Oglio, non fosse un operatore “della periferia” cristiana, ma un protagonista di luoghi che sono centrali per la storia religiosa del mondo.Sono luoghi che, ritrovata la pace, centrali potrebbero tornare per un futuro di dialogo tra le fedi e le comunità, quando si potranno riproporre in quelle terre modelli convivenza che hanno avuto un lungo corso in tempi diversi ad Alessandria, a Merv, a Baghdad, la città, quest’ultima, del potente patriarca Timoteo, che tra VIII e IX secolo dialogava con il califfo al Mahdi sulla vera religione, un po’ come Nathan il Saggio di Lessing faceva con il suo Sultano. [...]
Il libro di Jenkins ci costringe non solo a rimuovere assiomi stereotipati, ma anche a questo “spostamento di un centro” che assumevamo come irriflesso e ci costringe a riesaminare certezze che parevano indiscutibili, andando a illuminare aree della storia poco conosciute perché appartenute a comunità sconfitte. E ci propone il problema che forse è per l’autore quello principale di tutto il suo lavoro: come e perché le religioni muoiono? alcune svaniscono, altre si riducono “da grandi religioni mondiali a una manciata di seguaci”. È accaduto al manicheismo, è accaduto al buddismo, per mille anni dominante in India, ora marginale: sistemi di fede di portata mondiale si rivelano vulnerabili quanto le religioni azteca e maya. E come dimenticare gli ebrei, che appena un secolo fa prosperavano in tutto il Medio Oriente e che sono ormai quasi scomparsi con l’eccezione di Israele: dal 1950 a oggi in Egitto da centomila a cinquanta persone.
Jenkins, cristiano episcopale, costringe qui i credenti di ogni fede a una riflessione sulle estinzioni religiose, che è di grande interesse anche per i non credenti, perché apre un varco essenziale per una prospettiva di pluralismo: il varco è di natura teologica, ma presenta evidenti possibili riflessi politici. Le sorti cangianti delle religioni e gli esiti plurali e travagliati della geografia confessionale concentrano l’attenzione, per ciascuna religione, anche sul ruolo delle altre.
 Se il destino dei rapporti tra le fedi è così alterno e imprevedibile e può produrre l’esito umano della loro scomparsa su vaste porzioni del mondo e la loro sostituzione con altre a seguito di cambiamenti politici (o anche climatici, come Jenkins sottolinea), e se tutto ciò deve avere un senso “in un disegno divino” quale che sia, allora una possibile “teologia della estinzione” non può che essere una teologia delle religioni, una teologia che ne spieghi la molteplicità, i successi e la caducità, in una parola: una teologia pluralista.
Se il destino dei rapporti tra le fedi è così alterno e imprevedibile e può produrre l’esito umano della loro scomparsa su vaste porzioni del mondo e la loro sostituzione con altre a seguito di cambiamenti politici (o anche climatici, come Jenkins sottolinea), e se tutto ciò deve avere un senso “in un disegno divino” quale che sia, allora una possibile “teologia della estinzione” non può che essere una teologia delle religioni, una teologia che ne spieghi la molteplicità, i successi e la caducità, in una parola: una teologia pluralista. -
> RIPENSARE L’EUROPA! La buona-esortazione del BRASILE (2005). --- Clima: «Un evento così estremo non sarebbe avvenuto in condizioni preindustriali». Intervista ad A. Pasini, climatologo del Cnr (di17 luglio 2021, di Federico La Sala
Europa
Il climatologo: «Un evento così estremo non sarebbe avvenuto in condizioni preindustriali»
Intervista. Parla Antonello Pasini, climatologo del Cnr. "Questi eventi saranno la norma". "Il fatto che la fonte del riscaldamento della temperatura globale è umana deve essere considerata una buona notizia, se fosse naturale non ci potremmo fare niente"
di Serena Tarabini (il manifesto, 17 luglio 2021).
Dopo settimane di precipitazioni che avevano già saturato i suoli, circa 150 mm di pioggia in una giornata hanno innescato la piena. Un disastro la cui entità evoca scenari da Sud Est asiatico, quando invece ci troviamo in Germania. Un episodio dovuto alla persistenza per giorni sulla stessa area geografica di una specifica condizione metereologica, coerente con i cambiamenti climatici in corso e l’inadeguatezza dei territori verso fenomeni sempre più estremi. Antonello Pasini fisico climatologo del Cnr, insegna fisica del clima e sostenibilità ambientale.
Dal suo punto di vista di climatologo e studioso dei fenomeni atmosferici che cosa è successo in Germania tale da provocare un’alluvione di simile intensità e durata? Si tratta di qualcosa senza precedenti a quelle latitudini?
Innanzitutto eravamo reduci da un anticiclone che ha invaso il Nord Europa determinando una situazione in cui il mare era molto caldo, una problematica diventata abbastanza tipica con il riscaldamento globale che porta più energia in atmosfera e che ha di fatto esteso verso Nord una circolazione di tipo tropicale, quindi questi anticicloni ora riescono ad arrivare anche a latitudini elevate. In questo caso c’è stata quella che noi chiamiamo “goccia fredda”, una grande quantità di aria più fresca che è calata da Nord per controbilanciare l’aria calda proveniente da Sud, e che si è istallata sulla Germania. Inoltre noi a queste latitudini siamo abituati a vedere la circolazione atmosferica che va da ovest verso est, dei treni di onde in transito che portano a giorni di tempo buono, poi un po’ di variabilità, poi due giorni di tempo meno buono etc. Quanto accaduto in invece è dovuto a delle onde molto più lunghe che si innalzano dai poli verso l’equatore e viceversa; quando sono così lunghe le onde si fermano e fanno permanere sul territorio una situazione come questa anche per giorni. È quella che noi chiamiamo una situazione di “blocco” che può riguardare anche il fenomeno opposto, quello delle ondate di calore che sono molto forti e molto lunghe. Sicuramente al disastro avvenuto in Germania concorrono anche altri tipi di fattori, ma dal punto di vista climatico si è trattato di un fenomeno impressionante.
Il collegamento con il cambiamento climatico è ormai dato per certo, si tratta semmai di stabilire in che misura. Quali sono i segnali inequivocabili, se ci sono, della determinante antropica sulle condizioni del clima e le sue conseguenze?
La scienza del clima lavora in modo particolare. Noi analizziamo i fenomeni attraverso dei modelli metereologici e climatici con cui sostanzialmente ricostruiamo un evento. Una volta fatto ciò, cambiamo delle cose nel modello, per es. se stiamo studiando un evento caratterizzato da un’ondata di calore molto forte in aria o nel mare, riportiamo le temperature dell’acqua e dell’aria alle condizioni della normalità climatica, magari del secolo scorso. Il modello fatto “correre” alle nuove condizioni ci consente di capire se questo evento sarebbe avvenuto ugualmente, in che misura, con qual valori di precipitazione o calore dell’acqua. C’è un gruppo di ricercatori che si occupa di attribuzione degli eventi estremi al cambiamento climatico che ha già studiato l’ondata di calore avvenuta in Canada e con questo metodo hanno visto che è stata eccezionale ma che non sarebbe mai avvenuta in condizioni preindustriali: oggi invece è stata possibile e lo sarà anche in futuro se la temperatura continuerà a salire. Nel passato la frequenza di eventi di questo tipo si calcolava fosse di uno ogni 20.000 anni. Nelle condizioni attuali si calcola potrebbe avvenire ogni 400 anni. Ma se la temperatura aumenta di due o tre gradi, può succedere anche ogni 20 anni.
Quali sono le zone del pianeta più esposte? O che vedono incrementare maggiormente la percentuale di rischi legata ai cambiamenti del clima?
Il nostro bacino Mediterraneo è un luogo sensibile. Una volta era dominato dall’anticiclone delle Azzorre che lasciava passare le perturbazioni a nord e teneva fermo il caldo africano sull’Africa, ora l’arrivo di questi anticicloni africani e flussi di aria fredda che arrivano quando l’anticiclone si ritira, hanno determinato una indubbia estremizzazione del clima. Dopodiché i rischi che un territorio corre sono il risultato di un insieme di fattori. Nel libro L’equazione dei disastri. Cambiamenti climatici su territori fragili utilizzo appunto un’equazione per individuare i fattori che determinano i danni ambientali. C’è un fattore sicuramente climatico, ma poi bisogna guardare alla fragilità del territorio e della società, il livello di esposizione di risorse e persone. Chiaro che nel mondo, a parità di cambiamento climatico, l’impatto di un fenomeno estremo è maggiore laddove le condizioni di sicurezza sono inferiori, o il welfare è meno strutturato.
Della Germania colpisce l’entità del disastro in una zona i cui standard non la fanno ritenere fra le più fragili. Siamo a un punto di svolta? O comunque ci sono delle nuove fragilità da prendere maggiormente in considerazione?
Anche la Germania non è stata esente da errori come l’eccesso di cementificazione e di estrazione e la natura si riprende i suoi spazi. In questo caso si sono rotti degli argini e i fiumi sono esondati, quindi dei manufatti umani sono risultati non adeguati a quelli che sono i cambiamenti del clima e le sue conseguenze. Quando progettiamo e costruiamo un’opera evidentemente i calcoli che facciamo non possono più fare riferimento alle statistiche del passato, bisogna tenere conto degli scenari climatici futuri, legati a una situazione che evolve verso una deriva climatica.
Questi fenomeni eccezionali sono destinati a diventare la norma?
Purtroppo sì se non facciamo nulla per limitare l’aumento della temperatura globale. Quello che dico sempre è che il fatto che la fonte di questo riscaldamento è umana deve essere considerata una buona notizia, se fosse naturale non ci potremmo fare niente. Conosciamo le cause: aumento gas serra, deforestazione, agricoltura e allevamento non sostenibili, possiamo quindi fare qualcosa affinché gli effetti dannosi di queste attività vengano ridotti. Dal punto di vista di principio anche politicamente in Europa ci stiamo muovendo in un modo senza precedenti. L’influenza di determinate lobby è ancora forte e mette dei limiti a quella che deve essere una vera e propria transizione ecologica globale, non solo energetica.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE (2005) --- La "filosofia" di Kant e la ’lezione’ (di Nietzsche e) di un aborigeno canadese (2005).1 luglio 2021, di Federico La Sala
In onore di Francesco e Chiara d’Assisi, dei Francescani (Dante Alighieri, compreso!) ... e di Leonard Boff
IGNOTI A SE’ STESSI ...ED ESPORTATORI DI ’CRISTIANESIMO’ E DI ’DEMOCRAZIA’!!!
La ’lezione’ (di Nietzsche e) di un aborigeno canadese ai ’registi’ della politica ’cattolica’ (e ’laica’).
di Federico La Sala (ildialogo.org, 22 novembre 2005)
Credo che ormai siamo proprio e davvero al capolinea - nella totale ignoranza di sé stessi i componenti della Gerarchia della Chiesa ’cattolica’ si agitano ... alla ’grande’!!! Non hanno proprio più nulla da dire, evidentemente! Sono scesi in campo ... ma contro Chi?!, contro che cosa?! Contro lo spirito francescano!!!
In segno di solidarietà, qui ed ora - 2005 dopo Cristo, con i francescani in carne ed ossa, oggetto di un richiamo, con un Motu Proprio, da parte dell’ex- prefetto ’kantiano’ Ratzinger, il papa Benedetto sedicesimo, forse non è inutile un breve commento a margine... per cercare di stare svegli e di svegliarci, possibilmente - tutti e tutte!
Dennis McPherson, un aborigeno (che ormai ’ci’ conosce bene, evidentemente!) canadese, ecco cosa (sapientemente e sorprendentemente - per noi, occidentali!!!), alla domanda - “qual è l’essenza dell’essere umano? E’ una creatura speciale con una missione speciale?” - di un’antropologa-intervistatrice, ha risposto:
- “ Ha mai sentito parlare di Emanuele Kant? Certo che sì! Sa qual è l’asserzione più importante di Kant? E’ che non può: Kant = can’t (gioco linguistico tra il nome del filosofo e il verbo inglese, che hanno lo stesso suono). Questo sta cercando di fare lei. Sa perché? Perché sta cercando di capire la cultura aborigena! Siete lontano migliaia di anni, siete nell’età dell’oscurantismo”(Rita Melillo, Tutuch (Uccello tuono). A colloquio con gli aborigeni del Canada, Presentazione di D. A. Conci, Mephite s.r.l., Atripalda (AV) 2004, p. 211 e p. 217).
Se teniamo presente le famose parole “De nobis ipsis silemus [...]”(di Francesco Bacone), messe da Kant sopra (come una pietra tombale) e prima di iniziare il suo discorso della e nella Critica della ragion pura, si può dire che il ’nostro’ aborigeno ha capito e visto più che bene - e meglio di tutti i filosofi e teologi dell’Occide[re]nte!!! E ’ce’ lo ha detto in faccia - ’papale’, ’papale’: basta!!!
Noi che non conosciamo ancora noi stessi (Nietzsche) .... e che navighiamo nel più grande “oscurantismo” - quello (più importante!!!) relativo a noi stessi, vogliamo pure dare lezioni ed esportare ’cristianesimo’ e ’democrazia’ in tutto il mondo!? “Mi”!?, e “Mah”!!!?
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Il Canada chiede conto al Papa per la strage dei bambini indigeni
- Ritrovati i resti di quasi mille bambini in ex scuole gestite dalla Chiesa, 6mila mancano all’appello. Trudeau a Bergoglio: opportuno chiedere scusa sul suolo canadese (di Giulia Belardelli, 28.06.2021)
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
FLS
-
> RIPENSARE L’EUROPA! La buona-esortazione del BRASILE (2005). Una "memoria" --- Amazzonia, attacco mortale ad ambiente e indios: l’ecocidio della foresta e il genocidio dei suoi popoli iniziato 500 anni fa (di Angelo Bonelli).29 giugno 2021, di Federico La Sala
Amazzonia, attacco mortale ad ambiente e indios: l’ecocidio della foresta e il genocidio dei suoi popoli iniziato 500 anni fa
La resistenza dei popoli indigeni per la loro sopravvivenza e contro la propria estinzione ha tutelato parte della foresta sino ad oggi, ma nel 2020 l’Amazzonia ha subito la più grande deforestazione degli ultimi 12 anni. Secondo l’Istituto Socio Ambiental nei primi due anni del governo Bolsonaro la deforestazione è aumentata di quasi il 48% nelle aree protette
di Angelo Bonelli (Il Fatto quotidiano, 27 Giugno 2021)
L’attacco mortale finale alla Foresta Amazzonica si chiama “PL 490”, projecto Lej 490, che cancellerà l’Amazzonia, terminando il genocidio contro gli indios iniziato 500 anni fa. Il 22 giugno, mentre fuori dal parlamento brasiliano la polizia di Jair Bolsonaro reprimeva con la violenza le proteste degli indios provenienti da tutta l’Amazzonia, veniva approvata la PL 490 dalla commissione per la Costituzione, la Giustizia e la Cittadinanza che ora attende di essere definitivamente ratificata dal congresso nazionale del Brasile. Con questa legge la costituzione viene modificata in via ordinaria, questo è un aspetto contestato dai legali che assistono i popoli indios, stabilendo che le terre indigene sono quelle occupate dai popoli tradizionali alla data del 5 ottobre del 1988. In questo modo è chiesta ai popoli indios la prova della presenza in quelle terre e quindi del loro diritto a viverci, il giorno in cui fu promulgata la costituzione brasiliana, la legge inoltre vieta l’espansione delle terre che sono già state delimitate, indipendentemente dai criteri e dalle rivendicazioni delle popolazioni indigene interessate e consente di rendere possibile l’entrata nelle aree abitate da indios isolati per motivi di pubblica utilità: la pubblica utilità è lo sfruttamento della foresta. Questa legge voluta dai parlamentari vicini a Bolsonaro ed in particolare dalla cosiddetta “Bancada ruralista” una lobby molto potente che raccoglie 200 deputati federali su 513 di diversi partiti, apre allo sfruttamento di quelle parti dell’Amazzonia che hanno resistito alla deforestazione perché difese dai popoli indios che vivono nelle terre demarcate. La Bancada ruralista rappresenta i grandi interessi dei grandi produttori agricoli e dei latifondisti, ed è considerata la più influente nella discussione, articolazione e negoziazione della politica pubblica nell’ambito del potere legislativo: nel 2019 è stata determinante per far approvare l’amnistia per chi ha deforestato illegalmente nella foresta amazzonica.
Cosa accadrà se la PL 490 verrà approvata dal congresso nazionale brasiliano? I popoli indios dovranno dimostrare al governo federale brasiliano la prova della loro presenza alla data del 5 ottobre del 1988 nelle terre dove vivono da secoli e secoli. Un’assurdità, criminogena, se pensiamo che fino al 1988 le popolazioni indios non venivano considerate dal governo, persone con capacità giuridica. Nei decenni gli indios sono stati sottoposti a processi di espulsione dalle loro terre e a gravi violenze per le continue invasioni dei cercatori d’oro, dei land grabber, tagliatori di legna e latifondisti: per le popolazioni indigene dimostrare che si trovavano nelle terre da loro rivendicate o provare che sono stati espulsi è molto difficile se non impossibile. Per comprendere la ratio criminale di questa legge contro i diritti umani e l’ambiente, prendo ad esempio una famiglia che coltiva un terreno da secoli, arrivano dei banditi armati e ti cacciano con la violenza dalle terre, viene approvata una legge che dice che siccome nella data fissata tu non c’eri a coltivare le terre hai perso il diritto a stare su quelle terre.
La resistenza dei popoli indigeni per la loro sopravvivenza e contro la propria estinzione ha tutelato parte della foresta sino ad oggi. La demarcazione delle loro terre ancestrali, determinata dalla Costituzione del 1988, era funzionale a garantire la loro sopravvivenza e quella della foresta. In Amazzonia vivono 100 popoli indios isolati, che non hanno mai avuto contatti con i bianchi, sono persone che vogliono solo vivere in pace nelle terre dove vivono da sempre e per questo, preferiscono stare lontano dai bianchi. La PL 490 prevede la modalità per cacciarli e quindi portarli all’estinzione. Dice l’art.29 della PL 490: “nel caso di popolazioni indigene isolate, spetta allo Stato e alla società civile rispettare le loro libertà e modi di vita tradizionali, e il contatto dovrebbe essere evitato il più possibile, salvo prestare assistenza medica o mediare atti statali di pubblica utilità”. E’ bene ricordare che gli indios isolati hanno una difesa immunitaria diversa dalla nostra e l’influenza o una congiuntivite li può sterminare, ma il vero obiettivo è messo nero su bianco dalla legge: realizzare miniere, centrali idroelettriche, strade dentro le aree indigene e per poterlo fare Bolsonaro deve espellere gli indios.
Bolsonaro da presidente del Brasile ha tollerato e coperto le invasioni illegali delle terre indigene, realizzate con violenza e omicidi, da parte di cercatori d’oro, latifondisti e allevatori intensivi. Nelle sole terre indios Yanomami e Munduruku vi sono oltre 30.000 minatori che devastano la foresta minacciando e bruciando le case dei leader indios che si oppongono alle loro violenze. Nel maggio scorso un villaggio indigeno Yanomami che si trova lungo il fiume Uraricoera ha subito un attacco armato da parte di garimperos, cercatori d’oro, arrivati con i motoscafi provocando vittime e feriti, tra i quali due bambini di uno e cinque anni. Nelle terre indios l’estrazione mineraria è illegale, e nessuna autorità governativa li ferma anzi li tollera. Secondo la Cpt, commissione pastorale per la terra brasiliana, nel 2019 si sono registrati 1823 conflitti per le occupazioni delle terre con 32 leader indigeni assassinati. Uno di questi casi di omicidio è quello di Emyra Waiãpi, della terra indigena di Waiãpi, assassinata nel luglio 2019, all’età di 69 anni. È stata pugnalata a morte perché si opponeva all’invasione di cercatori d’oro in una regione dove sono in corso processi minerari illegali per l’estrazione di tantalio e oro. Questi dati e fatti vengono valutati dalla commissione pastorale come una conseguenza delle politiche dell’attuale governo.
Nel 2020, l’Amazzonia ha subito la più grande deforestazione degli ultimi 12 anni: 1.085.100 ettari sono stati distrutti, secondo i dati Inpe, Istituto nazionale per la ricerca spaziale. Un’altra ricerca, quella dell’Istituto Socio Ambiental, evidenzia come nei primi due anni del governo Bolsonaro la deforestazione è aumentata di quasi il 48% nelle aree protette dell’Amazzonia. Lo scienziato Carlos Nobre, premio Nobel per la Pace, ha denunciato che l’Amazzonia si sta avvicinando sempre di più al punto di non ritorno, ovvero a rischio desertificazione. L’aggressione al bioma dell’Amazzonia favorisce una maggiore interazione umana con gli animali selvatici tra chi vive nelle zone rurali e chi lavora nel cuore della foresta per organizzare la deforestazione, aumentando così le possibilità che un virus virulento, un batterio o un fungo salti da una specie all’altra, come ha affermato Adalberto Luís Val, ricercatore presso il National Amazon Research Institute (Inpa), con sede a Manaus. L’Istituto Evandro Chagas, un’organizzazione di ricerca sulla salute pubblica a Belém, capitale dello stato del Parà in Brasile nel cuore dell’Amazzonia, ha identificato circa 220 diversi tipi di virus in Amazzonia, 37 dei quali possono causare malattie negli esseri umani e 15 con il potenziale di causare epidemie. Se l’Amazzonia cesserà di essere un grande “regolatore climatico” sarà molto difficile, se non impossibile, contrastare il cambiamento climatico. La protesta degli indios, che a migliaia in questi giorni si trovano a Brasilia per protestare contro questa legge, sono nostri fratelli e sorelle e la loro battaglia deve diventare la mobilitazione di tutta la comunità internazionale per fermare quello che sta per trasformarsi in un crimine contro l’umanità.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE (2005) ---- Teologia della speranza e della liberazione. "Pinocchio alla rovescia": una rilettura delle "avventure di Pinocchio" di Rubem Alves (di R. Carnero).19 giugno 2021, di Federico La Sala
Pinocchio ridotto a lavoratore e consumatore?
Una rilettura del personaggio di Collodi da parte del brasiliano Rubem Alves: un ragazzino si trasforma in burattino. Un duro attacco alle odierne strutture educative, che tendono a fabbricare bambini su misura
di Roberto Carnero (Avvenire, 16.06.2021).
Molti sono convinti di conoscere"Pinocchio" perché hanno visto il cartone animato di Walt Disney o se va bene, da bambini hanno letto una versione scorciata del romanzo in edizione illustrata. Eppure Le avventure di Pinocchio e un grande classico della letteratura italiana, che andrebbe letto ascuola, come si fa con I promessi sposi e la Divina Commedia. Perché a riprova del suo valore - il romanzo di Collodi è una delle opere italiane più tradotte nel mondo ed è un testo dai significati complessi e stratificati. Collodi, infatti, è stato capace, grazie alla sua vena fantastica, di evocare atmosfere diverse, sperimentando soluzioni narrative assai ricche, con molti episodi che ben figurerebbero in un romanzo picaresco, altri in uno d’avventura, altri ancora in una narrazione "nera", e non è cosa da poco per un libro scritto per i ragazzi. Tra le disavventure del burattino, le sue cadute e risalite, Collodi non rinuncia mai alla dimensione irrazionale e magica del racconto e alla perfetta fusione di fiabesco e quotidiano: quello di Pinocchio è una sorta di viaggio dantesco tra umano e soprannaturale, in cui la fantasia e l’immaginazione si compenetrano alla perfezione con la realtà di un’umanità concreta, perfino dolorosa. Non stupisce perciò che fin dal suo primo apparire sul "Giornale per i bambini" (a puntate, dal 1881 al 1883) questo romanzo sia stato oggetto di numerose interpretazioni e anche di "riscritture": il destino, quest’ultimo, tipico dei grandi classici.
L’ultima in ordine di tempo è un Pinocchio alla rovescia (a cura di Paolo Vittoria, Marletti 1820, pp. 56, curo 7,00) di Rubem Alves (1933-2014), uno dei maggiori scrittori brasiliani del Novecento. Filosofo, storico, poeta, pedagogista, psicanalista e autore di racconti per bambini, con il suo saggio Teologia della speranza umana (in Italia pubblicatonel 1971 da Queríniana) era stato uno degli ispiratori della teologia della liberazione.
 Nel 2010,invece, ha riscritto il capolavoro di Collodi "al contrario". Il suo Pinocchio non è più un burattino che diventa bambino, bensì un bambino, di nome Felipe, che si trasforma in burattino. In che modo? Adeguandosi ai meccanismi e agli ingranaggi sociali che, sin dalla scuola, richiedono al singolo di uniformarsi e omologarsi.
Nel 2010,invece, ha riscritto il capolavoro di Collodi "al contrario". Il suo Pinocchio non è più un burattino che diventa bambino, bensì un bambino, di nome Felipe, che si trasforma in burattino. In che modo? Adeguandosi ai meccanismi e agli ingranaggi sociali che, sin dalla scuola, richiedono al singolo di uniformarsi e omologarsi.Attraverso questa vicenda metaforica e simbolica, Alves lancia un duro atto d’accusa nei confronti delle odierne strutture educative, tutte tese alla standardizzazione dei percorsi formativi, alla certificazione di conoscenze, competenze e abilità, e, se serve, persino alla medicalizzazione, di fronte al disagio di quei ragazzi che, per le loro caratteristiche personali, non riescono a integrarsi in itinerari prestabiliti e uguali e per tutti. Ecco la risposta della maestra al piccolo protagonista: «La scuola non serve a imparare quello che vuoi, ma a imparare quello che devi imparare. Quello che devi imparare è ciò che hanno detto gli uomini intelligenti del Governo. Tutto nel giusto ordine. Una cosa alla volta. Tutti i bambini allo stesso tempo e con la stessa velocità...». E l’idolatria dei programmi, ammanniti ogni anno uguali a sé stessi, senza che siano mai suscettibili di una vera disamina critica.
Così Alves definisce il "disturbo dell’attenzione": «Disturbo dell’attenzione è quando l’attenzione sta nel luogo dove il cuore desidera e non nel luogo dove il maestro comanda». Ma una scuola simile sembra esistere solo «per trasformare i bambini che giocano in adulti che lavorano». Questo di Alves è un breve libretto che dovrebbe essere letto dai docenti, dagli educatori, dagli psicologi, dai genitori. Innanzitutto per una riflessione su che cosa dovrebbe essere la scuola: una macchina burocratica da far funzionare alla perfezione oppure un luogo, unico e straordinario, in cui scoprire i talenti e liberare le energie? E in secondo luogo per comprendere che in ogni vicenda educativa al centro deve essere posto sempre il ragazzo: solo così possiamo evitare di trasformarlo in un burattino.
-
> RIPENSARE L’EUROPA! La buona-esortazione del BRASILE (2005). --- E la "sollecitazione" di Dante (oggi) a ripensare il problema del nascere "a la riva/ de l’Indo" (Par. XIX, 70-71).13 giugno 2021, di Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Germania. Il cardinale Marx ha presentato le dimissioni al Papa: "Questa società ha bisogno di una Chiesa che si rinnovi" ("Avvenire").4 giugno 2021, di Federico La Sala
Germania. Il cardinale Marx ha presentato le dimissioni al Papa
Ha spiegato che intende assumere la corresponsabilità per la catastrofe degli abusi sessuali da parte di esponenti della Chiesa. Il testo della lettera al Papa
di A.M.B. (Avvenire, venerdì 4 giugno 2021)
- [Foto] Il cardinale Reinhold Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga - Ansa
Ha offerto le sue dimissioni al Papa il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, già presidente della Conferenza episcopale tedesca (dal 2014 al 2020). Nel comunicato pubblicato sul sito dell’arcidiocesi si legge come motivazione la “catastrofe” degli abusi sessuali compiuti da uomini di Chiesa nei decenni scorsi.
In una lettera del 21 maggio a papa Francesco - si legge nel comunicato - il cardinale ha spiegato le ragioni di questo passo e che il Papa lo ha informato che la lettera può ora essere pubblicata e che potrà continuare a svolgere il suo servizio episcopale fino a quando non sarà presa una decisione.
La lettera di Marx al Papa
"Indubbiamente la Chiesa in Germania sta attraversando dei momenti di crisi" esordisce Marx nella lettera al Papa. "La crisi viene causata anche dal nostro personale fallimento, per colpa nostra. Questo mi appare sempre più nitidamente rivolgendo lo sguardo sulla Chiesa cattolica in generale e ciò non soltanto oggi, ma anche in riferimento ai decenni passati. Mi pare - e questa è la mia impressione - di essere giunti ad un ’punto morto’ che, però, potrebbe diventare anche un punto di svolta secondo la mia speranza pasquale".
“Sostanzialmente per me si tratta di assumersi la corresponsabilità relativa alla catastrofe dell’abuso sessuale perpetrato dai rappresentanti della Chiesa negli ultimi decenni”, ha scritto Marx al Papa. Le indagini e le perizie degli ultimi dieci anni "mi dimostrano costantemente che ci sono stati sia dei fallimenti a livello personale che errori amministrativi, ma anche un fallimento istituzionale e ’sistematico’". Le polemiche e discussioni più recenti "hanno dimostrato che alcuni rappresentanti della Chiesa non vogliono accettare questa corresponsabilità e pertanto anche la co-colpa dell’Istituzione. Di conseguenza rifiutano qualsiasi tipo di riforma e innovazione per quanto riguarda la crisi legata all’abuso sessuale". Il cardinale Marx ha chiaramente respinto questa posizione. "Due sono gli elementi che non si possono perdere di vista - prosegue -: errori personali e fallimento istituzionale che richiedono cambiamenti e una riforma della Chiesa. Un punto di svolta per uscire da questa crisi può essere, secondo me, unicamente quella della ’via sinodale’".
Con le sue dimissioni dall’ufficio, prosegue, si creerebbe forse spazio per un nuovo inizio, per un nuovo risveglio della Chiesa. “Voglio dimostrare che non è l’incarico ad essere in primo piano, ma la missione del Vangelo. Anche questo fa parte della cura pastorale. Pertanto, La prego vivamente di accettare le mie dimissioni". "Vorrei dedicare gli anni futuri del mio servizio in maniera più intensa alla cura pastorale e impegnarmi per un rinnovamento spirituale della Chiesa, così come Lei instancabilmente ammonisce" conclude.
IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA
"Il Papa mi ha ora comunicato che questa lettera potrà essere pubblicata"
Nella sua dichiarazione personale, il cardinale affermato di aver più volte pensato di dimettersi dall’incarico negli ultimi mesi. “Gli eventi e le polemiche e discussioni delle ultime settimane hanno avuto un ruolo del tutto secondario” precisa. E sugli abusi osserva: "Con preoccupazione vedo che negli ultimi mesi si nota una tendenza ad escludere le cause sistemiche e i rischi oppure, diciamolo pure, quelle che sono le questioni teologiche fondamentali e ridurre l’elaborazione ad un semplice miglioramento dell’amministrazione".
E conclude: "Questo passo non è facile per me. Mi piace essere prete e vescovo e spero di poter continuare a lavorare anche in futuro per la Chiesa. Il mio servizio per questa Chiesa e per le persone non termina qui. Tuttavia, per il bene di un nuovo e necessario inizio voglio assumermi la corresponsabilità per il passato. Credo che il „punto morto“, in cui ci troviamo attualmente, possa diventare un ’punto di svolta’. È questa la mia speranza pasquale e questo è ciò per cui pregherò e lavorerò".
IL TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE
"Questa società ha bisogno di una Chiesa che si rinnovi"
In conferenza stampa, tenutasi nel primo pomeriggio, il cardinale Marx ha dichiarato: "Non può andar bene che io sia contento personalmente che non mi venga addebitata alcuna colpa". Il punto, ha spiegato, "è la responsabilità istituzionale". "Non sono stanco della carica, e non sono demotivato", ha tenuto a sottolineare. "Sono convinto che questa società abbia bisogno della voce del Vangelo e di una Chiesa che si rinnovi".
I rapporti sugli abusi in Germania
Nel 2018 un rapporto commissionato dalla Chiesa tedesca aveva concluso che almeno 3.677 persone sono state vittime di abusi sessuali da parte di ecclesiastici fra 1946 e 2014. Oltre la metà di quelle persone aveva meno di 13 anni quando fu abusata, mentre quasi un terzo era costituita da chierichetti, secondo il rapporto. Quest’anno un altro studio relativo a Colonia ha rivelato numerosi altri casi di abusi sessuali da parte di sacerdoti. L’arcivescovo di Amburgo, Stefan Heße, già direttore del personale e poi vicario generale dell’arcidiocesi di Colonia, ha presentato nel marzo scorso le sue dimissioni al Papa e ha ricevuto un "congedo" per un tempo non specificato.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- Uscire dall’orizzonte della tragedia: "Da Versailles alla cibernetica". Una conferenza del 1966 (di Gregory Bateson).21 maggio 2021, di Federico La Sala
DA VERSAILLES ALLA CIBERNETICA.
di Gregory Bateson
- Testo della "conferenza tenuta il 21 aprile 1966 al «Two Worlds Symposium», presso lo State College di Sacramento". *
Devo parlare di storia recente, come appare a me nella mia generazione e a voi nella vostra, e mentre giungevo in aereo stamane, nella mia mente cominciarono a riecheggiare certe parole. Erano frasi più roboanti di quelle che io sarei mai capace di formulare. Una di queste frasi era: «I padri hanno mangiato il frutto amaro e i denti dei figli si sono allegati». Un’altra era l’asserzione di Joyce che «La storia è quell’incubo da cui non ci si sveglia». Un’altra era: «I peccati dei padri ricadranno sui figli anche fino alla terza o quarta generazione di quelli che mi odiano». E, infine, non così immediatamente pertinente, ma, penso, sempre pertinente al problema del meccanismo sociale: «Colui che vuol far del bene a un altro deve farlo nei Minuti Particolari. Il Bene Generale è la scusa del furfante, dell’ipocrita e dell’adulatore».
Stiamo parlando di cose gravi. Ho intitolato questa conferenza «Da Versailles alla cibernetica», menzionando i due eventi storici più importanti del XX secolo. La parola ’cibernetica’ è familiare, no? Ma quanti di voi sanno quello che accadde a Versailles nel 1919? Il problema è: che cosa conterà della storia degli ultimi sessant’anni? Io ho sessantadue anni, e quando ho cominciato a pensare alla storia che ho visto nel corso della mia vita, mi è sembrato in realtà di aver visto solo due momenti che definirei veramente importanti dal punto di vista di un antropologo.
 Uno concerne gli eventi che hanno condotto al Trattato di Versailles, e l’altro concerne la rivoluzione cibernetica. Forse sarete sorpresi o stupiti che io non abbia ricordato né la bomba atomica nè, addirittura, la seconda guerra mondiale. Non ho ricordato la diffusione dell’automobile o della radio e della televisione o molti altri fatti che sono accaduti negli ultimi sessant’anni.
Uno concerne gli eventi che hanno condotto al Trattato di Versailles, e l’altro concerne la rivoluzione cibernetica. Forse sarete sorpresi o stupiti che io non abbia ricordato né la bomba atomica nè, addirittura, la seconda guerra mondiale. Non ho ricordato la diffusione dell’automobile o della radio e della televisione o molti altri fatti che sono accaduti negli ultimi sessant’anni.Vi dirò il mio criterio per l’importanza storica.
I mammiferi in generale, e noi uomini in particolare, si curano moltissimo non degli episodi, ma delle strutture delle loro relazioni. Quando apro lo sportello del frigorifero e il gatto si avvicina emettendo certi suoni, esso non sta parlando del fegato o del latte, anche se so bene che è proprio quello ciò che il gatto vuole. Posso esser capace di indovinare e dargli ciò che desidera (se ce n’è nel frigorifero). Ciò che il gatto dice, in realtà, è qualcosa che riguarda la sua relazione con me. Se esprimessi con parole il suo messaggio, ne risulterebbe qualcosa del tipo: «dipendenza, dipendenza, dipendenza». In effetti il gatto sta parlando di una struttura piuttosto astratta nell’ambito di una relazione. Da quest’asserzione di una struttura, io dovrei passare dal generale al particolare: dedurre «latte» o «fegato».
Questo punto è fondamentale; questo è ciò che interessa i mammiferi. Essi si curano delle strutture di relazione, della posizione in cui si trovano rispetto agli altri in un rapporto di amore, odio, rispetto, dipendenza, fiducia, e astrazioni analoghe. Questo è il punto ove cadere in errore è doloroso. Se noi ci fidiamo di qualcuno e scopriamo che costui non meritava fiducia; o se diffidiamo di qualcuno e scopriamo che in realtà costui meritava fiducia, ci sentiamo male. Il dolore che può derivare agli uomini e a tutti gli altri mammiferi da questo tipo di errore è grandissimo. Se quindi vogliamo davvero sapere quali siano i punti significativi della storia, dobbiamo chiederci quali sono i momenti della storia in cui sono cambiati gli atteggiamenti. Sono questi i momenti in cui la gente soffre a causa dei ’valori’ precedenti.
Pensate al termostato di casa vostra. Il tempo fuori cambia, la temperatura della stanza scende, l’interruttore del termometro in soggiorno fa quello che deve fare e accende la caldaia, e quando la stanza è calda l’interruttore del termometro spegne di nuovo la caldaia. Il sistema è quello che si chiama un circuito omeostatico, o servomeccanismo. Ma c’è anche una scatoletta sulla parete del soggiorno con la quale si regola il termostato. Se nell’ultima settimana la casa è stata troppo fredda, dovete spostare in su il termostato dalla sua posizione attuale per far oscillare il sistema intorno a un altro livello. Il tempo esterno, in nessun modo, nè col freddo nè col caldo nè in altro modo, potrà cambiare questa posizione, che è detta ’polarizzazione’ del sistema. La temperatura della casa oscillerà, sarà più caldo o più freddo secondo varie circostanze, ma la posizione del meccanismo non sarà mutata da questi cambiamenti. Quando invece io vado a variare la polarizzazione, cambierò quello che si può chiamare l’ ’atteggiamento’ del sistema.
Analogamente, la domanda importante relativa alla storia è: la polarizzazione o l’atteggiamento sono stati cambiati? L’episodico accadere degli eventi sotto una polarizzazione stazionaria è cosa veramente trita. È questo che avevo in mente quando ho detto che i due eventi storici più importanti della mia vita sono stati il Trattato di Versailles e la scoperta della cibernetica.
I più, tra voi, probabilmente non sanno come si giunse a stipulare il Trattato di Versailles. La storia è molto semplice: la prima guerra mondiale continuava a trascinarsi; era abbastanza evidente che i tedeschi stavano perdendo. A questo punto George Creel, che si occupava di pubbliche relazioni (e vorrei che non dimenticaste che costui fu uno dei nonni delle moderne pubbliche relazioni) ebbe un’idea: l’idea era che forse i tedeschi si sarebbero arresi se avessimo offerto loro condizioni armistiziali leggere. Egli preparò allora un pacchetto di condizioni leggere, che non contemplavano provvedimenti punitivi. Queste condizioni erano articolate in quattordici punti; ed egli comunicò questi Quattordici Punti al Presidente Wilson. Se avete intenzione di ingannare qualcuno, come latore del messaggio dovete scegliere un uomo onesto; il Presidente Wilson era uomo di onestà quasi patologica e di sentimenti umanitari. Egli sviluppò i punti in un gran numero di discorsi: non dovevano esserci «né annessioni, nè riparazioni di guerra, nè distruzioni punitive...» e così via. E i tedeschi si arresero.
Noi, inglesi e americani (specialmente gli inglesi) continuammo ovviamente a tenere la Germania sotto embargo, perché non volevamo che i tedeschi si ringalluzzissero prima della firma del Trattato; e così, per un altro anno, essi continuarono a patir la fame.
La Conferenza di pace è stata vivacemente descritta da Maynard Keynes in The Economic Consequences of the Peace (1919).
Il Trattato fu finalmente redatto da quattro uomini, Clemenceau, «la Tigre», che voleva schiacciare la Germania, Lloyd George, che riteneva fosse politicamente vantaggioso ottenere dalla Germania molte riparazioni di guerra, e imporle qualche ritorsione; e Wilson, che doveva essere continuamente menato per il naso. Ogni volta che Wilson aveva dei ripensamenti su quei Quattordici Punti, essi lo portavano nei cimiteri di guerra e lo facevano vergognare di non sentirsi in collera coi tedeschi. Chi era l’altro? L’altro era Orlando, un italiano.
Si trattò di una delle più grandi svendite nella storia della nostra civiltà; un evento tra i più straordinari, che portò difilato e inevitabilmente alla seconda guerra mondiale. Portò anche (e questo è forse più interessante che non la prima conseguenza) a uno scadimento morale della politica tedesca. Se voi promettete qualcosa a vostro figlio, e poi vi rimangiate la promessa, inquadrando però tutta la faccenda su un piano etico elevato, la conseguenza sarà non solo che egli sarà in collera con voi, ma che i suoi atteggiamenti morali peggioreranno, in quanto egli sentirà l’ingiustizia della canagliata che gli fate. Non soltanto la seconda guerra mondiale è stata la risposta appropriata di una nazione che era stata trattata proprio in questa maniera; ciò che è più importante è che era lecito aspettarsi, da questo tipo di trattamento, uno scadimento morale di quella nazione. Lo scadimento morale della Germania ha causato anche il nostro scadimento morale. Ecco perché dico che il Trattato di Versailles è stato un giro di boa nell’ambito degli atteggiamenti morali.
Ritengo che sia necessario attendere ancora un paio di generazioni prima che i postumi di quella svendita esauriscano i loro effetti. Siamo, di fatto, come i membri della casa di Atreo nella tragedia greca. Prima ci fu l’adulterio di Tieste, poi Atreo ammazzò i tre figli di Tieste e glieli imbandì nel banchetto della riconciliazione; poi ci fu l’assassinio del figlio di Atreo, Agamennone, da parte di Egisto, figlio di Tieste; e infine Oreste uccise Egisto e Clitennestra.
La cosa continua ad andare avanti. È la tragedia della sfiducia, dell’odio e della distruzione, che vibrano e si propagano attraverso le generazioni.
Provate a immaginare di capitare nel bel mezzo di una tale sequela di tragedie. Come stanno le cose per la generazione intermedia degli Atridi? Essi vivono in un universo pazzesco. Dal punto di vista di quelli che hanno dato inizio al disastro, non è così pazzesco: essi sanno che cosa è accaduto e in che modo vi sono arrivati. Ma i successori, che all’inizio non erano presenti, si trovano a vivere in un universo pazzesco e si ritrovano pazzi proprio perché non sanno come ci sono capitati.
Prendere una dose di LSD va bene: si prova la sensazione di essere più o meno pazzi; ma ciò ha perfettamente senso, perché si sa che si è presa una dose di LSD. Se invece si prende I’LSD per accidente, e poi ci si sente impazzire senza sapere come e perché, questa è un’esperienza terribile e angosciosa; è un’esperienza assai più seria e spaventosa, molto diversa dal ’viaggio’, che potete anche godere se sapete di aver preso l’LSD.
Considerate ora la differenza tra la mia generazione e quelli di voi che hanno meno di venticinque anni. Tutti viviamo nello stesso pazzesco universo, in cui l’odio, la sfiducia e l’ipocrisia (specialmente a livello internazionale) risalgono ai Quattordici Punti e al Trattato di Versailles. Noi più anziani sappiamo come si è arrivati fino a questo punto. Ricordo che mio padre, leggendo a colazione i Quattordici Punti, disse: «Per Giove, vogliono conceder loro un armistizio decente, una pace onesta, o qualcosa del genere». E ricordo anche, ma non tento di ridirla, la cosa che disse quando il Trattato di Versailles fu reso noto: è una cosa che non si può stampare. Quindi io so più o meno come si è giunti a questo punto. Ma dal vostro punto di vista, noi siamo assolutamente pazzi, e voi non sapete quali eventi storici abbiano portato a questa pazzia. «I padri hanno mangiato il frutto amaro e i denti dei figli si sono allegati». Per i padri va bene: essi sanno che cosa hanno mangiato; ma i figli non sanno che cosa è stato mangiato.
CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- Uscire dall’orizzonte della tragedia: "Da Versailles alla cibernetica". Una conferenza del 1966 (di Gregory Bateson).21 maggio 2021, di Federico La Sala
CONTINUAZIONE E FINE
DA VERSAILLES ALLA CIBERNETICA.
di Gregory Bateson
- Testo della "conferenza tenuta il 21 aprile 1966 al «Two Worlds Symposium», presso lo State College di Sacramento". *
- [...]
Vediamo che cosa è lecito aspettarsi da persone che abbiano appena subito un atroce inganno. Prima della prima guerra mondiale si pensava generalmente che il compromesso e un pizzico d’ipocrisia fossero ingredienti molto importanti per il raggiungimento di un certo comfort nella vita d’ogni giorno. Se leggete, per esempio, Erewhon Revisited, di Samuel Butler, capirete che cosa intendo dire. Tutti i personaggi principali del romanzo si sono cacciati in guai terribili: alcuni debbono essere giustiziati, altri debbono divenire oggetto di pubblica esecrazione; e il sistema religioso della nazione minaccia di crollare. Queste difficoltà e complicazioni sono appianate da Mrs. Ydgrun (o, come diremmo noi, «Mrs. Grundy») custode dei costumi di Erewhon. Ella ricostruisce con cura la storia, come un rompicapo a intarsio, in modo che nessuno stia realmente male e a nessuno capitino disavventure (e specialmente che nessuno sia giustiziato). Questa filosofia era assai comoda. Un po’ d’ipocrisia e un po’ di compromesso lubrificano gl’ingranaggi della vita sociale.
Ma dopo il grande inganno questa filosofia non può reggere. Avete perfettamente ragione, c’è qualcosa di sbagliato, e questo qualcosa ha la natura dell’inganno e dell’ipocrisia. Voi vivete in mezzo alla corruzione.
Ovviamente le vostre reazioni spontanee sono puritane. Non è un puritanesimo sessuale, poiché sullo sfondo non c’è inganno sessuale. Ma un rigoroso puritanesimo contro il compromesso, un puritanesimo contro l’ipocrisia che finisce col ridurre la vita in piccoli pezzi. Sono le grandi strutture integrate della vita che sembrano aver portato alla follia, e così voi cercate di concentrarvi sulle cose più minute. «Colui che vuol far del bene a un altro deve farlo nei Minuti Particolari. Il Bene Generale è la scusa del furfante, dell’ipocrita e dell’adulatore». Il bene generale puzza d’ipocrisia per la nuova generazione.
Non ho dubbi che se voi chiedeste a George Creel di giustificare i Quattordici Punti, egli invocherebbe il bene generale. È possibile che la sua operazioncella abbia salvato la vita di qualche migliaio di americani nel 1918. Non so però quante vite essa sia costata nella seconda guerra mondiale, e, dopo, in Corea e nel Vietnam. Ricordo che Hiroshima e Nagasaki furono giustificate col bene generale e col risparmio di vite americane. Ci fu un gran parlare di ’resa incondizionata’, forse perché non avevamo fiducia nella nostra capacità di osservare un armistizio condizionato. Il destino di Hiroshima fu decretato a Versailles?
Voglio parlare adesso dell’altro evento storico importante accaduto durante la mia vita, nel 1946-47 circa. Si trattò del coagularsi di numerose idee che erano sorte in luoghi diversi durante la seconda guerra mondiale. Possiamo chiamare l’aggregato di queste idee cibernetica, o teoria delle comunicazioni, o teoria dell’informazione, o teoria dei sistemi. Queste idee nacquero in molti luoghi: a Vienna con Bertalanffy, a Harvard con Wiener, a Princeton con von Neumann, nei Laboratori della Bell Telephone con Shannon, a Cambridge con Craik, e così via. Tutti questi sviluppi separati in diversi centri intellettuali avevano a che fare con problemi di comunicazione e specialmente col problema di quale fosse la natura di un sistema organizzato.
Noterete che tutto ciò che ho detto sulla storia e su Versailles è una discussione sui sistemi organizzati e le loro proprietà. Ora voglio dire che stiamo cominciando in una certa misura a comprendere in modo rigorosamente scientifico questi misteriosi sistemi organizzati. Quello che sappiamo oggi è assai più di quanto avrebbe mai potuto dire George Creel. Egli fu scienziato applicato prima che la scienza fosse matura per essere applicata.
Una delle radici della cibernetica risale a Whitehead e Russell e a ciò che si chiama la Teoria dei Tipi logici. In linea di principio, il nome non è la cosa cui il nome si riferisce, e il nome del nome non è il nome, e così via. In termini di questa potente teoria, un messaggio sulla guerra non è parte della guerra.
Diciamo così: il messaggio ’Giochiamo a scacchi’ non è una mossa del gioco degli scacchi; è un messaggio in un linguaggio più astratto di quello del gioco che si svolge sulla scacchiera. Il messaggio ’Facciamo la pace in questi e questi termini’ non è nello stesso sistema etico al quale appartengono gl’inganni e gli stratagemmi della battaglia. Dicono che tutto è lecito in amore e in guerra, e questo può essere vero all’interno dell’amore e della guerra, ma all’esterno e riguardo all’amore e alla guerra, l’etica è un po’ diversa. Per secoli gli uomini hanno giudicato il tradimento durante la tregua o le trattative per la pace peggiore dell’inganno in battaglia. Oggi questo principio etico trova un rigoroso fondamento teorico e scientifico. Ora l’etica può essere esaminata in modo formale, rigoroso, logico, matematico, e così via; e poggia su basi assai diverse dalle prediche e dalle invocazioni. Non è più inevitabile che ciascuno la pensi a suo modo; a volte possiamo distinguere ciò che è giusto da ciò che è errato.
Ho preso la cibernetica come il secondo evento d’importanza storica nella mia vita perché ho almeno una tenue speranza che possiamo indurci a usare queste nuove conoscenze con un po’ di onestà: se comprendiamo un pochino quello che stiamo facendo, forse ciò potrà aiutarci a uscire dal labirinto di allucinazioni che ci siamo orditi intorno.
La cibernetica, a ogni modo, è un contributo al cambiamento: non solo un cambiamento dell’atteggiamento, ma addirittura un cambiamento nella comprensione di ciò che è un atteggiamento.
La posizione che ho assunto nello scegliere ciò che è importante nella storia (quando ho detto che le cose importanti sono gli istanti in cui viene determinato l’atteggiamento, gli istanti in cui viene cambiata la polarizzazione del termostato), questa posizione deriva direttamente dalla cibernetica. Sono pensieri plasmati dagli eventi accaduti dal 1946 in poi.
Non dobbiamo illuderci di aver trovata la soluzione bell’e pronta. Abbiamo ora a nostra disposizione molta cibernetica, molta teoria dei giochi, e cominciamo a conoscere e comprendere i sistemi complessi. Ma ogni conoscenza può essere usata a scopi distruttivi.
Ritengo che la cibernetica rappresenti il boccone più grosso che l’uomo abbia strappato dal frutto dell’Albero della Conoscenza negli ultimi duemila anni. Ma la maggior parte dei bocconi di questa mela si sono dimostrati piuttosto indigesti (di solito per motivi cibernetici).
In se stessa, la cibernetica è integra, e questo può aiutarci a non essere indotti a più grande follia, ma non possiamo confidare che essa ci preservi dal peccato.
Ad esempio i ministeri degli Esteri di parecchie nazioni utilizzano oggi la Teoria dei Giochi, con l’ausilio del calcolatore, come un mezzo per decidere la politica internazionale. Dapprima, identificano quelle che sembrano essere le regole di gioco dell’interazione internazionale; poi considerano la distribuzione geografica di forze, armi, punti strategici, controversie, eccetera, nelle nazioni identificate. Essi poi chiedono al calcolatore di computare quale dovrebbe essere la mossa successiva per minimizzare le possibilità di perdere la partita; il calcolatore ronza e cigola e dà una risposta: e quasi quasi si è tentati di obbedirgli. Dopo tutto, se si dà retta al calcolatore si è un po’ meno responsabili che se si fosse presa una decisione autonoma.
Ma se si fa ciò che il calcolatore consiglia, con quella mossa si dà il proprio appoggio alle regole del gioco che si erano fornite al calcolatore: si confermano le regole del gioco.
Anche le nazioni rivali hanno certamente i calcolatori e fanno giochi simili e confermano le regole del gioco che essere forniscono ai loro calcolatori. Il risultato è un sistema in cui le regole dell’interazione internazionale divengono sempre più rigide.
È mia opinione che il vero problema in campo internazionale è che le regole debbono cambiare. Non è questione di che cosa sia meglio fare con le regole così come esse sono oggi; ma piuttosto di come ci si possa svincolare dalle regole secondo le quali abbiamo agito negli ultimi dieci o venti anni, o fin dal Trattato di Versailles. Il problema è di cambiare le regole, e nella misura in cui permetteremo alle nostre invenzioni cibernetiche (i calcolatori) di trascinarci in situazioni sempre più rigide, non faremo altro che calpestare e offendere la prima promettente scoperta fatta dal 1918.
Naturalmente vi sono altri pericoli latenti nella cibernetica, e molti non sono stati neppure individuati. Non si sa, ad esempio, quali possano essere le conseguenze dell’impiego del calcolatore per la gestione di tutti gli schedari della pubblica amministrazione. Almeno questo tuttavia è certo: che nella cibernetica è anche latente il mezzo per conseguire una nuova e forse più umana filosofia, un mezzo per cambiare la nostra strategia del controllo e un mezzo per vedere le nostre follie in una prospettiva più vasta.
* Gregory Bateson, Verso un’ecologia della mente [tit. orig.: Steps to an Ecology of Mind, 1972], Milano, Adelphi, 1977, pp. 487-496.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- Uscire dall’orizzonte della tragedia (e dalla epistemologia "andrologica"). Oltre il vicolo cieco degli uomini che uccidono le donne (di Tiziana Plebani).20 settembre 2021, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA STORIA FILOSOFIA PSICOANALISI E PSICHIATRIA. UNA QUESTIONE DI DIGNITÀ DI LUNGA DURATA.... *
Oltre il vicolo cieco degli uomini che uccidono le donne
Violenza maschile. Alla povertà di un gesto, opporre visioni diverse. Non c’è mai una un’unica scelta
- [Foto] Roma, manifestazione contro i femminicidi del movimento "Non una di meno"
di Tiziana Plebani (il manifesto, 17.09.2021)
Una donna uccisa quasi ogni giorno. Ma spostiamo la visuale e guardiamo dall’altra parte: quasi ogni giorno un uomo uccide una donna. Viene da pensare che sia divenuto un gesto imitativo, un modello da seguire, orrendamente, assurdamente, forse inconsapevolmente, ma che, tuttavia, si è imposto nell’immaginario, nel ventaglio di comportamenti e reazioni.
Nel momento della fragilità, della crisi, della necessità di riprogrammarsi, bisogna fare la fatica di trovare una soluzione, una via di uscita. Questa scelta costa. C’è bisogno di silenzio, pena, sofferenza. Cosa fare? Quello che hanno fatto tanti, che ogni giorno viene ripetuto dai media, che è visto di continuo in televisione. È un gesto che si insinua nella testa, e nel momento del bisogno emerge automatico, l’hanno fatto altri. È come se ci fosse una strada maestra di risposta che azzera l’infinità di opzioni a disposizione dell’umano per risolvere un dramma personale.
Ricordo che anni fa, durante la crisi economica del 2008, assistemmo a un’altra di queste associazioni a catena, tragicamente automatiche: più di 1600 imprenditori si tolsero la vita. Cominciò uno di loro a suicidarsi e in poco tempo anche questo gesto venne ripetuto di continuo: una risposta cieca che pure in questo caso si era imposta come l’unica percorribile.
Certo, quegli uomini che ammazzano le donne hanno alle spalle una pratica violenta, tengono armi in casa, hanno coltivato una confidenza con il linguaggio dell’offesa che non si inventa da un giorno all’altro. Sono tutte morti annunciate, come sappiamo.
Che fare dunque? Suggerisco due piani di azione, uno nell’ambito comunicativo, l’altro che riguarda le strategie di prevenzione.
I media ripropongono la sequela di omicidi e purtroppo imprimono e sedimentano questa risposta. Non si tratta ovviamente di tacere questi crimini bensì di accompagnare la notizia con commenti e interpretazioni che innanzitutto smentiscano l’idea che si tratti di raptus, di accecamento istintuale, di rabbia (rimando a questo articolo).
Quasi tutti questi delitti, avvengono dopo episodi di minacce e di brutalità. E soprattutto, come ci insegna la storia delle emozioni, esistono stili di comportamento che emergono rispetto ad altri in alcuni momenti storici, e che in questo caso ci parlano di un deserto e non di un eccesso emozionale, di un analfabetismo dei sentimenti (di cui la nostra società attuale è afflitta), e di un appiattimento delle risorse individuali e collettive ai drammi e alle fatiche della vita.
Televisioni, social media, carta stampata dovrebbero insistere piuttosto sul ventaglio di risposte al disagio, proponendo storie finite in altro modo (che poi sono la stragrande maggioranza). Si deve comunicare la possibilità di uscire da quella che appare in maniera distorta come una strada maestra ma che è invece un vicolo cieco e orrendo.
Opporre alla povertà di un gesto la visione di un paesaggio molteplice e vasto, di scelte multiple, di percorsi attraversati da mille sentieri. Non c’è mai un’unica scelta.
L’altro piano riguarda l’azione preventiva. Si tratta a parer mio di riprendere le modalità con cui si è affrontata la protezione dei testimoni di mafia, ma mutando direzione. Invece che far subire alla donna minacciata e che ha denunciato lo stalking o peggio, l’allontanamento dalla sua casa, dal suo ambiente, dal lavoro e dalle sue reti personali, si vada a trasferire l’uomo violento in un’altra città e almeno in un’altra regione, possibilmente molto distante. E che abbia l’obbligo di firma, come i mafiosi, in modo che si possano controllare i suoi spostamenti.
Perché ciò che non dobbiamo permettere è che le conseguenze di un comportamento violento maschile vengano pagate in qualità di libertà personale femminile. Affinché queste donne non siano viste solo come vittime ma come soggetti autonomi che perseguono le loro scelte di vita.
L’autrice è storica e scrittrice
*
NOTA:
- "Oltre il vicolo cieco degli uomini che uccidono le donne" : "Una donna uccisa quasi ogni giorno. Ma spostiamo la visuale e guardiamo dall’altra parte: quasi ogni giorno un uomo uccide una donna (...)" (Tiziana Plebani, il manifesto, 17 settembre 2021).
QUASI OGNI GIORNO UN #UOMO UCCIDE UNA DONNA (ma chi l’addestrò per la vittoria?). Forse non è ora di svegliarsi dal sonno dogmatico e venir fuori dalla edipica tragedia della cosmoteandria e laica e religiosa?!
ANTROPOLOGIA E STORIOGRAFIA. Per uscire dal manicomio di una storia segnata (e raccontata, come Brecht ben illustra)) da una andrologia di lunga durata, dall’inferno della tragedia (Edipo), e vedere Lucifero a "gambe in sù" (Inf. XXXIV, 92) o, diversamente, la testa di Oloferne tagliata da Giuditta (Botticelli), oggi, è necessario non solo un radicale capovolgimento di ottica, ma soprattutto prendere coscienza della necessità di uscire da dentro un campo antropologico con la bilancia rotta (tutte le relazioni dell’intera società senza più giustizia)) e smetterla di continuare a fare "un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata" (come già denunciato da Franca Ongaro Basaglia). O, contro l’evidenza di Dante Alighieri, ogni speranza è ormai solo un’illusione?! E la storia è finita?!
COSTITUZIONE ("BIBBIA CIVILE") ED EPISTEMOLOGIA "BIBLICA"! . Benché sulla questione antropologica (Kant, "Logica", 1800) abbia richiamato tutta la sua attenzione, l’idealismo materialistico (o il materialismo idealistico) l’ha "conservata e negata" ("superata") nella grande "Scienza della Logica" dello Spirito Assoluto di Hegel (Napoleone). Recentemente, Gregory Bateson, benché (come egli stesso dice in una conferenza del 1979) abbia "all’enima della Sfinge" dedicato "cinquant’anni" della sua "vita di antropologo", non è riuscito a venir fuori dall’orizzonte della tragedia e dalla città di Edipo ed è ritornato sulla strada del "sacro"!
("DIGNITÀ DELL’UOMO". Non per sminuire nessuno, ma per uscire dalla "preistoria" (K. Marx), è bene ricordare che il "Dio" a cui guarda Gregory Bateson, è ancora il dio dell’antico patto, quello dell’andrologia di Paolo di Tarso: il cap. XIII di "Dove gli angeli esitano" (Adelphi,1989) è titolato "Il dio che non si può beffare" e mette in citazione la frase di san Paolo: "Non vi fate illusioni: Dio non lo si può beffare" (Gal., VI, 7)!!!
DIGNITÀ. Che dire?! l’antropologa Ida Magli non ha solo scritto "La femmina dell’uomo" (Laterza, 1982) ma anche scritto il libro "SULLA DIGNITA’ DELLA DONNA"; il sottotitolo è "La violenza sulle donne, il pensiero di Wojtyla". Che dire?! Continuare nello Spirito di Napoleone, Hegel, Bateson, Costantino?! Dopo Dante2021?!
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---BERLINO. Il Vvn denuncia i crimini israeliani contro i palestinesi. L’organizzazione dei sopravvissuti alla Shoah non sta con Netanyahu (di S. Canetta)..19 maggio 2021, di Federico La Sala
L’organizzazione dei sopravvissuti alla Shoah non sta con Netanyahu
Germania/Israele. Il Vvn denuncia i crimini israeliani contro i palestinesi. Lo scrittore Tomer Dotan Dreyfus e il suo reportage da Tel Aviv: «Perché in Germania i palestinesi contano meno di noi?»
di Sebastiano Canetta (il manifesto, 19.05.2021)
BERLINO. È stata la prima organizzazione fondata dai sopravvissuti ai campi di sterminio, combatte l’antisemitismo da ben 74 anni e non sta per niente dalla parte di “Bibi” Nethanyau. L’Unione dei Perseguitati dal regime nazista (Vvn) è la più antica istituzione antifascista tedesca, con una lista di membri illustri da enciclopedia della Resistenza: da Hannelore Willbrandt, militante della Rosa Bianca insieme ai fratelli Scholl ai tempi di Hitler, alla Pantera Nera Mumia Abul Jamal, prigioniero degli Usa dal 1981. Ieri non sono stati zitti di fronte all’oppressione di ebrei, rom e musulmani; oggi non tacciono di fronte ai crimini commessi in Palestina.
«La comunità ebraica tedesca non è responsabile della politica di Israele, quindi gli attacchi contro le sinagoghe sono atti di antisemitismo da condannare». L’Achtung preventivo campeggia sui social del Vvn insieme alla video-testimonianza dell’indicibile orrore di Abu Suhiab, padre di tre bambini di 5, 8 e 14 anni assassinati sabato scorso dagli F-16 di Tel Aviv.
L’equidistanza per il Vnn è solo questa. Mentre la sua idea di libera informazione su ciò che accade in Medio Oriente coincide con l’analisi a tutto tondo di Tomer Dotan Dreyfus, lo scrittore israeliano-tedesco che fra pochi giorni rappresenterà ufficialmente la Germania alla “Jewish Book Week” di Londra. Di pubblico dominio (sul sito freitag.de) il suo «Avviso agli spettatori»: la corrispondenza da Tel Aviv che a Berlino nessuno sembra volere leggere.
«Abbiamo i cartelli con scritto “ebrei e arabi rifiutano di essere nemici!”. Di fronte a noi la sede del Likud su cui pende ancora lo striscione elettorale: “Molti politici, un solo...”; è sempre difficile tradurre leader in tedesco, ma la foto è di Netanyahu. La polizia è tranquilla: siamo ebrei hipster, mica palestinesi. Alcuni uomini ci gridano: “siete malati” e “le vite di migliaia di palestinesi non superano quella di un singolo ebreo!”. Una ragazza risponde: “Fra tutti i popoli, proprio noi non abbiamo il diritto di dirlo”».
Fin qui la cronaca dei fatti, che pure già restituirebbe la complessità del malessere del popolo che ha subito la banalità del male. Ma Dreyfus continua: «A leggere i media tedeschi viene da pensare che 7 morti israeliani, indubbiamente terribili, valgano più di 100 palestinesi. Ma gli attacchi missilistici su Israele sono riportati più dei raid aerei su Gaza. È inquietante: non che non sia giusto denunciare i razzi - sono dovuto correre al rifugio in piena notte per questo - ma il focus significa che l’idea centrale è sempre la supremazia».
È il punto chiave per capire la logistica dell’odio che Dreyfus spiega esemplarmente. «Sui siti tedeschi dilagano le accuse contro i palestinesi: “Si nascondono dietro i civili”. Come se a Gaza ci fosse altra possibilità, come se la principale base dell’esercito israeliano non fosse nel mezzo di una città molto popolata. Di sicuro, solo che tutti sono disposti a sacrificare i bambini». È l’unico dato certo di questo conflitto dalle mille risposte e troppo poche domande.
«Perché in Germania si vuole considerare che i palestinesi contano meno di noi? Forse, perché ci sono rifugiati anche lì. E se piangiamo i morti di Gaza allora vale anche per chi lasciamo annegare nel Mediterraneo». Sillogismo impeccabile, peraltro all’attenzione di tutti i governi della Fortezza Europa.
A Berlino gli slogan contro gli ebrei scanditi da (pochi) ultras alla manifestazione pro-Palestina di sabato scorso hanno alimentato il timore per il crescente antisemitismo, che per Dreyfus è giustificato ma «c’è in tutte le forme e, secondo la polizia, molto più tra i tedeschi bianchi di estrema destra. Lo Stato sembra sopraffatto di fronte al fenomeno che è incistato nella Bundeswehr come nei parlamenti dei Land».
Due mezzi e due misure, come mai? «Il lutto per i morti ebrei nella percezione collettiva tedesca è legato alla lotta contro l’antisemitismo, quindi è più facile se i morti palestinesi sono anche antisemiti. Eppure se la Germania fosse un vero amico di Israele avrebbe denunciato per tempo le politiche di discriminazione di Netanyahu. La frase “Israele è sotto tiro” induce a credere che siamo un’unica entità politica, invece dopo 12 anni di Netanyahu la società è lacerata, piena di odio e sangue, mentre la destra israeliana è più forte che mai: Itamar Ben Gvir, che minacciò pubblicamente di morte Rabin, oggi dalla Knesset invita i suoi seguaci a picchiare gli arabi».
Quindi Dreyfus riassume la realtà quotidiana dei palestinesi nel Paese che l’Occidente considera l’unica democrazia del Medio Oriente. «Quando sono vittime di un crimine la polizia israeliana se ne frega, soffrono più degli ebrei per la povertà e le loro scuole ricevono meno fondi pubblici. E mentre vengono sfrattati sulla base di contratti di due secoli fa, non sono autorizzati a tornare nelle case da cui sono fuggiti nel 1948».
-
> RIPENSARE L’EUROPA --- Andrebbe riletto Primo Levi. La realtà è complessa e ognuno si porta dietro i segni sulla pelle della propria storia.(di Giulio Cavalli).14 maggio 2021, di Federico La Sala
Andrebbe riletta l’intervista dello scrittore e testimone della Shoah, in cui parlò di «orrore» per una «rappresaglia sbilanciata che assume forme e dimensioni barbariche» di Israele verso la Palestina. E molti altri suoi interventi sul tema
di Giulio Cavalli *
Andrebbe riletto Primo Levi. Andrebbe riletto il libro di Berel Lang in cui Levi dice: «Dal 1935 al 1940, rimasi affascinato dalla propaganda sionista, ammiravo il Paese e il futuro che stava pianificando, di uguaglianza e fratellanza».
Andrebbe riletta la Conversazione con Levi di Ferdinando Camon in cui Levi dice: «Lo Stato d’Israele avrebbe dovuto cambiare la storia del popolo ebraico, avrebbe dovuto essere un zattera di salvataggio, il santuario a cui sarebbero dovuti accorrere gli ebrei minacciati negli altri Paesi. L’idea dei padri fondatori era questa, ed era antecedente alla tragedia nazista: la tragedia nazista l’ha moltiplicata per mille. Non poteva più mancare quel Paese della salvezza. Che ci fossero gli arabi in quel Paese, non ci pensava nessuno. Ed era considerato un fatto trascurabile di fronte a questa gigantesca vis a tergo, che spingeva là gli ebrei da tutta Europa. Secondo me, Israele sta assumendo il carattere e il comportamento dei suoi vicini. Lo dico con dolore, con collera. Non c’è differenza tra Begin e Khomeini».
Andrebbe riletto il testo dell’appello pubblicato il 16 giugno 1982 su Repubblica (altri tempi, eh) che si intitolava “Perché Israele si ritiri” e iniziava con: «Facciamo appello, in quanto democratici ed ebrei, perché il governo israeliano ritiri immediatamente le sue truppe dal Libano». Lo firmarono Franco Belgrado, Edith Bruck, Ugo Caffaz, Miriam Cohen e Natalia Ginzburg, criticava «la soluzione militare» scelta da Israele perché evocava «un linguaggio di triste memoria per ogni ebreo» e i firmatari affermarono di averlo scritto sperando di «combattere i germi potenziali di un nuovo antisemitismo che si verrebbe ad aggiungere alle vecchie e mai scomparse tendenze antiebraiche in seno alla società civile».
Andrebbe riletta la sua intervista al Secolo XIX in cui Levi parlò di «orrore» per una «rappresaglia sbilanciata che assume forme e dimensioni barbariche».
Andrebbe riletto l’articolo di Levi sulla prima pagina de La Stampa il 24 giugno 1982 in cui scrisse: «Israele, sempre meno Terra Santa, sempre più Paese militare, va acquisendo i comportamenti degli altri Paesi del medio oriente, il loro radicalismo, la loro sfiducia nella trattativa». Oppure la sua intervista a Giorgio Calcagno de La Stampa il 12 giugno 1982 in cui raccontava il suo allontanamento da Israele: «Ho giudicato il sionismo una forza e una necessità politica. Questa gente non poteva che seguire un verbo che aveva una forma biblica. Oggi la questione si è complicata, perché la Palestina è in un nodo geografico sotto tensioni spaventose, costretta a una difesa costosissima e logorante, che spinge anche ad azioni temerarie o politicamente sbagliate. Il sionismo di allora pensava a un Paese contadino. Israele, oggi è diventato un Paese militare e industriale».
Altrimenti si rischia davvero di credere a certi articoli, di questi tristi giorni, che raccontano di una guerra iniziata per una “manciata di case” a cui i palestinesi non vorrebbero rinunciare. La realtà è complessa e ognuno si porta dietro i segni sulla pelle della propria storia.
Buon venerdì.
*Fonte: Left, 14.05.2021.
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- IL PARLAMENTO EUROPEO, in occasione dell’8 marzo, dedica a Clara Campoamor, avvocata e politica spagnola e a Sophie Scholl, due edifici.8 maggio 2021, di Federico La Sala
RIPENSARE L’EUROPA:
A CLARA CAMPOAMOR, avvocata e politica spagnola e a SOPHIE SCHOLL, la giovane studentessa della Rosa Bianca ...
A
Il Parlamento Ue dedica due edifici a eminenti donne europee
 A Clara Campoamor e a Sophie Scholl
A Clara Campoamor e a Sophie SchollBRUXELLES - In occasione della giornata internazionale della donna l’Europarlamento ha approvato la proposta di rinominare due dei suoi edifici col nome di due eminenti donne europee.
 L’edificio che sorge su rue Montoyer 63 prenderà il nome di Clara Campoamor, avvocata e politica spagnola che ha lottato per i diritti delle donne e contro la discriminazione di genere. Il suo sforzo ha contribuito a portare il diritto di voto per le donne nella costituzione spagnola del 1931.
L’edificio che sorge su rue Montoyer 63 prenderà il nome di Clara Campoamor, avvocata e politica spagnola che ha lottato per i diritti delle donne e contro la discriminazione di genere. Il suo sforzo ha contribuito a portare il diritto di voto per le donne nella costituzione spagnola del 1931.
 L’edificio di rue Wiertz 30-50 invece prenderà il nome di Sophie Scholl, studentessa tedesca e militante anti-nazista. Condannata a morte per alto tradimento dopo aver distribuito materiale propagandistico contro il regime, Sophie Scholl militò nella Rosa Bianca, uno dei gruppi della resistenza antinazista tedesca.
L’edificio di rue Wiertz 30-50 invece prenderà il nome di Sophie Scholl, studentessa tedesca e militante anti-nazista. Condannata a morte per alto tradimento dopo aver distribuito materiale propagandistico contro il regime, Sophie Scholl militò nella Rosa Bianca, uno dei gruppi della resistenza antinazista tedesca.
 La sala riunioni 1G2 dell’edificio dedicato ad Altiero Spinelli invece sarà intitolata a nome di Manolis Glezos, eurodeputato greco morto lo scorso marzo, una delle figure chiave della resistenza antifascista greca.
La sala riunioni 1G2 dell’edificio dedicato ad Altiero Spinelli invece sarà intitolata a nome di Manolis Glezos, eurodeputato greco morto lo scorso marzo, una delle figure chiave della resistenza antifascista greca.B
La scelta di Sophie
Il 9 maggio di cento anni fa nasceva la giovane della Rosa Bianca, simbolo della resistenza al nazismo, uccisa con il fratello Hans Scholl e l’amico Christoph Probst
di Grazia Villa, Avvocata per i diritti delle persone*
- [Foto] Hans e Sophie Scholl e Christoph Probst, luglio 1942
In occasione dell’8 marzo 2021 l’Europarlamento ha deciso di dedicare a due donne due dei suoi edifici: a Clara Campoamor, avvocata e politica spagnola e a Sophie Scholl, la giovane studentessa tedesca, che pagò con la vita la sua opposizione al nazismo. Della resistenza dei giovani della Rosa Bianca molto si è scritto e anche il cinema ne ha efficacemente narrata la storia. Le tracce della vita dell’unica ragazza del gruppo sono, però, da scoprire nelle pagine dei suoi diari, nella sua copiosa corrispondenza, nel verbale degli interrogatori della Gestapo, negli atti del suo processo lampo, nelle testimonianze di familiari e delle persone sopravvissute della Weisse Rose.
Seguendo i suoi passi s’incontra una fonte di acqua cristallina e ci s’immerge nel pozzo profondo e luminoso di una coscienza retta e libera, un tesoro prezioso racchiuso tra due battesimi. Il primo regala due nomi alla piccola Sofia Magdalena, il segreto della sua esistenza: la sapienza della “Sofia” e l’amore sconfinato della Magdalena, uniti nel motto in lei incarnato, di Jacques Maritain «bisogna avere un cuore tenero e uno spirito duro».
Il secondo è quello del suo sogno finale la notte prima dell’esecuzione. Sophie sta portando un bambino a battesimo, si sente sprofondare, ma lo mette in salvo, mentre lei cade nel baratro: «Il bambino simboleggia le nostre idee... trionferanno dopo la nostra morte».
Solo guardando al suo spirito e al suo cuore si comprende...la scelta di Sophie.
Nasce in Germania il 9 maggio 1921 a Forchtenberg, cent’anni orsono, muore ghigliottinata a Monaco di Baviera il 22 febbraio 1943, a 22 anni
É la quarta di sei figli, il loro legame forte segnò profondamente la vita di Sophie e anche la sua sorte. Il padre Robert, cristiano liberale, sindaco della cittadina, fu sempre avverso al nazismo, particolarmente alla sua propaganda verso le giovani generazioni, tanto da osteggiare apertamente l’iniziale adesione dei figli Hans e Sophie alle organizzazioni della gioventù nazista. La madre Magdalena Muller, cristiana luterana devota, il Vangelo al centro della sua vita, trasmesso alle figlie e ai figli, come messaggio di liberazione da ogni forma di potere e di male.
La famiglia Scholl vive in una casa aperta all’ospitalità delle persone e delle idee, un luogo ricco di affetto e di allegria, di rispetto delle differenze, di uguaglianza tra maschi e femmine, uno spazio ampio di letture, anche di libri proibiti dal regime, di scambi intellettuali, di appassionata ricerca. È il terreno fertile in cui fiorirono i primi petali di quella che sarà poi la Rosa Bianca, tanto che i biografi definiscono questo laboratorio familiare un vero Scholl-Bund, la Lega Scholl.
Dolce e ironica, timida e sfrontata, piccola e bruna, d’aspetto italiano più che ariano, senza trecce bionde, con frangia scomposta e impenitente, così è descritta Sophie, mentre lei chiarisce ben presto le sue aspirazioni di bambina: «La più brava non sono, la più bella non voglio essere, ma la più intelligente sì!».
L’adesione della giovanissima Sophie alla Lega delle ragazze tedesche, oltre che per le escursioni nella natura e per lo sport, rappresenta un’occasione per attrezzarsi alla lotta e rifiutare un modello edulcorato e sentimentale dell’essere donna. Subisce il fascino della Fuhrerin “Charlo” che aveva modificato per le sue ragazze il saluto dell’Heil Hithler in un gesto affettuoso che consisteva nello sfiorare la fronte della compagna e scompigliarle i capelli!
La libertà femminile e la sua autonomia di pensiero la spingono presto a uscire da tutte le organizzazioni della gioventù hitleriana, a contestarne la pedagogia sperimentata anche nel lavoro obbligatorio, ”trovavo il servizio noioso e sbagliato, quindi brutto e ingiusto perché mortificava l’individualità personale dei bambini e delle bambine”, a ipotizzare un ruolo speciale per le donne come nella sua tesina di maturità: «La mano che muove la culla, muove il mondo».
È poi negli affetti e nelle sue relazioni amicali che lo spirito indomito appare slegato da forme e condizionamenti. Non temeva di dire alle amiche: «non voglio mettermi dalla parte di tutto ciò che è banale» o al fidanzato: «io posso pensare tranquillamente a te. E sono contenta di poter fare così come voglio, senza alcun obbligo».
Il suo amore per la natura, la bellezza e la musica, traboccante nei suoi diari non solo ne manifesta lo slancio vitale, fino all’ultimo respiro, ma diventa una vera forma di contemplazione spirituale, rivelando una fede schietta e forte, anche dentro il buio dell’oppressione, della guerra, della prigione, una fede viva che alimenta la sua coerenza. Il cuore tenero di Sophie si esprime con l’esultanza della giovinezza:
«Come posso non vedere un torrente limpido senza bagnarvi i piedi, così non posso passare davanti a un prato a maggio senza fermarmi».
La musica «ammorbidisce il cuore, mette in ordine la sua confusione, scioglie la sua rigidità ... Sì, silenziosamente e senza violenza, la musica apre le porte dell’anima».
«Non è anche questo un mistero, che tutto sia così bello? Nonostante l’orrore, continua a essere così. (...) Per questo soltanto l’uomo è capace di essere veramente crudele, coprendo questo canto col rumore di cannoni, di maledizioni e di bestemmie. Ma il canto di lode ha il sopravvento... ed io voglio fare tutto quello che è possibile per associarmi alla sua vittoria».
Anche in cella in attesa dell’esecuzione ormai certa sussurrava: «Una giornata di sole così bella ed io me ne devo andare», ma subito con forza aggiungeva: «non importa di morire se le nostre azioni saranno servite a scuotere e risvegliare le coscienze».
La coscienza di Sophie è quella dei giovani della Rosa Bianca, è la stessa cui si appellano nei volantini rivolti a risvegliare il popolo tedesco soggiogato dal Male.
Lo spirito duro li conduce al martirio. La stessa durezza di Sophie davanti ai suoi accusatori, stupiti dalla determinatezza di questa piccola ragazza: «Non rinnego nulla. Sono convinta di aver agito nell’interesse del mio popolo. Non mi pento e ne accetterò tutte le conseguenze (...) non io, ma lei ha una falsa visione del mondo».
Nelle ultime pagine di diario scriveva: «la vita è sempre sul bordo della morte, una piccola candela brucia esattamente come una torcia ardente... Scelgo da me il modo di bruciare». Lo stesso fuoco d’amore che la portò alla ghigliottina per proclamare fino alla fine la sua Libertà: Freiheit, l’ultima parola gridata dal fratello Hans davanti ai suoi carnefici e da loro regalata a noi per sempre.
C’è un quadro ai Musei Vaticani intitolato Annunciazione, in cui Maria e l’angelo tengono in mano rose bianche.
È stato dipinto intorno al 1905 dalla pittrice espressionista Paula Modersohn - Becker molto amata da Sophie Scoll che di lei scrive in una lettera alla sorella Inge, nel 1939.
«Paula Modersohn mi ha entusiasmato tantissimo, l’ammiro veramente. Pensa ha sempre lavorato da sola, e non è mai stata guidata da nessuno nella realizzazione dei suoi quadri. Devi vederli. Dopo i suoi quadri tutti gli altri mi sono passati davanti impercettibili».
Artista ritenuta “degenerata” dal regime nazista, Paula Modersohn-Becker (Dresda 1876 - Worpswede 1907) si forma tra Londra e la Germania, ma sono gli incontri con l’opera di Cézanne, Gauguin e van Gogh, avvenuti durante un soggiorno a Parigi nel 1900, a influenzare la sua arte.
Sul suo immaginario esercita un fascino speciale l’arte africana e in particolare l’iconografia della Dea della fertilità, che contamina molti dei suoi ritratti femminili. «Ne è un esempio questa Annunciazione, in cui la pittrice offre una versione intima del momento in cui l’angelo incontra la Vergine, resa inquietante dalla totale assenza di lineamenti» (museivaticani.va). Morì a soli 31 anni per complicazioni seguite al parto della primogenita, Mathilde.
*Fonte: L’Osservatore Romano, 30 aprile 2021 (ripresa parziale, senza immagini).
C
Clara Campoamor *
Clara Campoamor (Madrid, 12 febbraio 1888 - Losanna, 30 aprile 1972) è stata un’avvocata e politica spagnola, promotrice del suffragio femminile in Spagna, ottenuto nel 1931 ed esercitato per la prima volta dalle donne nelle elezioni del 1933.
Nelle elezioni del 1931 viene eletta deputata nel collegio elettorale di Madrid, e prende parte della Commissione incaricata di redigere la nuova Costituzione che approverà il voto femminile, la ricerca della paternità, il divorzio, l’uguaglianza civile nel matrimonio.
Nel 1933 perde il suo seggio parlamentare e presta servizio per breve tempo come ministro del governo, prima di fuggire dal paese durante la guerra civile spagnola. Nel 1972 Campoamor muore in esilio in Svizzera e viene sepolta in Spagna nel cimitero di Polloe a San Sebastián.[...] *
* Fonte: Wikipedia, l’enciclopedia libera (ripresa parziale).
FLS
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Discorso sullo Stato dell’Unione 2021 (e ricordo della lezione di don Milani). La presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen: "L’Italia aveva ragione, l’Europa doveva intervenire. E questo è quello che abbiamo fatto".7 maggio 2021, di Federico La Sala
Von der Leyen, Italia aveva ragione su intervento Ue su Covid
La presidente della Commissione nel discorso sullo Stato dell’Unione 2021
di Redazione ANSA *
"Mi ricordo bene l’inizio della pandemia e l’appello dell’Italia all’Europa. Gli italiani chiesero la solidarietà ed il coordinamento dell’Europa. L’Italia aveva ragione, l’Europa doveva intervenire. E questo è quello che abbiamo fatto". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell’Unione 2021.
"La nostra campagna di vaccinazione è un successo. Quello che conta sono le ferme e crescenti consegne di vaccini agli europei e al mondo. Ad oggi 200 milioni di vaccini sono stati distribuiti nell’Ue. Sono abbastanza per vaccinare almeno la metà della popolazione adulta europea almeno una volta. Nè Cina o Russia, si avvicinano minimamente". Così la presidente della Commissione europea nel suo discorso.
"Con Draghi a Roma" il 21 maggio "ospiteremo il vertice sulla Salute. Dobbiamo muoverci da soluzioni ad hoc sulla pandemia ad un sistema che funzioni per tutto" il mondo. "Vogliamo discutere di cooperazione internazionali. Il nostro rinascimento sulla Salute inizia a Roma", ha detto Von der Leyen.
"A pochi chilometri da Firenze c’è un paesino, Barbiana, dove don Lorenzo Milani sul muro della scuola scrisse in inglese ’I care’. Lui disse agli studenti che quelle erano le due parole più importanti da imparare. ’I care’ significa assumere responsabilità. Gli europei hanno dimostrato con le loro azioni cosa significa. Questo deve essere il motto dell’Europa. ’We care’", ha sottolineato Von der Leyen.
"L’Ue è pronta a discutere qualsiasi proposta che affronti la crisi" del Covid "in modo efficace e pragmatico. Questo è il motivo per cui siamo pronti a discutere di come la proposta degli Stati Uniti per una deroga alla protezione della proprietà intellettuale" dei brevetti "per i vaccini Covid potrebbe aiutare a raggiungere tale obiettivo", ha aggiunto la presidente della Commissione Ue.
* ANSA 06 maggio 20210 (ripresa parziale).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- "I CARE": IL MOTTO DI DON MILANI, UN FARO. Von der Leyen: "Durante e oltre la pandemia" queste due parole "devono diventare il motto dell’Europa".7 maggio 2021, di Federico La Sala
Europa.
Von der Leyen: "I care" di don Milani diventi il motto Ue
Nel discorso sullo Stato dell’Unione, la presidente della Commissione apre alla decisione Usa di sospendere i brevetti dei vaccini anti-Covid
Von der Leyen: "I care" di don Milani diventi il motto Ue
di Redazione Internet (Avvenire, giovedì 6 maggio 2021)
"A pochi chilometri da Firenze c’è un villaggio che si chiama Barbiana" dove sorge "una piccola scuola di campagna dove, negli anni Sessanta, un giovane maestro, don Lorenzo Milani, scrisse su un muro due semplici parole in inglese: I care". Lo ha ricordato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso su The State of the Union, appuntamento annuale organizzato dall’Istituto universitario europeo. "Durante e oltre la pandemia" queste due parole "devono diventare il motto dell’Europa", ha sottolineato nel suo discorso in videoconferenza.
Don Milani "disse ai suoi studenti che quelle erano le due parole più importanti che dovevano imparare", ha aggiunto la presidente. "’I care’ significa prendersi responsabilità e quest’anno milioni di europei hanno detto ’I care’ con le loro azioni" di "volontariato o semplicemente proteggendo le persone che gli stavano attorno". "I care, we care, questa credo che sia la più importante lezione che possiamo imparare da questa crisi".
Sui brevetti dei vaccini "pronti a discutere sulla proposta Usa"
"La nostra campagna di vaccinazione è un successo. Quello che conta sono le ferme e crescenti consegne di vaccini agli europei e al mondo. A oggi 200 milioni di vaccini sono stati distribuiti nell’Ue. Sono abbastanza per vaccinare almeno la metà della popolazione adulta europea almeno una volta. Né Cina o Russia, si avvicinano minimamente" ha detto la presidente Ue.
"Qualcuno potrebbe dire che Paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito sono stati più veloci all’inizio" sulle vaccinazioni. "Ma io dico: l’Europa ha ottenuto" il suo successo, "rimanendo aperta al mondo. Mentre altri tengono per sé la produzione di vaccini, l’Europa è il principale esportatore di vaccini a livello mondiale. Finora, più di 200 milioni di dosi di vaccini prodotti in Europa sono state spedite nel resto del mondo" ha proseguito.
"L’Europa esporta quasi la stessa quantità di vaccini che fornisce ai propri cittadini - ha detto -. Per essere chiari, l’Europa è l’unica regione democratica al mondo che esporta vaccini su larga scala".
Inoltre sulla decisione degli Stati Uniti di sospendere i brevetti dei vaccini anti-Covid: "L’Ue è pronta a discutere qualsiasi proposta che affronti la crisi" del Covid "in modo efficace e pragmatico. Questo è il motivo per cui siamo pronti a discutere di come la proposta degli Stati Uniti per una deroga alla protezione della proprietà intellettuale" dei brevetti "per i vaccini Covid potrebbe aiutare a raggiungere tale obiettivo". ha spiegato Von der Leyen.
L’impegno europeo di Ursula VdL.
I «care» faro per tutti (una scelta da onorare)
di Francesco Gesualdi (Avvenire, venerdì 7 maggio 2021)
Parto da una doverosa precisazione: don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, il motto ’I care’ (m’importa, ho a cuore) non lo aveva scritto su un muro, ma sulla porta che separava la scuola dalla sua camera. Un particolare non secondario perché essendo il punto di ingresso nell’unico spazio in cui a sera si ritirava in privato, voleva annunciare lo spirito che aleggiava in quello spazio e quindi nella sua persona. Uno spirito di assunzione di responsabilità verso le creature che la vita gli aveva messo davanti tale da fargli dimenticare totalmente se stesso.
E uno spirito di coerenza verso la verità tale da fargli accettare le conseguenze che la difesa della verità spesso comporta. Don Lorenzo non lo ricordava per narcisismo, ma come invito a noi allievi a fare altrettanto, ricordandoci che se la società è ingiusta, violenta, predatrice, la responsabilità non è solo del ’potere’ che impartisce ordini sbagliati e scrive leggi ingiuste, ma anche di tutti coloro che quegli ordini e quelle leggi eseguono. Ha fatto bene Ursula von der Leyen a ricordare il motto ’I care’ proprio oggi che dall’altra parte dell’Atlantico, Joe Biden ha annunciato di voler appoggiare la richiesta avanzata da Sudafrica e India di sospendere le regole internazionali a difesa dei brevetti sui vaccini e ogni altro farmaco utile a sconfiggere la pandemia.
Ha fatto bene perché ciò che in Europa ci è meno noto è che la decisione di Biden non giunge come un fulmine a ciel sereno, ma come conseguenza di una forte pressione popolare organizzata negli Stati Uniti da parte delle organizzazioni umanitarie che hanno fatto arrivare a Biden milioni di messaggi a favore della sospensione.
Per questo la sua decisione è la vittoria di milioni di persone che in cuor loro hanno detto ’I care’ e hanno preso l’iniziativa di agire per manifestare il proprio pensiero e insistere finché il Presidente di tanti di loro, l’uomo più potente del mondo, ha deciso di stare dalla parte delle persone piuttosto che delle multinazionali farmaceutiche. Un’iniziativa ancor più lodevole perché non attuata a favore di se stessi, ma di persone lontane, africani, asiatici, latino americani, che rischiano di non poter essere vaccinati a causa dei costi imposti dai brevetti. Ma il vero spirito dell’I Care è proprio questo: si agisce non perché se ne trae un vantaggio, ma perché non si tollera la sofferenza, l’ingiustizia, l’umiliazione, il sopruso, il latrocinio, a chiunque sia inflitto.
Ursula VdL, allora, deve ricordarsi che avendo preso l’impegno solenne, per giunta a Firenze, di volere assumere lo spirito di ’I Care’ a livello personale e della politica dell’Unione Europea, si è assunta una grande responsabilità. La responsabilità di agire di conseguenza, applicando il suo e nostro ’I Care’ prima di tutto verso i migranti. Verso tutte quelle donne, quegli uomini, quei bambini che dopo essere fuggiti da zone di guerra si trovano respinti, addirittura aggrediti dai cani alla frontiera est della Ue. Verso tutti coloro che cercando di fuggire dai lager libici si mettono in mare per raggiungere la sponda Sud della Ue, ma in caso di avaria vengono lasciati annegare o sono ripescati dalla cosiddetta Guardia costiera libica che li riporta nei lager dai quali hanno cercato di fuggire.
Verso tutti i cittadini meno protetti della Ue che in tempo di austerità sono stati privati di un lavoro, di cure mediche, di scuola, sacrificati di nuovo sull’altare del debito. Un tema, quello del debito pubblico, tutt’altro che superato, perché ora che la Ue ha deciso di indebitarsi per sostenere la transizione ecologica e la ripresa sociale, sarebbe beffardo se domani, dovesse ripristinare l’austerità per ripagare il debito fatto oggi in nome del suo ’I Care’.
Finché siamo in tempo sarebbe meglio proporre di rivedere i Trattati, in particolare quelli che regolano le funzioni e i meccanismi di funzionamento della Banca centrale europea affinché la moneta, al pari dei vaccini, sia gestita come un bene comune al servizio della piena occupazione, della promozione dei servizi pubblici e della tutela della natura.
Grazie dunque alla signora Ursula VdL, per averci ricordato il valore di ’I Care’, ma per favore l’Europa un faro per i tanti cittadini che la guardano affinché di quello spirito sia dato l’esempio migliore.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- "LA CASA VIVENTE". "Oggi è chiara la necessità di uscire dalla bolla eurocentrica, di costruire in modo differente". Una sollecitazione di Andrea Staid (di Beatrice La Tella).29 aprile 2021, di Federico La Sala
Immaginare mondi, risignificare spazi
Nel suo libro l’antropologo Andrea Staid redige una mappatura dei diversi modi in cui è possibile abitare la Terra, raccontando come la casa del futuro passi dall’ibridazione e non dagli standard urbani occidentali.
di Beatrice La Tella (Futura-Network, 27.04.2021)
In molti idiomi vivere e abitare sono sinonimi, vicini a livello di campo semantico e di concetto. Questa simmetria non esiste nella lingua italiana, e la sua assenza è forse spia di un atteggiamento schizofrenico, comune al pensiero Occidentale, che ha avuto come conseguenze più disagi (quando non disastri) che benefici.
L’antropologo Andrea Staid pubblica il suo La casa vivente per Add Editore, proprio a partire dalla necessità di un decentramento, prospettico e fisico. Il volume si apre non a caso con una brevissima introduzione all’etnografia: non studio egemonico-quantitativo - lo sguardo di superiorità della civiltà (presunta) evoluta che osserva bonariamente società (presunte) arretrate - ma, al contrario, ricerca di stampo qualitativo fondata sullo scambio e il confronto alla pari. Conversando con le più diverse popolazioni nel corso dei suoi viaggi in Asia, Staid si è trovato spesso innanzi a visioni rovesciate delle nostre certezze (un esempio semplice quanto immediato: la paura di dormire con la porta chiusa piuttosto che con la porta aperta). Da questi raffronti è sorta la necessità impellente di rimettere in questione tanto il concetto quanto il potere stesso di abitare.
Occorre partire dall’idea che “la casa è un processo”: dimorare implica una presa in cura, un’azione sempre relazionale e continuativa. L’abitazione è un nodo e sprigiona contemporaneamente esigenze pratiche e funzioni simboliche che si muovono dallo spazio ristretto al paesaggio più ampio. Il modo in cui si occupa un luogo sottende una visione del mondo, una precisa struttura identitaria che non ha una norma fissa. Dimorare in un posto, infatti, non corrisponde necessariamente a stanziarvisi: “Abitare il mondo non vuol dire soltanto radicarsi, ma anche valicare confini”. L’abitare nomade, dunque, non è meno abitare di quello sedentario, anzi, mostra una diversa relazione tra l’uomo e il suo ambiente, dalla quale, sostiene Staid, si può trarre più di una lezione.
Può sembrare strano che si guardi a tende di pelle continuamente assemblate e smontate in mezzo al deserto in termini di futuribilità, eppure, proprio in queste usanze che a chi vive nei nostri condomini sembrano preistoriche, si possono rintracciare i semi di un modo più armonico di popolare il pianeta.
Per l’autore è fondamentale chiamarsi fuori dalla prospettiva industriale occidentale in favore di un approccio ecologista decoloniale. L’atto stesso della costruzione non deve più essere delegato: riappropriarsi dell’abitare significa, innanzitutto, conoscere i luoghi quanto i materiali che consentono l’edificazione e aprirsi inoltre alla possibilità di scoprirne di nuovi e insospettabili. Costruire, d’altronde, è un “atto immaginativo”, non un accumulo di materia inerte ma un’azione artigiana itinerante, ogni volta diversa, adattiva, che non può avere modelli prestampati cui obbedire ciecamente. La materia stessa è stata erroneamente avvertita nei secoli come passiva: oggi sappiamo invece che ha una propria agentività (agency), le cui ripercussioni si propagano anche nel sociale.
 Su questi argomenti, la studiosa di Scienza e Nanotecnologia dei materiali Laura Tripaldi scrive nel suo recente Menti parallele (effequ): “Forse in un futuro potremmo trovarci a vivere in case fluide, capaci di cambiare forma insieme a noi come il guscio di una chiocciola, o in città capaci di disassemblarsi e scomparire per ricostruirsi spontaneamente altrove. Finché queste prospettive fantascientifiche resteranno inaccessibili, possiamo accontentarci di sapere che le nanotecnologie odierne ci forniscono tutti gli strumenti per costruire e studiare sistemi capaci di organizzarsi, riprodursi e modificarsi in autonomia su diverse scale, mostrandoci che è possibile immaginare e progettare attivamente altre forme di vita e nuove menti”. La materia ha un’intelligenza ed è protagonista di importanti e costanti mutamenti: conoscerla è fondamentale per ripensare i nostri rapporti con essa e le infinite possibilità che ci dischiude.
Su questi argomenti, la studiosa di Scienza e Nanotecnologia dei materiali Laura Tripaldi scrive nel suo recente Menti parallele (effequ): “Forse in un futuro potremmo trovarci a vivere in case fluide, capaci di cambiare forma insieme a noi come il guscio di una chiocciola, o in città capaci di disassemblarsi e scomparire per ricostruirsi spontaneamente altrove. Finché queste prospettive fantascientifiche resteranno inaccessibili, possiamo accontentarci di sapere che le nanotecnologie odierne ci forniscono tutti gli strumenti per costruire e studiare sistemi capaci di organizzarsi, riprodursi e modificarsi in autonomia su diverse scale, mostrandoci che è possibile immaginare e progettare attivamente altre forme di vita e nuove menti”. La materia ha un’intelligenza ed è protagonista di importanti e costanti mutamenti: conoscerla è fondamentale per ripensare i nostri rapporti con essa e le infinite possibilità che ci dischiude.Nel mondo del Capitalocene, termine che Staid ritiene più centrato di Antropocene per indicare gli influssi devastanti e trasformativi dell’uomo sul pianeta, l’unica possibilità che ci è data come specie è vivere - e dunque, abitare - alleggerendo l’impatto umano. Lasciandosi alle spalle l’etnocentrismo, l’antropologo preferisce guardare al dimorare indigeno come possibile maestro di un diverso stare al mondo, fatto di ibridazione e connessioni (non a caso nel testo l’autore cita direttamente Chthulucene di Donna Haraway, che fa del legame - letteralmente kin, “parentela” - il fulcro del suo pensiero). Osservando varie comunità, Staid ha scoperto case che sono spazi sociali potenzialmente illimitati, non individualizzanti, spesso con un proprio ciclo di vita - case che nascono, crescono e muoiono dissipandosi secondo le leggi naturali dello spazio in cui sorgono.
 Il libro propone dunque una serie di esempi di “architettura spontanea”: dalla goahti dei sami all’izba russa, dal tulou cinese alla tolek africana, Staid esplora case vive costruite in armonia con l’ambiente circostante, case mobili, orti galleggianti, dimore fatte di scale che finiscono sugli alberi, in una rassegna breve ma allo stesso tempo ricca e suggestiva.
Il libro propone dunque una serie di esempi di “architettura spontanea”: dalla goahti dei sami all’izba russa, dal tulou cinese alla tolek africana, Staid esplora case vive costruite in armonia con l’ambiente circostante, case mobili, orti galleggianti, dimore fatte di scale che finiscono sugli alberi, in una rassegna breve ma allo stesso tempo ricca e suggestiva.- “Oggi è chiara la necessità di uscire dalla bolla eurocentrica, di costruire in modo differente; abbiamo bisogno di progettisti, autocostruttori visionari, capaci di immaginare altri mondi per risignificare il modo in cui abitiamo i nostri spazi”.
Se la casa è un “dispositivo cognitivo”, che si muove non solo in senso spaziale ma anche culturale, Staid ritiene che questo dispositivo vada espanso, e per farlo è necessario muovere altrove il nostro sguardo. Ciò non significa però soffermarsi solo su realtà distanti: è sufficiente scoprire anche proposte poco note sorte in Italia, come A.R.I.A. Familiare, cantieri di autocostruzione sorti ad Amatrice dopo il sisma.
 L’Occidente come sistema di pensiero avversa da sempre queste pratiche di autogoverno, anteponendo l’efficienza (spesso presupposta) ai meccanismi di condivisione e la burocrazia all’immaginazione. Si tende a favorire l’intorpidimento dell’homo comfort a scapito della manualità dell’homo faber. “È importante ricordare che la casa è un bene d’uso, non un bene di consumo”, sottolinea Staid e in questo senso fornisce esempi di progetti, come Pianeta U.M.A.N.A. & C., che sono scuole-cantiere volte proprio a istruire alle pratiche di autocostruzione familiare.
L’Occidente come sistema di pensiero avversa da sempre queste pratiche di autogoverno, anteponendo l’efficienza (spesso presupposta) ai meccanismi di condivisione e la burocrazia all’immaginazione. Si tende a favorire l’intorpidimento dell’homo comfort a scapito della manualità dell’homo faber. “È importante ricordare che la casa è un bene d’uso, non un bene di consumo”, sottolinea Staid e in questo senso fornisce esempi di progetti, come Pianeta U.M.A.N.A. & C., che sono scuole-cantiere volte proprio a istruire alle pratiche di autocostruzione familiare.
 In un’epoca di kit di case da montare proposti da Ikea, in cui la standardizzazione crea lotti malsani identici a se stessi, questo tipo di realtà mostra che altre direzioni sono possibili. Se la rivoluzione urbana, con i suoi condomini iperindividualizzanti, con la sua riduzione di spazi comunitari e la sua omogeneizzazione del paesaggio, genera un disagio abitativo dai volti molteplici, è evidente che urge una controrivoluzione.
In un’epoca di kit di case da montare proposti da Ikea, in cui la standardizzazione crea lotti malsani identici a se stessi, questo tipo di realtà mostra che altre direzioni sono possibili. Se la rivoluzione urbana, con i suoi condomini iperindividualizzanti, con la sua riduzione di spazi comunitari e la sua omogeneizzazione del paesaggio, genera un disagio abitativo dai volti molteplici, è evidente che urge una controrivoluzione.In questo senso Staid sottoscrive lo stretto legame che intercorre - o dovrebbe intercorrere - tra ecologia e lotta sociale: non riconoscere che le logiche capitaliste siano la causa principale della crisi ambientale significa mantenere uno sguardo parziale e insufficiente. “L’abitare deve diventare un progetto politico anticapitalista”, afferma in maniera diretta, proponendo poi un abecedario di buone pratiche basilari che passano dalla mobilità sostenibile alla riduzione dei rifiuti. È fondamentale ridimensionare l’umano e lasciare maggiore respiro al paesaggio, riportandoci al di fuori di quel centro in cui ci siamo storicamente auto collocati.
 Per comprendere questo scarto è sufficiente considerare che l’uomo rappresenta lo 0,01% della biomassa, contro le piante che corrispondono invece all’80%. È proprio alle altre specie che bisogna guardare per salvaguardare anche la nostra: un esempio è la fabbrica dell’aria realizzata dal botanico Stefano Mancuso, un sistema di filtraggio degli ambienti chiusi che si basa proprio sulla fotosintesi delle piante e la loro capacità di assorbire e degradare gli agenti inquinanti. Bisogna “pensare la fine dell’antropocene senza la fine della vita di noi animali umani sul pianeta”. Il primo passo è allo stesso tempo semplice e arduo: ammettere che il modo in cui abbiamo sempre abitato - infestato - il nostro pianeta possa non essere il migliore e cercare altrove nuovi paradigmi.
Per comprendere questo scarto è sufficiente considerare che l’uomo rappresenta lo 0,01% della biomassa, contro le piante che corrispondono invece all’80%. È proprio alle altre specie che bisogna guardare per salvaguardare anche la nostra: un esempio è la fabbrica dell’aria realizzata dal botanico Stefano Mancuso, un sistema di filtraggio degli ambienti chiusi che si basa proprio sulla fotosintesi delle piante e la loro capacità di assorbire e degradare gli agenti inquinanti. Bisogna “pensare la fine dell’antropocene senza la fine della vita di noi animali umani sul pianeta”. Il primo passo è allo stesso tempo semplice e arduo: ammettere che il modo in cui abbiamo sempre abitato - infestato - il nostro pianeta possa non essere il migliore e cercare altrove nuovi paradigmi.L’etnografia è un’esperienza di spaesamento, un approccio per cui ogni viaggio è scambio costante, attività transculturale contro ogni gerarchia e struttura verticale. L’obiettivo è progettare un abitare intraspecie, simile alle parentele auspicate da Haraway, che elimini ogni idea di ‘permesso calato dall’alto’ e riconosca pari dignità a tutto il vivente, concependo ogni specie come entità politica. Una volta superato il mito tossico della crescita e dello sviluppo infiniti sarà forse possibile smettere di infestare la Terra e cominciare ad abitarla e viverla, senza più separare i due concetti.
Risignificare l’abitare è risignificare l’umano: Staid invita a superare la paura che il mettersi in discussione reca sempre con sé e iniziare a concepirci diversamente come specie, agendo di conseguenza. Il suo invito, come la sua scrittura, è chiaro e privo di fronzoli: dobbiamo “immettere futuro nelle cose che si fanno nel presente”, azzardare nuovi immaginari perché la casa smetta di essere soltanto un edificio e ritrovi una più vasta rete di possibilità e significati.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Antropologia e Costituzione. Quale missione per gli architetti?
 ARCHITETTURA E DEMOCRAZIA. A margine del Congresso mondiale e della Biennale di Venezia [2008], un intervento-appello di Franco La Cecla.
ARCHITETTURA E DEMOCRAZIA. A margine del Congresso mondiale e della Biennale di Venezia [2008], un intervento-appello di Franco La Cecla.
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE (2005).
 (...) il “nuovo mondo” che abbiamo costruito dimostra quanto presto abbiamo dimenticato la ‘lezione’ delle foreste, dei mari, dei deserti, e dei fiumi e delle montagne!!!
(...) il “nuovo mondo” che abbiamo costruito dimostra quanto presto abbiamo dimenticato la ‘lezione’ delle foreste, dei mari, dei deserti, e dei fiumi e delle montagne!!!Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---L’ORDINAMENTO DEL MONDO E UNA DOMANDA DI QUELLE CHE NON DANNO PACE (ANNE FRANK - 13 GIUGNO 1944).10 aprile 2021, di Federico La Sala
UNA LETTERA DI ANNE FRANK (13 GIUGNO 1944) *
Carissima Kitty,
[...] piú volte mi sono posta una di quelle domande che non mi danno pace, e cioè perché un tempo, e spesso anche adesso, la donna nei popoli occupa un posto molto meno importante rispetto all’uomo. Chiunque può dire che è ingiusto, ma a me non basta, vorrei tanto conoscere il motivo di questa grande ingiustizia!
Si può immaginare che l’uomo, fisicamente piú forte, fin dall’inizio abbia avuto una posizione di supremazia rispetto alla donna; l’uorno che guadagna, che genera i figli, l’uomo che può tutto... È già stato abbastartza stupido da parte di tutte quelle donne che fino a poco tempo fa hanno permesso che fosse cosí senza protestare, perché quanti piú secoli questa regola ha resistito, tanto piú ha preso piede. Per fortuna la scuola, il lavoro e il progresso hanno un po’ aperto gli occhi alle donne, In molti paesi le donne hanno ottenuto gli stessi diritti degli uomini; molte persone, soprattutto donne, ma anche uomini, adesso capiscono quanto questa suddivisione fosse sbagliata e le donne moderne vogliono avere il diritto all’indipendenza totale!
Ma non è solo questo, è il rispetto della donna, quello che manca! In tutto il mondo l’uomo viene rispettato, perché non si può dire lo stesso della donna? Soldati ed eroi di guerra vengono onorati e festeggiati, gli scopritori hanno fama immortale, i martiri vengono osannati, ma di tutta l’umanità, quanti considerano la donna anche come un soldato?
Nel libro Guerrieri per la vita c’è scritta una cosa che mi ha molto colpita, e cioè piú o meno che le donne in generale già soltanto per i parti soffrono piú di qualsiasi eroe di guerra. E quale successo spetta alla donna, dopo avere sofferto tanto? Viene spinta in un angolo quando è sformata dalla gravidanza, i figli ben presto non sono piú suoi, la bellezza svanisce. Le donne sono molto piú stoiche, sono soldati piú coraggiosi che lottano e soffrono per la sopravvivenza dell’umanirà molto piú di tanti eroi che non sanno fare altro che vantarsi!
Con questo non voglio affatto dire che le donne debbano rifiurarsi di mettere al mondo bambini, anzi, cosí è per natura, e cosí è giusto che sia. Condanno solo gli uomini e tutto l’ordinamemo del mondo che non ha mai voluto rendersi conto del grande, pesante ma d’altronde anche bel fardello che la donna porta nella società.
Paul de Kruif, lo scrittore del libro sopraccitato, ha tutta la mia approvazione quando dice che gli uomini devono imparare che la nascita ha cessato di essere un fatto narurale e normale in tutte quelle zone del mondo che vengono definite civilizzate. Hanno un bel dire, gli uomini! Non hanno mai sopportato, né mai sopporteranno, le pene che toccano alle donne!
Secondo me il concetto che sia dovere della donna avere figli nel corso del prossimo secolo si modificherà e verrà sostituito da rispetto e ammirazione nei confronti di colei che si prende sulle spalle i pesi senza brontolare né darsi tante arie!
Tua Anne M. Frank
* Fonte: Dialogando con Anne..
* ANNE FRANK, "DIARIO. Edizione integrale", Einaudi, Torino 1993.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Un continente vittima degli egoismi nazionali e la gravità della situazione geopolitica. Il dittatore, Draghi e il sofà (di M. Smeriglio).10 aprile 2021, di Federico La Sala
Caro Michel, rispetta lo stato di diritto e fai un passo indietro
Il dittatore, Draghi e il sofà. Una bruttissima pagina per l’Europa che però svela una fragilità ancora più grave, quella di un continente vittima degli egoismi nazionali che non fanno cogliere la gravità della situazione geopolitica ai nostri confini
di Massimiliano Smeriglio (il manifesto, 10 aprile 2021).
Draghi ha detto non una, ma due cose impegnative. Con il candore e la freddezza dell’upper-class mondiale, ha usato parole chiarissime definendo Erdogan un dittatore. Aggiungendo che, in ogni caso, con questi signori bisogna collaborare. Probabilmente sarà stato influenzato dal viaggio in Libia, in cui ha speso parole positive per la guardia costiera libica e la sua opera meritoria di salvataggio in mare. Il disastro diplomatico della missione europea ad Ankara è tutto nella esplicita ammissione di una real politik piccola piccola.
Il 20 marzo la Turchia, con decreto presidenziale, è uscita dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Il 17 marzo è stata avviata presso la Corte Costituzionale la causa per chiedere lo scioglimento del Partito democratico dei popoli (Hdp). Nel medesimo arco di tempo Naci Agbal, presidente della banca centrale organismo sulla carta indipendente, è stato sollevato dal suo incarico per aver alzato i tassi d’interesse dal 17% al 19%. L’avvocata Kezban Hatemi continua a denunciare la prossima modifica del codice civile nella parte che equipara gli uomini alle donne, in un Paese in cui i femminicidi sono in costante aumento. Per non parlare della brutale repressione delle mobilitazioni studentesche contro la sottomissione del sistema universitario al potere politico di Erdogan.
Questa è la Turchia a cui hanno fatto visita i massimi vertici europei con l’obiettivo esplicito di avviare il disgelo dopo le tensioni con la Grecia e rilanciare una cooperazione rafforzata. L’Unione si è impegnata ad adempiere all’accordo sui migranti siglato nel 2016 che vale sei miliardi di euro (quattro già versati) con lo sguardo benevolo di Germania, primo Stato in scambi commerciali con la Turchia, e Italia, principale fornitore di armi dopo gli Usa. Obiettivo di fondo la modernizzazione dell’unione doganale in vigore dal 1996. Con 143 miliardi di euro nel 2020 l’Unione europea è il primo partner commerciale di Ankara.
Il contesto in cui ci muoviamo è evidente. L’Europa dello stato di diritto, dei diritti universali della persona è silente di fronte alla violenta svolta autoritaria che sta negando libertà politiche e civili a migliaia di cittadini, che colpisce la stampa libera e nega nei fatti l’autonomia della magistratura. Che altro può accadere?
Può accadere che di fronte al Sultano ultrà del patriarcato, vada in scena un siparietto per misurare i rapporti di forza tra Stati nazionali e istituzioni comunitarie. Il cerimoniale dell’incontro è stato definito con un delegato del gabinetto del Presidente del Consiglio europeo Michel. Ad Erdogan non è parso vero di enfatizzare il rapporto con gli Stati, mettere in difficoltà la Commissione e umiliare una donna. Per questo è giusto chiamare in parlamento Michel per un chiarimento, come ha fatto la capogruppo dei Socialisti e Democratici Iraxte Garcia. Insieme ad altri parlamentari, inoltre, abbiamo scritto sempre a Michel per chiedergli un passo indietro. “Non accettiamo che le nostre istituzioni debbano prostrarsi di fronte a un regime ostile allo stato di diritto”. Così nella interrogazione scritta a più mani.
Una bruttissima pagina per l’Europa che però svela una fragilità ancora più grave, quella di un continente vittima degli egoismi nazionali che non fanno cogliere la gravità della situazione geopolitica ai nostri confini. Una Unione politica debole e ricattabile. La Turchia è proprietaria delle chiavi della rotta balcanica, la sola minaccia della riapertura dei cancelli della Tracia ai profughi siriani ci zittisce. Così come la necessità di garantire l’arrivo per i prossimi anni del gas russo e azero attraverso le infrastrutture di Turkstream e Tanap/tap.
Agitare la leva dello stato di diritto a seconda della forza economica e militare dell’interlocutore trasforma in retorica afona i nostri principi. Ad Ankara è andata in scena la peggiore Europa e le parole di Draghi hanno certificato il livello delle nostre ambizioni e delle cose che abbiamo da dire sullo scenario globale. Qualche affare e poco altro.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Ambiente. La deforestazione e il Covid si nutrono a vicenda e corrono. Immaginiamo di osservare la mappa dell’Europa (di Lucia Capuzzi)1 aprile 2021, di Federico La Sala
Ambiente.
La deforestazione e il Covid si nutrono a vicenda e corrono
La pandemia e l’emergenza climatica due fenomeni in stretto collegamento
di Lucia Capuzzi (Avvenire, giovedì 1 aprile 2021)
- [Foto] La devastazione degli spazi verdi è una delle cause della diffusione del virus nelle comunità locali
Immaginiamo di osservare la mappa dell’Europa. Per scoprire, d’un tratto, che dal profilo del Continente è sparita l’Olanda. Fino a un anno prima era là, incastonata tra Belgio e Germania. E ora niente: Amsterdam con i suoi canali, Rotterdam e l’intero Paese sono stati cancellati. O, meglio, divorati dal «Nulla», come nel celebre romanzo di Micheal Ende. Una simile scomparsa creerebbe stupore, rabbia, quanto meno sconcerto nell’opinione pubblica globale, assuefatta, invece, alla perdita di analoghi “pezzi” di mondo, purché collocati nella periferia geopolitica del pianeta.
Eppure un’area estesa quanto i Paesi Bassi è stata cancellata dal planisfero nel corso del 2020 quando sono stati distrutti 4,2 milioni di ettari di foreste primarie tropicali. Ovvero il “magazzino” naturale di una quantità di CO2 pari alle emissioni di 570 milioni di auto che, non più stoccate dagli alberi, finiscono nell’atmosfera. Con i ben noti effetti in termini di riscaldamento globale e cambiamenti climatici. A dare l’allarme è il nuovo studio elaborato dal World resources institute in base ai dati raccolti dell’Università del Maryland e dal Global forest watch e diffuso in occasione della riunione preparatoria ieri di Cop26, il vertice Onu sull’ambiente in programma a novembre a Glasgow.
- Nel 2020 è stata cancellata una foresta grande come l’Olanda. Nei Paesi del Sud del mondo la crisi sanitaria sta colpendo le risorse naturali e le popolazioni indigene
Inizialmente previsto nel 2020 e rinviato a causa del Covid, il summit rappresenta un momento cruciale di rilancio dell’accordo di Parigi, messo a dura prova dalla defezione degli Stati Uniti nell’era Trump. Ora il quadro internazionale è mutato. E la Casa Bianca di Joe Biden sembra decisa a rimettere la questione al centro dell’agenda globale, soprattutto in tempi brevi. Retorica a parte, però, non sarà facile convincere i Grandi a rispettare gli impegni presi a Parigi per tagliare le emissioni e mantenere l’aumento della temperatura entro gli 1,5 gradi centigradi. Appelli alla comunità internazionale a «trovare un’intesa efficace» e «di lungo periodo» alla crisi ecologica sono arrivati anche da papa Francesco negli ultimi mesi.
«Non è solo l’essere umano ad essere malato, lo è anche la nostra Terra», ha detto nell’incontro con il corpo diplomatico dello scorso febbraio il Pontefice della Laudato si’, a cui la Santa Sede ha voluto dedicare l’anno in corso, il quinto dalla pubblicazione dell’Enciclica. I media scozzesi hanno anche ventilato un possibile intervento del vescovo di Roma al vertice, eventualità al momento non confermata dalla Sala stampa vaticana. Anche perché non si può escludere che l’appuntamento subisca un nuovo slitta- mento a causa dell’emergenza Covid, pur se fonti del governo britannico lo negano. La pandemia in effetti rischia di aggravare ulteriormente la crisi ambientale. Non è un caso che l’anno appena trascorso - come sottolinea il World resource institute - abbia visto un drastico incremento della deforestazione: +12%, il terzo risultato peggiore in due decenni.
Lockdown e restrizioni alla mobilità hanno ridotto la possibilità di verifiche sul campo. Il peggio, tuttavia, potrebbe verificarsi nel prossimo futuro. Come effetto collaterale della recessione post-virus, i governi - soprattutto i grandi esportatori di materie prime - potrebbero decidere di risparmiare sui meccanismi di controllo e tutela ambientale. E di intensificare lo sfruttamento delle risorse per aumentare il Pil.
 È quanto già in atto nel Brasile di Jair Bolsonaro, dove il disboscamento è stato più feroce nel 2020, con la distruzione di 1,5 milioni di ettari di Amazzonia e 200mila ettari di Pantanal, la superficie umida più vasta al mondo: il 25% in più dell’anno precedente.
È quanto già in atto nel Brasile di Jair Bolsonaro, dove il disboscamento è stato più feroce nel 2020, con la distruzione di 1,5 milioni di ettari di Amazzonia e 200mila ettari di Pantanal, la superficie umida più vasta al mondo: il 25% in più dell’anno precedente.
 Il caso brasiliano è particolarmente eloquente perché il Paese era riuscito a conseguire una drastica riduzione della deforestazione agli inizi degli anni Duemila. Le sforbiciate agli enti di tutela, però, hanno favorito l’inversione di tendenza, alimentata dalla “fame” di risorse del Nord del pianeta. Un esempio è la filiera della carne, come dimostrato da nuova indagine di Greenpeace International che ha identificato quindici aziende agricole legate agli incendi dello scorso ottobre nel Pantanal, i cui prodotti - attraverso una complessa rete di transazioni - vengono esportati in tutto il mondo. Inclusa l’Italia, al primo posto nell’Ue e al sesto nel mondo per acquisti di carne, per un valore di 96 milioni di dollari.
Il caso brasiliano è particolarmente eloquente perché il Paese era riuscito a conseguire una drastica riduzione della deforestazione agli inizi degli anni Duemila. Le sforbiciate agli enti di tutela, però, hanno favorito l’inversione di tendenza, alimentata dalla “fame” di risorse del Nord del pianeta. Un esempio è la filiera della carne, come dimostrato da nuova indagine di Greenpeace International che ha identificato quindici aziende agricole legate agli incendi dello scorso ottobre nel Pantanal, i cui prodotti - attraverso una complessa rete di transazioni - vengono esportati in tutto il mondo. Inclusa l’Italia, al primo posto nell’Ue e al sesto nel mondo per acquisti di carne, per un valore di 96 milioni di dollari.Di recente, le associazioni Hutukara e Wanassedume, espressioni degli indigeni Yanomami, con il supporto dell’Instituto socioambiental (Isa), hanno denunciato un incremento del 30% delle miniere illegali sul proprio territorio, al confine tra Brasile e Venezuela. L’invasione di 20mila cercatori d’oro clandestini ha provocato la distruzione di 2.400 ettari di foresta, un’estensione equivalente a 500 campi da calcio. Oltre a diffondere il contagio fra gli indios, incluso il popolo in isolamento volontario dei Moxihatëtëma, che vivono sulle rive del fiume Catrimani e sono particolarmente fragili di fronte ai virus esterni.
 La questione è tutt’altro che marginale. Più di 45mila delle 310mila vittime brasiliane del Covid sono concentrate in territorio amazzonico, come confermato dall’ultima rilevazione della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam). E proprio da Manaus proviene la variante responsabile della strage in atto in queste settimane nel Gigante del Sud.
La questione è tutt’altro che marginale. Più di 45mila delle 310mila vittime brasiliane del Covid sono concentrate in territorio amazzonico, come confermato dall’ultima rilevazione della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam). E proprio da Manaus proviene la variante responsabile della strage in atto in queste settimane nel Gigante del Sud.- In un anno è stato «bruciato» il magazzino naturale di una quantità di CO2 pari alle emissioni di 570 milioni di auto. E, non più stoccata dagli alberi, l’anidride carbonica finisce nell’atmosfera
Il legame tra disboscamento e diffusione dei virus è stata sottolineato fin dall’inizio. E ribadito da una recente ricerca del Centre national de la recherche scientifique (Cnrs) in Francia e dell’Università Kasetsart in Thailandia, secondo cui, un’analisi dei dati tra il 1990 e il 2016, ha evidenziato senza alcun dubbio una «forte correlazione tra la devastazione delle foreste e lo sviluppo di focolai infettivi » in territori del Brasile, Perù, Bolivia, Repubblica democratica del Congo, Camerun, Indonesia, Myanmar e Malaysia. Gli stessi Paesi citati dal World resource institute. Il Congo è la seconda nazione più colpita dalla deforestazione con 490mila ettari in meno, seguita da Bolivia, Indonesia, Perù, Colombia, Camerun, Laos, Malaysia, Messico e Cambogia. Nonostante lo scenario allarmante, però, qualcosa si muove. L’Indonesia, ad esempio, è riuscita a diminuire le aggressioni ai suoi boschi negli ultimi sei anni grazie alla massiccia campagna di prevenzione lanciata dal governo dopo i roghi del 2015.
Particolarmente significativo il calo nella provincia di Kalimatan, le cui autorità hanno siglato un accordo con la Banca mondiale per 110 milioni di dollari di investimenti in cambio di un impegno nella lotta alle emissioni. La strategia degli incentivi è quella proposta dagli esperti del World resource institute. Centrale, in tal senso, l’alleanza con le comunità locali, soprattutto indigene definite dall’Onu le più efficienti «sentinelle del pianeta». La terra affidata alla loro gestione è la meglio conservata. Poiché - affermava la Laudato si’ già nel 2015 - per loro «la terra non è un bene economico, ma un dono di Dio e degli antenati che in essa riposano, uno spazio sacro con il quale hanno il bisogno di interagire per alimentare la loro identità e i loro valori più profondi. Quando rimangono nei loro territori, sono quelli che meglio se ne prendono cura».
-
> RIPENSARE L’EUROPA! - LA POCA SAGGEZZA DELLA FILOSOFIA, I “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO DI DANTE E LA PRESENTE STORICA CRISI.16 marzo 2021, di Federico La Sala
LA POCA SAGGEZZA DELLA FILOSOFIA, I “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO DI DANTE E LA PRESENTE STORICA CRISI DELLA CULTURA EUROPEA...
- Una nota a margine dell’art. di Sergio Benvenuto, "La poca saggezza della filosofia", "Le parole e le cose" (15 marzo 2021).
CONSIDERATO CHE UN FILOSOFO, "Anche quando sbaglia di grosso, se è un vero filosofo sbaglia con argomenti non banali, fino al punto che, grazie a lui, l’errore brilla della luce convincente della verità" (cf. S. Benvenuto, op. cit.), E VISTO CHE EGLI HA MESSO IL DITO NELLA PIEGA (e nella piaga) della storia della filosofia, nel gioco sofistico di Socrate: «Malgrado lo slogan “so di non sapere”, tutti ci rendiamo conto che Socrate in realtà sapeva tante cose. Ma il suo sapere squisitamente filosofico era proprio quello di non sapere, ovvero, il suo appello all’epistheme come “ricominciare tutto daccapo”» (op.cit. ), VISTO IL PERSISTERE E , AL CONTEMPO, L’ESAURIRSI DELLA "GRANDE INSTAURAZIONE" ANTROPOLOGICA ED EPISTEMOLOGICA apollinea-socratica (su questo, si cfr. la grande analisi di Nietzsche!), forse, è bene e salutare riprendere alla radice (Marx!) la questione e, riaccogliendo l’indicazione di Sofocle, ripensare le «perversioni» di tremila e più anni (come sapeva Dante, meglio di Goethe), rileggere il cap. 15 del manuale di "Anatomia" (Roma, 1560) di Giovani Valverde, e ripensare l’«edipo completo», come voleva Freud e Fachinelli. Altro che continuare a menare la canna per l’aria. O no?!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. --- La profezia di Marielle Franco. Firenze le dedica una terrazza (di Glória Paiva).15 marzo 2021, di Federico La Sala
TRANSIZIONE CULTURALE... *
- "Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro (Mario Draghi)
Internazionale
Brasile, la profezia di Marielle Franco
Tre anni dopo. Resta senza mandanti l’omicidio della consigliera di Rio, avvenuto il 14 marzo 2018 per mano di due sicari. Ma alle ultime elezioni voti a valanga per 13 donne afrobrasiliane
di Glória Paiva (il manifesto, 14.03.2021)
Oggi il brutale omicidio della consigliera comunale brasiliana Marielle Franco e del suo autista Anderson Gomes compie tre anni. Militante, femminista, nera, residente a Favela da Maré e quinta consigliera più votata a Rio de Janeiro nel 2016, Marielle è diventata un simbolo mondiale della lotta antirazzista, per i diritti umani e lgbt+.
NONOSTANTE IL TEMPO trascorso, rimangono ancora domande sulle circostanze della sua morte. Perché le autorità locali e quelle nazionali non cooperano nella conduzione del caso? Qual è la conclusione dell’indagine relativa all’uso delle armi della polizia federale nel crimine? Chi ha spento le telecamere della strada in cui transitavano quella sera Marielle e Anderson? C’è stato un tentativo di depistaggio delle indagini? E la principale: chi ha ordinato l’omicidio di Marielle e perché?
Queste e altre questioni sono oggetto di un documento pubblicato dall’Istituto Marielle Franco, un’organizzazione creata dalla famiglia di Marielle per perpetuare la sua memoria. La famiglia chiede in modo costante risposte alle autorità di Rio de Janeiro che conducono le indagini. Tuttavia, si trovano spesso di fronte al silenzio: nell’ultima settimana, ad esempio, hanno cercato di incontrare il governatore dello stato, Cláudio Castro, e il procuratore generale, Luciano Mattos, ma non hanno avuto alcun riscontro, come ha riferito Anielle Franco, la sorella dell’attivista, in una conferenza stampa che si è tenuta venerdì 11 marzo.
FINORA, È NOTO SOLTANTO che Ronnie Lessa, poliziotto in pensione, e Élcio Queiroz, ex poliziotto, hanno aspettato l’auto di Marielle e Anderson nella Rua dos Inválidos, nel centro di Rio, prima di sparare contro il veicolo. Entrambi sono in un carcere di massima sicurezza e saranno sottoposti a un giudizio popolare, un processo in cui 25 cittadini, insieme al giudice, decideranno sulla colpevolezza o meno dell’imputato. L’ipotesi principale è che l’assassinio abbia avuto una motivazione politica e che vi abbiano partecipato delle milizie.
Secondo Jurema Werneck, direttrice esecutiva di Amnesty International in Brasile, i successivi cambiamenti negli organi responsabili delle indagini e la mancanza di trasparenza hanno ostacolato un’inchiesta rapida e imparziale. «In questi tre anni abbiamo avuto tre governatori, due procuratori generali, tre capi di polizia, tre pubblici ministeri. Nella pubblica sicurezza di Rio ci sono stati cinque cambi. Le autorità brasiliane non possono inviare un messaggio di impunità e di tolleranza rispetto alla violenza politica», dice Werneck. Che avverte: «Finché i mandanti sono liberi e sconosciuti, nessuno può sentirsi al sicuro».
«NON POSSIAMO ASPETTARE altri dieci anni prima che le donne nere vengano elette», aveva detto Marielle poche ore prima di essere uccisa. Il suo discorso è diventato una profezia: due anni dopo, nel 2020, alle ultime elezioni amministrative brasiliane, 13 donne nere sono state tra i candidati più votati nelle più grandi città del Brasile. Tra i consiglieri eletti, più di 70 si sono impegnati nella cosiddetta Agenda Marielle, che riunisce progetti di legge con pratiche e linee guida anti-razziste, femministe, lgbt + e popolari ispirate al lavoro svolto dall’attivista.
I politici sintonizzati su questi ideali, tuttavia, sono spesso a rischio. A Rio de Janeiro, le quattro donne nere elette con il Partito socialismo e libertà (Psol) hanno già registrato minacce di natura politica. «È necessario proteggere queste donne e inviare un messaggio a chi vuole mettere a tacere l’eredità di Marielle. Le persone che lottano per la giustizia, i diritti, la dignità devono essere protette perché sono un bene della società», dice Jurema Werneck.
Per il deputato federale Marcelo Freixo (Psol), amico ed ex compagno di lotta di Marielle, l’assassinio ha rivelato un lato brutale del Brasile. A cui il mondo ha reagito: «Le manifestazioni contro la morte di Marielle - osserva - mostrano la forza di ciò che lei ha rappresentato. Questa società capace di uccidere Marielle Franco non è la società che vogliamo»,
E Firenze le dedica una terrazza
Il messaggio di Marielle Franco ha fatto il giro del mondo e ha raggiunto anche Firenze. Dal 15 marzo l’attivista sarà la prima donna brasiliana nera ad avere il suo nome in uno spazio pubblico in Italia, sulla terrazza della Biblioteca delle Oblate.
 L’intitolazione è frutto della collaborazione tra la Cgil di Firenze e la Casa do Brasil a Firenze che hanno fatto specifica richiesta al Comune. «Questa terrazza non è uno spazio qualsiasi. Con vista sulla cupola del Brunelleschi, è un luogo simbolo del Rinascimento italiano. Possa la memoria di Marielle rinascere qui e offrire ai giovani la chance di riflettere su giustizia, diritti umani, diversità, tutto ciò che Marielle incarnava», commenta Ana Luiza Oliveira de Souza della Casa do Brasil a Firenze.
L’intitolazione è frutto della collaborazione tra la Cgil di Firenze e la Casa do Brasil a Firenze che hanno fatto specifica richiesta al Comune. «Questa terrazza non è uno spazio qualsiasi. Con vista sulla cupola del Brunelleschi, è un luogo simbolo del Rinascimento italiano. Possa la memoria di Marielle rinascere qui e offrire ai giovani la chance di riflettere su giustizia, diritti umani, diversità, tutto ciò che Marielle incarnava», commenta Ana Luiza Oliveira de Souza della Casa do Brasil a Firenze.
*SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" del 2004.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
FLS
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- MATEMATICA, ANATOMIA, E COSTITUZIONE: UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA.10 marzo 2021, di Federico La Sala
MATEMATICA, ANATOMIA, E BAMBINI E BAMBINE. UNA QUESTIONE DI CIVILTÀ..
- LA MATEMATICA È LA COSTITUZIONE, “È una disciplina che non ammette principio di autorità giacché nessuno possiede la verità da solo, le verità sono asserzioni verificabili da chiunque, o se non da chiunque (alcune volte è difficile) almeno da un certo numero di persone. Inoltre, la matematica è un linguaggio, una grammatica. Per discutere di matematica bisogna accettarne le regole. Sicché uno studioso, ma anche uno studente di matematica, è abituato a operare in un mondo di regole comuni, per ridiscutere le quali non si può essere in uno, bisogna essere almeno in due.
 Ovviamente la matematica non procede per voto o alzata di mano, ma per ipotesi e verifiche. Se i nostri politici avessero studiato matematica, e se studiandola l’avessero capita, si comporterebbero diversamente rispetto alle cariche dello Stato che ricoprono perché non agirebbero come singoli, ma come funzioni di un sistema più ampio del loro ego, e soprattutto non si preoccuperebbero delle cose ma delle relazioni tra le cose, dunque sarebbero più cauti nel dare una notizia falsa o non verificata, perché consci di quanto la notizia falsifichi il resto, talvolta il contesto.” (Chiara Valerio, La matematica è politica, Einaudi, Torino, 2020, p. 53).
Ovviamente la matematica non procede per voto o alzata di mano, ma per ipotesi e verifiche. Se i nostri politici avessero studiato matematica, e se studiandola l’avessero capita, si comporterebbero diversamente rispetto alle cariche dello Stato che ricoprono perché non agirebbero come singoli, ma come funzioni di un sistema più ampio del loro ego, e soprattutto non si preoccuperebbero delle cose ma delle relazioni tra le cose, dunque sarebbero più cauti nel dare una notizia falsa o non verificata, perché consci di quanto la notizia falsifichi il resto, talvolta il contesto.” (Chiara Valerio, La matematica è politica, Einaudi, Torino, 2020, p. 53).
Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo
risponde Luigi Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27)
«Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo».
Così inizia il capitolo 15 dell’Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato «De Testicoli delle donne» (p. 91). Dopo queste timide e tuttavia coraggiose ammissioni, ci vorranno altri secoli di ricerche e di lotte: «(...) fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società prepatriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano (...) che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme» (Françoise D’Eaubonne). Oggi, all’inizio del terzo millennio dopo Cristo, nello scompaginamento della procreazione, favorito dalle biotecnologie, corriamo il rischio di ricadere nel pieno di una nuova preistoria: «l’esistenza autonoma dell’embrione, indipendente dall’uomo e dalla donna che hanno messo a disposizione i gameti e dalla donna che può portarne a termine lo sviluppo» spinge lo Stato (con la Chiesa cattolico-romana - e il Mercato, in una vecchia e diabolica alleanza) ad avanzare la pretesa di padre surrogato che si garantisce il controllo sui figli a venire. Se tuttavia le donne e gli uomini e le coppie che si sentono responsabili degli embrioni residui dichiarassero quale destino pare loro preferibile, se un’improbabile adozione, la distruzione o la donazione alla ricerca scientifica, con la clausola che in nessun modo siano scambiati per denaro o ne derivi un profitto, la vita tornerebbe rivendicata alle relazioni umane piuttosto che al controllo delle leggi, ne avrebbe slancio la presa di coscienza dei vincoli che le tecnologie riproduttive impongono e più consenso la difesa della “libertà” di generare.
 Federico La Sala
Federico La SalaHo molto apprezzato la citazione di Valverde soprattutto per un motivo: perché dimostra, con grande chiarezza il modo timido e spaventato con cui da sempre gli uomini di scienza si sono accostati al tema della procreazione. Il problema di quello che era un tempo “l’anima” dell’essere umano, la sua parte più preziosa e più peculiare, quella cui le religioni affidavano il senso della memoria e dell’immortalità è stata sempre monopolio, infatti, dei filosofi e dei teologi che hanno difeso accanitamente le loro teorie (i loro “pregiudizi”: nel senso letterale del termine, di giudizi dati prima, cioè, del momento in cui si sa come stanno le cose) dalle conquiste della scienza. Arrendendosi solo nel momento in cui le verità scientifiche erano troppo evidenti per essere ancora negate e dimenticando in fretta, terribilmente in fretta, i giudizi morali e gli anatemi lanciati fino ad un momento prima della loro resa. Proponendo uno spaccato estremamente interessante del modo in cui il bisogno di credere in una certa verità può spingere, per un certo tempo, a non vedere i fatti che la contraddicono. Come per primo ha dimostrato, scientificamente, Freud.
Ragionevolmente tutto questo si applica, mi pare, alle teorie fra il filosofico e il teologico (come origine: i filosofi e teologi “seri” non entrano in polemiche di questo livello) per cui l’essere umano è tale, e tale compiutamente, dal momento del concepimento. Parlando di diritti dell’embrione tutta una catena ormai di personaggi più o meno qualificati per farlo (da Buttiglione a Schifani, da Ruini a La Russa) si riempiono ormai la bocca di proclami (sulla loro, esibita, profonda, celestiale moralità) e di anatemi (nei confronti dei materialistici biechi di una sinistra senza Dio e senza anima).
In nome dell’embrione sentito come una creatura umana, la cui vita va tutelata, con costi non trascurabili, anche se nessuno accetterà mai di impiantarli in un utero. Mentre milioni di bambini continuano amorire nel mondo e intorno a loro senza destare nessun tipo di preoccupazione in chi, come loro, dovendo predisporre e votare leggi di bilancio, si preoccupa di diminuire la spesa sociale del proprio paese (condannando all’indigenza e alla mancanza di cure i bambini poveri che nascono e/o vivono in Italia) e le spese di sostegno ai piani dell’Onu (mantenendo, con freddezza e cinismo, le posizioni che la destra ha avuto da sempre sui problemi del terzo mondo e dei bambini che in esso hanno la fortuna di nascere).
Si apprende a non stupirsi di nulla, in effetti, facendo il mestiere che faccio io. Quando un paziente di quelli che si lavano continuamente e compulsivamente le mani fino a rovinarle, per esempio, ci dice (e ci dimostra con i suoi vestiti e con i suoi odori) che lava il resto del suo corpo solo quando vi è costretto da cause di forza maggiore, ci si potrebbe stupire, se non si è psichiatri, di questa evidente contraddizione. Quello che capita di capire essendolo, tuttavia, è che i due sintomi obbediscono ad una stessa logica (che è insieme aggressiva e autopunitiva) e che il primo serve di facciata, di schermo all’altro che è il più grave e il più serio. E accade a me di pensare, sentendo Buttiglione e La Russa che parlano di diritti dell’embrione e ignorando nei fatti quelli di tanti bambini già nati, che il problema sia, in fondo, lo stesso. Quello di un sintomo che ne copre un altro. Aiutando a evitare il confronto con la realtà e con i sensi di colpa. All’interno di ragionamenti che dovrebbero essere portati e discussi sul lettino dell’analista, non nelle aule parlamentari.
Così va, tuttavia, il mondo in cui viviamo. Perché quello che accomuna la Chiesa di ieri e tanta destra di oggi, in effetti, è la capacità di far germogliare il potere proprio dalle radici confuse della superficialità e del pregiudizio. Perché essere riconosciuti importanti ed essere votati, spesso, è il risultato di uno sforzo, anch’esso a suo modo assai faticoso, “di volare basso”, di accarezzare le tendenze più povere, le emozioni e i pensieri più confusi di chi non ama pensare. Parlando della necessità di uno Stato che pensi per lui, che decida al suo posto quello che è giusto e quello che non lo è. Liberandolo dal peso della ragione e del libero arbitrio. Come insegnava a Gesù, nella favola immaginata da Dostojevskji, il Grande Inquisitore quando Gesù aveva avuto l’ardire di tornare in terra per dire di nuovo agli uomini che erano uguali e liberi e rischiava di mettere in crisi, facendolo, l’autorità di una Chiesa che per 16 secoli aveva lavorato per lui e agito nel suo nome.
Del tutto inimmaginabile, sulla base di queste riflessioni, mi sembra l’idea che Buttiglione e Ruini, Schifani e La Russa possano accettare oggi l’idea da te riproposta nell’ultima parte della tua lettera per cui «le donne, gli uomini e le coppie che si sentono responsabili degli embrioni» potrebbero/ dovrebbero essere loro a decidere quale destino pare loro preferibile.
Ragionando sui fatti con persone scelte liberamente da loro perché sentite come capaci di dare loro gli elementi necessari per la decisione più corretta. Affermando l’idea per cui gli uomini, le donne e le coppie possono e debbono essere i veri protagonisti di quella procreazione responsabile che è il passaggio più alto, più difficile, più esaltante e più faticoso della vita di tutti gli esseri umani. Quella che più fa paura a tanta parte della Chiesa e della destra, in fondo, è soprattutto la libertà della coscienza critica. Per ragioni, io torno qui sul mio ragionamento iniziale, che andrebbero discusse sul lettino dell’analista, però, non nelle aule parlamentari, sui manifesti o sulle pagine di un giornale.
- LA MATEMATICA È LA COSTITUZIONE, “È una disciplina che non ammette principio di autorità giacché nessuno possiede la verità da solo, le verità sono asserzioni verificabili da chiunque, o se non da chiunque (alcune volte è difficile) almeno da un certo numero di persone. Inoltre, la matematica è un linguaggio, una grammatica. Per discutere di matematica bisogna accettarne le regole. Sicché uno studioso, ma anche uno studente di matematica, è abituato a operare in un mondo di regole comuni, per ridiscutere le quali non si può essere in uno, bisogna essere almeno in due.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- BRUXELLES. Firmata la dichiarazione sulla Conferenza sul futuro d’Europa.10 marzo 2021, di Federico La Sala
Vertici Ue firmano dichiarazione sulla Conferenza sul futuro d’Europa Sassoli, von der Leyen e Costa presenti in aula al Parlamento Ue
di Redazione ANSA - 10 marzo 2021
BRUXELLES - Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il primo ministro portoghese Antonio Costa, per il Consiglio Ue e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno firmato la dichiarazione congiunta sulla Conferenza sul futuro dell’Europa. L’atto segna l’inizio del processo che permette ai cittadini di partecipare alla ridefinizione delle politiche e delle istituzioni dell’Unione europea. I tre leader politici erano presenti in aula al parlamento europeo.
"La giornata di oggi - ha dichiarato Sassoli - segna un nuovo inizio per l’Unione europea e per tutti i suoi cittadini. Con la conferenza sul futuro dell’Europa, tutti i cittadini europei e la nostra società civile avranno l’occasione unica di plasmare il futuro dell’Europa, un progetto comune per una democrazia europea funzionante. Chiediamo a tutti voi di farvi avanti per partecipare, con le vostre opinioni, alla costruzione dell’Europa di domani, la vostra Europa".
"Oggi vogliamo invitare tutti gli europei a esprimersi", ha detto von der Leyen poco prima della firma. "Per spiegare in quale Europa vogliono vivere, per plasmarla e per unire le forze e aiutarci a costruirla", ha aggiunto. Secondo von der Leyen "le aspettative dei cittadini sono chiare: vogliono dire la loro sul futuro dell’Europa, sulle questioni che incidono sulla loro vita. La nostra promessa di oggi è altrettanto chiara: noi li ascolteremo. E poi agiremo".
"La convocazione della Conferenza sul futuro dell’Europa è un messaggio di fiducia e speranza per il futuro che inviamo gli europei". Così il premier portoghese Antonio Costa nella sua dichiarazione in aula al Parlamento europeo. "Fiducia nel fatto che riusciremo a superare la pandemia e la crisi; speranza nel fatto che, insieme, riusciremo a costruire un’Europa equa, verde e digitale", ha aggiunto Costa.
"La conferenza sul futuro dell’Europa si prefigge come obiettivo conferire ai cittadini un ruolo più incisivo nella definizione delle politiche e delle ambizioni dell’Ue, migliorando la resilienza dell’Unione alle crisi, sia economiche che sanitarie. Costituirà un nuovo spazio d’incontro pubblico per un dibattito aperto, inclusivo, trasparente e strutturato con i cittadini europei sulle questioni che li riguardano e che incidono sulla loro vita quotidiana", riferisce una nota.
La dichiarazione comune presenta un elenco non esaustivo di possibili argomenti per la conferenza: la salute, i cambiamenti climatici, l’equità sociale, la trasformazione digitale, il ruolo dell’Ue nel mondo e il rafforzamento dei processi democratici che governano l’Unione europea. Questi temi coincidono con le priorità generali dell’Ue e con le questioni sollevate dai cittadini nei sondaggi d’opinione. In ultima analisi, saranno i partecipanti a decidere quali argomenti trattare nell’ambito della conferenza.
La conferenza fa capo alle tre istituzioni che guidano l’iniziativa, rappresentate dai rispettivi presidenti che fungono da presidenza congiunta. Presto sarà istituito un comitato esecutivo che rappresenterà le tre istituzioni in modo equilibrato, con i parlamenti nazionali nel ruolo di osservatori. Il comitato esecutivo supervisionerà i lavori e preparerà le riunioni plenarie della conferenza, compresi i contributi dei cittadini e il loro follow-up.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA: 8 MARZO 2021. Il videomessaggio del premier Mario Draghi: moltissimo da fare per la parità genere.9 marzo 2021, di Federico La Sala
Draghi: c’è tanto da fare per parità di genere a livelli Ue
Il videomessaggio del premier. Mattarella alla cerimonia per l’8 marzo: uomini e donne uniti contro violenze e soprusi
di Redazione Internet (Avvenire, lunedì 8 marzo 2021)
- [Foto] Il presidente Mattarella alla cerimonia al Quirinale per l’8 marzo
Sergio Mattarella ha aperto il suo intervento per l’8 marzo leggendo una lista di nomi di donna, dodici, tutte uccise dall’inizio dell’anno. Un elenco impietoso di dati con il quale il presidente della Repubblica ha voluto ricordare al Paese quale sia ancora la situazione della violenza contro le donne e quanto sia "impressionante": -"Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due mesi del nuovo anno. Ora siamo di fronte a una dodicesima uccisione: quella di Ilenia. L’anno passato - ha precisato Mattarella - le donne assassinate sono state settantatre".
"La diffusione del Covid-19, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente le componenti più deboli ed esposte. Le donne tra queste. Dal punto di vista occupazionale anzitutto. Secondo l’Istat abbiamo 440mila lavoratrici in meno rispetto a dicembre 2020. Mentre sono a rischio un milione 300 mila posti di lavoro di donne che lavorano in settori particolarmente colpiti dalla crisi". Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, da sempre vigile e attento sul tema, che anche quest’anno ha voluto dedicare alle donne e all’8 marzo una cerimonia dalle stanze del Quirinale.
"Va acceso un faro sulle forme - meno brutali, ma non per questo meno insidiose - della cosiddetta violenza economica, che esclude le donne dalla gestione del patrimonio comune o che obbliga la donna ad abbandonare il lavoro in coincidenza di gravidanze. Pensiamo all’odioso ma diffuso fenomeno della firma delle dimissioni in bianco. Questioni gravi, che incidono profondamente sulla vita delle donne. Questioni che richiedono il coinvolgimento attivo di tutti: uomini e donne, uniti, contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, anche se larvata", ha proseguito Mattarella, in occasione della Festa della donna.
Il videomessaggio del premier Draghi: moltissimo da fare per la parità genere
"A fronte dell’esempio di molte italiane eccezionali in tutti i campi, anche nella normalità familiare, abbiamo molto, moltissimo da fare per portare il livello e la qualità della parità di genere alle medie europee. La mobilitazione delle energie femminili, un non solo simbolico riconoscimento della funzione e del talento delle donne, sono essenziali per la costruzione del futuro della nostra nazione"
"Oggi, per le vittime dei troppi femminicidi e anche come reazione prodotta dalla pandemia, sembra formarsi una nuova consapevolezza che trova un’opportunità straordinaria nel programma NextGeneration EU per diventare realtà nell’azione di governo, del mio governo. Tra i vari criteri che verranno usati per valutare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sarà anche il loro contributo alla parità di genere. È con questo spirito di fiducia nel nostro, nel vostro, futuro e con l’impegno di questo governo a conquistarsela, che vi auguro buon 8 marzo". Così il premier, Mario Draghi, in un videomessaggio alla Conferenza Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere, promossa dalla Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.
Se ogni anno l’8 marzo è la Giornata internazionale della Donna, in tempo di Covid dovrebbero esserlo ancora di più. La pandemia infatti ha peggiorato la vita delle donne che si sono trovate a gestire le difficoltà quotidiane, spesso perdendo il lavoro e che hanno subìto - se possibile - ancora più violenze, costrette tra le mura di casa.
Anche il ministero dell’Economia e delle Finanze partecipa alle iniziative della campagna #ChooseToChallenge ("Scegli di sfidare", promossa dal network di cooperazione e sensibilizzazione sui valori di parità di genere IWD (International Women’s Day), illuminando di viola (scelto quest’anno come simbolo cromatico di giustizia e dignità) la facciata del Palazzo delle Finanze in via XX Settembre per una settimana.
Anche le istituzioni europee celebreranno la giornata con due ospiti d’eccezione: la vice presidente Usa Kamala Harris e la premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern interverranno alla plenaria del Parlamento Ue tramite video-messaggi, come annunciato dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.
Le parole però si infrangono davanti ai fatti e ai numeri, come quelli evidenziati dal report della Polizia criminale che vede in aumento al 41,1% l’incidenza delle donne uccise nel 2020. "La violenza contro le donne è espressione di una cultura di potere e di subordinazione che deve essere estirpata dalle radici; una cultura che deve essere intercettata dalle prime, apparentemente piccole, manifestazioni per prevenirne tempestivamente le conseguenze più gravi", dice la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.
 A lanciare l’allarme è anche la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese che chiede alle donne vittime di violenza di denunciare subito perché "discriminazioni e violenze", prosegue la responsabile del Viminale "hanno conseguenze per l’intera società. Fino a minare le fondamenta della convivenza civile".
A lanciare l’allarme è anche la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese che chiede alle donne vittime di violenza di denunciare subito perché "discriminazioni e violenze", prosegue la responsabile del Viminale "hanno conseguenze per l’intera società. Fino a minare le fondamenta della convivenza civile".Difficile denunciare però per chi non ha neppure autonomia economica, situazione in cui le donne si trovano da troppo tempo e che la pandemia ha peggiorato. Secondo l’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop), nell’anno del Covid il 70% di tutti i posti di lavoro persi nel 2020 sono di lavoratrici e la situazione rischia di aggravarsi quando finirà il blocco dei licenziamenti previsto dal governo.
 "Nella pandemia proprio le donne, lo dicono i dati, hanno pagato un prezzo più alto", conferma la psicologa Maddalena Cialdella. "Aumento drammatico dei femminicidi nel nostro Paese; posti di lavoro persi che al 99 per cento sono quelli della componente femminile della forza produttiva. E una condizione femminile generale ancora lontana da un orizzonte di diritti pienamente riconosciuti. Credo - conclude - sia arrivato il momento, non più procrastinabile di un cambio di passo".
"Nella pandemia proprio le donne, lo dicono i dati, hanno pagato un prezzo più alto", conferma la psicologa Maddalena Cialdella. "Aumento drammatico dei femminicidi nel nostro Paese; posti di lavoro persi che al 99 per cento sono quelli della componente femminile della forza produttiva. E una condizione femminile generale ancora lontana da un orizzonte di diritti pienamente riconosciuti. Credo - conclude - sia arrivato il momento, non più procrastinabile di un cambio di passo". -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- QUALE SOVRANITA’? QUALE CITTADINANZA? "Alcuni si illudono che il concetto di sovranità sia chiaro e netto, per via del «mito fondativo» della sovranità legato alla pace di Vestfalia" (di Andrea Ruggeri).).4 marzo 2021, di Federico La Sala
Quale sovranità?
C’è chi chiede più sovranità, intendendo più autonomia di decisione, ma anche chi vorrebbe più iniziativa collettiva
di Andrea Ruggeri (Il Mulino, 04 marzo 2021)
E se fossimo tutti sovranisti? C’è chi inarcherebbe il sopracciglio al solo pensiero di essere paragonato ai sovranisti nazionalisti. Ma c’è confusione su cosa si intende per sovranità. Sia chiaro, quest’ambiguità non è né strettamente un fenomeno italiano, né di sviluppo recentissimo.
 Queste note esplorano due domande, una analitica - cosa intendiamo per sovranità? - e una critica - possiamo illuderci che una sovranità condivisa, anziché solitaria, non abbia rischi?
Queste note esplorano due domande, una analitica - cosa intendiamo per sovranità? - e una critica - possiamo illuderci che una sovranità condivisa, anziché solitaria, non abbia rischi?Boris Johnson e Donald Trump - ma anche Matteo Salvini con il suo «prima gli italiani» - sono sovranisti che sostengono che «riprendersi il controllo» del processo decisionale sia sufficiente per tornare a essere pienamente sovrani e dare forma in maniera autonoma al futuro del proprio Paese. Sovranità intesa, dunque, come mantenimento delle decisioni dentro i confini nazionali: si è sovrani, se si è indipendenti nel decidere. E poi c’è chi crede che la sovranità si debba declinare come controllo delle politiche e degli effetti delle stesse. Per loro non è centrale il luogo ove si decide, ma essere sovrani è governare la politica o almeno influenzarla. Dunque, per (ri)prendere il controllo si deve non solo partecipare, ma anche pesare, nelle organizzazioni sovranazionali e multilaterali. Macron e Draghi potrebbero dunque rappresentare coloro che interpretano la sovranità anche come condivisone della stessa.
Ma, dunque, cosa intendiamo per sovranità? Nello studio della politica internazionale il concetto di sovranità è centrale, ma la sua ambiguità è palese, non solo poiché spesso si usa il termine per descrivere azioni sia di politica interna sia di politica estera, ma anche perché alcuni pensano che la sovranità si possa unicamente delegare, mentre altri che la si possa anche condividere. Alcuni si illudono che il concetto di sovranità sia chiaro e netto, per via del «mito fondativo» della sovranità legato alla pace di Vestfalia (1648). La sovranità vestfaliana, forse all’insaputa di molti oratori, è quella più utilizzata nei discorsi pubblici e che tendiamo a etichettare frettolosamente come sovranismo. Stephen Krasner definiva questa forma di sovranità come «un assetto istituzionale per l’organizzazione della vita politica che si basa sulla territorialità e sull’autonomia. Gli Stati esistono in territori specifici. All’interno di questi territori, le autorità politiche nazionali sono gli unici arbitri del comportamento legittimo». Altre caratteristiche chiave, spesso riportate, configurano la sovranità come eguaglianza formale fra Stati e indivisibilità della stessa.
Tuttavia, tantissimi autori hanno evidenziato come eguaglianza e indivisibilità della sovranità sono sfidati quotidianamente nel campo delle relazioni internazionali. David Lake, infatti, scrive che «la sovranità è divisibile e dividerla in passato non ha portato a un’erosione inesorabile del principio». Però, Krasner ha notato come oltre al concetto vestfaliano di sovranità, vi siano almeno altri tre concetti di sovranità, prossimi ma diversi. Primo, il grado di controllo esercitato dagli enti pubblici e dall’organizzazione dell’autorità entro i confini territoriali. Se l’autorità statale non riesce a proiettare il potere centrale, non c’è sovranità. Secondo, il grado di controllo esercitato dall’autorità interna sui movimenti transfrontalieri. L’incapacità di regolare il flusso di merci, persone e idee attraverso i confini territoriali è stata descritta come una perdita di sovranità. Terzo, la sovranità intesa come diritto di alcuni attori a concludere accordi internazionali, concetto sviluppato e utilizzato principalmente dagli studiosi di diritto internazionale. Gli Stati sovrani possono stipulare trattati. Ecco un’ambiguità analitica: la sovranità può essere intesa come controllo della politica interna, ma anche come relazione esterna fra entità sovrane. Tuttavia, John Agnew, coniando il termine «la trappola territoriale», faceva giustamente notare che la politica interna, e dunque la sovranità interna, non è indipendente dalla politica esterna ed estera: ci illudiamo che i confini possano difenderci da scelte esterne e cadiamo nella fallacia di dividere nettamente tra politica interna ed estera.
Kenneth Waltz, acuto analiticamente ma con un punto di vista parziale e profondamente americano, scriveva che fra Stati sovrani «nessuno ha il diritto di comandare; nessuno deve per forza obbedire». Ma quest’eguaglianza è chiaramente solo formale. Un fatto è dirsi sovrano perché si hanno personalità giuridica e organi decisionali, un altro è essere liberi dalle scelte e dalle politiche adottate da altri Paesi. Infatti, sebbene l’istituzione della sovranità affermi il principio di non intervento negli affari di altri Stati, l’intervento è sempre stato una caratteristica degli affari internazionali. Dunque, Krasner definì la sovranità vestfaliana come un’«ipocrisia organizzata», una pratica contraddittoria dove si afferma l’inviolabilità dei confini territoriali, ma si continua a intervenire negli affari altrui. Questa sovranità ipocrita, in un mondo meno globalizzato e con alleanze internazionali ben salde, era meno problematica per Paesi come l’Italia. Oggi, invece, l’influenza e gli effetti di soggetti esteri sono più forti, soprattutto se si rimane ancorati solamente a una visione della sovranità vestfaliana.
David Lake sottolinea un’ulteriore differenza analitica importante: si può delegare sovranità a un’organizzazione internazionale, ma vi può anche essere il raggruppamento della sovranità in sede internazionale. Nel delegare sovranità alle organizzazioni internazionali, gli Stati concedono loro porzioni di sovranità per eseguire determinati compiti limitati. Mettendo in comune l’autorità - raggruppamento della sovranità - all’interno delle organizzazioni internazionali, gli Stati trasferiscono l’autorità di prendere decisioni vincolanti da se stessi a un corpo collettivo di Stati all’interno del quale possono esercitare più o meno influenza. Oggi, secondo Lake, gran parte delle preoccupazioni riguarda la messa in comune di sovranità, piuttosto che la sua delega. E aggiunge che quando si parla di Unione europea più che cedere sovranità, si raggruppa sovranità.
A scopo esplicativo, per elaborare quanto scritto sopra sul concetto di sovranità, riprendo alcuni interventi recenti nel dibattito pubblico da parte di due presidenti del consiglio: Giuseppe Conte e Mario Draghi. Nel suo discorso alla Camera per la fiducia nel giugno del 2018, Conte dichiarava: «Le forze politiche che integrano la maggioranza di governo sono state accusate di essere populiste e antisistema. Se populismo è attitudine ad ascoltare i bisogni della gente, allora lo rivendichiamo». Per Conte il nodo centrale della sovranità è dove essa risiede, nel popolo. Nel suo discorso di fronte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York nel settembre 2018, Conte, per respingere alcune accuse contro il governo giallo-verde, ribadiva l’importanza di chi detiene la sovranità: «quando qualcuno ci accusa di sovranismo e populismo amo sempre ricordare che sovranità e popolo sono richiamati dall’articolo 1 della Costituzione italiana, ed è in quella previsione che interpreto il concetto di sovranità e il suo esercizio da parte del popolo». Dimenticava, Conte, la seconda parte dell’articolo 1, «che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Dove i membri della costituente chiaramente intesero, dopo un tragico conflitto mondiale, la possibilità e necessità di poter delegare sovranità per guadagnarne in cooperazione. Conte espresse allora un sostegno al concetto di sovranità come indipendenza decisionale, focalizzandosi sull’aspetto procedurale - chi decide e dove - ma recentissimamente ha condiviso l’idea che vi sono situazione e circostanze in cui si può cedere sovranità a organizzazioni sovranazionali.
 Conte, nella sua lectio all’ateneo fiorentino del 26 febbraio 2021, sembra dunque parzialmente rivedere cosa si debba fare con la sovranità: «Abbiamo sempre più integrato i nostri sistemi economici, i nostri modelli educativi, le nostre legislazioni sociali, cedendo spazi di sovranità e trasferendo competenze via via sempre più importanti dagli Stati all’Unione». La sovranità rimane nazionale, ma parziali deleghe possono avvenire per poter affrontate sfide contemporanee. Non è dunque esplicitata una necessità di sovranità collettiva, ma un’esigenza -dato il contesto - semmai di delega.
Conte, nella sua lectio all’ateneo fiorentino del 26 febbraio 2021, sembra dunque parzialmente rivedere cosa si debba fare con la sovranità: «Abbiamo sempre più integrato i nostri sistemi economici, i nostri modelli educativi, le nostre legislazioni sociali, cedendo spazi di sovranità e trasferendo competenze via via sempre più importanti dagli Stati all’Unione». La sovranità rimane nazionale, ma parziali deleghe possono avvenire per poter affrontate sfide contemporanee. Non è dunque esplicitata una necessità di sovranità collettiva, ma un’esigenza -dato il contesto - semmai di delega.Draghi, invece, è tetragono sul valore di una sovranità condivisa, o, come Lake direbbe, di «raggruppamento della sovranità», che si concentra di più sul risultato delle politiche, anziché sul processo decisionale. Draghi, nel suo discorso a Bologna nel 2019 per il conferimento di una laurea ad honorem, così definiva chiaramente la sua idea di sovranità: «La vera sovranità si riflette non nel potere di fare leggi - come vorrebbe una definizione giuridica - ma nella capacità di controllare i risultati e rispondere ai bisogni fondamentali delle persone. [...] La capacità di prendere decisioni indipendenti non garantisce ai Paesi tale controllo. In altre parole, l’indipendenza non garantisce la sovranità».
 Ed ecco che il passaggio succinto sulla sovranità nel suo discorso per la fiducia del suo esecutivo, forse in questo contesto può guadagnare ulteriore chiarezza: «Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa [...] Non c’è sovranità nella solitudine. C’è solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere».
Ed ecco che il passaggio succinto sulla sovranità nel suo discorso per la fiducia del suo esecutivo, forse in questo contesto può guadagnare ulteriore chiarezza: «Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa [...] Non c’è sovranità nella solitudine. C’è solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere».Sembra chiaro che il vulnus stia nel credere che «riprendere il controllo» e poter decidere indipendentemente si traducano nel poter plasmare il proprio futuro. In questo caso la sovranità viene declinata essenzialmente come processo decisionale, interno ai confini nazionali, anziché come effetto delle decisioni stesse. Ci si illude che potendo dire quel che si vorrebbe fare od ottenere - senza confrontarsi con altri - porti a fare e ottenere ciò che si vuole. Oggi, un’Italia che mirasse a una sovranità solitaria, in realtà non sarebbe sovrana perché sarebbe alla mercé della potenza egemone di turno. Oggi gli Stati Uniti, domani forse la Cina.
Se un sovranismo vestfaliano, di stampo indipendentista o nazionalista, è solamente frutto di un’ambiguità analitica o di un malinteso storico - o al massimo di una miopia retorica e strumentale- possiamo illuderci che una sovranità condivisa, anziché solitaria, non abbia rischi? L’interdipendenza economica di oggi è una realtà consolidata e le sfide globali, dal terrorismo transnazionale alle pandemie globali, fino al cambiamento climatico, non possono essere risolte dai singoli Paesi. Dunque, si può puntare al rafforzamento della sovranità - intesa come capacità di controllare i risultati - raggruppando autorità e risorse in organizzazioni sovranazionali, in primis, come l’Unione europea.
Tuttavia, anche in questo caso si rischia di cadere in una fallacia sovranista, ma di delega. La politica e dunque l’importanza della sovranità, è decidere «chi ottiene cosa, quando e come», come sosteneva Harold Lasswell. E dunque mettere insieme risorse per affrontare un’arena internazionale sempre più complessa e attori sempre più competitivi non può giustificare una delega in bianco, senza sviluppare al contempo e ulteriormente istituzioni e strumenti di controllo e partecipazione da parte della cittadinanza. Ma devono essere chiari ai cittadini quali benefici e politiche si potranno guadagnare e perseguire attraverso questa sovranità condivisa. E i benefici ottenuti dovranno essere diffusi e condivisi. La questione centrale non è dunque essere per il sovranismo o essere contro di esso, ma quale sovranità si vuole ottenere e come gestirla collettivamente, non solo in Europa, ma anche in qualità di cittadini.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Amazzonia. Il Covid ha ucciso il popolo Juma (di Lucia Capuzzi).21 febbraio 2021, di Federico La Sala
Amazzonia.
Il Covid ha ucciso il popolo Juma
di Lucia Capuzzi (Avvenire, sabato 20 febbraio 2021)
Morto in Brasile Aruká, l’ultimo rappresentante maschio, sopravvissuto alle invasioni dei signori del caucciù. Appello di Repam per le vaccinazioni nella regione
- [Foto] Aruká Juma è morto all’ospedale di Porto Velho - © Gabriel Uchida
Ha combattuto la sua ultima battaglia in un letto del reparto di terapia intensiva di Porto Velho. Per settimane ha resistito agli attacchi del virus. Poi, mercoledì, i suoi polmoni hanno ceduto. E Aruká Juma, tra gli 86 e i 90 anni, s’è aggiunto alla tragica lista delle quasi 245mila vittime brasiliane. Di queste, 970 sono indigeni amazzonici. Come Aruká.
 Un numero piccolo, per quando i nativi siamo un milione su una popolazione totale di 210 milioni. Almeno in apparenza. In realtà, è proprio la scomparsa di Aruká a svelarci l’enormità della tragedia che si abbatte sugli indios dell’Amazzonia. Insieme a lui potrebbe morire la cultura, storia, tradizione del popolo Juma, di cui era l’ultimo rappresentante maschio. Le tre figlie, in teoria, non possono trasmettere la memoria ancestrale perché la cultura Juma è patrilineare. La primogenita, Borehá, però, è intenzionata a provarci. -Così pure le sorelle. Fedeli al sogno di Aruká che i loro figli fossero un ponte tra la cultura Juma e quella Uru-eu-wau-wau dei loro padri. In tal senso, l’insegnamento del nonno - riconosciuto come amoé, saggio - era fondamentale.
Un numero piccolo, per quando i nativi siamo un milione su una popolazione totale di 210 milioni. Almeno in apparenza. In realtà, è proprio la scomparsa di Aruká a svelarci l’enormità della tragedia che si abbatte sugli indios dell’Amazzonia. Insieme a lui potrebbe morire la cultura, storia, tradizione del popolo Juma, di cui era l’ultimo rappresentante maschio. Le tre figlie, in teoria, non possono trasmettere la memoria ancestrale perché la cultura Juma è patrilineare. La primogenita, Borehá, però, è intenzionata a provarci. -Così pure le sorelle. Fedeli al sogno di Aruká che i loro figli fossero un ponte tra la cultura Juma e quella Uru-eu-wau-wau dei loro padri. In tal senso, l’insegnamento del nonno - riconosciuto come amoé, saggio - era fondamentale.Il Covid, dunque, ha potrebbe aver ucciso un popolo. Una "nazione ribelle" capace di resistere alle brutali invasioni dei "signori del caucciù" che catturavano e schiavizzavano gli indios nella raccolta della gomma naturale. I Juma hanno pagato cara la loro resistenza: nel XVIII secolo erano tra i 12mila e i 15mila. Duecento anni dopo ne rimanevano poche decine.
L’incursione più recente risale agli anni Sessanta del Novecento: Aruká l’ha sperimentata sulla propria pelle: ha visto morire una sessantina tra amici e familiari, cacciati come scimmie. Alla fine degli anni Novanta restavano sei superstiti: Aruká, le tre figlie, una coppia di parenti. Le autorità li hanno obbligati a trasferirsi, contro la loro volontà, nel territorio uru-eu-wau-wau. Sono potuti tornare nel 2004 quando, come previsto dalla Costituzione, il governo ha riconosciuto ai Juma il diritto ai 38mila ettari di terra che abitano da tempo immemorabile.
Aruká, insieme alle figlie, ai loro mariti e ai nipoti, ha cercato di ricostruire la comunità.
Fino a quando il Covid non l’ha stroncato. «La sua tragica scomparsa, come quella di migliaia di altri indigeni vittime della pandemia, non è semplicemente frutto di negligenza: è parte delle politiche genocide di Bolsonaro verso i primi popoli del Brasile», ha commentato su Twitter, Survival International Italia, in prima linea nella difesa dei nativi.
Di fronte all’allarmante diffusione della pandemia tra i nativi amazzonici, la Rete ecclesiale panamazzonica (Repam) ha rivolto un appello urgente a una vaccinazione in massa degli abitanti della regione. «Ancora una volta, le carenze del sistema sanitario sono apparse in tutta la loro evidenza, aggravando la pandemia: mancanza di letti negli ospedali, povertà e diseguaglianza», si legge nell’appello di Repam che ha registrato oltre 2 milioni di casi e più di 50mila morti (tra indigeni e non indigeni). Un quinto dei contagi e un quarto dei decessi sono avvenuti negli ultimi due mesi.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- CON "ATENE", AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE DI "PERICLE IL POPULISTA" E DI PLATONE.2 febbraio 2021, di Federico La Sala
AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE DI "PERICLE IL POPULISTA" E DI PLATONE...
- TUCIDIDE E LA GUERRA CONTRO I "POETI": "[...] non abbiamo bisogno di alcun Omero che canti la nostra gloria né di chi con le sue parole procurerà un diletto immediato, dando però un’interpretazione dei fatti che non potrà reggere quando la verità si affermerà: con la nostra audacia abbiamo costretto il mare e la terra interi ad aprirci le loro vie, e ovunque abbiamo innalzato alle nostre imprese, siano state esse sfortunate o coronate da successo, monumenti che non periranno. Ed è per una tale città che questi uomini hanno affrontato amabilmente la morte in combattimento [...]" (Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 41, Bari, Laterza 1986).
PER NON CADERE (di nuovo e ancora, dopo millenni) NELLA TRAPPOLA DELLA TRACOTANZA E DELLA MALAFEDE DI "PERICLE", E NON DIMENTICARE CHE LA SUA LINEA POLITICA SEGNA L’INIZIO DELLA FINE DELLA GLORIA E DEL PROGETTO POLITICO DI ATENE, forse, è opportuno - ricordando la messa al bando di Omero e dei "poeti" dalla "Repubblica" di Platone - riprendere e rivedere (non solo i lavori di Eric A. Havelock, ma anche) la brillante analisi del cosiddetto "Elogio di Atene" da parte di Umberto Eco nella sua nota sul "Pericle il populista" di ieri e di oggi (la Repubblica, 14 gennaio 2012):
- "Il discorso di Pericle (riportato da Tucidide, in Guerra del Peloponneso) è stato inteso nei secoli come un elogio della democrazia, e in prima istanza è una descrizione superba di come una nazione possa vivere garantendo la felicità dei propri concittadini, lo scambio delle idee, la libera deliberazione delle leggi, il rispetto delle arti e dell’educazione, la tensione verso l’uguaglianza. Ma che dice in realtà Pericle?";
e, al contempo, volendo, rimeditare la storica lezione di Giambattista Vico sulla questione "Omero" e riflettere sulla sua proposta di una "Scienza Nuova", al di là dell’imbalsamazione crociana.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- PIANETA TERRA. “La sovranità oltre lo Stato”. Intervista a Enzo Cannizzaro (di Red. "Letture")22 gennaio 2021, di Federico La Sala
Intervista
“La sovranità oltre lo Stato” di Enzo Cannizzaro *
Prof. Enzo Cannizzaro, Lei è autore del libro La sovranità oltre lo Stato edito dal Mulino: quali forme assume il dibattito contemporaneo sul concetto di «sovranità»?
Il dibattito sulla sovranità è polarizzato fra la prospettiva del ritorno allo Stato sovrano e le tendenze utopiche di uno Stato mondiale.
La prima tendenza si nutre dell’idea che la comunità nazionale, il popolo, debba riprendere in mano il proprio destino, sottrattogli da procedure decisionali tecnocratiche, prese in luoghi remoti e inaccessibili all’uomo della strada, prive di legittimazione democratica. Pur se, talvolta animate dal genuino intento di ripristinare i processi democratici, tali tendenze appaiono però antistoriche, alla luce dei processi di internazionalizzazione sul piano economico e sociale.
La seconda tendenza, che prospetta la necessità di un governo sovranazionale, se non addirittura mondiale, pecca di astrattismo e di elitismo, e non considera la forte coesione delle comunità nazionali, che condividono valori, tradizioni e modelli di vita.
Quali trasformazioni ha subito la sovranità?
Dalle sue origini, la sovranità è mutata radicalmente nel corso della storia. Sorta inizialmente per fornire legittimazione all’assolutismo regio, essa si è via via adeguata all’evoluzione del costume sociale e delle forme della politica.
La sovranità ha prestato una dottrina politica alle forme di Stato e ai regimi più diversi: alle monarchie costituzionali e ai rivoluzionali borghesi e poi socialisti, ai regimi liberali ai moderni regimi costituzionali, dai regimi democratici a quelli totalitari del Novecento. A questa trasformazione “politica” ha corrisposto una sorta di rarefazione della sovranità. Inizialmente identificata con la persona del sovrano, la sovranità è stata via via identificata nel popolo, nell’ordinamento giuridico, nel potere costituente, fino ad essere identificata come la forma di garanzia esterna all’ordinamento giuridico e politico della comunità.
Eppure, paradossalmente, la sovranità è rimasta eguale a sé stessa. Ancora oggi, la sovranità si esprime, come ai tempi di Hobbes, nel potere assoluto di una comunità di darsi un ordinamento giuridico e politico. Questa assolutezza affascina e atterrisce al tempo stesso. Può esservi, nelle nostre società democratiche, un potere assoluto, non legittimato e non regolamentato che da sé stesso?
Qual è l’impatto dei processi di internazionalizzazione sullo Stato sovrano?
Dire che i processi di internalizzazione premono sullo Stato ed evidenziano l’insufficienza del potere di governo dello Stato sovrano appare un luogo comune. Tuttavia, i luoghi comuni corrispondono spesso alla realtà. Oggi appare illusorio pensare di poter governare i fenomeni economici e sociali attraverso i meccanismi dello Stato sovrano. Nessun Stato, per quanto potente, può agire da solo nel disordine del mondo.
Occorre tuttavia identificare più precisamente cosa si intenda per “processi di internazionalizzazione”. Questa formula è sovente intesa in senso deteriore, come i processi economici e finanziari che, attraverso le libertà di circolazione, sfuggono agli Stati, creando forme di ricchezza sottratte ai sistemi fiscali e redistributivi nazionali. A propria volta, tali processi creano una comunità di individui che se ne avvalgono e costituiscono una sorta di comunità transnazionale ed elitaria che gode di separata da quelle nazionali e privilegiata.
Questa descrizione risponde a verità. Accanto ad essa, tuttavia, ve ne è un’altra, di segno molto diverso. Essa è data proprio dalla esistenza di masse di individui spinte fuori dalla concentrazione di potere e di ricchezza degli Stati nazionali, che si muovono per sfuggire a guerre, carestie, devastazione degli ambienti tradizionali di vita.
Or bene, l’una e l’altra di queste forme di internazionalizzazione premono contro i confini, fisici e giuridici, dello Stato nazionale; l’una e l’altra esprimono il bisogno di un governo dei fenomeni sociali che vada ben oltre lo Stato sovrano; l’una e l’altra - o, per meglio dire, le une e le altre - costituiscono comunità embrionali, in cerca di forme di organizzazione politiche oltre la sovranità.
Come si esprime la sovranità fuori dallo Stato?
La sovranità fuori dallo Stato si è espressa, finora, in forme di organizzazioni internazionali la quali hanno stabilito forme parziali di governo, a livello globale o a livello continentale. L’esempio migliore su base mondiale è dato dalle Nazioni Unite; quello su base continentale è dato dall’Unione europea.
Si tratta di modelli ben diversi. Le Nazioni Unite sono state istituite per sottrarre l’uso della forza agli Stati e per stabilire una forma di amministrazione centralizzata della forza. Con le debite proporzionali, si tratta di quel che ha fatto, con successo, lo Stato sovrano il quale si è gradualmente affermato come il monopolista dell’uso della forza entro i propri confini. Le Nazioni Unite, quindi, si sono proposte un obiettivo ambizioso: quello di sottrarre agli Stati la prerogativa principale della sovranità. In una espressione colorita, hanno teso ad abolire la guerra.
Di converso, l’Unione europea si è posta l’obiettivo esattamente opposto: quello di governare i fenomeni economici e sociali, lasciando, per lo meno formalmente, le prerogative della sovranità in capo agli Stati, nella convinzione che, una volta attuata l’integrazione dei popoli europei, le prerogative sovrane sarebbero spontaneamente venute meno.
Ambedue questi progetti di “esternalizzazione” sono sostanzialmente falliti. Il motivo di questo fallimento appare, paradossalmente, analogo. Esso risiede nel fatto che gli Stati si sono impadroniti delle procedure decisionali delle due organizzazioni, piegandole alle proprie logiche di potere. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Ambedue le organizzazioni sono incapaci di affermare un indirizzo politico se non su impulso degli Stati. Ambedue sollevano aspettative di una forma di governo di una comunità transnazionale, le quali sovente, rimangono irrealizzate.
Che rapporti hanno i diversi modelli di organizzazione politica «oltre lo Stato» con il principio di democrazia?
Il rapporto fra sovranità e democrazia e ambivalente. Nonostante il nobile tentativo di “idealizzare” la sovranità come garante della democrazia e dei diritti dell’uomo, la sovranità non ha bisogno della democrazia. Essa, anzi, ha prosperato - ed esprime le sue potenzialità più perverse - proprio in assenza di democrazia. D’altronde, la storia dimostra che i valori più nobili dell’età moderna, la democrazia e il costituzionalismo, non sono, di per sé, un antidoto alle derive illiberali del potere sovrano.
Tuttavia, oggi possiamo percepire, pur fra molte difficoltà, l’esistenza di una democrazia “oltre lo Stato”. Ciò è possibile proprio in virtù del tramonto dell’idea di comunità quale insieme di individui legati da vincoli etnici, religiosi o culturali, che distinguono una comunità da tutte le altre. Oggi sappiamo che esistono comunità parziali, legate da valori, interessi e da modelli di vita che non hanno la valenza totalizzante ed escludente che caratterizza la comunità chiusa, come immaginavano i primi teorici della sovranità. E queste comunità parziali hanno sviluppato, se pur ancora solo embrionalmente, forme di democrazia transnazionali, che filtrano la legittimazione democratica della propria comunità di riferimento al di là dello Stato sovrano.
Ma gli Stati - monopolisti della democrazia come lo erano dell’uso della forza - guardano a queste nuove forme di organizzazione con grande diffidenza. Lo Stato, sovrano democratico verso l’interno, tende a porsi come l’unico garante della democrazia e della legittimazione politica nell’ambito delle forme transnazionali di governo. In altri termini, la sovranità statale si esternalizza nell’ambito delle dinamiche politiche al di fuori di esso.
La sfida per la democrazia, quindi, è la sfida per l’affermazione di forme di legittimazione e di democrazia fuori dallo Stato. È una sfida difficile, dato che ancora oggi gli Stati sono gli attori “forti” nel panorama delle relazioni internazionali. Ma questa è la sfida che la storia ci propone: Le forme di governo fuori dallo Stato potranno rappresentare una alternativa alla sovranità solo a condizione che esse si dota di una dottrina della democrazia e della legittimazione politica transnazionale.
Quale futuro per la sovranità?
La sovranità non è destinata a sparire. Non vi sono le condizioni affinché ciò avvenga. Non, certamente, in un arco prevedibile di tempo. Se un mondo senza sovranità è difficilmente immaginabile, è però altrettanto difficile immaginare che la sovranità possa per sempre occupare l’orizzonte politico dell’umanità.
La pretesa di governare attraverso la sovranità un mondo sempre più complesso, sempre più interdipendente e sempre più ingiusto, appare illusoria. Piuttosto che inseguire l’impossibile restaurazione dello Stato sovrano conviene quindi volgere l’attenzione verso la costruzione di nuovi modelli di legittimazione e democrazia nelle comunità transnazionali, capaci di governare i fenomeni che sfuggono alla capacità dello Stato sovrano e di incanalare le esigenze di giustizia sociale che emergono a livello globale.
Se le tendenze storiche non ingannano, tuttavia, si può pensare che la sovranità sia destinata a perdere le prerogative di esclusività e di assolutezza che l’hanno caratterizzata fino ad ora. E, con esse, lo Stato sovrano sarà privato della pretesa di esaurire al proprio interno le dinamiche politiche di una comunità composita ed eterogenea. Esso non sarà più il monopolista delle istanze di legittimazione e di democrazia. Né esso sarà l’unico garante degli equilibri sociali. Allo Stato sovrano si dovranno affiancare, in una sorta di poliarchia globale, forme di organizzazione rappresentative di valori e di interessi di una comunità transnazionale e dotate delle competenze parziali necessarie a soddisfarli.
Enzo Cannizzaro è professore ordinario di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea presso l’Università Sapienza di Roma. Ha insegnato in qualità di visiting professor in varie Università europee e negli Stati Uniti. Dirige la rivista European Papers. A Journal on Law and Integration; è membro dei Comitati direttivi delle riviste European Journal of International Law, Rivista di diritto internazionale, Il diritto dell’Unione europea. Collabora frequentemente con la stampa periodica su questioni giuridiche e di politica internazionale.
* Fonte: Letture. org
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" --- “La prima legge dell’ecologia: ogni cosa è connessa con qualsiasi altra” (Barry Commoner, 1972)..22 dicembre 2020, di Federico La Sala
Una guerra contro la vita
di Paolo Cacciari *
- Le attività umane hanno trasformato tre quarti degli ambienti naturali terrestri. La pandemia è una conseguenza della guerra contro la vita. «Dovrebbe essere tutto chiaro su come l’umanità che ha un’impronta ecologica superiore alla media dovrebbe comportarsi: ritrarsi in buon ordine quel tanto che basta a lasciare campo libero alla natura affinché possa rigenerarsi, e noi con lei; riconoscere umilmente la nostra dipendenza dai sistemi naturali e rispettare le soglie insuperabili dei confini planetari...». E invece siamo convinti che la soluzione dei nostri guai non potrà venire che dalla tecnoscienza. Una volta George Bush senior ha detto che «il tenore di vita degli americani non è negoziabile». Aveva ragione lui. «In molti preferiscono vivere con la mascherina piuttosto che rinunciare allo shopping di Natale...» Tratta da unsplash.com
Tutti si sono ipocriticamente indignati di quel poveretto Domenico Guzzini, industriale da Macerata, che considera “qualche morto in più” un prezzo da pagare per fare andare avanti l’economia. Come se non si sapesse che è proprio il rischio (Ulrich Beck, La società del rischio, 1986) le regola aurea del meccanismo della crescita economica. In suo nome mettiamo in pericolo sistematicamente e quotidianamente le vite nostre e altrui, al lavoro, nelle strade, in casa nell’alimentazione. Il rischio è quotato in borsa attraverso le società di assicurazione e di riassicurazione. Anche le catastrofi hanno un prezzo e un costo.
 Razmig Keucheyan (La natura è un campo di battaglia, 2014, Ombre corte) ci faceva notare che “le recenti pandemie influenzali, suina (2009) e aviaria (dal 2003), hanno portato all’emissione di obbligazioni catastrofiche, che coprono gli assicuratori in casi di forte mortalità”. Pagare i premi conviene piuttosto che prevenire ed evitare i danni. Predisporre piani pandemici - ci hanno spiegato - costava troppo. Così la ricerca sui vaccini Sars.
Razmig Keucheyan (La natura è un campo di battaglia, 2014, Ombre corte) ci faceva notare che “le recenti pandemie influenzali, suina (2009) e aviaria (dal 2003), hanno portato all’emissione di obbligazioni catastrofiche, che coprono gli assicuratori in casi di forte mortalità”. Pagare i premi conviene piuttosto che prevenire ed evitare i danni. Predisporre piani pandemici - ci hanno spiegato - costava troppo. Così la ricerca sui vaccini Sars.Ma nessuno si indigna se a giocare sulla nostra pelle sono Goldman Sachs, Credit Suisse, Axa Investment. I Cat (catastrophe) Bond sono regolarmente valutati da agenzie di rating come la Standard and Poor’s, Fich e Mody’s. Titoli che probabilmente sono stati infilati nel portafoglio del nostro fondo pensionistico integrativo o in qualche altro prodotto finanziario confezionato dalla nostra banca. E allora perché prendersela col minus sapiens Guzzini se dice quello che nell’anonimato del capitalismo della “mano invisibile” è una prassi generale del sistema? È solo una questione di “percezione”, non scomodiamo i principi etici. L’accettazione psicologica della soglia di rischio, come si sa, è molto elastica, manipolabile dalle circostanze e dalle compensazioni. Lasciamo quindi perdere, per piacere, la morale. Chiediamoci piuttosto da dove viene il suo adombramento.
Mario Pezzella, in un recente seminario nella sua università a Pisa, ci invita a riscoprire Ernesto De Martino (La fine del mondo, 1977). Non ci accorgiamo della catastrofe ecologica, perché viviamo una “apocalisse culturale”. Abbiamo perduto la percezione del reale perché si è sgretolato attorno a noi l’ordine simbolico abituale. Abbiamo perso i punti di riferimento etici, oltre che le relazioni solidali interpersonali. L’umano si è perduto nel tecnico e nell’economico. Siamo convinti che la soluzione dei nostri guai non potrà venire che dalla tecnoscienza. In attesa dei prossimi mirabolanti risultati (il vaccino, l’energia pulita, l’economia circolare, la quarta rivoluzione digitale...) dobbiamo alimentare la ricerca e depositare tanti più brevetti possibili, lavorare e produrre sempre di più. Con qualche danno collaterale “inevitabile”. L’esempio, del resto, lo dà il governo nostrano emettendo il bonus accreditato automaticamente sullo smatphone per chi spenderà di più allo shopping natalizio. Non basta, ci sarà anche l’estrazione a premi. Ludopatia di stato.
Non ci sono altre spiegazioni. È da una vita, da Primavera silenziosa di Rachel Carson (1962), almeno, che una schiera di scienziati di ogni campo - come Cassandre - ci mostrano i segni della catastrofe ecologica. È stato scritto un Calendario della fine del mondo (un volume di Pacilli, Pizzo, Sullo, Intra Moenia, 2011) che scandisce il biocidio in corso. Ma ci eravamo sbagliati. Pensavamo che il pericolo principalmente venisse dall’alto, dal Sole che surriscalda una atmosfera intossicata dai gas sprigionati dalla combustione di carburanti fossili. Invece la nostra morte è venuta dall’interno del corpo vivo della Terra e nostro.
Virus e batteri sono i precursori e i supporti di ogni forma di vita. Il virologo Guido Silvestri (Il virus buono, Rizzoli, 2019) ci spiega che “viviamo tutti, letteralmente, dentro un mare di virus”. Gianfranco Bologna (Il grande insegnamento della natura indica cosa fare dopo la pandemia) ricorda i risultati delle ultime ricerche: in un corpo umano di 70 chilogrammi vi sono 38 mila miliardi di cellule batteriche e 30 mila miliardi di cellule umane. Nei mari la massa dei virus è dieci volte quella dei batteri. Ogni forma di vita è in simbiosi con i cicli biogeofisici della Terra.
Ha scritto Vandana Shiva (Il programma mondiale di Bill Gates e come possiamo resistere alla sua guerra contro la vita, mondalisation.org):
- “In realtà la pandemia non è una guerra. La pandemia è una conseguenza della guerra. Una guerra contro la vita”.
Le attività umane hanno trasformato il 75% degli ambienti naturali terrestri e il 66% degli ecosistemi marini. L’impatto antropico (estrazione di risorse non rinnovabili ed immissione di scarti non metabolizzabili) supera la carring capacity del sistema Terra. Scrisse Barry Commoner (Il cerchio da chiudere, 1972): “La prima legge dell’ecologia: ogni cosa è connessa con qualsiasi altra”.
 Un programma del 2019 della agenzia ambientale delle Nazioni Unite è titolato Healthy planet, healthy people (2019). Da ultimo papa Bergoglio, a Pasqua nella Piazza San Pietro deserta, ha detto: “Non illudiamoci di poter vivere in salute in un pianeta malato”. Scienziati e profeti parlano la stessa lingua.
Un programma del 2019 della agenzia ambientale delle Nazioni Unite è titolato Healthy planet, healthy people (2019). Da ultimo papa Bergoglio, a Pasqua nella Piazza San Pietro deserta, ha detto: “Non illudiamoci di poter vivere in salute in un pianeta malato”. Scienziati e profeti parlano la stessa lingua.Dovrebbe quindi essere tutto chiaro su come l’umanità che ha un’impronta ecologica superiore alla media dovrebbe comportarsi: ritrarsi in buon ordine quel tanto che basta a lasciare campo libero alla natura affinché possa rigenerarsi, e noi con lei; riconoscere umilmente la nostra dipendenza dai sistemi naturali e rispettare le soglie insuperabili dei confini planetari (Planetary Boundaries, Johan Rockström); vivere con ciò che si ha a disposizione, senza sottrarlo ad altri e senza negarlo a chi verrà dopo di noi. Questo dovrebbe essere l’insegnamento che viene dalla sindemia da Covid-SARS-2. Chi ce lo impedisce?
Una volta il presidente ultraliberista George Bush senior (1989) affermò che “il tenore di vita degli americani non è negoziabile”. Aveva ragione lui. In molti preferiscono vivere con la mascherina piuttosto che rinunciare allo shopping di Natale. Del resto non saprebbero come occupare altrimenti il loro tempo.
* Fonte: Comune-info, 18 Dicembre 2020 (ripresa parziale).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA: DANTE, LORENZO VALLA, E UNA "GALLERIA DI PAPI".11 novembre 2020, di Federico La Sala
UNA "GALLERIA DI PAPI", LA "DONAZIONE DI COSTANTINO", E "IL GRANDE ROMANZO DEI PAPI" ... *
“Il grande romanzo dei papi. La storia della Santa Sede attraverso le vite dei successori di san Pietro” di Riccardo Ferrigato. Intervista ...
di Letture*
Dott. Riccardo Ferrigato, Lei è autore del libro Il grande romanzo dei papi. La storia della Santa Sede attraverso le vite dei successori di san Pietro edito da Newton Compton: in che modo la storia dell’umanità si è intrecciata con quella millenaria di una delle più influenti istituzioni che l’umanità abbia creato, il papato?
Il grande romanzo dei papi. La storia della Santa Sede attraverso le vite dei successori di san Pietro, Riccardo FerrigatoFare riferimento alla “storia dell’umanità” è forse eccessivo, ma di certo il papato è stato elemento di notevole influenza per la storia europea e, in maniera più limitata e differenziata, per quella di alcune aree extraeuropee in cui il cattolicesimo ha avuto una significativa diffusione. In che modo lo ha fatto? Secondo registri completamente differenti, cioè mutando, modificandosi, adeguandosi ai tempi: non credo sia possibile che un’istituzione sopravviva altrimenti per un così lungo periodo.
Il vescovo di Roma ha maturato nei secoli, per gradi, un ruolo preminente all’interno della Chiesa - ruolo che, almeno nel primo millennio della sua storia, era tutt’altro che incontestato - e contemporaneamente ha giocato un ruolo politico in continuo divenire, con fasi di crescita e altre di declino, guadagnando il proprio spazio di manovra tra imperi, regni e repubbliche. Difficile sintetizzare in poche righe la parabola di questo percorso, ma direi così: finché il potere politico di un re o un imperatore ha avuto bisogno di giustificare la propria autorità attraverso il trascendente, il papa è stato un riferimento indispensabile. Questo, in realtà, ha determinato spesso la sottomissione della cattedra di Pietro ai bisogni di questa o quella corona, ma anche la crescita, lasciando persino spazio al sogno, mai realizzato, di mettere il vicario di Cristo al vertice dell’intero occidente.
In che modo da un modesto pescatore di Galilea si è giunti a fare del vescovo di Roma un monarca?
Il pescatore di Galilea, Pietro, primo tra gli apostoli di Gesù di Nazaret, non immaginava una chiesa strutturata in maniera verticista, probabilmente non pensava a figure assimilabili a quelle dei vescovi e lontanissima da lui era l’idea di una singola persona a capo di tutti i cristiani. Da ebreo qual era, immaginava piuttosto i fedeli riuniti secondo le modalità con cui la religione del suo popolo si organizzava da sempre, in piccole comunità collegate ma indipendenti, pronte all’imminente parusia, la venuta di Gesù alla fine dei tempi. Figuriamoci se può mai aver immaginato un vescovo che diviene monarca, cioè che assume su di sé anche un potere temporale!
In estrema sintesi, questo è stato possibile grazie a tre passaggi. Il primo è stato frutto dell’azione di Costantino, che ha dato alla chiesa una struttura affine a quella del potere imperiale, affiancando alle strutture di governo civile quelle ecclesiastiche. In secondo luogo, con la caduta dell’impero romano d’Occidente, la chiesa ha rafforzato la propria funzione politica, con i vescovi, a Roma e altrove, che divennero custodi - si pensi a Leone e Gregorio Magno - dei propri territori di influenza. Infine, l’alleanza con i Franchi di Pipino il Breve: nell’VIII secolo questo sovrano in cerca di una sacra investitura (Pipino non era re per diritto di nascita) conquistò al papa i territori di quello che divenne lo Stato della Chiesa. Di fatto Pipino e Stefano II, il papa dell’epoca, si legittimarono sul trono a vicenda.
Come è stato possibile che santi e martiri abbiano condiviso il medesimo scranno dei dissoluti papi del Rinascimento?
I papi sono stati 266 e questa gran massa di uomini rappresenta un completo campionario dell’animo umano: ogni passione - ma anche ogni vizio, ogni virtù - è stata incarnata. D’altra parte la cattedra di Pietro è un luogo di potere e il potere ha un effetto determinante sugli esseri umani, ne porta alla luce e ne inasprisce i tratti dell’animo.
La maggior parte degli uomini e delle donne possono permettersi di trascorrere una vita all’insegna di una tranquilla mediocritas: né troppo buoni né troppo malvagi, non ci è richiesto di dimostrare grande coraggio o eccezionali doti. Per un sovrano è diverso: nessuna via di mezzo per chi porta la corona, egli sarà vile o temperante, magnanimo o malvagio, perché il potere nelle sue mani è determinante per la vita o la morte di comunità intere.
Nel caso specifico del pontefice, poi, la tensione tra il potere politico e quello spirituale ha determinato spesso una vera iattura. Di norma ci riferiamo ai papi dissoluti del Rinascimento come a coloro che hanno umiliato la cattedra di Pietro - concubinari, nepotisti, festaioli, rivestiti di pietre e tessuti preziosi - ma alcuni di loro, con trame e strategie raffinate, hanno salvato la Chiesa del loro tempo. Al contrario, sant’uomini e personaggi di specchiata moralità, poiché sprovvisti di astuzia politica, hanno talvolta determinato la rovina dell’istituzione di cui erano a capo. Essere insieme re e sommi sacerdoti è come essere servi di due padroni e raccapezzarcisi non è semplice. Per questo Paolo VI poté dichiarare che era stata la Divina provvidenza, nel 1870, a togliere al papa l’incombenza di una corona da sovrano.
Quali sono state le figure di pontefici che maggiormente hanno inciso sulla storia del papato? La lista sarebbe lunghissima e, alla fine, non potrebbe risultare esaustiva. Tante e tali sono le rivoluzioni in questa storia di venti secoli, e tanti i frangenti sui quali un pontefice risulta determinante, che classifiche del genere sono davvero impossibili. In tempi recenti, però, non c’è alcun dubbio: la vera rivoluzione è stata quella di Giovanni XXIII e Paolo VI, grazie al coraggio del primo - quello di inaugurare un concilio, un vero concilio, aperto alla discussione e senza esiti predeterminati - e alla tenacia del secondo, che quell’assemblea ha condotto felicemente in porto. Un esito tutt’altro che scontato. Si tratta di una vicenda esemplare di come due pastori profondamente diversi per temperamento, per estrazione sociale, per esperienze pregresse, uniti quasi solo dalle comuni radici lombarde, abbiano governato la Chiesa con stili diversi, ma siano stati capaci di guardare nella medesima direzione. Purtroppo, però, il modello di una Chiesa maggiormente assembleare si è dovuto poi scontrare con un pontificato, quello di Giovanni Paolo II, fortemente accentratore. La Chiesa è così: si muove lentamente e, anche se talvolta subisce accelerazioni improvvise, la resistenza al cambiamento - la resilienza delle sue strutture secolari - rimane uno dei suoi caratteri distintivi.
Come è destinata a cambiare nel futuro, a Suo avviso, questa istituzione?
Previsioni di questo genere sono destinate a rivelarsi sempre inaccurate e, nel caso della Chiesa cattolica, è particolarmente difficile districarsi tra le tante correnti che spingono la barca di Pietro in diverse direzioni. Inoltre, la Chiesa è una struttura gerarchica, verticista, dove ogni cambio di pontefice può generare rivolgimenti prima impensati, tanto quanto le reazioni conseguenti. Bergoglio ha dato un’impronta, in questi anni, ma nessuno garantisce che il successore vorrà seguire il suo stesso percorso.
Su almeno un punto, però, la direzione è chiara poiché si tratta di un cambiamento ormai duraturo e inarrestabile: la Chiesa sta divenendo sempre più “cattolica”, vale a dire universale. Paesi un tempo marginali oggi guadagnano di importanza; cattedre vescovili prima considerate irrilevanti oggi si fanno centrali, mentre da decenni si parla di un’Europa scristianizzata. La Chiesa, da questo punto di vista, sta mutando lentamente ma inesorabilmente e anche il papato ne risentirà. Se si vuole un metro di giudizio, basti pensare a coloro che oggi entrerebbero in un immaginario conclave. Gli arcivescovi di città come Milano o Parigi rimarrebbero nei loro palazzi, dato che non sono cardinali; lo sono invece quelli di Kigali, in Ruanda, o di Bangui nella Repubblica centrafricana. E questi sono solo alcuni dei tanti che potrei riportare.
*
Fonte: Letture.org
NOTE:
A) - [LA "GALLERIA DEI PAPI"]: CELEBRANDOSI #OGGI [10.11.2020] LA FIGURA DI PAPA #LEONEMAGNO (https://it.wikipedia.org/wiki/Incontro_di_Leone_Magno_con_Attila ), SUL FILO DELLA #MEMORIA DI #RAFFAELLO E #GIULIOII, è BENE RICORDARE DI FARE QUANTO PRIMA UNA VISITA ALLA #GALLERIADEIPAPI DI #PALAZZOALTIERI AD #ORIOLOROMANO...
B) - #Rinascimento e #filologia:"#Erasmo non ha ancora scritto il suo #Elogiodellafollia [pubblicato nel 1511], #Lutero non ha ancora affisso le sue #tesi" [rese pubbliche nel 1517], #AntonioFerrariis, il #Galateo, dona nel 1510 a #GiulioII un esemplare greco della #DonazionediCostantino.
C) - #DANTE2021 #RINASCIMENTO #OGGI. Svegliarsi dal #sonnodogmatico, accogliere l’analisi di #LorenzoValla (https://it.wikipedia.org/wiki/Donazione_di_Costantino) e l’indicazione antropologico-politica dei #DueSoli
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- MEMORIA DI UNA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO" ITALICO-ROMANO.6 novembre 2020, di Federico La Sala
UNA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO" ITALICO-ROMANO. L’antitesi Mosca e Nuova York non si supera che in un modo, con la dottrina e con la prassi di Roma: *
A) Mussolini, Discorso dell’anno IX - Roma, 27 ottobre 1930: "Oggi io affermo che il Fascismo in quanto idea, dottrina, realizzazione, è universale; italiano nei suoi particolari istituti, esso è universale nello spirito, né potrebbe essere altrimenti. -Lo spirito è universale per la sua stessa natura. Si può quindi prevedere una Europa fascista, unì Europa che ispiri le sue istituzioni alle dottrine e alla pratica del Fascismo. Una Europa cioè che risolva, in senso fascista, il problema dello Stato moderno, dello Stato del XX secolo, ben diverso dagli Stati che esistevano prima del 1789 o che si formarono dopo.
 Il Fascismo oggi risponde ad esigenze di carattere universale. Esso risolve infatti il triplice problema dei rapporti fra Stato e individuo, fra Stato e gruppi, fra gruppi e gruppi organizzati. Per questo noi sorridiamo quando dei profeti funerei contano i nostri giorni. Di questi profeti non si troverà più non solo la polvere, ma nemmeno il ricordo, e il Fascismo sarà vivo ancora. Del resto ci occorre del tempo, moltissimo tempo, per compiere l’opera nostra. Non parlo di quella materiale, ma di quella morale. Noi dobbiamo scrostare e polverizzare, nel carattere e nella mentalità degli italiani, i sedimenti depostivi da quei terribili secoli di decadenza politica, militare, morale, che vanno dal 1600 al sorgere di Napoleone. È una fatica grandiosa.
Il Fascismo oggi risponde ad esigenze di carattere universale. Esso risolve infatti il triplice problema dei rapporti fra Stato e individuo, fra Stato e gruppi, fra gruppi e gruppi organizzati. Per questo noi sorridiamo quando dei profeti funerei contano i nostri giorni. Di questi profeti non si troverà più non solo la polvere, ma nemmeno il ricordo, e il Fascismo sarà vivo ancora. Del resto ci occorre del tempo, moltissimo tempo, per compiere l’opera nostra. Non parlo di quella materiale, ma di quella morale. Noi dobbiamo scrostare e polverizzare, nel carattere e nella mentalità degli italiani, i sedimenti depostivi da quei terribili secoli di decadenza politica, militare, morale, che vanno dal 1600 al sorgere di Napoleone. È una fatica grandiosa.
 Il Risorgimento non è stato che l’inizio, poiché fu opera di troppo esigue minoranze; la guerra mondiale fu invece profondamente educativa. Si tratta ora di continuare, giorno per giorno, in questa opera di rifacimento del carattere degli italiani [...]"(Messaggio per l’Anno Nono - Roma, 27 ottobre 1930, in B. Mussolini, Opera Omnia, vol. XXIV, p. 283).
Il Risorgimento non è stato che l’inizio, poiché fu opera di troppo esigue minoranze; la guerra mondiale fu invece profondamente educativa. Si tratta ora di continuare, giorno per giorno, in questa opera di rifacimento del carattere degli italiani [...]"(Messaggio per l’Anno Nono - Roma, 27 ottobre 1930, in B. Mussolini, Opera Omnia, vol. XXIV, p. 283).B) Mussolini - Milano, Piazza Duomo, 25 ottobre 1932: "Oggi, con piena tranquillità di coscienza, dico a voi, moltitudine immensa, che questo secolo decimoventesimo darà il secolo del Fascismo. Sarà il secolo della potenza italiana. Sarà il secolo durante il quale l’Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. Perché fuori dai nostri principi, e soprattutto in tempi di crisi, non c’è salvezza né per gli individui e tanto meno per i popoli.
 Fra dieci anni - lo si può dire. Senza fare i profeti - l’Europa sarà cambiata. Non da ora si sono commesse delle ingiustizie, anche contro di noi, soprattutto contro di noi. E niente di più triste il compito che vi spetta di dover difendere quello che è stato il sacrificio magnifico di sangue di tutto il popolo italiano. [...] Tra un decennio l’Europa sarà fascista o fascistizzata!
Fra dieci anni - lo si può dire. Senza fare i profeti - l’Europa sarà cambiata. Non da ora si sono commesse delle ingiustizie, anche contro di noi, soprattutto contro di noi. E niente di più triste il compito che vi spetta di dover difendere quello che è stato il sacrificio magnifico di sangue di tutto il popolo italiano. [...] Tra un decennio l’Europa sarà fascista o fascistizzata!
 L’antitesi Mosca e Nuova York non si supera che in un modo, con la dottrina e con la prassi di Roma [...]" (B. Mussolini, Opera Omnia, XXV, pp. 147-148).
L’antitesi Mosca e Nuova York non si supera che in un modo, con la dottrina e con la prassi di Roma [...]" (B. Mussolini, Opera Omnia, XXV, pp. 147-148).* Sul tema, mi sia consentito, si cfr.:
STORIA E STORIOGRAFIA DEL FASCISMO, "UN RINATO SACRO ROMANO IMPERO" (A. GRAMSCI, 1924). IL MITO DELLA ROMANITÀ, LA MONARCHIA, E IL FASCISMO : MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- DUE SOL, IL SOGNO DI UN’EUROPA "SANAMENTE LAICA", E UNA CONTROVERSIA INFINITA. Crocifisso nelle aule scolastiche senza pace, questa volta va in Cassazione.31 ottobre 2020, di Federico La Sala
DANTE 2021: DUE SOLI. "Sogno un’Europa sanamente laica" (papa Francesco, Lettera all’Europa) *
Laicismo.
Crocifisso nelle aule scolastiche senza pace, questa volta va in Cassazione
Rimessa alla decisione delle Sezioni unite la questione sollevata dalla battaglia legale di un insegnante di lettere toscano che chiede di rimuovere il simbolo cristiano durante le sue lezioni
di Marcello Palmieri (Avvenire, sabato 31 ottobre 2020)
Crocifisso sì o crocifisso no? Il simbolo cristiano divenuto nei secoli anche immagine di "laicissimi" e condivisi valori universali, torna di nuovo nelle aule giudiziarie. Ma non sul muro: sul banco degli imputati.
A portarcelo, stavolta, è un insegnante di lettere toscano, che ha ingaggiato da anni una battaglia legale contro il proprio dirigente scolastico - e pure contro l’assemblea dei suoi studenti - per vedersi riconoscere il diritto di staccare dal muro delle aule il crocifisso durante le ore delle proprie lezioni.
La vicenda, ora, è arrivata in Cassazione. Dove la Sezione lavoro, ritenendo la causa di particolare importanza, ha deciso di rimetterla al primo presidente della Corte, perché la devolva alle Sezioni unite. Così facendo, la pronuncia avrà un grande valore: difficilmente, infatti, i giudici territoriali potranno decidere in modo difforme eventuali casi analoghi che dovessero presentarsi successivamente in Italia.
Ma, già ora, sorge una perplessità di fondo: solitamente la Cassazione decide a Sezioni unite le questioni sulle quali si era formato un contrasto giurisprudenziale. Spesso, infatti, situazioni quasi uguali vengono risolte dai giudici in modo diverso, e lo stesso accade anche tra le diverse sezioni della medesima Cassazione.
Sulla presenza del crocifisso nei luoghi pubblici, però, sembrava non esserci più alcun dubbio. Il Consiglio di Stato nel 2006 aveva stabilito che «è un simbolo idoneo a esprimere l’elevato fondamento di valori civili (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, etc...)», che hanno sì un’origine religiosa, ma che pure «delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato». Da qui, dunque, l’idea che «il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica, altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni».
E che il crocifisso potesse rimanere nelle scuole l’ha detto più di recente, nel 2011, anche la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, massima istanza della Cedu: «È un simbolo essenzialmente passivo - hanno scritto i giudici di Strasburgo, decidendo la causa intentata da Soile Lautsi, un’italiana di origini finlandesi, contro il nostro Pese - che non contrasta né con il diritto dei genitori alla libera educazione dei figli né con la libertà di pensiero, coscienza e religione. E se è vero che questa icona «dà alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico», è pur sempre una discrezionalità dello Stato - insindacabile dalla Corte europea - quello di decidere dove esporlo.
Ma ecco che l’ordinanza di remissione alle Sezioni unite della Cassazione mette in dubbio proprio questa "passività" riconosciuta dalla Cedu: «Si potrebbe dubitare dell’asserito ruolo passivo - hanno scritto i giudici della Sezione lavoro - qualora all’esposizione del simbolo si attribuisse il significato di evidenziare uno stretto collegamento fra la funzione esercitata e i valori fondanti il credo religioso che quel simbolo richiama».
Ma per Angelo Salvi, giurista del Centro Studi Livatino, questa perplessità «non sembra valorizzare l’eredità più importante del causo Lautsi, che consiste nell’individuazione del perimetro nel quale va delimitato il concetto di neutralità religiosa».
In parole povere: secondo la Cedu, lo Stato non deve astenersi da qualsiasi richiamo religioso. Semplicemente, gli viene chiesto di non offendere i diritti di ognuno in relazione al proprio credo. Cosa che, ovviamente, un crocifisso appeso al muro non può fare. Ma attenzione: diversamente - è sempre Salvi a notarlo - si rischierebbe di «virare verso un modello di laicità "rigida" alla francese, che si declina in termini di incompatibilità con la religione».
L’Italia e il crocifisso, una controversia infinita
Dall’Europa l’ultimo sì, ’la sua esposizione non lede la libertà religiosa’
di Redazione ANSA 01 ottobre 2019
ROMA L’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici - in particolare nelle scuole, nelle aule di giustizia e nei seggi elettorali - è legittima o è in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini, di libertà di religione e di laicità dello Stato? La controversa questione - che contrappone da decenni cattolici e laici - si ripropone periodicamente e torna ora di nuovo di attualità alla luce delle ultime affermazioni del ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti, il quale ha detto di ritenere l’esposizione della croce nelle aule scolastiche "una questione divisiva" e di preferire una "scuola laica", suscitando reazioni di disapprovazione da parte del mondo cattolico, favorevoli da parte degli atei e degli agnostici. Sull’argomento, l’ultima pronuncia giurisdizionale di rilievo si è avuta nel 2011 ed è stata della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo, che, accogliendo un ricorso dell’Italia, ha definitivamente ritenuto legittima l’esposizione del crocifisso, ribaltando una sentenza di segno opposto della stessa Corte europea.
 La vicenda giudiziaria, durata quasi nove anni, ebbe origine in una scuola di Abano Terme e seguì un iter complesso: IL FATTO - Il 27 maggio 2002 il Consiglio di Istituto della scuola Vittorino da Feltre di Abano Terme (Padova) respinge il ricorso della famiglia di due alunne e decide che possono essere lasciati esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi, ed in particolare il crocifisso, unico simbolo esposto.
La vicenda giudiziaria, durata quasi nove anni, ebbe origine in una scuola di Abano Terme e seguì un iter complesso: IL FATTO - Il 27 maggio 2002 il Consiglio di Istituto della scuola Vittorino da Feltre di Abano Terme (Padova) respinge il ricorso della famiglia di due alunne e decide che possono essere lasciati esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi, ed in particolare il crocifisso, unico simbolo esposto.IL RICORSO - La decisione del Consiglio di Istituto viene impugnata dalla madre delle due alunne davanti al Tar del Veneto. Nel ricorso si sostiene che la decisione del Consiglio di Istituto sarebbe in violazione del principio supremo di laicità dello Stato, che impedirebbe l’esposizione del crocifisso e di altri simboli religiosi nelle aule scolastiche, perche’ violerebbe la "parità che deve essere garantita a tutte le religioni e a tutte le credenze, anche a-religiose".
LA POSIZIONE DEL MINISTERO - Il Ministero dell’Istruzione, costituitosi nel giudizio, sottolinea che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è prevista da disposizioni regolamentari contenute in due regi decreti: uno del 1924, n. 965; l’altro del 1928, n. 1297 Tali norme, per quanto lontane nel tempo, sarebbero tuttora in vigore, come confermato dal parere reso dal Consiglio di Stato n.63 del 1988.
LA PRIMA DECISIONE DEL TAR, ATTI ALLA CONSULTA - Il Tar compie un esame delle norme regolamentari sull’esposizione del crocifisso a scuola e conclude che esse sono tuttora in vigore. Rimette, tuttavia, gli atti alla Corte costituzionale. La norma che prescrive l’obbligo di esposizione del crocifisso - scrivono i giudici - sembra delineare "una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio", che apparirebbe in contrasto con il principio di laicità dello Stato.
LA CORTE COSTITUZIONALE, RICORSO INAMMISSIBILE - La Consulta dichiara inammissibile il ricorso: le norme sull’esposizione del crocifisso a scuola sono "norme regolamentari", prive "di forza di legge" e su di esse "non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale". Gli atti tornano al Tar.
SECONDA DECISIONE TAR, CROCE NON CONTRASTA CON LAICITA’ - Il crocifisso, "inteso come simbolo di una particolare storia, cultura ed identità nazionale (...), oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità (...), può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato". Si conclude con queste parole la sentenza del 2005 con la quale il Tar rigetta il ricorso della madre della due alunne di Abano.
IL CONSIGLIO DI STATO, CROCIFISSO HA FUNZIONE EDUCATIVA - Il Consiglio di Stato chiude la parte italiana della vicenda, con il rigetto definitivo del ricorso della madre delle due alunne.
 Il crocifisso - scrivono i giudici - non va rimosso dalle aule scolastiche perché ha "una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni"; non è né solo "un oggetto di culto", ma un simbolo "idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili" - tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla sua liberta’, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione - che hanno un’origine religiosa, ma "che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato".
Il crocifisso - scrivono i giudici - non va rimosso dalle aule scolastiche perché ha "una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni"; non è né solo "un oggetto di culto", ma un simbolo "idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili" - tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla sua liberta’, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione - che hanno un’origine religiosa, ma "che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato".CORTE EUROPEA BOCCIA ITALIA, POI RIMETTE A GRANDE CAMERA - Il 3 novembre 2009 la Corte europea per i diritti dell’uomo boccia l’Italia: il crocifisso appeso nelle aule scolastiche - rileva la Corte - è violazione della liberta’ dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni. Il governo italiano ricorre e la Corte europea decide di affidare la soluzione del caso alla Grande Camera.
GRANDE CAMERA STRASBURGO ASSOLVE L’ITALIA. Con la sentenza del 18 marzo 2011 la Grande Camera ribalta il verdetto della Corte e dice definitivamente sì all’Italia, ritenendo che l’ esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e negli altri luoghi pubblici non possa essere considerato un elemento di "indottrinamento" e dunque non comporta una violazione dei diritti umani. "Le autorità - dice la Grande Camera - hanno agito nei limiti della discrezionalità di cui dispone l’Italia nel quadro dei suoi obblighi di rispettare, nell’esercizio delle funzioni che assume nell’ambito dell’educazione e dell’insegnamento, il diritto dei genitori di garantire l’istruzione conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche".
FLS
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" --- “Sogno un’Europa sanamente laica, in cui Dio e Cesare siano distinti ma non contrapposti”. Lettera di papa Francesco all’Europa.27 ottobre 2020, di Federico La Sala
Lettera all’Europa.
Il Papa: ruolo dell’Europa ancor più rilevante al tempo del Covid
Nella lettera al cardinale Parolin sulla Unione Europea: “Sogno un’Europa sanamente laica, in cui Dio e Cesare siano distinti ma non contrapposti”
di Redazione Internet (Avvenire, martedì 27 ottobre 2020)
L’Europa ha avuto e deve ancora avere "un ruolo centrale": lo sottolinea papa Francesco in una lettera al cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, in occasione di alcuni anniversari: il 40° anniversario della Commissione degli Episcopati dell’Unione Europea, il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e l’Unione Europea e il 50° anniversario della presenza della Santa Sede come Osservatore Permanente al Consiglio d’Europa.
"Tale ruolo - sottolinea il Pontefice parlando dell’Europa - diventa ancor più rilevante nel contesto di pandemia che stiamo attraversando. Il progetto europeo sorge, infatti, come volontà di porre fine alle divisioni del passato. Nasce dalla consapevolezza che insieme ed uniti si è più forti, che l’unità è superiore al conflitto e che la solidarietà può essere uno stile di costruzione della storia, un ambito vitale dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una pluriforme unità che genera nuova vita".
"Nel nostro tempo che sta dando segno di ritorno indietro, in cui sempre più prevale l’idea di fare da sé, la pandemia - dice il Papa - costituisce come uno spartiacque che costringe a operare una scelta: o si procede sulla via intrapresa nell’ultimo decennio, animata dalla tentazione all’autonomia, andando incontro a crescenti incomprensioni, contrapposizioni e conflitti; oppure si riscopre quella strada della fraternità, che ha indubbiamente ispirato e animato i Padri fondatori dell’Europa moderna, a partire proprio da Robert Schuman".
Il Papa lancia, quindi, un appello all’Europa affinché ritrovi sé stessa. "All’Europa allora vorrei dire: tu, che sei stata nei secoli fucina di ideali e ora sembri perdere il tuo slancio, non fermarti - scrive il Papa nel messaggio al Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, per condividere con lui delle riflessioni in occasione delle celebrazioni di alcuni anniversari - a guardare al tuo passato come ad un album dei ricordi. Nel tempo, anche le memorie più belle si sbiadiscono e si finisce per non ricordare più. Presto o tardi ci si accorge che i contorni del proprio volto sfumano, ci si ritrova stanchi e affaticati nel vivere il tempo presente e con poca speranza nel guardare al futuro. Senza slancio ideale ci si riscopre poi fragili e divisi e più inclini a dare sfogo al lamento e lasciarsi attrarre da chi fa del lamento e della divisione uno stile di vita personale, sociale e politico".
"Europa, ritrova te stessa! Ritrova dunque i tuoi ideali - prosegue il Papa - che hanno radici profonde. Sii te stessa!"
"Non avere paura della tua storia millenaria che è una finestra sul futuro più che sul passato. Non avere paura del tuo bisogno di verità che dall’antica Grecia ha abbracciato la terra, mettendo in luce gli interrogativi più profondi di ogni essere umano; del tuo bisogno di giustizia che si è sviluppato dal diritto romano ed è divenuto nel tempo rispetto per ogni essere umano e per i suoi diritti; del tuo bisogno di eternità, arricchito dall’incontro con la tradizione giudeo-cristiana, che si rispecchia nel tuo patrimonio di fede, di arte e di cultura".
"Sogno un’Europa sanamente laica, in cui Dio e Cesare siano distinti ma non contrapposti. Una terra aperta alla trascendenza, in cui chi è credente sia libero di professare pubblicamente la fede e di proporre il proprio punto di vista nella società" scrive ancora papa Francesco nella Lettera al cardinale Parolin.
"Sono finiti i tempi dei confessionalismi, ma - si spera - anche quello di un certo laicismo che chiude le porte verso gli altri e soprattutto verso Dio, poiché è evidente che una cultura o un sistema politico che non rispetti l’apertura alla trascendenza, non rispetta adeguatamente la persona umana. I cristiani hanno oggi una grande responsabilità: come il lievito nella pasta, sono chiamati a ridestare la coscienza dell’Europa, per animare processi che generino nuovi dinamismi nella società. Li esorto dunque ad impegnarsi con coraggio e determinazione a offrire il loro contributo in ogni ambito in cui vivono e operano".
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" -- L’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile. Un piano d’azione per le persone, il Pianeta e la prosperità (di "ASviS")..19 ottobre 2020, di Federico La Sala
L’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile *
Un piano d’azione per le persone, il Pianeta e la prosperità. È l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni unite, tra cui l’Italia, per condividere l’impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo abitano.
L’Agenda globale definisce 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell’acronimo inglese) da raggiungere entro il 2030, articolati in 169 Target, che rappresentano una bussola per porre l’Italia e il mondo su un sentiero sostenibile. Il processo di cambiamento del modello di sviluppo viene monitorato attraverso i Goal, i Target e oltre 240 indicatori: rispetto a tali parametri, ciascun Paese viene valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali.
L’Agenda 2030 porta con sé una grande novità: per la prima volta viene espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale, superando in questo modo definitivamente l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e affermando una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.
- Leggi il testo dell’Agenda 2030
- È l’unico piano che abbiamo, per salvare l’unico Pianeta che abbiamo.
- Scarica gli SDGs
- Le 17 icone degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Le cinque "P" dello sviluppo sostenibile
L’Agenda 2030 è basata su cinque concetti chiave:
- Persone. Eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e uguaglianza.
- Prosperità. Garantire vite prospere e piene in armonia con la natura.
- Pace. Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive.
- Partnership. Implementare l’Agenda attraverso solide partnership.
- Pianeta. Proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.
- “La nuova Agenda è una promessa da parte dei leader a tutte le persone in tutto il mondo. È un’Agenda per le persone, per sradicare la povertà in tutte le sue forme, un’Agenda per il Pianeta, la nostra casa". (Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite)
Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono tutti collegati tra loro
Garantire un’istruzione di qualità, equa e inclusiva (Goal 4) vuol dire anche offrire pari opportunità a donne e uomini (Goal 5); per assicurare salute e benessere (Goal 3), occorre vivere in un Pianeta sano (Goal 6, 13, 14 e 15); un lavoro dignitoso per tutti (Goal 8) richiede l’eliminazione delle disuguaglianze (Goal 10). Gli SDGs sono fortemente interconnessi.
L’Agenda 2030 lancia una sfida della complessità: poiché le tre dimensioni dello sviluppo (economica, ambientale e sociale) sono strettamente correlate tra loro, ciascun Obiettivo non può essere considerato in maniera indipendente ma deve essere perseguito sulla base di un approccio sistemico, che tenga in considerazione le reciproche interrelazioni e non si ripercuota con effetti negativi su altre sfere dello sviluppo. Solo la crescita integrata di tutte e tre le componenti consentirà il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.
- "È la prima volta che i leader mondiali si impegnano in uno sforzo e in un’azione comune attraverso un’agenda politica così vasta e universale". (Onu, Agenda 2030)
Tutti sono chiamati a contribuire
Gli SDGs sono universali, rimandano cioè alla presenza di problemi che accomunano tutte le nazioni. Per questo motivo, tutti i Paesi sono chiamati a contribuire alla sfida per portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo. Ciò vuol dire che ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli SDGs e a rendicontare i propri risultati all’Onu.
Non solo. All’interno dei Paesi serve un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura: per abbracciare lo sviluppo in ogni sua parte è fondamentale l’impegno di tutti.
- "Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Nell’intraprendere questo grande viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà lasciato indietro". (Onu, Agenda 2030)
E tu, come puoi contribuire al cambiamento?
Tutti siamo parte del cambiamento per un domani migliore, tutti ne siamo responsabili. E sono le nostre azioni che influenzeranno il futuro dei nostri figli e delle prossime generazioni. Stili di vita corretti e azioni individuali fanno la differenza. Informati sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e interrogati su quel che puoi fare per contribuire al loro raggiungimento, condividi buone pratiche, partecipa alle campagne, racconta il tuo contributo alla realizzazione dell’Agenda 2030 sui social. Consulta i materiali di educazione allo sviluppo sostenibile, scopri come collaborare, chiunque può fare la sua parte!
Consulta i materiali per informarti e contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030 [...]
* Fonte: ASviS (ripresa parziale).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- FRATERNITA’. «Fratelli tutti»: la nuova enciclica sociale di papa Francesco (di Stefania Falasca).4 ottobre 2020, di Federico La Sala
Enciclica.
«Fratelli tutti»: la chiave di volta della fraternità universale
La nuova enciclica sociale di papa Francesco, firmata ad Assisi, per superare i mali e le ombre del mondo. Ecco i contenuti
di Stefania Falasca (Avvenire, domenica 4 ottobre 2020)
Un manifesto per i nostri tempi. Con l’intento di «far rinascere un’aspirazione mondiale alla fraternità». La nuova lettera enciclica di papa Francesco che si rivolge «a tutti i fratelli e le sorelle», «a tutte le persone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni religiose» è «uno spazio di riflessione sulla fraternità universale». Necessaria, nel solco della dottrina sociale della Chiesa, per un futuro «modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana». Per «agire insieme e guarire dalla chiusura del consumismo, l’individualismo radicale e l’auto-protezione egoistica». Per superare «le ombre di un mondo chiuso» e conflittuale e «rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale che viva l’amicizia sociale». Per la crescita di società eque e senza frontiere. Perché l’economia e la politica siano poste «al servizio del vero bene comune e non siano ostacolo al cammino verso un mondo diverso». Perché quanto stiamo attraversando con la pandemia «non sia l’ennesimo grave evento storico da cui non siamo stati capaci di imparare». Perché le religioni possono offrire «un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella società».
La fonte d’ispirazione per questa nuova pagina di dottrina sociale della Chiesa viene ancora una volta dal Santo dell’amore fraterno, il Povero d’Assisi «che - afferma il Papa - mi ha ispirato a scrivere l’enciclica Laudato si’, e nuovamente mi motiva a dedicare questa nuova enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale».
Sulla scia dell’adagio terenziano ripreso da Paolo VI nella sua enciclica programmatica Ecclesiam Suam, papa Francesco ricorda nell’incipit stesso della sua lettera enciclica quanto «tutto ciò che è umano ci riguardi» e che «dovunque i consessi dei popoli si riuniscono per stabilire i diritti e i doveri dell’uomo, noi siamo onorati, quando ce lo consentono, di assiderci fra loro». La Chiesa del resto, affermava Paolo VI, «chiamata a incarnarsi in ogni situazione e ad essere presente attraverso i secoli in ogni luogo della terra - questo significa “cattolica” -, può comprendere, a partire dalla propria esperienza di grazia e di peccato, la bellezza dell’invito all’amore universale».
Francesco spiega poi che le questioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale sono sempre state tra le sue preoccupazioni e che negli ultimi anni ha fatto riferimento ad esse più volte. L’enciclica raccoglie molti di questi interventi collocandoli in un contesto più ampio di riflessione. E se la redazione della Laudato si’ ha avuto una fonte di ispirazione dal suo fratello ortodosso Bartolomeo, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli che ha proposto con molta forza la cura del creato, in questo caso si è sentito stimolato in modo speciale dal Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, con il quale il Papa si è incontrato nel febbraio del 2019 ad Abu Dhabi per ricordare che Dio «ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro».
Papa Francesco ricorda che quello non è stato «un mero atto diplomatico, bensì il frutto di una riflessione compiuta nel dialogo e di un impegno congiunto». E che questa enciclica, pertanto, raccoglie e sviluppa i grandi temi esposti in quel Documento firmato insieme e recepisce, nel suo linguaggio, «numerosi documenti e lettere ricevute da tante persone e gruppi di tutto il mondo».
 La genesi della lettera tuttavia è stata accelerata da un’emergenza: l’irruzione inattesa della pandemia del Covid-19, «che - come scrive Francesco - ha messo in luce le nostre false sicurezze, e al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi Paesi, è apparsa evidente l’incapacità di agire insieme». Perché «malgrado si sia iper-connessi - spiega ancora il Papa - si è verificata una frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti». E adesso «se qualcuno pensa che si tratti solo di far funzionare meglio quello che già facevamo, o che l’unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà».
La genesi della lettera tuttavia è stata accelerata da un’emergenza: l’irruzione inattesa della pandemia del Covid-19, «che - come scrive Francesco - ha messo in luce le nostre false sicurezze, e al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi Paesi, è apparsa evidente l’incapacità di agire insieme». Perché «malgrado si sia iper-connessi - spiega ancora il Papa - si è verificata una frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti». E adesso «se qualcuno pensa che si tratti solo di far funzionare meglio quello che già facevamo, o che l’unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà».Il Papa afferma inoltre che se ancora una volta si è sentito motivato specialmente da san Francesco d’Assisi, anche altri fratelli non cattolici sono stati ispiratori: Martin Luther King, Desmond Tutu, il Mahatma Gandhi. In particolare cita però il beato Charles de Foucauld. E prendendo a prestito la sue parole così chiosa la sua conclusione agli otto capitoli e 287 punti di Fratelli tutti: «“Pregate Iddio affinché io sia davvero il fratello di tutte le anime di questo paese”. Voleva essere, in definitiva, “il fratello universale”. Ma solo identificandosi con gli ultimi arrivò ad essere fratello di tutti. Che Dio ispiri questo ideale in ognuno di noi. Amen».
Le ombre di un mondo chiuso
Nel primo capitolo vengono passate in rassegna le tendenze del mondo attuale che ostacolano lo sviluppo della fraternità universale. Tra queste i diritti umani non sufficientemente universali, le nuove forme di colonizzazione culturale, lo scarto mondiale dove «certe parti dell’umanità sembrano sacrificabili a vantaggio di una selezione che favorisce un settore umano degno di vivere senza limiti». «Mentre, infatti, una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali ignorati o violati. «La storia - afferma il Papa - sta dando segni di un ritorno all’indietro. Si accendono conflitti anacronistici che si ritenevano superati, risorgono nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi. Nuove forme di egoismo e di perdita del senso sociale mascherate da una presunta difesa degli interessi nazionali». «Abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” che abita la Casa comune. Tale cura non interessa ai poteri economici che hanno bisogno di entrate veloci. Spesso le voci che si levano a difesa dell’ambiente sono messe a tacere o ridicolizzate, ammantando di razionalità quelli che sono solo interessi particolari. In questa cultura che stiamo producendo, vuota, protesa all’immediato e priva di un progetto comune, «è prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni». E non manca un’attenzione anche verso la condizione delle donne: «L’organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal rispecchiare con chiarezza che le donne hanno esattamente la stessa dignità e identici diritti degli uomini. A parole si affermano certe cose, ma le decisioni e la realtà gridano un altro messaggio». È un fatto che «doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti».
L’esempio del Buon Samaritano
Per il superamento delle ombre il Papa indica la strada d’uscita nella figura del Buon Samaritano a cui dedica il secondo capitolo, sottolineando come in una società malata che volta le spalle al dolore e che è “analfabeta” nella cura dei deboli e dei fragili, tutti siamo chiamati - proprio come il Buon Samaritano - a farci prossimi all’altro, superando pregiudizi, interessi personali, barriere storiche o culturali. «È un richiamo sempre nuovo, benché sia scritto come legge fondamentale del nostro essere: che la società si incammini verso il perseguimento del bene comune e, a partire da questa finalità, ricostruisca sempre nuovamente il suo ordine politico e sociale, il suo tessuto di relazioni, il suo progetto umano». Dunque, afferma Francesco, «non dico più che ho dei “prossimi” da aiutare, ma che mi sento chiamato a diventare io un prossimo degli altri». E spiega che «in quelli che passano a distanza c’è un particolare che non possiamo ignorare: erano persone religiose. Questo indica che il fatto di credere in Dio e di adorarlo non garantisce di vivere come a Dio piace». «Una persona di fede - spiega - può non essere fedele a tutto ciò la fede stessa esige, e tuttavia può sentirsi vicina a Dio e ritenersi più degna degli altri. Ci sono invece dei modi di vivere la fede che favoriscono l’apertura del cuore ai fratelli, e quella sarà la garanzia di un’autentica apertura a Dio».
Società aperte che integrano tutti
«L’individualismo radicale - afferma Francesco nel terzo capitolo “Pensare e generare un mondo aperto” - è il virus più difficile da sconfiggere». «Ci fa credere che tutto consiste nel dare briglia sciolta alle proprie ambizioni, come se accumulando ambizioni e sicurezze individuali potessimo costruire il bene comune. Quando questo principio elementare non è salvaguardato, non c’è futuro né per la fraternità né per la sopravvivenza dell’umanità. Se la società si regge primariamente sui criteri della libertà di mercato e dell’efficienza, non c’è posto per costoro, e la fraternità sarà tutt’al più un’espressione romantica». Francesco indica la necessità di promuovere il bene morale e il valore della solidarietà: «È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero del denaro. La solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare la storia, si tratta di un’altra logica - spiega - Se non ci si sforza di entrare in questa logica, le mie parole suoneranno come fantasie. Ma se si accetta il grande principio dei diritti che promanano dal solo fatto di possedere l’inalienabile dignità umana, è possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a tutti. Questa è la vera via della pace, e non la strategia stolta e miope di seminare timore e diffidenza nei confronti di minacce esterne». Il diritto a vivere con dignità non può essere negato a nessuno, afferma ancora il Papa, e poiché i diritti sono senza frontiere, nessuno può rimanere escluso, a prescindere da dove sia nato. In quest’ottica, il Papa richiama anche a pensare ad «un’etica delle relazioni internazionali», perché ogni Paese è anche dello straniero ed i beni del territorio non si possono negare a chi ha bisogno e proviene da un altro luogo. Il diritto naturale alla proprietà privata sarà, quindi, secondario al principio della destinazione universale dei beni creati. Una sottolineatura specifica viene fatta anche per la questione del debito estero: fermo restando il principio che esso va saldato, si auspica tuttavia che ciò non comprometta la crescita e la sussistenza dei Paesi più poveri.
Interscambio e governance globale per i migranti
L’aiuto reciproco tra Paesi in definitiva va a beneficio di tutti e al tema delle migrazioni l’enciclica dedica l’intero quarto capitolo: “Un cuore aperto al mondo intero”. L’altro diverso da noi è un dono ed un arricchimento per tutti - scrive Francesco - perché le differenze rappresentano una possibilità di crescita. Nello specifico, il Papa indica alcune risposte soprattutto per chi fugge da «gravi crisi umanitarie»: -incrementare e semplificare la concessione di visti; aprire corridoi umanitari; assicurare alloggi, sicurezza e servizi essenziali; offrire possibilità di lavoro e formazione; favorire i ricongiungimenti familiari; tutelare i minori; garantire la libertà religiosa e promuovere l’inserimento sociale. Dal Papa anche l’invito a stabilire, nella società, il concetto di «piena cittadinanza», rinunciando all’uso discriminatorio del termine “minoranze”. «Quello che occorre soprattutto - si legge nel documento - è una governance globale, una collaborazione internazionale per le migrazioni che avvii progetti a lungo termine, andando oltre le singole emergenze, in nome di uno sviluppo solidale di tutti i popoli che sia basato sul principio della gratuità. In tal modo, i Paesi potranno pensare come una famiglia umana».
La politica di cui c’è bisogno e la riforma dell’ONU
“La migliore politica” è al centro del quinto capitolo. «Per rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale - scrive Francesco - capace di realizzare la fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano l’amicizia sociale, è necessaria la migliore politica, posta al servizio del vero bene comune. Purtroppo, invece, la politica oggi spesso assume forme che ostacolano il cammino verso un mondo diverso». «Mi permetto di ribadire - afferma - che la politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia». «Non si può giustificare un’economia senza politica, che sarebbe incapace di propiziare un’altra logica in grado di governare i vari aspetti della crisi attuale». Al contrario, «abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un nuovo approccio integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi». «Penso - afferma - a una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche, che permettano di superare pressioni e inerzie viziose». Non si può chiedere ciò all’economia, né si può accettare che questa assuma il potere reale dello Stato. «Il mercato da solo non risolve tutto, benché a volte vogliano farci credere questo dogma di fede neoliberale. I politici sono chiamati a prendersi «cura della fragilità, della fragilità dei popoli e delle persone. Prendersi cura della fragilità e fecondità in mezzo a un modello funzionalista e privatista che conduce inesorabilmente alla “cultura dello scarto”.
Davanti a tante forme di politica meschine e tese all’interesse immediato, ricorda che «la grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e pensando al bene comune a lungo termine. Compito della politica, inoltre, è trovare una soluzione a tutto ciò che attenta contro i diritti umani fondamentali, come l’esclusione sociale; il traffico di organi, tessuti, armi e droga; lo sfruttamento sessuale; il lavoro schiavo; il terrorismo ed il crimine organizzato.
 L’appello del Papa si volge a eliminare definitivamente la tratta, «vergogna per l’umanità», e la fame, in quanto è «criminale». Un altro auspicio riguarda la riforma dell’Onu: di fronte al predominio della dimensione economica che annulla il potere del singolo Stato, infatti, il compito delle Nazioni Unite sarà quello di dare concretezza al concetto di «famiglia di nazioni» lavorando per il bene comune, lo sradicamento dell’indigenza e la tutela dei diritti umani. Ricorrendo «al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato» - afferma il documento pontificio - l’Onu deve promuovere la forza del diritto sul diritto della forza, favorendo accordi multilaterali che tutelino al meglio anche gli Stati più deboli.
L’appello del Papa si volge a eliminare definitivamente la tratta, «vergogna per l’umanità», e la fame, in quanto è «criminale». Un altro auspicio riguarda la riforma dell’Onu: di fronte al predominio della dimensione economica che annulla il potere del singolo Stato, infatti, il compito delle Nazioni Unite sarà quello di dare concretezza al concetto di «famiglia di nazioni» lavorando per il bene comune, lo sradicamento dell’indigenza e la tutela dei diritti umani. Ricorrendo «al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato» - afferma il documento pontificio - l’Onu deve promuovere la forza del diritto sul diritto della forza, favorendo accordi multilaterali che tutelino al meglio anche gli Stati più deboli.Dialogo e amicizia sociale
Il vero dialogo - si afferma nel sesto capitolo - è quello che permette di rispettare la verità della dignità umana. Quanti pretendono di portare la pace in una società non devono dimenticare che l’inequità e la mancanza di sviluppo umano integrale non permettono che si generi pace. Che «senza uguaglianza di opportunità, le diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un terreno fertile che prima o poi provocherà l’esplosione. Quando la società - locale, nazionale o mondiale - abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno programmi politici, né forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare illimitatamente la tranquillità». Per il Papa «se si tratta di ricominciare, sarà sempre a partire dagli ultimi».
L’artigianato della pace
Il settimo capitolo si sofferma sul valore e la promozione della pace. «La Shoah non va dimenticata - afferma - è il «simbolo di dove può arrivare la malvagità dell’uomo quando, fomentata da false ideologie, dimentica la dignità fondamentale di ogni persona, la quale merita rispetto assoluto qualunque sia il popolo a cui appartiene e la religione che professa». Non vanno neppure dimenticati i bombardamenti atomici a Hiroshima e Nagasaki. E nemmeno vanno dimenticati le persecuzioni, il traffico di schiavi e i massacri etnici che sono avvenuti e avvengono in diversi Paesi, e tanti altri fatti storici che ci fanno vergognare di essere umani. «Vanno ricordati sempre, sempre nuovamente. Per questo, non mi riferisco solo alla memoria degli orrori, ma anche al ricordo di quanti, in mezzo a un contesto avvelenato e corrotto, sono stati capaci di recuperare la dignità e con piccoli o grandi gesti hanno scelto la solidarietà, il perdono, la fraternità. Fa molto bene fare memoria del bene». E considerando che viviamo «una terza guerra mondiale a pezzi», perché tutti i conflitti sono connessi tra loro, l’eliminazione totale delle armi nucleari è «un imperativo morale ed umanitario». Piuttosto - suggerisce il Papa - con il denaro che si investe negli armamenti, si costituisca un Fondo mondiale per eliminare la fame. Non manca anche il riferimento alla pena di morte: «È inammissibile. È impossibile immaginare che oggi gli Stati non possano disporre di un altro mezzo che non sia la pena capitale per difendere dall’aggressore ingiusto la vita di altre persone».
Le religioni al servizio della fraternità
Le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di ogni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella società. Il dialogo tra persone di religioni differenti non si fa solamente per diplomazia, cortesia o tolleranza. «Il comandamento della pace - spiega il Papa - è inscritto nel profondo delle tradizioni religiose che rappresentiamo. Come leader religiosi siamo chiamati ad essere veri “dialoganti”, ad agire nella costruzione della pace non come intermediari, ma come autentici mediatori. Come credenti ci vediamo provocati a tornare alle nostre fonti per concentrarci sull’essenziale: l’adorazione di Dio e l’amore del prossimo, in modo tale che alcuni aspetti della nostra dottrina, fuori dal loro contesto, non finiscano per alimentare forme di disprezzo, di odio, di xenofobia, di negazione dell’altro. La verità è che la violenza non trova base alcuna nelle convinzioni religiose fondamentali, bensì nelle loro deformazioni». Infine, richiamando i leader religiosi al loro ruolo di «mediatori autentici» che si spendono per costruire la pace, Francesco cita il “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza”, firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi, insieme al Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib. Dalla pietra miliare del dialogo interreligioso, il Papa riprende l’appello affinché, in nome della fratellanza umana, si adotti il dialogo come via, la collaborazione comune come condotta e la conoscenza reciproca come metodo e criterio. La conclusione dell’enciclica è affidata a due preghiere: una «al Creatore» e l’altra «cristiana ecumenica» per infondere «uno spirito di fratelli».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. --- La Convezione di Faro sul patrimonio culturale. L’Italia ha ratificato.23 settembre 2020, di Federico La Sala
Camera, l’Italia ratifica la Convenzione di Faro sul patrimonio culturale... *
La Convezione di Faro sul patrimonio culturale
Il FAI auspica che il Parlamento ratifichi presto la Convenzione di Faro - sottoscritta dall’Italia nel 2013 - perché è un testo davvero rivoluzionario sulla tutela del patrimonio culturale, e in linea con lo spirito dell’articolo 9 della nostra Costituzione.
di Redazione (FAI, 25 novembre 2019)
Nell’ormai lontano 27 ottobre 2005 nella città portoghese di Faro fu presentata la “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società”. Dopo otto anni, l’Italia l’ha sottoscritta nel 2013. Ora il Parlamento italiano sta finalmente per ratificarla, al termine di un percorso alquanto accidentato anche in questa legislatura, dopo i tentativi fatti già nella precedente.
 Il testo è stato approvato di recente a larga maggioranza nell’Aula di Palazzo Madama con 147 voti favorevoli, 46 contrari e 42 astenuti (a favore M5S, Pd, Iv, Leu, contraria la Lega, astenuta Forza Italia).
Il testo è stato approvato di recente a larga maggioranza nell’Aula di Palazzo Madama con 147 voti favorevoli, 46 contrari e 42 astenuti (a favore M5S, Pd, Iv, Leu, contraria la Lega, astenuta Forza Italia).
 Il testo, pertanto, è stato trasmesso alla Camera per la seconda lettura.
Il testo, pertanto, è stato trasmesso alla Camera per la seconda lettura.Nel frattempo la Convenzione è stata sottoscritta da 24 paesi membri del Consiglio d’Europa ed è stata ratificata da 18 Paesi: Armenia, Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Finlandia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Moldova, Serbia, Slovacchia, Slovenia, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Ucraina e Ungheria. Si attende ancora la ratifica di Albania, Belgio, Spagna, Bulgaria e San Marino, oltre all’Italia. Tra i paesi che non hanno né firmato né ratificato ci sono, fra gli altri, alcuni paesi importanti come la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Federazione Russa.
La Convenzione di Faro presenta notevoli caratteri di novità, a partire dalla stessa concezione del patrimonio culturale, che nella legislazione italiana, erede delle norme definite nel corso del Novecento e in particolare nella Legge 1089 del 1939, è ancora oggi legata alla centralità delle “cose”. Si introduce, infatti, una visione estremamente più ampia di patrimonio culturale, inteso come «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione» e soprattutto affida uno specifico ruolo, una grande responsabilità e un protagonismo prima impensabile alle “comunità patrimonio”, cioè a
- «un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future» (art. 2).
È un testo davvero rivoluzionario perché ribalta il punto di vista tradizionale: dell’autorità, spostata dal vertice alla base; dell’oggetto, dall’eccezionale al tutto; del valore, dal valore in sé al valore d’uso e, dunque, dei fini, dalla museificazione alla valorizzazione, come ha efficacemente sottolineato un grande economista della cultura recentemente scomparso, Massimo Montella.
Si segna, in tal modo, il passaggio dal “diritto del patrimonio culturale” (nel quale il nostro Paese ha una lunga e gloriosa tradizione) al “diritto al patrimonio culturale” (nel nostro Paese ancora tutto da affermare). Non sono più, cioè, solo gli specialisti, i professori e i funzionari della tutela a doversi ritenere gli esclusivi responsabili (a volte addirittura proprietari) del patrimonio culturale, ma sono tutti i cittadini, le comunità locali, i visitatori ad assumere un nuovo ruolo nelle attività di conoscenza, tutela, valorizzazione e fruizione. Non si escludono - sia ben chiaro - gli specialisti e i professionisti, come affermano alcuni oppositori. Ma si affida loro un nuovo e più impegnativo ruolo nella società contemporanea, nel rapporto con le “comunità di patrimonio”, con l’associazionismo, con la cittadinanza attiva. Si sottolinea, infatti, che
- «chiunque da solo o collettivamente ha diritto di contribuire all’arricchimento del patrimonio culturale» (art. 5).
Si ribadisce in più modi la necessità della partecipazione democratica dei cittadini «al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale», si attribuisce a tutti un ruolo attivo, riconoscendo il diritto (e il dovere) di partecipare alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio. Si invitano i Paesi sottoscrittori a
- «promuovere azioni per migliorare l’accesso al patrimonio culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare» (art. 12).
Si afferma il diritto, individuale e collettivo, «a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento» (art. 4) ed evidenzia la necessità che il patrimonio culturale sia finalizzato all’arricchimento dei «processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell’uso del territorio, ...» (art. 8).
La Convenzione di Faro allarga il concetto di patrimonio culturale anche a «tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi» e impone che il patrimonio culturale vada tutelato e protetto non tanto per il suo valore intrinseco ma in quanto risorsa per la crescita culturale e socio-economica.
Purtroppo la Convenzione di Faro arriva tardi alla ratifica in Italia, come anche in altri paesi europei. Eppure, i principi illustrati a Faro quindici anni fa sono oggi ancor più attuali ed è ancor più urgente che essi ispirino le politiche di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, che necessitano di una maggiore partecipazione attiva dal basso.
 Per questi motivi, il FAI, che fin dalla sua fondazione considera la partecipazione attiva della cittadinanza un elemento caratterizzante del suo DNA, auspica che il Parlamento ratifichi presto questa Convenzione e soprattutto che essa non corra il rischio di essere poi riposta in un cassetto ma che ispiri una profonda revisione delle nostre norme e delle procedure e soprattutto delle mentalità nel campo della tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, capaci di affrontare i problemi e le sfide del terzo Millennio.
Per questi motivi, il FAI, che fin dalla sua fondazione considera la partecipazione attiva della cittadinanza un elemento caratterizzante del suo DNA, auspica che il Parlamento ratifichi presto questa Convenzione e soprattutto che essa non corra il rischio di essere poi riposta in un cassetto ma che ispiri una profonda revisione delle nostre norme e delle procedure e soprattutto delle mentalità nel campo della tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, capaci di affrontare i problemi e le sfide del terzo Millennio.Un’ultima considerazione: la Convenzione di Faro appare perfettamente in linea con lo spirito e la lettera dell’articolo 9 della nostra Costituzione, con la sua innovativa, lungimirante e ampia concezione di tutela del “paesaggio e patrimonio storico e artistico della Nazione” affidata alla Repubblica (cioè, non solo allo Stato, ma a tutte le istituzioni pubbliche, Regioni, Città metropolitane, Province Comuni, e soprattutto all’intera comunità dei cittadini che formano la res publica) e lo stretto legame tra tutela e promozione dello “sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica”.
*NOTA BENE:
Camera, l’Italia ratifica la Convenzione di Faro sul patrimonio culturale
 237 voti favorevoli, 119 contrari e 57 astenuti ("Ag/Cult", 23.09.2020).
237 voti favorevoli, 119 contrari e 57 astenuti ("Ag/Cult", 23.09.2020).FLS
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- In memoria della "ragazza del secolo scorso". La recensione di Rossana Rossanda del lavoro di Luciana Castellina, "Cinquant’anni d’Europa. Una lettura antiretorica" (2007).21 settembre 2020, di Federico La Sala
Eu-ropa!!! Che cosa è oggi l’Europa?
RIFLESSIONI AUTOCRITICHE SULL’EUROPA. Rossana Rossanda presenta il lavoro di Luciana Castellina, "Cinquant’anni d’Europa. Una lettura antiretorica" (il manifesto, 14 marzo 2007).
Chi pensa che l’Europa ha da essere diversa e costituire nella globalizzazione un modello di controtendenza per metodi e fini, ha davanti a sé non molto più di un paio di anni per promuovere una campagna d’opinione che dovrebbe essere non meno vasta di quella che fece per un momento vacillare l’Italia alla scoperta di Tangentopoli [...].
E’ morta Rossana Rossanda, ’la ragazza del secolo scorso’
La fondatrice del Manifesto aveva 96 anni, è stata tra le intellettuali più autorevoli del Paese
- Rossana Rossanda © ANSA FOTO
di Redazione (ANSA, 20 settembre 2020)
E’ stata tra le intellettuali più autorevoli del Paese, memoria storica dell’Italia del Dopoguerra, ’la ragazza del secolo scorso’, Rossana Rossanda aveva 96 anni e si è spenta nella notte nella sua casa di Roma. Giornalista, intellettuale, comunista, scrittrice, fondatrice del Manifesto. La notizia è stata data dal sito del Manifesto che ha annunciato un’edizione speciale del giornale per martedì per ricordare la giornalista.
Amica di Jean Paul Sartre, aveva vissuto a lungo a Parigi, da dove era tornata due anni fa, stabilendosi a Roma, in una casa nel quartiere Parioli. Una delle sue ultime uscite pubbliche fu l’anno scorso, a maggio, per sostenere alla Casa delle donne alcune candidate della sinistra alle elezioni Europee.
Nata a Pola nel 1924, allieva di Antonio Banfi, antifascista, ha partecipato alla Resistenza. E’ stata dirigente del Partito Comunista Italiano negli anni Cinquanta e Sessanta, fino ad essere nominata da Palmiro Togliatti responsabile della politica culturale del Pci. L’esigenza di elaborare la crisi del socialismo reale, sull’onda dei movimenti studentesco e operaio, la conduce a fondare nel 1969 il gruppo politico e la rivista ’il Manifesto, quotidiano dal ’71, insieme a Luigi Pintor, Valentino Parlato, Lucio Magri e Luciana Castellina.
Le posizioni assunte dal giornale in contrasto con la linea maggioritaria del Partito, in particolare sull’invasione sovietica della Cecoslovacchia, nel 1969 determinano la radiazione della Rossanda e di altri del gruppo dal Pci. L’unica ad aver convinto il capo delle Brigate Rosse, Mario Moretti, a parlare in un’intervista del caso Moro. De "il manifesto", un giornale, un collettivo, dal quale si è separata con grande amarezza nel 2012: "Prendo atto della indisponibilità al dialogo della direzione e della redazione. Smetto di collaborare". Divergenze di linea politica e di approccio editoriale, incomprensione forse sanabile, il gap anagrafico: "Mi hanno sempre visto come una madre castratrice anche se io non mi sono mai sentita tale. Ma forse è una legge generazionale. I figli per crescere hanno bisogno di uccidere i padri e le madri. Ora è toccato a me".
Lucida, laica, politicamente razionale. Del Pci degli Anni 50 e Sessanta ricorda, nella sua autobiografia, pubblicata nel 2005 per Einaudi La ragazza del secolo scorso, tra storia e memoria lo straordinario contributo "al processo di democratizzazione della società italiana". (Una curiosità il libro arrivò nella cinquina dello Strega e fu in testa con Veronesi che quell’anno vince il la prima volta con Caos Calmo).
Il fallimento politico di Magri era anche quello di Rossanda, che lei avvertiva. Dopo essere stata direttrice del ’Manifesto’, continua la riflessione e il dialogo sui movimenti operai e femministi, e si dedica soprattutto alla letteratura e al giornalismo attraverso varie pubblicazioni tra cui, nel 1979, Le altre. Conversazioni sulle parole della politica (Feltrinelli); nel 1981 Un viaggio inutile (Einaudi); nel 1987 Anche per me. Donna, persona, memoria, dal 1973 al 1986 (Feltrinelli); nel 1996 La vita breve. Morte, resurrezione, immortalita’. Nel 2005 esce per Einaudi La ragazza del secolo scorso, autobiografia tra storia e memoria.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. --- Disurbanizzare le nostre vite. Esperienze di cooperazione territoriale (di Miriam Corongiu e Riccardo Festa).16 settembre 2020, di Federico La Sala
Disurbanizzare le nostre vite. Esperienze di cooperazione territoriale
La fusione tra città e campagna non solo è possibile, ma addirittura necessaria, oltre a essere un anelito profondissimo di chi vive agonizzando il contesto urbano e di chi interpreta come solitudine quello rurale. Una testimonianza dalla Terra dei Fuochi
di Miriam Corongiu e Riccardo Festa *
Parlare di “terra” vuol dire più comunemente discutere di un ideale luogo del vivere (urbano o rurale) e non di un reale modello spirituale, politico, produttivo ed ecologico o di una concreta possibilità occupazionale. Il vero e proprio genocidio culturale perpetrato a danno dei contadini, una strage che ha eradicato dalla memoria e dalla pratica un’intera civiltà, ha reso le campagne periferie non solo geografiche, ma soprattutto mentali, eclissando quella dimensione che Pasolini definiva paleocontadina e con la quale è svanita di certo l’estrema durezza del vivere che le era connaturata, ma anche un paradigma di resilienza e di comunità.
La narrazione (e la realtà) della pandemia di Covid-19, il disastro dei cambiamenti climatici e le devastazioni ambientali di ogni latitudine ci mostrano, come in una vetrofania, che abbiamo sbagliato tutto: il pianeta, le persone, hanno bisogno di una vita radicalmente diversa che non può esaurirsi negli spazi cubicolari delle metropoli, nel grigiore del travettismo spirituale o nell’idea di una natura altra e selvaggia l’accesso alla quale è appannaggio dei parchi o, peggio, degli zoo. Sono ormai decenni che numerose esperienze europee e d’oltreoceano ci raccontano di un’aspirazione differente, di un costante tentativo di volo verso forme del vivere più leggere e ricche. L’introduzione di usi agricoli nei contesti urbani come gli orti, il superamento della dicotomia tra città e campagna attraverso le transition town, pratiche come ecobox e re-urban ci parlano di centinaia di cittadini impegnati e condensati intorno all’agroecologia, l’apicoltura, il compostaggio di quartiere.
- Non sono soltanto improvvise polmoniti della modernità, non sono semplici fenomeni di ipossia da metropoli, ma una costante voglia di partecipazione reale nel bel mezzo della crisi più drammatica della “democrazia” rappresentativa e una voglia di “campagna” ormai ineludibile.
La fusione tra città e campagna non solo è possibile, ma addirittura necessaria, oltre a essere un anelito profondissimo di chi vive agonizzando il contesto urbano e di chi interpreta come solitudine quello rurale. Alla luce del coronavirus e dell’innaturale quanto ineluttabile caldo estivo - entrambi figli dell’antropocene - potremmo aggiungere che solo così sarà possibile imprimere l’indispensabile svolta in tema di emissioni climalteranti e perfino favorire l’accesso a condizioni migliori di vivibilità in periodi di contagi e quarantene. La fine della dicotomia tra città e campagna, teorizzata da Engels già alla fine del 1800, è rimasta per lo più uno slogan. Nonostante il sogno degli architetti disurbanisti russi che teorizzavano la dispersione (dedensificazione) dell’habitat, della distribuzione dell’energia, della decentralizzazione della politica e nonostante la terribile evidenza dei ghetti di stato nei quartieri malfamati o delle periferie deruralizzate in cui si producono fenomeni come quello della Terra dei Fuochi, siamo rimasti dentro l’incubo del capitalismo senza mettere in discussione nulla della città classica. La cancellazione pianificata a tavolino dei contadini ha completato il processo di urbanizzazione delle menti che, però, deve e può essere invertito con proposte politiche serie e attuabili sul piano nazionale/locale.
- Il governo del territorio deve passare attraverso scelte molto chiare sul modello agricolo da realizzare. L’agroecologia offre, a ogni livello di scala, un esempio di sviluppo che si basa sulla sovranità alimentare, sulla partecipazione dal basso ai processi decisionali e su metodologie resilienti.
I nostri comuni avrebbero mille modi per sostenere questo modello mettendo al centro dell’amministrazione ordinaria le aree agricole periurbane e marginali, in un’ottica di rivalutazione non solo dell’agricoltura locale, ma anche di miglioramento della qualità di vita nell’urbs strettamente intesa: l’elevata domanda di beni alimentari sani e naturali, di servizi ricreativi, di ristorazione e ospitalità rurale e - come ci ha duramente insegnato la Covid- 19 - di attività didattiche in spazi a misura di bimbo, impongono che ci si occupi di accrescere le relazioni tra contadini e tra contadini e cittadini, di stimolarne la partecipazione dal basso, di rendere accessibili le terre incolte ricadenti nelle proprietà comunali, di organizzare momenti formativi utili alla transizione ecologica e sportelli informativi indispensabili a orientarsi nella giungla tecnico/normativa. La Consulta Agricola Comunale, ad esempio, potrebbe essere lo strumento amministrativo attraverso il quale contadini, associazioni, cooperative e cittadini esprimono la loro opinione ed essere protagonisti della loro storia. Uno “sportello agricoltura” potrebbe fornire informazioni sulla finanza ordinaria, sulle attività dell’amministrazione locale e regionale, sui mercati locali e sulle scuole contadine.
In Terra dei Fuochi, cioè proprio dove le campagne sono il fulcro di una devastazione senza precedenti, le politiche per il governo del territorio non hanno assunto ancora questa visione. Risultano episodiche e malmesse le esperienze di pianificazione dei sistemi ambientali del territorio agricolo e forestale finalizzate a riqualificare colture, a salvaguardare ed estendere aree produttive di pregio, a tutelare gli assetti idrogeologici, a riqualificare naturalisticamente i bacini fluviali, ad aumentare la fertilità dei suoli, a regolamentare i microclimi, a valorizzare il paesaggio storico, a sviluppare economie locali attraverso la trasformazione dei prodotti tipici, l’artigianato, l’agriturismo.
- Solo un vago appellarsi a tradizioni da non dimenticare e un continuo voltare le spalle a soluzioni che metterebbero in un angolo la pessima politica di queste zone e al centro un futuro migliore.
A disegnare il filo tra città e campagna sono rimaste, perciò, le iniziative dal basso. Che sono tante. E convincenti. La facoltà di architettura della Federico II di Napoli, corso di Urban Planning, lavora a una mappatura degli orti sociali, delle aziende gestite da cooperative sociali e di quelle private caratterizzate da un’etica ambientale il cui approccio di comunità è il seme necessario alla disurbanizzazione delle nostre menti. Tra queste L’Orto Conviviale, alla periferia di un grande centro urbano alle falde del Somma-Vesuvio, tenta di colmare il vuoto culturale praticato tra contadini e cittadini anche attraverso pratiche di tipo spaziale: una casa aperta a tutti, al centro di un giardino, mette a disposizione di una comunità intera gli spazi di famiglia, la frescura dell’erba il cui conforto è sempre meno conosciuto, la possibilità di respirare in libertà e un patrimonio culturale che, ancora in tanti, si ostinano a coltivare reinterpretando quegli spazi incompiuti, indecisi, che non posseggono una funzione, ma che sono ambiti di opportunità per l’accoglienza della diversità respinta dagli spazi funzionali attivi possessori di una propria identità.
Un esperimento di successo sul piano della sostenibilità economico-ambientale e di trasformazione di un territorio come quello campano che soprattutto in ambito urbano produce “avanzi” corrispondenti ad aree in attesa di modificazione, sospese tra ciò che sono state e ciò che diverranno, una sorta di limbo durante il quale, di frequente, avvengono processi spontanei di rinaturalizzazione. L’agricoltura, considerata settore residuale dalle politiche economiche dominanti, deve dunque tornare a essere il centro di un’ampia rete di attività articolate attraverso la connessione di produzioni, servizi e opportunità.
- Diviene quindi necessario non solo innovare in senso ecologico il ciclo produttivo agricolo, ma diviene allo stesso tempo indispensabile che la progettazione e la pianificazione del territorio agricolo e forestale si trasformino in strumenti fondamentali per lo sviluppo sostenibile.
Lo spazio astratto dell’economia si materializza, infatti, attraverso la sepoltura della complessità territoriale e ambientale. Il luogo scompare e con esso l’articolazione integrata dell’ambiente fisico, costruito, abitato; scompaiono le identità locali, i valori stratificati nel tempo e reinterpretabili nella fase di transizione dall’economia moderna a una sostenibile; il suolo viene considerato come semplice supporto della costruzione mentre il piano e il progetto si sottraggono al confronto con le questioni poste dalla necessità di una transizione ecologica. Le aree residuali, “gli avanzi“, acquistano un valore rilevante per la sperimentazione di proposte trasformative in ogni direzione: la questione di fondo è utilizzare questi luoghi per il necessario passaggio a un’economia non più dipendente dall’energia fossile con modelli insediati funzionalmente e morfologicamente nuovi. L’esigenza di ridurre le emissioni di gas serra è l’occasione per queste aree di promuovere ricadute positive per l’intero sistema urbano attraverso la realizzazione di reti pedonali e ciclabili, implementazione della dotazione di verde, conservazione del patrimonio naturale, risparmio energetico, riqualificazione, mixité funzionale e sociale, riduzione del consumo di suolo, densificazione, dove possibile, e connettività.
Oggi serve molta innovazione nell’affrontare le questioni territoriali.
Abbiamo bisogno di mettere a punto una strategia di lunga durata che faccia della cooperazione tra aree contigue il punto di forza per ispirare, indirizzare e consolidare una nuova governance, efficace e resistente, dando vita a una nuova centralità diffusa con la potenzialità di essere insieme individuale e comunitaria. Individuale nella connessione all’innovazione gestionale e alla produzione cooperativa e comunitaria nella consapevole condivisione di risorse locali e di senso comune.
- Questo presuppone la capacità di riscoprire la comunità locale e il territorio, di prestare attenzione e riconoscerne le risorse e di integrarle in un profilo preciso agendo collettivamente.
In breve, presuppone la capacità di avere una visione concreta che preveda anche maggiore investimento in ricerca, in formazione ed educazione all’uso delle risorse. Significa fare città più resistenti nelle quali il consumo non si manifesti in montagne di rifiuti nei territori contigui e una cultura che non guardi a un prato come un tappeto sotto il quale seppellire rifiuti tossici. Significa creare territori consapevoli che cooperano, nei quali riuso, riciclo e infine smaltimento in piena sicurezza possano trovare forma chiare e condivise.
Per cambiare direzione è necessario mettere in campo azioni alle diverse scale che allo stesso tempo coinvolgano tutti. Non è solo “economia circolare”, è molto di più: è ripensare la dimensione economica della nostra esistenza creando spazi adatti a una vita piena e soddisfacente.
L’unica alla quale dovremmo ambire.
*
Miriam Corongiu è contadina e attivista ecologista
Riccardo Festa è architetto territorialista
Foto di copertina di Diego Delso da commons.wikimedia
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- IL MOMENTO DELLA SAGGEZZA. Meeting 2020. Il discorso di inaugurazione: "Da questa crisi l’Europa può uscire rafforzata. L’azione dei governi poggia su un terreno reso solido dalla politica monetaria" (di Mario Draghi )..19 agosto 2020, di Federico La Sala
Il discorso di inaugurazione
Meeting 2020, l’intervento integrale
di Mario Draghi (Corriere della Sera/Economia, 18 ago 2020)
Dodici anni fa la crisi finanziaria provocò la più grande distruzione economica mai vista in periodo di pace. Abbiamo poi avuto in Europa una seconda recessione e un’ulteriore perdita di posti di lavoro. Si sono succedute la crisi dell’euro e la pesante minaccia della depressione e della deflazione. Superammo tutto ciò. Quando la fiducia tornava a consolidarsi e con essa la ripresa economica, siamo stati colpiti ancor più duramente dall’esplosione della pandemia: essa minaccia non solo l’economia, ma anche il tessuto della nostra società, così come l’abbiamo finora conosciuta; diffonde incertezza, penalizza l’occupazione, paralizza i consumi e gli investimenti. In questo susseguirsi di crisi i sussidi che vengono ovunque distribuiti sono una prima forma di vicinanza della società a coloro che sono più colpiti, specialmente a coloro che hanno tante volte provato a reagire. I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri. La società nel suo complesso non può accettare un mondo senza speranza; ma deve, raccolte tutte le proprie energie, e ritrovato un comune sentire, cercare la strada della ricostruzione.
Nelle attuali circostanze il pragmatismo è necessario. Non sappiamo quando sarà scoperto un vaccino, né tantomeno come sarà la realtà allora. Le opinioni sono divise: alcuni ritengono che tutto tornerà come prima, altri vedono l’inizio di un profondo cambiamento. Probabilmente la realtà starà nel mezzo: in alcuni settori i cambiamenti non saranno sostanziali; in altri le tecnologie esistenti potranno essere rapidamente adattate. Altri ancora si espanderanno e cresceranno adattandosi alla nuova domanda e ai nuovi comportamenti imposti dalla pandemia. Ma per altri, un ritorno agli stessi livelli operativi che avevano nel periodo prima della pandemia, è improbabile. Dobbiamo accettare l’inevitabilità del cambiamento con realismo e, almeno finché non sarà trovato un rimedio, dobbiamo adattare i nostri comportamenti e le nostre politiche. Ma non dobbiamo rinnegare i nostri principii. Dalla politica economica ci si aspetta che non aggiunga incertezza a quella provocata dalla pandemia e dal cambiamento. Altrimenti finiremo per essere controllati dall’incertezza invece di esser noi a controllarla. Perderemmo la strada. Vengono in mente le parole della ‘preghiera per la serenità’ di Reinhold Niebuhr che chiede al Signore: Dammi la serenità per accettare le cose che non posso cambiare, / Il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare, / E la saggezza di capire la differenza.
Non voglio fare oggi una lezione di politica economica ma darvi un messaggio più di natura etica per affrontare insieme le sfide che ci pone la ricostruzione e insieme affermare i valori e gli obiettivi su cui vogliamo ricostruire le nostre società, le nostre economie in Italia e in Europa. Nel secondo trimestre del 2020 l’economia si è contratta a un tasso paragonabile a quello registrato dai maggiori Paesi durante la seconda guerra mondiale. La nostra libertà di circolazione, la nostra stessa interazione umana fisica e psicologica sono state sacrificate, interi settori delle nostre economie sono stati chiusi o messi in condizione di non operare. L’aumento drammatico nel numero delle persone private del lavoro che, secondo le prime stime, sarà difficile riassorbire velocemente, la chiusura delle scuole e di altri luoghi di apprendimento hanno interrotto percorsi professionali ed educativi, hanno approfondito le diseguaglianze.
Alla distruzione del capitale fisico che caratterizzò l’evento bellico molti accostano oggi il timore di una distruzione del capitale umano di proporzioni senza precedenti dagli anni del conflitto mondiale. I governi sono intervenuti con misure straordinarie a sostegno dell’occupazione e del reddito. Il pagamento delle imposte è stato sospeso o differito. Il settore bancario è stato mobilizzato affinché continuasse a fornire il credito a imprese e famiglie. Il deficit e il debito pubblico sono cresciuti a livelli mai visti prima in tempo di pace. Aldilà delle singole agende nazionali, la direzione della risposta è stata corretta. Molte delle regole che avevano disciplinato le nostre economie fino all’inizio della pandemia sono state sospese per far spazio a un pragmatismo che meglio rispondesse alle mutate condizioni. Una citazione attribuita a John Maynard Keynes, l’economista più influente del XX secolo ci ricorda “When facts change, I change my mind. What do you do sir?’’ Tutte le risorse disponibili sono state mobilizzate per proteggere i lavoratori e le imprese che costituiscono il tessuto delle nostre economie. Si è evitato che la recessione si trasformasse in una prolungata depressione. Ma l’emergenza e i provvedimenti da essa giustificati non dureranno per sempre.
Ora è il momento della saggezza nella scelta del futuro che vogliamo costruire. Il fatto che occorra flessibilità e pragmatismo nel governare oggi non può farci dimenticare l’importanza dei principii che ci hanno sin qui accompagnato. Il subitaneo abbandono di ogni schema di riferimento sia nazionale, sia internazionale è fonte di disorientamento. L’erosione di alcuni principii considerati fino ad allora fondamentali, era già iniziata con la grande crisi finanziaria; la giurisdizione del WTO, e con essa l’impianto del multilateralismo che aveva disciplinato le relazioni internazionali fin dalla fine della seconda guerra mondiale venivano messi in discussione dagli stessi Paesi che li avevano disegnati, gli Stati Uniti, o che ne avevano maggiormente beneficiato, la Cina; mai dall’Europa, che attraverso il proprio ordinamento di protezione sociale aveva attenuato alcune delle conseguenze più severe e più ingiuste della globalizzazione; l’impossibilità di giungere a un accordo mondiale sul clima, con le conseguenze che ciò ha sul riscaldamento globale; e in Europa, alle voci critiche della stessa costruzione europea, si accompagnava un crescente scetticismo, soprattutto dopo la crisi del debito sovrano e dell’euro, nei confronti di alcune regole, ritenute essenziali per il suo funzionamento, concernenti: il patto di stabilità, la disciplina del mercato unico, della concorrenza e degli aiuti di stato; regole successivamente sospese o attenuate, a seguito dell’emergenza causata dall’esplosione della pandemia. L’inadeguatezza di alcuni di questi assetti era da tempo evidente. Ma, piuttosto che procedere celermente a una loro correzione, cosa che fu fatta, parzialmente, solo per il settore finanziario, si lasciò, per inerzia, timidezza e interesse, che questa critica precisa e giustificata divenisse, nel messaggio populista, una protesta contro tutto l’ordine esistente. Questa incertezza, caratteristica dei percorsi verso nuovi ordinamenti, è stata poi amplificata dalla pandemia.
Il distanziamento sociale è una necessità e una responsabilità collettiva. Ma è fondamentalmente innaturale per le nostre società che vivono sullo scambio, sulla comunicazione interpersonale e sulla condivisione. È ancora incerto quando un vaccino sarà disponibile, quando potremo recuperare la normalità delle nostre relazioni. Tutto ciò è profondamente destabilizzante. Dobbiamo ora pensare a riformare l’esistente senza abbandonare i principi generali che ci hanno guidato in questi anni: l’adesione all’Europa con le sue regole di responsabilità, ma anche di interdipendenza comune e di solidarietà; il multilateralismo con l’adesione a un ordine giuridico mondiale. Il futuro non è in una realtà senza più punti di riferimento, che porterebbe, come è successo in passato, si pensi agli anni 70 del secolo scorso, a politiche erratiche e certamente meno efficaci, a minor sicurezza interna ed esterna, a maggiore disoccupazione, ma il futuro è nelle riforme anche profonde dell’esistente. Occorre pensarci subito.
Ci deve essere di ispirazione l’esempio di coloro che ricostruirono il mondo, l’Europa, l’Italia dopo la seconda guerra mondiale. Si pensi ai leader che, ispirati da J.M. Keynes, si riunirono a Bretton Woods nel 1944 per la creazione del Fondo Monetario Internazionale, si pensi a De Gasperi, che nel 1943 scriveva la sua visione della futura democrazia italiana e a tanti altri che in Italia, in Europa, nel mondo immaginavano e preparavano il dopoguerra. La loro riflessione sul futuro iniziò ben prima che la guerra finisse, e produsse nei suoi principi fondamentali l’ordinamento mondiale ed europeo che abbiamo conosciuto. È probabile che le nostre regole europee non vengano riattivate per molto tempo e certamente non lo saranno nella loro forma attuale. La ricerca di un senso di direzione richiede che una riflessione sul loro futuro inizi subito. Proprio perché oggi la politica economica è più pragmatica e i leader che la dirigono possono usare maggiore discrezionalità, occorre essere molto chiari sugli obiettivi che ci poniamo. La ricostruzione di questo quadro in cui gli obiettivi di lungo periodo sono intimamente connessi con quelli di breve è essenziale per ridare certezza a famiglie e imprese, ma sarà inevitabilmente accompagnata da stock di debito destinati a rimanere elevati a lungo. Questo debito, sottoscritto da Paesi, istituzioni, mercati e risparmiatori, sarà sostenibile, continuerà cioè a essere sottoscritto in futuro, se utilizzato a fini produttivi ad esempio investimenti nel capitale umano, nelle infrastrutture cruciali per la produzione, nella ricerca ecc. se è cioè “debito buono”. La sua sostenibilità verrà meno se invece verrà utilizzato per fini improduttivi, se sarà considerato “debito cattivo”. I bassi tassi di interesse non sono di per sé una garanzia di sostenibilità: la percezione della qualità del debito contratto è altrettanto importante. Quanto più questa percezione si deteriora tanto più incerto diviene il quadro di riferimento con effetti sull’occupazione, l’investimento e i consumi. Il ritorno alla crescita, una crescita che rispetti l’ambiente e che non umili la persona, è divenuto un imperativo assoluto: perché le politiche economiche oggi perseguite siano sostenibili, per dare sicurezza di reddito specialmente ai più poveri, per rafforzare una coesione sociale resa fragile dall’esperienza della pandemia e dalle difficoltà che l’uscita dalla recessione comporterà nei mesi a venire, per costruire un futuro di cui le nostre società oggi intravedono i contorni.
L’obiettivo è impegnativo ma non irraggiungibile se riusciremo a disperdere l’incertezza che oggi aleggia sui nostri Paesi. Stiamo ora assistendo a un rimbalzo nell’attività economica con la riapertura delle nostre economie. Vi sarà un recupero dal crollo del commercio internazionale e dei consumi interni, si pensi che il risparmio delle famiglie nell’area dell’euro è arrivato al 17% dal 13% dello scorso anno. Potrà esservi una ripresa degli investimenti privati e del prodotto interno lordo che nel secondo trimestre del 2020 in qualche Paese era tornato a livelli di metà anni 90. Ma una vera ripresa dei consumi e degli investimenti si avrà solo col dissolversi dell’incertezza che oggi osserviamo e con politiche economiche che siano allo stesso tempo efficaci nell’assicurare il sostegno delle famiglie e delle imprese e credibili, perché sostenibili nel tempo. Il ritorno alla crescita e la sostenibilità delle politiche economiche sono essenziali per rispondere al cambiamento nei desideri delle nostre società; a cominciare da un sistema sanitario dove l’efficienza si misuri anche nella preparazione alle catastrofi di massa. La protezione dell’ambiente, con la riconversione delle nostre industrie e dei nostri stili di vita, è considerata dal 75% delle persone nei 16 maggiori Paesi al primo posto nella risposta dei governi a quello che può essere considerato il più grande disastro sanitario dei nostri tempi. La digitalizzazione, imposta dal cambiamento delle nostre abitudini di lavoro, accelerata dalla pandemia, è destinata a rimanere una caratteristica permanente delle nostre società. È divenuta necessità: negli Stati Uniti la stima di uno spostamento permanente del lavoro dagli uffici alle abitazioni è oggi del 20% del totale dei giorni lavorati.
Vi è però un settore, essenziale per la crescita e quindi per tutte le trasformazioni che ho appena elencato, dove la visione di lungo periodo deve sposarsi con l’azione immediata: l’istruzione e, più in generale, l’investimento nei giovani. Questo è stato sempre vero ma la situazione presente rende imperativo e urgente un massiccio investimento di intelligenza e di risorse finanziarie in questo settore. La partecipazione alla società del futuro richiederà ai giovani di oggi ancor più grandi capacità di discernimento e di adattamento. Se guardiamo alle culture e alle nazioni che meglio hanno gestito l’incertezza e la necessità del cambiamento, hanno tutte assegnato all’educazione il ruolo fondamentale nel preparare i giovani a gestire il cambiamento e l’incertezza nei loro percorsi di vita, con saggezza e indipendenza di giudizio. Ma c’è anche una ragione morale che deve spingerci a questa scelta e a farlo bene: il debito creato con la pandemia è senza precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i giovani. È nostro dovere far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo pur vivendo in società migliori delle nostre. Per anni una forma di egoismo collettivo ha indotto i governi a distrarre capacità umane e altre risorse in favore di obiettivi con più certo e immediato ritorno politico: ciò non è più accettabile oggi. Privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza. Alcuni giorni prima di lasciare la presidenza della Banca centrale europea lo scorso anno, ho avuto il privilegio di rivolgermi agli studenti e ai professori dell’Università Cattolica a Milano.
Lo scopo della mia esposizione in quell’occasione era cercar di descrivere quelle che considero le tre qualità indispensabili a coloro che sono in posizioni di potere: la conoscenza per cui le decisioni sono basate sui fatti, non soltanto sulle convinzioni; il coraggio che richiedono le decisioni specialmente quando non si conoscono con certezza tutte le loro conseguenze, poiché l’inazione ha essa stessa conseguenze e non esonera dalla responsabilità; l’umiltà di capire che il potere che hanno è stato affidato loro non per un uso arbitrario, ma per raggiungere gli obiettivi che il legislatore ha loro assegnato nell’ambito di un preciso mandato. Riflettevo allora sulle lezioni apprese nel corso della mia carriera: non avrei certo potuto immaginare quanto velocemente e quanto tragicamente i nostri leader sarebbero stati chiamati a mostrare di possedere queste qualità. La situazione di oggi richiede però un impegno speciale: come già osservato, l’emergenza ha richiesto maggiore discrezionalità nella risposta dei governi, che non nei tempi ordinari: maggiore del solito dovrà allora essere la trasparenza delle loro azioni, la spiegazione della loro coerenza con il mandato che hanno ricevuto e con i principi che lo hanno ispirato. La costruzione del futuro, perché le sue fondazioni non poggino sulla sabbia, non può che vedere coinvolta tutta la società che deve riconoscersi nelle scelte fatte perché non siano in futuro facilmente reversibili. Trasparenza e condivisione sono sempre state essenziali per la credibilità dell’azione di governo; lo sono specialmente oggi quando la discrezionalità che spesso caratterizza l’emergenza si accompagna a scelte destinate a proiettare i loro effetti negli anni a venire. Questa affermazione collettiva dei valori che ci tengono insieme, questa visione comune del futuro che vogliamo costruire si deve ritrovare sia a livello nazionale, sia a livello europeo. La pandemia ha severamente provato la coesione sociale a livello globale e resuscitato tensioni anche tra i Paesi europei.
Da questa crisi l’Europa può uscire rafforzata. L’azione dei governi poggia su un terreno reso solido dalla politica monetaria. Il fondo per la generazione futura (Next Generation EU) arricchisce gli strumenti della politica europea. Il riconoscimento del ruolo che un bilancio europeo può avere nello stabilizzare le nostre economie, l’inizio di emissioni di debito comune, sono importanti e possono diventare il principio di un disegno che porterà a un Ministero del Tesoro comunitario la cui funzione nel conferire stabilità all’area dell’euro è stata affermata da tempo. Dopo decenni che hanno visto nelle decisioni europee il prevalere della volontà dei governi, il cosiddetto metodo intergovernativo, la Commissione è ritornata al centro dell’azione. In futuro speriamo che il processo decisionale torni così a essere meno difficile, che rifletta la convinzione, sentita dai più, della necessità di un’Europa forte e stabile, in un mondo che sembra dubitare del sistema di relazioni internazionali che ci ha dato il più lungo periodo di pace della nostra storia. Ma non dobbiamo dimenticare le circostanze che sono state all’origine di questo passo avanti per l’Europa: la solidarietà che sarebbe dovuta essere spontanea, è stata il frutto di negoziati. Né dobbiamo dimenticare che nell’Europa forte e stabile che tutti vogliamo, la responsabilità si accompagna e dà legittimità alla solidarietà. Perciò questo passo avanti dovrà essere cementato dalla credibilità delle politiche economiche a livello europeo e nazionale. Allora non si potrà più, come sostenuto da taluni, dire che i mutamenti avvenuti a causa della pandemia sono temporanei. Potremo bensì considerare la ricostruzione delle economie europee veramente come un’impresa condivisa da tutti gli europei, un’occasione per disegnare un futuro comune, come abbiamo fatto tante volte in passato. È nella natura del progetto europeo evolversi gradualmente e prevedibilmente, con la creazione di nuove regole e di nuove istituzioni: l’introduzione dell’euro seguì logicamente la creazione del mercato unico; la condivisione europea di una disciplina dei bilanci nazionali, prima, l’unione bancaria, dopo, furono conseguenze necessarie della moneta unica. La creazione di un bilancio europeo, anch’essa prevedibile nell’evoluzione della nostra architettura istituzionale, un giorno correggerà questo difetto che ancora permane. Questo è tempo di incertezza, di ansia, ma anche di riflessione, di azione comune. La strada si ritrova certamente e non siamo soli nella sua ricerca. Dobbiamo essere vicini ai giovani investendo nella loro preparazione. Solo allora, con la buona coscienza di chi assolve al proprio compito, potremo ricordare ai più giovani che il miglior modo per ritrovare la direzione del presente è disegnare il tuo futuro.
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- L’ORA DELLA SAGGEZZA. "Incertezza e responsabilità", il titolo della relazione di Mario Draghi che ha inaugurato il 41° Meeting di Rimini(di Paolo Viana).18 agosto 2020, di Federico La Sala
Rimini.
Draghi apre il Meeting: no a un mondo senza speranza, è l’ora della saggezza
Alle 11 si è aperta la 41esima edizione del Meeting dei Popoli, quest’anno in versione "light" in parte in presenza e per il resto trasmesso via social e tv
di Paolo Viana, inviato a Rimini *
Incertezza e responsabilità. E’ il titolo della relazione di Mario Draghi che ha inaugurato il 41° Meeting di Rimini ed è la chiave di lettura del mondo post-Covid che ci offre l’ex presidente della Bce. «Nelle attuali circostanze il pragmatismo è necessario - ha detto oggi al Meeting -. Dobbiamo accettare l’inevitabilità del cambiamento con realismo e, almeno finché non sarà trovato un rimedio al virus, dobbiamo adattare i nostri comportamenti e le nostre politiche. Ma non dobbiamo rinnegare i nostri principii. Dalla politica economica ci si aspetta che non aggiunga incertezza a quella provocata dalla pandemia e dal cambiamento. Altrimenti finiremo per essere controllati dall’incertezza invece di esser noi a controllarla. Perderemmo la strada».
Citando la preghiera per la serenità di Reinhold Niebuhr (Dammi la serenità per accettare le cose che non posso cambiare/ Il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare/ E la saggezza di capire la differenza), l’ex governatore di Bankitalia ha parlato tra l’altro dei sussidi erogati in questi mesi: «I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri. La società nel suo complesso non può accettare un mondo senza speranza; ma deve, raccolte tutte le proprie energie, e ritrovato un comune sentire, cercare la strada della ricostruzione».
L’intervento ha dedicato ampio spazio al tema dell’istruzione: «La situazione presente rende imperativo e urgente un massiccio investimento di intelligenza e di risorse finanziarie in questo settore. La partecipazione alla società del futuro richiederà ai giovani di oggi ancor più grandi capacità di discernimento e di adattamento».
Draghi ha sottolineato quindi che nel secondo trimestre del 2020 l’economia si è contratta a un tasso paragonabile a quello registrato dai maggiori Paesi durante la seconda guerra mondiale: «Alla distruzione del capitale fisico che caratterizzò l’evento bellico molti accostano oggi il timore di una distruzione del capitale umano di proporzioni senza precedenti dagli anni del conflitto mondiale.I governi sono intervenuti con misure straordinarie a sostegno dell’occupazione e del reddito. Il pagamento delle imposte è stato sospeso o differito. Il settore bancario è stato mobilizzato affinché continuasse a fornire il credito a imprese e famiglie. Il deficit e il debito pubblico sono cresciuti a livelli mai visti prima in tempo di pace. Aldilà delle singole agende nazionali, la direzione della risposta è stata corretta» ha commentato. Ma, ha aggiunto, «l’emergenza e i provvedimenti da essa giustificati non dureranno per sempre. Ora è il momento della saggezza nella scelta del futuro che vogliamo costruire».
Concludendo che «dobbiamo riformare l’esistente senza abbandonare i principi generali che ci hanno guidato in questi anni: l’adesione all’Europa con le sue regole di responsabilità, ma anche di interdipendenza comune e di solidarietà; il multilateralismo con l’adesione a un ordine giuridico mondiale».
Infine, ha parlato del debito pubblico e della ripresa. «La ricostruzione di questo quadro in cui gli obiettivi di lungo periodo sono intimamente connessi con quelli di breve è essenziale per ridare certezza a famiglie e imprese, ma sarà inevitabilmente accompagnata da stock di debito destinati a rimanere elevati a lungo. Questo debito, sottoscritto da Paesi, istituzioni, mercati e risparmiatori, sarà sostenibile, continuerà cioè a essere sottoscritto in futuro, se utilizzato a fini produttivi ad esempio investimenti nel capitale umano, nelle infrastrutture cruciali per la produzione, nella ricerca ecc. se è cioè "debito buono”. La sua sostenibilità verrà meno se invece verrà utilizzato per fini improduttivi, se sarà considerato "debito cattivo". I bassi tassi di interesse non sono di per sé una garanzia di sostenibilità: la percezione della qualità del debito contratto è altrettanto importante. Quanto più questa percezione si deteriora tanto più incerto diviene il quadro di riferimento con effetti sull’occupazione, l’investimento e i consumi».
E ha parlato anche della crescita. «Stiamo ora assistendo a un rimbalzo nell’attività economica con la riapertura delle nostre economie. Vi sarà un recupero dal crollo del commercio internazionale e dei consumi interni, si pensi che il risparmio delle famiglie nell’area dell’euro è arrivato al 17% dal 13% dello scorso anno. Potrà esservi una ripresa degli investimenti privati e del prodotto interno lordo che nel secondo trimestre del 2020 in qualche Paese era tornato a livelli di metà anni 90. Ma una vera ripresa dei consumi e degli investimenti si avrà solo col dissolversi dell’incertezza che oggi osserviamo e con politiche economiche che siano allo stesso tempo efficaci nell’assicurare il sostegno delle famiglie e delle imprese e credibili, perché sostenibili nel tempo».
TUTTI GLI ARTICOLI SUL MEETING DI RIMINI
*Avvenire, martedì 18 agosto 2020 (ripresa parziale, senza immagini).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- E se il nome di Europa avesse a che fare con il verbo greco che indica “lo scoprire”, “il trovare”, “l’inventare”? (di Marco Marino).9 agosto 2020, di Federico La Sala
La non-centralità alle origini dell’Europa
di Marco Marino (Treccani, Atlante, 26 luglio 2020)
«Miei cari: ditemi, dove sorge Atene, in quale terra?». Sembra una domanda innocente quella che la regina persiana Atossa, vedova del re Dario e madre di Serse, rivolge ai suoi fedeli sudditi nella tragedia di Eschilo, i Persiani. Dove sorge Atene, la città che in quel momento sta combattendo senza alcuna speranza contro l’esercito del figlio? L’armata di Serse, infatti, è di gran lunga più numerosa, più forte e più spietata, non c’è motivo di temere l’esito finale della guerra. Eppure, qualcosa la inquieta, un presagio che non riesce a decifrare. Si chiede dov’è quella città, in quale terra può sorgere un popolo tanto incosciente da tenere testa al regno che sta al centro del mondo.
Ecco, quell’interrogativo, che suona come un’incrinatura nella voce della regina, implica l’innocente certezza che la Persia sia il centro del mondo. Non c’è bisogno che lo attesti una mappa o un esploratore, la centralità del suo regno è stata la fissa e stabile sicurezza della sua vita e la ragione della forza del suo popolo. Ma nello stesso momento in cui pone quella domanda, qualcosa fuori e dentro di lei sta cambiando. Come se avesse avvertito un terremoto arrivare, come se si fosse accorta che la geografia che aveva sempre abitato, da un momento all’altro, stava per essere stravolta. O forse sarebbe meglio dire, scentrata.
In verità, è una storia di cui già conosciamo la fine: nella battaglia navale di Salamina del 480 a.C., Atene sconfigge la minaccia persiana. In che modo ci riesce, però? Cos’è andato storto? Senza soffermarci sulle mere strategie militari, e per provare a comprendere cosa effettivamente sbaraglia la flotta rivale, bisogna considerare una circostanza: a Salamina non ci troviamo di fronte all’ultimo duello tra Persia e Grecia, ma al primo scontro tra l’antica idea di Oriente e la nuova idea di Occidente. Tra l’idea di un impero centralizzato e piramidale e l’idea di una democrazia egualitaria e periferica. Due idee, due continenti: l’Asia, da una parte, e l’Europa appena nata, dall’altra.
 Lo storico Franco Cardini ne scrive in maniera efficace nei capitoli preliminari del suo saggio Lawrence d’Arabia (Sellerio, 2019): «I greci hanno inventato l’Occidente. Primi al mondo, per quanto noi ne sappiamo, hanno creato un modo di sentirsi non al centro dell’universo, bensì in una sua area periferica addirittura prossima all’estremità (quella dove il sole “va a morire”: beninteso, per chi lo guardi da una sponda mediterranea). Tutte le culture in generale si sentono al centro dell’universo: non quella occidentale. È un caso forse unico nelle millenarie vicende delle culture umane. L’Occidente nasce dalla consapevolezza di una non-centralità: d’altronde la Grecia era tributaria dell’impero persiano. Questa novità avrebbe segnato per sempre la “nostra coscienza identitaria occidentale”».
Lo storico Franco Cardini ne scrive in maniera efficace nei capitoli preliminari del suo saggio Lawrence d’Arabia (Sellerio, 2019): «I greci hanno inventato l’Occidente. Primi al mondo, per quanto noi ne sappiamo, hanno creato un modo di sentirsi non al centro dell’universo, bensì in una sua area periferica addirittura prossima all’estremità (quella dove il sole “va a morire”: beninteso, per chi lo guardi da una sponda mediterranea). Tutte le culture in generale si sentono al centro dell’universo: non quella occidentale. È un caso forse unico nelle millenarie vicende delle culture umane. L’Occidente nasce dalla consapevolezza di una non-centralità: d’altronde la Grecia era tributaria dell’impero persiano. Questa novità avrebbe segnato per sempre la “nostra coscienza identitaria occidentale”».Secondo Cardini, allora, è necessario attribuire ai Greci questa ennesima, rilevante scoperta: la coscienza della non-centralità del loro continente, la consapevolezza dell’essere periferici rispetto a qualcosa. Sono stati questi gli impareggiabili punti di forza che hanno permesso loro di vincere. D’altronde, il sentimento della non-centralità era già rintracciabile nella mitologia legata alle origini dell’Europa: a Sidone, lungo un fiume, insieme ad altre ragazze, la figlia del re Agenore e della regina Telefassa, chiamata Europa, sta raccogliendo dei fiori. Mentre gioca con le sue compagne, vengono tutte accerchiate da un branco di tori, tra questi uno di colore bianco si avvicina a Europa: lei lo accarezza e gli sale in groppa. Il toro bianco è Zeus, che ha cambiato le sue sembianze per rapire la principessa fenicia e portarla con sé in un continente sconosciuto. Che da quel momento da lei prenderà il nome.
Quindi il nome Europa non sorge da una inamovibile cultura millenaria, non descrive la fissità di un’idea di stato, ma racconta la storia di un rapimento, di un transito, di una dislocazione da una parte all’altra del Mediterraneo, da una periferia all’altra dell’universo conosciuto, senza centro, senza punti fissi: è un nome che custodisce la scoperta di un mondo nuovo e serba le tradizioni del mondo antico che ha dovuto abbandonare.
 Europa alcuni dicono significhi “dal vasto sguardo”, dividendo il sostantivo in due parti, eurys (“vasto”) e ops (“sguardo”). Altri, invece, pensano che sia connessa alla radice della parola Erebo, “la zona oscura”, dal momento che l’Europa è l’Occidente ovvero il luogo in cui tramonta il sole.
Europa alcuni dicono significhi “dal vasto sguardo”, dividendo il sostantivo in due parti, eurys (“vasto”) e ops (“sguardo”). Altri, invece, pensano che sia connessa alla radice della parola Erebo, “la zona oscura”, dal momento che l’Europa è l’Occidente ovvero il luogo in cui tramonta il sole.
 Nessuna etimologia è certa e fondata ed è per questo che vorremmo azzardare una terza ipotesi. E se il nome di Europa avesse a che fare con il verbo greco che indica “lo scoprire”, “il trovare”, “l’inventare”? Nella lingua di Eschilo si dice heurisko. A questo punto Europa non sarebbe più una zona d’ombra e nemmeno la capacità di una vista smisurata. Diventerebbe la fanciulla dallo sguardo adatto a scoprire, la donna destinata a trovare una terra inesplorata e a inventare dal nulla una civiltà diversa dalle precedenti. Una comunità senza centro, senza punti fissi.
Nessuna etimologia è certa e fondata ed è per questo che vorremmo azzardare una terza ipotesi. E se il nome di Europa avesse a che fare con il verbo greco che indica “lo scoprire”, “il trovare”, “l’inventare”? Nella lingua di Eschilo si dice heurisko. A questo punto Europa non sarebbe più una zona d’ombra e nemmeno la capacità di una vista smisurata. Diventerebbe la fanciulla dallo sguardo adatto a scoprire, la donna destinata a trovare una terra inesplorata e a inventare dal nulla una civiltà diversa dalle precedenti. Una comunità senza centro, senza punti fissi. -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- «Abolire subito le armi nucleari, anche l’Italia firmi il trattato». Appello di Pax Christi (di Giacomo gambassi).5 agosto 2020, di Federico La Sala
Pax Christi.
«Abolire subito le armi nucleari, anche l’Italia firmi il trattato»
di Giacomo Gambassi (Avvenire, mercoledì 5 agosto 2020)
«Immorali». Non aveva usato mezzi termini papa Francesco in Giappone lo scorso novembre per condannare gli armamenti nucleari e il loro potere distruttivo che hanno lasciato un segno indelebile ad Hiroshima e Nagasaki dove il 6 e il 9 agosto 1945 vennero sganciate le bombe atomiche americane.
Le parole del Pontefice, la sua «condanna» della minaccia nucleare, la denuncia dell’«affronto mortale» che mina non solo il benessere della terra ma anche il rapporto con Dio tornano nella lettera aperta che Pax Christi invia alla Cei in occasione del 75° anniversario dei bombardamenti atomici in Giappone dove sollecita i vescovi italiani a chiedere al Governo di firmare il trattato sul bando totale delle armi atomiche approvato dall’Onu nel 2017.
- 13.410 le testate nel mondo. Usa e Russia hanno il 90% delle testate:
- 5.800 quelle Usa (di cui 1.750 dispiegate), 6.375 quelle russe (1.570 pronte all’uso)
Il testo «ha un sempre più crescente sostegno mondiale», scrivono il vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, Giovanni Ricchiuti, e don Renato Sacco, rispettivamente presidente nazionale e coordinatore nazionale di Pax Christi. Tuttavia, aggiungono, «per diventare effettivo c’è bisogno di altre firme per superare la soglia necessaria di cinquanta Stati. Il Vaticano lo ha da tempo ratificato e le Conferenze dei vescovi cattolici di Giappone e Canada hanno chiesto ai loro esecutivi di fare altrettanto».
In Italia, invece, il tema sta passando sotto silenzio. «Nel nostro Paese - racconta don Sacco ad Avvenire - esistono due siti che ospitano ordigni nucleari: Aviano, in provincia di Pordenone, e Ghedi, nel Bresciano. Non sappiamo quanti siano ma il loro potenziale è di gran lunga più elevato di quello impiegato nel 1945. E, come dice il Papa, non va censurato solo l’uso ma anche il possesso».
Don Sacco ricorda il cartoncino fatto distribuire da Bergoglio a fine 2017 con la foto di un bambino di 10 anni che trasportava sulle spalle il cadavere del fratellino ucciso dalla bomba a Nagasaki. «Il Papa aveva scritto: “Il frutto della guerra...”. La tragedia avvenuta in Giappone è un monito per l’oggi, un grido sempre più attuale».
- 9 gli Stati che fanno parte del «club atomico»:
- Stati Uniti, Russia, Israele, Francia, Gran Bretagna, Cina, Pakistan, India, Corea del Nord
La lettera del Movimento cattolico per la pace prende spunto dall’emergenza Covid per riflettere sulla piaga atomica. «Le conseguenze dannose della pandemia impallidiscono rispetto a quelle che sarebbero capitate alla famiglia umana, e alla terra stessa, in caso di guerra nucleare», affermano Ricchiuti e Sacco. E spiegano che, mentre si cerca un vaccino al virus, «stiamo sperimentando come investire centinaia di miliardi di dollari per lo sviluppo, la fabbricazione, i test e lo spiegamento di armi nucleari non solo non è riuscito a renderci sicuri, ma ha privato la comunità umana delle risorse necessarie per il raggiungimento della vera sicurezza umana: sufficienza alimentare, alloggio, lavoro, formazione scolastica, accesso all’assistenza sanitaria».
- 12 milioni è la cifra (in dollari) che viene spesa ogni ora per mantenere in sicurezza gli arsenali, che richiedono una manutenzione continua
Ancora. «Di fronte al coronavirus le speranze di sopravvivenza nelle nostre comunità si sono fondate sul sacrificio in prima linea dei soccorritori. Eppure, ammonisce la Croce Rossa internazionale, tali soccorritori non ci sarebbero in caso di un attacco nucleare: i medici, gli infermieri e le infrastrutture sanitarie sarebbero essi stessi cancellati».
Ecco il richiamo. «La cosiddetta “sicurezza” offerta dalle armi nucleari si basa sulla nostra volontà di annientare i nostri nemici e la loro volontà di annientarci. A 75 anni dagli avvenimenti di Hiroshima e Nagasaki è giunto il tempo per rifiutare questa logica di reciproca distruzione e costruire una vera sicurezza».
Pax Christi chiarisce che in caso di una guerra nucleare, «anche se limitata», la vita sul pianeta «sarebbe messa in grave pericolo». Serve allora eliminare gli armamenti atomici. «Ma - conclude il movimento - la finestra temporale che ci resta potrebbe essere troppo breve. Se non riusciamo ad agire adesso e con decisione, giochiamo pericolosamente non solo con la pandemia ma anche con l’estinzione totale».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. --- "Amazzonizza te stesso!": il titolo della campagna in favore dell’Amazzonia della Conferenza episcopale del Brasile (Cnbb)26 luglio 2020, di Federico La Sala
Al via in Brasile la Campagna "Amazzonizza te stesso!"
Il lancio è previsto per domani. L’intento dei vescovi è di porre l’attenzione sulla violenza contro i popoli amazzonici, messi in pericolo anche dal coronavirus. Si tratta di un appello per partecipare attivamente alla salvaguardia dell’Amazzonia dove si sono intensificati, in tempo di pandemia, le attività estrattive, i roghi e la deforestazione
di Isabella Piro - Città del Vaticano *
“Amazzonizza te stesso!” è il titolo della campagna in favore dell’Amazzonia che la Conferenza episcopale del Brasile (Cnbb) lancerà lunedì 27 alle ore 16.00 locali. La presentazione avverrà in diretta streaming sul web e vedrà la collaborazione di diversi organismi ecclesiali e civili. La
campagna - si legge sul sito della Cnbb - “vuole essere attenta al contesto attuale, in cui la violenza contro i popoli tradizionali amazzonici è aggravata dalla pandemia di Covid-19” e in cui si registrano “la deforestazione, gli incendi, l’intensificazione delle attività estrattive”, che rappresentano ulteriori fattori di contagio del coronavirus “tra le comunità indigene”. “L’appello ad ‘amazzonizzare’ se stessi - continua la nota - propone la partecipazione attiva di tutti i popoli in difesa dell’Amazzonia, del suo bioma e dei suoi abitanti minacciati nei propri territori”.
 La Cnbb ricorda, infatti, “una realtà di tante vite offese, espulse dalle loro terre, torturate e uccise in conflitti agrari e socio-ambientali, vittime di una politica guidata dagli affari e da grandi progetti di sviluppo economico che non rispettano i limiti della natura e della sua salvaguardia”. Proseguendo il cammino intrapreso dal Sinodo speciale per l’Amazzonia, svoltosi in Vaticano nell’ottobre 2019, dunque, la campagna vuole porre al centro della riflessione la questione amazzonica e i rischi che essa corre, incluso quello della “distruzione dell’identità culturale”.
La Cnbb ricorda, infatti, “una realtà di tante vite offese, espulse dalle loro terre, torturate e uccise in conflitti agrari e socio-ambientali, vittime di una politica guidata dagli affari e da grandi progetti di sviluppo economico che non rispettano i limiti della natura e della sua salvaguardia”. Proseguendo il cammino intrapreso dal Sinodo speciale per l’Amazzonia, svoltosi in Vaticano nell’ottobre 2019, dunque, la campagna vuole porre al centro della riflessione la questione amazzonica e i rischi che essa corre, incluso quello della “distruzione dell’identità culturale”.Le azioni per "amazzonizzarsi"
Nello specifico, il lancio della campagna vedrà la presentazione di una raccolta di studi sulla realtà amazzonica, oltre a una serie di video con testimonianze delle popolazioni indigene e di personalità nazionali e internazionali. Prevista anche la diffusione di un elenco di azioni concrete da intraprendere, da soli o in gruppo, per “amazzonizzarsi”. Per questo, l’iniziativa si articolerà nella lotta a tre grandi questioni: “Vulnerabilità delle popolazioni indigene e delle comunità tradizionali al contagio da coronavirus, con particolare attenzione alle carenze delle strutture sanitarie pubbliche nella regione; accelerazione della distruzione del bioma amazzonico a causa dell’aumento incontrollato della deforestazione, degli incendi, dell’invasione dei territori indigeni e delle comunità tradizionali da parte delle multinazionali e degli effetti delle dighe idroelettriche sulle popolazioni fluviali; violazione sistematica della legislazione sulla protezione dell’ambiente e smantellamento delle agenzie governative” per espandere illegalmente le attività minerarie, la deforestazione e l’allevamento intensivo.
 Da ricordare che il neologismo “amazzonizzarsi” è stato usato per la prima volta nel 1986, in una lettera pastorale dell’allora vescovo di Rio Branco, monsignor Moacyr Grechi che invitò i fedeli ad abbracciare la causa dell’Amazzonia e la difesa dei suoi popoli.
Da ricordare che il neologismo “amazzonizzarsi” è stato usato per la prima volta nel 1986, in una lettera pastorale dell’allora vescovo di Rio Branco, monsignor Moacyr Grechi che invitò i fedeli ad abbracciare la causa dell’Amazzonia e la difesa dei suoi popoli.
 Ora, la campagna lanciata dalla Cnbb non solo vuole riprendere quel neologismo, ma anche lanciare un appello affinché “tutti ne facciano un’espressione personale per diventare, a loro volta, amazzonizzatori”.
Ora, la campagna lanciata dalla Cnbb non solo vuole riprendere quel neologismo, ma anche lanciare un appello affinché “tutti ne facciano un’espressione personale per diventare, a loro volta, amazzonizzatori”.* Fonte: Vatican News, 26 luglio 2020
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" ---- Il grido d’ allarme di Frei Betto: "fermare il genocidio che devasta il nostro caro e meraviglioso Paese".19 luglio 2020, di Federico La Sala
Internazionale
La politica necrofila di Bolsonaro sta compiendo un genocidio
La lettera. Il teologo, scrittore e politico Frei Betto lancia un grido d’allarme. Bolsonaro sta intenzionalmente lasciando diffondere l’epidemia per sbarazzarsi di anziani e poveri. È in corso un disastro umanitario
di Frei Betto (il manifesto, 19.07.2020)
Cari amici e amiche
In Brasile sta avvenendo un genocidio!
In questo momento che sto scrivendo, 16 luglio, il Covid, presente da febbraio, ha già ucciso 76 mila persone. Vi sono quasi 2 milioni di contagiati. Questa domenica 19/07 arriveremo a 80.0000 vittime. Ed è possibile che quando leggerai questo appello si sia arrivati a 100.000 mila vittime.
Quando ricordo che nella guerra del Vietnam, nel corso di 20 anni di storia, 58.000 militari americani furono scarificati, ho la consapevolezza della gravità della situazione nel mio Paese. E questo orrore causa indignazione e rivolta. E noi sappiamo che le misure di precauzione e restrizione, adottate in tanti altri Paesi, avrebbe potuto evitare un numero così alto di morti.
Questo genocidio è figlio dell’indifferenza del governo Bolsonaro. Si tratta di un genocidio intenzionale. Bolsonaro si compiace dell’altrui morte. Quando era un deputato federale in un’intervista del 1999 aveva dichiarato: “Tramite il voto non vai cambiare questo Paese, assolutamente in niente! Cambierà il Paese se ci sarà una guerra civile e se faremo ciò che la dittatura militare non ha fatto: uccidere 30 milioni di persone!”. Votando per l’impeachment della Presidente Dilma, Bolsonaro offrì il suo voto in memoria del più noto torturatore dell’Esercito, il Colonnello Brilhante Ustra.
Ed è talmente ossessionato dalla morte, che una delle principali politiche del governo è la liberazione del commercio delle armi. Intervistato all’ingresso del Palazzo presidenziale, se non gli importava di tutte le vittime della pandemia, Bolsonaro ha risposto: “Non credo a questi numeri “(7 marzo, 92 morti); “Tutti moriremo un giorno” (29 marzo, 136 morti); “E cosa posso farci?” (28 aprile, 5071 morti).
Perché questa politica “necrofila”? Sin dall’inizio Bolsonaro ha affermato che l’importante era salvare l’economia, non le vite umane. E così ha rifiutato di dichiarare il lockdown, di far proprie le linee guida dell’OMS e non ha importato respiratori e tute di protezione individuale. È stato necessario un pronunciamento del Supremo Tribunale che ha delegato questa responsabilità in materia di sanità ai governatori e ai sindaci. Bolsonaro non ha neppure rispettato l’autorità dei suoi ministri della Salute.
Da febbraio due ministri della Salute sono stati licenziati perché discordavano dalla linea del Presidente. Adesso vi è come ministro della Salute il generale Pazuello che non capisce nulla di sanità. Bolsonaro, inoltre, ha cercato di nascondere il dato delle morti; ha impiegato 38 militari in funzioni importanti ministeriali, senza la necessaria qualifica e ha cancellato tutte le interviste diarie attraverso le quali la popolazione riceveva orientamento.
Sarebbe esaustivo dire che tutte le misure per l’aiuto alle famiglie di reddito basso (cioè più di 100 milioni di brasiliani) non sono mai state eseguite.
Le intenzioni criminose del governo sono chiare. Lasciare morire gli anziani per risparmiare sulla Previdenza. Lasciare morire i portatori di malattie croniche per economizzare sulla spesa mutualistica. Lasciare morire i poveri per risparmiare i soldi del programma di assistenza “Bolsa Familia” e di altri programmi sociali destinati ai 52, 5 milioni di poveri che vivono in povertà e ai 13, 5 milioni che si trovano nella povertà assoluta (secondo i dati dello stesso governo federale).
Non soddisfatto con queste misure, il Presidente ha abrogato con il progetto di legge deliberato il 3 luglio scorso la norma di legge che obbligava all’uso di mascherine nei negozi aperti al pubblico, nelle scuole e nei templi di culto.. Ha vietato le multe previste per chi non ottempera a queste indicazioni e ha liberato il governo dall’obbligo di distribuire mascherine ai più poveri, che sono le principali vittime del Covid e alla popolazione carceraria. In ogni caso questi veti non annullano altre disposizioni di legislazioni locali che impongono l’uso delle mascherine.
L’8 luglio Bolsonaro ha eliminato le norme di legge, approvate dal Senato, che obbligavano il governo a fornire acqua potabile e materiale di igiene e pulizia, istallazione Internet, ceste alimentari, sementi e ferramenta agricole ai villaggi indigeni e ai quilombos (comunità nere, di discendenti africani).
Ha anche “bloccato” i fondi di emergenza destinati alla salute indigena, così pure le facilitazioni previste per gli abitanti dei villaggi indigeni e quilombos per incassare un assegno di 600 reais (100, 120 dollari) per tre mesi. Così pure ha eliminato l’obbligo del governo di fornire più letti ospedalieri e equipaggiamenti sanitari (maschere di ossigeno, ecc) a indios e abitanti dei quilombos.
Indios e quilombos sono stati decimati per la crescente devastazione socio ambientale, specialmente in Amazzonia.
Per favore divulgate questi crimini contro l’umanità! È assolutamente necessario che le denunce di ciò che sta avvenendo in Brasile arrivino ai Vostri governi, alle reti digitali, al Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU e al Tribunale dell’Aia, così come a Banche e imprese che fanno affari con il Brasile.
Ancor prima del giornale “The Economist”, nelle reti digitali parlo di Bolsonaro come un nuovo “Nerone”. In quanto Roma brucia, egli suona la lira e fa propaganda per la clorochina, che non ha nessuna efficacia scientifica contro il coronavirus... I suoi produttori sono però alleati del Presidente Bolsonaro!
Ringrazio per la divulgazione di questa lettera. Solo la pressione internazionale potrà fermare il genocidio che devasta il nostro caro e meraviglioso Paese.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- La guerra di Troia cantata da Omero una guerra civile. Un’ipotesi diventa certezza (di Paolo Martini).2 luglio 2020, di Federico La Sala
CULTURA
A Troia fu guerra civile: Godart riscrive leggenda omerica
(di Paolo Martini) *
Dagli ultimi scavi sulla collina di Hissarlik, in Turchia, un’ipotesi diventa certezza: a Troia non furono due popolazioni diverse a scontrarsi, molto più semplicemente fu una ’guerra civile’. Gli Achei venuti dalla Grecia combatterono contro gli Achei che si erano già insediati in città. Lo sostiene uno dei massimi studiosi delle civiltà egee, il professore Louis Godart, in un articolo che esce sul nuovo numero della rivista "Archeologia Viva" (Giunti Editore).
"Greci e Troiani parlavano la stessa lingua, avevano le stesse credenze, stessi usi e costumi, stesso tipo di armamento. Omero lo dice chiaramente nella sua Iliade. Oggi la conferma arriva dall’archeologia che aiuta a riscrivere un’intera pagina di storia, decisamente la più nota e popolare": così sintetizza la scoperta lo storico e archeologo Louis Godart, che ha insegnato Civiltà egee all’Università ’Federico II’ di Napoli ed è stato consigliere per la conservazione del patrimonio artistico presso la Presidenza della Repubblica italiana ed è membro dell’Accademia dei Lincei, dell’Institut de France e dell’Accademia di Atene.
"Le ricerche condotte a Troia dalla missione archeologica dell’Università tedesca di Tubinga abbinate a una riflessione sullo studio dei testi delle tavolette in lineare B scritte nel dialetto acheo dei Greci micenei - dichiara Godart - cambiano radicalmente le nostre prospettive sulla storia dell’Anatolia nord-occidentale e dell’Egeo alla fine del II millennio, in particolare tra il 1200 e il 1180 a.C.".
È a questo periodo che risale la cosiddetta Troia VIi (secondo le numerazione che gli archeologi hanno dato ai vari strati della lunga vita della città), in quel momento la città più importante dell’Anatolia e del Vicino Oriente, dove la gente si rifugiò all’interno delle mura sistemando nel suolo grandi vasi per lo stoccaggio di derrate alimentari (rinvenute dagli archeologi) per poter sostenere il lungo assedio che poi si concluse con la caduta della città, come lasciano intendere i resti umani e le tracce dei combattimenti rinvenuti nello strato di distruzione dell’insediamento.
Achei e Troiani, due facce dello stesso popolo. In Omero Achei e Troiani non sono mai differenziati in modo netto. Secondo l’Iliade, i due popoli pregavano gli stessi dèi, ai quali tributavano gli stessi sacrifici. Parlavano la stessa lingua e i troiani avevano nomi greci. Non vi sono mai problemi di comunicazione tra Achei e Troiani e anche il nome Ettore non era un nome barbaro per i greci, spiega sempre Godart. Vi era un culto di Ettore a Tebe; a Taso, isola vicina alla costa della Tracia, una divisione della città portava il nome di Priamides. In una serie di tavolette in lineare B (la scrittura dei Micenei) di Pilo, è stato identificato l’antroponimo ’e-ko-to’ che corrisponde al greco ’Hector’, mentre in un altro testo rinvenuto sempre nel palazzo di Nestore, c’era il patronimico ’e-ko-to-ri-jo’, ’Hectorio’s, ’figlio di Ettore’.
"Il nome Ettore è quindi un nome acheo, anche se nell’Iliade indica il grande campione troiano - illustra sempre Godart - Poiché i nomi degli eroi troiani sono greci, Omero, facendo parlare una stessa lingua agli Achei e ai Troiani, non fa altro che rispecchiare la situazione che vigeva sull’acropoli di Troia alla fine del XIII secolo a.C.".
"Sarei assolutamente propenso, come sostengo nel mio articolo su ’Archeologia Viva’ e nel mio libro ’Da Minosse a Omero’ (Einaudi) - spiega Godart - a ritenere che sia stata un’aristocrazia micenea a comandare a Troia nella fase VII che ispirò Omero. L’abbondante ceramica micenea rinvenuta sul sito di Troia negli strati del XIII secolo a.C. conforta indubbiamente una simile ipotesi. Se è davvero così e se Priamo era un re acheo, dovremmo ritenere che la guerra di Troia cantata da Omero sia stata una guerra civile in cui implacabilmente si opposero gli Achei del continente, delle isole e di Creta a altri Achei".
Louis Godart è autore di importanti pubblicazioni presso Einaudi: "Il disco di Festo. L’enigma della scrittura", "L’invenzione della scrittura", "L’oro di Troia. La vera storia del tesoro scoperto da Schliemann" (con Gianni Cervetti), e il recente "Da Minosse a Omero. Genesi della prima civiltà europea".
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE --- Le statue legate al periodo del colonialismo e della schiavitù potrebbero essere rimosse dalle più importanti chiese britanniche. Lo ha detto alla Bbc l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.26 giugno 2020, di Federico La Sala
Arcivescovo Canterbury: "Via statue razziste dalle chiese" *
Le statue legate al periodo del colonialismo e della schiavitù potrebbero essere rimosse dalle più importanti chiese britanniche. Lo ha detto alla Bbc l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, intervenendo nel dibattito avviato negli Stati Uniti, dove da giorni i manifestanti prendono di mira i monumenti dedicati a personalità che vengono legate ad un passato razzista. "Alcune dovranno essere rimosse - ha detto il capo della Chiesa anglicana - Alcuni nomi dovranno cambiare. Esamineremo molto attentamente la questione e vedremo se devono restare lì".
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- ADAMO ED EVA, MARIA E GIUSEPPE UGUALI DAVANTI A DIO : L’ALLEANZA DI FUOCO. SI’ ALLE DONNE VESCOVO: LA CHIESA ANGLICANA SORPASSA LA CHIESA "CATTOLICA"
VERITA’ E RICONCILIAZIONE. LA SAGGIA INDICAZIONE DEL SUDAFRICA DI MANDELA, DI TUTU, E DI DECLERCK
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
FLS
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE - Filologia e civiltà. Un "vecchio" invito a correggere un refuso tecnico.26 giugno 2020, di Federico La Sala
MONACI “BRASILIANI” NELLA TERRA DELLA “TRECCANI” (MA NON NELLA TERRA D’OTRANTO)! Filologia e civiltà...
di Federico La Sala *
ALLA LUCE DELLA PRESENTE STORICA SITUAZIONE, ricordando il recente intervento del prof. Armando Polito dal titolo “Quando l’Amazzonia era vicina a noi, ma c’è speranza...” e della mia nota su L’EUROPA E LE “REGOLE DEL GIOCO” DELL’OCCIDENTE (Fondazione Terra d’Otranto, 28/29 maggio 2020), sottoscrivo la sua “Lettera aperta a Massimo Bray,titolare del Mibac1″(Fondazione Terra d’Otranto, 26 maggio 2013) e rinnovo la sua costituzionale sollecitazione a non alimentare la già iperbolica diffusione di “fake news” e a correggere l’involontario refuso tecnologico.
PER LA STORIA E LA MEMORIA DELLA TERRA D’OTRANTO, non è più sopportabile che nella scheda relativa a Cesare Maccari ("Dizionario Biografico degli Italiani" - Treccani ) si legga e si continui a leggere che “Nel 1895 [...] fu incaricato da monsignor G. Ricciardi, vescovo di Nardò, di affrescare la cattedrale di S. Maria de Nerito [...] Il programma iconografico, dettato dal committente, era dedicato alla storia della salvezza dell’uomo e agli episodi locali del Trasporto delle reliquie di s. Gregorio Armeno, protettore della città, da parte dei monaci *BRASILIANI* e del Miracolo del crocifisso nero”! O no?!
*
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" - Tutti quei crimini che oggi incominciamo a vedere. Senza revisione (che non è revisionismo) la storia è nulla (di Franco Cardini).11 giugno 2020, di Federico La Sala
Statue abbattute e revisione storica.
Tutti quei crimini che oggi incominciamo a vedere
L’iconoclastia è una costante. E senza revisione (che non è revisionismo) la storia è nulla
di Franco Cardini (Avvenire, giovedì 11 giugno 2020)
- Un busto danneggiato del re del Belgio Leopoldo II
Nella complessa geografia politica dell’Africa le aree centrali del grande continente sono fra le più difficili da decifrare perché emergono - a poco a poco e solo da poco - dalla grande nebulosa che chiamiamo, collettivamente, Congo, e che ha dato vita a diversi Stati venuti fuori dai domini coloniali all’indomani della seconda guerra mondiale. Fra questi l’antico Congo belga oggi Repubblica Democratica del Congo, rimasta sotto il dominio di Bruxelles dal 1908 al 1960: ma prima di allora, tuttavia, la corona belga con il sovrano Leopoldo II aveva già giocato un ruolo importante nell’area.
Torniamo a parlarne oggi perché ad Anversa una statua del sovrano è stata rimossa da una piazza a seguito del movimento che, tra Stati Uniti e Europa, sta abbattendo o imbrattando le statue di personaggi che sono venerati come simboli della nazione, ma che allo stesso tempo si sono macchiati di crimini coloniali e schiavisti.
In Belgio il movimento Réparons l’Histoire ha lanciato una petizione chiedendo di rimuovere tutte le statue di Leopoldo II. Intendiamoci: è chiaro che la storia non si ’ripara’ e non è compito degli storici giudicare il passato; il loro ruolo è studiarlo, comprenderlo e insegnarlo. Tuttavia, non bisogna neppur credere ingenuamente che la realtà politica e il pensiero etico si esprimano e si esauriscano tutti e solo all’interno delle aule universitarie e dei seminari accademici: l’iconoclastia, cioè l’abbattimento dei simboli di potere o la cancellazione delle immagini, sono una costante della nostra storia; e la dimensione simbolica di tale azione non può nemmeno essere posta alla stregua di una qualche conferenza erudita.
A Londra una statua di Winston Churchill è stata imbrattata con uno scritta che accusa lo statista inglese di essere stato un razzista, il che è noto è comprovato: Churchill definiva ’bestie’ gli indiani e diceva che gli espropri dei Nativi americani e degli aborigeni australiani erano giustificati dalla necessità del trionfo della razza bianca; e fece anche di peggio, come quando durante la Seconda guerra mondale non permise alle derrate alimentari di raggiungere il Bengala, sotto il controllo britannico, affetto da una grave carestia, preferendo stornarle verso i suoi compatrioti: un’azione che portò alla morte di quattro milioni di persone.
Eppure per gli inglesi Winston Churchill significa la vittoria contro il nazifascismo: ecco che, dinanzi all’assenza di una memoria condivisa e al fenomeno per cui l’eroe secondo alcuni è un aguzzino secondo altri, la rabbia iconoclasta si propone come una risposta antropologicamente pregnante.
L’ha benissimo spiegato, a proposito di altre iconoclastie, David Freedberg nel suo apprezzatissimo Il potere delle immagini. Nel caso di Leopoldo II la storia è forse meno nota. Nel 1876, il re belga organizzò l’Associazione Internazionale Africana con la collaborazione dei principali esploratori sul continente e il sostegno di diversi governi europei per la promozione dell’esplorazione e della colonizzazione dell’Africa. Dopo che Henry Morton Stanley aveva esplorato la regione in un viaggio che si concluse nel 1878, Leopoldo corteggiò l’esploratore e lo assunse per sostenere i suoi interessi nella regione e, dal momento che il governo belga mostrava scarso interesse per l’impresa, il sovrano decise di portare avanti la questione per conto proprio.
La rivalità europea in Africa centrale condusse presto però a tensioni diplomatiche, in particolare per quanto riguardava il bacino del fiume Congo che nessuna potenza europea aveva ancora rivendicato. Nel novembre 1884 Otto von Bismarck convocò a Berlino una conferenza di 14 nazioni per trovare una soluzione pacifica alla crisi congolese. Nel corso di essa, pur senza formale approvazione delle rivendicazioni territoriali delle potenze europee in Africa centrale, ci si accordò su una serie di regole per garantire una pacifica spartizione dell’area. Esse riconoscevano il bacino del Congo come ’zona di libero scambio’ (un eufemismo splendido!). Leopoldo II uscì dai lavori della dalla Conferenza con una grande quota di territorio a lui assegnata come ’Stato libero del Congo, organizzato come un’impresa corporativa privata gestita direttamente da lui attraverso un ’libero sodalizio’, l’Association Internationale Africaine, appunto.
L’entità definita ’Stato libero’, comprendente l’intera area dell’attuale Repubblica Democratica del Congo, sussisté dal 1885 al 1908: solo allora, alla morte di Leopoldo, il governo belga procedette senza entusiasmo a un’annessione (molti i voti contrari in Parlamento). Sotto l’amministrazione di Leopoldo II, lo ’Stato libero del Congo’ era stato un disastro umanitario, un’autentica infame sciagura.
 La mancanza di dati precisi rende difficile quantificare il numero di morti causate dallo spietato sfruttamento e dalla mancanza di immunità a nuove malattie introdotte dal contatto con i coloni europei: come la pandemia influenzale del 1889-90, che causò milioni di morti anche nel continente europeo tra cui il principe Baldovino del Belgio. La Force Publique, esercito privato sotto il comando di Leopoldo, terrorizzava gli indigeni per farli lavorare come manodopera forzata per l’estrazione delle risorse. Il mancato rispetto delle quote di raccolta della gomma era punibile con la morte. Le punizioni corporali, comprese crudeli mutilazioni, erano ordinarie.
La mancanza di dati precisi rende difficile quantificare il numero di morti causate dallo spietato sfruttamento e dalla mancanza di immunità a nuove malattie introdotte dal contatto con i coloni europei: come la pandemia influenzale del 1889-90, che causò milioni di morti anche nel continente europeo tra cui il principe Baldovino del Belgio. La Force Publique, esercito privato sotto il comando di Leopoldo, terrorizzava gli indigeni per farli lavorare come manodopera forzata per l’estrazione delle risorse. Il mancato rispetto delle quote di raccolta della gomma era punibile con la morte. Le punizioni corporali, comprese crudeli mutilazioni, erano ordinarie.I miliziani della Force Publique erano tenuti a fornire una mano delle loro vittime come prova che ’giustizia era stata fatta’. Intere ceste di mani mozzate erano poste ai piedi dei comandanti; a volte i soldati ne tagliavano a prescindere dalle quote di gomma, per poter accelerare il congedo dal servizio militare. Nei raid punitivi contro i villaggi uomini, donne e bambini venivano impiccati e appesi alle palizzate.
 Il trattamento riservato agli indigeni, insieme alle epidemie, causò nel Congo di Leopoldo II una crisi demografica gravissima; anche se, come detto, le stime di morti variano, si parla di cifre che vanno tra i dieci e i venti milioni. Se tutti i regimi coloniali hanno accumulato una quota notevole di quelli che ormai definiamo ’crimini contro l’umanità’, e che nella pratica significano massacri impuniti di popolazioni locali, il caso di Leopoldo II è particolarmente efferato perché il Congo, prima del 1908, era una sua proprietà personale e le leggi provenivano direttamente da lui: da un sovrano costituzionale, cattolico e liberale.
Il trattamento riservato agli indigeni, insieme alle epidemie, causò nel Congo di Leopoldo II una crisi demografica gravissima; anche se, come detto, le stime di morti variano, si parla di cifre che vanno tra i dieci e i venti milioni. Se tutti i regimi coloniali hanno accumulato una quota notevole di quelli che ormai definiamo ’crimini contro l’umanità’, e che nella pratica significano massacri impuniti di popolazioni locali, il caso di Leopoldo II è particolarmente efferato perché il Congo, prima del 1908, era una sua proprietà personale e le leggi provenivano direttamente da lui: da un sovrano costituzionale, cattolico e liberale.
 Abbattere le statue dei responsabili di tali infamie non cambia certo il passato né risarcisce le vittime: semmai, chissà, forme più pesanti di damnatio memoriae sarebbero opportune soprattutto nei confronti di figuri che sino ad ieri venivano onorati come eroi civilizzatori. Il vero problema non è comunque l’iconoclastia quanto semmai il fatto che di questi crimini non si legga sui libri di scuola, che si continui a considerarli ’minori’ rispetto ad altri.
Abbattere le statue dei responsabili di tali infamie non cambia certo il passato né risarcisce le vittime: semmai, chissà, forme più pesanti di damnatio memoriae sarebbero opportune soprattutto nei confronti di figuri che sino ad ieri venivano onorati come eroi civilizzatori. Il vero problema non è comunque l’iconoclastia quanto semmai il fatto che di questi crimini non si legga sui libri di scuola, che si continui a considerarli ’minori’ rispetto ad altri.- Una statua sfregiata della regina Vittoria
Forse gli iconoclasti di oggi segnalano che finalmente è arrivato il momento di parlarne. San Giovanni Paolo II aveva fatto in merito un gesto esemplare e decisivo, quando aveva chiesto al genere umano perdono per i delitti dei cattolici nella storia. Ma quella scelta implicava anche un severo mònito: s’invitava con essa altre Chiese e religioni, altre associazioni, altri sistemi sociali a fare altrettanto. Molti risposero riduttivamente, quasi insoddisfatti: ’era ora’ che la Chiesa di Roma riconoscesse i suoi crimini. Il fatto era però che altri non erano stati da meno e molti erano stati da più: e non bastava certo l’alibi dell’unanime condanna dei delitti di Hitler e di Stalin. Papa Francesco, come gesuita argentino, sa bene che la Compagnia, nel Settecento, venne disciolta soprattutto in quanto alcuni governi europei protestarono contro la sua azione in favore degli indios dell’America latina contro le razzìe e i lavori forzati loro imposti dagli schiavisti.
E non parliamo del genocidio dei native Americans che fa parte integrante della storia della costruzione della ’nazione americana’ statunitense. Troppo comodo sarebbe, anche nelle scuole, continuar a condannare genericamente il colonialismo senza conoscerlo e senza studiarlo, fingendo di non sapere che esso fu parte della marcia verso il ’progresso’ e l’arricchimento dell’Europa liberista. Finché non faremo radicalmente e sistematicamente tutto ciò, il lavoro di ’purificazione della memoria’ indirizzato a stigmatizzare i crimini nazisti e stalinisti sarà un esercizio ipocritamente lasciato a metà strada. Non esistono crimini ’condannabili’ e crimini ’giustificabili’: i crimini sono crimini e basta.
Ed è fino dalla scuola che bisogna imparare a riconoscerli, anche con una diversa lettura del passato. E ciò, attenzione, non è ’revisionismo’. È puramente e semplicemente revisione alla luce di criteri di approfondimento e di lucidità. Perché se la storia non è revisione - vale a dire esame e verifica continua del passato alla, luce del presente e in funzione del futuro -, allora non è nulla.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" --- Giornata dell’Ambiente 2020. La lettera di Papa Francesco al presidente della Colombia.6 giugno 2020, di Federico La Sala
Giornata dell’Ambiente.
Il Papa: non possiamo fingerci sani in un mondo malato
La lettera di Francesco al presidente della Colombia, che ospita "virtualmente" la Giornata dell’Ambiente 2020: la casa comune va tutelata insieme
di Redazione Internet (Avvenire, venerdì 5 giugno 2020)
"Invertire la rotta", per un mondo "più vivibile" e una "società più umana". "Tutto dipende da noi, se lo vogliamo davvero". Lo scrive papa Francesco in una lettera, in spagnolo, al presidente della Repubblica di Colombia, Ivan Duque Marquez, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che ricorre oggi e che quest’anno è ospitata virtualmente dalla Colombia sul tema della biodiversità.
 IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA
IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA"Non possiamo pretendere di essere sani in un mondo malato. Le ferite causate alla nostra madre terra sono ferite che sanguinano anche in noi", denuncia il Papa. La cura degli ecosistemi, avverte, "ha bisogno di una visione del futuro. Il nostro atteggiamento verso il presente del pianeta dovrebbe impegnarci e renderci testimoni della gravità della situazione. Non possiamo tacere davanti al clamore quando verifichiamo i costi molto elevati della distruzione e dello sfruttamento dell’ecosistema".
Da qui il monito di Francesco: "Non è tempo di continuare a guardare dall’altra parte indifferenti ai segni di un pianeta che viene saccheggiato e violato, per l’avidità di profitto e in nome, molte volte, del progresso. È dentro di noi la possibilità di invertire la marcia e scommettere su un mondo migliore e più sano, per lasciarlo in eredità alle generazioni future. Tutto dipende da noi se lo vogliamo davvero".
Bergoglio ricorda il quinto anniversario dell’enciclica Laudato si’ appena celebrato e invita "a partecipare all’anno speciale" per il Creato. "E così, tutti insieme, per diventare più consapevoli delle cure e della protezione della nostra casa comune, così come dei nostri fratelli e sorelle più fragili e scartati nella società".
Infine Francesco incoraggia il presidente colombiano Marquez a deliberare "sempre a favore della costruzione di un mondo più vivibile e di una società più umana, in cui tutti abbiamo un posto e in cui nessuno sia lasciato indietro".
LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
A Sua Eccellenza Signor Iván Duque Márquez,
 Presidente della Repubblica di Colombia
Presidente della Repubblica di ColombiaSignore Presidente,
Sono lieto di rivolgermi a lei, a tutti i membri organizzatori e ai partecipanti della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che quest’anno si sarebbe dovuta celebrare in modo presenziale a Bogotá, ma che a causa della pandemia covid-19 si terrà in forma virtuale. È una sfida che ci ricorda che dinanzi all’avversità si aprono sempre nuovi cammini per stare uniti come grande famiglia umana.
La protezione dell’ambiente e il rispetto della “biodiversità” del pianeta sono temi che ci riguardano tutti. Non possiamo pretendere di essere sani in un mondo che è malato. Le ferite provocate alla nostra madre terra sono ferite che sanguinano anche in noi. La cura degli ecosistemi ha bisogno di uno sguardo di futuro, che non si limiti solo all’immediato, cercando un guadagno rapido e facile; uno sguardo che sia carico di vita e che cerchi la preservazione a beneficio di tutti.
Il nostro atteggiamento dinanzi al presente del pianeta dovrebbe impegnarci e renderci testimoni della gravità della situazione. Non possiamo rimanere muti di fronte al clamore quando comproviamo gli altissimi costi della distruzione e dello sfruttamento dell’ecosistema. Non è tempo di continuare a guardare dall’altra parte indifferenti dinanzi ai segni di un pianeta che si vede saccheggiato e violentato, per la brama di guadagno e in nome - molto spesso - del progresso. Abbiamo la possibilità d’invertire la marcia e puntare su un mondo migliore, più sano, per lasciarlo in eredità alle generazioni future. Tutto dipende da noi; se lo vogliamo veramente.
Abbiamo da poco celebrato il quinto anniversario della Lettera enciclica Laudato si’, che richiama l’attenzione sul grido che ci lancia la madre terra. Invito anche voi a essere partecipi dell’anno speciale che ho annunciato per riflettere alla luce di quel documento. E così, tutti insieme, prendere maggiormente coscienza della cura e della protezione della nostra Casa comune, come pure dei nostri fratelli e sorelle più fragili e scartati dalla società.
Infine, vi incoraggio in questo compito che avete intrapreso, affinché le vostre decisioni e conclusioni siano sempre a favore della costruzione di un mondo sempre più abitabile e di una società più umana, dove ci sia posto per tutti e dove nessuno sia di troppo.
E, per favore, vi chiedo di pregare per me. Che Gesù vi benedica e la Vergine Santa si prenda cura di voi.
Cordialmente,
Francesco
Vaticano, 5 giugno 2020
*L’Osservatore Romano, ed. quotidiana, Anno CLX, n. 128, 06/06/2020
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- COVID. Artisti e scienziati rispondono al grido di aiuto dei popoli dell’Amazzonia (di Lucia Capuzzi).29 maggio 2020, di Federico La Sala
L’evento.
Artisti e scienziati rispondono al grido di aiuto dei popoli dell’Amazzonia
Sono oltre 133mila i casi nella regione e quasi 7mila le vittime, tra loro già cinquecento nativi. Una maratona virtuale per aiutare gli indigeni, indifesi di fronte all’avanzare del Covid
di Lucia Capuzzi (Avvenire, giovedì 28 maggio 2020)
- [Foto]Controlli sanitari in Amazzonia brasiliana - Ansa
L’uragano Covid si abbatte sull’America Latina. E l’Amazzonia è nell’occhio del ciclone. Il Continente è il nuovo epicentro della pandemia, come ha affermato l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), con oltre 833mila contagiati e quasi 45mila vittime. Nella regione amazzonica - che abbraccia nove Paesi e un terzo della superficie regionale -, i casi sono oltre più di 133mila e i morti quasi 7mila, secondo i dati della Rete ecclesiale panamazzonica. Tra questi, oltre duemila positivi sono indigeni, come ha sottolineato il Coordinamento delle organizzazioni indie del bacino amazzonico (Coica). Le vittime fra i nativi sono più di cinquecento. Di fronte a questo scenario drammatico, i popoli della foresta, spesso dimenticati dai rispettivi governi, chiedono aiuto al mondo. Al loro fianco, si sono schierati artisti, scienziati, intellettuali che alle due di notte italiane - le 21 ora di Brasilia - realizzeranno “Artistas unidos pela Amazonia: progegendo os protetores”, per promuovere il Fondo Amazzonia, creato per soccorrere gli indios, indifesi di fronte al coronavirus (https://www.amazonemergencyfund.org/).
- [Foto] Una squadra di operatori sanitari fa prevenzione lungo il fiume - Ansa
L’evento virtuale, con musica e interviste - a cui partecipano tra gli altri le star di Hollywood Barbara Streisand, Jane Fonda e Morgan Freeman, lo studioso Nobel Carlos Nobre, nonché vari leader nativi - sarà trasmesso sul sito www.artistsforamazonia.org. «Rischiamo l’estinzione, la pandemia potrebbe portare a un nuovo genocidio», afferma José Gregorio Diaz Mirabel, coordinatore della Coica. Gli scarsi mezzi per la prevenzione, la precarietà delle strutture sanitarie e la corta memoria immunologica dei nativi, li rendono una “preda perfetta” per il virus. «Alla crisi sanitaria si somma l’incremento della violenza sui nostri territori - ribadisce Angela Kaxuyana, del Coordinamento delle organizzazioni indigene dell’Amazzonia brasiliana (Coiab) -. I cacciatori di risorse approfittano del momento in cui c’è minore attenzione per colpire. Non lasciateci soli».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE -- Amazzonia. Il Covid fa strage di indios: già 33 i popoli colpiti (di Lucia Capuzzi)..16 maggio 2020, di Federico La Sala
Amazzonia. Il Covid fa strage di indios: già 33 i popoli colpiti
Repam e Coica presentano il primo bilancio sull’impatto del virus nelle comunità native: 526 positivi e 113 morti. Lasciati soli dai governi, gli indigeni chiedono aiuto al mondo
di Lucia Capuzzi (Avvenire, venerdì 15 maggio 2020)
Un triplice virus infetta l’Amazzonia. Allo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali e allo smantellamento del sistema sanitario, ora si somma il Covid. Le conseguenze sono devastanti. Nella regione - che si estende per nove Paesi dell’America Latina e rappresenta quasi un terzo della superficie continentale - si contano ormai oltre 58mila malati di coronavirus e 3.554 vittime, secondo la Rete ecclesiale pan amazzonica (Repam) che monitora quotidianamente l’evolversi della pandemia. I dati finora non facevano distinzione tra nativi e il resto degli abitanti amazzonici. Ora, però, grazie alla collaborazione con la Coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica (Coica), Repam ha realizzato una mappa precisa del contagio nelle comunità indie, troppo spesso dimenticate nei registri ufficiali come dalle politiche governative. In base allo studio, presentato ieri da Repam e Coica, il Covid ha colpito 526 nativi di 33 differenti popoli e ne ha ucciso 113.
Numeri piccoli in termini assoluti ma drammatici rapportato allo scenario amazzonico dove numerose comunità hanno qualche decina di abitanti. Oltretutto, le principali vittime sono gli anziani, custodi della memoria ancestrale e pilastro dei villaggi. Nel bilancio, inoltre, non compaiono gli indios che abitano nelle metropoli della regione, come Manaus o Iquitos, che non vengono più considerati tali.
La metà dei casi è concentrata in Amazzonia brasiliana, dove si riportano 70 decessi. Le uniche nazioni della regione a non aver segnalato vittime fra gli indios sono Suriname e Venezuela. Paese quest’ultimo i cui dati - 13 positivi e nessun morto - destano forti dubbi.
Di fronte all’abbandono dei differenti governi, la Coica ha lanciato una raccolta globale per un Fondo di emergenza per il Covid in Amazzonia. L’obiettivo è quello di raccogliere tre milioni di dollari per assistere i tre milioni di nativi, divisi in 420 diversi popoli. «La situazione è grave», spiega José Gregorio Díaz Mirabal, presidente della Coica e esponente dell’etnia venezuelana Wakuenai Kurripaco. «Gli Stati ci hanno lasciati soli, per questo abbiamo deciso di unirci e chiedere aiuto al mondo. Già in passato, i virus hanno sterminato interi popoli, privi di anticorpi. Il Covid può provocare un nuovo genocidio. Intere culture rischiano di scomparire. E senza gli indios, i suoi guardiani, anche l’Amazzonia è in pericolo»
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" --- STORIA E FILOLOGIA: "IL DESTINO DI ROMA". un libro dello storico statunitense Kyle Harper (di Gabriele Nicolò).).16 aprile 2020, di Federico La Sala
L’impero romano tra cambiamenti climatici e pestilenze
In un libro dello storico statunitense Kyle Harper
di Gabriele Nicolò (L’Osservatore Romano, 15 aprile 2020)
Si racconta che uno storico tedesco abbia addotto duecentodieci motivi per spiegare il crollo dell’impero romano. Molto più parco è lo storico statunitense Kyle Harper che nel libro Il destino di Roma. Clima, epidemie e la fine di un impero (Torino, Einaudi, 2019, pagine 520, euro 34) di cause - a parte quelle “istituzionali” legate sia alle farraginose dinamiche della ormai fatiscente struttura governativa che al logorio dell’esercito e delle forze di combattimento in generale - ne individua due: i cambiamenti climatici e le pestilenze. Vale a dire, due cause che rivestono, evidentemente, un valore di attualità sorprendente e disarmante.
È vero che Giulio Cesare si vantava che i suoi soldati erano così vigorosi nel fisico che potevano resistere sia ai rigori dell’inverno che ai torridi raggi del sole d’estate, ma è altrettanto vero - rileva lo storico statunitense in un’intervista al settimanale francese «Nouvelle Observateur» - che i bruschi cambiamenti del clima, attestati tra l’altro da numerosi documenti d’epoca, con graduale e non arginata pressione finirono per incidere profondamente sulla popolazione dell’impero, e in particolare sulla psiche dei soldati, resi più vulnerabili dalle continue privazioni, inevitabile prezzo da pagare in una vita spesa sui campi di battaglia. E a dare il colpo di grazia al già fatiscente impero - sottolinea Harper - furono le pestilenze, la cui propagazione fu alimentata dalla vertiginosa crescita del numero della popolazione, non solo a Roma, ma anche nelle zone limitrofe, ovvero nelle campagne che, col declinare dell’impero, non vennero più adeguatamente bonificate come invece accadeva nei giorni di gloria.
In particolare - sostiene lo storico - a sbaragliare ogni forma di resistenza fu lo Yersinia pestis, che corrisponde alla moderna accezione di peste bubbonica. Un inquietante intreccio di morbi e di germi invase vaste regioni dell’impero mietendo, senza pietà, lutti e devastazione. I romani - ricorda Kyle Harper - avevano saputo come sconfiggere i nemici, anche perché aveva saputo imparare dalle lezioni derivanti dalle sconfitte subite. Ma non avevano le conoscenze e i mezzi adeguati per fronteggiare le ricorrenti pestilenze che certo potevano “approfittare”, per attecchire e poi infuriare, anche della mancanza di social distancing, misura certo non praticabile visto che i romani solevano vivere in ambienti molto ristretti e in accampamenti sovraffollati.
NOTA:
L’Impero romano e la ragione nascosta della sua caduta: una questione "filologica", epocale! L’ "In principio era il logos" (e sulla testa di tutti e di tutte, c’era la corona-virtus) diventa piano-piano l’ "In principio era il Logo" (e sul capo c’era il coronavirus)!!!
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. --- LA FINE DI UN MONOTEISMO CIECO E ZOPPO E LA COMUNITA’ CHE VIENE.14 aprile 2020, di Federico La Sala
LE ORIGINI DEL TOTALITARISMO, LA FEDELTA’ ALL’ AMORE DI HEIDEGGER ED HANNAH ARENDT, LA FINE DI UN MONOTEISMO CIECO E ZOPPO E LA COMUNITA’ CHE VIENE ... *
A) - UNA CASA DI CURA, UN OSPEDALE DA CAMPO: [...] Proprio un totalitarismo apolitico ed economico - fondato su una idea di soggetto come arbitrario e indefinito dispiegamento delle proprie potenzialità - ha impedito sinora di far fronte a tali questioni. Come la pandemia, si tratta di sfide che minano la sopravvivenza. Il virus ha scoperchiato il tetto e ci ha rigettato nella storia. Si può dunque iniziare da qui: dalla condizione storica in cui ci troviamo, che non è regredibile, e che è quella che la biopolitica analizza con acume. Se è vero che il potere sovrano si rivolge sempre più ai corpi, trovando un paradigma nell’oikos o nel campo, allora la “comunità che viene”, costituita da libertà non pure e astratte, ma malate e inchiodate a questi corpi, non potrà che iniziare a costituirsi nella forma di una casa di cura, o di un “ospedale da campo.” ( Francesco Valerio Tommasi, “Curarsi di. Una libertà inchiodata al corpo e alla storia”, Le parole e le cose, 14 aprile 2020);
B) - “UN NUOVO INIZIO”: “[...] Ma rimane altresì vero che ogni fine della storia contiene necessariamente un nuovo inizio; questo inizio è la promessa, l’unico «messaggio» che la fine possa presentare. L’inizio, prima di diventare avvenimento storico, è la suprema capacità dell’uomo; politicamente si identifica con la libertà umana. «Initium ut esset, creatus est homo», dice Agostino. Questo inizio è garantito da ogni nuova nascita; è in verità ogni uomo” (Hannah Arendt, “Le origini del totalitarismo”, Edizioni di Comunità, Milano 1996);
C) - ANTROPOLOGIA: KANT E LA RISCOPERTA DEL CORPO, LA RICERCA DI ENZO PACI SULLA NASCITA e la “fedeltà all’amore” di HEIDEGGER e ARENDT;
D) - CORONAVIRUS O SOVRANITA’ ( “CORONA VIRTUS”) ?! FILOLOGIA: ECCE HOMO! Ad evitare problemi di un cieco e zoppo monoteismo teologico-politico e biologico e uscire dal letargo e dalla caverna, ricordare che Ponzio Pilato disse: “«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)”;
E) - LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
*
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" --- Chi è il mostro oggi? Il coronavirus, la Merkel, l’Europa o forse noi stessi? (di Nicla Vassallo e Sabino Maria Frassà).9 aprile 2020, di Federico La Sala
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana ...
- [...] la nostra debolezza ci conduce spesso ad affondare nella palude della paura e della tuttologia, per abbracciare una colpevole strategia comunicativa, di matrice politica, che ammicca tanto a legittime angosce, quanto all’antico amor di sé, da cui non ricaviamo alcun aiuto, né sostegno. Avendo perso il nostro filo rosso, aiutiamoci a volare più in alto per vedere insieme non il mostro, ma quale sia la via d’uscita dal labirinto"(Nicla Vassallo e Sabino Maria Frassà).
Chi è il mostro oggi? Il coronavirus, la Merkel, l’Europa o forse noi stessi?
di Nicla Vassallo e Sabino Maria Frassà *
- “Il Mostro non è un virus, né un singolo Stato né un evento. Il Mostro risiede in noi e si alimenta dalle e nelle difficoltà e condizioni avverse... Abbiamo bisogno di saper condividere tale sofferenza, il che, pur non rinnegando i limiti e le difficoltà dell’oggi, si situa all’opposto di azioni e linguaggi che generano panico nell’altro-da-sé. Il Coronavirus è sì il Mostro (o uno dei mostri) di turno, al pari di altre pandemie che ci hanno afflitto in passato, ma pure al pari dell’atomica, impiegata a fini militari, dell’11 settembre, dell’Isis, e via dicendo, il che dovrebbe farci riflettere sulla nostra “universale” condizione errante, sulla finitezza umana e sull’impossibilità dell’onniscienza.” Nicla Vassallo & Sabino Maria Frassà
In attesa di un picco che non arriva, chiusi nelle nostre case, attraversiamo giorni claustrofobici e interminabili. Perduti in noi stessi, ci aggiriamo nelle nostre abitazioni-prigioni come se queste fossero labirinti. Dalla mitologia greca riusciamo ad attingere, quasi sempre, un appiglio significativo al fine di evitare un panico illimitato, che può condurci ad azioni del tutto irragionevoli, quale quella ad esempio di spendere le giornate inseguendo il roboante susseguirsi di notizie e numeri (per dolo o colpa) poco chiari riguardo lo sviluppo della pandemia di Coronavirus. Cerchiamo perciò di conferire un senso alla claustrofobia, pure oggettiva, ragionando sull’accezione di mostro. Chi è il mostro oggi?
IL MINOTAURO CORONAVIRUS
Recependoci smarriti e intrappolati nel labirinto della nostra psiche, ci sovviene in mente il mito del labirinto di Cnosso, abitato dal Minotauro. Frutto della gelosia e punizione divina, il Minotauro è feroce, impietoso, mostruoso, pure sul piano figurativo: il suo corpo ricalca quello di un maschio/uomo, mentre la sua testa quella di un toro. Teseo si offre di uccidere il Mostro e vi riesce. Rimane il problema di uscire dal labirinto, problema che viene risolto grazie all’ingegnosità e intelligenza di Arianna, con il suo noto e semplice filo rosso. Molti possono ritenere che il Minotauro sia il Coronavirus, mentre le ricerche scientifiche somiglino al il filo d’Arianna: troveranno il vaccino e ci consentiranno di sopravvivere piuttosto bene anche al post-virus? In ogni caso, al cospetto del Coronavirus, il Minotauro pare mostruoso, in una misura decisamente inferiore. Il Minotauro, alla fin fine, esige da Atene solo sette ragazzini e altrettante ragazzine all’anno, mentre sulla strage causata dal Coronavirus, quando e se verrà sconfitto, il numero di persone morte si ipotizza assai alto a livello mondiale. Ed economicamente come ci ritroveremo? Cosa prevarrà nei sopravvissuti? Egoismo? Altruismo? Narcisismo? Individualismo? E che dire della possibile crescita esponenziale di populismi e nazionalismi?
LA MEDUSA GERMANIA-EUROPA
Sempre alla mitologia greca dobbiamo Medusa, mostro che a differenza di altri/e, è mortale e con un tratto specifico, ovvero una testa cinta soprattutto di serpenti. Siamo portati a credere che la “nostra” Medusa sia la Germania, in quanto pietrifica ogni generosità europea e che l’Europa ci salvERà. Invece, da qualche giorno, stiamo osservando il problema in modo diverso, dato che quest’Europa pare non risultare affatto Gli Stati Uniti d’Europa, ovvero una Repubblica Federale, composta da più membri (Stati), tra loro uniti. Occultare l’attuale realtà non serve a nulla, se non a precipitare in un pericoloso auto-inganno: un aspetto innegabile della realtà è il fatto che l’Unione Europea si è trasformata (grazie anche a una certa recente politica del nostro paese) in un coacervo di avidità nazionali, con in testa la Germania e i pochi Paesi “ricchi” e virtuosi Paesi, che mal tollerano gli “scapigliati” e “spreconi” cugini poveri e “meridionali”.
LA CICLOPICA MERKEL
Riflettiamo infine sulla narrazione politica di questi giorni che descrive una fredda nonché calcolatrice Merkel in quarantena dopo l’incontro con un medico, risultato positivo, mentre adotta rigide misure nei confronti dei tedeschi. E che lo stesso stiano facendo i suoi colleghi di mezzo Mondo (Gran Bretagna, USA, Olanda in ordine sparso). Occorre chiedersi perché, fino a poco fa, si siano tutti percepiti immuni dal virus. Siamo alle solite, o no? Merkel: un “mostro” che cavalca i “conformisti cervelli” tedeschi? Anche, ma forse ci dimentichiamo come negli anni la Germania abbia destinato più risorse del proprio PIL alla sanità rispetto ad altri Paesi (che hanno magari preferito “investire” in pensioni insostenibili) e come sia un Paese che non ha bisogno di impiegare esercito o forze dell’ordine per far rispettare regole e leggi anti pandemia.
“Questo Mostro - sempre così latente - dovrebbe renderci più umili. Invece la nostra debolezza ci conduce spesso ad affondare nella palude della paura e della tuttologia, per abbracciare una colpevole strategia comunicativa, di matrice politica, che ammicca tanto a una legittime angosce, tanto nell’antico amor di sé, da cui non ricaviamo alcun aiuto, né sostegno. Avendo perso il nostro filo rosso, aiutiamoci a volare più in alto per vedere insieme non il mostro, ma quale sia la via d’uscita dal labirinto.“. Nicla Vassallo e Sabino Maria Frassà
CHI E’ ALLORA IL MOSTRO?
Sarebbe preferibile ammettere che non riusciamo a conferire un nome al Mostro. Non solo la realtà è così complessa e non c’è un unico mostro/nemico, ma dobbiamo ammettere che il “colossale”, nonché più che ragionevole, consiste nel nostro palese coinvolgimento in una situazione di cui risulta difficile una “veduta a volo d’uccello”, più alta e serena, basilare al fine di discernere tra miti e realtà. Oggi è meglio sospendere giudizi univoci, mantenere la lucidità e nutrire dubbi piuttosto che sentenze.
Possiamo così affermare che il Mostro non è un virus, né un singolo Stato né un evento. Il Mostro risiede in noi e si alimenta dalle e nelle difficoltà e condizioni avverse. Cerchiamo di guardare ai Mostri finora elencati con uno sguardo a volo d’uccello: il coronavirus è probabilmente determinato da uno sviluppo umano non sostenibile e dal conseguente cambiamento climatico. L’egotismo tedesco rintraccia un terreno fertile in quella politica italiana che ha fatto schizzare la spesa pubblica e il debito per fini meramente populistici, non affatto ai fini della crescita sul medio-lungo termine del Paese. Dopo la clamorosa bocciatura della Costituzione, l’Europa ha perduto la propria generosità perché di fatto l’Europa sognata dai Padri fondatori oggi non esiste e non esiste a causa del prevalere di troppi sovranismi (anche nostrani) oggi recriminanti.
COME CURIAMO I NOSTRI MOSTRI?
Come ci insegnano i Miti greci, all’intelligenza, alla razionalità e a una qualche astuzia dobbiamo la salvezza dai nuovi e illimitati Mostri, che accompagnano le nostre esistenze dall’inizio dei tempi.
Nel presente momento di difficoltà ci si appella profusamente all’empatia, anche se sarebbe forse meglio richiamare il bisogno di compassione e sostegno reciproco. La differenza non è poca: si corre infatti il rischio di limitare il nostro potere di reazione a bandierine, canzoncine e disegni, ovvero alla tentazione di crogiolarsi nella sofferenza. Abbiamo invece bisogno di saper condividere tale sofferenza, il che, pur non rinnegando i limiti e le difficoltà dell’oggi, si situa all’opposto di azioni e linguaggi che generano panico nell’altro-da-sé. Il Coronavirus è sì il Mostro (o uno dei mostri) di turno, al pari di altre pandemie che ci hanno afflitto in passato, ma pure al pari dell’atomica, impiegata a fini militari, dell’11 settembre, dell’Isis, e via dicendo, il che dovrebbe farci riflettere con sulla nostra “universale” condizione errante, sulla finitezza umana, sull’impossibilità dell’onniscienza.
Questo Mostro - sempre così latente - dovrebbe renderci più umili. Invece la nostra debolezza ci conduce spesso ad affondare nella palude della paura e della tuttologia, per abbracciare una colpevole strategia comunicativa, di matrice politica, che ammicca tanto a legittime angosce, quanto all’antico amor di sé, da cui non ricaviamo alcun aiuto, né sostegno. Avendo perso il nostro filo rosso, aiutiamoci a volare più in alto per vedere insieme non il mostro, ma quale sia la via d’uscita dal labirinto.
Nicla Vassallo e Sabino Maria Frassà, 1° aprile 2020 - dalla Quarantena ("amanutricresci").
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- AGONISMO TRAGICO E MENTE ACCOGLIENTE. LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" --- CORONAVIRUS, GUERRA, E METAFORE. Un immaginario diverso (di Franco Lorenzoni).7 aprile 2020, di Federico La Sala
Un immaginario diverso
di Franco Lorenzoni *
Trovo profondamente errato e fuorviante il continuo riferimento alla guerra che si fa in queste settimane. Contrastare una pandemia e combattere una guerra sono due azioni che non hanno nulla a che vedere. La guerra, qualsiasi guerra, si fonda sull’assassinio e la soppressione del nemico, il contrasto a un virus letale può contare solo sulla cura, la ricerca scientifica, comportamenti coerenti che fermino il contagio. Inoltre, come ha giustamente notato un ragazzo, “ai nostri nonni e bisnonni, un secolo fa, veniva imposto di partire per il fronte e finire carne da macello in trincea, a noi si chiede solo di stare chiusi in casa su un divano: c’è una bella differenza”.
Di comune c’è solo la presenza di donne e uomini che rischiano la vita, anche se in guerra affrontano il pericolo per uccidere nemici e bombardare innocenti, mentre in ospedale o visitando pazienti, infermieri e medici rischiano prendendosi cura e cercando di salvare più vite possibili.
Questa metafora, sbagliata e abusata, non la dobbiamo tuttavia dimenticare. Quando si dovrà decidere come e cosa ricostruire per uscire da una crisi economica che si annuncia devastante, dovremo ricordare con lucidità che per difenderci da possibili e probabili nuove pandemie, per affrontare le gravissime conseguenze del surriscaldamento globale che provoca già oggi milioni di profughi e vittime per siccità, inondazioni e fame, sarà necessario mettere al centro di ogni rinascita futura la necessità e il valore della cura reciproca, della ricerca scientifica, dell’arte e della cultura intese nel senso più ampio. Dovremo ricordare che le spese militari e i soldi per acquistare armi sono del tutto inutili per affrontare le enormi sfide che abbiamo di fronte, perché delle forze armate abbiamo constatato che le uniche armi utili sono gli ospedali da campo montati dagli alpini e da altri reparti militari.
Ancora una volta è parso evidente che dell’esercito può essere utile solo ciò che non è esercito: infermieri e medici militari che, invece di addestrarsi a usare armi per ferire, si sono formati per curare ferite.
 È tempo di ripensare con radicalità a ciò che davvero ci può difendere, riprendendo le intuizioni di Alexander Langer riguardo alla formazione in Europa di corpi civili di pace. Un solo sommergibile costa più di 5.000 posti letto di terapia intensiva, ha giustamente ricordato Gino Strada, che di guerre e ospedali ne sa qualcosa.
È tempo di ripensare con radicalità a ciò che davvero ci può difendere, riprendendo le intuizioni di Alexander Langer riguardo alla formazione in Europa di corpi civili di pace. Un solo sommergibile costa più di 5.000 posti letto di terapia intensiva, ha giustamente ricordato Gino Strada, che di guerre e ospedali ne sa qualcosa.Abbiamo sicuramente bisogno di più posti letto e ospedali migliori in ogni regione del nostro paese, dunque non potremo più tollerare tagli alla sanità pubblica. Abbiamo bisogno di più scienza e ricerca, quindi migliori università e ricercatori pagati degnamente, abolendo ogni numero chiuso per l’accesso alle facoltà. Abbiamo bisogno di una scuola più ricca, aperta e di qualità, con insegnanti in continua ricerca e formazione per riuscire finalmente a dare a tutte le ragazze e ragazzi la possibilità di terminare con successo i loro studi. Dovremo cercare di aumentare considerevolmente il numero dei laureati, che ha percentuali ridicole nel nostro paese, e affrontare di petto la ferita sociale della dispersione scolastica perché la povertà educativa, che è drammatica fonte di discriminazione sociale, va contrastata con politiche coerenti e l’impegno di ciascuno in ogni campo - dall’educazione alla formazione, all’arte e alla cultura diffusa nel territorio - perché la scuola da sola non ce la può fare (leggi anche il Manifesto dell’educazione diffusa, ndr)..
Lo sconcerto planetario di fronte a una tragedia della pandemia, che sta coinvolgendo miliardi di esseri umani, offre una straordinaria lezione a tutti noi e ci ricorda che l’alternativa è, davvero, tra istruzione e distruzione, tra scienza, conoscenza lungimirante, capacità di cura reciproca e passiva rassegnazione a modi di produrre, accumulare ricchezze, costruire e abitare che portano alla distruzione del territorio e dei fragili equilibri del pianeta che abitiamo. Naomi Klein sostiene che
- “solo una crisi reale o percepita produce un vero cambiamento”. A una condizione, tuttavia: “Quando una crisi si verifica, le azioni che vengono intraprese dipendono dalle idee che circolano”.
E allora è alle idee che circolano che dobbiamo prestare tanta attenzione quanta ne stiamo prestando al virus letale che attenta alle nostre vite. Ciascuno di noi - in particolare chi insegna - dovrebbe fare ogni sforzo per mantenere viva l’attenzione al linguaggio. Possedere un linguaggio per narrare questo tempo straordinario, tanti linguaggi per ragionare e provare a capire ciò che sta accadendo, è il più grande dono che la scuola deve tentare di offrire (anche a distanza) a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi che stanno vivendo momenti che ricorderanno tutta la vita. Questo tempo straordinario non sarà dimenticato, ma non lo si può comprendere davvero senza matematica e statistica, senza intendere qualcosa di biologia e di chimica.
Stiamo assistendo a eventi inimmaginabili e spaventosi e, come tutto ciò che è spaventoso, porta in sé elementi sconcertanti ed eccitanti. Chi ha mai visto le strade di New York deserte? Chi ha mai visto la propria città vuota e silenziosa? E allora cercare e affinare linguaggi che ci permettano di vivere con intensità e pensare con coscienza e profondità questo tempo che stiamo vivendo è più che mai necessario per nutrire la nostra memoria. E la memoria è tutto. Noi siamo la nostra memoria.
Guardarci dalle metafore che informano il nostro sentire ci aiuta non solo a fare esperienza con maggiore consapevolezza, ma anche a provare a immaginare una società capace di contrastare le malattie e catastrofi che ci attendono.
Nessuno avrebbe immaginato, solo due anni fa, che la cocciuta coerenza di una ragazza quindicenne avrebbe potuto scatenare una protesta giovanile mondiale per il clima, che non ha ancora prodotto risultati ma ha scosso le coscienze, ricordandoci quanto sia necessario rivedere la categoria dell’impossibile.
 Solo allargando il nostro immaginario e cimentandoci in un cambio radicale di paradigma possiamo ritrovare le radici della speranza.
Solo allargando il nostro immaginario e cimentandoci in un cambio radicale di paradigma possiamo ritrovare le radici della speranza.* Comune-info, 05 Aprile 2020 (ripresa parziale).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - UN SONNAMBULISMO DI LUNGA DURATA: VIVERE NELLA CAVERNA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS.29 marzo 2020, di Federico La Sala
UN SONNAMBULISMO DI LUNGA DURATA: VIVERE NELLA CAVERNA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS....
Nota a margine di "Il virus e l’inconscio. Diario di una quarantena" (di Sergio Benvenuto) *
FINALMENTE, E PIANO PIANO, EMERGE LA RADICALE CONSAPEVOLEZZA CHE “NOI” VIVAMO all’interno della “caverna”, dopo la “caduta”, e che uscire dal “letargo” (cf. Dante) è sempre più urgente. L’immaginario platonico-hegeliano ha esaurito ogni sua risorsa. L’orizzonte “andrologico” adamitico (e “ginecologico” eva-itico!) si va a chiudere, definitivamente:
«Attualmente politici, filosofi, moralisti, giornalisti, ripetono in Italia la stessa cosa: “Questa sarà un’occasione per renderci migliori!” Ricorrente idea consolatoria: pensare che se si attraversano catastrofi, tragedie, guerre, flagelli, poi si sarà migliori. Le traversie temperano il carattere, si diceva un tempo. [...] Attribuire agli umani tutti i mali è l’altra faccia di quella divinizzazione dell’Uomo (che risale a Pascal) che la filosofia più moderna ha denunciato: se si pensa che l’essere umano sia nel fondo potente come Dio, si penserà anche che possa avere la malvagia onnipotenza di Satana. Ma gli uomini non sono né Dio né Satana. »(SERGIO BENVENUTO - "Il virus e l’inconscio", cit., sopra)
SE CONSIDERIAMO CHE LA “SCIENTIFICA” TEO-LOGIA CATTOLICA COSTANTINIANA condivide ancora la “verità rivelata” dal cardinale Dario Castrillon Hoyos: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio” (dichiarazione alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio , “la Repubblica” del 17 novembre 2000, p. 35), -E CHE LEGGIAMO E INTERPRETIAMO l’ antropologico “Ecce Homo” di Ponzio Pilato ancora in temini “andrologici” e” viro-logici” (cf. il saggio “Ecce” di C. Ginzburg, in “Occhiacci di legno”; e il recente lavoro di S. Natoli su “L’uomo dei dolori”), ALLORA è più evidente che viviamo ancora NEL PASSATO, NELLA PREISTORIA, e che LA RISATA DI KANT ha ancora un carico di energia per svegliarci dal letargo, far crollare le pareti della caverna, e portarci fuori da millenni di labirinto (Nietzsche). Ricordiamo, su questo tema, anche la lezione di Elvio Fachinelli. O no?! Boh e bah?!
*
-
> RIPENSARE L’EUROPA! La buona-esortazione del BRASILE. --- «Spillover». Intervista a David Quammen (di Stella Levantesi).26 marzo 2020, di Federico La Sala
Europa
David Quammen: «Questo virus è più pericoloso di Ebola e Sars»
L’intervista. L’autore di «Spillover» (Adelphi, 2014) spiega il nesso tra uomini e pipistrelli. E perché la pandemia dipende soprattutto da noi
di Stella Levantesi (il manifesto, 25.03.2020)
Otto anni fa, nel 2012, il divulgatore scientifico e autore David Quammen ha scritto nel suo libro Spillover (Adelphi, 2014), una storia dell’evoluzione delle epidemie, che la futura grande pandemia («the Next Big One») sarebbe stata causata da un virus zoonotico trasmesso da un animale selvatico, verosimilmente un pipistrello, e sarebbe venuto a contatto con l’uomo attraverso un «wet market» in Cina.
Ma non si tratta di una profezia, Quammen è arrivato a queste conclusioni attraverso ricerche, inchieste e interviste accompagnate dai dati scientifici degli esperti.
Dalla sua casa in Montana, Quammen ci aiuta a comprendere meglio la pandemia di coronavirus, la sua genesi e il suo sviluppo.
Come avviene lo «spillover»?
Spillover è il termine che indica quel momento in cui un virus passa dal suo «ospite» non umano (un animale) al primo «ospite» umano. Questo è lo spillover. Il primo ospite umano è il paziente zero. Le malattie infettive che seguono questo processo le chiamiamo zoonosi.
Una delle sezioni del suo libro si chiama «Tutto ha un’origine», in che modo la distruzione della biodiversità da parte dell’uomo e l’interferenza dell’uomo nell’ambiente creano le condizioni per la comparsa di nuovi virus come il coronavirus?
Nei nostri ecosistemi si trovano molti tipi diversi di specie animali, piante, funghi, batteri e altre forme di diversità biologica, tutte creature cellulari. Un virus non è una creatura cellulare, è un tratto di materiale genetico all’interno di una capsula proteica e può riprodursi solo entrando all’interno di una creatura cellulare.
Molte specie animali sono portatrici di forme di virus uniche. Ed eccoci qui come potenziale nuovo ospite. Così i virus ci infettano. Così, quando noi umani interferiamo con i diversi ecosistemi, quando abbattiamo gli alberi e deforestiamo, scaviamo pozzi e miniere, catturiamo animali, li uccidiamo o li catturiamo vivi per venderli in un mercato, disturbiamo questi ecosistemi e scateniamo nuovi virus.
Poi siamo così tanti - 7,7 miliardi di esseri umani sul pianeta che volano in aereo in ogni direzione, trasportano cibo e altri materiali - e se questi virus si evolvono in modo da potersi trasmettere da un essere umano all’altro, allora hanno vinto la lotteria. Questa è la causa alla radice dello spillover, del problema delle zoonosi che diventano pandemie globali.
La distinzione tra zoonosi e non zoonosi aiuta in qualche modo a spiegare perché l’uomo ha sconfitto certe malattie e non altre? In altre parole, è più difficile “curare” le zoonosi? E se sì, perché?
Sì, è così. Il 60% delle malattie infettive umane sono zoonosi, cioè il virus è stato trasmesso da un animale in tempi relativamente recenti. L’altro 40% delle malattie infettive proviene da altro, da virus o altri agenti patogeni che si sono lentamente evoluti nel tempo insieme all’uomo.
Quindi possiamo sradicare le non zoonosi, il cui virus si è adattato solo a noi e non vive in altri animali. Il caso più famoso è il vaiolo, che abbiamo sradicato e ora esiste solo nei laboratori e non circola nella popolazione umana. Siamo riusciti a farlo perché non vive anche negli animali.
Se il vaiolo vivesse in un pipistrello o in una specie di scimmia, allora non potremmo liberarcene nella popolazione umana se non ce ne liberassimo anche in quell’animale, dovremmo uccidere tutti quei pipistrelli o curare anche loro dal vaiolo.
Ecco perché possiamo sradicare una malattia come il vaiolo ed è per questo che alla fine non potremo mai sradicare una zoonosi, a meno che non uccidiamo gli animali in cui vive.
Quindi, se un virus ci arriva dai pipistrelli, qual è la soluzione? Dovremmo uccidere tutti i pipistrelli?
No, la soluzione è lasciare i pipistrelli in pace, perché i nostri ecosistemi hanno bisogno dei pipistrelli.
Riguardo ai pipistrelli, il fatto che siano mammiferi come gli esseri umani rende più facile la trasmissione del virus da loro a noi? È proprio perché siamo entrambi mammiferi che lo «spillover» è più probabile?
Sì, è così. Molti dei virus che hanno causato le zoonosi negli ultimi 60 anni hanno trovato il loro ospite nei pipistrelli. Sono mammiferi come noi e i virus che si adattano a loro hanno più probabilità di adattarsi a noi rispetto a un virus che è in un rettile o in una pianta, per esempio.
La seconda ragione è che i pipistrelli rappresentano un quarto di tutte le specie di mammiferi sul pianeta, il 25%. È naturale, quindi, che sembrino sovra rappresentati come fonti di virus per l’uomo.
Ci sono un altro paio di cose oltre a questo che rendono i pipistrelli ospiti più probabili, vivono a lungo e tendono a rintanarsi in enormi aggregazioni. In una grotta, potrebbero esserci anche 60.000 pipistrelli e questa è una circostanza favorevole per far circolare i virus.
C’è un’altra cosa che gli scienziati hanno scoperto da poco: il sistema immunitario dei pipistrelli è più tollerante ad «estraneità» presenti nel loro organismo rispetto ad altri sistemi immunitari.
Da quanto ho capito le epidemie della storia non sono indipendenti l’una dall’altra ma, in qualche modo, sono collegate e ricorrenti per i motivi di cui abbiamo parlato prima, quindi dove vanno a finire i virus quando non presentano una minaccia diretta agli esseri umani?
Questa epidemia è talmente diffusa che potrebbe non scomparire del tutto, ma provo a fare un esempio diverso: l’Ebola nel 2014 in Africa occidentale. Non conosciamo ancora l’ospite con certezza ma sospettiamo che si tratti di pipistrelli. Si scatena un’epidemia che uccide migliaia di persone, medici e scienziati rispondono alla minaccia e finalmente rallentano l’epidemia che poi sparisce. Dove va a finire il virus? Se ne va? No, è ancora nell’ospite.
I virus non tornano dall’essere umano all’ospite ma il virus continua a risiedere nell’ospite. E questo è ciò che accade con la maggior parte di queste epidemie. Arrivano, colpiscono gli esseri umani, le persone soffrono, muoiono, gli esperti sanitari rispondono, l’epidemia viene messa sotto controllo, l’epidemia scompare e poi passano diversi anni prima che si ripeta. Dov’è il virus nel frattempo? È nell’ospite.
C’è una correlazione tra l’aumento del tasso di inquinamento in alcune zone e un impatto più forte del virus sulla popolazione di quella zona?
Sì, penso che ci possa essere una correlazione tra l’inquinamento dell’aria e i danni ai polmoni e alle vie respiratorie delle persone e quindi la loro suscettibilità a questo particolare virus. Credo che questa sia una domanda importante. Non abbiamo ancora risposte certe ma è una domanda che merita ricerca e attenzione.
È del tutto possibile che il danno ai polmoni delle persone, anche quando non si nota in circostanze normali, possa essere presente e sufficiente a renderle più vulnerabili a questo virus.
Un altro aspetto è che i sintomi arrivano più tardi del contagio. Quindi non c’è nessun allarme da parte dell’organismo che dice: «Sei infetto». Questo può rendere il Covid-19 più pericolosa di altre malattie che mostrano i sintomi prima?
Sì, la rende più pericolosa. Credo di aver scritto in Spillover che siamo stati fortunati con la Sars perché era un virus molto pericoloso: si diffondeva facilmente da un essere umano all’altro e aveva un alto tasso di mortalità, quasi il 10%, eppure, sarebbe stato peggio se le persone fossero state contagiose ancor prima di manifestare i sintomi. E ho scritto: «Dio non voglia che avremo a che fare con un virus grave come la Sars che si diffonde dalle persone prima che si vedano i sintomi». In questo momento abbiamo esattamente questo caso di virus.
Dicono che quando un proiettile ti colpisce non senti mai il colpo, perché il proiettile arriva prima e poi il suono arriva dopo. Questo virus funziona così.
Ho notato che la disinformazione scientifica che riguarda il coronavirus ha molti punti di contatto con le dinamiche della disinformazione climatica. Qual è la sua opinione al riguardo? E quanto è importante affrontare la disinformazione scientifica?
È estremamente importante affrontare la disinformazione scientifica. C’è sicuramente una sovrapposizione rispetto al cambiamento climatico. Ci sono persone che sono impazienti, arrabbiate e poco informate. Ricevono notizie da fonti inaffidabili e hanno appetito per una forma negativa di eccitazione. Hanno più interesse per le cospirazioni che per la scienza. La disinformazione si diffonde facilmente.
Dov’è la soglia limite tra l’offerta di notizie accurate, credibili, trasparenti e accessibili a tutti e il bombardamento continuo di “notizie” sul virus?
Esiste un limite e di informazione può essercene troppa. Viviamo in un mondo dove i media sono attivi 24 ore su 24 e vogliono aggiornamenti e occhi. Vogliono che la gente consulti la loro piattaforma perché hanno qualcosa un minuto prima di un’altra. È un tipo di competizione che non fa bene a nessuno - a parte agli azionisti della piattaforma stessa. Quindi penso che noi, come consumatori di notizie, dobbiamo resistere all’ossessione di sapere quale sia l’ultimo dato, l’ultimo caso, l’ultima notizia dell’ultima ora.
Dobbiamo seguire l’informazione sul virus, prestare attenzione al problema ma abbiamo bisogno anche di altre cose. Abbiamo bisogno di una copertura sul coronavirus che approfondisca le cause e gli effetti, ma anche di storie che non riguardino il coronavirus. Abbiamo bisogno di musica, di comicità, di arte, di persone che parlano di libri - e non solo del mio.
Che ruolo ha il sentimento di paura nelle dinamiche di comportamento collettivo durante una pandemia?
La paura è umana ed è naturale. Ma non è utile. Dobbiamo imparare di più su questo virus e prendere misure adeguate per controllarlo. Dobbiamo stare attenti, poi, che l’allontanamento sociale e l’autoisolamento non portino all’allontanamento emotivo e non cominciamo a vedere l’altro come una minaccia o un nemico. Quindi distanza sociale sì, ma con una connessione emotiva.
Cosa possiamo imparare da questa pandemia?
Prima di tutto possiamo imparare che le zoonosi possono essere molto pericolose e costose e dobbiamo essere preparati nell’affrontarle. Dobbiamo spendere molte risorse e molta attenzione nella preparazione.
Più posti letto in ospedale, più unità di terapia intensiva, più ventilatori, più mascherine, più formazione del personale sanitario, più formazione degli scienziati. Studiare piani di emergenza a livello locale, regionale, nazionale e tutto questo costa denaro.
L’altra cosa che dobbiamo imparare è che il modo in cui viviamo su questo pianeta ha delle conseguenze, delle conseguenze negative. Noi dominiamo questo pianeta come nessun’altra specie ha mai fatto. Ma ci sono conseguenze e alcune prendono la forma di una pandemia da coronavirus. Non è una cosa che ci è capitata. È il risultato delle cose che facciamo, delle scelte che prendiamo. Tutti ne siamo responsabili.
Ovviamente nessuno conosce davvero la risposta a questa domanda, ma come vede il mondo dopo il coronavirus? Cosa pensa che cambierà per le società e per la vita delle persone?
Spero che alla fine anche persone come Donald Trump imparino a prendere sul serio queste cose. Dobbiamo fare degli aggiustamenti. Potrebbe essere che inizieremo a ridurre il nostro impatto in termini di clima, di tutti i combustibili fossili che bruciamo, in termini di distruzione della diversità biologica, di invasione dei diversi ecosistemi. Forse cominceremo ad avere un passo più attento e più leggero su questo pianeta. Questo è quello che spero, ed è l’unico bene che può venire da questa esperienza.
Il sito dell’autrice è stellalevantesi.com. Sul manifesto in edicola il 25 marzo 2020 è stata pubblicata una versione ridotta di questa intervista. La versione in inglese è sul manifesto global.
-
> RIPENSARE L’EUROPA. La buona-esortazione del BRASILE --- Il riscaldamento globale al tempo del coronavirus (di Giuseppe Di Capua e Silvia Peppoloni).25 marzo 2020, di Federico La Sala
Il riscaldamento globale al tempo del coronavirus
di GIUSEPPE DI CAPUA e SILVIA PEPPOLONI*
Il coronavirus (Covid19) ha eclissato la comunicazione e il dibattito nei media sul riscaldamento globale, i cambiamenti climatici, l’economia verde, le minacce antropiche agli ecosistemi, l’inquinamento da plastiche negli oceani, ed altro ancora.
Il dato aggiornato al 16 gennaio 2020 del livello di CO2 atmosferica, misurato al Mauna Loa Observatory nelle Hawaii, segna un nuovo incremento, raggiungendo il valore di 413 parti per milione.
Il mondo è giustamente spaventato dal coronavirus e dalle conseguenze sanitarie di una pandemia rapida e ancora parzialmente ignota. L’economia globale è entrata in una fase di crisi che potrebbe addirittura avere conseguenze superiori alla grande crisi del 2007-2009. Le catene di approvvigionamento mondiali in grado di spostare rapidamente enormi flussi di energia e materia da una parte all’altra del pianeta si sono bruscamente interrotte o hanno ridotto la loro capacità operativa. Crolla il prezzo del petrolio per ragioni legate anche a strategie economiche e geopolitiche guidate dal alcune nazioni produttrici: questo renderà il greggio una fonte energetica ancora più appetibile per far ripartire l’economia nel breve futuro, ricordandoci ancora una volta che la storia energetica dell’umanità non è fatta di transizioni, ma di addizioni energetiche (Bonneuil e Fressoz, 2019) e che nei prossimi anni occorrerà aspettarsi una modifica del mix energetico utilizzato dalle società umane (con un incremento delle fonti rinnovabili di energia), piuttosto che un completo abbandono delle fonti fossili.
L’unica notizia di rilievo, ripresa ampiamente dai social media e dai media tradizionali in tema ambientale, è la riduzione dell’inquinamento in Cina da biossido di azoto (NO2), un gas prodotto dalla combustione ad alta temperatura che provoca forte irritazione polmonare. La riduzione sembrerebbe essere dovuta in larga parte al blocco delle attività industriali e alla drastica riduzione del trasporto veicolare per effetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid19. Anche nella Pianura Padana, area tra le più inquinate d’Europa, la riduzione dell’inquinamento da NO2 per il rallentamento dell’economia mostra una chiara evoluzione.
Il riscaldamento globale e tutti gli effetti associati sono quasi scomparsi dai media. Eppure non c’è da essere meno preoccupati della pandemia in corso, come fa notare il meteorologo Luca Mercalli in una recente intervista. Mario Tozzi su La Stampa collega l’epidemia in atto ai danni ambientali antropogenici. Allo stesso modo fa Simona Re sulla rivista Micron per la quale “clima e salute viaggiano in tandem” rifacendosi a quanto afferma il direttore dell’Istituto di Genetica molecolare del CNR-IGM di Pavia per spiegare la maggiore frequenza delle epidemie negli ultimi decenni. Del resto sempre Simona Re fa notare che “la sovrappopolazione e la crescente frequenza e rapidità dei nostri spostamenti sono fattori di rischio per lo scatenarsi di un’epidemia”.
Una cosa è certa: nella comune percezione il riscaldamento globale in questo momento non è un problema. D’altro canto, su La Stampa Jacopo Pasotti riflette sulle differenze nella risposta umana alla crisi ambientale e a quella sanitaria per pandemia, affermando che “dopo decenni di indifferenza”, l’emergenza climatica “sta forse cominciando a generare una comunque tiepida preoccupazione”.
In ogni caso, l’odierno atteggiamento generale delle persone verso l’emergenza climatica è del tutto comprensibile, viste anche le differenti scale temporali su cui gli effetti del coronavirus (da pochi giorni a qualche mese) e del riscaldamento globale (da qualche anno ad alcuni decenni) si sviluppano.
Ma come scrive Francesca Mancuso su greenMe, richiamandosi alle affermazioni di Antonio Guterres, Segretario Generale dell’ONU, e di Petteri Taalas (segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale) per i quali i cambiamenti climatici sono mortali, più del coronavirus, “Sembra incredibile agli occhi di un italiano, costretto a casa per paura del contagio, eppure il riscaldamento globale ci riguarda da vicino e può mettere a repentaglio la nostra vita e quella delle generazioni future”.
Di certo l’emergenza del Covid19 insegna, o meglio conferma, alcune riflessioni già emerse da alcuni anni nell’ambito della geoetica (etica per la gestione dell’interazione tra gli esseri umani ed il sistema Terra) (Peppoloni e Di Capua, 2020), utili proprio per affrontare la crisi ambientale in corso:
1) I comportamenti individuali fanno la differenza nell’affrontare anche le crisi globali. Alla base della catena di azioni che una società deve mettere in atto per risolvere i suoi problemi, c’è sempre il singolo individuo, chiamato a confrontarsi con il senso di responsabilità verso se stesso, gli esseri umani più prossimi, la società come comunità ampia delle relazioni umane.
2) Le responsabilità personali, inter-personali e verso la società sono fondamentali per vivere in salute e sicurezza in una società globalizzata, fortemente interconnessa.
3) La responsabilità di ciascuno verso il sistema Terra, implica il rispetto dei sistemi socio-ecologici (Berkes e Folke, 1998; Ostrom, 2009). La disattenzione e l’azione umana violenta nei confronti degli ecosistemi hanno l’effetto di accrescere l’esposizione e quindi il rischio di tutte le comunità umane a fenomeni imprevedibili che possono mettere a repentaglio l’attuale strutturazione della società globalizzata, portandola ad un collasso sistemico.
Da queste riflessioni, derivano alcune considerazioni etiche e sociali generali:
a) L’individuo non può sottrarsi dal confrontarsi con il proprio senso di responsabilità articolabile nei quattro domini etici dell’esperienza umana: il sé, la relazione prossimale con gli altri nelle comunità sociali di riferimento, la società per esteso, il sistema Terra da intendersi come aggregato complesso di sistemi socio-ecologici. Il comportamento irresponsabile anche di un solo individuo può generare nel tempo una crisi sistemica planetaria.
b) Le catene di approvvigionamento globale devono essere riprogettate per aumentare la resilienza in caso di shock. Una loro ridefinizione non può prescindere dall’intervento di “progettisti”/operatori capaci di pensare in modo sistemico e provvisti di una cultura del rischio non solo di tipo economico. La vulnerabilità dei sistemi integrati non è questione affrontabile semplicemente in termini ingegneristici, poiché si alimenta di fattori imprevedibili che sono noti, studiati e valutati da numerose discipline, tra cui la medicina e le geoscienze (o scienze della Terra). Una pandemia o un disastro innescato da un fenomeno naturale non sono imponderabili fenomeni della natura, ma eventi di cui è possibile quantificare incertezza e probabilità di accadimento e di impatto. L’approccio multidisciplinare alle questioni globali è una prassi da attuare con urgenza.
c) La creazione di una governance internazionale, chiara e strutturata preventivamente in campo sanitario e ambientale, non è più procrastinabile, ma impone scelte politiche all’interno degli stati nazionali e tra essi per favorire l’integrazione delle decisioni che impattano un sistema umano ormai globalizzato, a dispetto di azioni che si riferiscano solo a localismi e particolarismi. La diversità va tutelata, ma non totemizzata. Non si può continuare a posticipare una governance necessaria per affrontare una possibile grande crisi sistemica globale che in un non lontano futuro potrà interessare tutto il pianeta, se le attuali generazioni umane non saranno state in grado di prendere decisioni drastiche ed efficaci per ridurre gli impatti globali antropogenici.
d) Per la prima volta nella storia, l’umanità è chiamata a realizzare un quadro di riferimento di principi e di valori comuni che sappiano andare oltre la Carta dei Diritti dell’Uomo per diventare una Carta per lo Sviluppo Umano Responsabile, in grado di integrare in uno stesso orizzonte ideale la dimensione individuale e sociale della responsabilità umana e farsi prassi attraverso un sentimento di comune appartenenza di specie.
e) La modifica dei paradigmi economici, sociali e politici richiesti per dare una concreta ed efficace risposta ai problemi antropogenici globali ha bisogno di un cambiamento anche culturale nella società. Non è solo con leggi e provvedimenti che verrà impostato il cambiamento necessario. Occorre rendere i cittadini consapevoli e responsabili con un’azione sul piano educativo. Questo significa che nei prossimi anni gli investimenti nei sistemi scolastici, oltre che nella ricerca, dovranno costituire un obiettivo prioritario dell’azione dei governi. Il diritto non può sostituirsi all’educazione in una civiltà avanzata, specie se democratica.
f) Merito e competenza sono valori che devono essere messi al centro di un nuovo patto sociale tra i cittadini. Mai come in questo momento di emergenza sanitaria, chiunque esige risposte affidabili ed autorevoli da coloro che conoscono i problemi da un punto di vista scientifico, pur con incertezza e lacune, e da coloro che devono prendere di conseguenza delle decisioni difficili per la collettività. Allo stesso modo, affrontare il riscaldamento globale e tutti i problemi ecologici planetari esige competenza, studio, aggiornamento professionale, cooperazione onesta, confronto leale, apertura al dialogo, e decisioni politiche che siano scientificamente fondate e attentamente soppesate attraverso il parere di scienziati e tecnici.
Il tempo dell’improvvisazione e del pressappochismo sta per finire.
*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Riferimenti
Berkes F. and Folke C. (Eds.) (1998). Linking Social and Ecological Systems. Cambridge University Press, Cambridge.
Bonneuil C. e Fressoz J-B. (2019). La Terra, la storia e noi - L’evento Antropocene. Trad.: A. Accattoli e A. Grechi. Istituto della Enciclopedia Italiana, pag. XVII-367. ISBN: 978-8812007363.
Ostrom E. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. Science, vol. 325, pp. 419-422. doi:10.1126/science.1172133.
Peppoloni S. e Di Capua G. (2020). Geoetica e impatti globali antropogenici. In: Matione G. e Romanelli E. (a cura di): Il Corpo della Terra: La Relazione Negata. Castelvecchi Editore, Roma. ISBN 8832828715.
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- CORONAVIRUS E LETTERATURA: ANCHISE SULLE SPALLE DI ENEA, IL BAMBINO SULLE SPALLE DI SAN CRISTOFORO, E LA MEMORIA DI DANTE ("DANTEDì")24 marzo 2020, di Federico La Sala
CORONAVIRUS E CIVILTA’: ENEA, SAN CRISTOFORO, E DANTE - OGGI:
- A
La civiltà è Enea che porta Anchise sulle spalle
di Laura Marchetti (il manifesto, 24.03.2020)
«L’Italia vede decimata la generazione anziana, punto di riferimento per i giovani e per gli affetti». Le parole dette ieri dal presidente della Repubblica italiana, in maniera solenne e commovente, sembrano così voler far scudo contro quell’aberrante e diffusa convinzione, espressa in maniera più o meno sotterranea, che le morti così numerose non siano state poi così importanti perché riguardavano i vecchi, per di più già malati. Mattarella al contrario ci ricorda quale patrimonio siano i vecchi, come siano indispensabili per i bambini, proprio in quanto “rimbambiti”, ovvero anche loro bambini, disposti a giocare, a divagare, a trasgredire.
E come siano importanti per i giovani, per la possibilità che hanno di trasmettere loro antichi saperi, valori vissuti, comunitarie tradizioni, forme diverse di presa dello spazio e di percezione dei tempi. E come, in definitiva, siano importanti per ognuno di noi, perché nel tempo dell’effimero e dell’oblio, di fronte agli spettacoli e ai consumi, mostrano il valore degli affetti teneri, dei ricordi, della memoria e del compianto.
Le parole del presidente sono dunque dense di significato educativo ed esistenziale ma hanno anche un impatto politico radicale perché, per la prima volta, interrompono la filosofia eugenetica che è la pratica e lo spirito di questi insani tempi. Dal documento degli anestesisti spagnoli alla teorizzazione dell’immunità di gregge degli inglesi, fino alla sottrazione forzata dell’assistenza sanitaria accaduta in certi ospedali italiani, si teorizza la necessità, per la “medicina delle catastrofi”, di scegliere fra i vecchi e i giovani, come fra i deboli e i forti. Una scelta dovuta allo stato di eccezione e alla situazione estrema, tesa a sottrarre responsabilità alla coscienza personale, che porta però con sé la traccia indelebile di un giudizio di qualità dato alla vita, come se una vita - la più forte, la più abile - fosse solo per questo degna di essere mantenuta, mentre un’altra con più facilità dovrebbe essere rottamata.
In tale scelta gerarchica - che, perdurando lo stato di eccezione, potrebbe essere estesa anche a tutti i disabili e a tutti i fragili - si conserva il segreto del potere totalitario e della società “tanatologica”, la società di massa del ‘900 che si fonda su un continuo commercio con la morte.
Lo dice Elia Canetti in un libro magnifico e terribile scritto in anni bui e insani quasi come questi (Masse e Potere). In questa società tanatologica, potente diviene sia il capo, che acquisisce potere di morte, sia chi si distingue dalla morte sopravvivendo. La sopravvivenza è di per se stessa acquisizione di potere.
Chi è morto giace, sta per terra; chi sopravvive sta in piedi. Già solo questa collocazione spaziale rende “l’istante del sopravvivere, l’istante della potenza”, anche perché inconsciamente insorge la convinzione di una vera e propria “elezione”, una emozione comparativa che non risparmia nessun rapporto, nemmeno quello più affettivo, nemmeno quello con i figli o i genitori o i fratelli. Su questo senso di elezione si fonda dunque il totalitarismo, secondo Canetti. Ma, potremmo aggiungere, anche il capitalismo in quanto tale trasforma in Pil la sopravvivenza, poiché miglior produttori sono i vivi, cioè gli abili, i giovani, i forti.
C’è nel potere contemporaneo quindi, il persistere di una barbarie di fondo, una inciviltà. La civiltà si fonda invece al contrario e nasce quando Enea in fuga dall’incendio, porta con se il vecchio padre sulle spalle e, per mano, il giovane figlio. La pietà, che è la sua qualità esistenziale e la sua qualità sociale, lo spinge nell’aiutare, includere tutti, curare tutti, anche a scapito della propria sopravvivenza, del proprio potere.
Quella pietà è anche l’intelligenza della specie, in quanto la specie sopravvive, sottolineano i biologi della complessità, non nella lotta ma perché la madre continua ad allattare il figlio e perché gli uomini, anche quando vivono rintanati, non sono topi che si distruggono ma anzi si prestano soccorso.
Noi, nell’agenda delle cose che dobbiamo mettere in campo quando finirà la guerra e vorremmo fare il mondo nuovo, dovremmo mettere in campo la pietà. Fin da ora, in quanto già ora abbiamo due problemi. Il primo è quello di non morire, ma il secondo è quello di vivere civili.
- B
UN CAMBIAMENTO DI ROTTA FONDAMENTALE, UNA METANOIA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA URGENTE, PER QUANTI PRETENDONO DI ESSERE "PORTATORI DI CRISTO" DA UNA RIVA ALL’ALTRA DEL FIUME DEL TEMPO... *
Caro don Santino Bove Balestra
Vista la tensione e la passione personali che animano la sua Lettera "a san Cristofaro al tempo del Coronavirus" e, al contempo, sollecitato dalle sue stesse associazioni collegate a questa figura di gigante buono («Ti hanno fatto - forse un po’ abusivamente - diventare il patrono degli automobilisti (dopo essere stato più propriamente il protettore dei facchini): oggi dovresti ispirare chi dall’automobile passa alla bicicletta, al treno o all’uso dei propri piedi!»), il discorso fatto appare essere una forma implicita di autocritica "istituzionale" (cioè, da parte dell’intera Istituzione Chiesa paolina-costantiniana) della propria capacità di "portare Cristo" in giro, di qua e di là, avanti e indietro - e, della totale e più generale cecità antropologica e pedagogica, nei confronti del "Bambino" (che ognuno e ognuna di noi, tutti e tutte, è)!
SE,OGGI, AL TEMPO DEL CORONAVIRUS *, VALE l’esortazione “Restiamo tutti a casa!”, altrettanto sicuramente, domani, vale la consapevolezza che “Nulla sarà più come prima!” e, ancor di più, se vogliamo veramente cambiare rotta, che la “conversione eco-logica” (la ristrutturazione della nostra stessa "casa" !) è già "oggi necessaria", ora e subito ! Non c’è alcun tempo da perdere.
Portar-si il "bambino" sulle proprie spalle, « suprema fatica e suprema gioia », è impresa ancora tutta da tentare - e non ha nulla a che fare con il "sacrificio" e con la "messa in croce" di alcun "Bambino" ! O no?! -- *Federico La Sala
- C
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaFederico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE - Giornata mondiale delle Foreste, persa metà della superficie.21 marzo 2020, di Federico La Sala
Giornata mondiale delle Foreste, persa metà della superficie
Sos Wwf,ecosistemi antivirus del Pianeta, urgenti misure Ue 2021
di Redazione ANSA
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Oggi quasi la metà della superficie forestale che abbracciava e proteggeva il nostro Pianeta, non esiste più: si stima, infatti, che rispetto ai 6.000 miliardi di alberi che abbracciavano la terra all’inizio della rivoluzione agricola, oggi ne restino circa la metà, 3.000 miliardi. Solo la deforestazione produce dal 12% al 20% delle emissioni di gas serra e questo la rende una delle cause principali del riscaldamento globale.
Questo l’allarme lanciato dal Wwf nella Giornata mondiale delle Foreste. In un Rapporto appena pubblicato dal titolo ’Pandemie, l’effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi’, il Wwf evidenzia in particolare che "i cambiamenti di uso del suolo e la distruzione di habitat naturali come le foreste sono infatti responsabili dell’insorgenza di almeno la metà delle zoonosi emergenti".
"La deforestazione, spesso legata a pratiche illegali, agricoltura intensiva, zootecnia e cambiamenti climatici, sfocia nell’aumento esponenziale degli incendi", sottolinea l’associazione ambientalista nel rapporto Foreste. Dopo un 2019 di fuoco per Amazzonia, Bacino del Congo, Artico e Indonesia, l’inizio del 2020 ha visto l’Australia fronteggiare i roghi più catastrofici di sempre.
 "Qui si stima che oltre un miliardo di animali siano morti nelle fiamme e più di 12 milioni di ettari siano andati in fumo. Non è più confortante la situazione dell’Amazzonia, dove abbiamo ormai perso più del 17% della superficie forestale e stiamo drammaticamente raggiungendo un punto di non ritorno (tipping point), che diversi autorevoli scienziati indicano intorno al 25% del complessivo ecosistema amazzonico distrutto: oltre questo punto le foreste non saranno più in grado di svolgere le loro funzioni ecologiche e potrebbero arrivare al collasso, lasciando dietro di séerosione, siccità e aride savane".
"Qui si stima che oltre un miliardo di animali siano morti nelle fiamme e più di 12 milioni di ettari siano andati in fumo. Non è più confortante la situazione dell’Amazzonia, dove abbiamo ormai perso più del 17% della superficie forestale e stiamo drammaticamente raggiungendo un punto di non ritorno (tipping point), che diversi autorevoli scienziati indicano intorno al 25% del complessivo ecosistema amazzonico distrutto: oltre questo punto le foreste non saranno più in grado di svolgere le loro funzioni ecologiche e potrebbero arrivare al collasso, lasciando dietro di séerosione, siccità e aride savane".Il Wwf cita poi lo studio pubblicato sulla rivista Nature, illustrato da Wannes Hubau, ricercatore al Museo Reale dell’Africa centrale di Bruxelles, secondo il quale entro il 2040, "quello che attualmente rappresenta il polmone verde del nostro Pianeta potrebbe produrre più Co2 di quanta sia in grado di immagazzinare". E all’Europa il Wwf chiede "una nuova forte proposta di legge entro il 2021". (ANSA).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" --- Usa e Uk - Leadership morale anglosassone in crisi. Quell’aspra abdicazione (di Marco Tarquinio).17 marzo 2020, di Federico La Sala
Leadership morale anglosassone in crisi.
Quell’aspra abdicazione
di Marco Tarquinio (Avvenire, martedì 17 marzo 2020)
Siamo tutti parte di una generazione di italiani e di europei cresciuta nel cono di luce dei miti anglo-americani. Stati Uniti d’America e Regno Unito di Gran Bretagna, Usa e Uk, nazioni plurali e sistemi politico-sociali “speciali” in grado di esprimere leadership eroiche ed efficaci nella vittoriosa resistenza ai totalitarismi del Novecento, di vegliare sul consolidamento e la piena riconquista di libertà e democrazia nell’Europa continentale e di seminare con senso politico e filantropico (questo più gli americani dei britannici) semi di solidarietà (magari un po’ ogm) e idee e modelli coinvolgenti. Regni di nome e di fatto - come nella favole e in natura - e percepiti, a torto o a ragione, come moralmente superiori rispetto a quelli del Vecchio Continente, anche quando prendevano letteralmente a sberle certa morale e politica latina e mitteleuropea. Ebbene, ecco il punto, non so quanti di noi, in piena crisi mondiale da coronavirus, oggi affiderebbero salute, vita dei più fragili, destino comune del mondo - o anche solo di quel pezzo di mondo che abbiamo imparato a chiamare Occidente - ai grandi capi di Londra e di Washington.
La realtà è che con incresciosaa determinazione e quasi all’unisono, facendo anche baruffa tra loro, i “titolari” della grandi democrazie anglosassoni hanno abdicato al ruolo ereditato. Hanno abdicato alla leadership morale. Una primazìa con conseguenze, interessi e responsabilità che sinora talvolta qualche leader pro-tempore aveva tradito o mal indirizzato, ma che nessuno mai era arrivato a fare pubblicamente a pezzi come è invece accaduto in questi giorni esigenti e tesi. Boris Johnson, premier britannico e ultimo (e improbabile) discendente della genìa di leader conservatori che ha in Winston Churchill il capostipite, ha impostato la battaglia d’Inghilterra contro il coronavirus con malthusiana, algida sufficienza: qualche centinaio di migliaia di cittadini - soprattutto anziani, disabili, già malati - che moriranno, non valgono per lui la scelta di tenere il più possibile al riparo un popolo-gregge che solo pagando il prezzo della “scrematura” si farà immune. -Donald J. Trump dopo aver fatto a lungo finta di nulla, forse illudendosi di aver avuto dal virus un assist decisivo nella guerra commerciale con la Cina, ha lasciato che il suo nome finisse impigliato in un’altra di quelle storie, storielle e storiacce affaristico-politiche che non ne hanno intaccato più di tanto la popolarità in patria, ma ne costellano sempre più la presidenza agli occhi dell’opinione pubblica mondiale.
 La storia stavolta è quella di un presunto tentativo di deviare dalla Germania verso gli Usa, accaparrandosela, una delle più promettenti linee di ricerca del vaccino per Covid-19. Di certo c’è l’imbarazzante accusa e un subitaneo cambio al vertice della società coinvolta, imbarazzate smentite e l’approdo della questione sul tavolo di un redivivo G7 con un formale impegno a “globalizzare” la potenziale arma anti-coronavirus. Nessuno può far solo per sé e pensare solo a sé. Ovvio. Ma i cavalieri bianchi d’America e di Britannia stavolta non hanno galoppato in testa al gruppo, bandiere al vento, e neppure in mezzo. Ma ai lati, sovranamente concentrati su se stessi, e poco più.
La storia stavolta è quella di un presunto tentativo di deviare dalla Germania verso gli Usa, accaparrandosela, una delle più promettenti linee di ricerca del vaccino per Covid-19. Di certo c’è l’imbarazzante accusa e un subitaneo cambio al vertice della società coinvolta, imbarazzate smentite e l’approdo della questione sul tavolo di un redivivo G7 con un formale impegno a “globalizzare” la potenziale arma anti-coronavirus. Nessuno può far solo per sé e pensare solo a sé. Ovvio. Ma i cavalieri bianchi d’America e di Britannia stavolta non hanno galoppato in testa al gruppo, bandiere al vento, e neppure in mezzo. Ma ai lati, sovranamente concentrati su se stessi, e poco più.Rieccoci al punto. Nei giorni della pandemia preconizzata da tempo eppure arrivata come tempesta improvvisa e devastante, proprio in questi giorni di disciplina e di timore, di generosità e di abnegazione da parte di sanitari e di semplici cittadini, di preti e di artisti, di uomini in divisa e di politici chi vorrebbe avere BoJo e “The Donald” come “capitani” nella battaglia? Chi sente un fremito di emozione alle parole e ai gesti del primo ministro di Sua Maestà britannica e del capo della Casa Bianca? Noi no. E che bene o male oggi, «nell’ora più buia», Churchill abiti più la mediterranea preoccupazione e responsabilità di Giuseppe Conte e dei suoi ministri e dei suoi interlocutori istituzionali di ogni colore, che quella del suo pro-pro-pronipote politico è segno del tempo. Dice che il mondo sta cambiando, e cambierà di più. Nessuno abdica mai per caso.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- PENSARE DENTRO L’EMERGENZA. L’ “8 SETTEMBRE”, LA “CORONA-VIRUS”, E UNA “PACE PERPETUA”.11 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ “8 SETTEMBRE”, LA “CORONA-VIRUS”, E UNA “PACE PERPETUA”. Ora il “capro espiatorio” siamo noi, l’intero genere umano ...
ALLA LUCE DEL FATTO che i “vescovi fiorentini hanno vietato di scambiarsi il segno della pace durante il rito della messa”, che a “Lourdes hanno chiuso l’accesso alle acque miracolose”, “per CARITA’, UN LAICO ILLUMINISTA” (cfr. Mario Pezzella, “Sarà un 8 settembre?, "Le parole e le cose”, 11 marzo 2020) può pure compiacersi di “quanto la fede religiosa sia diventata un gadget turistico, che non regge di fronte a uno stato di necessità”, MA NON PUO’ CONTINUARE A “DORMIRE”, A PENSARE COME SE FOSSE TUTTO COME “PRIMA” E RIPROPORRE LA STESSA “MINESTRA”:
- “[....] Afferma Umberto Galimberti in una intervista televisiva che l’angoscia di fronte a un pericolo indeterminato è talmente insopportabile che si cerca il più presto possibile di incarnarlo in un capro espiatorio tangibile e concreto [...] Ora l’incarnazione del male siamo diventati noi. [...] Allo stato d’animo dell’angoscia, dovrebbe sostituirsi quello che Leopardi nella Ginestra, dinanzi alla potenza incombente del Vesuvio, definisce “vero amor”, e cioè la capacità di sostenersi reciprocamente “negli alterni perigli e nelle angosce della guerra comune” [....]” (Mario Pezzella, “Sarà un 8 settembre?”, cit.).
SE NON SAPPIAMO ANCORA che cosa significa “pensare dentro l’emergenza”, forse, è bene CON BENJAMIN (NON AGAMBEN), RITORNARE A SCUOLA DA PONZIO PILATO E RIASCOLTARE IL SUO “ECCE HOMO”, E CERCARE DI CAPIRE COSA VA SIGNIFICANDO NEL TEMPO LA SUA LEZIONE.
A DISTANZA DI SECOLI, e dopo Marx, dopo Nietzsche, dopo Freud, e dopo Lacan e dopo Foucault (il Foucault di “Che cosa è l’Illuminismo?”, 1983/1984), continuiamo a non capire che il “capro espiatorio” non è un caprone (cfr. “La crisi dell’Europa. Note per una riflessione storiografica”), ma un montone, un ariete, venuto a portarci in salvo (cfr.: “Guarire la nostra Terra. Necessità di “pensare un altro Abramo”), non a “sacrificarsi” per noi!!! Al contrario, oggi, l’intero genere umano, “noi stessi” ci apprestiamo a fare da “capro espiatorio” - e, pronti per la “pace perpetua” (cfr. Fine della Storia o della “Preistoria”?), abbiamo già messo sulla “nostra” testa la “corona” del sacrificio! O no?!
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- PENSARE DENTRO L’EMERGENZA. --- IL CAPRO ESPIATORIO. La nostra storia ha prodotto ininterrottamente capri espiatori (di P. A. Rovatti).12 marzo 2020, di Federico La Sala
Il capro espiatorio
di Pier Aldo Rovatti (*)
La nostra storia ha prodotto ininterrottamente capri espiatori. Minoranze, intere popolazioni, gruppi sociali e comportamenti sono stati stigmatizzati. La storia recente e contemporanea conosce vicende quasi impensabili come la persecuzione e l’eliminazione di milioni di ebrei durante il regime nazista, ma poi c’è un intero tessuto che continua a innervare il presente, anche là dove l’evoluzione sociale e il progresso materiale avrebbero dovuto cancellarlo, dallo stigma che ancora pesa sui folli o che non ha cessato di discriminare gli omosessuali e perfino le donne.
Oggi l’esempio più clamoroso è costituito dai migranti, sui quali riversiamo le nostre ansie considerandoli spesso alla stregua di orde barbariche che invadono la civile società in cui crediamo di vivere. Ma gli esempi possono moltiplicarsi, dalla paura che ormai ovunque possa celarsi un terrorista al semplice disagio con cui sperimentiamo la prossimità di chi ci appare diverso da noi e dunque capace di disturbare la nostra presunta identità.
Capri espiatori possono dunque essere intere popolazioni o anche singoli atteggiamenti, drammatici fenomeni sociali che si esprimono con un clamore generale oppure insidiosi fenomeni individuali che possiamo verificare nell’ambito ristretto e quotidiano delle nostre vite. Parlo di “capri espiatori” perché questa espressione, che ci arriva dalla notte dei tempi, non solo mantiene un senso fruibile nella sua esplicita chiarezza, ma anche perché, se ci fermiamo un momento a riflettere sulla sua provenienza e le sue implicazioni, ci può aiutare a orientarci dentro i nostri stessi problemi. La festività pasquale ci ha appena ricordato un indizio collegato al mondo cristiano e precisamente alla figura di Gesù Cristo che si sacrifica perché attraverso di lui i credenti rimettano le loro colpe. Al posto di un ispido caprone abbiamo in questo caso un grazioso ma altrettanto innocente agnellino a esercitare la funzione di animale simbolico.
L’ispido caprone o capro appare molto prima nelle parole della Bibbia intitolate al “Levitico”, cioè nel fondo della cultura ebraica e della sua mitologia. Se andiamo a leggere queste parole, scopriamo che in origine i capri sono due, uno il cui sacrificio ha una funzione espiatoria e un altro che svolge il ruolo di “emissario” e viene mandato a perdersi nel deserto, come se non bastasse la cerimonia dell’espiazione dei peccati o delle colpe degli uomini e occorressero quindi un supplemento e uno sdoppiamento, un prolungamento dell’espiazione affidata appunto a un emissario che porti con sé e disperda nello spazio e nel tempo queste colpe.
Ricordando l’origine dell’espressione, balza agli occhi che il significato che oggi le attribuiamo è molto distante, quasi antitetico. È sparita ogni pratica positiva di espiazione attraverso un tramite simbolico e al suo posto troviamo invece l’attribuzione della colpa a un altro soggetto che automaticamente diventa il colpevole. Costui viene caricato di ogni colpa grazie a un’identificazione abnorme. Il capro non era un soggetto o un insieme di soggetti da degradare, era invece un animale simbolico completamente innocente dotato di un formidabile potere espiatorio: esso era supposto possedere un’efficacia reale sullo sviluppo della presa di coscienza di se stessi. Oggi, il cosiddetto capro espiatorio è la vittima prescelta, il colpevole che sta al posto nostro, il nemico sul quale possiamo proiettare ogni male.
Rimando chi volesse entrare nella complessità della questione a un saggio che è ormai diventato un “classico” in proposito, Il capro espiatorio (titolo originale Le bouc émissaire) di René Girard, pubblicato nel 1982 (e tradotto da Adelphi nel 1999). A questo libro si è anche ispirato lo scrittore Daniel Pennac: “Malaussène”, il personaggio da lui inventato per costruirci attorno una serie di romanzi, comici e al tempo stesso seri, ambientati in un quartiere popolare di Parigi, è un capro espiatorio di professione. Pennac arriva anche a immaginare che in un ipermercato vi sia un ufficio dove la clientela possa liberamente esternare le sue lamentele a un funzionario (appunto Malaussène) che è lì proprio per dar ragione a tutti e assumersi ogni colpa. È un contrappasso letterario e sorridente di quanto accade nella dura realtà dei giorni nostri. Tra l’altro, dopo un lungo silenzio, Pennac riprende la sua saga con Il caso Malaussène, annunciato ora da Feltrinelli.
*
AUT AUT - IL SAGGIATORE (uscito su "Il Piccolo", 21 aprile 2017 - ripresa parziale).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- CHE COSA SIGNIFICA "ECCE HOMO": LA LEZIONE DI PONZIO PILATO E LA MEMORIA DI CHRISTINE DE PIZAN.10 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ECCE HOMO, L’8 MARZO AL TEMPO DEL “CORONA VIRUS”, E LA MEMORIA DI CHRISTINE DE PIZAN ...
ALLA LUCE DEL CHIARIMENTO DEL SIGNIFICATO DELLE PAROLE DI PONZIO PILATO: “ECCE HOMO”(cfr. sopra : https://www.fondazioneterradotranto.it/2020/02/26/dialetti-salentini-piticinu/#comment-269838), si comprende meglio anche il significato delle parole di Christine de Pizan, l’autrice della “Città delle dame” : «Or fus jee vrais homs, n’est pa fable,/De nefs mener entremettable » (« Allora diventai un vero uomo, non è una favola,/capace di condurre le navi» - cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan), che dicono ovviamente non della “metamorfosi” in “vir” - uomo, ma della “metanoia” in “homo” - essere umano (su questo, in particolare, si cfr. Michele Feo, “HOMO - Metanoia non Metamorfosi”, “dalla parte del torto”, Parma, autunno 2019, numero 86, pp. 12-13).
***
ASTREA ! “IAM REDIT ET VIRGO” ...
CARO ARMANDO... RICORDANDO DI NUOVO E ANCORA IL TUO PREGEVOLISSIMO LAVORO SU- GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA (si cfr. https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/08/gli-arcadi-di-terra-dotranto-premessa-1-x/#comment-238474), E LA TUA CONNESSIONE TRA LA “PIZANA” CAPACE DI “CONDURRE LE NAVI” CON LA FIERA E NOBILE Carola Rackete, A SUO E TUO OMAGGIO, riprendo qui una breve scheda su:
- ASTREA - L’Astraea Virgo, ” vergine delle stelle “, simbolo della giustizia, abitò la terra nell’età dell’oro e la lasciò per ultima nell’età del ferro, cedendo all’iniquità ormai dominante. Il ‛ritorno di A.‘ si identifica in Virgilio con il ritorno dell’età di Saturno (” magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. / iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, / iam nova progenies caelo demittitur alto “, Buc. IV 5-7). L’intero passo virgiliano è parafrasato in Pg XXII 70-72 Secol si rinova ; / torna giustizia e primo tempo umano, / e progenïe scende da ciel nova ; in Mn I XI 1 è riportato il v. 6 (cui segue la chiosa ‛ Virgo ‘... vocabatur iustitia, quam etiam ‛Astraeam‘ vocabant), ricordato anche in Ep VII 6 ; in Ep XI 15 il nome di A. è usato come metonimico di giustizia (http://www.treccani.it/enciclopedia/astrea_%28Enciclopedia-Dantesca%29/).
Buon 8 marzo 2020 - e buon lavoro...
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Decisione zero emissioni nel 2050. Greta Thunberg a Bruxelles: ’Con questa legge l’Ue ammette la resa. ’4 marzo 2020, di Federico La Sala
Greta Thunberg a Bruxelles: ’Con questa legge l’Ue ammette la resa’
Decisione zero emissioni nel 2050. Greenpeace e l’attivista bocciano la Commissione
di Redazione ANSA *
"Se la tua casa brucia, non aspetti qualche altro anno prima" di spegnere l’incendio, mentre è proprio "questo quello che la Commissione sta proponendo oggi. Nel momento in cui l’Ue presenta questa legge sul clima, con le emissioni zero entro 2050, indirettamente ammettete la resa: rinunciate agli accordi di Parigi, alle vostre promesse e alla possibilità di fare tutto il possibile per dare un futuro sicuro per i vostri figli". Così l’attivista svedese Greta Thunberg, intervenendo di fronte alla commissione Ambiente (Envi) del Parlamento Ue. Quando con le proteste sul clima "i vostri figli hanno fatto scattare ’l’allarme anti-incendio’, voi siete usciti, avete annusato l’aria e vi siete resi conto che era tutto vero: la casa stava bruciando, non era un falso allarme", ha detto Thunberg. "Poi però siete rientrati, avete finito la vostra cena e siete andati a dormire senza neanche chiamare i vigili del fuoco. Mi dispiace, ma questo non ha alcun senso", ha aggiunto. Secondo Greta, il testo presentato dalla Commissione Ue sul clima "manda il forte segnale che un’azione reale è in atto, quando in realtà non è così. La dura verità è che non ci sono né le politiche né la consapevolezza necessaria. Siamo nel pieno di una crisi che non viene trattata come tale. Avremmo moltissime soluzioni eccellenti", ha continuato Thunberg sottolineando che ci sono anche "tante persone pronte a fare il possibile per aiutare. Quello che manca - ha concluso - sono la consapevolezza, la leadership e soprattutto il tempo".
La Commissione europea ha proposto la "legge sul clima" che prevede emissioni nette azzerate entro il 2050, entro settembre una proposta per aumentare il taglio della CO2 al 2030, ampi poteri alla Commissione per aggiustare la ’traiettoria’ di riduzione delle emissioni ogni 5 anni (come richiesto dal trattato di Parigi), con il 2021 come orizzonte per proporre modifiche ai regolamenti europei sul clima, dal mercato Ets all’efficienza energetica, dalle rinnovabili alle emissioni in agricoltura e trasporti.
La Commissione europea ha anche avviato una consultazione pubblica per un ’patto sul clima’ per coinvolgere regioni, comunità locali, società civile, scuole, imprese e cittadini nell’impresa di tagliare le emissioni. La legge sul clima dovrà essere esaminata dal Consiglio e dall’Europarlamento prima di diventare legalmente vincolante. L’Italia e altri undici Paesi hanno scritto alla Commissione per accelerare i tempi sull’aumento del taglio delle emissioni al 2030, mentre il presidente della commissione ambiente dell’Eurocamera, Pascal Canfin, ha già indicato che si batterà per ottenere vincoli a livello nazionale.
"I cambiamenti climatici li abbiamo creati noi quindi sta a noi agire, la legge climatica guiderà ogni nostra azione per i prossimi 30 anni, ci dà gli strumenti per misurare i progressi verso l’obiettivo" di un’Europa a zero emissioni entro il 2050, ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen presentando la prima legge climatica europea. "Il testo della legge climatica è corto e semplice ma ci impegna verso azioni fondamentali: obbliga la Ue a inserire gli obiettivi ambientali in tutte le future legislazioni, è vincolante, offre prevedibilità e certezza a investitori, autorità pubbliche, è quello che ci chiedono", ha aggiunto. La presidente ha anche assicurato che la Ue è "pronta a proteggere le imprese", mettendole al riparo dalla concorrenza di chi non ha gli stessi standard ambientali. "Dobbiamo assicurare un terreno di gioco equo per le nostre imprese", ha detto.
Sull’ambiente "l’Unione europea deve essere capofila: avete l’obbligo morale di farlo, oltre all’opportunità" di essere "il vero leader sul clima" ha aggiunto Greta Thunberg. "La natura non scende a patti", ha sottolineato l’attivista svedese. "Non potete fare compromessi con la fisica" e "noi non vi consentiremo di rinunciare al vostro futuro". Al termine del suo intervento Greta è stata salutata da una standing ovation di circa un minuto dalla maggior parte dell’aula.
"L’analisi di Greta sulla nostra proposta è basata sull’approccio del bilancio di carbonio, secondo cui gli obiettivi di riduzione dovrebbero essere più alti. Io ho provato a spiegarle che noi usiamo un altro approccio e siamo più ottimisti di lei sulle tecnologie emergenti. Ma se non ci fosse stata lei e il modo in cui ha mobilitato due generazioni di giovani probabilmente oggi non staremmo neanche discutendo una legge sul clima". Così il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. L’impegno a ridurre le emissioni e ad adattarsi ai cambiamenti climatici, ha aggiunto Timmermans, "non serve a salvare il pianeta, che si salva da solo, ma a salvare l’umanità".
L’attivista svedese era stata accolta in mattinata dalla presidente Ursula von der Leyen, e dal vicepresidente esecutivo Frans Timmermans, al suo arrivo alla Commissione europea, dove partecipa al collegio dei commissari Ue. Durante la riunione è prevista l’adozione di una nuova proposta di legge sul Clima.
La Commissione europea ha avviato i lavori sul futuro meccanismo di adeguamento del prezzo del carbonio alle frontiere e la revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia, come strumenti del Green Deal europeo. "La tassazione avrà un ruolo chiave perché può incoraggiare comportamenti responsabili e compensare i costi della transizione", ha detto il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. "Dobbiamo salvaguardare le aziende che spostano la produzione in parti del mondo in cui gli standard sul clima sono meno rigorosi, è qui che entra in gioco il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio. Tuttavia, prima di presentare qualsiasi proposta, le varie opzioni devono essere attentamente valutate, in particolare per quanto riguarda le norme Wto e altri impegni internazionali", ha aggiunto.
"Senza obiettivi al 2030 basati sulla scienza, né misure per porre fine ai sussidi ai combustibili fossili, ci stiamo preparando al fallimento. Il momento di agire è ora, non tra 10 anni". Così il responsabile delle politiche per il clima di Greenpeace Europa Sebastian Mang si unisce al coro di critiche piovute addosso alla ’legge sul clima’ Ue ancora prima della sua presentazione.
Oltre a Greenpeace, il Climate Action Network, Friends of the Earth Europa e, in una lettera aperta, Greta Thunberg e altri 34 attivisti per il clima hanno mosso rilievi sostanziali alla proposta che fissa per legge un obiettivo Ue di azzeramento delle emissioni nette al 2050, perché non in linea con le raccomandazioni del panel intergovernativo dell’Onu sui cambiamenti climatici.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". La buona-esortazione del BRASILE. --- CORONAVIRUS. Marcel Mauss e il fatto «sociale totale» nel quale specchiarsi (di Filippo Barbera).4 marzo 2020, di Federico La Sala
Coronavirus, il fatto «sociale totale» nel quale specchiarsi
di Filippo Barbera (il manifesto, 04.03.2020)
Un fatto sociale totale - nella definizione del grande antropologo Marcel Mauss - è qualcosa in grado di influenzare e determinare un insieme di fenomeni coinvolgendo la gran parte dei meccanismi di funzionamento della comunità di riferimento. Per Mauss il fatto sociale totale per antonomasia era il dono, in quanto capace di unire le pratiche e le cornici di senso riferibili ad aspetti mitopoietici, economici, politici, espressivi e religiosi. Il fatto sociale totale permetterebbe così di interpretare «pezzi» apparentemente lontani e diversi della stessa società.
Mani pulite, in questo senso, è stato un fatto sociale totale: ha scosso le diverse fondamenta della società italiana e ne ha messo in luce i tratti e le dinamiche politiche, culturali, economiche e simboliche. Oggi, il coronavirus svolge la stessa funzione. Ogni misura sanitaria e di igiene pubblica è intimamente politica, tanto nelle sue cause che nelle sue conseguenze, si intende. Ma le misure decise in occasione della comparsa del coronavirus rivelano - come un reagente chimico - qualcosa di profondo e «totale» sulla società e politica italiane, nonché sulle sue credenze diffuse, modelli culturali e struttura economica. Il coronavirus mostra con ogni possibile forza come la vita politica italiana sia intrappolata - non da oggi - in un’arena hobbesiana, dove la divisione fra amici e nemici si sovrappone ai confini fra gruppi in competizione per il potere e l’influenza. Dove è assente un contesto condiviso (la Costituzione, la Nazione, la Patria, la Repubblica, etc.) che permette a questi gruppi di competere correndo dei rischi politici.
Nelle arene hobbesiane il rischio politico è accuratamente evitato dai gruppi in competizione che utilizzano la logica amico/nemico. La strategia razionale in un contesto come questo è - di fronte a un evento improvviso e in assenza di esperienza pregressa - quella di minimizzare il rischio politico delle decisioni prese. Non poter essere accusati di non «aver fatto tutto il possibile» per le persone contagiate o per bloccare il contagio (a prescindere dalle sue conseguenze), non dover essere obbligati a rifiutare ricoveri in terapia intensiva ad anziani con febbre e polmonite, non diventare oggetto di attacchi e accuse stigmatizzanti.
Consideriamo le misure sanitarie. Quelle previste dal ministero con le tre classi di rischio e misure proporzionate sono intese a contenere i focolai in modo che si esauriscano all’interno e non si allarghino alle aree ancora indenni. Il tutto basato sull’assunzione che il danno di una epidemia diffusa o addirittura di una pandemia sia più alto dei danni sociali ed economici attesi. Questa assunzione sembra eccessiva, dato che per quanto se ne sa finora, la severità delle conseguenze di questa influenza un po’ più grave non sarebbe così alta, soprattutto in una stagione invernale con una influenza vera molto mite.
Ciò che giustifica le assunzioni alla base delle misure prese è la minimizzazione del rischio politico, il non volersi esporre alle accuse che certamente pioverebbero da nemici e falsi ex amici, anche in assenza di una giustificazione basata sul calcolo costi-benefici. La minimizzazione del rischio politico è una metrica ipertrofica che si «mangia» tutte le altre, riducendole a semplici giustificazioni ex post. Dall’assalto ai supermercati, alla speculazione sui prezzi delle mascherine, alle dichiarazioni dei politici, alla crisi dell’export, del polo della logistica e del turismo, il coronavirus è il nostro miglior specchio. Dovremmo avere il coraggio di guardarlo senza abbassare lo sguardo.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- LA RINASCENZA MEDITERRANEA, IL "MARE NOSTRUM", E LA LEZIONE DI GIOVANNI BOCCACCIO.23 febbraio 2020, di Federico La Sala
LA RINASCENZA MEDITERRANEA, L’EUROPA, E IL “MARE NOSTRUM”: IL MEDITERRANEO AL DI LA’ DI OGNI PRETESA “IMPERIALISTICA” DI ORDINE LAICO O RELIGIOSO!!! UN OMAGGIO A PIERO DELFINO PESCE *
RICORDANDO CHE IL FIUME “SELE” è “Un fiume che sfocia in tre mari: nel Tirreno attraverso il suo corso naturale, e nei mari Adriatico e Ionio,attraverso quello artificiale, forzato dall’uomo per mezzo dell’Acquedotto Pugliese che lo ha deviato fino a S. Maria di Leuca e che con il suo tratto terminale diventa fontana monumento (cfr. http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5205#forum2233028) e, al contempo , RICORDANDO QUANTO IL MEDITERRANEO sia stato (ed è ancora!) un “eterno” campo di battaglie tra “opposti estremismi” ateo-devoti, laici e religiosi (cfr. “Due parole. Un segno rivelativo dei tempi. Una ‘memoria’ del 2004”: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=899), CONTRO I SOGNI DI OGNI “PRIVATIZZAZIONE” DELL’ACQUA DEI FIUMI come DELL’INTERO MEDITERRANEO, solleciterei (e sollecito!) L’EUROPA a programmare una immediata ricognizione di TUTTI I FIUMI dell’EUROPA, DELL’ASIA E DELL’AFRICA, che sfociano nel MEDITERRANEO.
P. S. In tempi di “coronavirus” e “cavernicole” illusioni politico-religiose, mi sia consentito richiamare alla memoria la figura di Giovanni Boccaccio e, con il suo lavoro, le origini stesse del Rinascimento italiano ed europeo (cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5421).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!!. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" - Politica e Diritto. «Costituente Terra», la scuola che vuole salvare la specie umana (di Giansandro Merli).22 febbraio 2020, di Federico La Sala
Politica
«Costituente Terra», la scuola che vuole salvare la specie umana
Diritto. Un progetto per immaginare gli strumenti politico-giuridici necessari ad affrontare i problemi del nostro tempo nella giusta scala
di Giansandro Merli *
«Per la prima volta nella storia esiste un interesse pubblico e generale assai più ampio e vitale di tutti i diversi interessi pubblici del passato: la sopravvivenza dell’umanità e l’abitabilità del pianeta». Luigi Ferrajoli, giurista e filosofo del diritto, pronuncia queste parole in piedi, circondato dai tomi antichi della splendida Biblioteca Vallicelliana, al centro di Roma.
L’occasione è la presentazione della scuola «Costituente Terra», che si è tenuta ieri. Poco prima avevano parlato Paola Paesano, direttrice dell’istituzione ospitante che in un raffinato intervento ha sottolineato le tensioni universalistiche che nel corso della storia hanno attraversato le biblioteche pubbliche, e un altro importante promotore del progetto, Raniero La Valle, giornalista, intellettuale ed ex senatore.
Sostenere l’esigenza di un costituzionalismo globale ai tempi dei rigurgiti sovranisti potrebbe sembrare un’azione fuori fuoco. E invece, sostengono i promotori, sono proprio quelle dinamiche a validare un simile sforzo. Le parole che La Valle e Ferrajoli mettono in fila sono come uno spillo che infrange la bolla di conoscenze acquisite e strumenti interpretativi che trasformano alcune contingenze nella forma del realismo. Lo sguardo è oltre la cronaca, così l’unico realismo diventa la consapevolezza che la politica ancorata agli Stati nazionali è impotente e inadeguata ad affrontare le sfide del nostro tempo.
L’alternativa possibile alle catastrofi cui essa va incontro e anzi produce, però, esiste. Sarà forse politicamente improbabile, almeno per ora, ma si può pensare. A ciò ambisce «Costituente Terra», al fine di revisionare il pensiero che ha portato l’umanità sull’orlo del baratro. Per farlo vuole espandere il costituzionalismo lungo tre direttrici: sovrastatualità; diritto privato; beni fondamentali. A esse corrispondono tre questioni cui occorre trovare risposte su scala planetaria: catastrofe ecologica; guerre; povertà e disuguaglianze. La loro soluzione passa per l’immaginazione politico-giuridica di istituti di garanzia dei diritti fondamentali a livello globale. È questo uno degli obiettivi della scuola, che però sarà anche anti-scuola. «Una scuola trasmette i saperi da una generazione all’altra per riprodurre la società come l’abbiamo ricevuta - dice La Valle - Invece noi dovremmo trasmettere un sapere che ancora non c’è, perché col sapere che c’è la società ricevuta non solo non va bene, ma nemmeno può continuare».
* Fonte: il manifesto, 22.02.2020 (ripresa parziale).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- BARI 2020: IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL MEDITERRANEO, E IL SOGNO DI LA PIRA (di Gualtiero Bassetti, presidente della Cei)21 febbraio 2020, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Mediterranea-mente ... *
Anticipazione
«Mediterraneo messaggero di pace per il mondo».
Il sogno di La Pira
Culla della famiglia di Abramo deve essere esempio di riconciliazione fra i popoli. Partendo dal "sindaco santo" l’introduzione del presidente Cei al libro suile idee che ispirano l’incontro pugliese
Gualtiero Bassetti (Avvenire, martedì 18 febbraio 2020)
- [Foto] Il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti
- Anticipiamo sintesi dell’introduzione di Una profezia per la pace (Lev, pagine 148, euro 20, fra pochi giorni in libreria), che raccoglie interventi del cardinale Gualtiero Bassetti. Un libro che illustra i principi ispiratori dell’Incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo frontiera di pace, che inizia mercoledì 19 febbraio a Bari.
Sono vissuto in un paese di orfani e di poveri. Tra i banchi della scuola elementare di Fantino, una minuscola frazione del Comune di Marradi sull’Appennino tosco-romagnolo, molti alunni erano orfani. I padri di quei bambini, infatti, erano stati uccisi il 17 luglio 1944 da una crudele rappresaglia tedesca nella vicina località di Crespino sul Lamone: ben 45 persone erano state fucilate senza alcuna pietà. Tra di loro anche il parroco, don Fortunato Trioschi, che era stato preso dai soldati mentre stava recitando il vespro in chiesa con le donne. «Strappato a viva forza dal suo pietoso ufficio - si legge nel Bollettino mensile di Crespino del marzo 1946 - egli recitava per i moribondi la preghiera della speranza cristiana». «Un colpo di mitra gli mozzò le parole sul labbro» e cadde riverso sulla fossa che aveva precedentemente scavato insieme ai suoi parrocchiani. All’indomani della fine del conflitto eravamo tutti poveri, ma di una povertà dignitosa. Siamo sopravvissuti alla miseria tipica degli anni del dopoguerra perché avevamo capito che il condividere è moltiplicare. Se mia madre faceva il pane, quel pane era anche per i vicini. Se un contadino aveva munto una mucca, quel latte era anche per i bambini. Se qualcuno comprava il sale, che era un alimento preziosissimo, ne dava un po’ anche agli altri. Si condivideva tutto. E condividendo tutto siamo cresciuti insieme, uomini, donne e bambini, in una comunità coesa in cui la Chiesa svolgeva una funzione importantissima. L’anticlericalismo era ben presente anche nell’Italia degli anni Cinquanta ma, nella vita quotidiana, non metteva in discussione la figura del sacerdote. Il prete, soprattutto nelle campagne, era il segno di una presenza religiosa, culturale e sociale. Le persone andavano dal sacerdote per consigli di tutti i tipi, perché era l’unica persona che aveva una cultura e che, al tempo stesso, si prendeva cura concretamente della «povera gente». Quella «povera gente» a cui anche Giorgio La Pira (terziario domenicano e francescano, professore universitario di diritto romano, membro dell’Assemblea costituente, deputato alla Camera per tre legislature e, soprattutto, sindaco di Firenze per molti anni) dedicò gran parte della sua esistenza.
Nell’aprile del 1950, su "Cronache Sociali", La Pira pubblicò un saggio molto importante dal titolo L’attesa della povera gente. Sebbene svolgesse un’analisi che partiva dall’esame del reddito pro capite mondiale, quello scritto non era solo un testo che si inseriva nel dibattito economico, ma era soprattutto la traduzione concreta del messaggio evangelico di giustizia sociale e amore verso gli ultimi.
 Quando entrai in seminario nel 1956 a Firenze, La Pira era un personaggio straordinariamente amato dalla popolazione. Non era solo il sindaco, era molto di più. Era una testimonianza di fede autentica riconosciuta da tutti. Il nostro rettore, uomo di grande cultura biblica, lo invitava spesso in semi- nario. Lui ci incantava ad ascoltarlo, si fidava di noi piccoli e ci parlava dei suoi grandi progetti. I fiorentini, sin da vivo, lo consideravano un santo.
Quando entrai in seminario nel 1956 a Firenze, La Pira era un personaggio straordinariamente amato dalla popolazione. Non era solo il sindaco, era molto di più. Era una testimonianza di fede autentica riconosciuta da tutti. Il nostro rettore, uomo di grande cultura biblica, lo invitava spesso in semi- nario. Lui ci incantava ad ascoltarlo, si fidava di noi piccoli e ci parlava dei suoi grandi progetti. I fiorentini, sin da vivo, lo consideravano un santo.
 Ogni incontro con La Pira, anche fugace, lungo la strada, rappresentava per i cittadini un momento di arricchimento personale. Egli annunciava con gioia il Vangelo in ogni momento e tutto, per lui, era motivo di contemplazione: dal campanile di Giotto ai pescatori sotto il ponte Vespucci. È stato, senza dubbio, un mistico prestato alla politica. Nella sua visione del mondo, carità e politica si fondevano in un legame indivisibile. E al centro della sua azione si collocava il cosiddetto «pilotaggio della speranza».
Ogni incontro con La Pira, anche fugace, lungo la strada, rappresentava per i cittadini un momento di arricchimento personale. Egli annunciava con gioia il Vangelo in ogni momento e tutto, per lui, era motivo di contemplazione: dal campanile di Giotto ai pescatori sotto il ponte Vespucci. È stato, senza dubbio, un mistico prestato alla politica. Nella sua visione del mondo, carità e politica si fondevano in un legame indivisibile. E al centro della sua azione si collocava il cosiddetto «pilotaggio della speranza».La sua missione terrena, collocata in un’epoca storica dominata dalle ideologie, non si esauriva nella gestione della cosa pubblica ma era una «missione essenzialmente religiosa» che rispondeva a una «specifica chiamata» divina. Egli è stato un «ambasciatore di Cristo», cioè un uomo di Dio o, meglio, un « nabì (bocca di Dio)», un profeta dei tempi odierni. Il profeta è un chiamato dal Signore e colui che parla per conto del Creatore. È colui che sa mettersi in ascolto della parola di Dio e perciò riesce a leggere in profondità il mondo che gli sta attorno. Il profeta è una «sentinella per la casa d’Israele» ed esprime con passione e generosità, fino a sembrare stolto e ingenuo, questa sua missione divina.
 Giorgio La Pira è stato un profeta del dialogo, della speranza e della pace. La fede era il motore della sua azione, che si innestava in un contesto internazionale caratterizzato da un «crinale apocalittico» dominato dallo scontro tra le due superpotenze e dall’incubo nucleare. Alla logica del conflitto, La Pira opponeva la supremazia del dialogo. Un dialogo cercato con tutte le forze nei Paesi dell’Europa dell’Est, in Asia, in America Latina e in Africa.
Giorgio La Pira è stato un profeta del dialogo, della speranza e della pace. La fede era il motore della sua azione, che si innestava in un contesto internazionale caratterizzato da un «crinale apocalittico» dominato dallo scontro tra le due superpotenze e dall’incubo nucleare. Alla logica del conflitto, La Pira opponeva la supremazia del dialogo. Un dialogo cercato con tutte le forze nei Paesi dell’Europa dell’Est, in Asia, in America Latina e in Africa.In questo sforzo incessante il sindaco di Firenze traccia una strada; è il «sentiero di Isaia» che si basava sull’antica profezia messianica: «Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci». Il sentiero di Isaia tracciato da La Pira si proponeva di arrivare al disarmo generale trasformando le «armi distruttive in strumenti edificatori della pace e della civiltà». Secondo la sua visione escatologica, tutta la storia convergeva verso «il porto finale» della pace.
 Per raggiungere la pace, La Pira incontra molti capi di Stato. In uno di questi incontri, conia una delle sue espressioni più note: «Abbattere i muri e costruire i ponti». Un’immagine che mutuò da quello che vide al Cairo nel 1967 dopo aver incontrato il presidente egiziano Nasser. In quell’occasione notò «una squadra di operai abbattere i muri che erano stati costruiti davanti alle porte dell’albergo, come strumenti di difesa antiaerea». In quel gesto vide il simbolo di una grande azione politica e culturale. Bisognava abbattere «il muro della diffidenza» tra i popoli e costruire ponti di dialogo tra le genti. Occorreva unire e non dividere.
Per raggiungere la pace, La Pira incontra molti capi di Stato. In uno di questi incontri, conia una delle sue espressioni più note: «Abbattere i muri e costruire i ponti». Un’immagine che mutuò da quello che vide al Cairo nel 1967 dopo aver incontrato il presidente egiziano Nasser. In quell’occasione notò «una squadra di operai abbattere i muri che erano stati costruiti davanti alle porte dell’albergo, come strumenti di difesa antiaerea». In quel gesto vide il simbolo di una grande azione politica e culturale. Bisognava abbattere «il muro della diffidenza» tra i popoli e costruire ponti di dialogo tra le genti. Occorreva unire e non dividere.Dopo la crisi di Suez del 1956, matura il progetto di convocare a Firenze un grande incontro internazionale dedicato al Mediterraneo. Nel maggio del 1958, all’interno di una corrispondenza fittissima col pontefice, invia una lettera a Pio XII in cui presenta il suo progetto di Colloqui mediterranei.
 «Vi dico subito, Beatissimo Padre, quale è la ’intuizione’ che da qualche tempo fiorisce sempre più chiaramente nella mia anima. Questa: il Mediterraneo è il lago di Tiberiade del nuovo universo delle nazioni: le nazioni che sono nelle rive di questo lago sono nazioni adoratrici del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe; del Dio vero e vivo. Queste nazioni, col lago che esse circondano, costituiscono l’asse religioso e civile attorno a cui deve gravitare questo nuovo Cosmo delle nazioni: da Oriente e da Occidente si viene qui: questo è il Giordano misterioso nel quale il re siro (e tutti i ’re’ della terra) devono lavarsi per mondarsi della loro lebbra (4 Re V, 10)».
«Vi dico subito, Beatissimo Padre, quale è la ’intuizione’ che da qualche tempo fiorisce sempre più chiaramente nella mia anima. Questa: il Mediterraneo è il lago di Tiberiade del nuovo universo delle nazioni: le nazioni che sono nelle rive di questo lago sono nazioni adoratrici del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe; del Dio vero e vivo. Queste nazioni, col lago che esse circondano, costituiscono l’asse religioso e civile attorno a cui deve gravitare questo nuovo Cosmo delle nazioni: da Oriente e da Occidente si viene qui: questo è il Giordano misterioso nel quale il re siro (e tutti i ’re’ della terra) devono lavarsi per mondarsi della loro lebbra (4 Re V, 10)».Secondo La Pira, dunque, il Mediterraneo, culla delle civiltà monoteiste che egli chiamava «la triplice famiglia di Abramo», è chiamato a riprendere il suo posto nella storia in un mondo sempre più minacciato da guerre e distruzione. Una costruzione della pace che passava anche dalla preghiera e dalla contemplazione. Dal 1951 al 1974, divenuto presidente delle Conferenze di San Vincenzo della Toscana, La Pira aveva introdotto nel programma dell’associazione una novità: l’assistenza economica da offrire ai monasteri di clausura in difficoltà, in cambio di preghiere. In questo modo, veniva inviato alle claustrali un foglietto stampato come «lettera circolare» in cui riportava le motivazioni e le iniziative «politiche» per cui chiedeva di pregare. Centinaia di monache risposero a questi appelli. In una di queste lettere alle claustrali, La Pira allega anche un lungo telegramma che, il 26 ottobre 1961, aveva scritto all’ambasciatore sovietico a Roma, Semen Kozirev, pregandolo di trasmettere il suo messaggio a Nikita Krusciov. In quel telegramma, La Pira prega il leader dell’Urss di impegnarsi concretamente verso il disarmo nucleare. Se questo avverrà, scrive, «ve ne sarà grato il Padre celeste che saprà considerare con cuore di padre il vostro atto di buona volontà».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Pianeta Terra. Mediterranea-mente .... GELBISON, GIBSON E LA CHIESA CATTOLICA. DUE PAROLE, UN ’RIVELATIVO’ SEGNO DEI TEMPI. UNA ’MEMORIA’ DEL 2004
I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" --- Incontro Mediterraneo. A Bari il G20 dei vescovi, per la riconciliazione fra i popoli.19 febbraio 2020, di Federico La Sala
Incontro Mediterraneo. A Bari il G20 dei vescovi, per la riconciliazione fra i popoli
Sono in arrivo 58 pastori da 20 nazioni. I primi ad arrivare i due provenienti dalla Siria. Il programma. Mediterraneo, a Bari l’incontro di pace
di Giacomo Gambassi, inviato a Bari *
Il primo soffio di Mediterraneo che Bari ha sentito due giorni fa è stato quello giunto da un Paese ancora segnato dalla guerra: la Siria. Perché da lì sono arrivati lunedì notte i primi due vescovi dei cinquantotto attesi, che porteranno l’intero bacino in Puglia: Youhanna Jihad Battah, arcivescovo di Damasco dei siri, e Nicolas Antiba, dell’arcieparchia di Damasco dei greco-melchiti. Strano scherzo della Provvidenza quello che fin da subito fa irrompere gli echi della guerra fra i pastori del Mediterraneo che per la prima volta si ritrovano insieme per cercare nuove vie di riconciliazione fra i popoli.
- Il programma
È l’incontro “Mediterraneo, frontiera di pace” che si apre oggi mercoledì a Bari e che fa abbracciare venti nazioni affacciate sul grande mare. Ecco perché sembra quasi un “G20” ecclesiale l’evento promosso dalla Cei che vuole chiamare tutti, a cominciare dai cristiani in comunione con Roma, a essere artigiani di pace. E come cornice ha il Castello svevo che nel 2017 ha già ospitato un G7. Da una delle torri scende l’enorme striscione con il logo azzurro del «laboratorio d’impegno», come viene definito, e quelle mani che si uniscono, auspicio di una nuova “civiltà dell’amicizia” per la regione.
Da questo pomeriggio le sale della fortezza diventeranno come aule sinodali per accogliere il confronto fra i vescovi: in assemblea e poi nei “circoli minori”.
Due i grandi temi: la trasmissione della fede, che farà da filo conduttore domani, giovedì; e il rapporto fra Chiese e società, al centro della giornata di venerdì.
Poi sabato verrà elaborato e approvato il testo finale.
«Non è un convegno accademico ma uno spazio di comunione tra vescovi che riflettono e, sotto la guida dello Spirito, provano a discernere i segni dei tempi - spiega il segretario generale della Cei, Stefano Russo -. I pastori che si incontrano hanno a cuore un Mediterraneo concreto con le genti che lo abitano. E il nostro progetto ambizioso ma necessario è di costruire ponti con una storia, una geografia e un’umanità che hanno fondazioni comuni».
«Pace, fede, fraternità, speranza» si legge nei quattro cartelloni appesi ai davanzali del Palazzo della città. Di fronte si sta già allestendo il palco per la Messa che papa Francesco presiederà domenica mattina e che concluderà l’evento Cei.
Almeno 40mila i fedeli previsti, anche se il numero potrebbe crescere in questi giorni.
 Fra loro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier Giuseppe Conte.
Fra loro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier Giuseppe Conte.È come un suggello la presenza di papa Francesco che prima della celebrazione si vedrà consegnare il documento finale, sintesi delle giornate di lavoro, e dialogherà con i vescovi dell’area. Ovunque è affisso il suo volto accompagnato dal simbolo del “forum”: sulle vetrine dei bar, alle porte delle case, all’ingresso della Basilica di San Nicola, emblema della città e richiamo alla sua vocazione a essere terra di incontro oltre il mare che la bagna.
- Chi ci sarà
Resta di cinquantotto il numero complessivo dei pastori che partecipano. C’è stata una defezione dell’ultimo minuto: Jesús Esteban Catalá Ibáñez, vescovo di Malaga, uno dei delegati della Conferenza episcopale spagnola, assente per un’improvvisa malattia. Invece interverrà - e non era inizialmente nella lista - l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli Stati. È uno dei tre rappresentanti della Santa Sede con il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, e il cardinale Michael Czerny, sottosegretario della sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.
Nove le porpore a Bari: oltre alle due di Oltretevere, è già in città il cardinale Vinko Puljic, arcivescovo di Sarajevo, mentre stamani arrivano Cristóbal López Romer, arcivescovo di Rabat in Marocco, Louis Raphaël Sako, patriarca di Babilonia dei caldei, Juan José Omella, arcivescovo di Barcellona, Angelo Bagnasco, presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione Europea.
E a fare gli onori di casa il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che ha ideato l’appuntamento e che questo pomeriggio alle 16 lo aprirà con una relazione introduttiva. L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve è nel capoluogo pugliese da ieri sera con il “gruppo” della Conferenza episcopale italiana che comprende anche i tre vice-presidenti Franco Giulio Brambilla, Mario Meini e Antonino Raspanti, quest’ultimo coordinatore del Comitato organizzatore che sempre oggi presenterà ai vescovi delegati lo stile e lo svolgimento delle giornate baresi.
* Avvemire, mercoledì 19 febbraio 2020 (ripresa parziale, senza immagini).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- IL PIANETA TERRA, IL MEDITERRANO, E "LE COSE DA SAPERE" SULL’INCONTRO DEI VESCOVI A BARI.13 febbraio 2020, di Federico La Sala
IL PIANETA TERRA, IL "PADRE NOSTRO", E IL SINODO DEI VESCOVI SUL MEDITERRANEO ...*
Mediterraneo, frontiera di pace. Le cose da sapere sull’incontro di Bari
Dal 19 al 23 febbraio l’evento per la pace. Cinque giornate di dialogo. Cinquantotto fra cardinali, patriarchi e vescovi che arriveranno in Puglia. Venti i Paesi rappresentati
di Giacomo Gambassi, inviato a Bari (Avvenire, mercoledì 12 febbraio 2020)
- [Foto] Il cardinale Gualtiero Bassetti mentre presenta l’Incontro "Mediterraneo, frontiera di pace"
Cinque giornate di dialogo. Cinquantotto fra cardinali, patriarchi e vescovi che arriveranno in Puglia. Venti i Paesi rappresentati. Tre i continenti che idealmente si abbracceranno: Europa, Asia e Africa. Ecco in numeri l’Incontro “Mediterraneo, frontiera di pace”, il grande forum ecclesiale voluto dalla Cei che per la prima volta riunisce i vescovi degli Stati affacciati sul grande mare e che sarà concluso da papa Francesco. -Le cifre non dicono tutto, ma raccontano la scommessa di un’iniziativa che si terrà dal 19 al 23 febbraio e che avrà come cornice Bari, la città “ponte” fra Oriente e Occidente come testimonia «la venerazione senza confini del suo patrono san Nicola» o la scelta del Pontefice di tenere nel luglio 2018 all’ombra del Castello svevo l’incontro per la pace in Medio Oriente con i capi delle comunità cristiane della regione, spiega l’arcivescovo di Bari-Bitonto, Francesco Carucci.
Adesso lo sguardo si allarga all’intero Mediterraneo chiamando a un supplemento d’anima le Chiese. È l’urgenza della pace l’orizzonte di un evento che invita a una nuova responsabilità il mondo cattolico. Non un convegno o un seminario accademico ma un «incontro di fraternità dallo stile sinodale che vuole aiutare le comunità ecclesiali a camminare sempre più insieme», spiega il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, durante la conferenza stampa di presentazione a Roma moderata dal direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, Vincenzo Corrado.
 Nel 2018 era stato proprio Bassetti a lanciare l’idea dell’evento «rileggendo i Colloqui mediterranei promossi da Giorgio La Pira circa sessant’anni fa», racconta il cardinale le cui radici affondano nella Firenze del sindaco “santo”.
Nel 2018 era stato proprio Bassetti a lanciare l’idea dell’evento «rileggendo i Colloqui mediterranei promossi da Giorgio La Pira circa sessant’anni fa», racconta il cardinale le cui radici affondano nella Firenze del sindaco “santo”.
 «Se La Pira aveva coinvolto l’ambito politico - dice Bassetti - io mi sono chiesto: perché anche i vescovi non possono mobilitarsi di fronte ai drammi delle proprie genti? Del resto la Chiesa non ha altro scopo che servire l’uomo. E ciò implica anche affrontare i problemi che le nostre comunità vivono». Tutto l’episcopato italiano ha sposato il percorso: ecco perché i pastori della Penisola saranno a Bari nelle ultime due giornate.
«Se La Pira aveva coinvolto l’ambito politico - dice Bassetti - io mi sono chiesto: perché anche i vescovi non possono mobilitarsi di fronte ai drammi delle proprie genti? Del resto la Chiesa non ha altro scopo che servire l’uomo. E ciò implica anche affrontare i problemi che le nostre comunità vivono». Tutto l’episcopato italiano ha sposato il percorso: ecco perché i pastori della Penisola saranno a Bari nelle ultime due giornate.Due i temi di cui discuteranno i vescovi del bacino: l’annuncio del Vangelo, a cominciare dai giovani; e il dialogo fra Chiese e società. «Di fatto come pastori ci siamo posti una domanda: che cosa Dio vuole oggi dal Mediterraneo? E l’incontro sarà un’occasione di discernimento», chiarisce il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, vice-presidente della Cei e coordinatore del comitato organizzatore.
 A fare da sfondo al confronto le guerre che ancora insanguinano l’area (dal conflitto israelo-palestinese a quelli in Siria, Iraq o Libia); le nuove tensioni che scuotono la regione; le ferite ancora aperte delle guerre che dai Balcani al Libano hanno segnato gli ultimi decenni; la povertà; le disuguaglianze fra la sponda nord e quella sud; le politiche di sfruttamento da parte dei grandi del pianeta; la complessa convivenza fra le fedi; le persecuzioni delle minoranze religiose, soprattutto cristiane; il dramma delle migrazioni.
A fare da sfondo al confronto le guerre che ancora insanguinano l’area (dal conflitto israelo-palestinese a quelli in Siria, Iraq o Libia); le nuove tensioni che scuotono la regione; le ferite ancora aperte delle guerre che dai Balcani al Libano hanno segnato gli ultimi decenni; la povertà; le disuguaglianze fra la sponda nord e quella sud; le politiche di sfruttamento da parte dei grandi del pianeta; la complessa convivenza fra le fedi; le persecuzioni delle minoranze religiose, soprattutto cristiane; il dramma delle migrazioni.
 «La questione della pace - dice Raspanti - non è disgiunta dagli squilibri sociali che qui si registrano. E anche lo stesso tema delle migrazioni sarà visto secondo prospettive diverse. Penso al grido che alcuni vescovi delegati hanno già lanciato chiedendo di aiutare i loro Paesi a non lasciare fuggire i cristiani».
«La questione della pace - dice Raspanti - non è disgiunta dagli squilibri sociali che qui si registrano. E anche lo stesso tema delle migrazioni sarà visto secondo prospettive diverse. Penso al grido che alcuni vescovi delegati hanno già lanciato chiedendo di aiutare i loro Paesi a non lasciare fuggire i cristiani».Lo stile dell’incontro è mutuato dal Sinodo dei vescovi. Non solo nei due anni di preparazione sono stati coinvolti gli episcopati del Mediterraneo che hanno contribuito a elaborare una bozza di lavoro, ma soprattutto le giornate di Bari saranno nel segno dell’ascolto e del dialogo fra i vescovi.
 «Ore e ore di discussione», annuncia Raspanti. Dal confronto scaturirà il documento che sarà approvato dai presuli e che domenica mattina verrà consegnato al Pontefice durante il suo incontro con i vescovi nella Basilica di San Nicola.
«Ore e ore di discussione», annuncia Raspanti. Dal confronto scaturirà il documento che sarà approvato dai presuli e che domenica mattina verrà consegnato al Pontefice durante il suo incontro con i vescovi nella Basilica di San Nicola.
 «Il Papa che condivide a pieno il nostro incontro - dice Bassetti - ci ha chiesto proposte concrete che vadano oltre le lamentele».
Il dialogo fra il Pontefice e i pastori della regione rappresenterà l’appuntamento centrale di Bari, che verrà aperto dal saluto di Bassetti e dalle testimonianze del cardinale Vinko Puljic, arcivescovo di Sarajevo e presidente della Conferenza episcopale di Bosnia ed Erzegovina, e dell’arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del patriarcato latino di Gerusalemme, e che si chiuderà con l’intervento dell’arcivescovo di Algeri, il gesuita Paul Desfarges, presidente della Conferenza episcopale regionale del Nord Africa. Momento concluso dell’evento sarà la Messa presieduta da Francesco alle 10.45 nel cuore di Bari.
«Il Papa che condivide a pieno il nostro incontro - dice Bassetti - ci ha chiesto proposte concrete che vadano oltre le lamentele».
Il dialogo fra il Pontefice e i pastori della regione rappresenterà l’appuntamento centrale di Bari, che verrà aperto dal saluto di Bassetti e dalle testimonianze del cardinale Vinko Puljic, arcivescovo di Sarajevo e presidente della Conferenza episcopale di Bosnia ed Erzegovina, e dell’arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del patriarcato latino di Gerusalemme, e che si chiuderà con l’intervento dell’arcivescovo di Algeri, il gesuita Paul Desfarges, presidente della Conferenza episcopale regionale del Nord Africa. Momento concluso dell’evento sarà la Messa presieduta da Francesco alle 10.45 nel cuore di Bari.L’incontro dei vescovi si porterà dietro anche un segno concreto di attenzione a tutto il Mediterraneo.
 «Si tratterà di borse di studio per giovani delle diverse sponde con lo scopo di formare una nuova classe dirigente», annuncia Bassetti. Il progetto avrà come guida la Caritas italiana e vedrà il coinvolgimento di Rondine-Cittadella della pace, il laboratorio della riconciliazione alle porte di Arezzo che fa studiare i giovani provenienti dai Paesi in guerra fianco a fianco con il loro "nemico".
«Si tratterà di borse di studio per giovani delle diverse sponde con lo scopo di formare una nuova classe dirigente», annuncia Bassetti. Il progetto avrà come guida la Caritas italiana e vedrà il coinvolgimento di Rondine-Cittadella della pace, il laboratorio della riconciliazione alle porte di Arezzo che fa studiare i giovani provenienti dai Paesi in guerra fianco a fianco con il loro "nemico".I lavori “sinodali” dei vescovi saranno a porte chiuse ma ogni giorno è previsto un briefing con la stampa. Guai comunque a pensare che le giornate siano blindate. Sono previste infatti Messe e momenti di preghiera aperti a tutti; venerdì sera ogni pastore delegato sarà ospite di una parrocchia; poi sabato pomeriggio, a partire dalle 15.30, al teatro Petruzzelli si terrà l’incontro di testimonianze con voci e volti da tutto il Mediterraneo e gli interventi dei vescovi e di esperti di geopolitica.
 Intanto si immagina già il “dopo Bari”. «Non ritengo che tutto si possa concludere in Puglia - avverte il presidente della
Cei -. È possibile che si creino tavoli di lavoro tematici che permetteranno ai vescovi di incontrarsi di nuovo. Del resto la sfida è far riscoprire la vocazione propria del nostro grande mare: una vocazione alla pace e all’incontro».
Intanto si immagina già il “dopo Bari”. «Non ritengo che tutto si possa concludere in Puglia - avverte il presidente della
Cei -. È possibile che si creino tavoli di lavoro tematici che permetteranno ai vescovi di incontrarsi di nuovo. Del resto la sfida è far riscoprire la vocazione propria del nostro grande mare: una vocazione alla pace e all’incontro».
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- SINODO DEI VESCOVI. L’ANNO DELLA PAROLA DI DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?!
LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Verso Bari 2020. Parla l’arcivescovo di Bari-Bitonto, Cacucci, padrone di casa all’Incontro dei vescovi del Mediterraneo sulla pace.9 febbraio 2020, di Federico La Sala
RINASCIMENTO, OGGI (2020): PER "LA PACE DELLA FEDE" (1453) E IL CONCICLIO DI NICEA(2025). Note... *
Verso Bari 2020.
«Bari, ponte di pace per il Mediterraneo. Sui passi di san Nicola»
Parla l’arcivescovo di Bari-Bitonto, Cacucci, padrone di casa all’Incontro dei vescovi del Mediterraneo sulla pace. Tutto pronto per la visita del Papa il 23 febbraio. «La nostra è terra di dialogo»
di Giacomo Gambassi (Avvenire, sabato 8 febbraio 2020)
C’è una frase che l’arcivescovo di Bari-Bitonto, Francesco Cacucci, ama ripetere per descrivere la vocazione della sua terra. È quella che gli aveva affidato papa Wojtyla durante una visita ad limina dei vescovi della regione. «Giovanni Paolo II si rivolge a me dicendo: “Dovete guardare al Mediterraneo e all’Africa”. Ecco, in un’espressione dal sapore profetico il Pontefice santo ha condensato ciò a cui siamo chiamati. Bari è tenuta a essere ponte fra le sponde del grande mare: in particolare fra Oriente e Occidente, come lo è stato e lo è ancora il nostro patrono san Nicola». Una pausa. «In quest’ottica va letto l’incontro per la pace in Medio Oriente voluto il 7 luglio 2018 da papa Francesco con i capi delle Chiese e delle comunità cristiane della regione - afferma l’arcivescovo -. E adesso l’Incontro “Mediterraneo, frontiera di pace” promosso dalla Cei».
- L’Incontro “Mediterraneo, frontiera di pace” promosso dalla Cei è una sorta di Sinodo del Mediterraneo che porterà a Bari dal 19 al 23 febbraio cinquantotto vescovi delle Chiese affacciate sul grande mare in rappresentanza di tre continenti (Europa, Asia e Africa). Sarà concluso da papa Francesco. Sui passi del "profeta di pace" Giorgio La Pira, i vescovi si confronteranno per indicare percorsi concreti di riconciliazione e fraternità fra i popoli in un’area segnata da guerre, persecuzioni, emigrazioni, sperequazioni
Mancano dieci giorni all’inizio di quello che il cardinale Gualtiero Bassetti ha definito “una sorta di Sinodo sul Mediterraneo” che dal 19 al 23 febbraio porterà nel capoluogo pugliese cinquantotto vescovi in rappresentanza di venti Paesi affacciati sul grande mare e di tre continenti (Europa, Asia e Africa). «Non ho proposto io Bari per questo evento - confida Cacucci -. È stato il cardinale Bassetti con il Consiglio permanente della Cei a indicare la nostra città. E come Chiesa locale abbiamo accolto con gioia la richiesta, ben sapendo che sono parte del nostro dna l’accoglienza, il dialogo, la cultura dell’incontro». L’arcidiocesi è in prima linea nell’organizzazione dell’iniziativa internazionale.
 Il Castello svevo accoglierà le tre giornate “sinodali” di confronto (a porte chiuse) fra i vescovi. La Basilica di San Nicola e la Cattedrale faranno da cornice alle Messe quotidiane. Le parrocchie ospiteranno venerdì sera i singoli pastori. Il teatro Petruzzelli sarà lo sfondo dell’evento pubblico di sabato pomeriggio. Poi domenica arriverà papa Francesco che sarà a Bari per la seconda volta in due anni e che nella Basilica di San Nicola dialogherà con i vescovi, prima di presiedere la Messa in corso Vittorio Emanuele.
Il Castello svevo accoglierà le tre giornate “sinodali” di confronto (a porte chiuse) fra i vescovi. La Basilica di San Nicola e la Cattedrale faranno da cornice alle Messe quotidiane. Le parrocchie ospiteranno venerdì sera i singoli pastori. Il teatro Petruzzelli sarà lo sfondo dell’evento pubblico di sabato pomeriggio. Poi domenica arriverà papa Francesco che sarà a Bari per la seconda volta in due anni e che nella Basilica di San Nicola dialogherà con i vescovi, prima di presiedere la Messa in corso Vittorio Emanuele.Eccellenza, l’Incontro giunge mentre il Mediterraneo torna a infiammarsi.
È vero, siamo di fronte a un disordine mondiale in cui gruppi etnici e formazioni militari scatenano conflitti sempre nuovi. Tutto ciò ha ripercussioni intorno al grande mare. Per questo l’iniziativa Cei si colloca in un momento dolorosamente provvidenziale per ciò che si sta verificando nel Mediterraneo. Se il bacino può essere considerato un «grande lago di Tiberiade», come lo definiva Giorgio La Pira, resta ancora oggi un luogo di morte. Pertanto dai vescovi che prenderanno parte alle giornate baresi non potrà che levarsi un’invocazione alla pace. Come del resto aveva fatto da qui, dal sagrato della Basilica di San Nicola, papa Francesco il 7 luglio 2018 quando aveva spiegato che la pace «va coltivata anche nei terreni aridi delle contrapposizioni perché oggi, malgrado tutto, non c’è alternativa possibile alla pace». Un’indicazione che troverà il suo sviluppo nell’imminente evento ecclesiale.
Bari si conferma sede privilegiata di dialogo.
Certo, a partire da san Nicola, uno dei santi più venerati nel mondo che collega Oriente e Occidente. Prima dell’incontro del 2018, il Papa aveva deciso che una reliquia del santo fosse traslata a Mosca e a San Pietroburgo. Un avvenimento straordinario, come ha sottolineato il patriarca Kirill, dal grande impatto ecumenico. Poi l’appuntamento per la pace nel Medio Oriente con il Pontefice. E adesso l’Incontro dei vescovi del Mediterraneo. In questo caso i protagonisti saranno i pastori cattolici che si ascolteranno a vicenda e poi consegneranno le loro osservazioni al Papa alla presenza dei vescovi italiani, invitati alle ultime due giornate.
Quale contributo alla pace dalle Chiese del bacino?
È proprio della nostra fede l’impegno per la pace. Di fronte agli odierni conflitti che costituiscono una «terza guerra mondiale a pezzi» secondo quanto detto dal Papa, come cristiani siamo chiamati ad annunciare al mondo che ogni uomo e ogni donna fa parte dell’unica famiglia umana. È questo il fondamento della fraternità. Il che significa prendere atto che esista un destino comune fra i popoli. Una visione rifluita nel Concilio come testimonia la Gaudium et spes la quale ci ricorda che la pace «non è mai qualcosa di stabilmente raggiunto ma un edificio da costruirsi continuamente».
 Comunque già Giovanni XXIII, nell’enciclica Pacem in terris, evidenziava che l’urgenza di avere artigiani di pace. Ecco, nell’Incontro sul Mediterraneo entrerà tutto questo, consapevoli che i vescovi non giocano un ruolo politico ma intendono farsi apostoli di riconciliazione. Da Bari, quindi, non dobbiamo attendersi risultati politici. Va aggiunto che il cammino verso la pace richiede anche un cambio di mentalità. Ad esempio, la globalizzazione non va vista come pretesto per fomentare le paure ma come occasione per essere fratelli nella diversità.
Comunque già Giovanni XXIII, nell’enciclica Pacem in terris, evidenziava che l’urgenza di avere artigiani di pace. Ecco, nell’Incontro sul Mediterraneo entrerà tutto questo, consapevoli che i vescovi non giocano un ruolo politico ma intendono farsi apostoli di riconciliazione. Da Bari, quindi, non dobbiamo attendersi risultati politici. Va aggiunto che il cammino verso la pace richiede anche un cambio di mentalità. Ad esempio, la globalizzazione non va vista come pretesto per fomentare le paure ma come occasione per essere fratelli nella diversità.L’Occidente e le grandi potenze agiscono ancora nel Mediterraneo per interesse particolare?
Negli ultimi due secoli è stato il Mediterraneo “coloniale” al centro delle preoccupazioni mondiali. Paradossalmente la creazione della Comunità europea ha spostato l’asse distante da questo mare. E ciò ha avuto l’effetto di allontanare le sponde, contribuendo ad alimentare il demone della paura. Di fatto l’Occidente non ha favorito il protagonismo del Medio Oriente o del Nord Africa. Così la riflessione dei vescovi intende aiutare anche l’Europa a ritrovare le sue radici che sono di per sé mediterranee.
A Bari papa Francesco aveva lanciato l’allarme sul rischio della scomparsa della presenza cristiana in alcuni angoli dell’area.
Tutti constatiamo che le persecuzioni verso i cristiani si sono intensificate. Non dimentichiamo che, anche solo guardando agli ultimi decenni, sono moltissimi i cristiani che hanno dato la vita per promuovere nel nome del Vangelo la convivenza pacifica fra i popoli in contesti segnati dalle guerre e dagli odi. Vorrei citare per tutti don Andrea Santoro ucciso in Turchia nel 2006. Ma siamo davvero consci che questa presenza abbia un ruolo profetico? O, come ammonisce il Papa, non c’è una congiura del silenzio?
Anche il tema dei migranti entrerà nell’agenda dei vescovi?
I processi di mobilità hanno accresciuto l’osmosi fra i popoli. Però da alcuni decenni il fenomeno migratorio ha subìto un’accelerazione a causa delle violenze e delle guerre ma anche della povertà generata da gravi ingiustizie e prevaricazioni. Tali processi hanno un inevitabile impatto sul dialogo fra le religioni e fra le confessioni cristiane ma anche sulla nostra identità di credenti. Se è vero che le migrazioni sono la conseguenza di un’assenza di pace, allora la questione non può non interrogare i vescovi. E anche tutti noi che siamo invitati a un’autentica testimonianza evangelica in grado di superare ogni sorta di egoismo.
Cacucci, dal 1999 arcivescovo di Bari-Bitonto
Ha 76 anni Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto e delegato pontificio per la Basilica di San Nicola a Bari. Nato nel capoluogo pugliese, è sacerdote dal 1966. È laureato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana e in scienze politiche all’Università di Bari. Nel 1987 viene nominato ausiliare di Bari-Bitonto e ordinato vescovo. Nel 1993 il Papa lo trasferisce alla sede arcivescovile di Otranto fino al 1999 quando torna come pastore nella sua Chiesa d’origine.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
SULL’INCONTRO DI RATZINGER - BENEDETTO XVI E BUSH. LA CRISI DEL CATTOLICESIMO ROMANO E DELLA DEMOCRAZIA AMERICANA NON SI RISOLVE... RILANCIANDO UNA POLITICA OCCIDENTALE DA SACRO ROMANO IMPERO.
- PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
- ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - L’ AUSTRALIA, UNA CULTURA CHE BRUCIA. Intorno aL fuoco gli aborigeni costruirono e trasmisero conoscenze (di Giulia Tabacco).6 febbraio 2020, di Federico La Sala
Australia, una cultura che brucia
di Giulia Tabacco (Il Mulino, 05 febbraio 2020])
Ben di mestiere appicca incendi. È nato nel bush, quella boscaglia talvolta fitta di alberi talaltra composta da arbusti gialli, bassi e puntuti che contorna l’Australia; è cresciuto in una giungla in cui i pitoni fanno compagnia agli ananas e ai bufali e ha una solida consapevolezza del territorio. Conosce le piante, le impronte e i versi degli animali, parla la lingua degli aborigeni, sa regolarsi con l’alternarsi delle stagioni e con un clima che pare funzionare per estremi: estremamente umido o estremamente caldo, a tratti secco come terracotta altre volte travolto dalle spirali violette dei cicloni.
Ben lavora per un’agenzia governativa nel Northern Territory, lo Stato con la minore densità abitativa d’Australia, un rettangolone che va dal Mare di Timor, tropicale e verdissimo, fino ai deserti centrali ventosi, pietrosi e sciapi. Lo Stato che custodisce il cuore dell’isola, che batte rosso nella mitica Uluru, la grande roccia, il luogo dove per millenni le famiglie aborigene trovarono riparo e acqua, dove storie e tradizioni venivano narrate e condivise, dove ai ragazzini si insegnavano le regole della vita.
Gli incendi in Australia ci sono sempre stati. La natura del suolo e della vegetazione, il clima nella parte centrale da milioni di anni in prevalenza arido, sono tra le cause principali. Da quarantamila anni gli incendi fanno parte dell’ambiente, come sanno e dicono coloro che vi abitano da sempre e per i quali il fuoco ha un valore concreto e, contemporaneamente, simbolico e spirituale. Non un nemico di cui avere paura ma, al contrario, uno strumento.
Il fuoco è parte della vita, è un elemento da osservare, da capire e con il quale confrontarsi. Intorno a esso gli aborigeni costruirono e trasmisero conoscenze che avevano una doppia finalità: la prima, più evidente, era evitare che fiamme incontrollate e incontrollabili mangiassero ettari ed ettari di terreno e che mettessero a repentaglio la vita di esseri umani, fauna e piante; la seconda era contribuire al mantenimento del suolo e al suo stato di salute.
Per fare questo, praticavano una tecnica di incendi di natura preventiva: incendi bassi, delimitati e controllati che permettevano la sopravvivenza e il rinnovamento del terreno. Affinché fossero sicuri ed efficaci era necessario saper leggere in profondità l’ambiente, avere una grande dimestichezza con le condizioni climatiche e naturali: aspetti, questi, che erano parte fondante della loro quotidianità. Perché queste genti per millenni abitarono spazi enormi e spesso difficili, per millenni tramandarono cantandole le storie e le caratteristiche della terra, degli animali e degli esseri mitologici: questo ne fa dei poeti e dei saggi conoscitori.
I fuochi volontari dovevano essere appiccati al momento giusto e servivano a delimitare il propagarsi, nei mesi più caldi e asciutti, di quelli provocati dai fulmini o dal vento. Allo stesso tempo, contribuivano a rigenerare l’ecosistema, alla sua biodiversità. Agivano cioè in sintonia con i ritmi della terra: attiravano animali che venivano cacciati, arricchivano il suolo di cenere, che agiva come fertilizzante, rendevano il terreno più ricco di minerali e di fonti di sostentamento e “pulivano” il suolo, bruciando foglie secche e cortecce, entrambe altamente infiammabili.
Gli aborigeni hanno una bella definizione per queste tecniche: le chiamano “fuoco culturale” (cultural burning). “Culturale”, sì, perché basato su una somma di saperi preziosa, fatta di consapevolezza, rispetto e volontà di preservare l’ambiente. Ben di lavoro fa quello che le genti originarie hanno sempre fatto. Studia tempi e spazi, analizza il terreno, percorre chilometri e chilometri, interpella e avvisa le persone, controlla i venti, delimita e monitora le aree di intervento.
Lo fa nello Stato con la più alta percentuale di popolazione aborigena, che sfiora il 30% (negli altri Stati la media supera di poco il 3%). Nel Northern Territory il governo opera congiuntamente con le popolazioni indigene e integra le tecniche degli “incendi tradizionali” con altre strategie, assolutamente necessarie in un Paese che ha vissuto rilevanti cambiamenti antropici e di sfruttamento del suolo negli ultimi 230 anni, cioè con l’arrivo e la colonizzazione britannica.
Va specificato che questi metodi sono utilizzati anche in altri Stati australiani: sinora, però, in maniera circoscritta e locale. La tecnica del fuoco prescritto, d’altra parte, è stata usata a partire dalla prima metà del Novecento anche in diversi ambienti forestali, arbustivi, di savana e prateria del Nord America, dell’Asia e dell’Africa nonché, dagli anni Ottanta, in alcune regioni italiane.
Ben mi racconta che per dare fuoco al bush bisogna avere una profonda esperienza del quando e del come. È fondamentale appiccare il fuoco al momento opportuno, in modo che non arrechi danni. Il periodo in cui si concentra questo lavoro è l’inizio della stagione secca, a partire dal mese di aprile. Allora abitualmente le piogge dei mesi precedenti lasciano il posto a giornate umide, ma con cieli perlopiù limpidi. Il bush è verde ma non ancora arso. Se l’incendio volontario viene appiccato troppo presto, c’è il rischio che gli arbusti abbiano tempo a sufficienza per crescere e svilupparsi nuovamente, diventando un potenziale combustibile. Se, al contrario, si arriva tardi, la vegetazione sarà assai più secca e, quindi, più incline a bruciare.
In questo periodo capita, percorrendo le lunghissime strade del Paese, di filare di fianco a terra nera che alita calore, sotto un cielo spesso e acre di fumo. Capita anche di vedere un camioncino bianco con il simbolo del Northern Territory fermo in prossimità di un cartellone a forma di mezza luna: un uomo con pantaloni cachi e scarponi sta regolando una lancetta gialla. La mezza luna ha spicchi di colori differenti che aggiornano sul livello di pericolo incendi: verde vuol dire moderato, azzurro sta per alto, giallo molto alto, rosso è estremo. L’ultimo spicchio, rosso acceso, indica uno stato catastrofico.
Ben dà fuoco alla boscaglia utilizzando una fiamma bassa per far sì che non brucino gli alberi, prezioso elemento ambientale oltre che dimora di uccelli, marsupiali e altri animali. La terra bruciata crea una barriera che impedirà agli incendi che dovessero sorgere spontanei di diramarsi. Il “fuoco freddo” va appiccato di notte o di mattina presto, quando di norma il vento è più lieve e non è ancora sorto il sole, che incoraggia le fiamme. L’incendio si propaga con lentezza, non bruciano i semi delle piante e non si distruggono né le radici né le chiome degli alberi.
Nell’isola abbondano gli alberi resinosi: i più diffusi sono gli eucalipti, dalle foglie molto oleose. Quando prendono fuoco, queste foglie crepitano e scoppiettano come fuochi d’artificio in miniatura, le fiamme salgono rapide e le chiome diventano palle di fuoco: se c’è vento, queste palle si diramano di cresta in cresta a grande velocità (anche dieci chilometri orari), espandendosi e allargandosi per giorni. Li chiamano cacatua fire perché in qualche modo fanno venire in mente i cacatua, grossi pappagalli bianchi con una folta cresta gialla.
“I cambiamenti climatici e la siccità degli ultimi anni hanno un peso rilevante nel fenomeno degli incendi”, dice Ben, l’uomo del fuoco. Sono le cinque di pomeriggio a Katherine e la sua giornata è terminata: ci troviamo a fare il bagno nelle pozze termali appena fuori dalla cittadina. “Di fronte a quello che sta accadendo le tecniche tradizionali, anche se fossero applicate in maniera diffusa, non sarebbero sufficienti né risolutive. Per questo attuiamo i cultural burning in concomitanza con altre politiche di riduzione del pericolo di incendi e con interventi adattati alla vita contemporanea. Tuttavia, sono convinto che diffondere queste conoscenze e metterle in pratica in maniera ampia ci aiuterebbe a preservare e conservare l’ambiente”.
Un ambiente, quello australiano, di una ricchezza grande come i suoi cieli che pare non finiscano mai. Affascinante, potente e unico.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
TERRA!!! TERRA!!! PIANETA TERRA: FILOLOGIA E ’DENDROLOGIA’ (gr.: "déndron" - albero e "lògos" - studio/scienza). L’ALBERO DELLA VITA ...
 RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO".
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO".Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- CONVERSIONE ECOLOGICA. Un Giubileo ecumenico per salvare il Pianeta (di Alex Zanotelli - "Mosaico di Pace".31 gennaio 2020, di Federico La Sala
Il sogno.
Un Giubileo ecumenico per salvare il Pianeta
di Alex Zanotelli (Avvenire, venerdì 31 gennaio 2020)
Caro direttore,
la situazione ambientale Cdel Pianeta è sempre più grave (gli orrendi fuochi in Australia e altrove ne sono una riprova) e i governi del mondo sempre più incapaci a trovare soluzioni.
Il fallimento della Cop25 di Madrid, che ha visto coinvolti tutti i governi del mondo per oltre due settimane dello scorso dicembre, è un brutto segnale per l’umanità. Ha vinto il petrolio, ha vinto il carbone! Ha perso la Politica: i governi sono prigionieri dei poteri economico- finanziari. La colpa è soprattutto degli Usa di Trump, del Brasile di Bolsonaro, dell’Australia di Morrison: è la vittoria del sovranismo ambientale.
Da Madrid ne escono invece sconfitti i Paesi impoveriti che subiranno il maggior danno del surriscaldamento, causato al 90% dai Paesi ricchi. Purtroppo questi ultimi si sono rifiutati di aumentare il Fondo per aiutare i Paesi impoveriti ad affrontare i disastri climatici. È il trionfo dell’eco-razzismo. Tutto questo è uno schiaffo ai movimenti ambientalisti di Fridays for Future, ai Sunrisers Usa, agli Extinction Rebellion, ai milioni di persone scese in piazza, a papa Francesco, così impegnato in questo campo con la Laudato si’ e il Sinodo per l’Amazzonia. Per questo, vista la gravità della situazione ambientale e l’arroganza dei Paesi sovranisti, noi chiediamo a papa Francesco un altro regalo: un Giubileo per salvare il Pianeta. È quanto chiede la nota economista inglese, Ann Pettifor, che ha diretto la vittoriosa campagna del Giubileo 2000 per la remissione dei debiti ai Paesi del sud del mondo. Lei fa notare nel suo recente libro The case for the Green New Deal che, se vogliamo guarire questo nostro eco-sistema malato, dobbiamo riordinare la finanza mondiale.
E allora un Giubileo potrebbe essere provvidenziale, in un momento così critico. Il Giubileo nasce dal concetto biblico del settimo giorno: il sabato, che significa riposare. È il principio sabbatico di riposo per gli uomini, per gli animali, per la terra, ma anche per i sistemi economicofinanziari.
 Il principio sabbatico è basato sul concetto del limite: non siamo Dio, siamo esseri limitati. Ed ecco il Giubileo biblico dei sette anni di sabati e poi di sette per sette anni di sabati, il grande Giubileo, che prevedeva la remissione dei debiti, la restituzione della terra, la liberazione degli schiavi e il riposo della terra. Gesù ha iniziato il suo ministero nella Galilea dei disperati, annunciando l’«anno di grazia», il Giubileo.
Il principio sabbatico è basato sul concetto del limite: non siamo Dio, siamo esseri limitati. Ed ecco il Giubileo biblico dei sette anni di sabati e poi di sette per sette anni di sabati, il grande Giubileo, che prevedeva la remissione dei debiti, la restituzione della terra, la liberazione degli schiavi e il riposo della terra. Gesù ha iniziato il suo ministero nella Galilea dei disperati, annunciando l’«anno di grazia», il Giubileo.Quello del 2000 ha finalmente ripreso questa dimensione sociale, affermando che ci sono limiti allo sfruttamento dei debitori da parte dei creditori. Così abbiamo ottenuto la remissione di tanti debiti dei Paesi impoveriti. Oggi abbiamo bisogno di un altro Giubileo che sappia coniugare la dimensione finanziaria con quella ecologica: il riposo della terra. «Non possiamo infatti affrontare la crisi del nostro eco-sistema - afferma sempre Pettifor - senza riformare il sistema economico-finanziario. Una linea diretta collega il credito emesso dalle banche, che aprono il rubinetto della liquidità, senza preoccuparsi dell’utilizzo che viene fatto di quel denaro, e la spinta verso un sistema basato sull’iperconsumo e sull’iperproduzione e quindi sulle emissioni di gas serra».
Perché questo possa avvenire - sostiene ancora Pettifor - il sistema finanziario globale deve di nuovo essere controllato dall’autorità pubblica, mentre oggi la finanza è controllata da autorità private ( Wall Street, City di Londra...). «Fintanto che la finanza non regolata - scrive il gesuita ed economista francese Gaël Giraud nel suo libro ’Transizione ecologica’ - prometterà un rendimento del 15% l’anno, il risparmio non potrà essere investito in un programma di industrializzazione verde, che potrà essere redditizia solo nel lungo periodo. Spetta dunque a noi, in seno alla società civile, nelle nostre Chiese, esigere dalla politica che adotti le misure che si impongono per regolare i mercati finanziari ». Il Sogno giubilare, che dovremo inseguire, secondo Giraud, è quello che «denaro e credito diventino beni comuni ».
Ecco perché in questo momento storico sarebbe importante un Giubileo che aiuti le comunità cristiane a ritrovare il ’Gran sogno di Dio’ espresso nelle tradizioni giubilari e radicalizzato da Gesù. Sarebbe straordinario se le Chiese cristiane, riunite nel Consiglio Mondiale delle Chiese-Wcc, dimenticando le polemiche passate sui Giubilei, si accordassero per proclamare un Giubileo ecumenico! Il Giubileo dovrebbe portare le Chiese a «una conversione ecologica - come afferma papa Francesco nella Laudato si’ - che comporta il lasciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda. Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana».
Sacerdote, missionario comboniano e direttore di ’Mosaico di Pace’
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" --- PER LA CRITICA DELLA RAGIONE "OLIMPICA". Il discorso di Greta Thunberg alle Nazioni unite.28 gennaio 2020, di Federico La Sala
Editoriale
PER LA CRITICA DELLA RAGIONE "OLIMPICA" .... *
Il discorso di Greta Thunberg alle Nazioni unite
di Greta Thunberg (il manifesto, 27.9.2019)
New York. E’ tutto sbagliato. Io non dovrei essere qui di fronte a voi. Dovrei essere a scuola dall’altra parte dell’oceano. Eppure venite tutti da me per avere speranza? Ma come osate! Voi avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre vuote parole. Eppure io sono una persona fortunata.
Le persone soffrono. Le persone stanno morendo. Interi ecosistemi stanno crollando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa. E tutto ciò di cui riuscite a parlare sono i soldi e le favole della crescita economica infinita. Come osate!
Per più di 30 anni la scienza è stata di una chiarezza cristallina. Con che coraggio osate continuare a girarvi dall’altra parte e venire qui assicurando che state facendo abbastanza, quando la politica e le soluzioni necessarie non sono ancora nemmeno all’orizzonte.
Dite che “ci ascoltate” e che comprendete l’urgenza. Ma non importa quanto io sia triste e arrabbiata, non voglio crederci. Perché se comprendeste davvero la situazione e continuaste a non agire, allora sareste malvagi. E mi rifiuto di crederci.
L’idea più diffusa sul dimezzare le nostre emissioni in 10 anni ci dà solo il 50% di probabilità di rimanere al di sotto di 1,5 ° C e disinnescare così reazioni a catena irreversibili al di fuori del controllo umano.
Forse il 50% di probabilità è accettabile per voi. Ma questi numeri non includono i punti di non ritorno, la maggior parte dei circuiti di feedback, il riscaldamento aggiuntivo nascosto dall’inquinamento atmosferico tossico o gli aspetti di giustizia e di equità. Fanno anche affidamento sull’ipotesi che la mia generazione e quella dei miei figli riuscirà a risucchiare centinaia di miliardi di tonnellate di CO2 dall’atmosfera con tecnologie che oggi esistono a malapena.
Quindi un rischio del 50% non è semplicemente accettabile per noi - noi che dobbiamo convivere con le conseguenze.
Per avere una probabilità del 67% di rimanere al di sotto di un aumento della temperatura globale di 1,5 ° C - le migliori probabilità stimate dal Pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici - il 1 ° gennaio 2018 il mondo aveva solo 420 gigatonnellate di anidride carbonica da poter rilasciare nell’atmosfera.
Oggi questa cifra è già sotto le 350 gigatonnellate. Come osate far finta che questo problema possa essere risolto con le solite soluzioni economiche e tecniche. Con i livelli di emissione odierni, la quantità di CO2 a disposizione sarà completamente sparita in meno di otto anni e mezzo.
Non ci saranno soluzioni o piani presentati secondo i dati di oggi. Perché questi numeri sono troppo scomodi. E voi non siete ancora abbastanza maturi per dire le cose come stanno.
Ci state deludendo e tradendo. Ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento. Gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi. E se sceglierete di fallire, vi dico che non vi perdoneremo mai.
Non vi lasceremo andare via come se nulla fosse. Proprio qui, proprio adesso, è dove tracciamo la linea. Il mondo si sta svegliando. E il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no.
* Testo del discorso all’Assemblea generale delle Nazioni unite di New York del 23 settembre 2019 (traduzione dall’inglese a cura di Matteo Bartocci).
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- PIANETA TERRA. Tracce per una svolta antropologica...
- MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours").
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINCINQUE SECOLI” DI LETARGO: "SE NON RIDIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI" (Mt. 18, 3).
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaGUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE (LA LEZIONE DI NELSON MANDELA).
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- PSICOANALISI: GUARDARE DALLO SPAZIO LA TERRA, CON LA "NAVE" DI GALILEI.11 gennaio 2020, di Federico La Sala
FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI. Al di là del "paradosso della ripetizione" ... *
- "Uno psicoanalista scomodo: Elvio Fachinelli" di Sergio Benvenuto (Le parole e le cose, 10.01.2020).
- Nota di commento: Non risulta affatto simpatico il signor Elvio Fachinelli da questo articolo.
- “Perché Fachinelli non indulse mai alla retorica anti-tecnologica, al rifiuto snob e/o retrogrado dei media, alla nostalgia agro-pastorale di un Pasolini ad esempio, al contrario, era attento ai nuovi portati dalla tecnologia.“
- Mi ha scoraggiata... Francesca
TROVO MOLTO INTERESSANTE l’indicazione di FRANCESCA (vedi - sopra) di mettere i piedi a Terra e guardare la Luna. Al di là dei limiti del percorso di Fachinelli, mia opinione, di ciò che resta fondamentale del suo lavoro è la decisiva messa in evidenza di quanto - antropologicamente - sta al fondamento della rivoluzione (e pratica!) psicoanalitica: "La mente estatica" (1989)! Si possono chiudere porte e finestre all’infinito, ma ora non solo dalla caverna platonica ma anche dall’isola di Creta ("Sulla spiaggia", 1985) si può uscire (cfr. Fachinelli e Freud nella "nave" di Galilei), riprendere la navigazione e guardare dall’Oceano, terrestre e celeste, la Terra ...
IL "GIARDINO" DEVASTATO E LE PIANTE. "Lo sciovinismo antropologico/antropocentrico (e più generalmente zoo-logico/zoo-centrico) che impera su gran parte della filosofia morale e politica dall’antichità ai giorni nostri non ammette un valore delle piante in quanto tali. Per gli esseri umani è molto più facile identificarsi con gli animali che con le piante, la cui fisiologia risulta difficile da comprendere (l’antropomorfismo e lo zoomorfismo vanno facilmente insieme). L’apparente immobilità delle piante, la loro apparente mancanza di differenziazione, il loro essere apparentemente inermi e inette, rendono le piante poco salienti per i sensi degli esseri umani - facilitando così anche la scomparsa della vita vegetale dall’orizzonte dell’etica e della politica.
 Quest’oblio è ingiustificato in sé e costituisce anche un problema urgente per l’etica dell’ambiente. Se non si dà valore alle piante, perché le si ritiene prive delle caratteristiche necessarie a generare valore (come l’autocoscienza, l’intelligenza, la capacità di provare sensazioni ed emozioni, di agire, di esercitare la volontà), allora non si potrà dare valore alla natura inanimata, cioè agli ecosistemi e al mondo naturale nel suo complesso, dichiarando così il fallimento di ogni tipo di etica dell’ambiente non fondamentalmente antropo- o zoo-centrica.
Quest’oblio è ingiustificato in sé e costituisce anche un problema urgente per l’etica dell’ambiente. Se non si dà valore alle piante, perché le si ritiene prive delle caratteristiche necessarie a generare valore (come l’autocoscienza, l’intelligenza, la capacità di provare sensazioni ed emozioni, di agire, di esercitare la volontà), allora non si potrà dare valore alla natura inanimata, cioè agli ecosistemi e al mondo naturale nel suo complesso, dichiarando così il fallimento di ogni tipo di etica dell’ambiente non fondamentalmente antropo- o zoo-centrica.
 Nella pratica, alcuni degli atteggiamenti più rapaci e noncuranti nei confronti della natura potrebbero ben derivare proprio dal nostro rifiuto o incapacità di aprirci alle piante e al loro valore, e addirittura alla stessa ipotesi che abbiano valore. Una buona quota della attuale crisi ecologica, possibilmente la più subdola e insidiosa, potrebbe risultare riconducibile a questa incapacità o rifiuto, e spiegabile attraverso il prisma delle nostre relazioni irrisolte con le piante.
Nella pratica, alcuni degli atteggiamenti più rapaci e noncuranti nei confronti della natura potrebbero ben derivare proprio dal nostro rifiuto o incapacità di aprirci alle piante e al loro valore, e addirittura alla stessa ipotesi che abbiano valore. Una buona quota della attuale crisi ecologica, possibilmente la più subdola e insidiosa, potrebbe risultare riconducibile a questa incapacità o rifiuto, e spiegabile attraverso il prisma delle nostre relazioni irrisolte con le piante.
 Se si dà valore alle piante si è sulla buona strada per dare valore alla natura tutta, inclusa tutta quella inanimata; e non solo come un insieme indistinto, ma come un ricettacolo di diversità e di specificità e particolarità inesauribile. Una visione del genere terrà conto, per esempio, del fatto che gran parte della natura è roccia, acqua, e piante: la vita animale si attesta, in proporzione, solo al quarto posto - la “nazione delle piante”, come la battezza Stefano Mancuso, è di gran lunga la più popolosa [...]"(dal volume "Etica e politica delle piante", di Gianfranco Pellegrino e Marcello Di Paola, e con contributi di Simone Pollo e Alessandra Viola).
Se si dà valore alle piante si è sulla buona strada per dare valore alla natura tutta, inclusa tutta quella inanimata; e non solo come un insieme indistinto, ma come un ricettacolo di diversità e di specificità e particolarità inesauribile. Una visione del genere terrà conto, per esempio, del fatto che gran parte della natura è roccia, acqua, e piante: la vita animale si attesta, in proporzione, solo al quarto posto - la “nazione delle piante”, come la battezza Stefano Mancuso, è di gran lunga la più popolosa [...]"(dal volume "Etica e politica delle piante", di Gianfranco Pellegrino e Marcello Di Paola, e con contributi di Simone Pollo e Alessandra Viola).*
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- USCIRE DALL’ORIZZONTE "COSMOTEANDRICO" IMPERIALE.4 gennaio 2020, di Federico La Sala
"ECCE HOMO": (ANTROPOLOGIA, NON "ANDROPOLOGIA" O "GINECO-LOGIA")!!! USCIRE DALL’ORIZZONTE COSMOTEANDRICO DA "SACRO ROMANO IMPERO"... *
- Dio creò l’uomo ("homo") ... e lo fece maschio ["masculum"] e femmina [" foeminam "] (Genesi, I.27).
- “Chi tene ‘a lingua, va ’n Sardegna" (antico proverbio campano)
La parola può tutto
di Ivano Dionigi (Avvenire, venerdì 3 gennaio 2020)
«Chiamo uomo chi è padrone della sua lingua». In questa sentenza fulminante di don Lorenzo Milani (Lettera a Ettore Bernabei 1956), ispirata a un deciso afflato di giustizia sociale, trovo il più bel commento al passo in cui Aristotele (Politica 1253 a) riconosce nella parola (logos) la marca che caratterizza l’uomo e lo distingue dagli animali, che ne sono privi (tà zóa á-loga). La parola: il bene più prezioso, la qualità più nobile, il sigillo più intimo. A una persona, a un gruppo, a un popolo puoi togliere averi, lavoro, affetti: ma non la parola. Un divario economico si ripiana, un’occupazione si rimedia, una ferita affettiva si rimargina, ma la mancanza o l’uso ridotto della parola nega l’identità, esclude dalla comunità, confina alla solitudine e quindi riduce allo stato animale. «La parola - continuava il profetico prete di Barbiana - è la chiave fatata che apre ogni porta»; tutto può, come già insegnava la saggezza classica: «spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione» (Gorgia, Elogio di Elena 8). Ma essa è di duplice segno, nella vita privata come in quella pubblica: con i cittadini onesti e i governanti illuminati si fa simbolica (syn-bállein), e quindi unisce, consola, salva; confiscata dai cittadini corrotti e dai demagoghi si fa diabolica (dia-bállein), e quindi divide, affanna, uccide.
- ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS - NON IL "LOGO"! La questione della "Parola" e della "Lingua".
- RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!!
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
- OBIEZIONE DI COSCIENZA !!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
“DE DOMO DAVID”?! GIUSEPPE, MARIA, E L’IMMAGINARIO “COSMOTEANDRICO” (COSMOLOGIA, TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA!) DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA... *
- Nota di commento a margine di "De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò" (cfr. "Fondazione Terra d’Otranto", 10.11.2019).
CARDINALE CASTRILLON HOYOS: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio”(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
PAPA FRANCESCO: “«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana! [...]” (LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, Omelia di papa Francesco, Basilica Vaticana, Mercoledì, 1° gennaio 2020).
*
A) - La costruzione del ’presepe’ cattolico-romano .... e la ’risata’ di Giuseppe!!!
 MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;B) Il magistero della Legge dei nostri Padri e delle nostre Madri Costituenti non è quello di “Mammona” (“Deus caritas est”, 2006)! EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA “NON CLASSIFICATA”!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907.
C) GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di “pensare un altro Abramo”.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- IMMAGINAZIONE COSMOTEANDRICA E ANTROPOLOGIA: "COME NASCONO I BAMBINI"?!2 gennaio 2020, di Federico La Sala
CREATIVITÀ E IMMAGINAZIONE COSMOTEANDRICA (cosmologia, teologia, e antropo-logia!). QUALE DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")? QUALE MADRE: "MARIA-EVA" O "MARIA-MARIA"?!....*
- "«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana! [...]" (LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, Omelia di papa Francesco, Basilica Vaticana, Mercoledì, 1° gennaio 2020)
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
SANTA MESSA NELLA SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO
LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
CAPPELLA PAPALE
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Basilica Vaticana
 Mercoledì, 1° gennaio 2020
Mercoledì, 1° gennaio 2020«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana!
Nel primo giorno dell’anno celebriamo queste nozze tra Dio e l’uomo, inaugurate nel grembo di una donna. In Dio ci sarà per sempre la nostra umanità e per sempre Maria sarà la Madre di Dio. È donna e madre, questo è l’essenziale. Da lei, donna, è sorta la salvezza e dunque non c’è salvezza senza la donna. Lì Dio si è unito a noi e, se vogliamo unirci a Lui, si passa per la stessa strada: per Maria, donna e madre. Perciò iniziamo l’anno nel segno della Madonna, donna che ha tessuto l’umanità di Dio. Se vogliamo tessere di umanità le trame dei nostri giorni, dobbiamo ripartire dalla donna.
Nato da donna. La rinascita dell’umanità è cominciata dalla donna. Le donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. Quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare. Va liberato dal consumismo, va rispettato e onorato; è la carne più nobile del mondo, ha concepito e dato alla luce l’Amore che ci ha salvati! Oggi pure la maternità viene umiliata, perché l’unica crescita che interessa è quella economica. Ci sono madri, che rischiano viaggi impervi per cercare disperatamente di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono giudicate numeri in esubero da persone che hanno la pancia piena, ma di cose, e il cuore vuoto di amore.
Nato da donna. Secondo il racconto della Bibbia, la donna giunge al culmine della creazione, come il riassunto dell’intero creato. Ella, infatti, racchiude in sé il fine del creato stesso: la generazione e la custodia della vita, la comunione con tutto, il prendersi cura di tutto. È quello che fa la Madonna nel Vangelo oggi. «Maria - dice il testo - custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (v. 19). Custodiva tutto: la gioia per la nascita di Gesù e la tristezza per l’ospitalità negata a Betlemme; l’amore di Giuseppe e lo stupore dei pastori; le promesse e le incertezze per il futuro. Tutto prendeva a cuore e nel suo cuore tutto metteva a posto, anche le avversità. Perché nel suo cuore sistemava ogni cosa con amore e affidava tutto a Dio.
Nel Vangelo questa azione di Maria ritorna una seconda volta: al termine della vita nascosta di Gesù si dice infatti che «sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore» (v. 51). Questa ripetizione ci fa capire che custodire nel cuore non è un bel gesto che la Madonna faceva ogni tanto, ma la sua abitudine. È proprio della donna prendere a cuore la vita. La donna mostra che il senso del vivere non è continuare a produrre cose, ma prendere a cuore le cose che ci sono. Solo chi guarda col cuore vede bene, perché sa “vedere dentro”: la persona al di là dei suoi sbagli, il fratello oltre le sue fragilità, la speranza nelle difficoltà; vede Dio in tutto.
Mentre cominciamo il nuovo anno chiediamoci: “So guardare col cuore? So guardare col cuore le persone? Mi sta a cuore la gente con cui vivo, o le distruggo con le chiacchiere? E soprattutto, ho al centro del cuore il Signore? O altri valori, altri interessi, la mia promozione, le ricchezze, il potere?”. Solo se la vita ci sta a cuore sapremo prendercene cura e superare l’indifferenza che ci avvolge. Chiediamo questa grazia: di vivere l’anno col desiderio di prendere a cuore gli altri, di prenderci cura degli altri. E se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, ci stia a cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è nato il Principe della pace. La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali. Perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace. Perciò, una conquista per la donna è una conquista per l’umanità intera.
Nato da donna. Gesù, appena nato, si è specchiato negli occhi di una donna, nel volto di sua madre. Da lei ha ricevuto le prime carezze, con lei ha scambiato i primi sorrisi. Con lei ha inaugurato la rivoluzione della tenerezza. La Chiesa, guardando Gesù bambino, è chiamata a continuarla. Anch’ella, infatti, come Maria, è donna e madre, la Chiesa è donna e madre, e nella Madonna ritrova i suoi tratti distintivi. Vede lei, immacolata, e si sente chiamata a dire “no” al peccato e alla mondanità. Vede lei, feconda, e si sente chiamata ad annunciare il Signore, a generarlo nelle vite. Vede lei, madre, e si sente chiamata ad accogliere ogni uomo come un figlio.
Avvicinandosi a Maria la Chiesa si ritrova, ritrova il suo centro, ritrova la sua unità. Il nemico della natura umana, il diavolo, cerca invece di dividerla, mettendo in primo piano le differenze, le ideologie, i pensieri di parte e i partiti. Ma non capiamo la Chiesa se la guardiamo a partire dalle strutture, a partire dai programmi e dalle tendenze, dalle ideologie, dalle funzionalità: coglieremo qualcosa, ma non il cuore della Chiesa. Perché la Chiesa ha un cuore di madre. E noi figli invochiamo oggi la Madre di Dio, che ci riunisce come popolo credente. O Madre, genera in noi la speranza, porta a noi l’unità. Donna della salvezza, ti affidiamo quest’anno, custodiscilo nel tuo cuore. Ti acclamiamo: Santa Madre di Dio. Tutti insieme, per tre volte, acclamiamo la Signora, in piedi, la Madonna Santa Madre di Dio: [con l’assemblea] Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio!
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETÀ. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
- IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!!
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Appello per una Costituzione della Terra. «Costituente Terra». «Perché la storia continui». «Costituente Terra».26 dicembre 2019, di Federico La Sala
«Perché la storia continui». Appello per una Costituzione della Terra
Proposte. Appello per un nuovo costituzionalismo globale, una bussola etica e politica per salvare il mondo e i suoi abitanti dalla distruzione.
di Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, Raffaele Nogaro, Paolo Maddalena, Mariarosaria Guglielmi, Riccardo Petrella (il manifesto, 26.12.2019)
Nel pieno della crisi globale, nel 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, il vescovo Nogaro, Riccardo Petrella e molti altri lanciano il progetto politico di una Costituzione per la Terra e promuovono una Scuola, «Costituente Terra», che ne elabori il pensiero e prefiguri una nuova soggettività politica del popolo della Terra, «perché la storia continui». Pubblichiamo le parti essenziali del documento che esce domani, in data 27 dicembre 2019.
L’Amazzonia brucia e anche l’Africa, e non solo di fuoco, la democrazia è a pezzi, le armi crescono, il diritto è rotto in tutto il mondo. «Terra! Terra!» è il grido dei naufraghi all’avvistare la sponda, ma spesso la terra li respinge, dice loro: «i porti sono chiusi, avete voluto prendere il mare, fatene la vostra tomba, oppure tornate ai vostri inferni». Ma «Terra» è anche la parola oggi più amata e perduta dai popoli che ne sono scacciati in forza di un possesso non condiviso; dai profughi in fuga per la temperatura che aumenta e il deserto che avanza; dalle città e dalle isole destinate ad essere sommerse al rompersi del chiavistello delle acque, quando la Groenlandia si scioglie, i mari son previsti salire di sette metri sull’asciutto, e a Venezia già lo fanno di un metro e ottantasette. «Che si salvi la Terra» dicono le donne e gli uomini tutti che assistono spaventati e impotenti alla morte annunciata dell’ambiente che da millenni ne ospita la vita.
Ci sono per fortuna pensieri e azioni alternative, si diffonde una coscienza ambientale, il venerdì si manifesta per il futuro, donne coraggiose da Greta Thunberg a Carola Rackete fanno risuonare milioni di voci, anche le sardine prendono la parola, ma questo non basta. Se nei prossimi anni non ci sarà un’iniziativa politica di massa per cambiare il corso delle cose, se le si lascerà in balia del mercato della tecnologia o del destino, se in Italia, in Europa e nelle Case Bianche di tutti i continenti il fascismo occulto che vi serpeggia verrà alla luce e al potere, perderemo il controllo del clima e della società e si affacceranno scenari da fine del mondo, non quella raccontata nelle Apocalissi, ma quella prevista e monitorata dagli scienziati.
Il cambiamento è possibile
L’inversione del corso delle cose è possibile. Essa ha un nome: Costituzione della terra. Il costituzionalismo statuale che ha dato una regola al potere, ha garantito i diritti, affermato l’eguaglianza e assicurato la vita degli Stati non basta più, occorre passare a un costituzionalismo mondiale della stessa autorità ed estensione dei poteri e del denaro che dominano la Terra.
La Costituzione del mondo non è il governo del mondo, ma la regola d’ingaggio e la bussola di ogni governo per il buongoverno del mondo. Nasce dalla storia, ma deve essere prodotta dalla politica, ad opera di un soggetto politico che si faccia potere costituente. Il soggetto costituente di una Costituzione della Terra è il popolo della Terra, non un nuovo Leviatano, ma l’unità umana che giunga ad esistenza politica, stabilisca le forme e i limiti della sua sovranità e la eserciti ai fini di far continuare la storia e salvare la Terra.
Salvare la Terra non vuol dire solo mantenere in vita «questa bella d’erbe famiglia e d’animali», cantata dai nostri poeti, ma anche rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo di tutte le persone umane.
 Il diritto internazionale è già dotato di una Costituzione embrionale del mondo, prodotta in quella straordinaria stagione costituente che fece seguito alla notte della seconda guerra mondiale e alla liberazione dal fascismo e dal nazismo: la Carta dell’Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, i due Patti internazionali del 1966 e le tante Carte regionali dei diritti, che promettono pace, sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri umani. Ma non sono mai state introdotte le norme di attuazione di queste Carte, cioè le garanzie internazionali dei diritti proclamati. Non è stato affatto costituito il nuovo ordine mondiale da esse disegnato. È come se un ordinamento statale fosse dotato della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di tribunali, di scuole e di ospedali che «di fatto la realizzino».
Il diritto internazionale è già dotato di una Costituzione embrionale del mondo, prodotta in quella straordinaria stagione costituente che fece seguito alla notte della seconda guerra mondiale e alla liberazione dal fascismo e dal nazismo: la Carta dell’Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, i due Patti internazionali del 1966 e le tante Carte regionali dei diritti, che promettono pace, sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri umani. Ma non sono mai state introdotte le norme di attuazione di queste Carte, cioè le garanzie internazionali dei diritti proclamati. Non è stato affatto costituito il nuovo ordine mondiale da esse disegnato. È come se un ordinamento statale fosse dotato della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di tribunali, di scuole e di ospedali che «di fatto la realizzino».È chiaro che in queste condizioni i diritti proclamati sono rimasti sulla carta, come promesse non mantenute. Riprendere oggi il processo politico per una Costituzione della Terra vuol dire tornare a prendere sul serio il progetto costituzionale formulato settant’anni fa e i diritti in esso stabiliti. E poiché quei diritti appartengono al diritto internazionale vigente, la loro tutela e attuazione non è soltanto un’urgente opzione politica, ma anche un obbligo giuridico in capo alla comunità internazionale e a tutti noi che ne facciamo parte.
Qui c’è un’obiezione formulata a partire dalla tesi di vecchi giuristi secondo la quale una Costituzione è l’espressione dell’«unità politica di un popolo»; niente popolo, niente Costituzione. E giustamente si dice che un popolo della Terra non c’è; infatti non c’era ieri e fino ad ora non c’è.
La novità è che adesso può esserci, può essere istituito; lo reclama la scena del mondo, dove lo stato di natura delle sovranità in lotta tra loro non solo toglie la «buona vita», ma non permette più neanche la nuda vita; lo reclama l’oceano di sofferenza in cui tutti siamo immersi; lo rende possibile oggi la vetta ermeneutica raggiunta da papa Francesco e da altre religioni con lui, grazie alla quale non può esserci più un dio a pretesto della divisione tra i popoli: «Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno» - hanno detto ad Abu Dhabi - non vuole essere causa di terrore per nessuno, mentre lo stesso «pluralismo e le diversità di religione sono una sapiente volontà divina con cui Dio ha creato gli esseri umani»; non c’è più un Dio geloso e la Terra stessa non è una sfera, ma un poliedro di differenze armoniose.
Per molti motivi perciò è realistico oggi porsi l’obiettivo di mettere in campo una Costituente della Terra, prima ideale e poi anche reale, di cui tutte le persone del pianeta siano i Padri e le Madri costituenti.
Una politica dalla parte della Terra
Di per sé l’istanza di una Costituzione della Terra dovrebbe essere perseguita da quello strumento privilegiato dell’azione politica che, almeno nelle democrazie, è il partito - nazionale o transnazionale che sia - ossia un artefice collettivo che, pur sotto nomi diversi, agisca nella forma partito. Oggi questo nome è in agonia perché evoca non sempre felici ricordi, ma soprattutto perché i grandi poteri che si arrogano il dominio del mondo non vogliono essere intralciati dal controllo e dalla critica dei popoli, e quindi cercano di disarmarli spingendoli a estirpare le radici della politica e dei partiti fin nel loro cuore. È infatti per la disaffezione nei confronti della politica a cui l’intera società è stata persuasa che si scende in piazza senza colori; ma la politica non si sospende, e ciò a cui comunque oggi siamo chiamati è a prendere partito, a prendere partito non per una Nazione, non per una classe, non “prima per noi”, ma a prendere partito per la Terra, dalla parte della Terra.
Ma ancor più che la riluttanza all’uso di strumenti già noti, ciò che impedisce l’avvio di questo processo costituente, è la mancanza di un pensiero politico comune che ne faccia emergere l’esigenza e ne ispiri modalità e contenuti.
Non manca certamente l’elaborazione teorica di un costituzionalismo globale che vada oltre il modello dello Stato nazionale, il solo nel quale finora è stata concepita e attuata la democrazia, né mancano grandi maestri che lo propugnino; ma non è diventato patrimonio comune, non è entrato nelle vene del popolo un pensiero che pensi e promuova una Costituzione della Terra, una unità politica dell’intera comunità umana, il passaggio a una nuova e rassicurante fase della storia degli esseri umani sulla Terra.
Eppure le cose vanno così: il pensiero dà forma alla realtà, ma è la sfida della realtà che causa il pensiero. Una “politica interna del mondo” non può nascere senza una scuola di pensiero che la elabori, e un pensiero non può attivare una politica per il mondo senza che dei soggetti politici ne facciano oggetto della loro lotta. Però la cosa è tale che non può darsi prima la politica e poi la scuola, né prima la scuola e poi la politica. Devono nascere insieme, perciò quello che proponiamo è di dar vita a una Scuola che produca un nuovo pensiero della Terra e fermenti causando nuove soggettività politiche per un costituzionalismo della Terra. Perciò questa Scuola si chiamerà «Costituente Terra».
«Costituente Terra»: una Scuola per un nuovo pensiero
Certamente questa Scuola non può essere pensata al modo delle Accademie o dei consueti Istituti scolastici, ma come una Scuola disseminata e diffusa, telematica e stanziale, una rete di scuole con aule reali e virtuali. Se il suo scopo è di indurre a una mentalità nuova e a un nuovo senso comune, ogni casa dovrebbe diventare una scuola e ognuno in essa sarebbe docente e discente. Il suo fine potrebbe perfino spingersi oltre il traguardo indicato dai profeti che volevano cambiare le lance in falci e le spade in aratri e si aspettavano che i popoli non avrebbero più imparato l’arte della guerra. Ciò voleva dire che la guerra non era in natura: per farla, bisognava prima impararla. Senonché noi l’abbiamo imparata così bene che per prima cosa dovremmo disimpararla, e a questo la scuola dovrebbe addestrarci, a disimparare l’arte della guerra, per imparare invece l’arte di custodire il mondo e fare la pace.
Molte sarebbero in tale scuola le aree tematiche da perlustrare:
1) le nuove frontiere del diritto, il nuovo costituzionalismo e la rifondazione del potere;
2) il neo-liberismo e la crescente minaccia dell’anomia;
3) la critica delle culture ricevute e i nuovi nomi da dare a eventi e fasi della storia passata;
4) il lavoro e il Sabato, un lavoro non ridotto a merce, non oggetto di dominio e alienato dal tempo della vita;
5) la «Laudato sì» e l’ecologia integrale;
6) il principio femminile, come categoria rigeneratrice del diritto, dal mito di Antigone alla coesistenza dei volti di Levinas, al legame tra donna e natura fino alla metafora della madre-terra;
7) l’Intelligenza artificiale (il Führer artificiale?) e l’ultimo uomo;
8) come passare dalle culture di dominio e di guerra alle culture della liberazione e della pace;
9) come uscire dalla dialettica degli opposti, dalla contraddizione servo-signore e amico-nemico per assumere invece la logica dell’ et-et, della condivisione, dell’armonia delle differenze, dell’ «essere per l’altro», dell’ «essere l’altro»;
10) il congedo del cristianesimo dal regime costantiniano, nel suo arco «da Costantino ad Hitler», e la riapertura nella modernità della questione di Dio;
11) il «caso Bergoglio», preannuncio di una nuova fase della storia religiosa e secolare del mondo.
Naturalmente molti altri temi potranno essere affrontati, nell’ottica di una cultura per la Terra alla quale nulla è estraneo d’umano. Tutto ciò però come ricerca non impassibile e fuori del tempo, ma situata tra due kairòs, tra New Delhi ed Abu Dhabi, due opportunità, una non trattenuta e non colta, la proposta di Gorbaciov e Rajiv Gandhi del novembre 1986 per un mondo libero dalle armi nucleari e non violento, e l’altra che ora si presenta di una nuova fraternità umana per la convivenza comune e la salvezza della Terra, preconizzata nel documento islamo-cristiano del 4 febbraio 2019 e nel successivo Comitato di attuazione integrato anche dagli Ebrei, entrato ora in rapporto con l’ONU per organizzare un Summit mondiale della Fratellanza umana e fare del 4 febbraio la Giornata mondiale che la celebri.
Partecipare al processo costituente iscriversi al Comitato promotore
Pertanto i firmatari di questo appello propongono di istituire una Scuola denominata «Costituente Terra» che prenda partito per la Terra, e a questo scopo hanno costituito un’associazione denominata «Comitato promotore partito della Terra». Si chiama così perché in via di principio non era stata esclusa all’inizio l’idea di un partito, e in futuro chissà. Il compito è oggi di dare inizio a una Scuola, «dalla parte della Terra», alle sue attività e ai suoi siti web, e insieme con la Scuola ad ogni azione utile al fine «che la storia continui»; e ciò senza dimenticare gli obiettivi più urgenti, il risanamento del territorio, la rifondazione del lavoro, l’abolizione del reato di immigrazione clandestina, la firma anche da parte dell’Italia del Trattato dell’ONU per l’interdizione delle armi nucleari e così via.
I firmatari propongono che persone di buona volontà e di non perdute speranze, che esponenti di associazioni, aggregazioni o istituzioni già impegnate per l’ecologia e i diritti, si uniscano a questa impresa e, se ne condividono in linea generale l’ispirazione, si iscrivano al Comitato promotore di tale iniziativa all’indirizzo progettopartitodellaterra@gmail.com versando la relativa quota sul conto BNL intestato a “Comitato promotore del partito della Terra”, IBAN IT94X0100503206000000002788 (dall’estero BIC BNLIITRR).
La quota annua di iscrizione, al Comitato e alla Scuola stessa, è libera, e sarà comunque gradita. Per i meno poveri, per quanti convengano di essere tra i promotori che contribuiscono a finanziare la Scuola, eventuali borse di studio e il processo costituente, la quota è stata fissata dal Comitato stesso nella misura significativa di 100 euro, con l’intenzione di sottolineare che la politica, sia a pensarla che a farla, è cosa tanto degna da meritare da chi vi si impegna che ne sostenga i costi, contro ogni tornaconto e corruzione, ciò che per molti del resto è giunto fino all’offerta della vita. Naturalmente però si è inteso che ognuno, a cominciare dai giovani, sia libero di pagare la quota che crede, minore o maggiore che sia, con modalità diverse, secondo le possibilità e le decisioni di ciascuno.
Nel caso che l’iniziativa non riuscisse, le risorse finanziarie mancassero e il processo avviato non andasse a buon fine, l’associazione sarà sciolta e i fondi eventualmente residui saranno devoluti alle ONG che si occupano dei salvataggi dei fuggiaschi e dei naufraghi nel Mediterraneo.
Un’assemblea degli iscritti al Comitato sarà convocata non appena sarà raggiunto un congruo numero di soci, per l’approvazione dello Statuto dell’associazione, la formazione ed elezione degli organi statutari e l’impostazione dei programmi e dell’attività della Scuola.
Roma, 27 dicembre 2019, 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana.
PROPONENTI E PRIMI ISCRITTI. Raniero La Valle, giornalista (Roma), Luigi Ferrajoli, filosofo del diritto (Roma), Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale, Raffaele Nogaro, ex vescovo di Caserta, Paolo Maddalena, già vicepresidente della Corte Costituzionale, Mariarosaria Guglielmi, Segretaria generale di Magistratura Democratica, Riccardo Petrella, ecologo, promotore del Manifesto dell’acqua e dell’identità di “Abitante della Terra”, Domenico Gallo, magistrato, Francesco Carchedi, sociologo (Roma), Francesco Di Matteo, Comitati Dossetti per la Costituzione, Anna Falcone. avvocata, Roma, Pippo Civati, Politico, Piero Basso (Milano), Gianpietro Losapio, cooperatore sociale, direttore del Consorzio NOVA, Giacomo Pollastri, studente in Legge (Roma), Francesco Comina, giornalista (Bolzano), Roberto Mancini, filosofo (Macerata), Francesca Landini, informatica (Roma), Giancarlo Piccinni e la Fondazione don Tonino Bello (Alessano), Grazia Tuzi, antropologa, autrice di “Quando si faceva la Costituzione. Storia e personaggi della comunità del porcellino” (Roma), Guido Innocenzo Gargano osb cam., monaco (Roma), Felice Scalia, s. J, (Messina), Marina Graziosi, docente (Roma), Agata Cancelliere, insegnante, (Roma), Raul Mordenti, storico della critica letteraria, Politico (Roma), Salvatore Maira, scrittore (Roma), Marco Malagola, francescano, missionario, (Torino), Norma Lupi (Roma), Andrea Cantaluppi, sindacalista (Roma), Enrico Peyretti (Torino), Nino Mantineo, università di Catanzaro, Giacoma Cannizzo, già sindaca di Partinico, Filippo Grillo, artista (Palermo), Nicola Colaianni, già magistrato e docente all’Università di Bari, Stefania Limiti, giornalista (Roma), Domenico Basile (Merate, Lecco), Maria Chiara Zoffoli (Merate), Luigi Gallo (Bolzano), Antonio Vermigli, giornalista (Quarrata, Pistoia), Renata Finocchiaro, ingegnere (Catania), Liana D’Alessio (Roma), Lia Fava, ordinaria di letteratura (Roma), Paolo Pollastri, musicista (Roma), Fiorella Coppola, sociologa (Napoli), Dario Cimaglia, editore, (Roma), Luigi Spina, insegnante, ricercatore (Biella), Marco Campedelli, Boris Ulianich, storico, Università Federico II, Napoli, Gustavo Gagliardi, Roma, Paolo Scandaletti, scrittore di storia, Roma, Pierluigi Sorti, economista, Roma, Vittorio Bellavite, coordinatore di “Noi siamo Chiesa”, Agnés Deshormes, cooperatrice internazionale, Parigi, Anna Sabatini Scalmati, psicoterapeuta, Roma, Francesco Piva, Roma, Sergio Tanzarella, storico del cristianesimo, Tina Palmisano, Il Giardino Terapeutico sullo Stretto, Messina, Luisa Marchini, segretaria di “Salviamo la Costituzione”, Bologna, Maurizio Chierici, giornalista. Angelo Cifatte, formatore, Genova, Marco Tiberi, sceneggiatore, Roma, Achille Rossi e l’altrapagina, Città di Castello, Antonio Pileggi, ex Provveditore agli studi e dir. gen. INVALSI, Giovanni Palombarini, magistrato, Vezio Ruggieri, psicofisiologo (Roma) Bernardetta Forcella (insegnante (Roma), Luigi Narducci (Roma), Laura Nanni (Albano), Giuseppe Salmè, magistrato, Giovanni Bianco, giurista, Roma.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!!Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. --- Linguaggio ed empatia in W. V. Quine: carità o empatia? (di A. Rainone).17 dicembre 2019, di Federico La Sala
USCIRE DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO. Amore (Charitas) o Mammona (Caritas)?! Il "principle of charity", il «principio di carità» ("caritas"!), un assunzione di tipo «imperialistico» (Robert Nozick, "The Nature of Rationality", 1993) *
CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO.
di Antonio Rainone *
- 3.Linguaggio ed empatia in W. V. Quine
Carità o empatia?
Esiste una tematica nella filosofia del linguaggio e nell’epistemologia di W. V. Quine che può apparire per molti versi atipica o sorprendente a chi abbia del celebre filosofo statunitense un’immagine limitata alle sue concezioni fisicalistiche e comportamentistiche, per non dire “scientistiche”, non di rado considerate le più caratteristiche della sua produzione filosofica. Si tratta della tematica dell’empatia, cioè della capacità di avanzare spiegazioni o interpretazioni del comportamento (linguistico e non) di altri soggetti “mettendosi nei loro panni” o “simulandone” la situazione cognitiva o, ancora, assumendone immaginativamente il ruolo.
 L’empatia - anche indipendentemente
da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione
nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a
un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con
la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori
sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione
a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object
(1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione
più tarda.
L’empatia - anche indipendentemente
da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione
nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a
un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con
la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori
sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione
a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object
(1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione
più tarda.A partire dagli anni Settanta, ma più esplicitamente negli anni Novanta, Quine ha considerato il metodo dell’empatia come il metodo fondamentale di traduzione nel celebre Gedankenexperiment della traduzione radicale (ovvero la traduzione di una lingua completamente sconosciuta), ma anche come una capacità naturale ai fini dell’acquisizione del linguaggio e dell’attribuzione di stati mentali intenzionali (ossia percezioni, credenze, desideri ecc.) ad altri. In effetti, l’empatia ha acquisito un rilievo così crescente in Quine che nei suoi due ultimi lavori sistematici, Pursuit of Truth (1992) e From Stimulus to Science (1995), essa appare come un nucleo centrale della sua filosofia del linguaggio e della mente.
È stato del resto lo stesso Quine a sottolineare la rilevanza dell’empatia nella sua filosofia del linguaggio, “retrodatandone”, per così dire, la teorizzazione agli anni Cinquanta. Così Quine si esprime in uno dei suoi ultimi interventi sulla questione:
- Il mio uso della parola “empatia” è piuttosto recente ed è stato notato, ma io avevo già riconosciuto che l’approccio del traduttore radicale è di tipo empatico in Word and Object e, in realtà, già nove anni prima. «Il lessicografo - avevo scritto - dipende [...] da una proiezione di sé stesso, con la sua Weltanschauung indo-europea, nei sandali del suo informatore Kalaba» (Quine, 2000, p. 410).
Il brano qui citato da Quine, ripreso dall’importante The Problem of Meaning in Linguistics (1951b, p. 63) - una notevole anticipazione della problematica della traduzione radicale - non è privo di una certa ambiguità, prestandosi a una duplice lettura. È forse vero che in Word and Object alcune affermazioni di Quine potrebbero essere interpretate come la proposta di un metodo empatico, sostenuto comunque in modo non del tutto esplicito (cfr. Rainone, 1995), ma possono essere avanzati dei dubbi circa la difesa di tale metodo nel saggio del 1951. Se da un lato il concetto di proiezione sembra proporre il metodo dell’empatia nell’attività di traduzione di una lingua completamente sconosciuta da parte di un etnolinguista, dall’altro sembra in effetti riferirsi non tanto al metodo empatico, quanto, piuttosto, a quello che, grazie allo stesso Quine, e in seguito a Donald Davidson (cfr. Davidson, 1984), sarebbe diventato noto come «principio di carità» (principle of charity). Il linguista - asseriva infatti Quine - proietta sé stesso con la sua Weltanschauung nei panni del nativo che usa una lingua sconosciuta, presupponendo (o ipotizzando) così che il suo informatore si conformi ai suoi principi logici e abbia le sue stesse credenze (ritenute vere) riguardo alla realtà (sono questi, grosso modo, i principali tenet del principio di carità, che presuppone una comune natura razionale tra interprete/ traduttore e interpretato/parlante).
In Word and Object Quine avrebbe esplicitamente utilizzato - e teorizzato - il principio di carità riguardo alla traduzione dei connettivi logici e degli enunciati “ovvi”. L’esempio più pertinente, in merito, è rappresentato dal «caso estremo» di qualche nativo che accetti come veri enunciati traducibili nella forma “p e non-p” (per esempio, “piove e non piove”), una forma enunciativa che, violando il principio di non contraddizione, deporrebbe per Quine non a favore dell’irrazionalità dei parlanti - come riteneva Lévy-Bruhl con la sua teoria della «mentalità prelogica» - ma contro la correttezza della traduzione (Quine, 1960, p. 58).
Il medesimo argomento varrebbe inoltre per la traduzione di enunciati ovvi: una risposta negativa da parte del nativo alla domanda (nella lingua nativa) “sta piovendo?” fatta sotto la pioggia costituirebbe una prova di cattiva traduzione nella lingua nativa, non del fatto che il nativo non condivida con il traduttore la credenza in qualcosa di così evidente. In generale, nota Quine in un famoso passo di Word and Object, «quanto più assurde o esotiche sono le credenze attribuite a una persona tanto più sospetti abbiamo il diritto di essere nei confronti delle traduzioni; il mito dei popoli prelogici segna solo il caso estremo» (ivi, p. 68).
Difficilmente, pertanto, la «proiezione» del linguista nei «sandali» del nativo di cui Quine parlava nel saggio del 1951 potrebbe apparire come una forma di metodo empatico, dal momento che essa “imporrebbe” al nativo uno «schema concettuale» (quello del linguista) che, per quanto il linguista può saperne, potrebbe essergli del tutto estraneo. Questo è, in fondo, il problema sottostante a tutto il celebre secondo capitolo di Word and Object3. Non vi sarebbe alcuna garanzia, infatti, secondo Quine, che i nativi condividano lo stesso schema concettuale (la stessa Weltanschauung) del linguista. Ma il linguista non può, d’altro canto, che fare affidamento sul proprio linguaggio (o schema concettuale), data la scarsa evidenza empirica di cui dispone nel tradurre la lingua sconosciuta. Basarsi sul proprio schema concettuale, proiettandolo sul «linguaggio della giungla», è una necessità pratica, che - asseriva Quine in Word and Object - investirebbe soprattutto l’elaborazione delle «ipotesi analitiche», ovvero le ipotetiche correlazioni tra le emissioni verbali olofrastiche dei nativi e le loro possibili traduzioni mediante cui il linguista deve stabilire quali frammenti di enunciati andranno considerati termini (singolari e generali), quali congiunzioni, quali articoli, quali desinenze per il plurale e quali pronomi, sulla cui base individuare un insieme plausibile di credenze ontologiche ed epistemiche. La scelta delle ipotesi analitiche, infatti, non è altro che un modo di «catapultarsi nel linguaggio della giungla utilizzando i propri modelli linguistici » (ivi, p. 70).
 Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione
del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative
bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili
sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa
a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i
nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare
i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.
Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione
del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative
bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili
sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa
a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i
nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare
i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.Utilizzare i modelli del proprio linguaggio per tradurre un linguaggio alieno non equivale quindi ad applicare un metodo empatico di comprensione, trattandosi al massimo di un’ulteriore e più ampia applicazione del principio di carità. L’empatia sembra in realtà qualcosa di diverso dalla carità: a differenza di quest’ultima, l’empatia non presuppone necessariamente una condivisione di significati e stati cognitivi (credenze). Forse l’assunzione di un’analogia di stati cognitivi tra interprete e interpretato - il «ritrovamento dell’io nel tu», secondo la celebre formula di Wilhelm Dilthey (1927, trad. it. p. 293) - può apparire inevitabile ed efficace riguardo alle risposte verbali fenomenologiche direttamente connesse a stimolazioni elementari provenienti da eventi osservativi intersoggettivi del mondo esterno (la pioggia, il colore rosso, il caldo e il freddo ecc.): ci si aspetta infatti che i nativi, che presentano una conformazione neurofisiologica e neuropsicologica analoga alla nostra, non abbiano percezioni di tipo diverso dalle nostre, rispondendo linguisticamente a tali percezioni in modo analogo a come risponderemmo noi; in tal caso l’empatia sembrerebbe indistinguibile dalla carità interpretativa, in quanto fondata sull’assunzione dell’esistenza di meccanismi percettivi comuni ai soggetti coinvolti. Ma difficilmente tale analogia potrebbe essere presupposta allorché si tratti di tradurre il linguaggio o spiegare il comportamento di soggetti appartenenti a una cultura del tutto estranea a quella dell’interprete. In questo caso l’interprete dovrà in qualche modo “entrare”, per così dire, nella “mente” dei soggetti da interpretare per comprendere il loro peculiare punto di vista, le loro credenze sulla realtà e i significati delle loro parole.
In definitiva, la differenza tra carità ed empatia può essere intesa come la differenza tra imporre il proprio punto di vista all’altro e assumere il punto di vista dell’altro. La differenza è particolarmente rilevante nei casi di interpretazione di soggetti appartenenti a “mondi” radicalmente diversi da quello dell’interprete. Se così non fosse, difficilmente gli etnoantropologi avrebbero potuto attribuire credenze animistiche o culti religiosi atipici (come i celebri cargo cults) alle popolazioni studiate (in entrambi i casi si dovrebbe trattare, secondo un’interpretazione caritatevole, di errori di traduzione o interpretazione).
Non dovrebbe costituire motivo di sorpresa, allora, che David K. Lewis, in un saggio dedicato alla problematica davidsoniana dell’«interpretazione radicale», avesse dato una definizione del principio di carità che ingloba, per così dire, anche il procedimento empatico: un soggetto di interpretazione, asseriva Lewis, «dovrebbe credere ciò che crediamo noi, o forse ciò che avremmo creduto noi al suo posto; e dovrebbe desiderare ciò che desideriamo noi, o forse ciò che avremmo desiderato noi al suo posto» (Lewis, 1974, p. 336; corsivi aggiunti). In pratica, secondo questa definizione del principio di carità, si tratterebbe di assumere empaticamente il punto di vista dei soggetti interpretati, tenendo conto delle loro credenze (eventualmente false o strane) e della loro cultura di appartenenza, attribuendo a essi non le credenze e i desideri dell’interprete, ma le credenze e i desideri che l’interprete avrebbe se fosse “nei loro panni”. Si può aggiungere, a tale proposito, che l’empatia rappresenta una sorta di “correttivo” del principio di carità, tenendo conto del punto di vista dell’altro.
Ma forse c’è ancora qualcosa da dire: mentre la carità impone dei vincoli normativi sulla razionalità dei soggetti da interpretare - vincoli a priori basati sui principi logici e sulle norme di razionalità epistemica e pratica dell’interprete, ritenuti universali 4 -, l’empatia sembrerebbe invece un metodo descrittivo ed empirico, essendo subordinata all’acquisizione di un’ampia gamma di informazioni relative alle credenze, alla cultura e alle esperienze passate dei soggetti da interpretare (inutile aggiungere che non c’è accordo su quest’ultimo punto).
4. Si può ricordare, riguardo a questa presunta universalità, che Robert Nozick ha contestato il principio di carità in quanto assunzione di tipo «imperialistico», conferendo tale principio «un peso indebito alla posizione che accade di occupare a noi, alle nostre credenze e alle nostre preferenze» (Nozick, 1993, p. 153). Giustamente, Nozick fa notare che difficilmente questa sarebbe l’assunzione di un antropologo relativamente alle cosiddette società “primitive” (ivi, p. 154).
* Cfr. Antonio Rainone, "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia", Carocci editore, Roma, 2019, pp. 55-59, ripresa parziale.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO"
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- BREXIT. Elezioni Gb, Johnson trionfa. Ai Tory la maggioranza assoluta.13 dicembre 2019, di Federico La Sala
PIANETA TERRA. LO SPIRITO DELL’EUROPA .... *
Elezioni Gb, Johnson trionfa: ’Ora realizzeremo la Brexit’. Vola la sterlina
Ai Tory la maggioranza assoluta. Shock LibDem, la leader Jo Swinson non rieletta
di Redazione ANSA*
- [FOTO] Boris Johnson e Carrie Symonds © ANSA/AP
Le elezioni britanniche consegnano a Boris Johnson e ai Tory un’ampia maggioranza assoluta a Westminster, le chiavi di Downing Street per i prossimi 5 anni e il lasciapassare per una Brexit che, a 3 anni e mezzo dal referendum del 2016, diventa irreversibile. La sterlina vola sui mercati valutari nel cambio con il dollaro e l’euro dopo: la valuta inglese passa di mano a 1,3446 sul dollaro (+2,1%) e a 0,8303 sull’euro (+1,8%). La moneta unica è scambiata invece in avvio di giornata senza sensibili variazioni sul dollaro.
"Mi congratulo con Boris Johnson e mi aspetto che il Parlamento britannico ratifichi il prima possibile l’accordo" negoziato sulla Brexit, ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.
La Ue "è pronta a discutere gli aspetti operativi" delle relazioni future, ha aggiunto, spiegando che i leader avranno una discussione sulla Brexit oggi.
Il partito conservatore ha incassato oltre 360 seggi su 650, mentre al Labour di Jeremy Corbyn ne vengono attribuiti circa 200. "Una decisione inconfutabile dei britannici", commenta Johnson che aggiunge: "Con questo mandato realizzaremo la Brexit".
Un risultato che non si vedeva dai tempi di Margaret Thatcher e segna invece la disfatta peggiore da decenni per il Labour.
Ed è guerra all’interno del partito, ma Jeremy Corbyn rimanda le dimissioni. Non guiderà il partito "in un’altra elezione", ma per ora resta in Parlamento e "guiderà il Labour in una fase di riflessione".
Il verdetto è chiarissimo. Il messaggio di BoJo, sintetizzato nella promessa-tormentone ’Get Brexit done’, è passato. E il controllo Tory sulla Camera nega ogni credibile spazio di manovra al fronte dei partiti che s’erano impegnati a convocare un secondo referendum sull’Europa per offrire agli isolani una chance di ripensamento.
Shock anche per i liberaldemocratici: la 39enne neo-leader del partito più radicalmente anti-Brexit del lotto, Jo Swinson, che aveva cercato di proporsi addirittura come una rivale diretta di Boris Johnson e di Jeremy Corbyn, non solo non è riuscita a far avanzare la sua formazione, ma è stata bocciata anche a livello personale nel collegio di Dumbartonshire East: scalzata per 149 voti da Amy Callaghan, indipendentista scozzese dell’Snp. Swinson non però annunciato le dimissioni da leader.
Nigel Farage non considera una sconfitta il risultato negativo - peraltro previsto dai sondaggi - del suo Brexit Party alle elezioni politiche britanniche. Il partito è rimasto al palo, con zero seggi secondo l’exit poll, di fatto riassorbito dal partito conservatore di Boris Johnson dopo il trionfo nel voto (proporzionale) delle Europee di maggio. Ma secondo Farage, intervistato a caldo dalla Bbc, ha comunque contribuito a favorire il successo Tory e a evitare lo spettro di un Parlamento senza maggioranza (hung Parliament): sia non presentando candidati in oltre 300 collegi già controllati dai conservatori, sia togliendo voti ai laburisti di Jeremy Corbyn in diverse circoscrizioni del cosiddetto ’muro rosso’ dell’Inghilterra centro-settentrionale e del Galles, tradizionalmente di sinistra, ma in maggioranza pro Brexit e contrarie a un secondo referendum.
Il partito laburista britannico tiene a Londra dove ha conquistato 49 su 73 seggi. Sia Boris Johnson che Jeremy Corbyn hanno vinto nelle loro circoscrizioni. I Tory hanno perso Putney ma hanno guadagnato Kensington ottenendo in totale 21 seggi. Fuori invece Chuka Umunna, ex astro nascente del Labour passato in queste elezioni ai LibDem.
* ANSA 13 dicembre 2019 (ripresa parziale).
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
ROMA BRUCIA. GRAZIE AL "TIMES" PER L’ALLARME, MA LONDRA NON RIDA (E ABBIA MIGLIOR CURA DI FREUD). L’incendio è generale. Un omaggio alla Sapienza di Oxford
LO SPIRITO DELL’ EUROPA. "BUOI AL GUADO" AD OXFORD, "CERVI ALLA FONTE" DELLA "SAPIENZA" DI ROMA. TRACCE PER UNA SOLA GRANDE FESTA: "LA LUCE SPLENDE NELLE TENEBRE" DELL’INVERNO. E per proseguire il comune cammino "eu-ropeuo"
L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO: "AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" (Cantico dei cantici: 8.6). Un omaggio a William Shakespeare* e a Giovanni Garbini**
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- VERSO "NICEA 2025": MESSAGGIO EVANGELICO, FILOLOGIA, ED ECUMENISMO6 dicembre 2019, di Federico La Sala
VERSO "BARI 2020", "NICEA 2025": MESSAGGIO EVANGELICO, FILOLOGIA, ED ECUMENISMO. Quale "carità" (Kapitas o Xapitas, caritas o charitas)?! *
Nicola. Protettore del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente
di Matteo Liut (Avvenire, giovedì 6 dicembre 2018)
La carità è il "miracolo" più grande che nasce dalla fede: prendersi cura degli ultimi, del prossimo in genere, oggi è il messaggio più profetico e rivoluzionario che ci lascia san Nicola. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia, divenne vescovo di Mira in un tempo di persecuzione e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino nel 313.
Difensore dell’ortodossia, forse partecipò al Concilio di Nicea nel 325. La tradizione gli attribuisce un’attenzione particolare nei confronti dei bisognosi, come le due giovani ragazze che poterono sposarsi solo grazie al dono da parte del vescovo di una dote. Morto attorno all’anno 335, nel 1087 le sue reliquie arrivarono a Bari, dove è venerato come patrono e considerato un protettore anche del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente.
 Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
 Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
 Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.
Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.
*
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
Commenti a Presicce, il suo patrono Sant’Andrea e la tela del suo martirio, opera del Catalano
- CHARITÉ: BERLINO RICORDA A PAPA RATZINGER IL NOME ESATTO DELL’ OSPEDALE E DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA.
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- CRITICA DELLA "RAGIONE OLIMPICA"! Ovidio e le "Metamorfosi". C’era una volta Cenis (di Alba Subrizio).25 novembre 2019, di Federico La Sala
Antichi Ritorni
Cenis/Ceneo, quando uno stupro cancella l’identità
Oltraggiata dal dio Poseidone la fanciulla chiede di diventare uomo
di Alba Subrizio (il Mattino di Puglia e Basilicata, 10/09/2017)
La prima trasformazione female-to-male ma soprattutto il rinnegamento della propria sessualità in virtù di una violenza subita. Ovidio con questa storia spiega come lo stupro ferisca non solo fisicamente ma anche mentalmente, al punto che la ragazza sente il bisogno di cancellare per sempre quella femminilità oltraggiata; nulla potrà mai essere come prima. Per cancellare quel dolore, Cenis ha bisogno di ripudiare se stessa, divenendo altro...
Lungi da me l’idea di fare politica, non posso tacere in merito agli stupri perpetrati nelle ultime settimane in tutta Italia e allo scempio mediatico a cui le vittime sono state sottoposte. In una società come la nostra, quasi assuefatta ai crimini della peggior specie (sic!), sembra che il ‘delitto’ commesso passi in secondo piano, il dolore, la vergogna subita, sono cose che non vogliamo vedere o che forse non ci interessano; ciò che invece interessa è sapere chi ha compiuto il misfatto: l’immigrato, l’italiano, il carabiniere finanche...
Soprattutto sui social network - ormai divenuti sempre più luogo di sfogo di personali frustrazioni da parte di individui che diversamente non saprebbero come esistere - leggo commenti insulsi, a dir poco da far accapponare la pelle: dopo i fatti di Firenze c’è chi inneggiava che a commettere l’abominio fossero stati esponenti dell’Arma (inneggiare sì, come se fosse una bella cosa, l’importante è che non fossero ancora una volta accusati cittadini extracomunitari); d’altra parte in seguito ai fatti di Rimini leggo gente “tutta contenta” utilizzare gli avvenimenti a sostegno delle loro teorie xenofobe... e poi numeri e numeri. Come se tutto ciò fosse un gioco: un gioco a calcolare quale ‘parte’ in gara ha compiuto più stupri.
Da questo quadro emerge solo un dato di fatto: il popolo italiano, di qualunque colore politico, ha perso ormai il senno. Ahinoi, non possiamo dire che i nostri antenati latini fossero poi così diversi; basti rileggere i miti antichi per accorgersi da quanti stupri e violenze sono disseminate queste storie: piccoli particolari senza valore all’interno di Storie ben più grandi, ben più importanti.
A convalida di ciò, si pensi solo a Zeus ed Apollo (i campioni dello stupro) per non parlare di altre divinità. Eh già, perché nell’antica Grecia i maggiori artefici di violenze erano gli dèi, proprio quelli che avrebbero dovuto proteggere gli uomini. Tra i tanti miti me ne viene in mente uno che, sebbene sconosciuto ai più, mi ha attratto per la forza delle immagini.
C’era una volta Cenis, una delle donne più belle di tutta la Tessaglia; nonostante decine e decine fossero i suoi pretendenti, lei non voleva concedersi e preferiva godere spensierata della sua fanciullezza. Ma un giorno, mentre passeggiava sulle rive del mare, il dio Poseidone, desiderandola, le usò violenza.
Dopo aver goduto di lei - così narra il poeta latino Ovidio nelle sue “Metamorfosi” - le disse che avrebbe realizzato per Cenis ogni suo desiderio. Così ella rispose: «L’ingiuria che ho patito provoca in me un desiderio grande: quello di non dover subire mai più alcunché di simile. Se farai in modo che io non sia più donna, mi avrai completamente accontentato». Fu così che il dio del mare trasformò Cenis in Ceneo.
Il mito non è una semplice metamorfosi come le altre: innanzitutto è la prima volta nella letteratura mondiale che leggiamo di una donna che diventa uomo (la prima trasformazione female-to-male), ma soprattutto è il rinnegamento della propria sessualità in virtù di una violenza subita.
Ovidio con questa storia spiega come lo stupro ferisca non solo fisicamente ma anche mentalmente, al punto che la ragazza sente il bisogno di cancellare per sempre quella femminilità oltraggiata; nulla potrà mai essere come prima. Scioccamente (da buon maschione) il dio crede di rimediare offrendo un dono, ma nulla può cancellare ciò che è stato. Lo sa bene Cenis, che pertanto, per cancellare quel dolore, ha bisogno di cancellare e ripudiare se stessa, divenendo altro.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINCINQUE SECOLI” DI LETARGO: "SE NON RIDIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI" (Mt. 18, 3).
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaFederico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" --- L’ex presidente brasiliano Lula presto libero. La Corte Suprema ha dichiarato l’incostituzionalità del provvedimento (di Lucia Capuzzi).8 novembre 2019, di Federico La Sala
Brasile. I giudici aprono le porte del carcere all’ex presidente Lula
La Corte Suprema ha dichiarato l’incostituzionalità del provvedimento che prevede la carcerazione dopo il secondo grado di giudizio. Una legge ad hoc per impedire la candidatura contro Bolsonaro
di Lucia Capuzzi (Avvenire, venerdì 8 novembre 2019)
- [Foto] L’ex presidente brasiliano Lula presto sarà libero (Ansa)
Le porte della cella di Luiz Inácio Lula da Silva sembrano sul punto di dischiudersi. Per volontà della Corte Suprema. Il voto decisivo è arrivato nella tarda serata di ieri, per bocca del presidente dell’alto tribunale, il giudice Antonio Dias Toffoli. Fino ad allora, la Corte era stata spaccata a metà: cinque contro cinque. Toffoli ha fatto pendere l’ago della bilancia a favore dei sostenitori dell’incostituzionalità del provvedimento che prevede la carcerazione del condannato dopo il secondo grado di giudizio. La norma, in vigore dal 2016, è stata approvata sull’onda dell’indignazione collettiva contro le tangenti suscitata dalla maxi inchiesta Lava Jato. Da allora, essa ha portato dietro le sbarre 4.894 persone, trentotto delle quali coinvolte in Lava Jato. Tra loro, l’ex presidente Silva recluso, dall’aprile 2018, a Curitiba per scontare una sentenza a otto anni e dieci mesi per corruzione passiva e riciclaggio.
- [Foto] La folla dei sostenitori di Lula davanati alla Corte Suprema brasiliana nella capit5ale Brasilia (Ansa)
Ora, buona parte - tutti quelli che non rappresentano un pericolo per la società - dovranno essere rilasciati. Incluso Lula che non smette di dichiararsi innocente. Il processo e il verdetto contro quest’ultimo non sono stati abrogati. La liberazione avviene per una questione tecnica.
E’ indubbio, però, che sugli alti togati abbia pesato il mutato clima sociale nei confronti di Lava Jato. A differenza di tre anni fa, l’indagine e il suo protagonista, Sergio Moro, non godono più di consenso unanime. L’ex giudice e ora ministro della Giustizia del governo di Jair Bolsonaro, è stato screditato da un’inchiesta di The Intercept che ha pubblicato, a giugno, una serie di messaggi scambiati via Telegram fra gli inquirenti di Lava Jato.
In alcuni di essi, Moro - che aveva funzione giudicante - sembrava "imbeccare" i pm per "incastrare" gli imputati. Da allora, la Corte Suprema è stata investita di ricorsi. Oltre a quello sulla costituzionalità della carcerazione dopo la seconda istanza, altri due rischiano di distruggere la macchina accusatoria creata da Lava Jato. Nelle prossime settimane, gli alti togati dovranno pronunciarsi sulle modalità di impiego dei collaboratori di giustizia. E sulla legittimità delle azioni dello stesso Moro.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" --- LA "NAVE D’ARGO", IL "LETARGO" DI "VENTICINQUE SECOLI" DI DANTE, E NOI, OGGI: "LA NAVE DEI FOLLI".1 novembre 2019, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: LA NAVE D’ARGO, IL LETARGO DI "VENTICINQUE SECOLI" DI DANTE, E NOI, OGGI .... *
La nave dei folli
di Pietro Barbetta *
Una gita a Clusone e una a Pinzolo non guastano. La danza macabra di Borlone de Buschis di Clusone (1485) e quella di Simone Baschenis di Pinzolo (1539) segnano forse l’inizio e la fine di un periodo di comunità inconfessabile (Blanchot, 1983). Inconfessabile perché composta di trapassati, che, in quanto tali, già sono passati in giudicato, ingiudicabili. In molti accomunano questa comunità a un’altra, che potrebbe essere anche la medesima, chissà. Si tratta della Stultifera Navis. -Cos’hanno in comune gli stolti e i morti? Il semplice fatto di non essere confessabili. Gli uni per il regno dei cieli, gli altri per la terra, sono inguaribili. Bosch e le illustrazioni a Brant di Dürer ne danno rappresentazione figurativa. Ecco una figura chiave, il centro del primo capitolo, della prima parte della Storia della follia di Foucault: Sebastian Brant (1458-1521). Vissuto tra l’opera del de Buschis e quella del Baschenis. Nel giugno 1984 Francesco Saba Sardi (1922-2012) ci regalò, in versi endecasillabi, la traduzione di Das Narrenschiff.
- [Foto] Borlone de Buschis di Clusone
Narrenschiff uscì per la prima volta nel 1494, due anni dopo la scoperta dell’America. Prima di Brant abbiamo alcune opere importanti sull’argomento a partire dal 1360. Si immagina una sorta di confraternita delle persone strambe - le sole che possano esservi ammesse. Corporazione non chiusa per via di censo, particolari privilegi o saperi occulti. Bisognava essere, per esempio, un vescovo che aveva ipotecato il reddito per comprare il titolo religioso, un alchimista che aveva sciolto nel crogiolo le sue ricchezze.
La follia è ingiudicabile altrettanto quanto la morte, inguaribile. Questa caratteristica segna una linea di confine comunitaria, la nave è uno dei suoi contenitori. A quel tempo - successivo alla lebbra e alla peste, coevo di una nuova malattia giunta dalle Americhe, la sifilide - i folli venivano allontanati dalle città, imbarcati su navi per essere abbandonati altrove, ma il navigatore spesso le gettava a mare o le sbarcava in qualche landa desolata, dove morivano. Molti annegavano. Non è difficile immaginarlo oggi che abbiamo sotto gli occhi le immagini di uomini e donne morti alla deriva delle coste italiane. Unica differenza: allora giungevano dove nessuno stava, oggi invece si torce il collo altrove.
Gran satira grottesca o poema moralista? L’opera di Sabstian Brant ci lascia ancora nel dubbio. Quando Foucault ci parla della Stultifera Navis, qualunque opera scritta o figurativa ci venga in mente, dà un senso a quell’insieme indistinto di uomini e donne che ci entravano. Foucault distingue questo ammasso indifferenziato dalla follia così come viene identificata a partire dal secolo XVIII. Dal Settecento la follia diventerà regno del dominio medico, verrà diagnosticata e sistematicamente curata.
La nave dei folli non è che l’inizio di un processo che vedrà successive partizioni, da Erasmo fino a Pinel; è un crogiolo umano, un pleroma. Per alcuni Brant si confronta con l’avvento del Nuovo Mondo. La nave dei folli richiama le navi che iniziano a salpare verso le Americhe, fino al Seicento con la Mayflower, carica di puritani. Nave che navigò la luna, secondo i versi di Paul Simon. Anche loro inconfessabili, in quanto protestanti, spirito del capitalismo.
- [Foto] Simone Baschenis di Pinzolo
Brant sarebbe il primo progressista dell’epoca moderna, sguardo disincantato verso il futuro imminente e immanente, fiducia nella città come luogo dell’innovazione e, per via dei commerci, luogo d’incontro multiculturale. La città è il centro dove ogni superstizione, credenza, invidia, odio saranno eliminati. Brant progressista. Invero sulla nave - destinata a Narragonia, che si dirige verso Cuccagna - non ci sono solo i folli contemporanei, bensì usurai, giocatori d’azzardo, adulteri, viziosi, prodighi, invidiosi, voluttuosi, ingrati, spergiuri, bestemmiatori. Tutta la follia premoderna raccolta dentro questa nave autorganizzata, autosufficiente, autopoietica. Brant moralista.
A voler ben guardare, la maggioranza del testo elenca, tra l’altro, la cupidigia, le nuove mode, il retto Catechismo, gli istigatori di discordia, le male costumanze, il dispregio delle Scritture, i galanti, la crapula e la gozzoviglia, le ciarle, i desideri superflui, gli studi inutili, le procrastinazioni, l’adulterio, la presunzione, la voluttà, l’ingratitudine, la bestemmia, l’usura.
- [Foto] Albrecht Dürer
Come scritto, Albrecht Dürer illustra l’opera di Brant e Bosch crea una sua opera, sempre nel 1494. Nel frattempo altre comunità inconfessabili si muovono per via terrena, gli Ebrei, cacciati da Spagna e Portogallo, i Valdesi perseguitati ed erranti tra le valli montane fino alla Riforma.
Quanto l’opera si adatti all’ultimo ventennio, quanto sia attuale, quanto si stia trasformando nella Nemesi, lo vediamo dal momento in cui l’Europa è essa stessa, oggi, una nave di folli. Ci si aspetta solo un grande evento naturale, il distacco dagli Urali.
- [Foto] Hieronymus Bosch
* Doppiozero, 27.02.2013 - ripresa parziale, senza immagini.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. - Per dare più voce al futuro (di Agostino Giovagnoli)30 ottobre 2019, di Federico La Sala
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE .... *
Occidente in ritiro, compito della Chiesa.
Per dare più voce al futuro
di Agostino Giovagnoli (Avvenire, mercoledì 30 ottobre 2019)
Mentre i turchi cacciano i curdi dal Nord della Siria, la Gran Bretagna è agitata dalle convulsioni della Brexit e Hong Kong è attraversata da una protesta sempre più radicale. Tre vicende molto diverse tra loro. Ma tutt’e tre rimandano a una progressiva smobilitazione dell’Occidente.
Con la decisione di far cessare una presenza militare americana in Siria settentrionale - strategica anzitutto sotto il profilo simbolico - Trump ha abbandonato alleati verso cui gli occidentali hanno molti debiti: l’impegno dei curdi contro il Daesh è stato infatti decisivo. Le sorti di questi dipendono oggi interamente da altri attori: oltre alla Turchia, la Russia di Putin e il governo di Assad. Per la prima volta, intanto, la Camera dei Comuni ha approvato una mozione a favore della Brexit, pur imponendone un ulteriore rinvio: un altro passo verso l’uscita di Londra dall’Unione Europea. L’anima anglosassone-marittima dell’Europa e quella continentale-terrestre sembrano destinate a separarsi radicalmente: è una frattura grave all’interno del grande edificio che chiamiamo Occidente. Infine a Hong Kong è sempre più in difficoltà il modello "un Paese, due Sistemi" che aveva l’ambizione di conciliare cultura cinese e metodi occidentali. Anche qui l’influenza dell’Occidente si sta riducendo.
L’ex colonia britannica, collocata in una posizione strategica rispetto a tutta l’Asia, è stata per molto tempo uno dei primi porti del mondo e un mercato finanziario di importanza globale. Al momento del passaggio sotto la sovranità cinese nel 1997, era la seconda area del mondo per reddito pro capite, settima per quantità di riserve valutarie straniere e terza per esportazione di indumenti. La formula "un Paese due Sistemi", creata da Deng Xiaoping, sembrava fotografare una situazione destinata a permanere a lungo: se Hong Kong fosse rimasta uno spazio di incontro tra crescita cinese e sistemi occidentali, non sarebbe convenuto a nessuno mettere in crisi questa simbiosi così originale. Ma con lo sviluppo di aree economiche speciali nella regione limitrofa e il declino degli interessi occidentali per il "Porto dei profumi" questa funzione si è gradualmente ridotta.
Intanto, i sistemi politici occidentali - in discussione anche in tradizionali patrie della democrazia come Stati Uniti e Gran Bretagna - hanno perso progressivamente appeal in tutto il mondo, man mano che altri sistemi politici - in primo luogo quello cinese - si rivelavano compatibili con ritmi di sviluppo economico-sociale molto intensi. Infine, il crescente protezionismo occidentale - di cui la guerra dei dazi dichiarata da Trump è l’espressione più emblematica - ha rovesciato le posizioni: ora è la Cina il principale sostenitore della globalizzazione.
 Nell’immaginario collettivo, l’iniziativa cinese della One Belt One Road (o Nuova Via della Seta) dall’Asia centrale all’Europa orientale passando per l’Africa, ha preso il posto di quell’iniziativa occidentale in Asia che per quasi due secoli ha avuto in Hong Kong il suo luogo più emblematico.
Nell’immaginario collettivo, l’iniziativa cinese della One Belt One Road (o Nuova Via della Seta) dall’Asia centrale all’Europa orientale passando per l’Africa, ha preso il posto di quell’iniziativa occidentale in Asia che per quasi due secoli ha avuto in Hong Kong il suo luogo più emblematico.Nella storia tutto è opera dell’uomo, anche le nazioni e gli Stati non sono nati per caso ma sono stati immaginati, voluti, costruiti. Vale anche per l’Occidente, uno straordinario progetto storico immaginato, voluto, costruito per secoli dagli europei, cui si sono poi aggiunti i nordamericani. Oggi però gli uni e gli altri non sembrano più credere a tale progetto come in passato. Lo mostrano le lacerazioni tra le varie aree dell’Occidente e l’assenza degli occidentali da tanti scenari importanti del mondo contemporaneo. Quando qualcosa tramonta ne vediamo meglio meriti e grandezza e oggi siamo in grado di capire che quello occidentale è stato uno dei più grandi progetti della storia capace di unire ispirazione religiosa, valori morali, sistemi economici, modelli politici ecc.
Ma che fare se oggi gli occidentali sembrano credere sempre di meno al progetto Occidente? Tutto questo lascia la Chiesa più sola e accresce la sua responsabilità di portatrice di un messaggio universale e di annunciatrice di salvezza ai popoli.
A Hong Kong, come la maggioranza dei suoi abitanti, anche molti cattolici hanno partecipato a manifestazioni che esprimono nostalgia del passato e paura del futuro. Ma le proteste non possono rimuovere le cause profonde per cui è in crisi la formula ’un Paese, due Sistemi’. Il loro sbocco appare oggi molto incerto. È probabile che nelle prossime settimane aumentino da un lato l’estremismo e dall’altro la repressione, contrapposti in una spirale che alimenta entrambe. C’è chi vorrebbe che la Santa Sede prendesse posizione su quanto sta avvenendo nell’ex colonia britannica, ma non è nelle sue possibilità fermare un ritiro dell’Occidente, da questa come da altre aree del mondo, che rende poco sincere tante dichiarazioni di principio su libertà e diritti.
 È proprio questo ritiro che ha spinto negli ultimi anni la Santa Sede a cercare un dialogo diretto e senza protezioni con il governo di Pechino. Molte voci critiche si sono levate, non a caso, da Hong Kong per criticare tale tentativo, ma quanto sta avvenendo ora nella ex colonia britannica ne conferma la necessità.
È proprio questo ritiro che ha spinto negli ultimi anni la Santa Sede a cercare un dialogo diretto e senza protezioni con il governo di Pechino. Molte voci critiche si sono levate, non a caso, da Hong Kong per criticare tale tentativo, ma quanto sta avvenendo ora nella ex colonia britannica ne conferma la necessità.A Roma, c’è comunque viva partecipazione alle sofferenze del popolo hongkonghese e nella grande città asiatica la saggia voce del cardinal John Tong si è espressa fin dall’inizio in modo pacato e fermo chiedendo giustizia, ma condannando la violenza. Un legame profondo, infatti, lega spesso violenza e disperazione ed entrambe finiscono sempre per alimentare la rassegnazione. L’anziano amministratore apostolico ha ricordato che la violenza «provoca solo ferite sempre più profonde» e ha richiamato la lezione pacifica di Gandhi e di Mandela. Ha espresso inoltre «profondo dolore nel vedere i giovani ansiosi e preoccupati a causa dell’attuale situazione sociale» ed esortato a una speranza che non è facile avere oggi ad Hong Kong, ma di cui c’è molto bisogno. È inutile continuare a credersi parte di un mondo che non c’è più, decisiva appare invece la capacità di guardare al futuro: solo la speranza, infatti, è in grado di sostenere gli animi quando la realtà delle cose mostra un volto sgradito e il cammino si prospetta lungo. Se all’inizio la voce di Tong è apparsa isolata, man mano si sono uniti alla sua altre voci, tra gli stessi cattolici, nel mondo protestante, in quello musulmano e in tutta la città.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’EUROPA, LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE, E LA LEZIONE DI NIETZSCHE.
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- La teologia corrente del Mediterraneo. Dall’esperienza di san Paolo alle riflessioni in musica di Cohen e Dalla (di Giuseppe Lorizio)23 ottobre 2019, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA. FILANTROPIA... E AMORE di "DIO" ("AGAPE", "CHARITAS") *
Spiritualità.La teologia corrente del Mediterraneo
Dall’esperienza di san Paolo alle riflessioni in musica di Cohen e Dalla: un viaggio per riscoprire l’essenza di un luogo di incontro e di mediazione
di Giuseppe Lorizio (Avvenire, martedì 22 ottobre 2019)
- [Foto] Il Santuario della Madonna dell’Angelo, nel lido veneziano di Caorle
Perseguo qui il tentativo di mostrare come il Mediterraneo, questo (non nuovo, ma antico e per questo sempre attuale) “luogo teologico”, possa e debba innestarsi nel nostro teologare. Muovo dal Nuovo Testamento e in particolare dall’esperienza di Paolo e dei suoi compagni nell’approdo a Malta. Essi qui sperimentano innanzitutto una «rara umanità». «Una volta in salvo, venimmo a sapere che l’isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci trattarono con rara umanità; ci accolsero tutti attorno a un gran fuoco, che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo» (At 28,1-2).
 Il testo greco la dice lunga e parla di «filantropia», rara e quindi eccezionale, senza la quale forse Paolo non avrebbe potuto raggiungere Roma. Sappiamo bene quanto sia “merce rara” l’umanità, che, in quanto filantropia apparterrebbe ai barbari, ma al tempo stesso dovrebbe essere inclusa nella forma agapica propria del cristianesimo, che deve esprimersi come «amore sconfinato » (R. Penna) e incondizionato, ossia senza e oltre le frontiere, o che comunque pensa la frontiera come luogo di incontro e non di scontro.
Il testo greco la dice lunga e parla di «filantropia», rara e quindi eccezionale, senza la quale forse Paolo non avrebbe potuto raggiungere Roma. Sappiamo bene quanto sia “merce rara” l’umanità, che, in quanto filantropia apparterrebbe ai barbari, ma al tempo stesso dovrebbe essere inclusa nella forma agapica propria del cristianesimo, che deve esprimersi come «amore sconfinato » (R. Penna) e incondizionato, ossia senza e oltre le frontiere, o che comunque pensa la frontiera come luogo di incontro e non di scontro.
 A proposito dell’agàpe, un’annotazione esegetica interessante riguarda la novità semantica che registriamo nei testi neotestamentari, dove il sostantivo ricorre solo diciassette volte (diciannove nella Settanta), mentre per ben centoquarantaquattro (centosessantatré nella Settanta) volte rinveniamo il verbo agapào. E se il verbo esprime - come afferma san Tommaso - una determinazione temporale, allora abbiamo a che fare non con qualcosa di atemporale (ad esempio la mediterraneità), ma con un sostantivo che (attraverso il verbo) deve penetrare nel tempo, nel nostro tempo, e sollecitare non solo la nostra mente, ma anche le nostre passioni. E a tal proposito possiamo leggere metaforicamente l’esperienza maltese/mediterranea di Paolo e dei suoi compagni, davvero carica di “umanità”.
A proposito dell’agàpe, un’annotazione esegetica interessante riguarda la novità semantica che registriamo nei testi neotestamentari, dove il sostantivo ricorre solo diciassette volte (diciannove nella Settanta), mentre per ben centoquarantaquattro (centosessantatré nella Settanta) volte rinveniamo il verbo agapào. E se il verbo esprime - come afferma san Tommaso - una determinazione temporale, allora abbiamo a che fare non con qualcosa di atemporale (ad esempio la mediterraneità), ma con un sostantivo che (attraverso il verbo) deve penetrare nel tempo, nel nostro tempo, e sollecitare non solo la nostra mente, ma anche le nostre passioni. E a tal proposito possiamo leggere metaforicamente l’esperienza maltese/mediterranea di Paolo e dei suoi compagni, davvero carica di “umanità”.
 Se trasferiamo quest’esperienza umana all’esperienza religiosa e credente, il calore di questo fuoco nella pietà popolare (ma anche individuale) degli uomini e delle donne mediterranee si esprime nella forma della “devozione” (il nocciolo duro che ha consentito al “ritorno del sacro” di archiviare la secolarizzazione). In questa prospettiva, mi piace leggere un’indicazione, suscitatami dalla lettura del bellissimo, prezioso e piccolo libro di Fabio Fiori, L’odore del mare. Piccole camminate lungo le rive mediterranee, (Ediciclo editore).
Se trasferiamo quest’esperienza umana all’esperienza religiosa e credente, il calore di questo fuoco nella pietà popolare (ma anche individuale) degli uomini e delle donne mediterranee si esprime nella forma della “devozione” (il nocciolo duro che ha consentito al “ritorno del sacro” di archiviare la secolarizzazione). In questa prospettiva, mi piace leggere un’indicazione, suscitatami dalla lettura del bellissimo, prezioso e piccolo libro di Fabio Fiori, L’odore del mare. Piccole camminate lungo le rive mediterranee, (Ediciclo editore).Karl Barth invitava infatti a leggere la letteratura profana e i giornali per comprendere la Scrittura del Nuovo Testamento: «Nel Mediterraneo - scrive Fiori - non c’è spiaggia che non sia stata teatro di approdi o naufragi, non c’è cala dove non sia stata calata ancora di pietra o di ferro. Lungo la riva il viandante ad ogni passo può incontrare il mito». La religiosità mediterranea assume in primo luogo una forma mitologica, piuttosto che logica.
 Del resto, come più volte affermato da papa Francesco, quella del “popolo” è una «categoria mitica»: «La parola popolo non è una categoria logica, è una categoria mitica», ha detto di ritorno dal Messico. In seguito, intervistato dal suo confratello gesuita Antonio Spadaro, ha voluto precisare: più che “mistica”, ha detto, «nel senso che tutto ciò che fa il popolo sia buono», è meglio dire «mitica»: «Ci vuole un mito per capire il popolo». Attingendo dal già citato Fabio Fiori, un primo spunto riguarda l’ibridazione, non semplicemente declinata secondo la categoria del meticciato: «La sponda mediterranea è il risultato di ibridazioni tra natura e cultura, più di qualsiasi altro luogo ».
Del resto, come più volte affermato da papa Francesco, quella del “popolo” è una «categoria mitica»: «La parola popolo non è una categoria logica, è una categoria mitica», ha detto di ritorno dal Messico. In seguito, intervistato dal suo confratello gesuita Antonio Spadaro, ha voluto precisare: più che “mistica”, ha detto, «nel senso che tutto ciò che fa il popolo sia buono», è meglio dire «mitica»: «Ci vuole un mito per capire il popolo». Attingendo dal già citato Fabio Fiori, un primo spunto riguarda l’ibridazione, non semplicemente declinata secondo la categoria del meticciato: «La sponda mediterranea è il risultato di ibridazioni tra natura e cultura, più di qualsiasi altro luogo ».A livello teologico, più che di ibridazione, possiamo considerare il Mediterraneo come luogo di “mediazione”. Del resto la nostra identità cristiana risiede nella mediazione di Cristo mediatore e si riferisce alle mediazioni partecipate come quella di Maria (mediatrice). In secondo luogo, la necessità di costruire una koinè, ovviamente non solo linguistica, onde non cedere alla tentazione dell’anglismo: «Una koinè da costruirsi ogni giorno, innanzitutto con l’esperienza, camminando e navigando, leggendo e ascoltando, annusando e assaggiando, osservando e chiacchierando», come dovevano certamente chiacchierare, magari esprimendosi con i gesti piuttosto che col greco che i barbari non comprendevano o con l’assistenza di qualche mediatore, intorno al fuoco, i personaggi del testo lucano sopra evocato. In terzo luogo l’identità o appartenenza, tenendo anche conto delle lucide osservazioni di O. Roy, che ci mette in guardia dall’identificare le ricorrenti esibizioni di “identità cristiana” con la fede.
 Tornando a Fiori: «L’appartenenza mediterranea non ha niente a che fare con il passaporto, il luogo di nascita, la nazione. L’appartenenza mediterranea si realizza con la pratica, sporcando il corpo di sale e riempendo i polmoni di salmastro». Con l’appello a realizzare la mediterraneità nel quotidiano, per non cadere nel rischio della retorica. «Noi con Albert Camus “vogliamo ricongiungere la cultura alla vita. Il Mediterraneo, che ci circonda di sorrisi, di sole e di mare, ce lo insegna” ». -Richiamerei, infine, l’invito di Edgar Morin a maternizzare e sacralizzare quella che definisce «l’essenza profana del Mediterraneo».
Tornando a Fiori: «L’appartenenza mediterranea non ha niente a che fare con il passaporto, il luogo di nascita, la nazione. L’appartenenza mediterranea si realizza con la pratica, sporcando il corpo di sale e riempendo i polmoni di salmastro». Con l’appello a realizzare la mediterraneità nel quotidiano, per non cadere nel rischio della retorica. «Noi con Albert Camus “vogliamo ricongiungere la cultura alla vita. Il Mediterraneo, che ci circonda di sorrisi, di sole e di mare, ce lo insegna” ». -Richiamerei, infine, l’invito di Edgar Morin a maternizzare e sacralizzare quella che definisce «l’essenza profana del Mediterraneo».Una teologia mediterranea esprimerà innanzitutto la dimensione storico-escatologica della Rivelazione cristologica. Essa si può rinvenire, con una sorta di pop-theology, nella strofa di una canzone tradotta e interpretata da Fabrizio De André, di Leonard Cohen, intitolata Suzanne, che recita: «E Gesù fu marinaio / finché camminò sull’acqua / e restò per molto tempo / a guardare solitario / dalla sua torre di legno / e poi quando fu sicuro / che soltanto agli annegati / fosse dato di vederlo / disse: Siate marinai finché il mare vi libererà. / E lui stesso fu spezzato / ma più umano abbandonato / nella nostra mente lui non naufragò». Raggiungiamo la dimensione cosmica della Rivelazione evocando il grido etico circa la custodia del creato che dal Mediterraneo (o se si vuole dal mare) ci viene rivolto. Quando non lo impediscano interpretazioni negazioniste e del tutto fuorvianti, il grido ci raggiunge e provoca, insieme alla nostra indignazione, la domanda in noi dei contadini di Fontamara: «che fare?», purché essa non venga metabolizzata e trasformata in triste rassegnazione.
 A tal proposito concludo evocando i versi di Lucio Dalla, nel famoso brano Come è profondo il mare, che non posso non pensare ispirato dai suoi soggiorni nelle isole Tremiti: «È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi è un pesce e come pesce è difficile da bloccare perché lo protegge il mare, come è profondo il mare. Certo chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l’oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare».
A tal proposito concludo evocando i versi di Lucio Dalla, nel famoso brano Come è profondo il mare, che non posso non pensare ispirato dai suoi soggiorni nelle isole Tremiti: «È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi è un pesce e come pesce è difficile da bloccare perché lo protegge il mare, come è profondo il mare. Certo chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l’oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare».
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
- Fontamara (Ignazio Silone).
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. ---Lo "spirito" di Eraclito, "la santa violenza" del cardinale Ravasi, e lo spirito del messaggio evangelico.17 ottobre 2019, di Federico La Sala
IL "POLEMOS" DI ERACLITO, "LA SANTA VIOLENZA" DEL CARDINALE RAVASI, E IL "PADRE NOSTRO" ("CHARITAS") DEL MESSAGGIO EVANGELICO....*
- Eraclito nel suo frammento 53: «La guerra (pólemos) è madre di tutte le cose e di tutte la regina (basiléus). Gli uni rende dèi, gli altri uomini; gli uni fa schiavi, gli altri liberi» (Gianfranco Ravasi, La santa violenza, cit. - vedi, qui -sotto)
- Eraclito nel suo frammento 53: "πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους." (Eraclito, fr. 53).
- Eraclito nel suo frammento 53: "Pólemos è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi.
Il nuovo libro di Ravasi.
Quando il sacro fa i conti con la violenza
Un orizzonte cupo, segnato da conquiste e lotte, sembra essere il basso continuo della storia umana: la Bibbia non ignora questa realtà, fino al radicale rovesciamento operato da Cristo
di Gianfranco Ravasi (Avvenire, giovedì 17 ottobre 2019)
- Proponiamo alcuni stralci del nuovo libro del cardinale Gianfranco Ravasi La santa violenza, in uscita oggi per Il Mulino (pagine 168, euro 14,00). Nel volume il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura esplora l’intreccio incandescente fra religione e violenza, dalle “guerre di Dio”, dove la violenza che reca il marchio sacrale al conflitto fra tribù alla guerra santa. Fino alla quasi scomparsa nei Vangeli, alla luce del dirompente messaggio di Cristo.
 Poi è la volta del fondamentalismo, «la lettera che uccide», un fenomeno che oggi riguarda soprattutto l’islam, ma che si inscrive anche nella tradizione ebraico-cristiana.
Poi è la volta del fondamentalismo, «la lettera che uccide», un fenomeno che oggi riguarda soprattutto l’islam, ma che si inscrive anche nella tradizione ebraico-cristiana.
 Infine, tocca il tema, vivo e lacerante ai nostri giorni, del rapporto con lo straniero: un incontro che può generare esclusione e rigetto, come emerge in vari passi biblici nazionalistici o etnocentrici, ma che può diventare anche dialogo, aprendosi all’universalismo della salvezza e all’uguaglianza di tutti gli esseri umani.
Infine, tocca il tema, vivo e lacerante ai nostri giorni, del rapporto con lo straniero: un incontro che può generare esclusione e rigetto, come emerge in vari passi biblici nazionalistici o etnocentrici, ma che può diventare anche dialogo, aprendosi all’universalismo della salvezza e all’uguaglianza di tutti gli esseri umani.
Sembra una ripresa cinematografica; è, invece, la descrizione di un poeta ebreo, il profeta Nahum, che nel 612 a.C. sta “sceneggiando” quasi in presa diretta la caduta di Ninive, la detestata capitale della superpotenza orientale, l’Assiria, sotto l’irruzione congiunta di Ciassare, re dei Medi, e di Nabopolassar, re della dinastia neobabilonese. Ecco la scena affidata a una sequenza impressionistica di azioni militari, costruita sulla secchezza di un elenco: «Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitìo di cavalli, cigolìo di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, s’inciampa nei cadaveri». Le pagine dell’Antico Testamento sono spesso striate dal sangue delle battaglie e si affacciano su rovine e devastazioni causate da eventi bellici. Una lingua lessicalmente povera come l’ebraico classico (5.750 vocaboli in tutto) si mostra sorprendentemente ricca quando deve designare la violenza
 Tanto per esemplificare, ecco la radice hms «fare violenza» (donde hamas «violenza»), o šddhrm «sterminare » (donde herem, la strage sacra), hrg «uccidere», rsh «assassinare», ‘nh «violentare, opprimere», hrs «distruggere », lhm «combattere » (donde milhamah «guerra»), nqm «vendicare», mhs «abbattere, fracassare», šht «mandare in rovina» e altri ancora.
Tanto per esemplificare, ecco la radice hms «fare violenza» (donde hamas «violenza»), o šddhrm «sterminare » (donde herem, la strage sacra), hrg «uccidere», rsh «assassinare», ‘nh «violentare, opprimere», hrs «distruggere », lhm «combattere » (donde milhamah «guerra»), nqm «vendicare», mhs «abbattere, fracassare», šht «mandare in rovina» e altri ancora.
 Un orizzonte cupo, segnato da conquiste e lotte, che per altro sembrano essere il basso continuo della storia umana, come pessimisticamente dichiarava Eraclito nel suo frammento 53: «La guerra (pólemos) è madre di tutte le cose e di tutte la regina (basiléus). Gli uni rende dèi, gli altri uomini; gli uni fa schiavi, gli altri liberi».
Un orizzonte cupo, segnato da conquiste e lotte, che per altro sembrano essere il basso continuo della storia umana, come pessimisticamente dichiarava Eraclito nel suo frammento 53: «La guerra (pólemos) è madre di tutte le cose e di tutte la regina (basiléus). Gli uni rende dèi, gli altri uomini; gli uni fa schiavi, gli altri liberi».
 Anche il Nuovo Testamento, che pure inalbera il vessillo dell’amore ed eredita l’aspirazione messianica biblica allo shalôm «pace», non ignora questa realtà aspra che costella le strade della vita dei popoli.
Anche il Nuovo Testamento, che pure inalbera il vessillo dell’amore ed eredita l’aspirazione messianica biblica allo shalôm «pace», non ignora questa realtà aspra che costella le strade della vita dei popoli.
 Lo stesso Gesù, ad esempio, ricorrerà a un modello di strategia militare applicandolo all’esistenza cristiana da vivere con intelligenza e sapienza: «Quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda un’ambasceria per chiedere pace».
Lo stesso Gesù, ad esempio, ricorrerà a un modello di strategia militare applicandolo all’esistenza cristiana da vivere con intelligenza e sapienza: «Quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda un’ambasceria per chiedere pace».
 La scelta radicale per il Regno di Dio, vero Leitmotiv della predicazione di Cristo, sarà da lui espressa con una dichiarazione paradossale, anche se evidentemente metaforica per indicare la natura “esplosiva” del suo messaggio: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma spada» [...].
La scelta radicale per il Regno di Dio, vero Leitmotiv della predicazione di Cristo, sarà da lui espressa con una dichiarazione paradossale, anche se evidentemente metaforica per indicare la natura “esplosiva” del suo messaggio: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma spada» [...].È indubbio che, sia a livello biblico sia nella storia della cristianità, questo intreccio tra guerra e religione è paradossalmente forte. Per stare alla Bibbia, basti solo pensare alle stragi sante - il cosiddetto herem o «sterminio sacro» - che accompagnano la conquista della Terra pro- messa da parte del popolo ebraico, oppure alle centinaia di testi violenti presenti nelle Scritture e alla stessa simbologia bellica usata per rappresentare il «Dio degli eserciti» (che, però, era originariamente un rimando all’armata astrale del Creatore, anche se poi applicata alle battaglie di Israele col palladio dell’Arca santa) [...]. Ci sono alcuni elementi di natura ermeneutica che dovremo costantemente ribadire [...]. Innanzitutto è da sottolineare la qualità storica della Rivelazione ebraico-cristiana, che nella Bibbia si presenta non come un’astratta serie di tesi teologiche speculative ma appunto come una concreta «storia di salvezza». All’interno degli eventi umani, spesso segnati dal peccato, dall’ingiustizia, dalla violenza, dal male, passa la presenza e l’opera di Dio che progressivamente e pazientemente cerca di condurre l’umanità verso un livello più puro, giusto e pacifico di vita. Il vertice è proprio - tenendo conto dell’unità «canonica » (cioè nell’unico Canone cristiano) dei due Testamenti - nella proclamazione: «Beati gli operatori di pace», formulata secondo lo spirito della citata «pace» messianica anticotestamentaria. La stessa tradizione giudaica successiva con rabbì Meir di Gher dichiarerà che «Dio non ha creato nulla di più bello della pace» [...].
Gesù, poi, nella sua proposta procederà fino alla scelta radicale dell’amore per il nemico così da trasformare quasi l’hostis in hospes e da introdurre il principio della non-violenza: «Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano».
 L’apostolo Paolo, in un passo della Lettera agli Efesini, ove elenca una completa attrezzatura militare (cinturone, corazza, calzature, scudo, frecce, elmo, spada), la trasfigura in una simbologia spirituale: «Attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace; afferrando lo scudo della fede col quale si possono spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno, prendendo l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio». Introduce, dunque, nel cuore dell’apparato militare, evocato già in chiave metaforica, il «vangelo della pace» come meta da raggiungere. Egli parla per due volte della panoplía, cioè dell’«armatura » di Dio che non è aggressiva contro gli altri ma solo contro il male diabolico: «Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo [...]. Prendete l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove».
L’apostolo Paolo, in un passo della Lettera agli Efesini, ove elenca una completa attrezzatura militare (cinturone, corazza, calzature, scudo, frecce, elmo, spada), la trasfigura in una simbologia spirituale: «Attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace; afferrando lo scudo della fede col quale si possono spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno, prendendo l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio». Introduce, dunque, nel cuore dell’apparato militare, evocato già in chiave metaforica, il «vangelo della pace» come meta da raggiungere. Egli parla per due volte della panoplía, cioè dell’«armatura » di Dio che non è aggressiva contro gli altri ma solo contro il male diabolico: «Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo [...]. Prendete l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove».
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
COME IL "PADRE" E’ ALL’ORIGINE ("URSPRUNG") DEL BAMBINO, COSI’ IL "POLEMOS" E’ ALL’ORIGINE DI TUTTE LE COSE: HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- RITORNO A CASA DEI SEFARDITI. Consentito ai discendenti degli ebrei cacciati dalla Spagna alla fine del XV secolo di “riacquisire” la "perduta" cittadinanza iberica13 ottobre 2019, di Federico La Sala
Storia e attualità.
Il ritorno a casa dei Sefarditi, cinque secoli dopo
Si è chiuso il procedimento avviato da una legge del 2014 che ha consentito ai discendenti degli ebrei cacciati dalla Spagna alla fine del XV secolo di “riacquisire” la "perduta" cittadinanza iberica
di Paola Del Vecchio (Avvenire, sabato 12 ottobre 2019)
- La cacciata degli ebrei dalla Spagna in un’antica incisione
Il colombiano Andrés Villegas spera di trascorrere «una gradevole vecchiaia » in Spagna. E per questo non gli è costato spulciare nei registri ecclesiastici e perfino negli archivi dell’Inquisizione di Cartagena, che condannava chi praticava riti ebraici, per risalire ai suoi avi. In particolare al capitano Cristobál Gómez de Castro, che nacque nel 1595 e fu perseguitato per diffondere l’ebraismo.
Andrés Villegas è uno delle decine di migliaia di ebrei sefarditi che recupereranno la nazionalità spagnola persa oltre cinque secoli fa dai propri ascendenti, cacciati in massa per effetto dell’editto di conversione al cattolicesimo o di espulsione degli ebrei (Decreto di Alhambra), firmato il 31 marzo del 1492 dai Re Cattolici. È all’origine della diaspora che pose fine a 1.500 anni di presenza degli ebrei a Sefarad, il toponimo col quale la tradizione ebraica identificava la penisola iberica, per cui i discendenti sono identificati come ebrei sefarditi.
Molti si rifugiarono nell’adiacente Portogallo, in nord Africa, nei Balcani, in Turchia, ma anche in Sardegna e Sicilia, sotto il dominio spagnolo, e poi nelle Americhe. «Alcuni di loro, come avviene nei bazar di Istanbul, ancora conservano le chiavi delle case dalle quali furono cacciati», ricorda Ibrahim Lorenz, sefardita marocchino naturalizzato spagnolo.
 Per riparare quella «ingiustizia storica», il governo di Madrid varò nel 2014 un disegno di legge per riconoscere la nazionalità - senza perdere quella d’origine - a tutti coloro in grado di dimostrare, con un certificato della Federazione delle comunità ebraiche in Spagna o dell’autorità rabbinica riconosciuta nel proprio Paese, la propria condizione di sefarditi per cognome, lingua, parentela e vincoli speciali con la cultura sefardita. La normativa, approvata all’unanimità dal Parlamento, puntava a «riparare un aggravio storico».
Per riparare quella «ingiustizia storica», il governo di Madrid varò nel 2014 un disegno di legge per riconoscere la nazionalità - senza perdere quella d’origine - a tutti coloro in grado di dimostrare, con un certificato della Federazione delle comunità ebraiche in Spagna o dell’autorità rabbinica riconosciuta nel proprio Paese, la propria condizione di sefarditi per cognome, lingua, parentela e vincoli speciali con la cultura sefardita. La normativa, approvata all’unanimità dal Parlamento, puntava a «riparare un aggravio storico».Il primo ottobre scorso, alla scadenza del termine previsto dalla normativa, sono state 149.822 le richieste pervenute al Ministero di giustizia e al Consiglio generale del notariato, delle quali oltre 72 mila nel solo ultimo mese, in gran parte provenienti dall’America Latina: circa 20 mila dal Messico, 15 mila dal Venezuela e 10 mila dalla Colombia. «I sefarditi non sono più ’spagnoli senza patria’», ha celebrato Isaac Querub, presidente della Federazione di comunità ebraiche, promotrice dell’iniziativa con l’allora ministro di Giustizia, Alberto Ruiz-Gallardon. «La Spagna ha chiuso una ferita storica con un atto di giustizia perdurante nella memoria», ha rilevato.
 Un rush finale per quello che è stato un percorso ad ostacoli, «relativamente difficile », secondo il quotidiano israeliano "Haaretz". Con la proroga di un anno della dead line, sono stati infatti semplificati alcuni dei requisiti richiesti. Non solo per la difficoltà delle comunità ebraiche di evadere le numerosissime petizioni, ma anche per la necessità di sostenere esami all’Istituto Cervantes, per accreditare la conoscenza di lingua e cultura spagnola. Più di tutto, l’esigenza di doversi recare in Spagna per registrare in atto notarile l’origine sefardita ha rappresentato un ostacolo per i circa 2 milioni di sefarditi stimati inizialmente da Madrid come eredi degli almeno 200 mila deportati e dispersi nel XV secolo.
Un rush finale per quello che è stato un percorso ad ostacoli, «relativamente difficile », secondo il quotidiano israeliano "Haaretz". Con la proroga di un anno della dead line, sono stati infatti semplificati alcuni dei requisiti richiesti. Non solo per la difficoltà delle comunità ebraiche di evadere le numerosissime petizioni, ma anche per la necessità di sostenere esami all’Istituto Cervantes, per accreditare la conoscenza di lingua e cultura spagnola. Più di tutto, l’esigenza di doversi recare in Spagna per registrare in atto notarile l’origine sefardita ha rappresentato un ostacolo per i circa 2 milioni di sefarditi stimati inizialmente da Madrid come eredi degli almeno 200 mila deportati e dispersi nel XV secolo.«Nello spirito della legge c’è una sorta di risarcimento storico, per compensare la sofferenza che i sefarditi hanno manifestato nei secoli nella propria letteratura, poesia e canzoni», spiega Santiago Palacios, dottore di Storia Medievale all’Università Autonoma di Madrid. «Ma - afferma - è puramente simbolico. Colpisce che non sia stato avviato lo stesso processo con i moreschi, che soffrirono le stesse persecuzioni, per la comunità musulmana oggi radicata in prevalenza nel Magreb».
 Per alcuni, come Doreen Alhadeff, statunitense di 69 anni di Seattle, che ha ottenuto la nazionalità per sé e le due nipoti, è stato più facile. In casa ascoltava parlare ladino, lo spagnolo che dal Medioevo le comunità sefardite ancora conservano. «Sentivo che era stato tolto qualcosa di importante alla mia famiglia e volevo recuperarlo», ha scritto nelle sue motivazioni.
Per alcuni, come Doreen Alhadeff, statunitense di 69 anni di Seattle, che ha ottenuto la nazionalità per sé e le due nipoti, è stato più facile. In casa ascoltava parlare ladino, lo spagnolo che dal Medioevo le comunità sefardite ancora conservano. «Sentivo che era stato tolto qualcosa di importante alla mia famiglia e volevo recuperarlo», ha scritto nelle sue motivazioni.
 Per altri, come lo scrittore francese Pierre Assouline, è stato più difficile. «Ho amici francesi che hanno ottenuto il passaporto spagnolo in maniera più rapida, è deludente», spiega l’autore, che nel suo dossier ha incluso una lettera al re Felipe VI.
Per altri, come lo scrittore francese Pierre Assouline, è stato più difficile. «Ho amici francesi che hanno ottenuto il passaporto spagnolo in maniera più rapida, è deludente», spiega l’autore, che nel suo dossier ha incluso una lettera al re Felipe VI.
 La misura di «riconciliazione» consente di avere un passaporto europeo che, per molti latinoamericani, è il principale obiettivo. Da qui la corsa finale.
La misura di «riconciliazione» consente di avere un passaporto europeo che, per molti latinoamericani, è il principale obiettivo. Da qui la corsa finale.
 Già nel 2007 il governo socialista di Zapatero lanciò un’iniziativa di ’riparazione’ nei confronti dei discendenti di spagnoli emigrati durante la Guerra civile (1936-39) e il franchismo, naturalizzando mezzo milione di latinoamericani che riuscirono a provare la loro discendenza dagli esiliati.
Già nel 2007 il governo socialista di Zapatero lanciò un’iniziativa di ’riparazione’ nei confronti dei discendenti di spagnoli emigrati durante la Guerra civile (1936-39) e il franchismo, naturalizzando mezzo milione di latinoamericani che riuscirono a provare la loro discendenza dagli esiliati. -
> Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" - Lo spirito dell’Amazzonia, papa Francesco, ed Eugenio Scalfari. Nota della Sala Stampa vaticana sulla divinità di Gesù.10 ottobre 2019, di Federico La Sala
Sulla divinità di Gesù. il Vaticano corregge Scalfari
Nota della Sala Stampa vaticana: dal fondatore di Repubblica libera e personale interpretazione. La precisazione dopo le sconcertanti e irreali frasi attribuite al Papa sulla divinità di Gesù Cristo
di Riccardo Maccioni (Avvenire, mercoledì 9 ottobre 2019)
Qualcuno stamattina leggendo “La Repubblica” avrà fatto un balzo sulla sedia. Nel suo commento al Sinodo intitolato “Francesco e lo spirito dell’Amazzonia” il fondatore del quotidiano Eugenio Scalfari attribuisce infatti al Papa riflessioni e opinioni quanto meno sconcertanti.
 In particolare Scalfari scrive: «Chi ha avuto, come a me è capitato più volte, la fortuna d’incontrarlo e di parlargli con la massima confidenza culturale, sa che papa Francesco concepisce il Cristo come Gesù di Nazareth, uomo, non Dio incarnato. Una volta incarnato, Gesù cessa di essere un Dio e diventa fino alla sua morte sulla croce un uomo».
In particolare Scalfari scrive: «Chi ha avuto, come a me è capitato più volte, la fortuna d’incontrarlo e di parlargli con la massima confidenza culturale, sa che papa Francesco concepisce il Cristo come Gesù di Nazareth, uomo, non Dio incarnato. Una volta incarnato, Gesù cessa di essere un Dio e diventa fino alla sua morte sulla croce un uomo».E a conferma di quanto appena detto, il giornalista e filosofo, passa in rassegna, modificandola anche un po’, la Passione di Gesù, soffermandosi in particolare sul grido di Cristo in croce, tratto dal Vangelo di Marco che riprende il Salmo 22: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Un’invocazione che Scalfari riassume in “Signore mi hai abbandonato”. «Quando mi è capitato di discutere queste frasi - aggiunge Scalfari - papa Francesco mi disse: “Sono la prova provata che Gesù di Nazareth una volta diventato uomo, sia pure un uomo di eccezionali virtù, non era affatto un Dio”». Davvero, quella di Scalfari, un’interpretazione troppo libera e palesemente irreale, al punto da meritarsi una “correzione”.
Arrivata con una nota del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: «Come già affermato in altre occasioni, le parole che il dottor Eugenio Scalfari attribuisce tra virgolette al Santo Padre durante i colloqui con lui avuti non possono essere considerate come un resoconto fedele di quanto effettivamente detto, ma rappresentano piuttosto una personale e libera interpretazione di ciò che ha ascoltato, come appare del tutto evidente da quanto scritto oggi in merito alla divinità di Gesù Cristo».
Del resto per capire che le espressioni attribuite al Pontefice non potevano essere reali sarebbe bastato recuperare le parole del Papa, ripetute in più occasioni. Poteva essere sufficiente anche solo riprendere pochi passaggi dell’udienza generale del 18 dicembre 2013: «Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana al punto da farsi una cosa sola con noi nella persona di Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Ma c’è qualcosa di ancora più sorprendente. La presenza di Dio in mezzo all’umanità non si è attuata in un mondo ideale, idilliaco, ma in questo mondo reale, segnato da tante cose buone e cattive, segnato da divisioni, malvagità, povertà, prepotenze e guerre. Egli ha scelto di abitare la nostra storia così com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi. Così facendo ha dimostrato in modo insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le creature umane».
Concetti ribaditi a Caserta il 28 luglio 2014: «L’Apostolo Giovanni è chiaro: “Colui che dice che il Verbo non è venuto nella carne, non è da Dio! È dal diavolo”. Non è nostro, è nemico! Perché c’era la prima eresia - diciamo la parola fra di noi - ed è stata questa, che l’Apostolo condanna: che il Verbo non sia venuto nella carne. No! L’incarnazione del Verbo è alla base: è Gesù Cristo! Dio e uomo, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, vero Dio e vero uomo».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" - Global strike, niente sarà più come prima (di Guido Viale).1 ottobre 2019, di Federico La Sala
Global strike, niente sarà più come prima
di Guido Viale (il manifesto, 28.09.2019)
Ieri, nel giorno conclusivo della settimana di mobilitazione contro la crisi climatica e ambientale, quasi due milioni di studenti sono scesi in piazza a protestare in diversi paesi del mondo (e in Italia più che in tutti gli altri).
Portando così a quasi sei milioni (quattro volte quelli dello scorso 15 marzo; ma a questo punto i numeri contano poco: al prossimo global strike, a novembre, saranno ancora di più) le persone che hanno risposto alla chiamata allo sciopero di Greta Thunberg.
Non è che l’inizio: da oggi non solo le piazze, ma anche e soprattutto le redini di ogni discussione sensata, la ragione, la politica (quella vera, che decide della vita di tutti) si sono trasferite nelle loro mani, lasciando politici di professione, impresa e finanza, mondo del lavoro (e soprattutto le sue rappresentanze) e quello accademico (con l’eccezione dei climatologi e di pochi altri) a girare a vuoto intorno ai loro totem: la «crescita», le Grandi opere, i decimi di punto di Pil e di deficit, ecc. «La nostra casa va a fuoco», gridano gli studenti. E se l’establishment non se ne è accorto, per ignoranza, perché troppo preso dai suoi affari, per paura di dover cambiar troppo «l’ordine delle cose», la paura del disastro, che Greta non è ancora riuscita a instillargli con i suoi interventi, comincerà ora a provarlo nei confronti di quei ragazzi e quelle ragazze che scendono in piazza contro di loro, cominciando a tagliare sotto i piedi l’erba del business as usual. Ci metteranno un po’, quei signori, a capire che il loro mondo è finito - che sta precipitando nel caos - e che per salvare la specie umana, cioè tutti loro insieme ai loro figli e nipoti, occorre metter mano a una svolta radicale: che loro non sanno nemmeno concepire e meno che mai progettare e realizzare: perché si sono cullati - tutti, maggioranze e opposizioni - nell’illusione di un eterno presente che la crisi climatica e ambientale ha dissolto per sempre.
Ma è ora di smettere di svalutare le nuove generazioni accusandole di consumismo, di aver perso il senso del limite e della «legge del padre»; magari perché i loro padri sono «evaporati».
Meno male, c’è da dire, che sono evaporati: sono stati loro a mettere in mano ai loro figli merendine, abiti firmati, smartfone e altri gadget. E adesso non capiscono perché si muovano così in tanti per tutt’altro. È una fiammata che si spegnerà da sola, dicono alcuni, ma non è così: ora sappiamo che il movimento continuerà a crescere.
E che essuno dei partiti, dei sindacati o delle associazioni dei loro “padri” riescirà più a portarne in piazza tanta gente se non unendosi a loro. E che nessuno ha collegamenti internazionali così solidi.
Adesso i più accorti tra i membri della “classe dirigente” si metteranno a scuola dai giovani di Fridays for future e degli scienziati con a cui hanno dato ascolto e con cui stanno tessendo rapporti stretti, mentre loro, i ”padri”, li hanno ignorati.
Altri si aggrapperanno al proprio ruolo cercando di mandare avanti «la macchina» finché non dovranno prendere atto del fatto che non li ascolta più nessuno.
Ma i piú tra di loro rischiano di andare ad aggregarsi, magari sotto spoglie diverse, al nucleo duro delle destre negazioniste, che hanno idee chiare su come affrontare l’emergenza climatica che pure negano: respingendo con la guerra i profughi ambientali che la crisi è destinata a moltiplicare; reprimendo con decreti liberticidi le rivolte contro la miseria e i disagi che la crisi ambientale e la stagnazione economica non mancherà di aggravare; e mandando avanti lo sfruttamento dei fossili fino all’ultima goccia di petrolio; perché dopo di loro ci sarà«il diluvio».
Possiamo imboccare un’altra strada; ma occorre prendere, tutti, la situazione sul serio, cominciando col dire la verità. Non la conosce quasi nessuno; tutti sanno, ormai, che un grande cambiamento climatico è in corso, ma quasi nessuno ha una percezione del disastro, per noi e i nostri figli, a cui ci sta trascinando. E pochi hanno la percezione del poco tempo che rimane a disposizione per invertire rotta.
Per questo si continua a scavare tunnel, posizionare gasdotti, costruire aeroporti e centri commerciali che forse nessuno potrà utilizzare (o a indire Olimpiadi senza più neve, progettare stadi senza più campionati, cementificare spazi senza più alberi) invece di destinar tutte le risorse, fisiche, finanziarie e intellettuali, a prevenire un disastro altrimenti certo. È ora che tutti costoro lascino un po’ di spazio a chi si è reso conto che davvero «la nostra casa è in fiamme».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- LONDRA. Corte, illegale la sospensione. Parlamento riprende i lavori. Verdetto unanime. Accolte le ragioni dei ricorsi24 settembre 2019, di Federico La Sala
Corte, illegale la sospensione. Parlamento riprende i lavori
Verdetto unanime. Schiaffo a Boris Johnson, accolte le ragioni dei ricorsi. Corbyn, si dimetta
- FOTO Una caricatura di Boris Johnson © ANSA/AP
DI Redazione ANSA *
LONDRA. Schiaffo a Boris Johnson. La Corte Suprema britannica ha dichiarato non legale la sospensione (prorogation) del Parlamento voluta dal primo ministro Tory fino al 14 ottobre, nel pieno della crisi sulla Brexit, accogliendo gli argomenti dei ricorsi di oppositori del governo e attivisti pro Remain. Il verdetto è stato raggiunto all’unanimità dal collegio degli 11 giudici.
Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha annunciato la ripresa dei lavori parlamentari domani, sulla base della sentenza "esplicita" della Corte Suprema che ha dichiarato oggi "illegale" e mai avvenuta la sospensione del Parlamento voluta dal governo di Boris Johnson. Bercow ha precisato che si tratta di una "ripresa" dei lavori e non di una "riconvocazione". Ha aggiunto che non ci sarà il Question Time del mercoledì del premier (a New York all’Onu), ma vi sarà spazio per interrogazioni urgenti ai ministri.
La sospensione prolungata del Parlamento britannico decisa Boris Johnson è "illegale, nulla e priva di effetti". Lo ha stabilito la Corte Suprema nel duro verdetto letto dalla presidente lady Brenda Hale. E’ come se il Parlamento non fosse "mai stato prorogato", ha decretato la Corte, attribuendo ora agli speaker di Comuni e Lord il potere di riconvocare ora le Camere quanto prima e dichiarando ’l’advice’ del premier alla Regina immotivato e inaccettabile in termini di limitazione di sovranità e poteri di controllo parlamentari
Il Parlamento britannico va riconvocato subito e Boris Johnson deve "valutare la sua posizione" di primo ministro: così il numero uno laburista e leader dell’opposizione parlamentare a Westminster, Jeremy Corbyn, ha commentato il verdetto della Corte Suprema. Corbyn parla di un verdetto "storico" che certifica "il disprezzo del Parlamento" di Johnson.
Parlando alla platea congressuale, fra le ovazioni del delegati laburisti che inneggiavano alle dimissioni di Johnson, Corbyn ha annunciato di voler prendere contatti con lo speaker dei Comuni, John Bercow, per chiedergli di riaprire la Camera - come la Corte Suprema lo ha autorizzato a fare - al più presto. Il Parlamento deve in ogni caso tornare "a chiedere conto" subito al governo delle sue azioni, ha detto il leader del Labour, e assicurare che esso "obbedisca alla legge" approvata nelle scorse settimane su iniziativa delle opposizioni per imporre che non vi sia una Brexit no deal e - in assenza di accordo di divorzio - Londra chieda a Bruxelles un rinvio dell’uscita dall’Ue oltre il 31 ottobre.
Corbyn si è infine detto fiducioso che le prossime elezioni possano portare al potere un governo laburista, assicurando che "un governo laburista accetterà lo scrutinio del Parlamento e la democrazia".
* ANSA, 24 settembre 2019 (RIPRESA PARZIALE).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE - Senza l’Amazzonia per il mondo c’è poca speranza di vita (di Claudio Hummes). .5 settembre 2019, di Federico La Sala
Il libro.
Senza l’Amazzonia per il mondo c’è poca speranza di vita
Esce alla vigilia del Sinodo il ricco reportage di Capuzzi e Falasca lungo la “frontiera” del polmone del pianeta dalla cui cura dipende il futuro dell’umanità
di Claudio Hummes (Avvenire, giovedì 5 settembre 2019)
- È da oggi in libreria Frontiera Amazzonia. Viaggio nel cuore della terra ferita, il volume (Emi, pagine 176, 15 euro) scritto dalle giornaliste di Avvenire, Lucia Capuzzi e Stefania Falasca. Un attento e importante reportage, tanto più significativo perché viene pubblicato nell’immediata vigilia del Sinodo dedicato a questo polmone del pianeta. La prefazione, di cui pubblichiamo ampi stralci, è del cardinale Claudio Hummes presidente della Rete ecclesiale panamazzonica e relatore generale al Sinodo sull’Amazzonia.
- «L’Amazzonia è una donna. Una donna stuprata. Ha negli occhi il colore della notte e i capelli lisci come gli strapiombi delle Ande. A Madre de Dios era scesa guardandoci senza dire una parola. Un urlo di silenzio. Volevamo incontrarla, poterla guardare negli occhi. E siamo andate. E siamo entrate in quegli occhi. Queste pagine ne sono la voce. Perché l’Amazzonia è vicina. È fuori e dentro la vita di tutti».
- Stefania Falasca, Lucia Capuzzi
Oggi è evidente che la crisi socio-ambientale dell’Amazzonia riveste un’importanza planetaria. Qui è in gioco il futuro del pianeta e dell’umanità. Senza l’Amazzonia resterà poca o nessuna speranza di vita al mondo. In questi ultimi decenni il pianeta è entrato in una grave situazione di crisi climatica ed ecologica. È necessario pertanto un grande impegno per superare la crisi: agire è urgente.
Due importanti eventi hanno risvegliato la coscienza mondiale su questo grave problema: la pubblicazione dell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco nel maggio 2015 e, pochi mesi più tardi, la realizzazione della Cop21 a Parigi, che si è conclusa con la pubblicazione di un articolato Accordo sul clima firmato da oltre 190 paesi e che ha indicato le azioni da intraprendere per superare gradualmente la crisi, entro questo ventunesimo secolo.
I due documenti, di portata storica e scientificamente irrefutabili, rendono evidente quanto la nostra madre Terra non sia più in grado di sopportare simili distruzioni e l’intervento predatorio da parte di un’attività umana irresponsabile. La causa profonda della crisi è strettamente collegata con il modello dominante di sviluppo adottato che la Laudato si’ indica con l’espressione di «globalizzazione del paradigma tecnocratico». Un modello che induce a considerare il pianeta alla stregua di una merce. E come tale esso può essere sfruttato, degradato e depredato senza scrupoli per accumulare denaro (...).
Questo spirito predatorio insaziabile e prepotente ha ormai già annientato una parte importante dell’enorme ricchezza amazzonica e minaccia ciò che ancora è riuscito a sopravvivere. Non soltanto l’ambiente: tra i sopravvissuti minacciati di estinzione ci sono gli stessi popoli originari che ancora vivono in essa. Si tratta dunque ancora di un neocolonialismo feroce che invade e distrugge questo particolare patrimonio di biodiversità espellendo e massacrando interi popoli.
Nella Laudato si’ papa Francesco chiama la Terra «la nostra casa comune», della quale dobbiamo avere molta cura. L’ecologia integrale è una realtà meravigliosamente nuova che il Papa ci ha messo davanti e che ci interpella. Si tratta di un modo innovativo di intendere la relazione profonda che esiste tra tutte le creature del pianeta. C’è una canzone brasiliana che dice: Tudo está interligado, como se fóssemos um, tudo está interligado nesta casa comum («Tutto è interconnesso, come fossimo una cosa sola, tutto è interconnesso in questa casa comune»).
Perché tra noi e la natura non esiste separazione. Tutto è interconnesso. Dio stesso, per l’incarnazione del suo Figlio, è in relazione, definitivamente, con la nostra casa comune. Il grido della natura e il grido degli ultimi sono perciò il medesimo unico grido. Non esistono due crisi separate: una sociale e una ambientale, c’è una sola, unica e complessa crisi socio-ambientale. Di conseguenza non si può separare la cura dei poveri dalla cura della casa comune. Le soluzioni richiedono un approccio integrale per contrastare la povertà, per restituire dignità agli esclusi e, simultaneamente, prendersi cura della natura (...).
Il tipping point dell’Amazzonia, il punto di non ritorno fissato dagli scienziati superato il quale la sua distruzione sarà irreversibile, è il 40 per cento della deforestazione. Siamo già quasi al 20 per cento. Nel contesto della crisi socio-ambientale mondiale, il Papa ha citato più volte, in modo esplicito, l’Amazzonia come regione cruciale, perché è determinante per il processo complessivo. Ha ricordato che l’Amazzonia è polmone del mondo e dunque chiesto la massima attenzione alla sua biodiversità per la vita. La vita della foresta, delle acque, dei suoi abitanti e la missione della chiesa in questa immensa regione: ecco da dove è nata la convocazione del sinodo per l’Amazzonia.
La Laudato si’ mi ha cambiato molto l’orizzonte delle cose. Mi aperto gli occhi a una visione nuova. Anche sulle responsabilità della Chiesa per la cura della casa comune, per la salvaguardia di tutta la creazione a partire dalla fede. La chiesa ha il dovere di occuparsi dell’ambiente, come una madre il suo bambino (...).
Papa Francesco ha denunciato ogni forma di neocolonialismo e ha esortato la Chiesa a non viverne lo spirito e la pratica nella sua missione evangelizzatrice. Quello del Papa è un richiamo a non fare della Chiesa in Amazzonia una colonizzatrice, a non proporsi di colonizzare i popoli indigeni riguardo alla loro fede, alla loro spiritualità e alla loro esperienza di Dio. La Chiesa in ogni regione della terra deve inculturarsi nelle culture locali. Come ha detto il Papa: «Anche Cristo si è incarnato in una cultura, l’ebraismo, e, a partire da esso, Egli offrì sé stesso come novità a tutti i popoli». Nella storia della Chiesa, il cristianesimo non dispone di un unico modello culturale. I valori e le forme positivi che ogni cultura propone arricchiscono la maniera in cui il Vangelo è annunciato, compreso e vissuto. Una cultura sola non è capace di mostrarci tutta la ricchezza di Cristo e del suo messaggio.
Dopo 400 anni di evangelizzazione, non siamo riusciti a far nascere qui una Chiesa inculturata. Finora la Chiesa ha difeso i diritti umani degli indigeni, ma noi dobbiamo fare un passo avanti, dobbiamo andare verso una chiesa indigena: aiutare cioè la nascita di una Chiesa che esprima pienamente la fede nella sua cultura, nella sua propria identità (...) .
I popoli indigeni sono e devono essere interlocutori indispensabili. Essi conoscono l’Amazzonia meglio di chiunque altro. Hanno vissuto nella regione per millenni. La loro visione del mondo e la loro concezione religiosa si sono formate a partire dalla propria esistenza nella foresta amazzonica, caratterizzata dall’immensità di acque, dai fiumi incredibilmente grandi, dai mille laghi, ruscelli e igarapé, piccoli corsi d’acqua. Da sempre vivono immersi in una biodiversità incalcolabile e affascinante. Sono i sapienti guardiani e custodi di questo immenso ecosistema privilegiato. La loro saggezza non può andare perduta, né la loro cultura, né le loro molte lingue, la loro spiritualità, la loro storia, la loro identità.
Questi popoli sono stati perseguitati, cacciati (sia nel senso di essere allontanati, sia nell’atroce senso di essere considerati alla stregua di selvaggina da braccare e cacciare), ridotti in schiavitù o decimati fin dai primi anni dall’arrivo dei coloni europei in queste terre di Dio. Numerose etnie sono state totalmente sterminate. Una piccolissima percentuale è sopravvissuta e continua a lottare per riuscire a esistere. Essi sono ancora aggrediti, maltrattati, espulsi dalle loro terre, disprezzati, umiliati, sfruttati e molti uccisi. A causa della persecuzione subita e che subiscono già da cinque secoli, alcuni gruppi di indigeni si sono volontariamente isolati, nascondendosi nelle foreste (...).
La storia della colonizzazione mostra con chiarezza quante violenze inaudite sono state commesse contro i popoli indigeni, quante ingiustizie, quanti stermini. Tutte queste tragiche realtà rappresentano un immenso debito contratto dalla società moderna nei confronti dei popoli originari, sottomessi e colonizzati. E fino a quando non saranno loro restituite le condizioni reali di essere soggetti della propria storia, questo debito non sarà estinto (...).
Oggi l’industria, l’agricoltura e molte altre forme di produzione dicono sempre più spesso che la loro attività è «sostenibile». Ma che cosa significa davvero «essere sostenibile»? Significa che tutto quanto estraiamo dal suolo o restituiamo al suolo come residuo non deve impedire alla terra di rigenerarsi e di restare fertile. Se gli interessi economici e il paradigma tecnocratico avversano qualsiasi tentativo di cambiamento e sono pronti a imporsi con la forza, violando i diritti fondamentali delle popolazioni nel territorio e le norme per la sostenibilità e la tutela dell’Amazzonia, dobbiamo sapere da che parte stare.
Il Sinodo per l’Amazzonia vuole diventare un faro e vuole aprire nuovi cammini per tutta la Chiesa della regione, sia nelle città, sia nella foresta, sia per la popolazione urbana, per i popoli indigeni, i ribeirinhos, i contadini, i seringueiros e altri che vivono nell’interno della regione, dispersi e fuori da agglomerati urbani, con un obiettivo principale, definito: la difesa e l’evangelizzazione incarnata nella cultura dei popoli indigeni in una prospettiva di ecologia integrale. Perché noi non dobbiamo e non possiamo arrenderci.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Tra le nebbie di Dover. Il Regno Unito, l’Europa e la chiarezza costituzionale (di Francesco Palermo).3 settembre 2019, di Federico La Sala
Il Regno Unito, l’Europa e la chiarezza costituzionale
Tra le nebbie di Dover
di Francesco Palermo (il Mulino, 02 settembre 2019)
La scorsa settimana circolava un tweet che andava al punto. Diceva pressappoco così: l’Italia ha trovato una nuova maggioranza parlamentare, il Regno Unito ha perso la sua monarchia parlamentare.
Il nuovo Primo ministro Boris Johnson è entrato nell’agone politico come un elefante in una cristalleria. Un atteggiamento molto in voga negli ultimi tempi, a tutte le latitudini. Entrato a Downing Street sulla scia del suo atteggiamento duro sulla Brexit, deciso a portare avanti l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea anche senza un accordo con Bruxelles, nel giro di pochi giorni ha compiuto due passi coordinati ed estremamente pericolosi. Dapprima ha posto all’Europa una (a suo dire) alternativa secca: o Bruxelles accetta un confine reale in Irlanda del Nord, o Londra è disposta a un’uscita senza accordo. -Questo almeno a parole, perché da autorevoli previsioni una hard Brexit, quindi un’uscita senza accordo, avrebbe conseguenze catastrofiche per il Regno Unito, almeno inizialmente, e a poco servirebbe la partnership privilegiata che il presidente americano Donald Trump dichiara di voler offrire a Londra una volta uscita dalle presunte grinfie dell’Unione europea. Anche questa tutta da verificare, ma contano i messaggi semplificati e di facile appiglio. Tanto che in alcune cancellerie si sta studiando l’ipotesi di andare a vedere le carte di Londra, e accettare la provocazione di una Brexit senza accordo. Scommettendo sulla necessità di Johnson di frenare all’ultimo.
Il secondo passo il Primo ministro britannico lo ha compiuto sul piano interno, di fatto sospendendo i lavori del Parlamento fino al limine della Brexit, per evitare che l’assemblea possa condizionare i suoi movimenti. Il senso della mossa è chiaro. La Corte suprema ha chiarito che il processo di distacco dall’Unione è in capo al Parlamento, ed è stato il Parlamento ad affossare per ben tre volte l’accordo negoziato da Theresa May con l’Unione europea, costringendo la ex premier alle dimissioni. Il decisionista Johnson non vuole correre il rischio di restare impiccato al Parlamento come accaduto a chi lo ha preceduto. E come può sempre accadere nelle democrazie parlamentari.
Chi non ha familiarità con i complessi meccanismi costituzionali britannici si chiederà come sia possibile, in un sistema così marcatamente parlamentare, che un Primo ministro, senza alcun contrappeso, blocchi per mesi i lavori del Parlamento.
 La costituzione britannica è uno strano animale, che viene direttamente dal Medioevo senza troppe modifiche formali. Il sistema si basa su un equilibrio di poteri tra Parlamento e Corona, emerso all’esito di un secolare processo di limitazione dei poteri monarchici da parte del Parlamento.
La costituzione britannica è uno strano animale, che viene direttamente dal Medioevo senza troppe modifiche formali. Il sistema si basa su un equilibrio di poteri tra Parlamento e Corona, emerso all’esito di un secolare processo di limitazione dei poteri monarchici da parte del Parlamento.
 Così il Parlamento è sì sovrano, ma molti poteri sono ancora formalmente in capo alla Corona, che li esercita attraverso il Primo ministro. Tra questi il potere di sciogliere il Parlamento e di convocarlo. Per questo è bastato che il Primo ministro (attraverso la Regina che regna ma non governa, e quindi non avrebbe potuto opporsi pena una crisi ancora più grave) stabilisse un periodo inusitatamente lungo tra la fine della sessione estiva e l’inizio di quella autunnale per mettere in scacco l’intero sistema. E provocare una crisi costituzionale gravissima, che mostra quanto sia facile che da un delicato equilibrio tra Parlamento e Corona si passi ad una pericolosa concentrazione di poteri in capo a chi tra questi due dovrebbe stare nel mezzo, il Primo ministro.
Così il Parlamento è sì sovrano, ma molti poteri sono ancora formalmente in capo alla Corona, che li esercita attraverso il Primo ministro. Tra questi il potere di sciogliere il Parlamento e di convocarlo. Per questo è bastato che il Primo ministro (attraverso la Regina che regna ma non governa, e quindi non avrebbe potuto opporsi pena una crisi ancora più grave) stabilisse un periodo inusitatamente lungo tra la fine della sessione estiva e l’inizio di quella autunnale per mettere in scacco l’intero sistema. E provocare una crisi costituzionale gravissima, che mostra quanto sia facile che da un delicato equilibrio tra Parlamento e Corona si passi ad una pericolosa concentrazione di poteri in capo a chi tra questi due dovrebbe stare nel mezzo, il Primo ministro.
 Una dinamica già vista ai tempi di Weimar, dello Statuto albertino e della terza Repubblica francese.
Una dinamica già vista ai tempi di Weimar, dello Statuto albertino e della terza Repubblica francese.Una volta di più la spirale autolesionista della Brexit sta prendendo a spallate la Costituzione più antica e finora più solida del mondo. E non potrà che portare a una maggiore formalizzazione dei rapporti tra le istituzioni. Come avvenuto in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Paradossalmente, almeno sul piano costituzionale, il processo di separazione dall’Europa sembra poter avvicinare il Regno Unito al continente.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- TEATR (TODI FESTIVAL). Come Dante salvò Primo Levi dall’inferno: Roberto Herlitzka e il ‘Canto di Ulisse’. Intervista (di Giuseppe Cassarà).30 agosto 2019, di Federico La Sala
Teatro
Come Dante salvò Primo Levi dall’inferno: Roberto Herlitzka e il ‘Canto di Ulisse’
In scena il 31 agosto al Festival di Todi, ’Il Canto di Ulisse’ è liberamente ispirato ai testi ’Se Questo è un Uomo’ e ’L’Ultimo Natale di Guerra’ di Primo Levi.
di Giuseppe Cassarà (GdS Globalist, 30 agosto 2019)
L’aggettivo che maggiormente ricorre in riferimento alla scrittura di Primo Levi è ‘lucida’. Lucida è la sua testimonianza del Lager, lucida la sua mente che non si è persa, ma ha lottato per trovare le parole in grado di raccontare un Male tanto cieco. Della sua scrittura, lo stesso Levi parlava in questi termini: “ho sempre teso a un trapasso dall’oscuro al chiaro, come (mi pare che lo abbia detto Pirandello, non ricordo più dove) potrebbe fare una pompa-filtro, che aspira acqua torbida e la espelle decantata: magari sterile”.
Nel Lager, dove la parola è castrata, ridotta a un rantolo, Primo Levi una mattina si dirige verso il refettorio accompagnato da un prigioniero di lingua francese. Per passare il tempo, per rimanere umani, Levi tenta di spiegare al compagno l’amata Divina Commedia. Sceglie un canto, il XXVI, in cui Dante incontra una lingua di fiamma che avvolge e tormenta lo spirito di Ulisse. I versi sfuggono alla mente di Levi, ma la memoria gli restituisce una terzina, la più nota del canto e una delle più citate di tutta la Commedia:
- Considerate la vostra semenza:
 fatti non foste a viver come bruti,
fatti non foste a viver come bruti,
 ma per seguir virtute e canoscenza.
ma per seguir virtute e canoscenza.
Ulisse canta, Dante ascolta, Levi racconta: la terzina per il prigioniero è “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”.
Il Canto di Ulisse è il titolo dello spettacolo diretto da Teresa Pedroni, in scena il 31 agosto in occasione del Todi Festival 2019. Un testo liberamente ispirato al capolavoro di Levi Se Questo è un Uomo e alla sua raccolta di racconti postumi L’Ultimo Natale di Guerra, fortemente voluto dal direttore artistico Eugenio Guarducci e interpretato dal Maestro Roberto Herlitzka, nei panni di un Primo Levi che racconta momenti del suo vissuto tragico nel Lager con una grande limpidezza unita a fughe dell’immaginazione, quando la fantasia si libera per lenire il peso della realtà.
Maestro, vorrei partire proprio da quella terzina, una delle poche che Levi ricorda con chiarezza, quella che gli restituisce, anche solo per un attimo, la sua umanità. A chi, oggi, potrebbero essere rivolte quelle parole?
Senza dubbio a chi soffre come Levi e i suoi compagni stavano soffrendo. Penso a quelle anime disperate che attraversano il mare per cercare una vita migliore, per esempio. Anche se, a dire il vero, consigliare loro di ‘seguir virtute e canoscenza’ può sembrare un po’ una beffa: l’unica cosa che conta, tutto ciò a cui ti aggrappi in situazioni del genere, è sopravvivere. Ma è per questo che le parole di Levi sono una sfida. Dante, e Levi, non scelgono Ulisse a caso: quando pronuncia quelle parole, l’eroe dell’Odissea si trova in un momento in cui il pericolo di morte è più reale che mai. Ulisse, come Levi, dice quelle parole ai suoi compagni, li sprona a ricordare la propria umanità, a proiettarsi oltre la paura. Ed è un monito che rivolge anche e soprattutto a sé stesso.
Mi ha sempre colpito che Levi, quando scriveva ‘Se Questo è un Uomo’, parlava delle vittime, non dei carnefici. I ‘bruti’ danteschi sono i prigionieri, i ‘sommersi’ nel Lager. Se queste parole sono un monito per tutta l’umanità, quali sono le nostre prigioni, oggi?
Guardi, non penso che oggi, almeno nel nostro mondo occidentale, si possa parlare di ‘prigioni’: nel mondo accadono cose orribili ma credo che nulla possa essere paragonabile a ciò che è stato il nazismo. Il nazismo non aveva la morte come mezzo, la morte era il fine del Lager. Una morte prima spirituale e solo dopo fisica. Il Lager tendeva all’annullamento della persona come essere umano, mirava a ridurre l’uomo in ‘bruto’. Le motivazioni che stanno dietro al male moderno sono più terrene, sono legate all’avidità, alla brama di potere. Quindi non penso che si possa fare un paragone tra il Lager nazista, tra l’esperienza di Primo Levi, e il tempo moderno. Ma è proprio questo che rende la voce di Levi essenziale: è la voce della memoria, dello sforzo sovrumano di un uomo che è rimasto tale nonostante fosse prigioniero in un luogo che voleva schiacciare la sua umanità. E lo ha fatto, per tornare a Dante, attraverso la sua sensibilità di artista, di scrittore. Nell’inferno, ciò che lo ha salvato è stata la poesia.
In un’intervista del tempo, Primo Levi parlava del Lager come dell’“unico momento in technicolor in una vita altrimenti in bianco e nero”. In che momento della sua vita troviamo il Primo Levi da lei interpretato nello spettacolo?
È un Primo Levi che sta cercando, come fece Ulisse davanti alla montagna del Purgatorio, di riscattare prima di tutto la propria coscienza. Penso sia questo il valore più grande della testimonianza di Levi. Altre voci, come la sua, hanno raccontato il Lager ma Levi con la sua scrittura ha riscattato l’umanità, ha permesso a chi è venuto dopo il nazismo di trarre le conseguenze di ciò che è stato. Ulisse racconta a Dante, e Levi racconta a noi, per trasmettere prima di tutto la memoria, l’esperienza di chi, di fronte alla più grande paura che l’uomo può provare, la paura della morte, dell’annullamento, scopre l’essenza più profonda della propria umanità.
Lo spettacolo, oltre che da ‘Se Questo è un Uomo’, è ispirato anche a una raccolta di racconti postumi, ‘L’Ultimo Natale di Guerra’. Sono racconti piuttosto diversi dal Levi più noto, dove la fantasia, l’immaginazione quasi infantile prendono alle volte il sopravvento sulla lucidità dello scrittore. Potremmo dire, quindi, ‘virtute, canoscenza’ ma anche poesia, immaginazione?
Certo che sì, anche se senza dubbio è una strada che può imboccare solo chi è dotato di grande creatività. Levi era già scrittore prima del Lager, anche se è chiaro che la sua vita di artista è stata irrimediabilmente segnata da ciò che ha vissuto ad Auschwitz. Ma Levi era un uomo capace di vivere di fantasia, di immaginazione. Come Ulisse, in fondo: solo chi può immaginare di espandere l’orizzonte del proprio mondo, di mettere sé stesso oltre le Colonne d’Ercole, può sfuggire alla morte dello spirito attraverso la poesia. Ed è quello che ha fatto Levi.
Il Canto di Ulisse, presentato dalla Compagnia ‘Diritto e Rovescio’, andrà in scena il 31 agosto presso il Teatro Comunale di Todi. Accanto al Maestro Herlitzka, troveremo Stefano Santospago e i musicisti Alessandro Di Carlo al clarinetto e Alberto Caponi al violino.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
PRIMO LEVI. Quando Levi morì (11 aprile 1987), Claudio Magris scrisse un articolo che cominciava così: «È morto un autore le cui opere ce le troveremo di fronte al momento del Giudizio Universale».
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO. CON MARX E FREUD. Una "ipotesi di rilettura della DIVINA COMMEDIA"
Federico La Sala
- Considerate la vostra semenza:
-
> RIPENSARE L’EUROPA! La buona-esortazione del BRASILE. --- L’Amazzonia brucia.... Il tempo è ora (di Guido Viale)27 agosto 2019, di Federico La Sala
Il tempo è ora
di Guido Viale (*)
L’Amazzonia brucia, liberando milioni di tonnellate di CO2. La Siberia brucia, emettendo altro CO2 e immense quantità di metano. I ghiacci della Groenlandia si sciolgono a ritmo vertiginoso e così anche la banchisa polare, le calotte glaciali dell’Artico e dell’Antartico e tutti i ghiacciai del mondo. In India, in preda alla siccità, muoiono di sete migliaia di persone e in tutto il mondo, Mediterraneo e Italia compresi, si moltiplicano i fenomeni metereologici estremi: ondate di calore, tempeste tropicali, gelate fuori stagione. Sono tutti effetti della crisi climatica in corso e al tempo stesso cause del suo rapido aggravamento.
Di tutto questo non c’é alcun riflesso nel Parlamento italiano né nelle manovre per formare un nuovo governo. Le istituzioni del nostro paese non si sono solo allontanate dai cittadini (e viceversa). Sono ormai lontane mille miglia dalla realtà (come lo sono i media che si occupano delle loro vicende). Ma è così anche in quasi tutto il resto del mondo.
C’è però in Italia e in tutto il mondo un “popolo” che quei fatti li ha messi al centro dell’attenzione, delle sue preoccupazioni e della sua iniziativa: i giovani di Fridays for future, che è un movimento mondiale la cui crescita non si fermerà più; la rete di Extinction Rebellion; i tanti movimenti contadini che difendono un’agricoltura sostenibile come Via campesina che riunisce 400 milioni di agricoltori; i popoli indigeni in lotta contro la devastazione dei loro habitat, in particolare l’Amazzonia, oggi sotto attacco, ma che sarà al centro di un sinodo voluto da Papa Francesco.
È statisticamente quasi impossibile che tra i mille parlamentari italiani non ce ne sia nemmeno uno che non si renda conto di quanto sia criminale ignorare la crisi climatica. Se anche in pochi, approfittando della visibilità che avrebbero in questo momento, formassero un raggruppamento interpartitico, non per “mettersi alla testa” dei movimenti già attivi in questo campo, magari con mire egemoniche (non ne avrebbero alcun titolo), ma per porre la crisi climatica e ambientale al centro delle loro preoccupazioni, potrebbero gettare un pesante masso nello stagno delle trattative per la formazione del nuovo governo e tutto il quadro politico potrebbe venirne scompaginato anche nel caso di eventuali elezioni.
Si tratterebbe di mettere all’ordine del giorno, non solo del Parlamento, che su questo tema per ora è sordo, ma del pubblico più vasto possibile, non l’inserzione dell’ambiente come una postilla in programmi inconcludenti e di facciata, ma la necessità inderogabile di una svolta radicale: abbandonare al più presto i progetti, le attività e i consumi responsabili delle maggiori emissioni climalteranti per promuovere ovunque impianti, sistemi e consumi a emissioni basse o nulle. Molte misure da assumere sono impopolari e per molti inaccettabili. Ma, di fronte all’evidenza dei fatti, questi atteggiamenti non dureranno a lungo anche perché i movimenti in campo per esigere un cambiamento radicale delle politiche cresceranno mano a mano che la crisi climatica farà sentire i suoi effetti.
Inoltre quei movimenti sono già fortemente intersecati dalle altre correnti di pensiero e di azione impegnate sulla prospettiva di un mondo diverso: il movimento delle donne contro il patriarcato e le sue tante manifestazioni, la solidarietà contro l’abbandono e respingimento dei migranti, le mobilitazioni contro la devastazione di territori e comunità in nome di progetti senza avvenire come NoTav o NoTap, i movimenti contro la guerra e le armi.
Certamente più difficile, nell’immediato, sarà raccogliere adesione e rivendicazioni di chi oggi lotta o vorrebbe lottare per difendere reddito o posto di lavoro, contro disoccupazione e precariato, per la casa, la salute, l’istruzione. C’è ancora da battere una cultura - negata a parole, ma confermata dalle scelte di tutte le forze politiche - che continua a contrapporre tutte queste cose alla difesa dell’ambiente; ma è e sarà sempre più chiaro che quelle rivendicazioni non avranno più alcuna possibilità di realizzarsi nella prospettiva di una generale catastrofe climatica.
Dalla capacità di affrontare qui e ora la questione della crisi climatica, senza aspettare che a muoversi siano altri paesi e altri Governi, ma con la convinzione che l’esempio ha un effetto trascinante e che chi la affronta prima si troverà in vantaggio mano a mano che gli effetti della crisi si faranno più pesanti, dipende alla fine anche la possibilità di ricondurre la politica al suo significato originario, che è quello di autogoverno. Cosa che non potrà mai realizzare una manovra chiusa nel quadro dell’attuale sistema politico, tutto legato al mito fasullo e ormai palesemente devastante della “crescita”. Il tempo per agire è ora. E se non ora, quando?
(*) https://www.guidoviale.it/il-tempo-e-ora/, 27.08.2019.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Incendi ed estintori. Salvare la foresta amazzonica e riconoscere le proprie colpe (di G. Pellegrino).27 agosto 2019, di Federico La Sala
INCENDI, ESTINTORI, E ... LANCIAFIAMME!!! Amazzonia... *
- [...] Su che cosa è stato edificato il “nuovo” mondo? Genocidi e stemini. Chi ha dato il nome a questo nuovo mondo? Un Vespucci (in verità non lui direttamente, ma ricordiamoci dei ragni e delle formiche di Bacone). Chi ha chiamato così l’Amazzonia? E. chi così il Brasile? A Napoli, sì sempre a “Nea-polis”, questo nome ricorda la brace, il braciere, persone intorno a un fuoco che riscalda, un cerchio familiare che si apre e accoglie chi ha freddo - non la devastazione e il deserto di chi cieco e folle si mette a distruggere tutto: *Edipo con in mano il lancia-fiamme a volontà - Platone, il Tecno-crate*. Di fronte alla Foresta gli uomini ciechi e folli di potenza (ma qui si parla anche delle donne amazzoni) vedono nulla e ... faranno il Brasile? (cfr. Federico La Sala, Le “regole del gioco” dell’Occidente e il divenire accogliente della mente, in “La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica”, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 180-181).
Incendi ed estintori. Salvare la foresta amazzonica e riconoscere le proprie colpe
di Gianfranco Pellegrino (Le parole e le cose, 27.08.2019)
Le foreste dell’Amazzonia stanno bruciando. Sappiamo molte cose su questi incendi: sappiamo che sono dolosi, sappiamo che chi li appicca è interessato a sfruttare commercialmente il terreno libero che si otterrà dalla distruzione degli alberi, sappiamo che il presidente Bolsonaro si è mostrato, sino a pochissimo tempo fa, acquiescente nei confronti degli speculatori, sappiamo che il venir meno di larghe parti della foreste pluviali avrà effetti pericolosi nel futuro - in termini di aumento del cambiamento climatico, di decremento della produzione di ossigeno, di aumento della quantità di biossido di carbonio nell’atmosfera (qui la catena causale è indiretta: meno foreste significa minore capacità di assorbimento di biossido di carbonio, e quindi maggiore percentuale di biossido di carbonio che rimane nell’atmosfera), di estinzione di specie animali e vegetali e di cancellazione di ecosistemi e nicchie ecologiche. Sappiamo pure che gli incendi sono in aumento. E, sappiamo che, pure se non fossero in aumento, man mano che ci spingiamo lungo la china del cambiamento climatico quel che non causava effetti nocivi o irreversibili prima può diventare un fattore che ci conduce al di là di punti di non ritorno.
 A parte pochi negazionisti climatici - alcuni purtroppo piazzati in posti di potere -, nessuno nega (almeno apertamente) fatti del genere. E cominciano an che a diminuire quelli che rimangono indifferenti. Anche per chi disprezza o dileggia l’attivismo di Greta Thunberg o le dottrine della Laudato Si’ l’alzata di spalle o il silenzio diventano sempre più difficili. Il dileggio è una forma d’attenzione, per quanto contorta e involontaria. Sappiamo, infine, che la sparizione delle foreste condanna all’estinzione anche civiltà indigene che di quegli ambienti hanno fatto la propria nicchia culturale.
A parte pochi negazionisti climatici - alcuni purtroppo piazzati in posti di potere -, nessuno nega (almeno apertamente) fatti del genere. E cominciano an che a diminuire quelli che rimangono indifferenti. Anche per chi disprezza o dileggia l’attivismo di Greta Thunberg o le dottrine della Laudato Si’ l’alzata di spalle o il silenzio diventano sempre più difficili. Il dileggio è una forma d’attenzione, per quanto contorta e involontaria. Sappiamo, infine, che la sparizione delle foreste condanna all’estinzione anche civiltà indigene che di quegli ambienti hanno fatto la propria nicchia culturale.Ma, paradossalmente, i fatti importanti non sono questi. Proprio perché sulla descrizione di quel che accade ed accadrà non ci sono più dubbi condivisi, è ora di volgerci con maggiore attenzione alla prescrizione, cioè ai principi etici e ai paradigmi di azione politica che dovrebbero guidare le nostre azioni in frangenti del genere.
Il 5 agosto, su Foreign Policy, Stephen Walt di Harvard ha scritto un breve articolo chiedendosi se gli incendi e la deforestazione dell’Amazzonia potrebbero costituire motivo per un intervento - armato o sotto forma di sanzioni - dell’ONU o della comunità internazionale nei confronti del Brasile (vedi qui: https://foreignpolicy.com/2019/08/05/who-will-invade-brazil-to-save-the-amazon/). Walt è un teorico delle relazioni internazionali di orientamento neo-realista, famoso per il suo scetticismo nei confronti dell’interventismo americano e della presunta base morale di tali interventi. Con l’atteggiamento caratteristico di questo genere di studiosi - presunta neutralità assiologica che nasconde scelte morali di fondo (peraltro spesso ovvie e condivisibili) -, Walt mostra che la prospettiva di muovere guerra o comminare sanzioni ai paesi che più sono responsabili dell’aumento delle emissioni di gas serra - paesi come Cina, India, Stati Uniti e Russia - è del tutto assurda, per quanto possa essere una tentazione. Per Walt, peraltro, la sovranità nazionale, per quanto limitata, rimane un limite alle ingerenze della comunità internazionale. E non è chiaro se l’impatto che le condotte interne di uno Stato può avere sui destini di tutti possa giustificare interventi e intromissioni così drastiche. Ciò che è chiaro è che la comunità degli Stati non permetterebbe mai che si stabilisca un precedente simile. Quindi, in un certo senso secondo questo tipo di prospettiva dovremmo lasciare tutto alla forza di persuasione degli attivisti, o alle politiche felpate di alcuni capi di Stato come Macron, all’interno di organismi come il G7.
Questo modo di procedere si basa sull’idea che ci siano solo due possibili punti di vista per considerare un problema come quello della deforestazione dell’Amazzonia. O si ha un paradigma puramente sovranista, per così dire - l’etichetta è volutamente vaga e suggestiva -, in cui la sovranità nazionale implica che chi detiene il potere politico abbia ipso facto potere sulle risorse naturali e di altro genere presenti nel territorio governato. Oppure si ha un paradigma internazionalista, o globalista, in cui c’è un potere politico globale che può porre limiti al controllo sovrano delle risorse. Entrambe le forme di potere sono soggette al gioco democratico, per molti. La scelta è fra la sovranità nazionale, o interna, di singoli elettorati, o un demos globale.
Se ci fossero solo questi due paradigmi, saremmo alle prese con due strade egualmente bloccate. Da un lato, ipotizzare che un ipotetico governo mondiale, o una comunità internazionale, privi gli elettori brasiliani del potere di scegliere come usare le risorse naturali del loro territorio sembra contrario a qualsiasi principio ovvio di autodeterminazione. Anche se ci fosse veramente un governo mondiale, o una comunità internazionale ben più forte di quel che abbiamo, e non esistessero Stati nazionali, e i principi dell’intervento umanitario coprissero anche le catastrofi ecologiche, che una parte del mondo decidesse, a maggioranza, che uso si dovrebbe fare delle risorse naturali che potrebbero favorire lo sviluppo economico di un’altra parte del mondo apparirebbe comunque una forma di tirannia della maggioranza. D’altra parte, l’impatto della progressiva deforestazione dell’Amazzonia ricadrà sul mondo intero, e lasciare del tutto la scelta ai brasiliani, o al loro governo, significherebbe rassegnarsi a una tirannia della minoranza.
Ma forse questo modo di impostare le cose trascura alcuni aspetti normativi che invece sono rilevanti. Il peggior effetto della deforestazione, come già detto, riguarda la percentuale di biossido di carbonio nell’atmosfera. Deforestare fa aumentare questa percentuale, e ciò aumenta, o rende più probabili, i cambiamenti climatici nel futuro. Deforestare aumenta la percentuale di biossido di carbonio perché fa venir meno gli alberi, che hanno la capacità di assorbire questo gas a effetto serra. Bruciare alberi impedisce che una parte del biossido di carbonio in eccesso venga assorbito. L’effetto della deforestazione, quindi, è nocivo non in assoluto, ma relativamente alle condizioni in cui ci troviamo - relativamente al fatto che, in virtù delle passate emissioni, c’è un eccesso di biossido di carbonio, e altri gas simili, nell’atmosfera.
Sostenere che la deforestazione dell’Amazzonia aumenti il cambiamento climatico, e quindi autorizzi interventi o pressioni, è come dire che chi danneggia un estintore causa un incendio, e quindi va punito come il piromane. Chi danneggia un estintore, o lo sottrae, quando ci sia un incendio in corso è certamente colpevole di qualcosa, ma chi ha appiccato l’incendio non può arrogarsi il diritto di punirlo, o nascondere le sue colpe.
L’eccesso di biossido di carbonio nell’atmosfera è responsabilità del mondo occidentale. La deforestazione dell’Amazzonia peggiora una situazione che è stata resa grave dall’industrializzazione del Primo mondo. Si potrebbe dire questo: in molti casi recenti, Stati che hanno invaso altri Stati, e hanno subito per questo interventi armati, venivano da faticosi processi di decolonizzazione e subivano le conseguenze di molte azioni dei governi occidentali. Ciò non ha reso meno necessari e fondati gli interventi. (Qui la materia è delicata, e dipende dalle convinzioni politiche di ognuno - e il giudizio può cambiare se si pensa al Kosovo degli anni Novanta o alla prima o alla seconda guerra del Golfo). E tuttavia il nesso causale nel caso della deforestazione è più stretto ed evidente. Se non fossimo in una condizione di cambiamento climatico antropogenico galoppante è ovvio che la perdita di alcune foreste sarebbe meno grave.
Quindi, imputare tutta la responsabilità a Bolsonaro e ai brasiliani è un atto di arroganza, anche se questo non vuol dire che bisognerebbe assistere inerti agli incendi. Forse bisognerebbe distinguere fra due risorse naturali. Da un lato, ci sono le foreste, dall’altro c’è la capacità del sistema terrestre di assorbire emissioni di biossido di carbonio senza che il clima muti. Nelle condizioni in cui ci troviamo, le due risorse sono direttamente connesse, ma non lo sarebbero in altre condizioni. In un mondo privo di cambiamento climatico antropogenico, le foreste potrebbero diminuire senza che la capacità della Terra di assorbire biossido di carbonio diminuisca a tal punto da far mutare il clima. Si potrebbe pensare che la prima risorsa, le foreste, sia oggetto della sovranità nazionale del Brasile, mentre le seconda sia una specie di patrimonio comune dell’umanità, che non si può lasciare alle decisioni di un solo governo nazionale - e, forse, dati gli impatti nel futuro, non si può lasciare alla decisione delle sole generazioni presenti.
Ma, una volta che si consideri questa risorsa globale, è difficile dimenticarsi delle responsabilità di chi ha sfruttato nei secoli passati gran parte di essa a proprio beneficio - cioè dei paesi che hanno goduto dell’industrializzazione. Alla luce di tutto questo, la reazione nei confronti degli incendi in Brasile non può essere quella di scegliere fra intervento armato o acquiescenza. Il comportamento dei brasiliani, o almeno del governo brasiliano, dovrebbe indurre la comunità internazionale a proporre vie di sviluppo economico alternative rispetto alla deforestazione. Il fatto che Bolsonaro abbia negato la natura antropogenica del cambiamento climatico e gli interessi economici evidenti di chi appacca gli incendi in Amazzonia non sono sufficienti a diminuire le responsabilità dei paesi che hanno una lunga storia di emissioni in eccesso. Questi paesi dovrebbero pagare il loro debito a chi ha lasciato intatto sin qui uno dei principali serbatoi di assorbimento del biossido di carbonio e garantire l’integrità dell’Amazzonia assumendosi ulteriori oneri. La questione principale, in altri termini, non è la democrazia e la sovranità nazionale, ma la giustizia distributiva e le compensazioni dovute a chi non ha tratto beneficio dall’industrializzazione e rischia di subirne solo gli effetti più negativi - paesi in via di sviluppo e generazioni future.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE “EU-ROPEUO”. Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una “memoria” (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=901)
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA! La buona-esortazione --- Brasile. Gli indios dell’Amazzonia: «Non fateci bruciare vivi». Gli incendi stanno devastando quasi 150 terre indigene. Allarme per le tribù non contattate.25 agosto 2019, di Federico La Sala
Brasile.
Gli indios dell’Amazzonia: «Non fateci bruciare vivi»
Gli incendi stanno devastando quasi 150 terre indigene. Allarme per le tribù non contattate. I vescovi brasiliani: basta deliri, azioni urgenti. In fiamme anche Bolivia e Paraguay
di Lucia Capuzzi (Avvenire, sabato 24 agosto 2019)
- [Foto] Indigeni in Amazonas, Ansa
«Andarcene? Dove? È la nostra terra, è parte di noi. Lotteremo. Siamo abituati a farlo. Come abbiamo resistito alle invasioni, ora resisteremo al fuoco». Eric, 23 anni, indigeno Karipuna, è uno dei 23 abitanti del villaggio Panorama, sulle rive del fiume Ji-Paraná, affluente del Rio delle Amazzoni. «In realtà, i Karipuna, in totale, siamo 58, ma più della metà vive in città, a Porto Velho, per ragioni di studio o lavoro». Panorama, nel Rondônia, è sulla “linea del fuoco”, come tutta la fascia del Brasile centro-occidentale, devastata da oltre 33mila incendi nell’ultimo mese. Un sesto di questi è avvenuto nello Stato che, inoltre, ha la maggior concentrazione di roghi per chilometro quadrato.
«Ora va un po’ meglio: ieri ha piovuto e le fiamme si sono arrestate. Ma oggi il fuoco potrebbe riprendere ad avanzare. Da soli non possiamo affrontarlo. Chiediamo al mondo di non voltarsi dall’altra parte. Il mio popolo, i Karipuna, ha rischiato di estinguersi per le violenze e le malattie portate dai conquistatori nei secoli passati. Siamo rimasti in 58. Altre tribù sono state cancellate. Lo sterminio prosegue nel presente: i cacciatori di risorse ci considerano un ostacolo. Chiediamo solo di poter continuare a esistere come indigeni. Non lasciate che veniamo ridotti in cenere», dice Eric, con la voce carica di commozione.
Il giovane non parla solo per il suo popolo: gli oltre 900mila indios brasiliani sono a rischio. Secondo gli ultimi dati dell’Instituto socioambiental (Isa), almeno 3.500 roghi stanno devastando 148 terre indigene, concentrate - oltre che in Rondônia -, in Mato Grosso, Tocantins, Acre e Pará. Zone in cui si sono rifugiati anche molte tribù in isolamento volontario. I traumi del passato, cioè, hanno spinto alcuni gruppi nativi a rifiutare il contatto con l’esterno, rintanandosi negli angoli più remoti della foresta. In Brasile, se ne contano un centinaio, secondo la Ong Survival, in prima linea nella difesa dei nativi. Nella terra Karipuna, legalmente restituita agli indios nel 1998, i Karipuna ne hanno individuato due. «Non sappiamo più nulla di loro da quando c’è stata l’ultimo blitz dei trafficanti di legname, due mesi fa. Ora rischiano di restare intrappolati nelle fiamme. Nessuno sa nemmeno che esistono. Per questo, noi Karipuna abbiamo il dovere di levare la voce in difesa dei nostri fratelli isolati. Il governo faccia qualcosa». Anche la Conferenza episcopale brasiliana ha chiesto «azioni urgenti», di fronte agli «assurdi incendi». «Non è il momento di deliri», hanno affermato i vescovi e aggiunto: «È ora di parlare, scegliere e agire con equilibrio e responsabilità, perché tutti si assumano la nobile missione di proteggere l’Amazzonia, rispettando l’ambiente, i popoli autoctorni, di cui siamo fratelli»
Il presidente Jair Bolsonaro, entrato in carica a gennaio, è considerato da più parti come parte del problema per le sue controverse affermazioni sulla necessità di «rendere produttiva» l’Amazzonia. Boutade concretizzate in una serie di proposte - ancora nel limbo - per diminuire le aree protette, consentire l’affitto dei terreni indigeni o aprirli allo sfruttamento minerario.
 Tale politica - accusano esperti e attivisti - avrebbe spinto i latifondisti a incrementare le “queimadas”: incendi per “pulire” il terreno da parte dei latifondisti e “sgomberarlo” di eventuali residenti. Il 5 agosto, il giornale locale “Novo Progresso”, in Pará, ha diffuso la notizia di un singolare evento organizzato, cinque giorni dopo, dagli agricoltori locali: “il giorno del fuoco”. I grandi proprietari - sostiene il quotidiano - avrebbero esortato a bruciare ampie porzioni di foresta per «dimostrare la propria volontà di lavorare al presidente Jair Bolsonaro».
Tale politica - accusano esperti e attivisti - avrebbe spinto i latifondisti a incrementare le “queimadas”: incendi per “pulire” il terreno da parte dei latifondisti e “sgomberarlo” di eventuali residenti. Il 5 agosto, il giornale locale “Novo Progresso”, in Pará, ha diffuso la notizia di un singolare evento organizzato, cinque giorni dopo, dagli agricoltori locali: “il giorno del fuoco”. I grandi proprietari - sostiene il quotidiano - avrebbero esortato a bruciare ampie porzioni di foresta per «dimostrare la propria volontà di lavorare al presidente Jair Bolsonaro».Informazione verificata o fake news, fatto sta che quel 10 agosto nel municipio di Altamira, in Pará, ci sono stati 431 roghi, altri 327 a Novo Progresso, per un totale di 1.457 incendi in meno di 48 ore. Se una regia unica è improbabile, è verosimile, però, che qua e là sia “scappata la mano”. Deforestazione e siccità avrebbero, poi, favorito la propagazione delle fiamme a tempo di record. Affermazioni smentite dal leader che, invece, ha puntato il dito sulle Ong.
 Di fronte al coro di critiche internazionali e alla minaccia di ritorsioni economiche - tra cui il congelamento dell’accordo Ue-Mercosur -, Bolsonaro ha schierato 44mila militari sul fronte del fuoco. Poi ha cercato di spegnere le fiamme della polemica con un intervento in diretta tv, in cui ha affermato: «Gli incendi esistono in tutto il mondo. Non possono diventare il pretesto per le sanzioni».
Di fronte al coro di critiche internazionali e alla minaccia di ritorsioni economiche - tra cui il congelamento dell’accordo Ue-Mercosur -, Bolsonaro ha schierato 44mila militari sul fronte del fuoco. Poi ha cercato di spegnere le fiamme della polemica con un intervento in diretta tv, in cui ha affermato: «Gli incendi esistono in tutto il mondo. Non possono diventare il pretesto per le sanzioni».
 In effetti, i roghi devastano anche Bolivia e Paraguay. Anche qui il fuoco non sembra una fatalità. Il presidente di La Paz, Evo Morales, ha abolito, a luglio, il divieto di bruciare i campi per “pulirli”. Asunción ha tra i maggiori indici di deforestazione.
In effetti, i roghi devastano anche Bolivia e Paraguay. Anche qui il fuoco non sembra una fatalità. Il presidente di La Paz, Evo Morales, ha abolito, a luglio, il divieto di bruciare i campi per “pulirli”. Asunción ha tra i maggiori indici di deforestazione.Quest’ultima è cresciuta esponenzialmente anche in Brasile: negli ultimi otto mesi sono andati perduti tremila chilometri quadrati di foresta. Il governo, inoltre, ha tagliato del 24 per cento i fondi all’Istituto brasiliano per l’ambiente (Ibama), braccio operativo del ministero dell’Ambiente. Quest’ultimo ha iniziato a ridurre le operazioni. In parallelo, sono calate le sanzioni per i crimini ecologici in Amazzonia di oltre un terzo. «Risultato: le invasioni sono diventate quotidiane - conclude Eric Karipuna -. I cacciatori di risorse si sentono spalleggiati. E lo sono: continuiamo a denunciare, ma nessuno interviene».
-
> Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" --- Giustizia e dignità per i popoli dell’Amazzonia. Una riflessione del cardinale Barreto (di Gianluca Biccini).18 luglio 2019, di Federico La Sala
Giustizia e dignità per i popoli dell’Amazzonia
· Sulla rivista dei gesuiti una riflessione del cardinale Barreto per il Sinodo di ottobre ·
di Gianluca Biccini (L’Osservatore Romano, 18 luglio 2019)
L’auspicio che «alcuni governi possano superare posizioni di sospetto e ascoltare con maggiore attenzione le voci flebili e gli appelli urgenti che vengono» dall’Amazzonia - come chiesto nell’Instrumentum laboris dell’assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la regione - è stato rilanciato dal cardinale peruviano Pedro Ricardo Barreto Jimeno sull’ultimo numero della rivista «La Civiltà Cattolica» (Quaderno n. 4058). A un mese dalla presentazione, il 17 giugno scorso, del Documento di lavoro, il vicepresidente della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam), dalle colonne della rivista dei suoi confratelli gesuiti prosegue la riflessione in preparazione all’assise in programma in Vaticano a ottobre, che era stata inaugurata dal cardinale presidente Cláudio Hummes con un’intervista rilasciata al direttore Antonio Spadaro.
«Sinodo e diritti umani. Popoli, comunità e stati in dialogo» è il tema affrontato dall’arcivescovo di Huancayo, in un testo che è la rielaborazione di un suo intervento a una riunione con i rappresentanti pontifici e gli ambasciatori delle nove nazioni amazzoniche. Un’analisi abbastanza forte, che parte dal presupposto per cui la presenza della Chiesa nell’area «non può essere in alcun modo considerata una minaccia per la stabilità o per la sovranità dei singoli paesi. Anzi - scrive il cardinale Barreto - essa è, in realtà, un prisma che permette di identificare i punti fragili della risposta degli stati, e delle società, davanti a situazioni urgenti, riguardo alle quali ci sono debiti concreti e storici che non si possono eludere».
Ecco allora che l’obiettivo della Chiesa, anche attraverso il cammino sinodale, è «creare le condizioni che permettano» a quanti abitano la vasta area «di vivere con dignità e di guardare con fiducia al futuro, sempre nella cornice del reciproco rispetto e del riconoscimento delle responsabilità differenziate e complementari che toccano agli attori sociali, politici e religiosi». Anche perché d’altro canto, chiarisce l’autore, il «guardare all’identità di questi popoli e alla loro capacità di proteggere» gli «ecosistemi secondo la loro visione del mondo, può consentire alle società non amazzoniche di creare condizioni adeguate per apprezzarli, rispettarli e apprendere da essi. Così un giorno forse - è la speranza del vicepresidente della Repam - riusciremo a superare la concezione di uno spazio vuoto o “arretrato”; anzi, ne trarremo orientamenti utili a individuare il perché dei nostri stessi fallimenti riguardo alla cura della “Casa comune”».
In tale prospettiva assume un rilievo strategico l’Instrumentum laboris che, secondo il porporato, «esprime il sentimento e i desideri di molti: le comunità che abitano le rive dei fiumi, gli afrodiscendenti, i piccoli contadini, i residenti nelle città». Esso è il risultato di «un’esperienza inedita per un Sinodo speciale, e pertanto è un buon indicatore di quanto accade» in Amazzonia. Al punto da far ritenere «che l’espressione di tale ricchezza possa apportare, al di là di ogni posizione sospettosa, elementi per una migliore comprensione di una realtà che grida».
Del resto il Documento di lavoro è frutto di «un processo di ascolto diretto», insieme alla consultazione delle Conferenze episcopali interessate, «per ampliare la partecipazione di appartenenti alle popolazioni locali e di persone di Chiesa, mediante assemblee, forum tematici e dibattiti», che hanno raggiunto oltre 87.000 individui: 65.000 nelle fasi preparatorie e 22.000 in eventi organizzati dalla Repam.
Soffermandosi sulla «situazione di vulnerabilità» e sulla «importanza della regione» il cardinale gesuita dapprima denuncia come la conca amazzonica sia stata «storicamente concepita come uno spazio da occupare e spartire in funzione di interessi esterni» - infatti le vengono associate immagini di arretratezza, di realtà tagliata fuori dalla centralità urbana e di vuoto demografico, secondo connotati «che consentono di considerarla un territorio disponibile» - e subito dopo ne rilancia la funzione strategica di “bioma” ovvero di «un sistema vivo, che funge da stabilizzatore climatico regionale e globale, mantenendo l’aria umida, e produce un terzo delle piogge» che alimentano il pianeta. Anche perché in Amazzonia, su una superficie di 7,5 milioni di chilometri quadrati, suddivisa fra otto stati sudamericani (Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname e Venezuela) più il territorio di oltremare della Guyana francese, si concentra il 20 per cento dell’acqua dolce non congelata della Terra e sorge il 34 per cento dei boschi primari, che ospitano fra il 30 e il 40 per cento della fauna e della flora mondiali. Un’altra caratteristica è la sua sociodiversità, dal momento che su circa 33 milioni di abitanti, 2.800.000 sono indigeni - appartenenti a 390 popoli, 137 dei quali isolati o senza contatti esterni - che parlano 240 idiomi, appartenenti a 49 famiglie linguistiche.
Insomma, è la tesi di fondo del cardinale Barreto, «questa porzione del pianeta è il bioma in cui si esprime la vita nella sua straordinaria diversità in quanto dono di Dio a tutti quelli che la abitano e a tutta l’umanità». E poiché essa è sempre più devastata e minacciata, la Chiesa deve necessariamente occuparsi della sua difesa, attingendo alla dottrina sociale che alla missione dei cristiani associa «un impegno profetico verso la giustizia, la pace, la dignità di ogni essere umano senza distinzione, e verso l’integrità del creato, in risposta a un modello di società predominante che produce esclusione, disuguaglianza».
Richiamando il magistero di Papa Francesco, in particolare l’enciclica Laudato si’ e il discorso pronunciato dal Pontefice nell’incontro con i popoli dell’Amazzonia a Puerto Maldonado il 19 gennaio 2018, il porporato peruviano da un lato critica il «modello fortemente neoestrattivista che oggi viene imposto» nella regione, mettendo a rischio l’esistenza e l’identità di culture plurisecolari, e dall’altro invita a una collaborazione della Chiesa «con tutte le istituzioni governative, con le organizzazioni della società civile e, specialmente, con i popoli stessi», affinché «vi sia quel “futuro sereno”, a cui si è riferito Papa Francesco nel convocare questo Sinodo».
In tale ottica, successivamente l’articolo di «La Civiltà cattolica» pone a confronto «stati, imprese straniere e diritti dei popoli nella Panamazzonia» per evidenziare come «l’esperienza pastorale di decenni», e più di recente quella della Repam, facciano «capire che tra i responsabili vanno compresi non soltanto quegli stati in cui vengono sviluppate le industrie estrattive, ma anche alcune imprese straniere e i loro stati di origine», ovvero «quelli che appoggiano e favoriscono gli investimenti estrattivi, pubblici o privati, al di fuori delle frontiere nazionali, a costo di impatti devastanti sull’ambiente amazzonico». Anche perché, «la maggior parte degli stati di questo territorio ha sottoscritto le principali convenzioni internazionali sui diritti umani e sui relativi strumenti associati ai diritti dei popoli indigeni e alla cura dell’ambiente». E in questo campo, assicura l’arcivescovo peruviano, «la Chiesa desidera essere ponte e collaboratrice per raggiungere» l’obiettivo.
Una tema questo che porta direttamente a quello dei cambiamenti climatici, per contrastare i quali «tutti gli stati che fanno parte della conca amazzonica sono firmatari dell’Accordo di Parigi». Ma, avverte il cardinale Barreto, bisogna «chiedere molto di più, così come l’intera società deve operare molto più efficacemente per questo fine». Infatti, ribadisce a chiare lettere, «esistono seri limiti e, in alcuni casi, mancano un impegno e una volontà» espliciti di attuazione. Mentre, parallelamente, i contadini nativi e altri settori popolari «hanno sviluppato processi politici organizzativi incentrati su agende improntate a diritti legittimi che devono essere riconosciuti e rispettati».
Infine dopo un accenno ai Popoli indigeni in isolamento volontario (Piav) - che «devono essere considerati con la massima attenzione, a causa del loro alto grado di vulnerabilità, della loro condizione antropologica specifica e della necessità di proteggerli da qualsiasi processo che possa sfociare in una violazione dei loro diritti» - il vicepresidente della Repam chiama in causa gli stessi membri della Chiesa cattolica in Amazzonia, il cui compito è «essere testimoni vivi di speranza e di cooperazione» e «continuare a prestare un servizio evangelizzatore che affondi le radici nel suolo fertile dove vivono i popoli amazzonici e le loro culture. In questo senso, il Sinodo, in quanto evento ecclesiale - conclude - può essere un segno importante della risposta efficace per la promozione della giustizia e la difesa della dignità delle persone più colpite».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. -- L’alba dell’era solare. Dalle analisi di Prem Shankar Jha emerge con chiarezza la grande resistenza che ha il mondo economico nell’abbandonare i metodi di produzione dell’energia attuali (di M. Corrado)..12 luglio 2019, di Federico La Sala
Fine della Storia o della "Preistoria"? *
A qualcuno piace caldodi Maurizio Corrado (Doppiozero, 11 luglio 2019)
La buona notizia è che non è vero che i combustibili fossili si stanno esaurendo, la cattiva è che non è una fake news, continueremo a riversare tonnellate di veleno nell’aria come non ci fosse un domani. Mentre fra le sabbie arabe e negli altri pozzi che bucherellano la terra si continuava a estrarre l’oro nero alla vecchia maniera, nel 2008 è stata messa a punto una nuova tecnologia chiamata fracking. L’idea è semplice: immaginate di appoggiare uno smisurato martello pneumatico alla crosta terrestre e di accenderlo in modo che, al posto dell’asfalto, frantumi la crosta rocciosa del pianeta sparando “un cocktail di prodotti chimici mescolati a grandi volumi d’acqua ad altissima pressione” riuscendo a raggiungere le sabbie bituminose sottostanti, intrise di petrolio di roccia, tigh oil, e gas naturale. Quando si è visto che il metodo funzionava, il mondo delle multinazionali ha tirato un grosso sospiro di sollievo, già si stavano quasi rassegnando a doversi convertire a metodi di produzione d’energia più puliti e meno remunerativi, visto che ormai era chiaro che mancavano una manciata di anni alla fine delle riserve. Invece no, improvvisamente la nuova tecnologia apre altri orizzonti.
 Gli Stati Uniti scoprono, insieme a Regno Unito, Cina e Russia, di avere delle riserve in casa, iniziano a diminuire le importazioni di petrolio e gas, e già dai tempi dell’amministrazione Obama qualcuno inizia a parlare di autosufficienza, con l’immancabile contorno di milioni di nuovi posti di lavoro, costo basso dell’energia e conseguente ripristino della minacciata supremazia statunitense nella politica mondiale, idee ereditate dalla nuova dirigenza americana a cui piacciono tanto anche perché aiutano a ignorare le innumerevoli ricerche scientifiche che danno sempre meno anni di vita alla vita stessa su questo pianeta.
Gli Stati Uniti scoprono, insieme a Regno Unito, Cina e Russia, di avere delle riserve in casa, iniziano a diminuire le importazioni di petrolio e gas, e già dai tempi dell’amministrazione Obama qualcuno inizia a parlare di autosufficienza, con l’immancabile contorno di milioni di nuovi posti di lavoro, costo basso dell’energia e conseguente ripristino della minacciata supremazia statunitense nella politica mondiale, idee ereditate dalla nuova dirigenza americana a cui piacciono tanto anche perché aiutano a ignorare le innumerevoli ricerche scientifiche che danno sempre meno anni di vita alla vita stessa su questo pianeta.Di questo e altro parla L’alba dell’era solare di Prem Shankar Jha, uscito a maggio 2019 per Neri Pozza. Classe 1938, Prem Shankar Jha è un economista indiano che ha studiato filosofia, con una lunga carriera di consulente per le Nazioni Unite e il governo indiano, di corrispondente per varie testate fra cui il Financial Express e il Times of India e di docente nelle Università della Virginia, alla Haward University e all’Institut d’études politiques di Parigi.
 Il libro parte da una domanda semplice: come mai, nonostante fin dai primi anni Settanta la comunità scientifica ripeta che il mondo si trova in una situazione di forte pericolo, chi può fare concretamente qualcosa continua a non fare nulla? Prem Shankar Jha indica nella santificazione del mercato la risposta. Quando i governi seguono esclusivamente le indicazioni del mercato, diventa pressoché impossibile proporre soluzioni che non siano quelle già esistenti. Con analisi precise e piene d’informazioni analizza diversi casi mostrando come alcune delle soluzioni più efficaci siano state affossate, denigrate e infine messe da parte esclusivamente per ragioni di convenienza commerciale di pochi grandi gruppi economici.
Il libro parte da una domanda semplice: come mai, nonostante fin dai primi anni Settanta la comunità scientifica ripeta che il mondo si trova in una situazione di forte pericolo, chi può fare concretamente qualcosa continua a non fare nulla? Prem Shankar Jha indica nella santificazione del mercato la risposta. Quando i governi seguono esclusivamente le indicazioni del mercato, diventa pressoché impossibile proporre soluzioni che non siano quelle già esistenti. Con analisi precise e piene d’informazioni analizza diversi casi mostrando come alcune delle soluzioni più efficaci siano state affossate, denigrate e infine messe da parte esclusivamente per ragioni di convenienza commerciale di pochi grandi gruppi economici.
 Non è la prima volta che si alza una voce di questo genere, la differenza con anche solo qualche anno fa sta nell’inquietante urgenza che assumono i temi sul tappeto ogni ora, ogni minuto, ogni secondo che passa. Proprio mentre state leggendo queste parole, ci stiamo dirigendo verso quello che già alla fine degli anni Settanta lo scienziato inglese James Lovelock chiamava il punto di non ritorno.
Non è la prima volta che si alza una voce di questo genere, la differenza con anche solo qualche anno fa sta nell’inquietante urgenza che assumono i temi sul tappeto ogni ora, ogni minuto, ogni secondo che passa. Proprio mentre state leggendo queste parole, ci stiamo dirigendo verso quello che già alla fine degli anni Settanta lo scienziato inglese James Lovelock chiamava il punto di non ritorno.Uno dei dati più inquietanti sta nell’ormai innegabile scioglimento dei ghiacci polari. Ma qui non si parla di orsi bianchi denutriti, di foche e trichechi che perdono il loro ambiente naturale, non si parla neppure della distruzione degli Inuit, che hanno subito la medesima sorte di ogni popolo che ha incontrato la nostra cultura addomesticata, cioè l’estinzione, culturale e fisica. C’è un problema sotto il ghiaccio. Agli inizi dell’ultima era glaciale, circa trentamila anni fa, un’immensa massa di resti vegetali si sono congelati formando quello che viene chiamato permafrost, uno strato della crosta terrestre che circonda il polo Nord, si estende sotto il mar Glaciale Artico ed è profondo da alcuni metri a più di tre chilometri. Il problema è che al suo interno sono intrappolati da 1,3 a 1,7 trilioni di tonnellate di carbonio sotto forma di resti vegetali in decomposizione. È una quantità che supera di almeno duemila volte l’annuale emissione prodotta dall’uomo. A questi si aggiungono i cosiddetti clatrati, o idrati di metano, un composto solido in cui una cospicua quantità di metano è come intrappolata in una struttura cristallina simile al ghiaccio. Un chilo di clatrato può contenere fino a 168 litri di gas metano.
 Detto in termini semplici, sotto i ghiacci del Polo c’è una quantità di gas intrappolato che se venisse liberato produrrebbe una catastrofe di proporzioni inimmaginabili, qualcosa di simile a quanto succede ne La nube purpurea, un romanzo di Matthew Shiel del 1901, dove una immissione di gas venefico proveniente dal mare provoca lo sterminio completo di tutta l’umanità a parte il protagonista e una ragazza che si salva perché sempre vissuta in una grotta.
Detto in termini semplici, sotto i ghiacci del Polo c’è una quantità di gas intrappolato che se venisse liberato produrrebbe una catastrofe di proporzioni inimmaginabili, qualcosa di simile a quanto succede ne La nube purpurea, un romanzo di Matthew Shiel del 1901, dove una immissione di gas venefico proveniente dal mare provoca lo sterminio completo di tutta l’umanità a parte il protagonista e una ragazza che si salva perché sempre vissuta in una grotta.E proprio dal mare può arrivare un’altra reazione che ci potrebbe scaraventare oltre il punto di non ritorno. Anche qui, non è tanto ciò su cui è concentrata l’attenzione mediatica, cioè l’inquinamento con la plastica, ma il fatto che gli oceani assorbono due terzi di tutta l’anidride carbonica trattenuta dalla natura attraverso le alghe e il fitoplancton. Quando la temperatura degli oceani supera una certa soglia, l’acqua in superficie smette di scendere e quella più fredda in profondità smette di salire, il fitoplancton non riesce più a vivere, l’equilibrio si spezza, l’anidride carbonica non viene più assorbita e cresce andando a incrementare il riscaldamento globale. Ecco un’altra formula che, reiterata all’infinito, si è scolorita perdendo il vero significato a favore di ciò di cui la riempiono i media quotidianamente, comprese le azioni della bimba svedese che ha trascinato con sé le nuove generazioni verso una ribellione contro il mondo degli adulti, colpevole di aver trascinato il mondo sull’orlo del baratro, ottenendo come effetto secondario che quel mondo relega questo genere di preoccupazioni fra le bagatelle da ragazzi, da bimbi, appunto, mentre gli adulti hanno ben altro a cui pensare.
Qual è la soluzione? Prem Shankar Jha sostiene che siamo ancora in tempo. Dobbiamo non solo smettere di produrre anidride carbonica, ma mettere a punto i sistemi che ci permettono di estrarla dall’atmosfera. Per l’autore indiano uno dei noccioli della questione sta nei trasporti, nel trovare un’alternativa valida alla benzina, alternativa che non solo è già disponibile da tempo, ma che ha avuto anche modo di essere già sapientemente affossata dai grandi gruppi economici. -Produrre energia dai rifiuti generici delle città e dagli scarti delle lavorazioni agricole, le biomasse, attraverso processi non inquinanti e convenienti è già una realtà in molti paesi, si tratta di indirizzare le lavorazioni verso la produzione di metanolo. Nel ’43, in piena Seconda Guerra Mondiale, la Germania aveva iniziato a usarlo come carburante su larga scala, dagli anni Cinquanta in due paesi lontani fra loro geograficamente e politicamente, Sudafrica e California, il metanolo veniva mischiato alla benzina con risultati eccellenti dato che la miscela aumenta le potenzialità del motore. Il problema della diffusione del metanolo non sta solo nella rete di distribuzione che deve attrezzarsi, ma soprattutto nella lobby agricola che ha spinto l’etanolo che, prodotto dall’amido di mais, ne provoca l’aumento di prezzo e mette a rischio larghe fasce di popolazione. Negli Stati Uniti, “secondo un rapporto del dipartimento dell’Energia, il metanolo era stato sconfitto dall’etanolo perché non aveva il sostegno di una lobby organizzata.”
Prem Shankar Jha analizza a fondo eolico, fotovoltaico ed etanolo mostrando come, essendo tutte soluzioni scarsamente efficaci, proprio per questo sono spinte dal sistema che non le teme, mentre le soluzioni che potrebbero rivoluzionare veramente la produzione di energia sono combattute e messe in condizioni di non nuocere. Tra queste, quella che più ritiene valida è l’energia solare termodinamica sviluppata dagli impianti a concentrazione solare, Concentrating Solar Power, CSP. Contrariamente al fotovoltaico, per la loro costruzione non si usano materiali rari ma essenzialmente acciaio e specchi. Il principio è molto simile a quello usato da Archimede per bruciare le navi romane durante l’assedio di Siracusa, una serie di specchi che dirigono la luce e il calore del sole in un punto centrale.
 Il 5 febbraio 2016 si è inaugurato a Ouarzazate in Marocco l’impianto a concentrazione solare più grande del mondo. L’azienda è spagnola, la volontà di costruirlo è del governo marocchino che non vuole più dipendere dalle importazioni per il fabbisogno energetico. Il risultato è che da quando l’impianto è in funzione la dipendenza energetica del Marocco è passata dal 97% al 58%.
Il 5 febbraio 2016 si è inaugurato a Ouarzazate in Marocco l’impianto a concentrazione solare più grande del mondo. L’azienda è spagnola, la volontà di costruirlo è del governo marocchino che non vuole più dipendere dalle importazioni per il fabbisogno energetico. Il risultato è che da quando l’impianto è in funzione la dipendenza energetica del Marocco è passata dal 97% al 58%.Dalle analisi di Prem Shankar Jha emerge con chiarezza la grande resistenza che ha il mondo economico nell’abbandonare i metodi di produzione dell’energia attuali soprattutto perché garantiscono la continuità della concentrazione del potere dov’è ora. Spostare la produzione dell’energia verso i paesi del sud del mondo significherebbe spostare a sud anche l’asse economico e questo, solo questo, evidentemente non è sostenibile.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
 J. Chirac, alla conferenza dei «Cittadini della Terra»: «Siamo alla soglia dell’irreversibile» (2007).
J. Chirac, alla conferenza dei «Cittadini della Terra»: «Siamo alla soglia dell’irreversibile» (2007).RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala
-
>BRASILE. Una "memoria" - Amazzonia e Soia. «Che cosa abbiamo intenzione di fare? Continuare a resistere - conclude con orgoglio Edinho -. Per noi, ma anche per voi. Non lasciateci soli»11 luglio 2019, di Federico La Sala
Il reportage.
In Brasile la soia si sta mangiando l’Amazzonia
Le coltivazioni fioriscono con Bolsonaro e aumenta la richiesta cinese del legume: i prezzi mantenuti bassi permettono di aggirare i dazi imposti da Trump. Gli indigeni: «Resisteremo, aiutateci»
di Lucia Capuzzi, Inviata a Bonfim, Roraina (Brasile)
(Avvenire, mercoledì 10 luglio 2019)
- [Foto] Gli incendi appiccati dai fazenderos erodono il territorio dell’Amazzonia lasciando spazio alle coltivazioni (Ap)
Appena fuori dal villaggio indigeno di Jabutí, ci si imbatte in un manto spugnoso di spighe dorate. Steli giallo-tenue circondati da fili d’erba pallida. La distesa prosegue monotona per chilometri e chilometri. Interrotta solo dalla «via dell’agrobusiness»: l’autostrada che collega Boa Vista, capitale dello Stato brasiliano del Roraima, con Bonfim, il municipio più vicino alla terra indigena, nonché nuova, dirompente frontiera della soia.
L’anno prossimo, il Brasile potrebbe superare gli Stati Uniti e diventarne il primo produttore, con 123 milioni di tonnellate. “Colpa” dell’insaziabile fame cinese e della guerra commerciale tra gli Usa di Donald Trump e Pechino. L’imposizione di dazi reciproci del 25 per cento alle rispettive importazioni ha spinto il Dragone a preferire il legume brasiliano a quello made in Usa. Per soddisfare la richiesta, il Gigante del Sud dovrebbe produrne quasi 40 milioni di tonnellate in più. Ciò, secondo la rivista “Nature”, significherebbe un aumento delle piantagioni del 39 per cento, circa 13 milioni di ettari. Ricavati - dato che è l’unica parte ancora intatta - dal disboscamento dell’Amazzonia.
A caccia di spazi, lo sguardo avido dell’agrobusiness si è rivolto al Roraima. Una meta allettante dato il clima favorevole e il basso prezzo delle proprietà fondiarie: un ventesimo, rispetto al resto della nazione. Negli ultimi sei anni, le coltivazioni sono cresciute di oltre il 136 per cento.
Certo, i loro 50mila ettari sono ancora poca cosa rispetto ai 34 milioni di ettari totali sparsi per il Brasile. Il ritmo di espansione, però, è incalzante. E va a discapito del lavrado. Non esiste un corrispettivo in italiano: si tratta di un ecosistema unico al mondo, un peculiare tipo di savana che si estende, però, a ridosso dell’Amazzonia, diventandone quasi parte integrante. Intorno a Jabutí, il lavrado cresceva rigoglioso. Ora il villaggio è circondato dai campi di soia. E i ruralistas, come vengono chiamati i latifondisti, vogliono sfondare. Cioè insinuarsi all’interno della terra legalmente restituita dallo Stato ai popoli Wapichana e Macuxi.
In teoria non potrebbero: in base alla Costituzione, i 500 indios sono i soli legittimi usufruttuari dei 14mila ettari di Jabutí. Ma i fazendeiros (latifondisti) cercano di aggirare gli ostacoli. «Sono determinati ad affittare la nostra terra. L’ultima volta, ci hanno offerto in cambio un’auto e una moto. Non li avevo mai visti prima, spesso i grandi proprietari utilizzano dei prestanome per non esporsi. Come al solito abbiamo detto no, ma sta diventando sempre più difficile. I più giovani si fanno allettare dalle promesse. All’ultima riunione ci hanno accusati di essere “contro il progresso”. Stanno riuscendo a spaccare la comunità», racconta Adison, uno degli anziani della comunità.
L’affitto dei singoli appezzamenti o di una loro parte è proibito. Il divieto, però, non impedisce ai latifondisti di cercare un accordo “informale”: noleggio a tempo indeterminato dei campi in cambio di qualche oggetto vistoso o un po’ di denaro. Poca roba per chi offre. Tanto per chi deve i conti ogni giorno la penuria cronica di beni e servizi. «Capisco che molti ragazzi vogliano cedere. Qualche soldo in più farebbe comodo a tutti. Ma se perdiamo la nostra terra smettiamo di esistere. Moriremo come comunità e come popolo. Per questo dobbiamo continuare a dire no».
La lotta perché agli indigeni fosse riconosciuto il diritto alla terra è stata feroce. Migliaia di nativi sono stati ammazzati. Alla fine, però, sostenuti dalla Chiesa, questi l’hanno spuntata. Gli indios hanno ottenuto il 46 per cento della superficie del Roraima, divisa in 32 maxi-appezzamenti. Un totale di dieci milioni di ettari riservato a un mosaico di undici popoli - di cui uno in isolamento volontario -, che, però, non supera il 18 per cento della popolazione. «Troppa terra per pochi uomini», ha già detto più di una volta il presidente Jair Bolsonaro.
«Non direi. Si dimentica spesso che gli indigeni non amministrano le terre a loro esclusivo vantaggio. Grazie a noi e alla nostra gestione sostenibile, c’è ancora il lavrado. Siamo i custodi e gli argini di un modello di sviluppo predatorio. Distruggere noi e il nostro modo di vivere, vuol dire distruggere l’Amazzonia e il mondo», sottolinea Edinho Batista, del popolo Macuxi e presidente del Consiglio indigeno del Roraima (Cir). «La battaglia, poi - prosegue - è ancora a metà. Rivendichiamo altri quattro territori e 22 già assegnati sarebbero da ampliare. Con la nuova Amministrazione, nazionale e regionale, però, non abbiamo molta speranza di essere ascoltati. Anzi, ormai dobbiamo giocare sulla difensiva per non perdere ciò che abbiamo già conquistato».
La pressione cresce. «È un fenomeno in atto da tre, quattro anni, quando si è paralizzato il processo di restituzione delle terre ai nativi - analizza Luis Ventura, coordinatore regionale del Consiglio indigenista missionario (Cimi), organismo della Conferenza episcopale brasiliana -. Al contempo, si è intensificata la pressione della bancada ruralista (parlamentari legati ai grandi latifondisti) per ridurre le tutele e aprire agli investimenti le aree protette. In tale ambito rientra la questione dell’affitto dei territori indigeni comunitari, di chiaro contenuto anticostituzionale».
L’elezione di Bolsonaro ha rappresentato un salto di qualità: gli ultimi dati dell’Istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpe) hanno rilevato un aumento dell’88 per cento nella deforestazione a giugno all’anno precedente. In Roraima la situazione è ancora più complicato. Le stesse elezioni vinte da Bolsonaro hanno assegnato l’incarico di governatore ad Antonio Denarium, noto produttore di soia, nonché rappresentante della cooperativa degli allevatori di carne dello Stato.
Del medesimo partito del presidente, Denarium non ha, però, escluso la possibilità di «rivedere alcune situazioni» per espandere la frontiera agricola e aumentare la produzione regionale. Del resto, il suo programma sottolinea la necessità di incentivare l’agrobusiness, anche attraendo investitori da altri Stati.
«Che cosa abbiamo intenzione di fare? Continuare a resistere - conclude con orgoglio Edinho -. Per noi, ma anche per voi. Non lasciateci soli». (2. Continua)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! ---" Siamo immersi in trasformazioni epocali": Discorso di insediamento al Parlamento europeo del Presidente David Sassoli.4 luglio 2019, di Federico La Sala
Discorso di insediamento al Parlamento europeo
del Presidente David Sassoli *
Cittadine e cittadini dell’Unione europea, signore e signori parlamentari, cari amici, colleghi, rappresentanti delle Istituzioni, dei Governi, donne e uomini di questa Amministrazione.
Tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell’assumere la Presidenza del Parlamento europeo e di essere stato scelto da voi per rappresentare l’Istituzione che più di ogni altra ha un legame diretto con i cittadini, che ha il dovere di rappresentarli e difenderli. E di ricordare sempre che la nostra libertà è figlia della giustizia che sapremo conquistare e della solidarietà che sapremo sviluppare.
Permettetemi di ringraziare il Presidente Antonio Tajani per il lavoro svolto in questo Parlamento, per il suo grande impegno e la sua dedizione a questa Istituzione. Voglio anche dare il benvenuto ai nuovi colleghi, che sono il 62% di quest’Aula, un bentornato ai parlamentari confermati e alle donne, che rappresentano il 40% di tutti noi. Un buon risultato, ma noi vogliamo di più.
In questo momento, al termine di una intensa campagna elettorale, ha inizio una legislatura che gli avvenimenti caricano di grande responsabilità perché nessuno può accontentarsi di conservare l’esistente. Ce lo dice il risultato elettorale, ce lo testimonia la stessa composizione di questa Assemblea.
Siamo immersi in trasformazioni epocali: disoccupazione giovanile, migrazioni, cambiamenti climatici, rivoluzione digitale, nuovi equilibri mondiali, solo per citarne alcuni, che per essere governate hanno bisogno di nuove idee, del coraggio di saper coniugare grande saggezza e massimo d’audacia.
Dobbiamo recuperare lo spirito di Ventotene e lo slancio pionieristico dei Padri Fondatori, che seppero mettere da parte le ostilità della guerra, porre fine ai guasti del nazionalismo dandoci un progetto capace di coniugare pace, democrazia, diritti, sviluppo e uguaglianza.
In questi mesi, in troppi, hanno scommesso sul declino di questo progetto, alimentando divisioni e conflitti che pensavamo essere un triste ricordo della nostra storia. I cittadini hanno dimostrato invece di credere ancora in questo straordinario percorso, l’unico in grado di dare risposte alle sfide globali che abbiamo davanti a noi.
Dobbiamo avere la forza di rilanciare il nostro processo di integrazione, cambiando la nostra Unione per renderla capace di rispondere in modo più forte alle esigenze dei nostri cittadini e per dare risposte vere alle loro preoccupazioni, al loro sempre più diffuso senso di smarrimento.
La difesa e la promozione dei nostri valori fondanti di libertà, dignità e solidarietà deve essere perseguita ogni giorno dentro e fuori l’Ue.
Cari colleghi, pensiamo più spesso al mondo che abbiamo, alle libertà di cui godiamo.... E allora diciamolo noi, visto che altri a Est o ad Ovest, o a Sud fanno fatica a riconoscerlo, che tante cose ci fanno diversi - non migliori, semplicemente diversi - e che noi europei siamo orgogliosi delle nostre diversità.
Ripetiamolo perché sia chiaro a tutti che in Europa nessun governo può uccidere, che il valore della persona e la sua dignità sono il nostro modo per misurare le nostre politiche
che da noi nessuno può tappare la bocca agli oppositori, che i nostri governi e le istituzioni europee che li rappresentano sono il frutto della democrazia e di libere elezioni
che nessuno può essere condannato per la propria fede religiosa, politica, filosofica che da noi ragazze e ragazzi possono viaggiare, studiare, amare senza costrizioni
che nessun europeo può essere umiliato e emarginato per il proprio orientamento sessuale che nello spazio europeo, con modalità diverse, la protezione sociale è parte della nostra identità
che la difesa della vita di chiunque si trovi in pericolo è un dovere stabilito dai nostri Trattati e dalle Convenzioni internazionali che abbiamo stipulato.
Il nostro modello di economia sociale di mercato va rilanciato. Le nostre regole economiche devono saper coniugare crescita, protezione sociale e rispetto dell’ambiente. Dobbiamo dotarci di strumenti adeguati per contrastare le povertà, dare prospettive ai nostri giovani, rilanciare investimenti sostenibili, rafforzare il processo di convergenza tra le nostre regioni ed i nostri territori.
La rivoluzione digitale sta cambiano in profondità i nostri stili di vita, il nostro modo di produrre e di consumare. Abbiamo bisogno di regole che sappiano coniugare progresso tecnologico, sviluppo delle imprese e tutela dei lavoratori e delle persone.
Il cambiamento climatico ci espone a rischi enormi ormai evidenti a tutti. Servono investimenti per tecnologie pulite per rispondere ai milioni di giovani che sono scesi in piazza, e alcuni venuti anche in quest’Aula, per ricordarci che non esiste un altro pianeta.
Dobbiamo lavorare per una sempre più forte parità di genere e un sempre maggior ruolo delle donne ai vertici della politica, dell’economia, del sociale.
Signore e Signori, questo è il nostro biglietto da visita per un mondo che per trovare regole ha bisogno anche di noi.
Ma tutto questo non è avvenuto per caso. L’Unione europea non è un incidente della Storia.
Io sono figlio di un uomo che a 20 anni ha combattuto contro altri europei, e di una mamma che, anche lei ventenne, ha lasciato la propria casa e ha trovato rifugio presso altre famiglie.
Io so che questa è la storia anche di tante vostre famiglie... e so anche che se mettessimo in comune le nostre storie e ce le raccontassimo davanti ad un bicchiere di birra o di vino, non diremmo mai che siamo figli o nipoti di un incidente della Storia.
Ma diremmo che la nostra storia è scritta sul dolore, sul sangue dei giovani britannici sterminati sulle spiagge della Normandia, sul desiderio di libertà di Sophie e Hans Scholl, sull’ansia di giustizia degli eroi del Ghetto di Varsavia, sulle primavere represse con i carri armati nei nostri paesi dell’Est, sul desiderio di fraternità che ritroviamo ogni qual volta la coscienza morale impone di non rinunciare alla propria umanità e l’obbedienza non può considerarsi virtù.
Non siamo un incidente della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l’antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi. Ma il nazionalismo che diventa ideologia e idolatria produce virus che stimolano istinti di superiorità e producono conflitti distruttivi.
Colleghe e colleghi, abbiamo bisogno di visione e per questo serve la politica. Sono necessari partiti europei sempre più capaci di essere l’architrave della nostra democrazia. Ma dobbiamo dare loro nuovi strumenti. Quelli che abbiamo sono insufficienti. Questa legislatura dovrà rafforzare le procedure per rendere il Parlamento protagonista di una completa democrazia europea.
Ma non partiamo da zero, non nasciamo dal nulla. L’Europa si fonda sulle sue Istituzioni, che seppur imperfette e da riformare, ci hanno garantito le nostre libertà e la nostra indipendenza. Con le nostre Istituzioni saremo in grado di rispondere a tutti coloro che sono impegnati a dividerci. E allora diciamo in quest’Aula, oggi, che il Parlamento sarà garante dell’indipendenza dei cittadini europei. E che solo loro sono abilitati a scrivere il proprio destino: nessuno per loro, nessuno al posto nostro.
In quest’aula insieme a tanti amici e colleghi con molta esperienza, vi sono anche tantissimi deputati alla prima legislatura. A loro un cordiale saluto di benvenuto.
Ho letto molte loro biografie e mi sono convinto si tratti di una presenza molto positiva per loro competenze, professionalità. Molti di loro sono impegnati in attività sociali o di protezione delle persone, e questo è un campo su cui l’Europa deve migliorare perché abbiamo il dovere di governare i fenomeni nuovi.
Sull’immigrazione vi è troppo scaricabarile fra governi e ogni volta che accade qualcosa siamo impreparati e si ricomincia daccapo.
Signori del Consiglio Europeo, questo Parlamento crede che sia arrivato il momento di discutere la riforma del Regolamento di Dublino che quest’Aula, a stragrande maggioranza, ha proposto nella scorsa legislatura.
Lo dovete ai cittadini europei che chiedono più solidarietà fra gli Stati membri; lo dovete alla povera gente per quel senso di umanità che non vogliamo smarrire e che ci ha fatto grandi agli occhi del mondo.
Molto è nelle vostre mani e con responsabilità non potete continuare a rinviare le decisioni alimentando sfiducia nelle nostre comunità, con i cittadini che continuano a chiedersi, ad ogni emergenza: dov’è l’Europa? Cosa fa l’Europa? Questo sarà un banco di prova che dobbiamo superare per sconfiggere tante pigrizie e troppe gelosie.
E ancora, Parlamento, Consiglio e Commissione devono sentire il dovere di rispondere con più coraggio alle domande dei nostri giovani quando chiedono a gran voce che dobbiamo svegliarci, aprire gli occhi e salvare il pianeta.
Mi voglio rivolgere a loro: considerate questo Parlamento, che oggi inizia la sua attività legislativa, come il vostro punto di riferimento. Aiutateci anche voi a essere più coraggiosi per affrontare le sfide del cambiamento.
Voglio assicurare al Consiglio e alle Presidenze di turno la nostra massima collaborazione e lo stesso rivolgo alla Commissione e al suo Presidente. Le Istituzioni europee hanno la necessità di ripensarsi e di non essere considerate un intralcio alla costruzione di un’Europa più unita.
Tramite il Presidente del Consiglio europeo voglio rivolgere anche un saluto, a nome di quest’Aula, ai Capi di Stato e di Governo.
Ventotto paesi fanno grande l’Unione europea. E si tratta di 28 Stati, dal più grande al più piccolo, che custodiscono tesori unici al mondo. Tutti vengono da lontano e posseggono cultura, lingua, arte, paesaggio, poesia inimitabili e inconfondibili. Sono il nostro grande patrimonio e tutti meritano rispetto.
Ecco perché quando andrò a visitarli, a nome vostro, non sarò mai distratto. E davanti alle loro bandiere e ai loro inni sarò sull’attenti anche a nome di coloro che, in quest’Aula, non mostrano analogo rispetto.
Lasciatemi infine rivolgere un saluto ai parlamentari britannici, comunque la pensino sulla Brexit. Per noi immaginare Parigi, Madrid, Berlino, Roma lontane da Londra è doloroso.
Sì sappiatelo, con tutto il rispetto che dobbiamo per le scelte dei cittadini britannici, per noi europei si tratta di un passaggio politico che deve essere portato avanti con ragionevolezza, nel dialogo e con amicizia, ma sempre nel rispetto delle regole e delle rispettive prerogative.
Voglio salutare i rappresentanti degli Stati che hanno chiesto di aderire all’Unione europea. Il loro percorso è avviato per loro libera scelta. Tutti capiscono quanto sia conveniente far parte dell’Unione. Le procedure di adesione proseguono e il Parlamento si è detto più volte soddisfatto dei risultati raggiunti.
Infine, un in bocca al lupo a tutta l’amministrazione e ai lavoratori del Parlamento.
Ci siamo dati un obbiettivo nella scorsa legislatura: far diventare il Parlamento europeo la Casa della democrazia europea.
Per questo abbiamo bisogno di riforme, di maggiore trasparenza, di innovazione. Molti risultati sono stati raggiunti, specie sul bilancio, ma questa legislatura deve dare un impulso maggiore.
Per fare questo c’è bisogno di un maggior dialogo fra parlamentari e amministrazione e sarà mia cura svilupparlo.
Care colleghe e cari colleghi, l’Europa ha ancora molto da dire se noi, e voi, sapremo dirlo insieme. Se sapremo mettere le ragioni della lotta politica al servizio dei nostri cittadini, se il Parlamento ascolterà i loro desideri e le loro paure e le loro necessità.
Sono sicuro che tutti voi saprete dare il necessario contributo per un’Europa migliore che può nascere con noi, con voi, se sapremo metterci cuore e ambizione.
Grazie e buon lavoro.
*
Fonte: https://eurodeputatipd.eu/2019/07/03/discorso-insediamento-del-presidente-david-sassoli/
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- “L’Unione europea non è un incidente della Storia”. Lo ha detto David Sassoli, neo presidente del Parlamento europeo, intervenendo in Aula a Strasburgo3 luglio 2019, di Federico La Sala
Ue, il discorso di Sassoli: “Europa antidoto alle degenerazioni nazionaliste che hanno avvelenato la nostra storia”
“L’Unione europea non è un incidente della Storia”. Lo ha detto David Sassoli, neo presidente del Parlamento europeo, intervenendo in Aula a Strasburgo. “Non siamo un incidente della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l’antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi. Ma il nazionalismo che diventa ideologia e idolatria produce virus che stimolano istinti di superiorità e producono conflitti distruttivi”.
-
> Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. ---- LA VOCE DEGLI ALBERI (di Amitav Ghosh)30 giugno 2019, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: FILOLOGIA E ’DENDROLOGIA’ (gr.: "déndron" - albero e "lògos" - studio/scienza). L’ALBERO DELLA VITA ... *
La voce degli alberi
di Amitav Ghosh (minima&moralia domenica, 30 giugno 2019)
- Ringraziamo l’editore Neri Pozza per averci autorizzato a riprodurre questo brano, uscito originariamente per “La Stampa” in occasione della presenza di Ghosh al festival “Le Conversazioni” di Capri. Trad. it. Martina Testa.
L’evento letterario più significativo degli ultimi anni è stato per me la pubblicazione di Overstory (Norton, 2018), l’elogiatissimo romanzo di Richard Powers, in buona parte perché affronta di petto il più grande di tutti i pregiudizi del mondo contemporaneo: quello che nega una voce agli esseri non umani. Al centro della narrazione di Powers c’è infatti un gruppo di protagonisti che non hanno voce, nel senso che non parlano nessuna lingua umana: gli alberi. Di fatto, il romanzo prova a dar voce a una categoria di esseri viventi a cui, nell’ambito della letteratura contemporanea, non è stato quasi mai permesso di parlare. [...]
Oggi sappiamo che gli alberi di una foresta in certe circostanze riescono a comunicare fra loro: possono prestare soccorso, sotto forma di carbonio, a membri del proprio gruppo in difficoltà; e possono avvertirsi a vicenda di epidemie e malattie. Oggi si ritiene che alcune piante possano addirittura emettere suoni che l’orecchio umano non sente ma che risultano udibili per altri esseri viventi.
Tutto ciò porta a pensare che il problema di una domanda come «I non umani possono parlare?» consista già nel modo in cui è formulata, perché ruota intorno a un termine, «parlare», legato necessariamente al linguaggio verbale, tipico attributo umano. In quanto mancanti di questo attributo, si può dire che gli alberi siano muti. Ma dato che a noi manca la capacità di comunicare nel modo in cui lo fanno gli alberi, non si potrebbe dire che per un albero siamo noi umani a essere muti?
Perciò, di chi è la definizione che deve prevalere? La risposta, di nuovo, è lungi dall’essere ovvia. Potrebbe sembrarci che, avendo la capacità di abbattere un albero, siamo noi a decidere chi parla e chi è muto. Ma molti alberi hanno una vita ben più lunga di quella degli esseri umani: alcuni arrivano a più di mille anni. Se davvero gli alberi disponessero di alcuni modi di ragionare possiamo stare certi che sarebbero calibrati su una scala temporale completamente diversa, che preveda magari anche l’estinzione del genere umano o una serie di catastrofi tali da decimarlo. In un simile mondo gli alberi prolifererebbero come mai prima, su un terreno arricchito da miliardi di corpi umani in decomposizione. Quindi ai nostri occhi può sembrare ovvio che siamo noi i giardinieri che decidono della sorte degli alberi. Ma, in una diversa scala temporale, potrebbe sembrare altrettanto ovvio che siano gli alberi a coltivare noi.
O forse questa è tutta una prospettiva sbagliata? In fondo, alberi ed esseri umani non sono - o non sono soltanto - avversari in competizione per uno stesso spazio. Sono anche legati da innumerevoli forme di cooperazione. Forse il difetto di tutto il ragionamento è l’idea stessa che esista una singola specie. Ora sappiamo che il corpo umano contiene enormi quantità di microorganismi di vario tipo; sappiamo che senza la loro presenza non saremmo in grado di funzionare; sappiamo che i microorganismi ci influenzano l’umore, le emozioni e le facoltà razionali. Quindi se è vero che la capacità umana di parlare si può mettere in atto solo in presenza di altre specie, si può davvero dire che la facoltà della parola sia propria esclusivamente degli esseri umani?
Come afferma Ana Tsing nel suo geniale nuovo libro, The Mushroom at the End of the World (Il fungo alla fine del mondo), sembra sempre di più che le specie non si evolvano singolarmente ma in stretta intimità con altri organismi. L’autrice cita l’esempio di certi animali che riescono a svilupparsi pienamente solo quando incontrano certi specifici microorganismi che non fanno parte del loro corredo genetico. Questi animali devono interagire con quei batteri, nel mondo: senza tali incontri non riescono a realizzare pienamente il loro potenziale.
Ma non si potrebbe dire anche degli esseri umani che la presenza di altre specie, in particolari circostanze di interazione, li mette in condizione di trascendere i loro limiti? Pensate a un momento fondamentale nella storia della coscienza umana: l’illuminazione del Buddha. L’evento è accaduto mentre il Buddha meditava sotto un albero della Bodhi (Ficus religiosa). Secondo la tradizione buddista, da più di duemila anni, la presenza di tale albero è stata inseparabile da quell’evento. Ciò non vuol dire che sia l’albero a trasmettere l’illuminazione, o anche solo che abbia parte attiva nel processo. E non è neanche vero che chiunque mediti sotto un albero della Bodhi raggiungerà l’illuminazione.
E tuttavia è da lungo tempo accettato, da molti milioni di persone, che l’incontro fra specie, in una particolare congiuntura storica, sia stato essenziale per l’illuminazione di uno specifico essere umano, il principe Siddharta Gautama. E il Buddha stesso era convinto che l’albero fosse stato essenziale per il suo raggiungimento del Nibbana (Nirvana, in Pali), ragion per cui milioni di buddisti considerano ancora oggi sacra quella specie di Ficus.
Cosa ci dice tutto questo? Innanzitutto, che un certo tipo di associazioni tra specie diverse non si possono considerare come se fossero processi o relazioni. Sono proprio incontri o eventi che avvengono in un particolare momento e non si possono ripetere. Il che significa che queste associazioni si possono concepire solo dal punto di vista storico, attenendosi alle circostanze in cui avvengono.
In secondo luogo, ci dice che fra gli esseri umani la consapevolezza della possibilità di questi incontri con altre specie è sempre esistita: basta solo pensare alle tradizioni che circondano san Francesco d’Assisi per riconoscere che ce ne sono molti altri esempi.
A prima vista la domanda «I non umani possono parlare?» appare assurda. Eppure, in questo momento storico, se guardiamo alla serie di vicende che ci hanno portato sulla soglia di una catastrofe planetaria, non possiamo non riconoscere che la nostra tragica situazione è in gran parte conseguenza del fatto che certe classi di umani hanno attivamente ridotto al silenzio tutti gli altri esseri rappresentandoli come bruti: vale a dire, creature la cui presenza sulla Terra ha un valore puramente materiale. La vera domanda, allora, non è se i non umani possano parlare, ma piuttosto: quando e come certi umani si sono convinti che le altre specie sono incapaci di espressione e di volontà proprie?
Ascoltare le voci dei non umani è, in effetti, l’impresa più importante del nostro tempo: e se non la affrontano gli artisti e gli scrittori, chi sarà a farlo?
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
RIPENSARE L’EUROPA (...) il “nuovo mondo” che abbiamo costruito dimostra quanto presto abbiamo dimenticato la ‘lezione’ delle foreste, dei mari, dei deserti, e dei fiumi e delle montagne!!!
“SMONTARE LA GABBIA”! USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”.... Una nota (Le parole e le cose, 26 giugno 2019).
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- IL POPOLO, iL DESIDERIO POLITICO, E IL SOVRANISMO. Che cos’è il populismo? L’inganno della parte che vuole essere il tutto23 giugno 2019, di Federico La Sala
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PERDERE LA COSCIENZA DELLA LINGUA ("LOGOS") COSTITUZIONALE ED EVANGELICA GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI ... *
Politica.
Che cos’è il populismo? L’inganno della parte che vuole essere il tutto
Il politologo Yves Mény: le democrazie rappresentative si fondano sul popolo ma lo relegano a osservatore. Ma non c’è reale alternativa: un vero potere popolare finirebbe nelle mani dell’uomo forte
di Yves Mény (Avvenire, giovedì 20 giugno 2019)
- [Foto] Parigi durante la manifestazione del novembre 2018 organizzata dai “Gilet gialli” per protestare contro le tasse introdotte dal Presidente francese Emmanuel Macron (Ansa/Ap/Michel Euler)
- Anticipiamo la lectio magistralis che Yves Mény, docente di Scienze politiche, terrà domani al Festival TaoBuk di Taormina. Meny è stato presidente del cda della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, attualmente insegna nell’Università Luiss-Guido Carli di Roma.
Le democrazie sono al centro del desiderio politico. O almeno lo sono state per molto tempo e si sono identificate con la libertà, l’autonomia, l’auto-governo, con la vittoria della maggioranza e del numero sul singolo sovrano. La democrazia è, potremmo dire in sintesi, il desiderio della multitudine di sostituirsi al re, al dittatore o a un gruppo ristretto ma dominante, alle élites, alla casta, all’establishment. Ma la folla, le masse, l’aggregazione dei singoli, si trova di fronte ad un impasse, che nel mio recente libro pubblicato dal Mulino, Popolo ma non troppo ho denominato “malinteso democratico”.
Come unire infatti tutti questi atomi, attraversati da aspirazioni, interessi, emozioni cosi diversi da impedire loro di fatto di unirsi? Nel corso della storia molti sono stati i tentativi: ridurre, ad esempio, la dimensione territoriale della città per rendere possibile la conoscenza e l’unione di tutti. È il sogno greco, rivisto da Rousseau; ma non possiamo scordare la deriva delle colonie greche di Sicilia dove il despota finisce per incarnare il demos.
Una variante diversa è offrire una visione alternativa del popolo. È il realismo senza pietà di Hobbes dove il sovrano, sulla copertina del suo libro, è rappresentato da mille corpi di cittadini assorbiti, ingoiati e capovolti per dar corpo all’unità. C’è poi il sogno-incubo della rivoluzione russa di dare il potere a una classe unica al prezzo di eliminare qualche privilegiato; e c’è il realismo all’inglese che “inventa” il principio rappresentativo per incanalare le aspirazioni di molti nella fattibilità pratica del governo di pochi; e c’è la non meno realistica e fredda osservazione di Gaetano Mosca sull’ineluttabilità delle élites, la doccia fredda sul desiderio.
"Unirsi in un popolo" è il desiderio che continuamente si ripresenta di trasformare la diversità in una unità metafisica. «L’Italia è fatta, bisogna fare gli italiani» constatava Massimo d’Azeglio; Eugen Weber descrive la trasformazione dei francesi di fine Ottocento «da contadini a cittadini»; Benedict Anderson evoca la nazione come «comunità sognata». Per farla breve, il “popolo” non smette di desiderare di diventare anche una realtà sociale e non soltanto un’utopia magica.
Purtroppo la contraddizione interna è sempre in agguato: il popolo come concetto è indispensabile per legittimare l’accesso al potere. Anche le dittature pretendono di governare in nome e per il bene del popolo. E questo popolo che le democrazie hanno posto sul piedestallo per poi relegarlo nel ruolo di osservatore degli atti dei governanti si rivolta sempre di più per far avverare l’utopia di Lincoln «Government of the people, by the people, for the people».
In altre parole, il popolo americano, ma anche tutti gli altri, fanno proprie le tre prime parole della costituzione americana «We the People...», che è una splendida frase per parlare di legittimazione, ma è una pia illusione quando si tratta di governare.
 Si potrebbe ricordare la reazione di un francese chiamato ad approvare la costituzione scritta da Napoleone: «Che c’è nella costituzione?» E la risposta fu «Bonaparte»...
Si potrebbe ricordare la reazione di un francese chiamato ad approvare la costituzione scritta da Napoleone: «Che c’è nella costituzione?» E la risposta fu «Bonaparte»...Non c’è alternativa alla necessità della rappresentanza: non vi è mai stato un “vero” potere popolare e se ci fosse si correrebbe il rischio di radunarsi di fatto sotto le ali di un uomo forte, di un salvatore. Dio ci salvi da questa fatalità! Il desiderio di sentirsi uniti in un popolo non è soltanto forte, inganna, inebria.
 Qualunque gruppo può pretendere di essere il popolo anche quando si tratta di una parte di popolo molto ridotta, come quella che vota sulla piattaforma Rousseau o quando i Gilets jaunes che da sei mesi pretendono di essere il «popolo» prendono più o meno 1,5% dei voti alle elezioni europee. La parte pretende cioè di essere il tutto.
Qualunque gruppo può pretendere di essere il popolo anche quando si tratta di una parte di popolo molto ridotta, come quella che vota sulla piattaforma Rousseau o quando i Gilets jaunes che da sei mesi pretendono di essere il «popolo» prendono più o meno 1,5% dei voti alle elezioni europee. La parte pretende cioè di essere il tutto.Ovviamente ci sono anche buone ragioni per portare avanti le proprie rivendicazioni perché il sistema rappresentativo è sempre (al meglio) il governo della maggioranza o, più spesso, appoggia su una minoranza sociologica trasformata in maggioranza politica grazie ai miracoli dei sistemi elettorali. La situazione non sembra particolarmente felice.
 Ma bisogna essere lucidi: l’unanimità, che sulla carta sembra il sistema più rispettoso della volontà del popolo è un sistema “blocca-tutto” ed esiste soltanto nelle piccole tribù primitive, benché sia attivo anche là dove la ricerca del consenso si trasforma in molteplici veti incrociati: l’Italia ne sa qualche cosa...
Ma bisogna essere lucidi: l’unanimità, che sulla carta sembra il sistema più rispettoso della volontà del popolo è un sistema “blocca-tutto” ed esiste soltanto nelle piccole tribù primitive, benché sia attivo anche là dove la ricerca del consenso si trasforma in molteplici veti incrociati: l’Italia ne sa qualche cosa...Ricordiamoci che l’unanimismo sfocia nella dittatura e soprattutto nella dittatura delle menti. Il populismo, «l’ideologia del popolo» rischia quindi di essere una grande illusione e un inganno. Riconosciamogli però un merito: rimescola le carte e spesso pone fine a quello che il poeta Paul Eluard chiamava «il duro desiderio di durare».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
- L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
MESSAGGIO EVANGELICO E SANTO PADRE?! ABUSO DEL TITOLO E MENZOGNA. L’ERRORE DI RATZINGER (E DI TUTTI I PAPI).
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE.21 giugno 2019, di Federico La Sala
IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE...*
1. La gioia della verità (Veritatis gaudium) esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la Luce di Dio[1]. La verità, infatti, non è un’idea astratta, ma è Gesù, il Verbo di Dio in cui è la Vita che è la Luce degli uomini (cfr. Gv 1,4), il Figlio di Dio che è insieme il Figlio dell’uomo. Egli soltanto, «rivelando il mistero del Padre e del suo amore, rivela l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione»[2].
Nell’incontro con Lui, il Vivente (cfr Ap 1,18) e il Primogenito tra molti fratelli (cfr Rm 8,29), il cuore dell’uomo sperimenta già sin d’ora, nel chiaroscuro della storia, la luce e la festa senza più tramonto dell’unione con Dio e dell’unità coi fratelli e le sorelle nella casa comune del creato di cui godrà senza fine nella piena comunione con Dio. Nella preghiera di Gesù al Padre: «perché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi» (Gv 17,21) è racchiuso il segreto della gioia che Gesù ci vuole comunicare in pienezza (cfr 15,11) da parte del Padre col dono dello Spirito Santo: Spirito di verità e di amore, di libertà, di giustizia e di unità. [:::] "(Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 29.01.2018. Proemio)
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante. Un nota sul “disagio della civiltà”
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Intervento del Santo Padre Francesco all’Incontro sul tema: “La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo”, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli, 20-21 giugno 2019).21 giugno 2019, di Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. --- EUROPA E CIELO STELLATO (KANT). La bandiera dell’Unione Europa, un cerchio di dodici stelle.14 giugno 2019, di Federico La Sala
L’EUROPA, LA COSTITUZIONE, E LA BANDIERA: LE RADICI CATTOLICHE DI MARIA ELENA (MADRE DI COSTANTINO) O LE RADICI CRISTIANE DI MARIA BEATRICE (MADRE DI DANTE)?! Al di là della trinità "edipica" e "mammonica" *
- UN "SEGNAVIA": DALLA TRINITA’ DI ADAMO ED EVA ALLA TRINITA’ DI GIUSEPPE E MARIA. LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI"
Europa.
Le radici cattoliche e mariane della bandiera dell’Unione Europea
Un saggio di Enzo Romeo ricostruisce la complessa genesi e la simbologia legata a Maria del vessillo di colore blu con il cerchio di dodici stelle, adottato dal Consiglio europeo nel 1955
di Edoardo Castagna (Avvenire, venerdì 14 giugno 2019)
- [Foto] La bandiera dell’Unione Europa, un cerchio di dodici stelle in campo blu
Ogni identità ha bisogno di simboli ai quali guardare, per riconoscersi e per ispirarsi. Lo sanno bene i populisti di ieri e di oggi, che usano le identità come sciabole per dividere. In modo diametralmente opposto, tanto politicamente quanto moralmente, lo sapevano bene anche i padri fondatori dell’Unione Europea nella loro ricerca di una nuova identità capace di abbracciare, unire, includere.
L’identità europea si è costruita un poco alla volta negli ultimi sessant’anni e, anche se nell’ultimo periodo sembriamo a un punto di stallo, non possiamo non vedere quanto di grande e buono è stato fin qui costruito. Anche attorno ai simboli. Abbiamo un inno nella musica di Beethoven; e abbiamo una bandiera, ormai presenza famigliare sulle facciate degli edifici pubblici - e non solo, come le ultime elezioni europee hanno dimostrato: non pochi balconi hanno visto esporre il drappo azzurro con le dodici stelle.
Alla storia di questa bandiera ha dedicato il suo ultimo saggio Enzo Romeo (Salvare l’Europa. Il segreto delle dodici stelle; Ave, pagine 190, euro 12,00), nel quale la ricostruzione dei passaggi che portarono le istituzioni europee alla scelta definitiva si accompagna alla riscoperta del retroterra imprevisto che agì sui suoi creatori. Il disegno finale è attribuito a un lavoro collegiale, nel quale tuttavia spiccano i contributi del direttore dell’Ufficio d’informazione e stampa del Consiglio d’Europa, Paul Michel Gabriel Lévy, e soprattutto di Arsène Heitz, impiegato dell’Ufficio e autore di diversi bozzetti per la bandiera comune - tra i quali, con poche modifiche, quello infine adottato.
Cattolico e assai devoto alla Madonna, Heitz lavorò su simboli in apparenza del tutto laici: eppure l’azzurro, le dodici stelle come quelle della “medaglia miracolosa” che commemora le apparizioni mariane di rue du Bac a santa Caterina Labouré nel 1830, e che Heitz portava sempre con sé... una simbologia mariana agì, forse più come “mano invisibile” che come ispirazione cosciente, almeno fino a quando, molto più tardi, lo stesso Heitz non la esplicitò, forse prendendone consapevolezza egli stesso: «Mi sentii ispirato da Dio - avrebbe confidato Heitz a padre Pierre Caillon nel 1987, poco prima di morire - nel concepire un vessillo tutto azzurro su cui si stagliava un cerchio di stelle, come quello della medaglia miracolosa. Cosicché la bandiera europea è quella di Nostra Signora».
Quello di Heitz, d’altra parte, non fu l’unica delle proposte a contenere richiami alla simbologia cristiana, anche più espliciti: per esempio, l’austriaco Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi, fondatore nel 1922 dell’Unione Paneuropea, suggerì un drappo blu con una croce rossa cerchiata di giallo; lo stesso Heitz propose una croce rossa in campo verde. Il verde fu tra i colori più ricorrenti nelle prime bozze: il francese Robert Bichet lanciò l’idea di quindici stelle verdi su campo bianco, il Movimento federalista europeo chiedeva che fosse adottato direttamente il proprio emblema, una “E” verde su campo bianco. Il blu fu comunque il colore più proposto, così come le stelle ebbero facilmente la meglio su altri simboli come i cerchi (un bozzetto a cerchi intrecciati fu bocciato perché ricordava troppo, a detta della commissione, una catena o la bandiera olimpica, se non addirittura la ghiera di un telefono...).
Le dodici stelle disposte a cerchio su fondo blu furono adottate dal Consiglio d’Europa (la bandiera identifica tanto questa istituzione quanto la successiva Unione Europea) nel 1955, con argomentazioni apparentemente anodine: il blu è quello del cielo dell’Occidente, le dodici stelle rappresentano tutti i popoli d’Europa nella loro diversità, il cerchio la loro unità. -Nessun riferimento, nei documenti ufficiali, a richiami mariani: ma, come nota giustamente Romeo, in questi casi «bisogna procedere su un piano assolutamente aconfessionale, evitando polemiche di sapore religioso o ideologico. Non si tratta di nascondere ipocritamente i segni della propria fede, ma di proporli su un piano universale, perché in questo caso essi trascendono l’appartenenza a una Chiesa e si trasformano nell’allegoria di un quadro valoriale comune». E, in effetti, ormai per mezzo miliardo di persone quelle stelle in campo blu hanno acquisito un po’ il colore di casa.
 Anche se di una casa ancora in costruzione.
Anche se di una casa ancora in costruzione.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. In memoria di Kurt H. Wolff.
"NUOVA ALLEANZA"?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!
Federico La Sala
- UN "SEGNAVIA": DALLA TRINITA’ DI ADAMO ED EVA ALLA TRINITA’ DI GIUSEPPE E MARIA. LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI"
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- DANTE, "L’ALTRA ARGO" (VIRGILIO), E "L’ARCADIA COME PARADIGMA POLITICO". Per una società felice.28 maggio 2019, di Federico La Sala
DANTE, "L’ALTRA ARGO" (VIRGILIO), E "L’ARCADIA COME PARADIGMA POLITICO" ...*
- "Allora vi sarà un altro Tifi e un’altra Argo" (Virgilio, Bucoliche, IV Ecloga, v. 34).
L’insegnamento politico dell’Arcadia
Per una società felice
di Pietro Pascarelli (Doppiozero, 31.03.2019)
Nell’antichità un popolo di un’impervia regione della Grecia ebbe fama di essere venuto al mondo prima degli astri e della luna, e di aver scoperto le fasi di questa, insieme al calcolo del tempo, rendendo possibile la storia.
Allora gli uomini percepivano nel paesaggio, nelle ombre degli anfratti silvani o nei lucori di improvvise radure, l’aura panica e il fluire irresistibile di eros, la presenza di ninfe e dei.
Paesaggio “ad alta densità mitologica secreta da millenni di convivenza umana” su cui il visitatore, Pausania il Periegeta, gettò nel II secolo d.C. uno sguardo “già archeologico” avvicinandosi alla città di Licosura.
In esso invisibili interstizi fra materia e soffio creatore, fra uomini e cose, accoglievano contrasti e opposizioni entro l’unificazione poetica in un senso superiore e inatteso.
Per intuizione e intelligenza suggerite dal cielo i greci e quel popolo misterioso “in possesso dell’amore del pensiero” riconobbero nel canto degli uccelli, un suono di origine naturale “privo di pensiero e di artificio”, il nomos, il quale corrisponde all’unità di una scansione tipica di note e suoni per ogni specie di uccelli, e a un metro che indica “ogni azione giusta”.
Fu riconosciuta così, come principio teoretico generale, la possibilità di un impulso di conoscenza che dal mondo non umano trapassa come dono impensato in quello umano, a fondarne i principi regolatori che si oppongono alla violenza e alla legge del più forte.
Qualcosa unisce il nomos alla terra, che nutre uomini, piante e animali, e alla musica, sicché con l’aiuto di dike - la Giustizia - venne inaugurato un mondo dispiegato dal mito e dalla poesia.
A dirci qual è questo popolo e a illustrare il suo contributo all’umanità, recuperando fonti storiche e letterarie del mondo antico lungo linee di ricerca ispirate al rigore filologico, è il libro di Monica Ferrando Il regno errante, L’Arcadia come paradigma politico, Neri Pozza 2018, che ci riporta al mito dell’Arcadia e dei suoi abitanti, a quanto si sa di una remota proto-civiltà che dal Peloponneso emerse nel mito e nella storia come modello rilevante di realtà politica, fondato sulla federazione di entità non-statali autoctone “disseminate” di pari rango, accomunate tanto dall’“etnia”, un’etnia “composita” come unità nella reciprocità dei diversi, che da un ideale politico, senza che nessuna dominasse le altre.
Fu Virgilio con le sue Bucoliche, ambientate fra i boschi di quella regione mondana e ultramondana insieme, a tramandare nei secoli con la forza della poesia l’Arcadia come simbolo di una realtà politica ideale, a lungo oggetto di un malinteso che la riduceva a idilliaca e imperturbata oasi di serenità pastorale.
Monica Ferrando si è assunta assai opportunamente il compito, con eleganza e risultati innovatori, di dimostrare che Virgilio adombra, oltre la scena poetica di idilliaci amori agresti, un’eminente organizzazione socio-politica e religiosa, portatrice di principi universali.
L’Arcadia, dove i santuari svolgono una funzione anche politica cruciale, è la terra natale di Ermes, osserva Ferrando, “il dio che mai si farà completamente assimilare dalla religione olimpica ... artefice di ogni singolo dei a possibile varietà di rapporto. ... Affidati a questa figura ... sono i rapporti armonici dei suoni tra loro, espressi dalla lira, e i rapporti psicologici tra parola e azione, i rapporti prodotti dalla parola umana e quelli degli dei tra loro”.
L’Arcadia è anche la terra del regale Pan, dio nomade degli spazi aperti, e simbolo di giustizia cosmica.
Alla concezione di Carl Schmitt di un nomos senza canto e di una dimensione solo letteraria dell’Arcadia virgiliana, Ferrando contrappone, sulla scorta di testi opportunamente vagliati, il nomos cantato e l’Arcadia come idea e nucleo politico germinali rispetto all’organizzazione della vita umana associata, secondo norme derivanti da un principio regolatore che è “uno scarto dalla natura”, cioè il nomos. Esso “riconduce a giustizia la sovranità”, e dunque non legittima ma riconverte la forza, e detta una pratica di vita e una politica dissimile e alternativa rispetto a quella della polis-stato pensata e rappresentata da Atene, potente entità accentrata contrapposta alle disperse poleis arcadiche. Queste erano invece una società modellata come non-polis senza capi, che ricorda un po’ le comunità Guayaki del Paraguay, società “indivise” e “non-Stato” studiate nella seconda metà del Novecento dall’antropologo francese Pierre Clastres, ammiratore di quello stesso Étienne de la Boétie, teorizzatore della pulsione alla servitù volontaria come spiegazione della genesi delle dominazioni, che Ferrando cita in epigrafe alla seconda parte del suo libro.
Mi sembra, alla fine, che l’impostazione di Ferrando inviti a rileggere Virgilio assegnando alla poesia il valore di “unico e autentico compendio dell’umano” e di guida ispirata per convivere in un mondo giusto. E riconoscendo nell’Arcadia la qualità di un nucleo simbolico indistruttibile, destinato a irradiare senza fine il suo insegnamento, in quanto essa “è una realtà topologica” ...paragonabile alle “figure geometriche le cui proprietà non dipendono da quantitativi rapporti di misure, ma dal qualitativo continuum formale che esse consentono”.
In questa realtà si afferma un principio politico materno e di pace, veicolato da Diotima, arcade di Mantinea, che mette al centro l’immagine e il corpo femminile “come simbolo naturale elevato ... scongiurando il sopravvento della logica maschile della forza, ovvero della legge di natura”, e un eros non distorto, non teso al denaro, come ad Atene, che da esso sarà avviata alla decadenza. Un eros invece volto alla sua giusta meta, un bene che coincide con l‘idea stessa del bello, un bello senza immagine, “rifugio di tutte le immagini”, al di là dei corpi concreti, che pone quindi in una regione psichica al di là di ogni seduzione.
Questa nuova interpretazione dell’Arcadia, ben fondata e così necessaria e confortante soprattutto oggi, nelle nostre società in cui il discorso pubblico è sempre più frammentato e povero, ruota intorno al recupero dell’origine poetico-musicale del nomos - poiché era nel canto che si tramandavano le leggi antiche - e del suo rapporto col modo di insediamento umano sulla terra e di distribuzione del nutrimento per uomini e animali, dunque della triplice indissolubile significazione del termine nomos come legge, pascolo, musica.
La legge non si impone con prepotenza né si staglia nel rigore astratto e distante, ma è cantata, e si tramanda con la musica, partecipe di un’armonia cosmica che in tutto si riverbera. Un’armonia in cui si riconosce un ritmo, lo stesso che sta al centro della poesia. Pulsazione che è un battere di piedi sulla terra, o di mani, un risuonare della voce, il respiro, un’intermittenza che segna il passo del cosmo, si ritrova nei metri cantati, nei “piedi” della poesia, e corrisponde all’alternarsi delle stagioni, a momenti dello spostamento nomade, a cicli del raccolto e della riproduzione degli animali.
Perché l’opera di Ferrando, di inesauribile ricchezza di spunti, mi pare importante anche al di là del suo contenuto specifico? Perché essa coglie l’importanza di due cose, la poesia e il mito, capaci di guidare l’umanità, oggi con riferimenti e contenuti diversi, ma sulla scia di metodo e di carisma di quell’antica dottrina, in cui il mito e il canto additano la via per una società non autoritaria, fondata sull’amore (non a caso Diotima, che l’amore illustra nel Simposio platonico, proviene dall’“amorevole” città arcade di Mantinea).
La poesia continua a mantenere una visione unitaria di ciò che i più vedono disgiunto e frammentato: gli uomini separati gli uni dagli altri e dalla natura; l’intelletto disgiunto dalle passioni, il sacro dal profano, l’oblio dalla memoria. Ma è sul tempo che la poesia si dimostra irrinunciabile. Essa dona il futuro quando nell’elaborazione del dolore, che pure ad essa soltanto riesce, sembra incombere assoluto il presente. “Fuori dalla poesia”, suggerisce Ferrando, “il tempo avrebbe totalmente smarrito la sua struttura musicale, cioè la sua forma ritmica, per richiudersi e scadere a quantità numerica senza limite e senza fine. Si sarebbe separato dalla realtà della parola, come scaturigine dei nomi delle cose entro l’accordo fondamentale con physis, che riconosce ad ogni cosa il suo nomos”.
Nella deriva attuale di imbarbarimento, che fa dubitare non di rado che vi possa essere grande udienza per istanze così elevate, anche se preziose adesso più che mai, la nostra società sembra recuperare la natura solo come bene supremo da proteggere (ne va della vita sulla terra) o anche come patrimonio di bellezza, come valore estetico e spirituale. Come qualcosa però di cui fruire, come un bene necessario, più forse che come valore in sé. Come oggetto di scienza, non di contemplazione, e non come sorgente di conoscenza.
Il poeta vede il perdurante rapporto fra uomo e società, natura e mito, senza farsi fuorviare dagli inganni della modernità alienata. Vede senza fumo negli occhi il genuino mito originario come il luogo dove uomo e pensiero tornano per rigenerarsi, e ritrovare e ridire sempre il senso della natura e del sacro, come della propria presenza in essa e fra le cose.
Leonardo Sinisgalli, ispirato dalla sua Arcadia, la Lucania, scrive una poesia, Vidi le Muse, nella raccolta omonima uscita da Mondadori nel 1943:
Sulla collina
Io certo vidi le Muse
Appollaiate tra le foglie.
Io vidi allora le Muse
Tra le foglie larghe delle querce
Mangiare ghiande e coccole.
Vidi le Muse su una quercia
Secolare che gracchiavano.
Meravigliato il mio cuore
Chiesi al mio cuore meravigliato
Io dissi al mio cuore la meraviglia.
C’è una connessione fra mito genuino, non piegato ai fini del potere, poesia e il farsi della realtà e della nostra vita individuale e collettiva in essa, che la poesia strappa all’estraneità raggelante del reale, all’assenza d’etica, al trionfo inumano e violento delle passioni allo stato originario, non rielaborate da nomos e dike e da un più ampio sistema simbolico di saggezza nella regolazione della vita interiore e pubblica.
E la poesia, che crea e riplasma la realtà agli occhi di tutti, quello slancio dello spirito che con esattezza scopre nel canto degli uccelli la misura, il nomos, che orienta nell’universo delle possibilità e detta in musica celeste principi di comportamento, la poesia, dico, non appartiene solo al verso, è inerente invece a ogni forma d’arte. Particolare importanza ad esempio assume la pittura, in cui, ci avverte Ferrando, trova espressione il favoloso, il mitico, respinto dalla storia.
Citerò ancora solo un poeta, William Carlos Williams, figura di spicco della poesia americana del Novecento.
Paterson, il suo capolavoro, è un grande poema in cinque parti composte in decenni, che in italiano comparve nel 1972 per le edizioni Accademia senza essere mai più ristampato, col sottotitolo Un uomo come una città. L’opera è l’epopea di una città (Paterson) e di un giovane Paese (l’America) che non ha un’antica storia mitica alle spalle e perciò ne reclama e ne inventa una, con un simbolismo che la avvicina a The bridge del grande Hart Crane, inno al ponte di Brooklyn metonimico di una New York avveniristica, e all’immensità dell’America.
 Paterson parte da un’identificazione del poeta, dell’uomo, con la città, come sua proiezione nel mito e nella storia, come sogno dell’artista che incarna la realizzazione degli ideali suoi e di generazioni di uomini e donne sperduti in un continente sterminato, dove a mano a mano avviene la conoscenza dell’ambiente naturale e in esso dei suoi insediamenti affettivi e civili, e infine di sé.
Paterson parte da un’identificazione del poeta, dell’uomo, con la città, come sua proiezione nel mito e nella storia, come sogno dell’artista che incarna la realizzazione degli ideali suoi e di generazioni di uomini e donne sperduti in un continente sterminato, dove a mano a mano avviene la conoscenza dell’ambiente naturale e in esso dei suoi insediamenti affettivi e civili, e infine di sé.La città è come il suo “secondo corpo” (come recita l’epigrafe di Saroyan in testa alla terza parte del poema). In essa e attorno ad essa, il ponte, la diga, la biblioteca, la fabbrica, sono altrettanti nuclei di una saga in cui uomo e natura, uomo e donna, forza generativa originaria, e i loro simboli (città, fiume, cascata, colline) si incontrano, amandosi o lottando corpo a corpo, mentre gli uomini si incontrano all’insegna delle emozioni e del diritto, o dei suoi mancati riconoscimenti.
Willams era ugualmente sensibile al fascino delle acque e dei boschi come agli scioperi operai, che seguì con particolare attenzione e coinvolgimento da poeta e pediatra qual era, in posizione di particolare vicinanza ai bisogni e alle sofferenze delle famiglie più povere. Anche Williams, come chi cantò i miti nell’antichità, trovava ispirazione e riscontro nella pittura, che rappresentava quel mondo in divenire nella sua cruda quotidianità e nel suo bisogno di iscriversi in un tempo sacro, da Bruegel, cui dedicò una raccolta (Immagini da Bruegel e altre poesie), ai contemporanei come Georg Luks, Robert Henri e John Sloan, per esempio, che ci indica Alfredo Rizzardi nella sua Introduzione alla traduzione italiana di Paterson.
La città poetica, la Paterson immaginaria di Williams, ha offerto lo spunto del film omonimo di Jim Jarmusch del 2016, che è un grande omaggio alla poesia, all’incrocio fra persona e terreno in cui vive, come rappresentazione trasfigurante del quotidiano e dell’assoluto sulla terra. Non del mondo, come guida per l’uomo, risuona ovviamente anche nelle cosiddette società “tradizionali”. Ad esempio nella narrazione dei prodigiosi eventi delle origini nella notte dei tempi dei Dogon, appartenenti alla civiltà del Verbo vivente e creatore, fatta dal cieco Ogotemmeli, “gran cacciatore di Ogol-basso”, riportata da Marcel Griaule in Dio d’acqua (1966). Ogotemmeli in trentatré giorni dell’anno 1946 narrò al visitatore europeo come in un tempo immemorabile si era costituita la sua civiltà, secondo una scansione di tappe ed eventi che suggerivano il loro senso profondo entro un complesso sistema simbolico. E spiegò come erano comparse quotidiane opere di lavoro e riflessione, dalla filatura alla classificazione delle cose, dall’enumerazione degli antenati e delle discendenze, e dal riconoscimento della natura divina della parola, alla narrazione di ciò che riguarda la “seconda” e la “terza” parola, alla rammemorazione del “sistema del mondo”, alla devozione per la pittura che ospitando acque e stelle aiuta il mondo a perdurare...
Anche il resoconto di Bruce Chatwin, nel libro Le vie dei canti, dicendo del modo di alcune popolazioni aborigene dell’Australia di descrivere col canto aree di territorio da loro abitate, conferma la centralità del canto e della musica nello sviluppo della civiltà. Ad ogni luogo, ad ogni credenza che ad esso è collegata, ad ogni cosa che si trova o si vede lungo una strada di un loro territorio, si associa una particolarità del canto che attraverso il suo ritmo e la sua intonazione, il suo “andamento melodico” al di là delle parole, descrive con frasi musicali e con la loro successione le caratteristiche del luogo, le distanze percorse, i movimenti dei piedi dell’antenato mitico e gli ostacoli che ha superato e quante volte lo ha fatto. La musica fa trovare la via che si cerca.
Metaforicamente, l’indicazione della via va oltre il terreno, mettendo a frutto i doni del contatto creativo ininterrotto fra umano e non umano.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours"). Un testo di Patricia Klindienst (trad. di Maria G. Di Rienzo)
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINCINQUE SECOLI” DI LETARGO: "SE NON RIDIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI" (Mt. 18, 3).
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaFederico La Sala
- "Allora vi sarà un altro Tifi e un’altra Argo" (Virgilio, Bucoliche, IV Ecloga, v. 34).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- L’American dream e la nuova sinistra americana. Che cos’è il sogno americano? (di Antonio Funiciello).25 maggio 2019, di Federico La Sala
L’American dream e la nuova sinistra americana
di Antonio Funiciello (Il Mulino, 24 maggio 2019)
Che cos’è il sogno americano? Lo storico premio Pulitzer James Truslow Adams ha scritto, in The Epic of America (1931):
- «è il sogno di una terra in cui la vita dovrebbe essere migliore, più prospera e più ricca per tutti, con opportunità per ciascuno secondo le proprie capacità o i risultati raggiunti. È un sogno difficile da interpretare adeguatamente per le classi dominanti europee... Non è un soltanto un sogno di auto nuove e salari elevati, ma un sogno di ordine sociale, nel quale ogni uomo e ogni donna devono essere capaci di raggiungere la massima realizzazione di cui sono, per natura, capaci di raggiungere; e devono essere riconosciuti dagli altri per quello che loro sono, a prescindere dalle circostanze fortuite legate alla nascita o alla posizione».
Thomas Jefferson, sempre in polemica con l’Europa classista, aveva già fissato l’obiettivo della nuova Repubblica che gli americani stavano costruendo: opporre all’aristocrazia europea dei privilegi e della ricchezza un’aristocrazia americana delle virtù e dei talenti. Una Repubblica guidata da una siffatta aristocrazia non avrebbe potuto che accrescere le proprie potenzialità e disporsi a essere lo spazio di vita migliore per quel pursuit of happiness che, in ultima istanza, è il vero fondamento e lo scopo del sogno americano.
Ma come calibrare il primato dell’American dream in una società aliena o allergica alla lotta di classe che, a partire dalla metà dell’Ottocento, infiammava invece il vecchio continente come un enorme bosco di alberi secchi? Semplice: concependo il sogno americano in un’ottica espansiva e includente. Lo suggeriva anzitutto la filosofia: quell’illuminismo schietto a cui i padri fondatori erano legati. Lo consigliava anche la geografia: in una terra così immensa per una popolazione così esigua, non c’era motivo di pensare che non ci sarebbe stato spazio e fortuna per tutti. Ma lo ispirava anche la lontananza da quell’Europa bigia e litigiosa, organizzata in società dove il destino dei singoli era strettamente legato alla discendenza familiare.
Così l’American dream divenne l’essenza dell’ethos nazionale americano: perché era un sogno che univa senza dividere; un sogno da fare insieme, eppure ognuno a casa propria; un sogno cominciato con tredici colonie, ma che non poteva avere fine perché i suoi principi erano truths to be self-evident in ogni luogo e in ogni tempo. E da subito, infatti, i partiti maggiori e i leader americani più importanti cominciarono a modellare la propria identità sulla base di chi meglio sapeva interpretare la capacità di espansione e il potere di inclusione dell’American dream.
Se è vero che la Guerra civile scoppiò prevalentemente per ragioni economiche, essa fu in realtà così dirompente perché si nutriva di una stringente contraddizione: negare la partecipazione attiva all’American dream a esseri umani di diversa pigmentazione di quella della maggioranza degli americani. Una contraddizione che andava sradicata almeno nominalmente, con esplicito richiamo nella legge fondamentale dell’Unione. Consapevolezza che lentamente maturò in quel secondo padre della patria che, dopo George Washington, fu Abramo Lincoln.
Da Lincoln in poi, i soggetti del bipartitismo statunitense si sono definiti in relazione al sogno americano. Nel Partito democratico, si è assistito a una divisione interna tra gli ammiratori del sogno e i loro imitatori (la suggestione kierkegaardiana è qui voluta, con il conseguente parallelo tra sogno americano e cristianesimo). Da Woodrow Wilson a John Kennedy, una lunga schiera di democratici ammiratori del sogno hanno centrato su di esso il loro racconto. Da Lyndon Johnson a Bill Clinton, un altrettanto importante insieme di imitatori, interpreti e testimoni viventi del sogno (uomini venuti dal nulla e arrivati al 1600 di Pennsylvania Avenue) hanno rafforzato, con la loro esemplare biografia, il legame della sinistra americana con il sogno.
Sia gli imitatori sia gli ammiratori dell’American dream non sono mai venuti meno - e ciò li unisce indissolubilmente - alla versione di un sogno che fosse espansiva e includente. In fondo, anche il lungo dibattito post Seconda guerra mondiale, che portò alle leggi del presidente Johnson contro l’apartheid verso i neri d’America, era un dibattito centrato sull’American dream. In particolare, i leader dei diritti civili si dividevano tra chi (Martin Luther King su tutti) concepiva la battaglia per i diritti civili come l’ennesima tappa dell’espansione includente dell’American dream a ogni cittadino e chi proponeva una versione redistributiva ed escludente del sogno.
Alla fine, com’è noto, l’ebbe vinta ancora una volta la versione originaria, quella che allarga il campo, contro quella che s’incarica di creare divisione e conflitto. Il più bel discorso politico di tutti i tempi, l’orazione di King al Lincoln Memorial di Washington, era proprio il racconto di una visione espansiva e accogliente del sogno americano («I have a dream that one day in Alabama... little black boys and black girls will he able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers»).
Oggi che nuove minoranze pesano felicemente e finalmente nella politica statunitense, e i loro rappresentanti al Congresso cominciano a farsi sentire, il punto di complessità della questione democratica che pongono è ancora una volta sull’interpretazione dell’American dream. Martin Luther King, a differenza di altri leader neri, non ha mai detto che per dare ai neri (includendoli nel sogno) bisognava togliere ai bianchi (riducendo il loro spazio nel sogno). Oggi, viceversa, molti dei leader delle minoranze che vivacizzano la nuova sinistra americana propongono un’interpretazione redistributiva ed escludente del sogno.
C’è di buono che questi leader, a parte qualche sciocchezza detta su Israele, ripudiano la violenza e si sentono appassionatamente ingaggiati nelle forme istituzionali e nei modi costituzionali dell’Unione. Tuttavia le loro battaglie sono per lo più all’insegna di una contestazione feroce dell’occupazione degli spazi politici negati dai wasp e dalle piccole minoranze ai wasp alleate. Se le loro modalità di lotta non somigliano a quelle violente degli anni Sessanta, la loro retorica non somiglia purtroppo a quella di King.
È vero: l’incremento del gap tra chi ha di più e chi ha di meno negli States è costantemente cresciuto negli ultimi anni. In particolare sotto Barack Obama, l’uscita dalla grande crisi economica è stata accompagnata da un forte indebitamento generale, con il paradossale (per un presidente di sinistra...) ulteriore aumento del gap di cui sopra. Questo problema esiste, non solo in America, ed è enorme. Ma le minoranze che animano a sinistra la politica americana, sono poste di fronte a un tema che, prima di essere sociale ed economico, è filosofico e culturale.
Limitarsi, infatti, a una critica economica e sociale delle degenerazioni del sogno rende inefficace la critica in quegli Stati, in particolare del Midwest, dove la globalizzazione e la grande crisi economica hanno fatto danni non tra le minoranze emergenti, ma nella maggioranza bianca del Paese. Le policies economico-sociali della nuova sinistra americana non possono fare breccia in quegli Stati. Se si vuole davvero che la critica produca una proposta di governo nazionale capace di essere competitiva alle prossime presidenziali, l’esercizio intellettuale e politico va impegnato anche sul fronte dell’interpretazione filosofica e culturale dell’American dream a cui ci si vuole associare.
L’American dream funziona quando non nega ad alcuno di potercela fare: un americano non può usare l’America dream contro un altro americano. Quando è successo, c’è stata la guerra tra gli americani o tensioni sociali che hanno mietuto morti e feriti. Il sogno americano o è espansivo e includente o non è il sogno americano. È un punto concettuale dirimente, con il quale la nuova sinistra americana è chiamata, che le piaccia o meno, a fare i conti.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" - di Federico La Sala.22 maggio 2019, di Federico La Sala
LA MEMORIA NELLE PAROLE. PER AMOS OZ.... *
Intervista.Fania Oz: «L’ascolto cambia il mondo»
Parla la storica israeliana: «Oggi la solidarietà è ancora viva, ma l’Europa ha il dovere di impedire che siano messi in discussione i valori fondamentali»
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, mercoledì 22 maggio 2019)
- [Foto] Fania Oz-Salzberger
- La memoria e il possibile è il tema della terza edizione di “Mens-a”, l’evento sui temi dell’ospitalità e del cosmopolitismo che da qui a settembre toccherà Modena, Vignola, Parma e Ravenna.
 Si parte giovedì 24 maggio alle 20,30 dall’Oratorio San Filippo Neri di Bologna (via Manzoni 5), con la serata dal titolo “Per Amos Oz: la memoria nelle parole”, durante la quale l’intervento di Fania Oz-Salzberger si intreccerà con le letture di Alessio Vassallo da Una storia d’amore e di tenebra, capolavoro riconosciuto del grande scrittore israeliano scomparso nei mesi scorsi: la moderazione è affidata all’ebraista Sarah Kaminski.
Si parte giovedì 24 maggio alle 20,30 dall’Oratorio San Filippo Neri di Bologna (via Manzoni 5), con la serata dal titolo “Per Amos Oz: la memoria nelle parole”, durante la quale l’intervento di Fania Oz-Salzberger si intreccerà con le letture di Alessio Vassallo da Una storia d’amore e di tenebra, capolavoro riconosciuto del grande scrittore israeliano scomparso nei mesi scorsi: la moderazione è affidata all’ebraista Sarah Kaminski.
 Tra venerdì e sabato si susseguiranno, sempre a Bologna, gli incontri con monsignor Erio Castellucci, con Benianimo de’ Liguori Caino della Fondazione Olivetti, con il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, con i filosofi Francesca De Vecchi, Rocco Ronchi e Sergio Givone, con lo psichiatra Eugenio Borgna, con lo studioso di estetica Pietro Montani e con numerosi altri ospiti. Per infomazioni www.mens-a.it.
Tra venerdì e sabato si susseguiranno, sempre a Bologna, gli incontri con monsignor Erio Castellucci, con Benianimo de’ Liguori Caino della Fondazione Olivetti, con il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, con i filosofi Francesca De Vecchi, Rocco Ronchi e Sergio Givone, con lo psichiatra Eugenio Borgna, con lo studioso di estetica Pietro Montani e con numerosi altri ospiti. Per infomazioni www.mens-a.it.
Fania Oz-Salzberger non ha dubbi: «Le parole possono peggiorare o migliorare il mondo - dice - ma ascoltare gli altri, ascoltarli veramente, può soltanto migliorarlo». È il suo modo di reinterpretare l’eredità ricevuta dal padre, il grande romanziere israeliano Amos Oz, morto a Tel Aviv negli ultimi giorni del 2018. Insieme, alcuni anni fa, avevano scritto un libro illuminante, Gli ebrei e le parole, edito in Italia da Feltrinelli. Ed è proprio sul legame strettissimo fra memoria, linguaggio e destino che la studiosa, docente di Storia delle idee all’Università di Haifa, si soffermerà domani a Bologna durante la lezione inaugurale di Mens-a, l’evento internazionale sul pensiero ospitale e il cosmopolitismo in calendario fino a sabato. «Ma c’è un’altra parola che aggiungerei alla lista», osserva Fania Oz-Salzberger.
Quale?
Verità. Mentre lavoravamo al libro, mio padre e io ci interrogavamo spesso sul suo significato. In che senso, mettiamo, un racconto biblico va considerato “vero”? Abramo e Sara potrebbero anche non essere esistiti, eppure la loro storia ha cambiato il mondo. Anche la verità letteraria non si basa sui fatti: Amleto non è una figura storica, ma attraverso di lui Shakespeare continua a svelarci qualcosa che si annida nella profondità della natura e dell’esperienza umana. “I fatti possono essere i peggiori nemici della verità”, ha dichiarato mio padre. Un racconto d’invenzione riesce a toccarci in maniera molto più autentica e decisiva rispetto alle notizie del telegiornale.
Scopriamo qual è il nostro destino?
Ecco, questo è un termine sul quale ci siamo subito intesi, mio padre e io. Essendo ebrei secolarizzati, siamo sempre stati persuasi che la storia sia un prodotto dell’azione umana e delle circostanze esteriori. Quanto alla memoria, la questione è più complessa: quella personale non coincide con quella storica ed entrambe differiscono da quella letteraria. Tutte insieme, però, cambiano il mondo. I ricordi di mio padre sulla madre, il modo in cui ebrei e palestinesi ricostruiscono il proprio passato, le nostre reminiscenze di lettori ( Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, nella fattispecie, influenzò molto mio padre): ciascuno di questi elementi modifica la relazione che intratteniamo con la famiglia, la tradizione, l’amore, il lutto. Entrano in gioco materiali mentali diversi, un po’ come accade con gli strumenti e i codici simbolici delle varie arti: pittura, musica, scrittura.
Qui entra in scena il linguaggio?
Ogni grande scrittore si nutre della propria lingua madre, che nel caso di mio padre era l’ebraico. Lo amava, ci giocava. In quanto storica, non posso permettermi un atteggiamento così disinvolto, ma ho comunque la facoltà di interrogare la lingua e approfondirne la comprensione. L’ebreo moderno, in questo senso, è stata la più importante startup linguistica del Novecento. Nessun’altra lingua ha avuto uno sviluppo altrettanto rapido, nessun’altra è riuscita a partire dal nulla fino a superare la soglia di dieci milioni di parlanti.
Come è potuto accadere? Grazie alla combinazione di due fattori irripetibili: l’alto livello di alfabetizzazione, specie maschile, e il permanere di una forte tradizione testuale. Ancora adesso, la Bibbia rappresenta una miniera inesauribile di espressioni, e così il Talmud, la poesia ebraica medievale, la letteratura profana. L’ebraico è una delle lingue più vive di oggi e il successo di molti autori contemporanei lo dimostra in modo eloquente.
Ma questo non contrasta con il ritorno del pregiudizio antisemita?
Mio padre amava ripetere che Hitler e Stalin, pur senza volerlo, ci hanno vaccinati contro l’odio razziale e il genocidio, ma che dopo settant’anni l’effetto del trattamento sta cominciando a svanire. L’affievolirsi della memoria risveglia i demoni e l’antisemitismo, come sappiamo, è uno tra i più feroci. Gli ebrei sono minacciati da destra e da sinistra. Da una parte li si identifica in blocco con lo Stato di Israele, giungendo a negare il loro diritto all’esistenza. Dall’altra, si torna ad accusarli di complotti globali e malefatte universali. Ci sono musulmani che si proclamano antisemiti e antisemiti che sono anche islamofobi. La discriminazione non si sposa bene con la logica.
Come si dovrebbe reagire?
Lo dico con chiarezza: è l’ora che l’Europa si prenda le sue responsabilità. A essersi rimessi in marcia, infatti, sono proprio i demoni della storia europea. Decine di migliaia di ebrei stanno lasciano la Francia, la Gran Bretagna e diversi Paesi dell’Est. Questa volta, per fortuna, hanno un posto in cui rifugiarsi, un luogo in cui sentirsi a casa. Ma un’Europa senza ebrei sarebbe ancora Europa?
Che cosa pensa dell’ondata populista?
Il filosofo Isaiah Berlin, che è stato mio maestro a Oxford, distingueva sempre tra nazionalità e nazionalismo. La prima va tranquillamente a braccetto con la democrazia, che il secondo invece non sopporta proprio. I nazionalisti amano l’ethnos, la componente etnica, e disprezzano il demos, perché la declinazione moderna del demos, ossia della cittadinanza nel suo complesso, prevede la compresenza di gruppi etnici tra loro differenti. Vogliono convincerci che nell’era del web la democrazia sia ormai fuori moda e che i social network diano una spinta al populismo, diffondendo l’odio in modo molto più rapido e capillare di quanto accada con l’amore e la solidarietà. Anche mio padre la pensava così. In questo, tra di noi, c’era una certa incomprensione generazionale. Al contrario di lui, io mi servo di internet, interagisco sulle piattaforme sociali e credo fermamente che il populismo vada combattuto dall’interno, contrastando con estrema durezza ogni incitamento all’odio presente in rete. Non abbiamo scelta: internet è una realtà irreversibile, è la piazza nella quale siamo chiamati a esprimerci, è il nostro campo di battaglia.
Anche la solidarietà è a rischio?
Lasci che le parli un po’ dell’impegno dei miei studenti a Lesbo, in Grecia. In questo momento, questo gruppo di giovani israeliani, sia ebrei che arabi, è la più efficace tra le organizzazioni non governative che operano con i rifugiati siriani raccolti sull’isola. Sono molto fiera di loro. Insieme con milioni di altre brave persone attive in tutto il mondo, dimostrano che ancora oggi amore e compassione sono più vivi e vitali che mai. Il problema è che troppo spesso il loro lavoro non viene percepito, perché è meno facile da twittare rispetto al razzismo e su Instagram risulta meno attraente di un’ereditiera viziata. Ma non possiamo dimenticare che l’attuale crisi dei migranti in Europa non deriva solo dal razzismo, ma anche da decisioni politiche inadeguate. Per accogliere milioni di persone non è sufficiente spendere qualche bella parola e neppure un bel mucchio di soldi. Occorre un serio lavoro sul campo, specie nella sensibilizzazione dei nuovi arrivati e degli abitanti di ciascun Paese, che devono essere messi in grado di capire quali valori vadano preservati e quali criteri di giustizia economico-sociale vadano rispettati. Si tratta di una transizione enorme, che purtroppo la maggioranza dei Paesi europei non ha saputo governare, accontentandosi di discorsi zuccherosi e di proclami solenni.
A che cosa si riferisce?
Trovo inaccettabile che, in nome del rispetto tra le culture, il ruolo della donna possa essere sminuito. E questo vale anche per le aggressioni agli ebrei, vale per la svalutazione dei valori fondamentali di convivenza. Se l’Europa vuole restare fedele a se stessa, deve liberarsi di queste ambiguità.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Palestina, Israele e la rinascita della lingua ebraica....
- ELIEZER BEN-YEHUDA. “Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” Memoria di ELIEZER BEN-YEHUDA]
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- PARIGI. Chiesa cattolica francese verso il riconoscimento dei figli di sacerdotI (Ansa).18 maggio 2019, di Federico La Sala
Una buona-scelta e una buona-notizia ...*
Chiesa Francia apre a riconoscimento figli sacerdoti
Le Monde, incontro segreto a febbraio, a giugno vedranno vescovi
di Redazione ANSA *
PARIGI. Apertura senza precedenti della Chiesa cattolica francese verso il riconoscimento dei figli di sacerdoti, secondo quanto annuncia oggi Le Monde. Stando a informazioni del quotidiano, alcuni figli di preti sono stati ricevuti per la prima volta da un responsabile ecclesiastico francese e a giugno testimonieranno davanti ad alcuni vescovi.
Tre figli di sacerdoti, membri dell’associazione francese Les Enfants du silence (in tutto una cinquantina di figli di preti) sono stati ricevuti per la prima volta - su loro domanda - da un responsabile ecclesiastico.
L’incontro, fin qui segreto, si è svolto il 4 febbraio a Parigi, nella sede della Conferenza episcopale di Francia (CEF). Per un’ora e mezzo, ad ascoltare la loro testimonianza, finora un tabù per la Chiesa, è stato il segretario generale, Olivier Ribadeau-Dumas. Una discussione "cordiale e costruttiva" secondo quanto spiegato dall’interessato, che ha ascoltato le "sofferenze" di questi uomini e donne abituati ad essere educati in una sorta di sentimento di vergogna e nel segreto, come "figli del peccato". Sempre secondo il quotidiano, gli esponenti di Les Enfants du Silence, "testimonieranno a giugno davanti ad alcuni vescovi".
*Sul tema, nel sito, si cfr.:
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA
Europa ed Evangelo. Una buona-scelta e una buona-notizia ...
 UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". -SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". -SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- I saldi princìpi ribaditi dall’euro-sentenza (di Giuseppe Anzani)15 maggio 2019, di Federico La Sala
Questa civiltà è da difendere.
I saldi princìpi ribaditi dall’euro-sentenza
di Giuseppe Anzani (Avvenire, mercoledì 15 maggio 2019)
Uomini in fuga, il mondo ne è pieno. Non attratti da un miraggio, ma spinti da una disperazione. Si fa presto a dire che sarebbe meglio che ognuno restasse a casa sua, in pace e sicurezza. I rifugiati sono uomini (e donne e bambini) che nel loro Paese patiscono persecuzione, o vivono nella paura, per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche.
A loro il mondo ha dedicato una Convenzione nel 1951, impegnando gli Stati, fra l’altro, a non prendere sanzioni penali, a motivo del loro ingresso o del loro soggiorno illegali, a carico di quei rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate. Già in questo originario principio brilla una sorta di gerarchia delle ragioni di giustizia sopra le formule legalistiche: le une e le altre stanno nel cerchio del diritto, simultanee, e però vita e libertà vincono non per violazione di disciplina, ma per giuridica preminenza.
Più vicino ai nostri anni, nel 2011, l’Unione Europea ha emanato una Direttiva che impegna gli Stati membri ad assicurare ai rifugiati «il pieno rispetto della dignità umana» e il diritto d’asilo. La parola "dignità" è pregnante, nel diritto europeo: essa dà titolo al primo capitolo della "Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea" e compendia una sorta di statuto elementare e insopprimibile degli esseri umani. Il trattamento che ne discende è un corollario coerente.
In Italia, benché se ne parli così poco che par dimenticato (o a bella posta negletto) l’articolo 10 della Costituzione dice che ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni di legge, lo straniero «al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana». Non dunque solo la fuga dalla persecuzione, dalla tortura, dalla guerra; persino la mancanza delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, cioè il ventaglio intero dei diritti umani disegnato dai nostri Padri.
Questo sistema ispirato al soccorso irrinunciabile delle vittime dell’oppressione, così ben scritto, appare oggi contraddetto da una riluttanza che s’è gonfiata in ostilità; ha alzato muri di pietra e di filo spinato, ma non solo: ha costruito maglie fitte di editti e norme e grida e comandi volti a impedire, a ostacolare, a scacciare. Ma ieri la Corte Europea di Giustizia ha dato una sterzata.
C’erano tre rifugiati (un ceceno nella Repubblica Ceca, due africani in Belgio), che avevano commesso reati e subito condanne; per loro c’era il rifiuto o la revoca dell’asilo e della protezione, si profilava l’espulsione e il rimpatrio. Verso un destino pauroso. La risposta di giustizia è stata ’no’.
La Corte ha sentenziato che «gli Stati membri non possono allontanare, espellere o estradare uno straniero quando esistono seri e comprovati motivi di ritenere che, nel Paese di destinazione, egli vada incontro a un rischio reale di subire trattamenti proibiti dalla Carta europea», cioè torture o trattamenti inumani o degradanti. La sentenza, emessa dal massimo organo giurisdizionale dell’Unione, ora vincola tutti.
Anche il reo, il condannato che espia la pena, non può diventare uno scarto da riconsegnare ai suoi aguzzini. Perderà quel che perderà, ma non il suo essere uomo, e i diritti dell’uomo. C’è un’ultima pennellata, infatti che ce lo rammenta, e a suo modo sposta di nuovo l’attenzione dal legalismo alla realtà del diritto-giustizia: l’uomo cui è stato revocato lo ’status’ (legale) di rifugiato, se in concreto è un fuggiasco per i motivi di persecuzione che abbiamo visto, resta lo stesso un ’rifugiato’, e conserva il diritto umano alla ’protezione internazionale’ secondo la Carta europea. Prendiamone definitiva nota, difendiamo questa civiltà e siamone all’altezza: è nostra e condivisa col mondo.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- A BERLINO, UN MUSEO DELL’ESILIO. La scintilla è una lettera di un’illustre esule, Herta Mueller, ad Angela Merkel.13 maggio 2019, di Federico La Sala
La storia
Alla vecchia stazione Sud
Da Freud a Brecht un museo a Berlino per i grandi esiliati
Mezzo milione di tedeschi e austriaci scapparono dal nazismo. La Germania li ricorda con un omaggio ai geni in fuga
di Tonia Mastrobuoni (la Repubblica, 13.05.2019)
BERLINO Thomas Mann lo chiamava "l’asma del cuore". È il dolore dell’esilio, il destino che colpì innumerevoli ebrei e oppositori del regime costretti dai nazisti a scappare, ad abbandonare i loro Paesi d’origine. Secondo alcune stime, si trattò di mezzo milione di persone - 360mila tedeschi, 140mila austriaci. C’è ormai un’ampia letteratura su Marlene Dietrich e Billy Wilder e la Hollywood dei tedeschi e degli austriaci. O sulla colonia dei Brecht, dei Mann, dei Feuchtwanger e degli Adorno che trascorsero il dodicennio più buio della storia tedesca sulla costa californiana, tra Pacific Palisades e Santa Monica. E tra quelle centinaia di migliaia di esuli, fuggiti non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, ci sono ovviamente geni come Walter Gropius, Hannah Arendt, Hedy Lamarr, Albert Einstein o Sigmund Freud.
In Germania, Paese attentissimo alla memoria storica e soprattutto alla ricostruzione dei crimini del nazismo, mancava finora un museo dedicato all’"asma del cuore", alle sofferenze e alle vite gli esuli - come dimenticare Stefan Zweig che si tolse la vita all’estero o Willy Brandt che fu meschinamente accusato di aver trascorso gli anni del nazismo in Norvegia. E così la capitale che più di ogni altra è abituata a mostrare al mondo le cicatrici del Novecento, Berlino, ha deciso di dedicare finalmente un museo a questo importante pezzo di storia tedesca e austriaca.
La scintilla è una lettera del 2011 di un’illustre esule, il Nobel della letteratura Herta Mueller, ad Angela Merkel. Allora la scrittrice scappata a Berlino trent’anni fa dalla Romania di Ceaucescu, scrisse alla cancelliera che «in nessun luogo di questo Paese esiste un posto che possa spiegare il significato dell’esilio attraverso il racconto di singoli destini. I pericoli della fuga, la vita sofferta nell’esilio, l’estraneità, la paura e la nostalgia di casa». Secondo la grande scrittrice cresciuta nella minoranza tedesca in Romania, «un Museo dell’Esilio potrebbe aiutare i giovani a capirne il significato. Sarebbe un esercizio di educazione alla partecipazione».
Entro il 2025 i terreni intorno all’Anhalter Bahnhof, la vecchia stazione sud di Berlino da cui partivano i treni per l’estero ma anche quelli per Auschwitz, ospiterà 4.000 metri quadri di video e documenti, comprese interviste che gli organizzatori stanno svolgendo in questi mesi agli esuli ancora vivi.
Finora al progetto per un Museo dell’Esilio si sono messi a lavorare a testa bassa soprattutto i privati.
Il fondatore della casa d’aste Villa Grisebach, Bernd Schultz, che lo ritiene «un progetto del cuore» e ha già investito sei milioni di euro per avviare la fondazione. E la squadra che si è buttata a capofitto nel progetto, e che, a parte Schultz, conta altri cervelli illustri. C’è l’ex direttore del meraviglioso museo della Storia tedesca ed ex assessore alla Cultura della capitale, Christoph Stoelzl e le note curatrici Meike-Marie Thiele e Cornelia Vossen.
Schultz ha raccontato al quotidiano Tagesspiegel che dal 1965 colleziona arte e che «in centinaia di viaggi a New York, in California, a Londra e ovunque nel mondo ho incontrato esuli, le loro collezioni, le loro perdite, i loro destini - e il debito che abbiamo nei loro confronti. L’esilio fa parte della memoria collettiva di questo Paese. Chi può ricordare al giorno d’oggi, ad esempio, che Lucian Freud era nato a Berlino?».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- "Europa matrigna" (Thierry Vissol). La Ue e il fattore «identità» (di V. Castronovo).12 maggio 2019, di Federico La Sala
La Ue e il fattore «identità»
Thierry Vissol. Di fronte all’affermazione di populisti e sovranisti, le istituzioni comunitarie devono essere capaci di costruire un modello fondato sulla solidarietà sociale e sullo sviluppo competitivo a livello globale
di Valerio Castronovo (Il Sole-24 Ore, Domenica, 12.05.2019)
Di questi tempi, in cui il discorso pubblico sulla governance e il futuro dell’Unione europea ha finito, nel nostro Paese, per essere dominato dalle irruenti sortite polemiche di sovranisti e populisti, risulta istruttiva un’analisi ponderata come quella condotta da Thierry Vissol. Oltre a contare sulla sua lunga esperienza di ex funzionario della Commissione europea, egli è uno storico ed economista, abituato quindi a valutare determinati eventi e fenomeni in base a metri di giudizio aderenti alla complessità del reale e non circoscritti al breve periodo.
Pertanto Vissol sottolinea, da un lato, quale importanza hanno avuto le conseguenze dei mutamenti strutturali prodotti dalla triade globalizzazione neoliberista-turbocapitalismo finanziario-quarta rivoluzione industriale nell’innesco della ventata nazional-populista. Dall’altro, pone l’accento sull’impatto di un vettore multimediale ambivalente come i social network, ossia uno strumento di comunicazioni e relazioni largamente accessibile ma proprio per questo tale da generare anche effetti incongrui e distorsivi.
Per comprendere quale grave grado di pericolosità sia insito in una congerie di teoremi ed enunciati trasmessi in Rete dai social, basti pensare al fatto che essi possono influenzare gli orientamenti di una vasta platea di cittadini e di mobilitarli sulla spinta di slogan e messaggi predittivi tanto più accattivanti e seducenti quanto di facile maneggio.
Sovranisti e populisti hanno fatto, per l’appunto, un uso crescente di questa leva sia per la loro opera di proselitismo che per il consolidamento della loro audience servendosi non solo delle armi classiche della dialettica politica ma, all’occorrenza, anche di tesi semplificatorie, di narrazioni non documentabili o prive di adeguate argomentazioni, di informazioni parziali e subdole.
D’altronde, nell’età digitale, non sono necessari consistenti apparati di propaganda e di orchestrazione della psicologia di massa, poiché le tecnologie infotelematiche offrono ampie possibilità di conseguire risultati analoghi, se non superiori, a quelli raggiunti in passato nell’organizzazione dall’alto del consenso.
Sta di fatto che l’utilizzo in chiave strumentale dei nuovi mass media, tanto più col supporto di piattaforme in esclusiva, ha un’incidenza politica rilevante, dato che la questione dell’identità riveste oggi un ruolo centrale agli effetti del rilancio o meno della causa europeista.
A questo proposito ben sappiamo come l’indirizzo dell’austerità perseguito dalla Ue, dopo la Grande crisi esplosa nel 2008, al fine di scongiurare il rischio di un’instabilità sistemica di conti e debiti pubblici, sia prevalso rispetto ad adeguate misure volte alla crescita dell’economia e a sostegno dell’occupazione. Col risultato che ciò ha determinato un’ondata a raggiera di paura e disorientamento, di rabbia e protesta nei confronti delle élite politiche e dell’establishment di Bruxelles. Di qui la ricerca di motivi e fattori di rivalsa e rassicurazione che ha portato tanta gente a vedere nel nazionalismo il massimo garante dell’interesse collettivo e di protezione sociale, e nel populismo l’espressione per eccellenza delle istanze dei ceti più deboli o più vulnerabili contri i “ricchi” e i cosiddetti “poteri forti”.
In questo contesto sovranisti e populisti, anche in quanto mirano all’avvento di una democrazia diretta, sostenendo che al popolo spetta esercitare il potere senza bisogno di alcuna forma di rappresentanza e intermediazione, sono divenuti promotori di un genere d’identità imperniato non solo sull’appartenenza a una determinata comunità nazionale, ma anche su un insieme di tradizioni etnico-religiose e di consuetudini autoctone, riportate quindi in auge e opportunamente reinterpretate. E ciò al fine di farne delle risorse fondamentali di cui assumere la tutela nei riguardi di minacce sociali e culturali esterne, date per certe e assodate.
Di qui la propagazione di un duplice assunto come l’ostracismo in blocco contro l’immigrazione e la restrizione dei diritti delle minoranze, quale antitesi a un’Europa aperta, liberale e pluralista.
Come Vissol rileva giustamente, è perciò cruciale la posta in gioco per le istituzioni comunitarie, in quanto devono essere oggi capaci di costruire un modello d’identità, a presidio della causa europeista, che abbia per asse portante un nuovo robusto assetto istituzionale e un nuovo sistema di congegni sia di solidarietà sociale sia di sviluppo competitivo a livello globale. Altrimenti l’Unione europea, qualora rimanga bloccata allo stadio di una compagine retta dal metodo intergovernativo, rischia di disintegrarsi. Perché resterebbe esposta sia a tendenze nazionalistiche autarchiche che a eterogenee suggestioni populiste, tali da costituire pesanti ipoteche a validi processi decisionali multilaterali di ordine strutturale, e destinata pertanto, prima o poi, a cedere terreno di fronte alla forza d’urto di colossi come Usa, Cina e India, ma pure di una risorgente Federazione russa. Di qui il paradosso e la contraddizione dei sovranisti, in quanto la “nuova Europa” che essi vagheggiano risulta in sostanza quella attuale, rappresentata dal Consiglio dei capi di Stato e di governo, dotati di un potere di veto che ognuno di loro detiene in misura paritaria.
*
 Europa matrigna. Sovranità, identità, economie
Europa matrigna. Sovranità, identità, economie
 Thierry Vissol
Thierry Vissol
 Donzelli, Roma, pagg. 231, € 19
Donzelli, Roma, pagg. 231, € 19 -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- INCONTRO DI PREGHIERA CON IL POPOLO ROM E SINTI.10 maggio 2019, di Federico La Sala
INCONTRO DI PREGHIERA CON IL POPOLO ROM E SINTI
PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Sala Regia
Giovedì, 9 maggio 2019 *
Delle cose che ho sentito, tante mi hanno toccato il cuore, ma prendiamone una per incominciare, poi arriveranno le altre.
Questa mamma che ha parlato, mi ha toccato il cuore quando ha detto che lei “leggeva”, “vedeva” la speranza negli occhi dei figli. Ne ha quattro, mi ha detto, e questo va bene, questi sono due. La speranza può deludere se non è vera speranza, ma quando la speranza è concreta, come in questo caso, negli occhi dei figli, mai delude, mai delude!
Quando la speranza è concreta, nel Dio vero, mai delude. Le mamme che leggono la speranza negli occhi dei figli lottano tutti i giorni per la concretezza, non per le cose astratte, no: crescere un figlio, dargli da mangiare, educarlo, inserirlo nella società... Sono cose concrete. E anche le mamme - oserei dire - sono speranza. Una donna che mette al mondo un figlio è speranza, semina speranza, è capace di fare strada, di creare orizzonti, di dare speranza.
In ambedue le testimonianze c’era sempre il dolore amaro della separazione: una cosa che si sente sulla pelle, non con le orecchie. Ti mettono da parte, ti dicono: “Sì, sì, tu passi, ma stai lì, non toccarmi”. [Si rivolge al giovane prete che ha fatto la testimonianza] In seminario, ti domandavano se chiedevi l’elemosina, se andavi a Termini... La società vive delle favole, delle cose... “No, Padre, quella gente è peccatrice!...”. E tu, non sei peccatore? Tutti noi lo siamo, tutti. Tutti facciamo sbagli nella vita, ma io non posso lavarmene le mani, guardando i veri o finti peccati altrui. Io devo guardare i miei peccati, e se l’altro è in peccato, fa una strada sbagliata, avvicinarmi e dargli la mano per aiutarlo ad uscire.
Una cosa che a me fa arrabbiare è che si siamo abituati a parlare della gente con gli aggettivi. Non diciamo: “Questa è una persona, questa è una mamma, questo è un giovane prete”, ma: “Questo è così, questo è così...”. Mettiamo l’aggettivo. E questo distrugge, perché non lascia che emerga la persona. Questa è una persona, questa è un’altra persona, questa è un’altra persona. I bambini sono persone. Tutti. Non possiamo dire: sono così, sono brutti, sono buoni, sono cattivi. L’aggettivo è una delle cose che crea distanze tra la mente e il cuore, come ha detto il Cardinale [Bassetti]. È questo il problema di oggi.
 Se voi mi dite che è un problema politico, un problema sociale, che è un problema culturale, un problema di lingua: sono cose secondarie. Il problema è un problema di distanza tra la mente e il cuore. Questo: è un problema di distanza. “Sì, sì, tu sei una persona, ma lontano da me, lontano dal mio cuore”. I diritti sociali, i servizi sanitari: “Sì, sì, ma faccia la coda... No, prima questo, poi questo”. È vero, ci sono cittadini di seconda classe, è vero. Ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente: questi sono di seconda classe, perché non sanno abbracciare. Sempre con l’aggettivo buttano fuori, scartano, e vivono scartando, vivono con la scopa in mano buttando fuori gli altri, o con il chiacchiericcio o con altre cose. Invece la vera strada è quella della fratellanza: “Vieni, poi parliamo, ma vieni, la porta è aperta”. E tutti dobbiamo collaborare.
Se voi mi dite che è un problema politico, un problema sociale, che è un problema culturale, un problema di lingua: sono cose secondarie. Il problema è un problema di distanza tra la mente e il cuore. Questo: è un problema di distanza. “Sì, sì, tu sei una persona, ma lontano da me, lontano dal mio cuore”. I diritti sociali, i servizi sanitari: “Sì, sì, ma faccia la coda... No, prima questo, poi questo”. È vero, ci sono cittadini di seconda classe, è vero. Ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente: questi sono di seconda classe, perché non sanno abbracciare. Sempre con l’aggettivo buttano fuori, scartano, e vivono scartando, vivono con la scopa in mano buttando fuori gli altri, o con il chiacchiericcio o con altre cose. Invece la vera strada è quella della fratellanza: “Vieni, poi parliamo, ma vieni, la porta è aperta”. E tutti dobbiamo collaborare.Voi potete avere un pericolo... - tutti abbiamo sempre un pericolo - una debolezza, diciamo così, la debolezza forse di lasciar crescere il rancore. Si capisce, è umano. Ma vi chiedo, per favore, il cuore più grande, più largo ancora: niente rancore. E andare avanti con la dignità: la dignità della famiglia, la dignità del lavoro, la dignità di guadagnarsi il pane di ogni giorno - è questo che ti fa andare avanti - e la dignità della preghiera. Sempre guardando avanti. E quando viene il rancore, lascia perdere, poi la storia ci farà giustizia. Perché il rancore fa ammalare tutto: fa ammalare il cuore, la testa, tutto. Fa ammalare la famiglia, e non va bene, perché il rancore ti porta alla vendetta: “Tu fai così...”. Ma la vendetta io credo che non l’avete inventata voi. In Italia ci sono organizzazioni che sono maestre di vendetta. Voi mi capite bene, no? Un gruppo di gente che è capace di creare la vendetta, di vivere nell’omertà: questo è un gruppo di gente delinquente; non la gente che vuole lavorare.
Voi andate avanti con la dignità, con il lavoro... E quando si vedono le difficoltà, guardate in alto e troverete che lì ci stanno guardando. Ti guarda. C’è Uno che ti guarda prima, che ti vuole bene, Uno che ha dovuto vivere ai margini, da bambino, per salvare la vita, nascosto, profugo: Uno che ha sofferto per te, che ha dato la vita sulla croce. È Uno, come abbiamo sentito nella Lettura che tu hai fatto, che va cercando te per consolarti e incoraggiarti ad andare avanti. Per questo vi dico: niente distanza; a voi e a tutti: la mente con il cuore. Niente aggettivi, no: tutte persone, ognuno meriterà il proprio aggettivo, ma non aggettivi generali, secondo la vita che fai. Abbiamo sentito un bel nome, che include le mamme; è un bel nome questo: “mamma”. È una cosa bella.
Vi ringrazio tanto, prego per voi, vi sono vicino. E quando leggo sul giornale qualcosa di brutto, vi dico la verità, soffro. Oggi ho letto qualcosa di brutto e soffro, perché questa non è civiltà, non è civiltà. L’amore è la civiltà, perciò avanti con l’amore.
Il Signore vi benedica. E pregate per me!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- La domanda di Enea da cui si origina l’Europa. Ma quale Patria? Si chiama Matria ed è la nostra lingua (di massimo Cacciari).7 maggio 2019, di Federico La Sala
L’OCCUPAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LINGUA ITALIANA: L’ITALIA E LA VERGOGNA.... *
Ma quale Patria? Si chiama Matria ed è la nostra lingua
Dalla nostalgia di Enea per la terra perduta alle radici dell’Europa la vera appartenenza è nell’idioma. Come sapevano bene Dante, Machiavelli e Leopardi. Una dimora che va difesa da chi oggi la vuole ridurre a chiacchiera
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 07.05.2019)
Dove trovare la Patria? Dove porre sede e finalmente cessare di inseguirla? È questa la domanda di Enea da cui si origina l’Europa - domanda forse ormai totalmente dimenticata. Gli dèi hanno decretato che per l’eroe sarà l’Italia questa patria. Ma l’Italia gli fugge sempre. All’eroe fuggitivo risponde l’Italia che fugge. Come agli eroi avvenire fuggirà l’Europa: Dove essa inizia? Dove finisce? Quante nazioni la abitano? Quali radici la sostengono? O il suo demone consiste proprio nel non averle, nel non potersi su nulla radicare? Aveva, sì, Patria Enea, anzi: la Patria, Troia. Ilio sacra è l’immagine della città perfetta, governata dal Re giusto e buono, abitata da chi ritiene massima virtù morire per la sua salvezza.
Enea avrebbe desiderato rimanere sulle sue rovine piuttosto che affrontare il destino di inseguire l’Italia. Anche le macerie di Troia sarebbero state per lui "più" Patria di qualsiasi altra futura. Ma la Patria è stata distrutta dagli Achei, dal potente connubio di astuzia e violenza che ne caratterizza l’esercito, una massa sradicata dai propri paesi, da anni lontana da ogni domestico affetto. Molti di loro non faranno ritorno, il più grande muore esule sotto le mura di Ilio; chi li ha guidati a costo di sacrificare la figlia viene assassinato appena mette piede in quella che pensava essere la propria dimora. Sciagurati eroi.
Con la fine di Ilio quella idea di Patria tramonta per sempre. Enea, tuttavia, fonda la nuova città mosso dalla nostalgia per essa, che lo domina. Senza la forza di tale nostalgia Roma non sarebbe mai sorta. Ma Roma non sarà Ilio, non ne conserverà la lingua, non sarà mai la città compiuta in sé, armoniosamente contenuta nei propri limiti; sarà invece la città-che-cresce, la città che-si-muove, Civitas augescens, Civitas mobilis, la città insaziabile, l’impero sine fine, la urbs che vuol farsi mondo. Anche Roma crolla - e anche di Roma dura la nostalgia, per la sua lingua, per il suo diritto, per le sue arti. Anche Roma diviene la Patria che manca. Come se vere Patrie apparissero sempre i luoghi che abbiamo perduto.
Nessuno ama la Patria più dell’esule da essa. Lo dice il coro delle donne troiane, che la prepotenza del vincitore trascina via schiave. Lo dice l’Ecuba euripidea, la grande accusatrice della follia dei mortali. Nel modo più tremendo lo mostra la straniera, la barbara, Medea. Sono le donne a soffrire inguaribilmente la distruzione o la perdita della Patria. Come se fossero strappate dal proprio stesso grembo. I maschi, invece, Enea, sono costretti a cercare altre terre e a convincersi che la Patria possa rinnovarsi. Ma anche per loro la nostalgia di Patria è tanto più forte e dolorosa quanto più l’avvertono smarrita. Tremendo è quando la nostalgia per la Patria che il destino ci ha rapito si combina con quella per un’altra impossibile. Fortunato Enea che alla fine la raggiunge, per quanto essa sia tale da non poter mai davvero sostituire l’antica. Vi è chi, invece, deve eternamente inseguire l’Italia che fugge.
Sventura tipica, sembra, delle nostre genti. Dante ha perduto la sua Firenze, che tanto più ama quanto più ne disprezza i nuovi padroni e costumi - e anela a un’Italia che sempre più gli appare irrealizzabile. Penoso è quando la terra che ti ha generato è stata distrutta o, peggio, ti è diventata straniera, e un’altra ne immagini, come anche salvezza della prima, continuamente contraddetta dalla realtà, fino ad apparire impossibile. La sorte di Dante si ripete in Machiavelli. E in quanti altri lungo tutta la nostra storia: il luogo della nostra origine è perduto, è divenuto irriconoscibile, oppure (Leopardi) è stato per noi sempre come un esilio, e la Patria, l’Italia, che abbiamo immaginato, sperato, pensato, resta ancora sempre da fare, un avvenire eterno. Ecco, quante volte la sua idea è sembrata realizzarsi, e subito dopo naufragare di nuovo.
Non resta forse altra vera Patria che la lingua. Lo dicono, in fondo, tutti i poeti esuli (Thomas Mann, ad esempio) nel tempo in cui le più grandi miserie si abbattono sui loro paesi. Abitare la lingua con tutta la cura possibile, questo ci è dato, coltivarla, arricchirla nel dialogo con altre, renderla sempre più capace di tradurle in sé. La lingua tanto più è ricca quanto più accoglie.
Cosi dovrebbe essere anche la Patria. Come la Patria non è un mezzo, uno strumento a nostra disposizione per perseguire i nostri, particolari fini, cosi non è un mezzo la lingua per informarci di questo o di quello. È pensiero, storia, cultura, e noi dobbiamo essere coloro che la trasformano custodendola.
La lingua è Matria, però, assai più che Patria; la lingua è materna. Dire che la nostra autentica Patria è la lingua significa affermare che nessuna Patria dovrà più essere a immagine del Padre Potente, della civiltà dominata dalla figura dell’onnipotenza del Padre Padrone. Sì, nella lingua è possibile dimora anche allorché naufraga la Patria.
Tuttavia anch’essa è dimora fragilissima. E, a differenza della Patria, i barbari che la minacciano stanno sempre all’interno dei suoi confini: sono coloro che la parlano facendone strame, che la riducono a frase e a chiacchiera, a strumento facilmente manipolabile, pronto per l’uso. Se resiste la Matria, la Patria non sarà mai impossibile, per quanto possa sempre apparire fuggitiva. Ma se la Madre lingua è perduta, allora la lingua che parleremo sarà comunque straniera e la vita un esilio.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI TROIA: L’ANALISI DI CARLO LEVI.
- TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
L’OCCUPAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LINGUA ITALIANA: L’ITALIA E LA VERGOGNA.
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza"
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- "Notre Dame" ( La preghiera di san Bernardo alla Vergine).16 aprile 2019, di Federico La Sala
PianetaTerra
Europa Francia Parigi
"Notre Dame"
La preghiera di san Bernardo alla Vergine
(Dante Alighieri, Paradiso, Canto XXXIII)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- "L’archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia" (Maria Pia Donato).12 aprile 2019, di Federico La Sala
Storia.
Il sogno di Napoleone: l’archivio dell’impero
Bonaparte aveva capito che, controllando la memoria dei popoli, li si teneva in pugno e si poteva scrivere la storia come prova della legittimità del proprio potere
di Edoardo Castagna (Avvenire, giovedì 11 aprile 2019)
- [Foto] Il ritratto di Napoleone dipinto da François Gerard François Daunou
Del saccheggio napoleonico di opere d’arte, con i lunghi strascichi relativi alle restituzioni o alle mancate restituzioni, molto si è scritto. Assai meno del saccheggio di uomini, della “carne da cannone” razziata come e più di quadri e statue in ogni angolo d’Europa, per finire seppellita tra le colline boeme o nelle steppe di Russia. Tutti iscritti all’anagrafe della storia come “francesi” sebbene in gran parte francesi non fossero affatto, come lo stesso Napoleone si premurò poi di rimarcare. Ma le appartenenze nazionali, così come le tradizioni storiche e le memorie collettive, si costruiscono. Ed è per questo che tra i tanti saccheggi napoleonici uno, perseguito con particolare tenacia, si concentrò sugli archivi delle varie capitali via via occupate e inglobate nell’Impero.
Vicenda meno nota di altre, ben ricostruita da Maria Pia Donato nel suo L’archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia (Laterza, pagine 170, euro 19,00). La sua versione dell’eterno sogno della biblioteca universale si declinò utilitaristicamente verso la condensazione sotto un unico controllo di quella che avrebbe dovuto essere la fonte primaria sia per la scrittura della storia nei secoli a venire, sia per la costruzione di una tradizione e di un’identità comune a tutta l’Europa posta sotto lo scettro di Napoleone, in ideale rimando all’unità medievale dei “due soli” a cui esplicitamente tale operazione si ispirò. Furono infatti la conquista, nel 1809, degli archivi del Sacro Romano Impero e del Papato a mettere in moto la macchina accentratrice dell’archivio dell’Impero.
Come in tante altre occasioni, la storia seguiva la propria strada indipendentemente dalla volontà degli uomini, tanto che l’idea di centralizzare gli archivi europei, sottolinea la Donato, seguì e non precedette l’inizio della sua realizzazione: il suo Napoleone è perfettamente tolstojano, in balìa di quegli stessi eventi epocali che si illude di governare. Stando al trattato con l’Austria nel 1809, avrebbero dovuto passare sotto controllo francese soltanto gli atti relativi ai territori ceduti agli occupanti: i quali invece, con militaresca ruvidità, prelevarono in blocco le carte conservate a Vienna, quali che fossero e di ogni epoca. Furono riempite oltre 2.500 casse, caricate sui carri e spedite a Parigi.
Simile fu la brutalità con la quale si procedette al- l’acquisizione degli archivi di Roma, il cui sequestro in realtà fu, almeno inizialmente, funzionale alla volontà di Napoleone di mettere sotto pressione il Papa: tanto che nel 1813, quando l’imperatore credette di averla spuntata su Pio VII, ordinò la restituzione delle carte. Per rimangiarsela, naturalmente, quando mutò nuovamente idea sul conto del Pontefice. Nel frattempo però, e anche in contraddizione con i tatticismi politici del momento, maturava in lui e nei suoi collaboratori «l’idea di creare un sito centrale della memoria per l’impero, anzi una grandiosa raccolta delle testimonianze scritte della civiltà», nota la Donato; via via furono acquisiti gli archivi olandesi, spagnoli, piemontesi, belgi, della galassia di staterelli tedeschi.
A sovrintendere al tutto fu l’archivista capo Pierre-Claude-François Daunou: ex prete, ex illuminista, ex fervente repubblicano, infine comodamente adagiato nell’ordine bonapartista (al quale peraltro sarebbe sopravvissuto). Nella sua opera trasfuse, al pari di quella contemporanea e simmetrica dei curatori del Louvre, del Jardin des plantes o della Biblioteca nazionale di Parigi, l’ideale e l’ambizione enciclopedici degli Idéologues illuministi. «Fu elaborata sul campo - nota la Donato - la dottrina che Édouard Pommier ha chiamato “la teoria del rimpatrio”, ossia l’idea che solo nella Francia rigenerata le opere delle scienze e delle arti avrebbero potuto sprigionare il loro potenziale di conoscenza ed emancipazione».
Daunou aveva ben servito Napoleone compilando un Saggio storico sul potere temporale dei papi tutto teso a mostrare le malefatte plurisecolari del Papato e le buone ragioni di un imperatore nel volerlo ridurre alla sua mercé; il Saggio venne ripetutamente riveduto e ampliato proprio grazie alle nuove fonti archivistiche divenute disponibili. Ma Daunou non era un mero cortigiano, anzi: nella sua opera di gran maestro dell’archivio napoleonico diede indubbie prove di capacità organizzative, di intelligenza pratica (fu l’inventore di quelle “schede”, uniformi per formato e ordine delle informazioni, divenute poi di uso universale fino all’avvento della digitalizzazione) e anche di un po’ di visionarietà.
Non ci fu il tempo di costruire l’immenso palazzo che avrebbe dovuto ospitare i Grandi Archivi, ma quello per affermarne la centralità storica sì: non solo, prosegue la Donato, «furono l’invenzione simbolica di un impero in cerca di radici», ma offrivano anche l’occasione di coltivare la storia pragmatica che era stata degli Idéologues. L’archivio serviva (anche) a scrivere la storia», e per questo esserne i controllori significava essere i controllori della memoria dei popoli. Nelle carte degli archivi si trovano i mattoni fondamentali per erigere quei monumenti umani collettivi che sono le identità naziona-li: una lezione, questa, che gli Stati- nazione che sarebbero sorti dopo il tramonto dell’età napoleonica, e che rientrarono in possesso dei rispettivi archivi, avrebbero ben messo a frutto.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- IN MEMORIA DI MARCEL DETIENNE. Memorie felici e concetti indelebili (Paolo Fabbri).2 aprile 2019, di Federico La Sala
A un grande ellenista che non studiava i Greci, ma voleva pensare con loro... *
Marcel Detienne: memorie felici e concetti indelebili
di Paolo Fabbri (Alfabeta, 31.03.2019).
La memoria è ospite del tempo. Viene ricevuta come lui crede e lo accoglie a modo suo. Di Marcel Detienne, da poco mancato, ho il ricordo a breve termine di qualche momento felice e di alcuni concetti indelebili.
Tra i primi, i soggiorni di ricerca sulla mitologia al Centro internazionale di semiotica e Linguistica di Urbino; la convivenza dei semiologi di A. J. Greimas e gli ellenisti di J. P. Vernant e P. Vidal Naquet al numero 10 rue m. le Prince, Parigi; un memorabile pranzo nella sua casa nella foresta di Fontainebleau, fino ai corsi dell’Escorial in Spagna, dove assistemmo, con Giulia Sissa, a un incontro di Sumo!
Ricordo infine la dichiarazione di Roland Barthes nella presentazione di una conferenza all’insegnamento del Collège de France: “un grand homme!”
Un grande ellenista infatti che non studiava i Greci, ma voleva pensare con loro. Non condivideva il tacito assunto dell’umanesimo occidentale, che fa della Grecia classica la referenza originale di valori senza tempo, misura metaculturale di ogni civiltà. Sulla scorta dello strutturalismo levi-straussiano, voleva distogliere l’occhio fisso dei filologi ellenisti (“tra i filologi c’è chi pensa e che se ne dispensa”) per indirizzarlo in una prospettiva comparativa e iscriverne la tradizione in un progetto antropologico sperimentale e costruttivo. Ad esempio, per spiegare la cosiddetta invenzione della democrazia, comparare l’esperienza italiana dei comuni medioevali e alcune comunità etiopi!
Il “dovere di comparatismo” descritto nel libro mastro Noi e i Greci, Cortina 2007, non è quello della forma originaria di un etimo con successive alterazioni, ma la ricerca della configurazione che prende un concetto una volta inserito in un corpus di culture altre. Un esperimento mentale ed empirico di laboratorio nel tessuto incessantemente ordito del politeismo per riconoscere, nel confronto delle loro filosofie implicite, l’originalità, i saperi taciti o l’impensato della Grecia classica. A questo scopo ha aperto i dossier sulla terra; sulla guerra e la caccia - che permettono l’elaborazione della metis, l’intelligenza scaltra - e soprattutto sulla scrittura, la cui invenzione era delegata a un personaggio minore, Palamede, facile vittima del versatile Ulisse.
Il confronto interculturale e l’approccio etnografico ha suscitato tenaci resistenze in luoghi recintati (“i greci non sono dei selvaggi come gli altri!”), ha permesso però a Detienne di rivedere pratiche inveterate come l’etimologia, i racconti scontati e molti concetti disciplinari “chiavi in mano”. Per lui erano centrali i rapporti tra Mito e Pensiero; Oralità e Scrittura; Filosofia e Saggezza, in rapporto alla Verità; Origine Politica e appunto, Invenzione della Democrazia.
Ne ho mandato a mente - ma preferisco il francese par coeur, - alcuni aspetti, a cui tengo e che mantengo.
In primo luogo la sua Archeologia della Verità che nel rapporto tra religione e filosofia e sofistica traccia una genealogia diversa dal logos ermeneutico e dai filosofemi heideggeriani. (“la verità epica è un oggetto culturale, non un concetto filosofico”). Nella introduzione del 1994 al suo I maestri di verità nella Grecia arcaica, Mondadori 1992, Detienne ricapitola un’epistemografia che va dalla parola sacra ed efficace del poeta, del veggente e del re fino a alla retorica laicizzata e il dibattito argomentato. Dal contarla - e cantarla - giusta al dimostrarla vera.
Quanto al Mito, oltre a Dumézil e Lévi- Strauss, è stata la ricerca insistente di Detienne a darne un’ immagine inedita e una nuova base di studi. Non ne ha cercato il senso all’interno o in allegorie esterne e neppure nell’inesprimibile che la ragione non riesce a formulare. E non lo ha studiato nel solo genere biografico degli dei e degli eroi: ha preferito riscrivere l’opposizione ottocentesca tra apollineo e dionisiaco fi cui ha ridefinito i tratti distintivi. L’energia vulcanica degli umori vitali di Dioniso e i suoi celesti misteri e l’arte troppo umana con cui Apollo dà forma, cioè taglia per fondare ed per escludere; il “Bell’ Omicida”, obliquo e agente epidemico, crea infatti e recide. (Apollo con il coltello in mano. Un approccio sperimentale al politeismo greco, Adelphi 2002)
È il concetto di Autoctonia, antica e moderna, che ha occupato gli ultimi anni dell’antropologo (Essere autoctoni. Come denazionalizzare le storie nazionali, Sansoni 2004). Un problema politico che Heidegger aveva evitato attribuendo a “polis” la falsa etimologia di “essere”. Per Detienne non c’era autoctonia in Atene e in Roma, e il concetto è l’esempio d’una “mitideologia” impiegata nella costruzione dei nazionalismi passati e, purtroppo, presenti e futuri. Il suo libro ha come sottotitolo “dal puro ateniese al francese radicato”. Uno studio rigoroso del discorso nazionalista e della sua semiurgia che investe i vaneggiamenti celtici della Lega italiana e l’immaginario sciovinista dell’accademia storica francese, che il belga Detienne trattava da “clero dell’Esagono” e in cui includeva horribile dictu! l’intoccabile F. Braudel. Per fare una nazione, motteggiava, bastano i cimiteri e degli storici inventori di tradizione.
Nella temperie attuale, che dibatte sui diritti d’asilo, e gli ius soli o sanguinis, queste pagine meritano orecchie. A Detienne fruttarono dopo lo spostamento dall’ EPHE alla Johns Hopkins di Baltimora una tenace ripulsa accademica.
La categorie epistemiche, come semplicità, coerenza, rigore ecc. sono anche virtù caratteriali dei ricercatori. Detienne era graffiante come la sua scrittura e la sua grafia. Gli era congeniale prestare l’orecchio alla “musica della dissonanza”. Fare la scelta di “di privilegiare le figure di rottura e di trasformazione radicale”. Radicalizzare strutturalmente le differenze. Non gli garbavano quanti indossavano “le tee-short con la scritta post-strutturalisti”.
Non saprei come dargli torto, io, semiologo, che gli devo la interdefinizione del sema: poros e del tekmor, nelle due accezioni di senso: quella estensiva della morfologia e quella intensiva della direzione. E la divertita scoperta che nella Grecia della geometria e della logica, le dicerie avevamo una loro dea, Femé.
I miei ricordi personali si assumono l’ovvia responsabilità del silenzio e dell’oblio che sono l’ombra inseparabile della memoria. Ci penserà la storia che della memoria è nemica giurata.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours"). Un testo di Patricia Klindienst
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- Brexit, le costituzioni e la tigre della sovranità popolare (di Francesco Palermo- "Il Mulino").1 aprile 2019, di Federico La Sala
Brexit, le costituzioni e la tigre della sovranità popolare
di Francesco Palermo (Il Mulino, 28 marzo 2019)
Il termine tedesco Schadenfreude indica la sensazione di piacere che si può provare quando a qualcuno vanno male le cose. Rallegrarsi delle disgrazie altrui, tuttavia, non solo è un sentimento negativo, ma può essere controproducente, giacché in un mondo interconnesso le sciagure altrui finiscono rapidamente per essere anche nostre. Di certo può essere un divertente e sottilmente perfido esercizio pensare a cosa avrebbe detto il mondo intero se il cortocircuito istituzionale sulla Brexit, che sta paralizzando da tre anni il Regno Unito, si fosse realizzato in Italia... Finita però la soddisfazione per lo scampato pericolo, e non potendo prevedere gli esiti di un processo nel quale la realtà supera quotidianamente la fantasia, si possono comunque avanzare un paio di riflessioni di sistema su questioni che riguardano non solo il Regno Unito, ma tutta Europa e forse tutto il mondo. Questioni sulle quali c’è poco da ridere, come sulle disgrazie altrui.
La prima è che la costituzione più antica e solida del mondo, l’unica talmente resistente da non avere avuto nemmeno bisogno di essere messa interamente nero su bianco in un unico documento, è rapidamente diventata troppo vecchia per stare al passo con la storia. I segnali ci sono già da almeno un paio di decenni (che comunque in termini di storia costituzionale britannica sono un batter di ciglia), e i vari tentativi di manutenzione che si sono susseguiti hanno solo mascherato e leggermente ritardato il declino.
Come talvolta capita alle persone anziane, che quasi all’improvviso passano da una buona forma alla condizione di moribondi, la costituzione britannica si è scoperta non più in grado di reggere le sfide della complessità moderna. Il meccanismo basato sull’onnipotenza del Parlamento, o meglio della sua maggioranza pro tempore, è andato in crisi di fronte ai paradossi delle decisioni a maggioranza. Non tutto può essere disponibile per le maggioranze parlamentari e dunque per i governi, e secoli di costituzionalismo, in buona parte nato proprio in Gran Bretagna, hanno insegnato che non basta confidare sulla responsabilità delle maggioranze, ma occorrono degli argini al loro potere.
Problema britannico si dirà? Niente affatto. Il problema è del mondo intero, perché in tempi burrascosi e difficili servono barche solide per non affondare. La costituzione britannica, a lungo vittoriosa come la flotta di Sua Maestà, si è mostrata troppo semplice e fragile nel momento in cui c’è bisogno di strumenti tecnici più sofisticati. Navigare ancora con un galeone del Settecento, per quanto straordinario fosse per quei tempi, non è consigliabile al giorno d’oggi. Mutatis mutandis vale per tutte le costituzioni: il loro mancato adeguamento tecnico le rende facilmente obsolete.
La seconda riflessione riguarda il cortocircuito del sistema decisionale. Quando la politica non è più in grado di assumere decisioni complesse, le scarica sulla popolazione. Pensando di trarne legittimità, finisce invece in un vicolo cieco. Poteva accadere col referendum sull’indipendenza della Scozia nel 2014. Ma siccome il giochino è sembrato funzionare, l’allora Primo Ministro David Cameron l’ha rifatto tale e quale con la Brexit. E gli è andata male.
Oggi, a fronte della paralisi istituzionale che si è creata, alcuni britannici e molti più europei suggeriscono l’idea di un secondo referendum. Che sarebbe un’idea più stupida della prima. Se anche i rapporti si ribaltassero, e il 52% fosse ora a favore della permanenza nell’Unione europea, cosa cambierebbe? Avremmo due risultati contraddittori presi in momenti diversi. La popolazione resterebbe spaccata e la politica ancora più confusa. E comunque non succederà, perché la tigre della sovranità popolare è già stata liberata, ha disarcionato chi provava a cavalcarla e ora ha reso prigionieri i suoi carcerieri. Quando May ripete che il popolo si è espresso e lei deve dare esecuzione alla volontà popolare dimostra tutta la debolezza del processo politico. E la dimostra proprio perché ha ragione: non ha più alternative, ormai è tardi, e un secondo referendum farebbe altri danni oltre a quelli già fatti dal primo.
Resta il problema di come decidere in contesti altamente complessi come questi. E anche il rischio che i processi decisionali siano lunghi nei tempi e insoddisfacenti nei risultati. Vero. Ma è esattamente quanto sta accadendo con la Brexit. Occorre accettare che servono freni alle maggioranze, invece di provare ad approfittare dell’effimera maggioranza del momento, chiunque l’abbia in mano. Questi freni si chiamano costituzioni. E vanno adeguati alla velocità e ai materiali moderni. Al di là della Schadenfreude momentanea, qualcuno pensa che sia un problema solo britannico?
-
> Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. --- Pianeta Terra. Clima. "L’onda verde dei giovani che sferza la politica" (di Aldo Masullo).22 marzo 2019, di Federico La Sala
Clima, Aldo Masullo: "L’onda verde dei giovani che sferza la politica"
L’analisi del grande filosofo dopo le recenti manifestazioni per l’ambiente, contro il riscaldamento globale del pianeta
di ALDO MASULLO (la Repubblica/Napoli, 22 marzo 2019)
Il mondo umano è divenuto, per dirla con Leopardi, "stretto", troppo stretto, strettissimo. Nelle catastrofi geologiche le placche continentali, premute l’una contro l’altra dai cedimenti tettonici, si accavallano deformandosi. Così il mondo che noi siamo, globalizzandosi, si è oggi compresso, schiacciato su se stesso, ha perso ogni porosità, è divenuto un blocco rigido. Tutti i suoi vuoti si sono riempiti. I buchi in cui si scaricavano i residui dei metabolismi, che toccava poi al tempo lungo distruggere, ora sono ostruiti, e il corpo del mondo, riempito dai suoi stessi escrementi, mostruosamente si gonfia. La sempre più capillare lotta tra le varie forze umane, che in se stesse senza sosta scomponendosi irresistibilmente accrescono gli scontri, non ha spazi per sia pur brevi pause. Le comunicazioni di massa e le affollate piazze elettroniche sempre più velocemente si rinviano segnali senza senso, cioè senz’altri significati che se stessi. Non c’è respiro.
In un mondo così ridotto una sola funzione lavora alla grande: la centrifugazione. L’enorme macchina mondo non fa altro che dall’immensa massa solida e opaca dei più separare la lucida liquidità dei pochissimi che hanno raggiunto il nuovo Olimpo, cioè la ricchezza e il potere, o almeno l’effimera celebrità. Le parti che la centrifugazione ha separate, restando chiuse entro la medesima strettezza, per l’inevitabile ruvidità dei loro contatti fanno attrito, e la tensione si accresce. Il bisogno senza soddisfazione possibile si fa brama rabbiosa.
Ad ogni individuo l’altro appare come una minaccia, contro cui non s’immagina difesa che non sia l’aggressione. Nessuno sopporta il suo prossimo. In tutti, anche nei mansueti, domina l’insofferenza, il cui aumento totale ancor più gonfia il mondo d’ira e di odio. Come sempre, non v’è vizio o disgrazia o pericolo, che non siano ottime occasioni per affaristi. Non mancano dunque persone e gruppi che profittano dell’ira e dell’odio per farsene supporto di potere politico. Così sulla febbre del mondo si getta acqua bollente.
Ma la febbre dipende essenzialmente dalla percezione del pericolo globalizzato. Non c’è luogo né tempo in cui poter immaginare di rifugiarsi. Crescono l’oscuro avvertimento del pericolo in agguato d’ogni parte e il presentimento di un futuro sempre peggiore. La sensazione di fondo, angosciosa, è che non c’è scampo. Peraltro, se si vuole, come si deve, ignorando le emozioni considerare lo stato delle cose con freddo giudizio, si è costretti a riconoscere che le emozioni non hanno torto.
Globale infatti è il dominio per cui si preparano a scontrarsi le massime potenze continentali; globale è il potere tecnologico a cui si mira; globale è la distruttività degli armamenti che non si cessa di accumulare; globale è lo sconvolgimento che lo sviluppo produttivo selvaggio opera nel delicato equilibrio dell’ecosistema. Sono tutti processi molto difficilmente reversibili, anzi oltre un certo limite, oltre un punto di non ritorno, irreversibili. E sono tutte minacce globali. Ma il dissesto dell’ecosistema è la minaccia che per gl’inauditi furori e i devastanti effetti del mutamento climatico è immediatamente percepibile. A questo stato d’insicurezza globale le generazioni che hanno finora gestito il mondo, sempre più impigliate negl’ingranaggi del loro sfrenato attivismo, ci hanno portati, e non sono capaci neppur di cominciare a porvi riparo.
L’allarme intanto risuona sempre più forte. Qualche giorno fa il Presidente della Repubblica ha con autorevole saggezza denunciato i rischi della "crisi climatica globale". Ma chi potrebbe fronteggiare la minaccia globale che, a partire dalla crisi climatica, incombe sul mondo, se non una forza globale, moralmente intatta, capace di ragionare in modo nuovo? In questi giorni la speranza si è accesa. "L’onda verde di una generazione può cambiare il mondo". Lo ha notato, tra gli altri, il sociologo Ilvo Diamanti a commento delle manifestazioni che venerdì scorso hanno accomunato un milione e mezzo di giovani in ogni praticabile piazza del mondo. Si tratta di una generazione "global" perché, "per quanto cresciuta in un contesto "no-global", di critica alla globalizzazione", essa di fatto si è "affermata oggi in prospettiva "globale"", "guardando "avanti", per necessità e per vocazione".
Soprattutto, nota il sociologo, i giovani nell’abbraccio di tutti con tutti hanno rotto la loro solitudine digitale, si sono sottratti alle "relazioni senza empatia", hanno rifiutato l’autosequestro nel bozzolo elettronico. Sarà forse quest’immensa onda verde giovanile un’iridescente bolla di sapone destinata in breve a dissolversi contro il potere dell’ottusità globalizzata?
 Eppure non si scherza! L’allarme degli scienziati è drastico: se le emissioni di CO2 continuano al ritmo attuale, nel 2030, cioè tra 11 anni!, si produrrà con l’aumento della temperatura una situazione globale di irreversibile disastrosità.
Eppure non si scherza! L’allarme degli scienziati è drastico: se le emissioni di CO2 continuano al ritmo attuale, nel 2030, cioè tra 11 anni!, si produrrà con l’aumento della temperatura una situazione globale di irreversibile disastrosità.Dunque per i ragazzi di oggi ne va della maggior parte della vita che hanno da vivere. Ancor più ne va per la vita delle generazioni successive, per la sopravvivenza dell’umanità stessa. In effetti nella minaccia climatica si riassumono tutte le minacce globali.
Capire ciò, capirlo sul serio, cioè agendo, è porsi in una prospettiva globale del tutto nuova: significa nel proprio vivere levarsi all’altezza del come è necessario pensare, affinché la storia umana continui.
 In ogni modo, il fatto che questa generazione di ragazzi si sia messa in movimento comporta da subito, nei giorni del nostro mondo tutto "stretto" nella sua globalità soffocante, la boccata d’aria frizzante di curiose inversioni generazionali: giovani che precedono lungimiranti gli adulti, insegnanti che imparano dagli allievi le buone pratiche, padri a cui i figli additano la via della salvezza. Un tal paradosso mette allegria prima ancora che speranza.
In ogni modo, il fatto che questa generazione di ragazzi si sia messa in movimento comporta da subito, nei giorni del nostro mondo tutto "stretto" nella sua globalità soffocante, la boccata d’aria frizzante di curiose inversioni generazionali: giovani che precedono lungimiranti gli adulti, insegnanti che imparano dagli allievi le buone pratiche, padri a cui i figli additano la via della salvezza. Un tal paradosso mette allegria prima ancora che speranza.D’un tratto sembra possibile che la globalizzazione significhi un mondo non più "stretto" ma, ancor nel linguaggio leopardiano, più "largo": non bloccato in una soffocante pienezza, dove le varie moltitudini si riducono ad altrettante fobiche identità pressate l’una contro l’altra, bensì ricchezza di spazi aperti per incontri pacifici d’innumerevoli diversità, tutte libere, insomma un universo elastico di umanità in espansione.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- GIUSTINIANO, LO STATO DI DIRITTO, E LA CINA. Il codice pronto nel 2020.17 marzo 2019, di Federico La Sala
Così gli italiani hanno scritto il Codice civile per Pechino
L’ex ministro Diliberto ha portato il diritto romano in Cina. “E’ un lavoro enorme, dalla proprietà privata all’eredità”
di Mattia Feltri (La Stampa, 06/03/2017)
- Oliviero Diliberto, 60 anni, è stato contattato nel ’98 dal governo cinese quando era ministro della Giustizia nell’esecutivo D’Alema
Roma. «È cominciata per caso», dice Oliviero Diliberto. Lo ricordate, vero? Inizi nel Pci, poi in Rifondazione, fino al 2013 leader dei Comunisti italiani. È stato ministro della Giustizia (premier Massimo D’Alema) dal ’98 al 2000. Oggi ha sessant’anni, è ordinario di Diritto romano alla Sapienza, e tutta questa breve biografia ha contribuito al caso. E cioè, nel 1998 la Cina decide di dotarsi di un codice civile. Non lo aveva, prima. A che serve un codice civile a un Paese comunista, in cui non c’è proprietà privata?
Ma nel ’98 il mondo era cambiato. «Era cambiato da un po’», dice oggi Diliberto. «Nel 1988 il professor Sandro Schipani, docente di Diritto romano a Tor Vergata, raggiunge in Cina uno studioso, Jiang Ping, che aveva conosciuto l’anno prima a Roma. Attenzione, il Muro di Berlino era ancora in piedi. E a Schipani viene l’intuizione: vi servirà un codice civile. La Cina, che veniva da un lunghissimo periodo di nichilismo giuridico, per cui la legislazione civile era una sovrastruttura borghese, capisce che il futuro è la globalizzazione e già sta evolvendo in un sistema misto, di economia statale e privata. E come gestisci un’economia così senza un codice civile?».Si sarà già capito dove stiamo andando a parare. La discussione in Cina dura a lungo: tocca decidere se adottare il Common law anglosassone o il Civil law di stampo romanistico.
«Ma intanto Schipani sta traducendo dal latino al cinese il Corpus Iuris Civilis, il fondamentale codice di Giustiniano che alla caduta dell’Impero Romano raccoglie il complesso delle leggi civili e così salva l’Europa, le dà un fondamento. E quando nel ’99 Pechino sceglie il diritto romano, si chiede: ma quale ne è la culla? L’Italia. Chi è ministro della Giustizia in Italia? Diliberto. Toh, è pure docente di diritto romano! E persino comunista! Perfetto! E così insieme a Schipani iniziamo, su richiesta cinese, a formare una classe di giuristi che poi dovranno scrivere il codice».
 Il che, grosso modo, equivale ad averlo scritto.
Il che, grosso modo, equivale ad averlo scritto.«Il codice lo scrivono benissimo i cinesi, ma c’è del vero. Hanno cominciato a venire da noi studenti cinesi, passati attraverso selezioni durissime. Oggi ne ho con me dieci ma negli anni sono stati una cinquantina, molti di loro sono diventati professori e stanno lavorando appunto al codice. In quattro anni imparano l’italiano, il latino, il diritto romano e infine scrivono la tesi di dottorato».
Ma che significa scrivere il codice civile per la Cina? Un lavoro enorme, dice Diliberto, «pensate di introdurre in un Paese giuridicamente vergine, comunista, enorme, complesso, concetti come la proprietà, l’usufrutto, la successione, la compravendita, la proprietà intellettuale per libri e brevetti. Hanno dovuto creare e introdurre i notai. Pensate le difficoltà in un Paese in cui tutta la terra è dello Stato, e ai contadini ora viene data in concessione, mentre si riconosce la proprietà privata delle aziende o delle squadre di calcio. Pensate, in una Cina che a un certo punto ammette che uno molto bravo può diventare molto ricco, al problema dell’eredità. Perché i figli non sono molto bravi, solo molto fortunati». Si è risolta con una elevatissima tassa di successione, e ogni volta che si pone una questione del genere «partono le telefonate, i consulti, si organizzano convegni».
Il codice sarà pronto nel 2020 ma intanto «sono state scritte legislazioni singole, entrate in vigore, sugli aspetti più impellenti». Diliberto ha una cattedra all’Università Zhongnan of Economics and Law di Wuhan, terza città della Cina. Va due volte l’anno per tenere lezione. Come detto, altri studenti cinesi vengono a Roma.
«La Cina ha fame e urgenza di formare giuristi che la accompagnino all’interno e nel mondo. Ma intanto anche nostri studenti vanno in Cina. Ora ce ne sono quattro a fare dottorati sul diritto civile cinese. Diventeranno merce pregiatissima, avvocati del cui sostegno avrà bisogno chiunque intenda stringere affari in Cina. La Germania è molto avanti rispetto a noi, ma il volume dei nostri affari con la Cina cresce vertiginosamente. Poche settimane fa, alla presenza del presidente Mattarella, abbiamo inaugurato alla Sapienza il più grande centro di studi giuridici cinesi d’Europa. Chiunque debba approfondire la materia verrà da noi. E ci tengo a dirlo: tutto pagato da Pechino. Dal nostro governo non è arrivato un euro».
 Rimangono un paio di dubbi.
Rimangono un paio di dubbi.Primo, ma davvero i cinesi hanno fiducia in noi? «Intanto amano la nostra cultura classica, e in particolare la musica operistica. In questo momento, pochi lo sanno, ma in Italia ci sono mille e cinquecento giovani cinesi che stanno studiando l’opera lirica. E poi i cinesi sono diversi, ragionano sulla base dei millenni, e nel loro grande orgoglio ci considerano dei pari, alla loro stessa altezza perché anche noi come loro abbiamo avuto l’impero, siamo figli di un impero che conquistava e civilizzava il mondo». Secondo dubbio, il solito: d’accordo il codice civile ma, di civile, dovrebbero esserci anche i diritti.
Diliberto non è uno che si lasci andare al romanticismo, e prevede che «i diritti arriveranno per processo naturale. Già oggi la Cina è profondamente diversa da quella di quaranta o venti anni fa. Sono leciti il mercato e la proprietà privata. E per i cinesi oggi sono fondamentali il diritto alla vita e alla sussistenza.
Il Presidente Xi Jingping ha posto tra le priorità lo “stato di diritto”, conquista enorme. Anche la politica seguirà un processo naturale, ma le trasformazioni saranno gestite dal Partito comunista, evitando qualsiasi gorbaciovismo. Sarebbe folle il contrario, come fu folle l’idea di esportare la nostra forma di democrazia: che è il prodotto di 25 secoli di storia, dall’Atene di Pericle alla rivoluzione francese. Ma i cinesi Pericle non l’hanno avuto. E tu glielo vuoi imporre da un giorno con l’altro?».
-
>LA TERRA AL "CAPOLINEA". Per lo "Strike4Climate", manifestazione che sostiene la battaglia in difesa del clima dell’attivista 16enne svedese Greta Thunberg, promotrice delle marce di giovani in tutta Europa.15 marzo 2019, di Federico La Sala
LA TERRA AL "CAPOLINEA". Manifestazioni in tutto il mondo per il salvare il pianeta...
Sciopero clima: in Italia 182 piazze da nord a sud
Gli organizzatori,no a simboli di partito o bandiere identitarie
di Redazione Ansa *
Migliaia di studenti scenderanno in piazza oggi, in 150 Paesi, per lo "Strike4Climate", manifestazione che sostiene la battaglia in difesa del clima dell’attivista 16enne svedese Greta Thunberg, promotrice delle marce di giovani in tutta Europa. La giovane è stata proposta da tre parlamentari norvegesi per il premio Nobel per la Pace. "Non c’è più tempo, anche gli adulti devono agire", dice la ragazzina e fa appello ai suoi coetanei: "Mobilitiamoci tutti per cambiamenti reali". E già decine di migliaia di giovani sono scesi in piazza in 50 città di Australia e Nuova Zelanda.
Piccole, medie e grandi città italiane per un totale 182 piazze in cui oggi i giovani daranno vita allo sciopero per il clima. Non ci saranno simboli di partito o bandiere identitarie almeno questa è la richiesta degli organizzatori, ma solo cartelli e striscioni sul tema dei cambiamenti climatici. ROMA: nella Capitale partiranno mini-cortei da scuole medie inferiori e licei e istituti, mentre dagli atei i manifestanti si muoveranno in bicicletta. Un corteo partirà dalla fermata metro Colosseo alle 10.30 per arrivare nella vicina piazza Madonna di Loreto, a pochi passi da piazza Venezia, dove alle 11 inizieranno gli interventi sui gradini. Unico adulto al microfono il geologo Mario Tozzi, poi 7 interventi di studenti delle elementari, medie, licei e università, dai 9 ai 24 anni.
MILANO: i giovanissimi attivisti attraverseranno la città con una marcia per il clima che partirà alle 9,30 da largo Cairoli e arriverà a piazza della Scala,davanti alla sede del Comune dove, dalle 11 alle 13, è prevista la manifestazione. Alle 18 un’altra manifestazione, a cui aderiscono associazioni ambientaliste come Greenpeace, partirà sempre da largo Cairoli per un corteo in difesa dell’ambiente. Sempre in città la scuola media di primo grado Pertini ha organizzato una marcia per il clima in collaborazione con Legambiente, alla quale parteciperà anche il sindaco, Giuseppe Sala, a fianco degli studenti.
 VIDEO. Manifestazioni in tutto il mondo per il salvare il pianeta
VIDEO. Manifestazioni in tutto il mondo per il salvare il pianeta*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
MASSIMO ALLARME TERRA: IL DOVERE DELLA PAURA. CINQUE MINUTI A MEZZANOTTE. Cambia il clima del pianeta, cambieranno i nostri modi di vivere, ed è sperabile che anche la politica cambi. Un’analisi di Barbara Spinelli
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- MITO E "ARCHEOLOGIA". ARACNE, PENELOPE, E "UN FALSO MITO".12 febbraio 2019, di Federico La Sala
SULLE TRACCE DI EUROPA. ARACNE, PENELOPE, E "UN FALSO MITO"... *
- IL MITO DI ARACNE (Publio OVIDIO Nasone, Metamorfosi, VI, 1-145 (trad. a cura di Bernardini Marzolla P., Einaudi, Torino 1994)
Pàllade, la dèa del Tritone, aveva seguito con attenzione il racconto. Elogiò il canto delle dee d’Aònia, e trovò giusta la loro ira. Ma poi, tra sé: “Lodare va bene, ma anche io voglio essere lodata, nemmeno io permetterò che si disprezzi la mia divinità impunemente!” E decise di rovinare Aracne della Meònia, la quale - le era giunta voce - non intendeva considerarsi inferiore a lei nell’arte di lavorare la lana. Costei, non per ceto o lignaggio era famosa, ma perché era un’artista. Suo padre, Idomone di Colofonie, tingeva la lana spugnosa con porpora di Focèa; la madre era morta, ma anch’essa era una popolana, della stessa condizione del marito. Malgrado ciò, Aracne con la sua attività si era fatta n gran nome per le città della Lidia, benché, nata appunto da umile famiglia, abitasse nell’umile Ipèpe.
Per vedere i suoi meravigliosi lavori, spesso le ninfe del Timolo lasciarono i loro vigneti, le ninfe del Pactòlo lasciarono le loro acque. E non soltanto meritava vedere i tessuti finiti, ma anche assistere a quando li faceva, poiché era un vero spettacolo. Sia che agglomerasse la lana greggia nelle prime matasse, sia che lavorasse di dita e sfilacciasse uno dopo l’altro con lungo gesto i fiocchi simili a nuvolette, sia che con l’agile pollice facesse girare il liscio fuso, sia che ricamasse, si capiva che la sua maestria veniva da Pàllade. Ma Aracne sosteneva di no, e invece di essere fiera di una così grande maestra, diceva impermalita: “Che gareggi con me! Se mi vince potrà fare di me quello che vorrà”.
Pàllade si traveste da vecchia, si mette sulle tempie una finta capigliatura bianca e prende anche un bastone che sorregga le membra piene di acciacchi. Poi comincia a parlare così: “Non tutto è male nell’età avanzata. Più si invecchia più cresce l’esperienza. Dài retta a me: ambisci pure ad essere la più grande tessitrice, tra i mortali; ma non voler competere con la dèa,e chiedile con voce supplichevole di perdonarti per quello che hai detto, o temeraria; chiediglielo, e non ti rifiuterà il perdono”.
Aracne le lancia una torva occhiata, lascia andare i fili già cominciati e a stento trattenendosi dal percuoterla, con una faccia che tradisce l’ira, così dice di rimando a Pàllade che ancora non si è palesata: “O scimunita, smidollata dalla lunga vecchiaia, vivere troppo eccome se rovina! Queste cose valle a dire a tua nuora, valle a dire a tua figlia, se ne hai una! Io mi so regolare benissimo da me, e perché tu non ti creda di aver combinato qualcosa con i tuoi ammonimenti, sappi che io la penso come prima. Perché non viene qui? Perché non accetta la sfida?”
Allora la dèa: “È venuta!”, dice, e si spoglia della figura di vecchia e si rivela - Pàllade. Le ninfe e le donne della Lidia si prostrano dinnanzi alla divinità; soltanto la vergine non si spaventa. Tuttavia trasalisce, e un improvviso rossore le dipinge suo malgrado il viso e poi ridilegua, come l’aria s’imporpora al primo comparire dell’aurora e dopo breve tempo s’imbianca, quando sorge il sole. Insiste sulla via che ha preso, e per insensata bramosia di gloria corre verso la propria rovina.
E infatti la figlia di Giove non rifiuta, e non l’ammonisce più, e nemmeno rinvia più la gara. Subito si sistemano una da una parte, l’altra dall’altra, e con gracile filo tendono ciascuna un ordito. L’ordito in alto è legato al subbio, il pettine di canna tiene distinti i fili, la spola appuntita inserisce la trama, con l’aiuto delle dita, e i denti intagliati nel pettine, dando un colpo, comprimono la trama passata tra un filo e l’altro.
Lavorano tutte e due di lena, e liberate le spalle dalla veste muovono le braccia esperte, con tanto impegno che non sentono fatica. Mettono nel tessuto porpora che ha conosciuto la caldaia a Tiro, e sfumature delicate, distinguibili appena: così, quando la pioggia rifrange i raggi solari, l’arcobaleno suole tingere con grande curva, per lungo tratto, il cielo, e benché risplenda di mille diversi colori, pure il passaggio dall’uno all’altro sfugge all’occhio di chi guarda, tanto quelli contigui si assomigliano, sebbene gli estremi differiscano. Anche intridono i fili di duttile oro, e sulla tela si sviluppa un’antica storia.
Pàllade effigia il colle di Marte nella città della di Cècrope [ATENE] e l’antica contesa sul nome da dare alla contrada. Sei dèi più sei, e Giove nel mezzo, siedono con aria grave e maestosa su scanni eccelsi: ciascuno ha come impressa in volto la propria identità; l’aspetto di Giove è quello di un re. Poi disegna il dio del mare, mentre colpisce col lungo tridente il macigno di roccia e da questo squarciato fa balzare un cavallo indomito, perché la città gli venga aggiudicata. A sé stessa assegna uno scudo, un’asta dalla punta acuminata, un elmo e l’egida per proteggere il capo e il petto; e rappresenta la terra che percossa dalla sua lancia genera l’argentea pianta dell’ulivo con le sue bacche; e gli dei che guardano stupefatti; infine la propria vittoria. Ma perché la rivale capisca da qualche esempio cosa dovrà aspettarsi per così folle ardire, aggiunge ai quattro angoli quattro altre sfide, vivaci nei colori, ma nitide nei tratti minuti. In un angolo si vedono Ròdope di Tracia ed Emo, ora gelidi monti, un tempo esseri mortali, che avevano usurpato il nome degli dei maggiori. Dall’altra parte la sorte pietosa della madre dei Pigmei: avendola vinta in una gara, Giunone impose che diventasse una gru e s’azzuffasse col suo popolo. Poi effigia Antigone, che una volta osò competere con la consorte del grande Giove e che dalla regale Giunone fu mutata in uccello: né Ilio né il padre Laomedonte poterono impedire che, spuntatele le penne, come candida cicogna applaudisse sé stessa battendo il becco. Nell’angolo che rimane Cìnira, perdute le figlie, abbraccia i gradini di un tempio, già carne della sua carne, e, accasciato sulla pietra, si staglia in lacrime.
 Contorna i bordi con rami d’olivo, segno di pace, e con la pianta che le è sacra conclude l’opera sua.
Contorna i bordi con rami d’olivo, segno di pace, e con la pianta che le è sacra conclude l’opera sua.Aracne invece disegna Europa ingannata dalla falsa forma di toro: diresti che è vero il toro, vero il mare; la si vede che alle spalle guarda la terra e invoca le compagne, e come, per paura d’essere lambita dai flutti che l’assalgono, ritragga timorosa le sue gambe. E raffigura Asterie che ghermita da un’aquila si dibatte, raffigura Leda che sotto le ali di un cigno giace supina; e vi aggiunge Giove che sotto le spoglie di un satiro ingravida di due gemelli l’avvenente figlia di Nicteo; che per averti, Alcmena di Tirinto, si muta in Anfitrione; che trasformato in oro inganna Dànae, in fuoco la figlia di Asopo, in pastore Mnemosine, in serpe screziato la figlia di Cerere. Effigia anche te, Nettuno, mentre in aspetto di torvo giovenco penetri la vergine figlia di Eolo, mentre come Enìpeo generi gli Aloìdi, e inganni come ariete la figlia di Bisalte; te, che la mitissima madre delle messi dalla bionda chioma conobbe destriero, che la madre con serpi per capelli del cavallo alato conobbe uccello e Melanto delfino. Ognuno di questi personaggi è reso a perfezione e così l’ambiente. E c’è pure Febo in veste di contadino, e le volte che assunse penne di sparviero o pelle di leone, e che in panni di pastore ingannò Isse, figlia di Macareo. C’è come Libero sedusse Erìgone trasformandosi in uva, come Saturno in cavallo generò il biforme Chirone.
 Tutto intorno alla tela corre un fine bordo, con fiori intreccisti a rami d’edera flessuosi.
Tutto intorno alla tela corre un fine bordo, con fiori intreccisti a rami d’edera flessuosi.Neppure Pàllade, neppure la Gelosia poteva trovar qualcosa da criticare in quell’opera. Ma la bionda dèa guerriera ci rimase malissimo e fece a brandelli la tela che illustrava a colori le colpe degli dèi, e trovandosi in mano la spola di legno del Citoro, tre e quattro volte colpì con quella sulla fronte Aracne, figlia di Idmone. La poveretta non lo tollerò, e corse impavida a infilare il collo in un cappio.
Vedendola pendere, Pàllade ne ebbe compassione e la sorresse, dicendo così: “Vivi pure, ma penzola, malvagia, e perché tu non stia tranquilla per il futuro, la stessa pena sia comminata alla tua stirpe e a tutti i tuoi discendenti!” Detto questo, prima di andarsene la spruzzò di erbe infernali, e subito al contatto del terribile filtro i capelli scivolarono via, e con essi il naso e gli orecchi; e la testa diventa piccolissima, e tutto il corpo d’altronde s’impicciolisce. Ai fianchi rimangono attaccate esili dita che fanno da zampe. Tutto il resto è pancia: ma da questa, Aracne riemette del filo e torna a rifare - ragno - le tele come una volta.
NOTE...
RIANDANDO CON LA MEMORIA alla “poesia” della RAGAZZA e del RAGNO, della “TARANTATA”, di Pellegrino Scardino di San Cesario, e, RICORDANDO CHE il mito di ARACNE raccontato da OVIDIO (Metamorfosi, VI, 1-145) "narra della sfida tra Athena ed Aracne sull’arte della tessitura. E’ proprio Aracne a lanciare la sfida, e ne pagherà le tragiche conseguenze: non solo ha osato sfidare la dea, ma la rabbia che suscita in Athena è nel fatto che le sue tele si mostrano addirittura superiori a quelle della dea stessa. L’ira che la fanciulla provocherà in Athena sarà tale da costringerla al tentativo di suicidarsi: non poteva reggere difatti il peso della rabbia divina. Ma la dea fermerà il tentativo di suicidio di Aracne e la trasformerà in ragno" e, ANCORA, che sul tema - come ha ricordato lo stesso Gianfranco Mele (ARACNE, LE TARANTATE, E UN FALSO MITO - il prof. Armando Polito ha offerto brillanti contributi di approfondimenti iconografici, credo sia opportuno invitare ancora e di nuovo a una lettura attenta dell’intera narrazione ovidiana, per cercare possibili ragioni del "falso mito".
CONTRARIAMENTE a quanto si è pensato e si continua a pensare, c’è un filo doppio che lega Athena e Aracne - una identità speculare (uguale e opposta) che emerge chiara dal confronto della loro situazione "familiare" e e della loro “ideologia” emergente dalle "immagini" dei loro arazzi: quello di Athena che celebra la fondazione di Atene, sé stessa, e la punizione di chi osa sfidare soprattutto la sposa di Zeus, e, quello di Aracne che celebra le "avventure" di Zeus (e di altri déi) con donne mortali, a partire dal famoso "ratto di Europa" ...
ENTRAMBE, rimaste senza madre (quella di Aracne è morta, quella di Athena l’ha "ingoiata" Zeus) ed entrambe al "servizio" dei loro "Padri", SONO tutte e due collegate nelle varianti del mito a Penelope, come da scena di una xilografia del XVI sec.: Pallade e Penelope con le ancelle e Aracne indignata a tessere la tela - in attesa di un... Ulisse/Zeus, partito per le sue avventure “europee”. O, dato che ormai l’Europa è sulla via del tramonto, anche questa "variante" è da ritenersi "un falso mito"? O, in altro modo, che Athena, Aracne, Penelope, e la stessa Arianna tentano di offrire ancora la chiave per saper riconoscere un falso mito e riprendere il cammino? O no?
Federico La Sala
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
 TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- PIANETA TERRA. I compiti delle Nazioni (di Roberto Mussapi).9 febbraio 2019, di Federico La Sala
PIANETA TERRA. LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE, E LA LEZIONE DI NIETZSCHE.... *
- "Oriente e Occidente - scrive Nietzsche in Schopenhauer come educatore - sono tratti di gesso che qualcuno disegna davanti ai nostri occhi per beffarsi della nostra pavidità".
- La Terra vista dalla Luna: "Se il programma spaziale non avesse dato alcun frutto (e spesso io faccio mólta fatica a discernere che cosa ci abbia dato), gli dobbiamo essere grati per aver prodotto tale fotografia" (M. Konner, L’ala impigliata. I condizionamenti bilogici dello spirito umano, Milano, Feltrinelli, 1984).
I compiti delle Nazioni
di Roberto Mussapi (Avvenire, sabato 9 febbraio 2019)
«Spesso si è discussa l’utilità delle spedizioni polari. Se si considera solo il vantaggio morale che si ricava da tali spedizioni, io lo credo sufficiente a compensare i sacrifici che per esse si fanno. Come gli uomini, che nelle lotte quotidiane, col superare le difficoltà, si sentono più forti per affrontarne delle maggiori, così è delle Nazioni, che dai successi riportati dai propri figli si devono sentire maggiormente incoraggiate e spinte a perseverare nei loro sforzi per la propria grandezza e prosperità».
Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, tra il 1899 e il 1900 guida una spedizione, Stella Polare, con lo scopo di portarsi con una nave lungo una terra il più a settentrione possibile, e dal sito di sverno procedere con le slitte verso il Polo. La meta non fu raggiunta, ma lo scopo fu conseguito. Lo scopo della sua e di ogni altra spedizione, scrive Amedeo di Savoia, è di offrire un conforto e un modello all’uomo che nelle sue «lotte quotidiane», col superare le difficoltà si sente più forte per affrontarne altre maggiori. Così devono fare le Nazioni, «che dai successi riportati ai propri figli si devono sentire maggiormente incoraggiate.» Figli non mandati in guerra, ma all’avventura della conoscenza del mondo.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IL "SIDEREUS NUNCIUS": UNO SHOCK, IERI E (ANCORA) OGGI. L’annuncio stellare (1610) di Galileo Galilei, l’alba di una nuova visione del mondo.
PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986). Tracce per una svolta antropologica
 OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE.
OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE.Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- LETTERA/APPELLO. Noi psicoanalisti non possiamo tacere - FORUM. Le due passioni che dividono l’Europa: "Amore e odio per l’Europa" (di Silvia Vegetti Finzi).6 febbraio 2019, di Federico La Sala
Decreto sicurezza, noi psicoanalisti non possiamo tacere
sono 621 le firme in calce a questa lettera *
Noi tutti, firmatari di questa lettera, siamo psicoanalisti appartenenti alla storica Società Psicoanalitica Italiana (SPI), componente dell’International Psychoanalytical Association (IPA), della quale fanno parte società psicoanalitiche di tutto il mondo. Molti di noi fanno parte di un gruppo denominato PER (Psicoanalisti Europei Per i Rifugiati), con il quale la SPI ha inteso raccogliere le esperienze di molti psicoanalisti che già da anni operano su tutto il territorio nazionale nel settore della migrazione. Del Gruppo PER inoltre, fanno parte anche psicoanalisti che appartengono al gruppo denominato Geografie della Psicoanalisi che ha per scopo l’indagine e i contatti della psicoanalisi con altre culture.
Grazie allo specifico sapere psicoanalitico, in grado di cogliere la complessità del lavoro con i migranti e con l’intero fenomeno che sappiamo essere attivatore di grande sofferenza psichica, è stato possibile fornire un contributo clinico scientifico in favore dei migranti e degli stessi operatori delle varie associazioni che, essendo in diretto contatto con i migranti, si fanno carico quotidianamente della sofferenza psichica di cui essi sono portatori silenti.
È proprio quest’esperienza quotidiana di contatto con il disagio psichico profondo e con la sofferenza legata a traumi, sradicamento e lutto migratorio che ci spinge a scrivere e ad assumere una posizione critica, ritenendo che non si possa tacere sulle complesse e gravi condizioni in cui versano i migranti in Italia.
La situazione, da tempo critica, si è drammaticamente aggravata dopo il varo e l’approvazione del “Decreto Sicurezza” che, contrariamente al termine “sicurezza”, sta già rendendo la condizione dei migranti e, consequenzialmente quella italiana, sempre più “insicura”. Concordiamo con quanto Lei afferma: “la vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza”.
Ed è proprio a partire da questa Sua dichiarazione che pensiamo di poter affermare che la convivenza non è un dato, ma una paziente tessitura da costruire nel quotidiano, sfidando paure e diffidenze reciproche inevitabili. L’accoglienza e la convivenza possono essere prove difficili quanto l’esilio ed è per questo che vanno sostenute attraverso politiche e azioni sociali capaci di dare ascolto anche al disagio della popolazione residente, evitando che si radicalizzi quel cieco rifiuto che si sta attivando.
E’ grave chiudere gli SPRAR, in quanto sistemi di “accoglienza integrata”, che fino ad oggi non si sono occupati solo del sostegno fisico delle persone immigrate, ma hanno anche promosso percorsi di informazione, assistenza e orientamento, necessari a favorire un loro dignitoso inserimento socio-economico. Precludere queste opportunità non vuol dire solo annullare drasticamente gli SPRAR, ma cancellare ogni possibilità di dare dignità alle persone sostenendo il loro legittimo diritto di aspirare ad una vita migliore e alla salute che, come sancito dall’OMS, “...è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo l’assenza di malattia o infermità”.
La nuova legge, di fatto, rende impossibile l’integrazione dei migranti in Italia, esponendoli ancora una volta al rischio di umiliazioni e sofferenze psichiche profonde e disumane, non riconoscere più il permesso di soggiorno per motivi umanitari è disumano!
Gestire il fenomeno migratorio come una pura questione di ordine pubblico è segno di pericolosa miopia. Noi pensiamo che sia urgente ripensare completamente anche le politiche migratorie, riaprendo, ad esempio, i canali regolari della migrazione da lavoro, come opportunità per avvalersi dell’apporto di energie nuove che sempre le migrazioni riuscite hanno rappresentato e che sono alla base di ogni autentico processo di integrazione.
Quelli di noi che operano a Bologna, Genova, Milano, Roma, Trieste, Gorizia, Venezia, Caserta hanno visto, dopo l’approvazione della legge, da un giorno all’altro, centinaia di migranti lasciati in strada senza protezione. Diventati fantasmi, privati di tutto, uomini e donne che restano esposti al pericoloso circuito vizioso alimentato dalla condizione di bisogno estremo, vulnerabili e inermi, assoggettabili a contesti delinquenziali che possono spingerli/costringerli verso comportamenti anti sociali.
E’ doveroso chiedersi da dove nasca questa ossessione per il migrante da parte dei nostri governanti, che generano e alimentano paure sociali, dal momento che gli sbarchi sono passati da circa 160.000 nel 2016 a 22.000 nel 2017. Siamo consapevoli che le paure possono accecare al punto da distorcere la percezione non solo dell’altro ma persino della propria stessa umanità. La disumanità è un rischio costante per l’umano in cui si può scivolare quasi inavvertitamente spostando sempre un po’ più in là l’asticella di ciò che è tollerabile. E’ questa la ragione per cui è ancora più necessario riuscire ad ascoltare anche quello che si cela sotto la paura, per trasformarla in possibilità di contatto con se stesso e con l’altro. Attraverso il nostro lavoro di psicoanalisti siamo vicini alle complesse realtà umane e sentiamo urgente lavorare e riflettere, anche al difuori del nostro ambito, sulla possibilità di elaborare il “male” per prevenire il rischio che il “male” possa essere agito.
E’ necessario operare affinché l’inconsapevole distruttività, cui tutti siamo esposti, possa trasformarsi in conoscenza e comprensione generatrice di consapevole tensione verso il diverso, l’ignoto, l’altro.
Tragicamente sono aumentati percentualmente i morti in mare per la restrizione quasi totale della possibilità di operare salvataggi da parte delle navi di soccorso. Chi soccorre in mare può, paradossalmente rispetto alle leggi di mare, essere soggetto a processo per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina! Per non dire di ciò che accade nei percorsi di terra e nell’attraversamento dei deserti.
Quanto poi ai rimpatri, essi, di fatto, sono semplicemente impossibili in assenza di accordi sicuri con le Nazioni di partenza. In questo contesto, è molto grave che l’Italia non abbia partecipato al Global Compact for Migration dell’ONU, accordo globale sull’accoglienza dei migranti approvato con il voto favorevole di 152 Paesi.
Non possiamo accettare il razzismo crescente che sfocia in atti di cui una nazione civile dovrebbe vergognarsi. E’ in atto un diffuso, impressionante processo di disumanizzazione. Noi analisti siamo sempre attenti quando vediamo negli individui, nei piccoli e nei grandi gruppi, fenomeni più o meno striscianti o palesi di razzismo e di disumanizzazione. Siamo sensibili per formazione professionale e cerchiamo di tenere a mente l’insegnamento della storia, anche perché nel periodo delle leggi razziali, la psicoanalisi fu vietata e molti colleghi di allora, perché ebrei, furono costretti a emigrare. Operando nel settore, non finiamo mai di stupirci di quanto dolore possa essere inflitto a un essere umano, anche senza volerlo, anche solo girando la testa dall’altra parte.
Conosciamo le gravi conseguenze psichiche di tutto ciò che sta succedendo, sia in coloro che si sentono rifiutati ed emarginati, sia nei figli che avranno, sia in coloro che si trovano a dover operare in modo disumano e che rischiano essi stessi di impoverirsi dei valori fondamentali dell’esistere. Non siamo disposti, per tutti questi motivi, a vedere una parte dell’Italia abbracciare xenofobia e razzismo. Organismi internazionali come Amnesty International hanno segnalato questi gravi fenomeni razzisti e xenofobi in Italia.
Un’altra Italia esiste e inizia a esprimere il proprio profondo dissenso: noi ne facciamo parte. Lavoriamo affinché i valori dell’ospitalità, della tolleranza, della convivenza e della responsabilità individuale per il futuro di tutti, siano mantenuti vivi. Siamo una “comunità di vita”, come lei ha definito il nostro Paese e, come tale, vogliamo continuare a esistere. Non possiamo tacere perché tacere sarebbe colpevole anche verso le generazioni future di figli e nipoti che ci potranno chiedere dove eravamo quando un’umanità dolente e in cerca della possibilità di ricostruire la propria identità spezzata e perduta, veniva respinta, emarginata o segregata in modo disumano.
Ci rivolgiamo a Lei, Signor Presidente della Repubblica, nella Sua qualità di Garante dei diritti umani e civili sui quali Essa è stata fondata, affinché questo appello, nato dalla nostra esperienza professionale, sostenuto dal nostro ruolo di cittadini e dalla nostra identità di esseri umani, abbia ascolto.
Le due passioni che dividono l’Europa
Il 16 febbraio all’Università Statale di Milano il Forum di psicoanalisi
di Silvia Vegetti Finzi (Corriere della Sera, 06.02.2019)
Amore e odio per l’Europa, il titolo del Forum Europeo che si terrà sabato 16 febbraio presso l’Università Statale di Milano per iniziativa della Scuola lacaniana di psicoanalisi, introduce nell’acceso dibattito tra europeisti e nazionalisti due termini inattesi, che appartengono al catalogo delle passioni più che al calcolo delle ragioni. Un’antinomia originaria che incrina la nascita stessa dell’Unione Europea.
Non dimentichiamo che l’ideale europeista nasce nel 1941, a Ventotene, dalla fantasia utopica di due condannati al confino per antifascismo, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi in collaborazione con Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann. Dall’esilio, i padri fondatori redigono un documento che affida all’Europa la realizzazione degli ideali di pace, libertà e giustizia travolti dalla guerra. Ma quando, nel 1950, si attua la prima forma di coesione, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca), sarà un patto meramente economico, una «fusione a freddo» che lascerà estranea e indifferente l’opinione pubblica, rendendo fragile e incompiuto il progetto unitario.
Tuttavia solo la crisi economica e l’impossibilità di contenere i flussi migratori riveleranno, all’inizio di questo secolo, il potenziale passionale celato dall’indifferenza.
Sull’onda di vecchie e nuove formazioni politiche e il riemergere di termini desueti quali «populismo» e «sovranismo», il disinteresse iniziale si frantuma lasciando emergere contraddittorie dinamiche di amore e odio, speranza e paura. Un coagulo di passioni che, nel corso dei lavori, gli psicoanalisti intendono analizzare dialogando con storici, filosofi ed economisti, nonché con i rappresentanti di varie istituzioni culturali.
Come suggerisce Marco Focchi, direttore del Forum: «Senza il collante dell’ideale, che convoglia i sentimenti ambivalenti mettendo a profitto l’amore ed economizzando l’odio come energia trasformativa, le passioni tracimano, si scatenano incontrollate, creano correnti alternative, attriti, collisioni, incontri cercati e al tempo stesso rifuggiti».
Per uscire da un’implosione che immobilizza e corrode, la psicoanalisi propone di riconoscere la coesistenza dei contrari che Lacan chiama hainamoration: una commistione di odio che divide e di amore che unisce, finalizzata a mantenere la giusta distanza tra Sé e l’Altro. Ove l’altro è anche una parte di me, la componente oscura di cui liberarmi e che, proiettata sull’estraneo lo rende, in quanto ricettacolo del negativo, sconosciuto e minaccioso. Si stabilisce così, nella logica speculare dell’inconscio, un’inversione paradossale: non sono io che odio l’altro, è l’altro che odia me. In un clima diffuso di sospetto e ostilità, non basta tuttavia la buona volontà per realizzare un buon uso delle passioni.
Tanto più in presenza di una profonda dissimmetria tra l’inconsistenza dell’Europa, sentita come un’istituzione algida e lontana, e una immagine del nostro Paese calda e condivisa, radicata nella temperie collettiva del Risorgimento e della Prima guerra mondiale. I nostri ragazzi crescono circondati da simboli e narrazioni - vie, lapidi, monumenti, musica e teatro - che rammemorano e celebrano fatti ed eroi di quelle storiche imprese. Nulla di simile per quanto riguarda l’Europa: se l’Italia rappresenta la madre patria, l’Europa evoca la matrigna che vorrebbe usurparne il posto. Come far coesistere due figure così eterogenee? Mentre l’una appare unitaria e coesa (una lingua, un suolo, una Legge), l’altra si presenta come polimorfa, composita e conflittuale, aliena.
Poiché ogni epoca storica si caratterizza per un problema da affrontare, alla nostra si chiede soprattutto di declinare uguaglianza e differenza fondendole in modo che l’amore prevalga sull’odio, l’unione sulla divisione. Ma perché quell’alchimia possa avvenire è necessario promuovere, in nome dell’Europa, una cultura diffusa e una formazione delle nuove generazioni all’altezza della sfida che le attende.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- PIANETA TERRA: TROIA, ELENA, E "IL SOGNO DELLA BELLEZZA" (di Roberto Mussapi)30 gennaio 2019, di Federico La Sala
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. In principio era il Logos ... *
Il sogno della Bellezza
di Roberto Mussapi (Avvenire, mercoledì 30 gennaio 2019)
«Un tempo mi stupivo perché una guerra così lunga/ d’Europa e d’Asia davanti a Pergamo/ fosse stata causata da una donna./ Adesso vi comprendo, siete stati saggi,/ Paride e Menelao, tu a rivolerla, / Paride a non volerla cedere. / Fu così bella che valse la pena// che in suo onore Achille morisse, / e Priamo lodasse le cause della guerra.»
Molteplici le cause delle guerre. Spesso economiche, a volte mascherate da valori civili, patriottici o religiosi. Qui però non ci riferiamo a una delle tante tragiche guerre storiche, ma alla prima, che, anche se realmente avvenuta, diviene mito di fondazione del nostro mondo. Troia esiste e fu assalita e arsa dalla lega dei greci.
Ma pur se storica, quella vicenda è mitica, oltre il tempo della storia e del calendario: un poeta, Properzio, il primo ma non l’unico, intuisce il mistero e il segreto di quella terribile contesa: Elena, moglie di un nobile greco, fuggita con un principe troiano: Elena sarà dell’uno e dell’altro, e mai di nessuno definitivamente. È la bellezza assoluta, irraggiungibile, che nessuno potrà mai definitivamente possedere.
La guerra dei primordi è la perversione di un sogno umanamente comprensibile: ognuno di noi vuole la Bellezza, e non comprende che non può essere solo sua. Ci preesiste.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
 TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
L’EUROPA, LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE, E LA LEZIONE DI NIETZSCHE.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
- Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE. Una nota di Roberto Mussapi.18 gennaio 2019, di Federico La Sala
I medici nascono senza frontiere
di Roberto Mussapi (Avvenire, venerdì 18 gennaio 2019)
«In quante case io entri mai, vi giungerò per il giovamento dei pazienti tenendomi fuori da ogni ingiustizia e da ogni altro guasto, particolarmente da atti sessuali sulle persone sia di donne che di uomini, sia liberi sia schiavi». Siamo all’inizio di uno scritto che segna una tappa fondamentale della civiltà: il Giuramento di Ippocrate, il medico che fonda il compito e traccia le basi della sua arte. «Io giuro su Apollo medico e Asclepio e Igieia e Panacea, e su tutti gli dei e le dee, prendendoli a miei testimoni...».
Il giuramento di Ippocrate, su cui si fonda la medicina, è fatto agli dèi, il compito del medico non riguarda esclusivamente il mondo della polis, ma è vincolato a quello sacro del divino. Studi recenti datano il giuramento intorno al V secolo a. C, il secolo che vede nascere la tragedia come genere teatrale di poesia, e la filosofia, pensiero come logos. Alle spalle il rito dionisiaco tragico, e il pensiero dei presocratici, i baldi e travolgenti scienziati-poeti. Prodigioso momento di creazione dei Greci che fondano l’Occidente.
Cittadini di una democrazia, non servi di un Re come gli Egizi o i Persiani. Ma civiltà non ancora compiuta. Le donne non godono di diritti civili, né considerazione, meno ancora degli schiavi. Insomma molestare una donna, o uno schiavo, non è, per il greco del tempo, così grave. Non sono cittadini, maschi.
Per Ippocrate invece è la stessa cosa. Supera i limiti della sua civiltà. Va oltre: giuro di non fare violenza a nessuno, perché tutti, comprese donne e schiavi, sono, siamo uguali. Supera i pensatori del suo tempo. È un medico. I medici nascono senza frontiere.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - DANZICA. «Il livello del dibattito pubblico deve cambiare per evitare di incoraggiare le persone a compiere tali gesti» (Lech Walesa)..15 gennaio 2019, di Federico La Sala
Danzica, ferito a morte il sindaco dei diritti
Polonia. Il primo cittadino accoltellato durante un concerto di beneficenza da un ventisettenne «non affiliato a organizzazioni politiche». Era diventato un bersaglio facile dell’estrema destra polacca
di Giuseppe Sedia (il manifesto, 15.01.2019)
VARSAVIA «Danzica è generosa, Danzica condivide il bene, Danzica vuole essere una città di solidarietà», sono queste le ultime parole pronunciate dal sindaco della città polacca sul Mar Baltico Pawel Adamowicz accoltellato a morte nella serata di domenica su un palco durante l’evento clou della Grande Orchestra di Solidarietà Natalizia (Osw).
La parola «solidarietà» in polacco rimanda anche a Solidarnosc, il primo sindacato libero dei paesi del blocco sovietico guidato da Lech Walesa e nato dagli scioperi dell’agosto 1980 proprio tra i cantieri navali di Danzica. Ogni anno l’Osw organizza una raccolta di fondi tra i cittadini in Polonia e all’estero per l’acquisto di attrezzature mediche per la cura dei bambini e delle persone anziane.
Ieri Walesa ha ammonito: «Il livello del dibattito pubblico deve cambiare per evitare di incoraggiare le persone a compiere tali gesti».
È una morte che lascia un segno indelebile quella del primo cittadino di Danzica, deceduto in ospedale nella tarda mattinata, anche perché avvenuta durante uno di quei pochi eventi nazionali in grado di unire i cittadini polacchi al di là della cosiddetta «guerra polsko-polska» tra i sostenitori e gli oppositori del governo della destra populista di Diritto e giustizia (PiS), attualmente al potere in Polonia.
VERSO LE ORE 20 di domenica il ventisettenne Stefan W. (in Polonia i cognomi degli indagati non possono essere diffusi in assenza di una condanna o dell’assenso da parte della persona indagata), era riuscito a intrufolarsi nel locale e a salire sul palco dopo aver mostrato agli addetti alla sicurezza, una tessera della Pap, la principale agenzia di stampa polacca. Dopo aver colpito ripetutamente Adamowicz al torace con un coltello a serramanico di 15 centimetri, l’aggressore è stato disarmato non senza riuscire a prendere la parola sul palco: «Mi chiamo Stefan W., sono stato incarcerato per un ingiustizia. Piattaforma civica mi ha torturato. E per questo che Adamowicz è morto».
Piattaforma civica (Po) è una formazione liberale di centro-destra a cui appartiene anche l’attuale presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ma è soprattutto il principale antagonista politico del PiS a livello nazionale. Secondo le prime informazioni l’omicida affetto da disturbi psichiatrici era stato condannato in precedenza per una rapina in banca ma non risulterebbe affiliato ad alcuna organizzazione politica.
DUE ESTATI FA l’organizzazione para-fascista della Gioventù polacca (Mw) aveva rilasciato 11 certificati di «decesso politico» con tanto di fotografia per undici sindaci polacchi rei, secondo gli organizzatori dell’happening, di aver sottoscritto un patto di collaborazione tra le amministrazioni locali in materia di immigrazione. Tra i destinatari del certificato l’ex-sindaca di Varsavia Hanna Gronkiewicz-Waltz (Po) ma anche lo stesso Adamowicz. In Polonia le varie forme di incitamento all’odio costituiscono un reato ai sensi degli articoli 256 e 257 del codice penale. I dati della procura nazionale sulle indagini hanno registrato un aumento di questi fenomeni negli ultimi anni. All’inizio del 2017 il ministro dell’interno polacco Mariusz Blaszczak aveva parlato di «sporadicità» dei casi di incitamento all’odio sottolineando quanto fosse inutile intraprendere azioni specifiche per arginare il problema.
È INDUBBIO che la vittima fosse diventata un bersaglio facile dell’estremismo. In carica come sindaco dal 1998, Adamowicz è stato un membro del Po fino al 2016. Alle elezioni amministrative di ottobre scorso, che hanno visto la debacle del PiS nei grandi centri del paese, si era presentato come candidato indipendente sconfiggendo alle urne proprio il figlio di Walesa, Jaroslaw del Po, e successivamente al ballottaggio, anche il candidato del PiS Kacper Plazynski.
Nell’amministrazione cittadina Adamowicz si è sempre distinto per le sue posizioni progressiste, a sostegno dei diritti delle minoranze, degli immigrati e della comunità lgbt. Alcuni già si chiedono chi prenderà il posto dell’indimenticato Adamowicz alla guida di Danzica. Secondo le normative in vigore, l’esecutivo è chiamato a designare un successore ad interim per la carica di sindaco, in attesa di nuove elezioni cittadine che dovrebbero avere luogo non oltre il mese di aprile 2019.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Decreto sicurezza, noi stiamo con le Antigoni. Manifesto disobbediente (dell’ Officina dei Saperi)13 gennaio 2019, di Federico La Sala
Decreto sicurezza, noi stiamo con le Antigoni
Manifesto disobbediente dell’Officina dei Saperi *
Si ripropone, da secoli, ogni volta che insorge lo «stato di eccezione» - ovvero ogni volta che il potere politico esubera non solo rispetto all’ordine giuridico ma alle norme etiche o alla percezione di valori non scritti della civiltà - lo storico conflitto fra Creonte e Antigone, fra la Legge storica e la Legge naturale e umana della compassione e della pietà. Il conflitto è noto e gli dà voce l’immensa tragedia di Sofocle: da una parte le ragioni di Creonte, il tiranno di Tebe che, interpretando le leggi della città che impediscono sepoltura ai traditori, proibisce l’inumazione del ribelle Polinice; dall’altra le ragioni di Antigone, la giovane fanciulla sorella di Polinice che, vedendo il cadavere esposto al martirio dei corvi, disobbedendo alla legge, con rischio personale, sacrificando la sua felicità (è promessa ad Emone, figlio di Creonte), porta il corpo del fratello nella città e lo seppellisce.
Sofocle, i Greci cioè, non prendono posizione per una delle due parti (anche se la tragedia si chiama Antigone). Sono tragici appunto e sanno che non ci può essere società e giustizia senza il rispetto della legge, così come non può esserci umanità senza la pietà e l’inumazione dei morti. Da tragici, cavalcano entrambe le ragioni (anche se, appunto, la tragedia continua a chiamarsi Antigone).
Noi invece, qui ed ora, stiamo dalla parte di Antigone e di tutte le Antigoni. Perché sono molte, dopo quella dell’alba greca. In nome di Antigone, per esempio, si schierarono gli avvocati che accusarono i criminali nazisti durante il processo di Norimberga: processo che in nome di Creonte non avrebbe mai potuto essere celebrato in quanto quei capi nazisti non avevano fatto altro che obbedire alla legge scritta, storica, del loro Stato. Così come fu in nome di Antigone che i soldati americani strapparono la loro carta di identità per disobbedire alla scelta scellerata della guerra del Vietnam, ed è in nome di Antigone che in ogni paese, tanti e tanti disobbedienti, si ribellano alla violazione dei diritti umani pur sancita dalla legge di quei Paesi.
Stiamo dunque con le Antigoni , disobbedienti per far andare avanti la vita, perché è falsa la separazione, perché è falso che possa esistere una Legge che sia contro la Vita.
La vita, la sua dignità, la cura della sua fragilità, è il fondamento della legge, senza del quale la legge non è che esercizio retorico o peggio, brutale esercizio del potere: uno «sterile e colpevole legalismo», come denunciò nel ’46 Piero Calamandrei, appellandosi invece alle «leggi superiori di Antigone», leggi dell’umanità che poi improntarono lo spirito e i principi della nostra Costituzione.
Stiamo con le Antigoni e dunque con quei Sindaci, che, mettendo a rischio la sicurezza del loro mandato, in questi giorni disobbediscono ad un Decreto contro l’immigrazione, una vera e propria legge razziale che fomenta la violenza e la paura, sentimento non ammissibile nello Stato, ma appunto foriero a legittimare solo uno «stato di eccezione». Stiamo con le Antigoni e con i Sindaci anche perché la civiltà che più amiamo è figlia di un mare di terre e di mari, come diceva un suo grande cantore, che non può essere pensato se non come una koinè ospitale, dove le voci, le storie degli uomini e delle donne, si intrecciano, si scambiano e si danno rifugio e reciproco soccorso.
In questo mare, nel basso Mediterraneo, si sta compiendo un crimine che ci rinfacceranno tutti i libri di storia. E fossimo stati più giovani, molti di noi avrebbero prestato i loro corpi per fermare questo massacro, magari andando su quelle navi dove la meglio gioventù europea oggi va all’aiuto dei naufraghi.
Possiamo però oggi mettere a disposizione le nostre parole, i nostri libri, gli spazi nei giornali, i nostri insegnamenti a scuola e all’università, per sostenere un grande movimento di disobbedienza e resistenza civile che restituisca all’Italia la pietà (la pietas). In nome di Antigone.
Per Officina dei Saperi:
Laura Marchetti, Ilaria Agostini, Lucinia Speciale, Maria Pia Guermandi, Cristina Lavinio, Tiziana Drago, Renata Puleo, Lidia Decandia, Rossella Latempa, Amalia Collisani, Francesca Leder, Piero Bevilacqua, Enzo Scandurra, Tonino Perna, Giuseppe Aragno, Vittorio Boarini, Dino Vitali, Roberto Budini Gattai, Francesco Trane, Alessandro Bianchi, Luigi Vavalà, Velio Abati, Battista Borghi, Alfonso Gambardella, Francesco Santopaolo, Rossano Pazzagli, Battista Sangineto, Giuseppe Saponaro, Romeo Salvatore Bufalo, Paolo Favilli, Piero Caprari, Gianni Vacchelli, Franco Blandi, Franco Novelli, Piero Totaro, Carmelo Albanese, Giovanni Attili. Andrea Battinelli, Alberto Ziparo, Franco Toscani, Ugo M.Olivieri.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Dinanzi all’orrore e all’infamia dei governanti di un intero continente che rifiutano di soccorrere una cinquantina di naufraghi nel Mediterraneo, uomini, donne e bambini innocenti sopravvissuti alle violenze... (di Peppe Sini).).8 gennaio 2019, di Federico La Sala
IN DIGIUNO DINANZI ALL’ORRORE
Dinanzi all’orrore e all’infamia dei governanti di un intero continente che rifiutano di soccorrere una cinquantina di naufraghi nel Mediterraneo, uomini, donne e bambini innocenti sopravvissuti alle violenze dei lager libici, vorrei associarmi alla preghiera del papa e di innumerevoli altre persone di volonta’ buona: siano salvate queste vite innocenti, si aprano i porti, siano accolte queste persone, esseri umani come noi.
*
Provo orrore del governo italiano che da mesi commette il reato di omissione di soccorso.
Provo orrore del governo italiano che da anni come altri governi europei nega di fatto a chi e’ in fuga da guerre e fame di poter giungere in salvo in modo legale e sicuro, e cosi’ getta tanti inermi fuggiaschi tra gli artigli delle scellerate mafie schiaviste dei trafficanti.
Provo orrore del governo italiano che per bocca del suo vero dominus reitera impunemente il reato di istigazione all’odio razziale, come il partito razzista di cui e’ a capo fa da decenni.
Provo orrore del governo italiano che con una delirante e disumana antilegge razzista pretende imporre in Italia un regime di apartheid, una delirante e disumana antilegge razzista che intende perseguitare migliaia e migliaia di vittime innocenti, una delirante e disumana antilegge razzista che viola la Costituzione della Repubblica Italiana.
Provo orrore del governo italiano che tradisce e infrange la Costituzione cui ha giurato fedelta’ all’atto del suo insediamento: violare la Costituzione per imporre un regime razzista e’ un crimine che costituisce altresi’ un tentativo di colpo di stato.
*
Provo orrore di tanta violenza; e come tante persone di volonta’ buona ho cercato e cerco di oppormi ad essa, con la forza della verita’, con la scelta della nonviolenza.
Per questo sto digiunando.
Un gesto minimo (che so essere miserrima cosa dinanzi all’orrore) per testimoniare il dolore che provo di fronte alla barbara violenza razzista commessa dal governo italiano che non soccorre i naufraghi e che perseguita tanti esseri umani innocenti. Un gesto minimo che vuole valere altresi’ come invito a me stesso e ad ogni persona senziente e pensante ad agire in difesa della legalita’ che salva le vite, in difesa della vita, della dignita’ e dei diritti di tutti gli esseri umani.
*
Occorre infatti agire, come vuole la legalita’, come vuole la democrazia, come vuole la morale, come vuole la civilta’, affinche’ le persone vittime di orrende violenze in Libia e di naufragio in mare siano finalmente salvate e accolte in Italia come vuole la legge e la morale.
 Occorre infatti agire, come vuole la legalita’, come vuole la democrazia, come vuole la morale, come vuole la civilta’, affinche’ siano revocate tutte le misure razziste, criminali e criminogene imposte dal governo della disumanita’.
Occorre infatti agire, come vuole la legalita’, come vuole la democrazia, come vuole la morale, come vuole la civilta’, affinche’ siano revocate tutte le misure razziste, criminali e criminogene imposte dal governo della disumanita’.
 Occorre infatti agire, come vuole la legalita’, come vuole la democrazia, come vuole la morale, come vuole la civilta’, affinche’ il governo della disumanita’ si dimetta ed i ministri responsabili di crimini abominevoli ne rispondano nelle aule di giustizia secondo la legge.
Occorre infatti agire, come vuole la legalita’, come vuole la democrazia, come vuole la morale, come vuole la civilta’, affinche’ il governo della disumanita’ si dimetta ed i ministri responsabili di crimini abominevoli ne rispondano nelle aule di giustizia secondo la legge.L’Italia e’ una repubblica democratica, uno stato di diritto, un paese civile.
Salvare le vite e’ il primo dovere.
Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo
Viterbo, 7 gennaio 2019
Mittente: "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo, strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: centropacevt@gmail.com (segnaliamo che il Centro cura dal 2000 la pubblicazione del notiziario telematico quotidiano "La nonviolenza e’ in cammino" cui e’ possibile abbonarsi gratuitamente attraverso il sito www.peacelink.it)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- IL SOVRANISMO PSICHICO. Creare un’illusione di forza e di autonomia, dello stato, del popolo e dell’individuo, a copertura della loro fragilità (di I. Dominijanni - L’io sovrano del Censis).29 dicembre 2018, di Federico La Sala
Italia
L’io sovrano del Censis
di Ida Dominijanni, giornalista *
Di anno in anno, con il suo rapporto annuale, il Censis non solo fornisce un’ottima radiografia dello stato dell’Italia, ma produce uno slogan destinato a scuotere un dibattito mediatico sempre più politicista, autoreferenziale e ripetitivo. Fu così qualche anno fa, quando De Rita prese pari pari dalle analisi lacaniane la diagnosi dell’eclissi del desiderio e la scaraventò su un’Italia ancora avvolta nel regime del godimento berlusconiano. Ed è così quest’anno, con il cinquantaduesimo rapporto che fa perno sul “sovranismo psichico” e mette di nuovo a fuoco il legame che nelle fasi di cambiamento stringe assieme la dimensione politica, quella sociale e quella psichica, individuale e collettiva.
Nel sovranismo, dice in sostanza il Censis, non ne va solo della nostalgia della sovranità nazionale “usurpata” dall’Unione europea e dell’invocazione della sovranità popolare “usurpata” dalle élite. Ne va di una certa mentalità, di certi sentimenti e comportamenti, di una certa configurazione degli individui. Lo si potrebbe dire - è stato detto: anche stavolta il Censis attinge a un’ampia ancorché non dichiarata letteratura - in altri termini: il discorso sovranista ha generato il suo soggetto, fatto a immagine e somiglianza dello stato sovrano perduto che evoca. L’uno e l’altro, lo stato e il soggetto, si sentono assediati da invasori alieni e minacciosi, l’uno e l’altro erigono muri a difesa dei propri confini, l’uno e l’altro nascondono dietro maschere fortificate e irrigidite la loro vulnerabilità e la loro dipendenza da altro e da altri. La forza - e la trappola - del sovranismo sta precisamente qui: nel creare un’illusione di forza e di autonomia, dello stato, del popolo e dell’individuo, a copertura della loro fragilità.
La ripresa inesistente
Il Censis però rovescia il cono: non vede nel soggetto sovranista un effetto del discorso politico, ma nel discorso politico un effetto della crisi sociale. In Italia il tempo s’è fermato: siamo fermi, e più spesso procediamo all’indietro come i gamberi. La ripresa economica intravista nel 2017 non s’è realizzata: “È sopraggiunto un intralcio, un rabbuiarsi dell’orizzonte”. Rallentano gli indicatori macroeconomici, cresce la sfiducia verso le istituzioni e il rancore di tutti contro tutti. Nell’assenza di progetto politico e di intervento statuale, peggiora in ogni campo la vita quotidiana, salvo che per una fascia di pochi privilegiati: la natalità diminuisce, l’ascensore sociale è bloccato, il lavoro manca, le disuguaglianze crescono, i soldi sono pochi (siamo il paese dell’Unione europea dove mediamente si guadagna di meno) e quei pochi stanno fermi in banca, i consumi non sono mai tornati ai livelli pre-crisi. Ma soprattutto, ogni cosa è sulle spalle dei singoli (aumentati del 50 per cento in dieci anni, mentre i matrimoni e le convivenze crollano) e delle famiglie: l’assistenza ai non autosufficienti, la sopravvivenza in un territorio a rischio perpetuo di crolli e frane, lo slalom nella giungla burocratica, la formazione culturale in un paese che non investe nulla sulla scuola e l’università. E per giunta, questo defatigante lavoro di adattamento alla crisi non viene riconosciuto né ripagato in gratitudine da nessuna istituzione.
Sono le radici profonde della delusione, della sfiducia e di un rancore pervasivo ormai convertitosi, scrive il Censis, in una cattiveria diffusa e in una conflittualità latente, “pulviscolare e individualizzata”. Da qui la soluzione del “sovranismo psichico”: un si salvi chi può che si regge sulla caccia paranoica del capro espiatorio, identificato nei migranti e più in generale in qualunque differenza o alterità perturbante. La maschera arcigna dell’io sovrano che presidia digrignando i denti un’identità immaginaria, in realtà destabilizzata dall’incertezza e dall’assenza di prospettive. Un’identità nazionale - “prima gli italiani”- bianca, proprietaria (e, dimentica di dire il Censis, maschile, come dimostra la misoginia imperante che il rapporto stranamente non contabilizza). Che “guarda al sovrano autoritario” come garanzia di contenimento dell’angoscia e di stabilità.
L’illusione traballante del sovranismo
La soluzione del governo sovranista sarebbe dunque l’effetto coerente di questa trasformazione psichica e sociale. “La delusione per il non-cambiamento miracoloso ha incattivito gli italiani e li ha resi disponibili a un salto rischioso e incerto, un funambolico camminare sul ciglio di un fossato che mai prima d’ora aveva visto da così vicino, se la scommessa era poi quella di spiccare il volo. Quasi una ricerca programmatica del trauma, nel silenzio arrendevole delle élite”. C’è da chiedersi tuttavia, rovesciando di nuovo il cono, se la soluzione politica sarebbe stata necessariamente quella populista-sovranista in presenza di un discorso politico diverso. Se qualcuno avesse dato ascolto all’incertezza invece di rimuoverla nella narrativa trionfale della ripresa e alla precarietà invece di annegarla nella retorica delle start up. Se qualcuno, nella crisi, avesse fatto appello alla solidarietà invece che all’autoimprenditorialità e alla competitività. Se le responsabilità del debito accumulato fossero ricadute su chi di dovere invece che su un senso di colpa collettivo deprimente e mortifero. Eccetera eccetera: a incattivirci, prima del sovranismo psichico e politico, è stato il neoliberalismo, di cui il sovranismo è solo l’effetto perverso. E del resto, già pericolante. La grottesca vicenda della manovra economica ha già dimostrato che il ritorno alla sovranità dello stato-nazione è una beata illusione. Il crollo dell’illusione psichica dell’io sovrano seguirà immancabilmente.
* Internazionale, 8 dicembre 2018
Sul tema, nel sito, si cfr.:
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!- LA LIBERTA’, LA "PAROLA" E LA "LINGUA" DELL’ITALIA, E IL COLPO DI STATO STRISCIANTE DEL PARTITO "FORZA ITALIA".
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- La mia terra si trova qui e ovunque / Ritrovare l’Europa (di Francesco M. Cataluccio)26 dicembre 2018, di Federico La Sala
La mia terra si trova qui e ovunque /
Ritrovare l’Europa
di Francesco M. Cataluccio (Doppiozero, 24.12.2018) *
“Gioia, il tuo incanto rende uniti (...), i mendicanti diventano fratelli dei prìncipi. Abbracciatevi, moltitudini! Questo bacio vada al mondo intero!” Cotanto invito alla fratellanza è l’Inno alla gioia (An die Freude, 1786), del poeta tedesco Friedrich Shiller, musicato da Ludwig van Beethoven nella Nona Sinfonia, ed è stato adottato, nel 1972, come inno europeo. Un inno che si esegue poco, mentre continuano a imperversare quelli nazionali (alcuni particolarmente retorici e bellicosi), perché rimane ancora incompiuta l’Europa.
Significativamente, il regista polacco Krzystof Kieślowski, nel Film blu (1993), immaginò la storia di un musicista che, morendo in un incidente stradale, lascia incompiuto l’inno europeo...
- Per introdurre il discorso che farò mi serve una fotografia e la sua storia che ci parla di anticonformismo e rifiuto dell’intolleranza.
Il signore evidenziato da un cerchio della polizia è il tedesco August Landmesser (1910-1944). Era un operaio che lavorava presso l’arsenale navale Blohm & Voss di Amburgo: fu l’unico fra centinaia di operai e autorità che si rifiutò di eseguire il saluto nazista ad Adolf Hitler, rimanendo impassibile a braccia conserte nel corso dell’inaugurazione del varo della nave scuola della marina militare tedesca, la Horst Wessel, il 13 giugno 1936. Landmesser era stato membro del Partito Nazionalsocialista dal 1931 al 1935, costretto all’adesione solamente perché spinto dal bisogno di ottenere un posto di lavoro. Cominciò a osteggiare il nazismo quando fu accusato di "disonorare la razza", avendo avuto due figlie da una donna di religione ebraica (Irma Eckler che fu arrestata nel 1938 dalla Gestapo e detenuta dapprima nel campo di concentramento di Fuhlsbüttel ad Amburgo e successivamente trasferita nei campi femminili di Oranienburg e Ravensbrück, per poi venir soppressa il 28 aprile del 1942). Landmesser fu dapprima espulso dal Partito e poi incarcerato due volte nel campo di concentramento di Börgermoor. Nel febbraio 1944, fu mandato al fronte dove morì nel corso di una missione operativa a Stagno in Croazia. Questa la foto, scattata per giustificare la sua sentenza (ritrovata soltanto nel 1991 e pubblicata da “Die Zeit”), è diventata un emblema dell’eroismo. Landmesser con il suo gesto non ha salvato nessuno, anzi si è condannato, ma ha salvato il suo onore e quello dell’umanità: per questo Landmesser deve essere ricordato come un Giusto.
Quand’è che si iniziò a pensare l’Europa come la intendiamo e vorremmo, e in parte conosciamo, oggi? Nel bel mezzo della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, nel 1941, nel confino dell’isoletta di Ventotene, due antifascisti, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, che ebbero modo di discuterne con gli altri prigionieri, scrissero Il Manifesto di Ventotène (titolo originale: Per un’Europa libera e unita. Progetto d’un manifesto), che auspicava l’unità europea, e fu poi pubblicato e diffuso da Eugenio Colorni. Con qualche ingenuità, ma si pensi a quando e dove fu scritto, il Manifesto prefigurava la necessità di istituire una federazione europea dotata di un parlamento e di un governo democratico con poteri reali in alcuni settori fondamentali, come economia e politica estera, passando per una breve fase dittatoriale: "Attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo stato e attorno ad esso la nuova democrazia." La Storia mostrava infatti che tutti i grandi aggregati nazionali erano sorti attraverso un’unificazione imposta, spesso con la forza, dalla nazione egemone (si pensi all’Impero russo, alla Prussia, ma persino all’unità d’Italia). La grande sfida era che questa unità fosse il risultato di una rivoluzione di tutti i popoli europei. Era necessario cioè un movimento che sapesse mobilitare tutte le forze popolari attive nei vari paesi al fine di far nascere uno Stato federale, con una propria forza armata e con “organi e mezzi sufficienti per far eseguire nei singoli stati federali le sue deliberazioni dirette a mantenere un ordine comune, pur lasciando agli stati stessi l’autonomia che consenta una plastica articolazione e lo sviluppo di una vita politica secondo le peculiari caratteristiche dei vari popoli”.
La riforma della società, volta a far riprendere immediatamente in pieno il processo storico contro la disuguaglianza e i privilegi sociali, doveva passare attraverso la rivoluzione europea, necessariamente socialista “cioè dovrà porsi l’emancipazione delle classi lavoratrici e la realizzazione per esse di condizioni più umane di vita”.
Per questo motivo Altiero Spinelli fondò poi, tra il 26 e 28 agosto del 1943, nella casa milanese del chimico Mario Alberto Mario Rollier, con Eugenio Colorni, Ernesto Rossi, Ursula Hirschmann, Manlio Rossi Doria, Giorgio Braccialarghe e Vittorio Foa, il Movimento Federalista Europeo.
Di unione europea si ricominciò a parlare più concretamente alla fine degli anni quaranta, al termine della complicata fase dei trattati di pace e della prima ricostruzione. Il ministro degli affari esteri francese, Robert Schuman, nella sua “Dichiarazione” del 9 maggio 1950, che viene considerata il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa, espresse il desiderio di superare la rivalità storica tra Francia e Germania, paesi legati alla produzione di carbone e acciaio. Tendere la mano ai nemici sconfitti, far sì che la Germania non venga frazionata in tanti piccoli staterelli e umiliata oltre misura (come era accaduto dopo la Prima Guerra Mondiale):
“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. (...) L’Europa) sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una SOLIDARIETÁ di fatto”.
L’Unione Europea, al suo sorgere (nel 1950), si chiamò Ceca (Comunità del carbone e dell’acciaio) e troverà poi la sua piena realizzazione un anno dopo (nel 1951) con il cosiddetto “Trattato di Parigi”, al quale aderirono Belgio, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Gli artefici di questo inizio di unità europea furono un francese, Robert Schuman, un tedesco, Konrad Adenauer e un italiano, Alcide De Gasperi: tre uomini che avevano vissuto sulla propria pelle gli orrori della guerra, tre perseguitati dal nazifascismo, tre statisti. Questo accordo, di carattere economico, aveva alle spalle una filosofia che può essere racchiusa nello slogan “MAI PIÚ”: mai più guerre, odi e distruzioni, che avevano sempre afflitto il continente europeo ma che, con le due Guerre Mondiali e il moderno sviluppo della Tecnica, avevano assunto proporzioni catastrofiche insostenibili. Come ha sottolineato proprio pochi giorni fa (il 26 novembre) il Presidente delle Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro Carignano di Torino, per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università:
“Se negli anni Cinquanta alcuni stati hanno deciso di mettere insieme economia e risorse energetiche, dando vita alla storica scelta di integrazione dell’Europa a cui tanti paesi si sono fortunatamente associati è perché avvertivano un sottofondo e la base di comune cultura”.
Non staremo qui a rifare la storia dell’Unione europea, ma già così possiamo comprendere quale, sin dall’inizio, fosse la difficile posta in gioco: un’unione economica che avrebbe dovuto andare di pari passo con un’unione politica e amministrativa, culturale e sociale.
Una grande accelerazione all’Unione Europea, e il suo allargamento, sono avvenuti con la caduta dei muri tra Ovest ed Est, nel 1989. I piccoli paesi dell’Europa Centrale e dell’Est, avendo perso l’Europa e l’Occidente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’hanno capita e rivendicata con coraggio e ostinazione, pur mantenedo contemporaneamente vive misere istanze nazionalistiche. Proprio per questo, la spinta a ricongiungersi all’Europa è stato uno dei motori dei movimenti sociali e politici che hanno contribuito all’abbattimento dei regimi totalitari.
“Noi moriremo per l’Ungheria e per l’Europa”, è il messaggio che inviò al mondo, via telex, il direttore dell’agenzia di stampa ungherese un attimo prima che i carrarmati sovietici conquistassero Budapest.
Questo sogno dell’Europa è stato alimentato soprattutto da intellettuali come lo scrittore ceco Milan Kundera, che, tra l’altro, scrisse, nel 1983, un testo amaramente lucido: Un occidente sequestrato: ovvero la tragedia dell’Europa centrale (in “Nuovi Argomenti”, n. 9 (gennaio-marzo 1984)-
Sosteneva Kundera:
“I popoli centroeuropei sono inseparabili dalla Storia europea, non potrebbero esistere senza di lei, ma non rappresentano che il rovescio di questa Storia, le sue vittime e i suoi outsider. È da questa esperienza storica disincantata che nasce l’originalità della loro cultura, della loro saggezza, della loro mancanza di serietà che si fa beffe della grandezza e della gloria: ‘Non dimentichiamoci che è solo opponendoci alla Storia in quanto tale che possiamo opporci a quella di oggi’. Mi piacerebbe incidere questa frase dello scrittore polacco Witold Gombrowicz sulla porta d’ingresso dell’Europa centrale”.
Altrove Kundera rivendicava con orgoglio la natura di quest’Altra Europa:
"Spesso mi sembra che la cultura europea conosciuta nasconda tuttora un’altra cultura, sconosciuta, delle piccole nazioni dalle lingue curiose: quella dei polacchi, dei cechi, dei catalani, dei danesi. Si ritiene che i piccoli siano per necessità imitatori dei grandi. È un’illusione. Essi sono persino molto differenti. La prospettiva di un piccolo non è la stessa di un grande. L’Europa delle piccole nazioni è ancora oggi un’altra Europa, ha un altro punto di vista e il suo sistema di pensiero è spesso il vero contrappunto dell’Europa dei grandi. (...) Gli ebrei e i cechi non hanno avuto la tendenza a identificarsi con la Storia, a vedere serietà e senso nei suoi spettacoli. Un’esperienza immemorabile li ha disabituati a venerare questa Dea, a tessere elogi della sua saggezza. Così, l’Europa dei piccoli stati, meglio protetta contro la demagogia della speranza, ha avuto un’immagine più lucida dell’avvenire che non l’Europa delle grandi nazioni, sempre pronte ad esaltarsi con la loro gloriosa missione storica" (Praga: la carta in fiamme, in "L’illustrazione italiana", n. 1, Milano 1981).
Già a partire dall’Ottocento, nell’Europa centrale, era cominciata a formarsi un’intelligentsia di origine borghese indipendentista, e filo-occidentale allo stesso tempo, che rivendicava l’identità culturale e linguistica del proprio paese ma guardava all’Europa come a un sogno di modernità ed emancipazione nazionale e sociale. Come ha notato il filosofo polacco Krzystof Pomian, in L’Europe et ses nations (1990): "Se esistono nazioni delle quali si può dire che furono create dai loro stati, queste nazioni invece sono state create dalle loro élites religiose e culturali, dai loro sacerdoti e maestri di scuola".
Un ruolo fondamentale lo giocarono gli ebrei: costretti ad attraversare i confini per le persecuzioni e anche per lavoro, educati al di sopra delle dispute nazionali, essi sono stati il principale elemento cosmopolita e integratore dell’Europa centrale, il suo cemento intellettuale, la sua condensazione spirituale. Anche per questo motivo sono stati perseguitati e anche sterminati dai nazionalisti, e ancor oggi sono considerati con ostilità dai nemici dell’Europa.
- CONTINUA ... POST SUCCESSIVO
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- La mia terra si trova qui e ovunque / Ritrovare l’Europa (di Francesco M. Cataluccio)26 dicembre 2018, di Federico La Sala
- continuazione - RITROVARE L’EUROPA ....
Gli intellettuali centroeuropei, proprio per il fatto di appartenere a piccoli paesi vittime dei vicini più potenti e prepotenti, che spesso soffiarono sul fuoco delle esasperazioni nazionaliste, hanno avuto le antenne più sensibili nel capire i guasti del totalitarismo, del populismo, del razzismo, dell’intolleranza religiosa. Intellettuali come il filosofo ungherese Istvàn Bibò, il poeta polacco, premio Nobel nel 1980, Czesław Miłosz (autore, nel 1959, del bellissimo saggio Europa familiare, trad. it. La mia Europa, trad. di F. Bovoli, Adelphi, Milano, 1985), il drammaturgo e politico ceco Václav Havel (diventato presidente del suo paese dopo il 1989), lo scrittore rumeno Paul Goma, solo per citare i più noti, ci hanno aiutato a capire la “vulnerabilità dell’Europa”, sono riusciti a convincere le società civili dei propri paesi della necessità di “tornare in Europa” perché dell’Europa e dei suoi valori si sentivano parte e la consideravano un antidoto contro il cieco nazionalismo.
Purtroppo, dopo la caduta dei muri, molti abitanti dei paesi ex comunisti immaginarono che entrare finalmente in Europa avrebbe significato maggiore benessere. Non è stato per tutti così. E quindi l’Europa è diventata il capro espiatorio di tutte le delusioni a seguito di troppo facili illusioni. La cosiddetta Europa di Maastricht (dal nome del paesino dei Paesi Bassi dove il 7 febbraio 1992 fu firmato il Trattato dell’Unione Europea), che permette, in base all’Accordo di Schengen, a tutti i cittadini dei 26 stati europei di circolare liberamente nel continente senza passaporto, e prometteva di avere, in prospettiva, una moneta unica, una sola bandiera, una sola polizia ed esercito, oggi è ferma e fa acqua da tutte le parti.
Le forze di destra, che hanno sempre visto nell’Europa e nei suoi ideali il nemico del loro nazionalismo, hanno avuto gioco facile nell’attaccare i partiti liberal-democratici che, pur tra errori e indecisioni, hanno gestito con successo la transizione. Li hanno accusati di essere rappresentanti delle élite cittadine privilegiate al servizio della Germania e della Francia (considerate le “padrone dell’Europa”), delle banche e degli stranieri che si sono comprati a buon mercato le aziende post comuniste.
Nel nome dell’orgoglio nazionale e del malcontento delle popolazioni rimaste ai margini e, a volte, ulteriormente impoverite, hanno preso campo ideologie nefande, demagogiche, semplificatorie e intolleranti, che hanno conquistato rapidamente consensi sempre crescenti in fasce di popolazione “dove alberga l’impotenza e la frustrazione di chi è stato costretto a immaginare mondi che non possiederà mai”. Con le elezioni hanno preso il potere maggioranze che oggi governano, grazie a leggi elettorali discutibili, in modo autoritario, non rinunciando ai vantaggi europei (sussidi all’agricoltura e alle infrastrutture), ma contrastando, in nome della propria sovranità, gli obblighi comunitari (sia in materia di quote di migranti, che del rispetto dei prìncipi costituzionali e dei valori di laicità e tolleranza previsti dalla carta d’Europa).
Come scrisse Friedrich Nietzsche nelle sue Considerazioni inattuali: “Il nazionalismo è l’effluvio di chi sa andar fiero solo del fatto di essere un gregge”. Il nazionalismo e il populismo sono i peggiori nemici dell’Europa perché ne mettono in discussione i valori e gli accordi.
Proprio per questo, i valori europei sono la migliore arma per sconfiggere gli egoismi, le intolleranze, gli odi. Una grande responsabilità spetta quindi oggi alle scuole per diffondere questi valori educando alla democrazia, alla tolleranza, al rispetto, alla fratellanza, al sentirsi cittadini dell’Europa e del mondo.
Lo storico del Medioevo, Bronisław Geremek, che fu uno dei consiglieri di Solidarność e poi Ministro degli esteri e artefice dell’ingresso della Polonia nell’Unione europea e nell’Alleanza atlantica, e autore tra l’altro di un volume intitolato Le radici comuni dell’Europa (ed. it. a cura di F. M. Cataluccio, il Saggiatore, Milano 1991), era inizialmente convinto che si dovesse partire dalla conoscenza comune della Storia dell’Europa. Ma la cosa si è dimostrata impossibile. Nonostante gli sforzi di associazioni di insegnati come EUROCLIO (fondata nel 1993), con sede a L’Aia, che si occupa di facilitare l’introduzione delle più recenti innovazioni didattiche nell’insegnamento della storia nei paesi che fanno parte dell’Europa, non si sono fatti passi avanti. Nonostante le Raccomandazioni per i Professori di Storia, emanate nel 2001 dal Consiglio d’Europa, ci si è accorti che, proprio a partire da quell’anno, l’interesse politico per un approccio storiografico di tipo nazionale andava rapidamente crescendo nei curricola scolastici di molti Paesi, con una conseguente diminuzione d’interesse per le tematiche europee. Già nel 1992 si era tentato di produrre un testo scolastico di storia su scala europea, radunando un gruppo di dodici storici in rappresentanza di altrettanti Stati europei. Il risultato è stato un fallimento: la Storia dell’Europa. Popoli e Paesi, in francese nell’edizione originale (la lingua che tutti gli autori hanno convenuto di utilizzare), non sta in piedi e dimostra che dopo secoli di guerre e massacri, confini che si sono spostati decine di volte, è impossibile scrivere una storia dell’Europa che metta d’accordo e accontenti tutti. La complessità è tale che non si fa ridurre e risolvere con dei compromessi. Non è quindi dalla Storia che si può pensare creare una coscienza europea comune. Bisogna partire dai VALORI.
Ma cosa sono i VALORI EUROPEI? Quali sono le RADICI COMUNI DELL’EUROPA, oggi messe in discussione dal risorgere degli egoismi nazionali?
Vale la pena ritornare al lavoro del regista polacco Krzystof Kieślowski. Dopo la caduta del regime comunista, e mentre la Polonia come gli altri paesi del Centro Europa, faceva i passi necessari per entrare nell’Unione Europea, Kieślowski iniziò a lavorare a un progetto di tre film che mettessero a fuoco, con delle storie esemplari, l’importanza e le contraddizioni dei valori europei. Tre film intitolati come i colori della bandiera francese - Film blu (1993), Film bianco (1994), Film rosso (1994) - e rappresentanti ciascuno i tre valori fondamentali: LIBERTÁ, EGUAGLIANZA, FRATERNITÁ.
Questi - assieme al collante che alla Rivoluzione francese mancò: la TOLLERANZA - sono i valori dell’Europa. Purtroppo, seppur tra mille contraddizioni, il primo e il terzo si sono abbastanza realizzati, il secondo (l’Eguaglianza) non si è, pur nei limiti del possibile e le compatibilità con un sistema economico come quello capitalistico, diffuso. Anzi, con la crisi economica, le ineguaglianze sono cresciute, dividendo ancor di più i cittadini europei tra benestanti e disagiati. Nel vuoto di questa Europa sentita come traditrice è cresciuta la malapianta dell’intolleranza e del risentimento. L’arrivo dei migranti ha ulteriormente accentuato la diffidenza e la paura verso lo straniero, ma già prima si era assistito a vergognose campagne contro persone della stessa Europa: si pensi agli attacchi all’“idraulico polacco”, al “lavavetri rumeno”, all’albanese, al bosniaco...: attacchi che, del resto, non erano del tutto nuovi, basti ricordare, negli anni cinquanta, quelli contro i lavoratori italiani meridionali, e negli anni settanta contro gli emigranti turchi (e vediamo oggi che grande, madornale, errore è stato tenere fuori l’allora ancora laica Turchia dall’Europa).
Nel Film rosso (Fraternità) di Kieślowski, che è quello della trilogia ad aver avuto il maggior successo, c’è un episodio iniziale che merita una riflessione: la protagonista che salva un cane investito da una macchina. Ci farà capire che non lo ha fatto né per l’animale, né per il suo padrone, ma per salvare se stessa. La fratellanza è anzitutto un aiuto a se stessi.
Questo mi pare anche il senso del ragionamento che abbiamo sempre fatto sui Giusti. Non santini o eroi da cartolina, ma persone vere (con tutte le contraddizioni e difetti umani): uomini e donne che hanno messo a repentaglio la propria vita per salvare gli altri: “Cosa avreste fatto al mio posto?”, chiedeva candidamente il commerciante Giorgio Perlasca, convinto fascista, che salvò a Budapest centinaia di ebrei dalla furia nazista. Salvando quelle persone, rispondendo all’indignazione della sua coscienza, aveva in fondo salvato anche se stesso.
L’esperienza del lavoro sui Giusti e la creazione dei Giardini che li ricordano e li fanno vivere nelle esperienze educative, ci insegnano che bisogna ripartire dagli individui, dai singoli e concreti cittadini europei, con i loro retaggi culturali particolari e i loro mille linguaggi, facendo conoscere i valori europei universali come sono stati assimilati, vissuti e messi in pratica da persone che sono state straordinarie ma come potrebbe essere ciascuno di noi, se desse ascolto alla propria coscienza.
La parola "Europa" non indica un’entità geografica, ma una nozione mentale. L’Europa non deve essere uno Stato, ma una federazione di liberi stati diversi, uniti da una cultura e un destino comuni che permettono di fissare alcune regole e accordi di convivenza (che non possono però essere solo economiche, monetarie e doganali).
Dopo tutte le tragedie che l’Europa ha prodotto e subìto, soprattutto a causa dei nazionalismi, ancora recentemente (basti pensare alla tragedia delle guerre balcaniche che è stato il più grande fallimento dell’Europa) è molto importante fare proprie le parole del poeta Czesław Miłosz, che, all’inizio del suo esilio in occidente, scrisse una poesia bellissima e molto significativa intitolata Mittelberghein, Alsazia 1951:
"(...) La mia terra
Si trova qui e ovunque, da qualunque parte mi volga
O in qualunque lingua oda
Il canto d’un bimbo, la conversazione di amanti”.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- MANIFESTO PER LA DEMOCRATIZZAZIONE DELL’EUROPA. Appello promosso da Thomas Piketty10 dicembre 2018, di Federico La Sala
Manifesto per la democratizzazione dell’Europa
- Thomas Piketty, economista francese, è tra i firmatari dell’appello. L’elenco completo è su www.tdem.eu *
Noi, cittadini europei, provenienti da contesti e paesi diversi, lanciamo oggi questo appello per una profonda trasformazione delle istituzioni e delle politiche europee. Questo Manifesto contiene proposte concrete, in particolare un progetto per un Trattato di democratizzazione e un Progetto di budget che può essere adottato e applicato nella sua forma attuale dai paesi che lo desiderino, senza che nessun altro paese possa bloccare quanti aspirino al progresso. Può essere firmato on-line (www.tdem.eu) da tutti i cittadini europei che in esso si riconoscono. Può essere modificato e migliorato da qualunque movimento politico.
Dopo la Brexit e l’elezione di governi antieuropeisti a capo di diversi paesi membri, non è più pensabile continuare come prima. Non possiamo limitarci ad aspettare le prossime uscite o un ulteriore smantellamento senza apportare cambiamenti radicali all’Europa di oggi.
Oggi il nostro continente è preso tra i movimenti politici il cui programma è limitato alla caccia agli stranieri e ai rifugiati, un programma che ora hanno iniziato a mettere in atto, da un lato. Dall’altro, abbiamo partiti che pretendono di essere europei, ma che in realtà continuano a considerare che il duro liberalismo e la diffusione della concorrenza a tutti (Stati, imprese, territori e individui) sono sufficienti per definire un progetto politico. In nessun modo riconoscono che è proprio questa mancanza di ambizione sociale che porta alla sensazione di abbandono. Oggi, da un lato il nostro continente è intrappolato tra movimenti politici il cui programma si limita alla caccia a stranieri e rifugiati, programma che ora hanno iniziato ad attuare; dall’altro, vi sono partiti che si dichiarano europei, ma che in realtà sono ancora convinti che il liberalismo di base e la diffusione della concorrenza a tutti (Stati, imprese, territori e individui) siano sufficienti a definire un progetto politico. Non riconoscono in alcun modo che è esattamente questa mancanza di ambizione sociale che conduce al sentimento di abbandono.
Vi sono alcuni movimenti sociali e politici che tentano di porre fine a questo dialogo fatale muovendosi nella direzione di una nuova base politica, sociale e ambientale per l’Europa. Dopo un decennio di crisi economica non mancano tali criticità specificatamente europee: sottoinvestimenti strutturali nel settore pubblico, in particolare nel campo della formazione e della ricerca, aggravamento delle disuguaglianze sociali, accelerazione del riscaldamento globale e crisi nell’accoglienza di migranti e rifugiati. Tuttavia, questi movimenti spesso stentano a formulare un progetto alternativo e a delineare con precisione il modo in cui intendono organizzare l’Europa del futuro e le infrastrutture decisionali ad essa dedicate.
Noi, cittadini europei, con la pubblicazione di questo Manifesto, del Trattato e del Budget, stiamo formulando proposte precise e pubblicamente accessibili a tutti. Non sono perfette, ma hanno il merito di esserci. Il pubblico ha la possibilità di accedervi e migliorarle. Si basano su una semplice convinzione. L’Europa deve costruire un modello originale per garantire uno sviluppo sociale equo e duraturo dei propri cittadini. L’unico modo per convincerli è quello di abbandonare promesse vaghe e teoriche. Se l’Europa vuole riconquistare la solidarietà dei propri cittadini, potrà farlo solo dimostrando concretamente di essere in grado di stabilire una cooperazione tra europei e facendo in modo che coloro che hanno tratto vantaggio dalla globalizzazione contribuiscano al finanziamento dei beni pubblici che oggi in Europa sono gravemente carenti. Ciò significa far sì che le grandi imprese contribuiscano in misura maggiore delle piccole e medie imprese e che i contribuenti più abbienti paghino in misura maggiore dei contribuenti più poveri. Oggigiorno non è così.
Le nostre proposte si basano sulla creazione di un Budget per la democratizzazione che verrebbe discusso e votato da un’Assemblea europea sovrana. Questo consentirà finalmente all’Europa di dotarsi di un’istituzione pubblica in grado di far fronte immediatamente alle crisi in Europa e di produrre un insieme di beni e servizi pubblici e sociali fondamentali nel quadro di un’economia duratura e solidale. In questo modo, la promessa fatta fin dal Trattato di Roma di "armonizzazione delle condizioni di vita e di lavoro" diventerà finalmente significativa.
Questo Budget, se l’Assemblea europea lo desidera, sarà finanziato attraverso quattro grandi imposte europee, segni tangibili di questa solidarietà europea. Esse si applicheranno agli utili delle grandi imprese, ai redditi più alti (oltre 200.000 euro all’anno), ai maggiori possessori di patrimoni (oltre 1 milione di euro) e alle emissioni di anidride carbonica (con un prezzo minimo di 30 euro per tonnellata). Se fissato al 4% del PIL, come proponiamo, questo stanziamento potrebbe finanziare la ricerca, la formazione e le università europee, un ambizioso programma di investimenti per trasformare il nostro modello di crescita economica, il finanziamento dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti e il sostegno a coloro che si occupano di attuare la transizione. Potrebbe inoltre lasciare agli Stati membri un certo margine di bilancio per ridurre l’imposizione fiscale regressiva che grava sui salari o sui consumi.
La questione qui non è quella di creare una "Europa dei bonifici" che tenti di prelevare denaro dai paesi "virtuosi" per destinarlo a quelli che lo sono meno. Il progetto per un Trattato di Democratizzazione (www.tdem.eu) lo afferma esplicitamente, limitando il divario tra le spese dedotte e le entrate versate da un paese a una soglia dello 0,1% del proprio PIL. Il vero problema è altrove: si tratta innanzitutto di ridurre le disuguaglianze all’interno dei diversi paesi e di investire nel futuro di tutti gli europei, a cominciare naturalmente dai più giovani, con nessun singolo paese che goda di preferenze.
Poiché dobbiamo agire rapidamente, ma dobbiamo anche far uscire l’Europa dall’attuale impasse tecnocratica, proponiamo la creazione di un’Assemblea europea. Questo permetterà di discutere e votare queste nuove imposte europee come anche il budget per la democratizzazione. Questa Assemblea europea può essere creata senza modificare i trattati europei esistenti.
L’Assemblea europea dovrebbe ovviamente comunicare con le attuali istituzioni decisionali (in particolare con l’Eurogruppo in seno al quale i ministri delle finanze della zona euro si riuniscono informalmente ogni mese). Ma, in caso di disaccordo, l’Assemblea avrebbe l’ultima parola. Se così non fosse, la sua capacità di essere sede di un nuovo spazio politico transnazionale in cui partiti, movimenti sociali e ONG potrebbero finalmente esprimersi sarebbe compromessa. Allo stesso modo, sarebbe a rischio la sua effettiva efficacia, dal momento che la questione è quella di liberare finalmente l’Europa dall’eterna inerzia dei negoziati intergovernativi. Dobbiamo ricordare che la regola dell’unanimità fiscale in vigore nell’Unione europea blocca da anni l’adozione di qualsiasi imposta europea e sostiene l’eterna evasione nel dumping fiscale dei ricchi e dei più mobili, una pratica che continua ancora oggi nonostante tutti gli interventi. Questa situazione si protrarrà nel caso in cui non vengano stabilite altre regole decisionali.
Dal momento che questa Assemblea europea avrà la capacità di decidere le imposte e di entrare nel cuore del patto democratico, fiscale e sociale degli Stati membri, è importante coinvolgere realmente i parlamentari nazionali ed europei. Conferendo ai membri eletti nazionali un ruolo centrale, le elezioni nazionali e parlamentari si trasformeranno di fatto in elezioni europee. Gli eletti nazionali non potranno più limitarsi a trasferire la responsabilità a Bruxelles e non avranno altra scelta che spiegare agli elettori i progetti e i bilanci che intendono difendere in seno all’Assemblea europea. Riunendo i parlamentari nazionali ed europei in un’unica Assemblea, si creeranno abitudini di co-governance che al momento esistono solo tra i capi di Stato e i ministri delle finanze.
Per questo motivo proponiamo nel Trattato di democratizzazione disponibile online (www.tdem.eu), che l’80% dei membri dell’Assemblea europea provengano da membri dei parlamenti nazionali dei paesi firmatari del Trattato (in proporzione alla popolazione dei paesi e dei gruppi politici), e il 20% dall’attuale Parlamento europeo (in proporzione ai gruppi politici). Questa scelta merita di essere ulteriormente discussa. In particolare, il nostro progetto potrebbe funzionare anche con una percentuale inferiore di parlamentari nazionali (ad esempio il 50%).
Ora dobbiamo agire rapidamente. Se da un lato sarebbe auspicabile che tutti i paesi dell’Unione europea aderissero senza indugio a questo progetto e benché sia preferibile che i quattro maggiori paesi della zona euro (che insieme rappresentano oltre il 70 per cento del PNL e della popolazione della zona euro) lo adottino fin dall’inizio, il progetto nel suo complesso è stato concepito per essere adottato e applicato da qualsiasi sottoinsieme di paesi che lo desiderino. Questo punto è importante perché consente ai paesi e ai movimenti politici che lo desiderino di dimostrare la propria volontà di compiere progressi ben precisi adottando questo progetto, o una sua versione migliorata, fin da subito.
Invitiamo ogni uomo e ogni donna ad assumersi le proprie responsabilità e a partecipare a una discussione articolata e costruttiva per il futuro dell’Europa.
Thomas Piketty, economista francese, è tra i firmatari dell’appello. L’elenco completo è su www.tdem.eu
* Fonte: la Repubblica, 10.12.2018
*MANIFESTO-PETIZIONE: https://you.wemove.eu/campaigns/per-la-democratizzazione-dell-europa?utm_campaign=p&utm_medium=widget&utm_source=youmove
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- Parigi: «È in corso una secessione interna all’Occidente». "No Society": "France Périphérique". Intervista a Christophe Guilluy.3 dicembre 2018, di Federico La Sala
Intervista a Christophe Guilluy
"Negli Scontri di Parigi è nata la secessione sociale"
di Anais Ginori (la Repubblica, 03.12.2018)
PARIGI Il geografo Christophe Guilluy ha inventato quattro anni fa il termine "France Périphérique" mappando sul territorio le classi popolari escluse dalla globalizzazione. «Per molto tempo non sono stato ascoltato», ricorda Guilluy, citato oggi come uno dei primi intellettuali ad aver avviato una riflessione sul divorzio tra popolo ed élite. I suoi libri - l’ultimo "No Society" che sarà tradotto in Italia - sono al centro dell’analisi sui gilet gialli, la grande rivolta della Francia Periferica. «È in corso una secessione interna all’Occidente», spiega Guilluy.
La Francia è l’epicentro di questa crisi?
«Da anni spiego che c’è un elefante malato in mezzo al negozio di porcellana. Molti rispondevano: ma no, è solo una tazza scheggiata. E invece l’elefante eccolo qui: è la classe media. Sono agricoltori e operai, famiglie delle zone semiurbane, piccoli commercianti e imprenditori che non arrivano a fine mese. Dopo Brexit, elezione di Trump, cambio di governo in Italia, tutti vedono il problema ma siamo ormai arrivati a un punto di insurrezione» . Quando è cominciata la "secessione" tra popolo ed élite?
«Io prendo come inizio la famosa frase di Margaret Thatcher del 1987: "There is no society". Il suo messaggio è stato ripreso non solo dai conservatori ma dall’insieme delle classi dominanti occidentali. Tutte hanno abbandonato la nozione di bene comune in favore della privatizzazione dello Stato.
 Siamo così entrati in quella che definisco "a-società", con la crisi della rappresentanza politica, l’atomizzazione dei movimenti sociali, l’arroccamento delle borghesie, l’indebolimento del welfare».
Siamo così entrati in quella che definisco "a-società", con la crisi della rappresentanza politica, l’atomizzazione dei movimenti sociali, l’arroccamento delle borghesie, l’indebolimento del welfare».Tutte le statistiche dimostrano che la Francia è oggi più ricca di qualche decennio fa. Non è un paradosso?
«È un andamento che giova solo al ceto medio alto: sono i vincenti della globalizzazione ormai asserragliati tra Parigi e le altre grandi metropoli. Il modello economico non sa integrare la maggioranza dei lavoratori».
C’è una specificità francese?
«Esiste una Francia periferica come esiste un’Italia periferica, tra Mezzogiorno e altre zone remote. Mentre la sinistra pensa sia solo una questione sociale, la destra riduce tutto a una crisi identitaria.
 Sbagliano entrambi. E a complicare le cose in Francia c’è un sistema di fabbricazione delle élite che produce un pensiero conformista».
Sbagliano entrambi. E a complicare le cose in Francia c’è un sistema di fabbricazione delle élite che produce un pensiero conformista».Dove porterà questa crisi?
«È solo l’inizio. La buona notizia è che ormai i perdenti non sono più invisibili. Quel che succede in Francia ne è una straordinaria dimostrazione».
Ovvero?
«Non è un caso che il movimento abbia preso come simbolo il gilet giallo usato dagli automobilisti per essere avvistati sulle strade. È un modo rudimentale di combattere contro l’invisibilità sociale. I gilet gialli hanno già vinto la loro battaglia culturale come direbbe Gramsci. Finalmente si parla di loro».
L’unico collante della protesta è l’opposizione a Macron?
«Molti hanno pensato che potesse affrancarsi dall’ideologia dominante. Invece Macron si è allineato, come già avevano fatto Hollande, Sarkozy. Adesso l’unica soluzione per il presidente è prendere sul serio le rivendicazioni del popolo».
Alla fine sono i populisti che cavalcano la rabbia e ci guadagnano.
«I populisti si adattano alla domanda politica. Un buon esempio è Salvini, che viene dalla sinistra, è stato neoliberista, secessionista e oggi invece è in un governo che fa votare il reddito di cittadinanza e si fa applaudire nel sud Italia. Nel medio periodo però il voto populista non risolve nulla».
Perché?
«Le classi popolari non vogliono mendicare, non si accontentano di un nuovo sussidio o del reddito di cittadinanza. Quel che vogliono è poter vivere dignitosamente con un lavoro e una giusta remunerazione».
La Francia Periferica è orfana della sinistra?
«La gauche ha compiuto una doppia cesura: con la sua base popolare e con la sua visione teorica. Il partito comunista è stato forte perché rappresentava il proletariato, ma aveva una classe intellettuale capace di elaborare strumenti di trasformazione sociale. Solo ristabilendo un legame di fiducia tra l’alto e il basso si potranno ricostruire le società occidentali».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA: LA QUERELA (DEL 1517) DI ERASMO DI ROTTERDAM.19 novembre 2018, di Federico La Sala
MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA ...
iL "PADRE NOSTRO"?! Alcune pagine dalla "Querela pacis" (1517)
di Erasmo *
Pochi anni fa, quando il mondo era travolto a prendere le armi da non so quale peste esiziale, alcuni araldi del Vangelo, frati Minori e Predicatori, dal sacro pulpito davano fiato ai corni di guerra e ancor piú infervoravano chi già propendeva per quella follia. In Inghilterra aizzavano contro i Francesi, in Francia animavano contro gli Inglesi, ovunque spronavano alla guerra. Alla pace non incitava nessuno tranne uno o due, a cui costò quasi la vita l’aver soltanto pronunciato il mio nome.
 Prelati consacrati scorrazzavano un po’ dovunque dimentichi della loro dignità e dei loro voti, e inasprivano con la loro opera il morbo universale, istigando ora il pontefice romano Giulio, ora i monarchi ad affrettare la guerra, quasi che non fossero già abbastanza folli per conto loro. Eppure questa patente pazzia noi l’avvolgemmo in splendidi titoli.
Prelati consacrati scorrazzavano un po’ dovunque dimentichi della loro dignità e dei loro voti, e inasprivano con la loro opera il morbo universale, istigando ora il pontefice romano Giulio, ora i monarchi ad affrettare la guerra, quasi che non fossero già abbastanza folli per conto loro. Eppure questa patente pazzia noi l’avvolgemmo in splendidi titoli.
 A tal fine sono da noi distorte con somma impudenza - dovrei dire con sacrilegio - le leggi dei padri, gli scritti di uomini santi, le parole della Sacra Scrittura. Le cose sono giunte a tal punto che risulta sciocco e sacrilego pronunciarsi contro la guerra ed elogiare l’unica cosa elogiata dalla bocca di Cristo. Appare poco sollecito del bene del popolo e tiepido sostenitore del sovrano chi consiglia il massimo dei benefici e scoraggia dalla massima delle pestilenze.
A tal fine sono da noi distorte con somma impudenza - dovrei dire con sacrilegio - le leggi dei padri, gli scritti di uomini santi, le parole della Sacra Scrittura. Le cose sono giunte a tal punto che risulta sciocco e sacrilego pronunciarsi contro la guerra ed elogiare l’unica cosa elogiata dalla bocca di Cristo. Appare poco sollecito del bene del popolo e tiepido sostenitore del sovrano chi consiglia il massimo dei benefici e scoraggia dalla massima delle pestilenze.Ormai i sacerdoti seguono perfino le armate, i vescovi le comandano, abbandonando le loro chiese per occuparsi degli affari di Bellona. Ormai la guerra produce addirittura sacerdoti, prelati, cardinali ai quali il titolo di legato al campo sembra onorifico e degno dei successori degli Apostoli. Per cui non fa meraviglia se hanno spirito marziale coloro che Marte ha generato. Per rendere poi il male insanabile, coprono un tale sacrilegio col sacro nome della religione. Sugli stendardi sventola la croce.
 Armigeri spietati e ingaggiati per poche monete a compiere macelli spaventosi innalzano l’insegna della croce, e simboleggia la guerra il solo simbolo che dalla guerra poteva dissuadere.
Armigeri spietati e ingaggiati per poche monete a compiere macelli spaventosi innalzano l’insegna della croce, e simboleggia la guerra il solo simbolo che dalla guerra poteva dissuadere.
 Che hai a che fare con la croce, scellerato armigero? I tuoi sentimenti, i tuoi misfatti convenivano ai draghi, alle tigri, ai lupi. -Quel simbolo appartiene a Colui che non combattendo ma morendo colse la vittoria, salvò e non distrusse; da lí soprattutto potevi imparare quali sono i tuoi nemici, se appena sei cristiano, e con quale tattica devi vincere.
Che hai a che fare con la croce, scellerato armigero? I tuoi sentimenti, i tuoi misfatti convenivano ai draghi, alle tigri, ai lupi. -Quel simbolo appartiene a Colui che non combattendo ma morendo colse la vittoria, salvò e non distrusse; da lí soprattutto potevi imparare quali sono i tuoi nemici, se appena sei cristiano, e con quale tattica devi vincere.
 Tu innalzi l’insegna della salvezza mentre corri alla perdizione del fratello, e fai perire con la croce chi dalla croce fu salvato?
Tu innalzi l’insegna della salvezza mentre corri alla perdizione del fratello, e fai perire con la croce chi dalla croce fu salvato? Ma che! Dai sacri e adorabili misteri trascinati anch’essi per gli accampamenti, da queste somme raffigurazioni della concordia cristiana si corre alla mischia, si avventa il ferro spietato nelle viscere del fratello e sotto gli occhi di Cristo si dà spettacolo della piú scellerata delle azioni, la piú gradita ai cuori empi: se pure Cristo si degni di essere là. Colmo poi dell’assurdo, in entrambe le armate, in entrambi gli schieramenti brilla il segno della croce, in entrambe si celebra il sacrificio. -Quale mostruosità è questa? La croce in conflitto con la croce, Cristo in guerra con Cristo. È un simbolo fatto per atterrire i nemici della cristianità: perché adesso combattono quello che adorano? Uomini degni non di quest’unica croce, ma della croce patibolare.
Ma che! Dai sacri e adorabili misteri trascinati anch’essi per gli accampamenti, da queste somme raffigurazioni della concordia cristiana si corre alla mischia, si avventa il ferro spietato nelle viscere del fratello e sotto gli occhi di Cristo si dà spettacolo della piú scellerata delle azioni, la piú gradita ai cuori empi: se pure Cristo si degni di essere là. Colmo poi dell’assurdo, in entrambe le armate, in entrambi gli schieramenti brilla il segno della croce, in entrambe si celebra il sacrificio. -Quale mostruosità è questa? La croce in conflitto con la croce, Cristo in guerra con Cristo. È un simbolo fatto per atterrire i nemici della cristianità: perché adesso combattono quello che adorano? Uomini degni non di quest’unica croce, ma della croce patibolare.Ditemi, come il soldato può recitare il “Padre nostro” durante queste messe? Bocca insensibile, osi invocare il Padre mentre miri alla gola del tuo fratello? “Sia santificato il tuo nome”: come si potrebbe sfregiare il nome di Dio piú che con queste vostre risse? “Venga il tuo regno”: cosí preghi tu che su tanto sangue erigi la tua tirannide? “Sia fatta la tua volontà, come in cielo, cosí anche in terra”: Egli vuole la pace, tu prepari la guerra.
 “Il pane quotidiano” chiedi al Padre comune mentre abbruci le messi del fratello e preferisci che vadano perse anche per te piuttosto che giovare a lui?
“Il pane quotidiano” chiedi al Padre comune mentre abbruci le messi del fratello e preferisci che vadano perse anche per te piuttosto che giovare a lui?
 Infine come puoi pronunciare con la lingua le parole “e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” mentre ti lanci a un fratricidio? Scongiuri il rischio della tentazione mentre con tuo rischio getti nel rischio il fratello. “Dal male” chiedi di essere liberato mentre ti proponi di causare il massimo male al fratello?
Infine come puoi pronunciare con la lingua le parole “e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” mentre ti lanci a un fratricidio? Scongiuri il rischio della tentazione mentre con tuo rischio getti nel rischio il fratello. “Dal male” chiedi di essere liberato mentre ti proponi di causare il massimo male al fratello?*
Erasmo da Rotterdam, Il lamento della pace, Einaudi, Torino, 1990, pagg. 51-55.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO, HENRI DE LUBAC, E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- EUROPA 1918. "DOPO GLI ULTIMI": EPISTOLA DI BENEDETTO XV AL CARDINALE GASPARRI (DAL VATICANO, 8 NOV. 1918).11 novembre 2018, di Federico La Sala
EUROPA 1918 - EUROPA 2018. Noi pregustiamo la dolcezza di quel giorno, non più lontano, in cui la carità tornerà a regnare ....
- [Dal Vaticano, 8 novembre 1918]
EPISTOLA
DOPO GLI ULTIMI
 DEL PAPA BENEDETTO XV
DEL PAPA BENEDETTO XV
 AL CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
AL CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA
 PIETRO GASPARRI,
PIETRO GASPARRI,
 SEGRETARIO DI STATO,
SEGRETARIO DI STATO,
 IN OCCASIONE DELLA FIRMA DELL’ARMISTIZIO
IN OCCASIONE DELLA FIRMA DELL’ARMISTIZIO
 FRA ITALIA E AUSTRIA *
FRA ITALIA E AUSTRIA *Signor Cardinale, dopo gli ultimi fortunati successi delle armi italiane, i nemici di questa Sede Apostolica, fermi nel loro proposito di sfruttare a suo danno tanto i tristi quanto i lieti avvenimenti, hanno procurato e procurano di eccitare contro di essa l’opinione pubblica italiana esultante per la ottenuta vittoria, quasi che il Sommo Pontefice ne fosse invece in cuor suo dispiacente.
Ella, signor Cardinale, ben conosce per quotidiana consuetudine i Nostri sentimenti, come altresì quale sia la prassi e la dottrina della Chiesa in simili circostanze. Nella lettera del 1° agosto 1917 ai Capi delle diverse Potenze belligeranti Noi facemmo voti, ripetuti poi anche in altre occasioni, perché le questioni territoriali fra l’Austria e l’Italia ricevessero soluzione conforme alle giuste aspirazioni dei popoli; e recentemente abbiamo dato istruzione al Nostro Nunzio in Vienna di porsi in amichevoli rapporti colle diverse nazionalità dell’Impero Austro-Ungarico che ora si sono costituite in Stati indipendenti. Egli è che la Chiesa, società perfetta, che ha per unico fine la santificazione degli uomini di ogni tempo e di ogni paese, come si adatta alle diverse forme di Governo, così accetta senza veruna difficoltà le legittime variazioni territoriali e politiche dei popoli.
Crediamo che se questi Nostri giudizi ed apprezzamenti fossero più generalmente conosciuti, nessuna persona assennata vorrebbe insistere nell’attribuirci un rammarico che non ha fondamento.
Non possiamo peraltro negare che una nube turba ancora la serenità nell’animo Nostro, perché non sono cessate dovunque le ostilità, ed il fragore delle armi cagiona ancora in più luoghi e preoccupazioni e timori. Ma, sperando che la lieta aurora di pace, spuntata anche sul Nostro diletto paese, non tardi ormai a rallegrare gli altri popoli belligeranti, Noi pregustiamo la dolcezza di quel giorno, non più lontano, in cui la carità tornerà a regnare fra gli uomini e la universale concordia stringerà le Nazioni in lega feconda di bene.
Ci è caro intanto di confermare a lei, signor Cardinale, la Nostra particolare benevolenza, e vogliamo che di questa Le sia nuovo pegno la Benedizione Apostolica che le impartiamo con effusione di specialissimo affetto.
*
Dal Vaticano, 8 novembre 1918.
BENEDICTUS PP. XV
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- PIRANDELLO E LA BUONA-NOVELLA. DALL’ITALIA, DALLA SICILIA, DA AGRIGENTO, DA BONN, DA ROMA, DA MILANO, DA NAPOLI, DA SAN GIOVANNI IN FIORE, E DA GERUSALEMME: UN "URLO" MAGISTRALE PER BENEDETTO XV ... E BENEDETTO XVI
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"! I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
- PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- GERMANIA. Weimar 1918-2018. Cent’anni dopo la sindrome tedesca torna d’attualità (di Gian Enrico Rusconi).8 novembre 2018, di Federico La Sala
Weimar 1918-2018
Cent’anni dopo la sindrome tedesca torna d’attualità
di Gian Enrico Rusconi (La Stampa, 08.11.2018)
Anche la Germania festeggia il novembre 1918 - a suo modo. Ricorda la sua «rivoluzione democratica» del 9 novembre da cui è nata la prima repubblica tedesca. Questa passerà alla storia come la Germania di Weimar, dal nome della città dove viene elaborata la nuova Costituzione. Ma Weimar rimane nella memoria collettiva e nella storiografia come esperienza politica fallita: come il «fantasma di Weimar».
Nessuno poteva immaginare che anche oggi le difficoltà della situazione politica tedesca potessero rievocare quel fantasma. -Dieci anni fa, in occasione del novantesimo anniversario della rivoluzione, era stato molto apprezzato un saggio intitolato Dalla democrazia improvvisata alla democrazia riuscita.
 «Improvvisata» era considerata la democrazia di Weimar, «riuscita» invece era quella della Bundesrepublik. Questa aveva accolto molti aspetti positivi (soprattutto di ordine sociale) della Costituzione weimariana, ma ne aveva corretti altri.
«Improvvisata» era considerata la democrazia di Weimar, «riuscita» invece era quella della Bundesrepublik. Questa aveva accolto molti aspetti positivi (soprattutto di ordine sociale) della Costituzione weimariana, ma ne aveva corretti altri.
 Aveva ridotto drasticamente le competenze del presidente della Repubblica che a Weimar aveva di fatto portato a un regime presidenziale diventato poi (preterintenzionalmente) un regime totalitario; aveva introdotto la «sfiducia costruttiva» per evitare i pericoli della ingovernabilità; aveva imposto ai partiti la soglia di sbarramento del 5% per evitare la frammentazione partitica.
Aveva ridotto drasticamente le competenze del presidente della Repubblica che a Weimar aveva di fatto portato a un regime presidenziale diventato poi (preterintenzionalmente) un regime totalitario; aveva introdotto la «sfiducia costruttiva» per evitare i pericoli della ingovernabilità; aveva imposto ai partiti la soglia di sbarramento del 5% per evitare la frammentazione partitica.Ma l’iniziativa più importante è stata l’enunciazione di una serie di diritti fondamentali inalienabili che garantiscono l’intangilità stessa della sostanza democratica della Costituzione. Detto in termini più espliciti: nessuna maggioranza parlamentare può modificare i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
 A questo scopo è stato istituito un organo di controllo effettivo della costituzionalità delle iniziative politiche partitiche: la Difesa della Costituzione (Verfassungsschutz).
A questo scopo è stato istituito un organo di controllo effettivo della costituzionalità delle iniziative politiche partitiche: la Difesa della Costituzione (Verfassungsschutz).
 Tutto ciò mancava a Weimar. I suoi nemici godevano della libertà democratica di distruggerla - in nome del «popolo» quale era interpretato dalla destra estrema e poi dal nazionalsocialismo.
Tutto ciò mancava a Weimar. I suoi nemici godevano della libertà democratica di distruggerla - in nome del «popolo» quale era interpretato dalla destra estrema e poi dal nazionalsocialismo.Dobbiamo preoccuparci anche oggi? Perché gli organi per la Difesa della Costituzione hanno aumentato la loro attenzione verso i comportamenti di alcuni gruppi e movimenti di estrema destra, comprese alcune sezioni regionali della Alternative für Deutschland, il partito «populista di destra» che siede in Parlamento con il 12,6% ed è presente ormai in tutti i Parlamenti dei Länder? Mette in pericolo la democrazia? Si sta creando una sindrome Weimar?
È sbagliato equiparare senz’altro il «populismo di destra» di oggi con la destra razzista e antidemocratica degli anni Trenta, con il nazionalsocialismo. Anche se non mancano frange neonaziste, saluti hitleriani nelle manifestazioni pubbliche e soprattutto atteggiamenti e linguaggi völkisch, che sono il modo tipico tedesco di essere populisti radicali. L’ Alternative für Deutschland (AfD) non è la Nsdap (il partito nazista); tra i suoi leader non ci sono Führer carismatici o aspiranti tali. I vertici politici dell’AfD non sono «negazionisti». Eppure lamentano il «culto della colpa», che sarebbe stato imposto ai tedeschi dalla sinistra e dal liberalismo di sinistra per quanto è accaduto con il nazismo. A detta del leader della AfD, invece, il nazismo è stata semplicemente una «stronzata» (sic) rispetto alla lunga gloriosa storia tedesca.
Queste parole sono soltanto espressione dell’involgarimento del linguaggio pubblico o segnalano qualcosa di più insidioso? Nelle manifestazioni pubbliche dei movimenti affini alla AfD vengono urlate espressioni che risentono del vecchio linguaggio völkisch, diventato poi nazista, con particolare insistente denuncia della «stampa bugiarda» (Lügenpresse). Il rifiuto dei migranti assume toni ossessivi. Ogni migrante è visto virtualmente come un criminale e soprattutto non integrabile. La presenza di massa di migranti (soprattutto di fede islamica) mette a repentaglio la cultura e l’integrità della popolo tedesco. L’assoluta centralità del concetto di popolo-Volk, miticamente elevato a criterio di omogeneità etno-culturale, pretende unanimità dei consensi. Chi non è d’accordo in nome di quello che è diffamato come «astratto universalismo» o «impossibile multiculturalismo», è nemico del popolo.
«Noi siamo il popolo» è lo slogan che ha caratterizzato la «rivoluzione pacifica» del 1989 nella ex Ddr comunista. Ora viene usato contro il governo democratico e in generale contro il sistema dei partiti esistenti. Ci sono tutti i motivi perché gli organi della Difesa della Costituzione siano in allerta. Ma probabilmente all’orizzonte non c’è una fine della democrazia in stile Weimar, ma una variante non meno insidiosa per la quale è già pronto il nome, sulla base di alcune esperienze che abbiamo sotto i nostri occhi: una democrazia illiberale.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- 4 NOVEMBRE 1918 - 2018. L’«inutile strage» cambiò l’assetto dell’Europa. La fine di una Grande Guerra che durò ancora a lungo.4 novembre 2018, di Federico La Sala
Centenario.
La fine di una Grande Guerra che durò ancora a lungo
Un secolo fa la battaglia di Vittorio Veneto e il crollo della Germania. L’«inutile strage» cambiò l’assetto dell’Europa e innescò una crisi che toccò l’apice nel 1929
di Gianpaolo Romanato (Avvenire, sabato 3 novembre 2018)
- [Foto]: Soldati italiani in trincea
Oggi celebriamo il centenario della fine della Prima guerra mondiale cui seguì la Conferenza di pace di Parigi (18 gennaio 1919 - 21 gennaio 1920). Ma un bel libro dello storico tedesco Robert Gerwarth, apparso l’anno scorso da Laterza - La rabbia dei vinti. La guerra dopo la guerra. 1917-1923 - ha ben chiarito che nel novembre del 1918 la guerra non finì affatto. Per altri cinque anni almeno in tutta l’Europa continuarono guerre, rivoluzioni, massacri, di ogni tipo. Dalla Finlandia all’Anatolia, dal Caucaso all’Irlanda, dalla Germania alla Grecia, la violenza continuò a dilagare e a mietere vittime. E siccome in diversi casi (Finlandia, Russia, Bulgaria, Ungheria, Germania) si trattò di guerre civili, la selvaggia ferocia in cui precipitò il continente che fino al 1914 si era attribuito la missione di insegnare al mondo la civiltà - ferocia freddamente raccontata con abbondanza di particolari da Gerwarth nelle sue pagine - ci lascia senza parole. Anche senza contare l’epidemia di spagnola, si può affermare che «le vittime dei conflitti armati dell’Europa in quei cinque anni furono ben più di 4 milioni, più delle perdite subite complessivamente dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dagli Stati Uniti durante la Grande guerra».
Insomma, per un decennio (la guerra più il dopoguerra), i popoli europei sono stati i più violenti, i più turbolenti, i più crudeli del pianeta. Ma allora, che pace celebreremo nei prossimi mesi? Che cosa ci racconteremo nei convegni, nelle tavole rotonde, nei libri che riempiranno le biblioteche? Vale la pena di chiedercelo, prima che inizi il festival delle rimembranze. E merita di farlo con l’ausilio di due libri che furono scritti a caldo, a ridosso della Conferenza di Parigi, da due uomini che avevano partecipato alla Conferenza stessa. Due libri preveggenti, controcorrente, che non hanno il sapore della facile e comoda scienza del dopo. Il primo fu pubblicato alla fine del 1919 da John M. Keynes, il celebre economista britannico: Le conseguenze economiche della pace (Adelphi, 2007). Il secondo dal politico italiano Francesco Saverio Nitti alla fine del 1921: L’Europa senza pace (riedizione con prefazione di Giulio Sapelli, goWare, 2014). Entrambi scrissero che il summit parigino - svoltosi mentre il continente era ancora in fiamme - tutto fece tranne che predisporre una pace equa e duratura.
Scrive dunque Nitti - che era stato Ministro del tesoro dopo Caporetto e Presidente del consiglio tra il 1919 e il 1920 - che a Parigi (città la meno adatta a ospitare la conferenza, traboccando di odio antitedesco) si architettò una pace cartaginese volta solo a distruggere la Germania. Grande regista dell’operazione fu Georges Clemanceau, che condusse la Conferenza come se il dopoguerra non fosse altro che una prosecuzione della guerra sotto altre forme, mentre una vera pacificazione esige moderazione, equilibrio, sguardo volto al futuro e non condizionato dal passato. Il presidente americano Wilson, totalmente ignaro dei problemi europei, finì al rimorchio dei francesi e disattese la lettera e lo spirito dei 14 punti che aveva enunciato portando il suo paese in guerra, mentre il presidente italiano Orlando, condizionato dall’unico (e falso) problema di Fiume, fu un irrilevante comprimario. I soli a comprendere che si viaggiava verso il baratro furono gli inglesi, ma senza la sponda italiana, non appoggiati dagli americani, condizionati dall’esigenza di difendere la loro supremazia navale e coloniale, non riuscirono ad arginare la furia dei francesi.
In questo clima avvelenato maturò la punizione dei vinti a opera dei vincitori. Alla Germania furono imposte amputazioni territoriali tanto a est come a ovest (con conseguente perdita dei territori più ricchi di carbone); la totale smilitarizzazione della Renania (che consegnava alla Francia una pistola carica puntata contro la Germania); la cessione come bottino di guerra di gran parte del patrimonio ferroviario e navale, che ne prostrò definitivamente l’economia; un ridimensionamento talmente drastico dell’organizzazione militare da rendere difficile anche il controllo dell’ordine interno; la cessione di tutte le colonie. In pratica veniva lasciata in totale balia della Francia a ovest e di una fragilissima Polonia a est (Nitti fa notare che più di metà della rinata Polonia era abitata da popolazioni non polacche). Analoghe misure furono assunte nei confronti dell’ex Impero austro-ungarico, in particolare nei confronti dell’Ungheria.
In questa revisione territoriale dell’Europa, che ne cambiò radicalmente la fisionomia (bisogna mettere a confronto una carta geografica del 1914 con una del 1920 per rendersene conto), si commisero tre errori capitali. Il primo fu quello di disseminare l’Europa orientale (Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Iugoslavia) di minoranze tedesche e magiare destinate a essere un perenne focolaio di disordini. Il secondo consistette nell’attribuire ai paesi nuovi (in particolare ex austro-ungarici) una forza di contenimento che essi (deboli, divisi, improvvisati) non erano in grado di esercitare. In particolare fu premiata la Polonia (con la follia del cosiddetto “corridoio di Danzica”, che le assicurava lo sbocco al mare rompendo contro ogni logica geopolitica la continuità territoriale della Germania) nella falsa illusione che potesse essere un valido divisorio fra due vicini fatalmente troppo più forti di lei, la Germania e la Russia.
Non essendo stato poi affrontato il problema della Russia, in quel momento travolta dalla rivoluzione, non ci si accorse di creare nell’est europeo quel ventre molle del continente che è rimasto una questione irrisolta fino a oggi. Il terzo errore fu la creazione dell’Austria, ridotta al solo territorio tedesco dell’ex Impero asburgico, ma con una clausola che le impediva di unirsi alla Germania. Un’altra mina vagante, che il primo demagogo avrebbe potuto far esplodere.
La conclusione di Nitti è in questo suo giudizio quasi scultoreo: «Tutta la storia dei popoli di Europa non è che un’alterna vicenda di vittorie e di sconfitte. La civiltà consiste nel determinare quelle condizioni che rendono la vittoria meno brutale e la sconfitta più tollerabile. I recenti trattati che regolano o dovrebbero regolare i rapporti fra i popoli rappresentano uno spaventevole regresso, la negazione di quelli che erano i principi acquisiti del diritto pubblico». E infatti, come oggi ben sappiamo, ressero, e anche malamente, solo vent’anni.
Il libro di Keynes, che aveva fatto parte della delegazione britannica a Parigi, dalla quale si era dimesso il 7 giugno del 1919, uscì prima di quello di Nitti, alla fine del 1919. Da economista, egli affronta soprattutto la questione dei debiti e delle riparazioni imposte dai vincitori, scrivendo che si stava pretendendo l’impossibile dai vinti e che la distruzione economica della Germania, ovvero del cuore pulsante del continente, del territorio più ricco e produttivo, attraverso il quale transitano obbligatoriamente uomini, merci, alimenti e rifornimenti di ogni paese, sarebbe ricaduta addosso a tutti, precipitando l’Europa e il mondo intero in una crisi senza precedenti.
A Parigi si aveva una «sensazione di incubo», scrive in una delle pagine più forti del libro, osservando la «leggerezza, la cecità, l’arroganza» con cui, tra «vuoti e aridi intrighi», i cosiddetti Grandi trattavano le sorti dei popoli, mentre «quasi ad ogni ora arrivavano notizie della miseria, disordine e disgregazione di tutta l’Europa centrale e orientale», dello «sfinimento» di mezzo continente dove si tornava a morire per mancanza di alimenti come all’epoca della Guerra dei Trent’anni. «È straordinario - aggiunge, ripensando ai mesi in cui prese parte ai lavori parigini - come il fondamentale problema di un’Europa che languiva di fame e si sgretolava davanti ai loro occhi sia la sola questione sulla quale fu impossibile suscitare l’interesse dei Quattro». Accecati dall’odio, preoccupati solo di aumentare il bottino a proprio favore, non videro che nell’intero continente, anche nel campo dei vincitori, «la terra tremava» e stavano iniziando «le paurose convulsioni di una civiltà morente», che avrebbe travolto i vincitori non meno dei vinti. «Chiedendo l’impossibile - aggiunse - alla fine perderanno tutto».
Che fare allora? La proposta di Keynes si può riassumere citando questa sua pagina: «La guerra è terminata con tutti che devono a tutti enormi somme di denaro. La Germania deve un’enormità agli Alleati; gli Alleati devono un’enormità alla Gran Bretagna; la Gran Bretagna deve un’enormità agli Stati Uniti. In ogni paese lo Stato deve un’enormità ai possessori di cartelle del prestito di guerra; e questi e altri contribuenti devono un’enormità allo Stato. L’intera situazione è artificiosa, fuorviante vessatoria al massimo grado. Non riusciremo più a fare un passo se non districhiamo le gambe da questi ceppi cartacei. Un falò generale è una necessità così impellente, che se non vi provvediamo in modo ordinato e benigno, senza fare grave ingiustizia a nessuno, il falò, quando infine avrà luogo, diventerà un incendio che può distruggere molte altre cose insieme».
Dunque: revisione del Trattato di Versailles e condono generale di debiti e crediti. Non si fece né l’una né l’altra cosa. Quando Keynes scriveva il suo libro, Hitler era solo uno degli innumerevoli disperati che vagabondavano per le vie di Monaco. Se si fosse data retta all’economista inglese, a Nitti, ai molti che condividevano le loro idee, sarebbe probabilmente rimasto tale.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EUROPA. LA PREMESSA DELLA CATASTROFE: IL TRATTATO DI VERSAILLES. L’atto di accusa (1919) di John M. Keynes. Una nota di Dario Antiseri
- MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. "VA’, RIPARA LA MIA CASA"!!! Benedetto XVI ha ricordato la conversione di Francesco: «l’ex play boy convertito dalla voce di Dio»... ma ha "dimenticato" la denuncia sul "ritardo dei lavori", fatta da Pirandello già a Benedetto XV. Che disastro!!!
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
-
> RIPENSARE L’EUROPA! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" - Quando Curzio Malaparte scrisse “Tecnica del colpo di stato” non immaginava che (di Juan Luis Cebrian).2 novembre 2018, di Federico La Sala
I colpi di Stato senza militari che mettono alla prova la democrazia
di Juan Luis Cebrian (La Stampa, 02.11.2018)
Quando Curzio Malaparte scrisse “Tecnica del colpo di stato” non immaginava che, col passare del tempo, i processi di sostituzione del potere costituito con metodi illegali sarebbero migliorati in modo consistente grazie ai progressi della tecnologia e ai nuovi equilibri della società. Corrono voci insistenti secondo le quali Jair Bolsonaro, vincitore indiscusso del secondo turno delle elezioni brasiliane, sarà presidente del Paese grazie a un piano premeditato contro il potere legittimo del Pt (il partito dei lavoratori guidato da Lula), quando forze più o meno occulte andarono all’attacco della presidenza di Dilma Rousseff. Da lì ebbe inizio, in modo apparentemente rispettoso degli usi democratici, anche se non altrettanto delle regole del gioco, l’offensiva neofascista che sarebbe culminata nella vittoria elettorale di domenica.
Anche in Spagna i separatisti catalani sono stati accusati dai partiti fedeli alla Costituzione di aver tentato un colpo di stato quando hanno approvato unilateralmente l’indipendenza. Molti autori affermano che i colpi di stato classici, con gli appelli all’esercito e all’uso della forza, non si usano più. Si parla, ad esempio, di golpe finanziario, se si manipolano le quotazioni di Borsa e il tasso di cambio per indebolire o far cadere i governi, e di autogolpe quando il potere costituito si mette scientemente in pericolo per cercare di perpetuarsi, come nel Perù di Fujimori.
Il fantasma di Bannon
L’uso dei social network per influenzare le elezioni diffondendo notizie false e voci diffamatorie su questo o quel candidato è un altro modo per distorcere la realtà e screditare l’avversario e per cercare di sconfiggerlo alle urne. I movimenti populisti, da Trump a Salvini, mettono costantemente in atto questo metodo con risultati non disprezzabili. Gli oppositori di Bolsonaro accusano Steve Bannon, senza portare alcuna prova, di aver contribuito a sobillare i social network contro i partiti di sinistra. Sia vero o no, gli obiettivi e l’ideologia dell’ ex capo della campagna elettorale di Trump sostanzialmente coincidono con il pensiero del nuovo presidente del Brasile, e sono contigui agli impulsi antidemocratici dei governanti della Polonia o dell’Ungheria, e anche a quelli dei sostenitori del caotico governo italiano. Però anche la vittoria nel Paese del samba di questo ex capitano espulso dall’esercito, xenofobo, razzista e anti-femminista, una specie di maschio alfa prestato alla politica, si deve all’ indignazione popolare per le conseguenze della crisi finanziaria ed economica e all’aumento delle disuguaglianze. La demagogia populista sa come alimentare queste passioni per poi placarle con promesse che non potranno mai essere mantenute.
Il pretesto della corruzione
La corruzione, diffusa non solo in America Latina, per quanto enorme, non cessa di essere un pretesto per suscitare ulteriore malcontento. In Brasile, come nella maggior parte dei Paesi democratici, trova le sue motivazioni nel finanziamento delle campagne elettorali. L’uso di Petrobras, colosso petrolifero di proprietà pubblica, per ottenere fondi per tali fini, è cominciata certamente molto prima del governo di Fernando Henrique Cardoso, iniziale artefice del cosiddetto miracolo brasiliano, il cui impatto economico è stato proseguito dai governi di Lula da Silva.
Dopo la giornata di domenica, il Paese è stato diviso in due parti, e anche questa estrema polarizzazione è un segno dei tempi. C’è chi sostiene che se si fosse espresso oltre il 20% di chi si è astenuto o ha annullato il voto, il risultato sarebbe stato diverso, ma è un argomento discutibile. La verità è che Bolsonaro ha unito tutte le forze conservatrici e che, incredibilmente, anche i liberali hanno aderito alle sue proposte di estrema destra, che minacciano di distruggere il tessuto politico brasiliano. A lui si è contrapposto un candidato indebolito anche dal calendario, perché è stato scelto poco prima delle elezioni, dopo che i tribunali avevano vietato la candidatura di Lula, debole nel suo tentativo di proseguire sulla strada delle politiche socialdemocratiche caldeggiate dai moderati del Pt. I suoi leader hanno dimenticato che l’insicurezza dei cittadini e la crescente violenza delle mafie sono tra i motivi del consenso elettorale di chi promette legge e ordine, anche a costo di mettere a ferro e fuoco il Paese.
Le troppe brutalità
Anche se nelle sue prime dichiarazioni dopo la vittoria Bolsonaro ha cercato di moderare la brutalità del suo linguaggio, nessuno dimentica che durante la campagna elettorale aveva detto che i rossi potevano solo scegliere la prigione o l’esilio e persino che bisognava fucilare gli esponenti del Pt. Il partito e l’ex presidente Lula sono stati demonizzati all’estremo durante la campagna elettorale, ma hanno ancora la rappresentanza più forte in un Parlamento, frammentato in dozzine di gruppi diversi.
Nel breve termine si prevede che l’economia del Paese rimanga stabile, ma i rischi di destabilizzazione politica e la tentazione dell’ala più a sinistra del Pt di portare l’opposizione in piazza disegnano un orizzonte incerto. Le istituzioni democratiche saranno messe seriamente alla prova. Con un esecutivo che fa la voce grossa e una legislatura di maggioranze quasi impossibili, molti democratici guardano ai tribunali come l’unica barriera contro la deriva autoritaria. E anche se un settore considerevole dei giudici si è politicizzato (è sufficiente vedere il destino del presidente Lula) la speranza in una giustizia indipendente appare l’ultimo baluardo per proteggere le minoranze dallo tsunami che si è scatenato domenica scorsa.
 (Traduzione di Carla Reschia)
(Traduzione di Carla Reschia) -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! . La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" - Austerità, armi libere e militari al potere. Ecco la ricetta di Bolsonaro per il Brasile. Dal Venezuela a Cuba, le conseguenze non si faranno attendere.30 ottobre 2018, di Federico La Sala
Austerità, armi libere e militari al potere
Ecco la ricetta di Bolsonaro per il Brasile
Il neo presidente punta ad eliminare burocrazia e corruzione dello Stato nei primi cento giorni di mandato
di Emiliano Guanella (La Stampa 30.10.2018)
SAN PAOLO. «Più Brasile e meno Brasilia» per Jair Bolsonaro, che già questa settimana, però, dovrà affrontare i meandri politici della capitale per iniziare a disegnare la sua squadra di governo. Sebbene si sia presentato come il candidato anti-sistema, Bolsonaro conosce alla perfezione il «mostro» burocratico da dove si controlla la politica brasiliana; è stato deputato per 28 anni di fila, passando da nove partiti differenti, compreso quel PP (partito progressista, anche se in realtà è di destra) che si è alleato con Lula da Silva e Dilma Rousseff e ha fatto parte dello schema di corruzione della Petrobras.
Bolsonaro ha promesso di fare piazza pulita della vecchia politica di favori e alleanze, il «toma là da cà» (prendi questo, dammi quello) che da sempre regna nei corridoi dei palazzi progettati da Oscar Niemeyer. «Ci impegniamo - ha detto - a snellire lo Stato, a liberarlo dalla burocrazia e dalla pressione fiscale enorme sui cittadini che non ricevono nulla in cambio». Pensa ad austerità, rigore e disciplina militare, tanto che ha già ipotecato almeno quattro ministeri a generali o ex generali; Difesa, Trasporti, Educazione e Scienza e Tecnologia. «I militari - ha spiegato - sono meno corrompibili perché i civili hanno sempre paura delle uniformi».
Dalle promesse ai fatti
Dopo le promesse e le fake news di campagna adesso è giunto il momento di pensare a cosa fare nei primi 100 giorni, approfittando della luna di miele data dai mercati. Il Brasile è fermo, dopo la recessione del 2015-2016 la crescita è troppo lenta, non si può perdere tempo. Bolsonaro ha delegato la «questione economica» al neoliberista Paulo Guedes, ex banchiere, scuola di Chicago Boys e garante del governo davanti agli operatori finanziari. Guedes ieri ha spiegato che uno dei primi obiettivi del 2019 sarà quello di azzerare il deficit fiscale, pari oggi al 8% del Pil. Il primo scoglio è la necessaria riforma della previdenza, ma per Bolsonaro non sarà facile visto che dovrà toccare anche gli enormi privilegi dei militari, che in alcuni casi vanno in pensione a 50 anni.
I limiti del budget
L’ex capitano vorrebbe investire molto su sicurezza e infrastrutture, ma deve fare i conti con le ristrettezze della finanziaria 2019. La spesa pubblica rappresenta il 19,3% del Pil e il 93% sono spese obbligatorie che non si possono toccare; in cassa da spendere ci saranno poco più di 25 miliardi di euro, non l’ideale per un governo che inizia. Nel toto ministri ieri è circolato anche il nome di Sergio Moro alla Giustizia. Moro è il cervello della Mani Pulite brasiliana ed è stato il grande accusatore di Lula da Silva; non ha mai nascosto le sue simpatie di un «cambiamento generale» del sistema politico, ma andare al governo sarebbe per lui una mossa forse troppo azzardata. L’alternativa potrebbe essere un posto alla Corte Suprema, visto che Bolsonaro potrà nominare due giudici.
Più vicino a Donald
In politica estera si dà per scontato il riconoscimento di Gerusalemme capitale d’Israele e un maggiore avvicinamento con gli Stati Uniti di Donald Trump, che ha chiamato per congratularsi. I primi viaggi ufficiali del neo presidente del Brasile saranno in Cile e, per l’appunto, negli Stati Uniti. All’Italia Bolsonaro ha promesso l’estradizione di Cesare Battisti, ma il caso è fermo alla Corte Suprema e, almeno per i prossimi mesi, non dipenderà molto da lui.
Tra i progetti considerati prioritari c’è la liberalizzazione del porto d’armi; per farlo basta una maggioranza semplice nel Congresso e la lobby dei fabbricanti capitanata dalla brasiliana Taurus, le cui azioni ieri sono schizzate in Borsa, ha già pronto il progetto di legge. Più complesso, invece, l’iter per ridurre l’età punibile per legge da 18 a 16 anni, che richiede di una maggioranza di tre quinti dei parlamentari. Il pallottoliere mostra oggi 108 deputati fedelissimi a Bolsonaro, 165 all’opposizione e ben 240 deputati di centro pronti a pendere da una parte o dall’altra secondo l’opportunità. Il famoso «centrao» è composto da una dozzina di partiti che sarebbero disposti ad appoggiare il governo ma che difficilmente lo faranno gratuitamente. Bolsonaro ha ripetuto più volte che non farà accordi sullo stile della «vecchia maniera» e ha promesso che ridurrà il numero di ministeri dagli attuali 27 a 15. Ma sarà davvero difficile ottenere l’appoggio di tutti senza scontentare nessuno.
Il Brasile fa tremare le vene dell’America Latina
Democrazia in pericolo. "Fenomeno" Bolsonaro. Perché le classi dominanti si sono sbilanciate a favore di una sorta di neo fascista psicopatico. Dal Venezuela a Cuba, le conseguenze non si faranno attendere
di Roberto Livi (il manifesto, 30.10.2018)
La netta vittoria (55% dei voti contro il 45%) di Jair Bolsonaro mette in pericolo 30 anni di ritorno alla democrazia in Brasile. Questa volta un candidato neo fascista, apertamente favorevole alla repressione violenta di ogni forma di opposizione e organizzazione popolare, sale al potere non grazie alla forza delle armi ma a un consenso popolare basato su un pericolosissimo cocktail: da un lato un (falso) populismo nazionalista e antisistema, dall’altro l’appoggio della corrente più integralista dell’evangelismo americano, scatenato in una guerra senza quartiere a Sodoma e Gomorra. Non è solo il Brasile che trema. Bolsonaro sarà il presidente di estrema destra in una regione dove di recente gli elettori hanno scelto leader conservatori o di destra in paesi come Argentina, Cile, Paraguay, Perù e Colombia. Il Cono sud dell’America latina corre il pericolo di precipitare - se non ai tempi orribili dell’Operazione Condor condotta dalle dittature militari di Pinochet e Videla - nella tenaglia di un blocco autoritario, neoliberista e subordinato alla politica imperiale degli Usa ai tempi di Trump.
LE CONSEGUENZE non tarderanno a farsi sentire per il Venezuela bolivariano, che vede alle sue fontiere due governi di destra (Colombia) ed estrema destra (Brasile) pronti ad appoggiare un’eventuale azione militare «umanitaria» degli Stati uniti. E per Cuba che torna a subire una politica da guerra fredda da parte dell’Amministrazione di superfalchi di Donald Trump.
Fernando Haddad, il candidato sconfitto del partito dei lavoratori (Pt) lo ha detto chiaramente e con coraggio nel suo intervento dopo i risultati finali delle presidenziali: il Brasile popolare deve prepararsi a un periodo di resistenza e di lotta per la democrazia. Non si tratta di difendere un partito o una parte della sinistra ma di organizzare un vasto movimento popolare per la difesa della libertà di espressione e di organizzazione popolare e della vita democratica. Nel gigante sudamericano vi sono molti movimenti popolari e di lotta sociale, dai Senza terra ai Senza tetto, dagli ecologisti alle femministe. Tutti sono ora in pericolo. «O se ne vanno fuori del paese o vanno in galera», è la ricetta promessa da Bolsonaro.
IL SUO PROGRAMMA di sicurezza fa tremare le vene: pene più severe e riduzione dell’età (a 16 anni) per essere responsabili penalmente, armi per tutti e licenza d’uccidere per le forze dell’ordine, che già hanno un triste primato continentale. Secondo, il Forum Brasileiro de Segurança Pública, tenuto conto delle proporzioni tra le popolazioni, la polizia brasiliana uccide 19 volte di più di quella statunitense. A Bolsonaro però va bene così perché «un poliziotto che non uccide non è un poliziotto».
Il nuovo presidente ha promesso mano dura anche contro le riserve degli indios e le aree di conservazione dell’Amazzonia, le principali barriere di contenimento alla devastazione della più grande foresta tropicale e polmone verde del mondo. «Non avranno nemmeno un centimetro di terra». Il ministero dell’Ambiente sarà incorporato a quello dell’Agricoltura che - parola di Bolsonaro - agirà in consonanza col «settore produttivo». Ovvero lascerà «mano libera» all’agrobusiness, ai pascoli delle grandi fazendas, ai latifondisti della soja, alle attività minerarie e ai grileiros, potenti locali che si impadroniscono delle terre pubbliche a colpi di pistola. E che poi le disboscano selvaggiamente.
IL “FENOMENO” BOLSONARO - un parlamentare semisconosciuto che in 28 anni non è riuscito a far approvare un solo progetto di legge e che vede il suo partito passare da un pugno di parlamentari a 53 deputati - non si può spiegare senza l’appoggio dei poteri forti militari, economici e finanziari e dei maggiori mass media.
Perché le classi dominanti si sono sbilanciate a favore di una sorta di psicopatico come Bolsonaro, il cui prossimo governo, come afferma l’analista Xosé Hermida, promette una società polarizzata e «con licenza di odiare»? Come osserva Gramsci nei Quaderni, in situazione di «crisi organica», quando si produce una rottura nell’articolazione esistente tra le classi dominanti e i loro rappresentanti politici e intellettuali, la borghesia e i suoi alleati si sbarazzano dei loro portavoce tradizionali e cercano una figura provvidenziale che permetta di affrontare le sfide del momento.
IN QUESTO CASO le classi dominanti brasiliani si propongono di portare a compimento il “golpe” attuato due anni fa con Temer e che l’attuale presidente - e i suoi alleati conservatori - non sono stati in grado di assicurare: mettere un punto finale all’”eredità” dei governi del Pt. E iniziare un’epoca di neoliberismo con un presidente malleabile, che si affida in materia economica a un Chicago boy col turbo, Paulo Guedes, con una sola filosofia: privatizzare e privatizzare.
Di recente un noto commentatore “liberal” ha affermato che in questa fase i nemici della democrazia in America latina rischiano di essere i giudici (che in Brasile hanno messo in galera Lula) e non i generali. E che questa situazione rappresenta «un progresso» per il subcontinente. L’elezione di Bolsonaro è una solenne smentita.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Brasile. Elezioni presidenziali: Jair Bolsonaro risulta vincitore con il 55,7%, contro il 44,30% ottenuto da Fernando Haddad.29 ottobre 2018, di Federico La Sala
Brasile: Bolsonaro è il nuovo presidente con il 55,7% dei voti
Dopo lo scrutinio dell’88,45% dei voti. Fernando Haddad si ferma al 44,30%
di Redazione ANSA SAN PAOLO *
Dopo lo scrutinio dell’88,45% dei voti nel ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro risulta vincitore con il 55,7%, contro il 44,30% ottenuto da Fernando Haddad. "Cambieremo il destino del Brasile. Vi offriremo un governo degno che lavorerà per tutti i brasiliani". Lo ha detto Jair Bolsonaro, nel suo primo discorso da neopresidente del Brasile.
Il primo messaggio dopo la vittoria Bolsonaro lo ha affidato a Facebook, come ha spesso fatto anche durante la campagna elettorale. Un breve video, trasmesso sui social dal suo appartamento di Barra de Tijuca, quartiere residenziale dell’ovest di Rio de Janeiro. "Sono molto grato a tutti voi, per la vostra considerazione, le vostre preghiere e la vostra fiducia", ha detto l’ex militare, aggiungendo che "adesso, tutti insieme, cambieremo il destino del Brasile: sapevamo dove stavamo andando, e ora sappiamo cosa dobbiamo fare". Il Brasile, ha sottolineato, "non poteva continuare a flirtare con il socialismo, il comunismo, il populismo e l’estremismo della sinistra" e ora "la verità comincerà a regnare in ogni casa del paese, cominciando dal suo punto più alto, che è la presidenza della Repubblica", perché "il Brasile ha tutto quello che serve per essere una grande nazione".
- IL MESSAGGIO VIDEO DEL NUOVO PRESIDENTE BRASILIANO
La quarta democrazia più grande del mondo sarà governata da un ex ufficiale dei paracadutisti denunciato da molti come una "minaccia fascista": Jair Bolsonaro è stato eletto presidente del Brasile, battendo il suo rivale Fernando Haddad di almeno 11 punti, il 55% dei voti. Una vittoria immediatamente salutata in Italia dal leader della Lega Matteo Salvini: "Anche in Brasile - ha twittato - i cittadini hanno mandato a casa la sinistra! Buon lavoro al presidente Bolsonaro, l’amicizia tra i nostri popoli e i nostri governi sarà ancora più forte". Ed ha aggiunto: "Dopo anni di chiacchiere, chiederò che ci rimandino in Italia il terrorista rosso Battisti".
Intanto in Brasile, da Rio de Janeiro a San Paolo, sono scesi in piazza migliaia di simpatizzanti. Malgrado la rimonta registrata negli ultimi giorni da Haddad - l’erede politico scelto da Lula da Silva come candidato del Partito dei Lavoratori (Pt) - i risultati del ballottaggio hanno confermato le previsioni dei sondaggi, che davano Bolsonaro come favorito anche prima del primo turno delle presidenziali, lo scorso 7 ottobre. La vittoria di Bolsonaro rappresenta una frattura storica per il Brasile, dopo una fase di quattro governi consecutivi del Pt, chiusasi nell’agosto del 2016 con l’impeachment di Dilma Rousseff, e il breve intermezzo dell’amministrazione di Michel Temer, che arriva alla fine del suo mandato battendo tutti i record storici di impopolarità.
Il risultato del voto in Brasile segna anche una nuova sconfitta per i partiti e i leader protagonisti della cosiddetta "marea rosa" progressista che investì l’America Latina all’inizio del secolo XXI, dopo le vittorie elettorali del centrodestra in Argentina, Cile, Perù e Colombia e le derive autoritarie in Venezuela e Nicaragua. Bolsonaro, un deputato che è passato per otto partiti diversi in quasi due decenni di attività parlamentare e fino a poco fa era considerato un personaggio eccentrico, noto per le sue dichiarazioni polemiche a favore della dittatura militare e la tortura e contro le donne e le minoranze razziali, etniche e sessuali, è diventato in pochi mesi il leader che ha cavalcato il crescente malessere di grandi fasce della società brasiliana.
* ANSA SAN PAOLO, 29 ottobre 2018 (ripresa parziale - senza allegati)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. --- "Perché è successo qui" (Maurizio Molinari). La frattura tra élite ed elettori da cui nasce il populismo27 ottobre 2018, di Federico La Sala
Il saggio "Perché è successo qui" di Maurizio Molinari
La frattura tra élite ed elettori da cui nasce il populismo
di Stefano Folli (la Repubblica, 26.10.2018)
- Il libro. "Perché è successo qui" di Maurizio Molinari (La nave di Teseo, pagg.122, e. 17)
Non è un libro rassicurante, questo di Maurizio Molinari sulle ragioni di fondo della rivoluzione populista in Italia. Ma è assai utile come guida nei tempi che viviamo. Non è rassicurante perché evita ogni risvolto convenzionale e si affida a un linguaggio scarno, al di là di ogni pseudo-verità di comodo. Ha lo stile dell’inchiesta giornalistica e il passo del saggio basato su fatti, dati, circostanze. Molinari, oggi direttore della Stampa di Torino e in precedenza corrispondente a lungo dagli Stati Uniti e da Israele, ha appreso le regole del miglior giornalismo: quello fondato su saldi valori morali, ma anche consapevole che l’obiettività assoluta non esiste e ciò che le si avvicina di più è l’onestà intellettuale di scavare nella cronaca senza pregiudizi al fine di ricavarne una tesi generale documentata e convincente.
L’esplorazione intorno al 4 marzo, giorno delle elezioni che hanno cambiato l’Italia, diventa allora un viaggio nell’Italia di oggi e nelle sue contraddizioni. Che sono sociali ed economiche. Hanno a che vedere con le nuove diseguaglianze economiche, con la devastazione dei ceti medi a cui sono state tolte le certezze, con le paure - in primo luogo l’immigrazione e l’Islam - tipiche di un Paese dal presente confuso e dal futuro avvolto nella nebbia. Lega e Cinque Stelle, due fenomeni politici complementari ma solo in parte sovrapponibili, non vengono da Marte né rappresentano l’invasione degli Hyksos aggiornata al nuovo secolo.
Sono la fotografia di una frattura verticale tra élite e popolo; o se si preferisce tra establishment e popolo. Nonché una risposta istintiva da parte di un’Italia irritata con le forze tradizionali che hanno in sostanza fallito la loro missione in una ben determinata contingenza storica.
Per meglio dire, i due soggetti vincitori il 4 marzo, nella loro mancanza di legami con la memoria collettiva e addirittura, si può dire, estranei al patto costituzionale, rappresentano il prodotto di un mutamento in atto non solo in Italia, ma che qui ha assunto quel carattere di anteprima senza precedenti di cui già altre volte, se vogliamo risalire indietro nei decenni, l’Italia è stata protagonista: dal fascismo a Tangentopoli, volendo semplificare. E non si capisce quello che è accaduto prima del marzo 2018 se non si collocano nella giusta prospettiva i passi falsi commessi nel corso degli anni da una dirigenza politica responsabile di approssimazione, inadeguatezza e calcoli sbagliati. Fino all’esito inevitabile: rappresentarsi come "casta" privilegiata e corrotta, anziché come classe dirigente responsabile, agli occhi del cittadino comune.
Le nuove povertà non sono un’invenzione polemica, ma risultano documentate dalle indagini Istat. Il senso di insicurezza nella vita quotidiana sarà pure solo "percepito", ma è talmente diffuso - anche a causa di orribili vicende di cronaca nera - da essere ormai il principale asso nella manica di uno dei due "populismi", quello improntato a destra dalla Lega. Il bisogno di protezione sociale è palpabile. Infine la "miopia" dei partiti tradizionali: un aspetto che va oltre i nostri confini, come si è visto con il declino dei socialisti francesi e persino dei socialdemocratici tedeschi (senza contare l’appannamento dei democristiani di Angela Merkel).
Da noi però la miopia è spinta alle soglie del suicidio, come si è visto nel caso del Pd che invece di affrontare i temi cruciali della diseguaglianza e della perdita di "status" delle classi medie si è incartato per mesi in un referendum costituzionale trasformato dal premier del momento in un velleitario plebiscito personale a cui gli italiani, pressati da altri problemi, hanno risposto "no".
Conclusione: si è accesa la miccia che ha fatto esplodere il quartier generale. Ora si tratta di capire fino a che punto ha ragione Steve Bannon, l’ideologo del "trumpismo", il singolare Che Guevara che vuole esportare in Europa la filosofia politica della Casa Bianca, quando dice a Molinari che l’Italia è ormai "la forza trainante del nazional-populismo". E non c’è dubbio che l’affermazione di Trump in America ha avuto conseguenze sconvolgenti in tutto il mondo occidentale. Se le prossime elezioni nell’Unione saranno cruciali, se la scommessa di Salvini coincide con la speranza di buttare all’aria i vecchi assetti a Bruxelles, questo lo si deve in buona misura all’avvento di Trump. Come pure al nuovo mito dell’"uomo forte" incarnato da Putin e dalla sua strategia "dello scompiglio" o della destabilizzazione: per la quale tutti i mezzi sono leciti, anche l’uso delle tecnologie del web.
Era dai tempi della guerra fredda che l’Italia non si trovava così al centro dell’attenzione internazionale. Molinari decifra il rebus con freddezza, mescolando l’analisi della dimensione locale con quella del quadro mondiale di cui ha sperimentata conoscenza. In attesa che i prossimi mesi sciolgano gli interrogativi di fondo: il populismo al governo è una svolta storica o una parentesi, per quanto rilevante?
Contro lo straniero e contro le élite due populismi diversi
Sinistra / governo. Questo nuovo governo nasce da una parziale convergenza tra due diverse forme di discorso populista. Difficile dire quanto stabile si rivelerà, ma in ogni caso, è su questa linea di frattura che dovrebbe insinuarsi un discorso democratico alternativo
di Antonio Floridia (il manifesto, 13.06.2018)
«Del resto mia cara di che si stupisce/anche l’operaio vuole il figlio dottore/e pensi che ambiente che può venir fuori/non c’è più morale, Contessa». Torna in mente questa celebre canzone, a sentire certe reazioni di un’opinione pubblica colta e democratica, di fronte alla nascita del nuovo governo.
Un atteggiamento tra lo sconsolato e lo spocchioso, un sentimento di stupore e di estraneità: ma come si è potuti giungere fino a questo punto? E giù, poi, con le ironie sull’incompetenza di questi parvenu.
Alcuni settori politici, giornalistici e intellettuali, invece di chiedersi come mai il “popolo” non abbia dato loro minimamente retta, sembrano ritrarsi in una posizione di ripulsa, di denigrazione delle masse. Un vecchio riflesso condizionato, tipico dei conservatori del buon tempo antico, quando si pensava che il governo fosse una prerogativa naturale dei colti e delle èlites.
Ma appare assai dubbio che, in questo modo, si possa costruire un’opposizione efficace a questo governo e che si possa fare ricredere quei milioni di connazionali che hanno votato per queste forze “impresentabili”. Limitarsi a lanciare un grido allarmato sui “populisti al governo” non intacca il consenso di cui godono. Un’opposizione credibile presuppone un saldo “punto di vista” alternativo. Ed è questo che oggi manca del tutto: dire che “mancano le coperture” è un argomento assai fragile (e persino controproducente: un elettore che ha votato per questi partiti, può sempre pensare: “beh, allora gli obiettivi sono giusti, almeno ci stanno provando”).
Costruire una cornice politica e ideale che possa davvero insidiare l’egemonia populista presuppone, intanto, che si torni a praticare quella che un tempo si chiamava “analisi differenziata”.
E quindi, in primo luogo, occorre interrogarsi su che tipo di populismo abbiamo di fronte.
Possiamo assumere una definizione, minima ma essenziale, di populismo: il populismo è un modo di costruzione del discorso politico, un’operazione egemonica sugli schemi interpretativi della realtà sociale e del conflitto politico, fondata sulla creazione di una dicotomia che separa “noi” (il popolo”) da “loro” (gli “altri”). Possiamo dire allora che questo nuovo governo nasce da una parziale convergenza tra due diverse forme di discorso populista: la prima identifica l’”altro” con lo “straniero”, la seconda con le “èlites”. Difficile dire quanto stabile si rivelerà questa convergenza: ma in ogni caso, è su questa linea di frattura che dovrebbe insinuarsi un discorso democratico alternativo.
Il primo passo per una controffensiva è quello di non “regalare” all’avversario anche il controllo sul linguaggio della politica, e su alcune parole, in particolare: “l’anti-elitismo” e la “sovranità popolare”. Le teorie elitistiche del potere sono sempre state un caposaldo del pensiero conservatore. Da Gaetano Mosca fino ad alcuni scienziati politici americani del Novecento, la critica alla democrazia di massa si è sempre fondata sull’idea che il “cittadino comune” è incompetente, incapace di avere una visione lungimirante dei propri stessi “veri” interessi: e sull’idea che, in fondo, l’apatia è un segno di consenso, o che un eccesso di “partecipazione” popolare è pericoloso. Ebbene, la sinistra, oggi, non dovrebbe recuperare una sana attitudine “anti-elitista”?
Ossia, individuare le vere oligarchie che dominano l’economia e la società e indicare le vie per contrastarne lo strapotere? E poi, la “sovranità popolare”: diamine, è un termine che appartiene alla storia del pensiero democratico e rivoluzionario! Possiamo ridurre tutto a “sovranismo” nazionalista? o non si dovrebbe ridare un senso all’idea di una sovranità democratica, a fronte del dominio cieco e impersonale di potenze economiche e finanziarie imperscrutabili e sfuggenti? Solo così, al M5S si potrà poi rivolgere un’obiezione cruciale: le “èlites” sono per voi sono solo le “caste” politiche? E come la mettete con la flat tax?
Se analizziamo la cultura politica del M5S troviamo un’idea ibrida di democrazia. Da una parte, più che di democrazia “diretta”, è giusto parlare di una sua visione immediata e “direttistica”: l’idea che la “volontà popolare”, univoca e indifferenziata, si possa tradurre senza filtri e mediazioni in una “volontà generale”; dall’altra, specie a livello locale, ci si appella invece ad un’idea di democrazia “partecipativa” che ha alimentato l’esperienza politica e associativa di molti attivisti (ad esempio, in molti programmi amministrativi del M5S, frequente è il richiamo al “bilancio partecipativo”). Una miscela contraddittoria: un’idea di democrazia “a binario unico”, che può condurre ad ignorare i principi cardine di un costituzionalismo democratico, ma che esprime anche, in forme distorte, un’idea di recupero della sovranità popolare, oggi comunemente sentita come svuotata, con un appello al protagonismo civico. Da qui anche la novità di un ministero alla “democrazia diretta” e l’inserimento nel “contratto” di alcune proposte di riforma dell’istituto referendario (su alcune delle quali si può discutere, mentre altre sono assai più problematiche). Ma anche in questo caso, è una sfida che può essere raccolta solo se la sinistra torna a proporre una visione ricca della democrazia rappresentativa, che sia fondata sulla partecipazione politica dei cittadini, e non su una mera selezione elettorale delle èlites.
Si può far leva su queste contraddizioni; ma come sarà possibile se, ad esempio, all’interno del Pd, ci sono ancora forze che pensano con nostalgia alla riforma costituzionale sconfitta al referendum, o a leggi elettorali simil-Italicum, che proprio ad una visione plebiscitaria della democrazia erano ispirate? Sembra oramai largamente condivisa l’idea che la crisi della sinistra sia nata dalla sua subalternità al neo-liberismo economico; meno frequente appare il richiamo ad un’altra, non meno grave, subalternità: quella ad una visione elitistico-competitiva della democrazia. Anche su questo terreno si dovrà misurare una possibile ricostruzione della sinistra.
NOTA 1 :
A Rossana Rossanda sono venuti i capelli bianchi il 4 novembre 1956, in seguito all’invasione sovietica deell’Ungheria *
A Rossana Rossanda sono venuti i capelli bianchi il 4 novembre 1956, in seguito all’invasione sovietica deell’Ungheria. Aveva trentadue anni, e rimase sconvolta dalla visione di una fotografia:
 «Un funzionario appeso a un fanale, il collo spaccato e il volto scomposto dell’impiccato, mentre sotto di lui un paio di operai della grande fabbrica in rivolta ridevano. Fu la prima volta che mi dissi: ci odiano. Il povero e l’oppresso non hanno sempre ragione. Ma i comunisti che si fanno odiare hanno sempre torto. E quello era un odio massiccio, sedimentato; non si arriva a questa enormità senza un’offesa lungamente patita».
«Un funzionario appeso a un fanale, il collo spaccato e il volto scomposto dell’impiccato, mentre sotto di lui un paio di operai della grande fabbrica in rivolta ridevano. Fu la prima volta che mi dissi: ci odiano. Il povero e l’oppresso non hanno sempre ragione. Ma i comunisti che si fanno odiare hanno sempre torto. E quello era un odio massiccio, sedimentato; non si arriva a questa enormità senza un’offesa lungamente patita».* Cinquantamila.it, 07.02.2001
NOTA 2:
L’URLO DI ITALO CALVINO (1980). --- Quello scontro tra Di Vittorio e Togliatti sulla repressione del 1956 in Ungheria.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Avere il coraggio di assumere il fenomeno migratorio come l’autentico fatto costituente dell’ordine futuro (di Luigi Ferrajoli)24 ottobre 2018, di Federico La Sala
Popolo costituente e migrante
Il diritto a emigrare ha radici antiche, teoriche e politiche, che si scontrano con la miseria xenofoba del presente. Uno stralcio tratto dall’ultimo numero di «Critica marxista» *
di Luigi Ferrajoli (il manifesto, 24.10.2018)
Il principale segno di cambiamento manifestato finora dall’attuale sedicente «governo del cambiamento» è la politica ostentatamente disumana e apertamente illegale da esso adottata nei confronti dei migranti. Di nuovo il veleno razzista dell’intolleranza e del disprezzo per i «diversi» sta diffondendosi non solo in Italia ma in tutto l’Occidente, nell’Unione Europea e negli Stati Uniti, quale veicolo di facile consenso nei confronti degli odierni populismi e delle loro politiche di esclusione.
È SU QUESTO TERRENO che rischia oggi di crollare l’identità civile e democratica dell’Italia e dell’Europa. Le destre protestano contro quelle che chiamano una lesione delle nostre identità culturali da parte delle «invasioni» contaminanti dei migranti. In realtà esse identificano tale identità con la loro identità reazionaria: con la loro falsa cristianità, con la loro intolleranza per i diversi, in breve con il loro più o meno consapevole razzismo. Laddove, al contrario, sono proprio le politiche di chiusura che stanno deformando e deturpando l’immagine dell’Italia e dell’Europa, che sta infatti vivendo una profonda contraddizione: la contraddizione delle pratiche di esclusione dei migranti quali non-persone non soltanto con i valori di uguaglianza e libertà iscritti in tutte le sue carte costituzionali e nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, ma anche con la sua più antica tradizione culturale.
Il diritto di emigrare fu teorizzato dalla filosofia politica occidentale alle origini dell’età moderna. Ben prima del diritto alla vita formulato nel Seicento da Thomas Hobbes, il diritto di emigrare fu configurato dal teologo spagnolo Francisco de Vitoria, nelle sue Relectiones de Indis svolte nel 1539 all’Università di Salamanca, come un diritto naturale universale. Sul piano teorico questa tesi si inseriva in una edificante concezione cosmopolitica dei rapporti tra i popoli informata a una sorta di fratellanza universale. Sul piano pratico essa era chiaramente finalizzata alla legittimazione della conquista spagnola del Nuovo mondo: anche con la guerra, in forza del principio vim vi repellere licet, ove all’esercizio del diritto di emigrare fosse stata opposta illegittima resistenza. Tutta la tradizione liberale classica, del resto, ha sempre considerato lo jus migrandi un diritto fondamentale. John Locke fondò su di esso la garanzia del diritto alla sopravvivenza e la stessa legittimità del capitalismo: giacché il diritto alla vita, egli scrisse, è garantito dal lavoro, e tutti possono lavorare purché lo vogliano, facendo ritorno nelle campagne, o comunque emigrando nelle «terre incolte dell’America», perché «c’è terra sufficiente nel mondo da bastare al doppio dei suoi abitanti».
KANT, a sua volta, enunciò ancor più esplicitamente non solo il «diritto di emigrare», ma anche il diritto di immigrare, che formulò come «terzo articolo definitivo per la pace perpetua» identificandolo con il principio di «una universale ospitalità». E l’articolo 4 dell’Acte constitutionnel allegato alla Costituzione francese del 1793 stabilì che «Ogni straniero di età superiore a ventuno anni che, domiciliato in Francia da un anno, viva del suo lavoro, o acquisti una proprietà, o sposi una cittadina francese, o adotti un bambino, o mantenga un vecchio, è ammesso all’esercizio dei diritti del cittadino».
Lo ius migrandi è da allora rimasto un principio elementare del diritto internazionale consuetudinario, fino alla sua già ricordata consacrazione nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. Fino a che l’asimmetria non si è ribaltata. Oggi sono le popolazioni fino a ieri colonizzate che fuggono dalla miseria provocata dalle nostre politiche. E allora l’esercizio del diritto di emigrare è stato trasformato in delitto.
Siamo perciò di fronte a una contraddizione gravissima, che solo la garanzia del diritto di emigrare varrebbe a rimuovere. Il riconoscimento di questa contraddizione dovrebbe non farci dimenticare quella formulazione classica, cinicamente strumentale, del diritto di emigrare: perché la sua memoria possa quanto meno generare - nel dibattito pubblico, nel confronto politico, nell’insegnamento nelle scuole - una cattiva coscienza sull’illegittimità morale e politica, prima ancora che giuridica, delle nostre politiche e agire da freno sulle odierne pulsioni xenofobe e razziste.
QUESTE POLITICHE crudeli stanno avvelenando e incattivendo la società, in Italia e in Europa. Stanno seminando la paura e l’odio per i diversi. Stanno screditando, con la diffamazione di quanti salvano vite umane, la pratica elementare del soccorso di chi è in pericolo di vita. Stanno fascistizzando il senso comune. Stanno, in breve, ricostruendo le basi ideologiche del razzismo; il quale, come affermò lucidamente Michel Foucault, non è la causa, bensì l’effetto delle oppressioni e delle violazioni istituzionali dei diritti umani: la «condizione», egli scrisse, che consente l’«accettabilità della messa a morte» di una parte dell’umanità. Che è il medesimo riflesso circolare che ha in passato generato l’immagine sessista della donna e quella classista del proletario come inferiori, perché solo in questo modo se ne poteva giustificare l’oppressione, lo sfruttamento e la mancanza di diritti. Ricchezza, dominio e privilegio non si accontentano di prevaricare. Pretendono anche una qualche legittimazione sostanziale.
Un secondo effetto è non meno grave e distruttivo. Consiste in un mutamento delle soggettività politiche e sociali: non più le vecchie soggettività di classe, basate sull’uguaglianza e sulle lotte comuni per comuni diritti, ma nuove soggettività politiche di tipo identitario basate sull’identificazione delle identità diverse come nemiche e sul capovolgimento delle lotte sociali: non più di chi sta in basso contro chi sta in alto, ma di chi sta in basso contro chi sta ancora più in basso. È un mutamento che sta minando le basi sociali della democrazia. Una politica razionale, oltre che informata alla garanzia dei diritti, dovrebbe muovere, realisticamente, dalla consapevolezza che i flussi migratori sono fenomeni strutturali e irreversibili, frutto della globalizzazione selvaggia promossa dall’attuale capitalismo.
DOVREBBE anzi avere il coraggio di assumere il fenomeno migratorio come l’autentico fatto costituente dell’ordine futuro, destinato, quale istanza e veicolo dell’uguaglianza, a rivoluzionarie i rapporti tra gli uomini e a rifondare, nei tempi lunghi, l’ordinamento internazionale. Il diritto di emigrare equivarrebbe, in questa prospettiva, al potere costituente di questo nuovo ordine globale: giacché l’Occidente non affronterà mai seriamente i problemi che sono all’origine delle migrazioni se non li sentirà come propri. I diritti fondamentali, come l’esperienza insegna, non cadono mai dall’alto, ma si affermano solo allorquando la pressione di chi ne è escluso alle porte di chi ne è incluso diventa irresistibile. Per questo dobbiamo pensare al popolo dei migranti come al popolo costituente di un nuovo ordine mondiale.
*
SCHEDA: Una rivista che legge le trasformazioni
Il testo integrale di Luigi Ferrajoli - con il titolo: «La questione migranti: Italia incivile, Europa incivile» - apre dopo l’editoriale di Aldo Tortorella sulla fase politica («San Giorgio, il drago e i mostriciattoli di turno») il n. 5 della rivista «Critica Marxista», dove alcuni temi di attualità sono affrontati da Tiziano Rinaldini («Il “decreto dignità” e i gravi ritardi della sinistra sul lavoro») Alberto Leiss («Il baratro di Genova»), Francesco Garibaldo («Fca e Fca Italia dopo Marchionne: un’eredità difficile»), Romeo Orlandi (La sinistra, la Cina, la globalizzazione), infine E. Igor Mineo («Le sinistre e la crisi dell’Unione europea»). Il «Laboratorio culturale» è aperto da un saggio di Ida Dominijanni sul dibattito femminista in Occidente («Femminismo in/addomesticabile»), mentre Daniele Caputo scrive su «Il regresso oligarchico». Riccardo Bellofiore ricorda la figura e il pensiero di Lucio Magri («Provarci ancora, fallire di nuovo, ma fallire meglio»
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- «Scardinare il mondo intero». "Non è superfluo ricordare (...) che quel gigante del pensiero e dell’arte europea che fu Tolstoj (...) diede impulsi profondi sia a Lenin che a Trotsky" (Luciano Canfora23 ottobre 2018, di Federico La Sala
PLATONE E NOI, OGGI. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!.... *
- "Non è superfluo ricordare qui, conclusivamente, che quel gigante del pensiero e dell’arte europea che fu Tolstoj - il quale a lungo rifletté sul «moto storico» incessante - diede impulsi profondi sia a Lenin che a Trotsky"(Luciano Canfora, qui).
Nel buio della «notte politica» la sfida di una filosofia militante
Esce giovedì il nuovo saggio di Donatella Di Cesare (Bollati Boringhieri)
Un forte richiamo alla funzione pubblica del pensiero critico
di Luciano Canfora (Corriere della Sera, 22.10.2018)
- Il saggio di Donatella Di Cesare, Sulla vocazione politica della filosofia, sarà in libreria il 25 ottobre per Bollati Boringhieri (pp. 180, e. 19).
Un giovane filologo italiano, Max Bergamo, si accinge a pubblicare gli appunti che, alle lezioni di greco di Friedrich Nietzsche professore a Basilea, prese, e conservò, nel semestre invernale 1871-1872, un allievo d’eccezione, Jacob Wackernagel, destinato a diventare uno dei maggiori storici delle lingue classiche. Il corso di quel semestre verteva su Platone. Abbiamo dunque sia gli appunti dell’allievo, sia il molto ricco dossier preparatorio del maestro (ne è imminente la traduzione presso Adelphi), che ormai si integrano a vicenda e si completano.
Scrive Nietzsche: «Non è lecito considerare Platone come un sistematico in vita umbratica, ma come un agitatore politico che vuole scardinare il mondo intero e che è, a questo scopo, tra le altre cose anche scrittore (...) Egli scrive per fortificare nella lotta (bestärken im Kampfe) i suoi compagni dell’Accademia (da lui fondata)». L’allievo annotò le parole del maestro così: «L’Accademia non è per lui che un mezzo. Indirettamente scrittore. (A noi invece appare in primo luogo scrittore). Un politico che vuole scardinare il mondo intero». Notare che «scardinare» appare in entrambi (aus den Angeln heben). Dunque Nietzsche disse proprio così: «Scardinare il mondo intero».
Al centro della lotta per cambiare il mondo c’è Platone. Ed è questo uno dei centri motori - insieme ai «casi» Marx e Heidegger - del nuovo saggio di Donatella Di Cesare Sulla vocazione politica della filosofia (Bollati Boringhieri). Scrive Donatella Di Cesare nel capitolo da cui prende avvio il suo saggio: «Guardiano della città, già prima di Platone e della sua politeia, Eraclito denuncia la notte politica». L’immagine della «notte» viene da un paio di frammenti dell’opera perduta di Eraclito, che paragonano la cecità impolitica dei suoi concittadini (di Efeso, metropoli greca sulla costa asiatica) al torpore del sonno.
A significare che la vocazione politica è inerente al filosofare, e ne costituisce l’avvio o anche la premessa, la Di Cesare parte da ben prima di Platone e segue quel filo fino al nostro presente. L’autrice potrebbe, credo, riconoscersi nelle parole con cui Togliatti tratteggiò il cammino di Gramsci: «Nella politica è contenuta tutta la filosofia reale di ognuno, nella politica sta la sostanza della storia, e per il singolo, che è giunto alla coscienza critica della realtà e del compito che gli spetta nella lotta per trasformarla, sta anche la sostanza della sua vita morale» (Convegno Gramsci, Roma, gennaio 1958).
Ma il filo conduttore è: «scardinare» l’esistente (Platone secondo Nietzsche) ovvero «trasformarlo», secondo la insopprimibile «tesi su Feuerbach» di Marx ventisettenne (1845). Il libro della Di Cesare è una battaglia in favore di questa concezione della filosofia, in antitesi rispetto a tutti i benpensanti (da Aristotele alla Arendt) secondo cui la politicità totale del filosofare sarebbe «passo falso» o «tentazione di intervenire».
Per Aristotele (nel secondo libro della Politica) le fondamenta e i presupposti della Kallipolis (città verso cui tendere) di Platone - superamento della proprietà, della famiglia etc. - sono devianze teoretiche e (forse anche) cadute immorali. La Arendt si riferisce a Heidegger. È chiaro che l’impegno a fianco del nazionalsocialismo fu un pauroso andare fuori strada, ma non lo fu il fatto stesso dell’impegnarsi. E questo vale anche per Gentile. Nel concreto dell’esistenza si sta «o con Lutero o con il Papa».
Il caso Heidegger e il suo gigantesco abbaglio sono ben noti alla Di Cesare: soprattutto, vien da dire, a lei, che ne ha attraversato il pensiero come - diceva l’ex coraggioso poeta Orazio all’amico Asinio Pollione - in una traversata «sui carboni ardenti».
Anche Platone, precoce, si era coinvolto nel governo più demonizzato che Atene abbia mai visto nella sua drammatica storia: quello dei Trenta cosiddetti «tiranni», capeggiati da Crizia, socratico e allucinato riformatore, di cui Platone era nipote. E Platone non lo nasconde affatto, al principio della lettera settima (che già per questa «confessione» sofferta e moralmente elevata, è ovviamente autentica!): perché - afferma - quel governo si proponeva come portatore di una rifondazione radicale della politica in nome di alcuni «princìpi». Platone ne descrive anche il fallimento e la sconfitta ma gli rende omaggio, del tutto controcorrente, rispetto al perbenismo della cosiddetta democrazia restaurata. E nel Timeo, al principio del dialogo - dove Socrate viene sollecitato da Timeo a riassumere «ciò che ha detto il giorno prima» (cioè il nocciolo della Repubblica) - Crizia dice a Socrate, rendendogli omaggio: «La città che tu ieri ci hai descritta come una favola (la città riordinata secondo la radicale proposta riformatrice illustrata nella Repubblica) noi la trasferiremo nella realtà e la porremo qui» (Timeo, 26E).
Platone fa, qui, dire a Crizia, cioè al capo dei Trenta, parole che rivendicano orgogliosamente la genesi socratica del tentativo (pur abortito) dei Trenta e la coincidenza di quel tentativo (per lo meno nelle intenzioni) col progetto «utopistico» contenuto nella Repubblica. La «leggenda nera» gravante su Crizia viene così cancellata. Ma nell’Atene democratica queste erano parole indicibili. E come dimenticare, a questo punto, l’appropriazione nazionalsocialista di Platone (Hitlers Kampf und Platons Staat di Bannes)?
Donatella Di Cesare, che ripercorre in questo saggio il cammino di alcuni grandi filosofi che «si sporcarono le mani», e descrive con efficacia l’esito di Marx come studioso che - dopo reiterate sconfitte - «si ritirò sempre più in sé stesso per scoprire anzitempo la legge della storia che avrebbe portato sino all’ultimo salto prima del regno della libertà», lancia al termine una sfida inattuale a chi predica (da qualche decennio) la fine della storia, la fine del pensiero («delle ideologie» dicono i pappagalli semicolti), cioè (suprema stupidità) la fine del moto perenne della storia. E propugna in un «poscritto anarchico» una via d’uscita di rifiuto indomito dell’arché, del comando. È certo consapevole del rischio di ridurre così i filosofi a «testimoni», sia pure emozionanti.
 E approda, a mio avviso, a un esito tolstoiano.
Non è superfluo ricordare qui, conclusivamente, che quel gigante del pensiero e dell’arte europea che fu Tolstoj - il quale a lungo rifletté sul «moto storico» incessante - diede impulsi profondi sia a Lenin che a Trotsky.
E approda, a mio avviso, a un esito tolstoiano.
Non è superfluo ricordare qui, conclusivamente, che quel gigante del pensiero e dell’arte europea che fu Tolstoj - il quale a lungo rifletté sul «moto storico» incessante - diede impulsi profondi sia a Lenin che a Trotsky.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- "Oriente e Occidente - scrive Nietzsche in Schopenhauer come educatore - sono tratti di gesso che qualcuno disegna davanti ai nostri occhi per beffarsi della nostra pavidità".
- LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- GERMANIA, 1933: MARTIN HEIDEGGER E KARL BARTH (di Benedetto Croce).21 ottobre 2018, di Federico La Sala
BENEDETTO CROCE, Recensione 1934*:
- MARTIN HEIDEGGER. -Die Selbstbehauptung der deutschen Universitaten. Rede gehalten bei der feierlichen Uebernahme des Rektorats der Universitat Freiburg i. E. anl 27.5.1933 - Breslau, Korn, 1933 (8.o, pp. 22).
- KARL BARTH. - Theologische Existenz heute! - Munchen, Kaiser, 1933 (8.o, PP. 40).
Il prof. Heidegger non vuole che la filosofia e la scienza siano altro, per i tedeschi, che un affare tedesco, a vantaggio del popolo tedesco. Gli studenti tedeschi, a suo dire, hanno tre «Bindungen», tre obblighi, il primo e fondamentale dei quali è la «Volksgemeinschaft», il nazionalismo. Ma se egli si ripiegasse davvero sulla sua coscienza morale (l’ha ogni uomo e l’avrà anche lui), direbbe piuttosto che il primo obbligo, di studenti e di professori, è il timor Dei, come sta scritto sul frontone della Sapienza di Roma.
Scrittore di generiche sottigliezze, arieggiante a un Proust cattedratico, egli che nei suoi libri non ha dato mai segno di prendere alcun interesse o di avere alcuna conoscenza della storia, dell’etica, della politica, della poesia, dell’arte, della concreta vita spirituale nelle sue varie forme - quale decadenza a fronte dei filosofi, veri filosofi, tedeschi di un tempo, dei Kant, degli Schelling, degli Hegel! -, oggi si sprofonda di colpo nel gorgo del più falso storicismo, in quello, che la storia nega, per il quale il moto deila storia viene rozzamente e materialisticamente concepito come asserzione di etnicismi e di razzismi, come celebrazione delle gesta di lupi e volpi, leoni e sciacalli, assente l’unico e vero attore, l’umanità.
Scrive nel bello stile che ci è già noto dai suoi libri filosofici: «Der Wille zum Wesen der deutschen Universitat ist der Wille zur Wissenschaft als Wille zum geschichtlichen geistigen Auftrag des deutschen Volkes als eines in seinem Staat sich selbst wissende Volkces. Wissenschaft und deutsche. Schicksal mussen zumal in Wesenswillen zur Macht kommen» (p. 7). E così si appresta o si offre a rendere servigi filosofico-politici: che è certamente un modo di prostituire la filosofia, senza con ciò recare nessun sussidio alla soda politica, e, anzi, credo, neppure a quella non soda, che di cotesto ibrido scolasticume non sa che cosa farsi, reggendosi e operando per mezzo di altre forze, che le son proprie.
Ben diverso atteggiamento è quello del teologo Karl Barth, che dice il fatto loro ai «Deutschen Christen», ai tedesco-cristiani, pronti a gridare che la chiesa evangelica deve servire alla fortuna del popolo tedesco e del terzo Impero, a richiedere un capo, una sorta cli papa, che fermamente li governi nella nuova vita cominciata con la primavera del 1933, e ad escludere, per intanto, dal loro seno i cristiani di sangue giudaico o a trattarli come cristiani di second’ordine, e via per simili turpitudini.
«Noi - scrive il Barth - abbiamo l’ufficio di portare al popolo tedesco la parola di Dio; e pecchiamo non solo verso Dio, ma anche verso questo popolo stesso se perseguiamo altri ideali e fini, che non sono cominessi a noi. Nella natura del nostro ufficio è che esso non possa essere subordinato o coordinato ad alcun’altra istanza; e di nuovo peccheremmo verso Dio e verso il nostro popolo, se lasciassirilo scuotere anche solo menomamente quest’ordine gerarchico!».
Il Barth degnamente tutela l’indipendenza della teologia, mentre il prof. Heidegger si è affrettato a far getto di quella della filosofia.
B. C.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg
CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
VENI, CREATOR SPIRITUS: LO SPIRITO DELLA VERITA’. Lo Spirito "costituzionale" di Benedetto Croce, lo spirito cattolico-romano di Giacomo Biffi, e la testimonianza di venti cristiani danesi (ricerca scientifica)
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- "Poveri diavoli. Cristianesimo e socialismo" (Karl Barth, 1911).23 ottobre 2018, di Federico La Sala
Testimoni.
Barth «politico». La rivoluzione è cristiana
Per la prima volta in volume la conferenza tenuta nel 1911 dal teologo protestante morto 50 anni fa e dedicata al rapporto tra cristianesimo e socialismo “politico”. La rivoluzione è cristiana
di Karl Barth (Avvenire, sabato 20 ottobre 2018)
- [...] il testo di Karl Barth del quale pubblichiamo qui un estratto, Poveri diavoli. Cristianesimo e socialismo (pagine 68, euro 7,50), che raccoglie una conferenza del 1911 inedita in volume (apparve sulla rivista “Linea d’ombra” nel 1990) e curata per Marietti da Alberto Gallas.
Il socialismo è il movimento di coloro che non sono indipendenti sul piano economico, di coloro che in cambio di un salario lavorano per un altro, un estraneo; è il movimento del proletariato, come lo si chiama nei libri. Il proletario non è necessariamente povero, ma nella sua esistenza è necessariamente dipendente dalle possibilità economiche e dalla buona volontà di colui che gli dà il pane, il padrone della fabbrica. È qui che interviene il socialismo: esso è e vuole essere un movimento proletario. Esso vuole rendere indipendenti coloro che non lo sono, con tutte le conseguenze che ciò può comportare per la loro esistenza materiale, morale e spirituale.
Non possiamo sostenere che anche Gesù si sia impegnato precisamente su questo punto, già semplicemente per il fatto che duemila anni fa non esisteva ancora un proletariato nel senso moderno del termine, non essendovi ancora le fabbriche. Tuttavia, chiunque legga senza pregiudizi il Nuovo Testamento, dovrebbe restare colpito dal fatto che ciò che Gesù è stato, ha voluto, e ha ottenuto, considerato da un punto di vista umano, era esattamente un movimento dal basso. Egli stesso proveniva da uno dei ceti più umili del popolo ebraico di quel tempo.
Vi ricorderete certamente del racconto di Natale e della mangiatoia di Betlemme. Suo padre faceva il carpentiere in un angolo sperduto della Galilea, e lo stesso mestiere ha fatto anche Gesù stesso, tranne che nei suoi ultimi anni di vita. Gesù non era un pastore, non era un parroco, era un operaio. Giunto al trentesimo anno di età, ha appeso al chiodo i suoi arnesi, e ha cominciato a girovagare da una località all’altra perché aveva qualcosa da dire agli uomini. Ma anche allora la sua posizione è stata completamente diversa da quella di un pastore dei nostri giorni. Noi pastori dobbiamo essere a disposizione di tutti, di chi sta in alto e di chi sta in basso, dei ricchi e dei poveri, e la nostra personalità spesso soffre di questa duplice faccia della nostra professione. Gesù si sentiva inviato ai poveri, agli umili: questo è uno dei dati più indiscutibili che ricaviamo dalla storia del vangelo.
Il senso della sua attività si riassume in una frase, nella quale sentiamo ancora oggi ardere il fuoco di un’autentica sensibilità sociale: «Vedendo il popolo, si commosse, perché erano come pecore senza pastore» (Mc 6,34). Talvolta leggiamo anche che gli si sono accompagnati dei ricchi, ma se pure non si sono tirati indietro, dopo un breve momento di entusiasmo, come il giovane ricco (Mt 19,16-22) - e aveva le sue buone ragioni per farlo - costoro facevano parte della sua cerchia come ospiti, piuttosto che essere veramente legati a lui. Un esempio tipico in questo senso è offerto da quel Nicodemo (Gv 3,2-1), «un capo dei Giudei», che si recò da lui nottetempo.
Certo, nelle ultime settimane di vita egli si è rivolto con il suo messaggio anche ai ricchi, alle persone colte: si è spostato dalla Galilea a Gerusalemme - ma sapete bene che questo tentativo s’è concluso con la croce, sul Golgota. Quello di cui era portatore era un lieto annuncio ai poveri, al popolo dei dipendenti e degli incolti: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli» (Lc 6,20). «Il più piccolo fra tutti voi diventerà il più grande» (Lc 9,48). «Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli» (Mt 18,10). Queste affermazioni non possono essere interpretate come parole consolatorie pronunciate da un filantropo con tono di condiscendenza. Gesù ha affermato: «Vostro è il regno dei cieli», e con questo ha inteso dire: rallegratevi di rientrare nel novero della gente minuta: voi siete più vicini alla salvezza degli altolocati e dei ricchi.
«Ti ringrazio, Padre del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25). Gesù stesso si è comportato in questo modo: egli ha scelto i suoi amici tra i pescatori del lago di Galilea, tra i pubblicani al servizio dei romani, sospettati da tutti, addirittura tra le prostitute delle città di mare. Nella scelta dei propri compagni non si può scendere verso il fondo della scala sociale più di quanto abbia fatto Gesù. Per lui, nessuno si trovava troppo in basso o contava troppo poco.
Lo ripeto: non si trattava di una sussiegosa compassione dall’alto al basso, ma nell’esplosione di un vulcano dal basso verso l’alto. Non sono i poveri ad aver bisogno di compassione, ma i ricchi, non i cosiddetti “senza Dio”, ma gli uomini pii. Queste inaudite parole: «I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio» (Mt 21,31), e: ’Guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione» (Lc 6,24), Gesù le ha pronunciate rivolgendosi verso l’alto, mentre rivolgendosi verso il basso ha detto: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò» (Mt 11,28). Lo spirito che ha valore agli occhi di Dio è lo spirito sociale. E l’aiuto prestato sul piano sociale è la strada che conduce alla vita eterna.
Gesù non ha soltanto parlato, ma ha anche agito in questo modo. Se si legge il vangelo con attenzione, non si può non restare stupefatti di come sia stato possibile fare di Gesù un pastore o un maestro, il cui scopo sarebbe stato quello di insegnare agli uomini una fede e una vita corrette. «Da lui usciva una forza che sanava tutti» (Lc 6,19).
 Questa era la sua attività essenziale. Sia che si interpretino queste guarigioni come eventi soprannaturali o naturali - resta il fatto che egli ha operato delle guarigioni e che questa sua capacità sta al centro della sua vita molto più di quanto abitualmente si pensi. «Egli passò beneficiando e risanando» (At 10,38). Troviamo molti altri episodi del genere.
Questa era la sua attività essenziale. Sia che si interpretino queste guarigioni come eventi soprannaturali o naturali - resta il fatto che egli ha operato delle guarigioni e che questa sua capacità sta al centro della sua vita molto più di quanto abitualmente si pensi. «Egli passò beneficiando e risanando» (At 10,38). Troviamo molti altri episodi del genere.Guardando a questi dati noti a chiunque abbia letto la Bibbia, credo che nessuno abbia il diritto di dire che la socialdemocrazia è non cristiana e materialista per il fatto d’essersi posta come obiettivo l’introduzione di un ordinamento sociale più favorevole agli interessi materiali del proletariato. Gesù si è opposto alla miseria sociale affermando, con le parole e con i fatti, che essa non deve esistere. Certamente, egli ha fatto ciò infondendo negli uomini lo spirito, che trasforma la materia. Al paralitico di Cafarnao ha detto per prima cosa: «Ti sono rimessi i tuoi peccati»; e, dopo: «Alzati, prendi il tuo letto e cammina». Egli ha operato dall’interno verso l’esterno. Ha creato uomini nuovi, per creare un mondo nuovo.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ’Il lavoro rende liberi’, oggi. Per uscire dal buio. Decalogo: Lavoro (di Aboubakar Soumahoro).12 ottobre 2018, di Federico La Sala
Per uscire dal buio
Decalogo *
Parole rifondative: di un progetto, un’identità, una speranza di futuro. Nelle prossime settimane si riuniranno in tanti, a sinistra o da quelle parti: si comincia questa domenica con la marcia della pace Perugia-Assisi, cinquant’anni dopo la morte di chi la sognò, Aldo Capitini, scomparso il 17 ottobre 1968. Seguiranno nel Pd la Piazza Grande del nuovo aspirante leader Nicola Zingaretti, a Roma il 14 ottobre; e la Leopolda dell’ex ma sempre incombente Matteo Renzi, una settimana dopo. E le manifestazioni del 13 ottobre in tutta Europa, comprese molte città italiane, «contro il nazionalismo, per un’Europa unita» (www.13-10.org).
Si discuterà di nomi, sigle, contenitori, per provare a riempire il vuoto di presenza, il deserto di alternativa visibile. Quello che ancora manca è la battaglia di idee: una sida politica e culturale, popolare e non elitaria. Qualche settimana fa l’Economist ha offerto ai suoi lettori un manifesto per ripensare il liberalismo.
L’Espresso, nel solco di questo dibattito italiano e europeo, ha chiesto ad alcune sue firme, diverse per cultura e esperienza, un decalogo di parole-chiave (altre ne seguiranno). Da “Noi e Tu” di Massimo Cacciari a “Tutti” di Francesca Mannocchi, il nostro alfa e omega. Un segno di luce, per uscire dal buio.
***
Lavoro
di Aboubakar Soumahoro
Prima il lavoro, si dice, d’accordo. Ma prima del lavoro c’è il lavoratore. E, prima ancora, gli esseri umani. Oggi, nei convegni e nelle relazioni prodotte dai centri studi, si parla dei lavoratori come se fossero macchine, corpi senza anime, robot. Lavoratori senza legami sociali, atomizzati. Lavoratori isolati, ognuno per sé, senza una dimensione collettiva, senza relazioni umane in grado di creare solidarietà.
Si parla di intelligenza artificiale, ma sono gli esseri umani a finire progressivamente trasformati in automi. Partire dal lavoro significa allora restituire alle persone i loro diritti e la loro dignità, ma anche la possibilità di sentirsi protagonisti di una costruzione sociale. Il lavoro è impoverito, e impoveriscono i lavoratori, oppure è dequalificato, giovani iper-laureati oggi svolgono lavori dequalificati.
Nell’era digitale il lavoro ti impedisce di realizzare le tue aspettative e al tempo stesso colonizza il tempo di vita. Vale per tutti i lavoratori, gli operai e i braccianti, i precari, per quelli impegnati nel privato e per quelli che si muovono nella sfera del pubblico, dove anni di privatizzazioni, blocco delle assunzioni, appalti all’esterno di funzioni che appartengono allo Stato hanno creato una situazione di precarietà di vita e non soltanto di condizioni lavorative. Uno Stato che partecipa a fenomeni di sfruttamento e di abbrutimento.
Parlare del lavoro, dunque, significa parlare delle persone, nella loro quotidianità, nelle loro spese, nella fatica di portare a termine la giornata, non soltanto dal punto di vista economico. I bisogni vitali delle creature, come diceva Giuseppe Di Vittorio. Creature: è la parola più tipicamente umana, contiene in sé ogni cosa. Noi siamo da questa parte, lo dico anche nell’ottica di un sindacalista contemporaneo che vive in questo tempo e in questa stagione. Siamo dalla parte delle persone, senza disparità di pelle o di genere, dovrebbe essere la normalità, ma oggi sta avvenendo il contrario. Lavoro oggi significa cultura, emancipazione, rispetto, giustizia sociale. Significa battersi per evitare che il lavoro torni a coincidere con lo sfruttamento degli esseri umani, la loro alienazione. Vuol dire ricomporre valori comuni, oggi spezzati. Ricucire.
* l’Espresso, O7.10.2018
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Una situazione eccezionalmente difficile dentro e fuori la Chiesa. La scelta di un papa inquieto (di G.E. Rusconi).11 ottobre 2018, di Federico La Sala
La scelta di un papa inquieto
di Gian Enrico Rusconi (La Stampa, 11.10.2018)
«L’aborto è come affittare un sicario». E’ un’immagine pesante, non facilmente comprensibile e vagamente diffamatoria quella usata dal Papa. Ma l’aborto viene da lui senz’altro omologato al «disprezzo della vita» quale si esprime nel lungo elenco delle guerre, degli sfruttamenti di ogni genere, di tutti gli abusi per opportunismo. Si tratta di parole gravi che contano, pronunciate da un maestro della comunicazione diretta e coinvolgente come Papa Francesco.
Eppure sulla base della sua esperienza pastorale, il Pontefice dovrebbe sapere che l’aborto non è semplicisticamente riducibile a «un problema per risolvere il quale si fa fuori una vita umana». E’ un’esperienza angosciosa intima.
Soprattutto Bergoglio ignora che «il problema» o «il diritto» all’’interruzione della gravidanza è riconosciuto dalla legge secondo determinate e ben precise condizioni. Essa riguarda «una gravidanza che comporti un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o alla previsione di anomalie o malformazioni del concepito. L’accesso all’intervento abortivo è dalla legge garantito in quelle circostanze, cosicché parlare di libertà di aborto è una forzatura che la legge non consente». Così ha scritto qualche giorno fa su questo giornale Vladimiro Zagrebelsky, augurandosi che non si ritorni a contrapposizioni irragionevoli, aggressive e diffamatorie.
Invece ci risiamo, e proprio per bocca del Papa. Adesso ci manca solo l’intervento di Matteo Salvini.
 E’ triste dover fare questa battuta. Ma ferme restando le ragioni di principio dell’opposizione del Pontefice e del mondo cattolico all’interruzione della gravidanza, è innegabile che essa risenta del mutamento del clima politico e culturale del Paese. E che ci sia la tentazione di approfittarne per riaprire una questione che sembrava risolta nel rispetto reciproco delle convinzioni etiche.
E’ triste dover fare questa battuta. Ma ferme restando le ragioni di principio dell’opposizione del Pontefice e del mondo cattolico all’interruzione della gravidanza, è innegabile che essa risenta del mutamento del clima politico e culturale del Paese. E che ci sia la tentazione di approfittarne per riaprire una questione che sembrava risolta nel rispetto reciproco delle convinzioni etiche.Questa tentazione è un segnale importante dell’ avanzare di una democrazia illiberale nel nostro Paese. Si fanno prepotenti i segnali di insofferenza della classe politica al governo per ridurre o condizionare gli spazi di libertà di espressione della stampa. In maniera più pasticciata e subdola vengono alterati i diritti costituzionalmente riconosciuti ai richiedenti asilo, ai profughi, ai migranti. A questo proposito però esiste il consenso detto e non detto della popolazione e dello stesso mondo cattolico - con l’eccezione di pochi gruppi che rischiano però di godere di una visibilità mediatica fine a se stessa.
In tema di migrazione, accoglienza e integrazione dei migranti la stessa voce del Papa così forte, insistente, perentoria e persino provocatoria sino ad un anno fa, sembra in qualche modo ridimensionata. Si è fatta più realistica. Spero che questa mia affermazione non venga maliziosamente fraintesa.
Papa Bergoglio si trova in una situazione eccezionalmente difficile dentro e fuori la Chiesa. Nei suoi contatti e comunicazioni esterne talvolta si ha l’impressione che, senza abbandonare la sua tipica giovialità, sia profondamente turbato.
 Questo turbamento si esprime anche nel suo schietto linguaggio tradizionale che mette continuamente in guardia qui e ora contro la presenza e l’opera del demonio. In fondo è lui il sicario dell’aborto.
Questo turbamento si esprime anche nel suo schietto linguaggio tradizionale che mette continuamente in guardia qui e ora contro la presenza e l’opera del demonio. In fondo è lui il sicario dell’aborto. -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Per«un patriottismo allargato». Diamo un’anima alla bandiera Ue (di Bono - "U2").10 ottobre 2018, di Federico La Sala
L’intervento
Diamo un’anima alla bandiera Ue
di Bono (la Repubblica, 10.10.2018)
La nostra band, gli U2, ha dato avvio al tour europeo due mesi fa con un’idea che pensavamo potesse risultare un po’ provocatoria, un po’ trasgressiva. Appigliandoci alla presunzione bonaria delle rockstar impegnate in una causa, abbiamo annunciato che avremmo sventolato una grande, sgargiante bandiera blu dell’Ue. Non sapevamo che tipo di reazioni questo gesto avrebbe suscitato. Il che, in un certo senso, era esattamente il motivo per cui intendevamo farlo. Volevamo scoprirlo.
Da due mesi, e mentre adesso ci prepariamo a sventolare la bandiera a Milano, rimaniamo sorpresi nel vedere il pubblico ai concerti alzarsi in piedi e applaudire un simbolo oggetto di grandi polemiche, persino di disprezzo in alcuni ambienti.
L’Europa, che a lungo ha suscitato sbadigli, oggi provoca aspre e accese discussioni. L’Europa è teatro di forze potenti, impulsive e contrastanti destinate a dare forma al nostro futuro. Dico il nostro futuro perché non si può negare che ci troviamo tutti sulla stessa barca, in mari agitati da condizioni meteorologiche estreme e politiche estremiste.
L’idea di Europa non è particolarmente in voga di questi tempi, e ciò malgrado negli ultimi 50 anni non vi sia stato posto migliore in cui nascere dell’Europa stessa. Sebbene si debba lavorare molto più duramente per estendere i vantaggi del benessere, gli europei sono più istruiti, più al riparo dagli abusi delle grandi multinazionali e, rispetto alle persone che vivono in ogni altra regione del mondo, conducono una vita migliore, più lunga, più sana e in generale più felice. Esatto, più felice. C’è chi le misura queste cose!
L’Irlanda è un posto con un legame emotivo speciale con l’Europa, e con l’idea di Europa. Forse perché l’Irlanda è un piccolo scoglio in mezzo al vasto mare, desiderosa di far parte di qualcosa di più grande di noi ( perché la maggior parte delle cose sono più grandi di noi). Forse perché ci sentivamo più vicini all’Europa che ad altre persone che vivevano sulla nostra stessa isola.
L’appartenenza all’Europa ci ha permesso di diventare una versione migliore e più sicura di noi stessi. Camminiamo un po’ più a testa alta tra i nostri amici. E più il Nord e il Sud dell’Irlanda si sono avvicinati all’Europa, più noi irlandesi ci siamo avvicinati gli uni agli altri. La vicinanza ha oltrepassato il confine e ha abbattuto le barriere. Per dolorose ragioni storiche, non prendiamo alla leggera il concetto di sovranità. Se per sovranità si intende il potere di un Paese di governare sé stesso, l’Irlanda ha constatato che collaborare con altre nazioni le ha dato un potere maggiore di quello che avrebbe potuto esercitare da sola, e una migliore capacità di agire sul proprio destino.
Da europeo mi sento orgoglioso pensando agli italiani e ai tedeschi che hanno accolto così tanti rifugiati siriani quando questi, terrorizzati, hanno cominciato a fuggire dalla guerra civile ( mi sentirei ancora più orgoglioso se fossero stati molti più Paesi a farsi avanti); orgoglioso della lotta dell’Europa per porre fine alla povertà estrema e al cambiamento climatico; e, sì, estremamente orgoglioso dell’accordo di pace del Venerdì Santo (Good Friday Peace Agreement) e di come altri Paesi si siano stretti attorno all’Irlanda sulla questione dei confini, riaccesa dalla Brexit.
Mi sento privilegiato ad aver assistito al più lungo periodo di pace e prosperità della storia del continente europeo. Ma tutti questi successi sono ora minacciati, perché il rispetto per la diversità - premessa dell’intero sistema europeo - viene messo oggi in discussione.
Come ha detto il mio connazionale John Hume: «Ogni conflitto ruota attorno alla differenza, che si tratti di una differenza di razza, religione o nazionalità. Gli architetti dell’Europa hanno deciso che la differenza non è una minaccia... La differenza è l’essenza dell’umanità » e dovrebbe essere rispettata, esaltata e, persino, coltivata.
Stiamo assistendo a una impressionante perdita di fiducia in questa idea. Fomentati dalle asimmetrie della globalizzazione e dal fallimento della gestione della crisi migratoria, i nazionalisti affermano che la diversità è un pericolo. Rifugiatevi - ci dicono - nell’omogeneità; scacciate il diverso. La loro visione per il futuro mi sembra molto simile al passato: politica identitaria, risentimento, violenza. Abbiamo sentito questo appello pieno di odio in Polonia, ad esempio, e in Ungheria, nonché il mese scorso alle elezioni in Svezia. Il nazionalismo è tornato e ha un impatto penalizzante sulle pari opportunità.
La generazione che ha subìto la guerra mondiale ha assistito ai risultati funesti di quel modo di pensare. Ha scorto un sentiero fuori dalle macerie, oltre i muri di cemento e il filo spinato, per far arretrare la cortina di ferro tratteggiata sul cavalletto di Stalin, e ha respinto l’idea che le nostre differenze siano tutto ciò che ci definisce. Ha compreso che il pensiero a somma zero era un patto suicida.
L’Italia è uno degli Stati fondatori dell’Unione europea. Il sogno che ci ha uniti era tanto italiano quanto francese o tedesco o ancora, anche se abbiamo aderito anni dopo, irlandese. L’Italia è sempre stata al centro di questo grande progetto comune. Adesso invece si trova al centro di una crisi che minaccia tutti noi e che, se lasciamo che le nostre divisioni ci definiscano, potrebbe consumarci.
Amo le nostre differenze: i nostri dialetti, le nostre tradizioni, le nostre peculiarità, «l’essenza dell’umanità», come diceva Hume. E credo che lascino ancora spazio a quello che Churchill chiamava «un patriottismo allargato» : una pluralità di appartenenze, identità stratificate, che consentano di essere al contempo irlandese ed europeo, italiano ed europeo, non l’uno o l’altro. La parola patriottismo ci è stata rubata da nazionalisti ed estremisti che esigono che vi sia uniformità. Ma i veri patrioti riconoscono l’unità al di sopra dell’omogeneità. Riaffermare questo primato è, per me, il vero progetto europeo.
Può sembrare che non ci sia romanticismo in un " progetto" o fascino in una burocrazia ma, come ha detto la grande Simone Veil, «l’Europa è il grande progetto del XXI secolo». Di sicuro alcuni elementi di quel progetto devono essere ripensati e aggiornati. Ma i nostri valori e le nostre aspirazioni no. Rendono l’Europa molto più di una semplice istituzione o di un luogo geografico. Rappresentano il vero nucleo di chi siamo come esseri umani, e di chi vogliamo essere. Su quell’idea di Europa vale la pena scrivere canzoni, e sventolare grandi e sgargianti bandiere blu. Per trionfare in quest’epoca travagliata, l’Europa è un’idea che deve diventare un sentimento.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- “Il razzismo è ben più allarmante dei conti” (Barbara Spinelli)5 ottobre 2018, di Federico La Sala
Barbara Spinelli: “Il razzismo è ben più allarmante dei conti”
di RQuotidiano *
Barbara Spinelli è intervenuta nella sessione plenaria del Parlamento europeo in seguito alle dichiarazioni di Consiglio e Commissione europea su “Emergenza umanitaria nel Mediterraneo: sostenere le autorità locali e regionali”.
“La Commissione si allarma - ha detto l’europarlamentare italiana - per il possibile deficit spending in Italia (ricordo che i poveri assoluti sono nel mio paese cinque milioni) ma approva una legge sulla sicurezza che decurta i permessi umanitari, toglie certezza legale ai richiedenti asilo, elimina fondi per le strutture municipali di accoglienza migranti.
Dice Draghi che ci sono parole che creano danni alle imprese, ma le parole di Salvini sul sindaco di Riace, arrestato ieri per favoreggiamento dell’immigrazione e irregolarità minori, sono benevolmente ignorate. ‘Sei uno zero’, ha detto il ministro di chi, con fondi in diminuzione, ha salvato un intero villaggio dallo spopolamento integrando i profughi.
Non parlo solo dell’Italia: arresti e violenze contro chi facilita accoglienza e integrazione si moltiplicano. Cédric Herrou, Diego Dumont, il sindaco Mimmo Lucano: la lista si sta allungando, Commissario Oettinger, e vorrei sapere se questo allarma anche lei”.
* Il Fatto, 05.10.2018: https://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/barbara-spinelli-il-razzismo-e-ben-piu-allarmante-dei-conti/
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Cultura, logos e traduzione. Se fossi un docente di scuola dedicherei un tempo adeguato a ricordare la grande scuola dei traduttori nella Toledo medievale e poi a Siviglia e a Murcia (Carlo Sini).4 ottobre 2018, di Federico La Sala
Cultura, logos e traduzione
L’occidente è una parola scritta
di Carlo Sini (Corriere della Sera, 04.10.2018)
- Domani a Milano (ore 18.30, Villa Necchi Campiglio) viene presentato il Premio internazionale di letteratura araba «Sheikh Zayed Book Award». Intervengono Ali Bin Tamim, presidente del Premio, Abdulla Majed Al-ali, Samer Abou Hawwach, Paolo Spinicci, Alessandro Zaccuri e Marco Zapparoli, di Marcos y Marcos, presidente degli editori indipendenti italiani. Modera Paolo Gualandris. Il filosofo Carlo Sini terrà una «lectio minimalis» che anticipiamo.
La memoria corta genera ignoranza, presunzione e ingiustizia. Se fossi un docente di scuola dedicherei un tempo adeguato a ricordare la grande scuola dei traduttori nella Toledo medievale e poi a Siviglia e a Murcia (non so quanto oggi lo si faccia): senza di loro tutto il nostro sapere e la nostra cultura «occidentale», di cui giustamente siamo fieri e che sta diventando sempre più planetaria, non ci sarebbero.
La premessa storica è il periodo d’oro della conquista araba della Spagna, accompagnata da una grande quantità di manoscritti. Quando i re cristiani si impadronirono di quelle terre, cacciando gli arabi (in realtà la situazione si ribaltò più di una volta), quei preziosi manoscritti ispirarono la grande impresa della loro traduzione in latino, consegnando un po’ alla volta a tutte le scuole d’Europa trattati preziosissimi di filosofia, di teologia, di astronomia, di scienza, di matematica e con essi una parte cospicua della cultura greca sino ad allora perduta o dimenticata in Occidente. Senza questi lavori la grande rivoluzione della Scolastica in Europa, patrocinata anzitutto da Tommaso d’Aquino, non sarebbe stata possibile.
La cosa ancora oggi straordinaria e degna di molta riflessione fu il progetto di far convivere in armonia studiosi arabi, cristiani ed ebrei: progetto che consentì quella fiorente scuola di traduttori che Alfonso X re di Castiglia e di Leon particolarmente protesse e potenziò, ispirando anche traduzioni dal latino al castigliano.
L’Occidente, in conclusione, è l’invenzione e l’uso della parola scritta, invenzione resa nel tempo universale dalla cultura greca. Come ogni pratica, anche la scrittura si accompagna a forme di vita e a istituti diversi, ma essa è e rimane il cuore della nostra cultura, greca, araba, romana, cristiana ed ebraica: ignorarlo o trascurarlo è un delitto contro la civiltà e un suicidio intellettuale.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- La lezione (dimenticata) del Novecento: la divisione tra Stati è un’eredità del passato che il capitalismo riattualizza facendone forse l’arma più efficace del suo successo.29 settembre 2018, di Federico La Sala
I confini e le sovranità necessarie alla retorica del capitalismo
Europa fronte del conflitto. L’organizzazione e la divisione tra Stati è un’eredità del passato che il capitalismo riattualizza facendone forse l’arma più efficace del suo successo di classe
di Piero Bevilacqua (il manifesto, 29.09.2018)
Ma davvero, al livello cui è giunta l’economia mondiale, avremmo ancora bisogno di «crescere»,«correre», «competere», se l’umanità non fosse divisa in stati, con le loro frontiere e le loro bandiere? Avremmo ancora bisogno di «andare avanti», cioè di accumulare ulteriore ricchezza, se ciascuno non perseguisse per sé, l’obiettivo che è comune, vale a dire il benessere di tutti? Osservata da una prospettiva che prescinda dagli stati nazionali, questa costruzione storica che ancora decide il destino dell’umanità, il meccanismo che ispira il capitalismo del nostro tempo, appare in tutta la sua tragica assurdità. Che bisogno c’è ancora di crescere se ogni anno vanno al macero 1, 3 miliardi di tonnellate di cibo, rimangono invendute, solo in Europa, decine di milioni di auto e un numero imprecisato viene quotidianamente rottamato, se l’iperconsumo fa crescere di anno in anno rifiuti e discariche in ogni angolo del pianeta, e una nuova micidiale spazzatura - la cosiddetta e-waste, la spazzatura elettronica - va divorando sempre nuovi territori, tanto nei paesi ricchi che in quelli poveri?
E QUALE RAZIONALITÀ SEGRETA sorregge questa corsa all’infinito, dal momento che per alimentarla, stiamo distruggendo la vita dei mari, saccheggiando le risorse idriche del pianeta, avvelenando le terre fertili, inquinando l’aria, riducendo la biodiversità naturale, alterando irreversibilmente il clima? A che fine questa corsa l’un contro l’altro stato, se essa condanna una parte estesa dell’umanità alla disoccupazione e alla precarietà, alla polverizzazione della vita sociale, al ritorno del lavoro schiavile anche nelle campagne ?
È EVIDENTE che l’organizzazione e la divisione tra stati è una eredità del passato che il capitalismo del nostro tempo - grande stratega nelle mosse di dominio sull’umanità - riattualizza facendone forse l’arma più efficace del suo successo di classe. Dunque è sufficiente porre mente a questo stato di cose per scorgere oggi l’inanità della lotta politica tutta interna ai vincoli dei singoli stati nazionali. Restando chiusi dentro questi confini i partiti politici operano come zelanti servitori delle retoriche capitalistiche, accentando una insuperabile subalternità al capitale industriale e finanziario, libero di muoversi senza limiti di frontiere e di bandiere.
NON È CERTO UN CASO che da quando è scomparso dalla scena del mondo l’antagonista globale rappresentato dal comunismo, mostro burocratico, ma pur sempre «mostro», questo modo di produzione va celebrando i fasti più distruttivi della sua storia, contro il lavoro e contro gli ecosistemi della Terra. E non è vero che a impedire oggi il conflitto di classe sia la destrutturazione postfordista del lavoro di fabbrica. È la limitatezza territoriale della lotta operaia e popolare di fronte allo spazio di movimento mondiale del capitale. Ma mai come oggi la logica della crescita fa tutt’uno con la distruzione degli equilibri della Terra, offrendo alla sinistra l’opportunità egemonica di far coincidere il riscatto dei subalterni con la salvezza del pianeta. È evidente che senza una forza di contrapposizione di ampiezza sovranazionale, capace di colpire il capitale nei suoi interessi vitali, la politica riformista ha la potenza del graffio del gatto.
LA SPAZIO POLITICO dell’Unione europea è dunque lo spazio minimo in cui pensare un’azione politica in grado di una qualche efficacia, come hanno efficacemente argomentato su questo giornale Luciana Castellina (14/ 9 e Marco Bascetta, 22/9). Del resto, quel che può ancora oggi la politica di fronte ai colossi dell’economia, l’ha mostrato proprio l’UE con le recenti sanzioni a Microsoft e Google. Sappiamo bene che è arduo modificare i trattati neoliberisti che reggono l’impalcatura dell’Unione, ma il fronte della lotta oggi è questo continente, non le retrovie nazionali.
Esattamente per tale ragione, occorre dire che i vari tentativi oggi in corso di resuscitare il centro-sinistra costituiscono velleità da scansare. L’operazione avrebbe la stessa possibilità di tenuta del ponte Morandi ricostruito con le macerie oggi nel greto del Polcevera. Non si costruisce nulla di solido con le rovine di un edificio, per giunta mal costruito. E non c’è modo più serio di liberare le forze avanzate e riformatrici attive in quell’ambito che dichiarare solennemente chiusa quella esperienza.
MA TALE POSIZIONE chiede alla sinistra radicale una serietà e un senso di responsabilità che finora sono mancati. Il tentativo di Varoufakis - uno dei pochi leader politici che ha conoscenza profonda dell’Unione - e di altri dirigenti di Diem (una trama transnazionale con un organico programma per le elezioni europee) deve essere colto dalla varie sigle della nostra sinistra come una grande occasione di unificazione in un momento grave della storia d’Europa. Potere al Popolo, Sinistra Italiana, Rifondazione, Possibile non possono più continuare il loro irresponsabile gioco a scacchi.
La lezione (dimenticata) del Novecento
Dietro gli slogan sovranisti l’eterno ritorno del nazionalismo
di Umberto Gentiloni (la Repubblica, 29.09.2018)
Come me nessuno mai, sono stato il più capace di tutti» parole pronunciate martedì scorso dal presidente degli Stati Uniti nel Palazzo di vetro delle Nazioni Unite mentre il paragone azzardato con amministrazioni precedenti scatenava risa e facili battute in platea. Ma come spesso accade, quando sembra che le frasi di Trump siano destinate al fugace contesto del suo profilo Twitter, alla fine di un discorso restano gli interrogativi sui destinatari di messaggi che sono ben più profondi e impegnativi di una battuta fuori luogo. Gli ingredienti dei suoi continui richiami al primato americano sono ormai sperimentati e ben noti tra gli addetti ai lavori e non solo: isolazionismo e chiusura identitaria, protezionismo come orizzonte di riferimento combinato con il rilancio di paure e impulsi contro l’immigrazione e l’immigrato in quanto tale. Una ricetta venduta come grande innovazione del tempo presente, come scoperta e rivelazione epocale che in realtà ha già attraversato pagine e tornanti della storia degli Stati Uniti e delle relazioni tra il nuovo mondo e il vecchio continente. Basta tornare a dare un senso alle parole che leggiamo o ascoltiamo.
Dietro le presunte categorie di un "sovranismo" diffuso che va per la maggiore si celano le più classiche sembianze di un becero nazionalismo che ha attraversato e insanguinato il secolo scorso. Gli anni tra le due guerre mondiali portano il segno di un passato rimosso troppo in fretta, quando la sconfitta del disegno di un ordine internazionale rilancia le ragioni di un’America chiusa, restia a uscire dai recinti di un perimetro rassicurante e sperimentato.
Un’oscillazione continua tra l’apertura e il dialogo per costruire ponti o architetture condivise e le sirene di un primato fondato sulla forza economica o il predominio militare. La sconfitta del wilsonismo e dei suoi valori di riferimento mette da parte, negli anni Venti del Novecento, un’ispirazione morale che pur tra debolezze e incongruenze aveva abbozzato l’ipotesi di radicare un sistema internazionale condiviso e partecipato, un embrione possibile di un governo mondiale come risorsa contro aggressioni e prove di forza. Ma il pendolo ha continuato a oscillare pericolosamente, confermando i timori di chi con ambizione e utopia pensava di poter ridimensionare il ricorso alla guerra come principale strumento per la risoluzione dei conflitti.
Un tracciato che affonda le radici nella democrazia americana e nelle priorità della sua politica estera per dirla con Walter Russell Mead e un suo celebre volume del 2001 ( Il serpente e la colomba. Storia della politica estera degli Stati Uniti d’America): l’economia prima di tutto (hamiltoniani), la difesa della democrazia ad ogni costo (jeffersoniani), la nazione e la sua rispettabilità minacciata (jacksoniani), i valori morali irrinunciabili e intoccabili (wilsoniani).
Filoni contraddittori e contrastanti di presenza degli Usa sulla scena internazionale per scrollarsi di dosso le insinuazioni del cancelliere Bismark che avevano come bersaglio la proiezione esterna della nascente potenza americana considerata illogica e pericolosa, salvata da una «speciale provvidenza in grado di mettere insieme i matti, gli ubriachi e gli Stati Uniti d’America». E il secolo americano avrebbe rilanciato la dialettica tra egoismo e partecipazione portandosi dietro il paradosso di una doppia contrarietà: chi ha contrastato il predominio e l’interventismo unipolare e su un altro versante chi ne ha sottolineato i rischi per un disimpegno, una fuga da teatri di crisi di difficile gestione.
Troppa o poca America a seconda dei casi e delle esigenze strumentali. La collaborazione tra diversi presuppone che il nazionalismo della singola nazione non metta in discussione un quadro condiviso di regole e riferimenti, non intacchi un tessuto prezioso eredità di generazioni lontane. Altro che primato in solitaria di una potenza incontrastata: voltarsi indietro rischia di essere un cammino senza ritorno. Ogni soggetto è pronto (o dovrebbe esserlo) a rinunciare a porzioni crescenti di sovranità e potere, questo il lascito doloroso del secolo XX. Nessuno può salvarsi da solo.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- SOVRANITA’ (Costituzione), SOVRANISMI (Partiti), E "IL SOGNO DI UNA COSA".29 settembre 2018, di Federico La Sala
SOVRANITA’ (Costituzione), SOVRANISMI (Partiti), E ... “FORZA FRANCIA” (1994-2018)!!! IL SOGNO DI UNA COSA ...
Una nota "Sul sovranismo democratico" *
di Federico La Sala
Per mettere (per così dire) i piedi per terra (e la testa in aria), a mio parere, data la situazione storica presente in cui “naviga” l’Italia e l’intera Europa, considerato “il nuovo scenario come dominato dalla polarizzazione tra sovranisti e macroniani” (Paolo Costa, "Sul sovranismo democratico", "Le parole e le cose", 24.09.2018), mi sembra più che pertinente richiamare la lezione marxiana:
“Non basta dire come fanno i francesi che la loro nazione è stata colta alla sprovvista. Non si perdona a una nazione, come non si perdona a una donna, il momento di debolezza in cui il primo avventuriero ha potuto farle violenza. Con queste spiegazioni l’enigma non viene risolto, ma soltanto formulato in modo diverso. Rimane da spiegare come una nazione dì 36 milioni di abitanti abbia potuto essere colta alla sprovvista da tre cavalieri di industria e ridotta in schiavitù senza far resistenza” (K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, 1852).
 “Io mostro, invece, come in Francia la lotta di classe creò delle circostanze e una situazione che resero possibile a un personaggio mediocre e grottesco di far la parte dell’eroe”(K. Marx, cit., 1869).
“Io mostro, invece, come in Francia la lotta di classe creò delle circostanze e una situazione che resero possibile a un personaggio mediocre e grottesco di far la parte dell’eroe”(K. Marx, cit., 1869).SOVRANITA’ DEMOCRATICA E COSTITUZIONE ITALIANA. Prima di tutto, concepire e recuperare la nostra personale e politica “sovranità”: “Sàpere aude!” (Kant)! Presupposto fondamentale e necessario è che ogni cittadino e ogni cittadina della Repubblica (artt. 1, 2, 3), uscito dallo “stato di minorità”, sia un sovrano e una sovrana e, in quanto tale, rispetti come “re” e come “regina” il “patto di alleanza” (la Costituzione) sottoscritto e, all’interno di essa, come “suddito” e “suddita”, “obbedisca” alle decisioni del Governo (il “patto di sudditanza”).
A TUTTI I LIVELLI, (micro e macro!), in ogni società COSTITUZIONAL-MENTE organizzata, a questi DUE PATTI tutti e tutte si è legati/e... se non si vuole “vivere” nella guerra di tutti/e contro tutti/e. E, ovviamente, il “patto di alleanza” è quello fondante - in sua assenza, si è fuori dalla “grazia” di “Dio”, e nelle braccia di “Mammona”!
SOLO camminando SU QUESTA STRADA, forse, è possibile vincere il ” pessimismo antropologico che non mi sembra granché di sinistra e che la riduzione monologica del potere alla sovranità esemplifica alla perfezione. È quella roba che dai tempi della Thatcher si usa chiamare TINA - there is no alternative - e di cui paghiamo il prezzo politico (con interessi superiori a quelli del debito italiano) oggi” (P. Costa, cit.), e contrastare il misticismo politico del “sovranismo democratico”!
PURTROPPO “la semplicità - è difficile a farsi” (B. Brecht)! La “produzione” va avanti a pieno regime - e non c’è più solo qualcuno/a che vuole e pretende di essere al di sopra della Costituzione, della Legge, “come Dio”, un “Diavolo in persona”, e lavora per la “pace perpetua” di tutto il Pianeta!!!
CHE FARE?! Questa è l’alternativa: “Uno spettro si aggira per l’Europa (...) una lotta che è sempre finita o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società, o con la totale rovina delle classi in lotta”(“MEGA” - “Marx-Engels Gesamtausgabe”).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Chi condanna l’Europa all’autodistruzione. Un potere che non tollera alcuna trasformazione, ma anche privo di prospettive (Ignazio Masulli)..25 settembre 2018, di Federico La Sala
Chi condanna l’Europa all’autodistruzione
Derive europee. Si lascia credere che gli immigrati rappresentano una minaccia per gli standard di vita e addirittura per la sicurezza dei cittadini
di Ignazio Masulli (il manifesto, 25.09.2018)
Anche al recente vertice di Salisburgo si è assistito all’eterno minuetto di paesi e istituzioni dell’Unione europea che con vari toni manifestano una sostanziale e comune indisponibilità a politiche di accoglienza e positiva regolazione dei flussi migratori. Un comportamento ingiustificato, irresponsabile e, alla fine, autodistruttivo.
È ingiustificato perché l’invecchiamento della popolazione dei paesi europei sta creando uno squilibrio demografico e sociale insostenibile.
Inoltre è ampiamente dimostrato che gli immigrati nati all’estero e regolarizzati pagano al fisco degli stati in cui vivono e lavorano contributi che eccedono di oltre la metà le spese di cui usufruiscono Né è vero che sottraggono lavoro a chi già risiede perché contribuiscono in misura significativa all’aumento del Pil e, quindi, alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Si lascia credere che gli immigrati rappresentano una minaccia per gli standard di vita e addirittura per la sicurezza dei cittadini, alimentando sentimenti di xenofobia e di razzismo con effetto-contagio su chi vede peggiorare le proprie condizioni sociali, come gran parte della popolazione lavoratrice e ceti medi. Una situazione in cui proprio le fasce più vulnerabili guardano con avversione ed ostilità chi si trova al gradino inferiore.
Oggi in Europa governi di destra, di centro o che si autodefiniscono progressisti non sono disposti ad accogliere nemmeno piccole quantità di migranti. Lo fanno stentatamente o si rifiutano, anche quando si tratta di rifugiati e richiedenti asilo garantiti dal diritto internazionale.
Pur con vari gradi di oltranzismo, ma con sostanziale parità di posizioni agli effetti pratici, i governi dei paesi membri e i rappresentati delle istituzioni centrali dell’Unione europea, concertano e perseguono politiche di puro e semplice respingimento dei migranti. Lo fanno senza alcuno scrupolo di stipulare accordi politici e finanziari con i paesi d’origine e di transito dei migranti, perché li trattengano o li intercettino. Lo fanno benché consapevoli di accrescere, in tal modo, ogni genere di sofferenze, violenze, fino alla morte di persone inermi. E con un’indifferenza che può spingersi oltre ogni limite, come purtroppo mostra anche il caso italiano.
L’obiettivo di fondo è di sostituire le risposte necessarie alla perdurante stagnazione economica e crescenti diseguaglianze sociali con false sicurezze e identità fasulle, come quelle di nazione, razza, “civiltà”. Non si può pensare che i governanti dei paesi dell’Unione e i suoi dirigenti siano inconsapevoli di tutto questo e non vedano ciò che è sotto gli occhi di tutti e cioè che stiamo andando verso un’Europa dei fascismi, quindi, verso la fine di ogni base politica e morale dell’Unione.
Ma vince l’obbedienza cieca al più potente blocco di potere nella storia del capitalismo, potere economico, finanziario, tecno-militare e politico tanto coeso quanto pervasivo. E che, nel quarantennio neoliberista, oltre a rafforzarsi oltre misura, si è irradiato stabilendo alleanze con i gruppi dominanti dei paesi emergenti e in via di sviluppo che ne hanno condiviso le strategie.
Un potere che non tollera alcuna trasformazione, ma anche privo di prospettive, proprio perché comprime la vitale e continua opera di costruzione e ri-costruzione della società, indispensabile alla sua evoluzione. Evoluzione di cui l’emigrazione è sempre stata veicolo essenziale e costitutivo in tutta la nostra storia.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- La Germania alla ricerca di una nuova unificazione, economica, sociale e morale. La grande impresa tedesca in campo contro il razzismo,22 settembre 2018, di Federico La Sala
La grande impresa tedesca in campo contro il razzismo
di Isabella Bufacchi (Il Sole-24 Ore, 22 settembre 2018)
«Commerzbank è un’azienda cosmopolita, accompagniamo i nostri clienti in 150 Paesi. Respingiamo fermamente la xenofobia e l’estremismo, crediamo nella condivisione e nella tolleranza e continueremo a batterci per questi valore in futuro». Interpellato dal Sole 24 Ore sulla posizione della banca nei confronti di episodi crescenti di razzismo in Germania, il portavoce del secondo istituto di credito tedesco scandisce con enfasi il messaggio che in questi giorni tutte le principali aziende tedesche si stanno impegnando a rilanciare con vigore: no al razzismo e all’intolleranza, sì alla diversità. Deutsche Bank, Allianz, EY e Commerz per la finanza, Daimler, Bmw, Mini, VW per l’auto e poi ancora Siemens, Metro, Adidas, Basf, DB: chi su Facebook, chi Twitter, chi su Instagram.
Comunicato congiunto contro l’estremismo
Lunedì l’associazione tedesca della Carta delle pari opportunità e uguaglianza sul lavoro, “Charta der Vielfalt”, pubblicherà un comunicato congiunto delle 24 grandi aziende tedesche per prendere una posizione forte e comune contro razzismo e xenofobia. «Vogliamo che il nostro messaggio arrivi forte e chiaro, più forte dei manifestanti estremisti di Chemnitz», sottolineano i rappresentanti di Charta, che dallo scorso giovedì ha creato l’hashtag #Flagge für Vielfalt per le aziende che vogliono sostenere pubblicamente la diversità. Anche la piattaforma web Wir-zusammen, fondata nel 2016 da 36 grandi imprese tedesche per promuovere l’inserimento dei rifugiati, conferma l’anti-razzismo: in poco più di due anni ha aiutato 230 imprese tedesche, di cui 19 quotate sul Dax, a dare posti di lavoro a 33.500 rifugiati, e altri 22mila sono ora assistiti.
«Non è mai accaduto prima di ora, in maniera così eclatante, che tutto l’establishment industriale e finanziario tedesco prendesse una posizione pubblica così forte e unita contro il razzismo», ha commentato un banchiere tedesco, ricordando che nell’ultima grande ondata di razzismo risalente al 1993 il mezzo dirompente di comunicazione dei social networks non esisteva. E come gli estremisti di destra hanno usato con grande efficacia il passa-parola sui social networks in tutta Germania per radunarsi copiosi a Chemnitz, così il mondo dell’industria e della finanza alza ora la sua voce sui social. Per ora sono i grandi marchi a fare notizia. Ma quel che farà veramente la differenza, a livello sociale oltrechè economico, sarà l’adesione delle piccole e medie imprese a iniziative comuni contro il razzismo. Sono in migliaia le aziende tedesche piccole e medie che hanno già aderito alla Charta per la diversità.
Il contributo dei migranti al motore tedesco
È indubbio che comunque la Germania conti ora come in passato sull’immigrazione per contribuire ad alimentare e potenziare il motore della crescita. Sebbene il 90% circa dei lavoratori in Germania abbia il passaporto tedesco, stando a statistiche riportate da Handelsblatt la manodopera straniera ha pesato per il 52% sui 750mila nuovi assunti tra il maggio 2017 e il maggio 2018: di questi, uno su cinque proviene dall’Europa dell’Est, 7% da Ucraina e Russia, 13% i richiedenti asilo da Siria ed Eritrea e solo il 3% da Italia, Spagna e Portogallo. E in aggiunta, guardando avanti, la Germania conta sui non-residenti per trovare la domanda per 430mila posti di lavoro in offerta per manodopera con bassa specializzazione o non qualificata, rifiutati dai tedeschi .
L’ascesa della destra nei sondaggi
Non basta però l’impegno del mondo industriale, imprenditoriale e finanziario in Germania per contrastare e contenere questa nuova ondata di estremismo di destra che si sta caratterizzando sempre più in una lotta contro gli immigrati, con derive razziste e persino naziste. È alla classe politica e alle istituzioni democratiche, che la Germania tollerante guarda ora. E quel che vede, non può piacerle. Ieri l’ultimo sondaggio sul gradimento degli elettori ha per la prima volta dal 1997, dall’inizio delle rilevazioni, registrato l’unione CDU-CSU sotto il 30%, al 28%. (-2%), AfD (Alternativa per la Germania) è il secondo partito con il 18% (+1%) dopo aver sorpassato l’Spd in calo al 17% (-1%).
La Germania deve ora andare alla ricerca di una nuova unificazione, economica, sociale e morale. È sempre più evidente che l’ ex-Germania dell’Est non abbia fatto lo stesso percorso, il “mai più” della Germania dell’Ovest, sul nazismo e sull’Olocausto. Ma la Germania è spaccata anche tra le regioni ricche al Sud e i Länder più poveri al Nord. E la disuguaglianza, sia pur in calo come rileva l’Ifo, c’è anche in un Paese come la Germania che ha il più grande ciclo economico di crescita dal 1990 e che ha toccato piena occupazione. Esiste poi un netto divario tra le grandi città e le zone rurali. C’è il disagio dato dalla crescita dei posti di lavoro a tempo determinato e part-time. E grava su tutti l’incertezza data dall’invecchiamento della popolazione. Problemi che la GroKo guidata da una indebolita e stanca Angela Merkel potrebbe affrontare attingendo a 100 miliardi di spesa pubblica in più, senza far deragliare i conti pubblici.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- PARLAMENTO EUROPEO. La destra illiberale cerca lo scontro frontale. Approvata la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria, dando così l’ok all’applicazione dell’articolo 7 dei Trattati. Note.12 settembre 2018, di Federico La Sala
La destra illiberale cerca lo scontro frontale
Parlamento europeo. Orban all’offensiva a Strasburgo, non cede niente. Oggi il voto sull’articolo 7. La destra tradizionale del Ppe è spaccata. I governi di Italia e Austria a pezzi. Orban inneggia al "popolo" contro la democrazia rappresentativa
di Anna Maria Merlo (il manifesto, 12.09.2018)
PARIGI Muro contro muro. Viktor Orbán sceglie lo scontro diretto e non cede niente di fronte all’europarlamento. Il primo ministro ungherese, leader del fronte illiberale, è intervenuto ieri a Strasburgo, la vigilia del voto di oggi degli europarlamentari per avviare la procedura dell’articolo 7, una risoluzione che, se approvata, chiederà al Consiglio di “constatare l’esistenza di un rischio chiaro di violazione grave da parte dell’Ungheria dei valori su cui si fonda l’Unione europea”. Anche se il risultato del voto di oggi resta estremamente incerto, Orbán ha accusato preventivamente il parlamento europeo di voler “condannare” non un governo ma un popolo, “che da mille anni è membro della famiglia europea”, che sarà punito “perché ha deciso che non sarà patria di immigrati”.
Orbán: “Volete escludere un popolo”. Ha urlato: sono venuto a Strasburgo “per difendere la mia patria”, anche “contro di voi se necessario”, perché “non accettiamo minacce e ricatti delle forze pro-immigrazione, difenderemo le nostre frontiere, fermeremo l’immigrazione clandestina”. Il fronte illiberale getta la maschera e afferma il disprezzo per la democrazia rappresentativa: in Italia, Salvini riprende la tesi di Orbán, il “parlamento non processi il popolo”.
Marie Le Pen lo complimenta: “Bravo! Orbán è rimasto inflessibile di fronte ai maestrini del Parlamento europeo, che calpestano la democrazia pretendendo di difenderla”. Orbán rilegge la storia e ingloba nella sua deriva autoritaria anche la rivolta contro i sovietici del ’56: “condannerete l’Ungheria che con il suo lavoro e il suo sangue ha contribuito alla storia della nostra magnifica Europa, che si è sollevata contro l’esercito più potente del mondo, quello sovietico, e che ha pagato un forte scotto per difendere la democrazia”.
Oggi l’Europarlamento vota sull’articolo 7 da applicare all’Ungheria (ci vogliono i due terzi di voti per presentare la richiesta al Consiglio, ma la procedura potrà poi essere bloccata da un veto, la Polonia è implicata in una procedura analoga avviata dalla Commissione nel dicembre 2017). Ma l’offensiva del fronte illiberale sta spaccando il Ppe, il principale gruppo parlamentare a Strasburgo con 218 seggi.
Emmanuel Macron, indicato come “nemico” principale dal fronte illiberale, qualche giorno fa ha inviato un messaggio al Ppe, perché chiarisca la sua posizione: “non si può essere contemporaneamente a fianco della cancelliera Angela Merkel e di Viktor Orbán” (in Francia, i Républicains sono già spaccati, in Germania la coabitazione tra Merkel e il ministro degli Interni Seehofer è sempre più problematica, soprattutto dopo le manifestazioni di Chemnitz e Köthen).
La Fidesz di Orbán fa ancora parte del Ppe. Oggi, tutti gli occhi saranno puntati sul voto del capogruppo, il tedesco (Csu) Manfred Weber, che ambisce alla successione di Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione e che ha cercato di calmare Orban, con una telefonata. Oltre a quello italiano, spaccato anche il governo austriaco, con l’Austria presidente semestrale del Consiglio Ue: il cancelliere Sebastian Kurz (Ppe) ha indicato che il suo partito voterà a favore dell’applicazione dell’articolo 7 all’Ungheria, mentre il vice-premier, Heinz-Christian Strache, dell’Fpö, ha invitato Orbán a raggiungere il gruppo dell’Europa delle nazioni e a creare un forte polo di estrema destra a Strasburgo. Per Juncker (Ppe) “l’appartenenza di Fidesz al Ppe è un problema”.
Oggi, al Ppe si conteranno i voti e l’entità della spaccatura (Forza Italia voterà contro l’applicazione dell’articolo 7, in sintonia con la Lega e l’estrema destra). A favore della procedura di sanzione dell’Ungheria ci sono la sinistra della Gue, il Pse, i Verdi, i centristi dell’Alde. Alexis Tsipras - la Grecia ha sofferto dell’intransigenza europea quando si tratta di soldi, mentre oggi il rischio del voto sull’Ungheria è di un cedimento di fronte alla difesa dei valori - ha riassunto a Strasburgo la situazione a pochi mesi dalle elezioni europee: sarà “una battagli di valori e di principi” e “tutte le forze progressiste, democratiche, pro-europee devono essere unite, non dobbiamo lasciare l’Europa fare un salto nel passato”.
Orbán vuole forzare la Ue, scardinarla dall’interno, ma non intende portare l’Ungheria fuori dall’Unione. I Fondi strutturali Ue sono il 4,4% del pil ungherese. La ministra delle relazioni con la Ue, Judith Varda, ha respinto “vigorosamente” il contenuto del rapporto dell’Europarlamento, redatto dalla verde (olandese) Judith Sargentini, considerato “una vendetta” per il rifiuto di Budapest di accogliere migranti. Ma l’Ungheria ha anche cercato di convincere gli europarlamentari delle sue buone ragioni. Ha inviato un documento di 109 pagine, dove pretende di smontare le critiche del rapporto Sargentini, si difende, sui Rom, sul sistema giudiziario. A luglio, la Commissione ha già contestato di fronte alla Corte di giustizia la legge anti-immigrazione dell’Ungheria.
Il Parlamento Ue condanna Orban, ora decidono i leader
Via libera all’articolo 7 per le sanzioni all’Ungheria
di Ansa (12 settembre 2018)
STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha approvato la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria, dando così l’ok all’applicazione dell’articolo 7 dei Trattati, che nella sua fase più avanzata può condurre a sanzioni contro il Paese. A favore hanno votato 448, 197 si sono espressi contro, 48 si sono astenuti, per un totale di 693 votanti. Ora la parola passa al Consiglio europeo, ovvero ai capi di Stato e di governo dell’Unione. E’ la prima volta il Parlamento ha adottato tale iniziativa per l’attivazione dell’articolo 7 per una grave minaccia allo Stato di diritto, alla democrazia e ai diritti fondamentali in uno Stato membro, in questo caso l’Ungheria.
Il Partito popolare europeo europeo si è spaccato, con la maggioranza del gruppo che ha votato a favore delle sanzioni a Orban e una minoranza, tra cui Forza Italia, che si è espressa contro. "Se fossi stato un eurodeputato, oggi anche io avrei votato per l’attivazione dell’articolo 7", ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che fa parte del Ppe. Solo 59 i voti contrari tra gli eurodeputati del Partito popolare europeo. Il movimento 5 Stelle è stato l’unico all’interno del gruppo (Efdd) a votare in favore delle sanzioni all’Ungheria di Viktor Orban, mentre gli europarlamentari della Lega, insieme a tutti gli altri componenti del gruppo Enf, hanno votato contro.
Dura la condanna della Lega. "Le sanzioni contro Orban e l’Ungheria votate dal Parlamento Europeo sono una pagina bruttissima per la democrazia e l’intera Europa", ha commentato la capogruppo del partito al Parlamento Europeo, Mara Bizzotto. "Che una parte consistente del Ppe si sia prestato a questo linciaggio politico contro uno dei suoi leader - ha sottolineato - è sotto gli occhi di tutti: spero che Orban, dopo questo affronto, molli il Ppe ed entri a far parte del nuovo blocco identitario e sovranista che stiamo costruendo in vista delle Europee del 2019". Secondo la Bizzotto, "il voto di oggi crea un precedente pericolosissimo. Dopo l’Ungheria di Orban e la Polonia di Kaczyski e Morawiecki, nei prossimi mesi la sinistra e la Ue metteranno nel mirino anche l’Italia, il nostro governo e il nostro leader Matteo Salvini. Non so se gli amici 5 Stelle abbiano compreso questo rischio".
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
EUROPA: LA CRISI UNGHERESE E NOI. Per il dialogo. quello vero!!!
 "Forza" ITALIA ... e "Forza" UNGHERIA!!! Il paradosso del politico mentitore. Un’analisi di BARBARA SPINELLI.
"Forza" ITALIA ... e "Forza" UNGHERIA!!! Il paradosso del politico mentitore. Un’analisi di BARBARA SPINELLI.EUROPA E FILOSOFIA. DALL’UNGHERIA UN APPELLO PER RIPRENDERE E RILANCIARE IL FILO DELLO SPIRITO CRITICO E DELL’ILLUMINISMO KANTIANO
 LA FILOSOFIA E IL CASO UNGHERIA. Ágnes Heller racconta
LA FILOSOFIA E IL CASO UNGHERIA. Ágnes Heller raccontaFREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
>PARLAMENTO EUROPEO. Approvata la relazione Sargentini -- Ridiamo speranza al progetto Europa. Finalmente l’Europa sembra essersi svegliata (di Dacia Maraini)19 settembre 2018, di Federico La Sala
Ridiamo speranza al progetto Europa
Se l’Europa riprende la coscienza del suo prezioso stare insieme costruendo pace e benessere, saprà affrontare anche la difficile e dolorosa questione della migrazione che non è una catastrofe naturale
di Dacia Maraini (Corriere della Sera, 18 settembre 2018)
Finalmente l’Europa sembra essersi svegliata. Grazie a una giovane italo olandese che per la prima volta, con chiarezza, a voce alta, senza timore di offendere, di configgere, di fare perdere quell’equilibrio instabile in cui sopravviveva, ha avuto il coraggio di ricordare che l’Europa non è solo una entità economica, ma una unità ideale, che si riconosce in alcuni valori e ha l’intenzione di difenderli. Parlo della condanna alla Turchia di Erdogan e della decisione di affrontare i grandi evasori della rete. -Naturalmente i soliti «realisti» hanno accusato Judith Sargentini di ingenuo ottimismo. Lei ha risposto: bisogna essere ottimisti, altrimenti si soccombe. E ha perfettamente ragione.
Siamo tutti buoni a criticare, rumoreggiare, tagliare il capello in quattro dicendo male dell’Europa, male della politica, male di chi fa progetti per il futuro. È passata, soprattutto a sinistra, la linea del mugugno e dell’autodenigrazione: tanto va tutto a rotoli, tanto non ce la faremo mai, ecc. In questo clima di sfiducia e rassegnazione amareggiata che coinvolge sia i politici che i politologi, la gente dà retta ai suoi istinti più bassi: quello che mio è mio, tornatene al tuo Paese, qui comando io, ecc.
Per cambiare qualcosa ci vuole fiducia e orgoglio. Oltre a distruggere bisogna avere voglia di costruire. Il suicidio ha un fascino sottile che fa girare la testa a molti. Il padre che uccide il suo bambino dopo avere litigato con la moglie, simboleggia nel suo orrore, questo periodo di massacro di affetti e speranze.
Io spero, lo spero con tutto il cuore, che la scossa data dalla giovane Sargentini stimoli il risveglio di un popolo spento e drogato, che risvegli la voglia di difendere conquiste che sono costate sudore sangue e non possiamo buttare nella spazzatura.
L’Europa è quello che pensa ed esprime con parole semplici la coraggiosa Judith Sargentini: un progetto ambizioso, se vogliamo, difficile da tenere in piedi, ma per cui vale la pena di darsi da fare.
Se l’Europa riprende la coscienza del suo prezioso stare insieme costruendo pace e benessere, saprà affrontare anche la difficile e dolorosa questione della migrazione che non è una catastrofe naturale, ma una umanissima fuga dalla fame che va regolata e affrontata con razionale fermezza, senza strapparsi i capelli e chiudere porte e finestre in un impeto di cieco egoismo.
-
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- La democrazia svanisce se diventa illiberale (di Sabino Cassese)29 agosto 2018, di Federico La Sala
La democrazia svanisce se diventa illiberale
di Sabino Cassese (Corriere della Sera, 29.08.2018)
Il vicepresidente del Consiglio dei ministri italiano ha incontrato a Milano il primo ministro ungherese Viktor Mihály Orbán. Quest’ultimo ha dichiarato già da tempo che «i valori liberali occidentali oggi includono la corruzione, il sesso, la violenza» e che «i valori conservatori della patria e dell’identità culturale prendono il sopravvento sull’identità della persona». Ispirato da questi orientamenti, ha poi trasformato la televisione pubblica in un mezzo di propaganda governativa, limitato la libertà di stampa, l’autonomia universitaria e l’indipendenza dell’ordine giudiziario.
Ha inoltre ridisegnato i collegi elettorali, fatto approvare una legge elettorale che gli consente di avere la maggioranza di due terzi dei seggi in Parlamento, con il 45 per cento dei voti, dato una svolta nazionalistica e anti-immigrazione al governo. Il maggiore esperto dei problemi ungheresi, la professoressa Kim Lane Scheppele, dell’Università di Princeton, ritiene che oggi l’Ungheria abbia una «costituzione incostituzionale» e il «Washington Post» qualche mese fa ha intitolato una sua analisi della situazione ungherese «la democrazia sta morendo in Ungheria e il resto del mondo dovrebbe preoccuparsi». Orbán, tuttavia, è stato eletto e rieletto, e gode quindi di un consenso popolare. Perché allora tante voci preoccupate? Basta il voto popolare per legittimare limitazioni delle libertà?
Il primo ministro ungherese ha dichiarato più volte di voler realizzare una «democrazia illiberale». Questo è un disegno impossibile perché la democrazia non può non essere liberale.
La democrazia non può fare a meno delle libertà perché essa non si esaurisce, come ritengono molti, nelle elezioni. Se non c’è libertà di parola, o i mezzi di comunicazione sono nelle mani del governo, non ci si può esprimere liberamente, e quindi non si può far parte di quello spazio pubblico nel quale si formano gli orientamenti collettivi. Se la libertà di associazione e quella di riunione sono impedite o limitate, non ci si può organizzare in partiti o movimenti, e la società civile può votare, ma non organizzare consenso o dissenso. Se i mezzi di produzione sono concentrati nelle mani dello Stato, non c’è libertà di impresa, e le risorse economiche possono prendere soltanto la strada che sarà indicata dal governo.
 Se l’ordine giudiziario non è indipendente, non c’è uno scudo per le libertà. Se la libertà personale può essere limitata per ordine del ministro dell’Interno (come è accaduto nei giorni scorsi in Italia), i diritti dei cittadini sono in pericolo. Insomma, come ha osservato già nel 1925 un grande studioso, Guido De Ruggiero, nella sua «Storia del liberalismo europeo», i principi democratici sono «la logica esplicazione delle premesse ideali del liberalismo»: estensione dei diritti individuali a tutti i membri della comunità e diritto del popolo di governarsi. Quindi, «una divisione di province tra liberalismo e democrazia non è possibile». Una «democrazia illiberale» non è una democrazia.
Se l’ordine giudiziario non è indipendente, non c’è uno scudo per le libertà. Se la libertà personale può essere limitata per ordine del ministro dell’Interno (come è accaduto nei giorni scorsi in Italia), i diritti dei cittadini sono in pericolo. Insomma, come ha osservato già nel 1925 un grande studioso, Guido De Ruggiero, nella sua «Storia del liberalismo europeo», i principi democratici sono «la logica esplicazione delle premesse ideali del liberalismo»: estensione dei diritti individuali a tutti i membri della comunità e diritto del popolo di governarsi. Quindi, «una divisione di province tra liberalismo e democrazia non è possibile». Una «democrazia illiberale» non è una democrazia.Tutto il patrimonio del liberalismo è parte essenziale della democrazia, così come oggi lo è quello del socialismo. Queste tre grandi istanze che si sono succedute negli ultimi due secoli in Europa e nel mondo, fanno ormai corpo. Il liberalismo con le libertà degli uomini e l’indipendenza dei giudici. L’ideale democratico, con l’eguaglianza e il diritto di tutti di partecipare alla vita collettiva (suffragio universale). Il socialismo con lo Stato del benessere e la libertà dal bisogno (sanità, istruzione, lavoro, protezione sociale). Questi tre grandi movimenti, pur essendosi affermati in età diverse, e pur essendo stati inizialmente in conflitto tra loro (come ha spiegato magistralmente, nel 1932, Benedetto Croce nella sua “Storia d’Europa nel secolo decimonono”) fanno ora parte di un patrimonio unitario e inalienabile come è dimostrato da due importanti documenti internazionali, il Trattato sull’Unione europea e la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite. Il primo dispone che l’Unione “si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto”. Il secondo che le Nazioni Unite si impegnano a «promuovere la democrazia e a rafforzare il rispetto per tutti i diritti umani e le libertà fondamentali».
L’Italia è ora in un punto di passaggio critico, nel quale si decide il futuro delle sue libertà e la sua collocazione internazionale, tra quelli che sono stati per secoli i nostri «compagni di strada» ed esempi (Francia, Germania, Regno Unito) o nuovi alleati. Che significato possiamo attribuire a un «incontro esclusivamente politico e non istituzionale o governativo», ma tenuto in Prefettura, tra il primo ministro ungherese e un vicepresidente del Consiglio dei ministri italiano?
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim).28 agosto 2018, di Federico La Sala
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo). *
Così Hannah Arendt descrisse (nel ’51) i populismi del Terzo millennio
L’inquietante attualità di “Le origini del totalitarismo”
- [Foto] Adolf Hitler e Joseph Goebbels al Teatro di Charlottenburg, a Berlino, in un’immagine scattata nel 1939 da Hugo Jaeger, fotografo personale del Führer fin dagli anni della sua ascesa al potere, uno dei pochi, all’epoca, a utilizzare il colore. Negli ultimi giorni della guerra seppellì le sue foto in 12 vasi di vetro nei dintorni di Monaco. Le recuperò dieci anni dopo e nel ’65 le vendette alla rivista Life
di Christian Rocca (La Stampa, 23.08.18)
Le origini del totalitarismo, il saggio scritto nel 1951 dalla politologa Hannah Arendt, è considerato uno dei libri più importanti del XX Secolo per l’analisi dei movimenti politici totalitari d’inizio ’900, in particolare del nazismo e dello stalinismo (secondo Arendt, il fascismo era invece un movimento nazionalista e autoritario). All’indomani dell’elezione di Donald Trump, i giornali internazionali segnalarono la ritrovata popolarità del saggio di Arendt, assieme a 1984 di George Orwell, e rileggendo l’ultima parte del saggio, quella dedicata alla trasformazione delle classi in masse, al ruolo della propaganda e all’organizzazione dei movimenti, si capisce bene perché.
Arendt descriveva il nuovo soggetto politico come «la folta schiera di persone politicamente neutrali che non aderiscono mai a un partito e fanno fatica a recarsi alle urne».
Fuori e contro il sistema dei partiti, indifferenti agli argomenti degli avversari
Secondo Arendt, i movimenti totalitari europei «reclutarono i loro membri da questa massa di gente manifestamente indifferente, che tutti gli altri partiti avevano lasciato da parte perché troppo apatica o troppo stupida. Il risultato fu che in maggioranza furono composti da persone che non erano mai apparse prima sulla scena politica. Ciò consentì l’introduzione di metodi interamente nuovi nella propaganda e un atteggiamento d’indifferenza per gli argomenti degli avversari; oltre a porsi al di fuori e contro il sistema dei partiti nel suo insieme, tali movimenti trovarono un seguito in settori che non erano mai stati raggiunti, o “guastati”, da quel sistema».
Se l’analisi è familiare, è proprio perché ricorda il reclutamento popolare e di classe dirigente dei nuovi partiti populisti occidentali di questo scorcio di secolo. Allora come adesso, prendendo a prestito le parole di Arendt, questi movimenti «misero in luce quel che nessun organo dell’opinione pubblica aveva saputo rilevare, che la costituzione democratica si basava sulla tacita approvazione e tolleranza dei settori della popolazione politicamente grigi e inattivi non meno che sulle istituzioni pubbliche articolate e organizzate».
Arendt elenca gli errori dei partiti politici tradizionali e la complicità delle élite borghesi tra le concause del successo dei movimenti totalitari ma, di nuovo, è impressionante quanto la fotografia del risveglio delle masse di allora rimandi a quella attuale: «Il crollo della muraglia protettiva classista trasformò le maggioranze addormentate, fino allora a rimorchio dei partiti, in una grande massa, disorganizzata e amorfa, di individui pieni d’odio che non avevano nulla in comune tranne la vaga idea che (...) i rappresentanti della comunità rispettati come i suoi membri più preparati e perspicaci fossero in realtà dei folli, alleatisi con le potenze dominanti per portare, nella loro stupidità o bassezza fraudolenta, tutti gli altri alla rovina».
Una profezia sulle conseguenze politiche di un dibattito pubblico guidato dalla postverità
Anche le pagine dedicate all’organizzazione dei movimenti totalitari degli Anni Trenta sembrano cronaca dei nostri giorni: «Sono organizzazioni di massa di individui atomizzati e isolati, da cui, in confronto degli altri partiti e movimenti, esigono una dedizione e fedeltà incondizionata e illimitata; ciò da prima della conquista del potere, in base all’affermazione, ideologicamente giustificata, che essi abbracceranno a tempo debito l’intera razza umana» e, per questo, «sono stati definiti società segrete operanti alla chiara luce del giorno» perché, come queste, «adottano una strategia di coerenti menzogne per ingannare le masse esterne di profani, esigono obbedienza cieca dai loro seguaci, uniti dalla fedeltà a un capo spesso sconosciuto e sempre misterioso».
E se non fosse chiaro, anche in tempi di fake news e post verità, Arendt continua così: «Forse il massimo servizio reso alle società segrete come modello ai movimenti totalitari è l’introduzione della menzogna coerente come mezzo per salvaguardare il loro mondo fittizio. L’intera gerarchia dei movimenti, dall’ingenuo simpatizzante al membro del partito, alle formazioni d’élite, all’intima cerchia intorno al capo, e al capo stesso, può essere descritta dal punto di vista del curioso miscuglio di credulità e cinismo in varie proporzioni con cui ciascun militante, secondo il suo rango, deve reagire alle mutevoli affermazioni menzognere dei dirigenti e all’immutabile finzione ideologica centrale».
In un passaggio, citato anche dal recente libro di Michiko Kakutani, The Death of Truth, Arendt scrive: «In un mondo in continuo mutamento, e sempre più incomprensibile, le masse erano giunte al punto di credere tutto e niente, da pensare che tutto era possibile e niente era vero».
La grande novità degli Anni 30, che pare non sia servita da lezione al mondo contemporaneo, era che «la propaganda di massa scoprì che il suo pubblico era pronto in ogni momento a credere al peggio, per quanto assurdo, senza ribellarsi se lo si ingannava, convinto com’era che qualsiasi affermazione fosse in ogni caso una menzogna. I capi totalitari basarono quindi la loro agitazione sul presupposto psicologicamente esatto che in tali condizioni la gente poteva essere indotta ad accettare le frottole più fantastiche e il giorno dopo, di fronte alla prova inconfutabile della loro falsità, dichiarare di aver sempre saputo che si trattava di una menzogna e di ammirare chi aveva mentito per la sua superiore abilità tattica».
Pensando al nazismo e al comunismo, Arendt ha spiegato perché sono falliti i tentativi di neutralizzarli, e la spiegazione è più che mai attuale: «Uno dei principali svantaggi del mondo esterno nei rapporti coi regimi totalitari è stato costituito dal fatto che, ignorando tale sistema, esso confidava che la stessa enormità delle menzogne ne avrebbe causato la rovina o che, prendendo in parola il capo, sarebbe stato possibile costringerlo a rispettare gli impegni, a dispetto delle intenzioni ordinarie. -Il sistema totalitario è purtroppo al sicuro da queste conseguenze normali; la sua ingegnosità sta appunto nell’eliminazione di quella realtà che smaschera il bugiardo o lo obbliga ad adeguarsi alla sua simulazione». Quella di Arendt, insomma, è l’analisi storica sulle origini del totalitarismo, ma riletta oggi suona anche come una profezia sulle conseguenze politiche di un dibattito pubblico che non si basa più sui dati di fatto e che si lascia guidare dalla post-verità.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
- LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza" di Marshall McLuhan
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - LE ELEZIONI EUROPEE DEL 2019 E LA NECESSITA’ DI PROSEGUIRE SULLA STRADA DI ALTIERO SPINELLI.28 agosto 2018, di Federico La Sala
È l’alternativa fra civiltà e barbarie.
La vera battaglia è per l’Europa
di Roberta de Monticelli (Il Fatto, 28.08. 2018)
“L’Europa è sull’orlo di una drammatica disgregazione, alla quale l’Italia sta dando un pesante contributo, contrario ai suoi stessi interessi”. Anche solo per questa frase, l’appello lanciato da Massimo Cacciari e altre autorevoli figure della cultura italiana dovrebbe essere ascoltato. Ciascuno dovrebbe meditare la sua drammaticità. Ed è quello che Cacciari stesso ci invita a fare in un intervento successivo, invitandoci a comprendere “che l’indifferenza è ormai equivalente a irresponsabilità”, e ad assumere “le iniziative che ritiene più utili per contrastare la deriva in atto”.
Alla politica - cioè all’opposizione - l’appello chiede una “netta ed evidente discontinuità”, che ponga al centro “una nuova strategia per l’Europa”. Perché tutti coloro che vogliono resistere alla deriva sovranista abbiano la possibilità di non perdere le prossime elezioni europee (23-26 maggio 2019), preparando così il suicidio dell’Unione. Credo e spero di andare nel senso di questo appello se mi chiedo: la discontinuità riguarda anche lo spirito con cui si guarda a queste elezioni?
Non ci fu niente di più insensibile al vero senso delle elezioni europee che la miope sicumera con cui Matteo Renzi attribuì a se stesso, al suo partito e alla sua politica nazionale l’inusuale consenso del 40% per il Pd nel 2014, come se appunto le elezioni del Parlamento europeo fossero un mezzo per rafforzare il partito e la sua politica nazionale, e non un mezzo per contribuire al compimento di una democrazia e di una politica sovranazionale.
Eppure sono state quelle le prime elezioni in cui la coalizione o il partito sovranazionale vincente (il Ppe) ha espresso il presidente della Commissione (Juncker). In cui cioè ha cominciato a incarnarsi nell’istituzione il principio del trasferimento di sovranità dagli Stati nazionali allo Stato federale, che sarebbe compiuto quando la Commissione fosse veramente divenuta l’esecutivo della Federazione, avocando a sé alcuni cruciali poteri ora caratteristici degli Stati e dei governi, e del loro Consiglio.
Altiero Spinelli nel suo Diario europeo 1948-1969 definisce il federalismo “un canone di interpretazione della politica”. Non soltanto un criterio d’azione, ma anche di conoscenza. “Tutta l’opera di Spinelli è espressione dell’esigenza di abbandonare il paradigma nazionale, con il quale la cultura dominante interpreta la realtà politica” (L. Levi, Introduzione a A. Spinelli, La crisi degli Stati nazionali).
Come si giustifica questa esigenza? Ognuno dovrebbe ricordare l’incipit del Manifesto di Ventotene: “La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l’uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita. Con questo codice alla mano si è venuto imbastendo un grandioso processo storico a tutti gli aspetti della vita sociale, che non lo rispettassero”. Ecco come ragiona Spinelli. In termini di interna coerenza del principio universalistico di civiltà definito in tutta la sua radicalità dall’Illuminismo europeo.
C’è un momento, pensa Spinelli, in cui questo principio di civiltà urta contro l’organizzazione delle società umane in Stati nazionali: perché tutti, anche quelli democratici, sono minati dalla polarizzazione della società in interessi organizzati “che si precipitano sullo Stato e lo paralizzano quando sono in equilibrio, e ne rafforzano sempre più il carattere dispotico, quando un gruppo o una coalizione di gruppi ha potuto sopraffare l’avversario e prendere il potere”.
Questa polarizzazione degli interessi organizzati, che Spinelli, sulla scorta dell’economista Lionel Robbins, chiama “sezionalismo”, è la forza che corrode le democrazie: “Oggi lottare per la democrazia significa rendersi anzitutto conto che occorre arrestare questa insensata corsa, non solo italiana, ma europea, verso una società polarizzata in interessi organizzati che si precipitano sullo Stato e lo paralizzano quando sono in equilibrio, e ne rafforzano sempre più il carattere dispotico, quando un gruppo o una coalizione di gruppi ha potuto sopraffare l’avversario e prendere il potere”.
Questo pensiero sembra attraversare la stagione dei partiti di massa - e da noi della Prima Repubblica - poi volare alto sulla “liquidità” post-ideologica - e da noi sopra il liquame immobile della Seconda Repubblica - fino a fotografare non solo il perdurante ingranaggio delle “macchine d’affari” partitiche di oggi, ma il dato nuovo e antico: le “forze primordiali” che la norma etica, giuridica, politica è chiamata a controllare. “L’uomo civile è un prodotto complicato e fragile. I più grandiosi frutti della civiltà sono dovuti alla ferrea disciplina che questa impone al selvaggio animo umano... quella disciplina si può spezzare e lasciar emergere le forze primordiali”. È questo pericolo che dobbiamo leggere nello sciagurato linguaggio dei demagoghi che stanno picconando l’Europa civile. È l’alternativa fra civiltà e barbarie.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - DUBLINO 2018. Incontro mondiale delle famiglie. " Così lo sguardo femminile può cambiare l’economia" (di Luigino Bruni).23 agosto 2018, di Federico La Sala
CREATIVITÀ E CARITÀ ("CHARITAS"). ADAMO ED EVA, MARIA E GIUSEPPE UGUALI DAVANTI A DIO. Il cattolicismo "andropologico" romano è finito...*
Risorsa famiglia.
Così lo sguardo femminile può cambiare l’economia
di Luigino Bruni (Avvenire, giovedì 23 agosto 2018)
- Il testo che segue è parte della relazione che l’economista Luigino Bruni ha tenuto ieri nella seconda giornata dell’Incontro mondiale delle famiglie in corso a Dublino.
Economia è una parola greca che rimanda direttamente alla casa ( oikos nomos, regole per gestire la casa), quindi alla famiglia. Eppure l’economia moderna, e ancor più quella contemporanea, si è pensata come un ambito retto da principi diversi, distinti e per molti versi opposti ai principi e ai valori che hanno sempre retto e continuano a reggere la famiglia. Un principio fondante la famiglia, forse il primo e quello sottostante gli altri, è quello di gratuità, che è quanto è di più distante dall’economia capitalistica, che conosce surrogati della gratuità (sconti, filantropia, saldi) che svolgono al funzione di immunizzare i mercati dalla gratuità vera.
La famiglia, infatti, è il principale luogo dove apprendiamo, per tutta la vita e in un modo tutto speciale da bambini, quella che Pavel Florensky chiamava ’l’arte della gratuità’. E lì che soprattutto da bambini impariamo anche a lavorare, perché non c’è lavoro ben fatto senza gratuità. La nostra cultura, però, associata la gratuità al gratis, al gadget, allo sconto, alla mezza ora in più al lavoro non remunerata, al prezzo zero (San Francesco ci ha invece detto che la gratuità è un prezzo infinito: non si può né comprare né vendere perché è impagabile).
In realtà la gratuità è qualcosa di molto serio, come ci ha spiegato con estrema chiarezza anche la Caritas in veritate, che rivendica alla gratuità anche lo statuto di principio economico. Gratuità è charis, grazia, ma è anche l’agape, come ben sapevano i primi cristiani, che traducevano la parola greca agape con l’espressione latina charitas (con l’h), proprio ad indicare che quella parola latina traduceva ad un tempo l’agape ma anche la charis, e per questo quell’amore diverso non era né solo eros né solo philia (amicizia). La gratuità, questa gratuità, allora, è un modo di agire e uno stile di vita che consiste nell’accostarsi agli altri, a se stesso, alla natura, a Dio, alle cose non per usarli utilitaristicamente a proprio vantaggio, ma per riconoscerli nella loro alterità e nel loro mistero, rispettarli e servirli.
Dire gratuità significa dunque riconoscere che un comportamento va fatto perché è buono, e non per la sua ricompensa o sanzione. La gratuità ci salva così dalla tendenza predatoria che c’è in ogni persona, ci impedisce di mangiare gli altri e noi stessi. E’ ciò che distingue la preghiera dalla magia, la fede dall’idolatria, che ci salva dal narcisismo, che è la grande malattia di massa del nostro tempo, per assenza di gratuità.
Se la famiglia vuole, e deve, coltivare l’arte della gratuità, deve fare molta attenzione a non importare dentro casa la logica dell’incentivo che oggi vige ovunque. Guai, ad esempio, ad usare la logica dell’incentivo all’interno delle dinamiche familiari. Il denaro in famiglia, soprattutto nei confronti dei bambini e dei ragazzi (ma con tutti), va usato molto poco, e se usato deve essere usato come un premio o riconoscimento dell’azione ben fatta per ragioni intrinseche, e mai usato come prezzo. Uno dei compiti tipici della famiglia è proprio formare nelle persone l’etica del lavoro ben fatto, un’etica che nasce proprio dal principio di gratuità. Se, invece, si inizia a praticare anche in famiglia la logica e la cultura dell’incentivo, e quindi il denaro diventa il ’perché’ si fanno e non si fanno compiti e lavoretti di casa, quei bambini da adulti difficilmente saranno dei buoni lavoratori, perché il lavoro ben fatto di domani poggia sempre su questa gratuità che si apprende soprattutto nei primi anni di vita, e soprattutto a casa.
L’assenza del principio di gratuità nell’economia dipende anche, e molto, dall’assenza dello sguardo femminile. La casa, l’oikos, è sempre stato il luogo abitato e governato dalle donne. Ma , paradossalmente, l’economia è stata, e continua ad essere, una faccenda tutta giocata sul registro maschile. Anche i maschi hanno sempre avuto a che fare con la casa, e molto. Il loro sguardo si è però concentrato sul provvedere i mezzi per il sostentamento, sul lavoro esterno, sui beni, sul denaro. E quando l’economia è uscita dalla vita domestica ed è diventata politica, sociale e civile, lo sguardo e il genio femminile è rimasto dentro casa, e quello maschile è rimasta la sola prospettiva della prassi e soprattutto della teoria economica e manageriale.
Le donne guardano alla casa e all’economia vedendo prima di tutto il nesso di rapporti umani che si svolge in esse. I primi beni che vedono sono quelli relazionali e i beni comuni, e dentro a questi vedono anche i beni economici. Non è certo un caso che l’Economia di comunione sia nata da uno sguardo di una donna (Chiara Lubich), né che la prima teorica dei beni comuni è stata Katherine Coman (nel 1911), e che Elinor Ostrom sia stata insignita (unica donna finora) del premio Nobel in economia proprio per il suo lavoro sui beni comuni. E ci sono due donne (Martha Nussbaum e Carol Uhlaner) all’origine della teoria dei beni relazionali. Quando manca lo sguardo femminile sull’economia, le sole relazioni viste sono quelle strumentali, dove non è la relazione ad essere il bene, ma dove i rapporti umani e con la natura sono mezzi usati per procurarsi i beni.
Se lo sguardo e il genio femminile della oikoscasa fossero stati presenti nella fondazione teorica dell’economia moderna, avremmo avuto una economia più attenta alle relazioni, alla redistribuzione del reddito, all’ambiente e forse alla comunione. È, infatti, la comunione una grande parola che dalla famiglia può passare all’economia di oggi. E qui si apre un discorso specifico per i cristiani.
 La chiesa oggi è chiamata ad essere sempre più profezia, se vuole salvarsi e salvare. La profezia è anche una parola della famiglia. La maggior parte dei profeti biblici erano sposati, e molte parole e gesti profetici della bibbia sono parole di donne. Isaia chiamò suo figlio Seariasùb, che significa ’un resto tornerà’, che uno dei grandi messaggi della sua profezia.
La chiesa oggi è chiamata ad essere sempre più profezia, se vuole salvarsi e salvare. La profezia è anche una parola della famiglia. La maggior parte dei profeti biblici erano sposati, e molte parole e gesti profetici della bibbia sono parole di donne. Isaia chiamò suo figlio Seariasùb, che significa ’un resto tornerà’, che uno dei grandi messaggi della sua profezia.Non trovò modo migliore per lanciare quel suo messaggio profetico di farlo diventare il nome del figlio. Ogni figlio è un messaggio profetico, perché dice con il solo suo esserci che la terra avrà ancora un futuro, e che potrà essere migliore del presente. La profezia della famiglia oggi, per essere credibile, deve prendere la forma dei figli e la forma dell’economia, e quindi della condivisione, dell’accoglienza e della comunione. Perché sia i figli che l’economia non sono altro che la vita ordinaria di tutti e di ciascuno, che è il solo luogo dove la profezia si nutre e cresce.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
ESTETICA (E NON SOLO) E DEMOCRAZIA. PER LA CRITICA DELLA FACOLTÀ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITÀ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
 CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- IL "FARE IL PROPRIO DOVERE", I DISASTRI "IRREPARABILI", E IL SENNO DI POI. Una riflessione sul "senno di prima".22 agosto 2018, di Federico La Sala
IL "FARE IL PROPRIO DOVERE", I DISASTRI "IRREPARABILI", E IL SENNO DI PRIMA....
- (...) assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può» (Maurizio Fiasco, "Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima", Avvenire, 18.08.2018)).
- "Non ho fatto che obbedire. Ho fatto solo il mio dovere" (Adolf Eichmann).
- Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto (don Lorenzo Milani),
Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima
Dopo il ragionamento è il solito, col senno di poi: come è stato possibile che nessuno vedesse e capisse prima dell’irreparabile fatto?
di Maurizio Fiasco (Avvenire, sabato 18 agosto 2018)
- Il balletto delle responsabilità inizia sempre dopo, col senno di poi. Il senno di prima è ignoto (Fotogramma)
Come accadono i disastri? C’è un’espressione, all’apparenza banale ma ricorrente, quando siamo sconcertati per un evento dai costi umani incalcolabili. «Col senno di poi». Che equivale: come è stato possibile che nessuno vedesse e capisse prima dell’irreparabile fatto? Quel che ha condotto al precipitare di una situazione - fisica, come un ponte, oppure comportamentale come una battaglia, un volo, il funzionamento di uno stabilimento industriale - aveva già emesso dei segnali.
 I disastri - risulta quasi sempre agli investigatori ex post - hanno avuto una incubazione, più o meno lunga. Incubazione tutt’altro che muta, o col bavaglio, anzi spesso visibile per un complesso di segnali. Come ha insegnato, quarant’anni fa un illuminato e inascoltato Barry Turner, non sono prevenuti - ovvero fermati da decisioni pragmatiche - per le patologie della comunicazione tra gli attori di un sistema. Industriale, amministrativo, finanziario, politico: non importa la scala di grandezza. Le incompetenze si strutturano e agiscono come un sistema.
I disastri - risulta quasi sempre agli investigatori ex post - hanno avuto una incubazione, più o meno lunga. Incubazione tutt’altro che muta, o col bavaglio, anzi spesso visibile per un complesso di segnali. Come ha insegnato, quarant’anni fa un illuminato e inascoltato Barry Turner, non sono prevenuti - ovvero fermati da decisioni pragmatiche - per le patologie della comunicazione tra gli attori di un sistema. Industriale, amministrativo, finanziario, politico: non importa la scala di grandezza. Le incompetenze si strutturano e agiscono come un sistema.I segnali sono sfuggiti a un apparato cognitivo, a una mente capace di connetterli e perciò di abbattere le barriere che inibiscono il giudizio. È mancata la responsabilità di contrastare la universale ottusità dei sistemi, di tutti i sistemi organizzativi. Che squalificano la coscienziosità di chi abbia colto il segnale e si sia posto in modo attivo per spingere al provvedere.
 Egli finisce per scontrarsi con la gerarchia, con i muri levati su dai rituali dell’organizzazione, per impattare con la squalificazione che si replica davanti all’umile operatore che sta sul terreno e lì ’vede’ qualcosa che non va. Oppure c’è il feticcio della responsabilità di vertice. Chi è in alto - pensa il testimone dei segnali che il disastro sta inviando - lo capirà più e meglio di me.
Egli finisce per scontrarsi con la gerarchia, con i muri levati su dai rituali dell’organizzazione, per impattare con la squalificazione che si replica davanti all’umile operatore che sta sul terreno e lì ’vede’ qualcosa che non va. Oppure c’è il feticcio della responsabilità di vertice. Chi è in alto - pensa il testimone dei segnali che il disastro sta inviando - lo capirà più e meglio di me.Ma il superiore guarda al consenso e alle conferme di chi siede ancora più in alto di lui. E quest’ultimo rivolge la sua mente al mandato di chi è il supremo detentore di quel bene, di quella situazione, di quel dato potere. E tutto questo complesso di fattori cambia la prospettiva, perché il conformismo è più potente della psicologia della responsabilità.
 A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può».
A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può».Insomma, la responsabilità, invece di essere ispirata a valori trascendenti, si attesta alla procedura, al ’di fronte’, a quel che le regole gerarchiche - per esempio il mandato degli azionisti - hanno assegnato. E così si scambia la diversa posizione ricoperta nella piramide organizzativa con la diversità di valori etici e professionali di quanti operano in una struttura complessa: che invece, a rigore, sono unici e universali. Cioè per tutti. Nelle forze armate, dal piantone al generale; nelle autostrade, dall’operaio che passa il bitume all’amministratore delegato della infrastruttura. Unitarietà dei valori e trasparenza della comunicazione sono la speranza del «senno di prima». Potremmo dire l’intelligenza del Buon Samaritano che si prende carico della complessità della situazione e non trascura alcuna variabile.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Dubček, la «primavera di Praga», e la "nuova impresa: realizzare una «democrazia dal volto umano», che dell’umano abbia anche, con comportamento conseguente, la mente e il cuore" (Emilio Gentile)..19 agosto 2018, di Federico La Sala
RIPENSARE L’EUROPA.... *
La primavera di Dubček morì d’estate
di Emilio Gentile (Il Sole-24 Ore, Domenica, 19 agosto 2018)
Il 12 agosto 1968 giunse a Karlovy Vary, cittadina termale della Cecoslovacchia, Walter Ulbricht, che dal 1950 deteneva il potere assoluto nel regime comunista della Repubblica democratica tedesca. Era venuto per incontrare Alexander Dubček, eletto il 5 gennaio segretario generale del partito comunista cecoslovacco. Dubček considerava «l’uomo dalla celebre barbetta da capra», come lo descrive nella sua autobiografia, «un dogmatico fossilizzato già ai tempi di Stalin», e lo trovava personalmente «ripugnante». E ancor più ripugnante dovette considerarlo durante la sua visita, avvenuta mentre Dubček era impegnato in un asperrimo confronto con Leonid Brežnev, l’onnipotente capo dell’Unione sovietica, ostile al nuovo corso intrapreso dal partito comunista cecoslovacco per realizzare un «socialismo dal volto umano». Altrettanto ostili erano Ulbricht e i despoti comunisti di Polonia, Ungheria e Bulgaria. Da otto mesi, infatti, Dubček aveva avviato un esperimento di riforma del regime comunista, per affrontare la grave crisi economica e sociale, acuita dall’asfissia d’ogni vitalità culturale, che stava degradando lo Stato cecoslovacco, nato alla fine del 1918 dalla unione fra la nazione ceca e la nazione slovacca, dopo la dissoluzione dell’impero austro-ungarico,
Da tale condizione, Dubček voleva risollevare il suo Paese, facendo approvare dal partito comunista, il 5 aprile 1968, un «programma d’azione» elaborato dalla corrente riformatrice, partendo dal presupposto che la nascita della Cecoslovacchia era stata «un progresso importante per lo sviluppo nazionale e sociale delle due nazioni». Il regime socialista, instaurato nell’ambito della comunità degli Stati socialisti guidata dall’Unione sovietica, aveva voluto proseguire sulla via dello sviluppo nazionale e sociale, eliminando «lo sfruttamento capitalistico e le ingiustizie sociali che ne derivavano».
 Questo era nei propositi: nella realtà, denunciava Il programma d’azione del Partito comunista di Cecoslovacchia, era avvenuta la «deformazione del sistema politico», dovuta alla «posizione monopolistica del potere in mano ad alcuni elementi», che aveva condotto «alla paralisi dell’iniziativa a tutti i livelli, all’indifferenza, al culto della mediocrità ed ad un esiziale anonimato», a una persistente crisi economica e sociale, aggravata da «un meccanismo che creava l’impotenza e la frattura tra la teoria e la pratica», provocando una generale degradazione morale e culturale.
Questo era nei propositi: nella realtà, denunciava Il programma d’azione del Partito comunista di Cecoslovacchia, era avvenuta la «deformazione del sistema politico», dovuta alla «posizione monopolistica del potere in mano ad alcuni elementi», che aveva condotto «alla paralisi dell’iniziativa a tutti i livelli, all’indifferenza, al culto della mediocrità ed ad un esiziale anonimato», a una persistente crisi economica e sociale, aggravata da «un meccanismo che creava l’impotenza e la frattura tra la teoria e la pratica», provocando una generale degradazione morale e culturale.L’unico rimedio per sanare la crisi e consolidare il socialismo, sostenevano Dubček e i riformatori, era l’attuazione di un nuovo modello di «democrazia socialista», ispirata al marxismo-leninismo, promossa e guidata dal partito comunista, il quale, però doveva rinunciare al monopolio del potere, alla prevaricazione sullo Stato, al dogmatismo; restaurare i diritti civili e la libertà di espressione, di associazione, di iniziativa. Tutto questo, precisava il programma, doveva essere attuato senza rimettere in discussione in politica estera l’adesione al Patto di Varsavia, che nel 1955 aveva subordinato le democrazie alla supremazia della Russia.
Avevano però ragione il capo dell’Urss e i despoti dei regimi satellitari a considerare la democrazia socialista di Dubček una eresia pericolosissima, che avrebbe potuto diffondersi fra i popoli assoggettati al totalitarismo comunista. Al di là del linguaggio cauto, infatti, il programma dei riformatori era un attacco radicale al «socialismo reale» e al suo corposo, immenso sistema di dominio, fondato sul monopolio del potere concentrato nelle mani dell’oligarchia privilegiata dei partiti comunisti e delle loro burocrazie. Contro un attacco così radicale, i despoti comunisti potevano concepire un solo rimedio altrettanto radicale, già sperimentato nel 1956 in Ungheria con efficaci risultati: stroncarlo con la forza delle armi.
Così avvenne. Nella notte fra il 20 e il 21 agosto 1968, truppe con carri armati dell’Unione sovietica, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Ungheria e Bulgaria, invasero la Cecoslovacchia. Dubček e gli altri governanti furono arrestati e trasportati a Mosca dove furono costretti, racconta Dubček, a fare «concessioni dolorose e umilianti per evitare il peggio», cioè un massacro della popolazione ceca e slovacca. Al potere in Cecoslovacchia furono insediati nuovamente i comunisti proni agli ordini del Cremlino. I riformatori, costretti al silenzio, furono diffamati e perseguitati come controrivoluzionari in combutta con l’imperialismo occidentale. Quasi mezzo milione furono gli iscritti espulsi dal partito; decine di migliaia abbandonarono il Paese. La «primavera di Praga», come fu chiamata, era stata stroncata.
Dubček, inviato come ambasciatore in Turchia, rientrato in patria ed espulso dal partito nel 1970, trovò lavoro come manovale, vivendo per venti anni sotto un controllo poliziesco quotidiano. Ebbe molto tempo per meditare sulla fine tragica della «primavera di Praga», che lui aveva coraggiosamente avviato, pensando sinceramente, col suo generoso e forse ingenuo idealismo, di poter realizzare un «socialismo dal volto umano» in un Paese accerchiato dal socialismo reale, che era nel 1968 possente e dominante, e che di «umano » in tutte le sue attuazioni, aveva soprattutto la malvagità e la volontà della più spietata oppressione.
I despoti del socialismo reale stroncarono la «primavera di Praga», per evitare che divenisse una calda estate, e incendiasse gli sclerotizzanti regimi del totalitarismo comunista. Ma l’ingenuo idealista Dubček ha avuto la rivincita, assistendo alla fine del socialismo reale. Nel 1989, fu eletto presidente dell’Assemblea nazionale nella rinata Repubblica democratica cecoslovacca, che lui, slovacco, tentò di mantenere unita. Un mortale incidente d’auto, il 14 novembre 1992, non lo fece assistere alla separazione fra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca.
Fu dunque alla fine un vincitore? Certo, lo fu, personalmente. La sua sfortunata impresa politica ha consegnato l’idealista Dubček alla Storia, con l’aureola di una straordinaria dignità. Ma è stato comunque sconfitto il «socialismo dal volto umano», coinvolto nella rovina del socialismo reale, che è stato sostituito dal nazionalismo illiberale nei paesi dove aveva dominato. Di socialismo dal volto umano non si parla più in tempi di «democrazia recitativa». Tuttavia, gli idealisti possono tentare una nuova impresa: realizzare una «democrazia dal volto umano», che dell’umano abbia anche, con comportamento conseguente, la mente e il cuore.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"CHARTA 77". La Cecoslovacchia, il rock dei "Plastic People of the Universe"...
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO"
IN MEMORIA DI Jan Patočka: HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI).
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Razzismo e noismo- le declinazioni del noi e l’esclusione dell’altro. La sistematica di Linneo (Luigi Luca Cavalli Sforza, Daniela Padoan).9 agosto 2018, di Federico La Sala
PSICHIATRIA E RAZZISMI
 Storie e documenti
Storie e documentiLa sistematica di Linneo
di Luigi Benevelli (POL.IT, 14 gennaio, 2014)
- Luigi Luca Cavalli Sforza, Daniela Padoan, Razzismo e noismo- le declinazioni del noi e l’esclusione dell’altro, Einaudi, Torino, 2013, pp. 72-75, passim.
Il pensiero occidentale è contrassegnato dalla prepotenza. Il grande sviluppo della sistematica ebbe pienamente luogo solo nel Settecento, con il botanico Carl Nilsson Linnaeus (1707-1778), che cominciò a organizzare le specie raggruppandole in generi, e quindi raggruppando i generi in una serie di categorie superiori basandosi sulle somiglianze morfologiche e anatomiche.
 Da quando nel 1735 venne introdotta la sua nomenclatura binomiale - basata sul modello aristotelico di «genere prossimo» e di «differenza specifica» - si è iniziato a declinare in latino il genere e la specie degli organismi.
Da quando nel 1735 venne introdotta la sua nomenclatura binomiale - basata sul modello aristotelico di «genere prossimo» e di «differenza specifica» - si è iniziato a declinare in latino il genere e la specie degli organismi.Linneo ha teorizzato un sistema di classificazione in cui il genere HOMO, posto in cima al regno animale, viene suddiviso in due specie: l’uomo «diurno», o homo sapiens, e l’uomo «notturno» o homo troglodytes, altrimenti detto uomo delle foreste o orangutan.
 È curioso come la nostra cultura abbia sempre teso a vedere la luce come il divino, l’alto, il sublime, e il buio come il demoniaco, il basso, il territorio dei bruti. Secondo il sistema delle similitudini e analogie, il Sole - simbolo platonico del Bene, che sempre nella sua corsa, tende a occidente - segna l’uomo occidentale.
È curioso come la nostra cultura abbia sempre teso a vedere la luce come il divino, l’alto, il sublime, e il buio come il demoniaco, il basso, il territorio dei bruti. Secondo il sistema delle similitudini e analogie, il Sole - simbolo platonico del Bene, che sempre nella sua corsa, tende a occidente - segna l’uomo occidentale.
 Il secolo dei Lumi, nelle retorica settecentesca, porta la ragione nelle menti ottenebrate dalla superstizione e dall’ignoranza; allo stesso modo, nella retorica coloniale del secolo successivo, dall’uomo occidentale procede la civilizzazione che porta la luce nel “cuore di tenebra” dei continenti selvaggi. Il che è perfettamente in sintonia con la classificazione linneiana di Homo sapiens in sei decrescenti varietà diurne, quattro varietà di «uomini normali», catalogabili secondo la provenienza geografica, il colore della pelle e le corrispettive «qualità morali», e due varietà di «uomini anormali».
Il secolo dei Lumi, nelle retorica settecentesca, porta la ragione nelle menti ottenebrate dalla superstizione e dall’ignoranza; allo stesso modo, nella retorica coloniale del secolo successivo, dall’uomo occidentale procede la civilizzazione che porta la luce nel “cuore di tenebra” dei continenti selvaggi. Il che è perfettamente in sintonia con la classificazione linneiana di Homo sapiens in sei decrescenti varietà diurne, quattro varietà di «uomini normali», catalogabili secondo la provenienza geografica, il colore della pelle e le corrispettive «qualità morali», e due varietà di «uomini anormali».
 Nella tassonomia di Linneo abbiamo
Nella tassonomia di Linneo abbiamo- Homo sapiens europaeus descritto come bianco ordinato, ingegnoso, inventivo, retto da leggi,
 Homo sapiens americanus,, rosso, amante della libertà, soddisfatto del proprio destino, irascibile,
Homo sapiens americanus,, rosso, amante della libertà, soddisfatto del proprio destino, irascibile,
 Homo sapiens asiaticus, giallastro, orgoglioso, avaro, melanconico,
Homo sapiens asiaticus, giallastro, orgoglioso, avaro, melanconico,
 Homo sapiens afer, nero, indolente, infido, scarsamente intelligente e incapace di autogoverno,
Homo sapiens afer, nero, indolente, infido, scarsamente intelligente e incapace di autogoverno,
 Homo sapiens ferus o uomo selvaggio, muto, quadrupede, villoso che comprende anche gli enfants sauvages, bambini abbandonati a se stessi e incapaci di parlare e apprendere, molto numerosi nella letteratura settecentesca,
Homo sapiens ferus o uomo selvaggio, muto, quadrupede, villoso che comprende anche gli enfants sauvages, bambini abbandonati a se stessi e incapaci di parlare e apprendere, molto numerosi nella letteratura settecentesca,
 Homo sapiens monstruosus o uomo teratologico, portatore di “forme devianti”, ovvero di malformazioni congenite e deficit cognitivi.
Homo sapiens monstruosus o uomo teratologico, portatore di “forme devianti”, ovvero di malformazioni congenite e deficit cognitivi.
Nella decima edizione del Systema naturae (1758), compare la classe dei primati, che sostituisce il precedente Anthropomorphae; qui avviene l’abbinamento del genere Homo con la specie sapiens. Dopo la scoperta dei fossili nella valle tedesca di Neanderthal, l’Homo sapiens divenne sapiens sapiens.
Sul tema, nel sito, cfr.:
PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986). Tracce per una svolta antropologica
 OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE.
OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE.Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Razzismo e noismo- le declinazioni del noi e l’esclusione dell’altro (di Silvia Antonelli).10 agosto 2018, di Federico La Sala
Razzismo e Noismo
di Silvia Antonelli *
Quali sono le tappe che portano alla costruzione dell’identità collettiva e quando e perché essa si configura attraverso la costruzione dell’altro, nemico e ostile da sé, solo in quanto portatore di diversità? Perché il “noi collettivo” si costruisce attraverso l’esclusione e la marginalizzazione dell’altro? Quali sono i postulati che consideriamo inderogabili, alla base della cultura europea e che hanno condotto a società fortemente e indiscutibilmente gerarchizzate?
Questi sono gli interrogativi da cui parte il bel libro-dialogo Razzismo e noismo. Le declinazioni del noi e l’esclusione dell’altro, frutto del confronto e dell’intreccio di ragionamenti di due studiosi molto diversi fra loro ma che decidono di incontrarsi, e in alcuni momenti scontrarsi, per cercare di delineare, a partire da prospettive e formazione diversi, le dinamiche che sono alla base della formazione dell’identità collettiva.
Già la struttura del libro anticipa e funge da manifesto di intenti: non è una narrazione lineare e sistematica, tipica della forma saggio, zeppa di constatazioni, assertiva, dogmatica, che pone sul piatto del lettore verità inconfutabili. È un dialogo che si compone gradualmente a partire da linguaggi diversi, che si mette in discussione; dove i due interlocutori si aprono all’ascolto dell’altro, sgombri da pregiudizi e da convinzioni preconcette. Si alternano, con un ritmo serrato e appassionato, con l’intento vivido di raggiungere il livello più viscerale di approfondimento, assumendo la complessità come inizio e prospettiva, senza cedere a semplificazioni e a scorciatoie.
Luigi Luca Cavalli Sforza è un genetista di fama mondiale i cui studi hanno dimostrato l’inservibilità del concetto di razza applicata agli uomini, mentre Daniela Padoan, di alcune generazioni più giovane, è una studiosa che si è occupata di testimonianze di deportazione, di genocidi e totalitarismi e di resistenze femminili.
 Due generazioni a confronto e due linguaggi, quello scientifico da una parte e quello umanistico dall’altro, che invece di correre, come fanno solitamente, su binari paralleli, decidono di intrecciarsi e dare forma ad un pensiero che per sua stessa natura nasce dall’incontro di diversità, che non si perdono l’una nell’altra ma che sono capaci di concorrere entrambe alla costruzione di un pensiero alt(r)o complesso e articolato.
Due generazioni a confronto e due linguaggi, quello scientifico da una parte e quello umanistico dall’altro, che invece di correre, come fanno solitamente, su binari paralleli, decidono di intrecciarsi e dare forma ad un pensiero che per sua stessa natura nasce dall’incontro di diversità, che non si perdono l’una nell’altra ma che sono capaci di concorrere entrambe alla costruzione di un pensiero alt(r)o complesso e articolato.In un momento storico e sociale in cui il richiamo ad una presunta identità collettiva sembra forte e urgente, e viene venduto come l’unico modo per superare una crisi economica di grandi dimensioni, questo libro diventa una miccia interessante in grado di innescare un ragionamento originale che si fa leva per porre in discussione l’intero sistema di dominio, sottomissione e sopraffazione che diamo per scontato e che consideriamo intoccabile nella sua ineluttabilità. Attraverso una ricostruzione delle dinamiche di relazione che hanno trasformato il vivere in comunità e tracciando una sorta di archeologia del dominio, il libro cerca di arrivare alle radici del razzismo, quale prodotto della gerarchizzazione del mondo, per poi indagare le numerose ramificazioni in cui esso si moltiplica e declina.
La chiave di volta attorno a cui ruota l’intera speculazione è il concetto di noi, nella sua declinazione di “noismo”, termine introdotto dallo stesso Cavalli-Sforza.
In italiano con il termine di egoismo indichiamo un concetto che gli anglosassoni nominano in due modi diversi: egoism e selfishness; in opposizione a quest’ultimo, gli inglesi contrappongono il termine we-ness
- we-ness è un senso del sé che si estende al noi, fino a includere un’appartenenza anche molto ampia, ed è questo che propongo di circoscrivere con il termine noismo. (...) Il noismo, in sostanza, è la funzionalità delle nostre azioni nei confronti del gruppo sociale al quale apparteniamo, il quale, naturalmente, ispira sentimenti diversi in vari altri individui appartenenti ad altri gruppi.
Lo studioso afferma che è esistito ed esiste un noi positivo, comunitario e che questo principio ha regolato in passato la nascita e lo sviluppo di molte società primitive che si sono sviluppate e che hanno progredito grazie a legami di solidarietà e di mutualità fra individui.
Dando ormai per assodato il fatto che l’umanità si origina dall’Africa e dalla migrazione con la quale alcuni gruppi si allontanarono per abitare altri continenti, Cavalli -Sforza ci ricorda che l’Homo sapiens sapiens finché visse di caccia e raccolta costituiva società egualitarie, non stratificate, dove a regolare le relazioni umane era il principio di un noi positivo, volto alla collaborazione e alla solidarietà. A seguito della rivoluzione agricola e dell’introduzione della divisione del lavoro e della proprietà individuale emersero differenziazioni di carattere socioeconomico che condussero alla formazione di una classe egemone, costituita da un gruppo ristretto o da un singolo individuo, che si fecero riferimento e orizzonte delle azione e del destino del gruppo sociale o economico di appartenenza.
Nasce il dominio, la sottomissione, la rinuncia della libertà in cambio della protezione dello stato. Da qui lo sviluppo delle società così come le conosciamo noi, che hanno impresso anche nei corpi e nel vivere quotidiano, l’abitudine alla violenza e alla sottomissione quali dati di fatto indiscutibili. Società plasmate sulla gerarchizzazione e sulla divisione in categorie predefinite, la cui affiliazione o esclusione diventa diritto o meno all’esistenza. La servitù, filo rosso della nostra civiltà, alimenta il razzismo e il disprezzo verso l’altro, necessari a legittimare la superiorità morale, culturale e anche genetica del maschio bianco europeo. É il dominio del noi che soppianta tutti gli altri modi del noi.
Daniela Padoan, che riporta continuamente il suo interlocutore ad una visione meno positivistica della storia, pone un altro cardine utile allo sviluppo del ragionamento e introduce la Shoah quale paradigma della categorizzazione del mondo che si alimenta della costruzione di un’identità collettiva, la cui immagine ideale diventa soglia e confine escludente dell’altro, fino a sancirne, indiscriminatamente, in nome di una presunta superiorità, il diritto all’esistenza.
Ecco come il noi positivo diventa disprezzo dell’altro, rifiuto della diversità quale minaccia alla propria integrità culturale e fisica di gruppo.
Interessanti e per nulla retoriche le pagine in cui la studiosa incalza la discussione partendo dal focus della Shoah che non è stata una parentesi disdicevole nel lungo e fruttuoso cammino della civiltà umana, nemmeno l’espressione del male assoluto e trascendentale; non fu pura follia, né un evento inspiegabile.
 Fu al contrario il prodotto della cultura europea. Il prodotto di società gerarchizzate che definiscono se stesse a partire dalla costruzione di confini e limiti.
Fu al contrario il prodotto della cultura europea. Il prodotto di società gerarchizzate che definiscono se stesse a partire dalla costruzione di confini e limiti.Assumere questa riflessione e farla propria significherebbe ripensare in profondità alle dinamiche di potere che regolano le nostre società oggi, alle pratiche di sottomissione cui ci siamo assuefatti. Abbiamo abdicato alla nostra libertà in cambio di una presunta sicurezza (argomento quanto mai attuale), costituito il nostro essere identitario a partire dalla marginalizzazione, anche visiva, dell’altro, che abbiamo ghettizzato, rinchiuso, allontanato, emarginato e anche eliminato dalle nostre società.
Questo libro complesso, che nasce e si sviluppa a partire dal confronto e dall’indagine, è una scintilla ragionata che ci riporta di fronte a noi stessi, che pone in discussione ogni dogma fino ad ora dato per scontato e soprattutto collega fatti storici e attualità che vorremo sconnessi, principi e causalità che è comodo tenere distanti; ci impone il ragionamento che nasce dalla conoscenza, ci suggerisce che esistono altri modi del noi e ci sollecita, con urgenza, a ripensare a noi stessi e alla nostra storia.
Silvia Antonelli
* Fonte: Umanità Nova, 02.06.2016
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- MEMORIA DI (MICHELANGELO, TERESA D’AVILA, HUSSERL,) EDITH STEIN. Una storia europea.9 agosto 2018, di Federico La Sala
EUROPA: Edith Stein. Ebrea, atea, cristiana...
Teresa Benedetta della Croce.
Dall’ateismo al Carmelo una storia europea di santità
di Matteo Liut giovedì 9 agosto 2018
Solo la ricerca di Dio conta, perché solo in lui la storia ha senso e solo lui trasforma la sofferenza in una strada verso la luce vera. Oggi la compatrona del nostro Continente, santa Teresa Benedetta della Croce (al secolo Edith Stein), offre all’Europa uno spunto per continuare a guardare al futuro. La sua storia è fatta di dolore e speranza, di ricerca e di dono: sono gli "ingredienti" dai quali può nascere una società più giusta.
Era nata nel 1891 a Breslavia in una famiglia di ebrei ma a 14 anni scelse l’ateismo. Si mise a cercare la verità nella filosofia (fu assistente di Husserl) ma nel 1921 leggendo la vita di santa Teresa d’Avila capì che il senso sta nella ricerca di Dio. Nel 1922 si fece battezzare e nel 1934 entrò tra le Carmelitane a Colonia. Arrestata dalla Gestapo in Olanda, morì nel 1942 nelle camere a gas di Auschwitz-Birkenau.
Altri santi. San Romano, martire (III sec.); santa Candida Maria di Gesù Cipitria, religiosa (1845-1912).
 Letture. Os 2,16.17.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13.
Letture. Os 2,16.17.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13.
 Ambrosiano. Os 2,15f-16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13.
Ambrosiano. Os 2,15f-16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
CARMELITANI SCALZI ED ECUMENISMO: STORIA E MEMORIA. Ritrovato nel salernitano "file" perduto del tardo Rinascimento
-
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
IL PROBLEMA DELLA GENESI, LA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE, E LA FENOMENOLOGIA TRASCENDENTALE....
 HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI). Una ’traccia’ dal "Diario fenomenologico")
HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI). Una ’traccia’ dal "Diario fenomenologico")PIAZZA SAN PIETRO: LA "TEOLOGIA" DELL’ELLISSE (DEI "DUE SOLI") E LE ILLUSIONI DELLA "TEOLOGIA" DEL "CERCHIO INCANTATO" (DELLA SCOLASTICA "CATTOLICA" E DELLA "SAPIENZA" RATZINGERIANA). IL DARSI DELLE COSE: LA LEZIONE DI HUSSERL.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- LA CULTURA BATTA UN COLPO. Di fronte ai nazionalismi gli intellettuali devono con urgenza risvegliare nei loro Paesi il sogno dell’Europa (Guido Crainz).6 agosto 2018, di Federico La Sala
L’EUROPA, OGGI: HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ....
La società civile
La cultura batta un colpo
Di fronte ai nazionalismi gli intellettuali devono con urgenza risvegliare nei loro Paesi il sogno dell’Europa
di Guido Crainz (la Repubblica, 06.08.2018)
Forse c’è una ragione se una parte non piccola del mondo culturale appare oggi impotente e quasi attonita di fronte alla crisi sempre più drammatica dell’Europa: forse di quella crisi ha anch’essa responsabilità non lievi. Forse al fondo non vi sono solo responsabilità politiche (certamente enormi) ma anche inadeguatezze e inerzie della cultura, incapace di accompagnare il processo di unificazione con un radicale salto di qualità nel confronto e nella circolazione di idee. Nella costruzione di uno sguardo comune sul futuro e al tempo stesso sulle ferite e sulle lacerazioni del passato.
Anche per pigrizie e passività della cultura, forse, i due momenti che sembrarono sancire il coronamento di un sogno - l’avvio dell’euro e poi l’allargamento del 2004 - segnarono in realtà l’inizio del suo incrinarsi. Era stato inevitabile - annotava vent’anni fa Ezio Mauro su queste pagine - « avviare l’unificazione attraverso l’unico comun denominatore oggi possibile, quello della moneta » , ma era urgente « dare un contesto istituzionale, culturale e politico a questa moneta. Perché rappresenti l’Europa e non soltanto un gruppo di Paesi comandati da una banca».
Il compito divenne ancor più necessario dopo l’allargamento del 2004, e fu disatteso ancor più gravemente: eppure entravano allora nell’Unione parti decisive di un Occidente che era stato a lungo "sequestrato" dall’Urss, per dirla con Milan Kundera, e largamente abbandonato dal resto dell’Europa (o che tale si sentiva).
Vi entravano Paesi che non avevano conosciuto reali democrazie neppure prima dei regimi comunisti, ove si eccettui la Cecoslovacchia fra le due guerre. E proprio la vicenda del " gruppo di Visegrád" ci fa cogliere nodi irti, perché esso non nasce " contro l’Europa". Tutt’al contrario, nasce nel 1991 come strumento per l’allargamento della costruzione europea, promosso da figure come Václav Havel e Lech Walesa: quando è iniziato il processo inverso? Su quali errori politici e su quali scelte economiche inadeguate, su quali cecità e chiusure esso ha potuto prosperare?
Appaiono oggi drammaticamente profetiche le parole pronunciate nel 1990 al Senato polacco da Bronislaw Geremek, uno dei principali dirigenti di Solidarnosc. Nei nostri Paesi post-comunisti, osservava, c’è oggi euforia per una libertà riconquistata ma vi è al tempo stesso «un senso di debole radicamento delle istituzioni democratiche e del pensiero democratico » . E aggiungeva:
 «Tre pericoli accompagnano in questa fase transitoria i Paesi che si sono liberati dalla dittatura comunista. Il primo è il populismo, che ha un naturale terreno di coltura nelle esperienze vissute finora da tali società e si fonda sulle illusioni egualitarie.
«Tre pericoli accompagnano in questa fase transitoria i Paesi che si sono liberati dalla dittatura comunista. Il primo è il populismo, che ha un naturale terreno di coltura nelle esperienze vissute finora da tali società e si fonda sulle illusioni egualitarie.
 Il secondo è la tentazione di instaurare governi dalla mano forte, particolarmente avvertita nelle società post-comuniste proprio perché in esse le istituzioni democratiche sono deboli. Il terzo è il nazionalismo ».
Il secondo è la tentazione di instaurare governi dalla mano forte, particolarmente avvertita nelle società post-comuniste proprio perché in esse le istituzioni democratiche sono deboli. Il terzo è il nazionalismo ».
 Sino ad ora, concludeva, il sentimento nazionale è stato un elemento naturale di solidarietà e di resistenza all’oppressione sovietica ma ora può «deformarsi e diventare nazionalismo e sciovinismo ».
Sino ad ora, concludeva, il sentimento nazionale è stato un elemento naturale di solidarietà e di resistenza all’oppressione sovietica ma ora può «deformarsi e diventare nazionalismo e sciovinismo ».Alcuni nodi sono tratteggiati qui in modo straordinario, e si aggiungano le ferite del passato: non ha certo pesato poco in Ungheria il trattato di Trianon - evocato sabato da Cuperlo - che dopo la Prima guerra mondiale l’ha amputata di ampie parti ( si legga almeno il Sándor Márai di "Volevo tacere"), o in Cecoslovacchia quel patto di Monaco che aprì la via ad Hitler ( il primo " tradimento dell’Europa", seguito dall’inerzia di fronte al colpo di stato comunista del 1948 e poi di fronte all’invasione dell’agosto di cinquant’anni fa).
Se questo è vero, è anche nella costruzione di uno sguardo comune sul futuro e sul passato che dobbiamo procedere, in un confronto molto più aperto e continuo di quello attuale: molto più capace di superare le deformazioni e di rispondere realmente alle differenti memorie nazionali. O a veri e propri vuoti di conoscenza. È un compito di lungo periodo, naturalmente, ma è decisivo avviare subito una radicale inversione di tendenza rispetto a troppe pigrizie intellettuali: l’avvicinarsi di elezioni europee cruciali, giustamente evocato dall’appello di Cacciari e di altri, ne aumenta l’urgenza.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Mediterraneo senza imperi. Il Mediterraneo ci aiuta a formulare i problemi sul mondo di oggi. Intervista a Maurice Aymard (di Carlo Vulpio).6 agosto 2018, di Federico La Sala
Intervista
L’analisi dello storico francese Maurice Aymard: i porti chiusi e il sovranismo antieuropeo non risolvono alcun problema
Mediterraneo senza imperi
«Questo mare non è mai stato così instabile. Anche Usa e Russia sono in affanno»
dal nostro inviato Carlo Vulpio (Corriere della Sera, 05.08.2018)
PARIGI «Il fatto radicalmente nuovo è che il Mediterraneo oggi è diventato un moltiplicatore mondiale di instabilità, e questo sarà un grande problema per le nuove generazioni». Maurice Aymard, 82 anni, storico di fama mondiale, è direttore di ricerca all’École des Hautes Études en Sciences Sociales e amministratore della Maison des Sciences de l’Homme dell’università La Sorbona. Allievo, amico e collega di Fernand Braudel, ne ha raccolto l’eredità alla guida della Scuola superiore.
Professor Aymard, il mare Mediterraneo, che dalla scoperta dell’America in poi sembrava sempre sul punto di diventare marginale, è invece tornato centrale. Ma, sostiene lei, questa volta come mai era successo prima. Perché?
«Perché oggi il Mediterraneo è molto frammentato e non è controllato da nessuno. Io stesso pensavo che con la decolonizzazione tutti i problemi sarebbero stati risolti, compresa la questione israelo-palestinese. Invece è accaduto di tutto e nella maniera più imprevedibile. Dopo la caduta del Muro di Berlino è stato un crescendo: l’assassinio di Yitzhak Rabin (il 4 novembre 1995, a Tel Aviv), la dissoluzione del Sud Est europeo e l’esplosione della Federazione jugoslava, con l’emergere di nazionalismi che nessuno avrebbe mai immaginato, e il Medio Oriente di nuovo in fiamme dopo l’intervento di Bush jr in Iraq. Ecco, quest’ultima era forse l’unica cosa che si poteva prevedere, e cioè che le guerre coloniali si perdono sempre. I sovietici hanno perso la loro guerra coloniale in Afghanistan, gli americani in Iraq. Per fortuna la Francia ne è rimasta fuori e l’Italia avrebbe fatto meglio a imitarla. Adesso, con la Siria e l’intervento della Turchia il quadro è completamente a pezzi: nessuno controlla la situazione, nemmeno Putin che ha sostenuto Bashar al-Assad».
Che cos’è diventato il Mediterraneo negli ultimi vent’anni?
«Un sistema di equilibrio politico-militare molto precario e allo stesso tempo una frontiera assoluta per i flussi migratori. I migranti non vengono più dalle periferie immediate, cioè dall’Algeria o dal Marocco, ma dall’Africa subsahariana. Non vengono più dal Medio Oriente, ma dall’Asia. Ciò vuol dire che c’è una dilatazione del Mediterraneo oltre le fasce costiere, che arriva fino al ventre dell’Africa e all’Estremo Oriente. Un fenomeno di dimensioni intercontinentali, mondiale».
Che cosa significa che il Mediterraneo è diventato un problema mondiale, che riassume in sé le grandi questioni del mondo irrisolte?
«Di più. È esso stesso un fattore dinamico di questa crescente frammentazione, ne è un moltiplicatore. È questo il fatto radicalmente nuovo. E sarà un grande problema per le nuove generazioni, che non troverà una risposta adeguata nel breve periodo. Per ora, credo che l’unica cosa che si possa fare a breve scadenza sia cercare di limitare i guasti e, a più lunga scadenza, di costruire qualcosa di più complesso e incisivo».
Finita la guerra fredda, i decisori forti, i russi e gli americani, sono rimasti. Come mai allora questa instabilità?
«Oggi la situazione è un po’ diversa. Non credo ci sia alcuna possibilità di una qualche “pax imperiale”. Per esempio, Putin ha potuto approfittare della situazione di debolezza americana dopo l’Afghanistan e il fallimento in Iraq, ma nonostante questo non controlla la situazione. E chi ne esce più forte è Assad, non lui».
Il Mediterraneo è da tremila anni scenario di migrazioni. Anche Erodoto parlava della sua migrazione, ma come quella di una persona che cercava un posto in cui vivere meglio, non per sfuggire a una guerra. Perché dunque dovremmo essere allarmati dalle migrazioni più di quanto non avvenisse allora? E perché dobbiamo credere di non poter affrontare il problema come merita?
«Lo dobbiamo affrontare. Il problema non è nuovo per il Mediterraneo, certamente, ma ci sono diversi tipi di immigrazione. La prima è stata quella che ha prodotto la nostra umanità, che, non dimentichiamolo, viene dall’Africa. In epoca antica, la popolazione di origine asiatica, dal Sud Est asiatico, non arriva nel Mediterraneo. Bisogna giungere fino al primo millennio dopo Cristo per una immigrazione di origine germanica che si spinge verso il Sud, ma le due grandi correnti migratorie sono quella africana - degli schiavi africani - e quella transoceanica degli europei, e siamo fra i 12-13 milioni di persone durante tre secoli e mezzo. Ma, attenzione, per quanto riguarda i neri parliamo sempre di schiavi. Persone che non avevano alcuna intenzione di spostarsi e che sono morte in gran numero nel tragitto o per lo sfruttamento a cui erano sottoposte, anche se poi i sopravvissuti hanno acquisito la libertà. Adesso, anche se si parla di “nuova schiavitù”, perché parliamo di gente trattata male, in realtà siamo di fronte a persone che vengono a lavorare come “liberi” salariati, cercano di inserirsi nella nuova società e di fare arrivare qui le loro famiglie: questa è una situazione del tutto nuova, basti considerare le cifre enormi del potenziale demografico subsahariano».
Come si può affrontare questa situazione inedita, chiudendo le frontiere e i porti?
«Ma no. Chiudere le frontiere significa solo favorire il contrabbando. È come il proibizionismo per l’alcol. Più lo vieti, più l’attività rende. Senza considerare il problema reale delle pensioni da pagare ai cittadini europei di oggi, che senza il lavoro degli immigrati, la cui incidenza è sempre più importante, corre un grande rischio. Bisogna pensare a una stabilizzazione, affrontando questo argomento con razionalità e intelligenza. Diceva Braudel: “Ho bisogno di pensare la totalità”. Questa è la sua vera lezione. Mentre oggi di fronte a questo quadro inedito ci si limita ad adattare analisi logore e logiche vecchie. Se c’è stata una emigrazione europea che è durata 100-150 anni e ha popolato il resto del mondo, dobbiamo accettare che si creino movimenti in senso contrario e cercare di governarli. Non serve a nulla rieditare i nazionalismi di fronte alle migrazioni».
E l’Europa, cosa può fare? Dobbiamo lasciare che si sfaldi o è la nostra unica ancora di salvezza?
«Resto favorevole alla costruzione europea, soprattutto per le nuove generazioni, che ormai vivono non solo in ambienti europei, ma transnazionali, in una società in cui ci saranno sempre più matrimoni tra persone di diversa origine e nazionalità... Mi sembra difficile e non auspicabile tornare indietro. Evidentemente l’Europa che ha inventato gli Stati nazionali ha qualche problema a inventare una nuova forma di cooperazione politica che conservi anche gli Stati nazionali... Una cosa è sicuramente irreversibile. La stragrande maggioranza dei cittadini europei non accetterebbe un ritorno a un sistema di controllo dei passaporti e dei visti per circolare in Europa».
Lo stesso discorso vale per l’euro?
«Se ci fosse un referendum contro l’euro, persino in Italia dove oggi avete questo governo strano, i no-euro perderebbero. Esattamente come in Grecia, dove ho visto i miei colleghi del ceto medio intellettuale che hanno investito i loro risparmi in Belgio. Insomma, la gente vive sempre di più in modo europeo, lo vediamo dall’acquisto di macchine, dalle tecnologie, dalla pluralità di lingue parlate. Questi sono stati negli ultimi sessant’anni i veri cambiamenti “dal basso”, introiettati dalla gente, e quindi irreversibili. E dimostrano che la strada da seguire è quella di una Europa che non agisca solo dall’alto».
È arrivato o no il tempo per l’Europa di agire politicamente per rendere più stabile il Mediterraneo?
«C’è una cultura, artistica e letteraria, che possiamo definire europea, anche se le diverse popolazioni vivono in modo diverso e hanno persino cucine diverse. E ciò è un bene. Ma certe regole politiche, i diritti politici, individuali, i diritti dell’uomo, che sono valori europei, ora vengono più o meno accettati ovunque».
Ma sull’altra sponda del Mediterraneo non è così.
«È vero, ma le migrazioni hanno anche avuto proprio questo merito, di diffondere la cultura europea dei diritti umani».
La Ue cosa può fare concretamente?
«Intanto, può evitare di fare sciocchezze, come quella di Sarkozy di bombardare la Libia, o di Lega e M5S di chiudere i porti. E poi scegliere per sé una evoluzione prudente, senza imporre dall’alto ciò che in basso non viene accettato, e chiarire che solo l’accettazione di regole comuni dà diritto ai relativi vantaggi. In caso contrario, come per la Gran Bretagna della Brexit o la Polonia e l’Ungheria del gruppo di Visegrád, questi vantaggi non spettano e non possono essere rivendicati».
Infine, cos’è dunque il Mediterraneo?
«Non è una piccola provincia, come si poteva pensare un secolo fa. Perciò l’Europa non deve mai perdere di vista che il Mediterraneo ci aiuta, più che a capire, a formulare i problemi sul mondo di oggi».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- L’ «illuminismo perduto» (Frederick Starr) e "L’Europa nel Medioevo"(Chris Wickham). Quando la sponda ricca del Mediterraneo era quella meridionale (di Amedeo Feniello)..5 agosto 2018, di Federico La Sala
Quando la sponda ricca del Mediterraneo era quella meridionale
Intorno all’anno Mille i viaggiatori musulmani descrivevano l’Europa occidentale come una terra di genti povere sporche incivili a situazione cominciò a cambiare nei tre secoli successivi
di Amedeo Feniello (Corriere della Sera, La Lettura, 05.08.2018)
Il Mediterraneo è, oggi, un mare di grandi divergenze. Da un lato, c’è un Nord sviluppato, capace di generare prosperità e sicurezza; dall’altro, un Sud arretrato, ribollente di tensioni e ostilità. Ma non è stato sempre così. Per molti secoli, la condizione è stata opposta. E, per colmare le differenze, il cammino dell’Occidente europeo è stato lungo e intricato, con andirivieni tipici del tracciato storico.
A cavallo dell’anno Mille, le differenze tra Nord e Sud erano abissali. Basta leggere un curioso episodio, avvenuto nella prima metà del X secolo. Un gruppo di viaggiatori musulmani compie una lunga spedizione in terra cristiana. Vogliono andare a Roma, spinti dai racconti sulle ricchezze della città. Fanno un giro tortuoso, via terra. Da Tessalonica, nell’allora Impero bizantino, passano nei Balcani. Da qui a Venezia e poi a Pavia, la capitale del Regno d’Italia. Attraversano la Pianura padana e si trovano in un incubo: lo spettacolo indecente di tende e capanne, abitate da una massa derelitta e macilenta. Uno shock, per gente di città, come erano i nostri viaggiatori. Ai quali resta un’idea: che, in questa zona d’Italia, si viva ancora come i barbari. «Alla maniera dei Curdi», scrivono.
Perché era così, l’Europa del tempo. Era il mondo in cui, come è stato detto, la preistoria irrompe di nuovo nella storia. Per miglia e miglia nient’altro che foreste e paludi. Qua e là, come oasi in un deserto, piccoli centri abitati, autosufficienti nel loro isolamento. Di città e di mercati, quasi solo ombre. Dappertutto castelli, per difendersi da nemici, lontani e vicini. Poche le persone. Tanti contadini, in una condizione di sfruttamento totale, legati a vita al proprio campo. Poi c’era chi pregava. E chi combatteva. Ed era tutta qui la società del tempo. Un ambiente depresso, in cui i livelli di vita, l’istruzione, la divisione del lavoro, l’uso di moneta erano ridotti al minimo. E l’unica speranza di qualche gioia era altrove, nell’aldilà della Chiesa romana, in un tempo ultraterreno di redenzione e di attesa.
Strano, questo continente. Chiuso, come scrive Chris Wickham nel libro L’Europa nel Medioevo (Carocci), tra le civiltà della Spagna araba ad ovest e dell’Impero di Bisanzio a est, con pochi sbocchi verso il mare. Ai musulmani questo Occidente non interessava, a differenza dell’altra area più avanzata del mondo di allora, la Cina, che ispirava in loro un’ammirazione aperta, per il suo sistema amministrativo e giudiziario, l’ordine sociale, l’organizzazione economica, la trama delle città. L’Europa no. Esiste come concetto, che in arabo diventa Arufa, che si ritrova nel X secolo in geografi come Hamdani per indicare il quadrante nord-ovest del mondo abitabile. Ma l’attenzione verso questo Occidente barbaro, incolto, privo di ogni bellezza, dai confini incerti, era irrilevante, se non come terra da saccheggiare. Abitato da gente, come i Franchi o i popoli nordici, dalle lunghe barbe e dagli stranissimi occhi azzurri, che vivevano in condizioni ambientali al limite del sopportabile, in terre gelide e irraggiungibili, osservati dai pochi viaggiatori musulmani con stupefazione, descritti come riprovevoli, sporchi - «i più sporchi del mondo» -, che «si accoppiavano brutalmente», idolatri, crudeli, feroci.
Dietro questi ritratti c’è, naturalmente, molto di ideologico. In particolare, l’idea di superiorità religiosa e culturale. Che derivava però da un dato di fatto: i musulmani che visitavano l’Occidente venivano davvero da un diverso pianeta, più avanzato per condizioni e abitudini sociali. Uomini che appartenevano a una civiltà dell’acqua, dell’Hammam (le terme), delle fontane, della pulizia, dei profumi. Con livelli di cultura e di istruzione progrediti, che, proprio in questi secoli, esprimono quello che Frederick Starr ha di recente definito un «illuminismo perduto», quando tra il Mediterraneo e l’Asia centrale musulmana fioriscono commerci, arti, centri religiosi e di istruzione. E tutti i campi della conoscenza - dall’astronomia alla matematica, dalla filosofia alla medicina - conobbero sviluppi con pochi eguali nella storia dell’umanità.
Tutto questo avvenne in città. Perché se c’è un dato sensibile che caratterizza la civiltà musulmana è proprio quello dell’edificazione di città. Che formano una rete e riuniscono ciò che era stato separato dal lungo conflitto tra Parti e Bizantini e condizionano lo sviluppo economico globale, dal Sudan all’India, dalla Cina al Sud Italia. Da ovest a est nascono - o rinascono - città come Cordova, Damasco, Il Cairo, Tunisi, Kufa, Shiraz, Samarcanda, Bukhara, Palermo. E poi la più grande metropoli del tempo, con più di un milione di abitanti: la dimora del califfo, la città circolare, Bagdad.
Dal Mille in poi, però, nel malandato Occidente successe qualcosa. Innanzitutto, durante il periodo 950-1300 la popolazione europea si moltiplicò, più o meno, per tre. Rinacquero tantissime città e il loro numero, in alcune zone, come l’Italia centro-settentrionale e le Fiandre, crebbe considerevolmente. I commerci e i mercati tornarono a vivere e la nuova figura del mercante si impose per la sua ideologia improntata all’intraprendenza. Si cominciarono a produrre merci, soprattutto nel settore tessile e metallurgico. Aumentò la specializzazione artigianale, a dismisura, con una complessità inimmaginabile nella diversificazione della forza lavoro. Avvenne una rivoluzione tecnica che interessò le campagne, la nascente industria, il mondo della navigazione. Però, tanti aspetti di questo processo restano quasi incomprensibili. Come, ad esempio, in quale momento sia cominciata l’espansione demografica; oppure quando gli scambi di merci a lunga distanza siano diventati così importanti da condizionare il complessivo mondo economico europeo.
In ogni caso, le variabili in campo furono davvero tante, che toccarono ogni aspetto della società del tempo; e che potremmo condensare in un’unica parola, vitalità. Come scriveva infatti Carlo Maria Cipolla «quando una società dimostra di essere vitale lo dimostra a tutti i livelli, e non solo in quello economico, facendo di più e meglio di quanto fanno o hanno fatto altre società disponendo di eguali risorse». Insomma, per intenderci, non si possono capire i mercanti italiani senza quell’ambiente eccezionale composto da personalità come San Francesco, Dante, Giotto o Mondino di Luzzi, che rivoluzionò gli studi di anatomia.
Ma se c’è un fattore che fece davvero la differenza in questa rinascita occidentale fu, per me, la curiosità. Sembra sorprendente che in un’epoca di rinnovata aggressività, fatta di Reconquista e di crociate, emerga pure qualcosa di nuovo. Si comincia a intuire appunto come anche il dialogo con l’altro - il diverso, il concorrente, il nemico religioso - possa risultare per molti aspetti fruttuoso. Per prime, mettono in campo questa strategia le nostre città marinare, da Amalfi a Genova, da Pisa a Venezia. Lo fanno alternando l’uso della forza. Ma tante volte, specialmente all’inizio, esse si adattano al mercato musulmano, vendendo ad esempio merci di contrabbando, armi, schiavi.
 Poi gli occidentali riescono a fare di meglio: apprendono da chi ne sa di più, imitano gli altri e trasformano le conoscenze acquisite in proprio bagaglio culturale. Lo fa Leonardo Fibonacci, che impara i numeri «alla maniera degli Hindi», ma esporta queste conoscenze in Occidente, con un sovrappiù di nozioni che elabora nel suo Liber abaci. Lo fa Gherardo da Cremona, monaco che emigra in Spagna e mette su, a partire circa dal 1150, nella multietnica Toledo, sotto l’egida di re Alfonso VI di Castiglia, un atelier di traduzione nel quale impegna intellettuali arabi, ebrei e cristiani per restituire all’Europa le parole di Aristotele e di Tolomeo.
Poi gli occidentali riescono a fare di meglio: apprendono da chi ne sa di più, imitano gli altri e trasformano le conoscenze acquisite in proprio bagaglio culturale. Lo fa Leonardo Fibonacci, che impara i numeri «alla maniera degli Hindi», ma esporta queste conoscenze in Occidente, con un sovrappiù di nozioni che elabora nel suo Liber abaci. Lo fa Gherardo da Cremona, monaco che emigra in Spagna e mette su, a partire circa dal 1150, nella multietnica Toledo, sotto l’egida di re Alfonso VI di Castiglia, un atelier di traduzione nel quale impegna intellettuali arabi, ebrei e cristiani per restituire all’Europa le parole di Aristotele e di Tolomeo.
 Ci riescono con successo i fiorentini, che per primi riportano monete d’oro in Occidente, dopo lunghi secoli di buio monetario, seguendo ciò che avevano fatto per secoli bizantini e musulmani. Oppure, per gareggiare nella produzione di tessuti, si ingegnano (come fanno oggi i cinesi) a imitare i modelli fiamminghi di Bruges, Anversa o Gand, creando nuovi prodotti che conquisteranno il Mediterraneo e faranno grande l’economia cittadina.
Ci riescono con successo i fiorentini, che per primi riportano monete d’oro in Occidente, dopo lunghi secoli di buio monetario, seguendo ciò che avevano fatto per secoli bizantini e musulmani. Oppure, per gareggiare nella produzione di tessuti, si ingegnano (come fanno oggi i cinesi) a imitare i modelli fiamminghi di Bruges, Anversa o Gand, creando nuovi prodotti che conquisteranno il Mediterraneo e faranno grande l’economia cittadina.Tre secoli di crescita, dal Mille al Milletrecento circa, che diminuirono la distanza col resto del mondo e tra Nord e Sud. Fu questo il Medioevo della rinascenza europea. Impossibile però da realizzarsi senza declinare i valori di scambio e curiosità, alla base di un’epoca che si mostrò tanto più aperta e innovativa di quanto oggi erroneamente si pensi.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Cinema e Filosofia. "Il pensiero ha le ali e niente può impedirgli di volare" (Averroè).
 Yussef Chahine. Il grande regista di "Il Destino" ("Al Massir") è morto. Per l’Egitto e non solo una "voce della libertà".
Yussef Chahine. Il grande regista di "Il Destino" ("Al Massir") è morto. Per l’Egitto e non solo una "voce della libertà". -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Memoria e spettri vecchi e nuovi. Hitler e il Discobolo (di Mauro Berruto).1 agosto 2018, di Federico La Sala
Hitler e il Discobolo, memoria e spettri vecchi e nuovi
di Mauro Berruto (Avvenire, mercoledì 1 agosto 2018)
Nel 1936 Adolf Hitler scelse la regista Leni Riefenstahl per realizzare un’opera cinematografica che fosse, grazie alle immagini dei Giochi Olimpici di Berlino, formidabile strumento di propaganda. L’Olympiastadion di Berlino diventò così un gigantesco set, il cui fine era l’esaltazione della razza ariana.
Leni Riefenstahl, affascinata dall’antichità classica, con un escamotage cinematografico, fece “animare” la statua del Discobolo Lancellotti, una delle copie migliori dell’originale in bronzo di Mirone, con una dissolvenza. Il marmo si trasformava in un atleta, ariano, impegnato nella rotazione del lancio del disco.
Adolf Hitler, innamorato del genio della Riefenstahl e stregato da quelle immagini decise di acquistare la statua dalla famiglia Lancellotti per un milione di Marchi. Fu presentata il 9 luglio 1938 nel Museo Glyptothek di Monaco, alla presenza del Führer. Esiste una foto, oggi esposta nella pancia dell’Olympiastadion, che ritrae Hitler, in posa davanti al Discobolo. Impietosa. Raffigura un omino con dei ridicoli baffetti e la svastica al braccio dominato, anzi sovrastato dalla bellezza, dall’armonia, dalla perfezione di quella statua che guarda giù e sembra sorridere di fronte a tanta imbecille arroganza.
 Il Discobolo nel 1948 tornò in Italia e oggi si può ammirare al Museo di Palazzo Massimo alle Terme, a due passi dalla stazione Termini di Roma.
Il Discobolo nel 1948 tornò in Italia e oggi si può ammirare al Museo di Palazzo Massimo alle Terme, a due passi dalla stazione Termini di Roma.Tre giorni fa Daisy Osakue, discobola azzurra, torinese, è stata gratuitamente aggredita e ferita. Ennesimo episodio di una spaventosa (nel senso letterale, che fa paura) sequenza di violenze che si stanno diffondendo nel nostro Paese. Episodi che hanno un tratto comune: colpire chi è debole, perché donna o vecchio o fragile, e chi è diverso per colore, etnia o confessione religiosa. I capisaldi del disprezzo per gli “altri”, il motore della xenofobia e del razzismo, insomma. Daisy difende la maglia azzurra della Nazionale di Atletica Leggera, non è una spacciatrice, una ladra, un’immigrata irregolare. È una bella ragazza, nata a Torino, con alle spalle tanti anni di allenamento e studio negli Stati Uniti, che quando lancia il disco si tinge le treccine di azzurro e quando vince canta fieramente l’Inno di Mameli. Il razzismo, tuttavia, non fa distinzioni. Si fonda sull’ignoranza. Ignoranza che genera paura. Paura che genera violenza. Violenza che genera odio. Odio che genera ignoranza. Da lì si riparte, su un livello sempre più alto. È sempre stato così.
William Sheridan Allen, storico americano, pubblicò nel 1965 un saggio che si intitola: “Come si diventa nazisti”, la storia di una piccola città della Germania durante la Repubblica di Weimar i primi anni del Terzo Reich. Una tranquilla e normalissima cittadina di diecimila abitanti, Nordheim, tra il 1930 e il 1935, come tutta la Germania, cambiò volto, quasi senza accorgersene, tra sottovalutazione e silenzio degli indifferenti.
 «La fine della democrazia è sempre possibile e, oggi come allora, gli avversari della democrazia stanno anche dentro di noi, nel perenne conflitto, ch’è a un tempo sociale e psichico, tra bisogno di sicurezza e desiderio di libertà», commenta il sociologo Luciano Gallino nell’introduzione a quel saggio. Chissà che cosa ne pensa il Ministro dell’Interno, colui che dovrebbe garantire la sicurezza del Paese. Fra un tweet e l’altro, fra un’emoticon e un “bacione” ai suoi detrattori, viene da pensare che il clima che respiriamo sia frutto di una sorta di tragico lasciapassare.
«La fine della democrazia è sempre possibile e, oggi come allora, gli avversari della democrazia stanno anche dentro di noi, nel perenne conflitto, ch’è a un tempo sociale e psichico, tra bisogno di sicurezza e desiderio di libertà», commenta il sociologo Luciano Gallino nell’introduzione a quel saggio. Chissà che cosa ne pensa il Ministro dell’Interno, colui che dovrebbe garantire la sicurezza del Paese. Fra un tweet e l’altro, fra un’emoticon e un “bacione” ai suoi detrattori, viene da pensare che il clima che respiriamo sia frutto di una sorta di tragico lasciapassare.Nel frattempo Daisy Osakue tornerà a lanciare il disco per la maglia azzurra. Lo farà presto ai Campionati europei di Atletica Leggera che si disputeranno a Berlino, proprio all’Olympiastadion. Quello dove Hitler guardava le gare, quello dove Leni Riefenstahl girava il suo documentario, quello soprattutto dove Jesse Owens diventò simbolo di quei Giochi Olimpici voluti per celebrare la razza ariana. Lui, nero dell’Alabama, vincitore di 4 medaglie d’oro. Perché la storia ha sempre in sé tanto la malattia che l’antidoto.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Sorpreso di quanto diversa sia la storia insegnata in Paesi diversi. C’è un’unica patria, è l’umanità. Fermiamo i nazionalisti (di Carlo Rovelli)31 luglio 2018, di Federico La Sala
Carlo Rovelli: fermiamo i nazionalisti.
C’è un’unica patria, è l’umanità
Le identità etniche sono un prodotto culturale che può diventare pericoloso, bisogna opporsi a chi le usa per alimentare i conflitti tra i popoli. La riflessione del fisico, pubblicata dal Guardian nei giorni scorsi
di Carlo Rovelli (Corriere della Sera, 31.07.2018)
La Gran Bretagna è un vecchio Paese. Il mio Paese, l’Italia, è giovane. Entrambi sono orgogliosi del loro passato. Entrambi sono contrassegnati da marcati caratteri nazionali: è facile identificare gli italiani o gli inglesi, tra la folla di un aeroporto internazionale. Riconosco facilmente l’italiano in me: non riesco a dire nulla senza agitare le mani, ci sono antiche pietre romane nelle cantine della mia casa a Verona, e gli eroi nella mia scuola erano Leonardo e Michelangelo ...
Eppure questa identità nazionale è solo uno strato sottile, uno tra tanti altri, assai più importanti. Dante ha segnato la mia educazione, ma ancora più lo hanno fatto Shakespeare e Dostoevskij. Sono nato nella bigotta Verona, e andare a studiare nella libertina Bologna è stato uno shock culturale. Sono cresciuto all’interno di una determinata classe sociale, e condivido abitudini e preoccupazioni con le persone di questa classe in tutto il pianeta più che con i miei connazionali. Sono parte di una generazione: un inglese della mia età è molto più simile a me di un veronese dall’età diversa. La mia identità viene dalla mia famiglia, unica, come è unica ogni famiglia, dal gruppo dei miei amici d’infanzia, dalla tribù culturale della mia giovinezza, dalla rete degli sparsi amici della mia vita adulta. Viene soprattutto dalla costellazione di valori, idee, libri, sogni politici, preoccupazioni culturali, obiettivi comuni, che sono stati condivisi, nutriti, per i quali abbiamo combattuto insieme, e che sono stati trasmessi in comunità che sono più piccole, o più grandi, o completamente trasversali ai confini nazionali. Questo è ciò che siamo tutti noi: una combinazione di strati, incroci, in una rete di scambi che tesse l’umanità intera nella sua multiforme e mutevole cultura.
Non sto dicendo che cose ovvie. Ma allora perché, se questa è la variegata identità di ciascuno di noi, perché organizziamo il nostro comportamento politico collettivo in nazioni e lo fondiamo sul senso di appartenenza a una nazione? Perché l’Italia? Perché il Regno Unito?
La risposta, ancora una volta, è facile: non è il potere che si costruisce attorno a identità nazionali; è viceversa: le identità nazionali sono create dalle strutture di potere. Visto dal mio giovane e ancora un po’ disfunzionale Paese, l’Italia, questo è forse più facile da notare che non dall’interno dell’antico e nobile Regno di sua maestà la regina. Ma è la stessa cosa. Non appena emerso, generalmente con fuoco e furia, la prima preoccupazione di qualsiasi centro di potere - antico re o borghesia liberale del XIX secolo - è promuovere un robusto senso di identità comune. «Abbiamo fatto l’Italia, ora facciamo gli italiani» è la famosa esclamazione di Massimo d’Azeglio, pioniere dell’unità d’Italia, nel 1861.
Sono sempre sorpreso di quanto diversa sia la storia insegnata in Paesi diversi. Per un francese, la storia del mondo è centrata sulla Rivoluzione francese. Per un italiano, eventi di dimensione universale sono il Rinascimento (italiano) e l’Impero romano. Per un americano, l’evento chiave per l’umanità, quello che ha introdotto il mondo moderno, la libertà e la democrazia, è la guerra di Indipendenza americana contro... la Gran Bretagna. Per un indiano, le radici della civiltà si trovano nell’era dei Veda... ciascuno sorride delle distorsioni degli altri, e nessuno riflette sulle proprie...
Leggiamo il mondo in termini di grandi narrazioni discordanti, che abbiamo in comune con i connazionali. Sono narrazioni create consapevolmente per generare un senso di appartenenza a famiglie fittizie, chiamate nazioni. Meno di due secoli fa c’era gente in Calabria che chiamava se stessa «greco», e non molto tempo fa gli abitanti di Costantinopoli chiamavano se stessi «romano»... e non tutti in Scozia o Galles hanno tifato Inghilterra nella coppa del mondo... Le identità nazionali non sono altro che teatro politico.
Non fraintendetemi. Non voglio suggerire che ci sia qualcosa di male in tutto questo. Al contrario: unificare popolazioni diverse - veneziani e siciliani, o diverse tribù anglosassoni - perché collaborino a un bene comune, è saggia e lungimirante politica. Se lottiamo tra noi stiamo ovviamente molto peggio che se lavoriamo insieme. È la cooperazione, non il conflitto, che giova a tutti. L’intera civiltà umana è il risultato della collaborazione. Qualunque sia la differenza tra Napoli e Verona, le cose vanno meglio per tutti senza frontiere fra l’una e l’altra. Lo scambio di idee e merci, sguardi e sorrisi, i fili che tessono la nostra civiltà, ci arricchisce tutti, in beni, intelligenza e spirito. Fare convergere persone diverse in uno spazio politico comune è vantaggio per tutti. Rafforzare poi questo processo con un po’ di ideologia e teatro politico, per tenere a bada i conflitti istintivi, montare la farsa di una Sacra Identità Nazionale, per quanto sia operazione fasulla, è comunque operazione utile. È prendere il giro le persone, ma chi può negare che la cooperazione è meglio del conflitto?
Ma è proprio qui che l’identità nazionale diventa un veleno. Creata per favorire la solidarietà, può finire per diventare l’ostacolo alla cooperazione su scala più larga. Creata per ridurre conflitti interni, può finire per generare conflitti esterni ancora più dannosi. Le intenzioni dei padri fondatori del mio Paese erano buone nel promuovere un’identità nazionale italiana, ma solo pochi decenni dopo questa è sfociata nel fascismo, estrema glorificazione di identità nazionale. Il fascismo ha ispirato il nazismo di Hitler. La passionale identificazione emotiva dei tedeschi in un singolo Volk ha finito per devastare la Germania e il mondo. Quando l’interesse nazionale promuove il conflitto invece che la cooperazione, quando alla ricerca di compromessi e regole comuni si preferisce mettere la propria nazione davanti a tutto, l’identità nazionale diventa tossica.
Politiche nazionaliste o sovraniste stanno dilagando nel mondo, aumentando tensioni, seminando conflitto, minacciando tutti e ciascuno di noi. Il mio Paese è appena ricaduto preda di questa insensatezza. Penso che la risposta sia dire forte e chiaro che l’identità nazionale è falsa. È buona se aiuta a superare interessi locali per il bene comune, è miope e controproducente quando promuove l’interesse di un gruppo artificiale, «la nostra nazione», invece che un più ampio bene comune.
Ma localismo e nazionalismo non sono solo errori di calcolo; traggono forza dal loro appello emotivo: l’offerta di una identità. La politica gioca con il nostro istintivo insaziabile desiderio di appartenenza. «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, ma il Figlio dell’Uomo non ha dove posare il suo capo...» offrire una casa fittizia, la nazione, è risposta fasulla, ma costa poco e paga politicamente. Per questo la risposta alla perniciosa ideologia nazionale non può essere solo un appello alla ragionevolezza, ma deve trovare l’anelito morale e ideologico che merita: glorificare identità locali o nazionali e usarle per ridurre la cooperazione su scala più ampia non è solo un calcolo sbagliato, è anche miserabile, degradante, e moralmente riprovevole.
Non perché non abbiamo identità nazionali - le abbiamo. Ma perché ognuno di noi è un crocevia di identità molteplici e stratificate. Mettere la nazione in primo luogo significa tradire tutte le altre. Non perché siamo tutti eguali nel mondo, ma perché siamo diversi all’interno di ciascuna nazione. Non perché non abbiamo bisogno di una casa, ma perché abbiamo case migliori e più nobili che non il grottesco teatro della nazione: la nostra famiglia, i nostri compagni di strada, le comunità di cui condividiamo i valori, che sono diffuse nel mondo; chiunque siamo, non siamo soli, siamo in tanti. E abbiamo un posto meraviglioso da chiamare «casa»: la Terra, e una meravigliosa, variegata tribù di fratelli e sorelle con i quali sentirci a casa e con i quali identificarci: l’umanità.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- PATRIA E COSTITUZIONE. Serve con urgenza una “operazione verità” condotta da un vasto movimento di opinione ben al di là dell’associazionismo europeista, una alleanza di innovatori (di Pier Virgilio Dastoli).28 luglio 2018, di Federico La Sala
IL SONNODELLARAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI.... *
Un dialogo difficile ma necessario per capire l’Unione europea
Europeisti, euro-critici, euro-scettici, euro-ostili
di Pier Virgilio Dastoli (Il Mulino, 24 luglio 2018)
L’editoriale di Ernesto Galli della Loggia, uscito qualche giorno fa sul “Corriere della Sera”, si inscrive in quella corrente di pensiero che è stata troppo genericamente definita “euroscettica” - espressione coniata nel 1985 dal “Times” per definire l’ostilità del Partito laburista britannico contro le politiche liberiste della Comunità economica europea. Da allora il termine “euroscettico” viene applicato indistintamente ai (pochi) partiti che si battono per l’uscita del loro Paese dall’Unione europea (come l’Ukip di Neil Farage), ai (sempre più numerosi) movimenti contrari alla cessione o alla perdita dell’apparente sovranità nazionale nella dimensione sopranazionale, a alcuni partiti della sinistra radicale e alle forze politiche di estrema destra xenofobe e antisemite.
Come avviene per la corrente di pensiero europeista, nella quale occorre distinguere gli orientamenti moderati o conservatori di chi difende l’Ue nel suo stato attuale - con le istituzioni consolidate nel Trattato di Lisbona (2009) e le politiche di austerità rappresentate dal Fiscal Compact (2013) - dalla cultura federalista che sostiene la necessità di sovranità condivise nel quadro di una democrazia europea multilivello, così fra gli euroscettici occorre distinguere fra chi sostiene l’idea di un’Europa intergovernativa, nella quale prevalga la difesa degli interessi nazionali e la posizione di chi è contrario in se al progetto di integrazione europea, che ne propugna la fine e che potremmo definire più correttamente “euro-ostile”. Dalla nascita della Comunità economica europea nel 1957, i cittadini e le cittadine di ventidue Paesi europei sono stati chiamati quaranta volte a esprimersi per referendum sul processo di integrazione europea dando il loro consenso ventinove volte (a cominciare dal primo referendum “europeo” nel Regno Unito del 1975) e il loro voto contrario undici, ivi compreso il doppio “no” dei norvegesi all’adesione. Si è concluso un ciclo durato oltre vent’anni, segnato da una globalizzazione caratterizzata da politiche liberiste senza regole, da una crisi economica che è stata la più lunga e profonda che abbia mai attraversato il mondo. La crisi ha prodotto disuguaglianze tra i ceti sociali in conseguenza di un processo redistributivo della ricchezza a scapito del lavoro, del ceto medio, dei giovani e tra i popoli, in cui con la stessa logica non i ceti, ma le economie più forti hanno prodotto un ulteriore impoverimento all’interno dell’Ue dove vivono oggi 120 milioni di persone che rischiano la povertà e l’esclusione sociale.
L’intero pianeta è interessato da processi che, in maniera sempre più interdipendente e con velocità crescente, ne mettono in discussione l’assetto geopolitico e ne accrescono gli squilibri sociali: da quelli concernenti la finanza e le monete alla loro ricaduta sull’economia e sull’assetto sociale, dalla crescita della popolazione mondiale alla disperata migrazione delle parti più deboli di essa che rende sempre più aleatoria la distinzione fra richiedenti asilo e migranti economici, dal consumo eccessivo delle risorse naturali non rinnovabili alla compromissione irreversibile dell’ambiente, dal miglioramento delle condizioni di benessere di una parte minoritaria della popolazione del pianeta al precipitare in condizioni di crescente povertà, fame e malattia di un’altra parte notevole della stessa popolazione. Questi processi interdipendenti, se non governati da autorità sopranazionali, provocheranno devastazioni degli assetti istituzionali anche nelle democrazie più progredite del pianeta.
Le conquiste di civiltà, in particolare quelle che caratterizzano l’Europa, conseguenti a contraddittorie e controverse secolari azioni di dominio mondiale, rischiano di essere messe in discussione. L’illusione degli Stati europei che ritengono di attraversare, immuni, gli sconvolgimenti planetari ai quali assistiamo, rinchiudendosi nell’ottocentesca dimensione nazionalista, sarà spazzata via non solo dai flussi migratori africani e asiatici, ma anche dal progredire degli Stati continentali.
Alle problematiche sopra accennate si aggiungono, tra le altre, quelle dell’energia e dell’ambiente che continuano a essere affrontate dagli Stati nazionali, singolarmente e nelle sedi internazionali, con scarse possibilità di successo, in assenza di soggetti di governo e di politiche che consentano di fronteggiare e governare i processi interdipendenti che le caratterizzano.
Per rispondere al neo-protezionismo degli Stati Uniti, al nazionalismo russo, alla trasformazione nella rete dei poteri globali e al neocolonialismo economico cinese, l’Ue dovrebbe essere dotata degli strumenti necessari a svolgere un ruolo autonomo di attore politico a livello planetario per contribuire ad avviare un nuovo ciclo nel governo dell’interdipendenza, segnato da uno sviluppo equilibrato e sostenibile, dalla distensione e dal rispetto della dignità umana.
Se la globalizzazione ha cambiato, nel bene e nel male, il mondo in rapidissima sequenza, l’Ue è così apparsa incapace di reagire velocemente e in modo adeguato, prigioniera del potere multi cefalo dei governi nazionali in settori chiave per la gestione di problemi di carattere nazionale. Al contrario di un Leviatano o di un Impero europeo che dà ordini a stati e sudditi satelliti dall’alto del Berlaymont (la sede della Commissione europea a Bruxelles), il potere europeo è passato progressivamente nelle mani dei governi nazionali e, per essi, dei capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio europeo all’interno di un’inedita “Santa Alleanza”, che costituisce quello che Habermas chiama il “federalismo degli esecutivi”. Amplificata dalla rivoluzione tecnologica e digitale, la globalizzazione ha sconvolto in questi anni gli equilibri più di quanto si immaginasse, causando una rapida redistribuzione internazionale del lavoro, delle ricchezze e degli investimenti. Se la portata inedita di tali fenomeni e il loro manifestarsi in veloce sequenza hanno cambiato il mondo, rendendo precari gli equilibri, l’Ue è apparsa vittima del suo gradualismo, delle risibili risorse finanziarie del bilancio Ue pari all’1% del Pil europeo e gestito da un’euro-burocrazia che costa a ogni cittadino 1,40 euro al mese.
L’analisi di Galli della Loggia non mi pare, dunque, fondata. Non vi è stata una vera eliminazione delle differenze fra gli Stati nazionali e le nazioni non sono scomparse. I Parlamenti nazionali sono stati in grado di recuperare parte dei loro poteri con il Trattato di Lisbona. Il pluralismo non è stato negato e gli indirizzi comuni nella sanità, nell’istruzione, nella cultura e nella ricerca sono passati dai tentativi (falliti) di armonizzazione al mutuo riconoscimento. La cittadinanza europea, infine, non ha sostituito le cittadinanze nazionali, ma ha aggiunto a esse diritti comuni che sono stati consolidati nella Carta europea dei diritti fondamentali.
Ogni giorno di più la realtà mostra, drammaticamente, che non ci può essere alternativa all’unità europea nella prospettiva di rinsaldare la secessione secolare con l’Oriente e con il Mediterraneo.
 Per costruire quest’alternativa serve con urgenza una “operazione verità” condotta da un vasto movimento di opinione ben al di là dell’associazionismo europeista, una alleanza di innovatori che nasca dal mondo dell’economia e del lavoro, della cultura e della ricerca, delle organizzazioni giovanili e del volontariato coinvolgendo tutti coloro che vivono l’utilità dell’integrazione europea e pagano le conseguenze dei costi della non-Europa.
Per costruire quest’alternativa serve con urgenza una “operazione verità” condotta da un vasto movimento di opinione ben al di là dell’associazionismo europeista, una alleanza di innovatori che nasca dal mondo dell’economia e del lavoro, della cultura e della ricerca, delle organizzazioni giovanili e del volontariato coinvolgendo tutti coloro che vivono l’utilità dell’integrazione europea e pagano le conseguenze dei costi della non-Europa.
*
POPULISMO E PRINCIPI COSTITUZIONALI
Perché la nazione ha ancora un senso
Il tema della patria è stato regalato a chi manipolandolo lo ha utilizzato per i propri scopi: è un inganno al quale non basta opporre il progetto europeista
di Ernesto Galli della Loggia *
L’Unione europea è visibilmente in crisi, non riesce a fare alcun passo avanti in quanto soggetto politico (anzi negli ultimi tempi ne ha fatto parecchi indietro), ma l’ideologia europeista almeno un successo importante può continuare comunque a vantarlo. Essere riuscita a delegittimare alla radice la dimensione della nazione in generale. Essere riuscita a farla passare come responsabile di tutte le sciagure novecentesche e come il ricettacolo delle più inquietanti ambiguità ideologiche, tipo quelle messe in circolazione da Matteo Salvini con il suo sciovinismo xenofobo a base di «prima gli italiani» e «padroni in casa nostra». Il risultato è che in pochi Paesi come l’Italia ogni riferimento alla nazione appare, ormai, come il potenziale preludio di una deriva sovranista, di una dichiarazione di guerra antieuropea, come sinonimo di sopraffazione nazionalistica. Non abbiamo forse sentito ripetere fino alla nausea, ad esempio, e dalle cattedre più alte, che gli Stati nazionali significano inevitabilmente la guerra? Come se gli esseri umani avessero dovuto aspettare la Marsigliese, il Kaiser o Mussolini per trovare il motivo di scannarsi. Come se prima dell’esistenza dei suddetti Stati nazionali di guerre non ce ne fossero mai state, e come se i Romani, l’impero turco, gli Aztechi, gli Arabi dell’epoca di Maometto o mille altri non avessero tutti coperto di stragi e di morti ammazzati il proprio cammino nella storia.
Naturalmente l’ostracismo comminato alla nazione ha avuto effetto non tanto sulla gente qualunque, sulla maggioranza dell’opinione pubblica quanto nei confronti delle élites, della classe dirigente. Anche perché l’Italia, si sa, non è la Francia. Da noi la cultura della nazione era già stata messa abbastanza nell’angolo dalla storia: non per nulla la Repubblica, nata e vissuta con l’obbligo di differenziarsi dal fascismo specialmente su questo punto, ha intrattenuto a lungo un rapporto per così dire minimalista con la nazione. Come del resto le sue maggiori culture politiche fondatrici (quella cattolica e quella comunista), il cui sfondo ideologico non aveva certo molto a che fare con la nazione.
Cresciuto per decenni in questa atmosfera, l’establishment italiano - in prima fila l’establishment culturale - si è dunque trovato prontissimo, dopo la fine della Dc e del Pci, a gettarsi nell’infatuazione europeistica più acritica. Trovandovi nuovo alimento non solo alla propria antica indifferenza, al suo disinteresse nei confronti di una dimensione nazionale giudicata ormai una sorta di inutile ectoplasma, ma per spingersi addirittura fino alla rinuncia della sovranità in ambiti delicatissimi come la formazione delle leggi. Mi domando ad esempio quante altre Costituzioni europee siano state modificate come lo è stata quella italiana nel 2001 con la nuova versione dell’articolo 117, che sottomette la potestà legislativa al rispetto, oltre che come ovvio della Costituzione stessa, anche «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario». (Sulla stessa linea, pur nella sua evidente vacuità prescrittiva, anche il primo comma aggiunto nel 2012 all’art. 97, secondo il quale «le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico»).
È accaduto così, attraverso queste vie e mille altre, che il tema della nazione sia stato pian piano regalato a chi, manipolandolo ed estremizzandolo, combinandolo con i cascami del populismo, se ne è sempre più servito per i propri scopi agitatori. Espulsa dalla cultura ufficiale del Paese, tenuta in non cale dal circuito della formazione scolastica, non più elemento vivo costitutivo del modo d’essere e di pensare della classe dirigente, la nazione (o meglio la sua caricatura) è fatalmente divenuta patrimonio e strumento di una parte. La quale non ci ha messo molto ad accorgersi della sua capacità di aggregare, di commuovere, e anche di illudere, d’ingannare, se del caso di trascinare alla più vile prepotenza.
Cioè di trasformarsi in nazionalismo, appunto. Ma di chi la colpa principale mi chiedo, se non di coloro che, pur potendo e sapendo, per cecità ideologica hanno omesso di ricordare che cosa ha veramente rappresentato l’idea di nazione? Di illustrare e di far valere nella discussione pubblica la reale portata storica, le innumerevoli conseguenze positive di quell’idea?
Senza la quale, tanto per dirne qualcuna, non ci sarebbero stati il liberalismo e la democrazia moderna, la libertà religiosa, le folle di esclusi e di miserabili trasformate in cittadini, le elezioni a suffragio universale. Senza la quale non ci sarebbe stata la scuola obbligatoria e l’alfabetizzazione di massa, il Welfare e la sanità pubblica, e poi la rottura di mille gerarchie pietrificate, di tante esclusioni corporative. Senza la quale infine - scusate se è poco - non ci sarebbe stata neppure l’Italia. Cioè questo Stato scalcagnato e pieno di magagne grazie al quale, bene o male, però, nel giro di tre o quattro generazioni (una goccia nel mare della storia) un popolo di decine di milioni di persone ha visto la propria vita migliorare, cambiare come dalla notte al giorno, in una misura che non avrebbe mai osato sperare prima.
All’inganno nazionalistico che incalza e che cresce non vale opporre la speranza sbiadita e senza voce, il disegno dai contorni tuttora imprecisi e imprecisabili, del progetto europeistico. Va opposta prima di ogni altra cosa, in tutta la sua forza storica, la cultura della nazione democratica. Che più volte - ricordiamo anche questo - ha dimostrato anche di sapere aprirsi al mondo superando i confini della propria patria con la sua carica emancipatrice volta all’umanità.
* Corriere della Sera, 19 luglio 2018 (modifica il 19 luglio 2018 | 20:30) (ripresa parziale, senza immagini).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI. Un invito e un appello a fare luce, a fare giorno
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- "Marrani. L’altro dell’altro". Donatella Di Cesare riattualizza la figura esoterica dell’ebraismo diasporico21 luglio 2018, di Federico La Sala
Il marrano, quel «corpo» politico della rivolta
Scaffale. Donatella Di Cesare riattualizza la figura esoterica dell’ebraismo diasporico
di Roberto Ciccarelli (il manifesto, 21.07.2018)
Nella filosofia italiana esiste la tendenza a individuare figure esemplari e liminari per descrivere la nostra attualità. È stato così per l’Homo Sacer di Giorgio Agamben, formula del diritto romano che indica un essere umano uccidibile senza che si compia un reato. Così oggi è il migrante affogato nel Mediterraneo o recluso nei campi di concentramento in Libia. Donatella Di Cesare ha delineato i tratti di una figura filosofica e l’ha definita straniero residente. Nel suo ultimo libro Marrani. L’altro dell’altro (Einaudi, pp.113, euro 12) aggiunge a questa figura che travalica la distinzione tra migrante e autoctono una genealogia che scava nella nostra identità politica.
PARTE DELLA PIÙ AMPIA filosofia delle migrazioni che la filosofa romana sta sviluppando, questo agile libro riattualizza una figura esoterica dell’ebraismo diasporico e lo considera come l’occasione di un pensiero radicale per reinventare una democrazia internazionalista, solidale, conflittuale. Nella filosofia contemporanea il marranesimo è un riferimento etico, politico, religioso. Dalla mistica di Teresa d’Avila - suo nonno Juan Sánchez era un convertito dall’ebraismo alla fede cattolica - alle campiture dell’Etica di Spinoza - ebreo oggetto del cherem (bando o scomunica), gravissimo e mai revocato, fino alla grazia tormentata di Jacques Derrida alle prese con la sua identità ebraica rimossa, molte sono le storie raccontate nel libro.
Il marrano è la figura iniziale di una nuova era della storia ebraica e di una tradizione politica di rivolta ancora in corso. È considerato come il primo migrante nella modernità politica. Cacciato dalla Spagna e dal Portogallo sciamò in tutta Europa, da Amsterdam fino a Livorno. E formò una «nazione anarchica», nel massimo segreto ideò un «progetto messianico mondiale». Era un senza terra, e senza religione, reinventò un credo religioso e un’idea di convivenza.
Da questa fonte sgorgò uno degli elementi del pensiero politico radicale del XX secolo: il messianismo. Quello che ha ispirato anche Walter Benjamin e il suo originalissimo pensiero marxista. O lo stesso Marx. Materialista, ateo, ebreo e comunista, anche il filosofo tedesco ha criticato nella Questione ebraica la separazione tra pubblico e privato in cui si dibatte il cittadino moderno, la stessa a cui è costretto il marrano obbligato a reinventare in privato l’identità che non può mostrare in pubblico. Marx ne dedusse l’inimicizia per la democrazia liberale e la sua idea di astratta uguaglianza. La tensione al superamento dell’alienazione per ritrovare l’unità caratterizza il «laboratorio politico della modernità».
PER DI CESARE tale ricerca è destinata allo scacco e, proprio per evitare che il soggetto resti scisso e irrisolto, bisogna rivendicare la dissonanza. Un progetto politico è tale quando resta aperto e incompiuto. Così ha una speranza di durare. In fondo questa è l’idea del «movimento che abolisce lo stato di cose presenti»: il comunismo.
 Il marranesimo non è dunque solo la storia di violenze e coercizioni, né la rivendicazione della purezza di un’identità religiosa. È l’opposto. Il perservare dei marrani nel loro inconfessabile segreto - l’essere ebrei anche se convertiti a forza - la speranza recondita di un ritorno a un’origine che mai si ripeterà come tale, traducono la condizione di chi è senza radici, spaesato, e alla ricerca di una terra da costruire con chi si trova nella stessa condizione. Estranei allo Stato, ma capaci di costruire politica oltre la sovranità.
Il marranesimo non è dunque solo la storia di violenze e coercizioni, né la rivendicazione della purezza di un’identità religiosa. È l’opposto. Il perservare dei marrani nel loro inconfessabile segreto - l’essere ebrei anche se convertiti a forza - la speranza recondita di un ritorno a un’origine che mai si ripeterà come tale, traducono la condizione di chi è senza radici, spaesato, e alla ricerca di una terra da costruire con chi si trova nella stessa condizione. Estranei allo Stato, ma capaci di costruire politica oltre la sovranità.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EUROPA. Atene....
 JACQUES DERRIDA. LA DEMOCRAZIA, IL PRINCIPIO-FANTASMA ARCAICO DELLA SOVRANITA’, E LA LIBERTA’ INCONDIZIONALE.
JACQUES DERRIDA. LA DEMOCRAZIA, IL PRINCIPIO-FANTASMA ARCAICO DELLA SOVRANITA’, E LA LIBERTA’ INCONDIZIONALE.FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" - Le scorciatoie non esistono, l’Africa, e la tradizione giuridica euro-occidentale (di Mario Giro).18 giugno 2018, di Federico La Sala
Uno choc di egoismi: a questo assomiglia l’Europa posta davanti alla sfida migratoria
Le scorciatoie non esistono
di Mario Giro (Il mulino, 18 giugno 2018)
Da una parte la demografia galoppante dell’Africa ma soprattutto il cambiamento dei suoi giovani che sentono il diritto di spostarsi come inalienabile. Vogliono un futuro migliore e cercano di afferrare con tutti i mezzi possibili la “loro parte” delle opportunità nella globalizzazione. Anche a rischio della vita. È una forma di “intrapresa individuale”, di investimento sul futuro. Niente può trattenerli, sanno che il mondo è anche loro.
 Dall’altra parte l’Europa: un mondo invecchiato e più impaurito, chiuso nel proprio benessere ma anche spaventato e colpito dal declassamento sociale, dalla diminuzione del Welfare e dalla mancanza di lavoro. Tutti lo sanno: se non c’è abbastanza lavoro è per la nuova redistribuzione della ricchezza e per l’innovazione tecnologica. Non potendo prendersela con la tecnologia, la reazione rabbiosa si concentra verso l’ultimo arrivato. Non vogliamo nessuno - si dice - non c’è spazio, la “barca è piena” come sostenevano gli svizzeri durante la seconda guerra mondiale respingendo ebrei...
Dall’altra parte l’Europa: un mondo invecchiato e più impaurito, chiuso nel proprio benessere ma anche spaventato e colpito dal declassamento sociale, dalla diminuzione del Welfare e dalla mancanza di lavoro. Tutti lo sanno: se non c’è abbastanza lavoro è per la nuova redistribuzione della ricchezza e per l’innovazione tecnologica. Non potendo prendersela con la tecnologia, la reazione rabbiosa si concentra verso l’ultimo arrivato. Non vogliamo nessuno - si dice - non c’è spazio, la “barca è piena” come sostenevano gli svizzeri durante la seconda guerra mondiale respingendo ebrei...La politica si adatta, si appiattisce senza colpi d’ala. Non si cercano soluzioni ma si annunciano apocalissi demografiche. Tutti parlano di “invasione” ma nessuno di integrazione, che è il nostro vero problema. A Bruxelles gli emendamenti al Trattato di Dublino - che disciplina le migrazioni e la concessione dei permessi - vanno verso l’indurimento. L’Italia ha posto il veto su un testo che costringeva il richiedente asilo di rimanere fino a 10 anni nel Paese di primo approdo: una follia.
Il nuovo governo italiano fa sentire la voce dello scontento italiano verso i partner che ci hanno riempiti di complimenti ma non hanno mosso un dito.
 È scandaloso che una decisione del Consiglio (la relocation) non sia stata applicata senza conseguenze. Inutile girarci attorno: l’Unione ha perso credibilità. La politica migratoria italiana resta sostanzialmente la stessa: lavorare in Libia (e coi Paesi di origine e transito) per trattenere; limitare l’operatività delle Ong in mare; riprovare coi rimpatri.
È scandaloso che una decisione del Consiglio (la relocation) non sia stata applicata senza conseguenze. Inutile girarci attorno: l’Unione ha perso credibilità. La politica migratoria italiana resta sostanzialmente la stessa: lavorare in Libia (e coi Paesi di origine e transito) per trattenere; limitare l’operatività delle Ong in mare; riprovare coi rimpatri.Il tono però è cambiato: prima lo si faceva tenendo conto del “bon ton” internazionale, senza esacerbare le divergenze. Le critiche si facevano in privato, ora apertamente. Lo choc delle passioni potrebbe essere deflagrante. La polemica politica interna ora aggredisce le relazioni esterne. D’altra parte anche ai commissari Ue o al presidente Juncker, ogni tanto sfuggono commenti che mettono in luce i loro enormi pregiudizi. Dovremmo stare attenti: le parole sono pietre e alla fine colpiscono tutti. Vittimismi uno contro l’altro armati non portano a nessun risultato. Una delle caratteristiche del “metodo europeo” è ridurre i problemi a procedure e regole: si fa apposta per raffreddare i bollenti spiriti nazionali, sempre all’erta. È stata e rimane una scelta politica. I “sovranismi” non sono tutti uguali né potranno mai allearsi.
 Le loro agende sono confliggenti: nessuno vuole aiutare l’altro o partecipare ai suoi sforzi: è lo sterile choc degli egoismi. Non esiste in natura (cioè in politica) una “alleanza dei sovranismi”: se sono sovranismi sono istintivamente contrapposti. Se invece si negozia - foss’anche da posizioni più dure - allora non si tratta di sovranismi ma di legittima strategia negoziale. Tutta un’altra cosa.
Le loro agende sono confliggenti: nessuno vuole aiutare l’altro o partecipare ai suoi sforzi: è lo sterile choc degli egoismi. Non esiste in natura (cioè in politica) una “alleanza dei sovranismi”: se sono sovranismi sono istintivamente contrapposti. Se invece si negozia - foss’anche da posizioni più dure - allora non si tratta di sovranismi ma di legittima strategia negoziale. Tutta un’altra cosa.Certamente l’Italia ha ragione quando sostiene che nessuno l’ha aiutata in questi anni, a parte il lip service complimentoso, divenuto davvero fastidioso. D’altra parte scontrarsi e insultarsi a vicenda non porterà a nessuna soluzione. Le contese europee di questi giorni sono purtroppo tutte improntate a ragioni di politica interna. Questo rende lo scenario preoccupante: con l’inerzia della quotidianità, l’agenda interna tende ad “accecare” e a dirottare quella delle relazioni internazionali, pur essenziale.
I governi devono trovare un equilibrio nuovo tra esigenze interne, più pressanti, e relazioni esterne, comunque vitali: una nuova architettura di dialogo. Quest’ultimo non è mai un “embrassons-nous” facile: è trattativa, fatica, pazienza, ascolto, mediazione.
 Dialogare non significa mai arrendersi ma trovare il giusto compromesso. Se si strappa il velo delle buone maniere, che talvolta cela anche l’ipocrisia, si ottiene solo un ambito di negoziato più aspro. Non conviene.
Dialogare non significa mai arrendersi ma trovare il giusto compromesso. Se si strappa il velo delle buone maniere, che talvolta cela anche l’ipocrisia, si ottiene solo un ambito di negoziato più aspro. Non conviene.Ciò accade soprattutto ora, un tempo in cui le emozioni sono così importanti. Si parla di percezione della realtà piuttosto che di realtà dei fatti. “Percepire più che capire”: tale è il leitmotiv attuale. Sembra che la percezione vada oltre la comprensione e sia più veritiera: intuisca il “non detto”, anticipi l’occultato, richiami il rimosso. Uomini politici più abili nel “sentire” lo spirito del tempo e meno ingessati nei riti della politica, ne fanno la loro condotta. Ma una volta strappato il velo del politicamente corretto, la difficoltà sta poi nel creare un nuovo binario in cui canalizzare bisogni e risposte. Altrimenti si perde il controllo.
Da sempre il vero compito degli “homines novi” è proprio tale costruzione. Non è sufficiente evidenziare la contrapposizione e cavalcarla: occorre il talento di una nuova sintesi. In parole povere: chiudere porti e/o respingersi migranti a vicenda; lasciarli in balia di libici e/o schiavisti; far finta che l’Africa non esista: ciò rappresenta un nuovo quadro politico? Non sembra proprio, non regge e non ha prospettiva, troppo schiacciato sul qui ed ora, troppo elettoralmente condizionato.
La risposta non è facile. Se ci si attesta sulla linea emergenziale si mettono a rischio i valori fondamentali della democrazia, del diritto occidentale, delle libertà. Tali principi sono validi in quanto universali, cioè per tutti e non per qualcuno soltanto. Neppure si può cancellare il fatto che nel più profondo, alla radice del sentimento popolare, vi è sempre iscritta un’esigenza di pace: la gente semplice (la “povera gente” di La Pira) si somiglia ovunque e non odia nessuno. La gente semplice, se scorge il bisogno non dice mai “tutti sono troppi”.
L’Europa ha già in passato perso il controllo di sé in molte occasioni. Le polemiche sui migranti non sono nuove: la stessa scena della nave Aquarius l’abbiamo già vista nel 2009, nel 2010, nel 2013. Ciò che più importa è che al fondo delle controversie attuali esiste un tema ricorrente nella storia europea: la questione della cittadinanza. Da secoli in maniera periodica i popoli europei si chiedono quale sia la qualità (o le qualità) per far parte della propria comunità nazionale. Ci sono biblioteche su tale indagine e sulle possibili risposte: per scelta, legge, diritto, etnia, razza, cultura, lingua, storia comune, terra, usi e costumi ecc. La discussione sull’identità è questa: come si forma un’identità? Può mai dirsi definitiva?
Tale dibattito è ciclico e si riaccende virulento ogni qualvolta l’Europa subisce una fase lunga di crisi economica. Sono periodi di tempo in cui si sopportano meno “nuovi arrivi” o “nuovi apporti”, in specie se diversi. Sappiamo che su tale assillo hanno lavorato varie correnti ideologiche e numerose scuole di pensiero. L’importante è non trascinare mai il dibattito fuori dal quadro delle nostre conquiste giuridiche occidentali. Per noi i diritti sono universali, il valore supremo è la persona e la sua libertà, la responsabilità è sempre personale e mai collettiva, ogni giudizio necessita garanzie, il rispetto della “rule of law” e dello stato di diritto sono fondamentali. Per questo chiediamo a tutti di adeguarvisi.
Tra quadro giuridico e costituzionale delle leggi da un lato, ed emozioni, paure e percezioni dall’altro, sembra che vi debba essere per forza conflitto. Non è così.
 Le leggi e le costituzioni servono proprio a ordinare ciò che non lo è, senza tradirlo e senza travalicarlo. È questo il risultato di tanti secoli di riflessione e maturazione che incalzano la storia, la interpretano e la riordinano alla luce di una sempre nuova coscienza e di nuove consapevolezze.
Le leggi e le costituzioni servono proprio a ordinare ciò che non lo è, senza tradirlo e senza travalicarlo. È questo il risultato di tanti secoli di riflessione e maturazione che incalzano la storia, la interpretano e la riordinano alla luce di una sempre nuova coscienza e di nuove consapevolezze.L’Unione europea, malgrado tutti i difetti, è la depositaria di tale tradizione giuridica euro-occidentale. I Trattati dell’Unione - i cui originali sono depositati e visibili alla Farnesina - sono complicatissimi, è vero, quasi illeggibili senza aiuto. Eppure contengono il distillato della nostra tradizione che ha avuto molte svolte nel corso della storia. In questo senso l’Ue è un superpower giuridico e normativo: garanzie di libertà e di diritti per tutti. È quello il luogo vero delle battaglie dell’Italia, il centro dove far valere le proprie ragioni. Una scorciatoia non c’è.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- "AQUARIUS" E LA STORIA DELLA CIVILTA’ DELL’UOMO A UNA DIMENSIONE. Se io fossi Papa (di Paolo Farinella).14 giugno 2018, di Federico La Sala
"ADAMO", "ABRAMO", I TRE MONOTEISMI, L’ONU, E LA STORIA DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE ... *
Aquarius: se io fossi Papa, scomunicherei Matteo Salvini
di Paolo Farinella, sacerdoye (Il Fatto quotidiano, 12 giugno 2018)
Finita la civiltà occidentale, è iniziata l’inciviltà di Salvini Matteo, segretario della Lega non più secessionista ma a vocazione planetaria, (vice)Presidente del Consiglio dei ministri in atto e cattolico «coerente» (l’ha detto lui medesimo in persona!), in risposta al cardinal Gianfranco Ravasi che twittava il Vangelo di Matteo al capitolo 25,43: «Ero straniero e non mi avete accolto». La motivazione della coerenza cristiana di Matteo Salvini: «Ho il rosario in tasca, io coerente con gl’insegnamenti del Vangelo».
 È il capovolgimento di ogni ordine e principio. Se avere un oggetto in tasca è segno di coerenza, chi porta le «Madonne ripiene» di Lourdes, le immagini dei Padri Pii e armamentari di questo genere, cosa è? Un padre/madre eterno in terra?
È il capovolgimento di ogni ordine e principio. Se avere un oggetto in tasca è segno di coerenza, chi porta le «Madonne ripiene» di Lourdes, le immagini dei Padri Pii e armamentari di questo genere, cosa è? Un padre/madre eterno in terra?Se io fossi Papa, lo scomunicherei in forza delle sue stesse parole che sono un insulto a tutto l’insegnamento evangelico, tenuto conto che per un ministro della Repubblica Italiana, fresco di giuramento «di servire con disciplina e onore», dovrebbe essere ininfluente l’aspetto, finto o vero che sia, della religione perché bastano e avanzano i principi della Costituzione che anche Salvini difese nel referendum del 2016, le leggi e i trattati internazionali, sottoscritti dall’Italia e la legge della coscienza che su tutto fa prevalere l’umanità e il pericolo imminente di vita.
Nella creazione, «Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte» (Gen 1,4-5), ora le tenebre prendono il posto del giorno come se niente fosse.
Mi ribello a questa ignominia che, come scrive Lucia Annunziata su Huffington Post, ci riporta indietro di 72 anni minimo alla vergogna della nave ebraica «Exodus». In questi giorni, nella mia parrocchia, abbiamo pubblicato tutti i bilanci e gli aiuti che diamo a oltre un centinaio di persone/famiglie (50% italiani e 50% di origine non italiana), provengono unicamente da contribuzioni volontarie di circa 150 persone.
 Non un soldo pubblico, non un contributo politico che non vogliamo perché abbiamo un senso di dignità che esige la compartecipazione e il sentimento umano. La «pacchia» la rimandiamo indietro al mittente perché è lui che lucra elettoralmente e politicamente dalla disgrazia dei migranti.
Non un soldo pubblico, non un contributo politico che non vogliamo perché abbiamo un senso di dignità che esige la compartecipazione e il sentimento umano. La «pacchia» la rimandiamo indietro al mittente perché è lui che lucra elettoralmente e politicamente dalla disgrazia dei migranti.A Salvini e a Di Maio che ho votato per scardinare l’immondo sodalizio «Renzi/Berlusconi» e non per trovarmi i fascisti al governo, nonostante la Costituzione, dedico queste parole nelle quali mi riconosco io e il meglio del popolo italiano:
- «Tutti i figli di Adamo formano un solo corpo, sono della stessa essenza. Quando il tempo affligge con il dolore una parte del corpo (anche) le altre parti soffrono. Se tu non senti la pena degli altri, non meriti di essere chiamato uomo».
Queste parole sono scolpite nell’atrio del Palazzo dell’Onu. Parole antiche, di Poeta e di Mistico, Saādi di Shiraz, Iran1203-1291. Nove secoli fa un persiano musulmano esprimeva un pensiero che è ebraico e cristiano. Nella Bibbia, «Adamo» non è nome proprio di persona, ma nome collettivo e significa «Umanità - Genere Umano», senza aggettivi perché non è occidentale, orientale, del nord o del sud, ma solo universale.
 L’Onu ha scolpito le parole sul suo ingresso perché le nazioni possano leggerla prima di deliberare per richiamarsi l’orizzonte delle decisioni. Europa, Italia e Occidente fan parte dell’Onu al punto che spiriti poveri osano parlare di «civiltà occidentale», identificandola, sacrilegamente, con il Crocifisso, senza memoria di storia, di geografia e di civiltà.
L’Onu ha scolpito le parole sul suo ingresso perché le nazioni possano leggerla prima di deliberare per richiamarsi l’orizzonte delle decisioni. Europa, Italia e Occidente fan parte dell’Onu al punto che spiriti poveri osano parlare di «civiltà occidentale», identificandola, sacrilegamente, con il Crocifisso, senza memoria di storia, di geografia e di civiltà.La nostra civiltà sta regredendo verso la preistoria, verso il nulla. Come insegna il secolo XX, secolo di orrori, la barbarie porta all’abisso e inghiotte la Storia in un buco nero senza ritorno. Guardando le immagini di umanità crocifissa nella miseria dell’opulenza attorno al Grattacielo della Regione Liguria, ho pensato istintivamente alle parole del pastore protestante tedesco, Martin Möller, pronunciate nel 1946 in un sermone liturgico: -***«Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare».
A Genova il Comune ha deciso di restaurare la Lanterna, simbolo della città, faro di luce nel buio e segnale per rotte sicure; a Genova, in Italia, in Europa e nel Mondo si perseguitano i poveri, i senza dimora, gli sbandati, figli di una società impazzita che crede di potersi chiudere in sé, erigendo muri e fili spinati, mentre si difendono Istituzioni ed Europa, gusci vuoti d’ideali, ma pieni di interessi miopi. Chi costruisce muri distrugge l’Europa e il proprio Paese, chi perseguita il povero si attira la collera di Dio che è «il Dio degli umili, il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati» (Gdt 14,11).
 La civiltà e il suo cammino lo avevano indicato nei millenni antichi le Scritture degli Ebrei, dei Cristiani e dei Musulmani, recepiti dalla modernità nell’esistenza stessa dello spirito delle Nazioni Unite, che si riconoscono in Saādi di Shiraz.
La civiltà e il suo cammino lo avevano indicato nei millenni antichi le Scritture degli Ebrei, dei Cristiani e dei Musulmani, recepiti dalla modernità nell’esistenza stessa dello spirito delle Nazioni Unite, che si riconoscono in Saādi di Shiraz.Se oggi, cittadini, uomini e donne, politici e amministratori, vescovi e preti, politici e governanti, sindaci e assessori, credenti e non credenti, docenti e studenti, non si riconoscono laicamente nelle parole che vengono dal lontano Medio Evo, noi abbiamo messo mano alla scure per recidere l’albero su cui siamo seduti. Se non ci si chiede la ragione per cui i poveri aumentano, i senza casa aumentano, gli sbandati crescono esponenzialmente e i migranti africani chiedono il conto, siamo colpevoli di assassinio della civiltà, non salveremo noi, ma ci votiamo destiniamo alla distruzione.
Berthold Brecht (1898-1956), poeta e drammaturgo, nelle Poesie di Svendborg (1933-1938), 1937 (traduzione di E. Castellani-R. Fertonani) ne ha una col titolo «Germania», atto di accusa al sopruso del forte sul debole, all’arroganza del sistema sulla persona. A sessant’anni della sua morte, Germania è nome simbolico, sostituibile con Italia, Ungheria, Polonia, Austria, Olanda, Genova, Torino Milano, Roma, Io, Tu, Egli, Noi, Voi e Loro: -***«Parlino altri della propria vergogna, / io parlo della mia. /O Germania, pallida madre! / come insozzata siedi / fra i popoli! / Fra i segnati d’infamia /tu spicchi. / Dai tuoi figli il più povero/ è ucciso. / Quando la fame sua fu grande / gli altri tuoi figli / hanno levato la mano su lui. / ... Perché ti pregiano gli oppressori, tutt’intorno, ma / ti accusano gli oppressi? / Gli sfruttati / ti mostrano a dito, ma / gli sfruttatori lodano il sistema / che in casa tua è stato escogitato! / E invece tutti ti vedono / celare l’orlo della veste, insanguinato / dal sangue del migliore / dei tuoi figli. / O Germania, pallida madre! / Come t’hanno ridotta i tuoi figli, / che tu in mezzo ai popoli sia / o derisione o spavento!» (Berthold Brecht).
Possano la Poesia e la Memoria rinsavire Ragione e Dignità. Salvini, la Lega, Di Maio e l’illusione passeranno, l’umanità sopravvivrà e i poveri porteranno fiori sulle loro tombe. È la Storia, bellezza! È la Storia!
*
SUL TEMA NEL SITO, SI CFR.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" ([Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010).
"ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi". Il lavoro di Emilio Gentile
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico
GUARIRE LA NOSTRA TERRA. "Potrei, per me, pensare un altro Abramo" (F. Kafka).
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Il sovranismo genera i conflitti. La vicenda dell’Aquarius ci offre un esempio concreto della natura e della intensità (di Gian Enrico Rusconi).13 giugno 2018, di Federico La Sala
Il sovranismo genera i conflitti
di Gian Enrico Rusconi (La Stampa, 13.06.2018)
La vicenda dell’Aquarius ci offre un esempio concreto della natura e della intensità dei conflitti che solleva il «sovranismo» che ha preso il posto, con parole nuove, del nazionalismo tradizionale, presuntivamente scomparso nell’Unione europea. L’Italia si trova protagonista per lo spregiudicato comportamento del suo ministro degli interni.
La questione della «sovranità» ha due dimensioni. Una esterna riguarda la posizione dell’Italia come membro dell’ Unione europea, partecipe di quella che retoricamente si chiama «sovranità condivisa». Si tratta in realtà di una finzione, clamorosamente confermata nell’ormai annoso problema della migrazione incontrollata e incontrollabile. Il trattato di Dublino è diventato la foglia di fico che nasconde la volontà di molti membri dell’Unione di non condividere affatto la responsabilità della accoglienza e della gestione dei migranti. I passati governi italiani non sono mai riusciti a far prevalere le loro buone ragioni.
Adesso Salvini, rispondendo ad una logica di potere interno, ha preso la decisione di sfidare apertamente l’Europa. Ma la sua retorica («non siamo più schiavi» o « servi» ecc.) presuppone l’esistenza di un «sovrano» padrone che in realtà oggi si defila. Infatti è in ordine sparso che le varie agenzie e istituzioni europee si fanno vive ammonendo o raccomandando il principio umanitario di salvare esseri umani. Enunciano un sacrosanto dovere/diritto che tuttavia non surroga la necessità di un decisore politico.
Ma dov’è il «sovrano» europeo che ha la legittimità di decidere efficacemente e consensualmente? Non è il Parlamento di Strasburgo, non è la Commissione dell’Unione bensì il Consiglio europeo degli Stati europei, che non riesce a modificare e ad andare oltre il trattato di Dublino. Il virtuale decisore sovrano è paralizzato, impotente. Quello che non hanno potuto fare i contrasti sui problemi economico-finanziari, lo sta ottenendo il dramma della migrazione.
Intanto sono già scattate brutali reazioni verbali tra le capitali. Durissime sono le parole che avrebbe pronunciato il Presidente francese Macron denunciando «una forma di cinismo e di irresponsabilità» da parte dell’Italia nel caso della nave Aquarius. Palazzo Chigi ha risposto altrettanto duramente. «L’Italia non può accettare lezioni ipocrite da Paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall’altra parte». E pensare che appena pochi giorni fa c’era stato un amichevole scambio di vedute tra il presidente Conte e Macron.
 Specularmente opposta è stata la reazione del primo ministro ungherese Viktor Orbàn che ha salutato la posizione italiana come «un grande momento che potrebbe davvero portare cambiamenti nella politica europea sulle migrazioni».
Specularmente opposta è stata la reazione del primo ministro ungherese Viktor Orbàn che ha salutato la posizione italiana come «un grande momento che potrebbe davvero portare cambiamenti nella politica europea sulle migrazioni».Ma a questo punto dobbiamo introdurre la seconda dimensione della rivendicazione della «sovranità»: quella interna, di «casa nostra». A nome di chi Salvini rivendica il suo modo di esercitare in esclusiva la «sovranità» nazionale dell’Italia? Il politico populista non ha dubbi: per lui sovrano è «il popolo» che egli stesso rappresenta. Ovvero la somma degli elettori che, nel caso italiano, combinando («con un contratto») due partiti, raggiunge la maggioranza.
Ma questo non risponde nè allo spirito nè alla lettera della nostra Costituzione che all’art.1 afferma: «la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». La frase è estremamente concisa ma perentoria nel non identificare «il popolo» con una maggioranza elettorale che ritiene di poter fare quello che vuole e come vuole.
 Il riferimento alla Costituzione infatti poi si articola nel testo come l’insieme di regole costituzionali che riguardano i partiti, i diritti dei cittadini, delle minoranze ecc, diciamo pure l’intera società civile. Ci sono le prerogative del Presidente della Repubblica e le competenze insostituibili della magistratura e dei grandi apparati amministrativi. Soprattutto c’è un grande sottinteso che univa tutti i costituenti al di là del loro peso numerico e delle loro differenze politico-ideologiche: la solidarietà e l’intesa comune quando sono in gioco i grandi interessi della nazione.
Il riferimento alla Costituzione infatti poi si articola nel testo come l’insieme di regole costituzionali che riguardano i partiti, i diritti dei cittadini, delle minoranze ecc, diciamo pure l’intera società civile. Ci sono le prerogative del Presidente della Repubblica e le competenze insostituibili della magistratura e dei grandi apparati amministrativi. Soprattutto c’è un grande sottinteso che univa tutti i costituenti al di là del loro peso numerico e delle loro differenze politico-ideologiche: la solidarietà e l’intesa comune quando sono in gioco i grandi interessi della nazione.Sta accadendo così in questi giorni? Salvini, seguendo il suo personale istinto politico, ha agito da solo. Non so se e come abbia preavvisato il presidente del consiglio Giuseppe Conte che in ogni caso ha dato l’impressione di seguire gli eventi, non di guidarli come capo del governo. Il Parlamento non ha avuto ancora modo e tempo di esprimersi.
Se questo è il «sovranismo» che ha in testa Salvini, c’è da essere inquieti. La sovranità di una nazione (democratica) è una cosa seria e impegnativa. Deve esprimersi anche attraverso l’attenzione e la lealtà reciproca tra le parti politiche, tra maggioranza e minoranze, pur nel mantenimento delle differenti posizioni. Ci attendono giorni e settimane di fermo confronto con i partner europei che non deve trasformarsi in scontro di sovranismi.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!!. La buona-esortazione del BRASILE. -- AMAZZONIA, MESSAGGIO EVANGELICO, E PAPA FRANCESCO. "Le donne non possono essere prete": lo stop di Ladaria (di Paolo Rodari).11 giugno 2018, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE....
"Le donne non possono essere prete": lo stop di Ladaria
Il cardinale prefetto dell’ex Sant’Uffizio: "La dottrina è definitiva, sbagliato creare dubbi tra i fedeli. Cristo conferì il sacramento ai 12 apostoli, tutti uomini"
di PAOLO RODARI (la Repubblica, 29 maggio 2018)
CITTÀ DEL VATICANO - Si tratta "di una verità appartenente al deposito della fede", nonostante sorgano "ancora in alcuni paesi delle voci che mettono in dubbio la definitività di questa dottrina". A ribadire il "no" del Vaticano all’ipotesi dell’ordinazione presbiterale femminile è il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il neo-cardinale gesuita Luis Ladaria, in un lungo e argomentato articolo pubblicato sull’Osservatore Romano. Intitolato "Il carattere definitivo della dottrina di ’Ordinatio sacerdotalis’", il testo è scritto per fugare "alcuni dubbi" in proposito.
Evidentemente, il ritorno di proposte aperturiste circa le donne-prete avanzate soprattutto in alcuni paesi sudamericani in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre dedicato all’Amazzonia, ha allarmato la Santa Sede che attraverso la sua massima autorità gerarchica ha voluto ribadire ciò che anche per Francesco sembra essere assodato: "Sull’ordinazione di donne nella Chiesa l’ultima parola chiara è stata data da Giovanni Paolo II, e questa rimane", ha detto Papa Bergoglio tornando nel novembre del 2016 dal suo viaggio lampo in Svezia.
Durante il Sinodo sull’Amazzonia uno dei temi centrali sarà quello della carenza di preti. Come superare il problema? In proposito, da tempo, si parla dell’opportunità di ordinare i cosiddetti viri probati, uomini sposati di una certa età e di provata fede che possano celebrare messa nelle comunità che, appunto, hanno scarsità di sacerdoti e dove è difficile che un prete possa recarsi con regolarità. Altri uomini di Chiesa fanno altre proposte: propongono, come ad esempio ha recentemente fatto monsignor Erwin Krautler della prelatura territoriale di Xingu in Amazzonia, che oltre ai viri probati si proceda con l’ordinazione delle diaconesse. Mentre altri ancora, invece, hanno parlato direttamente di donne-prete.
Ladaria ricorda che "Cristo ha voluto conferire questo sacramento ai dodici apostoli, tutti uomini, che, a loro volta, lo hanno comunicato ad altri uomini". E che per questo motivo la Chiesa si è riconosciuta "sempre vincolata a questa decisione del Signore", la quale esclude "che il sacerdozio ministeriale possa essere validamente conferito alle donne".
Già Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis del 22 maggio 1994, disse che "la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa". Mentre la Congregazione per la dottrina della fede, in risposta a un dubbio sull’insegnamento di Ordinatio sacerdotalis, ha ribadito che "si tratta di una verità appartenente al deposito della fede".
Chi vuole le donne-prete argomenta che la dottrina in merito non è stata definita ex cathedra e che, quindi, una decisione posteriore di un futuro Papa o concilio potrebbe rovesciarla. Dice, tuttavia, Ladaria che "seminando questi dubbi si crea grave confusione tra i fedeli" perché, Denzinger-Hünermann alla mano (l’autorevole volume che raccoglie simboli di fede, decisioni conciliari, provvedimenti di sinodi provinciali, dichiarazioni e scritti dottrinali dei Pontefici dalle origini del cristianesimo all’epoca contemporanea) la Chiesa riconosce che l’impossibilità di ordinare delle donne appartiene alla "sostanza del sacramento" dell’ordine. Una sostanza, dunque, che la Chiesa non può cambiare. "Se la Chiesa non può intervenire - dice ancora Ladaria - è perché in quel punto interviene l’amore originario di Dio".
Ladaria parla anche dell’infallibilità e del suo significato. Essa non riguarda solo pronunciamenti solenni di un concilio o del Papa quando parla ex cathedra, "ma anche l’insegnamento ordinario e universale dei vescovi sparsi per il mondo, quando propongono, in comunione tra loro e con il Papa, la dottrina cattolica da tenersi definitivamente". A questa infallibilità si è riferito Giovanni Paolo II in "Ordinatio sacerdotalis?, un testo che Wojtyla scrisse dopo un’ampia consultazione portata avanti a a Roma "con i presidenti delle conferenze episcopali che erano seriamente interessati a tale problematica". "Tutti, senza eccezione - ricorda Ladaria - hanno dichiarato, con piena convinzione, per l’obbedienza della Chiesa al Signore, che essa non possiede la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale".
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Una storia di lunga durata...
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- IL TEMPO DELLA COMPLESSITÀ (M. Ceruti). Il destino dell’uomo tra identità e diversità (di Michele Ciliberto).10 giugno 2018, di Federico La Sala
Controcorrente. I dialoghi filosofici di Mauro Ceruti con Walter Mariotti
Il destino dell’uomo tra identità e diversità
di Michele Ciliberto (Il Sole-24 Ore, Domenica, 10.06.2018)
- Il tempo della complessità Mauro Ceruti, Raffaele Cortina, Milano, pagg. 200, € 14
Questo volume si distingue per due elementi principali: presenta, come in una sorta di summula, le linee principali della riflessione di Mauro Ceruti; è costruito attraverso una serie di dialoghi con Walter Mariotti. Ed è una scelta che si rivela felice perché consente di affrontare molti temi in modo agile e accattivante. E come in genere accade quando si sceglie il genere letterario del dialogo, le posizioni sostenute appaiono come il risultato di una riflessione che si svolge sotto gli occhi del lettore.
La domanda intorno al quale gira il dialogo riguarda direttamente la condizione umana: quale è il destino dell’uomo oggi? Quali sono le sue prospettive? Sta nascendo una nuova umanità? E se così fosse, è una tappa prevedibile del lungo cammino dell’uomo, oppure può essere solo il frutto di un processo aperto a varie possibilità, in cui nulla è scontato, e che può anzi vedere la fine della nostra civiltà? Uno dei tratti più interessanti del libro è proprio il rifiuto di ogni teleologismo: nella storia umana, ed anche in quella dell’Europa, gioca un ruolo decisivo, scrive Ceruti, l’improbabile, cioè il non previsto - in positivo ma anche in negativo.
La dimensione dell’uomo è la libertà, la possibilità di scegliere il proprio destino, come proclama Giovanni Pico nella Oratio de hominis dignitate, citato a mo’ di programma all’inizio del libro; ma a differenza dei tempi del Conte della Concordia, oggi non esiste più un ordine definito rispetto al quale definire la propria identità. Nel nostro mondo “non si danno armonie prestabilite: il quadro del mondo è cambiato, è in piena fluttuazione”.
 Sono parole di Ernesto Balducci, e risalgono a ventisei anni fa; ma la situazione non è cambiata, anzi si è ulteriormente acuita, e la sua meditazione non ha perso di attualità. Viviamo un’epoca di trasformazioni profonde, che sconvolgono le vite degli individui e le strutture politiche e civili che il mondo - e l’Europa - si sono date lungo alcuni secoli. È mutato il rapporto tra nazione e stato, si è trasformata la composizione demografica delle società, bussano alle nostre porte moltitudini di uomini spinti dalla forza inesorabile e incontenibile della necessità. Tutto è effettivamente cambiato, e continua a cambiare, sottoponendo tutte le culture a prove assai dure, che possono decidere della loro vita o della loro morte, anche se non si ha in genere consapevolezza del vulcano su cui siamo seduti.
Sono parole di Ernesto Balducci, e risalgono a ventisei anni fa; ma la situazione non è cambiata, anzi si è ulteriormente acuita, e la sua meditazione non ha perso di attualità. Viviamo un’epoca di trasformazioni profonde, che sconvolgono le vite degli individui e le strutture politiche e civili che il mondo - e l’Europa - si sono date lungo alcuni secoli. È mutato il rapporto tra nazione e stato, si è trasformata la composizione demografica delle società, bussano alle nostre porte moltitudini di uomini spinti dalla forza inesorabile e incontenibile della necessità. Tutto è effettivamente cambiato, e continua a cambiare, sottoponendo tutte le culture a prove assai dure, che possono decidere della loro vita o della loro morte, anche se non si ha in genere consapevolezza del vulcano su cui siamo seduti.Tutto ciò - ed è questo il centro del libro di Ceruti - pone l’uomo di fronte a scelte radicali sul proprio destino: dove andare, come, e con chi, se si vuole evitare la fine della nostra civiltà, senza farsi illusioni, ma guardando la realtà per quello che è, misurandosi con le trasformazioni che la stanno sconvolgendo?
Sono questi gli interrogativi che percorrono il libro e ai quali Ceruti, sulla base della impostazione filosofica sua - e di Edgar Morin che introduce il libro - cerca di dare una risposta, andando per molti aspetti controcorrente; e questo è un bene. Bisogna, scrive, lavorare per costruire una «cittadinanza planetaria» all’altezza dello stato attuale del mondo ed occorre impegnarsi per un nuovo umanesimo, anzi per un umanesimo planetario. Ma questo, non è un destino scontato, e «se sarà, sarà prodotto dalla coscienza della comunità di destino che lega ormai tutti gli individui e tutti i popoli del pianeta, nonché l’umanità intera all’ecosistema globale e alla Terra».
È una proposta filosofica e politica che, si è detto, va controcorrente, perché oggi si stanno fortemente diffondendo posizioni che insistono invece sulla necessità di stabilire barriere sia sul piano culturale che su quello politico, anche riproponendo il modello statuale moderno, che sembrava ormai in crisi anche per l’imporsi dopo la tragedia della seconda guerra mondiale - e la nuova, lunga guerra dei trent’anni - dell’ideale europeo ad opera di grandi statisti come De Gasperi, Adenauer, Schumann. Un ideale, anzi un vero e proprio progetto politico che però oggi attraversa un momento di crisi profonda che ne mette in discussione lo stesso futuro.
È per ridare credibilità a questo ideale, collocandolo in una prospettiva planetaria, che Ceruti scrive il libro: una sorta di vero è proprio manifesto per una nuova Europa e una nuova umanità - processo sempre incompiuto e in divenire. Questo progetto, e qui arriviamo al centro del libro, ha però possibilità di svilupparsi solo se è basato su un intreccio organico di unità e molteplicità, di identità e diversità: su una unitas multiplex, come dice Ceruti riprendendo una formula famosa. È un intreccio che riguarda tutta l’esperienza umana, e può realizzarsi solo se si riesce ad agire su entrambi i tasti - identità e diversità - costituendo una società, e prima ancora, una umanità intessuta da una pluralità di differenze, da riconoscere, elaborare e potenziare nella nuova prospettiva di un cosmopolitismo planetario. Ed è un approccio che deve essere applicato anche alla costruzione dell’Europa, se si vuol metterla su basi solide. È, a mio giudizio, una prospettiva giusta: l’Europa, se vuole avere un futuro, deve essere capace di valorizzare e accogliere le differenze nazionali, inserendole in una nuova identità comune che dalle differenze viene potenziata, non diminuita.
Ceruti si collega, con la sua proposta, alla grande tradizione di Pico di cui discute l’Oratio de hominis dignitate e di Kant di cui cita l’Idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica. E ad essi congiunge testi e motivi della grande tradizione cristiana, fino a Papa Francesco. Il riferimento all’ umanesimo, nella pluralità dei suoi aspetti, è naturale, e comprensibile, in un’epoca come la nostra. Tutte le volte che è entrato in discussione il destino dell’uomo, i grandi umanisti sono infatti diventati attuali: basta pensare alla fortuna di Pico negli anni Trenta del secolo scorso.
Il colloquio con i grandi esponenti dell’umanesimo, dell’Illuminismo e con i più alti temi del cristianesimo è, in effetti uno dei motivi principali di originalità della riflessione di Ceruti e della sua visione della condizione umana. Visione, appunto - uso volutamente il termine perché questo propone Ceruti - una visione della «comunità di destino» che lega, a suo giudizio, oggi tutti gli uomini, e che oggi deve essere imperniata su un nuovo intreccio di diversità e identità, di unità e molteplicità nella prospettiva di una nuova universalità.
Aver proposto questa visione in un tempo come il nostro è, a mio giudizio, il maggior merito del libro. Naturalmente, una visione per non diventare esercizio retorico, deve poter appoggiarsi su forze storiche effettive sia politiche che spirituali, in grado di darle consistenza e sostanza. Individuarle, non era il problema di Ceruti, ma l’interrogativo resta aperto: su quali energie spirituali e politiche può contare oggi il progetto di cittadinanza planetaria che egli mette a fondamento della sua visione? E quali sono oggi le forze che possono impegnarsi nel rilancio della costruzione europea che egli auspica? È un cammino assai difficile. Può darsi che mi sbagli: ma oggi il vento della storia - in Europa e nel mondo - sembra soffiare in altre direzioni.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Bob Kennedy, la faccia morale dell’America finita nel sangue (di Furio Colombo)6 giugno 2018, di Federico La Sala
Bob Kennedy, la faccia morale dell’America finita nel sangue
Le lotte contro la segregazione razziale e le marce per i diritti dei latinos
di Furio Colombo (Il Fatto, 06.06.2018)
Quando cominci a parlare - nel mio caso, a riparlare - di Robert Kennedy, ti accorgi che qualcosa di diverso, di insolito e anche di difficile da spiegare, segna il ricordo e la riflessione, rispetto a ogni altro politico. Per esempio, con Robert Kennedy sei entrato nella segregazione razziale che conosceva ancora il linciaggio, e sei uscito in un mondo di diritti ottenuto con una sfida che è stata insieme di popolo e di governo, di grandi manifestazioni di massa combattute contro una polizia accanitamente ostile (cani lupo, bastoni e pompe d’acqua), ma con a fianco un ministro della Giustizia disposto, con le truppe federali, a tener testa a un governatore che aveva già schierato la sua guardia nazionale intorno alla sua università segregata. Il governatore Wallace, a gambe divaricate, davanti al portone da non valicare, ha spiegato: “Sono stato eletto per questo”. Il ministro della Giustizia, Robert Kennedy, ha risposto. “Sei stato eletto giurando sulla Costituzione”. Kennedy ha precisato che un’Alabama fuori dalla Costituzione sarebbe stato anche fuori dagli Strati Uniti. Quella stessa sera il primo afroamericano ha fatto il suo ingresso nell’università fino ad allora segregata.
Questo episodio, come tanti durante la lotta per i diritti civili, ci dice molto della tenacia e della forza morale di Robert Kennedy. Ma voglio far notare che ho detto forza morale, non forza politica. Politicamente Kennedy non era né più grande né più forte dei suoi elettori democratici al Congresso e nel Paese.
Tutti sapevano tutto dell’esclusione e umiliazione dei neri, e non avevano, fino a quel momento, mosso un dito. Ma durante la lotta per i diritti civili, che ha visto il governo americano (in prima fila il ministro della Giustizia) schierato dalla parte degli umiliati e offesi, è emerso un aspetto nuovo, unico e breve nella politica americana: la forza morale. Comincia qui la presenza di un fatto nuovo di cui è rappresentante e portatore Robert Kennedy. Non è la politica che affronta il problema della spaccatura razziale del Paese, non saprebbe come e non può perché.
Il conflitto nasce completamente fuori dalla politica, e - attraverso la voce di Martin Luther King -, diventa la grande questione morale. Robert Kennedy la raccoglie e capisce che quella è la strada che va al di là del razzismo, al di là della vita dei poveri, al di là delle disuguaglianze mortali. E, poco dopo, al di là e contro la guerra nel Vietnam.
Robert Kennedy si rende conto di essere entrato (fin dall’uccisione di suo fratello) nell’area della non convenienza, che dissuade ogni politico, nell’area del pericolo, perché ti opponi troppo a troppe cose che hanno un peso (e un costo) troppo grande. La sua immagine, sempre più amata e seguita da masse di giovani, si contrappone a volti e poteri non visibili.
Il fenomeno strano, che resta unico nella nostra memoria, è che “la sua strada sbagliata” (cito il senatore Humphrey, democratico e amico di famiglia che rimproverava a Robert Kennedy) gli porta un successo popolare immenso che, subito prima di essere ucciso, ha travolto l’America.
Ho vissuto giorno per giorno quell’ultimo periodo di febbre affettuosa ed entusiasta, una febbre sempre più grande. Ho partecipato, giorno per giorno, all’ultima campagna elettorale di Robert Kennedy e ricordo, ogni sera, le mani piagate da decine di migliaia di strette di mano.
Ma adesso, mentre ne scrivo nel giorno dell’anniversario del suo assassinio, non riesco a non ricordare un altro evento di cui Robert Kennedy è stato protagonista. È accaduto due anni prima. L’ex ministro della Giustizia si era messo alla testa di una lunga marcia dei raccoglitori di uva messicani, portati in California come clandestini, per raccogliere l’uva di immense coltivazioni per paghe inesistenti. La marcia a piedi partiva da El Centro e arrivava a Sacramento, e accanto a Robert Kennedy c’era Cesar Chavez, improvvisato sindacalista dei contadini senza paga, uomo intelligente e analfabeta, capace di tener testa alle televisioni in modo da coinvolgere l’intera America in un famoso “sciopero dell’uva”.
Ecco, ripensando e rivedendo la testa del giovane leader assassinato, mentre viene scrutata dai flash e dalle telecamere, sul pavimento dell’Hotel Ambassador, mi ricordo di quella marcia in cui Robert Kennedy e Cesar Chavez parlavano insieme alla folla, l’uno nello spagnolo dei campi, l’altro nel suo inglese di Harvard. E mi domando: può esistere una santità laica? E come mai, adesso, il luogo in cui viviamo (dall’America di Kennedy all’Italia di Spinelli e Colorni) sia diventato un mondo carogna, con le frontiere di filo spinato a lama di rasoio, in modo che i bambini con la faccia sfregiata siano i primi a imparare che le frontiere non si attraversano?
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - Le contraddizioni della competitività. L’alternativa è secca: o un «nuovo patto sociale per lo sviluppo» o l’implosione dell’eurozona..1 giugno 2018, di Federico La Sala
Cultura
Europa, le contraddizioni della competitività
SAGGI. «Chi non rispetta le regole?», il libro di Sergio Cesaratto edito da Imprimatur
di Michele Prospero (il manifesto, 01.06.2018)
Il nodo di una valutazione storico-realistica dell’esperienza dell’eurozona pare ormai ineludibile. Una riconsiderazione la impone anche il duello distruttivo in corso tra tecnocrazie, che scontano una crisi di consenso sociale sempre più accentuata verso la stagione neoliberista, e populismi, che con simbologie ingannevoli si proclamano gli autentici interpreti del vero sentire delle comunità invase da religioni altre e oppresse da burocrati privi di ogni legittimità.
Quello che manca nel dibattito pubblico contemporaneo, proprio mentre i paesi più fragili precipitano sull’orlo di una grave crisi costituzionale, è una riflessione disincantata sul rendimento effettivo della architettura dell’Europa e, con essa, una chiara indicazione dei pilastri essenziali della riprogettazione di un altro modello politico e sociale.
Lo sforzo che Sergio Cesaratto porta avanti nel suo recente volume (Chi non rispetta le regole?, Imprimatur, pp.125, euro 14) ha il pregio di coniugare le categorie di un pensiero economico critico e le indicazioni di un approccio politico attento alle suggestioni del realismo che evita di assumere come plausibili mitici punti zero. In questo quadro, che è insieme critico e realistico, egli assume le regole sul serio, e ciò serve per svelare le ambiguità costitutive del modello, le aporie che ne scandiscono la genesi, e per mostrare il funzionamento distorto che esse hanno conosciuto per lunghi anni.
ADOTTATE originariamente con una certa dose di azzardo, riguardo l’effettiva ricaduta di taluni principi che imponevano ai diversi paesi una comune disciplina del vincolo esterno, le regole del gioco hanno mostrato nella loro esperienza empirica che l’eurozona doveva vedersela con il peso delle differenziazioni, del plusvalore di singole aree o nazioni. Cesaratto ritiene che i dati obiettivi rendano possibile indicare la sussistenza di regolarità funzionali ineludibili. Sotto il velo di ignoranza, che sempre accompagna il progetto delle origini, si nasconde la maturazione con il tempo di un rapporto asimmetrico in base al quale la confezione dei trattati e l’adozione della moneta unica si imbatte assai diversamente sulle compatibilità delle diverse economie e sul grado effettivo di influenza che la riserva agli Stati o alle economie più solide.
Il principio di potenza condona a taluni paesi la violazione di regole esistenti con la possibilità di reiterati scostamenti dai parametri che ad altri sono preclusi da una idolatria dei numeri sacri. E rende accettabile la condotta eccentrica del paese che impone ad altri sistemi economici un selettivo e costoso Berlino Consensus (mistica del rigore fiscale, politiche di bilancio restrittive) e che per sé ritiene opportuno convivere con un surplus di bilancio lucrato in esplicita contraddizione con i paletti concordati.
SU QUESTA REALE antinomia che vede la coesistenza di paesi centrali e di paesi periferici, i sovranisti inscenano i donchisciotteschi moti populistici. Al di là delle formule pittoresche, la realtà per Cesaratto è che «il modello tedesco è destabilizzante per le altre economie, le condanna a una eterna deflazione per evitare di essere sommerse dalle esportazioni tedesche e dai conseguenti debiti».
La proposta del libro è quella di sondare la riformabilità delle istituzioni comunitarie minate da una contraddizione scaturita dalla difficoltà di conciliare la realtà della «super competitività» tra le economie (dumping salariale) e il richiamo alla possibilità di momenti di cooperazione (politica economica, fiscale e monetaria). La necessità di un ripensamento delle regole del mercato della concorrenza operante in un quadro di istituzioni minime è rimarcata ormai da tutti.
C’è chi si limita ad adattamenti funzionali, con il completamento delle istituzioni della moneta unica, con fasi di ingegneria per l’unione bancaria e il monitoraggio dei fondi pubblici, per l’assicurazione sui depositi. Secondo Cesaratto occorre invece un «rinnovato riformismo progressista» che accantoni il «surreale Fiscal Compact» e determini politiche economiche continentali per il «recupero della domanda aggregata». L’alternativa è secca: o un «nuovo patto sociale per lo sviluppo» o l’implosione dell’eurozona.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -Non solo ombre nel contratto Lega-M5S. L’allarme rosso generalizzato su Savona segnale che si è toccato un nodo decisivo (di Geminello Preterossi)26 maggio 2018, di Federico La Sala
La critica all’Europa, non solo ombre nel contratto Lega-M5S
L’intervento. L’allarme rosso generalizzato su Savona è il segnale che si è toccato un nodo decisivo. Si mette in discussione l’assetto dell’eurozona e i danni causati alla democrazia
di Geminello Preterossi (il manifesto, 26.05.2018)
 ordinario di Filosofia del diritto e di Storia delle dottrine politiche all’Università di Salerno
ordinario di Filosofia del diritto e di Storia delle dottrine politiche all’Università di SalernoPer inciso, dire ciò non significa negare che di politiche serie per la sicurezza e la legalità ci sia bisogno, così come che sia necessaria una gestione politica della questione dell’immigrazione, che non va da sé, e implica soprattutto politiche sociali di sostegno, inserimento e integrazione, per disinnescare la bomba sociale delle periferie-ghetto e delle guerre tra poveri.
Ancora: un intervento sulle tasse è certamente giusto e augurabile per quello che riguarda i salari medio-bassi, ma la proposta del “contratto” premia i redditi alti, rovesciando un principio fondamentale, quello della progressività, fissato nella Costituzione (di cui giustamente si vuole affermare il primato, anche sui trattati europei, ma evidentemente non su questo punto).
Così come si potrebbe proseguire nello specifico indicando omissioni (una su tutte, la reintroduzione dell’articolo 18), qualche genericità, e alcune proposte condivisibili come quella sull’acqua pubblica.
Ma ci sono due punti, nell’accordo di governo che si profila, che sono da considerarsi dirimenti, e in senso positivo: la messa in discussione per davvero del vincolo esterno (e nella prima bozza, che tanto scandalo ha suscitato, la cosa era detta in maniera ancora più chiara e netta); un intervento significativo sulla nuova questione sociale, contro disoccupazione e impoverimento, sul cui profilo complessivo si può discutere, ma che acquisisce un’indubbia valenza materiale e simbolica, attraverso l’introduzione del reddito di cittadinanza, investimenti pubblici “keynesiani” e la correzione della legge Fornero (legge che - lo vogliamo dire? - è stato un atto di violenza tecnocratica, oltre che di imperizia, considerando il disastro-esodati; poiché è un cavallo di battaglia di Salvini, dobbiamo far finta di niente e dire che va bene com’è?).
Mi colpisce molto, ma è assai rivelatore dei poteri antidemocratici che si sono messi in moto e della loro presa sul sistema mediatico, che ci si scandalizzi per l’eventuale nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia. Forse questo allarme rosso generalizzato è il segnale che si è toccato un nodo decisivo, dopo anni di cloroformio. In realtà, ciò che dovrebbe far riflettere è che certe verità fuori dal coro sull’eurozona, fondamentali per il futuro economico e sociale del nostro Paese, le dica con chiarezza un liberaldemocratico come Savona, dal pensiero autonomo, e non la sinistra (a parte alcuni grilli parlanti, che da tempo hanno cercato, inascoltati, di richiamare l’attenzione dei passeggeri del Titanic).
Non sarà dovuto, questo naufragio della sinistra, anche alla sua adesione cieca all’euro? E non è stato velleitario e irrealista limitarsi a vagheggiare un’altra Europa, senza porsi realisticamente il problema dei rapporti di forza, senza ragionare su un’alternativa, qualora la Germania, come credo, non accetti quell’unione politica della solidarietà - cioè dei trasferimenti interni, della condivisione del rischio-debito, degli eurobond - che sarebbe necessaria per sostenere l’impalcatura dell’euro senza costi sociali e democratici? Davvero l’idea di avere un “piano B” (come peraltro ha sostenuto anche Mélenchon) è così sbagliata? Eppure l’esperienza di Tsipras dovrebbe aver insegnato qualcosa anche a noi.
Le elezioni politiche italiane hanno confermato che la stabilizzazione (temporanea e più apparente che reale) dell’eurozona produce la destabilizzazione dei sistemi politici tradizionali: è il prezzo inevitabile delle politiche antisociali che la difesa fideistica dell’euro ha imposto e che le forze di sistema hanno assunto come un dogma. Guarda caso, negli ultimi tempi è tutto un profluvio di saggi “contro la democrazia”, i cui autori sono campioni dell’establishment neoliberale occidentale. Non sarà invece il caso di capire che certe parole d’ordine - sovranità popolare, sovranità dello Stato, critica del globalismo, difesa dei ceti popolari contro élites fallimentari e ciniche - debbono essere non rigettate, ma recuperate in chiave “costituzionale”? Certo, è un’operazione complessa, perché arriviamo tardi, e perché di quelle parole d’ordine si è appropriata, distorcendole, la destra. Ma riuscire a fare operazione culturali complesse, coraggiose e non equivoche, è la cifra della grande politica, quella che riesce ad aver presa sulla realtà.
Oggi la partita si gioca nel campo populista. Fuori c’è la spoliticizzazione (quella dell’elitismo tecnocratico e dell’europeismo di maniera, scollegato dalla realtà). L’obiettivo che abbiamo davanti (immane) dovrebbe essere, a mio avviso, quello di usare tatticamente un nuovo “populismo di sinistra” per rilanciare il conflitto sociale e una lotta egemonica.
Per fare questo, però, non serve demonizzare, ma distinguere. E soprattutto riconoscere coraggiosamente l’obiettivo rilievo sociale e politico di certe proposte (come quella del reddito di cittadinanza e del recupero di sovranità democratica contro l’establishment eurista), che hanno intercettato delle domande popolari che avrebbero potuto e dovuto essere raccolte da una sinistra di popolo, se solo ci fosse stata. E lasciamo le giaculatorie pro-euro ai corifei dei mercati.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - «Tacciano le armi in Medio Oriente». L’appello urgente contro la violenza in Palestina di un gruppo di personalità della cultura italiana.16 maggio 2018, di Federico La Sala
L’appello: «Tacciano le armi in Medio Oriente» *
Dopo la strage di Gaza. L’appello urgente contro la violenza in Palestina di un gruppo di personalità della cultura italiana . «Israele oggi assomiglia più a una fortezza che non a una casa», ha detto David Grossman aprendo, tre settimane fa, una cerimonia congiunta di commemorazione delle vittime del conflitto, israeliane e palestinesi, a Tel Aviv, in ebraico e in arabo.
In queste ore a Gaza sangue si aggiunge su sangue. Condividiamo il dolore delle vittime palestinesi. Noi sottoscritti, sostenitori del diritto di Israele ad esistere come stato entro confini legittimi, sicuri e riconosciuti, e ugualmente di quello dei palestinesi ad uno stato indipendente, guardiamo con estrema preoccupazione alle prime conseguenze, letali per le prospettive della pace, dello spostamento dell’ambasciata americana a Gerusalemme da parte dell’amministrazione Trump.
Non possiamo tacere di fronte all’uso sproporzionato della forza da parte di Israele. L’uso di armi da fuoco contro civili è ammissibile soltanto se detti civili partecipano direttamente ad azioni ostili, non se varcano o cercano di superare la frontiera con Israele. Vi sono mezzi non letali per contenere e disperdere proteste anche di massa.
Condanniamo la retorica fondamentalista di Hamas che non abbandona il rifiuto di Israele né desiste da una guerra di guerriglia che espone la gente di Gaza alla rappresaglia di Israele.
Chiediamo, soprattutto, che tacciano le armi e si cerchino ora e per il futuro, da parte di tutti, le vie politiche del dialogo, della conoscenza reciproca e della pace in tutta la regione.
- Hanno aderito tra gli altri
- Ruth Ben Ghiat, Edith Bruck, Donatella Calabi, Francesca Calabi, David Calef, Bruno Contini, Roberto Della Seta, Donatella Di Cesare, Anna Foa, Carlo Ginzburg, Lisa Ginzburg, Siegmund Ginsberg, Agostino Giovagnoli, Wlodek Goldkorn, Giorgio Gomel, Helena Janeczek, Gad Lerner, Simon Levis Sullam, Laura Mincer, Paolo Pezzino, Alessandro Portelli, Adriano Prosperi, Gigi Riva, Michele Sarfatti, Roberto Saviano, Bruno Segre, Maria Stone, Susanna Terracina, Alessandro Treves, Nadia Urbinati
 Per adesioni: taccianoarmiMO@gmail.com
Per adesioni: taccianoarmiMO@gmail.com -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" -- Israele ha la Bomba, non l’Iran. Gli alleati europei degli Usa, che formalmente continuano a sostenere l’accordo con l’Iran, sono sostanzialmente schierati con Israele.15 maggio 2018, di Federico La Sala
Israele, 200 armi nucleari puntate sull’Iran
di Manlio Dinucci (il manifesto, 15.05.2018)
La decisione degli Stati uniti di uscire dall’accordo sul nucleare iraniano - stipulato nel 2015 da Teheran con i 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu più la Germania - provoca una situazione di estrema pericolosità non solo per il Medio Oriente.
Per capire quali implicazioni abbia tale decisione, presa sotto pressione di Israele che definisce l’accordo «la resa dell’Occidente all’asse del male guidato dall’Iran», si deve partire da un fatto ben preciso: Israele ha la Bomba, non l’Iran.
Sono oltre cinquant’anni che Israele produce armi nucleari nell’impianto di Dimona, costruito con l’aiuto soprattutto di Francia e Stati Uniti. Esso non viene sottoposto a ispezioni poiché Israele, l’unica potenza nucleare in Medioriente, non aderisce al Trattato di non-proliferazione delle armi nucleari, che invece l’Iran ha sottoscritto cinquant’anni fa.
Le prove che Israele produce armi nucleari sono state portate oltre trent’anni fa da Mordechai Vanunu, che aveva lavorato nell’impianto di Dimona: dopo essere state vagliate dai maggiori esperti di armi nucleari, furono pubblicate dal giornale The Sunday Times il 5 ottobre 1986.
Vanunu, rapito a Roma dal Mossad e trasportato in Israele, fu condannato a 18 anni di carcere duro e, rilasciato nel 2004, sottoposto a gravi restrizioni. Israele possiede oggi (pur senza ammetterlo) un arsenale stimato in 100-400 armi nucleari, tra cui mini-nukes e bombe neutroniche di nuova generazione, e produce plutonio e trizio in quantità tale da costruirne altre centinaia.
Le testate nucleari israeliane sono pronte al lancio su missili balistici, come il Jericho 3, e su cacciabombardieri F-15 e F-16 forniti dagli Usa, cui si aggiungono ora gli F-35. Come confermano le numerose ispezioni della Aiea, l’Iran non ha armi nucleari e si impegna a non produrle sottoponendosi in base all’accordo a stretto controllo internazionale. Comunque - scrive l’ex segretario di stato Usa Colin Powell il 3 marzo 2015 in una email venuta alla luce - «quelli a Teheran sanno bene che Israele ha 200 armi nucleari, tutte puntate su Teheran, e che noi ne abbiamo migliaia».
Gli alleati europei degli Usa, che formalmente continuano a sostenere l’accordo con l’Iran, sono sostanzialmente schierati con Israele. La Germania gli ha fornito quattro sottomarini Dolphin, modificati così da poter lanciare missili da crociera a testata nucleare. Germania, Francia, Italia, Grecia e Polonia hanno partecipato, con gli Usa, alla più grande esercitazione internazionale di guerra aerea nella storia di Israele, la Blue Flag 2017.
L’Italia, legata a Israele da un accordo di cooperazione militare (Legge n. 94, 2005), vi ha partecipato con caccia Tornado del 6° Stormo di Ghedi, addetto al trasporto delle bombe nucleari Usa B-61 (che tra non molto saranno sostituite dalle B61-12). Gli Usa, con F-16 del 31st Fighter Wing di Aviano, addetti alla stessa funzione.
Le forze nucleari israeliane sono integrate nel sistema elettronico Nato, nel quadro del «Programma di cooperazione individuale» con Israele, paese che, pur non essendo membro della Alleanza, ha una missione permanente al quartier generale della Nato a Bruxelles. Secondo il piano testato nella esercitazione Usa-Israele Juniper Cobra 2018, forze Usa e Nato arriverebbero dall’Europa (soprattutto dalle basi in Italia) per sostenere Israele in una guerra contro l’Iran.
Essa potrebbe iniziare con un attacco israeliano agli impianti nucleari iraniani, tipo quello effettuato nel 1981 a Osiraq in Iraq. In caso di rappresaglia iraniana, Israele potrebbe far uso di un’arma nucleare mettendo in moto una reazione a catena dagli esiti imprevedibili.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- In un solo “interminabile” decennio, dalla difesa della razza (1938) alla difesa dei diritti (1948). Il futuro deve essere orientato diversamente nel solco dei diritti inalienabili.5 maggio 2018, di Federico La Sala
Una commissione contro il razzismo
di Liliana Segre (la Repubblica, 05.05.2018)
Cari ragazzi e ragazze della Nuova Europa, ci sono molti modi per impegnarsi, efficacemente, nella materia, enorme e delicata, della discriminazione, ed io non cerco scorciatoie. Per dirla con parole antiche (Giambattista Vico) i rischi di una deriva autoritaria sono sempre dietro l’angolo. Lui, l’autore dei corsi e ricorsi storici, aveva visto lungo. Arrivo subito al punto consegnando a voi, che siete su un’isola, un “messaggio in bottiglia”: il mio primo atto parlamentare.
Intendo infatti depositare nei prossimi giorni un disegno di legge che istituirà una Commissione parlamentare d’indirizzo e controllo sui fenomeni dell’intolleranza, razzismo, e istigazione all’odio sociale. Si tratta di raccogliere un invito del Consiglio d’Europa a tutti i paesi membri, ed il nostro Paese sarebbe il primo a produrre soluzioni e azioni efficaci per contrastare il cosiddetto hate speech.
Questo primo passo affianca la mozione che delibera, anche in questa legislatura ( la mia firma segue quella della collega Emma Bonino) la costituzione di una Commissione per la tutela e l’affermazione dei diritti umani. C’è poi il terzo anello del discorso, l’argomento che più mi sta a cuore e che coltivo con antica attitudine: l’insegnamento in tutte le scuole di ogni ordine e grado della storia del ‘900. In una recentissima intervista, la presidentessa dell’Anpi, Carla Nespolo, ha insistito sullo stesso punto: «La storia va insegnata ai ragazzi e alle ragazze perché raramente a scuola si arriva a studiare il Novecento e in particolare la seconda guerra mondiale. Ma soprattutto non si studia che cosa ha significato per interi popoli europei vivere sotto il giogo nazista e riconquistare poi la propria libertà». Ora che le carte sono in tavola rivolgo a voi un invito molto speciale.
Un appello per una rifondazione dell’Europa, minacciata da “autoritarismi e divisioni” che segnalano l’emergere di una sorta di “nuova guerra civile europea”.
Il vento che attraversa l’Europa non è inarrestabile. Riprendete in mano le carte che ci orientano, che sono poche ma buone: in quelle righe sono scolpiti i più alti principi della convivenza civile, spetta a voi battervi perché trovino applicazione: grazie alla nostra Costituzione (70 anni fa) siamo entrati nell’età dei diritti e gli articoli 2 e 3 della Carta sono lì a dimostrarlo, il passaporto per il futuro.
La carta europea dei diritti fondamentali (che ha lo stesso valore dei trattati) è l’elevazione a potenza europea di questi principi, intrisi di libertà ed eguaglianza che abbiamo, orgogliosamente, contribuito a esportare.
Se vogliamo impastare i numeri con la memoria direi che siamo passati, in un solo “interminabile” decennio, dalla difesa della razza (1938) alla difesa dei diritti (1948). Il futuro deve essere orientato diversamente nel solco dei diritti inalienabili ecco perché, concedetemi la citazione, a cinquant’anni dal suo assassinio, Martin Luther King diceva che occorre piantare il melo anche sotto le bombe. È questo il momento giusto!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - Un dio chiamato Capitale. La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria (di Massimo Cacciari).2 maggio 2018, di Federico La Sala
Due secoli di Marx
Un dio chiamato Capitale
Non è stata l’economia politica il cuore della rivoluzione del grande pensatore. Ma l’Economico come categoria dello spirito. La vera potenza che mette all’opera il mondo
di Massimo Cacciari (l’espresso, 29.04.2018)
Tacete economisti e sociologi in munere alieno. Marx non è affare vostro, o soltanto di quelli di voi che ne comprendano la grandezza filosofica, anzi: teologico-filosofica. Marx sta tra i pensatori che riflettono sul destino dell’Occidente, tra gli ultimi a osare di affrontarne il senso della storia. In questo è paragonabile forse soltanto a Nietzsche. Ma “Il Capitale”, si dirà? Non è l’economia politica al centro della sua opera? No; è la critica dell’economia politica. Che vuol dire? Che l’Economico vale per Marx come figura dello Spirito, come espressione della nuova potenza che lo incarna nel mondo contemporaneo. L’Economico è per Marx ciò che sarà la Tecnica per Heidegger: l’energia che informa di sé ogni forma di vita, che determina il Sistema complessivo delle relazioni sociali e politiche, che fa nascere un nuovo tipo di uomo. Nessuna struttura cui si aggiungerebbe una sovra-struttura a mo’ di inessenziale complemento - l’Economico è immanente in tutte le forme in cui l’agire e il pensare si determinano; ognuna di esse è parte necessaria dell’intero.
Marx è pensatore del Tutto, perfettamente fedele in questo al suo maestro Hegel. Il Sistema è più delle parti, irriducibile alla loro somma. Chi intende l’Economico come una struttura a sé, autonoma, che determinerebbe meccanicisticamente le altre, non ha capito nulla di Marx. Marx non è pensatore astratto, e cioè non astrae mai l’Economico dall’intero sistema delle relazioni sociali, culturali, politiche.
La sua domanda è: quale potenza oggi governa l’Intero e come concretamente essa si esprime in ogni elemento dell’Intero? L’Economico è infinitamente più che Economico. Esso rappresenta nel contemporaneo la potenza che mette all’opera il mondo.
 Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.
Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.Per Marx è questo il “nuovo mondo” che il sistema di produzione capitalistico crea, non certo dal nulla, ma certo sconvolgendo dalle radici forme di vita e relazioni sociali, insomma: l’ethos dell’Occidente, la “sede” in cui l’Occidente aveva ino ad allora abitato È il mondo dove il Logos della forma-merce si incarna in ogni aspetto della vita, per diventarne la religione stessa. E Marx ne esalta l’impeto rivoluzionario. È questo impeto che per lui va seguito, al suo interno è necessario collocarsi per comprenderne le contraddizioni e prevederne scientificamente l’aporia, e cioè dove la strada che esso ha aperto è destinata a interrompersi - per il salto a un altro mondo. Qui bisogna intendere bene: la contraddizione non viene da fuori, da qualcosa che sia “straniero” al Sistema.
Contraddittorio in sé è il capitalismo stesso. Il capitalismo è crisi, è fatto di crisi. Funziona per salti, che ogni volta mettono inevitabilmente in discussione gli equilibri raggiunti. Non vi è riproduzione senza innovazione. Questo è noto anche agli economisti.
 Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.
Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.
 È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.
È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.Questa contraddizione muove tutto. E ognuno è imbarcato in essa. L’idea di poterne giudicare “dall’alto” costituisce per l’appunto quella ideologia, che Marx sottopone a critica in dalle prime opere. Se la realtà dell’epoca è contraddizione inscindibilmente economica e politica, ogni interpretazione che la riduca a fatti naturalisticamente analizzabili la mistifica. Non è possibile cogliere la realtà del Sistema che collocandosi in esso, e dunque collocandosi nella contraddizione. Soltanto in questa prospettiva l’Intero è afferrabile. Non si comprende la realtà del presente se non in prospettiva e perciò a partire da un punto di vista determinato. Impossibile oggi un sapere astrattamente neutrale. La pretesa all’avalutatività è falsamente scientifica; l’epoca costringe a prender-parte, all’aut-aut. A porsi in gioco, alla scommessa anche. Il momento, o il kairòs, della decisione politica viene cosi a far parte della stessa potenza dell’Economico, resta immanente in essa.
 È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.
È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.Poiché concepisce la storia dell’Occidente come conflitto, e conflitto determinato dal suo carattere di classe, e poiché intende il presente alla luce dell’intrinseca contraddittorietà della stessa potenza rivoluzionaria del Sistema tecnico-economico, Marx pensa di aver posto saldamente sui piedi il pensiero dialettico dell’idealismo. Le epoche della Fenomenologia hegeliana dello Spirito non trovano conclusione in un Sapere assoluto che tutte accoglie e accorda, in una suprema Conciliazione, ma nella insuperabile contraddizione tra la potenza universale del Lavoro produttivo divenuto cosciente di sé e la sua appropriazione capitalistica. Si tratta di ben altro che di calcoli su valore e plusvalore.
 L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?
L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?
 Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.
Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.
 Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.
Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.
 La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.
La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
>RIPENSARE L’EUROPA. La buona-esortazione del BRASILE -- LULA. Siamo di fronte a quello che Cesare Beccaria, in «Dei delitti e delle pene», chiamò «processo offensivo» dove «il giudice», anziché «indifferente ricercatore del vero», «diviene nemico del reo» (Luigi Ferrajoli).7 aprile 2018, di Federico La Sala
Un’aggressione giudiziaria alla democrazia brasiliana
Lula. Siamo di fronte a quello che Cesare Beccaria, in «Dei delitti e delle pene», chiamò «processo offensivo» dove «il giudice», anziché «indifferente ricercatore del vero», «diviene nemico del reo»
di Luigi Ferrajoli (il manifesto, 07.04.2018)
Il 4 aprile è stata una giornata nera per la democrazia brasiliana. Con un solo voto di maggioranza, il Supremo Tribunal Federal ha deciso l’arresto di Inacio Lula nel corso di un processo disseminato di violazioni delle garanzie processali. Ma non sono solo i diritti del cittadino Lula che sono state violati.
L’intera vicenda giudiziaria e le innumerevoli lesioni dei principi del corretto processo di cui Lula è stato vittima, unitamente all’impeachment assolutamente infondato sul piano costituzionale che ha destituito la presidente Dilma Rousseff, non sono spiegabili se non con la finalità politica di porre fine al processo riformatore che è stato realizzato in Brasile negli anni delle loro presidenze. E che ha portato fuori della miseria 50 milioni di brasiliani. L’intero assetto costituzionale è stato così aggredito dalla suprema giurisdizione brasiliana, che quell’assetto aveva invece il compito di difendere.
Il senso non giudiziario ma politico di tutta questa vicenda è rivelato dalla totale mancanza di imparzialità dei magistrati che hanno promosso e celebrato il processo contro Lula. Certamente questa partigianeria è stata favorita da un singolare e incredibile tratto inquisitorio del processo penale brasiliano: la mancata distinzione e separazione tra giudice e accusa, e perciò la figura del giudice inquisitore, che istruisce il processo, emette mandati e poi pronuncia la condanna di primo grado: nel caso Lula la condanna pronunciata il 12 luglio 2017 dal giudice Sergio Moro a 9 anni e 6 mesi di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici per 19 anni, aggravata in appello con la condanna a 12 anni e un mese. Ma questo assurdo impianto, istituzionalmente inquisitorio, non è bastato a contenere lo zelo e l’arbitrio dei giudici. Segnalerò tre aspetti di questo arbitrio partigiano.
Il primo aspetto è la campagna di stampa orchestrata fin dall’inizio del processo contro Lula e alimentata dal protagonismo del giudice di primo grado, il quale ha diffuso atti coperti dal segreto istruttorio e ha rilasciato interviste nelle quali si è pronunciato, prima del giudizio, contro il suo imputato, alla ricerca di un’impropria legittimazione: non la soggezione alla legge, ma il consenso popolare.
L’anticipazione del giudizio ha inquinato anche l’appello. Il 6 agosto dell’anno scorso, in un’intervista al giornale Estado de Sao Paulo, il Presidente del Tribunale Regionale Superiore della 4^ regione (TRF-4) di fronte al quale la sentenza di primo grado era stata impugnata ha dichiarato, prima del giudizio, che tale sentenza era «tecnicamente irreprensibile».
Simili anticipazioni di giudizio, secondo i codici di procedura di tutti i paesi civili, sono motivi ovvi e indiscutibili di astensione o di ricusazione, dato che segnalano un’ostilità e un pregiudizio incompatibili con la giurisdizione. Siamo qui di fronte a quello che Cesare Beccaria, in Dei delitti e delle pene, chiamò «processo offensivo», dove «il giudice», anziché «indifferente ricercatore del vero», «diviene nemico del reo», e «non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia e crede di perdere se non vi riesce».
Il secondo aspetto della parzialità dei giudici e, insieme, il tratto tipicamente inquisitorio di questo processo consistono nella petizione di principio, in forza della quale l’ipotesi accusatoria da provare, che dovrebbe essere la conclusione di un’argomentazione induttiva suffragata da prove e non smentita da controprove, forma invece la premessa di un procedimento deduttivo che assume come vere solo le prove che la confermano e come false quelle che la contraddicono.
Di qui l’andamento tautologico del ragionamento probatorio, nel quale la tesi accusatoria funziona da criterio di orientamento delle indagini, da filtro selettivo della credibilità delle prove e da chiave interpretati va dell’intero materia le processuale. I giornali brasiliano hanno riferito, per esempio, che l’ex ministro Antonio Pallocci, in stato di custodia preventiva, aveva tentato nel maggio scorso una «confessione premiata» per ottenere la liberazione, ma la sua richiesta era stata respinta perché egli non aveva formulato nessuna accusa contro Lula e la Rousseff ma solo contro il sistema bancario.
Ebbene, questo stesso imputato, il 6 settembre, di fronte ai procuratori, ha fornito la versione gradita dall’accusa per ottenere la libertà. Totalmente ignorata è stata al contrario la deposizione di Emilio Olbrecht, che il 12 giugno aveva dichiarato al giudice Moro di non aver mai donato alcun immobile all’Istituto Lula, secondo quanto invece ipotizzato nell’accusa di corruzione.
Il terzo aspetto della mancanza di imparzialità è costituito dal fatto che i giudici hanno affrettato i tempi del processo per giungere quanto prima alla condanna definitiva e così, in base alla legge «Ficha limpia», impedire a Lula, che è ancora la figura più popolare del Brasile, di candidarsi alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre. Anche questa è una pesante interferenza della giurisdizione nella sfera della politica, che mina alla radice la credibilità della giurisdizione.
E’ infine innegabile il nesso che lega gli attacchi ai due presidenti artefici dello straordinario progresso sociale ed economico del Brasile - l’infondatezza giuridica della destituzione di Dilma Rousseff e la campagna giudiziaria contro Lula - e che fa della loro convergenza un’unica operazione di restaurazione antidemocratica. E’ un’operazione alla quale i militari hanno dato in questi giorni un minaccioso appoggio e che sta spaccando il paese, come una ferita difficilmente rimarginabile.
L’indignazione popolare si è espressa e continuerà ad esprimersi in manifestazioni di massa. Ci sarà ancora un ultimo passaggio giudiziario, davanti al Superior Tribunal de Justicia, prima dell’esecuzione dell’incarcerazione. Ma è difficile, a questo punto, essere ottimisti.
Lula resta tra i suoi sostenitori: «Vengano qui ad arrestarlo»
Brasile. L’ex presidente brasiliano nella sede del sindacato metalmeccanici. Ore concitate a San Paolo, Sem terra e Sem tetto pronti a circondare l’edificio: «Non un passo indietro, difendiamo la democrazia»
di Claudia Fanti (il manifesto, 07.04.2018)
Sono ore febbrili quelle che si stanno vivendo, mentre il giornale va in stampa, presso la sede del sindacato dei metalmeccanici di São Paulo, a São Bernando do Campo, dove l’ex presidente brasiliano Lula si è recato nella serata di giovedì, dopo l’emissione del mandato di cattura da parte del giudice Sérgio Moro.
SEMBRA ORMAI CERTO che Lula decida di non costituirsi, respingendo così la richiesta in base a cui, «in considerazione della dignità della carica svolta in passato», avrebbe potuto presentarsi volontariamente, entro le 17.00» (le nostre 22.00) di ieri, alla sede della Polizia federale di Curitiba, dove a Lula è stata preparata, per l’inizio dell’esecuzione della pena, una «cella riservata» nella quale, si legge nel decreto di arresto, l’ex presidente «sarà separato dagli altri detenuti, senza alcun rischio per la sua integrità fisica e morale».
«Costituirsi è un’ammissione di colpa, e non è questo il caso», ha commentato il senatore del Pt Lindbergh Farias, convinto della necessità «che vengano a prenderlo qui, in mezzo a questo mare di gente», perché sia evidente agli occhi del mondo «la vergogna» dell’«illegale detenzione di Lula».
SONO IN MIGLIAIA, infatti, i sostenitori accorsi a São Bernando do Campo, a cominciare dai militanti del Movimento dei senza tetto e del Movimento dei senza terra, decisi a circondare la sede del sindacato per impedire l’arresto del presidente. Non a caso l’hasthag #OcupaSaoBernardo appare come il quinto dei trending topics di Twitter nel mondo.
Ed è una «resistenza democratica» quella che ha promesso il pre-candidato presidenziale del Partito socialismo e libertà (Psol) Guilherme Boulos: «Stare qui oggi - ha detto - è stare dalla parte della democrazia. E la storia giudicherà chi si è schierato da un lato e chi dall’altro». E ha assicurato: «Non ci muoveremo di un passo. Ancora una volta, questo sindacato sarà una trincea della democrazia in questo Paese». E non sarà il solo, considerando che in queste ore si stanno attivando manifestazioni di protesta e blocchi stradali in tutto il Paese.
CHE SI TRATTI DI INGIUSTIZIA lo conferma anche la velocità lampo con cui, nei confronti d Lula, ha agito la sempre assai lenta giustizia brasiliana. Neppure si è atteso, per decretare l’arresto, che i legali dell’ex presidente presentassero gli ultimi possibili ricorsi presso il Tribunale federale regionale di Porto Alegre (Trf-4), qualificati sprezzantemente da Moro come «un patologico tentativo di procrastinazione che dovrebbe essere eliminato dal mondo giuridico». E sempre con estrema rapidità il Tribunale superiore di giustizia ha respinto il nuovo ricorso d’urgenza presentato dagli avvocati dell’ex presidente perché venisse sospeso il mandato emesso dal giudice Moro, perché in anticipo rispetto alla conclusione dell’iter processuale presso il Trf-4.
È ANCHE POSSIBILE, del resto, che la detenzione di Lula duri appena pochi giorni. La questione della costituzionalità o meno dell’arresto dopo la condanna in secondo grado non è stata affatto risolta con la decisione del Supremo tribunale federale di respingere l’habeas corpus presentato dai legali dell’ex presidente.
IL MINISTRO MARCO AURÉLIO Mello, uno dei cinque che hanno votato a favore di Lula e il più critico nei confronti della «strategia» della presidente della Corte suprema Cármen Lúcia, ha annunciato infatti di voler proporre al plenario del Stf, nella sessione di mercoledì 11, l’analisi di un provvedimento di urgenza diretto a impedire l’arresto dei condannati in secondo grado. A richiederlo sono stati i noti avvocati Antônio Carlos de Almeida Castro, Cláudio Pereira de Souza Neto e Ademar Borges de Sousa Filho, secondo i quali «nessuno può restituire agli individui i giorni passati in carcere in maniera illegittima».
Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dai tre avvocati già nel 2016 (ma all’epoca respinta dal Stf), in cui si invocava il rispetto di un articolo del Codice di procedura penale che vieta l’arresto prima che la sentenza passi in giudicato, viene oggi proposta una soluzione intermedia: che l’inizio dell’esecuzione della pena avvenga dopo l’analisi dei ricorsi da parte del Superiore tribunale di giustizia, il terzo grado di giudizio.
-
> RIPENSARE L’EUROPA. La buona-esortazione del BRASILE -- L’ex presidente brasiliano Lula si è consegnato alla polizia.8 aprile 2018, di Federico La Sala
Brasile: Lula si è consegnato alla polizia
L’ex presidente brasiliano, condannato a 12 anni di carcere per corruzione, aveva già tentato di lasciare l’edificio, ma i suoi sostenitori glielo avevano impedito *
L’ex presidente brasiliano Lula si è consegnato alla polizia. Ha lasciato a piedi la sede del sindacato ed è salito su un’auto delle forze dell’ordine. Lo riportano i media locali.
Lula alle 18.40 locali ha lasciato a piedi il quartiere generale del sindacato metallurgico dove era barricato da giorni, ha attraversato un vicolo ed è salito su un’auto della polizia federale che lo aspettava lì vicino. L’ex presidente brasiliano aveva tentato di lasciare l’edificio circa due ore prima, ma i suoi sostenitori glielo avevano impedito, costringendolo a rientrare. Lula è stato condannato a 12 anni di carcere per corruzione.
-
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - Combattere la solidarietà verso profughi e «stranieri» non la rafforza tra i «nativi». La storia del secolo scorso ci ha insegnato che questo è un piano inclinato da cui è sempre più difficile risalire (Guido Viale).4 aprile 2018, di Federico La Sala
Ecco come sarà l’Italia in mano ai razzisti
di Guido Viale (il manifesto, 04.04.2018)
Come sarà l’Italia in mano a partiti razzisti? Cominciamo a chiedercelo. Combattere la solidarietà verso profughi e «stranieri» non la rafforza tra i «nativi», ma distrugge anche quella: promuove sospetto, invidia, insensibilità per le sofferenze altrui, crudeltà. E affida «pieni poteri» a chi governa: non solo per reprimere e tener lontane le persone sgradite, ma anche per giudicare sgradite tutte quelle che non obbediscono. La società che respinge e perseguita gli stranieri non può che essere autoritaria, intollerante, violenta.
La storia del secolo scorso ci ha insegnato che questo è un piano inclinato da cui è sempre più difficile risalire. Ma che risultati possono raggiungere i governi impegnati a fare «piazza pulita» di profughi e migranti? Nessuno. La pressione dei profughi sull’Europa continuerà, perché continueranno a peggiorare le condizioni ambientali dei paesi da cui centinaia di migliaia di esseri umani sono costretti a fuggire a causa del saccheggio delle loro risorse e dei cambiamenti climatici che colpiscono soprattutto i loro territori. Quel degrado ambientale è anche la causa principale delle guerre che creano ulteriori «flussi» di profughi: quando le risorse disponibili si riducono, la lotta per accaparrarsele si fa più feroce.
«Aiutiamoli a casa loro» non vuol dire niente: chi mai li dovrebbe aiutare? Le multinazionali che saccheggiano le loro risorse? I tiranni e i governi corrotti che si appropriano di quel che resta? Le popolazioni locali che non hanno la forza per scrollarsi di dosso quei gioghi? Nessuno di loro, ovviamente; solo la volontà di far ritorno nel proprio paese può rendere coloro che ne sono dovuti fuggire i «catalizzatori» di una rigenerazione sociale e ambientale delle terre dove sono rimaste le loro comunità d’origine.
A condizione che profughi e migranti siano accolti bene; messi in condizione di collegarsi tra loro, di organizzarsi, di consolidare legami con cittadini e cittadine europee, di mettere a punto e far valere insieme a loro programmi di pacificazione dei rispettivi paesi e di contenimento e di inversione del loro degrado.
Niente di tutto ciò è prospettato o perseguito da chi ha ripetuto fino alla nausea «aiutiamoli a casa loro»; e meno che mai verrà fatto da chi ha fatto campagna elettorale promettendo di cacciare i «clandestini» dall’Italia. Quella politica, che abbiamo già vista all’opera con il ministro Minniti, non ha fermato gli sbarchi né li fermerà. Perché, anche se tutte le navi delle Ong solidali e delle marine europee venissero messe nell’impossibilità di operare, l’obbligo di salvare chi è in pericolo in mare resterà in capo ai mercantili in transito, come accadeva prima del programma Mare Nostrum; e il porto di sbarco non potrà che essere in Italia. In compenso ci sono stati e ci saranno sempre più morti, sia in mare che nel deserto; che resteranno per sempre sulla coscienza di chi non fa niente per cercare di garantire ai vivi una via di transito sicura verso l’Europa.
Ma soprattutto ci saranno sempre più violenze, torture, ricatti, estorsioni, schiavismo, sia in Libia che in tutti i paesi in cui si sta cercando o si cercherà di bloccare il transito dei profughi. Respingere i profughi significa renderli schiavi e schiave di bande locali o spingerli a farsi reclutare nelle loro armate; il che moltiplicherà i conflitti e renderà tutti i territori dell’Africa e del Medio Oriente infrequentabili per gli europei, sia turisti che tecnici o uomini d’affari. Il modo più sicuro per strangolare sia l’economia europea che le loro.
Ma che sarà, poi, di coloro che sono già in Italia, o in Europa, come «clandestini»? Espellerli tutti è impossibile: costerebbe troppo e chi continua a prometterlo lo sa benissimo.
D’altronde, nessun governo dei paesi di provenienza è disposto ad accoglierli e anche quelli che firmano accordi in tal senso (in cambio molto denaro) non li rispetteranno: quei rimpatriati a forza creerebbero solo problemi. Quei respingimenti li si può fare, o far fare, solo verso la Libia o verso paesi ridotti nello stesso stato: campi di prigionia e tortura a disposizione di un’Europa trasformata in fortezza.
Per questo i migranti «irregolari» resteranno qui, condannati a una clandestinità permanente, che significa costringere centinaia di migliaia di uomini e donne a delinquere, prostituirsi, farsi reclutare dalla criminalità organizzata di casa in molti ambienti politici (soprattutto quelli che più strillano contro il loro arrivo) e anche tra non pochi addetti all’ordine pubblico. È questo, e non l’arrivo di nuovi profughi, a creare quello stato di insicurezza che i nemici dell’accoglienza e della solidarietà dicono di combattere. Essere sempre più feroci con i profughi non fa che peggiorare la situazione; il che fa molto comodo a quei governi europei che già contano di usare l’Italia come discarica dei migranti che non vogliono accogliere, come noi stiamo usando la Libia.
Ma in Europa ci sono già decine di milioni di immigrati, recenti e no, molti anche già «naturalizzati», cioè cittadini e cittadine europee, che da ogni nuova manifestazione di razzismo, o anche di semplice «rifiuto» dello straniero, sono indotti a viversi sempre più come un «corpo estraneo» nella società; e a covare quello spirito di rivalsa che porta alcuni a voler vendicare in qualsiasi modo le sofferenze inflitte ai loro connazionali o correligionari.
Non è un caso che foreign fighters e terroristi vengano quasi tutti da comunità già insediate in Europa.
Per fermarli non basta la polizia; non si possono controllare tutti. Bisogna prevenire; e lo si può fare solo con più rispetto sia per loro che per i loro connazionali in cerca di una vita nuova in Europa.
I partiti che hanno governato e quelli che governeranno nei prossimi anni sono chiusi a questo ascolto.
Né bastano i sermoni per aprirgliele. È dalla pratica attiva della solidarietà che nasce un nuovo modo di vivere.Ed è da una rete di tutti coloro che si impegnano in questo campo che può nascere un’alternativa reale - sociale, politica e culturale - al disastro in cui ci ha trascinato la politica attuale
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - Quel che è accaduto negli ultimi dieci anni ha progressivamente cancellato e depotenziato la vocazione post-nazionale, e ha portato a emergenza l’identità d’Europa come Nazione Bianca (di Franco Berardi Bifo).1 aprile 2018, di Federico La Sala
Europa Nazione
di Franco Berardi Bifo (Alfabeta-2, 1 aprile 2018)
L’Unione europea fu concepita come progetto post-nazionale. Solo una piccola minoranza dell’opinione europea (una minoranza fascista) parlò nei decenni passati di Europa come nazione. Quel che è accaduto negli ultimi dieci anni ha progressivamente cancellato e depotenziato la vocazione post-nazionale, e ha portato a emergenza l’identità d’Europa come Nazione Bianca.
Le elezioni italiane segnano un nuovo passaggio - forse decisivo - nella disintegrazione di quella che fu l’Unione europea, e la trasformazione di quel progetto post-nazionale in un processo di fondazione della Nazione europea come entità di guerra razziale permanente.
Da Maastricht in poi l’Unione europea ha funzionato come dispositivo neoliberista finalizzato allo spostamento di risorse dalla società verso il sistema finanziario. Venticinque anni di politiche monetariste rivolte allo smantellamento dello stato sociale e alla precarizzazione del lavoro hanno prodotto l’effetto che potevamo attenderci e ci attendevamo: un’ondata di rigetto sempre più vasto del progetto europeo, un’ondata di nazionalismo legato alla rabbia impotente di coloro che hanno subito l’impoverimento sociale.
La popolazione della grande maggioranza dei paesi europei si è espressa contro le politiche globalizzanti e neoliberiste, e particolarmente contro il Fiscal compact, cioè l’imposizione di un debito che dissangua la vita sociale e sposta capitale verso il sistema bancario.
Dapprima, tra il 2011 e il 2015, questo rifiuto si è configurato come opposizione sociale: l’acampada spagnola, il movimento Occupy e infine il referendum greco contro l’imposizione del memorandum da parte della troika hanno segnato il tentativo di fermare il prelievo finanziario e lo smantellamento delle strutture sociali. Ma l’opposizione sociale è stata sconfitta, perché non disponeva degli strumenti concettuali e materiali per opporsi alla governance finanziaria, forma post-nazionale e astratta di dominio, contro cui nulla poteva un movimento territorializzato su base nazionale. L’impotenza è il tratto decisivo della vita sociale dopo la crisi del 2008: impotenza a resistere all’assalto predatorio della finanza, a impedire lo smantellamento delle strutture pubbliche come la scuola e la sanità, a mantenere un livello di vita paragonabile a quello delle generazioni passate. L’impotenza si è presto trasformata in risentimento, volontà di vendetta, e nostalgia reazionaria per la sovranità nazionale.
A questo punto si è presentata la nuova minaccia: la grande migrazione, effetto di processi di lunghissima durata (depredazione coloniale delle risorse umane e fisiche, degradazione dell’ambiente) e di processi più recenti, come la guerra scatenata dal clan Bush in Medio Oriente, cui i paesi dell’Unione europea si sono accodati, e le guerre francesi contro la Libia e contro la Siria, che hanno messo in moto il pandemonio.
La crisi dell’Unione europea, di cui le elezioni italiane rappresentano a mio parere il passaggio finale, è dunque nata dalla reazione contro due processi convergenti di deterritorializzazione: l’impoverimento generato dalla governance post-nazionale, che ha provocato una rivendicazione sovranista, e la grande migrazione, percepita come invasione del territorio bianco da parte delle vittime delle invasioni bianche del passato.
Questi due filoni della rabbia impotente si sono fusi in un unico potente movimento di riterritorializzazione reazionaria.
Incapace di concettualizzare quel che sta accadendo, l’opinione democratica e neo-liberale ha tentato di esorcizzare la duplice reazione con un’unica parola: populismo. Ma si tratta di un’espressione che non spiega niente e confonde due fenomeni del tutto differenti (il rifiuto sociale dell’impoverimento e il razzismo riemergente nell’inconscio europeo).
L’opinione democratica e neo-liberale difende un feticcio (la democrazia, cui non corrisponde più niente nella realtà politica post-nazionale) e difende un’ossessione (la crescita economica, la competizione, insomma la concentrazione di potere economico da parte della macchina astratta della finanza). Ma per difendere questo feticcio e questa ossessione identifica l’onda reazionaria montante con una definizione che potenzia l’onda reazionaria: populismo è tutto ciò che non si piega alle tendenze deterritorializzanti dello sfruttamento finanziario e della mobilità migrante.
Ma queste due tendenze sono distinte, anche se ovviamente interagenti. I due movimenti reattivi vanno considerati distintamente: una cosa è la difesa della vita sociale contro il profitto finanziario, un’altra cosa è la paura della grande migrazione.
Confondendo i due movimenti si ottiene l’effetto che abbiamo sotto gli occhi: il montare incontenibile di un’onda che ha un solo nome: nazional-socialismo.
Il nazismo è la tendenza emergente in larga parte del continente europeo, anche se questa parola è impronunciabile.
La dinamica che si manifestò in Germania dopo il Congresso di Versailles si è ripresentata su scala continentale per effetto della scomparsa di una sinistra capace di opporsi all’offensiva finanziaria, e per effetto dell’incapacità della politica europea di fare i conti con l’eredità del colonialismo.
Non so come potrà evolvere la situazione italiana nei prossimi mesi, ma mi pare evidente che l’unico elemento che accomuna tutte le forze politiche, in Italia come in tutti gli altri paesi europei, è il respingimento dell’onda migratoria inarrestabile. Sul respingimento razzista e sullo sterminio convergono perfettamente i vincitori delle elezioni, la Lega e i Cinque stelle, e i perdenti delle elezioni, il Partito democratico che con Marco Minniti ha espresso pienamente il razzismo costitutivo dell’Unione europea.
Su questo punto, il respingimento e lo sterminio, il fronte europeo si ricompone compatto.
Sul razzismo della popolazione europea (non dei governi nazionali, che su questo punto riflettono la volontà della maggioranza) si fonda la nuova identità della nazione europea (Nazione, perché fondata su un’identità razziale, e perché portatrice di sterminio e di guerra).
Il razzismo e il nazionalismo sono la conseguenza e il rovescio dell’impotenza sociale accumulate nell’ultimo decennio.
Le elezioni italiane hanno portato a compimento il processo di nazificazione dell’unione europea, anche se questa realtà è innominabile. Lo sterminio razzista - che si manifesta oggi nella costruzione di un campo di concentramento gigantesco nel quale milioni di non-bianchi sono detenuti, torturati, schiavizzati, eliminati, e alla fine annegati se tentano di fuggire - è il futuro già scritto di quella che, con sublime disprezzo dell’evidenza, continua a chiamarsi unione europea.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - IL CRISTIANESIMO, IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO, E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.9 marzo 2018, di Federico La SalaSTORIA E (FENOMENOLOGIA DELLO) SPIRITO. Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto...
 IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO: HENRI DE LUBAC E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO: HENRI DE LUBAC E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
 L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - Primo Levi e il suo monito eterno. Auschwitz è il naufragio dell’etica occidentale (di Donatella Di Cesare).11 febbraio 2018, di Federico La Sala
La collana in edicola con il «Corriere»
Primo Levi e il suo monito eterno: Auschwitz, spettro che può tornare
Esce il terzo volume della serie dedicata allo scrittore sopravvissuto alla Shoah.
 Il naufragio dell’etica occidentale nell’orrore dei campi di sterminio
Il naufragio dell’etica occidentale nell’orrore dei campi di sterminiodi Donatella Di Cesare (Corriere Sera, 11.02.2018)
Fu un tonfo sordo e inatteso. Quel sabato mattina una volante della polizia e un’autoambulanza raggiunsero in fretta Corso Re Umberto 75, al centro di Torino. Era di Primo Levi il corpo esanime, ai piedi delle scale. Quell’11 aprile 1987 la notizia del suicidio fece il giro del mondo e lasciò tutti attoniti, i lettori, ma anche gli amici. Pur sapendo della sua depressione, si rifiutavano di credere che avesse compiuto quel gesto. La lucidità di pensiero, l’altezza intellettuale, che avevano contrassegnato figura e opera di Levi, stridevano con quella spirale di ringhiere in cui era precipitata la sua vita. Molti dubitarono, vollero credere a un incidente. Il suicidio sembrava cancellare ogni scintilla di speranza inscritta nelle sue parole. Il «New Yorker» espresse questo timore apertamente. Molti altri, però, indicarono in quella morte la fine di una tenace sopravvivenza al lager.
Solo un anno prima, nel maggio 1986, era uscito I sommersi e i salvati, l’opera fondamentale di Levi. In quelle pagine la testimonianza personale, affidata ad altri libri precedenti, si coniuga con una riflessione profonda, un’analisi implacabile e un monito severo. «È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire». Le parole della conclusione sono il suggello di un libro pervaso dall’amarezza, a tratti dalla disperazione, ma sostenuto dall’esigenza di una denuncia senza compromessi. I sommersi e i salvati è scritto per i giovani; sono loro i destinatari. E perciò in ogni scuola dovrebbe oggi essere studiato, meditato.
Non basta leggere Se questo è un uomo , oppure La tregua. Perché è come se quella narrazione trovi una nuova luce. È a partire dall’attualità che viene infatti ripercorsa l’esperienza del lager. Auschwitz non è un mito lontano, ma uno spettro del futuro. Levi prende la parola per combattere, con le ultime forze, contro revisionisti e negazionisti.
Non si comprenderebbe il suo pensiero se non lo si interpretasse nel contesto di quei giorni. Nel giugno 1986 lo storico tedesco Ernst Nolte aveva articolato una tesi, già diffusa in Germania, con cui pretendeva di mettere sullo stesso piano il gulag e il lager, lo stalinismo e il nazismo, e vedeva anzi in quest’ultimo null’altro che una risposta al primo. Qualche tempo dopo, quel «laido conato» trovò spazio anche sulla stampa italiana. Levi fu implacabile: i due sistemi non erano paragonabili. Le camere a gas, quell’invenzione tutta tedesca, era la cifra ineguagliata dello sterminio.
La Germania che tentava invano di discolparsi, di «sbiancare il suo passato», gli faceva orrore. «Nessun tedesco dovrebbe dimenticare». Attento a non pronunciare un verdetto su un’intera nazione, con il tempo modificò il giudizio. La colpa era stata enorme: «Quasi tutti i tedeschi di allora» sapevano e non avevano avuto il coraggio di parlare. I sommersi e i salvati è un libro durissimo che mira a decostruire molti stereotipi. Ad esempio l’idea, ancora ben radicata, che Auschwitz sia il risultato della barbarie nazista.
Le cose sono ben più complicate. A quel progetto politico hanno aderito - occorre riconoscerlo - molti intellettuali. Ma sulla scia di Hegel, che aveva deificato lo Stato, l’intellettuale tedesco «tende a farsi complice del Potere». «Le cronache della Germania hitleriana - osserva Levi - brulicano di casi che confermano questa tendenza: vi hanno soggiaciuto Heidegger il filosofo, il maestro di Sartre; Stark il fisico, premio Nobel; Faulhaber, il cardinale, suprema autorità cattolica in Germania, ed innumerevoli altri».
Qualcuno ha scritto che in queste pagine Levi si rivela un grande moralista. Ma la definizione è fuorviante. Piuttosto, senza smettere di essere testimone, Levi veste i panni del filosofo per criticare la filosofia, per sfidarla, indicando temi rimasti fuori dall’inventario filosofico, come quello di vergogna, o mostrando i concetti che, come quello di morte o di libertà, vanno rivisti. Perché Auschwitz è il naufragio dell’etica occidentale. La responsabilità è stata frantumata. Levi ritorna sulla «zona grigia» dove alla vittima, per la prima volta, non è concesso più neppure il ruolo di vittima, al punto da renderla semicarnefice. È questo il «delitto più demoniaco del nazionalsocialismo».
Splendido, e forse sottovalutato, è il capitolo «Comunicare» . Auschwitz appare una nuova versione della Torre di Babele. Capire o non capire, sapere il tedesco, segna lo spartiacque tra la vita e la morte. La disumanizzazione dell’altro passa attraverso la lingua ridotta a crudele strumento di potere. La parola lascia il posto all’offesa e poi al nerbo. È il segnale che non si è più considerati umani. E Levi commenta: «Dove si fa violenza all’uomo, la si fa anche al linguaggio». Nel lager, però, si muore per mancanza non solo di informazione, ma anche di dialogo, quando nessuno «ti parla» più. Dove viene meno il vocativo dell’altro finisce la vita. Perciò scrive Levi rivolto ai suoi destinatari futuri: «Rifiutare di comunicare è colpa»
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - iTALIA. Attuazione ciclo di programmazione 2014-2020 e politica di Coesione post-20205 febbraio 2018, di Federico La Sala
L’Italia e la Politica di Coesione post-2020
Linee-guida condivisibili, ma si può e si deve fare di più
di Carmelo Petraglia - Giuseppe Provenzano (Il Mulino, 31 gennaio 2018)
Mentre in Italia faticosamente si avvia l’attuazione del ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, a Bruxelles siamo nel vivo della discussione sulla riforma della Politica di Coesione per il post-2020: lo scontro è acceso, con posizioni che addirittura ne negano l’utilità per il futuro.
La posizione del governo italiano sul post-2020 propone suggerimenti in larga parte condivisibili di riforma della Coesione europea, da finanziare con risorse adeguate anche nel prossimo ciclo, per porre un argine ai crescenti divari regionali nell’Ue e favorire la convergenza economica e sociale, quale “bene comune europeo”. In particolare, il position paper offre al dibattito europeo le seguenti linee-guida:
- un più virtuoso coordinamento della politica di coesione rispetto alla governance macroeconomica generale, tenuto conto della modesta dimensione finanziaria dei fondi strutturali (un terzo del già esiguo bilancio dell’Unione, che vale appena l’1% del Pil del continente);
- dare seguito allo sforzo di semplificazione e armonizzazione delle regole per garantire il più ampio accesso alle opportunità offerte dai fondi europei;
- salvaguardare le finalità proprie dei fondi della coesione, il loro utilizzo in coerenza con l’obiettivo di riduzione delle disparità regionali definito dai Trattati, e la loro specificità e indipendenza rispetto agli altri strumenti di promozione degli investimenti nell’Ue;
- superare il meccanismo della condizionalità macroeconomica (togliere risorse a chi non consegue gli obiettivi indicati dalla Commissione, anche per la finanza pubblica o le riforme “strutturali”) per evitare di penalizzare i territori con maggiori difficoltà strutturali.
Si tratta di indicazioni quanto mai opportune perché orientate alla correzione dei noti vizi “interni” alla Coesione. Ma, proprio alla luce dei risultati insoddisfacenti fin qui conseguiti, sarebbe troppo ottimistico attendersi che la politica di Coesione, da sola, una volta corretti i suoi difetti, possa rendere la convergenza regionale un “bene comune europeo”.
È opportuno, a tal proposito, ricordare le dinamiche economiche fortemente differenziate osservabili all’interno della periferia dell’Ue a partite dagli anni Duemila (cfr. Rapporto Svimez 2017). Da un lato, lo slancio delle economie in ritardo di sviluppo dei nuovi Stati membri dell’Est Europa è continuato, anche durante la crisi; dall’altro, il Mezzogiorno continua ad arretrare.
Andamenti così differenziati derubricano gli scarsi risultati dei fondi strutturali al rango di concausa dell’arretramento del Sud. Le altre cause, anche maggiori, vanno ricercate altrove: la Coesione europea interviene in una cornice di condizioni e politiche macroeconomiche ordinarie che creano rilevanti asimmetrie interne alla sua periferia, amplificando a livello regionale gli squilibri tra economie nazionali. La non ottimalità dell’area euro, l’incompiutezza della governance macroeconomica europea e l’assetto delle sue politiche impattano in misura rilevante sui fattori della resilienza e della crescita delle economie locali; creano condizioni competitive più vantaggiose per le regioni appartenenti a Paesi con sistemi fiscali e contributivi più leggeri, nella condizione di utilizzare lo strumento del cambio, e con vincoli di bilancio sovranazionali meno stringenti. Specularmente, il Sud Italia soffre di sfavorevoli condizioni macroeconomiche nazionali e sovranazionali alle quali aggiunge le sue difficoltà strutturali endogene: una condizione di “svantaggio strutturale” non compensabile “solo” con politiche di Coesione più virtuose.
Come abbiamo argomentato in un nostro recente contributo che contiene anche alcune proposte di riforma, l’Italia dovrebbe porre in Europa il tema del coordinamento tra la Coesione e la governance macroeconomica europea complessiva: la politica di Coesione non può essere lasciata “da sola” a perseguire la riduzione dei divari che le politiche ordinarie contribuiscono ad amplificare.
Rivendicare il “primato” della Coesione, come principale leva di investimento pubblico, che ha attutito gli effetti della crisi, è risibile, vista la generale mancanza di addizionalità dei fondi, in parte dovuta ai vincoli per la finanza pubblica che derivano dal Fiscal compact. Se per un intero ciclo la Coesione è stata (solo parzialmente) sostitutiva delle mancate politiche pubbliche ordinarie, non solo nel Mezzogiorno, allora davvero l’obiettivo originario e fondamentale della convergenza si risolve nel suo contrario.
Inoltre, il forte potenziamento anche finanziario degli interventi nelle regioni più sviluppate, per il raggiungimento degli obiettivi strategici europei per il 2020, evidenzia la relativa minore attenzione riservata all’obiettivo della “convergenza”. È una tendenza del corrente ciclo, e che si annuncia anche per il post-2020, scarsamente coerente con le disposizioni del Trattato sulla riduzione dei divari: incrementare le risorse per obiettivi, materiali e territoriali, diversi è un’ulteriore causa delle divergenze interne all’Ue e in particolare all’Eurozona.
Non può che essere la maggiore economia europea con i più ampi differenziali regionali interni e con la più vasta area economica in ritardo di sviluppo a portare questo tema in Europa. Tanto più che il rilancio del Sud viene indicato, pressoché da ogni parte politica, come presupposto imprescindibile per la ripresa del Paese.
Il perno intorno al quale ruota l’interesse nazionale da salvaguardare è una politica europea generale per la convergenza, all’interno della quale difendere le “finalità proprie” dei fondi strutturali di riduzione delle disparità regionali. È in quest’ultimo ambito che altri interessi nazionali sembrano invece prevalere con l’obiettivo opposto di indebolire la Coesione europea.
Il segnale più recente sta nella recente roadmap della Commissione europea per l’Unione economica e monetaria, che prevede la possibilità per i governi nazionali, già nel 2018, di destinare la riserva di performance dei fondi strutturali al finanziamento di riforme strutturali concordate con la Commissione. Riforme strutturali “nazionali” lontane dalla finalità di sviluppo dei territori deboli, è bene sottolinearlo. Questa possibilità sembra venire esplicitamente criticata dal position paper italiano, ma sarà bene che la critica si traduca in un’azione politica concreta di contrasto.
Le linee-guida del position paper italiano sono insomma più che condivisibili, ma questo è il tempo in cui si può e si deve dire di più, se si ha a cuore la tenuta socio-economica dell’Unione e se si vogliono contrastare i rischi di disgregazione.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - Un piano inclinato sul quale stiamo scivolando. Il razzismo dei governi si è già spinto molto avanti (di Guido Viale).2 febbraio 2018, di Federico La Sala
Razzismo, un piano inclinato sul quale stiamo scivolando
Migranti. Dello sterminio di ebrei, rom e sinti erano complici i popoli (i tedeschi insieme a quelli soggiogati). -E’ così anche con gli immigrati. Il razzismo dei governi si è già spinto molto avanti
di Guido Viale (il manifesto, 02.02.2018)
Il giorno della memoria o, meglio la memoria della Shoah e del Porrajmos, cioè dello sterminio di ebrei, rom e sinti da parte del nazismo, una memoria coltivata tutto l’anno, potrebbe e dovrebbe essere utilizzata come una lente attraverso cui esplorare il nostro presente.
Quello che occorre tener presente è la dinamica del razzismo: il suo esito estremo, ma anche i suoi inizi, perché anche la Shoah non è cominciata con le camere a gas ma con il disprezzo - anche l’invidia - del diverso.
Della Shoah e del Porrajmos va ricordato e ribadito che il suo fine non era lo sfruttamento del lavoro schiavo a cui adibire le razze ritenute inferiori; uno sfruttamento comunque largamente sviluppato nei tanti campi secondari costruiti accanto ad alcuni di quelli dedicati allo sterminio e a cui erano sottoposti gli uomini e le donne valide prima di essere soppresse. Il fine principale di Shoah e Porrajmos era lo sterminio, il genocidio, la cancellazione dalla faccia della terra di interi popoli.
NON È VERO CHE IL POPOLO tedesco non ne sapesse niente; sapeva tutto, anche se non c’erano ancora i mezzi di comunicazione di cui disponiamo noi oggi. Se gli ebrei italiani in “viaggio” verso Auschwitz sapevano quello che li aspettava - e ne abbiamo testimonianza - lo sapevano anche tutti gli altri. E infatti lo scopo fondamentale del genocidio era proprio quello di renderne complice, seppur indirettamente, il popolo tedesco - e poi tutti i popoli dei paesi soggiogati, dove erano stati immediatamente attivati rastrellamenti e deportazioni.
Quella complicità, sottaciuta e per lo più nascosta anche a se stessi, era lo strumento fondamentale di “fidelizzazione” delle popolazioni ai regimi che si rendevano responsabili di quei crimini; il sistema più sicuro per garantirsi che, in chi si sentiva ormai, in qualsiasi modo, complice di quell’eccidio, si spegnesse per sempre il desiderio e la volontà di dissociarsene, così come la partecipazione ad un crimine particolarmente efferato è il modo con cui le gang criminali si procurano la fedeltà dei nuovi adepti.
QUESTO MECCANISMO al tempo stesso militare, culturale e psicologico va tenuto presente quando analizziamo le “deportazioni” e gli eccidi di profughi e migranti che si svolgono oggi sotto i nostri occhi. Chi continua a sostenere che il fine delle sofferenze, delle violenze e del massacro a cui i nostri governi - intendo quello italiano, ma anche e soprattutto quello dell’Unione europea e quelli di tutti i paesi membri - è mettere in condizioni di inferiorità, e poi di schiavismo, una manodopera straniera per poterla sfruttare meglio; o, addirittura, con l’evocazione di un fantasioso “Piano Kalergi” che vede uniti sovranisti e razzisti di destra e di sinistra, sostituire la popolazione europea con una manodopera schiava di origine europea, non tiene conto del fatto che lo sfruttamento della manodopera straniera in condizioni di violenta emarginazione, in Europa ben prima che in Italia, era stato alla base di gran parte dello sviluppo economico del continente ben prima che suonasse l’allarme per una presunta “invasione dei profughi” contro cui oggi l’Unione europea e i governi suoi complici stanno mobilitando una mole crescente di risorse finanziarie, legislative, militari, ma anche sociali e culturali.
LO SFRUTTAMENTO della manodopera resa “clandestina” dalla legge è un byproduct, un effetto secondario, ancorché gradito e ben utilizzato - senza di esso gran parte dell’agricoltura italiana, e non solo, scomparirebbe - di qualcosa di molto più profondo: il coinvolgimento della popolazione italiana, sia quella consenziente che quella contrariata, in una corsa verso l’affermazione di una propria “identità” e, conseguentemente, di una propria superiorità, da salvaguardare nei confronti di persone e popoli da respingere; cioè in una pratica dalle evidenti connotazioni razziste.
Il razzismo è un piano inclinato che inizia con manifestazioni quasi impercettibili nascoste nel linguaggio o in sorrisi e allusioni malevole, apparentemente innocue, ma lungo cui è sempre più facile scivolare, e in modi sempre più accelerati, verso le sue forme più estreme; ma da cui è sempre più difficile risalire per tornare indietro, come hanno dimostrato, prima ancora della Shoah e del Porrajmos, la conquista delle Americhe, il colonialismo e lo schiavismo, il genocidio degli Armeni ed altro ancora.
OGGI NON C’È PIÙ BISOGNO di ricorrere a pseudo enunciati scientifici di carattere biologico per giustificarlo; basta coltivare un autocompiacimento per la propria miseria spirituale, soprattutto se sostenuto da leggi, norme e regolamenti che condannano l’altro all’emarginazione, all’esclusione e a una povertà peggiore della nostra; poi si potrà anche inveire contro ricchi calciatori di colore negli stadi o ministre di origine africana su facebook (senza però scandalizzarsi se sceicchi arabi o tycoon cinesi si comprano mezzo paese, perché il razzismo odierno nasce soprattutto dal disprezzo e dalla paura della povertà).
Così, passo dopo passo, senza che neppure ce ne accorgiamo, le politiche di respingimento, ma che di criminalizzazione e di disumanizzazione di profughi e migranti messe in atto dai governi (dai governi, e non solo dalle destre; o dai governi perché non fanno che copiare e inseguire le “ricette” delle destre) ci trascinano verso forme di assuefazione, prima, e di più o meno inconsapevole coinvolgimento, poi, da cui poi è sempre più difficile uscire.
Perché poco per volta, diventa la “normalità”: quella che Liliana Segre, riferendosi all’epoca del fascismo, delle leggi razziali, delle deportazioni e della Shoah, chiama, mettendola sotto accusa e in primo piano, “indifferenza”.
I NOSTRI GOVERNI - O ALCUNI dei loro esponenti - sono perfettamente consapevoli di questo meccanismo: sanno che dai fatti compiuti è sempre più difficile tornare indietro e cambiare rotta; e per questo spingono l’acceleratore in direzione di politiche che, a dir loro, dovrebbero mettere fuori gioco le destre, perché le renderebbero superflue; e che invece le rendono sempre più forti e, alla fine vincenti. Lungo quel piano inclinato siamo già andati, in tutta Europa - ma anche altrove - molto avanti. Basta pensare, da un lato, al linguaggio apertamente razzista ormai sdoganato da una certa parte politica, da TV e giornali e, conseguentemente, al bar; dall’altro alle politiche di respingimento promosse dall’Unione europea e dal nostro governo passando sopra alle più elementari forme di rispetto dei diritti della persona. Quello a cui dobbiamo fare attenzione ora è solo cercare di non superare il punto di non ritorno, che è il punto in cui ciascuno si sente talmente solo e isolato da non ritenere più di poter reagire.
QUANDO SI RIFLETTE sull’indifferenza che ha accompagnato la persecuzione prima e lo sterminio, dopo degli ebrei durante il fascismo e il nazismo ci si chiede spesso perché di fronte a tanta mostruosità, nessuno, o meglio, ben pochi, abbiano trovato la forza e la capacità di reagire, mentre la maggioranza ha assistito indifferente a quello che succedeva sotto i suoi occhi.
La risposta, forse, è che non si trattava, e non si tratta, solo di cinismo, bensì soprattutto di un senso di impotenza che paralizza.
Bisognava forse pensarci - e provvedere prima - quando ancora c’era la possibilità di farlo. Prima quando? Gli storici non ce lo sanno dire; o hanno opinioni diverse rispetto alla resistibile ascesa del razzismo che ha accompagnato fin dal nascer fascismo e razzismo. Ma dobbiamo cominciare a chiedercelo noi, rispetto al tempo presente. Per non ritrovarci poi a dire e a pensare che ormai è troppo tardi.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- LEGALITÀ E LEGITTIMITÀ. Uno spettro si aggira per l’Europa: Carl Schmitt (di Roberto Esposito).1 febbraio 2018, di Federico La Sala
Uno spettro si aggira per l’Europa: Carl Schmitt
di Roberto Esposito (la Repubblica, 01.02.2018)
La traduzione del saggio di Carl Schmitt su Legalità e legittimità, curata e introdotta magistralmente da Carlo Galli per il Mulino, presenta più di un motivo di interesse. Pubblicato nel 1932, subito dopo le ultime elezioni tedesche, prelude al collasso della Repubblica di Weimar e alla vittoria nazista. Se non si può dire che prepari la svolta totalitaria - pure accettata di buon grado dall’autore l’anno successivo - coglie tutti gli elementi della crisi che avrebbe portato al crollo della democrazia in Germania. Il tramonto dello Stato legislativo apre un varco nell’ordinamento che spezza l’equilibrio costituzionale tra legalità e legittimità, norma e decisione, diritto e politica.
Schmitt, almeno in linea di principio, non contrappone i due termini. Anzi tenta di articolarli, collocando il potere costituente nella volontà del popolo tedesco. In questo modo resta all’interno del quadro democratico, ma lo spinge all’estremo limite arrivando a richiedere un Custode della Costituzione capace di incarnare la volontà popolare. Ciò che in sostanza Schmitt propone è una democrazia plebiscitaria che modifichi in senso autoritario il regime di Weimar. Il secondo motivo di interesse è l’attitudine camaleontica dell’autore a “ripulire” a ritroso la propria storia, ampiamente compromessa col nazismo.
Nella postfazione, scritta nel 1958, Schmitt individua in Legalità e legittimità il «tentativo disperato di salvare» la Costituzione di Weimar dall’attacco concentrico delle forze antisistema di destra e sinistra. Ora è vero che Schmitt non fuoriesce formalmente dalla cornice costituzionale. Ma schierandosi per un rafforzamento senza bilanciamento dei poteri del presidente, apre la strada allo strappo del 1933, quando si passa dalla possibile dittatura commissaria di Hindemburg alla reale dittatura sovrana di Hitler: la legge sul conferimento dei pieni poteri e l’abrogazione dei partiti sono l’esito controfattuale del tragico tentativo di stabilizzare la Repubblica, lacerandone il tessuto istituzionale.
Eppure l’interesse del saggio di Schmitt non è circoscrivibile a una vicenda storica fortunatamente chiusa. Nonostante la distanza che ci separa, sono troppi gli echi che risuonano in queste pagine.
A cos’altro richiamano la crisi di legalità e il deficit di legittimità, l’impotenza del Parlamento e il conflitto dei partiti, le forzature della costituzione e il rischio di ingovernabilità, se non alle ferite delle nostre democrazie?
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
-
Il valore ha una sua propria logica ed è la logica del Dio-Valore, Mammona (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006).
 IL VATICANO E IL VALORE ASSOLUTO DELLA VITA. La critica anticipatrice di Carl Schmitt e di Federico Fellini della tradizionale e poco evangelica teologia di Papa Ratzinger
IL VATICANO E IL VALORE ASSOLUTO DELLA VITA. La critica anticipatrice di Carl Schmitt e di Federico Fellini della tradizionale e poco evangelica teologia di Papa Ratzinger
VOLONTÀ DI POTENZA E DEMOCRAZIA AUTORITARIA. CARLO GALLI NON HA ANCORA CAPITO CHE, NEL 1994, CON IL PARTITO "FORZA ITALIA", E’ NATO ANCHE IL "NUOVO" PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
LA BRUTTEZZA DI UNA DIPINTURA: "FABULA LEMURUM". In memoria di Giambattista Vico
 STORIA DELLA QUESTIONE INFAME: COME L’ITALIA, UN PAESE E UN POPOLO LIBERO, ROVINO’ CON IL "GIOCO" DEI "DUE" PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA.
STORIA DELLA QUESTIONE INFAME: COME L’ITALIA, UN PAESE E UN POPOLO LIBERO, ROVINO’ CON IL "GIOCO" DEI "DUE" PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA. -
Il valore ha una sua propria logica ed è la logica del Dio-Valore, Mammona (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - La Shoah, la Gare d’Austerlitz a Parigi, e la memoria dei beni razziati (di Elena Pirazzoli).31 gennaio 2018, di Federico La Sala
La Shoah fu anche un enorme affare economico, che portò sollievo ai conti della Germania nazista
La memoria dei beni razziati
di Elena Pirazzoli
L’annientamento degli ebrei d’Europa da parte nazista fu, per molti aspetti, anche un affare economico. In Germania, l’esproprio delle loro case garantì il ricollocamento di diversi cittadini tedeschi, i loro posti di lavoro vennero occupati da altri, le loro aziende furono statalizzate o vendute al miglior offerente. Alcuni anni fa una commissione di storici tedeschi pubblicò uno studio che mostrava come tra il 1933 e il 1945 il ministero dell’Economia sia stato parte attiva del processo di annientamento, dal lato finanziario, degli ebrei: inizialmente attraverso la tassazione, poi con la vendita dei beni depredati dopo la deportazione dei loro legittimi proprietari, fu possibile raccogliere denaro per coprire almeno il 30% delle spese di guerra tedesche. Il saccheggio dei beni ebraici non fu quindi un mero corollario della Shoah, ma un processo sistematico ad essa connesso.
Per molto tempo è stato noto soprattutto il caso delle opere d’arte, sequestrate per andare ad arricchire la collezione di Hermann Göring o la raccolta selezionata dalla Sonderauftrag Linz, la Commissione speciale Linz istituita per individuare dipinti e sculture che avrebbero dovuto fare parte del Führermuseum, il museo che Hitler voleva realizzare nella città della propria giovinezza.
Dopo la guerra, il recupero di questi beni è stato, ed è tuttora, molto difficile: di molti si sono perse le tracce, altri, come nel noto caso del ritratto di Adele Bloch Bauer dipinto da Gustav Klimt, sono stati oggetto di contenziosi legali.
Esistono diversi progetti che tentano di ritrovare le opere spoliate, come nel caso dei dipinti confiscati dalla Sonderauftrag Linz censiti dal Deutsches Historisches Museum, o vere e proprie iniziative governative come la German Lost Art Foundation, creata in Germania nel 2015 per cercare e identificare i beni sequestrati dal regime nazista in modo da assistere gli eredi dei legittimi proprietari.
Ma quello che forse colpisce maggiormente è il fatto che l’ossessione nazista per i beni ebraici non si limitasse ai dipinti, le sculture, gli oggetti di valore: con un approccio patologico al concetto di funzionalità, vennero create delle divisioni con il compito di espropriare e inventariare tutti gli oggetti appartenenti agli ebrei avviati alla deportazione. Con lo scoppio della guerra venne creato il Commando Rosenberg, che mise in atto la spoliazione sistematica dei beni degli ebrei nei Paesi occupati, in particolare in Francia. Nei suoi depositi parigini presso la Gare d’Austerlitz venne catalogato tutto in modo minuzioso, suddividendo le tipologie degli oggetti prelevati (stoviglie, mobili, porcellane, tappeti, pianoforti, libri...).
Nel romanzo Austerlitz di W.G. Sebald (Adelphi, 2002) vengono descritti questi depositi: “E là sotto, nel magazzino Austerlitz-Tolbiac, a partire dal 1942 è venuto accumulandosi tutto ciò che la nostra civiltà ha prodotto per rendere più bella l’esistenza o per semplice uso domestico, a cominciare dai cassettoni Luigi XVI, dalle porcellane di Meißen, dai tappeti persiani e da intere biblioteche per arrivare fino all’ultima saliera e pepaiola”.
Sebald descrive gli oggetti divisi per tipologie, le squadre di internati del campo di Drancy - antiquari, storici dell’arte, restauratori, falegnami, orologiai, pellicciai - condotti lì per sistemare i beni in arrivo e smistarli in base al valore e al genere. E immagina la presenza, negli ambienti di questi grandi magazzini coatti, di “alti gradi delle SS e della Wehrmacht, in compagnia delle consorti o di altre signore, per cercarsi un salotto adatto alla villa di Grunewald, oppure un servizio di Sèvres, una pelliccia o un Pleyel”. Le scene descritte nel romanzo non sono, tuttavia, invenzione narrativa, ma corrispondono alla realtà, come mostra un album fotografico conservato presso il Bundesarchiv, che documenta la “Möbel-Aktion”, l’operazione di sequestro e inventario di mobili, letti, biancheria, scarpe, giocattoli e suppellettili domestiche intrapresa dall’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg a Parigi, tra il 1942 e il 1943.
Nell’estate 2017 il piccolo album è stato esposto alla 14. edizione di documenta a Kassel, all’interno del progetto dell’artista tedesca Maria Eichhorn, che da diversi anni lavora sugli oggetti razziati dai nazisti agli ebrei, arrivando addirittura a fondare il un istituto di ricerca dedicato a Rose Valland, la storica dell’arte e membro della resistenza francese che salvò moltissime opere delle collezioni nazionali e private di Francia.
Lo spazio centrale della sala dedicata al lavoro di Maria Eichhorn a documenta era occupato da una torre di libri: volumi conservati nella Zentral- und Landesbibliothek di Berlino, tutti inventariati con un numero progressivo e una J. La J di Jude, “ebreo”. Si tratta di 2.000 degli oltre 40.000 libri comuni (quelli di pregio avevano altre destinazioni) prelevati dalle biblioteche private degli ebrei “evacuati”, tipico eufemismo della burocrazia nazista. E con un nuovo eufemismo, nel dopoguerra vennero rubricati come Geschenke, donazioni, quando invece erano frutto della spoliazione sistematica di ogni bene degli ebrei della città. Nulla si fece per cercare di restituirli.
A partire da dediche ed ex libris, Maria Eichhorn, insieme al personale della biblioteca, sta cercando ora di risalire ai legittimi proprietari o ai loro eredi ma, laddove anche si riescono a ritrovare i nomi di queste persone, il loro destino è quasi sempre lo stesso: la morte nei campi di sterminio.
[Immagine: Maria Eichhorn, Unlawfully Acquired Books from Jewish Ownership - Unlawfully acquired books from Jewish ownership by the Berliner Stadtbibliothek in 1943, registered in Zugangsbuch J (accession book J)]
* Il Mulino, 29 Gennaio 2018 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- ITALIA, 27 GENNAIO 2018. Le leggi razziali compimento del fascismo (di Enzo Collotti).27 gennaio 2018, di Federico La Sala
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ...
- "È una storia che deve indurci ad approfondire un esame di coscienza collettivo alle radici della nostra democrazia e a dare una risposta a fatti che sembrano insegnarci come la lezione della storia non sia servita a nulla se è potuto accadere che il presidente del tribunale fascista della razza diventasse anche presidente della Corte Costituzionale della Repubblica" (Enzo Collotti, "Le leggi razziali compimento del fascismo", Il manifesto, 27.01.2018)
- “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
Le leggi razziali compimento del fascismo
di Enzo Collotti (il manifesto 27.1.2018)
Quest’anno il Giorno della Memoria coincide con la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi contro gli ebrei dell’Italia fascista. Promulgazione ad opera di quel sovrano Vittorio Emanuele III al quale, se non altro per questa ragione, devono essere precluse le porte del Pantheon.
Come giustamente ricorda una importante pubblicazione edita l’anno scorso in Germania per gli ottanta anni dalle leggi di Norimberga, fu una iniziativa tutta italiana senza che vi fosse alcuna pressione da parte del Reich nazista, come si ostina a ripetere qualche tardo estimatore di Benito Mussolini.
Tutto quello che si può dire in proposito è che nell’Europa invasa dall’antisemitismo, l’Italia fascista non volle essere seconda a nessuno, ossessionata come era, fra l’altro, dallo spettro della contaminazione razziale.
Frutto avvelenato dell’appena conquistato impero coloniale e della forzata coabitazione con i nuovi sudditi africani.
Come tutti i neofiti, anche il razzismo fascista ebbe il suo volto truce. La «Difesa della razza», l’organo ufficiale del regime che ebbe come segretario di redazione Giorgio Almirante, ne forniva la prova in ogni numero contraffacendo le fattezze fisiche degli ebrei o rendendo orripilanti quelle delle popolazioni nere.
Il tentativo di fare accreditare l’esistenza di una razza italiana pura nei secoli aveva il contrappasso di dare una immagine inguardabile delle popolazioni considerate razzialmente impure. L’arroganza della propaganda non impedì che essa facesse breccia in una parte almeno della società italiana e ancora oggi non è detto che essa si sia liberata dall’infezione inoculata dal fascismo, come stanno a dimostrare piccoli, ma numerosi episodi che si manifestano, e non solo negli stadi.
Non bisogna fra l’altro dimenticare che non solo tra il 1938 e l’8 settembre del 1943 l’odio razziale ebbe libero corso, ma che dopo l’armistizio e l’occupazione tedesca la caccia agli ebrei divenne uno dei principali motivi dell’esistenza della Repubblica Sociale neofascista.
In nome della purezza della razza il regime costrinse a fuggire o mise in campo di concentramento ebrei che in altre parti d’Europa si erano illusi di trovare un rifugio non precario entro i confini italiani; ma costrinse all’emigrazione scienziati e intellettuali italiani, privando il Paese di una componente culturale che, nella più parte dei casi, non avrebbe fatto ritorno in Italia neppure dopo la liberazione anche a causa degli ostacoli non solo burocratici alla reintegrazione di quanti erano stati costretti a espatriare e che per tornare a esercitare il proprio ruolo in patria non avrebbero potuto contare su nessun automatismo.
Le leggi contro gli ebrei costituirono un’ulteriore penetrazione del regime nel privato dei cittadini: il divieto dei matrimoni con cittadini ebrei; l’espulsione degli ebrei come studenti ed insegnanti dalle scuole e dalle università; l’espulsione degli ebrei dalla pubblica amministrazione.
Di fatto, ma anche di diritto, si venne a creare una doppia cittadinanza con cittadini di serie A e cittadini di serie B, preludio dell’ostracismo generalizzato sancito dalla Repubblica Sociale che proclamò semplicemente gli ebrei cittadini di stati nemici, quasi a dare la motivazione non solo ideologica per la parteicpazione italiana alla Shoah.
Ancora oggi è difficile dare una valutazione sicura delle reazioni della popolazione italiana alle leggi razziali. Le azioni di salvataggio compiute dopo l’8 settembre non devono ingannare a proposito dei comportamenti che si manifestarono prima dell’armistizio.
Gli stessi ebrei non si resero esattamente conto della portata delle leggi razziali. Il fanatismo della stampa, in particolare nella congiuntura bellica in cui gli ebrei vennero imputati di tutti i disastri del Paese, andava probabilmente oltre il tenore dello spirito pubblico che oscillava tra indifferenza e cauto plauso, aldilà del solito stuolo dei profittatori.
Le autorità periferiche non ebbero affatto i comportamenti blandi che qualche interprete vuole tuttora addebitare loro. Il conformismo imperante coinvolse la più parte della popolazione. Il comportamento timido, più che cauto, della Chiesa cattolica non incoraggiò in alcun modo atteggiamenti critici che rompessero la sostanziale omogeneità dell’assuefazione al regime.
A ottanta anni di distanza la riflessione su questi trascorsi è ancora aperta e si intreccia con alcuni dei nodi essenziali della storiografia sul fascismo (per esempio la questione del consenso).
È una storia che deve indurci ad approfondire un esame di coscienza collettivo alle radici della nostra democrazia e a dare una risposta a fatti che sembrano insegnarci come la lezione della storia non sia servita a nulla se è potuto accadere che il presidente del tribunale fascista della razza diventasse anche presidente della Corte Costituzionale della Repubblica.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
FASCISMO E LEGGI PER LA DIFESA DELLA RAZZA (1938). De Felice, Mussolini, e la "percentuale" del 1932.
- EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ...
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. - Il coraggio della disobbedienza: un appello per un "Sanctuary Movement" (di Alex Zanotelli)23 gennaio 2018, di Federico La Sala
Il coraggio della disobbedienza
- Ci vogliono una certa dose di follia e molto coraggio in tempi di campagna elettorale a seminare la nascita di un Sanctuary Movement in Europa a cominciare dall’Italia. Ci vogliono una certa dose di follia e molto coraggio nell’epoca del razzismo scomposto di Trump e in quello economicista dell’Ue a promuovere azioni di disobbedienza che coinvolgano chiese ma anche università e amministrazioni locali. In fondo sono la follia e il coraggio con i quali lo scorso anno, anche se pochi lo raccontano, il New Sanctuary Movement ha visto raddoppiare negli Stati uniti il numero di chiese e di persone comuni che offrono rifugio e asilo politico ai migranti minacciati di deportazione. Il grido di Alex Zanotelli
di Alex Zanotelli*
Nel maggio del 2017 ho lanciato un appello alle Chiese, Sanctuary Movement, che rimetto di nuovo in circolazione visto l’aggravarsi della situazione dei migranti nel nostro paese. L’appello è un invito alle Chiese (cattolica, valdese, luterana, anglicana, evangelica) di iniziare, come avviene negli Usa, ad offrire le nostre chiese come “santuario” per asilo politico per coloro che sono destinati alla deportazione nei loro paesi, non perché criminali, ma perché privi di documenti.
Quell’appello non ha avuto alcun riscontro positivo da parte delle Chiese in Italia.
Sanctuary Movement
Negli Usa al contrario lo scorso anno il Sanctuary Movement ha visto raddoppiare il numero di chiese che offrono rifugio e asilo politico per i migranti minacciati di deportazione. Non tutte le chiese offrono ospitalità a tali persone, ma tutte si impegnano a sostenere i minacciati di deportazione sia offrendo assistenza legale, ma soprattutto con l’impegno da parte di pastori o preti, di accompagnare queste persone in tribunale o dalla polizia. Ma anche, quando necessario, con sit-in o pray-in davanti ai tribunali. Ci auguriamo che questo Movimento possa presto sbocciare anche nelle Chiese in Italia.
Infatti Bruxelles intende deportare un milione di migranti irregolari. Un’operazione quasi impossibile, oltre che costosa, ma che rivela quale politica la Ue stia perseguendo. «È vero che siamo una civiltà che non fa figli - ha commentato qualche tempo fa papa Francesco - ma anche chiudiamo la porta ai migranti. Questo si chiama suicidio». E Bruxelles chiede ai ventisette stati membri di mettere mano alla propria legislazione per una politica più restrittiva nei confronti dei migranti.
 L’Italia ha prontamente risposto con il decreto Orlando-Minniti, il cosiddetto Pacchetto Sicurezza. Il decreto, approvato dal parlamento il 12 aprile 2017 con il ricatto della fiducia, stabilisce che il rifiuto di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Commissione territoriale non è reclamabile se non in Cassazione. Non c’è quindi per il rifugiato la possibilità di un appello in tribunale. Respinta la domanda, al rifugiato non resta che andare in un Centro permanente per il rifugiato, per poi essere espulso nell’inferno da cui è fuggito.
L’Italia ha prontamente risposto con il decreto Orlando-Minniti, il cosiddetto Pacchetto Sicurezza. Il decreto, approvato dal parlamento il 12 aprile 2017 con il ricatto della fiducia, stabilisce che il rifiuto di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Commissione territoriale non è reclamabile se non in Cassazione. Non c’è quindi per il rifugiato la possibilità di un appello in tribunale. Respinta la domanda, al rifugiato non resta che andare in un Centro permanente per il rifugiato, per poi essere espulso nell’inferno da cui è fuggito.Atto di coraggio
E questo sta avvenendo non solo in Europa, ma anche negli Usa con Trump, che minaccia di espellere undici milioni di clandestini, in buona parte latinos. Infatti Trump, oltre al muro tra gli Usa e il Messico, che gli costerà un miliardo di dollari, ha iniziato ad espellere ogni settimana settecento clandestini. Per rispondere a questa tragedia, alcune Chiese hanno rilanciato il Sanctuary Movement (il movimento che offre asilo, rifugio, “santuario” a chi è ricercato dalla polizia per essere espulso, perché considerato “clandestino”).
È un movimento che si rifà alla tradizione biblica (Num. 35,9-34), ripresa poi nel Medioevo, per cui chi riesce a trovare rifugio in un luogo sacro o in una città asilo aveva il diritto di essere protetto. Questo movimento ha avuto inizio negli Usa negli anni Ottanta, quando Reagan deportava i rifugiati ai loro paesi come il Salvador o il Nicaragua dove li aspettava la morte. Più di cinquecento chiese si erano costituite “santuari” di asilo politico. Molti si sono salvati così.
 Ora, con Trump, oltre mille istituzioni (fra queste, anche città, università e contee) hanno iniziato a dare rifugio politico a chi rischia di essere espulso. I responsabili religiosi si rifiutano di aprire le chiese alla polizia, quando viene per arrestare i clandestini. «Le chiese devono aprire i loro battenti per accogliere coloro che Trump vuole deportare - afferma nella rivista ecumenica Sojourners, B. Packnett. Se Trump decidesse di deportare undici milioni di clandestini, dobbiamo chiedere una massiccia disobbedienza civile. La resistenza è un lavoro sacro. Ecco perché è il nostro lavoro”.
Ora, con Trump, oltre mille istituzioni (fra queste, anche città, università e contee) hanno iniziato a dare rifugio politico a chi rischia di essere espulso. I responsabili religiosi si rifiutano di aprire le chiese alla polizia, quando viene per arrestare i clandestini. «Le chiese devono aprire i loro battenti per accogliere coloro che Trump vuole deportare - afferma nella rivista ecumenica Sojourners, B. Packnett. Se Trump decidesse di deportare undici milioni di clandestini, dobbiamo chiedere una massiccia disobbedienza civile. La resistenza è un lavoro sacro. Ecco perché è il nostro lavoro”.Alle chiese si sono aggiunte anche alcune università, città e contee. Alle “città santuario” il 25 gennaio Trump ha deciso di tagliare i fondi federali. Ma ora è lo stesso stato della California a dichiararsi “stato-santuario”, attirandosi i fulmini di Trump. Questo movimento è uno straordinario stimolo per le sonnolente Chiese d’Europa. Data la gravità della situazione dei migranti in Europa, diventa pressante un appello anche alle Chiese in Italia perché lancino nel nostro paese il movimento delle ‘chiese santuario’!
Disobbedienza civile
È un atto di coraggio che la Chiesa cattolica in Italia deve fare: diocesi e parrocchie, comunità cristiane e conventi. È il coraggio della disobbedienza civile per la difesa della vita umana! E lo stesso coraggio lo devono avere le Chiese valdesi, luterane, battiste, metodiste, evangeliche presenti sul nostro territorio. Se le chiese dessero l’esempio, anche città, comuni, municipalità e università potrebbero seguirne l’esempio.
 «Sogno un’Europa in cui essere migrante non è un delitto», ha detto papa Francesco parlando alle massime autorità della Ue. Questo è anche il nostro sogno e il nostro impegno.
«Sogno un’Europa in cui essere migrante non è un delitto», ha detto papa Francesco parlando alle massime autorità della Ue. Questo è anche il nostro sogno e il nostro impegno.*Missionario comboniano
* Fonte: Comune-info, 21 gennaio 2018 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- Il «discorso di Nausicaa» (Odissea, libro Vi) e una filosofia della migrazione21 gennaio 2018, di Federico La Sala
Stranieri e diritti
Quei migranti senza pensiero
di Francesca Rigotti(Il Sole.24 Ore, Domenica, 21.01.2018)
- Donatella Di Cesare, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione ,Bollati Boringhieri, Torino, pp. 280.€ 19
C’è da chiedersi come mai la filosofia politica, nel suo costante richiamarsi alla cultura classica greca e latina, non abbia mai ripreso il «discorso di Nausicaa». Si tratta delle parole che nel libro VI dell’Odissea la giovanissima principessa dei Feaci rivolge alle sue ancelle, fuggite per lo spavento alla vista del profugo proveniente dal mare e che si rivelerà essere Ulisse: «Olà, disse, fermatevi. In qual parte/ Fuggite voi, perché v’apparve un uomo?/ Mirar credeste d’un nemico il volto? [...] Un misero è costui, che a queste piagge/ capitò errando, e a cui pensar or vuolsi. / Gli stranieri, vedete, ed i mendichi/ Vengon da Giove tutti, e non v’ha dono/ Picciolo sì, che a lor non torni caro» (tr. di I. Pindemonte).
Conosciamo a memoria il discorso di Pericle con l’elogio della democrazia ma queste parole che invitano all’accoglienza dello straniero ci sono ignote. Perché provengono da voce di donna? Perché una filosofia della migrazione in grado di riprenderle ed elaborarle non è mai stata scritta, che è l’argomento sostenuto in questo saggio poderoso e coraggioso da Donatella Di Cesare nel momento in cui ne propone a sua volta una? Certo, ci sono i pensieri nomadici di Deleuze e quelli nomadico-femministi di Braidotti; c’è la filosofia dell’esilio di Maria Zambrano e c’è un accenno di filosofia dei migranti in Vilèm Flusser (tutti, eccetto Deleuze, migranti, esuli, emigrati tornati e no, come Di Cesare, come me).
Eppure la filosofia politica tradizionale ha dimenticato i profughi e aggirato l’accoglienza. Mancano, scrive Di Cesare, «sia una riflessione sul migrare sia un pensiero intorno al migrante», e persino le idee acute e feconde di una rifugiata e apolide d’eccezione, Hannah Arendt, non vennero né da lei nè da altri elaborate in una complessiva filosofia della migrazione.
Perché di questo qui ci si occupa, non di trovare soluzioni politiche per regolare i flussi o integrare i migranti, temi che ricadono nella logica immunitaria che si comporta come la ferita che si chiude sui suoi bordi per difendersi dal corpo estraneo, e che tratta il migrante come un criminale recludendolo in campi di internamento. Qui si va alla ricerca di motivazioni e argomentazioni a favore sia di un pensiero dell’accoglienza che dia luogo - faccia posto come in uno scompartimento ferroviario, spiega la bella analogia dell’autrice - a chi arriva spinto dalle persecuzioni belliche come da quelle economiche; sia dell’elaborazione di uno ius migrandi che protegga la libertà di movimento e soprattutto promuova una redistribuzione egualitaria dei beni oltre che la condivisione della terra.
Le domande filosofiche ci interrogano dunque intorno all’autoproclamato diritto dei primi arrivati in un territorio e degli stati costituitisi intorno ad essi, di impedire o limitare a discrezione l’ingresso nel «proprio» territorio, ammettere ed escludere secondo il criterio dell’avvantaggiare i nostri, il nostro prossimo: «prima noi, prima i nostri, America ( o altro stato a piacere) first».
Ma anche, e a monte di questo, sul diritto di garantire giustizia sociale soltanto al vicino, al prossimo, al concittadino. È un grande tema su cui si sono interrogati Cicerone come pure Martha Nussbaum, e che val la pena di riprendere: dove Cicerone con cautela afferma che dovremmo preferire, nell’assegnare assistenza e aiuto, il vicino e l’amico, ed estendere l’aiuto e l’assistenza a chi è lontano o viene da lontano solamente se ciò può essere fatto senza sacrifici e dispendi per noi, Martha Nussbaum pensa e dice esattamente il contrario. Per motivare l’affermazione che abbiamo doveri verso persone in stato di bisogno che vengono da altre nazioni, Nussbaum sostiene che è incombente per noi abitanti dei paesi opulenti il dovere di salvare dalla fame, dalla povertà e dalla guerra abitanti di nazioni povere, affamate e in guerra. I doveri legati al senso di giustizia non si devono limitare a concedere beni non materiali (e non costosi) come rispetto e dignità, ma anche a distribuire aiuto materiale (che incide innegabilmente sulla tassazione).
Per parte sua Di Cesare analizza con acribia gli argomenti di coloro che sostengono il respingimento dei profughi in base alla priorità dei cittadini sugli immigrati, all’integrità nazionale e alla proprietà del territorio, tutte asserzioni che non hanno fondamento filosofico. E questo, anche se poi il migrante ben sa che la cesura dell’emigrazione non potrà mai essere saldata e riparata perché è un’esperienza che marchia a fuoco e che rende impossibile il ritorno all’innocenza.
Alla pars destruens del testo, che va a criticare la giustizia locale di Rawls e varie posizioni nazionaliste, liberali e cosmopolitiche, ma soprattutto il comunitarismo di Michael Walzer, nel cui stato-club l’appartenenza alla comunità è condizione di distribuzione di beni, segue la pars construens, che discute tre modelli dell’abitare la terra. Il modello dell’autoctonia ateniese, con la sua omogeneità garantita dalla purezza del ghénos e legata all’identità dell’origine; il modello aperto della civitas romana dove la cittadinanza è inclusiva e dinamica e infine il modello del paesaggio ebraico dove abitano gli «stranieri residenti» del titolo. La fonte della sovranità ebraica è l’estraneità, la condizione dello straniero da rispettare, «perché anche voi foste stranieri in Egitto».
Nella proposta di Di Cesare ospitalità e cittadinanza coincidono, nell’orizzonte di una comunità dissociata dalla nazione, dalla nascita e dalla filiazione, aperta all’accoglienza - come quella esercitata da Nausicaa con le parole e con le sue azioni - nonché capace di dar luogo a forme politiche dove l’immune lascia la precedenza al comune.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- «Migranti, Europa ricorda la tua storia» (di Paul Ricoeur - un ’appello’ inedito).16 gennaio 2018, di Federico La Sala
L’appello.
Ricoeur: «Migranti, Europa ricorda la tua storia»
di Paul Ricoeur (Avvenire, martedì 16 gennaio 2018)
- La rivista Vita e Pensiero pubblica un inedito in cui il filosofo francese, di fronte al fenomeno dell’emigrazione, invitava l’Occidente a ricordare il proprio passato di accoglienza e integrazione Ricoeur: «Migranti, Europa ricorda la tua storia»
La cultura europea presa nel suo insieme è forse la sola che ha assunto il compito considerevole di coniugare in modo così costante convinzioni e critica. Così il cristianesimo, a differenza dell’islam, ha dovuto sempre venire a patti con il suo avversario razionalista e interiorizzare la critica in auto-critica. In un certo senso la crisi non è un accidente contingente, meno ancora una malattia moderna: è costitutiva della coscienza europea.
 L’eterogeneità delle tradizioni fondatrici e la discordanza tra convinzioni e critica mi hanno indotto a pronunciare la parola fragilità. È su questa fragilità dello spazio d’esperienza dell’Europa che vorrei insistere prima di rivolgermi verso quella della coscienza del futuro. In effetti si passa facilmente dalla fragilità alla patologia. Quest’ultima si presenta come una crisi della memoria e della tradizione.
L’eterogeneità delle tradizioni fondatrici e la discordanza tra convinzioni e critica mi hanno indotto a pronunciare la parola fragilità. È su questa fragilità dello spazio d’esperienza dell’Europa che vorrei insistere prima di rivolgermi verso quella della coscienza del futuro. In effetti si passa facilmente dalla fragilità alla patologia. Quest’ultima si presenta come una crisi della memoria e della tradizione.
 Crisi della memoria: tocchiamo qui un paradosso sconcertante; spesso le regioni, le nazioni o i popoli soffrono a volte di un eccesso di memoria, altre di un difetto di memoria. Nel primo caso, illustrato tragicamente dall’ex Jugoslavia, ogni comunità vuole ricordarsi solo delle epoche di grandezza e gloria, e per contrasto solamente delle umiliazioni subite.
Crisi della memoria: tocchiamo qui un paradosso sconcertante; spesso le regioni, le nazioni o i popoli soffrono a volte di un eccesso di memoria, altre di un difetto di memoria. Nel primo caso, illustrato tragicamente dall’ex Jugoslavia, ogni comunità vuole ricordarsi solo delle epoche di grandezza e gloria, e per contrasto solamente delle umiliazioni subite.Nel secondo caso, quello dell’Europa occidentale post-staliniana, il rifiuto della trasparenza equivale a una volontà di oblio e conduce a una fuga davanti alla colpa. Ciò che è comune a questi due fenomeni, in apparenza opposti, è un rapporto pervertito con la tradizione. Strappata dalla dialettica prima evocata tra lo spazio d’esperienza e l’orizzonte dell’attesa, la tradizione si riduce a un deposito sedimentato e pietrificato che gli uni esaltano e gli altri si sforzano di nascondere e seppellire.
 Ma la crisi della memoria e della tradizione non avviene senza una crisi della proiezione verso il futuro; a volte l’orizzonte d’attesa si svuota di ogni contenuto, di ogni scopo degno di essere perseguito; così si riscontra un po’ dappertutto il diffondersi della diffidenza nei confronti di ogni previsione a medio termine e a maggior ragione nei confronti di ogni profezia a lungo termine; ma i fatti, all’opposto, si lasciano ugualmente osservare: in assenza di un progetto accessibile, ci si rifugia nelle utopie di sogno che distruggono ogni ragionevole e tenace volontà di riforme.
Ma la crisi della memoria e della tradizione non avviene senza una crisi della proiezione verso il futuro; a volte l’orizzonte d’attesa si svuota di ogni contenuto, di ogni scopo degno di essere perseguito; così si riscontra un po’ dappertutto il diffondersi della diffidenza nei confronti di ogni previsione a medio termine e a maggior ragione nei confronti di ogni profezia a lungo termine; ma i fatti, all’opposto, si lasciano ugualmente osservare: in assenza di un progetto accessibile, ci si rifugia nelle utopie di sogno che distruggono ogni ragionevole e tenace volontà di riforme.
 Questa doppia patologia che riguarda tanto il futuro quanto il passato si riflette a sua volta in un impoverimento del presente, compresa, come ho suggerito prima, la capacità d’iniziativa, d’intervento nel corso delle cose.
Questa doppia patologia che riguarda tanto il futuro quanto il passato si riflette a sua volta in un impoverimento del presente, compresa, come ho suggerito prima, la capacità d’iniziativa, d’intervento nel corso delle cose.È così che si assiste qui e là a una privatizzazione dei desideri e dei progetti, a un culto del consumerismo a corto raggio; all’origine di questo movimento di ripiegamento si percepisce senza fatica un disimpegno nei confronti di ogni responsabilità civica. Gli individui dimenticano che la nazione non esiste che in virtù di un voler vivere insieme sostenuto e ratificato da un vecchio tacito contratto tra i cittadini di uno stesso popolo e di una stessa nazione. L’individualismo, che sovente si deplora senza analizzarlo, è senza dubbio l’effetto del movimento di ritiro fuori da questo voler vivere insieme e fuori dal contratto civico che ratifica quest’ultimo. Qui ancora, la patologia del legame sociale non fa che rendere visibile l’estrema fragilità di quello.
 Concluderò questa riflessione sulla crisi della coscienza storica in Europa sottolineando il fenomeno sul quale Koselleck mette fortemente l’accento, cioè la perdita di ogni senso della storia, di ogni orientamento nel tempo storico.
Concluderò questa riflessione sulla crisi della coscienza storica in Europa sottolineando il fenomeno sul quale Koselleck mette fortemente l’accento, cioè la perdita di ogni senso della storia, di ogni orientamento nel tempo storico.Se alcuni parlano di epoca post-moderna, l’espressione è giustificata, nella misura in cui si può identificare la modernità all’idea razionale di progresso. In fondo non soffriamo meno della cancellazione dell’idea di progresso ricevuta dall’epoca dei Lumi che della secolarizzazione che patisce l’Europa cristiana, se non addirittura dell’allontanamento assai marcato dalla sorgente greca ed ebraica della nostra cultura privata e pubblica. È in questo modo che il crollo dell’idea di progresso conduce per contrasto ad aumentare uno dopo l’altro il sentimento di aleatorietà, o quello di un destino opprimente, quando non conduce a cedere alla seduzione esercitata su di noi dalle idee di caos, di differenza e di erranza. Quest’ultimo termine dovrà allertarci qui e ora quando ci riferiamo alle migrazioni.
 Perché le migrazioni riuscite che hanno fatto l’Europa e alle quali ho fatto già una prima allusione, sono state il contrario di un’erranza; o piuttosto vi sono forme di erranza che sono state intercettate e interrotte da lenti e penosi tentativi di acculturazione dei barbari da cui tutti discendiamo in qualche grado, negli spazi culturali stabiliti dall’Impero romano, poi dall’Europa cristiana, dal Rinascimento, dalla Riforma e dall’Europa dei Lumi. Sono queste le componenti di ciò che abbiamo prima chiamato spazio d’esperienza. -Prima di essere degli spazi di sedimentazione, furono degli spazi d’integrazione, di stabilizzazione. Ed è per questo che si pone la questione di sapere se, per riprendere una formula di Habermas, il progetto dei Lumi è oggi esaurito o, risalendo più in alto nel passato, se l’eredità greco-romana e l’eredità giudeo-cristiana sono ancora suscettibili d’essere riattivate.
Perché le migrazioni riuscite che hanno fatto l’Europa e alle quali ho fatto già una prima allusione, sono state il contrario di un’erranza; o piuttosto vi sono forme di erranza che sono state intercettate e interrotte da lenti e penosi tentativi di acculturazione dei barbari da cui tutti discendiamo in qualche grado, negli spazi culturali stabiliti dall’Impero romano, poi dall’Europa cristiana, dal Rinascimento, dalla Riforma e dall’Europa dei Lumi. Sono queste le componenti di ciò che abbiamo prima chiamato spazio d’esperienza. -Prima di essere degli spazi di sedimentazione, furono degli spazi d’integrazione, di stabilizzazione. Ed è per questo che si pone la questione di sapere se, per riprendere una formula di Habermas, il progetto dei Lumi è oggi esaurito o, risalendo più in alto nel passato, se l’eredità greco-romana e l’eredità giudeo-cristiana sono ancora suscettibili d’essere riattivate.
 Una tradizione non resta vivente se non è sempre reinterpretata. Questa osservazione si applica tanto alle tradizioni cristiane quanto alle eredità greco-romane, medievali così come alle tradizioni ricevute dall’epoca dei Lumi. La critica stessa è una tradizione tra le altre, incorporata nelle convinzioni ereditate e richiesta a una cultura continuamente rinnovata. Inoltre, alla luce della critica storica, una tradizione si rivela essere portatrice di promesse non adempiute, cioè impedite e rimosse dai nuovi attori della storia.
Una tradizione non resta vivente se non è sempre reinterpretata. Questa osservazione si applica tanto alle tradizioni cristiane quanto alle eredità greco-romane, medievali così come alle tradizioni ricevute dall’epoca dei Lumi. La critica stessa è una tradizione tra le altre, incorporata nelle convinzioni ereditate e richiesta a una cultura continuamente rinnovata. Inoltre, alla luce della critica storica, una tradizione si rivela essere portatrice di promesse non adempiute, cioè impedite e rimosse dai nuovi attori della storia.Si può dire, senza paradosso eccessivo, che gli uomini appartenenti a epoche passate erano portatori di attese, sogni, utopie che non sono stati soddisfatti e che importa liberare e incorporare alle nostre proprie attese, per fornirgli un contenuto e, oso dire, un corpo. In breve, occorre accedere a una concezione aperta della tradizione. Più esattamente, occorre riaprire il passato e liberare il suo carico di futuro.
 Non vi è qui una forma di migrazione nell’incompiuto del passato? Quest’ultima suggestione ci permette di dire una parola sulla terapia del futuro. Liberare le promesse non mantenute del passato è già una parte della terapia, nella misura in cui ciò di cui soffre la nostra capacità di proiezione nel futuro è una mancanza di contenuto. In questo senso, innovazione e tradizione sono le due facce di uno stesso fenomeno costitutivo della coscienza storica. Ma concordo volentieri che non è sufficiente attingere al passato e trattare le tradizioni come risorse vive piuttosto che come depositi per alimentare il nostro slancio verso il futuro. Qui vorrei insistere su un aspetto del problema che tocca la questione della migrazione in quanto aspetto del cambiamento culturale.
Non vi è qui una forma di migrazione nell’incompiuto del passato? Quest’ultima suggestione ci permette di dire una parola sulla terapia del futuro. Liberare le promesse non mantenute del passato è già una parte della terapia, nella misura in cui ciò di cui soffre la nostra capacità di proiezione nel futuro è una mancanza di contenuto. In questo senso, innovazione e tradizione sono le due facce di uno stesso fenomeno costitutivo della coscienza storica. Ma concordo volentieri che non è sufficiente attingere al passato e trattare le tradizioni come risorse vive piuttosto che come depositi per alimentare il nostro slancio verso il futuro. Qui vorrei insistere su un aspetto del problema che tocca la questione della migrazione in quanto aspetto del cambiamento culturale.
 L’invenzione maggiore alla quale oggi siamo invitati riguarda l’integrazione le une con le altre delle attitudini nei confronti del futuro che sono sempre minacciate di dissociarsi: che si tratti di prospettive tecnologiche, di anticipazioni economiche, di risoluzioni di problemi morali inediti posti dalle minacce all’eco-sistema, dalle possibilità d’intervento nel patrimonio genetico umano, dalla sovrabbondanza dei segni in circolazione eccedenti la nostra capacità di integrazione.
L’invenzione maggiore alla quale oggi siamo invitati riguarda l’integrazione le une con le altre delle attitudini nei confronti del futuro che sono sempre minacciate di dissociarsi: che si tratti di prospettive tecnologiche, di anticipazioni economiche, di risoluzioni di problemi morali inediti posti dalle minacce all’eco-sistema, dalle possibilità d’intervento nel patrimonio genetico umano, dalla sovrabbondanza dei segni in circolazione eccedenti la nostra capacità di integrazione.Dico che questo problema d’integrazione tocca il fenomeno della migrazione, nella misura in cui le migrazioni riuscite del passato sono consistite anch’esse in una integrazione progressiva di valori eterogenei, a uno spazio culturale di accoglienza che si è arricchito esso stesso delle invasioni che hanno nell’immediato minacciato la sua coesione.
 Amerei aggiungere a queste due componenti della terapia del passato di cui stiamo parlando, l’integrazione delle promesse liberate dal peso di un passato morto e la nostra capacità di progettare l’avvenire e l’integrazione in uno stesso orizzonte d’attesa di modalità eterogenee d’anticipazione. Questa terza componente è la più difficile da apprezzare nel suo giusto valore; voglio parlare della dimensione utopica. Si può diffidare delle utopie, in ragione della loro rigidità dottrinale, del loro disprezzo nei confronti delle prime misure concrete da prendere in direzione della loro realizzazione. Ma i popoli non possono più vivere senza utopia, così come gli individui senza sogno. -(Traduzione di Riccardo De Benedetti © Comité éditorial Fonds Ricoeur)
Amerei aggiungere a queste due componenti della terapia del passato di cui stiamo parlando, l’integrazione delle promesse liberate dal peso di un passato morto e la nostra capacità di progettare l’avvenire e l’integrazione in uno stesso orizzonte d’attesa di modalità eterogenee d’anticipazione. Questa terza componente è la più difficile da apprezzare nel suo giusto valore; voglio parlare della dimensione utopica. Si può diffidare delle utopie, in ragione della loro rigidità dottrinale, del loro disprezzo nei confronti delle prime misure concrete da prendere in direzione della loro realizzazione. Ma i popoli non possono più vivere senza utopia, così come gli individui senza sogno. -(Traduzione di Riccardo De Benedetti © Comité éditorial Fonds Ricoeur)
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI). Una ’traccia’ dal "Diario fenomenologico")
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- LA CHIESA CATTOLICA, IL POPOLO MAPUCHE, E I DISPOSITIVI IDEOLOGICI COLONIALI. Alla vigilia della visita di papa Francesco in Cile, occupata la nunziatura14 gennaio 2018, di Federico La Sala
IL POPOLO MAPUCHE, LA CHIESA CATTOLICA, E I DISPOSITIVI IDEOLOGICI COLONIALI. RIPENSARE L’EUROPA...
Nei giorni di Francesco i mapuche bruciano le chiese
“Simbolo di oppressione”
Alla vigilia della visita in Cile, occupata la nunziatura
di Andrea Freddi (La Stampa, 13.01.2018)
Chiese bruciate e la nunziatura occupata. È un Cile irrequieto quello che aspetta il Papa. I mapuche riscoprono una lotta anti religiosa, mentre nella capitale, un gruppo di manifestanti ha occupato la sede apostolica per protestare contro la visita di Francesco che comincia lunedì per concludersi in Perù il 22 gennaio.
Il cuore del viaggio di Bergoglio sarà l’Araucania, una zona ad alto rischio per il secolare conflitto tra latifondisti e comunità mapuche. E a partire dal 2016 l’attivismo indigeno ha preso un’inedita sterzata anti-religiosa: periodicamente la popolazione araucana si sveglia con una chiesa in meno. I tg trasmettono le immagini dei luoghi di culto incendiati da una rabbia con origini antiche. È a Temuco, capoluogo dell’Araucania, che il Papa farà tappa nel suo viaggio in Cile. Qui si concentra il 35% della popolazione mapuche su un totale di 1,3 milioni di persone. Per la messa collettiva Francesco ha chiesto di dare spazio a una cerimonia mapuche e di pranzare con alcune autorità indigene. Ma cosa dirà nella terra delle chiese in fiamme?
«Ci si aspetta un messaggio a favore del riconoscimento dei mapuche - dice Enrique Antileo, 35 anni, antropologo di origine mapuche -. Nella popolazione esiste la coscienza di essere un popolo colonizzato. È il debito storico che lo Stato cileno ha nei nostri confronti». I mapuche sono l’unica popolazione americana che ha resistito alla conquista: dopo decenni di campagne militari la corona spagnola dovette riconoscerne l’indipendenza. Fu lo Stato cileno a sconfiggere militarmente i mapuche, alla fine del XIX secolo, con la Pacificazione dell’Araucania. Una campagna genocida che smembrò il Wallmapu, l’antica nazione mapuche, costringendo gli indigeni nelle riserve, mentre le terre più fertili erano date agli europei chiamati a «sbiancare la razza».
L’obiettivo primario dell’attivismo indigeno è recuperare le terre e ricostituire il Wallmapu. «L’elemento in comune è il riconoscimento dei mapuche come nazione» continua Antileo «le differenze sono nel quanto e nel come». Si passa dall’associazione di sindaci mapuche, che si muove all’interno delle istituzioni e chiede allo Stato una riforma federalista, alla Wam, l’organizzazione radicale che ha rivendicato i roghi delle chiese e altri atti violenti, con posizioni più indipendentiste. Fonti ufficiali parlano di oltre venti casi, tra chiese e cappelle cattoliche e templi evangelici, dal marzo 2016. Perché?
«La chiesa cattolica è vista come un dispositivo ideologico coloniale», spiega Manuela Royo, 34 anni, avvocato difensore dei mapuche contro l’applicazione della legge antiterrorismo, provvedimento attraverso cui la dittatura perseguiva la dissidenza politica. La sua applicazione contro gli imputati mapuche favorisce incarcerazioni preventive e sospensione dei diritti dell’accusato. Al centro delle accuse c’è il vescovo di Villarica, Stegmeier che ha tagliato i canali di dialogo tra Chiesa e comunità indigene. L’atto scatenante è stato lo sgombero violento di una comunità mapuche da un territorio ecclesiastico rivendicato dagli indigeni. «Anche la Chiesa ha usurpato terre ai mapuche», afferma Royo «e nell’ostruire un processo di restituzione, si è schierata dalla parte degli impresari».
Il vescovo di Villarica appartiene all’Opus Dei ed è discendente di coloni tedeschi che hanno finanziato Colonia Dignidad, enclave nazista in Araucania e luogo di tortura durante la dittatura di Pinochet. Rappresenta la parte più conservatrice della Chiesa cattolica, contrastata da numerosi parroci che convivono con le comunità indigene. Tra loro i gesuiti. Tenendo conto che Francesco è la principale carica della gerarchia ecclesiastica, ma è anche di formazione gesuita, la sua visita a Temuco suscita in Cile interesse e preoccupazione. E tanti interrogativi. Il più grande sul contenuto del suo discorso.
Per Bergoglio è il viaggio più insidioso
di Andrea Tornielli (La Stampa, 13.01.2018)
Doveva essere un tranquillo ritorno nella «sua» America Latina. Invece il viaggio in Cile e Perù che Francesco inizia lunedì rischia di essere tra i più insidiosi. L’occupazione della nunziatura è un pessimo segnale, dato che lì Bergoglio dovrà alloggiare a Santiago.
Alcuni gruppi della minoranza Mapuche, pur non essendo ostili verso la Chiesa che li ha spesso difesi, con le loro azioni violente vogliono cercano visibilità. Oltre alle polemiche per i costi della visita, ci sono motivi di risentimento verso i vescovi per la gestione dei casi di pedofilia.
 Irrisolta è situazione del vescovo di Osorno, Juan Barros, formatosi alla scuola del potente padre Fernando Karadima, riconosciuto colpevole di abusi su minori. Barros dice di non aver mai saputo cosa facesse il suo mentore ma la sua presenza in diocesi sta diventando insostenibile.
Irrisolta è situazione del vescovo di Osorno, Juan Barros, formatosi alla scuola del potente padre Fernando Karadima, riconosciuto colpevole di abusi su minori. Barros dice di non aver mai saputo cosa facesse il suo mentore ma la sua presenza in diocesi sta diventando insostenibile.
 La Chiesa cilena, che al tempo di Pinochet godeva di un grande prestigio per le sue coraggiose denunce, oggi ha perso molta credibilità nell’opinione pubblica. Per invertire la tendenza Francesco dovrà muoversi fuori dai protocolli.
La Chiesa cilena, che al tempo di Pinochet godeva di un grande prestigio per le sue coraggiose denunce, oggi ha perso molta credibilità nell’opinione pubblica. Per invertire la tendenza Francesco dovrà muoversi fuori dai protocolli.
SUL TEMA, IN RETE, E NEL SITO, SI CFR.:
- DONNE, UOMINI E VIOLENZA... L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
- Patagonia. Il filo di lana e quello spinato (di Patrizia Larese -"Comune-info")
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- COABITARE IL MONDO. Un pensiero politico contro la xenofobia populista e il razzismo. Un saggio di Donatella Di Cesare.14 dicembre 2017, di Federico La Sala
Donatella Di Cesare, la sovversione di coabitare il mondo
«Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione», per Bollati Boringhieri. Un pensiero politico contro la xenofobia populista e il razzismo. La nostra casa non è lo Stato, né il mercato, ma il mondo intero: l’Internazionale
di Roberto Ciccarelli (il manifesto, 14.12.2017)
Chi è alla ricerca di un’istanza politica contraria al «nazionalismo» in epoca «post-nazionale» e al sovranismo razzista che lega la destra e la sinistra nell’abbraccio mortale con il populismo, la può trovare in Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione (Bollati Boringhieri, pp. 275, euro 19). È un libro importante quello scritto da Donatella Di Cesare, potente nella decostruzione della sovranità, incalzante nello svolgimento tra riflessione genealogica, racconto e saggio. Una prova dello stile della filosofia contemporanea: il «pensiero dell’attualità». Questo libro, scrive l’autrice, è un contributo alla definizione di uno jus migrandi in un momento politico in cui i diritti fondamentali delle persone sono soggetti a una torsione securitaria tale che appare lecito chiedersi se non sia finita l’idea stessa di ospitalità.
LA FILOSOFIA della migrazione non è una teoria dell’erranza senza ritorno alla «terra madre» o all’autorevole «padre». Non è una teoria economica, biologica o un’etica dell’«Altro». È una filosofia politica anti-sovranista, una politica della «coabitazione» nella terra spaesata, per di più in tempi di «globalizzazione» dove facciamo ritorno a una casa che è sempre altrove. Questa filosofia è l’espressione di un «diritto di fuga», mentre la libertà soggettiva di chi emigra è punita, tradotta in mobilità, resa adattabile a «quote» e fabbisogni di manodopera. Il migrare eccede ogni misura e indica un destino più ampio, il soggiorno umano sulla terra riguarda tutti, nessuno escluso.
SIN DA PLATONE e Aristotele la figura dello straniero ha destabilizzato il nomos stanziale della filosofia e oggi scuote le radici dello Stato in quanto átopos - il senza luogo, il fuori-luogo ovunque del nomadismo. Lo Straniero è una figura presente in tutte le culture e le religioni. Nella Torah, ad esempio, gli abitanti della terra sono gherim vetoshavim, stranieri e residenti temporanei allo stesso tempo. Questa è anche la condizione del lavoratore a giornata, il lavoratore che vende la forza lavoro, in cambio ottiene un salario spesso non sufficiente per sopravvivere, in più è sfruttato. Senza contare che, in questo caso, l’estraneità è l’esperienza di tutti i lavoratori rispetto al loro lavoro mercificato. Quando si incarna nel migrante, lo straniero diventa un’anomalia intollerabile. Non è solo un intruso illegale. La sua esistenza segregata in spazi di eccezione è percepita come una sfida all’esistenza dello Stato. Alla «nuda vita» è attribuita una carica sovversiva perché scredita la purezza mitica del potere e rivela i paradossi della cittadinanza: l’inclusione degli «autoctoni» è basata sull’esclusione degli «stranieri». La «democrazia» è tale quando si difende dall’esterno ed esercita un potere coercitivo contro gli inermi anche all’interno.
IL MIGRANTE, in quanto straniero, è una figura abissale perché rivela che l’estraneo non è solo l’altro da me, ma è quello che abita in me. Questa esperienza è stata definita da Freud «perturbante»: è ciò che turba l’ordine dell’Io, mostrando l’inquietudine più grande. L’Io non ha proprietà, una terra a cui appartenere, una coscienza a cui rimettere i suoi peccati, ma è un altro ed è straniero a se stesso. È Unheimlich, un essere-senza-casa. Il migrante mette a nudo il mito dell’identità autoctona, la finzione su cui è fondata la sovranità, il valore che lo Stato difende in nome della «sicurezza». Se l’Io è un altro, scriveva Rimbaud, allora il Sé immobile crolla. Un esito inaccettabile che lo Stato evita ricorrendo alla polizia e agli eserciti. Così la sovranità esibisce il suo ultimo potere: il monopolio della violenza.
QUESTA È LA TRAGEDIA dell’attuale governo italiano: dopo avere respinto i migranti in Libia, li ha guardati sulla Cnn venduti come schiavi. Un delitto atroce che non troverà, probabilmente, un giudice, ma forse molte testimonianze. Stranieri residenti è una di queste. Ed è bruciante. In tedesco esiste una parola che spiega questa esperienza perturbante: Wanderung. Significa migrare e errare. L’equivalenza tra un movimento fisico e l’esperienza dell’errare (vagare, sbagliare) è il fondamento della filosofia della migrazione. Il suo obiettivo è dimostrare che l’abitare non è mai puro. Chi abita in un territorio viene da un movimento e si dirige altrove. Così fa il migrante: il punto dove arriva coincide con una nuova partenza. L’abitante è anche lui un migrante che ha deciso di fermarsi, e poi ripartire di nuovo. Prima di un territorio statale, abitiamo una vita che non appartiene a nessuno ed è comune a tutti. Condividiamo un movimento ancora prima di un’appartenenza. Siamo tutti stranieri e residenti. Su questa «e» si gioca il conflitto.
LA CASA degli stranieri residenti non è lo Stato, né il mercato. È l’Internazionale. La riproposizione di questa categoria è una delle idee originali del libro. Di Cesare la intende come sinonimo di una «coabitazione oltre le appartenenze e la proprietà». In questa prospettiva l’Altro non è una metafisica, non è l’ospite, né può essere rinchiuso nelle contraddizioni del diritto di asilo. Se lo straniero siamo noi, allora il sé e l’altro non sono opposti, ma si implicano a vicenda. Lo straniero non è dunque l’ opposto del cittadino, entrambi sono stranieri residenti in un’Internazionale slegata dal territorio e dalla cittadinanza, capace di trasformare la prima e di superare le aporie della seconda. La coabitazione indica un essere-in-comune, pratica una convergenza politica e mostra un altro modo di stare al mondo. Per gli anarchici e i comunisti la casa è il mondo intero. Per tutti gli altri l’Internazionale è la coabitazione della futura umanità con i prossimi e gli stranieri.
-
> RIPENSARE L’EUROPA! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. Una "memoria" - L’ordinario fascismo delle ragazzate (di Luca Baldissara)29 novembre 2017, di Federico La Sala
L’ordinario fascismo delle ragazzate
di Luca Baldissara (Il Mulibo, 28 novembre 2017)
Non c’è quotidiano o sito d’informazione che nei giorni scorsi non abbia ripreso la notizia del saluto fascista col quale un calciatore ha esultato sul campo di calcio di Marzabotto, esibendo la t-shirt con la bandiera della Repubblica di Salò indossata sotto la maglia della squadra. Al gesto fascista - presumiamo programmato, a meno che il giovane non sia solito indossare magliette con l’effige saloina e non sia affetto dalla sindrome di Stranamore - segue l’ormai usuale e collaudata ritualità: indignazione (dell’Anpi e dell’amministrazione comunale in primis, poi di vari esponenti politici), scuse goffe e poco credibili del protagonista (avrebbe inteso salutare il padre in tribuna), presa di distanza della squadra e della società (immaginiamo la vestizione tenuta nascosta dell’aspirante saloino nella nota segretezza dello spogliatoio), denuncia da parte della destra degli eccessi d’attenzione strumentale delle “maestranze antifasciste” (così le ha definite Forza Nuova), espiazione in forma di visita al sacrario delle vittime.
Atti del genere non sono nuovi, tutt’altro. Anzi, dobbiamo riconoscere che dal 2005 - quando l’allora giocatore della Lazio Paolo Di Canio più volte sotto la curva dei tifosi compì questo stesso teatrale gesto (e non era la prima volta) - sono ricorrenti e sempre più frequenti. Intendiamoci: l’indignazione è sacrosanta. E doverosa - quanto, assai probabilmente e sulla base di precedenti simili, priva di esiti giudiziari concreti - è la denuncia per apologia di fascismo a norma della legge Scelba del 1952 da parte dei carabinieri. Condivisibili pure le parole - non troppe, in verità - di condanna ed esecrazione del gesto.
Questa procedura rituale fondata sulla sequenza colpa (il gesto), condanna (l’indignazione pubblica), assoluzione (le scuse e l’atto riparatore) ha probabilmente a che fare con le modalità esteriori della confessione/assoluzione di un cattolicesimo volgarizzato nelle sue forme esteriori, ma ha certo molto di più a che vedere con il moralismo sarcasticamente criticato da Charles Baudelaire nei suoi Diari intimi: ⪻Tutti gli imbecilli della Borghesia che pronunciano continuamente le parole: immorale, immoralità, moralità nell’arte e altre bestialità mi fanno pensare a Louise Villedieu, puttana da cinque franchi, che accompagnandomi una volta al Louvre, dove non era mai stata, si mise ad arrossire, a coprirsi la faccia, e tirandomi a ogni momento per la manica, mi domandava davanti alle statue e ai quadri immortali come si potessero esporre pubblicamente simili indecenze⪼.
Nel senso che il rituale conformista con cui gesto dopo gesto, saluto romano dopo saluto romano, si rinnova la pubblica esecrazione non appare in grado di cogliere le ragioni di questo infittirsi di comportamenti inneggianti il fascismo, né tantomeno di evitarne il ripetersi. Anzi, sembra ipocritamente e moralisticamente distogliere lo sguardo, proprio come Louise Villedieu, dalle sconcezze che prendono forma e visibilità.
C’è infatti da chiedersi se i sempre più numerosi saluti a braccio teso nel calcio non costituiscano tanto il problema in sé, quanto piuttosto la spia di un nuovo senso comune, sempre più solido e sempre più diffuso, che, insieme ad altre manifestazioni esteriori di fascismo (dall’intitolazione di strade e piazze alla gestione di “spiagge fasciste”, alle bandiere di Salò sventolate in cima alle Apuane), sempre più spesso evoca il fascismo quale dimensione “altra”, autentica, di valori ormai perduti in questa società senza bussola, materialista e in crisi di identità.
Vi saranno, certo, i nostalgici del passato. E vi saranno i convinti assertori dell’ideologia fascista in tutte le sue forme e declinazioni. Ma vi è anche, e soprattutto, chi in questa rappresentazione di fascismo intravvede la difesa di identità minacciate dai tumultuosi processi di mutamento del presente, l’attenzione per gruppi sociali abbandonati a se stessi dalle istituzioni e dalla sinistra, il rigore contro una classe politica che appare corrotta nel suo insieme, la concretezza di contro alle tante vuote ed ipocrite parole, la prospettiva potenziale di una solidarietà comunitaria contro il cosmopolitismo vacuo e astratto dei buoni sentimenti. Una società confusa, incerta, preoccupata, attraversata dall’ansia del futuro cerca risposte credibili. E sempre più la credibilità sembra fondarsi nella semplificazione, mentre ogni richiamo alla complessità del presente appare una forma di inganno, una truffa retorica. La logica binaria del pensiero - e della propaganda - di destra sembra dunque più sincera, più fondata, più autentica. La recente affermazione elettorale di CasaPound a Ostia è solo l’ultimo indicatore in ordine di tempo di tale fenomeno.
Ma che cosa in Italia - pur in un contesto europeo del fenomeno - ha reso possibile questa plausibilità del discorso fascista? Il fatto che dopo il 1989-91, dopo la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell’Urss, dopo l’implosione del sistema dei partiti e la scomparsa del Pci, il fascismo è stato “normalizzato”, reso un regime tra i regimi. Certo, esso è stato ricompreso in una famiglia autoritaria e totalitaria di cui erano parte allo stesso titolo il nazismo quanto il comunismo, quasi si trattasse di un virus che nella parte centrale del Novecento ha colpito taluni Paesi e diffuso rapidamente la malattia. Ma nella sua quotidianità il fascismo, a parte alcuni eccessi, peraltro condivisi appunto con altri regimi dell’epoca, ha in fondo governato il paese come altri governi in precedenza avevano fatto e altri avrebbero fatto in seguito. Violenza e repressione, antidemocrazia e aggressività nazionalista, erano presentati come frutto dei tempi, più che tratti distintivi. Tale visione politico-culturale di un fascismo normalizzato a partire dagli anni Novanta si è accompagnata anche alla sua banalizzazione nel discorso pubblico, consentendo ad esempio di descrivere Mussolini come “un grande statista”.
Tutto ciò mentre la volontà di costruire un’Europa capace di ricomprendere le due Europe, dell’Est e dell’Ovest, con le loro storie così diverse, conduceva a inventare una comune (e inesistente) identità antitotalitaria, indebolendo sistematicamente quella cultura dell’antifascismo che aveva rappresentato l’unico cemento coesivo di classi dirigenti politicamente divise al loro interno, consentendo loro di costruire la democrazia rappresentativa di massa nell’Europa occidentale, Italia compresa. Indebolito e delegittimato l’antifascismo, da allora sono andati rapidamente riemergendo lo sciovinismo, il nazionalismo, l’elitismo classista, il corporatismo sociale.
In Italia, dove la fine del bipolarismo ha coinciso con la fine del sistema dei partiti sorto con il crollo del fascismo, il passaggio alla cosiddetta “Seconda Repubblica” ha visto non solo l’indebolirsi, come in tutta Europa, della cultura dell’antifascismo, ridotto a un astorico antitotalitarismo, a una generica lotta per la libertà, dove fascismo e comunismo venivano accostati (ci si ricorda ancora del dibattito Fini-Violante sui ragazzi di Salò?). Ma ha identificato nello stesso sistema ciellenistico dei partiti antifascisti (la partitocrazia) l’origine del clientelismo e della corruzione che ne avrebbero provocato il crollo. Cosicché, critica e decostruzione dell’antifascismo hanno corrisposto allo sdoganamento del fascismo, non tanto nei suoi termini immediatamente politici (che pure non sono mancati), quanto nella sua ordinaria banalizzazione e normalizzazione. Così che qualcuno ha potuto immaginare un fascismo quale forma di anticomformismo, di possibile risposta all’inanità e alla corruzione delle classi dirigenti e del ceto politico.
Se Berlusconi nel 2005 poteva dunque sorridere al gesto di Di Canio, giudicandolo ⪻un ragazzo per bene, non è fascista⪼, il cui gesto era fatto ⪻solo per i tifosi, non per cattiveria⪼, così oggi Salvini, commentando il fatto di Marzabotto, può dichiarare che ⪻fa molti più danni la legge Fornero di un saluto al Duce⪼ e che ⪻uno può salutare col braccio teso o col pugno chiuso, rappresentano lo stesso autoritarismo, hanno lo stesso valore. Non torneranno più né il fascismo, né il comunismo⪼. Così Morris Battistini, il capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale a Marzabotto, può sostenere che ⪻da moderati e liberali quali siamo, esprimendo una ferma condanna verso l’esibizione di una maglietta che soprattutto in questo territorio non andava portata, non riteniamo però utile un linciaggio mediatico che ha il sapore di vetrina politica⪼.
Insomma, sono ragazzate. Come ha scritto il giovane calciatore dal braccio teso, un’azione compiuta ⪻con leggerezza, senza pensare alle conseguenze⪼. Del resto, come Giacomo Matteotti ricordava a Giolitti nella seduta della Camera del 31 gennaio 1921, con questi termini il questore di Bologna aveva bollato l’assalto fascista alla Camera del lavoro.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? Una riflessione di Angelo Casati
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - I "MONITI ALL’EUROPA" DI THOMAS MANN. Ripensare alcuni tragici nodi del passato, ma anche snebbiarsi gli occhi dalle opache interpretazioni del momento presente.21 novembre 2017, di Federico La Sala
LO SPIRITO DELL’EUROPA .... *
- "(...) anche se il futuro riplasmerà o modificherà questo o quel risultato delle sue ricerche, mai più potranno essere messi a tacere gli interrogativi che Sigmund Freud ha posto all’umanità; le sue scoperte scientifiche non si possono né negare, né occultare (...) e se mai alcuna impresa della nostra specie umana rimarrà indimenticabile, questa sarà proprio l’impresa di Sigmund Freud" (Thomas Mann)
Thomas Mann: è l’Europa l’unico antidoto al nazionalismo tedesco
Tornano, con una introduzione di Giorgio Napolitano, i Moniti etico-politici scritti tra le due guerre: mai così attuali
di Francesca Sforza (La Stampa, 21.11.2017)
Mai così tedesco, Thomas Mann, come quando era lontano dalla Germania. E mai così attuale come nei giorni in cui la Repubblica Federale, dopo aver per la prima volta riammesso nel Bundestag gli estremisti del partito di destra AfD, si prepara ad affrontare una stagione quanto mai difficile, senza una maggioranza di governo stabile, con una cancelliera sfinita da infruttuose consultazioni e un futuro segnato da incertezza e instabilità.
Leggere oggi Moniti all’Europa, raccolta di saggi di Thomas Mann scritti tra il 1922 e il 1945 - che Mondadori ripubblica dopo sessant’anni dalla prima edizione nella stessa traduzione di Lavinia Mazzucchetti e con un’importante introduzione di Giorgio Napolitano - significa dunque ripensare alcuni tragici nodi del passato, ma anche snebbiarsi gli occhi dalle opache interpretazioni del momento presente.
La raccolta si apre con lo storico discorso berlinese del 1922 Della repubblica tedesca, a sostegno della repubblica di Weimar, attraversa gli scritti più espressamente anti-hitleriani e i radiomessaggi inviati all’America al popolo tedesco durante gli anni della guerra, per poi concludersi con due fondamentali saggi del 1945: La Germania e i tedeschi, e Perché non ritorno in Germania, in cui Thomas Mann concentra in pagine brevi e intensissime il senso della missione individuata per il proprio Paese, ovvero quello di farsi il più possibile europeo.
Una domanda però sorge spontanea: siamo di fronte allo stesso autore che nel 1918 pubblicava le Considerazioni di un impolitico, manifesto del più puro neoconservatorismo, venato di pulsioni illiberali e antidemocratiche, ambiguo nei toni e appannato nei propositi? A tentare una risposta è Giorgio Napolitano, nella sua introduzione, quando sottolinea il bisogno di Mann di trovare, per sua stessa ammissione, «una verità nuova quale nuovo stimolo di vita»: l’adesione alla repubblica e alla democrazia, scrive il Presidente emerito, «risente in qualche passaggio ancora di un certo impaccio, ma senza più ombra di dubbio o equivoco», in particolare quando attacca «“i patrioti avversari”, il loro nazionalismo, e ne ridicolizza la nostalgia dinastico-imperiale del Paese».
C’è uno scritto, in particolare, che riassume con forza la ritrattazione di Considerazioni di un impolitico - ritrattazione a tratti insinuata, ma mai resa esplicita, è bene ricordarlo - ed è La Germania e i tedeschi, in cui Mann, per prima cosa, confessa di sentirsi profondamente a suo agio nei panni americani: «Così come le cose stanno oggi [giugno 1945, ndr], il mio germanesimo è qui, nell’ospitale cosmopoli, nell’universo nazionale e razziale che ha nome America, al suo posto migliore». È come se la permanenza americana portasse una ventilazione nuova nei suoi pensieri, facendogli cogliere la bellezza dell’universalismo, del cosmopolitismo, della mescolanza. E meglio mostrasse, per converso, l’angustia dei sovranismi, delle barriere nazionalistiche, dei deliri identitari e dei trionfalismi germanocentrici.
Ed è peculiare che Mann scelga, per meglio esprimere le contraddizioni dell’animo tedesco, Martin Lutero, il riformatore, l’uomo della separazione da Roma. Per un verso Mann ne riconosce la grandezza, relativamente alla capacità di garantire la libertà religiosa, per l’altro però ne vede l’incapacità di comprendere con la stessa lungimiranza la libertà del cittadino, come ben sintetizzò la sua posizione - di totale disprezzo e rifiuto - nei confronti della rivolta dei contadini.
Thomas Mann, di fronte a Lutero, è in primo luogo spaventato, e a spaventarlo è l’estrema «tedeschità» dell’uomo, il suo spirito anti-romano e anti-europeo: «Non mi sarebbe piaciuto essere ospite alla tavola di Lutero, mi sarei probabilmente sentito come nella dimora di un orco, mentre sono persuaso che me la sarei cavata molto meglio con Leone X, cioè con Giovanni de’ Medici, il cortese umanista che Lutero soleva chiamare “la scrofa del demonio, il Papa”».
In antitesi al modello-Lutero si staglia, nel percorso del Mann americano e rinnovato, la figura di Goethe, capace di conciliare forza popolare e civilizzazione: «Egli è il demonismo consumato, è spirito e sangue a un tempo, cioè arte [... ], con lui la Germania ha fatto un grandioso passo avanti sul cammino della civiltà umana».
Ciò che più di tutti Thomas Mann lamenta, nel guardare le macerie tedesche, è quel pendere dalla parte di Lutero, più che di Goethe. E risuona sinistra la domanda che pone e si pone: «Perché l’impulso di libertà tedesco deve sfociare sempre in una non-libertà interiore?».
Nel ribadire di non essere in alcun modo un nazionalista, Thomas Mann in questi scritti affida il destino della Germania, e anche il suo personale, all’impegno nei confronti dell’Europa, unico antidoto al nazionalismo tedesco: «Mi si conceda il mio germanesimo cosmopolita», scrive quasi chiedendo indulgenza per non voler ritornare in patria, dopo la guerra. Sarebbe stato per lui un gesto troppo politico, la cui portata, ne era forse consapevole, non avrebbe saputo gestire.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
ROMA BRUCIA. GRAZIE AL "TIMES" PER L’ALLARME, MA LONDRA NON RIDA (E ABBIA MIGLIOR CURA DI FREUD). L’incendio è generale. Un omaggio alla Sapienza di Oxford
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - “Moniti all’Europa”. Quando Thomas Mann non salvò la democrazia (di Massimo Cacciari).14 novembre 2017, di Federico La Sala
Considerazioni di un politico. Quando Thomas Mann non salvò la democrazia
Tornano, con un saggio di Giorgio Napolitano, i “Moniti all’Europa” del grande scrittore tedesco.
Orazioni civili per fermare la caduta di Weimar.
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 13 novembre 2017)
Documento storico di eccezionale importanza per la comprensione del “suicidio” politico d’Europa tra le due Guerre, delle ragioni dell’affermazione e del destino del regime nazista, della crisi di civiltà di cui esso fu espressione, ma ancora testimonianza dell’amore consapevole e tormentato di un grande intellettuale europeo per la sua patria, mai tanto amata quanto nell’angoscia di doverla abbandonare e, anzi, nel doverne auspicare la tragica disfatta.
Tutto questo significano i discorsi e i saggi politici di Thomas Mann, che Mondadori presentò ai lettori italiani nel 1947, con il titolo “Moniti all’Europa”, e che ora riedita con una introduzione di Giorgio Napolitano, che è un monito per noi, per il nostro presente, e, a sua volta, testimonianza di una straordinaria esperienza culturale, politica e umana, segnata da drammatici interrogativi e amare inquietudini. Questo “dialogo” tra due coscienze apparentemente lontanissime, ma in realtà e nel profondo amiche sia nel disincanto che nella speranza sul futuro d’Europa, rende il libro davvero necessario.
Nessuno potrà mai comprendere il dramma del dopoguerra tedesco e la crisi della Repubblica di Weimar, già immanente all’atto della sua fondazione, se non mediterà sul grande discorso Della repubblica tedesca tenuto da Mann a Berlino nell’ottobre del 1922. Gli sta alla pari forse soltanto quello di Max Weber agli studenti di Monaco durante la rivoluzione del ’18. È l’appello alla ragione, al realismo politico, alla sobrietà del discorso contro l’attivismo tumultuoso e impaziente; è l’appello alla forma contro l’impeto della vita che vorrebbe non riconoscere altro ordine, altro limite che quelli dell’espressione della propria potenza. In Weber parla la responsabilità politica, della politica come alta vocazione.
In Mann, che è trascinato nell’agone politico dalla guerra, che è costretto alla politica dalle tragedie dell’epoca, parla quella che per lui è la fondamentale tradizione, l’eredità del pensiero tedesco, la cui catastrofe coinciderebbe con la rovina della stessa Germania. Di fronte a entrambi i giovani - giovani che non li comprendono, estranei al loro linguaggio.
Il discorso di Mann è continuamente interrotto. A leggerlo si rivive un autentico dialogo tragico. Quale sofferenza maggiore di quella di uno scrittore, di un poeta che si ritiene e si vuole profonda espressione della propria terra, il quale si scopre senza figli, vede sterile la propria arte, e proprio a conclusione di un immane conflitto in cui egli si era schierato per la vittoria tedesca in quanto vittoria dello spirito e della cultura contro le potenze impersonali, sradicate, puramente tecnico- economiche della civilizzazione? Eppure dalla sofferenza occorre imparare. La prospettiva delle Considerazioni di un impolitico del 1918, le idee anti-politiche e anti-democratiche di quell’opera, alimenterebbero ora soltanto spiriti reazionari, nazionalismi esasperati e impotenti. Tuttavia Mann non abiura, «io non revoco niente. Non ritratto nulla di essenziale».
Questo punto è di fondamentale importanza. Esso segna la grande differenza del poeta tedesco con un altro intellettuale europeo che per tanti versi potrebbe apparirgli affine (e tale affinità certamente avverte Giorgio Napolitano), Benedetto Croce. Croce è del tutto estraneo alla temperie ideologica delle Considerazioni. Mann “emerge” dal loro crogiuolo infuocato e continua a portarne in sé tutti i “veleni”. Mann si è formato in Schopenhauer, in Nietzsche, in Wagner; il suo Goethe era il Goethe di costoro. Non li potrà mai abbandonare, ma re-interpretare e rivivere soltanto. Croce sembra invece ignorare la radicalità della crisi del pensiero europeo a cavallo del secolo; per lui non si tratta che di un tragico intervallo irrazionalistico in quella storia dell’affermazione dell’idea di libertà che è «la luce e l’anima dell’Occidente»( Mann).
Mann ne riconosce, invece, la necessità storica; le voci che l’hanno agitata né possono né debbono venire dimenticate. Esse esprimono una verità - ma questa deve essere diversamente ascoltata. È l’impervia impresa che egli tenta nel discorso Della repubblica tedesca di fronte a vecchi maestri e politici dotati di antica temperanza e misura, come “babbo” Ebert e Gerhart Hauptmann, ”il poeta pietoso”, e ai continui segni di disapprovazione della gioventù studentesca. Forse che Romantico significa semplicemente simpatia per la notte e la morte, per l’aorgico e il dionisiaco?
Non sono forse i suoi grandi poeti, invece, a esaltare la personalità della propria patria in quanto partecipe del “grande Stato” formato dall’intera umanità? Sono certi questi giovani, entusiasti fino al fanatismo, che Illuminismo e Romantico siano assolutamente opposti? Che Novalis nulla abbia a che fare con l’intelletto e la repubblica? Non è rintracciabile il germe di un’idea tedesca di repubblica negli stessi Maestri cantori? Grande retorica manniana, sul filo del paradosso, condotta con la penetrazione sim-patatetica di cui solo la più disperata speranza è capace. Coniugare Novalis con Walt Whitman - quale triplo salto mortale! Eppure sì, è necessario tentarlo. Necessario cantare Deutschland über Alles nella stessa tonalità con cui Whitman aveva cantato la democrazia americana.
La democrazia non può ridursi a una carta costituzionale vissuta come mera convenzione, a un ordinamento senz’anima. Se non ha chi la canta, anche in terra europea, se non saprà essere anche fede, non potrà resistere all’assalto dei suoi nemici. Herder ha insegnato a Goethe che ogni grande poesia è sempre il risultato di uno spirito nazionale; oggi è necessario che essa sia il riflesso dello spirito dell’idea repubblicana- democratica.
Idea che significa responsabilità personale, comprendere che lo Stato è ora nelle nostre mani, l’opposto di un’uguaglianza livellatrice. Soltanto nell’affermazione di questa idea si impedirà la liquefazione della eredità goethiana e dell’intera civiltà europea. La “rivoluzione” democratica tedesca appare perciò a Mann conservatrice: «In realtà io sono un conservatore ».
Repubblica e democrazia formano un tutt’uno nel contenere le potenze distruttive che la guerra ha scatenato. Anti-cristiche anche? Sì, tali appariranno palesemente nella figura di Hitler. Esse mirano a cancellare l’Europa o cristianità. L’idea democratica è in sé rivoluzionaria - come appunto la concepisce Whitman: una rivoluzione permanente volta al culto della persona umana e della pace - e nello stesso tempo profondamente conservatrice.
Questo spirito informa di sé la proposta politica manniana. E qui il monito del poeta si incontra con la dolorosa esperienza del politico di vocazione che oggi ce la introduce, il presidente Napolitano. La salvezza della Repubblica di Weimar, e cioè almeno il freno, il contenimento della reazione, sarà perseguibile soltanto se le forze dei partiti borghesi-liberali e quelle del partito socialdemocratico sapranno trovare un’intesa, e cioè comprendere la loro complementarietà.
La borghesia è dominata da una paura: il comunismo. Questa paura la spinge, nelle mani di una destra nazionalistica, razzista, autoritaria, e cioè al suicidio. Cos’è in realtà oggi il marxismo? Riformismo soltanto: proteggere e migliorare il tenore di vita delle classi lavoratrici; custodire la forma democratica; politica estera di pace. Sono questi obbiettivi estranei allo spirito della borghesia?
Il mio è un angosciato monologo alla borghesia tedesca, scrive Mann; io “figlio della borghesia” mi rivolgo a voi perché non spezziate il filo dell’alleanza possibile perseguita da politici come il cancelliere Stresemann, fondata su valori di libertà, giustizia, cultura, fede nel progresso, che sono i vostri - e che Mann ritroverà nell’esilio americano incarnati da Roosevelt. Napolitano sottolinea questi passaggi con interiore partecipazione.
L’alleanza tra cultura borghese e socialdemocrazia non ha rappresentato la ragione più profonda anche della sua esperienza politica? Non ha cercato per tutta la vita di liberare la borghesia dallo spauracchio del comunismo? E tuttavia “comunista” si chiamava il suo partito. Cosa significa una tale astuzia del destino? Forse è Mann, ma il Mann delle Considerazioni, a farcelo capire: l’epoca borghese e il suo mondo sono finiti per sempre con la Grande Guerra. La svolta è decisiva e irreversibile. Il romanzo giovanile, I Buddenbrook, ne rappresentano l’epitaffio.
Il capitalismo contemporaneo non è borghese, il suo sempre-più e sempre-oltre manca della misura, del Takt, della cultura che appartenevano all’illuminismo dei Diderot come al romanticismo dei Novalis. Un’epoca semi-barbara si spalanca, masslose la chiamava Nietzsche, per la quale il “grande Stato” che l’umanità costituisce non è che il mercato aperto dello scambio, insofferente di confini quanto di regole, e universale è davvero soltanto la potenza del denaro.
Come potrà esservi una politica «nella pienezza del suo significato e della sua efficacia» in una tale situazione storica? Questa la domanda che Napolitano si rivolge alla fine del suo saggio. Quando la politica perde la sua dimensione ideale e spirituale si fa per forza «di corto termine e respiro», e per ciò stesso impotente, come lo fu a Weimar nel costruire una solida repubblica democratica, cosi ora nel realizzare quella vera unità politica europea, di cui la Germania sia pilastro essenziale, che rappresentava l’incrollabile speranza di Mann.
Ma quella dimensione ideale e spirituale si identificava per lui con lo spirito della borghesia. Ha sperato Napolitano che la socialdemocrazia stessa potesse diventarne l’erede? Lo spera ancora dinanzi alla crisi che in tutta Europa sembra metterne in discussione la stessa esistenza? Sono domande che si addicono soltanto ai protagonisti massimi di una stagione storica, che forse soltanto loro sono oggi capaci di cogliere.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - I PAPI E LO SCHIAVISMO. "The Popes, the Catholic Church and the Transatlantic Enslavement of Black Africans 1418-1839"12 novembre 2017, di Federico La Sala
Quando la Chiesa amava tutti gli uomini esclusi gli africani
Il libro di un prete nigeriano svela il ruolo dei papi nella pratica dello schiavismo fino al 1839
di Rita Monaldi Francesco Sorti (La Stampa, 12.11.17
I papi hanno abusato della Bibbia per lucrare sul traffico di schiavi». Queste parole non vengono da qualche autore di thriller trash a base di scandali vaticani, ma da uno storico serio che sul tema vanta una doppia legittimazione. È nigeriano (quindi partie en cause) e soprattutto è un prete cattolico. Si chiama Pius Adiele Onyemechi ed esercita da 20 anni il suo ministero in Germania, nella regione del Baden-Württemberg.
La sua innovativa indagine The Popes, the Catholic Church and the Transatlantic Enslavement of Black Africans 1418-1839 (pp. XVI/590., €98 Olms, 2017), che tra gli storici già suscita discussioni, capovolge il vecchio dogma secondo cui il Papato è stato sostanzialmente estraneo alla più grande strage di tutti i tempi: la tratta degli schiavi. Una tragedia secolare che - come ricorda il grande scrittore danese Thorkild Hansen nella sua classica trilogia sullo schiavismo - ha seminato oltre 80 milioni di morti.
Una sorpresa
Proprio in questi mesi la prestigiosa Accademia delle Scienze di Magonza ha concluso un colossale progetto di ricerca sulla storia della schiavitù durato ben 65 anni, con la collaborazione di studiosi di primo piano come il sociologo di Harvard Orlando Patterson (egli stesso discendente di schiavi) e lo storico dell’antichità Winfried Schmitz. Quasi a suggello è arrivato il libro di don Onyemechi: una radiografia minuziosa del ruolo dei papi nel commercio di schiavi in Africa dal XV al XIX secolo, l’epoca dorata del business schiavistico.
Per la prima volta a suon di date, fatti e nomi don Onyemechi punta il dito su responsabilità morali e materiali, avviando un regolamento di conti col passato proprio nel momento in cui la Chiesa di Roma, nella sua tradizione secolare di sostegno ai più deboli, chiama alla solidarietà verso i migranti. Come riassume l’autore, i risultati «fortemente sorprendenti» venuti alla luce «affondano un dito nelle ferite di questo capitolo oscuro della Storia, e nella vita della Chiesa cattolica».
«La Chiesa», spiega il religioso, «ha abusato del passo biblico contenuto nel capitolo 9 della Genesi», in cui si afferma che tutti i popoli della terra discendono dai figli di Noè: Sem, Cam e Iafet. Dopo il diluvio, Cam rivelò ai fratelli di aver visto il padre giacere ubriaco e nudo. Noè maledisse Cam insieme a tutti i suoi discendenti, condannandoli a diventare servi di Sem e Iafet. La Chiesa allora affermò che gli africani sarebbero i discendenti di Cam. Pio IX, ancora nel 1873, inviterà tutti i credenti a pregare affinché sia scongiurata la maledizione di Noè pendente sull’Africa.
Documenti scomparsi
Nel nostro romanzo Imprimatur abbiamo reso noto il caso di Innocenzo XI Odescalchi (1676-1689), che possedeva schiavi, era in affari con mercanti negrieri e vessava i forzati in catene sulle galere pontificie. I documenti che lo provano, pubblicati nel 1887, sono poi misteriosamente scomparsi. Certo, nel Seicento i moderni diritti umani erano di là da venire, ma poi papa Odescalchi è stato beatificato nel 1956, e in predicato per la canonizzazione nel 2002.
Di simili contraddizioni don Onyemechi ne ha scovate a migliaia. Il commercio di schiavi in origine toccava Cina, Russia, Armenia e Persia; mercati internazionali si tenevano a Marsiglia, Pisa, Venezia, Genova, Verdun e Barcellona. Col tempo queste rotte sono tutte scomparse, tranne quelle africane. Come mai? Sarebbe stata la Chiesa a giocare il ruolo decisivo, raccomandando a sovrani e imperatori di «preferire» schiavi africani. Lo fecero vescovi e perfino Papi come Paolo V.
La giustificazione veniva non solo dalla Bibbia ma anche da Aristotele, per il quale alcuni popoli erano semplicemente «schiavi per natura». Una visione poi ripresa da San Tommaso e dall’influente facoltà teologica di Salamanca nel XV e XVI secolo. Padri della Chiesa come Basilio di Cesarea, Sant’Ambrogio, Gregorio di Nissa, Giovanni Crisostomo e lo stesso Sant’Agostino invece giustificavano la schiavitù come frutto del peccato originale.
Il Portogallo
A metà del XV secolo il portoghese Niccolò V concesse al suo Paese di origine il diritto di evangelizzare, conquistare e deportare «in schiavitù perenne» gli africani, bollati come nemici della Cristianità insieme ai saraceni (che in verità erano ben più pericolosi e martoriavano, loro sì, i regni cristiani). I successori Callisto III, Sisto IV, Leone X e Alessandro VI non fecero altro che confermare e ampliare i diritti concessi al Portogallo. Altri Pontefici (Paolo III, Gregorio XIV, Urbano VIII, Benedetto XIV) nelle loro Bolle ufficiali si schierarono contro la schiavitù degli Indiani d’America, ma non contro quella degli africani.
Dallo schiavismo la Chiesa ha avuto un concreto ritorno economico. Attivissimi i missionari portoghesi e soprattutto i gesuiti, che compravano gli schiavi per impiegarli nelle loro piantagioni in Brasile e nel Maryland. Oppure li rivendevano con la loro nave negriera «privata», che trasportava la merce umana da Congo, Luanda e São Tomé verso il Brasile.
Don Onyemechi cita il contratto con cui nel 1838 il Provinciale dei Gesuiti del Maryland, Thomas Mulledy, vendette 272 schiavi africani. Prezzo: 115.000 dollari al «pezzo». L’evangelizzazione consisteva per lo più nel battezzare in fretta e furia gli schiavi prima di imbarcarli. Anzi, tutto il meccanismo faceva sì che essi venissero tenuti ben lontani dalla parola di Cristo. I profitti venivano reinvestiti in nuove campagne di aggressione e deportazione.
Riconoscimento tardivo
«Solo nel 1839 la Chiesa ha riconosciuto gli africani come esseri umani al pari di tutti gli altri», ricorda lo storico di origine nigeriana. Lo sancì una Bolla di Gregorio XVI, in verità piuttosto tardiva: i commerci di schiavi erano stati già aboliti da quasi tutti gli Stati tra 1807 e 1818 e gli Inglesi ne avevano preso le distanze sin dalla fine del Settecento. Don Onyemechi ha lavorato su fonti originali nell’Archivio Segreto Vaticano e negli archivi di Lisbona (per decifrare i manoscritti lusitani ha imparato da zero il portoghese) e ha dato un contributo duraturo (realizzato con routine teutonica ogni giorno dalle 3 alle 8 del mattino) alla ricerca della verità storica. A Roma non dovrebbe riuscire sgradito, vista l’attenzione di papa Francesco - anche lui gesuita - per i popoli d’Africa.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - IL CASO DELL’ «AMISTAD» (1839). John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Nelson Mandela.13 novembre 2017, di Federico La Sala
Nota aggiunta.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
ABRAHAM LINCOLN E GLI STATI UNITI DI AMERICA, OGGI: LA LEZIONE DI STEVEN SPIELBERG.
UBUNTU: "Le persone diventano persone grazie ad altre persone".
 "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO.
"CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO.
-
-
>Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. -- IUS SOLI. "Per non doverci rammaricare". Appello di Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo Corsini, per non far morire la riforma3 ottobre 2017, di Federico La Sala
Ius soli, parlamentari e insegnanti iniziano sciopero fame: "Per non doverci rammaricare"
Ampia la risposta all’appello di Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo Corsini, per non far morire la riforma. Digiuno a partire da oggi
di VLADIMIRO POLCHI (la Repubblica, 03 ottobre 2017)
ROMA - Uno sciopero della fame tra i parlamentari "per non doverci amaramente rammaricare, tra qualche mese o qualche anno, della nostra ignavia o della nostra impotenza". Deputati e senatori rispondono all’appello di Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo Corsini, per non far morire la riforma dello ius soli. E dichiarano di essere pronti a digiunare a partire da oggi, assieme a 800 insegnanti a sostegno della legge sulla cittadinanza.
"Cara collega, caro collega - si legge nell’appello a cui aderiscono anche i Radicali italiani, il segretario Riccardo Magi e la presidente Antonella Soldo - vi scriviamo perché siete tra coloro che, dal primo momento e con maggiore determinazione, hanno sostenuto le buone ragioni della legge sullo ius soli. Ogni giorno lo spiraglio - pur esile, esilissimo - che sembra aprirsi sulle possibilità di una approvazione del testo, tende a chiudersi.
 Qualcosa si deve pur fare per non doverci amaramente rammaricare, tra qualche mese o qualche anno, della nostra ignavia o della nostra impotenza. Se, come tutto sembra indicare - e come segnalano anche le ripetute dichiarazioni del ministro Del Rio - questi sono giorni decisivi, proviamo a muoverci".
Qualcosa si deve pur fare per non doverci amaramente rammaricare, tra qualche mese o qualche anno, della nostra ignavia o della nostra impotenza. Se, come tutto sembra indicare - e come segnalano anche le ripetute dichiarazioni del ministro Del Rio - questi sono giorni decisivi, proviamo a muoverci"."Oggi, 3 ottobre - giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione - oltre 800 insegnanti attueranno uno sciopero della fame a sostegno della legge e informeranno i loro studenti del significato della propria azione. Potrebbe essere l’occasione, questa, per collegarsi a tale iniziativa rilanciandola nella nostra qualità di parlamentari. Si tratta di prendere una decisione immediatamente.
 L’ipotesi è quella di un digiuno a staffetta a sostegno della richiesta della presentazione in Aula prima possibile del disegno di legge. Dunque, per tenere aperto questo spiraglio e provare a inserirci in esso in maniera attiva ed efficace, coinvolgendo il maggior numero di persone affinché il governo decida di porre la fiducia".
L’ipotesi è quella di un digiuno a staffetta a sostegno della richiesta della presentazione in Aula prima possibile del disegno di legge. Dunque, per tenere aperto questo spiraglio e provare a inserirci in esso in maniera attiva ed efficace, coinvolgendo il maggior numero di persone affinché il governo decida di porre la fiducia"."I tempi potrebbero essere i seguenti: mercoledì 4 ottobre ci sarà il voto a maggioranza assoluta sulla nota di variazione di bilancio DEF. Dopo di ché si apre una sorta di finestra. Infatti la legge di stabilità arriverà in Senato (alle Commissioni) nell’ultima settimana di ottobre. Il calendario dei lavori dell’Aula si ferma a giovedì 19 ottobre. Occorrerà dunque una nuova Conferenza dei capigruppo. Ciò vuol dire che vi sono due settimane di tempo per ricercare i numeri necessari alla fiducia sul provvedimento relativo allo ius soli.
 Si tenga conto che quello stesso periodo di tempo coincide con la fase conclusiva della campagna Ero straniero. L’umanità che fa bene e della relativa raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata al superamento della legge Bossi-Fini. I due obiettivi potrebbero sostenersi e incentivarsi a vicenda. Pensiamo, in ogni caso, che si tratti di una prova difficile ma che vale la pena affrontare".
Si tenga conto che quello stesso periodo di tempo coincide con la fase conclusiva della campagna Ero straniero. L’umanità che fa bene e della relativa raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata al superamento della legge Bossi-Fini. I due obiettivi potrebbero sostenersi e incentivarsi a vicenda. Pensiamo, in ogni caso, che si tratti di una prova difficile ma che vale la pena affrontare"."Le modalità del digiuno a staffetta, a sostegno di questo percorso, verranno precisate puntualmente nelle prossime ore. E si ricordi che il pomeriggio del 13 ottobre, a partire dalle 16, davanti a Montecitorio è prevista una manifestazione alla quale sarebbe opportuno che tutti noi partecipassimo, promossa dalla rete degli "Italiani senza cittadinanza".
 Ti chiedo la tua adesione all’iniziativa nel più breve tempo possibile. Già una trentina di deputati si sono dichiarati disponibili a condividere con noi l’atto del digiuno. Aspettiamo la vostra adesione". Firmato: Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo Corsini.
Ti chiedo la tua adesione all’iniziativa nel più breve tempo possibile. Già una trentina di deputati si sono dichiarati disponibili a condividere con noi l’atto del digiuno. Aspettiamo la vostra adesione". Firmato: Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo Corsini.Hanno aderito finora: Loredana De Petris, Vannino Chiti, Walter Tocci, Laura Fasiolo, Francesco Palermo, Sergio Lo Giudice, Stefano Vaccari, Claudio Micheloni, Monica Cirinnà, Daniela Valentini, Laura Puppato, Luis Alberto Orellana, Massimo Cervellini, Peppe De Cristofaro, Alessia Petraglia, Deputati Michele Piras, Sandra Zampa, Mario Marazziti, Franco Monaco, Luisa Bossa, Eleonora Cimbro, Florian Kronbichler, Paolo Fontanelli, Nello Formisano, Gianni Melilla, Lara Ricciatti, Pippo Zappulla, Marisa Nicchi, Michele Ragosta, Luigi Laquaniti, Giovanna Martelli, Donatella Duranti, Toni Matarrelli, Filiberto Zaratti, Franco Bordo, Filippo Fossati, Tea Albini, Delia Murer.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- CITTADINANZA E "DIRITTO DEL SOLE" ("IUS SOLIS"): AL DI LA’ DEL DIRITTO DEL SANGUE ("IUS SANGUINIS") E DELLA TERRA ("IUS SOLI").
I DUE CORPI DEL RE, DEL PAPA, E DI OGNI ESSERE UMANO. La lezione di Dante, Kantorowicz, Freud e Mandela ...
 GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - Spagna: una nuova Costituzione e alla Catalogna tutta l’autonomia possibile (di Mauro Barberis).2 ottobre 2017, di Federico La Sala
RIPENSARE L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO E LA DEMOCRAZIA, A PARTIRE DALLA LEGGE DELLA UGUAGLIANZA ("LEY DE IGUALDAD") ... *
Europa
Spagna: una nuova Costituzione
di Mauro Barberis (Il Mulino, 02 ottobre 2017)
Si ha un bel dire, come ha fatto il premier spagnolo Mariano Rajoy, che il referendum catalano non c’è stato. Giuridicamente è così: quella che si è svolta ieri è una consultazione di fatto, svoltasi fuori da qualsiasi controllo, e non per colpa degli indipendentisti.
Per di più, il risultato finale - due milioni duecentomila elettori, con il novanta per cento a favore del sì - non ha neppure raggiunto la soglia psicologica della metà più uno dei catalani favorevoli alla secessione. Ma il punto è che se, come ha mostrato l’imbarazzante discorso di Rajoy, il governo spagnolo non ha un piano B che non sia l’invio della Guardia Civil, allora la convulsa giornata di ieri segna un punto decisivo a favore degli indipendentisti. Ci fosse scappato il morto, la secessione sarebbe già un fatto compiuto.
In attesa dello sciopero generale di domani e della probabile dichiarazione di indipendenza da parte del Parlamento catalano, chiediamoci come si sia arrivati a questo punto. Per noi italiani, la questione catalana evoca immediatamente la questione padana, oggetto di un referendum consultivo per l’autonomia, dichiarato dalla Lega con l’acquiescenza di Pd e M5S, che costerà al contribuente cinquanta milioni di euro. -Ma a differenza della Padania la Catalogna è davvero una nazione, con una storia, una lingua. E un’economia che produce un quinto del Pil spagnolo. (In più, i catalani sono maledettamente simpatici: almeno a chi tifa Barça, almeno dai tempi di Johann Crujiff).
La questione catalana, dunque, è più simile a quella dell’indipendenza della Scozia: altra nazione storica, confluita nel Regno Unito solo all’inizio del Settecento, e anch’essa percorsa dai venti della secessione. -Proprio il paragone con la Scozia, però, spiega perché la questione catalana rischia di esplodere nelle mani del governanti spagnoli e catalani. Il Regno Unito ha permesso agli scozzesi di pronunciarsi sulla loro indipendenza, ottenendone la risposta più prevedibile, almeno prima della Brexit: una sensibile maggioranza a favore dell’unione. In Catalogna, invece, le cose sono andate molto diversamente.
Da decenni i deboli esecutivi spagnoli contrattano la maggioranza in Parlamento con gli indipendentisti catalani, di destra e di sinistra, che alzano progressivamente il prezzo del loro sostegno senza ottenere un’autonomia paragonabile a quella dei Paesi baschi.
 Di errore in errore si è giunti così allo psicodramma di ieri, determinato dal tentativo di entrambe le parti di decidere la questione con una spallata. Come molti hanno notato, infatti, sino a ieri i catalani chiedevano solo l’autonomia, ottenuta dai Paesi baschi al prezzo di decenni di terrorismo. Solo l’atteggiamento miope e autoritario del governo centrale li ha spinti verso un’indipendenza, che potrebbero ottenere solo approfittando di un momento irripetibile, come nel caso della Brexit per il Regno Unito.
Di errore in errore si è giunti così allo psicodramma di ieri, determinato dal tentativo di entrambe le parti di decidere la questione con una spallata. Come molti hanno notato, infatti, sino a ieri i catalani chiedevano solo l’autonomia, ottenuta dai Paesi baschi al prezzo di decenni di terrorismo. Solo l’atteggiamento miope e autoritario del governo centrale li ha spinti verso un’indipendenza, che potrebbero ottenere solo approfittando di un momento irripetibile, come nel caso della Brexit per il Regno Unito.L’unica strada costituzionale percorribile, che sia politicamente e giuridicamente legittima, è un’altra, e dopo la consultazione di ieri appare più stretta di quella che si sta percorrendo. Questa strada non passa dai tentativi di spallate, da una parte e dall’altra, ma dalla via maestra di una riforma costituzionale. Le maggiori forze politiche spagnole potrebbero smetterla di fare accordi separati con gli indipendentisti e accordarsi su un cambiamento in senso federale della Costituzione del 1978, che dia alla Catalogna tutta l’autonomia possibile. A questo punto la riforma potrebbe persino prevedere la possibilità di un vero referendum per l’indipendenza: permettendo così ai catalani di decidere a mente fredda fra la certezza dell’autonomia e gli azzardi della secessione.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- DEMOCRAZIA "REALE": CHE COSA SIGNIFICA? CHE COSA E’? Alcuni chiarimenti, con approfondimenti
RIPENSARE L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO E LA DEMOCRAZIA, A PARTIRE DALLA LEGGE DELLA UGUAGLIANZA ("LEY DE IGUALDAD") DEL GOVERNO DI ZAPATERO ...
 CON LA SPAGNA DI "PUERTA DEL SOL", PER LA DEMOCRAZIA "REALE": RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DELL’UMANESIMO RINASCIMENTALE.
CON LA SPAGNA DI "PUERTA DEL SOL", PER LA DEMOCRAZIA "REALE": RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DELL’UMANESIMO RINASCIMENTALE.Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- UN MONDO SENZA LIMITI. "Spazio, potere, comunicazione nell’epoca dell’aria".2 ottobre 2017, di Federico La Sala
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE... *
Un mondo senza limiti
- [foto] Harrison Schmitt, The Blue Marble, 7 dicembre 1972, Houston, NASA Johnson Space Center
di Luigi Marfè ("Alfabeta2", 2 ottobre 2017)
- Matteo Vegetti, L’invenzione del globo. Spazio, potere, comunicazione nell’epoca dell’aria, Einaudi, 2017, 226 pp., € 24
Quando, a cominciare dal 1946, i vettori spaziali cominciarono a scattare fotografie della Terra, per la prima volta l’uomo poté vedere il proprio pianeta dall’esterno. Dalle prime immagini sfocate si giunse in breve a rappresentazioni più precise, come la Blue Marble scattata dall’Apollo 17 nel ’72, capaci di imprimersi a fondo nell’immaginario collettivo. Da sempre al centro della fantasia di esploratori e poeti, il sogno di abbracciare l’intero globo e delinearne un’immagine veritiera parve infine realizzarsi.
“Il costituirsi del mondo a immagine” sarebbe del resto, secondo Heidegger, “ciò che distingue e caratterizza il Mondo Moderno”. Le immagini spaziali della Terra - quello “sguardo dal di fuori” di cui parlava nel 1981 Alberto Boatto (il grande critico d’arte e saggista scomparso lo scorso 9 febbraio) in un saggio pioneristico dal titolo omonimo, recentemente ripubblicato da Castelvecchi (2013) - rappresenterebbero, in questa prospettiva, l’ultimo tassello di un processo di “invenzione della tradizione” che risalirebbe molto più indietro nel tempo.
L’invenzione del globo di Matteo Vegetti si concentra proprio su questa storia e ne verifica la consistenza in testi di varia origine, dalla filosofia alla poesia, dalla scienza politica alla dottrina militare, nella convinzione che tale ricostruzione possa contribuire a riflettere con meno approssimazione su uno dei concetti più abusati e consunti del dibattito pubblico attuale: quello di “globalizzazione”.
 Punto di partenza di Vegetti è un passo di Terra e Mare di Carl Schmitt (1942), in cui si allude a una vera e propria “rivoluzione spaziale” (Raumrevolution) grazie alla quale l’uomo si sarebbe appropriato dello spazio atmosferico, stravolgendo equilibri geopolitici secolari basati, fin dall’età delle scoperte geografiche, sullo scontro tra forze terrestri e forze navali.
Punto di partenza di Vegetti è un passo di Terra e Mare di Carl Schmitt (1942), in cui si allude a una vera e propria “rivoluzione spaziale” (Raumrevolution) grazie alla quale l’uomo si sarebbe appropriato dello spazio atmosferico, stravolgendo equilibri geopolitici secolari basati, fin dall’età delle scoperte geografiche, sullo scontro tra forze terrestri e forze navali.
 Dopo la lotta tra Behemot, mostro della terraferma, e Leviatano, mostro marino, la nuova epoca si sarebbe aperta nel segno di una nuova creatura biblica: l’uccello Ziz (Salmi, 50:11). Se Shakespeare poteva vantare nel Riccardo II (1595) la protezione dagli stranieri offerta all’Inghilterra dal mare, gli aerei venivano ora a smentirlo, rendendo qualunque paese un’isola affacciata su un altro oceano, quello atmosferico. La conquista dell’aria rappresenterebbe allora un vero e proprio cambio di paradigma, capace di accorciare le distanze e creare nuove relazioni tra i luoghi.
Dopo la lotta tra Behemot, mostro della terraferma, e Leviatano, mostro marino, la nuova epoca si sarebbe aperta nel segno di una nuova creatura biblica: l’uccello Ziz (Salmi, 50:11). Se Shakespeare poteva vantare nel Riccardo II (1595) la protezione dagli stranieri offerta all’Inghilterra dal mare, gli aerei venivano ora a smentirlo, rendendo qualunque paese un’isola affacciata su un altro oceano, quello atmosferico. La conquista dell’aria rappresenterebbe allora un vero e proprio cambio di paradigma, capace di accorciare le distanze e creare nuove relazioni tra i luoghi.“Nulla più si farà che non vi sia coinvolto il mondo intero”, aveva notato, già nel 1930, Paul Valéry, annunciando l’inizio del “tempo del mondo finito”. E con lui Claude Lévi-Strauss, Ernst Jünger e tutti quanti in quegli anni andavano osservando l’insorgere sempre più frequente di fenomeni di portata globale. Ma nessuno di loro poteva immaginare che, qualche decennio più tardi, le trasformazioni del sistema dei trasporti, limitate ai movimenti materiali di uomini e merci, sarebbero state un’inezia al confronto dell’ulteriore accelerazione dei flussi immateriali di notizie, idee e denaro, prodotta da un’altra forma di colonizzazione dell’aria, l’elettronica. “Dalla scoperta delle onde elettromagnetiche”, ha scritto Marshall McLuhan, “ciascun individuo scopre se stesso [...] simultaneamente presente sulla totalità della terra e del mare - coestensivo al pianeta”.
La conquista dell’aria ha finito così per mettere in crisi la tradizionale “ragione cartografica”, per dirla con Franco Farinelli, imponendo una nuova scala nella percezione dei fenomeni geografici. Se la vecchia rivoluzione marittima era avvenuta grazie alla scoperta di nuovi continenti, quella aerea ha agito più in profondità su territori già noti, rimodellandone la configurazione antropica, sociale, politica, economica. “Lo spazio può essere conquistato soltanto attraverso la produzione di spazio”, ha notato David Harvey: vale a dire, attraverso la creazione di relazioni tra luoghi, trasversali rispetto a ogni confine, capaci di produrre nuovi “paesaggi globali”, nella definizione di Arjun Appadurai, coesistenti ma non coincidenti, in continua tensione, in irresolubile divenire.
“Una volta raggiunta la Luna”, osservava Boatto, “avremmo dovuto guardarci dal di fuori, sentirci liberi finalmente da quell’appiccicosa pelle egoistica da cui trasudiamo tutta la nostra ansia antropocentrica” e, vedendoci “in un’infinitesima piccolezza”, intuire “l’urgenza e la necessità di un solo stato” e “una sola struttura in cui [...] riconoscerci”. Non è andata così. Se “l’imperialismo”, come ha scritto Peter Sloterdijk, “è planimetria applicata”, la conquista dell’aria ha prodotto una irreversibile riconfigurazione di tale “planimetria”, rendendo più complessa la relazione tra sovranità e territorio.
Il globo risulta oggi contraddistinto da “un ordine spaziale discontinuo”, nelle parole di Vegetti, “una geografia post-territoriale composta da una pluralità di centri o nodi fisicamente lontani tra loro” che “non si definiscono in funzione del contesto della loro ubicazione, bensì in funzione della rete che li implica in quanto propri elementi”. Non è ancora chiaro, tuttavia, se tale riconfigurazione dello spazio avrà come risultato la sostituzione dei vecchi equilibri con uno nuovo, o piuttosto una generale riformulazione, a livello sociale e politico, delle categorie di ordine e disordine cui siamo abituati.
L’immagine di un ordine fluido, che si tiene nell’aria, era del resto al centro di uno dei romanzi che meglio descrivono questa “geografia post-territoriale”, e che proprio quest’anno compie vent’anni, Underworld (1997) di Don DeLillo. “Il potere aveva un significato, trenta, quarant’anni fa”, vi si legge, “era una cosa stabile, focalizzata, tangibile. [...] E ci teneva insieme, [...] forse teneva insieme il mondo”. Il mondo narrato da DeLillo, invece, è tutt’altro che stabile, appeso com’è all’andirivieni di una pallina da baseball che un fuoricampo fa volare nell’aria, oltre gli spalti dello stadio di New York, durante la finale del campionato, per ridisegnare la trama di uno spazio urbano disconnesso e frammentario: “Molte cose ancorate all’equilibrio del potere e all’equilibrio del terrore si sono sciolte, liberate, così sembra. Le cose non hanno più limiti adesso”.
*
SUL TEMA, BEL SITO, SI CFR.:
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE (Capitolo III della Terza parte del lavoro di Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 162-189.
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- USCIRE DALLA CAVERNA, NON RINCHIUDERSI DENTRO. "Ius Soli" e concezione corazzata dell’identità (M. Recalcati).28 settembre 2017, di Federico La Sala
CITTADINANZA E "IUS SOLIS" (DIRITTO DEL SOLE). USCIRE DALLA CAVERNA, NON RINCHIUDERSI DENTRO .... *
Ius Soli
Figli nostri e figli dello Stato
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 28.09.2017)
LA RESISTENZA antropologica e psicologica, oltre che politica ed elettoralistica, allo Ius soli rende manifesta una tendenza sempre presente nella realtà umana: difendere il proprio status narcisistico, sociale e identitario dal rischio perturbante della contaminazione. È quella inclinazione autistica della vita umana che aveva condotto Freud a paragonare la sua condizione primordiale di esistenza a un guscio chiuso su se stesso e ostile per principio al mondo esterno, colpevole di essere “straniero e apportatore di stimoli”.
Questa concezione corazzata dell’identità nei tempi di crisi tende inevitabilmente a rafforzarsi e a sclerotizzarsi. La paura dello straniero incentiva l’edificazione di una versione dell’identità fobica, refrattaria allo scambio, iper-difensiva. I confini diventano muraglie, cessano di essere porosi, acquistano la consistenza del cemento armato. In un tempo dominato dal panico sociale generato dalla durezza della crisi economica, dal carattere anarchico e inarrestabile dei flussi migratori e dalla follia terrorista, la solidificazione dell’identità tende a configurarsi come una reazione giustificata alla minaccia incombente. I rigurgiti nazionalisti, etnici, populisti, sovranisti che caratterizzano la scena politica non solo nazionale ma internazionale cavalcano irresistibilmente questa onda. Ma la vita della città senza contaminazione è destinata all’imbarbarimento esaltato della setta, alla psicologia totalitaria delle masse. In questo senso dovrebbe essere chiaro a tutti che la partita dell’integrazione è il più grande antidoto ad ogni forma di violenza compresa quella del terrorismo.
Come non considerare che in questo mondo nuovo attraversato dall’esperienza inevitabile della contaminazione, del cosmopolitismo, dello scambio, della flessibilità dei confini, la nozione di cittadinanza deve essere radicalmente riformulata? Le situazioni di crisi non necessariamente sono destinate ad accentuare una difesa strenua contro quello che pare ingovernabile. È un insegnamento che proviene dalla vita psichica: il tempo di maggiore crisi - se elaborato nella direzione giusta - spesso coincide con il tempo delle trasformazioni più generative. L’attraversamento di una malattia non riporta mai la vita a com’era prima, ma la può rendere più ricca, più sensibile alla vita, più capace di vita. In questo senso la crisi può essere sempre un’occasione di apertura più che di chiusura.
La battaglia politica e culturale dello Ius soli potrebbe diventare un esempio luminoso. Alla tentazione della chiusura e del barricamento identitario vincolato al sangue e al particolarismo dell’etnia - che sono, in realtà, la faccia speculare della globalizzazione universalistica - si può rispondere ponendo con forza il tema della rifondazione positiva del senso di appartenenza alla vita della città. La psicoanalisi lo verifica quotidianamente nella sua pratica clinica: l’integrazione cura la dissociazione; l’esperienza del riconoscimento cura l’odio; la condivisione cura il senso di segregazione.
Il legame familiare, forse più di ogni altro, ci offre un esempio significativo di giusta cittadinanza. Non si diventa padri o madri perché si genera biologicamente una vita. La vita del figlio è tale solo se viene simbolicamente adottata al di là del sangue e della stirpe. C’è genitorialità solo se ci assumiamo la responsabilità illimitata che il prendersi cura della vita di un figlio comporta.
Questa nozione di responsabilità non è mai un fatto di sangue, ma implica un consenso, un atto, una decisione simbolica. Allo stesso modo lo Stato ha il dovere etico di adottare - di riconoscere come suoi figli - coloro che non solo e non tanto nascono nel suo territorio, ma si riconoscono come parte integrante di quello Stato contribuendo alla sua vita. Diversamente l’idea che la cittadinanza sia un diritto vincolato al sangue è un’idea fondamentale del Mein Kampf di Hitler. L’origine del razzismo e di ogni genere di fanatismo hanno sempre come loro fondamento l’ideale della purezza etnica che esclude il pluralismo.
La battaglia per lo Ius soli è una battaglia di Civiltà dal respiro ampio. Non riflette un colore politico. Per questa ragione i numeri non dovrebbero essere tutto. I partiti che la ritengono giusta dovrebbero mantenere il loro sguardo alto. In gioco non è un semplice guadagno elettorale ma il senso stesso del mondo.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
La lezione di Dante, Kantorowicz, Freud e Mandela ... GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.Federico La Sala
-
>RIPENSARE L’EUROPA!!! - STORIA, FILOSOFIA E ARCHEOLOGIA. Il Sedile di Nardò, la Costituzione, e quattro parole da ripensare.28 settembre 2017, di Federico La Sala
L’ITALIA, IL SEDILE, LA SELLA CURULE, LA "X" DI "REX" E "DUX", HENRY W, LONGFELLOW, E IL "DVX" DEL FASCISMO.... *
AD AMPLIARE e a contribuire a rendere più comprensibili ed evidenti i nessi tra i vari livelli del brillante lavoro di Armando Polito sul SEDILE di Nardò (Lecce), è bene tenere presente e ricordare cosa era la SELLA CURULE nella società dell’antica Roma:
"La sella curule (in lat. sella curulis) era un sedile pieghevole a forma di "X" ornato d’avorio, simbolo del potere giudiziario, riservato inizialmente ai re di Roma e in seguito ai magistrati superiori dotati di giurisdizione, detti perciò "curuli".
I magistrati solevano portare con sé la sella curulis assieme agli altri simboli del loro potere (fasci, verghe e scuri) e ovunque disponessero questi simboli, lì era stabilita la sede del loro tribunale.
Durante il periodo della Repubblica, il diritto di sedere sulla sella curule era riservato a: consoli, pretori, edili curuli, sacerdoti massimi, dittatori e al magister equitum. In epoca imperiale l’uso della sedia curule fu ampliato anche all’imperatore, al praefectus urbi e ai proconsoli.
Il simbolo di potere rappresentato dalla sedia curule affonda le sue radici nell’antica Etruria; infatti già gli Etruschi consideravano lo scranno pieghevole a forma di sella una prerogativa di chi poteva esercitare il potere (giudiziario ed esecutivo) sul popolo. Fu portato a Roma dal quinto re, Tarquinio Prisco.[1]
- (LAT.)
 « Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit; quae ita sancta generi hominum agresti fore ratus, si se ipse venerabilem insignibus imperii fecisset, cum cetero habitu se augustiorem, tum maxime lictoribus duodecim sumptis fecit. Alii ab numero avium quae augurio regnum portenderant eum secutum numerum putant. Me haud paenitet eorum sententiae esse quibus et apparitores hoc genus ab Etruscis finitimis, unde sella curulis, unde toga praetexta sumpta est, et numerum quoque ipsum ductum placet, et ita habuisse Etruscos quod ex duodecim populis communiter creato rege singulos singuli populi lictores dederint. »
« Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit; quae ita sancta generi hominum agresti fore ratus, si se ipse venerabilem insignibus imperii fecisset, cum cetero habitu se augustiorem, tum maxime lictoribus duodecim sumptis fecit. Alii ab numero avium quae augurio regnum portenderant eum secutum numerum putant. Me haud paenitet eorum sententiae esse quibus et apparitores hoc genus ab Etruscis finitimis, unde sella curulis, unde toga praetexta sumpta est, et numerum quoque ipsum ductum placet, et ita habuisse Etruscos quod ex duodecim populis communiter creato rege singulos singuli populi lictores dederint. »
- (IT)
 « Compiute secondo il rito le cerimonie sacre e riunita in assemblea la massa che non avrebbe mai potuto unificarsi in un unico organismo popolare se non con leggi, Romolo dettò norme giuridiche. Dunque, stimando che esse sarebbero apparse inviolabili a un materiale umano ancora rozzo solo se egli stesso si fosse reso venerabile per mezzo di segni esteriori dell’autorità, si fece più maestoso con fasto dell’abbigliamento e particolarmente con la guardia dei dodici littori. Alcuni ritengono che egli abbia considerato il numero degli uccelli che gli avevano presagito il potere. A me non dispiace l’opinione di coloro che pensavano che anche questo tipo di guardie derivasse dai vicini Etruschi da cui fu ricavata anche la sella curule e la toga pretesta, e pensano che anche il numero dei littori venisse di là e che tale fosse presso gli Etruschi per il fatto che, dopo che i dodici popoli avevano eletto in comune il re ciascuno di essi gli assegna un littore. » (Liv. Hist. I, 8) "( cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Sella_curule).
« Compiute secondo il rito le cerimonie sacre e riunita in assemblea la massa che non avrebbe mai potuto unificarsi in un unico organismo popolare se non con leggi, Romolo dettò norme giuridiche. Dunque, stimando che esse sarebbero apparse inviolabili a un materiale umano ancora rozzo solo se egli stesso si fosse reso venerabile per mezzo di segni esteriori dell’autorità, si fece più maestoso con fasto dell’abbigliamento e particolarmente con la guardia dei dodici littori. Alcuni ritengono che egli abbia considerato il numero degli uccelli che gli avevano presagito il potere. A me non dispiace l’opinione di coloro che pensavano che anche questo tipo di guardie derivasse dai vicini Etruschi da cui fu ricavata anche la sella curule e la toga pretesta, e pensano che anche il numero dei littori venisse di là e che tale fosse presso gli Etruschi per il fatto che, dopo che i dodici popoli avevano eletto in comune il re ciascuno di essi gli assegna un littore. » (Liv. Hist. I, 8) "( cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Sella_curule).
RICORDARE CHI ERA HENRY W. LONGFELLOW:
"Henry Wadsworth Longfellow (Portland, 27 febbraio 1807 - Cambridge, 24 marzo 1882) è stato uno scrittore e poeta statunitense, tra i primi letterati americani ad assurgere alla fama mondiale.
Longfellow fu il più famoso poeta della scena del New England nell’’800 e scrisse numerose opere tra cui Evangeline e Il faro.
Fu un acceso promotore dell’abolizione della schiavitù negli anni prima e durante la Guerra Civile Americana insieme ad altri intellettuali che gravitavano nell’orbita di Harvard e soprattutto insieme all’allora Governatore del Massachusetts John Andrew.
Intorno al 1862 insieme ai letterati James Russell Lowell, Oliver W. Holmes e George Washington Greene diede vita al cosiddetto "Circolo Dante", atto a promuovere la conoscenza della Divina Commedia di Dante Alighieri negli Stati Uniti. Insieme ai suoi colleghi del circolo, Longfellow ne portò a termine la prima traduzione statunitense in inglese nel 1867.
Da allora il successo dell’opera di Dante in America fu costante ed in seguito il Circolo diventò la "Dante Society", una delle più famose associazioni di dantisti nel mondo [...]" (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Wadsworth_Longfellow).
LE PAROLE ("DVX-LVX, REX-LEX") SCRITTE SULLA "CROCE" INSCRITTA NEL "CERCHIO" SULLA TOMBA DI LONGFELLOW sicuramente - via Dante Alighieri (e probabilmente anche via Dante Gabriele Rossetti) - si ricollegano al filo della tradizione religiosa cristiana, e sono riferite a CRISTO, concepito come LUCE, LEGGE, RE, DUCE.
E, ANCORA, per capire come e perché siano apparse le scritte "REX" e "DVX" sulla parete del SEDILE di Nardò (Lecce), bisogna RICORDARE chi era MARGHERITA GRASSINI SARFATTI e rileggere il suo "DVX" (sul tema, mi sia consento, cfr IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE).
E, INFINE, PER CAPIRE MEGLIO, E ALLA LUCE DEL SOLE ("INVICTUS"), IL SENSO DELLE "QUATTRO PAROLE" (LVX, LEX, REX, DVX), LEGGERE E RILEGGERE E ANCORA RILEGGERE LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ....
Federico La Sala
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
- INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
 ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI."CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
- (LAT.)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- INTELLIGENZA ARTIFICIALE, GEOPOLITICA, E "DATAISMO" (Y. N. HARIRI).20 settembre 2017, di Federico La Sala
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
La geopolitica dell’intelligenza artificiale
di Pierre Haski, L’Obs, Francia *
Vladimir Putin ha almeno una qualità, parla senza peli sulla lingua. La settimana scorsa ha detto chiaro e tondo quello che la maggior parte del mondo mormora sottovoce: “Il paese che sarà leader nel campo dell’intelligenza artificiale, dominerà il mondo”.
Di solito l’intelligenza artificiale (Ia) è evocata nell’ambito di cambiamenti positivi, per esempio nella sanità o nella regolazione del traffico, o negativi, come il suo impatto sull’occupazione o la possibilità che l’Ia sviluppi un giorno una “coscienza” capace di imporsi ai suoi creatori, gli esseri umani.
Ma è raro che se ne parli in termini geopolitici come ha fatto in modo così diretto il presidente russo. La cosa più strana è il contesto di questa dichiarazione: non una grande conferenza strategica come quella di Monaco - dove nel 2007 Putin aveva denunciato “l’unilateralismo americano” - ma una teleconferenza seguita da più di un milione di studenti russi in occasione dell’inizio dell’anno scolastico!
Dopo questa dichiarazione Elon Musk, il padrone di Tesla e di SpaceX, ha subito postato un tweet: “Si comincia...”.
E ha continuato affermando che “la competizione per la superiorità nazionale in materia di Ia sarà la causa più probabile della terza guerra mondiale”.
Se fosse necessario aggiungere altro, possiamo fare riferimento a quello che ha detto Yuval Noah Harari, storico israeliano e autore di successo, che si trovava a Parigi per il lancio dell’edizione francese del suo nuovo libro Homo Deus. Una breve storia del futuro.
Harari dice che gli sviluppi dell’intelligenza artificiale e delle biotecnologie rischiano di produrre un livello di “superuomini aumentati” che domineranno il mondo e di trasformare il resto dell’umanità in una “classe inutile”. Una dimostrazione sostenuta da molti esempi tratti dai progressi tecnologici e dai cambiamenti che implicano.
La nuova religione
Durante una presentazione del suo libro davanti a un folto gruppo di invitati, tra cui la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager che ha sfidato i Gafa (Google-Amazon-Facebook-Apple), Harari ha predetto che questi progressi scientifici produrranno delle disuguaglianze senza precedenti nella storia dell’umanità, tanto all’interno delle società quanto tra gli stati. Il divario tra chi controllerà queste tecnologie e chi non vi avrà accesso non sarà solo maggiore di quello che ha caratterizzato i paesi industriali e gli altri nel diciannovesimo e nel ventesimo secolo, ma soprattutto non potrà essere colmato.
Secondo Harari, la materia prima del futuro saranno i dati, i nostri dati personali raccolti da chi ne ha la capacità. I padroni di questi dati saranno i grandi sacerdoti della nuova religione, il “dataismo”.
Le idee di questo autore, che ha avuto un successo mondiale con il suo libro precedente Sapiens, hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto incontrarlo.
La dichiarazione di Putin sull’intelligenza artificiale ha avuto almeno il merito di rendere comprensibile il dibattito anche al grande pubblico: il capo del Cremlino ragiona in termini di dominazione e di sottomissione, sia sull’Ia sia sul resto.
L’Ia quindi non è solo un obiettivo di grande interesse economico che prende la forma (non così insignificante) di Alexa, l’assistente digitale di Amazon che risponde a tutte le vostre esigenze domestiche e che fa anche ripassare le tabelline delle moltiplicazioni ai vostri figli. Può anche essere uno strumento di dominio.
Non è un caso infatti se i maggiori investimenti in intelligenza artificiale sono quelli dei due grandi giganti del ventunesimo secolo, gli Stati Uniti e la Cina, con un probabile vantaggio dei cinesi in termini di fondi investiti.
Esigenze militari
Tutti conoscono Google, Microsoft e Amazon, le enormi aziende statunitensi alle quali tutti ricorriamo quotidianamente; alcuni conoscono Alibaba, il gigante del commercio elettronico cinese fondato dal molto mediatico Jack Ma; ma pochi europei conoscono Baidu o Tencent, due aziende cinesi altrettanto importanti delle loro controparti americane, che investono massicciamente nell’intelligenza artificiale.
Senza contare poi i centri di ricerca legati ai sistemi di difesa, che nei principali paesi del mondo sono oggi molto apprezzati, e valorizzati. Israele per esempio, al di là della start-up nation che ha prodotto l’applicazione di navigazione Waze e altri prodotti per il grande pubblico, ha creato un ecosistema di ricerca che parte prima di tutto dalle sue esigenze militari.
In un editoriale sul sito della Cnn il ricercatore americano Gregory C. Allen, autore di uno studio sull’”intelligenza artificiale e il problema della sicurezza nazionale”, afferma che se si esclude il settore delle armi oggi la Russia di Putin non è all’avanguardia nella ricerca sull’Ia:
- Nonostante le grandi ambizioni di Putin il tentativo russo di predominare nell’intelligenza artificiale non si realizzerà attraverso le innovazioni tecnologiche. Gli Stati Uniti e la Cina hanno industrie digitali molto più importanti, più sofisticate e con un ritmo di crescita molto più forte di quelle russe. In compenso la Russia potrebbe ben presto diventare leader nella militarizzazione dell’Ia per raggiungere il suo obiettivo strategico, che è quello di mettere fine all’egemonia americana nel sistema internazionale e di ristabilire l’influenza russa nella vecchia sfera sovietica. La Russia non è mai stata leader nelle tecnologie legate a internet, tuttavia ha sviluppato un gruppo importante di hackers capace di mettere in crisi gran parte della rete elettrica ucraina, di infiltrarsi negli impianti nucleari statunitensi, e di seminare il panico nelle elezioni americane del 2016.
Si può ancora impedire questa militarizzazione dell’Ia e questa corsa nazionale al suo dominio che ha tanto allarmato Musk? Difficile che possa succedere nell’attuale clima internazionale di nuova guerra fredda, che ha spazzato gli scrupoli etici come era successo mezzo secolo fa con la rivalità est-ovest.
In tutto ciò l’Europa è drammaticamente assente o molto in ritardo, sia nella battaglia sui dati condotta da imprese che sono raramente europee, sia nel perseguimento di questo obiettivo strategico sempre più importante. Forse per una volta bisognerebbe prendere Putin alla lettera e rendersi conto che si tratta veramente di un obiettivo di vitale importanza.
(Traduzione di Andrea De Ritis)
* Internazionale, 20 settembre 2017 (ripresa parziale).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- DOCUMENTA14. in Germania cancellata la performance di Bifo che paragona crisi dei migranti e Olocausto.5 settembre 2017, di Federico La Sala
Auschwitz on the Beach, in Germania cancellata la performance di Bifo che paragona crisi dei migranti e Olocausto: “Bigotti”
L’attivista e filosofo bolognese avrebbe dovuto esibirsi nell’ambito della celebre mostra di arte contemporanea Documenta14. Ma è stato sommerso dalla polemiche. Il ministro della cultura tedesco Boris Rhein e il sindaco di Kassel Christian Geselle hanno addirittura chiesto l’intervento della magistratura. Lui spiega a ilfattoquotidiano.it: "E’ la bigotteria di gente che ha ripetuto molte volte ’mai più Auschwitz’ e tuttavia non tollera che qualcuno gli faccia presente che in realtà Auschwitz sta accadendo di nuovo sotto i nostri occhi e con la nostra complicità"
di Felice Moramarco *
In Germania non si può paragonare la crisi dei migranti all’Olocausto degli ebrei, nemmeno se a farlo è un artista. Ha ricevuto critiche durissime la performance dal titolo Auschwitz on the Beach scritta dal filosofo e attivista bolognese Franco “Bifo” Berardi, prevista per il 24 agosto scorso nell’ambito della famosa mostra di arte contemporanea “documenta 14” a Kasselin Germania. La performance aveva come tema la crisi dei rifugiati, che secondo l’autore, ha assunto i tratti inquietanti di un olocausto. Proprio a causa delle polemiche, gli organizzatori di documenta 14 e Berardi hanno deciso di cancellare l’evento e sostituirlo con un incontro pubblico dal titolo Shame on Us, che ha visto una larghissima partecipazione. Molte sono state le accuse di relativizzare la tragedia dello sterminio degli ebrei. Si sono uniti alle critiche anche il ministro della cultura tedesco Boris Rhein e il sindaco di Kassel Christian Geselle, i quali hanno addirittura chiesto l’intervento della magistratura. Tuttavia c’è stato anche chi, come Philippe Ruch del Zentrum für Politische Schönheit si è chiesto se sia effettivamente così fuori luogo paragonare i campi di concentramento costruiti sulle coste libiche con l’avvallo degli stati Europei ai lager nazisti. Proprio in queste ore, la ong Moas ha interrotto i salvataggi nel Mediterraneo dicendo di non sapere cosa succede nei centri in Libia. E il parallelo con l’olocausto è stato fatto solo domenica 3 settembre alla Festa del Fatto Quotidiano dall’editorialista Furio Colombo: “Questa è la seconda Shoah”, ha detto durante un dibattito con il ministro dell’Interno Marco Minniti.
Immaginavate che l’annuncio di una performance dal titolo Auschwitz on the Beach sarebbe stato accolto in questo modo?
Noi europei stiamo ripetendo quello che i nazisti fecero negli anni ’40. Qualcuno potrebbe dire che questa è una esagerazione, ma certo che è un’esagerazione! Tuttavia, bisogna tener presente che per il momento abbiamo ucciso almeno trentamila migranti nel mar Mediterraneo. E non sappiamo quanti ne abbiamo uccisi nel deserto del Sahara e quanti cadaveri ci siano nelle fosse comuni libiche. Questo era quello che volevamo denunciare.
É risaputo che in Germania temi ed espressioni legate al loro passato nazista costituiscono ancora una ferita aperta.
Io sono disposto ad ascoltare questa obiezione dai rappresentanti della comunità ebraica tedesca, con cui ho infatti discusso. Ma non sono disposto ad ascoltare questa obiezione da qualche stronzetto che scrive sui giornali della “Grande Germania”, perché sono i nazisti tedeschi, che non sono mai scomparsi, ad aver inferto quella ferita all’umanità. Mio padre durante la guerra ha passato sette mesi in un carcere tedesco, quindi non accetto che un pezzo di merda come il signor Jens Jessen sulla Zeit mi venga a dire che quella ferita è ancora aperta, perché è proprio gente come lui che ha inferto quella ferita a gente come mio padre.
Allora perché avete deciso di cancellare la performance?
L’abbiamo cancellata perché la nostra intenzione non era tanto quella di mettere in scena un’opera d’arte, ma quella di lanciare un messaggio. Dato quello che è successo, cancellare la performance ci ha permesso di far circolare quel messaggio dieci, cento volte di più di quanto non sarebbe stato possibile se ci fossimo fatti intrappolare dalla retorica della libertà d’espressione. In gioco c’è qualcosa di molto più importante della mia libertà d’espressione. Non me ne frega niente della mia libertà d’espressione, quando in gioco c’è la vita di milioni di donne e di uomini!
L’unica cosa resa pubblica della performance è stato quindi il titolo.
Esatto.
E come si spiega che l’accostamento di due semplici parole, “Auschwitz” e “Beach” abbia innescato un dibattito così acceso?
Perché quell’espressione ha provocato la bigotteria del ceto neoliberale tedesco. La bigotteria di gente che ha ripetuto molte volte “mai più Auschwitz” e tuttavia non tollera che qualcuno gli faccia presente che in realtà Auschwitz sta accadendo di nuovo sotto i nostri occhi e con la nostra complicità. Sulla stampa tedesca sono stati pubblicati più di un centinaio di articoli da questi bigotti. Ma è il mio mestiere provocare, l’ho sempre fatto. Per mesi, sono stato su tutti i giornali italiani [nel 1977, n.d.r], descritto come provocatore e criminale, perché parlavo da una radio libera [Radio Alice, ndr]. E allora imparai che occorre non lasciarsi mai spaventare da gente come questa.
Non pensa che chi ha reagito in questo modo sia in realtà ben cosciente di ciò che sta accadendo e che semplicemente non vuole prendere atto delle proprie responsabilità.
Certamente. In gioco c’è qualcosa di enorme. Noi occidentali dobbiamo far fronte alle conseguenze di secoli di colonialismo e di quindici anni di guerra ininterrotta, di cui siamo totalmente responsabili. Ora, l’enorme debito che abbiamo accumulato, non vogliamo pagarlo. Ci rifiutiamo di investire le enormi somme di denaro necessarie per l’accoglienza dei migranti e preferiamo darle a Banca Etruria, al Monte dei Paschi e al sistema finanziario europeo. Bene, questo atteggiamento provoca la guerra. Una guerra che è già cominciata e che non vinceremo, perché abbiamo a che fare con un immenso esercito di disperati. Perderemo tutto. Perderemo la vita di molta gente, perderemo la democrazia e il senso dell’umanità.
* Il Fatto, 4 settembre 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - Auschwitz, la parola che fa ammutolire. Un’intervista con Franco Berardi Bifo che ha rinunciato alla sua performance a Kassel (di Lorenza Pignatti).1 settembre 2017, di Federico La Sala
Auschwitz, la parola che fa ammutolire
Un’intervista con Franco Berardi Bifo che ha rinunciato alla sua performance a Kassel, dopo le polemiche suscitate dal titolo «Auschwitz on the beach»
di Lorenza Pignatti (il manifesto, 01.09.2017)
KASSEL Alcune parole sembrano essere impronunciabili, tale è la loro forza e risonanza nell’immaginario collettivo. Una di queste è indubbiamente Auschwitz, come dimostra il clamore che la performance Auschwitz on the beach di Franco Berardi Bifo, Dim Sampaio e Stefano Berardi (era programmata per documenta14 a Kassel, dal 23 al 26 agosto), ha suscitato nella stampa internazionale e nella comunità ebraica, tanto da condurre alla sua cancellazione. In un incontro pubblico, ospitato in The Parliament of Bodies, Berardi ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere quel testo per la performance dall’innominabile titolo.
Era consapevole che la sua performance avrebbe suscitato tanto scalpore?
Dopo molte esitazioni, avevo deciso di usare l’espressione provocatoria Auschwitz on the beach affinché quel nome potesse essere uno «scudo», una protezione contro il pericolo, a mio parere sempre più attuale, che Auschwitz ritorni. Gunther Anders, nel libro Noi figli di Eichmann, nel 1967 scrisse di un possibile ritorno del nazismo in una società in cui la tecnica ha il sopravvento sull’uomo. Non è forse Auschwitz il primo esperimento di una gestione industrializzata e tecnologica dello sterminio? Quello a cui assistiamo oggi è l’inizio di uno sterminio basato sulla supremazia razzista. Pensiamo agli oltre 30mila migranti morti nel Mediterraneo negli ultimi quindici anni e alle decisioni politiche di far rimpatriare i migranti in Libia, dove è probabile che siano torturati o uccisi. E poi si descrivono le Ong - come Medici senza frontiere - in veste di taxisti del mare, quando invece sono organizzazioni che salvano la vita a migliaia di persone.
Sterminio su base etnica. Non è forse legittimo ravvisare gli estremi del nazismo e della supremazia razziale?
Kim Jong-un ha dichiarato che gli occidentali devono smettere di pensare che le guerre riguardino solo gli altri paesi perché ora anche loro sono in grado di portare la morte. E sappiamo che questo è vero, così come sappiamo che dopo l’11 settembre, con la guerra voluta dagli Stati Uniti, un esercito di suicidi terrorizza le città europee, da Parigi a Berlino, da Nizza a Barcellona.
 Ricordo quando nel 2004 ho guardato le immagini delle torture di Abu Ghraib in televisione. Ho subito pensato alle conseguenze che quelle immagini avrebbe potuto avere sui milioni di bambini mediorientali che le vedevano non solo in Iraq, in Egitto o in Afghanistan ma anche a Parigi o a Londra. Ora ne conosciamo le conseguenze con i kamikaze che si tolgono la vita indossando cinture esplosive o guidando furgoni per uccidere persone che passeggiano nelle città europee, ed è nostro compito cercare di cambiare tale deriva disumana. La pace, l’accoglienza e la solidarietà sono gli unici modi da attuare per sfuggire a una guerra che stiamo già perdendo, che distruggerà la nostra vita quotidiana e le nostre città.
Ricordo quando nel 2004 ho guardato le immagini delle torture di Abu Ghraib in televisione. Ho subito pensato alle conseguenze che quelle immagini avrebbe potuto avere sui milioni di bambini mediorientali che le vedevano non solo in Iraq, in Egitto o in Afghanistan ma anche a Parigi o a Londra. Ora ne conosciamo le conseguenze con i kamikaze che si tolgono la vita indossando cinture esplosive o guidando furgoni per uccidere persone che passeggiano nelle città europee, ed è nostro compito cercare di cambiare tale deriva disumana. La pace, l’accoglienza e la solidarietà sono gli unici modi da attuare per sfuggire a una guerra che stiamo già perdendo, che distruggerà la nostra vita quotidiana e le nostre città.Al posto della performance è stato organizzato un incontro pubblico che è stato molto emozionante. Si aspettava tanta partecipazione?
Si era acceso un acceso dibattito dopo che la stampa - tedesca, americana, inglese - aveva criticato la performance e alcuni centri di cultura ebraica avevano accusato gli organizzatori di documenta14 di violenza simbolica contro la memoria. Oltre ad aver cancellato la performance, prima dell’incontro pubblico serale, io, Paul B. Preciado e Adam Szymczyk, rispettivamente direttore del programma pubblico e direttore artistico della mostra, ci siamo recati al principale centro ebraico della città.
 Abbiamo discusso le nostre motivazioni, i rappresentanti hanno riconosciuto che la performance non aveva un carattere antisemita, pur ribadendo che Auschwitz appartiene alla storia e alla memoria ebraica, e hanno ricordato che nel 1938 gli ebrei tedeschi subirono da parte delle autorità americane e inglesi lo stesso rifiuto che oggi i migranti ricevono dalle autorità europee. Un numero incalcolabile di ebrei sono morti nei campi di concentramento nazisti perché inglesi e americani rifiutarono di accoglierli come rifugiati, con le stesse motivazioni con le quali oggi i governi europei respingono siriani o nigeriani. Diversi rappresentanti sono venuti anche all’incontro serale, intitolato Shame on us. La loro presenza è stata determinante per decostruire i malintesi e riflettere sull’emergere di nuove forme di razzismo. Pur non rinunciando alle mie motivazioni politiche e filosofiche, ho riconosciuto di non avere il diritto di procurare ulteriore dolore alla comunità ebraica, e ho annullato la lettura del testo scritto per la performance.
Abbiamo discusso le nostre motivazioni, i rappresentanti hanno riconosciuto che la performance non aveva un carattere antisemita, pur ribadendo che Auschwitz appartiene alla storia e alla memoria ebraica, e hanno ricordato che nel 1938 gli ebrei tedeschi subirono da parte delle autorità americane e inglesi lo stesso rifiuto che oggi i migranti ricevono dalle autorità europee. Un numero incalcolabile di ebrei sono morti nei campi di concentramento nazisti perché inglesi e americani rifiutarono di accoglierli come rifugiati, con le stesse motivazioni con le quali oggi i governi europei respingono siriani o nigeriani. Diversi rappresentanti sono venuti anche all’incontro serale, intitolato Shame on us. La loro presenza è stata determinante per decostruire i malintesi e riflettere sull’emergere di nuove forme di razzismo. Pur non rinunciando alle mie motivazioni politiche e filosofiche, ho riconosciuto di non avere il diritto di procurare ulteriore dolore alla comunità ebraica, e ho annullato la lettura del testo scritto per la performance.«Shame on us» è stato quindi il titolo dell’incontro...
Diversi messaggi ricevuti dai nostri accusatori ci dicevano che dovevamo vergognarci. E, in effetti, è accaduto: la vergogna riguardava però il fatto che nessuno di noi riesce a fermare le forme di fascismo che scandiscono l’agenda mediatica nazionale e internazionale. Mi preoccupa l’impotenza rispetto agli atti di brutalità a cui stiamo assistendo. Nel giugno 2016, mentre gli inglesi votavano per la Brexit e gli americani ascoltavano Trump, Zbigniew Brzezinski ha pubblicato un articolo intitolato Toward a Global Realignment. Nel testo rifletteva su quanto i massacri e le guerre compiute dai colonizzatori occidentali si siano risolti nello sterminio dei popoli colonizzati: la scala era paragonabile ai crimini del nazismo della seconda guerra mondiale, provocando centinaia di migliaia e talvolta milioni di vittime. Dovremmo accusare Brzesinski di antisemitismo e di relativizzare il nazismo? Non direi. Il politico americano di origini polacche, consigliere durante la presidenza di Jimmy Carter, scrive che il nazismo è l’aspetto più disumano che abbia caratterizzato la storia della nostra specie. Tale disumanità sta riemergendo nella società contemporanea sia come vendetta da parte degli oppressi, sia come sommossa razzista da parte della popolazione bianca che si sente minacciata e impotente rispetto alla perdita di potere e alla propria supremazia razziale.
Sta facendo riferimento agli eventi di Charlotteville?
Non solo a quelli. Sarebbe ingenuo circoscriverli agli Stati Uniti. L’arrogante supremazia razziale, che è parte della storia del colonialismo occidentale, ha portato all’elezione di Trump, alla Brexit, e alle tante manifestazioni di intolleranza e razzismo a cui assistiamo ogni giorno. Solo l’Internazionalismo proletario avrebbe potuto evitare che la resa dei conti del colonialismo passato e contemporaneo diventasse un bagno di sangue planetario. Ma il comunismo è stato sconfitto e ora vi è la guerra di tutti contro tutti in nome di niente.
Nel corso della sua lunga carriera si è occupato di politica, attivismo, «cognitariato» e semiocapitalismo. Nei suoi ultimi testi, in particolare modo il romanzo «Morte ai vecchi» e «Heroes. Suicidio e omicidi di massa», i toni sono diventati più distopici, terminali: perché?
Forse la risposta a questa domanda sta nelle cose, non nella mia personale evoluzione. La sconfitta del comunismo (della quale i comunisti sono i primi a portare la responsabilità) ha cancellato l’orizzonte internazionalista, cioè l’orizzonte di una possibile solidarietà tra gli oppressi e gli sfruttati, tra operai occidentali e masse dei paesi colonizzati. Ogni forma di solidarietà è stata cancellata dal prevalere dell’ideologia neoliberale e dalla precarietà. Competizione è diventato l’imperativo di ogni relazione sociale. Ora siamo alla precipitazione: gli effetti di trent’anni di egemonia neoliberale e di capitalismo finanziario hanno distrutto il tessuto sociale nei paesi occidentali, e hanno reso possibile una diffusione degli armamenti più distruttivi. L’apocalisse è all’ordine del giorno, non perché la vede qualche esagerato come me, ma perché il capitalismo porta la guerra come la nube porta la tempesta (Lenin).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere". Tracce per una svolta antropologica.17 agosto 2017, di Federico La Sala
"Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere"(M. Serres, Distacco, 1986):
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
 La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
 Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 138-189 (capp. II e III):
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- GUARDARE IN AVANTI. In difesa dei giusti, contro lo sterminio (di Guido Viale)15 agosto 2017, di Federico La Sala
In difesa dei giusti, contro lo sterminio
di Guido Viale *
- Alle Ong che cercano di sottrarre quei profughi a un destino di sofferenza e morte andrebbe riconosciuto il titolo di “Giusti” come si è fatto per coloro che ai tempi del nazismo si sono adoperati per salvare degli ebrei dallo sterminio. La lotta agli scafisti indetta dal governo italiano e dall’Unione Europea è in realtà una guerra camuffata contro i profughi, contro degli esseri umani braccati. Ed è una guerra che moltiplica il numero e i guadagni di scafisti, autorità libiche corrotte e terroristi: quei viaggi sono l’unica alternativa ai canali di immigrazione legale che l’Europa ha chiuso fingendo di proteggere i propri cittadini
Coloro che dalle coste della Libia si imbarcano su un gommone o una carretta del mare sono esseri umani in fuga da un paese dove per mesi o anni sono stati imprigionati in condizioni disumane, violati, comprati e venduti, torturati per estorcere riscatti dalle loro famiglie, aggrediti da scabbia e malattie; e dove hanno rischiato fino all’ultimo istante di venir uccisi.
Molti di loro non hanno mai visto il mare e non hanno idea di che cosa li aspetti, ma sanno benissimo che in quel viaggio stanno rischiando ancora una volta la vita. Chi fugge da un paese del genere avrebbe diritto alla protezione internazionale garantita dalla convenzione di Ginevra, ma solo se è “cittadino” di quel paese. Quei profughi non lo sono; sono arrivati lì da altre terre. Ma fermarli in mare e riportarli in Libia è un vero e proprio respingimento (refoulement, proibito dalla convenzione di Ginevra) di persone perseguitate, anche se materialmente a farlo è la Guardia costiera libica.
Una volta riportati in Libia verranno di nuovo imprigionati in una delle galere da cui sono appena usciti, subiranno le stesse torture, gli stessi ricatti, le stesse violenze, le stesse rapine a cui avevano appena cercato di sfuggire, fino a che non riusciranno a riprendere la via del mare. Alle Ong che cercano di sottrarre quei profughi a un simile destino di sofferenza e morte andrebbe riconosciuto il titolo di “Giusti” come si è fatto per coloro che ai tempi del nazismo si sono adoperati per salvare degli ebrei dallo sterminio.
Invece, ora come allora, vengono trattati come criminali: dai Governi, da molte forze politiche, dalla magistratura, dai media e da una parte crescente dell’opinione pubblica (i social!); sempre più spesso con un linguaggio che tratta le persone salvate e da salvare come ingombri, intrusi, parassiti e invasori da buttare a mare. Non ci si rende più conto che sono esseri umani: disumanizzare le persone come fossero cose o pidocchi è un percorso verso il razzismo e le sue conseguenze più spietate. Come quello che ha preceduto lo sterminio nazista.
Salvataggio in mare foto di Massimo Sestini/Polaris Nessuno prova a mettersi nei panni di queste persone in fuga, per le quali gli scafisti che li sfruttano in modo cinico e feroce sono speranza di salvezza, l’ultima risorsa per sottrarsi a violenze e soprusi indicibili. La lotta agli scafisti indetta dal governo italiano e dall’Unione Europea è in realtà una guerra camuffata contro i profughi, contro degli esseri umani braccati. Ed è una guerra che moltiplica il numero e i guadagni di scafisti, autorità libiche corrotte e terroristi: unica alternativa ai canali di immigrazione legale che l’Europa ha chiuso fingendo di proteggere i propri cittadini.
Da tempo le imbarcazioni su cui vengono fatti salire i profughi non sono più in grado di raggiungere l’Italia: sono destinate ad affondare con il loro carico. Ma gli scafisti certo non se ne preoccupano: il viaggio è già stato pagato, e se il “carico” viene riportato in Libia, prima o dopo verrà pagato una seconda e una terza volta. In queste condizioni, non c’è bisogno che un gommone si sgonfi o che una carretta imbarchi acqua per renderne obbligatorio il salvataggio, anche in acque libiche: quegli esseri umani violati e derubati sono naufraghi fin dal momento in cui salpano e, se non si vuole farli annegare, vanno salvati appena possibile.
Gran parte di quei salvataggi è affidata alle Ong, perché le navi di Frontex e della marina italiana restano nelle retrovie per evitare di dover intervenire in base alla legge del mare; ma gli esseri umani che vengono raccolti in mare da alcune navi delle Ong devono essere trasbordati al più presto su un mezzo più capiente, più sicuro e più veloce; altrimenti le navi che eseguono il soccorso rischiano di affondare per eccesso di carico, oppure non riescono a raccogliere tutte le persone che sono in mare o, ancora, impiegherebbero giorni e giorni per raggiungere un porto, lasciando scoperto il campo di intervento.
Vietare i trasbordi è un delitto come lo è ingiungere alle Ong di imbarcare agenti armati: farlo impedirebbe alle organizzazioni impegnate in interventi in zone di guerra di respingere pretese analoghe delle parti in conflitto, facendo venir meno la neutralità che permette loro di operare. Né le Ong possono occuparsi delle barche abbandonate, soprattutto in presenza di uomini armati fino ai denti venuti a riprendersele. Solo i mezzi militari di Frontex potrebbero farlo: distruggendo altrettante speranze di chi aspetta ancora di imbarcarsi.
I problemi continuano quando queste persone vengono sbarcate: l’Unione europea appoggia la guerra ai profughi, ma poi se ne lava le mani. Sono problemi dell’Italia; la “selezione” tra sommersi e salvati se la veda lei... I rimpatri, oltre che crudeli e spesso illegali, sono per lo più infattibili e molto costosi. Così, dopo la selezione, quell’umanità dolente si accumula in Italia, divisa tra clandestinità, lavoro nero, prostituzione e criminalità: quanto basta a mettere ko la vita politica e sociale di tutto paese.
Ma cercare di fermare i profughi ai confini settentrionali o a quelli meridionali della Libia accresce solo il numero dei morti. Dobbiamo guardare in avanti, accogliere in tutta Europa come fratelli coloro che cercano da lei la loro salvezza; adoperarci per creare un grande movimento europeo che lavori e lotti per riportare la pace nei loro paesi (non lo faranno certo i governi impegnati in quelle guerre) e perché i profughi che sono tra noi possano farsi promotori della bonifica ambientale e sociale delle loro terre (non lo faranno certo le multinazionali impegnate nel loro saccheggio). L’alternativa è una notte buia che l’Europa ha già conosciuto e in cui sta per ricadere
*Comune-info, 12 agosto 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA LEZIONE DI NELSON MANDELA: GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - Non era ancora accaduto, nel lungo dopoguerra almeno, in Europa e nel mondo cosiddetto «civile», che la solidarietà, il salvataggio di vite umane, l’«umanità» come pratica individuale e collettiva, fossero stigmatizzati, circondati di diffidenza, scoraggiati e puniti8 agosto 2017, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE ...*
Migranti, chi infligge colpi mortali al codice morale
Ong. Non era ancora accaduto, nel lungo dopoguerra almeno, in Europa e nel mondo cosiddetto «civile», che la solidarietà, il salvataggio di vite umane, l’«umanità» come pratica individuale e collettiva, fossero stigmatizzati, circondati di diffidenza, scoraggiati e puniti
di Marco Revelli (il manifesto, 08.08.2017)
Negli ultimi giorni qualcosa di spaventosamente grave è accaduto, nella calura di mezza estate. Senza trovare quasi resistenza, con la forza inerte dell’apparente normalità, la dimensione dell’«inumano» è entrata nel nostro orizzonte, l’ha contaminato e occupato facendosi logica politica e linguaggio mediatico. E per questa via ha inferto un colpo mortale al nostro senso morale.
L’«inumano», è bene chiarirlo, non è la mera dimensione ferina della natura contrapposta all’acculturata condizione umana.
Non è il «mostruoso» che appare a prima vista estraneo all’uomo. Al contrario è un atteggiamento propriamente umano: l’«inumano» - come ha scritto Carlo Galli - «è piuttosto il presentarsi attuale della possibilità che l’uomo sia nulla per l’altro uomo».
Che l’Altro sia ridotto a Cosa, indifferente, sacrificabile, o semplicemente ignorabile. Che la vita dell’altro sia destituita di valore primario e ridotta a oggetto di calcolo. Ed è esattamente quanto, sotto gli occhi di tutti, hanno fatto il nostro governo - in primis il suo ministro di polizia Marco Minniti - e la maggior parte dei nostri commentatori politici, in prima pagina e a reti unificate.
Cos’è se non questo - se non, appunto, trionfo dell’inumano - la campagna di ostilità e diffidenza mossa contro le Ong, unici soggetti all’opera nel tentativo prioritario di salvare vite umane, e per questo messe sotto accusa da un’occhiuta «ragion di stato».
O la sconnessa, improvvisata, azione diplomatica e militare dispiegata nel caos libico con l’obiettivo di mobilitare ogni forza, anche le peggiori, per tentare di arrestare la fiumana disperata della nuda vita, anche a costo di consegnarla agli stupratori, ai torturatori, ai miliziani senza scrupoli che non si differenziano in nulla dagli scafisti e dai mercanti di uomini, o di respingerla a morire nel deserto.
Qui non c’è, come suggeriscono le finte anime belle dei media mainstream (e non solo, penso all’ultimo Travaglio) e dei Gabinetti governativi o d’opposizione, la volontà di ricondurre sotto la sovranità della Legge l’anarchismo incontrollato delle organizzazioni umanitarie.
Non è questo lo spirito del famigerato «Codice Minniti» imposto come condizione di operatività in violazione delle antiche, tradizionali Leggi del mare (il trasbordo) e della più genuina etica umanitaria (si pensi al rifiuto di presenze armate a bordo). O il senso dell’invio nel porto di Tripoli delle nostre navi militari.
Qui c’è la volontà, neppur tanto nascosta, di fermare il flusso, costi quel che costi. Di chiudere quei fragili «corridoi umanitari» che in qualche modo le navi di Medici senza frontiere e delle altre organizzazioni tenevano aperti. Di imporre a tutti la logica di Frontex, che non è quella della ricerca e soccorso, ma del respingimento (e il nome dice tutto).
Di fare, con gli strumenti degli Stati e dell’informazione scorretta, quanto fanno gli estremisti di destra di Defend Europe, non a caso proposti come i migliori alleati dei nuovi inquisitori. Di spostare più a sud, nella sabbia del deserto anziché nelle acque del Mare nostrum, lo spettacolo perturbante della morte di massa e il simbolo corporeo dell’Umanità sacrificata.
Non era ancora accaduto, nel lungo dopoguerra almeno, in Europa e nel mondo cosiddetto «civile», che la solidarietà, il salvataggio di vite umane, l’«umanità» come pratica individuale e collettiva, fossero stigmatizzati, circondati di diffidenza, scoraggiati e puniti.
Non si era mai sentita finora un’espressione come «estremismo umanitario», usata in senso spregiativo, come arma contundente. O la formula «crimine umanitario». E nessuno avrebbe probabilmente osato irridere a chi «ideologicamente persegue il solo scopo di salvare vite», quasi fosse al contrario encomiabile chi «pragmaticamente» sacrifica quello scopo ad altre ragioni, più o meno confessabili (un pugno di voti? un effimero consenso? il mantenimento del potere nelle proprie mani?)
A caldo, quando le prime avvisaglie della campagna politica e mediatica si erano manifestate, mi ero annotato una frase di George Steiner, scritta nel ’66. Diceva: «Noi veniamo dopo. Adesso sappiamo che un uomo può leggere Goethe o Rilke la sera, può suonare Bach e Schubert, e quindi, il mattino dopo, recarsi al proprio lavoro ad Auschwitz». Aggiungevo: Anche noi «veniamo dopo».
Dopo quel dopo. Noi oggi sappiamo che un uomo può aver letto Marx e Primo Levi, orecchiato Marcuse e i Francofortesi, militato nel partito che faceva dell’emancipazione dell’Umanità la propria bandiera, esserne diventato un alto dirigente, e tuttavia, in un ufficio climatizzato del proprio ministero firmare la condanna a morte per migliaia di poveri del mondo, senza fare una piega. La cosa può essere sembrata eccessiva a qualcuno. E il paragone fuori luogo. Ma non mi pento di averlo pensato e di averlo scritto.
Consapevole o meno di ciò che fa, chi si fa tramite dell’irrompere del disumano nel nostro mondo è giusto che sia consapevole della gravità di ciò che compie. Della lacerazione etica prima che politica che produce. Se l’inumano - è ancora Galli a scriverlo - «è il lacerarsi catastrofico della trama etica e logica dell’umano», allora chi a quella rottura contribuisce, quale che sia l’intenzione che lo muove, quale che sia la bandiera politica sotto cui si pone, ne deve portare, appieno, la responsabilità. Così come chi a quella lacerazione intende opporsi non può non schierarsi, e dire da che parte sta. Io sto con chi salva.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.
IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
IL MESSAGGIO EVANGELICO, LA COSTITUZIONE, E IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, ATEO E DEVOTO. COME LA "SACRA FAMIGLIA" DIVENNE ZOPPA E CIECA E IL FIGLIO PRESE IL POSTO DEL PADRE DI GESU’ E DEL "PADRE NOSTRO" E DIVENNE IL SANTO "PADRINO".... CON E ACCANTO A "MAMMASANTISSIMA".
 LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA L’INDICAZIONE DI NELSON MANDELA: GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- MIGRANTI E POLITICA. Torturarli a casa loro? Io sto con Samed (di Andrea Inglese).7 agosto 2017, di Federico La Sala
Torturarli a casa loro? Io sto con Samed
di Andrea Inglese *
Certo che vorrei essere un rappresentante della classe media durante le sue due settimane ufficiali di vacanza da passare in modo spensierato e certo che vorrei mantenere lo spirito anarchico che non vuole né patria né padroni, ma le notizie che inevitabilmente leggo sulle nuove strategie messe in opera dallo Stato italiano con il solidale sostegno dell’Unione Europea per risolvere il problema del flusso di migranti dalla Libia all’Italia mi procurano un voltastomaco ben superiore rispetto a tutti i disagi della canicola epocale.
Il problema dell’identità nazionale è che anche se tu vuoi essere un cittadino del mondo, libero da vincoli e pregiudizi, ampiamente propenso a ideali come l’internazionalismo dei poveri cristi, che una volta si chiamava « proletario », anche se tu sei insomma al di sopra delle bassezze del tuo paese, della sua classe politica, o più precisamente del suo governo, che comunque di riffa o di raffa è a sua volta una qualche espressione più o meno limpida di una maggioranza elettorale italiana, in un paese dove le elezioni - quando ci sono - sono libere, ossia senza alibi totalitari, ebbene nonostante le velleità cosmopolite e transnazionali quando il tuo paese d’origine e di cittadinanza, quello che ti ha stampigliato il passaporto per intenderci, si comporta in modo vergognoso e vile, non è che tu riesci a fluttuare indenne sopra quella vergogna e quella viltà. Vorresti incazzarti equanimemente per tutte le nefandezze che paesi, governi, con più o meno grande sostegno delle loro popolazioni, commettono in giro per il pianeta, ma alla fine nessun paese ti farà incazzare come il tuo, nessuna nefandezza ti imbratterà lo spirito, da cima a fondo, come quelle commesse, in nome tuo - anche se avessi bruciato in un rito perfettamente anarchico la cartellina elettorale - dal paese che ti fornisce la cittadinanza.
Quello che ho deciso di scrivere qui, in ogni caso, non vuole essere la semplice espressione di un’indignazione rivolta a persone che potrebbero essere in sintonia con essa, ma un tentativo di raccogliere alcuni elementi che la provocano per memorizzarli, per fissarli con sufficiente chiarezza al di fuori delle nera notte dell’indignazione ritualizzata.
Il punto d’avvio della riflessione potrebbe essere lo sforzo del governo italiano per ridurre l’afflusso di migranti sulle coste siciliane, mettendo in riga, da un lato, il lavoro delle ONG che operano per soccorrere le imbarcazioni provenienti soprattutto dalla Libia, e contribuendo, dall’altro, a rafforzare i dispositivi di controllo libici sulle proprie coste.
Diverse sono state le letture critiche di questa azione governativa. Penso agli interventi di Alessandro Dal Lago e Luigi Manconi su “il manifesto”, alla lettera di Medici senza Frontiere al ministro Minniti, all’editoriale apparso ieri su “Repubblica” di Roberto Saviano, che si schiera con Medici senza Frontiere e chiarisce ulteriormente le ragioni che hanno spinto questa (e altre Ong) a non sottoscrivere il codice di comportamento che l’Italia vorrebbe imporre alle Organizzazioni umanitarie attive nel Mediterraneo.
Prima di occuparsi della disputa tra certe Ong e lo Stato italiano, bisognerebbe innanzitutto allargare un po’ lo scenario. L’Italia, all’interno di quella strana compagine politico-amministrativa che si chiama Europa, soffre di una posizione particolarmente sfavorita: ossia per la sua posizione geografica, così come accade alla Grecia, si trova a gestire frontalmente il grande flusso dei migranti proveniente dal continente africano e da alcune zone di quello asiatico, flusso di cui la Libia è il paese collettore principale; un paese senza struttura statale, in mano non solo a grandi fazioni politiche, ma a bande armate che agiscono senza controllo sul territorio. (Questa situazione di caos politico è poi la diretta conseguenza della guerra alla Libia di Gheddafi, inaugurata dalla Francia e poi sostenuta da un’ampia coalizione, che una volta detronizzato il dittatore è stata in grado di favorire un processo di ricostituzione politica e sociale del paese.)
In questa situazione l’Italia ha grandemente ragione di chiedere che il peso della cosiddetta “accoglienza” non ricada esclusivamente su di lei, come previsto da un accordo europeo quale la Convenzione di Dublino. Ed è vergognoso che tutta la retorica della solidarietà tra Stati membri costantemente rispolverata dai burocrati della Commissione e del Parlamento Europei non sia minimamente visibile non solo nella volontà di modificare questo trattato, ma in quella d’imporre effettivamente una più equa e intelligente distribuzione dei migranti arrivati in Italia. Di fronte a questa difficoltà, la scelta dell’attuale governo italiano è stata quella di rinunciare a fare pressione sui più forti, l’Europa e gli Stati membri in essa più influenti politicamente, come la Francia e la Germania, per scaricare tutta la sua legittima frustrazione sui più deboli, ossia le ONG, additate come complici dei trafficanti di uomini. In questo modo, non solo (in maniera vile) si colpiva un soggetto più debole sul piano istituzionale, ma anche si spostava il problema.
Invece di preoccuparsi della mancata accoglienza dei migranti in arrivo sul continente, e di quella quota in essi di rifugiati, ossia di persone a cui formalmente le istituzioni europee e nazionali di molti Stati dovrebbero garantire secondo i loro principi giuridici e politici non solo una forma immediata di ospitalità, ma anche di protezione e sostegno attivo, ebbene invece di dibattere di questa debolezza politica dell’Europea e della contraddizione che essa fa nascere nei confronti dei suoi principi fondatori, l’attenzione pubblica può finalmente considerare coloro che salvano i migranti dalla morte in mare come una fonte importante del problema. Questa operazione propagandistica, talmente grossolana per la sua spiccata tendenziosità, dovrebbe ragionevolmente essere destinata a un immediato fallimento. La maggior parte dei media, invece, accodandosi a una campagna di tipo “diffamatorio” già in opera da alcuni mesi, è riuscita in qualche modo a rendere plausibile un tale camuffamento del problema.
Si può certo cominciare ad inoltrarsi verso astratte ipotesi di “favoreggiamento dell’emigrazione clandestina” o di occulte connessioni tra ONG e scafisti, ma rimane un fatto incontrovertibile: i migranti che cercano di raggiungere l’Europa per via mare sono costantemente esposti a un pericolo mortale e delle cifre spesso ricordate dalla stampa o dalle stesse istituzioni internazionali ci ricordano quante persone innocenti, uomini, donne e bambini sono già morte annegate nel Mediterraneo. Il problema, quindi, numero 1, il più urgente e fondamentale, che nessuna propaganda italiana, appoggiata dall’Europa, potrà far scomparire è quello delle migliaia di persone costantemente in pericolo di vita alle frontiere dell’Europa. -Tutti sanno, in fondo, che l’esistenza non solo politico-amministrativa, ma anche culturale dell’Europa, non può davvero sopravvivere a un tale diniego esplicito e definitivo di umanità, quale sarebbe la trasformazione di queste morti alle proprie frontiere in un non problema. Tutti i valori che stanno alle basi dei suoi ordinamenti nazionali e transnazionali diventerebbero carta straccia. Non si avrebbe più alcun modo per distinguere il significato di termini quali “democrazia” e “diritto” da altri termini quali “fascismo” e “razzismo”, per esempio. I fascisti e i razzisti sono, infatti, coloro che assegnano a un gruppo irragionevolmente ristretto i requisiti dell’essere umano. Tutto ciò che sta al di fuori del loro riduttivo e limitato noi non è semplicemente degno di quella empatia elementare, che costituisce la condizione stessa per ogni reciprocità di tipo etico. La morte, in condizione disumane, di uomini come noi è un problema, solo per chi riconosce questa reciprocità di base. Qui nessuno può discettare sulle “condizioni disumane” che determinano e caratterizzano queste morti, si può al massimo, come i razzisti fanno - che siano italiani oppure no - discettare sul fatto che dei nigeriani, degli eritrei, dei ghaniani siano davvero altrettanto uomini quanto noi europei di carnagione pallida.
(In altri termini, i Salvini e tutti i suoi seguaci, si limitano a dire: “ma se questi non italiani muoiono al largo delle nostre coste, non è un problema nostro”. Le ONG come Medici senza Frontiere forniscono la risposta esattamente opposta. Cito dalla loro lettera al ministro Minniti: “Abbiamo sempre sottolineato che l’attività di ricerca e soccorso (SAR) in mare ha il solo obiettivo di salvare vite in pericolo e che la responsabilità di organizzare e condurre questa attività risiede innanzitutto nelle istituzioni statali. -L’impegno di MSF e delle altre organizzazioni umanitarie nelle attività SAR mira anzitutto a colmare un vuoto di responsabilità lasciato dai governi (...)”. Le ONG come MSF, sovvenzionate anche da privati cittadini come il sottoscritto, risponde infatti: il problema di salvare degli esseri umani è nostro, anche se sono gli Stati nazionali che se ne dovrebbero occupare. Se non c’è un bagnino patentato per trarre fuori dall’acqua un povero cristo che sta affogando, lo farò io che sono quello più prossimo alla possibile vittima.)
Il problema, quindi, non può davvero essere negato, neppure da un governo vile e subordinato come il nostro, e neppure da una fredda e opportunista macchina istituzionale come quella europea. Si può al massimo camuffarlo, spostarlo, trovare dei falsi e facili nemici (le ONG) oppure degli inaspettati (e meno facili) alleati, ossia i signori libici della guerra. Su questo secondo fronte, delle alleanze, il governo italiano è riuscito ad essere non solo velleitario, come già l’Unione Europea e la Francia, ma anche grottesco. Dopo aver, infatti, assicurato che accordi erano stati presi per una fruttuosa collaborazione italo-libica, uno dei presunti alleati ha fatto sapere che avrebbe volentieri cannoneggiato navi italiane in acque libiche. Secondo la stampa, gli italiani avrebbero trovato una controparte collaborativa in una sola delle fazioni che detengono il potere in Libia, quella capeggiata dal “presidente” Fayez el-Sarraj, suscitando la reazione ostile di un’altra delle fazioni, quella del “maresciallo” Haftar. Sembrerebbe, infatti, che la Libia presenti attualmente poche caratteristiche che la possano candidare a un paese in grado di ricevere soldi dall’Europa e appoggi militari dall’Italia, affinché gli uni e gli altri siano messi a frutto efficacemente per limitare il traffico di migranti verso l’Europa, e tutto questo nel rispetto dei diritti umani.
 Il problema un po’ preso sottogamba in questa circostanza è il fatto che la Libia non è ancora attualmente uscita da una situazione di guerra civile, ma anche questa formula è forse riduttiva se applicata al caos politico e sociale presente nel paese. Un esperto dei servizi segreti francesi, Alain Rodier, ne parla in una recente intervista: “Il maresciallo Haftar ha tutte le carte militari in mano dal momento che il potere è disperso tra le milizie di Tripoli, di Misurata a nord-est del paese, i Tuareg e i Toubou al sud, gli Amazigh alla frontiera tunisina e tutti i gruppi che dipendono sia da Al-Qaida nel Maghreb Islamico sia da Daech. E questo senza contare che questo elenco e semplicistico perché la Libia unificata non esiste più e ogni porzione di terreno è diretto dal signore locale della guerra che si allea con l’uno o l’altro secondo l’evolversi della situazione.”
Il problema un po’ preso sottogamba in questa circostanza è il fatto che la Libia non è ancora attualmente uscita da una situazione di guerra civile, ma anche questa formula è forse riduttiva se applicata al caos politico e sociale presente nel paese. Un esperto dei servizi segreti francesi, Alain Rodier, ne parla in una recente intervista: “Il maresciallo Haftar ha tutte le carte militari in mano dal momento che il potere è disperso tra le milizie di Tripoli, di Misurata a nord-est del paese, i Tuareg e i Toubou al sud, gli Amazigh alla frontiera tunisina e tutti i gruppi che dipendono sia da Al-Qaida nel Maghreb Islamico sia da Daech. E questo senza contare che questo elenco e semplicistico perché la Libia unificata non esiste più e ogni porzione di terreno è diretto dal signore locale della guerra che si allea con l’uno o l’altro secondo l’evolversi della situazione.”Anche su questo punto la propaganda del governo italiana risulta grossolana. Ciò che l’Europa ricca, pacifica, solida nelle istituzioni e prodiga di buoni propositi non riesce a fare, per gestire il flusso di migranti in arrivo, lo saprà fare per gestire il flusso in partenza, uno Stato-collassato in mano a fazioni in lotta tra loro, che governano grazie al semplice potere delle armi. Ci prendono davvero per imbecilli o per analfabeti di ritorno che non hanno mai letto un giornale dai tempi degli allori di Gheddafi.
Ma l’aspetto più grave è ancora un altro, che è rimasto in ombra anche in alcune reazioni critiche nei confronti del governo. Lo ricorda la già citata lettera di Medici senza Frontiere: “La Libia non è un posto sicuro dove riportare le persone in fuga, né dal territorio europeo né dal mare.” Qui la litote utilizzata sconfina nell’espressione quasi eufemistica. La Libia per un gran numero di migranti, un numero che resta difficile da determinare, è un luogo dell’orrore, un luogo che rievoca le più terribili e buie memorie europee, quelle dei lager e della tortura diffusa. Da questo punto di vista, non solo il governo italiano, ma anche la stampa generalista sembra soffrire di subitanee amnesie.
 Ma chi può pensare in buona fede che potremo aiutare i migranti “a casa loro”, ossia in Libia? Potremmo al massimo contribuire al fatto che essi vengano vieppiù torturati in Libia, che non è quasi mai casa loro, e da torturatori che non per forza sono esclusivamente di nazionalità libica, perché le bande criminali sembrano spesso associare carnefici di nazionalità diversa.
Ma chi può pensare in buona fede che potremo aiutare i migranti “a casa loro”, ossia in Libia? Potremmo al massimo contribuire al fatto che essi vengano vieppiù torturati in Libia, che non è quasi mai casa loro, e da torturatori che non per forza sono esclusivamente di nazionalità libica, perché le bande criminali sembrano spesso associare carnefici di nazionalità diversa.
 A partire da almeno il 2015, Amnesty International aveva denunciato violenze sui migranti e rifugiati da parte di trasportatori, trafficanti e gruppi armati, ma anche da parte della guardia costiera e dei centri di detenzione libici. (Possiamo semplicemente dimenticare, per quanto sopra ricordato, che in Libia esista una separazione chiara tra criminalità, gruppi paramilitari, polizia e esercito “ufficiale”.) Ma negli anni successivi, fino alle notizie circolate nei mesi di maggio e giugno di quest’anno anche sulla stampa italiana, è a poco a poco emersa la realtà spaventosa dei “mezra”, ossia “magazzini” in cui i migranti provenienti da altri paesi dell’Africa vengono tenuti sotto sequestro per mesi e torturati per estorcere grosse somme di denaro alle famiglie rimaste nei paesi d’origine, a cui vengono inviate immagini di queste sevizie. Si è, infatti, passati dallo stadio dell’inchiesta giornalistica a quello dell’inchiesta penale, con tanto di presunti colpevoli, testimoni diretti e processi in corso.
A partire da almeno il 2015, Amnesty International aveva denunciato violenze sui migranti e rifugiati da parte di trasportatori, trafficanti e gruppi armati, ma anche da parte della guardia costiera e dei centri di detenzione libici. (Possiamo semplicemente dimenticare, per quanto sopra ricordato, che in Libia esista una separazione chiara tra criminalità, gruppi paramilitari, polizia e esercito “ufficiale”.) Ma negli anni successivi, fino alle notizie circolate nei mesi di maggio e giugno di quest’anno anche sulla stampa italiana, è a poco a poco emersa la realtà spaventosa dei “mezra”, ossia “magazzini” in cui i migranti provenienti da altri paesi dell’Africa vengono tenuti sotto sequestro per mesi e torturati per estorcere grosse somme di denaro alle famiglie rimaste nei paesi d’origine, a cui vengono inviate immagini di queste sevizie. Si è, infatti, passati dallo stadio dell’inchiesta giornalistica a quello dell’inchiesta penale, con tanto di presunti colpevoli, testimoni diretti e processi in corso.Di queste faccende ne ho sentito parlare per la prima volta su una radio francese, dalle due autrici di un documentario del 2015 che s’intitola Voyage en barbarie e che ha cominciato a studiare il fenomeno di queste estorsioni attraverso sequestri e torture nella zona del nord-est del Sinai. In questo caso, le vittime sono soprattutto eritrei che fuggono la dittatura. Le informazioni fornite sul sito dedicato al documentario evocano le cifre di un gigantesco traffico di esseri umani. “Ad oggi, 50.000 persone sarebbero passare per il Sinai e 12.000 sarebbero morte sotto tortura. Nessun carnefice è stato arrestato.
 L’Egitto e Israele hanno lasciato prosperare questo traffico in totale impunità. I campi di tortura cominciano a proliferare nel Maghreb e in tutto il Corno d’Africa. Esistono già un centinaio di ‘case’ censite in Libia e altrettante nel Sudan e nello Yemen”.
L’Egitto e Israele hanno lasciato prosperare questo traffico in totale impunità. I campi di tortura cominciano a proliferare nel Maghreb e in tutto il Corno d’Africa. Esistono già un centinaio di ‘case’ censite in Libia e altrettante nel Sudan e nello Yemen”.Anche in questo caso, possiamo seguire i proclami del governo (“Partenze già crollate dell’80%”), oppure guardare i fatti ormai emersi e incontrovertibili: in Libia i migranti, quale che sia la loro condizione e provenienza, rischiano di essere torturati, stuprati, uccisi, che siano minori, adulti, uomini o donne.
Non è un bel mondo, lo è sempre di meno. Abbiamo governi e istituzioni transnazionali che sono come vecchi stregoni, pronti ad agitarsi, a gridare, per esorcizzare i problemi che affliggono la tribù. Nessuno può davvero crederci. È certo che tutto ciò - fare le pulci alle Ong, proclamare cooperazioni italo-libiche - ci permette di non vedere tutto questo orrore: gli annegati e coloro che rischiano l’annegamento, gli ammazzati sotto tortura, i sopravvissuti alla tortura, quelli che rischiano la tortura. I fascisti e i razzisti dicono che non è un “loro” problema. Se c’è una battaglia di civiltà, questa passa da qui. Se c’è oggi una battaglia antifascista e antirazzista passa da qui.
 Stare con Medici senza frontiere vuol dire stare per la salvezza di vite umane prima di tutto, quale sia la legge, l’umore dell’elettorato o del vicino di casa. E ci sono anche a livello quotidiano una quantità di cose che si possono fare e che vengono fatte. I fascisti e i razzisti gridano molto, e i media ne vanno pazzi e danno appena possono loro il microfono. Ma c’è un quantità di persone che lavorano più spesso silenziosamente per disfare la tela soffocante che queste persone vorrebbero creare intorno a noi, e dentro cui noi stessi finiremmo strangolati.
Stare con Medici senza frontiere vuol dire stare per la salvezza di vite umane prima di tutto, quale sia la legge, l’umore dell’elettorato o del vicino di casa. E ci sono anche a livello quotidiano una quantità di cose che si possono fare e che vengono fatte. I fascisti e i razzisti gridano molto, e i media ne vanno pazzi e danno appena possono loro il microfono. Ma c’è un quantità di persone che lavorano più spesso silenziosamente per disfare la tela soffocante che queste persone vorrebbero creare intorno a noi, e dentro cui noi stessi finiremmo strangolati.Mia moglie ed io quest’anno siamo diventati, in Francia, padrini di Samed, un ragazzo di diciassette anni proveniente dal Ghana. Samed tra i 15 e i 16 anni ha lasciato il suo paese, ha attraversato il Burkina Faso e il Niger per arrivare in Libia. Ha lavorato come aiuto meccanico in Libia cinque mesi. Non voleva venire in Europa, voleva andare a lavorare in Libia. Non era evidentemente cosciente della situazione in cui si trovava il paese. Non so che cosa abbia vissuto durante quei mesi. Di certo, si è deciso a partire, a tentare la fuga dalla Libia verso l’Europa. Me ne ha parlato come di un Far West. Comanda chi ha le armi. E le armi le hanno in mano quasi tutti.
Oggi Samed, in quanto minore non accompagnato, ha potuto godere di un sostegno e di una sistemazione da parte dello Sato francese. Non è un programma “privilegiato” per immigrati, è il programma che lo Stato francese destina a tutti i minori “orfani” o privi di sostegno familiare che si trovano sul suo territorio. Oltre a ciò, lui e noi possiamo godere di questa forma di ospitalità ulteriore e non istituzionale, che è l’affido a una famiglia d’accoglienza. Il parrainage si traduce in un rapporto concreto, affettivo, familiare. E Samed è diventato concretamente parte della nostra famiglia. Questo è solo un piccolo esempio di un’accoglienza cittadina, non istituzionale e nemmeno “umanitaria”, che può avere tanti volti e può esprimersi in tante e diverse occasioni. Io sto quindi con Samed, e sto con uno Stato non razzista, ossia che non distingue l’applicazione di diritti fondamentali secondo criteri di cittadinanza, e sto con le ONG che considerano che il problema di salvare delle vite umane è un loro problema, anche se è lo Stato che dovrebbe occuparsene.
* NAZIONE INDIANA, 7 agosto 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - AGAMENNONE, ULISSE, E LA GENETICA. "Nature" riscrive la storia dell’Egeo. Nulla di nuovo rispetto a quanto scritto da Omero ed Erodoto.4 agosto 2017, di Federico La Sala
STORIA E STORIOGRAFIA: IL MITO DELLA ROMANITÀ E DELLA GRECITÀ E LA BIOLOGIA. LA PUNTA DI UN ICEBERG. ...*
I greci sono davvero figli di Agamennone e Ulisse: lo dice il dna
Nature riscrive la storia dell’Egeo usando i dati del Dna dei tempi di Ulisse e di Minosse. Ma fra gli studiosi è dibattito: il genoma non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto scritto da Omero ed Erodoto
di ELENA DUSI *
L’analisi del Dna permette di ricostruire le migrazioni delle popolazioni antiche. Uno studio pubblicato su Nature oggi entra nei dettagli della storia greca, tracciando l’albero genealogico degli abitanti dell’Egeo dall’età del bronzo a quella odierna. Il genoma di 19 scheletri antichi dissepolti a Creta, nella penisola ellenica o nella Turchia dell’ovest è stato messo a confronto con quello di oltre 2mila individui di oggi. Il risultato - non sorprendente - è che i greci moderni sono figli di Agamennone: buona parte del loro Dna coincide con quello dei micenei, mentre più ridotto è il grado di parentela con i minoici. Sia il Dna di Minosse che quello di Ulisse derivano per tre quarti dal genoma dei primi agricoltori dell’Anatolia occidentale. Da lì, gli antichi uomini dell’età del bronzo (epoca che va dal 3.300 al 1.200 a.C.), avrebbero occupato l’Egeo e Creta. I micenei, in più, mostrano un legame più recente con i popoli delle steppe del Caucaso.
Ricostruzioni come queste sono preziose per dipanare la storia, ad esempio, di alcuni popoli primitivi. Ma di fronte a una civiltà raccontata da Erodoto e Omero, cosa hanno da dire le sequenze di geni sfornate dai computer ultrapotenti del Max Planck Institute, dell’università di Washington o da quella di Harvard? L’articolo di Nature ha aperto un dibattito fra gli esperti su quale possa essere il ruolo della genetica nello studio della storia.
"I risultati confermano quel che si sapeva già” è l’esordio (diplomatico) di Lorenzo Perilli, che insegna filologia classica all’università di Roma Tor Vergata. "Ribadiscono che il miracolo greco non esiste. L’immagine di un popolo che risplende nel suo isolamento, nata fra il ‘700 e l’800, non ha nulla a che vedere con la realtà. Minoici e micenei avevano, come è naturale, legami non solo commerciali, ma culturali e di parentela con le popolazioni vicine". L’origine di una civiltà così raffinata come quella minoica, nel terzo e secondo millennio avanti Cristo, resta avvolta nel mistero anche dopo l’analisi genetica. "Occorrerebbero fonti scritte, molte più di quelle che abbiamo. E purtroppo il Dna non potrà dirci molto a questo proposito" dice Perilli.
Il viaggio degli agricoltori anatolici verso est avvenne - conferma Nature - nel Neolitico. Ovvero diversi millenni prima della fioritura delle civiltà minoica e micenea. L’idea di risalire alle radici di queste migrazioni usando il Dna è venuta a George Stamatoyannopoulos, genetista dell’università di Washington con la passione per la storia. "Da più di un secolo circolano idee controverse sulle origini dei greci" spiega. "C’è l’ipotesi dell’Atena Nera, secondo cui la civiltà classica avrebbe origini afroasiatiche. E c’è l’ipotesi dello storico tedesco Fallmerayer, che nel 19esimo secolo scrisse che i discendenti degli antichi greci si erano estinti nel medioevo". Altre idee sostenevano che i micenei fossero una popolazione straniera arrivata forse da nord, estranea all’ambiente dell’Egeo. E che i minoici avessero un livello di cultura troppo elevato (inclusa una scrittura mai decifrata) per essersi sviluppato fra le rive di Creta. Forse - si arrivò a suggerire - erano i figli di una civiltà molto avanzata che decise di abbandonare la madrepatria.
Queste teorie vengono squalificate dal Dna. "Ma nessuno ci credeva ormai più" chiosa Perilli. "La realtà - spiega Giovanni Destro Bisol, antropologo della Sapienza di Roma - è che questi grandi progetti di genomica stanno soppiantando le ricerche sul campo". Ormai i grossi laboratori come quelli coinvolti nello studio di Nature hanno apparecchiature capaci di sequenziare un intero genoma umano in poche ore. "Hanno una potenza di fuoco enorme, non c’è che dire" prosegue Destro Bisol. "I loro risultati sono estremamente precisi. Ma si è creata una sorta di oligopolio, con pochi grandi laboratori che dominano il campo. I gruppi di ricerca che non hanno grandi risorse vengono tagliati fuori. Questo non è necessariamente un bene nella scienza".
Se Mario Capasso dell’università del Salento, presidente dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, giudica "comunque utili gli apporti della genetica, anche se in questo caso non aggiungono molto a quel che sapevamo già", più perplesso di dichiara Luciano Canfora, filologo classico dell’università di Bari e saggista: "Sono scettico, ma non sono Don Ferrante, non mi intendo dell’argomento e mi auguro fervidamente di essere contraddetto. Facciamo però l’esempio della peste di Atene. Fu narrata da uno dei più grandi storici, contagiato lui stesso, eppure ancora oggi gli scienziati dibattono su quale fosse esattamente la natura dell’epidemia. Quanto ai resti del Dna, che conservazione possono avere dopo tanti millenni?".
Il più critico nei confronti della genetica applicata al Minotauro è sicuramente Mario Torelli, archeologo e accademico dei Lincei. "Una volta, durante un convegno sulla Magna Grecia, arrivai quasi alle mani con un famoso genetista, Luigi Luca Cavalli Sforza" ammette. "Nel Mediterraneo, in epoca paleolitica, ci sono stati spostamenti enormi di popolazioni. E’ successo di tutto, e penso che le informazioni che ci arrivano dalla genetica siano irrilevanti. La storia è un’altra cosa”.
Non aggiungerà nulla di nuovo, ma il Dna degli antichi greci aiuta a fare ordine in un quadro - quello della storia dell’Egeo - dove teorie e ipotesi non sempre scientifiche si sono sovrapposte per secoli. "Le origini della civiltà micenea e greca sono state collegate fin dall’800 alla diffusione dei popoli indoeuropei". Dove per indoeuropei possiamo leggere anche ariani.
"Soprattutto in passato, il concetto è stato molto dibattuto” spiega ad esempio Marco Pacciarelli, che insegna preistoria e protostoria all’università di Napoli Federico II. Una delle tesi suggerite dagli scienziati di Nature è che la piccola differenza fra il genoma dei micenei rispetto a quello dei minoici nasca da una migrazione dall’est dell’Europa. “A parere degli autori questo confermerebbe l’ipotesi, avanzata in passato ma accolta all’inizio con scetticismo, che la lingua indoeuropea parlata dai micenei fosse arrivata in Grecia da qui" spiega Pacciarelli. "Secondo questa teoria, che risale a Marija Gimbutas, un gruppo di pastori e guerrieri delle steppe, sia pur minoritario, sarebbe riuscito a imporre il suo idioma. Della lingua dei minoici, infatti, si sa poco. Ma la maggior parte degli studiosi ritiene che non fosse indoeuropea".
E che gli antichi greci non fossero ariani biondi e con gli occhi azzurri è confermato anche da Nature, che li descrive scuri di occhi e di capelli, con la pelle chiara. Come oggi. E come in fondo li ritraeva l’arte dell’epoca.
*
Sul tema, si cfr.: la recensione del lavoro di Johann Chapoutot, "Il nazismo e l’antichità", nello "Speciale/Terzo Reich" (Alfabeta-2, 27 luglio 2017), Nazisti antiquari, non filologi di Roberto Danese,, con due mie note.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - L’ERRORE DEI GRECI. L’Ellenismo e le altre cutlture. Una lezione di Arnaldo Momigliano.6 agosto 2017, di Federico La Sala
I GRECI, LA "GLOBALIZZAZIONE" ELLENISTICA, E LA SAGGEZZA STRANIERA: LA LEZIONE DI ARNALDO MOMIGLIANO...
- Arnaldo Momigliano, Pagine ebraiche, Con un’intervista inedita ad Arnaldo Momigliano, A cura di Silvia Berti, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2016. *
MOMIGLIANO
di David Bidussa *
Il ritorno in libreria, dopo trenta’anni di Pagine ebraiche (ora per le Edizioni di Storia e Letteratura, nel 1987 il volume era stato edito da Einaudi) la raccolta degli scritti di Arnaldo Momigliano, magistralmente “creata” (più che redazionalmente curata) da Silvia Berti, per certi aspetti è di nuovo un evento (come trenta anni fa); per altri, ha la caratteristica di un contro evento. Sono più per la seconda ipotesi, perché il modello storiografico che dà significato alla ricerca di Momigliano, corrisponde a un senso storico che oggi mi sembra latitare o procedere con circospezione.
Prima di tutto il libro.
Pagine ebraiche è la raccolta di saggi o anche di recensioni che hanno per tema la storia degli ebrei e il modo di discuterne o di scavarci intorno. Nel caso si Momigliano significa piccole “perle” - per esempio la recensione a Cecil Roth, Gli ebrei in Venezia, testo che attrae l’attenzione di Antonio Gramsci che ne scrive nei suoi Quaderni del carcere e qui riproposti a pp. 163-167. Per Momigliano si può ripetere ciò Scholem scriveva di Benjamin - come ricorda Silvia Berti: anche nell’accenno marginale, apparentemente eccentrico s’intravede un tesoro di informazioni, ma anche di visioni. “Nel minimo si rivela il massimo”.
Elemento che corrisponde a un metodo e che consiste nel guardare alle culture come macchine, come costruzione nel tempo e soprattutto come dialogo con altre culture con cui ci si misura, ma soprattutto da cui si assorbe, si riformula.
L’idea di partenza è che nessuna cultura è un mondo a sé e dunque la storia della propria cultura non è mai la storia dello sviluppo naturale, del proprio codice interno.
Un tema che nella ricerca appassionata di Momigliano è costituito dalle ricerche dedicate al tema dell’ellenismo e che significativamente raccoglie e propone in un libro dal titolo provocatorio Saggezza straniera (che Einaudi pubblica nel 1980 e poi mai più riedito). Testo dedicato al rapporto tra l’ellenismo e le altre culture antiche: ovvero di come la Grecia e la sua espansione culturale (non disgiunta da quella politico-militare) fosse recepita dalle altre culture dell’area mediterranea; ma anche il problema contrario: come la Grecia recepisse le altre. Una storia di fraintendimenti, idealizzazioni, osmosi reciproche, contrasti e fascinazioni, tipiche di quella prima grande “globalizzazione” europeo-asiatica che fu l’ellenismo.
Proviamo a uscire da quella lunga congiuntura storica.
Dice niente a noi così immersi nello “scontro di civiltà”o convinti dell’ “autonomia” - meglio del’autosufficienza - di ogni singola cultura identitaria?
E’ l’identità la riproduzione di un solo codice culturale, quello della propria appartenenza, codice impermeabile, “senza porte né finestre” e quand’anche capace di assorbire servendosi solo dei propri strumenti interni?
Non è solo un problema di ibridazione di codici culturali, ma anche di rilevanza di metodi di analisi e dunque di modi di leggere e studiare i testi.
Proviamo a riprendere in mano un testo dal titolo Studi biblici e studi classici (scritto originariamente nel 1980). E’ il testo che apre Pagine ebraiche. Otto pagine in tutto che valgono il libro.
A un certo punto scrive Momigliano: “io non ho nulla da obiettare, in linea di principio, all’attuale moltiplicazione di metodi d’analisi retorica di testi storici. Si può fare tutta l’analisi retorica che si ritiene necessaria, purché essa porti al’accertamento della verità - o all’ammissione che la verità, in un dato caso, è purtroppo fuori portata. Ma dev’essre chiaro una volta per tutte che I Giudici e Gli Atti degli Apostoli, Erodoto e Tacito sono testi storici e devono essere esaminati allo scopo di recuperare le verità del passato”.
Si può dire meglio? Forse. In ogni caso vale ripeterlo.
*
David Bidussa: Arnaldo Momigliano, "Pagine Ebraiche", Edizioni di Storia e Letteratura. 2016.
-
> L’Ellenismo e le altre culture. Una lezione di Arnaldo Momigliano ---"Sai qual è la differenza fra uno storico e un grande storico? Uno storico è uno che offre risposte ai problemi storici. Un grande storico è uno che scopre problemi storici" ( Arnaldo Momigliano a Massimo Firpo).30 ottobre 2021, di Federico La Sala
LA POLITICA DELL’EUCARESTIA ... E "LA QUARTA «P» (QUELLA DELLA «PACE») CHE MANCA ALL’AGENDA DEL G20"
- Francesco-Biden e la diplomazia dell’eucarestia. Il presidente Usa: "Il Papa mi ha detto che posso accedervi". A breve i vescovi americani avrebbero dovuto decidere se negargliela per la sua posizione sull’aborto
- "A pochi giorni dal momento in cui i vescovi americani dovevano decidere se negare la comunione al presidente degli Stati Uniti per la sua posizione su una legge - in questo caso quella sull’aborto - il papa è intervenuto, e ha compiuto un atto primaziale che ha importanti conseguenze ecclesiologiche e politiche: ha detto a Joe Biden di accedere alla eucarestia in pace e gli ha concesso di rendere nota questa parte del loro colloquio [...] Tutto bene anche per i nodi politici, che non sono quelli del clima e dei vaccini che sono ovvia materia G20 [...] Tant’è che alla fine Biden ha elogiato il Papa come «uomo della pace»: la quarta «P» che accanto a People Planet Prosperity manca all’agenda del G20" (di Alberto Melloni, La politica dell’eucarestia, 30 ottobre 2021)
- ALBERTO MELLONI: "Sai qual è la differenza fra uno storico e un grande storico? Uno storico è uno che offre risposte ai problemi storici. Un grande storico è uno che scopre problemi storici" (Arnaldo Momigliano a Massimo Firpo).
#ANTROPOLOGIA #TEOLOGIA #STORIA E #FILOLOGIA. "La #politica dell’#eu-#carestia" - #oggi (la @repubblica , #30ottobre2021) - "segnala" un #problema di #dottrina, di #interpretazione, e di #storiografia di #lungadurata... quello della #Grazia ("#Charis"). O no? Buon lavoro. Grazie.
Federico La Sala
Scheda
MEMORIA DI LORENZO VALLA:
- Presentazione volume - Laurentii Valle Sermo de mysterio Eucharistie, a cura di Clementina Marsico, con un saggio di Marco Bracali. Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, II, Opere religiose, 3, Firenze, Polistampa 2019
Lunedì 24 febbraio [2020], alle ore 11.00, verrà presentato il volume Laurentii Valle Sermo de mysterio Eucharistie, a cura di Clementina Marsico, con un saggio di Marco Bracali. Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, II, Opere religiose, 3, Firenze, Polistampa 2019.
Interverranno:
Alberto Melloni, Segretario della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII
Antonio Manfredi, Scrittore latino della Biblioteca Apostolica Vaticana
Daniele Conti, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento
Sarà presente la curatrice del volume.
L’incontro - aperto a tutti gli interessati - si terrà nella Sala dei Seminari dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento.
* Fonte: INSR. Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 24 febbraio 2020
-
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- Ma che cos’è un albero? (di Marco Belpoliti - "Doppiozero", a sostegno Progetto "gli Jazzi"/Parco Nazionale del Cilento).4 agosto 2017, di Federico La Sala
TERRA!!! TERRA!!! PIANETA TERRA: FILOLOGIA E ’DENDROLOGIA’ (gr.: "déndron" - albero e "lògos" - studio/scienza). L’ALBERO DELLA VITA ... *
Ma che cos’è un albero?
di Marco Belpoliti *
- Continua l’intervento di doppiozero a sostegno del Progetto Jazzi, un programma di valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale e ambientale, materiale e immateriale, del Parco Nazionale del Cilento (SA).
 Gli Jazzi (da iacere, giacere) erano dimore temporanee, giacigli per il ricovero di animali da pascolo, punto di connessione tra tratturi e paesi: luoghi dell’indugio, della presa di contatto con le cose. Il progetto intende recuperare questo modo di abitare la natura, raccontando percorsi da attraversare con lentezza, riappropriandosi di spazi e luoghi e della loro storia, rinnovando esperienze - come l’osservare le stelle o il nascere del giorno - capaci di ripristinare il contatto con la natura, con il ciclo delle cose e delle stagioni. La sfida è anche quella di produrre innovazione e rigenerazione sociale, recuperando strutture e architetture rurali, mettendo in moto un circolo virtuoso di ospitalità diffusa che si nutra delle realtà esistenti e delle reti di relazione con i ‘nuovi viaggiatori’.
Gli Jazzi (da iacere, giacere) erano dimore temporanee, giacigli per il ricovero di animali da pascolo, punto di connessione tra tratturi e paesi: luoghi dell’indugio, della presa di contatto con le cose. Il progetto intende recuperare questo modo di abitare la natura, raccontando percorsi da attraversare con lentezza, riappropriandosi di spazi e luoghi e della loro storia, rinnovando esperienze - come l’osservare le stelle o il nascere del giorno - capaci di ripristinare il contatto con la natura, con il ciclo delle cose e delle stagioni. La sfida è anche quella di produrre innovazione e rigenerazione sociale, recuperando strutture e architetture rurali, mettendo in moto un circolo virtuoso di ospitalità diffusa che si nutra delle realtà esistenti e delle reti di relazione con i ‘nuovi viaggiatori’.
Stanotte una tempesta si è abbattuta furiosa contro le case. Ha piovuto fortissimo e tirato vento: mulinelli d’acqua, quasi delle piccole trombe. Oggi sono uscito a camminare e lungo la strada c’erano rami e alberi per terra. Un cipresso, neppure troppo vecchio, era caduto. Gli avevano tagliato i rami più lunghi. Ho guardato il tronco tutto scheggiato dalla furia del vento.Mi sono chiesto, ma che cos’è un albero? Un essere vivente; meglio: l’unico essere vivente che non si sposta mai. Giusto. Ma anche le erbe e i cespugli hanno la medesima prerogativa. Inoltre, le radici dell’albero si muovono, s’allargano, camminano, se così si può dire.
Secondo un botanico di cui ho letto tempo fa il libro, l’albero è prima di tutto il suo cappello di foglie: una struttura per sostenere il suo fogliame attraverso cui respira e anche si nutre, di luce prima di tutto. Nudo con i rami d’inverno, un albero non sarebbe davvero un albero. In effetti in inverno gli alberi non sono davvero alberi, ma strutture scheletriche che si propendono verso il cielo. Per Teofrasto un albero è prima di tutto il suo tronco. Carl G. Jung ha un’opinione simile. Ha scritto in un suo volume che il senso stesso dell’albero non sta né nelle radici né nella sua chioma, ma piuttosto“nella vita che scorre tra le due”. Jung non considera troppo le foglie, e non ha il senso malinconico del tempo che passa, cosa che appartiene invece a Freud. Per lui il mondo si compone di archetipi, strutture eterne e durature, che superano l’esistenza dei singoli individui. Possiede una saggezza che si sposa bene con il senso della durata che gli alberi possiedono. Se non fosse per quel cipresso schiantato che ho visto stamane, avrei pensato anche io alla vita che scorre e alla durata dell’albero.
Un selvicoltore tedesco, autore di La saggezza degli alberi (Garzanti) definisce, non a caso, l’albero un “essere enigmatico”. In verità Peter Wohlleben, questo il suo nome, parla di alberi al plurale, e di alberi al singolare citandone i vari tipi: betulla, quercia, olmo, faggio, eccetera. Gli alberi per lui sono il bosco, sebbene il bosco non sia composto solo di alberi, ma di tante altre cose sotto gli alberi. Italo Calvino nel suo romanzo arboricolo, Il barone rampante, descrive il bosco mediterraneo parlando del “frastaglio di rami e foglie, biforcazioni, lobo, spiumii minuti e senza fine” dentro cui il cielo si vede solo “a sprazzi irregolari e ritagli”. Wohlleben è un ammiratore di questa forma vivente che cresce contrastando la legge di gravità. L’ammira per la sua forza, per l’altezza, per la quiete che infonde, per la durata nel tempo: gli alberi vivono più a lungo di qualsiasi forma di vita del Pianeta. Tuttavia ogni albero, come mi ha ricordato stamani il cipresso schiantato, è il risultato di una strenua lotta per la vita. Come tutti gli esseri viventi, anche l’albero deve superare una competizione continua. Wohlleben parla esplicitamente di “fatica d’essere un albero”.
L’albero cerca di crescere intercettando più energia possibile: lotta per la luce solare. Nel bosco ci sono gli alberi sovrani. Li vedi subito: sono maestosi, altissimi, grandi, occupano tutto lo spazio. Intorno non cresce nient’altro, se non fili d’erba, o al massimo bassi cespugli, esolo se riescono a trovare energia per poterlo fare. I rami dei re del bosco si estendono in tutte le direzioni. Sotto il loro cappello però crescono altri alberi, più piccoli. Un grande albero possiede almeno 200.000 foglie, che occupano, secondo i botanici, una superficie di circa 1000 metri quadrati. Gli alberi piccoli cercano di trovare il loro posto. Non sempre ce la fanno. Il re li esclude dal bagno di luce. Se si osserva con attenzione il bosco, si vedono tanti piccoli alberi intorno al sovrano, piccoli dignitari della sua corte. Alcuni anche piegati nell’inchino al signore e padrone della radura. Se potessimo misurare l’età di questi alberelli, scopriremmo che è ragguardevole. Alcuni hanno anche 100 anni, come capita in certi boschi del Nord Europa, ma anche nei boschi meridionali, al Sud dell’Italia, nel Meridione e in Grecia. Lì ci sarà meno sottobosco, per via del calore e della siccità, ma gli alberi attorno hanno età diverse: da 100 fino a qualche decina. Molti alberi nati sotto il gigante muoiono in breve tempo e si trasformano in humus per alimentare il re della radura. Solo se l’albero maggiore si ammala e muore, si trova lo spazio per crescere.
L’albero è un organismo sensibile. Non ci sono solo gli elementi atmosferici, il vento, la pioggia; ci sono anche nemici invisibili, almeno ai nostri occhi di non esperti: parassiti, muffe, microorganismi, funghi, insetti. Li minacciano e ne contrastano la crescita. Ne attentano alla vita. Non basta ammirarlo per la sua immobilità, per la solidità e forza. Dobbiamo ammirarlo per essere diventato grande in barba a tanti nemici e avversari. Il faggio, per esempio, albero molto ammirato dagli umani, è un terribile avversario. Arriva persino a tagliare i rifornimenti ai vicini, accaparrandosi le riserve d’acqua e i possibili nutrimenti nel terreno. Gli alberi non sono solo belli o buoni, sono anche spietati. Il cappello di foglie del faggio si è sviluppato nel corso di una lunghissima evoluzione per arrivare a creare una trama fittissima che toglie ai concorrenti almeno il 20% della luce che cade dall’alto. La forma degli alberi dipende da questioni come questa. Per esempio, la foggia conica di una conifera è la miglior risposta al carico di neve che cade nei climi freddi: non può accumularsi più di tanto sui suoi rami e cade giù, anzi scivola.
Leggo questo in un bel libro di Giuseppe Barbera, docente di Colture arboree all’Università di Palermo: Abbracciare gli alberi (il Saggiatore). Non c’è solo questa prerogativa, spiega. Questa forma serve alle conifere anche per intercettare la poca luce di quelle regioni: i raggi solari sono bassi sull’orizzonte. Nei climi secchi, invece, quando il sole è a perpendicolo, la medesima forma consente una minor insolazione nelle ore più calde, e quindi un risparmio d’acqua. Il pino mediterraneo ha una forma a ombrello, che è una silhouette aerodinamica, per resistere ai venti caldi disseccanti e per consentire un più facile raffreddamento della chioma. La forma tondeggiante della quercia, uno degli alberi più diffusi in Italia, è l’effetto dei climi temperati, perché consente di assorbire il massimo di energia offrendo al sole la massima superficie possibile. Non è solo la luce a determinare la forma degli alberi. C’è anche il vento, il terribile vento. Il pino mugo, che tanto piace agli escursionisti, ha deciso di restare un arbusto e non di diventare propriamente un albero, pur avendone la possibilità. Contorto e abbarbicato alle pietre, si ritrae, attento a radicarsi per contrastare il vento che soffia forte in alcune stagioni dell’anno.
Nelle regioni del Sud le architetture arboree sono poi modificate dai frequenti incendi, sia dolosi che spontanei - quest’anno è stato un disastro per tutto il Sud. Poi c’è la presenza delle capre, che ne inibisce la crescita. Alcuni alberi, come la quercia coccifera, detta anche spinosa, per via delle sue foglie, cerca di opporsi al morso delle capre e all’assenza di acqua: ha assunto questa forma nel corso di migliaia d’anni: un esempio di selezione. Sopravvivono le piante più adatte. Barbera ci assicura che potrebbe essere alta dai 5 ai 10 metri, ma per sopravvivere si è fatta arbusto cespuglioso. La lotta darwiniana per la vita non riguarda solo gli organismi cosiddetti superiori, ma anche quelli che noi reputiamo “inferiori” come cespugli ed erbe. L’intelligenza è distribuita in tutti e tre i regni della vita, e anche oltre. Anche le piante sono intelligenti e comunicano. Ad esempio, con gli insetti. Quando ci avviciniamo a un bell’albero in fiore - un ciliegio selvatico ad esempio -pensiamo, da narcisi della creazione, che si tratti di un omaggio a noi umani: i fiori sono per noi. L’albero invece sta dicendo agli insetti che si trovano lì intorno: venite qui, c’è un nettare delizioso per voi. L’albero vuole essere impollinato. E certamente noi non potremmo farlo: non abbiamo gli strumenti adatti e anche la nostra tecnologia, pur raffinatissima, non eguaglia quella degli insetti.
Gli alberi comunicano anche tra loro. Seuno di loro è attaccato dai bostrici, insetti dotati di grandi mandibole che s’incontrano nelle campagne,subito immagazzina nella corteccia sostanze repellenti. Non lo fa solo per sé, ma comunica la cosa ai suoi vicini attraverso l’odore, una forma di messaggio chimico simile a quello che usano gli insetti, api e formiche. Manifesta una volontà collaborativa. L’indicazione vola nell’aria seguendo un codice proprio. Inoltre, se non c’è la possibilità di farlo per via del vento, l’albero userà le radici che s’intrecciano a quelle dei suoi vicini. Gli alberi sono davvero un mistero. Sinora nessuno è ancora riuscito a spiegare interamente il processo attraverso cui una massa liquida valutabile tra i 500 e i 1000 litri d’acqua, durante il periodo vegetativo, riesca a salire lungo il tronco. Per capillarità, sostengono gli studiosi; ma c’è anche l’effetto traspirazione. Quando l’albero rilascia vapore acqueo attraverso i pori delle foglie si crea una pressione negativa e l’acqua procede verso l’altro. Tornando verso casa ho pensato a come mai le persone preferiscano gli alberi che non perdono le foglie, i sempreverdi, come il cipresso caduto. Le foglie mi affascinano per il fatto che pur essendo dello stesso albero sono tutte diverse. E sono diverse da albero ad albero, come abbiamo imparato da bambini, quando le raccoglievamo colpiti dalle loro differenze: pennate, lobate, dentate, settate, eccetera. Dipende tutto dalle necessità dell’albero: sagomarsi per raccogliere luce o per resistere al vento.
L’evoluzione ha funzionato anche in questo. Le foglie grandi sono idonee agli ambienti umidi, come le foreste tropicali; nei climi secchi non le troverete mai: lì sono piccole e spesse (si chiamano sclerofille), in modo da perdere poca acqua nella traspirazione. Le foglie sono un meraviglioso organismo. Sono loro la parte più attiva dell’albero. Traspirano attraverso gli stomi, delle piccole valvole disposte sulla parte inferiore. Mediante gli stomi avvengono gli scambi di gas, ricorda Barbera: entra l’anidride carbonica, fuoriescono vapore acqueo e ossigeno. Ecco perché sono così importanti per noi. E le radici. Sono tra le cose più disegnate da bambini, forse perché non si vedono. Un’altra meraviglia dell’albero. Sono più ampie della parte ramificata esterna, per necessità: sostengono l’albero e lo nutrono. Non scendono troppo in profondità. Sono superficiali, perché nel primo metro di terra c’è la maggior parte del nutrimento necessario creato da resti organici di altre piante o animali. Lì c’è più ossigeno e acqua.
Una ricercatrice, Malini Moreshwar Nadkarni, ha dedicato uno studio sul rapporto tra gli esseri umani e gli alberi. Ne ha scritto in Tra la terra e il cielo (Elliot). Questa è la loro posizione, non solo simbolica, come sostengono gli steineriani, ma reale. Sopra di noi umani ci sono gli alberi. Più sopra le nuvole. Tuttavia le nuvole non stanno piantate nella terra. Vanno e vengono, appaiono e scompaiono. Gli alberi tendono come noi verso l’alto. Per salire in alto, quando ancora non avevamo mongolfiere, palloni aerostatici o aeroplani, dovevamo arrampicarci sugli alberi. Secondo alcuni paleontologi siamo scesi da lì. Ci saremmo dotati del pollice opponibile per muoverci tra i rami. Ecco perché Cosimo di Rondò, il Barone rampante di Italo Calvino, piace ai giovani lettori: perché dà forma a qualcosa di ancestrale che si è conservato in noi, nei bambini. Arrampicarsi sugli alberi è un’esperienza fondamentale, non solo in senso evolutivo. Confuso omaggio e ritorno all’origine della specie, ha scritto Primo Levi. Gli alberi c’erano prima di noi e ci saranno dopo di noi, a meno che non li estinguiamo. Invece di tagliarli, piantiamoli. Il cipresso caduto sarà ripiantato, mi ha rassicurato il mio vicino. Per arrivare all’altezza del gigante di prima ci vorranno decenni. Forse noi non ci saremo. Gli alberi e la lunga vita.
* Doppiozero, 27.07.2017 (ripresa parziale - senza immagini).
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
Pianeta Terra. Mediterranea-mente ....
 GELBISON, GIBSON E LA CHIESA CATTOLICA. DUE PAROLE, UN ’RIVELATIVO’ SEGNO DEI TEMPI. UNA ’MEMORIA’ DEL 2004
GELBISON, GIBSON E LA CHIESA CATTOLICA. DUE PAROLE, UN ’RIVELATIVO’ SEGNO DEI TEMPI. UNA ’MEMORIA’ DEL 2004Federico La Sala
- Continua l’intervento di doppiozero a sostegno del Progetto Jazzi, un programma di valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale e ambientale, materiale e immateriale, del Parco Nazionale del Cilento (SA).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- "Parole armate. Quello che l’Isis ci dice e che noi non capiamo" (P.-J. Salazar).1 agosto 2017, di Federico La Sala
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA.
Storiografia in crisi d’identità ...
LO SPIRITO E L’OSSO storia, immaginario, filosofia e psicoanalisi
L’analogia armata del Califfato. Parole e conflitti retorici
di Fabio Milazzo*
- Review of: Philippe-Joseph Salazar, Parole armate. Quello che l’Isis ci dice e che noi non capiamo, Bompiani, Milano 2016, pagg.199.
- «Mi domando quanta cultura, retorica,
persuasione e dialettica abbiamo perso in Europa
per non comprendere quello che sta succedendo e non essere in grado di reagire»
 Philippe-Joseph Salazar[1]
Philippe-Joseph Salazar[1]
Sgozzature, lapidazioni, defenestrazioni, crocifissioni, esecuzioni di donne, bambini e anziani, come forma di disciplinamento di massa alle "quali assistono folle intere, mentre fanno acquisti o nel bel mezzo del traffico di tutti i giorni" (p. 10). Tra tanti segni di barbarie, gli omicidi ritualizzati e "scenarizzati" a fini di propaganda, forse, rappresentano l’elemento che più di tutti ha colpito l’immaginario dell’Occidentale, quello che si confronta con ciò che Slavoj Žižek definisce l’orrore del Reale insimbolizzabile. Un orrore incomprensibile che, proprio per questo, scatena sterili reazioni di diniego e ingenui tentativi di reductio ad absurdum. Si invoca l’analfabetismo culturale e politico, l’idiozia gutturale sottolineata "dalle grida dei selvaggi" (p. 10), si riporta tutto alla miseria psico-sociale di chi, nato e cresciuto in una condizione di cieca disperazione, regredirebbe alla condizione animale (avete mai visto animali uccidere ritualmente?). Ma siamo così sicuri che oltre lo sconcerto ci sia solo il confronto con un mondo-barbaro da cui crediamo esserci emancipati?
 Non è che semplicemente ci stiamo rapportando con un mondo che utilizza logiche espressive - e quindi modelli mentali - troppo diversi dai nostri per poterli ridurre alle comode e rassicuranti coordinate che danno forma al mondo sorto dall’Illuminismo?
Non è che semplicemente ci stiamo rapportando con un mondo che utilizza logiche espressive - e quindi modelli mentali - troppo diversi dai nostri per poterli ridurre alle comode e rassicuranti coordinate che danno forma al mondo sorto dall’Illuminismo?- Abū Bakr al-Baghdādī durante una predica
Questi interrogativi tengono in piedi il libro di P.-J. Salazar "Paroles Armées. Comprendre et Combattre la Propagande Terroriste, appena tradotto in Italia per Bompiani. Lo dico subito: quello di Salazar è un grande libro che ha il coraggio di non abbandonarsi ai toni ideologici della maggior parte delle ermeneutiche in circolazione e, senza girarci intorno, chiarisce la posta in gioco dello scontro con l’Is: la retorica.
 Continuare a ripetere che le ragioni dello scontro sono (innanzitutto) economiche, legate all’arretratezza dell’Islam o effetti residuali del colonialismo, non consente di focalizzare quella che possiamo chiamare l’oscena fantasia che tiene in piedi le narrazioni in campo. Ci sono visioni del mondo - quindi modi di usare le parole per costruire le storie che riempiono l’immaginario - totalmente diverse tra l’Occidente logocentrico e questo Islam tanto violento quanto retoricamente eccessivo e dallo stile figurato.
Continuare a ripetere che le ragioni dello scontro sono (innanzitutto) economiche, legate all’arretratezza dell’Islam o effetti residuali del colonialismo, non consente di focalizzare quella che possiamo chiamare l’oscena fantasia che tiene in piedi le narrazioni in campo. Ci sono visioni del mondo - quindi modi di usare le parole per costruire le storie che riempiono l’immaginario - totalmente diverse tra l’Occidente logocentrico e questo Islam tanto violento quanto retoricamente eccessivo e dallo stile figurato.
 Precisiamo che le dicotomie, i "noi" e i "loro", ovviamente, non hanno ragion d’essere alla luce di una microfisica psico-sociale in grado di evidenziare la contingenza e l’irriducibile valore differenziale delle soggettività, ma mostrano il loro valore nel momento in cui si ha a che fare con il campo dell’immaginario di gruppo, con quei quadri-mentali-collettivi[2] su cui tanto si sono dibattuti gli storici novecenteschi delle Annales[3]. Quadri riconosciuti dallo stesso Lacan con la definizione di "mentalità". D’altra parte il parlante è sempre immerso nel proprio involucro immaginario, fatto di parole che organizzano sia le rappresentazioni, sia il senso attraverso cui fa esperienza del mondo. Non si capisce perché questa considerazione - neanche troppo originale oggi - non debba valere per le collettività, per mondi e nicchie-antropologiche che prendono forma entro coordinate storico-discorsive contraddistinte da una condivisione retorica di fondo molto forte.
Precisiamo che le dicotomie, i "noi" e i "loro", ovviamente, non hanno ragion d’essere alla luce di una microfisica psico-sociale in grado di evidenziare la contingenza e l’irriducibile valore differenziale delle soggettività, ma mostrano il loro valore nel momento in cui si ha a che fare con il campo dell’immaginario di gruppo, con quei quadri-mentali-collettivi[2] su cui tanto si sono dibattuti gli storici novecenteschi delle Annales[3]. Quadri riconosciuti dallo stesso Lacan con la definizione di "mentalità". D’altra parte il parlante è sempre immerso nel proprio involucro immaginario, fatto di parole che organizzano sia le rappresentazioni, sia il senso attraverso cui fa esperienza del mondo. Non si capisce perché questa considerazione - neanche troppo originale oggi - non debba valere per le collettività, per mondi e nicchie-antropologiche che prendono forma entro coordinate storico-discorsive contraddistinte da una condivisione retorica di fondo molto forte.In quest’ottica, non comprendere la mentalità dei terroristi, ridurla ad epifenomeno di cause economiche e materiali, significa operare con un perverso rasoio irriflesso in nome del riduzionismo più becero e ingenuo. Salazar lo sottolinea a più riprese, evidenziando quanto il problema dello scontro con l’Isis riguardi l’incomunicabilità di mondi che usano forme discorsive diverse.
 "C’è - ci dice - una logica dietro i discorsi del Califfato, che sembrano presentare uno scarto rispetto a ciò che noi consideriamo logico, ragionevole e persuasivo in politica. Una logica di altro genere [...] che possiede, oltre alla professione di fede e alla sua forza evocativa poetica un rigore dialettico. Il rigore del ragionamento per analogia" (p. 14).
"C’è - ci dice - una logica dietro i discorsi del Califfato, che sembrano presentare uno scarto rispetto a ciò che noi consideriamo logico, ragionevole e persuasivo in politica. Una logica di altro genere [...] che possiede, oltre alla professione di fede e alla sua forza evocativa poetica un rigore dialettico. Il rigore del ragionamento per analogia" (p. 14).
 Soprattutto queste ultime parole fanno venire voglia di riprendere in mano un gigante del pensiero come Enzo Melandri che nel suo «La linea e il circolo»[4] lungamente si è espresso sulle peculiarità di questo procedimento discorsivo. Si tratta di fare fino in fondo i conti con uno stile retorico-espressivo, ma anche con modelli di pensiero, che solo a fatica possono essere ricondotti "al sistema logico dei ragionamenti scientifici o razionali" (p.13). Se l’Europa ha messo al bando (salvo riconoscergli un ruolo osceno) la poetica e la retorica, separandole nettamente dal ragionamento logico e dalle argomentazioni scientifiche, così non è accaduto nel mondo islamico in cui "uno slancio lirico" vale come argomento e prova logica. -Facciamocene una ragione.
Soprattutto queste ultime parole fanno venire voglia di riprendere in mano un gigante del pensiero come Enzo Melandri che nel suo «La linea e il circolo»[4] lungamente si è espresso sulle peculiarità di questo procedimento discorsivo. Si tratta di fare fino in fondo i conti con uno stile retorico-espressivo, ma anche con modelli di pensiero, che solo a fatica possono essere ricondotti "al sistema logico dei ragionamenti scientifici o razionali" (p.13). Se l’Europa ha messo al bando (salvo riconoscergli un ruolo osceno) la poetica e la retorica, separandole nettamente dal ragionamento logico e dalle argomentazioni scientifiche, così non è accaduto nel mondo islamico in cui "uno slancio lirico" vale come argomento e prova logica. -Facciamocene una ragione.
 Siamo dunque condannati all’incomunicabilità e all’impossibilità del dialogo? Salazar non è così pessimista e lo dice bene in questa intervista:
Siamo dunque condannati all’incomunicabilità e all’impossibilità del dialogo? Salazar non è così pessimista e lo dice bene in questa intervista:«Se le armi non bastano, come possiamo contrastare il Califfato? Con l’istruzione. Dobbiamo educare una popolazione, quella europea, che vive di luoghi comuni. [...] Gli allievi europei non studiano bene la storia e la geografia. Di conseguenza, il vecchio continente si ritrova con una marcia in meno rispetto al Califfato che invece mette in mostra una notevole cultura, coltiva i grandi testi non solo religosi, cita i filosofi, recita poesie e canta inni. L’Europa mette in mostra una tecnologia che le si ritorce contro e nel frattempo vive un deficit culturale»[5].
Per inciso, la scuola - e il suo valore formativo - trova in queste dichiarazioni spazi inediti di possibile affermazione e rivalutazione in un periodo di profonda crisi in atto. Ma questo è un altro discorso. Il libro di Salazar non si limita soltanto ad evidenziare quanto sia scorretto, oltre che inutile, cercare di imporre la logica argomentativa sviluppatasi dopo la rivoluzione scientifica come chiave di lettura per decifrare l’orrore del Califfato, ma sottolinea anche quanto siano falsate - e ingenue - le ermeneutiche che riducono il fenomeno jihadista a semplice effetto sovrastrutturale, a conseguenza di una subordinazione economica, da parte del mondo musulmano, insostenibile nell’epoca della colonizzazione mediatica.
 Questa tesi, più o meno argomentata, è inconsistente se consideriamo quanto il proselitismo del Califfato interessi anche (soprattutto?) persone istruite che sembrano essere alla ricerca di valori chiari e di ideali da difendere, piuttosto che il riscatto economico, centrale invece per l’immaginario collettivo Occidentale.
Questa tesi, più o meno argomentata, è inconsistente se consideriamo quanto il proselitismo del Califfato interessi anche (soprattutto?) persone istruite che sembrano essere alla ricerca di valori chiari e di ideali da difendere, piuttosto che il riscatto economico, centrale invece per l’immaginario collettivo Occidentale.
 Non «considerare - ci dice l’Autore - il jihadismo come qualcosa di diverso da una patologia di imbecilli» (p.70) è una «cantonata» fondamentale, tipica di una società incapace di relazionarsi con l’Altro - per dirla con Lacan - senza ridurlo all’altro - delle proiezioni narcisistiche. I video e i periodici dei jihadisti dell’Isis, invece, sono pensati «per giovani intelligenti e istruiti, beneficiari di un buon capitale culturale e materiale, lettori attenti alla ricerca di argomenti solidi (anche se in ordine ad una teoria dell’argomentazione diversa dalla “nostra”) e di idee sviluppate con cura» (p.71).
Non «considerare - ci dice l’Autore - il jihadismo come qualcosa di diverso da una patologia di imbecilli» (p.70) è una «cantonata» fondamentale, tipica di una società incapace di relazionarsi con l’Altro - per dirla con Lacan - senza ridurlo all’altro - delle proiezioni narcisistiche. I video e i periodici dei jihadisti dell’Isis, invece, sono pensati «per giovani intelligenti e istruiti, beneficiari di un buon capitale culturale e materiale, lettori attenti alla ricerca di argomenti solidi (anche se in ordine ad una teoria dell’argomentazione diversa dalla “nostra”) e di idee sviluppate con cura» (p.71).
 Non deve così sorprendere - né essere considerata una eccezione - che le «tre brillanti liceali inglesi passate al Califfato [...] e il giovane medico australiano che è andato a esercitare il suo mestiere là dove lo hanno portato le sue convinzioni» (p.71) appartengano a quell’universo di gente istruita, che è andata a scuola e si è magari laureata, che le teorie del sottosviluppo economico come molla per l’adesione agli ideali dell’Isis dovrebbero non contemplare.
Non deve così sorprendere - né essere considerata una eccezione - che le «tre brillanti liceali inglesi passate al Califfato [...] e il giovane medico australiano che è andato a esercitare il suo mestiere là dove lo hanno portato le sue convinzioni» (p.71) appartengano a quell’universo di gente istruita, che è andata a scuola e si è magari laureata, che le teorie del sottosviluppo economico come molla per l’adesione agli ideali dell’Isis dovrebbero non contemplare.
 Invece ecco che si palesa un dato: la propaganda del Califfato si rivolge a persone «animate da un desiderio meditato» (p.71) di martirio. Per quanta fatica si faccia ad accettare questo elemento, questo ci dicono i dati a nostra disposizione e negarli, o cercare spiegazioni poco convincenti e contorte per giustificare una tesi postulata per principio è non soltanto epistemologicamente scorretto ma anche intrinsecamente contraddittorio.
Invece ecco che si palesa un dato: la propaganda del Califfato si rivolge a persone «animate da un desiderio meditato» (p.71) di martirio. Per quanta fatica si faccia ad accettare questo elemento, questo ci dicono i dati a nostra disposizione e negarli, o cercare spiegazioni poco convincenti e contorte per giustificare una tesi postulata per principio è non soltanto epistemologicamente scorretto ma anche intrinsecamente contraddittorio.
 Ma allora «come rispondere a tutto questo? Banalizzando il fenomeno - ci dice Salazar-: facendo circolare quelle riviste [del Califfato] nelle scuole, prendendone spunto per analisi del testo e decostruzioni radicali [...] per ridurre a poca cosa quei documenti materiali attraverso prove argomentate di linguaggio, grazie a ciò che la tradizione culturale francese sa fare meglio. Pensare in modo chiaro e distinto» (p.100). Si tratta cioè di non rifiutare il confronto, di non giocare sulla difensiva ma di contrattaccare retoricamente. E, in tale ottica, la risposta più intelligente che possiamo dare è quella di costruire narrazioni convincenti, basate su argomenti solidi, in grado di convincere quei giovani che sono tentati di abbracciare l’idea mortifera del Califfato di quanto l’intenzione sia una scelta da vicolo cieco. Contro-narrazioni in grado di decostruire la propaganda jihadista e di offrire valide alternative teoriche innanzitutto. Continuare a ripetere lo stanco e logoro mantra dell’arretratezza culturale, figlia del sottosviluppo economico, è controproducente, inutile e scioccamente supponente, anche se di una supponenza perversa, tipica di chi non riconosce effettiva autonomia di pensiero all’Altro ma, implicitamente, lo considera incapace di processi simbolici autonomi e, quindi, di scelte etiche libere. Lo dice con chiarezza Salazar:
Ma allora «come rispondere a tutto questo? Banalizzando il fenomeno - ci dice Salazar-: facendo circolare quelle riviste [del Califfato] nelle scuole, prendendone spunto per analisi del testo e decostruzioni radicali [...] per ridurre a poca cosa quei documenti materiali attraverso prove argomentate di linguaggio, grazie a ciò che la tradizione culturale francese sa fare meglio. Pensare in modo chiaro e distinto» (p.100). Si tratta cioè di non rifiutare il confronto, di non giocare sulla difensiva ma di contrattaccare retoricamente. E, in tale ottica, la risposta più intelligente che possiamo dare è quella di costruire narrazioni convincenti, basate su argomenti solidi, in grado di convincere quei giovani che sono tentati di abbracciare l’idea mortifera del Califfato di quanto l’intenzione sia una scelta da vicolo cieco. Contro-narrazioni in grado di decostruire la propaganda jihadista e di offrire valide alternative teoriche innanzitutto. Continuare a ripetere lo stanco e logoro mantra dell’arretratezza culturale, figlia del sottosviluppo economico, è controproducente, inutile e scioccamente supponente, anche se di una supponenza perversa, tipica di chi non riconosce effettiva autonomia di pensiero all’Altro ma, implicitamente, lo considera incapace di processi simbolici autonomi e, quindi, di scelte etiche libere. Lo dice con chiarezza Salazar:«Che si conduca o meno un’offensiva militare effettiva sul campo del Califfato, bisogna ripensare i termini retorici di questo eventuale impegno e ammettere che lo scontro comincia con una guerra retorica in cui l’avversario controlla una panoplia omogenea che va dall’ingiunzione all’analogia, passando per un’arte oratoria convincente e sostenuta dalla potente logica di un legalismo imperativo. [...] Bisognerà pensare islamico, parlare islamico, argomentare islamico. Mettersi alla portata retorica dell’avversario» (p.19).
Mettersi alla portata retorica dell’avversario significa anche considerarlo come tale, nel suo essere radicale differenza, alterità da prendere come tale, anche quando si serve, ragiona e giudica attraverso una forma argomentativa - quella analogica - che alle nostre orecchie stupisce e ci appare «perversa o delirante» (p. 14). «L’analogia è il quarto fondamento del ragionamento giuridico» (p.15) islamico, che vuol dire che attraverso l’analisi di un esempio tratto dalla Tradizione si procede all’emissione di un parere giuridico (fatwa) vincolante. Anche le condanne a morte, che tanto orrore provocano a Occidente, vengono inflitte su questa base logica. Possiamo davvero pensare di confrontarci con questo mondo senza aver adeguatamente sviluppato le conseguenze teoriche ed etiche di ciò? «Utilizzando le analogie nella sua propaganda - ci dice Salazar-, la politica jihadista si nutre quindi di un’atmosfera retorica che ci sembra strana o irrazionale [...], che però costituisce una forma politica di interpretazione delle cose, potente e generale» (p.16). Improntare una guerra-retorica per decostruire la propaganda dell’avversario, significa dunque, innanzitutto, «ripensare i termini retorici» (p. 19) di questo scontro e non sottovalutarne la portata performativa.
In definitiva la lezione di questo libro riguarda il fatto che c’è una "potenza oratoria e persuasiva" (p.8) assolutamente incomprensibile per i canoni logocentrici delle "nostre orecchie" abituati a concatenamenti logici di causa ed effetto e fintanto che non riusciremo a misurarne il peso e il valore saremo "disarmati", teoricamente innanzitutto. Prendere confidenza, conoscere, valutare "una logica di altro genere"(p.14), e i fantasmi (dell’inconscio collettivo) che la incorniciano, è quindi il passo necessario per evitare quella forma di etnocentrismo culturale da cui riteniamo di esserci vaccinati ma che, in forma perversa, rischia di vanificare le nostre interpretazioni e, quindi, le strategie per combattere la propaganda del Califfato.
- Philippe-Joseph Salazar, Parole armate. Quello che l’Isis ci dice e che noi non capiamo, Bompiani, Milano 2016, pagg.199, euro 17.
 [1] Cfr. P.-J. Salazar “Parole armate” di Salazar: ecco la cultura del Califfato che sottovalutiamo in «Io Donna- Corriere della Sera», 22 Gennaio 2016, http://www.iodonna.it/attualita/in-primo-piano/2016/01/22/philippe-joseph-salazar-parole-armate-il-califfato-lo-si-combatte-con-la-cultura-e-le-minacce-a-roma-sono-serie/
[1] Cfr. P.-J. Salazar “Parole armate” di Salazar: ecco la cultura del Califfato che sottovalutiamo in «Io Donna- Corriere della Sera», 22 Gennaio 2016, http://www.iodonna.it/attualita/in-primo-piano/2016/01/22/philippe-joseph-salazar-parole-armate-il-califfato-lo-si-combatte-con-la-cultura-e-le-minacce-a-roma-sono-serie/
 [2] Cfr. P. Corrao, Storia della Mentalità in «Studi culturali», http://www.studiculturali.it/dizionario/lemmi/storia_delle_mentalita.html
[2] Cfr. P. Corrao, Storia della Mentalità in «Studi culturali», http://www.studiculturali.it/dizionario/lemmi/storia_delle_mentalita.html
 [3] Cfr. Voce «Annales» in Treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/annales/
[3] Cfr. Voce «Annales» in Treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/annales/
 [4] Cfr. E. Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia (1968), Quodlibet, Macerata 2004
[4] Cfr. E. Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia (1968), Quodlibet, Macerata 2004
 [5] Cfr. P.-J. Salazar “Parole armate” di Salazar: ecco la cultura del Califfato che sottovalutiamo...cit.
[5] Cfr. P.-J. Salazar “Parole armate” di Salazar: ecco la cultura del Califfato che sottovalutiamo...cit.- FONTE: BLOG - LO SPIRITO E L’OSSO. storia, immaginario, filosofia e psicoanalisi di Fabio Milazzo, 30 gennaio, 2016 (ripresa parziale - senza immagini).
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA. Storiografia in crisi d’identità:
- IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg.
- EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo). HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura (pdf, scaricabile)
PAROLA DI VICO. SULLA MODERNITÀ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti italiani: «Rompiamo il silenzio sull’Africa».28 luglio 2017, di Federico La Sala
Appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti: «Rompiamo il silenzio sull’Africa»
Rilanciamo l’appello che il missionario Comboniano, direttore della rivista Mosaico di Pace, rivolge alla stampa italiana. «Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli stanno vivendo», scrive.
di Alex Zanotelli*
Scusatemi se mi rivolgo a voi in questa torrida estate, ma è la crescente sofferenza dei più poveri ed emarginati che mi spinge a farlo. Per questo come missionario uso la penna (anch’io appartengo alla vostra categoria) per far sentire il loro grido, un grido che trova sempre meno spazio nei mass-media italiani. Trovo infatti la maggior parte dei nostri media, sia cartacei che televisivi, così provinciali, così superficiali, così ben integrati nel mercato globale.
So che i mass-media , purtroppo, sono nelle mani dei potenti gruppi economico-finanziari, per cui ognuno di voi ha ben poche possibilità di scrivere quello che vorrebbe. Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli stanno vivendo.
Mi appello a voi giornalisti/e perché abbiate il coraggio di rompere l’omertà del silenzio mediatico che grava soprattutto sull’Africa. (Sono poche purtroppo le eccezioni in questo campo!)
È inaccettabile per me il silenzio sulla drammatica situazione nel Sud Sudan (il più giovane stato dell’Africa) ingarbugliato in una paurosa guerra civile che ha già causato almeno trecentomila morti e milioni di persone in fuga.
È inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto da un regime dittatoriale in guerra contro il popolo sui monti del Kordofan, i Nuba, il popolo martire dell’Africa e contro le etnie del Darfur.
È inaccettabile il silenzio sulla Somalia in guerra civile da oltre trent’anni con milioni di rifugiati interni ed esterni.
È inaccettabile il silenzio sull’Eritrea, retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di giovani in fuga verso l’Europa.
È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica che continua ad essere dilaniato da una guerra civile che non sembra finire mai.
È inaccettabile il silenzio sulla grave situazione della zona saheliana dal Ciad al Mali dove i potenti gruppi jihadisti potrebbero costituirsi in un nuovo Califfato dell’Africa nera. È inaccettabile il silenzio sulla situazione caotica in Libia dov’è in atto uno scontro di tutti contro tutti, causato da quella nostra maledetta guerra contro Gheddafi.
È inaccettabile il silenzio su quanto avviene nel cuore dell’Africa , soprattutto in Congo, da dove arrivano i nostri minerali più preziosi.
È inaccettabile il silenzio su trenta milioni di persone a rischio fame in Etiopia, Somalia , Sud Sudan, nord del Kenya e attorno al Lago Ciad, la peggior crisi alimentare degli ultimi 50 anni secondo l’ONU.
È inaccettabile il silenzio sui cambiamenti climatici in Africa che rischia a fine secolo di avere tre quarti del suo territorio non abitabile.
È inaccettabile il silenzio sulla vendita italiana di armi pesanti e leggere a questi paesi che non fanno che incrementare guerre sempre più feroci da cui sono costretti a fuggire milioni di profughi. (Lo scorso anno l’Italia ha esportato armi per un valore di 14 miliardi di euro!).
Non conoscendo tutto questo è chiaro che il popolo italiano non può capire perché così tanta gente stia fuggendo dalle loro terre rischiando la propria vita per arrivare da noi.
Questo crea la paranoia dell’“invasione”, furbescamente alimentata anche da partiti xenofobi. Questo forza i governi europei a tentare di bloccare i migranti provenienti dal continente nero con l’Africa Compact , contratti fatti con i governi africani per bloccare i migranti.
Ma i disperati della storia nessuno li fermerà.
Questa non è una questione emergenziale, ma strutturale al sistema economico-finanziario. L’ONU si aspetta già entro il 2050 circa cinquanta milioni di profughi climatici solo dall’Africa. Ed ora i nostri politici gridano: «Aiutiamoli a casa loro», dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a farlo con una politica economica che va a beneficio delle nostre banche e delle nostre imprese, dall’ENI a Finmeccanica.
E così ci troviamo con un Mare Nostrum che è diventato Cimiterium Nostrum dove sono naufragati decine di migliaia di profughi e con loro sta naufragando anche l’Europa come patria dei diritti. Davanti a tutto questo non possiamo rimane in silenzio. (I nostri nipoti non diranno forse quello che noi oggi diciamo dei nazisti?).
Per questo vi prego di rompere questo silenzio-stampa sull’Africa, forzando i vostri media a parlarne. Per realizzare questo, non sarebbe possibile una lettera firmata da migliaia di voi da inviare alla Commissione di Sorveglianza della RAI e alla grandi testate nazionali? E se fosse proprio la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) a fare questo gesto? Non potrebbe essere questo un’Africa Compact giornalistico, molto più utile al Continente che non i vari Trattati firmati dai governi per bloccare i migranti? Non possiamo rimanere in silenzio davanti a un’altra Shoah che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Diamoci tutti/e da fare perché si rompa questo maledetto silenzio sull’Africa.
*Alex Zanotelli è missionario italiano della comunità dei Comboniani, profondo conoscitore dell’Africa e direttore della rivista Mosaico di Pace.
* FONTE: FNSI, 18.07.2017
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". - LA PUNTA DI UN ICEBERG: IL MITO DELLA ROMANITÀ E DELLA GRECITÀ.28 luglio 2017, di Federico La Sala
IL MITO DELLA ROMANITÀ E DELLA GRECITÀ: LA PUNTA DI UN ICEBERG. Molti filologi, storici, archeologi e filosofi italiani e tedeschi si prestarono a favorire questa operazione ...*
Nazisti antiquari, non filologi
di Roberto M. Danese (Alfabeta-2, 27 luglio 1917)
- Johann Chapoutot, Il nazismo e l’Antichità, traduzione di Valeria Zini, Einaudi 2017, 523 pp., € 34
Nel 2008 esce in Francia il volume di Johann Chapoutot Le national-socialisme et l’Antiquité per le edizioni PUF. Nel 2012 il libro viene ripubblicato in edizione rivista con il titolo Le nazisme et l’Antiquité. È quest’ultima versione che esce ora in Italia come Il nazismo e l’Antichità. La differenza nel titolo non è secondaria. Se vogliamo trovare infatti un limite in quest’opera, è il tono generale un po’ troppo apertamente irridente nei confronti dei nazisti, a partire dalla scelta di sostituire nel titolo l’originario national-socialisme con il più polemico nazisme usato negli anni Venti dagli oppositori di Hitler.
Chapoutot è un brillante storico del Terzo Reich, che ha voluto riservare specifica attenzione a un fenomeno già piuttosto noto e indagato, ma comunque bisognoso di una nuova analisi scientifica. La necessità di un libro come questo, molto ben documentato e altrettanto ben costruito, è data non solo dall’interesse per un aspetto importante della politica culturale nazista, ma anche dall’impatto che uno studio del genere può avere sul nostro tempo.
Chapoutot dimostra con grande abilità che il nazismo non si è limitato a mistificare la cultura greca e romana, ma ha fatto di questa mistificazione una base fondamentale per la giustificazione ideologica del proprio agire politico e uno strumento formidabile di indottrinamento per il popolo tedesco. Insomma, ben più di quanto fece il fascismo con il folclorico riutilizzo della romanità. Hitler (e in qualche modo Himmler) prima crearono, grazie alla connivenza di studiosi tedeschi proni al dettato ideologico del Reich, una base scientifica che sancisse in modo indiscutibile l’origine germanica delle grandi civiltà greca e romana, quindi utilizzarono questa - per loro - incontrovertibile verità per rivendicare a sé tutti i migliori frutti di quelle antiche culture, a cominciare dalle città e dalle opere d’arte.
Non fu purtroppo solo un gioco propagandistico, ma una delle giustificazioni principali per l’espansionismo tedesco e per il progressivo irrobustirsi della politica razziale: proclamandosi eredi e insieme padri delle civiltà di Pericle e Augusto (entrambi, per loro, di sangue nordico), si arrogarono il diritto di proclamare inferiori, corrotte e corruttrici tutte quelle razze e quelle culture che non rientravano in questa netta linea genealogica, arruolando come campioni della razziologia autori quali Tirteo oppure Orazio.
Sulla reviviscenza di quegli antichi valori modellarono poi il loro inquietante programma ideologico: superiorità della razza nordica, eliminazione delle razze degenerate di origine negroide-semitica, una institutio nazionale che unisse cura del corpo e della mente, fede nell’irrazionalismo e nello Stato sociale contro il razionalismo di matrice umanistica, opposizione fra l’uomo “totale” ariano e l’uomo “scisso” di ascendenza cristiana.
Il libro di Chapoutot è molto dettagliato e complesso, ma di lettura agevole e avvincente, soprattutto chiaro nel mettere a fuoco gli obiettivi che il nazismo perseguiva nell’utilizzo dell’antichità classica. Sarebbe interessante analizzare molti aspetti di questo saggio, ma ne sceglierò solo un paio per cercare di mostrarne l’utilità e l’attualità. Nel 1933 Hitler volle una grande riforma scolastica che contribuisse a formare sin dall’infanzia il vero uomo tedesco.
Molti filologi, storici, archeologi e filosofi tedeschi si prestarono a favorire questa operazione, che voleva inculcare nei ragazzi i grandi ideali “nordici” della Grecia e di Roma, senza però farli riflettere troppo sui testi. Chapoutot documenta molto bene il dibattito che si accese in merito fra politica, classicisti e insegnanti di scuola: bisognava esaltare l’affinità di sangue e di cultura con gli antichi, ma bisognava anche diminuire le ore di greco e di latino nelle scuole, privilegiando gli studi storico-ideologici a discapito di quelli linguistico-grammaticali.
Se guardiamo al dibattito oggi in atto in Italia e in Europa sugli studi classici, non possiamo non accorgerci che si stanno usando simili argomentazioni per limitare il ruolo e lo studio delle lingue antiche, in vista del perseguimento di una cultura del fare più che del pensare.
Scrive Chapoutot sul programma educativo nazista: “Il sapere è legittimo solo nella misura in cui è immediatamente utile alla comunità del popolo e allo Stato”. E poi: “Il sapere specializzato consacrato dal regime è un sapere tecnico, pratico, immediatamente disponibile e utilizzabile, che dunque esclude ogni meditazione e quella libertà disinteressata che è propria del pensiero”.
Leggete gli attacchi contemporanei verso il liceo classico e verso lo studio del greco e del latino sui nostri giornali e sul web, considerate la filosofia di accreditamento degli Atenei da parte delle Agenzie per la Valutazione dell’Università e della Ricerca, quindi provate a fare un confronto con la cultura del fare esaltata dal regime nazista e messa alla base di ogni suo progetto formativo. Alla fine anche Heidegger aveva capito che tutto ciò era pericoloso, molto pericoloso...
Veniamo poi al marcato antifilologismo di tanti intellettuali al servizio del Führer. Chapoutot ci racconta che Hitler volle un aumento di attenzione verso l’antichità classica ma un’attenuazione del suo studio dal punto di vista veramente scientifico.
È qualcosa di simile a quello che sta succedendo oggi, in un quadro di crescente attenzione per l’antichità classica: nelle università ci sono sempre più archeologi che non sanno una parola di greco o di latino, modernisti che non riusciranno mai a leggere Stazio o Virgilio in latino, latinisti e grecisti che considerano un fastidio fare edizioni critiche e lavorare su testi ecdoticamente fondati. Non parliamo di quello che succede nei licei.
Lo studio delle grammatiche e della prassi filologica per l’antichità classica insegna a non dar mai per scontato nulla di fronte a un testo, insegna a interrogarsi sempre su ciò che una sequenza di parole o di immagini vuol veramente dire, insegna a capire le retoriche.
Questo per i nazisti non solo era inutile, ma anche dannoso: la verità sul significato dei testi antichi su cui si fondava la loro ideologia la diceva il regime stesso, quindi perché fornire allo studente i mezzi per cercare di comprendere da solo quei testi, rischiando di fargli nascere nella testa idee “sbagliate”?
La filologia è invece un bene prezioso perché, come ci hanno mostrato i primi grandi umanisti, raffina l’arte del dubbio: e anche oggi non dobbiamo dimenticare quanto si debba stare in guardia nei confronti di chi subdolamente bolla come inutile al progresso e perditempo colui che indugia nel lento esercizio della perplessità e della riflessione.
Il libro di Chapoutot non è dunque solo interessante, ma anche assai utile e la sua lettura dovrebbe essere consigliata a molti, se è vero che historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriæ, magistra vitæ, nuntia vetustatis.
*
SUL TEMA, SI CFR.:
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
- UNA LEZIONE DI JOYCE (da "FINNEGANS WAKE")
- L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova"
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- BENEDETTO CROCE. La prosa clericale di un laico antico (di G. Pecorini).25 luglio 2017, di Federico La Sala
CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA... *
La prosa clericale di un laico antico
di Giorgio Pecorini (il manifesto, 25 agosto 2012)
La pagina conclusiva dei «Coni d’ombra» in cui Marco D’Eramo (il manifesto del 18 agosto) ha perpetrato quel «crimine di lesa crocianità» di cui molto si è doluto Massimo Raffaeli (21 agosto), inviata a farsi. Non m’avventuro certo in astrattezze filosofiche o esegesi storiche: conto soltanto sulle capacità osservatorie del mio mestiere di cronista. Incoraggiato e aiutato questa volta dalle osservazioni di Norberto Bobbio sul «giustificazionismo intrinseco» ricordate dallo stesso D’Eramo nella sua replica (sempre il 21). E torno, recidivo, al famoso Perché non possiamo non dirci cristiani pubblicato da Benedetto Croce su La Critica del 20 novembre 1942 e due anni dopo ristampato in fascicolo, sempre nel pieno delle seconda guerra mondiale.
In quel suo saggio il filosofo si dichiara impegnato a scrivere con libero spirito laico «né per gradire né per sgradire agli uomini delle chiese». Rivendica come «legittimo e necessario» l’uso di quel nome anche da parte di chi non appartiene ad alcuna chiesa. Vuole «unicamente affermare, con l’appello alla storia, che noi non possiamo non riconoscerci e non dirci cristiani e che questa denominazione è semplice osservanza della verità. (...) Il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta, così comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi, che non meraviglia che sia apparso e ancora possa apparire un miracolo, una rivelazione dall’alto, un diretto intervento di Dio nelle cose umane, che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo affatto nuovo».
Il trionfo del genocidio
Ma se davvero non possiamo non dirci cristiani, allora non possiamo neppure non tenerci corresponsabili di una serie di errori e crimini del cristianesimo. Misurandoli col proprio metro razionale laico, il filosofo liberale assolve la «chiesa cristiana cattolica per la corrutela che dentro di sé lasciò penetrare e spesso in modo assai grave allargare», dato che «ogni istituto reca in sé il pericolo della corrutela». E anzi la elogia per aver animato «alla difesa contro l’Islam, minaccioso alla civiltà europea». Le riconosce infine il merito, «continuando nell’opera sua», di aver riportato «i trionfi migliori nelle terre di recente scoperte del Nuovo mondo». Il fatto che quel «trionfo» sia consistito in un genocidio cristianissimo distruttore assieme alla vita della cultura e della dignità di un intero popolo è soltanto uno fra i tanti accidenti del generale processo storico con le sue crisi, e amen. Se poi gli abitatori originarii di quel Nuovo mondo non hanno gioito di quel «trionfo», non se ne sono almeno contentati se non addirittura rallegrati fra una tappa e l’altra di un genocidio cristianissimo che la loro cultura non s’è limitato a minacciarla: l’ha distrutta, assieme alla loro storia e alla loro stessa identità, dipende dalla loro mancante sensibilità eurocentrica e occidentalocentrica, che li autorizza, unici, a non dirsi cristiani. Il «famigerato giustificazionismo intrinseco» all’analisi crociana denunciato da Bobbio, appunto.
Perché non possiamo non dirci cristiani è uno smilzo opuscoletto di appena una ventina di pagine ma dense di analisi e di riferimenti a meditazioni e conclusioni precedenti dell’autore. Tanto dense che molti credenti anziché leggerle si contentano del titolo, per sbatterlo in faccia ai miscredenti: se persino un grande filosofo e critico liberale e ateo come Croce dice così.
Avessero la pazienza di leggerlo, ci andrebbero più cauti nel prenderlo e cercar di imporlo come assoluzione laica dei dogmatismi religiosi. Riconosciuta la «nuova qualità spirituale» di quella rivoluzione, cioè l’aver agito «nel centro dell’anima, nella coscienza morale» dell’uomo, Croce sùbito la ridimensiona: «non fu un miracolo che irruppe nel corso della storia e vi si inserì come forza trascendente e straniera (...) fu un processo storico, che sta nel generale processo storico come la più solenne delle sue crisi».
Il saggio di Croce è del 1942, conviene ripeterlo: nel pieno della seconda guerra mondiale. Mezzo secolo giusto dopo, 1992, chiusa anche la guerra fredda, nel cinquecentenario della presunta scoperta dell’America da parte dell’Europa e dell’inizio del genocidio delle popolazioni americane indigene da parte degli europei in nome della civiltà e del Vangelo, il Nobel per la pace viene assegnato a una donna guatemalteca di 33 anni, discendente dei rari scampati ai massacri: Rigoberta Menchù.
La scelta della giuria del premio sembra ad alcuni un contentino fra il paternalistico e il demagogico al risentimento degli amerindi e dei loro pochi sostenitori bianchi per l’enfasi e la retorica con cui l’Occidente andava celebrando l’impresa di Cristoforo Colombo. Alcuni altri si indignano: per gente di mondo smaliziata, ricca di esperienza e di efficienza pragmatica, è una scelta che suona resa e bestemmia: «Per compiacere la pseudocultura dell’ultimo anticolonialismo abbiamo messo la sordina a una delle più straordinarie vicende della storia europea. È assurdo che il papa, a Santo Domingo, si sia scusato pubblicamente come un qualsiasi uomo politico giapponese; ed è ridicolo che i discorsi commemorativi abbiano fatto ipocrite concessioni agli umori dominanti del terzomondismo pacifista. Ma che i giurati di Oslo abbiano scelto il cinquecentesimo anniversario di una grande epopea occidentale per dare l’insufficienza a Cristoforo Colombo ci pare francamente risibile». Firmato: Sergio Romano, ex ambasciatore della Repubblica italiana presso alcune fra le maggiori capitali del mondo, da molti anni oracolo dei migliori radio e telegiornali italiani pubblici e privati, abituale commentatore politico oggi del Corriere prima della Stampa. (La frase qui citata era sul quotidiano torinese del 17 dicembre ’92, in un articolo intitolato: «Se il Nobel boccia Colombo»).
Lo spirito dei tempi
Per compiacere l’eterno pragmatismo della chiesa postcostantiniana, l’Europa e l’Occidente dovrebbero insomma rivendicare gli sbudellamenti fatti in nome di Dio dalle crociate all’Iraq, i roghi delle streghe e degli eretici, le benedizioni ai regni e agli eserciti, le indulgenze, le scomuniche eccetera: tutto quanto a quelle radici è intrecciato.
Il papa assimilato con disgusto a «un qualsiasi uomo politico giapponese» era il polacco Wojtyla. Per schivare un eguale rischio, il suo successore tedesco, Ratzinger, ci chiede di non giudicare il passato col metro dell’oggi: bisogna tener conto dei diversi contesti, delle percezioni e sensibilità mutate. E come si faccia a farlo ce lo ha mostrato in concreto lui, con la visita e i discorsi ai campi di sterminio nazisti in Polonia.
S’arriva così sullo scivoloso terreno del «segno dei tempi» e alla vecchia storia delle condanne seguite dalle riabilitazioni. Vicende emblematiche di quelle tecniche riappropriatorie, di quelle smanie di normalizzazione che, accompagnate da sapienti manipolazioni censorie e da cauti sondaggi santificatorii, presiedono sempre all’interno di ogni chiesa, religiosa, culturale o politica, a ogni operazione riabilitatoria. Tecniche e smanie vecchie (si pensi soltanto a Galileo) ma che con aggiustamenti minimi continuano a funzionare. Con l’obiettivo di far credere che ad aver bisogno di perdono e riabilitazione sia il perseguitato, non il persecutore. Al quale va sempre riconosciuto lo stato di necessità o almeno l’attenuante del «segno dei tempi».
Segno talmente vago ed elastico da dover tener conto persino del «livello medio della cultura dominante da non contraddire, non urtare, non rovinare», pensa Ferdinando Camon, scrittore cattolico. Che pazientemente ci spiega: «la condanna di Galileo fu pronunciata dalla chiesa come intermediaria del senso comune». (editoriale sul supplemento Tuttolibri de La Stampa, 16 novembre 1995).
Ecco dove si finisce, a furia di non potersi non dichiarare cristiani. Al laico don Benedetto va bene così, convinto com’è che il «reale è razionale», sempre e comunque. Ma ecco anche perché un altro filosofo e matematico ateo, Piergiorgio Odifreddi, ha preso e rovesciato proprio la strausata sentenza di Croce per farne il titolo di un proprio libro contro tutte le radici dei possibili fondamentalismi religiosi: Perché non possiamo essere cristiani. E per scrupolo di maggior chiarezza ci ha aggiunto tra parentesi: (e meno che mai cattolici).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
TEORIA E STORIA DELLA STORIOGRAFIA. IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE
 CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.- VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova". Note per una rilettura (pdf, scaricabile)
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
CRISTIANESIMO E COSTITUZIONE (DELLA CHIESA E DELL’ITALIA). PERDERE LA COSCIENZA DELLA LINGUA ("LOGOS") COSTITUZIONALE ED EVANGELICA GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI ...
 I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?".
I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?".FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIU’ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIU’ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!! -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- COLONIALISMO. ITALIA: ISTITUIRE LA GIORNATA DELLA MEMORIA LIBIA, ETIOPIA, E SOMALIA. UNA PROPOSTA DELLO STORICO ANGELO DEL BOCA24 luglio 2017, di Federico La Sala
COLONIALISMO. ITALIA...
ISTITUIRE LA GIORNATA DELLA MEMORIA
per 500mila Africani uccisi dalla presenza coloniale italiana in
LIBIA, ETIOPIA, E SOMALIA.
UNA PROPOSTA DELLO STORICO ANGELO DEL BOCA
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- FILOSOFIA. Sulla tomba di KANT "Legge Morale" e "Cielo stellato" sulla tomba dell’EUROPA Napoleone-Hegel-Heidegger?!22 luglio 2017, di Federico La Sala
Sulla tomba di KANT
"Legge Morale"
e
"Cielo stellato"
sulla tomba dell’EUROPA
Napoleone-Hegel-Heidegger?!
KANT, FREUD, E LA BANALITA’ DEL MALE
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. --- La Chiesa non può rimanere prigioniera dell’Occidente (di Rocco Buttiglione).21 luglio 2017, di Federico La Sala
INDIETRO NON SI TORNA. Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto:
La Chiesa non può rimanere prigioniera dell’Occidente
Il filosofo Rocco Buttiglione risponde al collega Marcello Pera che aveva criticato duramente Francesco affermando che non comprende i problemi delle democrazie occidentali
- Jorge Mario Bergoglio viene creato cardinale da san Giovanni Paolo II nel giugno 2001
di Rocco Buttiglione *
Marcello Pera ha criticato violentemente Papa Francesco in un articolo sul Mattino di Napoli. Il Papa, dice Pera, non è un difensore dell’Occidente, non capisce i problemi delle democrazie occidentali e, sui temi della immigrazione, assume un punto di vista che noi occidentali non possiamo condividere. Egli ha una posizione profondamente diversa e perfino opposta rispetto a quelle di san Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Pera è acuto come sempre e molte delle cose che dice sono vere. Io penso tuttavia che non abbia capito il senso più profondo di questo pontificato e provo a spiegare perché.
Pera ha ragione in un punto: per questo Papa l’Europa non è più il centro del mondo. Non è giusto pensare che non gli importi dell’Europa o della difesa della sua anima cristiana. È vero però che non pensa che questo sia il suo compito primario. La difesa dei valori cristiani che stanno alla base dell’Europa è compito dei vescovi europei, dei laici e dei politici europei. Il Papa ovviamente li appoggia ma questo non sarà più per lui il compito prevalente.
Il Papa non è europeo ma latinoamericano. Non è soltanto un dato anagrafico. Abbiamo un Papa latinoamericano e non europeo perché la Chiesa Cattolica non è più prevalentemente europea. Viviamo la crisi della egemonia mondiale dell’Europa. Più esattamente viviamo la crisi della egemonia mondiale dell’Occidente. È una crisi demografica: la Chiesa conta sempre meno in Europa ma l’Europa conta sempre meno nel mondo. Cresce invece in Africa ed in tutto quello che una volta si chiamava Terzo Mondo. La maggioranza relativa dei cattolici vive oggi in America Latina e forse due terzi dei cattolici vive nel Terzo Mondo.
La crisi è anche culturale. Una volta era diffusa la convinzione che i paesi non occidentali fossero “arretrati” e avrebbero alla fine seguito le tendenze stabilite dai paesi occidentali. Oggi sembra piuttosto che stiano cercando nuove strade. Molti fenomeni che noi consideriamo di “progresso” potrebbero alla fine risultare piuttosto fenomeni del declino e della decadenza europea. È interessante osservare che anche economicamente Europa e Stati Uniti rappresentano oggi meno del 50% del PIL mondiale.
Sbaglia Papa Francesco a pensare di dovere assumere una ottica più universale e meno europea? Sbaglia ad assumere un punto di vista e un linguaggio che sono più da “Terzo mondo” che europei e che, peraltro, gli sono anche più congeniali? Forse non sbaglia. Chiese che eravamo abituati a considerare periferiche sono diventate (stanno diventando) centrali e noi siamo diventati un po’ periferici. Il processo è complicato, rischioso e pieno di pericoli. È però inevitabile. I problemi della Chiesa nascono dalla dinamica demografica mondiale (America Latina) e dalla grande crescita missionaria della Chiesa stessa (Africa ed Asia). Sarebbe ingeneroso pensare che essi derivino solo o primariamente da Papa Francesco. Derivano in realtà dalla forza delle cose o (meglio) dalla volontà imperscrutabile dello Spirito Santo.
Forse faremmo meglio a domandarci che tipo di conversione lo Spirito di Dio ci chiede in questa tappa della storia della Chiesa e della storia della umanità. Uno dei problemi di questa fase storica per noi occidentali è che dobbiamo fare i conti con una immagine di noi stessi che non ci piace. I poveri del mondo pensano che ci siamo appropriati di una parte troppo grande delle ricchezze del pianeta. Pensano di essere stati espropriati e derubati. Questo giudizio non è del tutto vero ma non è neppure del tutto falso. Con ammirevole equilibrio Papa Francesco ha avuto il coraggio di dire che il colonialismo ha avuto anche dei lati positivi. Non ha nascosto però di pensare che ha avuto i suoi lati negativi, ed è difficile dargli torto. Non si può nemmeno dire che su questo punto si contrapponga a san Giovanni Paolo II. Basta ricordare il discorso di san Giovanni Paolo II a Gorée, alla fortezza degli schiavi.
In questo passaggio di epoca molti importanti valori rischiano di andare perduti. Valori di razionalità sociale ed anche di comprensione scientifica della società. La comprensione dei valori della competizione e del mercato è un valore permanente. Se i paesi poveri oggi sono diventati meno poveri e molti di loro hanno iniziato un percorso virtuoso di crescita economica questo è dovuto al fatto che hanno saputo utilizzare in modo giusto la regola del mercato.
Non riusciremo però a difendere questa verità se non confesseremo che molte volte questa regola della competizione è stata utilizzata in modo falsato, le carte del gioco sono state truccate e i poveri ne hanno fatto le spese. Se si legge con animo sgombro da pregiudizi la grande enciclica Centesimus Annus di san Giovanni Paolo II si vede che essa riconosce pienamente i valori del mercato ma è lungi dall’essere apologetica del capitalismo. Alle economie di mercato, delle quali si riconoscono i meriti anche etici, si pongono però delle forti esigenze morali. Quanto stiamo onestamente dando soddisfazione a questi obblighi morali? È importante notare, d’altro canto, che Papa Francesco ha sottolineato molte volte la positività del modello della economia sociale di mercato.
Noi dobbiamo cercare di aiutare il transito nella nuova sintesi dei valori permanenti dell’Occidente ma per farlo dobbiamo essere capaci di spogliarli di aspetti contingenti che ne possono impedire la giusta universalizzazione. Siamo chiamati anche ad ascoltare e a comprendere, senza pretese di falsa superiorità, altre sensibilità ed altre culture.
Una accusa sollevata frequentemente contro Papa Francesco è quella di essere populista. Forse è vero ma siamo sicuri di sapere esattamente che cosa sia il populismo latino/americano, al di là delle usuali caricature? Il populismo è l’unica originale filosofia politica latino/americana. Essa fa leva sulle idee di giustizia e di diritto naturale che entra nella cultura latino/americana con Bartolomé de Las Casas e con la sua difesa degli Indios. Essa si mescola poi con elementi anarchici, anarco/sindacalisti ed anche fascisti. C’è dentro il meglio ed il peggio ma una autentica visione politica latino/americana verrà fuori da una depurazione e da una scissione interna del populismo.
Un grande amico di Papa Francesco (e mio), Alberto Methol Ferré, ha indicato i lineamenti ed i percorsi di questa possibile purificazione. Non è compito della Chiesa (latinoamericana) accompagnare e sostenere questa purificazione attraverso un confronto serrato con la dottrina sociale cristiana?
Pera vede nel cristianesimo un baluardo dell’Europa e della civiltà occidentale. Ha ragione e questo baluardo io voglio difendere insieme con lui. Quella sintesi europea del cristianesimo contiene valori permanenti e senza di essi l’Europa si dissolve. Il cristianesimo però non si esaurisce nella funzione di difesa della civiltà occidentale. Il cristianesimo può entrare all’interno di altri orizzonti culturali e produrre nuove sintesi. Quella occidentale non esaurisce le potenzialità del cristianesimo. Per questo non è giusto che la Chiesa si identifichi con l’Occidente.
L’Occidente è solo uno dei suoi figli. Come non smettere di esercitare il suo ruolo fondamentale nell’Occidente senza peraltro identificarsi con esso? È necessario che ciascuno si assuma con più decisione le proprie responsabilità. Nel caso della immigrazione è chiaro che il Papa la vede prevalentemente con l’ottica dei paesi poveri. I leader politici e culturali dell’Occidente devono invitare i loro popoli ad essere generosi ma devono anche dire sinceramente, anche al Papa, quali sono i limiti della generosità dei loro popoli, limiti che non possono essere superati senza scatenare una reazione di razzismo e xenofobia.
La Chiesa non può rimanere prigioniera dell’Occidente. Uscendo dal limite dell’Occidente essa può forse mediare quel conflitto delle civiltà di cui parla Huntington che è già cominciato e minaccia di estendersi sempre più nel futuro portando alla fine alla distruzione dell’umanità. La Chiesa è chiamata ad essere più veramente cattolica, cioè universale. Il Papa latinoamericano è una tappa di questo cammino.
* Filosofo, politico e accademico italiano, è stato Ministro per due volte, Parlamentare europeo, consigliere comunale a Torino e Vicepresidente della Camera dei Deputati
* LA STAMPA, 20/07/2017 (ripresa parziale - senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto.
 INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT. Un omaggio a WOJTYLA: UN CAMPIONE "OLIMPIONICO", GRANDISSIMO. W o ITALY !!!
INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT. Un omaggio a WOJTYLA: UN CAMPIONE "OLIMPIONICO", GRANDISSIMO. W o ITALY !!! -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- 14 LUGLIO 2017. JOHN DEWEY, KANT, L’ATTIVISMO ACCECANTE DEL "FAR WEST", E LA CATASTROFE DELL’EUROPA (COME DEGLI U.S.A.)15 luglio 2017, di Federico La SalaL’ATTIVISMO ACCECANTE DEL "FAR WEST" E IL "SAPERE AUDE" DELLA "CRITICA DELLA RAGION PURA": JOHN DEWEY SPARA A ZERO SU KANT, SCAMBIATO PER UN VECCHIO FILOSOFO "TOLEMAICO". Alcune sue pagine da "La ricerca della certezza" del 1929, con alcune note.
 L’ASSASSINIO DI KANT, I CATTIVI MAESTRI E LA CATASTROFE DELL’EUROPA (COME DEGLI U.S.A.). “Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
L’ASSASSINIO DI KANT, I CATTIVI MAESTRI E LA CATASTROFE DELL’EUROPA (COME DEGLI U.S.A.). “Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- "Il mio grido al G20 sui migranti". Colloquio con il Papa a Santa Marta (di Eugenio Scalfari)8 luglio 2017, di Federico La Sala
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA.
Scalfari intervista Francesco: "Il mio grido al G20 sui migranti"
Colloquio con il Papa a Santa Marta: "Temo il pericolo di alleanze pericolose tra Potenze. Noi, lei lo sa bene, abbiamo come problema principale e purtroppo crescente nel mondo d’oggi, quello dei poveri, dei deboli, degli esclusi"
di EUGENIO SCALFARI (la Repubblica, 08 luglio 2017)
GIOVEDÌ scorso, cioè l’altro ieri, ho ricevuto una telefonata da Papa Francesco. Era circa mezzogiorno e io ero al giornale, quando è squillato il mio telefono e una voce mi ha salutato: era di sua Santità. L’ho riconosciuta subito e ho risposto: Papa Francesco, mi fa felice sentirla. "Volevo notizie sulla sua salute. Sta bene? Si sente bene? Mi hanno detto che qualche settimana fa lei non ha scritto il suo articolo domenicale, ma poi vedo che ha ripreso".
Santità, ho tredici anni più di lei. "Sì, questo lo so. Deve bere due litri d’acqua al giorno e mangiare cibo salato". Sì lo faccio. Sono seguiti altri suoi consigli ma io l’ho interrotto dicendo: è un po’ che non ci parliamo, vorrei venire a salutarla, vado in vacanza tra pochi giorni ed è parecchio che non ci vediamo. "Ha ragione, lo desidero anche io. Potrebbe venire oggi? Alle quattro?". Ci sarò senz’altro.
Mi sono precipitato a casa e alle tre e tre quarti ero nel piccolo salotto di Santa Marta. Il Papa è arrivato un minuto dopo. Ci siamo abbracciati e poi, seduti uno di fronte all’altro, abbiamo cominciato a scambiare idee, sentimenti, analisi di quanto avviene nella Chiesa e poi, nel mondo.
Il Papa viaggia incessantemente: a Roma, in Italia, nel mondo. Il tema principale della nostra conversazione è il Dio unico, il Creatore unico del nostro pianeta e dell’intero Universo. Questa è la tesi di fondo del suo pontificato, che comporta una serie infinita di conseguenze, le principali delle quali sono l’affratel-lamento di tutte le religioni e di quelle cristiane in particolare, l’amore verso i poveri, i deboli, gli esclusi, gli ammalati, la pace e la giustizia.
Il Papa naturalmente sa che io sono non credente, ma sa anche che apprezzo moltissimo la predicazione di Gesù di Nazareth che considero un uomo e non un Dio. Proprio su questo punto è nata la nostra amicizia. Il Papa del resto sa che Gesù si è incarnato realmente, è diventato un uomo fino a quando fu crocifisso. La " Resurrectio" è infatti la prova che un Dio diventato uomo solo dopo la sua morte ridiventa Dio.
Queste cose ce le siamo dette molte volte ed è il motivo che ha reso così perfetta e insolita l’amicizia tra il Capo della Chiesa e un non credente.
Papa Francesco mi ha detto di essere molto preoccupato per il vertice del "G20". "Temo che ci siano alleanze assai pericolose tra potenze che hanno una visione distorta del mondo: America e Russia, Cina e Corea del Nord, Putin e Assad nella guerra di Siria".
Qual è il pericolo di queste alleanze, Santità?
"Il pericolo riguarda l’immigrazione. Noi, lei lo sa bene, abbiamo come problema principale e purtroppo crescente nel mondo d’oggi, quello dei poveri, dei deboli, degli esclusi, dei quali gli emigranti fanno parte. D’altra parte ci sono Paesi dove la maggioranza dei poveri non proviene dalle correnti migratorie ma dalle calamità sociali; altri invece hanno pochi poveri locali ma temono l’invasione dei migranti. Ecco perché il G20 mi preoccupa: colpisce soprattutto gli immigrati di Paesi di mezzo mondo e li colpisce ancora di più col passare del tempo".
Lei pensa, Santità, che nella società globale come quella in cui viviamo la mobilità dei popoli sia in aumento, poveri o non poveri che siano?
"Non si faccia illusioni: i popoli poveri hanno come attrattiva i continenti e i Paesi di antica ricchezza. Soprattutto l’Europa. Il colonialismo partì dall’Europa. Ci furono aspetti positivi nel colonialismo, ma anche negativi. Comunque l’Europa diventò più ricca, la più ricca del mondo intero. Questo sarà dunque l’obiettivo principale dei popoli migratori".
Anch’io ho pensato più volte a questo problema e sono arrivato alla conclusione che, non soltanto ma anche per questa ragione, l’Europa deve assumere al più presto una struttura federale. Le leggi e i comportamenti politici che ne derivano sono decisi dal governo federale e dal Parlamento federale, non dai singoli Paesi confederati. Lei del resto questo tema l’ha più volte sollevato, perfino quando ha parlato al Parlamento europeo.
"È vero, l’ho più volte sollevato". E ha ricevuto molti applausi e addirittura ovazioni. "Sì, è così, ma purtroppo significa ben poco. I Paesi si muoveranno se si renderanno conto di una verità: o l’Europa diventa una comunità federale o non conterà più nulla nel mondo. Ma ora voglio farle una domanda: quali sono pregi e difetti dei giornalisti?".
Lei, Santità, dovrebbe saperlo meglio di me perché è un assiduo oggetto dei loro articoli.
"Sì, ma mi interessa saperlo da lei".
Ebbene, lasciamo da parte i pregi, ma ci sono anche quelli e talvolta molto rilevanti. I difetti: raccontare un fatto non sapendo fino a quale punto sia vero oppure no; calunniare; interpretare la verità facendo valere le proprie idee. E addirittura fare proprie le idee di una persona più saggia e più esperta attribuendole a se stesso. "Quest’ultima cosa non l’avevo mai notata. Che il giornalista abbia le proprie idee e le applichi alla realtà non è un difetto, ma che si attribuisca idee altrui per ottenere maggior prestigio, questo è certamente un difetto grave".
Santità, se me lo consente ora vorrei io porle due domande. Le ho già prospettate un paio di volte nei miei recenti articoli, ma non so come Lei la pensa in proposito. "Ho capito, lei parla di Spinoza e di Pascal. Vuole riproporre questi suoi due temi?".
Grazie, comincio dall’Etica di Spinoza. Lei sa che di nascita era ebreo, ma non praticava quella religione. Arrivò nei Paesi Bassi provenendo dalla sinagoga di Lisbona. Ma in pochi mesi, avendo pubblicato alcuni saggi, la sinagoga di Amsterdam emise un durissimo editto nei suoi confronti. La Chiesa cattolica per qualche mese cercò di attirarlo nella sua fede. Lui non rispondeva e aveva disposto che i suoi libri fossero pubblicati soltanto dopo la sua morte. Nel frattempo però alcuni suoi amici ricevevano copie dei libri che andava scrivendo. L’Etica in particolare, arrivò a conoscenza della Chiesa la quale immediatamente lo scomunicò. Il motivo è noto: Spinoza sosteneva che Dio è in tutte le creature viventi: vegetali, animali, umani. Una scintilla di divino è dovunque. Dunque Dio è immanente, non trascendente. Per questo fu scomunicato.
"E a lei non sembra giusto. Perché? Il nostro Dio unico è trascendente. Anche noi diciamo che una scintilla divina è dovunque, ma resta immune la trascendenza, ecco il perché della scomunica che gli fu impartita". E a me sembra, se ben ricordo anch’io, su sollecitazione dell’Ordine dei Gesuiti. "All’epoca di cui parliamo i Gesuiti erano stati espulsi dalla Chiesa, poi furono riammessi. Comunque, lei non mi ha detto perché quella scomunica dovrebbe essere revocata".
La ragione è questa: Lei mi ha detto in un nostro precedente colloquio che tra qualche millennio la nostra specie si estinguerà. In quel caso le anime che ora godono della beatitudine di contemplare Dio ma restano distinte da Lui, si fonderanno con Lui. A questo punto la distanza tra trascendente e immanente non esisterà più. E quindi, prevedendo questo evento, la scomunica si può già da ora dichiarare esaurita. Non le sembra, Santità?
"Diciamo che c’è una logica in ciò che lei propone, ma la motivazione poggia su una mia ipotesi che non ha alcuna certezza e che la nostra teologia non prevede affatto. La scomparsa della nostra specie è una pura ipotesi e quindi non può motivare una scomunica emessa per censurare l’immanenza e confermare la trascendenza".
Se Lei lo facesse, Santità, avrebbe contro di sé la maggioranza della Chiesa?
"Credo di sì, ma se solo di questo si trattasse ed io fossi certo di ciò che dico su questo tema, non avrei dubbi, invece non sono affatto certo e quindi non affronterò una battaglia dubitabile nelle motivazioni e persa in partenza. Adesso, se vuole, parliamo della seconda questione che lei desidera pormi".
Porta il nome di Pascal. Dopo una gioventù alquanto libertina, Pascal fu come improvvisamente invaso dalla fede religiosa. Era già molto colto, aveva letto ripetutamente Montaigne e anche Spinoza, Giansenio, le memorie del cardinale Carlo Borromeo. Insomma, una cultura laica e anche religiosa. La fede a un certo punto lo colpì in pieno. Aderì alla Comunità di Port-Royal des Champs, ma poi se ne distaccò. Scrisse alcune opere tra le quali i "Pensieri", un libro a mio avviso splendido e religiosamente di grande interesse. Ma poi c’è la sua morte. Era praticamente moribondo e la sorella l’aveva fatto portare nella propria casa per poterlo assistere. Lui voleva morire nell’ospedale dei poveri, ma il suo medico negò il permesso, gli restavano pochi giorni di vita e il trasporto non era fattibile. Chiese allora che un povero tratto da un ospedale che gestiva i poveri pessimamente, anche in fin di vita, fosse trasportato nella casa dove stava e con un letto come quello che aveva lui. La sorella cercò di accontentarlo ma la morte arrivò prima. Personalmente penso che uno come Pascal andrebbe beatificato.
"Lei, caro amico, ha in questo caso perfettamente ragione: anch’io penso che meriti la beatificazione. Mi riserbo di far istruire la pratica necessaria e chiedere il parere dei componenti degli organi vaticani preposti a tali questioni, insieme ad un mio personale e positivo convincimento".
Santità ha mai pensato di mettere per iscritto un’immagine della Chiesa sinodale? "No perché dovrei?". Perché ne verrebbe un risultato abbastanza sconvolgente, vuole che glielo dica? "Ma certo mi fa piacere anzi lo disegni".
Il Papa fa portare carta e penna e io disegno. Faccio una riga orizzontale e dico questi sono tutti i vescovi che Lei raccoglie al Sinodo, hanno tutti un titolo eguale e una funzione eguale che è quella di curare le anime affidate alla loro Diocesi. Traccio questa linea orizzontale poi dico: ma Lei, Santità, è vescovo di Roma e come tale ha la primazia nel Sinodo perché spetta a Lei trarne le conclusioni e delineare la linea generale del vescovato. Quindi il vescovo di Roma sta sopra la linea orizzontale, c’è una linea verticale che sale fino al suo nome e alla sua carica. D’altra parte i presuli che stanno sulla linea orizzontale amministrano, educano, aiutano il popolo dei fedeli e quindi c’è una linea che dall’orizzontale scende fino a quello che rappresenta il popolo. Vede la grafica? Rappresenta una Croce.
"È bellissima questa idea, a me non era mai venuto di fare un disegno della Chiesa sinodale, lei l’ha fatto, mi piace moltissimo".
Si è fatto tardi. Francesco ha portato con sé due libri che raccontano la sua storia in Argentina fino al Conclave e contengono anche i suoi scritti che sono moltissimi, un volume di centinaia di pagine. Ci abbracciamo nuovamente. I libri pesano e li vuole portare lui. Arriviamo con l’ascensore al portone di Santa Marta, presidiato dalle guardie svizzere e dai suoi più stretti collaboratori.
La mia automobile è davanti al portico. Il mio autista scende per salutare il Papa (si stringono la mano) e cerca d’aiutarmi a entrare in automobile. Il Papa lo invita a rimettersi alla guida e ad accendere il motore. "L’aiuto io" dice Francesco. E accade una cosa che secondo me non è mai accaduta: il Papa mi sostiene e mi aiuta a entrare in macchina tenendo lo sportello aperto. Quando sono dentro mi domanda se mi sono messo comodo. Rispondo di sì, lui chiude la portiera e fa un passo indietro aspettando che la macchina parta, salutandomi fino all’ultimo agitando il braccio e la mano mentre io - lo confesso - ho il viso bagnato di lacrime di commozione.
Ho scritto spesso che Francesco è un rivoluzionario. Pensa di beatificare Pascal, pensa ai poveri e agli immigrati, auspica un’Europa federata e - ultimo ma non ultimo - mi mette in macchina con le sue braccia.
Un Papa come questo non l’abbiamo mai avuto.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Beatificazione di Blaise Pascal? Un genio dei numeri. Ma adatto agli altari? (di Piergiorgio Odifreddi)13 luglio 2017, di Federico La Sala
Un genio dei numeri. Ma adatto agli altari?
di Piergiorgio Odifreddi (la Repubblica, 13.07.2017)
- Blaise Pascal può aspirare alla beatificazione? La questione è nata dal confronto tra Eugenio Scalfari e papa Francesco pubblicato su Repubblica di sabato scorso.
Scalfari si è rivolto a un papa che sembra poco interessato alle questioni dottrinali e ai pronunciamenti ex cathedra, e che per le sue dichiarazioni estemporanee è stato appunto spesso accusato o elogiato, a seconda dei gusti, di «essere protestante».
Anzitutto, parlando di Pascal bisogna ricordare di avere a che fare con un genio, che all’età di soli sedici anni rivoluzionò la geometria dimostrando un teorema su una strana configurazione che egli stesso chiamò “esagramma mistico”, rivelando fin da subito una singolare propensione a mescolare fra loro il diavolo della matematica con l’acqua santa della spiritualità.
Un’attitudine che trovò in seguito la sua migliore espressione nella famosa “scommessa”: l’idea, cioè, che conviene credere, perché si rischia di meno che a non credere. Se infatti Dio non esiste, si spreca una vita terrena di durata finita, ma se Dio esiste, si guadagna una beatitudine eterna.
Ma bisogna anche considerare che Pascal è ricordato in Francia come un padre della prosa, per quel capolavoro che sono le Lettere provinciali: un testo che metteva alla berlina i gesuiti, criticandoli raffinatamente su due fronti. Da un lato, emergeva il loro pensiero contraddittorio e compromissorio a proposito del pentimento, la confessione, l’assoluzione, la penitenza e la comunione. E, dall’altro lato, veniva avanti il loro esplicito tentativo di blandire gli intellettuali di riferimento dell’epoca per arruolarli dalla loro parte.
Riletto oggi, quel pamphlet di Pascal appare applicarsi quasi alla lettera alle posizioni del gesuita Bergoglio sulla comunione ai divorziati, da un lato, e al suo rapporto con i media, dall’altro, e difficilmente passerebbe il vaglio degli “organi vaticani preposti”. Infatti, saggiamente, Scalfari fa riferimento nella sua proposta non alle meno note Lettere provinciali, ma ai più famosi Pensieri di Pascal, che definisce «un libro splendido e religiosamente di grande interesse».
La cosa è sorprendente, da un punto di vista letterario e intellettuale. I Pensieri non sono infatti un’opera autografa di Pascal, ma una raccolta postuma che stupì e imbarazzò persino i suoi più intimi amici e i suoi più appassionati difensori. Il discepolo Pierre Nicole li definì «un’accozzaglia di materiali indistinti, di cui non sono riuscito a intuire l’uso che volesse farne l’autore». E lo storico ufficiale del giansenismo Sainte-Beuve si domandò: «Non è che semplicemente ci troviamo di fronte a un malato, un visionario, un allucinato? Pascal, insomma, non ha, nei suoi ultimi anni di vita, smarrito la ragione?».
I Pensieri contengono alcuni noti aforismi sparsi, ma presentano nell’insieme una visione dell’uomo come un mostro incomprensibile a sé stesso, tormentato dalla propria incomprensibilità, che cerca inutilmente di comprendersi mediante le filosofie e le religioni non cristiane, e trova conforto solo nell’interpretazione letterale e superficiale della Bibbia: una visione integralista che, come notò già Voltaire, scandalizza i moderni.
Il Pascal delle Lettere provinciali e dei Pensieri è l’antitesi di Bergoglio. I matematici continueranno a mantenerlo sui piedistalli della matematica e a ricordare i suoi geniali risultati di geometria, calcolo infinitesimale e teoria della probabilità. Ma dubito che un papa gesuita e la sua Chiesa gli permetteranno mai di salire sui loro altari, e di venir additato ufficialmente come un esempio di ortodossia e di santità.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Dove sparendo la foresta e l’aria verde, chi resta sospira nel sempre più vasto paese guasto (Giorgio Caproni)21 giugno 2017, di Federico La Sala
Versicoli quasi ecologici
di Giorgio Caproni *
 Non uccidete il mare
Non uccidete il mare
 la libellula, il vento.
la libellula, il vento.
 Non soffocate il lamento
Non soffocate il lamento
 (il canto!) del lamantino.
(il canto!) del lamantino.
 Il galagone, il pino:
Il galagone, il pino:
 anche di questo è fatto
anche di questo è fatto
 l’uomo. E chi per profitto vile
l’uomo. E chi per profitto vile
 fulmina un pesce, un fiume,
fulmina un pesce, un fiume,
 non fatelo cavaliere
non fatelo cavaliere
 del lavoro. L’amore
del lavoro. L’amore
 finisce dove finisce l’erba
finisce dove finisce l’erba
 e l’acqua muore. Dove
e l’acqua muore. Dove
 sparendo la foresta
sparendo la foresta
 e l’aria verde, chi resta
e l’aria verde, chi resta
 sospira nel sempre più vasto
sospira nel sempre più vasto
 paese guasto: «Come
paese guasto: «Come
 potrebbe tornare a esser bella,
potrebbe tornare a esser bella,
 scomparso l’uomo, la terra».
scomparso l’uomo, la terra».*
See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/maturita-tema-italiano-poesia-analisi-del-testo-versicoli-quasi-ecologici-significato-giorgio-caproni-d9fb210c-72ef-49c0-a80d-eebf554c09b3.html
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Il mondo delle sembianze e della storia, egualmente porteremo con noi in fondo all’acqua, incerta e lucida, il cui velo nero nessun idrometra più -pattinerà (Giorgio Caproni)21 giugno 2017, di Federico La Sala
L’idrometra
di Giorgio Caproni *
 Di noi, testimoni del mondo,
Di noi, testimoni del mondo,
 tutte andranno perdute
tutte andranno perdute
 le nostre testimonianze.
le nostre testimonianze.
 Le vere come le false.
Le vere come le false.
 La realtà come l’arte.
La realtà come l’arte.
 Il mondo delle sembianze
Il mondo delle sembianze
 e della storia, egualmente
e della storia, egualmente
 porteremo con noi
porteremo con noi
 in fondo all’acqua, incerta
in fondo all’acqua, incerta
 e lucida, il cui velo nero
e lucida, il cui velo nero
 nessun idrometra più
nessun idrometra più
 pattinerà - nessuna
pattinerà - nessuna
 libellula sorvolerà
libellula sorvolerà
 nel deserto, intero.
nel deserto, intero.* Giorgio CAPRONI, L’opera in versi, edizione critica a cura di L. Zuliani, introduzione di P.V. Mengaldo, cronologia e bibliografia a cura di A. Dei, Milano, Mondadori (I Meridiani), 1998.
-
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- "Sulla democrazia in America chiedi a Tocqueville". Intervista a Romeo Castellucci (di U. Sebastiano).12 giugno 2017, di Federico La Sala
UNA “CATTOLICA”, “UNIVERSALE”, ALLEANZA “EDIPICA” E LA DEMOCRAZIA (DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI)!!! L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE (L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO) REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO ...
- La democrazia ateniese e quella americana spartiscono poco oltre al nome. Le differenzia, per quel che qui interessa, il fatto di essere una germogliata nella stessa polis che diede origine alla tragedia e al teatro occidentale tutto, l’altra di essersi sviluppata nel ventre del Puritanesimo. La prima dopo la morte del dio Pan, la seconda in dialogo col Dio della Bibbia (Annalisa Sacchi, “Romeo Castellucci, il ventre puritano della democrazia”, Alfabeta2, 12.06.2017).
Intervista
"Sulla democrazia in America chiedi a Tocqueville"
Il regista Romeo Castellucci parla del suo nuovo spettacolo, in tournée da fine aprile liberamente ispirato al libro del saggista francese
di Umberto Sebastiano (l’Espresso, 17 marzo 2017)
Il nuovo spettacolo di Romeo Castellucci, regista fra i più acclamati e visionari della scena teatrale internazionale, si intitola “La democrazia in America” ed è liberamente ispirato al libro di Alexis de Tocqueville, pubblicato in Francia nel 1835 e concepito a partire dall’esperienza del lungo viaggio che il giovane aristocratico francese fece in America nel 1831. Lo stile letterario, lo straordinario acume di Tocqueville nel cogliere luci e ombre della giovane democrazia, la lungimiranza nel prevederne i più nefasti sviluppi, hanno fatto sì che “La democrazia in America” diventasse un classico della riflessione politica moderna e contemporanea.
Da parte sua, Romeo Castellucci, quando si appassiona a un testo, non si limita a illustrarlo, ma lo usa piuttosto come un terreno fertile per seminare immagini, idee, per costruire percorsi alternativi, ramificazioni. Dopo il debutto ad Anversa, lo spettacolo andrà in scena anche in Italia: al Fabbricone - Teatro Metastasio di Prato dal 27 al 30 aprile, poi l’11 e il 12 maggio all’Arena del Sole di Bologna e il 16 maggio al Teatro Sociale di Trento.
Perché ha sentito la necessità di lavorare a uno spettacolo dal titolo “La democrazia in America”? E più in generale, cosa trasforma una suggestione, una lettura in uno spettacolo teatrale?
«Lo dico subito: comprendo che si possa pensare che questo spettacolo nasca come reazione a ciò che sta avvenendo negli Stati Uniti, ma non è così, non c’è il minimo accenno alla cronaca, neanche la minima allusione. È un lavoro sul linguaggio, sull’antico testamento, sulla fede, ma anche sulla perdita dell’innocenza, sul crollo di certi valori che sono ritenuti inossidabili e invece non lo sono. Ho scelto questo titolo per il potere evocativo che scatena, che non è moderno, bensì antico. Per il resto non esistono “ragioni” per voler fare uno spettacolo. Lo si fa e basta; lo si fa perché si cade in un titolo come in un buco per la strada. Poi sono le idee a condurre il gioco».
E allora: che strada stava percorrendo quando è “caduto” ne “La democrazia in America”?
«Quella della grande letteratura americana. Sono interessato a tutto ciò che la letteratura americana ha prodotto, i grandi scrittori del passato come i più recenti, fino ad arrivare a David Foster Wallace che per me è una sorta di Dostoevskij. Sono naturalmente attratto dalla durezza veterotestamentaria della letteratura americana: non c’è amore, c’è la legge, c’è la famiglia, c’è il sangue, ci sono le razze, la terra, il cammino, le strade, e questo universo mi piace molto. Non c’è il perdono, non c’è Gesù, c’è Mosè: l’antico testamento è ancora il pilastro di questa cultura che ha prodotto in letteratura dei capolavori assoluti. È così che mi sono imbattuto nel saggio di Alexis de Tocqueville, un libro bellissimo, che conoscevo solo di fama e che parla proprio delle radici della democrazia americana, del fondamento puritano nella concezione della legge, del destino, della terra. I puritani, che a partire dal 1620 sbarcarono sulle coste del nord America, erano famosi per il loro rigore morale e l’assoluto rispetto della legge, rigidissimo. Venivano chiamati pellegrini, erano cristiani, ma cristiani che mal sopportavano Gesù: per loro i comandamenti andavano presi alla lettera. La forza muscolare dell’individualismo americano nasce da questa radice. Ed è proprio questo aspetto che è diventato il nucleo dello spettacolo».
È quella che Tocqueville definisce la “puritan foundation” della democrazia americana. In che modo prende forma sulla scena?
«La storia è quella di due contadini puritani, un uomo e una donna. La terra è la loro missione. Non una conquista fatta con le armi, ma con il lavoro più semplice. Essi vogliono contribuire a trasformare l’America nella nuova Terra Promessa. Si affidano a Dio, ma la vita durissima li metterà alla prova. La donna entra in una crisi profonda e la sua preghiera si trasforma in una sorta di blasfemia. Questa donna, come unica fonte di consolazione, comincia a bestemmiare, ma lo fa come se fosse una preghiera, e tutto questo è come bruciare sul nascere la radice puritana. Il sogno americano, il sogno che come specie umana abbiamo nei confronti della terra, del destino, della comunità, dello stare insieme, si infrange immediatamente in un fallimento».
A chi rivolge le sue preghiere la donna? Da cosa scaturisce la sua crisi?
«È una preghiera sincera verso il vuoto, o forse dovremmo dire il Vuoto, con l’iniziale maiuscola. Come in un’epifania, il vuoto di colpo si rivela alla donna. Gli spazi immensi americani qui si mostrano, per questa gente, per quello che sono: il grande vuoto. Ciò che mette in crisi la donna è probabilmente quello che l’uomo non riesce a vedere: il fatto che si sono sbagliati e che quella non è la Terra Promessa che avevano sognato. La terra è dura, sterile, e la comunità umana che li circonda è ancora più arida. Ci sono pagine molto precise di Tocqueville su questo, quando parla della morte per carestia delle prime ondate di coloni puritani. Dio non li ascolta perché ha scelto altri. L’uomo cerca di arginare le faglie che la donna spalanca sotto i loro piedi, ma non è abbastanza forte, e la donna a un certo punto sembra dotata di una forza soprannaturale. Una donna con grandi poteri».
Si tratta di una sciamana, di una strega?
«Nel New England, nel Seicento, la caccia alle streghe era un’ossessione collettiva, basta pensare alla vicenda delle streghe di Salem, e fungeva da strumento di controllo sociale, soprattutto nei confronti delle donne. Nel contesto dello spettacolo il richiamo alla stregoneria serve però a gettare un’ombra sui fondamenti delle comunità bianche. Un cuore oscuro dentro corpi bianchissimi».
Ha accennato alla caccia alle streghe e alla capacità di una donna di riconoscere e di affrontare il vuoto. Nel cast ci sono solo attrici. È un caso?
«Niente è un caso nella misura in cui tutto è casuale. Comunque non c’è una vera ragione, vorrei che nessuno lo notasse, mi piacerebbe questo. C’è una mia predilezione a formare delle compagnie “monosessuali”, perché in questo modo si produce un’energia che funziona molto bene. Al di là di questo, mi hanno colpito le pagine che Tocqueville ha dedicato alle donne. Ripete più volte che senza le donne l’America non sarebbe stata l’America, intuisce il ruolo nuovissimo che le donne hanno nella società e preconizza un loro ruolo più attivo. D’altra parte, in quel periodo, c’erano donne che fondavano religioni. Anche questo fenomeno è interessante: in America fioccavano nuove religioni perché tutto era ancora possibile. “La Democrazia in America” è considerata una delle opere fondamentali della riflessione politica contemporanea».
Cosa c’è di politico in questo spettacolo?
«Lo spettacolo non vuole essere politico ma polemico nei confronti della politica. Si potrebbe obiettare che uno spettacolo teatrale è di per sé politico, anche solo per il fatto di andare in scena in un luogo pubblico. A un certo livello sì, è politico. Sulla scena però succede qualcosa: nel luogo dell’invenzione della nuova democrazia, alcune persone prendono distanza dalla promessa della politica. Non ci credono più. Non credono più all’edificio americano. Si volgono altrove, verso un luogo mitologico dove la politica non ha ancora ragione di essere perché deve ancora venire. Tecnicamente, la politica nasce quando gli dei muoiono. Quando il grande dio Pan muore, nasce la politica; quando la festa finisce, nasce la politica. La politica e tutti i diritti che ne conseguono hanno origine nel momento in cui si smette di danzare. In quello stesso istante nasce il teatro greco. E la polemica nei confronti della politica è anche un modo di riconsiderare la funzione del teatro. I modelli politici sono usurati e il teatro dà accesso a una nuova forma di pensiero che è impensato. Il teatro rappresenta il doppio della vita, non fornisce modelli, non c’è nessuna pedagogia, se dio vuole, nessuna pedagogia. Il teatro offre dei lampi, dei bagliori in un abisso, mostra delle possibilità. Grazie alla narrazione, alla finzione, il teatro è in grado di sospendere la realtà, e questa è una forma di autentica liberazione, di riconciliazione con il tuo corpo, con il corpo degli altri, con il fatto di stare insieme».
C’è passione in queste parole, mi sembra che lei riconosca al teatro una grande forza.
«Il teatro ha questa forza perché è il punto di origine, è continuamente il punto di origine: non della tradizione, non si parla di quello, ma è proprio il punto originante. Il grande laboratorio della tragedia greca si faceva carico della disfunzione dell’essere. La tragedia greca non è altro che la teoria dell’uomo, e su quel terreno crescono la civiltà occidentale, l’estetica, la filosofia: germogli che sbocciano su un fondamentale pessimismo antropologico. Tutto questo in America non avviene perché il fondamento puritano è una sbarra, una retta senza alcuna articolazione che recide il legame con la negatività. E per questo motivo la democrazia americana è un fiore nel deserto, un fiore tossico, come ha dimostrato Tocqueville, permeato da un elemento ombroso, un cuore di tenebra».
Dopo il debutto di Anversa e le date italiane, “La Democrazia in America” andrà in scena in molte città europee: Losanna, Berlino, Bilbao, Vienna, Amsterdam, Atene, Parigi. Poi sarà la volta delle tournée in Asia e negli Stati Uniti. Pensa che il grande interesse che questo spettacolo ha suscitato dipenda anche dal bisogno sempre più diffuso di riflettere sulla crisi della democrazia?
«Può essere, certo. Nonostante i produttori siano gli stessi con i quali lavoro da tempo, ho effettivamente notato che rispetto a questo titolo c’è un interesse diverso e più forte. Ne sono rimasto sorpreso e, per così dire, questa consapevolezza mi inquieta perché, come dicevo all’inizio, non voglio creare aspettative tendenziose. Non è uno spettacolo su Trump».
Come avrà notato, non l’ho mai nominato.
«Ha fatto bene, sarebbe meglio non nominarlo. Anche se lui è già presente, completamente, in quello che scrive Tocqueville: basta pensare alle pagine dedicate al pericolo di una tirannia della maggioranza, quando parla della manipolazione delle coscienze, della propaganda, del fatto che i ricchi possono avere accesso a una parola con maggiore peso. Sono tutte cose già scritte nel 1831, negli appunti di viaggio di questo ventiseienne francese. Si spiega perfettamente quello che sta succedendo in questi giorni in America. E non è un caso che, alla luce del disastro delle ultime elezioni americane, Alexis de Tocqueville sia un autore al quale ci si rivolge sempre più spesso».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- NOAH CHOMSKY, KANT, E LA CREATIVITÀ. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.8 giugno 2017, di Federico La Sala
COSÌ VA IL MONDO: NOAH CHOMSKY, KANT, E LA CREATIVITÀ.
Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico (e un omaggio a G.B. Zorzoli): *
- Non è facile portare a sintesi il pensiero politico di Noam Chomsky [...] "Così va il mondo" è composto da ben settantaquattro interviste, raggruppate in modo spesso arbitrario [...] Tutti temi di grande spessore, ridotti in pillole [...] Insomma, brevi cenni sull’universo [...] Nei vecchi libri dell’editore Bompiani era inserito un foglietto con un breve messaggio: non prestare questo libro: se ti è piaciuto, fai un torto all’editore; se non ti è piaciuto, lo fai a chi l’hai dato. "Così va il mondo" non lo presterò a nessuno. Anche perché il torto maggiore lo farei al pensiero di Chomsky (G. B. ZORZOLI)
[...] Kant è il punto di svolta: le condizioni di possibilità della conoscenza non vengono “più ricercate in qualcosa di preesistente, in un modello ontologico ideale, o in un luogo di modelli ideali, che - soli - consentono di parlare del mondo reale come appare e come è conosciuto”. Ciò che ancora non abbiamo capito è che Kant va alla radice e ci porta fuori del vecchio programma centrato sul “come conosciamo”: il suo problema - come è possibile la conoscenza scientifica (e non)? - è la risposta più radicale, e più adeguata, all’altezza della nuova Terra e del nuovo Cielo, scoperti dalla nuova fisica, e alla navigazione dell’umanità nell’“oceano celeste” (Keplero a Galilei, 1611).
[...] Compresa con Chomsky tutta l’importanza della distinzione tra la creatività sotto un codice dato (la “rule-governed creativity”) e la creatività “nel senso pieno del termine” (la “rule-changing creativity”), si rende - sulla spinta dei contributi di Antonucci e De Mauro - di quanto e di come sia necessario portare il problema oltre la chomskiana “struttura profonda”, “in quanto struttura già linguistica”, in una struttura intesa “non più come qualcosa di linguisticamente omogeno, quanto piuttosto come un dispositivo eterogeneo, linguistico e non-linguistico, per esempio anche intellettuale e psicologico”, e così scrive e precisa: “In altre parole, si tratta non di una presa di posizione antichomskiana, o più in generale antigenerativa, ma di un suo approfondimento ulteriore, che tende a portare al di là del linguaggio. (Si intende al di là del linguaggio, non nell’aldilà della speculazione)”. E a questo punto, con il conforto e e la spinta del contributo di Hogrebe, la via a e di Kant è riaperta e ripresa! Non è che l’inizio: Kant è ancora tutto da rileggere, a partire dalla “Storia universale della natura e teoria del cielo” e dai “Sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica”.
* SI CFR.: "CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico".
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- ULISSE, TELEMACO, E "LA SOCIETA’ ORIZZONTALE". La vera società libera è quella che rifiuta la tirannia dei padri.2 giugno 2017, di Federico La Sala
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO ...
- CON LA COSTITUZIONE IL POPOLO ITALIANO HA FATTO "LA RIFORMA", MA NE’ I CATTOLICI NE’ I LAICI LO HANNO CAPITO. A PIETRO SCOPPOLA, CHE AVEVA COMINCIATO A CAPIRLO ..... A SUA MEMORIA
La vera società libera è quella che rifiuta la tirannia dei padri
Nel loro saggio Marco Marzano e Nadia Urbinati riflettono sulle trasformazioni della nostra organizzazione di vita proponendo un “patto” tra pari che elimini ogni leaderismo
di Giulio Azzolini (la Repubblica, 02.06.2017)
- IL SAGGIO. Marco Marzano e Nadia Urbinati La società orizzontale. Liberi senza padri. Feltrinelli Collana: Campi del sapere. 2017 pagg. 112 euro 16.
Chi ha paura della “morte del padre”? Chi teme la crisi di quell’autorità che la tradizione ha visto incarnata nella figura maschile e paterna? Non certo Marco Marzano e Nadia Urbinati, che anzi nel loro saggio La società orizzontale (Feltrinelli) si scagliano apertamente contro quello che chiamano «il modello di Telemaco»: il figlio che, nell’attesa del padre Ulisse, non scatena il conflitto generazionale di Edipo né mira all’autoaffermazione di Narciso. Invece, secondo il sociologo e la teorica della politica, l’attesa del padre tradisce piuttosto l’invocazione del leader, dunque una qualche nostalgia per le vecchie gerarchie.
Alla «logica neo-patriarcale» andrebbe contrapposta, a parer loro, la rivendicazione di una «società orizzontale», ovvero autenticamente democratica. E il saggio, che pone in modo polemico e sempre lucido questioni radicali, àncora tale rivendicazione a una duplice argomentazione, volta a mostrare che una società senza padri è desiderabile e, d’altro canto, che il processo di “orizzontalizzazione” è comunque un destino, malgrado la nostra economia sia stata segnata da quella scandalosa «mutazione antiegualitaria» denunciata proprio da Nadia Urbinati nel 2013 (Laterza).
La società orizzontale, in sintesi, sarebbe non solo augurabile, ma anche possibile, a patto tuttavia di vincere una precisa battaglia culturale: quella che ha per avversario la cosiddetta «controrivoluzione dei padri ». Secondo i due autori, infatti, l’Italia ha bisogno di riaffermare il valore etico della democrazia a partire da tre ambiti cruciali: religioso, famigliare e politico.
Sul piano religioso, Marzano e Urbinati descrivono una sorta di passaggio al protestantesimo, compiuto da una generazione di giovani che ragiona in autonomia e stabilisce un rapporto sempre più diretto e libero con la dimensione del divino. Sul piano famigliare, si nega che il declino della famiglia tradizionale, cioè paternalistica e autoritaria, rappresenti una catastrofe.
Al contrario, la democratizzazione delle famiglie avrebbe portato con sé un clima più pacifico, fatto di dialogo e di rispetto reciproco.
Sul piano politico, infine, viene diagnosticata la crisi dei partiti identitari. La loro restaurazione è una causa persa. Ma la loro natura dev’essere per forza leaderistica o verticale? No. La sfida, secondo gli autori, è quella di costruire partiti orizzontali, con una struttura sempre meno piramidale e più reticolare, capace cioè di federare gruppi sorti nella società civile. E ciò non implica il rigetto della dicotomia destra-sinistra, come pretende l’attuale vulgata movimentista. Marzano e Urbinati sostengono che gli stessi valori democratici possono ancora essere declinati con uno spirito riformista e sociale oppure conservatore e liberista, e dunque che le categorie di destra e sinistra restano utili criteri di orientamento.
Se non è l’assenza di padri, il pericolo che incombe sulla società orizzontale è quindi un altro: la trasformazione dell’individualismo in atomismo, ossia l’aggravarsi di una patologia tipica di quegli individui liberi e uguali che rappresentano il cuore della democrazia moderna. Il rischio dei nostri giorni è che le persone si isolino, risultando sempre più sconosciute, indifferenti o ostili le une alle altre, e che il presente si separi da un passato percepito come oscuro ed estraneo. Ma la salvezza sta nella collaborazione tra pari, non già nel ritorno, magari in nome del padre, del capo.
-
>CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA --- Proteste al G7, la Statua della Libertà come un naufrago.26 maggio 2017, di Federico La Sala
-
>Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. -- Rileggere i "Promessi Sposi" (e "il fondamnetalista riluttante")!!!23 maggio 2017, di Federico La Sala
I "PROMESSI SPOSI": DON RODRIGO, DON ABBONDIO, E QUEL "RAMO D’ORO" DEL LAGO DI COMO! Liberare gli studenti dalla "boria" dei "sapientissimi" proff. e dalle sapientissime proff.!!!
- Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
 Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! (Federico La Sala)
Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! (Federico La Sala)
- DONNE, UOMINI E VIOLENZA. L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
- "ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi". Il lavoro di Emilio Gentile, recensito da Riccardo Chiaberge
“Liberiamo gli studenti dai Promessi sposi”
La noia di leggere Manzoni a quindici anni
I "Promessi sposi" sono testo obbligatorio dal 1870. Ora docenti come Giunta e Gardini, e scrittori come Camilleri, Terranova e Trevi chiedono di cambiare. Per salvare le prossime generazioni di lettori
di Marco Filoni ("pagina 99", 19 maggio 2017)
Facciamo un esperimento. Provate a immaginare una sensazione, un’immagine che vi torna alla mente dei Promessi sposi. D’accordo, a tutti più o meno risuona il famoso incipit Quel ramo del Lago di Como... Ma provate a far emergere dai vostri ricordi qualcosa che più che a mezzogiorno “volge” alle vostre emozioni. -Siate sinceri: pensate a un misto di noia e fastidio? Bene, la cosa non deve preoccuparvi. Fatti salvi gli studiosi, rientrate nella quasi totalità della popolazione italiana che, a scuola, ha letto le pagine dei Promessi sposi. Lo chiamano “effetto-Manzoni” e, secondo molti, sarebbe alla base di una successiva ripulsa verso la letteratura di molti giovani.
C’è però una considerazione che forse è arrivato il momento di fare. Ovvero: quanto questo romanzo ottocentesco (la prima versione è del 1827, la sua edizione definitiva uscì fra il 1840 e il 1842) è davvero costitutivo del carattere nazionale dell’Italia?
La domanda non suoni peregrina. Se la sono posta allo scoccar d’ogni decennio funzionari ministeriali, scrittori e insegnanti dal 1870 in poi - alternando elogi delle pagine manzoniane a severi giudizi sulla loro utilità, proponendo alternative (le Confessioni di un ottuagenario di Ippolito Nievo nel 1922, fra gli altri) e netti rifiuti (come Giosuè Carducci «perché dalla lingua dei Promessi sposi a certa broda di fagioli non c’è traghetto e dall’ammagliamento logico dello stile e discorso manzoniani alle sfilacciature di calza sfatta di cotesti piccoli bracaloni c’è di mezzo un abisso di ridicolo»).
Sul nuovo numero di pagina99, in edicola e in versione digitale, pubblichiamo una lista dei libri che sono le letture obbligatorie in differenti Paesi del mondo (compilata da Daryl Chen e Laura McClure per il sito dei Ted Talks). Perché sapere cosa un Paese fa leggere ai suoi giovani ci dice qualcosa di quel Paese. Prendiamo la Germania, dove si legge Il diario di Anna Frank (scritto in olandese, non in tedesco). Per non dire dei molti Paesi che fanno leggere romanzi scritti negli ultimi decenni: per esempio il Pakistan che propone Il fondamentalista riluttante di Mohsin Hamid (2007).
Verrebbe da chiedersi, con Italo Calvino, cos’è oggi un classico... E nel rispondere a questa domanda ci vorrebbe forse un po’ di coraggio per superare un certo familismo culturale che investe la nostra società: i nostri padri vogliono che studiamo le stesse cose che hanno studiato loro, così come noi vogliamo che i nostri figli studino quello su cui siamo incappati noi stessi. Una sorta di immobilismo che ritroviamo esplicitato nelle così dette riforme della scuola italiana, alla cui crisi si accompagna una mancanza di coraggio (ricordate don Abbondio?) forse insita nel nostro patrimonio culturale...
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
(federico la sala)
- Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Storiografia in crisi d’identità.22 maggio 2017, di Federico La Sala
Storiografia in crisi d’identità ...
- "ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi". Il lavoro di Emilio Gentile, recensito da Riccardo Chiaberge
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO. -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- RIPENSARE COSTANTINO! Note sul Concilio di Nicea.20 maggio 2017, di Federico La Sala
- PIO XI E MUSSOLINI: "[...] nel 1922, prima della sua elezione a Papa nel febbraio dello stesso anno, in occasione di un’intervista concessa al giornalista francese Luc Valti (pubblicata integralmente nel 1937 su L’illustration), il cardinale Achille Ratti aveva dichiarato a proposito di Mussolini:
- « Quell’uomo, ragazzo mio, fa rapidi progressi, e invaderà tutto con la forza di un elemento naturale. Mussolini è un uomo formidabile. Mi ha capito bene? Un uomo formidabile! Convertito di recente, poiché viene dall’estrema sinistra, ha lo zelo dei novizi che lo fa agire con risolutezza. E poi, recluta gli adepti sui banchi di scuola e in un colpo solo li innalza fino alla dignità di uomini, e di uomini armati. Li seduce così, li fanatizza. Regna sulla loro immaginazione. Si rende conto di che cosa significhi e che forza gli fornisca? Il futuro è suo. Bisognerà però vedere come tutto questo andrà a finire e che uso farà della sua forza. Che orientamento avrà, il giorno in cui dovrà scegliere di averne uno? Resisterà alla tentazione, che insidia tutti i capi, di ergersi a dittatore assoluto?.[32] »
- Nell’agosto 1923 Ratti confidò all’ambasciatore del Belgio che Mussolini “non è certo Napoleone, e forse neppure Cavour. Ma lui solo ha compreso di che cosa il suo paese abbia bisogno per uscire dall’anarchia in cui un parlamentarismo impotente e tre anni di guerra l’hanno gettato. Voi vedete come abbia trascinato con sé la Nazione. Possa essergli concesso di portare l’Italia alla sua rinascita”.[33]" (Wikipedia - senza le note).
Il Concilio di Nicea
di Arnaldo Casali *
- Il primo concilio ecumenico (qui raffigurato in un’icona ortodossa) si svolse a Nicea, l’odierna İznik in Turchia, il 20 maggio del 325
- “Lo conosco quell’arme, so cosa vuol dire quella faccia d’ariano, con la corda al collo”.
- E un ceffone partito dalla mano di Babbo Natale centrò la faccia del padre di tutti gli eretici.
No, non è stata decisa la divinità di Cristo, al Concilio di Nicea; con buona pace di Dan Brown che l’ha scritto nel [Codice Da Vinci (**), scomodando centinaia di intellettuali per smentire la solenne baggianata e facendo conoscere anche ai più sprovveduti in materia religiosa il più importante Concilio della storia.
Se non ha votato la proposta di trasformare in Dio un profeta mortale (non ce ne era bisogno visto che la divinità di Cristo è già dichiarata nei Vangeli e predicata dagli apostoli) il Concilio di Nicea, aperto solennemente nel palazzo imperiale il 20 maggio dell’anno 325, ha stabilito in compenso la data della Pasqua, prodotto il Credo ancora oggi recitato durante ogni messa e scatenato la più grande eresia del Medioevo: l’unica - fino alla Riforma luterana - capace di uscire dalla dimensione della setta per trasformarsi in una vera e propria Chiesa alternativa a quella cattolica.
Eppure al primo Concilio ecumenico della storia della Chiesa il Papa non ha partecipato, e a convocarlo e presiederlo è stato un laico che non era nemmeno battezzato: l’imperatore Costantino.
Non c’è nulla di così strano, in realtà. A quel tempo il Papa non era il capo della cristianità ma semplicemente il vescovo di Roma; il suo potere aumenterà progressivamente, nel corso del Medioevo, quando - venuto meno l’impero romano - andrà di fatto a colmare il vuoto lasciato dai Cesari.
Nel 325, però, l’impero è ancora saldo e sul trono siede uno dei più grandi sovrani della storia romana che, dodici anni prima, dalla nuova capitale Milano ha emanato l’editto con cui viene garantita la libertà religiosa a tutti i cittadini, mettendo fine alle persecuzioni e segnando una svolta radicale nella storia del Cristianesimo.
- Costantino convoca i vescovi a Nicea per il concilio in un mosaico (ca. 1000) in Santa Sofia, Istanbul
Costantino non è un cristiano vero e proprio: si farà battezzare solo dodici anni dopo, in punto di morte, promuove il culto del dio Sole ed è il Pontefice Massimo della religione romana; all’indomani del Concilio farà uccidere suo figlio e sua moglie, mentre nella sua nuova capitale farà edificare vari templi a divinità pagane.
Certo, già dalla battaglia di Ponte Milvio che il 28 ottobre 312 lo aveva visto trionfare contro Massenzio, Costantino aveva ostentato la sua simpatia per la nuova religione, rifiutando i rituali divinatori degli aruspici e preferendo affidarsi alla protezione del “Sommo Dio”. Quando era entrato trionfante in Roma, poi, non era nemmeno salito in Campidoglio, dove c’era il tempio più sacro della città.
Negli anni successivi la politica religiosa nei confronti dei cristiani è passata dalla tolleranza al sostegno e l’imperatore, che ha progressivamente abbandonato i culti di Ercole e Giove, ha iniziato a far inserire simboli cristiani su vessilli, statue e monete. Nel 321 ha introdotto la settimana e stabilito che la domenica debba essere riconosciuta come giorno festivo (chiamandola però con il nome pagano di “Giorno del Sole”) e nel 324 ha messo al bando i rituali di magia e vietato le esecuzioni dei condannati a morte durante i giochi circensi. Tutto questo, però, senza proibire i culti pagani, continuando a manifestare rispetto per i fedeli dell’antica religione e mantenendo una certa ambiguità sulla sua fede personale.
Si tratta senza dubbio di una strategia politica, che mira a pacificare l’impero e a venire a patti con il sempre più potente movimento religioso, dopo il fallimento delle persecuzioni di Diocleziano. L’obiettivo di Costantino è quello di trasformare la forza potenzialmente disgregante delle energiche comunità cristiane in una forza di coesione per l’impero, che sarà ancora più forte sotto la protezione dell’unico vero Dio e con il sostegno dei suoi devoti.
Ma non si tratta solo di gestione di potere: l’interesse religioso dell’imperatore è sincero e sposare apertamente una religione che conta ancora appena il 10% dei cittadini non è certo una scelta popolare.
Tuttavia, più che seguace di Gesù Cristo, Costantino è un convinto monoteista.
- Il volto della statua colossale di Costantino I (Musei Capitolini, Roma)
Non è tanto il Vangelo ad affascinarlo, quanto l’idea di un Dio unico, che non necessariamente si identifica con la trinità: di fatto il primo imperatore cristiano promuove un sincretismo che tende a unire il cristianesimo con i culti mitralici e solari. Insomma quello che interessa a Costantino è che ci sia un solo Dio e che questo Dio non sia egli stesso (come pretendevano i suoi predecessori) ma un’entità superiore e onnipotente a cui affidarsi; tanto che nello stesso Editto di Milano si parla della “divinità che sta in cielo, qualunque essa sia” che “a noi e a tutti i nostri sudditi dia pace e prosperità”. E senza dubbio il Sole è la più tangibile forma di un Dio padre e re dei cieli, che illumina e dà vita e che ogni giorno muore e ogni mattino risorge, vincendo le tenebre e donando nuova luce al mondo.
In alcune lettere private Costantino afferma di voler convertire tutti alla religione cattolica, ma di fatto la sua azione politica punta ad un ecumenismo che faccia confluire in un’unica forma le credenze religiose di tutti i popoli sottomessi a Roma.
D’altra parte se l’unico Dio è il sovrano dei cieli, sulla terra il padrone è lui. E a lui spetta, quindi, assumersi la responsabilità di gestirne il culto assicurando la benevolenza al suo popolo. Per questo Costantino, mentre mantiene le più alte cariche religiose pagane, si assume anche il compito di guidare il popolo cristiano.
- “Il Primo Concilio di Nicea” in un affresco della chiesa di Stavropoleos a Bucarest
Nel 325, dunque, con il singolare ruolo di “vescovo di quelli che sono fuori dalla Chiesa” ha convocato a Nicea la prima assemblea plenaria della Chiesa Cattolica dai tempi del Concilio di Gerusalemme (la riunione raccontata negli Atti degli Apostoli a cui avevano partecipato - pochi anni dopo la morte di Gesù - il fratello Giacomo, gli apostoli e san Paolo, per decidere se mantenere il cristianesimo nell’ambito dell’ebraismo o farne una religione nuova).
Al primo Concilio ecumenico vengono quindi convocati tutti i vescovi del mondo; quello di Roma, però, non si presenta perché la città turca è decisamente fuori mano e manda due preti in sua rappresentanza.
Costantino, d’altra parte, si prepara a trasferire in oriente la capitale stessa dell’impero, ma la scelta costa al Concilio l’adesione delle chiese occidentali: se l’imperatore ha invitato i vescovi di tutte le 1800 comunità del mondo cristiano a Nicea se ne presentano solo 300, e tutti provenienti dall’oriente o dal nord Africa, con sole tre eccezioni: Marco di Calabria dall’Italia, Osio di Cordova dalla Spagna e Nicasio di Digione dalla Gallia.
È vero anche che il principale problema che la riunione deve risolvere, per il momento, riguarda il Medi Oriente: si tratta del dibattito sulla natura di Cristo che ha spaccato la comunità di Alessandria e rischia di dilagare in tutto il mondo.
- Nel best seller di Dan Brown le questioni affrontate nel Concilio di Nicea sono molto semplificate
Dan Brown, nel suo stile, ha semplificato al massimo la questione parlando di una contrapposizione tra chi sosteneva che Cristo fosse un semplice uomo e chi lo venerava come Dio. In realtà il nodo era piuttosto se Gesù fosse stato creato o generato da Dio Padre. In parole più semplici, se Gesù è una creatura di Dio (ed è quindi nato in un preciso momento) o è la manifestazione storica di Dio stesso, ed è quindi eterno.
Da questo punto di vista i Vangeli non sono molto coerenti: se Marco, Matteo e Luca presentano Cristo come un personaggio storico nato a Betlemme di Giudea e rivelatosi in seguito essere il Messia e il figlio di Dio, Giovanni ne parla come del “Verbo” divino incarnato.
Il principale sostenitore della tesi secondo cui Gesù - in quanto figlio - è stato creato in un preciso momento storico è il prete e teologo libico Ario, che già nel 300 era stato scomunicato dal patriarca di Alessandria Pietro. Nel 311 Ario era stato riabilitato dal nuovo patriarca Achilla, e alla sua morte - nel 312 - era diventato il principale candidato alla successione.
Ario era stato però sconfitto alle elezioni da Alessandro, che nel 318 aveva convocato un sinodo appositamente per scomunicare di nuovo il rivale. Fuggito dalla città, il teologo eretico aveva trovato nuovi seguaci in Siria e in Palestina, raccogliendo il consenso anche di illustri teologi come Eusebio di Cesarea. Nel 321 un sinodo di cento vescovi egiziani ha di nuovo condannato le sue tesi e chiesto la convocazione di un concilio per fare maggiore chiarezza in materia cristologica.
Sotto il profilo squisitamente teologico non è in discussione la divinità di Cristo, quanto piuttosto se il Padre e il Figlio siano composti dalla stessa sostanza (nel senso aristotelico del termine) o se il Figlio sia stato creato dal Padre e si trovi dunque in una posizione subordinata.
Tutta la diatriba ruota intorno alla differenza terminologica tra “generato” e “creato”; differenza sostanziale secondo Alessandro e inesistente secondo Ario. 800px-constantine_burning_arian_books
- Il Concilio di Nicea, presieduto da Costantino, condanna gli eretici ariani in un manoscritto dell’Archivio capitolare di Vercelli (sec. IX)
I promotori della Consustanzialità credono che seguire l’eresia ariana significhi spezzare l’unità della natura divina e rendere il Figlio diverso dal Padre, in palese contrasto con le Scritture (“Io e il Padre siamo una cosa sola”, dice Gesù in Giovanni 10,30). Gli ariani, dal canto loro, rispondono citando il passo 14,29 dello stesso Vangelo: “Io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me”. Gli uni replicano dicendo che la trinità è eterna, quindi il Padre è sempre stato Padre e il figlio è sempre stato il figlio indipendentemente dalla sua incarnazione, gli altri ribadiscono che Cristo è una creatura elevata ad uno status divino. Lo scontro, come è evidente, riguarda elucubrazioni di teologia estrema riservate a dotti filosofi, e che non hanno alcuna ripercussione pratica sulla vita cristiana; eppure la diatriba, sempre più aspra, rischia di lacerare la Chiesa; per questo Costantino vuole che la questione venga risolta prima che sfugga di mano.
Ma quello dell’arianesimo non è l’unico nodo della matassa cristiana che l’imperatore si trova a dover sciogliere con i padri conciliari. C’è una questione ancora più delicata che va chiarita una volta per tutte: la data della Pasqua.
Quando bisogna celebrare le principali feste cristiane, infatti, ci si trova di fronte a un paradosso: della nascita di Cristo non si sa assolutamente nulla, eppure - per volontà dello stesso Costantino - la data del Natale è stata stabilita convenzionalmente il 25 dicembre, proprio per farla coincidere con la festa del Sole Invitto e identificare così le due divinità. All’opposto, del momento più importante della vita cristiana - la Resurrezione - la data si conosce con esattezza eppure ogni comunità la festeggiava in un giorno diverso.
Questioni di calendario: secondo i Vangeli Cristo è risorto il giorno 14 del mese di Nisan. Il problema è che i mesi ebraici seguono un calendario lunare dalla redazione molto complessa, anche perché legata alle osservazioni astronomiche e alla maturazione dell’orzo (per la festa degli azzimi, strettamente legata alla Pasqua ebraica); di conseguenza il 14 di Nisan cade ogni anno in un giorno diverso e con notevoli sfasamenti di anno in anno e persino di luogo in luogo. Inoltre, nei Vangeli è scritto che Gesù è risorto il giorno dopo il sabato, per questo ogni domenica i cristiani celebrano la resurrezione, che è - di fatto - una Pasqua settimanale. Il giorno di Pasqua deve quindi cadere necessariamente di domenica.
- Il battesimo di Cristo nel mosaico sul soffitto del Battistero degli Ariani a Ravenna (prima metà del sec. VI)
La confusione creata da tutte queste variabili aveva visto affermare, nel corso dei secoli, prassi molto diverse tra loro: lo scontro principale era tra quelli che celebravano la Pasqua insieme agli ebrei (detti Quatrodecimani) e quelli che la celebravano la domenica successiva. Altri ancora si erano svincolati dal calendario ebraico - giudicato inattendibile per le troppe variabili che conteneva - e avevano calcolato autonomamente le fasi lunari. Ma di fatto poteva capitare persino di celebrare due volte la Pasqua nello stesso anno solare.
Secondo alcuni cronisti, Costantino in persona si esprime per una presa di distanza dal calendario ebraico, con argomentazioni antisemite: “Fu prima di tutto dichiarato improprio il seguire i costumi dei Giudei nella celebrazione della santa Pasqua, perché, a causa del fatto che le loro mani erano state macchiate dal crimine, le menti di questi uomini maledetti erano necessariamente accecate” scrive Teodoreto di Cirro. “Non abbiamo nulla in comune con i Giudei, che sono i nostri avversari evitando ogni contatto con quella parte malvagia. Quindi, questa irregolarità va corretta, in modo da non avere nulla in comune con quei parricidi e con gli assassini del nostro Signore”.
Il Concilio di Nicea stabilisce così che la Pasqua venga festeggiata ogni anno la prima domenica dopo il plenilunio successivo all’equinozio di primavera. E così viene calcolata ancora oggi.
Nel frattempo Ario ed Eusebio di Nicomedia, il suo principale sostenitore, si ritrovano in poco tempo in minoranza. E come sempre accade in questi casi, non tanto per le argomentazioni quanto per il caratteraccio: l’arroganza dei due teologi, infatti, è così insopportabile da indisporre la fazione moderata e indurla a votargli contro. Alla fine la teoria del Figlio della stessa sostanza del Padre vince con una larghissima maggioranza: persino Eusebio cambia posizione e solo Teona di Marmarica e Secondo di Tolemaide votano a favore di Ario.
Il nuovo dogma viene inserito nella Professione di fede che i cristiani reciteranno da quel momento in poi durante ogni celebrazione liturgica, in cui si precisa così che Gesù Cristo è “generato, non creato della stessa sostanza del Padre”.
Tuttavia il turbolento clima conciliare per niente conciliante, degenera al punto che san Nicola di Bari, vescovo di Mira, arriva a prendere a schiaffi Ario.
Uno schiaffo che il teologo sconfitto avrebbe restituito con gli interessi ai vincitori.
- Icona che raffigura Costantino tra i padri del primo Concilio di Nicea
Sconfessato ufficialmente, infatti, Ario non si arrenderà: appena tre mesi dopo il Concilio, Eusebio di Nicoledia e Teognis di Nicea saranno esiliati in Gallia perché - pur avendo firmato gli atti dell’assemblea - riprenderanno a predicare la teologia ariana, guadagnando alla loro causa anche il Custode degli atti stessi.
Non solo, ma persino l’imperatore Costantino negli ultimi anni di vita finirà per passare al nemico, riabilitando Ario e ricevendo il battesimo ariano da Eusebio (e giocandosi così il titolo di santo, che verrà assegnato invece alla madre Elena).
Nei decenni l’eresia ariana continuerà a crescere fino a diventare una vera e propria chiesa alternativa a quella cattolica.
Se di eresie ce ne erano state già sin dall’inizi del Cristianesimo (dagli gnostici ai manichei, dai meleziani ai novaziani) e il Medioevo ne vedrà sorgere di importantissime (basti pensare ai catari, contro cui Innocenzo III bandirà addirittura una crociata, e i valdesi - che riusciranno a sopravvivere fino al Cinquecento ed entreranno nella Riforma protestante arrivando fino ad oggi) gli ariani saranno gli unici a conquistare intere nazioni, tanto da diventare - nell’alto medioevo - una vera e propria seconda Chiesa cristiana, a cui aderiranno la maggior parte delle popolazioni germaniche, tanto che a Ravenna esiste ancora la cattedrale ariana fatta costruire da Teodorico con tanto di battistero.
L’ariano resterà così nell’immaginario cristiano l’eretico per antonomasia, tanto che durante le crociate in occidente gli stessi musulmani verranno chiamati “ariani” e così continueranno ad essere chiamati per secoli.
A dare testimonianza di come il termine, ancora nel Seicento, venisse usato per indicare gli arabi è Alessandro Manzoni nel capitolo XIV dei Promessi sposi: Renzo si è ubriacato in una locanda e l’oste gli chiede le generalità come prescritto da un’apposita legge. Alle rimostranze di Renzo gli mostra la circolare, in cui campeggia lo stemma del governatore don Gonzalo Fernandez de Cordova con il volto di un re moro incatenato per la gola.
“Lo conosco quell’arme - risponde il nostro - so cosa vuol dire quella faccia d’ariano, con la corda al collo. Vuol dire, quella faccia: comanda chi può, e ubbidisce chi vuole”. E così sia.
* FESTIVAL DEL MEDIOEVO (ripresa parziale - senza immagini).
** DAN BROWN, IL CODICE DA VINCI ... KOYAANISQATSI (LA VITA SENZA EQUILIBRIO - LIFE OUT OF BALANCE).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- NELL’ORIZZONTE DELL’IMMAGINARIO DI COSTANTINO (“IN HOC SIGNO VINCES”). Un best seller senza tempo: il "Combattimento spirituale" di Lorenzo Scupoli.3 novembre 2018, di Federico La Sala
NELL’ORIZZONTE DELL’IMMAGINARIO DI COSTANTINO (“IN HOC SIGNO VINCES”). Lorenzo Scupoli, Francesco di Sales, e Maria Gaetana Agnesi ....
PER COMPRENDERE come e perché il libro di Lorenzo Scupoli (nato intorno al 1530 a Otranto, l’antica Hydruntum, che cinquant’anni prima era stata teatro del tragico martirio di ottocento suoi concittadini, decapitati dai turchi sul colle della Minerva), sia diventato un “bestseller senza tempo” (cfr.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2018/11/01/lorenzo-scupoli-1530-1610-di-otranto-e-il-suo-best-seller-senza-tempo/), non è male RICORDARE CHE
A) [...] il Combattimento spirituale di Lorenzo Scupoli va collocato all’interno di una ricca e articolata produzione centrata sulla nozione di ‘milizia cristiana’, che poteva esibire un precedente di assoluto rilievo come Le armi necessarie alla battaglia spirituale di Caterina da Bologna e visse la sua stagione più feconda nei convulsi anni del Concilio di Trento e nei decenni successivi [...]” (cfr.: http://www.ereticopedia.org/lorenzo-scupoli).
B) “Francesco di Sales considerava un bene prezioso il Combattimento spirituale, che portava sempre con sé da ben diciotto anni, come ricorda in una lettera del 1607”, E CHE “Discutendone con l’amico e corrispondente epistolare Jean-Pierre Camus, il Sales espresse l’opinione che il Combattimento dello Scupoli costituiva per i teatini, mutatis mutandis, ciò che gli Esercizi spirituali di sant’Ignazio avevano rappresentato per i gesuiti” (op.cit.),
C) “[...] Il Combattimento spirituale fu una delle letture preferite di Maria Gaetana Agnesi, newtoniana e matematica di respiro europeo, il cui Cielo mistico - rimasto a lungo inedito - attinge soprattutto alla spiritualità teatina dei primordi, a sant’Andrea Avellino e a Lorenzo Scupoli, che con l’ascetica dell’imitatio Christi e la devozione della Croce offrivano immagini e suggestioni di straordinaria efficacia psicologica e visiva. Agnesi possedeva il Combattimento in un’edizione padovana del 1724 e di certo doveva ritrovarvi molte idee proprie, che sul piano spirituale riflettono una fede di matrice teatina, attenta alle deliberazioni del Tridentino ma sensibile alle istanze riformatrici di stampo muratoriano, in dialogo continuo con le esigenze della ragione e la sensibilità tipica dei Lumières. In tale contesto iniziò a diffondersi a metà Settecento il mito che Agnesi, da precoce adolescente qual era, aveva tradotto in greco il Combattimento spirituale di Scupoli [...] (op.cit.).
Federico La Sala
NOTA
SULL’immaginario del cattolicesimo romano e sull’ "istanze riformatrici di stampo muratoriano", nel sito, si cfr.:
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
 MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. MuratoriFLS
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- RIPENSARE COSTANTINO! --- RIPENSARE LA "CONVERSIONE DI SAN PAOLO".25 gennaio 2020, di Federico La Sala
MEMORIA E STORIA / STORIA E MEMORIA.... *
il santo del giorno
Conversione di san Paolo.
La luce improvvisa, la caduta, la voce di Cristo. La fede è apertura all’inaspettato infinito
di Matteo Liut (Avvenire, sabato 25 gennaio 2020)
Il cambio di rotta, la strada nuova, la svolta imprevista: la fede è apertura all’inaspettato, alla novità che trasforma la vita, all’infinita luce che entra dentro il buio dei nostri errori. Ecco perché la Chiesa oggi celebra la Conversione di san Paolo, ricordando a tutti, così, che Dio ci chiama sempre, continuamente, che nessuno è "spacciato".
 "All’improvviso lo avvolse una luce dal cielo - si legge negli Atti degli Apostoli - e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?". Era l’inizio di una nuova esistenza per Paolo, che sarebbe diventato uno dei pilastri della comunità dei credenti, l’apostolo che fece del Vangelo un messaggio davvero "cattolico", cioè offerto a ogni popolo e a ogni nazione della Terra.
"All’improvviso lo avvolse una luce dal cielo - si legge negli Atti degli Apostoli - e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?". Era l’inizio di una nuova esistenza per Paolo, che sarebbe diventato uno dei pilastri della comunità dei credenti, l’apostolo che fece del Vangelo un messaggio davvero "cattolico", cioè offerto a ogni popolo e a ogni nazione della Terra.
 Dopo l’incontro con Cristo sulla via di Damasco, Paolo rimase accecato e dopo aver recuperato la vista fu battezzato: l’immersione nella vita di Dio è il dono di uno sguardo diverso sul mondo.
Dopo l’incontro con Cristo sulla via di Damasco, Paolo rimase accecato e dopo aver recuperato la vista fu battezzato: l’immersione nella vita di Dio è il dono di uno sguardo diverso sul mondo.Altri santi. Sant’Anania di Damasco, martire (I sec.); beata Arcangela Girlani, vergine (1460-1494).
 Letture. At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18.
Ambrosiano. At 9,1-18; Sal 116 (117); 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29.
Letture. At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18.
Ambrosiano. At 9,1-18; Sal 116 (117); 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
AUGUSTO, LA SIBILLA TIBURTINA, E LA "MADONNA DI FOLIGNO" DI RAFFAELLO.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- VALORI OCCIDENTALI? Di quali valori stiamo parlando? (di Marco Aime)18 maggio 2017, di Federico La Sala
Valori occidentali?di Marco Aime (DoppioZero, 18.05.2017)
Integrazione. Questa è la parola chiave, usata troppo spesso, senza che ci si renda pienamente conto del suo significato reale. Il verbo “integrare” significa, nella sua accezione principale, «rendere integro o intero». Integrare significa quindi rendere un qualcosa di diverso conforme all’intero, renderlo simile. Un’operazione del genere si fonda però su di un presupposto ineluttabile: deve esistere un intero. Se voglio integrare, devo prima avere un integro di riferimento. Integro è un aggettivo che si associa a qualcosa di completo, intatto.
Questo significa che, quando a proposito di stranieri, parliamo di integrazione, partiamo da un assunto fondamentale: la nostra società, la nostra comunità è un intero, è intatta, un unicum in cui tutti condividono gli stessi valori, rispettano le stesse leggi, pensano allo stesso modo.
 Questo è un po’ il messaggio che emerge dalla recente sentenza con cui la Corte di Cassazione ha condannato a un’ammenda di 200 euro un sikh che il 6 marzo del 2013 era stato sorpreso a Goito, dove c’è una grande comunità sikh, mentre usciva di casa, come sempre, con il kirpan (un coltello lungo quasi 20 centimetri) infilato nella fascia che avvolge la vita. Quel coltello, per i sikh è un simbolo religioso ed è segno di difesa della fede, non è considerato un’arma. Tanto è vero che la sua richiesta di assoluzione era stata condivisa dalla Procura della Suprema Corte che aveva ritenuto tale comportamento giustificato dalla diversità culturale. Sentenza non confermata dall’ultimo grado di giudizio.
Questo è un po’ il messaggio che emerge dalla recente sentenza con cui la Corte di Cassazione ha condannato a un’ammenda di 200 euro un sikh che il 6 marzo del 2013 era stato sorpreso a Goito, dove c’è una grande comunità sikh, mentre usciva di casa, come sempre, con il kirpan (un coltello lungo quasi 20 centimetri) infilato nella fascia che avvolge la vita. Quel coltello, per i sikh è un simbolo religioso ed è segno di difesa della fede, non è considerato un’arma. Tanto è vero che la sua richiesta di assoluzione era stata condivisa dalla Procura della Suprema Corte che aveva ritenuto tale comportamento giustificato dalla diversità culturale. Sentenza non confermata dall’ultimo grado di giudizio.Il fatto ha subito trovato ampio spazio su tutti i giornali e come spesso accade, la questione può essere liquidata in modo semplicistico, da una parte o dall’altra: “poche storie, le leggi sono uguali per tutti” oppure, “ciascuno ha il diritto di esprimere i propri simboli culturali”.
 In realtà la questione è più complessa, non tanto sul piano della sanzione, quanto su quello delle motivazioni. Se la legge prevede che non si può circolare con una lama superiore ai venti cm, c’è poco da discutere, il signore in questione l’ha trasgredita. Semmai si può discutere sul fatto se le leggi debbano o no essere adeguate alle nuove realtà culturali che caratterizzano il nostro paese.
In realtà la questione è più complessa, non tanto sul piano della sanzione, quanto su quello delle motivazioni. Se la legge prevede che non si può circolare con una lama superiore ai venti cm, c’è poco da discutere, il signore in questione l’ha trasgredita. Semmai si può discutere sul fatto se le leggi debbano o no essere adeguate alle nuove realtà culturali che caratterizzano il nostro paese.Quello che invece fa riflettere sono le affermazioni per cui gli immigrati che hanno scelto di vivere nel mondo occidentale hanno “l’obbligo” di conformarsi ai valori della società nella quale hanno deciso "di stabilirsi" ben sapendo che "sono diversi" dai loro e «non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante».
 Di quali valori stiamo parlando? Quelli della società occidentale? In Gran Bretagna, che anche dopo la Brexit credo rimanga occidentale, il kirpan è ammesso. Il velo è proibito nei luoghi pubblici in Francia, ma non in altri paesi occidentali. Per i paladini nostrani dell’abolizione del velo, questa peraltro varrebbe solo per le donne islamiche, non per le suore o le fedeli ortodosse. Proibire di circolare armati è senza dubbio giusto, meno armi, meno pericoli, però stride con lo spirito della legge appena approvata in Parlamento sulla legittima difesa.
Di quali valori stiamo parlando? Quelli della società occidentale? In Gran Bretagna, che anche dopo la Brexit credo rimanga occidentale, il kirpan è ammesso. Il velo è proibito nei luoghi pubblici in Francia, ma non in altri paesi occidentali. Per i paladini nostrani dell’abolizione del velo, questa peraltro varrebbe solo per le donne islamiche, non per le suore o le fedeli ortodosse. Proibire di circolare armati è senza dubbio giusto, meno armi, meno pericoli, però stride con lo spirito della legge appena approvata in Parlamento sulla legittima difesa.Di due l’uno: siamo per bandire ogni arma o solo alcune?
«In una società multietnica, - prosegue il verdetto della Suprema Corte - la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere». Parole condivisibili, ma qual è il nucleo comune? Quali i valori di riferimento? Sono comuni a tutti coloro che includiamo nel “noi”? In altri termini, siamo davvero un “integro” tale da considerarci una unità coerente? Certo, esistono punti di riferimento più o meno condivisi, ma sono difficili da identificare e soprattutto non sono un’esclusiva dell’Occidente, ma in molti casi sono condivisi anche da altri.
Visto che si parla di integrare, esiste peraltro anche un’altra accezione del verbo, che indica: «completare aggiungendo ciò che manca o che serve a migliorare, ad arricchire o a modificare.»
Letta in questo senso, l‘integrazione assume un’altra prospettiva, quella di un processo dove non abbiamo una parte fissa, immobile, monolitica che assorbe l’altra, ma uno scambio dialettico, dove entrambe le parti danno e prendono, dando vita a nuove forme culturali, come sempre è avvenuto nella storia dell’umanità.
Questo episodio, perciò, potrebbe essere un valido e interessante punto di partenza per una riflessione più ampia, che affronti in modo sereno e non strumentale la necessità di armonizzare il carico di memoria e di ricordo che chi arriva da fuori si porta dietro, con il comprensibile desiderio di conservare un certo modus vivendi di chi accoglie, tenendo conto del vantaggio di quest’ultimo. Solo così, negoziando senza pregiudizi, si può arrivare a una convivenza pacifica, tenendo sempre ben presente, che nessuna comunità è mai totalmente omogenea, nessuna è un intero.
 Integro, tra l’altro, significa anche onesto, incorruttibile.
Integro, tra l’altro, significa anche onesto, incorruttibile. -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- LA CASSAZIONE, LA TEOCRAZIA, E I SIKH (di Alessandro Gilioli)17 maggio 2017, di Federico La Sala
I SIKH, LA COSTITUZIONE, E LA TEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO ...
- L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
La Cassazione e la teocrazia
di Alessandro Gilioli *
Mi rendo conto che l’argomento è complicato - perfino un po’ filosofico, quindi magari palloso.
Ma la questione posta dalla sentenza della Cassazione sul sikh che voleva girare con un coltello in realtà non parla di un sikh che voleva girare con un coltello: porta dritti a temi come l’ontologia, il relativismo, la teocrazia, perfino a Nietzsche e a Dostoevskij.
Ecco: dopo aver allontanato il 90 per cento dei lettori con la frase sopra, provo a spiegarmi - e chi sa già queste cose mi perdonerà le semplificazioni divulgative.
Per un paio di millenni o quasi, nessuno in Europa aveva dubbi sulla fonte oggettiva di ciò che era giusto e ciò che era sbagliato. La fonte che stabiliva giusto e ingiusto era Dio. Qualcosa di ontologico, appunto: in sé e per sé, oltre l’opinabile umano. Le leggi di cui le società si dotavano derivavano da una fonte etica e valoriale indubitabile, oggettiva, immutabile ed eterna.
Come noto - ma questa è divagazione - la legittimazione ontologica e religiosa della legge finì per attribuire un potere al papato che andava molto oltre i territori controllati dalla Chiesa. Il Papa che nel Medioevo incoronava gli imperatori o i re era il simbolo di questo passaggio di legittimazione: da Dio al Papa, dal Papa al monarca, il quale poi esercita questo potere derivante da Dio. Nel corso della lotta per le investiture, nell’XI secolo, diversi pensatori vicini al papato arrivarono a teorizzare che senza il placet pontificio il re non avesse quindi alcuna legittimazione a governare, e che il popolo avesse nel caso diritto a ribellarsi. Questo - al netto delle questioni di interesse - perché il potere e le sue leggi derivavano da Dio, il Papa ne era l’intermediario in terra e il re ne era solo il provvisorio depositario finale.
Ne conseguiva, sostanzialmente, una società teocratica, come ovvio se tutti i valori e le leggi derivano da Dio.
Questa cosa, tuttavia, a un certo punto si è incrinata. Non la faccio lunga, che è cosa nota: l’Illuminismo, la Ragione, il vaglio critico della mente umana. Frutto, si sa, di una borghesia che voleva spezzare l’ordine antico del rapporto di potere esclusivo tra aristocrazia a Chiesa. Ma al di là delle questioni di classe, fu anche una rivoluzione culturale: si iniziò a dubitare che la fonte del giusto e dell’ingiusto - e delle leggi che vi si conformavano - fosse Dio. Si iniziò a pensare che fosse, invece, l’uomo.
Quindi che il giusto e l’ingiusto fossero qualcosa di soggettivo, opinabile e non eterno. Privo di una fonte oggettiva, di un aggancio ontologico. Era nato il relativismo.
Il relativismo poneva diversi problemi. Ad esempio, Dostoevskij si chiedeva se in assenza di Dio fosse tutto lecito. Cioè se l’assenza di una fonte oggettiva non determinasse la fine dell’etica. Bel problema, se senza Dio ognuno poteva fare quel che gli pareva, perché tanto nessuna legge aveva più un aggancio ontologico.
I relativisti invece partorirono la democrazia. Cioè l’idea che in termini etici ognuno avesse i paradigmi valoriali che voleva, ma in termini pratici la legge con cui regolare la convivenza sociale doveva essere il frutto della volontà della maggioranza.
In altre parole, non è che morto Dio fosse tutto lecito. Semplicemente, morto Dio era la maggioranza delle persone a decidere cos’era lecito e che cosa no. Per regolare la convivenza civile, la società non ha più bisogno di Dio: fa da sé. E la questione etico-valoriale viene staccata da quella pratica-legislativa: la prima è libera e soggettiva, ma all’interno delle regole poste dalla seconda la cui unica fonte è la maggioranza.
Ovviamente anche questa soluzione ha i suoi punti deboli.
Ad esempio, in termini logici contiene un paradosso: si stabilisce che non esiste un valore etico oggettivo e assoluto, se non il fatto che non esiste alcun valore etico oggettivo e assoluto (quindi si fa a maggioranza). Un paradosso logico, appunto. Ma finora non si è ancora trovata una soluzione migliore se non quella di proclamare come oggettiva e assoluta un’opinione valoriale soggettiva e di minoranza. E quest’ultima è una soluzione peggiore, come ho cercato di dimostrare qualche tempo fa sfottendo chi si oppone al suffragio universale.
Il secondo punto debole della relativizzazione di ogni norma a ciò che vuole la maggioranza (senza alcun aggancio ontologico valoriale) è che la maggioranza può fare cazzate gigantesche, dal "Crucifige!" che salvò Barabba alle elezioni che diedero la vittoria a Hitler. Non che invece le decisioni prese da pochi potenti nella storia non abbiano provocato altrettante ingiustizie, ma insomma non è detto che le democrazie la imbrocchino sempre.
Per questo sono nate le Costituzioni. Che hanno mura più solide di leggi ordinarie, esigono più riflessioni e più passaggi per essere modificate, per alcuni punti si stabilisce perfino che non siano modificabili (es.: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale»), quindi - nuovo paradosso - se ne presume una seppur parziale eternità ontologica.
Insomma un discreto casino. Non è tutto semplice e chiaro come quando le leggi provenivano da Dio. Ma finora non si è appunto riusciti a fare di meglio - e tutto sommato la cosa funziona. Se qualcuno ha proposte alternative, dica pure.
È all’interno di questo contesto culturale che forse occorre fare qualche valutazione critica del dispositivo della sentenza della Cassazione.
Perché non vi è dubbio che la legge - la laica legge, semplice espressione della maggioranza - impedisce a chicchessia di andare in giro con un coltello lungo 20 centimetri. Dal 1975, mi pare. Per decisione del Parlamento italiano, eletto dai cittadini, sul tema delle armi improprie.
Altro è fare riferimento all’esigenza, anzi all’obbligo, di "conformarsi ai valori del mondo occidentale". Perché qui vi è un richiamo ontologico. Oggettivo. Assoluto. Metodologicamente teocratico. Pre illuminista, se non anti illuminista. Un richiamo a un presunto sistema di valori oggettivo (la cui vaghezza e i cui confini peraltro potrebbero essere oggetto di discussioni molto ampie) che antecede la legge, ne è la fonte.
Un grosso passo indietro culturale, a mio avviso, frutto delle paure identitarie proprie di quest’epoca incerta, spaventata dalla velocità dei cambiamenti e delle contaminazioni.
Forse non è proprio un caso che gli Stati Uniti - con tutti i loro difetti, ma pur sempre figli dell’Illuminismo - si guardino bene dal chiedere agli immigrati e ai nuovi cittadini di "conformarsi ai valori del mondo occidentale". Chiedono solo, molto a chiare lettere, di rispettare le leggi e di pagare le tasse.
Roba laica, insomma. Non teocratica.
E un grazie di cuore a chi ha avuto la pazienza di leggere fin qui.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Memoria e Ricerca (1917-2017). I messaggi di Fatima tra anticomunismo, religiosità popolare e riconquista cattolica (J. Barreto). Nota di M. Roncalli.13 maggio 2017, di Federico La Sala
- PIO XI, PAPA RATTI, E MUSSOLINI: "[...] nel 1922, prima della sua elezione a Papa nel febbraio dello stesso anno, in occasione di un’intervista concessa al giornalista francese Luc Valti (pubblicata integralmente nel 1937 su L’illustration), il cardinale Achille Ratti aveva dichiarato a proposito di Mussolini:
- « Quell’uomo, ragazzo mio, fa rapidi progressi, e invaderà tutto con la forza di un elemento naturale. Mussolini è un uomo formidabile. Mi ha capito bene? Un uomo formidabile! Convertito di recente, poiché viene dall’estrema sinistra, ha lo zelo dei novizi che lo fa agire con risolutezza. E poi, recluta gli adepti sui banchi di scuola e in un colpo solo li innalza fino alla dignità di uomini, e di uomini armati. Li seduce così, li fanatizza. Regna sulla loro immaginazione. Si rende conto di che cosa significhi e che forza gli fornisca? Il futuro è suo. Bisognerà però vedere come tutto questo andrà a finire e che uso farà della sua forza. Che orientamento avrà, il giorno in cui dovrà scegliere di averne uno? Resisterà alla tentazione, che insidia tutti i capi, di ergersi a dittatore assoluto?.[32] »
- Nell’agosto 1923 Ratti confidò all’ambasciatore del Belgio che Mussolini “non è certo Napoleone, e forse neppure Cavour. Ma lui solo ha compreso di che cosa il suo paese abbia bisogno per uscire dall’anarchia in cui un parlamentarismo impotente e tre anni di guerra l’hanno gettato. Voi vedete come abbia trascinato con sé la Nazione. Possa essergli concesso di portare l’Italia alla sua rinascita”.[33]" (WIKIPEDIA - senza le note).
-
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
Fatima, una storia tra fede e politica
Il contesto nazionale, la restaurazione cristiana del Portogallo, il conflitto mondiale, la guerra fredda, il Concilio, la decolonizzazione
di MARCO RONCALLI (La Stampa, 10/05/2017)
Roma. Un culto che prima si afferma a livello nazionale e poi si dilata nel mondo per un secolo conquistando fedeli, vescovi, Papi. E tutto che inizia con tre pastorelli analfabeti - Jacinta, Francisco e Lúcia -e il racconto dell’ apparizione di una “signora vestita di bianco”: che il 13 maggio 1917 li invita a dire il rosario per i peccatori e la fine della guerra; il 13 giugno ripete l’invito ed esorta Lúcia a imparare a leggere; il 13 luglio torna a chiedere preghiere per la fine della guerra, promettendo un miracolo entro tre mesi e rivelando loro un “segreto”; il 13 agosto dice di usare le donazioni per il culto; il 13 settembre insiste sulla preghiera per la fine del conflitto e chiede una cappella a Fatima; il 13 ottobre - ultima apparizione, durante la quale si verifica un fenomeno solare (il miracolo promesso?) - rivela come richiesta della Madonna del Rosario preghiere e penitenze, garantendo un rapido rientro dei soldati a casa.
Fermandosi solo sulle relazioni coeve alle apparizioni del ‘17, con le risposte semplici dei tre bambini, considerando che la guerra cessò solo alla fine del ‘18, non è facile capire la devozione popolare concentratasi subito su Fatima.
 E forse ha ragione José Barreto nel suo saggio “I messaggi di Fatima tra anticomunismo, religiosità popolare e riconquista cattolica” pubblicato da poco su “Memoria e Ricerca” del Mulino, ad allargare lo sguardo anche alla cornice storica e socio-politica. Proviamo a seguirlo.
E forse ha ragione José Barreto nel suo saggio “I messaggi di Fatima tra anticomunismo, religiosità popolare e riconquista cattolica” pubblicato da poco su “Memoria e Ricerca” del Mulino, ad allargare lo sguardo anche alla cornice storica e socio-politica. Proviamo a seguirlo.«Con Fatima - scrive - si aprì un canale di comunicazione con il sovrannaturale in un periodo tormentato della storia contemporanea portoghese, iniziato con la rivoluzione repubblicana del 1910 durante il quale si era verificata la maggiore offensiva contro la Chiesa mai registrata nel Paese». Chiesa che nel precedente periodo del costituzionalismo monarchico (1834-1910), pur con il cattolicesimo come religione di Stato, aveva vissuto una situazione definita da Manuel Clemente «una gabbia e nemmeno dorata».
 È dunque un periodo particolare quello che vede la diffusione dei messaggi di Fatima: di guerra, e in Portogallo di guerra di religione. Con una imperante laicizzazione della società che vede scuole cattoliche chiuse, preti detenuti, beni ecclesiastici nazionalizzati, aule di culto e seminari trasformati in uffici pubblici, e vescovi importanti accusati di comportamenti contrari alle leggi e spediti in esilio persino durante le apparizioni del settembre e ottobre ’17.
È dunque un periodo particolare quello che vede la diffusione dei messaggi di Fatima: di guerra, e in Portogallo di guerra di religione. Con una imperante laicizzazione della società che vede scuole cattoliche chiuse, preti detenuti, beni ecclesiastici nazionalizzati, aule di culto e seminari trasformati in uffici pubblici, e vescovi importanti accusati di comportamenti contrari alle leggi e spediti in esilio persino durante le apparizioni del settembre e ottobre ’17.
 «Il tentativo di connotare politicamente Fatima era inevitabile, e iniziò immediatamente a partire dal 1917», ha scritto Barreto. Aggiungendo: «I repubblicani denunciarono lo sfruttamento della “superstizione” popolare da parte delle forze anti-repubblicane; quest’ultime interpretarono le apparizioni della Vergine come le precorritrici del “miracolo” dello schiacciamento della “serpe giacobina“ riferendosi al colpo di Stato del dicembre 1917 di Sidonio Pais che destituì i repubblicani radicali e instaurò un regime presidenzialista terminato nel dicembre successivo».
«Il tentativo di connotare politicamente Fatima era inevitabile, e iniziò immediatamente a partire dal 1917», ha scritto Barreto. Aggiungendo: «I repubblicani denunciarono lo sfruttamento della “superstizione” popolare da parte delle forze anti-repubblicane; quest’ultime interpretarono le apparizioni della Vergine come le precorritrici del “miracolo” dello schiacciamento della “serpe giacobina“ riferendosi al colpo di Stato del dicembre 1917 di Sidonio Pais che destituì i repubblicani radicali e instaurò un regime presidenzialista terminato nel dicembre successivo».Se si può convenire che, nella regione di Fatima, nei confronti dell’offensiva antireligiosa non ci fu allora una vigorosa resistenza cattolica, né ci fu un immediato consenso del clero sulle apparizioni, così come non è corretto indicare in quel periodo una correlazione tra apparizioni e militanza antirepubblicana, successivamente invece, la trasformazione di Fatima in una “Lourdes portoghese” finì per riflettere nei fatti un’opposizione allo spirito della repubblica atea e massonica. Senza dimenticare che le apparizioni potevano leggersi come un segno di salvezza per un Paese preda di angosce con le sue truppe in trincea a fianco dell’Intesa, preda di incertezze per la scarsità di beni primari e via dicendo.
Detto questo, restando sul fronte politico, è indubbio che è il golpe militare del dicembre ‘17 a riportare la riappacificazione tra il governo e la Chiesa e il riallacciamento delle relazioni diplomatiche con il Vaticano: che avranno pienezza con la dittatura militare (1926-1933) e larga parte dell’ Estado Novo (1933-1968 con Salazar e 1968-1974 con Caetano nel segno delle “tre F”: fado, futbol, Fatima. Ed è solo in questo arco cronologico che pare convincente l’affermarsi di una connotazione anche ideologica - in chiave anticomunista - dei messaggi mariani. Del resto l’ufficializzazione del culto di Fatima passò attraverso tutte le indagini canoniche avviate nel 1922 e concluse ben otto anni dopo con il riconoscimento formale del carattere sovrannaturale dei fatti, mentre in attesa del verdetto si registrarono un impegno del clero nella ricostruzione ufficiale della storia delle apparizioni, una vasta propaganda sulla stampa cattolica, visite importanti, e persino - dopo che Benedetto XV non si era mai pronunciato - la “indiretta approvazione” di Fatima da parte di Pio XI che nel 1929 benedice una statua della Vergine di Fatima arrivata dal Portogallo al Pontificio Collegio Portoghese di Roma. Lo stesso Pio XI di cui il cardinale Confalonieri che era stato suo segretario riportava questa frase a proposito di mistiche che gli inviavano lettere su lettere circa rivelazioni di Maria: «...Se ha qualcosa da farmi sapere, potrebbe dirlo a me».
Quando nel 1930 il vescovo di Leiria-Fatima Correia da Silva dichiara le apparizioni «degne di essere credute», morti Francisco e Jacinta, è Lúcia l’unica testimone di esse: entrata nel frattempo tra le Suore dorotee di Porto e inviata in Spagna, nel monastero di Tuy ha continuato ad avere visioni e locuzioni interiori (nel ’25 la richiesta di diffondere la «comunione dei cinque primi sabati» in riparazione dei peccati) e ha già steso la prima delle sei “Memorie” (1922, 1937, due nel 1941, 1989, 1993, edite in Italia dalla Queriniana con il titolo “Lucia racconta Fatima”, a cura di António Maria Martins) dedicate ai fatti della Cova da Iria e alle rivelazioni. Rivelazioni che, a ben vedere - una volta rese note - palesano intrecci con drammi del XX secolo: dalle guerre mondiali alla parabola della Russia sovietica.
Tra le istruzioni che alla fine del maggio ‘30 Lúcia afferma di aver ricevuto dal cielo - preceduta da un «se non mi sbaglio» - ecco la promessa divina di «porre fine alla persecuzione in Russia se il Santo Padre avesse, insieme a tutti i vescovi del mondo, compiuto un solenne e pubblico atto di riparazione e di consacrazione della Russia ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria». Sino a questo momento, fissato in una lettera al confessore, il gesuita José Bernardo Gonçalves, non si trova alcun riferimento pubblico o privato alla Russia e al comunismo, ma proprio nel febbraio precedente, peggiorate le condizioni di ortodossi e cattolici, congelate le trattative segrete che la Santa Sede aveva provato a tessere con i sovietici, Pio XI pubblicamente aveva chiesto a tutto il mondo cristiano una «crociata di preghiera per la Russia». In ogni caso, come ha osservato Barreto nel saggio citato, «le istruzioni celesti ricevute da Lúcia nel ‘30 non ottennero una grande attenzione dal vescovo di Leiria fino al ‘36, quando il Fronte Popolare prese il potere nella vicina Spagna». E proprio in quel periodo Lúcia accettò la proposta del suo confessore di insistere con il vescovo e il Vaticano sul tema della «consacrazione della Russia», pur rinnovando per scritto il timore di «essersi lasciata illudere dall’immaginazione», o da qualche «illusione diabolica»,come scrisse in due lettere del 18 maggio e 5 giugno 1936.
L’anno dopo, imperversando la guerra civile spagnola, il vescovo di Leiria mette a conoscenza Papa Ratti delle richieste celesti a Lúcia circa la «consacrazione della Russia ai Sacri Cuori di Gesù e Maria» da effettuarsi insieme a «tutti i vescovi del mondo cattolico», e l’approvazione papale della devozione dei «primi sabati», come condizioni per la fine della persecuzione religiosa in Russia.
 Nella lettera (riportata tra i Novos Documentos de Fátima editi dall’ Apostolado da Imprensa nel 1984), il vescovo ricordava a Pio XI come già nelle raccomandazioni che la Vergine di Fatima aveva fatto nel 1917 fosse chiaro «come Nostra Signora stesse preparando la lotta contro il comunismo», dal quale il Portogallo era stato sino ad allora preservato. Il Pontefice non risponde a questa richiesta (come non rispose ad una analoga richiesta di un’ altra veggente portoghese, Alexandrina da Costa, ai tempi screditata e poi beatificata da Giovanni Paolo II). «Quanto alla consacrazione della Russia al Cuore immacolato di Maria, non è stata fatta nel mese di maggio come lei si aspettava. Si farà certamente, ma non subito», così Lúcia il 15 giugno del ’40 a padre Gonçalves.
Nella lettera (riportata tra i Novos Documentos de Fátima editi dall’ Apostolado da Imprensa nel 1984), il vescovo ricordava a Pio XI come già nelle raccomandazioni che la Vergine di Fatima aveva fatto nel 1917 fosse chiaro «come Nostra Signora stesse preparando la lotta contro il comunismo», dal quale il Portogallo era stato sino ad allora preservato. Il Pontefice non risponde a questa richiesta (come non rispose ad una analoga richiesta di un’ altra veggente portoghese, Alexandrina da Costa, ai tempi screditata e poi beatificata da Giovanni Paolo II). «Quanto alla consacrazione della Russia al Cuore immacolato di Maria, non è stata fatta nel mese di maggio come lei si aspettava. Si farà certamente, ma non subito», così Lúcia il 15 giugno del ’40 a padre Gonçalves.Nel frattempo successore di Pio XI è Papa Pacelli. Obbedendo al vescovo di Leiria e di Gurza, Lúcia gli scrive nell’ottobre ’40 collocando per la prima volta la richiesta celeste di consacrazione della Russia nel 1917, come parte del segreto da lei custodito dal 13 luglio di quell’anno (lettera che sarà resa nota pubblicamente solo negli anni ’70).
 Nell’estate del ’41 mentre è in corso l’invasione dell’Urss da parte della Germania, il vescovo di Leiria ordina a Lúcia di redigere una nuova memoria sulla guerra e la Russia. E a questo testo - completato nell’ottobre ’41 - Lúcia affida la versione definitiva delle due prime parti del segreto (la terza parte, redatta nel ’44 e inviata a Roma nel ’57, sarebbe stata divulgata da Giovanni Paolo II nel 2000) che Pio XII rende pubbliche nel ’42, la visione di un pezzo di inferno («un grande mare di fuoco» con immersi «i demoni e le anime») e il messaggio della Vergine sulla consacrazione della Russia («se ascolterete le mie richieste, la Russia si convertirà e avrete pace; diversamente, diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo guerre e persecuzioni....»).
Nell’estate del ’41 mentre è in corso l’invasione dell’Urss da parte della Germania, il vescovo di Leiria ordina a Lúcia di redigere una nuova memoria sulla guerra e la Russia. E a questo testo - completato nell’ottobre ’41 - Lúcia affida la versione definitiva delle due prime parti del segreto (la terza parte, redatta nel ’44 e inviata a Roma nel ’57, sarebbe stata divulgata da Giovanni Paolo II nel 2000) che Pio XII rende pubbliche nel ’42, la visione di un pezzo di inferno («un grande mare di fuoco» con immersi «i demoni e le anime») e il messaggio della Vergine sulla consacrazione della Russia («se ascolterete le mie richieste, la Russia si convertirà e avrete pace; diversamente, diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo guerre e persecuzioni....»).Nel frattempo il testo del “segreto”, integro, per sunto, stralci, con riferimenti alla Russia alterati o tagliati, gira per il mondo. Ed è Pio XII che il 31 ottobre ‘42, data delle nozze d’argento delle apparizioni e della sua consacrazione episcopale, con un radiomessaggio consacra il «genere umano» al Cuore immacolato di Maria, invocata con il titolo di “Regina della pace” (come aveva fatto Benedetto XV). In questa preghiera il Papa si allontanava dalla richiesta precisa della Vergine, ma faceva allusioni alla devozione mariana dei russi «popoli separati dall’errore e la discordia», e alla loro auspicata ricongiunzione «all’unico gregge di Cristo, sotto un unico, vero pastore». Nello stesso testo anche però un riferimento all’intervento celeste grazie al quale la «nave dello stato portoghese «persasi «nella tormenta anti-cristiana e anti-nazionale» aveva ritrovato «il filo delle sue più belle tradizioni che la rendevano una nazione fedelissima» e persino un omaggio anche alla classe politica del cambiamento, definita «uno strumento della Provvidenza». Da non dimenticare che Paolo VI alla chiusura della terza sessione del Vaticano II avrebbe fatto riferimento a questa consacrazione del predecessore inviando con una missione la simbolica rosa d’oro al santuario della Madonna di Fatima.
Non solo. Come ha scritto sulla rivista “Jesus” Alberto Guasco: «Se una rivelazione ex post eventu è manna per critici e avversari, Pio XII mostra invece di prenderla sul serio». Eccolo così promuovere l’istituzione della festa del Cuore immacolato di Maria (1944), far incoronare la Madonna di Fatima regina del mondo (1946), ripetere la consacrazione in una lettera apostolica del 7 luglio 1952. A quella data Pio XII conosce anche la terza parte del segreto ricevuta in busta chiusa dal vescovo di Leiria, ma non ne ha ritenuto opportuna la divulgazione. A quella data le peregrinazioni dell’immagine di Fatima continuano in tutto il mondo e sulla “Piazza Bianca” del santuario si sono già viste scene come quella dell’ottobre 1951: con il noto predicatore americano Fulton Sheen, che davanti a 100mila pellegrini profetizza, come risultato delle preghiere dei milioni di fedeli lì affluiti, la trasformazione del simbolo del martello e della falce in una croce e una luna sotto i piedi dell’Immacolata.
Non tutti però manifestano in quel periodo entusiasmi così accesi. Anzi già dalla fine della guerra, Fatima occupa discussioni fra teologi, avviate da Edouard Dhanis, il gesuita belga che ne ha diviso la storia in due parti - una vecchia sulle testimonianze raccolte nel 1917, una nuova sul corpus originale integrato con i nuovi dati contenuti nelle “memorie”- scrivendo già nel ’44: «Siamo portati a credere che, nel corso degli anni, alcuni eventi esterni e certe esperienze spirituali di Lúcia abbiano arricchito il contenuto originale del segreto». Senza porre in causa la sincerità della veggente, Dhanis osservava che «il modo poco oggettivo in cui nel segreto erano state descritte le cause che avevano provocato la Guerra [mondiale] poteva solo essere spiegato dalla influenza che la Guerra civile spagnola aveva avuto sul pensiero di Lúcia». -In effetti, il segreto imputava alla Russia tutta la responsabilità per le guerre e le persecuzioni verso la Chiesa, seppure all’interno di una concezione non storica e apocalittica di questi flagelli come punizione divina per i peccati del mondo. Le tesi di Dhanis poi rettore della Pontificia Università Gregoriana, sarebbero state duramente dibattute negli ambienti vicini a Fatima costringendolo a toni più concilianti. Lui, membro sino alla morte della Commissione teologica internazionale, a fare da apripista per altri teologi come nel suo caso accusati dai tradizionalisti di essere «nemici di Fatima».
Accuse dalle quali non furono risparmiati Papi come Giovanni XXIII e Paolo VI, invitati più volte a rinnovare in modo completo la consacrazione e a divulgare l’ultima parte del segreto, non disposti in tempi di Ostpolitik e di Concilio, a lasciar passare interpretazioni del messaggio di Fatima ultraconservatrici, anti-ecumeniche, in un quadro rinnovato nel quale la Chiesa tesseva nuove relazioni ad Est, affievolendo le aspettative delle tesi legate all’«ultimo segreto di Fatima» che per molti si sarebbe riferito ad una grave crisi interna alla Chiesa causata dal Concilio. Il resto è noto: nel ‘59 e nel ‘65 Giovanni XXIII e Paolo VI lessero il segreto e decisero di non divulgarlo (facendo alimentare nuove speculazioni).
 Negli anni ’60 la questione coloniale segnò un divario tra Vaticano e governo portoghese già alle prese con una vera opposizione cattolica interna intensificatasi con l’inasprimento delle guerre in Africa e l’esilio forzato del vescovo di Porto nel 1959. Proprio quest’ultimo, Ferreira Gomes, rientrando nel ’70 dal suo esilio in Francia, fu il primo prelato portoghese a formulare aperte critiche nei confronti di Fatima (già da lui definita una «Lourdes reazionaria»), sottolineandone aspetti di «culto magico» e «religione utilitaristica». «Per i cattolici che in questo periodo combattevano il regime in Portogallo, Fatima ebbe un significato molto diverso, se non opposto, a quello che avrebbe avuto per la lotta di liberazione polacca degli ani ’80», ha notato Barreceto. Aggiungendo che: «L’episcopato portoghese, tra la crescente contestazione proveniente dalla Chiesa e le critiche cattoliche internazionali, riuscì, seppur tardivamente, a svincolarsi dal regime poco prima della rivoluzione dell’aprile 1974 che ne decretò la fine». Apparentemente incurante degli sconvolgimenti politici, il santuario di Fatima continuò ad accogliere folle di devoti. Anzi la forza della fede popolare protesse la Chiesa dal potere rivoluzionario del biennio ‘74-‘76.
Negli anni ’60 la questione coloniale segnò un divario tra Vaticano e governo portoghese già alle prese con una vera opposizione cattolica interna intensificatasi con l’inasprimento delle guerre in Africa e l’esilio forzato del vescovo di Porto nel 1959. Proprio quest’ultimo, Ferreira Gomes, rientrando nel ’70 dal suo esilio in Francia, fu il primo prelato portoghese a formulare aperte critiche nei confronti di Fatima (già da lui definita una «Lourdes reazionaria»), sottolineandone aspetti di «culto magico» e «religione utilitaristica». «Per i cattolici che in questo periodo combattevano il regime in Portogallo, Fatima ebbe un significato molto diverso, se non opposto, a quello che avrebbe avuto per la lotta di liberazione polacca degli ani ’80», ha notato Barreceto. Aggiungendo che: «L’episcopato portoghese, tra la crescente contestazione proveniente dalla Chiesa e le critiche cattoliche internazionali, riuscì, seppur tardivamente, a svincolarsi dal regime poco prima della rivoluzione dell’aprile 1974 che ne decretò la fine». Apparentemente incurante degli sconvolgimenti politici, il santuario di Fatima continuò ad accogliere folle di devoti. Anzi la forza della fede popolare protesse la Chiesa dal potere rivoluzionario del biennio ‘74-‘76.Morto Paolo VI e subito dopo Giovanni Paolo I, che da patriarca di Venezia aveva incontrato Lucìa, ecco Giovanni Paolo II: il “Papa di Fatima” nonché «protagonista della terza parte del segreto». Il Papa che a Fatima nel 1982 non esita a riconoscere che la Vergine gli ha salvato la vita, che ripete la consacrazione del mondo (13 maggio ‘82 e 25 marzo ‘84), che beatifica i due pastorelli che ora Francesco canonizza; che ha consentito la divulgazione del terzo segreto con tanto di “guida alla lettura” dell’allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, il cardinale Joseph Ratzinger. Sì, il futuro Benedetto XVI, che nel 1996 a Fatima, ricordò l’invito vero di Maria che «parla ai piccoli per mostrarci quanto è necessario sapere: cioè, prestare attenzione all’unico necessario: credere in Gesù Cristo» . Quanto al resto ci vengono in mente solo le parole di Paul Claudel che definì Fatima «un’esplosione traboccante del sovrannaturale in un mondo dominato dal materiale».
LEGGI ANCHE: Fatima, mistero e profezia del Novecento
LEGGI ANCHE: Il Terzo Segreto di Fatima: dati certi, dubbi e retroscena
* www.lastampa.it, 10.05.2017.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" --- Il mondo va incontro a qualcosa di peggio. Intervista a Leonard Boff (di Agustín Saiz e Paola Becco).13 maggio 2017, di Federico La Sala
TERZO MILLENNIO
Il mondo va incontro a qualcosa di peggio
LEONARD BOFF. Il fondatore della Teologia della liberazione fa un sentito appello di fronte all’imminente collasso sociale ed ambientale
Intervista
di Agustín Saiz e Paola Becco *
- Leonardo Boff, scrittore, filosofo, ecologista, ex sacerdote francescano messo a tacere dal Vaticano arrivato a Buenos Aires per presentare il suo ultimo libro “Sustentabilidad, la urgencia ante el grito de la Tierra”. L’ex sacerdote è autore di oltre 60 libri, ha conseguito un dottorato in Teologia e Filosofia presso l’Università di Monaco. E’ entrato nell’Ordine dei Frati Minori francescani nel 1959 poi è stato professore di Teologia e Spiritualità nelle università del Brasile e anche in Portogallo, Spagna, USA, Svizzera e Germania.
 Nel 1984, a causa del suo pensiero della Teologia della Liberazione esposto nel suo libro “Chiesa: Carisma e Potere”, fu processato dal Vaticano e condannato l’anno seguente ad un anno di “silenzio ossequioso”. Pena sospesa poi nel 1986 a seguito della forte pressione mondiale sul Vaticano che gli ha permesso di continuare le sue attività.
Nel 1984, a causa del suo pensiero della Teologia della Liberazione esposto nel suo libro “Chiesa: Carisma e Potere”, fu processato dal Vaticano e condannato l’anno seguente ad un anno di “silenzio ossequioso”. Pena sospesa poi nel 1986 a seguito della forte pressione mondiale sul Vaticano che gli ha permesso di continuare le sue attività.
 Nel 1992, in seguito ad un’altra possibile condanna del Vaticano Boff ha deciso di rinunciare alle sue attività sacerdotali e continuare ad essere teologo della liberazione, scrittore, professore dando conferenze in tutto il mondo.
Nel 1992, in seguito ad un’altra possibile condanna del Vaticano Boff ha deciso di rinunciare alle sue attività sacerdotali e continuare ad essere teologo della liberazione, scrittore, professore dando conferenze in tutto il mondo.
 Venerdì 5 maggio presso l’Hotel Bue, nella città di Buenos Aires, questo grande pensatore latinoamericano ha affrontato diversi temi sempre da un’ottica di grande sensibilità e impegno sociale.
Venerdì 5 maggio presso l’Hotel Bue, nella città di Buenos Aires, questo grande pensatore latinoamericano ha affrontato diversi temi sempre da un’ottica di grande sensibilità e impegno sociale.
Cosa pensa dell’avanzamento della destra? Recentemente in America latina si sono create le condizioni per aprire nuovi orizzonti ma difficilmente si sono poi concretizzate, quali sono gli errori commessi?
Credo che abbiamo vissuto due fasi, due epoche dopo i colpi militari. Prima la resurrezione delle democrazie e dei governi progressisti appoggiati da grandi movimenti popolari e questo ha permesso grandi trasformazioni positive che hanno promosso la giustizia sociale, la partecipazione, ecc. Poi però, con la crisi globale, che ha minato lo status di benessere dei paesi europei, si è spezzato questo avanzamento popolare e la logica dell’impero degli USA ci ha colpito. Poi nel 2007, 2008, quando il sistema capitalista entrò in crisi, fu lo Stato a salvare la situazione ma venne lasciato spazio all’ascesa della destra in tutto il mondo.
Questo insieme di cose, questa forma di pensiero, secondo me, a iniziato a farsi strada con la salita al potere di Reagan e della Thatcher, furono loro stessi ad affermare che la società non esisteva, in altre parole equivale a dire che esiste è l’individuo.
Ora c’è un’omogeneità dello spazio politico, economico, biologico. Non c’è più guerra fredda, non c’è contro-rivoluzione e tutti siamo, consapevoli o no, ci trovaimo a vivere secondo la logica del capitalismo. Si è dato il via ad un processo di capitalizzazione tremendamente vorace, individualista, si è creata la cultura del capitale: il consumismo.
Inoltre dobbiamo tenere in considerazione la strategia dell’impero. Ci sono studi molto dettagliati che sostengono che il Pentagono ha tre linee guida. La prima è: “un mondo un impero”, loro vogliono dominare tutto.
 Curiosamente il Papa, nella sua ultima enciclica ha detto invece “un mondo e un progetto collettivo”, che è ben diverso. Secondo: occupare ogni spazio, l’espressione equivalente in inglese è “full screen”, controllare tutti gli spazi (mediatici, fisici, personali ecc) e non lasciare nessuno libero. E terzo, in termini politici è destabilizzare tutti i governi progressisti di base popolare dell’America latina, senza utilizzare la forza militare, bensì il parlamento.
Curiosamente il Papa, nella sua ultima enciclica ha detto invece “un mondo e un progetto collettivo”, che è ben diverso. Secondo: occupare ogni spazio, l’espressione equivalente in inglese è “full screen”, controllare tutti gli spazi (mediatici, fisici, personali ecc) e non lasciare nessuno libero. E terzo, in termini politici è destabilizzare tutti i governi progressisti di base popolare dell’America latina, senza utilizzare la forza militare, bensì il parlamento.E’ curioso il fatto che la stessa ambasciatrice che organizzò il colpo di Stato in Honduras fu trasferita in Paraguay per mettere in atto un altro golpe e fu poi trasferita in Brasile così da provocare un ulteriore colpo di Stato.
Basti pensare che l’Atlantico Sud, dove ci sono i grandi giacimenti di gas e petrolio del Brasile e che si affaccia all’Africa, è uno spazio aperto. Ma siccome il sistema USA non accetta che un Paese abbia una politica sovrana con un proprio percorso. Gli Stati uniti hanno deciso di intervenire nell’Atlantico Sud con due intenzioni. La prima è quella di per occupare lo spazio fisico, mettendo la quarta flotta nordamericana, si pensi che solamente il portaerei ha più potere di fuoco che tutte le armi della seconda guerra mondiale.
La seconda intenzione è di dare una dimostrazione di forza alla Cina, dobbiamo pensare che la nuova guerra fredda non è tra la Russia e gli USA ma tra gli USA e la Cina. Quest’ultima, infatti, sta entrando in tutta l’America latina ed ora costruirà una ferrovia che va dall’Atlantico al Pacifico, 54.000 milioni di dollari, un progetto immenso per l’esportazione. Il fatto che investa anche in Argentina preoccupa molto gli Stati Uniti per cui per i governi che seguono la linea degli Stati Uniti è fondamentale frenare la Cina.
Questo gioco geopolitico complica l’analisi e il trovare la soluzione per i nostri problemi. Il problema in Argentina non si risolve solo a partire dall’Argentina, così come quello del Brasile. Bisogna considerare quella correlazione di forze. Ad esempio, i giacimenti di gas e petrolio delle coste oceaniche del Brasile sono tra i più grandi del mondo e vengono privatizzati. Il giacimento più grande è stato venduto al governo della Norvegia ad un prezzo irrisorio, fissando il prezzo di barile di petrolio all’equivalente di una coca-cola. Quello che costava 10 miliardi di dollari lo hanno venduto per 2 miliardi di dollari.
Credo che questo impedisca una reale applicazione della sovranità popolare, dove il cittadino sia partecipe alla vita politica e sociale. Se analizziamo quanto all’effetivo siano presenti i diritti umani e la giustizia nelle democrazie attuali, ci rendiamo conto che sono più che altro una farsa. Non sono vere democrazie. Sono sistemi mantenuti da oligarchie, dai grandi gruppi economici globalizzati che occupano il paese, e hanno quindi quella forza di imporre quel tipo di politica.
Dall’altra parte, ci sono diversi movimenti sociali che si stanno risvegliano perché sono stati depoliticizzati. Si stanno risvegliando e tornano a scendere in strada per manifestare, discutere e cercare di fare la resistenza. Questo sta crescendo enormemente in Brasile. All’ultimo sciopero di tre giorni fa ha aderito oltre un milione di persone, il fatto positivo è che più di 100 vescovi hanno convocato il popolo ad uscire in strada, questo è profetico!
Le persone che beneficiavano di borse di cibo, i poveri, stanno cadendo nella miseria. E sono milioni. Hanno sottomesso completamente il popolo, tutti i progetti sociali sono stati tagliati. E così ci sono milioni di persone che tornano nella miseria questo comporta un aumento della violenza terribile a Rio e nelle grandi città. Nascono vere e proprie guerre civili, urbane dove spesso scappa il morto o dove vengono bruciati autobus ed altri mezzi. E’ decisamente una situazione allarmante e preoccupante.
Come vede lo spostamento forzato dei popoli aborigeni che sta avvenendo in tutta l’America latina, a causa degli ‘agroaffari’ che espropriano le terre a queste persone con violenze continue, mentre i governi restano in silenzio. Qual’è la sua analisi?
In Brasile c’è un massacro sistematico di indigeni a causa degli ‘agrobusiness’ con la scusa che gli indigeni stanno "invadendo" le nostre terre, quando in realtà sono loro i legittimi proprietari. Una settimana fa hanno ucciso otto di loro, hanno tagliato loro le mani. Il governo centrale è illegittimo, tutti i ministri sono accusati di corruzione, e non intervengono. E l’‘agrobusiness’ sta dominando perché è quello che produce la ricchezza del paese, con l’esportazione di soia e carne. Una situazione drammatica.
D’altra parte, io che sto circolando per l’America Latina, mi preoccupo di trovare gruppi indigeni. Loro stanno recuperando le loro memorie, la loro dignità, le loro lingue, le loro religioni, nella consapevolezza che sono delle vere nazioni. Chi ha preso più sul serio la questione è stato Evo Morales che ha costruito un paese, con l’interazione di popoli indigeni. Qualcosa di nuovo che prima era disprezzato, considerato un elemento naturale come gli animali, non valorizzati come indigeni.
Emerge quindi un fenomeno nuovo e credo che in questo le chiese hanno svolto un ruolo importante, valorizzando le culture originarie, difendendo i loro diritti e le loro lingue ed accettando le loro religioni. Ora c’è dialogo tra le religioni. Lo stesso succede anche con le tradizioni afrobrasiliane, prima erano "riti", ora sono religioni. Non bisogna dimenticare che il 62% della popolazione brasiliana è nera, è il secondo paese più grande del mondo dopo il Kenya con popolazione nera. È un fenomeno abbastanza nuovo, e molti stanno riscattando le loro lingue attraverso scuole dove le reimparano, celebrano i loro riti, come i mapuche, i maya, gli inca.
Io ho partecipato a molte di queste celebrazioni e secondo me i maya sono i più creativi. E si vede che stanno cercando di recuperare i testi smarriti, stanno scoprendo sempre di più frammenti che ricostruiscono le loro tradizioni e questo è un fenomeno nuovo che bisogna appoggiare. Noi abbiamo un debito che non abbiamo mai pagato perché l’invasione iberica, europea, fu un genocidio. Quando Hernán Cortés arrivò dal Messico c’erano 20 milioni di abitanti, 70 anni dopo 1,7 milioni, morirono in guerra o per malattie.
Come vede il ruolo delle religioni al di là delle chiese, in questo scenario che ci sta descrivendo, dove ci sono oltre 40 situazioni di conflitto, il problema dell’ambiente, la violenza sociale, quale è il contributo delle religioni in questo momento?
Io credo che uno degli sforzi più importanti che il Papa sta facendo sia quello di articolare le chiese e i sentieri spirituali, per agire insieme a beneficio dell’umanità e specialmente dell’umanità più povera, più vulnerabile. Di tutti i viaggi che ha fatto, 80 sono stati in paesi non cristiani. Ed il Papa non accetta la tesi che la religione musulmana sia una religione violenta di guerra. Violento è il sistema di morte, dell’adorazione del capitalismo, dello sfruttamento della Terra, delle persone. Quello è il nemico della vita. Ed è quello che alimenta le guerre. Quindi, io credo che bisogna astrarre il fondamentalismo islamico che ha un aspetto di violenza che bisogna analizzare, che non proviene dalla religione ma dalla politica. Il Papa a Lampedusa disse una frase importante che bisogna ricordare: “Quei rifugiati sono qui perché prima noi siamo stati lì per 200 anni sfruttando le loro terre, le loro ricchezze, imponendo i nostri stili di vita, la nostra politica, la nostra religione, per questo motivo ora sono qui”.
Quindi dietro la violenza ed i gruppi radicali islamici, c’è molta delusione, molta rabbia, molta indignazione nel trattare con l’Occidente.
Io ho avuto l’opportunità di trattare con gli arabi, quelli al potere e dicevano: "Noi abbiamo il sangue del sistema che è il petrolio, ma nessuno ci invita a discutere le soluzioni del mondo", come se non esistessero, ma sono essenziali per il sistema. D’altra parte, io credo che le religioni stanno giocando un ruolo molto importante in termini di presa di coscienza della nostra responsabilità del futuro della Terra e dell’umanità.
Il Papa sta facendo questo, il consiglio mondiale delle chiese negli anni 70 proclamava giustizia, pace e protezione del Creato. Io credo sia importante che le religioni lavorino con un atteggiamento ecologico corretto, che è il rispetto verso la natura, il sentirsi parte della natura, e intenderla come creazione. Dopo tutto la missione dell’essere umano è anche di tutelare quelle leggi sacre.
- Leonardo Boff, scrittore, filosofo, ecologista, ex sacerdote francescano messo a tacere dal Vaticano arrivato a Buenos Aires per presentare il suo ultimo libro “Sustentabilidad, la urgencia ante el grito de la Tierra”. L’ex sacerdote è autore di oltre 60 libri, ha conseguito un dottorato in Teologia e Filosofia presso l’Università di Monaco. E’ entrato nell’Ordine dei Frati Minori francescani nel 1959 poi è stato professore di Teologia e Spiritualità nelle università del Brasile e anche in Portogallo, Spagna, USA, Svizzera e Germania.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- FRANCIA. La fascista non ha vinto. Ma il sonno della memoria produce mostri (di Paolo Flores d’Arcais).8 maggio 2017, di Federico La Sala
- PER LA PACE E PER IL DIALOGO, QUELLO VERO, PER "NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo")
 ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN.
ISRAELE E IL NODO ANCORA NON SCIOLTO DI ADOLF EICHMANN.
Francia
La fascista non ha vinto. Ma il sonno della memoria produce mostri
di Paolo Flores d’Arcais *
L’orrore è stato evitato, il candidato fascista non salirà i gradini dell’Eliseo. Un grande sospiro di sollievo dunque, ma da entusiasmarsi c’è poco. Se nel cuore storico della democrazia europea, la Francia di “liberté, égalité, fraternité” che deve la legittimità delle sue istituzioni ai sanculotti del 1789 e ai resistenti del maquis e del governo in esilio contro il tradimento di Vichy, il candidato di un partito intasato di negazionisti in nostalgia di Petain e di cattolici vandeani, prende un terzo dei consensi, sarebbe più serio mantenere un certo timore, oltre che qualche oncia di vergogna. E capire come sia stato possibile arrivare a tanto, andando alle radici per poter reagire. Prima che sia troppo tardi.
Perché è già molto tardi. Lo dice la noncuranza di massa (e anche di élite) che ha minimizzato o negato, in realtà rimosso, il carattere fascista del partito Fn, nella continuità tra Le Pen padre, figlia e nipotina Marion. E che ancor più lo farà, ora che “Marine la Patriota” cercherà di accreditarsi tale addirittura “rifondando” con nuovo nome e nuovi apporti il Fn.
Noncuranza che si lascia imbambolare da qualche frase ad effetto, belletto e botulino ideologici, e sarebbe il meno, ma che si radica soprattutto per affatturazione della sirena sociale e collasso dello spessore storico, massime nella generazioni più giovani. Circolano massicciamente posizioni del tipo “il nazi-fascismo - salvo frange minoritarie di nostalgiche macchiette - è un fenomeno del secolo scorso”, oggi esistono solo “destre sociali”, “il revisionismo storico è una posizione culturale, all’operaio che vede ridursi i suoi diritti non importa niente di cosa Le Pen pensi di Giulio Cesare”.
Destra sociale? I fascismi si sono sempre dichiarati sociali, dalla parte dei lavoratori e dei disoccupati. Hitler aveva chiamato il suo partito “nazional-socialista” (nazismo è la contrazione). Abbindolate le masse, hanno sistematicamente e regolarmente distrutto ogni organizzazione di lavoratori, intrecciato valzer e amorosi sensi con i più biechi poteri finanziari e industriali, distrutto ogni possibilità legale di lotta per i non privilegiati.
È evidente e sacrosanto che prima viene la pancia piena e poi la morale (citazioni di Brecht a bizzeffe, volendo), e che anzi il grande capitale e la grande finanza, quando messi alle strette, tra un’avanzata democratica di oppressi ed emarginati e la soluzione fascista hanno troppo spesso preferito quest’ultima. E allora? E’ un buon motivo per fare harakiri e immaginare che il DNA della Resistenza antifascista non sia più necessario? La pancia vuota che si lascia affatturare da un fascista resterà vuota, e non potrà neppure lottare, se non a rischio di carcere tortura e vita.
Ma ogni generazione sente il prepotente bisogno di ripetere gli errori delle generazioni precedenti. Anche Mussolini, e Hitler, e i loro scherani, a molte personalità e persone comuni dell’epoca apparivano delle “macchiette”: in pochi anni hanno ridotto l’Europa in macerie e fame.
Oggi queste consapevolezza storica minima si è perduta, e il sonno della memoria, come quello della ragione, produce mostri. Purtroppo, in Francia, come in Italia, come in Europa tutta, si sconta un peccato originale, non aver dato vita nel dopoguerra alla necessaria epurazione antifascista in tutti gli apparati dello Stato (ma anche nel giornalismo e nella cultura). Non aver realizzato quella damnatio memoriae tassativamente ineludibile, che non garantisce contro ritorni di fascismo (la pulsione di servitù volontaria possiede circuiti neuronal-ormonali più antichi e radicati di quelli illuministico-democratici, ahimè), ma ne riduce le probabilità per il possibile.
Invece, nei decenni, con lenta ma infine inesorabile crescita, si è tollerato che partiti e movimenti fascisti si ricostruissero, si legittimassero per partecipazione elettorale, divenissero per mitridatizzazione parte del panorama ordinario del nostro habitat politico e sociale.
È stata questa l’altra faccia di una politica di establishment che per guerra fredda prima e liberismo selvaggio poi ha impedito che venissero realizzate nelle leggi e nella pratica di governo le solenni promesse contenute nelle Costituzioni nate dalla vittoria contro i fascismi.
In Italia fu chiaro da quasi subito, purtroppo. Il 2 giugno 1951 Piero Calamandrei, che della Costituente era stato uno dei massimi protagonisti, già doveva stigmatizzare che mentre nella Costituzione “è scritta a chiare lettere la condanna dell’ordinamento sociale in cui viviamo”, la politica del governo andava in direzione opposta, e il vero nome della festa della Repubblica era perciò “La festa dell’Incompiuta”.
E rivolgendosi ai giovani nel 1955, a Milano, ribadiva: “La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma solo in parte. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere”. In Italia, come in Francia, come in Europa, siamo più che mai a questo, e la convinzione ormai dilagante che i fascismi siano lontani dal nostro orizzonte possibile quanto Giulio Cesare, fornisce ai reazionari e conservatori un’ulteriore arma di narcolessia di massa.
Macron non è la soluzione, a meno che da Presidente non diventi un Macron inedito, perché la finanza (e più in generale la politica economica) liberista è il motore della crisi sociale e della deriva politica che, per hybris di diseguaglianze, infesta e mina le democrazie. Rispetto ai lepenismi (in Europa si sono ormai moltiplicati sotto le più diverse e accattivanti fogge, ma sempre humus fascista veicolano), la vittoria di Macron potrebbe confermarsi solo il laccio emostatico che tampona l’emorragia in attesa dell’intervento chirurgico. Ora si tratta di realizzarne gli strumenti, quella sinistra illuminista egualitaria e libertaria oggi purtroppo introvabile in forma politica organizzata, ma diffusa in forma sommersa o carsica nelle società civili di molti paesi d’Europa.
- PER LA PACE E PER IL DIALOGO, QUELLO VERO, PER "NEGARE A HITLER LA VITTORIA POSTUMA" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo")
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- NEL NOME DI MOSE’. Ascoltare parole e approfondire (di Roberto Saviano)7 maggio 2017, di Federico La Sala
- «Superman è senza dubbio ebreo!». Oltre-uomo o..... Superuomo (Nietzsche)? Il lato inquietante di una storia. Una nota di Elena Loewenthal
Nel nome di Mosé
È un prete, vive in Svizzera e lo chiamano così. Ogni giorno divide le acque per i rifugiati. Salvando vite. E invitandoci a restare umani
- Padre Mussie Zerai
Ascoltare parole e approfondire. Non lasciarle macinare dal vortice. Nella trama delle parole scelte c’è l’interpretazione del mondo stesso. Quando il vicepresidente della Camera ha usato la parola “taxi” riferita alle imbarcazioni che salvano vite, ha descritto con una parola che sa di comodità una situazione di disperazione.
Poi ha cercato di recuperare distinguendo tra «ong buone e ong cattive». E poi la frase di rito, facile da dire e facile da applaudire: «Che la magistratura faccia il suo corso», pietra tombale su ogni ragionamento. Lo scopo è stato raggiunto e le ong diventano “complici” di malviventi difficilmente identificabili (un capro espiatorio serve e da qualche parte va trovato). Le espressioni da cui vengono accompagnate ormai sono: «improvvisamente proliferate», «finanziate da chi ha interesse a destabilizzare l’Europa» e a usarle è chi sa che non sono proliferate all’improvviso e che sono altri i fattori che destabilizzano l’Europa. Ad esempio la crisi economica, che non è scaturita dall’arrivo di migranti. Ma quanto è più facile dire: state male perché siete invasi, piuttosto che: continuate a stare male perché il nuovo che avanza è uguale al vecchio. Dietro le polemiche sulle ong nessuna volontà di fare chiarezza, ma solo razzismo, quello acchiappavoti e quello di chi ha completamente abdicato al ragionamento.
Vi racconto la storia di un uomo che dal 2003 salva vite. È un prete cattolico di origini eritree che oggi vive in Svizzera. Si chiama Mussie Zerai: Mosé lo chiamano i migranti, perché in qualche modo divide le acque per far arrivare i naufraghi sulla terraferma. Nel 2003 Gabriele Del Grande gli chiese di tradurre le testimonianze di alcuni rifugiati eritrei che erano in un centro di detenzione in Libia dopo aver tentato di migrare verso l’Europa.
Padre Zerai rimase scioccato dalle storie dei suoi connazionali che gli raccontarono la vita in quella prigione, tanto che prese l’impegno di denunciare la situazione e lasciò il suo numero di cellulare ai prigionieri. Nei giorni che seguirono quell’incontro iniziò a ricevere telefonate da migranti che erano in mezzo al mare, che chiedevano aiuto. Come era possibile che chiamassero lui? Semplice. Qualcuno aveva inciso il suo numero su una parete del carcere in Libia con sotto scritto: «In caso di emergenza chiamate questo numero». Lo aveva letto una donna, che se l’era trascritto sulle mani e dalle mani lo aveva trascritto sui legni di un barcone durante il suo viaggio dalla Libia verso Lampedusa.
I migranti, in genere, scrivono il numero dei familiari sui vestiti, in modo che si sappia a chi restituire la salma in caso finisse male, lei invece aveva scritto il numero di Padre Mosé, perché fosse visibile in caso di emergenza. Da quel giorno il cellulare di Padre Zerai non ha più smesso di squillare. A chiamarlo sono indifferentemente cattolici, musulmani, ortodossi, a cui è stato detto che Padre Zerai è capace di far comparire una scialuppa di salvataggio in mezzo al mare. Succede questo: quando le cose si mettono male in mare, chiamano padre Mosé e lui cerca di organizzarne il salvataggio, comunicando alla Guardia Costiera italiana più informazioni possibili per andare a prestare soccorso. Secondo le autorità italiane il cellulare di Padre Zerai ha permesso di salvare finora almeno 5 mila vita umane.
E poi c’è Nawal Soufi, chiamata la vedetta del Mediterraneo. Nawal Soufi è nata in Marocco, vive a Catania ed è diventata un punto di riferimento per chi fugge verso l’Italia. «Tutti hanno il mio numero, ne ho salvati a migliaia», dice. Il suo contatto passa tra chi fugge dalla guerra tentando l’approdo sulle coste europee. I profughi l’hanno soprannominata Lady SOS perché la chiamano dai barconi in difficoltà per dare le loro coordinate prima di affondare. E lei lancia l’allarme telefonando alla Guardia Costiera con un cellulare vecchio di 10 anni «perché almeno la batteria dura 4 giorni e posso essere sempre reperibile». Presta gratis questo servizio da oltre due anni ed è stata anche denunciata per aver facilitato l’immigrazione illegale (per la Bossi-Fini la solidarietà è un crimine). Nawal è in Italia da quando aveva un mese, studia Scienze Politiche e parla perfettamente italiano, la sua storia l’ha raccontata Daniele Bella nel libro “Nawal, l’angelo dei profughi”.
Immagino Padre Zerai e Nawal Soufi chiedere al telefono: «Mi scusi, non sarà mica uno scafista, perché nel caso sa che le dico, potete pure morire tutti».
Saviano: “Mosè per me era un amico immaginario, un alleato, un supereroe”
di Gisella Ruccia *
“Non ho mai visto Mosè come una una severa figura, la più importante dell’ebraismo, ma l’ho visto quasi come un alleato, una di quelle figure a cui parlare come un amico immaginario“. Sono le parole di Roberto Saviano ai microfoni di “Sorgente di vita”, il programma di Rai Due curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dedicato alla cultura ebraica.
Lo scrittore, che ha aperto quest’anno il Festival internazionale della letteratura e cultura ebraica di Roma, racconta il suo amore e la sua ammirazione per l’ebraismo. “La cultura ebraica non mi ha semplicemente attratto, ma formato” - afferma - “Gli scrittori ebrei mi hanno insegnato a non disperare, a cercare sempre una via d’uscita”.
E rivela: “I racconti biblici di mio nonno per me sono stati fondamentali. Quando ero bambino, Mosè era davvero un supereroe. Accanto a Batman, Superman, Spiderman, l’Uomo Tigre, c’era Mosè. Lui era il balbuziente che guida un intero popolo, sbaglia di continuo, viene punito sempre per il minimo errore”. Saviano aggiunge: “Ci penso spesso a Mosè e penso spesso a me bambino che guardava a Mosè come qualcuno che, anche se sbagliava, sapeva che poteva farcela e poteva farcela a trovare un senso alle cose”
di Gisella Ruccia
* The Huffington, 31 luglio 2013 (ripresa parziale - con video).
- «Superman è senza dubbio ebreo!». Oltre-uomo o..... Superuomo (Nietzsche)? Il lato inquietante di una storia. Una nota di Elena Loewenthal
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- ISRAELE, PALESTINA, E RESISTENZA. La perversione del senso del 25 aprile (di Moni Ovadia).23 aprile 2017, di Federico La Sala
La perversione del senso del 25 aprile
Polemiche. Le bandiere palestinesi al corteo? Un vulnus inaccettabile per il presidente della comunità ebraica romana Pacifici e per qualche ultrà del sionismo più isterico. Ma screditando le ragioni di chi lotta per una Palestina libera si sovverte il significato della Resistenza
di Moni Ovadia (il manifesto, 11.04.2015/23.04.2017)
Nel corso della mia vita e da che ho l’età della ragione, ho cercato di partecipare, anno dopo anno a ogni manifestazione del 25 aprile.
Un paio di anni fa, percorrendo il corteo alla ricerca della mia collocazione sotto le bandiere dell’Anpi, mi imbattei nel gruppo che rappresentava i combattenti della “brigata ebraica”, aggregata nel corso della seconda guerra mondiale alle truppe alleate del generale Alexander e impegnata nel conflitto contro le forze nazifasciste. Qualcuno dei componenti di quel drappello mi riconobbe e mi salutò cordialmente, ma uno di loro mi rivolse un invito sgradevole, mi disse: «Vieni qui con la tua gente». Io con un gesto gli feci capire che andavo più avanti a cercare le bandiere dell’Anpi che il 25 aprile è «la mia gente» perché io sono iscritto all’Anpi con il titolo di antifascista. Lui per tutta risposta mi apostrofò con queste parole: «Sì, sì, vai con i tuoi amici palestinesi».
Il tono sprezzante con cui pronunciò la parola palestinesi sottintendeva chiaramente «con i nemici del tuo popolo». Io gli risposi dandogli istintivamente del coglione e affrettai il passo lasciando che la sua risposta, sicuramente becera si disperdesse nell’allegro vociare dei manifestanti.
Questo episodio, apparentemente innocuo, mi fece scontrare con una realtà assai triste che si è insediata nelle comunità ebraiche.
I grandi valori universali dell’ebraismo sono stati progressivamente accantonati a favore di un nazionalismo israeliano acritico ed estremo. Un nazionalismo che identifica stato con governo.
Naturalmente non tutti gli ebrei delle comunità hanno imboccato questa deriva sciovinista, ma la parte maggioritaria, quella che alle elezioni conquista sempre il “governo” comunitario, fa dell’identificazione di ebrei e Israele il punto più qualificante del proprio programma al quale dedica la prevalenza delle sue energie.
Io ritengo inaccettabile questa ideologia nazionalista, in primis come essere umano perché il nazionalismo devasta il valore integro e universale della persona, poi come ebreo, perché nessun altro flagello ha provocato tanti lutti agli ebrei e alle minoranze in generale e da ultimo perché, come insegna il lascito morale di Vittorio Arrigoni, io non riconosco altra patria che non sia quella dei diseredati e dei giusti di tutta la terra.
L’ideologia nazionalista israeliana negli ultimi giorni ha fatto maturare uno dei suoi frutti tossici: la decisione presa dalla comunità ebraica di Roma, per il tramite del suo presidente Riccardo Pacifici, di non partecipare al corteo e alla manifestazione del prossimo 25 aprile. La ragione ufficiale è che nel corteo sfileranno bandiere palestinesi, vulnus inaccettabile per il presidente Pacifici, in quanto nel tempo della seconda guerra mondiale, il gran muftì di Gerusalemme Amin al Husseini, massima autorità religiosa sunnita in terra di Palestina fu alleato di Hitler, favorì la formazione di corpi paramilitari musulmani a fianco della Germania nazista e fu fiero oppositore dell’instaurazione di uno stato Ebraico nel territorio del mandato britannico. Mentre la brigata ebraica combatteva con gli alleati contro i nazifascisti. Tutto vero, ma il muftì nel 1948 venne destituito e arrestato: oggi vedendo una bandiera palestinese a chi viene in mente il gran muftì di allora? Praticamente a nessuno, se si eccettua qualche ultrà del sionismo più isterico o qualche fanatico modello Isis.
Oggi la bandiera palestinese parla a tutti i democratici di un popolo colonizzato, occupato, che subisce continue e incessanti vessazioni, che chiede di essere riconosciuto nella sua identità nazionale, che si batte per esistere contro la politica repressiva del governo di uno stato armato fino ai denti che lo opprime e gli nega i diritti più elementari ed essenziali. Un governo che lo umilia escogitando uno stillicidio di violenze psicologiche e fisiche e pseudo legali per rendere esausta e irrilevante la sua stessa esistenza.
Quella bandiera ha pieno diritto di sfilare il 25 aprile - com’è accaduto per decenni e senza polemica alcuna - e glielo garantisce il fatto di essere la bandiera di un popolo che chiede di essere riconosciuto, un popolo che lotta contro l’apartheid, contro l’oppressione, per liberarsi da un occupante, da una colonizzazione delle proprie legittime terre, legittime secondo la legalità internazionale, un popolo che vuole uscire di prigione o da una gabbia per garantire futuro ai propri figli e dignità alle proprie donne e ai propri vecchi, un popolo la cui gente muore combattendo armi alla mano contro i fanatici del sedicente Califfato islamico nel campo profughi di Yarmouk, nella martoriata Damasco.
E degli ebrei che si vogliono rappresentanti di quella brigata ebraica che combatté contro la barbarie nazifascista hanno problemi ad essere un corteo con quella bandiera? Allora siamo alla perversione del senso ultimo della Resistenza.
La verità è che quella del gran muftì di allora è solo un pretesto capzioso e strumentale. Il vero scopo del presidente Pacifici e di coloro che lo seguono - e addolora sapere che l’Aned condivide questa scelta -, è quello di servire pedissequamente la politica di Netanyahu, che consiste nello screditare chiunque sostenga le sacrosante rivendicazioni del popolo palestinese.
Per dare forza a questa propaganda è dunque necessario staccare la memoria della persecuzione antisemita dalle altre persecuzioni del nazifascismo e soprattutto dalla Resistenza espressa dalle forze della sinistra. È necessario discriminare fra vittima e vittima israelianizzando la Shoah e cortocircuitando la differenza fra ebreo d’Israele ed ebreo della Diaspora per proporre l’idea di un solo popolo non più tale per il suo legame libero e dialettico con la Torah, il Talmud e il pensiero ebraico, bensì un popolo tribalmente legato da una terra, da un governo e dalla forza militare.
Se come temo, questo è lo scopo ultimo dell’abbandono del fronte antifascista con il pretesto che accoglie la bandiera palestinese, la scelta non potrà che portare lacerazioni e sciagure, come è vocazione di ogni nazionalismo che non riconosce più il valore dell’altro, del tu, dello straniero come figura costitutiva dell’etica monoteista ma vede solo nemici da sottomettere con la forza.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- STORIOGRAFIA IN CRISI. LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!23 aprile 2017, di Federico La Sala
 MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ...
MITO E STORIA, POLITICA E TEOLOGIA: "LUCIFERO!" E LA STELLA DEL DESTINO. Storiografia in crisi d’identità ...
 RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- MAPPE MENTALI. CARTOGRAFARE IL PRESENTE.18 aprile 2017, di Federico La Sala
CARTOGRAFARE IL PRESENTE ....
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
-
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Mappe mentali
Arte, Rete e cartografia del mondo interiore
di ALEJANDRINA SOLARES *
- “L’universo è complesso? Tali saranno gli spazi di un edificio. Gli scienziati lavorano sulla teoria del caos? Le articolazioni saranno sghembe, oblique, frattali. Si orecchiano cambiamenti nelle discipline filosofiche? Immagini inquietanti materializzeranno l’assenza di punti di riferimento. Va di moda il pensiero debole o il poststrutturalismo? Si decostruiscono gli spazi come fossero concetti.”
 Silenziose avanguardie, Luigi Prestinenza Puglisi- Test&Immagine, Torino, 2001. Pag. 10.
Silenziose avanguardie, Luigi Prestinenza Puglisi- Test&Immagine, Torino, 2001. Pag. 10.
L’umanità prima ha percepito lo spazio e poi lo ha rappresentato. Ogni civiltà ha mostrato la volontà di rappresentare, almeno la parte del mondo nella quale ha svolto la propria storia.
Anche se siamo abituati alle carte geografiche fin da quando cominciamo ad andare a scuola e oggi la tecnologia con l’uso dei media informatici offre ad ogniuno di noi la possibilità di vedere con precisione tutto, anche il più piccolo pezzo di mondo e avere coordinate spazio-temporali precise grazie ai sistemi satellitari e al uso del web. Nonostante ciò ci troviamo nella dificolta di rapresentare il mondo contemporaneo. Nella complessa realtà attuale traspare il predominio del simulacro sulla realta, attualmente la carta geografica è sostituita da spazio e tempo - di fatto confondiamo la carta con il territorio.
Una pretesa illuminista era quella di ridurre la complessità del mondo a una mappa e tutt’ora fatichiamo a scrollarci questa illusione. La mappa perfetta non esiste, perché in realtà non esiste un punto di vista assoluto su cui centrare la mappa, nella sfera terrestre non vi sono limiti né di spazio né di tempo. Il fenomeno della globalizzazione ha accentuato la difficoltà, oggi un pensiero nuovo come quello della Rete offre una inedita chiave di lettura, creando connessioni tra i diversi livelli di realtà.
Il pensiero della “Rete” fatto di connessioni è uno strumento di lettura e interpretazione del mondo, veicola la produzione di una cartografia di spazi físici e mentali in cui ogni osservazione genera una nuova esperienza dello sguardo, una esplorazione che porta ad scoprire luoghi sconosciuti o individuare nuove caratteristiche di un luogo già noto. Un’estensione della “mappa del mondo interiore”, segni e tracie rendono conto che la nostra visione non è una semplice immagine di ciò che si trova fuori di noi, ma viene determinata anche dal nostro “mondo interiore”, dai processi mentali ed emozionali attraverso i quali osserviamo e costruiamo il reale.
Aspetti simili al pensiero della “Rete” lo troviamo nelle “mind maps”, sviluppate negli anni sessanta da Tony Buzan, “le mappe mentali” sono una tecnica dove le parole-chiave si irradiano dal centro alla periferia attraverso una struttura radiale e una logica associazionistica. Queste mappe servono ad organizzare graficamente il proprio pensiero per elaborare nuove idee, creare connessioni tra argomenti diversi, prendere appunti, realizzare report e brainstorming.
Le mappe mentali si basano sulla capacità della mente umana di associare idee e pensieri in maniera non lineare, in queste mappe si crea una geografia personale che si sviluppa in uno spazio multidimensionale, molto simile a quello della rete. Nelle mappe mentali come nelle mappe immaginarie, i pensieri e le emozioni sono rappresentati geograficamente attraverso il movimento nello spazio.
Nella storia molti artisti hanno sovvertito il linguaggio della mappatura: come nel mappa mondo dei surrealisti; nelle mappe mentali, di Lewis Carroll ad Erik Beltran; nei diversi concetti di spazio, in lavori che sono una reazione contestazione-critica al potere come nelle cartografie di: Allighiero Boetti, Thomas Hirschhorn, Francis Alÿs e Marcel Broodthaers. Nelle cartografie corporee di Yves Klein e di Ana Mendieta. Sono in molti gli artisti che hanno indagato aspetti legati alla cartografia come: Richard Hamilton, Mona Hatoum, Saul Steinberg, Damien Hirst, Gilbert & George, Guy Debord, Richard Long, Louise Bourgeois, Matthew Barney, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Matthew Barney, Yoko Ono, Giovanni Anselmo, Christian Boltanski, Anish Kapoor, El Lissitzky, Félix González-Torres, Robert Smithson, On Kawara, William Kentridge, Paul Klee, Gordon Matta-Clark, Hiroshi Sugimoto, Adolf Wölfli, Gerhard Richter, Ed Ruscha, Carolee Schneemann; solo per citarne alcuni.
Nella storia sono state create opere dove l’arte e la cartografia si sono più volte incontrate, dando vita ad ibridazioni e mutamenti della visione. Nel passato pittore e cartografo potevano coincidere ma ora si sono aggiunti parametri scientifici rilevanti: tutto è misurato. In occidente abbiamo riconosciuto il sistema di Tolomeo come l’unico sistema scientificamente valido di trasferire il globo terrestre su un piano, anche se ci sono degli errori, altri popoli avevano adottato altri sistemi.
Di seguito accenno ad alcune opere nate da suggestione cartografica:
Le Mappe Canistris sono un’eccezione della cartografia dell’inizio del Trecento. Opicinus De Canitris era un prete italiano, che proiettava il proprio mondo interiore attraverso la realizzazione di carte geografiche, sulla carta disegnava personaggi appartenenti alla sua vita immaginativa. La serie di mappe s’ispiro a carte nautiche medievali anche se lo scopo di queste mappe era ovviamente non geografica o di navigazione, ma semplicemente un affascinante mezzo per il trasporto di un insieme di idee. Le mappe Canistris sono fantasiose prospettive antropomorfe di geografia, cartografia e religione, Canitris crea uno stile che sarebbe diventato una forma popolare di critica sociale e politica nei XXVII e IXX secolo.
Una mappa che cambiò corso alla cartografia immaginaria e divenne un punto di riferimento è la “Mappa del paese della Tenerezza”, (Carte du Pays de la Tendre) creata da Madaleine de Scudèry e incisa da François Chauveau (1654). Questa è una mappa immaginaria dove è disegnato un percorso emozionale ma come un paesaggio, Questa mappa è anche la visualizzazione intima dello spazio interiore di una donna che assume una forma di topografia, va vista quindi anche come una rappresentazione del corpo che allude all’organo femminile, il paesaggio assomiglia ad un utero e attraverso i fiumi e i mari suggerisce il viaggio dei liquidi corporei femminili.
 La mappatura di Madaleine è un racconto che viene identificato geograficamente, il punto di partenza del viaggio è in basso a destra dove quattro figure sostano accanto a grandi alberi. Lungo il tragitto si possono scegliere diversi itinerari, che sono la rappresentazione spaziale degli stadi dell’amore. Questa mappa divenne un punto di riferimento per la “nuova mappatura delle emozioni”, creando un vero e proprio genere.
La mappatura di Madaleine è un racconto che viene identificato geograficamente, il punto di partenza del viaggio è in basso a destra dove quattro figure sostano accanto a grandi alberi. Lungo il tragitto si possono scegliere diversi itinerari, che sono la rappresentazione spaziale degli stadi dell’amore. Questa mappa divenne un punto di riferimento per la “nuova mappatura delle emozioni”, creando un vero e proprio genere.Una carta che esplora i territori del sentire e il tempo fu pubblicata nel 1777. La mappa immaginaria disegnata da Johann Gottlob Immanuel Breitkopf ( Das Reich der Liebe) L’impero dell’Amore, era accompagnarla con un breve testo esplicativo. La mappa rappresenta il percorso possibile dei giovani che partono dalla Terra della Giovinezza, dove si trovano le sorgenti dei fiumi Gioia e Desiderio, per affacciarsi all’età adulta in cui vivranno in uno dei sei paesi rappresentati e descritti (Terra del Risposo, Terra dell’Amore Luttuoso con il deserto della malinconia e il fiume di lacrime, Terra della Perdizione-desiderio al di là si trova la terra di nessuno che contiene le città di separazione e odio, Terra dell’Amore Felice, Terra dell’Apprendimento, Terra delle Ossessioni).
Dieci anni dopo, nel 1787 l’intellettuale francese Luigi Lagrange, da la definizione di carta geografica: è una rappresentazione ridotta, approssimata e simbolica della superficie terrestre o di una parte di essa. Più tardi con le fondamentale coordinate di distanza dall’equatore e dal meridiano, venne danno il sistema di lettura di tutte le carte.
Nel 1917 l’artista russo Kasimir Malevic scrive a Matjusin:
- “Mi sono visto nello spazio, nascosto tra punti e fasce colorate; là, tra di essi, sprofondo nell’abisso. Quest’estate mi sono proclamato presidente dello spazio.”
Nell’Opuscolo “suprematista” (1920), Malevic parla di voli interplanetari e di satelliti orbitali sui quali potrà vivere l’umanità. Malevic realizza una serie di disegni (planimetrie) i Planiti e una serie di plastici gli Architectonen si tratta di progetti per architetture immaginarie di abitazioni ed edifici collocati in sospensione nell’aria, atte ad ospitare l’uomo nello spazio. Queste opere sono una testimonianza di una precoce preoccupazione per una umanità sospesa nello spazio, una bella sintesi di fantasia, poesia, fiducia nel futuro e preveggenza sulle possibili applicazioni tecnologiche.
L’arte dalla fine degli anni Sessanta presenta un ampio spettro di trasmutazioni del segno, le idee si evolvono, si ibridano, le forme “mutano”.
Mona Hatoum, “Hot Spot III 2009”. L’opera è un globo in acciaio composto come una griglia, sono riprodotti i continenti, il globo presenta una inclinazione simile all’angolo della Terra, ha la dimensione circa di una persona che ha le braccia tese. I continenti sulla sua superficie sono descritti in neon rosso, la scelta cromatica può suggerire un riferimento ai pericoli del riscaldamento globale ma anche che il mondo intero è un hot-spot politico coinvolto in conflitti e disordini.
Artisti, scrittori, architetti, cineasti e scienziati, esplorano la visione percezione della realtà - paesaggio che gli circonda, si delinea una “cartografia alternativa” che si colloca tra sogni o mondi immaginari, visioni parallele della realtà e stratigrafie del quotidiano.
La cartografía elaborata dagli artisti del ventessimo e ventunesimo secolo pone delle domande sul sistema di rapresentazione. Si pone come un basto campo d’indagine, dal quale nascono “approfondimenti artistici cartografici” che affrontano temi quali: il corpo come strumento di percezione del mondo, lo spazio mentale (dal pensiero ai sogni), lo spazio fisico (ma anche politico, economico, militante), dando vita ad opere realizzate con moltissime tecniche come: il disegno, la realizzazione di teche tridimensionali, il collage fotografico e non, la danza, il video, la scultura, ecc. In altre occasioni la produzione artistica ha indagato e visualizzato sistemi di orientamento nello spazio “oggettivi”, utilizzando come “materiale d’arte” le cartine geografiche di antica e recente data, i sistemi di geolocalizzazione attuali, tutti materiali cartografici, misurabili e comparabili che entrano a far parte delle opere.
Quindi mappa non solo come rappresentazione geografica dello spazio, ma anche come strategia di rappresentazione soggettiva di noi stessi in specifici luoghi, partendo dal nostro situarci nel mondo. Ogni uno di noi possiede un personale approccio al mondo, che incrocia la geografia fisica a quella interiore, che determina il modo in cui ci interroghiamo sul come attraversiamo il nostro spazio.
Fin dalla nascita tutti noi possediamo “carte mentali” perché tutti abbiamo delle rappresentazioni mentali dello spazio, in realtà esiste in ogni persona un paesaggio interiore (come fu definito da Eugenio Montale). Ora questo paesaggio “interiore” è un’immagine indelebile che si è creata dentro di noi, che non deve coincidere necessariamente con “quel luogo” in cui si è nati o si è vissuti ma ovunque ci troveremmo scriveremo o parleremmo sempre della stessa piazza, strada e casa che costituiscono quel paesaggio intimo.
Le cartografie sono state, e sono ancora, ampiamente usate perché sono il modo con cui l’uomo illustra il proprio posizionamento nel mondo in un rapporto tra reale-virtuale, per farlo tiene conto dell’esperienza di vita e delle relazioni con gli altri nel tempo. Creare una mappa è un’esplorazione interiore, un racconto di un viaggio che si concretizza nei ricordi e nei racconti intimi, mettendoci in contatto con i mondi interiori e i paesaggi mentali. La pratica artistica di “Cartografare il presente” è uno dei modi per interpretare la complessità del mondo contemporaneo e un mezzo per l’artista di comunicare il proprio punto di vista su di esso. Una mappa può rappresentare qualsiasi cosa.
Infondo, la mappa è un insieme astratto di segni grafici che non trovano corrispettivo nel mondo reale.
*
Solares Alejandrina è un’artista che esplora e analizza un tema profondo e unitario: le forme che la vita assume nel suo dilatarsi e organizzarsi attraverso argomenti quali la sofferenza umana, il dolore fisico e la precarietà della vita. Tra i suoi obiettivi: lo studio di aspetti del quotidiano che normalmente sono trascurati o percepiti solo in parte. Profilo completo.
* http://wsimag.com/it/arte/10546-mappe-mentali (ripresa parziale, senza immagini).
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - SIRIA. La logica dello schieramento (di Marcello Flores)13 aprile 2017, di Federico La Sala
La logica dello schieramentodi Marcello Flores (Il Mulino, 13 aprile 2017)
L’attacco con il gas (presumibilmente il sarin) a Khan Sheikhoun, in Siria, il 4 aprile scorso e il lancio di missili ordinato da Trump qualche giorno dopo hanno suscitato molti commenti ma poche analisi, spingendo la nostra opinione pubblica, già predisposta a questa tentazione, a lasciarsi andare a una logica di schieramento, che nei social media ha visto il pianto accorato per la sorte dei bambini colpiti ma anche, subito dopo e spesso dalle stesse persone, l’indignazione per l’azione neoimperialista del presidente americano.
A oggi ancora non è chiara la dinamica dell’attacco che ha provocato oltre 80 vittime. Sono previste inchieste (la più importante da parte della Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) che lo stesso Putin richiede adesso con insistenza. Ma affinché qualsiasi indagine porti a qualche risultato occorre che la Siria collabori, cosa che al momento sembra improbabile. La presenza del sarin sembra al momento essere confermata dalle testimonianze dei medici presenti e dai risultati dei primi test autoptici compiuti in Turchia sotto il controllo dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Tutti gli esperti in armi chimiche concordano sul fatto che i ribelli siriani, quelli che secondo Assad e Mosca avevano nascosto il gas in un magazzino colpito casualmente dai bombardamenti degli aerei governativi, non dispongano delle minime capacità tecniche di stivare e controllare un gas pericoloso e difficile da maneggiare come il sarin. Una constatazione che vale un po’ di più, probabilmente, della valutazione che Assad non aveva alcun interesse, nel momento in cui sta vincendo, a utilizzare un’arma che aveva giurato essere stata distrutta.
La logica dell’uso delle armi chimiche, da quando sono state usate, è quella di terrorizzare la popolazione, per costringerla a fuggire o comunque per indebolirne fortemente le capacità di reazione. Che questo fosse l’obiettivo di Assad nel bombardamento di Khan Sheikhoun è testimoniato in modo abbastanza chiaro dall’attacco che, qualche giorno dopo e proprio sull’onda delle polemiche su chi fosse il responsabile del lancio del sarin, lo stesso Assad ha lanciato a Saraqeb, a pochi chilometri di distanza dal bombardamento chimico. In questo caso sono state lanciate bombe incendiarie di fabbricazione russa che sono proibite dal terzo protocollo della Convenzione sulle armi convenzionali, che la Siria non ha firmato ma la Russia sì, e i suoi aerei hanno partecipato all’attacco rendendo oggettivamente corresponsabile anche il governo di Putin.
A fronte della necessaria e legittima attesa dei risultati delle inchieste, non ci si può, tuttavia, nascondere dietro la convinzione fideistica che Assad aveva distrutto del tutto il suo armamentario chimico e che lui e Putin non avevano alcun interesse a montare, in questo momento di parziale vittoria sul terreno militare, un “caso” del genere. Al momento sono prevalenti le possibilità che il sarin sia stato sganciato volutamente dagli aerei di Assad e che Putin ne sia stato preventivamente informato.
Il secondo grande interrogativo su cui si è dibattuto riguarda la reazione militare di Trump, considerata, almeno in Italia, una legittima risposta momentanea al crimine commesso (questa la posizione del governo, ad esempio) o, nella gran parte delle risposte del “popolo di sinistra”, un pericoloso intervento che non farà che compiere una escalation disastrosa alla violenza in quella regione.
Vale la pena, prima di rispondere in modo automatico e non riflessivo sulla base di principi generali e di valutazioni che riguardano la figura di Trump, considerare, per esempio - nessuno in Italia ne ha parlato - le reazioni che hanno manifestato uomini e donne che sono state vicinissime a Obama nel momento in cui, nel 2013, minacciò l’intervento se Assad avesse superato “la linea rossa” dell’uso delle armi chimiche, salvo poi decidere successivamente di credere a un accordo per la distruzione completa di quelle armi grazie alla mediazione della Russia di Putin. Michael McFaul, che era all’epoca ambasciatore di Obama in Russia, ha ricordato il pericolo di “fare accordi” con i dittatori; Anne-Marie Slaughter, figura di spicco del Dipartimento di Stato di Obama, ha twittato che Trump aveva fatto la cosa giusta: “Finalmente! Dopo anni di inutili strette di mano di fronte a orrende atrocità”.
Certamente i motivi che hanno spinto Trump sono stati prevalentemente di ordine interno, e l’azione non risulta inserita in una chiara strategia, di cui probabilmente lui stesso non conosce il seguito, le possibilità, i risultati. La sua azione, tuttavia, ha posto il mondo intero di fronte alla domanda cui non si è riusciti a dare il minimo tentativo di risposta in tutti gli anni della mattanza di Assad, che ha ormai raggiunto la cifra del mezzo milione di vittime e di parecchi milioni di profughi e rifugiati: cosa fare per fermare non già una guerra locale più o meno circoscritta, ma ripetuti e diffusi crimini contro l’umanità e tentativi di genocidio? Bisognerebbe cogliere l’occasione della risposta di Trump per tentare di rispondere a questo quesito, invece di allontanarlo ancora sulla base di una condanna scontata quanto inutile del suo comportamento.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- RIPENSARE L’"AMERICA"!!! Destino manifesto - come schivarlo forse (di Franco Berardi Bifo)26 marzo 2017, di Federico La Sala
- LA STATUA DELLA LIBERTA’ DEGLI U.S.A. - CON LA SPADA SGUAINATA: "GUAI AI VINTI"!!! LA LEZIONE DI FRANZ KAFKA, IL MAESTRO DELLA LEGGE: RIPENSARE L’AMERICA. E il sogno del "nuovo mondo"!!!
Destino manifesto (come schivarlo forse)
di Franco Berardi Bifo *
Viaggiando verso il Canada dove in questi giorni, all’università di London Ontario, si tiene un convegno sul pensiero italiano, mi sono fermato a New York, e ho passato una settimana in un albergo sulla Bowery nella zona in cui trentacinque anni fa vissi un periodo eccitante.
In questi pochi giorni ho avuto l’impressione che l’America sia prossima al collasso nervoso. E questa non è una buona notizia visto che si tratta pur sempre della più grande potenza militare (nucleare per la precisione) di tutti i tempi.
New York è una città santuario, come molte altre nel paese: istituzioni locali, scuole, musei hanno dichiarato che intendono sottrarsi agli ordini di deportazione e di violenza: questo determina una situazione di doppio potere, ovvero di guerra civile potenziale.
Sono andato a visitare il New Museum che sta sulla Bowery e non esisteva quando ci abitavo. C’è una mostra di Raymond Pettibon, un artista nato a Tucson nel 1957 che dagli anni ’70 disegna con un gusto rabbioso tardo-hippy che mi ha fatto venire in mente la rivista italiana Cannibale, e particolarmente i fumetti di Filippo Scozzari. Nella mostra sono esposte sue opere che dai suoi esordi vanno fino ai primi anni del nuovo secolo, quelli della guerra irachena.
abu ghraib1Molte delle opere di Pettibon raffigurano scene che abbiamo visto nelle fotoface della prigione di Abou Ghraib nel 2004: gruppi di soldati nudi e sghignazzanti che circondano un prigioniero e gli ficcano il cazzo da qualche parte, ripugnanti facce di George Bush e così via.
La mostra, intitolata A Pen of All Work e curata da Gary Carrion-Murayari e Massimiliano Gioni, occupa tre dei cinque piani del museo e contiene circa ottocento disegni o dipinti oltre a diverse fanzine auto-prodotte negli anni del punk. La dissoluzione della retorica idealista e ottimista dell’America sconciamente puritana oggi ha un significato particolare e fa un effetto agghiacciante, mentre il fascismo americano oggi si dispiega in tutta la sua spaventosa aggressività.
Non sapevo che le cifre fossero già così enormi. 34.000 persone al giorno sono deportate alla frontiera e sbattute fuori dal paese nel quale vivono magari da venti anni. Me lo dice un’insegnante all’assemblea che si tiene a Topos domenica pomeriggio. Topos è una libreria alla periferia estrema tra Brooklyn e Queens, in un quartiere abitato da albanesi e portoricani. Un gruppo di compagni hanno affittato uno spazio che sta sulla strada. Sono le quattro del pomeriggio quando entro nella libreria: dai due finestroni entra la luce di un sole allegro di inizio primavera e c’è gente seduta che beve il caffè leggendo un libro. Sulla parete c’è una foto di David Bowie accanto a una foto di Totò. Non posso crederci: Totò in America? Ma certo mi dice uno, non è forse l’attore di un film di Pasolini che si chiama Uccellacci e Uccellini?
Poi ci trasferiamo nella sala accanto dove comincia ad arrivare gente. C’è una trentina di persone sedute intorno al tavolo in uno stanzone spoglio, sullo scaffale ci sono libri sulle culture indigene del nord e sud America. Insegnanti, lavoratori precari, molti immigrati di vario colore ed estrazione. La discussione riguarda in primo luogo il concetto di “sanctuary”. Santuario è un’istituzione o un organismo sociale di base o un’organizzazione non governativa che si propongono di proteggere le persone esposte alla violenza trumpista. Il giorno prima un’amica libanese mi aveva detto che sua figlia (13 anni) è depressa e piange spesso e non riesce a dormire. Una coppia di amici palestinesi non ha potuto venire alla riunione: sono dovuti andare a trovare la sorella di lei, perché il nipote di nove anni nelle ultime settimane ha continui attacchi di panico. L’odio della minoranza razzista che governa il paese filtra in ogni luogo, in ogni momento del giorno e della notte.
Prendo la parola per chiedere cosa potrà accadere se a un certo punto il governo centrale decide di attaccare qualche santuario. Si apre quindi una breve discussione sulla questione della violenza. Ci si deve preparare a reagire, a difendersi con le armi? Fin da quando ero ragazzo mi hanno insegnato che quando si tratta di difendersi dal fascismo l’uso della violenza armata è non solo legittimo ma necessario, e che a questo occorre prepararsi. Ma non sono tanto sicuro che questa lezione valga ancora, se non altro per il fatto che in questo paese le armi sono nelle mani dei bianchi elettori di Trump. Qualche mese prima delle elezioni disse che se il governo democratico avesse legiferato contro il diritto di comprare armi, il popolo del secondo emendamento avrebbe risposto con le armi.
La guerra civile non è una lontana possibilità nella realtà degli Stati Uniti di oggi. Tecnicamente il paese si trova già in condizione di doppio potere: interi settori dell’apparato statale (non solo le città santuario ma anche parti dell’FBI e dell’esercito) sono in rotta di collisione con il governo trumpista. Quanto alla violenza armata contro le minoranze, questo paese è in guerra da sempre.
Ora parla un ragazzo che si auto-definisce ex-black bloc. È un black bloc spiritoso che sostiene una tesi interessante. Le azioni del black bloc, lui dice, non sono intese a fare violenza, ma a colpire simbolicamente l’immaginazione collettiva, a isolare il potere e terrorizzare i suoi strumenti armati. Interessante tesi, gli dico, ma allora forse bisogna cominciare a ragionare in modo scientifico sulle modalità dell’azione simbolica evitando il pericolo di essere massacrati e anche quella di far del male a qualcuno.
Poi interviene un ragazzo che attacca il partito democratico, e la sinistra in generale, dicendo che Trump ha vinto grazie alla prepotenza del clan Clinton al servizio del potere finanziario. Gli dico che anche l’ascesa del nazionalismo in Europa è conseguenza del sistematico tradimento della sinistra che negli ultimi trent’anni si è messa al servizio della classe finanziaria facendosi strumento delle politiche neo-liberiste.
Poi sono dovuto partire per Toronto. Vado all’aeroporto JFK, aspetto in mezzo a una folla di poveracci che non viaggiano certo per turismo: vanno a trovare le famiglie lontane, vanno a lavorare da qualche parte. Saliamo sull’aereo dell’American Airlines, un aereo malandato che mi pare un Antonov degli ultimi anni sovietici. Si rolla sulla pista per mezz’ora poi si ritorna indietro. Scusate tanto problemi tecnici aspettiamo di ripartire. Finalmente si risale sullo sgangherato aereo, si rolla ancora un po’ poi si torna indietro. Il volo è cancellato, folla inferocita. Le impiegate hanno l’aria nervosa. Faccio la fila per sentirmi dire che parto domattina con un’altra compagnia. Air Canada. Penso che qualcuno mi pagherà l’albergo per la notte, come usa nei paesi civili, invece no.
Le impiegate di American Airlines mi mandano a Air Canada, quelli di Air Canada mi rimandano da American Airlines, mica siamo noi che abbiamo cancellato il volo. Ma American Airlines mi dicono non se ne parla: la cancellazione non è colpa loro ma è dovuta a problemi di traffic congestion.
Mi pagherò il fetido albergo per la notte, e mi sembra che le infrastrutture del paese siano messe veramente male: traffic congestion significa collasso circolatorio della mobilità. E mi sembra che tutti siano estremamente nervosi, rabbiosi, depressi. Sentimento di essere in trappola in una vita di merda, correndo avanti e indietro con quei ripugnanti bicchieri di plastica in cui questi poveretti che della vita non sanno niente bevono il loro schifoso caffè.
La mattina dopo parto per il Canada, e mi viene da pensare: finalmente la civiltà. Ma qui c’è poco da fare gli spiritosi, il paese del super controllo e della tecnologia pervasiva sta evidentemente sprofondando nel caos. Il caos è la nemesi della pretesa di perfetta sottomissione di un’umanità impoverita psichicamente oltre che socialmente. Avete visto Nebraska, lo struggente film in bianco e nero di Alexander Paine? Nella cittadina di Billings, Montana, il vecchio Woody Grant vuole andare in Nebraska per ritirare un milione di dollari, il premio che crede di avere vinto. Il figlio cerca di dissuaderlo, perché capisce che il padre rimbecillito dalla birra e dalla solitudine ha preso alla lettera una pubblicità di un giornale popolare. Ma non c’è modo di impedire al vecchio di perseguire il suo sogno. Il figlio decide allora di accompagnarlo in un viaggio che è un incubo triste attraverso la demenza dell’immensa provincia nord-americana, quella che Cormack McCarthy ha descritto in romanzi come Il buio fuori o Cavalli selvaggi. Paine racconta con commovente comprensione l’ignoranza, lo smarrimento, lo stordimento alcolico e farmacologico dell’umanità che ha portato alla presidenza americana un idiota aggressivo e razzista. Idiozia e razzismo son quel che è rimasto alla classe operaia, ridotta oggi a popolo: massa amorfa senza vita sociale, senza cultura e senza speranza.
Il destino manifesto d’America appare oggi in una luce oscura. L’idealismo imperialista americano identificava questo destino con la diffusione della democrazia nel mondo. Ma questa pericolosa illusione funzionava nell’epoca in cui gli americani vincevano le guerre, mentre ora sono riusciti a perdere due guerre in un decennio e non riescono neppure a svincolarsene, come nel 1975 riuscirono a fare fuggendo in elicottero dal tetto dell’ambasciata di Saigon.
Ora il destino degli Stati Uniti è portare il pianeta e i suoi abitanti in un inferno di violenza, di depressione e di morte come dimostra la vittoria di Trump. Del resto questo destino è scritto nelle origini, e non c’è illusione imperiale che possa rimediarlo. All’origine della storia di questo paese c’è un manipolo di testardi fanatici puritani chiamati padri pellegrini che portarono la morte all’intera comunità Wempanoag sulle coste dell’attuale New England. Continuarono a seminare morte, dapprima contro il popolo indigeno delle grandi praterie, poi a milioni di africani strappati alle loro terre e sottoposti alla brutalità schiavista.
Sono un popolo che non sa vivere, che non sa nulla del piacere e della gentilezza, eppure vuole imporre dovunque il suo lifestyle. Un popolo di infelici rabbiosi e ignoranti che sprofondando nella miseria psichica e nella disperazione aggressiva a un certo punto si suiciderà. Ma i suicidi animati da fanatismo generalmente non lo fanno da soli: vogliono portare all’inferno quanta più gente si può. E la sola cosa in cui questo popolo è superiore è l’armamento.
Riuscirà l’umanità a evitare il destino manifesto cui vuole trascinarla la razza degli sterminatori? Non dipende certo dal partito democratico, che merita il disprezzo di cui è circondato. Non dipende neppure dalla costituzione, o dalle prossime elezioni, ammesso che alle prossime elezioni ci si arrivi mai. Dipende dall’intelligenza del variegato mondo del lavoro cognitivo, dai milioni da artisti, scienziati, sperimentatori che forse potremmo chiamare Silicon Valley Globale. In un’intervista uscita recentemente sul Sole 24 Ore, Jonathan Franzen, l’autore di The Corrections, Freedom e Purity, dice cose abbastanza banali accusando la Silicon Valley di avere provocato il rimbecillimento aggressivo degli americani.
Mi dispiace dirlo perché Jonathan Franzen è a mio parere uno scrittore grandissimo e i suoi romanzi ci permettono di comprendere l’impotenza aggressiva della classe media bianca, ma prendersela con Twitter o Facebook è una semplificazione che non aiuta né a capire né a cambiare. La tecnologia e i media possono funzionare come amplificatore di demenza aggressiva solo quando la demenza aggressiva è coltivata dai rapporti sociali, dallo sfruttamento e dalla povertà. Ma possono anche funzionare come fattore di liberazione, e la mia convinzione è che succederà solo quando i lavoratori cognitivi, che costituiscono il settore più avanzato e produttivo della classe operaia americana e mondiale, si renderanno conto del disastro e investiranno le loro energie nella direzione del sabotaggio e della riprogrammazione della macchina tecnica globale.
La catastrofe in cui gli Stati Uniti sono precipitati (e in cui sta precipitando il mondo) può culminare nell’apocalisse di un olocausto globale, ma può invece aprire la strada a una presa di coscienza della sola sezione di lavoro che può ancora evitare il precipizio, che può iniziare un processo di riscrittura del codice secondo regole diverse da quelle del profitto e della devastazione.
- LA STATUA DELLA LIBERTA’ DEGLI U.S.A. - CON LA SPADA SGUAINATA: "GUAI AI VINTI"!!! LA LEZIONE DI FRANZ KAFKA, IL MAESTRO DELLA LEGGE: RIPENSARE L’AMERICA. E il sogno del "nuovo mondo"!!!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- LA LEZIONE DI HABERMAS. Senza l’Ue usciamo dalla storia mondiale (di Francesco Bellusci)25 marzo 2017, di Federico La Sala
Senza l’Ue usciamo dalla storia mondiale
di Francesco Bellusci (DoppioZero, 25 marzo 2017)
Alla fine del V secolo a. C., ad Atene, c’era un filosofo che proponeva di salvare e recuperare la giustizia nella vita della comunità, sostituendo la democrazia con un’aristocrazia di custodi, esperti del bene comune, filosofi da convertire in tecnocrati. Il suo nome era Platone.
 Oggi, agli inizi del XXI secolo, a Francoforte, sede della Goethe-Universität ma anche di un’istituzione comunitaria nevralgica come la Banca centrale europea, c’è un filosofo che propone di salvare la democrazia in Europa facendole varcare i confini nazionali e di sottrarre l’Unione europea alla spirale tecnocratica, in cui è ricaduta soprattutto nel modo di affrontare la crisi economica e finanziaria dei debiti sovrani dopo il 2008.
Oggi, agli inizi del XXI secolo, a Francoforte, sede della Goethe-Universität ma anche di un’istituzione comunitaria nevralgica come la Banca centrale europea, c’è un filosofo che propone di salvare la democrazia in Europa facendole varcare i confini nazionali e di sottrarre l’Unione europea alla spirale tecnocratica, in cui è ricaduta soprattutto nel modo di affrontare la crisi economica e finanziaria dei debiti sovrani dopo il 2008.
 Il suo nome è Jürgen Habermas. A differenza del malcapitato Platone e delle sue disavventure col tiranno di Siracusa, il filosofo di Francoforte sembra, invece, finalmente aver avuto udienza presso la Bundeskanzlerin Merkel e il suo governo di Grosse Koalition.
Il suo nome è Jürgen Habermas. A differenza del malcapitato Platone e delle sue disavventure col tiranno di Siracusa, il filosofo di Francoforte sembra, invece, finalmente aver avuto udienza presso la Bundeskanzlerin Merkel e il suo governo di Grosse Koalition.La proposta recente della cancelliera tedesca di rivedere i Trattati contemplando la possibilità di un’Europa a due velocità o a geometrie variabili, con ritmi e livelli diversi di integrazione, rilanciano e collimano, infatti, con l’idea che Habermas propugna da almeno dieci anni, di procedere più speditamente con l’integrazione politica di un “nucleo di Europa” (Kerneuropa), da far coincidere con l’area dell’euro o dei Paesi fondatori della Comunità economica europea nel 1957.
Erede principale della storica “Scuola di Francoforte” di Adorno, Horkheimer e Marcuse, ma anche allievo coerente delle intuizioni di Hannah Arendt su potere, politica e spazio pubblico, Habermas ha inteso il lavoro del filosofo politico non come il costruttore a tavolino di una “città ideale”, ma come il ricostruttore dei processi politici reali, a partire da un rapporto riflessivo con la tradizione e le istanze della modernità, e, conseguentemente, alla luce dei mutati scenari internazionali post-guerra fredda, non ha smesso, con saggi, interventi e interviste, di incalzare le élites europee in vista del rilancio del progetto comunitario, denunciandone gli stop and go e l’“incrementalismo” dei piccoli passi. E dell’Unione europea che, attualmente, i nuovi “nazional-populismi”, così definiti da Taguieff, hanno fatto assurgere a loro bersaglio privilegiato, Habermas ha sempre difeso la prospettiva e la funzione civilizzatrice, per un continente dilaniato da rivalità e guerre fino alla prima metà del secolo scorso, intrecciando questa difesa con l’approfondimento teorico della sua concezione normativa di democrazia deliberativa.
Sono la recente crisi economica del 2008 e i suoi effetti di medio periodo che, secondo Habermas, hanno posto l’Ue di fronte ad un bivio cruciale: “O danneggiare in maniera irreparabile, rinunciando all’euro, il progetto dell’Unione europea che abbiamo perseguito nel dopoguerra, oppure approfondire l’Unione politica - a partire dall’eurozona -, in maniera tale da dare legittimità democratica, oltrepassando le frontiere, ai trasferimenti di valuta e alla messa in comune dei debiti. Non possiamo evitare la prima cosa senza realizzare la seconda” (Nella spirale tecnocratica. Un’arringa per la solidarietà europea, Laterza 2014). Percorrere la seconda strada e cioè superare ogni remora verso il progetto europeo, affrontando l’errore di aver costruito una comunità monetaria senza unione politica, significa, d’altronde, per Habermas, sconfessare due mainstream che tendono a indebolire e alla lunga inficiare o pregiudicare la realizzabilità di quel progetto.
La prima è la tesi del “No demos”: senza un “popolo” europeo, senza omogeneità etnica, storica e linguistica, non si può edificare una comunità politica, dal momento che un ordinamento democratico-liberale ed egualitario è possibile, nella sostanza, solo dentro il cerchio dell’appartenenza nazionale.
 Contro questa tesi che torna a singhiozzo, Habermas ha sempre sostenuto che la coscienza nazionale non è mai stata qualcosa di naturale, anche in presenza di una omogeneità etnico-linguistica, ma il prodotto di una sedimentazione e stratificazione di contributi narrativi di varie fonti (storici, etnologi, giuristi, linguisti e storici letterari) e di vari media (scuola, mezzi di comunicazione di massa, servizio di leva), che ha seguito una duplice declinazione, “patriottica” e “repubblicana” insieme, e non solo la prima. In fondo, in Habermas, troviamo una filosofia della storia ben precisa.
Contro questa tesi che torna a singhiozzo, Habermas ha sempre sostenuto che la coscienza nazionale non è mai stata qualcosa di naturale, anche in presenza di una omogeneità etnico-linguistica, ma il prodotto di una sedimentazione e stratificazione di contributi narrativi di varie fonti (storici, etnologi, giuristi, linguisti e storici letterari) e di vari media (scuola, mezzi di comunicazione di massa, servizio di leva), che ha seguito una duplice declinazione, “patriottica” e “repubblicana” insieme, e non solo la prima. In fondo, in Habermas, troviamo una filosofia della storia ben precisa.
 Nel giro di un secolo e mezzo di storia europea e mondiale, dalla Rivoluzione francese alla Seconda guerra mondiale, l’idea di nazione ha suscitato, allo stesso tempo, il risveglio e il più tremendo sonno della ragione. Lo Stato-nazione moderno è stato l’impasto dialettico di due correnti: il repubblicanesimo e il nazionalismo. Il repubblicanesimo ha immaginato una nazione di cittadini che si riconoscono liberi ed eguali nella formazione della volontà collettiva; il nazionalismo ha immaginato una nazione come comunità di destino, fondata sulla discendenza dallo stesso ceppo etnico, cioè su legami prepolitici.
Nel giro di un secolo e mezzo di storia europea e mondiale, dalla Rivoluzione francese alla Seconda guerra mondiale, l’idea di nazione ha suscitato, allo stesso tempo, il risveglio e il più tremendo sonno della ragione. Lo Stato-nazione moderno è stato l’impasto dialettico di due correnti: il repubblicanesimo e il nazionalismo. Il repubblicanesimo ha immaginato una nazione di cittadini che si riconoscono liberi ed eguali nella formazione della volontà collettiva; il nazionalismo ha immaginato una nazione come comunità di destino, fondata sulla discendenza dallo stesso ceppo etnico, cioè su legami prepolitici.Il primo ha incoraggiato il senso civico, il sentimento della libertà e della partecipazione, ha legittimato la democrazia; il secondo ha incoraggiato la disponibilità a combattere e a morire per la patria, ma anche il senso dello Stato e della sua indipendenza. Durante l’Ottocento romantico, come testimoniano anche i movimenti risorgimentali, il nazionalismo è stato un potente vettore del repubblicanesimo e dell’affermazione dei principi universalistici della democrazia. Emblematica di questa convergenza è la figura di Mazzini, ad esempio. Ma questa complementarietà è stata drammaticamente spezzata dalla strumentalizzazione del mito nazionale, messo prima al servizio dell’imperialismo e della politica di potenza dalle élites politiche europee tra il 1871 e il 1914 e, poi, da Mussolini e Hitler, al servizio di un progetto totalitario, completamente incompatibile con i principi repubblicani. -Nella seconda metà del Novecento, dopo i disastri del nazionalismo bellicoso e totalitario e con l’avvento di società multiculturali e multietniche, l’idea di democrazia repubblicana si è sganciata da un concetto “romantico” di nazione intesa come entità naturalistica, che ha conosciuto un progressivo declino. Ed è da qui che deve ripartire e alimentarsi l’idea europea.
La seconda tesi è quella che vede il compimento dell’integrazione politica europea solo nella costruzione di un super-Stato, cioè di uno “Stato federale europeo”. Habermas si professa un eurodemocratico, ma non un eurofederalista.
 A suo avviso, la sfida futura di fronte all’Unione europea è di costruire qualcosa di storicamente inedito. Vale a dire, una democrazia sovranazionale fondata su un doppio binario: i cittadini europei che formano discorsivamente la loro volontà attraverso una sfera pubblica informale e istituzionalizzata, che ha il suo vertice in partiti transnazionali e nel Parlamento europeo; i popoli-di-Stati europei che formano discorsivamente la loro volontà con la mediazione dei rappresentanti di governo e degli Stati nel Consiglio europeo e nella Commissione.
A suo avviso, la sfida futura di fronte all’Unione europea è di costruire qualcosa di storicamente inedito. Vale a dire, una democrazia sovranazionale fondata su un doppio binario: i cittadini europei che formano discorsivamente la loro volontà attraverso una sfera pubblica informale e istituzionalizzata, che ha il suo vertice in partiti transnazionali e nel Parlamento europeo; i popoli-di-Stati europei che formano discorsivamente la loro volontà con la mediazione dei rappresentanti di governo e degli Stati nel Consiglio europeo e nella Commissione.
 La stessa persona partecipa, quindi, a questo nuovo consorzio, secondo procedure democratiche giuridificate, sia come cittadino dell’Ue sia come cittadino dello Stato membro, che continua ad avere il ruolo di garante dei diritti e delle libertà attraverso le costituzioni nazionali.
La stessa persona partecipa, quindi, a questo nuovo consorzio, secondo procedure democratiche giuridificate, sia come cittadino dell’Ue sia come cittadino dello Stato membro, che continua ad avere il ruolo di garante dei diritti e delle libertà attraverso le costituzioni nazionali.
 Habermas non trascura di esaminare le implicazioni sul piano dell’architettura istituzionale comunitaria di questo approccio: “Il Parlamento europeo dovrebbe poter varare iniziative di legge. La procedura legislativa cosiddetta ordinaria - richiedente l’accordo di entrambe le camere - dovrebbe potersi estendere a tutti i settori della politica.
Habermas non trascura di esaminare le implicazioni sul piano dell’architettura istituzionale comunitaria di questo approccio: “Il Parlamento europeo dovrebbe poter varare iniziative di legge. La procedura legislativa cosiddetta ordinaria - richiedente l’accordo di entrambe le camere - dovrebbe potersi estendere a tutti i settori della politica.Nello stesso tempo il Consiglio europeo (cioè l’assemblea dei capi di governo), dopo aver goduto finora di una posizione semi-costituzionale, dovrebbe essere incorporato nel Consiglio dei ministri. E infine la Commissione dovrebbe assumere i compiti di un vero governo, egualmente responsabile sia verso il Consiglio sia verso Parlamento. Con questa trasformazione dell’Unione in una comunità sovranazionale che risponde a criteri democratici, entrambi i princìpi della eguaglianza-degli-stati e della eguaglianza-dei-cittadini verrebbero soddisfatti in maniera paritetica. Nella simmetrica partecipazione di entrambe le “camere” al processo legislativo, così come nella simmetrica posizione di Parlamento e Consiglio nei riguardi dell’esecutivo, si rifletterebbe la volontà democratica di entrambi i soggetti costituenti.” (“Micromega”, 2014).
Questo modello diventerebbe per Habermas anche pilota rispetto a un’associazione sovranazionale di cittadini e dei popoli su scala mondiale, poiché “la concezione, sviluppatasi sull’esempio dell’Unione europea, di una cooperazione costituente fra cittadini e Stati indica la via lungo la quale l’esistente comunità internazionale di Stati intorno alla comunità dei cittadini del mondo potrebbe essere portata a compimento in una comunità cosmopolitica” (Questa Europa è in crisi, Laterza 2012).
Una strada ancora lunga e impervia, ma questo ci rimane da fare: o approfondire politicamente l’unione e contribuire così alla società mondiale e alle sue strategie per fronteggiare le crisi globali (ecologiche, sanitarie, economiche, sociali e tecnologiche) o, tornando divisi, ridurci a una “piccola Svizzera museificata”.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Sessant’anni di Europa. Le linee di frattura dell’Unione (di Alessandro Cavalli)23 marzo 2017, di Federico La Sala
Sessant’anni di Europa
Le linee di frattura dell’Unione
di Alessandro Cavalli (Il Mulino, 21 marzo 2017)
Gli anniversari sono tempo di bilanci. Il 25 marzo si celebrano i 60 anni dalla firma del Trattato di Roma dal quale è nata quella che oggi chiamiamo Unione europea. Il bilancio però è difficile. Per alcuni il bicchiere è mezzo pieno, per altri è mezzo vuoto, ma non è facile capire chi dei due abbia più ragione. La pace tra gli Stati membri non è venuta meno e, per ora, sembra garantita. L’Unione è sopravvissuta - con qualche acciacco - alla crisi del secolo, la più grave dopo quella che è sfociata nella Seconda guerra mondiale.
 La povertà non è stata vinta e le disuguaglianze sono aumentate, ma nel complesso l’Europa resta in questo mondo una delle regioni nelle quali si sta meglio. Con qualche severa restrizione in alcuni Paesi, le libertà e i diritti umani fondamentali sono sostanzialmente rispettati. In un’ottica di lungo periodo e guardando a gran parte del resto del mondo, bisogna riconoscere che non ci è andata poi così male.
La povertà non è stata vinta e le disuguaglianze sono aumentate, ma nel complesso l’Europa resta in questo mondo una delle regioni nelle quali si sta meglio. Con qualche severa restrizione in alcuni Paesi, le libertà e i diritti umani fondamentali sono sostanzialmente rispettati. In un’ottica di lungo periodo e guardando a gran parte del resto del mondo, bisogna riconoscere che non ci è andata poi così male.
 Molti di noi, se dovessero scegliere dove vivere, alla fine sceglierebbero proprio l’Europa, come del resto tanti profughi, rifugiati, migranti che bussano alla porta, anzi, perlopiù entrano senza bussare. Per loro l’Europa è una terra promessa: molti finiranno delusi, ma molti altri vi troveranno una nuova patria dove far crescere i loro figli.
Molti di noi, se dovessero scegliere dove vivere, alla fine sceglierebbero proprio l’Europa, come del resto tanti profughi, rifugiati, migranti che bussano alla porta, anzi, perlopiù entrano senza bussare. Per loro l’Europa è una terra promessa: molti finiranno delusi, ma molti altri vi troveranno una nuova patria dove far crescere i loro figli.E però, le crepe dell’edificio dell’Ue sono visibili a tutti e non riguardano solo la sfida dell’uscita del Regno Unito (voluta, giova ripeterlo, dal 37% degli aventi diritto al voto e dal 52% dei votanti).
Nelle aree limitrofe del Medioriente e dell’Africa regnano la guerra e il caos, e l’Unione non ha né le risorse né le competenze per far sentire la sua voce e per tentare di ricomporre i conflitti. I mercati finanziari sono sempre in agguato, sensibili all’altalena delle dinamiche imprevedibili della fiducia e della sfiducia sull’affidabilità dei singoli Paesi e dei loro debiti sovrani. Mario Draghi ha sparato tutte le munizioni che aveva a disposizione (e forse anche qualcuna di più) per fronteggiare la crisi monetaria, nel suo arsenale sono rimaste solo poche armi di emergenza. I movimenti anti-europei di destra, ma anche di sinistra, si apprestano a raccogliere, nell’anno elettorale incominciato nei Paesi Bassi, il consenso di tutti quegli scontenti che attribuiscono all’Europa e alla sua moneta la causa dei loro guai. Sulla scena mondiale sia Putin a Est sia Trump a Ovest sembrano entrambi ben intenzionati, sia pure con motivazioni diverse, a mettere i bastoni tra le ruote del processo di unificazione europea. Luci e ombre, a ognuno decidere se prevalgano le prime oppure le seconde.
La diga olandese ha tenuto; se in Francia le ambizioni di Marine Le Pen saranno ridimensionate e, soprattutto, se in autunno in Germania si affermasse una coalizione disposta a prendere l’iniziativa di qualche significativo passo avanti, gli scenari di una ever closer union potrebbero riaprirsi.
La Commissione Juncker ne ha disegnati cinque che si possono riassumere così, nel linguaggio delle parate militari: fermi tutti, un passo indietro, un passo laterale a sinistra, un passo laterale a destra, un passo avanti. Solo che la Commissione non ha il potere di dare ordini e di pretendere che vengano eseguiti, si limita a indicare le mosse possibili, sta ai governi decidere, insieme e quasi sempre all’unanimità, in che direzione andare. Al momento attuale, gli esiti sono tutti ancora aperti, da quelli perversi a quelli virtuosi.
Tra gli esiti possibili c’è la geometria variabile, i cerchi concentrici, l’Europa a due o più velocità. Diciamolo chiaro: se si vuole fare un passo avanti non si può farlo in ventisette.
 Le linee di faglia sono troppo consistenti. C’è quella Nord-Sud che ci (noi, italiani) riguarda direttamente e quella Est-Ovest che riguarda i nuovi arrivati dopo l’allargamento del 2004. Lo sapevamo già allora che l’allargamento prima dell’approfondimento significava l’annacquamento. È a dir poco superficiale chi sostiene che allora non si doveva fare l’allargamento. La domanda da porsi è invece un’altra: che cosa sarebbe successo in Polonia, Ungheria, Bulgaria, Romania eccetera se l’allargamento non ci fosse stato? Basta guardare a che cosa è successo nella ex Jugoslavia e a che cosa succede ancor oggi in Ucraina.
Le linee di faglia sono troppo consistenti. C’è quella Nord-Sud che ci (noi, italiani) riguarda direttamente e quella Est-Ovest che riguarda i nuovi arrivati dopo l’allargamento del 2004. Lo sapevamo già allora che l’allargamento prima dell’approfondimento significava l’annacquamento. È a dir poco superficiale chi sostiene che allora non si doveva fare l’allargamento. La domanda da porsi è invece un’altra: che cosa sarebbe successo in Polonia, Ungheria, Bulgaria, Romania eccetera se l’allargamento non ci fosse stato? Basta guardare a che cosa è successo nella ex Jugoslavia e a che cosa succede ancor oggi in Ucraina.A ventisette, a diciannove, a undici, a nove o a sei, l’egemonia sarà di fatto, lo si voglia o no, della Germania. È meglio per l’Europa nel suo insieme una Germania all’interno di un vincolo europeo rafforzato in un numero ridotto oppure un vincolo lasco per un gruppo più numeroso? Questo è il dilemma sul quale sarebbe utile un ampio e approfondito dibattito pubblico e sul quale si dovrebbero ridisegnare gli schieramenti politici. La Germania conta di più in un’Europa divisa, o in un’Europa unita, sia pure, ristretta?
Questa volta i cittadini non devono solo aspettare che piovano dall’alto le decisioni dei governi. Le campagne elettorali del 2017 avranno tutte al centro il tema dell’Europa e degli immigrati, certamente in Francia e Germania e, prima o poi, anche in Italia. Tutto lascia prevedere che siamo di fronte a una svolta nella quale si gioca il futuro del continente e questa volta a decidere saranno (anche) i popoli.
Sarà però utile riflettere sul fatto che il populismo nazionalista anti-europeo è solo un effetto, non una causa, della crisi dell’Unione. Le cause sono tante: l’assenza di visione e di leadership nei Paesi che hanno finora guidato il processo, la fragilità e la farraginosità dell’architettura istituzionale, la scarsa legittimazione democratica, la forza degli interessi finanziari e delle imprese multinazionali che lucrano sulla diversità dei sistemi pubblici e dei regimi fiscali e che non vedono negativamente la conservazione dello status quo e, infine, anche la forza di inerzia dell’esistente.
 Gli Stati nazionali, con i loro apparati burocratici, con i loro sistemi politici, con i sentimenti di appartenenza che riescono ancora a suscitare nelle popolazioni, possono durare ancora per secoli senza interrompere il loro declino. In fondo, di civiltà che sono declinate a lungo e sono scomparse lentamente, oppure in modo brusco e drammatico, la storia ne ha conosciute diverse. Se non facciamo qualcosa, questo potrebbe essere il destino anche dell’Europa.
Gli Stati nazionali, con i loro apparati burocratici, con i loro sistemi politici, con i sentimenti di appartenenza che riescono ancora a suscitare nelle popolazioni, possono durare ancora per secoli senza interrompere il loro declino. In fondo, di civiltà che sono declinate a lungo e sono scomparse lentamente, oppure in modo brusco e drammatico, la storia ne ha conosciute diverse. Se non facciamo qualcosa, questo potrebbe essere il destino anche dell’Europa. -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Politica della post verità o potere sovralegale? (di Ugo Morelli)22 febbraio 2017, di Federico La Sala
Politica della post verità o potere sovralegale?
di Ugo Morelli *
Gli orientamenti politici e gli esiti delle decisioni collettive sfidano oggi le tradizionali categorie della psicologia del potere. L’opinione pubblica alla base delle scelte si forma per vie che sfuggono alle forme conosciute e le campagne elettorali sono costruite al di fuori del mondo dei fatti. Non solo, ma chi sceglie in un certo modo, concorrendo a esiti determinanti anche per il proprio presente e il proprio futuro, sembra cambiare idea un momento dopo, a fatti compiuti e, almeno per un certo tempo, irreversibili.
Viene sempre più spesso in mente Winston Churchill e la sua affermazione sulla difesa della democrazia «purché non voti mia suocera». Una provocazione alla sua maniera che comunque induce a interrogarsi sul presente della democrazia e delle forme di esercizio del potere. A fare affermazioni senza prove e senza logica; smentendole immediatamente dopo o cambiando versione continuamente, si ottiene seguito e consenso e viene da chiedersi come sia possibile.
Se consideriamo l’elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti d’America, la domanda da porsi è come abbia fatto una minoranza di americani a portarlo al potere. L’interrogazione è, perciò, su un deficit di democrazia e sulla perdita di democrazia partecipativa, come sostiene Judith Butler.
«Ci avviciniamo all’ipotesi che ci pare di poter sostenere: non siamo di fronte a un’epoca di post-verità, bensì all’affermazione di forme di potere sovralegale», come le aveva definite Carl Schmitt.
L’uso del sistema democratico per prendere il potere e appropriarsene da parte di chi democratico non è, né nello stile né nella sostanza, mentre è comunque in grado di ottenere il consenso soprattutto di chi è in tutt’altra condizione, consente un accentramento del potere che non sarebbe concepibile in situazioni di una almeno relativa democrazia partecipativa. È necessario considerare la dematerializzazione e la virtualizzazione dell’esperienza per cercare di comprendere alcune delle vie di creazione del consenso e di affermazione del potere oggi. Si tratta, ad esempio, di riprendere quello che Jean Baudrillard scriveva parecchi anni fa:
- «L’astrazione oggi non è più quella della mappa, del doppio, dello specchio o del concetto. La simulazione non è più quella di un territorio, di un essere referenziale o una sostanza. È piuttosto la generazione di modelli di un reale senza origine o realtà: un iperreale. Il territorio non precede più la mappa, né vi sopravvive. [...] È la mappa che precede il territorio - precessione dei simulacri - è la mappa che genera il territorio [...]. L’età della simulazione comincia con l’eliminazione di tutti i referenti - peggio: con la loro resurrezione artificiale in un sistema di segni, che sono una materia più duttile dei significati perché si prestano a qualsiasi sistema di equivalenza, a ogni opposizione binaria, e a qualsiasi algebra combinatoria. Non è più una questione di imitazione, né di duplicazione o di parodia. È piuttosto una questione di sostituzione del reale con segni del reale; cioè un’operazione di cancellazione di ogni processo reale attraverso il suo doppio operazionale. [...] sarà un iperreale, al riparo da ogni distinzione tra reale e immaginario, che lascia spazio solo per la ricorrenza di modelli e per la generazione simulata di differenze.» (Simulacres et simulation)
I fatti non contano e la loro rappresentazione narrata predomina e vince. Come sostiene Judith Butler in un’intervista a Christian Salmon, apparsa il 24 dicembre 2016 su Robinson, parlando delle elezioni di Donald Trump e dei contenuti delle sue affermazioni:
- «Al momento i fatti sembrano indicare che non è così. Ma lui non vive in un mondo di fatti. (.....) Ha poca importanza se si contraddice o se si capisce che rigetta esclusivamente le conclusioni che intaccano il suo potere o la sua popolarità. Questo narcisismo sfrontato e ferito e questo rifiuto di sottomettersi ai fatti e alla logica lo rendono ancora più popolare. Lui vive al di sopra della legge, ed è così che molti dei suoi sostenitori vorrebbero vivere».
Da tempo ci siamo resi conto di vivere in un’epoca in cui non disponiamo più di verità indiscutibili e la nostra condizione, come ampiamente segnalato da un profondo filosofo come Aldo Giorgio Gargani, è quella di chi è passato dalla verità al senso della verità. Secondo Giorgio Agamben: «La civiltà che noi conosciamo si fonda innanzitutto su una interpretazione dell’atto di parola, sullo ‘sviluppo’ di possibilità conoscitive che si considerano contenute e ‘implicate’ nella lingua» (Che cos’è la filosofia?, Quodlibet 2016). L’uso della lingua e soprattutto i suoi effetti non sono determinabili a priori. Vi è una dimensione performativa che piega i significati a seconda delle contingenze.
Accade per esempio oggi che la parola sicurezza sia usata efficacemente per ridurre e decimare i diritti democratici di libertà e, per molti aspetti, la democrazia stessa. E non accade senza consenso. Chi predica la sicurezza dà voce ad aspettative che sono poi alla base di ampi consensi. Sulla consapevolezza delle conseguenze di quel consenso si potrà discutere, ma intanto si produce una legittimazione di un sistema di potere. Sarà pure una minoranza della popolazione americana ad aver portato Trump al potere; rimane il fatto che c’è riuscita affermando le proprie aspettative profondamente antidemocratiche di vivere e agire al di sopra della legge.
Appare evidente che entrano in campo emozioni arcaiche e primordiali sollecitate e amplificate da mezzi virtuali contemporanei che non governiamo, ma ci dominano. Nel momento in cui, in modo confuso e contraddittorio, un leader libera l’odio, invita a usare la cosiddetta pancia per scegliere, legittima la possibilità di esprimere la collera senza limitazioni, rende dichiarabile e proponibile il razzismo, ognuno può sentirsi libero di tirar fuori le viscere. L’arcaismo emozionale e la pratica del voto con lo stile immediato e pratico del “mi piace”/ “non mi piace” di Facebook, producono una miscela sostenuta dalle vie mediatiche, in grado di mettere in discussione le forme della democrazia così come la conosciamo.
I processi di identificazione immediati generano dinamiche di “altercasting” e nel momento in cui le persone si riconoscono in un modo di essere e di fare volendo essere come il leader, non ci sono più disposizioni a verificare la verità delle affermazioni o la fattibilità delle proposte, ma solo adesione massiva e conformista, come abbiamo mostrato nella voce Conformismo.
Ma perché le persone aderiscono? Probabilmente ciò accade per emulazione e per paura. Un leader può guadagnarsi l’ammirazione per aver trovato il modo di non pagare le tasse o per il fatto di riuscire ad avere tante donne a disposizione, molestie sessuali incluse. Il leader va dove vuole, fa quello che vuole e prende quello che vuole. Chi vota vorrebbe essere come lui. Ciò però non basta. L’emulazione riguarda anche la corporeità, la gestualità, la teatralità delle espressioni e la corrispondenza a un modello mediatico stereotipato. Come ha mostrato Marco Belpoliti ne Il corpo del capo , il corpo si afferma come metafora e come forma di esercizio del potere, in particolare nelle modalità totalitarie. La forza attrattiva dei gesti e la loro capacità di coinvolgimento, soprattutto nelle performance comunicative, mostra di essere una componente non secondaria del potere sovralegale.
Accanto a questi fattori e impastandoli di un clima particolare, agisce la paura. Sia la paura suscitata ad hoc enfatizzando fenomeni del tempo come l’immigrazione, il pericolo derivante dagli emarginati o da forme di rivolta, le donne, i disoccupati, i diversi di ogni tipo; sia la paura indotta dai rischi del presente e dalla cosiddetta società del rischio.
Il rapporto tra il potere che non si basa sulla legittimazione, sulla dimostrazione dialogica dei fatti e sulla critica reciproca, ma si situa al di sopra della legge; il rapporto tra quel potere e la paura è stato molto ben descritto da Herta Müller, premio Nobel per la letteratura, a proposito delle continue visite che riceveva a casa dai servizi segreti:
 «Mia madre chiese: che cosa vogliono da te?
«Mia madre chiese: che cosa vogliono da te?
 Risposi: paura.
Risposi: paura.
 Era vero. Questa breve parola si spiegava da sé. Perché l’intero Stato era un apparato della paura. C’erano i sovrani della paura e il popolo della paura. Ogni dittatura è formata da chi incute paura e dagli altri, che hanno paura. Da chi vuole farti paura e chi morde per paura. Ho sempre pensato che la paura sia lo strumento quotidiano di chi vuole metterti paura e il pane quotidiano di chi, per paura, morde».
Era vero. Questa breve parola si spiegava da sé. Perché l’intero Stato era un apparato della paura. C’erano i sovrani della paura e il popolo della paura. Ogni dittatura è formata da chi incute paura e dagli altri, che hanno paura. Da chi vuole farti paura e chi morde per paura. Ho sempre pensato che la paura sia lo strumento quotidiano di chi vuole metterti paura e il pane quotidiano di chi, per paura, morde».La paura da centralizzata si è fatta diffusa e dà vita a forme di potere non semplicemente riconducibili né ai fascismi storici e neppure alla post-verità.
Abbiamo due volte paura di questi tempi: paura per sé e per gli altri e paura dell’altro. E la maggior parte delle persone contribuisce ad alimentare la paura portandosela con sé, oltre a cercare di ottenere dalla paura propria e altrui il massimo vantaggio. Gestire la paura non è altro che il preludio all’ubbidienza.
C’è un’epidemiologia del potere che si basa su un particolare tipo di collusione tra chi domina e chi è dominato; su un forte accentramento e su un monopolio della comunicazione: tutto è reso possibile dal fatto che la maggioranza delle persone usa subendoli i social network, il sistema mediatico e i molteplici canali di informazione e comunicazione. Più che una post-verità sembra affermarsi una surverità, un potere sovralegale che non è raggiungibile con gli strumenti della critica e del conflitto politico come finora li abbiamo conosciuti.
* DOPPIOZERO, 18 febbraio 2017
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- UNA DOMANDA ALL’ITALIA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! UN "BORDELLO STATE": UN PAESE BORDELLO. Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- ATENE/EUROPA. VOLARE SULL’ABISSO: "THE DESTRUCTION OF EUROPE".Note a margine.17 febbraio 2017, di Federico La Sala
ATENE/EUROPA. VOLARE SULL’ABISSO: THE DESTRUCTION OF EUROPE. La fine del mondo ...
 SE PENSIAMO (anzi, Bifo SE PENSI!) CHE IL LAVORO di Ernesto de Martino,”La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali”, è stato pubblicato (a cura di Clara Gallini) dall’Einaudi nel 1977, e che nel 1979 uscì uno straordinario lavoro di Elvio Fachinelli, “La freccia ferma. Tre tentativi di annullare il tempo (cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3263), ci rendiamo conto in quale “abisso di oscurità” siamo scivolati, e come e quanto - nonostante la diffusa ripresa dei lavori e i vari “cantieri” aperti (si cfr., ad es., la lodevolissima rivista dell’Associazione Internazionale “Ernesto De Martino”, “NOSTOS”: http://rivista.ernestodemartino.it/index.php/nostos) - SIA NECESSARIO ripartire dal nostro presente e camminare sulla strada dell’antropologia della storia (non dalla storia dell’antropologia!), da Kant (come ha indicato anche l’ultimo Foucault e, già anche Giambattista Vico! - come aveva cominciato a capire Enzo Paci, al di là di Benedetto Croce!) e, anche, dai contributi di Ernesto De Martino ed Elvio Fachinelli! O no?! (Federico La Sala).
SE PENSIAMO (anzi, Bifo SE PENSI!) CHE IL LAVORO di Ernesto de Martino,”La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali”, è stato pubblicato (a cura di Clara Gallini) dall’Einaudi nel 1977, e che nel 1979 uscì uno straordinario lavoro di Elvio Fachinelli, “La freccia ferma. Tre tentativi di annullare il tempo (cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3263), ci rendiamo conto in quale “abisso di oscurità” siamo scivolati, e come e quanto - nonostante la diffusa ripresa dei lavori e i vari “cantieri” aperti (si cfr., ad es., la lodevolissima rivista dell’Associazione Internazionale “Ernesto De Martino”, “NOSTOS”: http://rivista.ernestodemartino.it/index.php/nostos) - SIA NECESSARIO ripartire dal nostro presente e camminare sulla strada dell’antropologia della storia (non dalla storia dell’antropologia!), da Kant (come ha indicato anche l’ultimo Foucault e, già anche Giambattista Vico! - come aveva cominciato a capire Enzo Paci, al di là di Benedetto Croce!) e, anche, dai contributi di Ernesto De Martino ed Elvio Fachinelli! O no?! (Federico La Sala). FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA:
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4829
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA:
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4829Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- DAL MITO DEL DUCE AL MITO DEL DUCE. LA LEZIONE DI KAFKA13 febbraio 2017, di Federico La Sala
ITALIA E USA - USA E ITALIA:
DAL MITO DEL DUCE AL MITO DELL’AMERICA E DAL MITO DELL’AMERICA AL MITO DEL DUCE. LA LEZIONE DI FRANZ KAFKA ...
ALLA LUCE DEL NOSTRO PRESENTE STORICO, E DELLA CORAGGIOSA E PREZIOSA ANALISI E AUTOANALISI di Fabrizio Denunzio ("La morte nera. La teoria del fascismo di Walter Benjamin, ombre corte, 2016, 119 pp., € 10), PER NON CONFONDERE I PIANI E NON SCAMBIARE la "RIPRESA" CON LA "ripetizione", non è per niente male rileggersi il bel saggio di Simona Urso, "Margherita Sarfatti. Dal mito del Dux al mito americano" (Marsilio, Venezia 2003) e, insieme, il già citato lavoro di Nicola Fanizza, "Maddalena Santoro e Arnaldo Mussolini. La storia d’amore che il duce voleva cancellare"(cfr.:http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5882) e RIMEDITARE la "vecchia" LEZIONE DI FRANZ KAFKA (cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1367).
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- DOPO AUSCHWITZ. Viktor Frankl, L’amore per la vita, nonostante tutto.3 febbraio 2017, di Federico La Sala
- AUSCHWITZ, QUEL GIORNO (di Luigina D’Emilio): Primo Levi, La tregua: "La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla (...)"
DOPO AUSCHWITZ. Dialogo tra un teologo e uno psicologo: Pinchas Lapide e Viktor Frankl. "Entrambi ebrei, entrambi sopravvissuti ai lager: e l’Olocausto sempre lì, con i suoi interrogativi" (Marco Roncalli)
- Auschwitz: Drone video of Nazi concentration camp Nella Giornata della memoria vale davvero la pena condividere queste straordinarie immagini girate dalla BBC nel 2015, in occasione del 70esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Birkenau, ad Auschwitz in Polonia. Il sito oggi è patrimonio dell’Unesco e viene visitato ogni anno da migliaia di persone, tra cui sopravvissuti all’eccidio nazista. Più di un milione di prigionieri - di cui la maggior parte ebrei - persero la vita in questo campo di sterminio tra il 1940 e il 1945 (Pisa Pier Luigi Pisa, 27 gennaio 2016).
Viktor Frankl, L’amore per la vita, nonostante tutto. Si riproduce l’introduzione a Viktor E. Frankl, L’uomo alla ricerca di senso. Uno psicologo nei Lager e altri scritti inediti (Daniele Bruzzone - Alfabeta2, 27.01.2017)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- STORIA, FILOSOFIA, E FILOLOGIA. Gaffe della Casa Bianca su Theresa May: l’ufficio stampa ha dimenticato di mettere la ’h’.27 gennaio 2017, di Federico La Sala
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Una storia di lunga durata...
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- SULL’INCONTRO DI RATZINGER - BENEDETTO XVI E BUSH. LA CRISI DEL CATTOLICESIMO ROMANO E DELLA DEMOCRAZIA AMERICANA NON SI RISOLVE... RILANCIANDO UNA POLITICA OCCIDENTALE DA SACRO ROMANO IMPERO
Gaffe della Casa Bianca su Theresa May, diventa pornostar
Nei suoi comunicati, l’ufficio stampa ha dimenticato di mettere la ’h’
di Redazione ANSA *
Nuova gaffe dell’amministrazione Trump in politica estera. Dopo aver confuso il ministro degli Esteri australiano Julie Bishop per il premier Malcolm Turnbull, l’ufficio stampa della Casa Bianca ha ’dimenticato’ la ’h’ nel nome della premier britannica Theresa May. Risultato: in due documenti l’inquilina di Downing Street è diventata la nota star del soft-porn Teresa May.
L’errore, poi corretto, è stato ripetuto due volte nel comunicato di ieri con il quale la Casa Bianca annunciava l’agenda odierna degli incontri Trump-May e una volta in un comunicato dell’ufficio del vice presidente. "Nel pomeriggio il presidente parteciperà ad un incontro bilaterale con il primo ministro del Regno Unito, Teresa May", recitava la nota dell’ufficio stampa della Casa Bianca.
E qualche riga dopo la ’h’ era di nuovo sparita nel previsto "pranzo di lavoro con Teresa May...". Ancora una volta, nella nota dell’ufficio di Mike Pence il nome di battesimo di May è diventato quello della star di un video per la canzone ’Smack My Bitch Up’ del gruppo The Prodigy. "E’ per questo che Donald Trump era eccitato di incontrarla?", commenta ironico il tabloid britannico Mail online riferendosi al previsto colloquio di oggi tra il neo presidente e la premier britannica a Washington. Sempre ieri, ricorda il Mail online, in un altro comunicato la Casa Bianca ha definito il ministro degli Esteri australiano Julie Bishop il ’primo ministro degli Esteri’ del Paese.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- "LA MORTE NERA. LA TEORIA DEL FASCISMO DI WALTER BENJAMIN" (FABRIZIO DENUNZIO). NOTE.13 gennaio 2017, di Federico La Sala
Psicoanalisi, Storia e Politica....
- L’ITALIA, IL VECCHIO E NUOVO FASCISMO, E "LA FRECCIA FERMA". La lezione sorprendente e preveggente di Elvio Fachinelli
- FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
- RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI --- LE SIBILLE, I PROFETI, E IL SERPENTE DI BRONZO: MICHELANGELO, ABY WARBURG, E UN ANAGRAMMA!!!
‘La morte nera’ e il fascista che è in noi
di Iside Gjergji *
Il recente libro di Fabrizio Denunzio, La morte nera. La teoria del fascismo di Walter Benjamin (Ombre Corte 2016) è uno dei testi più interessanti pubblicati in Italia nel 2016. L’opera prosegue e, forse, conclude una elegante e seducente lettura di Walter Benjamin, già avviata da Denunzio con L’uomo nella radio. Organizzazione e produzione della cultura in Walter Benjamin (Giulio Perrone 2012) e, prima ancora, con Quando il cinema si fa politica. Saggi su “L’opera d’arte” di Walter Benjamin (Ombre Corte 2010).
Il libro tratta un tema attuale - il fascismo - e lo fa attraverso le parole e i silenzi del filosofo berlinese. La morte nera non è solo un testo di critica e, senza dubbio, non è uno di quei lavori che - come va di moda - si accaniscono sul “corpo” di un autore, nella speranza di ricavarne un lembo, al fine di assicurarsi un posto nella koinè culturale che conta.
Al contrario, il testo ha un obiettivo ambizioso: vuole realizzare uno schizzo multidimensionale del fascismo, vuole mostrare il suo cuore segreto, ancora palpitante, per farci sentire anche nella vigna dei testi il suono inquietante del “duro metallo della violenza” (Baudelaire). Obiettivo riuscito.
Inoltre, come si può intuire già dal titolo (per gli amanti di Guerre stellari, la Morte Nera è l’arma potente e segreta dell’Impero, che, da sola, può annientare interi pianeti, cosi come “Morte Nera” è l’espressione con la quale si definisce la peste che sterminò più di un terzo della popolazione europea nel XIV secolo), il lavoro ha un carattere ibrido. Vi si trova la critica più rigorosa attraversata da intuizioni, collegamenti storici e biografici, rimandi a frammenti letterari, epistolari, trasmissioni radiofoniche e film.
Nella prima parte si svolge come una sceneggiatura in tre atti (fasi), denominata “Il fascismo”, il cui prequel, nella seconda parte, è dedicato a “Il fascista”.
Ma andiamo con ordine. Denunzio, come anticipato, individua tre fasi nello sviluppo del pensiero benjaminiano sul fascismo. Nel periodo compreso tra il 1924 e il 1930, Benjamin pensa a un modello di fascismo a partire da una analisi “giornalistico-informativa”, anche come diretta conseguenza del suo girovagare in Europa.
La sua attenzione è catturata pressoché interamente dalla figura del “duce”. L’autore coglie in questa fase lo sguardo critico di Benjamin sull’Illuminismo e la sua conseguente spiegazione della legittimazione popolare del “duce” attraverso il conflitto tra ragione e religione. Il collegamento è da ricercare nel “vuoto che si viene a creare quando la ragione abolisce ogni collegamento con la trascendenza”, creando spazio a “personaggi che, contrabbandando un soprannaturale di scarto, [...] vengono investiti di un potere che sicuramente useranno contro quanti gliel’hanno conferito” (p. 34).
 La soggettività a cui Benjamin pensa in questo periodo non coincide con l’uomo razionale, ma con l’uomo religioso, capace di esperire la trascendenza.
La soggettività a cui Benjamin pensa in questo periodo non coincide con l’uomo razionale, ma con l’uomo religioso, capace di esperire la trascendenza.La seconda fase, secondo l’autore, coincide con gli anni 1934-36 e si caratterizza per l’approccio “politico-combattente” del filosofo. Benjamin perviene, infatti, a un modello di fascismo fondato su elementi strutturali, tenendo conto della composizione delle classi e delle strategie di dominazione del capitalismo. È in questo passaggio che il filosofo tedesco accantona la coppia concettuale “ragione-religione” e abbraccia un’altra, anch’essa oppositiva, ovvero “natura-tecnica”.
La riflessione più matura sull’Illuminismo e sulla modernità spinge Benjamin a pensare un rapporto inedito tra natura e tecnica, in quanto egli riesce a immaginare la tecnica “liberata dal fine strumentale di dominare la natura e finalmente impiegata per fare giocare e divertire gli uomini” (p. 63).
 La soggettività dominante nel pensiero benjaminiano di questa fase non è l’individuo, ma la classe lavoratrice. È il lavoro a mediare le relazioni e, di conseguenza, la trascendenza finisce in secondo piano (senza però scomparire del tutto) per lasciare maggiore spazio alla Ragione.
La soggettività dominante nel pensiero benjaminiano di questa fase non è l’individuo, ma la classe lavoratrice. È il lavoro a mediare le relazioni e, di conseguenza, la trascendenza finisce in secondo piano (senza però scomparire del tutto) per lasciare maggiore spazio alla Ragione.L’ultimo e terzo atto della sceneggiatura denunziana sulla teoria del fascismo di Benjamin si consuma nel 1940, che è anche l’ultimo anno di vita del filosofo, ormai esule e solitario nelle strade d’Europa, nelle quali imperversa la “follia”. Il modello di fascismo delineato in questa fase conserva il nesso struttura/sovrastruttura sviluppato nelle fasi precedenti, ma questa volta l’elemento (strutturale) economico trova un perfetto rispecchiamento nella sovrastruttura ideologica del fascismo: “La conservazione millenaria della prima si rispecchia fedelmente nell’eternità della seconda” (pp. 72-73). Benjamin perviene così a una riflessione sul tempo nella modernità, sui momenti temporali dell’eternità e dell’istante.
La chiave di lettura dell’intera sceneggiatura è, però, nascosta nel prequel, ovvero nella seconda parte del libro, laddove Denunzio, in modo raffinato, sviluppa un’analisi sociologica e psicoanalitica, setacciando il tempo, la vita e le parole del filosofo tedesco, a caccia di lapsus, di non detti e del rimosso. È nella seconda parte, infatti, che le parole e i silenzi abitano corpi che ci consentono di interpretare e comprendere comportamenti, testi, dottrine ed eventi narrati nella prima parte. E nondimeno ci consegnano un ritratto completo di Benjamin, con le sue luci e le sue (non poche) ombre nere. Qui il fascismo diventa una silhouette autoritaria e tirannica, una presenza che si produce in fasi storiche e passaggi biografici caratterizzati da “vuoti” di autorità e che si manifesta sotto molteplici sembianze: padri sostituivi con simpatie naziste, personaggi letterari che evocano tiranni, poeti vicini alle SS.
L’autore sottolinea, dunque, quanto già evidenziato dalla migliore tradizione della Scuola di Francoforte, ovvero l’imprescindibilità della teoria freudiana nella comprensione del fascismo come fenomeno sociale, in quanto pone l’urgenza di comprendere, accanto a tutto il resto, anche i condizionamenti e le tirannie interne (IL fascista interno) al soggetto. Curiosamente, però, Fabrizio Denunzio attribuisce l’ulteriore sviluppo di tale riflessione, nella seconda metà del Novecento, ad alcuni illustri autori francesi, quali Foucault, Deleuze, Guattari, i quali notoriamente si sono ispirati a pensatori come C. Schmidt, Nietzsche e Heidegger, tutti, almeno a parere di chi scrive, reazionari, anti-dialettici e immersi nel tunnel dell’irrazionale. La lotta contro i residui del “fascista” (morte nera) dentro di noi, a quanto pare, non può mai dirsi conclusa. Che la Forza sia con noi!
*
IL FATTO QUOTIDIANO, di Iside Gjergji | 23 dicembre 2016
- Sul concetto di presente storico. Note per le "Tesi" di W. Benjamin (cfr. pdf allegato).
- LA RINASCENZA DEL SOGGETTO. SULLE TRACCE DI BENJAMIN, AL DI LA’ DELL’EDIPO.
Walter Benjamin, l’inquilino in nero
di Massimo Palma (alfapiù, 11 gennaio 2017)
- Fabrizio Denunzio, La morte nera. La teoria del fascismo di Walter Benjamin, ombre corte, 2016, 119 pp., € 10
A Fabrizio Denunzio la taccia di eresia non importa. Collocarsi al di fuori di ogni corrente degli studi su Benjamin è in sé un merito, dati i successi di questo loser nelle mode filosofiche, editoriali e culturali di questi anni.
L’angolatura è originale - evidente sin da Quando il cinema si fa politica (2010). Ancor più nella Morte nera. Lo stile è assertorio, didascalico, deduttivo. Denunzio avvicina testi notissimi come fosse la prima volta, li incrocia con frammenti poco visitati e propone un mash up che costringe immancabilmente a leggerlo due volte: quando affianca al celebre saggio su Kraus la poco nota recensione di Haecker, la chiosa è cristallina: «non volendo essere affatto raffinati, anzi, volendo peccare di rozzezza». Lo stesso accade quando impiega concetti inventati con indubbia capacità plastica (l’Illuminismo «compresso»), quasi fossero concetti benjaminiani. In più, Denunzio incrocia temi forti: l’arte politica, l’uso della radio.
Brillante, oggi, la scelta di affrontare una variante della Germania segreta, lemma che Benjamin mutua da Stefan George (chissà perché assente nel libro), e delle tante letture dell’intima affinità tra l’Intelligenz tedesca e le idee naziste, che da Kantorowicz e Lukács a Jesi e Lacoue-Labarthe, hanno attraversato l’incompiuta seduta di autocoscienza europea.
Qui si tocca un capitolo inedito: Benjamin e il fascismo. Fascismo che, ben mostra Denunzio, Benjamin ha visto di persona - nel 1924, nel mitico viaggio a Capri, vede Mussolini, restando colpito da una fisicità goffa e inarticolata -, ha intervistato nella sua versione francese (Georges Valois), ha recensito nella sua variante tedesca prenazionalsocialista (il libro di Ernst Jünger e soci, stroncato nel 1930), per poi farne un oggetto teorico, sicuramente avversario, ma - questa la tesi dirompente - altresì abitante nel corpo biografico e nell’armamentario teorico benjaminiano.
Non solo, quindi, Benjamin studia, avversa e teorizza il fascismo, ma Benjamin ha un fascista dentro di sé: nel senso pasoliniano, deleuziano, che è sempre il caso di riattivare. E Denunzio si cimenta con zelo sull’ipotesi di un Benjamin abitato. Lo mostrerebbero ricordi infantili sedimentati nella Cronaca berlinese, il rapporto negli anni Dieci con Gustav Wyneken, «guida» autoritaria e guerrafondaia del Movimento giovanile, ma anche il ruolo del tiranno nello studio sul barocco tedesco, la cui coincidenza con la «visione» di Capri viene usata come detonatore onniesplicativo, la lettura di Kafka e dei suoi funzionari sadici.
Che i due punti biografici (il padre e Wyneken) ricorrano teoricamente in chiave psicanalitica in due dei suoi scritti maggiori è assunto problematico, ma va a sostanziare la tesi di un inquilino imprevisto nel Benjamin teoreta del fascismo: Benjamin fascista.
Esattamente questo afferma Denunzio: «la coerenza sistemica della teoria del fascismo benjaminiana può essere assicurata solo postulando che il suo autore si sia profondamente identificato con esso. Dal momento che non si può dare fascismo senza l’uomo fascista, allora, la validità di questa teoria di Benjamin sta nel fatto che ad averla pensata è il fascista che lo abitava, ma che, per fortuna, non lo possedeva».
Questo postulato d’inizio libro resta tale. Tutto lo studio ne consegue. Questa premessa-conclusione - «il fascismo intrapsichico di Benjamin», il «padre compensativo interiorizzato da Benjamin per rispondere alla crisi d’autorità paterna: guerrafondaio, criminale e sadico» - si dirama, serpe in seno al lettore, in parallelo alla formula dell’«ebreo comunista esule e perseguitato» che, assieme all’intellettuale antifascista precario declassato non-accademico, classifica WB nel casellario vittimario. Paria come tanti.
Eppure, tale premessa-conclusione per esser presa sul serio deve celare una sottaciuta rilettura del concetto di immedesimazione o empatia, che Benjamin individua come una dannazione operativa della storiografia e della «tecnica» artistica in generale e che legge in questi termini sin dall’Origine del dramma barocco tedesco, per demolirlo nella tesi VII Sul concetto di storia come funzione «fascista» della scrittura.
Ma il libro sul barocco viene ignorato da Denunzio fin quasi alla fine: non lo menziona riguardo alla ricostruzione iper-cattolica, à la Schmitt, della «filosofia» del primo Benjamin (schiacciato sul Programma della filosofia futura e definito «non rassegnato a vivere in un mondo senza dei e trascendenza»), ma solo per affrontare il tiranno. E certo, nel momento in cui si affronta la teoria della storia di Benjamin, la decostruzione dell’Einfühlung deve emergere, perché è una decostruzione politica che modula il concetto anti-fascista di storia che Benjamin lascia ai posteri.
Dobbiamo quindi supporre che Denunzio la dia per scontata, nel momento in cui la sua tesi verte sul consentire col fascismo e sull’identificazione di Benjamin nel capo fascista («Benjamin si trova ad aver interiorizzato proprio una figura di Capo di questo tipo»). Un’immedesimazione il cui precipitato, nel critico che usa fonti tedesche già compromesse col regime, è esposto senza infingimenti: «li si disponga tutti assieme in un’unica immagine, i Kommerell, gli Obenauer e gli Schmitt, a mo’ di foto dell’epoca, semmai con tanto di divise e di fasce al braccio, e si vedrà in tutta la sua crudezza una costante dell’atteggiamento di Benjamin nei confronti di questi gerarchi del sapere fascista idealmente fotografati: la complicità».
Crudo, insinuante, il libro di Denunzio usa una bibliografia parca ed equilibrata (undici titoli di Benjamin, undici di Denunzio, articoli di giornale inclusi, poi altri diciotto testi, poi basta), ed è pieno di intuizioni. Eppure, il tessuto argomentativo rapido, apodittico, oltre al fuoco del libro, lascia colare anche omissioni (dov’è Georges Sorel, menzionato di corsa in un libro sul fascismo e Benjamin?, dove Bachofen?), inutili parafrasi di Habermas (utilizzato a piene mani in un excursus per un riassuntino di storia della filosofia), slalom speciali su temi-chiave: dell’empatia si è detto, ma si pensi al concetto fascista di natura, sfiorato e mai analizzato, ma centralissimo proprio nelle Teorie del fascismo tedesco e possibile volano per sfuggire alla rilettura proposta, iper-francofortese, del bivalente illuminismo benjaminiano; si pensi infine a come, figlio dell’alta borghesia ebraica assimilata, Benjamin della borghesia ha marxianamente mostrato l’ambigua, contraddittoria grandezza.
Restano gli affondo, la profondità abissale del tema, la libertà di ricerca esibita, ma anche l’incedere di un libro pesantissimo che vola da un fiore all’altro dell’orto benjaminiano, decontestualizzando un singolo riferimento epistolare del 1924, un passo di diario del 1938 e passaggi di opere complesse (decenni di ricezione non solo «idealista» né «teologico-politica» sarebbero lì a testimoniarlo), per attribuire all’autore l’inconscia «richiesta di uno Stato forte» e un «desiderio» di fascismo», senza dialogare con alcuno se non i suoi testi.
In questa sua singolare forma anti-scientifica, l’intenzione davvero profonda che abita il saggio, e forse lo possiede, risulta difficilmente comprensibile al di fuori del moto d’identificazione spiegato nelle Memorie di famiglia dell’Introduzione (il lignaggio fascista dell’autore, naturalmente ripudiato). Un tratto, questo, che rende sì il testo una ricerca di antidoti, ma anche una requisitoria senza contraddittorio, perché in sostanza autoaccusa. Raccolta di intuizioni talora lancinanti, La morte nera è un libro da integrare, argomentare, arredare, senz’altro abitare col rigore necessario. Per poi magari espropriarlo di ogni immedesimazione.
 NOTA *:
NOTA *:LE “REGOLE DEL GIOCO” DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE. La teoria del fascismo di Walter Benjamin ...
Benché segnata da timore e tremore, l’autore della recensione ("Alfabeta2", 11 gennaio 2017) non ha potuto non riconoscere il coraggio dell’Autore e del suo lavoro sulla “morte nera” ... e superate le resistenze ha saputo accogliere anche dentro di sè “l’inquilino in nero”!!!
Trovata la “cosa” di grande interesse teoretico e storico (sul tema, ad ampio ‘spettro’, si cfr.: “Le due metà del cervello”, “Alfabeta”, n. 17, settembre 1980, p. 11), l’ho ripresa qui: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5556#forum3119697, in collegamento e in riferimento a un mio ‘vecchio’ lavoro (“La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica”, Roma 1991).
*
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- KANT, IL “MOSE’ DELLA NAZIONE TEDESCA” E LE ORIGINI DELL’“IMPERATIVO CATEGORICO” DI HEIDEGGER E DI EICHMANN.16 gennaio 2017, di Federico La Sala
WALTER BENJAMIN, IL “PROGRAMMA DELL FILOSOFIA FUTURA”, E “CAGLIOSTRO”: KANT, IL “MOSE’ DELLA NAZIONE TEDESCA” E LE ORIGINI DELL’“IMPERATIVO CATEGORICO” DI HEIDEGGER E DI EICHMANN.... *
CONDIVIDENDO LA CONCLUSIONE DELLA NOTA DI Iside Gjergji (si cfr.:‘La morte nera’ e il fascista che è in noi - http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/23/la-morte-nera-e-il-fascista-che-e-noi/3274504/):
- L’autore sottolinea, dunque, quanto già evidenziato dalla migliore tradizione della Scuola di Francoforte, ovvero l’imprescindibilità della teoria freudiana nella comprensione del fascismo come fenomeno sociale, in quanto pone l’urgenza di comprendere, accanto a tutto il resto, anche i condizionamenti e le tirannie interne (IL fascista interno) al soggetto. Curiosamente, però, Fabrizio Denunzio attribuisce l’ulteriore sviluppo di tale riflessione, nella seconda metà del Novecento, ad alcuni illustri autori francesi, quali Foucault, Deleuze, Guattari, i quali notoriamente si sono ispirati a pensatori come C. Schmidt, Nietzsche e Heidegger, tutti, almeno a parere di chi scrive, reazionari, anti-dialettici e immersi nel tunnel dell’irrazionale. La lotta contro i residui del “fascista” (morte nera) dentro di noi, a quanto pare, non può mai dirsi conclusa. Che la Forza sia con noi!
MI PERMETTO DI DIRE, SOLAMENTE, CHE “leggere *monotematicamente* Benjamin” e “metterlo al servizio del comunismo” - come chiarisce Fabrizio Denunzio nelle “Memorie di famiglia” (si cfr. l’Introduzione a “La morte nera”, Ombre Corte, Verona, 2016, p. 14) riporta al punto di partenza, nel vicolo cieco - da cui lo stesso Benjamin non è uscito.
Sulla “teoria del fascismo di Walter Benjamin”, Denuzio ha brillantemente messo e rimesso a fuoco il problema, ma non ha visto e non poteva vedere la “CAGLIOSTRO-sità” del problema per essersi collocato con lo stesso Benjamin in un’orizzonte hegelo-marxista (e non più propriamente “kantiano” - alla Kant, e “marxiano” - alla Marx!) e pensare meglio e bene il nesso tra “ragione e religione”, il materialismo - “quel vuoto che si viene a creare quando la ragione abolisce ogni collegamento con la trascendenza”(op. cit., p. 34), e, infine, lo stesso “Messia” delle Tesi “Sul concetto di storia”.
Benjamin (come Freud, Aby Warburg, Kantorowicz) cerca di imitare “Mosè”, pensa il problema dell’”esodo”, ma alla fine non riesce a scappare “dall’Egitto” e, drammaticamente, finisce per restare (e con Goethe!) nella terra e nell’orizzonte del “Grande Copto”, del “Cagliostro” di turno. La “carica rivoluzionaria dell’Illuminismo” (op. cit., p. 11) di Kant è rimasta impensata - e ancora impensabile!
* Sul tema, mi sia consentito, cfr.: FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA... http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4829: in particolare, HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI... http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790
Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- WALTER BENJAMIN E IL NAZISMO. PER NON PERDERE IL FILO: "IL PARADISO DEI GIUSTI".18 gennaio 2017, di Federico La Sala
PER NON PERDERE IL FILO... *
STORIA E STORIOGRAFIA: IMMANENZA E TRASCENDENZA. "In ogni epoca bisogna cercare di strappare la tradizione al conformismo che è in procinto di sopraffarla" (Walter Benjamin):
L’ATLANTE DEL "PARADISO IN TERRA", BOLOGNA, DANTE, E LA "MEMORIA" DI ABY WARBURG... http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5878.
IL "LIBER PARADISUS" (https://it.wikipedia.org/wiki/Liber_Paradisus) DEL XX SECOLO: LA LISTA DI SCHINDLER ("Schindler’s List" - https://it.wikipedia.org/wiki/Schindler’s_List_-_La_lista_di_Schindler) - IL GIARDINO DEI GIUSTI ("Il primo Giardino dei Giusti (https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_dei_Giusti), nato a Gerusalemme nel 1962, è dedicato ai Giusti tra le nazioni. Il promotore è Moshe Bejski, salvato da Oskar Schindler).
«Neppure i morti saranno al sicuro dal nemico, se vince. E questo nemico non ha smesso di vincere» (Walter Benjamin)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- "Modernità e Olocausto": Zygmunt Bauman ha fatto della Shoah il caleidoscopio attraverso cui guardare nell’abisso disumano di una modernità che non ha mantenuto le promesse.10 gennaio 2017, di Federico La Sala
1925-2017
Morto Zygmunt Bauman
Nella Shoah vide lucidamente il nesso tra orrore e modernità
Il sociologo polacco è morto lunedì 9 gennaio all’età di 91 anni
L’analisi dello sterminio e il richiamo all’etica: ci si può sempre opporre al male
di DONATELLA DI CESARE
- L’immagine più celebre del ghetto di Varsavia (1940-1943), dov’erano confinati gli ebrei della capitale polacca occupata dai nazisti
Quando Zygmunt Bauman pubblicò, nel 1989, il suo libro Modernità e Olocausto (il Mulino), ancora pochi, a parte i testimoni, avevano azzardato riflessioni o ipotesi interpretative. A lungo si era protratta una afasia, dovuta non solo a rimozione, inconscia o intenzionale, ma anche alla difficoltà di pensare quel che era accaduto. Il suo libro ruppe il silenzio con un coraggio intellettuale senza precedenti. E da allora è rimasto una pietra miliare.
«Il regime nazista è finito da tempo, ma la sua venefica eredità è tutt’altro che morta», così avvertiva Bauman. Ebreo polacco, scampato all’invasione nazista nel 1939, chiedeva molto più della punizione del crimine. Se si trattasse di questo - scriveva - si potrebbe «affidarlo allo studio degli storici». Ma la questione andava al di là degli esecutori, al di là perfino delle vittime. «Oggi più che mai l’Olocausto non costituisce un’esperienza che appartiene ai soggetti privati (ammesso che mai sia stato così): non ai suoi esecutori, affinché vengano puniti; non alle sue vittime dirette, perché godano di simpatia, favori o indulgenze particolari in nome delle loro sofferenze passate; e non ai suoi testimoni, in cerca di redenzione o di certificati di innocenza. Il significato attuale dell’Olocausto è dato dalla lezione che esso contiene per l’intera umanità».
Bauman è stato il primo ad avanzare l’esigenza di considerare la Shoah un capitolo della storia umana, quella terribile ed estrema del Novecento. Senza farne un evento unico, fuori dalla storia e fuori dalla ragione, ma senza neppure ignorare quelle caratteristiche che l’Olocausto non condivide con nessuno dei precedenti casi di genocidio.
Certo, l’omicidio di massa non è un’invenzione recente. La storia è punteggiata di violenze, massacri, stermini. Ma l’industrializzazione della morte nelle officine di Hitler impone una riflessione peculiare. Lo sterminio appare a Bauman l’epilogo della civiltà industriale e tecnologica, di quella organizzazione burocratica del mondo in cui viene profilandosi il dominio totalitario. Perciò Bauman punta l’indice contro la modernità.
Non si può non vedere il ruolo attivo della civiltà moderna nello scatenamento e nell’esecuzione dell’Olocausto. E, soprattutto, non si può non riconoscere il fallimento della modernità. Auschwitz non è un capitolo chiuso, concluso. Perché noi continuiamo a vivere in quella stessa modernità che ha consentito la «soluzione finale» volta ad annientare gli ebrei d’Europa.
Sul tema della colpa Bauman non si lascia andare a speculazioni metafisiche o a imponderabili teodicee. Quale senso può avere avuto la sofferenza degli innocenti? Non confermerebbe tutto ciò un mondo senza Dio? Anche se l’incommensurabilità dei crimini perpetrati sembra andare oltre ogni giustizia, la responsabilità è tutta umana. Il male non è un principio della mistica di cui dovrebbe rispondere Dio. È un’offesa di cui deve rispondere l’uomo.
La grande domanda che Bauman si è posto, a partire dalla sua riflessione sulla Shoah, è stata quella sulla responsabilità. Si può dire che il suo volume Le sfide dell’etica (Feltrinelli), pubblicato pochi anni dopo, nel 1993, sia in gran parte un precipitato di quei suoi studi. Delegittimata, schernita, l’etica appare fuori moda, destinata alla pattumiera della storia. Come se la modernità avesse decretato una emancipazione dall’etica.
Bauman denuncia l’illusione e il pericolo di questo modo fin troppo diffuso di pensare. Proprio quel che è accaduto ad Auschwitz ci insegna che l’etica è indispensabile e che la responsabilità è sempre assolutamente individuale. Il male non è onnipotente - è possibile, è doveroso resistere. «Non importa quante persone abbiano preferito il dovere morale alla razionalità dell’autoconservazione, ciò che importa è che qualcuno l’abbia fatto».
Zygmunt Bauman ha fatto della Shoah il caleidoscopio attraverso cui guardare nell’abisso disumano di una modernità che non ha mantenuto le promesse. Si condensa forse qui il compito ultimo della sua intensa e instancabile ricerca, un compito che questo grande diagnostico del mondo contemporaneo non ha mai disatteso.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- UNA NUOVA POLITICA. «Lo stato sociale è finito, è ora di costruire il “Pianeta Sociale”» (Zygmunt Baumann)10 gennaio 2017, di Federico La Sala
- DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia"
-
CHI SIAMO NOI, IN REALTÀ?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Intervista a Zygmunt Baumann
UNA NUOVA POLITICA
di Alessandro Lanni (Reset Nov 2008) *
«Lo stato sociale è finito, è ora di costruire il “Pianeta Sociale”». Solo così, spiega Zygmunt Baumann, si potrà uscire dalla crisi globale che il mondo contemporaneo sta vivendo. La politica deve avere la forza di reinventarsi su scala planetaria per affrontare l’emergenza ambientale o il divario crescente tra ricchi e poveri. Altrimenti è con-dannata alla marginalità in una dimensione locale, con stru¬menti obsoleti adatti a un mondo che non esiste più. L’inventore della "società liquida" non crede in una capacità di auto-riforma della politica, «meglio costruire un’opinione pubblica globale e affidarsi a organizzazioni cosmopolite, extraterritoriali e non governative».
I nostri politici ce la faranno a cambiare paradigma, passan¬do dal locale al globale?
«Io non conterei molto sui governi - di nessun paese, piccolo o grande che sia - e ancor meno sui loro tentativi di collaborazione, che finiscono regolarmente in una poesia di nobili intenzioni piuttosto che in una prosa di concreta realtà. I poteri che decidono sulla qualità della vita umana e sul futuro del pianeta sono oggi globali e dunque, dal punto di vista dei governi, sono extraterritoriali ed esenti dalla loro sovranità locale. Finché non innalziamo la politica ai livelli ormai raggiunti dal potere, le probabilità di arrestare gli sviluppi catastrofici cui stiamo conducendo la nostra vita sul pianeta sono, quantomeno, scarse».
Dunque, di quali strumenti alternativi dovrebbe dotarsi la politica per affrontare le grandi emergenze del nuovo mondo globale?
«L’obiettivo di arrestare le ineguaglianze globali che tendono a divenire rapidamente più profonde non compare tra le priorità delle agende politiche degli Stati-nazione più potenti, nonostante le tante promesse fatte al riguardo. Contemporaneamente, mancano ancora un’ "agenda politica planetaria" e delle istituzioni politiche globali efficaci e dotate di risorse che gli permettano di perseguire simili obiettivi rendendoli operativi. Le prerogative territoriali degli Stati-nazione ostacolano la creazione di tale agenda e di tali istituzioni e rendono ancora più difficile il tentativo di mitigare il processo di polarizzazione».
Gli Stati da soli non possono farcela. I singoli cittadini hanno qualche possibilità in più di mettere mano ai disagi che avvertono, per organizzare un’azione collettiva?
«Qui interviene quel fattore che è stato ampiamente descritto con il termine "individualizzazione". Con il progressivo abbassarsi della condizione di difesa mantenuta contro le paure esistenziali, e con il venir meno di accordi per l’autodifesa comune, come per esempio i sindacati o altri strumenti di contrattazione collettiva, depotenziati della competizione imposta dal mercato, spetta ai singoli trovare e mettere in pratica soluzioni individuali a problemi prodotti dalla società nel suo complesso. Ma fare tutto questo da soli e con strumenti per forza limitati risulta palesemente inadeguato al compito prefisso».
Anche il climate change è tra le grandi paure e insicurezze che l’uomo occidentale deve fronteggiare.
«L’insicurezza deriva dal divario tra la nostra generale interdipendenza planetaria e la natura meramente locale, a portata di mano, dei nostri strumenti di azione concertata e di controllo. I problemi più terribili e spaventosi che ci tormentano e che ci spingono a provare una sensazione di insicurezza e incertezza riguardo a tutto ciò che ci cir-conda hanno origine nello spazio globale che è al di là della portata di qualsiasi istituzione politica ora esistente; tuttavia questi problemi sono scaricati sulle entità locali - città, province e Stati - dove si pretende che vengano risolti con quei mezzi disponibi¬li a livello locale: un compito praticamente impossibile».
Eppure in molti sostengono che alcune questioni relative all’inquinamento, alla produzione d’energia, ai rifiuti, possono essere affrontate a livello «micro», di città, di governi locali.
«L’inquinamento atmosferico e la mancanza di acqua potabile sono questioni che traggono origine nello spazio globale, ma sono poi le istituzioni locali a doverle gestire. Lo stesso principio si applica al problema delle migrazioni, del traffico di droga e armi, del terrorismo, della criminalità organizzata, dell’incontrollata mobilità dei capitali, dell’instabilità e della flessibilità del mercato del lavoro, della crescita dei prezzi dei beni di consumo e così via. La sfera politica locale è sovraccarica di compiti e non è abbastanza forte o abbastanza dotata di risorse per svolgerli. Solo istituzioni politiche e giuridiche internazionali - finora assenti - potrebbero tenere a bada le forze planetarie attualmente sregolate e raggiungere le radici dell’insicurezza globale».
E un governo planetario che salverà il mondo?
«Allo stadio di sviluppo a cui è ormai giunta la globalizzazione dei capitali e dei beni di consumo, non esiste nessun governo che possa permettersi, singolarmente o di concerto con altri, di pareggiare i conti - e, senza che si pareggino i conti, è impensabile che si possano effettivamente mettere in atto le misure tipiche dello Stato sociale, volte a ridurre alla radice la povertà e a prevenire che l’ineguaglianza continui a crescere a piede libero. E’ altrettanto difficile immaginare governi capaci di imporre limiti sui consumi e aumentare le tasse locali ai livelli necessari perché lo Stato possa continuare a erogare servizi sociali, con la stessa intensità o con maggior vigore».
La globalizzazione cancella anche lo Stato sociale. Professor Bauman, non lascia speran¬za per un briciolo di giustizia e di eguaglianza nel mondo del XXI secolo?
«Non esiste una maniera adeguata attraverso la quale uno solo o più Stati territoriali insieme possano tirarsi fuori dalla logica di interdipendenza dell’umanità. Lo Stato sociale non costituisce più una valida alternativa; soltanto un "Pianeta sociale" potrebbe recuperare quelle funzioni che, non molto tempo fa, lo Stato cercava di svolgere, con fortune alterne. Credo che ciò che può essere in grado di veicolarci verso questo immaginario "Pianeta sociale" non siano gli Stati territoriali e sovrani, ma piuttosto le organizzazioni e le associazioni extra-territoriali, cosmopolite e non-governative, tali da raggiungere in maniera diretta chi si trova in una condizione di bisogno, sorvolando le competenze dei governi locali e sovrani e impedendogli di interferire».
* Segnalazione di don Aldo Antonelli.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- IL LIBER PARADISUS, DANTE, E LA LISTA DI SCHINDLER.6 gennaio 2017, di Federico La Sala
DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia"
- IL "LIBER PARADISUS" DEL XX SECOLO: LA LISTA DI SCHINDLER ("Schindler’s List") - IL GIARDINO DEI GIUSTI ("Il primo Giardino dei Giusti, nato a Gerusalemme nel 1962, è dedicato ai Giusti tra le nazioni. Il promotore è Moshe Bejski, salvato da Oskar Schindler).
- PAURA DELLLA GUERRA CIVILE, SCHIAVITU’, E COSTITUZIONE. Dal film "Amistad", l’arringa davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti di John Quincy Adams.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Da Bauman a Diamanti, viaggio al termine della democrazia (di Wlodek Goldkorn)30 dicembre 2016, di Federico La Sala
STORIA E STORIOGRAFIA. "In ogni epoca bisogna cercare di strappare la tradizione al conformismo che è in procinto di sopraffarla" (W. Benjamin):
- L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
IngrandimentoDa Bauman a Diamanti, viaggio al termine della democrazia
Avanza l’idea che con la globalizzazione sia finita un’epoca iniziata con l’Illuminismo. E dopo? Ecco le diagnosi
di Wlodek Goldkorn (l’Espresso, 29 dicembre 2016)
Come il romanzo e la borghesia, i due migliori prodotti della modernità occidentale, anche la democrazia da quando esiste è in crisi: si interroga sempre e in continuazione su se stessa mentre lotta per la propria (non garantita) esistenza. Questa volta però, nel quarto lustro del Ventunesimo secolo, forse non siamo più a una qualche correzione di rotta e aggiustamento delle procedure. Molti studiosi concordano ormai sull’ipotesi che siamo nel “dopo la democrazia”.
O meglio, avanza l’idea che qui in Occidente sia finita la democrazia come l’abbiamo conosciuta e immaginata a partire dal Secolo dei Lumi e fino alla globalizzazione. E ancora, fin dall’irruzione dei partiti di massa sulla scena politica (una forma di “parlamentarizzazione” della lotta di classe, altrimenti cruenta perché i proletari erano trattati alla stregua di “selvaggi” come i popoli colonizzati; e basti pensare a Bava Beccaris o al massacro dei comunardi di Parigi) a partire dall’ingresso dei partiti socialisti nel gioco parlamentare dunque, eravamo convinti che ci fosse un nesso intimo tra le seguenti categorie: progresso, libertà, democrazia, crescita economica, scolarizzazione di massa, emancipazione. Le cose andavano insieme, più libertà e più consumi; più democrazia e maggiore crescita economica e personale e via coniugando.
- vedi anche:
 Colin Crouch: "L’illusione della rivolta apre le porte ai dittatori"
Ha descritto un mondo in mano alle élite dove al popolo era concessa solo la “finzione” del voto. «Ma oggi è molto peggio». Parla il sociologo che ha inventato la parola “postdemocrazia”
Colin Crouch: "L’illusione della rivolta apre le porte ai dittatori"
Ha descritto un mondo in mano alle élite dove al popolo era concessa solo la “finzione” del voto. «Ma oggi è molto peggio». Parla il sociologo che ha inventato la parola “postdemocrazia”
Certo, le guerre mondiali e i fascismi hanno segnato dei passi indietro, ma dal 1945 regnava in Occidente una specie di stabile e progressiva convergenza tra il liberalismo e la socialdemocrazia (due avversari storici): più profitti e più uguaglianza, più libertà e più garanzie dei lavoratori e fino all’apoteosi, quasi hegeliana, dei diritti umani nel 1989. Poi, all’improvviso tutto è finito. I nostri figli vivranno peggio di noi; il voto non stabilisce legame tra gli eletti e i cittadini; il lavoro è precario quando c’è; e il futuro appare come una minaccia angosciante e non più come promessa e magnifica immaginazione. Del progresso nessuno parla se non per dire che è “cane morto” e illusione del passato, il sol d’avvenire è spento e i politici sembrano figuri grotteschi, dediti a celebrare riti vuoti dal punto di vista semantico, perché incapaci di suscitare un motto di identificazione con chi ci dovrebbe rappresentare (e basti pensare all’immagine delle consultazioni quirinalizie poche settimane fa).
E allora, cosa ci aspetta? L’abbiamo chiesto a studiosi, filosofi, scienziati della politica. A partire da Zygmunt Bauman. Ma prima di sentirlo, due ulteriori premesse. Nel 1991 Christopher Lasch, storico americano scomparso ventidue anni fa, in un libro “Il paradiso in Terra” (Neri Pozza) in cui dava addio all’illusione appunto del progresso, citava un’osservazione di George Orwell (del 1940) per cui mentre le democrazie offrirebbero agiatezza e assenza di dolore, Hitler offriva lotta e morte; e ancora, nell’ultimo anno dell’Ottocento, Georg Simmel, sociologo tedesco cantore della metropoli con il suo caos e il denaro come la misura di tutto, diceva di comprendere comunque i laudatori dei valori all’antica e dei gesti eroici. E allora, anche oggi, di fronte alla Babele del pianeta globalizzato, stiamo cominciando (sotto le mentite spoglie dei populismi) a rivalutare il valore della comunità chiusa, isolata e retta da un uomo forte?
La risposta di Bauman è sì. Il sociologo parte dalla nozione di “retrotopia”, utopia retroattiva: richiamo a un passato mitico, inventato e che si presenta come la più seducente possibilità di fuga dalla angustie di un incerto presente. La retrotopia spiega per esempio il successo di Trump. Il presidente eletto non ha offerto, appunto, alcuna visione di un futuro migliore, di avanzamento della condizione della gente (come un Roosevelt o un Kennedy): il suo messaggio è invece quello di ripristinare il “glorioso” passato degli States rurali e proletari, non contaminato dal linguaggio politicamente corretto delle élite mondializzate, attente alle “regole”; regole incomprensibili però per l’uomo comune che così si sente escluso e non all’altezza di competere per il proprio posto al sole. vedi anche: AGF-EDITORIAL-59412-jpg La democrazia? E’ viva e lotta insieme a noi "L’elettorato protesta contro l’establishment, non contro il metodo democratico. Siamo scontenti delle scelte immediate dei nostri governanti, delle loro politiche. Ma non vedo all’orizzonte forze che seriamente vorrebbero rovesciare il sistema democratico". Il controcanto di Bernard Manin
Le élite politiche, a loro volta, non sono in grado di mantenere le promesse fatte. E non lo sono perché abbiamo a che fare con «il divorzio tra il potere e la politica». Il potere è sempre meno legato al territorio, sempre più rappresentato da entità astratte e immateriali (banche, finanza, mercati). Tutto questo crea frustrazione, ricerca del colpevole, del capro espiatorio, desiderio di tornare dalla “condizione cosmopolita” (teorizzata già oltre un secolo fa da austromarxisti e da socialisti del Bund ebraico) verso una comunità chiusa e dove è possibile un’illusoria ed estrema semplificazione. Chiusura e semplificazione (accresciute dalla paura dei migranti) che si trasformano nel desiderio di un “uomo forte”. Dice Bauman: «Forse la parola democrazia non sarà abbandonata, ma sarà messa in questione la classica tripartizione di potere tra l’esecutivo, il legislativo e il giudiziario». Addio, dunque Montesquieu: porte spalancate a possibili forme dittatoriali. Anche perché, «perfino la speranza è stata privatizzata».
Ma forse Bauman, non teorico dell’azione, ma critico dell’esistente è troppo pessimista (in realtà, in privato ammette di sperare in una rinascita della sinistra cosmopolita). Forse occorre aggrapparsi alle parole di Chantal Mouffe, belga, celebre per i suoi studi sul populismo e sul concetto dell’egemonia, quando parla della necessità di tornare a una sinistra antagonista e che rigetti il compromesso liberal-socialdemocratico. O forse ha ragione Pierre Rosanvallon, politologo francese, tra i più rinomati che va ripetendo che non siamo più in democrazia (“Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia”, “Le Bon Gouvernement”) e propone misure concrete di resistenza. Tra queste: sorvegliare, vigilare, controllare il potere e «parlar chiaro e dire la verità». E con quest’ultima parola d’ordine torna alle ricerche di Michel Foucault sulla “parresia”, il dire ciò che si pensa dei Greci ai tempi di Pericle, virtù cittadina e mezzo di opposizione alle tentazioni di ogni tirannide.
Fin qui la speranza, perché Rosanvallon dice anche che la vecchia idea di un parlamento che legifera e un governo che esegue non esiste più, perché il potere politico è ormai in mano all’esecutivo e cresce la voglia di presidenzialismo ovunque. Gli fa eco David Van Reybrouck, uno studioso che arriva a teorizzare il sorteggio di persone chiamate a decidere delle cose della politica, come avveniva appunto ad Atene, tanto da aver scritto un libro intitolato “Contro le elezioni” (e aggiunge: «Gli eletti sono élite»). Dice Donatella Di Cesare, professoressa di Filosofia teoretica a La Sapienza e femminista con forti tendenze anarchiche: «La democrazia è l’ultimo tabù. Nessuno osa metterlo in questione, eppure bisogna cominciare a farlo se non vogliamo la catastrofe e se desideriamo preservare le nostre libertà». Indica l’America per dire: «La democrazia sta diventando dinastia».
E allora che fare? «Rendere la democrazia più femmina e meno maschio. Accettare, in questi tempi di mondializzazione e di flussi di migranti, una sovranità limitata, condizionata, distaccata dall’ossessione identitaria, aperta invece ad Altri. Chi esalta la sovranità rigida, finirà per rinunciare alla libertà in nome appunto della mera sovranità. Io lo temo». Lo teme pure Jan Zielonka docente a Saint Antonys College, a Oxford, alla Cattedra intitolata a Ralph Dahrendorf, per decenni pontefice massimo del liberalismo. Da Varsavia, dove si trova in vacanza, al telefono conferma: «Sta vincendo la controrivoluzione. Certo, l’ondata controrivoluzionaria avanza grazie a elezioni e non con putsch militari o barricate, ma pensare che si possa tornare indietro verso il rassicurante mondo della democrazia liberale è una follia».
A questo punto non resta che fare un po’ di ordine e ripetere la domanda: che fare? La parola va a Emmanuel Todt, personaggio geniale, controverso, poliedrico, storico «della lunga durata» (così si autodefinisce), che prima di esplicare il suo pensiero ci tiene a presentarsi come prosecutore delle tradizioni della «vecchia borghesia israelitica patriottica». Usa questa definizione desueta per sottolineare la sua impermeabilità alle mode identitarie, perché poi difende una certa idea di identità. Otto anni fa Todt pubblicò un libro intitolato “Après la démocratie” (dopo la democrazia). Oggi dice: «La storia dell’Occidente non coincide con la storia della democrazia». E anche: «La democrazia era legata alla diffusione del sapere a alfabetizzazione delle masse», per arrivare ad affermare: «Oggi invece le élite, minacciate da un popolo ormai in grado di leggere e scrivere cercano di stabilire comunque la differenza culturale. E così tradiscono la democrazia, dicendo che chi vota Trump o Brexit è ignorante». Rimarca: «La democrazia comunque non esiste più. È morta assieme alla globalizzazione e all’euro, ai flussi migratori incontrollati. Se io non sono padrone della moneta e del territorio, non posso esercitare i miei diritti democratici». Ripete: «Non sono uno xenofobo, ho in odio il Front national, ma mi preme dire ciò che penso».
E allora, davvero è finita la democrazia? Conclude Ilvo Diamanti. Che dice due cose fondamentali. La prima: la democrazia è una forma di potere, di “cratos”, non può dunque essere parziale e deve anzi corrispondere a un territorio abitato e gestito da una popolazione di cittadini (una constatazione non del tutto ovvia ai tempi del mondo globale). In altre parole: la responsabilità, principio della democrazia contempla la delimitazione, quindi l’esistenza dei confini. La seconda: la forma della democrazia corrisponde alla tecnologia della comunicazione. Ai tempi dei notabili, l’arena era il parlamento e i partiti nascevano nelle Aule delle assemblee, elette per lo più per censo. Poi sono subentrati i partiti di massa e si è passati alla piazza e ai giornali. Lo stadio successivo è stata la personalizzazione e il leaderismo e siamo alla tv.
Oggi a queste forme (nessuna del tutto scomparsa) va aggiunta la Rete. E siamo alla “democrazia ibrida”. Aggiunge: «La Rete permette qualcosa che assomiglia alla democrazia immediata, dove la deliberazione e l’esecuzione avvengono contestualmente. Ma la democrazia ha bisogno delle mediazioni, là dove invece è immediata e radicale (come nell’utopica visione giacobina o ad Atene del V secolo avanti Cristo) tende ad abolire se stessa». La abolirà? «Penso», risponde, «che vivremo in un mix tra democrazia mediata e immediata». E non è un futuro rassicurante.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - Wlodek Goldkorn: la memoria preziosa di un ebraismo che non coincide col sionismo.30 dicembre 2016, di Federico La Sala
Wlodek Goldkorn: la memoria preziosa di un ebraismo che non coincide col sionismo
di Gad Lerner (sabato, 4 giugno 2016)
Ho letto con emozione l’ultimo bellissimo libro di Wlodek Goldkorn, “Il bambino nella neve” (Feltrinelli), non solo perchè si tratta dell’opera più intima e impegnativa di un amico al cui tragitto esistenziale mi sento affratellato. Figlio di ebrei polacchi sopravvissuti alla Shoah che avevano deciso di restare a vivere nel loro paese e che invece dovettero emigrare in Israele nel 1968, di fatto espulsi dal regime comunista con una valigia e cinque dollari a testa, Wlodek ha trovato le parole per raccontarci le molteplici conseguenze di quello strappo perpetrato nel cuore dell’Europa. In cui pure è ritornato a vivere, trovando in Italia una terra capace di ospitare la sua anima tormentata e cosmopolita.
Straordinarie sono le pagine dedicate all’infanzia trascorsa a Katowice, non lontano da Auschwitz, nei casermoni abbandonati nel 1945 dagli occupanti nazisti, col mobilio e le stoviglie ancora marchiati dalle svastiche. Custodire la memoria degli sterminati e perpetuare sotto il comunismo sovietico una cultura yiddish depurata da anacronismi superstiziosi, si rivelò una sfida improba. Eppure, indispensabile. Perchè l’ebraismo vive nel tempo d’attesa del Messia e non solo nello spazio proprietario di una terra idolatrata, sia essa pure la terra d’Israele da cui Wlodek si sentirà nuovamente respinto.
Non a caso si sceglierà come maestro di vita Marek Edelman, il vicecomandante della rivolta del ghetto di Varsavia divenuto cardiochirurgo e testimone del dissenso antiregime. La sua è un’adesione postuma al Bund, il partito socialista ebraico che contrastava il progetto sionista, considerando prioritaria l’emancipazione “qui e ora” degli ebrei nella terra in cui già vivevano da secoli. Impegnati a custodire le tombe e presidiare i luoghi di uno sterminio mai visto prima, ma nello stesso tempo a perpetuare l’anelito di redenzione incarnatosi nell’impegno per la giustizia sociale e i diritti universali.
In altre parole, raccontando le vicissitudini della sua famiglia nelle asperità di un dopoguerra tutt’altro che pacificato, Wlodek Goldkorn mantiene vivo lo spirito di un ebraismo che non può accettare di ricondursi per intero nel destino del sionismo. Tanto più oggi, quando Israele soffre di un’involuzione particolaristica che ne sta mettendo a repentaglio la natura democratica e distorce a fini politici i suoi millenari insegnamenti. Wlodek è un prezioso testimone dell’ebraismo. Laico, non credente, eppure messianico. Con questo libro, corredato dalle belle fotografie di Neige De Benedetti che l’ha accompagnato in una sorta di pellegrinaggio nell’indicibile dei campi di sterminio, si rivela essere anche uno scrittore di vaglia.
“Il bambino nella neve” è un libro importante, colma un buco nero. L’esperienza vissuta in prima persona da persone sensibili e colte come il suo autore, ha un valore inestimabile che durerà nel tempo.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - Guida al nuovo occidente che ha perduto l’idea di futuro: "Occidente senza utopie" (di Roberto Esposito)30 dicembre 2016, di Federico La Sala
STORIA E STORIOGRAFIA. "In ogni epoca bisogna cercare di strappare la tradizione al conformismo che è in procinto di sopraffarla" (W. Benjamin):
- FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Guida al nuovo occidente che ha perduto l’idea di futuro
Il saggio di Massimo Cacciari e Paolo Prodi analizza la crisi della società attraverso il declino di due categorie fondamentali: “profezia” e “utopia”
di Roberto Esposito (la Repubblica, 13.09.2016)
- Il libro Occidente senza utopie di Massimo Cacciari e Paolo Prodi (Il Mulino pagg. 150, euro 14)
Il saggio di Massimo Cacciari e Paolo Prodi analizza la crisi della società attraverso il declino di due categorie fondamentali: “profezia” e “utopia”. In molti oggi parlano di crisi dell’Europa e dell’Occidente. Ma ben pochi risalgono alla sua origine scavando tanto a fondo nel corpo della nostra tradizione, come fanno Massimo Cacciari e Paolo Prodi nel loro Occidente senza utopie (il Mulino). Ciò che, pur nella diversità degli strumenti, incrocia i loro sguardi è da un lato il rifiuto di categorie lineari come quella di laicizzazione; dall’altra il coraggio di dichiarare il fallimento del progetto moderno.
La grande tradizione che è nata dalla tensione tra Atene e Gerusalemme e che, attraverso Roma, è sfociata nel diritto pubblico europeo, è arrivata a termine e non è possibile riattivarla, se non passando per la piena consapevolezza di quanto è accaduto. Se non si ha la forza, come scrive Paul Valéry, di fissare gli spettri che ci lasciamo alle spalle, non basteranno incontri di vertice o rifondazioni istituzionali per riprendere quel cammino interrotto.
I due paradigmi su cui gli autori misurano la distanza che separa il presente dalle sue radici, sono quelli di profezia e di utopia. Senza la potenza critica che hanno sprigionato nei secoli, alla nostra civiltà mancherebbe un lievito decisivo. Eppure il loro orizzonte è stato profondamente diverso.
La profezia - al centro del saggio di Prodi - ha espresso una critica del potere che ha aperto lo spazio di libertà per la creazione della democrazia. È lo spirito profetico che per la prima volta, in Israele, ha separato il sacro dal politico, rompendo l’identificazione teologico- politica tra potere e legge. Profeta è colui che, da un punto marginale, ha l’autorità per contestare il potere regale e sacerdotale. Il divieto ebraico di pronunciare il nome di Dio va inteso anche come difesa da ogni indebita sacralizzazione del potere. Ma anche la distinzione cristiana tra quel che è di Cesare e quel che è di Dio conserva, fino a un certo momento, la distinzione. Tuttavia la figura del profeta non resiste a lungo. Già ridotta nel Medioevo a quella del predicatore, è presto espulsa fuori dall’“accampamento” cristiano, nelle frange ereticali. Tradotta in un impossibile progetto politico da Savonarola, a partire da fine Settecento si fa da un lato anelito rivoluzionario e dall’altro contatto personale con Dio. Dopo la parentesi dei totalitarismi, interpretabili come forme perverse di religione politica, nell’attuale dominio della finanza globale sembra venuto meno ogni impulso profetico. E con esso l’anima stessa dell’Occidente.
Un percorso diverso, ma altrettanto esaurito, quello dell’utopia, ricostruito genealogicamente da Cacciari. Intanto essa non va confusa con le mitologie, antiche e medioevali, di ritorno alle origini. L’utopia si strappa dal passato per radicarsi nel proprio tempo con la potenza di un progetto volto al futuro. Da qui il rilievo che in essa hanno la scienza e la tecnica. Se si passa dall’Utopia di Moro alla Città del sole di Campanella, alla Nuova Atlantide di Bacone, questo elemento costruttivo, sistematico, viene sempre più in primo piano. Organizzazione economica, incremento del sapere e tolleranza religiosa sono le precondizioni di una società armonica e pacifica. Ma è proprio questo progetto di neutralizzazione dei conflitti a entrare presto in contrasto con la realtà altamente conflittuale dell’Europa moderna. Non solo la politica, ma anche lo sviluppo dell’economia e della scienza passano per un continuo susseguirsi di crisi che rompono ogni immagine di armonia.
Se le utopie ottocentesche di Fourier e Proudhon presuppongono la crisi della forma-Stato, Marx mette impietosamente a nudo il carattere ideologico dell’utopia. Mentre ancora Bloch persegue una proiezione salvifica verso il futuro, Benjamin revoca in causa ogni modello progressivo. Contro il principio- speranza di Bloch e la coscienza di classe di Lukács, egli nega che la redenzione possa passare per la prassi. Solo l’irrompere del divino nella storia può produrre novità radicale. Ormai l’idea di rivoluzione implode su se stessa insieme a quella di riforma. La via per il futuro è sbarrata. E dunque cosa resta da fare? La risposta di Cacciari, già da tempo avanzata, è quella di un dualismo assoluto. Autonomia del politico, sempre più ridotto a tecnica amministrativa, da un lato. E attesa di un Dio impossibile dall’altro. Weber e Wittgenstein: limpidezza dello sguardo e sobrietà delle parole. Tra i due, l’ascolto dei segni enigmatici con cui il Nuovo può sempre annunciarsi.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- I VENTI PSICOTICI DELL’EUROPA CONTEMPORANEA E L’INDICAZIONE DI CHRISTOPHER BOLLAS.25 dicembre 2016, di Federico La Sala
LA "COPPIA FREUDIANA". L’OPERA DI CHRISTOPHER BOLLAS "disegna il limite al quale si può spingere oggi l’analisi reciproca":
Prenderli al volo prima che precipitino
di Pietro Barbetta ( "Doppiozero", 22 ottobre 2016)
Il giovane Holden ha un momento di tenerezza davanti alla domanda della sorellina. Phoebe, questo il nome della piccola, gli chiede che cosa vuol fare da grande. Holden risponde che ci sono tanti ragazzi: “e intorno non c’è nessun altro, nessun grande, voglio dire, soltanto io. E io sto in piedi sull’orlo di un dirupo pazzesco. E non devo fare altro che prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere nel dirupo... io devo saltar fuori da qualche posto e acchiapparli”.
È la parte più tenera del romanzo, quella che gli dà il titolo in lingua inglese il suo cuore: The Catcher in the Rye (l’intraducibile: Acchiappatore nella segale). Holden Caulfield prosegue: “Non dovrei far altro tutto il giorno. Sarei solo l’acchiappatore nella segale e via dicendo. So che è una pazzia, ma è l’unica cosa che mi piacerebbe veramente fare. Lo so che è una pazzia” (Salinger, Il giovane Holden).
Una delle ultime opere di Cristopher Bollas s’intitola Catch Them Before They Fall, prendili prima che precipitino. Prima che cadano nel dirupo. Ciò che Il giovane Holden racconta alla sorellina Phoebe, sembra rispecchiare la missione di Bollas nel suo lavoro con gli schizofrenici.
Cristopher Bollas nasce il 21 Dicembre del 1943 a Washington. Negli Stati Uniti riceve formazione umanistica e letteraria, con predilezione verso gli studi storici. Bollas conosce l’opera di Sigmund Freud come pochi e sviluppa, nel corso della sua vita, una pratica clinica intensa. È il più noto esempio vivente di umanista che, fin da giovane, è immerso nel flusso della clinica, ricevendo - nel tempo, col suo trasferimento a Londra - la formazione psicoanalitica. È un’epoca in cui, nel Regno Unito, non si fanno distinzioni tra medici e laici, conta la passione clinica.
La sua vita si svolge tra gli Stati Uniti e Londra. Nell’ultimo libro Se il sole esplode. L’enigma della schizofrenia, uscito per Raffaello Cortina, Bollas racconta il suo lavoro con persone schizofreniche e la sua formazione clinica, come se le due cose andassero in parallelo.
Bollas sembra sostenere che per lavorare con la psicosi, in particolare con la schizofrenia, l’essere psicoanalisti, o psicoterapeuti di qualunque scuola, non basta. Bisogna riconoscere che questo lavoro è una pazzia. Che il terapeuta ha bisogno di condividere la pazzia, di liberarsi dal terrore di venire contaminato, di essere, anche lui, un po’ schizofrenico, folle, delirante; al punto da considerare il delirio nient’altro che un sistema complesso di libere associazioni. Un esempio di sovra-determinazione freudiana.
Autore prolifico - le opere di Bollas hanno avuto particolare successo in Italia, grazie a Raffaello Cortina, Astrolabio, Borla e Antigone - è tra i massimi psicoanalisti viventi e attivi. Mentre qui da noi ci sono ancora psicoanalisti che si chiedono se sia corretto usare la lampadina elettrica, dal momento che ai tempi di Freud si usavano le lampade a gas, Bollas, senza alcuna inibizione da psicoanalista, scrive delle sedute che fa per telefono, via Skype; lasciandoci surplace.
Durante le mie lezioni di psicologia dinamica, propongo a un gruppo di studenti un seminario su Cristopher Bollas. Gli studenti intitolano il paper, scaturito dal lavoro collettivo: Alla scoperta dei temi controversi nella psicoanalisi. Ne nasce un animato dibattito tra il gruppo degli studenti coinvolti, il resto della classe e me. Il gruppo dà questo titolo al seminario per sottolineare come una serie di argomenti di Bollas si sviluppi a partire da riferimenti critici, addirittura di rottura, rispetto alla psicoanalisi. Evocano Ronald Laing e, più in generale, l’idea di psichiatria democratica.
Altri sottolineano che la cultura di Bollas è ricca di elementi storici, letterari, filosofici, che il libro sulla Mente orientale ricorda lo Zen e le considerazioni di Bateson su Bali.
Altri ancora sostengono che il transfert in Bollas è il contrario dell’idea di neutralità nella psicoanalisi classica, che per molti aspetti Bollas somiglia a un terapeuta rogersiano, a un terapeuta narrativo sistemico, a uno psicoanalista della relazione.
C’è chi, infine, dice che tutte queste tematiche sono recepite da buona parte dei membri della società psicoanalitica freudiana (la famosa IPA) e che oggi non si può più definire chi sia eretico in psicoanalisi. Chi, tra gli studenti, è già in terapia, dichiara che il suo terapeuta è come Bollas, ha lo stesso stile.
Forse Bollas dà voce a un modo accogliente di fare terapia che è già diffuso in campo psicoanalitico, transazionale, sistemico, gestaltico. Non fa che descrivere la terapia, distinguerla da quel guazzabuglio di interventi coatti e autoritari che hanno dominato l’inizio del millennio e che - finalmente! - stanno tramontando. Se così, dobbiamo dire che la sua voce è efficace, è un autentico metodo basato sull’evidenza; evidenza che la psicoterapia è, come la follia: creazione.
I racconti dei casi clinici, così come li scrive Bollas - in quello stile elegante tipico della letteratura anglosassone - sono opere letterarie, lontane dai gerghi psicoanalitici. Racconti didascalici, chiari, privi di espressioni tecniche. Bollas non usa la scolastica psicoanalitica in modo diretto. Quando la usa, come nel caso del termine inconscio collettivo, non dà mai per scontato che cosa significhi per lui e come mai, in quella circostanza, ha usato quel termine junghiano.
Il lettore che legge i suoi libri non sente sul collo il fiato della psicoanalisi seria, di quella cosa che Foucault chiamerebbe pratica discorsiva. Mi capita spesso di leggere in parallelo un testo letterario e dei saggi. Mentre leggo Bollas, non mi accorgo della differenza, non sento il salto tra saggistica e narrativa. I suoi scritti partono sempre dal soggetto Christopher, piuttosto che dal dottor Bollas.
Bollas non ha dunque alcuna pretesa teoretica astratta, nessun modello filosofico/antropologico definitivo da proporre. Scrive partendo dalla vita e la vita è vita di relazione tra sé e i suoi casi clinici, casi della vita. Nel libro Il mondo dell’oggetto educativo, Bollas insiste in maniera singolare su un termine: coppia freudiana. Non si tratta di un nuovo concetto da inserire nel lessico psicoanalitico, si tratta di un lemma che riguarda la relazione terapeutica.
Che cos’è la coppia freudiana? La coppia freudiana è un evento. Accade quando l’inconscio del soggetto che frequenta la terapia tocca l’inconscio del terapeuta. Questa definizione della traslazione in psicoanalisi non può non ricordare un autore che sta sullo sfondo del pensiero di Bollas, un po’ come Nietzsche sta sullo sfondo del pensiero di Freud: Sandor Ferenczi.
Il termine coppia freudiana evoca l’analisi reciproca di Ferenczi. L’opera di Bollas disegna il limite al quale si può spingere oggi l’analisi reciproca. Il coraggio di parlare di sé alle persone che frequentano le sedute e di scrivere di sé ai suoi lettori, non va scambiato con il narcisismo. È semmai il contrario. È immerso in un orizzonte di ironia e di curiosità terapeutica. È la maniera di mettere in comune le proprie esperienze con quelle del soggetto in terapia, di condividere le passioni, di reagire agli eventi, di riconoscere gli errori del terapeuta, di entrare in relazione.
Insomma, la traslazione del terapeuta non è contro-transfert, semmai co-transfert, se vogliamo usare il gergo della psicoanalisi.
Il terapeuta non è istruttore, interpretante, riparatore, è la parte di un incontro, non sempre dialogico, non senza conflitti. Ma la terapia è anche un mondo in cui i conflitti si gestiscono insieme.
Vorrei infine sottolineare l’uso diagnostico del termine psicosi per definire il periodo storico di una nazione: le tendenze psicotiche interne agli Stati Uniti negli anni Sessanta, secondo capitolo del suo ultimo libro, nome del capitolo: “La follia di una nazione”.
Mi è capitato di recente di scrivere su doppiozero.com alcune note sull’epoca psicotica che stiamo attraversando in Europa - sto persino cercando di scriverci sopra un libro - e mi conforta sapere che le mie riflessioni sono corroborate da un autore ben più importante. Dall’assassinio di Kennedy alla guerra del Vietnam, venti psicotici hanno pervaso gli Stati Uniti così come oggi questi venti pervadono l’Europa; dai comportamenti delle banche e dei più potenti manager alle incursioni dello Stato Islamico, dal risorgere di venti fascisti e nazionalisti all’insorgenza dei massacri della crescente sociopatia. Come i bimbi dell’East Bay Activity Center di Oakland, in California, negli anni Sessanta sentivano la patologia della nazione dentro la pelle, così gli adolescenti che mi capita di incontrare nel mio lavoro quotidiano sentono i venti psicotici dell’Europa contemporanea.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- RIPENSARE COSTANTINO. Dallo Stato sovrano allo Stato partecipato (di Paolo Prodi).23 dicembre 2016, di Federico La Sala
- FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Dallo Stato sovrano allo Stato partecipato
di Paolo Prodi (Il Mulino, 19 dicembre 2016]) *
In un precedente intervento su questa rivista, ho avanzato la tesi che la riduzione del problema delle pensioni a dilemma tra sistema retributivo e sistema contributivo ‒ come avviene non solo nella stampa e nei talk show, ma anche in interventi di autorevoli esperti ‒ è deviante e pericoloso particolarmente in questo momento storico: quando stiamo già abbandonando, con la rivoluzione tecnologica, il sistema della fabbrica e delle strutture burocratiche sulle quali si era costruito il Welfare State nell’Ottocento, con il coinvolgimento dei lavoratori e delle imprese. Il ricorso alla tassazione generale, al fisco, diventa invece inevitabile e urgente quando le figure del produttore-lavoratore e del consumatore non coincidono più.
Ora penso sia inevitabile ampliare il discorso con una seconda tesi, mettendo in discussione le conseguenze che questa diagnosi ha ‒ se è vera ‒ nel processo generale di superamento del moderno Stato sovrano di diritto. Senza affrontare il problema della crisi dello Stato nazionale nel mondo globalizzato, devo precisare come punto di partenza che per me è in crisi lo «Stato sovrano», non lo «Stato» considerato come realtà che muta attraverso i secoli e che, persa la sovranità tradizionale, sta cercando nuove funzioni. Non si tratta di un mutamento solo di pelle, ma di una metamorfosi che sta investendo sia il potere politico sia quello economico (nonché il sacro, sembra): pensiamo ai fondi sovrani o, forse in senso inverso, al capitalismo di Stato cinese.
È entrata dunque in crisi la sovranità statale, ma con questa anche, secondo l’espressione che era così cara all’amico Roberto Ruffilli, la sovranità del cittadino che sta perdendo con la crisi della rappresentanza politica la sua identità collettiva, la sua personalità sociale senza che nessuno possa fare da arbitro. Quando si parla di crisi della politica mi sembra che anche gli esperti politologi, sia negli interventi più tecnici sia sulla stampa, si limitino, sulle orme dei nostri classici sino a Norberto Bobbio, a grandi discorsi sui sintomi della malattia, senza vedere che la crisi ha le sue radici proprio nella non-partecipazione e non viceversa, nella perdita soprattutto del collante collettivo che un tempo era costituito dalla «Patria».
Per fare un esempio che sembra marginale ‒ ma che non lo è ‒ se io dovessi scegliere una data periodologica per segnare, almeno per l’Italia, un passaggio epocale, io sceglierei il 2005 come anno in cui fu decisa l’abolizione della leva militare obbligatoria: se non si deve più morire per la Patria, mi sembra che tutto il resto diventi secondario.
Venuto meno questo collante, mi sembra che il rapporto tra detentori del potere economico e del potere politico sia radicalmente cambiato dal paradigma che è nato dalle rivoluzioni industriali dei secoli precedenti: è caduta l’ideologia della rivoluzione che ad esse era collegata ma non certo l’idea di rivoluzione come progetto di una nuova società.
La distinzione tra destra e sinistra è messa in causa non perché sia venuta meno, ma perché è venuto meno il rapporto storico, del quale la Rivoluzione francese era stata la massima espressione, tra tra libertà, uguaglianza a fraternità che ne aveva caratterizzato il successo nel passaggio dal sistema feudale a quello della proprietà.
Da questo punto di vista, le proposte che oggi vengono avanzate non affrontano in nessun modo i mutamenti che procedono con il nuovo capitalismo finanziario. Anche le proposte di un reddito di cittadinanza sembrano partire dalla coda anziché dalla testa del problema; così come il taglio delle pensioni più alte con l’invocazione della solidarietà risulta totalmente al di fuori di ogni logica giuridica nell’ordinamento attuale, anche se malformazioni ereditate dai cosiddetti «diritti acquisiti» possono essere corrette nel breve termine.
L’intervento pubblico organico deve essere basato su un ripensamento della fiscalità generale non per statalizzare, ma ancor più quando si vuole alleggerire il peso del welfare sullo Stato e ricorrere ai corpi intermedi e al volontariato.
Qui si toccano naturalmente i punti più profondi della crisi della democratica parlamentare e dei nuovi populismi. L’obiettivo della politica è ora certamente l’acquisizione del consenso, e non possiamo fermarci alle strutture di rappresentanza parlamentare. Dobbiamo forse arretrare e riflettere ancora una volta sulle origini della democrazia nella Grecia antica: l’acquisto del consenso da parte dei detentori del potere non ha più confini né geografici né di comunicazione nelle nuove cosmopoli (anche il tema delle frodi fiscali può essere evasivo).
*
[Riproduciamo un articolo uscito il 15 giugno 2016. Anche questo breve intervento, come tutte le cose pubblicate da Paolo Prodi per questa rivista, siasu carta sia sul sito, testimoniano una instancabile curiosità per un mondo in continua e faticosa trasformazione. Le sue riflessioni, a partire dallo straordinario lavoro di storico, venivano spesso condivise con alcuni amici e, per fortuna di tutti, si traducevano quasi sempre in scrittura. L’opera di Paolo Prodi è quasi interamente patrimonio del «suo» Mulino, che gli deve molto quanto a lavoro intellettuale e di animatore culturale.]
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - RIAPRIRE IL "LIBER PARADISUS": IL “PARADISO IN TERRA”, LA “MEMORIA” DI ABY WARBURG, E LA LEZIONE DI WALTER BENJAMIN.16 dicembre 2016, di Federico La Sala
- DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia"
 Al tempo di Bonaccorso di Soresina, podestà di Bologna, del giudice ed assessore Giacomo Grattacello, fu scritto quest’atto, che deve essere detto PARADISO, che contiene i nomi dei servi e delle serve perché si sappia quali di essi hanno riacquistato la libertà e a qual prezzo (...) [Allegato - in fondo, qui] *
Al tempo di Bonaccorso di Soresina, podestà di Bologna, del giudice ed assessore Giacomo Grattacello, fu scritto quest’atto, che deve essere detto PARADISO, che contiene i nomi dei servi e delle serve perché si sappia quali di essi hanno riacquistato la libertà e a qual prezzo (...) [Allegato - in fondo, qui] *
- RINASCIMENTO, OGGI: LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA -- IL SERPENTE DI BRONZO: MICHELANGELO, WARBURG, E UN ANAGRAMMA.
IL “PARADISO IN TERRA”, LA “MEMORIA” DI ABY WARBURG, E LA LEZIONE DI WALTER BENJAMIN. *
C’ERA UNA VOLTA IL PARADISO SEGNATO SULLE CARTE. “Il paradiso in terra. Mappe del giardino dell’Eden”, (Bruno Mondadori, Milano, 2007) di Alessandro Scafi è per molti versi un’opera sorprendente - soprattutto per l’essere il lavoro di un “Lecturer in Medieval and Renaissance Cultural History” presso il Warburg Institute di Londra.
Muovendo dalla storica acquisizione che la “gran parte delle mappe medievali contengono un riferimento visivo al giardino dell’Eden”, egli cerca di rispondere alla domanda su quali siano state “le condizioni che hanno reso possibile la cartografia del paradiso”. Lo scopo del suo libro, infatti, è quello di “visitare il nostro passato come si fa con un paese straniero, tentando di effettuare la visita con la massima apertura mentale e il massimo rispetto” e cercare di esplorare e scoprire - premesso che “chi metteva il paradiso su una carta aveva le sue buone ragioni” - queste “buone ragioni” (p.7).
Se è vero - come egli stesso sostiene - che “ieri segnare il paradiso su una carta significava una confessione dei limiti della ragione una dichiarazione di fede in un Dio che interveniva nell’arena geografica della storia”, e, altrettanto, che “oggi una mappa che tra le ragioni del mondo comprenda anche il paradiso sembra dover richiedere uno slancio di fantasia o uno sforzo di immaginazione”, è da pensare che l’Autore - alla luce del suo percorso e, ancor di più, delle sue stesse conclusioni - ha trovato molte e grandi difficoltà e che - per dirlo “con una parola-chiave dell’orizzonte di Aby Warburg - che la Memoria (“Mnemosyne”) gli ha giocato un brutto scherzo!
Nell’ Epilogo, con il titolo “Paradiso allora, paradiso ora”, dopo aver premesso in esergo la seguente citazione:
“Sarebbe difficile trovare un qualsiasi argomento in tutta la storia delle idee che abbia invitato a formulare così tante ipotesi, per poi smentirle tutte e renderle assolutamente inutili, come ha fatto il giardino dell’Eden (...) Sono state proposte teorie dopo teorie, ma non è stata trovata nessuna veramente convincente (...) Il luogo dell’Eden sarà sempre classificato, insieme alla quadratura del cerchio e all’interpretazione della profezia non avverata, tra quei problemi irrisolti - forse insolubili - che esercitano un fascino così pieno di mistero” (William A. Wright, Eden, in Smith, Dictionary of the Bible, 1863),
Scafi così comincia: “Per cercare di capire la cartografia del paradiso abbiamo compiuto un lungo viaggio nel tempo. Siamo partiti dagli albori del cristianesimo e, passando attraverso il Medioevo, il Rinascimento e la Riforma, siamo arrivati ai giorni nostri. Abbiamo incontrato il paradiso terrestre in una grande varietà di forme, sia descritto a parole sia sagomato dalle linee di una carta”.
E ormai stanco del percorso fatto, nello sforzo di non farsi accecare dalla varietà delle forme e di (farci!) cogliere l’essenziale (il “dio”) che nei “dettagli” si “nasconde”, così ricorda e prosegue: “Come si è visto, localizzare il paradiso terrestre descritto dalla Genesi non era soltanto un problema geografico, e tutti coloro che hanno voluto interpretare il racconto del peccato di Adamo si sono trovati di fronte ai grandi interrogativi sul destino ultimo dell’uomo”. E, a chiusura del discorso e a esclusione di ulteriori domande in questa nebbiosa direzione metafisica ed escatologica, così precisa: “Non c’è meravigliarsi, allora, che le risposte offerte da tanti secoli di tradizione cristiana siano state formulate e riformulate, con il passare del tempo, in maniera così diversa”!
LA RINASCITA DELLA “HYBRIS” ANTICA: I MODERNI. L’attenzione di Scafi, nonostante ogni buona intenzione, è conquistata da altro: “Quello che colpisce, invece, è il modo in cui, a partire dal Rinascimento e dalla Riforma, ogni autore che si sia cimentato sull’argomento si è sempre industriato a ridicolizzare le teorie dei suoi predecessori. Scrivere sul paradiso sembrava richiedere sempre una carrellata preliminare sulle stravaganze precedenti, per bollare come insostenibili tutte le teorie pregresse e quindi proporre la propria soluzione, che si auspicava definitiva”. E così sintetizza e generalizza: “L’abitudine di presentare, in un’ironica rassegna, le assurdità e gli errori del passato è diventata così un topos che è durato fino ad oggi”; e, ancora, precisa: “A ben vedere, si possono rintracciare già nella tarda antichità le avvisaglie di questa pratica post-rinascimentale”(p. 306).
Colpito da questa “evidenza” e da questa “scoperta”, egli prosegue con l’antica e moderna ‘tracotanza’ (il “folle volo”) a narrare la sua “odissea”, aggiorna il numero della “varietà delle forme” delle mappe del giardino dell’Eden, e, senza alcun timore e tremore, completa la sua personale “ironica rassegna”, - con una “carrellata” sulle ultime e ultimissime “stravaganze”, su quelle degli artisti russi Ilya ed Emilia Kabakov, coi loro “progetti singolari e fantasiosi” (in particolare, “Il paradiso sotto il soffitto”), che Scafi così commenta:
- “Per la nostra mentalità moderna, l’unico vero paradiso, per usare le parole di Proust, è sempre quello che abbiamo perduto. I Kabakov invece negano questa visione pessimistica, anche se non parlano di un paradiso celeste che ci aspetta alla fine dei tempi. Quando alzano lo sguardo verso il soffitto per superare il pessimismo di chi immagina paradisi solo remoti e inaccessibili e scoraggiare la pericolosa idolatria di chi insegue paradisi artificiali, invitandoci a vedere il cielo in una stanza, i due artisti russi sembrano condividere il pensiero dei teologi e dei cartografi medievali. Anche per loro il paradiso perduto porta sempre con sé la promessa di un paradiso ritrovato, e anche per loro questo paradiso è accessibile in qualunque momento. Basta soltanto prendere una scala, e salirne i gradini. Qui e ora” (p. 314).
“MAPPING PARADISE”. Questa è la conclusione di "A History of Heaven on Earth”: per dirla in breve, una pietra tombale sull’idea stessa del “paradiso in terra”, e non solo sulle “carte” dei Kabakov, anche se “i due artisti russi sembrano condividere il pensiero dei teologi e dei cartografi medievali”.
Che a questo “destino” dovesse approdare tutta la ricerca, nonostante le apparenze del percorso, Scafi l’aveva già ‘annunciato’, come in una “profezia che si auto-adempie”, in un breve paragrafo dedicato a Dante e alla “Commedia”, intitolato “Un volo poetico in paradiso”, dove - separata “poesia” e “non poesia” - così pontifica:
- “L’interesse dei teologi e dei filosofi naturali per la geografia era condiviso da Dante Alighieri, che aveva una grande varietà di interessi e che nella sua Commedia (c. 1305-20) raccontava, come è noto, la sua esperienza attraverso i tre regni dell’inferno, del purgatorio e del paradiso. Il celebre poema era un’opera letteraria che esprimeva la conoscenza geografica e cosmografica del tempo (...) Per Dante la geografia era sempre subordinata alla poesia. Nel canto XXVI dell’Inferno, il poeta si riferisce al “folle volo” di Ulisse. La morale della storia del marinaio ed eroe greco che oltrepassò le colonne d’Ercole e che da lontano riuscì a gettare solo uno sguardo verso la montagna del paradiso, prima di vedersi sbarrata la strada da una tremenda tempesta, era che l’uomo non poteva penetrare, solo con le sue forze e senza il sostegno della rivelazione divina, il mistero del paradiso terrestre” (p.153).
Fin qui, niente di speciale: il suo punto di approdo è lo stesso di “chi scrive di storia per il grande pubblico” e degli “storici di professione”(p. 7)! E la sua “storia dell’arte” cartografica del “paradiso in terra” di “oggi”, alla fin fine, potrebbe benissimo essere collocata, in una possibile ristampa, nel “Dictionary of the Bible” di “ieri” (1863).
LA SCALA DEGLI INDIANI PUEBLO E LA “MEMORIA” DEL PARADISO DI ABI WARBURG. Per “ironia della sorte”, quasi cento anni prima della mostra dei Kabokov a Londra (1998), nel 1896, Aby Warburg è nel Nuovo Messico e in Arizona, incontra gli indiani Pueblo e - come poi racconterà e cercherà di descrivere con disegni e foto nel 1923 (cfr. “Il rituale del serpente”, Adelphi, Milano, 2005) - conosce elementi della loro cosmologia, un universo “concepito come una casa”, con il tetto con “le falde a forma di scala”, una “casa-universo identica alla propria casa a gradini, nella quale si entra per mezzo di una scala”, e comprende quanto è importante per l’uomo “la felicità del gradino”, il salire (“l’excelsior dell’uomo, il quale dalla terra tende al cielo”). E, al contempo, sempre nel 1896 (il 26 giugno), ad un suo amico, così scrive:
- “Non permetto che mi si trascini attraverso l’Inferno se non a colui che confido sappia anche portarmi attraverso il Purgatorio fino al Paradiso. Ma proprio di ciò difettano i moderni. Non dico un Paradiso dove tutti cantino salmi avvolti in bianche tuniche e privi di genitali, dove le care pecorelle si aggirino in compagnia dei bei leoni fulvi senza desideri carnali - ma disprezzo chi perde di vista l’ideale dell’homo victor”.
Warburg rimase persuaso di ciò sino alla fine. Ma se fu questo suo atteggiamento ad allontanarlo dagli esteti e anche dagli storici dell’arte, fu il suo intenso interesse - come cita, scrive, e commenta Ernst H. Gombrich (cfr. Aby Warburg. Una biografia intellettuale, Feltrinelli, Milano, 2003, pp 274) - per le questioni psicologiche fondamentali ad avvicinarlo a una generazione che aveva assimilato la lezione di Freud e si rendeva sempre più conto dell’immensa complessità della mente umana. E qui la fama di Warburg non si basa certo su un fraintendimento.
IL PARADISO E L’ANGELO DELLO STORIA. LA LEZIONE DI WALTER BENJAMIN:
- "C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus [1920]. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, al bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta"(Tesi di filosofia della storia).
"Articolare storicamente il passato non significa conoscerlo "come propriamente è stato". Significa impadronirsi di un ricordo come esso balena nell’istante di un pericolo [...] In ogni epoca bisogna cercare di strappare la tradizione al conformismo che è in procinto di sopraffarla. Il Messia non viene solo come redentore, ma come vincitore dell’Anticristo. Solo quello storico ha il dono di accendere nel passato la favilla della speranza, che è penetrato dall’idea che anche i morti non saranno al sicuro dal nemico, se egli vince. E questo nemico non ha smesso di vincere"(Tesi di filosofia della storia).
*
Allegato:
“LIBER PARADISUS” (BOLOGNA, 1257):
Dio onnipotente piantò un piacevole Paradiso (giardino) e vi pose l’uomo, il cui corpo ornò di candida veste donandogli una libertà perfettissima ed eterna. Ma l’ uomo, misero, immemore della sua dignità e del dono divino, gustò del frutto proibito contro il comando del Signore. Con questo atto tirò se stesso e i suoi posteri in questa valle di lagrime e avvelenò il genere umano legandolo con le catene della schiavitù al Diavolo; cosi l’ uomo da incorruttibile divenne corruttibile, da immortale mortale, sottoposto a una gravissima schiavitù. Dio vedendo tutto il mondo perito (nella schiavitù) ebbe pietà e mandò il Figlio suo unigenito nato, per opera dello Spirito Santo, dalla Vergine madre affinché con la gloria della Sua dignità celeste rompesse i legami della nostra schiavitù e ci restituisse alla pristina libertà. Assai utilmente agisce perciò chi restituisce col beneficio della manomissione alla libertà nella quale sono nati, gli uomini che la natura crea liberi e il diritto delle genti sottopone al giogo della schiavitù.
Considerato ciò, la nobile città di Bologna, che ha sempre combattuto per la libertà, memore del passato e provvida del futuro, in onore del Redentore Gesù Cristo ha liberato pagando in danaro, tutti quelli che ha ritrovato nella città e diocesi di Bologna astretti a condizione servile; li ha dichiarati liberi e ha stabilito che d’ora in poi nessuno schiavo osi abitar nel territorio di Bologna affinché non si corrompa con qualche fermento di schiavitù una massa di uomini naturalmente liberi.
Al tempo di Bonaccorso di Soresina, podestà di Bologna, del giudice ed assessore Giacomo Grattacello, fu scritto quest’ atto, che deve essere detto Paradiso, che contiene i nomi dei servi e delle serve perché si sappia quali di essi hanno riacquistato la libertà e a qual prezzo: dodici libbre per i maggiori di tredici anni, e per le serve: otto libbre bolognesi per i minori di anni tredici (...).
- DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia"
-
> RIPENSARE L’EUROPA! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. --- LA LAICITA’ E IL CATTOLICISMO DELL’ALLEANZA LAICISTA ATEA E DEVOTA.12 dicembre 2016, di Federico La Sala
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER (COME RATZINGER) A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG.
Laicismo, l’anti-religione contraria alla laicità
di Fabrice Hadjadj (Avvenire, 04.12.2016)
La parola "laico" è un segno ostensibile nella lingua francese e anche in quella italiana. È vero che l’udibile spicca meno del visibile; ecco perché il suono della parola "laico" ci colpisce meno della visione di un crocifisso. Tuttavia, a chi sa ascoltare quel suono, a chi sa ricollocarlo nella sua prospettiva storica, si offre la visione di uno strano spettacolo: alcune persone brandiscono un crocifisso garantendo che si tratta invece di un martello - o del segno più dell’addizione; si esprimono con il tono degno dei migliori predicatori e ci spiegano che è per sottolineare una neutralità quando non una distanza dalle religioni; ripetono infine senza sosta un versetto del vangelo ma sono persuasi di intonare un ritornello del loro repertorio.
Essi infatti dicono e ridicono che bisogna «dare a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio», si fanno promotori di carte della laicità, senza accorgersi che questa promozione è stata resa possibile dall’eredità cristiana. Perché è in primo luogo la teologia cattolica che distingue il laico dal chierico. Ed è sempre la teologia cattolica che pone quella «separazione dei poteri» ben più fondamentale di quella di Montesquieu, la separazione del potere temporale e del potere spirituale.
A dire il vero, anche la capacità di bestemmiare è ancora un segno ostensibile del cristianesimo. Un pensiero di Pascal lo dice con chiarezza: «Vi è campo aperto per la bestemmia, anche su verità quanto meno assai visibili». Il vero teologo non può essere fondamentalista: egli sa che, se Dio è trascendente, non fa parte delle evidenze mondane (la verità «erra coperta da un velo» dice ancora Pascal, immagine molto interessante che mostra il rifiuto dei sostenitori del burqa di una trascendenza trascendente e dunque velata: nascondendo la donna, il velo integrale pretende di esibire la verità islamica, affermarla come un’evidenza di quaggiù). Allora, l’accesso a tale trascendenza non può avvenire attraverso seduzioni o coercizioni: esso esige un movimento intimo del cuore, che impegni liberamente la persona, un atto di fede. Ora, questa esigenza stessa implica la pazienza davanti al rifiuto.
Ecco perché il campo della fede è «aperto alla bestemmia». Si può dirlo in un altro modo prendendo il punto di vista del bestemmiatore. Che cosa c’è dietro al piacere di bestemmiare? Da una parte ci vuole che l’idea di Dio sia ancora abbastanza viva nella società. Se Dio - ahimè! - non c’è, che divertimento ci sarebbe a coprirlo di ingiurie?
Di questo si lamenta il Marchese de Sade nella sua Storia di Juliette: «Il mio più grande dolore è che in realtà non esiste un Dio, e quindi mi vedo privato del piacere di insultarlo più positivamente». Ma per godere della bestemmia, non occorre solamente che Dio esista, almeno nel pensiero, è anche necessario non incappare subito nella pena di morte. Così, in una società completamente atea la bestemmia è impossibile; nello stato islamico è vietata. L’unica configurazione perfetta per il blasfemo è quella di una società ancora cristiana.
In una tale società, Dio è ancora presente; ma, dato che il suo stesso Figlio fu condannato come blasfemo dai grandi sacerdoti della sua epoca, si fa attenzione a non condannare troppo rapidamente uno che bestemmia. Ecco il paradosso implacabile con cui siamo confrontati noi francesi e noi europei: affermare un «principio di separazione della società civile e della società religiosa» nello stato presuppone ancora un legame privilegiato con la fede cristiana (e alla fede cristiana aggiungo l’esistenza ebraica che le è legata intimamente - la permanenza del popolo ebraico è un principio di pluralità irriducibile all’interno del pensiero stesso della Chiesa).
O, per dirlo in altro modo, la neutralità dello stato a riguardo delle confessioni religiose presuppone una predilezione per l’eredità culturale giudaico-cristiana. Senza tale predilezione, o quella neutralità diventa impotente, perché il neutro in sé non può produrre una qualsiasi determinazione; o si trasforma in neutralizzazione e diventa la religione dell’anti-religione, il laicismo.
Il laicismo è il contrario della laicità. La laicità non può affermarsi che distinguendosi da un clero di cui riconosce l’esistenza. Può essere anticlericale, nel senso di una diffidenza critica nei confronti dei chierici, delle loro prediche e dei loro comportamenti, come nel Decamerone di Boccaccio; ma non oserebbe escluderli dal dibattito pubblico, perché, in questo caso, tradirebbe se stessa costituendosi come un nuovo e supremo clero.
Quanti sedicenti difensori della laicità salgono in tribuna, più che in cattedra, per pronunciare scomuniche e imporre un catechismo molto più rigido e riduttore del dogma cattolico? Il laicista corrisponde molto precisamente al curato di fantasia che vuole denunciare. Riprende il discorso preliminare dell’enciclopedia, nel quale D’Alembert deplora l’«abuso dell’autorità spirituale riunita a quella temporale» ma commette egli stesso quell’abuso nel senso opposto.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. -- COSTITUZIONE E SOVRA-UNITA’: UNA LEZIONE ATTUALE. L’esito del referendum costituzionale del 2006 E DEL 2016.7 dicembre 2016, di Federico La Sala
- DONNE E UOMINI, CITTADINE E CITTADINI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico ....
- 25 Giugno 2006: salviamo la Costituzione e la Repubblica che è in noi
- UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema
- IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
Una lezione attualeIl confronto con l’esito del referendum costituzionale del 2006
di Salvatore Settis (la Repubblica, 07.12.2016)
IL DATO più rilevante nei risultati del 4 dicembre emerge dal confronto con l’esito del referendum costituzionale del 2006. In ambo i casi il voto popolare ha respinto una riforma costituzionale assai invasiva (54 articoli modificati nel 2006, 47 nel 2016), approvata a maggioranza semplice da una coalizione di governo che ostentava sicurezza per bocca di un premier (allora Berlusconi, ora Renzi) in cerca di un’investitura plebiscitaria.
Le due riforme abortite non sono identiche, ma vicine in aspetti cruciali (la fiducia riservata alla sola Camera e il nebbioso ruolo del Senato). Se guardiamo ai numeri, il confronto è impressionante: nel 2006 i No furono il 61,29%, nel 2016 il 59,25; quanto ai Sì, si passa dal 38,71% (2006) al 40,05 (2016). Un rapporto di forze simile, che diventa più significativo se pensiamo che l’affluenza 2016 (68,48%) è molto superiore a quella del 2006 (52,46%): allora votarono 26 milioni di elettori, oggi ben 32 milioni, in controtendenza rispetto al crescente astensionismo delle Europee 2014 e delle Regionali dello stesso anno.
Eppure, dal 2006 ad oggi il paesaggio politico è completamente cambiato, per l’ascesa dei 5Stelle, la frammentazione della destra berlusconiana, le fratture di quella che fu la sinistra. Più affluenza oggi di dieci anni fa, un cambio di generazioni, con milioni di giovani che votavano per la prima volta a un referendum costituzionale: eppure, nonostante i mutamenti di scenario, un risultato sostanzialmente identico, con un No intorno al 60%.
Una notevole prova di stabilità di quel “partito della Costituzione” che rifiuta modifiche così estese e confuse. Esso è per sua natura un “partito” trasversale, come lo fu la maggioranza che varò la Costituzione, e che andava da Croce a De Gasperi, Nenni, Calamandrei, Togliatti. Il messaggio per i professionisti della politica è chiaro: non si possono, non si devono fare mai più riforme così estese e con il piccolo margine di una maggioranza di parte.
Nel 2006 e nel 2016, due governi diversissimi hanno cercato di ripetere il discutibile “miracolo” del referendum 2001, quando la riforma del Titolo V (17 articoli) fu approvata con il 64% di Sì contro un No al 36%: ma allora l’affluenza si era fermata al 34% (16 milioni di elettori). Si è visto in seguito che quella riforma, varata dalle Camere con esiguo margine, era mal fatta; e si è capito che astenersi in un referendum costituzionale vuol dire rinunciare alla sovranità popolare, principio supremo dell’articolo 1 della Costituzione.
Per evitare il ripetersi (sarebbe la terza volta) di ogni tentativo di forzare la mano cambiando la Costituzione con esigue maggioranze, la miglior medicina è tornare a un disegno di riforma costituzionale (nr. 2115), firmato nel 1995 da Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano, Leopoldo Elia, Franco Bassanini. Esso prevedeva di modificare l’art. 138 Cost. nel senso che ogni riforma della Costituzione debba sempre essere «approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti», e ciò senza rinunciare alla possibilità di ricorrere al referendum popolare.
Questo l’art. 4; ma anche gli altri di quella proposta troppo frettolosamente archiviata sarebbero da rilanciare. L’art. 2 prevedeva che la maggioranza necessaria per eleggere il Presidente della Repubblica debba sempre essere dei due terzi dell’assemblea (l’opposto della defunta proposta Renzi-Boschi, che avrebbe reso possibile l’elezione da parte dei tre quinti dei votanti, senza computare assenti e astenuti); e che qualora l’assemblea non riesca ad eleggere il Capo dello Stato «le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente assunte dal Presidente della Corte Costituzionale». L’art. 3, prevedendo situazioni di stallo nell’elezione da parte del Parlamento dei membri della Consulta di sua spettanza, prevedeva che dopo tre mesi dalla cessazione di un giudice, se il Parlamento non riesce a eleggere il successore «vi provvede la Corte Costituzionale stessa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti». Previsione lungimirante: è fresco il ricordo del lungo stallo delle nomine alla Corte, finché nel dicembre 2015 si riuscì a nominare tre giudici dopo ben 30 tentativi falliti.
In quelle proposte, come si vede, la Corte Costituzionale aveva un ruolo centrale, e il rafforzamento delle istituzioni passava attraverso un innalzamento delle maggioranze necessarie per passaggi istituzionali cruciali, come le riforme costituzionali o l’elezione del Capo dello Stato. In un momento di incertezza come quello che attraversiamo, quella lezione dovrebbe tornare di attualità, anche se molti firmatari di quella legge sembrano essersene dimenticati.
La riforma Renzi-Boschi è stata bocciata, ma fra le sue pesanti eredità resta una cattiva legge elettorale, l’Italicum, che la Consulta potrebbe condannare tra poche settimane, e che comunque vale solo per la Camera. Compito urgente del nuovo governo, chiunque lo presieda, sarà dunque produrre al più presto una legge elettorale finalmente decorosa, e compatibile (si spera) con riforme costituzionali come quelle sopra citate. Le prossime elezioni politiche, anticipate o no, dovranno portare alle Camere deputati e senatori liberamente eletti dai cittadini e non nominati nel retrobottega dei partiti.
Il referendum da cui veniamo è stato un grande banco di prova per la democrazia: ma ora è il momento di mostrare, per i cittadini del No e per quelli del Sì, che sappiamo essere “popolo” senza essere “populisti”. Che per la maggioranza degli italiani la definizione di “popolo”, della sua sovranità e dei suoi (dei nostri) diritti coincide con quella della Costituzione, la sola che abbiamo. Il “ritorno alla Costituzione” che ha segnato i mesi scorsi e che ha portato all’esito del referendum mostra che è possibile.
Smuraglia: è un No per attuare la Costituzione
"Al referendum non hanno vinto i partiti", dice il presidente dell’Anpi. "Leggere la vittoria referendaria del 4 dicembre solo sul terreno del confronto politico è un modo per ridimensionare il risultato popolare"
intervista di Andrea Fabozzi (il manifesto, 7.12.2016)
Carlo Smuraglia, presidente dell’Associazione nazionale partigiani, si aspettava questo successo del No?
Onestamente no. Immaginavo il paese spaccato a metà e speravo in una vittoria con il minimo distacco. Avevo indicazioni molto positive dalle nostre manifestazioni, in particolare l’ultima a Roma al teatro Brancaccio. Ma l’esperienza mi insegna a non fidarmi di quello che si vede nelle piazze e nei teatri, perché è la gente silenziosa che decide il risultato. E c’era da temere la propaganda del governo, le promesse, le proposte e le minacce del presidente del Consiglio, la complicità della stampa con il Sì...
E invece.
Mi ha sorpreso felicemente la grande partecipazione. Avevamo captato questo desiderio di capire e di partecipare, ma forse l’abbiamo persino sottovalutato. Evidentemente i cittadini che si sono informati sulla riforma, l’hanno compresa bene e giudicata male, sono stati la maggioranza. Anche se questa parte ragionata del No, adesso, mi pare messa del tutto tra parentesi, rimossa.
Non le piace come viene raccontata la vittoria del No?
Mi sorprende che tra le tante ragioni della sconfitta del Sì, la più elementare - e cioè che la riforma è stata bocciata nel merito - sia finita nell’ombra. Tutte le analisi sono sul terreno politico, tornano a farsi sentire come vincitori partiti che in campagna elettorale avevamo visto poco. Io credo che leggere il 4 dicembre esclusivamente sul terreno del confronto tra partiti sia un modo per ridimensionare lo straordinario risultato popolare.
Lei invece ci legge il segnale di una speranza? Si può ricominciare a parlare di attuazione della Costituzione?
Noi ne parliamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questa campagna elettorale. Alla fine dei miei incontri c’era sempre chi mi chiedeva “ma se vince il No cosa facciamo?”. E io rispondevo “Prima brindiamo, poi diciamo che invece di cambiarla la Costituzione bisogna attuarla”. A quel punto arrivava l’applauso più forte. Perché tutti vedono l’enorme contrasto che c’è tra i principi fondamentali della Carta e la realtà. Non voglio illudermi, ma credo che dentro questo 60% di No ci sia anche questa richiesta di attuazione.
Insieme a un voto contro il governo, non le pare?
Non per quanto ci ha riguardato. L’ho detto anche a Renzi nel nostro confronto di settembre a Bologna. Non ci è mai interessata la sorte del governo, volevamo solo difendere la Costituzione da uno strappo. Mi pare che lei non sia rimasto contento del modo in cui è stato raccontato quel confronto alla festa dell’Unità. Non sono rimasto contento che sia stato oscurato. Evidentemente non si era concluso come giornali e tv si auguravano, con la vittoria di Renzi.
Secondo lei, adesso, come si viene fuori dalle dimissioni del presidente del Consiglio?
La richiesta di votare presto mi pare infondata. Mancano molti presupposti, innanzitutto la legge elettorale: ne abbiamo due diverse per camera e senato e la prima è attesa al giudizio della Consulta. In più tutti i partiti dicono di volerla cambiare. La corsa alle urne è ingiustificata, il presidente della Repubblica, anche di fronte alle dimissioni di Renzi, ha molti strumenti prima di accettare le elezioni anticipate, provvederà con saggezza.
Questo No mette fine ai tentativi di riscrivere la Costituzione, almeno per un po’?
La Costituzione non è mai messa sufficientemente al riparo e bisogna stare sempre in guardia. Ma un No di questa entità ha anche un valore di ammonimento molto forte, si è capito che la Costituzione non è una legge ordinaria e non si può modificarla a cuor leggero, ma solo quando ce n’è effettivamente bisogno. E con il massimo di consenso.
In campagna elettorale si è parlato molto delle divisioni dell’Anpi. Vicenda chiusa? Lascerà qualche segno tra voi?
I segni sono stati più esterni che interni. Ogni piccola cosa è stata ingigantita e presa per buona, noi non abbiamo mai allontanato né sanzionato nessuno. Abbiamo solo chiesto ai nostri iscritti di non fare campagna per il Sì nel nome dell’Anpi, visto che la nostra posizione era opposta. La verità è che ha dato molto fastidio che l’Anpi si fosse schierata per il No. La nostra associazione è portatrice di valori in cui tutti devono riconoscersi, e dunque a molti abbiamo fatto fare almeno un pensierino.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA - Il paradosso della Costituzione. (di Giovanni De Luna)9 dicembre 2016, di Federico La Sala
IL PARADOSSO DELLA COSTITUZIONE:
LA ’NAZIONALIZZAZIONE’ DEL MENTITORE
- UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE. PER UN CONVEGNO E UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ’UNITA’ E DI SOVRANITÀ (SOVRA-UNITÀ). Materiali sul tema
- L’ITALIA (1994-2016), TRE PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA SENZA "PAROLA", E I FURBASTRI CHE SANNO (COSA SIGNIFICA) GRIDARE "FORZA ITALIA". In memoria di Sandro Pertini e di Gioacchino da Fiore, alcuni appunti per i posteri
Il paradosso della Costituzione
Difesa oggi dagli antipartito, 70 anni fa nel mirino degli “apolitici” dell’Uomo Qualunque. Bobbio li definiva il “pantano in cui finirà per impaludarsi il rinnovamento democratico”
di Giovanni De Luna (La Stampa, 09.12.2016)
Il paradosso del referendum del 4 dicembre è questo: la Costituzione del 1948 è stata vittoriosamente difesa dalle forze politiche che ne hanno sempre criticato il carattere «comunista» (Berlusconi e la Lega) o denunciato la fissità «talmudica» (così Grillo, nel 2011 sul suo blog). Il paradosso è anche più evidente se lo si confronta con le polemiche che - tra il 1945 e il 1947 - accompagnarono il varo della Carta Costituzionale.
Allora, il passaggio dalla dittatura alla democrazia fu accolto con sospetto e diffidenza da una larga fetta dell’opinione pubblica, abituata da venti anni di fascismo a considerare la politica una pratica «inconcludente» e incline a guardare agli uomini dei partiti con la diJffidenza dovuta a chi svolgeva «non un’attività disinteressata al servizio della collettività e della nazione, cercando invece di procurare potere, ricchezza, privilegi a sé stesso, alla propria famiglia, fazione, clientela elettorale». Queste frasi - tratte da uno dei tanti rapporti dei carabinieri che allora funzionavano come oggi i sondaggi di opinione - fotografavano un diffuso sentimento «antipartito» che si tradusse negli impetuosi successi elettorali dell’Uomo Qualunque.
La nuova Repubblica
Anche tra le file del Partito d’Azione - al quale oggi viene attribuita la paternità della Costituzione - all’inizio la forma partito era vista con sospetto. La nuova Repubblica che nasceva dalla Resistenza avrebbe dovuto puntare direttamente sugli uomini (con un rinnovamento della classe dirigente) e sulle istituzioni (con un allargamento della partecipazione politica fondata sulle autonomie e sull’autogoverno). Lo scriveva un giovane Norberto Bobbio (non aveva ancora 40 anni): «Una responsabilità pubblica ciascuno può assumerla dentro o fuori dei partiti, secondo le sue capacità e le sue tendenze, e magari meglio fuori che dentro».
Ma proprio i suoi articoli di allora sul quotidiano Giustizia e Libertà ci consentono oggi di capire che intorno alla Costituzione la partita si giocò essenzialmente tra la politica e l’antipolitica, meglio - come si diceva a quel tempo - tra gli «apolitici» e gli uomini dei partiti. Il qualunquismo nascondeva dietro la maschera della «apoliticità» e dell’«indipendenza» una lotta senza quartiere ai partiti del Cln, giudicati come il lascito più significativo e più pericoloso della Resistenza. BJobbio lo diceva esplicitamente: «gli indipendenti [...] non sono né indipendenti, né apolitici. Sono politici, ecco tutto, di una politica che non è quella dei comitati di liberazione o del fronte della Resistenza».
«Vizi tradizionali» italiani
L’«apoliticismo» (per Bobbio «l’indifferenza o addirittura l’irrisione per ogni pubblica attività in nome dell’imperioso dovere di lavorare senza ambizioni né distrazioni per la famiglia, per i figli e soprattutto per sé») si traduceva in una critica alla «politica di partito» che, scriveva, «lusinga e quindi rafforza inveterate abitudini, vizi tradizionali del popolo italiano, incoraggia gli ignavi, fa insuperbire gli ottusi e gli inerti [...], offre infine a tutti gli apolitici un motivo per allearsi, facendo di una folla di isolati una massa organica, se non organizzata, di persone che la pensano allo stesso modo e hanno di fronte lo stesso nemico [...] generando di nuovo quel pantano in cui finirà per impaludarsi lo sforzo di rinnovamento democratico dello Stato italiano».
Per gli uomini della Resistenza il nemico era quindi diventato quella «sorta di alleanza dei senza partito», «scettica di quello scetticismo che è proprio delle classi medie italiane», alimentata «da un dissenso di gusti, un disaccordo di stati d’animo, uno scontro di umori, una gara di orgogli, dai quali null’altro può derivare che invelenimento di passioni, impacci all’azione ricostruttrice».
La Carta strumentalizzata
Sembra che Bobbio parli proprio di quell’estremismo di centro che caratterizza oggi una parte della società italiana e un movimento come quello di Grillo. Allora fu un passaggio decisivo per l’approdo a una sua convinta adesione alla «democrazia dei partiti», frutto di una riflessione approfondita su un «modello», quello inglese, che, partendo dai capisaldi fondamentali delle origini (la divisione dei tre poteri, la monarchia costituzionale e il governo parlamentare), era stato in grado di rinnovarsi, spostando progressivamente verso il basso, verso il corpo elettorale, rappresentato e diretto dai partiti, il baricentro del sistema politico.
Le cifre del referendum del 4 dicembre ci dicono come l’elettorato dei movimenti più tipicamente antipartito (Cinque Stelle e Lega) abbia votato massicciamente per il No (l’80%), affiancato da una ristretta fascia di elettori appartenenti al Pd (23%) o alle varie sigle accampate alla sua sinistra. Essere salvata da quelli che volevano affossarla, adesso come nel 1948: da questo duplice paradosso cronologico la Costituzione esce come schiantata, degradata a puro pretesto, con una torsione innaturale che la espone, in futuro, a ogni tipo di uso strumentale.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- COSTITUZIONE E SOVRA-UNITA’. L’ITALIA E IL REFERENDUM: A CHE GIOCO GIOCHIAMO?!3 dicembre 2016, di Federico La Sala
- IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
- SE VADO A CASA DI ZAGREBELSKY E ... COMINCIO A FARE IL MIO COMODO DICENDO DI ESSERE DEL PARTITO "FORZA ZAGREBELSKY", CHE COSA HO FATTO E CHE COSA SONO?! L’ITALIA NON S’E’ DESTATA ED E’ STATA UCCISA!!!
Caro Scalfari, con il Sì passa un’espropriazione di sovranità
di Gustavo Zagrebelsky *
Caro Eugenio Scalfari, ieri mi hai chiamato in causa due volte a proposito del mio orientamento pro-No sul referendum prossimo venturo e, la seconda volta, invitandomi a ripensarci e a passare dalla parte del Sì. La "pessima compagnia", in cui tu dici ch’io mi trovo, dovrebbe indurmi a farlo, anche se, aggiungi, sai che non lo farò. Non dici: "non so se lo farà", ma "so che non lo farà", con il che sottintendi di avere a che fare con uno dalla dura cervice.
I discorsi "sul merito" della riforma, negli ultimi giorni, hanno lasciato il posto a quelli sulla "pessima compagnia". Il merito della riforma, anche a molti di coloro che diconono di votare Sì, ultimo Romano Prodi, appare alquanto disgustoso. Sarebbero piuttosto i cattivi compagni l’argomento principale, argomento che ciascuno dei due fronti ritiene di avere buoni motivi per ritorcere contro l’altro.
Un topos machiavellico è che in politica il fine giustifica i mezzi, cioè che per un buon proposito si può stare anche dalla stessa parte del diavolo. Non è questo. Quel che a me pare è che l’argomento della cattiva compagnia avrebbe valore solo se si credesse che i due schieramenti referendari debbano essere la prefigurazione d’una futura formula di governo del nostro Paese. Non è così. La Costituzione è una cosa, la politica d’ogni giorno un’altra. Si può concordare costituzionalmente e poi confliggere politicamente. Se un larghissimo schieramento di forze politiche eterogenee concorda sulla Costituzione, come avvenne nel ’46-’47, è buona cosa. La lotta politica, poi, è altra cosa e la Costituzione così largamente condivisa alla sua origine valse ad addomesticarla, cioè per l’appunto a costituzionalizzarla. In breve: l’argomento delle cattive compagnie, quale che sia la parte che lo usa, si basa sull’equivoco di confondere la Costituzione con la politica d’ogni giorno.
Vengo, caro Scalfari, a quella che tu vedi come un’ostinazione. Mi aiuta il riferimento che tu stesso fai a Ventotene e al suo "Manifesto", così spesso celebrati a parole e perfino strumentalizzati, come in quella recente grottesca rappresentazione dei tre capi di governo sulla tolda della nave da guerra al largo dell’isola che si scambiano vuote parole e inutili abbracci, lo scorso 22 agosto. C’è nella nostra Costituzione, nella sua prima parte che tutti omaggiano e dicono di non voler toccare, un articolo che, forse, tra tutti è il più ignorato ed è uno dei più importanti, l’articolo 11. Dice che l’Italia consente limitazioni alla propria sovranità quando - solo quando - siano necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni. Lo spirito di Ventotene soffia in queste parole. Guardiamo che cosa è successo. Ci pare che pace e giustizia siano i caratteri del nostro tempo? Io vedo il contrario. Per promuovere l’una e l’altra occorre la politica, e a me pare di vedere che la rete dei condizionamenti in cui anche l’Italia è caduta impedisce proprio questo, a vantaggio d’interessi finanziario-speculativi che tutto hanno in mente, meno che la pace e la giustizia. Guardo certi sostegni alla riforma che provengono da soggetti che non sanno nemmeno che cosa sia il bicameralismo perfetto, il senato delle autonomie, la legislazione a data certa, ecc. eppure si sbracciano a favore della "stabilità". Che cosa significhi stabilità, lo vediamo tutti i giorni: perdurante conformità alle loro aspettative, a pena delle "destabilizzazioni" - chiamiamoli ricatti - che proprio da loro provengono.
Proprio questo è il punto essenziale, al di là del pessimo tessuto normativo che ci viene proposto che, per me, sarebbe di per sé più che sufficiente per votare No. La posta in gioco è grande, molto più grande dei 47 articoli da modificare, e ciò spiega l’enorme, altrimenti sproporzionato spiegamento propagandistico messo in campo da mesi da parte dei fautori del Sì. L’alternativa, per me, è tra subire un’imposizione e un’espropriazione di sovranità a favore d’un governo che ne uscirebbe come il pulcino sotto le ali della chioccia, e affermare l’autonomia del nostro Paese, non per contestare l’apertura all’Europa e alle altre forme di cooperazione internazionale, ma al contrario per ricominciare con le nostre forze, secondo lo spirito della Costituzione. Si dirà: ma ciò esigerebbe una politica conforme e la politica ha bisogno di forze politiche. E dove sono? Sono da costruire, lo ammetto. Ma il No al referendum aprirà una sfida e in ogni sfida c’è un rischio; ma il Sì non l’aprirà nemmeno. Consoliderà soltanto uno stato di subalternità.
Questa, in sintesi, è la ragione per cui io preferisco il No al Sì e perché considero il No innovativo e il Sì conservativo.
Ti ringrazio dell’attenzione. A cose fatte avremo tempo e modo
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --"I DUE CORPI DEL RE" - E DI OGNI ESSERE UMANO. LA DIGNITA’ NON MUORE MAI: CUBA E "LA SCOMPARSA DEL CAPO".29 novembre 2016, di Federico La Sala
LA DIGNITA’ NON MUORE MAI
- "I DUE CORPI DEL RE" - E DI OGNI ESSERE UMANO. La lezione di Dante, Kantorowicz, Freud e Mandela ...
- DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. --- KANTOROWICZ, UN GRANDE LETTORE DI DANTE.
- LA COSTITUZIONE E I "DUE CORPI DEL RE" - DEL CITTADINO. L’ analisi di Barbara Spinelli
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
La storia Come nelle antique esequie reali, un autentico teatro sacralizza l’ultimo viaggio del Comandante
La scomparsa del Capo
Così l’isola celebra l’apoteosi dell’ultimo sovrano del secolo breve
di Marino Niola (la Repubblica, 29.11.2016)
HASTA SIEMPRE Comandante. Ieri in Plaza de la Revolución è cominciato il solenne addio di Cuba a Fidel Castro. Una folla oceanica sfila davanti all’urna con le ceneri del Líder Máximo, circondata da un picchetto d’onore di militari in alta uniforme e sovrastata da una sua foto in bianco e nero. Il lutto per l’ultima icona del Novecento durerà nove giorni. E culminerà il 4 dicembre a Santiago, città madre della rivoluzione, da dove nel 1959 partì la marcia vittoriosa della Carovana della Libertad. Il compagno presidente riposerà a Santa Ifigenia, il cimitero dei padri della patria, accanto a José Marti, il liberatore di Cuba dalla colonizzazione spagnola e a Compay Segundo, l’entrañable presencia del Buena Vista Social Club, che toccava la chitarra con la grazia di un Orfeo tropicale.
Adesso un’isola senza voce e senza musica si prepara a celebrare l’apoteosi laica dell’ultimo sovrano del secolo breve. E lo fa ricorrendo a una simbologia millenaria che, sin dai tempi degli imperatori romani, fa della scomparsa del capo, un autentico teatro della morte. Una grande drammatizzazione dello scarto che sussiste tra l’immortalità del potere e la mortalità dell’uomo che lo incarna. Quello stesso scarto che separa le ceneri di Fidel dalla gigantografia dell’eroe rivoluzionario. I resti mortali dell’uomo dalla sua effigie immortale. Che, ora come allora, serve a rappresentare e garantire la continuità del potere e dunque la continuità della vita di tutti.
Nel Medio Evo, un’autorevole dottrina politica, destinata a sopravvivere fino alla fine delle monarchie assolute, accreditava ai regnanti due nature, a immagine e somiglianza di Cristo. È la cosiddetta teoria dei due corpi del re, secondo la quale il sovrano possiede sia un corpo fisico, che palpita, sanguina, si ammala, muore. Sia un corpo politico, che coincide con la sua nazione e il suo popolo, di cui è il simbolo supremo. Questa seconda natura invece è considerata immortale. La simbiosi tra queste due facce della sovranità rendeva indispensabile scongiurare in tutti i modi il contagio di malattie e lo stesso invecchiamento del re, perché l’indebolirsi del suo organismo fisico non contagiasse l’organismo sociale. Perché in un certo senso l’uomo può morire, ma lo Stato assolutamente no. Tanto che nella Francia e nell’Inghilterra rinascimentali per esorcizzare il pericolo dell’interregno, cioè del vuoto di potere che si apriva alla morte del sovrano, si nutriva e si trattava come persona viva un simulacro del defunto, una sorta di manichino regale, fino all’incoronazione del successore. Insomma, il re è morto, viva il re!
Si trattava di una sorta di transfert simbolico dal potere verso l’immagine. Come dire che la mano del defunto non ha più la forza di reggere lo scettro, ma non ha ancora lasciato la presa. Paradossalmente per allungare la vita del morto, ogni giorno veniva visitato dai medici il suo avatar, fatto di cera o di cuoio, che per tutta la durata del periodo di lutto ne constatavano il peggioramento. Come se il cadavere fosse ancora gravemente ammalato, ma non spirato. Questa messa in scena si chiamava funus imaginarium, ovvero funerale dell’immagine. Un rito che prevedeva una lunghissima processione attraverso l’intera nazione, durante la quale i due corpi del sovrano erano inseparabili. Il climax veniva raggiunto con il rogo finale del fantoccio su una pira di aromi e incensi, che trasportavano l’immagine del sovrano in cielo tra gli dei. Solo allora il re veniva dichiarato morto. E sepolto.
Il caso più celebre è quello del funerale di Francesco I di Francia, avvenuto nel 1547 e che durò alcuni mesi, perché il feretro regale doveva toccare tutte le città più importanti e non poteva saltarne nemmeno una, senza provocare una rivolta popolare.
Questa necessità di sospendere il tempo prima della sepoltura trova la sua spiegazione nel fatto che il rito funebre ha un fortissimo senso politico, sociale, culturale. E soprattutto emotivo. In questo senso l’urna cineraria del Jefe Máximo toccherà insieme alle città e ai villaggi, anche e soprattutto i cuori del suo popolo. Anche perché l’itinerario ripercorre a ritroso il cammino dei barbudos. È un ritorno nel ventre materno della revolución. Che torna sui suoi passi. Fino a quella prova generale che è stato l’assalto fallito alla caserma Moncada di Santiago del 26 luglio del 1953, quando Fidel lanciò il primo guanto di sfida a Fulgencio Batista.
Insomma proprio come nelle antiche esequie reali, e come nelle processioni delle icone religiose, l’ultimo viaggio del Comandante sacralizza un percorso che è fatto di spazio e di tempo, di sentimenti e di avvenimenti. Così il corpo cremato del capo riassume insieme la storia e la geografia dell’isola. Con un rituale solenne che chiude per sempre una pagina memorabile del Novecento e al tempo stesso ne apre una nuova.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - LA DIGNITA’ NON MUORE MAI - «Fidel soy yo», l’urlo di Cuba. Dall’Europa unico leader, Alexis Tsipras.1 dicembre 2016, di Federico La Sala
- CHI E’ STATO? E CHI SIAMO NOI?! - CUBA. Nella sua lunga vita Fidel Castro ha incontrato tre Papi. La scomparsa del Capo. Note
Intellettuali in campo per Fidel
Cuba. Scrittori, musicisti, filosofi a scuola di Revolucion
di Geraldina Colotti (il manifesto, 1.12.2016)
Stratega militare, politico, però anche intellettuale. «Raro caso di un capo di stato sempre disposto ad ascoltare e a discutere, senza mai la superbia che tanto spesso ottunde la capacità di comprendere dei leader». Nell’obituary su Fidel Castro, l’intellettuale argentino Atilio Boron ne ha ricordato anche l’alto profilo intellettuale: «Come Chavez, Fidel era un uomo coltissimo e un lettore insaziabile. La sua passione per l’informazione esatta era minuziosa e inesauribile». Boron, una delle voci più presenti nel nuovo corso bolivariano dell’America latina, ha raccontato «l’immensa fortuna» di aver assistito a «un intenso ma rispettoso scambio di idee tra Fidel e Noam Chomsky a proposito della crisi dei missili dell’ottobre ’62 o dell’Operazione Mangusta». In nessun momento «l’anfitrione fece orecchie da mercante a quel che diceva il visitatore nordamericano».
LA CRISI DEI MISSILI fu uno dei momenti più critici della Guerra fredda tra Stati uniti e Unione Sovietica, che seguì al tentativo di invadere Cuba, nell’aprile del ’61, e portò al dispiegamento difensivo di missili nucleari sovietici nell’isola. Come attestano documenti Usa desecretati, l’Operazione Mangusta venne approvata da Kennedy il 18 gennaio del ’62, con lo scopo di «aiutare i cubani a rovesciare il regime comunista a Cuba e istituire un nuovo governo con cui gli Stati uniti possono vivere in pace». Si prevedevano quattro compiti per azioni di intelligence, sei di tipo politico, tredici relativi alla Guerra economica, quattro a quella Psicologica e quattro di tipo militari, con l’obiettivo di giustificare un’invasione dell’isola da parte dell’esercito Usa.
IN QUEGLI ANNI arrivavano all’Avana intellettuali da ogni parte del mondo: scrittori, pittori, musicisti... E al ritorno dedicavano un omaggio a Cuba. Leonard Cohen, scomparso a novembre, arrivò all’Avana pochi giorni prima dell’invasione della Baia dei Porci. Vent’anni dopo, ha ricordato la figura di Fidel Castro nelle note surrealiste della canzone «Field commander». Nel ’61, Fidel Castro tiene il primo discorso storico agli intellettuali.
DÀ CONTO di «tre sessioni» di accese discussioni, che metteranno le basi per la politica culturale degli anni a venire: «Noi siamo stati agenti di questa Rivoluzione, della rivoluzione economico-sociale che si sta tenendo a Cuba - dice Fidel - A sua volta, questa rivoluzione economico-sociale deve produrre una rivoluzione culturale». Da lì, il «punto più polemico della questione: se deve esserci o no un’assoluta libertà di contenuto nell’espressione artistica».
UN TEMA che, negli anni più complicati della rivoluzione cubana, porterà gli intellettuali a schierarsi. «Nel 1961 - scrive il compianto scrittore Manuel Vazquez Montalban - la Rivoluzione cubana era coccolata dall’intelligencia di sinistra di tutto il mondo e l’Avana come Mosca nel 1920 fu la Mecca di tutti i trasgressori di codici del mondo, che cercavano in Cuba un nuovo destinatario sociale capace di intendere il nuovo». E ricorda il viaggio che fecero Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, che definirono Fidel Castro «un amico».
TUTTAVIA, la prima grande incrinatura si produsse nel 1971, di fronte al gruppo di scrittori che appoggiarono Heberto Padilla, i quali ritenevano che la rivoluzione avesse tradito. «Quale dev’essere la prima preoccupazione: i pericoli reali o immaginari che possono minacciare il libero spirito creatore, o i pericoli che possono minacciare la Rivoluzione stessa? Dentro la rivoluzione, tutto, contro della rivoluzione, niente», diceva Fidel agli intellettuali, nel ’61. Molti scelsero di sostenere Cuba purchessia, altri le voltarono le spalle, magari per ritornare sui loro passi molti anni dopo.
IL RUOLO di Cuba nei cambiamenti strutturali del continente, ha però rimesso in campo un nuovo immaginario, una nuova mitopoiesi «bolivariana» nutrita dai punti più alti e poliedrici portati dai nuovi movimenti latinoamericani. Si è creata la Rete mondiale degli intellettuali e artisti in difesa dell’umanità, guidata da Venezuela e Cuba, e un laboratorio di pensiero - anche critico, ma fraterno - che va dall’Europa al Latinoamerica, agli Usa, e che si è fatto sentire in questi giorni per ricordare l’apporto di Fidel.
«Fidel soy yo», l’urlo di Cuba
Hasta Siempre. Oltre un milione di cubani ha invaso l’Avana per il saluto al «lìder maximo». Dall’Europa unico leader, Alexis Tsipras
di Roberto Livi (il manifesto, 1.12.2016)
«Donde está Fidel?» domanda il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega. «Aqui, yo soy Fidel» risponde un boato che scuote l’Avana. È la voce di più di un milione di persone, una valanga umana che riempie la gigantesca Piazza della Rivoluzione, debordando poi per un lungo tratto del viale d’accesso. Una marea tutt’altro che amorfa, quella che ieri sera per quasi quattro ore ha animato la cerimonia per l’estremo saluto dell’Avana al Comandante della Rivoluzione cubana. Sventolio di bandiere, canti - «Fidel, qué tiene Fidel que los americanos no pueden con él» -, applausi e qualche lacrima e il ritmare di quello slogan col quale un popolo intero vuole identificarsi col suo leader e il suo lascito politico: «Io sono Fidel».
JOSÈ MARTÌ Più in alto, sotto la grande statua di José Martí, di fronte all’entrata del mausoleo dedicato al padre della patria di Cuba, la tribuna delle autorità cubane e soprattutto degli ospiti, che ha visto riuniti i membri delle delegazioni di capi di Stato e di governo, più di venti, o di inviati dei paesi di quattro continenti, America, Europa, Asia e Medioriente e Africa. In prima fila i rappresentanti dell’Alleanza bolivariana, con il presidente venezuelano Nicolás Maduro - simbolicamente seduto alla destra del presidente Raúl Castro (in uniforme da generale) - e i colleghi della Bolivia, Evo Morales, dell’Ecuador, Rafael Correa, del Nicaragua, Daniel Ortega, affiancati dal presidente del Salvador, Salvador Sánchez Céren-, dal messicano Enrique Peña Nieto e dal panamense Juan Carlos Varela. L’Africa australe era rappresentata dai presidenti del Sudafrica e della Namibia.
SCARSE le rappresentanze di altri paesi. A dimostrazione che, anche da morto, Fidel polarizza gli schieramenti, tra chi lo giudica un gigante del XX secolo che ha contribuito a «cambiare il volto dell’America latina e a influenzare il mondo» e chi, soprattutto leader di paesi entusiasticamente neoliberisti, lo ritiene un «caudillo» che ha imposto a Cuba un regime totalitario. La Spagna era rappresentata da Juan Carlos di Borbone e l’Ue dal premier greco Alexis Tsipras. Il presidente Obama non ha voluto sfidare le ire dei repubblicani e ha inviato a rappresentarlo il diplomatico Jeffrey DeLaurentis e Ben Rhodes, il consigliere alla Sicurezza che ha partecipato alle trattative per la normalizzazione dei rapporti con Cuba. Assente anche il presidente russo Vladimir Putin che ha inviato il presidente della Duma, Volodin, a rappresentarlo.
UNA PROVA visibile, comunque, di quanto ha affermato nel suo intervento il presidente della Bolivia, Evo Morales: «Fidel ha portato Cuba nella mappa politica del mondo, lottando contro l’avidità dell’impero. E oggi il mondo riconosce Fidel come un figura politica di taglia inacessibile». Un successo e un credito davvero eccezionali per un’isola di 11 milioni di persone che , fino alla vittoria dei «barbudos» di Fidel nel 1959, era nota soprattutto per gioco d’azzardo, prostituzione e la produzione, monopolizzata dagli Usa, di zucchero. Correa ha affermato che Fidel «è morto invitto» e ha duramente criticato l’embargo degli Usa. «Poche vite sono state tanto complete e luminose. Fidel non se ne va, resta con noi, assolto dalla Storia della patria grande» (latinoamericana), ha detto il presidente Maduro, assicurando Raúl Castro che «può contare oggi più che mai sull’appoggio del Venezuela». Il vicepresidente della Cina ha definito il leader scomparso «un colosso della storia».
Particolarmente emotivi sono stati gli interventi del presidente del Sudafrica, Jacob Zuma e della Namibia, Hage Gengob. Il primo ha messo in risalto l’importanza dell’intervento militare cubano - «con quasi mezzo milione di soldati» - in Angola nella seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso per contrastare l’invasione delle truppe del Sudafrica in quegli anni governato dai fautori dell’apartheid. La vittoria cubana comportò non solo la sovranità dell’Angola, «ma anche la decolonizzazione della Namibia e la sconfitta del regime razzista» a Pretoria. «Fidel non inviò le sue truppe per impadronirsi del petrolio, dell’oro o dei diamanti - ha detto Zuma - ma per la libertà e l’indipendenza dei nostri popoli». Tesi confermata dal presidente Gengob: «Quando incontrai Fidel mi disse che dall’Africa avevano portato via solo i resti mortali dei loro soldati».
COMMOVENTE e ripetuto è stato il continuo richiamo alla solidarietà che Fidel, «nonostante l’illegale blocco economico degli Usa», ha saputo assicurare a varie nazioni e popoli: «Ha inviato personale medico e ha formato a Cuba centinaia di nostri studenti di medicina» (Jacob e Gengob), «per il Vietnam si è detto disposto a dare anche il proprio sangue» - (presidente della Camera dei deputati Nguyen Thi) - «dopo un ciclone dimostrarono che con noi erano disposti a dividere il pane» (Daniel Ortega).
La gigantesca manifestazione è stata conclusa dall’intervento del presidente Raúl, il quale ha avuto anche un inatteso motto di spirito assicurando i partecipanti che il suo era «l’ultimo intervento». Un discorso asciutto, che ha ricordato come la piazza della Rivoluzione è stata il luogo dove il fratello maggiore ha annunciato e spiegato tutte le decisioni del suo governo, dalla riforma agraria - «che è stata come passare il Rubicone» - alla dichiarazione del carattere socialista della Rivoluzione.
L’ITALIA «È stata una grande manifestazione di orgoglio nazionale in memoria di un personaggio storico del XX secolo che ha saputo conquistare e difendere l’indipendenza del suo paese», ha dichiarato il viceministro degli Esteri Mario Giro che ha rappresentato il governo italiano. «Un governo che è stato sempre amico di Cuba, pronto a collaborare nei settori economici, commerciali e culturali».
Ieri mattina è partita dalla capitale la carovana funebre che porterà l’urna di legno rivestita dalla bandiera di Cuba all’interno di una teca di vetro che contiene le ceneri di Fidel lungo tutta l’isola fino a Santiago dove saranno inumate domenica. Lungo tutto il percorso - circa 900 chilometri - si prevede una fila ininterrotta di cubani per salutarlo.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - LA DIGNITA’ NON MUORE MAI --- Le nuove baie dei Porci e noi (di Tommaso Di Francesco)2 dicembre 2016, di Federico La Sala
Le nuove baie dei Porci e noi
di Tommaso Di Francesco (il manifesto, 2.12.2016)
Le immagini e le voci che giungono da Cuba sono inequivocabili. Milioni di persone di ogni età aspettano la carovana con le ceneri di Fidel e danno il loro personale e collettivo addio all’uomo che considerano giustamente come il leader che ha difeso, a caro prezzo, l’indipendenza dell’isola e quelle che possiamo definire come le difficili, minime quanto straordinarie, conquiste in campo sociale.
Mentre tutto questo accade, una miriade di altisonanti tromboni di destra e di ex sinistra si scatena in un nuovo gioco: aprire nuove baie dei Porci, lanciando vere e proprie aggressioni verbali e scritte.
Prima di tutto al buon senso e alla verità storica. L’invasione della Baia dei Porci fu, nel 1961, il tentativo dell’Amministrazione Usa di abbattere il giovane potere rivoluzionario dell’Avana, fallito per la sollevazione armata del popolo cubano.
Ora quella baia sembra tornare d’attualità. Il fatto è che a distanza di quasi sessanta anni a Fidel non riescono a perdonare l’avere garantito che Cuba non diventasse misera come Haiti e che, nel cortile di casa degli Stati uniti, non venisse aggregata senza identità e dignità come Porto Rico alle altre stelle americane; non riescono a perdonarle che l’affermazione della rivoluzione cubana sia stata d’esempio per l’intero continente, latinomaericano che, negli anni Settanta subì l’intervento militare dei golpisti locali supportati dall’Occidente «democratico», Usa in prima fila a ordire il massacro del Cile di Allende e a coordinare le stragi sanguinose del Plan Condor.
Un continente intero che poi si riscattò con un dispiegarsi di movimenti, dal Brasile al Cile, dal Venezuela all’Argentina e alla Bolivia che, arrivati al potere, realizzarono cambiamenti epocali del potere e delle condizioni sociali di milioni e milioni di esseri umani. Certo ora i governi di quella svolta sono dappertutto in crisi, ma la transizione dai golpe alla democrazia è potuta accadere fra l’altro avendo Cuba come punto di riferimento.
Non gli perdonano a Fidel anche il fatto di avere sostenuto in Africa le lotte dell’Anc di Nelson Mandela contro l’apartheid e quelle anticoloniali in Angola, Mozambico e Guinea Bissau.
Non gli perdonano in buona sostanza l’avere dimostrato che «ribellarsi è giusto». Per questo Obama e quasi tutti i leader europei non vanno ai funerali di Fidel (come non va Putin per «rispetto» al neoeletto Donald Trump).
E sfottono sulla libreta, la carta annonaria cubana che dà diritto ai beni alimentari essenziali, non sapendo che negli avanzati Stati uniti 30milioni di persone vivono con la più semantica food card; sfottono sulla egualitaria sanità cubana, dimenticando che a soli 6 km dalla Casa bianca, a Washington, nel famigerato e nascosto ghetto nero di Anacostia c’è una così alta mortalità infantile da essere denunciata nelle statistiche di Save the Children e delle Nazioni unite; strillano sui diritti umani ma scordano che il campo di concentramento di Guantanamo - base militare Usa in terra cubana - è una vergogna del mondo e di ogni diritto internazionale che si rispetti.
Sono queste aggressioni ignoranti le nuove invasioni della baia dei Porci.
Detto questo però, per noi resta decisivo un ragionamento. Se non vogliamo avere un atteggiamento solo celebrativo, dobbiamo considerare che non sarà la nostra solidarietà verbale a salvare dal nuovo isolamento a cui Cuba sarà di nuovo costretta per l’avvento di Trump - meraviglioso prodotto del disastro democratico statunitense. Solo una capacità di critica positiva delle trasformazioni realizzate a Cuba come delle difficili, contraddittorie riforme avviate da Raúl Castro, sosterrà lo sforzo di continuare quell’esperienza rivoluzionaria. E insieme solo la ripresa di una iniziativa politica e di movimento per la trasformazione radicale del potere e del modello di sviluppo qui, nelle cittadelle avanzate del capitalismo, in Occidente, potrà rompere una logica rituale e immobile per fare dell’addio a Fidel Castro una testimonianza concreta di nuovo impegno. Hasta siempre.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- "È tempo di mobilitarsi per fermare i populisti". Appello degli intellettuali per salvare l’Europa.19 novembre 2016, di Federico La Sala
Appello degli intellettuali per salvare l’Europa: "È tempo di mobilitarsi per fermare i populisti" *
Politici, uomini d’arte e cultura creano una piattaforma per far sentire la voce dei cittadini nella Ue e prevenire le derive nazionaliste
- I PROMOTORI DELL’APPELLO: GUILLAUME KLOSSA, SANDRO GOZI, DANIEL COHN-BENDIT, FELIPE GONZALEZ, ROBERT MENASSE, ROBERTO SAVIANO, DAVID VAN REYBROUCK, GUY VERHOFSTADT, WIM WENDERS
Come la Brexit, la vittoria di Donald Trump ancora una volta ci ha colto di sorpresa. Eravamo per lo più convinti che un approccio ragionevole al dibattito politico avrebbe prevalso su un discorso populista.
Le radici della Brexit e della vittoria di Trump sono in gran parte le stesse: aumento delle disuguaglianze, ascensore sociale bloccato, paura della perdita di identità moltiplicata per la paura dell’immigrazione di massa, abbandono della questione sociale, sistema educativo e culturale carente, diffidenza verso élite ossessionate per i propri interessi personali e verso istituzioni pubbliche percepite come costose e inefficaci.
In entrambi i casi, le conseguenze per gli europei e per il mondo sono rilevanti.
Al rischio di disgregazione dell’Unione Europea, causato dalla Brexit, si aggiunge quello di un allontanamento progressivo tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea e della fine del mondo costruito nel dopoguerra, basato sul multilateralismo e sulla leadership benevola degli Stati Uniti. Il presidente americano eletto è stato chiaro: gli europei devono occuparsi di più della propria sicurezza, politicamente e finanziariamente. Le sue parole non fanno che accelerare una dinamica in atto sin dalla caduta del Muro di Berlino, 27 anni fa.
Questi eventi non possono che galvanizzare i populisti del Vecchio continente, in vista degli appuntamenti elettorali o degli importanti referendum che si terranno nei prossimi mesi in Austria, Italia, Paesi Bassi, Francia e Germania. Ovunque, i partiti moderati sono minacciati.
È dunque urgente agire.
Se noi europei non impariamo rapidamente la lezione che viene da questi eventi, il crollo dell’Unione e la marginalizzazione dei nostri interessi e dei nostri valori in un mondo in cui presto non rappresenteremo più del 5% della popolazione (e dove nessuno Stato europeo farà più parte del G7) diventeranno sempre più probabili.
Non avremo più i mezzi per essere ascoltati, né per garantire la sicurezza, mentre si moltiplicano le minacce alle nostre frontiere. Sarà sempre più difficile difendere i nostri interessi economici e commerciali - quelli della prima potenza esportatrice mondiale - quando la tentazione protezionista troverà sempre più consenso. La nostra idea di sviluppo sostenibile del pianeta rimarrà lettera morta. Non sarà più possibile finanziare i nostri modelli sociali fondati sulla redistribuzione, né i nostri importanti servizi pubblici.
Nessuno dei nostri Stati ha gli strumenti per trovare, da solo, soluzioni a queste sfide. Ora più che mai, l’unità europea è indispensabile. L’urgenza è quella di trovare il modo di riconciliare i cittadini con il progetto europeo e di inventare l’Europa del futuro, capace di offrire speranza per tutti. L’Europa del futuro deve avere il cittadino nel cuore, e dimostrare che serve in modo efficace gli interessi di tutti i cittadini europei, e non solo delle proprie élite.
È questa convinzione che ci porta al Movimento del 9 maggio, lanciato da cittadini e personalità da ogni provenienza, da ogni settore e da ogni sensibilità del continente, per far sì che l’Europa adotti senza indugio una tabella di marcia ambiziosa, concreta e pragmatica. La sfida è ridurre concretamente le disuguaglianze, stimolare la crescita, dare una risposta forte alla questione delle migrazioni, rafforzare la sicurezza dei cittadini, ambire a un’ulteriore democratizzazione dell’Unione e rimettere istruzione e cultura, fondamento della nostra identità democratica, al centro della Ue. Tra le nostre proposte ce ne sono alcune fortemente simboliche: la creazione di un Erasmus degli studenti medi; una politica di ricerca e sviluppo (R&S)comune nel campo della difesa; un raddoppio immediato del piano Juncker per gli investimenti; la creazione di liste transnazionali per le prossime elezioni europee.
In parte siamo stati ascoltati dalle istituzioni europee, che hanno ripreso alcune delle nostre linee guida e adottato l’idea di una tabella di marcia.
Ma oggi è necessaria più ambizione, è giunto il momento di lanciare una vera politica estera e di difesa europea. È tempo che l’Unione diventi una grande potenza politica, democratica, culturale, sociale, economica e ambientale. Il vertice europeo che si terrà a Roma il 25 marzo prossimo, in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, dovrà rappresentare l’opportunità di un forte rilancio dell’Ue. Dovrà anche essere l’occasione per rafforzare la democrazia in Europa, sviluppando di metodi di democrazia deliberativa che possano permettere in modo efficace ai cittadini di contribuire alla definizione di priorità per il progetto europeo, e inventare i nuovi diritti e le nuove libertà del XXI secolo.
Senza questo nuovo slancio politico rivolto ai nostri cittadini i demoni populisti che ora ci stanno indebolendo, ci porteranno alla sconfitta. La Storia varia nelle sue forme, ma il risultato sarebbe comunque disastroso. E la possibilità che l’Ue non festeggi neppure il suo 70° anniversario è concreta.
Questa riscossa sarà possibile solo se le decine di milioni di cittadini che condividono la nostra ambizione si mobiliteranno per dare un futuro al nostro continente. È per questo che nel prossimo mese di gennaio creeremo una Piattaforma Civica Federale, ed è per questo che abbiamo lanciato in tutta Europa degli accordi civici per diffondere collettivamente la nostra voce. Dopo Parigi, lo scorso 15 ottobre, le prossime tappe saranno a Bratislava, Berlino, Roma e Bruxelles. Invitiamo tutti coloro che vogliono trasformare l’Europa a unirsi a noi.
All’appello aderiscono anche: László Andor; Lionel Baier ; Mercedes Bresso; Elmar Brok; Philippe de Buck; Georges Dassis; Paul Dujardin; Cynthia Fleury; Markus Gabriel; Danuta Huebner; Cristiano Leone; Jo Leinen; Sofi Oksanen; Maria Joao Rodrigues; Petre Roman; Nicolas Schmit; Gesine Schwan; Kirsten van den Hul; René Van Der Linden; Philippe van Parijs; Luca Visentini; Vaira Vike- Freiberga; Cédric Villani; Sasha Waltz; Mars di Bartolomeo
* la Repubblica, 18 novembre 2016
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Le oligarchie e il suicidio delle vecchie sinistre (di Barbara Spinelli)13 novembre 2016, di Federico La Sala
Le oligarchie e il suicidio delle vecchie sinistre:
(...) Il guaio è che la vecchia sinistra non crede di vivere il sonno della ragione. Crede d’incarnare la ragione ed esser più sveglia di tutti gli altri (Barbara Spinelli, Il Fatto Quotidiano, 12 novembre 2016 )
-
> RIPENSARE L’EUROPA! - USA 2016. In una notte, un intero mondo è diventato vecchio. L’Unione sembra un club di vecchi reduci.12 novembre 2016, di Federico La Sala
EUROPA
L’Unione sembra un club di vecchi reduci
di Danilo Taino (Corriere della Sera, 12.11.2016)
Europa confusa, nella reazione a Donald Trump presidente degli Stati Uniti. Ancora più che la sorpresa - che c’è stata anche questa volta, come dopo la Brexit - sono la lettura di quel che è successo in America, l’atteggiamento da tenere verso la nuova Washington e il senso di abbandono creato dal «tradimento americano» a dare l’idea delle difficoltà dei leader della Ue di fronte al mondo cambiato da un outsider. Tutti consapevoli di dovere collaborare ma Angela Merkel fredda, Jean-Claude Juncker sarcastico e sprezzante, François Hollande alla ricerca di chiarimenti.
È una svolta della storia e il Vecchio Continente, disorientato, vacilla. In difficoltà per ragioni sue - Brexit, rifugiati, economia, Putin, Erdogan - l’Europa non era pronta per lo choc dell’8 novembre. Di fronte al riallineamento dell’ordine mondiale, è allibita. Impreparata più di quanto non lo siano Russia, Cina, India; e più di quanto non lo siano gli Stati Uniti stessi, che la svolta storica hanno innescato, e la Gran Bretagna, che verso nuovi equilibri stava già veleggiando.
In una notte, un intero mondo è diventato vecchio. Persino nell’iconografia. Il passato darà la sua triste festa d’addio a Berlino, dal 16 al 18 novembre, quando Frau Merkel riceverà Obama: baci d’addio. Nella mattinata del 18, alla cancelliera si aggiungeranno Hollande, Renzi, Theresa May e Mariano Rajoy: quando è stato deciso l’incontro, nessuno prevedeva la svolta di Washington; ora, la festa sembrerà una rimpatriata di reduci del vecchio ordine transatlantico.
A Trump, Merkel chiede il rispetto dei valori di libertà e democrazia. Giusto. Hollande vuole chiarezza su guerra al terrorismo, Ucraina, Siria, accordo nucleare con l’Iran e cambiamenti climatici. Più che giusto. La realtà, però, è che dietro alle corrette dichiarazioni politiche europee c’è il terrore che il mondo sia avviato verso le scorrette soluzioni politiche alle quali l’Europa del soft power non è in grado di rispondere.
È il terrore della solitudine davanti a sfide straordinarie ora che l’alleato di 70 anni vuole ridimensionare i legami transatlantici.
Ieri, a Berlino, numerosi politici speravano che Angela Merkel annunciasse al più presto la decisione di ricandidarsi: è l’unico paio di mani sicure nella vecchia Europa frastornata. Non può bastare.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! . Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. --- USA 2016. Trump, la seconda profezia del regista Moore: “Non arriverà a fine mandato”.12 novembre 2016, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
- POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
Elezioni USA 2016
Trump, la seconda profezia del regista Moore: “Non arriverà a fine mandato”
Il documentarista americano aveva già profetizzato la vittoria del magnate repubblicano alle primarie e poi alle presidenziali. Ora è sicuro che il tycoon si dimetterà o subirà l’impeachment: "Un narcisista come lui è probabile possa infrangere la legge"
di F. Q. (12 novembre 2016)
“Donald Trump non porterà a termine il suo mandato”. E’ la seconda profezia di Michael Moore. Il regista, che a luglio aveva preannunciato la vittoria del magnate repubblicano alle primarie e poi alle presidenziali, sostiene che si dimetterà o dovrà subire l’impeachment, la messa in stato d’accusa del presidente, prima della fine del suo mandato. “Il motivo per cui non dovremo soffrire per 4 anni è il fatto che Trump non ha nessuna ideologia se non la sua - ha detto alla Msnbc il premio Oscar del 2003 con ‘Bowling for Columbine‘ - e quando ti trovi davanti a un narcisista come lui, è probabile che possa, anche involontariamente, infrangere le leggi”.
Moore è sicuro: “Trump infrangerà le leggi perché penserà solo a ciò che è meglio per lui”. Secondo il regista, la vittoria del tycoon si rivelerà una benedizione per la sinistra e i democratici non cadranno nella disperazione dopo il risultato inaspettato delle elezioni. “Resisteremo e ci opporremo - ha aggiunto Moore - sarà una resistenza massiccia, un milione di donne hanno già annunciato che marceranno nel giorno del suo insediamento. Sarà la più grande manifestazione mai organizzata”. Il documentarista americano è ormai una bandiera della sinistra schierata contro il miliardario newyorchese: a ottobre è uscito il suo ultimo film ‘Michael Moore in TrumpLand‘, una sorta di instant movie realizzato per contrastare la corsa alle presidenziali americane del candidato repubblicano.
-
> RIPENSARE L’EUROPA! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. --- USA. Quei cardinali che tifano per Donald (di Massimo Franco)11 novembre 2016, di Federico La Sala
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Quei cardinali che tifano per Donalddi Massimo Franco (Corriere della Sera, 11.11.2016)
Il Vaticano aveva scelto la strategia del «male minore». E alla fine sembrava così rassegnato alla vittoria di Hillary Rodham Clinton da pensare a lei come alla candidata meno sgradita: sebbene forse non ci credesse fino in fondo. Donald Trump era considerato «non votabile» per le rivelazioni sul suo maschilismo aggressivo, che si aggiungevano alle minacce di deportare oltre il confine sud undici milioni di messicani, di impedire l’entrata negli Usa agli islamici: cose ormai archiviate.
E invece, il presunto «male maggiore» Trump è emerso a furor di popolo come nuovo inquilino della Casa Bianca, a conferma di un’America arrabbiata e radicalizzata.
 E per la Santa Sede si tratta di una sconfitta bruciante: culturale prima che politica. Tra l’altro, è il segno che la Chiesa cattolica non aveva captato i sommovimenti più profondi in atto nel maggiore Paese occidentale.
E per la Santa Sede si tratta di una sconfitta bruciante: culturale prima che politica. Tra l’altro, è il segno che la Chiesa cattolica non aveva captato i sommovimenti più profondi in atto nel maggiore Paese occidentale.La cautela ufficiale e le parole di augurio rivolte al neopresidente dal segretario di Stato vaticano, cardinale Piero Parolin, sono state doverose e ineccepibili. Ma si affiancano a una preoccupazione palpabile. Va detto che sarebbe stata una sconfitta anche se avesse vinto la Clinton, considerata un bastione del laicismo più ideologico e indigesto alle gerarchie ecclesiastiche. Ma Trump è simbolicamente «l’uomo del muro» col Messico. È il cantore della sbrigativa associazione Islam-terrorismo. Ancora, ha vinto dopo essersi presentato come argine «bianco» contro l’invasione demografica degli immigrati latino-americani, di cui l’argentino papa Francesco è il sommo protettore.
Così, a Roma è stato percepito e raffigurato come una sorta di anti Papa, al di là dei suoi meriti e demeriti. Lui stesso, d’altronde, scelse questo ruolo quando il 18 febbraio scorso accusò Jorge Mario Bergoglio di essere «un agente del governo messicano per l’immigrazione». Il Papa tornava da un viaggio al confine tra Messico e Usa, dove aveva celebrato una messa proprio sul versante «povero» . E reagì con una durezza insolita. «Chi pensa che bisogna costruire muri e non ponti», scolpì, «non è cristiano».
«Nessuno sa cosa è rimasto nell’anima di Trump dopo le parole del Santo Padre...», ammette un influente cardinale italiano. Allora, il candidato repubblicano replicò a brutto muso. Oggi, quella domanda rimbalza nella Roma papale, perché il «cristiano non cristiano» Trump dal 20 gennaio sarà alla Casa Bianca. La sua «cultura dei muri» e l’islamofobia minacciano di legittimare tutti i populismi; e soprattutto di fare breccia nei circoli cattolici più conservatori, che diffidano dei toni inclusivi di Bergoglio verso i divorziati e gli omosessuali e della difesa dei migranti.
Non è un caso che il 22 settembre scorso Trump, protestante presbiteriano, abbia diramato una lista di «trentatré cattolici conservatori» come consiglieri elettorali: era un amo elettorale.
L’arcivescovo di New York, Timothy Dolan, ha definito la campagna per le presidenziali «disgustosa», pur invitando i cattolici a non astenersi. E l’episcopato americano si è tenuto su una posizione di formale equidistanza che è suonata come presa di distanza da entrambi i candidati; ma alla fine è apparso disorientato.
Nelle pieghe buie dei sondaggi è cresciuto silenziosamente un «partito di Trump» affezionato al motto «Dio, patria, famiglia e armi», caro all’America profonda; e appoggiato da pezzi di organizzazioni cattoliche potenti come i Cavalieri di Colombo, in quanto contrario all’aborto e alle unioni gay.
Ultimamente, anche in Vaticano si parlava sottovoce dell’esistenza di frange della Curia affascinate da Trump in opposizione alla «laicista Hillary», e come nemico di un establishment logorato dal potere. Si tratta di settori minoritari che però adesso si sentono rafforzati. Capofila è il cardinale Raymond Leo Burke, critico coriaceo delle aperture di Bergoglio: Burke ha già benedetto il neopresidente come «difensore dei valori della Chiesa». Ma dietro di lui si indovinano invisibili benedizioni di cardinali e vescovi di peso, schierati da sempre per la «sacralità della vita»: «guerrieri culturali» contro il Partito democratico di Barack Obama e dei Clinton.
La lotta all’aborto è uno dei punti di incontro fra Trump e l’episcopato cattolico nordamericano, che teme una Corte Suprema e una legislazione troppo progressiste. In più, potrebbe emergere una sintonia con Francesco se fosse confermata una politica più conciliante con la Russia di Putin, che il Vaticano considera un alleato in Medio Oriente e nei rapporti col mondo ortodosso. Al fondo, tuttavia, la vera incognita per Bergoglio rimangono l’Occidente e la sua metamorfosi culturale. «Crediamo che a votare per Trump siano stati pochi vescovi», spiega un profondo conoscitore degli Usa dentro la Santa Sede. «Il problema è che lo hanno votato molti cattolici».
Significa evocare un’opinione pubblica percorsa da pulsioni che vanno in direzione opposta a quella indicata da Francesco: in America e in Europa, dove la categoria del populismo va declinata con meno sufficienza, perché coinvolge anche persone che populiste non sono. C’è chi prevede che, se Bergoglio non ricalibra la strategia, dal prossimo Conclave potrebbe spuntare un Papa ultraconservatore. Il texano col cappello da cowboy e il crocifisso al collo, felice per l’elezione di Trump, che mercoledì 8 novembre è stato intervistato dai media statunitensi all’udienza in piazza San Pietro, non era un’anomalia. Era l’emblema di un paradosso destinato a scuotere la Chiesa di Francesco.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Dalla psicopatologia delle élite alla pedagogia costituzionale (di Luca Verzichelli - "il Mulino")10 novembre 2016, di Federico La Sala
- CRISI COSTITUZIONALE DI LUNGA DURATA. DUE PRESIDENTI GRIDANO: FORZA ITALIA!!! .... E IL LUNGO SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI INTELLETTUALI.
 BERLUSCONI E LA "MEZZA" DIAGNOSI DEL PROF. CANCRINI. Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" - "L’Italia è il mio Partito": "Forza Italia"!!!
BERLUSCONI E LA "MEZZA" DIAGNOSI DEL PROF. CANCRINI. Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore" - "L’Italia è il mio Partito": "Forza Italia"!!!
Referendum Costituzionale Riforme
sì/no: un voto decisivo
Dalla psicopatologia delle élite alla pedagogia costituzionale
di Luca Verzichelli (il Mulino, 09.11.2016)
Può piacere o meno, ma che la discussione attorno al referendum abbia assunto fin dalla sua fase iniziale i toni di un confronto, in qualche modo autodistruttivo, tra i vari segmenti delle élite, è sotto gli occhi di tutti. Se molti politici tendono a litigare agitando con fare non sempre avveduto concetti importanti ma assai delicati come governabilità e responsabilità, gli opinion maker fanno eco con toni anche più grevi. I protagonisti dei social media, e anche il residuo manipolo di praticanti dell’antico ma ancora in auge wrestling televisivo completano il quadro, alimentando di fatto la patologia autodistruttiva della nostra classe dirigente.
Tale azione si appoggia all’uso di strumenti distribuiti in egual misura tra i competitori, sia pure con dosaggi diversi: chi insiste sulla contrapposizione tra vecchio e nuovo, chi continua a puntare sull’irrisione sistematica o sulla presunta inadeguatezza culturale degli avversari, chi ricorre a espressioni popolari per solleticare gli istinti più tipici della mentalità populista, come la connaturata sfiducia nella capacità riformatrice dei «politici di professione».
Che le élite politiche italiane siano un disastro lo diciamo da un po’. E non è neppure una novità che le campagne elettorali siano spesso un disastro. Se pensiamo a una campagna come quella appena chiusa per l’elezione del presidente negli Stati Uniti, incentrata a lungo sugli scandali e sulle inadeguatezze dei candidati, se non sulle pratiche loro, dei loro parenti e dei loro amici, non sembriamo messi poi troppo male: grazie al buon senso di molti - inclusi molti amici del Mulino - una parte della discussione rimane sul merito della riforma e comunque su valutazioni politiche complessive informate e ponderate.
Tuttavia, si può e si deve fare di più quando parliamo di Costituzione. La classe politica, intanto, deve smettere di guardarsi allo specchio e uscire dalla palude delle bassezze, per non fare la figura di un insieme di free rider che restituiscono al cittadino la responsabilità di scelte complesse e tecniche senza nemmeno informarlo doverosamente sulle proposte.
Ma ancor più dannosa è l’auto-celebrazione degli esponenti dell’élite socio-culturale i quali, pur nel tentativo lodevole di dare un contributo alla scelta pubblica, finiscono per mettere in ridicolo con le proprie approssimazioni anche i progetti della propria parte politica. Roberto Escobar ha evidenziato la contraddizione di una comunicazione basata sul ticket politica-società civile, dove la società civile, rappresentata dal difensore del brand costituzionale in tempi berlusconiani, ruba la scena anche al riformatore, paventando gli scenari più foschi in caso di fallimento della riforma. Mi chiedo se Benigni non avesse dovuto prefigurare alcune delle implicazioni che discendono da questo operato. Così come mi chiedo se alla fine non sia imbarazzante per uno storico dell’arte autorevole come Montanari costruire uno spot elettorale leggendo in un’opera d’arte l’immagine della ribellione nei confronti di una leadership telecomandata dalla finanza internazionale.
Insomma, quando la comunicazione scivola su questo piano, viene il sospetto che anche l’autonomia di giudizio dell’intellettuale sia entrata in riserva. Invece di una «visione» da prestare alla propria parte politica ne esce fuori un ulteriore messaggio personalizzato al proprio piccolo popolo di follower.
Mi si dirà che in tempi di democrazia senza partiti è di questo che si ciba l’opinione pubblica. Ok. Tuttavia, parlando di Costituzione e di referendum, un lavoro intellettuale che reitera la mera partigianeria, senza dare agli elettori un minimo elemento per fugare i loro dubbi, non mi pare un grande aiuto.
Non sarebbe meglio spendere queste ultime settimane di campagna ad ascoltare chi ha davvero qualcosa da dire nel merito? Sarebbe possibile inserire negli spiegoni televisivi gli elementi descrittivi alla base delle decisioni sulle quali dobbiamo esprimerci, magari partendo dal funzionamento attuale del bicameralismo, oppure introducendo qualche elemento oggettivo di analisi comparata? Inoltre, sarebbe auspicabile rinunciare alla logica del «ring» e ai contradditori più inutili, per lasciare posto a illustrazioni sinottiche sui pro e i contro, commentate ovviamente dai politici e da esperti con capacità dissertative adeguate.
Con una tale strumentazione, e con la certezza che si tratta di un voto su una proposta di manutenzione costituzionale (che possiamo naturalmente valutare nei modi più diversi), forse focalizzeremo meglio la vera partita che stiamo giocando. A seconda del livello di interesse e delle competenze, potremo valutare in coscienza il merito politico della riforma, e produrre un qualche «spacchettamento», necessario per calcolare la somma algebrica di migliorie e peggioramenti. Ci sentiremo forse un po’ meno decisivi per le sorti del Paese, rispetto a quanto ci hanno detto molti assertori del «sì» e del «no», ma alleggeriti nel nostro stato d’animo e coscienti che a noi adesso spetta fare questo e solo questo. Saremo inoltre meno sensibili al ciarpame mediatico e più interessati a imparare qualcosa sulla nostra costituzione, apprezzando le analisi approfondite come quelli ospitate dal «Mulino». Nel contempo, ci impratichiremo con un esercizio, davvero utile, di coinvolgimento civico.
Spostare il dibattito dalla psicopatologia delle élite alla pedagogia costituzionale sarebbe un primo risultato importante del referendum.
- CRISI COSTITUZIONALE DI LUNGA DURATA. DUE PRESIDENTI GRIDANO: FORZA ITALIA!!! .... E IL LUNGO SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI INTELLETTUALI.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Cerchiamo di capire cosa è successo. Come fece nel 1933, la classe operaia si vendica di chi l’ha presa per il culo negli ultimi trent’anni (di Franco berardi Bifo)10 novembre 2016, di Federico La Sala
- LA STATUA DELLA LIBERTA’ DEGLI U.S.A. - CON LA SPADA SGUAINATA: "GUAI AI VINTI"!!! LA LEZIONE DI FRANZ KAFKA, IL MAESTRO DELLA LEGGE: RIPENSARE L’AMERICA. E il sogno del "nuovo mondo"!!!
- UNA DOMANDA ALL’ITALIA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! UN "BORDELLO STATE": UN PAESE BORDELLO. Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia) di Federico La Sala
- POLITICA, FILOSOFIA, E MERAVIGLIA. Materiali sul tema
Nazional-Operaismo e guerra razziale
di Franco Berardi Bifo*
Cerchiamo di capire cosa è successo. Come fece nel 1933, la classe operaia si vendica di chi l’ha presa per il culo negli ultimi trent’anni. Uno schiavista che per sua stessa ammissione non ha mai pagato le tasse, un violentatore seriale è diventato Presidente degli Stati Uniti d’America. Hanno votato per lui coloro che sono stati traditi dalla sinistra, in America come in Europa.
La più urgente azione da compiere ora sarebbe linciarli, coloro che hanno aperto la strada al fascismo mettendosi al servizio del capitale finanziario e della riforma neo-liberale: Bill Clinton e Tony Blair, Massimo d’Alema e Matteo Renzi, Giorgio Napolitano, François Hollande, Manuel Valls e Sigmar Gabriel. Chiamiamoli per nome i mascalzoni che per cinismo e per imbecillità hanno consegnato alle grandi corporation finanziarie il governo sulla nostra vita, e hanno aperto la porta al fascismo che ora dilaga, alla guerra civile globale alla quale ora non c’è più modo di porre argini.
Nel Regno Unito e in Polonia, in Ungheria e in Russia e ora negli Stati Uniti, ha vinto il Nazional-Operaismo. La classe operaia bianca, umiliata negli ultimi trent’anni, ingannata dalle promesse riformiste dei suoi rappresentanti, impoverita dall’aggressione finanziaria, porta uno schiavista violentatore alla Casa Bianca.
Dato che la sinistra ha tolto dalle mani dei lavoratori le armi per difendersi, ecco la versione fascista e razzista della lotta di classe: Wall Street è riuscita a sconfiggere Bernie Sanders alle primarie, e ora un uomo del Ku Klux Klan sconfigge la rappresentante di Wall Street.
I prossimi dieci anni saranno tremendi, è bene saperlo. Il crollo della globalizzazione capitalista è l’inizio di una guerra nella quale poco di ciò che chiamammo civiltà è destinato a sopravvivere. «Zero Hedge», il giornale online in cui scrivono gli intellettuali trumpisti ha pubblicato qualche giorno fa un articolo che sintetizza benissimo quello che sta accadendo e anticipa quello che accadrà:
È la classe media demoralizzata e disillusa che ha perduto di più, depredata dalla Federal Reserve, con salari che languiscono dagli anni Ottanta. Gli interessi a zero hanno punito lavoratori pensionati e risparmiatori mentre hanno beneficiato i milionari della finanza. Il prossimo collasso finanziario, che è dietro l’angolo provocherà una guerra di classe nelle strade.
Trump ha vinto perché rappresenta un’arma nelle mani dei lavoratori impoveriti, dato che la sinistra li ha consegnati disarmati nelle mani del capitale finanziario. Purtroppo si tratta di un’arma che si rivolgerà presto contro i lavoratori stessi, e li porterà a una guerra razziale. L’altra faccia dell’Operaismo trumpista è infatti il Nazionalismo bianco. Scrive ancora «Zero Hedge»: «Alle elezioni le persone bianche, sposate, rurali e religiose si scontrano contro le persone nere, senza padre, e non religiose».
La minaccia di guerra razziale è del tutto esplicita nelle posizioni del Nazional-Operaismo americano. Sconfitti sul piano sociale dal capitalismo finanziario, gli operai bianchi si riconoscono come razza degli sterminatori e degli schiavisti.
Il movimento Black Lives Matter sponsorizzato da Soros ha creato il caos nelle città americane, spingendo giovani neri a uccidere ufficiali di polizia, e portando all’estremo il programma di riparazioni ispirato da Obama. Ma se provano a uscire dai loro ghetti urbani creati dai democratici e se provano a venire nelle zone dell’America rurale incontreranno i possessori legali di armi che gli spareranno addosso. La guerra razziale si concluder presto e non c’è dubbio su chi sarà il vincitore. I bianchi moderati e conservatori sono stufi marci del programma liberal e del vittimismo nero. La risposta che daremo è: fatela finita di fare figli fuori dal matrimoni, andate a lavorare, educatevi. La vita è dura. Imparatelo. Nessuno vi deve nulla.
Aspettando la seconda guerra civile americana, in questi giorni mi trovo a Mosca per una conferenza. Mentre parlavo in una galleria d’arte ai fighetti come me e come i lettori di Operaviva, fuori, nel gelido nevischio della metropoli il popolo russo festeggiava. Cosa? Cosa si celebra, e si ricorda all’inizio del mese di Novembre in Russia? Non la rivoluzione sovietica del 1917 ma la cacciata dei polacchi nel 1612. Il fascismo russo ha salutato l’erezione della statua di Vladimiro il savio, cristianizzatore della patria 18 metri di altezza. Molte donne e molti bambini vestono con uniformi militari e inneggiano ai peggiori assassini che la storia ricordi, da Ivan il Terribile a Stalin il massacratore di comunisti.
La razza bianca in armi prepara un finale spaventoso per la storia spaventosa del colonialismo moderno. Riusciremo a sfuggire a questo finale già scritto nei libri dell’Armageddon che il capitalismo finanziario ha preparato e cui la sinistra riformista ha aperto la strada?
* Ha aderito alla campagna Facciamo Comune insieme. Questo articolo è stato pubblicato su operaviva.info
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- LONDRA. La Brexit va votata dal Parlamento. Gina Miller, ’al settimo cielo per vittoria’.3 novembre 2016, di Federico La Sala
Alta Corte della Gran Bretagna: la Brexit va votata dal Parlamento. Gina Miller, ’al settimo cielo per vittoria’
L’organismo dà torto al governo di Theresa May
di Redazione ANSA *
LONDRA. L’Alta corte di Londra ha accolto il ricorso di un gruppo di attivisti pro Ue che chiedono un voto del Parlamento di Westminster per avviare l’iter della Brexit. Il giudice ha dato così torto al governo di Theresa May che rivendica il pieno diritto d’invocare l’articolo 50 del Trattato di Lisbona. Governo pronto al ricorso alla Corte Suprema.
"Siamo determinati ad andare avanti coi nostri piani", ha detto, tramite un suo portavoce, la premier britannica Theresa May commentando il verdetto dell’Alta corte. Il governo inoltre non ha nessuna intenzione di lasciare che questo possa modificare i tempi indicati, che prevedono l’attivazione dell’articolo 50 entro il marzo 2017.
"Il principio fondamentale della costituzione del Regno Unito è che il Parlamento è sovrano", ha detto il giudice dell’Alta corte, Lord Thomas of Cwmgiedd, nel leggere il verdetto. Come sottolineano i media britannici, non solo si tratta di una forte umiliazione per il governo di Theresa May ma questo di sicuro avra’ ripercussioni sui tempi della Brexit, rallentandola. Secondo il Guardian, non e’ comunque la fine di questo storico caso legale, che vedra’ la sua conclusione molto probabilmente di fronte alla Corte suprema, che gia’ si starebbe preparando per dibatterlo.
Il governo britannico ha dato il via libera per presentare un appello alla Corte suprema contro il verdetto dell’Alta corte in favore di un voto del Parlamento sull’avvio della Brexit. Ne dà notizia il sito della Bbc.
Si è detta "al settimo cielo" per la storica vittoria ottenuta oggi all’Alta corte di Londra. Gina Miller, donna d’affari e attivista, ha organizzato e guidato la campagna per ’sfidare’ in tribunale il governo di Theresa May sulla Brexit. E’ lei l’"eroina’ del giorno, intervistata da tutti i principali media. Ma Gina cerca di ricordare a tutti che questo non è un trionfo personale e nemmeno politico ma "per il futuro del Regno Unito".
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Papa in Svezia a commemorare 500 anni Riforma Lutero.31 ottobre 2016, di Federico La Sala
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo" -
Papa in Svezia a commemorare 500 anni Riforma Lutero
Bergoglio partito da Fiumicino, per il 17.mo viaggio internazionale del pontificato
di Redazione ANSA *
Papa Francesco è partito per la Svezia. L’airbus A321 di Alitalia è decollato alle 8.25 dall’aeroporto di Fiumicino. L’arrivo è previsto per le 11 all’aeroporto internazionale di Malmoe.
Il Papa parte per il 17.mo viaggio internazionale del pontificato che lo porta in Svezia: è stato invitato dalla Federazione luterana mondiale (LWF) a partecipare alla cerimonia di commemorazione dei 500 anni della Riforma di Martin Lutero. Il viaggio ha questa forte connotazione ecumenica, e quando papa Francesco ha accolto il desiderio della piccola comunità cattolica svedese e dei paesi vicini, di celebrare una messa, ha voluto che avvenisse in un altro giorno e in un altro luogo rispetto alle celebrazioni ecumeniche, proprio per rimarcare l’importanza e la specificità di queste.
Oggi dunque avrà due incontri ecumenici - un rito nella cattedrale di Lund e un evento con testimonianze nella Malmo Arena - e domani, festa di Ognissanti, celebrerà la messa presso lo stadio di Malmo, alla quale sono invitati anche gli esponenti della LWF. Durante il viaggio in Svezia il Papa pronuncerà quattro interventi pubblici, tra omelie, discorsi e Angelus, ed è previsto che parli in spagnolo.
La Svezia ha già accolto un papa nel 1989, quando Giovanni Paolo II ha compiuto un viaggio in Scandinavia. Papa Francesco dunque, arriverà alle 11 all’aeroporto di Malmo, dove ci sarà l’accoglienza ufficiale ai piedi della scaletta, da parte del premier svedese, Stefan Lofven e del ministro della Cultura, signora Alice Bah-Kuhnke. Ci saranno anche altre autorità e alcuni membri della LWF. L’accoglienza è semplice e non ci saranno discorsi. Subito dopo, nella sezione Vip dell’aeroporto, papa Bergoglio incontrerà privatamente il premier e il ministro della Cultura.
Subito dopo, trasferimento in macchina per circa 42 chilometri a Igelosa, dove presso una grande struttura di ricerca medica che ha già ospitato gli incontri della Conferenza episcopale svedese, papa Francesco alloggerà durante questo viaggio. Percorsi circa dieci chilometri in automobile, il Pontefice raggiungerà Lund, dove presso il Palazzo Reale renderà alle 13,35 una visita di cortesia al re Carlo Gustavo XVI e alla regina Silvia. Con i reali, poi, il Papa percorrerà i centro metri che separano la Residenza reale dalla cattedrale di Lund.
Qui alle 14,30 ci sarà la preghiera ecumenica comune comune, e sia il Papa che il presidente della LWF, Munib Younan, pronunceranno un discorso. Alla fine, percorrendo in pullmino 28 chilometri, i leader religiosi si recheranno alla Malmo Arena, dove, introno alle 16,40, è previsto un evento ecumenico con l’ascolto di quattro testimonianze di impegno comune tra LWF e Caritas internationalis.
Prima dell’evento, i leader religiosi si incontreranno nella Green Room della Arena. Alle 18,10 nella Malmo Arena, poi, il Papa e il segretario generale della LWF, Martin Junge e il presidente del Pontificio consiglio per l’unità dei cristiani, card. Kurt Koch, saluteranno individualmente i 30 capi delle delegazioni cristiane presenti alla commemorazione dei 500 anni della Riforma. Alle 19 papa Francesco sarà a Igelosa, per la cena e la notte.
Domattina l’arrivo allo stadio di Malmo per la messa è fissato alle 9,15 e, dopo la messa e l’Angelus papa Francesco ripartirà dall’aeroporto di Malmo alle 12,45, e l’arrivo a Roma Ciampino è previsto intorno alle 15,30.
*
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Dopo 500 anni, da Michelangelo e dalle "95 tesi", il Papa apre ai luterani, imparare da loro: Riforma e Scrittura.29 ottobre 2016, di Federico La Sala
- UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! UNA MEMORIA DI "VECCHIE" SOLLECITAZIONI.
-
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Il Papa apre ai luterani, imparare da loro: Riforma e Scrittura
Alla vigilia del viaggio in Svezia: ’E’ un passo di vicinanza’
di Redazione ANSA *
"Riforma e Scrittura" sono le due "parole" che vengono in mente al Papa, interpellato da C. Cattolica su cosa i cattolici potrebbero imparare dalla tradizione luterana". "All’inizio quello di Lutero era un gesto di riforma in un momento difficile per la Chiesa". E "Lutero ha fatto un grande passo per mettere la Parola di Dio nelle mani del popolo". E nelle "Congregazioni prima del conclave la richiesta di una riforma" è stata "sempre viva e presente".
"Mi vengono in mente - ha risposto il Papa a Civiltà cattolica - due parole: ’riforma’ e ’Scrittura’. Cerco di spiegarmi. -La prima è la parola ’riforma’. All’inizio quello di Lutero era un gesto di riforma in un momento difficile per la Chiesa. Lutero voleva porre un rimedio a una situazione complessa. Poi questo gesto - anche a causa di situazioni politiche, pensiamo anche al ’cuius regio eius religio’ (la norma per cui i popoli dovevano professare la stessa confessione dei loro principi, ndr) - è diventato uno ’stato’ di separazione, e non un ’processo’ di riforma di tutta la Chiesa, che invece è fondamentale, perché la Chiesa è ’semper reformanda’.
 La seconda parola - ha proseguito papa Francesco - è ’Scrittura’, la Parola di Dio. Lutero ha fatto un grande passo per mettere la Parola di Dio nelle mani del popolo. Riforma e Scrittura sono le due cose fondamentali che possiamo approfondire guardando alla tradizione luterana. Mi vengono in mente adesso - ha aggiunto - le Congregazioni Generali prima del Conclave e quanto la richiesta di una riforma sia stata viva e presente nelle nostre discussioni".
La seconda parola - ha proseguito papa Francesco - è ’Scrittura’, la Parola di Dio. Lutero ha fatto un grande passo per mettere la Parola di Dio nelle mani del popolo. Riforma e Scrittura sono le due cose fondamentali che possiamo approfondire guardando alla tradizione luterana. Mi vengono in mente adesso - ha aggiunto - le Congregazioni Generali prima del Conclave e quanto la richiesta di una riforma sia stata viva e presente nelle nostre discussioni".Il Papa invita a proseguire sulla strada del dialogo teologico, e per i cattolici che vivono in Svezia (alla vigilia del viaggio nel Paese) pensa a ’una sana convivenza, dove ognuno può vivere la propria fede ed esprimere la propria testimonianza vivendo uno spirito aperto ed ecumenico’.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- LUND. L’incontro di papa Francesco con il vescovo, Antje Jackelén, primate di Svezia apre le celebrazioni della riforma di Lutero (1517 - 2017)30 ottobre 2016, di Federico La Sala
Anniversari storici (1517 - 2017)
Annus lutheranus
L’incontro di papa Francesco con il vescovo (donna) primate di Svezia apre le celebrazioni della riforma di Lutero
di Gianfranco Ravasi (Il Sole-24 ore, Domenica, 30.10.2016)
Domani papa Francesco varcherà la soglia della chiesa più antica e importante di Svezia, la Domkyrkan della città di Lund, sede della prestigiosa università verso la quale era diretto il vecchio professor Isaac Borg per ricevere il premio a suggello della sua carriera, come ricordano tutti coloro che hanno visto e amato Il posto delle fragole, lo stupendo film che Bergman girò nel 1957. All’interno di quel capolavoro dell’architettura romanica nordica - che i turisti ammirano soprattutto per il trecentesco orologio astronomico della facciata con la sua sfilata di Magi a ogni battere d’ora - ad accogliere il papa sarà l’arcivescovo di Uppsala, primate luterano di Svezia, che attualmente è una donna, Antje Jackelén. Precedentemente questa teologa occupò proprio la sede episcopale di Lund ove era anche docente presso la già citata università: io stesso ho avuto occasione di incontrarla varie volte e di svolgere con lei un importante dialogo nell’Accademia delle Scienze di Stoccolma.
Come è noto, la data scelta per questo atto ecumenico è legata a quel mercoledì 31 ottobre 1517 quando Martin Lutero affisse (secondo una tradizione non strettamente documentata) le celebri 95 tesi alle porte della chiesa del castello di Wittenberg, cittadina sull’Elba in Sassonia, ideale manifesto del protestantesimo. In realtà, come dice il titolo dell’editio princeps, quelle asserzioni ruotavano attorno alla questione dibattuta delle indulgenze, Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum, ma già vi si intravedevano i germi della futura Riforma.
 Col gesto ecumenico di papa Francesco si apre l’anno dedicato a Lutero e alla sua opera, ma si manifesta in modo incisivo la distanza che intercorre rispetto alla tensione e alla divisione che imperavano cinquecento anni fa e nel prosieguo dei secoli successivi.
Col gesto ecumenico di papa Francesco si apre l’anno dedicato a Lutero e alla sua opera, ma si manifesta in modo incisivo la distanza che intercorre rispetto alla tensione e alla divisione che imperavano cinquecento anni fa e nel prosieguo dei secoli successivi.Naturalmente avremo occasione di rievocare ancora questo centenario che domani ha il suo avvio. Ci accontentiamo ora solo di qualche segnalazione bibliografica recente, per certi versi marginale. Una particolare sottolineatura merita subito il breve saggio di un cardinale tedesco noto teologo, Walter Kasper, che fu per più di un decennio a capo del dicastero vaticano per la promozione dell’unità dei cristiani. Il suo è un ritratto di Lutero in “prospettiva ecumenica”, posto all’insegna del dialogo: infatti, «abbiamo bisogno di un ecumenismo accogliente, in grado di imparare gli uni dagli altri» e non di esorcizzarci a vicenda, frapponendo subito il muro delle differenze dottrinali ed ecclesiali che pure devono essere riconosciute.
Proprio per questo è necessaria un’opera di contestualizzazione perché Lutero è intimamente intrecciato nei fili aggrovigliati di un’epoca storica ove religione e politica si arruffavano e si azzuffavano, un grembo oscuro ma fecondo dal quale sarebbe nata la modernità. Il grande riformatore, perciò, si rivela certamente rivestito degli abiti consunti di un passato ormai remoto, ma al tempo stesso svela un’attualità intima profonda, anche perché egli «con inaudita energia pone al centro la più centrale di tutte le questioni, la questione su Dio» e, di conseguenza, «la questione teologica decisiva del rapporto tra teonomia e autonomia». Il suo impulso primario non era quello di fondare una Chiesa separata ma di rinnovare la cristianità, riportandola alla sua matrice, cioè la gloria e la grazia di Dio e la fede dell’uomo.
Come scrive Kasper, al di là della vis polemica, di cui pure non difettava, e delle derive a cui fu costretto dal contesto socio-politico e dall’infausta e dura reazione cattolica, «il vangelo per Lutero ... era un messaggio vivo che interpella esistenzialmente la persona, un incoraggiamento e una promessa pro me et pro nobis. Era il messaggio della croce, il solo che dona pace».
Per cogliere questa temperie spirituale radicale di un uomo dal fascino magnetico, che talora era persino rozzo e brutale ma che sapeva essere anche mistico e delicato, può essere utile - all’interno dell’immensa sua produzione teologica - ritagliare alcune sue preghiere. È ciò che hanno fatto un teologo valdese, Fulvio Ferrario, e una funzionaria consolare, Berta Ravasi, con una suggestiva selezione di invocazioni che coprono l’arco intero dei momenti spirituali e liturgici della giornata dall’alba alla sera, della contemplazione e della tentazione, del peccato e del perdono, del matrimonio e della famiglia, della vita ecclesiale e di quella civile, per approdare all’ultima ora, quando la morte, spesso evocata, verrà abbracciata perché essa conduce all’incontro con l’amato Signore e alla sua pace infinita.
Certo, la Riforma protestante va oltre il suo primo artefice e si rivela più complessa e non sempre facilmente accessibile. Un docente di storia di un’università americana, Glenn S. Sunshine, propone allora un profilo un po’ “impressionistico” della Riforma «per chi non ha tempo», puntando soprattutto su quella traiettoria storica dalle mille ramificazioni che giunge alla pace di Vestfalia quando, il 24 ottobre 1648, tutte le potenze europee coinvolte nell’aspra guerra politico-religiosa dei Trent’anni giunsero a un accordo, facendo calare il sipario sul Sacro Romano Impero.
 Il percorso, necessariamente semplificato, accompagnato dalle vignette un po’ grossolane di Ron Hill, è delineato da un’angolatura protestante ma sostanzialmente equilibrata e lineare e si allarga a tutto l’orizzonte europeo comprendendo perciò lo scisma di Enrico VIII, le scelte radicali di Zwingli, l’opera di Calvino e anche quella Svezia da cui siamo partiti (nella imponente cripta della cattedrale di Lund, sorretta da 28 colonne, riposa l’ultimo arcivescovo cattolico, Birger, morto nel 1519 e artefice del restauro di quel tempio), mentre un’appendice di Carlo Papini si interessa anche del protestantesimo italiano.
Il percorso, necessariamente semplificato, accompagnato dalle vignette un po’ grossolane di Ron Hill, è delineato da un’angolatura protestante ma sostanzialmente equilibrata e lineare e si allarga a tutto l’orizzonte europeo comprendendo perciò lo scisma di Enrico VIII, le scelte radicali di Zwingli, l’opera di Calvino e anche quella Svezia da cui siamo partiti (nella imponente cripta della cattedrale di Lund, sorretta da 28 colonne, riposa l’ultimo arcivescovo cattolico, Birger, morto nel 1519 e artefice del restauro di quel tempio), mentre un’appendice di Carlo Papini si interessa anche del protestantesimo italiano.Un protestantesimo minoritario costretto a confrontarsi, spesso aspramente, con la prevalente cattolicità. Senza voler entrare in questo territorio accidentato, vorremmo proporre solo un curioso documento recentemente pubblicato dal Comitato Edizioni Gobettiane. Si tratta di un breve saggio sulla Rivoluzione protestante (e il titolo è significativo) di un amico di Gobetti, il noto pensatore antifascista sostenitore di un liberalismo progressista: è il calabrese Giuseppe Gangale (1898-1978), prima cattolico, poi ateo, successivamente massone e infine convertito al protestantesimo, con un forte impegno intellettuale e sociale e un’esperienza di esilio in paesi protestanti.
Ebbene, la sua analisi lo conduce ad assumere, tra l’altro, una delle componenti della visione protestante, il richiamo alla coscienza individuale, per abbozzare una “rivoluzione” da far serpeggiare nel terreno sociale italiano, contaminato da quella sorta di zizzania che era ai suoi occhi il cattolicesimo, definito senza esitazione «il male d’Italia». Si propone, così, come osserva uno dei nostri maggiori teologi protestanti, Paolo Ricca, nella sua puntuale postfazione critica, una religione (e una concezione civile) in cui «l’uomo è sacerdote a se stesso e l’autorità non è più esteriore ma interiore, fondata sulla coscienza autonoma e non più eteronoma». Da queste pagine si riesce a intuire per contrasto quanto sia complesso ma necessario un serio dialogo in tutte le sue forme, per evitare fraintendimenti e stereotipi, semplificazioni ed equivoci, ma scoprire anche coincidenze e valori comuni.
-
> RIPENSARE L’EUROPA! -- SCHIACCIATO DALLA VERGOGNA. I profughi fuggono dall’orrore che noi ci ostiniamo a ignorare (di Bernard Guetta)28 ottobre 2016, di Federico La Sala
I profughi fuggono dall’orrore che noi ci ostiniamo a ignorare
di Bernard Guetta, France Inter, Francia *
Noi non vogliamo più vedere le immagini dell’orrore quotidiano che vivono i profughi tentando di raggiungere le coste europee, ma il 26 ottobre l’Onu ha riassunto il loro dramma in un numero.
Tremilaottocento uomini, donne e bambini sono morti annegati nel Mediterraneo da gennaio, un numero di vittime che ha già superato quello complessivo del 2015. Noi europei, alle prese con tutt’altro genere di difficoltà - dalla crescita lenta alla disoccupazione in aumento all’inquietudine che ne deriva - ci dimentichiamo che vicino a noi, al largo delle nostre spiagge, altre persone come noi muoiono ogni giorno dopo sofferenze indicibili.
Queste persone muoiono perché dittature ridicole o la follia sanguinaria del gruppo Stato islamico non gli lasciano altra scelta se non quella di una fuga disperata. Muoiono perché trafficanti senza scrupoli li trasportano a peso d’oro su barconi che si ribaltano al primo soffio di vento. Muoiono perché abbiamo così tanta paura di loro che preferiamo vederli morire in mare piuttosto che organizzarci per accoglierli.
Schiacciato dalla vergogna
Queste persone scappano da tutto ciò che noi condanniamo, dittature e fanatismi religiosi. Vedono in noi un’oasi di pace e diritto, il vertice di civiltà di cui ci vantiamo fieramente. Ma noi abbiamo paura di loro, come se incarnassero l’orrore da cui fuggono e non fossero fratelli che credono negli stessi valori che noi rappresentiamo ai loro occhi.
Non so voi, ma io mi vergogno, sono schiacciato dalla vergogna per quello che sta accadendo, per questi 3.800 morti in meno di dieci mesi, morti davanti a noi, su quel mare che è il nostro mare comune e fa rima con vacanze, sole e felicità.
- Potremmo accoglierli ma non lo facciamo perché persone senza vergogna ci invitano a difendere ‘le radici cristiane dell’Europa’
Qualcuno dice che non possiamo accogliere tutta la miseria del mondo. È vero, ma sul serio non possiamo aprire le porte a qualche centinaio di migliaia di persone, a due-tre milioni di persone in tutta l’Unione europea, dove vivono quasi cinquecento milioni di individui?
La verità è che potremmo farlo, e presto ne trarremmo un grande vantaggio. Potremmo ospitarli più di quanto fanno già il Libano, la Giordania o la Turchia, ma non vogliamo farlo perché uomini senza vergogna gridano al lupo invitandoci a difendere “le radici cristiane dell’Europa”, per usare le parole di Orbán in Ungheria.
Davvero? Come si può difendere il cristianesimo dimenticando il suo primo insegnamento, “amerai il prossimo tuo come te stesso”? Come si può difendere il cristianesimo ignorando gli appelli di papa Francesco, che ha invitato ogni parrocchia ad accogliere una famiglia di profughi? Come si può essere fedeli a Cristo e non trovare un posto per chi rischia la morte?
Non so cosa rispondere, ma so che voglio fare un applauso al presidente del consiglio italiano Matteo Renzi, che il 26 ottobre ha detto che il suo paese non voterà il prossimo bilancio dell’Unione se paesi che ne traggono un grande beneficio continueranno a opporre il filo spinato alle persone in fuga dall’orrore.
(Traduzione di Andrea Sparacino)
-
> RIPENSARE L’EUROPA! - RIPENSARE L’AMERICA! Quando la fantapolitica ha il profilo di Trump: “Da noi non può succedere”, il romanzo di Sinclair Lewis del1936 (pref. di Federico Rampini)27 ottobre 2016, di Federico La Sala
- UNA DOMANDA ALL’ITALIA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! UN "BORDELLO STATE": UN PAESE BORDELLO. Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia)
- SULL’INCONTRO DI RATZINGER - BENEDETTO XVI E BUSH. LA CRISI DEL CATTOLICESIMO ROMANO E DELLA DEMOCRAZIA AMERICANA NON SI RISOLVE... RILANCIANDO UNA POLITICA OCCIDENTALE DA SACRO ROMANO IMPERO
- LA STATUA DELLA LIBERTA’ DEGLI U.S.A. - CON LA SPADA SGUAINATA: "GUAI AI VINTI"!!! LA LEZIONE DI FRANZ KAFKA, IL MAESTRO DELLA LEGGE: RIPENSARE L’AMERICA. E il sogno del "nuovo mondo"!!!
 "IN GOD WE TRUST": TUTTO A CARO-PREZZO ("DEUS CARITAS EST")!!! IL DERAGLIAMENTO DELLA DEMOCRAZIA E BUSH CHE FA LA "BELLA STATUINA".
"IN GOD WE TRUST": TUTTO A CARO-PREZZO ("DEUS CARITAS EST")!!! IL DERAGLIAMENTO DELLA DEMOCRAZIA E BUSH CHE FA LA "BELLA STATUINA".
Quando la fantapolitica ha il profilo di Trump
Arriva in Italia “Da noi non può succedere”, il romanzo di Sinclair Lewis che nel 1936 immaginava l’avvento negli Usa di un regime parafascista
di Federico Rampini (la Repubblica, 27.10.2016)
- IL LIBRO Sinclair Lewis, Da noi non può succedere ( Passigli, pagg. 320, euro 19,50). Qui anticipiamo la prefazione di Federico Rampini
Ci voleva un grande conservatore per osare pronunciare quella parola. Il fascismo in America? A spezzare il tabù è stato Robert Kagan, già consigliere di George W. Bush, “neocon” esperto di geopolitica, autore della celebre metafora su «gli americani che vengono da Marte, gli europei da Venere».
In un editoriale-shock sul “Washington Post”, il 18 maggio 2016 Kagan ha messo da parte cautele verbali, circonvoluzioni e inibizioni dell’intellighenzia. Il titolo è stato come un pugno nello stomaco: Ecco come il fascismo arriva in America.
Il portatore della peste nera, Kagan non aveva dubbi, si chiama Donald Trump. L’intellettuale di destra in quell’intervento drammatico non risparmiava le accuse ai suoi compagni di partito: «Lo sforzo dei repubblicani per trattare Trump come un candidato normale sarebbe ridicolo, se non fosse così pericoloso per la nostra repubblica». Seguiva una descrizione del ciclone- Trump in tutti i suoi ingredienti: «l’idea che la cultura democratica produce debolezza», «il fascino della forza bruta e del machismo», «le affermazioni incoerenti e contraddittorie ma segnate da ingredienti comuni quali il risentimento e il disprezzo, l’odio e la rabbia verso le minoranze ». Il verdetto finale: «è una minaccia per la democrazia », un fenomeno «che alla sua apparizione in altre nazioni e in altre epoche, fu definito fascismo ».
Tutto ciò accadeva all’inizio del duello fra Trump e Hillary Clinton. Mentre scrivo, il verdetto finale non è ancora arrivato. La Clinton viene data per favorita. Ma anche se dovessimo evitare il peggio, l’America avrà vissuto un’incredibile campagna elettorale, dove è accaduto tutto ciò che Da noi non può succedere. Un candidato ha sdoganato il razzismo, la misoginia, l’evasione fiscale. Ha elogiato Vladimir Putin e altri regimi autoritari in giro per il mondo. Ha invocato l’aiuto degli hacker russi contro la sua rivale. Ha promesso di mandare in galera la candidata democratica. E, anche se chi mi legge sta vivendo in un futuro in cui lo scenario peggiore non si è avverato, come spero, resta il fatto che col fenomeno Trump abbiamo convissuto per un’intera campagna presidenziale. Con lui dovremo fare i conti a lungo, molto a lungo: per tutto ciò che ha fatto emergere dall’America di oggi.
Torno al monito severo di Kagan. Dopo che il guru neo-conservatore aveva lanciato contro The Donald l’accusa che molti non osavano pronunciare, il New York Times decise di sbattere la controversia in prima pagina. Con il titolo L’ascesa di Trump e il dibattito sul fascismo, il quotidiano liberal dava conto nella primavera del 2016 di un allarme che stava diventando esplicito. Un politico, l’ex governatore del Massachusetts William Weld, paragonava il progetto di Trump per la deportazione di undici milioni di immigrati alla “notte dei cristalli” del 1938 in cui i nazisti si scatenarono nelle violenze contro gli ebrei. Il New York Times allargava l’orizzonte per cogliere dietro il fenomeno Trump una tendenza più globale: mettendo insieme una generazione di leaders che vanno da Vladimir Putin al turco Erdogan, dall’ungherese Orban ai suoi emuli in Polonia, più l’ascesa di vari movimenti di estrema destra in Francia, Germania, Grecia.
È così che l’élite intellettuale newyorchese ha riscoperto due romanzi di fantapolitica. Scritti da due premi Nobel, in epoche diverse, ma con la stessa trama: l’avvento di un autoritarismo nazionalista in America. Il primo è questo Da noi non può succedere di Sinclair Lewis, finalmente disponibile in italiano. Affermazione rassicurante, quella del titolo: ma contraddetta dalla trama narrativa. Scritto e ambientato nel 1936, immagina che Franklin Roosevelt dopo un solo mandato sia sconfitto e sostituito da un fascista. L’altro romanzo è di Philip Roth, molto più recente (2004): immagina che nel 1940 Roosevelt sia battuto dall’aviatore Charles Lindbergh, simpatizzante notorio di Hitler e Mussolini. È probabile che Roth si sia ispirato al precedente di Lewis. La grande letteratura aveva previsto ciò che i politologi non vollero prendere in considerazione?
La reticenza che aveva impedito questo dibattito ha varie spiegazioni. Al primo posto, la fiducia sulla solidità della più antica tra le liberal-democrazie. Poi, l’America è abituata a considerarsi all’avanguardia; è imbarazzante ammettere che nel 2015-2016 ha importato tendenze già in atto da molti anni in Europa (Berlusconi-Bossi- Grillo, tanto per citare solo i nostri) e culminate nel Regno Unito con Brexit. L’autocensura che ha trattenuto gli intellettuali nasce anche da un complesso di colpa: la narrazione dominante dice che l’élite pensante ha ignorato per anni le sofferenze di quel ceto medio bianco (declassato, impoverito dalla crisi, “marginalizzato” dalla società multietnica) che nel 2016 si è invaghito di Trump. Dargli del fascista può sembrare una scorciatoia per ignorare le cause profonde di un disagio sociale: quel tradimento delle élites che ho messo al centro del mio ultimo saggio.
Sulle etichette, molti preferiscono sfumature diverse, dalla “democrazia illiberale” ai “populismi autoritari”. L’allarme di Kagan si è rivelato comunque troppo tardivo per arrestare la tendenza dei repubblicani a salire sul carro del vincitore. Frastornati, storditi, imbarazzati, umiliati, ma in larga parte troppo codardi, i repubblicani avranno una responsabilità immensa: l’aver consegnato il Grand Old Party di Abraham Lincoln e di Dwight Eisenhower a un affarista imbroglione, egomaniaco, narcisista e con pulsioni autoritarie. La cui somiglianza col protagonista di questo romanzo è impressionante, inquietante.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- BREXIT: UNA SFIDA alla Davide contro Golia. Gina Miller mette in crisi la premier Theresa May (di E. Franceschini)18 ottobre 2016, di Federico La Sala
La guerra di Gina contro la Brexit: così "la Davide britannica" mette in crisi la premier May
Una donna d’affari chiede all’Alta Corte che sulla legge voti il Parlamento: dovesse vincere, l’intero processo è a rischio. Anche per l’ulteriore irrigidimento e i nuovi timori del premier irlandese Enda Kenny mentre il leader dei cattolici secessionisti chiede che comunque l’Irlanda del Nord resti nella Ue
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *
LONDRA - Gina Miller è abituata alle missioni impossibili. Insieme al marito ha creato uno dei fondi di investimento più ricchi di Gran Bretagna, poi ha fatto causa all’industria dei fondi di investimento sostenendo che certe speculazioni sono troppo opache. Abbandonati i fondi si è impegnata a tempo pieno nella beneficenza, poi ha fatto causa al settore della beneficenza affermando che spende troppi soldi per funzionari e uffici, non abbastanza per aiutare i poveri.
E una volta che si è stufata di tutto, ha cambiato radicalmente vita, girovagando tre anni con consorte e figli per l’America Latina. Ma la sua più grande sfida è l’ultima: nei giorni scorsi la 51enne businesswoman britannica di origini sudamericana (è nata in Guyana) ha presentato ricorso all’Alta Corte di Londra contro la decisione del primo ministro Theresa May di invocare l’articolo 50 del trattato europeo nel marzo prossimo, il meccanismo che metterà in moto la secessione del Regno Unito dall’Unione Europea, senza sottoporre il procedimento a un voto del Parlamento. Se il ricorso verrà accolto dai giudici, la premier dovrà affrontare una votazione alla camera dei Comuni e a quella dei Lord, spiegando che tipo di Brexit vuole realizzare, e potrebbe verosimilmente essere sconfitta. A quel punto il governo dovrebbe cambiare strategia e tutto sarebbe possibile: un Brexit meno “hard”, per esempio restando dentro al mercato comune (e dunque mantenendo la libertà di immigrazione), un nuovo referendum, elezioni anticipate. Magari, in ultima analisi, niente più Brexit.
La sfida di una donna fino a ieri relativamente poco conosciuta alla donna più conosciuta del regno (a parte la regina) ha qualcosa di eroico, quasi cinematografico, alla Davide contro Golia. “Mi sono svegliata la mattina dopo il referendum del giugno scorso come dentro un incubo”, racconta Gina Miller, che aveva votato perché il suo paese rimanesse nella Ue. E l’incubo è peggiorato, dal suo punto di vista, quando si è resa conto che la nuova premier May ha deciso praticamente da sola, insieme a un pugno di ministri radicalmente euroscettici, non soltanto di portare la Gran Bretagna fuori dalla Ue ma anche fuori dal mercato comune europeo, promettendo di ristabilire la totale “indipendenza e sovranità parlamentare” britannica, a suo parere violata fino ad ora dalle leggi europee che vi si sovrappongono.
Sono in tanti a criticare la scelta di Downing street: parlamentari dell’opposizione e dello stesso partito conservatore, finanziari e banchieri della City, commentatori sui giornali. Nessuno, tuttavia, ha avuto l’idea di mettere un ostacolo concreto, sulla strada di Theresa May: una sentenza dell’Alta Corte. Ci ha pensato Gina Miller, rivolgendosi a uno dei più prestigiosi studi legali della capitale.
Le sue argomentazioni sono di due tipi. Una prettamente legale: il governo sostiene di non avere bisogno di un voto del parlamento, nonostante il referendum fosse sulla carta soltanto “consultivo”, in virtù di un’antica “royal prerogative”, un diritto reale di agire senza necessità di approvazione parlamentare. Insostenibile, a suo parere, nel caso di una decisione storicamente importante come quella di portare il Regno Unito fuori dalla Ue. La seconda argomentazione è più politica, o se vogliamo etica: sarebbe ben strano voler ristabilire la “sovranità parlamentare” britannica, rifiutandosi però di ascoltare l’opinione in materia del Parlamento.
Adesso la premier afferma che perlomeno lo “ascolterà”, avendo accettato, dopo un iniziale rifiuto, un dibattito su Brexit ai Comuni: ma dovrà essere un dibattito senza un voto, secondo Downing street. E così le due donne finiranno per affrontarsi simbolicamente all’Alta Corte, ciascuna rappresentata da uno stuolo di avvocati: Gina Miller contro Theresa May. In una nazione in cui la separazione dei poteri è ben netta, e dove anche un comune cittadino può sfidare le più alte cariche dello stato, in teoria è possibile che la businesswoman della Guyana sconfigga la premier conservatrice.
Non è l’unico ostacolo sulla strada di Brexit per Theresa May. In verità se ne aggiungono di nuovi tutti i giorni. Un altro è il calo della sterlina, che punisce i consumatori e farà aumentare l’inflazione, prevede la Banca d’Inghilterra. Un altro ancora è venuto fuori stamane: il premier irlandese Enda Kenny ammonisce sui “gravi danni” economici e politici che verrebbero causati da un “hard Brexit”, ovvero dall’uscita della Gran Bretagna da Ue e mercato comune. Dagli accordi di pace del 1996, sull’Isola di Smeraldo non c’è più un confine fra repubblica irlandese e “provincia” britannica dell’Irlanda del Nord: ma il confine, se l’Irlanda del Nord, in quanto parte della Gran Bretagna, si ritrovasse completamente fuori dall’Europa, verosimilmente tornerebbe a esistere, creando complicazioni non soltanto commerciali.
Il pericolo maggiore sarebbe la recrudescenza del conflitto fra cattolici e protestanti in Irlanda del Nord. Nella quale, non a caso, proprio ieri Gerry Adams, leader dello Sinn Fein, il partito cattolico secessionista che vuole la ricongiunzione dell’Irlanda del Nord con l’Irlanda, ha chiesto formalmente che l’Irlanda del Nord (in cui, nel referendum su Brexit, un’ampia maggioranza ha votato per restare nella Ue) possa restare almeno dentro al mercato comune europeo.
La stessa richiesta fatta nei giorni scorsi da un’altra regione autonoma britannica che nel referendum ha votato per restare nella Ue: la Scozia, che in caso contrario medita di organizzare un nuovo referendum sull’indipendenza dalla Gran Bretagna. Uno scenario che vedrebbe Scozia e Irlanda del Nord nel mercato comune ma non nella Ue (come la Norvegia), mentre Inghilterra e Galles sarebbero fuori da tutto. Ammesso che Bruxelles sia d’accordo, ma anche questo è difficile se non impossibile: la Spagna già minaccia di mettere il veto, per non creare precedenti in cui la Catalonia possa raggiungere accordi separati per contro proprio.
In questo calderone di ipotesi si inserisce pure la rivelazione di oggi del Financial Times, secondo cui il governo May, contrariamente a quanto promesso dai “brexitiani” nella campagna referendaria, continuerebbe a versare miliardi di sterline al budget della Ue per mantenere l’accesso al mercato comune soltanto in certi settori chiave dell’economia, come la finanza e l’automobile. Una sorta di mercato comune “alla carta”, questo piatto sì e quest’altro no, su cui è da tutto da vedere cosa pensi Bruxelles. Se fosse realizzato, Brexit sarebbe un puzzle ancora più contraddittorio e confuso: la City e la città di Sunderland (la città in cui tutto dipende dalla locale fabbrica della Reanult/Nissan) dentro il mercato comune europeo, il resto dell’economia nazionale fuori. Un situazione da far girare la testa. E la trattativa su Brexit non è neanche ancora cominciata. Nemmeno comincerà, probabilmente, se Gina Miller batte Theresa May all’Alta Corte.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- "La legge del sangue" (Johann Chapoutot). La concezione che portò allo sterminio di massa fu attuata non solo da Hitler e dal partito, ma da una foltissima schiera di dotti giuristi, scienziati, medici, teologi e giornalisti (di Emilio Gentile)16 ottobre 2016, di Federico La Sala
- EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo). HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Nazismo
La «cultura» della purezza razziale
La concezione che portò allo sterminio di massa fu attuata non solo da Hitler e dal partito, ma da una foltissima schiera di dotti giuristi, scienziati, medici, teologi e giornalisti
di Emilio Gentile (Il Sole-24 Ore, Domenica, 16.10.2016)
- Johann Chapoutot, La legge del sangue. Pensare e agire da nazisti , Einaudi, Torino, pagg. 472, € 32
Nel 1945, diciotto medici tedeschi di un ospedale pediatrico furono processati dal tribunale di Amburgo, su iniziativa delle truppe di occupazione britanniche, perché accusati di aver assassinato con iniezioni letali cinquantasei bambini malati. Il direttore dell’ospedale respinse l’accusa di «crimine contro l’umanità» perché tale crimine, disse agli inquirenti britannici, «non può essere commesso che contro uomini, mentre gli esseri viventi di cui dovevamo occuparci non possono essere qualificati come “esseri umani”». Cinque anni dopo, i giudici assolsero gli imputati affermando di «aver creduto alla legalità dei loro atti».
Inizia con questo episodio un’ampia indagine dello storico francese Johann Chapoutot sul modo di pensare e di agire dei nazisti, ricostruito con una folta documentazione di oltre milleduecento libri e articoli pubblicati durante il regime nazista negli ambiti più vari, dai testi ideologici alla letteratura pedagogica, dal diritto alla medicina, dalla biologia alla filosofia, dall’antropologia alla storia e alla geografia, con l’aggiunta di una cinquantina di film prodotti dal Terzo Reich. Dall’indagine, suddivisa per temi, emerge un’elaborata e coerente concezione nazista del mondo, che fu messa in pratica durante i dodici anni del dominio hitleriano. Il nazismo attuò così una rivoluzione culturale oltre che politica, per istituire un diritto, una morale, un’etica e una religione esclusivamente tedesche, fondate sulla superiorità biologica della razza germanica, e per inculcare nel popolo tedesco l’imperativo categorico di preservare la purezza del sangue, che era l’essenza della sua superiorità su tutte le altre razze.
Milioni di tedeschi si convinsero che per preservare l’integrità e la salvezza della razza germanica, era necessario eliminare con la sterilizzazione o l’eutanasia le persone afflitte da mali ereditari; impedire la contaminazione biologica con altre razze; invadere i Paesi dell’Europa orientale per conquistare spazio vitale alla razza germanica e sottomettere gli slavi come schiavi.
E soprattutto si convinsero della necessità inevitabile di una spietata guerra razziale contro gli ebrei, fino alla loro totale eliminazione, perché da seimila anni l’ebreo era il nemico naturale del popolo tedesco, un pericolo mortale per la sua purezza e la sua integrità, come il bacillo della tubercolosi per un corpo sano e vigoroso.
Per molti decenni dopo la fine del regime hitleriano, la concezione nazista del mondo è stata considerata dagli storici una paccottiglia di farneticanti elucubrazioni, esibite da folli criminali per adornare con arcaici miti una sfrenata libidine di potere, che alla fine si sfogò con una barbarica guerra di conquista e con il sadico sterminio organizzato di oltre cinque milioni di ebrei. La follia, la barbarie, il sadismo apparivano motivi sufficienti per spiegare storicamente la criminalità del nazismo, alimentata anche dall’avidità di un capitalismo imperialista che per due volte nell’arco di trent’anni aveva tentato di dare l’assalto al potere mondiale provocando due guerre mondiali.
Comune a queste interpretazioni, osserva Chapoutot, era la «disumanizzazione dei protagonisti del crimine nazista», ma in tal modo, aggiunge, «facendo di loro dei soggetti estranei alla nostra comune umanità, noi ci esoneriamo da ogni riflessione sull’uomo, l’Europa, la modernità, l’Occidente, insomma su tutti i luoghi che i criminali nazisti abitano, dei quali partecipano, e che noi abbiamo in comune con loro», confortandoci al pensiero che «l’idea secondo la quale noi potremmo condividere qualcosa con gli autori di tesi e crimini così mostruosi ci ripugna».
Pur se legittima, tale ripugnanza ci induce però a eludere questioni fondamentali della nostra storia e del nostro tempo, perché le idee della concezione nazista del mondo erano solo in minima parte originaria produzione dei nazisti: «Né il razzismo, né il colonialismo, né l’antisemitismo, né il darwinismo sociale o l’eugenismo sono nati tra il Reno e Memel». Inoltre «la Shoah avrebbe provocato un numero molto minore di vittime se non ci fosse stato lo zelante concorso di poliziotti e di gendarmi francesi e ungheresi», insieme a «innumerevoli nazionalisti baltici, volontari ucraini, antisemiti polacchi, alti funzionari e uomini politici pervasi da volontà di collaborazione». Come lo furono, in Italia, politici, funzionari e intellettuali fascisti.
Vi erano tuttavia movimenti culturali tedeschi che fin dall’Ottocento avevano diffuso con convinzione le idee sopra citate, e la loro presenza favorì il successo della concezione nazista, che dopo il 1933 fu messa in pratica con ossessiva tenacia non solo da Hitler e dal partito nazista, ma da una foltissima schiera di dotti giuristi, scienziati, medici, teologi, ideologi e giornalisti, con l’ausilio del cinema di finzione e del cinema documentario. Milioni di tedeschi, sia persone di elevata cultura sia gente comune, si convinsero che gli ebrei tramavano da seimila anni per distruggere il popolo tedesco, inquinandolo con incroci di sangue e con idee disgregatrici, come il cristianesimo, il diritto romano, l’individualismo, l’universalismo, l’umanitarismo, il liberalismo, il socialismo, il bolscevismo. Queste idee minavano le virtù, la morale, l’etica, le tradizioni e l’integrità della comunità germanica.
Fu la concezione nazista del mondo, diffusa con martellante, capillare, pervasiva propaganda quotidiana, a trasformare milioni di uomini e donne, non predestinati alla follia né al crimine, in zelanti esecutori della persecuzione e dello sterminio. Ogni tentazione alla pietà fu anestetizzata con l’invocazione della necessità di agire con mezzi spietati per annientare i nemici della razza germanica che da seimila anni tramavano per annientarla.
Conoscere il modo di pensare e di agire dei nazisti considerandoli uomini cresciuti e vissuti in contesti particolari, con un proprio universo di significati e di valori, è il compito proprio dello storico, afferma Chapoutot. Ciò non attenua affatto la mostruosità delle idee e dei crimini nazisti: anzi, rende ancora più consapevoli della sua gravità, perché nulla esclude che tale mostruosità possa ripetersi, con altre idee e in altri contesti, nell’azione di altri uomini convinti che essa sia necessaria per salvare la propria comunità.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- L’Europa respinga gli antichi fantasmi (di Angelo Bolaffi)3 ottobre 2016, di Federico La Sala
L’Europa respinga gli antichi fantasmi
I governanti dei Paesi dell’Est credono possibile rispondere alla sfida planetaria della migrazione ricostruendo una nuova cortina di ferro
di Angelo Bolaffi (la Repubblica, 03.10.2016)
SOLO una macabra farsa: questo era il referendum ungherese contro gli stranieri e contro “i diktat” di Bruxelles fortemente voluto dal premier Viktor Orbán. E tale si è rivelato. Il popolo cui amano fare appello piccoli e grandi dittatori questa volta ha preferito tacere.
FORSE ha fiutato l’inganno e ha evitato di acclamare l’uomo forte di Budapest. Ma il danno resta per l’immagine di quel Paese e per il destino futuro dell’Europa. La grande speranza si è rivelata una fugace illusione: avevamo creduto che la caduta del Muro di Berlino se non proprio la “fine della storia” avesse, almeno in Europa, segnato la fine dell’età dei muri e dei reticolati di filo spinato. E invece sta accadendo esattamente il contrario. Quella che una volta tra ammirazione e sospetto veniva chiamata Mitteleuropa sembra tornata preda di antichi fantasmi e di pulsioni identitarie nell’illusione di trovare risposte alle sfide del mondo globale in una inattuale autarchia economica e spirituale.
I governanti dei Paesi dell’Est Europa capeggiati proprio da Orbán credono possibile dare risposta alla sfida planetaria rappresentata dalla migrazione di popolazioni in fuga dalle guerre del Medio Oriente, o dalla miseria del continente africano, ricostruendo quella che, per più di mezzo secolo, era stata causa delle loro sofferenze: una nuova cortina di ferro.
Un passo dopo l’altro, una crisi dopo l’altra, dunque, l’Europa procede spedita verso la sua disunione politica e culturale: come capitò ai sonnambuli che scivolarono senza neppure averne consapevolezza nella Prima guerra mondiale, gli europei potrebbero uno di questi giorni scoprire di aver superato il punto di non ritorno verso uno storico fallimento. Un fallimento che appare tanto più paradossale in quanto i governi dei singoli Paesi cercano risposte nazionali, o peggio ancora nazionaliste, a sfide che essi stessi definiscono di natura globale e condannano in tal modo i propri Paesi e l’intera Europa ad un declino irreversibile.
Oggi, come accadde negli anni ’20-’30 del Novecento, assistiamo infatti allo scontro di “due Europe”: quella che crede che sia possibile governare le metamorfosi in atto nel segno della giustizia sociale, della libertà e dell’universalismo dei diritti. L’altra che, invece, fa politica con la paura e l’odio e insinua la velenosa convinzione che sia possibile impedire l’irruzione del mutamento innalzando Muri e chiudendo i confini nazionali.
Sappiamo come andò a finire allora. Non è del resto un caso che, da buon conoscitore della storia europea, Helmut Kohl nel discorso tenuto nell’ottobre del 1993 dinnanzi all’Assemblea nazionale francese avesse messo in guardia gli europei ricordando loro che «gli spiriti maligni non sono stati banditi per sempre dall’Europa» e ammonendo che «ad ogni generazione si pone di nuovo il compito di impedire il loro ritorno, di superare i pregiudizi e di far cadere i sospetti».
La previsione fatta dal Cancelliere dell’unificazione tedesca appare drammaticamente confermata da quanto accade oggi in tutto il Vecchio Continente, dalla Brexit all’anarchia spagnola. E soprattutto dall’enorme potenziale di consenso che movimenti xenofobi e populisti riescono a catalizzare anche in Paesi di antica civiltà giuridica e storica tradizione di universalismo politico com’è il caso della Francia.
La verità è che in quel Paese come in molti altri, Italia compresa, si contrappongono, provocando una crescente conflittualità politica e spirituale che supera la classica contrapposizione tra destra e sinistra, due “visioni del mondo”. Una è convinta non solo della possibilità di governare la dimensione di questo esodo carico di tragedie, ma anche che questo fenomeno rappresenti un obbligo morale e al tempo stesso una opportunità per il futuro che altrimenti la demografia condannerebbe a un declino irreversibile. L’altra è una “visione del mondo” dominata da dubbi e paure, da pregiudizi ma anche da timori diffusi tra le parti più deboli, socialmente e culturalmente, delle società europee sulla possibilità di riconquistare o quanto meno di difendere determinati livelli di sicurezza sociale. Come pure i valori tradizionali che guidano il funzionamento della vita quotidiana, minacciati dalla sensazione di non essere più padroni del proprio destino di cui è metafora la crisi della sovranità sui confini nazionali.
Oggi è molto difficile formulare una ragionevole previsione sui destini d’Europa o addirittura di quello che abbiamo imparato a indicare, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, come l’Occidente. Non sappiamo se le istituzioni dell’Unione europea reggeranno l’urto del terribile ciclo elettorale che vedrà coinvolti nei prossimi dodici mesi - nel settembre del 2017 si svolgeranno le elezioni in Germania - praticamente tutti i principali Paesi del Vecchio continente. Né quale America uscirà dal confronto tra il feroce populismo di Trump e l’occidentalismo tradizionale ma dallo scarso carisma di Hillary Clinton.
Certo tutto sarebbe diverso se l’Europa fosse in grado di esprimere una politica, se sapesse e potesse parlare con una sola voce. Se: ma non è così. Le democrazie europee strette in una implacabile tenaglia, da un lato le questioni globali e dall’altro la necessità di conquistare legittimità politica parlando un linguaggio locale, tra dover elaborare un “nuovo racconto” che tenga conto delle mutate condizioni geo-politiche e geo-economiche del pianeta-mondo dell’età globale e dover dare ascolto alle attese spesso corporative di cittadini protagonisti di cicli elettorali sempre più brevi, rischiano il corto circuito. Se da qualche parte in Europa c’è qualche leader capace di impedire che essa faccia bancarotta una seconda volta nel giro di un secolo, è questo il momento che si faccia sentire.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Ezra Pound, non finisce mai il naufragio dell’Occidente. Com’è avara l’Europa.3 ottobre 2016, di Federico La Sala
L’antologia degli scritti in prosa di Ezra Pound: dall’introduzione di Giorgio AgambenPound, non finisce mai il naufragio dell’Occidente
Dalla critica all’usura delle banche e alla “denarolatria” alle riflessioni su Confucio, al necrologio per Eliot
di Giorgio Agamben (La Stampa, TuttoLibri, 01.10.2016)
Non si comprende l’opera di Pound se non la si colloca innanzitutto nel suo contesto proprio. Questo contesto coincide con una frattura senza precedenti nella tradizione dell’occidente, una frattura da cui l’occidente non soltanto non è ancora uscito, ma nemmeno potrà farlo se non sarà prima in grado di misurarne la portata in ogni senso decisiva. Dopo la fine della prima guerra mondiale era, infatti, chiaro per chi avesse mantenuto la lucidità, che qualcosa di irreparabile si era prodotto in Europa e che il nesso tra passato e presente si era spezzato.
Che i primi a rendersene conto siano stati i poeti e gli artisti non deve stupire, poiché è ad essi che incombe in ogni tempo la trasmissione di ciò che vi è di più prezioso: la lingua e i sensi. Non si può nemmeno porre il problema delle avanguardie poetiche del Novecento se non s’intende preliminarmente che esse sono il tentativo di rispondere - con maggiore o minore consapevolezza secondo i casi - a questa catastrofe: esse non hanno a che fare con la poesia e con le arti, ma con la loro radicale impossibilità, col venir meno delle condizioni che le rendevano possibili.
La trasposizione in termini estetico-mercantili della crisi epocale che si era espressa nelle avanguardie è, per questo, una delle pagine più vergognose della storia dell’occidente, di cui i musei di arte contemporanea rappresentano oggi l’estrema e più ignava propaggine. Ciò in cui ne andava della stessa possibilità della sopravvivenza dell’uomo in quanto essere spirituale viene ridotto a un fenomeno di moda e liquidato una volta per tutte in forma di produzione di nuove merci [...]. Soltanto in questo contesto l’opera di Pound - almeno a partire dai primi Cantos - diventa intellegibile. Egli è il poeta che si è posto con più rigore e quasi con «assoluta sfacciataggine» di fronte alla catastrofe della cultura occidentale.
Ben più decisamente di Eliot, egli dimora in questa «terra devastata» - un inferno che, come egli suggerisce nel canto XLVII non si può credere, come ha fatto il «reverendo Eliot», di «attraversare in fretta». Ma proprio per questo, per lui «tutte le età sono contemporanee» ed egli può riferirsi immediatamente all’intera storia della cultura, da Omero a Cavalcanti, da Mani a Mussolini, da Dante a Browning, da Persefone a Woodrow Wilson, da Confucio a Arnaut Daniel. «Soltanto Pound» ha detto Eliot «è capace di vederli come esseri viventi» - a condizione di precisare che, nei Cantos, essi sono in verità soltanto frantumi, che sbucano per un attimo dal Lethe e incessantemente si rituffano in esso [...].
Se la tradizione è accessibile solo come scheggia e frammento, il poeta a caccia di forme non vede davanti a sé chemacerie - anche se queste sono, almeno per lui, vive e vitali proprio in quanto frammenti. Il suo canto inaudito è intessuto di questi lacerti, che, una volta esaurita la loro funzione, non sopravvivono a esso. Di qui l’impressione di artificiosità, così spesso ingiustamente rimproverata alla sua poesia: Pound procede come un filologo che, nella crisi irrevocabile della tradizione, prova a trasmettere senza note a piè di pagina la stessa impossibilità della trasmissione.
Nella frase del Canto 76, in cui egli evoca se stesso come scriptor di fronte al naufragio dell’Europa, il termine sarà ovviamente da intendere «scriba», non scrittore. Di fronte alla distruzione della tradizione, egli trasforma la distruzione in un metodo poetico e, in una sorta di acrobatica «distruzione della distruzione» mima ancora, come copista, un atto di trasmissione. In che misura questo atto riesca, in che misura, cioè, il testo illeggibile, in cui un ideogramma cinese sta accanto a una parola greca e un vocabolo provenzale risponde a un emistichio latino, possa essere veramente letto è una questione a cui non è possibile rispondere sbrigativamente.
La verità e la grandezza di Pound coincidono - cioè si pongono e cadono - con la risposta a queste domande [...]. Di qui l’importanza di quegli scritti in prosa - come quelli di cui questo volume fornisce un’ampia testimonianza - in cui Pound espone le sue idee sulla poesia, sull’economia e la politica. Questi scritti sono a tal punto parte integrante della sua produzione poetica, che si è potuto a ragione affermare che «i Cantos sono ovviamente l’esposizione di una teoria economica che cerca nella storia una esemplificazione».
Come un poeta arcaico, Pound si sente responsabile dell’intero paideuma (come egli ama dire, usando un termine di Frobenius) dell’occidente in tutti i suoi aspetti. «Usura», «denarolatria» e, alla fine, «avarizia» sono i nomi che egli dà al sistema mentale - simmetricamente opposto allo «stato mentale eterno» che, secondo il primo assioma di Religio, definisce la divinità - che ne ha determinato il collasso e che domina ancora oggi - ben più che ai suoi tempi - i governi delle democrazie occidentali, dediti concordemente, anche se con maggiore o minore ferocia, all’«assassinio tramite capitale».
Non è qui il luogo per valutare in che misura, malgrado le sue illusioni sui «popoli latini» e sul fascismo, le teorie economiche di Pound siano ancora attuali. Il problema non è se la geniale moneta di Silvio Gesell, che tanto lo affascinava e sulla quale, per impedirne la tesaurizzazione, si deve applicare ogni mese una marca da bollo dell’un per cento del suo valore, sia o meno realizzabile: decisivo è, piuttosto, che, nelle intenzioni del poeta, essa denuncia quella «possibilità di strozzare il popolo attraverso la moneta» che egli vedeva non senza ragione alla base del sistema bancario moderno. Che il poeta che aveva percepito con più acutezza la crisi della cultura moderna abbia dedicato un numero impressionante di opuscoli ai problemi dell’economia è, in questo senso, perfettamente coerente. «Gli artisti sono le antenne della razza. Gli effetti del male sociale si manifestano innanzitutto nelle arti. La maggior parte dei mali sociali sono alla loro radice economici».
- Ezra Pound
- Dal naufragio di Europa. Scritti scelti 1909-1965
- collana: La Quarta Prosa *
- ISBN 978-88545-0961-0
 Pagine 640
Pagine 640
 Euro 28,00
Euro 28,00
- Questa ampia antologia degli scritti in prosa di Ezra Pound è la sola che l’autore abbia fatto in tempo ad autorizzare tre mesi prima della morte. Che tratti di poesia, di religione o di economia, la sua voce parla «dal naufragio di Europa», dalla «terra devastata» della cultura occidentale, che forse nessuno come lui ha attraversato con assoluta lucidità e altrettanto assoluta visionarietà. Solo Pound - ha detto una volta Eliot - è capace di vedere tutte le figure del passato come contemporanee: Omero e Cavalcanti, Dante e Mussolini, Mani e Browning, Persefone e Woodrow Wilson, Confucio e Arnaut Daniel sono per lui ugualmente vivi e ugualmente significanti. Per questo l’ABC dell’economia non è meno importante dei principi dell’arte della poesia e la critica, tuttora attuale, del sistema bancario, «che strozza i popoli attraverso la moneta», va di pari passo in queste pagine con una limpida introduzione agli assiomi della religione e della filosofia. Che il poeta che aveva percepito con più acutezza la crisi della cultura moderna abbia dedicato un numero impressionante di opuscoli alla critica della «denarolatria» e dell’usura è, in questo senso, perfettamente coerente. «Gli artisti sono le antenne della specie. Gli effetti del male sociale si manifestano innanzitutto nelle arti. La maggior parte dei mali sociali sono alla loro radice economici».
- «Pound è il poeta che si è posto con più rigore e quasi con “assoluta sfacciataggine” di fronte alla catastrofe della cultura occidentale». Giorgio Agamben
- SCHEDA EDITORIALE: NERI POZZA
Com’è avara l’Europa vista da Pound
Escono gli scritti scelti del poeta. Ormai sdoganato anche da un filosofo come Agamben
di Luca Gallesi (il Giornale - Ven, 16/09/2016)
Dalla gabbia di Pisa, in attesa di una non improbabile condanna a morte, Ezra Pound si definiva una «formica solitaria di un formicaio distrutto». A distanza di settant’anni, il formicaio è ancora ridotto in macerie, ma la formica non è più solitaria.
Lo dimostra il crescente interesse per la sua vita e le sue opere, interesse che sembra affiancato da una cauta riammissione nel salotto buono delle lettere. Lo prova anche la pubblicazione in lingua italiana di un volume fondamentale della bibliografia poundiana, Dal naufragio di Europa (Neri Pozza, pagg. 654, euro 28), traduzione di quella formidabile antologia intitolata Selected Prose 1909-1965, la cui edizione originale, tra l’altro, manca da più di quarant’anni sul mercato editoriale in lingua inglese. Pubblicata nel 1973 a cura del generoso William Cookson, che spese tutta la vita a promuovere la grande letteratura con la sua rivista Agenda, questa raccolta di Scritti scelti 1909-1965 - come recita correttamente il sottotitolo - può essere considerata la vera summa del pensiero poundiano. Autorizzata, tra l’altro, dall’Autore che redasse una breve ma efficace nota introduttiva, è probabilmente l’ultimo scritto di Pound, che qui chiarisce come «Riguardo all’USURA: ero fuori strada, scambiando il sintomo per la causa: la causa è l’avarizia». Da un concetto astratto, che aveva animato tutta la sua opera nel tentativo di correggere il male del mondo, l’autore dei Cantos si concentra, alla fine, su un vizio concreto, che è la causa del male nell’uomo.
Per meglio comprendere il vero significato di questo peccato originale, bisogna affrontare senza timori reverenziali, e soprattutto senza preoccuparsi di seguirne necessariamente l’ordine, le fitte pagine di questo volume, divise per argomenti e ordinate, come sottolinea Cookson, allo scopo di «restituire l’unità della visione di Ezra Pound e l’integrità dei suoi interessi, per liberarsi dell’idea che nella sua opera ci sia una frattura di fondo». Già, perché, contrariamente a quanto potrebbe sembrare dalla apparente disorganicità e dalla talvolta eccessiva eterogeneità, il corpus poundiano è di una sorprendente unità.
Purtroppo, la crisi, anzi, la frattura della modernità non permette che una ricostruzione inevitabilmente frammentaria, come sottolinea Giorgio Agamben nella nota introduttiva, perché frammentato è il mondo del Novecento, e i poeti, oltre che i primi a rendersene conto, sono gli unici che possono tentare una reazione. Non i preti, perché Dio è morto, non i filosofi, perché la Ragione è insufficiente, non gli scienziati, perché la Tecnica è incontrollabile: il gravoso compito spetta quindi ai custodi della Parola, i poeti, che sono preposti alla trasmissione di ciò che vi è di più prezioso, la lingua e i sensi. Si può quindi capire, e questo volume ci accompagna tanto alla comprensione quanto al perdono di alcune intemperanze solo verbali, la violenta reazione di Pound alla mercificazione dell’arte e al cancro immondo dell’usura, che tutto riduce a un prezzo e a una possibilità di guadagno. La vita è altro: il Tempio è sacro perché non è in vendita, e al poeta spetta l’ingrato compito di «raccogliere le membra di Osiride», come recita il titolo dello scritto scelto da Pound come introduzione al volume.
Al capitolo di apertura seguono le sezioni dedicate a «Religione», «Confucio e Mencio», «Patria mia», «America», «Civiltà», «Denaro e storia», «L’arte della poesia», per concludere con una galleria dedicata ai «Contemporanei». Se i nomi di alcuni personaggi magari, oggi, suonano dimenticati o affatto sconosciuti, quasi tutti i temi trattati sono di bruciante attualità. Profetico, ad esempio, l’interesse per la Cina, che se un secolo fa sembrava una civiltà saccheggiata dal peggior colonialismo, oggi è una superpotenza in gara per il dominio del mondo. Attualissime, poi, sono le considerazioni sulla decadenza culturale dei Presidenti degli Stati uniti, che un tempo, come risulta dalla corrispondenza tra Jefferson e Adams, erano innanzitutto membri dell’élite culturale della loro epoca, mentre già cent’anni fa risultavano piccole pedine di quello che si sarebbe poi chiamato il complesso militar-industriale. Non parliamo, inoltre, della lungimiranza di Pound sulle cause della crisi economica che nel 1929 avrebbe schiantato il Nuovo mondo e quindici anni dopo avrebbe ridotto in macerie il Vecchio continente. Per sua fortuna, a Pound è stato risparmiato il desolante panorama attuale del mondo globalizzato, ovvero totalmente vampirizzato dall’economia finanziaria, desertificato dalla speculazione e reso sterile dall’idolatria del politicamente corretto.
Come già detto, l’edizione italiana è eccellente, anche se, a voler essere pignoli, presenta due piccole mancanze: non c’è l’indice dei nomi, che nell’edizione originale è un prezioso ausilio per il lettore esigente e curioso, e manca una pur minima bibliografia italiana, dove si scoprirebbe, oltre all’esistenza di molte versioni critiche dei testi poundiani qui raccolti, anche la disponibilità di recenti traduzioni di tanti autori cari a Pound e qui citati, come ad esempio Del Mar, Douglas, Gesell e Orage.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Abbiamo ancora bisogno della storia? Il senso del passato nel mondo globalizzato (Serge Gruzinski).1 ottobre 2016, di Federico La Sala
SCHEDA EDITORIALE *
Abbiamo ancora bisogno della storia?
Il senso del passato nel mondo globalizzato
di Serge Gruzinski
Come suscitare ancora interesse per la storia, accusata di riportare tutto all’Europa e al suo passato?
 titolo Abbiamo ancora bisogno della storia?
titolo Abbiamo ancora bisogno della storia?
 sottotitolo Il senso del passato nel mondo globalizzato
sottotitolo Il senso del passato nel mondo globalizzato
 autore Serge Gruzinski
autore Serge Gruzinski
 argomenti Storia
argomenti Storia
 collana Saggi
collana Saggi
 editore Raffaello Cortina Editore
editore Raffaello Cortina Editore
 formato [Libro] Libro
formato [Libro] Libro
 pagine 166
pagine 166
 pubblicazione 09/2016
pubblicazione 09/2016
 ISBN 9788860308306
€18,00 €15,30
ISBN 9788860308306
€18,00 €15,30Come suscitare ancora interesse per la storia, accusata di riportare tutto all’Europa e al suo passato? Le narrazioni nazionali del passato non ci dicono molto in merito alle radici del nostro mondo globalizzato. Lo stesso vale per le produzioni dell’industria dell’intrattenimento: dai videogiochi a sfondo storico alle serie televisive “in costume”, il passato riciclato propone raramente chiavi interpretative per comprendere il presente.
Serge Gruzinski difende nel volume le ragioni di una storia capace di far dialogare criticamente passato e presente e il cui sguardo sia in grado di decentrarsi. Una storia globale, che ci invita a riconsiderare da nuovi punti di vista una tappa fondamentale per l’umanità: il Rinascimento. Con la conquista degli oceani, attraverso la scoperta di altri mondi, l’Europa prende coscienza di se stessa, gli orizzonti si ampliano, le idee cominciano a circolare, mentre iniziano ad articolarsi le prime reti commerciali mondiali. La storia di questo cambiamento illumina, attraverso numerose esperienze concrete, il presente multiforme in cui viviamo.
Biografia dell’autore
Serge Gruzinski insegna Storia dell’America iberica coloniale e Storia globale in Francia, negli Stati Uniti e in Brasile. Nel 2015 ha ricevuto il Premio CISH-Jaeger-LeCoultre, l’International Prize for History.
FONTE: RAFFAELLO CORTINA EDITORE.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- La reinvenzione della storia. Per capire il mondo meticcio serve un patto con l’antropologia (di Adriano Favole) .2 ottobre 2016, di Federico La Sala
La reinvenzione della storia
Per capire il mondo meticcio serve un patto con l’antropologia
di Adriano Favole (Corriere della Sera, La Lettura, 02.10.2016)
Si chiama Labyrin-thé il sito «patrimoniale» che ho visitato l’estate scorsa, nel sud dell’isola di La Réunion, un dipartimento francese dell’Oceano Indiano, a qualche centinaio di chilometri a est del Madagascar. Situato a oltre mille metri di altitudine, il villaggio di Grand Coude che ospita il sito è disteso su una stretta ed aerea striscia di terra che, da una parte e dall’altra, strapiomba con falesie quasi verticali verso le parti più basse dell’isola. L’attrazione principale è un «labirinto» di sentieri di oltre un ettaro, ricavato in un fittissimo bosco di alberi di tè e boschetti di bambù. Il nome gioca ovviamente sulla presenza, nel termine francese labyrinthe , della parola the . Mentre le mie figlie si perdevano e ritrovavano nel labirinto, una guida ci portava in una vicina piantagione di gerani e in campi di tè ancora produttivi.
I primi esploratori di Grand Coude furono con tutta probabilità, a metà Ottocento, schiavi di origine africana fuggiti dalle sottostanti piantagioni di canna da zucchero - La Réunion ne è tuttora il maggior produttore europeo. A fine secolo alcuni coloni francesi costruirono le prime abitazioni permanenti, per sfruttare l’abbondante legname della foresta circostante.
Furono loro a introdurre, più tardi, la coltivazione del tè, in un periodo in cui la domanda europea era particolarmente forte e i prezzi elevati. Con l’apertura di colture e mercati asiatici, la piccola produzione locale di tè cadde tuttavia in declino e fu sostituita da quella di gerani per la distillazione di essenze base, destinate all’industria dei profumi. Poco dopo la metà del secolo scorso anche la coltivazione di gerani ebbe fine, per la concorrenza di essenze prodotte a minor costo in altre parti di mondo: Grand Coude sopravvisse come luogo di allevamento di bovini, per l’autoconsumo di carni e latte. Oggi, il turismo patrimoniale ed «etnico» offre un’occasione di riscatto e il fittissimo bosco di tè abbandonato e trasformato in labirinto, le residue piante di geranio profumato, gli alambicchi di rame in cui si ricavava la preziosa essenza dal fascino antico, attraggono i turisti di passaggio.
Grand Coude è un sito che piacerebbe a Serge Gruzinski, autore di Abbiamo ancora bisogno della storia? (Raffaello Cortina), perché consente di definire e articolare bene la sua nozione di «storia globale» (global o world history come dicono gli inglesi). A Grand Coude si incontrano perfettamente la storia globale e quella «nuova» antropologia che non teme di tornare in luoghi concepiti a lungo e in modo errato come «esotici» e «altri», e che si rivelano invece oggi profondamente intrecciati con la storia e i destini delle società europee. Luoghi in cui hanno preso forma società scaturite dall’incontro, dalla creatività e dal meticciato; luoghi modellati dalle forze dure e spesso violente del colonialismo e della globalizzazione, ma che hanno saputo a loro volta resistere e ridefinire i flussi e le correnti globali.
«Privilegiare una prospettiva globale significa concentrare l’attenzione sui rapporti che le società intrattengono tra loro, sulle articolazioni e sulle aggregazioni che costruiscono, ma anche sul modo in cui tali organizzazioni umane, economiche, sociali, religiose o politiche omogeneizzano il globo oppure resistono al movimento», scrive Gruzinski nel quinto capitolo, una sorta di manifesto per una storia globale.
Le stratificazioni che lo storico e l’antropologo colgono sull’isola di La Réunion ci riportano alle esplorazioni portoghesi del XVI secolo delle vie marittime per le Indie; all’annessione francese della Réunion nel secolo successivo per farne un’isola in cui rifornirsi di prodotti agricoli freschi nei lunghi viaggi verso l’Oriente; allo schiavismo volto alla lavorazione della canna da zucchero e alla resistenza dei grandi latifondisti locali alla sua abolizione, nel 1848; alle risposte locali alle domande globali del XX secolo (il legname, il tè, il geranio) e oggi, all’epoca in cui il capitalismo prende la forma della «collezione» e dello sfruttamento della memoria e dei siti «patrimoniali», come hanno osservato Luc Boltanski e Arnaud Esquerre su «Les Temps Modernes» nel 2014.
Una storia globale riconnette società che condividono frammenti o parti consistenti di passato (e di presente); inquadra gli eventi in una dimensione internazionale e interculturale; i personaggi, gli accadimenti e i luoghi di cui si interessa sono inevitabilmente locali, ma il locale non è più inteso come «autentico» e «isolato» bensì come crocevia in cui è possibile cogliere i movimenti, i flussi e le correnti della storia.
Grand Coude così è un pezzo di storia europea e non solo perché appartiene a un’isola francese: la storia europea si è forgiata e ha forgiato gli altri continenti, in un labirinto di fili intrecciati e interrotti che storici e antropologi, insieme, possono cercare di dipanare. La globalizzazione, non da oggi, prevede andate e ritorni, espansioni e interruzioni. Inoltrarsi oggi nel labyrinthe de l’histoire in compagnia di Gruzinski, insomma, significa evitare le storie etnocentriche ed eurocentriche che ancora dominano molte accademie del vecchio continente e, allo stesso modo, andare al di là dell’antropologia esotica, affascinata da popoli totalmente altri-da-noi.
-
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- BUONA SCUOLA E SOVRANITA’: STORIA E STORIOGRAFIA, MAPPA E TERRITORIO.29 settembre 2016, di Federico La Sala
- CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?!
FILOSOFIA E FILOLOGIA
L’EUROPA ... E LA "BUONA-SCUOLA": STORIA E STORIOGRAFIA, MAPPA E TERRITORIO. Note (ripresa parziale) dalla discussione a margine dell’articolo di Armando Polito, La Terra d’Otranto in una mappa dell’Europa del secolo XVI
- VISTA LA MAPPA DELL’EUROPA DEL SECOLO XVI E LETTE LE ACUTE RIFLESSIONI DI COMMENTO SULLA RAPPRESENTAZIONE DELL’ITALIA E DELLA TERRA D’OTRANTO, io direi di approfittare della bella (agile e veloce) lezione del PROF. POLITO, AMPLIARE il discorso, OSSERVARE anche la modalità della rappresentazione della GRECIA, e infine (ricordando che qui si è già a quasi un secolo di distanza dalla "scoperta dell’America") RIFLETTERE su origini e signigicato del NOME della stessa EUROPA.
- [...] In origine il nome “Europa” designò un territorio ristretto, forse la regione a nord dell’Egeo; in seguito i geografi indicarono con questo nome tutte le terre a nord del Mediterraneo. E, se ci fidiamo delle parole greche, significava e indicava un “buon” (gr.: “Eu”) luogo dove si poteva “far fascine”, “far legna” (gr.: “ropeuo”). Lì, i greci impararono a ‘orientarsi’ e a ‘leggere’: a ‘scegliere’, a ‘raccogliere’, a ‘legare’ e a ‘collegare’, cioè a “far legna”, e a “far fasci” ... ma non di tutte le erbe, né di tutta la legna!!!
 Impararono, e impararono presto, divennero saggi (sofòi) e, infine, molto, troppo saggi (sofisti) ... e fu l’inizio della fine!. Nietzsche, che ha tentato di chiarire l’enigma, qualcosa aveva capito: se è vero che “la grecità fu la prima grande unificazione e sintesi di tutto il mondo orientale e appunto perciò l’inizio dell’anima europea, la scoperta del nostro ‘mondo nuovo’”, è anche vero che il “nuovo mondo” che abbiamo costruito dimostra quanto presto abbiamo dimenticato la ‘lezione’ delle foreste, dei mari, dei deserti, e dei fiumi e delle montagne!!! [...]
Impararono, e impararono presto, divennero saggi (sofòi) e, infine, molto, troppo saggi (sofisti) ... e fu l’inizio della fine!. Nietzsche, che ha tentato di chiarire l’enigma, qualcosa aveva capito: se è vero che “la grecità fu la prima grande unificazione e sintesi di tutto il mondo orientale e appunto perciò l’inizio dell’anima europea, la scoperta del nostro ‘mondo nuovo’”, è anche vero che il “nuovo mondo” che abbiamo costruito dimostra quanto presto abbiamo dimenticato la ‘lezione’ delle foreste, dei mari, dei deserti, e dei fiumi e delle montagne!!! [...]
***** L’Historia si può veramente deffinire una guerra illustre contro il Tempo... ****
INNANZITUTTO, CARO ARMANDO, UN GRANDE "GRAZIE" PER LA GENEROSA E PUNTUALE RISPOSTA. PUR APPREZZANDO (e proprio per questo) gran parte delle tue argomentazioni, devo dire (partendo - vedi, sopra - dal tuo iniziale lapsus sull’etimologia) che alla fine scopri il fianco e offri alla filologia (e alla filosofia) "la mano esatta" (e, così, senza volerlo, via lavoro di Marziano Capella: "De nuptiis Philologiae et Mercurii", ritorniamo alla figura di ERMETE TRISMEGISTO e le SIBILLE e i PROFETI - da cui siamo partiti) a favore dello spirito "eu-ropeuo"!!!
A QUANTO PARE, il breve testo didattico su "LE DOMANDE DI UN LETTORE OPERAIO" di Bertolt Brecht, se pure conosciuto, è ancora un testo tutto da rileggere e rimeditare. E, proprio ripartendo dalla nostra mappa dell’Europa del XVI secolo, chiedersi con lui: "Filippo di Spagna pianse, quando la sua flotta - fu affondata [1588]. Nessun altro pianse?".
CHE COSA VOGLIO DIRE CON QUESTO? VOGLIO DIRE - CON UN PIZZICO DI SALE, OVVIAMENTE - CHE, IN QUESTO "NON SAPERE" (Socrate!) DISTINGUERE TRA Storia ("RES GESTAE") e Storio-grafia ("HISTORIA RERUM GESTARUM"), vanno rintracciate le radici della CATASTROFE (non solo dei GRECI di ieri, ma anche) DELL’EUROPA (di oggi)!!!
CONTRARIAMENTE A QUANTO PENSI, CICERONE non ha sparato (come dici) "la più grande cazzata della storia"!!! Allievo dei GRECI, Cicerone ha ripetuto e ha detto - con parola esattissima (e qui siamo sempre e ancora in "Eu-ropa"!) - la stessa "cosa" detta (al plurale) da ERODOTO, a cominciare dal titolo della sua opera: Le STORIE (in greco antico: Ἱστορίαι, HISTORIAI).
CON LA PAROLA "HISTORIA", Cicerone sapeva benissimo di che cosa stava parlando, a chi, e di che cosa, e ne dichiarava - con questa sola parola! - l’origine, il senso, e il significato: dalla "aut-opsia", dal vedere con i propri occhi e dal pensare con la propria testa!!! E sollecitava a rifletterci su, a porsi DOMANDE, e a non prendere per oro colato e a bocca aperta ciò di cui si parla o si canta o si narra e scrive nelle "Historiai" dei vari "Catilina" - a tutti i livelli! A non confondere - come si dice oggi - la MAPPA con il TERRITORIO. E, per dirla in breve e ancora, a non scambiare il figlio del Profeta e Re Davide (Salomone), con il figlio del Profeta e Re "Salame" ("Salamone")!
CERTAMENTE, L’IDIOZIA non è affatto né di OMERO ("Cantami, o Diva, del Pelide Achile..."), né di ERODOTO ("Historiai"), né di Cicerone ("Historia magistra vitae"): "noialtri scolaretti siamo cerebralmente scarsi" (con tre punti esclamativi), in quanto "la carriera della maestra l’abbiamo costruita noi", senza alcuna capacità di DISTINGUERE, SCEGLIERE, RACCOGLIERE, LEGARE, e di riflettere BENE non solo sul buon-italiano (sulla buona-scuola!) ma anche sul buon-europeo ( "eu-ropeuo")!!! Federico La Sala
- [...]
CARO ARMANDO - ovviamente!!! - non era assolutamente in dubbio o in discussione la qualità della tua magistralità di studioso, di ricercatore, e di storico "di spirito prof-etico dotato"! Condivido, pienamente! Un buon scolaretto?! Non cè da farsi scolaretto di nessuno! Dietro i cattivi (nel senso e nel significato delle loro ac-"captiv"-anti parole, volte solo ad ammaliare, fare prigionieri, e aggiogare i loro scolaretti) maestri, ancora si celebra e si propone come "modello" la loro "storiografia", quella di un burattino che diventa ragazzino per bene!!! E a dire che fin dall’inizio Collodi invita a fare attenzione e avverte in modo chiaro e tondo: "C’era una volta. - Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori. - No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno"!!! Vale a dire: non Salomone, ma Salamone!!! Federico La Sala
- CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- 80 anni fa la guerra civile spagnola. Quando l’Europa tradì la democrazia (di Valerio castronovo)27 settembre 2016, di Federico La Sala
- RIPENSARE L’EUROPA.. “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
- HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
Quando l’Europa tradì la democrazia80 anni fa la guerra civile spagnola
di Valerio Castronovo (Il Sole-24 Ore, 27.09.2016)
Ottant’anni fa, il 29 settembre 1936, con l’instaurazione a Burgos del governo golpista presieduto da Francisco Franco, ebbe inizio la guerra civile spagnola, che è stata considerata, per il carattere che essa assunse di uno scontro frontale fra le forze democratiche e quelle fasciste, il preludio dell’immane conflitto poi scoppiato nel settembre 1939. In realtà, la guerra che si combattè per quasi tre anni tra i franchisti e il governo di Madrid, anche se complicò la situazione politico-diplomatica in Europa, non giunse comunque al punto da rappresentare un’incubatrice della seconda conflagrazione mondiale.
Essa fu innanzitutto il risultato di una profonda crisi politica interna in corso in Spagna da vari anni; da quando nel 1931 i partiti progressisti avevano vinto le elezioni delle Cortes costituenti proclamando la repubblica, per poi uscire sconfitti nelle elezioni legislative del novembre 1933, in quanto presentatisi divisi nei confronti di una coalizione sotto l’egida della vecchia classe dominante (composta dai grandi proprietari terrieri, dall’aristocrazia nostalgica della monarchia e da una parte consistente del clero).
È vero che già allora era comparso un movimento d’ispirazione fascista come la Falange; ma fu un gruppo di alti ufficiali, dopo il trionfo nelle elezioni del febbraio 1936 del Fronte Popolare (che comprendeva repubblicani, socialisti, comunisti e anarchici) a prendere l’iniziativa dando vita, fra il 17 e il 19 luglio, a una sedizione contro il governo mobilitando le truppe coloniali di stanza nel Marocco e con l’appoggio di alcuni presidî militari nella Spagna metropolitana.
Gran Bretagna e Francia si attennero successivamente alla risoluzione del “non intervento”, sottoscritta il 9 settembre da ventotto Stati, fra cui pure l’Italia e la Germania, sebbene Mussolini e Hitler avessero cominciato ad assicurare il loro aiuto ai rivoltosi. Senonché Londra intendeva evitare che la destra franchista avanzasse rivendicazioni su Gibilterra, mentre Parigi temeva che i golpisti intralciassero i collegamenti con le sue colonie nordafricane.
In pratica, soltanto l’Unione sovietica decise di soccorrere la repubblica spagnola facendole giungere, attraverso l’Internazionale comunista, munizioni e carburante, oltre a un nucleo di tecnici e consiglieri militari: ma solo dopo che Berlino inviò una squadriglia aerea (quella della “Legione Condor”, resasi tristemente celebre per il bombardamento terroristico su Guernica nell’aprile 1937) e Roma dislocò in Spagna un corpo di spedizione di 50mila uomini, accanto alle truppe di Franco.
Ciononostante il governo di Madrid riuscì a reggere a lungo all’offensiva dei franchisti, contando, oltre che su una parte delle forze armate rimasta fedele, su un vasto appoggio popolare, garantito dai partiti e dai sindacati, nonché sull’azione delle “Brigate Internazionali”, composte da volontari antifascisti provenienti da molti Paesi e di cui facevano parte anche esuli italiani (organizzati da Carlo Rosselli del movimento “Giustizia e Libertà”, dal socialista Pietro Nenni, dal comunista Luigi Longo e dall’anarchico Camillo Berneri). Inoltre il governo aveva mantenuto il controllo delle regioni del Nord e dell’Est, quelle più dotate di risorse materiali e impianti industriali.
Ad accreditare la causa del Fronte popolare contribuirono numerosi e famosi intellettuali, tra cui i pittori Pablo Picasso e Joan Miró, i poeti Federico García Lorca e Pablo Neruda, scrittori come Arthur Koestler, Simone Weil, Paul Eluard, Virginia Woolf, William Faulkner, John Steinbeck, Thornton Wilder, Richard Wright. Altri parteciparono direttamente ai combattimenti, nelle file delle Brigate Internazionali, come André Malraux, Ernest Hemingway, W.H. Auden, Tristan Tzara, John Dos Passos, George Orwell.
Sta di fatto che Franco riuscì nella primavera del 1938 a tagliare in due il territorio della repubblica e a separare così Madrid dalla Catalogna. Ma se Barcellona finì per cadere nel gennaio 1939 in mano ai franchisti, fu anche a causa della decisione dei comunisti filo-sovietici di annientare frattanto in un conflitto armato i gruppi anarchici e i militanti del partito operaio di matrice trotskista. Stalin avrebbe poi portato a compimento la propria vendetta nei confronti di Lev Trotsky, l’ex condottiero dell’Armata Rossa durante la rivoluzione e suo principale rivale politico, esiliato nel 1936, facendolo assassinare nell’agosto 1940 a Città del Messico.
A Franco non rimase perciò che concludere vittoriosamente la guerra nel marzo 1939, ormai riconosciuto da Francia e Gran Bretagna rimaste da sempre neutrali; e scatenare subito dopo una durissima repressione con decine di migliaia di vittime che andarono ad aggiungersi al mezzo milione di morti nel conflitto.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- A che punto è la notte? Il limite dell’infamia è stato superato (di Franco Berardi Bifo)27 settembre 2016, di Federico La Sala
A che punto è la notte Europea?
L’Europa della finanza ha scelto di impoverire i cittadini e di rendere impotenti parlamenti e opinioni pubbliche. Intanto l’ondata migratoria è stata accolta da sentimenti rabbiosi che si esprimono in forme identitarie e razziste
di Franco Berardi Bifo (Comune-info, 25 settembre 2016)
La sottomissione della dimensione sociale alla regola finanziaria, che negli ultimi cinque anni è stata formalizzata nel Fiscal Compact, ha prodotto una condizione di paralisi dell’Unione che al momento appare terminale.
Proviamo a ricostruire i passaggi della distruzione finanziaria del progetto europeo.
L’imposizione del debito come orizzonte dell’azione politica ha prodotto due effetti che si sono ormai consolidati.
Il primo effetto è lo svuotamento della democrazia: le decisioni della popolazione e degli stessi governi nazionali non valgono niente quando si confrontano con la superiore autorità del finanziario.
Il secondo effetto è un impoverimento drammatico delle condizioni di vita, uno smantellamento progressivo dei servizi sociali, una precarizzazione crescente del lavoro.
Mentre la società europea si impoveriva, senza riuscire in nessun modo a sottrarsi alla sistematica predazione del finanziario, l’ondata di migrazione da lungo tempo annunciata, si è materializzata, alimentata dalla guerra e dalla povertà dei paesi che il passato coloniale ha devastato.
Nei venti anni passati i governi nazionali del continente non hanno voluto affrontare in modo organizzato e lungimirante l’ondata migratoria, e hanno messo in atto quasi soltanto misure di respingimento, contenimento, e dissuasione.
La conseguenza è che la migrazione è diventata un’emergenza, anche se le dimensioni dell’ondata migratoria sarebbero socialmente sostenibili se si fossero create le strutture per l’accoglienza (due milioni di persone di persone all’anno possono essere integrate in un continente con mezzo miliardo di abitanti).
Essendo costretti a pagare un debito astratto che ha la funzione di rafforzare il sistema finanziario, non abbiamo i mezzi per pagare il debito concreto che i paesi europei hanno contratto verso le popolazioni che il colonialismo europeo ha impoverito.
Contemporaneamente l’impoverimento dei lavoratori europei, unito all’impotenza politica dei parlamenti e delle opinioni pubbliche nazionali, ha diffuso un sentimento rabbioso che si esprime in forme identitarie e talvolta apertamente razziste.
Dopo la vittoria elettorale del 2015 Syriza provò a modificare in qualche misura la logica austeritaria. Il referendum del 5 luglio manifestò la volontà dei greci di aprire una via d’uscita dallo strangolamento finanziario.
Tsipras fu lasciato completamente solo a combattere la sua battaglia, e alla fine a perderla. Matteo Renzi a quell’epoca non si mosse certo per difendere la richiesta greca di flessibilità. Quel farabutto di Giorgio Napolitano nel 2012 pronunciò la frase: “l’Italia non è la Grecia”.
Nelle ultime settimane il presidente del consiglio italiano Matteo Renzi - consapevole del fatto che le misure legislative denominate riforme (per esempio il Jobs Act) non hanno nessuna possibilità di contrastare la stagnazione, di ridurre la disoccupazione e di restituire risorse alla popolazione impoverita, ha manifestato a più riprese insofferenza verso il “rigore” europeo.
Ho paura che sia troppo tardi. Il presidente della Bundesbank, e il presidente della commissione europea Jean Claude Juncker (successore del signor Manuel Barroso che adesso è funzionario della Goldmann Sachs) hanno ricordato al giovane fiorentino recalcitrante che è troppo tardi per fare le bizze.
Il Fiscal Compact lo avete firmato, lo avete messo nella costituzione e adesso pagate e fate il favore di non rompere.
Sullo sfondo della rissa europea una folla di uomini e donne chiede di avere rifugio nel continente europeo. La risposta dell’Unione, dopo Bratislava, è univoca: crepate sotto le bombe, oppure rivolgetevi a quel galantuomo di Erdogan.
L’Unione firma un contratto con la Turchia islamo-fascista perché si riprenda i siriani afghani e iracheni che sono arrivati sulle coste europee.
Il limite dell’infamia è stato superato, il razzismo è destinato a divenire il marchio distintivo dell’Unione agonizzante, e la Deutsche Bank si prepara a dichiarare fallimento se non riuscirà a pagare le multe che lo stato americano le ha imposto per comportamento fraudolento. Lo so che non è un bello spettacolo, ma il catalogo è questo. La notte europea non è destinata a finire presto, scusate la rima.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- PATOLOGIE AL PETTINE DEL POPULISMO. Quel che sta succedendo oggi in Europa fu da molti previsto già venti, trent’anni fa.23 settembre 2016, di Federico La Sala
Patologie democratiche al pettine del populismo
Europa. Quel che sta succedendo oggi in Europa - le ansie e la collera di masse impoverite e precarizzate - era facilmente prevedibile e fu da molti previsto già venti, trent’anni fa, ai tempi in cui si misero nero su bianco i Trattati neoliberisti e poi ci si affidò all’unione monetaria e alle politiche di austerity
di Alberto Burgio (il manifesto, 23.09.2016)
A New York, tre giorni dopo il frustrante summit di Bratislava, Matteo Renzi ha ricevuto il Global Citizen Award dalle mani di John Kerry che lo ha calorosamente elogiato (guidata da un leader europeo dinamico e sempre più importante, l’Italia va nella giusta direzione) e pubblicamente definito uno «high energy guy». Una soddisfazione, non c’è che dire. È bello che ogni tanto qualcuno mostri di volerti bene e ti dia pure una mano.
È stato in quella circostanza che, raggiante, euforico, commosso, il presidente del Consiglio ha detto una cosa seria. Delle cui implicazioni non sappiamo quanto sia consapevole. In Europa, ha dichiarato, manca la volontà politica di trovare una soluzione all’ondata migratoria nel Mediterraneo. Questo, perché «siamo quasi tutti sotto scopa elettorale, in Germania, in Francia e anche noi abbiamo il referendum».
Che i governi siano sotto scopa, cioè dipendano in larga misura dagli orientamenti e persino dagli umori dei loro elettorati, è fisiologico. Anche Renzi sa che è un corollario fondamentale della democrazia. Se se ne è lamentato, è probabilmente perché intende che questo principio va tuttavia assunto con ragionevolezza, pena la trasformazione della democrazia nel suo contrario e in un incubo. Nel dominio dei cattivi demagoghi, in quella che i classici chiamavano oclocrazia.
È giusto che i governanti dipendano dai governati e ne assecondino le aspirazioni. Ma la loro dipendenza dev’essere riequilibrata dall’autorevolezza delle classi dirigenti. Le istituzioni democratiche debbono sì rappresentare (interpretare e tradurre in fatti) la volontà del popolo sovrano. Ma l’opinione pubblica dev’essere anche orientata. Le classi dirigenti debbono aiutarla a definire criteri di giudizio illuminati e a elaborare valori e standard di comportamento adeguati a una società complessa. Un tempo si sarebbe detto, in modo forse un po’ spiccio che debbono educare il popolo alla tolleranza, alla solidarietà e all’equità.
In effetti, da questo punto di vista la questione dei flussi migratori mette allo scoperto un grave problema, per non dire un fallimento delle democrazie europee. Naturalmente i politici badano a non perdere consensi. E siccome da lungo tempo hanno smesso di farsi carico della qualità etica della cittadinanza - non hanno voluto o sono stati semplicemente incapaci di farlo - ora si trovano a inseguire le pulsioni più retrive delle popolazioni. I politici - anche democratici, socialisti e progressisti - sanno che qui e ora l’accoglienza irrita, indispone e preoccupa la maggioranza dei loro elettori, quindi propendono perlopiù per politiche improntate all’egoismo, quando non alla reazione nazionalistica, comunitarista e razzista. Di qui un essere «sotto scopa» che denota una patologia della democrazia. E anche un grave pericolo, poiché a giovarsi di questa sconfitta sono soprattutto le forze della destra populista e xenofoba.
Renzi ha posto quindi un problema reale e gliene va dato atto. Dopodiché è lecito chiedersi se l’ha fatto strumentalmente, perché è in difficoltà in Europa, oltre che in Italia. Oppure perché è consapevole di ciò che questo problema implica e suggerisce. Sarebbe un bel passo in avanti, ma non sembra molto probabile. Il fatto è che guardare seriamente in faccia il fallimento pedagogico delle classi dirigenti democratiche in Europa imporrebbe di ricercarne le radici politiche e culturali. Richiederebbe in particolare di interrogarsi sulle conseguenze del primato dell’economia sulla politica che la destra reaganiana ha imposto con la rivoluzione neoliberale e le sinistre liberal e uliviste (clintoniane) hanno a loro volta avallato e radicalizzato.
Quando a dar forma al senso comune, alla mentalità e all’ethos prevalenti non sono le istituzioni democratiche, a cominciare dalla scuola pubblica e dai partiti di massa, bensì - immediatamente, senza filtri né contrappesi efficaci - il mercato, vale poi poco piangere sul latte versato e predicare con voce rotta sulla necessità di concepire politiche generose e lungimiranti. Non solo perché il mercato è l’arena dei particolarismi in conflitto, ma anche perché le conseguenze della competizione mercantile - non certo un pranzo di gala - sono di per sé, per i soccombenti, tremendamente dolorose.
Non c’è bisogno di aver trascorso ore in meditazione sulle pagine di Marx, di Keynes e di Polanyi per intendere che se la politica non pone argini alla bulimia del capitale, è la stessa democrazia a venirne travolta. Basta un rapido sguardo sul Novecento.
Quel che sta succedendo oggi in Europa - le ansie e la collera di masse impoverite e precarizzate - era facilmente prevedibile e fu da molti previsto già venti, trent’anni fa, ai tempi in cui si misero nero su bianco i Trattati neoliberisti e poi ci si affidò all’unione monetaria e alle politiche di austerity. Oggi si può cercare l’applauso in qualche salotto internazionale e ci si può anche atteggiare a statista contro i lillipuziani della politica europea. Ma non sono che futili soddisfazioni e sortite poco consistenti se ci si limita a lagnarsi delle conseguenze di quelle scelte, evitando accuratamente di denunciare le cause.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- «Parliamoci. È vera rivoluzione culturale». Intervista a Bauman (di Stefania Falasca)21 settembre 2016, di Federico La Sala
- IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS - NON IL "LOGO". La questione della "Parola" e della "Lingua" ...
- RILEGGERE SAUSSURE (E ANCHE ARISTOTELE). UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!! Un omaggio e un appello a Tullio De Mauro.
Intervista
Bauman: «Parliamoci. È vera rivoluzione culturale»
di Stefania Falasca (Avvenire, 20/09/2016)
«Le guerre di religione? Solo una delle offerte del mercato ». Zygmunt Bauman, il più acuto studioso della società postmoderna che ha raccontato in pagine memorabili l’angoscia dell’uomo contemporaneo - lo incontriamo ad Assisi prima del suo intervento - ci parla della sfida del dialogo.
Professore, la sua intuizione sulla postmodernità liquida continua a offrire uno sguardo lucido sul tempo presente. Ma in questa liquidità si registra un esplosione di nazionalismi, identitarismi religiosi. Come si spiegano?
Cominciamo dal problema della guerra. ll nostro mondo contemporaneo non vive una guerra organica ma frammentata. Guerre d’interessi, per denaro, per le risorse, per governare sulle nazioni. Non la chiamo guerra di religione, sono altri che vogliono sia una guerra di religione. Non appartengo a chi vuole far credere che sia una guerra tra religioni. Non la chiamo neppure così. Bisogna stare attenti a non seguire la mentalità corrente. In particolare la mentalità introdotta dal politologo di turno, dai media, da coloro che vogliono raccogliere il consenso, dicendo ciò che loro volevano ascoltare. Lei sa bene che in un mondo permeato dalla paura, questa penetra la società. La paura ha le sue radici nelle ansietà delle persone e anche se abbiamo delle situazioni di grande benessere, viviamo in una grande paura. La paura di perdere posizioni. Le persone hanno paura di avere paura, anche senza darsi una spiegazione del motivo. E questa paura così mobile, inespressa, che non spiega la sua sorgente, è un ottimo capitale per tutti coloro che la vogliono utilizzare per motivi politici o commerciali. Parlare così di guerre e di guerre di religioni è solo una delle offerte del mercato.
Al panico delle guerre di religione si unisce quello delle migrazioni. Già anni fa Umberto Eco diceva che per chi voleva capitalizzare la paura delle persone, il problema dell’emigrazione era arrivato come un dono dal cielo....
Sì è così. Guerre di religione e immigrazione sono nomi differenti dati oggi per sfruttare questa paura vaga incerta, male espressa e mal compresa. Stiamo però qui facendo un errore esistenziale, confondendo due fenomeni differenti: uno è il fenomeno delle migrazioni e l’altro il fenomeno dell’immigrazione, come ha fatto osservare Umberto Eco. Non sono un fenomeno, sono due differenti fenomeni. L’immigrazione è un compagno della storia moderna, lo Stato moderno, la formazione dello Stato è anche una storia di immigrazione. Il capitale ha bisogno del lavoro il lavoro ha bisogno del capitale. Le migrazioni sono invece qualcosa di diverso è un processo naturale che non può essere controllato, che va per la sua strada.
Come pensa si possa trovare un equilibrio per questi fenomeni?
La soluzione offerta dai governi è quella di stringere sempre più il cordone delle possibilità di immigrazione. Ma la nostra società è ormai irreversibilmente cosmopolita, multiculturale e multireligiosa. Il sociologo Ulrich Beck dice che viviamo in una condizione cosmopolita di interdipendenza e scambio a livello planetario ma non abbiamo neppure iniziato a svilupparne la consapevolezza. E gestiamo questo momento con gli strumenti dei nostri antenati... è una trappola, una sfida da affrontare. Noi non possiamo tornare indietro e sottrarci dal vivere insieme.
Come integrarci senza aumentare l’ostilità, senza separare i popoli?
È la domanda fondamentale della nostra epoca. Non si può neppure negare che siamo in uno stato di guerra e probabilmente sarà anche lunga questa guerra. Ma il nostro futuro non è costruito da quelli che si presentano come ’uomini forti’, che offrono e suggeriscono apparenti soluzioni istantanee, come costruire muri ad esempio. La sola personalità contemporanea che porta avanti queste questioni con realismo e che le fa arrivare ad ogni persona, è papa Francesco. Nel suo discorso all’Europa parla di dialogo per ricostruire la tessitura della società, dell’equa distribuzione dei frutti della terra e del lavoro che non rappresentano una pura carità, ma un obbligo morale. Passare dall’economia liquida ad una posizione che permetta l’accesso alla terra col lavoro. Di una cultura che privilegi il dialogo come parte integrante dell’educazione. Si faccia attenzione, lo ripete: dialogo-educazione.
Perché secondo lei il Papa è convinto che sia la parola che non ci dobbiamo stancare di ripetere? Alla fine il dialogo cos’è?
Insegnare a imparare. L’opposto delle conversazioni ordinarie che dividono le persone: quelle nel giusto e quelle nell’errore. Entrare in dialogo significa superare la soglia dello specchio, insegnare a imparare ad arricchirsi della diversità dell’altro. A differenza dei seminari accademici, dei dibattiti pubblici o delle chiacchiere partigiane, nel dialogo non ci sono perdenti, ma solo vincitori. Si tratta di una rivoluzione culturale rispetto al mondo in cui si invecchia e si muore prima ancora di crescere. È la vera rivoluzione culturale rispetto a quanto siamo abituati a fare ed è ciò che permette di ripensare la nostra epoca. L’acquisizione di questa cultura non permette ricette o facili scappatoie, esige e passa attraverso l’educazione che richiede investimenti a lungo termine. Noi dobbiamo concentraci sugli obiettivi a lungo termine. E questo è il pensiero di papa Francesco, il dialogo non è un caffè istantaneo, non dà effetti immediati, perché è pazienza, perseveranza, profondità. Al percorso che lui indica aggiungerei una sola parola: così sia, amen.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- NUOVE SFIDE. “In Europa si va avanti insieme nella libertà”. Il discorso integrale di Mario Draghi ("Premio De Gasperi")19 settembre 2016, di Federico La Sala
- CARISMA, COSTITUZIONE, E POLITICA: AL DI LA’ DELLA TRAPPOLA ATEA E DEVOTA. Una importante provocatoria riflessione di Lidia Ravera
Il discorso integrale
«Riscoprire lo spirito di De Gasperi: lavorare insieme per un’Unione efficace e inclusiva»
di Mario Draghi (La Stampa, 13/09/2016)
Ho tante ragioni per essere grato e onorato della vostra decisione di attribuirmi oggi il Premio De Gasperi. La sua figura, nel ricordo della sua esperienza, ci trasmette un messaggio ispirato, forte, convinto: “In Europa si va avanti insieme nella libertà”.
Le radici di questo messaggio affondano nella storia europea del secolo scorso.
La ragione ultima di esistenza di un governo consiste nell’offrire ai propri cittadini sicurezza fisica ed economica e, in una società democratica, nel preservare le libertà e i diritti individuali insieme a un’equità sociale che rispecchi il giudizio degli stessi cittadini.
Coloro che nel secondo dopoguerra volsero lo sguardo all’esperienza dei trent’anni precedenti conclusero che quei governi emersi dal nazionalismo, dal populismo, da un linguaggio in cui il carisma si accompagnava alla menzogna, non avevano dato ai loro cittadini sicurezza, equità, libertà; avevano tradito la ragione stessa della loro esistenza.
Nel tracciare le linee dei rapporti internazionali tra i futuri governi, De Gasperi e i suoi contemporanei conclusero che solo la cooperazione tra i paesi europei nell’ambito di una organizzazione comune poteva garantire la sicurezza reciproca dei loro cittadini.
La democrazia all’interno di ogni paese non sarebbe stata sufficiente; l’Europa aveva anche bisogno di democrazia tra le sue nazioni. Era chiaro a molti che erigere steccati tra paesi li avrebbe resi più vulnerabili, anche per la loro contiguità geografica, meno sicuri; che ritirarsi all’interno dei propri confini avrebbe reso i governi meno efficaci nella loro azione.
Dalle parole che De Gasperi pronunciò in vari discorsi in quegli anni traspare la sua visione di come doveva caratterizzarsi questo processo comunitario.
Le sfide comuni andranno affrontate con strategie sovranazionali anziché intergovernative. All’Assemblea della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) del 1954 De Gasperi afferma: dal 1919 al 1939 sono stati conclusi circa settanta trattati intergovernativi e tutti si sono ridotti a carta straccia quando si è dovuti passare alla loro attuazione, perché mancava il controllo congiunto delle risorse comuni[1]. L’esperienza dei politici trovava riscontro nelle analisi di eminenti economisti, fra cui Ragnar Nurkse, che mettevano in luce come i trattati intergovernativi finissero per fomentare il protezionismo.
L’integrazione doveva prima di tutto rispondere ai bisogni immediati dei cittadini. Sempre nelle sue parole: dobbiamo iniziare mettendo in comune soltanto lo stretto indispensabile per la realizzazione dei nostri obiettivi più immediati, e farlo mediante formule flessibili che si possano applicare in modo graduale e progressivo.
L’azione comunitaria andava concentrata in ambiti in cui era chiaro che l’azione individuale dei governi non fosse sufficiente: il controllo congiunto delle materie prime della guerra, in particolare carbone e acciaio, costituì uno dei primi esempi.
In tal modo i padri del progetto europeo furono capaci di coniugare efficacia e legittimazione. Il processo era legittimato dal consenso popolare e trovava il sostegno dei governi: il progetto era diretto verso obiettivi in cui l’azione delle istituzioni europee e i benefici per i cittadini erano direttamente e visibilmente connessi; l’azione comunitaria non limitava l’autorità degli Stati membri, ma la rafforzava e trovava quindi il sostegno dei governi.
A incoraggiare De Gasperi e i suoi contemporanei non fu solo l’esperienza fallimentare del passato, furono anche gli immediati successi a cui portarono queste prime fondamentali decisioni del dopoguerra.
I risultati ottenuti lavorando insieme
La costruzione della pace, questo risultato fondamentale del progetto europeo, produsse immediatamente crescita, iniziò la strada verso la prosperità. Al suo confronto stanno le devastazioni dei due conflitti mondiali.
Il PIL pro capite in termini reali si riduce del 14% durante la Prima guerra mondiale e del 22% durante la Seconda, annullando gran parte della crescita degli anni precedenti.
L’integrazione economica costruita su questa pace produce a sua volta miglioramenti significativi nel tenore di vita. Dal 1960 la crescita cumulata del PIL pro capite in termini reali è stata superiore del 33% negli UE 15 rispetto agli Stati Uniti. Nei paesi europei più poveri il tenore di vita converge verso i livelli dei più ricchi.
I cittadini dell’UE acquistano il diritto di vivere, lavorare e studiare in qualsiasi paese dell’Unione; con l’istituzione delle corti di giustizia europee beneficiano dello stesso livello di tutela ovunque si trovino.
Il mercato unico, uno dei principali successi del progetto europeo, non è mai stato soltanto un progetto diretto ad accrescere l’integrazione e l’efficienza dei mercati. È stata soprattutto una scelta dei valori rappresentati da una società libera e aperta, una scelta dei cittadini dell’Unione Europea.
Il progetto europeo ha sancito le libertà politiche, ha fin dall’inizio promosso il principio della democrazia liberale. Garante dei principi democratici, è stato il punto di riferimento per paesi che volevano sottrarsi alla dittatura o al totalitarismo; così è stato per la Grecia, il Portogallo, la Spagna o i paesi dell’Europa centrale e orientale. I criteri di Copenaghen e la Carta dei diritti fondamentali assicurano che tutti i paesi dell’UE rispettino principi politici ben definiti, iscritti nelle leggi nazionali ed europee.
Non è dubbio che queste libertà abbiano immensamente contribuito al benessere dell’Europa. È anche per queste libertà, che oggi flussi imponenti di rifugiati e di migranti cerchino il loro futuro nell’Unione Europea.
L’integrazione europea ha assicurato ai propri cittadini molti anni di sicurezza fisica ed economica, forse più di quanto non sia mai avvenuto nella storia dell’Europa, diffondendo e instillando al tempo stesso i valori di una società aperta. I cittadini europei che hanno iniziato questo processo e noi che lo abbiamo vissuto abbiamo dimostrato al mondo che sicurezza e libertà non sono in antitesi. Radicando la democrazia abbiamo assicurato la pace.
Nuove sfide per l’Europa
Una insoddisfazione crescente nei confronti del progetto europeo ha però caratterizzato gli ultimi anni del suo percorso. Con il referendum del 23 giugno i cittadini del Regno Unito hanno votato a favore dell’uscita dall’Unione europea.
Per alcuni dei paesi dell’Unione questi sono stati anni che hanno visto: la più grave crisi economica del dopoguerra, la disoccupazione, specialmente quella giovanile, raggiungere livelli senza precedenti in presenza di uno stato sociale i cui margini di azione si restringono per la bassa crescita e per i vincoli di finanza pubblica. Sono anni in cui cresce, in un continente che invecchia, l’incertezza sulla sostenibilità dei nostri sistemi pensionistici. Sono anni in cui imponenti flussi migratori rimettono in discussione antichi costumi di vita, contratti sociali da tempo accettati, risvegliano insicurezza, suscitano difese.
La disaffezione ha certamente anche altre cause: la fine dell’Unione Sovietica, la conseguente scomparsa della minaccia nucleare hanno distolto l’attenzione dalla nozione di “sicurezza nei numeri”. Il riequilibrio delle forze tra le nazioni più grandi, le continue tensioni geopolitiche, le guerre, il terrorismo, gli stessi cambiamenti negli equilibri climatici, gli effetti del continuo, incalzante progresso tecnologico: in un breve arco di tempo tutti questi fattori interagiscono con le conseguenze economiche della globalizzazione, in un mondo disattento verso la distribuzione dei suoi pur straordinari benefici. Mentre nelle economie emergenti questa ha riscattato dalla tirannia della povertà miliardi di persone, nelle economie avanzate il reddito reale della parte più svantaggiata della popolazione è rimasto ai livelli di qualche decina di anni fa.
Il senso di abbandono provato da molti non deve sorprendere. L’ansia è crescente. Le risposte politiche a essa date talvolta richiamano alla memoria il periodo tra le due guerre: isolazionismo, protezionismo, nazionalismo. Era già successo in passato. Sul finire della prima fase di globalizzazione, all’inizio del XX secolo, diversi paesi, compresi quelli con una tradizione di immigrazione come l’Australia o gli Stati Uniti, introdussero restrizioni all’immigrazione, in risposta alla paura delle classi operaie di perdere il posto di lavoro a causa dei nuovi arrivati disposti a lavorare per salari più bassi. Ma il biasimo, il rifiuto di queste risposte, pur giustificato, non deve impedire una disamina delle cause della minore partecipazione al progetto europeo.
Di nuovo la lungimiranza delle parole di De Gasperi ci aiuta a capire:
 “Se noi costruiremo soltanto amministrazioni comuni, senza una volontà politica superiore vivificata da un organismo centrale, nel quale le volontà nazionali si incontrino (...) rischieremo che questa attività europea appaia, al confronto della vitalità nazionale particolare, senza calore, senza vita ideale potrebbe anche apparire ad un certo momento una sovrastruttura superflua e forse anche oppressiva”.
“Se noi costruiremo soltanto amministrazioni comuni, senza una volontà politica superiore vivificata da un organismo centrale, nel quale le volontà nazionali si incontrino (...) rischieremo che questa attività europea appaia, al confronto della vitalità nazionale particolare, senza calore, senza vita ideale potrebbe anche apparire ad un certo momento una sovrastruttura superflua e forse anche oppressiva”.L’impianto dell’integrazione europea è saldo, i suoi valori fondamentali continuano a restarne la base, ma occorre orientare la direzione di questo processo verso una risposta più efficace e più diretta ai cittadini, ai loro bisogni, ai loro timori e meno concentrata sulle costruzioni istituzionali. Queste sono accettate dai cittadini non per se stesse ma solo in quanto strumenti necessari a dare questa risposta.
In altre occasioni è stata invece l’incompletezza istituzionale che non ha permesso di gestire il cambiamento imposto dalle circostanze esterne nel miglior modo possibile. Si pensi all’Accordo di Schengen. Pur avendo eliminato in larga parte le frontiere interne dell’Europa, non ha previsto un rafforzamento di quelle esterne. Pertanto l’insorgere della crisi migratoria è stato percepito come una perdita di sicurezza destabilizzante.
A questi bisogni, a questi timori l’Unione Europea, gli Stati nazionali hanno dato una risposta finora carente. I sondaggi, assieme al calo del sostegno all’integrazione economica europea, mostrano un’opinione pubblica che ha meno fiducia nell’Unione Europea e ancor meno negli Stati nazionali.
Ciò non vale solo per l’Europa. I dati segnalano che anche negli Stati Uniti è diminuita la fiducia dei cittadini verso quasi tutte le istituzioni: la Presidenza, il Congresso e la Corte Suprema[6]. Il fatto che si tratti di un fenomeno mondiale non può però essere di giustificazione per noi europei, perché noi soli nel mondo abbiamo costruito un’entità sovranazionale con la certezza che solo con essa gli Stati nazionali avrebbero dato quelle risposte che non erano stati capaci di dare da soli.
L’Europa può ancora essere la risposta?
La domanda è semplice ma fondamentale: lavorare insieme è ancora il modo migliore per superare le nuove sfide che ci troviamo a fronteggiare?
Per varie ragioni, la risposta è un sì senza condizioni. Se le sfide hanno portata continentale, agire esclusivamente sul piano nazionale non basta. Se hanno respiro mondiale, è la collaborazione trai i suoi membri che rende forte la voce europea.
Il recente negoziato sul cambiamento climatico sia di esempio. La questione globale può essere affrontata solo attraverso politiche coordinate a livello internazionale. La massa critica di un’Europa che parla con una voce sola ha condotto a risultati ben oltre la portata dei singoli paesi. Solo la spinta esercitata dai paesi europei che hanno presentato un fronte comune ha permesso il successo della conferenza sul clima di Parigi. Solo l’esistenza dell’Unione Europea ha permesso la costruzione di questo fronte comune.
In un mondo in cui la tecnologia riduce le barriere fisiche, l’Europa esercita la sua influenza anche in altri modi. La capacità dell’Europa, con il suo mercato di 500 milioni di consumatori, di imporre il riconoscimento dei diritti di proprietà a livello mondiale o il rispetto dei diritti alla riservatezza in Internet è ovviamente superiore a ciò che un qualsiasi Stato membro potrebbe sperare di ottenere da solo.
La sovranità nazionale rimane per molti aspetti l’elemento fondamentale del governo di un paese. Ma per ciò che riguarda le sfide che trascendono i suoi confini, l’unico modo di preservare la sovranità nazionale, cioè di far sentire la voce dei propri cittadini nel contesto mondiale, è per noi europei condividerla nell’Unione Europea che ha funzionato da moltiplicatore della nostra forza nazionale.
Quanto alle risposte che possono essere date soltanto a livello sovranazionale, dovremmo adottare lo stesso metodo che ha permesso a De Gasperi e ai suoi contemporanei di assicurare la legittimazione delle proprie azioni: concentrarsi sugli interventi che portano risultati tangibili e immediatamente riconoscibili.
Tali interventi sono di due ordini.
Il primo consiste nel portare a termine le iniziative già in corso, perché fermarsi a metà del cammino è la scelta più pericolosa. Avremmo sottratto agli Stati nazionali parte dei loro poteri senza creare a livello dell’Unione la capacità di offrire ai cittadini almeno lo stesso grado di sicurezza.
Un autentico mercato unico può restare a lungo libero ed equo solo se tutti i soggetti che vi partecipano sottostanno alle stesse leggi e regole e hanno accesso a sistemi giudiziari che le applichino in maniera uniforme. Il libero mercato non è anarchia; è una costruzione politica che richiede istituzioni comuni in grado di preservare la libertà e l’equità fra i suoi membri. Se tali istituzioni mancheranno o non funzioneranno adeguatamente, si finirà per ripristinare i confini allo scopo di rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini.
Pertanto, per salvaguardare una società aperta occorre portare fino in fondo il mercato unico.
Ciò che rende oggi questa urgenza diversa dal passato è l’attenzione che dovremo porre agli aspetti redistributivi dell’integrazione, verso coloro che più ne hanno pagato il prezzo. Non credo ci saranno grandi progressi su questo fronte e più in generale sul fronte dell’apertura dei mercati e della concorrenza se l’Europa non saprà ascoltare l’appello delle vittime in società costruite sul perseguimento della ricchezza e del potere; se l’Europa, oltre che catalizzatrice dell’integrazione e arbitra delle sue regole non divenga anche moderatrice dei suoi risultati. È un ruolo che oggi spetta agli stati nazionali, che spesso però non hanno le forze per attuarlo con pienezza. È un compito che non è ancora definito a livello europeo ma che risponde alle caratteristiche delineate da De Gasperi: completa l’azione degli Stati nazionali, legittima l’azione europea. Le recenti discussioni in materia di equità della tassazione, e quelle su un fondo europeo di assicurazione contro la disoccupazione, su fondi per la riqualificazione professionale e su altri progetti con la stessa impronta ideale vanno in questa direzione.
Ma poiché l’Europa deve intervenire solo laddove i governi nazionali non sono in grado di agire individualmente, la risposta deve provenire in primo luogo dal livello nazionale. Occorrono politiche che mettano in moto la crescita, riducano la disoccupazione e aumentino le opportunità individuali, offrendo nel contempo il livello essenziale di protezione dei più deboli.
In secondo luogo, se e quando avvieremo nuovi progetti comuni in Europa, questi dovranno obbedire agli stessi criteri che hanno reso possibile il successo di settant’anni fa: dovranno poggiare sul consenso che l’intervento è effettivamente necessario; dovranno essere complementari all’azione dei governi; dovranno essere visibilmente connessi ai timori immediati dei cittadini; dovranno riguardare inequivocabilmente settori di portata europea o globale.
Se si applicano questi criteri, in molti settori il coinvolgimento dell’Europa non risulta necessario. Ma lo è invece in altri ambiti di chiara importanza, in cui le iniziative europee sono non solo legittime ma anche essenziali. Tra questi oggi rientrano, in particolare, i settori dell’immigrazione, della sicurezza e della difesa.
Entrambi gli ordini di interventi sono fondamentali, poiché le divisioni interne irrisolte, che riguardano ad esempio il completamento dell’UEM, rischiano di distrarci dalle nuove sfide emerse sul piano geopolitico, economico e ambientale. È un pericolo reale nell’Europa di oggi, che non ci possiamo permettere. Dobbiamo trovare la forza e l’intelligenza necessarie per superare i nostri disaccordi e andare avanti insieme.
A tal fine dobbiamo riscoprire lo spirito che ha permesso a pochi grandi leader, in condizioni ben più difficili di quelle odierne, di vincere le diffidenze reciproche e riuscire insieme anziché fallire da soli.
In conclusione torno a citare Alcide De Gasperi, le cui parole conservano dal 1952 a oggi tutta la loro attualità:
La cooperazione economica è certamente il risultato del compromesso tra desiderio naturale di indipendenza di ogni partecipante e aspirazioni politiche preminenti. Se la cooperazione economica europea fosse dipesa dai compromessi avanzati dalle varie amministrazioni coinvolte, saremmo incappati probabilmente in debolezze e incoerenze. È dunque l’aspirazione politica all’unità a dover prevalere. Deve guidarci anzitutto la consapevolezza fondamentale che la costruzione di un’Europa unita è essenziale per assicurarci pace, progresso e giustizia sociale.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Siamo umani, dunque globali (di Mauro Bonazzi).19 settembre 2016, di Federico La Sala
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. -- KANT CON IL COSMOPOLITISMO DI DIOGENE E NON DI ALESSANDRO MAGNO E NAPOLEONE (O HITLER E MUSSOLINI)!!!:
Siamo umani, dunque globali
Quando gli chiesero quale fosse la sua patria, Diogene il cinico rispose che era un cosmopolita, un cittadino del mondo
di Mauro Bonazzi (Corriere della Sera, La Lettura, 18.09.2016)
Quando gli chiesero quale fosse la sua patria, Diogene il cinico rispose che era un cosmopolita, un cittadino del mondo. Una frase brillante, di cui Immanuel Kant si sarebbe ricordato nel 1784, quando diede alle stampe un breve saggio con un titolo lungo, Idee di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, che fondava su basi più solide l’ideale del cosmopolitismo. Solo una comunità politica universale permetterà agli uomini di realizzare la loro natura di esseri razionali e sociali, offrendo la possibilità di una vita soddisfacente. Questa, scriveva, è la meta verso cui ci stiamo dirigendo e per cui dobbiamo lottare.
Kant è stato un grande filosofo e per una volta si è rivelato buon profeta, visto che il cammino dell’umanità sta procedendo nella direzione di una sempre maggiore integrazione, proprio come lui aveva auspicato. Il suo entusiasmo, però, non troverebbe molto seguito oggi. Il mondo appare più piccolo ma i problemi sono sempre più complicati e diffusi. E così si leva insistente la voce di chi sogna un ritorno alle genuine tradizioni nazionali che fecero grande l’Europa e che l’Illuminismo avrebbe colpevolmente cancellato.
Fosse tutto così semplice: come ricorda Jean-François Pradeau (Gouverner avec le monde. Réflexions antiques sur la mondialisation, Manitoba/Les Belles Lettres, 2015), la vocazione universalista precede, e di molto, le discussioni di Kant e Voltaire. Cosmopolita è una parola greca: e lo è anche l’idea, che poi passò nel mondo cristiano. Gli uomini sono uguali e non si capisce perché non possano vivere insieme, seguendo le indicazioni della ragione: questi sono gli Stoici. Gli uomini sono tutti figli di Dio e non si capisce perché non debbano vivere insieme, aspirando alla pace comune: questo è Agostino. Anche «cattolico», lo si dimentica spesso, è un termine greco; vuol dire universale. Insomma: i Greci, il cristianesimo, l’Illuminismo. L’ideale cosmopolitico è parte costituente della tradizione europea.
Per gli antichi era tutta una questione di cerchi concentrici. Ciò che siamo, la vita che viviamo, si definisce a partire da una serie di relazioni sempre più estese: ci sono la famiglia e gli affetti privati; poi il mondo degli amici e del lavoro; e ancora, quello dei cittadini e della patria; e via di seguito fino al cerchio esterno che include tutti gli uomini. È evidente che ciò che ci è più vicino importa, e tanto. Ma non possiamo non riconoscere la linea di continuità che ci lega a tutti gli altri esseri umani in quanto esseri umani. In fondo dove nasciamo dipende in gran parte del caso: ma rimaniamo pur sempre parte dell’unica famiglia umana, membra dello stesso corpo. «Sono un Antonino, la mia patria è Roma; sono un essere umano, la mia patria è il mondo», scriveva Marco Aurelio, l’imperatore filosofo, accampato presso le rive del Danubio. Lo aveva già detto anche uno scrittore di commedie, Terenzio, arrivato a Roma dall’Africa (come Agostino del resto): «Sono un uomo, nulla che sia umano mi è estraneo».
Erano riflessioni che nascevano spontanee, tentativi di comprendere il senso della storia degli uomini, mentre Roma estendeva il suo controllo su parti sempre più estese del mondo conosciuto, e i confini tradizionali venivano meno. Non si trattava di annullare le differenze ma di accoglierle in un’unità più ampia. Le istituzioni sovranazionali odierne, nate per tutelare i diritti dell’uomo, affondano le radici in questa tradizione.
I problemi non sono soltanto, come si continua a ripetere, politici o economici, argomenti su cui gli antichi avevano peraltro idee strampalate. Platone e gli Stoici intitolavano i loro trattati Costituzione o Repubblica e finivano inevitabilmente per parlare di sesso. Diogene, poi, il primo cosmopolita confesso, con la politica non voleva avere proprio nulla a che fare, rifiutandosi di pensare che le convenzioni sociali o eventuali appartenenze di gruppo potessero concorrere a definire quello che lui era, la sua identità. Famigerato per i comportamenti scandalosi al limite del tollerabile (c’era un motivo se lo chiamavano il «cane»), fautore di una libertà così estrema da non essere desiderabile (ma davvero tutto può essere permesso?), ha comunque il merito di chiarire il vero problema in discussione con il cosmopolitismo.
È una questione prima di tutto individuale, che riguarda come noi vediamo noi stessi. Il confronto con gli altri è sempre faticoso: si giudica e si è giudicati, su tutto. Non è facile scoprire che molte delle idee e principi a partire da cui organizziamo le nostre giornate non costituiscono verità insindacabili ma sono semplici abitudini, che potrebbero anche essere modificate. La tentazione di rinserrarsi nel cerchio di ciò che è familiare o consueto nasce da qui ed è onnipresente. È scontato criticare gli operai inglesi che si sono chiusi al mondo votando contro l’Unione Europea. Ma, come ha scritto giustamente Ross Douthat sul «New York Times», bisogna stare attenti a non cadere nella retorica stantia che oppone nativisti (o localisti) e internazionalisti (o cosmopoliti).
I «cittadini globali» che si sentono sempre a casa propria in qualunque parte del mondo, e che però di fatto dormono in alberghi sempre uguali, comprano gli stessi vestiti negli stessi negozi, e fanno insomma sempre le stesse identiche cose in non importa quale posto (con l’aggiunta eventuale di un tocco di esotismo: un po’ di religiosità orientale, di dolce vita italiana...), non costituiscono una tribù anche loro? Una tribù, quel che è peggio, che non si riconosce come tale e non è perciò in grado di confrontarsi con gli altri gruppi di chi la pensa diversamente. È sempre una questione di appartenenza, e la sfida del cosmopolitismo è tutta qui, nell’invito a ripensare le nostre relazioni in tutte le direzioni.
«Essere vasto, diverso e insieme fisso», scriveva Montale: non rifiutare i rapporti più stretti, ma provare a guardare allo spettacolo della vita umana, così diverso eppure così simile, con occhi meno preoccupati. Al filosofo Pirrone è servito. Aveva seguito Alessandro Magno nella sua campagna alla conquista del mondo. Vide quanto vari o arbitrari potessero essere gli usi e i costumi dei popoli ma osservò anche che gli uomini si affaccendavano sempre dietro agli stessi problemi, sempre inquieti, come le api e le mosche. Senza giudicare, imparò a dare il giusto peso alle cose, liberandosi della pretesa di essere il centro del mondo. Si racconta che trovò la felicità.
I cerchi, intanto, continuano a espandersi. Quando Diogene o Marco Aurelio affermavano di essere cosmopoliti, intendevano quello che dicevano. Parliamo di mondializzazione, globalizzazione, cosmopolitismo, ma pensiamo sempre a noi stessi, agli uomini, mai al mondo (al globo, al cosmo). È come se importassimo solo noi. E invece quello che siamo dipende anche dalla nostra relazione con ciò che ci circonda.
Ogni tanto conviene alzare lo sguardo e realizzare che è tutto molto più grande: quale è il senso della nostra esperienza di esseri umani - di questa mia esistenza particolare - rispetto a questo universo immenso che ci circonda? Per gli antichi la domanda era naturale perché sentivano di far parte di un tutto vivente e perfettamente organizzato: anche i pianeti, esseri divini e perfetti che percorrono eternamente le loro orbite circolari, sostenevano, sono abitanti di quella città immensa che è l’universo, e dunque nostri concittadini. Può sembrare bizzarro, ma anche Dante nell’ultimo canto del Paradiso, quando ha finalmente coronato l’obiettivo del suo viaggio, inizia a ruotare («sì come rota ch’igualmente è mossa») intorno a Dio, «l’amor che move il sole e l’altre stelle». Ci sono di nuovo i cerchi e i moti circolari: l’immagine questa volta è aristotelica, ed è l’espressione di un’armonia raggiunta - con se stessi, con gli altri, con le cose, finalmente consapevoli di fare parte di un tutto che si squaderna ogni giorno nella sua meravigliosa regolarità. È questa la vera appartenenza: «La sola vera cittadinanza è quella che si esercita nell’universo», ripeteva il solito Diogene.
La scienza moderna ha definitivamente smantellato l’idea, in fondo così rassicurante, di un universo chiuso e perfettamente organizzato intorno a noi. E tutto diventa più complicato. Il pensiero corre a Friedrich Nietzsche, quando parlava di un universo che precipita eternamente, spaventoso nell’infinita solitudine del tutto («non si è fatto più freddo?»); o alla luna di Giacomo Leopardi nel Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, silenziosa, indifferente, ormai estranea, lontana. Sono immagini suggestive. Ma troppo unilaterali, forse. Perché il mondo è anche la natura, quel ciclo della vita che fiorisce intorno a noi, e di cui dovremmo ritornare a riconoscere il ritmo, come esortava un poeta, Archiloco, consapevoli del fatto che anche noi ne facciamo comunque parte.
Gli antichi non avrebbero mai creduto che l’uomo potesse arrivare a modificare l’ambiente naturale che lo circonda, come invece sta accadendo. Ma, per una volta tutti insieme senza litigare, avrebbero osservato con uno sguardo benevolo i presidenti degli Stati Uniti d’America e della Repubblica Popolare cinese, Barack Obama e Xi Jinping, firmare l’accordo per ridurre le emissioni di gas inquinanti.
La terra sarà pure un piccolo punto insignificante e marginale nelle immensità dell’universo; la vita sarà pure il risultato casuale di alcune reazioni chimiche innescatesi accidentalmente. Ma sarebbe comunque un peccato sprecare tutto, no?
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- LA LECTIO DI DRAGHI. E il carisma politico della verità che manca all’Europa (di Roberto Napoletano).18 settembre 2016, di Federico La Sala
Il carisma politico della verità che manca all’Europa
di Roberto Napoletano ( Il Sole-24 Ore, 18 settembre 2016)
«La ragione ultima di esistenza di un governo consiste nell’offrire ai propri cittadini sicurezza fisica ed economica e, in una società democratica, nel preservare le libertà e i diritti individuali insieme a un’equità sociale che rispecchi il giudizio degli stessi cittadini. Coloro che nel secondo dopoguerra volsero lo sguardo all’esperienza dei trent’anni precedenti conclusero che quei governi emersi dal nazionalismo, dal populismo, da un linguaggio in cui il carisma si accompagnava alla menzogna, non avevano dato ai loro cittadini sicurezza, equità, libertà; avevano tradito la ragione stessa della loro esistenza».
Mario Draghi scandisce queste parole, al Teatro Sociale di Trento, nella sua lectio in occasione del conferimento del premio Alcide De Gasperi, e mi colpisce quel riferimento al linguaggio «in cui il carisma si accompagnava alla menzogna», ma anche la parola cittadini che ritornerà spesso dopo, il richiamo ai loro bisogni e ai loro timori, alla sicurezza, all’equità, alla libertà. In una parola, a tutto ciò che la menzogna, aiutata dal carisma, aveva tradito. La traccia ispirativa di De Gasperi(«In Europa si va avanti insieme nella libertà») è dichiarata, ma c’è qualcosa di politico, nella sua cifra recondita, che appartiene naturalmente all’argomentare del più innovativo dei banchieri centrali: racconta del passato, ma parla al futuro.
Riproduco un passaggio che riguarda la stagione d’oro dei Fondatori dell’Europa: «I padri del progetto europeo furono capaci di coniugare efficacia e legittimazione. Il processo era legittimato dal consenso popolare e trovava il sostegno dei governi: il progetto era diretto verso obiettivi in cui l’azione delle istituzioni europee e i benefici per i cittadini erano direttamente e visibilmente connessi; l’azione comunitaria non limitava l’autorità degli Stati membri, ma la rafforzava e trovava quindi il sostegno dei governi. A incoraggiare De Gasperi e i suoi contemporanei non fu solo l’esperienza fallimentare del passato, furono anche gli immediati successi a cui portarono queste prime fondamentali decisioni del dopoguerra. La costruzione della pace, questo risultato fondamentale del progetto europeo, produsse immediatamente crescita, iniziò la strada verso la prosperità. Al suo confronto stanno le devastazioni dei due conflitti mondiali. Il PIL pro capite in termini reali si riduce del 14% durante la Prima guerra mondiale e del 22% durante la Seconda, annullando gran parte della crescita degli anni precedenti. L’integrazione economica costruita su questa pace produce a sua volta miglioramenti significativi nel tenore di vita».
Tutto cambia, quando si passa all’oggi: «Con il referendum del 23 giugno i cittadini del Regno Unito hanno votato a favore dell’uscita dall’Unione europea. Per alcuni dei Paesi dell’Unione questi sono stati anni che hanno visto: la più grave crisi economica del dopoguerra, la disoccupazione, specialmente quella giovanile, raggiungere livelli senza precedenti in presenza di uno stato sociale i cui margini di azione si restringono per la bassa crescita e per i vincoli di finanza pubblica. Sono anni in cui cresce, in un continente che invecchia, l’incertezza sulla sostenibilità dei nostri sistemi pensionistici. Sono anni in cui imponenti flussi migratori rimettono in discussione antichi costumi di vita, contratti sociali da tempo accettati, risvegliano insicurezza, suscitano difese».
 Questa la fotografia, poi un altro passaggio che riguarda i nostri giorni e ripropone la straordinaria attualità del pensiero degasperiano: «L’impianto dell’integrazione europea è saldo, i suoi valori fondamentali continuano a restarne la base, ma occorre orientare la direzione di questo processo verso una risposta più efficace e più diretta ai cittadini, ai loro bisogni, ai loro timori e meno concentrata sulle costruzioni istituzionali. Queste sono accettate dai cittadini non per se stesse ma solo in quanto strumenti necessari a dare questa risposta (...). Quanto alle risposte che possono essere date soltanto a livello sovranazionale, dovremmo adottare lo stesso metodo che ha permesso a De Gasperi e ai suoi contemporanei di assicurare la legittimazione delle proprie azioni: concentrarsi sugli interventi che portano risultati tangibili (...). Se si applicano questi criteri, in molti settori il coinvolgimento dell’Europa non risulta necessario. Ma lo è invece in altri ambiti di chiara importanza, in cui le iniziative europee sono non solo legittime ma anche essenziali. Tra questi oggi rientrano, in particolare, i settori dell’immigrazione, della sicurezza e della difesa».
Questa la fotografia, poi un altro passaggio che riguarda i nostri giorni e ripropone la straordinaria attualità del pensiero degasperiano: «L’impianto dell’integrazione europea è saldo, i suoi valori fondamentali continuano a restarne la base, ma occorre orientare la direzione di questo processo verso una risposta più efficace e più diretta ai cittadini, ai loro bisogni, ai loro timori e meno concentrata sulle costruzioni istituzionali. Queste sono accettate dai cittadini non per se stesse ma solo in quanto strumenti necessari a dare questa risposta (...). Quanto alle risposte che possono essere date soltanto a livello sovranazionale, dovremmo adottare lo stesso metodo che ha permesso a De Gasperi e ai suoi contemporanei di assicurare la legittimazione delle proprie azioni: concentrarsi sugli interventi che portano risultati tangibili (...). Se si applicano questi criteri, in molti settori il coinvolgimento dell’Europa non risulta necessario. Ma lo è invece in altri ambiti di chiara importanza, in cui le iniziative europee sono non solo legittime ma anche essenziali. Tra questi oggi rientrano, in particolare, i settori dell’immigrazione, della sicurezza e della difesa».Mi tornano in mente il carisma e la menzogna e mi rendo conto che anche la verità ha bisogno di carisma, ha bisogno di donne e uomini che si riconoscono nel leader politico carismatico, se ne facciano portabandiera. Ha bisogno di una comunità che abbia fiducia in chi lo governa, di modo che scatti la scintilla emotiva, si avvertano i benefici, si percepisca il trasporto, c’è bisogno di una comunità che si senta parte attiva di un progetto di vita e di un disegno condiviso di sviluppo e di equità. Rispondere subito ai timori e ai bisogni dei cittadini, in fondo è questo il messaggio più alto della politica, è il segno costitutivo della lectio di Draghi.
A suo modo, è stata la cifra di una vita di un uomo come Ciampi che ha avuto in Italia tutte le responsabilità e mi piace ricordarlo in questi giorni che se ne è andato. Li chiamano “tecnici”, semplificando molto, rappresentano in realtà la passione e l’intelligenza politica di cui ha bisogno la verità di un’Europa che non può tornare indietro e non riesce ad andare avanti.
SUL TEMA, due TWEET:
L’ITALIA CONTESA DA "DUE" PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA E IL MANCATO " GIUDIZIO DI SALOMONE":
UN OMAGGIO A #Ciampi. A sua memoria. RIPARTIRE DALL’#Italia: VIVA L’ITALIA, VIVA LA #Costituzione ... http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=913
#Ciampi LA #BIBBIACIVILE e il #Giudizio di #SALOMONE (la #Cortecostituzionale senza #coscienza e #sapienza) ... http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5171
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO".-- La dimensione psichica di “esilio”, il rigetto dei profughi, e la cancelliera Merkel10 settembre 2016, di Federico La Sala
Paura dell’esilio
Verità nascoste. La causa specifica del rigetto dei profughi è il vissuto di sradicamento di cui sono portatori È un vissuto contagioso perché entra in rapporto con la dimensione psichica di “esilio” presente in ognuno di noi
di Sarantis Thanopulos (il manifesto, 10.09.2016)
La cancelliera Merkel è stata sconfitta nel suo collegio elettorale dalla destra xenofoba. Le masse dei profughi ospitati dalla Germania hanno minato il suo consenso apparso, fino ad oggi, inossidabile. Il primo posto (in arretramento) ottenuto dalla Spd, con Linke e i verdi in netto calo, è magra consolazione. I partiti sconfitti si interrogheranno sulla convenienza di un ripiegamento su posizioni più prudenti. Nel fare questo perderanno l’ennesima occasione di preferire la strategia alla tattica.
La paura dello straniero non è necessariamente rivolta a colui che è di un’etnia diversa, di un’altra lingua. I greci della Turchia, in esodo di massa un secolo fa, hanno trovato nella “madre patria” un’accoglienza ostile. Utilizzati perlopiù nei mestieri più umili, sono stati a lungo confinati in baraccopoli nella periferia delle grandi città. Gli istriani hanno avuto un destino migliore, ma non proprio benevolo e i tedeschi dell’Est stentano ancora a integrarsi nella patria riunita.
Nell’opposizione ai profughi, si possono individuare due cause aspecifiche e una specifica. Le cause aspecifiche sono il sentimento di essere invasi, quando i senza terra arrivano in modo massiccio e rapido, e quello di essere derubati, quando non è possibile stabilire con loro relazioni vere di scambio. Il secondo sentimento è una costruzione puramente psichica: serve per allontanarsi da una posizione desiderante, quando questa comporta un investimento unilaterale, un atto di donazione a “perdere”. Più che la paura di un impoverimento reale pesa la ferita narcisistica. La rinuncia contingente è avvertita come diminuzione di sé permanente (in società opulente che fanno del loro benessere il centro dell’amor proprio o nei strati sociali più deboli).
La causa specifica del rigetto dei profughi è il vissuto di sradicamento di cui sono portatori. È un vissuto contagioso perché entra in rapporto con la dimensione psichica di “esilio” presente in ognuno di noi. Ci costituiamo come soggetti sociali attraverso una sequenza di esili da un’età all’altra, da un contesto affettivo-relazionale a quello successivo (a partire dall’esperienza fondamentale della separazione dalla nostra madre). E ogni nostra relazione con l’altro richiede la possibilità di un reciproco esilio: dell’uno nel modo di essere dell’altro. L’esperienza dell’esiliarsi, condizione necessaria del sogno, del lutto e della relazione erotica, viaggia pure a ritroso nel tempo, nel nostro passato e in quello delle generazioni che ci precedono.
Il sentirsi sradicati priva la dimensione psichica dell’esilio della sua natura isterica, antinomica: essere cittadini della propria terra e, al tempo stesso, abitare come apolidi l’altrove che appare all’orizzonte. Al cospetto del rifugiato si attiva lo spettro dello spaesamento, sempre presente nel desiderio di esiliarsi, la preoccupazione di perdersi nel proprio sogno senza più ritrovarsi nella realtà. Il rischio è di espellere il migrante che sogna in noi.
Chi governa dovrebbe avere il coraggio di dire ai cittadini che fare spazio, donare in modo unilaterale, non è impoverimento né misericordia/sacrificio. È un investimento per il futuro loro e dei propri figli, crea le condizioni per essere ricambiati, quando lo scambio di doni sarà diventato possibile.
L’unico modo per rendere vivibile un mondo sempre più in movimento e irrequieto, proteggerlo da smottamenti catastrofici. Tuttavia, se non si affronta il nodo di una società sempre più arbitraria e ineguale, chi è disposto a scommettere un solo soldo sull’avvenire del dono unilaterale, sulla bontà dell’incontro fondato sull’esilio?
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- I profughi sono i nostri alleati contro gli estremisti. La lucidità di Angela Merkel serve all’Europa contro l’estrema destra (di Bernard Guetta)9 settembre 2016, di Federico La Sala
La lucidità di Angela Merkel serve all’Europa contro l’estrema destra
di Bernard Guetta ( France Inter, Francia) *
Dopo una batosta del genere altri avrebbero messo da parte le proprie convinzioni, ma non Angela Merkel. Sfiduciata il 4 settembre dagli elettori del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, che le rimproverano la sua politica di accoglienza verso i profughi, e umiliata dalla sconfitta che ha visto la i cristianodemocratici fermarsi a due punti dalla nuova estrema destra di Alternative für Deutschland (Alternativa per la Germania, AfD), la cancelliera ha raccolto il guanto di sfida.
“Sono sicura che se diremo la verità riconquisteremo la fiducia degli elettori”, ha dichiarato il 7 settembre davanti al Bundestag. “Se invece cominceremo a orientarci in funzione di chi non vuole presentare soluzioni allora perderemo la bussola. Se ci lanceremo in una scalata vinceranno quelli che usano parole forti e propongono soluzioni semplicistiche”.
In poche parole Angela Merkel ha chiesto ai tedeschi di non pensare che l’unico mezzo per combattere l’estrema destra sia adottare il suo approccio, e per questo bisogna ringraziarla.
Le bugie della destra
Dobbiamo applaudire la cancelliera, perché è chiaro che è lei a dire le cose come stanno nel dibattito sui profughi. La verità non sta certo nelle parole dell’AfD, del Front national e dei loro amici di altri paesi europei che parlano di un’invasione dell’Europa da parte di orde di islamici pronti a seminare il terrore, imporre la sharia e sottomettere la cristianità.
- I profughi sono i nostri alleati contro gli estremisti
La verità è dall’altra parte, dalla parte di papa Francesco, della cancelliera tedesca e della Commissione europea, convinti che un’Unione di 500 milioni di abitanti abbia tutti i mezzi per accogliere in modo decente un milione di sventurati che fuggono da una morte certa, che non possiamo denunciare la barbarie della dittatura di Assad e la follia sanguinaria del gruppo Stato islamico (Is) se ci rifiutiamo di tendere la mano alle loro vittime e che paesi la cui identità è plasmata dai lumi e dalla cristianità non possono voltare le spalle ai loro princìpi come se fossero solo parole vane utili soltanto ad ammantarci di virtù ma che non si applicano a noi stessi.
Questi rifugiati non sono barbari ma uomini, donne e bambini, il più delle volte appartenenti alle classi medie e spinti a fuggire dall’islamismo e dalla dittatura. Sono i nostri alleati contro l’Is, le dittature e il fanatismo religioso. Anche se non ne abbiamo compassione, dovremmo comunque aiutarli per fare i nostri interessi, per non dare armi e motivazioni agli islamisti che ci accusano giorno e notte di essere irriducibili nemici dell’islam e di tutti i musulmani.
Seguendo l’estrema destra, rinnegando la nostra identità e lasciandoci dominare dalla paura, non facciamo altro che facilitare il reclutamento per il jihad, perdere i nostri alleati nel mondo arabo e avvicinarci a quella guerra di civiltà che gli islamisti vogliono scatenare. Le estreme destre sono un cattivo esempio, ed è precisamente questo che vuole farci capire Angela Merkel, con fermezza e lucidità.
(Traduzione di Andrea Sparacino)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" --- Dio e marketing. Francesco prima di Steve Jobs (di Alessandro Barbero).6 settembre 2016, di Federico La Sala
- CATTOLICESIMO (E CRISTIANESIMO) OGGI: LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA. Tutti a scuola in Vaticano, per aggiornamenti. Materiali per approfondire
- PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est") . Al di là della semantica e del paradigma degli affari e del "caro-prezzo" ("caritas").
 PER UNA "ECONOMIA CIVILE" E UNA TEOLOGIA "CIVILE"!!!
PER UNA "ECONOMIA CIVILE" E UNA TEOLOGIA "CIVILE"!!!
Dio e marketing
Francesco prima di Jobs
Furono i francescani del Medioevo a inventare la politica aziendale adottata oggi dai giganti globali
diALESSANDRO BARBERO (La Stampa, 06.09.2016)
Immaginiamo una grande organizzazione multinazionale, conosciuta in tutto il mondo, fondata grazie allo slancio visionario di un giovane fondatore carismatico, che è diventato un mito già da vivo e ancor più dopo la morte; un’organizzazione riconoscibile anche visivamente per le sue scelte di comunicazione e per il look inconfondibile che la caratterizza.
Sto parlando della Apple e di Steve Jobs? No, sto parlando di san Francesco e dell’ordine francescano. Le analogie tra gli ordini religiosi del Medioevo e le grandi aziende odierne sono così vistose che viene da chiedersi se le strategie e il linguaggio delle multinazionali non si siano ispirati consapevolmente a quell’esperienza.
Oggi non c’è documento di marketing o manuale di comunicazione aziendale che non impieghi a ogni riga le parole vision e mission, che rivelano immediatamente la loro appartenenza al linguaggio dei frati e dei monaci. E d’altra parte, perché le aziende non dovrebbero ispirarsi a un modello di tale successo?
Dieci anni dopo che Francesco ebbe l’intuizione di fondare il suo ordine, i francescani erano già alcune migliaia, il che vuol dire che erano quasi raddoppiati ogni anno; per l’esattezza, si è calcolato un tasso di crescita dell’80% annuo. La conquista di nuovi mercati era gestita con campagne mirate: nati in Italia Centrale, dopo un po’ i francescani decidono di espandersi a Nord, e mandano apposite task force in Lombardia e in Germania, affidate a frati che sanno predicare nelle lingue straniere, «in lombardico et in theutonico».
Nel 1219 Francesco decide di mandare un gruppo di frati in Francia, per diffondere l’Ordine anche in quel regno; ven t’anni dopo sono già fondati qualcosa come 72 conventi.
Non stupisce che Francesco, a un certo punto, abbia aperto gli occhi e si sia accorto di aver creato un mostro: era a capo di una multinazionale, lui che voleva andare in giro scalzo con un gruppetto di amici, parlando di Gesù alla gente e scaricando casse al mercato per mantenersi. Negli ultimi anni di vita Francesco si dimise dalla guida dell’ordine, creando grossissimi problemi ai suoi successori, perché per l’immagine dell’organizzazione e la motivazione dei membri il mito del fondatore è essenziale.
Fra il Novecento e il Duemila i grandi fondatori di aziende, gli Henry Ford, i Bill Gates, gli Steve Jobs sono stati mitizzati in vita, e sono diventati delle leggende dopo la morte, grazie anche all’invenzione di quel peculiare genere letterario, la biografia autorizzata, erede diretto dell’agiografia medievale.
Il caso di Steve Jobs conferma che i visionari del Medioevo avevano ragione quando insistevano sull’importanza del look. La biografia autorizzata di Walter Isaacson ci svela che non era certo un caso se Jobs vestiva sempre uguale, jeans blu senza cintura e maglioncino nero a collo alto. Più volte il fondatore di Apple propose che tutti i dipendenti dell’azienda si vestissero allo stesso modo, ma i lavoratori non apprezzavano l’idea, e Jobs dovette accontentarsi di vestirsi lui così: nell’armadio aveva un centinaio di dolcevita neri, tutti uguali, e previde correttamente che gli sarebbero bastati per tutta la vita.
Francesco, invece, riuscì a imporre ai frati di vestirsi tutti allo stesso modo, con un saio bigio e un cappuccio a punta, da contadino; ma dopo la sua morte i francescani ebbero dei sai larghi e comodi, di ottima stoffa, e il cappuccio diventò ampio e arrotondato, come voleva la moda.
Grazie alle tecnologie moderne gli storici dell’arte hanno scoperto che diverse tavole col ritratto di San Francesco sono state modificate dopo la sua morte, cancellando l’odiato cappuccio a punta e sostituendolo con un cappuccio da giovanotto elegante.
Tutti sapevano che l’immediata riconoscibilità era un ingrediente del successo. Quando il monastero di Cîteaux cominciò a fare concorrenza a quello di Cluny, i cistercensi scoprirono che nella regola benedettina non stava scritto da nessuna parte di che colore doveva essere l’abito; per tradizione era nero, ma loro si vestirono di bianco, perché la gente doveva vedere la differenza.
Il mantello bianco era anche la prerogativa dei Templari, e quando un ordine concorrente, i Teutonici, volle adottarlo, i templari protestarono col papa, perché impedisse quella concorrenza sleale: il copyright era loro! Poi gli ordini militari ebbero il problema, comune a tante aziende, di una crisi di mercato che ridusse la domanda.
Dopo la perdita della Terrasanta e la fine delle crociate non c’era più un gran bisogno di monaci guerrieri. C’erano ben tre ordini militari, i Templari, gli Ospedalieri e i Teutonici, e sempre più voci si levavano contro questi enti inutili, che per la cristianità rappresentavano un passivo netto. Gli ordini reagirono presentando un progetto di fusione: così, argomentò il Gran Maestro del Tempio, si realizzeranno dei grossi risparmi, dove prima c’erano tre poltrone ne rimarrà una sola.
Ma l’antitrust intervenne: i sovrani europei fecero sapere al papa che non avevano nessuna voglia di trovarsi fra i piedi una multinazionale monopolistica e strapotente .
Alla fine, com’è noto, Filippo il Bello risolse a modo suo il problema della ridondanza dei templari; ma i loro rivali , gli Ospedalieri , esistono ancora, col nome di Ordine di Malta. E a questo proposito, ci sono due organizzazioni che recentemente hanno lanciato un progetto chiamato Vision 2050.
Sono progetti che non hanno niente in comune, ma sono stati chiamati nello stesso modo per caso da manager che condividono lo stesso tipo di linguaggio.
Una è il Wbcsd, organizzazione che riunisce circa 200 multinazionali , e che col progetto Vision 2000 si propone di guidare la « global business community» verso un futuro sostenibile. L’altra è appunto l’Ordine di Malta, che col progetto Vision 2000 si propone di reclutare giovani e finanziare iniziative fino alla metà del secolo. Così una potentissima associazione di multinazionali, fondata nel 1992, con sede a Ginevra, e l’Ordine di Malta, il vecchio concorrente dei Templari, che nel suo sito ufficiale dichiara di essere in attività dal 1048, usano lo stesso linguaggio ; ed è molto difficile decidere chi è che sta imitando l’altro.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- L’ AUXILIUM (L’AIUTO). Mario Cresci, Interazioni con la Pietà Rondanini di Michelangelo (Milano, Castello Sforzesco)26 agosto 2016, di Federico La Sala
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA .... DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
- "IL CIELO STELLATO SOPRA DI ME E LA LEGGE MORALE IN ME": ESSERE GIUSTI CON KANT. La lezione di Michel Foucault e la sorpresa di Habermas.
La Pietà Rondanini sotto al cielo stellato di Mario Cresci *
Un unico blocco di pietra, denso, avvolgente, dai dettagli a volte appena sbozzati, altri dolcemente rifiniti, dove le figure della Madonna e di Cristo si confondono: è la Pietà Rondanini, l’ultima opera di Michelangelo alla quale lo scultore ha lavorato fino al 1564, pochi giorni prima di morire.
Oggi questo capolavoro è reinventato dalla macchina fotografica di Mario Cresci (Chiavari, Genova, 1942) in un percorso esposto a Milano, nelle Sale dell’Antico Ospedale Spagnolo del Castello Sforzesco (dove l’opera risiede dal 2 maggio 2015), dal titolo Mario Cresci in aliam figuram mutare. Interazioni con la Pietà Rondanini di Michelangelo (fino al 25 settembre).
Il progetto di Mario Cresci è intitolato all’auxilium (l’aiuto) e gravita intorno alla luce come creazione del cosmo, al movimento e alla materia che è scabra, spezzata e tenue, materia che diventa figura.
 Nella chiave di lettura di Cresci l’auxilium, la misericordia di questa nuova Pietà, va oltre ed è rivolta ad altri volti fotografati e coperti da luccicanti coperte termiche, quelle con cui si avvolgono i naufraghi: sono i visi coperti dei migranti a cui dovrebbe andare tutta la nostra pietas e il nostro auxilium. Per noi. Per tutta l’umanità.
Nella chiave di lettura di Cresci l’auxilium, la misericordia di questa nuova Pietà, va oltre ed è rivolta ad altri volti fotografati e coperti da luccicanti coperte termiche, quelle con cui si avvolgono i naufraghi: sono i visi coperti dei migranti a cui dovrebbe andare tutta la nostra pietas e il nostro auxilium. Per noi. Per tutta l’umanità.*
Su «la Lettura» #246, numero speciale di Ferragosto in edicola dal 13 al 21 agosto, un articolo di ARTURO CARLO QUINTAVALLE racconta la mostra al Castello Sforzesco.
 In questo percorso per immagini (a cura di Jessica Chia) alcuni scatti di Mario Cresci esposti a Milano
In questo percorso per immagini (a cura di Jessica Chia) alcuni scatti di Mario Cresci esposti a Milano -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" - La «primavera di Praga», una lezione per l’Europa di oggi (di Federigo Argentieri)21 agosto 2016, di Federico La Sala
Agosto 1968
La «primavera di Praga», una lezione per l’Europa di oggi
Il cosidetto «socialismo dal volto umano» conteneva ideali che sarebbero molto utili
di Federigo Argentieri (Corriere della Sera, 20.08.2016) E’ probabile che il termine Primavera di Praga sia pressoché sconosciuto a chi ha meno di cinquant’anni, a meno che non si tratti di persone professionalmente impegnate nello studio della storia o della politica internazionale; ed è altrettanto probabile che nella Repubblica ceca e nella Slovacchia di oggi il 21 agosto - data della fine (nel 1968) di quella esperienza, causata dall’invasione armata da parte di cinque paesi guidati dall’URSS - sarà ricordato svogliatamente e soltanto come la fine di un’illusione ingenua, per non dire stupida.
Similmente, è prevedibile che in Occidente si dia poco spazio a quello che oltretutto non è neanche un anniversario tondo, per concentrarsi sui problemi odierni, «ben altrimenti importanti»: il terrorismo, l’immigrazione, il rapporto tra multiculturalismo e lealtà alle istituzioni, il disastro umanitario in Siria, la perdurante instabilità in Libia e così via. Sarebbe invece necessario prestare maggiore attenzione ai legami che esistono tra gli eventi di ieri e quelli di oggi, e tra quelli che riguardano l’Europa orientale e il Medio oriente, che in fin dei conti rappresentano le due principali aree di instabilità, per tentare di comprendere meglio la posta in gioco e i rischi esistenti nel medio e nel lungo termine.
Il mondo occidentale è sempre più diviso tra chi vuole chiudere le frontiere, regredendo così di molti decenni, e chi invece vuole distinguere tra terrorismo, da prevenire e combattere, e accoglienza nei limiti del possibile e del ragionevole ai rifugiati: tale divisione potrebbe divenire irrimediabile se, cosa non impossibile, Trump vincesse le prossime elezioni americane e Marine Le Pen quelle francesi del 2017.
Ciò è ben noto a tutti, ma meno noto è che la Russia di Putin prema con forza - perlopiù occulta, ma ugualmente discernibile - per uno scenario di questo genere, che si è già fregiato di una formidabile vittoria nel recente referendum in Gran Bretagna, portando Boris Johnson al Foreign Office; e il suo brutale intervento in Siria anticipa quello che potrebbe succedere in futuro. A Mosca si sa bene che negli anni elettorali i presidenti americani sono «anatre zoppe»: sia l’invasione della Cecoslovacchia che quella dell’Ungheria nel 1956 avvennero in prossimità di tali elezioni, e la pressione militare di questi giorni sull’Ucraina fa presagire un déjà vu che anche nelle modalità aggressive e menzognere ricorda i peggiori aspetti della cosiddetta «dottrina Brezhnev», pilastro dell’imperialismo sovietico.
L’Ucraina negli ultimi tre anni ha messo in moto il quinto tentativo di un paese vicino alla frontiera russa o sovietica di staccarsi da un impero intruso e sgradito, e di avvicinarsi all’Occidente: nel 1953 ci aveva provato la Germania Est, poi l’Ungheria, la Cecoslovacchia e la Polonia nel 1980-81. Soprattutto in questi ultimi tre casi il processo suscitò speranze enormi, e la sua brutale repressione, che colpì intere generazioni, ha prodotto il cinismo e l’egoismo di oggi: questi paesi sono liberi, ma di princìpi che non siano l’affarismo o gli interessi di bottega non vogliono saperne perché «in passato hanno causato solo guai».
Invece il cosiddetto «socialismo dal volto umano» della Primavera di Praga conteneva ideali che sarebbero molto utili all’Europa di oggi: se il continente fosse realmente unito e solidale, potrebbe avere forza sufficiente sia per opporsi alle ricorrenti tentazioni unilateraliste americane e all’endemico imperialismo moscovita, che per combattere il terrorismo favorendo contemporaneamente soluzioni di pace e di integrazione rispettose di ogni identità.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- SALVIAMO IL LATINO, LA LINGUA PIù PARLATA DEL MONDO. Note di Gramsci e appello di Salvatore Settis.16 agosto 2016, di Federico La Sala
Perché studiare il latino e il greco?
di Antonio Gramsci (Eddyburg, 11 Agosto 2016)
- Un recente articolo di Stefano [Salvatore, fls] Settis [QUI, sotto, di seguito - fls] sull’importanza della conoscenza del latino ci ha ricordato questo scritto di Antonio Gramsci. Lo pubblichiamo sottolineando l’ampiezza della visione del pensatore comunista, e la sua capacità di comprendere il ruolo della conoscenza in una società caratterizzata, come quella di oggi, dalla dialettica della lotta di classe. *
Non si impara il latino e il greco per parlare queste lingue, per fare i camerieri o gli interpreti o che so io. Si imparano per conoscere la civiltà dei due popoli, la cui vita si pone come base della cultura mondiale. La lingua latina o greca si impara secondo grammatica, un po’ meccanicamente: ma c’è molta esagerazione nell’accusa di meccanicità e aridità. Si ha che fare con dei ragazzetti, ai quali occorre far contrarre certe abitudini di diligenza, di esattezza, di compostezza fisica, di concentrazione psichica in determinati oggetti. Uno studioso di trenta-quarant’anni sarebbe capace di stare a tavolino sedici ore filate, se da bambino non avesse «coattivamente», per «coercizione meccanica» assunto le abitudini psicofisiche conformi? Se si vogliono allevare anche degli studiosi, occorre incominciare da lì e occorre premere su tutti per avere quelle migliaia, o centinaia, o anche solo dozzine di studiosi di gran nerbo, di cui ogni civiltà ha bisogno.
Il latino non si studia per imparare il latino, si studia per abituare i ragazzi a studiare, ad analizzare un corpo storico che si può trattare come un cadavere ma che continuamente si ricompone in vita. Naturalmente io non credo che il latino e il greco abbiano delle qualità taumaturgiche intrinseche: dico che in un dato ambiente, in una data cultura, con una data tradizione, lo studio così graduato dava quei determinati effetti. Si può sostituire il latino e il greco e li si sostituirà utilmente, ma occorrerà sapere disporre didatticamente la nuova materia o la nuova serie di materie, in modo da ottenere risultati equivalenti di educazione generale dell’uomo, partendo dal ragazzetto fino all’età della scelta professionale. In questo periodo lo studio o la parte maggiore dello studio deve essere disinteressato, cioè non avere scopi pratici immediati o troppo immediatamente mediati: deve essere formativo, anche se «istruttivo», cioè ricco di nozioni concrete.
Nella scuola moderna mi pare stia avvenendo un processo di progressiva degenerazione: la scuola di tipo professionale, cioè preoccupata di un immediato interesse pratico, prende il sopravvento sulla scuola “formativa” immediatamente disinteressata. La cosa più paradossale è che questo tipo di scuola appare e viene predicata come “democratica”, mentre invece essa è proprio destinata a perpetuare le differenze sociali. Il carattere sociale della scuola è dato dal fatto che ogni strato sociale ha un proprio tipo di scuola destinato a perpetuare in quello strato una determinata funzione tradizionale.
Se si vuole spezzare questa trama, occorre dunque non moltiplicare e graduare i tipi di scuola professionale, ma creare un tipo unico di scuola preparatoria (elementare-media) che conduca il giovane fino alla soglia della scelta professionale, formandolo nel frattempo come uomo capace di pensare, di studiare, di dirigere o di controllare chi dirige. Il moltiplicarsi di tipi di scuole professionali tende dunque a eternare le differenze tradizionali, ma siccome, in esse, tende anche a creare nuove stratificazioni interne, ecco che nasce l’impressione della tendenza democratica. Ma la tendenza democratica, intrinsecamente, non può solo significare che un manovale diventi operaio qualificato, ma che ogni “cittadino” può diventare “governante” e che la società lo pone sia pure astrattamente nelle condizioni generali di poterlo diventare.
Anche lo studio è un mestiere e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio anche nervoso-muscolare, oltre che intellettuale: è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo e il dolore e la noia. La partecipazione di più larghe masse alla scuola media tende a rallentare la disciplina dello studio, a domandare facilitazioni. Molti pensano addirittura che la difficoltà sia artificiale, perchè sono abituati a considerare lavoro e fatica solo il lavoro manuale. È una quistione complessa. Certo il ragazzo di una famiglia tradizionalmente di intellettuali supera più facilmente il processo di adattamento psicofisico: egli già entrando la prima volta in classe ha parecchi punti di vantaggio sugli altri scolari, ha un’ambientazione già acquisita per le abitudini famigliari. Così il figlio di un operaio di città soffre meno entrando in fabbrica di un ragazzo di contadini o di un contadino già sviluppato per la vita dei campi.
Ecco perchè molti del popolo pensano che nella difficoltà dello studio ci sia un trucco a loro danno; vedono il signore compiere con scioltezza e con apparente facilità il lavoro che ai loro figli costa lacrime e sangue, e pensano ci sia un trucco. In una nuova situazione politica, queste quistioni diventeranno asprissime e occorrerà resistere alla tendenza di rendere facile ciò che non può esserlo senza essere snaturato. Se si vorrà creare un nuovo corpo di intellettuali, fino alle più alte cime, da uno strato sociale che tradizionalmente non ha sviluppato le attitudini psico-fisiche adeguate, si dovranno superare difficoltà inaudite.
Quaderni dal Carcere, 4 (XIII), 55.
- FILOLOGIA E TEOLOGIA. A KAROL WOJTYLA, IN MEMORIA. "Se mi sbalio, mi coriggerete" (Giovanni Paolo II)
- PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI.
- CANOVA E IL VATICANO: LE GRAZIE, AMORE E PSICHE Una gerarchia senza Grazie (greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Caritas"). Materiali per riflettere
Salviamo il latino, la lingua più parlata del mondo
L’appello: "Quel che serve è un vero rilancio del latino come palestra per le generazioni future, tenendo in conto anche le sue enormi potenzialità come piattaforma di intercomprensione fra le lingue romanze, gigantesco serbatoio linguistico da cui pescano anche le lingue germaniche e slave, apparato concettuale che favorisce la comunicazione fra le culture"
di SALVATORE SETTIS (la Repubblica, 10 agosto 2016)
La lingua più parlata del mondo? È il latino. Non quel che resta del latino ecclesiastico, né quello dei pochi filologi classici ancora in grado di scriverlo, né dei certami ciceroniani, stranamente popolari. Ma il latino che parliamo ogni giorno, con le sue trasformazioni storiche: quello delle lingue neolatine, o romanze. Lo spagnolo come lingua materna è da solo, con 500 milioni di parlanti, secondo al mondo soltanto al cinese. Se vi aggiungiamo il portoghese (230 milioni), il francese (100), l’italiano (65) e il romeno (35), si arriva a 930 milioni di “parlanti latino”.
Senza contare le numerose lingue minori (come il ladino). Poco meno dei “parlanti cinese”, che però si suddividono anch’essi in numerose lingue diverse, non sempre mutuamente intellegibili se parlate, ma unificate concettualmente da una scrittura ideografica che non rispecchia direttamente la pronuncia. E il latino ha una presenza capillare anche fuori dell’ambito propriamente romanzo: in inglese (terza lingua materna più parlata al mondo, con 350 milioni) il 58% del lessico deriva dal latino o da lingue neolatine, specialmente francese. Lo stesso è vero di tutte le lingue europee, dal tedesco al russo: forse nessuna lingua più del latino ha mostrato forza di penetrazione e tendenza a radicarsi in sistemi linguistici di altra origine. Inoltre, anche numerose parole di matrice greca (come “filosofia”) o etrusca (come “persona”) si sono diffuse universalmente, ma passando attraverso il latino.
Fra cinese e latino c’è un abisso, ma anche qualcosa in comune: “cinese”, infatti, è la piattaforma di intercomprensione fra tutte le lingue della famiglia sinica, “latino” può essere la piattaforma di intercomprensione fra tutte le lingue romanze. Se usassimo una scrittura ideografica come i cinesi, potremmo leggere il portoghese e il romeno anche senza averli mai studiati. Ma davvero l’italiano è così simile al latino? Proviamo a leggere qualche verso: «Te saluto, alma dea, dea generosa, / O gloria nostra, o veneta regina! / In procelloso turbine funesto / Tu regnasti secura: mille membra / Intrepida prostrasti in pugna acerba». La metrica è italiana, ma il testo “funziona” perfettamente sia come italiano che come latino. Autore di questo poemetto in lode di Venezia fu Mattia Butturini (1752-1817), amico di Ugo Foscolo e professore di greco a Pavia. E continua: «Per te miser non fui, per te non gemo, / Vivo in pace per te: Regna, o beata, / Regna in prospera sorte, in pompa augusta, / In perpetuo splendore, in aurea sede! / Tu severa, tu placida, tu pia, / Tu benigna, me salva, ama, conserva». Perfetto italiano, perfetto latino, come in altri poemi simultaneamente bilingui, a cominciare da quello di Gabriello Chiabrera nel tardo Cinquecento.
L’ottusa lotta contro il latino e contro il liceo classico, che riemerge periodicamente con la complicità di ministri maldestri e sprovveduti, non tiene conto di questo aspetto assolutamente centrale. È vero, nella scuola sopravvive un approccio piattamente grammaticale, che nello studio del latino vede solo una sorta di astratta educazione alla precisione del pensiero, a prescindere da tutto il resto. Ma tradurre tale critica in un ripudio del latino sarebbe « un gesto violento e arrogante, un attentato alla bellezza del mondo e alla grandezza dell’intelletto umano » , come scrive Nicola Gardini in un libro bello e intenso (Viva il latino. Storia e bellezza di una lingua inutile, Garzanti). Quel che serve è un vero rilancio del latino come palestra per le generazioni future, tenendo in conto anche le sue enormi potenzialità come piattaforma di intercomprensione fra le lingue romanze, gigantesco serbatoio linguistico da cui pescano anche le lingue germaniche e slave, apparato concettuale che favorisce la comunicazione fra le culture. Ha ragione Gardini, «grazie al latino una parola italiana vale almeno il doppio».
Ma non è tutto. Le parole non sono nulla se non le vediamo agire nel loro contesto, nei testi latini da Cicerone a Newton. Lo spessore ( il valore) delle parole latine, trasmigrate in altre lingue, si può apprezzare se siamo in grado non solo di snocciolare elenchi di parole o sfogliare vocabolari, ma di leggere e comprendere Virgilio e Sant’Agostino, le lettere di Petrarca e la cosmografia di Keplero. Trama narrativa, struttura della frase, tecnica dell’argomentare danno alle parole e alle frasi quella forza che aiuta a riconoscerne la traccia in Dante, in Shakespeare, Cervantes, Goethe. Quando leggiamo un testo, scrive Gardini, « non si tratterà propriamente del latino di Cicerone né del latino di Virgilio, ma piuttosto di quel che il latino compie e ottiene quando esce dallo stilo di Cicerone o dallo stilo di Virgilio » , in termini di « capacità lessicale, correttezza sintattica e convenienza ritmica » .
Questo doppio registro del latino, in orizzontale ( lettura dei testi e rimando ai contesti) e in verticale (come piattaforma di intercomprensione fra lingue oggi parlate) ha un altro vantaggio. Funziona come macchina della memoria, ci ricorda che quel che leggiamo del latino classico è un’infima parte di quel che fu allora scritto. E che, nonostante questo, abbiamo preteso per secoli di continuare, sulla scena del mondo, la storia di Roma. Non per niente quelli che noi chiamiamo “ bizantini” chiamarono se stessi sempre rhomaioi, “ romani”, e il più intimo carattere della grecità, conservatosi anche sotto la dominazione ottomana, si esprime in neogreco con la parola rhomaiosyne, “ romanità”; eppure intanto a Istanbul i sultani, dopo aver spodestato l’ultimo imperatore romano, mantennero dal 1453 al 1922 il titolo di Kayser- i- Rum, “ Cesare di Roma”. “ Cesare”, cioè imperatore; come il Kaiser a Vienna o a Berlino, lo Czar a Mosca o Pietroburgo.
Altro esempio, il diritto: i sistemi di civil law sono fondati sul diritto romano ( spesso, ma non sempre, attraverso il codice napoleonico), e oltre all’Europa continentale, inclusa la Russia, coprono l’America Latina e vari Paesi in Asia e Africa. Ma anche i sistemi di common law, pur di origine inglese, esprimono in latino molti termini- chiave, a partire dal principio fondamentale stare decisis ( conformarsi alle sentenze già emesse); perciò anche nei film americani sentiamo parlare di subpoena, affidavit, persona non grata; per non dire di habeas corpus.
Il latino come dispositivo della memoria culturale, come versatile interfaccia multilingue, come ponte o viadotto verso altre culture. Il latino come lingua viva, perché vive nelle lingue che parliamo. Questo, e non un’impalcatura di precetti, dovrebbe saper trasmettere la nostra scuola. “ Nostra”, cioè quanto meno europea. Questa Europa delle tecnologie saprà inventare una nuova didattica del latino che contribuisca all’intercomprensione culturale? E l’Italia, dove il latino è nato, avrà in merito qualcosa da dire?
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - PER IPAZIA, IL PREMIO ANDERSEN 2016, E UN GIARDINO A TOR SAPIENZA (ROMA)8 agosto 2016, di Federico La Sala
Letteratura
Ipazia, maestra del dubbio
di Armando Massarenti (Il Sole-24 Ore, 05.08.2016)
L’età cruciale per diventare dogmatici e intolleranti oppure, al contrario, persone aperte, amanti del dialogo e della pluralità dei punti di vista è l’adolescenza. Una serie infinita di studi sullo sviluppo del cervello umano lo dimostra.
La regista e scrittrice Roberta Torre però, con il suo libro dedicato a Ipazia e la musica dei pianeti - edito da rueBallu nella collana Jeunesse ottopiù, cioè per bambini di più di otto anni, vincitrice del Premio Andersen 2016 come miglior progetto editoriale - ci ricorda implicitamente quanto sia bene cominciare presto a preparare il nostro cervello all’apertura mentale e al pensiero critico. E che cosa c’è di meglio di una scienziata di epoca alessandrina, che sembra anticipare l’approccio fallibilista di Karl Popper, per raccontare una bella storia, attualissima in tempi di Isis, in cui i cattivi sono i fondamentalisti e i buoni sono coloro che socraticamente sanno di non sapere? Solo loro potranno elevare il dubbio a metodo rigoroso, individuando l’unica via percorribile per arrivare alla conoscenza.
Ipazia è stata una martire. Non una martire cistiana, però, bensì una martire uccisa dai cristiani. «A uccidermi - dice in questo racconto, splendidamente illustrato da Pia Valentinis - sono state le persone. Parabolani li chiamavano, dei monaci del deserto, guerrieri, pronti a uccidere per Dio, o meglio per quello che altri uomini più furbi indicavano loro circa il volere di Dio. Che una donna non fosse degna, di insegnare, di parlare, di pensare».
E Ipazia, proprio come Socrate, amava insegnare ovunque le capitasse: «Per strada, alle persone qualsiasi, a chiunque incontrassi e volesse sapere qualcosa sui filosofi del passato, sulle loro idee. Indossavo il mio mantello e uscivo per le vie di Alessandria. Ecco quello che mi manca della vita...». Sì perché il racconto è ambientato in una specie di oltretomba spaziale. Camilla, un’astronauta che ha appena compiuto vent’anni, atterra su un asteroide per fare una serie di rilevazioni da mandare alla base. In realtà non ha pensieri scientifici, come i buchi neri o i limiti della galassia, ma passa il suo tempo ad ascoltare musica rock con gli auricolari. È lì che Ipazia ora passa i suoi giorni. Ne nasce un dialogo, costellato dalle vicende che la videro protagonista nell’Alessandria del quarto secolo dopo Cristo.
Ipazia è una delle poche donne filosofo della storia occidentale, e a quei tempi essere filosofi significava occuparsi anche e soprattutto di astronomia, di matematica, geometria, di tutte le arti liberali. Perfezionò l’astrolabio di Ipparco e insegnò alla scuola della Biblioteca di Alessandria, prima che questa subisse l’ennesima distruzione da parte dei cristiani in lotta contro i seguaci di Serapide, motivati dalla politica loro favorevole dell’imperatore cristiano Teodosio.
Ipazia è divenuta celebre per avere criticato il sistema tolemaico e difeso l’eliocentrismo di Aristarco, se è vero ciò che scrive il suo allievo prediletto, Sinesio. L’opera di Tolomeo non era da considerarsi, agli occhi degli studiosi di Alessandria, definitiva e inattaccabile, ma popperianamente falsificabile.
La filosofia neoplatonica di cui la maestra Ipazia nutriva i suoi discepoli - un neoplatonismo che prendeva le distanze dagli eccessi teologici delle scuole orientali ed era invece improntato più al modello ateniese - li educava al rispetto della pluralità delle ipotesi e alla ricerca della verità.
Ipazia fu massacrata in modo barbaro e violento. Furono i cristiani a ucciderla. Forse perché i suoi insegnamenti astronomici erano visti con sospetto. Forse perché era una donna. Forse perché era “laica”, libera, in un’età di lotte atroci tra fondamentalismi religiosi.
Alla fine forse proprio questo è ciò che Roberta Torre vuole trasmettere ai bambini dagli otto anni in su - almeno fino ai venti di Camilla, che pur appartenendo a una missione scientifica non sembra essere una campionessa di pensiero critico: - la laicità come elemento essenziale delle persone libere, amanti della conoscenza e della civiltà. La musica dei pianeti può legare la neoplatonica Ipazia alla musica dell’iPod di Camilla ma solo se anche lei, come già Sinesio, saprà abbeverarsi alla scuola del dubbio.
«Forse tutta questa rabbia che hanno nell’affermare il loro credo - dice Ipazia - è un modo per non pensare ai dubbi, che pure devono esserci. Come si fa a non avere dubbi?, dicevo a Sinesio, e lo ripeto anche a te, astronauta. Che cosa bella sono i dubbi, sono degli amici che sembrano nemici, ma in verità ti dico che il nostro compito come studenti è quello di diventare amici dei dubbi».
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
- LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
UN GIARDINO PER IPAZIA: MEGLIO TARDI CHE MAI *
Finanlamente dopo secoli di oblio, una piazza, o meglio un giardino, verrà dedicato a Ipàzia (Alessandria d’Egitto, 415) che considerata la prima matematica, astronoma e filosofa della greca antica. La sua uccisione da parte di una folla di cristiani in tumulto composta di monaci detti parabolani guidati dal Vescovo Cirillo di Alessandra, peraltro poi fatto Santo, che non vedevano di buon occhio una donna dedicarsi a materie allora ritenute prettamente "maschili".
Il Comitato “Una Piazza per Ipazia”, costituitosi a seguito della raccolta firme lanciata dalla sezione ANPI Trullo-Magliana nel dicembre 2014, e promotore della richiesta di intitolazione di una Piazza o Giardino alla filosofa neoplatonica e filomate Ipazia d’Alessandria comunica che è stata finalmente apposta dalla toponomastica di Roma Capitale la targa, in zona Tor Sapienza, che intitola un giardino ad “Ipazia d’Alessandria”.
"Abbiamo più volte sottolineato - spiega il comitato - come Ipazia sia di grande attualità per i significati che veicola la sua singolare esistenza: vittima del fondamentalismo religioso ma anche esempio di donna integerrima, studiosa, scienziata, divulgatrice di conoscenza".
- Leggi anche IPAZIA MAESTRA DEL DUBBIO di Armando Massarenti [qui, sotto, di seguito - fls]
"È per noi significativa in quanto simbolo di una resistenza morale e non violenta all’ordine dominante al quale rispose con il rifiuto di sottomettersi docilmente alla costrizione. Tale rifiuto legandosi all’impegno positivo di difendere valori fondamentali quali l’uguaglianza e la libertà assume la veste dell’affermazione. Da uno degli allievi di Ipazia, Sinesio di Cirene, si apprende che Ipazia è stata la madre della scienza moderna in quanto utilizzava la sperimentazione pratica, Fermat la definì ’la meraviglia del suo secolo’."
"Ci auguriamo - conclude il comitato - che il riconoscimento attribuitole con la dedica di un giardino nella nostra città possa essere uno stimolo per restituirle la visibilità che merita per, parafrasando Sinesio, “tenere desti i semi di sapienza da lei ricevuti”.
Per celebrare l’intitolazione il comitato si farà promotore della cerimonia che si terrà nel Giardino Ipazia d’Alessiandria, in data da definire".
* Comitato “Una Piazza per Ipazia” (ANPI Trullo - Magliana Sez. “F.Bartolini”; Ipazia ImmaginePensiero onlus;Donne di Carta; Associazione Filomati-Philomates Associaton; Associazione Toponomastica Femminile; G.A.MA. DI; UDI Monteverde; Circolo UAAR Roma , Civiltà Laica Roma, Adriano Petta.)
* Fonte: Gravità-Zero, domenica 7 agosto 2016 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- {Appello alle donne e agli uomini dell’Università (Circolo universitario "Giorgio Errera" - Pavia)7 agosto 2016, di Federico La Sala
Appello alle donne e agli uomini dell’Università
di Redazione *
Siamo davvero impotenti di fronte alla violenza e alla guerra assunte come unico modo per regolare i rapporti tra gli uomini?
Siamo davvero impotenti di fronte all’involuzione autoritaria impressa da molti governi, e oggi dal governo turco, alla vita democratica del loro paese?
Per comprendere e valutare quanto sta succedendo in Turchia occorre certamente il tempo dell’analisi informata e non ideologica. Tuttavia, abbiamo fin d’ora il dovere di riflettere. Se il primo atto repressivo del governo nel dopo golpe è stato privare della libertà di movimento e limitare così la libertà di insegnamento e di ricerca migliaia di nostri colleghi e colleghe (come conferma in un’intervista del 28 luglio 2016 Betül Tanbay, presidente della Società Matematica Turca, che non ha potuto partecipare al congresso della European Mathematical Society di Berlino perché tutti gli accademici turchi sono diffidati dal lasciare il paese), o addirittura costringerli alle dimissioni, quanto sta succedendo è la prova dell’immenso potere che il pensiero critico, la diffusione del sapere e la libertà di ricerca hanno nella vita delle comunità, in quanto indispensabile terreno di coltura della democrazia e della pace.
In questa circostanza contingente, abbiamo il dovere di riflettere sul fatto che la prima azione del dopo golpe turco è stato il controllo del settore dell’educazione. In generale, abbiamo il dovere di riflettere sul nesso, dimostrato, tra il tasso dell’investimento in formazione e cultura, e la crescita: crescita non semplicemente economica, ma di civiltà e di felicità dei paesi. Queste riflessioni ci consegnano un’arma molto potente: l’arma del sapere. Il sapere come arma ci impone il dovere di richiamarci, in ogni contesto e con gli strumenti di cui disponiamo, agli effetti reali del sapere nelle nostre comunità.
«L’educazione ‘liberale’ libera la mente dalle catene dell’abitudine e della tradizione, formando persone in grado di operare con sensibilità e prontezza come cittadini del mondo», scrive Seneca nel De ira: è questa la straordinaria potenza del pensiero critico, che è tanto temuta da ogni regime illiberale, proprio perché, in quanto esercizio di verità, e «compito per definizione infinito», non può che apparire al potere, agli automatismi e all’opacità dei suoi processi decisionali, «una tecnica di disturbo» (Edward Said).
Come donne e uomini del mondo universitario, dobbiamo oggi ribadire con forza e con orgoglio il significato dell’universitas: “università” non è altro che una totalità che è sempre in divenire, che si fa cioè continuamente attraverso la libera produzione e circolazione del sapere, e attraverso il confronto aperto e spesso produttivamente conflittuale delle idee e delle tesi.
Una protesta unitaria di tutto il mondo universitario che richiami al valore formativo del pensiero critico sarebbe un momento di assunzione consapevole del nostro compito di docenti e ricercatori, e della forza e dell’importanza che questo compito ha: difendere il diritto al sapere contro la repressione e la violenza.
Sarebbe anche una prova straordinaria di quell’Europa come comunità di cui siamo tutti alla ricerca.
La Redazione
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Gli intellettuali di «armiamoci e partite». Basta sfogliare i giornali dei 20/25 anni alle nostre spalle (di Angelo d’Orsi)28 luglio 2016, di Federico La Sala
- LA STATUA DELLA LIBERTA’ DEGLI U.S.A. - CON LA SPADA SGUAINATA: "GUAI AI VINTI"!!! LA LEZIONE DI FRANZ KAFKA, IL MAESTRO DELLA LEGGE: RIPENSARE L’AMERICA. E il sogno del "nuovo mondo"!!!
Gli intellettuali di «armiamoci e partite»di Angelo d’Orsi (Il manifesto, 27 luglio 2016)
Il mondo sembra non avere più senso, e nella confusione delle nostre menti, nell’angoscia dei nostri cuori, nell’ansia che ci accompagna ormai in ogni situazione pubblica (da un treno a un ristorante affollato), ci abbandoniamo alla deprecazione, all’invocazione a qualche entità superiore, minacciamo di ritirarci nel cenobio, piangiamo le vittime di tutti i giorni di questo terrore cieco. Tutto ciò è legittimo e comprensibile. Persino giusto, almeno in quanto serve a scaricare le nostre paure. Eppure dobbiamo conservare accanto all’occhio caldo dei sentimenti, quello freddo della razionalità.
Non dobbiamo smettere di ricordare, a noi stessi e agli altri, che l’Afghanistan è stato demolito dagli Stati uniti foraggiando i Taliban, facendo prosperare Al Qaeda, salvo poi punire un intero Paese per catturare Osama bin Laden, fino a poco prima amico dei Bush & Co. In Iraq sappiamo come è andata: si cercavano anche là gli amici di Osama, poi le «armi di distruzione di massa», e in mancanza degli uni e delle altre, a Washington si decise di procedere comunque contro «Saddam, minaccia per il mondo» e perché «gli iracheni meritano la democrazia».
Sulla base del successo per l’eliminazione di Saddam, con una impiccagione coram populo si decise che si poteva bissare con Gheddafi. In questo caso furono le potenze europee, Francia e Gran Bretagna, ad intervenire, trascinandosi dietro gli alleati, timorosi che Londra e Parigi potessero collocare le loro imprese estrattive in posizioni di vantaggio sulla concorrenza, e Gheddafi risultava un osso duro per tutti gli occidentali. La sua uccisione è un capitolo della barbarie dell’Occidente. Infine, sullo stesso modello Saddam-Gheddafi si era puntato l’obiettivo su Assad, un altro dittatore da eliminare per restituire la democrazia al suo popolo.
E l’Isis che colpisce a destra e manca, e dove non colpisce comunque lucra del terrore, da chi è stato sostenuto negli scorsi anni, fino a non troppo tempo fa? Dagli occidentali, Usa in testa, fino almeno alla Turchia di Erdogan, che ora si dedica amorevolmente a custodire il suo popolo, sgominando il “nemico interno”, vero o immaginario, sulla base di un disegno politico preciso, semplicemente di tipo dittatoriale.
Rispetto ai tanti progetti Usa-Nato, sappiamo come è andata. La vita non assomiglia più a niente, scriveva Tahar Ben Jalloun dopo una visita a Baghdad, qualche anno fa; una frase che vale per Kabul, Baghdad, Tripoli, Damasco, Aleppo, e l’elenco può continuare, in una lista collana di morte disperazione dolore. Insensatezza. Le armi che vengono impiegate in quei luoghi sono quasi sempre nostre. I mercenari inviati a combattere per la democrazia sono perlopiù sul libro paga di agenzie occidentali. La grande regia è a Washington, a cui si accoda senza fiatare Londra (Tony Blair che chiede scusa ammettendo di aver sbagliato nel 2003 è un po’ penoso).
Seguono, gli altri, praticamente tutti gli altri, nel coacervo criminale della Nato, partecipano alla mattanza, ora frenando, ora accelerando, a seconda degli interessi nazionali; che sono poi gli interessi di gruppi dominanti, legati al mercato delle armi, a interessi finanziari e imprenditoriali.
Ma naturalmente i morti non sono tutti uguali, come uguali non sono i vivi. E lo sdegno per la Francia, per la Germania, e così via non si riproduce per le notizie che giungono dall’Africa, dal Medio e dall’Estremo Oriente, a cominciare dallo stillicidio di nefandezze portate avanti dai governanti israeliani a danno dei Palestinesi. E la nostra pietas di occidentali viene opportunamente distribuita, in base a convenienze, dei media, dei governanti, dei potenti. Ma anche in base alla nostra capacità di attenzione critica, che lo stesso susseguirsi di eventi tragici finisce per abbassare, fino al suo obnubilamento. E sta proprio qui il problema. La perdita dell’attenzione critica.
Certo, noi comuni cittadini non siamo in grado di fare alcunché contro i governanti stranieri. Ma possiamo almeno tenere sotto osservazione e sotto pressione i nostri. E possiamo, anzi dobbiamo, puntualmente sbugiardare i giornalisti, commentatori, intellettuali che, per stupidità, ignoranza, disonestà intellettuale, si sono resi complici di menzogne e inganni in tutti questi anni, sostenendo la favola velenosa della esportazione della democrazia, credendo o fingendo di credere a Bush, a Blair, a Sarkozy, e compagnia cialtrona. «Io so», diceva Pasolini, «so i nomi, ma non ho le prove», in riferimento alle colpe della Dc.
Noi abbiamo le prove. Basta sfogliare i giornali dei 20/25 anni alle nostre spalle, e oggi con la Rete tutto è assai agevole. Andiamo a rileggere i commenti, le analisi, e le pseudo-verità di questo esercito degli «armiamoci e partite», le grottesche macchiette di «eroi in pantofole», che hanno incitato l’Occidente a «difendere i suoi valori», a suon di bombe. Andrebbero invitati quanto meno a usare il loro intelletto in modo meno disonesto, e a fare una robusta autocritica, pur nella convinzione che non la faranno, ma almeno ricordargli cosa hanno scritto e detto li inchioda alle loro responsabilità. Costoro, a furia di predicare vento, hanno raccolto tempesta. Purtroppo questa tempesta, non solo colpisce e travolge tutti, indiscriminatamente, colpevoli e, soprattutto, innocenti; ma suscita mostruosi giochi dell’orrore, imitazioni sadiche, e un nichilistico desiderio di morte, che prende a oggetto gli altri e sé stessi.
E mentre orrore e terrore si propagano, a noi che rimane? Rimane il dovere della denuncia, il compito della documentazione, l’impegno della militanza dalla parte degli innocenti. A cominciare da quei bambini siriani che, facendoci versare più di una lacrima, hanno issato cartelli con le immagini dei maledetti Pokemon, e un amaro invito: «Venite a cercare anche noi».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - 14 LUGLIO 20116. HIROSHIMA SUL LUNGOMARE DI NIZZA. BREVE DISCORSO SUL NOSTRO ORRORE QUOTIDIANO E SUI COMPITI DELL’ORA.15 luglio 2016, di Federico La Sala
HIROSHIMA SUL LUNGOMARE DI NIZZA. BREVE DISCORSO SUL NOSTRO ORRORE QUOTIDIANO E SUI COMPITI DELL’ORA
- Sintesi del discorso tenuto dal responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani", Peppe Sini, la mattina di venerdi’ 15 luglio 2016 nel piazzale di Santa Barbara a Viterbo
1. Ovunque e’ Hiroshima
In ogni luogo si puo’ essere sterminati.
Esistono armi cui non si puo’ sfuggire, e poteri assassini disposti ad usare quelle armi contro chiunque. L’umanita’ e unificata nel segno del dolore e della paura.
E questa violenza che dall’alto incombe su tutti, tutti contagia, e dagli eserciti passa alle milizie, dalle milizie alle mafie, e dai criminali ai reietti, dagli emarginati senza speranza alle persone fino a ieri integrate o equilibrate che un giorno il delirio offusca o la sventura abbatte e precipita nella sofferenza piu’ inesorabile e nel rancore che null’altro desidera se non che altri soffrano anch’essi, che anche ad altri sia strappato ogni bene, e di ogni bene il fondamento: la nuda vita.
E questa violenza trova sempre un’ideologia, infinite ideologie, che la giustifichino, che la glorifichino; e che effettualmente inducono esseri umani oppressi e infelici, o illusi e avidi, a farsi assassini.
I poteri imperiali hanno le atomiche, i proiettili a uranio impoverito, il fosforo bianco, i droni, gli equipaggiamenti robotici. Ma basta un mitra, una pistola, una daga. O anche: un aereo, un camion, un coltello per tagliare il pane che alla bisogna anche le gole squarcia, le nude mani del marito e del fidanzato.
*
2. La guerra ha raggiunto le nostre citta’
Fino a ieri i nostri governi - ed i potentati economici di cui sono asservita espressione - compivano o commissionavano stragi altrove, ma strage dopo strage la piena del fiume di sangue ha rotto gli argini dilagando ovunque, il massacro sta arrivando nei nostri quartieri, nei nostri bar, nella redazione del giornale da ridere, nel locale del concerto pop, nel ristorante degli imprenditori, sulla passeggiata della festa, e alle stazioni dei treni, negli aeroporti, dinanzi agli stadi.
Questo terrorismo cellulare e artigianale che raggiunge le nostre citta’ e’ il nostro terrorismo coloniale e imperiale che in un movimento pendolare ritorna e ci investe. Ne e’ il prodotto diretto. Pochi giorni fa i mass-media davano notizia dell’uccisione di uno dei principali capi dell’Isis, detto "il ceceno", ed aggiungevano con noncuranza che era stato addestrato dagli americani. La carriera di terrorista di Bin Laden inizio’ in Afghanistan finanziata dagli Usa. La nascita dell’Isis e il suo radicamento territoriale (con la sua enorme efficacia in termini propagandistici, di reclutamento e di possibilita’ di addestramento e armamento) e’ conseguenza diretta delle nostre infamissime e scelleratissime guerre che hanno destrutturato l’Iraq, la Siria, la Libia.
*
3. Aprire gli occhi
Certo, noi vediamo solo le stragi che avvengono dove i nostri telefonini le riprendono, le nostre televisioni le trasmettono. E non vediamo il massacro quotidianamente eseguito dai nostri aerei, le nostre bombe, i nostri armamenti venduti ed usati nei continenti delle dittature e della fame, della schiavitu’ e della desertificazione, della rapina imperialista e razzista.
Certo, noi ci sentiamo il cuore spaccato quando muore un nostro concittadino, e non vediamo le innumerevoli vittime delle nostre guerre, che consentiamo che siano chiamate "missioni di pace", che arricchiscono il "made in Italy" dei mercanti di morte, e neppure ci accorgiamo che i milioni di esseri umani in fuga dall’Africa e dall’Asia che muoiono nei lager turchi e libici, che muoiono nel braccio di mare tra l’Anatolia e Lesbo, che stanno colmando di cadaveri il Mediterraneo, sono i nostri governi a trucidarli, in una immane mattanza. L’orrore e’ tale che non lo percepiamo piu’.
*
4. Tornare a sentire, tornare a pensare
Questo dovremmo innanzitutto fare: tornare a sentire, tornare a pensare.
Tornare a pensare alla condizione umana nell’eta’ atomica con Guenther Anders, tornare a pensare alle tre verita’ di Hiroshima di cui ci parlava Ernesto Balducci, tornare a pensare i nostri pensieri in dialogo con i pensieri di Mary Wollstonecraft, di Karl Marx, di Rosa Luxemburg, di Virginia Woolf, di Simone Weil, di Mohandas Gandhi, di Hannah Arendt, di Emmanuel Levinas, di Nelson Mandela, di Wangari Maathai, di Franca Ongaro Basaglia e di Luce Fabbri.
Riconoscere che ogni vittima ha il volto di Abele.
Riconoscere che vi e’ una sola umanita’, che esiste nella pluralita’ di esseri umani tutti diversi e tutti eguali in dignita’ e diritti, tutti ugualmente bisognosi di aiuto, tutti ugualmente viventi in quest’unico mondo vivente casa comune dell’umanita’, tutti ugualmente esposti al dolore e alla morte e quindi tutti in diritto di ricevere aiuto e tutti in dovere di recarlo altrui.
Opporsi alla guerra e a tutte le uccisioni. Giacche’ togliere la vita ad un essere umano (ovvero rapinarlo di quell’unico bene senza del quale nessun altro bene si da’) significa ed implica negare l’umanita’ di tutti e di ciascuno, anche la propria.
Opporsi al razzismo e a tutte le persecuzioni. Giacche’ negare la dignita’ umana di qualcuno significa ed implica estinguerla in tutti, innanzitutto in se stessi.
Opporsi al maschilismo e a tutte le oppressioni. Sapere che l’oppressione maschile che spacca in due l’umanita’ e pretende ridurre meta’ dell’umanita’ a servo e merce e cosa e possesso - e che cosi’ disumanizza l’umanita’ intera, nelle vittime e nei carnefici - e’ la prima radice e il primo paradigma di ogni violenza.
Opporsi al totalitarismo e alla schiavitu’, opporsi alla violenza non solo nei confronti degli altri esseri umani, ma anche nei confronti degli esseri viventi e del mondo vivente tutto, quest’unico mondo vivente di cui siamo parte, quest’unico mondo vivente in cui possiamo vivere.
Ricordarsi di essere fallibili.
*
5. Cosa occorre fare subito
Abolire le armi.
Abolire gli eserciti.
Soccorrere, accogliere, assistere tutte le persone bisognose di aiuto.
Nei luoghi della sofferenza recare aiuti umanitari: tutto e’ interconnesso, tutto e’ interdipendente.
Del sapere e della tecnica fare uso non piu’ per opprimere e rapinare e asservire altri, ma per recare assistenza e giovamento.
Educare al rispetto di se’ e quindi al riconoscimento degli altri e quindi alla riconoscenza per gli altri, all’empatia ed alla responsabilita’. Educare alla consapevolezza che la civilta’ umana e’ un cammino unitario e un compito comune, che l’umanita’ e’ plurale e una, che ogni persona deve sentirsi responsabile di tutto.
Avere sempre come primo criterio di giudizio la liberta’ delle donne: dove sono negati, misconosciuti o violati i diritti umani delle donne, li’ e’ gia’ il fascismo.
Riconoscere a tutti gli esseri umani il diritto di muoversi su quest’unico mondo casa comune.
Prendere le decisioni che tutti riguardano sempre e solo col consenso di tutte le persone coinvolte.
Tutto cio’ puo’ esser detto con una sola parola: nonviolenza.
*
6. Solo la nonviolenza puo’ salvare l’umanita’
Chiamiamo nonviolenza la lotta che a tutte le violenze si oppone ed opera in modo concreto e coerente affinche’ tutte le vite siano riconosciute, difese, salvate.
Chiamiamo nonviolenza la lotta delle oppresse e degli oppressi per la liberazione comune dell’umanita’ e la preservazione della biosfera.
Chiamiamo nonviolenza la consapevolezza che solo facendo il bene ci si puo’ opporre al male, solo salvando le vite si contrasta la morte, solo agendo umanamente si resta umani.
Trattare l’umanita’ con umanita’: tu sei il prossimo del tuo prossimo.
Questa e’ la politica necessaria, la sola politica adeguata alla tragica ora presente dell’umanita’.
Questo e’ l’unico modo per non dimenticare tutte le vittime.
Rispetto per la vita, forza della verita’, amore per il mondo: solo la nonviolenza puo’ salvare l’umanita’ dalla catastrofe.
Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo
Viterbo, 15 luglio 2016
Mittente: Centro di ricerca per la pace e i diritti umani, strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, -e-mail: nbawac@tin.it, centropacevt@gmail.com, centropaceviterbo@outlook.it
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- STRANIERI. IN UNA NOTTE, tre milioni di europei che vivono nel Regno Unito. L’Europa, se vuole avere un domani, deve far ricorso ai suoi simboli migliori (Marino Niola))13 luglio 2016, di Federico La Sala
Stranieri
Siamo tutti figli di un dio venuto da molto lontano
Tra Dioniso e la polis cercando l’antica saggezza dell’ospitalità
di Marino Niola *
La tessera hospitalis era un pegno di amicizia tra Romani e forestieri Nell’Iliade e nell’Odissea filos, amico, e xenos sono sinonimi
Strangers in the night. Stranieri in una notte. È quello che sono diventati tre milioni di europei che vivono nel Regno Unito. Professionisti, lavoratori, studenti che, per effetto della Brexit, si sono addormentati comunitari e risvegliati extra-britannici. Da pari a impari.
Da cittadini a immigrati. Del resto è stata proprio la paura dell’immigrazione, la benzina gettata da Nigel Farage e da Boris Johnson sul fuoco isolazionista. Che adesso rischia di fare della Gran Bretagna il cortile in fiamme di un continente sull’orlo di una crisi di nervi. Dove il timore presunto dell’invasione e la minaccia reale del terrorismo portano acqua al mulino dei nazionalismi, che vedono in ogni straniero un nemico. Un’equazione xenofoba per una questione ostica. Che viene però da molto lontano, tant’è che è scritta a chiare lettere nelle matrici linguistiche della nostra civiltà. Non a caso parole chiave del presente, come xenofobia, straniero, estraneo, strano, nemico, ospite, e perfino ostico, derivano tutte da uno stesso nucleo incandescente.
Un magma etimologico ancora impresso in certe esitazioni del nostro vocabolario che, per esempio, definisce con il termine ospite, sia chi accoglie sia chi viene accolto. Un’ambivalenza spiazzante. Ma una confusione soltanto apparente, perché quando non ci sono due parole distinte per definire due ruoli diversi significa che in realtà quei due ruoli sono uno solo. Una coincidenza reale tra due falsi opposti. Perché la legge non scritta dell’ospitalità comanda di accogliere lo straniero in quanto ciascuno di noi, a sua volta, è stato o sarà uno straniero in cerca di ospitalità.
In realtà siamo di fronte a figure e concetti che sin dalle origini delle società euro-mediterranee, danno senso e forma ai pericoli e, al tempo stesso, alla necessità dell’accoglienza. Il fatto che in latino una stessa parola, hostis, definisca lo straniero e il nemico, ma anche l’ospite, riflette immediatamente l’indeterminazione del rapporto con l’altro, che per definizione può oscillare tra un estremo ospitale e un estremo ostile. Tra l’accoglienza e il conflitto.
Ancor più illuminante è il greco xenos, straniero - da cui deriva il nostro xenofobia - che in origine designa semplicemente l’ospite. Insomma l’estraneo che bussa alla porta è ospite per antonomasia, proprio in quanto viene da un altro paese. Come dice Omero, forestieri e mendicanti sono incarnazioni di Zeus. Addirittura, nell’Iliade e nell’Odissea filos, amico, e xenos ricorrono spesso come sinonimi, quasi a sottolineare che l’altro è l’amico per eccellenza. È il prossimo tuo. Una sacralizzazione che risuona come un gong remotissimo, le cui vibrazioni arrivano fino a quel passo del Vangelo di Matteo dove Gesù dice ai discepoli «ero straniero e voi mi avete accolto». Rivelando così che una scintilla del Cristo brilla in ogni povero cristo.
E nella Grecia di Pericle, terra madre della democrazia occidentale, si chiama xenia il patto di amicizia che lega il cittadino al forestiero in un rapporto reversibile, una relazione double face, in cui le parti sono fatte per essere scambiate. Accogliere ed essere accolti, offrire e ricevere asilo non sono, infatti, azioni diverse, ma due tempi e due modi di una stessa azione. Non a caso nelle lingue indoeuropee dare e prendere derivano da una stessa radice, do. E chiedersi se un senso preceda l’altro, è come domandarsi se è nato prima l’uovo o la gallina. Lo diceva il grande linguista Émile Benveniste, che allo studio delle parole che stanno sotto le nostre parole ha dedicato tutto il suo genio.
Il patrono della xenia antica è Dioniso, il nume straniero per eccellenza, la personificazione del fermento che l’arrivo dell’altro porta con sé. Un’alterazione vitale. E virale. Proprio per questo i rituali in onore del dio del vino si chiamano epidemie. Secondo Marcel Detienne, il grande antropologo del mondo antico, il termine epidemia in origine non appartiene al vocabolario della medicina, ma a quello della religione e designa l’irruzione improvvisa di una potenza ignota. E tale è Dioniso, che irrompe sulla scena della polis come un ospite inatteso e sconosciuto, portato dalle onde su una imbarcazione di fortuna, oggi la chiameremmo un barcone della disperazione.
Nel rito i cittadini fingono di voler ricacciare indietro la barca. In realtà il rimpatrio forzato del dio epidemico mette in scena i sogni e gli incubi degli autoctoni, perché rappresenta le due facce dello scambio. La necessità del contatto e la paura del contagio. O, con parole nostre, i rischi e i vantaggi della globalizzazione. Ancora una volta il mito non parla al passato, ma al presente remoto, come un fotogramma anticipato del tempo che stiamo vivendo. Perché nella storia tutto cambia ma tutto torna. E sotto le onde del tempo che corre ci sono le correnti del tempo che ricorre.
E proprio perché l’incontro con lo straniero è un fatto etico ma anche pratico, da governare con lungimiranza, i Romani che di senso pratico ne avevano da vendere, avevano inventato la tessera hospitalis, un contrassegno che veniva spezzato in due parti quale pegno di amicizia e promessa di reciprocità fra una famiglia romana e una straniera. Era la contromarca concreta del patto di ospitalità e delle condizioni che lo regolano. Perché se le parole volano, i simboli rimangono. E le due metà della tessera valevano come segno di riconoscimento anche per i discendenti, vincolati a loro volta dal patto di solidarietà contratto dagli antenati.
È proprio questa possibilità di mediare e calibrare l’ospitalità che sembra mancare alle politiche dell’accoglienza di oggi, che riducono tutto a percentuali e quote, muri e lasciapassare, centri di identificazione e libertà coatte, false generalità e respingimenti, senza coinvolgere e responsabilizzare chi arriva e far sentire tutelato chi accoglie. Ecco perché l’immigrazione sta diventando il cavallo di Troia del continente.
Se c’è una lezione che possiamo prendere dal passato è proprio questa. Il rapporto con l’altro ha bisogno di essere regolato dalle norme, ma anche di essere suggellato da simboli e rituali che trasformino il dettato astratto delle leggi in relazioni e in emozioni, in pegni ed impegni che mettono in gioco sentimenti e volontà, rispetto e dignità, disponibilità e lealtà. Insomma, qualcosa come una tessera hospitalis declinata al presente. Perché l’Europa, se vuole avere un domani, deve far ricorso ai suoi simboli migliori come antidoto contro i suoi istinti peggiori.
*
1. continua
* la Repubblica, 12.07.2016
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- "La idea de Europa" (Alejandro Bancalari Molina): Un’idea di continente (di Martino Menghi)10 luglio 2016, di Federico La Sala
Fine della Storia o della "Preistoria"?
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
Un’idea di continente, Europa a braccia aperte
Gli storici antichi la descrissero diversa dall’Asia per clima e politica. E si accorsero che era più aperta all’accoglienza
di Martino Menghi (Il Sole-24 Ore. Domenica, 10.07.2016)
- Alejandro Bancalari Molina, El idea de Europa en el mundo romano. Proyecciones actuales, Editorial Universitaria, Santiago del Cile, pagg. 148, $ 10
Di fronte alle pesanti emergenze odierne, l’Europa sembra scontare la mancanza di un forte progetto politico unitario, come confermano le spinte centrifughe che l’attraversano. Un problema cui potrebbe porre rimedio prendendo spunto da una appropriata conoscenza dell’esperienza greco-romana, come sostiene Alejandro Bancalari Molina nella parte conclusiva del suo libro La idea de Europa. Una vicenda, allora come oggi, segnata da conflitti, da pregiudizi nei confronti dello straniero, ma anche dalla capacità di inclusione, di integrazione e di scambio culturale tra i popoli. Rivediamone i punti essenziali sulla scorta dell’eccellente lavoro di questo studioso.
Nel racconto del conflitto tra Greci e Persiani Erodoto ci fornisce una prima accezione di Europa come entità politica, economica e culturale contrapposta all’Asia. È per bocca di Demarato, un esule spartano presso la corte persiana, che viene enunciato questo dualismo. Interrogato da Serse sul possibile esito di quella guerra, gli ricorda che la Grecia è sempre stata un Paese “povero”, ma proprio questa sua condizione ha permesso agli Elleni di essere forti, di superare le difficoltà, di difendere fino alla morte la propria terra e la propria libertà dall’invasore.
All’opposto, la ricchezza dell’Asia, in mano al Gran Re, ha corrotto la massa dei sudditi, asservendoli al suo capriccio e deprivandoli del senso di una causa comune per cui lottare. Sulla base di questo stereotipo veniva letta e celebrata la vittoria dei Greci sui Persiani a Maratona e a Salamina (490; 480 a.C.).
Non c’è ancora in Erodoto una precisa delimitazione geografica dell’Europa, vagamente situata lungo un asse Nord-Est/Ovest che dal Tanai (Don) giunge fino alle Colonne d’Ercole (Gibilterra) passando per la Grecia e le sue colonie nel Mediterraneo. Con Ippocrate (fine del V secolo a.C.) e Aristotele (IV secolo a.C.), il discorso si amplifica in senso geografico e si radicalizza in quello ideologico. Per il primo, l’instabilità del clima dei popoli europei, ora situati anche nelle regioni settentrionali del continente, li rende più operativi e coraggiosi, mentre il clima più uniforme degli asiatici li spinge all’inerzia e alla pigrizia; di più, l’essere costoro governati da monarchi accentua la loro debolezza di carattere.
Aristotele, tripartisce l’ecumene, assegnando ai popoli settentrionali il coraggio ma non l’intelligenza, e a quelli asiatici l’intelligenza ma non il coraggio, per attribuire ai popoli mediani, ovvero ai Greci, sia l’uno che l’altra e la loro vocazione al dominio delle altre genti. Quest’ultima prospettiva conoscerà un’originale attuazione con Alessandro che, nel segno dello scambio culturale e dell’integrazione, unifica la Grecia con l’impero persiano in un’unica realtà economico-politica.
Erede di questa vicenda sarà Roma, che conquisterà in pochi secoli un impero esteso dalla Scozia all’Africa settentrionale, da Gibilterra ai Balcani e a parte del Medioriente, sempre grazie a una sapiente politica di integrazione dei popoli man mano conquistati.
Il dualismo Europa/Occidente vs. Asia/Oriente, archetipo di tanti stereotipi xenofobi e razzisti, è di fatto contraddetto dalla storia. Ma lo è anche dal mito, che della storia è in qualche modo il riflesso: il nome di Europa deriverebbe dall’omonima principessa fenicia che Zeus, nelle sembianze di un docile toro, rapì, portò a Creta e lì si unì a lei; Enea, il leggendario fondatore della stirpe romana, è un eroe troiano, fuggito dalla sua città conquistata dagli Achei. Lo è infine dall’esperienza del cristianesimo, nato in Palestina in seno al giudaismo, che nell’arco di pochi secoli diventerà la religione dello Stato romano ereditandone le istituzioni, la cultura, compresa la capacità di integrare i popoli barbari.
Il modello romano rivive nell’impero fondato da Carlo Magno, in quello di Napoleone, e infine nel progetto europeo del secondo dopoguerra. Ma di quel modello occorre oggi conoscere, per valorizzarli, i punti di forza, prima di cedere alla tentazione di andare ognuno per la sua strada.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- LA MACCHINA DEL RAZZISMO. Gli omicidi a sfondo razziale non sono casi isolati, sono alimentati da un pensiero profondo mai sradicato (di Igiaba Scego)8 luglio 2016, di Federico La Sala
- UBUNTU: "Le persone diventano persone grazie ad altre persone".
 A NELSON MANDELA, UN OMAGGIO SOLARE: "INVICTUS".
A NELSON MANDELA, UN OMAGGIO SOLARE: "INVICTUS".
L’omicidio di Fermo è l’ultimo atto del profondo razzismo italiano
Igiaba Scego, scrittrice (Internazionale, 07 Lug 2016)
Emmanuel Chidi Namdi, 36 anni, è morto.
Quando ho letto la notizia mi è mancato il fiato.
Davvero è successo?
Davvero si può scappare da Boko haram, uno dei gruppi terroristici più efferati del mondo, e non sopravvivere all’Italia?
Davvero l’Italia è peggio di Boko haram?
Penso alla moglie che ha assistito impotente all’omicidio. Penso a quegli attimi prima della morte di Emmanuel. Mi immagino una coppia in una tranquilla sera di estate a Fermo, mano nella mano, progettando il futuro. E poi un uomo nel buio, il suo odio, la sua spranga, il sangue, il cervello che schizza tutto intorno, la paura, il dolore, la furia.
Dicono che è stato un ultrà. Che parola strana ultrà. Non ha un reale significato. Ti rimanda allo stadio, alle curve, al tifo. Però nasconde a volte anche altro. Nasconde il razzismo, il fascismo, un certo gusto di menar le mani. Ma dire ultrà, ripeterlo in tutti i telegiornali, è anche un modo di non prendersi le responsabilità di un atto efferato. È lui, solo lui, l’uomo con la spranga, il colpevole, sembrano giustificarsi tutti. Lui, un balordo, uno strano, un emarginato in fondo. Succede, sembra dire la vulgata pubblica, non è colpa nostra se ci sono certe bestie in giro. E ci dimentichiamo che una bestia non nasce per caso. Che anche un omicidio a sfondo razziale è terrorismo.
“Not in my name”, l’ho scritto e detto tante volte contro gli attentati jihadisti. Ci siamo schierati quando occorreva farlo e odiosamente nessuno lo ha notato. Il mondo islamico a cui appartengo sa di essere la prima vittima del terrorismo, ma sa anche che il terrorismo nasce dalle sue devianze. E anche il razzismo, l’odio di cui è avvolto tutto il paese, è roba nostra. Made in Italy. Non è un fatto isolato. E ora, dopo la morte di Emmanuel, non possiamo far finta di nulla. Dobbiamo capire da dove viene quest’odio, quali sono le cause profonde di questa sciagura.
- Dopo l’omicidio di Jerry Maslo, nel 1989, l’Italia si risvegliò più brutta, più sporca e più cattiva
Ed ecco che il nome di Emmanuel Chidi Namdi si mischia con tanti altri con Ahmed, Jerry, Abba, Samb.
Non è la prima volta che succede.
Il primo di cui ho memoria era un somalo, uno studente promettente caduto in disgrazia, di nome Ahmed Ali Giama.
Ahmed era arrivato a Roma nel 1978. Alle spalle aveva una borsa di studio in Unione Sovietica, la voglia di cambiare il mondo, un comunismo a cui credeva più di se stesso. Poi qualcosa andò storto nella sua vita. L’Unione Sovietica lo rimandò a casa, in Somalia, perché il suo comportamento era stato considerato inopportuno. La motivazione ufficiale era che “beveva troppo”. Ma Ahmed Ali Giama sapeva di non bere più degli altri, sicuramente non più di quanto si faceva in Russia. Si sentiva vittima di una profonda ingiustizia.
Ahmed arriva in Italia perché fugge da una dittatura militare, quella di Siad Barre, che gli sta stretta. Ma anche qui niente va bene. Una vita sempre più ai margini, tra i cartoni e le mense che offrono un po’ di cibo. E poi quella notte terribile, tra il 21 e il 22 maggio 1979, quattro ragazzi annoiati gli danno fuoco e lui muore senza un perché sotto l’arco del tempio della Pace, a Roma. I ragazzi erano fascisti? Uno aveva simpatie di destra, ma la ragazza era una che stava nei movimenti, una compagna. Un omicidio né di destra né di sinistra. Solo un grande squallore.
Poi c’è stato Giacomo Valent a Udine. Era uno studente brillante. Anche la sua famiglia era brillante. Una famiglia di quelle che si vedono nei telefilm americani. Il padre era stato cancelliere dell’ambasciata italiana in Jugoslavia e la madre era una splendida somala di nome Egal Ubax Osman. Una coppia che univa il bianco e il nero, con figli belli, eleganti, brillanti. A Udine una famiglia così non l’avevano mai vista. Le ragazze andavano in visibilio per quei Valent. Davvero erano fantascienza. Giacomo, poi, era di sinistra e questo lo rendeva ancora più bello, ancora più tosto. A volte a scuola discuteva con i compagni di destra. Qualcuno lo chiamava scimmia e usava il razzismo perché non aveva argomenti davanti a quel ragazzo così intelligente. Giacomo non si lamentava mai per le battutacce. Andava avanti a testa alta. Sapeva di valere.
Fu così che molti a Udine cominciarono a non sopportare quella famiglia troppo perfetta. Come si permetteva quel “negro” di frequentare una scuola friulana esclusiva? Dovevano dargli una lezione. E poi era troppo di sinistra. E così Giacomo pagò quell’odio strisciante. Due compagni di classe lo attirarono con una scusa in un capanno e lì giù botte e coltellate. Daniel P. (14 anni) e Andrea S. (16 anni) volevano dare una lezione a un diverso. E la lezione furono 63 coltellate che lasciarono Giacomo in un lago di sangue. Era il 1985.
L’Italia dell’apartheid
In seguito arrivò il 24 agosto 1989 a Villa Literno. Era già da parecchi anni che giovani africani venivano usati dai caporali per la raccolta dei pomodori. Erano di fatto schiavi, pagati una miseria, per un lavoro faticoso ed estenuante. I ragazzi dormivano in baracche fatiscenti e anche se non c’era spazio per nulla, loro cercavano comunque di trovare un posticino per i loro sogni e il loro futuro che prima o poi sarebbe decollato. Stringevano i denti, “non sarà per sempre”. Lo deve aver pensato anche Jerry Maslo, un sudafricano scappato dall’apartheid. Jerry aveva tanti sogni. Soprattutto quello di poter camminare libero per le strade del suo paese, senza che nessuno gli dicesse dove poteva o non poteva passare. Sognava la fine dell’apartheid. Non mancava molto. Nelson Mandela aveva resistito così tanto in carcere anche per lui. Jerry lo sapeva, ci sperava.
Ma il giovane sudafricano non vide mai la fine del regime di segregazione razziale perché fu ucciso da chi odiava il colore della sua pelle. Non era il Sudafrica dell’apartheid, era l’Italia dell’apartheid. Quattro persone, con delle calze di nylon sulla testa, fecero irruzione nelle baracche dove dormivano gli africani e cominciarono quella mattanza insensata. Si impossessarono anche di due spiccioli. Ma non erano i soldi il motivo dell’incursione. Il motivo era lo stesso degli assassini di Giacomo Valent: dare una lezione al diverso. L’assassinio di Jerry Maslo fece capire all’Italia che il razzismo non era solo quello degli altri.
L’Italia si risvegliò più brutta, più sporca e più cattiva. Si parlò tanto di razzismo in quel 1989. Lo stesso grido di dolore, che oggi accompagna la morte di Emmanuel Chidi Namdi, accompagnò la salma di Jerry Maslo. Il funerale fu trasmesso in tv. L’Italia pianse, più per se stessa che per Jerry. Era stato un colpo scoprirsi razzista.
- Odio gli indifferenti, aveva detto Gramsci in tempi simili ai nostri
A quello di Jerry Maslo seguirono altri omicidi. Abdul Salam Guibre, detto Abba, un ragazzo italiano, una seconda generazione, originario del Burkina Faso preso a sprangate a Milano perché aveva rubato un pacco di biscotti. Lenuca Carolea, Menji Cloptar, Eva Cloptara, Danchiu Caldaran, bambini rom morti in un rogo a Livorno. Samb Modou e Diop Mor, uccisi a Firenze da un simpatizzante di Casa Pound . E come non ricordare, solo due mesi fa, Mohamed Habassi, torturato e ucciso nel silenzio generale dei mezzi d’informazione e della politica? Torturato non a Raqqa, ma a Parma?
Ed ecco che improvvisamente ripenso alle parole sentite in uno spettacolo teatrale. In scena Mohamed Ba, attore e mediatore culturale senegalese. Mohamed il 31 maggio 2009 fu pugnalato mentre aspettava l’autobus a Milano. Un uomo gli si era avvicinato dicendo: “Qui c’è qualcosa che non va”. Poi arrivò quella pugnalata allo stomaco. Mohamed Ba è vivo per miracolo. Non fu soccorso subito. La gente non si fermò ad aiutarlo. L’odio era nella mano che lo aveva pugnalato, ma anche nello sguardo indifferente di chi non lo aveva soccorso mentre si stava dissanguando.
Odio gli indifferenti, aveva detto Gramsci in tempi molto simili ai nostri. Ed è proprio l’indifferenza per questo odio, che viene sparso ogni giorno da giornali, tv e leader politici, che uccide e tortura. Ci siamo abituati ai titoli razzisti e urlati dei mezzi d’informazione, alle battute politicamente scorrette e agli articoli “perbene” scritti da persone “insospettabili” che parlano di civiltà superiori, di occidente moderno contro selvaggi di diversa provenienza. E siamo indifferenti verso la storia di questa Italia che si è formata e costruita sul razzismo e sul solco che ha tracciato sulla pelle del diverso. Sul luogo dell’omicidio a Fermo, il 7 luglio 2016. - Cristiano Chiodi/Sandro Perozzi, Ansa Sul luogo dell’omicidio a Fermo, il 7 luglio 2016. (Cristiano Chiodi/Sandro Perozzi, Ansa)
Dopo l’unità d’Italia si dovevano fare gli italiani, quante volte ce lo hanno detto a scuola? Nel 1861 gli italiani, di fatto, non esistevano. Esistevano i lombardi, i siciliani, i piemontesi, i toscani. L’Italia era pura astrazione. Per questo si cominciò a sottolineare l’idea di un italiano bianco ed europeo. Diverso dal suo meridione per prima cosa. Quindi prima si colonizzò il sud Italia, poi si colonizzò l’Africa per rimarcare questa unicità e diversità italiana. E il nero (ma anche il meridionale) divenne, di fatto, quello a cui l’Italia si doveva opporre.
Una giovane studiosa, Marta Villa, in un suo saggio (contenuto in Costruire una nazione) ricorda un episodio di goliardia tutta maschile legato all’impresa africana. In Calabria un bracciante disoccupato del luogo fu oggetto di uno scherzo a dir poco crudele. Il poveretto aveva il naso schiacciato, la bocca larga, la fronte bassa e un lungo mento che lo faceva somigliare all’imperatore d’Etiopia, contro cui l’Italia di Mussolini aveva non solo scatenato una guerra tra le più assurde del novecento, ma anche una campagna razzista allucinante. Il bracciante fu fatto ubriacare da alcuni abitanti del paese. Poi gli fu impiastricciata la faccia di nerofumo per farlo assomigliare ancora di più a un africano. Infine fu avvolto in un lenzuolo bianco e fu fatto montare su un asino. Così conciato venne portato in giro per il paese, che sfogò la sua violenza su di lui con sputi e cattiverie di ogni genere.
- Gli omicidi a sfondo razziale non sono casi isolati, sono alimentati da un pensiero profondo mai sradicato
L’Africa, o almeno l’idea di un’Africa da conquistare e sottomettere, era “un perfetto altro da sé atto a rinforzare e così incorporare finalmente l’immagine di una identità italiana condivisa”. I riferimenti alla violenza contro l’altro si ritrovano spesso nelle canzoni fasciste della conquista dell’Etiopia. In Stornelli neri viene detto: “Se l’abissino è nero gli cambierem colore! / A colpi di legnate poi gli verrà il pallore!”. In Povero Selassié, invece, i camerati cantano: “Non piangere, mia cara, stringendomi sul petto / con la pelle del Negus farò uno scendiletto!”.
In una canzone per bambini, Topolino va in Abissinia, c’è un Topolino fomentatissimo che vuol menare le mani e uccidere tutti. Imbrattare le sue appendici da topo con il sangue di gente aggredita impunemente. Nella canzone Topolino dichiara candidamente che “appena vedo il Negus lo servo a dovere. Se è nero lo faccio diventare bianco dallo spavento”. Ma il Negus non gli basta. Topolino vuole massacrare tutti. E ha un motivo ben preciso, che spiega ai suoi comandanti: “Ho molta premura. Ho promesso a mia mamma di mandarle una pelle di un moro per farci un paio di scarpe”. Ma sua madre non è l’unica ad avere bisogno di pelli. Topolino infatti aggiunge: “A mio padre manderò tre o quattro pelli per fare i cuscini della Balilla. A mio zio un vagone di pelli perché fa il guantaio”. E poi chiosa: “Me la vedrò da solo con quei cioccolatini”.
Topolino va in Abissinia, una canzone per bambini....
La macchina del razzismo
Gli omicidi a sfondo razziale in Italia non sono casi isolati, sono alimentati da un pensiero profondo che non è stato mai sradicato. Sono atti quasi rituali, che si ripetono uguali a se stessi nel tempo, una rottura del quotidiano che sfoga su un elemento percepito come altro le frustrazioni di una società in crisi. Ecco perché il colonialismo e l’antisemitismo in Italia non sono fatti secondari, incidenti di percorso della nazione. Come ha detto Tatiana Petrovich Njegosh in Gli italiani sono bianchi? Per una storia culturale della linea del colore in Italia (in Parlare di razza, Ombre Corte), sono di fatto “eventi cruciali nella costruzione dell’identità nazionale italiana”.
Paola Tabet lo aveva già perfettamente spiegato nella prefazione di un volume fondamentale per capire il razzismo in Italia, La pelle giusta. L’antropologa aveva raccolto dei temi di bambini delle elementari dal titolo “Se i miei genitori fossero neri”. In questi temi i bambini scrivono cose come “se i miei genitori fossero neri li metterei in lavatrice con Dasch, Dasch Ultra, Omino Bianco, Atlas, Ace detersivo, Ava, Dixan 2000, Coccolino, Aiax così sarei sicuro che ritornerebbero normali”. I bambini sono razzisti allora? No, certamente. Ma hanno respirato un’aria tossica che considera una pelle giusta e l’altra sbagliata.
Per Paola Tabet il dispositivo xenofobo è “come un motore di un’automobile” che “può essere spento, può essere in folle, andare a cinquemila giri. Ma anche spento, è un insieme coordinato. Il sistema di pensiero razzista, che fa parte della cultura della nostra società, è come questo motore, costruito, messo a punto e non sempre in moto né spinto alla velocità massima. Il suo ronzio può essere quasi impercettibile, come quello di un buon motore in folle. Può al momento buono, in un momento di crisi, partire”.
Ed è ripartito a Fermo, città che già nel 2011 aveva visto l’aggressione di alcuni somali presi di mira da un commando squadrista. Occorre fermare quel ronzio di cui parla Paola Tabet. Un ronzio fatto di mezzi d’informazione che flirtano con il razzismo, di leader politici che incitano all’odio per una manciata di voti, di benpensanti che pensano male abbracciando apocalittici scontri di civiltà. Dobbiamo fermare quel ronzio. Perché l’Italia merita di vivere in armonia abbracciando tutti i suoi colori.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- LA MACCHINA DEL RAZZISMO. -- Il senso dell’onnipotenza. Dagli Usa a Fermo (di Alessandro Portelli).8 luglio 2016, di Federico La Sala
Il senso dell’onnipotenza
Dagli Usa a Fermo. Il governatore del Minnesota scappa, i governanti dell’Italia accorrono a Fermo a far vedere quanto sono solidali. Chissà dov’erano quando quattro bombe sono scoppiate, nella stessa città di Fermo, davanti a chiese colpevoli di ospitare migranti e rifugiati. Da noi è meno marcato il senso dell’onnipotenza, ma coltiviamo accuratamente la pianta della paura e siamo maestri nella pietà parolaia intrisa di indifferenza
di Alessandro Portelli (il manifesto, 08.07.2016)
Chissà se in uno dei prossimi concerti Bruce Springsteen canterà “Devils and Dust”: “ho il dito sul grilletto, non so di chi fidarmi, ho Dio dalla mia parte e sto solo cercando di sopravvivere - la paura è una cosa potente, prende la tua anima piena di Dio e la riempie di diavoli e polvere....”E’ la metafora di un’America che da un quarto di secolo sta collocata alle crossoads fra onnipotenza e paura, con Dio dalla sua parte ma un mondo ostile e sconosciuto tutto intorno... E’ l’America che fra onnipotenza e terrore ha ucciso Calipari, e che fra onnipotenza e terrore continua gli omicidi quotidiani di polizia (580 nel 2016 finora, cui almeno 100 afroamericani disarmati).
Era “visibilmente nervoso” e spaventato il poliziotto del Minnesota che ha sparato a Philando Castile: gli hanno insegnato che i neri sono tutti pericolosi, criminali e drogati, e che i criminali drogati sono tutti armati. Perciò quando Castile ha ripetuto il gesto che costò la vita ad Amadou Diallo (allungare la mano per prendere il documento che gli aveva chiesto), ha dato per scontato che stesse invece per prendere un’arma: come si può immaginare che un negro abbia un portafoglio? Il poliziotto aveva paura; ma era anche armato e quindi onnipotente: non capisco, ho paura, ma posso uccidere quello di cui ho paura, e lo faccio. Per un portafoglio scambiato per una pistola, Amadou Diallo fu crivellato da 41 colpi, per Philando Castile ne sono bastati quattro.
Del senso di onnipotenza fa parte anche la quasi certezza dell’immunità. Finora nessuno dei poliziotti responsabili di uccisioni nel 2016 è stato punito. Dietro questa impunità c’è il senso - condonato, se non sotterraneamente condiviso, nella cultura delle istituzioni - che le persone di colore sono meno umane degli altri, ucciderle è meno grave. Questo è il gesto che ha sancito la morte di Allen Sterling in a Baton Rouge in Louisiana: un essere pensato come subumano per la sua identità è reso ancora più degno di essere schiacciato proprio dalla sua impotenza, lì a terra indifeso come un insetto che ti invita a schiacciarlo (abbiamo visto una scena identica, e finora identica impunità, anche a Hebron lo scorso marzo).
E infine. Noi siamo governati da un parlamento che ha votato allegramente (Partito “democratico” compreso) che chiamare “orango” una donna nera (l’ex ministro Cécile Kyenge) “fa parte del discorso politico” e non è un insulto. Anche qui, insomma, sono le istituzioni le prime a designare i bersagli di violenza etichettandoli come subumani, meno meritevoli di esistere.
Perciò se un fascista di Fermo chiama scimmia una donna africana sopravvissuta a Boko Haram, si tratta tutt’altro che di un pazzo e di un isolato, di uno che fa parte di una deviante e minoritaria cultura ultrà, ma del portatore estremo di un senso comune che non sfigurerebbe nel parlamento della Repubblica.
E se il marito della donna offesa reagisce, allora l’aggressore è lui: i neri devono stare al loro posto, prendersi ingiurie e insulti e stare zitti. Anche qui, quando la vittima è a terra, l’assassino non si ferma, non è soddisfatto, deve andare fino in fondo, deve schiacciare questo insetto che da un lato ha la sfrontatezza di protestare e ti fa sentire minacciato (ma senti come minaccia la sua mera presenza), e dall’altro non ha la possibilità di colpire e ti fa sentire onnipotente. Il governatore del Minnesota scappa, i governanti dell’Italia accorrono a Fermo a far vedere quanto sono solidali. Chissà dov’erano quando quattro bombe sono scoppiate, nella stessa città di Fermo, davanti a chiese colpevoli di ospitare migranti e rifugiati. Da noi è meno marcato il senso dell’onnipotenza, ma coltiviamo accuratamente la pianta della paura e siamo maestri nella pietà parolaia intrisa di indifferenza.
In Louisiana e in Minnesota, gli afroamericani scendono in strada, gridano, protestano, cercano di ricordarci che “Black lives matter”, le vita nere contano negli Stati Uniti come nelle Marche. Ma fino a quando continueremo a pensare che le vite dei neri contano solo per i neri, che la Shoah sia un’offesa che riguarda solo gli ebrei, che la strage di Orlando è una questione dei gay, che gli assassini di polizia e gli assassini razzisti siano offese a una “razza” e non offese all’umanità - fin quando la sollevazione contro queste schifezze non sarà universale, anche la nostra rabbia non sarà che parole e polvere.
- UBUNTU: "Le persone diventano persone grazie ad altre persone".
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Elie Wiesel, l’uomo che vide Dio appeso a una forca (di Elena Loewenthal)3 luglio 2016, di Federico La Sala
Elie Wiesel, l’uomo che vide Dio appeso a una forca
Si è spento a Boston, a 87 anni, lo scrittore premio Nobel per la Pace
Nato in Romania, rinchiuso nel ghetto e poi ad Auschwitz aspettò a lungo prima di raccontare l’orrore, ma poi non ha più smesso
di Elena Loewenthal (La Stampa, 03.07.2016)
Ed è giunta anche per lui quella notte infinita di cui la sua scrittura aveva fatto cifra del male assoluto in terra e in cielo. No, qualcosa di più: La notte di Elie Wiesel è il ritratto del mondo che ha attraversato: il ghetto. Buchenwald. Auschwitz. «Dietro di me sentii il solito uomo domandare: Dov’è Dio. E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: Dov’è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca». Appeso a quella forca c’era un bambino, ancora vivo per un soffio di tempo.
Elie Wiesel ci ha lasciatI: l’annuncio arriva dalla collina dello Yad Vashem, il memoriale della Shoah a Gerusalemme, ed è come un’eco triste che risuona ai quattro angoli del mondo, ovunque lui ha vissuto, scritto, lottato. Era nato nel 1928 a Sighetu Marmatiei, in Romania, anzi fra i monti Carpazi, là dove c’era un ebraismo remoto, distante da tutto nel tempo e nello spazio, quasi millenario. Un ebraismo di campagna e di montagne, fatto più di silenzi che di parole. Wiesel aveva attraversato l’infanzia insieme allo yiddish e a un chasidismo dolce, mite, condito di un umanesimo spontaneo, fatto di parole antiche. Aveva studiato tanta Torah, sia con il padre sia con la madre.
Nel 1944 lui, tutta la sua famiglia e la comunità ebraica erano stati rinchiusi nel ghetto. Anticamera di quello sterminio che da un campo all’altro, da una forca all’altra si portò via tutto il suo mondo. Dopo la guerra Wiesel cominciò a peregrinare: da un luogo all’altro, da una lingua all’altra, da una solitudine all’altra. Incominciò a scrivere, come giornalista e traduttore. Studiò il francese. Nel 1955 si trasferì a New York, ma in fondo ha continuato per tutta la vita a viaggiare fra le sue diverse esistenze, fra le sue lingue - yiddish, romeno, inglese, francese, ebraico -, a muoversi dentro il proprio passato, ad abitarlo con le parole, raccontarlo nello strazio, riviverlo nella consapevolezza che trasmettere la storia di quel male fosse una missione imprescindibile. Un dettato: non divino ma umano.
Ci mise però molti anni a raccontare. Diversamente da Primo Levi che, appena tornato a casa da Auschwitz sentì impellente il bisogno di scagliare sulla pagina quella esperienza, come unica strada per provare a ricominciare a vivere, Wiesel tacque per almeno dieci anni: non voleva né scrivere né parlare di quello che aveva attraversato durante la Shoah. Ma quando cominciò fu un fiume in piena, in yiddish, Un di velt hot geshiving (E il mondo tacque, una specie di immensa bozza di autobiografia sulla quale sarebbe poi tornato varie volte, affinando la scrittura, rendendo tutto via via più lucido. Da quelle originarie 900 pagine fu tratto La notte, uscito nel 1992 nella meritoria traduzione italiana di Daniel Vogelmann per La Giuntina editrice.
Da questo libro in poi, Elie Wiesel è diventato uno dei grandi cantori di quell’orrore. Ma è stato anche molto altro. Intellettuale militante, sempre pienamente coinvolto nell’attualità, sempre in dialogo con le grandi questioni del presente. E quando parlava, la sua voce aveva sempre uno spessore tutto particolare, fatto di impegno e pacatezza, di profonda partecipazione alla vita. Non a caso non vinse mai il Nobel per la Letteratura, ma nel 1986 ebbe quello per la Pace. Undici anni dopo gli fu offerta la carica di Presidente dello Stato d’Israele, ma declinò, cedendo così il passo a Shimon Peres.
Eppure Elie Wiesel è stato tutt’altro che un’icona, una figura «statica» dall’aura spirituale carica di sacralità. La sua vera cifra, come uomo e come scrittore, è l’umanità nel senso più pieno e anche più contraddittorio. Ricco di quelle contraddizioni che raccontano una complessità ricca di sfumature, capace di sfuggire sempre alle semplificazioni. Lui che era nato in un mondo ebraico così conservatore, così ai margini storici e geografici, divenne un ebreo cosmopolita, capace di abitare lingue e spazi diversi: un cittadino del mondo. Si era formato in un ebraismo tradizionale, era cresciuto dentro la Torah e dentro il pietismo chasidico cui era rimasto in un certo senso fedele per tutta la vita, come testimoniano i suoi tanti scritti dedicati a quel mondo scomparso, da Il Golem. Storia di una leggenda alle Celebrazioni chasidiche. Aveva scritto anche tanto di Bibbia e Talmud, aveva una intimità profonda e spontanea al tempo stesso con tutta la tradizione d’Israele.
Eppure come pochi altri intellettuali aveva sfidato la fede, aveva sfidato Dio. Vuoi quando lo vede con rabbia e rassegnazione e un dolore indicibile appeso alla forca nel corpo di un bambino impiccato che lancia al mondo i suoi ultimi palpiti. Vuoi quando scrive Il processo di Shamgorod: un testo bellissimo e terribile sull’assenza di Dio, sull’ingiustizia del mondo, dove, a differenza del biblico Giobbe, all’uomo non resta rassegnazione ma solo un’interrogazione senza risposta. E uno sgomento muto di fronte al male, alla sua presenza così incomprensibilmente invadente.
Elie Wiesel è stato un grande testimone, un grande scrittore, uno straordinario uomo di spirito, e anche di azione. Ma è stato soprattutto una figura dalla complessità straordinaria, mai arreso di fronte all’incomprensibile, mai stanco di interrogare e interrogarci. Ci mancherà la sua parola. Ci mancherà la sua notte. Ci mancherà quel silenzio abissale che stava sempre lì, tra una riga e l’altra di testo.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Addio a Elie Wiesel, mai in silenzio di fronte al male Nobel per la pace, sopravvisse alla Shoah e ne raccontò l’orrore.3 luglio 2016, di Federico La Sala
Addio a Elie Wiesel, mai in silenzio di fronte al male
Nobel per la pace, sopravvisse alla Shoah e ne raccontò l’orrore
di Redazione ANSA *
E’ morto Elie Wiesel. Nobel per la pace e sopravvissuto alla Shoah, aveva 87 anni. Lo ha annunciato Yad Vashem da Gerusalemme.
Eliezer "Elie" Wiesel era nato il 30 settembre del 1928 in Romania a Sighet. Autore prolifico (57 libri) e attivista dei diritti umani, Wiesel è stato conosciuto in tutto il mondo per la promozione dell’educazione e del memoria della Shoah. Il suo libro di memorie ’Notte’ basato sulla sua esperienza da ragazzo nel campo di sterminio di Auschwitz è uno dei racconti più importanti sull’Olocausto.
Quando gli fu assegnato il Nobel fu definito "messaggero per l’umanità" e il suo lavoro per la causa della pace un potente messaggio di "pace, di espiazione e di dignità umana" alla stessa umanità. Educato in una famiglia religiosa su di lui ha avuto grande influenza il nonno materno Dodye Feig come ha ricordato in molti libri lo stesso Wiesel.
Dopo la guerra Wiesel si trasferì in Francia dove cominciò a collaborare con diversi giornali israeliani tra cui Yediot Ahronot. Per oltre 10 dieci non volle scrivere della sua esperienza nella Shoah, ma fu decisivo l’incontro con Francois Mauriac e nacque ’Notte’. Nel 1955 Wiesel si trasferì negli Usa e prese la cittadinanza Usa. Nel 1986 il Nobel per la Pace per il suo impegno contro il razzismo e la violenza.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- "Oro dentro". La vita esemplare di Fabio Maniscalco, archeologo in trincea (di Tomaso Montanari)29 giugno 2016, di Federico La Sala
- C’era un lord in Lucania (Italia): "The Vico road goes round and round to meet where terms begin. Still anappealed to by the cycles and onappaled by the recourses, we fill all serene, never you fret, as regards our dutyful cask... before there was a man in Ireland there was a lord in Lucan " (...).
 E, ancora: nessuno sa che Giambattista Vico, stampata la sua prima “Scienza Nuova”, inviò a Londra, a Isaac Newton una copia del suo capolavoro. E che la "Scienza Nuova" seconda (1730), con la "dipintura" di Domenico Antonio Vaccaro, è un omaggio e una ’risposta’ al lavoro di Shaftesbury (a Napoli, dal 1711 al 1713, anno della sua morte).
E, ancora: nessuno sa che Giambattista Vico, stampata la sua prima “Scienza Nuova”, inviò a Londra, a Isaac Newton una copia del suo capolavoro. E che la "Scienza Nuova" seconda (1730), con la "dipintura" di Domenico Antonio Vaccaro, è un omaggio e una ’risposta’ al lavoro di Shaftesbury (a Napoli, dal 1711 al 1713, anno della sua morte).
La vita esemplare di Fabio Maniscalco, archeologo in trincea
di Tomaso Montanari (Nazione Indiana, 29 giugno 2016)
- (Pubblichiamo l’intervento di Tomaso Montanari letto alla presentazione romana del volume di Laura Sudiro e Giovanni Rispoli, Oro dentro. Un archeologo in trincea: Bosnia, Albania, Kosovo, Medio Oriente, Skira 2015. Nato a Napoli il primo agosto 1965, Fabio Maniscalco, archeologo, è protagonista di una serie di originali, pionieristiche esperienze nella tutela del patrimonio culturale minacciato, sovente offeso, dai conflitti insorti tra la fine del Novecento e i primi anni Duemila. Rielabora e sistematizza le conoscenze sperimentate in Bosnia - Sarajevo in particolare -, Albania, Kosovo, Cisgiordania dando vita a una nuova disciplina, per l’appunto la tutela dei beni culturali nelle aree di crisi, che insieme all’archeologia subacquea diventa per lui materia d’insegnamento all’Orientale di Napoli. Un tumore provocato dall’esposizione all’uranio impoverito durante le missioni nei Balcani lo stronca, a soli quarantadue anni, il primo febbraio 2008.)
Oro dentro. Un archeologo in trincea: Bosnia, Albania, Kosovo, Medio Oriente è un libro che bisognava scrivere: Laura Sudiro e Giovanni Rispoli lo hanno fatto nel migliore dei modi. L’ ‘oro dentro’ del titolo è quello, metaforico, di chi ha il cuore abbastanza grande da spendere la propria vita per salvare un bene comune (proprio quel patrimonio culturale: e cioè la memoria e il futuro, di paesi in guerra). Ma è anche quello, purtroppo letterale, che l’uranio impoverito delle bombe Nato esplose in Kosovo ha fatto penetrare, insieme ad altri metalli, nel corpo in cui batteva quel cuore: fino a ucciderlo. Sono queste le due terribili facce della breve, ma meravigliosa, vita di Fabio Maniscalco.
Se questo Paese avesse ancora un servizio pubblico televisivo, la figura di Fabio (che non ho avuto la fortuna di incontrare di persona, ma che dopo aver letto questo libro mi sembra di conoscere da sempre) dovrebbe essere al centro di un racconto fatto di documentari, rigorose inchieste giornalistiche e (perché no?) anche di fiction capaci di far conoscere a tutti un italiano di cui essere, finalmente, fieri. Un italiano da cui imparare qualcosa.
Questo libro, d’altra parte, fa esattamente questo: anzi, fa qualcosa di più. È sempre raro (ma oggi è rarissimo) che un libro riesca a storicizzare la figura di un contemporaneo senza affogarla nella retorica, o senza ridursi ad un’inchiesta o ad una denuncia. Oro dentro, invece, ci riesce: è come se la materia della nostra vita quotidiana, la nostra cronaca, le nostre esistenze così seriali, simili, piccole e in fondo irrilevanti riuscissero qui ad apparire in una luce esemplare. Si arriva all’ultima pagina commossi, e profondamente turbati: ma soprattutto pieni di una fiducia rinnovata nelle possibilità di ognuno di noi.
Laura Sudiro e Giovanni Rispoli sono riusciti a trasmetterci il messaggio essenziale della vita di Fabio Maniscalco: e quel messaggio è che un singolo individuo può fare la differenza. Sempre: e - pensate! - perfino in Italia. Anche di fronte a sistemi corrotti e impermeabili (la nostra povera università), o ben decisi a non farsi cambiare (l’esercito): e perfino nel fuoco di terribili conflitti armati, mossi spesso da interessi imperscrutabili, giocati così in alto sopra le nostre teste.
Questo libro, dunque, fa quello che dovrebbero fare la scuola, o per l’appunto l’università: farci capire (quando siamo ancora in tempo) che la nostra vita è preziosa, importante. Forse essenziale. Può essere il granello che finalmente inceppa la macchina del sistema. Può essere quel millimetro in più che riesce a fare saltare lo stato delle cose. Può lasciare un segno. Può fare, davvero, la differenza.
Fabio cresce a Napoli, dove la progressiva distruzione del patrimonio artistico pare - come molte altre cose - fatale, irreversibile, immutabile. Se crolla un Lungarno nella mia Firenze (giustamente) il mondo tiene il fiato sospeso: ma se l’ennesima chiesa storica della Napoli in cui ho scelto di insegnare sprofonda nell’ennesima voragine, la notizia non arriva nemmeno al telegiornale regionale. Non inganni la propaganda di Pompei che rinasce e della Reggia di Caserta che risplende: chiunque vive in Campania conosce il vero stato delle cose.
Ma Fabio - che lo conosce come nessuno - non si arrende, e non si abitua: studia, invece. E non per fuggire: ma per cambiare le cose. A Napoli succede. C’è un bellissimo film (La seconda natura, di Marcello Sannino) che racconta l’esperienza di Gerardo Marotta e dell’Istituto di studi filosofici di Napoli. «La rivoluzione si fa studiando»: è questa la frase chiave del film. È questo l’unico modo di uscire dalla nostra condizione servile di uomini ad una sola dimensione - quella economica. L’unico modo di combattere e cambiare una classe dirigente dominata - dice Marotta - dalla «regina Ignoranza».
La voce profetica di Marotta e la testimonianza eroica di Fabio Maniscalco arrivano all’Italia e all’Europa dal luogo da cui meno te lo aspetteresti: dalla Campania, che lo stesso Marotta definisce la pattumiera d’Europa, una regione popolata di ombre, di condannati a morte. È da questa terra - per millenni la più bella e feconda d’Europa -, da questa terra oggi ridotta ad un pozzo di veleni, da questa terra che avrebbe bisogno di tutto, che si alzano queste voci: fragili, e insieme fortissime.
La sua voglia di riscatto spinge Fabio, dopo una laurea in archeologia alla Federico II, ad andare a difendere il patrimonio dove le condizioni sono ancora più estreme: ufficiale a Sarajevo, e poi nel Kosovo. Ed è impossibile non pensare che sia stata la fragilità di Napoli ad insegnare a Fabio l’amore per le fragilità ancora più radicali. A Napoli, uno come Fabio non diventa egoista. Anche se Fabio è tormentato da quello che gli autori chiamano «la spirale del precariato»: una delle abissali vergogne dell’Italia presente. Ma proprio qui, in Italia, Fabio scopre che non ci si salva da soli.
In compenso è da solo, a mani nude, che il tenente archeologo Fabio Maniscalco riesce a fare quello che nessuno Stato sovrano sembra interessato a praticare: attuare l’articolo 7 della Convenzione Internazionale dell’Aja del 1954, che prevede che ogni esercito abbia un nucleo specializzato nella tutela del patrimonio culturale. È un’idea semplice e rivoluzionaria: mettere la conoscenza, la cura, la tutela nell’occhio del ciclone dei conflitti. Frivolezze? Preoccupazioni delle anime belle? No: sacrosanta sollecitudine di chi sa che, passata la guerra, la ricostruzione morale e culturale sarà impossibile se non potrà basarsi su un patrimonio monumentale ancora vivo e condiviso. È la lezione dell’Italia del dopoguerra: e Fabio la ricorda.
Ma Fabio è uno dei pochissimi: sono temi davvero marginali nel discorso pubblico. E la pubblica opinione non ha strumenti per giudicare. Per esempio, i caschi blu dell’arte voluti dal ministro Franceschini e accolti dall’Unesco sono una soluzione, o sono solo l’ennesimo spot? Quanto avrei voluto leggere un editoriale di Fabio Maniscalco, per poterlo capire!
E intanto nessuno ne parla. Fa impressione ricordarlo oggi, di fronte alle devastazioni dei barbari del sedicente Stato Islamico, ma anche gli stati europei - anche l’Italia - hanno contribuito, direttamente o indirettamente, alla distruzione di un’enorme fetta del patrimonio culturale del Kosovo. Lo sappiamo? Esiste qualche organo di stampa che sia interessato a denunciarlo, a documentarlo, a ricordarlo? Pare di no.
Fabio Maniscalco lo sapeva, e per anni ha combattuto con tutte le sue forze: andando sul campo, documentando, fotografando, studiando, fondando osservatori, scrivendo ai governi, mobilitando la pubblica opinione. Un archeologo, uno studioso, un soldato: ma prima un cittadino. Un cittadino esemplare.
Dietro tutto questo c’era una convinzione profonda: lottare per il patrimonio, significa lottare per i diritti fondamentali, per la salute psichica e fisica delle persone. Anche questa è una lezione imparata a Napoli: il veleno nella terra e la distruzione dei monumenti sono due facce della stessa medaglia. Quando dalla terrazza della Reggia di Carditello, devastata fino a poco tempo fa dalle razzìe della Camorra, si alza lo sguardo verso la campagna si vede un turbine di gabbiani: che non segnala il mare, ma la discarica di Maruzzella, criminalmente realizzata su un terreno acquitrinoso in cui il percolato penetra fino alla falda, avvelenando i frutteti circostanti, e compromettendo per decenni la catena alimentare, e dunque l’uomo. In questa distruzione simultanea dell’ambiente, del paesaggio, e del patrimonio storico e artistico pare di scorgere davvero «il cadavere della patria» (per usare un’espressione che Raffaello adoperò per descrivere la Roma classica devastata dai pontefici medioevali), cioè il volto sfigurato dell’Italia.
Fabio Maniscalco l’aveva capito: la lunga guerra per l’ambiente (usiamo un’espressione di Elena Croce), la lunga guerra per il patrimonio culturale, è anche la guerra per la nostra salute fisica e mentale. Come in un mito antico e crudele, Fabio ha sperimentato questa intima unione sulla propria pelle, fino a morirne: non basta essergli grati, bisogna proseguire il suo lavoro.
Aver scritto questo libro è stato il primo passo per farlo. Ora tocca a noi.
- C’era un lord in Lucania (Italia): "The Vico road goes round and round to meet where terms begin. Still anappealed to by the cycles and onappaled by the recourses, we fill all serene, never you fret, as regards our dutyful cask... before there was a man in Ireland there was a lord in Lucan " (...).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- RESTARE SVEGLI. La notte europea. Brexit, l’eredità della signora Thatcher (Franco Berardi Bifo)28 giugno 2016, di Federico La Sala
La notte europea
Brexit, l’eredità della signora Thatcher
Coup de dés
di Franco Berardi Bifo ( Opera Viva, 27 giugno 2016)
Non so se l’Unione europea sopravviverà al referendum britannico.
In ogni caso l’unione europea è già morta nel cuore delle persone decenti da quando Alexis Tsipras venne pubblicamente umiliato, e con lui Syriza e l’intero popolo greco che nel luglio del 2015 aveva votato al 62% contro l’austerità. La prima osservazione dopo il referendum inglese è proprio relativa alla differenza di trattamento che le autorità europee riservano a chi è forte e a chi è debole. Nel 2011 Georgy Papandreou fu costretto alle dimissioni per avere ventilato l’ipotesi di un referendum sul memorandum della Troika. Nel 2015 Tsipras fu costretto a rimangiarsi i risultati del referendum del 5 luglio e presentarsi in mutande davanti al tribunale della finanza europea.
Da quando l’autonomia sociale è stata messa a tacere dal tradimento della sinistra e dalla precarizzazione del lavoro, gli attori della tragedia europea sono rimasti due soli: il sistema finanziario globalizzato e il nazionalismo razzista, e questi si fronteggiano ora senza più mediazioni. La società è scomparsa, il movimento dei lavoratori è scomparso. Restano i banchieri ed i nazisti. Ma chi è responsabile di questa situazione?
Il principale responsabile di questa situazione è il ceto della sinistra che da decenni si è prestato a fornire alla dittatura finanziaria il consenso dei lavoratori. Perché mai questi mediocri individui che si chiamano Blair D’Alema Hollande, Renzi perché mai quel ceto di burocrati si sono prestati a tradire in modo sistematico gli interessi e le attese di coloro che li hanno votati e che pagano loro uno stipendio, è un argomento che gli storici dovranno approfondire prima o poi. Ignoranza, subalternità psicologica e politica, pura e semplice mascalzonaggine sono le spiegazioni che mi vengono in mente. Intanto li dobbiamo ringraziare per avere prodotto insieme l’impoverimento della società, il potenziamento senza controllo del sistema bancario, e la resurrezione di quello che un tempo si chiamava nazional-socialismo su una scala mai vista prima.
Il referendum del 2005 suonò il campanello d’allarme. I lavoratori francesi e olandesi non dissero di no al progetto di unità europea, né alla Costituzione che doveva sancire quel progetto. Dissero no alla trasformazione dell’Unione in una macchina di precarizzazione del lavoro, e di generale abbassamento del salario. La sinistra finse di non sentire quel campanello, ne ignorò il significato e l’intenzione, e pensò di poter salvare la pace distruggendo la giustizia. Non poteva che finire come sta finendo.
Il progetto europeo conteneva in origine elementi di solidarietà sociale e di internazionalismo, e forse un progetto simile non poteva realizzarsi senza aver fatto i conti con l’eredità di cinquecento anni di colonialismo europeo. Solo avviando un processo di redistribuzione della ricchezza, solo creando le condizioni per l’accoglienza di milioni di persone che fuggivano dalla miseria e dalle guerre prodotte dall’ordine coloniale si sarebbe potuto avviare un processo di integrazione. Ma la sinistra non ha voluto affrontare questo problema epocale, e i conti con il colonialismo si fanno adesso nella maniera più spaventosa.
L’Unione europea si è trasformata in una fortezza, ha chiuso le frontiere esterne e affermato il primato del capitale finanziario nelle frontiere interne.
Ecco le conseguenze: il razzismo diviene forza di maggioranza in larga parte del continente, e vince un referendum nel baluardo inglese del neoliberismo. Quanto a lungo durerà la notte europea non possiamo dirlo. Quel che possiamo dire è che la notte finirà soltanto quando il movimento dei lavoratori si ricomporrà su basi europee e porrà al primo posto la redistribuzione della ricchezza tra il nord e il sud del mondo, e affermerà l’autonomia del sapere dal paradigma dell’accumulazione e della crescita.
Per quanto mi riguarda non credevo nella Brexit: non credevo che una maggioranza dei cittadini di quel paese avrebbe detto col voto che sta dalla parte dell’assassino nazista che ha ucciso Jo Cox. Ma al tempo stesso occorre riconoscerlo: i lavoratori inglesi, convertiti al nazionalismo non hanno fatto che ribadire il no franco-olandese del 2005.
I lavoratori inglesi che hanno massicciamente votato per la Brexit hanno preso un abbaglio colossale: l’aggressione anti-sociale del neoliberismo è iniziata proprio nel paese di Margaret Thatcher. Il nemico dei lavoratori inglesi non è l’Europa, ma l’eredità di Margaret Thatcher. Non l’Inghilterra doveva uscire dall’Unione Europea, ma l’Unione europea doveva liberarsi del male inglese. Purtroppo è tardi per farlo, perché l’Unione europea, dopo avere contratto il male inglese, è da tempo ridotta a un dispositivo di impoverimento della società, precarizzazione del lavoro e concentrazione del potere nelle mani del sistema bancario. Gran parte delle motivazioni che hanno portato i lavoratori inglesi a votare per la Brexit sono perciò comprensibili nonostante tutto.
E adesso? Ci occorre forse più Europa politica come dicono ritualmente le sinistre al servizio delle banche? Ciò che occorre alla società europea non è più politica, ma una politica diversa, una politica che metta al centro l’autonomia dei saperi - non la privatizzazione della ricerca e dell’educazione. Una politica di riduzione del tempo di lavoro e di redistribuzione delle risorse.
Esistono le condizioni perché accada questo? Non esistono - lo sappiamo bene - perché il tradimento della sinistra e l’indebolimento strutturale del movimento del lavoro ha ristretto il campo del possibile all’alternativa mostruosa tra l’assolutismo finanziario e il sovranismo nazionalista e razzista. Ma siccome la crisi europea è destinata a sconvolgere per anni la vita quotidiana e anche disgraziatamente a rendere la pace civile sempre più fragile - il compito che ci attende nel tempo che viene è quello di tradurre in termini post-leninisti la vecchia consegna: trasformare la guerra imperialista in guerra civile rivoluzionaria.
Cent’anni dopo l’Ottobre sovietico mi sembra che il compito di chi pensa senza dogmi sia chiedersi: cosa vuol dire Ottobre nell’epoca di internet, nelle condizioni del lavoro cognitivo e precario? Durante la notte che scende sull’Europa dobbiamo restare svegli per rispondere a questa domanda.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Londra e la società aperta. Per ritornare a nutrire un po’ di speranza occorre probabilmente rivolgersi alla filosofia.26 giugno 2016, di Federico La Sala
Se Londra mette in discussione l’idea di libertà
di Massimiliano Panarari (La Stampa, 26.06.2016)
E terremoto è stato. Così, se la Brexit è il combinato disposto di una serie di nuove fratture sociali e politiche (oltre che anagrafiche) e di leadership miopi e dal fiato corto, per ritornare a nutrire un po’ di speranza occorre probabilmente rivolgersi alla filosofia. Nel senso letterale del termine, quello del pensiero, che in Gran Bretagna, nelle sue manifestazioni più alte, ha sempre riconosciuto la centralità della libertà.
Ora, voltare le spalle a un’Europa considerata terra di regolamentazioni e burocrazia ossessive, come hanno voluto fare i votanti del «Leave», può legittimamente venire ritenuta come una rivendicazione di libertà. Ma proprio la migliore filosofia britannica contiene una nozione di libertà alternativa, fondata su un’idea dell’interrelazione e dell’interdipendenza - oltre che della responsabilità - di qualità assai differente dalla volontà solipsistica di bastare a se stessi.
Una visione, che si identifica nel liberalismo inglese capace di confrontarsi con quello continentale, nella cui elaborazione la libertà è salvaguardia dell’individuo da qualunque forma di coercizione - compreso il potere delle maggioranze - ed espansione delle libertà positive e dei diritti (la cui contrazione sta infatti pesando molto, in negativo, sulla fiducia nel futuro dei cittadini-elettori occidentali).
Un liberalismo positivo per il quale, ancora, la democrazia è sempre stata governo di opinione e un insieme di contrappesi e garanzie rispetto alle ingerenze di uno Stato prevaricatore, ma nella piena consapevolezza dell’utilità dell’intervento pubblico per correggere le storture - precisamente come servirebbe oggi di fronte alle domande sociali pressanti che vengono da ceti medi impoveriti e da classi popolari che non riescono a beneficiare della globalizzazione, accomunati dalla richiesta di sicurezza e di politiche efficaci in materia di immigrazione.
La politica inglese ha sempre vissuto di un’oscillazione tra l’egoismo nazionalista (derivante anche dalla condizione di insularità) e una grande apertura (legata al suo essere una potenza marittima e commerciale). In questi giorni, malauguratamente, il pendolo si è fermato sul primo di questi poli e, allora, di fronte agli spaventati calcoli di corto respiro possiamo provare a rivolgerci ai pensieri lunghi. Perché, giustappunto, le matrici della filosofia inglese sono il pragmatismo, da un lato, e il realismo empirico (l’adesione al dato di realtà, e il confronto serrato con la scienza), dall’altro.
Tutta la grande, e varia, tradizione del liberalismo britannico - da John Locke ad Adam Smith e Jeremy Bentham, da John Stuart Mill ai positivisti, da Bertrand Russell a Karl Popper (appunto non inglese di nascita) - si è ritrovata nel concetto di società aperta. A sua volta indissolubile dall’idea del mercato, che ha bisogno del talento, mentre alla politica spetterebbe il compito di ridurre la forbice delle disuguaglianze e scongiurare, coi fatti, il dilagare del senso di esclusione.
È di qui che il pensiero liberale deve ripartire per riaprire le frontiere (mentali e geografiche): rilanciando la battaglia per l’allargamento dei diritti, che valgono per tutti e non sono in competizione reciproca. E, così, aumenteranno le chances - e l’appeal - di realizzare una società dell’inclusione.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- «Il paradosso dell’inglese che resta la lingua ufficiale nei palazzi a Bruxelles».26 giugno 2016, di Federico La Sala
- ROMA BRUCIA. GRAZIE AL "TIMES" PER L’ALLARME, MA LONDRA NON RIDA (E ABBIA MIGLIOR CURA DI FREUD). L’incendio è generale. Un omaggio alla Sapienza di Oxford
«Il paradosso dell’inglese che resta la lingua ufficiale nei palazzi a Bruxelles»
di Dino Messina (Corriere della Sera, 26.06.2016)
«La “Brexit” - dice il professor Giovanni Iamartino, presidente degli anglisti italiani - ha prodotto un paradosso: l’inglese continuerà a essere la lingua più importante dell’Europa, così come lo è nel resto del mondo, mentre la Gran Bretagna è fuori».
Sarà così anche nei palazzi delle istituzioni a Bruxelles e a Strasburgo?
«Le regole dell’Ue prevedono che i documenti ufficiali vengano tradotti in tutte le lingue dell’Unione, mentre le discussioni si svolgano in inglese, tedesco o francese. È difficile che la situazione cambierà e che l’inglese venga bandito come lingua, perché, mi scusi il bisticcio, l’inglese non è più degli inglesi».
Che cosa pensano i suoi colleghi, italiani e inglesi, della Brexit?
«Sono tutti scioccati e si strappano le vesti. Una collega mi ha scritto sconsolata: d’ora in poi per consultare un libro alla British library ci chiederanno il visto? Ma al di là dei professori, pensi a tutti gli studenti dell’Erasmus che non potranno più andare in Inghilterra. Una vera rivoluzione nel nostro costume».
Ne risentirà anche la ricerca?
«Sicuramente. Cesseranno i finanziamenti europei verso i dipartimenti delle grandi università britanniche. I colleghi di Oxford, Cambridge e di altre prestigiose istituzioni erano bravissimi a chiederli e a ottenerli».
Forse è per questo che tra i giovani e i laureati ha vinto il voto favorevole al Remain...
«Sì, ma non è bastato. Si è affermato lo spirito interpretato da una famosa battuta di fine Ottocento: nebbia nella Manica, il continente isolato. I risultati del referendum sono la prova che gli inglesi si ritengono superiori al resto del mondo».
Irlandesi del Nord e scozzesi non sono d’accordo...
«Nell’Irlanda del Nord protestante potrebbe ripetersi quel che è già avvenuto nella cattolica Scozia: un referendum per staccarsi dalla madre patria e restare in Europa... E anche in Scozia, nonostante nel recente referendum i separatisti siano stati sconfitti ci potrebbero essere ripercussioni».
Quale personaggio letterario oggi sarebbe contento per l’affermazione della Brexit?
«C’è un personaggio inventato agli inizi del Settecento dal giornalismo inglese che si chiama John Bull: la perfetta incarnazione dello scetticismo, del sano buon senso, del patriottismo, del malcelato disprezzo inglese nei confronti dello straniero. Un po’ saggio, un po’ ottuso».
E quale sarebbe invece oggi addolorato?
James Boswell nella sua biografia del critico Samuel Johnson, fa dire al suo protagonista che il perfetto gentiluomo inglese, per dirsi tale, deve aver viaggiato nei Paesi del Mediterraneo, culla della civiltà occidentale. Se invece vogliamo restare nella fiction, al di là dei personaggi di Shakespeare, penserei a David Copperfield di Charles Dickens, un orfano che prima di ottenere il suo riscatto viaggia in lungo e in largo per l’Europa».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- JOHANN W. GOETHE, VIAGGIO IN ITALIA (1816/2016)25 giugno 2016, di Federico La Sala
"VIAGGIO IN ITALIA" (BICENTENARIO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRIMO VOLUME -1816/2016). *
Il 5 marzo 1787, Johann W. Goethe è a Napoli:
"Debbo darvi qualche breve ragguaglio di carattere generale circa un uomo egregio che ho conosciuto in questi giorni: il cavalier Filangieri, noto per il suo libro sulle legislazioni. Dal suo contegno traspare il decoro del soldato, del cavaliere e dell’uomo di mondo, temperato però dall’espressione d’un delicato senso morale diffuso in tutto il suo essere e che emana bellamente dalla parola e dal gesto (...). Egli non tardò a intrattenermi su uno scrittore d’altri tempi, nella cui insondabile profondità questi moderni italiani, amici delle leggi, trovano edificazione e conforto; il suo nome è Giovan Battista Vico, e lo tengono per superiore a Montesquieu. Da una rapida scorsa al suo libro, che mi fu consegnato come una reliquia, ho avuto l’impressione che vi siano esposti sibillini presagi del bene e del giusto, il cui avvento è previsto o prevedibile, sulla base di severe meditazioni intorno a ciò che ci è stato tramandato e a ciò che vive. E’ molto bello per un popolo possedere un tal patriarca; un giorno i tedeschi avranno in Hamann un breviario non dissimile".
Pochi giorni dopo, il 23 marzo 1787, insieme con C. H. Kniepp, un valente disegnatore, è a Paestum. Il nuovo direttore degli scavi, Gabriel Zuchtriegel, con l’iniziativa “Goethe nel tempio”, riannoda i fili della storia e rilancia la necessità di portare avanti i lavori e salvaguardare l’intera Città.
*
NEL BICENTENARIO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRIMO VOLUME DEL “VIAGGIO IN ITALIA” (1816) DEL FIGLIO, Johann Wolfang Goethe, UNA OTTIMA PRECISAZIONE (NON SOLO PER CASTELLANETA, PENSO) SUL “VIAGGIO IN ITALIA” (1740) DEL PADRE, Johann Kaspar Goethe, E SULL’IMPORTANTE RUOLO GIOCATO NELLA VICENDA (SIA SUL LATO DEL PADRE SIA SUL LATO DEL FIGLIO) DALLA FIGURA DELLO STUDIOSO PUGLIESE, DOMENICO ANTONIO GIOVINAZZI:
"Un italiano avanti negli anni e simpatico, maestro di lingua, di nome Giovinazzi, lo aiutava in questo lavoro [la stesura del Viaggio in Italia]. Inoltre il vecchio cantava discretamente e mia madre aveva preso l’abitudine di accompagnarsi ogni giorno con lui al pianoforte, sicché ben presto io venni a conoscere l’esistenza di Solitario bosco ombroso, e lo imparai a memoria prima ancora di capirne il significato" (Johann W. Goethe, Dichtung und Wahrheit, parte I, cap. I).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- E’ TEMPO DI CAMBIARE. L’uscita della Gran Bretagna dall’UE non è uno scherzo. Salviamo l’Europa, adesso!24 giugno 2016, di Federico La Sala
- ROMA BRUCIA. GRAZIE AL "TIMES" PER L’ALLARME, MA LONDRA NON RIDA (E ABBIA MIGLIOR CURA DI FREUD). L’incendio è generale. Un omaggio alla Sapienza di Oxford
I cittadini europei riprendano il progetto europeo tra le proprie mani
Salviamo l’Europa, adesso!
Domenica 9 ottobre marciamo da Perugia ad Assisi per costruire una nuova Europa solidale e nonviolenta *
Non è uno scherzo. E’ la vittoria dell’egoismo, della paura e del nazionalismo. L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea è un eccezionale terremoto politico ed economico che cambia la storia dell’Europa e del mondo. Le sue conseguenze sono immense. Ora si apre un periodo difficilissimo che aggiunge instabilità ad instabilità.
I responsabili di questo disastro sono da ricercare tra tutti quelli che hanno spento il sogno europeo di pace, prosperità e diritti umani.
Da decenni chiediamo ai responsabili dei governi e delle istituzioni dell’Europa di cambiare strada, di rimettere al centro le persone e il lavoro dignitoso, di promuovere equità e giustizia, inclusione sociale e sviluppo sostenibile. Lo abbiamo fatto con tutta l’energia e la passione che abbiamo avuto a disposizione. Senza essere ascoltati.
Ma un’Europa che abbandona i suoi cittadini in difficoltà, un’Europa stanca e rassegnata, senza un forte progetto, incapace di rispondere alla crisi economica, ai grandi drammi delle guerre e delle migrazioni, prigioniera di lobby irresponsabili, non ha futuro.
E senza l’Europa anche per l’Italia sarà tutto più difficile. Per questo è urgente cambiare. Chi si ostina a non sentire, deve farsi da parte!
C’è stato un tempo in cui i cittadini europei si sono uniti contro il pericolo di guerra atomica e la mancanza di libertà e sono riusciti a far cadere il muro di Berlino e a mettere fine a cinquant’anni di guerra fredda. E’ tempo che i cittadini europei riprendano il progetto europeo tra le proprie mani e costruiscano una nuova Europa.
Dopo il grande dibattito sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea è indispensabile aprire il grande dibattito sull’Europa che vogliamo, i nostri valori, la sua ragione di esistere in un mondo sempre più complesso, globalizzato e interdipendente, i nostri interessi comuni, il nostro ruolo nel mondo.
Lo abbiamo detto mille volte e lo ripetiamo ancora: è tempo di cambiare! Con coraggio e lungimiranza. Per questo invitiamo tutti a partecipare alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità del prossimo 9 ottobre. Ri-uniamo tutte le energie positive. Riflettiamo sulle cose che dobbiamo fare ma poi rimettiamoci in cammino. Insieme. Per una nuova Europa solidale e nonviolenta.
Flavio Lotti, Coordinatore della Tavola della pace
Perugia, 24 giugno 2016
 Tavola della Pace
Tavola della Pace
 Cell. 3356590356 - segreteria@perlapace.it
Cell. 3356590356 - segreteria@perlapace.it
 www.perlapace.it - www.perugiassisi.org
www.perlapace.it - www.perugiassisi.org -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - BREXIT. La Gran Bretagna esce dall’Unione europea. Cameron si dimette. Oltre 17 milioni di sudditi di sua maestà (51,89%) hanno votato a favore.24 giugno 2016, di Federico La Sala
La Gran Bretagna esce dall’Unione europea. Oltre 17 milioni di sudditi di sua maestà (51,89%) hanno votato a favore del Brexit. *
- Remain: 16.141.241 (48.11%)
- Leave: 17.410.742 (51.89%)
Affluenza molto alta al referendum (72,2%), che dopo i conteggi della notte ha consegnato un verdetto storico, che ora quasi sicuramente scatenerà un effetto domino per tutto il continente. Diverse forze anti-europeiste infatti hanno già chiesto il referendum sull’Unione.
Sterlina ai minimi storici, crollo delle borse mondiali.
La Banca d’Inghilterra assicura che prenderà “tutti i passi necessari per la stabilità finanziaria e monetaria”.
Il leader dell’Ukip, Nigel Farage, ha chiesto le dimissioni del premier David Cameron: “E’ il nostro giorno dell’indipendenza, una vittoria della gente vera, una vittoria della gente ordinaria, una vittoria della gente per bene”.
Preoccupazioni anche per la tenuta del Regno Unito, visto che Scozia e Irlanda del Nord hanno votato massicciamente a favore dell’adesione all’Europa. Lo Scottish National Party (Snp) si prepara in ogni caso a chiedere a Westminster di partecipare al negoziato tra Regno Unito e Ue per il ritiro. E’ altamente probabile che contestualmente sarà richiesta la possibilità di un secondo referendum limitato alla sola Scozia. Alex Salmond (Snp): “L’esito del referendum cambia completamente tutto il contesto dell’indipendenza scozzese.
Secondo i trattati l’uscita di Londra andrà ora negoziata con l’Ue ma la trattativa e l’uscita definitiva dovrebbe concludersi entro due anni (salvo proroghe).
Non è escluso che in questo lungo processo di uscita, la Scozia scelga di tenere un nuovo referendum definitivo sulla permanenza o no nell’Ue a differenza del Regno Unito.
Critiche all’interno del Labour anche per il leader Jeremy Corbyn, a favore del Remain. Il Guardian parla di manovre rapidissime dietro le quinte per votare la sfiducia al segretario e costringerlo alle dimissioni.
Previste per la mattinata riunioni in tutte le cancellerie del mondo.
Rinviata a data da destinarsi la direzione del Partito democratico che era stata convocata per oggi dopo la sconfitta alle elezioni comunali.
Si è tenuta questa mattina presso la Sala Situazioni della Presidenza del Consiglio una riunione convocata da Matteo Renzi. Alla riunione hanno partecipato il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, il Ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Marco Minniti (servizi segreti) e il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco.
Alle 11.30 conferenza stampa a Parigi di Marine Le Pen (in Francia le presidenziali si terranno l’anno prossimo). La leader del Fronte Nazionale ha già chiesto l’indizione di un identico referendum in Francia e in tutti i paesi Ue che lo vorranno.
Il premier belga Charles Michel ha chiesto la convocazione immediata di un vertice europeo senza la presenza inglese.
Le tre istituzioni che guidano l’Europa (il premier olandese Rutte come presidente di turno, Juncker per la Commissione, Tusk per il Consiglio) si riuniranno oggi alle 10.30.
Convocato nel pomeriggio in Lussemburgo un vertice di tutti i ministri degli Esteri europei.
Nel suo discorso alla nazione, in diretta televisiva (alle 9.20 ora italiana, le 8,20 a Londra), il premier David Cameron ha detto che Galles, Scozia e Irlanda del Nord saranno coinvolte nei negoziati con Bruxelles.
Cameron si dimette da primo ministro e affida al congresso del Partito Conservatore di ottobre la scelta di individuare il suo successore, continuerà a governare per i prossimi tre mesi.
Non azionerà lui, fino ad allora, l’articolo 50 del trattato di Lisbona che dà l’avvio formale al processo di uscita della Gran Bretagna dall’Ue. Non sarà, dunque, il primo ministro che gestirà la Brexit.
* iL MANIFESTO, 24.05.2016 (ripresa parziale).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Hitler secondo l’anarchico Feyerabend. Rileggere senza ipocrisia le pagine più buie della nostra storia (di A. Massarenti).19 giugno 2016, di Federico La Sala
- INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
 C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo. Alcuni appunti sul tema
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo. Alcuni appunti sul tema
Hitler secondo l’anarchico Feyerabenddi Armando Massarenti (Il Sole-24 Ore, Domenica, 19.06.2016)
Dopo la recente affermazione della destra xenofoba in Austria, a un passo dal vincere le elezioni, ho ripensato a ciò che scriveva Paul K. Feyerabend nella sua splendida autobiografia, intitolata Ammazzando il tempo e uscita per Laterza nel 1994, anno della sua morte, a 70 anni di età. Esordiva fin dalle prime pagine avvertendo degli strani scherzi che può fare la memoria: quelli in forza dei quali magari oggi ci si stupisce del rinascere di certe idee che pensavamo del tutto tramontate.
Aveva deciso di scrivere quel libro nel 1988, durante il cinquantenario dell’unificazione tra Austria e Germania. «Ricordavo che gli austriaci avevano accolto Hitler con straordinario entusiasmo, ma ora mi ritrovavo ad ascoltare condanne secche e toccanti appelli umanitari. Non che fossero tutti in malafede, eppure suonavano vuoti: lo attribuii alla loro genericità e pensai che un resoconto in prima persona sarebbe stato un modo migliore di fare storia. Ero anche piuttosto curioso. Dopo aver tenuto lezioni per quarant’anni in università inglesi e americane, mi ero quasi dimenticato dei miei anni nel Terzo Reich, dapprima come studente, poi da soldato in Francia, Iugoslavia, Russia e Polonia».
Persino lui, Paul K. Feyerabend, dunque, già allora quello spirito libero che poi sarebbe divenuto famoso come l’epistemologo dell’anarchismo metodologico, aveva subito una forma di attrazione per il regime, e aveva anche meditato di entrare nelle SS. «Perché? Perché un uomo delle SS aveva un aspetto migliore, parlava meglio e camminava meglio di un comune mortale: le ragioni erano estetiche, non ideologiche». Finalmente un libertario, un democratico capace di non cadere nelle trappole dell’ipocrisia! ho pensato ai tempi leggendo Ammazzando il tempo. E che ci fa capire meglio perché il nazismo potesse attrarre le giovani generazioni. Anche rivedere l’immagine stereotipata di Hitler era per Feyerabend un modo per capire meglio la realtà. Abbiamo visto mille volte spezzoni di documentari che ce lo mostrano come una macchietta in preda all’ira. Si tratta di una precisa scelta della propaganda post-bellica. Feyerabend descrive invece così la sua arte oratoria: «Hitler accennava ai problemi locali e a quanto era stato fatto fino ad allora, faceva battute, alcune abbastanza buone. Gradualmente cambiava il modo di parlare: quando si riferiva a ostacoli e inconvenienti aumentava il volume e la velocità del parlare. Gli accessi violenti che sono le uniche parti dei suoi discorsi conosciute in tutto il mondo erano preparati con cura, ben interpretati e utilizzati con umore più calmo una volta finiti; erano il risultato di controllo, non di rabbia, odio o disperazione».
Ancora oggi, se del nazismo non cerchiamo di capire le ragioni interne, e magari non ci spaventiamo a rileggere Mein Kampf, non sapremo mai perché esso ha appassionato così tante persone. E sarà anche più difficile difendere i nostri valori più cari: libertà, pluralismo, democrazia. Benché l’intelligenza critica di Feyerabend fosse già piuttosto acuta, al punto da commentare la lettura di Mein Kampf (ad alta voce alla famiglia riunita) come un «modo ridicolo di esporre un’opinione», «rozzo, ripetitivo, più un abbaiare che un parlare», egli stesso, pochi giorni dopo, avrebbe concluso un tema scolastico su Goethe legandolo proprio a Hitler. Non solo la memoria collettiva può fare brutti scherzi: anche la nostra attenzione critica è qualcosa di quanto mai fragile. Ma lo è ancora di più se ci rifiutiamo di rileggere senza ipocrisia le pagine più buie della nostra storia.
- INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- I confini del Mein Kampf. Corrado Augias risponde a Sabine Heymann16 giugno 2016, di Federico La Sala
FASCISMO E LEGGI PER LA DIFESA DELLA RAZZA (1938)
- RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. (federico la sala)
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. (federico la sala)
I confini del Mein Kampf
risponde Corrado Augias (la Repubblica, 16.06.2016)
- STIMATO signor Augias, ho letto che un giornale di destra italiano regala il libro di Hitler “Mein Kampf” dicendo che anche in Germania era stato fatto lo stesso. Non è vero. In Germania il famigerato libro non è stato pubblicato per 70 anni. Solo a gennaio di quest’anno, dopo l’estinzione dei diritti d’autore, il prestigioso Institut für Zeitgeschichte di Monaco e Berlino ha presentato un’edizione scientificamente commentata. Questa edizione è stata preparata da anni da un gruppo di storici specializzati. 1966 pagine, corredate da più di 3500 annotazioni che cercano di rendere in evidenza la storia del pensiero di Hitler, le radici, di correggere errori, spiegare riferimenti alla storia contemporanea. Soprattutto intraprendono un confronto tra il programma di Hitler e quello che è stato poi realizzato.
 In Germania l’edizione originale è costata 59 € (tascabile 16,90 €) ed è subito diventato un bestseller; solo all’inizio del mese di maggio, dopo sei mesi è uscito dall’elenco dei dieci libri più venduti. È importante sapere che in Germania la pubblicazione del libro di Hitler è stata preceduta da decenni di un dibattito profondo e vivace sull’opportunità di una sua pubblicazione. Quello che Il Giornale ha fatto adesso, è proprio quello che in Germania non si è voluto fare. Anche se non vedo che questo libro, incomprensibile e poco seduttivo, possa spingere qualcuno a imitare le gesta di Hitler, ma c’è una moralità che va difesa - soprattutto in questi tempi.
In Germania l’edizione originale è costata 59 € (tascabile 16,90 €) ed è subito diventato un bestseller; solo all’inizio del mese di maggio, dopo sei mesi è uscito dall’elenco dei dieci libri più venduti. È importante sapere che in Germania la pubblicazione del libro di Hitler è stata preceduta da decenni di un dibattito profondo e vivace sull’opportunità di una sua pubblicazione. Quello che Il Giornale ha fatto adesso, è proprio quello che in Germania non si è voluto fare. Anche se non vedo che questo libro, incomprensibile e poco seduttivo, possa spingere qualcuno a imitare le gesta di Hitler, ma c’è una moralità che va difesa - soprattutto in questi tempi.
 Sabine Heymann
Sabine Heymann
HO LETTO la prefazione che lo storico contemporaneista Francesco Perfetti (Luiss, Roma) antepone per una dozzina di pagine al volume. Nonostante le dichiarate simpatie politiche del professor Perfetti, la presa di distanza dallo scritto di Hitler è abbastanza netta anche se un tema così sanguinoso avrebbe meritato ben altro approfondimento. Una cautela editoriale comunque fragile. Il volume riproduce in anastatica l’edizione fascista pubblicata (Bompiani) tra il 1934 e il 1937.
C’è la breve prefazione allora scritta ad hoc dal Fuhrer e una “Vita di Adolf Hitler” redatta con molta enfasi. Il tono di questi contributi stabilisce la vera temperatura del volume delineando la figura di un eroe, come del resto l’asservimento dell’Italia fascista al Reich imponeva. Nulla quindi a che vedere con le cautele storico-critiche di ben altra serietà adottate in Germania dopo lungo dibattito.
Non so perché il direttore de Il Giornale abbia preso una decisione di tale gravità. Sono state fatte molte ipotesi che vanno dalla simpatia personale per quei giorni al calcolo elettorale in vista dei ballottaggi. Si tratta di illazioni e non ho elementi per commentarle. So per certo che pubblicare un volume che ha avuto un tale peso criminale nella storia umana comporta una responsabilità morale (come sottolinea anche la signora Heymann) che la frettolosa edizione italiana, a voler essere benevoli, ignora: il 1937 è l’anno che precede la promulgazione delle leggi razziali il cui fondamento si trova in queste pagine.
- RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- LA TEOLOGIA POLITICA DI ERACLITO E "LA CITTA’ DIVISA". Note intorno al capolavoro di Nicole Loraux.15 giugno 2016, di Federico La Sala
- PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986). Un omaggio a Giambattista Vico ....
 LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE .Un’interpretazione dell’intera storia della filosofia, semplicemente straordinaria
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE .Un’interpretazione dell’intera storia della filosofia, semplicemente straordinaria
- RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". (federico la Sala)
SCHEDA *
La città divisa
Nicole Loraux
Neri Pozza Editore, pagg.448, Euro 40,00
IL LIBRO - Questo libro è il capolavoro di Nicole Loraux, la grande antichista francese da poco scomparsa. Esso tenta di ripensare da capo la polis greca, questo modello prestigioso di tutta la tradizione politica occidentale. La scoperta della Loraux è che a fondare la città greca, a fungere da paradigma alla democrazia, non sono né la libertà, né l’unità, né la comunità, ma qualcosa come un paradossale legame attraverso la divisione. Si tratta, cioè, di ripensare Atene sotto il segno della “stasis”, della guerra intestina, che divide e insanguina non solo la città, ma anche, l’”oikos”, la famiglia -o, piuttosto, circola, in un movimento incessante, dalla famiglia alla città, dai fratelli rivali ai cittadini nemici. La guerra civile non è, però, soltanto rottura e anomia, ma costituisce il legame politico segreto che anima e segna profondamente la vita e le istituzioni della democrazia greca, dal giuramento all’amnistia, dalla vendetta alla riconciliazione. Una città divisa deve essere, infatti, capace non solo di ricordare, ma anche di dimenticare, di ricomporre attraverso l’oblio (l’amnistia) l’unità perduta. E a poco a poco, come in ogni grande libro di storia, l’analisi del passato permette di guardare in una nuova luce le divisioni e i conflitti, la memoria e la smemoratezza della società in cui viviamo.
DAL TESTO - “La città degli antropologi [...] non agisce nel tempo dell’evento, ma in quello ripetitivo delle pratiche sociali - il matrimonio, il sacrificio -, in cui fare è ancora un modo di pensare. Di pensare se stessi assegnando (tentando di assegnare) un posto all’altro, a tutti gli altri e, di conseguenza, al medesimo: ricollegando i margini al centro, a quegli “andres” che sono la città ma hanno bisogno, per esempio, delle donne per costituirla veramente. Così il matrimonio fonda la città assicurandone la riproduzione. Dopodiché, una volta costituitasi la “polis” in società umana, la si può situare in rapporto a un altrove. O meglio: di questo altrove, tempo degli dei, mondo selvaggio delle bestie, la città proclama la distanza per meglio farlo, mettendolo al posto opportuno. La città ha assorbito il suo fuori, e il sacrificio fonda la “polis”: lontani dagli dei, ma dotati della cultura, gli uomini sacrificano loro un animale, e questo gesto distribuisce il sistema di esplosioni e integrazioni intorno al nucleo degli “andres”. Dal taglio sacrificale e della sua interpretazione in atto nascerebbe a ogni cerimonia il politico: ugualitario come la condivisione, isomorfo... Diremo anche neutralizzato? Il politico come circolazione immobile, o la città a riposo”.
L’AUTORE - Nicole Loraux (1943-2003) ha insegnato «Histoire et anthropologie de la cité greque» presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales dal 1981 al 1994. Dei suoi numerosi libri, in italiano sono apparsi: “Come uccidere tragicamente una donna” (Laterza, 1988), “Il femminile e l’uomo greco” (Laterza, 1991), “Le madri in lutto”(Laterza, 1991), “Nati dalla terra. Mito e politica ad Atene” (Meltemi, 1998) e “La voce addolorata. Saggio sulla tragedia greca”(Einaudi, 2001).
INDICE DELL’OPERA - Introduzione, di Gabriella Pedullà - Prefazione - La città divisa: sopralluoghi - I. L’oblio nella città - II. Ripoliticizzare la città - III. L’anima della città - Sotto il segno di Eris e di alcuni suoi figli - IV. Il legame della divisione - V. Giuramento, figlio di Discordia - VI. Dell’amnistia e del suo contrario - VII. Su un giorno vietato del calendario ateniese - Politiche della riconciliazione - VIII. La politica dei fratelli - IX. Una riconciliazione in Sicilia - X. Della giustizia come divisione - XI. E la democrazia ateniese dimenticò il “kratos” - Ringraziamenti - La guerra nella famiglia
* http://www.archiviostorico.info/Rubriche/Librieriviste/recensioni6/Lacittadivisa.htm
- PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986). Un omaggio a Giambattista Vico ....
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- IL NAZISMO E LA DEVASTAZIONE DELL’EUROPA. Leggere il Mein Kampf apre gli occhi (di Carlo Rovelli).14 giugno 2016, di Federico La Sala
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
Perché SI
Leggere il Mein Kampf apre gli occhi
Il volume è utile per capire che il centro delle emozioni dell’estrema destra non è essere forti, ma la paura di essere deboli. Il senso di inferiorità spinge a voler dominare gli altri anche attraverso il terrore
di Carlo Rovelli (Corriere della Sera, 14.06.2016)
Il Giornale propone in edicola copie del libro di Hitler, Mein Kampf. Ci sono ragioni per essere offesi o disgustati da questa scelta, e Alessandro Sallusti, il direttore del Giornale, lo dico apertamente, non è persona che mi piace. Eppure mi sono trovato d’accordo con lui quando, forse un po’ goffamente, ha provato a difendere la sua provocazione dicendo che per combattere un male bisogna conoscerlo.
Ho letto Mein Kampf qualche tempo fa, e effettivamente mi ha insegnato delle cose: cose che non mi aspettavo. Provo a riassumerle. Il nazismo è stato un feroce scatenarsi di aggressività. Dalla notte dei lunghi coltelli alla disperata difesa di Berlino, ha cavalcato la violenza estrema. La giustificazione ideologica immediata per la brutalità e la violenza era la superiorità della razza e della civiltà germanica, l’esaltazione della forza, la lettura del mondo in termini di scontro invece che di collaborazione, il disprezzo per chiunque fosse debole.
Questo pensavo, prima di leggere Mein Kampf. Il libro di Hitler è stato una sorpresa perché mostra cosa c’è alla sorgente di tutto questo: la paura. Per me è stata una specie di rivelazione, che mi ha d’un tratto fatto comprendere qualcosa della mentalità della destra, per me da sempre difficile da cogliere. Una sorgente centrale delle emozioni che danno forza alla destra, e all’estrema destra sopratutto, non è il sentimento di essere forti: è la paura di essere deboli.
In Mein Kampf, questa paura, questo senso di inferiorità, questo senso del pericolo incombente, sono espliciti. Il motivo per cui bisogna dominare gli altri è il terrore che altrimenti ne saremo dominati. Il motivo per cui preferiamo combattere che collaborare è che siamo spaventati dalla forza degli altri. Il motivo per cui bisogna chiudersi in un’identità, un gruppo, un Volk, è per costruire una banda più forte delle altre bande ed esserne protetti in un mondo di lupi. Hitler dipinge un mondo selvaggio in cui il nemico è ovunque, il pericolo è ovunque, e l’unica disperata speranza per non soccombere è raggrupparsi in un gruppo e prevalere.
Il risultato di questa paura è stata la devastazione dell’Europa, e una guerra con un bilancio totale di 70 milioni di morti. Cosa ci insegna questo? Penso che quello che ci insegna è che ciò da cui bisogna difendersi per evitare le catastrofi non sono gli altri: sono le nostre paure degli altri. Sono queste che sono devastanti. È la paura reciproca che rende gli altri disumani e scatena l’inferno. La Germania umiliata e offesa dall’esito della prima guerra mondiale, spaventata dalla forza della Francia e della Russia, è stata una Germania che si è autodistrutta; la Germania che, imparata la lezione sulla sua pelle, si è ricostruita come centro di collaborazione e di resistenza alla guerra è una Germania che è fiorita. A me questo insegnamento suona attuale. Forse ora nel mondo la paura reciproca sta aumentando, non lo so, ma a me sembra che noi siamo i primi ad alimentarla. Chi si sente debole ha paura, diffida degli altri, difende se stesso e si arrocca nel suo gruppo, nella sua pretesa identità. Chi è forte non ha paura, non si mette in conflitto, collabora, contribuisce a costruire un mondo migliore anche per gli altri. Pochi libri svelano questa intima logica della violenza come Mein Kampf.
-
>IL NAZISMO E LA DEVASTAZIONE DELL’EUROPA. -- Mein Kampf in edicola, scherzare con il fuoco (E. Collotti) - Non è un libro normale, è un inno allo sterminio (D. Di Cesare)15 giugno 2016, di Federico La Sala
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
Mein Kampf in edicola, scherzare con il fuoco
L’iniziativa de Il Giornale. La scelta di Sallusti non offende solo la sensibilità degli ebrei, come si sente dire da più parti, ma il buonsenso di tutte le persone civili. Al di la della illeggibilità di un testo infarcito delle farneticazioni di un tribuno da operetta che sfruttava il disorientamento di un popolo, ciò che impressiona oggi è l’ingenuità della sua riproposizione come se in esso si trovasse anche l’antidoto ai veleni di cui esso stesso è portatore.
di Enzo Collotti (il manifesto, 14.06.2016)
La trovata de Il Giornale di distribuire il Mein Kampf per aumentare le vendite è semplicemente indecente. Non si capisce se è una trovata spregiudicata o se vuole essere un ammiccamento morboso ad uso di un pubblico sicuramente non avvezzo a bocconi così forti.
Certo non è una lettura neutrale, e il proposito di farne l’introduzione ad una serie di pubblicazioni sul nazismo non rende l’idea meno perversa. Essa sfrutta l’appeal che continua ad avere il Führer in virtù dell’attrazione del mostro ma senza fornire gli strumenti per neutralizzarlo.
È un po’ scherzare con il fuoco, come se in un frangente in cui tornano virulenti populismi e razzismi nelle più diverse matrici ci fosse ancora bisogno di normalizzare l’orrore offrendolo in pasto agli ignari lettori fuori dal contesto in cui il Führer lo concepì e a distanza di quasi un secolo dalla sua originaria pubblicazione.
Un anacronismo, si direbbe, se non fosse che c’è ancora qualcuno che pensa a pulizie etniche, a muri di separazione, a gerarchie di razza, ad egoistici esclusivismi e che potrebbe trovare in un simile oggetto incoraggiamento e argomenti.
Al di la della illeggibilità di un testo infarcito delle farneticazioni di un tribuno da operetta che sfruttava il disorientamento di un popolo uscito dalla sconfitta, dalla catastrofe economica e dalla demoralizzazione e che prometteva con freddo calcolo l’assassinio di milioni di esseri umani, ciò che impressiona oggi è l’ingenuità della sua riproposizione come se in esso si trovasse anche l’antidoto ai veleni di cui esso stesso è portatore.
Il fatto singolare è che mentre in Germania, come cercheremo di spiegare in altra sede, si procede con cautela a ristampare con un’edizione «critica», corredata da un autorevole e anche troppo pignolesco commento di accompagnamento, il testo incriminato, in Italia senza troppi complimenti lo si distribuisce quasi gratuitamente e senza troppo curarsi della sua correttezza non dico filologica ma neppure logica.
Si tratti di una consapevole provocazione o di una operazione mirata e sicuramente male architettata, l’iniziativa de Il Giornale non offende solo la sensibilità degli ebrei, come si sente dire da più parti, ma il buonsenso di tutte le persone civili che sono messe a confronto con uno dei capolavori del pensiero perverso senza essere necessariamente preparati a svelenirne il contenuto.
Sarebbe vano invocare censure, dovremmo contare solo sulle capacità di ciascuno di esercitare la propria censura interna e di avere una cultura e un’educazione storica e politica superiori a quella dei media che insieme al buon senso insidiano la buona fede e la curiosità dello sprovveduto lettore attratto dall’apparente novità nel singolare quanto orrido messaggio.
Mein Kampf
Non è un libro normale, è un inno allo sterminio
di Donatella Di Cesare (Corriere Sera, 14.06.2016)
Hitler non si addice alle edicole. La scelta di «regalare» Mein Kampf come allegato deve essere condannata con grande fermezza da una società civile. Quali che siano i motivi reconditi che possono aver spinto il Giornale a diffondere il libro di Hitler, si tratta di una scelta gravissima, irragionevole e ingiustificabile.
Questo fatto - come ha dichiarato Efraim Zuroff, direttore del Centro Wiesenthal di Gerusalemme - è «senza precedenti». Non stupisce che la stampa internazionale abbia dato rilievo alla notizia. Dalla Frankfurter Allgemeine a Die Welt e al Washington Post , per citare solo alcune testate, lo sconcerto è unanime. E ci si chiede come mai, nell’Italia di oggi, Hitler possa tornare a essere popolare.
Il «regalo» è giunto sabato scorso - per gli ebrei alla vigilia di Shavuot, la festa in cui si ricorda il dono della Torah, il Libro dei libri. Triste coincidenza, dunque, che nelle edicole di un Paese europeo, coinvolto nello sterminio, girasse la «Bibbia del nazismo». Né si può sorvolare su una coincidenza inquietante: solo pochi giorni fa è stata finalmente approvata la legge contro il negazionismo.
Vuoi per richiamo morboso, vuoi per banale interesse, nelle edicole l’allegato è esaurito. Questa sarebbe una operazione culturale? Distribuire il secondo volume del testo di Hitler, intitolato La mia battaglia , nella vecchia edizione Bompiani del 1937? Non è una edizione critica: non ci sono né note, né commenti. Non può farne le veci la breve e discutibile introduzione di Francesco Perfetti, il quale sembra ignorare il successo ottenuto, persino nel mondo accademico tedesco, dall’«antisemitismo della ragione» propugnato da Hitler. L’edizione critica, pubblicata in Germania nel gennaio del 2016, è costituita da due volumi di 2.000 pagine e corredata da ben 3.500 note.
Ma arriviamo al punto. I campioni dell’ultraliberalismo hanno gridato alla censura e si sono appellati alla necessità di leggere Hitler come «documento storico». Qui è bene chiarire: Mein Kampf non è un libro come un altro. Non può essere paragonato ad altri libri antisemiti che hanno propagato e propagano ancor oggi le teorie del complotto. Mein Kampf è il libro che contiene il primo progetto di sterminio planetario del popolo ebraico.
Chi lo ha letto lo sa. E sa giudicare la gravità incommensurabile di quelle pagine che preludono all’annientamento. Per Hitler gli ebrei sono gli «stranieri», che cancellano i confini - quelli geografici e quelli tra i popoli. Distruggono gli altri per dominare il mondo; la loro «vittoria» sarebbe «la ghirlanda funeraria dell’umanità», decreterebbe la fine del cosmo. Il pericolo maggiore viene indicato nella possibile fondazione di uno «Stato ebraico». Perché non ci deve essere luogo alcuno, per gli ebrei, nel mondo. Di qui l’annientamento.
Dare allora queste pagine da leggere senza una guida critica? Certo che occorre conoscere Mein Kampf . E chi responsabilmente si occupa della Shoah lo legge e lo fa leggere. Non era necessario che il Giornale degradasse la cultura italiana per avvertirci che il male si deve conoscere. Noi il male non lo dimentichiamo. Ma siamo convinti che uno studio critico, come quello che d’altronde già si compie in molte università e scuole italiane, sia la strada giusta per conoscere il passato e per guardare con più consapevolezza al futuro.
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- La grande illusione della guerra giusta (di Massimo Cacciari)11 giugno 2016, di Federico La Sala
- CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
In un’epoca di incertezza diffusa in cui Amico e Nemico si scambiano continuamente i ruoli, l’unica strada possibile per sottrarsi alla barbarie è riflettere sulla genesi filosofica della parola “conflitto”. Rileggendo Eraclito
La grande illusione della guerra giusta
Oggi è sparita la dimensione politica degli sforzi bellici: non sappiamo nemmeno per quale pace combattiamo
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 11.06.2016)
- IL LIBRO Questo testo è un estratto del saggio Il tramonto di padre Polemos, contenuto nella raccolta Senza la guerra (Il Mulino, pagg.125, euro 12).
Quando altro non è possibile affermare se non che la forma della guerra si è andata radicalmente modificando e che nessun Sovrano sembra oggi in grado di porla in una qualche forma giuridico-politica, proprio allora, forse, diventa più necessario ritornare a pensare i termini fondamentali del problema. Nulla appare oggi scontato o di per sé evidente; nessun paradigma regge alla esperienza fattuale. Allora tutto dovrebbe reimpo-starsi, appunto, dalle fondamenta. E qui troviamo una parola originaria della nostra civiltà, sul cui sfondo hanno continuato a proiettarsi i diversi e, almeno all’apparenza, contrastanti modi in cui l’Occidente ha detto e fatto la guerra. Essa ritorna per forza propria; noi non facciamo che trarla fuori dal suo “eterno passato”, a farne cioè, letteralmente, esegesi, ogni volta che facciamo la guerra.
Questa parola dice: «Polemos (il Colli non lo traduce; Diano: il conflitto; Marcovich: guerra) è padre di tutte le cose, di tutte è re, e gli uni édeixe (valore gnomico: ha mostrato e sempre mostra) dèi, e gli altri uomini, gli uni epoíese (come prima per édeixe: ha fatto e fa) schiavi, gli altri liberi» (Eraclito). Polemos non “sostituisce” Zeus, ma stabilisce un Principio a tutti gli essenti comune, un Principio cui tutti per necessità obbediscono, anche se non lo sanno, quel Principio che parla nel Logos stesso di Eraclito. Tale Principio è pater, cioè potens, solo esso ha patria potestas effettiva. La sua potenza, cioè, non si manifesta distruggendo, ma ponendo: essa costituisce gli uni come dèi, gli altri come uomini; essa rende gli uni schiavi, gli altri liberi. Il Principio-Polemos genera distinguendo, ovvero tutti accomuna proprio nel costituirli come differenti. Polemos pone gli opposti e tra gli opposti deve esservi contesa, éris. La guerra individua, fa emergere il carattere-dèmone di un individuo contra l’altro, entrambi nel loro opporsi manifestano questo comune: il porsi, cioè, di ciascuno come se stesso nella sua differenza dall’altro.
Nello spasmo in cui si è trasformato e serrato in sé il nostro spazio-tempo, popoli e culture vanno incrociandosi e affastellandosi gli uni con gli altri, eliminando ogni “amicizia” o “prossimità”. Più ci si meticcia semplicemente e meno ci si ospita. Sono movimenti tellurici, zolle di crosta terrestre alla deriva, che oggi danno di cozzo. La guerra perde ogni forma. Dove si svolge? Al centro o alla periferia del “comando”, alle porte di Roma o a Palmira? In qualsiasi punto in cui esploda, il conflitto può farsi catastroficamente centrale. È guerra diffusa, policentrica; ogni esplosione minaccia di travolgere il tutto. L’ordinato gioco tra parte e intero, che ci era apparso nell’idea di Polemos, è travolto. Non solo il concetto di guerra giusta crolla definitivamente, ma la stessa definizione di Nemico si fa ardua. Essa diviene preda dell’occasionalità più nuda.
Amico e Nemico si scambiano i ruoli con “insostenibile leggerezza”, rendendo esercizio di scuola il paradigma schmittiano. L’assenza di limiti della guerra contemporanea si era già imposta con il tramonto dello ius belli; le grandi guerre civili mondiali dell’altro secolo avevano già fatto crollare ogni differenza tra combattenti e non combattenti, avevano già fatto uso di ogni strumento ideologico per demonizzare il nemico e ricorso a ogni mezzo terroristico. (Nulla rende più evidente la confusione che regna oggi in questo campo dello scriteriato uso del termine “terrorismo”, applicato indistintamente a ogni azione che sfugga a una logica classica di affrontamento tra eserciti. Terrorismo significa terrorizzare le popolazioni “innocenti”; i combattenti non sono terrorizzabili per definizione).
Oggi questa assenza di limiti assume una forma diversa, totale: da un lato, tende a sparire il “campo di battaglia”; dall’altro, Amico e Nemico si fanno interscambiabili. Ma soprattutto assenza di limiti viene a significare l’assoluta impotenza a definire la guerra in termini morfogenetici. Per la sua capacità di produrre nuove forme politiche, nella sua dimensione costituente, si era sempre potuto parlare di arte della guerra e di una virtus bellica. Questi timbri erano anche avvertibili nell’arcaico termine Polemos. Oggi è la stessa politicità della guerra (la comune radice di pólemos e pólis) che non riesce più a esprimersi. Quale ordine si intende difendere dal presunto attacco? E quale costituire dopo l’auspicata disfatta dell’aggressore? Insomma: per quale pace si fa la guerra? Se non si sa chi sia il Nemico e dove stia, e tantomeno si conosce chi sia l’alleato, la guerra finirà con l’essere condotta con i mezzi più disparati, e con efficacia scarsa o nulla.
Così Polemos, non più pater, finisce con l’apparire sempre ingiusto. Non sapendo dare più al termine “guerra” un significato, si tenta di rimuoverne l’esistenza stessa derubricandola alla famiglia del “sorvegliare-e-punire”, ad azione di intelligence e di polizia. E si sogna che tra politica e guerra si possa scavare l’abisso. Compaiono spezzoni delle antiche “grandi forme”, dei tradizionali “eroici” tentativi di mettere in forma il Gioco crudele - come relitti sulle nostre spiagge abbandonati dalla colossale risacca dell’ultimo secolo.
Con fiducia particolare ci si abbarbica all’idea di “giusta guerra difensiva”. Ma che significa? Difesa del territorio? E quali ne sono i confini reali? Difesa dell’onore? E come impedire, allora, che essa possa farsi anche preventiva, se entra in gioco l’onore di uno Stato? Defensio innocentium? Ma quale Stato non ha da più di due secoli reso “colpevoli” i suoi cittadini? Quale “scala di valore” può affermare se stessa assoluta? Dove siede il Tribunale dell’Umanità? Spezzoni, frammenti, balbettii che si inseguono nel nostro mondo successivo al crollo della forma politico-militare imposta dai grandi Titani usciti vincitori dalla seconda Grande guerra.
Ripetere frammenti e balbettii non renderà più chiara la visione. Tantomeno se si crederà di uscire da questa fase epimeteica inseguendo di nuovo il sogno del supremo Tribunale, capace di ridurre ogni conflitto a formalismo giuridico e a perseguire come un crimine la guerra. Questo sogno non fa che esprimere l’indisponibilità europea, e ormai sempre più di tutto l’Occidente, ad affrontare la “prova del fuoco”. In Polemos il dissidio, in tutte le sue forme, era concepito e affrontato come segno di Dike, della Necessità, e perciò i distinti nel loro opporsi erano anche sempre visti nel Comune, cui appartengono e il cui Logos è pre-potente rispetto a ogni loro manifestazione di potenza. Questa prospettiva appartiene al nostro linguaggio più originario e non può perciò essere definita utopistica. Forse essa ci indica ancora una non vana, non cieca speranza per conferire un senso costituente, morfogenetico all’attuale tumulto, anche se ignoriamo per quali vie e attraverso quali tragedie essa potrà mai realizzarsi.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- OLIMPIADI DI FILOSOFIA. Apriamo gli studenti all’ubuntu (di Luca M. Scarantino)6 giugno 2016, di Federico La Sala
- Per la dignità e la libertà di tutti gli esseri umani ...
 UBUNTU: "Le persone diventano persone grazie ad altre persone". NELSON MANDELA, UN COMBATTENTE SUL RING DELLA STORIA.
UBUNTU: "Le persone diventano persone grazie ad altre persone". NELSON MANDELA, UN COMBATTENTE SUL RING DELLA STORIA.
- DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Pace, giustizia, e libertà nell’aiuola dei mortali
 DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI.
DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI.
OLIMPIADI DI FILOSOFIAApriamo gli studenti all’ubuntu
 di Luca Maria Scarantino (Il Sole-24 Ore, 05 giugno 2016)
di Luca Maria Scarantino (Il Sole-24 Ore, 05 giugno 2016)Donna non si nasce, lo si diventa: commentando questa celebre massima di Simone de Beauvoir, due liceali della Corea del Sud hanno vinto le Olimpiadi mondiali di filosofia. La terza medaglia d’oro, ex-aequo, è andata a uno studente turco, autore di un saggio sulla logica di Aristotele. Nessun paese aveva mai ottenuto due primi posti in una stessa edizione.
Leggendo gli elaborati nello splendore fiammingo di Gent, ripensavo alle parole di un collega della giuria. «Stanno vincendo», mi aveva detto il giorno prima, mentre i militari belgi in tenuta di guerra ci perquisivano in prossimità dell’aeroporto di Charleroi: nell’Europa sotto attacco siamo noi le armi che i nostri nemici stanno preparando. Non si tratta solo di abitudini quotidiane sconvolte da questo stato d’assedio strisciante. È la crescente tentazione di chiudersi, di ripiegarsi in una tradizione, in un’identità, di restringere il proprio mondo a un insieme circoscritto, rassicurante, quasi tribale di coordinate culturali. Gli scritti dei liceali venuti a Gent da tutto il mondo per comporre un breve saggio di filosofia dicevano cose molto diverse.
«Ogni volta che devo barrare una casella, la società mi impone di scegliere “femmina”; eppure tutto dentro di me si sente maschio»: inizia all’incirca così uno degli elaborati vincitori. «Sono donna perché da diciassette anni la società mi impone di esserlo... ma ogni donna dovrebbe battersi non solo per il diritto di diventare donna, ma anche per quello di non diventarlo»: parole decise, coraggiose e piene di vita di ragazze e ragazzi coreani, svizzeri, norvegesi, croati che non hanno paura di esplorare i propri sentimenti e la propria identità di genere, servendosi della filosofia per capire meglio se stessi e la società in cui vivono. Oltre metà delle medaglie d’oro e d’argento, compresi due dei tre vincitori, sono andate a saggi dedicati a questi temi. Non è strano che adolescenti cerchino di costruirsi, né che si interroghino sul proprio rapporto con la società che li circonda; ma è evidente che la rilevanza sociale delle questioni di genere sta diventando un fenomeno universale, parecchio sentito da questi ragazzi che si chiedono in modo consapevole quanto siano pertinenti per la loro vita le norme tradizionali che regolano l’identità di genere: e lo fanno con stili, convinzioni, tesi e conclusioni assai diverse.
Alcuni colleghi europei si chiedevano quanto gli studenti giapponesi, indiani, coreani o cinesi conoscano la tradizione filosofica occidentale. I saggi arrivati in finale ci dicono che maneggiano assai bene Aristotele e Putnam, Locke e Wittgenstein, Foucault, Heidegger, Sartre e Derrida, la tradizione analitica e il pensiero femminista... Questa familiarità con altri mondi, unita a sistemi educativi particolarmente efficaci, aiuta a capire i ripetuti successi degli studenti asiatici.
Chiediamoci allora quanto i nostri studenti, liceali o universitari, conoscano delle altre culture e siano esposti al confronto con esse. Cosa sanno i ragazzi italiani (e prima ancora: cosa sappiamo noi) di Nishida, Wonhyo, Dasan, Laozi, dell’ubuntu, di Senghor, Iqbal e di tanti altri autori e autrici di formidabile rilievo teorico e culturale? Qualcosa si muove, certo; le iniziative rivolte ad aprire l’insegnamento della filosofia e delle scienze umane in senso interculturale non si possono più trascurare; e l’Italia non sta peggio di altri paesi europei. Eppure, troppo spesso si continua a identificare la filosofia con la filosofia occidentale.
È tesi corrente, in Italia e non, che molte delle espressioni culturali non occidentali siano forme di spiritualità, di religiosità, di saperi tradizionali - ma non siano filosofia. Può darsi. Ma da sempre il pensiero filosofico trae la propria forza dalla capacità di integrare una pluralità di forme e pratiche culturali, sino a fondersi con esse: si pensi all’indissolubile rapporto con la religione che ha caratterizzato gran parte del pensiero occidentale, o all’importanza dell’astrologia che attraversa l’intero Rinascimento. Certo, proprio questi saperi, una volta esaurito il proprio ruolo storico, sono stati rifiutati, evacuati dalla comprensione storica del pensiero filosofico: al punto che oggi non siamo quasi più in grado di riconoscerli.
Ma a cosa può aspirare oggi una filosofia che si mura entro un’unica tradizione, lasciando fuori e anzi respingendo oltre i propri confini intere tradizioni spirituali e di pensiero? Davvero vogliamo escludere dall’ambito del pensiero filosofico interi secoli di storia della cultura, abbandonare ad altre discipline lo studio del sufismo, del confucianesimo, delle tradizioni dell’India? Aprire invece, viene da pensare, spalancare le porte della propria mente a culture, filosofie, letterature, religioni di tutto il mondo, anche a costo di scardinare alcuni riflessi culturali ben radicati nella tradizione europea: è di questo che hanno bisogno questi ragazzi per competere nel mondo di oggi e di domani.
La Corea raccoglie i frutti di decenni di investimenti in cultura, educazione, scienze; ed è comunque probabile che già l’anno prossimo si abbiano vincitori di paesi diversi. Eppure, da uno dei più suggestivi borghi della vecchia Europa giunge un segnale da non sottovalutare: al netto di facili generalizzazioni, molti ragazzi extra-europei, e asiatici in particolare, sembrano assai meglio preparati a muoversi nella complessità del mondo di oggi. Ne capiscono e ne affrontano di petto i problemi, le esigenze, le difficoltà. Anche con qualche ingenuità, certo. Ma non hanno alcuna paura di mettersi in gioco: sono gay, ci dice la ragazza coreana con inesorabile forza argomentativa, e se la società vuole a tutti i costi fare di me una donna, allora la società va cambiata. Chissà se i risultati delle Olimpiadi di Gent saranno motivo di stimolo e di accresciuta apertura anche per il nostro sistema educativo.
- Per la dignità e la libertà di tutti gli esseri umani ...
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Nella notte dell’Europa: "La decisione" (B. Böhler). Quando Thomas Mann seppe dei poteri illimitati a Hitler (di Ezio Mauro)29 maggio 2016, di Federico La Sala
Un libro racconta i tre giorni in cui il grande scrittore, da esule, scelse tra mille tormenti di esporsi pubblicamente contro il nazismo
Thomas Mann
Nella notte d’Europa il dilemma tra silenzio e denuncia del Male
Quando seppe dei poteri illimitati a Hitler prese la moglie per mano: stava tremando
di Ezio Mauro (la Repubblica, 28.05.2016)
- IL LIBRO La decisione di Britta Böhler (Guanda, traduzione di Laura Pignatti, pagg. 200, euro 15)
C’è un uomo col cane sul sentiero che porta nel bosco gelato della campagna di Kusnacht, sul lago di Zurigo, quel sabato mattina d’inverno. Attorno i corvi beccano la terra, dai campi affiora uno spaventapasseri, nell’aria passa il suono delle campane senza che la nebbia lasci vedere la chiesa. Il cane è un terrier marrone con una striscia nera sulla schiena e sui fianchi. Di fronte ci dev’essere il lago nascosto nella foschia, perché qui c’è la panchina dove normalmente lo si può guardare in pace. Sciolto il guinzaglio, l’uomo si siede sulla panca col cappotto nuovo dal collo di pelliccia grigio scuro abbottonato in alto, i guanti imbottiti, la sciarpa stretta sotto il mento, i suoi 61 anni. Da tre - fa il conto quel primo giorno di febbraio del 1936 - vive in esilio volontario in Svizzera, dopo aver dedicato al suo Paese il premio Nobel per la letteratura: «Depongo questo premio mondiale ai piedi della Germania e del mio popolo». Adesso ha poche ore di tempo per decidere se la Germania diventata hitleriana merita che lui denunci l’orrore davanti al mondo, oppure se gli conviene tacere e vivere come se non sapesse. Ieri nel suo studio, da solo, ha riletto per l’ultima volta la lettera di condanna indirizzata alla Neue Zurcher Zeitung, ha tolto la stilografica dall’astuccio e ha firmato i tre fogli col suo nome: Thomas Mann.
Mentre getta un ramoscello al cane, cerca in tasca il portasigarette d’argento, non riesce a smettere di torturarsi come ha fatto tutta la notte. Soprattutto una frase della lettera gli torna in mente, come un’ossessione: «Dall’attuale governo tedesco non può venire nulla di buono né per la Germania né per il mondo ». Gli sembrava perfetta, quando l’ha scritta, riletta e corretta. Ma di notte ne ha avuto timore. Stamattina appena alzato ha chiamato il caporedattore del giornale svizzero in lingua tedesca, Korrodi, e gli ha chiesto di aspettare, di non pubblicare nulla: ha bisogno di riflettere. È come se i tre anni passati fuori dalla Germania fossero stati vissuti solo per arrivare fin qui, a questi tre giorni finali e supremi, quelli della scelta. I gesti di ogni giorno, che gli danno la sicurezza della regolarità - sveglia alle 8, colazione con caffè, pane e marmellata, lavoro, passeggiata, pranzo, riposo, corrispondenza, tè, passeggiata serale, cena, lettura, diario - adesso gli appaiono puri strumenti per portarlo a questo fine settimana che non riesce a finire, dilatato nell’incertezza della scelta. Settantadue ore che sembrano montate apposta per riassumere e ingigantire l’angoscia del dilemma, quel nodo tra vita e letteratura che può sciogliere soltanto lui, tra Germania e Europa, esilio e patria, essere e dover essere: per lasciarlo infine solo e nudo davanti al dubbio capitale della sua vita. Un dubbio che confida ogni sera al suo diario, tormento dopo tormento, e che Britta Böhler ha rovesciato nel romanzo sulla Decisione, ora proposto in Italia da Guanda, proprio mentre il Saggiatore con La svolta pubblica la scelta di campo contro il regime di suo figlio Klaus.
Lui, Thomas, non aveva guardato un’ultima volta la terra di Germania tre anni prima, mentre in treno attraversava il confine svizzero-tedesco tra Lindau e Bregenz, un po’ perché era assopito, ma soprattutto perché non sapeva che sarebbe stata l’ultima volta. Dopo una serie di conferenze su Wagner a Monaco, Amsterdam, Bruxelles e Parigi, ecco tre settimane di riposo in montagna al Waldhotel di Arosa, che come ogni anno gli riservava la stessa camera, dove poteva lavorare. Gli erano sempre piaciuti i grandi alberghi coi tappeti spessi, gli enormi lampadari, gli stucchi e d’inverno le slitte a cavalli. Voleva rimettersi a scrivere Giuseppe in Egitto, stava immaginando le sponde del Nilo coperte di limo mentre ordinava il punch del pomeriggio all’Old India, quando dai giornali cominciò a capire che il suo mondo si stava distruggendo. L’incendio del Reichstag, i comunisti messi fuori gioco, la croce uncinata che diventa la nuova bandiera della Germania, abolendo i colori del Reich. Non poteva pensare che il suo Paese fosse perduto, si trattava solo di aspettare. In fondo, non aveva sempre pensato che per la politica poteva bastare la mano sinistra? Ma quando Medi, la figlia, pianse al telefono da Monaco chiedendo ai genitori di poter scappare, subito, perché a scuola tutto era cambiato, ogni mattina dovevano cantare l’inno nazista, cominciarono a capire. Quando ascoltò alla radio Svizzera la votazione di fine marzo al Reichstag sui poteri dittatoriali a Hitler, aveva già compreso. Era in poltrona nella hall dell’albergo, prese la moglie Katja per mano e stava tremando.
Fu allora che arrivarono i primi attacchi dai giornali tedeschi. Improvvisamente lo accusavano di «aver imbrattato Wagner», proprio mentre la Gestapo entrava per una perquisizione nella sua casa di Monaco e il Rotary gli comunicava per lettera l’espulsione. Era chiaro che non poteva più tornare in Germania. Lui, che non aveva fatto del male a nessuno. Che nelle Considerazioni di un impolitico parlava del suo sensibilissimo «spirito di solidarietà con la mia epoca». Che nel Mio tempo scriverà di aver «sempre sentito il bisogno di essere patriota ». Basta. Non sarebbe più tornato nel suo studio, non avrebbe avuto i suoi ottomila libri e il pianoforte a coda dietro cui appariva vestito da mago a Carnevale, col mantello nero e le stelle dorate sul cilindro quando Erika e Klaus erano piccoli. La casa era perduta, come la Germania.
E infatti vagarono per sette mesi tra Lugano, Basilea, il Sud della Francia, dove poteva incontrare in un caffè del porto il fratello Heinrich, sotto il maestrale. Infine la Svizzera, dove Erika trovò la casa sul lago. Arrivarono i pochi mobili che avevano potuto salvare, la sua scrivania, la poltrona da lettura, il grammofono con i dischi per la sera. Ma la sensazione era di un albero strappato dalla sua terra, quasi come se vivere lontano significasse tradire il Paese, con il tormento di sperare talvolta che la Germania «rimettesse la testa a posto». Ma ecco quella stella gialla, le leggi razziali. Dove sta andando la Germania, dove finirà? Come aveva scritto nella lettera? Ecco, l’aveva riletta così tante volte da saperla a memoria: «L’odio dei tedeschi o dei loro governanti per gli ebrei è il tentativo di scrollarsi di dosso legami di civiltà e minaccia di portare a un orribile e sciagurato allontanamento tra la terra di Goethe e il resto del mondo».
Ma c’è anche un’altra frase della lettera che dice la verità. Prima di tutto a se stesso: «Com’è difficile I’arte di restare neutrali». Sono le vicende angosciose del suo Paese che lo hanno spinto fin qui, sul bordo del lago a mezzogiorno del sabato, sull’orlo della decisione che non sa prendere. Anche la sua famiglia lo spinge. Il fratello Heinrich da lontano, Klaus e Erika, i figli grandi, rimproverandolo com’è successo a Natale perché tace da troppo tempo, davanti alla fine del mondo. Erika soprattutto si attende che lui, il suo Mago, parli. Poi quegli allarmi, la Gestapo che a Monaco interroga i suoi camerieri e l’autista. Il rogo dei libri. Aveva ragione Erika, non poteva restare in disparte, come fosse superiore a tutto e a tutti. Aveva ragione Klaus: «Non c’è più ritorno». D’altra parte come scriveva lui in Mario e il Mago? C’è sempre un momento in cui lo spettacolo finisce e ha inizio la catastrofe. Così aveva preparato la lettera in una settimana, fumando quei sigari svizzeri che gli facevano rimpiangere Monaco. Poi ieri, venerdì, aveva chiesto a Katja di accompagnarlo in auto a Zurigo. Tutto sembrava risolto. Ma ecco che al giornale manca proprio Korrodi, deve lasciare la lettera più importante della sua vita a un assistente, la mano esita, vorrebbe ritirarla, infine la consegna.
Va al cinema con la moglie, vedono Le Rosier de madame Husson, ma lui nel buio si lascia catturare nuovamente dal dubbio. Cosa diranno gli amici? Gli viene in mente l’ultimo incontro con Herman Hesse e il suo consiglio: «Non si immischi, amico mio, si tenga fuori». Ma come si può rimanere “fuori” dall’orrore, c’è un fuori? La notte non dorme e sente che sta cambiando idea: non può dare l’addio definitivo alla Germania, ci sarà pure un’altra strada. Il sabato mattina esce nel freddo per schiarirsi le idee, poi telefona al giornale e ferma la lettera. «Voglio pensarci bene», dice alla moglie, che non commenta. Ma poi Katja non scende a pranzo. Lui mangia tre bocconi di carne, da solo, si chiude nello studio. Guarda le edizioni straniere dei suoi romanzi sugli scaffali, si domanda a cosa servono se i suoi libri finiranno all’indice in Germania. Perché si sta rendendo la vita così difficile? Eppure c’è una via di mezzo, che porta alla salvezza: terrà semplicemente la bocca chiusa, esiste il diritto di tacere.
Si sente solo, nella casa adesso silenziosa e non sa che quello è il dilemma dell’Europa intorno a lui - tacere o rischiare - , un pezzo della tragedia morale dell’Occidente e delle democrazie davanti al Male. L’individuo di fronte al peso della storia, la coscienza personale e la vicenda di un intero Paese, la sproporzione tra il suo dandismo letterario e l’abisso tedesco, e tuttavia il sentimento di dichiararsi e infine il calcolo delle conseguenze. Poi, laggiù in fondo alla stanza, la paura. Dovrà giustificarsi, in un caso o nell’altro? Non sa che fare. Accompagna Katja dalla sarta a Zurigo, l’aspetta all’hotel Baur du Lac dov’erano stati in luna di miele. Quel tavolino d’angolo, con un vermut che profuma di erbe mentre intorno passano torte “Foresta Nera” è il posto giusto per prendere la decisione, vuole costringersi a farlo prima che Katja ritorni. Gli è insopportabile l’idea di rompere con Erika ma anche quella di rompere coi suoi lettori. Poi, mentre si fa buio, un’idea si fa strada dentro il tormento. Lucida, chiara: non vuole tornare in Germania, vuole che la Germania torni da lui, torni com’era prima della follia.
Sardine, uova sode, pane e prosciutto, birra e limonata, cucina Katja e cenano soli. I bambini sono a Basilea, Klaus è continuamente in viaggio, Golo ormai lavora a Rennes, Monika è a Firenze, Erika ovunque col suo cabaret. Alza la birra verso la moglie: «Salute. A volte bisogna lasciare che le cose seguano il loro corso». Nello studio mette sul grammofono il preludio del Lohengrin, la sua opera preferita. Si addormenta in poltrona, cercando nel dormiveglia qualcosa tra politica e cultura, musica e sventura, chiedendosi se star zitti oggi è un’altra forma del patto col diavolo, ricordando confusamente che anche nel suo Doctor Faustus l’accordo con Satana era stato siglato fuori dalla Germania. Finché il disco arriva alla fine. La domenica si sveglia sapendo che non c’è più tempo e non ci sono alternative. È vero, sarà senza terra, ma lo spirito e l’arte non possono essere separati dalla politica e poi la sua Germania non esiste più. Si lucida le scarpe con la cera, scende per colazione, beve un bicchiere di sambuco. «Telefono adesso - dice a Katja - . Domani la lettera uscirà sul giornale». Nel diario di tela cerata chiuso nel primo cassetto dello studio insieme con vecchi occhiali, spago, ceralacca, fiammiferi, c’è scritto: «Ho concluso con commozione». Poco più in là, il calendario arrivato chissà come da Monaco, spalancato sulla data del giorno d’addio alla Germania tre anni prima, l’11 febbraio. Adesso quei fogli si potevano finalmente girare per arrivare al terribile 1936 dell’Europa, il tempo poteva ricominciare a scorrere, come la vita.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- DEMOCRAZIA E DIO-MERCATO. I poteri economico-finanziari convinti che produzione ed economia possano prosperare solo in una situazione di democrazia decurtata (Andrea Colombo)27 maggio 2016, di Federico La Sala
- IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
- IL SONNO MORTIFERO DELLA CHIESA: DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ?("Caritas")
Se la democrazia è incompatibile con il mercato
di Andrea Colombo (il manifesto, 27.05.2016)
Il pronunciamento netto a favore della riforma istituzionale col quale ieri Vincenzo Boccia ha inaugurato il mandato alla guida di Confindustria non è uno dei tanti pareri che piovono in questi giorni, in seguito alla scelta renziana di aprire la campagna referendaria con mesi di anticipo.
Sul sì degli industriali, che verrà ufficializzato il 23 giugno dal Consiglio generale dell’associazione, non c’erano dubbi. Le motivazioni dell’entusiasta sostegno degli industriali alla riforma meritano tuttavia di essere considerate con attenzione. Boccia infatti non le manda a dire: le riforme sono benvenute e benemerite perché devono «liberare il Paese dai veti delle minoranze e dai particolarismi», il cui perverso esito è stato «l’immobilismo».
Immobilismo? In un Paese in cui, nel 2011, un governo da nessuno eletto ma imposto dall’Europa e da un capo dello Stato che travalicava di molto i confini del proprio ruolo istituzionale ha stracciato in quattro e quattr’otto diritti e garanzie del lavoro conquistate in decenni, senza che quasi nessuno proferisse verbo? Con un governo che nella sua marcia ha incontrato un solo serio ostacolo, costituito non dalle minoranze e dai particolarismi ma da una parte integrante della truppa del premier, i cosiddetti catto-dem? Dal giorno dell’ascesa a palazzo Chigi di Renzi, anche lui senza alcun voto popolare, il loro è stato l’unico no che il governo ha dovuto ingoiare ma è improbabile che a questo alludesse Boccia. Per il resto nessuna minoranza e nessun particolarismo hanno trovato ascolto alle orecchie del gran capo.
Il problema è che gli industriali, proprio come la grande finanza e le centrali del potere europeo, stanno mettendo le mani avanti. Non hanno bisogno di intervenire sul presente, che dal 2011 gli va benone così com’è, ma sul futuro. Devono impedire che la democrazia, dissanguata in nome della crisi dei debiti e del voto del 2013, reclami domani diritti che sulla carta ancora avrebbe. Si tratta, non certo per la prima volta nella storia italiana, di rendere un’emergenza permanente.
Quello degli industriali non è un endorsement tra i tanti: è la vera chiave della riforma, la sua ragion d’essere. Per smontare la retorica sui guasti del bicameralismo che costringerebbe le leggi a transitare come anime in pena tra Montecitorio e Palazzo Madama basterebbero i dati sui tempi di approvazione delle leggi in Europa. L’Italia è nella media.
Da quel punto di vista il bicameralismo non desta preoccupazioni. I tempi diventano biblici solo quando leggi spinose vengono chiuse nel cassetto e lì dimenticate. Nulla, nel nuovo assetto disegnato dalla riforma, impedirebbe di farlo ancora, sia pure in una sola camera.
I poteri economico-finanziari, però, si sono convinti che produzione ed economia possano prosperare solo in una situazione di democrazia decurtata e in virtù di governi autoritari, tali cioè da non doversi misurare con «le minoranze e con i particolarismi», in concreto, con un libero Parlamento.
Come quasi tutti gli orientamenti imposti dall’Europa e dai poteri economico-finanziari si tratta di un dogma. Anche a voler accettare il prezzo salatissimo dello scambio tra democrazia e produttività, nulla garantisce che i risultati arriverebbero, anche solo in termini di efficienza produttiva. Proprio il caso dell’Italia, dove la democrazia parlamentare è soffocata da ormai cinque anni senza risultati apprezzabili, dovrebbe dimostrarlo, ma tant’è. Questa è la strada decisa da chi deve decidere per tutti.
Questo ha detto nel suo primo discorso il presidente di Confindustria. Scusate se è poco.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- E’ venuto il tempo della responsabilità globale. Il Vecchio Continente è chiamato a riscoprire la propria vocazione planetaria (di Agnes Heller)23 maggio 2016, di Federico La Sala
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Europa, è venuto il tempo della responsabilità globale
Il Vecchio Continente riscrive di continuo la sua autobiografia
Ora è chiamato a riscoprire la propria vocazione planetaria
di Agnes Heller (La Stampa, 23.05.2016)
Solitamente noi filosofi iniziamo le nostre riflessioni ponendoci la domanda: «che cosa?». E perciò mi chiedo subito: che cos’è l’Unione Europea? E, quindi, che cos’è l’Europa? In prima battuta, si può rispondere facilmente all’interrogativo. Che cos’è l’Europa se non l’insieme delle storie che vengono narrate sull’Europa? Sono state raccontate molte storie sull’Europa. E sono molto differenti le une dalle altre. Alcune addirittura contrastanti. La lettura delle vicende passate e il giudizio su di esse sarà parziale.
Tuttavia, anche se non sarà possibile ricordare tutte queste storie, bisogna menzionare almeno quelle più significative. Non solo per ragioni di scelta, ma anche di attenzione o rifiuto, abbiamo bisogno di ricordare le storie dell’Europa. L’Europa non vanta un numero così sorprendente di storie solo perché è il continente più antico, ma è diventata quella che è oggi proprio perché ha così tante storie. L’Europa è uno storytelling continent, un continente che ha costruito la sua identità come una sorta di autobiografia.
Centro e periferia
Fin dai tempi del primo Rinascimento sono state scritte o sono comparse diverse autobiografie dell’Europa. Una storia era incentrata sul continente cristiano contrastato da continenti non cristiani, un’altra sull’Occidente contrastato dall’Oriente, un’altra sul continente moderno contrastato da quello tradizionale, un’altra sul continente degli uomini bianchi contrastato dai continenti delle persone di colore, un’altra ancora sui colonizzatori contro i colonizzati, e così via. Come in tutti i casi di costruzione dell’identità, anche l’identità dell’Europa è stata forgiata contrapponendo il «nostro» continente agli «altri», alla non-Europa. [...]
Le storie future dell’Europa saranno scritte dai cittadini europei e senza dubbio sotto specifiche circostanze, che però solo parzialmente saranno frutto delle loro scelte. In linea teorica, le circostanze nelle quali si compiono le proprie scelte e si definiscono le proprie azioni possono anche essere indipendenti rispetto alle proprie scelte e azioni di padri. L’Europa appartiene al mondo e deve rispondere alle sfide che esso pone. E, forse, i cittadini europei possono influenzare il corso degli eventi che si consumano in una zona remota del mondo. Si tratta di un nuovo tipo di responsabilità, una sorta di responsabilità allargata, che possiamo chiamare «responsabilità planetaria».
In primo piano c’è la relazione fra centro e periferia. L’Unione Europea è un impero atipico. Perché un «impero» e perché «atipico»? È un impero per molti versi simile agli imperi europei precedenti alla Prima guerra mondiale. Quegli imperi godevano di un vantaggio rispetto agli Stati nazionali che si erano formati dopo il processo di secessione. Un impero ha una forza economica di gran lunga superiore alla somma del potere economico delle singole nazioni. È, in sostanza, un grande corpo composto da differenti nazioni e da molti popoli che usano linguaggi differenti e che seguono differenti tradizioni. E questo è un grande vantaggio rispetto a Stati nazionali indipendenti e spesso diffidenti, e non poche volte ostili, l’un nei confronti dell’altro.
L’impero atipico
Il caso dell’Unione Europea è simile. Tuttavia c’è una differenza sostanziale. Al contrario dei vecchi imperi europei, ci sono istituzioni democratiche centralizzate: è quindi un’entità del tutto nuova. D’altronde, la modernità consente la possibilità di inventare istituzioni, forme di organizzazione e di governo totalmente nuove. Come ho ricordato, sia la democrazia liberale sia il totalitarismo sono proprio esempi di invenzioni moderne: la prima come nuova forma di governo che sostituisce, da un lato, le vecchie repubbliche e, dall’altro, le monarchie liberali; il secondo come sostituto delle dittature militari e dei dispotismi, mentre l’Unione Europea rappresenta una nuova entità che sostituisce i vecchi imperi europei. È molto probabile che, se le democrazie liberali si estenderanno, allo stesso modo il modello dell’Unione Europea potrà stabilirsi in altri continenti.
Ci sono tuttavia ancora diversi problemi da affrontare, non del tutto differenti da quelli che avevano i vecchi imperi europei. C’è ancora, o per lo meno ci potrà essere in futuro, un conflitto fra centro e periferia, perché, così come è accaduto molte volte in passato nel Vecchio Continente, il primo è più ricco della seconda. Inoltre, l’Unione Europea condivide un’altra importante tendenza con i tradizionali imperi, ossia che l’espansione territoriale ed economica rappresenta il suo elemento vitale. E più si espande e cresce, più la distinzione fra centro e periferia si accentua.
Libertà vs benessere
Ho sostenuto prima che l’Unione Europea è un impero atipico, dal momento che ha soppiantato gli imperi europei. In primo luogo è un’Unione nella quale gli Stati membri hanno uguale influenza, e dove i singoli Stati nazionali rimangono indipendenti nonostante abbiano concordato un autorestringimento della propria sovranità. La difficoltà di elaborare e di accettare una costituzione vincolante per tutti gli Stati membri è dunque la mancanza che deriva da una condizione iniziale ideale. In secondo luogo, l’Unione Europea è un impero atipico perché non ha un esercito. Un impero senza esercito è indifeso perché deve basarsi esclusivamente sul proprio potere economico o sul potere militare di altri. Questo problema dovrà essere risolto dalle prossime generazioni. E non è affatto semplice. Se l’Europa sviluppa un apparato militare al suo interno, si troverà più pronta e in grado di resistere a un eventuale ricatto; per fare ciò, dovrà però sacrificare una parte della sua ricchezza.
Il conflitto fra libertà e benessere apparirà, con ogni probabilità, in tutta la sua pienezza nell’orizzonte temporale della nostra vita. Ma anche senza considerare questo aspetto, l’integrazione non potrà essere garantita esclusivamente da vantaggi economici. Questi, allo stesso modo in cui giungono, possono venire meno. Ma se il conflitto fra libertà e benessere è una questione che riguarda il futuro, un altro conflitto è già apparso nell’orizzonte europeo: quello fra benessere (inteso non esclusivamente in termini economici, ma riferito anche al diritto di condurre una vita senza minacce, presunte o reali) e responsabilità nei confronti del pianeta.
 Traduzione di Antonio Campati
Traduzione di Antonio Campati - GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Il sogno di un nuovo umanesimo (di Marcello Neri)12 maggio 2016, di Federico La Sala
- L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
Il sogno di un nuovo umanesimodi Marcello Neri (Il Mulino, 10 maggio 2016])
Il discorso di papa Francesco, in occasione della consegna del Karlspreis alla presenza dei rappresentanti di tutte le istituzioni europee (dal Parlamento alla Bce), spariglia le carte e traccia un nuovo profilo dell’interlocuzione tra Chiesa cattolica e Europa. I grandi vocaboli, dalla legge naturale alla nominazione costituzionale di Dio, su cui si era articolato un diritto pregiudiziale della Chiesa sulla configurazione del continente e sulle scelte delle sue istituzioni, sono scomparsi come d’incanto.
 Indice di un mutato interesse con cui si guarda all’Europa: non più per una residuale riaffermazione della Chiesa e del cristianesimo, ma in virtù di qualcosa che solo l’Europa può nel contesto attuale della vita del mondo. Le coordinate di fondo per una nuova alleanza tra la secolarità europea e la fede cristiana sono offerte in attesa di una risposta all’altezza del meglio della storia, passata e recente, del nostro continente. Tutti i soggetti coinvolti, su entrambi i lati, sono chiamati a dare prova di sé. All’Europa, guardandola come chi viene dall’esterno, il papa chiede semplicemente un esercizio di riapprendimento di quella «capacità generatrice e creatrice» che l’ha resa possibile sul piano storico, culturale e politico.
Indice di un mutato interesse con cui si guarda all’Europa: non più per una residuale riaffermazione della Chiesa e del cristianesimo, ma in virtù di qualcosa che solo l’Europa può nel contesto attuale della vita del mondo. Le coordinate di fondo per una nuova alleanza tra la secolarità europea e la fede cristiana sono offerte in attesa di una risposta all’altezza del meglio della storia, passata e recente, del nostro continente. Tutti i soggetti coinvolti, su entrambi i lati, sono chiamati a dare prova di sé. All’Europa, guardandola come chi viene dall’esterno, il papa chiede semplicemente un esercizio di riapprendimento di quella «capacità generatrice e creatrice» che l’ha resa possibile sul piano storico, culturale e politico.Inventare sintesi inedite, nel crocevia dell’incontro di civiltà e culture di matrici diverse, senza previ punti in comune, è l’impresa di cui è stata capace l’Europa; quella da cui essa si genera sempre di nuovo, come un modo specifico del suo essere una parte del mondo. Le difficoltà e gli arretramenti che conosce oggi l’Europa rappresentano quindi, in primo luogo, una sorta di malessere rispetto a se stessa e al compito che essa si è data per diventare, nella seconda metà del secolo scorso, «una novità senza precedenti nella Storia». E anche le tensioni che si possono produrre, su singole questioni, tra idealità evangelica della Chiesa e pragmatismo delle politiche nazionali vengono ricondotte all’idea di Europa come spazio che ha in se stesso non solo le forze per ricomporle, ma anche per farle funzionare in maniera virtuosa. La parola di Francesco intercetta e s’innesta esattamente sul profilo più alto di cui l’Europa è stata capace: diritti dell’uomo, democrazia, libertà. Smascherando il cortocircuito in cui queste grandi figure cadono quando vengono praticate come la loro privatizzazione, secondo la logica di un individualismo spinto che le sgancia dalla dimensione sociale a cui esse sono votate.
Ridare ariosità sociale a queste figure vuol dire, per Francesco, declinare i diritti dell’uomo come capacità di integrazione, la democrazia come esercizio di dialogo che riconosce in ogni abitante delle nostre città un interlocutore valido, la libertà come principio di una cultura che convoca tutti alla «sua elaborazione e costruzione». Quello che Francesco immagina è una corrispondenza creativa, capace di immaginarsi nuovi scenari e adeguate forme di convivenza umana fra i diversi, che siano all’altezza dell’ideale di queste figure portanti dello spirito europeo.
 Nel sogno di un’Europa capace di un nuovo umanesimo, che attinga a quello di cui essa «è stata la culla e la sorgente», Bergoglio lancia la sfida di un’inusuale confessione di europeismo intorno a cui intrecciare le passioni della fede e la passione per l’umana dignità di essere della storia che ci ha generati.
Nel sogno di un’Europa capace di un nuovo umanesimo, che attinga a quello di cui essa «è stata la culla e la sorgente», Bergoglio lancia la sfida di un’inusuale confessione di europeismo intorno a cui intrecciare le passioni della fede e la passione per l’umana dignità di essere della storia che ci ha generati.Lo snodo decisivo di questo incontro, libero e autonomo, di passioni è rappresentato dalla capacità di immaginarsi e realizzare un diverso ordinamento economico, che non richieda il sacrificio dei legami fondamentali dell’umano e non viva dell’ossessione di consumarsi in se stesso per produrre profitti a breve durata. L’investimento che deve azzardare oggi l’Europa è quello sulle generazioni più giovani, che già oggi sono «agenti di cambiamento e trasformazione». L’azzardo di una fiducia da concedere per uscire dalla stanchezza e dagli arretramenti che sembrano governare la litigiosità delle politiche europee.
 Pensando la Chiesa come collaboratrice per questa «rinascita di un’Europa affaticata, ma ancora ricca di energie e di potenzialità». Non padrona dispotica del destino dell’Europa, ma istituzione fra le istituzioni che realizza il Vangelo che custodisce andando «incontro alle ferite dell’uomo». Memoria, questa, in cui la radicalità evangelica e l’idealità europea possono stringere davvero un’alleanza capace di sognare insieme un nuovo umanesimo per tutti: «Sogno un’Europa di cui non si possa dire che il suo impegno per i diritti umani è stata la sua ultima utopia. Grazie».
Pensando la Chiesa come collaboratrice per questa «rinascita di un’Europa affaticata, ma ancora ricca di energie e di potenzialità». Non padrona dispotica del destino dell’Europa, ma istituzione fra le istituzioni che realizza il Vangelo che custodisce andando «incontro alle ferite dell’uomo». Memoria, questa, in cui la radicalità evangelica e l’idealità europea possono stringere davvero un’alleanza capace di sognare insieme un nuovo umanesimo per tutti: «Sogno un’Europa di cui non si possa dire che il suo impegno per i diritti umani è stata la sua ultima utopia. Grazie». -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Bulgaria 1943 l’olocausto sventato: una storia sconosciuta. La protesta di Dimitar Peshev10 maggio 2016, di Federico La Sala
Bulgaria 1943 l’olocausto sventato
23.01.1992 - Sofia
Una storia sconosciuta. Così nel Paese alleato di Hitler la mobilitazione popolare salvò gli ebrei.
[di Enrico Deaglio] *
Difficile scegliere, in questi giorni di cinquantesimo anniversario della Conferenza nazista di Wannsee, il sintomo più cupo del razzismo nell’Europa di oggi. Se la lingua tagliata di Berlino, le coltellate di Roma, le teste rasate di Vienna o il Mein Kampf, best-seller in Polonia. Spero allora che sia sollievo per i lettori apprendere la storia di un olocausto che non avvenne, semplicemente perché un popolo lo impedì.
Una storia sconosciuta, avvenuta in un Paese lontano, la Bulgaria. Tra le poche tracce che ne restano, due brevi comunicati radio.
Il primo è di Radio Berlino, che il 20 maggio 1943 annunciava, con burocratica sicurezza, l’imminente deportazione dei ventimila ebrei di Sofia, una delle tante tappe previste nella “Endoesung der Judenfrage”, la “soluzione finale del problema ebraico” decisa l’anno prima nella villa a Wannsee.
Il secondo è della Bbc. Il 24 maggio, il suo servizio internazionale informava di una manifestazione di protesta a Sofia. Migliaia di persone in piazza avevano impedito la partenza dei convogli nazisti. La deportazione non aveva avuto luogo. Una ribellione, in un Paese occupato, nell’angolo più sperduto della guerra, seguiva di un mese l’insurrezione del ghetto di Varsavia. Poi, però, non si seppe più nulla.
La Bulgaria era da due anni alleata del Reich; il suo re, Boris III, discendente di una nobile famiglia prussiana, aveva ottenuto da Hitler l’appoggio militare per una espansione territoriale, a spese di Romania, Jugoslavia e Grecia. Un caso abbastanza tipico di do ut des balcanico.
Gli avvenimenti seguirono con rapida cadenza. Il 21 gennaio 1941, il Parlamento bulgaro votò (pur fra fortissime opposizioni) una legge antisemita imposta dalla Germania. Il 3 marzo, l’“esercito fratello” entrò nel Paese. Il 2 aprile, con l’appoggio militare tedesco, i bulgari presero possesso di ampie zone della Serbia meridionale, della Macedonia e della Tracia. Ma i tedeschi si dimostrarono subito molto scontenti del loro nuovo alleato: i bulgari si rifiutavano ostinatamente di mandare i propri soldati a combattere contro l’Unione Sovietica; e per quanto riguardava il programma antisemita, le loro leggi apparivano ai funzionari nazisti del tutto ridicole.
Il servizio informazioni di Himmler comunicava a Berlino che le limitazioni di orario e di residenza imposte agli ebrei non venivano rispettate, che la stella gialla obbligatoria sui vestiti era “piccolissima” e che la ditta incaricata di fornirla aveva addirittura sospeso la fabbricazione. Un altro rapporto informava Berlino che a Sofia gli ebrei che passavano per strada con la stella gialla erano salutati “con manifestazioni di simpatia”, che il metropolita Stefan simpatizzava con loro, che a fianco degli ebrei si erano schierati molti parlamentari e associazioni di professionisti.
Gli ebrei erano presenti in Bulgaria, come in tutta la Penisola Balcanica, fin dal 1200. Poi arrivarono, a partire dal 1492, i “sefarditi” cacciati dalla Spagna, che, nei secoli, conservarono, con pochissime modifiche, la loro lingua spagnola. Elias Canetti ha definito la sua una “infanzia meravigliosa” in una città bulgara del Basso Danubio, Rustschuk, dove “in un solo giorno si potevano sentire sette o otto lingue” e si scambiavano commerci e libri tra bulgari, turchi, greci, albanesi, armeni, ebrei spagnoli. E con zingari che venivano ogni tanto ad accamparsi. E così doveva essere in tante altre cittadine. In Bulgaria gli ebrei spagnoli non conobbero mai i ghetti, fecero parte invece di un naturale “melting pot”. Non si diffusero le tendenze hassidiche, così forti in Polonia e in Russia.
A Sofia, all’inizio del secolo, una borghesia ebraica viveva nel centro della città a fianco della grande sinagoga, peraltro adiacente al tempio della Chiesa ortodossa e alla moschea musulmana. In un altro quartiere, Yuchbunar, abitavano gli ebrei artigiani, piccoli commercianti, o operai. C’erano poi i militanti del sindacato socialdemocratico, i giornali, in cirillico o in ebraico con gli apprezzamenti per Carlo Marx e per la grande rivoluzione del 1917 a Pietroburgo, quei socialisti russi che avevano sostenuto i bulgari nella guerra contro l’oppressione dell’Impero Ottomano.
Ci furono anche in Bulgaria, come nel resto d’Europa, movimenti fascisti, ma ebbero scarso seguito, confinati nell’ambiente universitario: in Bulgaria, lo stereotipo dell’“ebreo alieno” non ebbe mai successo. Nella loro maggioranza, politicamente conservatori, gli ebrei bulgari ebbero piuttosto una grande simpatia per le teorie sioniste di Theodor Herzl, da molti indicato come il Messia.
Secondo i programmi di Wannsee, gli ebrei da avviare ai mattatoi della Polonia erano 48 mila, uno su cento della popolazione bulgara. L’attuazione del piano venne affidata da Adolf Eichmann al suo vice Theodor Dannecker (già organizzatore delle deportazioni dalla Francia) e all’ambasciatore tedesco a Sofia, Adolf Beckerle.
Si decise di cominciare con i 20 mila ebrei residenti nelle zone di Serbia e Grecia appena occupate dalla Bulgaria. Il 22 febbraio del 1943 vennero rastrellati 11.450 ebrei. Le poche testimonianze parlano di uomini e donne con berretti di agnello e scialli variopinti ammassati sui carri merce, spaventati ed incapaci di comprendere quello che stava accadendo. Venivano da vallate remote dove avevano sempre vissuto in pace con i loro vicini, o da città che erano poco più che villaggi. Dal campo di sterminio di Treblinka, cui vennero avviati, ne tornarono solamente 11.
Per l’inizio di marzo venne fissata la partenza di 6 mila ebrei residenti nella stessa regione, ma in territorio della Bulgaria storica, da concentrare nella cittadina di Kustendil. Ma qui successe il primo imprevisto. Gli ebrei di Kustendil informarono i loro deputati di quello che era nell’aria e questi corsero a Sofia.
La delegazione venne ricevuta dal vicepresidente del Parlamento, Peshev, che la portò al ministro degli Interni, Grabowsky. In poche ore vennero raccolte 42 firme di deputati dei partiti della maggioranza filotedesca, che con veemenza condannavano l’operazione. Il governo comunicò ai nazisti che l’operazione doveva ritenersi “sospesa per 90 giorni”.
A maggio i nazisti tornarono alla carica. Questa volta furono indicati come obbiettivo i 20 mila ebrei di Sofia. Un editto ordinò loro di presentarsi alla stazione il 24 maggio, giorno di Cirillo e Metodio, inventori dell’alfabeto cirillico, festa nazionale.
Quel giorno, a Sofia, successe un evento unico in tutta Europa. A gruppi, gli ebrei cominciarono a manifestare. Alcuni si recarono alla grande sinagoga, altri a quella del quartiere popolare di Yuchbunar, dove il rabbino promosse una manifestazione. Venne deciso di marciare verso il palazzo reale. Partirono in poche centinaia, ma dalle case di Sofia molti cominciarono a scendere in strada. I manifestanti divennero migliaia, i gruppi comunisti clandestini tra i più attivi. La stazione venne presidiata, mentre il corteo affrontava la polizia e gli attoniti ufficiali delle SS. Ci furono 400 arresti, ma i treni rimasero vuoti. Il governo autorizzò solamente lo sfollamento degli ebrei dalla capitale verso le campagne.
In una serie di comunicati stizziti, Beckerle e Dannecker comunicarono a Himmler che “i bulgari mancano della illuminazione ideologica dei tedeschi. Vivendo da troppo tempo con armeni, greci e zingari, il popolo bulgaro non vede nell’ebreo difetti che giustifichino misure speciali contro di lui”.
Nei mesi successivi continuarono a riferire a Berlino che anche nelle campagne gli ebrei erano “ben accolti” e che “non c’era nulla da fare”. Nell’agosto del 1944, con l’avvicinarsi dell’Armata Rossa, le leggi antisemite vennero revocate: alla fine della guerra non un solo ebreo bulgaro era stato deportato.
Gli storici definiscono il “caso bulgaro” una “anomalia”. Hannah Arendt ricordò un antecedente di fierezza di quel popolo nella vicenda di Georgi Dimitrov, il comunista bulgaro accusato nel 1933 a Berlino dell’incendio del Reichstag. Portato a processo, venne interrogato da Goering, ma da accusato si trasformò in accusatore. Fu assolto. Ammirato da tutto il mondo, tanto che si disse: “In Germania oggi è rimasto un solo uomo, ed è un bulgaro”.
Ma forse gli avvenimenti di Kustendil e di Sofia furono solo un fantastico caso di normalità, di quelle che creano imbarazzo: un Parlamento decoroso, una opinione pubblica civile e coraggiosa, una Chiesa solidale con gli oppressi.
Il reporter Roberto Pistarino - giramondo con telecamera - ha ritrovato nei mesi scorsi i ricordi di questa storia a Sofia, intervistando protagonisti e testimoni. Oggi in Bulgaria vivono in tutto 2500 ebrei; gli altri emigrarono tutti in Israele: si realizzava il loro vecchio sogno sionista, mentre il comunismo applicato non prometteva niente di buono. Theodor Zivkov, il segretario del pc fino al 1989, cercò negli Anni 50 di ottenere una candidatura al Nobel per la pace, ma non riuscì mai a provare di avere avuto un ruolo preminente nel salvataggio degli ebrei di Sofia.
Per il resto non esiste molto. Due libri elogiativi dell’opera del partito comunista, un piccolo circolo ebraico - “Shalom” - e un film documentario girato nel 1987 dalla regista Ivanka Grabceva sugli avvenimenti del 1943. Venne finanziato dalla televisione di Stato, ma non andò mai in onda, perché il partito comunista non vi appare come l’unico protagonista. La regista ha però il permesso di regalarne tre cassette a visitatori stranieri che ne facciano motivata richiesta. Nella grande sinagoga di Sofia è conservato il più importante archivio delle memorie sefardite, ma è quasi impossibile poterlo consultare.
 Autore: Enrico Deaglio
Autore: Enrico Deaglio
 Fonte: La Stampa
Fonte: La Stampa* http://www.bulgaria-italia.com/bg/news/news/02453.asp
La lettera di protesta di Dimitar Peshev (17.03.1943) *
Egr. Sig. Primo Ministro
Il senso di grande responsabilità storica che condividiamo in questo momento con il governo, la nostra costante fedeltà alla sua politica e al regime, così come il nostro desiderio di contribuire in ogni modo al suo successo, ci danno il coraggio di rivolgerci a Lei, sperando che lo consideri un passo fatto con sincerità e in buona fede...
Alcune recenti misure adottate dalle autorità dimostrano la loro intenzione di prendere nuovi provvedimenti contro le persone di origine ebraica. Da parte dei settori responsabili non vengono fornite spiegazioni né sulla natura di questi provvedimenti, né sui criteri con cui sono stati presi, sulla loro motivazione e sul loro scopo. In una conversazione con alcuni deputati, il Ministro degli Interni ha confermato che non ci sono ragioni per adottare delle misure eccezionali contro gli ebrei dei vecchi confini. In pratica, queste misure sono state annullate.
Considerato tutto questo e in base a nuove voci, abbiamo deciso di rivolgerci a Lei, sicuri che tali misure possono essere prese solo a seguito di una decisione del Consiglio dei Ministri. La nostra unica richiesta è che vengano prese in considerazione solo quelle misure riguardanti le reali necessità dello Stato e della nazione nel momento attuale e che non vengano dimenticati gli interessi relativi al prestigio e alla posizione morale della nostra nazione.
Non vogliamo contestare alcuna misura imposta dalle ragioni di sicurezza dettate dai tempi in cui viviamo, perché sappiamo che chiunque tenti di ostacolare gli sforzi dello Stato e del popolo, direttamente o indirettamente, dovrà essere neutralizzato. Ci riferiamo a una linea politica adottata dal governo con la nostra approvazione e collaborazione, una politica alla quale siamo stati fieri di partecipare con tutto il nostro prestigio e le nostre ricchezze. L’eliminazione di ogni ostacolo al successo della sua politica è un diritto dello Stato e nessuno lo può negare, ma esiste un limite alle necessità reali e non bisogna cadere negli eccessi che si possono definire "crudeltà inutili". E questo può essere considerato il caso in cui vengano prese delle misure contro donne, vecchi e bambini, che a livello individuale non abbiano commesso alcun crimine.
Non possiamo credere che ci siano dei piani per deportare questa popolazione dalla Bulgaria, come suggeriscono alcune voci a danno del governo. Tali misure sono inammissibili, non solo perché queste persone - cittadini bulgari - non possono essere espulse dalla Bulgaria, ma anche perché ciò avrebbe serie conseguenze per il paese. Sarebbe un’indegna macchia d’infamia sull’onore della Bulgaria, che costituirebbe un grave peso morale, ma anche politico, privandole in futuro di ogni valido argomento nei rapporti internazionali.
Le piccole nazioni non possono permettersi di trascurare questi argomenti, che, qualsiasi cosa accada in futuro, costituiranno sempre un’arma potente, forse la più potente di tutte. Per noi questo è molto importante perché, come Lei forse ricorderà, in un recente passato abbiamo sofferto pesanti perdite morali e politiche, a causa delle deviazioni dalle leggi umane e morali da parte di alcuni bulgari e spesso per colpa di persone irresponsabili. Quale governo bulgaro potrebbe assumersi una simile responsabilità riguardo al nostro futuro?
L’esiguo numero di ebrei in Bulgaria e il potere dello stato, che ha a disposizione tante leggi e tanti mezzi, rendono innocuo ogni elemento pericoloso o dannoso, a qualsiasi strato sociale appartenga, al punto tale che, secondo noi, è del tutto inutile adottare nuove misure eccezionali e crudeli, che potrebbero condurre a un massacro. Una cosa del genere si ritorcerebbe soprattutto contro il governo, ma colpirebbe anche la Bulgaria. È facile prevedere le conseguenze che una simile situazione potrebbe avere ed è per questo che ciò non deve succedere.
In base a queste considerazioni non ci sentiamo di assumere alcuna responsabilità su questo punto. Un minimo livello di legalità è necessario per governare, come l’aria è necessaria alla vita. L’onore della Bulgaria e del popolo bulgaro non è solo una questione di sentimento, è soprattutto un elemento della sua politica. È un capitale politico del massimo valore ed è per questo che nessuno ha il diritto di usarlo indiscriminatamente se il popolo intero non è d’accordo.
Le inviamo i nostri più rispettosi ossequi.
Sofia, 17 marzo 1943
Seguono le firme dei 43 deputati della XXV Assemblea Nazionale. Tratto dal Fondo n. 1335, u.a. 85, Sofia Archivio Storico Nazionale.
Dimitar Peshev fu informato un suo vecchio compagno di scuola ebreo proveniente da Kjustendil che il governo, in accordo coi tedeschi, stava preparando per il giorno dopo la deportazione segreta della minoranza ebraica. I treni erano già stati predisposti nelle stazioni. La notte successiva gli ebrei dovevano essere rastrellati e caricati sui vagoni, che sarebbero partiti la mattina dopo per la Polonia.
"Era il 7 marzo del 1943. Tutto era stato deciso in gran segreto per non mettere in allarme la popolazione. Peshev, in effetti, aveva sentito circolare strane voci, ma come tutti, allora, non se n’era preoccupato. Ora, di fronte a un amico che gli chiedeva di aiutarlo, ebbe come un sussulto, un risveglio della coscienza. Si scosse dal suo torpore e agì d’istinto, con l’idea, in un primo momento, non tanto di salvare un popolo, quanto di aiutare i suoi amici di Kjustendil. Si precipitò in parlamento, radunò qualche altro deputato, piombò di sorpresa nell’ufficio del ministro degli interni Gabrovski e dopo uno scontro drammatico lo costrinse a revocare l’ordine della deportazione. Poi telefonò personalmente a tutte le prefetture per verificare che il contrordine fosse stato rispettato."
Poiché in questo modo la deportazione era stata solo sospesa, Peshev decise di lanciare un’offensiva in parlamento. Si era reso conto che in gioco non c’era soltanto la vita di qualche amico, ma la salvezza dei cinquantamila ebrei bulgari. Non c’era un minuto da perdere: stese una lettera di protesta molto dura e raccolse le firme di una quarantina di deputati per chiedere al governo e al re di non commettere un crimine così grande, che avrebbe macchiato per sempre l’onore della Bulgaria.
tratto dal libro di Gabriele Nissim - "L’uomo che fermò Hitler"
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- UN COLPO D’ALA. Sadiq Khan, nuovo sindaco di Londra (di Daniele G. Gessa)7 maggio 2016, di Federico La Sala
Sadiq Khan, musulmano attento ai diritti gay ed ecologista favorevole al business. Ecco chi è il nuovo sindaco di Londra
Il 45enne avvocato dei diritti umani è nato in una famiglia proletaria di immigrati pachistani. Il suo programma punta all’incremento dell’edilizia sociale ma anche alla lotta contro il terrorismo e ogni tipo di estremismo
di Daniele Guido Gessa (Il Fatto, 6 maggio 2016)
Londra ha ora un sindaco musulmano, laburista, ecologista ma attento anche al business e alle imprese, almeno stando alle promesse. E soprattutto da venerdì 6 maggio la capitale ha un primo cittadino che è forse l’unica vera magra consolazione per il Labour di Jeremy Corbyn, il leader dell’opposizione dallo scorso 12 settembre, che è stato accusato da più fronti di aver fatto virare il partito troppo a sinistra. Mentre si leccano ancora le ferite per i brutti risultati a livello locale (nel Regno Unito si votava anche per i parlamenti nazionali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord e per diversi consigli comunali, nonché per due seggi parlamentari riassegnati in due elezioni suppletive), i laburisti possono ora vantare un amministratore che, nel panorama europeo, è veramente rivoluzionario.
E Sadiq Khan, avvocato per i diritti umani 45enne, non è dirompente solo per le sue origini pachistane e per la sua fede di musulmano praticante, ma anche per le sue aperture ai diritti gay, tanto da aver votato da parlamentare a favore della legge sui matrimoni fra persone dello stesso sesso, nel 2013, ricevendo diverse minacce di morte. Ma anche per la sua estrazione proletaria: figlio di un autista di autobus e di una umile sarta, avendo vissuto per anni in una casa di edilizia popolare, fra ‘lavoretti’ del fine settimana, molti sacrifici e una carriera tutta in salita e assolutamente guadagnata fino in fondo. Senza appoggi o ‘spintarelle’, si direbbe in Italia.
Al di là dell’agiografia del vincitore, comunque, Khan è stato in grado, scrive la stampa britannica, di intercettare le vere volontà dei cittadini londinesi, quasi 9 milioni di abitanti di cui almeno il 40% nato all’estero o comunque di origine straniera. Stop all’aumento spropositato delle tariffe del trasporto pubblico, già ora uno dei più cari al mondo, con l’introduzione di un biglietto della durata di un’ora sugli autobus. Non è così ora a Londra, dove se si prende più di un mezzo si paga un biglietto diverso - e lo si paga veramente, altrimenti non si sale sul bus - ogni volta che si passa dalla porta anteriore. Ancora, sì all’ambientalismo ma senza esagerare: la coscienza ‘verde’ di Khan non pare essere così sviluppata come quella di Zac Goldsmith, il candidato conservatore sconfitto, che dell’ecologismo ha sempre fatto il suo cavallo di battaglia. Rinnovo del parco auto, dei mezzi del trasporto pubblico e soprattutto un abbattimento delle emissioni domestiche sono comunque fra gli obiettivi del nuovo sindaco laburista, che aggiunge nel suo programma di voler far diventare Londra una città waste free, libera dalla schiavitù della produzione di rifiuti. Non si sa come, ma le promesse sono importanti. E Khan ci ha messo la faccia, dicendo di capire le ragioni degli ambientalisti soprattutto per la sua asma che spesso non gli dà pace.
Ancora, Khan, che da giovane lavorò anche in un negozio, promette di essere estremamente attento al business, che mai come oggi a Londra ha bisogno di essere protetto dai rischi della Brexit. L’eventuale uscita del Regno Unito dall’Unione europea, in seguito al referendum del prossimo 23 giugno, è uno spauracchio sempre più concreto considerando la relativa vittoria alle elezioni locali di giovedì 5 maggio dell’Ukip di Nigel Farage. Più che uno spauracchio, è un vero e proprio terrore per le aziende, con la Cbi, la ‘Confindustria britannica’, che più volte si è espressa contro l’eventualità. Ecco così che Khan promette incentivi, un ambiente ancora più internazionale e favorevole al business, se possibile, e una generale e maggiore attenzione alle ragioni degli uomini di impresa in quella che già da tempo è una delle capitali mondiali della finanza, dei servizi, delle startup, della ricerca, della scienza e della tecnologia.
Ancora, per Khan, uno dei temi vincenti riconosciuti dalla stampa, durante la sua campagna elettorale, è stato quello della casa, in una città dove i prezzi delle abitazioni sono alle stelle a causa degli investitori internazionali (sceicchi arabi, oligarchi russi ma anche molti italiani) che arrivano sotto il Big Ben solamente per comprare appartamenti e ville. Con il risultato che ormai il prezzo medio di un’abitazione londinese supera le 500mila sterline (650mila euro al cambio attuale), un fatto che ormai è un incubo persino per la classe media, sempre più impossibilitata a comprare casa. Le giovani coppie scappano sempre più da Londra, città dove già oggi una larghissima parte della popolazione vive in affitto, avendo spesso difficoltà a pagarlo. Ecco così che Khan ha promesso più edilizia sociale per tutti, con l’obiettivo di costruire anche fino a 80mila nuove abitazioni all’anno. Edilizia sociale (o popolare) ma anche case a prezzi calmierati e il rendere la vita più difficile a chi affitta case ed è senza scrupoli. Chissà se il ragazzo cresciuto in un council flat, e che proprio nel giorno delle elezioni ha visitato i suoi poveri ex vicini, riuscirà nell’impresa.
Infine, e non è roba di poco conto in una metropoli così multietnica, la lotta al terrorismo e all’estremismo di ogni genere. “Sarò il sindaco di tutti i londinesi”, ha promesso più volte Khan. Aggiungendo però di voler andare contro tutti quei londinesi che fanno preoccupare Scotland Yard, antiterrorismo e servizi segreti. Nel suo programma elettorale c’è la chiara volontà di “predisporre un piano per affrontare la diffusione dell’estremismo”. Nella sua carriera da avvocato per la difesa dei diritti umani, Sadiq Khan ha difeso tanti clienti dal passato oscuro e dai legami non molto chiari. E i tabloid hanno puntato molte volte sul presunto rischio dell’avere in città un sindaco musulmano.
Per ora una cosa è certa: i londinesi non si sono fatti prendere dalla paura e hanno votato in massa per il “ragazzo più sveglio del Labour”, come è stato più volte definito. Del resto era nello stesso suo proclama elettorale: “Scegliete la speranza e non la paura”, aveva scritto a chiare lettere il nuovo sindaco prima di essere eletto. Per ora i londinesi - e con lui anche i britannici europeisti e mezza Europa tutta - sperano con forza.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Il futuro della Ue è a rischio. I risultati dell’ultimo sondaggio Demos e un’intev. a Marc Lazar.9 maggio 2016, di Federico La Sala
L’Europa si chiude, cresce la voglia di confini, solo i giovani dicono no
L’Italia è il paese più vecchio del continente: nel 2015 la popolazione è scesa di 100mila unità, nel 2013 sono partite 95mila persone, per lo più sotto i 30 anni
Anche per questo da noi, come in altre nazioni, cresce il numero di quelli che vorrebbero alzare muri: i risultati dell’ultimo sondaggio Demos
di Ilvo Diamanti (la Repubblica, 09.05.2016)
PAPA FRANCESCO, come sempre, è stato molto chiaro. Questa volta, semmai, anche più di altre. Perché si rivolgeva a una platea di re, ambasciatori, leader politici ed economici. Fra gli altri: Schulz, Tusk, Juncker, Merkel, Renzi, il re di Spagna Felipe VI. E Draghi. Tutti presenti, alcuni giorni fa, alla consegna del Premio internazionale Carlo Magno al Santo Padre. «Per l’impegno a favore della pace, della comprensione e della misericordia in una società europea di valori». Nell’occasione, però, il Papa ha rammentato quanto l’Europa, oggi, sia in difficoltà nell’affermare i valori a cui si ispiravano i padri fondatori. Tanto più, nell’affrontare il futuro. Perché l’Europa, oggi è una «nonna, vecchia e sterile». Senza più ricordi.
Ieri, non per caso, Francesco ha ricevuto in udienza gli uomini e le donne del Cuamm. L’associazione dei Medici con l’Africa, che ha sede a Padova. Animata per oltre cinquant’anni da don Luigi Mazzucato. Un viandante generoso, che ci ha lasciati circa sei mesi fa. Il Cuamm è divenuto un crocevia della solidarietà fra l’Italia e l’Africa. Dove ha inviato oltre 1000 medici volontari, negli ospedali dell’area subsahariana. Fra le più colpite da malattia, miseria, povertà. Le origini principali delle grandi ondate migratorie che, da tempo, si dirigono in Europa. Attraversano il Mediterraneo, spinte dalla disperazione. Sfruttate da mercanti di dolore. Migliaia e migliaia di “persone” - perché di tali si tratta, anche se si tende a dimenticarlo - che, dopo lo sbarco, se ci riescono, proseguono nel loro esodo difficile e talora penoso. Partono dall’Italia, dalla Grecia. Dalla Turchia, dai Balcani. Dalla Spagna (di cui si parla meno). E si dirigono a Nord. Verso i Paesi dove lo sviluppo e il sistema del welfare offrono maggiori prospettive. E dove li hanno preceduti altre persone, della loro rete familiare, del loro Paese.
Insieme ai migranti, sono cresciute le inquietudini. E i muri. Comunque: i controlli. Lungo i percorsi dell’esodo. Da Sud verso Nord. E fra un Paese e l’altro. L’Austria sta accentuando la sorveglianza in diverse direzioni. Non solo sul Brennero, in questi giorni al centro di polemiche e di scontri. Ma anche ai confini con l’Ungheria, la Slovenia - e, implicitamente, la Croazia e la Serbia. Un esempio seguito, in parte anticipato, dall’Ungheria. Ma le “frontiere” stanno diventando “barriere” anche altrove. In Macedonia, in Bulgaria. Inoltre, al confine tra Paesi che hanno tradizioni civili e democratiche solide. Nel Centro-Nord dell’Europa. Fra Gran Bretagna e Francia, a Calais. E, nei momenti di grande flusso, anche tra Francia e Italia. Mentre la Danimarca e i Paesi scandinavi difendono il loro welfare. Dagli “altri” che vorrebbero accedervi. Il risultato di questo gioco di movimenti e chiusure è il ri-sorgere delle frontiere. Meglio: delle “barriere”.
Perché le frontiere servono. Definiscono confini in base a cui confrontarsi e dialogare. Ma quando diventano blocchi, luoghi di controllo e sorveglianza, allora, diventano ostacoli all’integrazione. Non solo degli “altri”. Anzitutto, “fra noi”. Perché frenano l’integrazione e la costruzione europea. D’altronde, i muri e le frontiere, oggi, hanno un significato eminentemente simbolico. Vengono utilizzati a fini perlopiù politici. Servono, cioè, ad assecondare le paure e ad alimentare i populismi. Popoli alla ricerca di nemici. Figurarsi se - come ha osservato Lucio Caracciolo - la frontiera del Brennero potrebbe scoraggiare il passaggio dei migranti che intendono attraversare l’Austria (per andare altrove, peraltro).
Tuttavia, in Europa, cresce dovunque la domanda di sorvegliare i confini. Basta vedere i dati del sondaggio di Pragma (febbraio 2016) per l’Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, curato da Demos per la Fondazione Unipolis. Nei Paesi europei dov’è stata condotta l’indagine, coloro che “insistono” a rivendicare frontiere aperte, in Europa, costituiscono una minoranza limitata. Talora, molto limitata. Mentre la maggioranza dei cittadini vorrebbe reintrodurre i controlli. Sempre. Non in circostanze particolari. In Italia lo sostiene oltre metà delle persone (intervistate). La domanda di chiusura, peraltro, risulta più elevata fra le persone anziane. Dovunque. Parallelamente, la fiducia nell’Ue è più alta presso i più giovani.
In Italia, il sentimento verso gli “altri”, gli immigrati che giungono da lontano, si traduce in paura. Fra tutti, ad esclusione dei più giovani (indagine Demos, aprile 2016). E produce distacco, sfiducia nelle istituzioni, richiesta di nuove e maggiori divisioni. Forse perché siamo il Paese più vecchio d’Europa. Insieme alla Germania. Che, tuttavia, per questo, mostra un atteggiamento verso gli immigrati ben diverso. Ispirato, cioè, all’apertura “selettiva”. A favore di componenti demografiche (giovani) e “professionali” particolarmente utili al mercato del lavoro. In Italia, invece, di recente si assiste a un declino demografico inquietante.
Nel 2015, ad esempio, la popolazione è calata di circa 100 mila persone. Come non avveniva dal 1917-18. Cioè, dalla Grande Guerra. Perché in Italia fanno meno figli perfino gli immigrati (come spiega l’Istat). Mentre i giovani sono una “razza” in declino. E quando possono se ne vanno. A studiare, lavorare e, infine, a vivere: altrove. Nel 2013, infatti, dal nostro Paese sono partiti quasi 95mila italiani (più degli stranieri arrivati nello stesso periodo). Soprattutto giovani in possesso di titolo di studio elevato.
Così, diventiamo sempre più vecchi, sempre più soli. Sempre più impauriti. E vorremmo chiuderci in casa. Alzare muri e confini dovunque. Intorno a noi. Metafora dell’Europa delineata da Papa Francesco. Ma ridursi a una terra attraversata da frontiere e da muri non coincide con il sogno di Altiero Spinelli, Robert Schuman e Jean Monnet. Evoca, semmai, un incubo. Noi italiani, noi europei: chiusi in casa, in attesa dell’invasione, fra anziani in mezzo ad altri anziani, monitorati da sistemi di allarme sofisticati, sorvegliati da cani mostruosi, osservati da telecamere a ogni passo e a ogni movimento. Ma come possiamo illuderci di essere felici?
“Troppe paure e individualismi il futuro della Ue è a rischio”
Parla il sociologo francese Marc Lazar: “L’Unione è oramai una sorta di capro espiatorio su cui tutti sparano a zero. Per evitare che si disgreghi occorre una vera battaglia culturale”
Serve una riforma delle istituzioni
Per capire dove stiamo andando, il referendum sulla Brexit sarà decisivo
intervista di Anna Lombardi (la Repubblica, 09.05.2016)
«LA paura è senz’altro il tratto unificante dell’Europa in questo momento. Insieme, come mostrano i dati analizzati da Demos, a un grande senso di ripiegamento che non lascia molta speranza sul futuro del progetto europeo».
 Marc Lazar, professore di storia e sociologia politica all’Istituto di Studi Politici di Parigi Sciences Po e alla Luiss di Roma, non è particolarmente ottimista. «L’Europa è diventata una sorta di capro espiatorio su cui tutti sparano a zero. E anche se la sua storia è stata fatta anche da questi grandi momenti di crisi, che hanno spinto a trovare nuove soluzioni, ora, con i movimenti populisti scatenati, è sempre più complicato».
Marc Lazar, professore di storia e sociologia politica all’Istituto di Studi Politici di Parigi Sciences Po e alla Luiss di Roma, non è particolarmente ottimista. «L’Europa è diventata una sorta di capro espiatorio su cui tutti sparano a zero. E anche se la sua storia è stata fatta anche da questi grandi momenti di crisi, che hanno spinto a trovare nuove soluzioni, ora, con i movimenti populisti scatenati, è sempre più complicato».Che cosa ha determinato una crisi così profonda?
«Almeno tre elementi. Il primo è naturalmente legato alla complessità della situazione economica e politica che stiamo attraversando. Un altro è dovuto al fatto che i due principali modelli di integrazione europea, quello multiculturale britannico e quello dell’integrazione repubblicana francese, sono chiaramente in crisi. A questo va aggiunta la paura provocata dalla minaccia terroristica. Se davvero solo il 10 percento dei francesi è favorevole al mantenimento della libera circolazione delle persone, la spiegazione va cercata nel fatto che dopo gli attentati di Parigi i migranti sono associati all’idea che fra loro si insinuano i terroristi».
I dati sembrano mostrarci un’Europa sempre più disgregata anche dal punto di vista generazionale. I giovani sembrano più aperti, mentre la voglia di innalzare barriere cresce con l’età...
«Sarebbe interessante conoscere le differenze sociali all’interno delle diverse fasce di età analizzate, a maggior ragione fra i giovani. Mi sembra normale che chi ha un livello di istruzione più alto è più portato a vedere le barriere come un ostacolo. Mentre chi ha un livello di istruzione inferiore ed è magari in una situazione più difficile vede le cose diversamente. Ha più paura. Ovvio che la cosiddetta generazione Erasmus è potenzialmente più aperta. Per mettere le cose alla pari bisognerebbe inventare una qualche forma di Erasmus anche per chi non ha accesso agli studi universitari. Potrebbe essere un modo per non creare una generazione nella generazione di giovani declassificati, ancor più precari degli altri, che subiscono ingiustizia e forte ineguaglianza. C’è d’altronde un dato che mi colpisce molto proprio fra i giovani...»
Quale?
«L’accettazione della sorveglianza generalizzata nei luoghi pubblici. L’85 percento dei giovani fra i 18 e i 24 anni è favorevole. Numero che scende al 23 per cento se invece si tratta di leggere la posta privata, le email senza consenso. Differenza che resta impressionante anche nelle altre fasce di età. Siamo ormai una società sempre più individualista. Nello spazio pubblico la restrizione della libertà è accettata. Nella vita privata, il rispetto della libertà personale resta un valore. Un cambiamento culturale importante, che non credo dipenda solo dall’effetto Snowden».
Quale futuro si prospetta dai dati analizzati?
«L’Europa non può continuare così. Serve una riforma delle istituzioni, oltre alla ripresa economica e alla riduzione delle ineguaglianze sociali, e una nuova narrazione. Per capire dove stiamo andando, decisivo sarà il risultato del referendum britannico. Per scongiurare il peggio servirebbe una grande battaglia culturale. Purtroppo, a fare discorsi coraggiosi è rimasto solo papa Francesco: è lui che ci ricorda l’importanza della dimensione etica dell’Europa. Ma che sia il solo a farlo, dimostra quanto oggi sia debole la politica in Europa».
-
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- A Papa Francesco il premio Carlo Magno. Le tre missioni del futuro per noi leader della Ue (di Jean-Claude Juncker - Martin Schulz)6 maggio 2016, di Federico La Sala
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
- CHARITÈ: BERLINO RICORDA A PAPA RATZINGER IL NOME ESATTO DELL’ OSPEDALE E DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA. Una nota a margine di un evento
La decisione di conferire quest’anno a Papa Francesco il premio Carlo Magno è eccezionale
Le tre missioni del futuro per noi leader della Ue
di Jean-Claude Juncker - Martin Schulz (la Repubblica, 06.05.2016)
- Jean- Claude Juncker è presidente della Commissione europea Martin Schulz è presidente del Parlamento europeo
LA DECISIONE di conferire quest’anno a Papa Francesco il premio Carlo Magno è eccezionale. Alcuni potrebbero fare dell’ironia sul fatto che all’Unione europea le cose vanno male al punto di avere bisogno di un aiuto dal Papa, mentre altri potrebbero chiedersi perché un Papa che viene dall’Argentina riceva un premio che rende omaggio a chi si è prodigato per l’unificazione pacifica dell’Europa. Siamo convinti che Papa Francesco si sia meritato questo premio per il messaggio di speranza rivolto all’Europa.
Forse occorrono gli occhi di un argentino, che osservano dall’esterno ciò che intimamente lega noi europei, per prendere coscienza dei nostri punti di forza. Proprio in un momento in cui l’Europa e la crisi vengono spesso messe sullo stesso piano, tendiamo facilmente a dimenticare ciò che l’Europa ha già fatto e ciò di cui è capace: i nostri padri e le nostre madri hanno costruito un progetto di pace e umanità che ha visto la luce dalle macerie della Seconda guerra mondiale. Si sono allontanati consapevolmente dalla propaganda bellica, dal desiderio di distruzione e dalla disumanità che hanno caratterizzato la prima metà del XX secolo. Essi hanno invece messo insieme le loro forze per costruire un’Europa dove non vi sarebbero stati vincitori né vinti, bensì solo vincitori. Agendo in tal modo, hanno dimostrato di aver imparato dalla storia che, quando noi europei ci siamo combattuti, le conseguenze sono state tragiche per tutti, mentre quando siamo rimasti uniti tutti ne hanno tratto beneficio.
L’anima dell’Europa è rappresentata dai suoi valori. Ed è proprio a questi ultimi che il Papa ci rinvia quando ricorda che «l’Europa che guarda e difende e tutela l’uomo è un prezioso punto di riferimento per tutta l’umanità». Eppure, in un momento in cui l’Europa passa da un vertice di emergenza all’altro e la gente si chiede se tutti in Europa condividano gli stessi valori, risulta ancora più importante prendere coscienza della nostra forza comune. Nell’era della globalizzazione noi europei abbiamo quanto mai bisogno gli uni degli altri, come testimoniano le tre sfide cui siamo attualmente confrontati.
In primo luogo, la necessità di preservare il nostro stile di vita europeo. In un mondo sempre più connesso, dove emergono inesorabilmente altri Paesi e regioni, dobbiamo unire le nostre forze, in quanto il contributo dell’Europa e dei suoi Stati ai risultati economici mondiali nonché alla popolazione del pianeta si sta riducendo. Chi di fronte a tali prospettive crede che sia arrivato il momento di tornare agli Stati nazionali ha perso il senso della realtà. Tali sviluppi potranno anche non piacerci, ma non possiamo tornare indietro; possiamo invece plasmarli come desideriamo se restiamo uniti. Nessuno Stato membro - per quanto possa essere influente - è in grado da solo di imporre i propri interessi e valori; tuttavia, se resteremo uniti, potremo riuscire a definire le regole che disciplinano la competizione tra le grandi potenze.
Per noi europei appare quindi sensato restare uniti, poiché è in gioco il nostro modello di società, che poggia sui valori di democrazia, Stato di diritto, solidarietà e diritti umani. In Europa sono garantiti i diritti civili, la libertà di stampa e il diritto di sciopero, non si pratica la tortura e non esiste il lavoro minorile né la pena di morte. La nostra forza economica deriva dal mercato unico, la cui solidità ci permetterà di assicurare e sviluppare in futuro il nostro modello sociale europeo fondato sui valori.
Secondo: garantire la sicurezza e la pace. Se noi europei restiamo uniti, possiamo fare grandi cose. Ne sono dimostrazione l’accordo sul nucleare con l’Iran e l’accordo di Parigi sul clima. Questi esempi dovrebbero incoraggiarci, come europei, ad agire uniti e ad assumere maggiori responsabilità sulla scena mondiale. Il mondo è sempre più complesso e, secondo alcuni, più pericoloso. Gli Stati Uniti riducono progressivamente il loro impegno a livello internazionale, la Russia si mostra sempre più aggressiva, la Cina acquisisce influenza nell’Asia orientale. Nel nostro immediato vicinato sono in atto conflitti e guerre: in Siria si registrano ogni giorno nuove vittime, mentre nell’Ucraina orientale la situazione rimane preoccupante. Gli attentati di Bruxelles, Lahore, Istanbul e Parigi ci ricordano amaramente che il terrorismo islamico rappresenta una minaccia globale. Di fronte a un simile scenario mondiale non possiamo permetterci di sprecare le nostre forze a causa di vanità nazionali. Dobbiamo esprimerci con una sola voce: solo così potremo rafforzare la nostra influenza.
Terzo: gestire la migrazione. Oggi le persone in fuga da guerre, conflitti e persecuzioni sono molto più numerose che in ogni altro periodo dopo la Seconda guerra mondiale. Uomini, donne e bambini vengono da noi in cerca di protezione dalla brutalità dello Stato islamico e dalle bombe di Assad. Il problema ha una portata tale che nessuno Stato membro è in grado di risolverlo da solo; insieme però possiamo condividere questa responsabilità, in quanto continente con oltre 500 milioni di abitanti.
La visita di Papa Francesco a Lesbo è stata più di un gesto simbolico. Accogliendo dodici profughi siriani, ha agito in modo più concreto e solidale di molti Stati dell’Unione. Papa Francesco incoraggia anche noi ad agire. La solidarietà e l’amore per il prossimo non devono essere soltanto belle parole; questi valori sono importanti solo se li mettiamo in pratica. È quello che fanno ogni giorno numerose decine di migliaia di volontari che si adoperano fino allo sfinimento e anche oltre per garantire alle persone un rifugio dal terrore, dalla guerra e dalla violenza. Forniscono cibo ai rifugiati, si assicurano che abbiano vestiti e sostengono i bambini nell’apprendimento per garantire loro un futuro. Questi volontari mostrano ai rifugiati e al mondo intero il volto di un’Europa umana.
È anche questo il compito della politica, soprattutto in un continente che troppo spesso, nella sua storia, è stato diviso da muri e recinzioni, trincee e frontiere. Superare queste divisioni per creare un’Europa di pace e di benessere è stata una delle nostre conquiste. Ciascuno di noi ne beneficia, ad esempio quando viaggiamo o commerciamo oltre le frontiere.
A tale riguardo, Papa Francesco ripone in noi una grande fiducia e auspica che riusciremo a sfruttare meglio le nostre potenzialità. Il nostro modo europeo di cooperare e gettare ponti tra i popoli e i Paesi ci ha già permesso, in fondo, di superare la divisione del nostro continente. Di fronte alle molteplici crisi odierne, abbiamo più che mai bisogno di attingere a questa forza. Le premesse sono forse migliori di quanto non crediamo. In ogni caso, Papa Francesco ci infonde coraggio quando afferma che «le difficoltà possono diventare promotrici potenti di unità». È ormai tempo che noi europei ci mobilitiamo e lottiamo insieme per un’Europa unita.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- I «dannati della terra» e il tradimento del profugo Enea.(di Guido Crainz)28 aprile 2016, di Federico La Sala
- TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA ....
 L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI TROIA: L’ANALISI DI CARLO LEVI.
L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI TROIA: L’ANALISI DI CARLO LEVI.
Il tradimento del profugo Eneadi Guido Crainz (la Repubblica, 28.04.2016)
HANNO il significato di un simbolo le scelte dell’Austria sul Brennero, un simbolo che fa inevitabilmente riaffiorare fantasmi del passato. E rende ineludibili i nodi già emersi nei mesi scorsi assieme ai muri eretti in molte forme da differenti Paesi.
ASSIEME a quei muri: la dolente e straziata popolazione dei profughi ha reso solo evidenti questioni più profonde. Certo, sulle decisioni austriache influiscono oggi ragioni e tensioni elettorali ma non è inevitabile che i peggiori nazionalismi facciano vincere le elezioni (né che i socialdemocratici inseguano gli avversari sul loro terreno nel vano tentativo di non perderle): sul perché si è giunti a questo è dunque necessario continuare a interrogarsi.
Non c’è dubbio, l’ipotesi di chiudere il Brennero è una resa dell’Europa, è contro la storia e contro il futuro: non c’è nulla da aggiungere a quel che hanno detto il presidente Renzi e la presidente Boldrini. Quell’ipotesi tocca da vicino il nostro vissuto, ci richiama alla mente il sofferto percorso con cui abbiamo superato lacerazioni drammatiche: la generazione cresciuta negli anni Cinquanta e Sessanta ha ancora memoria viva, ad esempio, delle tensioni connesse al nodo del Sudtirolo, per non evocare più antichi traumi e tragedie.
Abbiamo memoria, anche, della stella polare che ci ha aiutati a superare quelle lacerazioni ed è proprio quella stella polare, l’Europa, ad essere oggi a rischio. Con questo ci stiamo misurando. Poco tempo fa, su Repubblica, Giorgio Napolitano ha ricordato al presidente austriaco le speranze del 1998, quando «da ministro dell’Interno fui al Brennero con il mio omologo ministro austriaco per rimuovere insieme la barriera al confine tra i nostri due Paesi». Non è immaginabile che si torni indietro, ha concluso giustamente Napolitano, ma è proprio l’inimmaginabile a fare paura. Molte altre barriere sono cadute poi in tutta Europa nel dicembre del 2007, superando ferite storiche: sembrava ancor più impossibile tornare indietro eppure sta succedendo. Di questo si tratta e con questo dobbiamo misurarci, assieme all’obbligo di dare al dramma dei profughi la risposta che i Paesi civili sono tenuti a dare.
Toccandoci da vicino, dunque, le scelte che riguardano il Brennero ci precludono definitivamente le rimozioni in cui troppe volte abbiamo cercato rifugio. Destre aggressive e nazionalismi xenofobi erano apparsi già prima di quel gioioso 2007: dall’esplosione del movimento di Jean Marie Le Pen, nel 2002, al diffondersi di movimenti non dissimili in diverse aree europee; dai pronunciamenti referendari della Danimarca e della Svezia contro l’euro a quello della Francia e dei Paesi Bassi contro la Costituzione europea. Ben prima delle dilaganti esplosioni dell’ultimissimo periodo.
Sottovalutammo questi e altri segnali, e sottovalutammo quel che Carlo Azeglio Ciampi aveva annotato nei suoi diari già molto prima, al momento stesso del varo dell’euro: è necessario ora, scriveva, un rinnovamento complessivo capace di investire anche la cultura, i costumi, gli stili di vita. È stato inevitabile, aggiungeva allora Ezio Mauro, avviare l’unificazione «attraverso l’unico comun denominatore oggi possibile, quello della moneta » ma è ormai urgente «dare un contesto istituzionale, culturale e politico a questa moneta. Perché rappresenti l’Europa e non soltanto undici Paesi comandati da una banca».
A questa sfida siamo mancati: è mancata la politica e più ancora - è necessario dirlo - è mancata la cultura: ad essa in primo luogo spettava costruire ponti (lo aveva scritto da sempre Alex Langer), delineare orizzonti e utopie comuni, ragioni di fratellanza e di comunità. Non è successo, o è successo troppo, troppo poco.
Non è responsabilità solo della politica dunque se, lontana ormai la stagione delle speranze, i cittadini europei vivono oggi in una Unione priva di strumenti istituzionali efficaci e in un continente quasi sconosciuto.
Ignari più di prima dei processi in corso al suo interno, esposti alle pulsioni nazionaliste e al tempo stesso incapaci di comprenderne le radici. E incapaci di dare risposte civili ai «dannati della terra» che cercano rifugio in Europa e in Italia. Quell’Italia che in fondo, ci ha ricordato un bel libro di Fabio Finotti, ha il suo mito fondativo nel profugo Enea.
- TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA ....
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Lawrence D’Arabia (l’uomo che creò l’Oriente): se non manteniamo la parola «il prezzo da pagare sarà altissimo» (di Giuseppe Catozzella)28 aprile 2016, di Federico La Sala
Due saggi raccontano come l’Occidente non solo ridisegnò la geografia delle terre tra Egitto e India, ma ne fece un’ideologia
Lawrence D’Arabia l’uomo che creò l’Oriente
“Se non manteniamo la parola con quei popoli genereremo rabbia e fanatismo”
di Giuseppe Catozzella (la Repubblica, 28.04.2016)
Per Edward Said il modo dell’Occidente di rapportarsi al Medio Oriente ha un nome preciso: “Orientalismo” (titolo del suo saggio del 1978). E orientalismo è «l’insieme delle istituzioni create dall’Occidente al fine di gestire le proprie relazioni con l’Oriente». Istituzioni che implicano rapporti di forza economici, politici e militari. Ma occorrono anche, per Said, “fattori culturali”, vale a dire un «insieme di nozioni sull’Oriente», non importa se veritiere o fittizie, che consentano all’Occidente di esercitare «la propria influenza e il proprio predominio » su quelle terre. Un discorso, comune e condiviso da tutto l’Occidente, nell’accezione suggerita da Foucault nell’Archeologia del sapere. Senza quel discorso, quei fattori culturali, spiega Said, «risulta impossibile spiegare la disciplina costante e sistematica con cui la cultura europea ha saputo trattare - e persino creare - l’Oriente in campo politico, sociologico, militare, ideologico, scientifico e immaginativo». L’idea che oggi abbiamo di quelle terre, «sede delle più antiche, ricche, estese colonie europee» è, per Said, frutto di decenni di pratiche discorsive su «uno dei più ricorrenti e radicati simboli del Diverso ».
Ma dove si forma questo discorso, come oggi lo conosciamo? Un libro di Phillip Knightley e Colin Simpson, da poco pubblicato, Le vite segrete di Lawrence d’Arabia (Odoya, pagg. 362, euro 22), rintraccia quel momento nel primo periodo in cui Thomas Edward Lawrence, a diciannove anni, si iscrisse a Oxford, nel 1907. Lì conobbe David George Hogarth, suo mentore, confessore e protettore, senza il quale «non è esagerato dire che non ci sarebbe stato nessun Lawrence d’Arabia». Hogarth lo introdusse al circolo della Round Table, un periodico che propugnava la Federazione (cioè l’unione di tutti i bianchi dell’Impero) e l’Imperialismo. Sulle sue pagine si legge del ruolo di «principale forza civilizzatrice dei paesi di lingua inglese», e che l’imperialismo «dovrà diventare la fede riconosciuta di tutta la nazione ».
È così che Lawrence, attraverso il suo maestro, coltiva, come scrive lui stesso, l’idea di «formare una nuova nazione di gente entusiasta della nostra libertà e desiderosa di entrare a far parte del nostro Impero»: si riferisce al popolo arabo, a coloro che stavano tra l’Egitto e l’India, i due grandi possedimenti della Corona.
Un altro testo, recentemente pubblicato, ci viene in aiuto. È Lawrence d’Arabia e l’invenzione del Medio Oriente di Fabio Amodeo e Mario José Cereghino (Feltrinelli, pagg. 208, euro 17), dove si comprende come «all’inizio del Novecento la parola Medio Oriente non esisteva. A usarla per primo fu nel 1902 Alfred Mahan sulla National Review». Non era infatti ancora sorta la necessità di identificare le terre tra Egitto e India. Mahan era un ammiraglio, e per primo teorizzò che «la Royal Navy dovesse proteggere le rotte tra il Canale di Suez, il Mar Rosso, il Golfo Persico».
Perché? C’era, certo, la doppia minaccia: da nord, da parte «dello zar di tutte le Russie»; e da ovest, «la crescente egemonia finanziaria e commerciale del Reich tedesco sulla Turchia asiatica». Ma c’era anche altro. Verso la fine del 1908, Lawrence presenta l’idea della sua tesi di laurea: la premessa è che i crociati abbiano portato nel Medio Oriente quei princìpi di architettura militare che in genere tutti gli esperti asseriscono venire dal Medio Oriente. Così, impara l’arabo e parte per la Siria, che allora comprendeva le attuali Israele, Giordania e Libano. Ma queste spedizioni archeologiche erano finanziate da ministeri che con l’archeologia nulla avevano a che vedere.
Ecco che Lawrence si trova in pieno dentro il Grande Gioco, e nel 1914, Hogarth lo fa entrare nei servizi segreti militari. Occorreva vincere la Prima guerra, e vincerla sia via mare, sfruttando la geniale trovata dell’ammiraglio Fisher di alleggerire i vascelli militari dal carbone, alimentandoli con motori a scoppio da poco inventati, sia via terra «sfruttando gli arabi per scardinare la Sublime Porta».
Così Lawrence, il 10 giugno 1916, convince «lo sceriffo della Mecca a innalzare il suo vessillo contro i turchi», e per farlo promette loro la libertà e l’indipendenza, pur sapendo che una volta vinta la guerra la politica imperiale britannica, che lui ha collaborato a formulare, farà di quelle promesse lettera morta. Certo, scrive Lawrence, «era meglio vincere e rinnegare la parola che perdere». E non soltanto per questioni geografiche. I dispacci che giungevano alla Corona parlavano infatti del «propellente del futuro, un idrocarburo viscoso, i cui giacimenti si trovano tra la Persia e la Mesopotamia (attuali Iran e Iraq): petrolio ». Energia del futuro capace di far correre le nuove navi della Royal Navy. Nascono le grandi compagnie petrolifere, dalla Turkish Petroleum, alla Shell, alla Deutsche Bank Petroleum.
Gli arabi sconfiggono gli Ottomani, ma in cambio non ottengono nulla. Al contrario, Inghilterra e Francia si dividono il neonato Medio Oriente creando nazioni a tavolino nate per spartire le royalties dei proventi dei pozzi, sulla base dell’accordo di Sykes-Picot, senza tenere conto delle differenti etnie o confessioni: «Sciiti con sunniti, curdi con armeni, alawiti con drusi». La Mesopotamia (l’Iraq) e la Persia (Iran) agli inglesi, e così la Palestina. Fu inventata la Giordania, sempre agli inglesi. La Siria e il Libano ai francesi. La penisola arabica finì sotto il controllo inglese.
Lawrence, di fronte al fatto compiuto e pentito, in quei mesi avvertì: se non manteniamo la parola «il prezzo da pagare sarà altissimo», si genererà un «desiderio di riscatto, rabbia e deviazioni fondamentaliste». Rimase inascoltato.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- La dissuasione della «cristiana» civiltà europea. C’è poca democrazia in questa Europa.28 aprile 2016, di Federico La Sala
La dissuasione della «cristiana» civiltà europea
di Alessandro Dal Lago (il manifesto, 27.04.2016)
È sicuro ormai che l’Europa è solo all’inizio di un processo di decomposizione politica. I segnali si moltiplicano. La vittoria dell’estrema destra in Austria, la crisi polacca, il regime di Orbán, l’affermazione dell’AdP in Germania, la chiusura delle frontiere, il referendum sul Brexit. Ma il voto con cui la Camera dei comuni inglese ha rifiutato di accogliere i 3000 bambini di Calais è qualcosa di molto più profondo e sinistro di una crisi politica continentale. È, come hanno notato i critici della decisione, di qualcosa di vergognoso.
Perché in gioco, oltre al destino migliaia di orfani, c’è un confine che le cosiddette democrazie occidentali non dovrebbero, almeno ufficialmente, varcare: il senso minimo di umanità, quello che per gli apologeti distinguerebbe la «civile» Europa dagli altri mondi.
Oddio, anche sequestrare beni ai profughi, come fanno la Danimarca e altri stati della Ue, è vergognoso, proprio come lasciarli alla deriva a Idomeni e Lesbo, o dare un po’di quattrini a Erdogan perché non ce ne mandi altri.
Ma i bambini non dovrebbero essere sacri, nell’Europa cristiana, cattolica, anglicana o luterana che sia? Con il voto alla Camera dei comuni, la risposta è stata semplicemente «No!» D’altra parte, i leader della Afd tedesca non hanno forse dichiarato che è legittimo sparare ai profughi che attraversano illegalmente i confini, anche quando sono donne e bambini? Certo, i conservatori inglesi a parole non arrivano a tanto. Ma il risultato non è molto diverso.
Che fine faranno i bambini che il socialista Hollande fa marcire a Calais, tra assalti xenofobi e manganellate? Nessuno lo sa e a nessuno interessa.
La motivazione del voto inglese è sublime nella sua ipocrisia squisitamente british. Noi non li accogliamo, per dissuadere altri profughi dal chiedere asilo in Inghilterra. Con la stessa scusa, le navi militari inglesi non soccorrono più la carrette del mare dei migranti nel Mediterraneo.
Ora, immaginiamo dei bambini che scampano alla morte in Siria e poi ai naufragi nell’Egeo o nel canale di Sicilia. Ebbene, qualcuno pensa che si faranno dissuadere dal passare in Europa, e magari dal raggiungere dei parenti in Inghilterra, pensando al voto della Camera dei comuni? Quando la Svizzera respinse i profughi ebrei che scappavano dalla Germania con la motivazione che «la barca piena», si macchiò della stessa vergogna, ma con meno ipocrisia.
Noi europei, dopo la Shoah, non dovremmo sorprenderci più di nulla. E nemmeno pensare che, con la sconfitta del nazismo e del fascismo, siamo al sicuro dagli stermini di massa. Migranti e profughi muoiono a migliaia per raggiungere le nostre terre benedette dalla ricchezza.
Dopo un po’ di lacrimucce sui bambini annegati sulle spiagge greche e turche, ecco che prendiamo a calci quelli che non sono annegati, o semplicemente ne ignoriamo l’esistenza.
Noi europei, così civili e democratici, stiamo gettando le premesse di nuovi stermini, magari per omissione, disattenzione o idiozia. Ma per le vittime non fa nessuna differenza.
C’è poca democrazia in questa Europa
di Giovanni Belardelli (Corriere della Sera, 27.04.2016)
L’Europa è mortale? Così un giornale non sospettabile di antieuropeismo come Le Monde ha intitolato un lungo articolo sulla situazione attuale dell’Unione Europea. Per sottolineare il rischio di fine imminente che la minaccia e insieme l’inconsapevolezza che di ciò sembriamo avere, l’autore dell’articolo, Arnaud Leparmentier, ha paragonato la nostra condizione a quella che Stefan Zweig, nel Mondo di ieri , attribuiva all’impero asburgico alla vigilia del fatidico giugno 1914: «Tutto nella nostra quasi millenaria monarchia austriaca sembrava duraturo e lo Stato stesso appariva il sommo garante di questa ininterrotta solidità». Le cose, come è universalmente noto, avrebbero preso tutt’altra direzione.
Non è la prima volta che vengono formulati paragoni del genere: tre anni fa un centro studi americano, il Pew Research, definì la Ue come «il malato d’Europa», riprendendo l’espressione che un tempo si usava per l’impero ottomano (e anche in questo caso è ben noto come andò a finire).
Eppure la nostra discussione pubblica sembra non prendere troppo sul serio questi segnali di allarme e predilige temi e toni legati alla quotidianità: la polemica Merkel-Draghi, la guardia di frontiera europea, l’ultima dichiarazione di Juncker sulla richiesta italiana di flessibilità e così via.
Tutte cose rilevanti, non c’è alcun dubbio, e tuttavia che danno vita a dibattiti e analisi non adeguati alla crisi di fondo che l’Unione Europea sta attraversando. Una crisi che, a partire dal 2008, è esplosa proprio sul terreno che più costituiva il legittimo vanto degli europei: l’economia. Ma anche una crisi che in questi ultimi anni si è andata allargando ad altri terreni: dall’incapacità di dar corpo a una politica estera europea alla indisponibilità di molti Paesi dell’Ue ad applicare gli accordi sul ricollocamento dei richiedenti asilo.
Il modo prevalente in cui la maggioranza dei media, dei politici, degli esperti di vario genere affronta ciascuno dei terreni di crisi è caratterizzato da forme verbali esortative: di fronte a Stati che ripristinano i controlli alle frontiere si dichiara che non ci devono essere muri; di fronte alle migrazioni di massa si afferma che si deve realizzare la redistribuzione dei migranti; che si deve attuare un servizio di sicurezza europeo; anzi, più in generale, una vera unione politica europea.
Il discorso europeista, in sostanza, corrisponde sempre più a quella forma verbale esistente in alcune lingue che è l’ottativo: una forma che esprime un desiderio, un auspicio e poco si cura del fatto che la sua realizzazione trovi ostacoli spesso non superabili. Primo fra tutti il fatto che, su ciascuna delle soluzioni appena citate, è ampiamente documentato il disaccordo dell’opinione pubblica di questo o quel Paese.
Ma di ciò che pensano i cittadini europei - della loro crescente disaffezione per le istituzioni comunitarie - generalmente poco ci si cura. A volte, anzi, si è teorizzato che non vi si debba prestare troppa attenzione: quei cittadini, e i loro governi, avrebbero la colpa di non riuscire a prescindere dall’orizzonte nazionale, soltanto negando il quale l’Europa può avere un futuro.
Sta probabilmente qui, nell’illusione che gli Stati nazionali fossero entrati in una crisi definitiva dopo il 1945 e fossero perciò destinati a una rapida scomparsa, uno dei limiti culturali originari dell’europeismo ufficiale. Non solo perché quella previsione non si è realizzata, ma anche perché ad essa si accompagnava la mancata comprensione del nesso tra Stato nazionale e democrazia.
Sulla scia di John Lennon possiamo auspicare che in un futuro più o meno lontano non sia più così («Imagine there’s no countries, it isn’t hard to do...»), ma fino a oggi lo Stato nazionale ha rappresentato (e continua a rappresentare) la premessa e l’ambito di esistenza della democrazia.
Stigmatizzare il fatto che la cancelliera Merkel sia tornata indietro rispetto al suo iniziale atteggiamento di apertura verso gli immigrati per seguire l’orientamento dell’opinione pubblica tedesca ha poco senso. Cos’altro mai dovrebbe fare il capo del governo in un regime democratico?
Ma la democrazia, il rapporto di fiducia tra eletti ed elettori, è marginale se non assente nella complessa struttura di governo delle istituzioni europee. Secondo alcuni ciò sarebbe addirittura un bene, perché solo il carattere funzionariale-burocratico di quelle istituzioni permetterebbe di fare il superiore interesse europeo contro gli interessi nazionali. Prima o poi bisognerà riconoscere che è una strada pericolosa, che rischia di allontanare ancora di più i cittadini dalle istituzioni europee, lasciando ai vari populismi antieuropeisti - dal partito di Farage ad Alternative für Deutschland - la non disprezzabile risorsa di potersi presentare come i paladini della democrazia.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Quando il mondo non ascoltò Keynes. E sbagliò (di Luca Fantacci)21 aprile 2016, di Federico La Sala
Bretton Woods, quando il mondo non ascoltò Keynes. E sbagliò
A settant’anni dalla morte del celebre e spesso evocato economista britannico, raccontiamo il giorno in cui il suo sogno di creare una moneta globale fu sconfitta, nonostante con ogni probabilità avesse ragione
di Luca Fantacci (LINKiesta, 21 Aprile 2016)
- Pubblichiamo un estratto del volume “Moneta Internazionale. Un piano per la libertà del commercio e il disarmo finanziario” (ll Saggiatore) che raccoglie alcuni scritti dell’economista britannico John Maynard Keynes legati al suo sogno di creare, dopo il secondo conflitto bellico, una moneta internazionale in grado di garantire la pace. Il brano in questione è tratto dall’introduzione dell’economista Luca Fantacci, che ha tradotto e curato l’opera. E che racconta come l’idea di Keynes fu sconfitta dagli americani e dall’adozione del dollaro come moneta universale.
 A settant’anni dalla morte, le parole di Keynes suonano profetiche. Quando preconizza il dominio del mondo da parte degli Usa attraverso il Dollaro. Quando ammonisce contro il rischio di colonialismo finanziario attraverso aiuti a pioggia da parte dei paesi ricchi a quelli poveri. E quando coglie, ai suoi albori, tutto il potenziale di instabilità politica - non solo finanziaria - che un sistema così concepito porta con sé.
A settant’anni dalla morte, le parole di Keynes suonano profetiche. Quando preconizza il dominio del mondo da parte degli Usa attraverso il Dollaro. Quando ammonisce contro il rischio di colonialismo finanziario attraverso aiuti a pioggia da parte dei paesi ricchi a quelli poveri. E quando coglie, ai suoi albori, tutto il potenziale di instabilità politica - non solo finanziaria - che un sistema così concepito porta con sé.
Dopo tre anni di pianificazione e di negoziati bilaterali, Gran Bretagna e Stati Uniti giungono a formulare una proposta congiunta, il cosiddetto Joint Statement. Stilato ad Atlantic City nell’aprile del 1944, il documento fungerà da base di discussione per la conferenza dei paesi alleati che si apre a Bretton Woods il 10 luglio successivo, e dalla quale emergono, dopo tre settimane di colloqui, gli accordi che dettano le regole dell’ordine monetario postbellico.
Keynes vive la firma degli accordi come una dichiarazione di resa incondizionata. È costretto a firmare senza nemmeno poter leggere il testo definitivo dall’inizio alla fine. È pur vero che lui stesso, nel corso delle trattative, ha sostenuto l’importanza di raggiungere un’intesa anche a costo di qualche compromesso. È lecito dubitare, tuttavia, che al momento della stipula Keynes fosse nella condizione di apprezzare la reale portata delle concessioni che si apprestava a sottoscrivere.
Solo poco prima della chiusura della conferenza, infatti, gli statunitensi introducono arbitrariamente nel testo degli accordi quello che sarà l’elemento più importante dell’intero sistema economico internazionale del dopoguerra: l’utilizzo del dollaro come moneta internazionale.
I contorni precisi della vicenda sono emersi solo di recente, con la pubblicazione integrale degli atti della conferenza. Ne emerge con chiarezza che, ancora a pochi giorni dalla conclusione, la bozza prevedeva un sistema perfettamente simmetrico, in cui nessuna valuta di nessun paese godeva di uno status privilegiato. Sarebbe stato l’oro a conservare il ruolo di unità di conto internazionale. Si delineava, in sostanza, una riedizione del gold standard, in cui il Fondo monetario, attraverso i propri prestiti, avrebbe avuto la funzione di attenuare le rigidità e le tendenze deflative che avevano caratterizzato i precedenti sistemi a base aurea. Il riferimento al dollaro americano è inserito all’ultimo momento, senza alcuna discussione e senza che i delegati mostrino la minima consapevolezza delle implicazioni.
Che nel 1944 il dollaro possa essere accettato come equivalente dell’oro è piuttosto ovvio: la sua parità aurea è fissa da più di un secolo, i forzieri di Fort Knox custodiscono oltre l’80 per cento delle riserve auree mondiali, la convertibilità del dollaro in oro (35 dollari per ogni oncia) non può essere messa in dubbio. Eppure, sancire sul piano giuridico un’equivalenza di fatto non è privo di conseguenze. Adottare una moneta nazionale come moneta internazionale significa, come aveva ammesso lo stesso White qualche anno prima, sia pure in termini astratti e alquanto eufemistici, «accordare al paese titolare di quella valuta un qualche lieve vantaggio in termini di pubblicità o di commercio».
Di fatto, la possibilità di utilizzare la propria moneta come mezzo di pagamento internazionale fornisce agli Stati Uniti una fonte di liquidità potenzialmente illimitata, al servizio dell’egemonia mondiale e delle sue molteplici leve: aiuti internazionali, commercio, investimenti esteri, spese militari.
Keynes ha il sentore che il sistema di Bretton Woods non nasca sotto i migliori auspici, come lascia trasparire nel breve discorso che tiene a Savannah il 9 marzo 1946, in occasione della sua inaugurazione (Documento vii). Il tono è sarcastico dall’inizio alla fine, e tradisce la delusione di Keynes nel veder naufragare per la seconda volta le sue speranze di porre fine alla guerra con una vera pace.
- Keynes, parlando della nascita del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, invoca la benedizione di tre fatine, affinché donino ai gemelli imparzialità, forza e saggezza. Ed esprime l’auspicio che il maestro di cerimonie non abbia dimenticato di invitare al battesimo una quarta fata, cattiva, che per ripicca avrebbe maledetto i neonati, facendoli diventare due politici
La conferenza di Savannah è il «battesimo dei gemellini», esordisce Keynes, riferendosi al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (destinata a diventare, in seguito, la Banca mondiale). E subito ironizza sui nomi delle due creature, che sembrano essere stati invertiti: quella a cui si dà il nome di Banca funziona, di fatto, come un fondo d’investimento; quella battezzata come Fondo, in realtà, è, o avrebbe dovuto essere, una banca commerciale. Questa inversione non è un errore di poco conto agli occhi di Keynes, che aveva sempre insistito sull’opportunità di distinguere fra una finanza di breve termine, al servizio degli scambi commerciali, sostanzialmente garantita dai beni reali, e una finanza di lungo termine, strutturalmente esposta all’incertezza, a sostegno degli investimenti.
Keynes prosegue invocando la benedizione di tre fatine, affinché donino ai gemelli imparzialità, forza e saggezza. Ed esprime l’auspicio che il maestro di cerimonie non abbia dimenticato di invitare al battesimo una quarta fata, cattiva, che per ripicca avrebbe maledetto i neonati, facendoli diventare due politici. Pochi giorni dopo, Keynes s’imbarca da New York per rientrare in Inghilterra. Chi lo incontra a bordo della Queen Mary lo descrive deluso e amareggiato, intento a scrivere quello che sarà il suo ultimo articolo, sugli squilibri della bilancia dei pagamenti americana.
Non passa molto tempo, infatti, prima che i presentimenti di Keynes si mostrino fondati e la fata maligna consumi la sua vendetta. I moventi politici, in effetti, dominano le relazioni economiche internazionali del dopoguerra. Non tanto attraverso il Fondo monetario e la Banca mondiale che, essendo dotati di un capitale irrisorio e inadeguato ai loro compiti, sono relegati a un ruolo marginale. Sono gli Stati Uniti il vero centro di potere: nel nuovo regime monetario internazionale imperniato sul dollaro possono agire da fonte di liquidità per il mondo intero.
E lo fanno, in effetti, con una generosità senza precedenti. Il Piano Marshall costituisce notoriamente il programma di aiuti internazionali più ingente della storia. Altrettanto noto è che non risponde solo a una logica di potenziamento economico, ma anche alla necessità politica di consolidare il blocco occidentale di fronte alla minaccia sovietica. Ciò che invece rischia di passare inosservato è che le generose donazioni americane sono rese possibili proprio dal regime di eccezione di cui godono gli Stati Uniti, in virtù dello status privilegiato del dollaro come moneta internazionale.
Come la vedova di Sarepta, l’America può dare allo straniero ciò di cui ha bisogno, senza che nulla venga a mancare a lei. I miliardi di dollari che mette a disposizione degli alleati non riducono di un solo centesimo il denaro che le resta, poiché quei dollari sono creati dal nulla. Sono aiuti senza costo... ma non senza prezzo: ciò che si perde, tanto nel caso dei donatori quanto nel caso dei beneficiari, è il senso economico delle loro reciproche relazioni. Non c’è modo di distinguere fra dono, prestito e scambio, in un regime in cui tutti e tre possono essere praticati indifferentemente senza intaccare il potere d’acquisto di chi li effettua.
Keynes aveva messo in guardia da un simile rischio: «Sarebbe altresì un errore sollecitare, di nostra iniziativa, un aiuto finanziario degli Stati Uniti a nostro favore dopo la guerra, che sia a titolo di dono, di prestito senza interesse o di ridistribuzione gratuita di riserve auree». Perciò aveva respinto ogni idea di «piano filantropico crocerossino, grazie al quale i paesi ricchi vengono in soccorso di quelli poveri».Cinque anni prima che fosse concepito il Piano Marshall, Keynes contestava la logica che lo avrebbe ispirato: era una logica di potenza che avrebbe sbilanciato irreparabilmente le relazioni economiche e finanziarie, consegnando al paese più ricco la fonte stessa della ricchezza, consentendogli di acquistare senza spendere, di prestare senza rinunciare, di donare senza perdere.
- Pubblichiamo un estratto del volume “Moneta Internazionale. Un piano per la libertà del commercio e il disarmo finanziario” (ll Saggiatore) che raccoglie alcuni scritti dell’economista britannico John Maynard Keynes legati al suo sogno di creare, dopo il secondo conflitto bellico, una moneta internazionale in grado di garantire la pace. Il brano in questione è tratto dall’introduzione dell’economista Luca Fantacci, che ha tradotto e curato l’opera. E che racconta come l’idea di Keynes fu sconfitta dagli americani e dall’adozione del dollaro come moneta universale.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Papa a Lesbo: "Non siete soli, imploro l’Europa". Dall’isola greca riparte per Roma con 12 profughi.16 aprile 2016, di Federico La Sala
Papa a Lesbo: "Non siete soli, imploro l’Europa". Dall’isola greca riparte per Roma con 12 profughi
Conclusa la visita nell’isola greca emblema dell’emergenza
di Redazione ANSA *
Papa Francesco è rientrato a Roma dopo il suo viaggio sull’isola greca di Lesbo. Il Pontefice, sul volo di ritorno, ha portato con sé dodici profughi: saranno ospitati a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. Si tratta di tre famiglie di rifugiati dalla Siria, di cui 6 minori. Erano già presenti nei campi di accoglienza di Lesbo prima dell’accordo fra Unione Europea e Turchia. Tutti i membri delle tre famiglie sono musulmani. "Non ho fatto una scelta tra cristiani e musulmani: queste tre famiglie avevano carte e documenti in regola e potevano venire. In liste c’erano anche due famiglie cristiane ma non avevano le carte in regola. Nessun privilegio". Così il Papa ha risposto a una giornalista che chiedeva perché i profughi ospitati oggi sul volo papale fossero tutti musulmani. "I dodici - ha commentato Francesco - sono tutti figli di Dio". Polemico il leader della Lega Matteo Salvini: "I poveri ci sono anche vicino al Vaticano, ma fa più cchic andarli a prendere".
Per fare memoria delle vittime delle migrazioni, nel porto di Mitilene, a Lesbo, papa Francesco, il patriarca ecumenico di Costantinopoli e l’arcivescovo ortodosso greco Hieronymos, dopo aver recitato ciascuno una preghiera e dopo un minuto di silenzio, hanno ricevuto da tre bambini delle corone di alloro che hanno lanciato in mare dal molo.
"Voglio dirvi che non siete soli", e "questo è il messaggio che oggi desidero lasciarvi: non perdete la speranza!". Immergendosi tra le centinaia di profughi del Moria Camp di Lesbo, papa Francesco ha voluto portare fisicamente oggi la propria vicinanza e solidarietà a chi, spesso in condizioni disperate, fugge da guerre, persecuzioni e privazioni, lanciando un forte appello a che il mondo affronti questa che - ha detto ai giornalisti durante il volo da Roma - è "la catastrofe più grande dopo la seconda guerra mondiale".
"Un viaggio diverso dagli altri, segnato dalla tristezza", ha definito Francesco questa sua visita-lampo a Lesbo, la ’Lampedusa dell’Egeo’, teatro di tanti drammi di chi cerca di entrare in Europa fuggendo soprattutto dalla guerra siriana.
Accolto al suo arrivo dal premier Alexis Tsipras, e costantemente accompagnato dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e dall’arcivescovo greco Hieronymos, ai quali di deve l’invito al Pontefice, Francesco ha salutato uno per uno i rifugiati accolti nel campo dell’isola, ascoltato le loro storie, consolato il loro pianto.
"Siamo venuti per richiamare l’attenzione del mondo su questa grave crisi umanitaria e per implorarne la soluzione", ha detto poi nel suo discorso. "Speriamo che il mondo si faccia attento a queste situazioni di bisogno tragico e veramente disperato, e risponda in modo degno della nostra comune umanità". Lodando la "generosità" mostrata dal popolo greco, pur nelle difficoltà della sua grave crisi economica, Bergoglio ha rivolto un chiaro appello all’Europa: "Possano i nostri fratelli e le nostre sorelle in questo continente, come il Buon samaritano, venirvi in aiuto in quello spirito di fraternità, solidarietà e rispetto per la dignità umana, che ha contraddistinto la sua lunga storia".
TWEET DEL PONTEFICE
Con Bartolomeo e Hieronymos, quindi, Francesco ha firmato una dichiarazione congiunta in cui, rinnovando il richiamo alla comunità internazionale ad affrontare decisamente la crisi umanitaria, si chiedono soluzioni contro i conflitti in corso, la difesa delle minoranze dalle persecuzioni e la fine dei traffici di persone, oltre all’estensione dell’asilo temporaneo e alla concessione dello status di rifugiato a tutti quanti ne siano idonei. Dopo il pranzo con i profughi nel campo, il Papa, insieme agli altri due leader religiosi, nel porto di Mitilene getterà in mare una corona di fiori. Secondo i media greci, Bergoglio ha offerto di portare oggi con sé al ritorno in Vaticano dieci migranti, otto siriani e due afghani.
Papa a Mattarella, in Grecia per portare conforto a profughi - "Nel lasciare il suolo italiano per recarmi in Grecia a portare conforto a tanti profughi, mi è particolarmente gradito rivolgere a lei signor presidente il mio deferente saluto, che accompagno con preghiera fervida e pensiero benedicente, affinché il popolo italiano possa affrontare con lungimiranza e solidarietà le sfide dei nostri giorni". E’ quanto afferma papa Francesco nel telegramma di saluto inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento di lasciare il territorio italiana per recarsi in visita all’isola greca di Lesbo.
Mattarella, messaggio del Papa scuota l’Europa - "Nella certezza che il suo messaggio possa scuotere nel profondo l’anima dell’Europa e della comunità internazionale, mi è gradita, Santità, l’occasione per rinnovarle i sensi della mia profonda stima e considerazione". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a papa Francesco in merito al suo incontro con i migranti a Lesbo.
La polemica di Salvini -"Ricordo che i poveri sono anche a due passi dal Vaticano. Ci sono i poveri in Grecia ma anche a due minuti dal Vaticano. Forse fa meno chic perché non li vai a prendere con l’aereo; ma sono anche qui". Lo ha detto il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, commentando in un video postato sul proprio profilo Facebook, la decisione di Papa Francesco di accogliere 12 profughi in Vaticano portati da Lesbo.
*
ANSA LESBO 16 aprile 2016 20:04 (ripresa parziale).
-
> ESSERE "EU-ROPEUO". -- Che nessuno in Europa alzi muri contro i bambini (di Andrea Iacomini - UNICEF Italia)15 aprile 2016, di Federico La Sala
Che nessuno in Europa alzi muri contro i bambini
di Andrea Iacomini
 Portavoce dell’UNICEF Italia
Portavoce dell’UNICEF Italia
 (L’Huffington Post, 15/04/2016)
(L’Huffington Post, 15/04/2016)Ci sono 22mila bambini fuggiti da tutto, fame, guerre, povertà, chiusi in Grecia in condizioni assurde, contrarie ad ogni norma di diritto internazionale, di cui si parla poco o nulla. Ci sono loro e ci sono migliaia di bambini greci che vivono per le strade delle città elleniche in condizioni di povertà estrema, una notizia oramai che fa meno scalpore di altre ma reale. Eppure la Grecia accoglie tutte queste umanità mentre molti paesi d’Europa alzano muri.
L’Europa nel 2012 è stata insignita del Premio Nobel per la Pace. Tutti ne fummo fieri. Noi, come agenzie umanitarie perché conoscevamo il grande impiego di risorse che l’Ue aveva messo a disposizione per le nostre attività nei paesi della diaspora siriana per allestire, scuole, campi d’accoglienza e tante altre attività.
Mi chiedo: l’Europa di oggi è la stessa del 2012? Quella che sembrava non accorgersi che di lì a poco sarebbe "scoppiata" la rotta balcanica che avrebbe portato sulle sue terre migliaia di profughi provenienti da quella guerra in Siria che nessun paese occidentale è riuscito a fermare? È la stessa Europa? Sicuri? Quella che silenziosa da settembre osserva morire in 6 miglia di mare tra la Turchia e la Grecia 2 bambini al giorno, innocenti, li guarda annegare nell’Egeo mentre i loro genitori cercano un luogo sicuro dove iniziare una nuova vita? E di quale popolo continente o nazione parliamo quando ci siamo nutriti in televisione del fango di Idomeni, che ha visto nascere nella sua melma bambini e crescere la disperazione di popoli che altra scelta non hanno se non la fuga?
L’elenco dei paesi "europei" (ma possiamo ancora definirli tali?) culle di grandi civiltà, che hanno deciso di alzare barriere, si fa tristemente più lungo di giorno in giorno. Per ogni muro che si alza però, per ogni lacrimogeno sparato in faccia ai bambini ai confini, per ogni treno che fa sempre la stessa rotta, avanti e indietro, non vedo corrispondere la stessa indignazione, il coro dei "fanno bene" sembra più forte di quelli che dovrebbero urlare "fermatevi"!
Sapete che penso, che l’Europa unita ha meritato il premio Nobel, perché il paese che stava per essere buttato fuori da essa stessa, la Grecia, incredibile, oggi è l’ultimo avamposto di resistenza umana e di civiltà che a nome di tutti i membri, tutti i membri, ha deciso di non chiudere le sue frontiere, di non usare le ruspe malgrado le mille difficoltà, di metterci la faccia. E’ paradossale vero? Ma è così. E noi italiani? Noi siamo alla sfida finale. Noi che fino ad oggi abbiamo accolto, salvato tante vite umane dal mare, noi che abbiamo ospitato migliaia di migranti e rifugiati, moltissimi bambini, noi che da Lampedusa a Belluno abbiamo deciso di integrare, di tollerare, diciamolo anche di amare chi sta peggio di noi, ci ritroveremo forse chiusi tra la Libia e l’Austria, come la Grecia tra Macedonia e Turchia e dovremo essere pronti, più e meglio della Grecia.
Arriveranno dopo giorni di cammino, in tutti i modi, spinti dalla disperazione che non conosce limiti e non potremo rimandarli in Libia dove il solo pensiero delle condizioni dei luoghi di detenzione e l’instabilità politica fanno venire i brividi, né in Egitto (lasciamo perdere), né in Nigeria dove c’è Boko Haram, né in Siria dove c’è una tregua fragile ma si continua a morire. Perché per noi l’alternativa non può essere morire in mare.
Arriveranno e punteranno a Nord. Padri, madri e tanti figli e prima che arrivino al Brennero sarà bene assicurarsi con l’aiuto dell’ "Europa che resta" che non vengano davvero alzati muri perché i bambini, che sono innocenti, che volevano restare a casa loro, che fuggono dalle guerre che non riusciamo a risolvere NOI, che se ne fregano di conoscerne le cause, meritano di stare in posti sicuri non di sbattere il muso contro un muro che neanche mai gli Asburgo si sarebbero sognati di alzare.
Non li vogliamo vedere nascosti nei bagagliai dei Tir in fila, non vogliamo vederli camminare disperati per le vie di Bolzano, ne fermarsi a migliaia nei posti di frontiera. Vogliamo vedere uno sforzo di tutti per accoglierli, non perché siamo più bravi degli altri ma solo perché nel 1989 anche l’Austria come tutti i paesi dell’Ue ha firmato la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, il trattato più violato al mondo che vincola alla protezione di ogni bambino.
Io non voglio che un giorno questi "figli di un Dio minore" raccontino da adulti ai loro figli il calvario che hanno subito per colpa delle grandi democrazie europee che si indignano per i propri morti ma non si commuovono per loro disperazione, specie se ci sono le elezioni alle porte. Che nessuno tocchi i bambini. Quando arriveranno al Brennero o quando sbarcheranno a Lampedusa e soprattutto che nessuno di quelli con la coscienza sporca inizi ipocritamente a lodare Papa Francesco quando sarà a Lesbo domani e ci richiamerà tutti ai nostri doveri perché è inutile, retorico e poco serio. Sappiamo già come andrà a finire. Ora bisogna agire.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Muri e fili spinati tornano ai confini degli Stati-Nazione, Quella che prima era una faglia, ora è diventato un abisso.8 aprile 2016, di Federico La Sala
Agnès Heller: l’Europa non è innocente
Filosofia. Incontro con la filosofa ungherese Agnès Heller. Muri e fili spinati tornano ai confini degli Stati-Nazione, la fortezza chiude le porte e respinge moltitudini di rifugiati e migranti dalla Grecia verso la Turchia. «Questa crisi è un test di esistenza per un continente senza identità politica, dove risorge il bonapartismo dei leader, mentre il nazionalismo ha sconfitto la solidarietà»
intervista di Roberto Ciccarelli (il manifesto, 08.04.2016)
- Il ritratto: filosofa radicale della vita quotidiana
 Nata nel 1929 da una famiglia ebrea di Budapest, Agnès Heller è stata una delle principali esponenti della «Scuola di Budapest», una corrente del marxismo critico che ha ispirato le politiche del «dissenso» nei paesi comunisti dell’Europa dell’Est. Il libro che l’ha fatta conoscere in Italia è statoLa teoria dei bisogni in Marx» e gli studi sull’economia politica e la rivoluzione della vita quotidiana. Allieva di Gyorgy Lukacs nel 1959 è stata espulsa dall’università ungherese per aver sostenuto «le idee false e revisioniste» del maestro da giovane, ispiratore del marxismo critico per cinquant’anni con il potente libro «Storia e coscienza di classe».
Nata nel 1929 da una famiglia ebrea di Budapest, Agnès Heller è stata una delle principali esponenti della «Scuola di Budapest», una corrente del marxismo critico che ha ispirato le politiche del «dissenso» nei paesi comunisti dell’Europa dell’Est. Il libro che l’ha fatta conoscere in Italia è statoLa teoria dei bisogni in Marx» e gli studi sull’economia politica e la rivoluzione della vita quotidiana. Allieva di Gyorgy Lukacs nel 1959 è stata espulsa dall’università ungherese per aver sostenuto «le idee false e revisioniste» del maestro da giovane, ispiratore del marxismo critico per cinquant’anni con il potente libro «Storia e coscienza di classe».
 Nel 1973 è stata di nuovo espulsa dall’Accademia delle Scienze. Nel 1977, insieme al marito Ferenc Fehér, altro esponente della scuola di Budapest, lasciò l’Ungheria per l’Australia dove ha insegnato sociologia. Poi il trasferimento a New York alla New School for Social Research. Tra i suoi libri più recenti: «La filosofia radicale. Il bisogno di un’utopia concreta e razionale» (Pgreco); con Z. Bauman, «La bellezza (non) ci salverà» (Il Margine); il classico che ha segnato il suo rapporto con l’Italia: «L’Uomo del rinascimento. La rivoluzione umanista» (Pgreco).
Nel 1973 è stata di nuovo espulsa dall’Accademia delle Scienze. Nel 1977, insieme al marito Ferenc Fehér, altro esponente della scuola di Budapest, lasciò l’Ungheria per l’Australia dove ha insegnato sociologia. Poi il trasferimento a New York alla New School for Social Research. Tra i suoi libri più recenti: «La filosofia radicale. Il bisogno di un’utopia concreta e razionale» (Pgreco); con Z. Bauman, «La bellezza (non) ci salverà» (Il Margine); il classico che ha segnato il suo rapporto con l’Italia: «L’Uomo del rinascimento. La rivoluzione umanista» (Pgreco).
Da bambina Agnès Heller ha fatto l’esperienza della persecuzione e dello sterminio nazista. L’origine ebraica condannò suo padre, che fu ucciso a Auschwitz nel 1945. Con sua madre lei si salvò per miracolo, nel ghetto di Budapest. L’inizio sconvolgente di una vita: «Ho pensato tutta la vita cosa significa negare a un perseguitato un rifugio in un altro paese - racconta oggi - Se gli altri paesi europei ci avessero dato asilo forse la metà degli oltre 600 mila ebrei ungheresi si sarebbero salvati».
Da filosofa, già allieva di Gyorgy Lukacs ha perso due volte la cattedra per le sue opinioni politiche: la prima dopo il 1956, dopo la repressione sovietica della rivoluzione ungherese; la seconda perché criticò l’invasione della Cecoslovacchia e Praga rimase sola. Agnès fuggì prima in Australia, poi a New York dove ha insegnato nella cattedra di Hannah Arendt. Due grandi filosofe unite dallo stesso destino, nello stesso luogo: quello dell’immigrazione, della persecuzione per le idee o per l’origine. Insieme hanno vissuto il paradosso del migrante,: un essere umano protetto dai diritti umani che per essere rispettato deve diventare oggetto di repressione, di controllo o respingimento da parte delle leggi degli stati.
Una contraddizione esplosiva nel cuore della democrazia liberale e dello stato di diritto, prospettive oggi sostenute da questa filosofa ungherese di 86 anni. Oggi c’è qualcosa di peggio dei fili spinati e dei muri che tornano a svettare sui confini dell’Europa dell’Est fino alla Germania: il miscuglio di paure dello straniero, cinismi geopolitici e nazionalismi risorgenti che hanno portato al discutibile e gravoso accordo tra Unione Europea e Erdogan che bloccherà migranti e profughi provenienti dalla Siria (e non solo) in Turchia. Sei miliardi di euro per tenere lontano dall’Europa gli effetti delle guerre, rafforzando un continente che vuole restare una fortezza.
«I filosofi non offrono soluzioni, illuminano le contraddizioni» sostiene Heller parlando prima di iniziare una conferenza organizzata dai senatori del Pd ieri nella biblioteca di piazza della Minerva a Roma. Comunque una soluzione viene proposta dalla filosofa: «Fare entrare in Europa chi è in pericolo e in cambio chiedergli l’osservanza della legge e della costituzione - sostiene - Tutti devono potere diventare cittadini e non essere rifiutati». Il problema, tuttavia, resta l’Europa e le sue politiche migratorie. «Sono il frutto di un conflitto tra diritti umani e diritti di cittadinanza - spiega Heller - Le carte dei diritti umani sono finzioni giuridiche che hanno valore di fatto. I diritti di cittadinanza sono invece fatti che hanno un valore politico. L’universalismo dei diritti umani spinge ad aprire le porte ai rifugiati, senza fare distinzione tra migranti e profughi di guerra. In nome dei diritti di cittadinanza si può arrivare a chiudere la porta usando la motivazione del Welfare: visto che è in crisi, e le risorse sono poche, si sostiene che gli europei non dovrebbero condividerli con chi non lo è. In questo modo salta l’unico legame possibile tra queste prospettive: la solidarietà».
Quella che prima era una faglia, ora è diventato un abisso. La crisi economica l’ha squadernato, i partiti xenofobi e nazionalisti intingono il loro pungolo dentro l’inchiostro dell’odio. Heller cita il premier del suo paese, Viktor Horban, il primo ad avere eretto muri e fili spinati sulle rotte delle moltitudini umane che hanno attraversato nell’ultimo anno i confini d’Europa. «Come cittadina ungherese trovo assurdo puntare sull’odio infondato contro gli stranieri, e opporre un «noi» europeo o nazionalistico a un’entità astratta ed estranea identificata con i migranti». Questo è accaduto. Il trattato di Schengen non ha avuto più storia: molti altri paesi hanno chiuso i confini e le paure delle destre sono diventate incendi nelle cancellerie. L’Europa coltivava il sogno di un’entità sovranazionale, ma si è riscoperta un’unione di Stati-Nazione.Horban si è messo all’avanguardia di una delle tradizioni politiche europee: il bonapartismo che diventa un nazionalismo che sembrava non avere più credito.
L’Europa non è mai stata innocente. I primi rifugiati, ricorda Heller, sono stati gli europei che fuggivano dalle loro guerre. Dopo la prima guerra mondiale e i primi anni venti la «nazione» - un concetto che ha un passato rivoluzionario - sconfisse l’internazionalismo proletario e le aspirazioni cosmopolitiche della borghesia e generò il fascismo. Heller ha vissuto nel socialismo reale e descrive l’universo concentrazionario dei Gulag.
«L’Europa ha sempre definito gli altri come “infedeli”, “selvaggi”, “barbari”, “nemici” o “sottosviluppati” - afferma - Dopo il nazifascismo si è identificata con le sue vittime e ha istituzionalizzato l’universalismo. Oggi è in corso una battaglia sui suoi valori costituenti che mette a rischio la sua stessa esistenza. L’identità europea non può essere data per scontata, oggi più che mai, visto che non suscita entusiasmo». «Questa crisi è un test di esistenza per l’Europa. Se gli stati sceglieranno il bonapartismo e le rivendicazioni nazionalistiche e persino etniche, ai danni dell’universalismo della tradizione repubblicana e federalista, se sceglieranno il nazionalismo al posto della solidarietà, l’Europa resterà un insieme economico di Stati, senza identità politica». E questo può essere l’antefatto di un altro inferno.
- Il ritratto: filosofa radicale della vita quotidiana
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- La necessità di un nuovo ordine internazionale (di Ignazio Masulli)6 aprile 2016, di Federico La Sala
La necessità di un nuovo ordine internazionale
Europa. Nell’ostilità contro i nuovi flussi migratori si occultano le responsabilità dirette che le potenze euro-atlantiche hanno nelle guerre e negli squilibri economici che condannano all’emigrazione
di Ignazio Masulli (il manifesto, 05.04.2016)
In più di un ventennio, gli Usa e i loro maggiori alleati europei hanno intrapreso azioni militari con i più vari e pretestuosi obiettivi, senza alcun risultato coerente e apprezzabile. Lo stesso è avvenuto in tanti interventi, affatto interessati e arbitrari, nei conflitti interni di altri paesi. Su un altro versante, le pur giustificate reazioni a violenti attentati terroristici sono apparse spesso velleitarie o fuori misura se non, addirittura, strumentali. Ancor più grave e desolante è l’incapacità di rispondere in modo responsabile e adeguato ai nuovi e crescenti flussi migratori, cui si reagisce con vane chiusure e negazione dei diritti umani.
Su tutti e tre i fronti sono apparsi del tutto evidenti i limiti delle politiche internazionali perseguite dai paesi della Nato negli ultimi decenni. Limiti che non lasciano intravedere alcuna prospettiva affidabile per il futuro, sia immediato che di più lungo periodo.
Nel 1990, col venir meno dell’equilibrio bipolare che aveva contrassegnato, in modo duro e minaccioso, i rapporti internazionali dal secondo dopoguerra, si ritenne possibile la costruzione di un nuovo ordine nei rapporti internazionali. Un ordine pluripolare e basato su politiche di pace e cooperazione.
Purtroppo, nulla di tutto questo si è verificato. All’ordine bipolare se n’è sostituito uno monopolare e affatto unilaterale. I paesi del Patto Atlantico, di fronte a uno scacchiere libero dai precedenti vincoli, si sono lanciati in una partita economica e politica in cui hanno affermato in modo prepotente e univoco gli interessi dei propri gruppi dominanti, economici, tecnologici, tecno-militari e politici.
La conseguenza è stata la riproposizione di modelli e strategie di politica internazionale, aggressivi e bellicisti, non molto dissimili da quelli praticati nei decenni precedenti.
Così è stato, ad esempio, nel controllo di zone d’influenza da mantenere ed espandere in antagonismo con altri paesi. Un altro strumento ben collaudato e tornato in auge è stato quello di far leva sulle ambizioni di un paese in una determinata regione contrapponendole a quelle di un altro ritenuto più distante o ostile rispetto agli interessi perseguiti. Salvo verificare poi che, proprio per l’azione svolta, il regime di cui ci si è serviti ha acquistato un potere e autonomia giudicati eccessivi e, quindi, da ridimensionare. Così è accaduto per l’Iraq di Saddam Hussein, l’Egitto di Hosni Mubarak, la Tunisia di Ben Ali e simili.
Altre volte, i pretestuosi obiettivi di combattere contro minacce incombenti o in difesa della democrazia sono stati agitati contro regimi ritenuti decisamente ostili, come nel caso di Mu’ammar Gheddafi in Libia e Bashar al-Assad in Siria. In ogni caso, i risultati sono stati fallimentari e hanno comportato solo grandi sofferenze per le popolazioni civili. In diversi contesti, non ci si è fatto scrupolo di rinfocolare vecchie contrapposizioni etniche o religiose per strumentalizzarle ai propri fini o giustificare interventi affatto arbitrari. Com’è accaduto in vari paesi dell’Africa centrale e orientale.
La logica unilaterale che, in tal modo, si è affermata nella regolazione dei rapporti internazionali ha avuto l’esigenza della continua individuazione di un nemico e di una presunta minaccia esterna. La funzione vicaria e meramente strumentale di tale esigenza è dimostrata da accuse, poi smentite, come quella del possesso di “armi di distruzioni di massa”.
Perfino nei casi, obiettivi e drammatici, di gravi attentati terroristici, il carattere chiaramente sproporzionato ed erroneo delle reazioni ha dimostrato l’uso strumentale che se n’è fatto, sia a fini interni che internazionali. E nell’ostilità dispiegata contro i nuovi flussi migratori si occultano le responsabilità dirette che proprio le potenze euro-atlantiche hanno nelle guerre e negli squilibri economici che condannano molti milioni di persone all’emigrazione.
Si fa credere che un fenomeno di tale portata può essere effettivamente arginato. Si cerca di deviare l’attenzione delle popolazioni autoctone dalle cause effettive del peggioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita. Si omettono i vantaggi demografici, economici e sociali che dai flussi migratori possono derivare solo che si voglia e si sia capaci di governarli in modo positivo e inclusivo. Capacità che manca non per difetti soggettivi, bensì per scelte politiche conservatrici. Scelte che vanno in direzione esattamente opposta alle trasformazioni necessarie e possibili nell’interesse di tutti.
Sono proprio queste mistificazioni, che sempre più facilmente si mischiano e si sovrappongono, a mostrare come ci si stia muovendo in una situazione di confusione e instabilità nello scenario internazionale assai pericolosa e priva di prospettive.
Nonostante la fine della guerra fredda, la logica dei rapporti internazionali è rimasta unilaterale e aggressiva, basata sulla chiusura più che sull’apertura, sulla competizione più che sulla cooperazione, sull’affermazione di false identità più che sul dialogo e il riconoscimento dell’altro. Ma si tratta, appunto, di un ordine residuale e velleitario.
La spiegazione di questo stato di cose va ricercata nel fatto che l’attuale ordine dei rapporti internazionali si è costruito nella difesa dei blocchi di potere dei paesi del capitalismo storico consolidati nella contrapposizione a un’alleanza politico-militare e modello sociale avversi e ritenuti pericolosi per i propri interessi dominanti.
La costruzione necessaria di un nuovo ordine internazionale foriero di pace, aperto alla cooperazione economica, alla partnership e collaborazione politica non può avvenire se non modificando i blocchi di potere così come si sono costituiti all’interno dei paesi euro-atlantici e nelle loro diramazioni internazionali dal secondo dopoguerra a oggi. Si tratta di una sfida certamente assai ardua. Ma non si vede come sia possibile affrontare i problemi complessi e strettamente interdipendenti del mondo contemporaneo se non in una logica e pratica dei rapporti internazionali assai diverse dalla parzialità, disordine e assenza di prospettive che caratterizzano quelle attuali.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - " I libri che hanno fatto l’Europa" (Mostra dei Lincei). Per fare l’Europa non basta l’euro. Bisogna tornare all’umanesimo (di Paolo Di Stefano)30 marzo 2016, di Federico La Sala
- Sibille e profeti oggi. L’onda lunga del Rinascimento (di Nicola Fanizza - "L’Acropoli")
Per fare l’Europa non basta l’euro
Bisogna tornare all’umanesimo
In mostra a Roma le opere fondamentali della cultura «comunitaria»: 186 manoscritti e stampe della Biblioteca Corsiniana, da altre biblioteche pubbliche e dalla Vaticana
di Paolo Di Stefano (Corriere della Sera, 30.03.16)
Non è mai troppo tardi per interrogarsi sull’identità culturale europea: e anzi diventa urgente in un’epoca in cui le migrazioni mettono in gioco idee di chiusura che si scontrano con prospettive più aperte, in una fase di crisi economica, in un momento di tragedie e di odi primitivi. Sono passati quasi quindici anni, ma fatto l’euro bisognerà prima o poi fare l’Europa, meglio: gli europei. I libri che hanno fatto l’Europa è una mostra che parte da questo presupposto: interrogarsi sulle sue numerose radici e ramificazioni, rappresentando materialmente, attraverso una ricca serie di opere fondamentali, il percorso storico-culturale che si è sviluppato da Carlo Magno alla rivoluzione gutenberghiana, gli oltre sei secoli che hanno portato dalla cultura e letteratura classico-cristiana e mediolatina a quella romanza e moderna. Va da sé che un tale cammino si può illustrare solo attraverso l’evoluzione della forma-libro, l’oggetto principe in cui si conserva la memoria culturale europea.
Dunque, la mostra di Palazzo Corsini presenta 186 manoscritti e stampe, in gran parte della Biblioteca Corsiniana, ma anche provenienti dalle altre biblioteche pubbliche romane (Angelica, Casanatense, Nazionale, Vallicelliana), oltre che dalla Vaticana.
«Dalla consapevolezza che l’euro non basta - dice il filologo Roberto Antonelli, accademico dei Lincei cui si deve il progetto - abbiamo avviato da tempo, alla Sapienza, varie ricerche sull’importanza di coltivare una coscienza europea, di riconoscere l’importanza di valori comuni».
Antonelli, che insegna Filologia romanza all’Università di Roma, parla della necessità di unificare il canone letterario europeo nella formazione scolastica, così come si è fatto per avvalorare l’unità italiana: «È necessario l’insegnamento di una “letteratura europea”, tale da fornire un minimo comun denominatore ai vari Paesi dell’Ue per la formazione letteraria dei giovani: questo problema è stato da noi analizzato e collegato, in una ricerca che ha coinvolto cinque grandi Paesi europei (Portogallo, Spagna, Germania, Romania e Italia), anche al rapporto tra emozioni e letteratura nei giovani».
Intanto, la mostra dei Lincei, che non riguarda solo la letteratura, parte dalla tradizione classico-cristiana, risultato della convergenza tra patrimonio greco-latino e insegnamento soprattutto della Bibbia: padri fondatori Sant’Agostino e San Girolamo; mezzi di trasmissione i codici attraverso la fitta rete dei monasteri. Viene rappresentato il sistema scolastico medievale, che si basa sul ciclo delle sette arti liberali: da una parte il Trivio dedicato alla parola, dall’altra il Quadrivio consacrato alle capacità di «conto», «calcolo» e «misura». Il canone degli autori latini (Virgilio, Orazio, Ovidio...) è il fondamento dell’insegnamento linguistico che si prolunga fino all’Umanesimo e oltre e che, come la Bibbia, si presta a una lettura allegorica in chiave di exemplum e di insegnamento morale. Due culture, quella pagana e quella cristiana, diverse e opposte, che si fondono in una «gigantesca trasmissione e consegna di valori e di testi, sia scritti che orali, formando, di generazione in generazione, una tradizione (da tradere, tramandare, consegnare) che diviene nel tempo una vera e propria forma mentale».
Nella prima sezione, le Bibbie miniate e istoriate (la cosiddetta «atlantica», di enormi dimensioni, proviene dalla Nazionale) si accompagnano con i trattati di retorica (la diffusissima Rethorica ad Herennium in volgare) e, tra gli altri, con quelli di aritmetica. Continuità della tradizione è un concetto chiave: si vedano, per esempio, gli approfondimenti delle Confessioni di Agostino (modello per Petrarca) e della Consolatio Philosophiae di Boezio. Le enciclopedie medievali, che con le immagini dello speculum e del thesaurus rielaborano concetti greci, avranno in Vincenzo di Beauvais e in Brunetto Latini (il maestro di Dante) i loro interpreti più illustri in senso moderno, mentre la compilazione etimologica di Isidoro da Siviglia puntava su un presunto statuto originario del linguaggio.
Si diceva che la continuità è tutto e che non si può parlare di cultura europea prescindendo dalla tradizione: da Plinio discende un filone di trattatistica scientifica che si coniuga con il lascito della medicina greca e araba (Ippocrate, Galeno, Avicenna). La Corsiniana conserva un trattato arabo di oftalmologia che contiene la prima rappresentazione occidentale dell’occhio.
Nel cuore della cultura europea del Basso Medioevo si colloca il sapere giuridico, che si estende, anche in chiave «politica», nell’ambito universitario in concorrenza con la teologia fin lì dominante. Ma un’altra grande svolta per la cultura europea è rappresentata dall’aristotelismo che, entrato nell’Occidente latino con le traduzioni arabe nel XII secolo e quasi integralmente tradotto nel Duecento, va a impattare con l’idealismo cristiano, «permettendo di inserire il sapere in una sintesi razionale», come osservano le schede della mostra che compongono una profonda e insieme agile sintesi di storia della cultura europea: dal filosofo islamico Averroè si va alla Summa di Tommaso d’Aquino e al suo sforzo di «trovare un accordo tra filosofia aristotelica e rivelazione cristiana, innestando le strutture metafisiche, logiche e fisiche desunte da Aristotele nella teologia».
Agiografia, letteratura didattica, storiografia, epica e romanzo. Sono voci di una rassegna che reca titoli illustri: a cominciare dalla Legenda aurea di Iacopo da Varazze e dai Fioretti di San Francesco , passando per il Roman de la Rose e per i vari libri di moralità laica, fino alle tipologie testuali, spesso contaminate, che ci portano verso la modernità. Il filone della chanson de geste si apre con la Chanson de Roland per arrivare fino all’Ariosto, mentre il romanzo (termine che deriva da romanz, che significa parlare in volgare) avrà lunga vita nelle sue molteplici declinazioni, a partire dall’invenzione del triangolo amoroso di Tristano e Isotta o dalle avventure cavalleresche di Chrétien de Troyes con la ricerca del Graal, archetipo vitale fino ai colossal hollywoodiani e alle fiction televisive.
Ed eccoci alla lirica, che nasce dai trovatori ma troverà un punto di passaggio cruciale nella riflessione dantesca (il prezioso codice Vaticano Chigiano, con la Vita nuova, è visibile in mostra). L’Italia darà il suo massimo contributo alla letteratura europea con il primo canone di lunghissima durata: il padre Dante («e l’invenzione dell’io», ricorda Antonelli), la lirica petrarchesca, la narrativa di Boccaccio. La coscienza della nostra dimensione europea passa anche (o soprattutto) da lì. Chi volesse rinfrescarsi la memoria faccia un viaggio a Palazzo Corsini.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- “Da fuori. Una filosofia per l’Europa”: un l di Roberto Esposito (di A. Gnoli)24 marzo 2016, di Federico La Sala
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA.
Abbiamo ancora bisogno della filosofia
Perché la crisi di inizio Millennio si sconfigge col pensiero critico. Il nuovo libro di Roberto Esposito
di Antonio Gnoli (la Repubblica, 24.03.2016)
- IL SAGGIO Da fuori, di Roberto Esposito (Einaudi pagg. 256, euro 22)
Il nuovo libro di Roberto Esposito (che esce dall’editore Einaudi) ha come oggetto l’Europa: com’era e com’è. Già il titolo “Da fuori” sembra richiamare forze sociali e culturali imprevedibili che stanno trasformando l’immagine del vecchio continente. Oggi in crisi, come lo fu negli anni Venti e Trenta dello scorso secolo. “Da fuori” ha un sottotitolo: “Una filosofia per l’Europa”.
Ma può l’Europa essere salvata dalla filosofia? Non c’è riuscita la politica; e neppure l’economia; perché mai il sapere che fu di Platone e Aristotele dovrebbe avere qualche chance di successo? Perché una disciplina instabile, contraddittoria, a volte rissosa, dovrebbe partorire dal suo ventre le giuste risposte? «Forse perché - risponde Esposito - è proprio l’inquietudine della filosofia, la sua mobilità, a consentirle di seguire e talvolta di anticipare le trasformazioni repentine del mondo contemporaneo meglio di saperi più statici e piantati sulle loro radici».
La filosofia già in passato, con Husserl e Heidegger, in particolare, aveva affrontato la crisi europea riconducendola al grande tema del nichilismo: «Con l’espressione nichilismo, quei pensatori intendevano dirci che la civiltà occidentale era esausta e che il solo modo di ritrovare l’egemonia perduta era risalire alle radici greche. Il riferimento costante dell’Europa di Heidegger e di Husserl - malgrado la loro diversità profonda - è tornare al proprio “centro”, ossia all’origine».
Nel mondo greco, sostenevano i nostri autorevoli filosofi, c’erano le risposte giuste. Bastava cercarle. Bastava calarsi nel grande pozzo che nel frattempo l’Occidente aveva scavato e riemergerne con la verità tra le mani. «Fu un terribile fraintendimento, pensare che la crisi dell’identità europea fosse risolvibile con l’appello ai presocratici e ai valori della Grecia antica. La filosofia era troppo concentrata su di sé, troppo autoreferenziale perché potesse davvero cogliere quello che avveniva al suo esterno. La sua miopia fu, in altri termini, non essersi accorta che lì, in quella manciata di anni aveva inizio la fine irrimediabile della centralità dell’Europa».
Non solo Heidegger e Husserl, ma anche Valéry, Benda e Ortega sostarono sui bordi di quella crisi immaginando che la soluzione fosse tutta interna al pensiero e che bastasse l’appello allo spirito greco e ai suoi valori per poter ridare smalto al vecchio continente. «Ma la partita giocata tutta dentro il linguaggio filosofico non era sufficiente. Già per Hegel l’oggetto della filosofia non era la propria storia interna, ma il mondo con le sue contraddizioni. E quanto sta accadendo in questi anni recenti lo dimostra con assoluta evidenza. Nella nostra epoca di globalizzazione, non esiste più un luogo che non sia penetrato e modificato dal suo “fuori”».
Nella nuova consapevolezza che l’attuale scenario ha creato viene a maturazione un fatto di cui già un poeta della statura di Hölderlin ebbe modo di accertare, ossia che lo spirito dei greci non era imitabile. «Lo stesso Nietzsche, dice Esposito, aveva acutamente visto che quello che per Hölderlin era una frattura aperta tra modernità e classicità, diventava in lui un abisso senza fondo in cui precipitavano tutti i valori europei».
L’idea della “morte di Dio” tra le tante possibili declinazioni indicava per Nietzsche l’impossibilità di tornare a una origine autentica, di cui la metafisica fosse la garante assoluta. È di questo che le filosofie della fine del Ventesimo secolo si rendono conto? Da Foucault a Derrida, da Adorno a Habermas - in tempi differenti e con problematiche diverse - si prende atto che il compito della filosofia non è più eseguibile all’interno del proprio sapere.
Il richiamo alla biopolitica (Foucault), alla scrittura e violenza (Derrida), alla dialettica negativa (Adorno), al patriottismo costituzionale (Habermas), non è altro che il modo con cui, osserva Esposito, «il reale gioca la sua nuova partita con il pensiero, includendo così ciò che sta fuori dei suoi confini».
La parola confine sembra quella oggi più confusa e inadatta a garantire un certo tasso di sovranità: «Temo che il confine oggi svolga una funzione drammaticamente biopolitica. Ciò significa che il rapporto tra potere e vita si svolge sempre più lungo e dentro faglie territoriali, sociali e mentali che separano piuttosto che unire». Come dovremmo comportarci davanti alle scene che ogni giorno reportage di immagini ci sbattono sotto gli occhi? «Io credo che il confine resti una linea da cui bisogna passare. Non possiamo abolirlo, ma non possiamo neppure concepirlo come luoghi di operazioni poliziesche. Occorre ripensarlo come spazio politico».
La filosofia può aiutare in questo compito che oggi ci appare difficilissimo? «Il problema è che il confine non può essere solo una soglia di esclusione, ma ciò che articola e integra esperienze, culture, mondi diversi. Sono sempre più gli esseri umani che vivono, lavorano, soffrono ai confini di città e paesi».
Tutto quanto sta accadendo oggi era impensabile fino a una quindicina di anni fa. Il risveglio dei nazionalismi da un lato e del populismo dall’altro hanno scosso l’idea stessa di Europa e messo in crisi la categoria di sovranità. Costruire un mondo nuovo con dei “pezzi importanti” del mondo lasciato in frantumi non è semplice. Non lo è soprattutto se si pensa al dilagare di un neo-localismo volto a proteggere con miopia le proprie ragioni nazionali. Occorrerebbe che la filosofia, osserva Esposito, si traducesse in “grande politica”. Ma come? «Comprendendo anzitutto che nel mondo contemporaneo non è più possibile conservare gli attuali rapporti di forza tra paesi ricchi e paesi poverissimi. Si tratta di un equilibrio che ormai non tiene più e rischia di saltare tragicamente».
La partita filosofica secondo Esposito si gioca oggi nel lasciare aperto il discorso sulla civiltà senza tuttavia rinunciare alla forza. Secondo l’esempio di Machiavelli e Vico, si tratta di trovare un equilibrio tra le due componenti, evitando che una prenda il sopravvento sull’altra.
Ci si può chiedere in conclusione se l’idea d’Europa che avevano sognato i nostri padri abbia ancora un senso o non sia piuttosto tramontata. È probabile che quel nobile progetto oggi sia inadatto a risolvere le attuali contraddizioni. Forse un popolo europeo potrà nascere non in virtù dei trattati e delle convenzioni, ma da spinte che provengono dal basso: «Da questo sostrato salgono a volte umori e impulsi dissolutivi. Ma lì, io credo, è depositata anche l’energia costituente, senza la quale le élites rischiano di perdere i contatti con la vita reale. Il destino del nostro continente è sospeso a tale consapevolezza e alla risolutezza con cui saprà darle espressione».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- “Da fuori. Una filosofia per l’Europa” (R. Esposito). Una nota di Donatella Di Cesare10 aprile 2016, di Federico La Sala
FILOSOFIA
Un nuovo pensiero per l’Europa
«Da Fuori» (Einaudi), il nuovo libro di Roberto Esposito. Il vecchio continente vive una fase di smarrimento, per capirlo serve un’altra prospettiva filosofica. Meglio se italiana.
di DONATELLA DI CESARE (Corriere della Sera, 10.04.2016)
La filosofia italiana non ha nei media e nel dibattito pubblico del nostro Paese lo spazio che meriterebbe. Eppure, basta varcare le frontiere per constatare ovunque, non solo in Europa, ma anche altrove, il riconoscimento tributato al pensiero italiano. Si vorrebbe dire nemo propheta in patria. Ma qui agiscono motivi ulteriori e più profondi: l’atavico complesso di inferiorità di una cultura scaduta per anni nel provincialismo, insieme alla incapacità di valutare degnamente la propria tradizione, a cominciare da quella umanistica, e di farsi dunque carico di un lascito imponente.
Sceglie l’inglese Roberto Esposito per indicare, nel suo ultimo libro, le tre grandi linee della filosofia europea, cioè la German Philosophy, la French Theory e l’Italian Thought (la filosofia tedesca, la teoria francese, il pensiero italiano). L’inglese rinvia all’angolo di visuale che assume scrivendo e che si compendia nel titolo Da fuori (Einaudi). Perché - dice più volte Esposito - «è sempre l’esterno a illuminare l’interno».
Guardare l’Europa, nel suo smarrimento attuale, da fuori, è possibile anzitutto ripercorrendo il cammino della filosofia europea. Già nel Novecento appare chiaro che il malessere è il nichilismo. L’Europa, terra di nascita della filosofia, diviene allora consapevole di non poter perdere il suo nesso vitale con il pensiero, ciò che la contraddistingue. Rischierebbe altrimenti di perdere se stessa.
Ma le risposte al «dispositivo della crisi» sono diverse. Alla corrente eurocentrica, quella di Husserl, di Valéry, soprattutto di Heidegger, che reagisce arretrando, nella vana ricerca dell’origine greca, Esposito oppone una corrente che fugge invece dal centro, che contesta la radice, che considera la cultura greca inimitabile, perché già sempre eterogenea e alterata. Ai nomi di Hölderlin e Nietzsche affianca quello di Patocka, il filosofo, morto a Praga nel 1977 per le violenze subite, che nei suoi Saggi eretici aveva delineato una visione del «dopo» - l’Europa dopo e oltre la cortina, finalmente riunificata.
Costante è la presenza di Carl Schmitt nell’opera di Esposito. Anche in questo libro il suo ruolo è rilevante. Merito del giurista tedesco è di aver mutato la prospettiva sull’erosione dell’Europa: dalla terra al mare. Se Heidegger insiste sul radicamento nella terra, Schmitt accoglie la sfida del mare. D’altronde, non è forse nel mare che si costituisce l’Occidente? Come dimenticare la battaglia di Salamina, e quella di Lepanto? Schmitt rinuncia alla europeizzazione del mondo per volgersi alla mondializzazione dell’Europa.
Ecco allora il Vecchio continente visto «dall’altra sponda», con gli occhi di quegli ebrei tedeschi costretti a cercare rifugio oltre Atlantico. Fuori dall’Europa, ma estranei, malgrado tutto, anche all’America. Il «fascino intellettuale che promana dalla Scuola di Francoforte - scrive Esposito - risiede in questa duplice esteriorità». Pagine importanti vengono dedicate alla Dialettica dell’illuminismo e al modo in cui Adorno in particolare decostruisce ogni mitologia dell’origine e ogni «gergo dell’autenticità», scorgendo qui la regressione in cui è caduta l’Europa degli anni Trenta. Sarebbe però un errore credere che i Lumi della modernità possano far uscire dalla crisi, dato che Auschwitz è inscritto nella civiltà europea.
German Philosophy è la filosofia tedesca del dopoguerra, che dovrebbe prendere in carico l’eredità della Scuola di Francoforte e di quegli emigranti che fanno persino ritorno, forse anche per assecondare quel lascito. No, il passaggio di consegne non riesce - ha ragione Esposito. La carica critica si affievolisce nel neoilluminismo di Habermas, convinto che la modernità non si sia ancora compiuta. Serve ancora la Ragione universale - anche per l’Europa e per i suoi conflitti. Habermas diventa capostipite di una filosofia sempre più normativa, affannata a cercare rimedi costituzionalistici, incapace, anche nei suoi epigoni, di dare voce alla società civile.
L’eredità della Scuola di Francoforte viene reclamata, però, dall’altra parte del Reno. A cominciare da Lyotard, i francesi pensano che il progetto di emancipazione, fondato sulla ragione, si sia concluso. Conservatori non sono i postmoderni, ma quelli che cercano nel moderno le chiavi per interpretare una realtà che ne ha varcato i confini. La French Theory segna una nuova deterritorializzazione della filosofia europea. I filosofi francesi diventano egemoni nelle università americane. Ma la decostruzione di Derrida rischia, per Esposito, di esaurirsi nell’impolitico, mentre il futuro dell’Europa è cercato in una identità, talmente differenziata, da diventare evanescente.
L’Italian Thought si candida allora a essere il pensiero per un’Europa ferita, umiliata, irriconoscibile. Si candida ed è candidato - basta osservarne la risonanza mondiale degli ultimi anni. Erede della crisi interna alla filosofia francese, divisa tra Derrida e Foucault, il pensiero italiano riprende però anche la filosofia tedesca, da Heidegger a Schmitt, a Benjamin. Eccentrico per storia e vocazione, al contempo più arretrato e più giovane, esce da una lunga e traumatica fase di elaborazione negli anni Sessanta e Settanta, si sviluppa intorno alla biopolitica, trova il suo «fuori» nel politico. E riesce a volgerlo in un «contro». Ma non si crogiola nella negazione - è «affermativo». Lontano dall’autonomia della filosofia e dalla neutralità della teoria, è «pensiero» perché nasce dalla prassi. Mostra la sua fedeltà alla tradizione che da Machiavelli giunge fino a Gramsci, si richiama alla parola «civile» che Vico nella Scienza nuova ha elevato a categoria filosofica. Non dovrebbe l’Europa dei popoli aspirare ad essere «potenza civile»?
Italiano nello stile, non per aderenza territoriale, l’Italian Thought prova ad assumere la prospettiva del mondo per guardare all’Europa. Esposito lo descrive magistralmente dilatando il più possibile la nozione di biopolitica, consapevole che i suoi esponenti, da Tronti a Cacciari, da Agamben a Marramao, da Bodei a Vattimo, fino ai più giovani, pur accomunati da analoghe preoccupazioni - andare, ad esempio, oltre la metafisica, oltre la teologia politica - non sono riconducibili a un profilo unitario. Perciò l’Italian Thought ha il fascino di un progetto incompiuto, di un viaggio appena intrapreso.
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- BRUXELLES: FERMARE LE STRAGI NELL’UNICO MODO POSSIBILE (di Peppe Sini - del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo)22 marzo 2016, di Federico La Sala
FERMARE LE STRAGI NELL’UNICO MODO POSSIBILE
di Peppe Sini *
Le stragi che oggi hanno insanguinato Bruxelles ci colmano di orrore e di terrore, di lacrime e lutto, di un muto sgomento e di un dolore insostenibile.
Ma questo ennesimo abominevole crimine deve anche aprirci gli occhi, il cuore, la mente.
Ad esso occorre rispondere con la forza della verita’, della ragione, dell’umanita’.
*
La morte di massa che i criminali terroristi portano nel cuore dell’Europa e’ tragicamente la stessa morte di massa che da decenni le armate legali dei governi occidentali e dei loro sanguinari complici e sicari regionali, ed i prodotti letali dei mercanti di armi, spargono nel vicino e nel medio oriente; e le organizzazioni terroristiche che ora portano nelle nostre citta’ europee un diluvio di sangue sono state allevate dai nostri governi, dalle nostre guerre, dalle nostre armi, e la politica del terrore globale dei poteri imperiali riproducono specularmente sulla scala ad esse accessibile.
*
Come ci si poteva illudere che quelle guerre non avrebbero raggiunto anche le nostre case?
Come ci si poteva illudere che i terroristi cola’ finanziati, armati e addestrati dalle potenze occidentali e dai loro complici regionali non avrebbero prima o poi esteso il loro campo d’azione da quelle terre alle nostre?
Come ci si poteva illudere di essere in un’isola felice, in una campana di vetro, in una torre d’avorio, in una fortezza inespugnabile, quando le tecnologie hanno unificato il mondo e le armi di sterminio sono a disposizione di tutte le mafie cosi’ come dell’uomo piu’ solo, piu’ stolto e piu’ disperato? mentre milioni e milioni di esseri umani, gia’ oggi vittime delle guerre e della fame, del terrore e delle devastazioni, delle dittature e della schiavitu’, hanno perso ogni loro bene e sono costretti a fuggire attraverso deserti e mari, attraverso paesi e continenti, affrontando la morte - e sovente alla morte soccombendo quando ormai la meta agognata sembrava vicina -, perche’ i governi dei paesi europei negano loro il primo di tutti i diritti: il diritto a salvare la propria vita, rifiutando ad essi l’approdo in un luogo in cui vivere in pace?
*
C’e’ un solo modo per fermare le stragi: cessare di commetterle e di favoreggiarle.
C’e’ un solo modo per sconfiggere il terrorismo: scegliere la nonviolenza.
Occorre una immediata politica di disarmo e di proibizione assoluta di produrre, commerciare e detenere armi.
Occorre una immediata politica di smilitarizzazione dei conflitti e di intervento umanitario non armato e nonviolento per salvare tutte le vite.
Occorre contrastare il militarismo, il razzismo e il maschilismo: che sono le reali basi ideologiche e i modelli comportamentali del terrorismo stragista e schiavista (che usa oggi strumentalmente la religione esattamente come appena ieri usava altrettanto strumentalmente le ideologie laiche otto e novecentesche - il patriottismo e il nazionalismo, ma anche il socialismo e l’anarchia).
*
L’Italia decida di contrastare le guerre e le stragi, con la drastica riduzione delle spese militari e l’avvio della Difesa popolare nonviolenta e dei Corpi civili di pace, con gli aiuti umanitari ovunque occorrano, con la cessazione immediata della produzione armiera, con la denuncia e l’impegno per lo scioglimento delle alleanze militari terroriste e stragiste (come la Nato), e convochi l’Unione Europea a fare altrettanto.
L’Italia decida di lottare davvero contro il razzismo, accogliendo tutti i profughi e garantendo loro un servizio di trasporto pubblico e gratuito che consenta a tutte le persone l’ingresso in Italia in modo legale e sicuro - e convochi l’Unione Europea a fare altrettanto.
L’Italia decida di lottare davvero contro il maschilismo, innanzitutto applicando pienamente la Convenzione di Istanbul e sostenendo i centri antiviolenza delle donne, e convochi l’Unione Europea a fare altrettanto.
*
Alla violenza occorre opporre la nonviolenza.
All’odio che uccide occorre opporre la solidarieta’ che salva.
Alla barbarie che disumanizza occorre opporre la civilta’ che affratella e assorella.
Al male occorre opporre il bene.
Ogni vittima ha il volto di Abele.
Vi e’ una sola umanita’.
Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo
Viterbo, 22 marzo 2016
Mittente: "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani", strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532,
 e-mail: nbawac@tin.it, centropacevt@gmail.com, centropaceviterbo@outlook.it, crpviterbo@yahoo.it
e-mail: nbawac@tin.it, centropacevt@gmail.com, centropaceviterbo@outlook.it, crpviterbo@yahoo.it -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- PROFUGHI E DIRITTI UMANI. Lampedusa-Lesbo-Barcellona: Tre sindaci, un patto di civiltà (di Piero Bosio - "Radio Popolare")20 marzo 2016, di Federico La Sala
PROFUGHI E DIRITTI UMANI
Tre sindaci, un patto di civiltà
di Piero Bosio *
“Dobbiamo creare una nuova visione del nostro Mediterraneo e cambiare l’immagine che l’Unione europea vuole farci vedere, ossia il mare come frontiera. Siamo dalla parte giusta, quella dei diritti umani e della legge del mare, e vogliamo che il Mediterraneo acquisti finalmente centralità nelle politiche comunitarie”.
Sono le parole di Giusi Nicolini, sindaca di Lampedusa e Linosa, nel giorno in cui ha stretto un accordo di collaborazione con i sindaci di Barcellona, Ada Colau, e quello di Lesbo, Spyros Galinos. Il progetto ambizioso è quello di mettere le basi per un solido patto per il Mediterraneo, a partire dalle municipalità che si affacciano sullo stesso mare, una rete dei Comuni per affrontare i flussi migratori e per sviluppare progetti di pace, cooperazione, dialogo e di sviluppo tra le diverse sponde del Mediterraneo.
Un patto che la sindaca Ada Colau, il 16 marzo, ha contestualizzato cosi: “Se la Ue lavora dall’alto per fortificare l’Europa, aiutiamoci da città a città, creiamo una rete di Comuni che siano all’altezza dei propri cittadini e cittadine. Uniamoci contro l’imposizione di qualsiasi trattato che consenta le deportazioni di massa e la violazione del diritto all’asilo”.
Il sindaco di Lesbo, Spyiros Galinos, ha sottolineato l’importanza di indicare “la vera radice del problema: le bombe che cadono sulla Siria. Le persone che sbarcano sulle nostre coste sono vittime”. Galinos ha rivendicato la necessità che l’Europa fermi il traffico di esseri umani e combatta la xenofobia crescente e ha ricordato che l’isola di Lesbo “non ha perso la sua bellezza, anzi. Continuiamo a conservare la nostra natura e la bellezza della solidarietà della nostra gente”.
L’incontro tra i tre sindaci è avvenuto nel giorno in cui Giusi Nicolini ha ricevuto al Museo del Mare a Barcellona il XXXVI Premio per la Pace dell’Anue, l’Associazione per le Nazioni Unite Spagna, “per l’impegno e l’attività svolta come persona e come sindaca di Lampedusa e Linosa in favore dei diritti umani”.
Ada Colau ha spiegato che questa iniziativa, inquadrata nel piano “Barcellona città rifugio”, nasce dalla necessità delle città di “proteggere i diritti umani. Ci sentiamo direttamente chiamati in causa davanti a un’Unione europea che sta fallendo, come lo Stato spagnolo, impedendo la ricollocazione dei rifugiati e non predisponendo un passaggio sicuro”. La sindaca di Barcellona ha poi annunciato iniziative concrete : “Gli accordi che abbiamo fatto assicurano l’aiuto del Comune di Barcellona per tutti gli aspetti tecnici, logistici e di appoggio sociale e ambientale che queste città possono richiedere per gestire il forte impatto sul territorio e sulla popolazione rappresentato dall’arrivo in massa di persone che cercano rifugio in Europa. Barcellona ha inoltre destinato un contributo straordinario di 300mila euro agli enti e alle Ong che stanno lavorando nel Mediterraneo per assistere i rifugiati.
Nel febbraio di quest’anno il direttore di Giustizia Globale del Comune di Barcellona, David Listar, ha visitato Lesbo e Lampedusa per offrire l’aiuto della città catalana. Questo primo contatto ha portato alla firma dell’accordo attuale tra i tre sindaci, che si andrà sviluppando nei prossimi mesi man mano che si definiranno le necessità dell’isola greca e di quella italiana.
L’accordo comprende anche la possibilità di avviare programmi di promozione economica per aiutare i Comuni a generare occasioni di rilancio dell’economia interna, danneggiata dalla situazione e dall’abbandono da parte dell’Unione europea.
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- UNO SCAMBIO MISERABILE. Sull’accordo tra Consiglio d’Europa e Turchia un senso opprimente di vergogna (di A. Dal Lago)20 marzo 2016, di Federico La Sala
Uno scambio miserabile
di Alessandro Dal Lago (il manifesto, 19 marzo 2016)
Sull’accordo di ieri tra Consiglio d’Europa e Turchia bisogna reprimere un senso opprimente di vergogna.
I 28 statisti che governano questo continente di 506 milioni di abitanti hanno negoziato con Davutoglu (cioè con il suo padrone Erdogan) il seguente accordo: l’Europa accetterà 72.000 profughi e ne rimanderà altrettanti dalla Grecia in Turchia.
In cambio Ankara ottiene per il momento 3 miliardi di Euro per progetti sui migranti (i termini qui sono vaghi per occultare le promesse europee di altro denaro), l’avvio della procedura di ammissione della Turchia alla Ue e una facilitazione, anch’essa vaga, dei visti d’ingresso dei cittadini turchi in Europa.
Davotoglu ha avuto la faccia tosta di definire questo accordo non un mercanteggiamento ma una questione di «valori». Certo, basta dividere i 3 miliardi ottenuti dalla Turchia per 72.000 e otteniamo poco più di 40.000 euro a persona. Ecco il valore di migranti e profughi per Ankara. E che cosa ne faranno Erdogan e Davutoglu del gruzzoletto? Pasti caldi e comodi alloggi per tutti o magari, con i quattrini risparmiati sui rifugiati, un po’ di armi e di bombe? Bisognerà chiederlo ai curdi.
Ma accusare la sola Turchia di speculare sull’umanità alla deriva tra Egeo e Macedonia sarebbe ingiusto. Perché i veri mercanti di uomini sono gli stati europei. Come ha scritto ieri la Tageszeitung, 72.000 sono solo gli stranieri arrivati in un anno a Berlino.
Una cifra irrisoria se proiettata sull’intero continente. Un numero che non risolve nulla, che lascia le cose come stanno e che serve solo ad alleggerire il peso dell’accoglienza che si è scaricato negli ultimi mesi sulla Grecia. Ora, orde di funzionari, poliziotti e guardie di confine europee invaderanno le isole dell’Egeo per “selezionare” gli stranieri buoni da quelli “illegali”. Per uno che entra, uno deve uscire. È la roulette russa del profugo.
L’ipocrisia europea ha toccato in questo caso cime abissali. Poiché una recente sentenza della Corte di giustizia prescrive che un profugo possa essere espulso in uno stato terzo solo se questo è “sicuro”.
Paese “sicuro”, cioè non specializzato in torture, ecco che alla Grecia basterà riconoscere alla Turchia questa qualifica e, voilà, i giochi sono fatti. La Turchia uno stato “sicuro”? Quella che rade al suolo le sue città abitate dai curdi? Quella che manganella manifestanti a tutto spiano? Quella che chiude i giornali non allineati al regime di Erdogan?
L’accordo di ieri non ha nulla a che fare con l’umanità, di cui ha parlato qualche tempo fa Frau Merkel. È la risposta miserabile della Ue alle paranoie di Hollande, all’eccezionalismo high brow di Cameron, alle pretese fascistizzanti di Orban, del governo ultra-reazionario di Varsavia, dell’estrema destra tedesca e di tutti gli altri cultori del filo spinato. E anche delle istituzioni finanziarie che ora, se l’emergenza di Idomeni finirà, potranno dedicarsi a spennare ancora un po’ Atene. E probabilmente della Nato, di cui la Turchia è membro irrinunciabile.
Che fine faranno i 72.000 rimandati in Turchia e tutti gli altri che dovevano essere ricollocati da mesi e vagano tra Sicilia, Calais e chissà dove? Che ne sarà di quelli che arriveranno ora, con la stagione calda, e che sicuramente la Turchia farà passare per spillare ancora quattrini agli europei? Renzi ha dichiarato che la questione dei migranti si risolve in Africa. Bisognerà dirlo agli afghani, agli iracheni e a tutti gli altri che non sono africani, non sono riconosciuti come profughi ed errano in quell’enorme campo minato che si stende tra Istanbul e Kabul, passando per Damasco e Baghdad. Con l’accordo di ieri l’Europa ha chiuso gli occhi sul loro destino.
Sì, c’è da vergognarsi di avere il passaporto dell’Unione europea.
-
-
> RIPENSARE L’EUROPA! -- Una Magna Carta globale delle nazioni democratiche unite che sostenga e rinforzi la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (di Garry Kasparov).16 marzo 2016, di Federico La Sala
- A Mikhail Gorbaciov e a Karol J. Wojtyla ... per la pace e il dialogo, quello vero!!!
 "AVREMMO BISOGNO DI DIECI FRANCESCO DI ASSISI". LA RIVOLUZIONE EVANGELICA, LA RIVOLUZIONE RUSSA, E L’ "AVVENIRE" DELL’UNIONE SOVIETICA E DELLA CHIESA CATTOLICA. Le ultime riflessioni di Lenin raccolte da Viktor Bede
"AVREMMO BISOGNO DI DIECI FRANCESCO DI ASSISI". LA RIVOLUZIONE EVANGELICA, LA RIVOLUZIONE RUSSA, E L’ "AVVENIRE" DELL’UNIONE SOVIETICA E DELLA CHIESA CATTOLICA. Le ultime riflessioni di Lenin raccolte da Viktor Bede
Kasparov: contro le dittature serve una Magna Carta globale
Un’anticipazione dell’ultimo libro dello scacchista e dissidente russo che domani esce in Italia. “Le democrazie aiutino chi non è libero”
di Garry Kasparov (La Stampa, 16.03.2016)
Il 9 novembre del 1989 è stato uno dei giorni più gloriosi della storia mondiale. Centinaia di milioni di persone furono liberate dal comunismo totalitario dopo generazioni di tenebre. Non vi è certo carenza né di dottrine né di opinioni sul perché a suo tempo sia caduto il Muro. Io sono ben felice di imbarcarmi in simili discussioni infinite, tuttavia dobbiamo riconoscere che cercare una causa precisa per un evento specifico significa perdere di vista l’essenziale. Sappiamo bene che, senza l’unità del mondo libero contro un nemico comune, e senza una presa di posizione forte basata sul rifiuto di negoziare sul valore della libertà individuale, il Muro sarebbe in piedi ancora oggi e io starei ancora giocando a scacchi per l’Unione Sovietica. [...]
Singoli individui hanno giocato un ruolo da ambo le parti, da Roland Reagan a Margaret Thatcher, da Lech Walesa a papa Giovani Paolo II, fino a Michael Gorbaciov, scatenando delle forze che quest’ultimo non poteva controllare. L’argomento decisivo era tanto semplice quanto vero: la Guerra Fredda era una guerra dei buoni contro i cattivi e, cosa ancora più importante, non era una faccenda meramente filosofica, ma una battaglia reale che valeva la pena di combattere. [...]
Il Muro è caduto e il mondo ha tirato un sospiro di sollievo. La lunga guerra che andava avanti da generazioni era finita. La minaccia nucleare che pendeva sulle nostre teste sarebbe presto scomparsa. Tuttavia le vittorie, perfino le più grandi, hanno un prezzo, anche se si tratta semplicemente di abbassare la guardia.
Non ci sono state commissioni per la verità sul comunismo, né processi né condanne per gli impressionanti crimini perpetrati da questi regimi. Il Kgb ha cambiato nome ma non pelle. È stata chiaramente la compiacenza dell’Occidente ad aver dato mano libera a tutti i suoi nemici, non solamente a Putin.
Le odierne dittature possiedono ciò che i soviet potevano a malapena sognare: un facile accesso ai mercati globali per finanziare la repressione al loro interno. Non soltanto i petrol-Stati come la Russia, l’Iran e il Venezuela, ma anche gli Stati industriali.
L’idea che il mondo libero avrebbe usato a favore dei diritti umani la linea del compromesso per esercitare pressioni sui dittatori è stata vanificata dagli stessi Stati autoritari, giacché questi ultimi sono disposti a sfruttare quel tipo di leva senza alcuna esitazione, laddove nel mondo libero non c’è una simile volontà.
Anzi, la linea del compromesso ha fornito alle dittature ancor più consumatori del petrolio che estraggono e degli iPhone che assemblano. Questi regimi utilizzano l’Interpol per perseguitare i dissidenti all’estero; finanziano o creano partiti politici e Ong per esercitare pressioni a favore della propria causa; scrivono editoriali sul New York Times zeppi di appelli ipocriti per la pace e l’armonia. E tutto questo mentre a casa propria attuano un giro di vite più duro che mai. [...]
Che cosa bisogna fare, dunque? Ogni situazione, ogni crisi, ha chiaramente le proprie necessità. Negli scacchi, lo spostamento di una singola pedina cambia l’intera posizione. È per questo che mi piace dire che io invoco i principi, non e politiche. Quando si possiedono principi solidi e tutto il mondo li conosce, le politiche poi tendono a essere più semplici da sviluppare e da rafforzare. Spetta ai leader, a coloro che sono responsabili del proprio popolo, formulare delle politiche. [...] Fare delle raccomandazioni senza l’autorità per renderle esecutive o la responsabilità di doverne rispondere è una stravaganza. Offre il fianco all’ipocrisia e alla follia della peggior specie.
Mi rendo conto che una simile strategia, per quanto onesta e appropriata, risulta essere anche una forma di fuga. Nessuno sarebbe contento se un medico gli diagnosticasse una malattia mortale per poi rifiutarsi di indicargli un rimedio. Ci sono molti passi che possono essere compiuti e che richiedono coraggio e volontà. Una Magna Carta globale è uno di questi, un documento che possa condurre alla creazione di un’organizzazione delle nazioni democratiche unite che sostenga e rinforzi la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. [...]
Il mondo libero possiede risorse e potere al di là dell’immaginazione e questo deve essere usato per aiutare i non liberi a unirsi a noi, altrimenti è un potere sprecato. Un altro motivo per cui non serve fare raccomandazioni per delle politiche specifiche sta nel fatto che queste diventano inevitabilmente obsolete.
Nel corso degli anni ho compilato una lunga lista di cose che andrebbero fatte per rispondere, ad esempio, alla dittatura di Vladimir Putin. Perfino adesso che questi ha dato prova di quanto fossero fondate le mie peggiori paure e che tutti mi dicono quanto io avessi ragione, ben poche delle mie raccomandazioni sono state messe in atto. Altre sono state portate avanti, come ad esempio le sanzioni e l’espulsione della Russia dal G7, ma in modo troppo debole o lento perché avessero l’effetto deterrente da me auspicato.
 ©2015 by Garry Kasparov, Edizione Italiana Fandango Libri 2016, published by arrangement with Berla & Griffini Rights Agency
©2015 by Garry Kasparov, Edizione Italiana Fandango Libri 2016, published by arrangement with Berla & Griffini Rights Agency - A Mikhail Gorbaciov e a Karol J. Wojtyla ... per la pace e il dialogo, quello vero!!!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Prospettiva di AstroSamantha: «Visto da lassù il Mediterraneo è una pozzanghera. Non ha senso barricarsi» parola di astronauta.2 marzo 2016, di Federico La Sala
- Astrosamantha, dallo spazio al cinema. In uscita l’1 e il 2 marzo in oltre 120 sale italiane, Astrosamantha - la donna dei record nello spazio, è il film-documentario di Gianluca Cerasola che ha seguito Samantha Cristoforetti nella preparazione della missione Futura, con cui la prima astronauta italiana ha conquistato il record europeo e femminile di permanenza nello spazio in un unico volo. Dal 3 marzo il film sarà disponibile per proiezioni scolastiche di Giulia Alice Fornaro (LE SCIENZE)
- "LEFT". Solo questa sera e domani nei cinema d’Italia verrà proiettato il documentario "Astrosamantha" che racconta la storia di Samantha Cristoforetti la prima italiana ad andare sullo spazio considerata la donna dei record. Qui un suo ritratto che vi avevamo proposto all’inizio di quest’anno: http://goo.gl/aVpZ9X:
Nel 2016 ne sentirete parlare: Samantha Cristoforetti, lo spazio e i confini dell’Umanità
di Giorgia Furlan ("Left", dicembre 29th, 2015)
Questo 2015 è indubbiamente stato l’anno dello spazio, siamo andati al cinema a vedere Interstellar e abbiamo seguito Matt Damon sopravvissuto in The Martian. Incollati allo schermo abbiamo guardato le nuove foto di Plutone, assistito alla scoperta dell’acqua, e quindi della potenziale vita, su Marte. Soprattutto abbiamo sentito parlare di Samantha Cristoforetti. Samantha, classe 1977, passerà alla storia perché è la prima donna italiana ad essere andata nello spazio e vi ha trascorso ben 220 giorni, anche questo un record.
La rivista Time ha voluto assolutamente intervistarla: «con equipaggi ancora prevalentemente maschili, rimane solo un soffitto di cristallo tra la Terra e l’ orbita, e sono le donne, non gli uomini, a doverlo sfondare» scriveva Jonathan D. Woods il 10 agosto di quest’anno presentando l’astronauta italiana. Il Financial Times addirittura la indica, unica italiana insieme alla scrittrice Elena Ferrante, nella lista delle donne del 2015, forse proprio per quel record di permanenza nello spazio conquistato sulla Stazione Internazionale. Lei che per arrivare lassù ha superato una selezione fra altri 8500 candidati. Lei che volente o no, quest’anno, tra un tweet dal suo account @AstroSamantha e un altro, sempre mentre era ancora in orbita, è diventata un simbolo nazional popolare tanto da essere stata ospite in collegamento dalla Iss durante il Festival di Sanremo. Tanto da essere invitata da Matteo Renzi - uno che alle cose che hanno anche solo un sentore di nazional popolare non sa resistere - alla Leopolda 6. Invito a quanto pare rispedito al mittente dall’ingegnere trentina.
Sicuramente quella della Cristoforetti è una storia che ci piace raccontare perché parla di un’Italia fatta di eccellenza e meritocrazia, ma Astrosamantha è anche qualcosa di più. È un simbolo, inconsapevole, che in qualche modo racchiude in sè i desideri, le aspirazioni e le difficoltà dell’anno appena trascorso.
Lanciare una navicella nel buio lassù ci entusiasma e ci galvanizza, è il trionfo dell’illuminismo, un piccolo passo per un uomo, enorme per una donna, sicuramente: “un grande passo per l’Umanità”
Samantha Cristoforetti non ci ha appassionato così tanto perché eravamo consci dell’importanza scientifica della sua missione, ma perché per noi la sua era un’impresa epica, un viaggio oltre il confine dell’atmosfera che su di noi, poveri profani rimasti con i piedi sulla terra, ha avuto lo stesso fascino della conquista del West. Ha mostrato la possibilità concreta di pensare come valicabile un confine che sembrava invalicabile. “Sfondare il soffitto di cristallo” di cui parla Jonathan D. Woods sulle pagine di Time.
Se, infatti, indubbiamente questo è stato l’anno dello spazio, altrettanto indubbiamente, è stato anche quello dei confini. E lo stesso spazio è questione di confini, limiti tecnici e fisici, che vengono superati (pensate all’atmosfera o alla gravità). Lanciare una navicella nel buio lassù ci entusiasma e ci galvanizza per questo, è il trionfo dell’illuminismo, un piccolo passo per un uomo, enorme per una donna - dopo tutto che saranno mai 8.500 concorrenti - sicuramente: “un grande passo per l’umanità”.
L’umanità, ecco, un’altra cosa che, soprattutto quest’anno, ha avuto a che fare con i confini. Quelli segnati dal filo spinato varcati dai rifugiati; quelli liquidi del Mediterraneo solcati dai migranti; quelli rivendicati dai kurdi impegnati nella resistenza contro Daesh; quelli che, dopo Charlie Hebdo e gli attentati di Parigi, le destre populiste hanno tentato di tracciare tra noi e “loro”, come se la vita fosse un film hollywoodiano dove esistono solo buoni e cattivi.
Quest’anno ha avuto a che fare con i confini europei - quelli di un’Unione che vorrebbe essere forte, ma spesso si dimostra fragile - per cui la Grecia doveva essere dentro o fuori. E con le “frontiere” ambientali discusse a Parigi che, più che confini, sono limiti da rispettare e traguardi a cui tendere. Infine, quest’anno ha appunto avuto a che fare con la linea di confine tracciata dall’idea di spazio dove è finita Samantha Cristoforetti e che, forse per una banale questione metaforica di micro e macro o per il fatto altrettanto simbolico che in tutte quelle foto il globo lo vediamo dall’alto e per intero, potrebbe includere tutti quanti gli altri. Quasi si trattasse di un monito e di un memento.
A dicembre, nell’ultimo numero di Left abbiamo inserito uno degli scatti di Samantha nel nostro portfolio di fine anno e abbiamo titolato l’immagine così: “Se da lassù a guardarci è una donna”.
Ecco, “se da lassù a guardarci è una donna”, forse si finirebbe con il pensare che no, non è vero che l’Umanità ha dei confini. Che dividere il mondo in noi e loro è solo una questione di prospettiva, ridotta. Che per questo 2016 dovremmo impegnarci a guardare il mondo dalla prospettiva di AstroSamantha.
In fondo: «Visto da lassù il Mediterraneo è una pozzanghera. Non ha senso barricarsi» parola di astronauta.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- IL PARADIGMA DI KANT. Dalla crisi può nascere la vera Europa: l’Europa come progetto federale (di Nadia Urbinati).13 febbraio 2016, di Federico La Sala
- RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Dalla crisi può nascere la vera Europadi Nadia Urbinati (la Repubblica, 13.02.2016)
LE CRISI possono diventare occasioni importanti di rinnovamento e di ridefinizione di vecchi equilibri di potere, soprattutto in quelle congiunture storiche nelle quali l’ordine esistente si alimenta della rovinosa continuazione della situazione di stallo. Questa è stata per molti versi la dinamica che ha visto nascere l’ideale europeo moderno. Essa si è sprigionata dall’interno dell’Europa dei totalitarismi e dei nazionalismi; anzi, dalle prigioni e dai luoghi di confino dove quei regimi liberticidi avevano voluto mettere a tacere gli avversari politici.
L’ideale di una unione politica continentale fu maturato nella clandestinità, intuizione di pochi visionari convinti che solo gettando il cuore oltre l’ostacolo si potesse sconfiggere lo status quo e dar vita all’Europa del dopo, democratica e pacifica. È importante ricordare oggi che fu all’interno di una cornice anti-nazionalistica che prese corpo il Manifesto di Ventotene, uno dei prodotti più significativi dell’ideale liberal socialista.
Nelle interviste di Eugenio Scalfari a Laura Boldrini e di Stefano Folli a Giorgio Napolitiano, ospitate su Repubblica, non si può non sentire la forza di quell’ideale, e soprattutto la consapevolezza che ci troviamo, di nuovo, in una situazione di stallo critico, di equilibrio catastrofico che può avere esiti regressivi. Perché, come allora, anche oggi i pericoli al progetto di unione vengono dal nazionalismo, populista e non.
Ben inteso, da quando la crisi economica si è abbattuta sul nostro continente e le politiche europee hanno messo a dura prova le politiche economiche e fiscali nazionali, le rimostranze degli Stati membri non sono state sempre ingiustificate. Le resistenze della Grecia, che lo scorso anno si trovò pressoché sola a contestare Bruxelles e la Troika, hanno aperto tuttavia un fronte nel quale altri paesi oggi sembrano volersi identificare. Le polemiche sulle politiche monetarie e le regole bancarie, sulla mancanza di una politica comune sull’immigrazione e il rischio di sospendere provvisoriamente Schengen: tutte queste questioni aperte, e le dinamiche politiche che possono innescare, ci inducono a temere per il futuro del progetto europeo.
Chi può rompere questo stallo, questo equilibrio potenzialmente catastrofico? Sostiene Napolitano, con ottime ragioni, che solo chi sa vedere oltre le strette politiche nazionali, chi non si lascia incagliare nelle questioni locali, può vincere la battaglia europea e, quindi, anche quella nazionale. Non vi è modo per reagire a chi vuole rialzare muri e chiudere le frontiere se non portando il cuore oltre l’ostacolo, progettando una soluzione che non sia nè un ritorno al passato, con gli stati padroni (nani) in casa loro, ma nemmeno la persistenza dello status quo, magari per strappare con trattative nazionali un piccolo “parecchio”. L’Europa degli accordi intergovernativi che si è stabilizzata in questi anni di crisi rischia di aprire entrambi questi scenari, alimentando una voglia di secessione. Per contenere sul nascere questi esiti occorrerebbero grandi leader, visionari che sappiano convicere i loro cittadini e quelli europei che il vero utile nazionale si persegue con politiche anti-nazionaliste. Che si deve volere l’Europa per voler il bene delle proprie società nazionali.
L’Europa deve farsi politica, dunque; superare il livello intermedio dell’attuale costituzionalismo funzionale, indiretto e burocratico, per marcare il corso verso un costituzionalismo compiutamente politico, dove obiezioni e proposte possano godere di legittimità democratica. E che sia il presidente della Bce, Mario Draghi, a farsi propugnatore di questo salto oltre l’ostacolo, a suggerire una unione politica “più perfetta” come direbbero gli americani, a prospettare la necessità di una politica bancaria e fiscale europea, strada verso un governo continentale legittimo, rende pienamente il senso della situazione grave nella quale si trova il progetto di Ventotene. Non leader politici, ma un leader “tecnico”, responsabile di un potere neutro, sente l’urgenza di avviare un’innovazione istituzionale forte. L’Europa con un bilancio comune, con politiche fiscali comuni e cogenti, condizioni essenziali per una vera unione monetaria e bancaria: l’Europa come progetto federale.
Nell’Europa autoritaria e dei totalitarismi, nacque una visione politica e morale che aveva un respiro sovrannazionale. Il Manifesto di Ventotene rispecchiava quella visione assai fedelmente quando sosteneva che “il principio di libertà” é fondamento della società umana e la critica di “tutti quegli aspetti della società che non hanno rispettato quel principio”. In conseguenza di ciò dichiarava il nazionalismo degli Stati come il vero responsabile della Prima guerra mondiale e dell’imperialismo nazionalista che ne era seguito.
Il Manifesto sosteneva inoltre che senza il superamento della sovranità assoluta degli Stati la diseguaglianza economica e il nazionalismo avrebbero continuato ad essere un rischio per la pace, anche qualora gli stati europei fossero divenuti democratici. Fino a quando non fosse stata superata la prospettiva nazionalistica, non ci sarebbe stato futuro sicuro né per la pace né per la libertà.
Traducendo il paradigma di Kant in un programma politico, i visionari di Ventotene lanciavano il loro doppio progetto: una trasformazione democratica e costituzionale interna agli stati (che è avvenuta), e la creazione di una federazione europea (che stenta ancora a nascere).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- «Muoviamoci. O sarà la disintegrazione». Intervista a Yanis Varoufakis sul Movimento per la democrazia in Europa (DiEM 25).15 febbraio 2016, di Federico La Sala
Europa
Yanis Varoufakis, «Muoviamoci. O sarà la disintegrazione»
Intervista. L’economista ed ex ministro delle finanze greco parla del Movimento per la democrazia in Europa lanciato a Berlino. "La tempesta perfetta del 2015 allarma anche chi non aveva posizioni critiche sull’Unione. C’è spazio per nuove coalizioni"
di Marco Bascetta, Sandro Mezzadra (il manifesto, 14.02.2016)
Incontriamo Yanis Varoufakis il giorno dopo il lancio del Movimento per la democrazia in Europa (DiEM 25) alla Volksbühne di Berlino, chiedendogli, per iniziare, un’illustrazione del progetto.
Nel 2015 abbiamo avuto in Europa una sorta di tempesta perfetta, per il sommarsi di molteplici fattori di crisi: lo scontro tra il governo greco e la troika, i rifugiati, l’assenza di una politica estera europea su quanto accade in Nord Africa e in Siria, in Ucraina. Queste crisi hanno due conseguenze essenziali: accelerano una tendenza alla disintegrazione dell’Unione Europea, ma mettono in allarme anche quanti, in questi anni, non hanno avuto posizioni critiche sull’Europa: molti democratici liberali, moderati, affezionati alla democrazia, difficilmente possono sentirsi a loro agio in questa Unione, dopo quanto è avvenuto nel 2015. Questo disagio lascia spazio a nuove coalizioni, tra democratici liberali, socialdemocratici, radicali di sinistra, verdi, attivisti come quelli della rete Blockupy. È una possibilità che non durerà a lungo. Se non la cogliamo, se non costruiamo un movimento “pan-europeo” capace di interrompere la tendenza alla disintegrazione dell’Europa, al riemergere dei nazionalismi, mancheremmo un compito decisivo.
Il progetto e il manifesto di DiEM pongono al centro la questione della democrazia. Ma come intendono superare quella crisi della democrazia rappresentativa così evidente non solo a livello europeo ma anche nei singoli Stati membri? A noi sembra che vi siano ragioni strutturali che spingono verso l’emergere di processi di governo “post-democratici”. E che dunque il riferimento alla democrazia debba essere qualificato in maniera radicalmente innovativa.
Credo che si debbano distinguere due aspetti. C’è una crisi generale della democrazia, nell’epoca del capitalismo finanziarizzato. Il capitale finanziario è nemico della democrazia ovunque nel mondo, negli Usa come in Europa. Ma c’è una specificità tossica per quanto riguarda l’Europa: non abbiamo una federazione con specifiche istituzioni democratiche, la stessa Banca Centrale Europea ha uno statuto non paragonabile ad esempio a quello della Federal Reserve. Non abbiamo neppure i checks and balances di base che caratterizzano le democrazie. La stessa crisi della democrazia negli Stati nazionali è qui connessa con il modo in cui funziona l’Ue: quest’ultima prende tutte le decisioni che contano per un Paese come l’Italia, ad esempio, e il demos non ha la possibilità di intervenire. I suoi rappresentanti nazionali non hanno alcun potere di realizzare le loro promesse, come abbiamo visto in Grecia.
Ci sembra tuttavia che in questo modo non venga aggirata la difficoltà di riproporre sul livello europeo soluzioni istituzionali centrate attorno alla rappresentanza, nel momento in cui questa si trova di fronte a fattori di crisi che hai definito «universali».
Non sono un federalista nel senso conservatore del termine, non penso che la soluzione consista semplicemente nel fatto che i governi si riuniscano e decidano qualche tipo di federazione. Penso ad esempio alle proposte di Schäuble: non determinerebbero democrazia ma autocrazia, condurrebbero a una sorta di dispotismo fiscale. L’unione politica non è necessariamente democratica. Il punto fondamentale è questo: noi non pensiamo che la democratizzazione possa venire dall’alto! Può solo venire dal basso, e questa convinzione è ciò che fa di DiEM un movimento, e non un think tank o un partito federalista europeo. Il primo passaggio per noi è la trasparenza dei processi decisionali: siamo fortemente convinti che questo punto possa cambiare le regole del gioco. La seconda priorità, per discutere sulla democratizzazione dell’Ue, è rimuovere i fattori che ne stanno determinando la disintegrazione. Penso a interventi radicali sul debito, sul sistema bancario, sul basso tasso di investimenti, sulla povertà e sulle migrazioni. Si può farlo reinterpretando le regole esistenti, non semplicemente invocando “flessibilità” come fa Renzi, e cioè la gentile concessione di non seguire le regole. Dobbiamo riorganizzare le istituzioni esistenti, cambiare la politica della Bce, della Banca Europea per gli Investimenti. È possibile lavorare all’interno delle regole, ma reinterpretandole radicalmente: Schäuble lo fa di continuo, a modo suo.
La disintegrazione dell’Europa ha tra l’altro aspetti che si possono definire in termini geografici. Alla divisione tra Nord e Sud si aggiunge ora, in maniera molto aspra quella tra Est e Ovest, che non riguarda solo la questione dei rifugiati ma l’idea stessa del rapporto tra governanti e governati. In queste condizioni come può svilupparsi un’iniziativa “pan-europea”?
La frattura tra Est e Ovest attraversa ogni ambito, dal tema dei migranti a quello dell’organizzazione della zona euro e della politica estera. Molti Paesi dell’Est reclamano una politica aggressiva, militaristica contro la Russia, pretendono la nostra solidarietà su questo terreno senza offrirne alcuna su questioni come la ristrutturazione del debito pubblico. Come possiamo costruire ponti tra Est e Ovest? L’unico modo è attraverso movimenti capaci di coinvolgere i democratici, i progressisti di quei Paesi, offrendo loro un’opportunità. Immaginate di essere giovani dissidenti ungheresi, non avete un’iniziativa, un soggetto a cui aderire. Il partito europeo della sinistra non accetta iscrizioni dirette, è una confederazione di partiti nazionali, e i suoi rappresentanti in Paesi come l’Ungheria o la Repubblica Ceca sono screditati. Se il DiEM riesce ad affermarsi come punto di riferimento credibile e attraente per i democratici nell’Europa dell’Est, può costruire dei ponti.
La questione del rapporto con la Russia ci sembra cruciale e gravida di pericoli. Alle sue spalle c’è la questione del rapporto tra l’Unione europea e gli Stati uniti e in particolare il ruolo della Nato. Che cosa ne pensi?
Ho lavorato a lungo negli Stati Uniti, e ho avuto colleghi collaboratori della Nato. Molti di loro sono convinti che la Nato abbia esaurito la sua funzione. Il problema è che la Nato è alla costante ricerca di ragioni che ne legittimino l’esistenza. Deve inventare continuamente nuovi nemici. È quel che vogliamo in Europa? Non credo. Prendiamo Putin. Lo considero un criminale di guerra, non per l’Ucraina ma per quel che ha fatto in Cecenia. Il più grande regalo alla carriera politica di Putin è stata l’espansione della Nato a est. Può dire al suo popolo che l’autoritarismo in Russia è giustificato dall’incombere di un nemico. Oggi la Nato offre un senso di sicurezza fittizio a Paesi come l’Estonia, la Georgia, l’Ucraina. In realtà la sua espansione a est comporta militarizzazione e continue occasioni di conflitto con la Russia. Una Ue consapevole dei suoi interessi dovrebbe semplicemente non partecipare a questo gioco.
L’obiettivo di lungo termine del DiEM è la convocazione di un’assemblea costituente in Europa. Quali sono le condizioni per compiere questo passo che, nella storia, ha sempre seguito grandi rotture e sommovimenti sociali?
La mia compagna, un’artista, una volta mi ha detto: perché sugli aerei c’è una scatola nera che ci potrà dire dopo la catastrofe per quali ragioni siamo morti? Non sarebbe meglio averne una da aprire prima dell’incidente, in modo che questo non avvenga? Mi sembra un’ottima domanda: perché dovremmo aspettare il disastro per organizzare un’assemblea costituente e non farlo invece perché non avvenga? Le condizioni oggettive per un’assemblea costituente sono date in Europa per la frammentazione di fronte a cui ci troviamo. Abbiamo bisogno di un insieme di movimenti che impongano alle istituzioni europee un’agenda di stabilizzazione nel senso che cercavo di spiegare prima. Solo su questa base si può creare un sistema elettorale inclusivo e realmente europeo per l’elezione dell’assemblea. I tedeschi, ad esempio, devono avere la possibilità di votare candidati italiani o francesi (e viceversa). Una buona fonte di ispirazione possono essere i progetti di ricerca finanziati dalla Commissione nelle università: se vuoi fare domanda per un finanziamento devi creare un consorzio tra Università di almeno sette Paesi. Perché non immaginare che per candidarsi alla costituente sia necessario formare liste con candidati di dieci o quindici Paesi?
Hai parlato in questi giorni dell’austerità come una forma di “guerra di classe” dall’alto. Ma quali forze oggi possono essere messe in campo dal basso non solo per difendersi dall’attacco ma per esercitare un reale potere costituente?
Molti compagni e amici mi hanno rimproverato un riferimento troppo generico alla democrazia. Ma pensate alla definizione che ne ha dato Aristotele, il quale non era certo un democratico: il governo dei liberi e dei poveri. È una buona definizione: i poveri, i subalterni, gli sfruttati sono la maggioranza. E dunque una democrazia reale non può che essere dominata dai movimenti dei poveri. Le democrazia liberali, che hanno le loro radici nella tradizione della Magna Charta, sono state certo un’altra cosa. La Magna Charta è una carta dei baroni, dei proprietari terrieri contro il Re, che garantiva loro di avere i propri servi e di non vederseli portare via dal sovrano. La democrazia liberale ha questo pedigree. Questa democrazia è arrivata ai suoi limiti con il capitalismo finanziarizzato. Un movimento democratico oggi è per definizione un movimento che punta a mettere fine alla guerra di classe dall’altro organizzando un contrattacco dal basso.
Questo pone il problema, per noi fondamentale, di pensare una nuova articolazione tra movimento democratico e lotta di classe. Come pensi concretamente una simile articolazione?
Se è la stabilizzazione il problema basilare in Europa, questa non è possibile senza la crescita tumultuosa di un movimento democratico. I poteri esistenti non ne sono in grado. Immaginate un movimento che imponga alla Banca centrale di cominciare ad acquistare il debito della Banca Europea per gli Investimenti anziché quello tedesco o italiano, per finanziare un ambizioso Green New Deal per l’Europa. Invece di stampare moneta per i circuiti del capitale finanziario, la creazione di moneta andrebbe a finanziare la cooperazione produttiva, a creare posti di lavoro in settori innovativi, ponendo al tempo stesso condizioni favorevoli per l’organizzazione e la lotta dei lavoratori e contrastando la mercificazione e la precarizzazione del lavoro.
DiEM ha l’ambizione di costituire una forza transnazionale di tipo nuovo, collegando attivisti, politici, intellettuali, artisti, sindacalisti su un terreno immediatamente “pan-europeo”. Non è una scommessa facile e sono pochi i modelli a cui ispirarsi. Qual è il processo innovativo che hai in mente?
La disintegrazione dell’Ue è qualcosa di inedito, contraddice una storia fondata sul progressivo avanzamento dell’integrazione. Per questo c’è bisogno di uno strumento nuovo. I partiti di sinistra europei hanno la loro base negli Stati nazionali, e il Gue ne costituisce una sorta di confederazione, che non mette in discussione il fondamento nazionale. È una delle ragioni della loro impotenza. Non è una questione di cattiva volontà: sono costretti ad articolare programmi di governo che non potranno mai essere attuati. Se questa diagnosi è corretta una piattaforma comune per i democratici in Europa deve essere costruita attraverso un’azione politica che non abbia la propria base negli Stati nazionali. E non può essere un partito, per definizione gerarchico. I militanti dei partiti di sinistra possono aderire a DiEM e continuare a militare nel loro partito nazionale. Ma in DiEM affrontiamo i nostri problemi comuni indipendentemente dalla affiliazione partitica o dalle convinzioni filosofiche di ciascuno. La risposta alla vostra domanda non potrà che essere trovata gradualmente. È un work in progress. Come diceva Brian Eno alla Volksbühne martedì, se non hai una ricetta comincia a cucinare, la ricetta arriverà.
Quali saranno i prossimi passi di DiEM?
Abbiamo già annunciato una petizione, indirizzata ai Presidenti dell’Eurogruppo, del Consiglio Europeo e della Bce, chiedendo che assicurino lo streaming delle loro riunioni (alla Bce chiediamo di fare quello che fa la Federal Reserve: rendere pubblici i verbali delle riunioni due settimane dopo che si sono tenute). Sarà anche un’occasione per cominciare a organizzare il movimento attorno a una campagna concreta. Stiamo cominciando a costituire gruppi di lavoro per costruire una piattaforma digitale che ci consenta di intervenire nel dibattito pubblico e di articolare il nostro lavoro. Abbiamo poi individuato cinque aree tematiche, di cruciale importanza per il futuro dell’Europa: il Green New Deal, la questione del debito e del sistema bancario, le migrazioni e i confini, la trasparenza e il tipo di Costituzione di cui l’Europa ha bisogno.
 Vogliamo arrivare nel giro di un anno ad avere cinque policy papers su questi temi. Cominceremo con il comporre un elenco di problemi e di domande per ciascuna di queste aree tematiche, per poi lanciare una grande campagna di consultazione in diverse sedi e in diversi Paesi. Da queste riunioni emergeranno proposte che verranno “filtrate” e “ricombinate” da gruppi di lavoro che sottoporranno il risultato a grandi assemblee tematiche. Queste assemblee voteranno un documento finale, che sarà poi sottoposto al giudizio di tutti i membri di DiEM. È un processo che può essere definito di democrazia in azione, da cui emergerà un vero Manifesto di DiEM, non una semplice dichiarazione di principi.
Vogliamo arrivare nel giro di un anno ad avere cinque policy papers su questi temi. Cominceremo con il comporre un elenco di problemi e di domande per ciascuna di queste aree tematiche, per poi lanciare una grande campagna di consultazione in diverse sedi e in diversi Paesi. Da queste riunioni emergeranno proposte che verranno “filtrate” e “ricombinate” da gruppi di lavoro che sottoporranno il risultato a grandi assemblee tematiche. Queste assemblee voteranno un documento finale, che sarà poi sottoposto al giudizio di tutti i membri di DiEM. È un processo che può essere definito di democrazia in azione, da cui emergerà un vero Manifesto di DiEM, non una semplice dichiarazione di principi.
 (La versione integrale dell’intervista è pubblicata nel sito www.euronomade.info)
(La versione integrale dell’intervista è pubblicata nel sito www.euronomade.info)
- RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- La Rivoluzione francese fu la fine dell’età dei Lumi, non la sua consacrazione (di Vincenzo Ferrone)7 febbraio 2016, di Federico La Sala
La tragedia dell’Illuminismo
La Rivoluzione francese fu la fine dell’età dei Lumi, non la sua consacrazione Robespierre ne eliminò gli uomini più lungimiranti e moderati, come Condorcet
di Vincenzo Ferrone (Il Sole-24 Ore, Domenica, 07.02.2016)
- Jonathan Israel, La Rivoluzione francese. Una storia intellettuale dai Diritti dell’uomo a Robespierre, traduzione di Palma Di Nunno e Marco Nani, Einaudi, Torino, pagg. 960, € 42
Che libro strano questo di Jonathan Israel sulla Rivoluzione francese. Con le sue quasi mille pagine esso appare tanto affascinante e provocatorio quanto discutibile - se non inaccettabile, a mio parere - nella sua tesi di fondo che «l’Illuminismo radicale fu incontrovertibilmente l’unica “grande” causa della Rivoluzione francese» (pag. 790).
Non v’è dubbio che Israel figuri in prima fila tra quanti hanno alimentato l’impetuoso e inevitabile rinnovamento della storiografia internazionale dopo il 1989 e la liquidazione dell’utopia comunista. Un rinnovamento che ha avuto il suo cuore pulsante soprattutto nel mondo di lingua inglese, e di cui, curiosamente, le motivazioni ideologiche e le forme che esso sta assumendo sono passate sotto silenzio in Europa.
Spetta infatti a questo autorevole professore dell’ Institute of Advanced Studies di Princeton il merito di aver riportato la questione dell’Illuminismo al centro del dibattito storiografico mondiale, facendone un tema che per interesse e ricchezza di risultati è secondo solo all’ormai affollatissimo settore di studi della Global History.
In tre monumentali volumi, Israel ha dato vita a una suggestiva e potente narrazione unitaria dell’Illuminismo come da tempo non si era più vista. Lo ha fatto con una sorta di ritorno al passato, coniugando polemicamente storia e filosofia contro la storia sociale, la storia economica di matrice marxista, la nascente storia culturale e quel poco che ancora restava in circolazione degli epigoni delle «Annales».
Israel reinterpreta i Lumi come la concreta realizzazione nel corso del Settecento di un sistema filosofico, di una coerente e specifica ideologia spinoziana fondata sul monismo razionale e materialistico e sull’ateismo di Spinoza, e nutrita della circolazione e della diffusione di un sistema di idee eversive, repubblicane e democratiche che aveva i suoi nemici naturali nelle monarchie e le religioni.
In questa prospettiva Israel divide, con tassonomica inflessibilità, gli illuministi buoni da quelli cattivi, gli atei dai deisti, i radicali dai moderati. Al Radical Enlightenment (titolo del suo primo volume sul tema, pubblicato nel 2001) rappresentato soprattutto da Helvetius, Diderot, d’Holbach, Condorcet - atei, anticlericali, fautori del repubblicanesimo, dei diritti umani, della democrazia rappresentativa - egli oppone una sorta di Illuminismo moderato, incarnato da Locke, Hume, Montesquieu, Voltaire, Turgot, Rousseau, fautori della religione naturale e del provvidenzialismo deista e “colpevoli” di posizioni politicamente conservatrici come l’assolutismo monarchico o il costituzionalismo inglese, o pericolose come la democrazia diretta celebrata dal grande ginevrino, padre spirituale di Robespierre e del Terrore.
Inutile dire che questa rigida rappresentazione di un Illuminismo radicale che vive di un legame organico tra il materialismo ateo e il radicalismo politico è stata duramente e giustamente contestata dalla critica. Per rimanere in Italia, come si fa a considerare un illuminista radicale quel Gaetano Filangieri che univa il costituzionalismo repubblicano e l’amore per i diritti dell’uomo alla militanza massonica e al credo deista? E che dire di Vico, addirittura segnalato come repubblicano e materialista?
Indomabile, impermeabile a ogni critica, Israel ora non esita a entrare con il suo teorema riduzionista nel terreno incandescente della Rivoluzione, rilanciando la vexata quaestio del nesso tra quest’ultima e i Lumi, nesso antico e tutto teleologico da tempo abbandonato dagli specialisti. Lo fa accusando tutti i protagonisti di un’ormai secolare storiografia - da Mathiez a Lefebvre a Soboul, sino a Furet - di non avere capito che la soluzione dell’enigma delle origini del 1789 non stava nello studio dei prezzi, o delle sollevazioni contadine o delle dinamiche di piazza, ma soprattutto se non esclusivamente nella storia intellettuale, nella potente «rivoluzione della mente» (per usare una sua espressione) prodotta dagli illuministi radicali. Inutile dire che l’Hegel della Fenomenologia dello spirito avrebbe sorriso vedendo finalmente confermata la sua tesi della Rivoluzione come frutto del pensiero; non lo hanno fatto, invece, gli studiosi americani, che hanno subito reagito alla provocazione con recensioni al curaro.
Israel ripercorre la Rivoluzione reinterpretandone i momenti cruciali, naturalmente a modo suo. Prende sul serio le tesi complottarde di Barruel e le accuse di Burke agli illuministi quali padri della Rivoluzione, salvo tacciarle di genericità per non aver distinto tra illuministi radicali e moderati. Ai primi, pochi, ma padroni dell’opinione pubblica attraverso i giornali, guidati da Mirabeau, Sieyès, Brissot, Condorcet, Israel attribuisce la leadership rivoluzionaria sino al 1793. Sono loro i veri fautori dei diritti dell’uomo (non i deisti alla Voltaire o alla Rousseau), i padri delle leggi per l’eversione dell’aristocrazia, la separazione tra Chiesa e Stato, l’eguaglianza di fronte alla legge, l’abrogazione della monarchia, l’abolizione della schiavitù, l’introduzione del divorzio.
Nei convulsi dibattiti sulla prima costituzione democratica del mondo, nel 1793, i radicali si scontrarono con gli illuministi moderati ispirati al modello britannico, e seguaci di Montesquieu, Voltaire, Hume; al tempo stesso ebbero contro da un lato i robespierristi, dall’altro i fautori del Contro-illuminismo ispirati ai valori dell’Antico Regime. Essi si batterono a favore dei diritti dell’uomo, poi brutalmente sospesi nel 1793-94 e progressivamente abbandonati tra il 1799 e il 1804, anno del ripristino della schiavitù da parte di Napoleone.
La narrazione, va detto, è avvincente. E tuttavia, a un’analisi attenta, essa risulta tanto suggestiva quando artificiosa. Israel sopravvaluta l’omogeneità, l’identità e quindi i successi del fronte radicale. Condorcet, il grande eroe del libro, presunto capo degli illuministi radicali, non era certo un ateo militante ma bensì un massone deista, lockiano e ammiratore di Voltaire e di Rousseau. Così come deista era Thomas Paine, l’autore dei Rights of Man che fondava i diritti nella religione naturale.
Del resto persino un indiscutibile materialista come d’Holbach preferiva parlare di doveri anziché di diritti dell’uomo, rendendo evidente come radicalismo filosofico e progressismo politico non andassero necessariamente accoppiati. La stessa Chiesa temeva e denunciava, più che gli atei materialisti, i deisti riformatori alla Voltaire; per Pio VI la Costituzione civile del clero era eretica e scismatica, non figlia dell’ateismo.
Si potrebbe continuare, ma sarebbe ingeneroso. Ad Israel spetta infatti il grande merito di aver raccontato per la prima volta quella che potremmo definire la tragedia dell’Illuminismo, la sua fine nel sangue al di là delle ipotizzate distinzioni al suo interno. Quel mondo, in tutte le sue componenti, fu infatti la prima vittima del Terrore, dell’odio di Marat e Robespierre e del cosiddetto «populismo autoritario» dei montagnardi per gli intellettuali, gli accademici e le élite. Giustiziati i massimi rappresentati dell’Illuminismo, fatti morire in carcere personaggi come Condorcet, la ghigliottina non risparmiò neppure le prime coraggiose femministe, teoriche dei diritti della donna, Olympe de Gouges e Madame Roland.
Il racconto di questa tragedia appare in queste pagine indignate una risposta forte anche a chi ha sempre voluto trasformare le vittime in carnefici invocando le presunte origini illuministiche del Terrore e condannando in blocco una Rivoluzione nata nel segno dei diritti dell’uomo e terminata con la dittatura di Napoleone, le Restaurazioni dell’Antico regime e la nascita dei primi egoismi nazionali.
Ma soprattutto queste pagine aprono di fatto una nuova stagione di studi sull’eredità dell’Illuminismo nella storia dell’Occidente: toccherà indagare, in futuro, sui cosiddetti Risorgimenti nazionali del XIX secolo, cui è estraneo il concetto di diritti dell’uomo, per comprendere davvero da dove veniamo. Di questo, al di là dei dissensi, dobbiamo essere grati alla fatica di Jonathan Israel.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Jonathan Israel: La Rivoluzione francese. Dai diritti dell’uomo al Terrore, una storia “intellettuale” che riporta in primo piano il ruolo di filosofi e ideologi.6 febbraio 2016, di Federico La Sala
- IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg.
- VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"! E CON SHAFTESBURY, CON LA "TAVOLA DELLE COSE CIVILI"! VICO, PENSATORE EUROPEO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova".
La Rivoluzione francese? L’hanno fatta i LumiDai diritti dell’uomo al Terrore, una storia “intellettuale” che riporta in primo piano il ruolo di filosofi e ideologi
di Massimiliano Panarari (La Stampa, TuttoLibri, 06.02.2016)
Ci sono questioni che infiammano gli studiosi. Una di queste, ça va sans dire, riguarda la genesi e le «cause scatenanti» della Rivoluzione del 1789, il dibattito intorno alle quali è stato rilanciato da un monumentale volume ora pubblicato anche in Italia. La Rivoluzione francese. Una storia intellettuale dai Diritti dell’uomo a Robespierre di Jonathan Israel ha fatto esplodere in vari ambienti intellettuali una discussione furibonda e accesissima. Lo storico dell’Institute for Advanced Studies di Princeton propone infatti quello che, per molti versi, rappresenta un cambio di paradigma interpretativo, con l’obiettivo di rimettere al centro, in materia, la storia intellettuale e delle idee rispetto alla lunga egemonia di quella sociale. Una via alternativa (quarta assai più che terza...) tanto rispetto al nutrito filone marxista del passato che al revisionismo neoliberale di François Furet, e che configura una linea storiografica per la quale gli eventi rivoluzionari discesero in linea retta dall’Illuminismo. E, così facendo, in buona sostanza Israel individua nell’eredità dei Lumi il cuore autentico (e il «nocciolo duro») dell’identità culturale dell’Occidente, quel complesso di valori da mesi sotto attacco ferocissimo, stretto nella morsa a tenaglia di un rifiuto che viene dall’interno dei confini della nazione che l’ha partorito (il populismo del Front national) e di un mostruoso rigetto omicida che arriva dall’esterno, targato Isis e islamismo armato.
Analizzando nel dettaglio (attraverso nuovi documenti e la disamina approfondita degli Archives parlamentaires), e per centinaia di pagine, la battaglia culturale tra le fazioni e le «correnti» della Rivoluzione, Israel individua una filiazione diretta del suo lascito a partire dalle elaborazioni del «partito» degli illuministi radicali (tesi che caratterizza fortemente il suo lavoro da vari anni a questa parte). Un’avanguardia autentica, secondo lo studioso (che colloca nelle élites il motore fondamentale dei fatti rivoluzionari da cui venne scalzato l’Antico regime), coincidente con la componente del «parti des philosophes» (assai più che con l’ampia pattuglia di avvocati che finì per detenere la leadership politica, ma non culturale) accomunata sotto il profilo ideologico dal repubblicanesimo, da un anticlericalismo inflessibile (fondato quasi sempre sull’adesione al materialismo), dalla fiducia nell’empirismo e nella scienza e dalla strenua opposizione alla ripartizione dell’Assemblea nazionale secondo i tre ordini o «stati».
Un’ala giustappunto radicaleggiante dell’Illuminismo nella quale si riconosceva un gruppo variegato di personalità che andava dal «caposcuola» marchese di Condorcet (teorico della valenza democratica dei sistemi elettorali, nonché alfiere dei diritti delle donne e dell’emancipazione dei neri) al leader girondino Brissot, dall’idéologue conte di Volney al deputato Kersaint, dal direttore del Mercure national Robert al medico Lanthenas, dal giornalista (e «ghostwriter» di Mirabeau) Chamfort fino all’americano Thomas Paine (anch’egli eletto alla Convenzione) - gran parte dei quali ghigliottinati o imprigionati dal Terrore.
Alla base della loro visione si trovava l’idea dell’uguaglianza quale fondamento di un rinnovamento della politica, delle istituzioni e delle relazioni tra gli individui che prendeva la forma della nozione originalissima dei diritti umani fondamentali.
Nel libro di Israel siamo quindi marcatamente in presenza della concezione per cui sono le idee a muovere la storia, camminando sulle gambe degli uomini (e di varie donne che ebbero ruoli decisivi, dalle dame dei salotti anticamere della Rivoluzione sino a Olympe de Gouges), e circolando per mezzo del gran numero di pamphlet e giornali che, tra il 1787 e l’88, veicolarono una «nuova cultura politica».
Lo storico ritiene imprescindibile riconoscere l’esistenza di un dualismo costitutivo della Rivoluzione, in seno alla quale si confrontò sostanzialmente una coppia di prospettive antitetiche. L’una contro l’altra armate - la prima con le armi della critica e la seconda, invece, con una sanguinosissima critica delle armi - si fronteggiarono così la Rivoluzione della Ragione degli illuministi radicali e la Rivoluzione della Volontà dei robespierristi (incarnatasi nel russovismo giacobino istituzionalizzato nel dopo 1793 e di cui, insieme all’«Incorruttibile», erano capi Marat, Saint-Just e Hébert). Ambedue acerrime avversarie della terza anima - quella del moderatismo politico ispirato alle dottrine di Montesquieu e Voltaire, tra liberalismo monarchico e fascinazione per il «modello inglese» - ma orientate da visioni inconciliabili, che assumevano anche le forme del cosmopolitismo del parti de philosophie e del patriottismo xenofobo dei montagnardi. Insomma, secondo Israel, a dominare la scena rivoluzionaria fu il duello, mortale, tra l’Illuminismo radicale e il populismo dispotico. Echi di futuro...
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- Il manifesto di Ventotene. Chi lo scrisse, chi lo stampò (Alessandro Figà Talamanca - Sergio Romano)4 febbraio 2016, di Federico La Sala
Il manifesto di Ventotene
Chi lo scrisse, chi lo stampò
risponde Sergio Romano (Corriere della Sera, 04.02.2016)
- Nel corso della sua visita a Ventotene il presidente del Consiglio Renzi ha ricordato che proprio a Ventotene fu scritto il cosiddetto Manifesto di Ventotene che proponeva per il dopoguerra un’Europa unita e democratica. Renzi ha menzionato tuttavia solo uno degli autori del Manifesto: Altiero Spinelli, dimenticando gli altri due autori: Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi, allora confinati, assieme a Spinelli, a Ventotene. Vuole farlo lei?
 di Alessandro Figà Talamanca, Presidente della Fondazione «Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini»
di Alessandro Figà Talamanca, Presidente della Fondazione «Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini»
Caro Figà Talamanca,
Il Manifesto nacque dalle lunghe conversazioni di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. Il primo veniva dalle file del Partito comunista, ma era stato profondamento indignato dal Trattato di amicizia che l’Unione Sovietica aveva firmato con la Germania nazista nell’agosto del 1939.
Rossi aveva lavorato con Gaetano Salvemini, aveva partecipato alla fondazione di Giustizia e Libertà, aveva scontato 9 anni di carcere prima di essere confinato a Ventotene, ed era un liberale libertario, allergico a qualsiasi dogmatismo politico o religioso. Entrambi, nei loro frequenti colloqui, erano giunti alla conclusione che soltanto una Federazione europea avrebbe salvato l’Europa dalle dittature e dalle guerre.
Per Spinelli, in particolare, l’Europa fu l’ideale in cui riporre tutte le speranze che il comunismo, ormai strumento del nazionalismo russo, aveva tragicamente deluso. Nelle loro riflessioni furono aiutati da Luigi Einaudi che li nutriva con l’invio dei suoi testi e di quelli, soprattutto economici, che erano apparsi in Gran Bretagna dopo la fine della Prima guerra mondiale.
Eugenio Colorni era socialista e aveva una formazione filosofica, con una particolare predilezione per Leibnitz. Aveva insegnato filosofia all’Istituto magistrale di Trieste e aveva impiegato una buona parte del suo tempo, durante gli anni del confino, nelle redazione di un testo autobiografico, La malattia filosofica, che sarebbe apparso con altri saggi nel 2009, in occasione del centenario della nascita. Lesse il testo del Manifesto in corso d’opera, suggerì probabilmente aggiunte e correzioni, e scrisse la prefazione della edizione che apparve, per sua iniziativa, nel 1944. Ma ebbe, nella scrittura del testo, un ruolo diverso da quello dei suoi compagni di confino. Morì a Roma nel maggio del 1944, pochi giorni prima dell’ingresso degli Alleati nella città, quando fu arrestato e ferito a morte da un gruppo di miliziani fascisti.
Degli altri due autori quello che maggiormente lavorò per l’Europa è Spinelli. Fu membro della Commissione di Bruxelles dal 1970 al 1976, parlamentare europeo dal 1979 al 1989 e autore di un progetto per la costituzione degli Stati Uniti d’Europa.
Rossi si dedicò al Partito d’Azione, fu sottosegretario alla Ricostruzione e presidente dell’Arar, l’«Azienda rilievo e alienazione residuati», con il compito di mettere sul mercato una montagna di materiali che le truppe inglesi e americane avevano lasciato in Italia dopo la fine della guerra: camion, pneumatici, materiale elettrico, impianti telegrafici e telefonici, piccolo naviglio, aerei, vestiti e medicinali per un valore pari ad alcune migliaia di miliardi di lire. Il liberale libertario, bastian contrario e polemista, si dimostrò un perfetto amministratore.
- Nel corso della sua visita a Ventotene il presidente del Consiglio Renzi ha ricordato che proprio a Ventotene fu scritto il cosiddetto Manifesto di Ventotene che proponeva per il dopoguerra un’Europa unita e democratica. Renzi ha menzionato tuttavia solo uno degli autori del Manifesto: Altiero Spinelli, dimenticando gli altri due autori: Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi, allora confinati, assieme a Spinelli, a Ventotene. Vuole farlo lei?
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- L’inciviltà della confisca dei beni dei migranti. Sembrava impossibile, ma invece è accaduto (di Carlo Smuraglia).3 febbraio 2016, di Federico La Sala
Il commento /
L’inciviltà della confisca dei beni dei migranti
di Carlo Smuraglia *
Sembrava impossibile, ma invece è accaduto: una nazione civile come la Danimarca ha fatto da apripista (e speriamo che non si vada oltre) disponendo che saranno confiscati i beni e i valori in possesso dei rifugiati, che superino il limite di 1.350 Euro. A me sembra un’idea iniqua, che ricorda angosciosamente tempi contrassegnati dall’orrore, quando si confiscavano i beni agli ebrei.
In un certo senso, si va ancora più in là di quel terrificante abuso, perché dovrebbe essere normale che un migrante, se può, porti con sé qualche cosa per vivere, o addirittura sopravvivere, se non riesce ad insediarsi in un Paese, con un lavoro ed un reddito sicuro. È vero che l’abuso di potere e la disumanità non hanno limiti, ma colpisce il fatto che ad introdurre questo “sistema”, sia proprio un Paese che godeva fama di essere fra i più civili.
D’altronde, di fronte al problema enorme della migrazione, la tentazione è, per molti, quella di ergere muri e fili spinati, respingere decine di migliaia di rifugiati, introdurre deroghe alle leggi vigenti (non solo Schengen), ma addirittura alle Costituzioni e alle leggi di libertà. Tutta questa linea è assolutamente inaccettabile ed improponibile.
Credo che sia veramente da apprezzare quella Ministra della Giustizia francese (Chistiane Taubira) che si è dimessa, disapprovando la linea del suo Governo, che si propone di ridurre le libertà previste dalla stessa Convenzione dei diritti dell’uomo. Speriamo, peraltro, che ci siano anche altri che si ispirino alla scuola della “schiena dritta” e del rispetto dei diritti.
*
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Una Ue che non ha più certezze. E i welfare state davanti a una scelta ineludibile. Note di V. Visco e di Hans W. Sinn.30 gennaio 2016, di Federico La Sala
Una Ue che non ha più certezze
di Vincenzo Visco (Il Sole-24 Ore, 29.01.2016)
Il 2016 si prospetta come un anno molto complicato per l’Europa che può vedere compromessa la sua stessa esistenza. Le difficoltà economiche permangono e la crescita risulta debole e a rischio; le crisi bancarie in Portogallo, ma soprattutto in Italia, possono far precipitare l’Unione in una crisi anche più grave che nel 2011. Il fatto che si esiti ad affrontarle con misure adeguate alimenta gli istinti speculativi dei mercati. Da questo punto di vista la decisione della Commissione di bloccare la bad bank italiana è semplicemente irresponsabile.
Il rischio che il referendum britannico sulla permanenza nella Comunità possa avere un esito negativo è reale e, al momento attuale, crescente. La eventuale uscita del Regno Unito potrebbe determinare un effetto domino micidiale: la Scozia potrebbe ribadire la sua volontà di restare nella Comunità e quindi dichiarare la propria indipendenza; uscita l’Inghilterra, anche i Paesi del nord avrebbero minori ragioni per una loro permanenza. Le spinte secessionistiche in altri Paesi (Spagna, ma non solo) potrebbero rafforzarsi. Ila Brexit inoltre diventerebbe più probabile se si prospettasse un’altra crisi greca, evento del tutto possibile dal momento che il programma imposto al Paese è apparso fin dall’inizio di difficilissima, se non impossibile, realizzazione e di improbabile successo.
A questa situazione va ancora aggiunta la violazione di fondamentali regole democratiche da parte di alcuni Paesi europei: l’Ungheria di Orban (ormai da diversi anni, senza nessuna reazione da parte della Commissione e dei Paesi leader), e più recentemente la Polonia di Kaczynski, nei confronti della quale le reazioni sembrano esserci e saranno fonte di conflitto. Ambedue i governi, comunque, sono fortemente euroscettici.
Altri Paesi come l’Austria e la Danimarca sono stati indotti dalla pressione delle opinioni pubbliche ad assumere posizioni radicali nella gestione del problema della immigrazione.
In sostanza l’Europa appare sempre più balcanizzata, percorsa da spinte nazionalistiche sempre più forti, e incapace di ogni reazione.
I partiti più radicali di destra e di sinistra conquistano spazio in tutti i Paesi: dalla Francia, dove solo un sistema elettorale che consente di escludere il 25 o più per cento del corpo elettorale, e che comincia giustamente ad essere posto in discussione, ha evitato che si materializzasse il successo del Fronte popolare, alla Spagna (ancora in cerca di un governo), al Portogallo.
All’origine di questo disastro vi sono due fattori principali: la crisi economica e il fenomeno dell’immigrazione. La crisi del 2007 ha avuto dimensioni epocali e, come quella del 1929, rischia di avre conseguenze politiche devastanti in Europa dove la leadership tedesca ha imposto una terapia insensata, ispirata agli interessi di breve periodo della Germania, ma assolutamente iatrogena per tutti gli altri, che ha spinto le economie del continente a divergere sempri di più e a scaricare sui ceti più deboli tutto il costo dell’aggiustamento, creando insicurezza, paura e risentimento, e anche mettendo a rischio la ripresa mondiale affidata solo agli sforzi degli Stati Uniti. La pervicacia con cui il ministero delle Finanze tedesco e la Bundesbank continuano a portare avanti la loro linea incuranti delle macerie materiali e morali che essa ha provocato fa temere che in verità i gruppi dirigenti tedeschi (o una loro parte) abbiano già deciso di considerare chiusa l’esperienza dell’euro se non della stessa Unione.
Per quanto riguarda l’immigrazione la minaccia di una vera e propria invasione dal sud è reale, così come sono fondate le preoccupazioni delle popolazioni europee. Tuttavia il problema non è gestibile con recinzioni e respingimenti. Si tratta infatti di oltre 20 milioni di potenziali migranti, di disperati che dal Medioriente e dall’Africa fuggono da guerre, carestie, desertificazioni, collasso degli Stati, violenze gratuite. Solo un intervento coordinato, non solo dell’Europa, ma della comunità internazionale, orientato sia a ristabilire la pace, sia a fornire generose erogazioni tipo piano Marshall, possono darci la speranza di non essere invasi e travolti in un modo o nell’altro, in tempi non brevissimi.
Stando così le cose, è evidente che ciò che manca è la politica. Sarebbe necessaria una iniziativa di alto livello e ad ampio ragio che fosse in grado di affrontare sia la questione economica che quella dell’immigrazione. È anche evidente che la guida dell’iniziativa non potrebbe che essere degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, ma gran parte dei costi dovrebbe essere affrontata dall’Europa che sarebbe il beneficiario principale dell’operazione.
Sarebbe quindi opportuno che questi problemi venissero per lo meno posti formalmente sul tappeto nella loro interezza ed esplicitandone il collegamento. Nella situazione attuale le polemiche, le punture di spillo che si scambiano i protagonisti della politica europea servono veramente a poco.
L’ondata migratoria mette sempre più in crisi i sistemi di welfare degli Stati Ue
Se il magnete sociale non funziona
di Hans Werner Sinn (Il Sole-24 Ore, 29.01.2016)
Il conflitto armato che sta destabilizzando alcuni paesi arabi ha messo in moto un’enorme ondata di rifugiati diretti per lo più in Europa. Nella sola Germania nel 2015 ne sono arrivati circa 1,1 milioni. Al contempo, l’adozione del principio di libertà di circolazione all’interno dell’Europa ha innescato flussi migratori inter-europei di massa, che passano inosservati e dei quali per lo più non ci si occupa. Nel 2014 la Germania ha conosciuto un saldo migratorio netto con l’Ue di 304mila persone provenienti da altri paesi dell’Unione, fatto senza precedenti, e questa cifra, probabilmente, è stata assai simile anche nel 2015.
Alcuni stati membri dell’Ue - tra i quali Austria, Ungheria, Slovenia, Spagna, Francia e altri paesi che in un primo tempo si erano mostrati particolarmente accoglienti, come Danimarca e Svezia - hanno reagito sospendendo di fatto gli Accordi di Schengen e ripristinando i controlli alle frontiere. Gli economisti non si stupiscono poi tanto di ciò. Negli anni Novanta, decine di studi accademici avevano affrontato proprio la questione delle migrazioni negli stati che offrono welfare e prestazioni sociali, evocando molti dei problemi che ormai si vanno chiaramente palesando. Io stesso all’epoca ho scritto molto su questo argomento, cercando, per lo più inutilmente, di aumentare la consapevolezza nei confronti di questo problema tra i politici.
In gioco c’è una questione fondamentale. I welfare state sono definiti dal principio di redistribuzione: coloro che godono di entrate superiori alla media pagano più imposte e contributi rispetto a ciò che ricevono indietro sotto forma di servizi pubblici, mentre coloro che hanno entrate inferiori alla media pagano meno di quanto ricevono. Questa redistribuzione, che drena le risorse pubbliche nette per convogliarle verso nuclei famigliari a reddito più basso, costituisce una correzione sensibile all’economia di mercato, una sorta di assicurazione contro le vicissitudini della vita e la dura legge del prezzo della rarità, che caratterizza l’economia di mercato e ha poco a che fare con la giustizia sociale
I welfare state sono essenzialmente incompatibili con la libera circolazione dei popoli tra i paesi se i nuovi arrivati hanno un accesso immediato e totale alle prestazioni sociali nei paesi che li ospitano. Qualora ciò accadesse, i paesi che li accolgono fungono da welfare magnet (calamite sociali), e possono attirare molti più migranti di quanti sarebbe economicamente consigliabile accogliere, perché i nuovi arrivati ricevono, oltre ai salari, una sovvenzione sotto forma di bonifici. Soltanto se i migranti ricevono unicamente i salari ci si può aspettare un’auto-regolamentazione efficiente del fenomeno migratorio.
Il primo ministro britannico David Cameron ha tratto una legittima conclusione da tutto ciò: il fenomeno del magnetismo sociale non porta soltanto a un’inefficiente distribuzione geografica delle persone, ma per di più erode e nuoce anche alle capacità dello stato che eroga prestazioni sociali. Ecco il motivo per il quale Cameron dichiara di avere il diritto di fissare un limite al principio di integrazione, che si dovrebbe applicare perfino per i migranti economici intra-europei. Dice Cameron che anche nel caso in cui i migranti trovassero un lavoro, soltanto dopo quattro anni dovrebbero avere accesso alle prestazioni sociali offerte dal welfare finanziato dalle entrate fiscali. Ora come ora, un periodo sostanziale di attesa è previsto e in vigore unicamente per i cittadini dell’Ue che migrano per motivi di lavoro e che devono risiedere nel Regno Unito cinque anni prima di conquistare il pieno accesso alle prestazioni sociali pubbliche.
La proposta non si tradurrà necessariamente in una maggiore severità nei confronti dei migranti dall’Ue: essa implica semplicemente che, a prescindere dal tipo di aiuto di cui possono aver bisogno nell’arco dei primi quattro anni, essi dovranno riceverlo dal paese di provenienza. Indubbiamente ci sarebbe molto da dire a favore del mantenimento temporaneo del principio dell’addebito delle spese al paese d’origine, e sulla traduzione di questa disposizione nelle regole dell’Ue: il paese d’origine di un migrante dovrebbe continuare a essere responsabile nei suoi confronti e a fornirgli prestazioni sociali per un certo numero di anni, fino a quando non si potrà applicare il principio di integrazione.
È difficile comprendere perché, per esempio, un tedesco che non può lavorare e usufruisce del welfare tedesco debba essere preso in carico dallo stato spagnolo qualora decida di vivere a Maiorca. E sarebbe altrettanto poco plausibile negare a questa stessa persona il diritto di scegliere il luogo nel quale eleggere il proprio domicilio a suo piacimento soltanto per tutelare lo stato spagnolo. Se intendiamo prendere sul serio il principio della libertà di circolazione delle persone, dovremmo deciderci una volta per tutte a immolare la vacca sacra dell’eleggibilità immediata ai sussidi e alle prestazioni sociali elargite dallo stato ospite.
Quanto detto, naturalmente, non vale per i migranti economici provenienti dai paesi extra-Ue, e ancor meno per i rifugiati, perché in generale il principio del paese d’origine in questi casi è inapplicabile. Ma, per le stesse motivazioni sopra evidenziate, questi migranti non possono essere integrati a centinaia di migliaia nel welfare state senza mettere a repentaglio la vivibilità dell’intero sistema.
In conclusione, sarebbe necessario sostituire al sistema dei sussidi di disoccupazione che prevale oggi, applicabile agli aventi diritto quando costoro restano senza posto di lavoro, un sistema che proponga e offra integrazioni salariali e lavoro a favore della comunità. Ciò consentirebbe di abbassare le spese nette delle prestazioni sociali e di ridurre gli incentivi a migrare. Andrea Nahles, ministro del lavoro tedesco, di recente ha suggerito proprio questo, difendendo ciò che i tedeschi chiamano il concetto del “posto di lavoro a un euro”, che in pratica converte il contributo sociale in un salario.
Si tratta di un consiglio sensato in un contesto per altro estremamente caotico. Se si manterrà la libertà di circolazione all’interno dell’Europa - e se proseguiranno gli afflussi di cittadini extra-Ue - i welfare state europei si troveranno davanti a una scelta ineludibile: adattarsi o soccombere.
 (Traduzione di Anna Bissanti)
(Traduzione di Anna Bissanti) -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Immigrazione: Europa mostra volto disumano davanti a dramma umanitario, agire subito (Cgil)..28 gennaio 2016, di Federico La Sala
Immigrazione: Cgil,
Europa mostra volto disumano davanti a dramma umanitario, agire subito
di CGIL, 28/01/2016
"Non si può più aspettare: il dramma sconcertante di bambini, donne e uomini che continuano a morire in mare è il volto disumano di un’Europa che non è in grado di elaborare una visione comune e soluzioni condivise e che sta mettendo in pericolo non solo migliaia di vite, ma i valori fondanti della sua stessa civiltà. Subito corridoi umanitari, il superamento di Dublino e una politica comune di accoglienza". Questo quanto si legge in una nota dell’Ufficio Immigrazione della Cgil nazionale.
Per il sindacato di Corso d’Italia “lo scenario a cui assistiamo è straziante e sempre più buio: notizie quotidiane di nuove morti in mare, il rischio di ulteriori perdite di vite umane a causa del freddo nell’area balcanica, tra chi è rimasto intrappolato dai troppi muri innalzati in questi mesi, il trionfo degli egoismi nazionali e la crescita di forze xenofobe e populiste, il proliferare di deprecabili politiche discriminanti e punitive, come la confisca dei beni ai richiedenti asilo in Danimarca”. “Di fronte a tutto questo - prosegue la nota - constatiamo l’incapacità di elaborare proposte funzionali e utili all’intero territorio dell’Unione, di cui è un esempio il fallimento del minimo sforzo previsto dall’Agenda Junker di settembre".
La Cgil inoltre ritiene "vergognoso e pericoloso" il piano a cui sta lavorando la presidenza di turno olandese dell’Ue che prevedrebbe l’accoglienza di 250mila migranti provenienti dalla Turchia in cambio di respingimenti, che saranno sicuramente di massa, dei migranti sbarcati ’illegalmente’ sulle isole greche".
L’Ufficio Immigrazione della Cgil ribadisce "la necessità urgente di una politica di asilo europea che preveda il superamento del Regolamento di Dublino e cancelli le attuali incongruenze e incertezze, come quelle derivanti dalla suddivisione tra ’profughi’ e ’migranti economici’, basata sul nulla, e dalla labile definizione di ’Paesi sicuri’".
“Occorre aprire subito i corridoi umanitari, disegnare una politica di accoglienza comune e avviare processi di pace per via politica nelle zone di conflitto, nonché politiche di cooperazione con i paesi messi in ginocchio da crisi economiche e ambientali. Non è un’emergenza - si legge infine nella nota Cgil - ma un imperativo da cui dipendono il futuro della civiltà europea e il rispetto di quei valori su cui l’Unione è stata fondata dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Valori di cui oggi sembra essersi dimenticata”.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! -- MEMORIA E STORIA. La Shoah oggi? Moni Ovadia: il nuovo Olocausto è nella fossa comune del Mediterraneo (di Emma Barbaro)28 gennaio 2016, di Federico La Sala
- "Meditate che questo è stato" (Primo Levi)
 SHOAH - STERMINIO DEL POPOLO EBRAICO. 27 GENNAIO: GIORNO DELLA MEMORIA - LEGGE 20 luglio 2000, n. 211, DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SHOAH - STERMINIO DEL POPOLO EBRAICO. 27 GENNAIO: GIORNO DELLA MEMORIA - LEGGE 20 luglio 2000, n. 211, DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La Shoah oggi? Ovadia: il nuovo Olocausto è nella fossa comune del Mediterraneo
L’artista ospite del Teatro "Gesualdo" per una due giorni in città all’insegna della memoria come insegnamento per l’oggi
di Emma Barbaro (Il Ciriaco. Notizie di Avellino e provincia, 26 Gennaio 2016)
"Io conosco la Shoah. Tuttavia ritengo che oggi essa venga strumentalizzata per altri scopi. Il giorno della memoria sta diventando il giorno della falsa coscienza e della retorica. L’Ebreo è divenuto il Totem attraverso cui ricostruire la verginità della civiltà occidentale. Ma l’ebreo di oggi è il rom, considerato ancora paria dell’umanità; è il musulmano, il palestinese; è il profugo che trova la morte nella fossa comune del Mediterraneo". A parlare è l’artista poliedrico Moni Ovadia. Un ebreo italiano, nato in Bulgaria nel 1946. Un uomo, innanzitutto. La sua famiglia vive gli anni della persecuzione nella schiera dei ’fortunati’. Sfuggono ai campi di concentramento perché Bulgaria e Danimarca non cedono alle pressioni internazionali e scelgono di non piegarsi alle deportazioni di massa. "Vuol dire che si poteva fare- ricorda Ovadia- e che gli altri Stati hanno deciso consapevolmente di non farlo".
Parole dure come macigni, che rispolverano quel concorso di colpa tutto italiano nelle vicende della Seconda Guerra Mondiale. La memoria scivola a quel 16 ottobre del 1943, data in cui 1024 ebrei romani, 1024 italiani, furono arrestati, tenuti prigionieri e infine caricati come bestiame sui quei vagoni la cui ultima fermata recava ’Auschwitz Birkenau’. Circa 847 di loro furono direttamente ’selezionati’ all’arrivo per le camere a gas. Tornarono in sedici, una donna e quindici uomini. "Abbiamo bisogno di sapere- suggerisce Ovadia- che la memoria serve ad edificare presente e futuro. Altrimenti, è solo vuoto celebrativismo. E allora, che si parli pure di una giornata ’delle memorie’".
Ad ascoltare, attenti, gli studenti della Scuola Media ’Perna-Alighieri’ e quelli del Liceo delle Scienze Umane ’P. V. Marone’ che ogni anno, nel mese di febbraio, porta i suoi studenti a visitare il tristemente noto campo di concentramento di Auschwitz Birkenau. Nell’ambito della rassegna ’Teatro Civile’, il Teatro Carlo Gesualdo e il Conservatorio Cimarosa di Avellino si sono fatti promotori di una due giorni incentrata sul ricordo delle vittime della Shoah. Presenti all’incontro il presidente dell’Istituzione Teatro comunale Luca Cipriano, l’assessore con delega alla Cultura Teresa Mele e l’assessore alle Politiche Sociali Marco Cillo, che nel donare a Moni Ovadia una sciarpa realizzata nel maglificio confiscato alla camorra ’CentoQuindici Passi’ ricorda le vittime trasversali del ’sonno della ragione’. "Se il compito del Terzo Reich- afferma Cillo- è stato quello di cercare di cancellare dalla memoria le vittime innocenti del genocidio, al pari la mafia tenta di nascondere alle coscienze il ricordo dei suoi morti. Oggi abbiamo il compito di affidare questi nomi agli studenti per dar loro la possibilità di perpetrare la memoria. Il 27 gennaio dovrebbe uscire dal calendario ed entrare nella nostra quotidianità".
Ma è Moni Ovadia a rinsaldare la consapevolezza. A ricostruire il sottile legame con la coscienza. "Si è passati- afferma- dallo sterminio degli ebrei alla israelianizzazione della memoria. Ho ascoltato politici, per me furfanti, uscire dal campo di concentramento di Auschwitz e dire "mi sento israeliano". Ma che affermazione è questa? Non sento nessuno affermare di sentirsi rom, omosessuale, antifascista, slavo o menomato. Eppure anche loro furono vittime dello sterminio. Vedete, distinguere tra morti è uno schifo. Primo Levi ha scritto un capolavoro assoluto della memorialistica e della riflessione, ma non l’ha intitolato ’Se questo è un ebreo’ ma ’Se questo è un uomo’.
Ricordiamoci degli esseri umani. Anche se noi italiani siamo specialisti in retorica e falsa coscienza, sfatiamo il mito degli ’italiani brava gente’. Ricordiamo che quello fascista è stato il regime dei genocidi: in Cirenaica, ad opera del generale Graziano; in Etiopia, il generale Badoglio ordinò lo sterminio col gas. Centotrentacinquemila morti civili, innocenti spariti in una volta sola. Ricordiamoci della ex Jugoslavia. Facciamo come i tedeschi. Loro hanno fatto chapeau. Loro, con la storia, ci hanno fatto i conti. Forse dovremmo iniziare a farlo anche noi".
Nella memoria di Ovadia sfilano gli armeni, lo sterminio di massa in Manciuria, quello delle Filippine; ma anche il tentativo di cancellazione di un’intera generazione in Argentina con i desaparecidos, la lotta interna della Cambogia, la guerra civile dell’ex Jugoslavia tra coloro che pregavano lo stesso Dio: i cattolici-croati e i serbi-ortodossi. E l’Europa, ferma a guardare le sue faglie in rotta di collisione tra loro. Pronta a favorire gli uni piuttosto che gli altri interessi. Per non parlare delle crociate di democrazia moderne, dei morti civili in Iraq, Afghanistan, Siria, Libano, Palestina.
La lista è lunga, ma la domanda resta: si può oggi escludere una persistenza della mentalità degli stermini? "Il Mar Mediterraneo è una fossa comune- aringa Ovadia- Ancora una volta gli interessi economici vengono anteposti alla dignità degli esseri umani. Eppure siamo stati noi occidentali a dire che ’gli uomini nascono liberi e uguali, pari in dignità e diritti’. Ma ancora manca il diritto di residenza universale. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ed io condivido con tutto il cuore questa impostazione, propone l’abolizione universale del permesso di soggiorno. Altrimenti non saremo mai una vera umanità. I dati Onu ci dicono che le ’guerre moderne’ causano oggi il 95 percento delle vittime civili. La guerra non è di per sé un atto criminale?".
"Io voglio stare in esilio finché vivrò- conclude l’artista- L’Italia è il mio Paese ma non la mia patria. Patrie non ne voglio avere. Vengo a parlare con questi ragazzi perché le loro vite non subiscano passivamente la falsa coscienza e retorica. Perché oggi i rom vengono considerati ancora i paria dell’umanità mentre gli ebrei sono le vacche sacre? Perché i primi non hanno uno Stato, mentre i secondi sono armati fino ai denti con testate nucleari e cercano costantemente di estendere i propri confini. Ecco perché l’antisemitismo di Stato è scomparso. Per carità, sopravvive in alcuni corpuscoli nazisti, ma è stato espunto dallo spazio pubblico. Si deve avere coraggio e lungimiranza per affermare certe idee. Poi ne paghi il prezzo: io non dirigo teatri o festival, collaboravo per alcune testate e ora non mi ci fanno più scrivere. Ma settant’anni cominci a fregartene e comprendi che l’informazione è importante, ma non deve mai ridursi a mera comunicazione. In questi giorni assisteremo ad un profluvio di trasmissioni sulla Shoah, ma nessuno penserà di collegare quel ricordo con gli stermini di massa di cui siamo complici nel presente. L’informazione- conclude- va incrociata con l’indagine del presente per poter essere un elemento fruibile dalle future generazioni".
- "Meditate che questo è stato" (Primo Levi)
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- "Polizia della Frontiera. Frontex e la produzione dello spazio europeo". I guardiani del Leviatano sovranazionale (di Dario Melossi).26 gennaio 2016, di Federico La Sala
I guardiani del Leviatano sovranazionale
di Dario Melossi (il manifesto, 19 gennaio 2016)
Difficile pensare ad un libro più «topico» di questo appena apparso di Giuseppe Campesi, Polizia della Frontiera. Frontex e la produzione dello spazio europeo (DeriveApprodi, pp.236, euro 17), specialmente perché tratta di questioni delle quali quotidianamente leggiamo e vediamo nelle news.
Sembra essere in corso un tentativo di revisione della struttura, compiti e ruolo della «Guardia di frontiera europea» o come la si vorrà chiamare. Campesi ci fa vedere come Frontex costituisca un osservatorio privilegiato dal quale scrutnare in realtà il complesso della costruzione europea. Se ciò che è in gioco, come egli propone, è la costruzione di «uno spazio politico europeo», tramite la designazione dei «confini» (borders) di questo spazio, la questione che è lecito porsi, e che Campesi pone nelle prime pagine del suo testo è: per cosa sta tale «spazio»? Di quale spazio si tratta?
Campesi è assai cauto nel rispondere che questo è lo spazio di una sorta di «superStato» o forse meglio tout court di uno Stato federale europeo «in formazione». E che, così come per altri concetti fondamentali della convivenza politica, cittadinanza, fiscalità, forza, democrazia, anche per lo «spazio» si pone la questione di cosa significhi che esso è «europeo». -In particolare, se ciò significhi semplicemente che si tratta dello spazio-somma di 28 (per il momento) spazi nazionali oppure se sia qualcosa di più e di diverso. Al fine di rispondere a questa domanda di fondo Campesi ripercorre prima la genealogia della costruzione dell’organizzazione il cui agire dà vita a questo spazio, Frontex appunto, e poi quella che ne potremmo definire la fenomenologia.
Frontex è quindi un «capitolo fondamentale della costituzione materiale d’Europa», che ha dato vita ad uno spazio europeo della sicurezza. Tale spazio costituisce un aspetto cruciale di quell’animale burocratico-amministrativo che verrebbe voglia di chiamare il Leviatano europeo. E che, così come il Leviatano di Hobbes prendeva forma - si veda il bel saggio di Carlo Ginzburg nel suo recente Paura reverenza terrore - dalla paura della moltitudine di soggetti che gli conferiva vita, così anche la sua nuova versione «europea» sembra essere sospinta da una sorta di mantra ripetuto incessantemente in decine di documenti, trattati e convenzioni, quello della lotta contro «il terrorismo, il crimine organizzato e l’immigrazione illegale». -Si ripete qui, naturalmente, una storia che abbiamo già vista, nel corso del ventesimo secolo, sull’altra costa dell’Atlantico, laddove il sorgere delle «polizie federali», in primis l’Fbi, si nutrì della lotta contro anarchici e «tratta delle bianche» negli anni Venti del Novecento, «gangsters» come John Dillinger negli anni Trenta, comunismo negli anni della guerra fredda e infine pericolosi sovversivi, soprattutto il «Partito delle Pantere Nere», negli anni Settanta.
Sino ad oggi, secondo Campesi, il ruolo di Frontex veniva individuato in una produzione di conoscenza, a beneficio degli stati membri e delle loro forze di sicurezza, che si basava innanzitutto sulla individuazione di elementi di rischio. -Particolarmente efficaci appaiono le pagine di Campesi ove egli spiega come il problema centrale di Frontex stia nel contemperare e bilanciare l’imperativo neoliberale di aprire, rendere fluidi, e quasi inesistenti, i confini, e presidiare al tempo stesso la sicurezza della società neoliberale. A ciò si è finora risposto con la politica definita, sulla scorta della leadership nordamericana, degli «smart borders». I confini sono «intelligenti» quando riescono a capire - preferibilmente in 12 secondi - se l’individuo che chiede di transitare dal confine corrisponda o meno ad un profilo prestabilito di pericolosità.
Profilo che si basa sull’incrocio delle informazioni provenienti da un numero sempre crescente di banche dati (di qui, ad esempio, il dibattito attuale tra chi vorrebbe estendere in modo ancora più universale l’acquisizione di dati, come nel caso del Pnr e i difensori invece della privacy dei viaggiatori).
Dopo gli attentati di Parigi, tuttavia, tendenze già presenti da tempo ma che erano state tenute a bada da una coalizione mista di euroscettici e difensori della privacy, sembrano essere emerse con maggiore aggressività, e il processo di costruzione della sagoma del Leviatano europeo sembra avere fatto passi avanti, al punto di prospettare addirittura la trasformazione di Frontex in una opportunamente denominata polizia, o guardia, o agenzia europea di frontiera, in grado anche di imporsi alle forze di sicurezza nazionali se queste sembrassero esitare nell’affrontare i compiti che l’Ue, come interpretata da Frontex, ha loro imposto. Tutta la tematica della creazione dei cosiddetti «Hotspots», che si dovrebbero accompagnare - ma qui, guarda caso, la «volontà europea» sembra vacillare assai - ad un superamento delle «regole di Dublino», è legata a tale impostazione. In luoghi come Lampedusa, Pozzallo, o Lesbo, l’iniziale registrazione dei rifugiati dovrebbe avvenire, si dice, anche a costo di usare la forza, sotto l’occhio vigile di «guardie europee» che non si capisce se siano più interessate a ispezionare i migranti o coloro che li devono registrare.
C’è infatti una curiosa ironia - verrebbe da chiamarla ironia se non si trattasse della vita e del destino di milioni di persone! - in ciò che è accaduto alle frontiere meridionali d’Europa negli ultimi due anni e cioè che la sostanziale «devianza» di migranti e rifugiati - devianza rispetto a quello che dovrebbe essere l’«ordinato svolgersi» degli spostamenti da un paese all’altro, e che nel caso dei rifugiati non ha alcun modo di svolgersi in maniera ordinata in quanto non esiste «visto» per i rifugiati e quindi chi voglia sottrarsi ai pericoli sulla propria persona e sulla persona dei propri famigliari lo può fare solamente in modo eslege, al di fuori della legge - tale devianza, insomma, si è magicamente comunicata agli stessi organi di vigilanza e di sicurezza delle nazioni presidianti i confini i quali hanno finito per assecondare la volontà di centinaia di migliaia di rifugiati di cercare di trasferirsi verso quelle zone d’Europa che essi, a torto o a ragione, ritenevano più accoglienti.
In pratica, ciò ha significato la creazione di vie di fuga analoghe a quelle che, ai tempi della lotta antischiavista negli Stati Uniti antebellum, si chiamavano underground railroad. I cosiddetti «trafficanti di esseri umani» non fanno infatti che fornire, per un prezzo, un servizio che gli aspiranti rifugiati richiedono, nella assoluta assenza di alternative, sacrificati sull’altare del nuovo Moloch della «legalità». Non vi è dubbio che il bel libro di Giuseppe Campesi abbia dato un contributo importante alla critica della costruzione del Leviatano europeo, critica che fa tutt’uno con l’emergere di un reale processo di costruzione della democrazia europea. Anche per questo ci auguriamo che venga al più presto tradotto in inglese e nelle altre lingue dell’Unione.
*
-
> RIPENSARE L’EUROPA! - Prometeo, Ulisse e Faust gli ispiratori di "La società europea", secondo Cavalli e Martinelli (di Maurizio Ferrera)25 gennaio 2016, di Federico La Sala
RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!:
Sono Prometeo, Ulisse e Faust gli ispiratori dell’Europa
Secondo Cavalli e Martinelli la razionalità e l’individualismo sono i due valori portanti della costruzione comunitaria. Oggi minacciati dal terrorismo e dai risorgenti egoismi nazionali
di Maurizio Ferrera (Corriere della Sera, La Lettura, 24.01.2016)
La cosiddetta generazione Erasmus è la più europeizzata della storia. Nulla incide così direttamente sulla formazione di un giovane come un’esperienza vissuta in un altro Paese, insieme a studenti di molte nazionalità. È proprio pensando ai millennials erasmiani che Alessandro Cavalli e Alberto Martinelli hanno scritto La società europea (Il Mulino), che può essere letto anche come un manuale per accrescere e organizzare le conoscenze sull’Europa, nonché per sviluppare la piena consapevolezza di appartenere a una cultura e a una comunità politica più ampia e ricca di quella nazionale. Il libro è, in realtà, molto più di un manuale. Non descrive soltanto: interpreta, riflette e fa riflettere. Poggia sulla migliore letteratura accademica, fornisce descrizioni fattuali e spunti analitici preziosi anche per gli addetti ai lavori. Insomma, è un libro importante, frutto di un lavoro decennale, destinato a restare.
I dodici capitoli analizzano vari aspetti della società europea: dalle religioni alle città, dal welfare alle istituzioni politiche, dalle lingue alle università. Ciascun aspetto viene illustrato prima in prospettiva storica, poi nelle sue articolazioni contemporanee e infine nel ruolo che esso ha giocato nel processo di integrazione. Alla fine di ciascun capitolo, al lettore restano due impressioni: il grande spessore del panorama europeo, ma anche la sua grande diversità. Un pluralismo «denso» di valori, pratiche sociali, strutture economiche, istituzioni politiche. Questo embarras de richesse è quasi inebriante, ma fa anche sorgere due domande: ricchezza e diversità non costituiscono un impedimento per l’integrazione? E, prima ancora, è possibile identificare che cosa è, quintessenzialmente, «europeo», al di là del pluralismo?
Che gli autori abbiano una risposta si intuisce dal titolo: La società europea al singolare, non al plurale. Per Cavalli e Martinelli, gli elementi caratterizzanti della cultura europea sono essenzialmente due: il razionalismo e l’individualismo (o soggettività). Il primo si esprime attraverso l’incessante ricerca di conoscenza, guidata dal pensiero critico. Nata nell’antica Grecia, la mentalità razionale si è approfondita e articolata durante la modernità, in particolare grazie all’Illuminismo. Il Prometeo liberato (Shelley), il Faust di Goethe e, prima ancora, l’Ulisse dantesco sono i personaggi simbolo di questo ethos (la ricerca del sapere e del nuovo come «virtude»), che ha dato frutti straordinari nel campo dell’arte, dell’architettura, della filosofia, della scienza. E che ha fornito la cornice di senso entro cui hanno potuto svilupparsi l’economia di mercato e il capitalismo.
Prometeo, Ulisse e Faust simboleggiano bene anche il secondo tratto: la fiducia nell’individuo, la promozione della sua autonomia, la concezione per cui ciascuno è artefice del suo destino e perciò responsabile delle sue scelte e azioni. L’ ethos individualista è alla base dei principi di libertà ed eguaglianza affermati dal giusnaturalismo e dal pensiero liberale. Al quale si devono non solo la elaborazione e la concreta realizzazione della nozione di cittadinanza, ma anche l’impulso a conciliare il valore della libertà e quello dell’eguaglianza (accentuato soprattutto dalla tradizione socialista). Democrazia e welfare state sono le incarnazioni paradigmatiche di questa conciliazione. La prova provata che libertà ed eguaglianza sono complementari, anche se il loro rapporto va continuamente calibrato in base alle trasformazioni sociali.
Razionalità e individualità sono naturalmente due valori cornice: definiscono le coordinate generali di uno spazio culturale in cui tali valori si combinano concretamente in mille forme. Chi abita questo spazio deve osservare una regola di condotta che è condizione del pluralismo: la tolleranza, l’apertura verso posizioni diverse, l’inclusione dell’altro (per dirla con Jürgen Habermas).
Cavalli e Martinelli riconoscono (anzi sottolineano) che la storia europea ha prodotto anche tanti «mostri»: pensiamo, per tutti, alla Shoah. L’affermazione della cornice razionale e individualista non ha seguito una traiettoria lineare ed è stata accompagnata da tremendi conflitti. Possiamo però dire che, per prove ed errori, la cultura europea sia riuscita di volta in volta ad «apprendere» e selezionare le soluzioni sociali e istituzionali più amichevoli verso il proprio ethos di base.
Che dire della religione? Quale ruolo e che peso assegnare alla tradizione giudaico-cristiana nel processo che ha plasmato l’identità europea? Gli autori propendono per una risposta «dialettica». Il cristianesimo ha influenzato profondamente la cultura e le istituzioni del nostro continente durante i secoli. Nella visione cristiana, l’uomo ha un rapporto diretto con il Dio trascendente.
Insieme al diritto romano, il pensiero cristiano ha contribuito ad avvalorare il concetto di persona, ad abbinarlo con quello di dignità. Ma al tempo stesso la Chiesa ha teso a contrastare l’affermazione dell’ ethos razionalista e individualista, assumendo in alcuni momenti posizioni fortemente antimoderne. La separazione del potere spirituale da quello temporale è stata un processo lento e faticoso, così come l’affrancamento dei fedeli dalla soggezione gerarchica rispetto a dogmi che riguardano anche la sfera secolare e privata. Il cristianesimo ha giocato dunque sia un ruolo costruttivo sia un ruolo dialettico in seno alla cultura europea. Nel senso che è stata spesso considerata come polarità dalla quale distanziarsi.
Ma veniamo all’integrazione. Gli autori non hanno dubbi: l’unificazione europea è un progetto autenticamente moderno ed è nata dalle dure lezioni della prima metà del Novecento. Gli europei sono usciti traumatizzati dal «mostro» della guerra e, proprio come Ulisse, si sono legati le mani per perseguire un progetto mai tentato prima: la costruzione di una associazione politica plurinazionale (una demoicracy, da demoi, «popoli», secondo la felice espressione di Kalypso Nicolaidis) non attraverso mezzi coercitivi, ma attraverso la legge.
La Ue è nata come comunità di mercato e si è a poco a poco trasformata in una comunità giuridica con finalità politiche. L’elemento straordinario di questo processo è stato proprio l’uso politico della diversità per «accomunare», facendo leva sull’ ethos razionalista e individualista, sulla tolleranza e sul mutuo riconoscimento.
Gli autori non sono certo ingenui e sono ben consapevoli dei rischi di questo progetto, diventati molto evidenti sulla scia della crisi. La cornice valoriale che contraddistingue l’identità europea è emotivamente «fredda», basata più sul calcolo utilitario (anche se temperato dai principi di reciprocità) che non sulle passioni. Oggi siamo di fronte a due sfide gigantesche che mettono a dura prova il nostro modello: l’immigrazione e il terrorismo legato al fondamentalismo islamico.
La Ue è a un bivio. La paura e le passioni spingono i demoi del continente a ripiegarsi su se stessi, resuscitando miti e simboli nazionalisti. L’ ethos razionale spinge invece verso l’ulteriore integrazione: sia come strumento per gestire meglio le due sfide, sia per difendere i valori universalistici che gli europei hanno inventato. La responsabilità che incombe sui leader della Ue (come capi di governi nazionali e insieme co-registi dell’integrazione) non potrebbe essere più grande e gravida di conseguenze che interessano i destini politici di tutta l’umanità.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! - la fine o il declino di questo continente incombe da anni, da quando si è dichiarato incapace di dare una speranza di vita a chi, oltretutto, potrebbe aiutarlo a crescere (Alessandro Dal Lago)23 gennaio 2016, di Federico La Sala
Editoriale
La doppia pena del migrante
di Alessandro Dal Lago (il manifesto, 23.01.2016)
- Oggi, sul "Manifesto", è uscito un mio pezzo leggermente abbreviato (per motivi redazionali) su un aspetto orrendo dell’ingresso dei migranti e rifugiati in Europa, cioè il sequestro dei beni e dei contanti, per "finanziare la loro accoglienza". Ha cominciato la Danimarca e poi è stato il turno di Svizzera e Baviera. Ecco il pezzo integrale:
Prendiamo una famiglia di profughi siriani. Marito, moglie e due figli piccoli. Dopo la fuga da una città in fiamme, tra milizie e bande di ogni tipo, su strade sconnesse e insicure, riescono a passare in Turchia. Da qui, dopo essere stati detenuti in qualche campo, in base alle imperscrutabili decisioni di Erdogan, sbarcano in un’isola greca, rischiando di morire nell’Egeo.
Traversata la Grecia, entrano in Macedonia e, attavversando le frontiere a piedi, nella neve, in Serbia. Evitata l’ospitale Ungheria (il paese del muro, delle manganellate ai profughi e delle giornaliste che fanno lo sgambetto ai bambini), attravversano Serbia e Slovenia. Infine, forse, entrano in Austria, da dove sono spediti in Germania, cioè in Baviera. E quale è la prima mossa dei bavaresi, costretti a farli entrare da Angela Merkel? Sequestrare beni e contanti superiori a 750 Euro, “per finanziare la loro accoglienza”.
Prima di maledire il governo bavarese, è utile qualche considerazione microeconomica, anzi di economia domestica. Per un viaggio del genere, una famiglia tipo, in cui lavora solo il capofamiglia, di quanto denaro avrà potuto disporre, in dollari? Tenendo conto che il reddito pro capite in Siria non arriva a 2000 dollari (nel 2007, prima della guerra), meno di un ventesimo di quello tedesco o austriaco, è difficile immaginare più di un migliaio o due, cucito nelle fodere, ma solo se stiamo parlando di professionisti o commercianti. Il resto, se ce l’avevano, se ne sarà andato, sicuramente, a ungere miliziani e doganieri, non solo in Turchia, e a comprarsi da mangiare. E poi, ci saranno anche qualche gioiello di famiglia, un orologio, un cellulare e magari un tablet. Sequestrare a questa gente i valori oltre 750 Euro è una cosa schifosa. La Danimarca ha fatto scuola.
Ma non è solo schifosa, è insensata. Se si sfogliano i quotidiani economici europei si troveranno spesso, ma solo nelle pagine interne, analisi sulla necessità dei migranti per un continente che non cresce e la cui popolazione invecchia. In altri termini, il welfare europeo - o meglio i conti pubblici europei - hanno bisogno di gente che sostenga la domanda e paghi le tasse. È il punto di vista dell’economia di mercato, fatto proprio da Merkel, a cui interessano fino a un certo punto le giaculatorie identitarie. Nulla di filantropico, per carità. Si parla della stessa tecnopolitica transnazionale che non ha voluto far fallire la Grecia, ma solo per comprarle a poco prezzo gli asset, insomma per succhiarle un po’ di sangue.
Torniamo alla famiglia siriana. Perché imporre il balzello d’ingresso, se poi, trovato un lavoro, anche misero, il capofamiglia e la moglie (lui facendo il lavapiatti, anche se in Siria magari era un dentista, e lei riparando giacche) cominceranno a finanziare il welfare bavarese? La risposta è in un concetto del sociologo algerino Sayad, “la doppia pena del migrante”. Loro non sono come noi e, se vogliono vivere tra noi, devono pagare pegno. Non solo stranieri, ma anche tenuti sotto il tallone.
E di che pegno si tratta? I danesi, che hanno introdotto il sequestro d’ingresso, lo hanno detto chiaramente. Sappiamo che è una misura priva di qualsiasi significato economico, ma così li scoraggiamo. Tra l’altro, la Danimarca partecipa attivamente ai bombardamenti della Siria - cioè prima dice di bombardare l’Isis per sconfiggere il fondamentalismo e poi impone i balzelli a chi scappa dall’Isis. Un miracolo di logica.
D’altronde, nella vicenda dei profughi non c’è alcuna logica, tanto meno europea. Ogni stato, in base alla sua specifica xenofobia o paura del populismo, erige i suoi muri, chiude le sue frontiere, impone i suoi balzelli. Non esiste uno straccio di politica comune delle migrazioni, né di autorità capace di realizzarla, come mostra la vicenda dei ricollocamentii dei migranti approdati in Italia e Grecia. Una politica unitaria non esiste, perché l’Europa è solo un’espressione finanziaria, per citare un famigerato motto di Metternich sull’Italia. Così, innalzare le barriere interne, come stanno facendo stati xenofobi o paranoici, significa compromettere quel po’ di libertà, di cosmopolitismo infra-europeo facilitato dalla libera circolazione delle merci.
Molti osservatori preconizzano che, con la crisi di Schengen, inizia la probabile agonia della Ue. Ma la fine o il declino di questo continente incombe da anni, da quando si è dichiarato incapace di dare una speranza di vita a chi, oltretutto, potrebbe aiutarlo a crescere.
-
> RIPENSARE L’EUROPA! -- «Corsa ad ostacoli verso l’Europa», s’intitola così l’ultimo rapporto di Medici senza frontiere: «L’Ue ha fallito sui profughi, è disumana».22 gennaio 2016, di Federico La Sala
Europa
Medici senza frontiere: «L’Ue ha fallito sui profughi, è disumana»
di redazione (il manifesto, 22.01.2016)
«Corsa ad ostacoli verso l’Europa», s’intitola così l’ultimo rapporto di Medici senza frontiere che denuncia il «catastrofico fallimento dell’Unione europea nel rispondere ai bisogni umanitari di rifugiati, richiedenti asilo e migranti nel 2015». «Mai prima d’ora - dice Federico Zamatto, responsabile medico di Msf - abbiamo dovuto avviare così tanti progetti in Europa per salvare vite in mare. Mai prima d’ora abbiamo dovuto assistere così tanti disperati alle frontiere, curando le conseguenze fisiche e psicologiche dei drammatici viaggi, delle violenze subite e della mancanza di assistenza».
Nel 2015 i numeri dell’ong per la migrazione in Europa sono triplicati. Tra il 1° gennaio e il 15 dicembre, ha effettuato oltre 100.000 consultazioni mediche e psicologiche - sulle navi di ricerca e soccorso e nei progetti in Italia, Grecia e Balcani - e tra maggio e dicembre ha soccorso 23.747 persone in mare. In tutto Msf ha speso circa 31,5 milioni di euro e mobilitato 535 operatori umanitari.
Il rapporto descrive gli ostacoli che l’Europa e i governi hanno imposto lungo il percorso di oltre un milione di persone, la maggior parte in fuga da guerre e persecuzioni: mancanza di alternative alle pericolose traversate del mare, filo spinato per chiudere i confini, continui cambiamenti nelle procedure amministrative e di registrazione, condizioni di accoglienza inadeguate in Italia e Grecia, violenze in mare e alle frontiere di terra.
Per Msf, frutto di«un approccio atroce e inaccettabile» mentre servirebbero canali legali e sicuri per i richiedenti asilo (anche con alle frontiere di terra), riunificazioni familiari facilitate, visti umanitari e ricollocamenti; percorsi legali per ridurre viaggi pericolosi e reti di trafficanti; ricerca e soccorso in mare, luoghi di sbarco predefiniti con condizioni umane e assistenza medica; investimenti nell’accoglienza invece che nella deterrenza, schemi di ricollocamento più ambiziosi.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- IL PARADOSSO DEL LEVIATANO: HOBBES, SCHMITT, KANT, E LA CRISI DEGLI STATI NAZIONE.22 gennaio 2016, di Federico La Sala
- LA TIRANNIA DEI VALORI: IL VATICANO E IL VALORE ASSOLUTO DELLA VITA. La critica anticipatrice di Carl Schmitt e di Federico Fellini della tradizionale e poco evangelica teologia di Papa Ratzinger
DA HOBBES A SCHMITT ECCO IL LEVIATANOdi ANTONIO GNOLI *
Il Leviatano è un grandissimo libro di teoria politica. Ancora oggi ci turbano le sue analisi. Ancora oggi stupisce la capacità introspettiva con cui Thomas Hobbes indagava la natura umana, estraendone miserie e nefandezze: la cupidigia e l’ invidia, l’ ostilità e la paura, la menzogna e il tradimento, la violenza e il sopruso. Sentimenti dell’ uomo sorretti dal bisogno innato di prevalere sul proprio simile.
Si tratta di descrizioni note che tornano alla mente in occasione della nuova edizione del Leviatano (edita da Rizzoli) e della pubblicazione di un vecchio saggio di Carl Schmitt: Sul Leviatano (edito da il Mulino). Entrambi i libri presentano un’ introduzione di Carlo Galli che ricostruisce con grande competenza l’ alfa e l’ omega del capolavoro hobbesiano.
Quando nel 1651 Hobbes pubblica il suo libro, l’ Europa - con la pace di Westfalia - ha messo fine al lungo periodo di guerre civili e religiose. Si avverte nel continente la necessità di un rinnovo profondo delle istituzioni, fino ad allora eccessivamente condizionate da una visione feudale e teologica. Hobbes è conscio che soltanto un gesto radicale che azzeri tutto quanto è accaduto in passato, possa far nascere un organismo così potente e persuasivo da regolare la vita dei sudditi.
La macchina politica hobbesiana - che Galli riconduce alla prima costruzione del moderno Stato rappresentativo del diritto - ignora i problemi legati alla legittimazione divina e va dritta alla questione essenziale: come superare il disordine che è insito nella natura umana, creando un ordine che sia stabile, duraturo e condiviso? Il passaggio dallo stato di natura allo Stato propriamente detto (e riconosciuto) si avvale secondo Hobbes di un patto di non belligeranza che gli uomini stringono tra loro, perché fuori da quel patto la vita risulterebbe brutale e insicura.
Tuttavia, un accordo così vasto non può che essere un artificio grazie al quale Hobbes formalizza la nascita dello Stato moderno e del legame sociale. Garantendo la pace e con essa la vita degli individui, lo Stato spoglia i suoi sudditi di tutti gli altri diritti. Non a caso c’ è chi ha visto in Hobbes delinearsi una prima forma di totalitarismo.
Galli ridimensiona questa preoccupazione e semmai scorge nel volto barocco del Leviatano (il nome allude a un mostro marino che Hobbes riprese dalla tradizione biblica) una potenza costantemente minacciata dalle forze della storia. Lo stato hobbesiano è in grado di arginare e ritardare il conflitto, ma non di debellarlo definitivamente. È il dramma nichilistico nel quale versa il pensiero di Hobbes.
Il Leviatano ha avuto numerosi interpreti. Da Rousseau, Kant ed Hegel fino agli stimoli novecenteschi offerti da Benjamin, Strauss, Macpherson, Bobbio e ovviamente Carl Schmitt. Il cui libro, Sul Leviatano, fu pubblicato nel 1938. Giurista autorevole, ma ormai inviso al regime nazista, Schmitt ci consegna pagine esoteriche, attraversate da deliranti pulsioni antisemite, ma anche capaci di illuminare il destino teorico di Hobbes. Già in passato Hobbes era stato al centro dei suoi interessi, ma qui si configura un problema nuovo: è in grado lo Stato leviatanico di affrontare e risolvere quei conflitti per i quali era predisposto?
Schmitt mette in dubbio la solidità di fondo dello Stato moderno insidiato dalla imprevedibilità dei soggetti patologici (ai quali lo stesso partito nazista appartiene). È probabile che una tale convinzione la ricavi dalla consapevolezza di vedere i primi segni della crisi dello jus publicum europaeum. Il crepuscolo della sovranità statale sarà infatti uno dei temi portanti del Nomos della Terra. Con l’ opera del 1950 Schmitt si va sempre più convincendo che lo spazio geopolitico stia mutando radicalmente e che gli stessi soggetti della politica (in primis gli Stati nazione) come Hobbes li aveva teorizzati, stavano tramontando.
Strana coppia Hobbes e Schmitt. Così la definisce efficacemente Galli. Tanto uno è all’ inizio del Moderno quanto l’ altro si colloca alla fine di quell’ esperienza. «Si tratta», osserva Galli, «di due visioni prospettiche della medesima epoca storica».
Scrivendo il Leviatano Hobbes immaginò che il disordine originario, fonte di mortale pericolo, dovesse essere quanto più possibile neutralizzato e sostituito dalle certezze dell’ ordine normativo creato dalla ragione umana. È proprio ciò che alla fine Schmitt mise in discussione: l’ efficacia di contenere il politico dentro una forma giuridica stabile e condivisa. Era convinto che le potenze (piùo meno segrete) della storia difficilmente si sarebbero adeguate alla misura umana. E alla sua ragione.
*Archivio: la Repubblica, 29.10.2011
La guerra all’Is e i dettami di Kant
di Nadia Urbinati (la Repubblica, 21 novembre 2015)
NON sappiamo quanto lunga sarà la convivenza con il terrorismo. I timori per la vita non sono amici diretti della libertà; eppure sono condizioni essenziali per creare la sicurezza, grazie alla quale soltanto la libertà può crescere. Su questo paradossale legame di paura, sicurezza, libertà - il paradosso del Leviatano - si incastonano le nostre istituzioni e i nostri diritti.
Non si dà diritto e quindi libertà senza una cornice di sicurezza e di sovranità statale le cui funzioni siano costituzionalizzate e il potere limitato e temperato dalla legge. Su questo “abc” si basa l’Occidente, quel grappolo di libertà, civili, politiche, morali che contraddistingue la nostra vita quotidiana. Se la guerra è una condizione tragica (e a volte necessaria) che ci accomuna tutti alla specie umana, la pratica della legge e dei diritti è quella straordinaria costruzione che qualifica la nostra tradizione dall’antichità, permeando tutte le sfere di vita, religiosa e secolare, privata e pubblica. Questo è l’Occidente.
E lo è soprattutto quando la violenza terroristica, cieca e imprevedibile, costringe a pensare in fretta e con determinazione quali misure prendere. Che cosa fare. Il governo francese ha messo in atto immediatamente dopo l’attentato, quasi reagendo all’emozione dell’indeterminato, una strategia di guerra e di polizia. François Hollande ha proposto modifiche d’urgenza alla Costituzione francese, per estendere nel tempo e nelle prerogative lo stato d’emergenza, e per dettare criteri di revoca della cittadinanza francese nel caso di terroristi che ne abbiano due. Le misure di guerra in Siria e quelle di stato d’emergenza interno prefigurano condizioni di eccezionalità che possono destare preoccupazione.
L’esperienza americana dopo l’11 settembre 2001 dovrebbe assisterci nelle nostre valutazioni. A partire da quella tragedia, George W. Bush prese due decisioni che si rivelarono onerosissime per gli Stati Uniti e il mondo, entrambe improntate alla logica della guerra: contro i nemici esterni e contro i nemici interni (cittadini americani e non). Tutte le forme di intervento vennero rubricate e gestite come operazioni di “guerra”. Si ebbe prima l’invasione dell’Afghanistan e poi dell’Iraq (dove l’argomento era distruggere i siti di produzione di armi nucleari e cacciare il dittatore Saddam Hussein) e, nel frattempo, la creazione di un campo di reclusione per prigionieri-nemici totali situato fuori della giurisdizione americana, a Guantánamo, Cuba (poiché la Costituzione, che non venne comunque mai cambiata, avrebbero vietato una detenzione arbitraria dentro i confini statali).
Come riconoscono ormai tutti gli esperti, queste misure si sono rivelate onerose e fallaci da tutti i punti di vista: giuridico, economico, militare e politico. Con l’alleanza della Gran Bretagna di Tony Blair (il quale recentemente ha chiesto scusa per gli errori commessi con l’invasione dell’Iraq) gli Stati Uniti hanno creato oggettivamente le condizioni di instabilità radicale nelle quali fiorisce oggi il terrorismo dell’Is: la demolizione dello Stato di Hussein in Iraq ha consegnato parte di quel territorio vasto e ricco di petrolio a forze militari terroristiche o a loro sodali. Una condizione che si è recentemente ripetuta con la Libia.
Ha spiegato Romano Prodi, in alcune interviste rilasciate in questi giorni, che la strategia da anteporre a quella militare, e da integrare con quella di polizia, dovrebbe essere l’intervento sulle “libertà economiche” di cui godono i terroristi: libertà di vendere petrolio alle compagnie multinazionali occidentali a costi probabilmente competitivi o a mercato nero. L’introito miliardario di quel libero commercio consente ai terroristi di acquistare armi. Intervenire sul mercato delle armi e del petrolio è possibile solo se tutti gli stati si uniscono per limitare una condizione di quasi totale anarchia, a causa della quale le nostre libertà rischiano di morire.
L’Occidente ha dunque l’arma della legge, che è fortissima se usata con l’obiettivo giusto in mente, quello di combattere le forze terroristiche prima di tutto con l’intelligence e le forze dell’ordine, e intanto togliere loro risorse materiali e sostegno sulla scena globale.
Una sinergia di azioni coordinate tra tutti gli stati che si riconoscono nella famiglia dell’Onu può essere vincente, seguendo i dettami della pace perpetua di Kant: primo fra tutto, quello per cui la libertà si difende con armi proprie, che sono il diritto e la legge
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- «Ancora due mesi, poi la Ue è finita». L’allarme di Juncker e Tusk per la scelta di alcuni stati di chiudere i confini.20 gennaio 2016, di Federico La Sala
Europa
Tusk: «Ancora due mesi, poi la Ue è finita»
Europa. L’allarme di Juncker e Tusk per la scelta di alcuni stati di chiudere i confini. «Dopo Schengen toccherà all’euro»
di Carlo Lania (il manifesto, 20.01.2016)
Due mesi, non un giorno di più. A marzo sapremo se l’Unione europea esisterà ancora, almeno così come la conosciamo oggi, oppure se la vedremo crollare sotto i colpi inferti dagli interessi nazionali. A lanciare l’allarme non è certo l’ultimo arrivato, ma il presidente del consiglio europeo Donald Tusk parlando ieri al parlamento di Strasburgo. «Abbiamo due mesi per rimettere la situazione migratoria sotto controllo - ha avvertito -: il consiglio di marzo sarà l’ultima occasione per vedere se la nostra strategia funziona. Altrimenti affronteremo una crisi come il crollo di Schengen».
Dietro le parole di Tusk c’è la scelta presa da sempre più Stati di ripristinare i controlli alle proprie frontiere. Ha cominciato la Germania, poi è toccato a Svezia e Danimarca. Sabato scorso è stata la volta dell’Austria e nelle prossime ore la stessa cosa la faranno anche Slovenia e Croazia. Uno dietro l’altro stanno segnando la fine della libera circolazione delle persone (e delle merci), fino a oggi baluardo e vanto dell’Unione europea messo in ginocchio dalla crisi dei migranti ma anche dalla determinazione di molte capitali a non accoglierli.
«L’Unione europea è minacciata alla base e forse non ce ne rendiamo conto» ha rincarato la dose Jean Claude Juncker, per il quale se non si inverte in fretta la rotta a essere messi in dubbio ben presto non saranno solo i confini. «Oggi si reintroducono i controlli alle frontiere, domani ci accorgeremo che il colpo economico è considerevole e dopodomani ci chiederemo perché c’è ancora una moneta unica se non c’è più la libertà di movimento» ha ammonito il presidente della commissione Ue.
Non è certo la prima volta che da Bruxelles, e in particolare proprio da Juncker, si sottolineano i rischi per l’Europa. Mai, però, la situazione è stata così grave. Ai paesi dell’est, si è infatti aggiunto un blocco di Stati tradizionalmente fedeli alle regoli europee e che oggi invece scelgono altre strade. Segnali di una crisi che forse va oltre l’emergenza migranti. «Ormai l’Ue è minacciata nei fondamenti», avverte non a caso Juncker.
Che non si tratti del solito grido «al lupo, al lupo»lo provano come al solito i fatti. Bruxelles spinge da mesi perché gli Stati accettino al loro quota di migranti? ben oggi il governo austriaco presenta una serie di misure per ridurre il numero dei migranti e rendere più sicuri i confini. «Ci saranno misure su come rendere l’Austria meno attraente» per i rifugiati, ha spiegato il ministro delle Finanze, il conservatore Hans Joerg Schelling.
Ieri invece a Praga si sono visi i ministri degli Interi di Slovacchia, Ungheria, Polonia e repubblica ceca per un vertice , il cosiddetto gruppo di Visegrad, che hanno ribadito la loro opposizione al sistema di quote obbligatorie per la distribuzione dei rifugiati proposta dalla commissione Ue. Alla riunione hanno partecipato anche i ministri dei di Slovenia, Serbia e Macedonia, con i quali è stato stretto un patto di collaborazione per i controllo dei confini dei Balcani occidentali.
Messa di fronte alle sua incapacità di gestire il fenomeno migratorio, terrorizzata da quanto potrebbe accadere a primavera, quando il bel tempo incoraggerà nuove partenze di massa dalla Siria, l’Unione europea torna a riproporre l’unica ricetta che considera utile per non affondare: rafforzare i controlli lungo le frontiere esterne. Tradotto vuol dire: investire soldi, uomini e mezzi non per salvare i migranti, ma per impedirgli di partire.
Per raggiungere il suo scopo Bruxelles spinge soprattutto sulla Turchia e sulla sua capacità di fermare i profughi.«Ankara è la chiave per fermare i migranti», ha spiegato il ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmaier. Berlino ha anche criticato l’Italia per le obiezioni sollevato riguardo ai criteri di pagamento dei tre miliardi di euro decisi a novembre dall’Ue come contributo ad Ankara.
Mentre l’Europa litiga, lungo i suoi confini ogni giorno si consumano tragedie, rese più probabili dalle basse temperature di questi giorni. L’Unicef ha lanciato l’allarme per i tanti bambini in arrivo nell’Europa sudorientale. Piccoli stremati dal viaggio, impauriti, stressati e spesso che necessitano di assistenza medica, denuncia l’organizzazione, secondo la quale almeno uno ogni tre rifugiati arrivati nei Balcani è minorenne. Costretti a camminare per ore in mezzo alla neve senza avere, denuncia sempre l’Unicef, né abiti adatti né cibo a sufficienza.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- "Piccola storia della fotografia" del «Dio mortale». Il "Leviatano" e il migrante «mobile» (di Franco Farinelli)18 gennaio 2016, di Federico La Sala
Politiche e territori. Il "Leviatano" e l’esercizio centralizzato del potere
Il migrante «mobile» che mette in crisi la staticità dello Stato
di Franco Farinelli (Corriere della Sera, La Lettura, 17.01.2016)
Che fine hanno fatto gli abitanti di Parigi? Se lo chiedeva Walter Benjamin a proposito delle foto scattate da Eugène Atget nell’Ottocento, del tutto prive di persone quasi che la città fosse deserta, una scena vuota. E metteva in guardia, nella sua Piccola storia della fotografia, contro il «nascosto carattere politico» di tali immagini, di cui non riusciva però a decifrare la natura, la ragione.
 Per rispondere sarebbe bastata un’occhiata al frontespizio del Leviatano di Hobbes, il testo cui più di ogni altro lo Stato moderno deve la propria fondazione teorica, apparso a metà Seicento: un’epoca in cui la prima pagina di un libro valeva come sintesi illustrata di tutto il contenuto, al punto che Cartesio poteva vantarsi di non aver bisogno di aprire un volume per venire a capo del problema posto dal titolo.
Per rispondere sarebbe bastata un’occhiata al frontespizio del Leviatano di Hobbes, il testo cui più di ogni altro lo Stato moderno deve la propria fondazione teorica, apparso a metà Seicento: un’epoca in cui la prima pagina di un libro valeva come sintesi illustrata di tutto il contenuto, al punto che Cartesio poteva vantarsi di non aver bisogno di aprire un volume per venire a capo del problema posto dal titolo.A prima vista il corpo del Leviatano, emblema dello Stato territoriale centralizzato come lo chiamava Carl Schmitt, sembra soltanto villoso, oppure formato da molteplici scaglie. In realtà la gigantesca forma del mostruoso principe, che brandisce sul mondo le insegne del potere sia religioso che civile, risulta costituita dalla massa dei singoli corpi dei sudditi, tutti privi di volto perché ritratti di spalle, a segno dell’assenza di ogni loro reciproca differenza al cospetto del nuovo «Dio mortale». -Soltanto il capo e le mani (gli organi del pensiero e dell’azione) della potentissima creatura sono fatti di una sostanza non umana, del tutto estranea rispetto all’ingombro materiale della somma degli individui: i cui apparati fisici, parti coerenti e solidali dello stesso unico insieme, già anticipano, nella loro reciproca equivalenza e nella intercambiabilità della loro disposizione, la logica della produzione di serie, il cui primo annuncio i filosofi di Francoforte scorgeranno invece nelle macchine erotiche descritte da de Sade.
Diversamente però da quel che accade in quest’ultime, nel corpo del Leviatano i soggetti debbono restare immobili o almeno in tal modo vengono concepiti, pena la crisi della staticità dello Stato stesso, che si chiama così proprio perché non si muove.
Fu Machiavelli, all’inizio del Cinquecento, il primo ad adoperare tale termine nel significato di una formazione politica che coincide con un’estensione territoriale: ancora nel Quattrocento «stato» era soltanto sinonimo di condizione, quella privilegiata di un essere umano dotato di particolari e superiori prerogative dal punto di vista dell’esercizio del potere, a partire da quello di dire giustizia.
 Come un soggetto si sia oggettivato trasformandosi in una cosa, come la parola che designa un potente sia passata invece a distinguere l’ambito d’esercizio del suo potere (di ciò infatti si tratta) è un processo che ancora attende puntuale ricostruzione. Ma intanto è proprio da tale sparizione del soggetto che deriva l’assenza di persone nelle fotografie che a Benjamin facevano problema, e di cui intuisce la funzione politica: come nelle foto Alinari su cui abbiamo studiato al liceo Storia dell’arte, gli uomini e le donne sono assenti perché stanno altrove, a comporre il corpo dello Stato, di cui le immagini stesse sono più o meno consapevole e mediata espressione.
Come un soggetto si sia oggettivato trasformandosi in una cosa, come la parola che designa un potente sia passata invece a distinguere l’ambito d’esercizio del suo potere (di ciò infatti si tratta) è un processo che ancora attende puntuale ricostruzione. Ma intanto è proprio da tale sparizione del soggetto che deriva l’assenza di persone nelle fotografie che a Benjamin facevano problema, e di cui intuisce la funzione politica: come nelle foto Alinari su cui abbiamo studiato al liceo Storia dell’arte, gli uomini e le donne sono assenti perché stanno altrove, a comporre il corpo dello Stato, di cui le immagini stesse sono più o meno consapevole e mediata espressione.
 E oltre che invisibili gli atomi di cui il Leviatano si compone sono immobili perché se è vero che lo Stato moderno non ha territorio ma è il territorio, come insegnano i giuristi, quest’ultimo è una costruzione geometrica, uno spazio propriamente detto, al cui interno ogni cittadino corrisponde a un punto, dalla cui supposta stabilità la stabilità (la staticità) dell’intero sistema dipende. Da dove altrimenti deriverebbe l’uguaglianza (l’egalité) dei cittadini? Accadde l’11 settembre, del 1789: per la prima volta, a Parigi, il voto dell’Assemblea venne espresso singolarmente, non più per «ceto» ma per «testa», appunto in omaggio al principio dell’equivalenza generale dei punti geometrici sul piano.
E oltre che invisibili gli atomi di cui il Leviatano si compone sono immobili perché se è vero che lo Stato moderno non ha territorio ma è il territorio, come insegnano i giuristi, quest’ultimo è una costruzione geometrica, uno spazio propriamente detto, al cui interno ogni cittadino corrisponde a un punto, dalla cui supposta stabilità la stabilità (la staticità) dell’intero sistema dipende. Da dove altrimenti deriverebbe l’uguaglianza (l’egalité) dei cittadini? Accadde l’11 settembre, del 1789: per la prima volta, a Parigi, il voto dell’Assemblea venne espresso singolarmente, non più per «ceto» ma per «testa», appunto in omaggio al principio dell’equivalenza generale dei punti geometrici sul piano.Ecco perché le figure del migrante e del rifugiato mettono davvero in crisi l’ordinamento politico esistente: perché la loro visibilità e mobilità, ripristinando le più immediate funzioni antropologiche, minano prima d’altro la fondamentale finzione (la funzionale idealizzazione, il «congelamento metonimico» direbbe Arjun Appadurai) sulla cui base l’intero sistema statale moderno è stato costruito.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- La libertà delle donne, il metro della democrazia, e la laicizzazione e secolarizzazione dello Stato (di Susanna Camusso)14 gennaio 2016, di Federico La Sala
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
Spiace che neanche la sinistra misuri la democrazia con la libertà delle donne
di Susanna Camusso (The Huffington Post, 12/01/2016)
Ho una convinzione irremovibile: la libertà delle donne è metro di misura della democrazia. Non da oggi, non dalla notte di Capodanno, ma da quando ho preso coscienza penso che la libertà non sia uguale a quella degli uomini se le donne sono considerate un corpo di proprietà altrui, sganciato dalla loro testa che... Non esiste.
Convinzione che si rafforza quando nei conflitti, anche in quelli più recenti, ho visto, sentito, capito che si ripetevano azioni di guerra condotte sui corpi delle donne; quando ho seguito con ammirazione le donne di Kobane; quando mi sono indignata perché siamo pronti a onorare le vittime del terrorismo in tutto il mondo, ma poi dimentichiamo le ragazze rapite, convertite a forza, stuprate e uccise da Boko Haram, come fossero altro, diverse dagli altri morti.
La libertà delle donne è metro di misura della democrazia, ha la stessa forza degli altri fondamenti democratici? No, né per la destra, né, spiace dirlo, per la sinistra. Ricordo ancora il dibattito sulla rivoluzione iraniana, quando il ritorno al velo, i limiti all’istruzione, i guardiani o la Shari’a erano considerati conseguenze secondarie ed ininfluenti. Sbagliavamo. Per questo "Colonia", al di là delle ricostruzioni, mi chiama in causa perché di aggressione alla libertà delle donne si tratta. La sostanza non cambia se si è trattato di aggressione organizzata, collettiva, preparata o meno. L’aggressione alle donne è aggressione alla libertà delle donne.
Certo si sprecano in queste ore le classificazioni, atto di guerra, scontro di civiltà, terrorismo e per ognuna possiamo trovare motivazioni per negarle prima di tutto perché ciascuna di quelle pone la l’interpretazione e la giustificazione fuori di noi, della cultura europea. Sottintende che solo ad "altri", di una differente cultura o ancor di più di religione diversa, la libertà delle donne fa orrore e mette paura. Come dire che in Europa le donne sono considerate sempre inviolabili. Purtroppo, milioni di statistiche, fatti, evidenze, racconti, spiegano l’opposto.
Per questo è odioso, strumentale e anche insopportabile che si leghi quanto avvenuto a Colonia direttamente all’immigrazione o ai rifugiati. È salvifico per gli uomini, per l’intera cultura europea, per la finzione di non sapere cosa succede, con infinita frequenza, tra le mura delle nostre case. Anche non ritrovandomi in quelle definizioni penso comunque che sia indispensabile approfondire la riflessione. Lo scopo evidente è la proprietà e la trasformazione in oggetti dei corpi delle donne diffondendo paura. La paura è lo scopo precipuo del terrorismo. Cambia i comportamenti, genera richiesta di sicurezza, protezione e favorisce l’idea che per difendersi si possa limitare la libertà. Paura e modifica dei comportamenti mettono in forse la civiltà, come noi la intendiamo, fondata sulla libertà, esercitabile perché sancita dai principi democratici.
Fu faticoso alzare la voce sugli stupri di piazza Tahrir. Fu difficile perché per molti, troppi, veniva prima l’importanza di una lotta per la democrazia che la libertà e la sicurezza delle donne, senza neppure domandarsi che democrazia possa essere quella che può fare a meno della libertà di metà del mondo Molte domande suscita "Colonia" e molto ancora c’è da riflettere, non nel silenzio ma provando ad aprire un dibattito pubblico sul che fare, su cosa chiediamo a noi stesse e a noi stessi per affermare la piena libertà delle donne e, certo, anche sull’integrazione e sui modelli di accoglienza, su ciò che chiediamo a chi arriva per avere asilo e futuro. Dobbiamo riflettere su come rendere esplicita e inviolabile la libertà delle donne, senza dare per scontato, perché non lo è, che il nostro modo di essere sia rispettoso della loro libertà, della loro autodeterminazione, della loro libertà di scelta. Poi, dobbiamo porci la domanda, non ultima, se la religione, sfera privata per eccellenza, sia parte di questo ragionamento.
Penso che per troppo tempo abbiamo finto che non lo sia, che non ci sia relazione tra laicità dello Stato e libertà delle persone. L’Islam che si fa Stato, che applica la Shari’a (e non mi riferisco solo a Daesh), che vuole determinare la proprietà e la sottomissione delle donne a un uomo, non può più essere un problema di altre, delle donne musulmane prime vittime di questa radicale confessionalizzazione della politica e del governare. Mondi paralleli non esistono, nonostante le politiche d’integrazione siano state spesso questo. È una condizione che riguarda tutti e tutte perché se condividi spazio e tempo non possono esistere isole separate e intangibili.
 La lunga strada della laicizzazione e della della secolarizzazione dello Stato e dei governi è un patrimonio - ancora incompiuto - della cultura europea e non solo. Che sia Colonia, Delhi o Raqqa è al centro di un conflitto e di uno scontro che è tuttora in corso e che coinvolge il mondo intero.
La lunga strada della laicizzazione e della della secolarizzazione dello Stato e dei governi è un patrimonio - ancora incompiuto - della cultura europea e non solo. Che sia Colonia, Delhi o Raqqa è al centro di un conflitto e di uno scontro che è tuttora in corso e che coinvolge il mondo intero. - Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" --- Il dovere della Merkel. Come Ribaltare quell’orrore. La notte di Colonia costituisce, sotto il profilo simbolico, un avvenimento grave11 gennaio 2016, di Federico La Sala
Il dovere della Merkel
di Angelo Bolaffi (la Repubblica, 11.01.2016)
Molti sono gli interrogativi su quanto accaduto nella notte di Capodanno. A Colonia, Amburgo, Stoccarda e in altre città tedesche. E non ancora pienamente chiarite sono colpe e responsabilità. Per ora è caduta la testa del capo della polizia di Colonia. Ma il ministro della Giustizia Heiko Maas ha addirittura ipotizzato l’esistenza di una regia occulta dietro episodi che di spontaneo o di casuale avrebbero poco e nulla. Per questo dovremo attendere i prossimi giorni, quando si terrà la prima sessione del Parlamento tedesco che segnerà la ripresa della vita politica dopo le festività, per avere un quadro “a bocce ferme” della situazione.
Intanto sia in Germania, dove l’emozione è fortissima, che in Europa (e nel mondo) ci si interroga su quali potranno essere le conseguenze per la politica tedesca in tema di immigrazione. E soprattutto se Angela Merkel saprà o vorrà restare fedele alla sua strategia di apertura e disponibilità all’accoglienza dei profughi che ha sollevato critiche nel suo stesso partito ma anche obiezioni in parte dell’opinione pubblica di orientamento liberale. Lo scorso dicembre la Cancelliera tedesca era stata prescelta dal Financial Times quale “personalità dell’anno” per il coraggio politico dimostrato nelle difficili settimane d’autunno durante le quali centinaia di migliaia di profughi hanno attraversato la frontiera tedesca per cercare asilo accolti con calore e solidarietà.
In un articolo scritto per Repubblica Timothy Garton Ash ha sostenuto che Angela Merkel fosse per questo meritevole di essere candidarla al Nobel per la pace. Poi di colpo il barometro del giudizio sulla politica della Cancelliera tedesca ha cominciato a segnare tempesta. E nelle consuete previsioni di fine anno lo stesso Financial Times ha pronunciato una fosca profezia: nel 2016 la questione dei profughi segnerà la fine del regno di Angela Merkel. Il malcontento e l’incertezza prevarranno sulla ammirazione nei confronti della sua capacità di leadership: una rivolta dei leader politici locali della Cdu, espressione di un crescente malumore popolare nei confronti della sua politica di apertura la avrebbe costretta alle dimissioni.
La gravità dei reati commessi nella notte di San Silvestro, primo fra tutti l’intollerabile offesa fisica e morale alla libertà delle donne simbolo di uno dei valori non negoziabili della cultura europea e occidentale, è sembrata drammatica conferma di quella pessimistica prognosi. E fatto sorgere il dubbio che la Cancelliera tedesca sarà costretta a cambiare strada nel tentativo di salvare il suo destino politico e quello della Grosse Koalition che oggi governa il Paese.
Per ora dalle sue prime dichiarazioni «la sensazione, in questo caso delle donne, di sentirsi completamente in balia senza alcuna difesa, è per me anche personalmente intollerabile», come pure dall’andamento tutto sommato moderato nei toni del tradizionale incontro annuale organizzato nel giorno dell’Epifania dalla Csu bavarese nell’idilliaco villaggio di Wildbad Kreuth, l’impressione è che all’orizzonte non ci siano drastiche mutamenti di rotta nella politica seguita nei confronti dei profughi. E che nessuna forza politica oggi presente nel Parlamento, diverso è ovviamente il caso degli xenofobi di Pegida, voglia strumentalizzare quanto accaduto o soffiare sul fuoco giocando la carta della xenofobia.
 Certo verranno con maggiore determinazione perseguiti quanti si sono resi o si renderanno responsabili di reati, rompendo così il velo di ipocrisia che nel segno di un insensato ideologismo («il problema è sociale, non culturale») e in nome del “politicamente corretto”, anche la notte di Capodanno, ha spinto a chiudere non uno ma due occhi sul fatto che degli immigrati stavano commettendo dei gravi reati. «Un sospetto generalizzato», così il ministro degli Interni Thomas de Mazière, «è altrettanto sbagliato quanto tabuizzare la nazionalità dei criminali»: fermezza nella difesa di uno Stato di diritto che deve e vuole difendersi anche se a violare le leggi sono “i dannati della terra”.
Certo verranno con maggiore determinazione perseguiti quanti si sono resi o si renderanno responsabili di reati, rompendo così il velo di ipocrisia che nel segno di un insensato ideologismo («il problema è sociale, non culturale») e in nome del “politicamente corretto”, anche la notte di Capodanno, ha spinto a chiudere non uno ma due occhi sul fatto che degli immigrati stavano commettendo dei gravi reati. «Un sospetto generalizzato», così il ministro degli Interni Thomas de Mazière, «è altrettanto sbagliato quanto tabuizzare la nazionalità dei criminali»: fermezza nella difesa di uno Stato di diritto che deve e vuole difendersi anche se a violare le leggi sono “i dannati della terra”.
 Ma anche ragionevole saggezza perfettamente espressa dal sindaco socialdemocratico di Amburgo Olaf Scholz che riferendosi ai possibili colpevoli ha affermato: «Non importa da dove vengano, importa dove sono» per poterli prendere. Massima apertura, dunque, per chi vuole integrarsi e accetta i valori culturali e principi giuridici del Paese che li ospita. Severa applicazione della leggi («se serve potremmo anche cambiarle», ha affermato il capo della Spd Sigmar Gabriel) e accelerazione dei processi di espulsione arrivando a minacciare di tagliare gli aiuti economici ai Paesi di origine che si opponessero al rimpatrio.
Ma anche ragionevole saggezza perfettamente espressa dal sindaco socialdemocratico di Amburgo Olaf Scholz che riferendosi ai possibili colpevoli ha affermato: «Non importa da dove vengano, importa dove sono» per poterli prendere. Massima apertura, dunque, per chi vuole integrarsi e accetta i valori culturali e principi giuridici del Paese che li ospita. Severa applicazione della leggi («se serve potremmo anche cambiarle», ha affermato il capo della Spd Sigmar Gabriel) e accelerazione dei processi di espulsione arrivando a minacciare di tagliare gli aiuti economici ai Paesi di origine che si opponessero al rimpatrio.Questa ferma ma equilibrata determinazione della classe politica tedesca, nonostante una fisiologica dialettica interna, si basa sul convincimento, tutto sommato ancora condiviso, che ha guidato le scelte della Cancelliera: e cioè che la Germania (e l’Europa) per ragioni demografiche e geopolitiche non hanno futuro economico senza immigrazione. E che quello dei profughi è un fenomeno di portata globale che nessuna nazione europea, neppure le “grande Germania”, può affrontare da sola.
 A meno di illudersi di trovare salvezza dietro nuovi ma fragilissimi muri. In tal modo la “questione tedesca” torna, com’è evidente, a intrecciarsi sistematicamente con quella europea. E l’interesse nazionale, non solo quello della Germania, il Paese che ha più confinanti di tutti nel Vecchio Continente, ma anche quello dell’Italia o della Grecia, i Paesi più esposti sul fronte dell’immigrazione, non può essere difeso a prescindere dalla solidarietà tra europei. Altrimenti l’alternativa sarà semplice e disastrosa: ognuno per sé e la crisi per tutti.
A meno di illudersi di trovare salvezza dietro nuovi ma fragilissimi muri. In tal modo la “questione tedesca” torna, com’è evidente, a intrecciarsi sistematicamente con quella europea. E l’interesse nazionale, non solo quello della Germania, il Paese che ha più confinanti di tutti nel Vecchio Continente, ma anche quello dell’Italia o della Grecia, i Paesi più esposti sul fronte dell’immigrazione, non può essere difeso a prescindere dalla solidarietà tra europei. Altrimenti l’alternativa sarà semplice e disastrosa: ognuno per sé e la crisi per tutti.
 “Rispetto, solidarietà e nessuna tolleranza”: questa la parola d’ordine della manifestazione di quanti, in prima fila le donne tedesche, sabato a Colonia si sono contrapposti a quanti inneggiavano all’odio e all’intolleranza. In nome di questi valori vale la pena tentare di salvare le conquiste di Schengen per cercare di costruire assieme una nuova frontiera europea.
“Rispetto, solidarietà e nessuna tolleranza”: questa la parola d’ordine della manifestazione di quanti, in prima fila le donne tedesche, sabato a Colonia si sono contrapposti a quanti inneggiavano all’odio e all’intolleranza. In nome di questi valori vale la pena tentare di salvare le conquiste di Schengen per cercare di costruire assieme una nuova frontiera europea.
Colonia
Come ribaltare quell’orrore
La notte di Colonia costituisce, sotto il profilo simbolico, un avvenimento grave
di Valerio Magrelli (la Repubblica 11.1.16)
LA notte di Colonia costituisce, sotto il profilo simbolico, un avvenimento grave. Grave quanto la strage nel Bataclan. Infatti, ad essere colpita non è stata una generica folla formata da individui di ogni sesso, età, credo o classe, bensì donne, soltanto donne, ossia i soggetti storicamente più fragili della nostra società. A differenza di quanto accaduto a Parigi, insomma, qui non si è sparato nel gruppo, ma ci si è accaniti sull’anello più debole, sull’elemento più discriminato. Sempre e solo sul piano strettamente simbolico, lo ripeto, tale orrore è forse paragonabile alla “Notte dei cristalli” del novembre 1938, quando la feccia di Hitler distrusse migliaia di negozi ebraici, incendiando sinagoghe, massacrando centinaia di persone e stuprando a man bassa. L’analogia fra nazismo e Is è cosa nota, così come pare assodato che i criminali di Colonia abbiano seguito le direttive dello Stato Islamico. Da tempo si dice che quest’ultimo miri a fomentare una sorta di guerra civile europea. Ebbene, bisogna ammettere che la missione è riuscita, spaccando una società basata sull’ideale di assimilazione.
Appunto perciò, sostengo che i colpevoli non vadano rimpatriati. Troppo facile. Occorre condannarli per quanto hanno fatto. Senza vendetta, certo, ma accantonando ogni senso di colpa. Noi siamo gli eredi di Verri e Beccaria, ma ciò non significa lasciare impuniti i colpevoli. Dunque, mostriamo loro la nostra superiorità civile - perché di questo si tratta, con buona pace di ogni relativismo: chiuderli in una prigione, piuttosto che accecarli e castrarli, mozzando lingua e mani, costituisce una forma di superiorità culturale.
Oggi, grazie alle nostre democrazie, ogni ragazza può uscire sola, di notte, vestita come vuole. Sappiamo bene quanto sia stato difficile ottenere questa meravigliosa vittoria: come dimenticare i recenti, disgustosi discorsi sulle donne in jeans “responsabili” della foia maschile? Che splendore, al contrario, una giovane raggiante, tranquilla, cosciente di vivere in un mondo che la rispetta e la tutela! Ci piace questa immagine? E allora proteggiamola.
Non va consentito a nessuno di mettere in dubbio certe acquisizioni cruciali. Dirò di più: facciamo di Colonia la bandiera delle nostre conquiste. Rovesciamo l’obbrobrio in vittoria. Non lasciamo ai forcaioli un tema tanto importante e rappresentativo per la nostra democrazia. Stare dalla parte dei deboli: ecco la vera essenza progressista della nostra civiltà. E quindi basta con quel malinteso senso di clemenza che regna ormai in Italia ed in Europa.
Il femminicidio, come ogni altra forma di molestie sulla donna, deve diventare l’emblema di una nuova giustizia, il nuovo tabù della nostra specie, proprio come l’incesto. Rilanciamo l‘edilizia. Costruiamo istituti di pena umani e degni della nostra tradizione libertaria, dopo di che riempliamoli, tanto per cominciare, con chiunque osi ancora oltraggiare una donna. Sì, dovrà esistere un altro calcolo del tempo.
Avremo sempre un a. C. e un d. C., però intendendo con ciò “avanti Colonia” e “dopo Colonia”. Le centinaia di donne traumatizzate per sempre da questa tragedia, avranno una sorta di nuovo 1° maggio. Dalla festa dei lavoratori, alla festa delle passeggiatrici - rivendicando quel termine orrendo per cui, se compiuto da una femmina, il gesto più innocente (camminare di notte) viene a coincidere con la prostituzione.
 Perché mai, quando gli uomini passeggiano, li si chiama filosofi (i “peripatetici” seguaci di Aristotele) o flâneur (da Baudelaire a Benjamin), mentre le donne che si azzardano a fare la stessa cosa, diventano puttane? Pertanto, slogan per slogan, rifacendoci a Kennedy, propongo che si smetta di dire “ Ich bin ein Berliner”, ossia: “Sono un uomo di Berlino”, per affermare invece: “ Ich bin eine Kölnerin”, “Sono una donna di Colonia”.
Perché mai, quando gli uomini passeggiano, li si chiama filosofi (i “peripatetici” seguaci di Aristotele) o flâneur (da Baudelaire a Benjamin), mentre le donne che si azzardano a fare la stessa cosa, diventano puttane? Pertanto, slogan per slogan, rifacendoci a Kennedy, propongo che si smetta di dire “ Ich bin ein Berliner”, ossia: “Sono un uomo di Berlino”, per affermare invece: “ Ich bin eine Kölnerin”, “Sono una donna di Colonia”. -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- USCIRE DALLA ’PREISTORIA’. - Inciviltà di genere (di Giuliana Sgrena)10 gennaio 2016, di Federico La Sala
- USCIRE DALLA ’PREISTORIA’. Genere UmaNO: Donne e Uomini..... "Due Soli"(Dante)!!!
- UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. In memoria di Kurt H. Wolff.
Inciviltà di genere
Colonia. Donne vittime e profittatori maschi dello scontro di civiltà
di Giuliana Sgrena (il manifesto, 10.01.2016)
Se fosse stato un attacco preordinato - ma non c’è nessuna prova per sostenerlo - sarebbe stato perfetto. Mentre tutta l’Europa si prepara militarmente e psicologicamente ad affrontare attentati terroristici la maggiore destabilizzazione arriva nella notte di capodanno in piazza. In diverse piazze della Germania - Colonia, Amburgo, Stoccarda - ma anche Zurigo ed Helsinki.
Una massa incontrollabile di maschi - di origini arabe o musulmane, forse anche richiedenti asilo, ma ci sono anche occidentali, ubriachi, armati di bottiglie, anche qualche molotov, coltelli e forza bruta - aggrediscono le donne, tutte quelle che si trovano di fronte, sulla strada, le picchiano, feriscono, stuprano, perfino derubano, la polizia non può, non sa, non ha i mezzi per intervenire. Tanto che ad Amburgo sono i buttafuori dei locali notturni a salvare le donne aprendo le porte dei locali che proteggono.
È un attacco molto diverso da quello che è avvenuto a Parigi - al quale è stato da alcuni media paragonato - non sono locali di musica, ristoranti o la sede di un giornale satirico - i simboli della laicità francese - ad essere colpiti, ma la piazza come luogo di incontro di tutti e le donne, che simbolizzano il nemico - il diavolo verrebbe da dire - per i sostenitori di una cultura misogina e patriarcale.
Non solo tra i musulmani, la barbarie è ovunque. Aggredire, violentare le donne vuol dire colpire un genere nella sua più profonda identità e intimità, vuol dire usare strumenti che sono purtroppo diventati usuali nelle guerre e non solo moderne.
Un attacco di questo tipo non spinge a uscire per dimostrare di essere ancora presenti - anche se c’è chi lo fa - nonostante le bombe e i kamikaze, si può rischiare una pallottola ma andare incontro a uno stupro è diverso.
Eppure ieri le donne sono scese di nuovo coraggiosamente in piazza contro le violenze subite e contro la destra anti-islam e i neonazisti, pronte ad accusare «i nemici, uguali dappertutto, del sessismo e del fascismo». Nonostante la gente resti attonita e, colpita psicologicamente, cancella la partecipazione al famoso carnevale di Colonia.
Se fosse stato un atto terroristico sarebbe riuscito perfettamente. Ma anche se fosse stato organizzato dalle bande naziste e xenofobe, del resto i terroristi - anche quelli dell’Isis - non hanno forse la stessa ideologia fascista? La destra tedesca vedrebbe in questi atti confermata la sua previsione: verranno i barbari e stupreranno le nostre donne. E anche se non è così, la destra più estrema ne sta già approfittando. Ma anche tutta quella che vuole il respingimento dei migranti e Angela Merkel pagherà sicuramente - in termini elettorali - la sua politica di accoglienza, anche se finora era riuscita a contenere le opposizioni. La sua reazione a questi fatti è stata infatti molto dura.
Le reazioni sono state ritardate dai rapporti edulcorati della polizia che ha peccato oltre che per il mancato intervento anche per l’eccesso di politically correct: i temi della migrazione, dei profughi, dell’islam e la violenza sono tabù in Germania.
È chiaro che se tra le bande che hanno attaccato le donne ci fossero stati anche profughi o richiedenti asilo saranno loro a pagare il prezzo più alto o comunque lo saranno soprattutto i prossimi profughi che cercheranno di approdare sul territorio europeo. Lo vediamo anche in Italia dove la legge per l’abolizione del reato di clandestinità - che doveva passare tra breve in parlamento - sarà con ogni probabilità rinviata, con il beneplacito di tutti, a non si sa quando.
Ancora una volta possiamo dire che le donne sono state le vittime di questo criminale assalto ma saranno i maschi sostenitori dello scontro di civiltà ad approfittarne.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Colonia. La miscela dello scontro di civiltà. L’obiettivo politico ora è l’accoglienza di Angela Merkel (di Alberto Burgio)..9 gennaio 2016, di Federico La Sala
- USCIRE DALLA ’PREISTORIA’. Che si apra finalmente la guerra alla violenza sulle donne ovunque, perché quella sulle donne è violenza capace di tutto e buona a nulla ....
La miscela dello scontro di civiltàColonia. Nei fatti accaduti a capodanno colpisce la dimensione del fenomeno. Ma l’obiettivo politico ora è l’accoglienza di Angela Merkel
di Alberto Burgio (il manifesto, 09.01.2016)
La notte di Colonia comincia a schiarirsi, le denunce si moltiplicano e così gli arresti, mentre monta una polemica al calor bianco che scuote il governo federale (con le dimissioni del capo della polizia) e riecheggia in tutta Europa, dove alcuni paesi dell’Unione annunciano misure per fermare l’«invasione musulmana» e altri rivedono in senso restrittivo le clausole di Schengen. Eppure di quella notte non sappiamo abbastanza per un’interpretazione univoca dei fatti e tanto meno per sposare letture precipitose o pregiudiziali.
Le ultime notizie parlano di 31 arresti, tra cui 18 profughi (oltre a due tedeschi e a un cittadino statunitense). Le ipotesi di reato riguardano furti e lesioni personali, ma anche tre casi di violenza sessuale. La presenza di rifugiati tra le persone fermate collega oggettivamente l’episodio alla politica di accoglienza della cancelliera Merkel la quale, dopo l’iniziale riserbo, si è sentita in dovere di affermare la necessità di «un segnale forte» e di chiarire che, per salvaguardare il diritto d’asilo, non dovrà esservi indulgenza («niente sconti né attenuanti») per i colpevoli delle aggressioni.
Il dato più macroscopico consiste nelle dimensioni dell’episodio. Violenze anche sessuali sono triste routine in occasione di appuntamenti festosi di massa. A Monaco, per l’Oktoberfest, e nella stessa Colonia, per il famoso carnevale. E del resto Colonia non è stata l’unico teatro di violenze nella notte di san Silvestro, né in Germania (episodi analoghi si sono registrati ad Amburgo, Stoccarda e Francoforte) né altrove (Zurigo, Helsinki e Salisburgo). La peculiarità del caso di Colonia sta nel fatto che il grande branco era composto da un migliaio di persone, un assembramento tale da avere addirittura sopraffatto le forze di polizia presenti.
Con tutto ciò, il quadro rimane ancora alquanto oscuro, anche a causa della lentezza delle indagini e delle contraddittorie versioni fornite. Non si sa in quanti abbiano effettivamente preso parte alle violenze. Sembra che la polizia tenesse d’occhio alcune bande dedite alla microcriminalità, che sono state tuttavia lasciate libere di scorrazzare. Ed è difficile anche intendere la logica del branco, capire che cosa cercasse - se di sfogare pulsioni maciste in preda all’alcol o di rubare, o che cos’altro ancora - visto che alcuni erano armati di bottiglie molotov.
 Quello che non è affatto oscuro è invece il contesto politico generale in cui l’episodio si colloca: un contesto molto significativo che va tenuto presente per evitare conclusioni affrettate.
Quello che non è affatto oscuro è invece il contesto politico generale in cui l’episodio si colloca: un contesto molto significativo che va tenuto presente per evitare conclusioni affrettate.Da mesi in Germania (e non solo) le politiche di accoglienza decise da Angela Merkel sono oggetto di polemiche furibonde. La cancelliera è di continuo attaccata non soltanto dall’estrema destra xenofoba ma anche da cristiano-sociali e democristiani (la sua parte politica) che danno voce alle preoccupazioni di chi teme che una politica di accoglienza troppo generosa possa compromettere l’identità del paese.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state proprio quelle scene che hanno commosso il mondo quando, quest’estate, i profughi siriani in arrivo nelle stazioni ferroviarie tedesche sono stati salutati dagli applausi e dai canti dei cittadini accorsi ad accoglierli. Una cosa mai vista, si è detto. E inaspettata. Ma anche una sorpresa allarmante per chi ha sempre fatto affidamento sulla spontanea ostilità della gente verso i migranti. Che cosa stava succedendo? Stavano forse saltando anche i presidi naturali alle frontiere della nazione? E non si rischiava davvero un’invasione per colpa della sconsiderata svolta decisa dalla cancelliera?
Ora, se c’è una cosa di cui possiamo star certi è che lo shock provocato dai fatti di Colonia è piombato su questa delicata discussione con la violenza di un macigno. La Merkel ha chiesto di non strumentalizzare l’accaduto ma è inevitabile che chi sostiene le ragioni dell’accoglienza e della solidarietà sia ora in grande difficoltà, mentre i critici - quanti invocano giri di vite, espulsioni e chiusura delle frontiere - hanno buon gioco. Di meglio essi non potevano chiedere. E certo non sono dispiaciuti per il mistero che ancora avvolge tutta la vicenda e che fa lievitare ansie e risentimenti.
Di qui a dire che le aggressioni siano state organizzate dalla destra xenofoba tedesca ce ne corre, ma le prime reazioni, peraltro prevedibili, non confutano le congetture più sospettose. Anzi. Un articolo come quello scritto da Pierluigi Battista sul Corriere della sera di giovedì 7 non fa che rafforzarle con l’accostare la notte di Colonia alla strage parigina nella redazione di Charlie Hebdo.
 È lo schema Fallaci, o Huntington. Il sempreverde modello dello «scontro tra civiltà». Battista è andato subito a colpo sicuro, scrivendo di un attacco deliberato alle libertà occidentali, al nostro stile di vita, alla nostra cultura. Lui non ha dubbi: le bande di Colonia «volevano punire» la libertà delle donne; «hanno voluto manifestare» il loro odio verso lo spirito di libertà dell’Occidente cristiano.
È lo schema Fallaci, o Huntington. Il sempreverde modello dello «scontro tra civiltà». Battista è andato subito a colpo sicuro, scrivendo di un attacco deliberato alle libertà occidentali, al nostro stile di vita, alla nostra cultura. Lui non ha dubbi: le bande di Colonia «volevano punire» la libertà delle donne; «hanno voluto manifestare» il loro odio verso lo spirito di libertà dell’Occidente cristiano.Di fronte a tanta sicurezza, una certezza possiamo dire di averla anche noi, in attesa che le indagini in corso facciano piena luce. Mentre i conflitti tendono a radicalizzarsi - in Europa sotto il peso di una gravissima crisi sociale; in Medio Oriente e in Asia centrale per effetto di dinamiche geopolitiche che hanno innescato guerre (scatenate proprio dall’Occidente cristiano), colpi di Stato, balcanizzazione dei territori e un’inedita escalation terroristica - c’è chi non rinuncia a soffiare sul fuoco augurandosi che l’incendio dilaghi e ripromettendosi di trarne profitto.
Dopo Colonia le destre europee brindano, siano o meno estranee all’organizzazione degli attacchi. E con loro si compiacciono i teorici dello scontro di civiltà, che pure affettano collera e preoccupazione. Tutti evidentemente hanno dimenticato quanto sia pericoloso giocare con la paura dei più deboli. E come, una volta appiccato l’incendio, domare le fiamme sia molto difficile per chiunque.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Germania. La cancelliera rivendica la politica di accoglienza tedesca verso i migranti.2 gennaio 2016, di Federico La Sala
La resistenza di frau Merkel
Germania. Con un discorso sottotitolato in arabo, la cancelliera rivendica la politica di accoglienza tedesca verso i migranti. «Per l’integrazione ci vorrà tempo - dice -, ma rappresenta le fondamenta dela nostra società»
di Sebastiano Canetta (il manifesto, 2.1.2016)
BERLINO Germany, governo da Berlino dei flussi migratori, tradizione applicata al futuro. È il marchio di fabbrica di Angela Merkel, in corsa per il quarto mandato da Kanzlerin federale. Lo ha scandito in diretta dagli schermi di Zdf, la televisione pubblica di Magonza: «È importante non dar seguito a coloro che, con freddezza o addirittura odio nei loro cuori, pretendono l’identità tedesca esclusivamente per sé negandola agli altri».
Un discorso, sottotitolato in arabo e inglese, che conferma la linea politica uscita vincente dal recente congresso Cdu di Karlsruhe. «Sono profondamente convinta: affrontato per il verso giusto anche il grande compito dell’arrivo e dell’integrazione di così tante persone è un’opportunità per il domani. Tutto dipenderà dalla capacità di stare uniti».
Mutti Angela ringrazia i volontari per «l’ondata di spontanea solidarietà con cui hanno accolto i rifugiati» e rivendica lo spirito convincente della riunificazione, lo stesso che ha permesso alla Germania di Helmut Kohl di metabolizzare una sfida altrettanto gigantesca. Il milione di migranti del 2015 ha messo sotto pressione i 16 Land e le autorità locali «ben oltre quanto spettasse ai nostri obblighi». Il capo del governo spiega ai tedeschi quello che ha convinto i delegati del suo partito.
E avverte: «Per l’integrazione ci vorrà tempo, denaro e fatica, senza ricadere negli errori del passato e difendendo il modello di integrazione che rispetta i nostri valori, le tradizioni, le leggi, la lingua e le regole». L’esempio migliore della ricetta democristiana? La nazionale campione del mondo che schiererà agli Europei di giugno in Francia calciatori tedeschi all’anagrafe, ma di origine turca, albanese, ghanese, tunisina, polacca e marocchina.
Nessuna concessione al populismo, ai sovranisti e agli alleati di coalizione. «Sono queste le fondamenta che sorreggono la nostra società, requisiti fondamentali per la convivenza positiva e reciprocamente rispettosa di tutte le persone in Germania. Vale per tutti coloro che vogliono vivere qui. L’immigrazione così comporta un guadagno economico e sociale». Ma è anche «un concetto politico globale» che deve coinvolgere tutti i livelli: nazionale, europeo e internazionale.
Anche in tv Merkel ribadisce l’imperativo categorico «Wir schaffen das - ce la possiamo fare» perché «la Germania è un paese forte». Messaggio forte e chiaro anche per Bruxelles, tanto più che lei nel 2017 punta alla consacrazione politica e storica sulla scia di Vladimir Putin (zar dal 1999) e Recep Erdogan (sultano dal 2003).
Missione impossibile secondo Financial Times che pure aveva scelto proprio Merkel come personaggio dell’anno 2015: «Aprendo le porte dell’Europa ad oltre un milione di rifugiati, per lo più musulmani, Angela Merkel lascia un’eredità permanente quanto quella del suo mentore Kohl, che ha presieduto il processo di riunificazione tedesca e la nascita dell’euro».
Gideon Rachman, capo del desk esteri della prestigiosa testata inglese, prevede al contrario la caduta della cancelliera proprio a causa dell’emergenza profughi: «Al ritmo di migliaia di arrivi al giorno, la pressione diventerà insostenibile fino a rendere ingestibile la situazione». Di qui la previsione di Rachman: Merkel lascerebbe, proprio sulla soglia del nuovo storico mandato.
Fuori dal discorso ufficiale, in realtà, c’è la vera agenda europea della cancelliera. Il «confronto» con il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker sul controllo dei conti pubblici dei 28 paesi membri. La vicenda dei rapporti con la Russia che va al di là del disegno geografico per il gasdotto baltico. E soprattutto la bomba a orologeria del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Ue: per Merkel, l’eventuale Brexit sarebbe ben peggio della scongiurata Grexit.
Nel frattempo, Die Welt contabilizza la spesa per la gestione dei profughi. Nel 2016 è prevista una somma pari a 16,5 miliardi di euro, in base ai bilanci dei responsabili finanziari delle regioni tedesche con l’eccezione di Brema, città-stato che non ha fornito cifre. Uscite più onerose rispetto a quelle del sistema dell’educazione che assorbe15,3 miliardi all’anno.
In parallelo procede spedita la politica dei rimpatri. Le statistiche ufficiali - fornite da Thomas de Maizière, ministro degli interni e «falco» Cdu - registrano fino a novembre 2015 l’esecuzione di 18.363 procedure di espulsione dalla Germania. In tutto il 2014 i rimpatri erano stati 10.844. In cima alla classifica delle domande dei richiedenti asilo respinte la Baviera di Horst Seehofer, padre-padrone della Csu: oltre 3.600 rimpatriati rispetto al migliaio di dodici mesi prima. Soltanto in Turingia l’unico fenomeno in controtendenza con 152 rimpatri rispetto ai precedenti 234.
E da oggi si apre il capitolo, anche politico, della gestione dei minori non accompagnati: ora saranno distribuiti in tutti i Land e non più affidati a chi li aveva registrati al momento del loro ingresso in Germania.
-
> CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" --- LE RADICI DELL’EUROPA, I "DUE CRISTIANESIMI", E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO.30 dicembre 2015, di Federico La Sala
I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?". Una nota di Antonio Thellung, da"mosaico di pace"
 COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano. -
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- L’EU E IL FUTURO GIA’ SCRITTO. Il volume del 2045 della "Oxford History of Modern Europe" (di Timothy Garton Ash)23 dicembre 2015, di Federico La Sala
Il futuro dell’Europadi Timothy Garton Ash (la Repubblica, 23.12.2015)
ESTRATTO dal volume della collana Oxford History of Modern Europe pubblicato nel 2045:
- «I primi mesi del 2005 si possono considerare l’apogeo del cosiddetto progetto europeo. Nella primavera precedente dieci Stati dell’Europa centrale e orientale aderirono all’Unione Europea, dando vita al più ampio commonwealth di democrazie liberali della storia d’Europa. L’Unione propose un trattato costituzionale, noto come Costituzione europea. La moneta unica, l’euro, pareva valida e Paesi come Spagna, Portogallo e Grecia ebbero l’impressione di entrare in sinergia con il nucleo storico dell’Europa unita, attorno a Germania, Francia, Belgio e Olanda. Molti europei erano pervasi da una sensazione di ottimismo, vedevano nell’Ue un faro di progresso, come sistema di ordine internazionale regolamentato e come modello sociale. Lo scoppio della “rivoluzione arancione” pro europea in Ucraina convinse il presidente russo Putin che l’Ue, all’apparenza inoffensiva, costituiva una minaccia al suo potere. Persino lo scettico Tony Judt, nella sua storia dell’Europa post-45 pubblicata nel 2005 scrisse che “il XXI secolo potrebbe appartenere ancora all’Europa”. Il decennio successivo tuttavia dimostrò del tutto illusorie queste ipotesi grandiose.
 Le crisi che seguirono, a partire dalla bocciatura della costituzione europea nei referendum in Francia e Olanda, per passare alla crisi decennale di un’eurozona mal congegnata, l’annessione da parte russa di alcune aree dell’Ucraina, gli attacchi terroristici islamisti, il referendum britannico sull’uscita dall’Ue, milioni di profughi in fuga dal Medio Oriente e dall’Africa, nonché la crescita dei partiti euroscettici e xenofobi portarono i leader europei a vacillare storditi, come il pugile ucraino Klitschko sotto i colpi del suo sfidante britannico Fury.
Le crisi che seguirono, a partire dalla bocciatura della costituzione europea nei referendum in Francia e Olanda, per passare alla crisi decennale di un’eurozona mal congegnata, l’annessione da parte russa di alcune aree dell’Ucraina, gli attacchi terroristici islamisti, il referendum britannico sull’uscita dall’Ue, milioni di profughi in fuga dal Medio Oriente e dall’Africa, nonché la crescita dei partiti euroscettici e xenofobi portarono i leader europei a vacillare storditi, come il pugile ucraino Klitschko sotto i colpi del suo sfidante britannico Fury.
 Purtroppo i leader europei riuniti a Bruxelles nel dicembre 2015 per uno dei soliti interminabili vertici non seppero rendersi conto di quanto fosse profonda la crisi esistenziale dell’Unione.
Purtroppo i leader europei riuniti a Bruxelles nel dicembre 2015 per uno dei soliti interminabili vertici non seppero rendersi conto di quanto fosse profonda la crisi esistenziale dell’Unione.
 L’Unione Europea non crollò all’improvviso, alla maniera dell’Impero romano, come ebbe a dire uno storico, con orde di barbari a occupare i palazzi della burocrazia di Bruxelles.
L’Unione Europea non crollò all’improvviso, alla maniera dell’Impero romano, come ebbe a dire uno storico, con orde di barbari a occupare i palazzi della burocrazia di Bruxelles.
 Ebbe un declino più simile a quello del Sacro romano impero: i trattati, il cerimoniale e le istituzioni restarono formalmente in vita, ma sempre più svuotati del loro significato. Così la decisione di sciogliere formalmente l’Unione europea nel 2043 non fu altro che la tardiva presa di coscienza di una realtà politica preesistente».
Ebbe un declino più simile a quello del Sacro romano impero: i trattati, il cerimoniale e le istituzioni restarono formalmente in vita, ma sempre più svuotati del loro significato. Così la decisione di sciogliere formalmente l’Unione europea nel 2043 non fu altro che la tardiva presa di coscienza di una realtà politica preesistente».
Nessuno conosce il futuro. Nulla di quanto sopra descritto è inevitabile. Ma è uno scenario plausibile per il futuro dell’Ue. Dovremmo però fare il possibile per scongiurarlo. Churchill disse che la democrazia è la peggior forma di governo possibile, eccezion fatta per tutte le altre forme che si sono sperimentate nel tempo. L’Europa in cui viviamo è l’Europa peggiore possibile, eccezion fatta per tutte le altre Europe sperimentate fin qui. Nessuna alleanza è durata per sempre, ma dovremmo augurarci che l’Europa duri il più a lungo possibile.
L’élite europea criticherà questo mio approccio come troppo pessimista, addirittura disfattista. Mi accuseranno di esprimere un “punto di vista britannico”, incarnando inconsapevolmente proprio quel genere di pregiudizio nazionale che sostengono di voler sconfiggere. In realtà questo mio realismo pessimista costituisce una base ben più solida su cui ricostruire il traballante progetto europeo di quanto non lo sia l’interpretazione Whig della storia come continuo progresso, una pia illusione che caratterizza larga parte dell’euro-dibattito.
L’Europa è conciata male: il primo passo verso la guarigione sta nell’ammettere la gravità della malattia, non certo nel negarla. Siamo di fronte a tante problematiche: profughi, xenofobia, Eurozona, Ucraina, la Brexit - per molti dei quali non esistono soluzioni totali, ma solo parziali, che ci permettano di andare avanti. Non è il momento di grandi disegni. Molti colleghi europei stanno tornando all’idea di un’Europa a più velocità, con un nucleo centrale in testa e il resto che segue, pena l’emarginazione. Questa non è e non sarà la realtà.
Rifiutare la retorica dei grandi disegni progressisti non significa semplicemente ricadere nel pragmatismo disorganico, quello che Der Spiegel ha definito die Philosophie des Durchmuddelns (la filosofia del tirare a campare). Due fili cuciono insieme i diversi pezzi di stoffa di questo patchwork: un nuovo futuro e il possibile ritorno di un triste passato.
Di fronte a potenze emergenti come Cina, India, Brasile, non solo l’Europa ma l’Occidente non dettano più le regole. In questo mondo di giganti i Paesi europei hanno bisogno di una dimensione che solo la loro Unione può dare. È una tesi interessante, ma poco allettante, soprattutto agli occhi dei giovani spagnoli disoccupati o dei francesi che non riconoscono più il loro Paese. Il secondo filo è il passato europeo che potrebbe tornare nel nostro futuro. Abbiamo assistito a flashback della barbarie che ha caratterizzato il XX secolo in Europa. Guerra in Ucraina. Professionisti della classe media costretti a fare la coda alle mense dei poveri ad Atene. Terrore nelle strade di Parigi. Il cadavere del bimbo profugo restituito dal mare su una spiaggia del Mediterraneo. Antisemitismo, razzismo e espressioni di becero pregiudizio contro i musulmani. In qualche modo continuiamo a considerarle eccezioni, ma se diventassero la regola?
Il progetto della comunità politica europea è insolito in quanto il suo avversario, “l’altro” che ne definisce l’identità è il suo stesso passato. Per tre generazioni, le memorie individuali della guerra, dell’occupazione, dell’Olocausto, delle dittature fascista e comunista sono state la motivazione più forte e profonda a favore dell’integrazione europea. Dato che la maggioranza dei giovani europei non ha più queste memorie individuali, abbiamo più che mai bisogno della memoria collettiva che chiamiamo storia. Per evitare un brutto futuro dobbiamo far sì che le nuove generazioni non dimentichino il nostro triste passato che potrebbe oggi ritornare in forme nuove e vecchie. Come scrisse Bertolt Brecht: «L’utero da cui è sgusciato fuori è ancora fertile» . Ancora non è troppo tardi per riscrivere il volume del 2045 della Oxford History of Modern Europe, ma non abbiamo tempo fino al 2045 per farlo.
 Traduzione di Emilia Benghi
Traduzione di Emilia Benghi - «I primi mesi del 2005 si possono considerare l’apogeo del cosiddetto progetto europeo. Nella primavera precedente dieci Stati dell’Europa centrale e orientale aderirono all’Unione Europea, dando vita al più ampio commonwealth di democrazie liberali della storia d’Europa. L’Unione propose un trattato costituzionale, noto come Costituzione europea. La moneta unica, l’euro, pareva valida e Paesi come Spagna, Portogallo e Grecia ebbero l’impressione di entrare in sinergia con il nucleo storico dell’Europa unita, attorno a Germania, Francia, Belgio e Olanda. Molti europei erano pervasi da una sensazione di ottimismo, vedevano nell’Ue un faro di progresso, come sistema di ordine internazionale regolamentato e come modello sociale. Lo scoppio della “rivoluzione arancione” pro europea in Ucraina convinse il presidente russo Putin che l’Ue, all’apparenza inoffensiva, costituiva una minaccia al suo potere. Persino lo scettico Tony Judt, nella sua storia dell’Europa post-45 pubblicata nel 2005 scrisse che “il XXI secolo potrebbe appartenere ancora all’Europa”. Il decennio successivo tuttavia dimostrò del tutto illusorie queste ipotesi grandiose.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- SALENTO: AFFAIRE XYLELLA. La procura di Lecce salva gli ulivi e indaga commissario e scienziati (di Marilù Mastrogiovanni)20 dicembre 2015, di Federico La Sala
Italia
La procura di Lecce salva gli ulivi e indaga commissario e scienziati dell’emergenza xylella
Salento. Sequestrati gli ulivi soggetti ad eradicamento forzato. Con i nuovi accertamenti scientifici di fatto vengono a cadere i presupposti per chiedere l’emergenza e la calamità naturale, in base alle quali si sta già usufruendo di ingenti fondi pubblici, sia ministeriali sia europei
di Marilù Mastrogiovanni (il manifesto, 20.12.2015)
Non uno ma nove diversi ceppi di xylella. E non dal 2013, ma probabilmente da molti anni prima. Oppure, altra ipotesi, introdotti recentemente in più tranche. La Procura di Lecce rimescola le carte, indica altre verità rispetto a quelle indicate dal CNR e dall’Università di Bari, dalla Regione Puglia e dal Ministero delle politiche agricole e sequestra preventivamente (con facoltà d’uso per garantirne la cura e la raccolta delle olive da parte dei proprietari) gli ulivi che il Commissario per l’emergenza xylella, Giuseppe Silletti, avrebbe ripreso a sradicare già dal 16 dicembre. Se non glielo avessero impedito gli agricoltori e i cittadini, frapponendosi tra le ruspe e gli ulivi.
E lo indaga.
Indaga Silletti e altri nove protagonisti del grande affaire xylella.
Antonio Guario, 64 anni, in qualità di ex dirigente dell’Osservatorio fitosanitario regionale di Bari;
Giuseppe D’Onghia, 59 anni, dirigente del Servizio Agricoltura area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia;
Silvio Schito, 59 anni, dirigente dell’Osservatorio fitosanitario regionale di Bari;
Giuseppe Blasi, 54 anni, capo dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello Sviluppo rurale del Servizio fitosanitario centrale;
Nicola Vito Savino, 66 anni, professore universitario e direttore del centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura Basile Caramia di Locorotondo;
Franco Nigro, 53 anni, micologo di Patologia vegetale dell’università di Bari;
Donato Boscia, 58 anni, responsabile della sede operativa del Cnr dell’istituto per la Protezione sostenibile delle piante;
Maria Saponari, 43 anni, ricercatrice del CNR dell’istituto per la Protezione sostenibile delle piante;
Franco Valentini, 44 anni, ricercatore dello IAMB.
Diverse le ipotesi di reato: diffusione di fitopatologia, falso ideologico, violazioni colpose delle disposizioni ambientali, deturpamento di bellezze naturali, turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Dunque gli alberi d’ulivo sui quali pende l’ordinanza di abbattimento del commissario straordinario per l’emergenza xylella, Giuseppe Silletti, sono stati sequestrati preventivamente per impedire che si sradichino sulla base di decisioni poggiate su falsi presupposti, sia scientifici sia, di conseguenza, amministrativi.
Una figuraccia internazione, sia del Ministero delle politiche agricole, sia della comunità scientifica italiana, in particolare il CNR di Bari e l’Università di Bari, sia della Regione Puglia.
Il capo della procura di Lecce Cataldo Motta ha fissato i primi paletti di un’indagine condotta con ritmo serrato in un anno e mezzo e partita dall’esposto di due associazioni: Forum ambiente e salute e Spazi popolari.
“Siamo partiti dagli esposti ma poi le indagini hanno preso una piega diversa - ha tenuto a precisare il procuratore - agendo, come sempre accade, in maniera autonoma”.
Le indagini, coordinate dalle pm Elsa Valeria Mignone e Roberta Licci, che hanno incaricato un pool di esperti per verificare i presupposti scientifici su cui si sono basate le decisioni prese dalla Regione Puglia e comunicate alla Ue, hanno riscontrato l’esistenza di ben 9 ceppi di xylella fastidiosa, non uno solo, come affermato dai ricercatori del CNR.
Questo induce a concludere che è molto verosimile che la xylella sia presente nel Salento da molto tempo e che si sia nel tempo mutata geneticamente, come è normale facciano i batteri per adeguarsi all’ambiente in cui vivono. Oppure che sono state introdotte più tipologie di xylella che poi si sono mescolate tra loro.
I consulenti tecnici della procura avanzano diverse ipotesi ma di certo si può affermare che diversi tipi di xylella sono presenti da molti anni e da molto tempo prima rispetto a quando è stata comunicata la sua presenza alla Ue da parte dell’Istituto fitosanitario regionale, cioè il 15 ottobre 2013.
Di fatto vengono a cadere i presupposti per chiedere l’emergenza e la calamità naturale, in base alle quali si sta già usufruendo di ingenti fondi pubblici, sia ministeriali sia europei.
Si tratterebbe di indebita percezione di finanziamenti ministeriali ed europei? Le indagini su questo e su molto altro sono ancora aperte, inclusa l’analisi della memoria dei pc sequestrati al CNR di Bari, ancora sotto la lente d’ingrandimento della procura; per ora non è ipotizzato il dolo, semplicemente perché è difficile provarlo, ma sono ipotizzati “solo” la “colpa”, l’imperizia, la superficialità, la negligenza.
“E’ anche da precisare, ha dichiarato Motta, che la Ue non impone di sradicare gli alberi e che anzi l’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha precisato che sradicare gli alberi non serve per eradicare il batterio, eppure è stata una scelta della Regione Puglia, quella di sradicare gli ulivi per bloccare l’avanzamento della presunta infezione da xylella.
La “Ue è stata indotta in errore in base a dati impropri e non del tutto esatti comunicati dagli uffici regionali”, ha detto Motta.
In una parola, sono state prodotte false dichiarazioni alla Ue.
Inoltre, ha detto Motta, le piantine di vite infettate da xylella fastidiosa per l’ormai famigerato seminario del 2010 tenutosi presso lo Iamb di Valenzano, sono entrate in Europa senza “passaporto verde”, cioè senza alcuna autorizzazione.
Abusive.
Il colpo di scena è stato che la procura è riuscita, con i suoi periti, a dimostrare con la logica e senza effettuare l’attesa prova di patogenicità del batterio xyella fastidiosa sugli ulivi (prova che ancora manca), che non c’è relazione diretta tra la presenza del batterio e il disseccamento.
“Abbiamo fatto delle analisi su ulivi sani, cioè senza sintomi di disseccamento, e c’era xylella; abbiamo fatto le stesse analisi su ulivi con gravi sintomi di disseccamento e la xylella non c’era”, ha detto Motta.
Il Piano Silletti bis dunque è definitivamente fallito: da una parte il sabotaggio dei cittadini, che hanno bloccato le ruspe, ponendo i loro corpi tra i mezzi meccanici e gli alberi, occupando le strade e la ferrovia; dall’altra le decine di ricorsi al Tar e i due ricorsi alla Corte di giustizia europea; infine la Procura, che ha bloccare lo sradicamento degli ulivi, sequestrandoli.
Questa è solo la punta dell’iceberg del grande affaire xylella fastidiosa, le indagini proseguono e c’è da star certi che altri colpi di scena seguiranno.
Il problema è che, come sempre accade in Italia, si possono perseguire gli esecutori di un delitto, ma i mandanti sono difficili da trovare.
Dovranno però, al di là delle indagini della Procura, dare conto ai pugliesi i responsabili politici di questo scempio: l’allora presidente della regione Puglia Nichi Vendola, l’ex assessore Fabrizio Nardoni, il ministro Martina, che dovrebbe immediatamente dimettersi (avendo comunicato falsità alla Ue e avendo speso soldi pubblici per un’emergenza e una calamità che non ci sono) il senatore Dario Stefàno, l’ex presidente della Commissione agricoltura Paolo De Castro e attuale direttore scientifico del Ciheam, organismo internazionale cui fa capo lo Iamb di Bari, che gode di immunità extraterritoriale, per cui la Procura non ha potuto sequestrare alcun documento o pc che non fosse volontariamente messo a disposizione dallo stesso Istituto agro mediterraneo di Bari.
Se la Ue è stata indotta in errore da false comunicazioni della Regione Puglia, del CNR di Bari e di conseguenza del Ministero, c’è dunque da aspettarsi un annullamento della procedura di infrazione avviata dalla Ue nei confronti dell’Italia, come chiesto dai tanti comitati a difesa degli ulivi sorti in Puglia.
* Direttrice del Tacco d’Italia e del supplemento digitale xylellareport.it
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- GLI OLIVI GIGANTI DEL SALENTO (di Alessandro Romano).20 dicembre 2015, di Federico La Sala
GLI OLIVI GIGANTI DEL SALENTO
di Alessandro Romano *
Da millenni, olivi giganti, secolari testimoni di epoche e stirpi diverse, si danno il cambio fra loro, accompagnando il cammino dell’uomo su questo territorio. Il volto stesso del Salento ha la chioma verde argentata e il tronco solido e rugoso di questi colossi della natura, che hanno sfamato, accresciuto, accudito con la loro generosità le genti salentine.
Come dimostrano anche le pitture vascolari rinvenute un pò ovunque, la coltivazione di questi alberi era praticata intensamente già ai tempi di Greci e Romani, e fu soltanto dopo la caduta dell’Impero nel 476 d.C. che entrò in crisi. Tornando prepotentemente in auge con i Bizantini, che colonizzarono l’Italia meridionale dopo le guerre con le popolazioni nordiche discese ad occupare la Penisola.
Questo è un breve viaggio per immagini, come facciamo sempre su questo sito, che vuol regalare le emozioni vivide, i “colori”, che queste foto non mancheranno di suscitare, specie nel visitatore forestiero, ma anche nel salentino distratto o cittadino (...per continuare a leggere e, soprattutto, per vedere le immagini, clicca su QUI).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- Xylella, il procuratore di Lecce accusa: "Europa ingannata, lucrano sull’emergenza" (di Chiara Spagnuolo)20 dicembre 2015, di Federico La Sala
Xylella, il procuratore di Lecce accusa: "Europa ingannata, lucrano sull’emergenza"
Per il capo dei pm Cataldo Motta alla base del caos ci sarebbe una conoscenza incompleta del problema: "Il commissario ha privilegiato solo ipotesi che portavano all’eradicazione"
di CHIARA SPAGNOLO (la Repubblica/Bari, 19 dicembre 2015 - ripresa parziale)
"L’Unione europea è stata tratta in inganno con una falsa rappresentazione dell’emergenza xylella fastidiosa, basata su dati impropri e sull’inesistenza di un reale nesso di causalità tra il batterio e il disseccamento degli ulivi". Per questo l’inchiesta della Procura di Lecce "indagherà anche sui finanziamenti stanziati e usati per l’emergenza, considerato che di emergenza non si tratta".
Il giorno dopo il sequestro di tutti gli ulivi salentini per cui è stata disposta l’eradicazione e l’invio di avvisi di garanzia al commissario di governo e a nove fra dirigenti e ricercatori che si sono occupati del caso, è il capo della Procura leccese, Cataldo Motta, a spiegare il motivo di un provvedimento che ha posto fine ai tagli di alberi e forse anche all’esperienza del commissario Giuseppe Silletti. Alcuni ambientalisti, entrati nella stanza del procuratore poco prima della conferenza stampa, hanno applaudito e mostrato un cartello di ringraziamento ai pm che hanno condotto l’inchiesta. Sul cartello la scritta: "C’è un giudice a Lecce, anzi due. Grazie".
A quest’ultimo viene contestato di avere disposto Piani inappropriati e addirittura dannosi per l’ambiente salentino, a causa del massiccio uso di fitofarmaci. E di eradicazioni a tappeto, che non sembrano affatto risolutive. Il nodo sta tutto nel fatto che la xylella è presente in Puglia "da almeno venti anni" e che allo stato esistono ben nove ceppi diversi, che ne mostrano la mutazione genetica. "Ciò escluderebbe la necessità di interventi emergenziali - ha chiarito Motta - e la stessa legittimazione della quarantena, che è stata la base da cui l’Europa è partita per imporre misure drastiche".
Secondo quanto hanno accertato gli uomini del Corpo forestale (di cui fra l’altro il commissario Silletti è comandante regionale), alla base del caos xylella ci sarebbe innanzitutto una conoscenza incompleta del problema, "determinata dalla scarsità di confronto scientifico e dall’aver privilegiato solo alcune ipotesi, che portavano inevitabilmente alle eradicazioni". Per questo il sostituto procuratore Elsa Valeria Mignone - che ha coordinato l’indagine assieme alla collega Roberta Licci - si è augurata che "inizi proprio da ora un confronto scientifico vero sulla materia", al fine di individuare la strada giusta per combattere il disseccamento rapido degli ulivi.
Sul fatto che i tagli non siano la scelta migliore, i magistrati non hanno dubbi: "l’eradicazione del batterio non si fa con l’estirpazione delle piante - ha chiarito il procuratore capo - E anche l’Unione europea non ha mai imposto di abbattere immediatamente tutti gli alberi malati ma di contenere la malattia, provando prima altre soluzioni". Tentativi che, a quanto pare, non sono stati fatti. E sui quali, a questo punto, bisogna ragionare perché l’Ue chiede comunque risposte che fino a pochi giorni fa si pensava dovessero pagare dalle eradicazioni. Intanto gli indagati penseranno a difendersi. I reati contestati sono diffusione colposa della malattia delle piante, falso ideologico e materiale in atto pubblico, inquinamento ambientale e deturpamento delle bellezze naturali.
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- L’ ULIVO E IL SUO OLIO NELLA STORIA. Quell’albero carico di simboli caduto dal giardino dell’Eden7 febbraio 2016, di Federico La Sala
- L’ ULIVO E IL SUO OLIO NELLA STORIA
 Un vecchio articolo di Marino Niola sull’ulivo, dai miti greci alla Bibbia al centro della storia del Mediterraneo.
Un vecchio articolo di Marino Niola sull’ulivo, dai miti greci alla Bibbia al centro della storia del Mediterraneo.
Marino Niola
Quell’albero carico di simboli caduto dal giardino dell’Eden *
Ci voleva una vergine per darci l’extravergine. Così almeno la pensavano i Greci che attribuivano la nascita dell’ulivo alla dea Atena, l’illibatissima figlia di Zeus. La divina guerriera si contendeva con lo zio Poseidone il diritto di dare il nome alla città più importante dell’Ellade. Ciascuno dei due offrì un dono prezioso per mostrarsi degno del titolo. Ad aprire la gara fu lo zio che colpì la terra col tridente facendo scaturire una pozza d’acqua salata. La sua offerta consisteva dunque nel dominio dei mari.
Agli effetti speciali del suo rivale l’astuta vergine rispose con una pensata geniale. Fece spuntare il primo ulivo della storia. davanti a quell’albero carico di frutti verdissimi, la giuria popolare, a maggioranza femminile, non ebbe dubbi e plebiscitò Atena. Che legò per sempre il suo nome ad Atene, la città simbolo della democrazia occidentale. Il mito attribuisce dunque all’ulivo e all’olio un valore dietetico e insieme politico. Simbolo del Mediterraneo nelle arti della cucina come in quelle del governo.
E se la Grecia sacralizza l’invenzione dell’olivicoltura, le altre cività mediterranee non sono da meno. Nella tradizione ebraica il primo seme dell’ulivo sarebbe addirittura caduto dal paradiso terrestre e atterrato sulla tomba di Adamo. Un regalo di Dio al primo uomo. Come dire che la storia di questo albero e quella dell’umanità sono la stessa cosa.
Questi miti in realtà raccontano in modo favoloso una storia che ha trovato recenti conferme scientifiche nell’archeologia preistorica che fa risalire la cultura dell’olio addirittura all’età del bronzo, quando i nostri nerboruti antenati usavano pietre pesantissime per la spremitura delle olive. A freddo, of course.
E che il commercio oleario venga da molto lontano lo prova il codice babilonese di Hammurabi che ben duemilacinquecento anni prima di Cristo ne regola la produzione e la vendita costituendo, di fatto, il primo disciplinare dell’extravergine.
Il cristianesimo riprende la tradizione ebraica e quella greca, facendo dell’ulivo uno dei suoi simboli centrali. Segno di pace soprattutto, in ricordo del ramoscello che secondo l’Antico Testamento la colomba porta a Noè alla fine del diluvio universale per suggellare la cessazione delle ostilità tra Dio e gli uomini.
Dalle antiche civiltà mediterranee il cristianesimo attinge anche pratiche come l’unzione per consacrare i sacerdoti, i re e tutti coloro che vengono prescelti dall’alto, gli "unti del Signore". Come Cristo, che significa proprio l’unto, e che non a caso per prepararsi al sacrificio prega nell’uliveto dei Getsemani. E non per nulla ogni cristiano, prima di presentarsi al cospetto del suo dio, riceve il sacramento dell’unzione.
In realtà a spiegare la fortuna simbolica dell’ulivo in tutte le culture mediterranee sono, oltre alle ragioni della dieta e del gusto, le stesse caratteristiche fisiche dell’olio. In particolare la sua capacità di articolare relazioni tra le cose, e in senso figurato fra le persone. Lega e al tempo stesso impedisce agli ingredienti di attaccarsi e di confondersi. Unisce e insieme divide. Sembra una grande astrazione e invece è l’esperienza quotidiana di chi olia una teglia o unge un ingrediente per farlo scivolare meglio. L’olio è dunque un potentissimo connettivo, materiale e simbolico. Congiunge e disgiunge. Proprio perchè unge.
- L’ ULIVO E IL SUO OLIO NELLA STORIA
-
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- PUGLIA. Prima viene il paziente - l’ulivo, poi la "xylella fastidiosa"!!! Un intervento di alcuni tutori dell’ "ordine scientifico" a favore dell’eradicazione degli ulivi.24 dicembre 2015, di Federico La Sala
Prima viene il paziente - l’ulivo, poi la "xylella fastidiosa"!!! Non è affatto bene fare di tutte le erbe un fascio, dare fuoco alla propria coda di paglia, e gridare in coro "al lupo, al lupo", a destra e a manca!!!
- Nel 1614 il medico ebreo sefardita Rodrigo De Castro pubblicava ad Amburgo il testo Medicus-politicus, che segna le origini della moderna etica medica con una ispirazione specifica nel richiamare l’attenzione pubblica verso la coincidenza tra virtù morali del medico e astensione dall’inganno o da pratiche fraudolente ai danni dei malati.
- Nel 2015 - La procura di Lecce salva gli ulivi e indaga commissario e scienziati dell’emergenza xylella
 Salento. Sequestrati gli ulivi soggetti ad eradicamento forzato. Con i nuovi accertamenti scientifici di fatto vengono a cadere i presupposti per chiedere l’emergenza e la calamità naturale, in base alle quali si sta già usufruendo di ingenti fondi pubblici, sia ministeriali sia europei (Marilù Mastrogiovanni, il manifesto, 20.12.2015).
Salento. Sequestrati gli ulivi soggetti ad eradicamento forzato. Con i nuovi accertamenti scientifici di fatto vengono a cadere i presupposti per chiedere l’emergenza e la calamità naturale, in base alle quali si sta già usufruendo di ingenti fondi pubblici, sia ministeriali sia europei (Marilù Mastrogiovanni, il manifesto, 20.12.2015).
No ai processi al metodo scientifico
di Gilberto Corbellini, Roberto Defez (La Stampa, 24.12.2015)
Se in Italia sopravvive ancora una comunità scientifica degna di tale nome, ovvero delle accademie scientifiche consapevoli del loro ruolo a difesa dei valori di libertà e indipendenza della scienza, dovrebbero battere urgentemente un colpo. Farsi sentire.
E due colpi li dovrebbero battere il Consiglio Superiore della Magistratura, che è organo a garanzia dell’autonomia e indipendenza del governo della giustizia nel nostro Paese, e i politici che negli anni recenti si sono opposti alla politicizzazione, alla manipolazione e agli abusi di potere perpetrati ai danni della scienza. Senza lasciar fuori il Presidente della Repubblica.
Coloro che si sono indignati contro i tentativi di imporre attraverso sentenze di magistrati le pseudo-cure Di Bella o Stamina o contro il rinvio a giudizio e la condanna in primo grado della Commissione Grandi Rischi, per non aver dato l’allarme per il terremoto dell’Aquila o contro la credenza che i vaccini causino l’autismo, dovrebbero tutti insorgere per quanto sta accadendo nel Salento in merito alla vicenda Xylella fastidiosa, il batterio che sta uccidendo o concorre a uccidere gli ulivi (per ora solo) in quella regione.
Perché si tratta di un caso emblematico di scelte autoreferenziali di un pubblico ministero nell’esercizio dei suoi poteri, che seleziona un ristretto manipolo di esperti scientifici.
Ma, come si scelgono i consulenti scientifici in una materia tanto complessa? Si prendono quelli la cui opinione coincide con quella di un magistrato, o si chiede consulenza ai massimi organi scientifici nazionali e casomai internazionali?
La vicenda è nota già a livello internazionale perché qualche mese fa Nature scrisse un articolo denunciando il «vilipendio» a mezzo inchiesta giudiziaria ai danni degli scienziati che stanno studiando il fenomeno di diffusione del batterio, e il ruolo dello stesso nella sindrome patologica che causa il disseccamento degli ulivi salentini.
Gli ulivi del Salento sono attaccati da un batterio che è considerato, per le sue caratteristiche altamente contagiose e per gli effetti patogeni devastanti sulle piante, una gravissima minaccia a livello mondiale.
Questo batterio causa o concorre a causare una malattia che chiude i vasi della pianta (una specie di arterioscleresi per gli umani) portando al disseccamento degli ulivi e uno dei modi per limitare l’epidemia è sradicare gli ulivi già colpiti, ridurre gli insetti che diffondono Xylella e creare un cordone sanitario che isoli le piante infette.
Nulla di nuovo sotto il sole: la microbiologia dispone di metodo standardizzati per studiare come un agente causale è implicato in una malattia. Come tutte le malattie infettive la sindrome che vede Xylella protagonista ha caratteristiche che dipendono dall’ecologia locale e quindi si dove esaminare sperimentalmente la questione, tenendo conto anche delle linee guida europee e internazionali finalizzate al contenimento del patogeno.
Naturalmente, come fu per l’Aids e la sua causa cioè l’Hiv, ci sono i negazionisti, che con argomenti pretestuosi manipolano le incertezze e generano sospetti sulla trasparenza dei ricercatori o su qualche legame con i soliti poteri economici e con le solite multinazionali che farebbe loro sostenere una posizione che non è tanto scientifica quanto dovuta a interessi loschi.
E’ uno scenario già visto, ma un Paese civile non dovrebbe essere così esposto a questo genere di manovre politiche ai danni della scienza e del metodo che essa utilizza. Di fatto gli scienziati sono indagati per una serie di reati, tra cui quello di aver diffuso colposamente la malattia e di aver presentato i fatti in modo da arrivare ad avvallare come soluzione l’eradicazione delle piante malate. Sulla scia di un immaginario collettivo che ricorda i processi per inquisizione o i linciaggi pubblici per accontentare gli umori rabbiosi di una popolazione alla ricerca di capri espiatori, di far parte di qualche complotto sovrannazionale inteso a distruggere la tradizione agricola salentina, iniziando dagli ulivi.
L’inchiesta del procuratore Cataldo Motta è stata criticata duramente dall’ex Presidente del Tribunale di Bari Vito Savino, che l’ha paragonata alle vicende Di Bella e Stamina.
Ora, la questione su cui vorremmo richiamare l’attenzione, al di là della gravità dei contenuti degli avvisi di garanzia inviati agli scienziati che stavano studiando il fenomeno, riguarda il rapporto tra scienza e magistratura, ovvero come i giudici affrontano emergenze che possono essere capite solo tramite gli strumenti scientifici.
La vicenda salentina è l’ennesimo caso nel quale l’intraprendenza di un magistrato si esercita in un vuoto normativo per quel che riguarda le modalità di acquisire prove che abbiano base scientifica. È accaduto diverse volte, a partire dalla vicenda Di Bella e in modo macroscopico con la vicenda Stamina, nella quale i giudici prescrivevano il trattamento Stamina nonostante si trattasse di un imbroglio.
Sarebbe nell’interesse della magistratura, ma soprattutto, del Paese pensare e predisporre uno strumento che renda meno discrezionale il modo di procedere dei giudici quando le questioni sono precisamente definite dalle regole non negoziabili del metodo scientifico.
*Università La Sapienza
**Biologo e genetista Cnr
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! .. l’ulivo, la "xylella fastidiosa" --- Pensieri basati sui fatti. Saper distinguere "da adulti" la scienza dalla pseudoscienza (di G. Corbellini).25 gennaio 2016, di Federico La Sala
- PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA, IN FILOSOFIA E PEDAGOGIA. DEWEY (in gran compagnia, ancor oggi) CONTRO LO SPIRITO CRITICO DELL’ILLUMINISMO ...
 L’ATTIVISMO ACCECANTE DEL "FAR WEST" E IL "SAPERE AUDE" DELLA "CRITICA DELLA RAGION PURA": JOHN DEWEY SPARA A ZERO SU KANT, SCAMBIATO PER UN VECCHIO FILOSOFO "TOLEMAICO".
L’ATTIVISMO ACCECANTE DEL "FAR WEST" E IL "SAPERE AUDE" DELLA "CRITICA DELLA RAGION PURA": JOHN DEWEY SPARA A ZERO SU KANT, SCAMBIATO PER UN VECCHIO FILOSOFO "TOLEMAICO".
- LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO E IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE. PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA E DELLA TEOLOGIA POLITICA DI "MAMMONA" E DI "MAMMASANTISSIMA" - E DEL SUO "SUPERUOMO".
 L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI
L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI
- COSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
Logica e democrazia
Pensieri basati sui fatti
Se non è empirica la filosofia rischia di essere vaga. A scuola bisogna insistere sulla capacità di argomentare
di Gilberto Corbellini (Il Sole-24 Ore, Domenica, 24.01.2016)
I filosofi stanno discutendo abbastanza su cosa significhi oggi fare filosofia. È vero che chi scrive si identifica in una posizione scientista, per cui tutto quel che esiste ed è conoscibile è accessibile alla scienza e ai suoi metodi. Penso, in sostanza, che non esista in linea di principio niente di quel che accade che non possa essere compreso usando procedure empiriche controllate, se le nostre strutture cognitive riescono a concettualizzare e a interrogare sperimentalmente i processi che lo producono.
Questa è l’unica posizione filosofica per me ragionevole. Tutto il resto, come diceva Francis Crick, equivale a fischiare nel buio per farsi coraggio. Non penso però che la filosofia non serva a niente. Anzi. Oltre a produrre, insieme alla religione o alla letteratura o all’arte, suoni rassicuranti per chi ha paura del buio, può far capire meglio come funziona la scienza, togliendo di torno illusioni e autoinganni che ostacolano una comprensione critica e una disponibilità psicologica verso le conoscenze più affidabili che produciamo, cioè quelle scientifiche.
Un aiuto prima di tutto per i giovani, che invece di perdere tempo sul pensiero di tanti filosofi che hanno detto cose sbagliate, potrebbero acquisire salutari elementi di storia della scienza e di epistemologia scientifica, senza i quali non si capisce il mondo nel quale viviamo.
Davvero non si capisce, non è retorica! Le false credenze e le diffidenze verso la scienza e il metodo scientifico, così diffuse in Italia, sono la conseguenza anche del fatto che non sono chiari gli obiettivi dell’insegnamento scolastico: se non si aiutano i giovani a correggere l’epistemologia ingenua con cui approcciano la realtà, non distingueranno da adulti la scienza dalla pseudoscienza.
Oggigiorno non si può essere cittadini pienamente in grado di esercitare i diritti costituzionali se, per esempio, non si sa cosa è una probabilità, quali componenti teoriche entrano nella definizione di rischio, come si stabilisce che un dato scientifico è corretto o non falsificato, come funziona una sperimentazione clinica, cosa sono i bias cognitivi ed emotivi, etc. -Il fatto tragico è che questi concetti sono estranei in primo luogo a chi è impegnato a fare leggi, ad applicarle o ad amministrare la giustizia.
 L’esperienza più shoccante che si prova consultando le legislazioni anglosassoni è la chiarezza e l’organizzazione logica delle argomentazioni. Raramente sono scritte in modi illogici, per confondere le idee o non far capire cosa c’è scritto, come le leggi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
L’esperienza più shoccante che si prova consultando le legislazioni anglosassoni è la chiarezza e l’organizzazione logica delle argomentazioni. Raramente sono scritte in modi illogici, per confondere le idee o non far capire cosa c’è scritto, come le leggi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.Se «siamo un paese che odia la scienza», come denunciava lunedì scorso Paolo Mieli sul Corriere della Sera, è perché a cominciare dalla classe politica e passando per quasi tutti gli intellettuali che fanno tendenza, non si trova qualcuno che non storca il naso o non dica inesattezze quando si usa o si propone di usare un metodo scientifico per stabilire come stanno determinati fatti.
Per esempio quando si utilizzino i risultati della ricerca sperimentale per sostenere che mentono coloro i quali dicono che i vaccini possono causare l’autismo e sono più rischiosi della malattie che devono prevenire, che gli Ogm sono sicuri per l’ambiente e la salute nonché un toccasana per l’agricoltura, che le staminali mesenchimali non hanno curato alcuna malattia, che Xylella è un vero patogeno e i suoi effetti possono essere stabiliti e contrastati solo con metodi scientifici, etc.
Non è pensabile che un paese economicamente sviluppato possa rimanere tale e possa allevare un élite politica e intellettuale in grado di renderlo internazionalmente competitivo se non cambia radicalmente la qualità della cultura scientifica. Un risultato che non si ottiene solo incrementando la divulgazione o comunicazione della scienza, e tantomeno trascinando la scienza in controversie politiche, filosofiche o ideologiche. Va detto che se siamo a questo punto anche la comunità scientifica e il mondo accademico hanno pesanti responsabilità, che non sono soltanto l’attendismo, il servilismo e l’opportunismo che hanno caratterizzato i rapporti con la politica sin dall’ultimo dopoguerra più o meno.
C’è un problema culturale per cui non sono solo i cittadini profani che avrebbero bisogno di imparare un po’ di filosofia. Perché gli scienziati, che con disinvoltura riescono sempre più spesso a scavarsi la fossa con le loro mani, scadono frequentemente nei più triti luoghi comuni e gestiscono o furbescamente o ingenuamente le interazioni con la politica o con la magistratura.
Benché l’apprendimento della scienza dovrebbe averli immunizzati dalle trappole delle idee di senso comune e delle preferenze ideologiche, alla prima occasione per dar spazio a qualche ambizione di potere o bisogno narcisista si prestano a fare confusione e alimentare il pregiudizio che “gli scienziati sono divisi”, quindi tanto vale ignorarli o usarli come ci fa comodo.
Gaston Bachelard diceva che la scienza del suo tempo non aveva filosofi all’altezza del compito. Oggi si possono fare molti esempi che gli scienziati non sono spesso all’altezza della scienza che producono.
È triste leggere articoli di scienziati e accademie scientifiche che s’arrampicano sugli specchi per sostenere che le più recenti tecnologie del genome editing sono naturali o intrinsecamente diverse da quelle con le quali si facevano gli ogm, insultando la logica e l’epistemologia della biologia - è chiaro che non sanno nulla di teoria evoluzionistica, altrimenti non farebbero ragionamenti per i quali i giganti del pensiero genetico-evoluzionistico si rivoltano nella tomba. Tutto per rincorrere l’ignoranza dei politici che chiedono loro di abiurare ai principi etici della scienza - dire come stanno i fatti - se vogliono usare queste nuove tecnologie. Ma solo in laboratorio, dice l’improbabile ministro dell’agricoltura nostrano.
Ecco qualche compito utile per la filosofia. Rendersi conto che il sapere che vale amare è quello scientifico, e quindi lavorare non solo per farlo entrare meglio nella cultura civile, ma anche per proteggerlo dagli stessi scienziati.
- PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA, IN FILOSOFIA E PEDAGOGIA. DEWEY (in gran compagnia, ancor oggi) CONTRO LO SPIRITO CRITICO DELL’ILLUMINISMO ...
-
-
> RIPENSARE L’EUROPA! --- XYLELLA FASTIDIOSA. Nessuna emergenza. Dalla Regione false dichiarazioni alla Ue (di Marilù Mastrogiovanni).19 dicembre 2015, di Federico La Sala
Motta: “Ci sono 9 xylelle ma nessuna emergenza. Dalla Regione false dichiarazioni alla Ue”
di Marilù Mastrogiovanni *
Nessuna emergenza, ma una falsa rappresentazione della realtà da parte degli organi istituzionali deputati a comunicare con la Ue e da parte dei Centri di ricerca baresi. Dunque gli alberi d’ulivo sui quali pende l’ordinanza di abbattimento del commissario straordinario per l’emergenza xylella, Giuseppe Silletti, sono stati sequestrati preventivamente (con facoltà d’uso per garantirne la cura e la raccolta delle olive da parte dei proprietari) per impedire che si sradichino sulla base di decisioni poggiate su falsi presupposti, sia scientifici sia, di conseguenza, amministrativi.
Questo emerge dalla conferenza stampa di oggi, nel corso della quale il capo della procura di Lecce Cataldo Motta ha fissato i primi paletti di un’indagine condotta con ritmo serrato in un anno e mezzo e partita dall’esposto di due associazioni: Forum ambiente e salute e Spazi popolari.
“Siamo partiti dagli esposti ma poi le indagini hanno preso una piega diversa - ha tenuto a precisare il procuratore - agendo, come sempre accade, in maniera autonoma”.
Il decreto di sequestro preventivo elenca i nomi degli indagati e le ipotesi di reato (CLICCA QUI).
Le indagini, coordinate dalle pm Elsa Valeria Mignone e Roberta Licci, che hanno incaricato un pool di esperti per verificare i presupposti scientifici su cui si sono basate le decisioni prese dalla Regione Puglia e comunicate alla Ue, hanno riscontrato l’esistenza sul territorio di ben 9 ceppi di xylella fastidiosa, non uno solo, come affermato dai ricercatori del CNR.
Questo induce a concludere che è molto verosimile che la xylella sia presente nel Salento da molto tempo e che si sia nel tempo mutata geneticamente, come è normale facciano i batteri per adeguarsi all’ambiente in cui vivono. Oppure che sono state introdotte più tipologie di xylella che poi si sono mescolate tra loro.
Il consulenti tecnici della procura avanzano diverse ipotesi, che illustreremo in un’altra puntata.
Di certo si può affermare che diversi tipi di xylella sono presenti da molti anni e da molto tempo prima rispetto a quando è stata comunicata la sua presenza alla Ue da parte dell’Istituto fitosanitario regionale, cioè il 15 ottobre 2013.
motta e mignone procure lecce xylellaDi fatto vengono a cadere i presupposti per chiedere l’emergenza e la calamità naturale, in base alle quali si sta già usufruendo di ingenti fondi pubblici. Si tratterebbe di indebita percezione di finanziamenti ministeriali ed europei?
Le indagini su questo e su molto altro sono ancora aperte, inclusa l’analisi di svariati terabyte di memoria dei pc sequestrati al CNR di Bari, ancora sotto la lente d’ingrandimento della procura (CLICCA QUI); per ora non è ipotizzato il dolo, semplicemente perché è difficile provarlo, ma sono ipotizzati “solo” la “colpa”, l’imperizia, la superficialità, la negligenza.
“E’ anche da precisare - ha dichiarato Cataldo Motta - che la Ue non impone di sradicare gli alberi e che anzi l’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha precisato che sradicare gli alberi non serve per eradicare il batterio, eppure è stata una scelta della Regione Puglia, quella di sradicare gli ulivi per bloccare l’avanzamento della presunta infezione da xylella”.
La “Ue è stata indotta in errore in base a dati impropri e non del tutto esatti comunicati dagli uffici regionali”, ha detto Motta.
In una parola: sono state prodotte false dichiarazioni alla Ue.
Inoltre, ha detto Motta, le piantine di vite infettate da xylella fastidiosa per l’ormai famigerato seminario del 2010 tenutosi presso lo Iamb di Valenzano, sono entrate in Europa senza “passaporto verde”, cioè senza alcuna autorizzazione.
Abusive.
Capiremo fra un po’, dai diversi filoni d’indagine, come è possibile che questo sia potuto accadere e anche come è possibile che piantine abusive siano poi state eliminate (così emerge dai documenti) a norma di legge.
“Abbiamo fatto delle analisi su ulivi sani, cioè senza sintomi di disseccamento, e c’era xylella; abbiamo fatto le stesse analisi su ulivi con gravi sintomi di disseccamento e la xylella non c’era”, ha detto Motta.
Il Piano Silletti bis dunque è definitivamente fallito: da una parte il sabotaggio dei cittadini, che hanno bloccato le ruspe, ponendo i loro corpi tra i mezzi meccanici e gli alberi, occupando le strade e la ferrovia; dall’altra le decine di ricorsi al Tar e i due ricorsi alla Corte di giustizia europea; infine la Procura, che ha bloccare lo sradicamento degli ulivi, sequestrandoli.
Questa è solo la punta dell’iceberg del grande affaire xylella fastidiosa, le indagini proseguono e c’è da star certi che altri colpi di scena seguiranno.
Il problema è che, come sempre accade in Italia, si possono perseguire gli esecutori di un delitto, ma i mandanti sono difficili da trovare.
Dovranno però, al di là delle indagini della Procura, dare conto ai pugliesi i responsabili politici di questo scempio:
 l’allora presidente della regione Puglia Nichi Vendola,
l’allora presidente della regione Puglia Nichi Vendola, l’ex assessore regionale Fabrizio Nardoni,
l’ex assessore regionale Fabrizio Nardoni, l’ex assessore regionale (attualmente senatore) Dario Stefàno,
l’ex assessore regionale (attualmente senatore) Dario Stefàno,Alla prossima puntata.
* Xylella Report, 19.12.2015 (ripresa parziale - per approfondimenti, cliccare sul rosso).
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" --- Quale integrazione? La laicità francese ha fallito serve un nuovo modello (di Mauro Magatti)18 dicembre 2015, di Federico La Sala
La laicità francese ha fallito serve un nuovo modello Errori Il terrorismo ha sfruttato una globalizzazione che elude il controllo degli Stati nazione
Errori Il terrorismo ha sfruttato una globalizzazione che elude il controllo degli Stati nazione
 Pesca nello scontento cronico di una situazione economica e sociale non più sostenibile L’unica soluzione è coordinarsi a livello europeo sui migranti
Pesca nello scontento cronico di una situazione economica e sociale non più sostenibile L’unica soluzione è coordinarsi a livello europeo sui migranti
 Coltivare un’identità esterna a quella del Paese di residenza crea problemi
Coltivare un’identità esterna a quella del Paese di residenza crea problemidi Mauro Magatti (Corriere della Sera, 18.12.2015)
Le vicende di questi ultimi tempi mettono a nudo le gravi difficoltà nelle quali si ritrova il modello della laicità francese. Ci sono infatti almeno tre aspetti che appaiono oggi problematici.
Il primo riguarda la possibilità di coltivare un’identità esterna a quella del Paese di residenza. È uno degli effetti della globalizzazione: a prescindere da dove ci si trovi a vivere è molto facile oggi comunicare, fare affari, raggiungere il proprio Paese d’origine. I terroristi di Parigi sono stati probabilmente addestrati in Siria e hanno comunque sfruttato una rete organizzativa sovranazionale. Ciò costituisce un evidente problema per il modello della laicità che presuppone invece uno Stato nazionale in grado di esercitare il monopolio identitario. Specie in Europa dove le frontiere sono state aperte con estrema disinvoltura.
Il secondo aspetto problematico ha a che fare con i cronici fallimenti nei processi di integrazione sociale e economica. La laicità alla francese fallisce poiché non ha più le risorse né le capacità per sostenersi. Oltre alle inefficienze, sono le risorse che in un contesto di economia aperta vengono a mancare. Come dimostrano chiaramente le tante banlieue dove la promessa di cittadinanza viene nei fatti sistematicamente negata. Non ci vuole molto per capire, come si è peraltro ripetuto mille volte, che i ragazzi abbandonati dallo Stato, dall’economia e dalla società sono le prede ideali dei gruppi estremisti.
Il terzo aspetto ha a che fare con il deterioramento, nella sfera pubblica, dei canoni di rispetto reciproco. In nome di una male interpretata idea di libertà di espressione, il positivo superamento di ogni censura è stato inteso come licenza di ingiuria e offesa. Formando una spirale che finisce per alimentare risentimento e odio sociale. In un mondo in cui tutto può essere detto e fatto, l’onere della sopportazione non viene abolito: semplicemente si sposta sulle spalle di chi è reso bersaglio.
La situazione storica nella quale ci troviamo a vivere - con interi Paesi islamici in pieno subbuglio politico e religioso e la contemporanea presenza di una consistente minoranza di cittadini di quella stessa religione nelle nostre città - pone il problema (non solo alla Francia) di quale modello di integrazione si possa e si debba seguire.
Tornare indietro, cioè ricreare le condizioni di plausibilità per il modello della laicità, comporta superare i tre aspetti sopra ricordati. Cosa molto difficile. Soprattutto per Paesi come la Francia, la Germania e l’Italia che oggi avrebbero difficoltà a invertire il processo di integrazione europea.
Si tratta allora di ridiscutere, con maggiore adeguatezza, alcuni capisaldi comuni di un modello sostenibile di integrazione. Muoversi per questa via, che allo stato in cui siamo sarebbe quella più ragionevole, comporta affrontare almeno due temi. Il primo è quello di cui si sta parlando da mesi: una politica europea seria e coordinata per i profughi e un controllo più accurato delle frontiere. Facile a dirsi, difficile, pare, a farsi.
Una tale questione, per quanto urgente, non è però la più importante. La società europea nel suo insieme - e le diverse società nazionali al suo interno - ha bisogno di chiarirsi le idee attorno al rapporto da tenersi con la popolazione islamica.
Anche su questo punto il modello della laicità francese ha mostrato limiti evidenti: negare persino la visibilità della fede religiosa nella sfera pubblica, nelle condizioni sopra ricordate, non è una buona idea. Ciò che va piuttosto chiarito, come ha scritto Claudio Magris sul Corriere della Sera, sono i diritti e i doveri delle comunità di fede musulmana. Sia dentro i confini europei che fuori.
A questo proposito si possono avanzare due considerazioni. La prima riguarda l’urgenza di rilanciare, con le dovute chiarificazioni, il principio della libertà religiosa, affermato da tutte le istituzioni internazionali. In un’epoca di migrazioni, la libertà religiosa va resa una priorità sul piano concreto dei rapporti internazionali, vincolandola al principio di reciprocità. Una linea d’azione che deve arrivare a responsabilizzare le stesse comunità religiose qui residenti, che di norma mantengono stretti legami etnici o nazionali: il riconoscimento in Europa non può essere indipendente da quello che accade nei Paesi di origine.
La seconda considerazione nasce dalla riflessione sul modello italiano, specialmente sullo strumento del concordato. Trattandosi di soggetti che hanno un importante ruolo sociale, le chiese devono essere disposte ad assumere una esplicita riconoscibilità pubblica, con precisi diritti e doveri, che le renda responsabili e leali nei confronti delle istituzioni. L’idea che i gruppi religiosi costituiscano un affare esclusivamente privato finisce per creare enclave semiclandestine. Cosa oggi del tutto inaccettabile.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" --- "2084": Istruzioni per evitare la prossima Apocalisse. Interv. a Boualem Sansal (di Gloria Origgi).18 dicembre 2015, di Federico La Sala
Intervista all’algerino Boualem Sansal: “L’islam non teme la guerra”
Istruzioni per evitare la prossima Apocalisse
- Pubblichiamo un estratto dell’intervista sul nuovo numero di Micromega
di Gloria Origgi (la Repubblica, 18.12.2015)
Boualem Sansal è un uomo mite, ironico e ispirato al tempo stesso. L’intervista avviene nella sede dell’editore Gallimard, nel cuore di Saint-Germain a Parigi. Sansal ha i capelli lunghi grigi raccolti in una coda di cavallo e un profilo da santone indiano. -Il suo ultimo romanzo, “2084”, un successo planetario, di prossima pubblicazione in Italia per Neri Pozza, è ambientato in un futuro prossimo in cui il mondo libero è stato soggiogato da uno stato totalitario, l’Abistan, che controlla le menti, ha cancellato il passato e ha reso tutti schiavi.
In che modo il suo libro visionario,“2084”, esprime una sua visione buia del futuro?
«Sono anni che penso che attacchi del genere di quelli che si sono prodotti a Parigi a gennaio e novembre sarebbero accaduti. Penso che l’islamismo sia ormai un fenomeno anche europeo. Ed ero sicuro che sarebbe passato in fretta alla fase violenta, ossia alla fase di guerra dichiarata. Dunque la cosa non mi ha sorpreso: come molti altri ero convinto che un giorno o l’altro questo sarebbe avvenuto. E da qualche parte l’Europa non ha voluto vedere, ha sottovalutato il rischio».
Cosa dobbiamo sapere che non sappiamo? Che cos’è l’islamismo?
«La gente pensa che l’islamismo sia qualcosa di recente. Come il fascismo. Invece è nato insieme all’islam. L’islam viene fondato e poi comincia a dividersi. Nasce allora il sunnismo, lo sciismo, il sufismo. L’islamismo è una visione apocalittica della religione. Come in tutte le religioni ci sono movimenti apocalittici che pensano che la fine del mondo sia vicina e stravolgono tutte le credenze orientandole alla fine del mondo».
E perché oggi assistiamo al trionfo di questa visione apocalittica? Anche il suo libro è in fondo apocalittico.
«Le visioni apocalittiche hanno sempre accompagnato le religioni. In tutte le religioni ritroviamo una corrente puramente religiosa, una corrente puramente mistica e una corrente apocalittica il cui pensiero dominante è che raggiungere la fine dell’umanità significa andare incontro a Dio. È un modo di esistenza: è come portare dentro di sé una tentazione suicida che ci fa vivere in modo più “forte”, sempre all’orlo del precipizio».
Se capisco la sua visione, l’islamismo contemporaneo non solo trae la sua forza dall’atteggiamento apocalittico, ma anche dalla dimensione globale.
«Come il cristianesimo, l’islam ha un progetto planetario. I cristiani volevano cristianizzare tutti, compresi i cosiddetti “selvaggi”, quelli che non erano nemmeno considerati esseri umani, che abitavano nelle foreste... Popolazioni che i missionari consideravano come “scimmie” eppure volevano evangelizzarli lo stesso. Per farli diventare umani. L’islam ha la stessa ambizione planetaria di fare regnare Allah sulla terra. L’unico monoteismo che non ha questa tendenza planetaria è la religione ebraica. L’ebraismo è la storia di un popolo eletto, non dell’umanità».
Lei è un laico...
«Io non sono credente, sono ateo. E dunque ovviamente sono laico, nel senso che non voglio vedere la religione interferire con le questioni di Stato».
Lei dice cose indicibili anche in Europa, per esempio contro il “politically correct” o contro le moschee e i musulmani...
«Ci sono troppe moschee, ci sono troppi “barbuti”, c’è troppo rispetto ovunque per la religione. Non dirlo è il segno di una civiltà che muore, che si proibisce da sola di dire quello che pensa. Eccesso di prudenza. In Europa, nel trattato di Lisbona, si è pure inserito un principio di precauzione, come per istituzionalizzare la paura che ormai abbiamo di tutto. Gli europei si sentono circondati, minacciati, e non sono disposti a cambiare, a rinunciare a nulla».
Ha scritto cose che le hanno causato grandi problemi, ha perso il suo posto di alto funzionario a causa dei suoi libri, è stato minacciato più volte. Eppure va avanti.
«Perché non posso pensare e dire tutto ciò senza fare nulla, anche se so che non serve a niente. È una questione di coerenza personale. Poi è la mia natura. Io non posso non parlare. E non parlo mai in modo aggressivo. Però dico sempre quel che penso. Io lo posso fare perché non ho paura di perdere nulla. I politici non possono parlare liberamente perché hanno paura di perdere il potere, sono ostaggio dei loro elettori».
Non è paradossale? Sembra quasi che nelle società cosiddette liberali sia più rischioso parlare che in Algeria...
«Perché sono società terrorizzate, che hanno paura di tutto, di dire quello che pensano, e non sanno nemmeno più cosa pensare. Io che vivo in Algeria, che sono stato minacciato un sacco di volte, non mi sento in pericolo. Avrei potuto ottenere il premio Goncourt quest’anno e molti altri premi se non avessi detto le cose che dico in tivù che mi fanno passare per un islamofobo... ma gli editori hanno avuto paura di dare un premio del genere a qualcuno che dice che l’islam è una vergogna. Ma io me ne infischio dei premi. Se vogliono darmeli va benissimo. Se non vogliono il problema è loro».
Dove si trovava venerdì 13 novembre al momento degli attentati di Parigi?
«Quel fatidico venerdì, mi trovavo nella magnifica città di Uzès per presentare il mio romanzo 2084... Di fronte al nostro tavolo c’era una televisione accesa senza volume. Mentre cenavamo, guardavamo distratti i poliziotti che correvano, le ambulanze, la confusione, senza capire veramente di che si trattasse. Poi sono cominciati i sottotitoli sullo schermo: 5 morti al Bataclan, 2 allo stadio... Il mio libro, il mio racconto apocalittico diventava realtà. Mi vergognavo quasi di averlo immaginato. Come se avessi dato sostanza a quel fantasma».
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" --- I Lumi perduti dell’Islam. Interv. a Boualem Sansal (di G. Caldiron)).31 marzo 2016, di Federico La Sala
Boualem Sansal
I Lumi perduti dell’Islam
Un’intervista con lo scrittore algerino, in Italia per presentare il nuovo romanzo «2084» (Neri Pozza), accusato «di islamofobia»
intervista di Guido Caldiron (il manifesto, 31.03.2016)
«Siamo in guerra e dobbiamo comportarci di conseguenza». Dopo le stragi di Bruxelles, la reazione a caldo di Boualem Sansal non lascia spazio a dubbi quando invoca una risposta adeguata alla minaccia del terrorismo jihadista. I mezzi sono ovviamente culturali, ma poi aggiunge che occorre anche una «risposta militare». Lo scrittore algerino che dagli anni Novanta ha contrastato nel suo paese sia l’ascesa dell’islamismo armato che la deriva autoritaria del regime di Bouteflika, è stato allontanato dal ministero dell’Industria a causa delle sue prese di posizione critiche contro il regime algerino, ha messo del resto da tempo al centro del suo lavoro proprio la denuncia del fondamentalismo islamico, arrivando appunto a prospettare una risposta militare. Del suo percorso sono testimoni i romanzi.
Dopo Les serment des barbares (2008) e Il villaggio del tedesco (Einaudi), Sansal ha immaginato con 2084 (Neri Pozza, pp. 254, euro 17), romanzo che gli è valso il gran premio dell’Académie française e la nomination per il Nobel per la letteratura nel 2014, che una gran parte del mondo, ribattezzata come Abistan, al termine di una feroce guerra santa, di cui nessuno conserva però più memoria diretta, sia stata sottomessa da un regime autoritario islamista la cui vita quotidiana è scandita da pellegrinaggi senza fine e da punizioni pubbliche. Un romanzo che sembra interrogarsi anche sulla drammatica attualità rappresentata dall’emergere del sedicente Stato Islamico.
Il suo romanzo sembra iscriversi, fin dal titolo, nella stessa prospettiva distopica inaugurata da George Orwell con «1984»: il riferimento ai regimi autoritari del Novecento può perciò aiutarci a comprendere appieno la minaccia jihadista di oggi?
Forte della lezione della sua epoca storica, Orwell osservava come fossimo tutti destinati a vivere prima o poi all’interno di regimi totalitari. Così, con il suo celebre romanzo ha cercato di decodificare le strutture portanti di una organizzazione totalitaria della società: il ruolo e il profilo del «capo», il controllo esercitato sulla Storia, la lingua e via dicendo. Da quando ho letto la prima volta 1984, negli anni Settanta, mi sono chiesto quali punti di contatto avesse quanto vi era descritto con la realtà che stava crescendo intorno a me.
In Algeria, avevo dapprima assistito all’instaurarsi di un sistema poliziesco e militare e quindi all’emergere di un sistema altrettanto minaccioso ma di natura religiosa. Perciò, ho cominciato a interrogarmi sulla possibilità che gli elementi su cui si era concentrato Orwell, potessero essere validi anche per il totalitarismo di matrice religiosa che stava emergendo nel mio paese. Questo perché solo se si capisce il contesto in cui siamo precipitati possiamo trovare il modo di reagire e intraprendere il cammino verso la libertà.
Ne «Il villaggio del tedesco», nel quale provocatoriamente suggerisce un parallelo tra l’islamismo e il nazismo, lei racconta dell’ascesa di un nuovo fenomeno politico-religioso nelle periferie delle metropoli europee, come accaduto a Bruxelles. Di cosa si tratta?
Sì, per documentarmi sul contesto nel quale era cresciuto il personaggio di Malrich, figlio di un criminale di guerra nazista rifugiatosi in Algeria dopo il 1945, vale a dire la periferia di Parigi, ho fatto una sorta di viaggio in quei luoghi. Mi sono recato sul posto e ho incontrato gli abitanti, i genitori e gli amici di questi ragazzi reclutati dai predicatori islamisti nelle moschee più radicali. Nelle banlieue, il fatto che molti non musulmani abbiano scelto progressivamente di trasferirsi altrove ha finito per alimentare la deriva comunitarista e il senso di isolamento che si vive tra le famiglie di origine immigrata.
In questo contesto, l’influenza degli islamisti, che hanno poco per volta rimpiazzato il tradizionale islam pacifico e solidale dei quartieri dell’immigrazione con una sorta di bizzarro bricolage, nervoso, aggressivo, diffuso da degli «imam fai da te», ignoranti e capaci solo di ripetere in continuazione «Allah Akbar», non ha fatto che crescere, fino alla drammatica situazione in cui ci troviamo ora. In molti di questi quartieri l’intera comunità si trova ostaggio di un islam grottesco, di facciata, che si mostra attraverso quella sorta di divisa rappresentata dalla barba lunga per gli uomini e dalla gandura e il velo per le donne. Simboli che intendono incutere paura e rispetto con l’obiettivo di attirare i piccoli «duri» del quartiere, per trasformarli, come accaduto per esempio a Parigi e Bruxelles, in terroristi.
Nel mondo descritto in «2084» il tempo sembra essersi fermato. Quasi un’evocazione del clima che ha regnato a lungo, e continua a regnare anche oggi malgrado le primavere di rivolta degli scorsi anni, in buona parte dei paesi arabi, apparentemente immersi in un eterno presente senza prospettiva che ha finito per alimentare la crescita dell’islamismo. È così?
In molti paesi del mondo arabo e musulmano gli orologi si sono fermati ormai da tanto tempo. E in ogni caso si tratta di un mondo che non funziona con gli stessi tempi, per esempio, dell’Europa. La scena è dominata da un immobilismo politico in grado di sopravvivere anche a scosse significative ma che non riescono mai a condurre a cambiamenti definitivi. Non a caso, i figli dell’élite al potere, come in Algeria, vivono lontani, spesso negli Stati Uniti ed in Canada, e quando rientrano in patria per prendere il posto dei loro genitori alla testa di questo o quell’apparato del regime, esprimono una mentalità paternalistica nei confronti dei loro connazionali considerati alla stregua di bambini che non potranno mai davvero crescere e assumersi delle responsabilità. Del resto, se ciò avvenisse, questi caid perderebbero tutti i loro privilegi. Così, almeno all’inizio, in molti casi si è preferito aprire agli islamisti perché continuassero a tenere buona la società procedendo, come accaduto proprio nel mio paese, verso una sua revisione per così dire in chiave religiosa. Dopodiché, «i barbuti» hanno cercato di prendersi l’intero potere.
Le sue posizioni sono state talvolta tacciate di islamofobia e c’è chi l’ha paragonata a Michel Houellebecq, l’autore di «Sottomissione». Cosa risponde?
Non sono islamofobo. Soltanto rifiuto ogni ideologia autoritaria, religiosa o laica che sia. Certo combatto e continuerò a combattere con tutte le mie forze gli islamisti radicali. Forse manca semplicemente un termine per descrivere ciò che provo e che scrivo: dovremmo coniare un neologismo come «islamistafobo» ma non ha un bel suono. In ogni caso, libertà significa anche poter dire che non si ama l’islam wahhabita dell’Arabia Saudita o l’islam tout court, senza per questo odiare nessuno. Le persone hanno il diritto di criticare ogni cosa, religioni comprese e soprattutto tutte le religioni se lo ritengono opportuno. Quanto a Houellebecq non saprei che dire. Con il suo romanzo si è occupato di questi temi ma ora è già passato ad altro. Per me è diverso: questa è la mia principale fonte d’ispirazione.
Ho cominciato a scrivere in un paese in guerra per colpa degli islamisti, dell’islamismo politico radicale. Sono cresciuto dentro questo conflitto. La comunicazione degli jihadisti ha puntato molto sul senso di colpa dell’Occidente, ma si deve fare molta attenzione a non finire per considerare gli aguzzini alla stregua delle vittime. Il vero problema è però rappresentato dal fatto che l’Occidente non oppone più alcuna idea e alcun valore alla minaccia jihadista, se non quella incarnata dall’ideologia del mercato e del denaro. Se non si tornano a difendere con forza i valori della libertà individuale e della democrazia, questa guerra è già persa in partenza.
-
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! --- L’EUROPA PER FORZA. L’estate scorsa Angela Merkel aveva fatto sperare. Oggi, i burocrati anonimi di Bruxelles stanno rimettendo le cose al loro posto.16 dicembre 2015, di Federico La Sala
L’Europa per forza
di Alessandro Dal Lago (il manifesto, 16.12.2015)
L’idea di un’Europa solidale con i deboli, accogliente e aperta agli stranieri è naufragata giorno dopo giorno, negli ultimi anni, tra eruzioni di sciovinismo nazionale e locale, negazione dei diritti umani e ottusità burocratica comunitaria. Oggi, la Commissione europea dà un altro colpo di piccone all’ideologia europeistica, già abbondantemente compromessa, rivelandosi apertamente per quello che è, ovvero un’istituzione, non eletta da nessuno, ma delegata dagli stati al controllo economico interno ed esterno.
Il richiamo all’Italia per l’attivazione degli hot spot e di procedure «legislative» per rilevare le impronte digitali dei migranti anche con «la coercizione» è un capolavoro di ipocrisia e ingerenza negli affari interni di uno stato membro. Con che diritto un’istituzione esecutiva si fa promotrice dell’adozione di un «quadro legale» che legittimi pratiche di violazione dei diritti umani? Intendiamoci, qui non si tratta di difendere il governo italiano, che gioca a rimpiattino in tema di immigrazione ed è sempre pronto a lamentarsi di essere stato abbandonato da mamma Europa.
Qui si tratta di comprendere come le leggi invocate non siano altro che formule verbali di copertura di pratiche illegittime.
Per cominciare, l’Europa non dispone di una legislazione omogenea in tema di impronte digitali. La maggioranza degli stati non consente questa procedura per i richiedenti asilo (il che è dettato da ovvie considerazioni di protezione delle persone). Altri, ma non tutti, lo consentono solo per i migranti irregolari o presenti illegalmente sul territorio dell’Unione. Alcuni stati non permettono di prelevare le impronte senza un provvedimento del giudice. La mossa della Commissione, insomma, si configura come una forzatura dettata da pure ragioni di controllo e di restrizione degli spazi di libertà personale dopo gli attentati di Parigi (d’altronde la Francia, già considerata paradiso dei diritti umani, ha dichiarato ufficialmente che è disponibile a revocarne alcuni per ragioni di sicurezza...).
Quanto agli «hotspot», cioè i punti caldi delle frontiere mediterranee dell’Unione, il gioco è evidente: irrigidire, nei limiti del possibile, il ruolo dei Cie e centri di detenzione analoghi senza prendere in considerazione le denunce di irregolarità e violazione dei diritti umani che periodicamente li riguardano. Immaginiamo che significhi a Pozzallo, Lampedusa e altrove usare la «coercizione» quando si prendono le impronte digitali. Stiamo parlando di migranti a cui si impedisce di fatto di essere registrati come richiedenti asilo, donne, minori, bambini. Parlare di uso della forza significa legittimare a priori, con o senza il «quadro legale», pratiche di limitazione delle libertà personali e violenza che non dipendono tanto dalla buona volontà o inclinazione personale di agenti e operatori vari, ma dall’ambiguità e dalla discrezionalità delle procedure.
La banale verità è che l’Europa non vuole tra i piedi gente sospettabile di simpatizzare con l’islamismo radicale, anche quando i sospetti non hanno alcun fondamento.
All’ultimo vertice europeo sono stati stanziati tre miliardi per la Turchia di Erdogan, affinché ci tenga lontani gli immigrati e possibili richiedenti asilo, che verosimilmente provengono da Siria, Iraq, Afghanistan e così via. La stessa Turchia che reprime il dissenso interno, incarcera i giornalisti, combatte i kurdi e ingaggia un braccio di ferro dalle conseguenze imprevedibili con la Russia di Putin.
L’estate scorsa Angela Merkel, la donna più potente d’Europa, aveva fatto sperare che l’Europa si aprisse ai profughi. Oggi, i burocrati anonimi di Bruxelles stanno rimettendo le cose al loro posto.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- L’Europa nella morsa dei populismi (di Beda Romano)9 dicembre 2015, di Federico La Sala
L’Europa nella morsa dei populismi
In una ventina di Paesi i partiti più radicali hanno raccolto almeno il 10% dei voti alle ultime elezioni
di Beda Romano (Il Sole-24 Ore, 8.12.2015)
Bruxelles Non c’è quasi paese in Europa che non debba fare i conti con partiti radicali, a destra come a sinistra. Il successo alle elezioni regionali del Fronte Nazionale in Francia non è che l’ultimo segnale di una lunga serie. Qui a Bruxelles c’è evidente preoccupazione per i risvolti che questa tendenza ha e avrà sul funzionamento dell’Unione. Peraltro, il 2016 è un anno elettorale in Europa, con elezioni politiche in cinque paesi, di cui quattro in una Europa dell’Est spesso poco europeista.
Secondo le più recenti statistiche, in una ventina di paesi dell’Unione i partiti più radicali hanno raccolto alle ultime elezioni nazionali oltre il 10% dei suffragi, secondo una ricerca del centro studi inglese Open Europe. Attualmente, i partiti più radicali, siano essi euroscettici o nazionalistici - per non usare la parola connotata e imprecisa di populisti - governano in almeno sei paesi dell’Unione: la Grecia, la Finlandia, la Polonia, l’Ungheria, la Lituania, e la Slovacchia.
«La verità è che segmenti importanti delle società occidentali non hanno beneficiato della globalizzazione. I partiti radicali offrono loro presunte soluzioni», spiega un responsabile europeo. «Il problema del populismo - aggiunge un altro responsabile europeo - è che ha un impatto politico anche quando il partito che incarna questo pensiero non è al potere. In tutti i paesi o quasi, i partiti più tradizionali tendono a cavalcare gli stessi temi nella speranza di rassicurare gli elettori ed evitare un travaso di voti».
La Commissione Juncker è arrivata al potere alla fine del 2014 affermando di volere imporre all’Unione un passo avanti decisivo nell’integrazione europea, pur di dare una risposta concreta alle sfide economiche e sociali del continente. «La verità è che in tutti i paesi o quasi si nota la tendenza ad atteggiamenti nazionalistici - spiega un diplomatico europeo - . Ciò è vero nella gestione della crisi greca, ma soprattutto nell’emergenza provocata dall’arrivo di rifugiati dal Vicino Oriente».
Dopo mesi di negoziato, i Ventotto hanno accettato di redistribuire in tutta Europa 160mila migranti arrivati in Grecia e in Italia. A circa tre mesi da quando la decisione è stata presa, sono pochissimi i profughi che hanno trovato una nuova patria. Il nazionalismo sta complicando lo stesso governo dell’Unione europea che si basa sulla ricerca di un terreno comune tra i Ventotto. Il compromesso è al ribasso proprio in una fase in cui le soluzioni dovrebbero essere più federali e meno confederali.
Sono almeno due i motivi per cui i partiti più radicali hanno successo.
 Prima di tutto, la crisi finanziaria sta lasciando strascichi di insoddisfazione per come l’establishment politico affronta i problemi economici e sociali. Chiamati a ridurre i costi e a risanari i bilanci, i governi nazionali devono imporre sacrifici sempre più impopolari. In questo contesto, a crescere è anche la disaffezione nei confronti di una Europa, a cui vengono attribuite molte delle difficoltà.
Prima di tutto, la crisi finanziaria sta lasciando strascichi di insoddisfazione per come l’establishment politico affronta i problemi economici e sociali. Chiamati a ridurre i costi e a risanari i bilanci, i governi nazionali devono imporre sacrifici sempre più impopolari. In questo contesto, a crescere è anche la disaffezione nei confronti di una Europa, a cui vengono attribuite molte delle difficoltà.Un sondaggio Eurobarometro pubblicato la settimana scorsa per conto del Parlamento europeo ha mostrato che l’opinione dell’Italia nei confronti della costruzione europea non è entusiastica. Il 55% degli italiani «non è interessato agli affari europei» (rispetto a una media europea del 45%). Il 51% degli italiani «non si sente legato all’Unione europea» (la quota media in Europa è del 47%). Solo il 40% degli italiani pensa che appartenere all’Unione sia «un bene» (la media europea è al 55%).
Anche il Nord è in crisi. Dopo una raccolta di firme, il Parlamento finlandese dibatterà dell’adesione all’euro. Spiega il deputato Paavo Vayrynen: «Dal 2008 la Svezia è cresciuta dell’8%, mentre noi ci siamo contratti del 6%». Al di là della crisi, ed è questo il secondo motivo del successo dei partiti più radicali, i partiti tradizionali non riescono a convincere gli elettori della loro specificità, anche per la scelta di cercare al centro la Neue Mitte o la Third Way, cancellando le differenze tra destra e sinistra.
Si capisce la preccupazione di Bruxelles per il futuro della gestione pratica dell’Unione: nel 2016 si voterà in molti paesi. In Germania, un paese nel quale le paure dell’integrazione di migliaia di rifugiati ha spinto nei sondaggi il partito Alternative für Deutschland al 10%, si voterà a Berlino, nel Meclemburgo-Pomerania Occidentale, nel Baden-Württemberg, nella Renania-Palatinato, e nella Sassonia-Anhalt. Elezioni legislative si terranno in Lituania, in Slovacchia, in Romania, in Irlanda e nella Repubblica Ceca.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Il tempo della guerra e il tempo della storia (di Massimo Campanini)23 novembre 2015, di Federico La Sala
Il tempo della guerra e il tempo della storia
di Massimo Campanini (Il Mulino, 23 novembre 2015)
È venuto il tempo della guerra, pare, ma è venuto anche il tempo della parresia. Del dire la verità. Michel Foucault, nella prolusione di apertura dei suoi corsi al Collège de France nel 1970, come sempre avanzava un’idea geniale ma, come al solito, non arrivava a trarne tutte le conseguenze. Da una parte, infatti, notava giustamente che uno dei più potenti meccanismi di controllo e di esclusione esercitati dal potere nella società contemporanea è quello della manipolazione del discorso e del controllo sulla parola. D’altro canto, l’esigenza che sottende al dire, l’esigenza che spinge gli uomini a parlare è la volontà di verità, ma questa volontà di verità - e qui Foucault sbagliava - avrebbe l’implicazione negativa di alimentare l’esclusione, grazie al suo stesso essere assertivo. In parte ciò è vero, ma se non si cerca la verità, o almeno “una” verità provvisoria, per manifestarla con la parola, come si può riuscire a smascherare il meccanismo del controllo e dell’esclusione?
È quello che accade oggi con l’islam su cui l’unico discorso veramente lecito è quello dell’esecrazione e del sospetto, sulla base della convinzione che si tratti di un pericolo mortale per la civiltà (dell’Occidente ovviamente, come se ce ne fosse una sola). Se volessimo applicare la parresia che viene stimolata dalla volontà di verità, potremmo ritornare alla conoscenza e alla storia, e accorgerci che ciò che sta accadendo a partire dagli anni Novanta del secolo scorso non è l’erompere irrazionale di forze magmatiche che risalgono dalle profondità dell’inferno, di un inferno dove Maometto veniva atrocemente punito da Dante come seminatore di scisma (nel Medioevo l’islam era spesso dipinto come un’eresia cristiana). Il jihadismo invece ha una storia, un perché.
L’opinione pubblica in Occidente si ferma attonita davanti ai suoi morti, ma deve imparare a ragionare freddamente, deve imparare a individuare le radici della malattia per combatterla. E queste radici non stanno nell’intrinseca violenza dell’islam come farneticano alcuni intellettuali, politici e opinion makers. Anche se ci volessimo fermare al testo base, il Corano, disconoscendo le conquiste di scienza, d’arte e di pensiero dell’islam lungo quindici secoli, il Corano contiene sì versetti bellicosi, ma anche versetti come il seguente: «O uomini, invero Noi [è Dio che parla, NdA] vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù perché vi conosceste a vicenda» (49,13). Dunque, il pluralismo e il rispetto reciproco sono voluti da Dio, sono insiti nell’islam.
Pertanto non vale richiamare ridicoli parallelismi tra il Corano e il Mein Kampf, se non si dice la verità storica, se non si formula un discorso storico che smaschera il meccanismo dell’esclusione. Perciò è necessario cominciare col colonialismo tra Ottocento e Novecento, con l’espropriazione violenta della libertà e della cultura dei popoli afro-asiatici (e musulmani) in seguito all’espansione imperialistica. L’impatto violento, attraverso il colonialismo, sulla visione del mondo musulmana da un lato le ha fatto (in parte) smarrire l’identità, dall’altro ha suscitato reazioni di antagonismo anche radicale.
L’atteggiamento colonialista dell’Occidente in realtà non è mai finito, anche dopo che i Paesi musulmani hanno conquistato l’indipendenza. La pesante ingerenza euro-americana in Medioriente, fino agli ultimi anni, dall’Afghanistan all’Iraq alla penisola araba, ha dato una motivazione a Bin Laden nell’organizzare al-Qaeda. Il jihadismo si è poi alimentato nel marasma delle dissoluzioni delle statualità mediorientali, come in Libia, in cui la caduta di Gheddafi è stata determinata decisivamente dall’intervento franco-britannico.
Nello stesso orizzonte si colloca naturalmente la questione israelo-palestinese, una ferita mai sanata dal 1948 (nascita dello Stato di Israele) fino ad oggi, con tutto quanto ha comportato in termini di guerre, destabilizzazione regionale, sradicamento di popoli, fronti del “rifiuto”.
Sul piano interno ai Paesi arabi-musulmani, i regimi dittatoriali - per decenni sostenuti proprio dall’Occidente che ipocritamente predica una democrazia a suo uso e consumo - hanno annientato la società civile, rendendola fragile e incapace di sviluppare anticorpi efficaci contro la negazione dei diritti. E infine, last but not least, una devastante crisi economica e sociale, favorita dall’applicazione di un liberismo selvaggio, iniziata già a partire dalla fine degli anni Settanta, ha depauperato le classi medio-basse.
In questo humus, la propaganda aggressiva di predicatori estremisti, il richiamo al jihad di organizzazioni spesso, se non create, alimentate per fini egemonici da Paesi strategicamente importanti (leggi l’Arabia Saudita), l’insipienza della strategia occidentale (leggi la miope emarginazione dell’Iran) e le stesse divisioni interne tra i Paesi chiave (come gli Stati Uniti e la Russia) hanno preparato il terreno a un incancrenirsi del jihadismo che rischia di affascinare ampi settori di popolazione, soprattutto giovanile, disadattata e in cerca di un Welfare che la società di mercato non offre più.
La parresia storica dunque fornisce una chiave di interpretazione credibile e non semplicistica. La ponderazione degli elementi che compongono questo quadro, la correzione delle storture che ne emergono sono gli unici veri mezzi per andare alle radici di quello che chiamiamo, con un termine che non spiega nulla, ma si limita ad accrescere spavento e insicurezza, “terrorismo”. A ciò dovranno aggiungersi la conoscenza e l’educazione, nelle scuole, nelle università, nei mass-media che plasmano l’opinione pubblica ma che finora consentono, come diceva Foucault, un solo tipo di discorso lecito.
-
> RIPENSARE L’EUROPA!!! Una "memoria" --- Serve una cultura di pace. Ma per parlare di pace bisogna bloccare la vendita di armi agli Stati da cui si riforniscono l’Isis e i suoi vassalli (di Guido Viale).18 novembre 2015, di Federico La Sala
Serve una cultura di pace, oggi è minoritaria
Guerra. Coloro che invocano un altro conflitto europeo in Siria e in Libia resuscitando le invettive di Oriana Fallaci, che speravamo sepolte, contro l’ignavia europea, non si rendono conto dei danni inflitti a quei paesi e a quelle moltitudini costrette a cercare una via di scampo tra noi; né dell’effetto moltiplicatore di una nuova guerra
di Guido Viale (il manifesto, 18.11.2015)
La guerra non è fatta solo di armi, eserciti, fronti, distruzione e morte. Comporta anche militarizzazione della società, sospensione dello stato di diritto, cambio radicale di abitudini, milioni di profughi, comparsa di «quinte colonne» e, viva iddio, migliaia di disertori e disfattisti, amici della pace. Quanto basta per capire che siamo già in mezzo a una guerra mondiale, anche se, come dice il papa, «a pezzi».
Questa guerra, o quel suo «pezzo» che si svolge intorno al Mediterraneo, è difficile da riconoscere per l’indeterminatezza dei fronti, in continuo movimento, ma soprattutto degli schieramenti.
Se il nemico è il terrorismo islamista e soprattutto l’Isis, che ne è il coagulo, chi combatte l’Isis e chi lo sostiene? A combatterlo sono Iran, Russia e Assad, tutti ancora sotto sanzione o embargo da parte di Usa e Ue; poi i peshmerga curdi, che sono truppe irregolari, ma soprattutto le milizie del Rojava e il Pkk, che la Turchia di Erdogan vuole distruggere, e Hezbollah, messa al bando da Usa e Ue, insieme al Pkk, come organizzazioni terroristiche.
A sostenere e armare l’Isis, anche ora che fingono di combatterlo (ma non lo fanno), ci sono Arabia Saudita, il maggiore alleato degli Usa in Medioriente, e Turchia, membro strategico della Nato. D’altronde, ad armare l’Isis al suo esordio sono stati proprio gli Stati uniti, come avevano fatto con i talebani in Afghanistan. E se la Libia sta per diventare una propaggine dello stato islamico, lo dobbiamo a Usa, Francia, Italia e altri, che l’hanno fatta a pezzi senza pensare al dopo. Così l’Europa si ritrova in mezzo a una guerra senza fronti definiti e comincia a pagarne conseguenze mai messe in conto.
La posta maggiore di questa guerra sono i profughi: quelli che hanno varcato i confini dell’Unione europea, ma soprattutto i dieci milioni che stazionano ai suoi bordi: in Turchia, Siria, Iran, Libano, Egitto, Libia e Tunisia; in parte in fuga dalla guerra in Siria, in parte cacciati dalle dittature e dal degrado ambientale che l’Occidente sta imponendo nei loro paesi di origine. Respingerli significa restituirli a coloro che li hanno fatti fuggire, rimetterli in loro balìa; costringerli ad accettare il fatto che non hanno altro posto al mondo in cui stare; usare i naufragi come mezzi di dissuasione.
Oppure, come si è cercato di fare al vertice euro-africano di Malta, allestire e finanziare campi di detenzione nei paesi di transito, in quel deserto senza legge che ne ha già inghiottiti più del Mediterraneo; insomma dimostrare che l’Europa è peggio di loro. Ma respingerli vuol dire soprattutto farne il principale punto di forza di un fronte che non comprende solo l’Isis, le sue «province» vassalle ormai presenti in larga parte dell’Africa e i suoi sostenitori più o meno occulti; include anche una moltitudine di cittadini europei o di migranti già residenti in Europa che condividono con quei profughi cultura, nazione, comunità e spesso lingua, tribù e famiglia di origine; e che di fronte al cinismo e alla ferocia dei governi europei vengono sospinti verso una radicalizzazione che, in mancanza di prospettive politiche, si manifesta in una «islamizzazione» feroce e fasulla.
Un processo che non si arresta certo respingendo alle frontiere i profughi, che per le vicende che li hanno segnati sono per forza di cose messaggeri di pace. Troppa poca attenzione è stata dedicata invece alle tante stragi, spesso altrettanto gravi di quella di Parigi, che costellano quasi ogni giorno i teatri di guerra di Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, Nigeria, Yemen, ma anche Libano o Turchia. Non solo a quelle causate da bombardamenti scellerati delle potenze occidentali, ma anche quelle perpetrate dall’Isis e dai suoi sostenitori, di Stato e non, le cui vittime non sono solo yazidi e cristiani, ma soprattutto musulmani. «Si ammazzano tra di loro» viene da pensare a molti, come spesso si fa anche con i delitti di mafia. Ma questo pensiero, come quella disattenzione, sono segni inequivocabili del disprezzo in cui, senza neanche accorgercene, teniamo un’intera componente dell’umanità.
È di fronte a quel disprezzo che si formano le «quinte colonne» di giovani, in gran parte nati, cresciuti e «convertiti» in Europa, che poi seminano il terrore nella metropoli a costo e in sprezzo delle proprie come delle altrui vite; e che lo faranno in futuro sempre di più, perché i flussi di profughi e le cause che li determinano (guerre, dittature, miseria e degrado ambientale) non sono destinati a fermarsi, quali che siano le misure adottate per trasformare l’Europa in una fortezza (e quelle adottate o prospettate sono grottesche, se non fossero soprattutto tragiche e criminali).
Coloro che invocano un’altra guerra dell’Europa in Siria, in Libia, e fin nel profondo dell’Africa, resuscitando le invettive di Oriana Fallaci, che speravamo sepolte, contro l’ignavia europea, non si rendono conto dei danni inflitti a quei paesi e a quelle moltitudini costrette a cercare una via di scampo tra noi; né dell’effetto moltiplicatore di una nuova guerra. Ma in realtà vogliono che a quella ferocia verso l’esterno ne corrisponda un’altra, di genere solo per ora differente, verso l’interno: militarizzazione e disciplinamento della vita quotidiana, legittimazione e istituzionalizzazione del razzismo, della discriminazione e dell’arbitrio, rafforzamento delle gerarchie sociali, dissoluzione di ogni forma di solidarietà tra gli oppressi. Non hanno imparato nulla da ciò che la storia tragica dell’Europa avrebbe dovuto insegnarci.
Una politica di accoglienza e di inclusione dei milioni di profughi diretti verso la «fortezza Europa», dunque, non è solo questione di umanità, condizione comunque irrinunciabile per la comune sopravvivenza. È anche la via per ricostruire una vera cultura di pace, oggi resa minoritaria dal frastuono delle incitazioni alla guerra. Perché solo così si può promuovere diserzione e ripensamento anche tra le truppe di coloro che attentano alle nostre vite; e soprattutto ribellione tra la componente femminile delle loro compagini, che è la vera posta in gioco della loro guerra.
Nei prossimi decenni i profughi saranno al centro sia del conflitto sociale e politico all’interno degli Stati membri dell’Ue, sia del destino stesso dell’Unione, oggi divisa, come mai in passato, dato che ogni governo cerca di scaricare sugli altri il “peso” dell’accoglienza.
Eppure, fino alla crisi del 2008 l’Ue assorbiva circa un milione di migranti ogni anno (e ne occorrerebbero ben 3 milioni all’anno per compensare il calo demografico). Ma perché, allora, l’arrivo di un milione di profughi è diventato improvvisamente una sciagura insostenibile?
Perché da allora l’Europa ha messo in atto una politica di austerity, a lungo covata negli anni precedenti, finalizzata a smantellare tutti i presidi del lavoro e del sostegno sociale e a privatizzare a man bassa tutti i beni comuni e i servizi pubblici da cui il capitale si ripromette quei profitti che non riesce più a ricavare dalla produzione industriale.
Ma quelle politiche, che non danno più né lavoro né redditi decenti a molti, né futuro a milioni di giovani, non possono certo concedere quelle stesse cose a profughi e migranti. Devono solo costringerli alla clandestinità, per pagarli pochissimo, ridurli in condizione servile, usarli come arma di ricatto verso i lavoratori europei per eroderne le conquiste.
Per combattere questa deriva occorrono non solo misure di accoglienza (canali umanitari per sottrarre i profughi ai rischi e allo sfruttamento degli «scafisti» di terra e di mare, e permessi di soggiorno incondizionati, che permettano di muoversi e lavorare in tutti i paesi dell’Unione); ma anche politiche di inclusione: insediamenti distribuiti per facilitare il contatto con le comunità locali, reti sociali di inserimento, accesso all’istruzione e ai servizi, possibilità di organizzarsi per avere voce quando si decide il futuro dei loro paesi di origine.
Ma soprattutto, lavoro: una cosa che un grande piano europeo di conversione ecologica diffusa, indispensabile per fare fronte ai cambiamenti climatici in corso e alternativo alle politiche di austerity, renderebbe comunque necessaria. Ma per parlare di pace occorre che venga bloccata la vendita di armi di ogni tipo agli Stati da cui si riforniscono l’Isis e i suoi vassalli, che non le producono certo in proprio.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! - CHE FARE? Una nuova Europa finalmente unita e fondata suoi principi fondanti di libertà eguaglianza fraternità (di Augusto Vegezzi)18 novembre 2015
CHE FARE? Noi o loro. *
Sembra che ormai il dibattito infiammi i dialoganti sull’antitesi manichea letta nell’ottica Vita mea mors tua: Noi o loro.
Non è così semplice. Quanto avviene tra Isis e Francia-Europa è un gioco terribile e marginale di giochi più profondi fino agli abissi o vertice della geopolitica e geoeconomica finalmente dominati dai supremi regolatori, la plutocrazia finanziaria. Vedi Piketti.
Tutti i giochi coinvolgano l’umanità, oltre 7 miliardi di singoli, largamente organizzati, manipolati e coatti in complesse stratificazioni socio-economo-politiche ideologiche, etniche, geografiche... La Globalizzazione è un tentativo di Ordine planetario basato essenzialmente sul mercato... dominato ancora dal Minotauro USA , sempre più contestato dal Dragone cinese e dai Brics. Etc.
Che fare? Una grande missione. Solo una nuova Europa finalmente unita e fondata suoi principi fondanti di libertà eguaglianza fraternità con-passione democrazia diretta etc. può superare i conflitti in corso in un processo di Liberazione di tutti gli uomini e tutte le donne.
"Per un periodo ancora indeterminato la storia verrà fatta dalla potenza delle polizie e dalla potenza del denaro, contro l’interesse dei popoli e la verità dell’ uomo. Ma forse proprio per questo è consentita la speranza. Visto che non viviamo più il tempo della rivoluzione, impariamo a vivere il tempo della rivolta" (A. Camus).
Cordialmente. G
*
[Augusto "Gughi" Vegezzi]
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Dopo Parigi. Dopo la «crisi finanziaria» e la «crisi dei rifugiati», la guerra potrebbe uccidere l’Europa (di Etienne Balibar)17 novembre 2015, di Federico La Sala
EditorialeSiamo dentro la guerra
Dopo Parigi. Bisogna rimettere la pace, e non la vittoria, al centro della nostra agenda politica
di Etienne Balibar (il manifesto, 17.11.2015)
Sì, siamo in guerra. O meglio, siamo ormai tutti dentro la guerra. Colpiamo e ci colpiscono. Dopo altri, e purtroppo prevedibilmente prima di altri, paghiamo il prezzo e portiamo il lutto. Ogni persona morta, certo, è insostituibile. Ma di quale guerra si tratta?
Non è semplice definirla, perché è fatta di diversi tipi, stratificatisi con il tempo e che paiono ormai inestricabili. Guerre fra Stato e Stato (o meglio, pseudo-Stato, come «Daesh»). Guerre civili nazionali e transnazionali.
Guerre fra «civiltà», o che comunque si ritengono tali. Guerre di interessi e di clientele imperialiste. Guerre di religione e settarie, o giustificate come tali. È la grande stasis del XXI secolo, che in futuro - ammesso che se ne esca vivi - sarà paragonata a modelli antichi, la Guerra del Peloponneso, la Guerra dei Trent’anni, o più recenti: la «guerra civile europea» fra il 1914 e il 1945.
Questa guerra, in parte provocata dagli interventi militari statunitensi in Medioriente, prima e dopo l’11 settembre 2001, si è intensificata con gli interventi successivi, ai quali partecipano ormai Russia e Francia, ciascun paese con i propri obiettivi. Ma le sue radici affondano anche nella feroce rivalità fra Stati che aspirano tutti all’egemonia regionale: Iran, Arabia saudita, Turchia, Egitto, e in un certo senso Israele - finora l’unica potenza nucleare.
In una violenta reazione collettiva, la guerra precipita tutti i conti non saldati delle colonizzazioni e degli imperi: minoranze oppresse, frontiere tracciate arbitrariamente, risorse minerarie espropriate, zone di influenza oggetto di disputa, giganteschi contratti di fornitura di armamenti. La guerra cerca e trova all’occorrenza appoggi fra le popolazioni avverse.
Il peggio, forse, è che essa riattiva «odi teologici» millenari: gli scismi dell’Islam, lo scontro fra i monoteismi e i loro succedanei laici. Nessuna guerra di religione, diciamolo chiaramente, ha le sue cause nella religione stessa: c’è sempre un «substrato» di oppressioni, conflitti di potere, strategie economiche. E ricchezze troppo grandi, e troppo grandi miserie. Ma quando il «codice» della religione (o della «controreligione») se ne appropria, la crudeltà può eccedere ogni limite, perché il nemico diventa anatema. Sono nati mostri di barbarie, che si rafforzano con la follia della loro stessa violenza - come Daesh con le decapitazioni, gli stupri delle donne ridotte in schiavitù, le distruzioni di tesori culturali dell’umanità.
Ma proliferano ugualmente altre barbarie, apparentemente più «razionali», come la «guerra dei droni» del presidente Obama (premio Nobel per la pace) la quale, ormai è assodato, uccide nove civili per ogni terrorista eliminato.
In questa guerra nomade, indefinita, polimorfa, dissimmetrica, le popolazioni delle «due sponde» del Mediterraneo diventano ostaggi. Le vittime degli attentati di Parigi, dopo Madrid, Londra, Mosca, Tunisi, Ankara ecc., con i loro vicini, sono ostaggi.
I rifugiati che cercano asilo o trovano la morte a migliaia a poca distanza dalle coste dell’Europa sono ostaggi. I kurdi presi di mira dall’esercito turco sono ostaggi. Tutti i cittadini dei paesi arabi sono ostaggi, nella tenaglia di ferro forgiata con questi elementi: terrore di Stato, jihadismo fanatico, bombardamenti di potenze straniere.
Che fare, dunque? Prima di tutto, e assolutamente, riflettere, resistere alla paura, alle generalizzazioni, alle pulsioni di vendetta. Naturalmente, prendere tutte le misure di protezione civile e militare, di intelligence e di sicurezza, necessarie per prevenire le azioni terroristiche o contrastarle, e se possibile anche giudicare e punire i loro autori e complici. Ma, ciò facendo, esigere dagli Stati «democratici» la vigilanza massima contro gli atti di odio nei confronti dei cittadini e dei residenti che, a causa della loro origine, religione o anche abitudini di vita, sono indicati come il «nemico interno» dagli autoproclamatisi patrioti. E poi: esigere dagli stessi Stati che, nel momento in cui rafforzano i propri dispositivi di sicurezza, rispettino i diritti individuali e collettivi che fondano la loro legittimità. Gli esempi del «Patriot Act» e di Guantanamo mostrano che non è scontato.
Ma soprattutto: rimettere la pace al centro dell’agenda, anche se raggiungerla sembra così difficile. Dico la pace, non la «vittoria»: la pace duratura, giusta, fatta non di vigliaccheria e compromessi, o di controterrore, ma di coraggio e intransigenza. La pace per tutti coloro i quali vi hanno interesse, sulle due sponde di questo mare comune che ha visto nascere la nostra civiltà, ma anche i nostri conflitti nazionali, religiosi, coloniali, neocoloniali e postcoloniali. Non mi faccio illusioni circa le probabilità di realizzazione di quest’obiettivo. Ma non vedo in quale altro modo, al di là dello slancio morale che può ispirare, le iniziative politiche di resistenza alla catastrofe possano precisarsi e articolarsi. Farò tre esempi.
Da una parte, il ripristino dell’effettività del diritto internazionale, e dunque dell’autorità delle Nazioni unite, ridotte al nulla dalle pretese di sovranità unilaterale, dalla confusione fra umanitario e securitario, dall’assoggettamento alla «governance» del capitalismo globalizzato, dalla politica delle clientele che si è sostituita a quella dei blocchi. Occorre dunque resuscitare le idee di sicurezza collettiva e di prevenzione dei conflitti, il che presuppone una rifondazione dell’Organizzazione - certamente a partire dall’Assemblea generale e dalle «coalizioni regionali» di Stati, invece della dittatura di alcune potenze che si neutralizzano reciprocamente o si alleano solo per il peggio.
Dall’altra parte, l’iniziativa dei cittadini di attraversare le frontiere, superare le contrapposizioni fra le fedi e quelle fra gli interessi delle comunità, il che presuppone in primo luogo poterle esprimere pubblicamente. Niente deve essere tabù, niente deve essere imposto come punto di vista unico, perché per definizione la verità non preesiste all’argomentazione e al conflitto.
Occorre dunque che gli europei di cultura laica e cristiana sappiano quel che i musulmani pensano circa l’uso della jihad per legittimare avventure totalitarie e azioni terroristiche, e quali mezzi hanno per resistervi dall’interno. Allo stesso modo, i musulmani (e i non musulmani) del Sud del Mediterraneo devono sapere a che punto sono le nazioni del «Nord», un tempo dominanti, rispetto al razzismo, all’islamofobia, al neocolonialismo. E soprattutto, occorre che gli «occidentali» e gli «orientali» costruiscano insieme il linguaggio di un nuovo universalismo, assumendosi il rischio di parlare gli uni per gli altri. La chiusura delle frontiere, la loro imposizione a scapito del multiculturalismo delle società di tutta la regione, questa è già la guerra civile.
Ma in questa prospettiva, l’Europa ha virtualmente una funzione insostituibile, che deve onorare malgrado tutti i sintomi della sua attuale decomposizione, o piuttosto per porvi rimedio, nell’urgenza. Ogni paese ha la capacità di trascinare tutti gli altri nell’impasse, ma tutti insieme i paesi potrebbero costruire vie d’uscita e costruire argini.
Dopo la «crisi finanziaria» e la «crisi dei rifugiati», la guerra potrebbe uccidere l’Europa, a meno che l’Europa non dia segno di esistere, di fronte alla guerra.
E’ questo continente che può lavorare alla rifondazione del diritto internazionale, vegliare affinché la sicurezza delle democrazie non sia pagata con la fine dello Stato di diritto, e cercare nella diversità delle comunità presenti sul proprio territorio la materia per una nuova forma di opinione pubblica.
Esigere dai cittadini, cioè tutti noi, di essere all’altezza dei loro compiti, è chiedere l’impossibile? Forse; ma è anche affermare che abbiamo la responsabilità di far accadere quel che è ancora possibile, o che può tornare a esserlo.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Se ci faremo ipnotizzare dal nemico non perderemo solo la guerra. Molto peggio: perderemo noi stessi, ovvero quel che resta delle nostre libertà.19 novembre 2015, di Federico La Sala
L’analisi
Scacco al terrore in 4 mosse
di Lucio Caracciolo (la Repubblica, 17 novembre 2015)
Per questa battaglia la vittoria non dipende dai carnefici ma dalle vittime. I terroristi non possono vincere. Non hanno i mezzi per sopraffarci, per governarci. La bandiera nera non sventolerà in Piazza San Pietro né in nessuna capitale occidentale. Il nostro destino dipende da noi. I terroristi suicidi vogliono spingerci al suicidio civile e politico, alla “guerra santa”.
Se ci faremo ipnotizzare dal nemico non perderemo solo la guerra. Molto peggio: perderemo noi stessi, ovvero quel che resta delle nostre libertà. Se invece sapremo leggere la cifra di questa sfida e reggere nel tempo agli attacchi con cui i jihadisti cercheranno di convertirci alla loro barbarie, finiremo per averne ragione.
Conviene perciò chiedersi chi siano e quali progetti abbiano i nostri nemici.
I jihadisti sono umani. Certo, usano tecniche disumane. Molti (non tutti) paiono ubriachi di fanatismo. Ma non sono insensibili alla fama, al denaro e al potere. Si occupano anzi di accumularne. In attesa di farsi trovare dalla parte giusta allo scoccare dell’Apocalisse. L’ideologia da fine del mondo è un formidabile magnete, capace di attrarre non solo islamisti radicali emarginati nelle nostre periferie estreme, ma anche figli della buona borghesia europea in cerca di avventura. Persino atei, cristiani, ebrei. A ricordarci quanto fragili e sempre revocabili siano le fondamenta della nostra civiltà.
Sarebbe ingenuo scambiare la propaganda di Abu Bakr al-Baghdadi per strategia. Il califfato universale è un riferimento metapolitico evocato a fini seduttivi da chi sa di non poterlo avvicinare.
L’obiettivo dello Stato Islamico non è la conquista di Roma, di Parigi o di Washington. È anzitutto di radicarsi nel territorio a cavallo dell’ormai inesistente frontiera fra due Stati defunti - Siria ed Iraq - espellendone o liquidandone le minoranze refrattarie al proprio dominio. A cominciare dagli arcinemici: i musulmani sciiti. Da questo Stato in fieri e grazie al suo marchio vincente il “califfato” mira ad espandere la propria influenza nel mondo sunnita.
Nel loro territorio i jihadisti di al-Baghdadi si dedicano a gestire traffici d’ogni genere - dagli idrocarburi ai reperti archeologici, dalle armi alle droghe e agli esseri umani - i cui mercati di sbocco sono tutti in Occidente. Quando ci interroghiamo sui loro finanziatori, alla lunga lista di entità islamiste e petromonarchie sunnite dobbiamo aggiungere noi stessi.
Di qui alcune conseguenze operative per evitare di suicidarci in questo scontro di lungo periodo, che ci impone pazienza, freddezza, capacità di assorbire attacchi e provocazioni.
Primo. Sgombrare il campo dalla retorica militarista. Possiamo e dobbiamo infliggere allo Stato Islamico qualche serio colpo che ne limiti l’aura d’invincibilità. Ma non abbiamo mezzi, uomini e volontà per ingaggiare una grande guerra “stivali per terra” nei deserti mesopotamici. Fra l’altro, è proprio quanto il “califfo” vorrebbe facessimo, certo di sconfiggerci sul terreno di casa, o almeno di conquistarsi un martirio che scatenerebbe per generazioni schiere di seguaci disposti a seguirne l’esempio.
Secondo. Definire il campo degli amici e dei nemici. Il nemico è chiaro: il jihadismo in generale e lo Stato Islamico, sua attuale epifania di successo, in particolare. Il nemico del nemico è altrettanto palese: l’islam sciita, ovvero l’Iran e i suoi alleati a Baghdad, Damasco e Beirut, e in prospettiva gli stessi regimi sunniti, Arabia Saudita in testa, che hanno alimentato i seguaci del “califfo”. Meno definito il quadro occidentale. Alcuni di noi - americani e britannici su tutti - hanno flirtato col jihadismo. Spesso lo hanno armato e finanziato per provvisori fini propri, salvo poi perdere il controllo del mostro che avevano contribuito a nutrire. Le priorità sono dunque due: ricompattare gli atlantici e comunicare ai sauditi e alle altre cleptocrazie del Golfo che il tempo del doppio gioco è scaduto. In questa battaglia non c’è posto per un “mondo di mezzo”, che con una mano istiga con l’altra ostenta di reprimere l’idra jihadista. Infine, è ovvio che su questo scacchiere russi e iraniani sono risorse, non avversari. Fare la guerra fredda a Putin e la guerra calda al “califfo”, insieme trattando i persiani da appestati, è poco intelligente.
Terzo. Serrare le file fra tutti gli alleati sul fronte dell’intelligence e delle polizie. Siamo lontani da un’effettiva cooperazione. Un esempio per tutti. Il giorno prima della catena di attentati a Parigi i carabinieri del Ros, insieme alle polizie britannica, norvegese, finlandese, tedesca e svizzera, avevano messo le mani su una rete di sedici jihadisti curdi e un kosovaro, dopo un’indagine di cinque anni condotta soprattutto sulla Rete (“Operazione Jweb”). A coordinare i terroristi era il famigerato mullah Krekar. Non da chissà quale anfratto mediorientale, ma dal suo carcere norvegese. Appartamento di tre stanze e servizi, dal quale - grazie ai laschi standard norvegesi - era in costante contatto in codice via Internet con i suoi diciassette apostoli, e chissà quanti altri. Finché i partner europei e atlantici continueranno a muoversi ciascuno per suo conto e con i suoi metodi, sarà arduo prevenire gli attacchi terroristici.
Quarto, ma non ultimo per rilievo. Resistere alle tentazioni razziste, rilanciate da media in cerca di visibilità. Le equazioni arabo musulmano=terrorista e (peggio) rifugiato=jihadista oltre che false sono pericolose. Manna per la propaganda “califfale”. E conferma che sul decisivo fronte della comunicazione spesso siamo i peggiori nemici di noi stessi.
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! - GIUBILEO. Parolin: "L’Anno Santo sarà aperto ai musulmani". I fatti di Parigi non cambiano l’agenda del Papa16 novembre 2015
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
- Eu-angélo e UmaNITA’. In principio era l’amore pieno di grazia ("charitas"), non pieno di interesse ’mammonico’ ("caritas")!!!
 95 TESI? FORSE NE BASTA UNA SOLA! Per un nuovo CONCILIO, la ’sollecitazione’ di una ’vecchia’ riflessione
95 TESI? FORSE NE BASTA UNA SOLA! Per un nuovo CONCILIO, la ’sollecitazione’ di una ’vecchia’ riflessione
Giubileo, Parolin: "L’Anno Santo sarà aperto ai musulmani"
Il segretario di Stato Vaticano ribadisce che non ci sarà nessun passo indietro: "Lanciamo l’offensiva della misericordia. I fatti di Parigi non cambiano l’agenda del Papa". Bagnasco: "Non rispondiamo a violenza con altra violenza" *
CITTA’ DEL VATICANO - Rispondere alla violenza con la misericordia e l’accoglienza. Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ribadisce che il Giubileo (dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016) si farà, come aveva detto già il portavoce della Santa Sede Padre Lombardi, e che, anzi, accoglierà anche i musulmani: "Nel mondo lacerato dalla violenza, è il momento giusto per lanciare l’offensiva della misericordia" ha detto il cardinale in un’intervista al giornale cattolico francese La Croix. "Si può capire che dopo gli attentati ci sono sentimenti di vendetta ma bisogna davvero combatterli. Il Papa vuole che il Giubileo serva alle persone per incontrarsi, comprendersi e superare l’odio", spiega il segretario di Stato Vaticano. Dopo gli attentati, questa finalità esce rafforzata. Riceviamo la misericordia di dio per adottare questo atteggiamento verso gli altri. La misericordia è anche il più bel nome di dio per i musulmani, che possono essere coinvolti in questo Anno Santo, come l’ha voluto il Papa".
Gli attentati in Francia mostrano che "nessuno può considerarsi escluso dal terrorismo. Il Vaticano può essere un bersaglio per il suo significato religioso. Siamo in grado di aumentare il livello delle misure di sicurezza in Vaticano e nei dintorni. Ma non ci lasciamo paralizzare dalla paura" prosegue Parolin. "Questi fatti non cambiano niente nell’agenda del Papa".
Il cardinale è fermo nella condanna della violenza: "Non è possibile tollerare la violenza indiscriminata" e dunque, come ha detto il Papa lo scorso anno, è possibile fermare l’aggressore ingiusto. Parolin cita al proposito il Catechismo della Chiesa Cattolica, spiegando che per uno Stato è giusto difendersi, proteggere i suoi cittadini e respingere i terroristi. Ma "nel caso di un intervento dall’esterno, occorre cercare la legittimazione attraverso le organizzazioni che la comunità internazionale si è data".
Per rispondere a quanto è accaduto a Parigi "abbiamo bisogno di una mobilitazione generale in Francia, in Europa e in tutto il mondo. Una mobilitazione di tutti i mezzi di sicurezza, della polizia e delle forze di intelligence per sradicare il male del terrorismo. Ma anche una mobilitazione che dispieghi tutte le risorse spirituali per dare una risposta positiva al male. Ciò richiede l’educazione al rifiuto dell’odio, per dare risposte ai giovani che scelgono la jihad. Dobbiamo convocare tutti gli attori, politici e religiosi, nazionali e internazionali. Dobbiamo davvero fare uno sforzo per lottare e combattere insieme. Senza questa unità, questa battaglia, molto dura, non sarà vinta. Ed è necessario coinvolgere gli attori musulmani. Devono essere parte della soluzione".
I fatti di Parigi non devono spaventare e non devono fare reagire con violenza. L’arcivescovo di Genova e presidente della Cei Angelo Bagnasco invoca una maggiore vigilanza sì ma non una chiusura: "La strage di Parigi è un altro fatto dolorosissimo che mette inquietudine, ma che non deve spaventare l’Europa, né tanto meno la Francia a cui esprimo, come presidente dei vescovi italiani, tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza. Reagire alla violenza con altra violenza non risolverebbe nulla, ma moltiplicherebbe soltanto l’odio. La reazione deve essere quella di una maggiore vigilanza, che ritengo sia possibile in un senso di compattezza del popolo, non per rinchiudersi ma per continuare a vivere con fiducia".
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- ’Ecco perché quel titolo istiga a odio e razzismo’, la lettera di Houda Sboui, scrittrice e docente italo-tunisina, a Belpietro.16 novembre 2015, di Federico La Sala
La scrittrice e docente italo-tunisina
’Ecco perché quel titolo istiga a odio e razzismo’, la lettera della scrittrice tunisina a Belpietro *
Houda Sboui (* ADNKRONOS, Pubblicato il: 16/11/2015
"Caro Maurizio, io e te non ci conosciamo. Tu sei italiano di nascita, io ho ottenuto la cittadinanza italiana più di quindici anni fa. Infatti, sono tunisina, musulmana e mi sono trasferita in Italia all’età di 23 anni per sposare mio marito, cattolico, dal quale abbiamo una figlia nata e cresciuta in Italia". Inizia così la lettera aperta scritta da Houda Sboui, studiosa e scrittrice tunisina di cittadinanza italiana, dopo il titolo ’Bastardi islamici’ pubblicato dal quotidiano Libero all’indomani dell’attentato di Parigi.
"Mia figlia è senza religione. Crede soltanto in un solo Dio. Un Dio che nessuno vede, che nessuno tocca eppure, ci crede e ci crediamo. In giro per il mondo, ci sono tantissime famiglie come la mia. Semplici famiglie che vivono giorno per giorno tutte le difficoltà della vita per dare il meglio ai figli", scrive Houda, autrice del libro ’Un ricordo per Jamal’, esperta in marketing, docente di lingua e civiltà araba nella scuola media di Palermo, ma anche autrice di uno studio comparato di legislazione tunisina ed europea, con particolare riguardo al diritto di famiglia islamico. "Per insegnare loro, valori come l’onestà, il rispetto, l’integrità e la tolleranza. Mi ricordo che a Tunisi, nella mia scuola elementare studiavamo Educazione Civica. Ci riempivano la testa di concetti come: rispettare il diverso, accettare le differenze, aiutare gli anziani e i malati, rispettare i genitori, la lista è lunga. Ed è esattamente quel che ho cercato di trasmettere a mia figlia", scrive la docente nella lettera affidata all’Adnkronos.
"Quel che accade oggi in nome dell’Islam mi fa riflettere molto. Poiché, persone come lei, intellettuali, intelligenti, colti e soprattutto giornalisti di professione, hanno una marcia in più rispetto a noi, semplici cittadini che viviamo lavorando e ascoltando le ’notizie’ che ci comunicate - scrive Houda - Notizie che prendiamo per ’vere’, poiché nel nostro immaginario collettivo sono ’verificate’ e ’fondate’. Eppure, mi rendo conto, che c’è sempre da parte vostra quel desiderio di colpire l’opinione pubblica con un titolo, che sai bene in fondo a te stesso, che è molto offensivo e soprattutto pericoloso. Pericoloso, quando viene percepito dal semplice lettore che non vuole approfondire l’argomento e non vuole addentrarsi in una materia così complessa come lo è l’Islam. Un titolo pericoloso che istiga all’odio e al razzismo. In fondo, con questo titolo, tu hai raggiunto il tuo obiettivo: sei in prima pagina, sui social è partita una petizione per radiarti dall’Albo dei giornalisti, hai venduto tante copie, sei sulla bocca di tutti, hai fatto simpatia a tanti che non ne possono più di avere gli immigrati sul territorio, per farla breve: hai colpito".
"Purtroppo, hai tralasciato un aspetto fondamentale che mette veramente in discussione la libertà di espressione - aggiunge Houda Sboui - Hai superato quella linea rossa necessaria, che distingue un bravo giornalista da un semplice giornalista divorato solo dalla voglia di vendere e raccogliere più denaro che può. Un giornalista che fa fatica a restare in prima linea e fa di tutto per essere in prima pagina. Capisco. È legittimo. Però, non hai pensato un attimo che hai fatto il gioco dei terroristi. Con il tuo titolo, hai dato loro la possibilità di sentirsi forti, bravi, intelligenti, perché percepiscono nell’opinione pubblica quel timore che indirettamente filtra da quel titolo. Che alcuni giornalisti, anziché andare fino in fondo e cercare la “vera verità” sul nuovo ordine mondiale, si lasciano andare a delle conclusioni superficiali, che fanno effetto sul momento e poi svaniscono nel nulla".
"Caro Maurizio, il tuo titolo come dicevo mi fa solo riflettere. Riflettere parecchio se insegni questo ai tuoi figli. Il tuo titolo mi preoccupa, perché, a mio avviso, non sei andato alla ricerca della vera notizia. Hai solo dato importanza ai terroristi - aggiunge nella lettera a Belpietro Houda Sboui - Ti invito, da musulmana molto tollerante, a rivedere la tua posizione in merito al Mondo di Oggi. T’invito a considerare il discorso del Presidente Putin all’occasione del Summit annuale di Valdai1, tenutosi dal 19 al 22 ottobre 2015. Un discorso, che l’editorialista dell’Asia Times, Pepe Escobar ritiene ’un discorso che merita di essere accolto con favore da tutto il mondo, in quanto espressione di ’politica vera”.
"Ti invito a rettificare il tiro e a chiedere scusa ai tanti musulmani che vivono in Italia e che giorno dopo giorno, insegnano ai loro figli il rispetto e la tolleranza. Ai tanti italiani che vogliono vivere in Pace e che costruiscono giorno dopo giorno un percorso di dialogo e fratellanza con i tanti stranieri che vivono in Italia - aggiunge - Ricordati che abbiamo sulla nostra coscienza, noi, i genitori di oggi, il dovere di lasciare un mondo in Pace ai ragazzi. Loro devono imparare a vivere insieme, l’uno nel rispetto dell’altro. Non puoi, solo perché hai in mano un potere straordinario, distruggere con un Titolo simile, anni e anni di integrazione e rispetto. Ancora di più se sono stati costruiti con fatica e difficoltà. Dimostra quanto sei grande facendo un piccolo passetto indietro. Sarai sicuramente apprezzato":
"’Bastardi Islamici’ mortifica i tanti italiani e i tanti musulmani per bene. ’Bastardi Islamici’ suona come “una chiamata alla guerra” e credimi, il mondo oggi, non ne ha bisogno - conclude la tunisina Houda Sboui -Cosa c’è meglio del dialogo e del confronto pacifico? Cosa c’è meglio della serenità e della fratellanza? E’ vero, sono concetti oramai seppelliti dal Dio Denaro, ma siamo esseri umani, e come tali, facciamo il nostro destino e insegniamo ai nostri figli di fare anche il loro. Quindi, la vita è nelle nostre mani, il mondo è nelle nostre mani e se vogliamo un mondo migliore, sicuramente, noi uomini lo possiamo ottenere. Tutto dipende da noi".
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- "La Francia è in guerra". Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande a Versailles davanti le Camere riunite16 novembre 2015
Parigi: la Francia si ferma, un minuto di silenzio. Hollande: "La Francia è in guerra"
Oggi riaperte le scuole
Redazione ANSA ROMA
 16 novembre 2015 17:18
16 novembre 2015 17:18"La Francia è in guerra". Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande a Versailles davanti le Camere riunite dopo gli attentati di Parigi.
La Francia si ferma, un minuto di silenzio - Tutta la Francia si è fermata per un minuto a mezzogiorno in memoria delle 129 vittime degli attacchi terroristici di venerdì sera a Parigi. Lo riferiscono i media francesi. Questa mattina hanno riaperto tutte le scuole, la riapertura di musei, teatri e altri luoghi di cultura è previsto per le 13.
La Francia si è fermata per un minuto di silenzio in ricordo delle vittime degli attentati di Parigi. Il presidente francese Francois Hollande ha osservato il minuto di silenzio dalla Sorbonne, al termine del quale ha intonato la Marsigliese insieme al congresso riunito a Versailles.
Marsigliese dopo un minuto di silenzio alla scuola ebraica - Prima un lungo e intenso minuto di silenzio. Poi il canto della Marsigliese, a pieni polmoni. E alla fine un lungo applauso. Il ricordo delle vittime degli attacchi di venerdì tra i ragazzi della scuola ebraica ’Ecole de Tavail’, nel cuore di Marais, ha un sapore tutto speciale. L’istituto di rue de Rosiers si trova a due passi dal ristorante Goldemberg, dove nel ’92 un commando terrorista uccise sei persone. Fondato nel 1852, ospita 150 allievi, metà di religione ebraica, 30% musulmani, 20% cattolici. Un esempio di convivenza e di tolleranza.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- PARIGI. Il pericolo dello «stato di emergenza» (di Raffaele K Salinari)16 novembre 2015, di Federico La Sala
- "STATO DI EMERGENZA" E "STATO DI PERICOLO": GUARIRE LA NOSTRA TERRA... UNA NOTA SULLE TESI DI FILOSOFIA DELLA STORIA DI WALTER BENJAMIN
EditorialeIl pericolo dello «stato di emergenza»
di Raffaele K Salinari (il manifesto, 16.11.2015)
È scattato a seguito degli attentati terroristici di Parigi lo «stato di eccezione». Una condizione che nelle democrazie occidentali è, e deve, restare una misura contingente, ma che rischia invece di diventare la modalità attraverso la quale non solo si cerca di governare l’avvenimento eccezionale ma si normalizza l’andamento democratico in nome della sicurezza nazionale.
L’istituto dello «stato di eccezione» è antico quanto il potere stesso; nell’impero romano esisteva già lo iustitium, cioè la sospensione del diritto durante il periodo che intercorreva tra la morte dell’imperatore e la nomina del successore. In quel periodo non c’era legge dato che era l’imperatore stesso ad essere la legge. Dunque un «momento extragiudiziario», come lo definisce Carl Schmitt nella sua Politische Teologie del 1922, il testo di riferimento per la Costituzione nazista che sugli stati extragiudiziari edificherà il Reich. Carl Schmitt identifica dunque lo «stato di eccezione» con la definizione stessa di potere sovrano.
Sostiene Giorgio Agamben che l’essenziale contiguità fra «stato di eccezione» e sovranità, come viene definita da Carl Schmitt, non ha ancora portato a una vera e propria teoria dello «stato di eccezione», che dunque manca nel diritto pubblico, per cui i giuristi sembrano considerare il problema più come una quaestio facti che come un serio problema giuridico.
Da parte sua, riferendosi proprio ai pericoli che implica questa mancanza definitoria, Jacob Taubes nel suo La teologia politica di San Paolo, argomenta in questo modo l’incipit della Teologia Politica di Carl Schmitt: «Il libro inizia con uno squillo di trombe: ‘Sovrano è colui che decide sullo stato di eccezione’. Qui scrive un giurista non un teologo, ma non si tratta di un elogio della secolarizzazione, piuttosto del suo smascheramento. Il diritto statuale non sa ciò che dice poiché lavora con concetti il cui fondamento, le cui radici, gli sono ignoti... Su questa premessa Schmitt analizza la letteratura giuridica, poiché in effetti è un giurista e sa circoscrivere il proprio ambito. Alla fine del saggio scrive: ‘sarebbe prova di un razionalismo coerente dire che l’eccezione non dimostra nulla e che solo la normalità può essere oggetto dell’interesse scientifico. L’eccezione turba l’unità e l’ordine dello schema razionalistico. Nella dottrina dello Stato positivista si trova spesso un simile modo di argomentare. Alla domanda su come si debba procedere in mancanza di una legge naturale, Anschutz risponde che ciò non costituisce affatto una questione giuridica’».
Continua Taubes: «Qui si palesa non tanto una lacuna nella legge, cioè nel testo della costituzione, quanto una lacuna nel diritto, che nessuna operazione concettuale della giurisprudenza è in grado di colmare. Il Diritto si ferma qui». E ancora Taubes commentando il passo di Schmitt: «Questo si legge nel testo di Anschutz il più grande giureconsulto della sua generazione, ‘Il diritto si ferma qui’. Nel momento decisivo, egli sostiene, il diritto statutale non ha più nulla da dire, incredibile!».
E prosegue con quella parte della citazione di Schmitt che più ci interessa: «Ma proprio una filosofia della via concreta non può tirarsi indietro di fronte all’eccezione ed al caso estremo, ma deve anzi dimostrare il massimo interesse nei suoi confronti. Per essa l’eccezione può essere più importante della regola, non in base ad un’ironia romantica per la paradossalità, ma con tutta la serietà di un giudizio che va più a fondo delle palesi generalizzazioni di ciò che mediamente si ripete. L’eccezione è più interessante del caso normale. La normalità non comprova nulla, l’eccezione comprova tutto; non solo essa conferma la regola, ma la regola stessa vive solo dell’eccezione. Nell’eccezione la forza della vita reale spacca la crosta di una meccanica irrigidita nella ripetizione. Lo ha affermato un teologo protestante, dando prova dell’intensità vitale di cui la riflessione teologica sa essere capace nel XIX secolo: ‘L’eccezione spiega il caso generale a se stessa. E se si vuole studiare correttamente il caso generale è sufficiente ricercare una sua eccezione. Essa porta alla luce tutto più chiaramente dello stesso caso generale».
Ecco allora il pericolo di dichiarare lo «stato di emergenza» in un momento così fragile per gli equilibri democratici non solo francesi ma europei.
Bisogna che i democratici si preparino ad evitare che questa situazione venga estesa oltre i limiti del dovuto, cioè la necessità di individuare gli attentatori di Parigi, e non venga invece utilizzata come cornice extragiudiziaria per normalizzare altre libertà repubblicane, come la libera circolazione delle persone o gestire con mezzi eccezionali i flussi migratori e quant’altro attiene alla globalizzazione in un mondo di guerra permanente.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- L’ AMORE EVANGELICO ("CHARITAS"), IN FRANCESE, E’ "CHARITÈ"! TORNARE ALLE "COSE STESSE", A NOI STESSI E A NOI STESSE. .15 novembre 2015
Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. AMORE EU-ANGELICO (" CHARITAS"), IN FRANCESE E’ "CHARITÈ", MA IN VATICANO SCRIVONO "DEUS CARITAS EST" E "DIEU EST AMOUR". CHE CONFUSIONE!!! E CHE "LATINORUM"!!!
AMORE EU-ANGELICO (" CHARITAS"), IN FRANCESE E’ "CHARITÈ", MA IN VATICANO SCRIVONO "DEUS CARITAS EST" E "DIEU EST AMOUR". CHE CONFUSIONE!!! E CHE "LATINORUM"!!! TORNARE ALLE "COSE STESSE" (HUSSERL): ANDARE A NOI STESSI, A NOI STESSE.
TORNARE ALLE "COSE STESSE" (HUSSERL): ANDARE A NOI STESSI, A NOI STESSE.
 NOTE SULLA VIA DELLA VITA, NON DELLA GUERRA E DELLA MORTE.
NOTE SULLA VIA DELLA VITA, NON DELLA GUERRA E DELLA MORTE. -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- IL LOGO DELLA PACE. Con all’interno una Tour Eiffel stilizzata è stata creata dal disegnatore Jean Jullien.14 novembre 2015
Spopola logo pacifista con Tour Eiffel
Non è di Banksy ma l’ha condivisa sui social ed ora è virale
(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Un simbolo della pace disegnato in nero con all’interno una Tour Eiffel stilizzata. Non è di Banksy, come si credeva all’inizio, ma dopo pochi minuti che l’artista l’ha condivisa sui social è diventata virale ed è destinata a diventare il simbolo dell’atrocità e dell’orrore di Parigi e al contempo della voglia di ripartire e del bisogno di pace. L’immagine è stata in realtà creata dal disegnatore francese Jean Jullien, che l’ha pubblicata sul suo sito internet.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! -- Attentati Parigi, Emergency: "Le nostre scelte di guerra ci stanno presentando il conto". Gino Strada cita Brecht.14 novembre 2015
Attentati Parigi, Emergency: "Le nostre scelte di guerra ci stanno presentando il conto".
Gino Strada cita Brecht
di Redazione (L’Huffington Post, 14/11/2015)
"Le nostre scelte di guerra ci stanno presentando il conto di anni di violenza e di distruzione". È questo il riassunto del pensiero dei volontari di Emergency, che all’indomani dei tragici fatti di Parigi, commentano così la strage su Facebook: "Siamo scioccati dal massacro di Parigi. "Ancora una volta colpire la popolazione civile è un gesto disumano e vigliacco", scrivono.
"Vediamo accadere in Europa quello che da anni accade in Afghanistan, in Iraq, in Siria: le nostre scelte di guerra ci stanno presentando il conto di anni di violenza e di distruzione. Diritti, democrazia e libertà sono l’unico modo di spezzare il cerchio della violenza e del terrore".
"L’alternativa è la barbarie che abbiamo davanti e alla quale non possiamo arrenderci", concludono. Un pensiero naturalmente condiviso dal fondatore Gino Strada che per chiarire le sue idee al riguardo cita Bertold Brecht: "La guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente".
Poi la chiosa che è un grido di dolore e di battaglia: "L’unico modo per far finire la violenza è smettere di usarla".
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --Vertice di La Valletta. Diciamo che da ieri la politica della Ue verso l’Africa ha gettato trionfalmente la maschera (di A. Dal Lago)13 novembre 2015, di Federico La Sala
L’Europa getta la mascheradi Alessandro Dal Lago (il manifesto, 13.11.2015)
Al vertice di La Valletta tra i leader europei e africani ha vinto il cinismo globale. Noi vi diamo un miliardo e ottocento milioni di euro e voi ci tenete i migranti lontani dalle coste e dai confini della Ue. Non bastano, hanno rilanciato subito i leader africani, i quali si divideranno però la mancia, anche se nessuno sa di preciso come e quando. Qualche tempo fa, Angela Merkel, che pure aveva suscitato grande scalpore e simpatia dichiarando di aprire le porte della Germania ai profughi siriani, aveva fatto una proposta simile al governo turco, il quale ha risposto più o meno picche. Qual è il senso di questo mercanteggiamento sulla pelle di centinaia di migliaia di esseri umani?
Facciamo un passo indietro. Offrire un po’ di quattrini in cambio delle repressione dei migranti da parte dei paesi «di fuori» è prassi ventennale in Europa. L’allora ministro Dini propose nel 1995 di aprire campi di detenzione per «clandestini albanesi» in Albania. Un’idea così insensata che Tirana la lasciò subito cadere. I governi italiani hanno sempre stipulato trattati di riammissione con Tunisia, Libia ecc., per lo stesso «nobile» motivo e infischiandosene se, con Gheddafi e Ben Alì, i migranti venivano vessati, spogliati di tutto e fatti morire nel deserto. Dal 2000 in poi, la prassi è divenuta normale per l’Unione europea. Diciamo che da ieri la politica della Ue verso l’Africa ha gettato trionfalmente la maschera.
Salvini, Le Pen, Grillo, Pegida ecc. diranno che è troppo poco, ma in fondo ammetteranno che questa è la strada giusta. «Aiutiamoli a casa loro!» non era forse uno slogan di Bossi?
Ora, la realtà, secondo stime della World Bank, è che solo una quota minima di migranti sub-sahariani (il 30% del totale) sceglie di spostarsi verso l’Europa, mentre più della metà migrano verso altri paesi africani e una piccola quota in Asia In altre parole, anche l’Africa è soprattutto terra di immigrazione. Analogamente, gran parte dei rifugiati e profughi di guerra è ospitata non in Europa, ma in Turchia, Giordania, Libia o e così via. Come spiegare allora il vertice di La Valletta?
Si tratta di una sorta di esternalizzazione preventiva, il cui scopo è scaricare sui paesi africani il controllo sia dei loro migranti e profughi, sia di quelli, provenienti dall’Asia, che scegliessero le rotte africane dopo la chiusura delle frontiere mediterranee e balcaniche. E come? In sostanza, incarcerando migranti e profughi, in lager vecchi o nuovi, grazie alla carità pelosa della Ue, in attesa che la situazione in Tunisia, Libia (e Siria) si chiarisca, magari con qualche bombardamento o intervento limitato. D’altronde, niente di nuovo sotto il sole: è da una quindicina d’anni che paesi come il Marocco o la Tunisia allestiscono Cpt a vantaggio dell’Europa.
E così lo scenario che si disegna è quella di un continente di 480 milioni di abitanti che dice di andare in crisi per l’arrivo di alcune centinaia di migliaia di persone, che sigilla le frontiere nei già turbolenti Balcani provocando una crisi dopo l’altra tra Austria, Ungheria, Slovenia, Croazia ecc., che si fa condizionare da nazisti o da gente alleata di Casa Pound, che dice di combattere i trafficanti per tener fuori migranti e profughi - e che soprattutto sta militarizzando il Mediterraneo, intasandolo di fregate e cannoniere, manco fossimo nel caos che ha preceduto la prima guerra mondiale.
Queste centinaia di migliaia di esseri umani in fuga dalla guerra o della fame sono divenuti merce di scambio e ricatto politico tra maggioranze e opposizioni, tra governi europei e potenze emergenti, tra Ue e stati africani o asiatici. Un bambino morto su una spiaggia turca emoziona il mondo, ma l’emozione sfuma in pochi giorni e lascia lo spazio a queste tremende burocrazie europee e statali con le loro organizzazioni e nuove missioni dai nomi dementi, Frontex, Triton, Eunavfor Med e altre che inevitabilmente impareremo a conoscere. Tutte prive di senso rispetto al loro obiettivo sbandierato di salvare vite umane, ma tutte coerenti nel controllare, registrare e internare.
In questo panorama di sigle, dichiarazioni, accordi, leggi prive di senso, facce feroci di ministri e migliaia di poveri annegati, spicca il sorriso vacuo di Renzi. Certo l’Italia non è più sola. È davvero in buona compagnia.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- CAMBIAMENTO POSSIBILE. L’immigrazione e il cambiamento climatico temi centrali del confronto politico per i prossimi decenni.30 ottobre 2015, di Federico La Sala
L’ambiente inquinato degli stati d’Europa
Cambiamento possibile. L’immigrazione e il cambiamento climatico saranno i temi centrali del confronto politico per i prossimi decenni Le prospettive puramente nazionali o istituzionali sono del tutto insufficienti ad intaccare questi problemi
di Guido Viale (il manifesto, 30.10.2015)
Due temi oggi centrali, apparentemente distinti, andrebbero invece connessi in modo diretto.
Primo, la COP 21 di Parigi, forse ultima occasione per un’inversione di rotta sul riscaldamento globale che rischia di rendere irreversibili i cambiamenti climatici già in corso. A questa minaccia abbiamo da tempo contrapposto il programma di una conversione ecologica, sulle tracce di Alex Langer e, ora, anche dell’enciclica Laudato si’ e del libro Una rivoluzione ci salverà dove Naomi Klein spiega che abbandonare i combustibili fossili richiede un sovvertimento radicale degli assetti produttivi e sociali; per questo le destre conservatrici, e non solo loro, sono ferocemente negazioniste. L’aggressione alle risorse della terra si lega alla povertà e alle diseguaglianze del pianeta: sia nei rapporti tra Global North e Global South, sia all’interno di ogni singolo paese: ciò che unisce in un unico obiettivo giustizia sociale e giustizia ambientale.
Secondo, i profughi. La distinzione tra profughi di guerra e migranti economici, su cui i governi dell’Ue stanno costruendo le loro politiche di difesa da questa presunta invasione di nuovi «barbari», non ha alcun fondamento: entrambi sono in realtà «profughi ambientali», perché all’origine delle condizioni che li hanno costretti a fuggire dai loro paesi, cosa che nessuno fa mai volentieri, c’è una insostenibilità provocata dai cambiamenti climatici, dal saccheggio delle risorse locali, dalla penuria di acqua, dall’inquinamento dei suoli, tutti fenomeni in larga parte prodotti dall’economia del Global North. Il problema occuperà tutto lo spazio del discorso politico e del conflitto nei prossimi anni. E, nel tentativo di scaricarsene a vicenda l’onere, sta dividendo tra loro i governi dell’Unione europea che avevano invece trovato l’unanimità nel far pagare alla Grecia la sua ribellione contro l’austerità. L’Ue, non come istituzione, e neanche nei suoi confini, bensì come ambito di un processo sociale, culturale e politico che abbraccia insieme all’Europa tutto lo spazio geografico e politico coinvolto da questi flussi, deve restare un punto di riferimento irrinunciabile per una prospettiva politica che, rinchiusa a livello nazionale, non ha alcuna possibilità di affermarsi.
Coloro che si sono riuniti per affermare un loro posizionamento riassunto nelle formule «No all’euro, No all’UE, No alla Nato» (declinate in termini di sovranità nazionale, anche con lo slogan «Fuori l’Italia dalla Nato», che lascia da parte l’Europa) si sono dimenticati dei profughi. Nella loro prospettiva a fronteggiare i flussi presenti e futuri, sia con i respingimenti che con l’accoglienza, resterebbero solo gli unici due punti di approdo di questo esodo: Italia e Grecia. Ma mentre l’Europa nel suo complesso avrebbe le risorse per farvi fronte, l’Italia, con una recuperata sovranità - posto che la cosa abbia senso e sia realizzabile - ne rimarrebbe schiacciata: il che forse rientra tra le opzioni della governance europea, non tra le nostre. Quei flussi migratori stanno però creando una frattura sociale, culturale e politica anche all’interno di ogni paese: tra una componente maggioritaria, ma non ancora vincente, di razzisti, che vorrebbero sbarazzarsi del problema con le spicce, e una componente solidale, oggi minoritaria, ma tutt’altro che insignificante (come lo è invece la maggior parte della sinistra europea).
Tra loro i governi dell’Europa si barcamenano: dopo aver aizzato il loro elettorato, per fidelizzarlo, contro i popoli fannulloni e parassiti che sarebbero all’origine della crisi economica, si rendono ora conto che quel tema gli sta sfuggendo di mano e viene ripreso, in funzione anti-migranti, da forze ben più capaci di loro di metterlo a frutto.
Se per fermare quei flussi bastasse adottare misure molto dure, come barriere, respingimenti, esternalizzazione dei campi, esclusione sociale e carcerazione, probabilmente avrebbero già vinto i nostri antagonisti. Ma le cose non stanno così. Innanzitutto quei profughi e migranti sono già, per molti versi, cittadini europei, perché si sentono tali: vedono nell’Europa la zona forte di un’area molto più vasta, quella dove si manifestano gli effetti dei processi - guerre, dittature, devastazioni, cambiamenti climatici - che li hanno costretti a fuggire.
Pensano all’Europa come a un loro diritto: un sentire che li pone in aperto conflitto con i governi dell’Unione, che di quel diritto non ne vogliono sapere. Per questo sono una componente fondamentale del proletariato europeo che esige un cambiamento di rotta fuori e dentro i confini dell’Unione.
Poi, sigillare la «fortezza Europa» non è semplice: significa addossarsi la responsabilità di una strage continua e crescente che sconfina con una politica di sterminio pianificata e organizzata: un processo già in corso da tempo e taciuto nel suo svolgimento quotidiano. Ma quanti sanno che i morti nei deserti, durante la traversata verso i porti di imbarco, sono più numerosi degli annegati nel Mediterraneo?
Terzo: la chiusura delle frontiere non può che tradursi in feroce irrigidimento degli assetti politici interni: repressione, autoritarismo, disciplinamento e limitazione delle libertà; a complemento delle politiche di austerità.
Infine, in una prospettiva di militarizzazione sociale non c’è spazio per la conversione ecologica e la lotta contro i cambiamenti climatici. Ma il deterioramento di clima e ambiente procederà comunque, trovando la fortezza Europa sempre più impreparata sia in termini di mitigazione che di adattamento.
Per questo accoglienza, inclusione e inserimento sociale e lavorativo dei profughi si innestano sui programmi di conversione ecologica: attraverso diversi passaggi:
- 1. occorre prendere atto che i confini dell’Europa non coincidono né con quelli dell’euro, né con quelli dell’Unione o della Nato, ma abbracciano tutti i paesi da cui provengono i flussi maggiori di migranti: Medio Oriente, Maghreb, Africa subsahariana.
- 2. Occorre saper vedere nei profughi che raggiungono l’Europa, o che sono già insediati in essa, ma anche in quelli malamente accampati ai suoi confini, i referenti - grazie anche ai rapporti che continuano a intrattenere con le loro comunità di origine - di un’alternativa sociale alle forze oggi impegnate nelle guerre, nel sostegno alle dittature e nelle devastazioni dei territori che li hanno costretti a fuggire. Non c’è partigiano della pace migliore di chi fugge dalla guerra; né sostenitore della rinascita del proprio paese più convinto di chi ha subito le conseguenze del suo degrado.
- Dobbiamo vedere nell’inserimento lavorativo dei profughi una componente irrinunciabile della loro inclusione sociale e politica. Per questo occorrono milioni di nuovi posti di lavoro, un’abitazione decente e un’assistenza adeguata sia per loro che per i cittadini europei che ne sono privi. Non bisogna alimentare l’idea che ai profughi siano destinate più risorse di quelle dedicate ai cittadini europei in difficoltà.
La conversione ecologica e, ovviamente, la fine delle politiche di austerità possono rendere effettivo questo obiettivo. I settori in cui è essenziale intervenire sono noti: fonti rinnovabili, efficienza energetica, agricoltura e industria di piccola taglia, ecologiche e di prossimità, gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile, edilizia e salvaguardia del territorio. Oltre agli ambiti trasversali: cultura, istruzione, salute, ricerca.
L’establishment europeo non ha né la cultura, né l’esperienza, né gli strumenti per affrontare un compito del genere; ha anzi dimostrato di non volere accogliere né includere neanche milioni di cittadini europei a cui continua a sottrarre lavoro, reddito, casa, istruzione, assistenza sanitaria, pensioni.
Meno che mai si può affidare quel compito alle forze «spontanee» del mercato. Solo il terzo settore, l’economia sociale e solidale, nonostante tutte le aberrazioni di cui ha dato prova in tempi recenti - soprattutto in Italia, e soprattutto nei confronti dei migranti - ha maturato un’esperienza pratica, una cultura e un bagaglio di progetti in questo campo. Per questo è della massima importanza impegnarsi nella promozione di questi obiettivi, anche utilizzando la scadenza del Forum europeo dell’Economia sociale e solidale a Bruxelles il prossimo 28 gennaio.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- LA MALEDIZIONE DEL MURO. Pensavamo che con il 1989 fosse caduta l’idea di Cortina di ferro (di Angelo Bolaffi).28 ottobre 2015, di Federico La Sala
La maledizione del Muro che perseguita l’Europa
Pensavamo che con il 1989 fosse caduta l’idea di Cortina di ferro. Ecco perché invece la storia si ripete
di Angelo Bolaffi (la Repubblica, 28.10.2015)
La grande speranza si è rivelata una fugace illusione: avevamo creduto che la caduta del Muro di Berlino se non proprio la “fine della storia” avesse, almeno in Europa, segnato la fine dell’età dei muri e dei reticolati di filo spinato. E invece sta accadendo esattamente il contrario. Incapaci di trovare una risposta razionale e solidale alla migrazione di popolazioni che fuggono dalle guerre del Medio Oriente e attraversando i Balcani cercano salvezza nel Vecchio Continente, i governanti dei paesi dell’Est Europa pensano di poter risolvere il problema ricostruendo quella che per più di mezzo secolo era stata causa delle loro sofferenze: una nuova cortina di ferro. Già ma chi è l’autore di questa metafora geopolitica che ha segnato un capitolo fondamentale della storia del secondo dopoguerra in Europa?
È convinzione diffusa che il primo a parlare di cortina di ferro (iron courtain) sia stato Winston Churchill nel discorso tenuto il 5 marzo del 1946 al Westminstern College di Fulton (Missouri) per mettere in guardia l’Occidente e l’opinione pubblica mondiale su quanto stava accadendo nei paesi dell’Europa orientale “liberati” dall’Armata Rossa: «Da Stettino nel Baltico a Trieste nell’Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea si trovano tutte le capitali dei vecchi Stati dell’Europa centrale e orientale. Varsavia, Berlino, Praga, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia».
In realtà il vecchio statista inglese, artefice dell’alleanza antinazista tra i paesi anglosassoni e l’Unione Sovietica di Stalin, si guardò bene - sarebbe stato davvero molto imbarazzante - dal citare la fonte da cui aveva tratto quella formulazione. E soprattutto evitò di fare il nome di chi prima di lui aveva parlato di una cortina di ferro. Era stato il ministro della propaganda nazista Joseph Goebbels che il 26 febbraio del 1945 sulla rivista nazista Das Reich aveva scritto: «Se il popolo tedesco depone le armi, i sovietici, in base agli accordi presi da Roosevelt, Churchill e Stalin, occuperanno tutta l’Europa orientale e sud-orientale assieme a gran parte del Reich. Una cortina di ferro scenderà su questo enorme territorio controllato dell’Unione Sovietica, dietro la quale inizierebbe un massacro di massa col prevedibile plauso della stampa ebraica di Londra e New York».
Ma in realtà neppure Goebbels è il vero autore di questa espressione. Infatti sempre nella stessa rivista Das Reich qualche settimana prima che apparisse l’articolo di Goebbels era uscita firmata “cl Lissabon” una analisi delle conseguenze delle conferenze di Mosca (ottobre del 1944) e di Jalta (inizio di febbraio del 1945). In questo articolo compare per la prima volta quella espressione: «Una cortina di ferro di fatti compiuti dai bolscevichi è scesa su tutta l’Europa sud-orientale nonostante il pellegrinaggio di Churchill a Mosca dinnanzi alla scelta di Roosevelt (...) essa discende inesorabile sull’Europa (...). Il Dipartimento di Stato e il Foreign Office fanno a gara per inventare un qualche marchingegno diplomatico al fine di dare nei loro paesi l’impressione che anche le potenze occidentali in qualche modo collaborino a manovrare la cortina di ferro prima che dietro di essa scompaia tutta l’Europa».
Ma chi c’era dietro la sigla “cl Lissabon”? Già nel lontano 1964 lo storico Karl Heinz-Minuth in un saggio apparso sulla rivista Geschichte in Wissenschaft und Unterricht aveva cercato ma senza successo di venire a capo del mistero. Oggi grazie alle ricerche di Georg Meyer, uno storico di questioni militari, conosciamo il nome dell’autore.
Si tratta di Max Walter Clauss: nato nel 1901 (morì nel 1988), aveva studiato ad Heidelberg presso Alfred Weber e Robert Curtius. Protagonista della vita mondana e dei salotti della Germania di Weimar, Carl Schmitt lo riceveva a casa sua a colazione, aveva rapporti tra gli altri con Carl Jacob Burkhardt (in una lettera del 1971 lo definisce «un uomo, come lei, così politicamente dotato, una personalità ricca di esperienza, del tatto necessario e di savoir vivre»), con Thomas Mann e T.S. Eliot. Quest’ultimo dopo una visita a Londra di Clauss ne parla come mon cher ami et confrère.
Traduttore di Monsieur Test di Valéry (una recente edizione Suhrkamp prende ancora a riferimento questa traduzione), legato alla cerchia politico-culturale cui faceva parte anche Hoffmansthal, Clauss in qualità di redattore della Europäische Revue sostenne la necessità di «rendere cosciente l’unità spirituale dell’Europa». Partecipò alle riunioni di gruppi cattolico-reazionari a Barcellona, Cracovia e anche a Milano dove pur essendo stato invitato Mussolini decise di non farsi vedere.
Divenuto un fervente sostenitore del regime hitleriano Clauss evitò gli anni della guerra e del primissimo dopoguerra lavorando come giornalista nel Portogallo di Salazar del cui regime fece una calda apologia in un saggio apparso in una rivista tedesca.
All’inizio degli anni ’50 fece ritorno diventando un collaboratore del ministro dell’economia Erhard in una Germania nella quale gli ex nazisti continuavano a occupare decisivi posti di potere. Il suo saggio più importante apparve nel 1952 col titolo Il cammino verso Jalta. Responsabilità di Roosevelt. In esso oltre a sostenere che Roosevelt «avrebbe sulla coscienza la responsabilità della guerra» - un «servizio alla vendetta ebraica mondiale» - Clauss continua a difendere la sua tesi reazionaria tipica della Kulturkritik secondo la quale l’Europa avrebbe dovuto contrapporsi sia al bolscevismo che al materialismo americano: «poiché allora il mondo senza di noi sarebbe il mondo ideale per bolscevismo e americanismo, un mondo culturalmente desolato senza storia, barbarico e livellatore, un mondo senza il volto europeo. A questo vero declino dell’Occidente nel XX secolo si contrappone la realtà combattiva dell’Europa». Insomma un manifesto dell’europeismo reazionario che purtroppo ancora oggi continua a circolare presentandosi talvolta come protesta contro “l’imperialismo americano”.
Per fortuna l’idea d’Europa che ha vinto è un’altra: è l’idea che lega i valori europei e il futuro politico del Vecchio Continente alle grandi tradizioni occidentali dell’illuminismo, della rivoluzione americana e francese. E al suo cuore c’è una Germania lontanissima da quella sognata da Clauss. Una nazione che ha appreso a proprie spese che pensare di “vagabondare” tra Occidente e Oriente è una fatale illusione dalle conseguenze catastrofiche. Una Germania, insomma, per dirla col titolo di una magistrale opera dello storico tedesco Heinrich Winkler, che ha percorso «il suo cammino verso Occidente».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Migranti, il salto di qualità che Merkel chiede all’Europa (di Danilo Taino)28 ottobre 2015, di Federico La Sala
Migranti, il salto di qualità che Merkel chiede all’Europa
di Danilo Taino (Corriere della Sera, 28.10.2015)
Angela Merkel ha messo la testa sul ceppo nell’istante stesso in cui, a inizio settembre, ha aperto le porte della Germania, e dunque dell’Europa, a milioni di profughi. Si è presa un rischio di cui nessuno la riteneva capace. Può vincere la sfida, oppure può perderla: si vedrà. In un mondo in cui il cinismo è spesso considerato un segno di modernità e di «realismo», la scelta della cancelliera tedesca viene però commentata molto più per le conseguenze che avrà sul suo (piccolo) destino politico che per quel che veramente è.
Si può discutere sulle ragioni (e sui ritardi) per le quali Frau Merkel ha preso l’iniziativa. E sulla saggezza della scelta. La cosa certa è che si tratta di un game changer consapevole: sin dal primo momento ha sostenuto che il flusso di chi cerca asilo avrebbe trasformato i connotati della Germania e dell’Europa.
È qualcosa che ha cambiato le regole del gioco. In più di un senso. Innanzitutto, ha reso politico un terreno sul quale i governi europei si impegnano solo a parole, quello morale. Per la sua semplicità, la questione arriva al cuore del problema: a chi fugge dalle guerre e da situazioni di alto rischio va dato asilo. Punto. Lascia perplessi come, in molto dibattito, questo aspetto venga trascurato. Viste le critiche (astratte) all’aridità e agli opportunismi della politica dei decenni scorsi, non considerare la portata di questo cambio di prospettiva è piuttosto infelice.
In secondo luogo, l’apertura ha dato una scossa forte a un’Europa che da vent’anni si trascina parlando di moneta e di bilanci degli Stati. È una scelta che mette in gioco l’idea di Ue alla quale ci siamo abituati, che le fa correre dei rischi, che provoca divisioni tra Est e Ovest - come ricordano ogni giorno Jean-Claude Juncker e Donald Tusk.
Ma che, soprattutto, costringe gli europei a misurarsi con un progetto di lungo periodo, quello dell’integrazione di milioni di persone, per lo più di religione islamica, in una delle aree più ricche e istruite del pianeta. Un’impresa di lungo periodo e non scontata: però di grande trasformazione, in un continente che invecchia, e allo stesso tempo inevitabile.
Inevitabile non solo per l’imperativo morale, che se venisse negato provocherebbe una grave involuzione politica e probabilmente conseguenze violente: ma anche perché mette finalmente l’Europa (e la Germania) di fronte alle responsabilità nel mondo globalizzato.
Questo è il terzo cambiamento delle regole gioco. Da almeno due decenni, l’Europa si è chiusa in se stessa, concentrata sulla moneta unica, sulla discussione austerità/spesa pubblica, sulla difesa di qualche settore industriale. Nell’illusione che la Storia fosse davvero finita nel 1989. Prima la crisi ucraina, poi il Medio Oriente - crisi violente ai propri confini - le hanno fatto sapere che non è così.
Bene: l’apertura ai rifugiati della Siria, dell’Iraq, dell’Afghanistan è un passo verso un’Europa che non può più credere di essere una bella addormentata in una foresta popolata da banditi. Non è così, e i rapporti con il resto del mondo, con i vicini e le loro crisi è meglio gestirli piuttosto che venirne gestiti.
L’asticella che l’apertura di Frau Merkel ha fissato è molto alta. Non è detto che l’Europa e la Germania ce la facciano a saltarla. La cancelliera - sottoposta a critiche pesanti in casa - dovrà dimostrare di avere un piano chiaro e di saperlo mettere in pratica: dal punto di vista organizzativo, cosa per ora non scontata, e in un progetto di integrazione che risponda alle paure dei cittadini nei confronti dei diversi in arrivo. L’avere messo la sua testa sul ceppo fa pensare che cercherà di riuscirci.
Andrebbe sostenuta. Molti altri leader - nell’Est europeo ma anche i non pochi David Cameron dell’Europa occidentale - il rischio invece non lo hanno finora preso: attenti, più che agli aspetti morali e geopolitici posti dal flusso dei rifugiati, a non fare piccoli passi falsi. Una sconfitta della cancelliera tedesca, però, sarà anche la loro, anche la nostra.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- IL GIOCO DEI POTENTI. Crimini di guerra (di Tonio Dell’Olio).28 ottobre 2015, di Federico La Sala
Mosaico dei giorniCrimini di guerra
di Tonio Dell’Olio (Mosaico di pace, 27 ottobre 2015)
Sono almeno tre gli errori sulla guerra in Iraq che Tony Blair ammette dodici anni dopo in un’intervista alla Cnn: la non veridicità della presenza delle armi di distruzione di massa, la cattiva pianificazione della guerra e il mancato calcolo delle conseguenze dopo la destituzione di Saddam.
Quanti morti, quanta distruzione, quanta sofferenza hanno provocato quegli errori ammessi oggi con colpevole ritardo?
E poi mi chiedo se basti ammettere gli errori e se non sarebbe più giusto davanti alla storia individuare le responsabilità e processare chi ha causato centinaia di migliaia di morti come si fa con chi commette un omicidio o un furto.
Ma è il gioco dei potenti.
O forse è che siamo abitati dalla tolleranza verso la guerra che stravolge le regole normali per cui le uccisioni in quel caso non sono definiti omicidi ma perdite umane.
Insomma, il paradosso è che la pubblica confessione di un criminale di guerra qui da noi non crea scandalo e nemmeno scalpore. Nemmeno alla luce delle conseguenze ancora più tragiche che quella guerra ha creato di fatto favorendo l’insorgere e il rafforzarsi di altri criminali sotto la bandiera nera dell’IS.
E infine mi chiedo chi ci sta mentendo oggi e quante sono oggi le vittime dei giochi dei potenti?
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- IL DISASTRO DELLA MEMORIA. Ai vertici ecco di nuovo un sovrano assoluto. Un’Unione siffatta ci fa forse uscire dallo Stato nazione, non dall’esperienza fascista9 ottobre 2015, di Federico La Sala
Perdite di memoria in Europa
di Barbara Spinelli *
L’Unione europea è un animale ambiguo, dal punto di vista della memoria e di quella che i tedeschi chiamano politica della memoria.
Da una parte fu il progetto di imparare dal passato, di capire perché nel ‘900 le guerre tra europei avevano raggiunto il culmine della devastazione. Le radici furono individuate nell’osmosi che il fascismo aveva creato tra nazione, Stato, e cittadino. La Stato-nazione era divenuto valore supremo e sovrano assoluto, e ai cittadini veniva tolta ogni sovranità: anch’essi dovevano entrare in osmosi con lo Stato deificato e totalizzante. Il fascismo italiano ideò questo termine - totalitarismo - applicato poi a varie forme di dispotismo. Secondo Giovanni Gentile, uno dei più intelligenti ideologi dell’epoca mussoliniana, “per il fascista tutto è nello Stato e nulla di umano e spirituale esiste e tantomeno ha valore fuori dallo Stato. In tal senso il fascismo è totalitario».
L’Europa unita fu nel dopoguerra il tentativo di superare i tre mali che avevano prodotto il fascismo: la grande crisi economica con la miseria e il furore che essa aveva creato nelle popolazioni; il nazionalismo che doveva assorbire questo furore; infine il colonialismo. Il Manifesto di Ventotene affronta insieme questi tre mali, proponendo non solo un’unità tecnica fra europei ma una democrazia più disseminata e un sistema di protezioni sociali che avrebbe ridotto la solitudine e il risentimento dei cittadini davanti alla miseria. Non dimentichiamo che gli estensori del Manifesto, gli antifascisti Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, proposero un reddito minimo europeo, e che tra i fondatori dell’europeismo originario c’è anche William Beveridge, l’inventore del Welfare State.
Ma l’Europa è stata anche il contrario di tutto questo. Non la memoria viva, ma la sua deliberata negazione. La Germania ovest fu riammessa nell’area delle democrazie come se il nazismo fosse stato un incidente, anche perché simultaneamente fu inserita nella Nato. Il solo fatto di essere nella Comunità la esentava da una politica della memoria che cominciò molto più tardi, negli anni ’60 sulla scia del processo Eichmann e dei movimenti studenteschi.
Fu così che l’Europa fu al tempo stesso lavoro di memoria e amnesia collettiva, non solo in Germania. L’Italia non ha mai lavorato sulla propria memoria: onorò perfino i responsabili della guerra chimica in Etiopia. E a differenza della Germania, che ha chiesto ufficialmente scusa per il bombardamento di Guernica, non si è mai scusata per i bombardamenti di Barcellona durante la guerra di Spagna. La Francia per decenni non ammise la propria collaborazione col nazismo. I primi storici di Vichy furono americani, non francesi. L’Unione è stata anche questo: una specie di patto dell’oblio, di patto della Moncloa.
Non c’è dunque da stupirsi se il passato si banalizza e rivive. L’Europa si sta trasformando oggi in un territorio cosparso di centri di detenzione per migranti senza documenti, e chi ha visitato questi centri ha visto quanto somiglino a campi dove le persone sono concentrate, in attesa di un’esplosione che di sicuro verrà.
L’Europa torna a essere un esercizio in amnesia. Anche in Germania, dove più si è lavorato sul passato, pareti intere di memoria precipitano. I tedeschi hanno ricordi vividi dell’inflazione che colpì la democrazia prima dell’avvento di Hitler, ma hanno completamente dimenticato che una delle cause di tale avvento fu la recessione - antikeynesiana già allora - adottata subito prima dal governo Brüning. Hanno dimenticato che nel dopoguerra parte dei suoi debiti le furono condonati dagli Stati stessi che aveva distrutto (fra essi la Grecia).
Intanto siamo sommersi dalle commemorazioni, ripetitive e sempre più vuote. La cosa più insopportabile sono le chiacchiere sui valori. È Habermas a chiamarle così. Più parliamo di valori, più calpestiamo quel che davvero conta: non i valori in astratto, ma i diritti e le costituzioni.
Il disastro della memoria è questo: dell’Europa antifascista si ricorda solo la parte tecnica del progetto, e la delega di sovranità nazionali si riduce a un fine in sé. Serve a schiacciare ogni altra sovranità: delle nazioni come dei popoli. Ai vertici ecco di nuovo un sovrano assoluto, anche se meno afferrabile: legibus solutus, sciolto dalle leggi, dallo Stato di diritto. Un’Unione siffatta ci fa forse uscire dallo Stato nazione, non dall’esperienza fascista.
* BARBARA SPINELLI.IT giovedì, settembre 24, 2015 (ripresa parziale).
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! -- Distinzione criminale. Perché è irrazionale dividere i profughi dai migranti economici (di Alessandro Dal Lago)9 ottobre 2015, di Federico La Sala
Distinzione criminale
Limiti e strumentalità della proposta Ue
Perché è irrazionale dividere i profughi dai migranti economici
di Alessandro Dal Lago (il manifesto, 09.10.2015)
In un vecchio film di guerra, alcuni soldati in trincea discutono di pace. Il modo migliore per ottenerla - dice uno - è , in caso di controversie tra gli stati, obbligare re e capi di governo a salire con i guantoni sul ring e suonarsele di santa ragione finché uno non vince.
La battuta mi è tornata in mente quando ho letto del piano segreto, elaborato dai ministri degli interni dell’Unione europea, per il rimpatrio di 400.000 migranti «economici».
Giusto per dare un’idea a questi pensosi statisti di che cosa significhi migrare oggi si potrebbe, che so, portarli (a cominciare dall’ineffabile onorevole Alfano) in qualche paese del centro Africa e poi, con un po’ di dollari o Euro raccolti tra altri ministri e sotto-segretari, trasportarli in autobus in Libia, imbarcarli su un gommone , farli rischiare il naufragio e arrivare fradici e affamati a Lampedusa, rinchiuderli nel Cie e, dopo una detenzione di durata indefinita, riportarli al punto di partenza. E chiedere loro: la pensate come prima? Avete ancora voglia di distinguere tra profughi e migranti economici? Non sarebbe il caso di rivedere questa distinzione ipocrita, utile solo per manipolare opinioni pubbliche paranoiche e destrorse? In un sogno o in un film, in caso di risposta sbagliata si potrebbe ricominciare con loro daccapo...
Quando Angela Merkel e il vice-cancelliere tedesco Gabriel hanno dichiarato, nello scorso agosto, di aprire le porte della Germania a 5 milioni di profughi, hanno realizzato un buon numero di obiettivi: rispondere a un’opinione pubblica tedesca complessivamente non insensibile agli Asylanten presenti e futuri, nonostante la rumorosa presenza del partito xenofobo Pegida e dei neo-nazisti, isolare le frange di estrema destra e, di fatto, assumere la guida politico-morale di un’Europa fragile, litigiosa e incerta sul da farsi in campo internazionale. Ovviamente, considerazioni demografiche e finanziarie, in un paese in cui non nascono più bambini, devono avere avuto il loro peso, ma sta di fatto che l’odiosa Germania della crisi greca è diventata la nobile Germania d’agosto, non offuscata nemmeno dalla crisi della Volkswagen.
Ma tutto questo ha come contrappeso la distinzione tra profughi (vittime di guerra ecc.) e migranti economici, i quali affronterebbero deserti e mari, per non parlare di prigioni ungheresi e manganelli di mezza Europa, così, per sport o sete d’avventura, e non per sopravvivere o vivere meglio.
Una distinzione insensata, che non riesce a mascherare l’assoluta mancanza di una strategia europea nei rapporti con gli altri mondi e con le persone che per qualsiasi ragione ne provengono. Una distinzione che serve a tacitare le strumentalizzazioni lepeniste, leghiste e di Grillo (che sul suo blog ha pubblicato tempo fa un encomio di Orbán). In termini puramente quantitativi, 3 milioni di migranti «economici» in dieci anni non cambierebbero in nulla l’assetto demografico di una Ue che conta oggi 500 milioni di abitanti distribuiti su 4 milioni di chilometri quadrati.
Ma bisognerebbe cambiare metodo, emarginare sul serio gli Orban, i Salvini e Le Pen, impedire le stragi in mare, che continuano imperterrite alla faccia di Frontex, immaginare un’integrazione sociale decente per gli stranieri e disporre di una vera politica internazionale comune - invece che manganellare i migranti a Ventimiglia e Calais, moltiplicare i Cie e litigare in modo miserabile alle frontiere.
Ed ecco perché i ministri degli Interni, riuniti da qualche parte a stilare piani segreti di espulsione lasciano filtrare cifre prive di qualsiasi senso (400.000, 300.000, nessuno, tutti?).
Per coprire la loro mancanza di idee, che non siano lo sfruttamento della forza lavoro straniera e le preoccupazioni per le prossime elezioni. Nel frattempo, la ministra Pinotti e Matteo Renzi, che su queste materie non hanno mai nulla da dire, fanno scaldare i motori dei Tornado.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Nota sul "Meeting sul’insegnamento della filosofia". In Spagna l’ultima riforma della scuola rende la materia facoltativa.9 ottobre 2015, di Federico La Sala
MA DOVE SONO I FILOSOFI
ITALIANI OGGI?!
MILANO. UNIVERSITA’ IULM -UNESCO
— - 14-16 Febbraio 2011: Meeting sul’insegnamento della filosofia *USCIRE DALLA CAVERNA
USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’
SAPERE AUDE!
- A 400 ANNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL "SIDEREUS NUNCIUS" DI GALILEO GALILEI E A 200 DALLE INDICAZIONI DI IMMANUEL KANT SULL’USO CRITICO DELLA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO (PER UNA STORIA E PER UNA FILOSOFIA DAL PUNTO DI VISTA COSMOPOLITICO - E - PER LA PACE PERPETUA)
- Rimettere al centro della filosofia (e soprattutto del suo insegnamento), la lezione dell’illuminismo kantiano!!!
DAL MEETING, UN ALLARME E UNA SOLLECITAZIONE. Una nota parziale (e - ovviamente - molto, molto riduttiva) sulla ricchezza degli interventi e delle discussioni dell’incontro): *
A) LA FILOSOFIA IN RITARDO (E IN PERICOLO NEL MONDO) E NON PRONTA A UNA DELLE SUE MISSIONI FONDAMENTALI - IL DIALOGO GLOBALE
B) RILANCIARE L’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA COME EDUCAZIONE ALLA PRATICA DELLA LIBERTA’, ALL’ESERCIZIO CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO, ALLA DEMOCRAZIA PLANETARIA - RIUNIRE SAGGEZZA E SCIENZA
C) NON INGESSARE L’UNESCO NELLA VALORIZZAZIONE E NELLA DIFESA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELL’UMANITA’ - PORTARE AVANTI E POTENZIARE L’ESPERIENZA DELLE "CATTEDRE UNESCO".
D) NECESSITA’ E URGENZA DI METTERE IN COMUNICAZIONE LA TRADIZIONE FILOSOFICA E LA POPOLAZIONE DEL "NUOVO MONDO" - I "NATIVI DIGITALI", L’UMANITA’ DIGITALE.
E) DOCUMENTO: "RACCOMANDAZIONI SULL’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA IN EUROPA E IN AMERICA SETTENTRIONALE"
*
Federico La Sala (16.02.2011)
Se la scuola volta le spalle alla filosofia
In Spagna l’ultima riforma rende la materia facoltativa, tra le proteste del mondo culturale
Ma il dibattito resta aperto. In tutti i paesi europei
di Alessandro Oppes (la Repubblica, 06.10.2015)
MADRID Le hanno tentate tutte, professori, filosofi, esperti di pedagogia, docenti di discipline umanistiche. Ma niente da fare. Non c’è posto nella scuola modello Rajoy - quella che ha ripristinato la religione obbligatoria e ha abolito l’educazione civica, troppo “ideologica” forse perché voluta dal socialista Zapatero - per la filosofia come pilastro del sapere.
L’ultima riforma dell’educazione, la Lomce, imposta dall’ormai ex-ministro José Ignacio Wert (sempre in coda nei sondaggi sul gradimento dei politici) dopo una lunga battaglia a suon di scioperi in cui studenti, presidi e genitori si presentavano uniti, relega la materia a un ruolo da comprimaria. Finora alle superiori si insegnavano tre discipline legate tra loro, filosofia, valori etici e storia della filosofia. Ora solo la prima sarà obbligatoria nel primo anno di “bachillerato”, il biennio che precede l’accesso all’università.
Per il resto, saranno gli assessorati all’educazione delle 17 regioni a decidere al principio che la legge definisce “libre configuración”, la libertà degli istituti di impartire corsi sui temi che preferiscono. La conseguenza paradossale è che in questo modo, nonostante una religiosità nettamente in calo, l’iscrizione ai corsi di religione ha subito un aumento 150 per cento perché alternativi alla disciplina dei “valori etici”, impartita da professori di filosofia ma considerata molto più ostica.
Nel corso dell’elaborazione della legge ci sono stati numerosi incontri tra rappresentanti del Ministero e delegazioni di insegnanti, ma senza alcuna concessione alle esigenze dei docenti. Il mondo della cultura non rinuncia però a mobilitarsi. Una lettera dal titolo La belleza de las humanidades, inviata al quotidiano El País, è stata condivisa da 200mila utenti Facebook. Parla di una filosofia «seppellita nell’oscuro baule dove sono già state relegate le sue sorelle musica, pittura, letteratura, storia». Sullo stesso giornale Antonio Campillo, presidente della Red Española de Filosofía, ricorda che «perfino le scuole per manager sanno che economisti e ingegneri hanno bisogno delle materie umanistiche ». Il dibattito continua.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Ecco, forse, si può affermare che il volto dell’Europa cambierà. Intervista ad Agnes Heller (di Radio Popolare)1 ottobre 2015, di Federico La Sala
In Europa
Intervista ad Agnes Heller
L’Europa dei nazionalismi
(Il Mulino,, 29 settembre 2015)
Quando scende dallo sgabello in cui si è inerpicata per leggere le mail al computer, ti rendi conto di quanto sia piccola ma energica Agnes Heller. 86 anni, ha vissuto il nazismo nel ghetto di Budapest, si è innamorata della filosofia studiando con Lukacs, è stata marxista non ortodossa, espulsa e poi riammessa nel Partito comunista ungherese. Negli anni Settanta riesce a uscire dal Paese per insegnare prima in Australia poi a New York. Il suo ultimo libro è La bellezza (non) ci salverà (Il Margine, 2015), dove dialoga con un altro vecchio mitteleuropeo, il sociologo polacco Zygmunt Bauman. Abbiamo incontrato Agnes Heller a pordenonelegge e abbiamo chiesto a lei, ungherese, che parole userebbe per descrivere cosa sta accadendo nel suo Paese ai migranti.
AH: I problemi sono complicati. Ecco perché non c’è una sola parola chiave. Si può descrivere cosa succede ora, cosa potrebbe accadere in futuro, quali possibili alternative per l’Europa e per il mondo: ma questo non può essere sintetizzato in una sola parola chiave. Ecco, forse, si può affermare che il volto dell’Europa cambierà.
Ma come cambierà l’Europa è tutta un’altra questione.
L’Europa sta chiedendo a chi bussa alle sue porte di accettare le sue leggi e la sua cultura. Cioè di assimilarsi, non integrarsi.
AH: L’Europa è fatta di Stati-nazione. E l’Europa è pessima nell’attuare l’integrazione. I popoli con differenti abitudini e culture hanno bisogno di essere integrati. L’Europa invece finisce sempre per tendere all’assimilazione. Ma assimilarsi diventa quasi impossibile per un così gran numero di persone. Credo che l’Europa debba chiedersi se vuole veramente l’integrazione, e non l’assimilazione: è un’opzione. In questo caso, se siamo d’accordo a integrare e non ad assimilare, otterremo nuovi e buoni lavoratori, dei patrioti. Ma se vorremo assimilarli produrremo dei nemici. Bisogna capirlo, altrimenti non si sa cosa accadrà in futuro.
 Guardate gli Stati Uniti: non sono uno Stato-nazione, hanno legalizzato 3 milioni di immigrati che sono diventati americani, quindi patrioti. Ma in Europa non è così: bisogna imparare la lingua, le abitudini, le regole del Paese ed è molto difficile. I musulmani, per esempio, non assimileranno mai la cultura cristiana. L’unica cosa che si può - e si deve - chiedere loro è di non limitare la libertà altrui, quella dei figli, delle donne, degli amici e di rispettare le leggi dello Stato e la sua Costituzione. Se lo fanno, possono fare ciò che vogliono. Possono vestirsi come vogliono, andare alla moschea quante volte desiderano. Possono continuare a vivere la propria cultura, a meno che essa non contravvenga alle leggi dello Stato o limiti la libertà altrui. Non si può introdurre la sharia per gli altri, ma si può seguirla individualmente. Che importa? Basta lasciare in pace gli altri, senza accusarli di decadenza o ateismo, altrimenti anche chi è integrato non sarà tollerato. Entrambe le parti devono imparare una lezione, oppure ci saranno molti problemi in futuro.
Guardate gli Stati Uniti: non sono uno Stato-nazione, hanno legalizzato 3 milioni di immigrati che sono diventati americani, quindi patrioti. Ma in Europa non è così: bisogna imparare la lingua, le abitudini, le regole del Paese ed è molto difficile. I musulmani, per esempio, non assimileranno mai la cultura cristiana. L’unica cosa che si può - e si deve - chiedere loro è di non limitare la libertà altrui, quella dei figli, delle donne, degli amici e di rispettare le leggi dello Stato e la sua Costituzione. Se lo fanno, possono fare ciò che vogliono. Possono vestirsi come vogliono, andare alla moschea quante volte desiderano. Possono continuare a vivere la propria cultura, a meno che essa non contravvenga alle leggi dello Stato o limiti la libertà altrui. Non si può introdurre la sharia per gli altri, ma si può seguirla individualmente. Che importa? Basta lasciare in pace gli altri, senza accusarli di decadenza o ateismo, altrimenti anche chi è integrato non sarà tollerato. Entrambe le parti devono imparare una lezione, oppure ci saranno molti problemi in futuro.La storia dell’Europa è un susseguirsi di guerre, di sangue versato in nome dei nazionalismi.
AH: Gli Stati-nazione sono nazionalisti! È una loro caratteristica. Sono nati dopo la Rivoluzione francese. Sono nazionalisti dalla nascita. Come ho già scritto, è stato durante la Prima guerra mondiale che il nazionalismo ha vinto contro l’internazionalismo proletario e la borghesia cosmopolita. Da allora l’Europa è stata caratterizzata dal nazionalismo. E non è facile cambiare. Perché se nella storia si sviluppa una certa identità, è molto difficile farla scomparire.
E il nazionalismo è anche l’ideologia vincente di questo momento: come si può combatterlo?
AH: La gente può avere una propria identità anche senza avere un’identità nazionale. L’Europa era un’Europa di popoli, ora è diventata un’Europa di nazioni. E da allora non si è più trattato di un’identità di popoli, di religione, di città (come in Italia) o di Stati (come negli Stati Uniti), ma di una soverchiante identità nazionale.
Come si può contrastare questo fenomeno? Si può affermare che bisogna invertire la direzione, che l’Europa deve tornare a essere un’Europa dei popoli. Ma chi può farlo? Quale potere ne è in grado? La nazione e il nazionalismo sono ottime armi politiche con cui i potenti conservano ed esercitano ancora più potere. I potenti possono fare sempre riferimento al bene della nazione. I cuori iniziano subito a battere quando si sente parlare della difesa della propria nazione... Ma come la difendiamo? Contro altre nazioni o no? Per esempio, quando vivevo in Australia e l’Italia ha vinto i Mondiali, tutta Melbourne era piena di emigrati italiani che festeggiavano. Non facevano male a nessuno! Se "nazione" significa volere che il mio Paese vinca nello sport, o provare orgoglio quando un mio compatriota riceve il Nobel o è una celebrità del tennis, va benissimo! Ma se "nazione" implica odio o disprezzo per altre culture, che consideriamo diverse, allora è difficile cambiare le cose. È difficile tirare indietro l’orologio della storia!
(Questa intervista ad Agnes Heller è stata raccolta e trasmessa da Radio Popolare)
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Dalla Corsica alla Baviera l’Europa si spacca nelle piccole patrie. Ecco un elenco, Paese per Paese, peraltro probabilmente incompleto.29 settembre 2015, di Federico La Sala
Dalla Corsica alla Baviera l’Europa si spacca nelle piccole patrie
Dopo la vittoria alle regionali in Catalogna dei partiti indipendentisti riprendono forza i movimenti autonomisti o separatisti. Mettendo in imbarazzo la Ue
di Andrea Bonanni (la Repubblica, 29.09.2015)
BRUXELLES Tante sono le “piccole patrie” di cui l’Europa si scopre casa comune, quante sono le sfumature dei movimenti indipendentisti, separatisti, federalisti e autonomisti che percorrono il Vecchio continente. Si va da chi, in passato, non ha esitato a imbracciare il fucile, come gli irlandesi del Nord, i baschi, i corsi, i sudtirolesi, a chi rivendica il diritto al recupero di una identità culturale perduta, come gli occitani in Provenza e nel Sud della Francia. Fuori dalla casa comune europea, l’indipendentismo è ancora bagnato di sangue, come dimostrano la guerra in Ucraina, l’occupazione della Crimea o i massacri dell’ex Jugoslavia. Sotto il cielo a dodici stelle dell’Unione, le rivendicazioni indipendentiste tendono invece a incanalarsi in processi democratici.
L’Europa ha avuto un ruolo nel favorire il dialogo, dall’Ulster all’Alto Adige, all’indipendentismo basco, o agevolando processi di federalizzazione, come in Belgio. Ma il crescente potere di Bruxelles a danno degli stati-nazione ha favorito il proliferare di rivendicazioni autonomiste. Non è un caso che, dalla Catalogna alla Scozia alle Fiandre, le regioni che ambiscono a lasciare lo stato nazionale in cui sono inserite vogliano comunque restare in Europa.
L’idea di una «Europa delle regioni» che progressivamente soppiantasse l’ «Europa delle nazioni» era uno dei cardini del pensiero federalista dei padri fondatori. Questi si sono poi adattati a far legittimare il progetto europeo dagli stati nazionali, ma sempre nella speranza che l’integrazione portasse al loro disfacimento e all’affermarsi di una comunità di popoli e di autonomie.
Non è un caso che questa volta il presidente della Commissione, Jean Claude Juncker, di fronte alle elezioni catalane abbia evitato di ripetere la dura presa di posizione del suo predecessore. Barroso, in occasione del referendum scozzese, minacciò gli elettori di tenere fuori una Scozia indipendente dall’Unione europea. Juncker, in questa occasione, ha assunto un atteggiamento molto più prudente. Tra gli esperti di affari europei c’è infatti anche chi sostiene che i Trattati hanno conferito a tutti i popoli dell’Unione lo status di cittadini europei. E che questa condizione, a meno di una esplicita rinuncia, sopravvive anche alla scelta di una nuova appartenenza nazionale.
Ma quali e quante sono le «piccole patrie» che cercano di affermarsi sotto l’ombrello europeo? Ecco un elenco, Paese per Paese, peraltro probabilmente incompleto.
GRAN BRETAGNA
SCOZIA. Gli indipendentisti scozzesi dello Scottish National Party sono i più agguerriti e dispongono di una maggioranza nel parlamento nazionale. Dopo la sconfitta di misura al referendum, la loro leader Nicola Sturgeon non ha rinunciato al progetto secessionista. Un distacco della Catalogna dalla Spagna, o un voto britannico per uscire dall’Ue, riaprirebbero la questione.
GALLES. Gli indipendentisti si riconoscono nel partito Plaid. Sono meno numerosi e meno radicali che in Scozia. Ma se Edimburgo dovesse lasciare il Regno Unito, anche Cardiff potrebbe essere tentata.
CORNOVAGLIA. Il partito indipendentista, Mebyon Kernow, si rifà alle radici celtiche della regione. Ma il fenomeno ha più il carattere di una rivendicazione culturale che politica.
SPAGNA
I catalani sono la regione più avanzata sulla via dell’indipendenza. Ma altrettanto determinati sono i baschi, le cui rivendicazioni sono danneggiate dai crimini compiuti in passato dai terroristi dell’Eta. Movimenti indipendentisti sono attivi anche in Galizia e in Aragona.
FRANCIA
La nazione che ha inventato lo stato unitario e lo ha imposto nel corso dei secoli è percorsa da numerose rivendicazioni indipendentiste. I più determinati sono i corsi, che però hanno perso un referendum nel 2003. Indipendentisti sono presenti in Bretagna, Alsazia e nella Francia del sud dove rivendicano l’autonomia dell’antica Occitania.
BELGIO
Gli indipendentisti fiamminghi dell’ N-VA sono il partito di maggioranza nel Nord del Paese. A differenza dell’estrema destra del Vlaams Blok, sono convinti filo- europei. Sotto la spinta dell’autonomismo fiammingo, il Belgio si è trasformato da Stato unitario in monarchia confederale e, infine, in Stato federale.
GERMANIA
La Germania è uno stato federale, con larghissimi margini di autonomia dei vari Lander. Questo ha mitigato le spinte indipendentiste. Tuttavia in Baviera c’è una piccolo partito, il Bayern Partei, che dal ‘46 chiede l’indipendenza, che ha una maggioranza cattolica e un’antica tradizione di sovranità.
POLONIA
Anche in Slesia esiste un partito, autonomista più che indipendentista, che ha raccolto quasi il nove per cento dei consensi nella regione. La Slesia, annessa alla Polonia dopo la guerra, faceva parte della Germania e l’influenza tedesca è ancora fortemente sentita, nonostante la pulizia etnica che ha costretto milioni di tedeschi a lasciare le loro terre nell’immediato dopoguerra.
FINLANDIA
Le isole Aaland, sotto sovranità finlandese, sono abitate da una popolazione di lingua svedese. Hanno ottenuto uno statuto di speciale autonomia nel 1991. Ma da sempre gli abitanti coltivano il sogno di una piena indipendenza, sia pure sotto l’ombrello europeo.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- LA GERMANIA, HITLER E IL NAZISMO. Günter Grass e Peter Schneider: Noi tedeschi in crisi d’identità27 settembre 2015, di Federico La Sala
- HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
Noi tedeschi in crisi d’identità
di Peter Schneider (la Repubblica, 26.09.2015)
LEGGENDO le drammatiche notizie sul caso Volkswagen, mi sembra che una parte dell’anima tedesca oggi appartenga ai colossi dell’auto made in Germany.
E QUINDI l’anima tedesca è in crisi, perché scopre all’improvviso che un simbolo decennale del suo successo di Paese risorto nel dopoguerra dalle macerie, democrazia solida e aperta al mondo - lo dico per Vw, non so quanti e quali altri produttori mondiali siano coinvolti - è fondata da tempo sull’inganno. L’anima tedesca è in crisi, perché questo inganno fa a pezzi l’immagine di credibilità attendibile che a fatica il Paese si era ricostruito.
Il caso colpisce al cuore l’anima tedesca, anche perché abbiamo sempre pensato che tutti gli altri paesi sono corrotti, ma noi no: addio all’illusione di essere diversi, migliori rispetto agli altri, in Europa e nel mondo.
Inutile illudersi, noi tedeschi e il resto d’Europa e del mondo, che sia in gioco solo la reputazione di Vw: è in gioco l’immagine del Made in Germany quale sinonimo costitutivo della ricostruzione postbellica, e della fierezza di se stessi, delle virtù tedesche - onestà, serietà, affidabilità - che dopo il 1945 ci fu così arduo ritrovare. Sono spesso in America, sento spesso dire dagli amici americani che per loro i sinonimi della Germania nel loro immaginario collettivo sono “Hitler and good engineering”. Ora purtroppo quel primo orrendo sinonimo resta, ma il secondo diventa “cheating engineering”, tecnologia imbrogliona. Truffa con cui Vw si è creata un vantaggio illegale e scorretto rispetto alla concorrenza mondiale, e questa sua truffa pesa oggi sulla coscienza della nazione.
Riflettendo ancor più a fondo, emergono altre consapevolezze amare: per anni Vw e forse altri produttori hanno mentito al mondo. Proprio loro simbolo del Made in Germany, di eccellenze di un Paese ecologista come pochi altri, hanno detto il falso, hanno sostenuto che è possibile produrre e vendere auto sempre più grandi, potenti e pesanti ma sempre meno inquinanti.
Fu soprattutto l’industria dell’auto tedesca e americana a illudere i consumatori mondiali convincendoli che i SUV, quelle orrende jeep di lusso sinonimo di visibile egoismo arrogante, erano ecologici. E’una menzogna di cui adesso paghiamo il conto.
La situazione è tanto seria, che persino la Schadenfreude (la gioia maligna per le disgrazie altrui, in questo caso gioia di altri per la disgrazia tedesca) non fa piacere. Nella mia vita, ho avuto la fortuna di vivere nella Germania più felice, migliore, più amata dal mondo che la Storia abbia mai visto. Fino a pochi giorni fa era così... anche con Angela Merkel e le sue braccia aperte ai migranti, risposta civile europea ai razzisti come Orbàn. Ma adesso ci troviamo a una cesura seria. Non siamo alla fine della Storia di questa Germania felice e in pace col mondo, ma alla fine della sua identificazione folle con i successi dell’industria dell’auto. Che tristezza, se pensiamo a come le nostre “famose capacità tecnologiche” avrebbero potuto essere usate per produrre auto sempre più pulite, anziché per imbrogliare con quei software che falsavano i test.
Ci è mancato qualcosa di costitutivo, in un comparto economico chiave e determinante. Ci è mancata, per scelta dei big dell’auto che volevano soltanto vendere ogni anno più vetture, l’immaginazione e la creatività che a volte non vediamo, a volte fingiamo di non vedere altrove. Penso per esempio agli Stati Uniti dove l’alta tecnologia è culturalmente piu legata all’innovazione in nome della curiosità e della qualità della vita. Basta l’esempio della Tesla, la supercar familiare elettrica da 500 cavalli che loro hanno pensato e costruito, e che vendono con successo. Noi avremmo la capacità tecnologica di farlo, ma i nostri grandi Autokonzern hanno scelto di rinunciarvi.
Purtroppo rimane un’altra domanda sul Dieselgate. Come spiegare il silenzio di anni del sindacato più potente del mondo, rappresentato in forza al vertice Volkswagen in nome della Mitbestimmung, la cogestione? Che cosa significa, e che cosa cela, questa armonia dei silenzi tra azienda-simbolo e sindacato- simbolo della democrazia nata dalle macerie? Finché ci mancheranno i risultati delle indagini sui responsabili, sulle aziende colpevoli e mentitrici tedesche e magari anche non tedesche, ci rimane solo etichettare ogni auto Volkswagen come un pacchetto di sigarette, con avvisi obbligatori sul pericolo dell’uso.
 (testo raccolto da Andrea Tarquini)
(testo raccolto da Andrea Tarquini) -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- EU-ROPA ED EU-ANGELO. LA ’CROCE’ DI CRISTO NON HA NIENTE A CHE FARE CON IL "CROCIFISSO" DELLA TRADIZIONE COSTANTINIANA E CATTOLICO-ROMANA.25 settembre 2015, di Federico La Sala
Eu-ropa ed Eu-angelo. Una buona-scelta e una buona-notizia ...
MATERIALI SUL TEMA:
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Cortile di Francesco d’Assisi. Via la guerra dalla storia. Intervista a Gino Strada - Cortile di Francesco d’Assisi. (di Alessandro Zaccuri)23 settembre 2015, di Federico La Sala
Intervista
Strada: Via la guerra dalla storia
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, 23 settembre 2015)
L’Europa vera è quella dei cittadini, non dei governi. Ne è convinto Gino Strada, da oltre vent’anni chirurgo nelle zone di guerra, fondatore della ong Emergency, voce tra le più ascoltate del pacifismo italiano. Non credente dichiarato, eppure a suo agio in un contesto come quello del Cortile di Francesco che si inaugura oggi ad Assisi (per informazioni cortile.sanfrancescopatronoditalia.it).
 Il suo dialogo con la giornalista Lucia Annunziata è in programma per questa sera alle 21, sulla piazza della Basilica Superiore. Si parlerà di guerre e migrazioni, due argomenti che Strada conosce molto bene, ma il cui legame è ancora troppo poco avvertito dall’opinione pubblica. «Basterebbe scorrere l’elenco dei Paesi da cui provengono i profughi -
osserva -. Siria, Afghanistan, Iraq. Tutti teatri bellici. E quando non lo sono in senso stretto, come in Nigeria, il terrorismo fa il resto e la guerra è dietro l’angolo».
Il suo dialogo con la giornalista Lucia Annunziata è in programma per questa sera alle 21, sulla piazza della Basilica Superiore. Si parlerà di guerre e migrazioni, due argomenti che Strada conosce molto bene, ma il cui legame è ancora troppo poco avvertito dall’opinione pubblica. «Basterebbe scorrere l’elenco dei Paesi da cui provengono i profughi -
osserva -. Siria, Afghanistan, Iraq. Tutti teatri bellici. E quando non lo sono in senso stretto, come in Nigeria, il terrorismo fa il resto e la guerra è dietro l’angolo».E questo che cosa significa?
«Che negli ultimi quindici anni l’opzione bellica è stata la più esercitata, difesa, praticata e osannata dai governi delle nazioni più potenti del mondo. Possiamo prendere come discrimine l’11 settembre 2001, anche se si tratta di una scelta molto approssimativa. Fatto sta che prima abbiamo esportato la guerra e adesso ne importiamo le conseguenze».
Il suo è un giudizio decisamente duro.
«A me sembra solo realistico. In molti Paesi, oggi, le condizioni di vita sono terribili e i diritti umani individuali pressoché inesistenti. Le persone scappano, certo: che cosa dovrebbero fare? Durante la Seconda guerra mondiale anche i nonni scappavano dai bombardamenti, ma ormai ce ne siamo dimenticati, non ci ricordiamo più che mezzo secolo fa gli sfollati eravamo noi. Le migrazioni di cui siamo testimoni in questo momento sono un fenomeno inarrestabile. Sarebbe stupido illudersi di fermare flussi di questa entità. Ma ancora più stupido è sostenere che questi stessi flussi abbiano un’influenza negativa sulle nostre società. Semmai, è vero il contrario: quello dei migranti è un contributo positivo, anche dal punto di vista economico».
Eppure in Europa sorgono muri e si rafforzano le frontiere.
«Segno che l’Europa resta una bella idea, ma all’atto pratico emergono ancora atteggiamenti di gretto nazionalismo. Di recente ci sono stati anche molti episodi di solidarietà e accoglienza, per fortuna, ma questa volta i protagonisti sono stati i cittadini d’Europa, non i loro governi. Ed è a questa Europa dei cittadini che i politici dovrebbero dare ascolto. In caso contrario, continuerà a prevalere la logica della paura e, quindi, della guerra».
Qual è la sua speranza?
«Che l’umanità riesca a fare finalmente il grande salto culturale che molti attendono ormai da secoli. Scacciare la guerra dall’orizzonte della storia, ecco quale dovrebbe essere il nostro obiettivo. Perché la guerra non produce nulla, se non nuove povertà e nuove discriminazioni. La mia speranza sarebbe questa, ma confesso di non essere troppo ottimista. So bene che la guerra è una caratteristica degli esseri umani. In natura capita che una volpe aggredisca una gallina, ma non si è mai visto un branco di polli dare l’assalto a un pollaio. Era già la convinzione di Erasmo da Rotterdam, ma anche con le citazioni, ormai, bisogna andarci piano. C’è sempre il rischio che qualcuno pensi che mi sto riferendo a un profugo olandese. Non si sa mai, a questo punto».
Eppure papa Francesco continua a pronunciarsi con forza contro la guerra.
«Come prima di lui ha fatto Giovanni Paolo II, per esempio. Parole chiare e inequivocabili, in un caso come nell’altro. La mia impressione, purtroppo, è che il Papa sia rispettato e ammirato in moltissime occasioni. Non appena prende posizione contro la guerra, però, viene considerato alla stregua di un vecchio idealista. Succedeva anche con Wojtyla, appunto, che su questo tema si è espresso con dichiarazioni di portata storica, alle quali in troppi non hanno voluto dare ascolto».
L’Anno Santo della Misericordia può essere un’occasione di riflessione?
«La misericordia è un atteggiamento su cui credenti e non credenti dovrebbero trovarsi in piena sintonia. Per me è il corrispettivo di quello che Bertrand Russell e Albert Einstein scrissero nel 1955 alla fine del loro Manifesto : “Ricordatevi della vostra umanità e dimenticate il resto”».
Emergency è nata nel 1994: da allora qualcosa sarà pure cambiato, no?
«La globalizzazione ha galoppato, il divario tra i pochissimi ricchi e i moltissimi poveri è ulteriormente peggiorato e la Terza guerra mondiale, nei fatti, è già cominciata. Proprio per questo, però, e proprio perché i cittadini sono sempre meno rappresentati, non si può rinunciare a far sentire la propria voce. Bisogna impegnarsi a favore delle generazioni future, investendo sempre di più sulla formazione e sulla sensibilizzazione. Seminare, seminare nonostante tutto, anche nella consapevolezza che non saremo noi a vedere i frutti. Abbiamo bisogno di una cultura diversa. Anzi, no, mi correggo: abbiamo bisogno di cultura. L’alternativa è la barbarie che abbiamo davanti e alla quale non possiamo arrenderci».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- "IO SONO UN IMMIGRATO". MIGRANTI E POLITICA. LA LEZIONE DI JOHN FITZEGERALD KENNEDY.19 settembre 2015, di Federico La Sala
MIGRANTI E POLITICA.
LA LEZIONE DI JOHN FITZEGERALD KENNEDY:
"IO SONO UN IMMIGRATO".
.Un testo del 1957, pubblicato per la prima volta in Italia (2009)
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Saranno i migranti a salvare l’Europa (di Thomas Piketty)20 settembre 2015, di Federico La Sala
Saranno i migranti a salvare l’Europa
 Prima della crisi finanziaria il Vecchio Continente si avviava a diventare la regione più aperta in termini di flussi migratori
Prima della crisi finanziaria il Vecchio Continente si avviava a diventare la regione più aperta in termini di flussi migratori
 Il dramma dei rifugiati potrebbe essere l’occasione per aprirsi al mondo rilanciando l’economia
Il dramma dei rifugiati potrebbe essere l’occasione per aprirsi al mondo rilanciando l’economiadi Thomas Piketty (la Repubblica, 19.09.2015)
Lo slancio di solidarietà in favore dei rifugiati osservato in queste ultime settimane è stato tardivo
 MA QUANTOMENO ha avuto il merito di ricordare agli europei e al mondo una realtà fondamentale. Il nostro continente, nel XXI secolo, può e deve diventare una grande terra di immigrazione. Tutto concorre in tal senso: il nostro invecchiamento autodistruttivo lo impone, il nostro modello sociale lo consente e l’esplosione demografica dell’Africa abbinata al riscaldamento globale lo esigerà sempre di più. Tutte queste cose sono largamente note. Un po’ meno noto, forse, è che prima della crisi finanziaria l’Europa si avviava a diventare la regione più aperta del mondo in termini di flussi migratori. È la crisi, scatenatasi nel 2007-2008 negli Stati Uniti, ma da cui l’Europa non è mai riuscita a uscire per colpa di politiche sbagliate, che ha condotto all’aumento della disoccupazione e della xenofobia, e a una chiusura brutale delle frontiere. Il tutto in un momento in cui il contesto internazionale (Primavera Araba, afflusso di profughi) avrebbe giustificato, al contrario, una maggiore apertura.
MA QUANTOMENO ha avuto il merito di ricordare agli europei e al mondo una realtà fondamentale. Il nostro continente, nel XXI secolo, può e deve diventare una grande terra di immigrazione. Tutto concorre in tal senso: il nostro invecchiamento autodistruttivo lo impone, il nostro modello sociale lo consente e l’esplosione demografica dell’Africa abbinata al riscaldamento globale lo esigerà sempre di più. Tutte queste cose sono largamente note. Un po’ meno noto, forse, è che prima della crisi finanziaria l’Europa si avviava a diventare la regione più aperta del mondo in termini di flussi migratori. È la crisi, scatenatasi nel 2007-2008 negli Stati Uniti, ma da cui l’Europa non è mai riuscita a uscire per colpa di politiche sbagliate, che ha condotto all’aumento della disoccupazione e della xenofobia, e a una chiusura brutale delle frontiere. Il tutto in un momento in cui il contesto internazionale (Primavera Araba, afflusso di profughi) avrebbe giustificato, al contrario, una maggiore apertura.Facciamo un passo indietro. Nel 2015 l’Unione Europea conta quasi 510 milioni di abitanti, contro circa 485 milioni nel 1995 (considerando le frontiere attuali dell’Unione). Questa progressione di 25 milioni di abitanti in vent’anni di per sé non ha niente di eccezionale (appena lo 0,2 per cento di crescita annuo, contro l’1,2 per cento della popolazione mondiale nel suo insieme nello stesso periodo). Ma il punto importante è che tale crescita è dovuta, per quasi tre quarti, all’apporto migratorio (più di 15 milioni di persone). Tra il 2000 e il 2010, l’Unione Europea ha accolto quindi un flusso migratorio (al netto degli espatri) di circa 1 milione di persone all’anno, un livello equivalente a quello degli Stati Uniti, con in più una maggiore diversità culturale e geografica (l’islam rimane marginale Oltreatlantico). In quell’epoca non così remota in cui il nostro continente sapeva mostrarsi ( relativamente) accogliente, la disoccupazione in Europa era in calo, almeno fino al 2007-2008.
Il paradosso è che gli Stati Uniti, grazie al loro pragmatismo e alla loro flessibilità di bilancio e monetaria, si sono rimessi molto in fretta dalla crisi che essi stessi avevano scatenato. Hanno rapidamente ripreso la loro traiettoria di crescita (il Pil del 2015 è del 10 per cento più alto di quello del 2007) e l’apporto migratorio si è mantenuto intorno a 1 milione di persone l’anno.
L’Europa, invece, impantanata in divisioni e posizioni sterili, non è mai riuscita a tornare al livello di attività economica precedente la crisi, e le conseguenze sono state la crescita della disoccupazione e la chiusura delle frontiere. L’apporto migratorio è precipitato drasticamente da 1 milione di persone l’anno fra il 2000 e il 2010 a meno di 400.000 fra il 2010 e il 2015. Che fare? Il dramma dei rifugiati potrebbe essere l’occasione, per gli europei, di uscire dalle loro piccole diatribe e dal loro egocentrismo. Aprendosi al mondo, rilanciando l’economia e gli investimenti (case, scuole, infrastrutture), respingendo i rischi deflazionistici, l’Unione Europea potrebbe tornare senza alcun problema ai livelli migratori registrati prima della crisi.
L’apertura manifestata dalla Germania al riguardo è una notizia ottima per tutti coloro che si preoccupavano dell’ammuffimento e dell’invecchiamento dell’Europa. Certo, qualcuno potrebbe sostenere che la Germania non ha scelta, tenuto conto della sua bassissima natalità: secondo le ultime proiezioni demografiche dell’Onu, che pure sono basate su un flusso migratorio due volte più elevato in Germania che in Francia nei prossimi decenni, la popolazione tedesca passerebbe dagli 81 milioni odierni a 63 milioni di qui alla fine del secolo, mentre la Francia, nello stesso periodo, passerebbe da 64 a 76 milioni.
Qualcuno potrebbe ricordare anche che il livello di attività economica osservato in Germania è in parte la conseguenza di un gigantesco surplus commerciale, che per definizione non potrebbe essere esteso a tutta l’Europa (perché non ci sarebbe nessuno sul pianeta in grado di assorbire una tale quantità di esportazioni).
Ma questo livello di attività si spiega anche con l’efficacia del modello industriale tedesco, che si fonda in particolare su un fortissimo livello di coinvolgimento dei dipendenti e dei loro rappresentanti (che hanno la metà dei seggi nei consigli d’amministrazione), e a cui faremmo bene a ispirarci.
Soprattutto, l’atteggiamento di apertura verso il mondo manifestato dalla Germania invia un messaggio forte agli ex Paesi dell’Europa dell’est membri dell’Unione Europea, che non vogliono né bambini né migranti e la cui popolazione messa insieme, sempre secondo l’Onu, dovrebbe passare dagli attuali 95 milioni a poco più di 55 entro la fine del secolo. La Francia deve rallegrarsi di questo atteggiamento della Germania e cogliere l’opportunità per far trionfare in Europa una visione aperta e positiva verso i rifugiati, i migranti e il mondo.
 (Traduzione di Fabio Galimberti)
(Traduzione di Fabio Galimberti)
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- L’onere è di tutti, il messaggio della cancelliera Merkel a Bruxelles (di Andrea Bonanni)14 settembre 2015, di Federico La Sala
L’onere è di tutti, il messaggio della cancelliera a Bruxelles
di Andrea Bonanni (la Repubblica, 14.09.2015)
BRUXELLES Solidali sì, ma non fessi. La generosità dei tedeschi è a favore dei rifugiati che fuggono la guerra. Non di quei governi europei che pensavano di approfittare del buon cuore di Berlino per scaricare sulla Germania l’onere di una emergenza che riguarda tutti. La decisione presa da Angela Merkel di chiudere temporaneamente le frontiere tedesche manda tre messaggi molto chiari ai partner europei.
Il primo è che l’afflusso spropositato di profughi, favorito e anzi alimentato dalla mancanza di controlli da parte dei vicini, ha saturato sia le capacità logistiche sia la tenuta politica del governo tedesco. La città di Monaco, che ha ricevuto 40mila fuggitivi in un solo week-end, è al collasso. E in seno alla coalizione che sostiene Angela Merkel i conservatori bavaresi cominciano a brontolare e ad accarezzare il cane della xenofobia che finora era rimasto miracolosamente a cuccia. Se vogliono che la Germania continui a mantenere aperte le proprie porte, dice Berlino, i partner europei devono darle il tempo di gestire l’emergenza in modo umanamente e politicamente non traumatico creando «zone di attesa» per i profughi, anche in Italia.
Il secondo messaggio è mirato più direttamente a Orbán e al governo ungherese, che sta usando i disperati in fuga dalla Siria come arma impropria per colpire Angela Merkel. Budapest, contraria a ogni proposta di quote europee, si è detta pronta perfino a rinunciare alla redistribuzione di 50mila dei suoi rifugiati che le era stata offerta dalla Commissione. Il nuovo piano di Juncker per ripartire altri 120mila profughi stipati in Italia, Grecia e Ungheria sarà discusso oggi dai ministri dell’Interno riuniti a Bruxelles. Ma Orbán pensa di poterne fare a meno, visto che le centinaia di migliaia di disgraziati oggi sul suo territorio chiedono solo di poter passare per andare verso Nord. Chiudendo le frontiere, la Germania dimostra a Orbán che quello da lui cinicamente definito «un problema tedesco» può rapidamente diventare un problema ungherese, in grado di mettere in ginocchio il suo piccolo e arrogante Paese.
Il terzo messaggio inviato dalla Merkel riguarda tutti gli europei, e in particolar modo quel blocco di Paesi dell’Est deciso ad evitare ad ogni costo il sistema delle quote proposto dalla Commissione e qualsiasi manifestazione di solidarietà con gli altri membri dell’Unione. Le regole di Dublino sul diritto di asilo, che io ho temporaneamente sospeso come gesto umanitario di fronte alla tragedia siriana, restano sempre in vigore, dice in sostanza la Cancelliera. O troviamo tutti insieme una soluzione condivisa, facendo ciascuno la propria parte, oppure applichia- mo le regole esistenti e la Germania, che come la Francia non ha frontiere esterne all’Ue, potrà tranquillamente ripararsi dietro lo scudo dei Paesi periferici più esposti all’assalto dei profughi.
Tutto questo, ovviamente, fa parte delle grandi manovre in vista della riunione dei ministri di oggi. Che però difficilmente sarà in grado di ricucire le lacerazioni apertesi tra un Sud dell’Europa travolto dall’ondata dei migranti e incapace di gestirla secondo le regole convenute, un Nord pronto a dimostrare solidarietà, ma a condizione che le regole vengano rispettate, e un Est che vede l’Europa solo come una fortezza entro le cui mura rifugiarsi opportunisticamente per trovare riparo dal vicino russo e, occasionalmente, anche dal profugo islamico. Questi fossati che l’emergenza migratoria sta scavando tra le tre aree culturali ed economiche dell’Unione non potrà essere colmata da un consiglio ministeriale. E probabilmente neppure dal vertice.
«L’ Europa ha fallito», denunciava ieri un ministro tedesco del partito bavarese. Ma i numerosi fallimenti dell’Europa, quelli passati e anche quelli che verosimilmente ci riserva il futuro, dimostrano solo una cosa. Dopo essersi dotata di strumenti centralizzati per gestire la libera circolazione delle merci e dei capitali, l’Europa non può più tardare a fare altrettanto per gestire la libera circolazione delle persone all’interno dei suoi confini, e regolare quella all’esterno. Juncker ha annunciato che proporrà entro l’anno la creazione di una Guardia di frontiera europea. Ma non può esistere una guardia di frontiera unica se ci sono politiche migratorie e di asilo diverse. Questo significa che, dopo aver messo sotto tutela i ministri nazionali dell’Economia, Finanze, Industria, Agricoltura e Commercio, è arrivato per Bruxelles il momento di mettere sotto tutela anche i ministri dell’Interno e le loro competenze rimaste finora ostinatamente e orgogliosamente sovrane. Ci riuscirà? Difficile dirlo. Ma in questa direzione ci spingono la Storia, i pochi governi che l’hanno capita e, soprattutto, alcune decine di milioni di profughi che si affollano alle nostre frontiere.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Sui migranti una crisi devastante, Parigi e Berlino ora salvino l’Europa (di Jürgen Habermas)12 settembre 2015, di Federico La Sala
Sui migranti una crisi devastante, Parigi e Berlino ora salvino l’Europa
Il filosofo tedesco: “I paesi della Ue non riescono ad accordarsi su una linea di azione comune, ed è un brutto segnale
Francia e Germania prendano l’iniziativa per riunire gli Stati legati dall’euro
Per dimostrare che esiste un nocciolo duro in grado di andare avanti unito”
di Jürgen Habermas (la Repubblica, 12.09.2015)
LA REAZIONE nel complesso positiva della popolazione tedesca all’afflusso di rifugiati segna un’importante discontinuità con lo stato d’animo imperante nel Paese all’inizio degli anni ‘90. Dimostra che una leadership politica risoluta - di cui finora, con la Merkel, abbiamo sentito la mancanza - può condurre nel lungo periodo l’opinione pubblica e la società civile a manifestare il loro sostegno e la loro volontà di venire in aiuto a queste popolazioni.
L’asilo politico non è una questione di valori - le chiacchiere sul tema dei “valori” mi esasperano - ma un diritto, e un diritto fondamentale. Questo diritto non può essere garantito solo dai Governi. Dev’essere rispettato dalla popolazione nella sua interezza. I Governi possono non riuscire a far fronte alla sfida attuale, per scoraggiamento o per mancanza di sostegno da parte dei loro mezzi di informazione e dei loro cittadini. E a volte anche per calcoli meschini e per la pusillanimità dei partiti politici di fronte alla pigrizia, l’egoismo e la mancanza di una visione alta nella popolazione.
Per il momento, vediamo che i Paesi membri dell’Unione Europea non riescono, complessivamente, ad accordarsi su una linea d’azione comune. L’onesta proposta del presidente Hollande e della cancelliera Merkel non incontra consenso. Si tratta indubbiamente di un segnale allarmante e vergognoso, ma che la dice anche lunga sul reale stato politico di una comunità che non è diretta da un Parlamento e un Governo comuni, bensì da compromessi stipulati tra ventotto Governi nazionali. Le diverse reazioni nazionali al problema urgentissimo che dovrebbe oggi vedere una risposta comune testimoniano anche realtà di cui bisogna tener conto: la differente anzianità di appartenenza all’Unione, le differenze economiche importanti - troppo importanti - fra Paesi membri, e soprattutto le differenti storie nazionali e le differenti culture politiche.
L’Europa, di fronte a questo disaccordo insormontabile sulla sfida politica e morale rappresentata dalla crisi migratoria, non deve fallire, col rischio di uscirne alla lunga devastata. E a tale scopo vedo solo una strada realistica: la Francia e la Germania devono prendere l’iniziativa e riunire i Paesi strettamente legati fra loro dall’euro e dalla crisi che attraversa questa moneta per proporre delle soluzioni comuni. La Francia e la Germania devono dimostrare che esiste un nocciolo duro dell’Europa in grado di agire e di andare avanti unito.
Un successo simile potrebbe portare anche, finalmente, a un cambiamento dell’atteggiamento del Governo tedesco, da cui dipende in toto un esito positivo, più a lungo termine, della crisi monetaria stessa. La Francia, se adottasse una linea di condotta energica sulla crisi dei profughi, oltre a restare fedele alla sua tradizione politica darebbe una spinta al Governo tedesco, in modo indiretto: non è solo questione di mostrarsi solidali con quelli che cercano asilo politico, perché una solidarietà di questo tipo è un dovere giuridico; una solidarietà finanziaria è anche una necessità politica in seno a una comunità monetaria che può sopravvivere solo con una politica fiscale, economica e sociale comune.
(Copyright Jürgen Habermas. Traduzione di Fabio Galimberti)
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Europa e migranti (di Piero Bevilacqua).11 settembre 2015, di Federico La Sala
Europa e migranti
La miseria morale della dirigenza neoliberista
La sinistra ha la possibilità di fornire delle risposte a questo scenario turbolento
di Pietro Bevilacqua (il manifesto, 10.09.2015)
Quando la globalizzazione cessa di presentarsi sotto forma di merci e di capitali, e assume l’aspetto di umani individui, addirittura di popoli in fuga, allora il pensiero unico neoliberale precipita in confusione. La libertà della sua assordante retorica riguarda i soldi e le cose, non gli uomini. Per le persone, la libertà di transito non può essere uguale a quella delle merci. È faccenda più complicata. E dunque la coerenza teorica viene abbandonata e si passa all’uso delle mani.
Di fronte al fenomeno migratorio il ceto politico europeo, salvo rare eccezioni, è caduto negli ultimi mesi assai al di sotto dell’intelligenza normale delle cose, della capacità di cogliere non tanto la sovrastante e incontrastabile potenza di un processo storico. In questo la miseria morale del suo atteggiamento, che ha assunto la faccia truce dell’intransigenza contro i derelitti del mondo, col tempo resterà incancellabile più per il lato ridicolo che per la ferocia. Leader e uomini di governo ci sono apparsi nell’atto di voler svuotare l’oceano con il cucchiaino.
Ma segno ancor più rilevante di una mediocrità politica senza precedenti è l’incapacità di rappresentare gli interessi di lungo periodo dei rispettivi capitalismi nazionali, di cui sono i solerti servitori. Ossessionati dalla conservazione del loro potere, con l’occhio sempre fisso ai dati del consenso personale, governanti e politici di varia taglia hanno di mira il solo scopo di vincere la competizione elettorale in cui sono perennemente impegnati contro avversari e sodali. E perciò sono spaventati dalle difficoltà dei problemi organizzativi che l’arrivo dei migranti pongono nell’immediato.
La loro campagna elettorale può riceverne solo danno. Se negli ultimi giorni le barriere sono cadute è perché - come è apparso chiaro - la vastità di massa e l’irruenza incontenibile del movimento di popolo poteva, da un momento all’altro, precipitare in un massacro. Rischiava di rappresentare agli occhi del mondo, ancora in Europa, una nuova forma di olocausto nel glorioso terzo millennio. E la Germania, soprattutto la Germania, con il suo passato, non poteva permetterselo.
Ma chi ha la testa sollevata al di sopra della palude della nanopolitica sa che il fenomeno migratorio è di lunga data, è solo esploso a causa delle guerre recenti in Oriente e in Africa. L’Human Development Report 2009, dedicato dalle Nazioni Unite a Human mobility and development, ricordava che «« Ogni anno, più di 5 milioni di persone attraversano i confini internazionali per andare a vivere in un paese sviluppato.»» E i maggiori e quasi esclusivi centri di attrazione erano e sono gli Usa e l’Europa.Una migrazione immane che dalla metà del secolo scorso ha spostato circa 1 miliardo di persone fuori dai luoghi in cui erano nate. Come potrebbe essere diversamente? Il capitalismo usa due potenti leve per sradicare i popoli dalle proprie terre.
La prima è quella dello “sviluppo”, la trasformazione delle economie agricole in primo luogo, la distruzione della piccola proprietà coltivatrice a favore delle grandi aziende meccanizzate, la nascita di poli industriali, lo svuotamento delle campagne, la formazione di megalopoli e di sconfinate bidonville. E lo sviluppo, che in tanti paesi avanza attraverso vasti diboscamenti e la rottura di equilibri naturali secolari, il saccheggio neocoloniale delle risorse, genera anche altre migrazioni: quella dei profughi ambientali, che fuggono da inondazioni o da prolungate siccità.
L’altra leva, sempre più attiva, è il potere incontenibile di attrazione che le società prospere dell’Occidente esercitano sulle menti delle popolazioni immiserite, deportate, segregate che si agitano nei vari angoli del mondo. Occorre tenerlo bene in mente: ogni giorno, anche nel più remoto villaggio africano, grazie a un’antenna satellitare va in onda lo spettacolo della più flagrante ingiustizia che lacera il destino delle genti sul nostro pianeta.
Uno spettacolo grandiosamente tragico che i dannati della Terra non avevano mai visto nei secoli e nei decenni passati. I miserabili, gli affamati, gli invalidi, i reclusi, le donne segregate, possono vedere dall’altra parte del mondo i loro simili, uomini e donne come loro, ricchi, sazi, sani, liberi. E questo spettacolo genera due scelte, ormai ben evidenti: l’estremismo terrorista o la fuga di massa.
Ma il ceto politico europeo, che vive alla giornata - non quello governativo americano, che dispone di centri di analisi strategica e di proiezioni di lungo periodo - non comprende, per specifica miseria intellettuale, neppure l’interesse del capitalismo che ha scelto di rappresentare. Dimentica, ad esempio, che l’immigrazione di popolazione “latina” negli Usa è stata una delle grandi leve del boom economico degli anni ’90 in quel paese.
Ma soprattutto non comprende quali vantaggi una forza lavoro giovane e abbondante procurerà alle imprese europee nei prossimi anni. E qui è evidente che il problema riguarda tutti noi, la sinistra politica, il sindacato. Siamo stati certamente encomiabili nel difendere i diritti dei migranti, il valore di civiltà del libero spostamento delle persone oltre le frontiere.
Ma l’arrivo di tanta forza lavoro a buon mercato non solo ci impone di vedere le persone umane, i titolari di diritti intangibili, oltre le braccia da fatica - cosa che in Italia abbiamo ben fatto, anche se solo a parole e senza alcuna mobilitazione - ma di cogliere per tempo la sfida che tutto questo ci pone. Sfida di organizzazione, di proposte, di soluzioni, di politiche. O facciamo un ulteriore salto di civiltà, tutti insieme, secondo le logiche della nuova storia del mondo, o regrediamo tutti insieme. Per strano che possa sembrare, la sinistra, in Italia, ha la possibilità, la possibilità teorica, di fornire delle risposte strategiche con cui rispondere allo scenario turbolento e difficile che si apre. Ci ritornerò prossimamente in maniera mirata.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Le 2 Europe. La Germania a “porte aperte” contro l’eterno ritorno dei Muri (di Angelo Bolaffi).10 settembre 2015, di Federico La Sala
Le 2 Europe
La Germania a “porte aperte” contro l’eterno ritorno dei Muri
La scelta della Merkel di accogliere i profughi traccia un modello di rapporto con l’Altro che cambia l’asse Ue
E che sfida le decisioni di segno opposto di Ungheria e Danimarca
di Angelo Bolaffi (la Repubblica, 10.09.2015)
«Dalla Germania solo e sempre cattive notizie» amava ripetere Tacito: evidentemente il grande storico romano non aveva previsto Angela Merkel. Colei che ancora solo poche settimane or sono nell’immaginario collettivo del Vecchio continente veniva raffigurata come “matrigna d’Europa”, arcigna espressione di una visione senza cuore della po-litica, si è come d’incanto trasformata in motivo di stupefatta sorpresa. In qualche caso persino di entusiastica ammirazione e il timore di una “egemonia tedesca” in speranza che la Germania assuma finalmente la guida del processo di unificazione europeo.
Certo: l’epocale svolta nella politica della accoglienza e dell’integrazione che la Merkel è riuscita nel giro di pochissime ore a imporre al suo paese ha una portata le cui conseguenze potremo valutare solo nei prossimi mesi o addirittura anni. Tanto più importante adesso, quando Ungheria e Danimarca guidano il fronte di chi rifiuta l’accoglienza. Essa infatti ridisegna non solo l’atlante geo-economico dell’area tra l’Europa e la costa meridionale del Mediterraneo ma ridefinisce anche i parametri etici dell’agire politico di una componente decisiva, l’Unione europea, del mondo occidentale.
Non è per questo esagerato paragonare la scelta della Merkel che ha trasformato la sua persona e il suo paese in motivo di speranza per centinaia di migliaia di profughi al gesto rivoluzionario compiuto da Willy Brandt il 7 dicembre del 1970 quando l’ex borgomastro di Berlino diventato cancelliere si inginocchiò dinnanzi al monumento in memoria della rivolta del ghetto di Varsavia. Un gesto grazie al quale la Germania fece pace con se stessa e col mondo.
Anche se drammatici fattori contingenti hanno avuto un peso non indifferente di questa “metamorfosi Merkel” è possibile razionalmente delineare la genesi. Ha cioè precise origini e spiegazioni che hanno a che fare con la vicenda storica tedesca ma anche con la natura specialissima della leadership politica che sta lentamente trasformando il cancellierato della Merkel in un fenomeno per i manuali di politologia.
La convinzione della Merkel e di tutto il governo tedesco di poter affrontare e risolvere («faremo tutto il necessario e ci riusciremo » questa l’impegnativa promessa della Merkel) la sfida di integrare 800mila migranti si fonda su due certezze: le precedenti esperienze storiche. E il solido funzionamento del sistema sociale, economico e politico-istituzionale.
Anche senza ritornare alle drammatiche vicende degli anni tra il 1944 e il 1950 quando milioni di profughi lasciarono le terre ex prussiano-tedesche cercando rifugio e integrazione nelle regioni ad occidente dell’Elba ci sono due altre esperienze che possono essere di utile riferimento. In primo luogo l’ integrazione a partire dagli anni ‘50 di milioni di lavoratori provenienti da Italia, Turchia e poi via via da Spagna, Grecia e Jugoslavia.
Ma la grande svolta avvenne alla fine degli anni ‘90 grazie al governo o guidato da Schröder e da Joschka Fischer. Grazie alle importanti riforme realizzate dopo la riunificazione del paese dal governo “rosso-verde”, la Germania è diventata la nazione in Europa in cui la pratica del riconoscimento è una filosofia messa in atto anche nelle realtà più estreme di degrado urbano.
Infatti la politica di integrazione sociale e culturale (religiosa) degli immigrati procede seguendo una sorta di “terza via” differenziandosi sia dal modello francese di “universalismo” assoluto che da quello “multiculturalista” inglese (e anglosassone in genere). Da quello francese che mira a una integrazione intesa come totale assimilazione ai valori della nation française e nega in tal modo qualsiasi riconoscimento delle differenze culturali. Ma parimenti anche dal modello inglese del Londonistan, basato sulla presa d’atto delle esistenza di una pluralità di realtà: è il multiculturalismo di ghetti contigui ma reciprocamente impenetrabili.
L’abbandono da parte della Germania del mito arcaico e barbaro dello jus sanguinis è stato possibile grazie all’azione di “stedeschizzazione” della morale collettiva compiuta dai Verdi. C’è poi un’altra ragione. All’inizio di questo secolo-millennio la Germania era “il malato d’Europa”: basso tasso di crescita, alto tasso di disoccupazione, debito pubblico fuori controllo, disaffezione degli investimenti privati.
Oggi grazie alle riforme dell’Agenda 2010 volute da Schröder la Germania è il centro di gravità democratico del Vecchio Continente: caso forse unico in Europa, nessuna formazione politica dichiaratamente xenofoba ha rappresentanza parlamentare (questo ovviamente non significa affatto che non esistano organizzazioni neonaziste). Certo le distanze tra l’Ovest e l’Est continuano ad esistere: ma chi viaggi oggi tra Lipsia e Dresda non può non prendere atto che quelle regioni hanno conosciuto una trasformazione davvero stupefacente.
Ma il vero arcano del Modell Deutschland consiste nella sistematica ricerca del “compromesso” a livello politico, sociale e istituzionale per assicurare la stabilità del sistema di cui quella della moneta e quella del governo sono le metafore per eccellenza. La segreta “teologia politica” di un paese che ha scelto, dopo averne fatto diretta e tragica esperienza, di mettere “fuori legge” la primitiva logica della contrapposizione “amico-nemico” tanto cara a Carl Schmitt, è un programmatico antidecisionismo.
E poi c’è il fattore Merkel: negli anni la Cancelliera è riuscita a costruire un rapporto di fiducia con l’elettorato come nessuno mai prima di lei. Né Adenauer o Kohl per la Cdu o Brandt e Sch- midt per la Spd. E non è la prima volta che tagliando corto con la sua proverbiale prudenza la Merkel è stata capace nel giro di poche ore di proporre un orizzonte totalmente differente all’azione politica. Ma questo successo apparentemente irresistibile della Merkel ha anche un suo “lato oscuro” su cui prima o poi converrà iniziare a interrogarsi. Intanto a dar vita al vero “partito della nazione” ci ha pensato lei.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- La Germania chiude i conti con il passato (di Ferdinando Camon)9 settembre 2015, di Federico La Sala
La Germania chiude i conti con il passato
di Ferdinando Camon (La Stampa, 09.09.2015)
L’accoglienza (così massiccia, così vistosa) dei profughi da parte della cancelliera Merkel chiude nella memoria degli europei l’epoca della Germania crudele e ostile, costruita dalla Seconda guerra mondiale. Per chi ha la mia età, quella era la Germania, non sarebbe mai cambiata.
Una Germania che attuava un rifiuto degli altri fino a compiere il più grande misfatto che la Storia abbia conosciuto. «Come faremo a liberarci di quel passato?» si chiedevano gli intellettuali tedeschi (e austriaci). Nel dibattito in Germania e in Austria quel passato era noto come «il passato che non passa». Nelle scuole per interi decenni non si parlava di quella colpa. Fu uno choc quando arrivò in tv un film (grossolano ma non reticente), intitolato «Olocausto» (termine sbagliato), in cui si vedeva l’incendio di case di ebrei con gli ebrei dentro, ma ricordo che tra i soldati tedeschi che osservavano il rogo correva questo dialogo: «Chi sono?», «Spie». Ancor oggi, nel far giustizia per la strage di Stazzema, la Germania non collabora con noi.
Aspetta che gli imputati, molto vecchi, muoiano. E se muoiono, con queste tremende accuse, sarà dannata la loro memoria? No, per niente. Una docente di Letteratura italiana all’università di Potsdam, Isabella von Tretzskow, aveva adottato per il suo corso un libro in cui raccontavo le stragi dei tedeschi nel Veneto. Il libro s’intitola La Vita Eterna in italiano, Das Ewige Leben in tedesco. I suoi studenti restano impressionati, vogliono saperne di più, cercano nelle biblioteche e negli archivi, ma non trovano nulla.
Come mai? Perché tutte le prove contro il comandante tedesco erano state distrutte, in obbedienza a una legge. Quel comandante era stato citato in processo da un pool di magistrati (onore a loro), e Das Ewige Leben era tra i documenti a carico, ma la notte prima della prima udienza ebbe un infarto e morì. Le prove contro di lui furono bruciate. Perché la Germania aveva varato una legge in base alla quale, se un cittadino tedesco viene accusato di crimini che possono infangare la sua memoria, ma muore prima che il processo sia giunto a condanna, ha diritto che tutte le prove siano distrutte. Il passato che non passa passa dichiarandolo mai esistito.
Non amo la Germania. Ho un amico che dice: «D’estate prendo l’auto e giro per l’Europa, se sento parlare tedesco accelero». Lo capisco. La lingua tedesca fu legata a eventi indelebili. A chi l’ha sentita urlare negli ordini militari, fa ancora paura. Nei libri, nei film, nei documentari, è la lingua del terrore. Pare inventata apposta per «dare sfogo a una rabbia vecchia di secoli» (Primo Levi). Era la lingua della superiorità, del disprezzo, della sopraffazione, della distruzione.
In pochi giorni, quell’immagine della Germania viene sostituita da un’altra immagine: masse di uomini disperati, che una volta sarebbero stati chiamati Untermenschen, entrano nei confini di quello Stato, agitano le mani in segno di giubilo, scandiscono il nome dello Stato e della cancelliera come santi e benefattori. E tutti vengono accolti. Chi voleva opprimere i popoli che nella gerarchia dell’umanità erano terzi, quarti, quinti, ora offre cibo e aiuto a uomini che sono gli ultimi. Chi in nome di Nietzsche cancellava il Cristianesimo, ora in nome del Cristianesimo cancella Nietzsche. Non è un caso che a guidare la storia tedesca verso questo ricominciamento sia una donna. Nella sua bocca la lingua tedesca perde ogni timbro militare.
Mi gira per il cervello la frase di uno scrittore tedesco, forse Goethe?, che dice: «La lingua tedesca e la lingua spagnola sono lingue sublimi, la lingua italiana e la lingua francese sono lingue belle». Penso che si potrebbe tranquillamente affermare il contrario. Però sulla militarità della lingua tedesca è tempo di ricredersi. Nella bocca della donna che ora guida la Germania la lingua tedesca ha un suono mite, languido, gentile. È una lingua umana. Come tutte. Il passato che non passava da 70 anni è passato in tre giorni.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Angela l’europea (di Adriana Cerretelli)9 settembre 2015, di Federico La Sala
Angela l’europea
di Adriana Cerretelli (Il Sole-24 Ore, 09.09.2015)
Raccontano che al principio della crisi greca, Angela Merkel non voleva sentir ragioni: per lei la Grecia poteva andare a fondo e l’euro perdere pezzi e magari anche la vita senza grandi contraccolpi sulla Germania. Più che la favola buona, la sacra icona da preservare, per il cancelliere venuto dall’Est l’Europa e i suoi problemi erano oggetti incomprensibili, culturalmente estranei e di confusa utilità. Lei l’Unione l’aveva conosciuta dall’altra parte della cortina di ferro, con il filtro della propaganda comunista della Germania di Honecker: una realtà ostile, il braccio armato del nemico capitalista e relativi intrighi.
Molti a Berlino avevano tentato di sensibilizzarla ai suoi pregi. Inutilmente. A un certo punto si decise di chiedere addirittura all’allora presidente della Commissione europea, José Barroso, di provare a conquistarla alla causa con un’approfondita lezione sulle ragion d’essere dell’Europa. Si dice che Barroso sia tornato a Bruxelles sconfortato.
Sono passate le crisi e gli anni. Alla fine è diventato evidente a tutti che i tempi di meditazione e di metabolismo di Angela sono lunghi e compassati ma non immobili. Un giorno si è scoperto che, nella distrazione generale e nel segno dell’apparente calma piatta, era nato un vero leader europeo. Se alla fine la tela dell’euro non è stata strappata e, nonostante a metà luglio tutto fosse pronto per farlo, la Grecia non è stata accompagnata alla porta il merito è tutto della Merkel che ha saputo guardare più lontano, sfidando il suo ministro delle Finanze, la sua opinione pubblica e il Bundestag, tutti sicuri che la moneta unica starebbe meglio senza un paese ritenuto irrecuperabile. Ormai convintasi che euro ed Europa sono un interesse strategico tedesco e una leva irrinunciabile della competitività globale, il cancelliere ha scelto di finanziare a condizioni draconiane il terzo salvataggio di Atene, pagando un costo certo piuttosto che l’oscura fattura di una lacerazione traumatica per l’Unione e la sua tenuta futura.
Il copione si è ripetuto davanti alla valanga dei rifugiati. Travolta da 100.000 arrivi nel solo mese di agosto, 800.000 attesi nell’anno, il quadruplo del 2014, per la seconda volta il cancelliere ha capito prima degli altri la qualità della crisi, che è strutturale e non temporanea, e ha proposto rimedi: no agli istinti protezionistici, deleteri e inefficaci, ma una risposta europea a una questione europea che va molto al di là della semplice contabilità dei numeri.
«Mai come oggi sono intimamente convinta che la nostra risposta deciderà se l’Europa sarà accettata come un continente di valori. Il mondo intero ci guarda. Non possiamo limitarci a dire che la Siria è troppo lontana e non vogliamo occuparcene. La politica europea di asilo deve esistere nei fatti e non sulla carta». In agosto aveva avvertito: «L’emergenza rifugiati occuperà i nostri Governi molto di più di quella greca». Poche frasi, la nuova dottrina europea: quote di ripartizione saranno obbligatorie per tutti, chi non ci sta dovrà contribuire con lo 0,002% del Pil al Fondo per i rifugiati, la solidarietà non sarà un optional per nessuno. Come non lo saranno registrazioni e rimpatri per i non aventi diritto. Ma questo sarà solo un primo passo. Tra l’altro doveroso per la Germania che ha storicamente i nervi scoperti sull’etica del profugo e, con l’inattesa prova di generosità, forse spera anche di scoraggiare i molti sentimenti anti-tedeschi scatenati dal diktat di luglio alla Grecia.
Per governare un problema strutturale che promette flussi crescenti nei prossimi anni però ci vorrà ben altro: pacificazione e aiuti allo sviluppo per i paesi destrutturati e in guerra sull’altra sponda del Mediterraneo e oltre, la fine quindi dell’ignavia europea, il principio di un impegno serio (anche militare?) in Siria e dintorni. Insieme al recupero concreto dei valori europei. In parole povere, ricostruzione di un’identità affondata nei meandri di ipocrisia, egoismi, indifferenza verso l’altro.
Senza un’identità forte e consapevole è infatti impensabile stabilire un dialogo utile e credibile con altre comunità e culture che si preparano a entrare e a vivere nell’Unione. Riempiendo il vuoto di idee e di azione che la circonda nell’Ue, da vero leader europeo la Merkel insomma traccia un programma d’azione collettivo che consenta a tutti, invece di subirne solo i problemi, di cogliere anche tutte le promesse dell’Europa multiculturale che si prepara.
Ovviamente lo fa cercando di far coincidere l’interesse tedesco con quello europeo. Come del resto dovrebbero fare tutti i suoi partner, invece troppo spesso assenti. Passate emozioni e commozioni, il cancelliere però sa che non sarà facile far digerire la svolta: nè in Europa, né in Germania né altrove, specie a Est. Ma sa che non c’è scelta: o l’Europa riuscirà a vivere di immigrati o ne sarà schiacciata.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Lo scontro fra due idee di Europa. Quando a fuggire dai paesi dell’Est erano i tedeschi (di Guido Crainz)10 settembre 2015, di Federico La Sala
Quando a fuggire dai paesi dell’Est erano i tedeschi
La lezione dimenticata di una tragedia del Dopoguerra
di Guido Crainz (la Repubblica, 10.09.2015)
L’hanno conosciuta drammaticamente settant’anni fa, milioni di tedeschi, la fuga disperata dai drammi di un feroce dopoguerra. Undici, dodici milioni in fuga dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall’Ungheria e da altri paesi ancora - luoghi ove avevano vissuto per generazioni - verso una Germania distrutta. In fuga dalle violenze dell’Armata rossa ma anche da popolazioni che il nazismo aveva perseguitato e sterminato e ora si scagliavano contro chiunque parlasse tedesco. In fuga già nell’inverno del 1944-45, ed è un giornale svizzero a descrivere «una di queste colonne di gente spaurita. Duemila cavalli esausti dalla fatica trascinano pesanti veicoli con sopra ventimila persone: uomini anziani, donne, ragazze e bambini ai quali si congelano le membra e il cuore non regge alla fatica. Quando hanno sete la placano soltanto con un po’ di neve; mangiano se ne hanno. Quando la neve si scioglierà, molti di questi miseri saranno trovati morti sulla strada, nei campi, nei prati». Una storia che L’usignolo dei Linke di Helga Schneider (Adelphi) racconta con due sguardi: quello di un bambino che ha vissuto il trauma della fuga davanti all’Armata rossa e ne resta segnato a vita, e quello di una bambina cacciata a forza con la sua famiglia dalla Polonia dell’immediato dopoguerra.
Si valuta che siano almeno un milione le vittime di questa fuga disperata iniziata alla fine della seconda guerra mondiale e proseguita con le espulsioni del dopoguerra: “selvagge”, prima, e sancite poi dalla Conferenza di Postdam. Alimentate al tempo stesso da una volontà di rivalsa e da un “nazionalismo etnico” che i regimi filosovietici fecero propri e che utilizzarono per conquistare consenso.
Nel 1938 la Cecoslovacchia era formata solo per due terzi da cechi e slovacchi, dopo questi processi saranno quasi la totalità: alle espulsioni dei tedeschi si aggiungono quelle di ungheresi e di altre minoranze ancora, e non è diverso il rimodellarsi della Polonia. Un secondo, profondo modificarsi di un’Europa centro-orientale già sconvolta dallo sterminio e dalla cancellazione della presenza ebraica. I drammi del dopoguerra si svolgono appunto nell’Europa devastata dal nazismo, e possiamo persino comprendere perché poche voci si siano levate allora contro quelle disumanità.
Fra democrazia e nazismo vi è certo contrapposizione di valori - scriveva, isolatissimo, l’ungherese István Bibó - ma «non vi è differenza fra il dolore di una madre il cui figlio è stato ucciso in un campo di sterminio tedesco e quello di una madre tedesca il cui figlio, morto di fame in un campo di concetramento cecoslovacco o per strada durante una marcia forzata, viene seppellito avvolto in un foglio di giornale. Se il numero di queste madri dovesse moltiplicarsi in Europa non troveremmo più nessuno a cui spiegare quale differenza vi sia fra la democrazia e il totalitarismo». Parole terribili, come è terribile questa storia: poche altre voci si aggiunsero, e possiamo comprendere perché allora esse siano rimaste isolate.
Comprendiamo molto meno perché ancora negli anni Novanta una grandissima parte di polacchi, cechi e slovacchi ritenesse sostanzialmente fondata l’epulsione dei tedeschi da quelle terre. Anche con questo - come ha ricordato su Repubblica Bernardo Valli - dobbiamo fare culturalmente i conti: con le modalità drammatiche con cui i paesi dell’Europa centrale hanno raggiunto una omogeneità etnica.
Va anche ricordato che le due Germanie devastate del dopoguerra seppero sostanzialmente accogliere quei milioni di profughi: non senza tensioni ma senza farne la ragione di rivalse e di revanscismi. Tentazioni presenti nella prima fase ma progressivamente stemperate e dissolte (forse vi è anche questo alla base dell’altro miracolo che fu compiuto dopo il 1989, con la riunificazione non traumatica di due realtà così profondamente differenti). Il resto dell’Europa occidentale preferì rimuovere quei drammi e i nodi di lungo periodo che essi facevano emergere. Preferì distogliere lo sguardo e poi cancellare quelle pagine dai manuali di storia (con poche eccezioni anche negli studi). Se non lo avessimo fatto capiremmo forse meglio che lo scontro fra due idee di Europa di questi giorni non ci parla di un inaspettato e incomprensibile altrove.
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- LA LEZIONE DI KANT. Il filosofo Markus Gabriel analizza la svolta tedesca sull’emergenza migranti: «È la Germania cosmopolita figlia di Kant».6 settembre 2015, di Federico La Sala
«È la lezione di Kant»
Il filosofo Markus Gabriel analizza la svolta tedesca sull’emergenza migranti: «È la Germania cosmopolita figlia di Kant».
di Danilo Taino (Corriere della Sera, 06.09.2015)
BERLINO. È la «Nuova Germania» che si manifesta, dice Markus Gabriel di fronte all’ondata di solidarietà nei confronti dei rifugiati che sta attraversando il Paese. «La Germania cosmopolita in senso kantiano», nata nel 1989. Gabriel, 35 anni, è uno dei filosofi emergenti tedeschi. Insegna Epistemologia, Filosofia moderna e contemporanea all’Università di Bonn. Parla sette lingue oltre a conoscere latino, greco antico, ebraico biblico. Quest’anno ha pubblicato in Italia Perché non esiste il mondo.
Professore, è stupito dalla solidarietà dei tedeschi?
«No, non sono molto sorpreso. Trovo piuttosto che sia interessante il fatto che altri lo siano. Siamo di fronte a un diritto di persone perseguitate per ragioni politiche. Negare questo diritto è come negare la democrazia o il governo della legge. Per noi è anche un principio della costituzione».
In altri Paesi la reazione non è la stessa.
«Rispetto ad altri Paesi la Germania è in una buona forma ideologica. Ma sta solo vivendo all’altezza di quelli che sono i valori europei».
Anche il governo ha risposto in modo positivo.
«È quello che speravo. In parte dipende dal fatto che si tratta di un governo stabile, al quale questa scelta non costa politicamente niente. La Germania d’oggi è come Cuba, con un partito unico, cristiano-democratico e socialdemocratico, al governo. Ma ha fatto una scelta intelligente. Non dimentichiamo che la Germania ha una storia di benvenuto nei confronti dei siriani lunga decenni. Apprezza da tempo le loro competenze. Come quelle degli iraniani. Si tratta di Paesi che hanno una classe media incredibilmente istruita. Chi arriva ha spesso valori che sono quelli che la Germania desidera».
Cos’è che mobilita i tedeschi? Solidarietà? Senso del dovere?
«È quella parte di ideologia tedesca universalista che considera tutti gli individui uguali, al di là della pelle, della lingua, della nascita. Che punta alla legge universale. Un’ideologia che puoi sempre usare. Ora, è la Germania al suo meglio, in certi momenti è stata al suo peggio».
Da dove viene?
«In questo momento non pensiamo come tedeschi ma come esseri. Deriva dall’Illuminismo dei primi tempi, una prevalenza che in Germania è tornata dopo la Seconda guerra mondiale».
Gioca un ruolo anche il senso di colpa per il passato?
«Forse in parte e per qualcuno. Ma non scordiamo che questo è un Paese di immigrati da decenni. Persone arrivate da altrove che oggi sono tedesche a tutti gli effetti. Non conta come sei: la Germania è cosmopolita. La vecchia Germania è finita nel 1989, con una rivoluzione. E con la riunificazione siamo diventati definitivamente un Paese di immigrati».
Conta anche la religione? La Germania sembra un Paese secolarizzato.
«Guardi che il 40% dei tedeschi vota per i cristiano-democratici. Il presidente federale Joachim Gauck era un pastore. Non direi che siamo un Paese secolarizzato. Vero, si può dire che l’Italia è un Paese cattolico e non si può dire che la Germania sia cattolica o protestante o musulmana. Ma ha una struttura molto teologica e il movimento di questi giorni ha anche una componente religiosa, di obbligo cristiano».
Quali radici filosofiche ci vede?
«La Germania è cosmopolita in senso kantiano. Per un certo periodo, fino ad anni recenti, hanno prevalso filosofie che spingevano al nazionalismo, compreso Heidegger. Ora, Kant e Habermas hanno preso il sopravvento. Ora l’idea prevalente è: essere tedeschi non è niente più che avere la cittadinanza tedesca e parlare la lingua. Non ci sono più consuetudini e usanze tedesche. Sono sparite. Nel bene e nel male».
Perché i Länder dell’Est sono più restii ad accettare i rifugiati?
«A dire il vero, opposizioni ci sono anche nel Baden-Württemberg, che è il Land più ricco con la Baviera, a Heidelberg. A Est, dove la popolazione è meno benestante, c’è più paura della concorrenza di chi arriva da fuori, si teme che porti via posti di lavoro. A fianco della nuova Germania c’è anche una Germania razzista che ha una sua idea di Heimat, di Patria».
Lei parla esplicitamente di Nuova Germania.
«Senza dubbio. La trasformazione si vede nella nazionale di calcio, dai Mondiali del 2006 (anche se non potremo mai vincere contro l’Italia). Müller e Özil fanno parte dello stesso team, senza differenza. E nessuno ne dubita. Durante la crisi greca, questa Nuova Germania non è stata capita da molti osservatori, che hanno visto un atteggiamento imperialista e repressivo nei confronti di Atene. È che spesso emerge quest’idea della Germania che cerca l’egemonia. Idea razzista: come dire che l’Italia è pizza e pasta. E incomprensione del fatto che c’è una Nuova Germania».
A proposito di Grecia: quanto pesa la buona salute economica del Paese sulla disponibilità dei cittadini ad accettare i profughi?
«Conta. Non credo che i tedeschi siano più caritatevoli di altri. Vista la sua situazione economica, la Germania può permettersi di mettere denaro a disposizione di altri. Se invece sei in difficoltà economiche il problema è molto diverso».
Quindi va ringraziato il ministro delle Finanze Schäuble.
«In qualche modo sì. Ma soprattutto va ringraziata la Cina, che finora è stato un partner economico fondamentale. Questo è il problema: beneficiamo tutti di un regime illiberale».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Weimar. Per dirla con Benedetto Croce: “Questa è la Germania che amiamo”.1 settembre 2015, di Federico La Sala
La lezione di Weimar
di Marino Freschi (Il Mulino, 24 agosto 2015)
Il genius loci di Weimar - e forse della migliore Germania - è Goethe, che, pur essendo nato nel 1749 a Francoforte sul Meno, in Occidente, a ventisei anni si trasferì a Oriente, nell’allora Ducato di Sassonia-Weimar, invitato da un intelligente quanto irruente principe, il duca Carl August, che in breve sarebbe divenuto l’illuminato monarca di un piccolo Stato che grazie a lui e a sua madre, la duchessa Anna-Amalia, divenne il centro spirituale, intellettuale, artistico della Germania e d’Europa.
Weimar contava allora circa 6.000 abitanti (oggi non arriva a 65.000); era impensabile che Goethe, che con il Werther era diventato l’autore più noto d’Europa, si fermasse più di qualche mese in quella minuscola capitale. E invece ci rimase fino alla morte, nel 1832. D’estate andava in vacanza in Boemia, alle famose terme di Karlsbad e di Marienbad, spesso con il duca, con la nobile Charlotte von Stein, cui si era legato da un profondo legame sentimentale (lei era sposata con sette figli), e con Herder, che era riuscito a far chiamare a Weimar.
Con una sorprendente eccezione: soggiornò quasi due anni in Italia, soprattutto a Roma, il grande amore della vita, dove, comunque, si guardò bene dal restare. Come pure non accettò l’invito di trasferirsi a Parigi che gli rivolse Napoleone, imperatore dei francesi e padrone d’Europa. Perché rifiutare? Proprio lui che era un leale ammiratore dell’Empereur, simpatia che gli procurò l’avversione della gioventù tedesca, che l’occupazione francese aveva risvegliato a un insano nazionalismo. E così Goethe rimase per tutta la vita in una cittadina che in virtù della sua presenza divenne un santuario culturale e artistico dell’Europa.
E la forza d’attrazione di questo “santuario” continuò. A Weimar si trasferì negli anni successivi Liszt; a Weimar morì, ancorché ormai obnubilato, Friedrich Nietzsche, di cui la città custodisce l’archivio, insieme a quelli, preziosissimi per la cultura mondiale, di Goethe, di Schiller e di Herder. E a Weimar agì anche il giovane Richard Strauss, proponendo le sue sinfonie giovanili più innovative. Nello stesso periodo all’Archivio Goethe lavorò Rudolf Steiner che, meditando sulle opere scientifiche di Goethe, fondò l’antroposofia e il suo straordinario centro spirituale, il Goetheanum, in Svizzera.
Ma la storia di questo luogo eccezionale continua: a Weimar Walter Gropius fondò il Bauhaus nel 1919 e nello stesso anno qui si raccolse il primo Parlamento tedesco per emanare la celebre Costituzione di Weimar (da cui la “Repubblica di Weimar”), così liberale e permissiva da non prevedere robusti argini contro il nazionalsocialismo, che scelse la città come uno dei suoi emblemi, nazificando il volto architettonico della città, altrimenti gioiosamente settecentesco e Biedermeier. Il terrore hitleriano è presente con il lager di Buchenwald, nei dintorni della città. Questa storia ora è raccontata da Annette Seemann in un godibile libro, Weimar (edizioni Beck), che varrebbe la pena tradurre.
Ma la città oggi può fornirci ancora molte lezioni: la sua storia recente comincia a metà Settecento. Vi sono musei e archivi e, da non trascurare, il più bel parco d’Europa, sul fiume Ilm. La Biblioteca Nazionale di Roma ha chiuso per il caldo. Quella universitaria di Roma Tre chiude per risparmiare energia. Quella di Weimar, aperta fino alle 21 (e anche qui fa caldo), è un gioiello (dedicato alla fondatrice Anna-Amalia) di organizzazione e di gentilezza, con fondi librari notevolissimi, molti di recente acquisizione (quando non c’è “mafia capitale”!) a cura della Fondazione Klassik Stiftung, mentre a Lipsia, a Marburg, a Friburgo le biblioteche non chiudono mai (a Berlino e a Monaco alle 24)! In questi giorni la maggioranza dei frequentatori sono italiani, e si capisce perché.
Weimar ha investito in cultura e ne ha ricevuto un riscontro immenso, sia finanziario sia come immagine di civiltà. Per dirla con Benedetto Croce: “Questa è la Germania che amiamo”. (Mi chiedo se Goethe trascorrerebbe ancora quasi due anni nella Città Eterna, a via del Corso 18, dove un bel museo lo ricorda: un museo tedesco!)
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- «Nessuna tolleranza per chi mette in dubbio la dignità di altri uomini e non è pronto ad aiutare quando è richiesto da umanità e diritto» (Angela Merkel).27 agosto 2015, di Federico La Sala
L’egemonia morale di frau Merkel
di Gian Enrico Rusconi (La Stampa, 27.08.2015)
«Nessuna tolleranza per chi mette in dubbio la dignità di altri uomini e non è pronto ad aiutare quando è richiesto da umanità e diritto». Queste sono le parole chiare e forti pronunciate da un capo di governo incurante delle contestazioni e degli insulti. E alle parole sono seguite iniziative molto concrete. Questa è la cancelliera Angela Merkel.
La Germania accoglierà tutti i profughi dalla Siria, anche quelli entrati nell’Ue dall’Italia, dalla Grecia, dall’Ungheria. In deroga alla norma (cosiddetta di Dublino) secondo cui i profughi dovrebbero rimanere nel Paese di arrivo. Non è un dettaglio burocratico: è la correzione ragionevole di una norma fissata a suo tempo, in modo astratto e formalistico, che si è rivelata di fatto contraria ai criteri di «umanità e diritto», di cui - in teoria - va fiera l’Europa.
La tragedia della migrazione di massa, cui stiamo assistendo impotenti, ha spalancato l’abisso tra i principi cui ci appelliamo e la nostra incapacità di rispondervi concretamente. Sappiamo perfettamente quanto sia difficile trovare risposte pronte e adeguate. Ma come è stato possibile trovarci così impreparati, dopo tanti segnali di premonitori di avvertimento? È umiliante leggere le cifre degli arrivi, le condizioni in cui sono costretti a vivere coloro che ce l’hanno fatta, la loro voglia di raggiungere le località desiderate, il numero (stimato) degli «spariti». Tutto questo a fronte della scarsità delle risorse a disposizione, anche perchè continua a dominare la convinzione che ogni euro speso per sistemare i profughi è rubato ai cittadini. Se lo è sentito urlare contro anche la cancelliera Merkel, con toni ancora più brutali perché accompagnati dall’accusa di «tradimento del popolo». Nulla di nuovo in questa Europa.
La decisione della cancelliera Merkel è stata salutata con soddisfazione dalla Commissione Ue che ha in programma di lanciare presto una politica comune dell’immigrazione. Se ne parla da tempo. Speriamo che non ci riservi l’ennesima delusione fatta di sole affermazioni generali, o anche solo di norme di regolamentazione selettiva più efficienti, o semplicemente di criteri vincolanti per tutti nella distribuzione dei legalizzati. Occorre un investimento di risorse materiali e culturali di grande proporzioni di cui la classe politica di tutto i Paesi non sembra rendersi conto, convinta com’è che in fondo si tratta una emergenza temporanea anziché di sommovimenti geo-politici profondi che mettono alla prova anche la nostra civiltà. È una sfida politica di prima grandezza.
Non mi è chiaro se il gesto di Angela Merkel, con tutta la forza simbolica che ha innanzitutto nei riguardi dei suoi concittadini tedeschi, vada in questa direzione. Se ha intenzione di incidere direttamente nella politica europea in tema di migrazione. O si limiterà a dire «fate come noi» - come ha dichiarato in altre circostanze. La Germania come nazione di riferimento.
Da qualche tempo nel dibattito pubblicistico tedesco è in atto una cauta riabilitazione del concetto di egemonia tedesca (respinta nettamente da un vecchio politico tradizionale come Wolfgang Schaueble). Egemonia intesa come sinonimo di responsabilità verso gli altri membri dell’Ue. È una elegante soluzione - purché non rimanga solo nominalistica. La sfida della migrazione offre il banco di prova.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- Le invasioni barbariche (di Marco Bascetta)28 agosto 2015, di Federico La Sala
Le invasioni barbariche
di Marco Bascetta (il manifesto, 28.08.2015)
I germanisti ci sperano sempre. In un qualche piccolo segnale di ripresa dell’etica e della cultura tedesca. A maggior ragione dopo una lunga sequenza di aspre critiche contro le forme che andava assumendo l’egemonia germanica sull’Europa: dall’ultimo pamphlet di Ulrich Beck alla pesantissima accusa rivolta da Juergen Habermas al governo di Berlino di aver dissipato in una sola notte (quella dell’imposizione del Memorandum ad Atene) l’intero patrimonio di apertura e affidabilità europeista accumulato dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Sarebbe di fronte all’ «immane tragedia» dell’immigrazione che alla Germania si offrirebbe ora l’occasione del riscatto, l’opportunità di correggere l’egemonia finanziaria con una «egemonia morale tedesca», come si intitola l’editoriale di Gian Enrico Rusconi su La Stampa del 27 agosto.
Del resto quel grande fenomeno storico che nei nostri libri di testo viene designato con l’espressione alquanto sprezzante di «invasioni barbariche» nelle scuole di lingua germanica è chiamato die Voelkerwanderung, ossia la migrazione dei popoli. Una espressione che però difficilmente vedremmo oggi applicata al gigantesco spostamento di popolazioni da numerose aree devastate del pianeta verso i più ricchi paesi d’Europa. Sarà perché questi uomini e queste donne non sono guidati dai rispettivi monarchi, dai quali, al contrario, rifuggono o perché l’unica arma di cui dispongono è quella del numero, di uno squilibrio intollerabile e, infine, di una necessità storica.
Di qui l’illusione che si tratti di una «emergenza umanitaria» e non di un processo incontenibile destinato a mutare radicalmente la composizione e la cultura delle società europee. Certo, l’ecatombe quotidiana, via terra e via mare, e le sue orripilanti circostanze (i sepolti vivi nelle stive dei barconi e nei camion), rivelano e celano al tempo stesso.
Rivelano la violenza spropositata delle condizioni di «viaggio» imposte ai migranti da trafficanti e guardie confinarie e dunque l’«emergenza umanitaria», ma celano la natura strutturale e affatto contingente dei flussi migratori.
Ma vediamo più da vicino in che cosa consiste l’ «esempio morale» di Angela Merkel. Sfidando i fischi e gli insulti di un gruppo di contestatori ultranazionalisti in quel di Heidenau, cittadina teatro di ripetute violenze dell’estrema destra, la cancelliera ha condannato con toni duri razzismo e xenofobia.
Qualunque altro governante europeo non avrebbe potuto fare altrimenti. A maggior ragione di fronte a una escalation di attentati e aggressioni di matrice razzista o neonazista come quella che la Germania ha lasciato crescere al suo interno, spesso civettando con l’ideologia della «priorità nazionale».
Fin qui, dunque, nulla di straordinario. Più rilevante, invece, la decisione di sospendere la regola di Dublino che impone ai richiedenti asilo di rimanere nel primo paese dell’Unione in cui sono arrivati. Un buon motivo per far tirare il fiato ai paesi di confine come il nostro. Ma c’è un però.
La Germania apre le porte ai soli siriani, considerati la punta dell’iceberg «umanitario». Così facendo propone un modello che di morale non ha proprio nulla.
Se anche si assumesse come solo motivo di legittima fuga la guerra guerreggiata, in che cosa si distinguerebbe chi fugge da Mosul da chi fugge da Aleppo, da Kandahar o dallo Yemen?
Se il «paradigma siriano» può alleggerire una contingenza esso introduce tuttavia una delirante tassonomia dei migranti, suscettibile di continue partizioni: profughi di guerra (da suddividere sulla base di un qualche indice bellico?), rifugiati politici (da ripartire secondo un diagramma della repressione?), rifugiati climatici ( da individuare sulle statistiche meteo?), perseguitati religiosi (da definire secondo una misura della libertà di culto?) migranti economici (tanto peggio per loro). Infine la distinzione più assurda di tutte: quella tra paesi sicuri e paesi insicuri. Un paese, infatti, non è parimenti sicuro o insicuro per tutti. Per un omosessuale l’Iran non è, per esempio, un paese sicuro, come non lo è l’Arabia saudita per una donna desiderosa di guidare un’automobile e l’elencazione potrebbe procedere all’infinito.
Possiamo immaginare i burocrati dei centri di identificazione e registrazione alle prese con questo ginepraio. Così, di fronte a tanta complicazione che manda in pezzi la stessa dimensione «umanitaria», il modello tedesco procede verso una ulteriore restrizione del diritto di asilo (del resto più volte ridimensionato nel corso degli ultimi anni) alla quale sta alacremente lavorando il ministro degli interni Thomas de Mazière.
A questo si affianca una politica di restrizione del welfare e degli strumenti assistenziali (per i migranti in primo luogo, ma non solo) tali da rendere il paese sempre meno appetibile per chi intendesse stabilirvisi.
Quanto a «egemonia morale» non c’è davvero che dire. Risparmio e deterrenza in un colpo solo. Ogni breccia nei muri visibili e invisibili che dividono l’Europa è per molti un’occasione di salvezza, ma non bisogna perdere di vista il fatto che il «paradigma siriano» risponde a una logica di governo e di controllo del «diritto di fuga» che, sia pure sotto la pressione di eventi estremi ( fomentati da politiche globali senza scrupoli), risponde pur sempre alla volontà di garantire l’impiego profittevole e competitivo delle «risorse umane».
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- L’Europa nella storia. Imperi, rivoluzioni, il sogno unitario (di Sergio Romano)26 agosto 2015, di Federico La Sala
L’Europa nella storia
Conflitti e legami tra popoli cugini. Imperi, rivoluzioni, il sogno unitario
di Sergio Romano (Corriere della Sera, 26.08.2015)
Ogni riflessione sull’identità europea corre il rischio di essere usata per fini politici. Chi parla di Europa cristiana, come accadde frequentemente durante la redazione del preambolo della Costituzione europea, nasconde spesso il desiderio di tracciare un invalicabile confine tra la cristianità e l’islam o tra la cristianità e la laicità. Chi parla di Europa giudaico-cristiana (una espressione coniata negli Stati Uniti verso la metà del Novecento) si propone probabilmente lo scopo opposto: quello di relativizzare il ruolo delle chiese cristiane nella storia del continente. Chi mette il Sacro Romano Impero in cima all’albero genealogico europeo vuole probabilmente respingere alla periferia della «vera» Europa i Paesi che non possono rivendicare quella ascendenza.
Sono definizioni sommarie che non rendono giustizia ad altri contributi. Dovremmo forse pensare che l’Andalusia e la Sicilia, per via della dominazione araba, siano state per alcuni secoli terre prigioniere di una potenza aliena? Forse è meglio abbandonare questi criteri e affrontare il problema da un altro angolo visuale.
Nell’ultima fase dell’Impero romano esistono tra le sue frontiere tre grandi gruppi nazionali: i latini, i celti e i germani. Tutti e tre hanno contribuito alla organizzazione e al rafforzamento dell’Impero nella fase della sua maggiore potenza; ma i celti e i germani hanno contribuito altresì a distruggerlo nella lunga fase del suo declino. Anche i celti e i germani, tuttavia, ne hanno subìto l’influenza, conservano una sorta di nostalgia per il grande «padre» scomparso e si comportano come se nel cuore del continente esistesse un trono vacante a cui anche i «barbari» possono aspirare. L’idea d’impero sopravvive alla propria morte e la sua memoria è responsabile di molti fra i conflitti che hanno sconvolto l’Europa da Carlo Magno a Carlo V, da Filippo II a Luigi XVI e Napoleone. (Tralascio in questo elenco Adolf Hitler perché non era né romano né cristiano).
Lo stesso può dirsi del cristianesimo. Dopo essere stato respinto e perseguitato, il cristianesimo è diventato la religione ufficiale dell’Impero. Il papa romano si fregia di un titolo imperiale, pontifex , e si attribuisce il diritto di conferire legittimità ai futuri imperatori. Le nuove comunità cristiane costruiscono i loro templi sui luoghi dove i romani adoravano le divinità imperiali. Il latino rimane per molti secoli la lingua della Chiesa cattolica e di tutti coloro a cui è assegnato il compito di trasmettere la cultura del passato. L’idea d’impero e l’autorità spirituale del pontefice sono i due maggior fattori unitari della storia d’Europa.
Ma ciò che unisce può anche dividere. La corsa al trono romano di alcune fra le grandi famiglie europee e i loro scontri sul campo di battaglia creano nuove organizzazioni statuali, nuovi ceti militari e amministrativi, disegnano i confini di nuove patrie. La guerra è sempre stata una straordinaria fabbrica di identità e sentimenti nazionali: unifica i vincitori nel ricordo del trionfo; unifica i perdenti nel ricordo dell’umiliazione subita, nella voglia di riscatto, nella rabbia verso i responsabili della sconfitta subita.
Le stesse considerazioni valgono per la Chiesa romana. Il messaggio monoteista del cristianesimo seduce i popoli e li autorizza a considerarsi membri di una grande famiglia universale. Ma i suoi missionari lo diffondono adattando il messaggio e le liturgie ai costumi dei popoli che vogliono convertire; e contribuiscono così alla nascita delle nazioni, spesso piccole patrie regionali delimitate da storie comuni, dalla lingua e da confini naturali. Più che di un cristianesimo europeo converrebbe parlare di una pluralità di cristianesimi che si sono spesso combattuti per affermare la propria «verità». La storia d’Europa è anche una storia di conflitti religiosi, di reciproche scomuniche, di Riforme e Controriforme, di sovrani, come Enrico VIII d’Inghilterra, che vogliono essere contemporaneamente re e papa.
Anche la tolleranza e la laicità sono il prodotto delle guerre di religione. Anziché separare i popoli e spingerli a percorrere strade opposte, le guerre per l’Impero e per la fede hanno l’effetto di rendere le nazioni europee permeabili alle reciproche esperienze.
La rivoluzione francese e l’epopea napoleonica creano nuove aspirazioni ideali, nuove ambizioni nazionali, nuovi modelli costituzionali. La rivoluzione industriale comincia in Inghilterra fra il XVIII e il XIX secolo, ma poi scende lungo i fiumi dell’Europa continentale, contagiando dapprima il Belgio, poi gli Stati tedeschi, la Svizzera, la Francia, l’Italia, la Spagna e, agli inizi del Novecento, anche la Russia. Il concetto moderno di nazione appare in Francia, Germania, Spagna, Italia agli inizi dell’Ottocento e si diffonde come un incendio nell’intero continente.
Nato dalla rivoluzione industriale e da quella urbanistica dopo il 1830, il socialismo segue lo stesso percorso. La Prima guerra mondiale crea le condizioni per la diffusione della ideologia comunista e di quella dei suoi nemici. La rivoluzione d’Ottobre a Pietrogrado, nel 1917, genera in seguito effimere «repubbliche dei consigli» a Berlino, Monaco di Baviera, Budapest, e suscita speranze rivoluzionarie a Vienna, nell’Italia del «biennio rosso», nella Spagna del 1936.
Anche il fascismo contagia l’Europa, conquista il potere in Italia e in Germania, crea imitatori più meno fedeli in Inghilterra, in Francia, nel Belgio, in Spagna e in Portogallo.
La Prima guerra mondiale crea un pacifismo europeo, ancora fortemente minoritario, che comincia a riflettere sul futuro del continente e sulla sua possibile unione. La Seconda guerra mondiale è percepita come una guerra civile e costringe i popoli europei a interrogarsi sulla crescente irrilevanza dei loro Stati e sull’utilità di un progetto comune.
Vengono quindi rilette le opere dei precursori dell’europeismo, dall’abate Castel de Saint-Pierre a Immanuel Kant, da Giuseppe Mazzini a Carlo Cattaneo. Appaiono nuovi «manifesti», come quello di Ventotene scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. Cresce una coscienza europea e si afferma una nuova classe dirigente a cui appartengono Aristide Briand, il conte Coudenhove Kalergi, Luigi Einaudi, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide Gasperi, Robert Schuman.
È una storia nuova. Ma anche questa grande idea, come tutte quelle che l’hanno preceduta, dalla rivoluzione mercantile del Duecento alle vicende del secolo dei Lumi, è stata possibile perché gli europei sono uniti dalla comune convinzione che le esperienze e le intuizioni di un Paese siano utilizzabili negli altri. Così come i sovrani dei regni europei amavano considerarsi cugini, così anche i latini, i celti e i germani dei nostri giorni possono sentirsi legati da una sorta di rapporto di famiglia.
È questa la ragione per cui è impossibile definire l’identità europea. Il volto dell’Europa è quello che ha assunto via via nel corso della storia. L’identità europea è un cantiere aperto, dove si lavora continuamente per costruire e anche, purtroppo, per distruggere.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Agnès Heller: “Sono d’accordo con Juncker l’Europa perderà la sua anima se continuerà ad alzare Muri”.25 agosto 2015, di Federico La Sala
Agnès Heller, filosofa e intellettuale marxista, molto critica con il governo ungherese
“Sono d’accordo con Juncker l’Europa perderà la sua anima se continuerà ad alzare Muri”
La filosofa ungherese apprezza l’appello del presidente della Commissione Ue: “Odio e ostilità devono soccombere davanti alla solidarietà per chi fugge da fame e guerra
di Andrea Tarquini (la Repubblica, 25.08.2015)
- L’America ha capito che integrare differenti culture è vantaggioso,e cresce il doppio rispetto a noi
 L’avversione allo straniero non ci difenderà dagli arrivi in massa,ma finirà per impoverirci
L’avversione allo straniero non ci difenderà dagli arrivi in massa,ma finirà per impoverirci
BERLINO .«Juncker ha ragione, l’Europa rischia di perdere la sua anima. Un’Europa nella quale paura e diffidenze della vecchia cultura degli Stati nazionali vinca sulla cultura moderna della globalizzazione solidale è votata alla sconfitta. E al populismo, pericolo mortale ». Così ci dice Agnès Hel-ler, massima intellettuale marxista vivente.
Professoressa Heller, che pensa dell’articolo di Juncker?
«Tocca il problema di fondo. L’Europa è prigioniera della sua Weltanschauung di Stati nazionali. L’America ha capito che integrare differenti culture è difficile ma vantaggioso, e ha una crescita doppia di quella Ue».
Però l’Europa è affollata di migranti, la gente ha paura, come reagire?
«Il problema esiste, ma come Juncker mi sembra dire la peggiore reazione è quella europea: odio, ostilità vittoriosi sui valori europei di solidarietà e accoglienza. L’Ungheria di Orbàn è il caso limite ma contagioso: propaganda d’odio e d’idea di esclusione degli altri. L’America con tutti i suoi difetti è l’Arca di Noé che accoglie e integra migranti a suo vantaggio, l’Europa non sa essere Arca di Noé e si danneggia da sola. Guai a ignorare il monito di Juncker».
Juncker condanna l’Europa dei nuovi Muri, che ne dice?
«Nell’Europa dei nuovi Muri rivive l’Europa degli Stati nazionali che si combatterono nella prima guerra mondiale, uscendone chi vincitore chi sconfitto. Purtroppo questa Ue che trema per i migranti senza saper trovare soluzioni comuni a un’emergenza reale è un’Europa di Stati nazionali, non di cittadini. Stati nazionali egoisticamente incapaci di accettare nuovi cittadini di altre culture, al contrario dell’America. La fine dell’Europa degli Imperi - austroungarico e germanico, britannico e russo - ci portò più sovranità nazionali ma anche meno multiculturalità e una nuova incapacità di pensare a come essere nazioni moderne, comunità di valori capaci di accogliere a loro vantaggio chi vuole integrarsi».
Ma come rispondere alla paura della gente comune per la “criminalità importata” e le maree umane?
«Guardi, la maggioranza dei profughi viene da Siria, Afghanistan o altri paesi in guerra. Fuggono da bombardamenti, massacri, terrore e morte, e spesso sono qualificati. E non erano criminali a casa. Se li integri, se tendi loro la mano, possono ricambiare. Fiorello La Guardia figlio di poveri migranti da sindaco fece decollare New York come metropoli globale. Ma se li respingi con la cultura dei Muri, diventano ostili, cominciano a odiarti, e arriva il peggio, da ogni parte».
Eppure la marea dei migranti rafforza i populisti: minaccia alla democrazia?
«Sono un filosofo, non mi chieda rimedi. Ma presto o tardi l’Europa perderà la sua identità di somma di Stati nazionali, che lo voglia o no. Internet, la cultura globale, informano tutti: sulle retribuzioni e i diritti umani in Germania o altrove nella Ue ben diversi per i qualificati in fuga da paesi derelitti in guerra. Continueranno ad arrivare. L’America lo ha capito, integra meglio e cresce di più, in economia scienza cultura ed eccellenze».
Insisto, tanti emigranti producono tanti populisti, e allora?
«È il pericolo più grave: che la cultura dell’odio e dell’esclusione conquisti l’Europa. Rischio tragico: per secoli l’Europa fu un continente di stranieri, gente che tra guerre, Stati finiti e nuovi Stati o Imperi, cambiava cittadinanza o nazionalità o cultura di riferimento. Quell’Europa delle tragedie fu anche l’Europa della cultura europea più vitale, dall’Illuminismo alle belle arti a ogni campo. Oggi l’avversione allo straniero non ci difenderà dagli arrivi in massa, ma ci impoverirà nell’animo. Certo, occorre porre loro condizioni severe d’integrazione, ma i Muri creano solo nuovi nemici, ostilità a casa nostra. Chi è accolto come nemico diventa nemico, nel nostro territorio. Chi è integrato diventa patriota come i nuovi americani».
Balcani ventre molle della marea umana, dice Juncker. Vero o falso?
«Vero, ma anche l’America ha il suo ventre molle al confine messicano. Però integra e dà cittadinanza, e insisto cresce il doppio della Ue. In Europa, non solo nella mia Ungheria, troppi parlano contro “chi ha un altro colore della pelle”. I migranti sono una sfida, ma come dice Juncker la risposta deve essere europea, non nazionale. Purtroppo ci manca persino una Costituzione europea, servirebbe anche nell’emergenza migranti».
- L’America ha capito che integrare differenti culture è vantaggioso,e cresce il doppio rispetto a noi
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- L’eredità culturale di Roma antica. I motivi portanti di una concezione etico-politica sempre attuale (di Giovanni Brizzi)21 agosto 2015, di Federico La Sala
L’eredità culturale di Roma antica ha segnato la storia dell’Occidente
 Il richiamo ai doveri dei governanti e l’idea universale della cittadinanza
Il richiamo ai doveri dei governanti e l’idea universale della cittadinanza
 Ecco i motivi portanti di una concezione etico-politica sempre attuale
Ecco i motivi portanti di una concezione etico-politica sempre attualedi Giovanni Brizzi (Corriere della Sera, 13.08.2015)
Il tema del retaggio lasciato dall’antica Roma all’Occidente è talmente vasto da poter riempire intere enciclopedie. Col volgere dei secoli infatti, dopo la conclusione della sua parabola storica, l’Urbe è divenuta grado a grado, nella memoria e nell’emozione delle età successive, un autentico luogo dello spirito, una sorta di categoria del pensiero; sicché i modelli politici e ideali che ha via via offerto ai posteri come exempla e come parametri di confronto cui ispirarsi, sono stati davvero infiniti e vanno dalla lingua (un latino che, affiancato nelle sue differenti versioni, dal greco e dall’infinita varietà dei dialetti locali, si è poi imposto a lungo, nell’Europa dei secoli seguenti, come strumento delle classi colte) al lessico militare e politico e all’intero pantheon dei rispettivi simboli; dagli sviluppi del diritto all’evoluzione di alcune forme letterarie o artistiche e al dibattito circa la struttura ideale, repubblica o impero, cui ispirarsi, sopravvissuto fino alle vicende delle grandi rivoluzioni al chiudersi del XVIII secolo.
Due almeno di questi motivi sembrano qui meritare un accenno. Una prima costante, lungo il solco tracciato dalla storia di Roma fino all’età di Costantino e all’avvento dell’impero cristiano, è la presenza, termine di confronto obbligato per chiunque detenesse il potere, della forma politica ideale fondata sul teorico «governo dei migliori». Questa poggia, a Roma, sul concetto di « virtus e su altre qualità e meriti concreti» che debbono esser prerogativa dei magistrati alla guida dello Stato (Emilio Gabba). In Honos et Virtus , in effetti, la coppia di valori divinizzati da alcuni Grandi della Repubblica per richiamarsi al merito, la Virtus coincide non con l’eccellenza nella funzione militare soltanto; ma con il complesso di valori proprio del buon cittadino e, in sostanza, con l’accettazione del munus serviano, del dovere verso lo Stato di cui il servizio in armi rappresenta solo l’espressione più alta; mentre l’ Honos richiama un consenso del popolo destinato a sfociare negli honores , le cariche cittadine che ne sono l’esito necessario.
La correlazione tra gli obblighi verso la «cosa di tutti» e i pubblici uffici è un principio teoricamente ineludibile, che condiziona molto a lungo i governanti di Roma. Pur ferito e inquinato da ambizione, corruzione e violenza, questo ideale sopravvive; e a porvi fine è solo il graduale imporsi di una funzione imperiale che ambisce a farsi assoluta e a sciogliersi dall’obbligo di giustificare il proprio potere. Più volte fallito, il tentativo riesce infine a partire da Costantino; che si appoggia alla più diffusa ed efficace tra le religioni orientali, un Cristianesimo il quale, da Paolo di Tarso in poi, fa derivare omnis potestas a Deo . Distruggendo il rapporto esistente tra responsabilità e potere, lo svincolarsi del sovrano dal munus verso lo Stato scioglie però dallo stesso obbligo anche i cittadini; che, trasformati in sudditi, saranno tenuti ormai solo ad un’obbedienza senza iniziative.
Il secondo motivo portante è la civitas , la cittadinanza, che si allarga ad abbracciare idealmente l’intera ecumene. Pur ridimensionato nelle sue ambizioni più concrete, l’universalismo dell’Urbe si rivela destinato a sopravvivere, come un principio fondamentale, ben oltre la fine dell’età romana; e ciò perché si tratta di un sogno che era stato il «frutto di una concezione... imperiale o brutale solo in apparenza» e perché davvero Roma aveva saputo, da ultimo, aprirsi a qualunque abitante dell’impero. Capace di chiamare a far parte di una realtà comune prima la popolazione della penisola, poi via via tutto il genere umano; capace di fare prima dell’Italia «un’unica città, che intratteneva» con il potere un tempo egemone «lo stesso tipo di rapporti paradossali e straordinari che, due secoli più tardi, Elio Aristide», nella sua orazione A Roma , «avrebbe sentito esistere tra l’Urbe e tutta la terra abitata», il genio politico romano aveva creato, «una concezione originale del diritto di cittadinanza».
La civitas seppe, oltretutto, mantenere in vita, rispettandolo, ogni singolo particolarismo giuridico, religioso o culturale presente nell’ambito dell’impero; e far germogliare ad un tempo i fermenti ideali necessari alla realizzazione «di quella cosmopoli con cui l’impero stesso, rivale della città di Dio, sarebbe giunto quasi a identificarsi».
Se il primo di questi grandi temi rappresenta una delle idealità politiche più alte e autenticamente fondanti per l’Occidente intero, il secondo vede Roma creare, «conciliandola sapientemente con l’autonomia locale delle leggi e dei costumi... una concezione originale del diritto di cittadinanza, non duplice... ma sdoppiata o, se si vuole, a due livelli» (Claude Nicolet), tale da render non solo l’Italia, ma l’intera orbe di allora patriam diversis gentibus unam , una patria per i popoli più diversi. Possa quell’Europa, che è di fatto alla radice stessa del grande Occidente moderno, raggiungere infine un analogo traguardo.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- La religione della Troika e l’Europa senz’anima (di Franco Gesualdi)15 luglio 2015, di Federico La Sala
- TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA ....
 L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI TROIA: L’ANALISI DI CARLO LEVI.
L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI TROIA: L’ANALISI DI CARLO LEVI.
La religione della Troika e l’Europa senz’animadi Franco Gesualdi (Adista - Notizie • N. 26, 18 LUGLIO 2015)
Nel loro ruolo di manipolatori dell’informazione i media, da un capo all’altro d’Europa, hanno fatto passare il referendum greco come una scelta fra rimanere nell’euro o tornare alla dracma. In realtà la scelta era fra continuare a fare da cavie o recuperare dignità.
Quella del debito pubblico greco è una storia di interessi privati in gestione pubblica. La commissione internazionale di audit, insediatasi ad aprile per verificare la legittimità del debito greco, afferma senza mezzi termini che il macigno non si è formato per permettere ai greci di gozzovigliare, ma prima di tutto per garantire interessi alle banche attraverso quel meccanismo perverso che i ragionieri conoscono come interesse composto.
A seguire, le regalie fiscali agli alti redditi, accompagnate da spese inutili e dannose come le opere per le Olimpiadi 2004 o l’acquisto di armi, il tutto ben condito da buone dosi di corruzione. E, come se non bastasse, nel 2008 è sopraggiunta la crisi, dolce regalo dell’avventatezza bancaria, che ha dato l’ultimo scrollone a quel corpo vilipeso.
L’assetto produttivo, già in crisi per la concorrenza dei prodotti tedeschi che in virtù della moneta unica avanzavano in Grecia come bulldozer, ha perso altri pezzi.
I disoccupati sono cresciuti ovunque, e gli Stati europei hanno dovuto decidere cosa farne. E anche il traballante Stato greco ha fatto quello che tutti facevano: ha aumentato la spesa sociale per tamponare la situazione.
Ma il debito è cresciuto ancora, finché i mercati hanno decretato che la Grecia non era più meritevole di fiducia, tagliando i prestiti.
Apparente ragionamento da ragionieri, in realtà cinica mossa da speculatori che al botteghino avevano scommesso sul fallimento della Grecia. In condizioni normali il Paese avrebbe chiesto nuovi prestiti per saldare i vecchi, così fan tutti, ma dopo la sentenza del mercato è fuori gioco.
Chi ha tremato di più di fronte all’insolvenza greca sono state le banche tedesche e francesi, che per incassare interessi avevano prestato fiumi di denaro senza verificare la solidità greca. Del resto, sapevano bene che in caso di difficoltà sarebbe stato sufficiente mandare un messaggino ai loro governi.
E così è stato: nel 2010, l’Ue, il Fmi, la Banca Centrale, la famosa Troika, prontamente hanno offerto alla Grecia quanto serviva per saldare le banche, diventando loro i nuovi creditori.
E la Grecia ha così sperimentato la tirannia dei creditori pubblici, esattamente come successo in passato ai Paesi del Sud del mondo: i poteri privati sono animati dai soldi, i poteri pubblici dai dogmi e i dogmi sono più pericolosi dei soldi.
La religione che la Troika custodisce si chiama liberismo, una fede che proclama la restituzione dei debiti come primo comandamento, ma che, inoltre, eleva il mercato a verità assoluta. E quando la Grecia è finita sotto il suo dominio, la Troika ha deciso di farne la vittima sacrificale.
Al grido di austerità e crescita, la Grecia è stata sottoposta ad ogni sorta di sacrificio pur di liberare risorse da destinare al debito. E, argomentando, fino ad ora, che i ricchi non si toccano perché la loro ricchezza è utile alla crescita, il peso dei sacrifici è gravato sui più poveri, con aumenti di tasse indirette e tagli alle pensioni, alla sanità e agli stipendi.
Così la povertà è salita al 35% (tre milioni di persone), mentre il 27% della popolazione resta senza copertura sanitaria. La mortalità alla nascita è aumentata del 21%, quella infantile del 43%.
Ma scoprendo che i sacrifici mettono in crisi l’intera economia (in tre anni il Pil è diminuito del 25% e i disoccupati sono saliti al 30%), la ricetta della Troika si è arricchita delle famose riforme, ossia l’obbligo di comprimere la democrazia e i diritti dei lavoratori per attirare gli investimenti esteri.
Domenica 5 luglio i greci hanno detto basta a questo gioco al massacro. Hanno detto che prima dei debiti e dei dogmi vengono le persone, i diritti, la dignità umana. Hanno detto che si può fare perché il problema non sono i soldi, visto che la Bce regala 60 miliardi al mese al sistema finanziario. Il problema è l’anima. L’Europa l’ha persa perché l’ha venduta ai mercanti. A noi il compito di recuperarla.
* fondatore e coordinatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo. Ha appena pubblicato il libro “Risorsa umana. L’economia della pietra scartata” (in vendita presso Adista; v. recensione sul numero di Documenti allegato)
- TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA ....
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- L’Ue cambi se vuole un futuro. Il progetto europeo è morto. Che cosa rischia di diventare l’Eurozona?!14 luglio 2015, di Federico La Sala
Il progetto europeo è morto
di Paul Krugmaan (la Repubblica, 14.07.2015)
Supponiamo che consideriate Tsipras uno stupido incompetente. Supponiamo che vi piaccia con tutto il cuore vedere Syriza lasciare il governo. Supponiamo che accogliate la prospettiva di cacciare questi indisponenti greci fuori dall’euro. Anche se tutto ciò fosse vero, l’elenco di richieste dell’Eurogruppo resterebbe una follia. L’hashtag di tendenza #ThisIsACoup ha assolutamente ragione. Qui si va oltre l’inflessibilità, si va nella pura ripicca, nell’annientamento assoluto della sovranità nazionale, senza nessuna speranza di sollievo. Plausibilmente, si tratta di un’offerta formulata in modo tale che la Grecia non possa accettarla; ma, anche così, si tratta di un grottesco tradimento di tutto ciò che si supponeva dovesse affermare e sostenere il progetto europeo.
C’è nulla che possa far arretrare l’Europa rispetto all’orlo del baratro? Si dice che Mario Draghi stia cercando di ricondurre un po’ alla ragione, che Hollande stia finalmente dando prova di un po’ di quell’opposizione al gioco delle Moralità che l’economia tedesca ama fare e che in passato egli ha vistosamente mancato di impedire. Ma molto danno è già stato arrecato. Dopo tutto ciò, chi mai si fiderà più delle buone intenzioni della Germania?
Da un certo punto di vista, l’economia è diventata qualcosa di secondario. Cerchiamo di essere chiari una volta per tutte, però: nelle ultime due settimane abbiamo imparato che far parte della zona euro significa che se sgarri i creditori possono annientare la tua economia. Tutto ciò non ha attinenza alcuna con l’implicita economia dell’austerità. Più che mai adesso è vero che imporre una rigida austerità senza un alleggerimento del debito significa scegliere una politica predestinata al peggio, a prescindere da quanto il paese sia disposto ad accettare tormenti. E ciò, a sua volta, significa che perfino una capitolazione assoluta della Grecia sarebbe un punto morto.
La Grecia riuscirà a organizzare con successo un’uscita dall’euro? La Germania cercherà di ostacolare una ripresa? (Mi dispiace, ma questo è il tenore delle domande che dobbiamo porci adesso). Al progetto europeo - un progetto che ho sempre esaltato e sostenuto - è stato appena inferto un colpo terribile, forse mortale. E, a prescindere da quello che pensate di Syriza o della Grecia, a infliggerlo non sono stati i greci.
 © The New York Times Traduzione di Anna Bissanti
© The New York Times Traduzione di Anna Bissanti
L’Ue cambi se vuole un futuro
di Marta Dassù (La Stampa, 14.07.2015)
Ha perso la Grecia, ma ha perso anche la Germania. E abbiamo perso, come Europa, credibilità e tempo: sei mesi buttati via in un tira e molla inconcludente fra debitori strafottenti e creditori supponenti. Mentre il prezzo del salvataggio aumentava. Per i greci e per gli europei. Alexis Tsipras ha calcolato - sbagliando - che il resto d’Europa avrebbe accettato il suo «azzardo morale» a qualsiasi costo, pur di salvare l’euro: in verità, è un costo molto alto. Wolfgang Schäuble ha preteso - sbagliando - di ottenere con quindici anni di ritardo quello che non era riuscito ad ottenere agli esordi dell’euro: una moneta unica riservata solo ai più forti e ai virtuosi. Una resa dei conti che gli ha fatto perdere l’appoggio di Parigi, non così forte e virtuosa da essere tranquilla sul futuro.
La tenuta pragmatica di Mario Draghi e l’incrinatura fra Germania e Francia hanno in qualche modo facilitato l’accordo della 17a ora. A dimostrazione che il tandem fra Berlino e Parigi ha senso - per l’Europa nel suo insieme, Roma inclusa - solo quando la Francia non rimane totalmente schiacciata da una Germania troppo spesso sicura di essere nel «giusto». E ancorata, come in passato, a una visione morale dell’economia in cui è una stessa parola - schuld - a definire sia debito che colpa.
Fra l’arroganza del debole e quella del forte, le istituzioni europee hanno funzionato da argine. Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha osservato che l’estenuante ricerca di un compromesso incarna proprio il «metodo europeo»: interpretazione al ribasso un po’ sconfortante, riuscita solo in extremis ad evitare lo scenario peggiore. Il principio che le decisioni monetarie siano anche politiche, non solo tecniche, ha alla fine prevalso: vedremo se reggerà alla prova dei fatti, siamo solo agli inizi.
Letta dall’interno del Vecchio Continente, la lunga battaglia di Grecia ha confermato le tesi di chi ritiene che l’unione monetaria non potrà sopravvivere a lungo senza un’Unione fiscale e senza un vero e proprio bilancio dell’Ue. Peccato che nessuno abbia chiaro come potere costruire consenso attorno a passi in avanti verso l’Unione politica - in parte contemplati nel «Rapporto» dei presidenti, già sul tavolo del Consiglio europeo. Che da una crisi di fiducia del genere debba nascere lo stimolo verso un’Unione federale può essere una conclusione razionale; ma non è certo un riflesso istintivo per cittadini europei che mancano di punti di riferimento e che in numeri crescenti (basta leggere i sondaggi di opinione) non riescono più a cogliere il valore aggiunto dell’Ue. Mentre le forze politiche a vario titolo euro-scettiche, a destra e a sinistra, alzano la voce nei Parlamenti nazionali e nel Parlamento di Strasburgo.
La sfida è semplice da capire ma non lo è da risolvere: per avere un futuro, l’Ue deve cambiare (e abbastanza rapidamente); ma per potere cambiare, deve anzitutto recuperare un appoggio democratico che ha ormai perso. La lezione greca - che in realtà si può leggere come una dura e surreale lezione sulla crisi europea - mi pare questa, prima di altre.
Vista dall’esterno, la vicenda greca è stata in parte una drammatica farsa; in parte è diventata oggetto di competizione geopolitica fra i nostri alleati - gli Stati Uniti - e la Russia. Con un po’ di Cina in aggiunta. In una logica geopolitica, salvare la Grecia - Paese Nato e cerniera sensibile con l’Est, un Mediterraneo in fiamme e Balcani in crisi di ritorno - era indispensabile. Specie dopo la semi-perdita della Turchia. Se ciò fosse stato chiaro fin dall’inizio, avremmo forse evitato qualche telefonata di Barack Obama, qualche ammiccamento russo e qualche nuova dimostrazione della fragilità dell’Ue come attore internazionale. La lezione greca, su questo versante, suona così: una clamorosa «distrazione» degli europei dai problemi esterni che premono alle porte di casa, a Est come a Sud. E che da problemi esterni stanno diventando interni, sfruttando proprio la debolezza delle economie periferiche del Vecchio Continente.
In un libro di qualche tempo fa sulla globalizzazione e i suoi paradossi, Dani Rodrik parlava di un «trilemma politico» alla base dell’integrazione economica internazionale: è ormai molto difficile, per le ragioni spiegate dall’economista di Harvard, tenere insieme democrazia, sovranità nazionale e apertura economica. Tenere insieme tutti e tre i poli del «trilemma». La lunga crisi greca ne è una conferma, in salsa europea: con l’Unione economica e monetaria, la sovranità nazionale è per definizione limitata («perduta» per gli euroscettici, «condivisa» per i filo-europei) e si apre una nuova questione democratica. E’ il momento di discutere apertamente questo problema essenziale; e di fare - su questo, non altro - la battaglia vera per il domani.
Se l’Eurozona dimentica il pensiero dei fondatori
di Vittorio Da Rold (Il Sole-24 Ore, 14.07.15)
Che cosa rischia di diventare l’Eurozona se passa l’idea di un Paese debitore che deve fare i compiti a casa pena l’esclusione? Un nucleo economico e monetario più omogeneo e solido o una zona dove i Paesi creditori hanno un potere maggiore dei Paesi debitori? E cosa rischia di diventare questa Eurozona dove chi ha debiti diventa sempre più debole e chi vanta crediti sempre più forte?
I padri fondatori avevano pensato l’Eurogruppo come una zona dove si produceva ricchezza che sarebbe stata distribuita ai partecipanti al club monetario. Invece accade che chi è forte e produce più dei partner raccoglie i benefici di un creditore, mentre chi è svantaggiato e si deve indebitare deve a sua volta pagare e si indebolisce sempre di più.
Una zona comune che non salva i debitori interni ma li tratta come Paesi stranieri dove la troika ha diritto di pieno accesso ai ministeri e con il diritto di veto sulla legislazione oggetto delle trattative, sono intrusioni nella sovranità nazionale che difficilmente sarebbero accettate anche da chi è fuori da un’unione monetaria.
È come se negli Usa la Fed giudicasse di non intervenire a favore dell’Arkansas, uno stato povero che ha dato un presidente e poco più agli altri 49 stati della confederazione, chiedendo di diventare una nuova Silicon Valley californiana, altrimenti sarebbe espulso dal sistema del dollaro.
Ogni Stato dell’Eurozona ha le sue caratteristiche e cercare di trasformare la Grecia in un Land tedesco è un’operazione impossibile economicamente e culturalmente. Ogni Stato deve rispettare le regole: e la Grecia ha molte colpe da farsi perdonare, dai conti truccati alle spese fuori controllo.
Detto questo, escludere il Paese che più ne necessita dal Quantitative easing appare poco comprensibile. Punire chi ha sbagliato va bene, ma in un’unione monetaria si aiuta il partner a migliorare, non lo si mette in un angolo. Altrimenti il partito della dracma torna al potere e riduce l’euro a un’unione di cambi fissi, dove ogni membro può decidere di uscire a suo piacimento.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Undici tesi ispirate dalla situazione greca. Cancellazione totale del debito speculativo di cui il popolo greco è perfettamente innocente (di Alain Badiou)13 luglio 2015, di Federico La Sala
Undici tesi ispirate dalla situazione greca
 di Alain Badiou (Effimera, 09.07.2015)*
di Alain Badiou (Effimera, 09.07.2015)*È più urgente che mai internazionalizzare la causa del popolo greco. Soltanto la cancellazione totale del debito assesterà un “attacco ideologico” all’attuale sistema europeo
* * * * *
1. Il “no” di massa del popolo greco non significa un rifiuto dell’Europa. Significa un rifiuto dell’Europa dei banchieri, del debito infinito e del capitalismo globalizzato.
2. Anche una parte dell’opinione nazionalista, e persino della destra estrema, ha votato “no” riguardo alle istituzioni della finanza? Al diktat dei governi reazionari europei? Ebbene, lo sappiamo che ogni voto puramente negativo è in parte confuso. La destra estrema, da sempre, può rifiutare certe cose che rifiuta pure l’estrema sinistra. Soltanto l’affermazione positiva di ciò che si vuole risulta chiara. E tutti sanno che ciò che vuole Syriza è opposto a ciò che vogliono i nazionalisti e i fascisti. Il voto non è dunque semplicemente una presa di posizione contro le esigenze antipopolari del capitalismo globalizzato e dei suoi servitori europei. È anche un voto che, per il momento, dona fiducia al governo Tsipras.
3. Che ciò avvenga in Grecia, e non - come sarebbe normale - ovunque in Europa, indica che la “sinistra” europea è in uno stato di coma irreversibile. François Hollande? La socialdemocrazia tedesca? Il PSOE spagnolo? Il Pasok greco? I laburisti inglesi? Il PD italiano? Tutti questi partiti sono palesemente degli amministratori del capitalismo globalizzato. Non esiste più una “sinistra” europea. Vi è però una piccola speranza, ancora flebile, da parte di formazioni politiche inedite, legate al movimento di massa contro il debito e l’austerità, ossia Podemos in Spagna e Syriza in Grecia. I primi, tutto sommato, rifiutano la distinzione tra “sinistra” e “destra”. La rifiuto anch’io. Tale distinzione appartiene al vecchio mondo della politica parlamentare, che deve essere distrutto.
4. La vittoria tattica del governo Tsipras è un incoraggiamento per tutte le nuove proposte nel campo politico. Il sistema parlamentare e i suoi partiti di governo sono in crisi endemica da decenni, dagli anni ’80. Che Syriza ottenga in Grecia dei successi, anche se provvisori, concorre in Europa a ciò che ho chiamato “il risveglio della Storia”. Ciò non può che aiutare Podemos, e tutto ciò che accadrà, successivamente e altrove, sopra le rovine della democrazia parlamentare classica.
5. Ciononostante, la situazione in Grecia resta a mio avviso molto difficile, molto fragile. È ora che cominciano le vere difficoltà. È possibile, visto il successo tattico del referendum, che li pone comunque in una posizione di accusati storici, che le Merkel, gli Hollande e gli altri delegati del capitale europeo modifichino le loro esigenze. Bisogna tuttavia agire senza badare troppo a loro. Il punto cruciale, ormai, consiste nel sapere se il voto per il “no” si prolungherà in un movimento popolare potente, che sostiene e/o esercita delle forti pressioni sul governo stesso.
6. A tal proposito, come giudicare oggi giorno il governo Tsipras? Cinque mesi orsono ha deciso di cominciare con la negoziazione. Ha voluto conquistare tempo. Ha voluto poter dire che aveva fatto di tutto per pervenire a un accordo. Avrei preferito che cominciasse altrimenti: con un appello immediato a una mobilitazione popolare di massa, prolungata, che impegnasse milioni di persone, sulla parola d’ordine centrale dell’abolizione completa del debito. E che intraprendesse una lotta intense contro gli speculatori, la corruzione, i ricchi che non pagano le tasse, gli armatori, la Chiesa... Ma non sono un greco, e non intendo impartire lezioni. Non so se una tale azione incentrata attorno alla mobilitazione popolare, un’azione in qualche sorta piuttosto dittatoriale, fosse possibile. Per il momento, dopo cinque mesi di governo Tsipras, vi è un referendum vittorioso, e una situazione ancora completamente aperta. È già molto.
7. Continuo a pensare che l’attacco ideologico più duro che si possa portare al sistema europeo attuale sia rappresentato dalla parola d’ordine della cancellazione totale del debito greco, debito speculativo di cui il popolo greco è perfettamente innocente. Oggettivamente, questa cancellazione è possibile: molti economisti, che non sono per nulla rivoluzionari, pensano che l’Europa debba annullare il debito greco. Ma la politica è soggettiva, e in ciò differisce dall’economia pura. Su questo punto, i governi vogliono assolutamente impedire una vittoria di Syriza. Dopo questa vittoria, vi sarebbe Podemos, e poi può darsi altre vigorose azioni popolari in altri grandi paesi europei. E poi, i governi, sospinti dalle lobby della finanza, vogliono punire Syriza, vogliono punire il popolo greco, piuttosto che regolare il problema del debito. Per punire coloro che vogliono questa punizione, il default del pagamento rimane la procedura migliore, quali che siano i rischi annessi. L’Argentina l’ha praticato qualche anno fa, e non ne è affatto morta, anzi!
8. Si agita ovunque, a proposito della Grecia, la questione di un’“uscita” dall’Europa. Ma in verità, sono i reazionari europei che brandiscono tale questione. Sono loro a fare del “Grexit” una minaccia imminente. Vogliono spaventare la gente. La linea giusta, che è fino ad ora quella di Syriza come quella di Podemos, consiste nel dire: “Noi restiamo in Europa. Noi vogliamo solamente, il che è nostro diritto, cambiare le regole di quest’Europa. Noi vogliamo che cessi di essere una cinghia di trasmissione tra il capitalismo liberale globalizzato e la riproduzione della sofferenza dei popoli. Noi vogliamo un’Europa realmente libera e popolare”. Tocca ai reazionari dire che ne pensano di ciò. Se vogliono cacciare la Grecia, che ci provino! Su questo punto, la palla è nelle loro mani.
9. Sullo sfondo, si agitano timori geopolitici. E se la Grecia si rivolgesse verso qualcun altro di diverso dai padri e dalle madri fustigatori dell’Europa? Allora, io direi: ogni governo europeo ha una politica estera indipendente. Ognuno coltiva delle amicizie semplicemente ciniche, come Hollande con l’Arabia saudita. Contro le pressioni alle quali è sottomessa, la Grecia può e deve avere una politica altrettanto libera. Siccome i reazionari europei vogliono punire il popolo greco, quest’ultimo ha il diritto di cercare degli appoggi esteriori, per diminuire o impedire gli effetti di questa punizione. La Grecia può e deve rivolgersi alla Russia, ai paesi dei Balcani, alla Cina, al Brasile, e anche al suo vecchio nemico storico, la Turchia.
10. Quali che possano essere questi ricorsi, la situazione in Grecia sarà recisa dai greci stessi. Il principio del primato delle cause interne deve applicarsi a questa situazione. Ora, i rischi sono veramente più considerevoli, visto che Syriza non è al potere che formalmente. Già ora, lo si sa, lo si sente, le vecchie forze politiche intrigano nei corridoi. Oltre al potere di governo, acquisito in condizioni regolari, e non rivoluzionarie, e ai suoi effetti corruttori, ci si può con ogni evidenza porre le questioni classiche: Syriza controlla completamente la polizia, l’esercito, la giustizia, l’oligarchia economica e finanziaria? Chiaramente no. Il nemico interno esiste ancora, è sostanzialmente intatto, rimane potente, ed è sostenuto nell’ombra dai nemici esterni, compresa la burocrazia europea e i governi reazionari. Il movimento popolare e le organizzazioni di base devono sorvegliare costantemente gli atti del governo. Ancora una volta, il “no” del referendum non costituirà una vera forza se non si prolunga attraverso delle forti manifestazioni indipendenti.
11. Un aiuto internazionale popolare, palese, mediatizzato e incessante dovrò appoggiare con tutte le sue forze la possibile insorgenza greca. Ricordo che, al giorno d’oggi, il 10% della popolazione mondiale possiede l’86% delle ricchezze possibili. L’oligarchia capitalista globale è molto ristretta, molto concentrata, molto organizzata. Contro di essa, i popoli dispersi, senza unità politica, rinchiusi nelle frontiere nazionali, resteranno deboli e quasi impotenti. Allo stato attuale delle cose tutto si gioca a livello globale. Trasformare la causa greca in causa internazionale ad alto valore simbolico è una necessità, quindi un dovere.
*
(Traduzione dal francese di Davide Gallo Lassere)
Articolo apparso originalmente l’8 luglio 2015 sul quotidiano francese Libération.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- IL "LOGO" DI MUSSOLINI. Le radici dell’Eu-ropa e il "fascismo" (di tutte le ispirazioni).13 luglio 2015, di Federico La Sala
 In principio era il Logos (non il "Logo")!!!
In principio era il Logos (non il "Logo")!!!
 Le radici dell’Eu-ropa e il "fascismo" (di tutte le ispirazioni). Il "gioco" di ogni progetto e "duce" autoritario è stato sempre questo: "AF-FASCInARE" E "AG-GIOGARE" IL POPOLO. NELLO AJELLO ed EMILIO GENTILE fanno il punto sul "LOGO" DI MUSSOLINI.
Le radici dell’Eu-ropa e il "fascismo" (di tutte le ispirazioni). Il "gioco" di ogni progetto e "duce" autoritario è stato sempre questo: "AF-FASCInARE" E "AG-GIOGARE" IL POPOLO. NELLO AJELLO ed EMILIO GENTILE fanno il punto sul "LOGO" DI MUSSOLINI.
-
> Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE ---- La chiesa di Francesco dice addio a Roma (di Francesco Peloso)13 luglio 2015, di Federico La Sala
La chiesa di Francesco dice addio a Roma
di Francesco Peloso, giornalista (Internazionale, 12.07.2015)
Roma è lontana, lontanissima dall’America Latina profonda visitata nell’arco di una settimana da papa Francesco. Montagne e foreste tropicali, deserti, indigeni, contadini, città marginali negli scenari contemporanei come Quito, La Paz, Asunción, capitali che raramente fanno, come si dice, notizia. Eppure è in questa porzione di mondo in cui si parlano decine di idiomi, in cui coesistono gruppi etnici diversi ma ci si capisce universalmente in spagnolo, in cui la natura conosce varietà sorprendenti, che il papa ha rotto definitivamente gli argini della clausura europea per la chiesa, una chiesa dal volto cupo e ieratico, nostalgico e triste, di chi vive la stagione del declino e del rimpianto.
È in questa porzione di mondo che il papa ha rotto definitivamente gli argini della clausura europea per la chiesa.
Francesco è andato nel cuore del “cono sud”, quello più povero e periferico e lo ha descritto come modello per “la patria grande”, il sogno bolivariano dell’integrazione latinoamericana, e per il mondo globalizzato. Popoli, culture e natura vivono in un delicato e prezioso equilibrio fra loro - è il caso della Bolivia e dell’Ecuador - e i leader figli di queste terre, i politici anomali Morales e Correa, sono interlocutori reali, e se pure commettono errori o incontrano difficoltà nel tentativo di costruire una società più giusta - è stato il messaggio di Francesco - hanno lo stesso rango dei politici dei Paesi ricchi e vanno ascoltati perché rappresentano il mondo nuovo sorto progressivamente in questi decenni in cui la democrazia, e quindi la voce degli esclusi, o degli “scartati” per dirla con Bergoglio, ha cominciato a farsi strada in America latina dopo l’epoca delle dittature spietate, come quella del Paraguay pure visitato dal papa.
E se ora Francesco tornerà inevitabilmente in un Vaticano che fin dal principio del suo pontificato ha fatto capire di amare poco, gli effetti di questa trasferta sudamericana sono destinati a lasciare il segno anche dentro la chiesa. Se insomma da una parte il pontefice argentino è diventato punto di riferimento per una vasta area di movimenti e personalità della cultura critici verso un modello economico incapace di comprendere al suo interno le comunità, la terra, il senso di solidarietà, la pluralità delle culture e la biodiversità intesa come bene comune, e quindi diritto umano non alienabile da soggetti privati, su un altro versante, quello del cattolicesimo, siamo di fronte a un momento di svolta.
Il doppio “mea culpa”
È nel corso dell’incontro con i movimenti popolari svoltosi in Bolivia che il papa ha detto parole importanti sul ruolo e la storia della chiesa. Ricollegandosi ai “mea culpa” di Wojtyla, Bergoglio ha chiesto perdono “per i crimini commessi contro le popolazioni indigene durante la cosiddetta conquista dell’America”. A questo punto però ha aggiunto un’osservazione significativa: “Insieme a questa richiesta di perdono, per essere giusti, chiedo anche che ricordiamo migliaia di sacerdoti e vescovi, che si opposero fortemente alla logica della spada con la forza della Croce. Ci fu peccato, ci fu peccato e fu abbondante, e per questo chiediamo perdono, e chiedo perdono, però là, dove ci fu il peccato, dove ci fu abbondante peccato, sovrabbondò la grazia mediante questi uomini che difesero la giustizia dei popoli originari”.
Francesco ha poi messo in luce l’impegno di tutti quei religiosi, suore e laici “che anonimamente percorrono i nostri quartieri poveri portando un messaggio di pace e di bene, che nel loro passaggio per questa vita hanno lasciato commoventi opere di promozione umana e di amore, molte volte a fianco delle popolazioni indigene o accompagnando i movimenti popolari anche fino al martirio. La chiesa, i suoi figli e figlie, sono una parte dell’identità dei popoli dell’America Latina”.
È possibile leggere in queste frasi un a sorta di secondo “mea culpa”, questa volta tutto interno a una chiesa che aveva negato o rimosso o emarginato, i sacerdoti e i vescovi uccisi perché difendevano gli ultimi? Siamo insomma di fronte alla riabilitazione di una storia trattata per lunghi decenni come fosse un fiume secondario e ambiguo del cristianesimo moderno? È recente la beatificazione del vescovo del Salvador Óscar Arnulfo Romero, vittima degli squadroni della morte e delle oligarchie locali, così come l’apertura della causa di beatificazione di monsignor Enrique Angelelli, ucciso dai militari in Argentina.
Sembra emergere e assumere pienezza una controstoria della chiesa, quella di chi si è schierato dalla parte degli indios e degli oppressi.
Ma le parole del papa dicono appunto qualcosa in più: sembra infatti emergere e assumere pienezza una controstoria della chiesa, quella di chi si è schierato dalla parte degli indios e degli oppressi; è la spinta a riscrivere la storia ufficiale, a definire un nuovo paradigma entro il quale collocare l’evoluzione del cristianesimo. Non si tratta più, dunque, di sottolineare solo l’importanza del singolo martire o del sacrificio di un prete, di una suora, di un laico, è piuttosto l’ingresso, nella storia del cattolicesimo moderno, di quella opzione preferenziale per i poveri, punto d’arrivo del riformismo conciliare in America Latina, che vuole porsi non più sotto ma a fianco, con pari dignità, della tradizione europea. È quindi il “poliedro” bergogliano, preferito alla globalizzazione uniformante, che diventa categoria per leggere anche la fede cattolica, fede per l’appunto universale (cioè non solo, o non innanzi tutto, europea).
Fine della guerra fredda
Molti altri temi rilevanti sono stati sollevati dal papa nel corso del viaggio in America Latina: la denuncia della chiesa “casta”, priva di misericordia, che sa solo condannare i fedeli e non immedesimarsi con la condizione umana; la descrizione di un impegno per mettere “l’economia al servizio dei popoli” partendo dal basso, dai movimenti popolari appunto, il cui primo compito deve essere quello di “difendere la madre Terra”; quindi il richiamo ai diritti umani, il dialogo con i non credenti, il riconoscimento delle donne quale soggetto sociale che ha saputo far sopravvivere Paesi come il Paraguay devastati dalle violenze politiche interne; e ancora, il valore della memoria in realtà sconvolte da dittature, guerre civili, violazioni.
“Un popolo che dimentica il suo passato”, ha affermato Bergoglio al suo arrivo in Paraguay. “La sua storia, le sue radici, non ha futuro, è un popolo secco. La memoria, poggiata saldamente sulla giustizia, libera da sentimenti di vendetta e di odio, trasforma il passato in fonte di ispirazione per costruire un futuro di convivenza e di armonia, rendendoci consapevoli della tragedia e dell’assurdità della guerra. Mai più guerra tra fratelli!” ha detto ancora il papa. In Bolivia ha parlato della memoria dei popoli, una “memoria che si trasmette di generazione in generazione, una memoria in cammino”, dentro la quale si trova anche l’attesa per una giustizia che non arriva”.
Questo parlare da figlio del continente da parte di papa Francesco, oltre a contenere un messaggio pastorale, è l’affermazione definitiva di una leadership che ora ha messo in mostra, schierato, il suo popolo. Un passaggio d’epoca è ormai compiuto: il papa latinoamericano è il capo di una chiesa uscita definitivamente dalla guerra fredda, dai vecchi conflitti ideologici, che si assume però l’onere di interpretare criticamente i grandi problemi contemporanei, a partire dalla propria biografia rivendicata come biografia collettiva dell’America Latina. Qui, infine, emerge un tema che si può solo accennare: quanto il Concilio Vaticano II, divulgato e conosciuto in Europa quale evento ecclesiale caratterizzato da un dibattito di alto livello fra teologi e uomini di chiesa principalmente europei, sia stato in realtà, e forse soprattutto, un evento sociale latinoamericano. In questa prospettiva, probabilmente, la storia della chiesa moderna ancora deve essere scritta.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO".--- GRECIA. Il colpo di stato Ue è in pieno svolgimento (di Franco Berardi Bifo)11 luglio 2015, di Federico La Sala
Il colpo di stato Ue è in pieno svolgimento
di Franco Berardi Bifo *
Il ricatto della classe dirigente finazista europea sta vincendo. Il risultato del referendum è sovvertito e tradito dall’accordo che Tsipras ha fatto accettare al Parlamento greco rompendo l’unità di Syriza. Non possiamo prendercela con Tsipras del voltafaccia. Ha una pistola puntata alla tempia. Quello che l’Unione europea sta compiendo è un colpo di stato fondato sulla minaccia della guerra civile e del colpo di stato militare.
Quello che accade è un ritorno vittorioso della Troika, una reimposizione del memorandum. Le reazioni si stanno già manifestando nelle strade di Atene. I partiti di destra e le forze militari che sono legate ad esse prima o poi presentano il conto.
Il colpo di stato europeo è in pieno svolgimento
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- "Tsipras ha sbagliato tutto, ma l’Ue è miope e ossessionata dai numeri". Parla lo scrittore Petros Markaris padre del Commissario Charitos.9 luglio 2015, di Federico La Sala
- "X"-FILOSOFIA. RELAZIONI CHIASMATICHE E POTERE: UN NUOVO PARADIGMA. (fls)
_________________________________________________________________________________________
Petros Markaris: "Tsipras ha sbagliato tutto, ma l’Ue è miope e ossessionata dai numeri".
Parla lo scrittore padre del Commissario Charitos
di Giulia Belardelli (L’Huffington Post, 08/07/2015)
Per un po’ il Commissario Kostas Charitos resterà in sospeso, senza casi da risolvere. Il “fratello greco di Maigret” o il “Montalbano di Atene”, come è stato soprannominato dalla critica internazionale, è rimasto anche lui vittima della tragedia greca a cui stiamo assistendo negli ultimi giorni. Il suo creatore, il famoso scrittore greco Petros Markaris, ha le vertigini di fronte a un baratro che sente di non poter (ancora) raccontare. “Sono arrabbiato sia con il primo ministro Alexis Tsipras che con le istituzioni europee - racconta ad HuffPost - perché da entrambe le parti manca un pensiero politico: non c’è la volontà di guardare oltre i numeri, si persevera in un assurdo gioco di potere”.
Oggi Markaris sarà a Expo per l’iniziativa organizzata da Coop “We Not Me - Il cibo di tutti”, una giornata dedicata alla cooperazione e all’economia partecipata. Oltre al racconto di eccellenze cooperative internazionali, come Park Slope Coop, ci sarà spazio per esplorare i limiti economici e sociali del liberismo su scala mondiale, regionale e nazionale. Di questi limiti Markaris è testimone e vittima diretta. Perché la sua Grecia - ripete con foga - è stata condannata a morte dall’egoismo dei politici greci e dalla miopia di un’Europa incapace di cooperazione.
Che opinione ha di Tsipras, e del modo in cui ha gestito il negoziato con i creditori?
Tutti i governi della Grecia, non solo quello guidato da Mr Tsipras, hanno perso tempo e gestito i negoziati nel modo sbagliato. Penso che la politica interna, in Grecia, abbia fatto e continui a fare degli errori enormi. Mr Tsipras non ha creato questa situazione, l’ha ereditata dai governi precedenti. Ciò che ha fatto, però, ha peggiorato ancora di più le cose. Negli ultimi cinque mesi non ha condotto negoziati seri e non ha fatto proposte specifiche. Ha tirato troppo la corda... e ora dove ci ha portato?
Dal mio punto di vista, l’ultima proposta di accordo della Commissione europea doveva essere accettata. Nell’ultima settimana le condizioni finanziarie della Grecia hanno subito un tracollo pesantissimo. Ora la situazione è molto più difficile di com’era prima. Abbiamo perso del tempo prezioso.
Pensa che la Grecia sia uscita più debole da questo referendum?
Penso che l’unico vincitore sia stato Tsipras. L’unico che ne ha tratto qualche vantaggio è stato lui. Per il resto, il referendum non ha aiutato nessuno. La domanda, tra l’altro, riguardava qualcosa che non esisteva più, un accordo già scaduto. Ora Tsipras gode di un mandato molto forte in Grecia, ma la sua posizione in Europa non si è rafforzata rispetto a prima.
Uno dei suoi libri - “Resa dei Conti” - è ambientato in uno scenario in cui Grecia, Spagna e Italia hanno appena lasciato l’euro... Pensa che stiamo andando in quella direzione?
Spero tanto che questa mia ipotesi non diventi realtà... Tornare alla dracma sarebbe un disastro, il colpo di grazia alla nostra economia. Chi afferma il contrario non realizza quanto sia dannoso. Purtroppo non ci sono soluzioni facili, bisogna scegliere l’opzione meno cattiva.
Eppure i giovani si sono espressi con forza contro quella proposta. La stragrande maggioranza ha votato “no” all’austerity...
Quando vivi in un Paese in cui la disoccupazione giovanile si avvicina al 60%, è comprensibile che i giovani siano furiosi. Vogliono una reazione, e questo voto, per loro, è stato una reazione. Non era un voto contro l’Europa, ma la richiesta di condizioni migliori. Capisco la rabbia dei giovani, di chi ha studiato tanto e non ha un lavoro. Ma la realtà, purtroppo, è che oggi andiamo verso un periodo molto molto duro. Abbiamo perso cinque mesi, e nell’ultima settimana la situazione è precipitata. Non c’è modo di scappare da questa situazione. Non riesco a vedere una possibilità, ora...
Che colpe ha in tutto questo l’Europa?
L’Europa ha responsabilità enormi. L’errore più grande risale al 2010, quando la Troika accettò la controproposta della Grecia. Il governo Papandreou, invece di essere spinto a fare le riforme, le posticipò: la resa dei conti venne spostata più avanti, accumulando ritardi e distruggendo la classe media. Commissione europea, Bce e Fmi avrebbero dovuto forzare il governo a fare le riforme allora. Avrebbero dovuto dire: ’non accettiamo nulla, tranne le riforme’. Invece hanno accettato una politica miope basata sull’aumento delle tasse, condannando a morte la classe media.
Entrambe le parti - governi greci e Ue - hanno fallito: la Grecia aveva bisogno di una forte spinta riformatrice su tutto il sistema, ma questa spinta non c’è stata. È stato facile per gli europei di Bruxelles e Francoforte dire che i greci non facevano le riforme; la verità è che non li spingevano a farle. Per racimolare soldi i governi greci hanno continuato ad aumentare le tasse per tutti i greci, arrivando a disintegrare la classe media. Peccato che, in un piccolo Paese come il nostro, l’economia sia fatta dalla classe media: se si distrugge questa fascia, se si toglie l’ossigeno alle piccole e medie imprese, alle cooperative, non c’è modo di ottenere un miglioramento. Sono profondamente convinto che di questo processo l’Europa sia responsabile.
Come si esce da questo vicolo cieco? A chi giova restarci?
Stiamo assistendo a un gioco di potere tra Ue e Grecia, un gioco tra minori che avrebbero un disperato bisogno di custodia. Dovremmo fermare questo stupido gioco di potere. Anche perché questo atteggiamento aggressivo dei vertici Ue rischia di diventare un boomerang per l’Europa. Ormai in Europa parliamo solo di economia. Renzi ha ragione quando dice che l’Europa ha bisogno di una prospettiva politica. Qui servono decisioni politiche: non ci sono solo i numeri, serve anche la cooperazione. Se la Grecia dovesse tornare alla dracma, sarebbe una sconfitta per l’Europa. Possiamo considerarlo un effetto collaterale, ma non possiamo prevederne gli effetti politici.
Che tipo di scenario ha in mente?
Le uniche forze che vedo fiorire in Europa sono quelle dell’estrema destra. Inutile che le spieghi chi sono i neonazisti di Alba Dorata. Questa situazione non è solo molto triste: è pericolosa. Ho molte critiche da obiettare a Syriza, ma vorrei che avesse successo. Altrimenti non voglio neanche immaginare cosa potrebbe succedere con Alba Dorata.
Quando dico che non c’è pensiero politico, intendo questo: bisognerebbe scongiurare in ogni modo la prospettiva dell’ascesa di un partito neonazista. Né i greci né tantomeno gli europei capiscono cosa potrebbe succedere... Non pensano politicamente: vedono solo i numeri, non c’è pensiero politico. L’Europa fa finta di niente, ma si trova di fronte un problema enorme: pensa che sia tutto economico, quando invece è tutto politico.
Nei sui libri crisi, povertà e corruzione fanno da sfondo alle avventure del Commissario Charitos. Lo troveremo a indagare con lo spettro di una Grexit?
Non voglio scrivere, voglio solo vedere cosa succederà. Ho molte idee, ma prima ho bisogno di capire. È la prima volta che mi capita di trovarmi in una situazione così complicata e oscura. Prima era più facile: sapevo che c’era una crisi, vedevo la sofferenza della popolazione... Ora ho un’immagine molto più confusa, devo aspettare che il quadro mi si chiarisca un po’... Nella vita di tutti i giorni sto attraversando una fase molto stressante, anche dal punto di vista emotivo. Sento di essere dentro a una storia che, per ora, non riesco a raccontare.
Il commissario Charitos ci spiega la Grecia
di Fabrizio Tonello *
È il 1 gennaio 2014 e la Grecia è uscita dall’euro, tornando alla dracma. Il governo annuncia che per tre mesi gli stipendi pubblici non saranno pagati. La famiglia Charitos (il commissario Kostas, la moglie Adriana, la figlia Caterina e il genero Fanis) si affida alla saggezza popolare di Adriana: “Non dobbiamo fare altro che ricominciare a vivere come si faceva nei paesi dove siamo cresciuti. Mangeremo carne solo una volta ogni tanto: tutti gli altri giorni verdure e legumi. Sono anni che in televisione gli esperti ci rompono le scatole con tutte le loro teorie sulla dieta sana. E ora la loro dieta sana è diventata obbligatoria”.
Inizia così Resa dei conti, l’ultimo romanzo di Petros Markaris, appena uscito da Bompiani, il volume che completa la trilogia dedicata alle vicende della Grecia nella crisi: i precedenti erano stati Prestiti scaduti e L’esattore. Anche in queste pagine il commissario Charitos indaga su delitti che hanno la loro origine nella politica, o meglio nel cocktail di affari, evasioni fiscali e corruzione che per decenni in Grecia è stato definito “politica”. Markaris, di famiglia greco-armena, nato a Istanbul nel 1937, non ha compiacenze per il paese dove ha scelto di vivere, definendolo “l’unica mafia al mondo che è riuscita a fare bancarotta” (L’esattore).
Il commissario Charitos compie 20 anni di carriera: fu nel 1993, infatti, che Markaris iniziò a scrivere romanzi che sarebbe improprio definire “polizieschi”. Si tratta, infatti, di “romanzi sociali con una trama poliziesca”, come dice lui stesso in una miniautobiografia pubblicata nel 2010 (Io e Kostas Charitos). Le indagini sui delitti sono parte di affreschi assai più vasti, in cui l’autore dipinge la società greca, con le sue famiglie piccoloborghesi, i suoi arricchiti, la sua memoria ancora divisa da una guerra civile (1945-49) che non è mai finita. E, paradossalmente, il suo obiettivo polemico principale è la “generazione del Politecnico”, come vengono chiamati gli ex studenti che si ribellarono nel 1971 ai colonnelli andati al potere nel 1967. La loro vittoria del 1973 ha creato una classe dirigente partita con grandi ideali e finita nella corruzione. Markaris, traduttore di Brecht e collaboratore del regista Anghelopoulos, la definisce “una generazione che è partita di sinistra ed è finita stronza” (La lunga estate calda del commissario Charitos).
Non è difficile capire il perché: la vita politica greca negli ultimi 40 anni è stata dominata da appena tre famiglie, che hanno fatto del clientelismo, dell’indebitamento, dell’acquisto dei voti un’arte: i Karamanlis, i Mitsotakis, i Papandreou. Una élite che ha portato il Paese prima nell’Unione Europea e poi nell’euro ma non ha intaccato minimamente le “tradizioni” locali: le opere pubbliche inutili, le raccomandazioni, le bustarelle, l’evasione fiscale, il debito con l’estero.
Markaris affronta tutti questi temi: le Olimpiadi del 2004 (Si è suicidato il Che), gli evasori (L’esattore), le banche (Prestiti scaduti). Il suo commissario Charitos assomiglia a Maigret nella testardaggine con cui continua a indagare su casi apparentemente insolubili ma, a differenza del commissario di Georges Simenon, ha a che fare con la politica quotidianamente: il capo della polizia Ghikas lo controlla passo passo. Charitos accumula prove lentamente, non usa la tecnologia (Resa dei conti è il primo romanzo in cui si serve di un computer, per altro regalatogli dalla figlia), non ha mai grandi intuizioni, in un certo senso è un poliziotto fin troppo normale. Il fascino dei romanzi sta nell’accuratezza con cui Markaris descrive una città, Atene, strangolata dal traffico, sprofondata nella corruzione ma piena di vitalità e di contraddizioni.
Kostas Charitos è uno dei protagonisti di quella che si potrebbe ben definire la scuola del “poliziesco mediterraneo”, come l’ispettore Fabio Montale, del compianto Jean-Claude Izzo, il commissario Montalbano di Camilleri e Petra Delicado, la protagonista dei romanzi di Alice Gimenez-Bartlett. A differenza degli ultimi due Charitos ha una vita sentimentale tranquilla, per non dire inesistente: una moglie che cucina e guarda la televisione ma piena di saggezza popolare, una figlia che diventa avvocato per difendere gli immigrati, un genero medico che sorveglia la sua salute. Questo microcosmo non è una tela di cartone, uno sfondo piatto come nei romanzi di Simenon (dove la signora Maigret compare solo per portare il caffè o la grappa dopo cena) ma un mondo concreto e vitale.
Charitos, come Montalbano e la Delicado, ha però quotidianamente a che fare con burocrazie che non vogliono noie, soprattutto se si tratta di indagare sui ricchi e sui potenti: Grecia, Italia e Spagna sono accomunate da questo, prima che dal sole del Mediterraneo e dai debiti con l’estero. Un motivo in più per inserirlo nella valigia dei libri da portare in vacanza.
Fabrizio Tonello
* IL BO. Il giornale dell’Universita’ di Padova, 3 luglio 2013
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- LA CARITA’ DELLA GRECIA (dono, grazia) E LA CARITA’ DELL’EUROPA (caro-prezzo)!!!8 luglio 2015, di Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- L’UNIONE MANCATA. Chi ha tradito i fondatori dell’Europa. L’Europa ha bisogno di un cuore8 luglio 2015, di Federico La Sala
L’Europa ha bisogno di un cuore
di Barbara Stefanelli (Corriere della Sera, 08.07.2015)
Nei giorni delle banche chiuse e delle dirette tv dalla disperazione, dei vertici d’emergenza e delle dispute accademiche sul grado di sovranità, un ventinovenne britannico di nome Thom Feeney ha avviato una campagna di crowdfunding - una raccolta di denaro via Internet - «a sostegno del popolo greco». In poche ore, sono arrivate sulla piattaforma digitale di Indiegogo migliaia di donazioni da 170 Paesi per un totale di due milioni di euro. I più generosi sono stati i tedeschi, poi gli inglesi e gli austriaci. Una grande piazza virtuale ha così accompagnato le piazze di Atene, percorse da tanti stranieri - quasi tutti europei - determinati a mostrare solidarietà durante quello che non viene vissuto come un dramma chiuso nei confini nazionali.
Ora dimentichiamo gli schieramenti per il Sì o per il No. Sospendiamo anche l’analisi delle colpe gravi e degli errori tattici. E chiediamoci: come è possibile che questo movimento verso i greci stia avvenendo proprio mentre la Grecia rischia di essere il primo Paese che viene accompagnato - o si fa accompagnare - alla porta dell’Unione, interrompendo un processo di inclusioni che continua dalla seconda metà del Novecento?
Le varie forme di partecipazione - i viaggi del turismo politico, le donazioni d’istinto, le conversazioni ossessive sul caso greco & noi - sono la prova che un senso di appartenenza (non solo obbligato) è cresciuto tra quelli che ormai fatichiamo a chiamare «i popoli», categoria abbandonata in mezzo ai rovi del populismo, appunto, in nome di vincoli superiori. Appartenenza a un continente, a una democrazia, a una cultura.
Quando nel 1981 la stessa Grecia entrò nella casa comunitaria, l’Europa rappresentava un sogno di stabilità, di diritti, di non paura dopo gli anni della guerra civile e della dittatura: non era solo questione di economie, era un modello al quale guardare per un futuro di prosperità che avrebbe unito Sud e Nord, Est e Ovest in una sintesi innovativa.
A un certo punto, la costruzione di un senso europeo e il racconto di quella costruzione si sono interrotti. E allora - mentre studiamo soluzioni urgenti al default greco, mentre riflettiamo sulla necessaria convergenza strutturale delle economie in zona euro - dovremmo anche chiederci perché non esista oggi un’ intellighenzia capace di una visione che non sia solo vincolo e costrizione, capace di contaminare positivamente l’immaginazione degli europei e legittimare dal basso il consenso.
Oltre i politici, accanto agli economisti, è difficile rintracciare un fronte robusto e attivo di pensatori che sappiano rovesciare il contagio del risentimento. E rianimare un sentimento europeista. Quando evochiamo le ragioni del nostro stare e restare insieme, ricorriamo fatalmente al ricordo di padri della patria straordinari quanto lontani, tiriamo fuori vecchie fotografie di leader che si tenevano per mano davanti a un’idea coraggiosa e che sono quasi tutti scomparsi. In tempi di crescita abbiamo commesso l’errore strategico di non coltivare quella cultura e quei progetti che ci avrebbero avvicinato, non abbiamo dato struttura a uno slancio che sembrava scontato e per sempre: l’intuizione di un continente forte della sua varietà e sensibile alle singole storie se ne è stata a galleggiare silenziosa tra gli Stati.
Adesso che i tempi sono cambiati e ci troviamo prigionieri di particolarismi trascinati dalla crisi, ridare fiato a quell’ambizione unitaria è molto complicato, a tratti pare impossibile. Ma il problema si è posto e sta in mezzo a tutti. Non è solo Grexit, non sarà neppure solo Brexit. E non basteranno gli appelli alla generazione Erasmus che ha condiviso studi, appartamenti e amicizie oltre confine. Al contrario, dovremmo meditare sulla coincidenza tra alcune forme radicali di euroscetticismo e i più giovani, che magari hanno sì in testa altre terre ma raramente la loro.
La verità è che la fiducia dei cittadini europei va riconquistata, anzi: va «acquistata» con misure che incidano là dove maggiore è l’inquietudine. In attesa di riaprire i Trattati, quando la temperatura continentale sarà scesa, a fare la differenza potrebbero essere interventi coraggiosi sulle migrazioni o sul lavoro. Uno schema Ue di sussidi di disoccupazione, per esempio, che mostri dove sta la solidarietà - non solo ideale. Troppo a lungo gli investimenti, i finanziamenti, i piani europei sono rimasti opachi: non sono stati raccontati e spiegati, liberando il campo alle invettive e alle proteste. In un’epoca di grandi narrazioni su tutto, la comunicazione da Bruxelles dovrà contribuire a quel rovesciamento del contagio negativo: servono parole sorprendenti, oltre le formule fredde e le burocrazie di comodo che hanno fatto battere in grigio il cuore comune.
Feeney, l’uomo del crowdfunding , ha calcolato che se ogni cittadino dell’Unione depositasse 3,19 euro nel salvadanaio digitale si arriverebbe a 1 miliardo e 600 milioni, quanto Atene deve al Fmi. In fondo è poco più di quel 3,14 - il misterioso Pi greco - che serve a misurare il cerchio: la figura geometrica simbolo di unione e inclusione
L’UNIONE MANCATA
di MASSIMO L. SALVADORI (la Repubblica, 08.07.2015)
ALTIERO Spinelli viene onorato come un grande padre dell’Unione Europea. Sennonché è rimasto un padre senza figli. Il suo progetto di Stati Uniti d’Europa, delineato nel 1941 a Ventotene, appare come un’utopia, che non ha avuto luogo e non si sa se e quando possa trovarlo. A leggerlo oggi suscita commozione e ironia. Vi si dice che la nazione è obsoleta, che avendo gli Stati nazionali seminato disastri all’ordine del giorno occorre porre la Federazione europea, che l’anima di questa dovrà essere l’emancipazione delle classi lavoratrici. Il Manifesto di Ventotene si chiudeva in modo battagliero: «La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà!». Sembra di trovarsi di fronte al sogno di un visionario. Abbiamo infatti una Unione nominale ma non reale, fortemente incompiuta, difettosa, traballante.
La drammatica crisi greca, che è la crisi di un Paese entro quella dell’intera Unione, non rappresenta se non l’ultimo capitolo di uno storico insuccesso. La clamorosa vittoria dei “no” al referendum di Atene ne è, al di là di ogni altra cosa, lo specchio nero. La federazione si colloca in un orizzonte senza tempo. Si profilano sintomi di disgregazione a partire dalla possibilità concreta che la Gran Bretagna - tradizionale palla al piede di ogni avanzamento verso l’unificazione politica - abbandoni l’Unione; avendo a corona una proliferazione di movimenti ostili al progetto europeistico.
Chi semina vento raccoglie tempesta. E a farlo è stata l’Unione stessa. È sotto i nostri occhi come le tendenze variamente antieuropeistiche siano state e siano alimentate dai limiti organici della sua costruzione. La Comunità economica europea da un lato era stata un successo, ma dall’altro aveva segnato il passo in relazione all’unificazione politica. Era stata posta sotto il segno di un debole e incompiuto confederalismo, sviluppatasi all’ombra della divisione del continente sanzionata dalla guerra fredda aveva lasciato il potere sostanziale in politica interna ed estera nelle mani degli Stati nazionali, si era legittimata sostenendo di aver dato finalmente pace ai popoli che la componevano: ma era retorica, poiché le chiavi della pace e della guerra erano tenute da Usa e Urss. Sotto lo stimolo della dissoluzione dell’impero sovietico, della riunificazione tedesca e con la prospettiva di un allargamento ormai alla portata, l’Unione Europea con il trattato di Maastricht del 1992 si pose il compito di marciare verso «un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini», di avviare dunque il processo per il passaggio alla federazione politica.
Ebbene, oggi possiamo misurare che le promesse e le speranze non sono state mantenute. Ecco le promesse non mantenute: l’Unione è stata incapace di darsi una costituzione; ha un Parlamento che lascia le decisioni che contano ai capi di Stato e di governo; le leve della politica estera restano prerogativa di Stati nazionali che talvolta si accordano e talvolta non si accordano affatto; è divisa tra Paesi che si sono dotati di una moneta unica e Paesi che ne sono rimasti fuori; ha una Banca centrale che però non ha alle spalle un governo politico comune; ha come valore la solidarietà ma ciascuno la concepisce come vuole; di fronte alla tragedia delle nuove ondate di immigrazione sta perdendo la testa suscitando tensioni che non sa come comporre. Il dramma della Grecia - esaltato dai penosi contrasti di capi di governo, tecnocrati ed economisti che propongono gli uni certe ricette e gli altri ricette opposte - mette a nudo i difetti profondi di un’Unione che divide.
In questo contesto giganteggiano i forti squilibri di potere politico ed economico tra i singoli membri dell’Unione. Essa è andata estendendosi fino a 28: un’estensione quantitativa difficile da governare in assenza di un governo federale in grado di stabilire quell’autorità centrale che costituisce il motore di qualsiasi effettiva Unione di Stati. È quindi inevitabile che all’interno di un tale precario assemblamento si stabiliscano ineguali rapporti di forza che giocano a favore anzitutto dello Stato istituzionalmente più solido, economicamente meglio at-trezzato, dotato di una leadership ampiamente condivisa da parte del suo popolo.
È qui che si apre la questione della Germania unificata, che ha stabilito la propria egemonia, come mostrato da ultimo dalla vicenda greca. La Germania galleggia nel mare dell’Unione come una grande isola, generando una pericolosa contraddizione: un’Unione nata per compattare le sue componenti va scollandosi anche perché i tedeschi si trovano ad esercitare un superpotere che provoca resistenze e avversioni. Romano Prodi ha invocato, come unico e urgente rimedio al fallimento, lo stabilirsi di un’autentica «autorità federale». È il grido di Spinelli che ritorna. Vero: l’Europa ha assolutamente bisogno di una simile autorità, ma tutto attualmente milita contro di essa. Siamo nel pieno di una crisi di sistema, di fronte alla quale vale l’eterna lezione di tutte le grandi crisi: o si mobilitano le maggiori energie o si assiste allo sfibrarsi dell’intero tessuto arrivando allo scacco. Hic Rhodus, hic salta.
Chi ha tradito i fondatori dell’Europa
di Nadia Urbinati (la Repubblica, 08.07.2015)
IL REFERENDUM greco ha accesso i riflettori sulla scena più contradditoria e convulsa che si trova a vivere l’Europa da quando ha intrapreso la strada dell’integrazione. Il destino di questo progetto di pace per mezzo della cooperazione è più che mai sospeso tra volontà e intenzioni contrapposte. Alla lucidità dei suoi visionari e fondatori fa seguito oggi una grande opacità, e soprattutto la rinascita prepotente degli interessi nazionali, pronti a usare l’Europa come arma per offendere e umiliare oppure come alibi dietro il quale nascodere la mancanza di volontà decisionale. La visione di un’Unione europea è nata tra le due guerre per sconfiggere i nazionalismi e i nazionalisti.
Le direttrici originarie di questa utopia pragmatica furono in sostanza due: quella che faceva perno sulla volontà politica costituente e quella che faceva perno sulla formazione dell’abitudine alla cooperazione mediante regole e accordi economici.
La prima era impersonata da Altiero Spinelli e faceva diretto ed esplicito appello alla volontà degli Stati di darsi un ordine politico federale, un progetto da prepararsi con il lavoro politico e delle idee (come fece il movimento federalista europeo).
La seconda era rappresentata da Jean Monnet. Quest’ultima divenne il paradigma ispiratore dell’Unione europea, il cui primo nucleo fu nel 1950 la creazione di un’alta autorità sulla produzione franco-tedesca dell’acciaio e del carbone. Quel trattato sarebbe stato il primo di una serie numerosa di trattati sottoscritti dai governi in tutti i settori di interesse comune. La federazione europea sarebbe cresciuta quindi per accumulazione, senza un fiat fondatore, ma come politica di auto-imbrigliamento degli Stati che avrebbe col tempo costituzionalizzato le pratiche sovrannazionali.
Le radici di questa via non-politica all’integrazione europea stanno nel Settecento, nella filosofia della mano invisibile e della funzione civilizzatrice del commercio. L’assunto kantiano era che gli individui tendono a muoversi, a interagire e a comunicare per ragioni loro proprie con la conseguenza di mettere in moto un processo indiretto di relazioni pubbliche e di diritti che col tempo avrebbero consolidato la convivenza pacifica per generale convenienza. In prospettiva, l’integrazione avrebbe potuto mettere capo a una più perfetta unione, senza che nessuno l’avesse esplicitamente voluta. Questa fu la filosofia che ha sostenuto il progetto europeo mediante decisioni di secondo ordine, indotte dalla convenienza a cooperare.
Questo paradigma è stato una strategia di successo nella fase espansiva della ricostruzione post- bellica, proprio per la sua capacità di contenere le potenzialità conflittualistiche della politica e dare spazio alla pratica degli accordi e dei trattati. Ma in questo tempo di crisi economica, tale metodo ha perso mordente. La sfida di fronte alla quale si trova oggi l’Europa richiederebbe una determinazione politica nello spirito di Spinelli. Come ha sostenuto il costituzionalista Dieter Grimm, la rete di diritti e costruzioni giuridiche ha bisogno di ancorarsi a una «espressione di autodeterminazione del popolo sovrano europeo» per riuscire a far valere appieno la sua autorità su tutti e in tutti gli Stati.
Affidarsi alle pratiche generate dall’uso di regole condivise, all’abitudine di vivere da europei come se le cose vadano avanti per forza propria: tutto questo regge e funziona fino a quando le cose procedono facilmente e non è necessario scomodare un supplemento di volontà per prendere decisioni ostiche, benché necessarie.
Il paradigma dell’eterogenesi dei fini su cui si è modellata l’Unione europea è figlio dell’utopia settecentesca del doux commerce , della forza civilizzatrice del commercio a condizone che sia la mano invisibile del mercato a muovere le decisioni, non la volontà politica. Il problema è che, mentre questa strategia ha avuto il merito di stabilizzare relazioni pacifiche essa non è in grado ora di guidare l’Unione europea verso una integrazione politica democratica, della quale invece vi sarebbe bisogno. La routine riproduce pratiche ma non sa creare scenari nuovi. Ecco perché oggi la lotta che si combatte in Europa è tra il partito della mano invisibile e il partito della volontà politica federale.
Non si giungerà mai ad una più perfetta unione se il demos europeo non sarà interpellato, se la volontà politica non acquisterà la sua autorità fondatrice, condizione senza la quale altri, dopo la Grecia, potrebbero pensare di usare lo strumento dell’appello al popolo nazionale per reagire contro decisioni che non sono prese nel nome di un popolo europeo.
Il “no” referendario alle condizioni sul debito imposte alla Grecia ha messo in luce che solo all’interno di un’Unione politica compiuta il caso greco potrebbe non essere solo e soltanto una questione di rapporto privato fra debitori e creditori. Solo in un’Unione politica la questione greca potrebbe essere a tutti gli effetti una questione europea, e la sua soluzione una straordinaria opportunità di crescita continentale. Per comprendere questo, la logica della mano invisibile non serve, e anzi è di ostacolo perché mentre rifiuta di dare la scena alla politica rafforza la pratica delle trattative intergovernamentali e quindi rafforza sempre di più gli interessi nazionali. Crea le condizioni per il declino dell’Unione europea.
In Come ho tentato di diventare saggio, raccontando come prese corpo l’idea federalista ed europeista, Altiero Spinelli così dipinse l’Europa degli anni ’30: «Tutti questi Stati d’Europa obbedivano sopra ogni altra cosa alla legge della conservazione e dell’affermazione della propria sovranità. Fossero essi democratici o totalitari, erano sempre più nazionalisti... La federazione europea non ci si presentava come una ideologia, non si proponeva di colorare in questo o in quel modo un potere esistente... Era la negazione del nazionalismo che tornava a imperversare».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Referendum in Grecia. Che cos’è adesso ancora sinistra? (di Slavoj Žižek)9 luglio 2015, di Federico La Sala
Referendum in Grecia
Che cos’è adesso ancora sinistra?
In questa settimana viviamo una lotta per la cultura-guida democratica. Non si tratta dei greci. Si tratta di noi tutti!
Slavoj Žižek, filosofo, insegna a Londra
 Die Zeit online - 5 luglio 2015
Die Zeit online - 5 luglio 2015(Traduzione dal tedesco di José F. Padova)
Una nota barzelletta dell’ultimo decennio dell’Unione Sovietica racconta di Rabinowitz, un ebreo, che vuole emigrare. Il burocrate dell’Ufficio Emigrazione gli chiede il perché e Rabinowitz risponde: «Vi sono due motivi. Il primo è che io ho paura di una perdita di potere dei comunisti nell’Unione Sovietica. I nuovi capi al potere potrebbero quindi scaricare la colpa dei crimini comunisti soltanto su noi, gli ebrei, - e potrebbero esserci di nuovo pogrom antiebraici...» «Ma», lo interrompe il burocrate, «questo è una totale assurdità, nulla può mai modificarsi nell’Unione Sovietica, il potere comunista si conserverà in eterno!». «Beh», replica Rabinowitz tranquillo, «questo è il mio secondo motivo».
Ora ad Atene circola una nuova versione di questa barzelletta. Un giovane greco va al Consolato australiano di Atene e chiede un visto d’ingresso per lavoro. «Perché vuole lasciare la Grecia?», chiede il funzionario. «Per due motivi», risponde il greco. «In primo luogo ho timore che la Grecia abbandonerà l’Unione Europea, cosa che porterà ancor più povertà e caos nel Paese...». «Ma», lo interrompe il funzionario, «ciò è una totale assurdità, la Grecia rimarrà nell’Unione Europea e si sottometterà alla disciplina finanziaria!» - «Beh», replica calmo il greco, «questo è il mio secondo motivo». Quindi entrambe le decisioni sono le peggiori, per parafrasare Stalin? È arrivato il momento in cui dobbiamo lasciarci indietro gli irrilevanti dibattiti sui possibili errori e giudizi sbagliati del governo greco. Nel frattempo vi è troppo in gioco.
Il fatto che nei negoziati fra la Grecia e gli amministratori dell’Unione Europea una formulazione di compromesso si sia volatilizzata sempre all’ultimo momento è in sé altamente significativo. Non si tratta più veramente di differenze di opinioni finanziarie - in questo campo le posizioni si diversificano soltanto minimamente. Di regola l’Unione Europea incolpa la Grecia di diffondere luoghi comuni e vaghe promesse senza dettagli impegnativi, mentre la Grecia rinfaccia all’Unione Europea di cercare di tenere sotto controllo proprio questi insignificanti dettagli e di imporre al Paese condizioni ancor più rigorose di quelle già accollate ai precedenti governi.
Dietro queste rimostranze si nasconde però un conflitto del tutto diverso, molto più profondo. Il premier greco Alexis Tsipras recentemente faceva notare che se si fosse incontrato a cena da solo con Angela Merkel entrambi avrebbero trovato una soluzione in un paio d’ore. Con questo voleva dire che Merkel e lui, due politici, avrebbero trattato il conflitto come politico, a differenza di amministratori tecnocratici come il capo dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem. Se in tutta questa storia c’è un cattivo, quello è Dijsselbloem col suo motto: «Se io le cose le prendo innanzitutto dal loro lato ideologico non ottengo più niente».
Anche i tecnocrati dell’Unione Europea seguono un’ideologia - soltanto che è una diversa
Con questo arriviamo al punto cruciale di tutto quanto: Tsipras e Varoufakis parlano come se fossero parte di un processo politico aperto, nel quale alla fine devono essere trovate decisioni “ideologiche” (che si basano su preferenze normative). I tecnocrati dell’Unione Europea parlano come se si trattasse per tutto di una questione di provvedimenti che regolano nel dettaglio e quando i greci rifiutano questo approccio e propongono problemi politici più sostanziali si rinfaccia loro di mentire e di svignarsela davanti a proposte concrete. Dalla parte greca la verità qui è univoca: la negazione che fa Dijsselbloem del “lato ideologico” è autentica ideologia, essa fornisce decisioni che sono veramente fondate sotto l’aspetto politico-ideologico, ma infondate come misure di regolamentazione.
A causa di questa asimmetria il “dialogo” fra Tsipras o Varoufakis e i loro partner dell’Unione Europea funziona spesso come il colloquio fra un giovane studente, che vorrebbe discutere seriamente su problemi di fondo, e un arrogante professore, che nelle sue risposte ignora vergognosamente questi temi e rimprovera lo studente per manchevolezze tecniche: «Questo non è formulato correttamente! Lei non ha tenuto presente questa regola!». O come lo scontro verbale fra una donna violentata che vuole disperatamente riferire quello che le è capitato e un poliziotto che la interrompe continuamente con domande su dettagli burocratici. Questo spostamento dalla politica vera e propria a una amministrazione anodina da parte di esperti contraddistingue il nostro intero processo politico: decisioni strategiche, fondate su rapporti di forza sono prese in misura crescente come regolamentazioni amministrative, che devono basarsi sul sapere neutrale degli esperti. E sono sempre più spesso pattuite dietro porte chiuse e fatte valere senza partecipazione democratica.
La battaglia che si svolge sotto i nostri occhi è la lotta per la cultura-guida europea, economica e politica. Le potenze dell’Unione Europea stanno per lo status quo tecnocratico, che da decenni blocca l’Europa. Nel suo contributo al concetto della cultura il grande, conservatore, T. S. Eliot osservò che vi sono momenti nei quali si ha la scelta soltanto fra eresia e incredulità. Inoltre vi è una sola possibilità di mantenere in vita una religione, mediante una frammentazione in sette del suo defunto corpo principale. Questa è oggi la nostra situazione in Europa. Soltanto una nuova “eresia” (che attualmente Syriza rappresenta) può salvare quello che nell’eredità europea merita il salvataggio: la democrazia, la fiducia nelle persone, la solidarietà ugualitaria... l’Europa, che otterrà, se ci riesce, di bloccare Syriza, è una “Europa dei valori asiatici” - ciò che naturalmente non ha nulla a che fare con l’Asia, ma invece tutto con la tendenza evidente e immediata del capitalismo contemporaneo a scalzare la democrazia. Quindi ora ha fallito l’Europa di sinistra? No, ha fallito l’Europa. Nell’Europa occidentale siamo inclini a guardare la Grecia come se fossimo osservatori distaccati, che pieni di partecipazione e compassione seguono la miseria di una nazione impoverita. Un simile comodo punto d’osservazione si basa però su un’illusione fatale - perché quello che si consuma in queste settimane in Grecia riguarda noi tutti, è il futuro dell’Europa che è in gioco. Se in questi giorni seguiamo le notizie sulla Grecia dovremmo sempre tenere in mente l’antica locuzione: De te fabula narratur, la storia parla di te.
Dalle reazioni dell’establishment europeo all’annunciato referendum greco emerge lentamente un ideale che il titolo di un commentario di Gideon Rachman sul Financial Times puntualizza: «Il membro più debole dell’Europa sono gli elettori». In questo mondo ideale l’Europa si sbarazza del suo «membro più debole» e gli esperti ottengono il potere di imporre direttamente le necessarie misure economiche - finché ancora si terranno, l’unica funzione delle elezioni è quella di confermare l’assenso degli esperti.
Ora, questa esperto-crazia si fonda purtroppo su una finzione, la finzione del «prolungare e fingere» (prolungamento del termine di restituzione [del debito] con la contemporanea simulazione che alla fine tutti i debiti sarebbero stati saldati). Perché questa finzione si mantiene così caparbiamente? Non soltanto perché rende accettabile agli elettori tedeschi un allungamento della situazione debitoria; e anche non soltanto perché un ammortamento del debito greco potrebbe suscitare simili richieste da parte di Portogallo, Irlanda o Spagna. Il motivo è molto più e cioè che i detentori del potere [europeo] non vogliono proprio che i debiti siano interamente ripagati.
I prestatori di denaro a debito e i relativi amministratori incolpano i Paesi indebitati di non sentirsi abbastanza in debito [colpevoli] - rinfacciano loro di non sentirsi per nulla in colpa [in debito] [ndt. Schuld significa debito ma anche colpa]. Il loro insistere corrisponde precisamente a quello che la psicoanalisi definisce Super-io: come Freud aveva chiaramente visto, questo è il paradosso del Super-io, che noi ci sentiamo tanto più colpevoli quanto più ci sottomettiamo alle sue [del Super-io] richieste. Come accade a un maestro crudele che impone ai suoi scolari compiti impossibili e poi sadicamente giubila quando vede il loro panico. Quando si presta denaro a un debitore, il vero scopo non consiste nel ricevere in restituzione il credito con il relativo utile costituito dagli interessi, bensì nell’illimitata continuazione del debito, ciò che mantiene il debitore in stato permanente di dipendenza e assoggettamento, in ogni caso la maggior parte dei debitori, perché c’è debitore e debitore.
Non solamente la Grecia, anche gli Stati Uniti non sono teoricamente in grado di pagare i loro debiti, come intanto viene riconosciuto pubblicamente. Vi sono quindi debitori che possono ricattare i loro creditori, essendo troppo grandi perché si possa lasciarli fallire (grandi banche), debitori che possono tenere sotto controllo le condizioni per l’estinzione del loro debito (il governo degli Stati Uniti) e infine debitori che si può tenere sotto pressione e umiliare (Grecia).
In sostanza i creditori e i loro amministratori incolpano quindi il governo Syriza di ritenersi non “abbastanza debitore”, ma “per niente debitore”. Questo è ciò che per l’establishment dell’Unione Europea è tanto inquietante nel governo Syriza: esso ammette i debiti, ma lo fa senza senso di colpa, si è sbarazzato del peso del Super-io. Varoufakis impersona questo atteggiamento nel suo rapporto con Bruxelles. Egli ammette l’indebitamento e argomenta del tutto ragionevolmente che di fronte all’evidente fallimento della politica dell’Unione Europea deve essere trovata un’altra soluzione. Suona paradossale l’argomento ripetutamente formulato da Varoufakis e Tsipras, che il governo di Syriza è l’unica chance per i creditori di ricever indietro almeno una parte del loro denaro.
Varoufakis si stupisce del mistero che le banche abbiano pompato denaro nelle casse della Grecia e abbiano collaborato con uno Stato clientelare, nonostante sapessero benissimo come stavano le cose - senza la tacita approvazione dell’establishment occidentale la Grecia non avrebbe mai potuto indebitarsi a tali livelli. Il governo di Syryza è totalmente consapevole che la minaccia principale non arriva da Bruxelles - essa è in agguato nella Grecia stessa, nella quintessenza di uno Stato clientelare e corrotto.
Syriza vuole qualcosa di giusto, che nel sistema esistente non è possibile
L’Europa (l’euro-burocrazia) deve rimproverare sé stessa per aver criticato la Grecia a causa della sua corruzione e inefficienza e allo stesso tempo per aver sostenuto con Nea Dimocratia [il partito di destra scalzato da Syriza] proprio la forza politica che impersonava questa corruzione e inefficienza. Al governo di Syriza tocca ora precisamente il compito di superare questo blocco sistemico - si legga soltanto la dichiarazione programmatica di Varoufakis al britannico Guardian, nella quale descrive l’estremo scopo strategico del suo partito: «Un’uscita greca o portoghese o italiana dall’eurozona porterebbe presto a un andare in pezzi del capitalismo europeo. La conseguenza sarebbe una regione dell’avanzo [di bilancio come religione] seriamente a rischio di recessione ad est del Reno e a nord delle Alpi, mentre il resto dell’Europa precipiterebbe in una brutale stagflazione. Chi approfitterebbe proprio di questa evoluzione? Una sinistra progressista che si solleverebbe nelle istituzioni pubbliche europee come una fenice dalle ceneri? O i nazisti di Alba Dorata, i diversi movimenti neofascisti, gli xenofobi e i furfanti? Non ho il minimo dubbio su chi dei due profitterebbe al massimo di un fallimento dell’eurozona. Da parte mia non sono disposto a soffiare vento fresco nelle vele di questa versione postmoderna degli anni ’30. Se questo significa che siamo noi, i marxisti adeguatamente imprevedibili, che dobbiamo salvare il capitalismo europeo da sé stesso, e sia! Non per amore del capitalismo europeo, dell’eurozona, di Bruxelles o della BCE, ma solamente perché vogliamo ridurre al minimo i costi umani di questa crisi».
La politica finanziaria del governo di Syriza si è attenuta strettamente ai seguenti principi: evitare il deficit, rigida disciplina finanziaria, maggiori entrate fiscali. Tuttavia alcuni media tedeschi hanno recentemente caratterizzato Varoufakis come uno psicotico, che vive in un suo universo particolare - ma egli è veramente così radicale? Ciò che in Varoufakis snerva non è la sua radicalità, ma la sua semplicità ragionevole e pragmatica. Da una considerazione più accurata delle sue proposte deve inevitabilmente balzare agli occhi che esse consistono in misure che quaranta anni fa erano state una parte del programma politico standard dei socialdemocratici [SPD]; i governi svedesi degli anni ’60 perseguivano scopi di gran lunga più radicali. È un triste segno del nostro tempo che oggi si deve appartenere alla sinistra radicale per sostenere le stesse misure - un segno di tempi oscuri, ma anche una chance per la sinistra di occupare lo spazio che alcuni decenni fa era ancora quello della sinistra moderata.
Ma forse va a segno questo argomento infinitamente ripetuto di come in realtà la politica di Syriza sia moderata, almeno quanto quella della buona vecchia socialdemocrazia. Di fatto Syriza è pericoloso, il partito rappresenta precisamente una minaccia per l’attuale impianto dell’Unione Europea - il capitalismo globale non può permettersi un ritorno al vecchio Stato sociale. Il convenire sulla moderazione delle mete di Syriza è quindi anche un poco ipocrita: i suoi aderenti vogliono effettivamente qualcosa che non è possibile entro le coordinate del sistema globale vigente.
Qui si tratta di centrare una scelta seriamente strategica: che fare, quando è venuto il momento di lasciare cadere la maschera e di entrare in un cambiamento essenzialmente più radicale, un cambiamento che è necessario per conseguire risultati anche soltanto moderati? Forse il referendum greco è il primo passo in questa direzione.
Traduzione dall’inglese di Michael Adrian
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- “Debito”uguale “colpa” quella parola unica che separa i tedeschi dal mondo greco (di Silvia Ronchey))8 luglio 2015, di Federico La Sala
“Debito”uguale “colpa” quella parola unica che separa i tedeschi dal mondo greco
 Nella Germania dell’etica protestante i due concetti coincidono, mentre nella lingua di Omero sono lessicalmente distinti
Nella Germania dell’etica protestante i due concetti coincidono, mentre nella lingua di Omero sono lessicalmente distinti
 È l’emblema di uno scarto storico-culturale che arriva fino a oggi
È l’emblema di uno scarto storico-culturale che arriva fino a oggidi Silvia Ronchey (la Repubblica, 08.07.2015)
- WALTER BENJAMIN. Il filosofo scriveva già nel 1921 che “Il capitalismo è un culto che non consente espiazione”
 MAXWEBER. L’essere in credito è connesso alla tradizione calvinista che lo studioso vedeva all’origine di tutto il sistema
MAXWEBER. L’essere in credito è connesso alla tradizione calvinista che lo studioso vedeva all’origine di tutto il sistema
 PLATONE. “Chreos” per la società ellenica è “ciò che serve”, un’accezione che si trova già nell’allievo di Socrate
PLATONE. “Chreos” per la società ellenica è “ciò che serve”, un’accezione che si trova già nell’allievo di Socrate
 LUCA Introduce nel suo Vangelo la variante “Rimetti a noi i nostri peccati”, dando luogo a infinite dispute teologiche
LUCA Introduce nel suo Vangelo la variante “Rimetti a noi i nostri peccati”, dando luogo a infinite dispute teologiche
Che cos’è il debito? In tedesco il sostantivo femminile Schuld designa insieme il debito e la colpa. «Il capitalismo è un culto che non consente espiazione, ma produce colpa e debito», scriveva già nel 1921 Walter Benjamin. La vittoria del no al referendum greco ha richiamato l’attenzione del mondo non solo sulla drammaticità della situazione politica ma anche sul conflitto culturale, sull’antinomia profonda connessa alla concezione del debito nell’evolversi della psiche collettiva: ancora una volta, sull’antica polarità tra Grecia e Germania.
Debito e colpa è il titolo di un libro appena uscito (Ediesse, pagg. 240, euro 12) che Elettra Stimilli ha dedicato alla centralità della figura del debito come colpa nell’indebitamento planetario che segna la più recente fase del capitalismo contemporaneo. Le forme di consumo illimitato basate sull’indebitamento privato, partite dall’America, sono diventate, argomenta Stimilli, il motore principale dell’economia. Dal 2009, con l’immediato globalizzarsi della crisi americana, l’aumento esponenziale del debito privato ha coinvolto il debito pubblico dei paesi economicamente avanzati fino ad arrivare ai debiti sovrani. La finanziarizzazione della vita quotidiana, la “democratizzazione del credito”, ha prodotto uno stato di indebitamento generalizzato in cui ognuno, sia come lavoratore sia come consumatore, è diventato per definizione anzitutto debitore.
Nella cultura attuale dell’occidente, la parola debito è eminentemente connessa a quell’etica protestante, che già Max Weber vedeva all’origine ideale e psicologica, prima ancora che materiale e sociale, del sistema capitalista, alla cui indubbia efficienza i teorici, da Karl Marx a Joseph Schumpeter, hanno sempre contrapposto, con diversi gradi di perplessità, la difficoltà etica della giustificazione teorica. Se per Max Weber il capitale nella sua forma moderna nasceva dalla concezione calvinista della grazia e del peccato per poi secolarizzarsi in ideologia profana, secondo Benjamin il capitalismo può considerarsi in sé una religione, il culto di un dio minore, privo di dogmi ma dalla legge implacabile. È proprio la connessione religiosa fra debito economico e colpa morale - attinta peraltro a un’intuizione degli scritti giovanili di Marx - che porta il povero insolvente, scriveva Benjamin, «a fare di sé una moneta falsa, a carpire il credito con inganno, a mentire, così che il rapporto di credito diventi oggetto di abuso reciproco».
Se in tedesco i concetti di debito e colpa si stringono in uno stesso nodo lessicale, la lingua greca, che sta all’origine del nostro pensiero e della nostra sintassi filosofica, distingue nettamente tra l’uno e l’altra. Nel greco antico, come ancora oggi nel greco moderno, debito si dice chreos , un sostantivo che deriva dal verbo chraomai , “usare”, e dalla locuzione chre , “ciò che serve”, che si usa e di cui c’è bisogno; è inoltre connesso con chreia , la “mancanza”. Il termine chreos viene usato ampiamente dagli storici, come Tucidide, dai filosofi, come Platone, e dai giuristi, fino alle Novelle di Giustiniano e ai Basilika : il greco bizantino assicurerà la continuità e trasmetterà la certezza del diritto romano nel suo transito millenario dall’età antica a quella moderna, attraverso i secoli solo in occidente oscuri del cosiddetto medioevo dominato dal diritto barbarico.
Ma la prima attestazione della parola chreos nella letteratura greca è già nell’ottavo canto dell’ Odissea , nel passo in cui Efesto incatena Ares e Afrodite dopo averli colti in adulterio. Tutti gli dèi ridono tranne Poseidone, che gli intima di scioglierli. Efesto rifiuta perché, dice, se lo facesse Ares fuggirebbe eludendo insieme due vincoli, quello materiale della catena e quello morale, il chreos , che lo lega ormai a Efesto. Questo secondo legame non è una servitù, impossibile tra dèi, piuttosto una comunanza di destino, un pegno. Il dio della guerra si è indebitato con il dio del fuoco, dell’ingegneria, dei fabbri, di tutti gli artigiani: cedendo all’amore, condividendo il fascino della dea, si è sottomesso al vincolo di un reciproco scambio.
Anche altrove il significato del chreos greco sfuma spesso in quello di una comunanza ferrea di destino, di una ineludibile necessità: designa “il debito che tutti devono pagare”, ossia, almeno a partire da Teognide, anzitutto e per definizione la morte. Un’accezione metaforica di chreos che si ritrova lungo tutta la letteratura greca, da Platone alla Sapienza di Salomone tradotta nella bibbia dei Settanta. La distinzione tra debito e colpa è evidente nel Nuovo Testamento, anzitutto in uno dei suoi passaggi più noti: la preghiera del discorso della montagna, che diventerà il padre nostro. Qui il greco della koiné usa, anziché chreos , il più materiale e umile sostantivo ophèilema , che si ritrova in Matteo 6, 12: “rimetti a noi i nostri debiti”. La clamorosa discrepanza dal testo di Luca 11, 4, che ha invece la variante “rimetti a noi i nostri peccati” e usa il ben distinto sostantivo amartìa, ha dato luogo a infinite dispute teologiche e fatto sospettare una comune ascendenza dall’ebraico hôb, hôbot, insieme debito e colpa. Ma proprio il fatto che il dettato neotestamentario debba adottare due voci diverse sottolinea l’estraneità dei due concetti nella psiche greca.
Lo squilibrio politico generato da un lungo e inestinguibile debito ha un precedente storico nel mondo greco. A provocare la caduta dell’impero di Bisanzio sei secoli fa è stato il debito con la repubblica di Venezia, incarnazione di quel capitalismo nascente che la percezione teologica e filosofica bizantina, erede di quella classica, non sarebbe mai riuscita ad assimilare né a comprendere. L’indebitamento dello stato bizantino con i banchieri dell’occidente spinse le sue élite verso l’oriente. La civiltà bizantina entrò allora nella sfera geopolitica dell’islam ottomano, da cui solo nel XIX secolo la Grecia è emersa.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Germania: etica protestante o riscrittura della storia? (di Paolo Ferrero)10 luglio 2015, di Federico La Sala
Germania: etica protestante o riscrittura della storia?
 di Paolo Ferrero
di Paolo Ferrero
 Segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea *
Segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea *Tra le leggende metropolitane che circolano maggiormente attorno alla vicenda greca, vi è quella dell’etica protestante che caratterizzerebbe la Germania e che renderebbe incomprensibile ai loro occhi la mediterranea Grecia. Gli elementi della leggenda sono pochi e semplici: i tedeschi sono seri, laboriosi protestanti e nella lingua tedesca debito e colpa hanno la stessa etimologia. I greci hanno il sole caldo, una furbesca attitudine al commercio e sono eredi del buonismo neotestamentario. La morale della fiaba (favola!, fls) altrettanto chiara: i tedeschi hanno ragione, i greci torto e non si possono capire tra di loro.
Penso che questa rappresentazione sia completamente falsa, inventata. In realtà i tedeschi hanno poco o nulla a che vedere con la loro autorappresentazione. In realtà ci troviamo di fronte ad una vera e propria riscrittura della storia che le classi dominanti tedesche hanno fatto nel corso dell’ultimo secolo. Una riscrittura della storia che è diventata egemone a causa della sudditanza dei molti ma non per questo meno falsa.
In primo luogo la storia del debito. Nel corso del 1900 i tedeschi non hanno mai pagato i loro debiti. Non hanno pagato i debiti di guerra della prima guerra mondiale se non dopo trent’anni ed un enorme sconto. Grazie alla conferenza di Londra del 1953, non hanno pagato i debiti della seconda guerra mondiale se non in parte limitatissima e dilazionati anch’essi in trent’anni. Inoltre non hanno pagato alcun risarcimento agli stati invasi per i danni prodotti nella Seconda Guerra mondiale nonostante la Conferenza di Londra del ’53 avesse previsto il loro pagamento quando fosse avvenuta la riunificazione della Germania. Nel 1990 la Germania si è riunificata ma non ha voluto pagare nulla.
La Germania è lo stato europeo di gran lunga più insolvente e di gran lunga meno portato a mantenere la parola data e gli accordi sottoscritti, oltre ad essere lo stato europeo di gran lunga più devastante nei confronti dei suoi vicini.
L’invenzione della tradizione non riguarda però solo il debito, riguarda anche le origini del nazismo. Secondo la vulgata corrente il nazismo sarebbe il frutto dell’iperinflazione che colpì la repubblica di Weimar. I biglietti da un miliardo di marchi portate a carrettate per comprare un chilo di burro sarebbero all’origine del nazismo. Niente di più falso. L’Iper inflazione tedesca avvenne nel corso del 1923 e terminò nel 1924 con il piano statunitense (Dawes) che impose nel 1924 una nuova moneta. La grande inflazione terminò quindi nel 1924 e non ve ne fu più traccia negli anni successivi, che furono invece anni di significativa ripresa economica e produttiva. Nel 1923, cioè l’anno culmine della grande inflazione praticamente il Partito Nazista esisteva solo sulla carta e ad esempio nelle elezioni del dicembre 1924 non risulta pervenuto. Del resto nelle stesse elezioni del 1928, quattro anni dopo la fine della grande inflazione i nazisti elessero 12 deputati, un quinto di quanti ne eleggevano i comunisti e meno di un decimo di quanti ne eleggevano i socialisti. La grande inflazione non ha quindi prodotto nessun sviluppo del movimento nazista, anzi.
Il partito nazista inizia a crescere velocissimo nel 1930 (107) deputati che raddoppiano nel 1932 (230), fino a vincere le elezioni nel 1933. Che cosa era successo nel frattempo? Era successo che il governo Bruning fece fronte alla crisi del 1929 con una politica economica di austerità, identica a quella che la Merkel ha oggi imposto a tutta Europa e che produsse in brevissimo tempo una recessione gravissima e milioni di disoccupati. Il nazismo è il frutto diretto delle politiche di austerità e il nazismo ebbe buon gioco ad indicare l’origine della crisi nella speculazione e quindi nei banchieri indicati come i registi del complotto giudaico massonico. La super disoccupazione frutto delle politiche di austerità e non la iper inflazione (di 5 anni prima) sono stati all’origine del nazismo. Hitler è figlio diretto delle folli politiche di austerità del governo Bruning, le stesse che la Merkel applica all’Europa, non dell’inflazione. Anche questa gigantesca operazione di riscrittura della storia non è innocente ma tutta finalizzata alle politiche di destra oggi in auge.
Più che davanti all’etica protestante, ci troviamo quindi dinnanzi ad un depistaggio continuo. Più che con Max Weber - che per altro parlava del calvinismo e non del luteranesimo proprio della cultura tedesca - abbiamo a che fare con Orwell: "Chi controlla il passato controlla il futuro: chi controlla il presente controlla il passato". Non mancano del resto altri esempi: Lo stato maggiore dell’esercito tedesco, sconfitto militarmente nelle trincee della prima guerra mondiale, scaricò la responsabilità della sconfitta addosso ai partiti di sinistra e al movimento dei lavoratori, facendo una campagna - poi ripresa in grande stile dal nazismo - sulla "pugnalata nella schiena".
La storia tedesca nel corso del 1900 è stata completamente e sempre riscritta dalle sue classi dirigenti a proprio uso e consumo. La Merkel non è da meno, anzi. Il fatto di essere nata nell’ex DDR, fa sì che lei non prenda nemmeno in considerazione le responsabilità collettive della nazione tedesca per quanto riguarda il nazismo. Bisognerebbe quindi smetterla di raccontare le frottole che le classi dirigenti tedesche raccontano a proprio vantaggio come se fossero vere. Non facciamo un buon servizio al popolo greco, all’Europa e nemmeno al popolo tedesco, che andrebbe aiutato a liberarsi da queste classi dirigenti e dalle loro narrazioni rassicuranti quanto completamente false.
- WALTER BENJAMIN. Il filosofo scriveva già nel 1921 che “Il capitalismo è un culto che non consente espiazione”
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione -- Oxi, Ya basta! Un grido nel mondo (di Oscar Oliveria)7 luglio 2015, di Federico La Sala
LA "X" DEL "NO" ("OXI") DELLA GRECIA:
"X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI":
IL NUOVO PARADIGMA.
Oxi, Ya basta! Un grido nel mondo
di Oscar Olivera*
Con il referendum, il popolo greco, volendo essere solo una luce, una torcia nell’oscurità nella quale pretendono di sottometterci i padroni del denaro, delle decisioni e delle armi, sapendo che la costruzione di una società senza padroni è un lavoro collettivo di tutte e tutti, anziani e anziane, donne e uomini, giovani e “giovan@” (come direbbe il sup), ci ha mostrato, una volta in più, il cammino non solo della Resistenza alla morte, alla paura, alla fame, all’imposizione, ma ha anche indicato in modo chiaro - non solo ai popoli del mondo che in questi giorni sono stati vicini alle nostre sorelle e fratelli dell’amata Grecia -, ma anche al proprio governo, qual è il cammino che deve seguire.
Il forte Oxi che è stato sentito in tutto il pianeta è questo No!, è questa eco dello Ya basta! del 1 gennaio 1994 che si è sentito nel sud del Messico e che continua a rimbombare in Argentina con i piqueteros, in Brasile con il Movimento dei Sem Terra e con i giovani del pase libre, in Bolivia con gli amaras, quechuas e i guerrieri dell’acqua, in Uruguay con la sua classe media, in Cile con il movimento studentesco, in Perù con i guardiani dell’acqua, in Ecuador con la Comaia ed in ogni parte del mondo dove le popolazioni si sono nuovamente rialzate per prendere nelle proprie mani la costruzione del nostro presente e del nostro futuro, con dignità, con solidarietà, con trasparenza e in forma comunitaria.
Salutiamo quello che è successo domenica nell’amata Grecia ed [oggi] inizia la vera battaglia che non è solo per Resistere, bensì per Ri-esistere, come ha fatto questo Popolo.
Salute e Lotta. Jallalla! Popolo greco!
* militante dei movimenti sociali latinoamericani, a cominciare dal movimento dell’acqua di Cochabamba
 Traduzione di Daniela Cavallo per Comune-info
Traduzione di Daniela Cavallo per Comune-info -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Ripensare subito l’Europa (di Gianfranco Viesti)6 luglio 2015, di Federico La Sala
Ripensare subito l’Europa
di Gianfranco Viesti (Il Mulino, 06 luglio 2015)
Siamo in terre incognite. Gravide di rischi, anche estremi: come quello di tornare indietro di decenni sulla strada della costruzione europea. Ma anche di una nuova speranza, rafforzata dal risultato di ieri. Ho sostenuto con convinzione le ragioni del “no” al referendum greco, nell’ambito di una dialettica come sempre ricca e costruttiva all’interno del comitato di direzione di questa rivista. Per un principale motivo: perché l’Europa costruita negli ultimi anni non funziona (come ho provato ad argomentare più compiutamente qui). Non riesce a risanare i suoi squilibri, a investire sulla crescita, a evitare nuove, profonde, fratture fra i suoi cittadini. Perseverare con la cieca austerità degli ultimi anni avrebbe solo distrutto ancor più la Grecia.Ma il punto è questo: l’Europa è sul baratro, indipendentemente dalle vicende elleniche. Ed è una gran fortuna che lo shock sia arrivato da un Paese con cittadini e governo che desiderano fortemente restare nell’Europa e nell’euro e non dai tanti, crescenti, movimenti nazionalisti e antieuropei. Siamo a un punto di svolta a cui saremmo comunque, prima o poi, arrivati.
Ora si aprono giornate decisive, su tanti di quei fronti che è persino impossibile ricordarli. Ma con una stella polare chiara: trovare un nuovo accordo che contemperi le posizioni della Grecia e dei partner europei, prevedendo sia la permanenza ellenica nell’euro, sia l’avvio di un lungo, complesso, processo di risanamento e di rilancio della sua economia. L’avvio di un grande ripensamento sull’Europa degli ultimi anni.
Per questo, è bene fermarsi a riflettere sugli eventi dell’ultima settimana, su cui si scriverà un’intera biblioteca. Si è tanto parlato di rischio default della Grecia: ma sono apparsi sulla scena altri, importanti, pericolosi, rischi di default. Che restano, comunque vadano le cose, almeno quattro:
1) Quello della libera informazione. Negli ultimi giorni, quantomeno in Italia, abbiamo assistito su molti grandi mezzi d’informazione di massa a un processo molto pericoloso: la trasformazione di molti cronisti in agit-prop. Non è un problema di opinioni e commenti, ovviamente liberi. Ma di distorsione dell’informazione, di trasformazione del ruolo di cronista in quello di propagandista. Gli esempi sono innumerevoli: basterà citare, da ultima, la notizia apparsa ieri (che probabilmente aveva come fonte l’oracolo di Delfi, in mancanza di qualsiasi dato ufficiale): il Pil greco sarebbe sceso dell’1,5% nell’ultima settimana, per colpa di Tsipras.
2) Quello del ruolo dell’Italia in Europa. Negli ultimi giorni l’Italia - grande Paese fondatore dell’Unione - semplicemente non c’era. Si è accodata supinamente alle posizioni tedesche rinunciando a priori a svolgere quel ruolo di mediazione, che sarebbe stato, oltre che nella sua tradizione, nel suo interesse. L’affermazione del nostro Primo ministro secondo cui si trattava di “un derby fra l’euro e la dracma” è stata particolarmente sconsiderata; è sembrato l’azzardo di un leader che, piuttosto che cercare un ruolo per il suo Paese, cerca benemerenze fra i veri potenti.
3) Quella del socialismo europeo. La settimana passata ha drammaticamente messo in luce l’inconsistenza politica del gruppo di partiti del Pse, ridotti a un ruolo di ruota di scorta dei partiti popolari e conservatori, incapaci di una minima elaborazione propria. Anzi, più realisti del re: il presidente dell’Europarlamento Schulz (chi in Italia ha votato per il Pd lo aveva indicato come presidente della Commissione) ha auspicato, dopo la vittoria del “sì”, la formazione di un governo “tecnocratico” in Grecia con cui trattare. Una via bancaria al socialismo?
4) Infine, quella dei vertici istituzionali europei. Le parole di ieri di Romano Prodi (“l’Ue è decisa a sbarazzarsi di Tsipras entrando a piedi pari nella campagna elettorale”) fotografano una situazione in cui i vertici europei hanno provato a condizionare pesantemente il processo elettorale in uno stato membro sovrano, con parole o omissioni. Allenato da anni come Primo ministro di uno stato che ha fatto del dumping fiscale (a nostro danno) la sua fortuna, Jean-Claude Juncker (lì grazie ai voti di quanti in Italia hanno sostenuto il centrodestra) ha provato a fare dumping elettorale. Questa volta con minor successo.
I fili da riannodare nei prossimi giorni, i grandi temi su cui discutere, sono tanti e fondamentali: non riguardano solo Atene.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- Il primo voto e la «barbarie» dei Ciclopi senza democrazia (di Eva Cantarella)6 luglio 2015, di Federico La Sala
LA "x" DELLA GRECIA - "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
Il primo voto e la «barbarie» dei Ciclopi senza democraziadi Eva Cantarella (Corriere della Sera, 06.07.2015)
Pensando alla partecipazione dei greci al referendum viene da pensare che a muoverli sia stata, accanto alla gravità del momento, anche l’eredità di una idea che risale a un’epoca precedente di molti secoli alla nascita delle istituzioni democratiche. Quando Omero nell’Odissea vuole descrivere la barbarie di Polifemo non parla del suo cannibalismo. Parla di qualcosa di peggio: il fatto che i Ciclopi «non hanno assemblee di consiglio, non leggi/fa legge ciascuno/ai figli e alle mogli e l’uno dell’altro non cura» (Od., 9, 112-115).
Il segno dell’inciviltà sta nella mancanza di quel momento di incontro che, pur non avendo ancora poteri istituzionalmente previsti, è il momento più importante della vita pubblica. Quel momento che, dice Omero, è «la gloria degli uomini» (Il., 1, 490). E di lì a qualche secolo Alceo, esiliato dalla patria, scriverà che la sua vita lontano dalle istituzioni civiche è quella di «un solitario lupo».
Come non avere la sensazione che i greci in fila, mentre uno per uno deponevano il loro voto fossero la raffigurazione dei valori che, con la nascita della democrazia, essi ci hanno tramandato? L’isegoria, vale a dire (un voto uguale per tutti) e la parrhesia (totale libertà di parola).
All’epoca di Pericle infatti, con l’affermazione della democrazia radicale, all’assemblea (ekklesia) avevano diritto di partecipare tutti i cittadini maschi che avevano compito i 20 anni, vale a dire raggiunto la maggiore età e compiuto due anni di servizio militare. E poi, su un ordine del giorno comunicato in precedenza, si votavano, sulla collina della Pnice, le proposte fatte dalla Boule, un Consiglio di 400 persone estratte a sorte, di età superiore ai 30 anni: a maggioranza assoluta, di regola per alzata di mano (cheirotonia) e dunque e scrutinio palese. Nei casi, invece, in cui il voto doveva essere segreto si votava introducendo nelle apposite urne una pietruzza (psephos).
Infine una considerazione sulle competenze dell’assemblea, che non si limitavano all’approvazione delle leggi, ma riguardavano la politica interna ed estera, la pace e la guerra, i trattati internazionali e le questioni finanziarie. In altre parole, tutti gli affari di Stato. La divisione dei poteri, ovviamente, era di là da venire, così come , ovviamente, il suffragio universale (donne e schiavi ne erano esclusi). Ma le basi perché ci si potesse arrivare erano state messe.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI: "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI"5 luglio 2015
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI.
"X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI":
IL NUOVO PARADIGMA..
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---La Grecia delle Termopili. Nel popolo greco un capitale simbolico (di Adriano Prosperi)4 luglio 2015
Nel popolo greco un capitale simbolico
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 04.07.2015)
DICEVA Machiavelli che “assaltare una città disunita, per occuparla mediante la sua disunione, è partito contrario”, cioè può produrre il risultato opposto: quello di unire e rendere compatto il popolo diviso. Forse il referendum greco potrebbe dimostrare la verità di questa osservazione. Vedremo, tra pochi giorni e ore. Ma la domanda avrebbero potuto e forse dovuto porsela gli statisti tedeschi e i loro ossequenti alleati europei e magari velare meglio l’aggressione nei confronti del regime greco.
Mai come in questo caso la regola della non ingerenza negli affari interni degli stati membri è stata così trasgredita. Tutti i capi di governo si sono schierati in maniera massiccia per il sì e contro Tsipras fin dal primo giorno. I media si sono uniformati. Assistiamo a episodi perfino grotteschi, come quello dell’inviato Rai che intervista cinque greci e vedi caso, scopre che tutt’e cinque sono decisi a votare sì. La disinformazione si unisce alle tante falsificazioni dei fatti: ad esempio, non è vero che la scelta sarà fra la dracma e l’euro, come ha sveltamente sintetizzato il premier Renzi.
Ma il nostro dovere, di tutti noi cittadini degli stati dell’unione europea, non è chiederci che cosa faranno gli elettori greci: la domanda è che cosa faranno le autorità che ci governano - la Germania di frau Merkel, il Fondo monetario internazionale - se e quando saranno riuscite a raggiungere il loro intento, cioè a delegittimare Syriza e il premier Tsipras. Perché una cosa è evidente: la natura politica e non economica o finanziaria dello scontro. Fin dall’inizio il governo espresso dalle elezioni greche ha dovuto fare i conti con un’ostilità fortissima. La stampa tedesca è stata perfino capace di superare il limite degli insulti personali nel descrivere l’abbigliamento del ministro Varoufakis.
Dobbiamo all’attenzione non imparziale del Wall Street Journal se dalle zone nascoste della battaglia è emerso il documento delle proposte greche e delle correzioni con pennarello rosso di Bruxelles: un documento impressionante, una nuova versione della favola del lupo e dell’agnello. Non imparziale l’editore, certo: tutti sanno quanto siano grandi i problemi che gli conquassi europei e la crescita della superpotenza tedesca stanno creando alle esigenze strategiche e finanziarie di quella americana. Ma intanto quelle che ci toccano sono le conseguenze di una eventuale umiliazione referendaria per il governo greco: se ci sarà, non per questo i vincitori avranno risolto il problema fondamentale, quello di una costruzione sbagliata in grave e generale crisi.
L’errore grave, tremendo, come dovrebbe riconoscere oggi qualche responsabile che invece ancora cinguetta sui giornali, è stato quello di una unione monetaria a cui non ha corrisposto un’unione politica. L’Europa non è uno stato federale. Come ricordava l’altro ieri Paul Krugman spiegando perché è stato un errore tremendo, in un vero stato federale come gli Stati Uniti quando in Florida scoppia una bolla immobiliare è Washington che protegge automaticamente gli anziani contro ogni rischio per le loro cure mediche e i loro depositi bancari.
In questa Europa anziani e malati e tutte le altre categorie dell’umanità debole sono vittime di misure di austerità imposte da una burocrazia politico-finanziaria tecnicamente irresponsabile all’insegna di un liberismo di facciata, con l’ossessione del fantasma dei diritti umani e politici, quelli dei lavoratori e dei migranti in primo luogo. E oggi le misure che si vorrebbero imporre alla Grecia garantiscono che il crollo diverrà spaventoso e che non sarà solo la popolazione greca a pagarne il conto. Una vittoria di Pirro, se ci sarà: non solo perché i costi finanziari sono stati altissimi, di centinaia di volte superiori agli spiccioli necessari alla Grecia per andare avanti pagando il suo debito in scadenza.
Ma perché vincere una battaglia aggraverà il problema di come convincere, lascerà aperta e più incerta la guerra per la costruzione di una vera Europa. Resterà il fatto dell’aver umiliato e spezzato il morale di un popolo che porta nel suo nome l’immenso capitale simbolico di avere inventato la democrazia e l’Europa.
Diceva il grande storico del mondo antico, Arnaldo Momigliano, che se non fosse stato per la Grecia delle Termopili, per Maratona e Salamina (vi combatté un soldato che si chiamava Socrate), non ci sarebbe stata nessuna Europa: saremmo tutti sudditi di qualche deposta asiatico.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- L’Ue ha cancellato le sue radici spirituali. Ma se cade la Grecia, crolla l’intero edificio europeo.4 luglio 2015, di Federico La Sala
L’Ue ha cancellato le sue radici spirituali. Ma se cade la Grecia, crolla l’intero edificio europeo
di Mauro Maldonato
 Professore universitario e autore di "Quando decidiamo" *
Professore universitario e autore di "Quando decidiamo" *Comunque vada a finire, il dramma greco è solo un sintomo di un male profondo che attanaglia l’Europa. Il rischio di bancarotta non riguarda solo la nazione greca, ma l’intero edificio europeo: una mastodontica struttura, ininfluente sugli equilibri geopolitici planetari, nel contrasto al terrore, preoccupata solo di immunizzarsi contro epocali flussi migratori e di coltivare i propri ottusi egoismi.
Un panottico più che una casa comune. Ed è davvero di stupefacente interesse l’inadeguatezza delle nostre classi dirigenti di fronte agli sconvolgimenti che avvengono minuto per minuto, all’enorme movimento di faglia della nostra civiltà. Una fitta nebbia e una tremenda incertezza. Come se lo sfinimento febbrile delle ’leggi’ della storia avesse spinto tutti verso una sorta di catatonia intellettuale.
A pensarci bene, non è nemmeno sorprendente. All’indomani del crollo del vecchio ordine bipolare, intere generazioni di intellettuali e politici occidentali sono apparse confuse, incapaci di formulare una prognosi credibile sull’avvenire della politica europea. Da un lato è prevalsa una formidabile strategia di rimozione; dall’altro, è emersa una fervente quanto acritica adesione all’unico modello rimasto in piedi: quello liberaldemocratico. Neppure l’ombra di un’analisi della catastrofe.
Non un tentativo di comprendere le ragioni, di ripensare valori, regole e istituzioni. La liberaldemocrazia si è affermata, così, come l’unico paradigma sopravvissuto ai totalitarismi di destra e di sinistra. Come terza utopia novecentesca, non solo ha preso il posto delle ideologie precedenti, ma si è estesa con ansia omologatrice oltre i tradizionali confini d’Europa, senza considerare specificità geografiche, tradizioni storiche, culture e identità nazionali.
Per tale obiettivo il progetto liberaldemocratico si è dotato di un’intelaiatura istituzionale e di sistemi raffinati e apparentemente neutrali.
L’irrazionalità dell’eurozona e il dilemma euro-moneta nazionale sono solo aspetti di superficie di un problema più profondo. Quello, cioè, di una costruzione nata da una innaturale uniformazione, non da una unificazione spontanea e volontaria. Del resto, a cosa poteva portare l’europeismo ideologico con i suoi feticci della coesione, dell’armonizzazione e della sussidiarietà forzata?
Non era difficile immaginare che le conseguenze sarebbero state, da un lato, una valanga di direttive burocratiche su ogni minuzia; e, dall’altro, un vuoto tremendo, proprio là dove c’è bisogno di decisioni cruciali: esteri, difesa, migrazioni. Davanti a noi vi sono domande inaggirabili. Innanzitutto, che legittimità hanno le istituzioni europee? Cosa vuol dire, oggi, "sovranità popolare"? Essere sovrani di se stessi? E chi è sovrano, e su chi?
Eppure, gli effetti più preoccupanti di tutto questo non sono solo l’infiacchimento della vitalità della civiltà europea, della sua dinamica pluralità, della fiducia e della speranza in una comunità di destino. Non è nemmeno aver generato una patetica cultura della resa e del piagnisteo. L’aspetto più inquietante è l’aver messo ai margini la potenza delle sue radici spirituali (greche, bibliche, rinascimentali, illuministe) e, infine, aver provocato odio di sé. Hanno origine qui le ombre sinistre che si allungano sul futuro dell’Europa.
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Il mito di Europa, o del nostro eterno amore per l’Ellade. Come Aristotele, si usi «intelligenza e molto cuore»4 luglio 2015
Il mito di Europa, o del nostro eterno amore per l’Ellade
di Eva Cantarella (Corriere della Sera, 04.07.2015)
Poco importa quali siano state le ragioni, quali e da quale parte stiano i torti che hanno portato a discutere di Grexit, bruttissima parola per una possibile, si spera ancora evitabile tragedia. In ogni caso l’ uscita della Grecia dall’Unione Europea non sarebbe solo una sconfitta, sarebbe la fine di una storia d’amore: quella tra il nostro continente e la Grecia.
Una lunga storia iniziata quando, in un giorno senza tempo, come sempre nel tempo del mito, una ragazza di nome Europa si innamorò di un dio. Il solito Zeus che vedendo Europa, figlia del re fenicio Agenore, mentre giocava sulla spiaggia con le amiche, se ne innamorò. E per soddisfare il suo desiderio ricorse a una delle tante metamorfosi di cui usava servirsi. Nella specie, assunse l’aspetto di un toro bianco che andò a stendersi ai piedi di Europa. Affascinata, questa sedette sulla sua groppa, e a questo punto il toro si gettò in acqua, nuotando fino all’isola di Creta.
Ma attenzione: la storia di Zeus e di Europa non è una delle tante violenze sessuali di cui la mitologia greca abbonda: i greci la vedevano come una storia d’amore.
A dimostrarlo un vaso di straordinario valore simbolico firmato da Assteas (attivo a Paestum nel IV secolo a.C.) sul quale Europa, nel suo viaggio verso Creta, è circondata da una simbologia amorosa: un piccolo Eros, la dea dell’amore Afrodite, l’immagine di Pothos, il desiderio amoroso ricambiato... Il mito della ragazza Europa racconta, insomma, la storia d’amore tra il continente che da lei prese il nome e la Grecia.
Una storia d’amore così forte che per lungo tempo ha portato a mitizzare le nostre origini. Basterà ricordare quello che scriveva Shelley nella Prefazione a Hellas: «Siamo tutti greci. Le nostre leggi, la nostra letteratura, la nostra religione, le nostre arti hanno le loro radici in Grecia. Se non fosse stato per la Grecia saremmo ancora selvaggi o idolatri».
Era il 1821, si parlava del «miracolo greco»: la civiltà occidentale, si diceva, era nata lì. Oggi, e da tempo, sappiamo che alle spalle del cosiddetto miracolo stavano secoli e secoli di scambi anche culturali con l’Oriente che hanno influenzato la cultura greca e quindi la nostra. Ma questo non toglie che dimenticare i nostri debiti verso la Grecia vorrebbe dire cancellare un passato senza il quale non saremmo quello che siamo. Vorrebbe dire perdere la nostra identità. Oltre che sulle questioni economiche e le conseguenze politiche della Grexit dovremo riflettere anche su questo.
Come Aristotele, si usi «intelligenza e molto cuore»
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, 04.07.2015)
Sono gli ultimi giorni dell’Europa? Quale che sia lo sviluppo degli eventi, essere giunti sull’orlo dell’abisso è un trauma che non sarà privo di conseguenze. Forse cinque anni fa, quando sono cominciati i problemi della Grecia, la situazione economica era peggiore. Ma non c’era l’Isis, né il caos in Libia, né lo scontro fra Ucraina e Russia, e l’ondata migratoria non aveva le proporzioni attuali. Nel complesso scenario politico di oggi non si vede perché l’Europa dovrebbe privarsi della Grecia.Si dirà: «Non hanno pagato i debiti», «non hanno introdotto le riforme». Ma i debiti della Grecia sono numeri stratosferici. Chi può pensare che verranno ripagati? Non avrebbe dovuto essere allestito un piano europeo comune per far fronte all’indebitamento greco? Nel passato la Grecia ha fatto «carte false» per entrare in Europa; ma non si capisce perché chi è nato in questi ultimi anni dovrebbe pagare per tutta la vita.
Nella sua Politica Aristotele scrive: «I popoli che abitano nelle regioni fredde dell’Europa sono pieni di coraggio, ma difettano di intelligenza e di abilità nelle arti della politica». E aggiunge che chi voglia essere un bravo legislatore deve avere «intelligenza e cuore». Questa Europa non ha né l’una né l’altro. E segue singolari criteri di democrazia, se può fare a meno di un Paese come la Grecia, e accettare invece l’Ungheria di Orbán, il cui regime ha ben poco di democratico.
Il grande problema dell’Europa sembra la Germania, desiderosa di assumere un ruolo-guida, e incapace di svolgerlo. Titubante, quanto rigida - soprattutto non all’altezza di quella «fiducia» nello «spirito europeo» a cui richiamava Hegel. «Debito» e «colpa» sono in tedesco una stessa parola: Schuld . Ma il debito non è una colpa. La Germania, con il suo ostinato moralismo, rischia di passare alla Storia come responsabile del naufragio europeo.
Ci dicono che Grexit non avrà per noi ripercussioni economiche. Se la Grecia, però, dovesse uscire dalla zona euro, quel mito tutto greco dell’Europa, si dileguerebbe per sempre in un’Europa mitica, sognata e non realizzata. Questo è il vero dramma. E per noi cambierà tutto.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Il referendum greco, Leonida, e le Termopili (di Gaetano Mirabella).3 luglio 2015, di Federico La Sala
IL REFERENDUM GRECO E LE TERMOPILI
Penso che il giorno del referendum greco sia una specie di "porta calda" che accomuna questa emergenza a quella che vide i Greci di Leonida contrapporsi alle soverchianti forze d’invasione dell’impero persiano di Serse nel 480 a. C. che alle Termopili (termopili = porte calde) bloccarono e ritardarono l’avanzata dell’esercito persiano. Allo stesso modo, oggi, ancora una volta il destino storico conferisce ai Greci il drammatico e difficile compito di contrapporsi all’avanzata della diabolica dittatura economico-finanziaria del cosiddetto "nuovo ordine mondiale" che sta tentando di distruggere la democrazia e libertà dei popoli e delle nazioni attraverso una capillare e demoniaca operazione ideologico-finanziaria con cui ha riversato sulle spalle dei popoli e delle nazioni, attraverso il trucco del "debito pubblico", la responsabilità del loro fallimento. Che Dio aiuti i Greci a gridare forte il NO che salverà il pianeta dalla minaccia silenziosa e strisciante della dittatura finanziaria che, attraverso la troika = fondo monetario internazionale, banca centrale europea, unione europea sta mettendo in atto il progetto criminale del dominio finanziario del pianeta.
Gaetano Mirabella
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- L’ultima pietra del Partenone (di Caterina Amicucci)3 luglio 2015, di Federico La Sala
L’ultima pietra del Partenone
di Caterina Amicucci *
In questi giorni, fra tutto quello che viene scritto e condiviso in rete sulla Grecia, é circolato molto il documento delle proposte greche con le correzioni in rosso della Troika. Da questo testo si é dedotto che i punti di maggiore disaccordo fra le parti siano l’aumento dell’Iva e la questione delle pensioni, che di fatto per molte famiglie rappesantano oggi l’unica fonte di ingresso. A questo documento stranamente mancano delle pagine, ovvero la parte finale riguardante il programma di privatizzazioni imposto dalla Banca centrale, il Fondo monetario internazionale e la Commissione europea come condizione del piano di salvataggio nel 2012.
Una lettura del documento finale completo, circolato molto meno dell’altro, aiuta a capire perchè “la proposta” della Troika è inaccettabile.
Prima di tutto occorre dare uno sguardo a questo agghiacciante sito-web. Si tratta della pagina ufficiale del Taiped o Fondo per lo Sviluppo degli Asset della Repubblica Ellenica (Hrdaf). In questo fondo durante il precedente governo, è stato trasferito l’intero patrimonio pubblico della Grecia: porti, aeroporti, ferrovie, imprese statali, proprietà immobiliari, perfino isole e spiagge. Obiettivo: dare un prezzo a ogni cosa e vendere tutto a investitori privati.
Ovvero disfarsi dell’intero patrimonio pubblico del paese, fino all’ultima pietra del Partenone se necessario, per ripagare il debito. L’elenco delle vendite effettuate é visionabile sullo stesso sito: vi troviamo la lotteria di stato, acquisita per altro da un consorzio al quale partecipa anche la Lottomatica, la società del calcio scommesse , numerose proprietà immobiliari.
Le privatizzazioni dei settori strategici erano previste per il 2015 nonostante già lo scorso anno il tentativo di vendere la società che gestisce il servizio idrico di Salonicco era stata fermata da un referendum cittadino e dal parere contrario della Corte costituzionale. Dopo le elezioni di gennaio, intenzione dichiarata del governo Tsipras era fermare il programma di svendita e privatizzazioni.
Per questo al punto 10 della “proposta” della troika si legge : “Il Consiglio direttivo del Hrdaf dovrá approvare il suo piano di sviluppo degli asset privatizzando tutto ciò che era giá incluso nel fondo prima del 31 dicembre del 2014. Ed il governo deve approvare il piano”.
A dicembre del 2014 Tsipras non era ancora stato eletto. Sostanzialmente si tratta di una vera e propria esautorazione del governo dalla gestione della cosa pubblica che equivale di fatto ad un commissariamento. Lo stesso capitolo prosegue intimando di prendere “misure irreversibili” per concludere le privatizzazioni giá in corso dei porti del Pireo e di Salonicco, delle ferrovie e degli aeroporti regionali.
Nessun governo che voglia conservare un minimo di sovranità nazionale potrebbe accettare una cosa del genere. Ed il dramma greco è esattamento questo, subire il primo esperimento applicato e perseguito con tenacia da anni, di una nuova forma di stato nazione senza alcuna sovranità. È l’approdo finale di un processo che il neoliberismo costruisce con pazienza da tre decadi.
* Fonte: Comune-info, 30 giugno 2015
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- “La Grecia esisterà anche dopo la Ue. Vogliono far cadere Syriza, è ingerenza” (Luciano Canfora).2 luglio 2015, di Federico La Sala
Luciano Canfora
“La Grecia esisterà anche dopo la Ue. Vogliono far cadere Syriza, è ingerenza”
da il Fatto, 02.07.2015
PARLARE della perdita di un pilastro della cultura europea, qualora la Grecia dovesse lasciare l’Ue a seguito del referendum che si svolgerà domenica, non è corretto perché "la Grecia preesiste all’Europa ed esisterà anche dopo". A pensarla così è il filologo e professore emerito dell’Università di Bari, Luciano Canfora. Conversando con l’AdnKronos, lo studioso sostiene, infatti, che "la Grecia, per moltissimo tempo, è stata posta ai margini della storia d’Europa. Mi riferisco dice ai secoli precedenti, cioè fino al pieno Ottocento e poi in tempi a noi più vicini, durante la Seconda guerra mondiale".
L’Italia, ricorda il filologo, "ha aggredito la Grecia e, in seguito, la Cia ha alimentato il Golpe dei colonnelli. La Grecia è sempre stata trattata per metà come terzo mondo e per metà come nostro subalterno. Il problema che viene posto dalla crisi monetaria è di altro tipo: alla Ue, che non è uno Stato federale ma è una moneta, conviene perdere questo pezzo? Gli effetti a catena sarebbero preoccupanti”.
Per la situazione politica attuale, Canfora spiega "che la partita è apertissima e il disegno concreto è quello di far cadere Tsipras, siamo di fronte a un caso dice ironicamente di rispetto assoluto dell’indipendenza dei singoli paesi. Se invece Tsipras dovesse vincere, si dovrebbe costringere Christine Lagarde (presidente del Fmi, ndr) a mollare qualche soldo in più per tenere agganciata la Grecia all’Europa. Sarebbe un caso di finto altruismo e di vero egoismo", conclude.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Anche l’Europa deve cambiare la sua politica. Pensare al da farsi così che il fallimento non si trasformi in un disastro (di Bill Emmot)2 luglio 2015, di Federico La Sala
Anche l’Europa deve cambiare la sua politica
di Bill Emmott (La Stampa, 02.07.2015)
Dove va l’Europa a questo punto, dopo il referendum greco del 5 luglio e il suo fallimento nel rimborsare il Fmi? La risposta è che non ha davanti a sé nulla di buono, dal momento che qualunque cosa accada questo è stato un grande fallimento per l’Unione europea, nonché un enorme fallimento per la Grecia e per il governo che aveva eletto solo a gennaio. Ma bisogna cominciare adesso a pensare al da farsi così che il fallimento non si trasformi in un disastro.
Molto dipende ancora dal modo in cui andrà il voto e quali passi saranno intrapresi dal governo greco subito dopo il suo esito. Se gli elettori greci a sorpresa voteranno «Sì» per accettare i termini offerti dai creditori del Paese e rimanere nell’euro, il prossimo passo dovrà consistere nelle dimissioni del governo di Syriza guidato da Alexis Tsipras e in nuove elezioni politiche.
Questo passo, tuttavia, comporta un rischio reale che il Paese finisca in balia della violenza politica. Quindi dall’estero sarebbe saggio intervenire con un generoso supporto finanziario a breve termine come gesto di buona volontà, per motivi umanitari.
Sembra più probabile, tuttavia, che il voto sarà «No», dato che lo stesso governo sta facendo propaganda per questo risultato.
Se è così, sulla base del suo comportamento degli ultimi tempi, dopo il voto, probabilmente il governo Tsipras tenterà inizialmente di riprendere i negoziati con i suoi creditori, pur avendo dichiarato il default sul debito. Cercherebbe, in altre parole, di interpretare il voto come una chiamata a rinegoziare restando nell’euro.
A quel punto, però, gli eventi si susseguiranno in fretta e i decisori politici avranno bisogno di muoversi altrettanto velocemente. Con controlli sui capitali in atto e un accesso limitato ai conti bancari, l’economia potrebbe ben presto entrare in stallo e nei risparmiatori crescerebbe sempre di più la preoccupazione per la distruzione della loro residua ricchezza. In tali circostanze, la Grecia avrebbe bisogno di muoversi in fretta per introdurre rapidamente o una nuova moneta o una valuta parallela da utilizzare accanto all’euro, e dovrebbe nazionalizzare le banche greche.
Tuttavia, per fare questo, continuando a pagare gli stipendi e le pensioni dei lavoratori del settore pubblico, avrebbe bisogno di finanziamenti di emergenza. Il modo migliore sarebbe che l’Unione europea e gli Stati Uniti di comune accordo riunissero un consorzio internazionale di governi per fornire fondi - preferibilmente un consorzio che comprenda la Cina e la Russia. In caso contrario, la Grecia diventerà una merce di scambio tra le superpotenze. Tutto ciò che può essere fatto per evitare un simile risultato dovrebbe essere messo in atto.
Il miglior approccio da parte dell’Unione europea, e in particolare dell’eurozona, sarebbe collocare tali aiuti in un quadro che riconosca l’uscita della Grecia dall’euro mantenendolo in Europa, e offra un eventuale percorso per un ritorno all’euro. Peraltro improbabile. Ma sarebbe significativo in termini politici. E dopotutto darebbe semplicemente alla Grecia lo stesso status di tutti gli altri membri dell’Ue che non sono nell’euro, a eccezione di quelli (come il Regno Unito), che hanno esplicitamente escluso la loro futura adesione.
Chiaramente, la priorità immediata dopo un «No» il 5 luglio sarà la stabilizzazione della Grecia. Ma la priorità a lungo termine deve essere la stabilizzazione dell’euro stesso. Perché il fallimento sulla Grecia è un fallimento che promette di influire sull’euro in due modi, principalmente.
In primo luogo l’uscita della Grecia conferma ciò che i mercati finanziari hanno sempre sospettato: che l’adesione alla moneta unica non è irrevocabile.
In effetti, se la Grecia supera l’emergenza economica e trova un percorso di recupero usando il default del debito e la svalutazione, come ha fatto l’Islanda dopo il suo doloroso periodo 2008-09, in ogni futura crisi economica inizierà la speculazione (e il dibattito politico sarà permanente) sull’opportunità per un altro Paese di seguire con successo la stessa strada.
Poiché tutta l’Europa dovrebbe sperare che la Grecia trovi un nuovo percorso verso la prosperità, l’eurozona dovrebbe pensare sul serio a come affrontare non solo il fallimento, ma anche questa forma di successo.
Il secondo modo in cui l’esperienza greca si ripercuoterà negativamente sull’euro sta nel fallimento della politica economica pan-europea che sottintende. Finora questo fallimento è stato negato, da troppe persone, soprattutto nei Paesi creditori. Ma la dura realtà e che a sette anni dall’inizio della crisi finanziaria, l’Unione europea ha ancora più di 23 milioni di disoccupati mentre gli Stati Uniti (la cui popolazione è circa due terzi di quella dell’Ue) ne hanno solo 7 milioni. L’insistenza sull’austerità fiscale universale, anche nei Paesi creditori solventi, è la ragione di questo fallimento.
La ripresa dell’economia europea si sta rivelando troppo lenta per affrontare la disoccupazione e la perdita di speranza che opprime la generazione più giovane di tutta l’eurozona. Lo shock greco ora la renderà ancora più lenta. E fino a che sarà così la reazione politica contro le politiche attuali, in Francia, Spagna, Italia e molti altri Paesi, potrà solo rafforzarsi. Dopo Tsipras nel 2015, dobbiamo pensare a Marine Le Pen nel 2017.
Per questo motivo, la migliore risposta allo shock greco sarebbe quella di cambiare politica, anche senza esplicitamente ammettere che questo è ciò che si sta facendo. Le norme fiscali non possono essere cambiate adesso, dato che sono state introdotte per la Grecia. Quindi è necessario un nuovo pacchetto di politiche, che disponga attorno a quelle norme un approccio positivo per una ripresa economica più rapida e rafforzi la solidarietà e la coesione della zona euro. Tale pacchetto può prendere due linee politiche esistenti e semplicemente ampliarle e renderle più ambiziose: la liberalizzazione del mercato unico, per i servizi e l’economia digitale; e un programma di investimenti pubblici per la ricostruzione delle infrastrutture e soprattutto per una rete a livello europeo per l’elettricità e il gas. Se si potesse concordare un programma del genere, con finanziamenti organizzati collettivamente al di fuori delle normali norme fiscali, anche la Grecia potrebbe esservi inclusa.
In aggiunta, tuttavia e legato a queste due politiche, l’eurozona dovrebbe dare il via a un programma graduale per sostituire parte dei debiti sovrani dei Paesi membri con Eurobond supportati collettivamente. Questa proposta è stata contrastata per molti anni dalla Germania. Dev’essere subordinata alle riforme strutturali e legata a severe regole di bilancio. Ma è l’unico modo per rendere la moneta unica una vera unione monetaria. Tutti per uno e uno per tutti: questa è l’unica parola d’ordine per l’euro che possa funzionare nel lungo periodo.
 traduzione di Carla Reschia
traduzione di Carla Reschia -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- LE DUE IDEE DI "DEMOS". Così l’antica Grecia creò il paradosso della “democratìa” (di Silvia Ronchey).2 luglio 2015, di Federico La Sala
Le due idee di “demos”
Tutto per il popolo così l’antica Grecia creò il paradosso della “democratìa”
Nella dialettica tra demos e kratos, tra cittadini e potere, il mondo ellenico ha sempre privilegiato un esercizio diretto, assai poco moderato, della sovranità
Una visione da cui deriva il referendum di domenica
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 02.07.2015)
- Nella Repubblica di Platone e in altre fonti quel concetto chiave non ha un senso positivo
 Byron ha combattuto ed è morto per la libertà del Paese simbolo delle nostre radici
Byron ha combattuto ed è morto per la libertà del Paese simbolo delle nostre radici
 Renan. Nella sua Preghiera sull’Acropoli si rivolge ad Atene “Dobbiamo tornare da te”
Renan. Nella sua Preghiera sull’Acropoli si rivolge ad Atene “Dobbiamo tornare da te”
Il popolo: una parola cruciale per il mondo greco, dove il termine democrazia si è creato a partire da due vocaboli: demos, “popolo” appunto, e kratos, che normalmente traduciamo “potere”. Ma il greco kratos ha una sfumatura precisa che ha poco a che fare con quell’idea di potere legittimo e moderato che normalmente associamo alla forma di governo chiamata dai moderni democrazia - la peggiore, secondo Churchill, ad eccezione di tutte le altre via via sperimentate. In greco kratos indica la forza nel suo esplicarsi violento.
Nelle antiche fonti greche, in Tucidide o anche in Isocrate per non parlare della Repubblica di Platone o perfino di Aristotele, la parola democrazia non è attestata in senso positivo: è un bersaglio polemico, una «parola dello scontro», come l’ha definita Luciano Canfora, usata in primo luogo dagli avversari di un governo popolare con l’intento di mettere in luce il carattere prevaricatorio, asimmetrico e minaccioso di ciò che esprime: il potere dei “non possidenti”. La torsione semantica che questo nesso della lingua greca ha subito lungo i secoli, la sua trasformazione in bene assoluto della nostra percezione collettiva, è uno dei grandi prodigi della storia.
Sull’accezione greca di demokratìa si è interrogata e divisa da sempre la filosofia politica - da Hobbes a Rousseau, da Constant a Tocqueville, da Dewey a Popper - nell’interpretare e studiare una forma di governo dalla natura e dalle implicazioni molto diverse, storicamente connessa a un’altra Europa rispetto a quella che i greci hanno conosciuto e dispiegato nella loro mitologia e nella loro geografia. Se il nesso storico-culturale tra i concetti astratti di Grecia, Europa e libertà resiste ai secoli e ai sussulti del globo, la genesi delle forme moderne di democrazia è successiva allo scindersi, con la conquista araba, di due Europe: l’una legata al papa di Roma e poi al cosiddetto sacro romano impero di Carlo Magno, un’Europa occidentale e via via sempre più nordica, più feudale, più lontana dal modello classico; l’altra esplicata in quella dislocazione e continuazione orientale del legittimo impero romano che fu Bisanzio, patria dello statalismo, dell’egualitarismo, della continuità nell’applicazione del diritto, la cui formula geografica, dopo l’islamizzazione del Nordafrica, si fece sempre più europea, ferma restando però la vocazione geopolitica di apertura, ibridazione e assimilazione in un’unica civiltà dei popoli e delle culture del sud e dell’oriente del mondo.
«Il mondo potrà salvarsi solo tornando a te», scriveva Ernest Renan nella sua Preghiera sull’acropoli, rivolgendosi alla città di Atene, al suo nume eponimo, la dea Atena, l’archegèta, «l’ideale che si incarna nei capolavori del genio umano». Il ritorno che Renan prospettava non era solo quello, ancora oggi atteso, dei marmi del Partenone, che immaginava riportati al suono del flauto in una lunga processione sacra dalle città del nord - Parigi, Londra, Copenhagen - fino alla soglia sudorientale di quella casa comune che già gli antichi chiamavano Europa. «Preferisco essere ultimo nella tua casa», scriveva, «piuttosto che primo altrove». Non si trattava solo della restituzione di spoglie archeologiche tanto simboliche quanto materiali. Renan auspicava anche il ritorno, da parte degli europei del nord, a un principio ideale, non necessariamente economico o razionale, ma essenziale: «Mi aggrapperò alla gradinata del tuo tempio, dimenticherò ogni disciplina che non sia la tua. Cosa più difficile: per te diventerò, quanto potrò, parziale».
Il ritorno all’ideale dell’antica esperienza greca passava per l’accettazione della Grecia contemporanea, del suo linguaggio, delle sue debolezze, dei suoi difetti: «Amerò solo te. Imparerò la tua lingua, disimparerò il resto». Anche a costo della rinuncia a una razionalità moderna: «Tutti coloro che fin qui hanno creduto di avere ragione si sono sbagliati, lo vediamo chiaramente. Possiamo davvero senza folle tracotanza credere che il futuro non ci giudicherà come noi giudichiamo il passato?».
L’omaggio all’Acropoli che Renan nel 1876 auspicava nei Souvenirs d’enfance et de jeunesse non sarebbe stato facile per i nordici colonizzatori «di un mondo più grande», che avevano visto «le nevi del polo e i misteri del cielo australe». Quante difficoltà prevedeva già allora Renan; quante inerzie mentali da superare. E però, pregava, rivolto al tempio sull’Acropoli: «Fermo in te, resisterò ai miei consiglieri fatali, allo scetticismo che mi fa dubitare del popolo».
Un terzo modello di Europa, che recuperasse questa tradizione come sola forma di pacificazione possibile tra le due anime europee sempre più distanti tra loro era stato già preconizzato, prima che da Renan e dai suoi contemporanei, dalle avanguardie colte il cui simbolo è Byron, che per la libertà della Grecia diede la vita; già Gibbon, lo storico inglese della decadenza e caduta dell’impero romano, scriveva: «Sia concesso al filosofo di ampliare la visione e di considerare l’Europa come una grande repubblica, i vari abitanti della quale sono giunti quasi allo stesso livello di civiltà e di cultura». Per questi intellettuali la Grecia non era solo la bandiera dell’occidente ma lo spalto estremo di un modello europeo alternativo a quello nordico, capace di coniugare l’ideale classico a quello bizantino: come esplicita anche Renan, alla fine della sua Preghiera sull’acropoli , includendo nell’invocazione la cupola cosmica di Santa Sofia a Costantinopoli, ulteriore simbolo di una larghezza di civiltà «abbastanza vasta da contenere una folla» incessante di popoli.
Con la caduta, all’inizio e alla fine del Novecento, degli imperi - quello ottomano a sudest, quello zarista, poi sovietico, a nordest - , questo terzo modello di Europa è approdato al suo collaudo politico. Il referendum cui i cittadini greci sono chiamati nella giornata di domenica può conside-rarsi, da un lato, una grande e plateale messa in scena di due diverse filologie della democrazia; d’altro lato, un’eco dell’appello di Renan ai governanti dell’Europa nordica: resistere allo scetticismo, ai calcoli e alle abitudini oligarchiche; non dubitare del popolo, dei non possidenti, non paventare il potere che abdica alla delega a favore di quell’antica e temibile espressione del kratos popolare che è lo strumento referendario.
- Nella Repubblica di Platone e in altre fonti quel concetto chiave non ha un senso positivo
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Non si esce per via politica da una trappola che ha natura meramente finanziaria (di Bifo - Colpo di Stato in Grecia).2 luglio 2015, di Federico La Sala
Colpo di Stato in Grecia
La finanza globale sta organizzando un colpo di stato riducendo alla fame milioni di greci. Facciamo finta di non sapere che si sta compiendo questo pogrom, mentre in altri luoghi si stanno svolgendo pogrom ai danni dei migranti
di Franco Berardi Bifo *
Osservando giorno per giorno il comportamento del Fondo monetario internazionale e della Banca centrale europea, cominciamo a decifrare lo scenario: il sistema finanziario globale sta organizzando un colpo di stato in Grecia, e per realizzarlo umilia e affama milioni di persone, spingendole verso un disastro umanitario quale in Europa avremmo pensato di non vedere mai.
Quand’ero giovane leggevo con orrore delle popolazioni di villaggi polacchi o tedeschi che fingevano di non sapere che a cinquecento metri dalle loro case si gettava la gente nei forni crematori. Nei villaggi italiani francesi o tedeschi oggi facciamo finta di non sapere che si sta compiendo un pogrom di dimensioni continentali contro il popolo greco, e in altri luoghi si stanno svolgendo pogrom ai danni del popolo migrante, gettato nella guerra dalla follia bellicista dei francesi e ora respinto verso l’abisso.
La guerra che già rumoreggia ai confini d’Europa si prepara ad esplodere in ogni sua città per il futuro prossimo. Nazionalismi aggressivi tendono a diventare maggioranza in Italia, Francia, Austria, per tacere d’Olanda e d’Ungheria.
Le condizioni sociali precipitano verso la povertà di massa e la precarietà generalizzata. In questo scenario mi pongo alcune domande.
. Domanda uno: Può sopravvivere l’Unione europea?
Risposta: Non può sopravvivere per la semplice ragione che l’Unione non esiste, e non è mai esistita, anche se ci abbiamo messo troppo tempo per capirlo. Da Maastricht in poi l’Unione non è nient’altro che un progetto finanziario di predazione della ricchezza sociale e di impoverimento dei lavoratori. Tutto il resto sono chiacchiere nelle quali siamo caduti.
L’aggressione finanziaria e il tentativo di umiliazione del governo greco sono prova evidente dell’inesistenza dell’Unione. Il fatto che non si sia manifestato alcun movimento di solidarietà con il popolo greco è prova che non vi è alcun popolo europeo: l’aggressione neoliberista ha distrutto ogni dimensione cosciente della società europea.
Ma a questo si aggiunge l’ottusità delle politiche europee nei confronti della popolazione migrante: la capitolazione del governo francese davanti al ricatto nazionalista, e il rifiuto generalizzato di condividere quote di immigrazione dimostrano che l’Unione non esiste. L’Unione europea è solo un fascio di crimini finanziari, di cinismo politico, e di viltà ignorante.
. Domanda due: Si può riformare l’Unione?
Risposta: La mia risposta è no, perché nazionalismo e razzismo sono la forza egemone in tutti i paesi europei con l’eccezione della Spagna e della Grecia. Noi - la sinistra, gli intellettuali, l’università, coloro che avrebbero dovuto rendere impossibile il ritorno della peste bruna in Europa - ne siamo responsabili: chi nel 2005 invitò francesi e olandesi a votare a favore di una finta costituzione europea che era sanzione definitiva della violenza neo-liberale porta la responsabilità di aver consegnato alla destra l’egemonia sociale che ora emerge invincibile. La peste bruna è in marcia in ogni villaggio di questo continente che è unito oggi come lo fu nel 1941.
. Domanda tre: Come se ne esce?
Risposta. Gli spiriti semplici indicano una soluzione sciocca: torniamo alla moneta nazionale. Come se la dracma o la lira potessero risolvere qualcosa perché finalmente potremmo svalutare e vendere molte merci a qualche pinguino. Gli spiriti semplici alla Bagnai non si rendono conto che il dramma non riguarda l’import-export, ma l’alternativa tra dittatura finanziaria globale e prospettiva di un rinascimento fondato sulla fine del Regime del Lavoro Salariato. Lo sguardo collettivo è incapace di vedere la possibilità di quel Rinascimento, dunque quel Rinascimento non ci sarà. E nessuno sa come se ne esce.
Il ceto finanziario intendeva distruggere l’Europa, e ora l’Europa è distrutta. Ma al tempo stesso non c’è modo di uscire da un’Unione che non esiste. Nella fine sta il segreto dell’inizio. La politica europea non è mai stata altro che una chiacchiera vuota per allocchi. Mentre noi discettavamo di democrazia il potere finanziario costruiva l’unica Europa che sia mai esistita: un dispositivo per lo spostamento di reddito dalla società alle banche, per la riduzione del salario e la precarizzazione del lavoro. Null’altro che questo è stato l’Unione, e non si esce per via politica da una trappola che ha natura meramente finanziaria.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- IL MITO FONDATIVO del vecchio continente. Siamo tutti figli del logos. Quel pensiero ci raccoglie insieme (di Massimo Cacciari)..1 luglio 2015, di Federico La Sala
La radice e la memoria
Siamo tutti figli del logos
Ecco perché la Grecia resterà sempre la miglior patria d’Europa
- La cultura nata all’ombra del Partenone fa parte del mito fondativo del Vecchio continente
 E i singoli Stati non devono ignorarlo se non vogliono disfarsi tra nazionalismi e calcoli economici
E i singoli Stati non devono ignorarlo se non vogliono disfarsi tra nazionalismi e calcoli economici
 Quel pensiero ci raccoglie insieme, è la nostra radice e ha informato di sé la storia e il destino dell’Occidente
Quel pensiero ci raccoglie insieme, è la nostra radice e ha informato di sé la storia e il destino dell’Occidente
 Oggi Atene grida al mondo che l’unità del denaro non produce di per sé alcuna comunità politica
Oggi Atene grida al mondo che l’unità del denaro non produce di per sé alcuna comunità politica
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 01.07.2015)
Può l’Europa fare a meno della Grecia? Se la domanda fosse stata rivolta a uno qualsiasi dei protagonisti della cultura europea almeno dal Petrarca in poi, questi neppure ne avrebbe compreso il significato. La patria di Europa è l’Ellade, la “migliore patria”, avrebbe risposto, come verrà chiamata da Wilhelm von Humboldt, fondatore dell’Università di Berlino. Filologia e filosofia si accompagnano, magari confliggendo tra loro, nel dar ragione di questa spirituale figliolanza. Non si tratta affatto di vaghe nostalgie per perdute bellezze, né di sedentaria erudizione per un presunto glorioso passato, coltivate da letterati in vacua polemica con il primato di Scienza e Tecnica.
Oltre le differenze di tradizione, costumi, lingue e confessioni religiose che costituiscono l’arcipelago d’Europa, oltre l’appartenenza di ciascuno a una o all’altra delle sue “isole”, si comprende che il logos greco ne è portante radice, che non si intende il proprio parlare, che si sarà parlati soltanto, se non restiamo in colloquio con esso. Quel logos ci raccoglie insieme e ha informato di sé la storia,il destino di Europa. Ciò vale per pensatori e movimenti culturali opposti, per Hegel come per Nietzsche.Vale per scienziati come Schroedinger, Heisenberg, Pauli. Vale anche per coloro che si sforzano di pensare ciò che nella civiltà europea resterebbe non-pensato o in-audito: anche costoro non possono costruire la propria visione che nel confronto con quella greca classica.
Per la cultura europea, dall’Umanesimo alle catastrofi del Novecento, la memoria della “migliore patria” è tutta attiva e immaginativa: non si dà formazione, non può essere pensata costruzione-educazione della persona umana nella integrità e complessità delle sue dimensioni senza l’interiorizzazione dei valori che in essa avrebbero trovato la più perfetta espressione. Un grande filosofo, Edmund Husserl, li ha riassunti in una potente prospettiva: nulla accogliere come quieto presupposto, tutto interrogare, procedere per pure evidenze razionali, regolare la propria stessa vita secondo norme razionali, volere che il mondo si trasfiguri teleologicamente in un prodotto della vita di questo stesso sapere. Una follia? Forse - ma una follia che ha veramente finito col dominare il mondo. Eurocentrismo? Certamente - ma autore dell’occidentalizzazione dell’intero pianeta.
La Grecia non assume più per noi alcun rilievo culturale e simbolico? Possiamo ormai contemplarla come l’Iperione di Hölderlin dalle cime dell’istmo di Coritno: «lontani e morti sono coloro che ho amato, nessuna voce mi porta più notizie di loro»? Come è spiegabile un simile sradicamento? L’anima bella “progressista” risponde con estrema facilità: quell’idea di formazione che aveva la Grecia al suo centro era manifestamente elitaria, anti-democratica; la sua fine coincide con l’affermazione dei movimenti di massa sulla scena politica europea. Io credo che la risposta sia ancora più semplice, ma estremamente più dolorosa. Tra l’ora attuale( noi, i “moderni”!) e la “patria migliore” c’è il suicidio d’Europa attraverso due guerre mondiali.
L’oblio dell’Ellade è il segno evidente della fine d’Europa come grande potenza. Si badi: grande potenza è anche lo Stato o la confederazione di Stati che intendano diventarlo. Essi dovranno, infatti, dotarsi tanto di armi politiche ed economiche quanto di una strategia volta alla formazione di classe dirigente e di una cultura egemonica. Sempre così è stato e sempre così avverrà. Quando vent’anni fa scrivevo Geofilosofia dell’Europa e L’Arcipelago ancora speravo che questo arduo cammino si potesse intraprendere. E ci si risparmi la fatica di ripetere che non è affatto necessario che ciò si realizzi nel senso di una volontà di potenza sopraffattrice.
L’Europa può ora pensare di dimenticare la Grecia, perché rinuncia a svolgere una grande politica, la quale può fondarsi soltanto sulla coscienza di costituire un’unità di distinti, aventi comune provenienza e comune destino. Se questa coscienza vi fosse stata, avremmo avuto una politica mediterranea, piani strategici di sostegno economico per i Paesi dell’altra sponda, un ruolo attivo in tutte le crisi mediorientali. E avremmo avuto grandi interventi comunitari per la formazione, gli investimenti in ricerca, l’occupazione giovanile. Tutto si tiene. Una comunità di popoli capace di svolgere un ruolo politico globale non può non avere memoria viva di sé, memoria di ciò che essa è nella sua storia, e non di un morto passato.
Tutti miti - diranno gli incantati disincantati dell’economicismo imperante. So bene - l’Europa attuale è quella costruita sulla base delle necessità economico- finanziarie. Gli staterelli europei usciti dalla seconda Guerra non avrebbero potuto sopravvivere senza l’unità del denaro. Oggi la Grecia grida al mondo che una tale unità non produce di per sé alcuna comunità politica. Se pensiamo all’Europa come a un colossale Gruppo finanziario, allora è “giusto” che una delle sue società di minore peso( magari mal gestita, da un management inadeguato) possa tranquillamente essere lasciata fallire.
L’importante è solo che non contagi le altre. Ma se l’Europa vuole ancora esistere in quanto tale,e non disfarsi in egoismi, nazionalismi e populismi, deve sapere che la Grecia appartiene al suo mito fondativo, e che nessuna credenza è più superstiziosa di quella, apparentemente così ragionevole e “laica”, che ritiene il puro calcolemus senso,valore e fine di una comunità.
- La cultura nata all’ombra del Partenone fa parte del mito fondativo del Vecchio continente
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Svegliamoci! È l’ora di fare davvero l’unione politica dell’Europa (di Roberto Castaldi - Il mondo brucia e i governi nazionali dormono. È l’ora di fare l’Europa!)30 giugno 2015, di Federico La Sala
Il mondo brucia e i governi nazionali dormono. È l’ora di fare l’Europa!
di Roberto Castaldi (l’Espresso, 29.06.2015)
La realtà fatica ad impossessarsi delle nostre coscienze e a produrre effetti politici in Europa. Così assistiamo attoniti allo spettacolo - difficile definirlo diversamente visto che ci comportiamo come se fossimo meri spettatori e non parte della vicenda - di un mondo che brucia intorno a noi, della nostra stessa casa che brucia (sebbene in modo diverso), e delle leadership politiche nazionali che si riuniscono inutilmente senza prendere alcuna decisione risolutiva. Come gli struzzi mettono la testa sotto lo sabbia e rimandano. Sono solo capaci di usare il potere di interdizione che gli è rimasto per impedire di fare quei timidi passi in avanti verso soluzioni europee che le istituzioni sovranazionali dell’Unione cercano invano di proporre.
Così, la crisi greca precipita senza che venga raggiunto un accordo, lasciando un retrogusto insieme di tragedia e di farsa, di fronte a un popolo in ginocchio e chiamato a decidere in un drammatico referendum fuori tempo massimo del suo destino e del nostro, perché i leader politici greci e quelli europei non sono stati capaci di prendere alcuna decisione. Tutto ciò è il risultato di un’Europa priva degli strumenti minimi essenziali - un bilancio federale fondato su risorse proprie - per risolvere un problema piccolo come il 2% del suo Pil. Così la palla passa ai governi nazionali che devono decidere insieme, ognuno attento solo alla propria opinione pubblica, invece che a trovare una soluzione.
Si rischia così la Grexit, che i greci non vogliono e che non è prevista dai trattati, che sanciscono che l’Unione monetaria è irreversibile. D’altronde, anche alcuni Stati americani in passato hanno fatto default, ma non hanno smesso di usare il Dollaro. Ma lì c’è un governo federale. Viviamo una crisi figlia dell’asimmetria dell’Unione monetaria, la cui cura doveva venire da un Rapporto sulla riforma dell’Eurozona presentato questa settimana. Peccato che proponga di realizzarne un assetto stabile e definitivo nel 2025 (avete letto bene!), attraverso le unioni finanziaria, di bilancio, economica e politica che il precedente Rapporto del 2012 fissava per il 2019. Gli euroscettici possono rallegrarsi, potranno continuare ad attaccare l’Unione per altri 10 anni almeno, in attesa che questa disponga dei poteri necessari a rilanciare l’economia europea. Nel frattempo l’intero fardello di tenere in piedi l’Euro, l’economia europea e la Grecia rimarrà sulle spalle della nostra unica istituzione economica federale, la Banca centrale europea, ma nel quadro dei limiti e dei vincoli giuridici posti dal suo Statuto e dai Trattati. Da mesi ricorda la necessità di istituzioni e politiche comuni, che la politica monetaria può comprare tempo, ma da sola non risolve i problemi e non scioglie i nodi politici e istituzionali che attanagliano l’Eurozona.
Intanto, i terroristi attaccano in diversi Paesi in Europa, Africa e Medio Oriente, ricordandoci che il mondo è interdipendente. E spingendo le persone a fuggire da tutto ciò e dalle guerre civili ormai quasi endemiche in tali aree. Una massa di migranti che gli Stati europei non sanno come gestire, non avendo voluto dare all’Unione adeguati poteri per farlo, e non riuscendo però a mettersi d’accordo tra di loro a livello intergovernativo. Anche in questo caso è stata la Commissione, l’embrione di un governo europeo, a portare avanti proposte fondate sull’interesse e la solidarietà europea, sia rispetto all’accoglienza, che al contrasto dei trafficanti.
In aggiunta si profila una nuova corsa agli armamenti in Europa tra Usa e Russia, che continua a destabilizzare l’Ucraina e risulta sempre più minacciosa per tutti i Paesi confinanti, inclusi i membri dell’UE - ma anche in Italia c’è chi mette la testa sotto la sabbia e guarda solo ai, pur limitati, effetti economici negativi delle sanzioni. Se la Gran Bretagna avesse considerato solo gli effetti economici negativi della guerra e non avesse resistito da sola, Hitler avrebbe vinto.
Ma oggi quel Regno Unito non esiste più, ha perso il suo ruolo nel mondo e il suo senso di responsabilità. Così contribuisce al caos, minacciando di uscire dall’Unione se non verranno concessi ulteriori privilegi che lo rendano ancora “più uguale degli altri”. Il tutto per ragioni di politica interna e contro i suoi stessi interessi politici ed economici.
Dovunque ci giriamo il mondo brucia, i nostri valori e i nostri interessi come europei vengono calpestati. Le nostre istituzioni sovranazionali cercano di proporre soluzioni, ma sono ancora troppo deboli e non hanno le competenze e i poteri necessari per affermarle e portarle avanti. I governi nazionali sono ancora più impotenti, reclamano il sostegno e la solidarietà europea, ma vorrebbero mantenere il loro potere di veto che paralizza l’Unione. Difendono una sovranità nazionale che era già prima “polvere senza sostanza” come osservava Einaudi, ma che oggi è un danno per i cittadini, che hanno bisogno di recuperare sovranità a livello europeo.
Secondo il grande storico inglese Toynbee gli europei sono come i greci delle polis di fronte all’ascesa dell’impero romano e come gli Staterelli della penisola italiana nel Rinascimento di fronte al consolidamento dei primi Stati moderni europei: hanno di fronte la semplice scelta tra unirsi e perire. Due grandi civiltà europee hanno perso questa sfida e sono morte. Sta a noi decidere se salvare la civiltà europea moderna o se lasciarla morire nel nome del mito della sovranità nazionale.
Abbiamo un disperato bisogno di un governo federale, almeno dell’Eurozona, con una politica economica ed un bilancio in grado di rilanciare investimenti e crescita - anche e soprattutto in Grecia! - ed una vera politica estera, di sicurezza, di difesa, e delle migrazioni. Cos’altro deve succedere perché si proceda verso una vera unità politica ed economica? Se il mondo brucia, per noi non ci sarà riparo. Svegliamoci! È l’ora di fare davvero l’unione politica dell’Europa.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Così si salva la democrazia. L’appello di Barbara Spinelli e Étienne Balibar.29 giugno 2015, di Federico La Sala
L’appello
Così si salva la democrazia
di Barbara Spinelli e Étienne Balibar (la Repubblica, 29.06.2015)
CARO direttore,
chiediamo ai tre creditori della Grecia (Commissione, Banca centrale europea, Fondo Monetario internazionale) se sanno quello che fanno, quando applicano alla Grecia un’ennesima terapia dell’austerità e giudicano irricevibile ogni controproposta proveniente da Atene. Se sanno che la Grecia già dal 2009 è sottoposta a un accanimento terapeutico che ha ridotto i suoi salari del 37%, le pensioni in molti casi del 48%, il numero degli impiegati statali del 30%, la spesa per i consumi del 33%, il reddito complessivo del 27%, mentre la disoccupazione è salita al 27% e il debito pubblico al 180% del Pil.
Al di là di queste cifre, chiediamo loro se conoscono l’Europa che pretendono di difendere, quando invece fanno di tutto per disgregarla definitivamente, deturparne la vocazione, e seminare ripugnanza nei suoi popoli.
Ricordiamo loro che l’unità europea non è nata per favorire in prima linea la governabilità economica, e ancor meno per diventare un incubo contabile e cader preda di economisti che hanno sbagliato tutti i calcoli. È nata per opporre la democrazia costituzionale alle dittature che nel passato avevano spezzato l’Europa, e per creare fra le sue società una convivenza solidale che non avrebbe più permesso alla povertà di dividere il continente e precipitarlo nella disperazione sociale e nelle guerre.
La cosiddetta governance economica non può esser vista come sola priorità, a meno di non frantumare il disegno politico europeo alle radici. Non può calpestare la volontà democratica espressa dai cittadini sovrani in regolari elezioni, umiliando un paese membro in difficoltà e giocando con il suo futuro. La resistenza del governo Tsipras alle nuove misure di austerità - unitamente alla proposta di indire su di esse un referendum nazionale - è la risposta al colpo di Stato postmoderno che le istituzioni europee e il Fondo Monetario stanno sperimentando oggi nei confronti della Grecia, domani verso altri Paesi membri.
Chiediamo al Fondo Monetario di smettere l’atteggiamento di malevola indifferenza democratica che caratterizza le sue ultime mosse, e di non gettare nel dimenticatoio il senso di responsabilità mostrato nel dopoguerra con gli accordi di Bretton Woods. Ma è soprattutto alle due istituzioni europee che fanno parte della trojka - Commissione e Banca centrale europea - che vorremmo ricordare il loro compito, che non coincide con le mansioni del Fmi ed è quello di rappresentare non gli Stati più forti e nemmeno una maggioranza di Stati, ma l’Unione nella sua interezza.
Chiediamo infine che il negoziato sia tolto una volta per tutte dalle mani dei tecnocrati che l’hanno fin qui condotto, per essere restituito ai politici eletti e ai capi di Stato o di governo. Costoro hanno voluto il trasferimento di poteri a una ristretta cerchia di apprendisti contabili che nulla sanno della storia europea e degli abissi che essa ha conosciuto. È ora che si riprendano quei poteri, e che ne rispondano personalmente.
*
Barbara Spinelli è europarlamentare indipendente del Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica. Étienne Balibar è un filosofo francese
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Anche i piccoli semi possono produrre grandi risultati. Cari intellettuali, sull’Unione siete ingenui e poco ambiziosi (di Maurizio Ferrera)24 giugno 2015, di Federico La Sala
Cari intellettuali, sull’Unione siete ingenui e poco ambiziosi
di Maurizio Ferrera (Corriere della Sera, 24.06.2015)
Negli ultimi mesi il dibattito sull’euro-crisi è stato dominato da due eccessi: tecnicismo e moralismo. Da un lato, balletti quotidiani di cifre e di sigle sconosciute e incomprensibili ai più. Dall’altro lato, giudizi su buoni e cattivi, santi e peccatori, creditori e debitori.
È mancato uno spazio di discussione intermedio, ancorato ai fatti ma ispirato a principi, e soprattutto capace di guardare lontano. Qualcuno già parla di un nuovo «tradimento dei clerici», resuscitando la formula usata da Julien Benda negli anni Venti per denunciare la viltà e la partigianeria degli intellettuali. Pur non del tutto priva di fondamento, l’accusa è esagerata.
Alcune grandi voci della cultura europea si fanno periodicamente sentire. Ieri è toccato a Jürgen Habermas. In un lungo intervento sulla Süddeutsche Zeitung, il decano dei filosofi continentali ha preso una posizione molto critica nei confronti della élite politica tedesca. È scandaloso, dice Habermas, che la vicenda greca sia degenerata in uno «scontro fra popoli», e che il possibile fallimento di uno Stato venga trattato alla stregua di una insolvenza privata.
E lo scandalo nello scandalo è l’ostinazione con cui il governo tedesco difende regole e assetti istituzionali che hanno amplificato a dismisura gli effetti della crisi. Le elezioni greche hanno introdotto un po’ di sabbia negli ingranaggi dell’eurozona. Un fatto salutare, ma Tsipras lo sta in buona parte sprecando, incapace com’è di europeizzare il confronto e opponendo al paradigma dell’austerità una nuova visione dell’Europa.
È un peccato, perché i tempi sarebbero invece maturi per un cambiamento. Ne è convinto Amartya Sen, un’altra illustre voce che ha recentemente parlato sul New Statesman (il 4 giugno scorso). Anche il noto filosofo-economista se la prende con i leader politici, assolvendo (in maniera a mio avviso troppo disinvolta) le truppe di economisti-consiglieri che hanno orientato le scelte delle varie istituzioni europee. Sen fa però un’osservazione di cui la Ue dovrebbe far tesoro. Riforme strutturali e austerità «indiscriminata» non debbono accompagnarsi per forza. Tenerle assieme è stato un errore madornale: è come dare a un paziente con la febbre un antibiotico (le riforme strutturali, necessarie per la crescita) mescolato a veleno per i topi (avanzi primari di tre o quattro punti di Pil, come chiesto alla Grecia: un viatico per il soffocamento).
Sia Habermas sia Sen auspicano un risveglio della Politica con la p maiuscola. Un auspicio condivisibile, ma a mio avviso insufficiente. Se è vero che servono nuove visioni, è un po’ ingenuo pensare che possa essere l’attuale classe politica europea ad elaborarle. Con ogni probabilità la crisi greca si risolverà con un compromesso dell’ultim’ora, scarsamente coerente e potenzialmente instabile. Ciò che serve è uno scatto di ambizione progettuale, un richiamo forte alla responsabilità storica che la leadership europea deve oggi esercitare. Se davvero siamo allo scontro fra popoli, la politica non può limitarsi a mediare, deve «riconciliare»: un processo delicato, al quale gli intellettuali hanno il dovere di contribuire in prima persona.
Parlando ieri alla Statale di Milano, la filosofa franco-bulgara Julia Kristeva ha proposto l’istituzione di una Accademia culturale europea, un luogo capace di generare idee-valore che consentano alle culture politiche nazionali di uscire dall’attuale «depressione». Occorre ben altro, dirà qualcuno. Ma la formazione di nuove comunità politiche è un processo molto lento e in parte imprevedibile. Anche i piccoli semi possono produrre grandi risultati.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Integrazione Ue, "Avanti con le 4 Unioni": l’appello del mondo accademico al Consiglio europeo20 giugno 2015, di Federico La Sala
Integrazione Ue, "Avanti con le 4 Unioni": l’appello del mondo accademico al Consiglio europeo
Oltre cento tra professori e personalità europee hanno sottoscritto una lettera aperta alle istituzioni comunitarie in vista del vertice europeo *
ROMA - "Bisogna imparare la lezione impartita dalla crisi: non è possibile vivere in un mercato unico con una singola moneta ma 19 diverse politiche economiche e fiscali". Sono oltre cento gli accademici e le personalità di svariati paesi dell’Unione Europea che in due giorni hanno sottoscritto una lettera aperta alle istituzioni europee, dalla Commissione al Parlamento, dal Consiglio alla Banca Centrale Europea alla vigilia del Consiglio europeo. L’invito è a procedere con un percorso e scadenze certe verso l’obiettivo delle 4 Unioni: bancaria, fiscale, economica e politica, "altrimenti la crisi potrebbe peggiorare ancora".
La strada indicata è una "integrazione differenziata, coniugando l’approfondimento dell’Eurozona con il desiderio di alcuni Stati membri di ridurre il loro livello di integrazione, senza però dar loro un potere di veto sui bisogni dei cittadini europei". Secondo le personalità europee è necessario trasformare il Meccanismo Europeo di Sicurezza in un Fondo Monetario Europeo "da un Vicepresidente della Commissione, che dovrebbe essere anche il presidente dell’Eurogruppo, incaricato di gestire una capacità fiscale e di prestito fondata su risorse proprie, almeno per l’Eurozona, e sotto l’effettivo controllo democratico del Parlamento Europeo".
Alla stesso modo "L’Europa deve trasformarsi da consumatrice a produttrice di sicurezza. Solo gli Stati di dimensione continentale - come Usa, Cina, India, Russia e Brasile - contano nel mondo globale". È quindi necessaria un’unica politica estera e una Cooperazione strutturata permanente sulla difesa.
Ecco il testo della lettera e i primi firmatari:
Lettera aperta ai presidenti della Commissione europea, del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, della Banca centrale europea e dell’Eurogruppo.
Gent.mi Presidenti,
al prossimo Consiglio europeo presenterete un report cruciale sulla riforma dell’Unione Economica e Monetaria che fisserà l’agenda politica dell’integrazione europea per la legislatura in corso. Potete basarvi sul successo dell’integrazione europea il cui nucleo è la condivisione della sovranità attraverso istituzioni democratiche sovranazionali. Dovrete partire dalle lezioni apprese dalla crisi: non possiamo vivere in un mercato unico con una moneta unica e 19 politiche economiche e fiscali. Il riconoscimento dell’insostenibilità di lungo termine di questa asimmetria aveva portato i vostri predecessori a stabilire nel documento del dicembre 2012 Towards a Genuine Economic and Monetary Union gli obiettivi delle unioni bancaria, fiscale, economica e politica.
I cittadini europei si aspettano da Voi una visone ambiziosa del futuro dell’Europa con un percorso chiaro e delle scadenze precise al fine di raggiungere queste unioni e creare un’Unione più efficiente e democratica. L’importante azione della Banca Centrale Europea ha attenuato la pressione dei mercati e l’Unione Monetaria appare oggi come un bambino abbandonato di cui nessuno voglia prendersi cura. Dal 2012 sono stati fatti significativi progressi solo riguardo all’Unione bancaria, per la mancanza di volontà politica degli Stati membri. Ma senza progressi verso le 4 Unioni la crisi potrebbe peggiorare ancora. Gli strumenti di emergenza, come il Meccanismo Europeo di Sicurezza, va riportato nel quadro giuridico dell’Unione e trasformato in un Fondo Monetario Europeo gestito da un Vicepresidente della Commissione, che dovrebbe essere anche il presidente dell’Eurogruppo, incaricato di gestire una capacità fiscale e di prestito fondata su risorse proprie, almeno per l’Eurozona, e sotto l’effettivo controllo democratico del Parlamento Europeo. Questo è essenziale per una politica economica europea, per investimenti finalizzati alla crescita, e per passare dalla solidarietà tra gli stati a quella tra i cittadini.
La crisi ha mostrato l’inefficacia del mero coordinamento delle politiche economiche e fiscali nazionali e la paralisi prodotta dall’unanimità. Gli Stati membri hanno ora più vicoli di bilancio che in un sistema federale pienamente sviluppato, senza beneficiare di un bilancio e di politiche federali. Così l’Europa non riesce a superare la crisi. Il completamento delle unioni bancaria, fiscale, economica e politica è necessario per portare l’Unione verso una stabile e sostenibile prosperità economica e sociale. L’integrazione differenziata può coniugare l’approfondimento dell’Eurozona con il desiderio di alcuni Stati membri di ridurre il loro livello di integrazione, senza però dar loro un potere di veto sui bisogni dei cittadini europei.
Lo spostamento del focus strategico americano sul Pacifico ha creato un vuoto di potere che promuove instabilità tutto intorno all’Europa, dall’Est al Sud. L’Europa deve trasformarsi da consumatrice a produttrice di sicurezza. Solo gli Stati di dimensione continentale - come Usa, Cina, India, Russia e Brasile - contano nel mondo globale. L’UE deve procedere verso l’Unione politica, con un’unica politica estera, di sicurezza e di difesa finalizzate a stabilizzare i suoi confini e a fare fronte alle attuali minacce e sfide geopolitiche. L’inizio di una Cooperazione strutturata permanente sulla difesa è una questione di volontà politica e non di risorse visto che i paesi “Euro-Plus” hanno la seconda spesa militare al mondo.
Il “tutto il necessario” del presidente Draghi è stato cruciale nel momento più difficile della crisi. Il vostro Rapporto dovrebbe essere il “tutto il necessario” politico da parte di tutte le istituzioni dell’Unione. Dovrebbe fornire un percorso e scadenze certe per completare l’unione bancaria e creare quella fiscale, economica e politica entro la fine di questa legislatura europea. Se questo richiede una modifica dei Trattato, la si faccia.
I cittadini hanno bisogno di una visione e di un percorso per un’Europa fondata sulla democrazia, la solidarietà e la sussidiarietà. Nient’altro potrà restituire la fiducia nell’Unione. L’alternativa è il diffondersi di una percezione sociale di un declino inevitabile e irreversibile, che alimenta il populismo, il nazionalismo e la xenofobia. La leadership implica una responsabilità nei confronti dei cittadini di oggi e di domani. Gli europei contano sulla vostra leadership, responsabilità e visione per portare loro e la loro Unione fuori dalla crisi.
Questa Lettera aperta è stata promossa dal prof. Roberto Castaldi il 16 giugno. In 2 giorni hanno aderito oltre un centinaio di accademici e personalità europee. Tra i primi firmatari: Edmond Alphandery, Enrique Baron Crespo, Franco Bassanini, Vitor Bento, Lorenzo Bini Smaghi, John Bruton, Carlos Closa, Anna Diamantopoulou, Sergio Fabbrini, Franco Gallo, Anthony Giddens, Daniel Innerarity, Pascal Lamy, Jo Leinen, Jean-Victor Louis, Claus Offe, Antonio Padoa Schioppa, Gianfranco Pasquino, Gian Enrico Rusconi, Vivien Schmidt, Zvetan Todorov, Jose Ignacio Torreblanca, Alexander Trechsel, Lukas Tsoukalis, Nadia Urbinati. È aperta a ulteriori adesioni sul sito www.cesue.eu
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- I migranti sono la cicatrice più profonda della globalizzazione: non li trattiamo come cittadini e, alla fine, nemmeno come uomini (di Julia Kristeva)17 giugno 2015, di Federico La Sala
Stranieri alla deriva senza voce né diritti l’ultima sfida dell’Occidente
I migranti sono la cicatrice più profonda della globalizzazione: non li trattiamo come cittadini e, alla fine, nemmeno come uomini
di Julia Kristeva (la Repubblica, 17.06.2015)
- L’APPUNTAMENTO Il testo è tratto dalla lectio magistralis che la scrittrice francese di origine bulgara Julia Kristeva terrà a Genova al Festival “Suq-Teatro del dialogo” il 22 giugno alle 18 durante la Giornata Mondiale del Rifugiato
DIRITTI dell’uomo o diritti del cittadino? Questa discordanza, di cui Hannah Arendt ha tracciato la genealogia, ma anche la degenerazione (la degenerazione che ha dato luogo al totalitarismo), compare con evidenza quando le società moderne affrontano il “problema degli stranieri”. La difficoltà che genera questa questione sarebbe racchiusa interamente nel vicolo cieco della distinzione che separa uomo e cittadino: non è forse vero che per stabilire i diritti che spettano agli uomini di una civiltà o di una nazione, anche la più ragionevole e la più consapevolmente democratica, si è obbligati a escludere da tali diritti i non cittadini, ovvero altri uomini?
Questo modo di procedere significa - è la sua estrema conseguenza - che si può essere più o meno uomini a seconda che si sia più o meno cittadini, significa che chi non è cittadino non è interamente un uomo. Fra l’uomo e il cittadino, una cicatrice: lo straniero. È interamente un uomo se non è cittadino? Non godendo dei diritti di cittadinanza, possiede i suoi diritti d’uomo? Se, consapevolmente, accordiamo agli stranieri tutti i diritti degli uomini, che cosa ne resta in concreto quando togliamo loro i diritti del cittadino?
Nella situazione attuale di mescolanza senza precedenti di stranieri sul pianeta, due soluzioni estreme si profilano: o si andrà verso degli Stati Uniti mondiali di tutti i vecchi Stati- nazione (processo immaginabile nel lungo periodo e che lo sviluppo economico, scientifico, mediatico lascia presumere), oppure il cosmopolitismo umanista si rivelerà un’utopia, e le aspirazioni particolaristiche imporranno la convinzione che i piccoli insiemi politici sono le strutture ottimali per la sopravvivenza dell’umanità.
Nella prima ipotesi, la cittadinanza è chiamata a integrarsi il più possibile nei diritti dell’uomo e a dissolversi in essi, perché assimilando gli ex stranieri i cittadini nazionali perderebbero necessariamente molti dei caratteri e dei privilegi che li definiscono in quanto tali. Altre differenze si formerebbero, probabilmente, dando luogo al caleidoscopio multinazionale degli Stati Uniti mondiali: differenze sessuali, professionali, religiose ecc.
Al contrario, se gli Stati-nazione dovessero sopravvivere ancora a lungo, come la difesa accanita dei loro interessi in questo momento pare indicare, lo squilibrio fra diritti dell’uomo e diritti del cittadino creerebbe degli equilibri più o meno sottili o brutali. Diventerebbe allora necessario creare uno statuto degli stranieri che tuteli dai reciproci abusi, precisando i diritti e i doveri delle due parti. Questo statuto dovrebbe essere provvisorio, evolutivo e adattarsi ai cambiamenti dei bisogni sociali e delle mentalità.
Quali che siano le differenze tra un paese e l’altro, si può generalizzare dicendo che nelle democrazie moderne gli stranieri sono esclusi da un certo numero di diritti. Prendiamo lo spinoso problema dell’esclusione degli stranieri dal diritto di voto. Gli argomenti delle due parti sono ben noti: «Gli stranieri in definitiva restano fedeli al loro paese d’origine e possono nuocere alla nostra indipendenza nazionale», dicono gli uni. «Gli stranieri costruiscono insieme a noi la nostra indipendenza economica, e pertanto devono godere dei diritti politici che conferiscono il potere di decisione», replicano gli altri.
Quale che sia la tesi che finirà per prevalere, possiamo osservare, come ritengono alcuni giuristi, che «in questo modo lo straniero è ridotto a un oggetto passivo»: gli stranieri non votano e non partecipano, né allo Stato, né al parlamento, né al governo, sono «alienati rispetto all’ordine giuridico, così come all’ordine politico e all’insieme delle istituzioni della società in cui vivono». A questo si deve aggiungere il fatto che l’Amministrazione ha il potere di interpretare, vale a dire modificare attraverso regolamenti e decreti, la giurisdizione esistente, cosa che può portare a fare del diritto degli stranieri un «diritto al ribasso».
Dopodiché nuovi stranieri inquietano ormai la globalizzazione: le rivendicazioni dei diritti spesso degenerano in vandalismo, o addirittura in gangster- integralismo e fanatismo che seminano morte. “Nuovi” perché agiscono, nel contesto di un risveglio della spiritualità, in nome di una spinta verso l’assoluto trasformata in quella che bisogna definire non più un’”idealità” (divina o universalista secolarizzata), ma una “malattia di idealità”. “Nuovi” perché in risonanza con i conflitti in Medio Oriente. E perché mettono in discussione il modello della secolarizzazione e della laicità.
Gli ideali stessi scompaiono, spazzati via dalla più pulsionale delle pulsioni, la pulsione alla morte, colpendo in profondità il motore della civiltà, mettendo in evidenza la distruzione del “bisogno di credere” prereligioso. Scopriamo che fra questi nuovi stranieri, alcune persone - in particolare adolescenti - soccombono alla malattia dell’idealità. Esplodono letteralmente, incapaci di distinguere il dentro e il fuori, il sé e l’altro. La pulsione alla morte riassorbe la vita psichica: senza il sé e senza l’altro, né “io” né “tu”, “noi” sprofondiamo nella distruttività cieca e autodistruttrice.
Le democrazie si trovano davanti a una sfida storica: sono in grado di affrontare questa crisi del bisogno di credere e del desiderio di sapere che il coperchio della religione non tiene più a freno, e che va a toccare il fondamento del legame fra esseri umani stranieri? L’angoscia che ci inchioda in questi tempi di eccessi con crisi economica e sociale sullo sfondo esprime la nostra incertezza davanti a questa posta in gioco colossale.
(Traduzione di Fabio Galimberti)
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Giuseppe Mazzini: “abolire la parola straniero dalla favella dell’umanità”! (di Alain Goussot - L’odio)16 giugno 2015, di Federico La Sala
L’odio
di Alain Goussot (comune-info, 13 giugno 2015)
In questo periodo alcuni dirigenti politici alzano la voce contro gli stranieri, quelli miserabili (non i miliardari arabi che si stanno comprando mezza Italia), quelli che scappano dalla fame, dalla guerra, dalle situazioni disumane e tragiche prodotte dalle politiche occidentali, in primis gli Usa e le multinazionali euro-statunitensi che sfruttano le risorse dell’Africa e del Medio-oriente. Quei dirigenti usano una violenza verbale, veicolata dai media, che fanno così da cassa di risonanza alla costruzione del capro espiatorio in una situazione di crisi sociale, culturale, morale, politica ed economica che sta affondando la democrazia italiana, ma anche di molti paesi europei.
La violenza verbale si accompagna purtroppo anche dalla violenza fisica di chi viene sfruttato da scafisti di tutte le nazionalità, basta vedere la vicenda di Roma (sulle vicende di Roma, Milano, Ventimiglia e, più in generale sulla situazione dei migranti in questo momento, leggi anche Migranti in trappola di Fulvio Vassallo Paleologo e la durissima denuncia di Amnesty). L’importante è fare crescere l’odio verso i poveri del mondo che chiedono aiuto, l’importante è metterli alla gogna facendo tremare i cittadini impoveriti e impauriti con le favole sulla scabbia, il terrorismo ecc.
La cosa grave è che il giornalismo italiano sembra non avere senso del pudore e della responsabilità sociale nell’influenzare l’opinione pubblica, anzi più si sbatte il mostro in prima pagina nei tg, più si dà spazi ai deliri razzisti e volgari di certi personaggi, più si amplifica il fenomeno della presunta invasione del paese. E se il paese è invaso vuol dire che siamo in guerra. Contro chi? Contro i poveri che arrivano dal Corno dell’Africa (ex colonie italiane), dal Medio-oriente (Sira, Iraq distrutti dalla guerre occidentali), dall’Africa centrale sfruttate dalle multinazionali per le sue materie prime. Non guerra alle diseguaglianza e alla povertà nel mondo e anche alle sue cause, dunque, ma guerra ai poveri.
Austerity
D’altronde che la guerra contro i poveri sia una realtà i cittadini europei se ne accorgono con le politiche di austerity che hanno avuto finora l’effetto d’impoverire la popolazione e di distruggere i sistema di diritti e di tutela dei lavoratori. Allora bisogna far crescere l’odio contro i profughi, scatenare la guerra tra i poveri facendo leva sugli istinti più bassi e incivili dell’essere umano per fare dimenticare che la crisi sociale in Italia e in Europa ha dei responsabili, cioè chi governa e conduce per conto dei mercati della finanza le politiche di distruzione dello Stato sociale per favorire il trasferimento di ricchezza verso chi è ricco e per rendere schiavi i salariati.
Come ha scritto René Girard nei suoi testi La violenza e il sacro e Il capro espiatorio, l’aggressione razzista è proporzionata non alla diversità dello straniero ma al fatto che ci assomiglia tanto, insomma aggrediamo l’altro perché è molto simile a noi e non il contrario (è quello che il filosofo francese chiama “la vendetta mimetica”). Nel caso dell’Italia con la sua storia d’emigrazione (rimossa anche se molto attuale, visto che negli ultimi tre anni hanno lasciato il paese 350.000 mila italiani) la questione diventa ancora più complicata poiché i profughi ci ricordano molte cose sulla sua storia passata e anche attuale. L’aggressività razzista e xenofoba è anche sempre lo specchio di una paura irrazionale, di una insicurezza e di un tentativo di eliminare l’altro diverso da sé per non fare i conti con se stesso, quindi con l’altro che ci sta dentro.
Il dominio sull’altro secondo Fanon
Psicologicamente si può dire, con lo psichiatra afro-martinichese Franz Fanon, che l’aggressività linguistica e simbolica nonché la violenza fisica sono parte di una logica di dominazione sull’altro agita da chi si sente insicuro (agendo come un “ferito psico-affettivo” che costruisce un rapporto di doppio legame con l’oggetto del proprio odio e della propria violenza). Si tratta di un tratto patologico che, negando dignità e umanità all’altro, porta a annichilire la propria dignità e umanità, quindi la propria capacità riflessiva lasciandosi travolgere dalle pur emozioni del momento, emozioni che non diventano sentimenti poiché quest’ultimi ci portano a relazionarci con i sentimenti dell’altro e quindi a considerarlo nella propria umanità.
L’odio ha purtroppo sempre funzionato nella storia umana permettendo alle classi dominanti di trovare, tra una parte dei dominati e sfruttati autoctoni, delle truppe e dei sostegni per continuare ad essere dominanti. L’odio è anche un modo molto più semplice di non dovere fare i conti con se stessi nella relazione con l’altro e quindi con la propria coscienza.
Giuseppe Mazzini l’aveva già capito nella prima metà dell’800 e sosteneva che solo la fratellanza tra i popoli, in particolare tra i popoli sfruttati e oppressi avrebbe permesso di costruire una Europa più democratica e più giusta, scrisse anche in un proclama indirizzo ai giovani italiani che bisognava “abolire la parola straniero dalla favella dell’umanità”!
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Il tramonto della cittadinanza europea (di Nadia Urbinati)15 giugno 2015, di Federico La Sala
Repubblica 15.6.15 Il tramonto della cittadinanza di Nadia Urbinati
LA CITTADINANZA europea, il progetto politico più coraggioso di cui é stato capace il vecchio continente, subisce i colpi della crisi economica in due sensi: per gli effetti elefantiaci che le strutture euro-burocratiche hanno in tempi in cui ci sarebbe bisogno di coraggiose scelte politiche comunitarie; e per gli effetti regressivi causati dalla rinascita dei nazionalismi. La debolezza della politica comunitaria alimenta indirettamente la propaganda dei confini. A soffrire gli effetti di questa spirale perversa sará la cittadinanza europea, quel nucleo di diritti civili e politici che hanno aperto spazi enormi alla creativitá e alla libertá. Le grida ringhiose di Salvini e alcuni governatori delle regioni del Nord contro rifugiati e profughi avranno effetti perversi sulla cittadinanza europea. La quale si è sviluppata proprio sul diritto di movimento: diritto non solo di uscita, giá contemplato nelle costituzioni democratiche, ma di entrata, ovvero diritto di emigrare. Il Trattato di Roma stabilì le condizioni di questa libertá fondamentale, perfezionata dai successivi trattati, e fece del continente uno spazio aperto, senza steccati, senza dentro e fuori. Qui sta l’embrione della cittadinanza sovrannazionale, del cosmopolitismo democratico; l’opposto é la cittadinanza identificata all’appartenenza nazionale, che chiude ed esclude.
L’Unione europea è nata su una premessa rivoluzionaria, simile a quella che portò alla genesi della cittadinanza nazionale con la Rivoluzione francese. Se nel 1789 la nazione conquistò lo stato, dal Trattato di Roma in poi prese avvio un processo più compiutamente universalista e più coerente con i principi del 1789, perché propose di disarticolare la cittadinanza dalla nazionalità per farne espressione piena dei diritti della persona.
Si trattó di una rivoluzione silenziosa, che marció attraverso trattati e abiti giuridici e mutó gradualmente il modo di concepire lo spazio di vita. La cittadinanza europea dissocia i due paradigmi che hanno segnato, nel bene e soprattutto nel male, la storia della cittadinanza moderna: ovvero la cittadinanza come assoggettamento alla legge dello stato e la cittadinanza come espressione di identità nazionale. Come ha scritto Ulrick Preuss, la “cittadinanza europea può essere considerata come un passo ulteriore verso un nuovo concetto di politica simultaneamente dentro e fuori la cornice di significato tradizionale che le diede lo stato-nazione”. Cittadini degli stati membri e cittadini di un ordine post- nazionale: questa doppia identitá rafforza le nostre libertá e ci assegna più poteri.
È l’immigrazione quindi la pietra di paragone per valutare la cittadinanza europea. In questi anni di destabilizzazione dell’ordine regionale in molte parti del globo e di impoverimento di un numero crescente di popoli, le frontiere sono tornate a essere il luogo della politica identitaria e le ragioni delle nazioni hanno ripreso forza contro le ragioni delle persone e della libera circolazione. Non ci si deve illudere dicendo che la chiusura delle nostre frontiere riguarda i non europei. Questo é un argomento sofistico: saranno anche i cittadini europei a subirne le conseguenze. E le recenti contestazioni di Schengen hanno un significato sinistro poiché se il bisogno della difesa dei “nostri” territori contro “gli altri” si fa strada, allora tra gli altri ci finiranno prima o poi anche coloro che provengono dagli stati membri, per esempio i più bisognosi di muoversi per cercare lavoro ed emigrare.
Insieme all’euro-burocrazia, dunque, la questione dell’immigrazione sta cambiando la natura del progetto europeo perché mette in moto gli unici soggetti di decisione politica al momento esistenti, ovvero gli stati nazionali. Con la contestazione di Schengen riprende forza la cittadinanza etnica e con essa la politica si riposiziona pericolosamente verso ragioni di esclusione. La cittadinanza torna a prendere i colori delle etnie, a usare i linguaggi della purezza da preservare dalla contaminazione con gli stranieri. Rispolvera il gergo del populismo crudo e di pancia che alimenta le retoriche semplicistiche della destra etno-fascista.
Come contro altre minoranze in passato, i populisti di oggi si appellano alla cittadinanza “nostra” per censurare tutto quel che la macchia. Fanno della cittadinanza un’arma di esclusione. Con la lungimiranza che veniva dal ricordo vivo delle sofferenze della guerra e delle persecuzioni, il Trattato di Roma aveva messo alla base del futuro la libertá di movimento. I destini della nostra libertá, negli stati membri come in Europa, sono ancora oggi aggrappati alla forza di quella libertá.
L’immigrazione é dunque una sfida alle ambizioni progressiste e democratiche dell’Europa perché mentre nessuno puó mettere in dubbio la ragionevolezza della necessitá di regolare i flussi migratori nei nostri paesi, non tutti sono convinti che questa regolamentazione debba avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignitá delle persone. Per sconfiggere sul nascere la propaganda etno-fascista dei populismi di destra, occorre che l’intera comunitá europea si impegni, non alcune regioni o alcuni stati membri; poiché, appunto, la questione della libertá di movimento é un bene di tutti i cittadini europei.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- Grecia. Il volto oscuro di un Paese in affanno. Theodoros Giannaros, direttore di ospedale: mi vergogno di essere europeo.11 giugno 2015, di Federico La Sala
Grecia
Il volto oscuro di un Paese in affanno
Bustarelle per il medico e record di suicidi
Theodoros Giannaros, direttore di ospedale: mi vergogno di essere europeo
di Giuseppe Sarcina (Corriere della Sera, 11.06.2015)
DAL NOSTRO INVIATO ATENE Theodoros Giannaros tiene gli occhi fissi sul computer e una sigaretta tra le dita. Guarda le immagini di alberi, di spiagge. È talmente assorto da non accorgersi che la cenere sta coprendo la tastiera. Compare l’immagine di un giovane. Bello, sorridente. «È mio figlio, si è tolto la vita pochi giorni fa. Aveva 26 anni. Quando l’ho saputo non sono riuscito a fare altro che questo video».
Atene, Ospedale Elpis: un complesso di palazzine bianche nel centro della città. È un giorno festivo, ma il dottor Giannaros si fa trovare nel suo ufficetto di direttore. Siede lì dal 2010. È un biologo molecolare, specializzato in genetica. Ha studiato a Karlsruhe, in Germania, a San Francisco e a Vienna. Da anni è un punto di riferimento assoluto per tutta la Grecia. Quando interviene sui giornali o in tv nessuno si permette di contraddirlo.
Fruga ancora nel pacchetto di nazionali, tira fuori l’ennesima sigaretta e un’altra sassata: «Mio figlio è solo l’ultimo di una lista interminabile. Da quando è iniziata la crisi in questo Paese si sono suicidate 10 mila persone. Sì ha capito bene: 10 mila. È come se una grande città fosse stata cancellata dalla carta geografica della Nazione».
Giannaros ha un passato nelle truppe speciali: mostra le foto delle sue ultime missioni, in mimetica, immerso in un fiume fino alle ginocchia. È come se avesse bisogno di una pausa, vuole raccontare ancora qualcosa della sua famiglia, degli altri due figli, 24 e 28 anni. «Anche il più piccolo è un soldato». Lo dice con un sottinteso chiaro: lui si è salvato. Ma quanti sono i giovani senza speranza? Le statistiche si afflosciano come svuotate di senso al cospetto della forza, della dignità di quest’uomo. «Appena arrivato qui incontravo pazienti che mi chiedevano: ma quanto devo pagare per operarmi qui? Quanto per una lastra? Nulla, rispondevo, questo è un ospedale pubblico. Poi mi sono fatto portare il registro delle prenotazioni e ho capito. La lista d’attesa risultava sempre infinita, ma con una buona “fakelaki” si poteva comodamente saltare la fila». “Fakelaki”, la bustarella. «In cortile ho fatto mettere dei cartelli con una busta sbarrata con una grande x rossa. Significa che qui non si accettano tangenti».
Le parole del più atipico dei manager conducono nell’antro della crisi. I ragionamenti sulla sostenibilità del debito lasciano il posto alla scarsità di siringhe, bisturi, persino guanti per la sala operatoria. «Abbiamo sviluppato un network di scambi tra le diverse cliniche. Andiamo avanti anche grazie a donazioni in arrivo dalla Svizzera, dall’Austria, dalla Germania». Theodoros accende un’altra sigaretta. Aspira profondamente, poi scarica fumo e una lunga invettiva. Contro le vecchie classi politiche, le dieci famiglie che hanno monopolizzato l’economia del Paese, le «idiote» prescrizioni della «troika», il Fondo monetario, la Bce, la Commissione europea, Angela Merkel. Spera che Alexis Tsipras possa raggiungere qualche risultato, «ma deve avere dietro tutti i partiti, tutta la Grecia. Questo è l’unico modo che abbiamo per sopravvivere». Già, «sopravvivere». «Penso continuamente a quei 10 mila morti che abbiamo seppellito nel silenzio. Penso a mio figlio. E penso che se in Germania un cane muore in malo modo, ecco che il caso finisce sui giornali, se ne dibatte in tv. Ma avete mai sentito parlare dei nostri giovani, dei nostri anziani che si sono suicidati? La guerra civile della Jugoslavia ha fatto 20 mila morti. Quella, però, era una guerra. Che cos’è, invece, questa nostra strage? È una domanda a cui non so rispondere, posso solo dire che in questo momento mi vergogno di essere un europeo».
Forse è arrivato il momento di andare. Ma Theodoros ha ancora qualcosa da dire: «In questi anni sono stato corteggiato da tutti i partiti, avrei potuto fare il ministro cento volte. Invece ho sempre voluto restare un uomo libero e mi sono fatto un mare di nemici. Continuo a stare qui, a lavorare per 1.400 euro al mese, cinque volte meno di qualche anno fa. Non posso permettermi la macchina, viaggio in scooter e giro con una pistola. Prima che mio figlio se ne andasse così, mi sentivo anche un privilegiato».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- L’allarme di Joseph Stiglitz: “Germania incosciente se Atene cade nel dirupo dentro ci finirà l’Europa”. Interv. (di di Eugenio Occorsio)9 giugno 2015, di Federico La Sala
Joseph Stiglitz
L’allarme del premio Nobel statunitense “Irragionevole pensare che l’austerity sia l’unica strada”
“Germania incosciente se Atene cade nel dirupo dentro ci finirà l’Europa”
di Eugenio Occorsio (la Repubblica, 09.06.2015)
ROMA «La posta in gioco è altissima, e non tutti sembrano rendersene conto. E’ in ballo il destino dell’Europa e quindi, vista l’importanza del continente, dell’economia mondiale». Parola di Joseph Stiglitz, classe 1943, economista della Columbia University, premio Nobel nel 2001. «La Germania - ci spiega - e con essa il forte schieramento dei Paesi nordici più ricchi, continua al di là di ogni ragionevole evidenza a proclamare l’austerity come l’unica politica possibile perfino per un caso come la Grecia. Non sono bastati gli errori giganteschi compiuti: è come se l’Unione europea stesse spingendo oltre il dirupo un Paese senza considerare che dietro ad esso crollerà l’intera Europa».
Stiglitz, dopo un bagno di popolarità al festival di Trento all’inizio del mese, è rimasto in Italia: in una villetta a Bellagio sul lago di Como passerà l’estate scrivendo il libro Creating a learning society per documentare l’importanza della formazione nello sviluppo. Il saggio uscirà in ottobre in America e subito dopo Stiglitz si getterà nella campagna di Hillary Clinton che l’ha nominato consigliere economico come già fece il marito alla Casa Bianca.
Professore, non tutti sono d’accordo sull’effetto domino che un’ipotetica Grexit avrebbe.
«Pensi solo a un aspetto. Draghi ha giocato una carta molto rischiosa proclamando nel 2012 che si sarebbe fatta qualsiasi cosa per salvare l’euro. Finora l’ha vinta ma in caso di Grexit la scommessa sarebbe completamente perduta. La consapevolezza che l’euro non è indistruttibile danneggerebbe irreparabilmente la credibilità della Bce, così come quella dei governanti europei: al primo attacco speculativo gli interessi sui titoli europei schizzerebbero a livelli stratosferici, a partire dai Paesi più deboli come l’Italia. E che ci sarà un attacco, e quindi una crisi che sarebbe molto più profonda delle precedenti, è nella logica delle economie capitalistiche».
È sicuro che ci sia una così diffusa inconsapevolezza?
«Il livello di incoscienza diffuso specialmente in Germania, è spaventoso. C’è chi arriva a dire con nonchalance che i mercati hanno già scontato la rottura dell’euro e perfino che l’uscita della Grecia sarebbe un bene per l’unione monetaria. Mi sembra una follia, pari se non superiore alla cecità con cui fu affrontata la crisi della Lehman Brothers nel settembre 2008, per la quale pure esistevano vistosi segnali premonitori come il fallimento della Bear Stearns nel marzo precedente. Il sistema finanziario americano fu salvato a carissimo prezzo dalle autorità federali, eppure ancora oggi sono aperte le cicatrici di quella ferita. In Europa tutto sarebbe ancora più difficile».
Però almeno converrà che molti Paesi, compresa l’Italia, dall’inizio del decennio si sono rafforzati. O no?
«Certo, hanno fatto riforme strutturali che però per ora, qui sta la debolezza, incidono sul lato dell’offerta: lavoro, pensioni, incentivi alle aziende. Quello che manca è la domanda, tuttora compressa dall’impronta della Germania ossessionata dall’austerity. Anni di sofferenze sembrano non aver insegnato nulla. Si è inseguito l’irraggiungibile traguardo di forzare la Grecia ad arrivare a un surplus primario del 4,5%: ma vi rendete conto? L’Europa ha perso un decennio, e rischia seriamente di perderne un altro finché si dichiara soddisfatta di una crescita dell’1%».
Lei firmò una dichiarazione con l’altro Nobel Amartya Sen in cui sosteneva che l’euro era costruito in modo da non poter funzionare. È sempre della stessa opinione?
«Intendiamoci: credo che oggi, visto che c’è, l’euro vada sostenuto. E spero, nell’interesse degli equilibri mondiali, che la Grecia vi resti dentro. Però la moneta unica così com’è strutturata non può sostenere il bisogno della popolazione di crescere. Finché le energie sono spese nell’affannoso tentativo di mantenerlo in vita, senza che nel contempo si affrontino i nodi veri della crescita, l’euro non è uno strumento di sviluppo. Né mi farei troppe illusioni sul quantitative easing : come già in America, porta a una rivalutazione della Borsa e a un risparmio di interessi, ma i meccanismi di trasferimento all’economia reale sono insufficienti. È l’equivoco della propaganda sulla trickle down economy: dai ricchi una volta che si sono arricchiti “trasuda”, “sgocciola”, qualche beneficio verso il basso. È provato che si tratta di un’illusione e che a guadagnarci sono solo i ricchi stessi e i “potenti” economici».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Mai come ora l’Europa si ritrova ad un bivio: è ormai urgente la scelta tra la grande Europa federale o la disgregazione.31 maggio 2015, di Federico La Sala
Il coraggio che serve per salvare l’Europa
di Guido Rossi (Il Sole-24 Ore, 31 maggio 2015)
Mai come ora l’Europa si ritrova ad un bivio: è ormai urgente la scelta tra la grande Europa federale o la disgregazione.
La fondamentale ambiguità dell’atto di fondazione, dalla quale anche l’attuale bivio deriva, è già presente nel discorso di apertura del primo presidente, Jean Monnet, nell’agosto del 1952, il quale sottolineava che i poteri sovrani rimasti ancora ai governi nazionali avrebbero dovuto passare a un’Europa federale, con competenze sovrane. Nel seguito si sono succedute alterne vicende, privilegiando ora la prevalenza delle forze intergovernative come ai tempi del generale de Gaulle, ora il progetto federalista di integrazione europea durante la presidenza della Commissione da parte di Jacques Delors.
Ma oggi la disgregazione è purtroppo più che mai vicina.
I segni sono molteplici: dal Front National di Marine Le Pen in Francia, che vuole che la Francia abbandoni l’Unione europea e riacquisti completa sovranità, riprendendo il franco in sostituzione dell’euro; ai minacciati referendum del Regno Unito; alla vittoria spagnola di Podemos, che si unisce a quella di Tsipras in Grecia nella feroce contestazione della politica europea di austerità. Quest’ultima ha portato la Grecia in una situazione che, dopo lunghe trattative, è tuttora di incerta soluzione, con la probabile alternativa di un’uscita della stessa Grecia dall’euro e dall’Unione e la prospettiva di un futuro disastroso.
A questi si aggiunga la tendenza di nuovi membri dell’Unione europea ad abbracciare regimi antidemocratici di destra, cui si accompagnano un po’ in tutti gli Stati membri movimenti populisti di chiare tendenze antieuropee, alimentate da una inefficiente politica dell’Unione sul sempre più grave e assillante problema delle migrazioni.
La possibilità di disgregazione è fortemente aumentata con la globalizzazione economica, accompagnata dalla sempre più dirompente finanziarizzazione del capitalismo e dell’economia mondiale.
Orbene, nonostante il mercato unico e la moneta comune, l’Europa è ancora vittima dell’ambiguità iniziale della sua fondazione, che in questo caso si rivela soprattutto nella mancanza di una politica fiscale ed economica europea. Così come è stato introdotto, l’euro è, per tutti i Paesi membri, una moneta straniera, tant’è che né la liquidità monetaria, né il tasso di interesse sono nel loro controllo. La conseguenza è che quando i singoli Stati dell’Unione si ritrovano in deficit devono rivolgersi ai mercati finanziari mondiali, alle loro speculazioni e ai grandi investitori, del tutto indifferenti al futuro dei popoli e delle nazioni.
Ed è così che quando il rapporto tra debito e prodotto interno lordo aumenta, inizia un pericoloso circolo vizioso, nel quale strumenti finanziari derivati aumentano, ad infestare i mercati, per assicurare il credito in caso di fallimento dello Stato debitore; i rating cominciano a declinare e i tassi di interesse a salire, aumentando la crisi del debito. È a questo punto che poi intervengono le politiche di austerità volute dalla “troika”, capeggiata dal Fondo Monetario Internazionale, che impongono riforme sempre più punitive, delle quali la Grecia è vittima esemplare.
Ed è così che, dopo anni di scarsa governance europea, da una Germania unita in un’Europa unita siamo arrivati ad una Germania egemone sul governo dell’Unione e sulla conseguente politica di rigore nei confronti di Paesi membri fortemente indebitati. In un’Europa dunque, sempre meno solidale e più divisa, si aggiunge ora un inquietante paradosso: quello che da tempo riguarda il complesso rapporto della Germania con l’Occidente e in particolare con l’Europa. Il profondo collegamento della Germania con i fondamenti della civiltà europea, alla quale è legata la sua grande cultura, e che ha creato una solida integrazione con l’Occidente, il cosiddetto Westbindung, ha avuto una recente conferma a seguito dell’annessione della Crimea da parte della Russia nel marzo del 2014, unita alle azioni militari della Russia in Ucraina.
Nonostante la dipendenza energetica della Germania dal gas russo e la enorme importanza delle esportazioni tedesche in Russia, Angela Merkel non solo ha approvato l’imposizione di sanzioni alla Russia, ma ha anche persuaso gli altri membri dell’Unione europea a seguirla.
Pur tuttavia, non c’è dubbio che l’attitudine della Germania nei confronti dell’Occidente è spesso stata ambigua. Sull’invasione dell’Iraq nel 2003, il Cancelliere Gerhard Schröder parlò di una “via tedesca” in contrasto con una “via americana”, contro l’uso delle forze militari. E non c’è dubbio che, ad incominciare proprio da Schröder, la Germania ha legato la politica estera ai propri interessi economici, e in modo particolare a quelli relativi all’esportazione.
Al grande balzo delle esportazioni verso la Russia, la quale dal 2013 rifornisce la Germania per quasi il 40% di petrolio e di gas - con una dipendenza energetica praticamente totale - si è aggiunto un incredibile rapporto anche con la Cina, divenuta il secondo maggior mercato delle esportazioni tedesche fuori dall’Unione europea e il più grande mercato per l’industria automobilistica, dalla Wolkswagen alla Mercedes.
Questa situazione ha fatto ricordare la vecchia politica verso Oriente inaugurata da Willy Brandt, e conosciuta come Ostpolitik, diretta a bilanciare lo Westbindung. Il caso più evidente di politica estera orientata alla Ostpolitik è forse quello del voto contrario all’intervento militare in Libia, della Germania, insieme alla Cina e alla Russia, nel 2011 al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove avevano invece votato a favore Francia, Regno Unito e Stati Uniti.
Il pericolo di una disgregazione europea, di fronte alla consistente aggregazione euroasiatica dimostra come anche il paradosso tedesco, che per la Germania comunque è una soluzione possibile, lasci gli altri Stati membri di un’Unione europea disgregata nella totale incapacità di risolvere i loro problemi e di assicurare il loro progresso e controllare il loro futuro.
Anche per la politica italiana una visione europea unitaria diventa quindi prioritaria, rispetto a tutti gli altri problemi. Vale qui la pena di ricordare ancora una volta il Manifesto di Ventotene, nel quale si individuava la federazione europea come garanzia per una politica globale pacifica. «E quando, superando l’orizzonte del vecchio continente, si abbracci in una visione d’insieme tutti i popoli che costituiscono l’umanità, bisogna pur riconoscere che la federazione europea è l’unica garanzia concepibile che i rapporti con i popoli asiatici ed americani possono svolgersi su una base di pacifica cooperazione, in attesa di un più lontano avvenire, in cui diventi possibile l’unità politica dell’intero globo».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- Hanno ucciso Eusebio, un indio Ka’apor che lottava contro la deforestazione dell’Amazzonia nello Stato brasiliano del Maranhã.9 maggio 2015, di Federico La Sala
Hanno ucciso Eusebio che difendeva le foreste per tutti noi
di Isabella Pratesi
 Direttore del programma di conservazione WWF *
Direttore del programma di conservazione WWF *Io saprei a chi dare il prossimo Nobel per la pace. Sono in tanti e ognuno di loro ne meriterebbe uno. Ma essendo persone generose sono sicura che sarebbero disposte a condividerlo, anzi a dedicarlo a quello che più hanno amato in vita: le loro foreste. Credo che nessuno conosca tutti i loro nomi. Vivevano in Brasile, in Perù, in Equador, ma anche in Russia, nel bacino del Congo o nelle foreste del Borneo. Sono quelli che la cronaca chiamerebbe "rappresentanti della società civile". Ma io credo che in vita ciascuno di loro abbia rappresentato molto più.
Sono le persone che con il loro coraggio, con la loro determinazione, ma anche con la loro semplicità, il loro entusiasmo e cocciutaggine, hanno cercato di salvare foreste in ogni angolo del mondo. E che per questo sono state uccise. Assassinate da chi legalmente o illegalmente preda e divora le foreste.
Le foreste sono quell’ecosistema che, proteggendo e formando suolo, acque, aria, rendono possibile la nostra vita su questo pianeta. La distruzione delle foreste porta al cambiamento climatico, al riscaldamento del pianeta, alla perdita di acque dolci disponibili, all’erosione del suolo fertile, alla desertificazione, alla fame, alle alluvioni, a frane e smottamenti.
Ma non solo: la deforestazione distrugge la casa di ben 60 milioni di indigeni che vivono in questi incredibili ecosistemi. Sono migliaia di tribù per cui le foreste sono casa, sono comunità, sono chiesa, sono ospedale e mensa. Il loro presente e il loro futuro è fra quei tronchi, con i piedi nel fango e la testa fra rami, liane, vapori e piogge. E noi, al chiuso delle nostre alienate città, ogni anno divoriamo, bruciamo, rubiamo e vendiamo 13 milioni di ettari di foreste. E poco ci interessa il destino di quei piccoli e grandissimi eroi che cercano di fermare questo possente crimine contro il pianeta e l’umanità.
Pochi giorni fa è stato ucciso Eusébio, un indio Ka’apor che lottava contro la deforestazione dell’Amazzonia nello Stato brasiliano del Maranhã. Prima di lui nella sola Amazzonia è toccata la stessa sorte a centinaia di grandi di piccoli eroi che chiedevano solo il diritto di vivere nelle loro foreste.
Impossibile ricordarli tutti. Ma se solo potessimo fare tesoro della loro lezione, del loro coraggio. Se potessimo scolpire da qualche parte i loro gesti eroici, potrebbe essere utile per ricordarci che quando sarà scomparso l’ultimo indigeno disposto a fermare con le mani nude la distruzione delle foreste, disposto a farsi sparare o massacrare a colpi di machete, saremo tutti infinitamente più poveri. E avremo intorno a noi un mondo in cui molto probabilmente varrà molto meno la pena di vivere.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- L’Expo, il cibo e l’agricoltura italiana (di Piero Bevilacqua)8 maggio 2015, di Federico La Sala
L’Expo, il cibo e l’agricoltura italiana
di Piero Bevilacqua ("comune info", 5 maggio 2015) *
C’è un fondamento storico evidente e apprezzabile nella scelta di dedicare l’Expo italiano del 2015 all’alimentazione e all’agricoltura. La varietà, ricchezza, genialità della nostra cucina sono ormai un’ovvietà da senso comune. E tale fondamento si ritrova anche nella scelta di Milano, che oltre a vantare un prestigio di grande città e la modernità dei suoi servizi, custodisce un passato agricolo di rilievo mondiale. Almeno dal XVIII secolo Milano e la bassa Lombardia hanno visto fiorire una delle più prospere agricolture d’ Europa e del mondo. Come sappiamo, questa grande opportunità, la ricchezza potenziale, culturale e politica di tale scelta, è andata in buona parte compromessa, se non è del tutto fallita.
Certo, in tutte le Esposizioni universali del passato, sia che si tenessero a Londra o a Parigi, lo spettacolo ha avuto sempre una parte preponderante. D’altra parte, si trattava per l’appunto di Esposizioni, cioè delle esibizioni di un capitalismo orgoglioso di mostrarsi a un pubblico internazionale con le sue mirabilia tecnologiche, ma anche nei suoi virtuosismi estetici, incastonati entro mondi urbani in febbrile espansione. L’affanno e il ritardo con cui ci arriva Milano sono lo specchio impietoso di un capitalismo nazionale gravemente usurato nella sua capacità progettuale, corroso all’interno dalla prolungata corruttela che governa da decenni la vita pubblica italiana.
Di sicuro circoleranno nelle giornate milanesi dei prossimi mesi discussioni importanti e serie, contributi alla comprensione della complessa realtà del mondo agricolo e della produzione e distribuzione del cibo. Ma intanto tutti i mesi di preparazione sono già passati sprecando una grande occasione: almeno un ampio dibattito nazionale sulle condizioni della nostra agricoltura, oltre che del nostro cibo, gettando uno sguardo sugli squilibri intollerabili che governano l’architettura mondiale della produzione alimentare.
Un Expo che si occupa del tema di “nutrire il pianeta” non dovrebbe dimenticare che il cibo si ottiene dalla terra e che è la sua mancanza alla base della fame di milioni di famiglie. Quella terra sottratta ai contadini dai possessi latifondistici, come accade in America Latina, dagli scavi minerari e dalle dighe, come accade in India e in Cina, dagli inquinamenti petroliferi, dall’agricoltura industriale, dalla desertificazione, e ora dalle guerre in Africa e in Medio Oriente.
Ma il cuore della discussione avrebbe dovuto essere e dovrebbe ancora essere la ragione storica del primato alimentare italiano. Perché il nostro cibo è cos’ straordinariamente ricco, sapido, inventivo, vario, amato e imitato dappertutto? La risposta è all’apparenza facile e nota. Ma perché esso rispecchia la ricchezza unica e irriproducibile della nostra biodiversità agricola, frutto della varietà straordinaria di habitat naturali della Penisola e di una storia senza possibilità di confronti delle numerosissime comunità agricole che vi hanno operato per millenni. E la manipolazione alimentare delle infinite varietà di piante, di ortaggi, legumi, frutta è anch’essa opera storica del mondo contadino, della creatività popolare.
In Italia come in Europa - lo ha ricordato più volte Massimo Montanari - anche l’elaborazione “alta” della cucina da parte dei cuochi professionali, faceva base sui piatti inventati dai contadini. E dunque l ‘Expo di Milano avrebbe dovuto e dovrebbe ancora porsi il problema fondamentale: quale sorte è riservata oggi ai contadini e ai lavoratori della terra del nostro Paese? Perché dovrebbe essere evidente il paradosso a cui l’Italia certo non sfugge: i contadini, i piccoli agricoltori, i produttori di cibo, quelle figure che alla fine consentono a tutti noi di vivere, che sono ancora oggi la base primaria e imprescindibile delle nostre società, sono i peggio remunerati fra tutti i ceti produttivi esistenti. Spesso sono in condizione di schiavitù sostanziale, come accade ai braccianti agricoli “extra-comunitari” di Rosarno, di Nardò e di altre campagne italiane. Un lato oscuro e vergognoso del made in Italy, denunciato da pochi coraggiosi, tra cui Carlo Petrini.
Tale discussione è drammaticamente urgente non solo per ragioni di giustizia sociale, ma perché è in pericolo anche il nostro patrimonio, quel cibo su cui si regge ancora tanta parte della nostra ricchezza e della nostra identità nazionale. E qui occorre esser chiari. Se noi non assicuriamo ai nostri produttori agricoli una remunerazione dignitosa, se non conserveremo la terra fertile per produrre cibo, noi perderemo in breve tempo la base di biodiversità agricola su cui si è fondata la nostra eccellenza in cucina.
Il made in Italy diventerà una finzione commerciale, un trucco all’Italiana di cui i consumatori internazionali si accorgeranno ben presto. Il processo è già in atto da tempo. Tra il 1982 e il 2010 sono scomparse 1 milione mezzo di aziende dalle nostre campagne. Abbandonano i campi i piccoli produttori e resistono le grandi aziende. E allora occorre chiedersi: è questo il modello di agricoltura che vogliamo? Vogliamo puntare sulle grandi imprese per “produrre di più” riducendo i costi? Dobbiamo addirittura inserire il mais e la soia Ogm nelle nostre campagne, come pretendono taluni scienziati italiani, che hanno tanto a cuore le sorti della loro ricerca, e si curano così poco della storia e delle ragioni della nostra agricoltura?
La sparizione delle piccole aziende tradizionali comporta di necessità una crescente uniformità bioagricola dei prodotti. Su questo abbiamo prove allarmanti. Oggi siamo in grado di misurare gli esiti statistici ed epidemiologici di tale processo omologante dell’agricoltura e dell’alimentazione industriale. Nel rapporto Nuove evidenze nell’evoluzione della mortalità per tumore in Italia, pubblicata nel 2005 dall’Istat e dall’Istituto Superiore di Sanità, si legge: «L’uniformità alimentare ha prodotto un danno alle popolazioni del Sud, che in questi trenat’anni hanno perso un vantaggio di salute che avevano» sul resto della popolazione italiana. L’alimentazione contadina che a lungo aveva protetto i meridionali dall’incidenza del cancro è stata dunque travolta. Un mutamento di paradigma alimentare che li espone alla virulenza cancerogena propria degli stili di vita delle società industriali.
Appare dunque evidente che le sorti dell’eccellenza italiana, il nostro cibo e i suoi infiniti piatti, al di la delle montagne di retorica che si sono sovrapposte sul tema, sono inscindibilmente legate al modello di agricoltura che vogliamo realizzare e in parte conservare. Essa dipende dal destino dei piccoli e medi produttori biologici, dalla loro disponibilità di terra, dalla remunerazione dei loro prodotti, dal premio dato a chi tutela la salubrità delle campagne, protegge il territorio su cui vive e opera, custodisce e restaura il paesaggio del Belpaese.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- AL CENTRO DEL MEDITERRANEO, NAUFRAGIO. Il racconto del sopravvissuto: ’Eravamo 950, in molti chiusi nella stiva’ (di Matteo Guidelli))..20 aprile 2015, di Federico La Sala
Naufragio: ’Eravamo 950, in molti chiusi nella stiva’
Il racconto del sopravvissuto, a bordo 50 bambini e 200 donne
dell’inviato Matteo Guidelli *
CATANIA
"Eravamo in 950. C’erano anche duecento donne e 50 bambini con noi. In molti erano chiusi nella stiva". Sono morti come topi in gabbia. Sono andati giù, in fondo al mare, senza neanche poter provare a salvarsi, ad aggrapparsi ad un pezzo di legno, al braccio di qualcuno. Sono morti senza poter lanciare un ultimo, disperato, urlo.
Non c’è fine all’orrore nel canale di Sicilia. Non c’è fine alla cattiveria dell’uomo. La strage di Lampedusa doveva segnare il punto di non ritorno; il "mai più" che papa Francesco, proprio da quell’isola bella e dannata, lanciò al mondo. E invece è arrivata la strage definitiva: perché è come se in mezzo al Mediterraneo fossero caduti, tutti insieme e nello stesso punto, almeno 6 aerei. Perché di fronte a 700-900 morti, che si vanno ad aggiungere ai 950 dall’inizio dell’anno, qualsiasi parola che non sia ’basta’ suona vuota e inutile. E allora bisognerebbe ascoltarle davvero le parole di chi sopravvive all’orrore.
Eccole, sono di un giovane del Bangladesh che è tra i 28 sopravvissuti: "siamo partiti da un porto a cinquanta chilometri da Tripoli, ci hanno caricati sul peschereccio e molti migranti sono stati chiusi nella stiva. I trafficanti hanno bloccato i portelloni per non farli uscire". Lo sanno tutti che funziona così: sotto ci vanno i paria, i senza diritti, quelli che pagano meno perché hanno meno soldi. Ma anche i più deboli, le donne sole con i bambini. Perché anche tra i disperati c’è chi è più disperato. Chi sta là sotto ha meno di 20 centimetri a disposizione, spesso l’acqua è mischiata con la nafta per consumarne di meno, la notte è nera che più nera non si può. Non ti muovi: muori fermo. A Lampedusa, quando hanno tirato fuori i morti che erano rimasti nella stiva, li hanno trovati ancora accucciati. I bambini abbracciati alle mamme. Ne sono arrivati decine di pescherecci così, con i migranti infilati - letteralmente - dai trafficanti anche tra le macchine. E una barca così è una bomba ad orologeria, basta un movimento sbagliato e non c’è speranza.
Ed è quello che è accaduto. Almeno secondo il racconto del comandante del mercantile portoghese King Jacob che per primo è stato dirottato nella zona. "Stavamo navigando nella loro direzione - ha detto l’uomo ai nostri soccorritori - Appena ci hanno visto si sono agitati e il barcone si è capovolto. La nave non lo ha urtato, si è rovesciato prima che potessimo avvicinarci e calare le scialuppe".
In quei momenti era già tutto compiuto. Chi ha potuto, chi era sul ponte, ha gridato, ha tentato di aggrapparsi a qualcosa. qualsiasi cosa. Ma in molti non hanno neanche capito quel che stava accadendo. Chi era nella stiva ha sentito solo il rumore sinistro del legno marcio che si frantuma e ha visto l’acqua entrare tutt’assieme, fredda e assassina. E poi il silenzio della morte. "C’è soltanto nafta e detriti, pezzi di legno che vanno alla deriva e qualche salvagente. Non troviamo più nulla dalle 10 di questa mattina" racconta uno di quelli che da 20 ore sta disperatamente cercando di salvare qualcuno.
In zona sono stati dirottati anche diversi pescherecci. In uno di questi c’era il comandante Giuseppe Margiotta. "Ci hanno chiamato dalla centrale operativa e ci hanno chiesto di mollare la pesca e di andare a salvare delle persone. E noi come sempre, non ci siamo tirati indietro. Ma di vivi non ne abbiamo visti. Abbiamo trovato quattro cadaveri e abbiamo atteso le autorità che arrivassero per prenderli". Ma forse qualcun altro vivo c’è ancora. "Non se ne trovano più vivi - dice il comandante - sono andati tutti sotto. Magari c’è ancora qualcuno aggrappato a qualcosa, ma quanto vuoi che resista".
Quando arriva il buio ti devi fermare per forza, non puoi più cercare. "Ogni volta speri. Speri di salvarne almeno uno - ti dice uno di quelli che nel canale di Sicilia a salvare migranti ci sta da dieci anni - E quando dopo venti ore che guardi il mare hai gli occhi che ti bruciano e non sei riuscito a vederne neanche uno, puoi soltanto piangere. Lo sai che sono tutti in fondo al mare, anche se non ci vuoi credere". E’ vero, non ti ci abitui mai. A metà mattina hanno recuperato un ragazzino, avrà avuto tra i 10 e i 15 anni al massimo. Era a faccia in giù, in mezzo ad una chiazza di nafta. Lo hanno preso con quanta più delicatezza fosse possibile. Per concedergli almeno un ultimo istante di dignità.
* ANSA, 20 aprile 2015 (ripresa parziale).
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- NAUFRAGIO. L’Italia e il rapporto con l’Europa (di Paolo Pombeni)20 aprile 2015, di Federico La Sala
L’Italia e il rapporto con l’Europa
di Paolo Pombeni (Il Mulino, 20 aprile 2015)
Con l’ennesima tragedia di migranti annegati nel canale di Sicilia si ripropone il tema, delicatissimo, del rapporto del nostro Paese con l’Unione europea. Rilevare l’inefficienza di Bruxelles sulla questione del governo dei flussi migratori che dalle zone di guerra limitrofe si riversano sul nostro continente è come sparare sulla Croce Rossa. Peraltro, nel contesto attuale aspettarsi che l’Unione sia in grado di rispondere seriamente a questa emergenza è piuttosto difficile.
Lo scatenarsi di pulsioni populiste di fronte al timore sempre più generalizzato che siano irreversibilmente finiti i famosi anni biblici delle vacche grasse è osservabile ovunque. In Italia non siamo affatto immuni da questo contagio, anzi dobbiamo sopportarlo in diretta, perché è sulle nostre sponde che si dirige la gran parte dei flussi migratori.
La domanda allora è: ma noi siamo in grado di reggere questa pressione, innanzitutto dal punto di vista psicologico? Il dubbio è notevole, non solo perché si tratta dei tipici fenomeni dai contorni oscuri e con la caratteristica di far presagire capovolgimenti epocali,ma perché abbiamo un sistema politico in gravi difficoltà nel produrre un potere di governo. Parliamo ovviamente di qualcosa di più della semplice esistenza di un “esecutivo”. Con un linguaggio tradizionale si dovrebbe dire che di fronte a eventi tragici (e il grande esodo di popolazioni verso l’Europa lo è) è necessaria una “solidarietà nazionale”. Solo questa può rendere il Paese autorevole a livello internazionale e può trasmettere fiducia all’interno dei propri confini.
Ci sembra difficile vedere nella situazione attuale le caratteristiche di una, sia pur blanda, “solidarietà nazionale”. Non è tanto questione dello sciacallaggio dei populismi, siano quello di Salvini o quello di Di Battista: sono fenomeni inevitabili in sé, il problema è solo quello di confinarli in un ambito circoscritto. Il tema vero è la debacle dei tradizionali partiti di governo, sia del Pd che di FI, cioè delle due componenti che si sono succedute alla guida dell’esecutivo negli ultimi vent’anni.
Entrambi i partiti sono avviluppati in lotte di fazione che impediscono ai loro gruppi dirigenti di elaborare una seria politica condivisa verso l’Unione europea. Le due situazioni sono certo differenti fra loro. Forza Italia in questo momento non ha neppure un vero vertice politico, essendo Berlusconi un fantasma che appare e scompare senza incidere (il suo annuncio di disponibilità a collaborare col governo è passato quasi inosservato), mentre il suo gruppo dirigente è ridotto ad alcuni pretoriani impegnati più che altro a evitare di essere travolti dalla crisi generale.
Nel Partito democratico una leadership c’è, ed è anche forte, ma è costretta continuamente a una politica muscolare per affermare la sua primazia contro una minoranza il cui unico scopo sembra essere quello di azzoppare il premier-segretario. Mentre, infatti, incombe la tragedia dell’immigrazione, c’è alle porte un delicato dossier con la Grecia, siamo testimoni di uno sconvolgimento endemico sulle sponde africane e mediorientali del Mediterraneo, sembra che il destino della democrazia sia legato a tecnicalità della legge elettorale come capilista bloccati e spazio da dare alle preferenze.
Davvero si pensa che uno spettacolo del genere possa metterci in grado di farci ascoltare in Europa e nel mondo?
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- EMERGENZA XYLELLA. Puglia, 27 aprile Consiglio regionale straordinario. Partecipano commissario Silletti ed esperti scientifici.16 aprile 2015, di Federico La Sala
Puglia, 27 aprile Consiglio regionale straordinario
Partecipano commissario Silletti ed esperti scientifici *
(ANSA) - BARI, 16 APR - Sarà convocato lunedì 27 aprile il Consiglio regionale straordinario e monotematico sull’emergenza xylella, allargato alla partecipazione del commissario Giuseppe Silletti, al professor Donato Boscia, dell’Istituto di virologia del CNR di Bari e di esperti dell’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. "Sarà l’occasione - afferma in una nota il presidente del consiglio regionale pugliese, Onofrio Introna - per approfondire dal punto di vista scientifico un problema allarmante, che ha investito la nostra agricoltura e assunto una rilevanza internazionale, dopo la chiusura delle frontiere francesi ai vegetali pugliesi". Introna ha raccolto le "giustificate sollecitazioni pervenute anche nell’ultima seduta consiliare sulla necessità di un confronto articolato sulla diffusione della patologia che sta penalizzando agricoltori, vivaisti e l’intero settore dell’olivicoltura".
Non si parlerà solo di iniziative del governo regionale - con gli interventi del presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola e dell’assessore regionale alle Risorse agricole Fabrizio Nardoni - e di embargo transalpino, ma verranno illustrati anche i provvedimenti emergenziali e le misure di profilassi e di prevenzione dell’epidemia del disseccamento rapido degli ulivi, causato dal batterio della xylella fastidiosa, veicolato da insetti vettori.
Da qui l’invito rivolto da Introna al commissario straordinario del Governo nazionale, Giuseppe Silletti, a spiegare le azioni poste in essere contro il focolaio epidemico e al professor Boscia, ad offrire un contributo tecnico-specialistico.
Con una nota indirizzata alla sede dell’Efsa a Parma, il presidente del Consiglio regionale ha inoltre chiesto "di autorizzare la partecipazione di un rappresentante dell’agenzia, per assicurare al confronto in Aula il supporto delle conoscenze avanzate dell’Autorità europea che esercita per gli Organi UE un autorevole ruolo di consulenza scientifica in materia fitosanitaria e di qualità dei prodotti agroalimentari".(ANSA).
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- EMERGENZA XYLELLA. "Le proteste non fermeranno il taglio degli ulivi", il commissario gela gli ambientalisti (di Chiara Spagnuolo)16 aprile 2015, di Federico La Sala
"Le proteste non fermeranno il taglio degli ulivi", il commissario gela gli ambientalisti
Silletti nei campi di Ugento per verificare le operazioni di aratura, fresatura e pulizia dei terreni che so stanno svolgendo in occasione del "Buonepraticheday"
di CHIARA SPAGNOLO (la Repubblica, 16 aprile 2015)
"il Piano sarà applicato in ogni parte, anche nelle eradicazioni, la scienza mi dice che queste sono le operazioni da intraprendere e io farò rispettare la legge": è categorico il commissario straordinario per l’emergenza xylella, Giuseppe Silletti, intervenuto al Buonepraticheday a Ugento. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato "La voce dell’Ulivo" e sponsorizzata anche dal ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, nei giorni scorsi. In campo decine di trattori - nel territorio di Ugento e di altri 60 comuni salentini - per mettere in campo le operazioni di aratura, fresatura e pulizia dei terreni, che il Piano impone debbano essere fatte entro fine aprile. "Con le buone pratiche si diminuisce la popolazione della sputacchina, che è il vettore della xylella fastidiosa e dunque si può limitare l’inoculo", ha spiegato Federico Manni della Voce dell’Ulivo, mentre l’assessore all’Agricoltura di Ugento, Daniela Specolizzi, ha chiarito che nel suo paese "la gente si è mobilitata appena siamo stati allertati, perché l’olivicoltura rappresenta la base fondante della nostra economia".
Presente nei campi anche il vescovo della Diocesi Ugento Santa Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli, il quale ha invitato "la scienza e le istituzioni ad ascoltare le voci del territorio e a tenere conto della sensibilità della gente". La stessa che sta portando da martedì decine di ambientalisti a presidiare le aree di potenziale eradicazione nel Nord Salento. Il presidio a Veglie è andato avanti per tutta la notte e continuerà ad oltranza, con l’obiettivo di impedire i tagli. Le eradicazioni, però, ha assicurato il commissario si faranno, probabilmente con un uso più massiccio di forze dell’ordine, al fine di garantire l’ordine pubblico, dopo la giornata calda di Oria: "saranno il prefetto e il questore a valutare cosa sarà necessario, di sicuro andremo avanti, io sto seguendo la legge".
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- XYLELLA (2014). Oltre a misure d’emergenza, una rivoluzione culturale e colturale!!!17 aprile 2015, di Federico La Sala
Per combattere efficacemente Xylella fastidiosa, oltre a misure d’emergenza, potrebbe quindi servire una rivoluzione culturale e colturale che rivaluti le buone pratiche agronomiche e di gestione degli oliveti, specie quelli secolari.
La Xylella potrebbe anche non essere così fastidiosa, da sola *
Sempre più insistenti i dubbi che Xylella fastidiosa, da sola, sia capace di provocare il disseccamento, così repentino e virulento, di interi areali olivicoli. Xylella è effettivamente un batterio particolarmente pericoloso, incluso nella lista Eppo A1 dal 1981, ma probabilmente già presente nell’ecosistema mediterraneo da anni.
Vi è poi stato un “miracoloso” recupero di alcuni degli olivi situati nella zona rossa, ovvero quella di massimo contagio, dove si prevedeva che l’unica possibilità fosse l’eradicazione. Alcune piante hanno ripreso a vegetare e a fare succhioni, anche nelle zone apicali della chioma.
Vero è che Xylella fastidiosa è un batterio xilematico. Il danno è l’interruzione del flusso di acqua e nutrienti nei vasi della pianta, provocandone il disseccamento. E’ quindi probabile che il fenomeno verificato in campo non sia altro che una reazione della pianta a questa invasione. Dopo lo shock iniziale, che ha portato gli olivi a perdere le foglie e, apparentemente, a disseccarsi, la pianta può aver reagito utilizzando i vasi xilematici non ancora “invasi” dal batterio. Il processo di infezione, infatti, può durare mesi e persino anni. Resta da capire se la pianta possa sviluppare processi di difesa naturali già conosciuti per altri patogeni, in maniera da isolare Xylella senza far procedere ulteriormente l’infezione nei nuovi tessuti che andrà a sviluppare.
In aiuto ci viene un recente studio delle Università di Foggia e di Firenze, pubblicato su Phytopatologia Mediterranea. L’indagine è stata condotta sia nelle zone del focolaio, quindi nel leccese, sia in altre aree (Cerignola, Foggia, Canosa di Puglia e Andria) dove sono stati riscontrati sintomi simili: disseccamenti dei rami e necrosi delle foglie.
Lo studio ha verificato che, nella piante colpite, non solo fosse presente il famigerato batterio Xylella fastidiosa ma anche tre funghi: Phaeoacremonium aleophilum, Neofusicoccum parvum, e Pleurostomophora richardsiae.
I risultati di questa ricerca sono particolarmente interessanti se correlati con l’andamento climatico delle ultime annate agrarie, particolarmente favorevole proprio allo sviluppo di funghi, ovviamente anche patogeni. E’ inoltre noto che piante poco curate e in stress nutrizionale possono essere più facilmente attaccate proprio da batteri patogeni e funghi.
Per combattere efficacemente Xylella fastidiosa, oltre a misure d’emergenza, potrebbe quindi servire una rivoluzione culturale e colturale che rivaluti le buone pratiche agronomiche e di gestione degli oliveti, specie quelli secolari.
* Da Teatro Naturale, 12/03/2014 (ACCADEMIA DEI GEORGOFILI)
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- EMERGENZA XYLELLA. Secondo rapporto - L’Efsa, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, non scioglie i dubbi (di Francesca Mandese)17 aprile 2015, di Federico La Sala
Xylella, l’Efsa non scioglie i dubbi. sul disseccamento degli ulivi
Pubblicato il secondo rapporto chiesto dalla Commissione Europea
di Francesca Mandese (Corriere del Mezzogiorno, 17.04.2015)
LECCE - L’Efsa, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, ha da poco pubblicato il rapporto chiesto dalla Commissione Europea sulla Xylella fastidiosa. Un parere che non scioglie i dubbi sulle cause del disseccamento rapido dell’ulivo che sta interessando la zona del Salento. Il rapporto sarà esaminato dalla Commissione Europea alla fine di questo mese e sulla base di esso sarà anche valuta la congruità delle misure messe in campo dall’Italia per affrontare il problema.
La sintesi
Ed ecco il testo integrale della sintesi del rapporto dell’Efsa: «Non esiste al momento alcuna evidenza scientifica che comprovi l’indicazione che alcuni funghi, piuttosto che il batterio Xylella fastidiosa, siano la causa primaria della sindrome del disseccamento rapido degli ulivi osservata in Puglia, nel sud dell’Italia. È questo l’esito principale di un’analisi condotta dall’EFSA sulla scorta di nuovi studi e di altre informazioni trasmesse all’Autorità.
Non vi è inoltre alcuna evidenza pubblicata in letteratura scientifica che il trattamento della malattia fungina riduca l’insediamento, la diffusione e le conseguenze della Xylella, benché una corretta gestione del campo sia generalmente benefica per la salute delle piante.
Gli studi esaminati dall’EFSA rilevano che i funghi tracheomicotici sono spesso associati all’avvizzimento dell’olivo e potrebbero essere coinvolti nella sindrome del disseccamento rapido dell’ulivo. La ricerca, tuttavia, non stabilisce né dimostra che tali funghi siano la causa primaria del declino degli ulivi.
Nella sua valutazione dei rischi da X. fastidiosa pubblicata a gennaio 2015 l’EFSA ha affermato che gli olivi malati “erano generalmente colpiti da un insieme di organismi nocivi comprendenti X. fastidiosa, diverse specie fungine appartenenti ai generi Phaeoacremonium e Phaemoniella nonché Zeuzera pyrina (falena leopardo)”. I nuovi studi, assieme ad altre evidenze disponibili, suffragano tale affermazione.
La Commissione europea ha chiesto all’EFSA di esaminare gli studi scientifici dopo che essi erano stati citati per suffragare l’ipotesi che i funghi tracheomicotici e non la X. fastidiosa fossero la causa principale del declino degli ulivi in Puglia. Oltre a esaminare le nuove evidenze e rivisitare studi utilizzati per la loro valutazione del rischio di gennaio, gli esperti EFSA in salute dei vegetali hanno tenuto una riunione tecnica con uno degli autori degli studi per accertarsi di averne compreso appieno i risultati».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- PUGLIA. “I Partigiani dell’Ulivo” e la Xylella: perché è urgente cambiare strategia. Che Resistenza sia! (di Antonia Battaglia)20 aprile 2015, di Federico La Sala
Xylella, perché è urgente cambiare strategia di Antonia Battaglia *
Nel Salento si voleva tagliare, un mese fa, un milione di ulivi, malati, secondo la Regione Puglia e il CNR di Bari, di Xylella fastidiosa. Nel frattempo Peacelink, con Spazi Popolari e le altre associazioni salentine, ha fatto pervenire alla Commissione Europea gli studi sul ruolo svolto dalle concause della malattia da disseccamento (Funghi e Zeuzera Pyrina). Un parere diverso rispetto alla tesi sostenuta dalla Regione, convinta sempre di più che in Puglia si tratti solo ed esclusivamente di Xylella, quale agente unico della malattia.
Il Presidente Vendola, che non ha mai visitato gli uliveti curati e guariti dagli agricoltori salentini, sentenzia che i cosiddetti “santoni” farebbero meglio a non contrastare la scienza ufficiale, ovvero solo e soltanto quella del CNR di Bari. La gestione della ricerca sulla malattia, infatti, sembra essere appannaggio esclusivo dell’establishment barese quando altri centri, come l’Università di Foggia, sembrano dare indicazioni scientifiche differenti.
Eppure la Xylella fastidiosa salentina che ha fatto scattare l’allarme europeo di quarantena, lanciato dall’Italia, non è dello stesso ceppo della Xylella fastidiosa (Well e Raju) già conosciuta in California, di cui si parla nella direttiva europea 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Il protocollo con l’obbligo di quarantena della Xylella è stato scritto sulla base dell’osservazione solo della sua patogenicità su vite e agrumi (Protocollo EPPO, Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante, “Norme EPPO PM7/24”, pag.188 e seguenti) e secondo logica andrebbe immediatamente rivisto in base alla malattia degli ulivi, alla luce del ruolo dei funghi e della cura degli alberi che avviene con successo!
Il ceppo della Xylella pugliese (subspecie pauca, ceppo CoDiRo) è pertanto diverso da quello regolamentato dall’UE, che invece è stato studiato su vite e agrumi. La Xylella salentina attacca solo l’ulivo e non è stata mai riscontrata su agrumi e vite, come scritto nelle stesse “Linee Guida Xylella CoDiRo, Regione Puglia”. EFSA conferma nel suo nuovo rapporto che “il genotipo della Xylella presente in Puglia è una nuova variante genetica della sottospecie pauca”, trovato su una serie di piante ma non su vite e agrumi. Di conseguenza, il regolamento europeo andrebbe adattato con flessibilità in considerazione del fatto che è un ceppo di Xylella diverso.
Oltre agli studi su funghi e altre con-cause, sono necessari studi mirati e approfonditi su questo specifico ceppo della Xylella salentina! Ci vuole un cambio di paradigma immediato nella strategia messa in atto in seno all’UE.
A conferma di tutto ciò, e cioè dell’insensatezza di un piano di taglio indiscriminato, c’è l’accorato e coraggioso appello lanciato con una lettera dal Professor Pietro Perrino, Dirigente di Ricerca del CNR di Bari, al Presidente Vendola, in cui si dice che “è difficile pensare che (il disseccamento, ndr) possa essere risolto con l’abbattimento degli alberi affetti e ancora peggio che possa essere utile lo sradicamento di piante sane per creare un cordone intorno alle aree focolaio. Entrambi i provvedimenti sono sbagliati. Nel primo caso perché le piante malate possono essere risanate e nel secondo perché si distruggerebbero piante sane”.
Ancora una volta, quindi, l’approccio migliore sembrerebbe quello che gli agricoltori e le associazioni salentine suggeriscono, ovvero quello agro-ecologico. “Gli studi osservazionali” - continua Perrino - “suggeriscono che le cause risiedono in un tipo di agricoltura che per decenni è stata caratterizzata da un uso eccessivo di concimi chimici, pesticidi, antiparassitari e di erbicidi, aventi come obiettivo quello di aumentare le produzioni”.
E’ urgente che la Regione, il Governo Italiano e di conseguenza la Commissione Europea cambino posizione, adesso, subito, concentrando tutti i loro sforzi su nuovi studi e analisi, e sulla sperimentazione in campo.
Se si tratta di un ceppo diverso di Xylella, e, se come dicono l’Università di Foggia e l’EFSA, è fondamentale capire il ruolo svolto dalle concause, perché la Regione continua a ignorare gli agricoltori che hanno curato e continuano a curare le piante con successo e quelle voci della scienza che credono sia urgente studiare le concause per definire una terapia adatta alla complessità del fenomeno?
Regione e Ministero sono responsabili della posizione di grandissimo caos creato a Bruxelles, avendo parlato prima della necessità di un taglio di un milione di ulivi, poi di “soltanto” 35.000 e infine di 10.000, senza aver ancora in mano nessun test di patogenicità né risposte sulle con-cause dell’infezione.
Ci sono altri 27 paesi in attesa di capire cosa accade in Puglia, ma, nonostante l’apertura creata presso la Commissione Europea da Peacelink con gli studi dell’Università di Foggia e con l’azione delle associazioni del Salento, le Istituzioni Italiane hanno continuato ad affermare la necessità dei tagli, l’urgenza del contenimento della malattia, la richiesta di indennizzi sulla base di nessuna certezza scientifica. Infatti, anche laddove fosse dimostrata la presenza della Xylella in alcuni ulivi, non ci sono certezze in merito al ruolo primario o meno svolto dalle concause, né sull’efficacia dei tagli per contenere un’eventuale epidemia.
Il ruolo che hanno svolto e che saranno chiamati a svolgere i rappresentanti istituzionali italiani influenzerà enormemente le prossime decisioni della Commissione Europea. Mentre il Ministro Martina festeggia il cibo italiano alla kermesse dell’EXPO di Milano, egli stesso sostiene posizioni in Puglia che poco hanno a che fare con la protezione dell’agricoltura e dell’olio d’oliva pugliese.
Il Presidente Vendola sembra invece stizzito, impaurito, parla di “diffamazione a danno del governo regionale”, un film già visto a Taranto. Ci deve essere una ragione se un’intera popolazione si muove contro le sue Istituzioni.
“I Partigiani dell’Ulivo” con le loro ronde sul campo, di giorno e di notte, rimandano indietro motoseghe, camion e rappresentano la vera grande novità di questa primavera pugliese. Chiusi nelle loro stanze i politici, impermeabili alle migliaia di voci che si levano da tutta la Regione, stizziti dall’azione degli agricoltori e di Peacelink a Bruxelles, pronti a banalizzare piuttosto che ad aprire al contatto sul campo con gli agricoltori e alla ricerca più ampia d’istituti italiani e internazionali.
Sembrerebbe che la Regione e il Governo si siano messi dalla parte della Francia, dalla parte dei concorrenti, dalla parte di chi la Puglia la vuole vedere in ginocchio. Sostengono posizioni che porteranno alla fine la Commissione e gli altri 27 Paesi a credere che non ci sono vie alternative al taglio degli alberi e all’utilizzo massiccio di pesticidi, che vengono chiamati “fitofarmaci” per fare meno grave.
È urgente, alla luce di questa incertezza messa in campo nuovamente dall’EFSA, che la comunità scientifica internazionale si adoperi con urgenza per accelerare e moltiplicare gli studi sia in laboratorio che in campo, secondo un approccio pluralistico che incoraggi e finanzi istituti diversi affinché proseguano e affinino le ricerche, sottopondendole al più presto alla “peer review” internazionale.
Tali ricerche devono anche verificare i risultati positivi ottenuti dagli agricoltori salentini, ripetendo sotto rigorosa osservazione scientifica, e corroborando e sistematizzando, i metodi di cura utilizzati in alternativa all’estirpazione degli alberi infetti e ai piani ormai inattuabili di eradicazione totale del batterio.
Prima di prendere decisioni che avrebbero conseguenze irreversibili sull’ecosistema della Regione Puglia e sul suo futuro è fondamentale acquisire una conoscenza più vasta ed approfondita del ruolo svolto dai diversi agenti infestanti.
Occorrerebbe moltiplicare le iniziative come quella di COPAGRI, che coordina e finanzia la ricerca e la sperimentazione sul campo svolte dall’Università di Foggia insieme all’Università del Salento.
La Resistenza degli Ulivi è una pagina importante della storia della nostra Regione e del nostro Paese. Essa non riguarda solo il Salento ma è simbolo di resistenza di un popolo intero, che parte da Lecce e tocca Taranto, Brindisi, il Gargano, la Puglia tutta, contro l’approccio autoritario che esclude i cittadini dal poter intervenire direttamente in questioni fondamentali della loro vita e del loro futuro.
Che Resistenza sia!
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- PUGLIA: LECCE. Inchiesta Xylella, nessuna emergenza. Motta: “Batterio in Salento da almeno 15 anni, Ue tratta in errore da dati impropri”.19 dicembre 2015, di Federico La Sala
Inchiesta Xylella, nessuna emergenza. Motta: “Batterio in Salento da almeno 15 anni, Ue tratta in errore da dati impropri”
di Cinzia Ferilli (Il Paese Nuovo, dicembre 19, 2015)
LECCE - La xylella è presente in Salento da almeno 15-20 anni, per questo non è possibile parlare né di emergenza nè di necessità di misure da quarantena. Inoltre non è certo che vi sia un nesso causale tra il batterio e l’insorgenza del Co.Di.Ro.
Ruota intorno a questi presupposti l’inchiesta della Procura di Lecce che ieri a distanza di oltre un anno e mezzo dall’apertura ha condotto ad un clamoroso sviluppo: l’iscrizione nel registro degli indagati di 10 persone, tra ricercatori e studiosi legati alla vicenda, tra cui spicca il nome del commissario straordinario del governo, Giuseppe Silletti. A spiegare il percorso che ha condotto a tali provvedimenti e al sequestro preventivo d’urgenza degli ulivi oggetto dell’ultima ordinanza di eradicazione emessa, datata 16 dicembre, è stato questa mattina il Procuratore della Repubblica di Lecce Cataldo Motta, che insieme ai sostituti procuratori Elsa Valeria Mignone e Roberta Licci, ha firmato gli atti che hanno scatenato la bufera sul caso xylella. Gli indagati dovranno rispondere di violazione delle disposizioni in materia ambientale, falso materiale e ideologico commesso da pubblico ufficiale, getto pericoloso di cose, distruzione di bellezze naturali. Tutti reati ipotizzati come colposi.
L’inchiesta si basa sul fatto “che non è stato accertato il nesso di causalità tra il complesso del disseccamento rapido degli ulivi e l’insorgenza della xylella fastidiosa” poiché i periti che hanno supportato l’attività investigativa della Procura hanno accertato la presenza di ulivi in perfetto stato di salute che erano però risultati positivi alla xylella e, al contrario, di attigui alberi secchi su cui non è risultata la presenza del batterio. Ma c’è di più.
Gli approfondimenti hanno permesso di accertare la presenza in Salento di ben 9 ceppi diversi di xylella, indice questo di una mutazione del batterio, processo che richiede tempi molto lunghi. Cosa che “ha condotto ad escludere una diffusione recente del batterio, bensì retrodatata. Non si può stabilire con precisione a quando risalga ma di certo non è più recente di un periodo orientativo di 15/20 anni” ha spiegato Motta. Non ci sarebbero, dunque, i presupposti per dichiarare la diffusione della xylella fastidiosa in Salento come un’emergenza, la quale si fonda su presupposti di insorgenza temporali e spaziali ben precisi: apparizione improvvisa in zone limitate di un patogeno mai esistito su quel territorio. Per la xylella fastidiosa, invece, non sarebbe stato così, in base a quanto emerge dalle indagini.
Pertanto “è esclusa la necessità di un intervento rapido e tempestivo poiché non siamo in presenza di una situazione di emergenza che comporti le misure legate alla quarantena” ha aggiunto Motta. Gli abbattimenti delle piante, nello specifico, risulterebbero dunque dei provvedimenti troppo aggressivi ed inutili a debellare un patogeno già radicato da tempo sul territorio. A condurre a queste misure sono state delle rigorose direttive europee emesse però sulla base di una “falsa rappresentazione di della situazione”.
Il ruolo dell’Unione Europea viene chiarito dal procuratore: “L’Ue è stata tratta in errore da quanto è stato rappresentato a sua volta basato su dati impropri ed inesatti” che facevano intendere si trattasse di una diffusione recente. Da questo presupposto a catena si sarebbero creati una serie di visioni errate della situazione, che avrebbero condotto a provvedimenti stringenti. Tutto però resta da accertare.
“L’indagine non è compiuta” ha specificato il procuratore, poiché gli accertamenti proseguiranno e potrebbero ampliarsi anche ad altri aspetti della vicenda come quello sulle modalità di concessione e utilizzo dei finanziamenti pubblici. Inoltre Motta ha spiegato che i tempi d’attesa trascorsi prima che si potessero avere dei risultati sono stati lunghi in quanto “si è scelto di procedere con cautela a causa della difficile materia su cui si andava ad indagare”.conferenza motta ambientalisti
Riguardo al coinvolgimento del commissario Silletti, il procuratore ha spiegato: “Silletti è indagato a causa della sua esperienza specifica. Probabilmente ci sono stati anche lì degli errori dovuti alla mancata conoscenza completa della situazione, ma resta tutto da valutare”. Infine la magistratura leccese richiama alle sue responsabilità anche il mondo scientifico: “Se ci fosse stata maggiore collaborazione e confronto nel settore si sarebbe dato il via a teorie migliori e ad accertamenti più specifici in modo tale da capire precisamente cosa si andava a combattere e come correttamente si doveva farlo”.
Enorme soddisfazione per questo improvviso e clamoroso risvolto dell’inchiesta è stato espresso dagli ambientalisti e dagli attivisti che da tempo speravano in questo risultato. Alcuni di loro hanno raggiunto la procura di Lecce in mattinata per ringraziare di persona i sostituti procuratori Elsa Valeria Mignone e Roberta Licci per il lavoro svolto, mostrando loro un cartello con scritto “C’è un giudice a Lecce, anzi due. Grazie”, e il procuratore Cataldo Motta per aver bloccato il taglio degli ulivi fermando il Piano Silletti.
-
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- XYLELLA. Strage degli ulivi in Puglia, una follia tutta italiana (di Antonia Battaglia).16 aprile 2015, di Federico La Sala
Strage degli ulivi in Puglia, una follia tutta italiana
di Antonia Battaglia *
In visita a Lecce qualche giorno fa, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali non ha perso tempo ad indicare l’intenzione del Governo di chiedere lo stato di calamità naturale per il Salento. Avanti tutta con il cosiddetto “piano Silletti”, che prevede l’abbattimento di migliaia di alberi per combattere il batterio della Xylella fastidiosa, del quale, fino al momento, non vi è prova scientifica di patogenicità sugli alberi di ulivo in Puglia.
Il Ministro Martina, assieme alla Regione, ha invitato da Lecce gli agricoltori ad arare le proprie terre, concludendo poi che in effetti non si taglierà un milione di ulivi, ma forse “solo 35.000”. Cifra poi smentita dallo stesso Commissario Silletti, che ha parlato di un monitoraggio in corso, di potature e sfrondature.
Sembra, pertanto, che la questione Xylella sia dominata in ambito istituzionale dal caos, da un rincorrersi di stime, cifre, metodiche, minacce. L’Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari ha dichiarato che se sarà necessario, ci saranno multe per chi non avrà arato i campi e ha affermato che “santoni e pseudo-ambientalisti, (sono) gli unici che veramente speculano sulla questione Xylella”.
Andiamo per punti. L’allarme europeo di quarantena da Xylella fastidiosa viene lanciato dalla Regione Puglia, certa che il disseccamento rapido degli ulivi nella Regione sia causato dal batterio e che tale batterio possa quindi diffondersi altrove sul continente. La Commissione Europea, di conseguenza, lancia un allarme da quarantena nonostante l’EFSA (European Food Security Agency) si fosse già espressa in maniera molto mitigata sulla questione. Il pressing che viene però dall’Italia è molto forte e convinto, e quindi si adotta la misura di quarantena.
Peacelink, per conto delle associazioni salentine riunite attorno all’Associazione Spazi Popolari, interviene in Commissione, apportando al dibattito le risultanze di ulteriori studi, che evidenziano come la Xylella potrebbe non essere la prima causa di malattia degli ulivi pugliesi, ma semplicemente una concausa o comunque un agente tra altri, riscontrato, dopo l’effettuazione di analisi, NON su tutti gli alberi affetti da disseccamento.
Studi realizzati dall’Università di Foggia, dall’Università della California nel 2014, pareri scientifici e diverse testimonianze in arrivo da numerose parti del mondo concordano nel sottolineare che la causa prima della malattia potrebbero essere i funghi. Il direttore dell’EFSA risponde a Peacelink con una lettera del 1 aprile 2015, dichiarando clamorosamente che ad EFSA non è mai stato chiesto uno studio sulla eziologia della malattia, quindi sul rapporto causa-effetto del disseccamento rapido degli ulivi.
Dopo l’intervento di Peacelink, la Commissione Europea ha invitato l’EFSA a fornire un ulteriore urgente parere sulla questione, al fine di discuterne al prossimo Consiglio Europeo Agricoltura e di prendere una decisione per fine aprile, quando si riunirà il Comitato sulla Salute delle Piante.
Quindi, ancora adesso, non ci sarebbe nessuna certezza scientifica sulla causa della malattia degli ulivi, come invece la Regione Puglia ha dichiarato sin dall’inizio e come sostengono le azioni che vengono messe di nuovo in campo da Regione stessa e Ministero.
Quello che appare singolare, di nuovo, è il fatto che Governo e Regione si apprestino a preparare un decreto legge per la dichiarazione dello stato di calamità naturale senza avere la certezza scientifica che si tratti di Xylella.
Ci sono state centinaia di voci che si sono levate, in queste settimane, contro l’abbattimento degli alberi, ma la Regione ha messo in campo un comportamento molto aggressivo, ottuso, chiuso nella propria decisione di continuare sulla strada dello sradicamento degli alberi.
Coldiretti, sin dall’inizio primo sostenitore della necessità dell’abbattimento immediato, in questi giorni ha sprecato parole durissime nei confronti della Francia, la quale ha bloccato l’importazione di poco più di un centinaio di piante dalla Puglia. Misura esagerata, dice Coldiretti, tuttavia “molto utile” per sostenere l’urgenza dello stato di calamità naturale.
La misura adottata dalla Francia è fuori dubbio eccessiva ma essa è conseguenza diretta dell’allarme lanciato dalla Regione Puglia e dal Ministero, che continuano a dichiarare urbi et orbi la pericolosità della Xylella per tutto il settore agricolo.
La Puglia, così facendo, si elimina da sola dal mercato mondiale, grazie alla miopia della propria classe politica e agli interessi spiccioli di una parte di essa che, probabilmente pressata dalla necessità di dover portare a casa un risultato propagandistico a fini elettorali (vedi prossime elezioni regionali del 31 maggio), si getta a capofitto in una storia dai contorni così tanto fumosi che la Magistratura di Lecce continua ad indagare a ritmo serrato.
E’ difficile immaginare che la Francia, per esempio, dichiarerebbe mai lo stato di calamità naturale nella regione del Bordeaux, laddove ci fosse un qualche rischio di patologia vegetale, mettendo a repentaglio le produzioni, l’esportazione, l’economia, il turismo, l’intero ecosistema di una regione ricca tanto quanto la nostra Puglia, pur di ottenere indennizzi e sussidi europei e nazionali.
La Puglia è un produttore strategico non solo di olio, ma anche di uva, agrumi, prodotti agroalimentari di diversa natura, frutta (mandorle, pesche, albicocche, gelsi, etc.), pomodori, piante aromatiche, cereali, piante ornamentali. Un fatturato annuo di circa 1.3 miliardi di euro.
Una ricchezza incredibile che dovrebbe esser difesa, protetta e non incautamente svenduta. Il danno all’immagine della regione è una ulteriore conseguenza gravissima di quanto accade: da diversi paesi europei, giungono testimonianze di preoccupazione per ciò che traspare della situazione. Sembra possa essere messa a rischio la stessa identità unica del Salento, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.
Ci si chiede come sia possibile affrontare sfide di questa portata in modo così malaccorto. Il danno produttivo, economico, non solo sul piano agroalimentare ma anche turistico, può diventare dirompente. La classe politica che si è trovata a gestire la questione avrebbe dovuto farlo cominciando dalla scienza e dalla terra.
Le misure di sostegno dovrebbero essere indirizzate alla ricerca, al rilancio dell’agricoltura biologica, alla garanzia del rispetto del paesaggio e dell’ecosistema della nostra Regione.
Coldiretti ha chiesto “un risoluto impegno di tutto il Parlamento italiano affinché sia resa possibile la dichiarazione di stato di calamità naturale nel Salento, dove sono a rischio 11 milioni di piante di ulivo”.
Ma se davvero a Coldiretti interessa proteggere gli 11 milioni di ulivi, perché non si impegna affinché la cura che ha guarito già più di 500 di questi ulivi venga estesa a tutte le piante malate? Perché non si convoca con immediatezza un panel indipendente di ricercatori che possa non solo produrre un nuovo urgente avviso scientifico, da sottoporre ad EFSA, ma anche testare la cura che già funziona?
Sarebbe interessante conoscere le risposte alle seguenti domande da parte del Ministro Martina e del Presidente Vendola:
1) sulla base di quali test di patogenicità siete convinti che il disseccamento degli ulivi sia prodotto dalla Xylella?
2) perché gli agricoltori che da più di un anno curano con efficacia gli alberi colpiti non vengono ascoltati?
3) perché non vengono presi in considerazione i numerosi studi scientifici italiani ed internazionali che evidenziano, in linea con l’EFSA, che esistono tipi di funghi riscontrati sulle piante malate che potrebbero essere la causa prima del disseccamento degli alberi?
4) perché l’azione del Governo e della Regione si concentra non sulla ricerca della causa della malattia ma sull’obiettivo dell’abbattimento e sulla richiesta di indennizzi all’Unione Europea? E questo nonostante la dichiarazione dell’EFSA sull’incertezza dell’eziologia della malattia?
Vengono prese decisioni così radicali sulla base di poco più di nulla, decisioni le cui conseguenze potrebbero essere devastanti su diversi piani e per centinaia di anni. Un ecosistema finirebbe, un’intera Regione verrebbe sfigurata e trasformata in una landa industriale competitiva e senza identità.
«Quista è casa mia, terra mia
 Lu Salentu nu se tocca!» (Sud Sound System).
Lu Salentu nu se tocca!» (Sud Sound System).-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Per fermare il mostruoso piano anti-xylella, sit-in in Procura a Lecce16 aprile 2015, di Federico La Sala
Sit-in in Procura a Lecce per fermare il mostruoso piano anti-xylella
Giovedì 16 aprile 2015 ore 11,00
Tutti sotto la Procura di Lecce per chiedere di fermare ruspe e motoseghe e si accerti tutte le responsabilità di questa mostruosa vicenda che vuole il Salento e i suoi millenari ulivi e ogni specie vegetale e d’insetto cancellati per sempre compiendo un vero e proprio BIOCIDIO senza il minimo scrupolo! Si smascheri questa gigantesca Frode!!!
I cittadini del Salento si raccolgono attorno alla Procura della Repubblica per chiedere il ripristino di quello stato di legalità che la maxi-frode biocida della “Xylella” e il folle piano su di essa costruito hanno nei fatti sospeso portando il Salento tutto in un baratro, mettendo in ginocchio l’intera economia non solo agricola ma anche turistica etc., ed comportando uno stato di agitazione sociale inevitabile che vede in questo momento centinaia e centinaia di cittadini presidiare le campagne di giorno e di notte a difesa dei vitali olivi e dell’ecosistema tutto dai “raid” assassina-olivi e per le velenifere chimicizzazioni.
Si sta chiedendo pertanto:
 un intervento urgente della Procura di Lecce e non solo per sequestrare i cantieri volti al taglio degli alberi d’olivo a Oria, a Veglie, come in altri paesi del Salento, (Leggi a tutela degli olivi: LEGGE dello Stato 14 febbraio 1951, n. 144; LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”;Legge dello Stato 14 gennaio 2013, n. 10 in particolare "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”);
un intervento urgente della Procura di Lecce e non solo per sequestrare i cantieri volti al taglio degli alberi d’olivo a Oria, a Veglie, come in altri paesi del Salento, (Leggi a tutela degli olivi: LEGGE dello Stato 14 febbraio 1951, n. 144; LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”;Legge dello Stato 14 gennaio 2013, n. 10 in particolare "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”);
 così il sequestro dei cantieri per il taglio della flora spontanea lungo i canali, fossi, strade, nelle aree verdi, (atti questi che calpestano la Direttiva Habitat 92/43/CEE; Rete Natura 2000; United Nations Conference on Environment and Development - UNCED, conferenza internazionale di Rio de Janeiro - del 1992 per la difesa della biodiversità ratificata dall’Italia; tra i principi fondanti della Carta Costituzionale italiana l’articolo 9 che afferma che la Repubblica tutela il Paesaggio);
così il sequestro dei cantieri per il taglio della flora spontanea lungo i canali, fossi, strade, nelle aree verdi, (atti questi che calpestano la Direttiva Habitat 92/43/CEE; Rete Natura 2000; United Nations Conference on Environment and Development - UNCED, conferenza internazionale di Rio de Janeiro - del 1992 per la difesa della biodiversità ratificata dall’Italia; tra i principi fondanti della Carta Costituzionale italiana l’articolo 9 che afferma che la Repubblica tutela il Paesaggio);
 il divieto di irrorazione di insetticidi, pesticidi e erbicidi in nome dellaXylella, (ciò in violazione dell’articolo 32 della Costituzione italiana che prevede la tutela della Salute dei cittadini; i principi di Precauzione e Prevenzione sanciti dalla Costituzione Europea; la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo);
il divieto di irrorazione di insetticidi, pesticidi e erbicidi in nome dellaXylella, (ciò in violazione dell’articolo 32 della Costituzione italiana che prevede la tutela della Salute dei cittadini; i principi di Precauzione e Prevenzione sanciti dalla Costituzione Europea; la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo);
 di impedire la distruzione delle piante bloccate ingiustamente all’interno dei vivai, nonostante esse siano completamente sane e del tutto prive diXylella come risultato dalle analisi. Un’assurdità la loro distruzione prevista nel piano anti-xylella, come i divieti dei reimpianti in Salento delle innumerevoli piante olivi, mandorli, rosmarino, alaterno, acacia, oleandri, albicocco, pesco, pruno, malva, ..., punti assurdi che chiediamo alla Magistratura di approfondire come sia stato possibile inserire all’interno di atti e decreti pubblici.
di impedire la distruzione delle piante bloccate ingiustamente all’interno dei vivai, nonostante esse siano completamente sane e del tutto prive diXylella come risultato dalle analisi. Un’assurdità la loro distruzione prevista nel piano anti-xylella, come i divieti dei reimpianti in Salento delle innumerevoli piante olivi, mandorli, rosmarino, alaterno, acacia, oleandri, albicocco, pesco, pruno, malva, ..., punti assurdi che chiediamo alla Magistratura di approfondire come sia stato possibile inserire all’interno di atti e decreti pubblici.In questo momento in cui è evidente che le istituzioni hanno smarrito la luce della Ragione chiediamo alla Magistratura di riportare razionalità, logicità, legalità, scientificità e, soprattutto, moralità nella nostra terra che è stata messa assolutamente in ginocchio non dal batterio, ma da quanto da taluni è stato mostruosamente costruito intorno ad esso.
* FONTE: La Rete delle Reti, mercoledì 15 aprile 2015 (ripresa parziale).
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- VEGLIE (LECCE). Xylella: sospese le operazioni di eradicazione dei 22 alberi di ulivo.14 aprile 2015, di Federico La Sala
Xylella: sospeso abbattimento a Veglie
Per presidio ambientalisti, venute meno condizioni sicurezza *
ANSA) - VEGLIE (LECCE), 14 APR - Sono state sospese le operazioni di eradicazione dei 22 alberi di ulivo colpiti dalla Xyilella che ricadono nell’area focolaio di Veglie. La struttura commissariale, informata del massiccio presidio in atto nella zona da parte di oltre un centinaio di ambientalisti, ha dato l’ordine di sospendere le operazioni, perchè sono venute meno le condizioni di garanzia per l’ordine pubblico. Si procederà modificando il cronoprogramma stabilito e mantenendo riserbo su spostamenti.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- VEGLIE (LECCE). Seconda giornata di applicazione del piano anti xylella, è prevista l’ eradicazioni di 22 alberi di ulivo infettati.14 aprile 2015, di Federico La Sala
Xylella:ripartono abbattimenti, proteste
Oggi prevista eradicazione 22 alberi in uliveto nel leccese
di Redazione ANSA VEGLIE (LECCE) *
Ambientalisti sul piede di guerra a Veglie dove, con la seconda giornata di applicazione del piano anti xylella, è prevista l’ eradicazioni di 22 alberi di ulivo infettati in un uliveto di Veglie, in provincia di Lecce, ad una quarantina di chilometri dall’area di Oria, nel brindisino dove ieri sono stati abbattuti i primi sette ulivi. Dopo il blitz e i conseguenti disordini di ieri, gli attivisti oggi si sono arrampicati sugli alberi destinati all’abbattimento.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ... L’impasse dell’Unione. Un’altra chance all’Europa. Le riflessioni di Barbara Spinelli e Giacomo Vaciago (di Mauro Campus)12 aprile 2015, di Federico La Sala
L’impasse dell’Unione
Un’altra chance all’Europa
Le riflessioni di Barbara Spinelli e Giacomo Vaciago ci esortano a uscire dal torpore attuale e ritrovare il senso morale di un grande progetto
di Mauro Campus (Il Sole-23 Ore, Domenica, 12.04.2015)
- Barbara Spinelli, La sovranità assente, Einaudi, Torino, pagg. 74, € 10,00;
 Giacomo Vaciago, Un’anima per l’Europa, Il Mulino, Bologna, pagg. 138, € 12,00
Giacomo Vaciago, Un’anima per l’Europa, Il Mulino, Bologna, pagg. 138, € 12,00
Siamo sinceri. Per parlare in maniera originale dell’Europa del 2015 sarebbe necessario ricorrere a provocazioni che aiutino a superare il tedio della litania che impegna da anni la politica del “Vecchio mondo”. E, infatti, di un programma che indirizzi uno slancio nella ricostruzione europea non vi è che qualche segnale, che ingrossa una pubblicistica cospicua ma con un’incidenza sulla formazione dell’opinione pubblica vicina allo zero. L’arte del rinvio cui il discorso pubblico europeo è inchiodato restituisce un’immagine di fissità alla quale niente sembra in grado di imporre un’accelerazione. E così su una scena usurata, davanti a un pubblico sempre meno interessato, si avvicendano protagonisti che si comportano da figuranti e recitano sempre la stessa parte.
Ciò appare ancora più grottesco se si considera che, di fronte a un’analisi intellettuale compiuta, la politica è incapace di rendere chiaro lo scopo dei sacrifici che ha chiesto alla popolazione o, semplicemente, il valore dell’edificio costruito in cinquant’anni di compromessi. Una classe politica paralizzata dal terrore di oltrepassare i confini del noto, e che è stata solo in grado di ancorarsi al mantra del rigore e alla ritualità dei vertici, ha polverizzato il consenso di cui godeva l’Unione e il suo modello di potenza civile.
Oggi l’agenda europea si aggiorna solo nell’attesa del vaglio di leggi finanziarie intercambiabili, e trema davanti a ogni starnuto borsistico. È probabile che un livello più intenso d’integrazione non sia praticabile in una situazione in cui percentuali di crescita simili ai vecchi prefissi telefonici sono acclamate come trionfi. Ed è altresì possibile che il sistema internazionale in cui prese avvio la costruzione europea fosse il non ripetibile luogo propizio per realizzare condizioni estinte con la fine del conflitto bipolare, e che la tensione verso la costruzione di un’area monetaria ideale sia stata equivocata con la prima tappa di una federazione.
Ma se ciò è verosimile, e l’innesto di una crisi economica violentissima su un’illusione collettiva ha reso tutto più difficile, è anche vero che una classe dirigente genuflessa a ortodossie vissute come dogmi ha reso più ipocrita la ripetizione di lezioncine mal digerite.
Sono tutti problemi arcinoti ai quali si è reagito - si sa - con un conformismo alla meglio ammantato di slogan. Ciò dimostra che per affrontare un problema non basta sapere cosa fare. È necessario creare possibilità e metterle in pratica: questo dovrebbe essere il ruolo della politica europea che, invece, sopravvive a se stessa recitando un copione, la cui stesura attribuisce all’irresponsabile burocrate di turno cui - casualmente? - lei stessa ha attribuito un ruolo chiave.
Due libri recenti individuano questi problemi e, sebbene sviluppino un ragionamento segnato da sensibilità politiche diverse, suggeriscono un’unica soluzione: il coraggio di tornare a costruire qualcosa di inclusivo che generi fiducia nella costruzione europea. Barbara Spinelli e Giacomo Vaciago dicono molto di quello che serve sapere su quell’Unione della diffidenza che è l’Europa contemporanea: indicano con chiarezza i passaggi attraverso i quali si è giunti al punto attuale, cosa si dovrebbe fare per evitare il prolungarsi dello stallo, e perché ancora non è stato fatto ciò che è necessario per dare un senso alla costruzione di un’identità meno insidiata da patetici interessi nazionali.
Nel suo La sovranità assente, Barbara Spinelli racconta un continente dominato dall’autoconsumo di cliché, proteso a praticare il vangelo del libero mercato, le virtù taumaturgiche di una finanza miracolosa, e a evocare un equilibrio raggiungibile solo attraverso l’applicazione di un prontuario sempre uguale, fuori dal quale vige una scomunica senza appello. Una commistione di valori che sembra alludere a un’equiparazione fra il flagello del debito e un peccato capitale.
Questa liturgia sembra ripetere la banale euforia dei primi anni Novanta del XX secolo, che fece piazza pulita delle lezioni di Keynes e Minsky sull’instabilità congenita del capitalismo, come se tutta l’elaborazione intellettuale di secoli di “Idea d’Europa” potesse essere soverchiata dal trionfo del liberal-capitalismo atlantico alla fine della Guerra fredda e dall’evocata fine della Storia.
La sordità della politica europea davanti a un mondo privo di leadership ha trasformato il sogno europeo in un incubo, in un’estraneità sempre più marcata del corpo elettorale, in una contorsione dei ruoli in cui l’Euro è additato a divinità per la quale i cittadini dell’Unione devono essere disposti a qualunque sacrificio che tocchi financo le fondamenta democratiche dei Paesi che vi hanno aderito.
Tutto ciò ha portato a quell’Europa priva di anima cui fa riferimento il titolo del libro di Giacomo Vaciago, Un’anima per l’Europa per l’appunto, che indica nella rivitalizzazione dell’economia sociale di mercato una possibile strada per rimettere in piedi una storia interrotta nel suo farsi.
Vaciago è un economista di valore, e quindi è naturale che la sua analisi si sviluppi intorno ai tasselli che completerebbero l’Unione monetaria e la metterebbero in grado di agire con rapidità durante le emergenze. Tuttavia non gli sfugge che tale operazione, se sconnessa da un’opera tesa a includere e a occuparsi seriamente della dilagante diseguaglianza che ha segnato le sorti dei cittadini del continente, avrebbe poco senso.
Entrambi gli autori evocano, dunque, il ritorno a un discorso politico solidale, in grado di sgombrare il campo dalla foresta di equivoci che avviluppa un’Europa divenuta il commissario liquidatore di sé stessa. Ciò che però entrambi più fortemente sembrano richiamare è quel che manca all’attuale classe politica: il coraggio morale. Ma, è noto, il coraggio viene facilmente meno quando si pensa che tutto sia inutile, che, se potremo ancora sottrarre al Moloch l’anima dei figli, non potremo farlo con quella dei nipoti, e che si è dei superstiti, i seguaci di una religione destinata a morire.
- Barbara Spinelli, La sovranità assente, Einaudi, Torino, pagg. 74, € 10,00;
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" - di Federico La Sala.24 marzo 2015, di Federico La Sala
Ma se muore il nostro ulivo muore il Mediterraneo
di Raffaele Nigro (la Gazzetta del Mezzogiorno, 22.03.2015)
La vicenda drammatica della «morte» degli oliveti nel Salento mi induce spesso a riflettere sul senso che questa pianta ha avuto e ha per gran parte del mondo mediterraneo e per noi pugliesi. Non si tratta infatti solo di una pianta bensì di un simbolo antico e profondo. Maometto scrive nella sura XXIV del Corano che «Dio è la luce simile a quella di una lampada collocata in una nicchia, in un vaso di cristallo e accesa grazie a un albero benedetto, un olivo che non sta a oriente né a occidente». Non ci sono organizzazioni al mondo innamorate dell’ulivo, nate per difenderlo, per chiederne un riconoscimento Unesco, pronte a magnificarlo in poesia, in fotografia e in pittura come ne vedo da sempre in Puglia.
La stessa Toscana dove si produce una eccellente qualità di olio magnifica il frutto e il prodotto ma poco la pianta. Da noi l’ulivo ha qualcosa di sacro, la pianta e la conformazione del suo tronco e della sua chioma hanno qualcosa di antropomorfo. L’ulivo è un progenitore, padre e fratello dell’uomo, probabilmente perché ha rappresentato per secoli l’unica forma di sostentamento, l’unico compagno di viaggio nell’arsura dell’estate, ha dato forma e colore a un ambiente brullo e siccitoso,ha custodito silenzio, monumentalità e frescura ma soprattutto la sua chioma si è sempre mareggiata di luce e di argento al punto da essere aureolata da una ininterrotta sacralità.
I piccoli alberi frondosi di Olimpia e della sponda greca riportano la mente all’oleastro, la pianta selvatica che Ercole avrebbe trasportato da Creta e con cui avrebbe popolato le montagnole della Grecia. Vincenzo Consolo ha stigmatizzato la diversità tra l’olivo, la pianta addomesticata dall’uomo e l’oleastro, il virgulto e il cespuglio selvatico. La società primitiva è come l’oleastro, naturale ma incapace di costruire un consorzio civile.
L’ulivo è invece la pianta potata e ammessa a offrire sostegno all’uomo. Il suo frutto è infatti ricco di glucidi, protidi e minerali e facilita la diminuzione del colesterolo nel sangue. Secondo un altro mito sarebbe stata Atena a far conoscere l’oleastro in Grecia e a diffondere la sacralità della pianta. L’olio veniva perciò usato per tenere in vita la lampada del tempio, donato in piccole quantità agli atleti che si erano distinti nelle gare olimpiche e usato per far brillare la loro pelle prima di scendere in gara. «Laudato sia l’ulivo nel mattino! - scrive D’Annunzio ripetendo i versi di San Francesco - Una ghirlanda semplice, una bianca/tunica, una preghiera armoniosa».
Secondo una documentazione meno fabulosa furono i Fenici a diffondere la pianta in tutto il Mediterraneo, tant’è che il Breviario di Predrag Matvejevic si apre sancendo una ipotesi o una verità: definiamo Mediterraneo quel luogo dove è diffusa la coltura dell’olivo.
Dopo i Greci furono i Romani ad acquisire la coltura della pianta, sposarono la sacralità dell’olivo e ne fecero un simbolo di prosperità e di pace. Una simbologia che era già viva presso gli Ebrei, i quali la rappresentarono nel racconto di Noè. Il patriarca invia una colomba a scrutare se le terre siano affiorate e l’uccello ritorna con un ramo d’olivo nel becco. La sacralità dell’olivo è descritta dal Vangelo apocrifo di Nicodemo, risalente al IV o V secolo. Si narra dei Giusti che prigionieri dell’inferno videro una luce abbagliante che annunciava la discesa all’inferno di Cristo. Il profeta scendeva a resuscitare Abramo e i patriarchi e coloro che avevano meritato la gloria divina e portava con sé l’olio santo con cui avrebbe unto e guarito coloro che si erano ammalati. Nel cristianesimo, l’olivo diventa simbolo di luce divina, di pace e prosperità ed è dal Monte degli Ulivi che ha inizio la passione di Cristo, simbolo della misericordia di Dio verso i suoi figli.
L’olivo è l’albero della vita, in quanto lega l’aldiqua e l’aldilà è l’unione della carne con lo spirito e dunque col Cristo. Viene perciò benedetto e scambiato tra i cristiani nella domenica delle palme, allorché Cristo entra in Gerusalemme per portare a compimento la sua missione. E da un olivo la tradizione sostiene che saranno ricavati i bracci della croce sulla quale il Messia verrà inchiodato. L’immagine del ramo entrerà più tardi nella pittura rinascimentale italiana, addirittura i pittori senesi raffigurarono Gabriele che non consegna un giglio a Maria, bensì un ramo d’olivo, per sostituire questa pianta all’odiato giglio fiorentino.
Ricordo che a Pasqua mi mandavano in chiesa a prendere l’acqua benedetta con un bicchiere. Prima che iniziasse il pranzo, mio nonno intingeva un ramoscello di olivo nel bicchiere e benediva tutta la famiglia. Mentre il mercoledì delle Ceneri si usava bruciare dei rami di olivo. Il sacerdote bagnava il pollice nella poltiglia di acqua benedetta e cenere di olivo e tracciava un segno di croce sulla fronte dei fedeli, pronunciando una formula bella e tragica che induceva a riflettere: Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris. Ricordati che polvere eri e polvere ritornerai.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- GRECIA. Trovata coppia di scheletri, abbracciati da 5.800 anni. Lo straordinario ritrovamento nella grotta di Alepotrypa, nel sud del Peloponneso.14 febbraio 2015, di Federico La Sala
Trovata coppia di scheletri, abbracciati da 5.800 anniLo straordinario ritrovamento nella grotta di Alepotrypa, nel sud del Peloponneso
di Redazione ANSA ATENE *
E’ innegabile: i ritrovamenti di scheletri abbracciati da secoli non smettono mai di emozionare perché sembrano confermare che, quando l’amore è davvero per sempre, è l’unico capace di unire una coppia oltre la morte. Sembra questo il caso dell’uomo e della donna i cui scheletri, ancora teneramente abbracciati dopo quasi 6000 anni, ovvero dall’epoca del Neolitico, sono stati rinvenuti ieri durante scavi presso la Grotta di Alepotrypa (il "Buco della volpe"), a ovest del villaggio di Mani, nel Peloponneso meridionale.
Non si sa ancora come e perché siano morti, ma di certo sappiamo che si amavano. Lo straordinario ritrovamento, che sinora ha un solo equivalente in Europa negli ’amanti di Valdaro’ - due scheletri di una giovane coppia risalenti al Neolitico, tumulati faccia a faccia e abbracciati, ritrovati in una necropoli scoperta nel 2007 nei pressi di Mantova - è stato annunciato ieri dalla Sovrintendenza Archeologica ellenica quasi in coincidenza con la festa, domani, di San Valentino, il patrono degli innamorati. Un analogo ritrovamento di una coppia, ma di epoca molto più recente, è avvenuto lo scorso settembre nella Cappella di Saint Morrell nel Leicestershire, in Gran Bretagna, dove sono stati rinvenuti due scheletri, risalenti al XIV secolo, che dopo 700 anni si tenevano ancora mano nella mano.
La sepoltura di Mani, che sembra non abbia subito violazioni, è stata trovata presso il luogo dove erano stati interrati un altro uomo e un’altra donna, rinvenuti accovacciati in posizione fetale. Le sepolture contenevano anche punte di freccia rotte. Grazie al metodo del Carbonio 14, gli scheletri della coppia abbracciata sono stati datati intorno al 3800 a.C., mentre l’analisi del Dna ha confermato che i resti appartenevano a un maschio e a una femmina.
Entrambe le sepolture fanno parte di una necropoli neolitica nell’area della grotta di Diros, dove gli scavi hanno già riportato alla luce tombe risalenti al 4200-3800 a.C. In base alle ricerche e alle analisi, sembra che la grotta ed i suoi dintorni siano stati utilizzati come residenza e come necropoli dal Neolitico antico (7000-5500 a.C.) sino al Neolitico recente (4200-3500 a.C.). Quindi, verso il 3200 a.C., un devastante terremoto avrebbe fatto crollare l’ingresso della grotta, sigillando all’interno coloro che vi abitavano.
Gli scavi nell’area ebbero inizio in seguito ad una scoperta fortuita fatta dagli speleologi Yiannis e Anna Petrocheilos nel 1958 e sono ripresi l’anno scorso sotto l’egida dell’Eforato di Paleoantropologia delle antichità, guidato da George Papathanassopoulos, e della Società speleologica della Grecia settentrionale, che si avvalgono della collaborazione di esperti greci e internazionali.
Commentando la scoperte, Papathanassopoulos ha ricordato che già dalla fine degli anni Settanta le visite turistiche alla grotta sono state proibite e, nello stesso periodo, sono stati avviati scavi più approfonditi. Presso il sito archeologico è stato realizzato un piccolo museo nel quale sono in mostra molti dei tantissimi reperti sinora rinvenuti. "Entrambe le tombe riportate alla luce sono in ottime condizioni - ha detto Papathanassopoulos -. Il tipo di sepoltura in posizione fetale è comune nell’epoca neolitica, ma la doppia inumazione con l’abbraccio è uno dei più antichi esempi conosciuti e, quando avremo finito di lavorarci, anch’essa sarà esposta nel museo".
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Riaccendiamo i Lumi (di Pankaj Mishra)8 febbraio 2015, di Federico La Sala
- RESTITUIRE L’ONORE A KANT E RICONCILIARSI CON FREUD. (Federico La Sala)
Riaccendiamo i Lumi- Musulmani, indù e buddisti hanno intrapreso una transizione dall’universo sacralizzato dei simboli a quello disincantato di fatti neutrali
 Tutti i popoli di quello che una volta era conosciuto come il Terzo Mondo sono “condannati alla modernità”
Ma cercano una forma meno disumana di conversione
Tutti i popoli di quello che una volta era conosciuto come il Terzo Mondo sono “condannati alla modernità”
Ma cercano una forma meno disumana di conversione
- Voltaire e la Rivoluzione francese hanno separato religione e ragione, politico e teocratico, laicità e fede
 Una secolarizzazione che oggi appare sempre più come disumanizzazione
Una secolarizzazione che oggi appare sempre più come disumanizzazione
 Ecco perché si chiede all’Occidente di pensare un nuovo illuminismo spirituale
Ecco perché si chiede all’Occidente di pensare un nuovo illuminismo spirituale
di Pankaj Mishra (la Repubblica, 08.02.2015)
L’ILLUMINISMO divenne possibile in Europa quando, secondo la definizione di Kant, gli individui cominciarono a «osare di sapere » - a impiegare la loro ragione, senza l’intercessione di una qualsiasi autorità. La Rivoluzione francese realizzò la grande svolta intellettuale dell’Illuminismo: la separazione tra il politico e il teocratico. La Rivoluzione contribuì anche a creare quella che Jacob Burckhardt ha chiamato la «volontà ottimista» - la fede nel progresso, nella ragione e nel cambiamento, che gli eserciti rivoluzionari francesi diffusero in tutta Europa e perfino in Asia. Con il progredire del XIX secolo, le innovazioni, le norme e le categorie dell’Europa raggiunsero un’egemonia universale.
Istituzioni politiche come lo stato-nazione, forme estetiche come il romanzo, ideologie come nazionalismo, liberalismo e socialismo, e processi come la scienza, la tecnologia, il capitalismo industriale divennero i punti di riferimento per la valutazione di ogni altra forma di vita umana, passata e presente.
La laicità è stata uno dei principi europei moderni più influenti nel suo considerare la religione tradizionale inferiore ai nuovi modi razionali di comprendere e migliorare la società umana. Di fronte a questa potenza europea senza precedenti, morale e intellettuale, ma anche militare, gli uomini nelle società asiatiche e africane si sono adattati oppure hanno opposto resistenza. In entrambi i casi, hanno finito col disporre antichi modi di vita, codici etici di condotta e culture, come il buddismo, l’induismo e l’islam, secondo le linee europee moderne.
C’è stata molta più secolarizzazione nel mondo dal XVIII secolo, quando alcuni filosofi europei e americani proposero un futuro nel quale gli individui, armati di ragione e diritti, avrebbero portato il progresso.
Non tutto è andato come previsto. La storia post-illuminista d’Europa ha reso inaccettabile gran parte dell’intemerata mancanza di rispetto di Voltaire per la religione - per esempio, la sua denuncia degli ebrei come fanatici nati che «meritano di essere puniti». Le politiche di assimilazione nell’Europa secolarizzata non sono riuscite a garantire i diritti degli ebrei, o a salvarli dalla discriminazione e dal disprezzo, inducendo un disperato Joseph Roth a esclamare che preferiva la vecchia «paura di Dio» europea al suo «cosiddetto umanesimo moderno». L’astratta nozione illuminista dell’uguaglianza di diritti si è rivelata debole rispetto agli imperativi della sovranità territoriale e nazionale.
Non c’è bisogno di essere cattolici o marxisti, per rendersi conto che l’Europa è circondata da problemi seri: disoccupazione alle stelle, crisi irrisolta dell’euro, crescente ostilità contro gli immigrati e una scioccante e diffusa perdita di speranza nel futuro dei giovani europei - eventi resi intollerabili per molti da invisibili detentori di titoli, da banchieri che godono di gratifiche esorbitanti e dal vizio della venalità che si diffonde in tutta l’oligarchia politica europea.
In queste circostanze, la supposizione non detta che, mentre tutto il resto cambia nel mondo moderno, le norme europee debbano rimanere autosufficienti e immutabili, meri- tandosi una sottomissione incondizionata da parte degli stranieri arretrati, ci costringe a fermarci un attimo.
Come ha dimostrato Tony Judt nel suo magistrale Dopoguerra, la nozione dell’Europa come l’incarnazione della democrazia, della razionalità, dei diritti umani, della libertà di parola, dell’uguaglianza di genere doveva sopprimere le memorie collettive di crimini brutali nei quali quasi tutti gli stati europei erano stati complici. Né non si può dire che abbiano dato nuovo vigore ai valori dell’Illuminismo negli ultimi anni.
Gli stati nazione europei, anche quelli che non hanno partecipato alle guerre e alle occupazioni anglo- americane, hanno permesso esecuzioni extragiudiziali, torture e estradizioni illegali, che in origine erano sanzionati in nome della ragione, della libertà e della democrazia.
La nostra epoca è caratterizzata da stati-nazione pesantemente armati, da potenti corporazioni e da ciò che sembra essere una disuguaglianza strutturale inestirpabile, insieme a una dilagante depoliticizzazione causata da una ampiamente avvertita perdita della sovranità individuale e collettiva.
I valori illuministici della libertà individuale si manifestano meglio in singoli atti di critica e di sfida. La maggior parte dell’arte e della letteratura moderne emerge da questo ethos critico dell’Illuminismo, dall’implacabile messa in discussione delle rivendicazioni del progresso e della civiltà.
Le élite egoiste, oggi ossessionate da premonizioni di declino, e intrappolate nello scontro tra la democrazia locale e il capitalismo globale, devono affrontare un’altra sfida, più esistenziale: è l’assenza, come disse lo storico Mark Mazower nel 1998, di «un avversario contro il quale i democratici possano definire ciò che rappresentano».
Gli attacchi terroristici dell’11 settembre hanno fornito un sostituto al nazismo e al comunismo: il «totalitarismo islamico». Questo grande concetto intellettuale è stato incautamente applicato a un gruppo sciolto di megalomani, fanatici, delinquenti e disadattati, la maggior parte dei quali ha prosperato nell’ecosistema dell’estremismo (scuole, moschee, giornali, canali satellitari) originariamente istituiti dai cittadini di un fedele sostenitore dell’alleanza con l’Occidente e della teocrazia, l’Arabia Saudita. Ha raggiunto un certo potere persuasivo solo dopo l’invasione e l’occupazione angloamericana dell’Iraq, che ha radicalizzato un numero significativo di musulmani, provocando attacchi di rappresaglia nelle città europee e la devastazione di gran parte dell’Asia e dell’Africa. Quella guerra disastrosa ora ha generato una culto nichilistico della morte, che ricorda gli Khmer Rossi, in Iraq e in Siria.
Il pericolo del totalitarismo islamico ha dimostrato, almeno in Europa, di essere un mediocre surrogato rispetto alla minaccia rappresentata dal comunismo dotato di armi nucleari. Putin, tornando ad assumere una posizione anti-occidentale, si è preso più territorio europeo e ha ucciso più persone; uno dei più grandi attacchi terroristici in Europa è stato messo in atto non da al-Qaeda, ma da un blogger norvegese islamofobo.
I musulmani, come gli indù e i buddisti, hanno intrapreso da tempo una transizione di tipo illuminista dal mondo sacralizzato dei simboli e dei segni significativi a un mondo disincantato di fatti neutrali, in cui la ragione e il giudizio individuali sono guide più affidabili dell’autorità trascendente. Tutti i popoli di quello che una volta era conosciuto come il Terzo Mondo sono «condannati alla modernità», come ha scritto una volta Octavio Paz.
I musulmani in Europa portano a compimento questo destino non come una borghesia commerciale che trionfa su un’élite religiosa e aristocratica, ma come una povera minoranza soggetta agli obblighi e ai pregiudizi di uno stato laico aggressivo con cui condividono una storia lunga e oscura.
La morale razionale dell’Illuminismo, come ammette anche Jürgen Habermas, il suo più eloquente difensore, «è finalizzata alla comprensione degli individui, e non favorisce alcun impulso ver- so la solidarietà, cioè verso l’azione collettiva guidata dalla morale». In un’epoca in cui il denaro è più che mai la misura di tutte le cose, la secolarizzazione può apparire troppo simile alla despiritualizzazione, se non alla disumanizzazione: una ricetta per l’inautenticità.
E il conflitto è sempre probabile se le minoranze asiatiche e africane sono costrette a rispettare le norme europee di secolarizzazione, che non solo comportano la retrocessione di simboli di identità religiosa, come il velo, allo «spazio privato», ma possono anche bruscamente stabilire che, come dice uno slogan molto citato dopo gli attentati di Parigi, «nessuno ha il diritto di non essere offeso».
Il problema per le persone condannate alla modernità «non è tanto sfuggire a questo destino», ha scritto Paz, «ma scoprire una forma meno disumana di conversione», che «non implichi, come adesso accade, la doppiezza e la scissione psichica».
Riconoscere che ci sono molti modi di passare alla modernità, ognuno con le proprie complesse tensioni, è muoversi verso una visione meno unilaterale dell’umanità, e, forse, verso una forma più accomodante di laicità e democrazia, sempre più necessaria in un’Europa irrevocabilmente multietnica.
I tentativi di definire l’identità francese o europea separandola violentemente dal suo presunto «altro» storico, e con la creazione di opposizioni - civili e arretrati, laici e religiosi - non può avere successo in un’epoca in cui questo «altro» possiede anch’egli il potere di scrivere e di fare la storia.
La globalizzazione economica, inducendo all’interdipendenza, sembrava in un primo momento minare il solipsismo nazionalista o di civiltà. In realtà, come rivela la recrudescenza del discorso sullo scontro di civiltà, siamo lontani dal superare nozioni obsolete e sempre più rigide di appartenenza e di identità.
La necessaria discussione di nozioni flessibili di cittadinanza e di sovranità o di identità fluide - imperative nell’era della globalizzazione - è rapidamente compromessa dal gettare la colpa sulla natura incorreggibilmente medievale delle persone religiose e sulla loro incapacità di apprezzare le virtù della modernità laica.
Come scrive il filosofo canadese Charles Taylor, «la nostra identità è in parte modellata dal riconoscimento o dalla sua assenza, spesso da un falso riconoscimento degli altri, e così una persona o un gruppo di persone può subire un danno reale, una vera distorsione, se la gente o la società che li circonda gli rimanda un’immagine limitata o un’immagine umiliante o spregevole di se stessi».
Non è necessaria un’ampia esplorazione della differenza tra la semiotica cristiana e quella islamica per capire che se molti musulmani si offendono personalmente per le immagini degradanti del profeta è perché egli è per loro un esempio di umanità nobile più che una figura distante autorevole e severa - uno il cui più piccolo atto è degno di emulazione.
Vivendo in un mondo diverso e instabile, e condividendo un presente comune pur venendo da retroterra diversi, tanto i non-musulmani che i musulmani sono chiamati a rinunciare, come ha scritto Hannah Arendt, non alla loro «tradizione e al loro passato nazionale», ma «all’autorità vincolante e alla validità universale che la tradizione e il passato hanno sempre preteso».
Senza questa rinuncia qualificata, il nostro stato di solidarietà negativa può diventare soltanto «un peso insopportabile», provocando «apatia politica, nazionalismo isolazionista, o una disperata ribellione contro tutti i poteri costituiti». La triste profezia della Arendt sembra realizzarsi oggi in molte rivolte e esplosioni di violenza in tutto il mondo.
Abbiamo sentito parlare molto dopo l’11 settembre di quella che Rushdie definisce la «mutazione letale nel cuore dell’Islam». Ma abbiamo sentito parlare relativamente poco dell’aumento dell’odio tribale verso le minoranze in tutto il mondo - la principale patologia del capro espiatorio suscitata dalle crisi politiche ed economiche - anche oggi che il mondo è molto più legato dalla globalizzazione.
La rinascita di questi fanatismi confessionali non implica tanto la vitalità della religione medievale quanto delle tristi mutazioni nel cuore della modernità laica. Michel Houellebecq è colpevole di un’esagerata autocommiserazione quando annuncia che «l’Illuminismo è morto, riposi in pace» e che l’Islam è una «immagine del futuro».
Ma la società laica contemporanea nei suoi cupi romanzi - caratterizzati da estrema disuguaglianza, perdita di comunità, egocentrismo narcisistico e indifferenza al dolore - sembra un vicolo cieco che molti di coloro che stanno attraversando il loro Illuminismo e elaborando la transizione verso il disincantato mondo moderno cercano di evitare.
La vecchia promessa di stati-nazione europei omogenei - dove se ti integri godrai del privilegio di una società basata sul concetto dei diritti individuali - non sembra più adeguata, anche se può essere interamente recuperata. Sembra indispensabile che queste diverse società ridefiniscano i loro principi in modo da ammettere esplicitamente visioni diverse, religiose e metafisiche, del mondo.
La pensatrice francese Simone Weil, che non ignorò mai le minoranze di Francia nelle sue riflessioni di ampio respiro, riconobbe presto che il vecchio modello standardizzato di progresso doveva essere sostituito, perché i valori dell’individualismo e dell’autonomia che in origine avevano dato vita all’uomo moderno erano giunti a minacciare la sua identità morale e spirituale.
In La prima radice, un libro scritto nel 1943 per chiarire le lezioni della capitolazione della Francia alla Germania nazista, Weil giunse al punto di abbandonare il linguaggio dei diritti. La difesa dei diritti individuali era stata fondamentale per l’espansione del commercio e di una società basata sul contratto nell’Europa occidentale. All’indomani della catastrofica sconfitta della Francia, Weil sosteneva che una società libera e radicata dovrebbe essere costituita da una rete di obblighi morali. Abbiamo il diritto di ignorare le persone che muoiono di fame, disse, ma dovremmo essere costretti a non lasciarle morire di fame.
Habermas è arrivato a credere che la «sostanza dell’umano» può essere salvata solo da società che «sono in grado di introdurre nel dominio secolare i contenuti essenziali delle loro tradizioni religiose». La profonda svolta di Habermas è un segno tra i tanti che l’identità dell’uomo laico moderno, che è stata costruita sulle nozioni esclusiviste della laicità, della libertà, della solidarietà e della democrazia in Stati nazionali sovrani, si è disfatta, e richiede una definizione più ampia.
Bisogna rinegoziare un nuovo spazio comune. Lo Stato militarmente e culturalmente interventista, favorevole alle imprese ma per il resto minimalista e che vuole spacciare una certa ideologia di crescita economica, non lo farà. Questa mancanza potrebbe anche giocare un ruolo nelle mani dei fanatici che vogliono distruggere il più prezioso lascito dell’Illuminismo: il distacco tra il teocratico e il politico.
Dovremmo recuperare l’Illuminismo, così come la religione, dai suoi fondamentalisti. Se l’Illuminismo è «l’emancipazione dell’uomo dalla sua immaturità auto-imposta», allora questo «compito» e «obbligo», come Kant lo definì, non è mai definitivamente compiuto; deve essere continuamente rinnovato da ogni generazione nel continuo cambiamento delle condizioni sociali e politiche. Sostenere la necessità di maggiore violenza e di altre guerre di fronte al fallimento ricorrente appartiene più al fanatismo che alla ragione.
 Il compito per coloro che hanno a cuore la libertà è quello di ripensarlo - attraverso un ethos di critica unita alla compassione e a un’incessante consapevolezza di sé - nelle nostre società irreversibilmente miste e fortemente disuguali e nel più ampio e interdipendente mondo in cui viviamo. Solo allora saremo in grado di difendere la libertà dai suoi veri nemici.
Il compito per coloro che hanno a cuore la libertà è quello di ripensarlo - attraverso un ethos di critica unita alla compassione e a un’incessante consapevolezza di sé - nelle nostre società irreversibilmente miste e fortemente disuguali e nel più ampio e interdipendente mondo in cui viviamo. Solo allora saremo in grado di difendere la libertà dai suoi veri nemici.Traduzione di Luis E. Moriones © Pankaj Mishra
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- BASTA CON GLI INGANNI. Ermano Olmi e l’Expo: «Ci salverà il mondo contadino» (di Giangiacomo Schiavi)7 febbraio 2015, di Federico La Sala
Il messaggio del regista: torniamo all’essenziale, basta con gli inganni
Ermano Olmi e l’Expo: «Ci salverà il mondo contadino»
Dobbiamo proteggere le piante, dosare l’acqua, rispettare la terra. «Prima viene l’onestà di chi produce, poi c’è il mercato», dice leggendo l’Apocalisse
di Giangiacomo Schiavi *
Ermanno Olmi dice che l’unica speranza per il futuro è il ritorno alla terra. Ai contadini. Anche per questo ha difeso Expo quando tutti l’attaccavano. Il cibo, l’acqua, il rispetto della natura, l’onesta relazione tra chi produce e chi consuma sono l’occasione unica per un cambio di passo, forse un nuovo inizio, la capacità di dare senso a ciò che conta veramente separandolo dal superfluo, dall’inutile che condiziona la vita oggi.
L’esposizione di Milano è carica di significati simbolici ma anche di contraddizioni: si parla di valori e spuntano favori, appalti sporchi, collusioni. Olmi vorrebbe picchiare un pugno sul tavolo per scoraggiare ogni misero e spregevole interesse davanti a un tema così grande: nutrire il pianeta, lotta alle diseguaglianze, onesto utilizzo delle risorse. Nella sua casa di Asiago monta e rimonta il filmato che di Expo dovrà essere il filo conduttore, un vademecum anche morale per una società senza squilibri e ingiustizie alimentari. E si interroga su quello che il mondo si aspetta da noi, da Milano, dall’Italia, su quell’anima di Expo che si fatica ancora a trovare: «Siamo nella fase in cui dopo aver consultato le mappe si mollano gli ormeggi e bisogna avere una rotta. O sai dove andare o vai verso un dove in cui il dove non sai dov’è...».
La rotta di Olmi è chiara, nitida, anche se intorno c’è un grande buio: è la civiltà contadina che abbiamo perso, l’onesta relazione tra chi produce e chi consuma, la sacralità del cibo che non si deve alterare, perché da lì discende la correttezza dei nostri comportamenti, il rapporto di fiducia tra produttore e consumatore, l’equilibrio e l’armonia del creato. «La priorità dell’Expo deve essere la sincerità del prodotto», spiega il grande regista, «bisogna salvaguardare il rapporto naturale tra l’uomo e la terra e fare di questo la garanzia della qualità. Dobbiamo imparare dai contadini a proteggere le piante, a dosare l’acqua, a rispettare la terra per garantire un futuro a chi verrà dopo di noi». A Olmi non piace chi bara sulle risorse e specula sui prodotti, la fame e la malnutrizione sono questioni che l’Expo deve porre senza spot ingannevoli, «perché prima viene l’onestà di chi produce, poi c’è il mercato», dice mentre legge le parole dell’Apocalisse di San Giovanni («...Fuori i cani, gli impostori, gli immondi, i depravati, gli omicidi, gli idolatri e tutti coloro che praticano la menzogna...»).
Ad Asiago con la neve e il tempo che sembra immobile, Olmi dice che si ritrova l’esatto trascorrere del giorno e della notte e ogni alba porta una speranza. Si sente un profumo d’infanzia e di sogno nelle sue parole. «I bambini ci regalano le emozioni più belle davanti alla natura, ma purtroppo noi abbiamo sostituito lo spazio della loro fantasia con qualcosa di predefinito, di artificiale... Ma possiamo ancora riscattarci, tornando all’essenziale, a quel che vale veramente e rischiamo di perdere». È quasi un testamento spirituale il suo contributo alla discussione sulla Carta di Milano, un videoframmento di poche parole sussurrate e registrate in questi giorni di lunga convalescenza: «...Se potessi ricominciare da capo/cercherei di capire meglio gli animali/gli alberi/le stagioni/il giorno e la notte/perché gli uomini resteranno sempre un enigma...». La sacralità del cibo non si può indagare né definire, dice ancora Olmi, mentre sullo schermo appare una pagnotta, il pane di ieri che ci riporta a quel che bastava un tempo per sfamare, alla giusta misura che il mondo oggi non ha.
Ai protagonisti dei tavoli tematici di Expo che si ritrovano il 7 febbraio a Milano ricorda che non è ammesso l’inganno: «I posteri ci giudicheranno e vedranno quel poco di buono o meno buono che abbiamo fatto, ma non ci perdoneranno di non aver fatto quello che potevamo fare». Al premier Renzi («che ha dei meriti ma a volte non lo vedi più, era qui e adesso dove va?...») suggerisce di insistere con la scuola, pietra angolare di tutto: «È lì che si formano gli uomini, che si diventa compratori consapevoli». E al commissario Sala («che stimo perché tiene il timone dritto con coraggio») offre leale collaborazione, mettendolo in guardia dalle derive, che sono business, predazioni ed egoismi.
Credibilità è una parola che Olmi usa spesso per Expo, credibilità, qualità e contagio dell’esempio, insieme ai valori calpestati della condivisione e della saggezza, possono fare miracoli. Se poi si mette anche papa Francesco dalla sua parte, c’è un motivo in più per avere fiducia nella battaglia per ridurre le disparità e le ingiustizie legate all’alimentazione: «Per me lo sviluppo è quando tutti ricevono quel che gli spetta, mentre spreco è quello che nasce dall’interesse di qualcuno a vendere di più». È difficile dire se la spinta di sognatori come lui accenderà qualche passione nuova attorno a un evento che è apparso troppo a lungo freddo e lontano dai cittadini, ma certamente se Expo deve avere un’anima non può che essere quella indicata da Olmi e Carlin Petrini, l’ideatore di Slow food: l’anima calda della creatività, del vivere solidale, del buon uso delle risorse, l’anima dei contadini, degli artigiani, di chi tiene viva la creazione e rispetta la natura. Possono farcela l’Expo, Milano e l’Italia a determinare un cambiamento in questa direzione? Olmi concede un credito: «Nonostante i nostri difetti e i nostri inganni io non ho perso la speranza: sarà la terra a salvarci».
*
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Islam. Un nuovo spettro si aggira per l’Europa (di Vito Mancuso)22 gennaio 2015, di Federico La Sala
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
 Islam
Islam
 Un nuovo spettro si aggira per l’Europa
Un nuovo spettro si aggira per l’Europa
 Come il comunismo anche l’Islam è totalizzante, nel senso che non è solo religione e ciò che questa porta con sé
Come il comunismo anche l’Islam è totalizzante, nel senso che non è solo religione e ciò che questa porta con sé
 Ma è anche politica
Ma è anche politica
di Vito Mancuso (la Repubblica, 22.01.2015)
“UNO spettro si aggira per l’Europa, lo spettro del comunismo”. Così inizia il Manifesto del Partito Comunista che Marx ed Engels pubblicarono a Londra nel 1848 e da allora dovettero passare quasi 150 anni perché quello spettro si placasse trovando pace. Quanto tempo dovrà passare perché avvenga lo stesso per lo spettro che nel frattempo ne ha preso il posto? Anche oggi infatti uno spettro si aggira per l’Europa, lo spettro dell’Islam.
Il parallelo con il comunismo non è casuale. Ben prima di diventare totalitario infatti il comunismo fu già da subito totalizzante. Non era cioè solo prassi politica, ma riguardava anche la dimensione interiore della persona alla quale si proponeva come cultura, etica, estetica, visione complessiva del mondo, non senza un’accentuazione religiosa per la fede e l’obbedienza richieste.
Allo stesso modo anche l’Islam è totalizzante, nel senso che non è solo religione e ciò che la religione porta con sé (etica, estetica, Weltanschauung); è anche politica, e nel suo essere tale anch’esso, da totalizzante, diviene spesso totalitario.
È possibile che una religione o un’ideologia totalizzante non diventi totalitaria? È possibile che le religioni (le quali sono tutte totalizzanti, perché per meno non sarebbero religio) non producano totalitarismi? Oppure, perché si possa dare libertà e quindi democrazia, occorre necessariamente la destituzione del pensiero totalizzante a favore del relativismo?
Venne poi Cartesio che nel 1637 segnò la svolta del pensiero filosofico europeo dicendo «io penso, quindi sono» ( cogito ergo sum ), ovvero la più grande consapevolezza di me stesso in quanto uomo mi è data dal mio essere pensante. Da qui si aprì la strada all’Illuminismo e al cammino faticoso (e sanguinoso) verso la democrazia, dove l’io penso filosofico divenne un io penso politico e sociale.
La Chiesa cattolica si oppose sistematicamente a questo cammino: scomunicò Lutero, mise all’Indice Cartesio e gli illuministi, avversò ogni rivendicazione in tema di diritti umani, soprattutto la libertà di coscienza. Alla fine però dovette cedere e finì per rivedere la sua stessa dottrina: la libertà di coscienza, che Gregorio XVI in linea con molti altri pontefici aveva definito un “delirio” ( deliramentum), un secolo dopo, il 7 dicembre 1965, divenne parte della dottrina cattolica con il documento Dignitatis humanae del Vaticano II e oggi è parte integrante della predicazione dei Pontefici.
La Chiesa si è convertita? È stata costretta a convertirsi, avendo perso lo scontro con la modernità. La quale però, non lo si dimentichi, venne suscitata da credenti quali Lutero e Cartesio, e nutrita anche da altri credenti tra cui gli illuministi tedeschi Lessing e Kant, e se lo sottolineo è per evitare banali conclusioni laiciste e far comprendere quanto il discorso sia dialetticamente molto complesso. In ogni caso l’esito del processo di modernizzazione ci consegna oggi una religione quale quella cristiana che, mantenendo la sua carica totalizzante per la vita individuale, non cade per questo nel totalitarismo sociopolitico.
Potrà avvenire lo stesso per l’Islam? Potrà giungere esso ad accettare lo spirito della democrazia, della diversità, della dimensione plurale dell’esistenza che il mondo oggi impone? Nessuno lo sa e certamente sarà un processo molto duro che condizionerà la vita dell’Europa per tanti anni a venire.
Che fare per favorire questo processo? Vi sono misure a breve, a medio e a lungo termine. A breve termine si tratta di combattere il terrorismo con tutta la durezza necessaria, monitorando anche la predicazione dei vari imam e impedendo quella che si rivela fomentatrice di odio, ma senza mai associare al terrorismo l’Islam in quanto tale: la distinzione tra terroristi e musulmani è assolutamente decisiva se non si vuole avere un miliardo e mezzo di nemici e ostacolare l’evoluzione positiva dell’Islam.
A medio termine si tratta di giungere finalmente al riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese da parte della comunità mondiale e mettere fine per sempre alla progressiva espansione dei coloni ebrei, facendo anzi tornare costoro nei territori di provenienza.
Oggi in Europa occorre sorvegliare con le armi le sinagoghe, ma l’Islam non è mai stato antisemita, gli ebrei hanno vissuto per secoli nei territori islamici, e quando il grande filosofo Mosè Maimonide fu costretto a lasciare Cordova sua città natale perché era giunta al potere una dinastia islamica oltranzista, non pensò minimamente di rifugiarsi nella Francia cristiana ma rimase ancora in terra musulmana, prima in Marocco poi in Egitto.
Se oggi molti musulmani stanno diventando nemici degli ebrei è solo per l’umiliazione sistematica cui è sottoposto da anni il popolo palestinese, con la compiacenza degli Usa. L’Europa non può e quindi non deve permettere più il protrarsi di questa ingiustizia.
Per quanto concerne le misure a lungo termine entra in gioco il discorso economico ed educativo, ovvero la possibilità di avere un lavoro e la scuola. Mi soffermo su quest’ultima. Il compito della scuola è offrire strumenti per la comprensione del mondo. Ora è evidente che senza mettere in gioco la religione il mondo oggi non lo si capisce.
In questa prospettiva l’Italia non può più permettersi di sprecare un’occasione così importante come l’ora di religione, di grande rilievo per la potenzialità geopolitica e al momento ben lungi dall’essere all’altezza della situazione.
Occorre trasformare l’ora attuale da insegnamento della religione cattolica in un’ora in cui siano presentate “tutte” le religioni, ovviamente in proporzione all’importanza di esse per l’Italia, e quindi con particolare attenzione ai monoteismi, ma senza trascurare le religioni orientali.
Quest’ora di “religioni”, in cui non si tratta di credere ma di conoscere, deve essere obbligatoria e avere la medesima dignità curricolare delle altre. La condizione è ovviamente togliere alla Chiesa cattolica ogni potere in merito a programmi e scelta degli insegnanti, costruendo un’ora del tutto laica, rispettosa in egual modo delle diverse religioni e super partes , dalla quale nessun cittadino deve temere condizionamenti a priori alla coscienza, per lo meno non diversamente da quanto li si tema nell’ora di letteratura o di filosofia.
Anche così i nostri ragazzi impareranno fin da piccoli a conoscere i lati positivi delle religioni altrui e a non averne paura, quella paura che genera l’odio di cui si nutre lo spettro che si aggira attualmente nelle nostre menti, ma senza la quale esso potrà placarsi e trovare finalmente accoglienza e pace.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Pensate: non più di venti anni fa, e nel cuore di questa civile Europa, è stato sognato un sogno demenziale, quello di edificare un impero millenario su milioni di cadaveri e di schiavi.21 gennaio 2015, di Federico La Sala
Capirete cosa è il contagio del male
Così fu Auschwitz: in un volume testimonianze inedite dello scrittore e di un suo compagno di prigionia
di Primo Levi (La Stampa, 21.01.2015)
Pensate: non più di venti anni fa, e nel cuore di questa civile Europa, è stato sognato un sogno demenziale, quello di edificare un impero millenario su milioni di cadaveri e di schiavi. Il verbo è stato bandito per le piazze: pochissimi hanno rifiutato, e sono stati stroncati; tutti gli altri hanno acconsentito, parte con ribrezzo, parte con indifferenza, parte con entusiasmo. Non è stato solo un sogno: l’impero, un effimero impero, è stato edificato: i cadaveri e gli schiavi ci sono stati. [...]
Ma c’è stato anche di più e di peggio: c’è stata la dimostrazione spudorata di quanto facilmente il male prevalga. Questo, notate bene, non solo in Germania, ma ovunque i tedeschi hanno messo piede; dovunque, lo hanno dimostrato, è un gioco da bambini trovare traditori e farne dei sàtrapi, corrompere le coscienze, creare o restaurare quell’atmosfera di consenso ambiguo, o di terrore aperto, che era necessaria per tradurre in atto i loro disegni.
Tale è stata la dominazione tedesca in Francia, nella Francia nemica di sempre; tale nella libera e forte Norvegia; tale in Ucraina, nonostante vent’anni di disciplina sovietica; e le medesime cose sono avvenute, lo si racconta con orrore, entro gli stessi ghetti polacchi: perfino entro i Lager. È stato un prorompere, una fiumana di violenza, di frode e di servitù: nessuna diga ha resistito, salvo le isole sporadiche delle Resistenze europee.
Negli stessi Lager, ho detto. Non dobbiamo arretrare davanti alla verità, non dobbiamo indulgere alla retorica, se veramente vogliamo immunizzarci. I Lager sono stati, oltre che luoghi di tormento e di morte, luoghi di perdizione.
Mai la coscienza umana è stata violentata, offesa, distorta come nei Lager: in nessun luogo è stata più clamorosa la dimostrazione cui accennavo prima, la prova di quanto sia labile ogni coscienza, di quanto sia agevole sovvertirla e sommergerla.
Non stupisce che un filosofo, Jaspers, ed un poeta, Thomas Mann, abbiano rinunciato a spiegare l’hitlerismo in chiave razionale, ed abbiano parlato, alla lettera, di «dämonische Mächte», di potenze demoniache.
Su questo piano acquistano senso molti particolari, altrimenti sconcertanti, della tecnica concentrazionaria. Umiliare, degradare, ridurre l’uomo al livello dei suoi visceri. Per questo i viaggi nei vagoni piombati, appositamente promiscui, appositamente privi d’acqua (non si trattava qui di ragioni economiche). Per questo la stella gialla sul petto, il taglio dei capelli, anche alle donne. Per questo il tatuaggio, il goffo abito, le scarpe che fanno zoppicare. Per questo, e non la si comprenderebbe altrimenti, la cerimonia tipica, prediletta, quotidiana, della marcia al passo militare degli uomini-stracci davanti all’orchestra, una visione grottesca più che tragica. Vi assistevano, oltre ai padroni, reparti della Hitlerjugend, ragazzi di 14-18 anni, ed è evidente quali dovevano essere le loro impressioni. Sono questi, dunque, gli ebrei di cui ci hanno parlato, i comunisti, i nemici del nostro paese? Ma questi non sono uomini, sono pupazzi, sono bestie: sono sporchi, cenciosi, non si lavano, a picchiarli non si difendono, non si ribellano; non pensano che a riempirsi la pancia. È giusto farli lavorare fino alla morte, è giusto ucciderli. È ridicolo paragonarli a noi, applicare a loro le nostre leggi.
Allo stesso scopo di avvilimento, di degradazione, si arrivava per altra via. I funzionari del campo di Auschwitz, anche i più alti, erano prigionieri: molti erano ebrei. Non si deve credere che questo mitigasse le condizioni del campo: al contrario. Era una selezione alla rovescia: venivano scelti i più vili, i più violenti, i peggiori, ed era loro concesso ogni potere, cibo, vestiti, esenzione dal lavoro, esenzione dalla stessa morte in gas, purché collaborassero. Collaboravano: ed ecco, il comandante Höss si può scaricare di ogni rimorso, può levare la mano e dire «è pulita»: non siamo più sporchi di voi, i nostri schiavi stessi hanno lavorato con noi. Rileggete la terribile pagina del diario di Höss in cui si parla del Sonderkommando, della squadra addetta alle camere a gas e al crematorio, e capirete cosa è il contagio del male.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- «Je suis Charlie, je suis juif, je suis européen». Domande scomode sull’antisemitismo (di Riccardo Franco Levi e Alberto Melloni)21 gennaio 2015, di Federico La Sala
Domande scomode sull’antisemitismo
di Riccardo Franco Levi e Alberto Melloni (Corriere della Sera, 21.01.2015)
«La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla: stavamo traportando alla fossa comune il cadavere di Somogyi, il primo dei morti tra i nostri compagni di camera... Erano quattro giovani soldati a cavallo, che procedevano guardinghi, coi mitragliatori imbracciati...». Così, nelle prime pagine de La tregua , Primo Levi descrive la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz.
A settanta anni esatti di distanza, il 27 gennaio, come avviene ormai da quattordici anni in base alla Legge n.211 del 20 luglio 2000, si celebrerà il Giorno della Memoria in ricordo, come dice la legge (senza mai pronunciare la parola «fascismo»), «dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti». «Affinché simili eventi non possano mai più accadere».
La realtà non sempre si adegua alla norma, foss’anche alla più giusta tra di esse, specie quando ultra vires sostituisce il problema del risultato sicuro del conoscere con gli effetti incerti del ricordare. Ma se ci fosse stato ancora bisogno di ricordare quanto e come l’odio antiebraico non sia sparito e non sia stato espulso dalle viscere profonde della società e degli uomini, a suonare l’allarme e a risvegliare le coscienze ci hanno pensato i terroristi di Parigi, allungando con il massacro al supermercato kosher, nelle ore di preparazione dello Shabbat, la scia di sangue e di morte che avevano iniziato a tracciare con la carneficina nella redazione di Charlie Hebdo.
A tanto orrore ha risposto l’enorme, emozionata partecipazione alla marcia che ha percorso e bloccato Parigi e scosso l’intera Europa. E una speranza si è riaccesa. Per quanto scomodi, urticanti addirittura, alcuni interrogativi, però, sono legittimi, anzi doverosi, proprio per non rinunciare alla razionalità critica che è quella che nella storia europea ha permesso a ciascuna delle sue culture di essere più profondamente se stessa.
Quanto della commozione, della condivisione di valori e sentimenti che si sono manifestati in quelle ore terribili è stato possibile grazie a quel «Je suis Charlie», il motto sventolato come impavida bandiera della libertà di espressione che ha saputo parlare dritto al cuore di tutti? Quanto ha pesato nell’eco e nell’emozione estesa da Parigi al mondo intero il fatto che le prime vite spezzate, spezzate come le matite subito assurte a simbolo dell’orrore, fossero vite di giornalisti, che ad essere colpito fosse stato il mondo dell’informazione? Quanto si sarebbe manifestato quel corale sentimento di fraternità se l’eccidio si fosse limitato ai quattro ebrei caduti sotto il fuoco omicida, o persino dei bimbi della scuola che i terroristi avevano progettato di colpire, ripetendo nella Ville Lumière l’orrore consumato nel 2012 a Tolosa? Avremmo visto, nelle strade, sui balconi, sulle prime pagine dei giornali, la scritta «Je suis Johan»? E noi, noi italiani, come avremmo reagito? Cosa avremmo pensato?
Se vogliamo evitare il rischio di una stanca ripetizione, il Giorno della Memoria potrà, dovrà essere l’occasione per risposte vere a questi interrogativi. In un’ottica innanzitutto e prevalentemente italiana che la stessa data del 27 gennaio, con il riferimento ad Auschwitz che essa implica, non aiuta ad assumere.
Come ha ricordato il ministro Giannini parlando agli studenti italiani ad Auschwitz pochi giorni fa, pur nel riconoscimento di quel luogo quale primo ed universale simbolo dell’orrore della Shoah, altri sono i luoghi, altre sono le date che parlano e devono parlare alle giovani generazioni della persecuzione contro gli ebrei italiani: l’aula della Camera dei deputati dove il 14 dicembre del 1938 furono all’unanimità approvate le leggi antiebraiche; il Ghetto di Roma dove avvenne il rastrellamento degli ebrei del 16 ottobre 1943; il Binario 21 della stazione Centrale di Milano da dove partivano i vagoni per la deportazione; il campo di Fossoli, ultima tappa prima di Auschwitz, la Risiera di San Sabba a Trieste, l’unico campo di sterminio in terra italiana.
Qui, non meno che ad Auschwitz, è e sarà bene portare gli studenti per far toccar loro con mano (sì, con la mano passata, ad esempio, sul legno dei vagoni conservati nel Memoriale del Binario 21) la realtà e la radice profondamente italiane delle persecuzioni contro gli ebrei.
Per aprire la porta a una conoscenza diffusa e a una comprensione più vera della storia, delle storie, delle responsabilità. Per superare gli stereotipi, le visioni rassicuranti, le verità di comodo: quella degli italiani brava gente, delle leggi razziali fasciste come frutto dell’obbligato accodarsi all’alleato nazista, della Chiesa avversaria del regime e impegnata, sotto la guida di papa Pio XII, a difesa e a protezione degli ebrei.
Così sappiamo che non fu. Non in questi termini, non senza sfumature, oscillazioni e codardie che è troppo facile sospingere fuori dalla storia con una retorica del diabolico, generando un risentimento autoassolutorio sui nazisti o sui croati o sugli ucraini.
Le norme antiebraiche italiane in alcuni aspetti persino peggiori di quelle tedesche. La polizia italiana ebbe un ruolo determinante nella cattura degli ebrei. La Santa Sede e il Cattolicesimo in generale che, non certo soli, ebbero un ruolo nell’ascesa al potere del fascismo e nella costruzione del suo consenso, s’illusero che tollerando la «parte cattiva» delle leggi razziste (che ci fosse la «parte buona» il portavoce del Papa lo sostenne privatamente anche dopo il 25 luglio 1943) avrebbe potuto svolgere la sua missione.
Ancora più in profondo, la propaganda e le argomentazioni fasciste a giustificazione e sostegno della legislazione antiebraica furono astutamente modellate sulla base di quell’insegnamento del disprezzo e quel diritto di segregazione iscritti nella storia dei cristiani: i cattolici della associazione «Amici Israël» che li volevano ripudiare furono sciolti nel 1928, e dovettero attendere fino al 1959 e all’inizio del Concilio perché il ripudio del linguaggio della «perfidia» e dell’antisemitismo «di chiunque e quandunque» aprisse una via nuova.
Quanto di questo substrato, di questi pregiudizi (sull’ebreo ricco ed avaro, potente nella finanza e nel mondo dell’informazione, corruttore della società, estraneo ed infedele alla nazione che lo «ospita») rimane vivo nella società italiana? E se sì, perché? Su questo sarà bene riflettere il prossimo 27 gennaio.
Dopo la marcia di Parigi, il presidente del Consiglio Renzi ha detto: «Je suis Charlie, je suis juif, je suis européen». Siamo sicuri che le sue parole rappresentino davvero il comune sentire di tutti noi italiani? E se qualcuno facesse compilare agli italiani un’autocertificazione razziale come quella richiesta ad Albert Einstein al suo ingresso in America, scriveremmo tutti di essere di razza «umana»?
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Cambio al vertice. Boko Haram e Califfato. L’Europa ha un solo leader che può arginare il nuovo terrore: Francesco (di Furio Colombo)11 gennaio 2015, di Federico La Sala
Cambio al vertice
Boko Haram e Califfato
L’Europa ha un solo leader che può arginare il nuovo terrore: Francesco
di Furio Colombo (il Fatto, 11.01.2015)
Molti sono stati colpiti dalla coincidenza di due fatti di sangue orrendi e lontani: la strage a Parigi nella redazione di un giornale giudicato blasfemo (dodici morti in una stanza, e l’altro evento di sangue francese). E il massacro di almeno duemila persone portato a termine in poche ore, fra villaggi e campagne, al confine con la Nigeria, da due diverse unità militari addestrate e armate di un nuovo fondamentalismo islamico, nel primo caso un commando, nel secondo un esercito. Emergono due capi, Al Baghdadi e Boko Haram, che proclamano due Califfati. Vuol dire dominio assoluto, l’uno dal Medio Oriente verso l’Europa, l’altro dal centro dell’Africa verso il mondo.
NON SAPPIAMO NULLA dei rapporti fra i due potentati al momento, ma sappiamo che i due potentati esistono e che la loro minaccia non è di parole. Al Baghdadi domina una parte dell’Iraq e della Siria, con capitale Mosul. Boko Haram (che, ricorderete ha esordito con il reclutamento forzato di bambini per il suo esercito, e poi con il rapimento di duecento giovanissime studentesse da “convertire” all’islamismo) è il padrone di villaggi, città e campagne in tutta la parte nord della Nigeria su cui impone e mantiene un potere di sangue. Se rileggete le righe di riassunto della situazione che precedono, noterete che, a prima vista, niente è nuovo o diverso dalle storie di violenza a cui la storia contemporanea ci ha abituato ai margini dell’impero.
Anche la grande minaccia, ormai varie volte realizzata, a partire dall’11 settembre, di colpire dentro l’impero, è causa di una continua paura, ma non è più un fatto nuovo. Ciò che è nuovo è l’emergere in posizioni di comando assoluto di nuovi personaggi che sono totalmente liberi di annunciare e poi di realizzare iniziative di una folle violenza, perché non appartengono ad alcuna classe dirigente del passato, rappresentano in modo arbitrario e autodefinito, valori ambigui che non devono giustificare ma solo proclamare. E così nasce un presunto Islam fondamentalista che è un’ottima trovata per disorientare i credenti di quella fede, e una buona mossa per chiamare alla guerra credenti altrettanto finti di un presunto mondo cristiano.
Ma è avvenuto qualcosa di nuovo persino rispetto ai tempi finiti da poco con una irruzione di “teste di cuoio” e l’uccisione di Osama bin Laden. È avvenuto un cambio di classe dirigente che improvvisamente si è autoassegnata la guida degli insorti di un mondo di autoproclamato fondamentalismo islamico, e che in realtà raccoglie tutte le ribellioni estreme lungo la linea non negoziabile di “rivincita” e “riconquista”, dopo la guerra in Iraq e le sue moltissime vittime, ma anche di “diverstà” inventata e sostenuta come tale dal pregiudizio europeo.
CHE COSA INTENDO per “nuova classe dirigente”? e come mai lo stesso fenomeno si manifesta con la stessa forza distruttiva e apparentemente cieca, dal Medio Oriente al cuore dell’Africa? Forse la spiegazione è questa. Fino a un momento fa occupanti e resistenti, invasori e ribelli, dominatori e dominati, erano guidati, allo stesso modo, dalle classi colte e dall’apparato dirigente, dai gruppi sociali delle parti in causa. Questo fatto non ha mai evitato durezza, crudeltà e violenza anche estrema. Ma disponeva di strumenti di comunicazione e di intesa reciproca, in caso di necessità. E le due parti avverse cercavano, ciascuna in modo diverso, compressione e sostegno in altre culture e altri Paesi del mondo.
Al Baghdadi e Boko Haram rappresentano un nuovo tipo di dirigente rivoluzionario che, tra le classi dirigenti del proprio ambito, o del mondo, non cercano e non chiedono niente. Non vogliono comprensione e non offrono giustificazione. Le loro radici sono altrove, nel tempo (che è evidentemente un mitico passato) ; nei luoghi, che sono vissuti come del tutto privi della struttura civile e organizzativa iniziata col colonialismo e poi divenute abituali; nei rapporti umani, che cercano in basso, e nella appartenenza concepita come ubbidienza e sottomissione; nelle regole, che sono libere da ogni codice e dettate solo da opportunismo spettacolare e da efficacia emotiva, dando e ricevendo il senso di un potere che non deve trattare condizioni o sottostare a doveri.
Ma un altro cambiamento drammatico segna questo ultimo periodo di vita politica internazionale. Dal punto cruciale dell’equilibrio mondiale escono gli Stati Uniti, che avevano e hanno pur sempre un potere sproporzionatamente grande. Ed entra la debole e divisa Europa, che non ha una politica e non ha una guida, ma appare come unico guardiano e garante delle regole del gioco.
IL CAMBIO DELLA GUARDIA non è stato pianificato o voluto. Accade perché gli Usa hanno ritirato le loro opzioni di guerra. Accade perché lo sconvolgimento e il cambiamento di classe dirigente del Medio Oriente e dell’Africa ricadono fatalmente sull’Europa e sugli europei, come ha dimostrato la vicenda francese. In ogni caso le ragioni del cambio della guardia contano poco. Conta che sia avvenuta. E colpisce l’inadeguatezza dell’Europa unita e delle sue istituzioni di fronte al compito di reggere l’equilibrio del mondo libero, e di tenere a bada le pulsioni violentemente aggressive. È questa situazione che ha dettato le pagine, controverse e apparentemente solo provocatorie del libro Soumission di Houellebecq: una Francia che si arrende, diventa islamica ed elegge un presidente islamico. Houellebecq non ha tenuto conto di Papa Francesco.
Non è un difensore, è un testimone. Con un compito più difficile del suo predecessore. Infatti la follia, come un incendio pericoloso, sembra venire da una parte e dall’altra, dalla “nuova classe dirigente” islamica disposta a tutto, e dal gruppo Le Pen-Salvini, altrettanto privo di scrupoli pur di esibirsi. Il compito di Francesco è grande e impossibile. Ma in Europa Francesco, al momento, è l’unico leader.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- “Ora in Europa il populismo sta conquistando anche i governi”. Colloquio con Jürgen Habermas (di Pascal Ceaux)2 dicembre 2014, di Federico La Sala
L’analisi del filosofo tedesco Jürgen Habermas
“Ora in Europa il populismo sta conquistando anche i governi”
“Ci si aggrappa ormai sempre di più alla sovranità degli Stati-nazione quando sarebbero necessarie politiche concertate per contrastare le crescenti diseguaglianze sociali ed economiche A Bruxelles, invece, è rissa continua”
di Pascal Ceaux (la Repubblica, 02.12.2014)
IL FILOSOFO Jürgen Habermas sostiene l’idea di un rafforzamento dell’Unione tra i Paesi del Vecchio Continente e analizza in questo colloquio le contraddizioni dell’Ue, auspicando un cambiamento di rotta. A suo parere, solo un governo economico comune ai Paesi del nocciolo duro europeo sarebbe in grado di combattere le crescenti disuguaglianze sociali in seno all’eurozona.
Habermas, sembra che ovunque l’euroscetticismo stia guadagnando terreno. Siamo in presenza di una crisi dell’Unione europea?
«Sì, l’euroscetticismo guadagna terreno in tutti gli Stati dell’Unione, in particolare in seguito alla crisi in atto da cinque o sei anni: che è bancaria e finanziaria, ma è al tempo stesso una crisi del debito pubblico. Se l’eurozona si rivela fragile, è soprattutto perché a Maastricht, al momento della fondazione dell’Unione monetaria europea, i politici in carica non trovarono il coraggio di trarre le conseguenze da quel passo, e di porre le premesse perché dall’unione monetaria potesse sorgere un’unione politica.
 Al momento le politiche fiscali, economiche e sociali rimangono prerogative degli Stati nazionali. Ma di fatto, solo un governo economico comune a quello che è il nocciolo duro europeo, impegnato a portare avanti una politica concertata, sarebbe in grado di appianare le non ottime condizioni che incontra l’Unione monetaria europea. Allo stato attuale non si fa abbastanza per evitare almeno che i divari tra le diverse economie nazionali continuino ad aumentare».
Al momento le politiche fiscali, economiche e sociali rimangono prerogative degli Stati nazionali. Ma di fatto, solo un governo economico comune a quello che è il nocciolo duro europeo, impegnato a portare avanti una politica concertata, sarebbe in grado di appianare le non ottime condizioni che incontra l’Unione monetaria europea. Allo stato attuale non si fa abbastanza per evitare almeno che i divari tra le diverse economie nazionali continuino ad aumentare».Non pensa che l’impasse politica finisca per dar ragione ai liberisti, che auspicherebbero un semplice spazio di libero scambio commerciale?
«Si tratta di vedere se siamo pronti a rassegnarci all’asimmetria che ormai caratterizza i rapporti tra politica e mercato. Una scelta in questo senso comporterebbe non solo l’abbandono del progetto di una democrazia sovranazionale, ma anche la rinuncia al modello sociale che ancora diciamo di voler difendere.
 Stiamo attenti a non invertire le cause e gli effetti. È in seguito alla liberalizzazione mondiale dei mercati finanziari che i margini di manovra dei governi nazionali si sono ristretti sempre più, e la pressione economica è aumentata a tal punto che gli Stati non dispongono più di livelli di copertura sufficienti per i sistemi di sicurezza sociale. Basterebbe questo a giustificare un’accelerazione dell’integrazione europea. Se ancora esiste una sinistra non rassegnata, il suo impegno andrebbe in questo senso».
Stiamo attenti a non invertire le cause e gli effetti. È in seguito alla liberalizzazione mondiale dei mercati finanziari che i margini di manovra dei governi nazionali si sono ristretti sempre più, e la pressione economica è aumentata a tal punto che gli Stati non dispongono più di livelli di copertura sufficienti per i sistemi di sicurezza sociale. Basterebbe questo a giustificare un’accelerazione dell’integrazione europea. Se ancora esiste una sinistra non rassegnata, il suo impegno andrebbe in questo senso».Come interpreta la volontà d’indipendenza che si manifesta in Scozia, o in Catalogna?
«Quando le crescenti sperequazioni sociali fanno montare l’angoscia e il senso d’insicurezza nella popolazione, sorge la tentazione di un ripiegamento all’interno dei confini familiari, in cui si crede di poter confidare; e la voglia di aggrapparsi a ciò che è “nativo” - la lingua, la nazione, la storia, ereditate o anche acquisite. Visto in quest’ottica, a mio parere il ritorno di fiamma del regionalismo, in Scozia come in Catalogna o nelle Fiandre, è di fatto, almeno sul piano funzionale, l’equivalente del successo del Front National in Francia...».
Non le sembra che oggi il ripiegamento degli Stati-nazione su se stessi sia all’ordine del giorno?
«Certamente. Nell’Ue stiamo assistendo a un ritorno dei nazionalismi, che non coinvolge solo le popolazioni ma anche i rispettivi governi. Certo, il senso di declassamento, la paura del degrado non si trasformano automaticamente in pregiudizi anti-europei; e non si può neppure dire che questi ultimi siano necessariamente associati a pregiudizi nei confronti di altre nazioni. Questa sindrome, che possiamo definire populismo di destra, nasce innanzitutto da una certa interpretazione della crisi bancaria e del debito pubblico, che anche vari partiti di governo leggono a modo loro. Secondo quest’interpretazione, il fatto che una nazione sia collettivamente “colpevole” o meno del proprio indebitamento si spiegherebbe con le differenze in materia di cultura economica nazionale. Oltretutto, è un modo per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dal “destino di classe” - che certo non conosce frontiere - di coloro che in questa crisi sono i vincenti e i perdenti. A riprova di questo ripiegamento sugli interessi nazionali basta osservare il clima sconfortante di rissa del Consiglio europeo. Tutti contro tutti, sembra che il termine solidarietà appartenga a un altro continente. Non c’è da stupirsi che da quel Consiglio non provenga alcun impulso per il rilancio dell’unificazione europea».
Il ritorno a una forma di egemonia impone alla Germania una responsabilità particolare?
«A causa della sua preponderanza economica e demografica, in questi ultimi anni di crisi la Germania ha assunto in Europa un ruolo di leadership che in parte le è stato imposto. Un ruolo che dovrebbe incuterle timore. Certo, questa posizione - anche se si tende a non dirlo - è vantaggiosa dal punto di vista dei suoi in- teressi nazionali. Così, a poco a poco, la Germania viene a trovarsi nuovamente di fronte al dilemma di quella “posizione semi-egemonica” in cui già era venuta a trovarsi a partire dal 1871, e che riuscì a superare solo dopo due guerre mondiali, e grazie all’unificazione europea. Ma proprio la Germania ha il massimo interesse a far uscire l’Unione europea da questa fase del suo sviluppo, in cui le decisioni possono o devono essere prese da un potenza dominante».
I tedeschi pensano che gli altri Paesi debbano fare gli sforzi di austerità che loro hanno compiuto, i francesi preferirebbero una politica di rilancio dell’economia...
«Il fatto che Germania e Francia siano oggi ai ferri corti, non è di buon auspicio per il futuro dell’Ue. In nome dei propri interessi, il governo di Berlino rifiuta di recuperare i ritardi in materia di solidarietà, e non sa decidersi a correggere la propria ostinata politica di risparmio, mentre gli stessi economisti tedeschi chiedono più investimenti. Il governo francese esige a buon diritto questa solidarietà, ma lo fa nell’intento di coordinare tra loro le politiche nazionali in senso tecnocratico.
 I capi di Stato e di governo dovrebbero superare le schermaglie e mettersi d’accordo su alcuni punti: 50 miliardi di risparmi da un lato contro 50 miliardi di investimenti dall’altro. Ma le due posizioni si bloccano reciprocamente. Da un lato il diniego della solidarietà, dall’altro il rifiuto di pagare il prezzo richiesto per un cambio di politica. E dall’una come dall’altra parte ci si aggrappa a una sovranità dallo Stato-nazione, svuotata di ogni significato».
I capi di Stato e di governo dovrebbero superare le schermaglie e mettersi d’accordo su alcuni punti: 50 miliardi di risparmi da un lato contro 50 miliardi di investimenti dall’altro. Ma le due posizioni si bloccano reciprocamente. Da un lato il diniego della solidarietà, dall’altro il rifiuto di pagare il prezzo richiesto per un cambio di politica. E dall’una come dall’altra parte ci si aggrappa a una sovranità dallo Stato-nazione, svuotata di ogni significato».Ma come conciliare lo spazio europeo comune con l’affermazione crescente di una sfera pubblica mondiale?
«Non dovrebbe essere un problema, se l’Europa mettesse in campo la sua potenza anche a livello mondiale, per civilizzare il capitalismo e instaurare i diritti umani».
Che dovrebbe fare l’Europa per rappresentare ancora un’idea di futuro?
«Non sembra vi sia negli Stati membri un dibattito reale sui problemi concreti dell’Unione, né sulle sue effettive possibilità d’azione. I molti partiti politici e i cittadini che trovano solo da ridire sull’Ue dovrebbero superare il loro disfattismo e avere il coraggio di affrontare una controversia tra posizioni chiaramente definite. Solo un dibattito chiaro, franco e senza sconti sulle diverse possibilità di futuro dell’Ue potrebbe restituire un futuro all’Europa».
 © Pascal Ceaux / L’Express ( traduzione di Elisabetta Horvat)
© Pascal Ceaux / L’Express ( traduzione di Elisabetta Horvat) -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Papa a Strasburgo: "Ideali Ue oscurati dalla burocrazia".25 novembre 2014
- RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Papa a Strasburgo: "Ideali Ue oscurati dalla burocrazia" *
Oltre 900 giornalisti accreditati da tutto il mondo e misure di sicurezza straordinarie fanno da contorno alla storica visita del Papa al Parlamento di Strasburgo, riunito per l’occasione in sessione solenne. Al suo arrivo Francesco sarà ricevuto dal Presidente Martin Schulz. I due parteciperanno a una breve cerimonia ufficiale, durante la quale sarà suonato l’inno dello Stato del Vaticano. In Aula Schulz terrà un breve intervento di saluto, prima di dare la parola al Papa, posto al centro dell’emiciclo, che pronuncerà il suo discorso in italiano.
PAPA ARRIVATO A STRASBURGO - Papa Francesco è arrivato a Strasburgo, dove stamani visita il Parlamento europeo e il Consiglio d’Europa. L’aereo con a bordo il pontefice è atterrato all’aeroporto internazionale della città francese. Ad accoglierlo il vice presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli e Antonio Tajani. Bergoglio è sceso a piedi dalla scaletta e si è avviato sempre a piedi verso l’edifico dell’aeroporto. Sull’aereo che lo ha portato a Strasburgo il Papa ha detto: "Vi ringrazio, ringrazio questa compagnia, spero oggi non sia troppo faticoso. Poco tempo, tante cose". Ed ha poi aggiunto una battuta: "Vi auguro una bella giornata, anche se sarà una giornataccia".
ARRIVO AL PARLAMENTO UE - Papa Francesco è arrivato al Parlamento europeo, prima tappa del suo viaggio odierno. All’ingresso Bergoglio è stato accolto dal presidente dell’Europarlamento Martin Schulz e ha assistito alla cerimonia dell’alzabandiera con il vessillo Vaticano. Dopo aver assistito all’esterno del Parlamento europeo, Papa Francesco è entrato nell’edificio dall’ingresso protocollare. Il pontefice, accompagnato dal presidente Martin Schulz, ha firmato l’albo d’onore degli ospiti illustri al Parlamento europeo. Schulz ha presentato il dono al Pontefice, un libro sulle memorie di Jean Monnet in spagnolo. "Un esemplare unico. Ero un libraio di professione, regalo sempre libri" ha detto il presidente del Parlamento parlando in francese. Papa Francesco è entrato nell’emiciclo dell’Euro Parlamento, accolto con un applauso lungo due minuti.
QUALE DIGNITA’ SE SI E’ DISCRIMINATI E SENZA LAVORO? - "Quale dignità può mai avere un uomo o una donna fatto oggetto di ogni genere di discriminazione? Quale dignità potrà mai trovare una persona che non ha il cibo o il minimo essenziale per vivere e, peggio ancora, il lavoro che lo unge di dignità?". Lo ha detto papa Francesco nel suo discorso al Parlamento Europeo. Questo passaggio è stato sottolineato da un applauso dell’emiciclo dell’Europarlamento.
EUROPA MALATA DI SOLITUDINE - "Una delle malattie che vedo più diffuse oggi in Europa è la solitudine, propria di chi è privo di legami", ha detto papa Francesco nel suo discorso al Parlamento Europeo. "La si vede particolarmente negli anziani - ha proseguito Papa Francesco -, spesso abbandonati al loro destino, come pure nei giovani privi di punti di riferimento e di opportunità per il futuro; la si vede nei numerosi poveri che popolano le nostre città; la si vede negli occhi smarriti dei migranti che sono venuti qui in cerca di un futuro migliore".
IDEALI EUROPEI OSCURATI DA TECNICISMI BUROCRATICI - "I grandi ideali che hanno ispirato l’Europa sembrano aver perso forza attrattiva, in favore dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni". Lo ha affermato Papa Francesco nel suo discorso al Parlamento Europeo a Strasburgo.
RADICI CRISTIANE EUROPA ANTIDOTO AD ESTREMISMI - Un’Europa "che sia in grado di fare tesoro delle proprie radici religiose, sapendone cogliere la ricchezza e le potenzialità", può essere "più facilmente immune dai tanti estremismi che dilagano nel mondo odierno, anche per il grande vuoto ideale a cui assistiamo nel cosiddetto Occidente".
SENZA FAMIGLIE UNITE CON FIGLI SI COSTRUISCE SULLA SABBIA - "La famiglia unita, fertile e indissolubile porta con sé gli elementi fondamentali per dare speranza al futuro. Senza tale solidità si finisce per costruire sulla sabbia, con gravi conseguenze sociali".
ACCOGLIERE MIGRANTI, MEDITERRANEO NON SIA CIMITERO - "E’ necessario affrontare insieme la questione migratoria. Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo diventi un grande cimitero!". Sui barconi che giungono quotidianamente sulle coste europee ci sono uomini e donne che necessitano di accoglienza e di aiuto - ha sottolineato Bergoglio -. L’assenza di un sostegno reciproco all’interno dell’Unione Europea rischia di incentivare soluzioni particolaristiche al problema, che non tengono conto della dignità umana degli immigrati, favorendo il lavoro schiavo e continue tensioni sociali". L’Europa, ha proseguito, "sarà in grado di far fronte alle problematiche connesse all’immigrazione se saprà proporre con chiarezza la propria identità culturale e mettere in atto legislazioni adeguate che sappiano allo stesso tempo tutelare i diritti dei cittadini europei e garantire l’accoglienza dei migranti; se saprà adottare politiche corrette, coraggiose e concrete che aiutino i loro Paesi di origine nello sviluppo socio-politico e nel superamento dei conflitti interni - causa principale di tale fenomeno - invece delle politiche di interesse che aumentano e alimentano tali conflitti". "È necessario - ha aggiunto - agire sulle cause e non solo sugli effetti".
* ANSA, 25 novembre 2014 (ripresa parziale).
- RIPENSARE L’EUROPA. PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- "Come vorremmo vivere, domani?" Lettera agli amici (di Giacomo Ulivi).10 novembre 2014, di Federico La Sala
- "Come vorremmo vivere, domani? No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere!"
 Dalla lettera agli amici di Giacomo Ulivi, fucilato 70 anni fa di fronte al Duomo di Modena. L’intera lettera è intensa e moderna, un testamento morale fatto di solo futuro: http://www.anpi.it/lettera-agli-amici-giacomo-ulivi/
Dalla lettera agli amici di Giacomo Ulivi, fucilato 70 anni fa di fronte al Duomo di Modena. L’intera lettera è intensa e moderna, un testamento morale fatto di solo futuro: http://www.anpi.it/lettera-agli-amici-giacomo-ulivi/
 Una biografia: http://www.anpi.it/donne-e-uomini/giacomo-ulivi/
Una biografia: http://www.anpi.it/donne-e-uomini/giacomo-ulivi/
Lettera agli amici,
di Giacomo Ulivi
Cari Amici,
Vi vorrei confessare innanzi tutto, che tre volte ho strappato e scritto questa lettera. L’avevo iniziata con uno sguardo in giro, con un sincero rimpianto per le rovine che ci circondano, ma, nel passare da questo argomento di cui desidero parlarvi, temevo di apparire "falso", di inzuccherare con un patetico preambolo una pillola propagandistica. E questa parola temo come un’offesa immeritata: non si tratta di propaganda ma di un esame che vorrei fare con voi. Invece dobbiamo guardare ed esaminare insieme: che cosa? Noi stessi. Per abituarci a vedere in noi la parte di responsabilità che abbiamo dei nostri mali. Per riconoscere quanto da parte nostra si è fatto, per giungere ove siamo giunti.
Non voglio sembrarvi un Savonarola che richiami il flagello. Vorrei che con me conveniste quanto ci sentiamo impreparati, e gravati di recenti errori, e pensassimo al fatto che tutto noi dobbiamo rifare. Tutto dalle case alle ferrovie, dai porti alle centrali elettriche, dall’industria ai campi di grano.
Ma soprattutto, vedete, dobbiamo fare noi stessi: è la premessa per tutto il resto. Mi chiederete: perché rifare noi stessi, in che senso? Ecco per esempio, quanti di noi sperano nella fine di questi casi tremendi, per iniziare una laboriosa e quieta vita, dedicata alla famiglia e al lavoro? Benissimo: è un sentimento generale, diffuso e soddisfacente.
Ma, credo, lavorare non basterà; e nel desiderio invincibile di "quiete", anche se laboriosa è il segno dell’errore. Perché in questo bisogno di quiete è il tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica. È il tremendo, il più terribile, credetemi, risultato di un’opera di diseducazione ventennale, di diseducazione o di educazione negativa, che martellando per vent’anni da ogni lato è riuscita ad inchiodare in molti di noi dei pregiudizi.
Fondamentale quello della "sporcizia" della politica, che mi sembra sia stato ispirato per due vie. Tutti i giorni ci hanno detto che la politica è un lavoro di "specialisti". Duro lavoro, che ha le sue esigenze: e queste esigenze, come ogni giorno si vedeva, erano stranamente consimili a quelle che stanno alla base dell’opera di qualunque ladro e grassatore.
Teoria e pratica concorsero a distoglierci e ad allontanarci da ogni attività politica. Comodo, eh? Lasciate fare a chi può e deve; voi lavorate e credete, questo dicevano: e quello che facevano lo vediamo ora, che nella vita politica - se vita politica vuol dire soprattutto diretta partecipazione ai casi nostri - ci siamo stati scaraventati dagli eventi.
Qui sta la nostra colpa, io credo: come mai, noi italiani, con tanti secoli di esperienza, usciti da un meraviglioso processo di liberazione, in cui non altri che i nostri nonni dettero prova di qualità uniche in Europa, di un attaccamento alla cosa pubblica, il che vuol dire a sé stessi, senza esempio forse, abbiamo abdicato, lasciato ogni diritto, di fronte a qualche vacua, rimbombante parola?
Che cosa abbiamo creduto? Creduto grazie al cielo niente ma in ogni modo ci siamo lasciati strappare di mano tutto, da una minoranza inadeguata, moralmente e intellettualmente. Questa ci ha depredato, buttato in un’avventura senza fine; e questo è il lato più "roseo", io credo: Il brutto è che le parole e gli atti di quella minoranza hanno intaccato la posizione morale; la mentalità di molti di noi.
Credetemi, la "cosa pubblica" è noi stessi: ciò che ci lega ad essa non è un luogo comune, una parola grossa e vuota, come "patriottismo" o amore per la madre in lacrime e in catene vi chiama, visioni barocche, anche se lievito meraviglioso di altre generazioni. Noi siamo falsi con noi stessi, ma non dimentichiamo noi stessi, in una leggerezza tremenda. Al di là di ogni retorica, constatiamo come la cosa pubblica sia noi stessi, la nostra famiglia, il nostro lavoro, il nostro mondo, insomma, che ogni sua sciagura è sciagura nostra, come ora soffriamo per l’estrema miseria in cui il nostro paese è caduto: se lo avessimo sempre tenuto presente, come sarebbe successo questo? L’egoismo - ci dispiace sentire questa parola - è come una doccia fredda, vero?
Sempre tutte le pillole ci sono state propinate col dolce intorno; tutto è stato ammantato di rettorica; Facciamoci forza, impariamo a sentire l’amaro; non dobbiamo celarlo con un paravento ideale, perché nell’ombra si dilati indisturbato. È meglio metterlo alla luce del sole, confessarlo, nudo scoperto, esposto agli sguardi: vedrete che sarà meno prepotente. L’egoismo, dicevamo, l’interesse, ha tanta parte in quello che facciamo: tante volte si confonde con l’ideale. Ma diventa dannoso, condannabile, maledetto, proprio quando è cieco, inintelligente. Soprattutto quando è celato. E, se ragioniamo, il nostro interesse e quello della "cosa pubblica", insomma, finiscono per coincidere.
Appunto per questo dobbiamo curarla direttamente, personalmente, come il nostro lavoro più delicato e importante. Perché da questo dipendono tutti gli altri, le condizioni di tutti gli altri. Se non ci appassionassimo a questo, se noi non lo trattiamo a fondo, specialmente oggi, quella ripresa che speriamo, a cui tenacemente ci attacchiamo, sarà impossibile. Per questo dobbiamo prepararci. Può anche bastare, sapete, che con calma, cominciamo a guardare in noi, e ad esprimere desideri. Come vorremmo vivere, domani? No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere!
Ricordate, siete uomini, avete il dovere se il vostro istinto non vi spinge ad esercitare il diritto, di badare ai vostri interessi, di badare a quelli dei vostri figli, dei vostri cari. Avete mai pensato che nei prossimi mesi si deciderà il destino del nostro Paese, di noi stessi: quale peso decisivo avrà la nostra volontà se sapremo farla valere; che nostra sarà la responsabilità, se andremo incontro ad un pericolo negativo? Bisognerà fare molto. Provate a chiedevi in giorno, quale stato, per l’idea che avete voi stessi della vera vita, vi pare ben ordinato: per questo informatevi a giudizi obbiettivi.
Se credete nella libertà democratica, in cui nei limiti della costituzione, voi stessi potreste indirizzare la cosa pubblica, oppure aspettare una nuova concezione, più egualitaria della vita e della proprietà. E se accettate la prima soluzione, desiderate che la facoltà di eleggere, per esempio sia di tutti, in modo che il corpo eletto sia espressione diretta e genuina del nostro Paese, o restringerla ai più preparati oggi, per giungere ad un progressivo allargamento? Questo ed altro dovete chiedervi. Dovete convincervi, e prepararvi a convincere, non a sopraffare gli altri, ma neppure a rinunciare.
Oggi bisogna combattere contro l’oppressore. Questo è il primo dovere per noi tutti: ma è bene prepararsi a risolvere quei problemi in modo duraturo, e che eviti il risorgere di essi ed il ripetersi di tutto quanto si è abbattuto su di noi.
Termino questa lunga lettera un po’ confusa, lo so, ma spontanea, scusandomi ed augurandoci buon lavoro.
- "Come vorremmo vivere, domani? No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere!"
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- La questione della lingua. "In Europa son già 103. Troppe lingue per una democrazia?". Intervista a T. De Mauro.4 novembre 2014, di Federico La Sala
 Tullio De Mauro
Tullio De Mauro
 «Sì all’inglese lingua europea. Allarme rosso per la scuola»
«Sì all’inglese lingua europea. Allarme rosso per la scuola»
 De Mauro: l’Italia ignora il tema dell’istruzione, specie quella degli adulti
De Mauro: l’Italia ignora il tema dell’istruzione, specie quella degli adulti
intervista di Paolo Di Stefano (Corriere della Sera, 3.11.2014)
Punto primo: l’Europa è, storicamente, un’entità multilingue sia pure con importanti spinte di convergenza.
 Punto secondo: la questione della lingua in Europa non riguarda solo gli aspetti istituzionali e burocratici, ma è una questione di democrazia, perché è difficile costruire una grande comunità politica democratica se i suoi cittadini non dispongono di una lingua comune.
Punto secondo: la questione della lingua in Europa non riguarda solo gli aspetti istituzionali e burocratici, ma è una questione di democrazia, perché è difficile costruire una grande comunità politica democratica se i suoi cittadini non dispongono di una lingua comune.
 Punto terzo: come tale, la questione linguistica è un problema che riguarda la cultura e che investe la scuola.
Punto terzo: come tale, la questione linguistica è un problema che riguarda la cultura e che investe la scuola.
 Punto quarto: gli Stati e l’Ue nel suo insieme se ne disinteressano totalmente.
Punto quarto: gli Stati e l’Ue nel suo insieme se ne disinteressano totalmente.Sono queste, a grandi linee, le tesi che Tullio De Mauro espone nel suo libro, In Europa son già 103 , in uscita per Laterza. Sottotitolo: Troppe lingue per una democrazia? . Con i suoi 82 anni portati appassionatamente, in poco più di 80 pagine, coniugando leggerezza e profondità, De Mauro affronta cronologie, mutamenti, contaminazioni, aspetti geopolitici. Senza dimenticare il caso italiano, per molti aspetti esemplare.
Professore, perché la questione della lingua in Europa è diventata cruciale?
«Se la prospettiva verso cui vogliamo andare è quella di una federazione di Stati, bisogna che ci sia, come già Aristotele insegnava, un terreno linguistico comune. Non è possibile che uno svedese e un napoletano discutano di politiche finanziarie in lingue diverse. E non è possibile delegare la discussione a un’élite ristretta».
Il guaio è che il multilinguismo, come lei mostra nel libro, è un tratto distintivo europeo. Come si può conciliare questa storia con l’aspirazione unitaria?
«Le due cose non si escludono. Ricordo che l’aspirazione all’unità nazionale, statale, intorno all’italiano è stata un filo conduttore della nostra storia. Tanti, compreso qualche linguista, pensavano che l’unità linguistica, raggiunta negli anni Sessanta, avrebbe spazzato via i dialetti, ma non è successo: oggi, dopo cinquant’anni, i dialetti sono ancora vivi. Così, adottando diffusamente una lingua comune in Europa, non è prevedibile che vengano lese le lingue nazionali radicate nella storia e nella cultura».
Lei si sofferma sulle affinità genetiche tra le lingue indoeuropee, sulla prossimità grammaticale e lessicale. Questo cosa significa?
«Già il linguista francese Antoine Meillet diceva, a proposito del vocabolario, che a dispetto dei nazionalismi miopi, tra le lingue europee c’è un fondo comune molto superiore alle differenze, che si è creato grazie a una rete fitta di condivisioni. E lo stesso Leopardi nello Zibaldone scrisse che guardando al vocabolario della cultura intellettuale, ci si accorgerebbe che esiste una specie di “piccola lingua” che accomuna, nelle diversità, tutte le lingue europee e che deriva in gran parte dal latino e dal greco. Il vocabolario inglese oggi è composto al 75% di prestiti dal francese o direttamente dal latino. Ci sono consonanze profonde. L’inglese è tutt’altro che vuoto di spessore culturale, e qualcuno l’ha definito una lingua neolatina ad honorem. Anche per questo sostenere che la sua adozione cancelli le identità nazionali è sbagliato».
Resta il problema della scuola, che in Italia ha già difficoltà a tenere un accettabile livello di formazione nella lingua materna.
«L’insegnamento della lingua materna resta prioritario. Ma il dato più preoccupante riguarda la popolazione adulta. Anche in Germania o nei Paesi del Nord (e persino negli Stati Uniti) più della metà della popolazione ha gravi difficoltà nel leggere e capire un testo semplice o nell’adoperare banali strumenti di calcolo. In Giappone e in Finlandia si arriva al 38%, in Italia si supera il 70. Direi che è un dato costante l’alto tasso di problemi nell’uso completo delle lingue materne: appena uscite dalla scuola, le persone finiscono per perdere ogni capacità».
Dal documento del governo sulla «Buona Scuola» si intravedono segnali in questo senso?
«Semplicemente la “Buona Scuola” ignora il problema linguistico e non fa alcun cenno alla dimensione dell’istruzione degli adulti, che è cruciale per la vita produttiva e per la vita sociale, perché ricade necessariamente sui figli. Una cosa è sicura: il livello di cultura sostanziale in famiglia è determinante sull’andamento scolastico dei ragazzi. Di istruzione degli adulti parlava la legge Berlinguer del 1999, ma da allora è rimasto tutto sulla carta».
La detrazione fiscale sui libri potrebbe servire?
«Se ne parla da anni, i tecnici temono che diventi una fonte di microevasione, ma sarebbe certamente utile, anche se ormai una pizza costa più di un Meridiano».
Al di là della questione lingua, la «Buona Scuola» come le sembra?
«Lasciamo stare la sovrabbondanza di anglicismi persino ridicoli tipo “gamification”... In sé è un documento accattivante, c’è un’atmosfera scherzosa, nello stile di Renzi, piacevole, con contenuti bizzarri. Io non voglio buttarla sul tragico, ma i problemi della scuola purtroppo lo sono: le strutture edilizie, le lacune del personale tecnico, il rapporto con il mondo del lavoro, le prospettive didattiche... Bisognerebbe rimettere mano all’impianto della scuola media superiore, formare gli insegnanti, che hanno ancora una visione disciplinarista e che invece dovrebbero collaborare tra di loro in funzione di una prospettiva trasversale, sul saper ragionare, argomentare, parlare... La “Buona Scuola” tace su questi argomenti, ma in compenso ne parla la finanziaria, che continua a tagliare sulla scuola, per non dire dell’università che è prossima a defungere».
Cosa pensa del Clil, cioè quel metodo che prevede l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera?
«Va usato con parsimonia. È già difficile avere dei buoni insegnanti di storia, figurarsi averne pure che parlino bene inglese. Diciamo che è un metodo auspicabile per alcuni insegnamenti universitari, ma per gli altri livelli mi pare poco realizzabile».
La «Buona Scuola» vorrebbe estendere il Clil alle elementari.
«La riforma Gelmini prevedeva corsi di formazione inglese, per insegnanti, di 30 ore faccia a faccia e 20 ore via internet: ma con 50 ore complessive non si arriva neanche all’Abc. Le primarie sono le scuole in cui si lavora meglio, in cui le discipline sono strumentali alla maturazione complessiva del bambino. Nei test internazionali i nostri si collocano al vertice: toccare le elementari sarebbe un delitto, perché i guai cominciano dopo. Le analisi Invalsi mostrano che tra i ragazzi usciti dalla media di base e i maturandi lo scarto di competenze è minimo».
L’iniziativa del Politecnico di Milano di adottare solo l’inglese per gli insegnamenti di master la convince?
«No, neanche nei master si può rinunciare alla lingua materna. Nel mondo ci sono masse di studenti che si spostano, sono i nuovi clerici vagantes : ma è difficile pensare che dei giovani trovino suggestive le università italiane perché offrono corsi in inglese. Quel che conta sono altri fattori: la qualità scientifica e le condizioni dell’accoglienza, ma questi aspetti vengono ignorati».
Tornando alla Babele europea, lei accenna al modello indiano e a quello del plurilinguismo svizzero.
«Lo ripeto: sono contro l’immagine catastrofista secondo cui l’inglese diffuso come lingua standard metterebbe a rischio le lingue nazionali. In India, nonostante le diversità etniche e religiose, l’inglese è diventato negli ultimi 60 anni una lingua secondaria affiancata al sanscrito come lingua nazionale: questo però non ha comportato la morte delle parlate locali, l’urdu e l’hindi. In Parlamento si parla in inglese, nei comizi in una delle 45 lingue locali. L’esempio indiano è interessante per l’Europa».
***
Il rischio è perdere il patrimonio del latino
di P.D.S. (Corriere della Sera, 03.11.2014)
Anche le nuove ondate migratorie contribuiscono a cambiare le 103 varietà linguistiche presenti in Europa: gli arabofoni in Francia, i turchi in Germania, i romeni in Italia, i cinesi a Londra, a Manchester, a Parigi, a Berlino, a Prato... Il panorama linguistico europeo presenta una fisionomia eccezionale: i circa 740 milioni di persone dei 50 Stati dall’Atlantico agli Urali usano 62 lingue ufficiali. Di queste, 50 hanno lo status di lingue nazionali ufficiali, altre sono lingue di minoranza. -Ricorda De Mauro che, al di là delle differenze, c’è un patrimonio comune che va valorizzato: «Mentre in India c’è una ripresa molto forte dello studio del sanscrito, mentre nelle zone arabofone resta importantissimo lo studio dell’arabo classico e in Israele c’è un rilancio dell’ebraico biblico, nei Paesi europei si tende a trascurare la tradizione latina. È un’autentica sciocchezza, perché la conoscenza del latino classico resta indispensabile per tutti, anche per gli anglofoni».
 In quella che De Mauro definisce l’«innovatività permanente» di ogni realtà linguistica, intervengono oggi, come si sa, i linguaggi tecnologici.
In quella che De Mauro definisce l’«innovatività permanente» di ogni realtà linguistica, intervengono oggi, come si sa, i linguaggi tecnologici.
 A questo proposito, dal 6 all’8 novembre si terrà a Firenze, organizzato dall’Accademia della Crusca, la VII edizione della Piazza delle Lingue su «L’italiano elettronico». Per informazioni sul convegno www.accademiadellacrusca.it. (p.d.s.)
A questo proposito, dal 6 all’8 novembre si terrà a Firenze, organizzato dall’Accademia della Crusca, la VII edizione della Piazza delle Lingue su «L’italiano elettronico». Per informazioni sul convegno www.accademiadellacrusca.it. (p.d.s.) -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" - di Federico La Sala.23 settembre 2014, di Federico La Sala
Se la Ue diventa una dittatura
di Luciano Gallino (la Repubblica, 23.09.2014)
«QUEL che sta accadendo è una rivoluzione silenziosa - una rivoluzione silenziosa in termini di un più forte governo dell’economia realizzato a piccoli passi. Gli Stati membri hanno accettato - e spero lo abbiano capito nel modo giusto - di attribuire importanti poteri alle istituzioni europee riguardo alla sorveglianza, e un controllo molto più stretto delle finanze pubbliche». Così si esprimeva il presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, in un discorso all’Istituto Europeo Le persone che decidono quali poteri lasciarci o toglierci, sono sì e no alcune dozzine: sei o sette commissari della Ce su trenta; i componenti del Consiglio Europeo (due dozzine di capi di Stato e di governo); i membri del direttivo della Bce; i capi del Fmi, e pochi altri.
Tutti, intendiamoci, immersi in trattative con esponenti del mondo politico, finanziario e industriale, in merito alle quali disposizioni della direzione Ce impongono che i cittadini europei non ne sappiano nulla sino a che non si è presa una decisione. Non esiste alcun organo elettivo - nemmeno il Parlamento Europeo - che possa interferire con quanto tale gruppo decide.
Pare evidente che la Ue abbia smesso di essere una democrazia, per assomigliare sempre più a una dittatura di fatto, la cui attuazione - come vari giuristi hanno messo in luce - viola perfino i dispositivi già scarsamente democratici dei trattati istitutivi. La dittatura Ue potrebbe essere tollerabile se avesse conseguito successi economici. Italiani e tedeschi hanno applaudito i loro dittatori per anni perché procuravano lavoro e prestazioni da stato sociale. Ma le politiche economiche imposte dal 2010 in poi hanno provocato solo disastri. Quali sciagure debbono ancora accadere, di Firenze nel giugno 2010.
Non parlava a caso. Sin dal 2010 la Ce e il Consiglio Europeo hanno avviato un piano di trasferimento di poteri dagli Stati membri alle principali istituzioni Ue, che per la sua ampiezza e grado di dettaglio rappresenta una espropriazione inaudita - non prevista nemmeno dai trattati Ue - della sovranità degli Stati stessi. Non si tratta solo di generiche questioni economiche. Il piano del 2010 stabilisce indicatori da cui dipende l’intervento della Ce sulla politica economica degli Stati membri; indicatori elaborati secondo criteri sottratti a ogni discussione da funzionari della CE. Se gli indicatori segnalano che una variabile esce dai limiti imposti dal piano, le sanzioni sono automatiche. Il piano è stato seguito sino ad oggi da nuovi interventi riguardanti la strettissima sorveglianza del bilancio pubblico, al punto che il ministero delle Finanze degli Stati membri potrebbe essere eliminato: del bilancio se ne occupa la Ce.
Il culmine della capacità di sequestro della sovranità economica e politica dei nostri Paesi da parte della Ue è stato toccato nel 2012 con l’imposizione del trattato detto fiscal compact , che prevede l’inserimento nella legislazione del pareggio di bilancio, «preferibilmente in via costituzionale». I nostri parlamentari, non si sa se più incompetenti o più allineati sulle posizioni di Bruxelles, hanno scelto la strada del maggior danno - la modifica dell’art. 81 della Costituzione.
Questi sequestri di potere a carico dei singoli Stati non sono motivati, come sostengono le istituzioni europee, dalla necessità di combattere la crisi finanziaria. I supertecnici della Ce (sono più di 25mila), ma anche di Fmi e Bce, mostrano di essere dilettanti allo sbaraglio. L’aumento del debito pubblico degli Stati dell’eurozona, salito dal 66% del 2007 all’86% del 2011, viene imputato dalle istituzioni europee a quello che essi definiscono il peso eccessivo della spesa sociale nonché al costo eccessivo del lavoro. Oltre a documenti, decreti, direttive, ad ogni occasione essi fanno raccomandazioni affinché sia tagliata detta spesa.
Pochi giorni fa Christine Lagarde, direttrice del Fmi, insisteva sulla necessità di tagliare le pensioni italiane, visto che rappresentano la maggior spesa dello Stato. Dando mostra di ignorare, la dotta direttrice, che i 200 miliardi della ordinaria spesa pensionistica sono soldi che passano direttamente dai lavoratori in attività ai lavoratori in quiescenza. Il trasferimento all’Inps da parte dello Stato di circa 90 miliardi l’anno non ha niente a che fare con la spesa pensionistica, bensì con interventi assistenziali che in altri Paesi sono a carico della fiscalità generale.
Dinanzi ai diktat di Bruxelles, il governo italiano in genere batte i tacchi e obbedisce, a parte qualche alzar di voce di Renzi. Le prescrizioni contenute nella lettera del 2011 con cui Olli Rhen, allora commissario all’economia della Ce, esigeva riforme dello Stato sociale sono state eseguite. La “riforma” del lavoro di cui si discute in questi giorni potrebbe essere stata scritta a Bruxelles.
Nessuno di questi interventi ha avuto o avrà effetti positivi per combattere la crisi; in realtà l’hanno aggravata. Combattere la crisi non è nemmeno il loro scopo. Lo scopo perseguito dalle istituzioni Ue è quello di assoggettare gli Stati membri alla “disciplina” dei mercati. Oltre che, più in dettaglio, convogliare verso banche e compagnie di assicurazione il flusso dei versamenti pensionistici; privatizzare il più possibile la Sanità; ridurre i lavoratori a servi obbedienti dinanzi alla prospettiva di perdere il posto, o di non averlo. Il vero nemico delle istituzioni Ue è lo stato sociale e l’idea di democrazia su cui si regge; è questo che esse sono volte a distruggere.
Si può quindi affermare che la Ue sarebbe ormai diventata una dittatura di finanza e grandi imprese, grazie anche all’aiuto di governi collusi o incompetenti? Certo, il termine ha lo svantaggio di essere già stato usato dalle destre tedesche, le quali temono - nientemeno - che la Ue faccia pagare alla Germania le spese pazze fatte dagli altri Paesi. Peraltro abbondano i termini attorno all’idea di dittatura: si parla di “fine della democrazia” nella Ue; di “democrazia autoritaria” o “dittatoriale” o di “rivoluzione neoliberale” condotta per attribuire alle classi dominanti il massimo potere economico.
Il termine potrà apparire troppo forte, ma si dia un’occhiata ai fatti. I poteri degli Stati membri di cui le istituzioni europee si sono appropriati sono superiori, per dire, a quelli dei quali gode in Usa il governo federale nei confronti degli Stati federati. quali insulti l’ideale democratico deve ancora subire, prima che si alzi qualche voce - meglio se sono tante - per dire che di questa Ue dittatoriale ne abbiamo abbastanza, e che se uscirne oggi può costare troppo caro è necessario rivedere i trattati, prima di assicurarci decenni di recessione e di servitù politica ed economica?
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Se l’Unione europea allontana persone e diritti (di Stefano Rodotà)20 settembre 2014, di Federico La Sala
Se l’Unione europea allontana persone e diritti
di Stefano Rodotà (la Repubblica, 19 Settembre 2014)
Nel Preambolo alla Carta dei diritti fondamentali si afferma che l’Unione europea «pone la persona al centro della sua azione». Parlando di “persona”, non si è evocata una astrazione. Al contrario. Con quella parola ci si voleva allontanare proprio dalle astrazioni, consegnate a termini come soggetto o individuo, e si intendeva dare rilievo alla vita materiale, alle condizioni concrete dell’esistere, ad un “costituzionalismo dei bisogni” fondato sull’inviolabile dignità di tutti e ciascuno.
Ma nel Mediterraneo ormai quasi ogni giorno muoiono centinaia di persone che all’Europa guardano con speranza, fuggendo dalla guerra, dalle persecuzioni, dalla miseria. I numeri impressionano, ma non sollecitano l’adempimento della promessa scritta nel Preambolo della Carta dei diritti, della quale Juncker ha parlato come di un riferimento obbligato per l’attività dell’Unione europea.
Questa disattenzione fa sì che l’Unione stia diventando complice di un “omicidio di massa”, come giustamente l’Onu ha definito questa terribile e infinita vicenda. Siamo di fronte ad uno degli effetti, niente affatto “collaterali”, della riduzione della politica a calcolo economico e finanziario, alimentando gli egoismi nazionali e spegnendo ogni spirito di solidarietà.
Le parole contano, dovrebbero risuonare con forza, per dare senso ad una Europa che si sta spegnendo proprio perché rinnega se stessa, il suo essere storicamente terra di diritti. Dalla Presidenza italiana dell’Unione europea, anche per la responsabilità assunta in politica estera all’interno della Commissione (sia pure non ancora formalizzata), dovremmo allora attenderci parole forti, liberate da ogni convenienza, pronunciate dallo stesso presidente Renzi che oggi può e deve parlare a nome dell’Europa.
Non è tempo di attese, e anche le mosse simboliche contano, soprattutto se poi riescono ad essere accompagnate da proposte concrete. Ve ne sono già molte, e la politica ufficiale dovrebbe prenderle in considerazione, riflettendo sui visti umanitari, sullo status di rifugiato comunitario, facendo un “investimento di cittadinanza”, ricorrendo a “bond” europei per la cittadinanza (ne ha parlato Mauro Magatti).
L’Europa non impallidisce soltanto in questa dimensione che ha davvero assunto il carattere della tragedia. Vi sono le infinite tragedie della vita quotidiana, moltiplicate in questi anni di crisi e che sono espresse da parole divenute terribilmente familiari: disoccupazione, perdita dei diritti sociali, diseguaglianza. Di nuovo l’Unione europea allontana da sé la persona con i suoi diritti, contraddice le parole che aprono la Carta - «la dignità umana è inviolabile » - perché si nega quel diritto a «un’esistenza dignitosa » di cui parla l’articolo 34 della stessa Carta.
A quell’abbozzo di costituzione europea affidato al Trattato di Lisbona e alla Carta dei diritti fondamentali è stata in questi anni contrapposta una sorta di “controcostituzione”, che ha il suo cuore nel “fiscal compact” e che ha portato ad una indebita amputazione dell’ordine giuridico europeo proprio attraverso la sostanziale cancellazione della Carta dei diritti, che pure ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Nel momento in cui giustamente si contesta la pericolosa riduzione dell’Unione ad una pura logica contabile, proprio la rivendicazione dell’importanza dei diritti è essenziale per muoversi in un orizzonte più largo. Cominciamo a sfruttare i segnali che vengono dalla stessa Unione, dalla sua Corte di giustizia, ad esempio, che con una sentenza del 13 maggio ha affermato che i diritti fondamentali, in via di principio, prevalgono sul mero interesse economico.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- Ripensare la Germania con Mann e Meinecke (di Luciano Canfora)8 settembre 2014, di Federico La Sala
Ripensare la Germania con Mann e Meinecke
di Luciano Canfora (Corriere della Sera, 08.09.2014)
In un libro pubblicato in Italia da Mondadori nel 1946, La conquista morale della Germania , il pubblicista tedesco, di origine ebraica, Emil Ludwig, suggeriva, tra le misure urgenti: «Non basta che spariscano dalla scena i lavori teatrali dell’èra hitleriana: bisogna anche proibire la Tetralogia di Wagner. Essa ha fatto, con la sua forza suggestiva, più male di tutti i libri nazisti perché in essa si trovano lampi di genio e l’impressione che produce è così potente che anche l’ascoltatore poco versato nella musica si trova incitato a conquistare il mondo, a venir meno ai giuramenti, a commettere tutti i delitti dei quali si sono poi macchiati i nazisti». Il libro si apre con una precisazione: «Il carattere nazionale è una realtà che riassume i tratti distintivi di un popolo considerato nel suo complesso, anche se alcuni degli individui che lo compongono non li possiedono».
Poco dopo apparve presso La Nuova Italia, La catastrofe tedesca di Friedrich Meinecke, edito in Germania anch’esso nel 1946. Meno drastico di Ludwig, ugualmente severo con la storia tedesca culminata nella catastrofe del 1945, stabiliva un filo negativo a partire dall’affermarsi del militarismo prussiano. E in uno degli ultimi capitoli si poneva anche il quesito se ci fosse «un avvenire per l’hitlerismo», paventando addirittura che «in virtù della sua superiorità demagogica che gli è conferita dal suo metodo di conquista delle masse, esso non sia destinato a diventare la forma di vita dominante nell’Occidente».
Nei 70 anni che ci separano dalla «catastrofe» analizzata da Meinecke sono intervenuti mutamenti epocali, anche se un osservatore attento non può non essere sensibile alla questione posta dal grande storico, scomparso nel 1954, e soprattutto alla sua intuizione veridica: essere stato cioè il nocciolo dell’hitlerismo la capacità di conquista demagogica delle masse.
Chi se la sente di negare che il problema è sempre sul tappeto? In certo senso il liberale Meinecke non si discosta molto (ovviamente senza conoscerla) dalla nota di diario del comunista Bertolt Brecht, scritta durante l’esilio americano: «Un fascismo americano sarebbe democratico» (intendeva dire: eviterebbe di ferire alcune esteriorità dei sistemi rappresentativi). Del resto anche Thomas Mann, nel discorso di Hollywood del 1948, lanciò l’allarme di fronte ai prodromi del maccartismo e non eluse certo il concetto di «fascismo».
Oggi la Germania è il perno dell’Unione Europea e il guardiano delle sue rigide regole economiche. Di queste soltanto, giacché gli altri campi dell’agire umano (dai problemi della guerra e della pace ad altri molto più specifici) non hanno in verità visto svilupparsi alcuna «unione». Perciò la Germania torna ad essere impopolare presso l’opinione pubblica dei Paesi che più patiscono dell’asserita, e vigorosamente presidiata, immodificabilità di «parametri» e «vincoli». Una impopolarità forse non così aspra come quella documentata dal libro di Emil Ludwig, ma certo difficilmente sanabile con le prediche .
Nascono perciò da ultimo libri di due generi: quelli che cercano, affettuosamente argomentando, di attutire quella diffusa avversione e quelli che, invece, mettono in relazione la riacquisita egemonia tedesca sull’Europa con i modi (e i costi) con cui, a partire dal novembre 1990, si attuò la riunificazione tedesca. L’infittirsi stesso della pubblicistica sull’argomento dimostra che un «problema tedesco» esiste oggi più che mai, ben diverso - s’intende - da quello cui vanamente cercavano di dare una soluzione, negli anni della guerra fredda, le periodiche conferenze tra i vincitori sul «problema tedesco».
Nel primo gruppo porrei due saggi: Cuore tedesco di Angelo Bolaffi (uscito da Donzelli nel 2013) e il nuovo Europa tedesca, Germania europea di Luigi Reitani (Salerno, pp. 104, e 7,90), in uscita il 17 settembre. Nell’altro gruppo porrei il saggio, molto documentato e illuminante, di Vladimiro Giacché, Anschluss. L’annessione: l’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa (Imprimatur editore).
L’idea dominante di Reitani, il quale, come germanista, ha dedicato molte energie alla teoria e alla pratica della traduzione, è condensata in questa osservazione: «Prima ancora che economica, politica e sociale, la questione europea è oggi in primo luogo una questione culturale. Il vero problema dell’Unione non è il mantenimento del patto di Stabilità o l’alternativa tra una politica di contenimento della spesa pubblica e quella di un incentivo alla crescita, ma il superamento delle barriere che impediscono la reciproca comprensione». Il pensiero verso cui converge il libro di Bolaffi è: «Tocca ai tedeschi assumersi la responsabilità storica di salvare l’Europa, dopo averla affondata due volte in passato. Ed è necessario che esercitino con saggezza e lungimiranza l’egemonia che loro compete».
Merito rilevante del libro di Giacché è di aver ricostruito, con gli strumenti dell’analisi economica, le modalità dell’unificazione o meglio annessione dei Länder dell’ex Germania Est: deindustrializzazione dell’ex Ddr, perdita di posti di lavoro in quei Länder, emigrazione di massa verso Ovest. L’interrogativo, non allegro, che il libro ci propone è se non si stia assestando in modi analoghi l’attuale riunificazione «tedesca» dell’Europa .
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- Germania. Karl Jaspers - L’essenza politica della colpa (di Giuseppe Bedeschi)9 settembre 2014, di Federico La Sala
Germania
L’essenza politica della colpa
di Giuseppe Bedeschi (Il Sole Domenica, 07.09.2014)
- Elena Alessiato, Karl Jaspers e la politica. Dalle origini alla questione della colpa, Orthotes, Napoli-Salerno, pagg. 262, euro 17,00
Karl Jaspers, uno dei più eminenti pensatori tedeschi del Novecento, fu duramente colpito quando il regime hitleriano procedette alla nazificazione delle università. Egli, "ariano", aveva sposato una donna ebrea, e, avendo rifiutato di divorziare, nel 1937 gli venne tolta la cattedra all’università di Heidelberg; nel 1938 gli fu imposto il divieto di pubblicare. Il filosofo si ritirò così fra le quattro mura della sua casa, dedicandosi interamente agli studi. La sua fu per parecchi anni una vita catacombale, interrotta da rare visite di amici. I coniugi Jaspers si salvarono in extremis: la loro deportazione era stata fissata per il 14 aprile 1945, ma il 30 marzo le truppe americane entrarono a Heidelberg.
Ricavo queste notizie dal bellissimo libro di Elena Alessiato, Karl Jaspers e la politica. Dalle origini alla questione della colpa (edito da Orthotes). Il terzo capitolo di questo libro è dedicato, appunto, alla Schuldfrage: un tema che suscitò, nel secondo dopoguerra, discussioni appassionate.
Jaspers tenne il suo primo corso di lezioni a Heidelberg, dopo la caduta del regime nazista, nel semestre invernale 1945-46, e lo dedicò alla «situazione spirituale della Germania». L’uditorio era numerosissimo (c’erano anche molti ex-soldati) e attentissimo, ma non manifestava consenso. Anzi, si percepiva, durante le lezioni, una tensione elevata (come Jaspers scrisse ad Hannah Arendt). Questa tensione era dovuta alle tesi che il filosofo veniva esponendo, e che sarebbero poi confluite nel saggio che egli pubblicò nel 1946, Die Schuldfrage.
La colpa che macchiava il popolo tedesco, secondo Jaspers, era soprattutto una colpa politica (che non doveva essere confusa con la colpa giuridica, o con quella morale, o con quella metafisica). «Quando i nostri amici ebrei - egli diceva - furono deportati, noi non siamo scesi nelle strade, non abbiamo gridato fino a farci annientare. Abbiamo preferito rimanere in vita, con la debole, anche se vera giustificazione, che la nostra morte non sarebbe servita a niente. Che noi viviamo, è la nostra colpa».
Le affermazioni del filosofo suscitarono grande scalpore, e vennero interpretate come una criminalizzazione del popolo tedesco: una criminalizzazione indiscriminata, che non teneva conto del fatto che non tutti i tedeschi erano stati nazisti, e che migliaia e migliaia di essi erano stati assassinati o reclusi nei campi di concentramento. Senza contare che alle generazioni più giovani - che nel 1945 avevano vent’anni o poco più - non poteva essere imputato alcunché; e a queste generazioni soprattutto era affidato il futuro della Germania.
Le perplessità che le posizioni di Jaspers suscitarono nel suo paese, furono manifestate anche altrove. In Italia, per esempio, il più illustre esponente della cultura antifascista, Benedetto Croce, liquidò la Schuldfrage in modo sprezzante. «Mi pare un po’ stupido credere - scrisse nel 1947, in occasione della edizione italiana del saggio di Jaspers - che un popolo vinto possa avere mai altro desiderio o coltivare altro dovere che di rimettersi in piedi e fronteggiare di nuovo gli altri popoli». Del resto, aggiungeva il vecchio filosofo, anche gli altri popoli avevano commesso le loro «colpe», se così si voleva chiamarle, perché essi erano «società di poveri uomini», come quello tedesco. «Conclusione: non stare a seccare, con inutili e arroganti rimbrotti e consigli moralistici, la Germania che soffre, perché seccare il prossimo, seccarlo a questo modo, è anch’essa una colpa, e delle meno perdonabili, verso l’umanità».
Questo giudizio di Croce appariva però troppo tranchant. Del resto egli stesso, in un bellissimo saggio scritto nel 1943, Il dissidio spirituale della Germania con l’Europa, aveva ravvisato nel nazismo «una crisi terribile che covava nella secolare storia tedesca», il «portato della storia di tutto un popolo». Il che significava che la nazione tedesca doveva compiere un profondo riesame di tutto il proprio passato. E questo fu fatto da illustri storici: dall’anziano, sommo maestro, F. Meinecke (che scrisse nel 1946 La catastrofe della Germania, in cui metteva sotto accusa la cultura politica nazionalista e militarista tedesca, che aveva reso possibile l’ascesa al potere di Hitler), a F. Fischer, a K. Bracher («è l’eredità della coscienza nazionale tedesca nel suo complesso che deve essere messa in questione, se si vuole comprendere come si è arrivati alla catastrofe»); e da illustri scrittori, come H. Boell e G. Grass, per fare solo alcuni nomi.
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- L’alternativa radicale alla globalizzazione. «Riterritorializzare» i processi economici (di Guido Viale).4 settembre 2014, di Federico La Sala
Editoriale
L’alternativa radicale alla globalizzazione
di Guido Viale (il manifesto, 02.09.2014)
L’articolo. «Riterritorializzare» i processi economici. Se è stata la globalizzazione a spalancare le porte alla competitività universale, noi dobbiamo pensare e praticare alternative che valorizzino i benefici dell’unificazione del pianeta in un’unica rete di rapporti di interdipendenza e di connettività
Molte delle minacce che incombono sul nostro pianeta - e di cui poco si parla - sono già fatti. Innanzitutto la data che renderà irreversibile un cambiamento climatico radicale e devastante si avvicina. A questo vanno aggiunte tutte le altre forme di inquinamento e di devastazione, sia a livello globale che locale, che lasceranno a figli e nipoti un debito ambientale ben più gravoso dei debiti pubblici su cui politici ed economisti si stracciano le vesti.
Governi e manager hanno per lo più cancellato il problema dalla loro agenda: la green economy promossa a quei livelli non è un’alternativa al trend in atto, ma una serie scollegata di misure, spesso dannose, che ne occupano gli interstizi. L’Italia, che ha una strategia energetica (Sen) recepita dal governo Renzi, ne è un esempio: ha impegnato cifre astronomiche nelle fonti rinnovabili a beneficio quasi solo di grandi speculazioni che devastano il territorio, ma dentro un piano energetico incentrato su trivellazioni e trasporto di metano in conto terzi. È una visione miope che distrugge, insieme all’ambiente, anche l’agognata competitività, e chiude gli occhi di fronte al futuro.
Viviamo ormai da tempo in stato di guerra: l’Italia - ma non è certo un’eccezione - è già impegnata con diverse modalità, tutte contrabbandate come «missioni di pace», su una decina di fronti. Ma questi interventi, che non sono mai guerre dichiarate, alimentano un meccanismo irreversibile: si armano o sostengono Stati o fazioni per combatterne altri o altre, che poi si rivoltano contro chi le ha armate in un alternarsi continuo dei fronti che non fa che allargarli. Dal conflitto israelo-palestinese alla guerra tra Iraq e Iran, dalla Somalia all’ex Jugoslavia, dalle due guerre contro l’Iraq all’Afghanistan, e poi all’Algeria, alla Libia, alla Siria e di nuovo all’Iraq, e poi in Ucraina, l’establishment dell’Occidente ha ormai perso il controllo delle forze che ha scatenato.
È difficile riconoscere coerenza a scelte (ciascuna delle quali ha o ha avuto una sua «logica») che messe in fila testimoniano la mancanza di una visione strategica. Il soffocamento o la degenerazione di molti processi nati da rivolte popolari contro miseria e dittature sono il risultato di una mancanza di alternative alla diffusione del caos che la «democrazia occidentale» - ormai identificata con il dominio feroce dei «mercati», cioè con una competitività universale - non è più in grado di prospettare e che le forze antagoniste non sono ancora capaci di proporre.
Entrambi quei trend sono destinati a produrre un crescendo continuo di profughi, sia ambientali che in fuga da guerre e miseria, destinati a sconvolgere la geopolitica planetaria. Già ora, e da anni, paesi come Pakistan, Siria, Giordania, Libano, Iraq, Turchia, Tunisia, sono costretti a ospitare milioni di profughi, molti dei quali si riversano poi - e si riverseranno sempre più, a milioni e non a decine di migliaia - in Europa. Pensare di affrontare questi flussi con politiche di respingimento è non solo criminale, ma del tutto irrealistico. Ma avere milioni di nuovi arrivati da «ospitare», con cui convivere per molto tempo o per sempre, a cui trovare un’occupazione, evitando di innescare in tutto il paese focolai di infezione razzista (e di reclutamento per milizie del terrore) rende addirittura risibili le politiche economiche e sociali di cui dibattono i nostri governi, tutte calibrate sui decimi di punto di Pil. È un dato che dovrebbe in realtà ridefinire in tutta Europa le politiche relative a scuola, sanità, abitazione, lavoro e cultura: i temi su cui noi stiamo riflettendo, mobilitandoci o cercando di lottare.
Molti di quei focolai accesi dalle strategie, o dalla mancanza di strategia, dell’Occidente nel corso degli ultimi decenni (Ucraina, Medio Oriente e Maghreb), poi trasformatisi in incendi, rischiano anche di interrompere l’approvvigionamento energetico dell’economia europea. Le conseguenze potrebbero essere deflagranti sia per la produzione che per le condizioni di vita e la mobilità. Ma anche in questo caso la governance europea non va più in là del giorno per giorno.
Di fronte a scenari come questi si evidenzia tutta la miopia delle politiche dell’Unione messe in atto con l’austerity, il fiscal compact, gli accordi come TTIP e TISA, l’eterna melina sul coordinamento delle politiche degli Stati membri. Qui tuttavia una strategia chiaramente perseguita c’è: mettere la finanza pubblica con le spalle al muro: non per «liberalizzare», ma per privatizzare tutto l’esistente: imprese e servizi pubblici, beni comuni, territorio, ma anche esistenze individuali e percorsi di vita; mettere con le spalle al muro il lavoro, per privarlo di tutti i diritti acquisiti in due secoli di lotta di classe; instaurare il dominio di una competitività universale: non, ovviamente, tra pari, ma dove i più forti siano liberi di schiacciare i più deboli.
Tuttavia anche in questo caso gli effetti vanno al di là del previsto: sono le stesse «teste pensanti» dell’establishment ad ammettere, anno dopo anno, che i risultati non sono quelli che si attendevano. Soprattutto ora che vengono al pettine contemporaneamente molti di quei nodi: deflazione, deindustrializzazione, disoccupazione, dipendenza energetica, guerre senza sbocco, disastri climatici, profughi. Ma non hanno vere alternative; e mettere toppe da una parte - cosa in cui Mario Draghi è maestro - non fa che aprire falle da un’altra.
Dunque un «piano B» non esiste. Dobbiamo lavorarci noi e questo deve essere l’orizzonte politico, e prima ancora culturale, di qualsiasi iniziativa, anche la più minuta, di cui ci occupiamo.
Non lasciamoci scoraggiare dalla sproporzione delle forze e delle risorse: in sintonia con noi ci sono altre migliaia di organizzazioni sparse per il mondo (e forse un passo importante per cominciare a coordinarci a livello europeo è stato fatto con la lista L’altra Europa; e non è né il primo né l’unico); e poi, ci sono milioni o miliardi di esseri umani che hanno bisogno di trovare in nuove pratiche e nuove elaborazioni un punto di riferimento per sottrarsi a quel «caos prossimo venturo» di cui già sono vittime. La radicalità di un movimento, di un programma, di un’organizzazione, cioè la loro capacità di misurarsi con lo stato di cose in essere, si misura su questo sfondo: si tratta di sviluppare a trecentosessanta gradi il conflitto con il pensiero unico e con la cultura e la pratica della competitività universale e le sue molteplici applicazioni, per promuovere al loro posto le condizioni di una convivenza pacifica, egualitaria, democratica e solidale tra gli umani e con la natura.
È stata la globalizzazione a spalancare le porte alla competitività universale. Noi dobbiamo pensare e praticare nell’agire quotidiano alternative che valorizzino i benefici dell’unificazione del pianeta in un’unica rete di rapporti di interdipendenza e di connettività, ma in condizioni che non facciano più dipendere la sopravvivenza di alcuni dalla morte di altri, il reddito di alcuni dalla miseria altrui, il successo di un’azienda dalla rovina dei concorrenti, il mantenimento o la «conquista» di un lavoro dall’espulsione di chi ne resta escluso, la «ricchezza delle nazioni» (il Pil!) dalla miseria delle rispettive popolazioni.
Queste alternative riconducono tutte alla riterritorializzazione dei processi economici: non al protezionismo, che non è più praticabile; non al confino in ambiti economici chiusi con il ritorno a valute nazionali in competizione tra loro; non alla ferocia di identità etniche e culturali fittizie che ci mettono in guerra con chiunque non le condivida; bensì alla promozione ovunque possibile - e certamente non in tutti i campi e per tutti i bisogni - di rapporti quanto più stretti, diretti e programmati tra produttori e consumatori di uno stesso territorio, ridimensionando a misura dei territori di riferimento, ovunque possibile, impianti, aziende, reti commerciali e il loro governo.
La trasferibilità del know-how a livello planetario ormai lo consente per molti processi, a partire dalla generazione energetica; il recupero dei materiali di scarto ci può rendere più indipendenti dall’approvvigionamento di materie prime; i servizi pubblici locali riportati alla loro missione originaria possono connettere un governo democratico e partecipato della domanda (di energia, alimenti, trasporto, di gestione del territorio, di cura delle persone, di promozione della cultura, dell’istruzione, dell’integrazione sociale) con misure di sostegno all’occupazione, di conversione ecologica delle attività produttive, di risanamento del territorio e del costruito. Si può così costruire, dentro il villaggio globale creato dalla circolazione dell’informazione e dall’interconnessione delle esistenze di tutti, le basi materiali di una vita di comunità ricca di relazioni.
Una strada che è la base irrinunciabile di un progetto politico alternativo per Europa e per il mondo intero; che va imboccata e seguita in ogni situazione in forme differenti e specifiche; ma tutte insieme possono fornire dei modelli a chi decide di imboccarla.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- LA GRANDE TRANSIZIONE. Il trapasso dell’egemonia mondiale (di Alfonso Gianni)30 agosto 2014, di Federico La Sala
Il trapasso dell’egemonia mondiale
di Alfonso Gianni (il manifesto, 28 Agosto 2014)
Non c’è che dire: papa Borgoglio gode di un lungo momento di grazia nell’opinione pubblica mondiale. Ogni cosa che dice diventa di riferimento anche in ambito non confessionale. Ne sia esempio la sua recente dichiarazione sull’esistenza nel mondo contemporaneo di una terza guerra mondiale “a pezzetti”. Il Papa non è un analista politico e quindi non si può pretendere da lui l’esattezza della definizione, ma è un fatto che essa ha sfondato anche nel campo della sinistra che pensa di interpretare così le varie guerre guerreggiate sanguinosamente in corso, dall’Ucraina al Medio Oriente. D’altro canto, vista la mancanza di profondità nella ricerca analitica e di pensieri lunghi nel campo della sinistra non deve stupire né infastidire questa supplenza pontificia.
Resta da domandarsi se le cose stanno proprio così. Se il papa ci ha preso oppure no. Propenderei, con tutto il rispetto e - perché no - anche ammirazione, per il no. Per quanto molteplici siano i conflitti in corso, non credo che si possa parlare di una terza guerra mondiale seppure a macchia di leopardo e a bassa intensità. Siamo piuttosto di fronte - ma ogni definizione è per necessità, come diceva il grande filosofo, una limitazione - ad una guerra civile prolungata senza frontiere, ove entrano in gioco una molteplicità di soggetti dai contorni imprecisi.
Per spiegarmi devo riprendere per sommi capi un punto che ritengo cruciale nell’analisi della crisi economica tutt’ora in corso - per l’Europa molto peggiore di quella degli anni Trenta - e che viene però o sottaciuto o negato. La crisi è trasformazione, non crollo. Anzi una grande trasformazione, per parafrasare Polanyi. Questa crisi si colloca e rimarca l’avvento di una grande transizione egemonica mondiale, ove il baricentro del potere, economico in primo luogo, si sposta da ovet ad est, dall’Atlantico al Pacifico. Non è la prima volta che nella storia dell’umanità avvengono passaggi così cruciali, come ci ha insegnato Fernand Braudel e la sua scuola. Questo è uno di quelli.
In questa crisi è maturato il sorpasso nel primato mondiale delle nazioni tra la Cina e gli Stati Uniti d’America. Qualche dato snocciolato in breve aiuta a valutare la portata del fenomeno. Tra il 2000 e il 2008, il commercio internazionale della Cina è quadruplicato. Le esportazioni sono aumentate del 474 per cento e del 403 per cento delle sue importazioni.
 Al contrario gli Stati Uniti hanno perso la loro posizione di prima potenza commerciale del mondo, una leadership che detenevano da un secolo. Prima della crisi finanziaria globale del 2008, gli Stati Uniti erano il principale partner commerciale di 127 paesi nel mondo, la Cina lo era solo per un po’ meno di 70 paesi.
Al contrario gli Stati Uniti hanno perso la loro posizione di prima potenza commerciale del mondo, una leadership che detenevano da un secolo. Prima della crisi finanziaria globale del 2008, gli Stati Uniti erano il principale partner commerciale di 127 paesi nel mondo, la Cina lo era solo per un po’ meno di 70 paesi.
 Oggi, Pechino è diventata il principale partner commerciale di 124 stati, mentre Washington lo è solo di circa 70 paesi. Su questa base la Cina pensa di potere imporre prima o poi la propria moneta quale riferimento per le transazioni internazionali scalzando definitivamente il primato del dollaro.
Oggi, Pechino è diventata il principale partner commerciale di 124 stati, mentre Washington lo è solo di circa 70 paesi. Su questa base la Cina pensa di potere imporre prima o poi la propria moneta quale riferimento per le transazioni internazionali scalzando definitivamente il primato del dollaro.D’altro canto non vi è dubbio che la Cina ha saputo reagire prima e meglio agli effetti della crisi mondiale. Lo ha fatto in virtù di un sistema fortemente centralizzato che attua un fermo controllo sui movimenti dei capitali. Non mancano, anzi sono in crescita, le tensioni e i conflitti sociali nell’universo cinese, ma anche le imminenti celebrazioni di Deng Hsiao Ping - con una megaproduzione televisiva tale da fare impallidire i tormentoni americani - sembrano configurare l’era comunista come una parentesi fruttuosa tra una società ancora largamente precapitalista ed una a capitalismo sviluppato proiettata nella globalizzazione con e grazie ad un forte intervento e controllo statali.
 In più la Cina ha saputo muoversi sullo scacchiere mondiale con un’attenzione particolare ai grandi fattori economici che possono cambiare d’un colpo solo la geoeconomia e la geopolitica del globo terrestre. Non mi riferisco soltanto alla preveggente penetrazione cinese in Africa, ma anche al recente accordo con la Russia sulle forniture di gas e al progetto con gli altri Brics di dare vita ad una sorta di banca mondiale alternativa a quella attuale.
In più la Cina ha saputo muoversi sullo scacchiere mondiale con un’attenzione particolare ai grandi fattori economici che possono cambiare d’un colpo solo la geoeconomia e la geopolitica del globo terrestre. Non mi riferisco soltanto alla preveggente penetrazione cinese in Africa, ma anche al recente accordo con la Russia sulle forniture di gas e al progetto con gli altri Brics di dare vita ad una sorta di banca mondiale alternativa a quella attuale.Il ruolo migliore che la presidenza Obama poteva assumersi di fronte alla storia per non lasciare un cattivo ricordo di sé, era quello di fare in modo che questo inevitabile trapasso di primato avvenisse nel modo più pacifico possibile. Naturalmente era una speranza assai fragile e gli avvenimenti successivi l’hanno facilmente contraddetta.
Sul piano geoeconomico e geopolitico gli Usa si muovono con decisione tentando di contenere la Cina e i Brics attraverso accordi capestro economico commerciali, fra cui il famigerato TTIP, che riguarda direttamente l’Europa; il TPA (trans pacific agreement) che però il Giappone mostra di non gradire; il meno noto TISA (trade in services agreement). Gli ultimi due sono in diretta funzione anticinese e antiBrics, il primo cerca di togliere sul nascere all’Europa ogni illusione di potere giocare un ruolo autonomo in questo processo di transizione egemonica mondiale.
Gli Usa hanno perso il primato economico, ma non certo quello militare. Sono teoricamente in grado di vincere qualunque guerra, ma non più di sostenerla economicamente. E di guerre lampo non se ne sono viste, tranne che nella sceneggiata di Granada. La differenza con il passato non è piccola. Anche con quello recente della guerra preventiva e infinita dei Bush e dei Clinton, quella semplificata con l’esempio dell’uccisione preventiva dell’orso - che ricorda quello che vorrebbe fare la Lega Nord nei confronti dell’orsa “anomala” di Pinzolo - raccomandata da Robert Kagan. Ecco allora che gli strateghi statunitensi rovistano nel passato.
 Nell’autorevole Foreign Affairs di luglio/agosto 2014, Jack Divine - 32 anni nella Cia - annota che: “ L’esperienza degli USA in Cile nei primi anni ’70 ha offerto una serie di lezioni su come portare avanti buone azioni segrete e su come evitarne di cattive. Alcune di queste lezioni sono state imparate, ma troppe di queste no” quindi, continua Divine, gli Usa si lasciano alle spalle le grandi azioni militari in Afghanistan e Iraq ed entrano in un nuovo periodo “nel quale le azioni segrete diventeranno davvero cruciali in luoghi come Iran, Pakistan, Syria e Ucraina.” Appunto.
Nell’autorevole Foreign Affairs di luglio/agosto 2014, Jack Divine - 32 anni nella Cia - annota che: “ L’esperienza degli USA in Cile nei primi anni ’70 ha offerto una serie di lezioni su come portare avanti buone azioni segrete e su come evitarne di cattive. Alcune di queste lezioni sono state imparate, ma troppe di queste no” quindi, continua Divine, gli Usa si lasciano alle spalle le grandi azioni militari in Afghanistan e Iraq ed entrano in un nuovo periodo “nel quale le azioni segrete diventeranno davvero cruciali in luoghi come Iran, Pakistan, Syria e Ucraina.” Appunto.La transizione egemonica mondiale e la resistenza ad essa degli Usa rendono quindi più instabili le condizioni dei paesi di confine fra Est e Ovest: in Europa, un tempo i Balcani, oggi l’Ucraina; nel Medio Oriente tutti i paesi, nessuno escluso. Gli altri non stanno a guardare. -Non la Russia di Putin, né tantomeno le forze che hanno fatto del fanatismo religioso islamico la loro forza egemonica. Ognuno cerca di riposizionarsi in questo trapasso mondiale, ridisegnando i confini geografici di intere zone del mondo, ove è più funzionale la guerra civile potenziata e foraggiata che non la classica invasione militare.
 Le contraddizioni interimperialistiche - si sarebbe detto un tempo - si risvegliano in nuove forme. Il Califfato oggi è questo: non solo terrorismo diffuso ma soffocamento delle istanze libertarie, progressiste e anche laiche che erano presenti nelle primavere arabe, in particolare tra le donne ed i giovani, come nella resistenza palestinese, per la costruzione di un nuovo stato nel nome della reazione più pura e brutale.
Le contraddizioni interimperialistiche - si sarebbe detto un tempo - si risvegliano in nuove forme. Il Califfato oggi è questo: non solo terrorismo diffuso ma soffocamento delle istanze libertarie, progressiste e anche laiche che erano presenti nelle primavere arabe, in particolare tra le donne ed i giovani, come nella resistenza palestinese, per la costruzione di un nuovo stato nel nome della reazione più pura e brutale. -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO" --- LA LEZIONE DI CARLO LEVI TUTTA DA RIMEDITARE.18 agosto 2014, di Federico La Sala
RIPENSARE L’ EUROPA!!! LA LEZIONE DI CARLO LEVI TUTTA DA RIMEDITARE.
 Una nota *
Una nota *Sul tema, mi permetto di invitare a rileggere il ricco e complesso lavoro sociologico-politico (altro che "romanzo"!) di Carlo Levi, “Cristo si è fermato ad Eboli”, e a soffermarsi - in particolare - sul passaggio relativo alla “Ditta Renzi - Torino”, alle tasse, e alle capre (pp. 40-41, ed. Einaudi: testo integrale disponibile al link: http://lnx.polocorese.it/phpnuke/upload/ebook/Carlo-Levi-CRISTO-SI-E’-FERMATO-A-EBOLI.pdf).
Il ’passaggio’ offre un ‘cortocircuito’ tra ieri (1935) e oggi (2014), una sintesi eccezionale della "cecità" di lunga durata delle classi "dirigenti" del nostro Paese!
Sul tema, in generale, non è male riflettere ancora su questa notazione: ” (...) quello che noi chiamiamo questione meridionale non è altro che il problema dello Stato (...) Le opere pubbliche, le bonifiche, sono ottime cose, ma non risolvono il problema. La colonizzazione interna potrà avere dei discreti frutti materiali, ma tutta l’Italia, non solo il mezzogiorno, diventerebbe una colonia” (p. 220).
A mio parere, il lavoro (non solo questo! Si veda almeno "Paura della libertà", scritto - dopo il confino - nel 1939 e pubblicato da Einaudi nel 1946) di Carlo Levi, è ancora tutto da leggere e da rimeditare, oggi! - assolutamente profetico; è nell’ottica di una visione inaudita e inedita della storia, per molti versi (per intendersi e orientarsi) vicina a Giambattista Vico* e a Walter Benjamin*.
Al di là dei vari storicismi idealistici o materialistici, con grande consapevolezza filosofica e teologico-politica, in un passaggio sul nodo della civiltà contadina e delle sue guerre ("le sue guerre nazionali") e della storia "di quello che non si svolge nel tempo: la sola storia di quello che è eterno e immutabile, una mitologia", così scrive:
 "La prima di esse [delle guerre nazionali] è quella di Enea. Una storia mitologica deve avere delle fonti mitologiche; e in questo senso, Virgilio è un grande storico. I conquistatori fenici, che venivano da Troia, portavano con sé tutti i valori opposti a quelli della antica civiltà contadina. Portavano la religione e lo Stato, la religione dello Stato. (...) Poi venne Roma, e perfezionò la teocrazia statale e militare dei suoi fondatori troiani, che, vincitori, avevano però dovuto accogliere la lingua e il costume dei vinti. E Roma si urtò anch’essa nella difesa contadina, e la lunga serie delle guerre italiche fu il più duro ostacolo al suo cammino"; e, ancora, fino ad illuminare il suo presente storico, scrive con lucidità e spirito critico: "(...) La quarta guerra nazionale dei contadini è il brigantaggio. Anche qui, l’umile Italia storicamente aveva torto, e doveva perdere. Non aveva armi forgiate da Vulcano, né cannoni, come l’altra Italia. E non aveva dèi: che cosa poteva fare una povera Madonna dal viso nero contro lo Stato Etico degli hegeliani di Napoli" (pp. 123-125, cit.).
"La prima di esse [delle guerre nazionali] è quella di Enea. Una storia mitologica deve avere delle fonti mitologiche; e in questo senso, Virgilio è un grande storico. I conquistatori fenici, che venivano da Troia, portavano con sé tutti i valori opposti a quelli della antica civiltà contadina. Portavano la religione e lo Stato, la religione dello Stato. (...) Poi venne Roma, e perfezionò la teocrazia statale e militare dei suoi fondatori troiani, che, vincitori, avevano però dovuto accogliere la lingua e il costume dei vinti. E Roma si urtò anch’essa nella difesa contadina, e la lunga serie delle guerre italiche fu il più duro ostacolo al suo cammino"; e, ancora, fino ad illuminare il suo presente storico, scrive con lucidità e spirito critico: "(...) La quarta guerra nazionale dei contadini è il brigantaggio. Anche qui, l’umile Italia storicamente aveva torto, e doveva perdere. Non aveva armi forgiate da Vulcano, né cannoni, come l’altra Italia. E non aveva dèi: che cosa poteva fare una povera Madonna dal viso nero contro lo Stato Etico degli hegeliani di Napoli" (pp. 123-125, cit.).Detto diversamente, egli ha ben compreso - come scrive all’editore Einaudi nel 1963 - non solo "la Lucania che è in ciascuno di noi", ma anche "tutte le Lucanie di ogni angolo della terra". Nato a Torino (29 novembre 1902) e morto a Roma (4 gennaio 1975), ora riposa nel cimitero di Aliano, nella sua Terra. A suo onore e memoria, possono valere (in un senso molto prossimo) le stesse parole del "Finnegans Wake" di Joyce, riferite a Giambattista Vico (che pure aveva vissuto molti anni, a Vatolla, ai margini della grande foresta ("ingens sylva") lucana: "Prima che vi fosse un uomo in Irlanda, c’era un lord in Lucania".
*
Federico La Sala (25.07.2014)
*
SUL PROBLEMA VICO (E, IN PARTICOLARE, SULL’INTERPRETAZIONE DI BENEDETTO CROCE DELL’OPERA DI VICO), SI VEDA NEL SITO:
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5737
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5737 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3? id_article=5634
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3? id_article=5634SULLA CONCEZIONE DELLA STORIA DI WALTER BENJAMIN, SI VEDA NEL SITO:
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/IMG/pdf/IMG-13.pdf
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/IMG/pdf/IMG-13.pdf -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ... Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. --- Il suicidio dell’austerità (di Thomas Fazi)16 agosto 2014, di Federico La Sala
Il suicidio dell’austerità
di THOMAS FAZI (Il manifesto, 15 agosto 2014)
Gli ultimi dati rilasciati ieri da Eurostat, l’agenzia statistica europea, confermano quello che ormai vanno dicendo da tempo schiere di economisti, anche di estrazione mainstream: la tanto sbandierata “ripresa” europea - che comunque rappresentava sempre una medi tra quegli stati che registravano modesti tassi di crescita (come la Germania) e quelli che continuavano a essere impantanati nella recessione post-crisi (come l’Italia) - era una pia illusione.
Senza un ribaltamento radicale delle politiche economiche, l’eurozona era inevitabilmente condannata a sprofondare in una cosiddetta “stagnazione secolare”: un lungo periodo di crescita bassa o nulla. E infatti l’ultimo bollettino di Eurostat parla chiaro: nell’ultimo trimestre dell’anno la crescita nella zona euro è stata dello 0.0%. A leggere il testo del comunicato, però, si direbbe che non c’è motivo di preoccuparsi: secondo la neolingua dei burocrati di Bruxelles, semplicemente “il Pil nell’area euro è rimasto stabile”. Tutto a posto, dunque?
Purtroppo no. In uno scenario di stagnazione secolare risolvere il problema della disoccupazione dilagante (18 milioni di senza lavoro solo nella zona euro), della deflazione alle porte (0.4% il tasso d’inflazione nella zona euro, mentre in alcuni paesi è già sotto lo zero) e del debito pubblico è praticamente impossibile. Al punto che c’è già chi parla di “stag-deflazione” (per fare il verso alla stagflazione degli anni ’70): uno scenario da incubo in cui crescita anemica, bassa domanda, prezzi in calo, disoccupazione crescente, carenza di investimenti, fallimenti aziendali, sofferenze bancarie e debiti pubblici alle stelle si alimentano a vicenda in una spirale senza fine.
Perché l’eurozona si trova in questa condizione, quando altre aree economiche colpite altrettanto duramente dalla crisi del 2008, come Stati uniti e Regno Unito, hanno ridotto la disoccupazione e sono tornate ai livelli di crescita pre-crisi o li hanno addirittura superati?
A prescindere dai limiti “strutturali” dell’eurozona (impossibilità della Bce di offrire liquidità agli Stati, ecc.), la causa principale dell’infinita crisi europea - come ormai denunciano anche giornali come il Financial Times e organizzazioni notoriamente neoliberiste come l’Fmi -, sono le folli politiche di austerity perseguite dall’establishment europeo negli ultimi anni, che hanno avuto l’effetto di strangolare ulteriormente l’economia, già affamata da un crollo della spesa privata, per mezzo di drastici tagli alla spesa pubblica, aumenti delle tasse e compressione dei salari.
Altrove hanno invece perseguito politiche monetarie e fiscali espansive, con risultati prevedibilmente positivi. Finora erano stati soprattutto i paesi della periferia a patire le conseguenze di queste politiche scellerate. L’Italia è il caso più esemplare: produzione industriale al -25%, Pil al -10%, tasso di accumulazione al -13%, disoccupazione e debito pubblico a livelli record. Un’apocalisse economica e sociale da cui il nostro paese impiegherà decenni a riprendersi (se mai ce la farà). La vera novità è che nell’ultimo trimestre anche la Germania ha registrato un tasso di crescita di negativo (-0.2%) per la prima volta dal 2010. Anche in questo caso c’è poco da sorprendersi.
L’avevano predetto in molti: continuando a comprimere la domanda interna e affamando i propri partner commerciali europei per mezzo dell’austerità la Germania avrebbe finito inevitabilmente per danneggiare la propria economia, fortemente basata sulle esportazioni. Basterà questo a convincere i tedeschi della necessità di un cambio di rotta? O almeno a convincere Matteo Renzi che la soluzione alla crisi non passa di certo per le [sue]“riforme strutturali"
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- La sinfonia di un’orchestra: la squadra di Joachim Löw. Così lo ius soli ha aiutato la Germania a vincere.17 luglio 2014, di Federico La Sala
Così lo ius soli ha aiutato la Germania a vincere
di Maria Luisa Colledani (Il Sole-24 Ore, 16.07.2014)
Chissà che cosa avrà pensato Helmut Kohl domenica sera davanti alla tv quando Philipp Lahm ha alzato al cielo di Rio la quarta coppa del mondo nella storia della Germania. Il cancelliere della Germania unita, sulle macerie del Muro di Berlino, perentoriamente aveva affermato: «Il nostro Paese non è e non potrà più essere in futuro terra di immigrazione».
Mai sentenza fu più fuori luogo, dopo il successo della squadra di Joachim Löw, in cui il calcio è sinfonia di un’orchestra - i giocatori - con lingue e provenienze diverse. Ci sono turchi (Mesut Özil), tunisini (Sami Khedira), ghanesi (Jérôme Boateng), polacchi (Miroslav Klose e Lukas Podolski, e lo è anche il cancelliere Merkel alla lontana), albanesi (Shkodran Mustafi), tutti vestiti di giallo-rosso-nero e tutti nati in Germania intorno al 1990, così giovani da aprire un’era calcistica.
È vero, non tutti cantano l’inno, ma questa nazionale è come quei palazzi di Potsdamer Platz che, fasciati di vetri ovunque, sono specchio fedele delle strade della capitale. Un mondo, quello tedesco, che ha lasciato il patriottismo e ha elaborato una storia drammatica per farsi modernità, frontiera del vivere globalizzato: a Berlino, la Grande Mela d’Europa, si parlano decine di lingue, la Germania nel 2013 è diventata la seconda destinazione al mondo per immigrati permanenti (dati Ocse: 400mila i nuovi arrivi soprattutto dai Paesi periferici della Ue, una persona su cinque viene da un qualche altrove).
E il Paese, come da Dna, non si è fatto trovare impreparato. Conscio dell’invecchiamento della propria popolazione (entro il 2050 spariranno 12-14 milioni di persone) si è dotato, dopo decenni trascinati fra accordi bilaterali, di una legge sull’immigrazione d’avanguardia.
In vigore dal 2005, la norma prevede che per qualsiasi tipo di permesso si deve dimostrare di essere in regola con il passaporto, di possedere mezzi di sussistenza, una situazione abitativa adeguata, di avere contributi pensionistici per almeno 60 mesi e di non avere subito condanne.
Poche regole, ben chiare, che si affiancano alla possibilità per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2000 su suolo tedesco da genitori non tedeschi di acquisire la nazionalità se almeno uno dei due genitori ha il permesso di soggiorno permanente da tre anni (è lo ius soli, grande sogno del presidente Napolitano).
Anche nelle pieghe delle norme volute dal Bundestag nasce la Germania multietnica e vincente di Löw. Certo, la Federcalcio tedesca ci ha messo del suo: esaurita la leva calcistica di Brehme, Klinsmann e Matthäus, si è ristrutturata dall’interno: prima ha cavalcato il Mondiale in casa per ammodernare gli stadi, poi ha costruito venti centri federali e investito 600 milioni di euro in dieci anni nei vivai. Il risultato, prima o dopo, doveva arrivare, d’altra parte la Germania, nel 2009, aveva vinto tre Europei: Under 21, Under 19 e Under 17. E in quelle squadre giocavano già i vari Özil, Boateng e Khedira. Dopo tanti tiri in porta, Rio è solo il gol vincente, il risultato di un progetto, giocato di sponda fra calcio e politica, cogliendo tutte le occasioni, compresa la fame di successo, di conquista sociale che possono avere occhi non proprio teutonici.
I tempi dei Gastarbeiter, i "lavoratori ospiti" che la Germania accolse a partire dagli anni 50, sono finiti, e pure quel tipo di immigrazione. Ora a Berlino, Monaco, Francoforte e Amburgo arrivano ingegneri, web designer, artisti, attratti dai posti di lavoro, da un’economia in movimento, dalla certezza delle regole e da un melting pot avviato al successo. Che in un Paese senza passato coloniale è un triplo salto carpiato riuscito di cui i calciatori sono la fotografia che la Germania ha mostrato al mondo nella notte di Rio.
Una Nazionale non si giudica da un calcio di rigore, non ne ha neppure avuto bisogno contro un’Argentina senza troppa fame. Una Nazionale si giudica dalla fantasia, che è anche scegliere come campo per l’ultimo allenamento prima della finale non il Maracanã ma il Sâo Januário, lo stadio del Vasco da Gama, primo club brasiliano a reclutare i giocatori senza distinzione di razza e di ceto sociale. Un piccolo particolare, solo un particolare; la grandezza e la storia si costruiscono anche così. E Löw lo sa meglio di chiunque altro.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- INNO ALLA GIOIA. Sinfonia n. 9 (di Schiller - Beethoven: testo)3 luglio 2014, di Federico La Sala
INNO ALLA GIOIA
[...] Già dal 1799 Beethoven manifestò la volontà di scrivere un’opera a partire dall’Inno alla Gioia di Friedrich Schiller, animato dai sentimenti di fratellanza universale che riflettevano gli ideali che avevano indotto lo scrittore tedesco ad affiliarsi alla Massoneria.[...] Allo stesso anno risale il primo abbozzo, sotto forma di Lied, mentre altri schizzi si trovano attualmente in raccolte risalenti al 1814 e 1815. Ma fu solo con la Nona Sinfonia che Beethoven adattò tale testo alla musica, la sua più grande sinfonia. E per far ciò, prese ispirazione da una stesura dell’Ode vista dall’autore stesso nel 1803.
L’ode "An die Freude" è una lirica nella quale la gioia è intesa non certo come semplice spensieratezza e allegria, ma come risultato a cui l’uomo giunge seguendo un percorso graduale, liberandosi dal male, dall’odio e dalla cattiveria.[...]
Le parole scritte da Beethoven (e non da Schiller) sono mostrate in corsivo.
(DE)
 «O Freunde, nicht diese Töne!
«O Freunde, nicht diese Töne!
 Sondern laßt uns angenehmere
Sondern laßt uns angenehmere
 anstimmen und freudenvollere.
anstimmen und freudenvollere.
 Freude! Freude!
Freude! Freude! Freude, schöner Götterfunken
Freude, schöner Götterfunken
 Tochter aus Elysium,
Tochter aus Elysium,
 Wir betreten feuertrunken,
Wir betreten feuertrunken,
 Himmlische, dein Heiligtum!
Himmlische, dein Heiligtum!
 Deine Zauber binden wieder
Deine Zauber binden wieder
 Was die Mode streng geteilt;
Was die Mode streng geteilt;
 Alle Menschen werden Brüder,[3]
Alle Menschen werden Brüder,[3]
 Wo dein sanfter Flügel weilt.
Wo dein sanfter Flügel weilt. Wem der große Wurf gelungen,
Wem der große Wurf gelungen,
 Eines Freundes Freund zu sein;
Eines Freundes Freund zu sein;
 Wer ein holdes Weib errungen,
Wer ein holdes Weib errungen,
 Mische seinen Jubel ein!
Mische seinen Jubel ein!
 Ja, wer auch nur eine Seele
Ja, wer auch nur eine Seele
 Sein nennt auf dem Erdenrund!
Sein nennt auf dem Erdenrund!
 Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
 Weinend sich aus diesem Bund!
Weinend sich aus diesem Bund! Freude trinken alle Wesen
Freude trinken alle Wesen
 An den Brüsten der Natur;
An den Brüsten der Natur;
 Alle Guten, alle Bösen
Alle Guten, alle Bösen
 Folgen ihrer Rosenspur.
Folgen ihrer Rosenspur.
 Küsse gab sie uns und Reben,
Küsse gab sie uns und Reben,
 Einen Freund, geprüft im Tod;
Einen Freund, geprüft im Tod;
 Wollust ward dem Wurm gegeben,
Wollust ward dem Wurm gegeben,
 Und der Cherub steht vor Gott.
Und der Cherub steht vor Gott. Froh, wie seine Sonnen fliegen
Froh, wie seine Sonnen fliegen
 Durch des Himmels prächt’gen Plan,
Durch des Himmels prächt’gen Plan,
 Laufet, Brüder, eure Bahn,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
 Freudig, wie ein Held zum Siegen.
Freudig, wie ein Held zum Siegen. Seid umschlungen, Millionen!
Seid umschlungen, Millionen!
 Diesen Kuß der ganzen Welt!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
 Brüder, über’m Sternenzelt
Brüder, über’m Sternenzelt
 Muß ein lieber Vater wohnen.
Muß ein lieber Vater wohnen.
 Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ihr stürzt nieder, Millionen?
 Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
 Such’ ihn über’m Sternenzelt!
Such’ ihn über’m Sternenzelt!
 Über Sternen muß er wohnen.
Über Sternen muß er wohnen. Freude heißt die starke Feder
Freude heißt die starke Feder
 In der ewigen Natur.
In der ewigen Natur.
 Freude, Freude treibt die Räder
Freude, Freude treibt die Räder
 In der großen Weltenuhr.
In der großen Weltenuhr.
 Blumen lockt sie aus den Keimen,
Blumen lockt sie aus den Keimen,
 Sonnen aus dem Firmament,
Sonnen aus dem Firmament,
 Sphären rollt sie in den Räumen,
Sphären rollt sie in den Räumen,
 Die des Sehers Rohr nicht kennt. »
(IT)
Die des Sehers Rohr nicht kennt. »
(IT) «O amici, non questi suoni!
«O amici, non questi suoni!
 ma intoniamone altri
ma intoniamone altri
 più piacevoli, e più gioiosi.
più piacevoli, e più gioiosi.
 Gioia! Gioia!
Gioia! Gioia!
 Gioia, bella scintilla divina,
Gioia, bella scintilla divina,
 figlia di Elisio,
figlia di Elisio,
 noi entriamo ebbri e frementi,
noi entriamo ebbri e frementi,
 celeste, nel tuo tempio.
celeste, nel tuo tempio.
 Il tuo fascino riunisce
Il tuo fascino riunisce
 ciò che la moda separò
ciò che la moda separò
 ogni uomo s’affratella
ogni uomo s’affratella
 dove la tua ala soave freme.
dove la tua ala soave freme. L’uomo a cui la sorte benevola,
L’uomo a cui la sorte benevola,
 concesse il dono di un amico,
concesse il dono di un amico,
 chi ha ottenuto una donna leggiadra,
chi ha ottenuto una donna leggiadra,
 unisca il suo giubilo al nostro!
unisca il suo giubilo al nostro!
 Sì, - chi anche una sola anima
Sì, - chi anche una sola anima
 possa dir sua nel mondo!
possa dir sua nel mondo!
 Chi invece non c’è riuscito,
Chi invece non c’è riuscito,
 lasci piangente e furtivo questa compagnia!
lasci piangente e furtivo questa compagnia! Gioia bevono tutti i viventi
Gioia bevono tutti i viventi
 dai seni della natura;
dai seni della natura;
 vanno i buoni e i malvagi
vanno i buoni e i malvagi
 sul sentiero suo di rose!
sul sentiero suo di rose!
 Baci ci ha dato e uva, un amico,
Baci ci ha dato e uva, un amico,
 provato fino alla morte!
provato fino alla morte!
 La voluttà fu concessa al verme,
La voluttà fu concessa al verme,
 e il cherubino sta davanti a Dio!
e il cherubino sta davanti a Dio! Lieti, come i suoi astri volano
Lieti, come i suoi astri volano
 attraverso la volta splendida del cielo,
attraverso la volta splendida del cielo,
 percorrete, fratelli, la vostra strada,
percorrete, fratelli, la vostra strada,
 gioiosi, come un eroe verso la vittoria.
gioiosi, come un eroe verso la vittoria. Abbracciatevi, moltitudini!
Abbracciatevi, moltitudini!
 Questo bacio vada al mondo intero!
Questo bacio vada al mondo intero!
 Fratelli, sopra il cielo stellato
Fratelli, sopra il cielo stellato
 deve abitare un padre affettuoso.
deve abitare un padre affettuoso.
 Vi inginocchiate, moltitudini?
Vi inginocchiate, moltitudini?
 Intuisci il tuo creatore, mondo?
Intuisci il tuo creatore, mondo?
 Cercalo sopra il cielo stellato!
Cercalo sopra il cielo stellato!
 Sopra le stelle deve abitare!
Sopra le stelle deve abitare! "Gioia" si chiama la forte molla
"Gioia" si chiama la forte molla
 che sta nella natura eterna.
che sta nella natura eterna.
 Gioia, gioia aziona le ruote
Gioia, gioia aziona le ruote
 nel grande meccanismo del mondo.
nel grande meccanismo del mondo.
 Essa attrae fuori i fiori dalle gemme,
Essa attrae fuori i fiori dalle gemme,
 gli astri dal firmamento,
gli astri dal firmamento,
 conduce le stelle nello spazio,
conduce le stelle nello spazio,
 che il canocchiale dell’osservatore non vede. »
che il canocchiale dell’osservatore non vede. »(Nona sinfonia in Re minore, Op. 125 di Ludwig van Beethoven - IV movimento - Wikipedia: ripresa parziale.)
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- INNO ALLA GIOIA. - Il rapporto stretto tra il Fidelio e la Nona Sinfonia non sfugge ovviamente a nessuno (di Paolo Isotta - Fidelio eroe della libertà)2 dicembre 2014, di Federico La Sala
Fidelio eroe della libertà
L’opera di Beethoven denuncia l’età del Terrore e ricorda Silvio Pellico
di Paolo Isotta (Corriere della Sera, 02.12.2014)
Se il Parsifal è la più grande Opera mai scritta, se i Maestri cantori , il Falstaff e Il cavaliere della rosa sono le più deliziose Commedie musicali (con profonda riflessione sulla tragedia della vita) mai scritte, il Fidelio è l’Opera più celestiale mai scritta. Non ripeterò che si tratta del più potente documento artistico contro il Terrore giacobino pur se ripeterlo giova oggi che si tenta di contrabbandarlo siccome parto rivoluzionario.
D’altronde rimandare ai miei minuziosi articoli pubblicati sul tema per i lettori del «Corriere» è poca cosa: intendo invece consigliare di nuovo il più bel libro mai scritto su Beethoven, quello monumentale di Piero Buscaroli che la Rizzoli ha per fortuna, dopo la prima edizione di dieci anni fa, ripubblicato nella Bur. È un’opera che onora la cultura italiana, che non ne è degna e non ha saputo recepirla; ma lo stato della cosiddetta musicologia è miserabile anche all’estero.
Nessuno come il Buscaroli ricostruisce la storia della composizione, del fatto storico che ne è all’origine, degli antecedenti operistici francesi e italiani. Io mi permetto di ricordare che per comprendere come il Terrore sia stato la più perversa macchinazione contro l’uomo mai escogitata occorre conoscere un’opera storica di Manzoni quasi sottaciuta e occultata, La rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859. Saggio comparativo.
Non ripercorrerò antologicamente le bellezze della suprema partitura che resta tale a onta dell’appartener il Fidelio all’ibrido genere della Commedia musicale (Singspiel), con dialoghi parlati. Ma questi non preponderano e vanno rarefacendosi a grado che l’Opera prosegue. E, per ciò che attiene al Recitativo, Beethoven, con Abscheulicher, wo eilst du hin, nel primo atto, offre uno dei più potenti Recitativi accompagnati mai composti, direttamente rifacentesi alla Scena e Aria italiana Ah, perfido! che il giovane aveva scritta nel 1796 su versi di Metastasio.
Ma avviene nel passaggio all’Opera qualcosa di magico: dal Mi bemolle maggiore della composizione giovanile il Sommo trascorre al Mi maggiore, ch’è il tono delle due più incantate Sonate pianistiche, l’op. 90 e l’op. 109, e del sublime Lied corale Opferlied. Leonora canta poi l’Aria con i tre corni soli che, nelle due sezioni, invocando la Speranza, è invocazione sì alta che dal lirico passa all’epos vergiliano; e tale invocazione possiede un inequivocabile accento religioso.
E infatti adesso giova dire che il testo drammatico del Fidelio , basato su di un avvenimento effettualmente svoltosi in Francia, spesso dileggiato dai musicologi e invece di grande qualità e intensità drammatica, viene accolto da Beethoven in una prospettiva che potremmo chiamare solo religiosa.
Il Fidelio è il dramma della lotta per la libertà. Non si vuol negare il suo aspetto di viva attualità politica; e tuttavia i prigionieri che vengon portati alla luce dalla segreta nella quale giacciono (e Beethoven introduce il coro con vaganti accordi di dominante su pedale di tonica, giacché i prigioni sono abbacinati e non vedono) anelano alla libertà spirituale, e le catene, come quelle di Florestano, sono loro allestite dal peccato e dall’ignoranza. Il coro dei prigionieri ha inequivocabile carattere religioso; come lo hanno il duetto tra Florestano e Leonora quando ella ha messo in fuga il tiranno Pizarro; e tutto l’ultimo quadro del Fidelio .
Il rapporto stretto tra il Fidelio e la Nona Sinfonia non sfugge ovviamente a nessuno. Ma ciò assevera il mio asserto. Il carattere religioso (e non solo nazionalistico, come vuole il Buscaroli) della Nona Sinfonia mi pare palese: secondo me l’ultimo movimento è il vero e proprio Magnificat di Beethoven. Scrive Wagner: «Non sono le idee espresse dalle parole di Schiller che attirano la nostra attenzione ma il timbro cordiale del coro che ci attrae a unire la nostra voce a partecipare come comunità a un ideale servizio divino, quel che accade all’entrata del Corale nelle Passioni di Sebastian Bach». Ciò tuttavia non toglie che a me la Missa solemnis paia artisticamente ancor più alta: Beethoven stesso la definisce «la mia opera più perfetta».
Ma carattere religioso e chiave dell’intera opera (torno al Fidelio ) è in un brano breve, prima facie un mero Recitativo, che però i sommi direttori d’orchestra ben hanno compreso affidandolo a cantanti di prima grandezza. Voglio citare soprattutto l’incisione meravigliosamente diretta da Karl Böhm che, se ha come Rocco Gottlob Frick, fa intervenire quale Don Fernando un sontuosissimo Martti Talvela. Del pari fa Karajan che nella sua incisione (uno dei punti più alti della storia del disco) affida il ruolo a Franz Crass.
Don Fernando è il ministro di Stato che giunge in apparenza per ispezionare il carcere, in realtà per far trionfare ex alto la libertà: il suo Recitativo Des besten Königs Wink und Wille ( Per cenno e volere dell’ottimo de’ Regi ), che approda a elisia melodia ove si parla dell’umana fratellanza, ce lo mostra siccome autentico inviato divino; e la fratellanza alla quale egli accenna è evidentemente quella in Cristo: significativo, e particolare da solo bastevole a mostrare il continuo sforzo di perfezionamento di Beethoven nella costruzione, che nella Leonore esso manchi.
Di quest’incisione diretta da Böhm esiste un «video»: la regia di Rudolph Sellner ottiene una tale recitazione dagl’interpreti che, anche a non conoscere il tedesco, si comprende ogni parola. Un sol difetto possiede, e purtroppo gravissimo: tra il I e il II atto non fa la necessaria pausa e addirittura durante l’introduzione orchestrale assistiamo alla ridiscesa dei cattivi nelle segrete: anche i grandi commettono leggerezze inspiegabili.
Tanto Böhm quanto Karajan non eseguono l’Ouverture Leonora n. 3 prima dell’ultimo quadro: quest’abitudine che io approvavo e venne seguita anche da Muti alla Scala oggi più matura riflessione m’induce a condannare: giacché anche questa grandiosa composizione contiene una tale sintetica rappresentazione drammatica dell’intera Opera da confliggere colla sua rappresentazione drammatica effettuale; né giova a difendere la prassi tedesca, risalente alla seconda metà dell’Ottocento e mettente capo a Hans von Bülow, il fatto che l’Ouverture venga collocata, si dichiara, dopo che tutti i conflitti drammatici sono risolti : ciò è mera apparenza: la risoluzione viene con il Recitativo di don Fernando e lo scioglimento delle catene.
La prima versione del Fidelio è la Leonore , o ur-Fidelio , in tre atti. Occorrerebbe fosse conosciuta assai di più essendo anch’essa celestiale. Il confronto col Fidelio è illuminante; a principiare dalle Ouvertures: quella in Mi maggiore, concentrata e veloce, è davvero l’introduzione in medias res ; quella oggi denominata Leonora n. 2 è un capolavoro d’invenzione, costruzione e ampiezza: è più che un tempo di Sinfonia; ma Beethoven, che non sbaglia mai, ben ha fatto a metterla da banda esaurendo essa in parte l’interesse drammatico medesimo.
Dicevo, è celestiale la Leonore: contiene una profluvie di meraviglie che Beethoven, dramatis causa , ha espunte dal Fidelio e che vanno conosciute di per sé, a prescindere dalla posizione drammatica loro. V’è il Terzetto Ein Mann ist bald genommen e il delizioso duetto tra Marcellina e Leonora Um in der Ehe froh zu leben , con violino solo; e una pagina che piangiamo noi per primi a calde lacrime è poi il sublime Recitativo di Florestano con oboe solo (nella Leonore - Fidelio l’oboe sembra avere una funzione d’incarnazione salvifica), prima del Duetto O namenlose Freude (III nella Leonore e II nel Fidelio ), Ich kann mich noch nicht fassen.
Più in generale nella Leonore vi è una rifinitura musicale straordinaria: i brani in comune delle due Opere vi durano assai di più ( per esempio, il finale del I atto - II nella Leonore , che diverrà completamente diverso nell’Opera definitiva; e la stessa introduzione del II - III nella Leonore ) e duole che si perdano; ma la scorciatura drammatica del Fidelio è unica. Una cosa fondamentale mi resta da dire. La Leonora e il Fidelio (le date estreme sono il 1805 e il 1814) in realtà principiano nel 1790, a Bonn, Beethoven ventenne.
I musicologi, che capiscono pochissimo, giudicano opere d’occasione i due straordinarî capolavori di quell’anno, i quali dimostrano come non sempre il genio sia pazienza e accumulo ma possa apparire già tutt’intero all’improvviso. Precocità simile fa pensare più a Alessandro Scarlatti che a Mozart (a non considerare l’esplosione del genio quattordicenne con il Mitridate, Rè di Ponto , splendente anticipazione dell’ Idomeneo ); e il fatto che tali opere fossero scritte quando Mozart era ancor vivo mostra il divario fra i due Sommi.
Si tratta della Cantata per la morte di Giuseppe II (che ascoltai per la prima volta in un’alatissima interpretazione di Franco Mannino), monumentale, e di quella, di poco successiva, più breve ma pur elisia, per l’intronizzazione di Leopoldo II. Ai nostri fini ci occuperemo della prima. Il testo si deve a uno sventurato di nome Averdonk che ricorda Giuseppe II, in realtà un sovrano meschino e tirannico, quale nemico dell’idra del fanatismo.
L’indagine storica del Buscaroli ha chiarito perché l’opera, a causa del disprezzo onde Giuseppe II era universalmente avvolto, venne eseguita solo nel 1885, auspice Brahms. L’introduzione orchestrale già contrappone gli accordi che, in Fa minore e con anticipazione di Wagner, daranno inizio al II atto del Fidelio colla disperazione di Florestano nelle tenebre. Ma quando il testo dice «Allora salirono gli uomini alla luce» si ode una sublime melodia dell’oboe in Fa maggiore: essa tornerà identica al vero scioglimento del Fidelio , quando don Fernando avrà fatto liberare dalla stessa Leonora Florestano dalle catene e verrà cantato O Gott! Welch ein Augenblick! : ossia O Dio! Quale istante!
Quest’articolo si chiuda col ricordare un umile e grande libro che la Scuola italiana aveva quelli della mia generazione indotto a disprezzare senza conoscere per l’enfatico panegirico che ne faceva; un libro nato dalla lotta per la libertà e risalente alla considerazione religiosa della prigionia in quanto tale; di pochi anni al Fidelio posteriore (1832): Le mie prigioni di Silvio Pellico. Ivi la tirannia è absburgica, ma è tirannia non meno.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- INNO ALLA GIOIA. Sinfonia n. 9 --- L’ispirazione del Fidelio: Léonore ou l’amour conjugal di Jean-Nicolas Bouilly.7 dicembre 2014, di Federico La Sala
L’ispirazione del Fidelio: Léonore ou l’amour conjugal di Jean-Nicolas Bouilly
da "Booksblog" *
- Léonore ou l’amour conjugal di Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842), la cui prima rappresentazione risale al 1805, racconta un episodio realmente accaduto, con al centro il coraggioso amore di una donna per suo marito nella Siviglia del XVII secolo.
- Le due opere più famose del repertorio tedesco sono oggetto di malintesi interpretativi: di Tristano si parla come di un’opera sull’amore mentre in realtà è un’opera sulla morte. L’amore in Wagner è piuttosto nel primo atto di Walkiria. Fidelio invece è spesso letto esclusivamente come dramma politico, mentre è la storia di una donna pronta a tutto per salvare l’uomo che ama.
Questo il giudizio di Daniel Barenboim su Fidelio, unico capolavoro lirico di van Beethoven che toccherà proprio al maestro Barenboim dirigere il prossimo 7 dicembre a La Scala.
Un giudizio riferito in realtà proprio alla storia da cui fu tratto ovvero Léonore ou l’amour conjugal di Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842), la cui prima rappresentazione risale al 1805 e che racconta un episodio realmente accaduto, con al centro il coraggioso amore di una donna per suo marito- nella Siviglia del XVII secolo.
Che la spingerà a travestirsi da uomo per salvare il consorte, Florestan, imprigionato da un suo nemico, il terribile governatore della prigione don Pizzarro. Una vicenda in cui di sicuro ci sono delle riflessioni autobiografiche, visto che l’autore del testo, Jean-Nicolas Bouilly ricopriva lui stesso il ruolo di giudice durante la rivoluzione Francese.
Lo stesso Bouilly dichiarò di aver tratto la sua ispirazione da una storia vera, che probabilmente cambiò il suo modo di vedere la vita: quella trasfigurata nel Fidelio è quindi una vicenda dalla quale avrà imparato di sicuro una forte lezione morale.
Infatti, nonostante la storia riporta come lui stesso firmò diverse condanne a morte durante il regime del terrore, ci tenne a riferire che in segreto si era preso cura dei suoi concittadini, a Tours, evitando che finissero sotto le mani degli estremisti rivoluzionari.
La ricerca della verità nel buio di una prigione, la scoperta dell’ingiustizia alla luce del sole e il potere dell’amore di vincere tutto: Fidelio è fatto di questo - commenta la regista dell’opera che andrà in scena a La Scala, Deborah Warner - . Non credo che al centro ci sia l’idea della libertà, credo che ci sia assolutamente l’idea dell’amore.
Amore che farà compiere alla protagonista un’azione straordinariamente coraggiosa, soprattutto per i tempi in cui l’opera è ambientata in cui le donne avevano un ruolo domestico e poco si avventuravano - quelle oneste - fuori dalle mura di casa.
* Scritto da: sara - giovedì 4 dicembre 2014 (ripresa parziale).
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Comunità europea e "Beethoven preso a calci"3 luglio 2014, di Federico La Sala
l’Unità, 02.07.2014
Beethoven preso a calci
«Abbracciatevi, moltitudini. Questo bacio vada al mondo intero, fratelli». Quando, nel 1985, si decise che la Comunità europea doveva avere un inno e che l’inno doveva essere il movimento finale della Nona Sinfonia di Beethoven, noto ai più come l’Inno alla Gioia, si decise pure che lo si sarebbe eseguito senza parole. La decisione fu presa per non far torto a nessuno e anche perché - diciamolo - sul fatto che l’originale sia in tedesco qualcuno avrebbe potuto storcere il naso. Così le parole dell’ode «An die Freude» scritte da Friedrich Schiller nel 1785 e messe in musica da Ludwig van Beethoven, già sordo e malato, nel 1823 nelle cerimonie ufficiali dell’Unione europea non vengono cantate.
Peccato, perché sono molto belle, esprimono l’anelito del Poeta alla fratellanza universale e furono scritte sotto la suggestione delle idee dell’illuminismo, quando tra gli artisti e i filosofi dell’Europa era diffusa l’idea che il progresso dell’umanità avrebbe portato pace e benessere in questa valle di lacrime. Magari.
Schiller è morto nel 1805 e Beethoven nel 1827 e così il poeta e il compositore si sono risparmiati parecchie amarissime delusioni. Altro che lo sgarbo dei seguaci di quell’inglese con il cognome francese che con la corte dei suoi a Strasburgo ha mostrato il culo, più che all’Europa, alla musica e alla buona educazione. Chiediamo scusa per loro. Sono trascorsi due secoli ma per gli imbecilli gli anni non passano.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- L’identità? Ecco cosa scriveva Freud nel 1915 (di Jérôme Ferrari - testo per il "Premio Strega europeo")1 luglio 2014, di Federico La Sala
Premio Strega europeo
L’identità? Un’illusione
Stasera ciascuno dei cinque candidati leggerà un testo. Ecco quello di Ferrari
di Jérôme Ferrari (l’Unità, 01.07.2014)
ANCHE SENZA PARLARE DI EUROPA, L’IDENTITÀ FRANCESE MI È SEMPRE SEMBRATA UN’ASTRAZIONE. Nel 2009 un ministro di cui preferisco tacere il nome ha avuto l’idea geniale di lanciare un dibattito sull’identità nazionale, rendendosi così colpevole di un doppio crimine: contro l’onore e contro l’intelligenza.
Perché l’identità non è una cosa, non si compone di un certo numero di elementi ben determinati di cui basterebbe stilare la lista per rilasciare certificati di fratellanza o, più probabilmente, giustificare sentenze di ostracismo.
L’identità è invisibile. Solo le differenze saltano agli occhi. Basta spostarsi da Tolosa a Lille o, come ho fatto spesso, da Parigi ad Ajaccio per rendersene immediatamente conto. Quindi cosa dovrebbe essere un’identità europea? La prima volta che sono andato in Spagna mi sono sentito spaesato come se fossi atterrato su un pianeta affascinante e sconosciuto.
Da allora, però, ho viaggiato molto. E ho appena passato due anni ad Abu Dhabi, una grande città nuova di zecca appena sorta dal deserto come un enorme organismo in piena crescita, una metropoli che prefigura probabilmente il mondo di domani, con le macchine di lusso e la miseria dei lavoratori immigrati, con grattacieli e centri commerciali, con l’orizzonte irto di gru e di pannelli pubblicitari.
È strano, da lontano lo sguardo si trasforma: le differenze si attenuano, e quello che non riuscivamo a vedere da vicino ci appare improvvisamente in piena luce. Ogni volta che torno in Europa, poco importa se a Würzburg, Madrid, Parigi o Torino, ho la sensazione di tornare a casa. Prendere un caffè all’aperto, seduto al tavolino di un bar, diventa una delizia incomparabile. Ogni minima pietra antica mi fa quasi venire voglia di piangere, e in questo senso Roma mette a durissima prova le mie ghiandole lacrimali.
A proposito dei privilegi di cui gode l’uomo europeo ho trovato un testo che descrive perfettamente quello che sto cercando di esprimere. Mi si permetta di citarlo:
«(...) Colui che non era trattenuto stabilmente in un luogo determinato dalle necessità della vita, poteva costituirsi grazie ai vantaggi e alle attrattive dei paesi civili una nuova patria più ampia, dove poter circolare indisturbato e senza suscitare sospetti. Poteva in tal modo bearsi del mare azzurro e di quello grigio, delle bellezze dei monti nevosi e di quelle delle verdi praterie, dell’incanto della foresta nordica e dello splendore della vegetazione meridionale, dell’atmosfera dei paesaggi legati ai grandi ricordi storici e della quiete della natura inviolata. Questa nuova patria era per lui anche un museo, pieno di tutti i tesori che gli artefici dell’umana civiltà hanno creato e tramandato nei secoli».
E, poco dopo: «Fra i grandi pensatori, poeti e artisti di tutte le nazioni, era andato scegliendo coloro ai quali pensava di dovere il meglio di ciò che gli era servito per gustare e capire la vita. (...) Nessuno di questi grandi gli era apparso straniero solo perché aveva parlato in una lingua diversa dalla sua, (...) e mai aveva creduto di doversi sentire per questo colpevole di tradimento verso la nazione o verso l’amata lingua madre».
Freud scriveva queste cose nel 1915. L’Europa che descrive era devastata dalla guerra, il museo si era trasformato in un gigantesco mattatoio, l’umanità civilizzata inventava nuove raffinate tecniche di ferocia e l’ampiezza della disillusione era tale che oggi non siamo in grado di farcene un’idea.
Noi forse non saremo al sicuro da disillusioni analoghe, ma finora, come giustamente ricordava Javier Cercas in un discorso del 2013, grazie all’unità europea siamo la prima generazione che non ha mai conosciuto la guerra. Non è cosa da poco. Anzi, è un fatto straordinario.
Ancora una volta, per convincersene basta spingere lo sguardo un po’ più in là, neanche troppo. Per esempio verso est, nei Balcani, dove vivono persone a cui non è stato concesso di dimenticare che la Storia, per citare un’altra volta Freud, «è più che altro una successione di omicidi» commessi da assassini che vivono accanto a noi, che vivono dentro di noi.
Ricordo ancora lo stupore incredulo che ho provato quando ho visto le prime foto dei conflitti in Iugoslavia. La guerra evadeva dagli archivi, diventava reale, emi rendo conto di quanto sia stato fortunato a potermi concedere il lusso di stupirmi. Forse questo ci permette di capire perché l’Unione europea, che in Francia e probabilmente in altri paesi suscita solo una cupa indifferenza venata di disprezzo, sia un oggetto di desiderio per le nazioni che vogliono entrare a farne parte.
È così: il benessere, quando diventa abituale, smette di essere percepito. Oltre alla pace, e grazie alla pace, usufruiamo di una libertà di spostamento che Freud non avrebbe neanche potuto concepire e che, mentre tanta gente vive all’interno delle proprie frontiere come dietro mura di una prigione, a noi sembra normale. Ma questo è l’ordine delle cose, non c’è motivo di sentirsi in colpa, come non c’è ragione di lasciarsi andare a un beato ottimismo.
L’Europa della cultura, quella descritta da Freud, l’unica che importi davvero, quella che ci permette di gioire non della nostra irreperibile identità, ma delle nostre differenze sullo sfondo di una storia comune, forse non sopravvivrà allo tsunami di uniformazione che si sta abbattendo sul mondo. Le differenze sono buone e apprezzabili in quanto tali, ed estremamente interessanti. Esistono ancora. Per il momento non siamo diventati in tutto e per tutto clienti intercambiabili di un gigantesco supermercato, ma temo che sia solo questione di tempo.
Preferisco attenermi all’Europa di Freud con il mare azzurro e quello grigio, i tesori, la coesistenza di uomini che parlano lingue diverse, la grande patria e le piccole patrie, ma non posso dimenticare che il quadro descritto da Freud è soprattutto quello di una dolce e meravigliosa illusione.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Grazie a Kant, nonostante Kant (di Marcello Neri)16 giugno 2014, di Federico La Sala
Grazie a Kant, nonostante Kant
di Marcello Neri (Il Mulino, rivista, 12 giugno 2014)
"La fede nei miracoli deve essere resa ultimamente irrilevante attraverso la religione morale, perché si palesa un imperdonabile grado di miscredenza morale, se non si vuole accordare alle norme del dovere, che sono originariamente inscritte nel cuore dell’uomo attraverso la ragione, nessun’altra autorità se essa non viene ulteriormente convalidata dal miracolo" (I. Kant).
Eppure, nonostante se stesso, Kant può anche fare miracoli - almeno questa è la sensazione che mi trascino dietro da quando, ieri pomeriggio, ho terminato la mia lezione di Etica all’università. Perché, ammettiamolo, abbiamo finito per trasformare le nostre università, uno dei patrimoni più alti dello spirito europeo (dalla Bologna dell’XI secolo alla Berlino di Humboldt), in qualcosa che le ha snaturate alla radice. Se per un attimo smettessimo di mentire a noi stessi, e riemergessimo dalla convulsione della burocrazia e del reperimento di finanziamenti esterni che soffoca il nostro essere lì per insegnare, ci accorgeremmo che i ragazzi non vengono più all’università per imparare. Li abbiamo trasformati, cuccioli imberbi di un’Europa senza più gusto del sapere, in agenzie di frequentazione di moduli astrusi e produzione meccanica di esami: numeri anonimi delle nostre performance accademiche. Senza accorgerci che senza discepoli anche la figura del maestro diventa futile, sbiadita e, da ultimo, non ha più alcuna ragion d’essere.
Un po’ tutti affascinati e ammaliati dal gioco perverso del rating e del ranking, abbiamo ridotto la perla preziosa dello spirito europeo, il sapere, a quantità calcolabile in equazione; svendendolo, infine, alle logiche del mercato. Perché nella quantificazione del sapere, a scuola e all’università, si può lucrare un bel gruzzolo. Qualcuno inizia ad accorgersi delle conseguenze, non proprio auspicabili, insite nel piegare apprendimento e insegnamento alla classifica; perché, così facendo, "si distoglie l’attenzione da obiettivi formativi meno misurabili, o incommensurabili, come lo sviluppo fisico, morale, civico e artistico; restringendo pericolosamente la nostra immaginazione collettiva a riguardo di cosa sia e debba essere l’educazione" (Open Letter To Andreas Schleicher, Ocse, Paris). Ma anche quando raggiungiamo questo grado di consapevolezza, rimaniamo sostanzialmente inerti; la macchina sta sbranando i suoi stessi ingranaggi.
E chi mai avrebbe potuto immaginarsi che proprio il filosofo di Könisberg potesse offrirci una qualche miracolosa ancora di salvezza - per sfuggire, almeno per un attimo, al risucchio impietoso di questa deriva. Non riesco, infatti, a scrollarmi di dosso la sensazione lasciatami dalla lezione pomeridiana sulla Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Con la ciurma colorata dei miei studenti, così impastati della nostra spappolata contemporaneità, che fa loro sentire il ragionamento di Kant come qualcosa che proviene da un pianeta talmente lontano da non riuscire neanche a sembrare virtuale. Eppure, come d’incanto, eccoli lì a dismettere l’ossessione per l’esame, impegnati a cercare di capire come questo viaggio fantastico nelle eteree e asettiche regioni della ragion pratica (certo, ancora solo in nuce) potesse essere qualcosa che valesse la pena di un qualche apprendimento. Quasi teneri nelle loro domande, che cercavano di ricondurre l’imperativo categorico a un qualcosa che potesse dare dignità, ma sì diciamolo, morale alla loro impresa di vivere.
Per un attimo, l’emergere del desiderio di essere lì anche per imparare, capire, per apprendere i rudimenti di una vita che non vuole essere solo consumata. Abbandonare al suo destino questo desiderio di imparare in nome del sapere (e basta, per dirla con Kant), vorrebbe dire dichiarare chiusa una volta per tutte l’avventura dell’accademia europea dei saperi; e noi saremmo la generazione ricordata per averne, così freneticamente e stoltamente, preso definitivo congedo.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ...La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" ---- Coppa del Mondo e popoli indigeni: il lato oscuro del Brasile (di "Survival")10 giugno 2014, di Federico La Sala
Coppa del Mondo e popoli indigeni:
il lato oscuro del Brasile
SURVIVAL INTERNATIONAL - Comunicato Stampa, 5 giugno 2014
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ... --- Brasile, il Mondiale non è il benvenuto. La maggioranza del paese ne avrebbe fatto a meno11 giugno 2014, di Federico La Sala
Brasile, il Mondiale non è il benvenuto
Domani il via al torneo, ma la maggioranza del paese ne avrebbe fatto a meno
di Giuseppe Bizzarri (il Fatto, 11.06.2014)
"Il Brasile non spenderà un centesimo di denaro pubblico per la costruzione e la riforma degli stadi destinati alla Coppa del mondo”. L’affermazione era stata fatta nel 2007 dall’ex ministro dello Sport Orlando Brito, il quale esultò, assieme all’ex presidente Inácio Lula e altri 12ministri del suo governo, quando Joseph Blatter, il presidente della Fifa, comunicò al mondo che il paese sudamericano aveva ottenuto il Mondiale di calcio.
Le cose non sono andate esattamente come forse avrebbe voluto Brito, poiché l’85 per cento dei 30 miliardi di reais spesi per organizzare il travagliato Mundial sono usciti dalle casse dello Stato brasiliano. Pochi avrebbero potuto pensare che, nell’auge dell’era Lula, quando i potenti della Terra osannavano il miracolo economico brasiliano, il calcio, la passione nazionale del Paese, sarebbe poi diventato la miccia di un’onda di rivendicazioni sociali e salariali da parte di milioni di cittadini, i quali avrebbero voluto che i fondi destinati alla Coppa fossero invece diretti verso la disastrosa educazione pubblica, la decadente sanità, lo sconquassato trasporto e la giustizia sociale. São Paulo, la città che Nunca para, non si ferma mai, è rimasta paralizzata per 6 giorni a causa dello sciopero dei trasportatori della metro, ma anche delle manifestazioni a favore dei lavoratori in sciopero.
Tredici scioperanti sono stati arrestati, 61 licenziati e gli uomini della Pm, la polizia militare, controllano in stato operativo le stazioni della subway. I leader dello sciopero hanno sospeso per due giorni l’agitazione. I paulisti sono oggi più preoccupati per il futuro della metropoli e della nazione, che per l’apertura della Coppa che avverrà giovedì nel nuovo stadio Itaquerão, dove avverrà la cerimonia di apertura del Mondiale, ma è anche morto l’operaio Fabio Hamilton da Cruz a causa dei disumani turni di lavoro. Per Hamilton e altri 7 lavoratori deceduti non ci sarà nessuna Coppa, e tantomeno per circa 170 mila carioca, i quali sono stati rimossi dalle loro case per fare posto a stadi, impianti sportivi, vie espresse, parcheggi e shopping center.
LO SCIOPERO della metro e il caos del transito cittadino che ha intrappolato nei giorni scorsi anche alti esecutivi della Fifa nel loro arrivo a São Paulo, sembra non preoccupare il segretario generale della federazione calcistica , Jérôme Valcke, ma secondo quanto rivelano fonti della Fifa al giornale Estado de São Paulo, lo sciopero, se dovesse riprendere, potrebbe diventare un incubo per la Fifa e la torcida. Lo sperpero del denaro pubblico usato per organizzare il business privato della Coppa ha innescato in tutto il paese, un’incessante onda di proteste che diventano sempre più imprevedibili soprattutto con l’accentuarsi dell’aggressiva campagna elettorale per le elezioni del 5 ottobre, quando i brasiliani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente e il futuro assetto politico (governatori, deputati e senatori) che guiderà nei prossimi quattro anni il gigante sudamericano.
“Não vai ter Copa”. Lo slogan è divenuto una hit molto popolare nell’eterogeneo mondo della protesta brasiliana, dove la stessa Fifa ammette che, secondo le statistiche di Datafolha, il 50,7 per cento della popolazione è contraria alla scelta del paese come sede della competizione mondiale. Il test di allenamento contro il Fluminense, vinto dalla Nazionale italiana 5-3, si è giocato a Volta Redonda nello Stato di Rio de Janeiro. La cittadina è un crocevia molto conosciuto anche alla Polizia federale brasiliana, dove sequestra carichi di cocaina e armi provenienti da São Paulo e diretti alle gang narcotrafficanti della Capitale carioca. A Rio de Janeiro è in atto un impressionante spiegamento di forze militari e civili. Durante la Coppa avverrà il maggior schieramento di militari e polizia mai avuto nella storia dei Mondiali.
L’esercito brasiliano occupa i punti strategici della città e la favela della Maré, dove lunedì i militari sono entrati in confronto con residenti e trafficanti della comunità. Le scaramucce armate tra narcos e militari, nonostante l’installazione dell’Upp, le Unità di pacificazione militare, non sono mai cessati anche nella Rocinha e nell’immenso agglomerato di favelas che compongono il Complexo do Alemão. Saranno l’esercito brasiliano, la polizia militare, la polizia federale, civile e municipale a tenere lontani fino a cinque chilometri di distanza dagli stadi, i manifestanti. All’interno di questo perimetro di sicurezza saranno invece i contractor della Fifa a mantenere l’ordine.
Preoccupano anche gli assalti di strada, le rapine sono aumentate del 40%. I pochi addobbi gialloverdi sono apparsi all’improvviso nelle strade di Rio de Janeiro, la città in cui la gente sembra più preoccupata a far quadrare i conti familiari a causa dell’inflazione galoppante e l’inadempienza bancaria che non era stata così alta sin dal 2010.
L’ATMOSFERA è tesa anche per le garotas de programa, le prostitute che lavorano in maniera indipendente e non nei bordelli camuffati da saune e discoteche. A Niteroi, la città turistica sulla sponda della baia de Guanabara opposta a quella di Rio de Janeiro, le prostitute sono scese ripetutamente in strada per protestare contro la polizia militare e la prefettura che hanno fatto sloggiare con forza e illegalmente circa duecento prostitute, le quali- nonostante affittassero regolarmente i propri appartamenti - sono oggi impedite di lavorare nel celebre bordello verticale autogestito dell’avenida Amaral Peixoto, meglio conosciuto come palazzo della Caixa
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- In Europa in gioco la democrazia (di Etienne Balibar, Joanna Bourke, Wendy Brown, Judith Butler ...).1 giugno 2014, di Federico La Sala
«Da Balibar a Zizek, l’analisi degli intellettuali dopo il voto europeo e l’affermazione di Tsiprası».
In Europa in gioco la democrazia
 il manifesto, 1 giugno 2014
il manifesto, 1 giugno 2014La recente vittoria di Syriza in Grecia offre un forte barlume di speranza per il futuro della democrazia economica e sociale in Europa. Però, allo stesso tempo, la crescita del nazionalismo di destra, con i suoi sentimenti razzisti e antisemititi, minaccia gli ideali di un’Europa plurale e democratica. Quei racconti mediatici che rappresentano in maniera scorretta l’importanza del crescente supporto elettorale per Syriza come la nascita dell’«estremismo» di sinistra vanno contrastati duramente.
Non vi è alcuna asimmetria contemporanea tra i cosiddetti «estremismi» di destra e sinistra. I tentativi di sminuire le richieste di giustizia economica in Grecia e Spagna (dove Podemos ha guadagnato l’8% dei voti) e di etichettarle come «populiste», «anti-Europee» o «euro-scettiche», non comprende la loro ampiezza e importanza. Queste vittorie della sinistra radicale non possono essere comparate con la nascita del Fronte Nazionale in Francia, dell’Ukip in Inghilterra, o con il rafforzamento dei partiti antisemiti in Grecia e Ungheria o con il populismo anti-immigranti in Belgio e Danimarca.
La crescita della destra «euro-scettica» risponde alle politiche di austerità e ai cambiamenti demografici con delle piattaforme chiaramente razziste. Mentre la crescita della sinistra offre una critica chiara e un’alternativa ben formulata alle diseguaglianze sociali ed economiche prodotte dalle politiche di austerità. Per impedire che la violenza e la disperazione si diffondano ulteriormente, l’Unione Europea ha bisogno di nuove alleanze attraverso i confini nazionali e di una riorganizzazione delle proprie istituzioni, al fine di raggiungere una più ampia uguaglianza economica.
Si dovrebbe lanciare un dibattito pubblico serio per discutere il futuro dell’Unione, il ruolo della solidarietà e della giustizia sociale e il significato dell’idea di Europa. Ma il successo di un dibattito pubblico democratico dipende dalla verità e dalla trasparenza delle rappresentazioni mediatiche dei movimenti politici e delle loro rivendicazioni. In questo senso, chiediamo attenzione per le differenze tra le varie forme di opposizione politica all’austerità, tra chi vuole più eguaglianza e chi vuole più disuguaglianza. Solo così è possibile vedere in maniera più chiara quanto sia davvero in gioco il futuro della democrazia.
Etienne Balibar, Joanna Bourke, Wendy Brown, Judith Butler, Drucilla Cornell, Simon Critchley, Jodi Dean, Costas Douzinas, Eric Fassin, Engin Isen, Chantal Mouffe, Jean-Luc Nancy, Toni Negri, Micael Lowy, Sandro Mezzadra, Bruce Robbins, Jacqueline Rose, Eleni Varikas, Hayden White, Slavoj Zizek
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Dietro il populismo (di Tito Boeri)28 maggio 2014, di Federico La Sala
Dietro il populismo
di Tito Boeri (Lavoce.info, 27 maggio 2014)
Squilibri e spinte migratorie. Se si pensa all’Unione Europea come a un unico paese e si guarda alla diseguaglianza dei redditi, concentrandosi in particolare sui giovani, si comprendono bene le ragioni che stanno dietro alla vittoria dei movimenti populisti alle elezioni europee. L’indice più comune per misurare la diseguaglianza, il coefficiente di Gini, tra i redditi delle famiglie con capofamiglia di meno di 30 anni è cresciuto marcatamente in tutto il periodo della grande recessione e della crisi del debito dell’Eurozona. È passato dal 28,5 per cento nel 2007 al 31,5 per cento nel 2011: un aumento del 10 per cento. E il rapporto “primi dieci-ultimi dieci” è aumentato in maniera simile, da 4 a 5: significa che il reddito medio nel decile più alto nella distribuzione è ora cinque volte maggiore del reddito medio nel decile più basso. L’aumento della disuguaglianza tra i giovani non è dovuto, come per gli altri gruppi d’età, a una concentrazione nella parte più alta della scala dei redditi, con alcune persone molto ricche che aumentano la loro distanza dal resto della popolazione. I giovani, che già all’inizio della crisi erano sottorappresentati nella parte più alta della distribuzione del reddito, sono oggi una percentuale ancora minore rispetto agli altri gruppi di età.
La diseguaglianza dei redditi è aumentata principalmente a causa delle differenze nei livelli di disoccupazione giovanile. In Grecia e Spagna i tassi di disoccupazione in quella fascia sono oltre il 50 per cento, in Italia sopra il 40 per cento, mentre in Austria e Germania sono sotto la doppia cifra. È significativo che sia l’aumento della diseguaglianza dei redditi sia l’aumento delle differenze nei tassi di disoccupazione giovanile tra le diverse aree dell’Unione Europea abbiano una dimensione marcatamente nazionale: la diseguaglianza tra paesi è quasi raddoppiata, mentre all’interno dei paesi la crescita delle diseguaglianze è stata molto più contenuta; nel caso dei tassi di disoccupazione, la variazione inter-regionale all’interno di ogni paese si è dimezzata, mentre la differenza tra paesi è aumentata di due volte e mezzo.
Populismi del nord e populismi del sud. Perché tutto questo è importante per capire la vittoria del populismo alle elezioni europee? I giovani sono la componente più mobile della popolazione e sperimentare la disoccupazione così presto, quasi all’inizio della loro vita lavorativa, lascia cicatrici profonde.
Quelli che vivono nei paesi con un’alta disoccupazione (il cosiddetto ClubMed, incluso il Portogallo) hanno solo due opzioni: exit or voice - andarsene via o “farsi sentire”. Londra e Berlino sono state inondate da giovani italiani e spagnoli. E ancora di più da giovani bulgari o rumeni che hanno lasciato l’Italia o la Spagna per cercare lavoro altrove. L’alternativa è farsi sentire e i movimenti populisti del Sud Europa tendono a consentire ai giovani proprio quel tipo diprotesta radicale contro le istituzioni europee e l’euro che più apprezzano. Il profilo di età dei voti di Tsipras in Grecia, del movimento di Grillo in Italia, di Podemos in Spagna e del Front National in Francia è molto ben definito: in molte circoscrizioni, questi movimenti sono il primo partito tra coloro che hanno meno di 30 anni.
L’altro lato della medaglia è il populismo del Nord Europa, che somiglia molto a una collezione di sentimenti anti-immigrazione. L’Ukip ha fatto la sua campagna contro il flusso di cittadini europei, chiedendo lo smantellamento della libera mobilità dei lavoratori, uno dei pilastri dell’Unione Europea fin dal trattato di Roma. E non sorprende che il profilo di età sia, in questo caso, speculare rispetto al populismo del Sud: quasi il 90 per cento dei sostenitori di Nigel Farage ha più di 40 anni, 3 sostenitori del People’s Party danese su 4 hanno più di 50 anni e il FPÖ austriaco ha percentuali doppie tra gli ultra cinquantenni. La concentrazione all’altro capo dello spettro di età nel populismo del Nord è dovuta al fatto che i lavoratori più anziani rappresentano le componenti meno mobili della popolazione ed è quindi probabile che soffrano di più per la competizione dei giovani lavoratori che arrivano da altre parti dell’Unione.
Come spendere meglio le risorse. Se l’analisi è corretta, ne consegue che sarà difficile per i movimenti populisti europei coordinare i loro voti utilizzando la grande fetta di seggi che si sono guadagnati nel Parlamento europeo. Ma ci sono lezioni ancora più importanti da imparare riguardo al futuro dell’Europa. A meno che non si faccia qualcosa per affrontare il problema delle diseguaglianze tra paesi e della disoccupazione giovanile, questa tendenza proseguirà e porterà con sé, al Nord, tensioni per l’immigrazione e, al Sud, fuga di cervelli ed euroscetticismo. Non è una prospettiva positiva per l’integrazione: è poco probabile che così si promuova un’identità europea, qualunque essa sia. I politici tedeschi conoscono molto bene la questione, dal momento che l’hanno dovuta affrontare dopo l’unificazione della Germania, spendendo molto per prevenire la migrazione da Est a Ovest. Fortunatamente, in questo caso, non c’è bisogno dei massicci trasferimenti fiscali registrati dall’Ovest verso l’Est dopo la caduta del Muro di Berlino. Sarebbe sufficiente prestare più attenzione allo sviluppo nelle economie più periferiche quando si prendono decisioni di politica monetaria, partendo col pianificare una svalutazione dell’euro rispetto al dollaro.
Allo stesso tempo, il bilancio europeo dovrebbe essere usato meglio per affrontare i problemi legati alla disoccupazione giovanile. Oltre a essere troppo contenuta (6 miliardi di euro, ovvero, circa 400 euro per giovane disoccupato all’anno), l’Iniziativa europea per l’occupazione giovanile si dà obiettivi sbagliati e coinvolge attori sbagliati: si propone di avviare al lavoro i giovani nei paesi in cui non ci sono posti disponibili per loro; inoltre, trasferisce denaro dal bilancio europeo direttamente alle regioni povere, saltando le giurisdizioni nazionali, mentre l’aumento della disoccupazione giovanile ha una dimensione marcatamente nazionale. Il risultato sono programmi regionali co-finanziati dall’Ue che, per contrastare la disoccupazione giovanile, si affidano a una grande varietà di progetti di piccola portata e di durata limitata. Vi rientrano molti corsi di formazione più adatti ad arricchire chi tiene il corso (spesso con curricula limitati, come quelli per estetista) che ad aiutare effettivamente coloro che dovrebbero beneficiare della formazione.
Nell’ambito dell’iniziativa non c’è spazio, invece, per le riduzioni fiscali permanenti e i sussidi salariali che promuoverebbero la domanda di lavoro per i più giovani nei paesi con un alto tasso di disoccupazione. Insomma, si ripetono esattamente gli stessi errori compiuti nell’allocazione dei fondi strutturali: spesso i governi locali non sanno che fare di questi soldi e finiscono o per non spenderli (la stessa efficiente amministrazione tedesca utilizza non più del 60 per cento delle allocazioni dei fondi strutturali) o per disperderli in una miriade di piccoli progetti, i cui costi di gestione superano frequentemente il 50 per cento del budget di ciascun singolo progetto.
Con le regole attuali, alle nazioni in crisi converrebbe arrivare a un accordo di “zero a zero”: non contribuire in alcun modo al bilancio Ue e non riceverne nulla in cambio. Ma se chi più ha bisogno di sostegno sotto i colpi di crisi asimmetriche ricava un maggior beneficio chiamandosi fuori dal fondo comune, è evidente che quel fondo comune non ha ragione di esistere sotto il profilo della condivisione del rischio e del mutuo soccorso. L’Iniziativa europea per l’occupazione giovanile dovrebbe quindi essere riconsiderata, consentendo il finanziamento di programmi nazionali per la creazione di posti di lavoro nei paesi con un’alta disoccupazione giovanile, mentre i fondi strutturali dovrebbero trasformarsi in strumenti per sostenere quelle riforme strutturali che incrementino la convergenza economica all’interno dell’Unione. Dovrebbero essere fondi per compensare gli svantaggi della liberalizzazione economica secondo la filosofia dei Contractual Arrangements, oltre che per assorbire gli shock. Oggi non ci sono le basi per un ampliamento del bilancio dell’Ue, ma possiamo iniziare a spendere meglio il denaro a disposizione.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- L’Europa esce dalle urne ferita e trasformata (di Ida Domijanni - L’Europa ferita e il partito-Stato italiano)26 maggio 2014, di Federico La Sala
L’Europa ferita e il partito-Stato italiano
di Ida Dominijanni (il manifesto, 26 Maggio 2014)
L’Europa esce dalle urne ferita e trasformata. Ferita, perché per quanto non abbiano sfondato le forze antieuropee hanno avuto risultati tutt’altro che trascurabili e in Francia, Gran Bretagna e Ungheria esplosivi. Trasformata, perché l’equilibrio fra stati (l’asse franco-tedesco) e fra partiti (le due grandi famiglie dei socialisti e dei popolari europei) non c’è più. Per quanto Angela Merkel, la custode dell’Europa neoliberale, austera e avara, incassi l’ennesima conferma della sua politica in casa, la soluzione di una grande coalizione che prosegua a livello continentale le dissennate politiche degli ultimi anni che hanno portato molte popolazioni europee alla disperazione è tutt’altro che scontata. Altre maggioranze sono possibili, e in ogni caso le forze portatrici della continuità non potranno non fare i conti non più con gli umori, ma con i numeri che esprimono una rivolta diffusa contro l’Unione che abbiamo sperimentato finora e una forte e allarmante istanza dal basso di ritorno alla sovranità popolare, la bandiera non a caso più fortemente agitata nell’immediatezza dei risultati da Marina Le Pen.
Il vento della trasformazione non spira però solo da destra, o dalle formazioni trasversali cosiddette populiste. Spira da sinistra, anzi nella sinistra, perché i risultati penalizzano ciò che resta della tradizione socialista novecentesca e fanno spazio a due sinistre nuove e diverse se non opposte fra loro, emblematicamente raffigurate dal partito di Renzi in Italia e da Syriza in Grecia, che rappresentano due uscite diverse dalla crisi, due visioni diverse della società, due ipotesi opposte di ricostruzione della sinistra post-novecentesca. Il trionfo di Renzi, che ne fa in primo luogo il leader più forte del fronte ”progressista” in Europa e lo carica di un potere e di una responsabilità insperati nel semestre europeo, va valutato in questo quadro di trasformazione della sinistra continentale.
La domanda cruciale, e qui dal contesto europeo scivoliamo in quello italiano, è se questo trionfo si debba a un sinistra che si risveglia dopo il ventennio berlusconiano o a una sinistra che in tanto finalmente sfonda in quanto ne incorpora gli elementi portanti. Non solo, va sottolineato, l’abilità comunicativa dell’attuale premier, mutuata dal precedente. Bensì molti e cruciali contenuti, dalla torsione populistico-plebiscitaria della democrazia al disegno di riforma costituzionale, dalla concezione del lavoro, dell’autoimprenditorialità e della flessibilità a quella della rottamazione del settore pubblico, secondo la versione lievemente corretta delle politiche neoliberali del ventennio passato sostenuta dal segretario del Pd. E’ la continuità nella discontinuità che l’elettorato italiano - un elettorato evidentemente molto trasversale - ha premiato, sostituendo nel suo immaginario la narrativa dell’ex sindaco di Firenze a quella ormai usurata dell’ex cavaliere di Arcore.
Il trionfo di Renzi tuttavia è di tale entità da mettere in difficoltà i suoi più accesi sostenitori, e non solo perché il risultato fa piazza pulita del ”duello” con Grillo montato dai media e smontato dalle urne. Ma perché il problema vero è quello della configurazione che il sistema politico prenderà.
L’avvento di Renzi, e l’accordo del Nazareno fra Renzi e Berlusconi, era stato salutato dai più come garanzia di ricostituzione di un bipolarismo di cui Berlusconi era stato creatore e garante , e di cui col declino di Berlusconi avrebbe dovuto diventare perno e garante il ”conquistatore” del Pd. Una prospettiva tranquillizzante, di sostanziale continuità con la cosiddetta seconda Repubblica, assunta come premessa dai due stessi contraenti del patto del Nazareno sulle riforme e sulla legge elettorale.
Non era tuttavia imprevedibile - mi ero permessa di segnalarlo in un seminario Crs sulle riforme - prima che la sondaggistica preelettorale, sbagliando clamorosamente, inchiodasse la gara sul match Renzi-Grillo - che si stesse delineando tutt’altro scenario, con un Pd pigliatutto saldamente piazzato al centro del sistema politico, a vocazione più totalitaria (uso questo termine depurandolo dai suoi connotati tragici novecenteschi) che maggioritaria, un partito-Stato senza nessuna alternanza bipolarista e nessuna necessità coalizionale all’orizzonte.
Si parla adesso, per questo, di nuova Dc, ma è bene sapere che il Pd non è la Dc, è un animale nuovo figlio della seconda repubblica e non della prima, della società forgiata dal berlusconismo e non di quella plasmata dal dopoguerra.
L’effetto di ritorno segnala al contempo quanto sia stata fragile la costruzione della seconda repubblica sul piano istituzionale, e quanto sia stata forte sul piano della trasformazione antropologica, sociale e delle identità politiche. Sono i miracoli delle rivoluzioni passive, che restanopd come a un partito « la caratteristica più singolare di questo singolare paese.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Politiche d’Unione. Europee, quello che nessuno dice (di Roberta De Monticelli)23 maggio 2014, di Federico La Sala
Politiche d’Unione
Europee, quello che nessuno dice
di Roberta De Monticelli (il Fatto, 23.05.2014)
Oggi, mentre le dimensioni morali, culturali, politiche ed economiche della civiltà italiana si stanno riducendo tanto penosamente, nessuno dei grandi partiti in lizza ha altro orizzonte che se stesso e la lotta politica interna all’Italia. È desolante ma vero: lo spirito di queste elezioni ci invita a un moto espansivo, ad allargare l’orizzonte del nostro respiro politico, e soprattutto a esercitare il nostro ruolo di cittadini europei (“Unione europea” sta scritto sulla copertina dei nostri passaporti sopra “Repubblica italiana”). E centinaia di migliaia di ragazzi, figli di Erasmus - cioè dell’Europa - sono già a tutti gli effetti, nelle città che abitano, nel lavoro che fanno o nelle prospettive che hanno, cittadini europei prima che del loro paese di provenienza. Ma i partiti non ci dicono qual è la posta in gioco di queste elezioni. Vincere le elezioni, per loro, significa risultare i primi in Italia .
Nessuno ci dice che invece non può essere un partito italiano, ma solo un raggruppamento politico europeo a “vincere le elezioni”. Che dunque chi non aderisce a un raggruppamento politico europeo (come M5S), quand’anche prendesse tanti voti, manderà una pattuglia di 20-30 deputati (sui 73 eleggibili in Italia), a disperdersi nel mare dei 751 eletti al Parlamento europeo.
E che la vera sfida sarà quella di chi avrà titolo per allearsi ai socialisti di Schulz: i popolari rappresentati da Juncker (Merkel) o la Sinistra Europea (Tsipras) e i Verdi della Keller? E quanto peserà l’Alleanza dei liberali e democratici per l’Europa, rappresentata da Verhofstadt?
“UNA VOLTA è stata messa in minoranza la linea Thatcher, quando è stato fatto l’euro”, ha scritto Barbara Spinelli. Oggi la chance di un’Europa più simile a quella che Altiero Spinelli sognava, è mettere in minoranza la Merkel.
Ma l’altra cosa che nessuno ci dice è cosa verrà tradito, se anche in Europa dovesse vincere l’intesa socialisti-popolari. Verrà tradito esattamente lo spirito e il senso di queste elezioni. Che sono fatte per passare dall’Europa inter-governativa del Consiglio europeo (quello che riunisce i capi di Stato e di governo europei, e che fa dell’Europa sostanzialmente il luogo del dominio degli interessi nazionali più forti), attualmente presieduto da Van Rompuy, all’Europa sovranazionale della cittadinanza, che sarà effettivamente rappresentata nel Parlamento solo quando la Commissione europea sarà l’effettivo governo dell’Unione.
Nessuno ci dice che queste elezioni sono state organizzate (Risoluzione del Parlamento del 4 luglio 2013), per “parlamentarizzare” l’elezione del presidente della Commissione, e cambiare i rapporti di forza fra la Commissione e il Consiglio, in modo che la prima diventi gradualmente il vero organo di governo dell’Unione europea, e il suo presidente, il capo del governo, al diretto servizio del bene comune dell’intera unione, come vorrebbe il Parlamento. E non, come vorrebbe la Merkel, quel mero coordinatore dei capi dei governi nazionali che è oggi Barroso.
Nel luglio 1939, Altiero Spinelli sbarcava a Ventotene, dopo aver scontato fra carcere e confino dodici anni dei sedici inflittigli - a neppure vent’anni - dal Tribunale Speciale fascista per la sua opposizione attiva al regime. Nel ’37, a Ponza, era stato espulso dal Partito comunista, perché, come Spinelli scrive nella sua autobiografia - una delle più intense della letteratura mondiale (Come ho cercato di diventare saggio, Il Mulino 1999) - era stato “tutto un monologo sulla libertà” quello che aveva iniziato “dal momento che le porte del carcere si erano chiuse alle [sue] spalle”.
Nel ’41 nasce - sotto la sua penna e in parte quella di Ernesto Rossi, frutto delle conversazioni con Eugenio Colorni e pochi altri, il Manifesto di Ventotene, con il suo memorabile attacco: “La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l’uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita. Con questo codice alla mano si è venuto imbastendo un grandioso processo storico a tutti gli aspetti della vita sociale, che non lo rispettassero” .
Tutti: e fra questi il contrasto fra la politica concepita sulla base degli Stati nazionali e l’economia globale. Vere democrazie che siano esclusivamente interne ai singoli stati, oggi, non sono più possibili. Quell’uomo visionario lo vide settant’anni fa. Ma la politica italiana vuole ridurre anche quella visione alla sua misura. Quella di una classe dirigente che affida la gestione della massima chance di riscatto nazionale agli occhi del mondo, l’Expo, ad alcuni avanzi di galera di vent’anni fa. Ecco l’Europa a misura d’Italia.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Il colonialismo non è mai morto (di Luciana Castellina)23 maggio 2014, di Federico La Sala
Il colonialismo non è mai morto
di Luciana Castellina (il manifesto, 23 maggio 2014)
L’Europa nata nel 1957 non è quella che era stata sognata dagli antifascisti al confino di Ventotene. Nel loro Manifesto l’obiettivo dell’unità fra paesi che allora erano per la seconda volta in pochi decenni impegnati in una guerra sanguinosa, era la pace. E invece il primo embrione della futura Unione, che fu significativamente chiamata Mec, l’Europa la spaccò. Fu infatti pensato soprattutto come strumento della guerra fredda: un avamposto dell’occidente a ridosso della cortina di ferro, strettamente collegato alla Nato. Pochi lo ricordano: il primo atto istituzionale a favore della nuova creatura europea non fu dei nostri parlamenti, bensì di quello americano. Fu votato nel 1947, il 10 marzo al Senato, il 23 al Congresso, auspice il potente segretario di stato John Foster Dulles, fratello dell’altrettanto potente Allen, capo della Cia.
Da questa nascita bastarda l’Europa è rimasta segnata, sicché, anche quando è caduto il muro, non è migliorata. Basti pensare alla sua politica estera che, anziché ricercare un rapporto di cooperazione con il grande vicino euroasiatico che avrebbe potuto conferire al continente la possibilità di garantirsi un ruolo autonomo nel mondo, si è invece appiattita sulla linea di Washington, interessata a mantenere il proprio controllo: accettazione di tutti i possibili missili sul proprio territorio ai tempi di Breznev e Andropov, anche quando sarebbe stato necessario aiutarlo ad uscire dalla fatale spirale del riarmo; e oggi estensione della Nato ai confini della Russia, come se dovessimo rilanciare la guerra fredda, una linea che copre solo i più biechi competitivi interessi petroliferi americani (nell’insieme un bel regalo all’odioso Putin, che per via del comportamento occidentale ha ritrovato popolarità nel suo paese).
L’impronta colonialista, così come l’arroganza occidentale, sono rimasti il tratto dell’orientamento dell’Ue in politica internazionale: ciò che possiamo fare noi europei non è concesso agli altri. Ad esempio, il precipitoso unilaterale riconoscimento dell’indipendenza da Belgrado delle repubbliche slovena e croata nel ’93 in nome del diritto dei popoli all’autodeterminazione e la violenta denuncia di chi in Ucraina sta rivendicando il medesimo diritto (significativo che nessuno ricordi oggi come la Jugoslava sia stata sbranata in nome di quel diritto senza che l’Ue nemmeno tentasse di aprire un tavolo di discussione fra le parti, come previsto dalla Conferenza per la sicurezza europea in cui era stato stabilito che nessun confine possa esser toccato senza un accordo. L’Unione europea plaudì persino al bombardamento di Belgrado in difesa dell’autodeterminazione dei kosovari).
Sull’incongruenza europea si potrebbe continuare, citando i casi del Sahara occidentale, di Timor Est, di Cipro e naturalmente della Palestina. Per non parlare del silenzio sulla bomba atomica posseduta da Israele, con buona pace del Trattato di non proliferazione. Così come delle guerresche punizioni a chi non obbedisce alle decisioni dell’Onu, ma dell’assoluzione delle tante avventure belliche che quella copertura non hanno avuto. Nel caso, ancora una volta, di Israele, e di quelle che hanno avuto l’Europa stessa come protagonista.
E poi, forse più grave di tutte, la politica verso il sud Mediterraneo. Con sonore fanfare si lanciò anni fa l’Accordo di Barcellona, che avrebbe dovuto essere un amichevole partenariato, in grado di lanciare un compromesso per un lungimirante co-sviluppo delle rispettive economie ed è stato invece solo un’apertura al libero scambio che non avrebbe mai potuto colmare - e infatti l’approfondì - l’enorme dislivello storico coloniale fra le economie delle due sponde.
Oggi il dramma gigantesco dell’immigrazione clandestina dovrebbe proporre una seria riflessione sulla politica internazionale dell’Europa, che non si esaurisce certo solo in un po’ di aiuti all’Italia per l’accoglienza degli scampati ai naufragi. Occorrerebbe ripensare il mondo, capire che siamo di fronte ad uno sconvolgimento storico che non si può fronteggiare né con le armi ma nemmeno con una politica miope che pensa l’Europa possa rimanere un giardino chiuso.
Qualche sintomo di ravvedimento? No, il contrario: l’impegno principale degli esecutivi dell’Unione consiste ora nel varo di un Trattato di libero scambio transatlantico che, se andrà in porto, cancellerà tutto quanto è stato conquistato nel ventesimo secolo in Europa dal movimento operaio e democratico. Nessuno, salvo la lista Tsipras, ne ha parlato in questa campagna elettorale. Non è un caso: sarebbe sufficiente questo problema a determinare il voto del 25 maggio ove la gente sapesse di cosa si tratta.
La prospettiva che questo accordo apre è di un’Europa che perde la specificità del suo modello sociale, che nel dopoguerra, e grazie a grandi lotte, ha rappresentato il compromesso sociale più alto. Se così finirà per essere, a che pro un’Unione europea? Diverrebbe solo un pezzetto del mercato globale e avrebbe cessato di avere una sua ragion d’essere, l’espressione di un modello diverso. I più pericolosi antieuropeisti sono senz’altro tutti quelli che vogliono farle perdere ogni identità, omologandola al peggio del mondo.
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Il Vecchio Continente fantasma politico in cerca di un’identità22 maggio 2014, di Federico La Sala
Già Marx e Nietzsche avevano capito che il processo di unificazione economica doveva essere intrapreso
Il Vecchio Continente fantasma politico in cerca di un’identità
di Massimo Cacciari (la Repubblica, 22.05.2014)
PIÙ appare inarrestabile la decadenza del ruolo politico e del peso economico dell’Europa nel mondo fattosi Globo (The Globe è il simbolo, consacrato all’esposizione universale di Parigi del 1889), più sembra crescere il desiderio di definirne la figura, di disegnarne l’identità, di stabilirne l’idea. Ma quanto esso si fonda su una reale conoscenza della storia europea? Quanto esso corrisponde al “dèmone” che ne presiede le continue metamorfosi? E di che natura sono i progetti e i programmi che da esso possono prendere vita?
Infermissima, insecura è l’idea di uno spazio culturale europeo fin dal suo primo manifestarsi. Europa non ha mai indicato un luogo in contrapposizione ad altri, tantomeno un “centro sacrale”, come molti un tempo hanno preteso, ma un’energia irradiante in ogni direzione, una radicale insofferenza per ogni confine che non significasse somica. glia da trasgredire. Qui mai il dio Termine ha trovato dimora.
Questa energia ha assunto due volti, che nella loro inseparabilità hanno costituito la tragica grandezza d’Europa: un’inquietudine interiore, da cui nasce la “invenzione” di un movimento storico, che tutto relativizza e, alla fine, travolge; l’impossibilità di “lasciare in pace”, il non poter fare a meno di trascinare nel vortice di quel movimento ogni altra cultura, magari soltanto con la volontà di “scoprirla”. Fame di conoscenza e fame di conquista sono categorie rigorosamente scisse solo nella fantasia delle anime belle.
La “detronizzazione” d’Europa, seguita inesorabilmente alle guerre mondiali che essa ha scatenato, ha posto fine a ogni sua possibile “missione”? Il suicidio delle sue volontà egemoniche deve comportare l’impotenza a deciderne qualsiasi “compito”? È chiaro che a queste domande non si risponde con i “programmi” per il rafforzamento (o il salvataggio) della sua unità economica.
Ben prima infatti che quel suicidio si compisse, i grandi “profeti” dell’età che viviamo, da Tocqueville a Marx a Nietzsche, avevano compreso la necessità che il processo di unificazione economica venisse intrapreso. Gli staterelli europei (diceva Nietzsche nel 1885!) saranno costretti sotto la spinta dei commerci mondiali a stringersi insieme in un’unica potenza. Il solo denaro li obbligherà a questo tentativo, per l’impossibilità evidente di competere nell’economia globale da parte di qualsiasi antico ”staterello sovrano”.
Riconoscere ciò che è necessario fare per sopravvivere è certo buon segno di volontà di vita, ma non indica di per sé alcuna “missione”, non può assumere alcun significato per il destino degli altri spazi dell’unico Globo.
Altrettanto evidente è, però, che nessun compito futuro può essere “inventato”, che qualsiasi “progetto” dovrà rivivere in sé fattori essenziali del passato e la sua lingua sapersi esprimere nei linguaggi in cui storicamente l’Europa si è rappresentata, non nell’universale esperanto tecnico-formale che appartiene al “solo denaro”, per trasformarli, magari, proprio parlandoli. Ora, l’Europa insecura, operante proprio sempre in forza di tale insecuritas, questa Europa, che mai è sembrata avere sede certa, attorno a un linguaggio si è tuttavia costruita o, meglio, a un suo “originario fenomeno”. Possiamo chiamarlo “filosofia”.
Non si tratta di contenuti determinati, tantomeno di astratti sistemi, ma di un atteggiamento complessivo che informa di sé tutta la nostra immagine del mondo, che determina una idea di vita: la possibilità che, al limite , essa possa essere condotta sulla base di norme razionali; che, proprio a tal fine, cultura e scienza debbano poter procedere autonomamente, ovverosia incondizionatamente, per potersi così esprimere in tutta la loro intrinseca potenza; che la libertà che in questa attività si incarna sia possesso del soggetto che opera, e che operando fa la propria storia, di noi, i Soggetti.
Si potrebbe dimostrare come questa prospettiva si sia intrecciata con tutte le dimensioni dell’esperienza europea, ma la questione che urge non è storiografica. Può l’Europa avere altro compito che quello che il suo dèmone filosofico gli ha dettato? Programmi, certo, ne potrà elaborare comunque, come qualsiasi grande spazio del Globo, per salvaguardare la propria “competitività”.
Ma una “identità” diversa da quella che nel linguaggio della filosofia si è tracciata, dove potrebbe mai immaginarla? Poiché questo appunto è il problema: che quel linguaggio è apparso compiuto (e, per tanti versi, vittoriosamente compiuto) nel corso del tragico “secolo breve”, che esso, proprio con la “occidentalizzazione” dell’intero pianeta, sembra giunto al suo estremo. Che rimane all’Europa da fare dopo aver compreso ogni alterità nella forma trascendentale del Cogito e svelato ogni “ideale” o “valore” come proprie creazioni, che di volta in volta storicamente si realizzano?
Forse nient’altro che la critica de-costruttiva, la messa in dubbio radicale della fondatezza di quell’eroica istanza. Può il compito attuale d’Europa consistere nell’esercizio ironico- scettico rispetto ad ogni pretesa di riduzione del mondo a “sistema”? Un gesto di rinuncia ne caratterizzerebbe, allora, l’idea. Rinuncia a ogni volontà di possesso e afferramento del reale sul metro della propria storia, rinuncia a ogni forma di teleologia.
Rinuncia che non significhi pessimistico abbandono, ma capacità di accogliere in sé, attenzione e ascolto rivolti all’infinita differenza che ci separa dal prossimo, e insieme a lui ci accorda. Il tramonto destinato della potenza europea può trasformarsi in una volontà operante, capace di indicare una destinazione: un mondo in cui l’esperienza della coscienza, per dirla con Hegel, giunga a comprendere che la presenza dell’altro è condizione necessaria della ricerca della propria stessa identità.
“Costituzionalizzare” l’Europa per impedirne il tramonto, per arrestare la decadenza della sua volontà di potenza, rappresenta la prospettiva opposta. E nessun “potere che frena” basterebbe alla bisogna. Che il tramonto divenga un tramontare , questo occorre, che sia conflitto verso ogni forma di idolatria identitaria, che sia apertura all’imprevedibile e all’inaudito che ogni incontro con l’altro, ogni nuova aurora, porta con sé.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Un progetto per l’altra Europa (di Chantal Mouffle)20 maggio 2014, di Federico La Sala
Un progetto per l’altra Europa
di CHANTAL MOUFFLE
- «Domenica 25 si vota per il futuro dell’Ue. Tra euroscettici ed europeisti neoliberali, esiste una terza via: la proposta di un progetto europeo che offra un’alternativa al modello egemone, in preda a una gramsciana «crisi organica». Syriza può essere il collante dell’antagonismo». Sbilanciamoci.info, newsletter n. 330, 19 maggio 2014 *
Le prossime elezioni europee dovrebbero essere considerate l’occasione per una competizione agonistica sul futuro dell’Unione. Una competizione, che oggi è assolutamente fondamentale. Molti a sinistra cominciano a dubitare che si possa realizzare, all’interno dell’attuale costruzione europea, un’alternativa al modello neoliberale di globalizzazione. E l’Unione europea è sempre più percepita come un progetto intrinsecamente neoliberale che non può essere riformato. In tal senso, appare inutile provare a trasformare le sue istituzioni, e l’unica strada possibile è quella dell’uscita.
Ma questa visione pessimistica deriva indubbiamente dal fatto che tutti i tentativi di contrastare le regole neoliberali dominanti vengano sistematicamente presentati come la mera espressione di attacchi anti-europei contro l’esistenza stessa dell’Unione. Non può certo sorprendere che un numero crescente di cittadini, privati della possibilità di avanzare legittime critiche alle politiche neoliberali, sia diventato euroscettico. Essi credono che il progetto europeo sia proprio la causa della condizione di emergenza che stiamo vivendo e temono che una maggiore integrazione comunitaria porti soltanto al rafforzamento dell’egemonia neoliberale.
Questa posizione minaccia la sopravvivenza del progetto europeo e l’unico modo per arrestare la sua diffusione consiste nel creare le condizioni per una contestazione democratica all’interno dell’Unione europea. Dal mio punto di vista, alla base della disaffezione nei confronti della Ue vi è la mancanza di un progetto che favorisca una forte identificazione tra i suoi cittadini e fornisca un obiettivo per mobilitare democraticamente le loro passioni politiche. La Ue è formata da consumatori, non da cittadini: è stata costruita essenzialmente intorno a un mercato comune e non ha mai creato una volontà comune. Nessuna sorpresa, quindi, se in tempi di crisi economica e di politiche di austerità più di qualcuno inizi a mettere in dubbio la sua utilità, dimenticando che l’Unione europea ha contribuito in modo decisivo alla pacificazione del continente. Ciò che serve in questa congiuntura è rafforzare il consenso popolare nei confronti dell’Unione grazie all’elaborazione di un progetto socio-politico finalizzato ad offrire un’alternativa al modello neoliberale che ha prevalso negli ultimi decenni: quel modello è ora in crisi, ma un altro ancora non esiste. Si potrebbe dire, sulle orme di Gramsci, che stiamo assistendo a una «crisi organica» in cui il vecchio modello non può più durare, mentre il nuovo modello non è ancora nato.
Purtroppo la sinistra non è in grado di trarre vantaggi da questa situazione, perché ha accettato per troppo tempo l’idea che alla globalizzazione neoliberale non vi sia alternativa. In molti paesi, i governi di centro-sinistra hanno giocato un ruolo fondamentale nel processo di deregolamentazione e privatizzazione che ha contribuito a consolidare l’egemonia neoliberale. E non si può negare che le istituzioni europee abbiano la loro parte di responsabilità nella crisi attuale. È un errore, però, concepire questa crisi come una crisi del progetto europeo.
Si tratta piuttosto di una crisi della sua incarnazione neoliberale, ed è per questo che i tentativi di risolverla somministrando una dose ancora più forte di politiche neoliberali non può avere alcun successo. Per combattere il dilagare di sentimenti anti-europei e fermare la crescita dei partiti della destra populista che eccitano tali sentimenti, è urgente offrire ai cittadini europei un progetto politico che possa dar loro la speranza di un futuro diverso, più democratico.
Fortunatamente in molti paesi d’Europa sono nati partiti che si pongono a sinistra delle socialdemocrazie e che sfidano il loro centrismo. Organizzati nel Partito della Sinistra europea, lavorano per un’alternativa all’egemonia neoliberale e hanno deciso di lanciare un’offensiva a livello continentale. Così, in occasione del quarto Congresso che si è tenuto a Madrid dal 13 al 15 dicembre 2013, hanno scelto di candidare il leader di Syriza in Grecia, Alexis Tsipras, alla presidenza della Commissione europea con l’obiettivo di proporre un altro modello per l’Unione. Syriza è una coalizione di partiti e movimenti sociali, e da questo connubio può istituirsi lo spazio per mobilitare la vasta costellazione di forze sociali che si oppongono alle attuali politiche della Ue.
In molti paesi i movimenti sociali hanno risposto positivamente all’appello del Partito della Sinistra europea a sostegno della candidatura di Tsipras, e sono ora impegnati a organizzare la loro partecipazione alla campagna politica. In Italia, per esempio, hanno dato vita a una Lista Tsipras per sostenere il programma che Tsipras ha presentato accettando la sua candidatura alle elezioni europee. Si tratta di uno sviluppo molto promettente, perché soltanto sulla base di una sinergia a livello europeo tra partiti della sinistra e movimenti sociali è possibile costruire una soggettività in grado di portare a una trasformazione radicale dell’attuale ordine neoliberale.
*
Fonte: Eddyburg
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Abbiamo bisogno di una visione politica e culturale diversa altrimenti diventeremo dei mostri (di Petros Markaris)24 aprile 2014, di Federico La Sala
«C’è bisogno di un’altra visione politica e culturale»
di Petros Markaris (il manifesto, 18 aprile 2014)
Grecia. Lo scrittore greco Petros Markaris: «Piangere sulla ricchezza passata è inutile, bisogna riabituarsi a lottare». «A pensarci bene, quello che ci ha rovinati è un ascensore troppo rapido». È così che la traiettoria sociale della Grecia è riassunta dal protagonista della fortunata serie noir di Petros Markaris, in Resa dei conti. La nuova indagine del commissario Charitos (Bompiani, 2012), l’ultimo libro uscito in Italia. Le vite segnate dalla crisi e le piccole strategie di resistenza sono molto più che lo sfondo per il mistero del delitto raccontato da Markaris. Sono al centro di una narrazione corale che riscopre legami familiari e solidarietà sociali, fa i conti con l’etica e con gli effetti del suo smarrimento da parte della politica. -Un’intervista telefonica con lo scrittore greco ha aperto il corso “Narratori d’Europa: volti e luoghi dalla crisi”, organizzato dall’Istituto regionale studi europei (Irse) del Friuli Venezia Giulia. Ne riprendiamo qualche estratto.*
Katerina e Adriana, le protagoniste femminili del suo ultimo romanzo, sono simboli della relazione complessa tra giovani e adulti e dei loro differenti modi di agire. In questo particolare momento della nostra vita, come si struttura questa relazione complessa?
Cominciamo a parlare del passato. Uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare con la crisi è quello di come abbiamo cresciuto i nostri figli, i giovani. Uno dei modi in cui lo abbiamo fatto è stato quello di lasciargli credere che la madre Europa avrebbe guarito tutto, e ora che ci rendiamo conto che non è così i giovani si sentono perduti. Oggi i giovani non sono preparati ad affrontare i tempi duri, e il problema è simile in Spagna, Grecia, Italia. La nostra generazione, la mia, è cresciuta lottando per tutto quello che poteva ottenere, quindi i giovani hanno bisogno di tempo per capire che devono lottare e ci sono tre condizioni basilari per questo: leggere, pensare e discutere la realtà. Questo è l’unico modo per affrontare la realtà.
È possibile trasformare la crisi in opportunità di cambiamento?
Penso di sì. È quello che è successo ai due protagonisti del mio libro, Zisis e Charitos, due persone provenienti da mondi molto distanti ma che trovano il modo di connettere le loro differenti personalità. Anche io sono cresciuto in una famiglia con difficoltà economiche, io stesso ne ho avute molte. Mia madre era una casalinga, è stata lei a tenere la famiglia unita, ha sempre trovato una soluzione, un po’ come, nel libro, la figura di Adriana. Tutte queste persone trovano alla fine il modo per sopravvivere, ma trovare il modo di sopravvivere più che una questione economica è un fatto soprattutto culturale, di valori. Piangere sulla passata ricchezza, che per la Grecia è stata più che altro virtuale, non è una soluzione. La soluzione possibile è trovare una ridefinizione del nostro punto di vista sulla vita. Solo in questo modo potremo uscire dalla crisi più forti.
Siamo alla vigilia delle elezioni europee e nessuno in Italia ne parla seriamente. Noi pensiamo che possano essere un’opportunità per chiedere a noi stessi quale Europa vogliamo, quale vita, quale welfare. Lei cosa ne pensa?
Questa è una domanda che mi rende molto triste e le spiego il perché. Credo che le prossime elezioni europee saranno un esperienza molto negativa per gli europei. Siamo convinti che il Sud Europa sia la parte che ha problemi ma se osserviamo bene vediamo che i problemi riguardano gli estremi, l’estrema destra in particolare. È questo il prezzo che stiamo pagando per avere ridotto l’Europa a economia. Voi avete citato Spinelli e Dahrendorf, io voglio citare Jean Monnet che prima di morire disse: «Ho fatto un errore, se dovessi rifare l’Europa dall’inizio punterei su politica e cultura». È vero, ma purtroppo è arrivato tardi. L’Europa ha bisogno di un’altra visione, noi ne abbiamo bisogno, non possiamo sempre dire sarà peggio. Abbiamo bisogno di una visione politica e culturale diversa altrimenti diventeremo dei mostri.
*
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Come i media preparano un regime e il silenzio calato sulla lista L’altra Europa con Tsipras (di Guido Viale)24 aprile 2014, di Federico La Sala
Come i media preparano un regime
di Guido Viale (il manifesto, 23 aprile 2014)
Ci si chiedeva spesso, decenni fa, nelle scuole e sui media, come fosse stato possibile che nel 1931, su oltre milleduecento docenti universitari, solo una quindicina avesse rifiutato di giurare fedeltà al fascismo; e come fosse stato possibile che con loro si fossero allineati migliaia di giornalisti, di scrittori, di intellettuali - la totalità di quelli rimasti in funzione - contribuendo tutti insieme a costruire una solida base di consenso alla dittatura di Mussolini.
Il contesto è sicuramente cambiato, ma forse il servilismo è rimasto invariato. Oggi, senza nemmeno l’alibi di un’imposizione da parte di un potere autoritario e incontrollato, a cui peraltro anche allora molti erano già ben predisposti, la corsa ad allinearsi con il potente di turno, magnificandone qualità e operato, ha assunto da due decenni a questa parte un andamento a valanga; per poi accorgersi, una volta usciti temporaneamente o definitivamente di scena i destinatari di tanta ammirazione, che i risultati del loro operare - del loro «fare» in campo economico, sociale, istituzionale e, soprattutto, culturale - erano inconsistenti, negativi, o addirittura drammatici. Ma rimaneva tuttavia, in alcuni angoli riservati del giornalismo cartaceo e televisivo, lo sforzo di un vaglio critico delle misure assunte dai governi che lasciava uno spiraglio alla legittimazione di un’opposizione.
Da qualche mese, al seguito della cavalcata sul nulla di Matteo Renzi - «dà con una mano per prendere con l’altra» (e molto di più) è la sintesi del suo operato - il coro delle ovazioni si è fatto assordante; lo spazio che gli riservano giornali e tv è totalitario (come documenta l’osservatorio sulle tv di Pavia); i toni sono perentori; i rimandi alle sue poliedriche capacità incontinenti; il servilismo degli adulatori dilagante (papa Francesco copia «lo stile di Renzi» ci ha informato un notiziario).
Non c’è più un regime fascista a imporre questo allineamento; sono piuttosto questi allineamenti a creare le solide premesse di un «moderno» autoritarismo. «Moderno» perché è quello auspicato dall’alta finanza, che ormai controlla la politica e le nostre vite; come emerge anche da un documento spesso citato della Banca J.P.Morgan che si scaglia contro le costituzioni antifasciste e democratiche che ostacolerebbero il proficuo svolgimento degli «affari».
È l’autoritarismo perseguito dalle «riforme» costituzionali ed elettorali di Renzi, tese a cancellare con premio e soglie di sbarramento ogni possibilità di controbilanciare i poteri dei partiti - o del partito - al potere: non solo in Parlamento, ma ovunque; a partire dai Comuni, non certo aiutati a «fare», bensì paralizzati dai tagli ai bilanci e dal patto di stabilità per costringerli ad abdicare dal loro ruolo, che è fornire quei servizi pubblici locali di cui è intessuta l’esistenza quotidiana dei cittadini. Renzi, come Letta, Monti e Berlusconi, vuole costringerli ad alienarli: come aveva fatto Mussolini sostituendo ai consigli comunali i suoi prefetti.
Una riprova non marginale di questo clima è il modo in cui stampa e media seguono la campagna elettorale europea, confinandola interamente in un confronto Renzi-Grillo (con Berlusconi ormai ai margini) privo di contenuti programmatici e tutto incentrato sulle diverse forme di «carisma» che i due leader esibiscono.
In questo contesto il silenzio calato sulla lista L’altra Europa con Tsipras, l’unica che si presenta con un programma per cambiare radicalmente l’Europa (che è l’argomento di cui è proibito parlare) e non per abbandonarla insieme all’euro, né per continuare sulla rotta di quell’austerity difesa e votata fino a ieri come passaggio obbligato per tornare alla “crescita”. Della lista L’altra Europa stampa e tv hanno seguito e ingigantito le difficoltà incontrate nel corso della sua formazione, per poi calare una cortina di silenzio totale sulla sua esistenza e sui suoi successi. La venuta di Tsipras a Palermo, con un teatro pieno, la gente in piedi e mille persone rimaste fuori ad ascoltare, con una visita all’albero di Falcone accompagnato da centinaia di sostenitori e con l’incontro con il sostituto Di Matteo, non ha meritato nemmeno un cenno o una riga. Nemmeno la consegna delle 220 mila firme raccolte per consentire la partecipazione della liste alle elezioni, un risultato su cui molti media avevano scommesso che non sarebbe mai stato raggiunto, ha avuto la minima menzione. L’apertura della campagna elettorale al teatro Gobetti di Torino con la partecipazione di Gustavo Zagrebelsky e altre centinaia di sostenitori è anch’essa scomparsa nel nulla. Quando si accenna di sfuggita alla lista L’altra Europa, per lo più per denigrare o sbeffeggiare i tanti intellettuali di valore che la sostengono - ribattezzati “professoroni”; e solo per questo se ne parla - il suo programma viene assimilato a quello dei no-euro, dei nazionalisti o addirittura dei fascisti. Perché “se non si è con Renzi non si può che essere contro l’Europa”.
Il baratro in cui è precipitato il giornalismo italiano si vede dal fatto che molti non riescono nemmeno a capire che si possa volere un’Europa diversa da quella che c’è; che è quella di Renzi, come lo era di Letta, di Monti e anche di Berlusconi e Tremonti quando erano al governo. Eppure non è mancato agli stessi giornali e telegiornali lo spazio per occuparsi del congresso del “nuovo” (il 14°) partito comunista fondato da Rizzo, della presentazione della lista elettorale Stamina, della riammissione dei Verdi alla competizione elettorale anche senza aver raccolto le firme (mentre chi le ha raccolte non ha meritato nemmeno una riga).
Il tutto viene completato con la presentazione di sondaggi che danno la lista per morta: sono i tre divulgati dalle tv di regime, mentre tutti gli altri sondaggi la danno due o tre punti al di sopra della soglia di sbarramento, ma non vengono resi noti. Io, che ho lavorato anche in una società di sondaggi, so bene come si fa ad orientarli (e anche a falsificarli) e quanto contribuiscano a “orientare” e a manipolare la realtà. Giornali occupati dalla stigmatizzazione della casta non fanno un cenno del fatto che siamo l’unica lista ad affrontare questa campagna elettorale senza un euro di finanziamenti di stato o di pubblicità. E così via. Poco per volta, e a volte impercettibilmente, si scivola verso un nuovo regime e in questa temperie persino le critiche all’operato di Renzi vengono proposte come ragioni per un sostegno dovuto e ineluttabile.
Tipico da questo punto di vista, perché riassume una parabola che coinvolge un po’ tutti i commentatori politici che in qualche modo devono misurarsi con numeri e dati che contraddicono frontalmente le dichiarazioni del leader, è l’editoriale (l’omelia settimanale) di Eugenio Scalfari comparso sul numero pasquale di Repubblica. In sostanza, vi si dice, gli 80 euro di Renzi sono una bufala senza copertura finanziaria, che gli servirà per stravincere le elezioni europee, anche se è basata un una serie di imbrogli contabili che presto verranno alla luce. Ma - scrive Scalfari, che pure, in margine a una critica alla riforma del Senato proposta da Renzi manifesta, senza sottolinearla, la consapevolezza che la sua riforma elettorale stravolgerà completamente l’assetto democratico del nostro paese - c’è da augurarsi comunque che quell’imbroglio funzioni; perché così il governo si rafforzerà, recupererà anche in Europa il prestigio perduto e la crescita potrà ripartire. Il che mostra in che conto Scalfari tenga “questa Europa”: quella a cui stiamo sacrificando le ormai molte “generazioni perdute” del nostro e di altri paesi, l’esistenza, la salute, la vecchiaia e la vita stessa di un numero crescente di cittadini, di lavoratori e di imprenditori, e l’intero tessuto produttivo del nostro e paese. E mostra anche che idea abbia - e non solo lui - della crescita (il “flogisto” del nostro tempo, come lo chiama Luciano Gallino: tutti ne parlano e nessuno sa che cosa sia).
Ma soprattutto mostra dove porta questa teoria, o visione, o percezione, sempre più diffusa dai media e tra la gente, del governo Renzi come “ultima spiaggia”. Così, quando si sarà compiuto il disastro economico, sociale e istituzionale a cui ci sta trascinando quella sua cavalcata fatta di vuote promesse, di trucchi contabili e di nessuna capacità di progettare un vero cambiamento di rotta per l’Italia e per l’Europa, non si potrà più tornare indietro. È per questo che bisogna fermarlo qui e ora, a partire da un rovesciamento dei pronostici - meglio sarebbe chiamarli auspici di regime - tutti a favore delle destre nazionaliste e razziste mascherate dietro la campagna anti-euro, o delle larghe intese tra Ppe e Pse, con le quali la politica economica, fiscale e monetaria dell’Unione dovrebbe proseguire indisturbata il suo cammino di distruzione.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Dante e Mozart, il futuro riparte da loro (di Ulrich Beck)10 aprile 2014, di Federico La Sala
Dante e Mozart, il futuro riparte da loro
di Ulrich Beck (la Repubblica, 10.04.2014) *
LA CRISI dell’Europa non è, essenzialmente, una crisi economica. La crisi dell’Europa è una crisi mentale; di più: una crisi di immaginazione della buona vita al di là del consumismo. Gran parte dei critici dell’Europa, degli anti-europei, che ora alzano la loro voce, è prigioniera di una impolverata nostalgia nazionale. In questo senso argomenta ad esempio l’intellettuale francese Alain Finkielkraut: l’Europa ha creduto di potersi costituire senza, o addirittura contro le nazioni.
VOLEVA punire le nazioni per gli orrori del XX secolo. Ma non c’è una democrazia post-nazionale. La democrazia parla una sola lingua. Non nasciamo cittadini del mondo. Le comunità umane hanno confini. L’Europa non ne tiene conto. Ma questa critica all’Europa si basa sull’illusione nazionale che in una società e in una politica europeizzate sia possibile un ritorno all’idillio nazional-statale. Essa presuppone l’orizzonte nazionale come quadro diagnostico per il presente e per il futuro dell’Europa. A queste critiche rispondo: aprite il vostro sguardo, e vedrete che non solo l’Europa, ma il mondo intero si trova in una transizione dove i confini entro i quali l’Europa si pensa politicamente non sono più reali.
Due esempi paradossali a questo riguardo: tutti i giornali, tutti i notiziari televisivi britannici sono pieni di accuse all’Ue - l’euroscettica Gran Bretagna è attraversata da un’ondata mai conosciuta di opinione pubblica europea. Oppure: la Cina, per effetto della sua politica degli investimenti e delle sue dipendenze economiche, è da tempo un membro informale dell’eurozona - se l’euro fallisse, per la Cina sarebbe un colpo durissimo. È chiaro, perciò, che la cosmopolitizzazione non crea cittadini del mondo, anzi: mentre la globalizzazione dissolve le frontiere, le persone ne cercano di nuove. Il bisogno di confini diventa tanto più forte, quanto più il mondo diviene cosmopolitico. Da un lato, lo dimostra il successo del Front National alle ultime elezioni locali in Francia, ottenuto con il motto «Fuori dall’euro, fuori dall’Ue!». Dall’altro, questo bisogno di confini ha contribuito al consenso raccolto da Vladimir Putin, con la sua massima «Dove abitano dei russi, lì c’è la Russia».
Tuttavia, proprio l’aggressivo nazionalismo interventista russo dimostra che non si può proiettare il passato delle nazioni sul futuro dell’Europa, senza distruggere il futuro dell’Europa. E se l’etno-nazionalismo imperiale di Putin fosse uno shock salutare per l’Europa afflitta dall’egoismo nazionale? Alain Finkielkraut controbatte: noi europei siamo traumatizzati da Hitler. Eppure Hitler disprezzava la nazione. Voleva sostituire la nazione con la razza. Oggi, però, facciamo espiare alle nazioni la follia hitleriana. Per il loro trauma da Olocausto i tedeschi vogliono forse eliminare l’intero nazionalismo? No, ma abbiamo un presupposto in comune: la catastrofe di Hitler, dell’Olocausto e della Germania nazionalsocialista. Proprio questa catastrofe, con i processi di Norimberga, ci ha fatto elaborare il concetto di crimini contro l’umanità. I soldati tedeschi o i guardiani dei campi di concentramento colpevoli di crimini nei confronti di ebrei erano soltanto criminali, anche se il diritto nazionale non puniva i loro misfatti. Così è nata una nuova dimensione, il diritto europeo, che relativizza il diritto nazionale - e, nello stesso tempo, una nuova visione mondiale dell’umanità: l’etica del “mai più”.
Noi, e il mondo, abbiamo più che mai bisogno (anch’io lo ho argomentato) di una visione europea, per venire a capo dei mali della globalizzazione - mutamento climatico, povertà, disuguaglianza estrema, guerra e violenza. L’idea è che la forza mobilitante della catastrofe anticipata fonda l’identità europea. La lotta contro i rischi globali è indubbiamente uno sforzo erculeo. Può perfino dar vita a una nuova morale mondiale della giustizia.
Il mutamento climatico è un rischio storicamente sconosciuto che minaccia tutti e costringe inevitabilmente ad agire. Chi dice “mutamento climatico” deve pensare al di là dei confini, cooperare con i nemici, tenere presenti le generazioni future, immedesimarsi nella situazione dei più poveri - non perché li ama, ma perché ne ha bisogno per creare assieme un futuro vivibile. Qui si delinea uno stile di vita purificato dal mutamento climatico, un “cosmopolitismo egoistico”, per così dire. Ma, siamo sinceri, lo spirito del mutamento climatico è la pozione magica che concilierà gli europei euroscettici con l’Unione Europea?
Un altro consiglio (tra gli altri, anche di Alain Finkielkraut) suggerisce che se l’Europa vuole superare la sua crisi della convivenza deve ritrovare la propria identità nelle grandi opere dell’Europa, nei monumenti, nei paesaggi della civiltà. Certo, rileggere l’opera di classici come Shakespeare, Cartesio, Dante o Goethe o farsi incantare dalla musica di Mozart e di Verdi non può che far bene.
A me, ad esempio, interessa politicamente il concetto di “letteratura mondiale” di Goethe. Con esso egli intende un processo di apertura al mondo, nel quale l’alterità dello straniero diventa componente anche della propria autocoscienza. Ciò implica l’apertura dell’orizzonte, del nazionale, della propria lingua. In questo senso Thomas Mann parla di “tedeschi del mondo”; ma si può parlare anche di “italiani del mondo”, “francesi del mondo”, “spagnoli del mondo”, “inglesi del mondo”, “polacchi del mondo”, ecc., cioè di un’Europa delle nazioni cosmopolitiche.
«Dalle coste dell’Africa», scrive Albert Camus, «dove sono nato, si vede meglio il volto dell’Europa. E si sa che non è bello». Per Camus, allievo di Nietzsche, la bellezza è un criterio della verità e della vita buona. La storia ha logorato tante cose - l’idea di nazione, l’astuzia della ragione, la speranza nella forza liberatrice della razionalità e del mercato; perfino l’idea di progresso è diventata l’origine dell’apocalisse. La poesia brilla, ma lo fa nel modo più intenso dove lotta con la disperazione, lo sdegno, la perversità, la mancanza di senso. Anzi, essa manifesta la sua massima efficacia quando fa dileguare il volto dell’uomo (europeo).
Il segreto dell’Europa, afferma un disilluso Camus, è «che non ama più la vita... ». E allora qual è l’antidoto, la visione alternativa di un’altra Unione Europea, nella quale si viva la gioia per il puro presente? L’Europa italiana! Ad esempio, il sogno di un «letto matrimoniale mediterraneo» (Michael Chevalier), nel quale l’Est e l’Ovest, il Nord e il Sud si amerebbero.
Nasce così l’immagine di un’Europa delle regioni dove valga la pena di vivere e che meriti di essere amata. Il nesso apparentemente necessario tra Stato, identità nazionale e lingua unitaria si è dissolto. L’Unione, gli Stati membri e le loro regioni si occupano a diversi livelli del bene dei cittadini. Da un lato, essi danno loro una voce nel mondo globalizzato; dall’altro, un senso di sicurezza e un’identità regionale. La democrazia diventa democrazia a più livelli, come già cominciamo a praticarla: il Mediterraneo - come savoir vivre, come gioia di vivere, indifferenza, disperazione, bellezza e speranza, cioè quella mescolanza contraddittoria che noi nord-europei veneriamo e romanticizziamo come i giardini del Sud, dove «fioriscono i limoni» (Goethe).
D’accordo, il senso di colpa ha imposto anche a questa estetica e a questa poetica dell’esistenza gioiosa, cosmopolitica, mediterranea un volto grigio, brutto. Ma non è forse vero che se i tedeschi fossero andati a scuola dai giocatori di bocce del Sud non avrebbero precipitato il mondo nella Seconda guerra mondiale? Oppure che se la cancelliera Merkel fosse stata un’appassionata giocatrice di bocce non avrebbe mai predicato con zelo missionario una politica protestante di risparmio ai Paesi mediterranei? O, ancora, che se Putin fosse nato giocatore di bocce mediterraneo non avrebbe mai concepito l’idea del tutto folle di annettere l’Ucraina?
Iris Radisch scrive che «il pensiero mediterraneo regionale e confederale è sopravvissuto alle grandi ideologie nazionali e politiche, e forse è la sola utopia sociale del XXI secolo che abbia ancora un futuro». E dunque, cosa potrebbe conciliare gli europei con l’Europa? Un anticentralismo. L’ibernazione della nostalgia etnico-nazionale in tutte le sue forme. Un riavvicinamento e un ritorno alla bellezza delle regioni. Il sentimento mediterraneo. La capacità di affrontare in modo non sgradevole il caos della vita. Di rispettare la natura interna ed esterna. La coesistenza con l’altro, lo straniero, per cercare il proprio arricchimento. Ovvero, come dice Gabriel Audisio, vivere bene e morire bene.
(Traduzione di Carlo Sandrelli)
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Per un’Europa di progresso. Manifesto degli scienziati (presentazione al CNR, a Roma).7 aprile 2014, di Federico La Sala
“Manifesto
Per un’Europa di progresso”
- Martedì 8 aprile presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Piazzale Aldo Moro a Roma verrà presentato il “Manifesto per un’Europa di progresso” (ore 11.00, Sala Convegni).
Il mondo è in rapida trasformazione. Società ed economia della conoscenza hanno profondamente ridisegnato equilibri ritenuti consolidati. Aree geografiche depresse hanno conquistato, in tempi storicamente irrisori, potenziali enormi di sviluppo e crescita. Conoscenza, cultura e innovazione rappresentano più che mai il traino decisivo verso il futuro.
All’opposto l’Occidente, e alcuni aspetti del suo modello di sviluppo, sono entrati in una crisi profonda. L’Europa, in particolare, risulta investita da gravissimi e apparentemente irresolubili problemi: disoccupazione, crisi del tessuto produttivo, riduzione sostanziale del welfare. A pochi anni dalla sua formale consacrazione, con la nascita ufficiale della moneta comune, l’Europa rischia di deflagrare come sogno di una comunità di cittadine e cittadini che avevano ambito ad una nuova Nazione comune: più ampia non solo geograficamente, quanto nello spazio dei diritti, dei valori e delle opportunità. Lo storico americano Walter Laqueur ha parlato della “fine del sogno europeo”.
Le responsabilità sono diverse e distribuite e investono certamente l’eccessiva timidezza nel processo di costituzione politica del soggetto europeo: la responsabilità di presentare questo orizzonte politico, culturale e sociale con le sole fattezze della severità dei “conti in ordine”. L’Europa dei mercanti e dei banchieri, della restrizione e del rigore: una sorta di gendarme che impone limiti spesso insensati, piuttosto che sostegno nell’ampliare prospettive di visuale sugli sviluppi del futuro.
Proprio a causa di ciò, assistiamo, in corrispondenza della crisi, ad un’impressionante crescita di egoismi locali, di particolarismi e di veri e propri nazionalismi.
Fenomeni spesso intenzionalmente organizzati per sfruttare malesseri veri, e reali stati di sofferenza, ma che rischiano di produrre reazioni esattamente opposte a quanto oggi servirebbe alle popolazioni d’Europa.
Come scienziate e scienziati di questo continente - consapevoli che esiste un nesso inscindibile tra scienza e democrazia - sentiamo quindi la necessità di metterci in gioco. Di ribadire che il processo di costruzione degli Stati Uniti d’Europa è la più importante opportunità che ci è concessa dalla Storia. Che società ed economia della conoscenza - essenziali per il processo di reale evoluzione civile, pacifica, economica e culturale - si alimentano di comunità coese e collaborative, di comunicazioni intense e produttive e di uno spirito critico che permei strati sempre più vasti della società.
L’unica risposta possibile alla crisi incombente è allora la costruzione dell’Europa dei popoli, di un’Europa di Progresso! Realizzata sulla base dei principi di libertà, democrazia, conoscenza e solidarietà.
Nutriamo la stessa speranza con cui Albert Einstein e Georg Friedrich Nicolai nel “Manifesto agli Europei” del 1914 richiamarono alla ragione i popoli europei contro la sventura della guerra, e con cui Altiero Spinelli, Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi ispirarono l’idea d’Europa nel loro “Manifesto di Ventotene” del 1943. Le stesse idee che ebbero indipendentemente fautori illustri anche in tutti i Paesi d’Europa.
Vogliamo riprendere ed estendere all’Europa lo spirito che nel 1839 portò gli scienziati italiani a organizzare la loro prima riunione e a inaugurare il Risorgimento di una nazione divisa.
Promotori (*) e Primi firmatari
Ugo AMALDI (CERN, Ginevra)
Giovanni BACHELET (Università di Roma “La Sapienza”)
Giorgio BELLETTINI (Università di Pisa e INFN)
Carlo BERNARDINI (*) (Università di Roma “La Sapienza”)
Sergio BERTOLUCCI (Direttore di ricerca, CERN, Ginevra)
Vittorio BIDOLI (INFN, Roma)
Giovanni BIGNAMI (Presidente Istituto Nazionale di AstroFisica - INAF)
Marcello BUIATTI (Università di Firenze)
Cristiano CASTELFRANCHI (Università Luiss, Uninettuno e ISTC-CNR)
Vincenzo CAVASINNI (*) (Università di Pisa e INFN)
Remo CESERANI (Università di Bologna e Stanford University, CA)
Emilia CHIANCONE (Presidente Accademia dei Quaranta)
Paolo DARIO (Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa)
Tullio DE MAURO (Università di Roma “La Sapienza”)
Luigi DI LELLA (CERN, Ginevra)
Rino FALCONE (*) (CNR Roma, Direttore Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione)
Stefano FANTONI (Presidente Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca)
Sergio FERRARI (già vice direttore ENEA)
Ferdinando FERRONI (Presidente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN)
Fabiola GIANOTTI (CERN, Ginevra)
Mariano GIAQUINTA (Scuola Normale Superiore, Pisa)
Pietro GRECO (*)(Giornalista e scrittore, Roma)
Angelo GUERRAGGIO (Università Bocconi)
Fiorella KOSTORIS (Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca)
Francesco LENCI (*) (CNR Pisa e Pugwash Conferences for Science and World Affairs)
Giorgio LETTA (Vice Presidente Accademia dei Quaranta)
Lucio LUZZATTO (Istituto Toscano Tumori)
Tommaso MACCACARO (INAF)
Lamberto MAFFEI (Presidente Accademia dei Lincei)
Italo MANNELLI (Scuola Normale Superiore, Pisa e accademico dei Lincei)
Giovanni MARCHESINI (Università degli studi di Padova)
Ignazio MARINO (Thomas Jefferson University, Sindaco di Roma)
Annibale MOTTANA (Università di Roma 3 e accademico dei Lincei)
Paolo NANNIPIERI (*) (Università di Firenze)
Pietro NASTASI (*) (Università di Palermo)
Luigi NICOLAIS (Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR)
Giorgio PARISI (Università di Roma “La Sapienza”, accademico dei Lincei)
Maurizio PERSICO (Università di Pisa)
Giulio PERUZZI(*) (Università degli studi di Padova)
Caterina PETRILLO (Università degli studi di Perugia)
Pascal PLAZA (CNRS e Ecole Normale Supérieure, Paris)
Claudio PUCCIANI (*) (Vice Presidente Associazione Caffè della Scienza - Livorno)
Michael PUTSCH (CNR Genova, Direttore Istituto di Biofisica)
Carlo Alberto REDI (Università di Pavia)
Giorgio SALVINI (Università di Roma “La Sapienza”, già Presidente dell’Accademia dei Lincei)
Vittorio SILVESTRINI (Presidente della Fondazione IDIS - Città della Scienza, Napoli)
Settimo TERMINI (*) (Università di Palermo)
Glauco TOCCHINI-VALENTINI (National Academy of Sciences, CNR-EMMA-Infrafrontier-IMPC, Monte Rotondo, Roma)
Guido TONELLI (CERN, Ginevra e Università di Pisa)
Enric TRILLAS (Emeritus Researcher European Centre for Soft Computing, già Presidente CSIC, Spagna)
Fiorenzo UGOLINI (Università di Firenze)
Nicla VASSALLO (Università di Genova)
Virginia VOLTERRA (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - CNR)
Elena VOLTERRANI (*) (Provincia di Pisa e INFN)
John WALSH (INFN)
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Per una costituente europea. Ora ci vuole la democrazia (di Raniero La Valle)25 marzo 2014, di Federico La Sala
Per una costituente europea. Ora ci vuole la democrazia
di Raniero La Valle *
Potrebbe essere uno sterile esercizio cercare di fare previsioni su quello che sarà l’esito delle prossime elezioni europee, perché le elezioni non sono un fattore determinante del futuro europeo. Lo sarebbero se le istituzioni europee fossero istituzioni democratiche, perché allora il voto degli elettori deciderebbe del governo e della politica, come avviene nelle democrazie e come avviene ancora da noi.
Ma le istituzioni europee non sono democratiche, non c’è una Costituzione europea, ci sono solo dei trattati internazionali fatti dai governi su misura dei mercati, e con il voto di maggio non si potrà nemmeno decidere se a fare il presidente della Commissione dovrà essere il tedesco socialdemocratico Schulz o il greco di sinistra Tsipras, perché pur tenendo conto dei risultati elettorali e delle preferenze del Parlamento di Bruxelles, a decidere su chi comanda in Europa resteranno i governi, e naturalmente i più forti tra loro.
Certo sarà interessante vedere che seguito potrà avere la nuova lista di sinistra “L’Altra Europa” capeggiata da Tsipras, nel momento in cui quella che fu la sinistra italiana è dispersa tra l’elettorato grillino, ciò che resta del Pd catturato nell’avventura personalista di Renzi, l’ex sinistra democristiana rottamata nel centrosinistra e le varie anime della cosiddetta sinistra alternativa.
I sondaggi accreditano la lista di Tsipras di 5 o 6 deputati eletti, ma questa lista è viziata da un peccato d’origine, che è la presunta contrapposizione tra una società civile, che sarebbe pura, e la società politica dei partiti che sarebbe contaminata ed esecranda. Infatti la lista è stata promossa da intellettuali, con al centro il nome di Barbara Spinelli; ma essi hanno decretato che i partiti e i loro dirigenti non ci dovevano entrare, e quando questo criterio di purità rituale è stato violato, sono cominciati i litigi, e Paolo Flores D’Arcais e Andrea Camilleri, che erano tra i padri nobili dell’iniziativa, si sono defilati e hanno tolto la loro garanzia al prodotto.
Ma ciò riguarda più l’Italia che l’Europa: perché appunto l’Europa non avendo un ordinamento democratico è sul piano istituzionale indifferente alle elezioni. Vero è che un successo delle forze populiste e antieuropee, che non è affatto da escludere, potrebbe innescare dinamiche distruttive della stessa Unione Europea. Ma ciò non farebbe che confermare che il vero problema non è la composizione del Parlamento, ma è il fatto che si tratta di un Parlamento figurativo nel quadro di un sistema non democratico.
C’è infatti alla base un equivoco di fondo. Si dice che l’Europa dovrebbe andare verso l’unità politica. Ma di fatto l’Europa è già una Federazione, nel senso che decide al posto degli Stati. Caratteristica di una Federazione è che le norme e i regolamenti stabiliti dall’autorità centrale entrano direttamente in vigore negli Stati federati senza bisogno di passare attraverso una ratifica dei rispettivi Parlamenti, e questo già avviene; e altra caratteristica è che c’è una distinzione tra due sfere di competenza, una di materie su cui decidono ancora gli Stati, l’altra di materie su cui decide l’autorità federale, come accade già oggi per l’intera materia economica, commerciale e finanziaria.
Il problema è che questa Federazione, che dunque già esiste, non è democratica, non conosce né limiti né garanzie contro il potere, e non gode di alcuna legittimazione, né ispirazione e, tanto meno, di alcun controllo popolare.
Qualcuno potrebbe dire che non è questo che conta, perché è una questione che riguarda solo la forma delle istituzioni. Ma la democrazia non attiene alla forma, bensì alla sostanza della vita di una comunità politica. E infatti il disastro in cui è caduta l’Europa in gran parte dipende proprio da questa mancanza di democrazia. È questa la ragione per la quale le elezioni per il Parlamento europeo avvengono nel segno di un rovesciamento.
Il sogno dell’Europa unita si sta trasformando in un incubo. In Grecia le famiglie devono scegliere se comprare la luce, il cibo o le medicine. In Italia imprenditori si suicidano perché nessuno paga i loro crediti. In Francia e in altri Paesi fondatori della Comunità europea il principale emigrante è diventato il lavoro, che va dove è più abbondante ed è meno pagato e non ha alcun diritto.
L’ideale politico dell’Europa unita, che avrebbe dovuto realizzarsi col superamento degli Stati nazionali e l’instaurazione della pace, è naufragato in un arretramento della politica, che ha ceduto all’economia, alla finanza e al denaro, nel frattempo diventato euro, il governo della società e la sovranità che dai singoli popoli avrebbe dovuto passare al popolo europeo.
In questo contesto le politiche antisociali di rigore imposte dagli organi comunitari in ossequio ai mercati finanziari stanno producendo, in gran parte dell’Unione, una recessione che pesa interamente sui ceti più deboli, provocando un aumento della povertà e della disoccupazione e una riduzione delle prestazioni dello Stato sociale. Ne risulta minato il processo di integrazione, ben prima che sul piano politico e istituzionale, nella coscienza e nel senso comune di gran parte delle popolazioni europee.
Sta così accadendo che il mercato comune e la moneta unica, che i padri costituenti dell’Europa concepirono e progettarono come fattori di unificazione, sono oggi diventati altrettanti fattori di conflitto e di divisione, mentre l’Europa, fino a pochi anni fa percepita in tutto il mondo come un modello di civiltà, è in preda, di nuovo, agli egoismi nazionalistici, alle pretese egemoniche, ai populismi, ai reciproci rancori che hanno sostituito l’originario spirito unitario e impediscono ogni contributo europeo alla crescita di un vero umanesimo mondiale.
Perciò la vera questione, ormai indilazionabile, è la riforma delle istituzioni europee. Queste sono le riforme necessarie, altro che quelle italiane. Ciò che urge è di introdurre la democrazia in Europa. Per questo il movimento chiamato Economia Democratica, i Comitati Dossetti per la Costituzione e Sbilanciamoci! hanno lanciato un appello per l’attribuzione di funzioni costituenti al Parlamento che si sta per eleggere, quale Assemblea Costituente Europea. Un’assemblea pubblica si svolgerà a Roma, il prossimo 12 aprile (ore 10 al Centro Congressi di via dei Frentani 4).
Il compito di tale Parlamento costituente dovrebbe essere quello di dotare l’Unione di una Costituzione che, nel quadro delle garanzie nonché dei limiti e vincoli ai poteri, ben noti alla tradizione costituzionale europea, stabilisca l’eguaglianza nei diritti e nei doveri di tutti i cittadini europei, così realizzando una vera unità politica.
Si tratta da un lato di riprendere e finalmente portare a buon esito l’antica lotta per l’eguaglianza, irrinunciabile obiettivo non solo di ogni sinistra ma di ogni umanesimo, dall’altro di intraprendere la nuova lotta per l’inclusione politica, economica e sociale di grandi masse di popolazione oggi emarginate, scartate, tenute fuori dal lavoro, dal godimento dei beni comuni, dai confini ideali o fisici dell’Europa e dalla stessa vita.
Questa è la vera, nuova, grande opportunità che si apre. Non è vero che dopo la crisi dell’euro e dopo il governo Renzi non resta che il diluvio. Dopo la transizione oggi in atto in Europa e in Italia, resta da rilanciare la Costituzione, resta da passare alla democrazia, con l’istituzione di un vero governo federale vincolato al Parlamento da un rapporto di fiducia, con una banca centrale dotata dei poteri di tutte le banche centrali, una fiscalità comune e un governo comune dell’economia obbligato a rispondere alla rappresentanza democratica dei cittadini europei.
Per avviare una riforma di questo tipo a noi sembra che i tempi, nonostante le apparenze, siano favorevoli, e ciò per due circostanze concomitanti. La prima è la gravità stessa della crisi che persuade milioni di persone della necessità di un cambiamento radicale ai fini della stessa salvaguardia del mondo. La seconda è la comparsa inaspettata sulla scena di una critica drastica al capitalismo finanziario oggi dominante in Europa e nel mondo, una critica che non ha nulla a che fare con la vecchia analisi marxista: è la critica rivolta da papa Francesco al dominio incontrollato del denaro, è la denuncia delle ideologie che si pongono a sostegno dell’assoluta autonomia dei mercati, della speculazione finanziaria e della società dell’esclusione e dello «scarto», è il suo rifiuto delle teorie della «ricaduta favorevole», che presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesca a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo, è il suo invito a una rifondazione di sistema, finanziaria ed etica «che produca a sua volta una riforma economica salutare per tutti».
Questo compito tocca naturalmente alla politica. Tenendo conto però dell’autorità della fonte da cui proviene questa istanza di cambiamento e dell’immensa platea di quanti se ne possono sentire chiamati in causa e coinvolti, si può dire che l’azione politica per un rinnovamento profondo dell’Europa e dell’ordine economico mondiale può trovare oggi, in aggiunta a quanti già in tutto il mondo hanno lottato e lottano per questi obiettivi, una ulteriore base di massa. Le elezioni europee possono essere la prima grande occasione per mettere questa possibilità alla prova.
* Giornalista e saggista. Articolo pubblicato sul blog http://ranierolavalle.blogspot.it
* Adista Segni nuovi n. 12 del 29/03/2014
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- OSARE LA DEMOCRAZIA. Per l’Europa è tempo di cambiare (di Martin Schulz)21 marzo 2014, di Federico La Sala
Per l’Europa è tempo di cambiare
di Martin Schulz (la Repubblica, 21.03.2014)
QUELLO che sta succedendo ai confini dell’Unione ci spinge a riflettere sul significato dell’identità europea, sul nostro progetto politico e sul futuro comune che vogliamo costruire. Il caso del voto Svizzero contro l’immigrazione è sintomo di un chiaro allontanamento da una delle conquiste fondamentali per l’Unione: la libera circolazione delle persone e dei lavoratori, non certo quella dei capitali. Dall’altra parte, l’Ucraina. Per i cittadini ucraini scesi in piazza a Maidan, l’Unione rappresenta tutto ciò che è loro negato: stato di diritto, democrazia, libertà civili, benessere, stabilità.
Per molti cittadini dell’Unione invece, la rivoluzione ucraina pro-europea e allo stesso tempo il voto svizzero sono stati un piccolo shock. Com’è possibile che gli ucraini abbiano dimostrato tanta voglia di avvicinarsi a un’Unione ancora in crisi, a bassa crescita, alta disoccupazione e che impone un fardello di regole e burocrazia ai suoi cittadini? E dall’altra parte, com’è possibile che i cittadini Svizzeri, con il loro benessere, con la loro bassissima disoccupazione, abbiano invece voluto mettere in pericolo la loro relazione con il loro più importante partner commerciale, e la partecipazione a programmi culturali e di ricerca comuni?
Svizzera e Ucraina obbligano noi cittadini dell’Unione a una riflessione sulla nostra identità, sui nostri valori, sulle fondamenta su cui si poggia la nostra Unione. Su cosa vogliamo salvare e cosa invece vogliamo riformare, su come vogliamo affrontare le sfide che abbiamo davanti, dal riscaldamento globale ai movimenti migratori, dal sistema economico ai nuovi diritti. Come vogliamo affrontare queste sfide? Uniti o divisi? Conservando o avanzando? Inseguendo o mostrando la nostra leadership come europei?
Molto è stato detto e scritto sull’origine della crisi che ha intrappolato il continente negli ultimi cinque anni. È in parte vero che, se la crisi non è stata fabbricata in Europa, in Europa ha trovato la sua espressione più grave: il peso dell’interdipendenza tra debito sovrano e banche è stato sostenuto dai cittadini, che hanno dovuto assistere a un deterioramento dei salari, dei servizi e della solidarietà europea.
Mentre gli Stati Uniti a inizio crisi davano vita a un sostanzioso pacchetto di stimolo per l’economia, noi siamo rimasti alla finestra e abbiamo aspettato che la crisi si materializzasse in tutta la sua forza prima di intervenire. È vero che la governance economica è stata rafforzata, e che siamo ora meglio equipaggiati per prevenire crisi future. Il quadro normativo è ora molto più forte e veramente europeo.
Grazie soprattutto all’azione del Parlamento europeo sono state create regole per mettere fine ai comportamenti più nocivi del settore finanziario. Ciononostante non possiamo non ammettere che l’intervento dell’Unione in materia macroeconomica è stato - per utilizzare un lessico caro agli economisti - pro-ciclico: chiedendo agli Stati membri maggiori sforzi nel consolidamento di bilancio, tagli, austerità, senza dall’altra parte creare uno strumento per rilanciare una domanda interna depressa e investimenti al palo.
Mentre dall’altra parte dell’Atlantico si creavano strumenti e politiche innovative per il rilancio dell’economia, sia a livello di politica economica federale, sia a livello di banca centrale, l’Europa si è concentrata soprattutto a estinguere le fiamme. Vediamo ora i segnali di una debole ripresa, ma ancora troppo debole per abbassare significativamente l’alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, e per fermare l’emorragia nella chiusura di piccole e medie imprese.
L’Europa ha bisogno di un cambiamento radicale. I partiti euroscettici, e anche alcune voci a sinistra, guardano all’euro come la causa di tutti i mali: una moneta troppo forte che non riflette il differenziale di competitività tra i vari paesi della zona euro. Rifiuto fermamente queste critiche alla moneta unica, una delle conquiste più importanti dell’Unione europea dalla sua creazione.
L’euro e la Banca Centrale Europea hanno garantito nei loro primi quindici anni di vita un rafforzamento del mercato unico, hanno eliminato le incertezze legate alle fluttuazioni del mercato della valuta all’interno della zona euro, hanno semplificato la vita a chi voleva fare impresa e garantito una stabilità di prezzi anche nei Paesi come l’Italia in cui, prima, l’inflazione intaccava i risparmi delle famiglie. È vero, è scomparso lo strumento della svalutazione competitiva, ma non siamo più negli anni ’80. L’euro ha funzionato come cuscinetto anti-shock (la Grecia senza l’euro sarebbe direttamente fallita, scenario che abbiamo evitato) e la Banca Centrale con la sua autorevolezza è intervenuta laddove i governi avevano esitato, garantendo l’unità della zona euro.
Il problema non è mai stato l’euro, ma la nostra politica economica. L’Unione si è focalizzata quasi totalmente sul lato dell’offerta, mentre i consumi hanno affrontato una lunga inesorabile crisi, aumentando gli squilibri. L’entrata nella coalizione di governo dei Social Democratici tedeschi, e la creazione di politiche di stimolo come la creazione di un salario minimo in Germania, rappresentano già un’importante segnale di una politica economica più equilibrata per la Germania e per l’Europa.
Anche a livello europeo dobbiamo continuare a correggere gli squilibri. Ma il bilancio dell’Unione da solo, pur essendo un formidabile strumento d’investimento per l’economia reale, per le regioni e i territori, per la ricerca, non è però lo strumento per creare una politica macroeconomica a livello europeo. La creazione di una vera politica economica a livello europeo deve essere uno dei temi centrali della prossima legislatura e di conseguenza uno dei temi centrali delle prossime elezioni europee di maggio.
L’Unione europea non può semplicemente creare una politica fatta di “target” - di cui il più noto è il famigerato 3% - certamente uno strumento utile perché gli Stati si “approprino” delle politiche europee, creando obiettivi nazionali per il raggiungimento di un risultato comune. Ma i target da soli non sono sufficienti. L’Unione ha bisogno di target anche nel campo sociale, ma ancor di più ha bisogno di politiche. La Commissione europea dev’essere un’istituzione assolutamente imparziale, ma non può essere un’istituzione neutrale.
Utilizzando un paragone calcistico, alcuni vogliono fare della Commissione europea un semplice arbitro tra squadre di calcio. La mia idea invece è che le istituzioni comunitarie, Commissione in primis, debbano avere il ruolo di allenatore, che scelga i giocatori, dia una strategia per affrontare la partita, sia responsabile dei successi, ma anche degli insuccessi della squadra. E quando i risultati sono insoddisfacenti non si cambia l’arbitro, si cambia il giocatore.
Dobbiamo essere in grado di dividere la critica all’Europa di un europeista dalla critica all’Europa di un antieuropeista. Io sono il primo critico dell’Europa, e penso che un cambiamento radicale sia indispensabile, ma nella direzione opposta a quella indicata dagli euroscettici. Credo che le soluzioni vadano cercate in un rafforzamento delle istituzioni comunitarie, sono antidoto al riemergere degli egoismi nazionali e delle pulsioni centrifughe.
Credo che solo insieme possiamo trovare risposte adeguate a questa crisi, e che il male di questi anni sia stato soprattutto la troppo poca e troppo tardiva solidarietà fra Stati europei. Nei trattati non c’è scritto come uscire dalla crisi e l’Unione non è riuscita a imprimere un forte senso di direzione. È arrivato il momento per la politica europea di tornare a osare: osare il cambiamento, osare la solidarietà, ma soprattutto “osare la democrazia”.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Uscire dalle menzogne è oggi l’emergenza (di Barbara Spinelli - L’Europa degli inganni)19 marzo 2014, di Federico La Sala
L’Europa degli inganni
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 19.03.2014)
È INUTILE accusare la tecnocrazia europea per le azioni mancate o sbagliate dell’Unione, come hanno fatto Renzi e Hollande a Parigi, quando sono i governi a fare e disfare l’Europa secondo le loro convenienze.
Ed è inadeguato presentarsi a Berlino come buon allievo, quando le mutazioni hanno da essere radicali. Il rischio è un inganno dei cittadini: dilaterà le loro malavoglie, i loro disorientamenti e repulsioni.
Come non sentirsi sbalestrati, se non beffati, da discorsi così contraddittori? A Parigi Renzi ha accusato gli eurocrati, poi a Berlino ha riconosciuto il primato tedesco, ricordando alla Merkel che non siamo «somari da mettere dietro la lavagna, ma un Paese fondatore che contribuisce a dare la linea». Chi detta legge, in ultima analisi: il tutore tedesco o l’eurocrazia? Chi ha l’ultima parola? Non dirlo a lettere chiare: questo è aggirare i popoli.
L’inganno è più che mai palese alla vigilia delle elezioni europee, che almeno sulla carta dovrebbero essere diverse dalle precedenti. Il trattato di Lisbona infatti è esplicito, e i deputati di Strasburgo l’hanno ribadito: il Presidente della Commissione sarà designato dal Consiglio europeo, ma «tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo» (art. 17). Quel che ci si accinge a fare è altra cosa. Ancora una volta, la decisione sarà presa a porte chiuse, senza dibattito pubblico preliminare, dai capi di Stato o di governo. Lo stesso Parlamento europeo è complice dell’inganno, col suo regolamento interno: la scelta delle nomine è a scrutinio segreto; non è prevista discussione pubblica.
Condotte simili non si limitano a ignorare i trattati: sono anche del tutto incompatibili con la trasparenza da essi ripetutamente evocata. Riavremo dunque lo stesso occulto mercanteggiamento tra Stati che ha ammorbato l’Unione per decenni. Il Parlamento può certo accampare diritti - può sfiduciare il presidente dell’esecutivo e l’intero collegio - ma il rifiuto avviene dopo la nomina. È più complicato. Non a caso l’assemblea non s’è mai azzardata a sfiduciare la Commissione.
Se davvero credessero in quel che professano, Renzi, Hollande e la Merkel manderebbero in questi giorni ben altro messaggio ai cittadini refrattari che apparentemente li angustiano tanto. Direbbero: «Ci atterremo alle nuove regole, vi ascolteremo sempre più. Quindi rispetteremo il verdetto delle urne». Nessuno di loro osa dirlo. Il dominio che esercitano, nella qualità di sovrani che nominano eurocrati al loro servizio, non vogliono né dismetterlo né spartirlo. Vogliono usarla, la tecnocrazia, come alibi: se le cose vanno male la colpa è sua. Gli Stati hanno potere, non responsabilità.
La mistificazione è massima perché la colpa è interamente loro, se l’Unione è oggi un campo di discordie, di ingiustizie sociali asimmetriche. Sono gli Stati e i governi che hanno fatto propria la teoria, predicata ad alunni somari e non, dell’»ordine» o dei «compiti in casa ». È la teoria tedesca dell’ordoliberalismo, nata nella Scuola di Friburgo tra le due guerre, che fissa quali debbano essere le priorità, perché i mercati operino senza ostacoli: prima va rassettata la «casa nazionale», e solo dopo verranno la cooperazione, la solidarietà, e comuni regole di uguaglianza sociale.
Nelle sedi internazionali, e anche in quella sovranazionale europea, basta insomma «coordinare» le singole linee, esortarsi a vicenda. Il motivo: l’esperienza totalitaria legata a interventi eccessivi dello Stato (memorabile l’accusa rivolta dall’ordoliberista Wilhelm Röpke, negli anni ‘50, all’ideatore dello Stato sociale: «Quello che voi inglesi state preparando, con il piano Beveridge, è una forma di nazismo». Non meno antiliberale fu giudicato il New Dealdi Roosevelt).
L’illusione ordoliberista, tuttora diffusa ai vertici degli Stati, è che se ognuno lasciasse fare i mercati, mettendo magari la briglia alla democrazia e a leggi elettorali troppo rappresentative, l’ordine finirebbe col regnare nel mondo. La crisi ha mostrato che solo invertendo le priorità una soluzione è possibile. È dalla solidarietà che urge ripartire, dalla messa in comune di risorse, dopodiché ogni Stato avrà più forze per aggiustare i conti, spalleggiato da istituzioni e bilanci federali. Così gli Usa risolsero la crisi del debito dopo la guerra di indipendenza: mettendo in comune i debiti, passando dalla Confederazione alla Federazione, dandosi una Costituzione.
L’esatto contrario avviene nell’Unione. Sono ancora gli Stati che hanno deliberato, nel febbraio 2013, di congelare il comune bilancio e di impedire l’aumento delle risorse che permetterebbe piani comunitari di ripresa, e soprattutto la conversione della vecchia industrializzazione in sviluppo verde, sostenibile. Una delibera che il Parlamento s’è rifiutato di ratificare, un mese dopo. Ma alla fine la decisione è stata accettata, pur rinviando il dibattito al 2016.
Sono gli Stati che hanno inventato la trojka, organismo che comprende la Banca Centrale europea, la Commissione, e non si sa per quale complesso di inferiorità il Fondo Monetario, e che oggi controlla 4 Paesi (Grecia, Portogallo, Irlanda, Cipro). Una trojka la cui sola bussola è la «casa in ordine». Sono infine gli Stati che hanno concordato il fiscal compact, che alcuni Paesi - tra cui l’Italia di Monti - hanno inopinatamente messo nella Costituzione nonostante nessuno l’avesse imposto.
Questo significa che viviamo nella menzogna, sull’Europa esistente e su quella da rifondare. Che chi ha in mano le scelte sono in realtà i mercati: non l’eurocrazia usata come alibi e non i finti Stati sovrani. Lo spiega bene Luciano Gallino, su la Repubblica del 15 marzo: non esiste stato di eccezione che consenta un’indifferenza così totale verso le sofferenze inflitte ai cittadini (Grecia in primis, e Italia, Spagna, Portogallo). Quanto al fiscal compact, si tratta, secondo Gallino, di eliminare dalla Costituzione le norme attuative, come proposto da Rodotà: «L’Italia non è in grado di trovare 50 miliardi di euro all’anno da tagliare (per 20 anni, ndr). Accadrà quello che è già accaduto altrove: tagli sanitari, bambini affamati, povertà» (intervista alManifesto,13-3).
Sono anni che Roma cerca di ingraziarsi Parigi, e forse qui è l’inganno più grande. I governi francesi, di destra o sinistra, hanno una responsabilità speciale: sin da quando, caduto il Muro, risposero sistematicamente no - in nome del mito sovrano gollista - all’unità politica e militare che Kohl chiese con insistenza per puntellare l’euro. Si denunciano le colpe tedesche, nella crisi, ma l’immobile insipienza francese è ancora più nefasta.
L’Europa, non dimentichiamolo, fu fatta grazie ai francesi Jean Monnet, Robert Schuman. Quel che fu creato lo si deve a Parigi. Ma anche quel che non fu fatto, e non si fa. A cominciare dall’unità militare, che consentirebbe all’Europa risparmi enormi: circa il 40%. Insieme si potrebbe valutare se sia sensato dotarsi degli F-35, e che tipo di pax europea vogliamo, autonoma da quella americana.
Uscire dalle menzogne è oggi l’emergenza. I cittadini, frastornati, faticano a capire che i governi, con le loro dissennatezze, sono più viziosi degli eurocrati. Che la Francia è un ostacolo non meno grande di Berlino, anche se governata dai socialisti (Sarkozy almeno ci provò: Hollande sull’Europa è muto). Che l’Unione ha bisogno di una Costituzione vera, che inizi come negli Usa con le parole: «We, the people...»: non con l’elenco dei governi firmatari.
Altrimenti non avremo solo il predominio degli Stati più forti. Avremo quella che Gallino chiama la Costituzione di Davos: una costituzione non scritta, i cui governi, vittime di una sindrome da “corteggiamento del capitale”, l’assecondano con strategie economiche incentrate sul taglio del Welfare e sui salvataggi bancari a carico dei contribuenti.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- GLI INVISIBILI DELL’EUROPA. Regna l’oblio storico di quel che è stata l’Europa, del perché s’è unita (di Barbara Spinelli)..26 febbraio 2014, di Federico La Sala
Gli invisibili dell’Europa
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 26 febbraio 2014)
«Il dolore sta producendo risultati»: fa impressione, proprio ora che è divenuto ministro dell’Economia, rileggere quel che Pier Carlo Padoan disse il 29 aprile 2013 al Wall Street Journal , quando era vice segretario generale dell’Ocse.
Già allora i dati sull’economia reale smentivano una così impudente glorificazione dell’austerità - e addirittura dei patimenti sociali che infliggeva - ma l’ultimo numero di Lancet , dedicato alla sanità pubblica in Grecia dopo sei anni di Grande Depressione, va oltre la semplice smentita. Più che correggersi, il ministro farebbe bene a scusarsi di una frase atroce che irresistibilmente ricorda Pangloss, quando imperterrito rassicura Candide mentre Lisbona è inghiottita dal terremoto raccontato da Voltaire: «Queste cose sono il meglio che possa accadere. La caduta dell’uomo e la maledizione entrano necessariamente nel migliore dei mondi possibili».
Lancet non è un giornale di parte: è tra le prime cinque riviste mediche mondiali. Il suo giudizio sulla situazione ellenica, pubblicato sabato in un ampio dossier (lo ha ripreso Andrea Tarquini sul sito di Repubblica), è funesto: la smisurata contrazione dei redditi e i tagli ai servizi pubblici hanno squassato la salute dei cittadini greci, incrementando il numero di morti specialmente tra i bambini, tra gli anziani, nelle zone rurali. Nella provincia di Acaia, il 70 per cento degli abitanti non ha soldi per comprare le medicine prescritte.
Emergency denuncia la catastrofe dal giugno 2012. Numerose le famiglie che vivono senza luce e acqua: perché o mangi, o paghi le bollette. Nel cuore d’Europa e della sua cultura, s’aggira la morte e la chiamano dolore produttivo.
«Siamo di fronte a una tragedia della sanità pubblica», constata la rivista, «ma nonostante l’evidenza dei fatti le autorità responsabili insistono nella strategia negazionista». Qualcuno deve spiegare a chi agonizza come sia possibile che il dolore e la morte siano «efficaci», e salvifiche per questo le riforme strutturali fin qui adottate.
Né è solo «questione di comunicazione» sbagliata, come sosteneva nell’intervista Padoan: sottolineare gli esiti promettenti del consolidamento fiscale, ammorbidendo magari qualche dettaglio tecnico, non toglie la vittoria al pungiglione della morte. Trasforma solo un’improvvida teoria economica in legge naturale, perfino divina. Moriremo, certo, ma in cambio il Paradiso ci aspetta. Soprattutto ci aspetta se non cadremo nel vizio disinvoltamente rinfacciato agli indebitati impoveriti: la «fatica delle riforme » (reform fatigue), peccato sempre in agguato quando i governi «sono alle prese con resistenze sociali molto forti». Quando siamo ingrati, come Atene, alle iniezioni di liquidità che l’Unione offre a chi fa bancarotta: nel caso greco, due bailout tardivi, legati a pacchetti deflazionistici monitorati dalla trojka. I contribuenti tedeschi hanno già dato troppo, dicono in Germania. Non è vero, i contribuenti non hanno pagato alcunché perché di prestiti si tratta, anche se a tassi agevolati e destinati in primis alle banche.
Difficile dar torto alle «forti resistenze sociali», se solo guardiamo le cifre fornite su Lancet dai ricercatori delle università britanniche di Cambridge, Oxford e Londra. A causa della malnutrizione, della riduzione redditi, della disoccupazione, della scarsità di medicine negli ospedali, dell’accesso sempre più arduo ai servizi sanitari (specie per le madri prima del parto) le morti bianche dei lattanti sono aumentate fra il 2008 e il 2010 del 43%. Il numero di bambini nati sottopeso è cresciuto del 19%, quello dei nati morti del 20.
Al tempo stesso muoiono i vecchi, più frequentemente. Fra il 2008 e il 2012, l’incremento è del 12,5 fra gli 80-84 anni e del 24,3 dopo gli 85. E s’estende l’Aids, perché la distribuzione di siringhe monouso e profilattici è bloccata. Malattie rare o estinte ricompaiono, come la Tbc e la malaria (quest’ultima assente da 40 anni. Mancano soldi per debellare le zanzare infette).
La rivista inglese accusa governi e autorità europee, ed elogia i paesi, come Islanda e Finlandia, che hanno respinto i diktat del Fondo Monetario o dell’Unione. Dopo la crisi acuta del 2008, Reykjavik disse no alle misure che insidiavano sanità pubblica e servizi sociali, tagliando altre spese scelte col consenso popolare. Non solo: capì che la crisi minacciava la sovranità del popolo, e nel 2010-2011 ridiscusse la propria Costituzione mescolando alla democrazia rappresentativa una vasta sperimentazione di democrazia diretta.
Non così in Grecia. L’Unione l’ha usata come cavia: sviluppi islandesi non li avrebbe tollerati. Proprio nel paese dove Europa nacque come mito, assistiamo a un’ecatombe senza pari: una macchia che resterà, se non cambiano radicalmente politiche e filosofie ma solo questo o quel parametro. Il popolo sopravvive grazie all’eroismo di Ong e medici volontari (tra cui Médecins du Monde , fin qui attivi tra gli immigrati): i greci che cercano soccorso negli ospedali «di strada» son passati dal 3-4% al 30%. S’aggiungono poi i suicidi, in crescita come in Italia: fra il 2007 e il 2011 l’aumento è del 45%. In principio s’ammazzavano gli uomini. Dal 2011 anche le donne.
Lancet non è ottimista sugli altri paesi in crisi. La Spagna, cui andrebbe assommata l’Italia, è vicina all’inferno greco. Alexander Kentikelenis, sociologo dell’università di Cambridge che con cinque esperti scrive per la rivista il rapporto più duro, spiega come il negazionismo sia diffuso, e non esiti a screditare le più serie ricerche scientifiche (un po’ come avviene per il clima). L’unica istituzione che si salva è il Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie, operativo dal 2005 a Stoccolma.
La Grecia prefigura il nostro futuro prossimo, se le politiche del debito non mutano; se scende ancora la spesa per i servizi sociali. Anche in Italia esistono ospedali di volontari, come Emergency.
La luce in fondo al tunnel è menzogna impudente. Senza denunciarla, Renzi ha intronizzato ieri la banalità: «L’Europa non dà speranza se fatta solo di virgole e percentuali - «l’Italia non va a prendere la linea per sapere che fare, ma dà un contributo fondamentale». Nessuno sa quale contributo. Scrive l’economista Emiliano Brancaccio che i nostri governi «interpretano il risanamento come fattore di disciplinamento sociale». Ma forse le cose stanno messe peggio: il risanamento riduce malthusianamente le popolazioni, cominciando da bambini e anziani.
Regna l’oblio storico di quel che è stata l’Europa, del perché s’è unita. Dimentica anche la Germania, che pure vive di memoria. Dopo il ‘14-18 fu trattata come oggi la Grecia: sconfitto, il paese doveva soffrire per redimersi. Solo Keynes insorse, indignato. Nel 1919 scrisse: «Se diamo per scontata la convinzione che la Germania debba esser tenuta in miseria, i suoi figli rimanere nella fame e nell’indigenza [...], se miriamo deliberatamente all’umiliazione dell’Europa centrale, oso farmi profeta, la vendetta non tarderà».
La vendetta non tardò a farsi viva, ed è il motivo per cui ben diversa e più saggia fu la risposta nel secondo dopoguerra. Quella via andrebbe ripercorsa e potrebbe sfociare in una Conferenza europea sul debito, che condoni ai paesi in difficoltà parte dei debiti, connetta i rimborsi alla crescita, dia all’Unione poteri politici e risorse per lanciare un New Deal di ripresa collettiva e ecosostenibile. È già accaduto, in una conferenza a Londra che nel 1953 ridusse quasi a zero i debiti di guerra della Germania. I risultati non produssero morte, ma vita. Fecero rinascere la democrazia tedesca. Non c’era spazio, a quei tempi, per i Pangloss che oggi tornano ad affollare le scene
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Come siamo arrivati al “Fottiti Europa” (di barbara Spinelli).12 febbraio 2014, di Federico La Sala
Come siamo arrivati al “Fottiti Europa”
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 12.02.2014)
Siamo scesi proprio in basso, se un vicesegretario di Stato americano, Victoria Nuland, programma la caduta del governo ucraino con il proprio ambasciatore a Kiev e parlando dell’Unione dice, con l’arroganza d’un capo-mandamento a caccia di zone d’influenza: «Che l’Europa si fotta! » («...and you know, fuck the EU»).
Già c’era stata, in ottobre, la storia avvilente di Angela Merkel spiata da Washington, tramite controllo del cellulare. Non un incidente di percorso, se pochi mesi dopo l’Europa è declassata così radicalmente dal lessico della Nuland, perché sospettata di troppa prudenza sul regime change ai propri confini.
Simile degenerazione è tuttavia un utile momento di verità. La risposta meno feconda è quella di chi, sgomento, s’offende per le male parole. Lo scontro come momento di verità, di svolta, obbliga invece gli Europei a guardare se stessi, l’occhio non fisso sull’America ma sulle proprie azioni e omissioni che spiegano tanto precipizio. Li costringe a scoprire l’inconsistenza, la vista corta, il grande inganno d’una presenza il più delle volte fittizia nel mondo, ignara delle sue mutazioni, fatta spesso solo di retorica, al rimorchio di un’America sempre più nazionalista, che non riconosce leggi sopra le proprie. Il dopo-guerra fredda ci lascia in perenne stato d’impotenza, stupore e dipendenza.
In questo mondo che cambia non siamo entrati, né come Stati e ancor meno come Unione che agisce in proprio. Non abbiamo una politica estera nemmeno per quanto riguarda la nostra area di frontiera - l’»estero vicino », come viene chiamato in Russia - né a Est della Polonia né a Sud nel Mediterraneo. E quando vogliamo esser presenti, come in Ucraina, applichiamo senza molto pensarci gli schemi neocoloniali adottati nel dopo guerra fredda. Crediamo di pesare se sappiamo imporre cambi di regime: un’esercitazione quasi fine a se stessa, completamente disinteressata alla storia dei paesi di cui pretendiamo occuparci. Appoggiamo questa o quella forza a noi vicina, e sistematicamente sbagliamo alleati. È già avvenuto in Iraq, Libia, Siria.
Alberto Negri ha spiegato bene quest’incapacità congenita ad assumersi il rischio che consiste nel fare politica, dunque nell’imparare dai propri errori: «Un po’ di esercizio di memoria, magari tornando agli sviluppi tragici dei Balcani negli anni ’90, dovrebbe suggerire anche la situazione in Ucraina: l’Europa troppo spesso applaude incondizionatamente le rivolte popolari che hanno un sapore democratico e libertario per poi fare da spettatrice muta e inefficace davanti a sanguinosi sviluppi. Non è forse andata in questo modo anche in Siria?» (Sole 24 ore,25-1-14).
L’Ucraina è emblematica perché il modello sembra ripetersi. È lo schema del mondo diviso in mandamenti, appunto: in quartieri da accaparrare, e spartire fra capi-picciotti. Se la Nuland usa il linguaggio del padrino è perché in Ucraina va in cerca di clienti, affiliati. Con l’Europa entra in un rapporto di rivalità mimetica, imitativa: di competizione e dominio. La rivolta in sé degli ucraini l’incuriosisce poco, e per questo viene occultata la presenza nei tumulti di destre estreme e neonaziste (il partito
Svoboda e il gruppo Pravi Sektor, «Settore di destra»). Importante è mettere proprie bandierine sul tecnocrate ed ex banchiere centrale Arseniy Yatsenyuk, nel caso americano. Su Vitali Klitschko, ex campione di pugilato e capo di Alleanza Democratica per la Riforma nel caso dell’Unione. Fottiti Europa vuol dire che c’è lotta per la conquista di clientes. Che un intero paese è visto, dagli uni e dagli altri, come cosa nostra.
Questa politica neocoloniale, l’Europa la conduce senza metterci né soldi, né intelligenza politica. Ci mette la propria superiorità morale: cioè parole soltanto, anche se belle. Se la prende con la Russia ignorando due cose. Primo: la russofobia di parte del movimento pro europeo non è diretta contro Mosca o Putin, ma contro gli ucraini di origine russa (22% della popolazione, soprattutto a Est e in Crimea). Secondo: se il paese è lacerato tra Mosca e Bruxelles è perché l’Unione s’è fatta meno attraente. Per gli ucraini - autoctoni e russi - ridotti alla miseria, non è indifferente il prestito annunciato da Putin (15 miliardi di dollari) né la promessa di forniture di energia a costi bassi. Siamo di fronte a due colonialismi, con la differenza che quello europeo offre poca sostanza e molta ideologia.
In realtà non è l’Unione a entrare nel rapporto di rivalità mimetica con Washington. Chi si è attivata è innanzitutto la Merkel, che ha interessi sia partitici sia geopolitici nel proprio retroterra. Accade così che ogni staterello dell’Unione ha il proprio particulare da difendere, e questo rafforza ancor più la convinzione Usa che l’Europa sia un pupazzo, da «fregare» senza farsi scrupoli.
Nel nostro piccolo, noi italiani non siamo da meno e addirittura diventiamo esemplari, come dimostra il caso dei marò processati in India. Sono due anni che Roma insiste per farli tornare a casa: è quasi l’unica nostra attività di politica estera, e anche in questo caso manca qualsiasi strategia politica, che tenga conto del mondo in mutazione e dell’importanza che ha oggi l’India. La giustizia indiana - è vero - sembra messa peggio della nostra. L’accusa di terrorismo è brandita con fini interni. Ma le responsabilità vanno chiarite, e anche qui offendersi e sgomentarsi è vano. Anche qui manca una valutazione fredda della realtà indiana, e di quel che è successo nei mari del Kerala. Solo nascoste in rete - nel sito Wu Ming - troviamo vere documentazioni sulla vicenda dei marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre: due militari utilizzati dal nazionalismo indiano, ma che hanno pur sempre causato la morte, il 15 febbraio 2012, di due pescatori indiani inermi (hanno anch’essi un nome: Valentine Jalastine e AjishBinki).
È sperabile che la giustizia indiana non li condanni - se colpevoli - a pene pesanti (sulla condanna a morte esiste un veto dell’Unione) ma non ha senso continuare a chiamarli eroi nazionali. È comprensibile la convinzione di Napolitano, anche se da verificare, secondo cui l’affare è stato «gestito in modi contraddittori e sconcertanti» dall’India: l’accusa di terrorismo, se mantenuta, non tiene. È assai meno comprensibile la promessa che ha fatto telefonicamente ai due fucilieri: «Tornerete (in Italia) con onore».
Perché con onore, prima di conoscere il verdetto indiano e le motivazioni di un’eventuale condanna? Può darsi che i marò rientrino in Italia. Non è detto che vi tornino con onore, fino a che non abbiamo prove decisive su quanto accaduto il giorno dell’uccisione dei pescatori indiani. È quello che ha scritto Ferdinando Camon su La Stampa (Perché i marò non hanno un video?, 5 febbraio): i marinai colpiti dai fucilieri sostengono che gli è piovuta addosso una gragnuola di colpi senza preavviso, l’emissario italiano Staffan de Mistura ha ammesso in una tv indiana che «i nostri hanno sparato in acqua, ma purtroppo alcuni colpi sono andati nella direzione sbagliata». Fondatamente Camon sostiene che avrebbero dovuto sparare in aria, cioè a vuoto, se si voleva solo preavvertire: «I colpi orizzontali non sai mai dove finiscono». Non esistono infine video probanti, che certifichino la tesi dell’innocenza.
Citiamo il caso dei marò per dire che la politica estera sta divenendo in Europa questione di visibilità partitiche. Giustamente il giornalista Matteo Miavaldi, che vive in Bengala, è caporedattore del sito China Files e ha indagato per Wu Ming i dettagli della storia dei marò, ricorda che le destre di La Russa o Gasparri usano l’affare per propagare risentimenti nazionalisti. In queste condizioni non stupiamoci più di tanto, se d’un tratto s’alza in piedi un vicesegretario di Stato americano per scaraventarci addosso parole oscene.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- "L’Europa ha bisogno di un cambiamento rivoluzionario”. Spinelli con Tsipras. Presentata ieri a Roma la lista per le Europee promossa dalla giornalista e da altri intellettuali.5 febbraio 2014, di Federico La Sala
 Spinelli con Tsipras
Spinelli con Tsipras
 “Una rivoluzione che parla al M5S”
“Una rivoluzione che parla al M5S”
 Presentata ieri a Roma la lista per le Europee promossa dalla giornalista e da altri intellettuali
Presentata ieri a Roma la lista per le Europee promossa dalla giornalista e da altri intellettuali
 Non solo un tentativo di riunire la sinistra, ma qualcosa di più
Non solo un tentativo di riunire la sinistra, ma qualcosa di più di Salvatore Cannavò (Il Fatto, 05.02.2014)
di Salvatore Cannavò (Il Fatto, 05.02.2014)"L’Europa ha bisogno di un cambiamento rivoluzionario”. La frase non è pronunciata da un militante dei centri sociali, ma da un autorevole esponente del pensiero progressista come Barbara Spinelli, editorialista di Repubblica, promotrice, insieme ad Andrea Camilleri, Paolo Flores d’Arcais, Luciano Gallino, Marco Re-velli, Guido Viale dell’ipotesi di una “lista Tsipras” alle prossime elezioni europee. Lista che non vuole riunire solo “le braci accese delle ceneri della sinistra” ma guardare avanti. Anche verso l’elettorato Cinque Stelle o i delusi del Pd.
Il progetto è stato presentato ieri a Roma dai promotori che, finora, hanno evitato una trattativa di vertice tra le forze politiche e quindi di correre il rischio che ha contribuito ad affossare Rivoluzione civile di Antonio Ingroia.
Nella presentazione di ieri, questo aspetto è stato ben sottolineato. Ma a occupare lo spazio centrale è stata la proposta politica espressa con molta convinzione da Barbara Spinelli: “Abbiamo scelto di ispirarci ad Alexis Tsipras anche perché il Der Spiegel lo ha indicato come nemico numero 1 dell’Europa dell’austerity”. “Tsipras invece - spiega la figlia di Altiero Spinelli - è l’emblema del No a questa Europa, il simbolo di un’altra Europa”.
Il suo programma in dieci punti, letto da Guido Viale, si muove all’insegna di un “New Deal europeo”, della “ristrutturazione del debito pubblico”, dell’ecologia e del no all’austerity e al Fiscal compact. Il simbolo di “un cambiamento rivoluzionario” che, con familiarità, Spinelli riconduce al “Manifesto di Ventotene”, costruito in mezzo alla guerra e con un “linguaggio rivoluzionario”. Lo stesso che serve oggi. In fondo, spiega la giornalista, “la crisi è una guerra, come quella esige un comportamento rivoluzionario”.
DI RIVOLUZIONARIO, la proposta di lista ha il metodo. Come illustrato da Marco Revelli, e come verrà spiegato in una lettera inviata ai 16 mila aderenti, le regole della lista stavolta saranno rigide. I partiti fanno un passo a lato e si costituirà un “forum” nazionale sull’esempio dei comitati per il Referendum sull’acqua. Le candidature saranno avanzate dai comitati appositamente costituiti o da tutti gli organismi che “superano i 50 iscritti”.
Il comitato operativo nazionale “cercherà di rispecchiare” tutte le posizioni. “Non potranno essere candidati consiglieri regionali e parlamentari nazionali o europei dal 2004 a oggi e chi ha avuto incarichi di governo nazionale e regionale”. Questa la principale norma “anti-casta” che salva, invece, i sindaci e gli assessori o i consiglieri comunali. Il tutto, infine, garantito dai sei promotori che dicono di non essere disponibili a candidarsi (per quanto siano molte le pressioni soprattutto sui nomi di Andrea Camilleri e Luciano Gallino, ma in particolare su Barbara Spinelli).
La fretta, dicevamo, è imposta dal metodo scelto per presentare la lista. “Nessuna scorciatoia rispetto alla raccolta delle firme” che però sono quasi proibitive: 150 mila in tutta Italia, 30 mila a circoscrizione di cui almeno 3000 in ciascuna regione. Quindi anche in Val d’Aosta. Per poter andare in giro con i banchetti le candidature dovranno essere pronte entro il 20 febbraio.
Tempi ultra-rapidi che giustificano i contatti già presi con i partiti, Sel e Prc, nei confronti dei quali aiuta la decisione di permettere la candidatura di sindaci o di amministratori comunali. Sel, ad esempio, sta pensando di chiedere un impegno al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, o a quello di Rieti, Simone Petrangeli. Difficile che possa impegnarsi quello di Genova, Marco Doria, impossibile la scesa in pista di Giuliano Pisapia.
LA QUESTIONE della collocazione nel gruppo europeo della sinistra europea (il Gue), ribadito ieri da Viale, non dovrebbe provocare fratture. La questione dirimente sarà, invece, quella delle candidature, visto che il nome di Tsipras in Italia è sconosciuto. Lui sarà a Roma venerdì prossimo con un’iniziativa pubblica al Teatro Valle occupato e poi con incontri separati sia con Paolo Ferrero, segretario del Prc, che con Nichi Vendola. Il leader greco, comunque, dovrebbe figurare sul simbolo: “Con Tsipras per un cambio in Europa” è il nome più gettonato ma si deciderà con una consultazione online.
Ma la politica non si ridurrà solo a quanto resta della sinistra radicale. “Nel metodo, diceva ieri Spinelli, Syriza ricorda il Movimento 5 Stelle, nella sua capacità di riunire gruppi molto diversi. E la nostra iniziativa è molto ampia, si rivolge a tutti, a partire dagli elettori del M5S”. In sala, presente anche Adriano Zaccagnini, uno dei primi deputati “grillini” ad aver abbandonato Grillo e che oggi dice di sperare molto in questa iniziativa. “E non sono il solo di quel mondo”.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Cercando l’Europa nella notte di Kiev. Il baratro dell’Ucraina è una sfida aperta per le democrazie europee.26 gennaio 2014, di Federico La Sala
Il baratro dell’Ucraina è una sfida aperta per le democrazie europee
Cercando l’Europa nella notte di Kiev
di Andrea Bonanni (la Repubblica, 26.01.2014)
BRUXELLES ORA che la gente muore per lei, l’Europa non sa cosa fare. Come una vera “femme fatale”, incapace di misurare le passioni che suscita, la Ue guarda inorridita alle notti gelate di Kiev.
NELLA capitale ucraina i manifestanti hanno trasfigurato la bandiera a dodici stelle in un simbolo di cui gli europei non sanno più riconoscere il valore. E si fanno ammazzare in nome di quel simbolo che da noi sembra suscitare ormai solo fastidio.
Con la solita miopia mercantile che le è propria, Bruxelles aveva creduto che il contenzioso con il regime ucraino sulla firma di un accordo di associazione fosse solo una questione commerciale: la sicurezza dei rifornimenti energetici in cambio di un po’ di aiuti economici, l’apertura di un grande mercato semi-vergine in cambio di una indiretta legittimazione politica per il governo di Yanukovich. Questioni importanti, certo, ma apparentemente gestibili in una logica contabile di costi-benefici che è ormai il pensiero unico delle autorità comunitarie.
Ci sono voluti Putin, lo stesso Yanukovich e infine i manifestanti di Kiev che muoiono nella neve per farci capire che la posta in gioco è in realtà molto più alta. Che la partita è insieme ideologica e geopolitica. Da una parte si confrontano la democrazia europea e il dispotismo russo. Dall’altra si decide la collocazione geografica di un territorio grande due volte l’Italia e profondamente diviso tra identità occidentale e anima slava.
Naturalmente la crisi, la scelta, spetta in primo luogo al popolo ucraino. Ma il dramma di Kiev obbliga anche l’Europa a fare scelte difficili, a cui non era preparata. In sessant’anni di vita, l’Unione europea si è allargata infinite volte, ma sempre in modo pacifico e consensuale. Anzi, spesso l’allargamento ha consentito la pacificazione interna di Paesi che uscivano potenzialmente dilaniati da un lungo letargo totalitario o da guerre fratricide: è successo con la Spagna, con il Portogallo e, più recentemente, con molti Paesi del-l’Est e con le ex repubbliche sovietiche del Baltico. Sta succedendo anche adesso con la Croazia e la Serbia. In questi casi, molto spesso, è stata la classe dirigente di quei Paesi a fare per prima la scelta europea e a proporla poi alla propria opinione pubblica come una soluzione consensuale che consentisse di lenire antiche ferite.
La crisi ucraina ribalta questa prospettiva. Per la prima volta si assiste ad un potere che dice «no» all’Europa voluta a gran voce dal popolo. E proprio la sollevazione popolare che ne consegue dimostra come quel rifiuto non fosse solo dettato da ragioni di interesse economico, come Bruxelles ha inizialmente creduto, ma dalla necessità di auto-preservazione di un regime che non potrebbe sopravvivere a lungo in un habitat europeo.
Come deve muoversi Bruxelles in questo frangente? Per anni, fin dai tempi della «rivoluzione arancione », la scelta europea è stata quella di proporsi come mediatore tra le tensioni che pervadono la società ucraina. Un modo per rivendicare una «alterità» dell’Unione, una certa qual estraneità ad un conflitto che Bruxelles riteneva non ci riguardasse direttamente.
Questa strategia si è rivelata sbagliata. Prima il caso Tymoshenko, poi la rivolta di Kiev hanno dimostrato che l’Europa non può tenersi fuori da un conflitto in cui entrambe le parti in lotta la vogliono coinvolgere. Non basta più dire «la nostra porta resta aperta», come hanno pilatescamente ripetuto per mesi i responsabili di Bruxelles, se il regime ammazza quelli che vorrebbero imboccarla. Sia pure con la solita esasperante lentezza che caratterizza le reazioni europee, questa lezione sembra essere stata capita.
Ieri, dal presidente del parlamento Schulz (ora sono possibili sanzioni») a Van Rompuy allo stesso premier italiano Enrico Letta («l’Ue non può accettare quanto sta accadendo»), si sono finalmente sentite reazioni più decise: minacce di sanzioni, moniti a rendere conto di una repressione «brutale». Il commissario all’allargamento Fuele è andato a Kiev. Sarà seguito a giorni dalla ministra degli esteri europea Catherine Ashton e da una missione del Parlamento europeo.
E il cambio di tono di Bruxelles ha già dato i primi frutti. Yanukovich si è detto pronto a fare concessioni. Sono segnali di speranza. Ma l’Unione commetterebbe un ennesimo errore se si illudesse che basti alzare un po’ la voce per risolvere la questione.
Se vuole giocare il ruolo che gli stessi ucraini le hanno assegnato nel dramma di Kiev, l’Europa deve cambiare modo di ragionare, capire che rappresenta ormai valori che vanno ben al di là del suo peso economico, e dotarsi degli strumenti necessari per far fronte al nuovo ruolo. Anche perché l’Ucraina è solo la prima avvisaglia di un profondo cambiamento ormai in corso.
Dietro l’Ucraina c’è la Bielorussia. E dietro ancora il Medio-Oriente, le primavere arabe incompiute, la questione islamica sempre più complicata, un Mediterraneo dove la gente annega sognando l’Europa, l’Africa sub-sahariana dilaniata dai conflitti civili.
Come già avvenuto per la crisi finanziaria, il Mondo va molto più veloce di quanto prevedano gli orari di Bruxelles, ma non ci permette di scendere dal treno in corsa. E all’Europa non resterà altra strada che trovare il modo di adeguarsi alle sfide che la Storia le pone.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Il continente selvaggio. L’Europa alla fine della Seconda guerra mondiale. L’Europa in un abisso di sangue e vendetta.12 gennaio 2014, di Federico La Sala
 Secondo dopoguerra
Secondo dopoguerra
 L’Europa in un abisso di sangue e vendetta
L’Europa in un abisso di sangue e vendetta di Vittorio Emanuele Parsi (Il Sole 24 Ore/Domenica, 12.01.2014)
di Vittorio Emanuele Parsi (Il Sole 24 Ore/Domenica, 12.01.2014)- Keith Lowe, Il continente selvaggio. L’Europa alla fine della Seconda guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari, pagg. 518, € 25,00
«L’immediato dopoguerra è uno dei periodi più importanti della nostra storia recente. Se la Seconda guerra mondiale distrusse il vecchio continente, il primo dopoguerra fu il caos proteiforme da cui si formò la nuova Europa». È dedicato esattamente allo studio di «questo tempo violento e vendicativo» nel quale «molte delle nostre speranze, aspirazioni, pregiudizi e risentimenti presero forma», il volume di Keith Lowe, che assai tempestivamente esce in edizione italiana, Il continente selvaggio. L’Europa alla fine della Seconda guerra mondiale. È un colossale, impressionante affresco delle condizioni europee tra il 1944 e il 1949, gli anni in cui per diversi Paesi europei si concluse la II guerra mondiale, senza che però si esaurissero le tante guerre locali (civili, di classe ed etniche) che ne intrecciarono il corso, alimentandola ed essendone a loro volta alimentate.
Il libro, magistralmente scritto da Keith Lowe, uno storico non accademico che dimostra tutte le qualità di scrupoloso ricercatore e di suggestivo narratore di Niall Ferguson, è diviso in quattro parti. La prima, dedicata all’eredità della guerra con il suo carico di distruzione fisica e morale, descrive con lucidità il paesaggio di un continente devastato dalla scomparsa di popoli interi, caratterizzato da una fame che sarebbe oggi inconcepibile associare all’Europa, da spostamenti forzosi e violenti di milioni di persone in uno scenario di caos totale, in cui città rase al suolo e infrastrutture devastate hanno riportato la condizione umana ai tempi più bui del Medioevo.
L’Europa tutta era un continente senza legge né ordine, in cui il sangue sarebbe cessato di scorrere solo mesi e talvolta anni dopo l’8 maggio del 1945, data della capitolazione tedesca. La sete di sangue rinfocolata o scatenata dalla brutalità senza precedenti con cui venne condotta la guerra, provocò una volontà di vendetta che attraversò l’intera Europa. Ed è proprio alle forme della vendetta che è dedicata la seconda parte del libro, e ne fa il primo studio generale sul ruolo che la vendetta giocò all’indomani della guerra, colmando un vero e proprio vuoto storiografico, finora prevalentemente oggetto di pamphlet partigiani e superficiali.
Dalla questione della sorte dei prigionieri di guerra germanici allo sfruttamento schiavistico delle minoranze tedesche in Polonia, Cecoslovacchia, a quello delle epurazioni nei confronti dei collaborazionisti: ogni singolo aspetto della vendetta sui vinti è preso in considerazione e indagato con scrupoloso rigore, compresi i temi scomodi delle violenze degli ex internati ebrei e dei deportati nei confronti dei propri carcerieri e della popolazione tedesca più in generale, oltre a quello, particolarmente odioso, della vendetta su donne colpevoli di avere "fraternizzato" con gli occupanti e sui bambini frutto di quelle unioni.
La terza parte considera la gigantesca questione della pulizia etnica che, iniziata da Hitler nei confronti degli ebrei, venne poi proseguita da polacchi, cechi, magiari, romeni trasformando l’Europa centro-orientale in qualcosa di radicalmente diverso da quel caleidoscopio etnico e religioso che era sempre stata.
L’ultima parte, infine, è dedicata alla lotta per fare dell’esito della II guerra mondiale la piattaforma per la diffusione della rivoluzione in tutta Europa, contrassegnata dalle scelte democratico-parlamentari delle dirigenze comuniste in Italia e Francia, dalla tremenda guerra civile greca, dall’assoggettamento al potere comunista di tutti i Paesi occupati dall’Armata Rossa e dall’eroica resistenza opposta per oltre un lustro dalle forze partigiane in Ucraina e nei Paesi Baltici.
Quello di Lowe è un libro mai banale e sempre documentatissimo, che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica, e che, soprattutto, ci aiuta a ricordare in quale abisso d’orrore era scivolata la "civilissima" Europa così da poter meglio apprezzare la grandiosità politica e morale della sua attuale unificazione politica.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- 1914-2014. L’Europa fu il Cavallo di Troia di se stessa (di Vittorio Zucconi - Gli ultimi giorni dell’Europa)12 gennaio 2014, di Federico La Sala
1914-2014 Gli ultimi giorni dell’Europadi Vittorio Zucconi (la Repubblica, 12.01.2014)
«Dall’alto della propria torre orgogliosa la Morte guardò il suicidio dell’isola nel mare ai suoi piedi». Fu questo verso di Poe che la storica Barbara Tuchman scelse per narrare il secolo del suicidio europeo cominciato nel 1914, l’anno fatale nel quale il continente più prospero, colto, sviluppato, civile, più egemone che il mondo avesse mai conosciuto, decise, per ragioni ancora inspiegabili, di autodistruggersi. L’Europa fu il Cavallo di Troia di se stessa. Implose - senza invasioni né attacchi, né orde di barbari - spalancando le porte della storia al Secolo Americano.
È difficile, per noi che abbiamo conosciuto soltanto l’Europa della miracolosa, e ora claudicante rinascita un secolo dopo quel 1914, comprendere quanto assoluta fosse la supremazia del nostro continente sul pianeta. E quanto improbabile apparisse in quell’anno la «marcia dei sonnambuli» - secondo la definizione di Christopher Clark a Cambridge - verso l’abisso. Chi lamenta la globalizzazione di oggi, non sa quanto già globale fosse il mondo della Belle Époque e profonda l’interdipendenza fra le nazioni del Vecchio Continente. Basteranno due cifre per dare la misura dello strapotere europeo: il 67 per cento della produzione industriale mondiale veniva da qui; l’80 per cento delle flotte militari e commerciali batteva bandiere europee.
Una guerra fra le corone, tutte posate sulla testa di parenti, cugini e cognati, e l’unica grande repubblica del tempo, la Francia, appariva anche più assurda di quanto possa sembrare oggi alle legioni di ragazzi che sciamano da un’università all’altra sotto il segno di Erasmo, ai turisti che salgono e scendono da voli low cost e treni superveloci, che passeggiano lungo le rive del Reno, della Mosa, della Vistola dopo avere attraversato frontiere di garitte vuote o bunker ormai coperti di edera.
In un best seller del tempo, il Nobel per la pace sir Norman Angell poteva scrivere nel 1910 che la devastazione del credito e della finanza avrebbero impedito lo scoppio di una guerra o ne avrebbe reso brevissima la durata, nella solita fiaba del “tutti a casa per Natale”. Ironicamente, il titolo del suo saggio, La grande illusione, sarebbe divenuto un indimenticabile film contro la guerra. Ma Angell non avrebbe potuto immaginare che la rivoltella di un allucinato nazionalista serbo-bosniaco, Gavrilo Princip, contro l’erede al trono degli Asburgo Francesco Ferdinando a Sarajevo avrebbe messo in moto «la marcia dei sonnambuli» destinata a durare per l’intero «secolo breve», come lo chiamò Eric Hobsbawm.
La stampa Usa, di fronte al clamore suscitato da quell’assassinio, si concesse addirittura qualche ironia. L’Heralddi New York scrisse che «con tutti i duchi e gli arciduchi che hanno in Europa, uno in meno non può fare grande differenza». Cento anni dopo, e ben più di cento milioni di morti direttamente o indirettamente attribuibili a quell’«arciduca in meno», storici della guerra come John Keegan si chiedono addirittura se non sia stata la farraginosità e la lentezza delle comunicazioni fra Cancellerie, non ancora adeguata alla velocità del telegrafo, dei telefoni già esistenti in cavi sottomarini, della neonata radio, a scatenare la reazione a catena.
Ma ciò su cui nessuno ha dubbi è il meccanismo di azioni e reazioni, catastrofi e vendette, conti di sangue lasciati in sospeso, che avrebbe prodotto la Guerra dei Trent’anni europea, chiusa soltanto nel maggio di trentun anni dopo per poi congelare il continente nella glaciazione del conflitto ideologico fra Est e Ovest. Tutto quello che sarebbe accaduto nella Seconda guerra, e nel lungo Dopoguerra che ancora tocca con le proprie dita gelide i rapporti fra Russia e Occidente, ha le proprie radici in quelle giornate di agosto 1914.
Le mostruose tecnologie di morte usate nella Seconda guerra hanno il Dna nella Prima, i bombardamenti aerei, i tentativi di estendere la sofferenza alle popolazioni civili colpendo Parigi con supercannoni dalla gittata di 130 chilometri, i panzer, i primi rudimentali missili usati per abbattere palloni aerostatici e dirigibili. E i gas letali che dalle trincee sarebbero passati direttamente alle camere dello sterminio nazista e, ancora oggi, sostanzialmente identici, ai massacri in Siria.
Molti, se non tutti, i protagonisti, della Seconda guerra, erano figli della Prima. Churchill, Lord dell’Ammiragliato fino al 1915; Gamelin, vincitore della prima battaglia della Marna nel 1914 e poi disastroso comandante supremo dell’Armée francese nel 1940; Hitler, reduce rancoroso e ferito nelle trincee del fronte occidentale; Zhukov, il conquistatore di Berlino, decorato sui campi del 1915 contro le armate del Kaiser; Badoglio, vincitore del Sabotino e poi Capo di Stato Maggiore per la sciagurata offensiva contro la Grecia del 1940. E naturalmente Mussolini, ferito sul Carso da una bomba durante un’esercitazione.
Insieme con il cumulo di macerie, cadaveri, di immensi danni economici che dimezzarono le capacità industriali di nazioni come la Germania e divorarono una generazione di giovani uomini che in Francia lasciarono, nel 1918, una proporzione di sei donne per quattro maschi e centinaia di migliaia diinvalides,l’eredità più sottilmente velenosa di quel 1914 fu quella che John Keegan definì «la militarizzazione della politica».
Nei totalitarismi prodotti dalla guerra, dove le ideologie e i partiti erano stati messi in divisa restò, e ancora sotto pelle sopravvive, «il morso dell’odio per il nemico e quel risentimento - scrive sempre Keegan - che è sempre veloce nell’azzannare e lentissimo nel lasciare la preda ». Dovette essere l’America, due volte strappata al sonno del suo isolazionismo, a impedire alla Terra Madre di precipitare in un abisso senza ritorno.
Oggi quel campo della morte che fu l’Europa è silenzioso. Ma la Signora di Edgar Allan Poe, alta sulla propria gigantesca torre, osserva l’isola nel mare ai suoi piedi e aspetta paziente.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. --- LA LEZIONE DI PIRANDELLO2 gennaio 2014, di Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- I sonnambuli d’Europa. La lezione del ‘14 non è stata ancora imparata (di Barbara Spinelli)31 dicembre 2013, di Federico La Sala
I sonnambuli d’Europa
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 31.12.2013)
«VERRÀ il momento in cui sbanderemo, come i sonnambuli d’Europa nell’estate 1914»: lo ha detto Angela Merkel, nell’ultimo vertice europeo, citando un libro dello storico Christopher Clark sull’inizio della Grande Guerra,tradotto in Italia da Laterza. I sonnambuli descritti da Clark sono i governi che scivolarono nella guerra presentendo il cataclisma, simulando allarmi, ma senza far nulla per scongiurarla. Da allora sono passati quasi cent’anni, e molte cose sono cambiate. L’Europa ha istituzioni comuni, l’imperialismo territoriale è svanito (resta solo l’Ungheria di Orbàn, residuo perturbante del mondo di ieri, a proclamare compatrioti a tutti gli effetti gli ungheresi di Slovacchia, Romania, Serbia, Austria, Ucraina). Non si combatte più per spostare confini ma l’Unione non è in pace come si dice, e la crisi che traversa la sta squarciando come già nel 1913-14.
È simile lo stato d’animo dei governi: allo stesso tempo deboli e pieni di sé. Impotenti sempre, anche quando mostrano arroganza o risentimento. Gli anniversari sono un omaggio che si rende al passato per accantonarlo. Meglio sarebbe celebrarli con parsimonia. Ma sul significato di questa ricorrenza vale la pena soffermarsi, e chiedersi come mai Berlino evochi il 1914 per dire che l’euro può sfracellarsi, che se non faremo qualcosa saremo di nuovo sorpresi dal colpo di fucile che distrusse il continente. Come mai torni questo nome - i Sonnambuli - che Hermann Broch scelse come titolo per una trilogia che narra la pigrizia dei sentimenti, l’indolenza vegetativa, che pervasero il primo anteguerra.
Quel che il Cancelliere non dice, ma che Clark mette in risalto, è l’inanità di simili moniti catastrofisti, l’enorme discordanza fra l’eloquio sinistro dei governanti e il loro agire ignavo, incapace di trarre le conseguenze da quel che apparentemente presagiscono.
Si comportarono da sbandati gli Stati europei, quando il 28 giugno 1914 Gavrilo Princip tirò i suoi due colpi di pistola a Sarajevo: quasi camminassero dormendo. A parole sembrava sapessero quel che stava per succedere, e però erano come incoscienti. Il dire era completamente sconnesso dai fatti, dal fare.
Allo stesso modo gli Stati odierni davanti alla crisi, quando recitano la giaculatoria sul baratro che perennemente sta aprendosi, e non fanno il necessario per allontanare l’Unione da quell’orlo ma anzi l’inchiodano sul bordo, sbrindellata e tremante com’è, senza governo né comune scopo, come se questa fosse l’ideale terapia per tenere vigili gli Stati, per dilatare le angosce dei cittadini, per non provocare la rilassatezza (il «rischio morale», lo chiamano i custodi dell’Austerità) che affligge chi, troppo rassicurato, smette il rigore dei conti.
Proprio come fa la Merkel, quando vaticina l’»esplosione dell’euro» e incrimina l’indolenza dell’Europa dormiente. L’accenno ai baratri, sempre miracolosamente sventati, è divenuto un trucco di governanti impotenti, inetti, che usano il linguaggio apocalittico e le paure dei popoli immiseriti «al solo scopo di restare titolari della gestione della crisi». Lo dice l’ultimo rapporto del Censis: non è «con continue chiamate all’affanno», né con la «coazione alla stabilità», che si ricostruirà una classe dirigente. Impossibile ridivenire padroni del proprio destino se gli Stati fingono sovranità già perdute e si consolano facilmente, come in Cocteau: «Visto che questi misteri ci oltrepassano, fingiamo di esserne gli organizzatori».
Terribilmente simili all’oggi che viviamo furono i prodromi della Grande Guerra. Verso la fine del luglio ‘14, poco dopo Sarajevo, il premier inglese Asquith preannuncia l’»Armageddon»: il luogo dell’Apocalisse dove tre spiriti immondi radunano i re della terra. Gli fa eco Edward Grey, ministro degli Esteri: «La luce si sta spegnendo su tutta Europa: non la vedremo più riaccendersi nel corso della nostra vita». In realtà gli inglesi avevano altri tormenti in quelle ore - non l’Europa ma l’autonomia dell’Irlanda - e poco si curavano del disastro continentale che profetizzavano.
Anche Churchill utilizzerà più tardi la metafora millenaristica del buio che irrompe: «Una strana luce cominciò a cadere sulla carta d’Europa». Quanto ai generali russi e francesi, le parole ricorrenti quell’estate erano «guerra di sterminio», «estinzione della civiltà».
Sapevano dunque - conclude Clark - ma la sapienza scandalosamente girava a vuoto: «Questa la cultura politica comune a tutti i protagonisti». Il ‘14-18 non è un giallo di Agatha Christie, col colpevole scovato nell’ultimo capitolo: la primaria colpa tedesca, fissata nell’articolo 231 del Trattato di Versailles, è invenzione dei vincitori. Il ‘14-18 fu una tragedia «multipolare e autenticamente interattiva ».
All’origine di questo voluto e fatale divaricarsi tra parole e presa di coscienza: l’ignoranza che ogni Stato mostrava per i patemi storici dell’altro. Ignoranza inglese dell’ossessione russa, ostile con i serbi all’impero austroungarico e ottomano. Ignoranza della Germania in ascesa. E accanto all’ignoranza: la flemma, l’abissale disinteresse per quello che la Serbia significava agli occhi d’un impero asburgico dato anzitempo per morto. Infine il fatalismo: la guerra era forse invisa, ma ritenuta inevitabile. Così l’Europa sbandò verso l’inutile strage denunciata da Benedetto XV.
Ricordando la leggerezza disinvolta narrata da Clark, la Merkel commette gli stessi errori, quasi credesse e non credesse in quel che dice. Anche nel ‘14 mancò l’immaginazione: quella vera, non parolaia. Gli europei erano immersi in una prima globalizzazione. Come poteva sgorgare sangue dal dolce commercio? Poteva invece, perché il mito delle sovranità assolute scatenò i nazionalismi e produsse non uno ma due conflitti: una lunga guerra di trent’anni. Solo dopo il ‘45 capirono, creando la Comunità europea.
Ora siamo di nuovo in piena discrepanza tra parole e azioni, e tutti partecipano alla regressione: compresi gli sfiduciati, i delusi pronti a disfarsi di un’Europa che non è all’altezza della crisi. È diffuso l’anelito a sovranità comunque inesistenti, e il sonnambulismo riappare con il suo corteo di irresponsabilità, ignoranza, patriottismi chiamati difensivi. Come allora, a trascinarci in basso sono i governi ma anche una cultura politica comune. Ecco la modernità brutale del 1914, scrive Clark.
Anche i popoli - spogliati di diritti, disinformati - barcollano sperduti fantasticando recinti nazionali eretti contro l’economia-mondo. Credono di contestare i governi. Sono in realtà complici, quando non esigono un’altra Europa: forte e solidale anziché serva dei mercati. Il pericolo, tutti lo sentono per finta. Dice ancora Broch: «Solo chi ha uno scopo teme il pericolo, perché teme per lo scopo».
Da anni siamo abituati a dire che l’Europa federale ha perso senso, col finire delle guerre tra europei. Ne siamo sicuri? La povertà patita da tanti paesi dell’Unione sveglia risentimenti bellicosi. E la mondializzazione non garantisce pace, come ammoniva già nel 1910 Norman Angell, nel libro La grande illusione.L’internazionalizzazione dell’economia rendeva «futili le guerre territoriali», questo sì. Ma intanto ciascuno correva al riarmo.
Oggi la Grande Illusione è pensare che il ritorno dell’equilibrio fra potenze assicuri nell’Unione il dominio del più forte, più stabile. Ma Darwin è inservibile in politica, e mortifera per tutti è la lotta europea per la sopravvivenza. Nel rapporto tra Usa e Israele, o tra Cina e Nord Corea, sono decisivi i piccoli, i più dipendenti: esattamente come cent’anni fa fu decisiva la Serbia panslavista, rovinosamente sostenuta dalla Russia. La forza fisica che Angell giudicava futile, e però letale, è quella dello Stato-nazione che s’illude di fare da sé, piccolo o grande che sia. La lezione del ‘14 non è stata ancora imparata.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO".---- Il ritorno strisciante della peste nera (di Moni Ovadia)21 dicembre 2013, di Federico La Sala
Il ritorno strisciante della peste nera
di Moni Ovadia (l’Unitàm 21 dicembre 2013)
L’Italia intera, nei giorni scorsi, si è di colpo ritrovata sotto shock per alcune immagini riprese da un telefonino e ritrasmesse immediatamente sulla Rete che ormai ci mostra in tempo reale, accadimenti che rimarrebbero altrimenti nella regione dell’inavvertito. Il breve filmato, mostrava alcuni immigranti internati nel Cie di Lampedusa, denudati per essere cosparsi con una soluzione chimica atta a prevenire la scabbia.
Questo trattamento brutale e inumano, come ha spiegato con chiarezza il senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione del Senato per la Tutela dei Diritti Umani, è diretta conseguenza delle modalità della reclusione che trasforma le persone in oggetti, in cose. I nazisti chiamavano gli internati del lager Stücke , pezzi. A sua volta, il processo di reificazione è figlio di una legge infame, la Bossi-Fini, la legge che istituisce il reato di clandestinità, ovvero una legge che trasforma un essere umano in criminale non per ciò che egli fa, ma per ciò che egli è, dunque una legge che si fonda sullo stesso impianto costitutivo delle Leggi di Norimberga.
Esponenti dell’Unione europea si sono scandalizzati, autorevoli rappresentanti del nostro governo si sono indignati, ma che anime belle! Davvero commoventi, e cosa dicono queste persone tanto sensibili delle diuturne vessazioni perpetrate contro i cittadini rom, perseguitati, segregati, deportati di campo in campo per esempio in Italia, per non parlare di quello che subiscono in Ungheria e in altri Paesi dell’ex blocco comunista dove vengono anche pestati e magari uccisi?
Cosa pensano della legge liberticida per reprimere le manifestazioni che prepara il governo Rajoy in Spagna? Cosa dicono dell’impetuosa ascesa di Marine Le Pen in Francia? Lo vogliono capire lorsignori che nella «civile» e imbelle Europa, è ancora attivo il virus della peste nera che si chiama fascismo che è pronto a riproporsi come prospettiva politica e che ci sono molti cittadini europei che, pur di vedere salvaguardato un loro status, reale o percepito che sia e di avere garantito un privilegio sia pur virtuale, sono pronti ancora a dar credito ai seminatori di razzismo, di odio e di xenofobia?
L’Europa cosa aspetta a dare senso alla sua stessa ragione d’essere: la convivenza pacifica fra i popoli e la loro unità politica e sociale, non solo economica? Non si possono accreditare illusioni di comodo magari parlando di pacificazione. Ci visioni del mondo inconciliabili. Pace, uguaglianza, libertà, giustizia sociale e fascismo, non possono convivere. Cosa si aspetta ancora per contrastare con inequivocabili leggi europee, il risorgere delle forze oscure dell’estrema destra che hanno partorito la peste nera che ha distrutto l’Europa e sterminato interi popoli?
L’idea stessa di un’Europa unita, libera e pacifica, si è forgiata e temprata nella lotta e nella cultura antifascista; chi lo dimentica, magari per quieto vivere, non è solo superficiale o opportunista, è colpevole. Gravemente colpevole!
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- «Una costituente per l’Europa». Gli scritti di Simone Weil oltre la tragedia del conflitto mondiale (di Arturo Colombo - L’onore perduto d’Europa).4 dicembre 2013, di Federico La Sala
Gli scritti di Simone Weil oltre la tragedia del conflitto mondiale
L’onore perduto d’Europa
di Arturo Colombo (Corriere della Sera, 04.12.2013)
- Il libro di Simone Weil, «Una costituente per l’Europa», viene dibattuto oggi alle 18 a Milano all’Ambrosianeum di via delle Ore 3 dai curatori del volume con Giovanni Cominelli, Roberta De Monticelli e Marco Garzonio
C hi conosce Simone Weil, classe 1909, sa che fra il novembre del 1942 e l’aprile del ‘43 si trasferisce dagli Stati Uniti a Londra: e in quel così breve periodo, che prelude alla sua fine repentina (va negli Stati Uniti e muore, infatti, nell’agosto del ‘43), lascia una serie straordinaria di scritti politici, pubblicati adesso nel volume Una costituente per l’Europa , a cura di Domenico Canciani e Maria Antonietta Vito (Castelvecchi, pp. 380, € 22). Hanno ragione i curatori a chiarire subito che la Weil, «militante di sinistra, operaia in fabbrica, esule e resistente delusa», è stata in grado con questi «scritti londinesi» di dare la misura della sua capacità, quasi incredibile (anche per l’età così giovane), di lasciarci una serie sorprendente di riflessioni sulla politica, la religione, la filosofia.
Il suo desiderio più vivo era di riuscire a combattere, anche con le armi, contro Hitler, il nazismo e ogni forma di potere totalitario. Ma non poteva farlo per le precarie condizioni di salute; e così il contributo più significativo della Weil è affidato a queste pagine, che non offrono solo una diagnosi, lucida e impietosa, della realtà contemporanea, ma diventano un’occasione preziosa per comprendere l’esigenza di quella «costituente per l’Europa», che neppure oggi noi siamo stati capaci di realizzare. Con fermo realismo - a proposito del saggio intitolato Riflessioni sulla rivolta - la Weil non esita a sottolineare che «l’Europa non ha perso solo la libertà, ma anche l’onore e la fede».
Di conseguenza, non basta «smantellare l’organizzazione del nemico»: quello che per la Weil costituisce «una necessità urgente, vitale» è impegnarsi a dare vita a «un certo tipo di unità europea», che sia in grado di «coinvolgere», insieme ai francesi, anche gli altri Stati del nostro continente, dagli spagnoli agli italiani, e «persino quei tedeschi la cui coscienza è stata sinceramente scossa dall’hitlerismo». Il rischio, anzi «l’orrore», è continuare a vivere nell’oppressione, questa specie di malattia mortale, che tutti può investire e travolgere, mentre occorre prendere atto e convincerci - insiste la Weil - che «tutti gli esseri umani sono assolutamente identici» e quindi tutti hanno gli stessi obblighi verso gli identici «bisogni terrestri dell’anima e del corpo», compreso il bisogno «di obbedienza consentita e di libertà».
Possono esserci proposte anche discutibili in queste pagine (come la soppressione dei partiti politici, considerati pericolose macchine per fabbricare consenso); ma la lucidità con cui la giovane Simone Weil osserva, giudica e condanna quei drammatici anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, nasconde una tale carica liberal, da rendere le sue osservazioni un patrimonio indispensabile per chi, ancor oggi, non rinuncia a battersi per contribuire a rendere il mondo meno angusto e meno ingiusto.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Così l’Iliade parla di oggi. "La rivelazione greca". Il viaggio di Simone Weil alle fonti della violenza (di Pietro Citati)11 gennaio 2014, di Federico La Sala
-
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA.
 Roma soggiogò la Grecia,/la Grecia soggiogò Troia,/ma Troia soggiogò la Grecia,/soggiogò Roma,/e tutta la Terra.
Roma soggiogò la Grecia,/la Grecia soggiogò Troia,/ma Troia soggiogò la Grecia,/soggiogò Roma,/e tutta la Terra.
Sotto il tallone della forzaCosì l’Iliade parla di oggi
Il viaggio di Simone Weil alle fonti della violenza
di Pietro Citati (Corriere della Sera, 11.01.2014)
La rivelazione greca di Simone Weil (pubblicata dalla Adelphi, con eccellente traduzione e commento di Maria Concetta Sala e Giancarlo Gaeta) è un libro senza paragoni. La parola Grecia ha un’estensione quale non aveva mai avuto nella storia, assai più che nell’Umanesimo e nel Rinascimento. Comprende l’Iliade , i testi orfici, pitagorici, Eschilo, Sofocle, Platone, i platonici; e Cristo e i Vangeli e la tradizione cristiana dove è più pura. Una frase di Platone risuona sulle labbra di Cristo; un detto di Cristo spiega una pagina o un dialogo di Platone; l’Iliade avvolge tutte le cose come una grande coltre materna; un tessuto fittissimo di risonanze e di echi colma secoli di vita, che a Simone Weil appaiono miracolosi.
Questa vita non è scomparsa: la Grecia non è una civiltà meravigliosa e irrimediabilmente finita, come appare anche ai più appassionati studiosi. La Grecia è viva, attuale: è il nostro irradiante presente; se immaginiamo una tragedia che parli al nostro cuore, dobbiamo pensare all’Antigone o all’Edipo re di Sofocle; se sogniamo un poema che comprenda la vita e la morte, il destino di chi vince e di chi è sconfitto, solo l’Iliade soddisfa i nostri desideri. Il primo e centrale di questi scritti, composti tra il 1936 e il 1943, è l’Iliade, poema della forza .
Il 4 dicembre 1934 Simone Weil era entrata in fabbrica, come ouvrière sur presses . Non vi era entrata per ragioni umanitarie o politiche: ma per provare sulla sua carne, con quel coraggio furibondo che non l’abbandonò mai, cosa fosse la mossa ferrea della necessità. Là dominava la macchina, senza rivali: come nei versi di Baudelaire, regnava la sventura moderna, dei grandi occhi muti; lei voleva fissare lo sguardo in quella orribile apparizione.
Conobbe la costrizione assoluta, la sinistra ripetizione, l’umiliazione profonda. Qualcuno le diceva all’orecchio, di minuto in minuto, senza che lei potesse rispondere: «Tu non sei nulla qui. Tu non conti. Tu sei qui per piegarti, subire tutto e tacere». Imparò cosa significa ciò che aveva letto nei libri: diventare una cosa, un pezzo di legno o di ferro.
Quelle esperienze di fabbrica diventarono, grandiosamente trasformate, l’esperienza di lettura dell’Iliade , dove scoprì la prima apparizione scritta della forza nel mondo. Nell’Iliade , la forza ha due aspetti, secondo che la si veda con gli occhi di chi la subisce o di chi la impone.
La forza fa di chiunque le sia sottomesso una cosa: cadavere e oggetto. Se egli è vivo, ha l’anima; e tuttavia è una cosa. Ci sono esseri sventurati che, senza morire, sono diventati cose per tutta la vita. Nelle loro giornate, non c’è alcun margine, alcun vuoto, alcun campo libero, per un soffio che venga da loro stessi. Non sono uomini che vivono più duramente di altri: si tratta di una diversa specie umana, un compromesso tra l’uomo e il cadavere.
Chi ferisce, violenta, uccide, comanda, impone non è più libero dalla forza di chi ne è distrutto. Egli non la possiede: vi fa troppo affidamento e ne è inebriato, travolto dalla propria hybris . Va al di là di ciò di cui dispone. Va inevitabilmente al di là, perché ignora cosa è limitazione e misura: viene abbandonato senza rimedio al caso, e le vicende non gli obbediscono più.
La storia greca aveva avuto inizio con un crimine atroce: Troia era stata distrutta e arsa; nella notte i guerrieri troiani erano stati massacrati, i bambini sfracellati contro le rocce; le donne prese prigioniere e portate in esilio. Allora, era nato un immenso rimorso, che aveva pesato su tutta la civiltà greca e, come suggerisce la Weil, su tutta la storia che gli uomini fabbricarono dopo di allora. Le lacrime di Andromaca dopo la morte di Ettore sono le lacrime che piangiamo su noi stessi come attori e vittime della storia.
* * *
La creazione del mondo non è stata - secondo la Weil - un atto di pienezza, di espansione e dilatazione di Dio, come racconta la Genesi. È stata una follia. Per darci spazio, Dio ha rinunciato a se stesso; si è limitato; si è nascosto negli abissi più remoti; si è ritirato dall’universo, come diceva Itzhak Luria. Nel luogo vuoto, che prima della creazione occupava, egli ha lasciato lo schermo tremendo della necessità: le leggi meccaniche dell’universo, il male, la miseria, l’angoscia, il lavoro, la guerra e la forza dell’Iliade , la morte violenta, la malattia, l’oggettività mostruosa della fabbrica moderna. Come uno schiavo, Dio si è incatenato con le catene della necessità, sulla quale non interviene.
Ora, nel mondo, non c’è alcuna traccia di misericordia divina; e questa assenza è il segno di Dio. A causa di questa rinuncia, egli non è più l’Uno, come i filosofi troppo ottimisti avevano creduto. È lacerato tra i suoi due volti opposti e contradditori, che tuttavia costituiscono il suo unico volto: diviso tra bene e necessità, come noi siamo. Nessuno, mai, nemmeno uno gnostico, aveva portato la lacerazione e la follia, che sono cose proprie dell’uomo, così addentro il volto segreto di Dio.
Il mondo è la conseguenza di questo paradosso divino. Da un lato Dio perduto, lontano, assente dalla sua creazione, dove possiamo rintracciare soltanto qualche lievissimo barlume di lui. Ma, d’altro lato, egli è onnipresente nella creazione, come nei Salmi. Tutte le cose sono una metafora e un riflesso multicolore della sua presenza. Egli è dovunque: nella bellezza, nell’ordine e nell’armonia del mondo, schiave della necessità, che la Weil celebra con gli accenti di una stoica o di una cristiana del quarto secolo. Egli è presente in ogni cosa che avviene nell’universo: nei fatti mostruosi che sono accaduti, nei fatti orribili che stanno per compiersi, i quali per l’uomo sono tutti carezze delicate e discrete della mano di Dio.
L’incarnazione e la passione rappresentano il culmine della follia e dello strazio di Dio. Appena parla di Cristo, ogni traccia gnostica e manichea scompare dalla mente della Weil: Cristo è colui che si è incarnato e ha patito con un reale corpo umano. Ma in lei non c’è nemmeno una traccia del Cristo salvatore e trionfatore della tradizione cristiana: Cristo non salva nessuno. Come Osiride, è il Dio fatto a pezzi, simbolo «dello spirito disperso attraverso lo spazio e la materia». Sulla croce, egli viene abbandonato da Dio, che verso di lui diventa gelido come la necessità; non c’è parola nei Vangeli che abbia tanto colpito la Weil quanto il grido di disperazione del Dio abbandonato. Come diceva Eschilo, «mediante la sofferenza e la conoscenza». «La croce del Cristo - ribadisce la Weil - è l’unica forza della conoscenza». Il solo pensiero umano degno di questo nome è lacerato, contradditorio, aguzzo, aforistico, come i due pezzi di legno levati inutilmente contro il cielo.
La tragedia della croce si ripete nella sventura - l’esperienza essenziale che ogni uomo fa di se stesso. Non c’è nessuna sensazione o sentimento che la Weil abbia espresso con tanta lucidità e intensità, con tanta appassionata partecipazione e orrore e riconoscenza come se per tutta la vita, malgrado le dolcezze discese dal cielo e gli sguardi innamorati alla natura, non fosse stata che «un poco di carne nuda, inerte e sanguinante, abbandonata senza nome sull’orlo di un fossato».
La sventura è una di quelle presse che la Weil aveva conosciuto in fabbrica: un meccanismo freddo, metallico e implacabile che domina il corpo, ostacola l’immaginazione, incatena il pensiero, ghiaccia tutti coloro che tocca. Come con un ferro rosso, imprime nello sventurato il disprezzo, il disgusto, la repulsione di sé, una sensazione di colpa e di lordura più grave di quella che suscita il delitto. Lo rende succube e complice, inietta un veleno di inerzia, si fa amare e desiderare, uccide le parole che potrebbero esprimerla; martella l’anima, la degrada, la riduce a una cosa, l’annienta. In quei momenti di desolazione, Dio abbandona chi soffre, come aveva abbandonato Giobbe e Cristo: «Egli è più assente di un morto, più assente della luce in un carcere completamente tenebroso».
Ma, subito dopo aver descritto con parole terrificanti la sventura, grazie a uno di quei capovolgimenti totali che costituiscono la chiave del suo pensiero - la Weil intona l’elogio della sventura. Con una specie di empietà nella voce, afferma che a causa della sofferenza «l’uomo è superiore agli dei». «Dio ha dovuto incarnarsi e soffrire per non essere inferiore all’uomo». «Se in questo mondo non ci fosse sventura, potremmo crederci in paradiso, orribile possibilità». Se sappiamo scendere in fondo alla sventura, come Omero e Sofocle, senza cercare consolazioni o illusioni, senza parole vane e bugiarde - lì, proprio in fondo all’abisso, in quelle profondità dove stanno le cose supreme, ritroveremo la sofferenza redentrice, la verità, la bellezza, la misericordia e l’amore di Dio.
-
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Non ricominciamo la guerra di Troia! Simone Weil: la violenza pietrifica le anime (di Elena Tebano)5 novembre 2016, di Federico La Sala
Simone Weil: la violenza pietrifica le anime
di Elena Tebano (Corriere della Sera, 03.11.2016)
«Mettiamo la maiuscola a parole prive di significato e, alla prima occasione, gli uomini spargeranno fiumi di sangue, accumuleranno rovine su rovine ripetendo quelle parole, senza mai ottenere davvero qualcosa di corrispondente; niente di reale può davvero corrispondere a queste parole, poiché non significano niente». Quando Simone Weil si esprimeva così in Non ricominciamo la guerra di Troia, quasi 80 anni fa, l’Europa era alla vigilia della Seconda guerra mondiale e i termini al centro dello scontro erano «nazione, sicurezza, capitalismo, comunismo, fascismo, ordine, autorità, proprietà, democrazia».
Il libro del potere, la breve raccolta di saggi dell’autrice francese a cura di Mauro Bonazzi, appena edita da Chiarelettere, ha il merito di restituircene tutto il vigore per un oggi in cui sono cambiati i termini con la maiuscola, ma non la loro pericolosa indefinitezza (si pensi alla contrapposizione tra una visione integralista dell’«Islam» e l’«Occidente»).
I tre testi del libro sono uniti dalla stessa, attualissima, esigenza: una riflessione sulla forza e sui suoi effetti al cospetto del mondo in cui vige il suo dominio. Per Simone Weil il modello è l’«ispirazione greca», la cui «essenza» - sostiene in L’ispirazione occitana , il terzo scritto della raccolta, pubblicato originariamente nel 1942, un tentativo di identificare nel cristianesimo evangelico il vero erede della cultura greca - è «la conoscenza della forza» e cioè «riconoscerla come pressoché unica sovrana di questo mondo e rifiutarla con disgusto e disprezzo».
All’analisi del «suo potere di trasformare gli uomini in cose», che «pietrifica seppur in modo diverso sia l’animo di coloro che la subiscono sia quello di coloro che la esercitano», è dedicato in particolare il primo saggio, L’Iliade o il poema della forza del 1940.
Ed è qui l’intuizione forse più interessante: un no fortissimo alla «scorciatoia» della violenza, come la definisce Bonazzi nell’introduzione, che alla complessità del reale preferisce «soluzioni drastiche, fondate su opposizioni nette: il bene contro il male, la luce contro il buio», perché distrugge anche chi ne esce vincitore.
Un rifiuto che Simone Weil ha incarnato con il suo radicalismo fino a morirne: non si è mai sottratta alle guerre che hanno segnato il suo tempo e ha sempre combattuto per gli ultimi, senza però mai cedere alla logica della forza.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- «L’Europa indebitata ripete i nostri errori». L’avvertimento di Rafael Correa, Presidente della Repubblica dell’Ecuador ("Le Monde Diplomatique").1 dicembre 2013, di Federico La Sala
L’avvertimento del Presidente ecuadoriano
«L’Europa indebitata ripete i nostri errori»
- Rafael Correa, Presidente della Repubblica dell’Ecuador, dottore in economia. Autore dell’opera «Equateur. De la république bananière à la non-république» (Ecuador. Dalla Repubblica delle banane alla non-repubblica), Utopia, Paris, 2013.
(Traduzione dal francese di José F. Padova) *
In occasione di una conferenza tenuta alla Sorbona il 6 novembre scorso, il presidente dell’Ecuador Rafael Correa si è rivolto ai suoi omologhi europei a proposito della gestione della crisi del debito pubblico. La quale gestione sarebbe caratterizzata da una sola ossessione: garantire gli interessi della finanza. Qui troviamo una sintesi della sua riflessione.
Noi, latino-americani, siamo esperti in crisi. Non perché saremmo più intelligenti degli altri, ma perché le crisi le abbiamo subite tutte. E le abbiamo gestite malamente, in modo terribilmente sbagliato, perché avevamo una sola priorità: difendere gli interessi del capitale, anche a rischio di far precipitare il subcontinente in una lunga crisi debitoria. Oggi con preoccupazione osserviamo l’Europa seguire a sua volta il medesimo cammino.
Negli anni ’70 i Paesi latino-americani sono entrati in una situazione di indebitamento intensivo con l’estero. La storia ufficiale afferma che questa situazione è il risultato di politiche portate avanti da governi «irresponsabili» e di squilibri accumulati a causa del modello di sviluppo adottato dal subcontinente dopo la guerra: la creazione di un’industria in grado di produrre localmente i prodotti importati, ovvero «industrializzazione come sostituto delle importazioni».
Questo profondo indebitamento, di fatto, è stato promosso - e perfino imposto - dagli organismi finanziari internazionali. La loro pretesa logica voleva che, grazie al finanziamento di progetti ad alta redditività, che all’epoca abbondavano nei Paesi del Terzo Mondo, si sarebbe approdati allo sviluppo, mentre il rendimento di questi investimenti avrebbe permesso di rimborsare i debiti contratti.
Tutto questo è durato fino al 13 agosto 1982, quando il Messico dichiarò la propria incapacità di fare fronte alle scadenze. Da allora tutta l’America latina ebbe a soffrire la sospensione dei prestiti internazionali, contemporaneamente al brutale aumento dei tassi d’interesse sul suo debito. Prestiti che erano stato contratti al 4% o al 6%, ma con tassi variabili, hanno improvvisamente raggiunto il 20%. Mark Twain diceva: «Un banchiere è qualcuno che vi presta un ombrello quando il sole splende e che se lo riprende quando comincia a piovere...».
La nostra crisi del debito è cominciata così. Durante il decennio ’80, l’America Latina ha effettuato un trasferimento netto di risorse ai suoi creditori di 195 miliardi di dollari (quasi 554 miliardi di dollari al valore attuale). Allo stesso tempo il debito estero dell’intera Regione passava quindi da 223 miliardi di dollari nel 1980 a... 443 miliardi di dollari nel 1991! Non già a causa di nuovi crediti, ma per il rifinanziamento e l’accumulo degli interessi.
Di fatto il subcontinente ha visto concludersi il decennio 1980 con gli stessi livelli di reddito per abitante degli anni ’70. Si parla di un «decennio perduto» per lo sviluppo. In realtà perduta fu un’intera generazione.
Benché le responsabilità fossero condivise, i Paesi dominanti, le burocrazie internazionali come il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Banca Mondiale e la Banca interamericana per lo sviluppo, come beninteso anche le banche private internazionali, hanno sintetizzato la situazione come un problema di indebitamento eccessivo degli Stati (overborrowing). Mai si sono assunti la loro responsabilità nella concessione irragionevole di crediti (overlending), ovvero per l’altra faccia della situazione.
Le pesanti crisi di bilancio e d’indebitamento esterno causate dal trasferimento netto di risorse dell’America latina verso i suoi creditori hanno portato un buon numero di Paesi della Regione a redigere «lettere d’intenti» dettate dal FMI. Questi accordi impegnativi permettevano di ottenere prestiti da parte di quell’organizzazione, come pure garanzie per la rinegoziazione dei debiti bilaterali con i Paesi creditori, riuniti nel Club di Parigi.
Carenza di dirigenti e d’idee I programmi di adeguamento strutturale e di stabilizzazione hanno imposto le prescrizioni di sempre: austerità di bilancio, aumento del prezzo dei servizi pubblici, privatizzazioni, ecc. Altrettante misure attraverso le quali non si cercava di uscire al più presto dalla crisi, né di alimentare la crescita o l’occupazione, ma di garantire il rimborso dei crediti delle banche private.
Alla fine dei conti, i Paesi colpiti erano sempre indebitati, non più con questi istituti, ma con gli organismi finanziari internazionali, che proteggevano gli interessi delle banche.
All’inizio degli anni ’80 un nuovo modello di sviluppo ha iniziato a imporsi nell’America latina e nel mondo: il neoliberismo. Questo nuovo accordo sulla strategia di sviluppo è stato soprannominato «accordo di Washington», poiché i suoi principali progettisti e promotori erano gli organismi finanziari e multinazionali la cui sede si trovava a Washington. Secondo la logica in voga la crisi in America latina era dovuta a un intervento eccessivo dello Stato nell’economia, all’assenza di un adeguato sistema di prezzi liberi e all’allontanamento dei mercati internazionali - sottintendendo che queste caratteristiche derivavano dal modello latino-americano d’industrializzazione mediante sostituzione delle importazioni.
Come conseguenza di una campagna di marketing ideologico senza precedenti, mascherata da ricerca scientifica, e di pressioni dirette esercitate dal FMI e dalla Banca Mondiale, la Regione è passata da un estremo all’altro: da diffidenza verso il mercato e fiducia eccessiva nello Stato al libero scambio, alla de-regolazione e alle privatizzazioni.
La crisi non è stata soltanto economica; è il risultato di una carenza di dirigenti e d’idee. Abbiamo avuto paura di pensare per conto nostro e abbiamo accettato in modo tanto passivo quanto assurdo i diktat stranieri.
La descrizione della crisi che ha attraversato l’Ecuador sarà senza dubbio famigliare a moltissimi europei. L’Unione Europea soffre di un indebitamento prodotto e aggravato dal fondamentalismo neoliberista. Pur rispettando la sovranità e l’indipendenza di ogni zona del mondo, siamo sorpresi nel constatare che l’Europa, pur essendo così illuminata, ripeta in ogni punto gli errori commessi dall’America latina.
Le banche europee hanno prestato alla Grecia pretendendo di non aver visto che il suo deficit di bilancio era quasi tre volte superiore a quello dichiarato dallo Stato. Si pone nuovamente il problema di un eccessivo indebitamento del quale si omette di evocare la contropartita: l’eccesso di credito. Come se il capitale finanziario non avesse mai la minima parte di responsabilità.
Dal 2010 al 2012 la disoccupazione in Europa ha raggiunto livelli allarmanti. Fra il 2009 e il 2012 il Portogallo, l’Italia, la Grecia, l’Irlanda e la Spagna hanno ridotto le loro spese di bilancio del 6,4% in media, arrecando così gravi danni ai servizi sanitari ed educativi. Si giustifica questa politica con un deficit di risorse, ma considerevoli importi sono stati liberati per rimettere a galla il settore finanziario. In Portogallo, in Grecia e in Irlanda la somma complessiva di questo salvataggio bancario supera il totale dei salari annui.
Mentre la crisi colpisce duramente i popoli europei si continua a imporre loro le misure che ovunque nel mondo hanno fatto fiasco.
Prendiamo l’esempio di Cipro. Come sempre, il problema comincia con la de-regolazione del settore finanziario. Nel 2012 la sua cattiva gestione diventa insostenibile. Le banche cipriote, la Banca di Cipro e la Laiki Bank in particolare, avevano concesso alla Grecia prestiti privati per un importo superiore al PIL cipriota. Nell’aprile 2013 la «troika» - FMI, BCE e Commissione europea - propone un «salvataggio» di 10 miliardi di euro. Lo condiziona a un programma di aggiustamento che include la riduzione del settore pubblico, la soppressione del sistema pensionistico dei nuovi funzionari, la privatizzazione delle imprese pubbliche strategiche, correzioni di bilancio fino al 2018, limitazione delle spese sociali e creazione di un «fondo di salvataggio finanziario», il cui obiettivo è il sostegno delle banche e la soluzione dei loro problemi, oltre al congelamento dei depositi superiori a 100.000 euro.
Nessuno dubita che siano necessarie riforme, che occorra correggere gravi errori, ivi compresi quelli originari: l’Unione Europea ha integrato Paesi con importanti differenziali nella produttività, che i salari nazionali non riflettono. Resta il fatto che, nell’essenza, le politiche applicate non cercano di uscire dalla crisi al minor costo per i cittadini europei, ma a garantire il pagamento del debito alle banche private.
Abbiamo evocato Paesi indebitati. Che ne è dei privati cittadini incapaci di rimborsare i loro debiti? Prendiamo il caso della Spagna. La mancanza di regolamentazione e il troppo facile accesso al denaro delle banche spagnole hanno generato un’immensa quantità di crediti ipotecari che hanno galvanizzato la speculazione immobiliare. Le banche stesse cercavano i clienti, stimavano il valore dei loro immobili e continuavano sempre più a fare credito, per l’acquisto di un’auto, di mobilio, di elettrodomestici, ecc.
Quando scoppia la bolla immobiliare il mutuatario in buona fede non può più rimborsare il suo prestito: non c’è più lavoro. Gli si porta via la casa, ma questa vale molto meno di quando lui l’ha comperata. Nel 2012 si sono registrati ogni giorno più di duecento sfratti, ciò che spiega una gran parte dei suicidi in Spagna.
Una questione si pone: perché non si fa ricorso a rimedi che sembrano evidenti e perché si ripete sempre lo scenario peggiore? Perché il problema non è tecnico, ma politico. È determinato da un rapporto di forze. Chi dirige le nostre società? Gli umani o il capitale?
Il torto più grande che si è fatto all’economia è di averla sottratta alla sua natura originaria di economia politica. Ci si è fatto credere che tutto era tecnico; si è mascherata l’ideologia come scienza e, incoraggiandoci a prescindere dai rapporti di forze all’interno di una società, siamo stati messi tutti al servizio dei poteri dominanti, di ciò che io chiamo l’«impero del capitale».
La strategia dell’indebitamento intensivo che ha generato la crisi del debito latino-americano non mirava ad aiutare i nostri Paesi a svilupparsi. Obbediva invece all’urgenza di collocare le eccedenze di denaro che inondavano i mercati finanziari del «primo mondo», i petrodollari che i Paesi arabi produttori di petrolio avevano piazzato nelle banche dei Paesi sviluppati. Queste liquidità provenivano dal rialzo del prezzo del petrolio conseguente alla guerra dell’ottobre 1973, poiché questi prezzi erano stati mantenuti a livelli elevati dall’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEP). Fra il 1975 e il 1980 i depositi presso le banche internazionali sono passati da 82 miliardi di dollari a 440 miliardi (1226 miliardi di dollari attuali).
Di fronte alla necessità di collocare quantità di denaro tanto ingenti il Terzo Mondo ha suscitato interesse. Così è cominciata, a partire dal 1975, la sfilata dei banchieri internazionali desiderosi di piazzare ogni sorta di crediti - ivi compresi quelli destinati a finanziare le spese correnti e l’acquisto di armi da parte delle dittature militari che governavano un gran numero di Stati. Questi zelanti banchieri, che non si erano mai fatti vedere nel Subcontinente, neppure come turisti, hanno anche portato grosse valigie di bustarelle e mazzette ai funzionari, per fare loro accettare nuovi prestiti, con pretesti qualsiasi. Allo stesso tempo gli organismi finanziari internazionali e gli enti per lo sviluppo hanno continuato a vendere l’idea secondo la quale la soluzione era l’indebitamento.
Un’ideologia camuffata da scienza L’indipendenza delle banche centrali, che di fatto serve a garantire la continuità del sistema qualunque sia il verdetto delle urne, all’inizio degli anni ’90è stata imposta come una necessità «tecnica», giustificata da sedicenti studi empirici, che dimostravano come un dispositivo di quel genere generasse migliori risultati macroeconomici. Secondo quelle «ricerche» le banche centrali indipendenti potevano agire in modo «tecnico», lungi da perniciose pressioni politiche. Sulle basi di un’argomentazione tanto assurda bisognerebbe rendere ugualmente autonomo il ministero delle Finanze, perché la politica di bilancio dovrebbe anch’essa essere puramente «tecnica». Come l’ha suggerito Ronald Coase, premio Nobel per l’economia, i risultati di quegli studi si spiegavano così: si erano messi sotto tortura i dati economici fino a fare dire loro ciò che da loro si voleva sentire.
Nel periodo che ha preceduto la crisi le banche centrali autonome si sono consacrate esclusivamente a mantenere la stabilità monetaria, vale a dire a controllare l’inflazione, nonostante avessero svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Paesi come il Giappone o la Corea del Sud. Fin agli anni ’70 l’obiettivo fondamentale della Federal Reserve era quello di favorire la creazione di posti di lavoro e la crescita economica; soltanto con le pressioni inflazionistiche dell’inizio degli anni ’70 è stato aggiunto il compito di promuovere la stabilità dei prezzi.
La priorità attribuita alla stabilizzazione dei prezzi significa ugualmente, in pratica, l’abbandono delle politiche miranti a mantenere il pieno impiego delle risorse nell’economia. Al punto che, invece di attenuare gli episodi di recessione e di disoccupazione, la politica di bilancio, comprimendo senza sosta le spese, li aggrava.
Le banche centrali dette «indipendenti», che si preoccupano unicamente di stabilità monetaria, fanno parte del problema, non della soluzione. Sono uno dei fattori che impediscono all’Europa di uscire più rapidamente dalla crisi.
Tuttavia le capacità europee rimangono intatte. Voi disponete di tutto: il talento umano, le risorse produttive, la tecnologia. Credo si debba trarne conclusioni forti: si tratta di un problema di coordinamento sociale, cioè di politica economica della domanda, o come si vorrà chiamarla. Al contrario, i rapporti di potere all’interno dei vostri paesi e a livello internazionale sono tutti favorevoli al capitale, in particolare a quello finanziario, motivo per il quale le politiche applicate sono contrarie a ciò che sarebbe socialmente auspicabile.
Randellati dalla sedicente scienza economica e dalle burocrazie internazionali, un gran numero di cittadini sono convinti che «non vi sia alternativa». Essi si sbagliano.
* Le Monde Diplomatique - n° 717 - dicembre 2013
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!!--- L’Europa ssomiglia sempre più all’Ufficio delle Lettere morte custodito da Bartleby lo scrivano, nel racconto di Herman Melville( (di Barbara Spinelli - Lettere smarrite)6 novembre 2013, di Federico La Sala
Europa
Lettere smarrite
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 06.11.2013)
SONO d’accordo con l’auspicio espresso domenica da Eugenio Scalfari: che l’Europa federale nasca, e la moneta unica si salvi. In caso contrario avremo, al posto dell’Unione, tanti staterelli senza lode ma non senza infamia, non amici ma più che mai vassalli della potenza Usa. Torneremo alla casella di partenza: vinti dai nostri nazionalismi come nelle guerre mondiali del ’900.
Sono meno d’accordo con il giudizio severo sui movimenti di protesta che ovunque nascono contro l’Europa come oggi è fatta, e ho un’opinione assai meno perentoria su 5 Stelle. Chi ascolti Grillo con cura sarà certo colpito dalle sue incongruenze; specie quando indulge alla xenofobia, procacciatrice di voti. Ma non s’imbatterà nel nazionalismo, né in vero antieuropeismo. Populismo è un’ingiuriosa parola acchiappatutto che non spiega nulla. Come spesso nella nostra storia, è sotterfugio autoassolutorio di chiuse oligarchie: lo spiega Marco D’Eramo in uno dei migliori saggi usciti in Europa sul populismo come spauracchio (Micromega 4-13). Serve a confondere l’effetto (la rabbia dei popoli, il suo uso) con la causa (l’Europa malfatta, malmessa). Letta fa la stessa confusione, nell’intervista alla Stampa di venerdì.
Qualche giorno fa Grillo ha detto sulla crisi dell’Unione cose sensate, che nessun nazionalista direbbe: un’Europa che si dotasse di strumenti finanziari (tra cui gli eurobond), e che mettesse in comune i debiti, potrebbe far molto per superare le difficoltà e salvare se stessa. Purtroppo c’è nel M5S chi propugna l’uscita dell’Italia dall’Euro, fantasticando di rimettere sul trono i re nazionali. Questo significa che Grillo esita a compiere scelte forti, quasi fosse già stanco all’idea di divenire un leader che educhi, unifichi. Non significa che i 5 Stelle siano assimilabili a Marine Le Pen, o ai neo-nazisti in Grecia e Ungheria. Anche se il protezionismo mentale li tenta, è difficile immaginare che un movimento nato dalla congiunzione di iniziative cittadine del tutto estranee al nazionalismo sfoci in destra estrema.
La questione di fondo è dunque un’altra. Non il nome interessa sapere, ma perché in Europa cresca un’umanità così infelice, disgustata. Chiamarla populista o reazionaria è fermarsi alle soglie del perché. La domanda sulle radici del grido è elusa. E la risposta è inservibile, se proteste e proposte tra loro tanto dissimili vengono espulse come grumo compatto che intasa chissà quale progresso.
Bollare un intrico di sdegni e rifiuti vuol dire ignorare che l’Europa di oggi distilla veleni cronici. Non basta dirla per farla, alla maniera performativa dei governi attuali. Vuol dire nascondere quel che pure è evidente: nazionalismo e conservazione sono vizi che affliggono i vertici stessi e le élite degli Stati dell’Unione.
Anche qui vale la pena andare oltre le parole: se si esclude la Francia, Federazione non è più vocabolo tabù. Molti oggi l’invocano. Ma senza che al verbo seguano atti concreti: la messa in comune dei debiti, una crescita alimentata da eurobond e da risorse europee ben più consistenti di quelle odierne. E ancora: un Parlamento europeo con nuovi poteri, e una Costituzione comune che sia espressione dei cittadini. Un’Europa che sia per loro un rifugio in tempi di angoscia, e non il guscio che protegge un’endogamica oligarchia di potenti che si blindano a vicenda.
L’Europa così com’è non è minacciata dalla rabbia (di destra e sinistra) dei propri cittadini. È minacciata da governi restii a delegare sovranità nazionali non solo finte ma usurpate, visto che sovrani in democrazia sono i popoli. La crisi del 2007-2008 la tormenta smisuratamente a causa di tali storture. Un’austerità che accentua povertà e disuguaglianze, un Patto di stabilità (Fiscal Compact) che nessun Parlamento ha potuto discutere: l’Europa che si vuol ripulire dai populismi è questa. È la miseria greca; sono gli occhi che spiano il debole, come nei Salmi. È la corruzione dei governi, che si ciba di disuguaglianze e di falsa stabilità.
Il caso delle sinistre radicali in Grecia è esemplare. Il Syriza, una coalizione di movimenti cittadini egruppi di sinistra, fu bollato come antieuropeo e populista, nelle due elezioni del maggio-giugno 2012. Le cancellerie europee si mobilitarono, dipingendo Syriza come orco da abbattere. Berlino minacciò di chiudere i rubinetti degli aiuti. Ma né Syriza né Alexis Tsipras che lo guida sono antieuropei. Chiedono un’altra Europa, sì, e questo atterrisce l’establishment.
Il 20 settembre, presentando il proprio programma al Kreisky Forum di Vienna, Tsipras ha sorpreso chi l’aveva infangato. Ha detto che l’architettura dell’euro e i piani di salvataggio hanno sfasciato l’Unione, invece di bendarne le ferite. Ha ricordato la crisi del ’29, i dogmi neoliberisti con cui fu gestita. Proprio come accade oggi, «i governi negarono l’architettura aberrante dei loro disegni, insistendo sull’austerità e sul mero rilancio dell’export». Ne risultò miseria, «e l’ascesa del fascismo in Sud Europa, del nazismo in Europa centrale e del nord». È il motivo per cui l’Unione va fatta da capo. Riprendendo le idee dei sindacati tedeschi, Syriza propone un Piano Marshall per l’Europa, un’autentica unione bancaria, un debito pubblico gestito centralmente dalla Banca centrale europea, e un massiccio programma di investimenti pubblici lanciato dall’Unione.
Ma Tsipras dice qualcosa di più: c’è un nesso che va denunciato, tra la crisi europea e le corrotte democrazie di Atene e di tanti Paesi del Sud. «La nostra cleptocrazia ha stretto una solida alleanza con le élite europee», e il connubio si nutre di menzogne sulle colpe greche o italiane, sui salari troppo alti e lo Stato troppo soccorrevole. Le menzogne «servono a trasferire la colpa delle debolezze nazionali dalle spalle dei cleptocrati a quelle del popolo che lavora duramente».
È un’alleanza che non ha più opposizione da quando la sinistra classica ha adottato, negli anni ’90, i dogmi neoliberisti. Gran parte della popolazione è rimasta così senza rappresentanza: smarrita, dismessa, punita da manovre recessive che paiono esercitazioni militari. È questa parte (una maggioranza, se contiamo anche gli astensionisti) che protesta contro l’Europa: a volte sognando un irreale ritorno alle monete e alle sovranità nazionali; a volte chiedendo invece un’altra Europa, che non dimentichi il grido dei poveri come seppe fare tra il dopoguerra e la fine degli anni ’70. Questo dice Tsipras. Cose simili, anche se più caoticamente, dice Grillo.
Se nulla si muove l’Europa sarà non più riparo, ma luogo che ti espone, ti denuda. Tenuto in piedi da élite di consanguinei - che campano di favori personali fatti e ricevuti senza che dubbio li sfiori (è il caso Cancellieri); che annunciano una ripresa smentita dai fatti - l’edificio somiglia sempre più all’Ufficio delle Lettere morte custodito da Bartleby lo scrivano, nel racconto di Herman Melville.
È sfogliando e gettando al macero migliaia di lettere spedite e mai recapitate che Bartleby matura il suo impallidito rifiuto, che a un certo punto lo indurrà a rispondere «Preferirei di no», con cadaverica tranquillità, a qualsiasi ordine o domanda. Ecco, l’Europa è oggi quell’Ufficio che ha trasformato il suo impiegato in un infelice: «Lettere morte! (...) Talvolta dalle pieghe del foglio il pallido impiegato estrae un anello: e il dito cui era destinato forse già imputridisce nella tomba; una banconota inviata con la più tempestiva delle carità: e colui che ne avrebbe ricevuto giovamento ormai non mangia più, non soffre più la fame; un perdono per coloro che morirono nello scoraggiamento; una speranza per quelli che morirono senza sperare; buone notizie per quelli che morirono soffocati da non alleviate calamità. Messaggere di vita, queste lettere precipitano nella morte. O Bartleby! O umanità!».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Gli spifferai magici e i cani di Kant (di Barbara Spinelli)30 ottobre 2013, di Federico La Sala
 Gli spifferai magici e i cani di Kant
Gli spifferai magici e i cani di Kant «Il Datagate è al servizio di un dispositivo d’aggressione collaudato da Bush jr e dilatato da Obama
«Il Datagate è al servizio di un dispositivo d’aggressione collaudato da Bush jr e dilatato da Obama
 I droni ai tempi di Bush erano 167, oggi 7000»
I droni ai tempi di Bush erano 167, oggi 7000»di Barbara Spinelli (la Repubblica, 30.10.2013)
APPARENTEMENTE sono tutti molto offesi, i governanti europei, per come Barack Obama - imperturbato, senza farsi scrupoli - li ha fatti spiare da anni. Soprattutto il controllo di un telefonino privato, quello del cancelliere Merkel, crea sconcerto: possibile che la Nsa americana (Agenzia nazionale di sicurezza) giudichi necessario origliare per oltre un decennio quello che dal dopoguerra è l’alleato cruciale nel vecchio continente?
Forse perché non è più cruciale come si pensava, né così fidato? Queste e altre domande hanno agitato il summit europeo dei giorni scorsi, ma oltre l’apparenza non si è andati. In parte per ignavia, in parte per quieto vivere, in parte per ossequiosa furberia, il comunicato dei capi di Stato o di governo riuniti a Bruxelles s’attarda sullo stile della poco cavalleresca intrusione, sulla rozza insensatezza delle liste di indiziati o sospetti. Il modo ancor li offende. Non il perché: quasi non li riguardasse, né in fondo li incuriosisse. Il perché è anzi tra le righe giustificato («la raccolta di intelligence è un elemento essenziale nella lotta contro il terrorismo»). In nessun passaggio del comunicato ci si chiede: ha senso affastellare dati su tutti e su tutto, su fidati e non fidati, su amici e nemici da abbattere - alla rinfusa, sotto la stessa regia - e gabellare questa maniacale compilazione di liste per lotta al terrorismo?
Se così non fosse, se i capi europei esaminassero alle radici le offese che d’un colpo scoprono di subire e il loro rapporto con gli Stati Uniti (ma anche con Londra, non meno implicata nello spionaggio), ben altra sarebbe stata da principio la loro reazione. Da tempo conoscevano gli intrichi dell’Agenzia di sicurezza, sin dal 6 giugno Edward Snowden li aveva rivelati al giornalista Glenn Greenwald; la notizia già era apparsa sul Guardian, sulWashington Post, su Spiegel. Ma lo sdegno aveva colpito il denunciatore, non l’impazzita macchina di spionaggio. Snowden fu catalogato come talpa, spia: anche da giornali che si dicono indipendenti, ma son usi a prender per buone le versioni ufficiali (da allora Greenwald parla di presstitutes, prostitute della stampa). Washington accusò Snowden di tradimento, e i governi europei abbozzarono.
Non li sfiorò l’idea di offrire rifugio in Europa a chi viene chiamato, da secoli, non già spia ma whistleblower (le leggi Usa proteggono i «suonatori di fischietto» dal XVIII e XIX secolo). Whistleblower è chi obbedendo alla propria coscienza denuncia misfatti dell’organo o del sistema che l’impiega. È un disobbediente civile: come Snowden, o Bradley Manning che rivelò a Wikileaks le malefatte americane in Iraq. Se giornalista alla maniera di Greenwald, è cane da guardia; vigila sui soprusi dei potenti. Secondo Kant aiuta a emancipare i cittadini, li rende adulti: cosa possibile solo se nasce uno spazio pubblico non asservito al comando politico, forte dei Lumi, non tenuto all’oscuro. «Hanno ristretto l’influenza della sfera pubblica»: è una delle accuse di Snowden ai governi Usa.
Snowden ha trovato asilo nella Russia di Putin, non in Europa dove è tuttora considerato un paria. Il giudizio non muta neanche dopo lo scandalo dei telefonini intercettati. Rispondendo ai giornalisti, venerdì a Bruxelles, Enrico Letta è stato perentorio. Il whistleblower resta un reietto: «Non penso che (la sua) sia un’attività utile e positiva: crea problemi e non produce gli effetti di “disclosure” che pretende». In realtà Snowden ha scoperchiato le verità della Nsa (perché parlare di «disclosure», quando c’è l’antica parola Lumi?), ma quel far luce e divenire adulti non è utile né positivo. Logicamente questo significa che altro è utile, tra Europa e Usa: il nascosto, la negazione della parresia ovvero della libera informazione e del libero parlarsi. Quanto all’Unione, significa nutrire l’abitudine alla subalternità del minorenne. Il quieto vivere, talmente meno costoso, ti libera da responsabilità ed è a questo prezzo. Per citare ancora Kant: sapere aude - osa sapere - è sin dai tempi di Orazio impresa troppo incandescente. Meglio definirla non positiva «ai fini della disclosure».
Questo spiega i toni del comunicato di Bruxelles: toni melodrammatici - le «profonde preoccupazioni» dei cittadini europei; l’appello a «più rispetto, più fiducia» - ma privi di proposte pratiche che vadano al di là di poco specificate iniziative e di colloqui bilaterali che Parigi e Berlino avranno con Obama (perché non l’Unione in quanto tale? perché l’Italia non colloquierà?). Rispetto e fiducia sono sentimenti pieni di rumore che non significano nulla, se non producono patti vincolanti e ordini internazionali non più egemonizzati dalla superpotenza. Tanto più essenziale è soffermarsi sul perché del Datagate, e metterlo in relazione con le guerre al terrorismo: con i suoi fallimenti, le sue degenerazioni sotto la presidenza Obama, l’intreccio perverso creatosi fra le informazioni raccolte sugli alleati e quelle che danno vita alle kill list,le uccisioni mirate dei terroristi indiziati. I servizi segreti compilano probabilmente le une e le altre, con l’assenso del potere politico. Questo allarma. Ecco perché la solidarietà dovrebbe andare, se l’Europa è patria del libero confronto di idee, alle persone che smascherano piani antiterrorismo sfuggiti a ogni controllo.
Definirle inutili vuol dire approvare una guerra che prosegue in altro modo, non dichiarata ma surrettizia, e considerare proficuo (anche se i modi offendono) quel che maggiormente la caratterizza: le raccolte dati interamente fondate sul sospetto, e l’affidarsi a mezzi tecnologici che «determinano con la forza dell’inerzia il fine prefissato», storcendo il fine stesso e confondendo tattica e strategia (è la tesi del giurista Stephen Holmes, London Review of Boooks, 18 luglio 2013).
Il Datagate riguarda solo marginalmente i governanti origliati urbi et orbi. Militarmente è al servizio di un dispositivo d’aggressione, collaudato da Bush jr e dilatato da Obama. Lo scopo è ridurre a zero le guerre di terra - costose finanziariamente, invise in patria - e colpire da lontano, senza più sporcarsi le mani (i droni ai tempi di Bush erano 167, oggi 7000). L’offensiva dei droni (Pakistan, Yemen, Somalia, Libia, ecc) è senza epiloghi e volutamente «non fa più prigionieri », sciogliendo nell’infamia la questione Guantanamo: i «combattenti illegali» sono liquidati nella notte e nella nebbia. Altro sostanziale vantaggio: la stampa non è mai presente.
Anche se non si chiamano più guerre (ma «operazioni d’emergenza esterna»), la dottrina è sempre quella di Bush jr: l’America è fortezza assediata, militarmente ed economicamente, che non si fida di nessuno e sospetta tutti - avversari reali e potenziali, amici fidati o competitori infidi. È stata denominata dottrina dell’Uno per cento, e fu il vicepresidente Dick Cheney a formularla per primo, nel 2006: «Se esiste un 1 per cento di possibilità che gli scienziati pakistani stiano assistendo Al Qaeda nello sviluppare un’atomica, dobbiamo trattare questa possibilità come una certezza, dal punto di vista della risposta. Qui non è in gioco la nostra analisi, ma la nostra risposta».
Risultato: a dodici anni dall’11 settembre 2001, si affronta il mondo con la stessa ignoranza militante di ieri, lo stesso sprezzo d’ogni analisi.Solo la risposta conta: quale che sia, giusta o sbagliata, purché si presenti come certezza non confutabile. Purché confermi l’America come superpotenza che non conosce limiti, né autorità superiori o pari alla propria. Che declina magari finanziariamente, ma non politicamente e strategicamente.
Che l’Europa creda ancora a questa favola raccontata da un idiota, senza mai discutere con l’alleato il senso e la natura delle guerre, senza mai osare sapere, fa di lei null’altro che «un’ombra che cammina».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- Verso il secondo suicidio dell’Europa e della sua tradizione culturale e sociale (di Fulvio Papi - Letteratura e nazionalismi).14 ottobre 2013, di Federico La Sala
LETTERATURA E NAZIONALISMI
di Fulvio Papi *
Se c’è ancora qualcuno che ama leggere la letteratura mitteleuropea del primo Novecento, scopre facilmente che in alcuni autori vi è la convinzione sulla superiorità etica del sovranazionale impero austriaco rispetto alle affermazioni delle singole nazionalità. L’impero, con l’efficienza della sua celebre burocrazia, consentiva una vita pacifica e tollerante alle diverse popolazioni che vi facevano parte rispetto alla reciproca aggressività delle diverse nazionalità divise e competitive. Al di là della nostalgia di un autore importante come Zweig (e dei suoi ripetitori italiani di una volta con il “complesso dell’imperatore”), credo di non essere lontano dalla verità se considero questo mito come un’elaborazione di una parziale verità storica.
Per esempio non dimentico l’ “azione parallela” de L’uomo senza qualità di Musil dove l’inconcludente e formale iniziativa celebrativa non riuscendo a diventare un progetto, declinava nella ripetizione e nella estensione delle sue pratiche formali, quasi simbolo della vita viennese che ascoltava se stessa, le proprie passioni, i propri teatri interiori ed esteriori, le proprie procedure come un corpo chiuso in una conchiglia. Ma, al tempo, le povere comunità degli ebrei polacchi erano libere nelle loro tradizioni religiose, costumi di vita, rapporti sociali.
Un mondo che qualche decennio dopo nel dominio di un grande Reich, fondato sull’unità di sangue, di lingua, di popolo, sterminò con una ferocia ideologica che un grande scrittore come Joseph Roth, prima di morire (nel 1939) riuscì perfettamente a comprendere e a odiare. Credo di sapere anche che culturalmente il nazionalismo nei Balcani, spesso così atroce e pericoloso, derivò dagli scrittori nazionalistici tedeschi dell’Ottocento. E sono anche sicuro che è un grandissimo errore scambiare l’affettivo e comunitario luogo della propria vita, la Heimat, con il superbo e aggressivo Vaterland.
Questa pericolosa confusione non è solo nella propaganda che per anni ha impestato l’Europa ma talora anche in persone di ottimo intelletto quando, per tara di pregiudizi, non riescono a distinguere. Oggi il diritto di cittadinanza a chi nasce nel nostro paese è il superamento di una patria chiusa e aggressiva. La storia si rinnova, e bisogna distinguere il positivo dal negativo, anche se nella realtà non sono come A e non-A nella logica formale. L’impero non era in grado di integrare quelle minoranze rigorose che desideravano una loro identità simbolica (nazionale e anche repubblicana), e quivi il conflitto diventava molto grave.
Ricordiamo tutti i grandi (Stuparich, Slataper, ecc.), e anche nella mia famiglia triestina due miei zii (oggi dimenticati da tutti) fuggirono dalla città per unirsi all’esercito italiano, e poi morirono nella terribile guerra sul Carso. Ma a me che vivo qui non dispiace ricordare che, quanto agli imbrogli, la legislazione dell’impero era molto severa, e ogni lettore di Svevo ricorderà che il cognato del suo protagonista Zeno, si uccide per evitare l’immagine del carcere che poteva attendere i falsificatori di bilanci.
Tutte queste chiacchiere sull’impero per concludere dicendo che i nazionalismi di stato furono la catastrofe dell’Europa. Un suicidio che nella prima guerra mondiale non fu minimamente compreso dagli accademici tedeschi, fedeli al potere guglielmino e persuasi dell’opposizione tra “Kultur” e “civiltà”, che invece gli intellettuali francesi ritenevano di incarnare e di difendere contro i nuovi barbari. E chi ricorda più l’assassinio di Jaurès, grande leader socialista francese che aveva tentato (e tentava sino all’ultimo) di impedire la catastrofe?
Tredici milioni di morti nella prima guerra mondiale, e cinquanta milioni nella seconda furono il prezzo tragico che fu necessario (ma perché necessario?) pagare perché l’Europa dopo il 1945 cercasse di inventare un’ altra strada (che socialisti come Spinelli e Colorni avevano indicato). In fondo fu trovata nel modo più semplice: il terreno fu quello economico. Dopo il piano Marshal e la ricostruzione, la strada, a parte le indubbie capacità politiche dei capi di stato, non fu complicata, e in certo senso mostrò una sua linearità storica: i trattati sul carbone e l’acciaio, il mercato comune, la moneta unica, e un tentativo di architettura politica del continente, tuttavia insufficienti per dirigere una economia integrata non solo nella dimensione del mercato, ma relativo ad un identico apparato legislativo nei settori fondamentali. Era un’impresa difficilissima che non è stata realizzata con il risultato, del tutto prevedibile, che in una crisi sarebbe rinata una dimensione nazionalistica a livello economico. La diversa forza produttiva di ogni paese, e rapporti sociali, la conduzione politica (dove la democrazia spesso è diventata demagogia di ceti oligarchici), le diseconomie - che in Italia meritano un libro a parte - sono tutti fattori che non possono non provocare forme di nazionalismo economico, terapizzate solo in parte dalle reciproche dipendenze di mercato.
Dobbiamo fare gli stati uniti d’Europa, dicono i saggi. Non sarà facile, ma così restando le cose con una direzione economica liberista senza una buona programmazione, è quasi certo che ci possiamo anche avviare verso il secondo suicidio dell’Europa e della sua tradizione culturale e sociale.
Mentre la storia del mondo, che è l’espressione dei nuovi capitalismi -dall’Asia all’America del Sud- mostra che in Africa si è sviluppato un nuovo potente colonialismo che ha messo in crisi quel principio di “autodeterminazione dei popoli” che fu l’ideologia un po’ ingenua del nostro anti-colonialismo. “Così va il mondo” diceva Hegel, ma sarebbe bene saperlo con chiarezza.
* Filosofo, vice-presidente della Casa della Cultura di Milano e presidente della Fondazione Corrente.
* FONTE: ODISSEA."Nessuna grande cultura può trovarsi in rapporto obliquo con la verità" (Robert Musil).
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" - di Federico La Sala.9 ottobre 2013, di Federico La Sala
La legge di Antigone e le colpe dell’Europa
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 09.10.2013)
INUTILE parlare di Europa madrepatria della democrazia, e proclamare nella sua Carta dei diritti che siamo «consapevoli del suo patrimonio spirituale e morale», dei suoi «valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà », quando tutto in noi pare spento: tutti i miti che fanno la nostra civiltà, assieme ai tabù che la sorreggono. E tra i primi forse il mito di Antigone, senza il quale non saremmo chi siamo. Oppure la solenne legge del mare, che obbliga a salvare il naufrago, quasi non esistesse peggiore sciagura delle acque che si chiudono mute sull’uomo. Il mare è senza generosità, scrive Conrad: inalterabile, impersona l’«irresponsabile coscienza del potere».
Sono uniti, i due miti, dalla convinzione che fu già di Sofocle: la norma superiore cui Antigone ubbidisce - fissata da dèi arcaici, precedenti gli abitanti dell’Olimpo - il re di Tebe non può violarla, accampando la convenienza politica e le proprie transeunti idee di stabilità. È norma insopprimibile, e Creonte che antepone il diritto del sovrano, ilnomos despòtes, paga un alto prezzo. Così la legge del mare.
Quando sfoggia vergogna, l’Europa suol cantilenare, come dopo Auschwitz, una sua frase inane ma contrita: «Mai più!» Inane perché contempla il passato, non il presente. Ma almeno è contrita. Oggi nemmeno questo: il «mai più» neanche è pronunciato, la violazione è attribuita a cieca fatalità e si esibisce impudica. Un ministro - si chiama Angelino Alfano, già ignorò il diritto d’asilo nell’affare kazako - sta sul bordo del mare e dice che i 232 morti sottratti alle acque di Lampedusa non saranno gli ultimi: «Non c’è ragione per pensare e per sperare che sarà l’ultima volta».
Colpisce il divieto di pensare, più ancora di quello di sperare. Neanche pensare possiamo, che l’Europa sia qualcosa di diverso da un fortilizio militarizzato. Che stiamo lì per difendere non solo un muro di cinta, ma gli esseri umani che disarmati provano a valicarlo. Per il ministro, ben altra è la questione amletica: dobbiamo sapere «se l’Europa intenda difendere la frontiera tracciata dal trattato di Schengen. Uno Stato che non protegge la sua frontiera semplicemente non è. L’Europa deve scegliere se essere o non essere».
Quattro considerazioni, a questo punto.
Primo: l’Europa è sì davanti a un bivio esistenziale, ma non quello che con porte bronzee nega l’idea stessa del bivio. Deve decidere se vuol essere all’altezza delle norme che professa, e che da tempi immemorabili le prescrivono di accogliere i fuggitivi, i supplicanti, oltre che di tutelare i confini da assalti stranieri. Né l’emigrazione economica clandestina né la fuga da guerre o dittature (spesso sono la stessa cosa) sono equiparabili a attacchi esterni. Vengono equiparati invece, e per questo è lecito parlare di guerra nel Mediterraneo. Il fuoriuscito stipato con i suoi nei barconi è trasformato in nemico. In homo sacer, come scrive Giorgio Agamben: vita nuda, soggetto non legale, bandito pur appartenendo agli Dèi: uccidibile. Entra in Europa e «vive in orbita», dice la lingua burocratica. La legge antichissima si spense, quando nel 2004 l’Unione creò Frontex (Agenzia che gestisce le frontiere esterne). Frontex coordina le misure di polizia, pattuglia coste, garantisce il rimpatrio dei clandestini. La protezione dei diritti umani è un obiettivo residuale, un ornamento.
Seconda considerazione: l’Europa ha sue responsabilità, ma l’Italia non ne ha di minori. Il reato di clandestinità, introdotto nel 2009 dal governo Berlusconi, definisce un crimine in sé l’esodo senza permessi anticipati. Di qui la parentela con la guerra: come se il clandestino fosse un combattente irregolare e specialmente insidioso, perché non combatte a viso scoperto, indossando l’uniforme, ma conduce una sorta di guerriglia che si confonde e confonde.
Ecco la legge di Tebe che si sovrappone alla norma di Antigone. La sicurezza e la stabilità- quest’ultima è addirittura eretta da Enrico Letta a «valore assoluto » , nuovo non negoziabile articolo di fede - esigono sacrifici e morte. Il migrante, bollato, è un pericolo sociale. La Corte Costituzionale s’oppose (sentenza n. 78/2007), escludendo che lo stato d’irregolarità siasintomo presuntivo di pericolosità sociale; ma il reato appena ritoccato (scompare la pena detentiva) resta. Fin dal 2002 la legge Bossi-Fini preparò il terreno: ingiungendo il respingimento immediato del migrante (poco importa se restituito o no alle dittature cui scampava) e rendendo impraticabili le procedure di concessione di asilo.
Di qui il pervertirsi della norma instaurata prima ancora che Cristo nascesse -Soccorrereè un dovere, non soccorrere è un reato - iscritta nella Convenzione di Ginevra sui rifugiati come nella Carta europea dei diritti fondamentali dell’Unione (art. 18). Non soccorrere è peccato di omissione, e più precisamente crimine di indifferenza. Che senso ha dire «mai più», se non vediamo che il delitto di clandestinità per forza incentiva l’omissione di soccorso. Chi aiuta il naufrago incorrerà in processi e pene per favoreggiamento del reato, e preferirà voltare lo sguardo altrove. È già successo. Nei paesi occupati dai nazisti, in Polonia ad esempio, chi tendeva la mano all’ebreo rischiava la morte.
Terza considerazione: parole come vergogna andrebbero abolite, nel lessico della politica. Nascono dall’emozione, dalla scossa introspettiva, non necessariamente osano l’aperto, l’agorà dove si disfano e si correggono le leggi positive. Dette dal Santo Padre hanno un senso, ma in politica conta l’azione, non l’emozionarsi e il compatire. Lo Stato sociale e la politica di asilo sono nati per sostituirsi alla carità, che è grandiosa e non si vanta e non si gonfia, ma è affidata al singolo o alla Chiesa.
Infine la quarta considerazione: le guerre da cui evadono i “migranti” il più delle volte ci vedono protagonisti. Le abbiamo attizzate noi, pretendendo di portare ordine e creando invece caos e Stati disfatti: in Africa orientale, Afghanistan, Iraq, Somalia e Eritrea, Siria. I confini siriani che scatenano conflitti, fu l’Europa coloniale a disegnarli. Gli esodi hanno a che vedere con noi.
Qualche tempo fa, in una trasmissione della radio tedesca (Südwestrundfunk, 26 giugno 2008, il titolo era:Guerra nel Mediterraneo), venne intervistato un alto dirigente della Guardia di Finanza italiana, Saverio Manozzi, arruolato nell’agenzia Frontex. Difficile dimenticare quello che ammise. Più che salvare, i guardiani delle mura erano chiamati alla caccia, alle retate: «Ho avuto a che fare con ordini secondo cui il respingimento consisteva nel salire a bordo dei barconi o delle navi, e nel portar via i viveri e il carburante affinché i transfughi non potessero continuare il viaggio, e facessero marcia indietro». Salvataggi e aiuti sono considerati un azzardo morale,perché fomentano sempre nuovi immigrati. Meglio dissuaderli con l’arma ultima: quasi 20.0000 affogati nel Mediterraneo, dal 1988. Si muore anche appesi ai fili spinati di Ceuta e Melilla, le due enclave spagnole sulle coste del Marocco. O nelle acque del fiume Evros, ai confini fra Turchia e Grecia. In Francia, respinti sono i Rom.
Di azzardo moralesi parla molto in questi anni di crisi. È l’assillo dei moderni Creonte. Gli Stati indebitati dell’Unione non vanno troppo aiutati: la solidarietà (welfare compreso) incita i viziosi a rammollirsi, a peccare ancora e ancora. Se assicuri la casa dal fuoco, non baderai più ai fiammiferi che accendi: ti rilasserai. La logica della polizza assicurativa si fonda sul sospetto, non sulla promessa e il dover-essere di Antigone. Se cadi disteso per terra o nel fondo marino qualche colpa ce l’avrai. Come dice Kafka: stramazzando susciterai ribrezzo, paura, perché dal tuo corpo emanerà il «puzzo della verità ».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- «Europa in trappola» (C. Offe). Berlino, gli intellettuali tacciono E intanto il ripiegamento tedesco rischia di fermare la Ue (di Giuseppe Sarcina)5 ottobre 2013, di Federico La Sala
Berlino, gli intellettuali tacciono
E intanto il ripiegamento tedesco rischia di fermare la Ue
di Giuseppe Sarcina (Corriere della Sera, 05.10.2013)
L’Europa è in trappola, sostiene Claus Offe, 73 anni, uno dei più importanti intellettuali tedeschi, politologo di ascendenze marxiste, già professore all’Università Humboldt di Berlino e oggi docente di sociologia politica nell’Università Hertie School of Governance, nella capitale tedesca.
L’affermazione perentoria («Europa in trappola») è anche il titolo del libro che uscirà in Italia a gennaio, per le edizioni del Mulino e con la presentazione dell’economista Michele Salvati. Dopo aver dominato le elezioni, Angela Merkel si prepara a cristallizzare lo status quo dell’Unione europea, senza intaccarne i limiti politici e gli squilibri economici.
La Germania oggi si sta richiudendo su se stessa con placida naturalezza in una sorta di pax merkeliana: inutile aspettarsi da Berlino la spinta necessaria per ripensare e rifondare l’Europa. Vigilanza, disciplina, manutenzione: questo è il massimo che può offrire ai partner comunitari il Paese più grande e più ricco. Offe ne ha parlato a lungo, ospite di un seminario organizzato dall’Associazione il Mulino, lunedì 23 settembre. Ne è uscito un dibattito in chiave minimalista, a tratti crepuscolare. L’orizzonte appare piatto. Gli antichi motori dell’integrazione, a cominciare dall’alleanza tra Francia e Germania, sono spenti.
L’analisi di Offe parte dal quadro socio-politico emerso nel voto di domenica 22 settembre. Le grandi forze del Paese, i cristiano democratici e, molto più in giù nella scala del consenso, i socialdemocratici, sono riuscite a neutralizzare le spinte eterodosse: la furia anti-euro dell’Alleanza per la Germania; le tentazioni stataliste della sinistra raccolta nella Linke. Ma sul piano propositivo non c’è nulla di nuovo. La coraggiosa epopea della riunificazione tedesca guidata dal conservatore Helmut Kohl (1989) e la stagione delle grandi riforme del Welfare promossa dal socialdemocratico Gerhard Schroeder (2003) sono come sparite in un denso grigiore, nel piccolo cabotaggio interno. Come se la Germania fosse semplicemente un’Olanda o una Finlandia più grande e non il Paese decisivo per il futuro dell’Europa.
Se le cose stanno così, l’Europa è in trappola perché la Germania è in trappola. Prigioniera di divisioni sociali che spaccano in modo trasversale gli schieramenti. Da una parte spezzoni della classe media sempre più inquieti, sempre più suggestionati da un irrealistico ritorno all’autarchia germanica, senza Grecia, senza Italia, senza conti da regolare per le indiscipline altrui. Sull’altro versante, in modo speculare, si fanno sentire larghe fasce di cittadini più svantaggiati: pretendono che neanche un euro vada disperso all’estero, quando milioni di tedeschi sono costretti ad accettare lavori part-time o precari (i cosiddetti mini-job a 400 euro al mese).
Il risultato, anche se in verità Offe non si è spinto fino a questo punto, è qualcosa che somiglia al Falso movimento, il film di Wim Wenders (1975). Uno scrittore tedesco viaggia in Europa, dal Mare del Nord fino alle Alpi per ritrovarsi alla fine con un senso di indifferenza, di vacuità nei confronti degli altri europei. Difficile aspettarsi qualcosa di più dal terzo governo di Angela Merkel. Ma, e su questo Offe è particolarmente severo, sarebbe illusorio attendersi almeno un sussulto anche dagli intellettuali, dalla cultura tedesca. Una «congiura del silenzio» copre le contraddizioni della Germania. Solo in via incidentale gli analisti spiegano che cosa sarebbe, per esempio, l’economia tedesca senza l’euro. Le esportazioni, il volano della crescita, si rivaluterebbero almeno del 20%; i tassi di interesse sui titoli del tesoro, oggi vicini allo zero, salirebbero inesorabilmente.
Poche idee, allora, anche sull’Europa. Eppure, argomenta Offe, la crisi finanziaria ha messo in chiaro che cosa servirebbe: eurozona più integrata; istituzioni più legittimate; crescita economica più sostenibile. Il politologo tedesco propone anche misure concrete. Qualcuna suggestiva: fissare un obiettivo minimo di redistribuzione del reddito per tutti i Paesi, prendendo come riferimento l’indice di Gini (l’indicatore che misura la disuguaglianza) dell’Olanda. Altre poco convincenti, come l’introduzione della progressività nella tassazione indiretta (Iva ed equivalenti), che con tutta probabilità avrebbe come effetto immediato un ulteriore calo dei consumi.
L’importante è convincere i tedeschi e tutti gli europei, a rimettersi in moto. C’è, però, un ulteriore problema. Offe chiama in causa Jurgen Habermas, il suo principale riferimento culturale. Oggi la politica, sostiene l’epigono della Scuola di Francoforte, più che dalla distinzione tra destra e sinistra, è dominata dalla separazione tra populismo e tecnocrazia. I populisti sono i più abili nella raccolta del consenso, ma non sono in grado di governare. I tecnocrati, invece, sono capaci di applicare le decisioni, ma senza l’appoggio dell’opinione pubblica. In Italia, esemplifica Offe, la linea divisoria corre tra Silvio Berlusconi e Mario Monti. In Europa tra le diverse anime dell’antieuropeismo e i funzionari di Bruxelles. E anche questo rende ancora più scomoda la trappola in cui, sembra, siamo caduti.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- FINISCA LA CECITA’, SI SALVINO LE VITE (di Peppe Sini)4 ottobre 2013, di Federico La Sala
FINISCA LA CECITA’, SI SALVINO LE VITE
di PEPPE SINI *
Come si fa a non vedere che prime responsabili del massacro dei migranti nel Mediterraneo sono le disumane politiche e le disumane normative razziste dell’Europa e dell’Italia?
Come si fa a non vedere che la vigente normativa europea ed italiana istituisce un vero e proprio regime di omicida apartheid planetario in danno della generalita’ dell’umanita’?
Come si fa a non vedere che sono le nostre mani ad essere di quel sangue innocente macchiate?
Questa cecita’, questa violenza assassina, questo razzismo istituzionale, non ci verranno perdonati dalle generazioni che verranno. Chiederanno di noi, come noi chiediamo dei complici del nazismo: come facevano a non vedere? come potevano essere complici, anche solo con la loro passivita’, di tanta vergogna e di tanto orrore?
*
C’e’ un modo semplice e definitivo per far cessare le stragi nel Mediterraneo: consentire finalmente a tutti gli esseri umani la libera circolazione sull’unico pianeta casa comune dell’umanita’ intera.
Consentire ai migranti di muoversi in modo legale e sicuro.
Dare attuazione al primo diritto umano che tutti gli altri fonda: il diritto a vivere.
Prendere sul serio la Costituzione della Repubblica Italiana che all’articolo 10, comma terzo, afferma che "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle liberta’ democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica".
Consentendo finalmente a tutti gli esseri umani la libera circolazione sull’unico pianeta casa comune dell’umanita’ intera, consentendo a tutti i migranti di muoversi in modo legale e sicuro, non solo si salverebbero innumerevoli vite, non solo si ripristinerebbe la vigenza del diritto, ma si annienterebbero anche in un sol colpo le mafie dei trafficanti e degli schiavisti.
*
Abolire gli accordi assassini di Schengen.
Abolire le misure persecutrici e razziste gia’ presenti nella legge Turco-Napolitano, poi aggravate nella infame antilegge Bossi-Fini, poi vieppiu’ aggravate nel cosiddetto "pacchetto sicurezza" hitleriano.
Abolire il nazismo in Italia e in Europa.
Riconoscere la dignita’ e i diritti di tutti gli esseri umani.
Riconoscere a tutti gli esseri umani il diritto di libera circolazione sull’unico pianeta casa comune dell’umanita’ intera.
Salvare le vite.
Vi e’ una sola umanita’.
* OGNI VITTIMA HA IL VOLTO DI ABELE
Numero 32 del 4 ottobre 2013
Supplemento de "La nonviolenza e’ in cammino" (anno XIV)
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac@tin.it, centropacevt@gmail.com, web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- L’Europa che ci manca (di Andrea Riccardi)4 ottobre 2013, di Federico La Sala
L’Europa che ci manca
di Andrea Riccardi (l’Unità, 4 ottobre 2013)
Quando accadono simili tragedie del mare, purtroppo tutt’altro che infrequenti nel Mediterraneo, la prima reazione del mondo politico - quasi un riflesso condizionato - è quello di rivolgere gli occhi verso Bruxelles.
Come per dire: l’Europa deve farsi carico del problema, le istituzioni dell’Unione devono fare di più. È una considerazione giusta, se si vuole persino ovvia. Ma rischiano di essere ancora parole vuote, se alla fase della commozione e del cordoglio, non seguono atti di buona e lungimirante politica.
Bisogna essere realistici, anche a costo di essere crudi: oggi non esiste, né forse è mai esistita, una politica europea dell’immigrazione perché non esiste una politica estera europea, men che meno una politica per il Mediterraneo.
È un problema, in un’Europa più volentieri proiettata verso l’Atlantico o l’Oriente, di lontananza geografica e culturale di Bruxelles dalle coste del Mediterraneo? Forse. Ma, in questo caso, ci sarebbe comunque da chiedersi perché i Paesi del Sud dell’Europa - i governi di Italia, Francia, Spagna, Grecia, Malta, Cipro - non sono stati mai in grado di fare fronte comune e spiegare ai loro «nordici partner» quale è la reale posta in gioco.
L’immigrazione - è un’altra questione nodale - è stata sempre gestita secondo l’ottica emergenziale e della sicurezza, lasciando i singoli Stati a sbrogliarsela con gli sbarchi, i campi di accoglienza, i salvataggi umanitari e il varo di leggi repressive più o meno efficaci. Intendiamoci, i pattugliamenti delle coste, gli accordi bilaterali con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, una attenta azione di contrasto alla tratta di uomini sono misure importanti che vanno potenziate. Ma è pur vero che nessun recinto, nessuna gabbia, per quanto solidi, possono imprigionare un fenomeno epocale come quello delle migrazioni di massa. L’ottica ristretta e provinciale -e se ne sono avute eco anche nel dibattito politico di ieri in Italia - non produce alcun risultato apprezzabile di fronte a problemi globalizzati.
Entra qui in ballo l’altra faccia della questione immigrazione: la cooperazione internazionale. I fenomeni migratori dall’Africa sono generati da guerre, conflitti, persecuzioni, dalla povertà. In una parola, dalla mancanza di futuro. È davvero così irrealistico sostenere un più diretto e efficace intervento dell’Ue in Africa e nel Medioriente a sostegno della fragile economia locale, dei processi di democratizzazione, della lotta agli estremismi e alle carestie? E non sembra invece più logico tentare di impedire gli incendi, piuttosto che prodigarsi, a rischio di ulteriori vite umane e con spese maggiori, per spegnerli?
La cooperazione internazionale, in Italia, è ridotta da tempo al lumicino. In Europa va un po’ meglio, ma non è ancora una delle colonne portanti della politica estera. Da ministro dell’Integrazione e della Cooperazione internazionale mi sono recato a Lampedusa e poi a Bruxelles.
Non solo per portare dei fiori sulle tombe senza nome dei tanti morti affogati o la solidarietà del governo a una popolazione generosa e stremata. Ma perché Lampedusa non deve restare un lembo dimenticato dell’estrema periferia italiana, ma deve diventare l’avamposto dell’Europa libera, civile e accogliente nel Mediterraneo, con un centro di avanguardia nell’accoglienza dei profughi, gestito direttamente dall’Ue, con la collaborazione degli Stati e aiuti europei per la popolazione isolana.
Sarebbe un segno tangibile di una consapevolezza e di una responsabilità nuove. Le stesse a cui ha voluto richiamarci profeticamente Papa Francesco nel suo viaggio a Lampedusa. Che è qualcosa di più di un monito. Ma una prospettiva e una visione.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Democrazia o capitalismo? Solidarietà, unione e diritti ecco come l’Europa può salvarsi (di Jürgen Habermas)4 settembre 2013, di Federico La Sala
 Democrazia o capitalismo?
Democrazia o capitalismo?
 Solidarietà, unione e diritti ecco come l’Europa può salvarsi
Solidarietà, unione e diritti ecco come l’Europa può salvarsi
 Un saggio contro le tesi nazionaliste e isolazioniste che si affermano in Germania
Un saggio contro le tesi nazionaliste e isolazioniste che si affermano in Germania
 I partiti di sinistra si sono mostrati troppo timorosi e succubi davanti agli argomenti populisti della destra
I partiti di sinistra si sono mostrati troppo timorosi e succubi davanti agli argomenti populisti della destra di Jürgen Habermas (la Repubblica, 04.09.2013)
di Jürgen Habermas (la Repubblica, 04.09.2013)- ANTICIPIAMO qui parte di un saggio di Jürgen Habermas che appare in versione integrale su Reset.it e rappresenta l’aprirsi di una Europa- Streit, di una polemica sull’Unione europea. Il filosofo tedesco accusa la sinistra di essersi fermata su posizioni “nostalgiche” e di ripetere l’errore nazionalista dell’inizio del XX secolo, che aprì la strada alla Prima guerra mondiale. L’attacco di Habermas prende di mira un libro del sociologo Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit, (Tempo comprato), Suhrkamp. Questi ha sostenuto, in una conferenza l’anno scorso e quest’anno nel libro, che l’Unione europea s’identifica oggi come l’epicentro del radicalismo neoliberale e che gli euro-idealisti di sinistra sono caduti vittime di un abbaglio, dando via libera alla costruzione di un edificio mostruoso. Queste tesi per Habermas riflettono un errore che nasce dalla timidezza della sinistra nei confronti delle tendenze populiste della destra e del centro. A chi lamenta l’assenza sulla scena pubblica tedesca di un dibattito aperto sull’Europa, Die Zeit fa notare in questi giorni che è assente solo dalle grandi tribune pubbliche di Stato e di partito. Su riviste e giornali la discussione divampa e non c’è dubbio che avrà un seguito.
Nella comunità monetaria europea è possibile osservare come i mercati limitino in forma perversa la capacità d’iniziativa politica degli Stati. Qui la trasformazione della Stato fiscale in Stato debitore costituisce lo sfondo del circolo vizioso tra il salvataggio di banche decotte da parte degli Stati i quali a loro volta sono spinti alla rovina da quelle stesse banche, con il risultato che il regime finanziario dominante mette sotto curatela le proprie popolazioni. Che cosa ciò significhi per la democrazia lo abbiamo potuto osservare al microscopio in quella notte del vertice di Cannes quando il premier greco Papandreu, fra le pacche sulle spalle date dai suoi colleghi, fu costretto a ritirare un referendum che aveva appena annunciato. Wolfgang Streeck ha il merito di aver dimostrato che la “politica dello Stato debitore”, che il Consiglio europeo porta avanti dal 2008 su pressione del governo tedesco, nella sostanza continua a seguire il modello politico favorevole al capitale che ha condotto alla crisi.
Wolfgang Streeck non propone di completare la costruzione europea, bensì di smontarla; vuole tornare nelle fortezze nazionali degli anni Sessanta e Settanta, al fine di «difendere e riparare per quanto possibile i resti di quelle istituzioni politiche grazie alle quali forse si potrebbe modificare e sostituire la giustizia del mercato con la giustizia sociale». Questa opzione di nostalgica chiusura a riccio nella sovrana impotenza di nazioni ormai travolte è sorprendente, se si considerano le trasformazioni epocali degli Stati nazionali che prima avevano i mercati territoriali ancora sotto controllo e oggi invece sono ridotti al ruolo di attori depotenziati inseriti a loro volta nei mercati globalizzati.(...) Evidentemente la capacità di intervento politico di Stati nazionali vigili custodi di una sovranità ormai da tempo svuotata non è sufficiente per sottrarsi agli imperativi di un settore bancario ipertrofico e disfunzionale.
Gli Stati che non si associano in unità sopranazionali e dispongono solo dello strumento dei trattati internazionali falliscono di fronte alla sfida politica di rimettere questo settore in sintonia con i bisogni dell’economia reale e di ricondurlo a dimensioni funzionali adeguate. In particolare sono gli Stati della comunità monetaria europea a vedersi sfidati dal compito di ricondurre mercati irreversibilmente globalizzati nel raggio d’azione di un intervento politico indiretto ma mirato. Nei fatti la loro politica anticrisi si limita al rafforzamento di una esperto-crazia per misure che rinviano i problemi. Senza la spinta di una vitale formazione della volontà da parte di una società di cittadini mobilitabile al di là dei confini nazionali, all’esecutivo di Bruxelles resosi ormai autoreferenziale manca la forza e l’interesse a regolare in forme socialmente sostenibili mercati ormai abbandonati ai loro spiriti animali.
Wolfgang Streeck condivide l’assunto che la sostanza egalitaria dello Stato di diritto democratico sia realizzabile solo sulla base dell’appartenenza nazionale, e quindi solo entro i confini territoriali di uno Stato nazionale unitario, perché altrimenti sarebbe inevitabile la marginalizzazione delle culture minoritarie. Anche prescindendo dall’ampia discussione sui diritti culturali, questo assunto, considerato da una prospettiva di lungo termine, è arbitrario. Già gli Stati nazionali si basano sulla forma altamente artificiale di una solidarietà tra estranei generata dal costrutto giuridico dello status di cittadino. Anche in società omogenee sul piano etnico e linguistico la coscienza nazionale non ha nulla di naturale. È piuttosto un prodotto, valorizzato sul piano amministrativo, della storiografia, della stampa e del servizio di leva. (...)
Wolfgan Streeck teme i tratti giacobini di una democrazia sovranazionale poiché questa, sulla via di una permanente marginalizzazione delle minoranze, non potrebbe che condurre a un livellamento delle comunità economiche e identitarie basate sulla vicinanza spaziale. In tal modo, però, egli sottovaluta la fantasia innovatrice e creatrice di diritto che si è già manifestata nelle attuali istituzioni e nelle regole vigenti. Penso all’ingegnosa procedura decisionale della “doppia maggioranza” o alla composizione ponderata del parlamento europeo, che proprio in vista di un’equa rappresentazione tiene conto delle forti differenze numeriche tra le popolazioni dei paesi più piccoli e dei più grandi.(...)
Lo Stato federale è il modello sbagliato. Infatti le condizioni di legittimazione democratica possono essere soddisfatte anche da una comunità democratica sovranazionale ma sovrastatale che consenta un governo comune. In essa tutte le decisioni politiche sarebbero legittimate dai cittadini nel loro doppio ruolo di cittadini europei e di cittadini dei vari Stati membri. In una siffatta unione politica, chiaramente distinta da un “superstato”, gli Stati membri, in quanto garanti del livello da essi rappresentato di diritti e di libertà, conserverebbero un ruolo molto importante se paragonati alle articolazioni subnazionali di uno Stato federale.
Il blocco può essere forzato se i partiti europeisti si trovano insieme al di là dei confini nazionali per lanciare campagne contro questa falsa trasposizione di problemi sociali in problemi nazionali. La tesi che «nell’Europa occidentale di oggi il nazionalismo non è più il maggior pericolo, e meno che mai quello tedesco » la considero politicamente una stoltezza. Che in tutte le nostre sfere pubbliche nazionali manchino scontri di opinione su alternative politiche poste correttamente posso spiegarmelo solo con i timori dei partiti democratici nei confronti dei potenziali politici di destra. Le controversie polarizzanti sulla politica dell’Europa possono essere chiarificatrici piuttosto che sobillatrici solo se tutte le parti in causa ammettono che non ci sono alternative prive di rischi e nemmeno alternative gratuite. Invece di aprire falsi fronti lungo i confini nazionali sarebbe compito di questi partiti distinguere perdenti e vincenti della crisi per gruppi sociali che, indipendentemente dalla loro nazionalità, risultano di volta in volta più o meno colpiti.
I partiti europei di sinistra sono in procinto di ripetere i loro errori storici del 1914. Anche oggi essi indietreggiano per paura della propensione al populismo di destra presente nel centro della società. Poi in Germania un panorama mediatico incredibilmente succube alla Merkel incoraggia tutte le parti in causa a non toccare in campagna elettorale i fili elettrici della politica europea, e a stare al suo gioco furbesco della non tematizzazione. Per questo c’è da augurarsi che “Alternative für Deutschland”(il nuovo partito liberale ed euroscettico, ndr.) abbia successo. Spero che essa riesca a costringere gli altri partiti a spogliarsi della tuta mimetica che rende invisibile la loro politica europea. Così dopo le elezioni politiche tedesche si potrebbe profilare, per il prossimo necessario primo passo, una “grandissima” coalizione. Infatti, per come stanno le cose, solo la Germania può assumersi l’iniziativa diun’impresa tanto difficile.
 (Traduzione di Walter Privitera)
(Traduzione di Walter Privitera) -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- Europa sull’orlo del collasso. Intervista a Ulrich Beck (di Benedetto Vecchi)3 settembre 2013, di Federico La Sala
Ulrich Beck: Europa sull’orlo del collasso
di Benedetto Vecchi (il manifesto, 29 Agosto 2013)
L’Europa parla sempre più tedesco. È il commento che, come un virus, si è diffuso nel vecchio continente. Attesta l’indubbia egemonia di Berlino nel definire le politiche dell’Unione Europea. A questo tema lo studioso tedesco Ulrich Beck ha dedicato un saggio - Europa tedesca, Laterza. Ne ha scritto su queste pagine Marco Bascetta il 31 maggio -, nel quale analizza la politica portata avanti da Angela Merkel. Beck non esita a criticarla e a mettere in evidenza il doppio regime seguito da Berlino: neoliberista in Europa, moderatamente in difesa del modello renano in casa.
Ma la sua riflessione si concentra anche sul fatto che la crisi economica ha accelerato la formazione di movimenti sociali che si muovono certamente sul piano locale, nazionale, ma all’interno di una cornice globale. O come preferisce qualificarla: cosmopolita. Da qui la consapevolezza di una crescente «provincializzazione» del Vecchio Continente all’interno di una geografia del potere mondiale che vede ormai protagonisti paesi come l’India, la Cina, il Brasile. Allo stesso tempo individua nei movimenti sociali l’unico antidoto possibile per le forme di nazionalismo che carsicamente ritorna ad occupare la scena nei paesi europei.
Ulrich Beck non è nuovo nell’analisi di come la «società del rischio» - espressione da lui coniata nel tramonto del Novecento - imponga di fare i conti con l’interdipendenza del capitalismo mondiale e con le ambivalenze dei fenomeni sociali emergenti nel capitalismo neoliberista. Esercita un cauto ottimismo della ragione e della volontà, proprio a partire da quei movimenti sociali che ormai sono diventati una costante nell’agenda politica globale. Sia ben chiaro, il teorico tedesco non propone nessun superamento del capitalismo. Il suo punto di vista è semmai da inscrivere nei tentativi di innovazione del modello sociale che si è soliti definire come il capitalismo del welfare state. Ma esprime posizioni che lo rendono un «compagno di strada» per chi invece opera per un superamento dell’attuale regime di accumulazione capitalista. Sapendo però che per superarlo non c’è spazio per un ritorno nostalgico allo Stato-nazione, considerato a sinistra come l’ultima linea di resistenza al capitalismo glocale. L’intervista affronta i temi che il teorico tedesco proporrà il primo settembre, in qualità di ospite al Festival della mente di Sarzana.
Nel suo ultimo libro - «Europa tedesca», Laterza - lei concentra la sua analisi sull’egemonia tedesca nel definire la politica economica e sociale dell’Unione Europea. Tuttavia, in Germania, il welfare state - e i corrispondenti diritti sociali - è un modello sociale e politico che, seppur modificato nel corso degli anni Ottanta e Novanta, continua a essere un punto fermo dell’agenda politica. Questo è però in contraddizione con la cornice neoliberista che racchiude invece le politiche economiche europee. Come spiega questa contraddizione?
«La politica di Angela Merkel è piena di contraddizioni. Sul piano europeo, vuol imporre un’agenda politica neoliberale ai paesi mediterranei e alla Francia. Sul piano nazionale attua, invece, una politica moderatamente socialdemocratica. Un caso esemplare di questo doppio regime viene dalla difesa del settore dell’acciaio tedesco: un protezionismo che tende a difendere i livelli occupazionali che è in contraddizione con il credo del libero mercato che plasma invece le politiche economiche degli altri paesi. Potremmo affermare che l’ortodossia neoliberale vale come principio regolatore, ma che può conoscere deroghe a livello domestico. Un’altra contraddizione: Angela Merkel persegue una strategia che delega alla Banca centrale europea la gestione della crisi economica che ha colpito molti paesi del vecchio continente. Questo non significa tuttavia che la Germania sia insensibile al destino dell’Europa. La sua vocazione europea emerge proprio dal tentativo di condizionare la politica dell’Ue affinché non accada quel big bang del Vecchio Continente che molti analisti hanno visto profilarsi all’orizzonte»
In Europa assistiamo, però, a una crisi del processo di unificazione politica che coincide con la cosiddetta crisi del debito sovrano. E questo avviene proprio quando sono pochi gli studiosi o i leader politici che mettono in discussione l’ortodossia neoliberale.... «C’è una significativa distanza tra la visione dell’Europa delle élite continentali e la percezione che ne hanno i popoli europei. La stragrande maggioranza dei governi del Vecchio Continente impone politiche di austerità in nome degli imperativi del mercato che hanno nell’Unione europea un solerte guardiano. Spesso la retorica dominante afferma che non «c’è alternativa» a quegli imperativi. I popoli europei vedono così svanire ogni possibilità di poter influire, condizionare le politiche stabilite in nome del libero mercato».
L’austerità è quindi vista come un marchingegno che li rende ostaggio e sudditi di qualcosa di lontano dalla loro vita. La distanza che emerge da quanto impongono le élite e i bisogni dei popoli spiega ad esempio la genesi di molti movimenti sociali di protesta in Europa, Nordafrica, ma anche, come è accaduto recentemente, in Turchia. È una distanza che non va sottovalutata, perché potrebbe portare alla morte del processo di unificazione politico dell’Europa. Recentemente, il filosofo francese Etienne Balibar ha sostenuto che in Europa il potere politico ha imposto una «rivoluzione dall’alto» per trovare una via d’uscita neoliberale dalla crisi del neoliberismo. Balibar si riferiva all’esperienza dei governi tecnici, come in Italia, o al commissariamento di alcuni governi dell’Europa mediterranea, come in Grecia. Stiamo dunque assistendo a prove tecniche di una rivoluzione dall’alto?
«Non sono sicuro di essere d’accordo con questa analisi. Sono invece interessato a capire come il sotterraneo nazionalismo che vediamo manifestarsi carsicamente possa mettere in discussione l’Unione Europea. Sono cioè convinto che il nazionalismo sia il nemico non tanto dell’Europa, bensì degli interessi dei paesi europei. La difesa degli interessi dell’Italia, ad esempio, può rafforzarsi solo in un ambito europeo e non in una politica nazionalista. E questo vale per tutti i paesi europei, non solo per il vostro paese. Per me, sovranità significa esercitare un potere all’interno di una cornice sovranazionale. E quel potere, in Europa, lo puoi esercitare solo se accetti lo spazio europeo come il miglior contesto nel quale far valere le tue ragioni nazionali per quanto riguarda le politiche ambientali, l’immigrazione, la disoccupazione.
Vorrei insistere sulle forme politiche che si stanno sviluppando durante la crisi del debito sovrano. Abbiamo visto prima profilarsi il governo dei tecnici, il commissariamento di alcuni paesi. Ora assistiamo a governi di grande coalizione, come quello italiano delle larghe intese. Dal 2008 in poi abbiamo anche notato il manifestarsi di movimenti sociali che hanno espresso una critica e una opposizione alle politiche di austerità. Abbiamo osservato movimenti di difesa dei cosiddetti beni comuni, movimenti per interventi contro una disoccupazione e una precarietà sempre più diffusi. Cosa ne pensa di una visione politica che crede nell’Europa, ma che è contro l’Unione europea?
«Da tempo, ho sviluppato una prospettiva cosmopolita che considera l’Europa solo come componente del pianeta Terra. Tuttavia, noi europei siamo chiamati a costruirla. L’obiettivo è realizzarla dal basso e non dall’alto, come invece è accaduto finora. Dobbiamo cioè costruire una società europea che contrasti e affronti i rischi di un capitalismo che, se lasciato a se stesso, corrode il legame sociale e mette a repentaglio le misure di protezione, pazientemente costruite in passato. Le politiche di austerità sono state presentate come misure necessarie per fronteggiare la crisi finanziaria, ma alimentano diseguaglianze sociale, favoriscono il salvataggio delle banche responsabili di quella stessa crisi finanziaria che legittima le politiche di austerità.
Molti uomini e donne vedono nell’austerità un vero e proprio mostro che divora le loro vite. Di fronte a questa situazione, assume nuova centralità l’antico termine «comunità». Al cospetto del dominio dell’individuo senza legami e responsabilità verso gli altri, la solidarietà che si intravede dietro il richiamo alla comunità ha un forte potere attrattivo. Rispetto alla sua domanda, potrei dire che abbiamo bisogno di maggiore sicurezza sociale e dunque di più Europa, perché è il contesto politico che la può favorire.
Nella società del rischio, il possibile collasso dell’economia può essere vista come un’opportunità per trasformare la realtà. Recentemente, tuttavia, molti opinion makers parlano di una possibile apocalisse del capitalismo. Le cosa pensa di questa «profezia»?
«Non sono d’accordo con loro. E la realtà comunque non è così semplice così come la descrivono. Dobbiamo invece fare i conti con la complessità e l’ambivalenza della società del rischio. Quando ho cominciato a parlarne, mi sono concentrato sull’interdipendenza di alcuni fenomeni. E sulla loro ambivalenza. Successivamente, ho posto al centro della mia riflessione, il cosmopolitismo, che è una visione della realtà pregna di speranza nel poter cambiare la realtà.
Il cosmopolitismo politico basato su una società civile globale può prevenire gli effetti collaterali - il cambiamento climato, le migrazioni, le diseguaglianze sociali - insiti nello sviluppo capitalistico. Il cambiamento climatico, ad esempio, impone come realistico il motto «cooperare o morire». In questo caso, il cosmopolitismo è un antidoto alla guerra e una via per superare il modello neoliberista e trovare nuove forme di responsabilità sovranazionali. Allo stesso tempo rafforzerebbe le richieste di maggiore di giustizia sociale e eguaglianza avanzate dai paesi «poveri». In altri termini, una visione apocalittica della crisi del capitalismo rafforza il modello neoliberista, lo blinda rispetto le possibilità di trasformarlo».
Impero, neoimperialismo, governo multilivello: sono queste le forme politiche usate per dipingere la globalizzazione. Ma corrono il rischio di fornire una rappresentazione statica del potere mondiale. Ci sono paesi - l’India, la Cina, il Brasile, la stessa Russia - che mettono in discussione gli assetti di potere globale. Qual è secondo lei la nuova geografia del potere che sta emergendo?
«Parto dal presupposto che dobbiamo guardare all’Europa con gli occhi degli altri per avere chiara la prospettiva di ciò che è accaduto e che accadrà. Non c’è stato solo uno spostamento del potere a favore di alcuni paesi postcoloniali (fattore che si riflette nella partecipazione di alcuni di loro ai summit del G-20). Abbiamo infatti assistito a uno spostamento del centro di gravità del potere economico dall’Atlantico al Pacifico. E, cosa meno prevedibile, è la perdita del monopolio del dollaro negli affari. Le riserve federali non costituiscono più l’alfa e l’omega degli scambi commerciali perché si stanno sviluppando forme bilaterali di scambi economici che fanno leva su valute diverse da quella statunitense.
«Sono tutti fenomeni che hanno il loro centro nei rapporti di cooperazione economica tra paesi nel Sud del mondo o tra quelli del Sud e dell’Est del pianeta. Questo significa che l’asso tra Europa e Stati Uniti sta perdendo non solo importanza economica, ma anche «morale». Il risultato è che il modello occidentale delle relazioni tra centro e periferia è al collasso. La novità è che i paesi, un tempo sottoposti al potere coloniale dell’Europa, svolgono oggi un ruolo sempre più egemonico nel Vecchio Continente. L’India è ormai una potenza economica; la Cina ha investito miliardi di euro in Grecia, costituendo per il paese ellenico una alternativa credibile all’Europa. E Pechino sta investendo molto anche in Spagna. La geografia del potere è dunque molto mutata e presenta un pianeta che non potrà mai più avere il suo centro di gravità nell’Occidente».
In un suo libro, dedicato al lavoro nella globalizzazione, lei ha sostenuto che il reddito di cittadinanza è la soluzione alla precarietà e alla disoccupazione strutturale nel capitalismo. Ha anche sostenuto che il lavoro ha perso la sua centralità nella vita sociale. Eppure la disoccupazione e la precarietà sono l’inferno dentro il quale si trovano a vivere milioni di uomini e donne in Europa. Come spiega questo paradosso costituito dalla crisi dell’etica del lavoro con la disoccupazione e la precarietà?
«Molti dei paesi europei guardano con ammirazione il miracolo tedesco della piena occupazione. Ma chiudono gli occhi che più della metà degli occupati tedeschi sono precari. In Germania, infatti, si parla di mini-jobs, di lavoro in affitto. Non è soltanto il lavoro ad essere in crisi, bensì il suo significato stesso. Nel cuore dell’Europa stiamo assistendo a un ridisegno del mercato del lavoro, con le caratteristiche che ricordano il lavoro e l’economia informale di molti paesi nel Sud del pianeta.
«Nel libro a cui fa riferimento scrivevo di una «brasilianizzazione» del mercato del lavoro. Era certo una descrizione approssimativa, ma quello che è certo è che il vecchio arsenale delle politiche del lavoro è insufficiente, se non inutile. L’ideologia del libero mercato e le politiche conseguenti hanno distrutto l’insieme delle sicurezze sociali costruite nel secolo scorso. E rischia di distruggere anche la democrazia. È questa la vera questione sociale e politica con cui fare i conti».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- “Salvataggio” della Grecia: il 77 percento dei soldi sono finiti nel settore finanziario (ATTAC Austria - Comunicato stampa)11 luglio 2013, di Federico La Sala
ATTAC Austria - Comunicato stampa del 17 giugno 2013
[Attac è un movimento internazionale impegnato per una organizzazione democratica e socialmente equa dell’economia mondiale; per l’Italia vedi: http://www.italia.attac.org/spip/]
 “Salvataggio” della Grecia: il 77 percento dei soldi sono finiti nel settore finanziario
“Salvataggio” della Grecia: il 77 percento dei soldi sono finiti nel settore finanziario
 La ricerca effettuata da Attac lo dimostra: la politica di crisi dell’Unione Europea salva le banche, non la popolazione
La ricerca effettuata da Attac lo dimostra: la politica di crisi dell’Unione Europea salva le banche, non la popolazione(traduzione dal tedesco di José F. Padova)
http://www.attac.at/news/detailansicht/datum/2013/06/17/griechenland-rettung.html
Dal marzo 2010 l’Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale (FMI) hanno impiegato 206,9 miliardi di euro in 23 tranche per il cosiddetto “Salvataggio della Grecia”. I dirigenti responsabili non documentano tuttavia quasi per nulla a quale scopo in dettaglio è stato usato questo grande importo di denaro pubblico. Perciò Attac ha effettuato ulteriori ricerche: per lo meno il 77 percento dei denari destinati all’aiuto sono finiti direttamente o indirettamente al settore finanziario.
I risultati in dettaglio
58,2 miliardi (28,1%) sono stati usati per la ricapitalizzazione delle banche greche - invece che per ristrutturare questo settore ampiamente sfibrato e per rendere responsabili i proprietari delle banche per le perdite da loro causate. 101,3 miliardi (49%) sono andati nelle tasche dei creditori dello Stato greco. Di questi 55,4 miliardi sono stati impiegati per rimborsare i prestiti statali in scadenza - invece di farne pagare il rischio ai creditori, che da questi prestiti avevano incassato lauti interessi. Ulteriori 34,6 sono serviti ad attirare creditori per la rata di debito del marzo 2012. In dicembre 2012 sono stati destinati 11,29 miliardi per un riscatto del debito pubblico, per il quale lo Stato greco acquistò dai suoi creditori obbligazioni pressoché prive di valore. 46,6 miliardi (22,5%) sono rifluiti nel bilancio dello Stato greco o non trovarono destinazione univoca. 0,9 miliardi (0,4%) sono andati quale quota greca nel nuovo Meccanismo Europeo di Stabilità ESM.
Un’elencazione precisa e dettagliata delle tranche, del loro impiego e delle fonti si trova in: http://www.attac.at/uploads/media/hintergrundmaterial_bailout_deutsch.pdf. [ndt.: non lo traduco, ma basta dare una scorsa per capire il meccanismo]
“Lo scopo delle élite politiche non è la salvezza del popolo greco, ma quella del settore finanziario”, così riassume i risultati Lisa Mittendrein di Attac: “Esse hanno impiegato centinaia di miliardi di denaro pubblico per mettere in salvo banche e altri enti finanziari, e soprattutto i loro proprietari, dalle conseguenze della crisi finanziaria da loro stessi provocata.
La politica definisce falsamente i “pacchetti di salvataggio”
Quanto precede contraddice la posizione, ampiamente diffusa e pubblicamente sostenuta dai politici europei, secondo la quale in Grecia il denaro dei cosiddetti “pacchetti di salvataggio” sono andati a beneficio delle persone. La popolazione greca deve invece pagare il salvataggio di banche e simili con una brutale politica di tagli, che ha ben note e catastrofiche conseguenze sociali.
Pratiche opache con il denaro pubblico
“I risultati delle nostre ricerche fanno luce sul fatto che dal 2008 il fine principale della politica di crisi consiste nel proteggere i patrimoni dei più ricchi. La politica ammette disoccupazione, povertà e miseria enormi - per salvare un settore finanziario che salvabile non è. Anche il governo austriaco da anni condivide questo andazzo, spregiatore del genere umano”, così Mittendrein completa il quadro. Sotto l’aspetto democratico è inoltre preoccupante che i responsabili della Troika [ndt.: il solito micidiale terzetto composto da Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale] e del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria non documentino affatto quello che fanno con i fondi pubblici. “È uno scandalo che la Commissione europea pubblichi centinaia di pagine di rapporti, ma da nessuna parte renda conto per quali scopi il denaro è stato concretamente usato. Essi sono obbligati a curare la massima trasparenza e a documentare chi effettivamente approfitta dei pagamenti”.
Traggono profitto miliardari e fondi d’investimento
Fra quelli effettivamente messi al sicuro si conta anche la famiglia di miliardari Latsis, una delle più facoltose famiglie greche, che possiede grandi quote del fondo statale «salvato» Eurobank Ergasias. Hanno approfittato anche gli speculatori: lo Hedgefond Third Point, nel corso del riscatto del debito di dicembre 2012 effettuato mediante impiego di denaro pubblico, ha incassato una plusvalenza di circa 500 milioni. “Quando il presidente della Commissione Barroso dice che il cosiddetto salvataggio della Grecia è un atto di solidarietà, sorge una domanda: solidarietà con chi?”, commenta Mitteldrein.
Altri 34,6 miliardi per il pagamento degli interessi
Del cosiddetto “pacchetto di salvataggio” 46,6 miliardi (22,5%) sono finiti nel bilancio statale greco. Tuttavia a fronte di questo importo vi sono nello stesso lasso di tempo ulteriori voci di spesa che non vanno a vantaggio della massa della popolazione. Più di 34,6 miliardi sono usciti dal bilancio dello Stato a favore dei creditori come interessi per obbligazioni statali in corso (dal 2° trimestre 2010 fino al 4° del 2012). Oltre a ciò lo Stato ha impiegato per spese di difesa militare altri 10,2 miliardi soltanto nei primi anni della crisi (2010 e 2011). Secondo informazioni dall’interno i governi di Berlino e Parigi hanno esercitato pressioni sulla Grecia perché non tagliasse le spese militari, altrimenti ne sarebbero stati danneggiati i gruppi industriali tedeschi e francesi degli armamenti.
Non è il primo salvataggio delle banche
Non si deve dimenticare che dal 2008 le banche in Europa hanno già ricevuto 670 miliardi come diretti aiuti statali (senza dare garanzie). Tuttavia il settore finanziario della Grecia - come anche dell’intera Europa - resta ancora instabile. Lo dimostra non per ultimo il recente pagamento di due tranche per la ricapitalizzazione delle banche dell’ammontare di 23,2 miliardi di euro del dicembre 2012.
La politica trascura la necessaria regolamentazione...
La quota di debito verso lo Stato greco ha colpito le banche locali tanto fortemente che lo Stato stesso ha dovuto nuovamente indebitarsi per salvarle a colpi di miliardi. “La politica europea ha trascurato, nei cinque anni dall’inizio del crack finanziario, di regolamentare i mercati finanziari e di emanare una legge sull’insolvenza delle banche. Così in ogni caso di perdite devono intervenire nuovamente i contribuenti, mentre i proprietari [azionisti] delle banche ne escono senza danni. I governi devono finalmente smettere di accordare al settore finanziario queste possibilità di ricatto”.
... e salva il corrotto sistema bancario greco
A questo si aggiunge, aggravandolo, il fatto che ulteriori miliardi fluiscono nelle casse delle banche greche nonostante alcune di esse adempiano le condizioni ufficiali stabilite in modi e misure dubbiosi. Un rapporto della Reuters del 2012 scoprì le pratiche scandalose con le quali le banche greche si procuravano reciprocamente crediti non garantiti mediante un sistema piramidale con imprese off-shore, per pura apparenza, allo scopo di avere ancora accesso al capitale privato e porre così le premesse per una ricapitalizzazione a spese dello Stato. “La politica europea e greca, mentre pretende dalla gran parte della popolazione sangue, sudore e lacrime, chiude gli occhi sugli affari segreti degli oligarchi finanziari, che sono i veri approfittatori del denaro per il salvataggio”, conferma Marica Frangakis, economista presso l’Istituto ateniese Nicos Poulantzas e membro fondatore di Attac Hellas.
Altri strani dettagli
La ricerca di Attac ha portato alla luce anche altri strani dettagli del cosiddetto “salvataggio greco”. L’Europa e il FMI hanno più volte smentito i loro stessi annunci e hanno trattenuto per settimane e per mesi le tranche di pagamenti promesse, per fare pressione sulla democrazia greca: nell’autunno del 2011, per impedire un referendum sulla politica dell’austerità, e in maggio/giugno 2012, per aumentare le chance di vittoria dei partiti amici della Troika alle elezioni parlamentari. Trattenendo il denaro promesso la Troika costringe il governo greco a emettere titoli di debito a breve termine, per evitare l’incombente bancarotta dello Stato. Poiché questi “Buoni del Tesoro”, della durata di poche settimane o mesi, rendono tassi d’interesse elevati, fanno aumentare il debito pubblico greco ma anche i guadagni dei creditori. È questa una ulteriore prova che il fine principale della Troika non è la riduzione del debito pubblico, ma primariamente un pretesto per accelerare la distruzione dello Stato sociale e dei diritti di lavoratori e lavoratrici.
Una tranche dell’entità di 1 miliardo di euro, che la Grecia aveva ricevuto nel giugno 2012 dal Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (EFSF) è servito in primo luogo a finanziare l’indebitamento greco nei confronti del successore del Fondo, il Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM). Quindi il EFSF ha finanziato il suo proprio successore - ma non direttamente, bensì mediante l’aumento del debito pubblico greco.
Klaus Regling, presidente di ESFS e di ESM, nella sua carriera è più volte passato dalla politica al settore finanziario e viceversa. Prima dell’attuale incarico ha lavorato alternativamente per il Governo federale tedesco, per il Fondo d’investimento Moore Capital Strategy Group, per la Direzione generale degli affari economici e finanziari della Commissione Europea e per il Fondo Hedgefonds Winton Futures Fund Ltd. Egli è quindi il simbolo dell’intreccio di finanza e politica, corresponsabile della finalizzazione al salvataggio del settore finanziario da parte della politica europea di crisi.
Secondo il rendiconto di gestione l’EFSF nel 2011 ha speso intorno a 3,1 milione di euro per il personale. In quell’anno lavoravano per l’EFSF, secondo notizie dei media, 12 persone. Quindi sono stati erogati 258.000 euro in media per ogni impiegato. Il presidente poi, Klaus Regling, guadagna presumibilmente 324.000 euro più indennità supplementari. Persone con redditi di questa grandezza amministrano una politica che in Grecia ha ridotto il salario minimo a 580 euro lordi al mese (510 per i giovani).
 Fonti:
Fonti:
 http://www.attac.at/uploads/media/hintergrundmaterial_bailout_deutsch.pdf
http://www.attac.at/uploads/media/hintergrundmaterial_bailout_deutsch.pdf -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- LA SINDROME DI WEIMAR. Günter Grass: «il silenzio degli intellettuali rovina dell’Europa» (di Andrea Tarquini)28 giugno 2013, di Federico La Sala
 La sindrome di Weimar
La sindrome di Weimar
 Il premio Nobel e il leader Spd Peer Steinbrück sulla sinistra e sui pericoli per la democrazia
Il premio Nobel e il leader Spd Peer Steinbrück sulla sinistra e sui pericoli per la democrazia Grass: «il silenzio degli intellettuali rovina dell’Europa»
Grass: «il silenzio degli intellettuali rovina dell’Europa» di Aldo Tarquini (la Repubblica, 28 giugno 2013)
di Aldo Tarquini (la Repubblica, 28 giugno 2013)BERLINO. «La sinistra deve ritrovare il coraggio d’essere creativa come ai tempi di Willy Brandt e di Olof Palme, per affrontare le cupe sfide attuali alla democrazia. E gli intellettuali progressisti devono uscire dal loro assordante silenzio. Se altrimenti finirà male, non si potrà dire “non è stata colpa mia”». Il monito, facile indovinarlo, è di Günter Grass.
In un dialogo-contraddittorio con il candidato Spd alla Cancelleria Peer Steinbrück nella sede del partito, a meno di tre mesi dalle elezioni, il Nobel è tornato in campo. Proponendosi come ispiratore e critico scomodo, dalla lingua spietata. Ecco il suo dialogo con Steinbrück, moderato dal più famoso leader Spd dell’Est tedesco, Wolfgang Thierse.
Thierse: Günter, oggi torni in campo. Quando e come decidesti negli anni Sessanta di schierarti con Brandt?
Grass: Quando lui, borgomastro di Berlino Ovest che lottava in piazza a fianco di Kennedy contro il Muro della vergogna costruito dall’Est, venne diffamato dal “cristiano” Adenauer come “figlio illegittimo” ed “esule”, perché Willy fu partigiano in Norvegia. Dovetti superare un duplice scoglio interno, per decidere di propormi a lui come intellettuale impegnato. Lo scoglio dell’ammirazione infinita che io - in gioventù stupidamente sedotto dal nazismo, militare nelle Ss, convinto fino all’ultimo nella vittoria finale del Reich - provavo per lui che in guerra, al contrario di me, aveva già capito come doversi schierare, e che cosa il conflitto in cui io credevo avrebbe provocato alla Germania e al mondo. Avevamo entrambi i media contro: lui per la coerenza di sinistra e la Ostpolitik, io perché considerato un anarchico: i miei punti di riferimento non erano i classici, bensì Albert Camus e Jean-Paul Sartre.
Thierse: Peer, quando iniziò la tua militanza?.
Steinbrück: Nel ’69, poco dopo che Grass aveva fondato l’iniziativa pro-Spd degli intellettuali in campagna elettorale. Fu un segnale grande. Gli intellettuali portarono al fianco della Spd lo Zeitgeist, lo spirito del tempo della società. Ci vorrebbe anche oggi, per la sinistra in Germania e in tutta Europa.
Thierse: Günter, come immaginavi e immagini il ruolo dell’intellettuale impegnato di sinistra?
Grass: Un ruolo di voce scomoda, sempre capace di dire le cose più spiacevoli. Una voce critica: allora saltando la siepe dell’ammirazione sconfinata per Brandt, e critica più che mai oggi contro i troppi silenzi e ritardi della sinistra democratica europea. Allora cercavo di star vicino a Brandt anche nei momenti di depressione. Ma lui aveva una statura che troppo spesso ai leader politici di oggi manca, anche a sinistra. Resisteva alle diffamazioni, ebbe l’idea geniale della Ostpolitik, mano tesa a Polonia e Urss restando fedele alleato degli Usa. Scrisse per l’Onu il profetico Rapporto Nord-Sud, che la sinistra dovrebbe ancora rileggersi oggi. Lui vedeva lontano, capì allora che il divario crescente ricchi-poveri avrebbe portato guerre e terrorismo. Ecco di quali visioni, di quali capacità di avvistare problemi in tempo, sento oggi la mancanza a sinistra. E al tempo stesso c’è bisogno del suo grande pragmatismo nell’azione quotidiana di governo. Ecco perché voglio essere una voce amica, ma molto scomoda per la sinistra europea.
Steinbrück: Ma non sempre Brandt seguì i suoi consigli. Che si aspetta dalla sinistra attuale?.
Grass: Insisto, non sono né hegeliano né un idealista tedesco, furono le polemiche tra Sartre e Camus a formarmi. Il tema sono le scelte necessarie: la sinistra come Sisifo, oggi al pari di allora.
Steinbrück: Insomma, Grass voleva e vuole essere consigliere, mentore, mugugnone, tutto insieme. Può e potrà essere molto irritante. Ma con Brandt mostrò come politici e intellettuali possono condurre un pas-de-deux. Quel tipo di pas-de-deux con gli intellettuali cambiò la Spd. Io mi auguro un nuovo impegno degli intellettuali nel dibattito politico, nella Germania d’oggi. Non lo vedo, purtroppo per la sinistra. L’ultimo grande impegno pubblico degli intellettuali tedeschi fu la querelle degli storici sulle tesi di Ernst Nolte sul nazismo. Oggi pesa il loro silenzio, anche su quel grande ideale di Brandt, una Germania buona amica di tutti i vicini, ideale oggi rovinato dall’inflessibile rigore che Angela Merkel cerca di imporre a tutti. In una Germania dove le disuguaglianze so- ciali si aggravano. Queste sfide, le carenze di noi politici di sinistra e i silenzi degli intellettuali possono minacciare di strappare alla sinistra la sua aspirazione originaria a essere la voce della modernità.
Grass: Ha ragione, i rapporti con i partner europei sono al peggio, la sinistra anche su questo dovrebbe dire di più. Merkel ha una doppia formazione: prima abituata ad adeguarsi per opportunità quando era nella Fdj, la gioventù comunista dell’est, poi alla scuola di tattica del potere ai tempi di Helmut Kohl. Anche il compito di ricostruire i rapporti in macerie con i partner è una sfida per la sinistra in un’Europa e in un mondo dove il rigore, lo strapotere delle lobbies sui Parlamenti, le nuove povertà, allontanano molti elettori e anche noi intellettuali. Weimar cadde perché solo due partiti, Spd e Centro, e troppi pochi cittadini vollero difenderla, non dimentichiamolo.
Steinbrück: Insisto, perché tanti intellettuali rifuggono dall’impegno?
Grass: La generazione mia e di Brandt fu scottata dal nazismo, dalla guerra, dai crimini tedeschi. Oggi s’allontana la memoria del terribile interrogativo di allora, perché una società civile come Weimar cadde sconfitta dal nazismo. Il motivo principale fu che, appunto, pochi la difesero. Anche pochi intellettuali, salvo Tucholsky e qualche altro. Scrittori e intellettuali di oggi sono cresciuti in tempo di pace, non hanno vissuto quelle memorie. Lo stesso vale per i politici. È necessario impegnarsi, ripeto. Per la giustizia sociale, contro lo scandalo della crescente povertà che colpisce anziani e tanti giovani, anche nella ricca Germania. Battersi per un’Europa che diventi politicamente legittimata, con poteri eletti e in equilibrio tra loro. Osare più democrazia, lo slogan con cui Brandt vinse, deve tornare valore centrale della sinistra in tutta Europa. Ripetere parole, frasi, concetti è letale per il letterato, ma indispensabile in politica. La crisi dell’Europa tra povertà e sfiducia nella politica non deve per forza far scoccare l’ora dei nazionalismi populisti, può far scoccare l’ora delle socialdemocrazie. Dobbiamo riuscirci
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Brasile, nuove manifestazioni contro i Mondiali di calcio 2014.19 giugno 2013, di Federico La Sala
Brasile, nuove manifestazioni contro i Mondiali di calcio 2014
Cinquantamila persone in piazza a San Paolo e migliaia di altre in numerose città del paese. Tensione altissima per le dichiarazioni del presidente della Fifa contro la protesta della popolazione brasiliana: "Il calcio è più importante dell’insoddisfazione della gente" *
SAN PAOLO - Oltre cinquantamila persone hanno preso parte ieri sera ad una nuova manifestazione di protesta contro gli alti costi dei Mondiali di calcio previsti nella nazione sudamericana nel 2014. L’occasione della marcia che ha attraversato il centro della città è stata la contestazione alla presidente Dilma Rousseff che proprio ieri ha iniziato un viaggio assieme al suo "mentore politico", l’ex presidente brasiliano Lula. I manifestanti accusano la presidente di ignorare le motivazioni della protesta, determinata anche dal caro-trasporti conseguente alle spese necessarie per le opere previste in occasione della kermesse calcistica.
Anche ieri sera ci sono stati duri incidenti tra la polizia e centinaia di persone che hanno dato alle fiamme un camion della televisione TV Record, una torretta di sorveglianza delle forze dell’ordine ed un’agenzia bancaria nei pressi del municipio della città. I manifestanti hanno anche tentato l’assalto alla sede municipale ma sono stati respinti dalla polizia che ha fatto largo uso di lacrimogeni, idranti e proiettili di gomma. Nel corso degli scontri sono stati danneggiati negozi e la facciata recentemente restaurata dell’Opera.
La manifestazione si è divisa in due tronconi, proprio davanti al municipio. La maggior parte del corteo ha proseguito pacificamente lungo la via principale, mentre il resto dei manifestanti ha dato vita agli incidenti con la polizia.
Altri cortei si sono svolti Sao Gonzalo, nei pressi di Rio de Janeiro, a Juazeiro do Norte, dove circa ottomila manifestanti hanno preso d’assalto il municipio e un’agenzia bancaria. Altre manifestazioni a Manaus e a Florianopolis. L’ondata di manifestazioni di protesta occorse nelle ultime ore in Brasile (circa 250 mila persone sono scese in piazza,lunedì, in almeno undici città del Paese, secondo quanto riferiscono oggi i media locali) sta scuotendo anche i brasiliani che vivono all’estero. In almeno 29 città di Europa, America Latina e America del Nord, oriundi del gigante sudamericano stanno organizzando iniziative analoghe.
A far alzare la tensione sono state anche le dichiarazioni del presidente della Fifa, Joseph Blatter, ha minimizzato le manifestazioni di protesta in atto in Brasile contro le spese per l’organizzazione della Confederations Cup e i Mondiali del 2014 affermando che "il calcio è più importante dell’insoddisfazione delle persone". "I manifestanti stanno usando la piattaforma del calcio e la presenza della stampa internazionale per ampliare la protesta", ha aggiunto.
A rincarare la dose ci ha pensato Marco Polo del Nero, vice presidente della Federcalcio brasiliana e rappresentante del suo Paese nella Fifa, secondo il quale "199 milioni di persone pensano a lavorare e ci sono pochi altri che danno fastidio". "La polizia è comunque ben preparata", ha aggiunto.
Un giorno dopo le proteste che in Brasile hanno portato in strada oltre 100mila persone, almeno cinque città hanno annunciato che ridurranno il prezzo dei trasporti pubblici. Lo riporta online il giornale O Globo. L’aumento del prezzo dei trasporti in 11 città del Paese è uno dei punti all’origine delle proteste, in cui i dimostranti lamentano anche scarsi servizi sanitari, di educazione e di sicurezza nonostante l’aumento della pressione fiscale. Denunciano anche le alte spese previste per l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2014 e i Giochi olimpici del 2016.
Le cinque città che faranno marcia indietro sui prezzi sono Cuiabà nello Stato del Mato Grosso, Joao Pessoa in Paraiba, Porto Alegre in Rio Grande do Sul, Recife in Pernambuco e Blumenau in Santa Catarina. Intanto a Rio de Janeiro, dove l’altro ieri durante le proteste ci sono stati tafferugli, il prefetto Eduardo Paes ha convocato i leader del movimento Passe Livre, uno dei gruppi che attraverso internet organizza le manifestazioni. Lo scopo è negoziare, riporta O Globo, ma sinora nessuno dei leader delle proteste ha confermato la sua presenza. Nuove manifestazioni sono programmate nella città per giovedì.
La presidente Dilma Rousseff, a Brasilia, ha comunque affermato che avrebbe tenuto conto delle motivazioni delle proteste in corso nel paese. Sembra infatti che nell’incontro con l’ex presidente brasiliano Lula, si sia a lungo discusso di un abbassamento dei prezzi del trasporto pubblico e di ulteriori iniziative per sostenere la sanità pubblica, tra le più degradate, a fronte di una spesa che il governo brasiliano sta affrontando per i Mondiali di calcio equivalente a circa 11 miliardi di Euro.
* la Repubblica, 19 giugno 2013
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- La macchia sull’Europa (di Barbara Spinelli).19 giugno 2013, di Federico La Sala
La macchia sull’Europa
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 19 giugno 2013)
Se almeno avessero le loro divinità antiche: forse i Greci capirebbero meglio quel che vivono, l’ingiustizia che subiscono, l’abulica leggerezza di un’Europa che li aiuta umiliandoli da anni, che dice di non volerli espellere e nell’animo già li ha espulsi. Le divinità d’un tempo, si sapeva bene che erano capricciose, illogiche, si innamoravano e disamoravano presto. Su tutte regnava Ananke: l’inalterabile Necessità, ovvero il fato. A Corinto, Ananke condivideva un tempio con Bia, la Violenza. L’Europa ha per gli Ateniesi i tratti di questa Necessità.
Forse capirebbero, i Greci, come mai a Roma s’è riunito venerdì un vertice di ministri dell’Economia e del Lavoro, tra Italia, Spagna, Francia, Germania, per discutere il lavoro fattosi d’un colpo cruciale, e nessuno di essi ha pensato di convocare la più impoverita delle nazioni: 27 per cento di disoccupazione, più del 62 per cento giovani. Sono i tassi più alti d’Europa. Forse avevano qualcosa da dire, i Greci, sui disastri della guerra che le istituzioni comuni continuano a infliggere con inerte incaponimento, e senza frutti, al paese reo di non fare i compiti a casa, come recita il lessico Ue.
La Grecia è la macchia umana che imbratta l’Europa, da quando è partita la cura d’austerità. Ha pagato per tutti noi, ci è servita al tempo stesso da capro espiatorio e da cavia. In una conferenza stampa del 6 giugno, Simon O’Connor, portavoce del commissario economico Olli Rehn, ha ammesso che per gli Europei è stato un «processo di apprendimento ».
In altri paesi magari si farà diversamente, ma non per questo scema la soddisfazione: «Non è stata cosa da poco, tenere Atene nell’euro»; «Dissentiamo vivamente da chi dice che non è stato fatto abbastanza per la crescita». Poi ha aggiunto piccato: «Sono accuse del tutto infondate». O’Connor e Rehn reagivano così a un rapporto appena pubblicato dal Fondo Monetario: lo stesso Fmi che con la Banca centrale europea e la Commissione è nella famosa troika che ha concepito l’austerità nei paesi deficitari e dall’alto li sorveglia.
L’atto di accusa è pesante, contro strategie e comportamenti dell’Unione durante la crisi. La Grecia «poteva uscirne meglio», se fin dall’inizio il debito ellenico fosse stato ristrutturato, alleggerendone l’onere. Se non si fosse proceduto con la micidiale lentezza delle decisioni prese all’unanimità. Se per tempo si fosse concordata una supervisione unica delle banche. Se crescita e consenso sociale non fossero stati quantità trascurabili. Solo contava evitare il contagio, e salvaguardare i soldi dei creditori. Per questo la Grecia andava punita. Oggi è paria dell’Unione, e tutti ne vanno fieri perché tecnicamente rimane nell’euro pur essendo out cast sotto ogni altro profilo.
Addio alla troika dunque? È improbabile, visto che nessun cittadino può censurare i suoi misfatti, e visto il sussiego con cui è stato accolto il rapporto del Fondo. L’ideale sarebbe di licenziarla fin dal Consiglio europeo del 27-28 giugno, dedicato proprio alla disoccupazione che le tre Moire della troika hanno così spensieratamente dilatato.
Il Parlamento europeo non oserà parlare, e quanto alla Bce, le parole di Draghi sono state evasive, perfino un po’ compiaciute: «Di buono, nel rapporto FMI, è che la Banca centrale europea non è criticata ». Il Fondo stesso è ambivalente, ogni suo dire è costellato di ossimori (di asserzioni acute-stupide, etimologicamente è questo un ossimoro). Il fallimento c’è, ma è chiamato «necessario». La recessione greca è «più vasta d’ogni previsione », ma è «ineludibile». Il fato illogico regna ancora sovrano, solo che a gestirlo oggi sono gli umani.
In realtà c’è poco da compiacersi. L’Unione non ha compreso la natura politica della crisi - la mancata Europa unita, solidale - e quel che resta è un perverso intreccio di moralismi e profitti calcolati.
Resta l’incubo del contagio e dell’azzardo morale. Condonare subito il debito, come chiedevano tanti esperti, significava premiare la colpa. E poi all’Europa stava a cuore proteggere i creditori, dice il rapporto del Fondo, più che scongiurare contagi: dilazionare le decisioni «dava tutto il tempo alle banche di ritirar soldi dalle periferie dell’eurozona ». La Banca dei regolamenti internazionali cita il caso tedesco: 270 miliardi di euro hanno abbandonato nel 2010-11 cinque paesi critici (Grecia, Irlanda, Portogallo, Italia, Spagna). Ma la vera macchia umana è più profonda, e se non riconosciuta come tale sarà ferita che non si rimargina.
È l’ascia abbattutasi sull’idea stessa dei beni pubblici, guatati con ininterrotto sospetto. È qui soprattutto che salari e lavori sono crollati. E la democrazia ne ha risentito, a cominciare dalla politica dell’informazione. Il colmo è stato raggiunto la notte dell’11 giugno, quando d’un tratto il governo ha chiuso radio e tv pubblica - l’Ert, equivalente della Bbc o della Rai - con la tacita complicità della troika che esigeva licenziamenti massicci di dipendenti pubblici.
Non che fosse una Tv specialmente pluralista, ma perfino chi era stato emarginato (come l’economista Yanis Varoufakis) ha accusato i governanti di golpe. Le televisioni private, scrive Varoufakis, sono spazzatura: «un torrente di media commerciali di stampo berlusconiano: templi di inculcata superficialità» da quando inondarono gli schermi negli anni ’90.
Il giorno dopo l’oscuramento di Ert (2700 licenziati) c’è stata una manifestazione di protesta a Salonicco. Tra gli oratori l’economista James Galbraith, figlio di John Kenneth, e il verdetto è spietato: cinque anni di crisi son più della seconda guerra mondiale condotta dall’America in Europa, più della recessione combattuta da Roosevelt.
E la via d’uscita ancora non c’è. Perché non c’è? Galbraith denuncia un nostro male: la mentalità del giocatore d’azzardo. Il giocatore anche se perde s’ostina sullo stesso numero, patologicamente.
Continuando a ventilare l’ipotesi dell’uscita greca l’Europa ha spezzato la fiducia fra gli Stati dell’Unione, creando una specie di guerra. Ci sono paesi poco fidati, e poco potenti, che non hanno più spazio: i Disastri di Goya, appunto.
Non è stata invitata Atene, alla riunione romana, ma neppure Lisbona: la sua Corte costituzionale ritiene contrari alla Carta due paragrafi del piano della troika, e da allora anche il Portogallo è paria. «Ci felicitiamo che Lisbona prosegua la terapia concordata: è essenziale che le istituzioni chiave siano unite nel sostenerla», ha comunicato la Commissione due giorni dopo la sentenza, rifiutando ogni rinegoziato. Mai direbbe cose analoghe sui verdetti della Corte tedesca, giudicati questi sì inaggirabili.
Macchie simili non si cancellano, a meno di non riscoprire l’Europa degli esordi. Non dimentichiamolo: si volle metter fine alle guerre tra potenze diminuite dopo due conflitti, ma anche alla povertà che aveva spinto i popoli nelle braccia delle dittature. Non a caso fu un europeista, William Beveridge, a concepire il Welfare in mezzo all’ultima guerra.
Le istituzioni europee non sono all’altezza di quel compito, attualissimo. Tanto più occorre che i cittadini parlino, tramite il Parlamento che sarà votato nel maggio 2014 e una vera Costituzione. È necessario che la Commissione diventi un governo eletto dai popoli, responsabile verso i deputati europei.
Una Commissione come quella presente nella troika deve poter esser mandata a casa, avendo generato rovine. Ha perso il denaro, il tempo e l’onore. Ha seminato odio fra nazioni. Ha precipitato un popolo, quello greco, nel deperimento. Si fa criticare da un Fmi malato di doppiezze. È affetta da quello che Einstein considerava (la frase forse non è sua, ma gli somiglia) il sommo difetto del politico e dello scienziato: «L’insania che consiste nel fare la stessa cosa ripetutamente, ma aspettandosi risultati differenti».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- TURCHIA. "Oggi, piazza Taksim è il castagno di Istanbul e deve continuare a esserlo" (di Orhan Pamuk - Sto con i ragazzi che combattono).7 giugno 2013, di Federico La Sala
 Il Nobel Pamuk si schiera con la rivolta di piazza Taksim: deriva autoritaria del regime
Il Nobel Pamuk si schiera con la rivolta di piazza Taksim: deriva autoritaria del regime L’albero dei ragazzi di Istanbul
L’albero dei ragazzi di Istanbul L’intervento dello scrittore premio Nobel Orhan Pamuk
L’intervento dello scrittore premio Nobel Orhan Pamuk Sto con i ragazzi che combattono
Sto con i ragazzi che combattonodi Orhan Pamuk (la Repubblica, 06.06.2013)
Il rapporto più recente sui diritti umani nel nostro Paese è il peggiore degli ultimi dieci anni. Mi riempie tuttavia di speranza e di fiducia vedere che la mia gente non rinuncerà alle manifestazioni pubbliche né a lottare per difendere il rispetto della propria libertà
PER dare un senso agli eventi di Istanbul, e per capire quei coraggiosi che scendono in strada e si scontrano con la polizia soffocando tra i fumi velenosi dei gas lacrimogeni, vorrei cominciare con una storia personale.
Nel mio libro di memorie Istanbul, ho scritto su come tutta la mia famiglia abitasse negli appartamenti che componevano il palazzo Pamuk a Nisantasi. Di fronte a questo edificio si trovava un castagno che aveva circa cinquant’anni, che per fortuna è ancora lì.
Un giorno, però, nel 1957, il comune decise di tagliare quell’albero per allargare la strada. Burocrati presuntuosi e amministratori autoritari ignoravano l’opposizione del quartiere. Così, il giorno in cui l’albero doveva essere abbattuto, mio zio, mio padre, e tutta la famiglia rimasero in strada giorno e notte, facendo a turno per fare la guardia. In questo modo, abbiamo protetto il nostro albero, ma abbiamo anche creato una memoria condivisa che l’intera famiglia ricorda ancora con piacere, e che ci lega l’un l’altro.
Oggi, piazza Taksim è il castagno di Istanbul e deve continuare a esserlo. Ho vissuto a Istanbul per sessant’anni e non riesco a immaginare che possa esistere una sola persona che viva in questa città e non abbia almeno un ricordo legato in qualche modo a piazza Taksim.
Negli anni Trenta, nella vecchia caserma di artiglieria che ora vogliono trasformare in un centro commerciale, c’era un piccolo stadio di calcio che ospitava delle gare ufficiali. Il famoso Gazino di Taksim, che fu il centro della vita notturna di Istanbul per tutti gli anni Quaranta e Cinquanta, sorgeva un tempo in un angolo del parco Gezi. In seguito, tutti quegli edifici vennero abbattuti, gli alberi furono tagliati, piantarono nuovi alberi, e lungo un lato del parco costruirono una serie di negozi e la più famosa galleria d’arte di Istanbul.
Negli anni Sessanta, sognavo di diventare pittore e di poter esporre le mie opere in questa galleria. Negli anni Settanta, la piazza fu sede delle entusiastiche celebrazioni dei sindacati di sinistra e delle Ong per il Primo Maggio e, una volta, partecipai anch’io a una di queste celebrazioni. (Nel 1977, quarantadue persone furono uccise in un’esplosione di violenza provocata e nel caos che ne seguì).
Da giovane, assistevo con curiosità e con piacere alle manifestazioni che tutti i partiti politici - partiti di destra e di sinistra, nazionalisti, conservatori, socialisti, socialdemocratici - tenevano a Taksim.
Quest’anno, il governo ha vietato di celebrare in questa piazza la Festa del Lavoro. E in quanto alla caserma che avrebbe dovuto essere ricostruita, a Istanbul tutti sanno che alla fine ci costruiranno un altro centro commerciale al posto dell’ultimo spazio verde rimasto nel centro della città.
Il fatto che dei cambiamenti così significativi, in una piazza e in un parco che custodiscono i ricordi di milioni di persone, siano stati progettati e messi in atto, per quanto riguarda la fase dell’abbattimento degli alberi, senza prima consultare gli abitanti di Istanbul, è stato un grave errore per il governo di Erdogan.
Questo atteggiamento insensibile è chiaramente dovuto a una crescente deriva del governo verso l’autoritarismo. (L’ultimo rapporto sui diritti umani in Turchia è il peggiore degli ultimi dieci anni). Mi riempie, tuttavia, di speranza e di fiducia vedere che la gente di Istanbul non rinuncerà né al suo diritto di tenere manifestazioni politiche in piazza Taksim, né ai suoi ricordi, senza combattere. (Traduzione di Luis E. Moriones)
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- La paura degli altri, il localismo esasperato sono sintomi di vere patologie (di Luigi Zoja)6 giugno 2013, di Federico La Sala
 Se l’Europa unita diventa una terapia psicoanalitica
Se l’Europa unita diventa una terapia psicoanalitica La paura degli altri, il localismo esasperato
sono sintomi di vere patologie trattate anche da Jung
La paura degli altri, il localismo esasperato
sono sintomi di vere patologie trattate anche da Jungdi Luigi Zoja (l’Unità, 06.06.2013)
L’IDEA DI EUROPA HA RADICI CHE RISALGONO SINO A ERODOTO E ATTRAVERSANO LE OPERE DI DANTE E GOETHE, DUNQUE NON SARANNO CERTO VICENDE CONTINGENTI COME LA CRISI DELL’EURO A METTERLA IN DISCUSSIONE. La storia di quest’idea ha a che fare sin dalle sue origini con una nozione fondamentale, il pluralismo. Narrare l’Europa significa descrivere il tentativo di condivisione, e quindi di organizzazione, di gestione spesso conflittuale di uno spazio comune da parte di soggetti diversi, che si esprimono con voci diverse e provano desideri diversi.
Sotto questo profilo la storia europea si riflette bene nella vicenda assai più breve di una disciplina, la psicanalisi, sorta proprio nel cuore della Mitteleuropa durante il secolo lungo, quello che si è chiuso con la grande guerra e con l’esplosione dei nazionalismi novecenteschi. Grazie a Carl Gustav Jung, infatti, si è compreso che ciascuno di noi è animato da una molteplicità di voci: Jung fece luce sulla nostra natura intimamente plurale, superando il monoteismo materialista della sessualità d’impostazione freudiana.
Il pluralismo è dunque, ad un tempo, un concetto politico e psicologico: al pluralismo della nostra psiche corrisponde, o potrebbe corrispondere, uno spazio politico, quello europeo, intimamente polifonico e politeista.
Nella mia personale esperienza di vita, ho potuto apprendere a fondo il valore di un autentico pluralismo vivendo e lavorando come psicanalista nel paese federalista per eccellenza, la Svizzera. Negli anni di Zurigo ho capito come per gli svizzeri l’esperienza stessa della cittadinanza rechi con sé un’idea di appartenenza molteplice.
Qualcosa di analogo, in fondo, accade anche per il concetto di cittadinanza negli Stati Uniti. Ma in molti altri paesi europei le cose vanno diversamente, perché il feticcio delle identità nazionali cresciuto nel secolo scorso gioca ancora un ruolo di primo piano.
È il caso di noi italiani, che siamo stati tra i più convinti europeisti solo finché ci è convenuto dal punto di vista economico, mentre oggi, di fronte alla complessità della globalizzazione e al continuo superamento dei confini che essa impone, ci spaventiamo.
E così, di fronte ad un’Unione Europea che è una sorta di sperimentazione su scala ridotta e controllata della globalizzazione, non rispondiamo promuovendo un pluralismo di stampo federalista. Al contrario, reagiamo provando una gran paura, che ci fa chiudere le porte e ripiegare sui localismi e sugli interessi privati.
Ebbene, questa chiusura, magari in nome della difesa della sovranità nazionale dalle misure di politica economica imposte dall’esterno, costituisce un problema anche dal punto di vista psicologico: rifiutare di sentirsi pienamente europei corrisponde, sul piano politico, al rifiuto di accettare che anche ciascuno di noi è molteplice, pieno di desideri che, come scriveva Platone, lo tirano in direzioni contrarie.
L’intuizione junghiana è che il sintomo nevrotico deriva proprio da una riduzione della nostra complessità. Ciascuno di noi, ad esempio, è naturalmente androgino: ci pensano poi la cultura e l’educazione a incanalare e arginare le nostre pulsioni, portando i maschi a esprimere più aggressività rispetto alle donne, un dato che è ancora vero per l’Italia di oggi e che il femminismo con tutti i suoi sforzi contro le differenze di genere non è riuscito a modificare. La sofferenza e la depressione si generano così, sono un sintomo di parzialità, di riduzione della nostra natura.
Il rifiuto della pluralità dentro e fuori di noi, prodotto in Italia e altrove dalla paura di un mondo complesso, ci chiude a un rapporto autentico e appagante con gli altri uomini e donne che attraversano la nostra vita.
Se la morte di Dio annunciata da Nietzsche fece risuonare lo spirito di fine ‘800, oggi è giusto decretare anche la fine di un altro comandamento biblico: l’amore del prossimo. Il prossimo è scomparso, frammentato dalle tecnologie di comunicazione e allontanato come una minaccia.
In questo scenario, i cittadini europei immemori della loro pluralità originaria si rendono sempre più disponibili a seguire le sirene dei populismi, che fanno leva sulla chiusura e sulla riduzione della complessità. Ma anche il populismo è legato a una patologia psichica dell’Europa: la paranoia, la follia lucida che ha pervaso il ‘900 e che, semplificando all’eccesso, oggi spinge a dar tutte le colpe agli altri, a inesistenti complotti di Berlino o di Bruxelles. Un’Europa politicamente più unita potrebbe forse costituirne la terapia, ma oggi ci appare troppo conservatrice e basata sul primato dell’economia.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---«Una crisi esplosiva di sistema» - «porre da subito il problema di una rifondazione dell’Unione, in vista della costruzione di un’altra Europa» (di Sandro Mezzadra - Sindrome europea. La «rottura» della cittadinanza).17 maggio 2013, di Federico La Sala
Sindrome europea. La «rottura» della cittadinanza
di Sandro Mezzadra (il manifesto, 17 maggio 2013)
Étienne Balibar ha perfettamente ragione («Una crisi esplosiva di sistema», il manifesto del 4 maggio): dobbiamo «porre da subito il problema di una rifondazione dell’Unione, in vista della costruzione di un’altra Europa». Dovremmo essergli grati per aver messo in corsivo sia «da subito» sia «rifondazione». Si deve agire ora, e quest’azione non può dare per scontata né l’esistenza delle forze politiche da mobilitare, né le coalizioni sociali capaci di sostenere una simile mobilitazione, né le energie intellettuali da attivare, né i canali e le strutture istituzionali da assumere come riferimento.
Serve, su ciascuno di questi livelli, una campagna costituente, che sappia trasformare forze e istituzioni esistenti, crearne di nuove, incanalare lotte e «indignazione» sociali verso l’obiettivo di «costruire un’altra Europa», producendo al tempo stesso nuovi linguaggi politici e immaginari culturali. Una campagna costituente, dicevo: non una campagna per un’«assemblea costituente», per la quale mancano attualmente tutte le condizioni. Penso a un progetto di durata decennale, in grado di reinventare radicalmente lo spazio europeo, la sua posizione in un mondo tumultuosamente in trasformazione, le sue istituzioni e la sua cittadinanza sulla base di una nuova coniugazione di libertà e uguaglianza. È necessario aggiungere che una simile reinvenzione non può che essere allo stesso tempo una reinvenzione della sinistra in Europa? Se la sinistra ha un futuro in questa parte del mondo, sono convinto che questo futuro non possa che essere costruito su scala continentale.
Dovremmo essere consapevoli della dimensione globale delle sfide di fronte a cui ci troviamo oggi in Europa. È evidente che la messa in discussione di consolidate gerarchie spaziali e l’affermazione di nuove geografie dello sviluppo e dell’accumulazione capitalistica figurano in primo piano tra le tendenze che sottendono l’attuale crisi economica globale. Nuovi regionalismi e nuovi modelli di multilateralismo stanno prendendo forma in molte parti del pianeta, una sorta di «deriva dei continenti» (per riprendere l’immagine geologica impiegata da Russell Banks nel famoso romanzo omonimo del 1985) sta ridisegnando il mondo. All’interno di questi processi, l’Europa è sempre più «provincializzata», anche se non necessariamente nel senso suggerito da Dipesh Chakrabarty nel suo importante libro del 2000.
Limiti dell’appartenenza
Di per sé, non è un male. Tutt’altro. Ma per cogliere e interpretare politicamente le opportunità connesse a questa provincializzazione dell’Europa abbiamo bisogno di una scala continentale di azione politica e di governo. Abbiamo bisogno di un’Europa politica. Al di fuori di quest’ultima, la prospettiva è quella di un’Europa ridotta a qualche isola di benessere e ricchezza in un mare di povertà e privazione: cosa che abbiamo già iniziato a sperimentare nel Sud del nostro continente. Inoltre solo su scala continentale è possibile immaginare la costruzione di un rapporto di forza favorevole con il capitale finanziario, il cui dominio all’interno del capitalismo contemporaneo è alla radice della crisi di ogni mediazione politica (ovvero della democrazia) oggi così evidente in Europa.
Non è questo il luogo per analizzare a fondo le implicazioni dello sguardo «geopolitico» sulla questione europea (il che significherebbe in particolare discutere su basi completamente nuove il problema delle relazioni tra Europa e Stati Uniti). Ma è importante tenere a mente la pertinenza degli argomenti qui appena evocati per qualsiasi indagine critica sull’attuale situazione europea. Nel seguito di questo breve intervento, in ogni caso, voglio concentrarmi su qualcos’altro. Parlare di una campagna costituente significa prendere in considerazione la necessità di una rottura allo scopo di aprire la via a un’«altra Europa».
Penso sia importante essere consapevoli, in questo senso di quanto profonda sia la rottura che è già stata prodotta all’interno della stessa struttura delle istituzioni europee nel contesto della crisi globale. Faccio parte di coloro che a partire dalla metà degli anni Novanta hanno cercato di lavorare «dentro e contro» la cittadinanza europea in formazione, soprattutto per quel che riguarda i movimenti e le lotte dei migranti. Non si tratta certamente di liquidare in modo sbrigativo quell’esperienza, che è stata anche accompagnata da importanti dibattiti teorici, nel tentativo di sfidare i limiti e i confini della concezione tradizionale della cittadinanza. Al tempo stesso, non si può evitare di fare un bilancio delle radicali trasformazioni che negli ultimi anni hanno investito la cittadinanza europea. Sia dal punto di vista dell’«appartenenza» che dell’architettura istituzionale - per richiamare i due punti di vista prevalenti negli studi sull’argomento - ci troviamo di fronte a una profonda crisi della cittadinanza europea.
Per dirla brutalmente, questo concetto è stato spogliato di qualsiasi significato «positivo» e «progressivo» agli occhi di una vasta maggioranza della popolazione europea, e in particolare in Paesi come la Grecia, la Spagna, l’Italia essa ha finito per essere ampiamente identificata con la continuità delle politiche di austerity e con il loro carattere «punitivo». Allo stesso tempo, come molti giuristi hanno notato, l’intero progetto di «integrazione attraverso il diritto», tratto distintivo dell’integrazione europea nel suo complesso, si è trovato di fronte ai propri limiti e alle proprie contraddizioni degli ultimi anni. L’equilibrio tra un sovra-nazionalismo giuridico e i processi politici di negoziazione, alla base di quel progetto, è stato destabilizzato: la processualità giuridica è stata sempre più nettamente caratterizzata da una dinamica autonoma, collegandosi in modi inediti con gli apparati burocratici europei e con una molteplicità di gruppi d’interesse.
Ne è emersa la cristallizzazione di un nuovo «assemblaggio» di potere capace di dettare standard e norme che restringono sempre di più il campo d’azione di qualsivoglia politica («europea» non meno che «nazionale»). Con il Fiscal Compact e con il Meccanismo Europeo di Stabilità, la camicia di forza della stabilità monetaria, i programmi di disciplina fiscale e la continuità dell’austerity si sono ulteriormente rafforzati, consolidando la posizione (e l’indipendenza) della Banca Centrale Europea al centro di questo «assemblaggio» di potere.
È difficile immaginare un’altra Europa politica senza porre l’accento sulla necessità di strappare questa camicia di forza e di spezzare questo «assemblaggio» di potere. «Default democratico» (Giandomenico Majone), «crisi di legittimità» (Fritz Scharpf), ulteriore rafforzamento della natura «elitaria» e «post-democratica» dell’Ue (Wofgang Streeck) sono alcune delle formule che circolano nei dibattiti sulla crisi europea nel tentativo di cogliere le implicazioni della rottura a cui si è fatto cenno - della soluzione di continuità che si è prodotta all’interno del processo di integrazione.
Lavoro vivo
Se nel concetto moderno di democrazia, per riprendere i termini proposti in un celebre saggio di Étienne Balibar, è iscritta una dialettica tra la dimensione «insurrezionale» e la dimensione «costituzionale» della politica, si deve riconoscere che oggi in Europa (sia a livello nazionale sia a livello di Ue) questa dialettica sembra essere interrotta. Quel che ne consegue è una divisione che attraversa gli stessi concetti di politica e democrazia. I loro momenti conflittuali e «insurrezionali» continuano a riprodursi all’interno delle lotte e dei movimenti sociali, ma essi non trovano nessun tipo di feedback all’interno delle istanze governative e «costituzionali». Quello che rimane a livello nazionale della «democrazia conflittuale» (citando nuovamente una formula di Balibar) su cui si è fondato lo sviluppo dello Stato sociale democratico è al momento in fase di smantellamento o comunque sotto attacco, mentre a livello europeo non c’è nessun tentativo di compensare questa «perdita» con l’edificazione di nuovi sistemi di welfare su scala continentale. Anche quanti avevano creduto che il Trattato di Maastricht avrebbe posto le basi per uno «scambio» di questo genere sono oggi costretti a ricredersi.
Inutile dire che questo tema dovrebbe essere prioritario nella «campagna costituente» che si tratta di avviare. E non è possibile immaginare una ricostruzione dei sistemi di welfare a livello europeo secondo il modello del welfare state «storico», quale lo abbiamo conosciuto in Europa occidentale dopo la seconda guerra mondiale. Troppe cose sono cambiate, e radicalmente, nella struttura del capitalismo e nella composizione di ciò che, con un concetto marxiano, possiamo chiamare il «lavoro vivo» contemporaneo. Basti pensare ai dibattiti sulla precarietà, sulle nuove caratteristiche delle migrazioni o, per limitarci a un unico ulteriore esempio, sulle trasformazioni della struttura famigliare e dei rapporti tra i generi. Attorno a queste e altre questioni, si sono sviluppati con straordinaria continuità movimenti e lotte sociali in tutto il continente: nessuna campagna per un’«altra Europa» è immaginabile senza un’intensificazione e un sempre maggiore coordinamento di queste lotte e di questi movimenti.
Lo scoglio della sinistra
«Non essere stata in grado di definire e di promuovere una solidarietà europea è la ragione del fallimento della sinistra in Europa», scrive Bo Strath commentando l’articolo di Balibar (cfr. www.opendemocracy.net/). Non potrei essere più d’accordo. Vorrei tuttavia aggiungere che questo «fallimento» è a sua volta legato alla miopia della sinistra di fronte alle profonde trasformazioni subite dal lavoro, nonché alle rivendicazioni emergenti da una composizione sociale anch’essa profondamente innovata.
L’Europa può avere un senso solo se la si costruisce come uno spazio all’interno del quale queste rivendicazioni possano essere articolate in un progetto politico capace di essere al contempo radicale ed efficace. Solo se diviene uno spazio in cui la lotta contro la povertà, lo sfruttamento e la discriminazione ha più possibilità di successo, in cui è più facile distruggere la paura inoculata e disseminata dalla crisi all’interno del tessuto sociale. Lottare contro il «ritorno dei nazionalismi» e l’ascesa di nuove forme di fascismo in Europa significa prima di tutto lottare per sradicare questa paura.
Quando parlo di una «campagna costituente» non penso a un’unica campagna organizzata centralmente. Ciò di cui abbiamo bisogno è in primo luogo forgiare uno «spirito costituente» attraverso una molteplicità d’iniziative, articolate su diversi livelli e capaci di investire diversi luoghi e forum (dalla mobilitazione di piazza al Parlamento europeo). Ecco perché, ottimisticamente forse, scrivevo di un progetto di durata decennale. Mi rendo perfettamente conto che le prospettive per un progetto del genere, in questo preciso momento, non appaiono particolarmente incoraggianti. Esso dipende, per citare ancora l’articolo di Balibar da cui ho preso le mosse, da «molte condizioni, tutte difficili e il cui adempimento è improbabile».
È un monito essenziale rispetto alla difficoltà del compito che ci spetta: ma nulla dice (e Balibar lo sottolinea) contro la realistica necessità di farsene collettivamente carico. In fin dei conti potremmo concludere ricordando, con un po’ di necessaria ironia, le parole di Max Weber, uno che di «realismo politico» se ne intendeva: «è senz’altro vero che non si raggiungerebbe il possibile se nel mondo non si tentasse sempre di nuovo l’impossibile».
SCAFFALE
Da OpenDemocracy ai movimenti
Il testo di Etienne Balibar è stato pubblicato inizialmente sul quotidiano francese «Liberation». Il giorno dopo, d’accordo con l’autore, è stato pubblicato sul «manifesto» (4 maggio). Successivamente è uscito anche su quotidiani tedeschi, greci, spagnoli, mentre il sito «OpenDemocracy» ha aperto una sessione dedicati ai temi sviluppati dal filosofo francese (l’articolo di Sandro Mezzadra ha aperto questa nuova «sezione» del sito dedicata all’Europa). In quell’articolo Balibar illustrava lo stato dell’Unione europea dopo la stagione del governo dei tecnici (qualificata dal filosofo francese come una «rivoluzione dall’alto»). Balibar invita a prendere nuovamente le fila di un ordine del discorso «europeista» (ma sarebbe più corretto chiamarlo come un «cosmopolitismo radicale») che sfugga alla gabbia d’acciaio dell’austerità costruita dalla troika per mettere in salvo un neoliberismo in crisi di legittimità.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". -- Il «modello tedesco» o come ostinarsi nell’errore (di Pierre Rimbert - "Le Monde Diplomatique")16 maggio 2013, di Federico La Sala
Il «modello tedesco» o come ostinarsi nell’errore
di Pierre Rimbert (Le Monde Diplomatique, lunedì 6 maggio 2013)
 (traduzione dal francese di José F. Padova)
(traduzione dal francese di José F. Padova)
 http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2013-05-05-allemagne
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2013-05-05-allemagneNon è raro che un personaggio di Tex Avery [ndt.: noto creatore di personaggi di cartoon], trascinato dal suo slancio, superi il bordo di un precipizio e per qualche istante continui la sua corsa nel vuoto prima di mordere la polvere. Le politiche d’austerità imposte ai Paesi europei dalla Germania, dalla Banca Centrale Europea (BCE) e - con entusiasmo calante - dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), come anche dalla Commissione Europea, hanno raggiunto quel punto in cui il corridore, comprendendo di colpo di non aver più nulla sotto i piedi, lancia uno sguardo mortificato prima di crollare.
Non ancora. Certamente, Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Ungheria, Repubblica Ceca, sottoposti all’obbligo di tagli netti ai loro servizi pubblici e alle spese di Stato, s’inabissano nella recessione. Perfino i Paesi Bassi e la Finlandia, alleati tradizionali della Germania in materia di rigore, hanno conosciuto un calo di attività nel 2012, mentre Francia e Regno Unito erano in stagnazione. Soltanto la Polonia l’anno scorso presentava una crescita superiore a... 1%.
Certamente, la Zona euro, passata sotto la cesoia della burocrazia dell’austerità, alla fine del mese d’aprile contava 19,2 milioni di disoccupati (12,1% della popolazione attiva secondo Eurostat), una cifra record che tuttavia non dice nulla del degrado vertiginoso delle condizioni di vita del popolo greco [ndt.: vedi “La nostra proposta per l’Europa” di Alexis Tsipras, trad. JFPadova del 12.2.13].
Certamente, un capo economista del FMI in gennaio ha riconosciuto che il suo Istituto aveva gravemente sottostimato i danni causati dall’imperativo delle restrizioni di bilancio: là dove il modello prevedeva che la riduzione di un euro della spesa pubblica avrebbe comportato un calo di 0,50 euro della ricchezza prodotta [il PIL], l’analisi empirica mostra che la contrazione dell’attività produttiva è da due a cinque volte superiore.
Certamente, infine, la tesi degli illustri economisti di Harvard Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, secondo la quale un debito pubblico superiore al 90% del PIL indebolirebbe la crescita, è stata fatta a pezzi da uno studente dell’Università del Massachusetts, che si è divertito a rifare i calcoli: gli autori, citati come profeti dai fautori dell’austerità - dal Commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn all’ex direttore della BCE Jean-Claude Trichet - avevano eliminato dati che contraddicevano la loro tesi e costruito il loro modello partendo da un foglio di calcolo elettronico [ndt.: in questo caso di Excel] infettato da un errore di formula (2).
Un asino non avrebbe avuto bisogno di tanto per fare dietrofront.
Eppure, alla maniera dei personaggi di Tex Avery, banchieri centrali, economisti ortodossi e dirigenti politici ignorano i fatti e galoppano, ancora qualche tempo, in un etere di certezze. Il loro credo del momento porta il nome di «modello tedesco», espressione sintetica della dottrina economica inalberata dalle élite europee, che lega assieme austerità di bilancio (ridurre il deficit dello Stato e il debito), austerità monetaria (moneta forte, lotta contro l’inflazione) e austerità salariale.
Quest’ultimo ritrovato, messo in opera dal Cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder negli anni 2000 e in seguito sistematizzato dalla destra tedesca, si fonda anch’esso su due principi: in primo luogo, «attivazione» coercitiva dei disoccupati mediante la piallatura delle prestazioni sociali e l’obbligo di accettare lavori mal pagati (i «mini-job»). Secondariamente, la creazione di un mercato del lavoro flessibile e precario, destinato ad accogliere questi nuovi salariati dei servizi in un Paese sprovvisto di salario minimo; e accordi sindacali di settore, che barattano simultaneamente il mantenimento nel posto di lavoro dei salariati dell’industria contro il rigore salariale e l’adattamento dei tempi di lavoro alla convenienza del datore d’impiego. Così questo apparato produttivo reso «competitivo» dalla riduzione dei «costi del lavoro» e drogato da una fiscalità di compromesso si orienta verso l’esportazione e la conquista dei mercati emergenti.
Sulla carta, questo «modello» seduce. La Germania non soltanto presenta un tasso di disoccupazione molto inferiore a quello dei suoi vicini dell’Ovest e del Sud (6,9% in aprile) e una bilancia commerciale eccedentaria, ma la Cancelliera Angela Merkel gode di una popolarità intatta dopo più di sette anni al potere. L’inflessibilità della signora Merkel sulla scena europea rassicura in effetti una popolazione poco incline a vedere il prodotto dei suoi sacrifici destinato a rimettere a galla i Paesi del Sud, presentati dalla stampa tedesca come un club di vacanze per bancarottieri indolenti.
Tuttavia il lato oscuro del «consenso di Berlino» potrebbe compromettere l’estensione durevole di questa politica all’insieme dei Paesi della Zona euro. Il paradiso delle piccole e medie industrie è anche quello della precarietà, dove quattro salariati su dieci sono pagati meno di 1.000 euro al mese. Dove l’immaginario sociale e le pratiche salariali relegano ancora largamente le donne alle faccende domestiche, abbellite o no da un «lavoruccio» a tempo parziale; pagate il 23% meno degli uomini, esse rappresentano la maggioranza dei tre milioni di salariati rimunerati meno di 6 euro all’ora. Dove l’invecchiamento spiega una parte importante del calo della disoccupazione - «fra il 2000 e il 2012, spiega il giornalista economico Guillaume Duval, la popolazione tedesca in età dai 15 ai 64 anni è diminuita di 1,7 milioni di persone, mentre in Francia è cresciuta di 2,8 milioni» (3). Perfino l’indicatore-totem del successo economico, la crescita, non raggiunge livelli atti a incantare gli investitori. Negativa nel quarto trimestre del 2012, essa è stimata dalle previsioni di Berlino allo 0,5% nel 2013.
Ogni fede religiosa ha la sua chiesa, i suoi prelati, i suoi cardinali. E i suoi inquisitori, ormai installati alla testa delle grandi redazioni francesi. Criticare il «modello tedesco», o semplicemente segnalare i suoi effetti collaterali, equivarrebbe a eresia. È bastato che una minuta di testo del partito socialista esprimesse, venerdì 26 aprile, alcune riserve sulla politica economica condotta da Berlino che Libération (29 aprile) titolasse «Il Partito Socialista sbanda», con un editoriale che evoca la convergenza del «populismo», della «xenofobia» e di una «ambigua germanofobia»; che Le Figaro (27-28 aprile) annunciasse in prima pagina che «Il Partito Socialista dichiara guerra alla Germania»; che l’editoriale del Monde (28-29 aprile) redarguisse «questo giochetto infantile [...] estremamente pericoloso», mischiando «demagogia» e «populismo». E perché il direttore del Point (2 maggio), Franz-Olivier Giesbert, uscito male da una condanna per diffamazione [ndt.: per la pubblicazione di una nota del discusso Bernard-Henry Lévy], sventasse le potenze malefiche dell’eterodossia con il suo consueto senso della misura: «Mischiate morfina, allucinogeni, pigrizia intellettuale e avrete il testo del Partito Socialista, un copia-incolla di buffonerie involontarie che si possono leggere su Le Monde Diplomatique o in Alternative economiche, le nostre due bibbie del vudù applicato alle finanze pubbliche».
Se hanno il diavolo nella testa, è ugualmente necessario esorcizzare i lettori del «Monde Diplomatique»?
 1) Olivier Blanchard and Daniel Leigh « Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers » (PDF), IMF working paper, janvier 2013.
1) Olivier Blanchard and Daniel Leigh « Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers » (PDF), IMF working paper, janvier 2013.
 2) Cf. par exemple « Une erreur dans une étude sur l’austérité dégomme les idées reçues », Lemonde.fr, 17 avril 2013.
2) Cf. par exemple « Une erreur dans une étude sur l’austérité dégomme les idées reçues », Lemonde.fr, 17 avril 2013.
 3) Guillaume Duval, Made in Germany. Le Modèle allemand au-delà des mythes, Seuil, Paris, 2013, p. 184. Les données de la phrase précédente sont également tirées de cet ouvrage, p. 67.
3) Guillaume Duval, Made in Germany. Le Modèle allemand au-delà des mythes, Seuil, Paris, 2013, p. 184. Les données de la phrase précédente sont également tirées de cet ouvrage, p. 67. -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- L’Unione somiglia oggi a una Chiesa corrotta, bisognosa di uno Scisma protestante: di una Riforma del credo, dei vocabolari. Di un piano con punti precisi (di Barbara Spinelli - Europa, il sonno della politica)15 maggio 2013, di Federico La Sala
Europa, il sonno della politica
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 15 maggio 2013)
Succede solo in quest’Europa, attratta dal naufragio non a causa dell’economia ma della convulsa scempiaggine della sua politica: parliamo dello scandalo di una Corte costituzionale tedesca divenuta cruciale per ogni cittadino dell’Unione, mentre la Corte costituzionale in Portogallo vale zero.
Parliamo di Jens Weidmann, governatore della Banca centrale tedesca, che accusa Draghi di oltrepassare il suo mandato - salvando l’euro con i mezzi a sua disposizione - e senza vergogna dichiara guerra a una moneta che chiamiamo unica proprio perché non appartiene solo a Berlino.
Il mandato della Bce è chiaro infatti, anche se Weidmann ne contesta la costituzionalità: mantenere la stabilità dei prezzi (articolo 127 del Trattato di Lisbona), ma nel rispetto dell’articolo 3, che prescrive lo sviluppo sostenibile dell’Europa, la piena occupazione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, la lotta all’esclusione sociale, la giustizia e la protezione sociali, la coesione economica, sociale e territoriale, la solidarietà tra gli Stati membri. Qualcosa non va nella storia che si sta facendo, se l’articolo 3 neanche fa capolino sul sito Internet della Bce, per timore che Berlino magari s’adombri.
Fra poco più di un anno, nel maggio 2014, voteremo per il rinnovo del Parlamento europeo.
Soprattutto per gli italiani sarà una data diversa dal solito. Perché l’Europa della trojka (Bce, Commissione, Fmi) pesa sulle nostre vite come mai in passato. Perché le sue medicine anti-crisi sono contestate ovunque dai popoli, scuotendo perfino il medico che più ardentemente le propina: il 22 settembre i tedeschi andranno al voto e forse premieranno un partito antieuropeo - Alternativa per la Germania
 appena nato nel febbraio scorso. I partiti dovranno smettere le menzogne che
vanno dicendo, sulla possibilità di «piegare» Angela Merkel. Specie in Italia, dovranno piantarla di
tradire elettori e cittadini. Per la prima volta infine, se oseranno, potranno indicare il presidente
della Commissione. Sta nei trattati.
appena nato nel febbraio scorso. I partiti dovranno smettere le menzogne che
vanno dicendo, sulla possibilità di «piegare» Angela Merkel. Specie in Italia, dovranno piantarla di
tradire elettori e cittadini. Per la prima volta infine, se oseranno, potranno indicare il presidente
della Commissione. Sta nei trattati.Se parliamo di menzogne, è perché nessun governo è in grado di piegare Berlino con gli argomenti esclusivamente economici fin qui sbandierati: un po’ meno austerità, un po’ di crescita, qualche condono. Convinta com’è che siano i mercati e nessun altro a disciplinarci, Berlino si muoverà solo se la politica prevarrà su tesi economiche degenerate in dogmi. Se governi, partiti e cittadini accamperanno visioni chiare di quella che deve essere un’altra Europa: non quella presente, dotata di risorse minime, precipitata in ottocenteschi equilibri di potenze.
L’Unione somiglia oggi a una Chiesa corrotta, bisognosa di uno Scisma protestante: di una Riforma del credo, dei vocabolari. Di un piano con punti precisi (erano 95 le tesi di Martin Lutero). Il Papato economico va sovvertito opponendogli una fede politica. Solo così la religione dominante s’infrangerà, e Berlino dovrà scegliere: o l’Europa tedesca o la Germania europea, o l’egemonia o la parità fra Stati membri.
Sempre ha dovuto scegliere in tal modo: l’Europa, disse Adenauer nel ‘58, «non va lasciata agli economisti». L’ortodossia tedesca è antica ormai, s’affermò nel dopoguerra e si chiama ordoliberalismo : i mercati sanno perfettamente correggere gli squilibri, senza ingerenze dello Stato, perché dotati di immutata razionalità. È l’ideologia della «casa in ordine»: ogni nazione espierà le proprie colpe da sola ( Schuld vuol dire debito e colpa, in tedesco). Solidarietà e cooperazione internazionale vengono dopo, a coronare i compiti a casa se ben fatti. Come in Inghilterra, viene invocata ingannevolmente anche la democrazia: trasferire parte della propria sovranità svuota i parlamenti nazionali. Per questo la Corte costituzionale tedesca è pregata di pronunciarsi su qualsiasi mossa europea.
Se è inganno, è perché nella fattoria-Europa non tutte le democrazie sono eguali: ce ne sono di sacrosante, e di dannate. Il 5 aprile scorso, la Corte costituzionale portoghese ha rigettato quattro misure dell’austerità imposta dalla trojka (tagli agli stipendi statali e alle pensioni), perché contrarie al principio di uguaglianza. Il comunicato diramato due giorni dopo dalla Commissione europea, il 7 aprile, ignora del tutto il verdetto, «si felicita» che Lisbona prosegua la terapia concordata, rifiuta ogni rinegoziato: «È essenziale che le istituzioni politiche chiave del Portogallo restino unite nel sostenere» il risanamento così com’è. Il diverso trattamento riservato ai giudici costituzionali tedeschi e portoghesi è a tal punto disonesto che l’Europa difficilmente sopravviverà come ideale nei suoi cittadini.
Alcuni dicono che può sopravvivere se l’egemonia tedesca si fa più benevola , restando egemonia. George Soros l’ha chiesto nel settembre 2012 sul New York Review of Books , con solidi argomenti. Lo esige il governo polacco. In Germania lo domanda chi teme non già l’egemonia, ma una poco splendida, introversa autoidolatria.Egemonia e autoidolatria sono tuttavia i sintomi, non la causa del male che cronicamente assilla la Germania. Sempre ai suoi governi è toccato fare i conti con il dogma della casa in ordine.
Sin dal dopoguerra la sua politica della memoria fu mutila: conscia come nessun altro del passato nazi-fascista, ma dimentica del ciclone economico che tramortì i tedeschi, negli anni ‘30, con l’austerità delle riparazioni inflitte dai vincitori. Lo scherzo della storia è atroce: proprio Keynes, che aveva denunciato nel ‘19 la punizione disciplinatrice dello sconfitto, è l’economista più inviso in Germania.
Se la Germania ha voluto un’Europa sovranazionale, fino a inserirla nella Costituzione, è perché gli ordoliberali (nella Banca centrale, nelle accademie) sono stati ripetutamente disarcionati. Adenauer impose la Cee e il patto franco-tedesco a un ministro dell’Economia - Ludwig Erhard - che fece di tutto per affossarli. Che accusava la Cee di «endogamia» protezionista, di «scemenza economica».
Con Londra provò a sabotare i trattati di Roma, preferendo di gran lunga una zona di libero scambio. Non l’ascoltarono né Adenauer, né il primo capo della Commissione Hallstein, grazie ai quali la razionalità politica vinse.
Lo stesso scenario riapparve con l’euro: anche qui, aggrappato a Parigi, Kohl antepose la politica scavalcando economisti mainstream e Banca centrale. Oggi il bivio è simile, ma con politici camaleontici, senza più volontà ferme. La crisi ha disilluso il popolo tedesco. L’ordoliberalismo si politicizza, assapora vendette antiche.
Non resta quindi che lo Scisma: la costruzione di un’altra Europa, che parta dal basso più che dai governi. Un progetto già c’è, scritto dall’economista Alfonso Iozzo: secondo i federalisti, può divenire un’ « iniziativa dei cittadini europei» (articolo 11 del Trattato di Lisbona), da presentare alla Commissione.
L’idea è di munire l’Unione di risorse sufficienti per fare crescita al posto di Stati costretti al rigore. Una crescita non solo meno costosa, perché fatta insieme, ma socialmente più giusta e più ecologica, perché alimentata dalla tassa sulle transazioni finanziarie, dalla carbon tax (biossido di carbonio) e da un’Iva europea. Dalle prime due tasse si ricaverebbero 80/90 miliardi di euro: il bilancio comune rispetterebbe la soglia dell’1,27 concordata a suo tempo. Mobilitando Banca europea degli investimenti ed eurobond, avremmo un piano di 300/500 miliardi, e 20 milioni di nuovi posti di lavoro nell’economia del futuro (ricerca, energia).
Per fare queste cose occorre tuttavia che la politica torni alla ribalta e ridiventi, come dice l’economista Jean-Paul Fitoussi, non un insieme di regole automatiche ma una scelta . Occorre l’auto-sovversione di Lutero, quando scrisse le sue 95 tesi e disse, secondo alcuni: «Qui sto diritto. Non posso fare altrimenti. Che Dio mi aiuti, amen».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- l’Unione va ripensata, oltre che rifatta: sapendo che solo lì recupereremo le sovranità perdute (di Barbara Spinelli - L’Europa di Kubrick).10 aprile 2013, di Federico La Sala
L’Europa di Kubrick
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 10 aprile 2013)
- L’articolo riproduce parte della lezione magistrale che Barbara Spinelli tiene oggi all’Università di Padova
Eyes wide shut: tale la postura dell’Europa, da quando è caduta nell’odierna crisi esistenziale. Vi è caduta con gli occhi spalancati dalla paura, dalla paralisi, ma sappiamo che se gli occhi li sbarri troppo è come se fossero chiusi.
È uno dei mali di cui soffre l’unità europea, quest’intreccio perverso tra visione e cecità: ne discendono le più convenienti mitologie, i più nefasti luoghi comuni. Tra questi vorremmo citarne uno: sempre più spesso, l’Europa è descritta come utopia, parente prossima di quei messianesimi politicio religiosi che fioriscono in tempi di guerre, di cattività, di esodo dei popoli. Il vocabolo ricorrente è sogno. I sogni hanno un nobile rango: dicono quel che tendiamo a occultare. Resta il loro legame col sonno, se non con l’ipnosi: ambedue antitetici alla veglia, all’attiva vigilanza.
Ebbene, l’Europa unita è qualcosa di radicalmente diverso da un sogno, e ancor meno è un’utopia, un’illusione di cui dovremmo liberarci per divenire realisti; o come usa dire: più moderati, pragmatici. La crisi cominciata nel 2007 ha disvelato quel che avrebbe dovuto esser chiaro molto prima, e che era chiaro ai padri fondatori: l’esaurirsi dei classici Stati nazione. La loro sovranità assoluta, codificata nel trattato di Westphalia nel 1648, s’è tramutata in ipostasi, quando in realtà non è stata che una parentesi storica: una parentesi che escluse progetti di segno assai diverso, confederali e federali, sostenuti già ai tempi di Enrico IV in Francia e poi da Rousseau o Kant. Gli effetti sulla vita degli europei furono mortiferi: questa constatazione, fatta a occhi ben aperti, diede vita, durante l’ultima guerra mondiale, non già al "sogno", ma al progetto concreto d’unificazione europea.
Nel frattempo tale sovranità assoluta - cioè la perfetta coincidenza fra il perimetro geografico d’un Paese e quello del potere statuale da esso esercitato - è divenuta un anacronismo non solo incongruo ma inconcludente, che decompone governi e Parlamenti. I nodi più ardui da sciogliere - una finanza mondiale sgovernata, il conflitto fra monete, il clima, le guerre, la convivenza tra religioni differenti - non sono più gestibili sul solo piano nazionale.
Tanto meno lo sono con l’emersione di nuove potenze economiche (i BRICS: Brasile, Russia, India, Cina, Sud-Africa). La loro domanda di energia, materie prime, beni alimentari, è in rapida crescita e quel che esse pretendono, oggi, è una diversa distribuzione delle risorse planetarie: inquiete per il loro rarefarsi, esigono la loro quota. Non è più tollerato che una minoranza di industrializzati perpetui tramite l’indebitamento il dominio sui mercati: è attraverso il debito infatti che i ricchi del pianeta s’accaparrano più risorse di quelle spettanti in base alla loro capacità produttiva. È il motivo per cui debiti che erano considerati solvibili non lo sono più: i BRICS non vogliono più rifinanziarli.
Il debito sovrano, in altre parole, non è più sovrano: va affrontato come incombenza mondiale, e per cominciare come compito continentale europeo. Pensare che i singoli Stati lo assolvano da soli, indebitandosi ancora di più, è non solo ingiusto mondialmente: è ridicolo e impraticabile. L’unità politica fra Europei è insomma la via più realistica, pragmatica, e la più promettente proprio dal punto di vista della sovranità: cioè dal punto di vista del monopolio della coesione civile, del bene pubblico, della forza. L’abbandono-dispersione del monopolio conduce all’irrilevanza del continente e al diktat dei più forti, mercati o Stati che siano.
I problemi da risolvere (per problemi intendo le crisi-svolte che aprono alla stasi o alla trasformazione) si manifestano dentro geografie diverse, ciascuna delle quali va governata. Non è più vero che il re è imperator nel suo regno: superiorem non recognoscens (ignaro di poteri sopra di sé), come nella formula del Medio Evo, quando l’impero era sfidato dai primi embrioni di Stati. La formula risale al XIII secolo, e nell’800-900 divenne dogma malefico. Oggi il singolo sovrano deve riconoscere autorità superiori: organi internazionali, e in Europa poteri federali e una Carta dei diritti che vincola Stati e cittadini.
Neanche la sovranità popolare è più quella sancita nell’articolo 1 della nostra Costituzione: non solo essa viene esercitata "nella forme e nei limiti della Costituzione" - dunque è divisibile - ma sempre più è scavalcata da convenzioni transnazionali (il Fiscal Compact è tra esse) che minacciano di corroderla e screditarla, se non nasce una potente sovranità popolare europea. I partiti non sono meno colpevoli degli Stati: nelle elezioni europee, è inesistente lo sforzo di vedere, oltre i propri Paesi, l’Europa e il mondo.
Questo significa che l’Unione va ripensata, oltre che rifatta: sapendo che solo lì recupereremo le sovranità perdute. Edificando un potere sovranazionale, e un Parlamento che possa controllarlo e eleggerne i rappresentanti. Le stesse Costituzioni esigeranno adattamenti alla nuova sovranità ritrovata solidalmente. Le discussioni della Corte costituzionale tedesca sono spesso dettate da chiusure nazionaliste, e tuttavia cercano di vedere e dominare mutazioni reali. È un peccato che discussioni analoghe non avvengano, con la stessa puntigliosa intensità, nelle Corti degli altri Stati dell’Unione.
Qui giungiamo al punto cruciale: all’astratto furore imputato a chi invoca gli Stati Uniti d’Europa. Tanto più astratto e fallimentare, vista la crescente disaffezione dei popoli. Disaffezione relativa, per la verità. Non è vero che tutti i referendum europei siano stati negativi, nella storia dell’Unione: la maggior parte non lo sono stati. Quanto all’euro, solo il 2 per cento dei cittadini (l’1 in Italia) vuole abbandonarlo.
Dove sta allora, oggi, l’utopia? Sta nella perpetuazione di sovranità nazionali fittizie: tenute in semi-vita da simulacri di poteri e da cittadini disinformati (le due cose vanno insieme: più spadroneggia lo status quo, più la realtà vien nascosta ai popoli).
Machiavelli descrive con occhio profetico le disavventure delle grandi mutazioni: "Debbesi considerare come non è cosa più difficile a trattare, né più dubbia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare, che farsi capo ad introdurre nuovi ordini. Perché lo introduttore ha per nimici tutti coloro che degli ordini vecchi fanno bene; ed ha tiepidi difensori tutti quelli che degli ordini nuovi farebbero bene. La qual tepidezza nasce parte per paura degli avversarii, che hanno le leggi dal canto loro, parte dalla incredulità degli uomini, li quali non credono in verità le cose nuove, se non ne veggono nata una ferma esperienza. Donde nasce che qualunque volta quelli che sono inimici hanno occasione di assaltare, lo fanno partigianamente, e quelli altri difendono tiepidamente, in modo che insieme con loro si periclita".
Tepidezza, incredulità, paura: questi i sentimenti che impediscono la nascita di ordini nuovi. L’ordine vecchio è difeso con partigianeria, anche quando è manifestamente defunto. Quello nuovo con tiepidezza, anche quando è manifestamente necessario.
Mi è sempre apparsa tiepida la formula di Gramsci, sull’ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione. Proprio la ragione deve essere ottimista (per ottimismo non intendo fede progressista, ma la non-rassegnazione di cui parla Pessoa: "Tutto vale la pena, se l’anima non è piccola"). Ogni volta che udite parlare di Stati che si riprendono la sovranità, state sicuri: di fronte avete un illusionista che "dell’ordine vecchio fa bene": usandolo per dominare. I veri populisti, ingannatori di popoli, oggi sono loro.
Anche lo scetticismo è parola da usare cautamente: per rivalutare il suo antico significato. Il vero scettico non apre alcun credito all’apparenza, e non è pregiudizialmente avversario dell’unità europea ma si fa sottile e assai dubbioso osservatore dello Stato nazione. Non teme il nuovo ordine. Diffida del vecchio, ed è lo status quo che considera una chimera. Lì è il sonno - l’incubo - da cui vale la pena svegliarsi, se l’anima non è piccola. Il vero scettico non si contenta dell’Europa così com’è, perché ha capito che è un ibrido velenoso. Dunque quando incontriamo un antieuropeo dovremmo replicare, se vogliamo cambiare il mondo: sono io lo scettico, non tu che stai sdraiato nel falso ordine vecchio per timore del nuovo che già è cominciato.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- INTERVISTA A MICHEL SERRES (di Kurt Hilgenberg)8 aprile 2013, di Federico La Sala
Elogio della filosofia
Michel Serres: “Altro che economia, l’Europa è una questione di Logos”
L’epistemologo francese si confronta con Kurt Hilgenberg “Dobbiamo trovare noi le giuste risposte alla crisi”
- Domani (alle 20 su Rai Scuola e poi su www.filosofia.rai.it) lo Speciale Europa apre la terza serie di Zettel, programma di Rai Educational diretto da Silvia Calandrelli, ideato da Gino Roncaglia e progettato e condotto da Maurizio Ferraris con Mario De Caro. Ci sarà una conversazione tra Ferraris e Umberto Eco con altri interventi. Anticipiamo l’intervista di Hilgenberg a Serres
Qual è il contributo della filosofia alla formazione del pensiero europeo?
«Credo i contributi siano tre: la filosofia della storia, la filosofia del diritto e la filosofia della conoscenza o della scienza. E, in primo luogo, dal punto di vista della filosofia della storia mi pare che l’Europa sia il luogo in cui è più viva la consapevolezza di possedere un’antichità. Nelle altre culture non c’è antichità, cioè una rottura netta tra una civiltà morta e una civiltà che ricomincia. E, quindi, in Europa, c’è una duplice fonte: quella dell’antichità greco-latina da un lato e, dall’altro, della tradizione giudeo-cristiana che le succede. E nell’idea che ha formato l’intelletto europeo, mi pare che ci sia quest’idea di biforcazione: un’antichità da un lato e poi, dall’altro, un cambiamento di direzione; non è più l’antichità greco-latina, diventerà quella giudeo-cristiana, pur conservando l’apporto greco e latino. Cioè, appunto, una biforcazione ma, al contempo, la conservazione di ciò che vi è stato in precedenza. Questo, per quanto riguarda la filosofia della storia. Poi, relativamente alla filosofia della conoscenza, nella tradizione greco-latina c’è l’idea del logos greco, dell’astrazione greca. E quest’idea di astrazione proseguirà a lungo nella filosofia. Ma d’altra parte, però, con il Rinascimento, in Europa assistiamo all’invenzione della fisica sperimentale. Quindi, quest’astrazione si proietterà nella concretezza, con una sorta di nuovo concetto che associa al contempo astratto e concreto. E anche questa è una caratteristica tipicamente europea. Infine, nella filosofia del diritto, la cosa più importante è vedere che in Europa c’è una dualità tra i paesi di diritto romano e i paesi che potremmo definire come di diritto anglosassone, cioè di diritto consuetudinario. E anche in questo caso troviamo da un lato l’idea di un logos astratto, di un’astrazione e dall’altro un’applicazione alla realtà».
Questo per il passato. Ma oggi, la filosofia può ancora al pensiero sull’Europa?
«Credo che la particolarità dell’Europa sia di aver inventato qualcosa che ci riguarda in modo molto concreto, nel senso che credo che sia stata l’Europa a inventare la nozione di “individuo”. Questa nozione è già in parte presente nei Greci, in parte nel diritto romano di cui ho parlato prima, ma è distintamente presente nel pensiero a partire dal Rinascimento. Il Rinascimento costituisce nuovamente una biforcazione rispetto al Medioevo, in cui si manifesta un tratto tipicamente europeo, l’idea d’inventività e insieme la capacità di inventare l’individuo. Il processo avviato con il Rinascimento dura ancora oggi, cioè in un periodo in cui l’individuo è veramente nato: con le nuove tecnologie, ad esempio, si vede benissimo che c’è una sorta di creazione di un nuovo individuo, in un quadro di trasformazioni radicali. Oggi parliamo molto della crisi economica senza accorgerci che la crisi economica forse è solo un fenomeno prodotto da crisi molto più profonde. Per esempio, in paesi come l’Italia, la Francia, la Germania o l’Inghilterra, all’inizio del Novecento, la metà degli abitanti erano contadini. Oggi abbiamo solo lo 0,8% di contadini. Quindi, nel ventesimo secolo, assistiamo a una crisi enorme a livello di rapporto con il mondo, di rapporto con la natura. In secondo luogo, quando sono nato io, il mondo aveva un miliardo e mezzo di abitanti. Oggi siamo sette miliardi e mezzo di persone. Di conseguenza, per i contadini non è più lo stesso mondo, per la democrazia mondiale non sono più le stesse persone. E oggi la speranza di vita è di 84 anni per le nostre compagne e, di 77 anni, credo, per gli uomini. Ma, solo cent’anni fa, la speranza di vita era di 50 anni e duecento anni fa era di 40 anni. Quindi, non è più lo stesso pianeta. Ne consegue, che la filosofia oggi deve individuare dei concetti nuovi, relativi non solo all’economia ma al posto dell’uomo nel mondo. In particolare, la filosofia può aiutare una futura Europa interrogandosi sul modo in cui gli individui si costituiranno in nuove comunità, e chiedendosi se ci sono nuove comunità da inventare. Questa è filosofia politica, un ambito in cui l’Europa è stata estremamente fertile nell’Ottocento, mentre lo è stata molto meno nel Novecento. Credo che bisognerebbe rilanciare l’idea di filosofia politica inventando nuove appartenenze ed è questo che, un po’ alla cieca, sta cercando l’individuo moderno».
Quindi, biforcazione, individuo, comunità sono i concetti centrali di un’Europa filosofica. Oltre ai concetti, le chiedo se esistono degli oggetti che esprimono l’Europa nel modo più completo.
«Il suo è un indovinello... A prima vista, direi che è un oggetto enorme, la cattedrale. Perché le cattedrali sono presenti in Inghilterra, in Francia, naturalmente, a Colonia, in Germania, a Milano, ovunque in Europa. La prima è forse Santa Sofia, a Costantinopoli. Dunque la cattedrale simbolizza bene l’Europa, ma è un oggetto di un’altra epoca. Ma sono state inventate nuove cattedrali, come il Cern, a Ginevra: ecco un’istituzione europea, una comunità europea, la costruzione di una cattedrale straordinaria e qualcosa, dal punto di vista scientifico, di prettamente europeo. Non contempla minimamente di applicare la scienza e di applicarla a interessi economici. Si tratta solo di ricerca pura, di ricerca disinteressata e questo è tipicamente tedesco, tipicamente francese, tipicamente italiano. Sì, il Cern è una buona idea, è una nuova cattedrale».
Qual è la via che i giovani devono o dovrebbero percorrere per arrivare a un nuovo pensiero europeo?
«La mia prima risposta è consistita nel dire: ciò che c’è di originale nel pensiero europeo è la biforcazione rispetto all’antichità, la biforcazione rinascimentale rispetto al Medioevo, cioè l’idea che l’avvenire è imprevisto, che è inventivo, che è inatteso. Anche oggi ha luogo una biforcazione. Come dicevo, oggi siamo degli individui, siamo meno tedeschi di una volta, meno italiani di una volta, meno francesi di una volta perché sappiamo che la nazione ci è costata milioni di morti e, dunque, non ne abbiamo più bisogno. E stiamo pensando che le comunità antiche sono un po’ desuete, un po’ obsolete. Ora, l’idea su cui, credo, bisognerebbe un lavorare sarebbe quella di chiedersi in che modo degli individui, siano essi di Cosenza, di Berlino o di Parigi, potrebbero riuscire a inventare una nuova comunità politica che non sia dominata da istituzioni antiche, concepite in un’epoca in cui il mondo non era ciò che è diventato. Ci sono dei matematici che, una decina di anni fa, si sono posti la seguente domanda: con quante telefonate un abitante di Cosenza può raggiungere un abitante di Berlino o di Parigi? Una persona qualsiasi che chiama un’altra persona qualsiasi. Hanno fatto dei calcoli e si sono accorti che con sette telefonate chiunque sul pianeta può chiamare chiunque altro. Ma alcuni mesi fa il calcolo è stato rettificato perché ci si è accorti che con le grandi reti presenti sul web si poteva scendere a quattro. E quindi, chiunque nel mondo, tenendo in mano il cellulare, può chiamare chiunque altro con quattro telefonate. I matematici hanno chiamato questo teorema, “teorema del mondo piccolo”, un mondo in cui posso chiamare chiunque altro, virtualmente, con quattro telefonate. Il che dimostra che abbiamo cambiato completamente spazio. Nel corso della storia, chi avrebbe potuto dire “ora, tenendo in mano il mondo...”? Forse Augusto, l’imperatore romano. Possiamo immaginare un’epoca della storia in cui avrebbero potuto esserci miliardi di Augusto?».
E quasi settant’anni di pace, almeno in buona parte dell’Europa.
«Sono abbastanza vecchio per sapere che l’Europa è un miracolo, perché ho conosciuto le guerre e il fatto che non ci siano più frontiere mi pare una cosa miracolosa. E quali che siano le critiche che si possono muovere all’Europa, non bisogna dimenticare che tutti i libri di storia ci dicono che le guerre sono sempre causate da una crisi economica. Ora, ormai da vent’anni siamo in una crisi economica e, che io sappia, non ci sono state guerre. Quindi, l’Europa è perfettamente efficace a livello di istituzioni visto che è in corso una crisi, una crisi comune che, però, non ha scatenato carneficine come nel caso delle crisi precedenti».
* la Repubblica, 08.04.2013
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- I custodi del vecchio ordine non vedono il nesso, tra le varie crisi: dell’economia, dell’Europa, del clima, delle democrazie (di Barbara Spinelli - Se la politica torna all’Agorà).20 marzo 2013, di Federico La Sala
Se la politica torna all’Agorà
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 20 marzo 2013)
«NIENTE esperimenti! -Keine Experimente!»: così Konrad Adenauer, Cancelliere dopo la disfatta di Hitler, si rivolse nel ’57 ai cittadini tedeschi. Voleva tranquillarli, toglier loro ogni ghiribizzo - o grillo che dir si voglia. Nacque una democrazia solida, e tuttavia c’era un che di ottuso e impolitico nel monito: era rivolto a un popolo vinto, sedotto per anni dalla più orrenda delle sperimentazioni. Nel fondo dell’animo tedesco, questa paura dell’esperimento non svanisce.
Oggi non è così, né in Italia né in Europa: la crisi ha smascherato Stati nazione impotenti, la democrazia è ovunque in frantumi. Politici e cittadini sono scollegati, con i primi chiusi nelle loro tane e i secondi che per farsi udire vogliono contare di più. A meno di non considerarci sconfitti di guerra, oggi è più che mai tempo di esperimenti, proprio nella sfera della democrazia. È tempo di disabituarci a schemi cui politici e giornalisti restano, per pigra convenienza, aggrappati. Manuel Castells, uno dei massimi studiosi dell’informazione, scrive su La Vanguardia del 2 marzo: «O innovare o perire».
I custodi del vecchio ordine non vedono il nesso, tra le varie crisi: dell’economia, dell’Europa, del clima, delle democrazie. Gli sdegni cittadini non dicono loro nulla, anche se il segnale è chiaro: la democrazia rappresentativa è un Titanic che sta schiantandosi. Tra governanti e governati c’è un deserto, e in mezzo campeggia un miraggio di rappresentanza: sono deboli i sindacati, spenti i partiti, e la stampa più che i lettori serve i potenti. Nel vuoto, però: una cittadinanza che vuole svegliarsi, sondare altre strade, ricominciare la democrazia.
Oggi l’Italia è a un bivio, scossa ma non vinta: il nuovo inizio invocato da Castells non genera un governo, i primi cambiamenti si fanno attendere. Intanto gli abitudinari gridano all’ingovernabilità. È dagli anni ’70 che si esercitano ad averne paura, a non vedere le crepe che fendono la stabilità cui dicono di anelare. In Europa abbiamo conosciuto un caso di ingovernabilità, spettacolare. È il caso dei belgi, che Grillo cita tra l’altro nel libro scritto con Dario Fo e Roberto Casaleggio (Il grillo canta sempre al tramonto, Chiarelettere 2013). Accadde in piena crisi del debito sovrano, dunque vale la pena farsi qualche idea su un evento che sorprese loro e noi.
Per 541 giorni il paese restò senza governo, fra il giugno 2010 e il novembre 2011. Ben presto si vide che non era semplice squasso tra Fiandre e Vallonia: a traballare era l’impianto stesso della democrazia rappresentativa. L’esperienza belga è istruttiva, per gli effetti negativi che ebbe ma anche per l’impeto di quelli trasformatori. Molti luoghi comuni si sfaldarono. Molte parole toccò ripescarle in soffitta: tra esse la parola riforma, che un tempo significava miglioramento (ma immediato: se no meglio la rivoluzione). Oggi vuol dire peggioramento. Il paese resse. L’ingovernabilità - lo stesso potrebbe valere per l’economia - fu letteralmente crisi: non stasi, ma occasione e svolta. Il lato negativo è palese: in assenza di governo, il re decise che per gli affari correnti sarebbe rimasto il governo battuto alle urne di Yves Leterme, democristiano. L’ordinaria amministrazione presto si rivelò poco ordinaria. I poteri del governo s’estesero, e si parlò delle insidie degli affari correnti. L’amministrazione ordinaria servì a sventare quel che gli immobilisti considerano da sempre la mostruosa causa dell’ingovernabilità: il «sovraccarico » delle domande cittadine. Nei 18 mesi di stasi, il governo facente funzione regnò impassibile, forte di maggioranze obsolete. Approvò l’austero bilancio del 2011, gestì il semestre di presidenza europea nel 2010. Partecipò perfino alla guerra libica. In Italia, sarebbe come prolungare Monti: un risultato non ottimo, per chi ha vinto alle urne promettendo di «innovare o perire».
Gli Stati-nazione periclitano, l’Europa ancora non è una Federazione di solidarietà, e lo status quo è salvo. Il non-governo crea un potere inedito, più libero dal popolo sovrano: assai simile al pilota automatico che, secondo Draghi, protegge la stabilità dal «sovraccarico » di domande cittadine.
Ma l’esperienza belga produsse al contempo novità enormi. Cosciente che in gioco era la democrazia, la cittadinanza si mosse. Prese a sperimentare soluzioni antiche come l’agorà greca che delibera, o l’Azione Popolare auspicata da Salvatore Settis, che risale alle «actiones populares » del diritto romano: i cittadini possono far valere non un interesse proprio ma della comunità, ed essendo titolari della sovranità in democrazia, saranno loro a inventare agende centrate sul bene comune. Non c’è altra via, per battere l’antipolitica vera: il predominio dei mercati, e un’austerità che senza ridurre i debiti impoverisce e divide l’Europa.
Lo Stato siamo noi, dice M5S: è l’idea del movimento scaturito dal non-governo belga. G1000 è il nome che si diede, e nacque durante l’ingovernabilità su iniziativa di quattro persone (un esperto di economia sostenibile, un archeologo, un politologo, un’attrice). Il primo vertice dei 1000 fu convocato l’11 novembre 2011, nell’ex sito industriale Tour et Taxisa Bruxelles.
Il Manifesto fondativo denuncia le faglie della democrazia rappresentativa e suggerisce rimedi. Non si tratta di distruggere rappresentanza o deleghe (i Mille estratti a sorte delegarono le proposte a 32 cittadini - il G32 - come già aveva fatto l’Islanda per la riscrittura della Costituzione, prima discussa in rete poi affidata a un comitato di 25 rappresentanti). Non si tratta neppure di «togliere lavoro ai partiti», scrive il Manifesto.
Quel che deve finire è lo status quo: la partitocrazia e - in era Internet - il giornalismo tradizionale: «In tutti i campi l’innovazione è stimolata, salvo che in democrazia. Le imprese, gli scienziati, gli sportivi, gli artisti devono innovare, ma quando si tratta di organizzare la società facciamo ancora appello, nel 2011, all’800».
È uno dei primi esempi europei di democrazia deliberativa (il Brasile iniziò nei primi anni ’90): Azione Popolare ha già una storia. Deliberare è discutere e poi decidere, e per il Manifesto del G1000 è più efficace dei referendum: «In un referendum ci si limita a votare, mentre in democrazia deliberativa bisogna anche parlare, ascoltare». Prende forma l’idea postmoderna dell’agire comunicativo, da Habermas nel 1981. Il fenomeno è continentale, non solo italiano. Avrà il suo peso, si spera, alle elezioni del Parlamento europeo nel maggio 2014. Sarà scelto dai cittadini, si spera, il futuro capo della Commissione che siederà nella trojka dell’austerità.
È difficile sperimentare, ricominciare. Lo si vede in queste ore: Grillo ha biasimato i parlamentari 5Stelle favorevoli a Grasso, ma la successiva scelta di far decidere i suoi a maggioranza (e l’apertura a governi non partitici) innova profondamente, rispetto alla prassi di tutti i partiti di trasmettere a deputati e senatori l’indicazione su come si deve votare. È quello che Machiavelli consiglia a chi innova: «Vedere le cose più da presso», considerare «come i tempi e non gli uomini causano il disordine » (Discorsi, I-47). Anche la democrazia rappresentativa fu difficile, anche proporre nell’800 il suffragio universale.
L’unica cosa impraticabile è dire no agli esperimenti, comportandosi come Adenauer da sconfitti. I veri esperimenti, quelli che usano le persone come mezzi e le Costituzioni come stracci, avvengono in Grecia, immiserita dall’austerità. O a Cipro, dove stabilità vuol dire defraudare i conti bancari dei cittadini, ricchi e no. Che altro fare, se non sperimentare quel che la cittadinanza attiva chiede si provi. Continuare a considerare un «sovraccarico» le sue domande: questa è ingovernabilità.
Se il nuovo Papa torna alle origini, chiamandosi Francesco, forse anche per la politica è ora di non confondere gli ultimi coi vinti. Di tornare all’agorà di Atene, all’Azione Popolare di Roma antica.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- «Ah, Granada mia!». Passaporto spagnolo per i Sefarditi, cacciati dall’Inquisizione nel 1492. Riparazione storica alla «Cacciata» (di Stefano Jesurum)..7 marzo 2013, di Federico La Sala
 Passaporto spagnolo per i Sefarditi
Passaporto spagnolo per i Sefarditi
 Riparazione storica alla «Cacciata»
Riparazione storica alla «Cacciata» di Stefano Jesurum (Corriere della Sera, 7 marzo 2013)
di Stefano Jesurum (Corriere della Sera, 7 marzo 2013)«Ah, Granada mia!»... da oltre cinque secoli, in molte famiglie sparse ormai per il mondo, si canta e si ricorda con romantica passione la patria perduta. E la si piange e la si invoca con i suoni poetici e cantilenanti dello judezmo o ladino o spaniolito che dir si voglia, insomma della lingua con cui ancora comunicano tra loro molti ebrei sefarditi - così chiamati perché da Sefaràd, dalla Spagna appunto, provengono. Sono i discendenti dei 300 mila perseguitati, convertiti a forza, cacciati dall’Inquisizione nel 1492, la cancellazione di un mondo. Gli stessi discendenti che ora il governo spagnolo invita a tornare offrendo loro la nazionalità.
Un paio di mesi fa, il ministro della Giustizia Alberto Ruiz-Gallardon annunciò infatti una procedura riparatrice. E da allora sono moltissimi, pare, coloro che stanno cercando di capire come fare ad ottenere il passaporto, magari più per sentimentalismo che per reale volontà di usarlo.
Un atto di giustizia? Un tentativo di riavvicinamento nei confronti dello Stato di Israele dopo che Madrid ha sostenuto la richiesta palestinese di un seggio all’Onu? Semplicemente una «sparata» propagandistica impossibile da attuare? Sia come sia, la mossa sembra abbia fatto breccia (e rumore) in una parte dell’ebraismo internazionale.
Il segretario generale della Federazione delle Comunità ebraiche spagnole, Mauricio Toledano, ha spiegato alla Bbc che il governo sta ancora lavorando sui dettagli, ma che quando la nuova legge sarà presentata al Parlamento, le Comunità si aspettano che vi sia affermato il principio che tutti i discendenti di quei 300 mila cacciati, siano essi ebrei o no oggi, potranno usufruirne.
Un ipotetico terremoto che riguarda mezzo pianeta, Italia in prima fila. Basti pensare che circa il 90% degli ebrei turchi è sefardita, come la quasi totalità di chi proviene dai Paesi del Nord Africa e si è poi trasferito in Israele, in Europa e in America a causa delle nuove persecuzioni subite, questa volta per mano araba. Ironia della Storia: nuove persecuzioni subite da quegli stessi musulmani che in quanto «moriscos» cinquecentoventuno anni fa furono cacciati come gli ebrei dalla regina Isabella di Castiglia.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- «L’EUROPA SIAMO NOI». LA LUNGA MARCIA ATTRAVERSO LE ISTITUZIONI. Rudi Dutschke, Beppe Grillo, il M5S, e Axel Springer (di Barbara Spinelli)6 marzo 2013, di Federico La Sala
- CULTURA E CRITICA. RIPENSANDO ALLA STORIA DI AXEL SPRINGER, E’ DA DIRE CHE L’ITALIA HA ’BATTUTO’ LA GERMANIA ALLA ’GRANDE’!
 GIORGIO BACKHAUS: "Springer usa il suo potere per creare i sudditi ideali dei nuovo regime ... Con strumenti infinitamente più moderni ed efficienti... Il suo ruolo è qúello di massimo battistrada del nuovo autoritarismo (...)"
GIORGIO BACKHAUS: "Springer usa il suo potere per creare i sudditi ideali dei nuovo regime ... Con strumenti infinitamente più moderni ed efficienti... Il suo ruolo è qúello di massimo battistrada del nuovo autoritarismo (...)"
La lunga marcia nelle istituzioni di Barbara Spinelli in “la Repubblica” del 6 marzo 2013Nessuno può dire di cosa parleranno Bersani e Grillo, se mai si parleranno. Tante voci, tante forze impaurite sono coalizzate contro questo tentativo - del tutto inedito, sgradito a chi resta appeso alle proprie abitudini - di immaginare non solo un’Italia ma un’Europa diversa, dove trovino spazio iniziative cittadine, proposte che circolano da anni nella società.
Ad esempio, reddito di cittadinanza, leggi anti-corruzione, nuove definizioni del prodotto interno lordo, diritti civili non negoziati con la Chiesa. Sono le idee che un quarto degli italiani ha cercato in 5 Stelle. Non sappiamo se Bersani saprà udirle - e quanto sarà condizionato dalle riluttanze dentro il Pd - ma neppure sappiamo se Grillo e Casaleggio desiderino davvero farsi udire.
Quel che è certo, è che in queste ore comincia per il movimento di Grillo qualcosa che lui stesso non aveva previsto: comincia quella lunga marcia attraverso le istituzioni, che per forza porterà il M5S - forte ancor ieri della sua natura extraparlamentare - ad assumersi responsabilità nella Repubblica.
Di Lunga marcia attraverso le istituzioni parlò nel 1967 Rudi Dutschke, il leader degli extraparlamentari tedeschi che auspicava una democrazia diretta e che subì una campagna diffamatrice, ordita dall’editore Axel Springer, simile a quella inflitta oggi a Grillo. Ferito da una rivoltellata l’11 aprile ’68, Dutschke non si riprese più: morì nel ’79. Ma il suo appello a conquistare un’egemonia culturale (una sovranità discorsiva , disse) facendo leva sulle istituzioni mise radici: il partito dei Verdi, nato grazie a lui, fu l’approdo di quella marcia. Oggi siamo nel mezzo di una mutazione, i paesi industrializzati perdono forza e ricchezze, ma la sfida resta quella.
Specie nel nostro continente, siamo immersi in una depressione da cui non usciremo senza radicali reinvenzioni, e la reinvenzione più grande riguarda l’Europa, che il ’68 ignorava. L’Europa quindi non dovrebbe essere uno degli argomenti trattati da Bersani o da chi proverà dopo di lui con 5 Stelle: è il punto decisivo, da cui tutto il resto discende. Il tema è schivato da Grillo, come dal Pd.
L’idea-forza del suo Movimento è che di fronte all’impotenza degli Stati, i cittadini devono sollevarsi e dire: «Lo Stato siamo noi». Ma l’idea è troppo poco ambiziosa. Forse è venuta l’ora di mirare molto più in alto, e di affermare: «L’Europa siamo noi», cittadini inascoltati in casa e nell’Unione. Dobbiamo darci una vera costituzione europea, che inizi come quella americana: «Noi, il popolo....».
Questo diceva l’appello di Daniel Cohn-Bendit e Ulrich Beck, il 3 maggio 2012 su Repubblica: se tanti s’indignano, se la crisi sgretola un’intera generazione, è perché «incombe una bancarotta degli Stati-nazione». L’Europa fatta dall’alto va riedificata dal basso. L’appello reclamava un «nuovo contratto fra Stati, Unione europea, strutture politiche nella società civile, mercato, previdenza sociale, sostenibilità ambientale».
Certamente ci sono, nelle 5 Stelle, avversari dell’Europa unita: considerata un’utopia, quando la sola chimera è la sovranità assoluta degli Stati. Ma essere scettici non è sinonimo di anti- europeismo. I federalisti stessi sono scettici, sull’Unione che non è all’altezza della crisi. Essere scettici - non contentarsi delle apparenze - è d’obbligo anche per chi esige oggi un’altra Europa.
Per Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, il voto italiano segnala la voglia di rinnovare la politica, e un rifiuto dell’austerità e della mancanza di risposte europee: «L’Europa ha le sue responsabilità, non può permettersi di fare lo struzzo mettendo la testa sotto la sabbia. Deve chiedersi fino a che punto una strategia di solo rigore, senza forti misure per la crescita, abbia spinto in Italia a un voto di protesta» ( Corriere , 1 marzo 2013).
La risposta non sarà il referendum di Grillo sull’euro: referendum online, riservato solo a chi padroneggia Internet (come superare il divario digitale fra chi accede e chi no, tra anziani e no?).
Se M5S vuol marciare attraverso le istituzioni europee oltre che nazionali, non potrà fare a meno di pensare l’Unione da capo, come formidabile opportunità per recuperare la sovranità perduta dagli Stati-nazione.
Non potrà non guardare la realtà: 6 Stati d’Europa sono di fatto «commissariati» dall’Unione e spesso dal Fondo monetario (Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo, Italia, Cipro). Non è lontano il giorno in cui anche l’Italia, con un debito pubblico non riducibile tagliando solo i costi della politica, dovrà rivolgersi al Fondo salva-Stati, e negoziare il Protocollo d’Intesa previsto dalle sue regole.
Di questo dovrebbe parlare Grillo con le controparti: che faremo, se avremo bisogno del Fondo? Come operare perché l’Unione si accolli parte dei debiti (un piano esiste già, elaborato in Germania: il cosiddetto Fondo di redenzione ) e imbocchi finalmente la via di Hamilton, quando accelerò la nascita in America di un potere federale forte, con poteri impositivi e un proprio bilancio, e su questa base assunse i debiti di Stati stremati dalla guerra d’indipendenza? Lo fece perché il paese usciva da una guerra, è vero. Ma l’Europa traversa una guerra, oggi, tra Stati e mercati.
È utile ripercorrere il tracollo greco. Quando si trovò sull’orlo del default, il Premier Papandreou scelse come consigliere Tommaso Padoa-Schioppa, ex ministro dell’economia nel secondo governo Prodi, e Padoa-Schioppa suggerì questo: sarà inevitabile ridurre il debito, ma come condizione chiedete che l’Europa si dia i mezzi per ri-crescere e sostenervi. La formula era: «Agli Stati il rigore
 all’Europa lo sviluppo». Papandreou divenne un pariah, quando su quest’idea volle indire un
referendum.
all’Europa lo sviluppo». Papandreou divenne un pariah, quando su quest’idea volle indire un
referendum.Joseph Stiglitz, il premio Nobel, ha scritto che il male non è negli Stati, ma nell’Unione restata a metà strada: «L’austerità è una strategia anti-crescita ». L’Europa ha bisogno di un’unione bancaria vera, e di comuni risorse ben più consistenti del «minuscolo bilancio appena decurtato dagli avvocati dell’austerità». Grillo ammira Stiglitz. Ma per ascoltarlo non dovrà accettare di governare in qualche modo?
Si diceva nel ’68 che l’immaginazione era andata al potere. Oggi deve andare al potere anche in Europa, perché lì si deciderà quel che saremo. Si dovrà decidere la politica estera e di difesa, che non potrà più dipendere dagli Usa. Si deciderà l’impoverimento o la ripresa. I militanti M5S sono addestrati a pensare assieme il globale e il locale. Manca loro il cruciale anello europeo.
Lo fa capire un articolo pubblicato su Eurobull.com dal federalista Antonio Longo: lo Stato-nazione «non offre oggi che briciole». Non basterà combattere la corruzione, per una nuova crescita sostenibile. Solo uno sviluppo europeo potrà controbilanciare le austerità nazionali, perché «garantirebbe costi complessivi più bassi, maggiore efficienza grazie alle economie di scala e benefici per tutti». Solo la Federazione salverà l’Italia.
Chiunque parlerà con Grillo avrà davanti a sé qualcuno che esecra i partiti, ma spesso guarda lontano. Grillo vede arrivare banche statali molto plausibili. Invita a scommettere tutto sulla ricerca scientifica (intervista a New Scientist , 27-2-13). Malandata com’è, l’Europa non è nel suo campo visivo. Vale la pena che la faccia entrare. L’occasione è ora. Se torneremo alle urne, l’Italia impaurita sceglierebbe la destra forgiata da Berlusconi. Stesso disastro con un governo tecnico appoggiato dal Pdl (un governo di partiti camuffati): sarebbe l’esplicito riconoscimento che il malcostume, la frode, la compravendita del consenso in Parlamento non sono un crimine. Convaliderebbe l’idea più che mai incongrua che i politici siano «tutti eguali », «tutti ladri». Potrebbe ferire a morte la nostra democrazia, e con essa la cittadinanza attiva voluta da Grillo.
- CULTURA E CRITICA. RIPENSANDO ALLA STORIA DI AXEL SPRINGER, E’ DA DIRE CHE L’ITALIA HA ’BATTUTO’ LA GERMANIA ALLA ’GRANDE’!
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Per una memoria comune d’Europa. La prima Giornata dei giusti che ricorda tutti i genocidi (di Gabriele Nissim)4 marzo 2013, di Federico La Sala
Per una memoria comune d’Europa
La prima Giornata dei giusti che ricorda tutti i genocidi
di Gabriele Nissim (Corriere della Sera, 4 marzo 2013)
Le celebrazioni per la Giornata dei giusti in Europa hanno un risultato sorprendente: per la prima volta si è aperto un processo di condivisione delle memorie. Da Milano, a Praga, a Varsavia, a Bruxelles, a Sarajevo si ricorderanno gli uomini che si sono assunti una responsabilità personale di fronte ai genocidi e ai totalitarismi.
Finora era impensabile che in un’unica giornata gli armeni ricordassero la Shoah assieme alla tragedia che ha colpito il loro popolo, che gli ebrei ricordassero assieme al più terribile genocidio della Storia le vittime di altri massacri in Ruanda o in Cambogia, che nei Paesi dell’Est assieme ai perseguitati del comunismo si ripensasse alla sorte degli ebrei durante il nazismo, dopo tanti anni di rimozione storica.
Questa difficoltà di condivisione non era campata in aria ma aveva ragioni molto serie. Il mondo ebraico, con in testa il memoriale di Yad Vashem, aveva giustamente timore che un processo di comparazione potesse annacquare le responsabilità del mondo nei confronti dello sterminio ebraico.
Ci sono voluti anni perché la riflessione sulla Shoah diventasse patrimonio di tutta la comunità europea e solo in questi ultimi anni in Francia, in Polonia, in Ungheria, in Ucraina si è aperto un dibattito sulle complicità dei loro Paesi e delle loro popolazioni durante lo sterminio nazista.
D’altronde gli armeni consideravano del tutto secondario occuparsi dei genocidi degli altri, quando il loro genocidio continuava a essere rimosso e dimenticato e la Turchia minacciava tutti coloro che se ne interessavano. E oggi le organizzazioni che si battono in Russia per la memoria dei gulag, come Memorial e Nomi restituiti, si trovano in grande difficoltà per il vento nazionalista di Putin che è riuscito a creare una cortina fumogena nei confronti del passato totalitario in nome della difesa della purezza della nazione.
Così per tanti anni il mancato riconoscimento delle responsabilità ha non solo impedito un dialogo fecondo tra le memorie, ma ha rallentato un processo di condivisione di un destino comune, pur all’interno di situazioni differenti.
Ognuno ha pensato esclusivamente alla propria storia e così spesso in Europa si è assistito a una sorta di concorrenza sul valore delle rispettive memorie, come se si dovesse stilare una gerarchia delle sofferenze e ci fossero vittime più significative delle altre.
Il risultato è dunque che un giovane, che vive a Praga, a Varsavia o a Bucarest, non ha la stessa percezione del passato di un giovane italiano, inglese o francese, quando invece una memoria condivisa dovrebbe unire tutti i cittadini europei. A Budapest si è arrivati al paradosso che per ricordare le vittime del comunismo si coprivano le responsabilità di quanti, come l’ammiraglio Horty, sono stati responsabili delle leggi antisemite.
Con la valorizzazione della memoria dei Giusti, ottenuta dall’approvazione della dichiarazione del Parlamento europeo del 10 maggio del 2012, si sono finalmente incrinati degli steccati che sembravano difficilmente ricomponibili.
Il motivo di questo inizio di metamorfosi è di tipo etico. Il richiamo al tema della responsabilità personale, incarnato da tutti gli uomini, che pur con tutte le loro imperfezioni si sono battuti per la dignità dell’altro uomo, permette di creare un inaspettato movimento di empatia.
L’uomo giusto è infatti colui che è stato capace di mettersi nei panni degli altri e di ergersi come un piccolo argine nei confronti del male. Questo tipo di esperienza, da parte di chi ha rischiato la propria vita per gli altri, è stata per certi versi simile nella Shoah, come in Ruanda o nel genocidio armeno.
Quando si riconosce questa similitudine nei comportamenti umani, da parte di chi ha avuto il coraggio di assumersi una responsabilità, diventa più facile comprendere come, al di là di tutte le differenze che hanno segnato i diversi totalitarismi, diventi fondamentale intraprendere un percorso comune e condiviso di tutte le memorie del male. È infatti l’universalizzazione della Shoah, come quella degli altri genocidi, che rende più forte le loro memorie e non la loro contrapposizione.
In tutte queste circostanze gli uomini sono stati chiamati a fare delle scelte sul valore della sacralità della vita e purtroppo solo pochi ne sono stati capaci. È attorno a questo enigma, che - come ha osservato Jan Karski - ha portato alla degenerazione morale di società intere, che diventa importante riflettere sulle storie degli uomini giusti.
Essi insegnano agli europei che la sfida in ogni tempo è sempre la stessa: ogni uomo ha sempre la possibilità di salvare il mondo nel suo piccolo, non aspettandosi che altri lo possano fare per lui.
Emmanuel Lévinas, come ricorda il filosofo Bernhard Casper, che con lui aveva avuto modo di discutere sulla sua esperienza durante la sua prigionia nello Stalag 1492, un campo per prigionieri vicino ad Hannover, gli aveva confidato come di fronte a una violenza gratuita priva di senso che sfuggiva a ogni comprensione, l’unica cosa che gli aveva permesso di resistere era quella voce interiore che gli diceva: «Tu, però, ama. Tu non uccidere e non lasciare l’Altro nel suo essere mortale». Ecco il segreto dei giusti: la responsabilità come l’ultimo baluardo della propria dignità quando l’umanità ha perso la bussola e ogni riferimento morale.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- LA CONQUISTA DELL’ AMAZZONIA. Massacri sognando l’Eldorado (di Massimo Firpo)25 febbraio 2013, di Federico La Sala
LA CONQUISTA DELL’AMAZZONIA
Massacri sognando l’Eldorado
di Massimo Firpo (Il Sole, 03.02.2013)*
«Mobile, liquida, instabile, frammentata e mescolata», così l’autore descrive la sconfinata Amazzonia, quale essa si presentò ai conquistatori europei tra ’500 e ’800. In tutto il continente americano l’arrivo dell’uomo bianco fu tragicamente distruttivo, e non solo perché esso portò con sé una invincibile supremazia tecnologica (il ferro, la polvere da sparo, l’archibugio, il cavallo eccetera), ma perché si presentò con il suo volto più violento e predatorio, con la sua inesauribile bramosia di oro, di argento e di schiavi, e soprattutto perché portò con sé virus e batteri devastanti per gli indigeni, privi di difese immunitarie e ben presto falcidiati da vaiolo, morbillo e influenze di vario tipo.
Ciò avvenne ovunque nel Nuovo Mondo, ma assunse caratteristiche almeno in parte diverse nella sconfinata foresta pluviale che circonda per milioni di chilometri quadrati il grande fiume, abitata da dozzine di tribù molto diverse tra loro, dotate di lingue, forme di vita associata, tecniche di sopravvivenza, caratteristiche identitarie molto diseguali, disperse in un territorio enorme e frammentato, prive delle forme di organizzazione politica, economica e religiosa di Incas e Maya. Anch’esse furono massacrate, razziate, depredate, destrutturate, fino a giungere ai limiti dell’estinzione alla metà del secolo scorso.
E ciò che di se stesse furono capaci di difendere scaturì non tanto dalle fragili resistenze che poterono mettere in atto, ma appunto dalla loro mobilità e instabilità, dal loro allontanarsi dalle rive di un fiume sempre più monopolizzato dagli invasori per cercare scampo nell’inospitale foresta, dal mescolarsi e dividersi, dall’abbandonare senza troppe difficoltà insediamenti precari, dall’arretrare e restringere i loro spazi finché ciò fu possibile.
È questa la storia raccontata nelle dense pagine del libro di Livi Bacci, dove i pochi e spesso contraddittori dati disponibili danno al demografo la possibilità di capire quanti fossero gli uomini che si affacciavano sulle rive del rio delle Amazzoni e dei suoi numerosi affluenti, quali i vuoti aperti dalle violenze di spagnoli e portoghesi e dalle malattie al loro seguito, mentre i pur confusi resoconti dei primi viaggiatori offrono un corposo materiale di riflessione sulla dimensione antropologica di quelle pur primitive aggregazioni sociali e sulle loro molteplici diversità.
Su di esse il libro indaga con accorta sensibilità, nella consapevolezza di potersi basare esclusivamente su quanto ne scrissero esploratori e missionari europei, ascoltando cioè solo la voce dei dei vincitori, poiché quella dei vinti non ha lasciato tracce ed è perduta per sempre. Ma demografia e antropologia si innestano a loro volta su una robusta prospettiva storica, che segue il dipanarsi di quella che potrebbe definirsi la brutale scoperta ed esplorazione dell’Amazzonia nei primi tre secoli in cui essa fu nota all’uomo bianco. Scoperta ed esplorazione che muovevano necessariamente da Occidente, dal Perù e dall’Ecuador, poiché era impossibile risalire a forza di remi la corrente del fiume a partire dal suo sbocco al mare.
Ma ciò comportava altresì il fatto che per raggiungere il bacino del rio delle Amazzoni occorreva valicare l’imponente bastione delle Ande, arrampicarsi su colli a 4mila metri d’altezza e ridiscendere a precipizio per vie impervie che conducevano a terre incognite, dove tutto era aspro e ostile; e comportava l’impossibilità di muovere da basi solide e attrezzate, di ricevere rinforzi o approvvigionamenti, di avere agevoli vie di ritirata. Chi lo faceva, lo faceva a suo rischio e pericolo, e senza vie di fuga.
E così fu per le prime spedizioni alla ricerca del mitico Eldorado, la città dove anche le tegole delle case erano d’oro, e poi per le imprese di avventurieri disposti a tutto,
E così fu per le prime spedizioni alla ricerca del mitico Eldorado, la città dove anche le tegole delle case erano d’oro, e poi per le imprese di avventurieri disposti a tutto, pronti a scendere su quell’immenso fiume a bordo di imbarcazioni fatiscenti, tormentati dagli stenti, dalla fame, dagli insetti, da animali pericolosi, da febbri e malattie, da popolazioni diffidenti e ben presto ostili, dopo che ovunque fu nota la brutalità e la violenza con cui gli spagnoli depredavano, razziavano, uccidevano.
Il primo viaggio giunto fino all’Atlantico, fu quello di Francisco de Orellana nel 1541, seguito da Pedro de Ursúa nel 1560, con al seguito il folle e sanguinario Lope de Aguirre (il furore di Dio interpretato da Klaus Kinski nel film di Werner Herzog), il cui tentativo di sostituirsi all’autorità di Filippo II in quelle terre sperdute e lontane finì in un gorgo senza fine di orrori e atrocità. E poi via via tutti gli altri, fino al grande scienziato francese Charles-Marie de la Condamine, capace di porre su nuove basi scientifiche la conoscenza di quell’immenso territorio, ma non disposto a scorgere negli indios se non miserabili selvaggi, privi di intelligenza e sentimento, animali bruti in grado di comprendere solo le dure leggi della sopravvivenza. I poveri amazzonici, ai quali mancò nel 500 un Bartolomé de Las Casas che ne patrocinasse la dignità e i diritti, ebbero il privilegio di essere esclusi anche dal settecentesco mito del buon selvaggio.
E infine, al seguito di esploratori e avventurieri, e sempre più numerosi con il passare del tempo, i missionari, spinti fin laggiù dal loro ardore religioso, ma non di rado stritolati dall’atroce durezza della vita di quella foresta inospitale, impossibilitati a raccogliere intorno alle chiese delle loro reducciones se non piccole comunità isolate, disperse e fluttuanti, disponibili ad accettare il battesimo soprattutto se ciò comportava il ricevere utensili di ferro, asce, machete, coltelli, ma pronte in caso contrario ad abbandonare i gesuiti e Gesù Cristo. Una cristianizzazione rozza e fallita, sulla quale la soppressione della Compagnia di Gesù nel Settecento fece calare l’ultimo sipario.
Ma vale la pena di leggere la storia, l’ennesima storia, della mannaia europea che le grandi scoperte geografiche della fine del Quattrocento fecero calare ovunque e senza pietà sulle popolazioni più arretrate allora confluite nell’orbita dell’Occidente, sia pure in tempi e modi diversi nell’America del Sud come in quella del Nord, fino alla spietata caccia ai pellerossa delle grandi praterie nell’Ottocento, quando si consumò anche l’ultima tragedia dei maori neozelandesi e degli aborigeni australiani. Atroci ferite della storia e del determinismo geografico, il cui retaggio è ancora presente nel nostro mondo, senza che ci si possa illudere che noi saremmo stati migliori dei nostri brutali antenati.
*Massimo Livi Bacci, Amazzonia. L’Impero dell’acqua, Il Mulino, Bologna, pagg. 296, e. 26.00
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- PER NON DIMENTICARE: UNA MEMORIA DI ELSA MORANTE (Roma 1° maggio 1945).25 febbraio 2013, di Federico La Sala
Dal "Diario" di Elsa Morante*
Roma 1° maggio 1945
Mussolini e la sua amante Clara Petacci sono stati fucilati insieme, dai partigiani del Nord Italia. Non si hanno sulla loro morte e sulle circostanze antecedenti dei particolari di cui si possa essere sicuri. Così pure non si conoscono con precisione le colpe, violenze e delitti di cui Mussolini può essere ritenuto responsabile diretto o indiretto nell’alta Italia come capo della sua Repubblica di Sociale. Per queste ragioni è difficile dare un giudizio imparziale su quest’ultimo evento con cui la vita del Duce ha fine.
Alcuni punti però sono sicuri e cioè: durante la sua carriera, Mussolini si macchiò più volte di delitti che, al cospetto di un popolo onesto e libero, gli avrebbe meritato, se non la morte, la vergogna, la condanna e la privazione di ogni autorità di governo (ma un popolo onesto e libero non avrebbe mai posto al governo un Mussolini). Fra tali delitti ricordiamo, per esempio: la soppressione della libertà, della giustizia e dei diritti costituzionali del popolo (1925), la uccisione di Matteotti (1924), l’aggressione all’Abissinia, riconosciuta dallo stesso Mussolini come consocia alla Società delle Nazioni, società cui l’Italia era legata da patti (1935), la privazione dei diritti civili degli Ebrei, cittadini italiani assolutamente pari a tutti gli altri fino a quel giorno (1938).
Tutti questi delitti di Mussolini furono o tollerati, o addirittura favoriti e applauditi. Ora, un popolo che tollera i delitti del suo capo, si fa complice di questi delitti. Se poi li favorisce e applaude, peggio che complice, si fa mandante di questi delitti. Perché il popolo tollerò favorì e applaudì questi delitti? Una parte per viltà, una parte per insensibilità morale, una parte per astuzia, una parte per interesse o per machiavellismo.
Vi fu pure una minoranza che si oppose; ma fu così esigua che non mette conto di parlarne. Finché Mussolini era vittorioso in pieno, il popolo guardava i componenti di questa minoranza come nemici del popolo e della nazione, o nel miglior dei casi come dei fessi (parola nazionale assai pregiata dagli italiani). Si rendeva conto la maggioranza del popolo italiano che questi atti erano delitti? Quasi sempre, se ne rese conto, ma il popolo italiano è cosìffatto da dare i suoi voti piuttosto al forte che al giusto; e se lo si fa scegliere fra il tornaconto e il dovere, anche conoscendo quale sarebbe il suo dovere, esso sceglie il suo tornaconto.
Mussolini, uomo mediocre, grossolano, fuori dalla cultura, di eloquenza alquanto volgare, ma di facile effetto, era ed è un perfetto esemplare e specchio del popolo italiano contemporaneo. Presso un popolo onesto e libero, Mussolini sarebbe stato tutto al più il leader di un partito con un modesto seguito e l’autore non troppo brillante di articoli verbosi sul giornale del suo partito. Sarebbe rimasto un personaggio provinciale, un po’ ridicolo a causa delle sue maniere e atteggiamenti, e offensivo per il buon gusto della gente educata a causa del suo stile enfatico, impudico e goffo. Ma forse, non essendo stupido, in un paese libero e onesto, si sarebbe meglio educato e istruito e moderato e avrebbe fatto migliore figura, alla fine. In Italia, fu il Duce. Perché è difficile trovare un migliore e più completo esempio di Italiano.
Debole in fondo, ma ammiratore della forza, e deciso ad apparire forte contro la sua natura. Venale, corruttibile. Adulatore. Cattolico senza credere in Dio. Corruttore. Presuntuoso: Vanitoso. Bonario. Sensualità facile, e regolare. Buon padre di famiglia, ma con amanti. Scettico e sentimentale. Violento a parole, rifugge dalla ferocia e dalla violenza, alla quale preferisce il compromesso, la corruzione e il ricatto. Facile a commuoversi in superficie, ma non in profondità, se fa della beneficenza è per questo motivo, oltre che per vanità e per misurare il proprio potere. Si proclama popolano, per adulare la maggioranza, ma è snob e rispetta il denaro. Disprezza sufficientemente gli uomini, ma la loro ammirazione lo sollecita.
Come la cocotte che si vende al vecchio e ne parla male con l’amante più valido, così Mussolini predica contro i borghesi; accarezzando impudicamente le masse. Come la cocotte crede di essere amata dal bel giovane, ma è soltanto sfruttata da lui che la abbandonerà quando non potrà più servirsene, così Mussolini con le masse. Lo abbaglia il prestigio di certe parole: Storia, Chiesa, Famiglia, Popolo, Patria, ecc., ma ignora la sostanza delle cose; pur ignorandole le disprezza o non cura, in fondo, per egoismo e grossolanità. Superficiale. Dà più valore alla mimica dei sentimenti , anche se falsa, che ai sentimenti stessi. Mimo abile, e tale da far effetto su un pubblico volgare.
Gli si confà la letteratura amena (tipo ungherese), e la musica patetica (tipo Puccini). Della poesia non gli importa nulla, ma si commuove a quella mediocre (Ada Negri) e bramerebbe forte che un poeta lo adulasse. Al tempo delle aristocrazie sarebbe stato forse un Mecenate, per vanità; ma in tempi di masse, preferisce essere un demagogo. Non capisce nulla di arte, ma, alla guisa di certa gente del popolo, e incolta, ne subisce un poco il mito, e cerca di corrompere gli artisti. Si serve anche di coloro che disprezza. Disprezzando (e talvolta temendo) gli onesti, i sinceri, gli intelligenti poiché costoro non gli servono a nulla, li deride, li mette al bando.
Si circonda di disonesti, di bugiardi, di inetti, e quando essi lo portano alla rovina o lo tradiscono (com’è nella loro natura), si proclama tradito, e innocente, e nel dir ciò è in buona fede, almeno in parte; giacché, come ogni abile mimo, non ha un carattere ben definito, e s’immagina di essere il personaggio che vuole rappresentare.
* Cfr.: Elsa Morante, Opere, Mondadori (Meridiani), Milano 1988, vol. I, pp. L-LII.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Albert Camus l’europeista. Il documento dello scrittore sul futuro del Continente.25 febbraio 2013, di Federico La Sala
 Albert Camus l’europeista
Albert Camus l’europeista
 Il documento dello scrittore sul futuro del Continente
Il documento dello scrittore sul futuro del Continente
 Nel 1955 l’intellettuale francese intervenne ad Atene sulle speranze del «puzzle» politico e geografico
Nel 1955 l’intellettuale francese intervenne ad Atene sulle speranze del «puzzle» politico e geografico
 Tesi profetiche e attualissime
Tesi profetiche e attualissimedi Anna Tito (l’Unità, 25.02.2013)
IL FUTURO DELLA CIVILTÀ EUROPEA È UN TEMA DI STRAORDINARIA ATTUALITÀ, E SEMBRA CHE SOLTANTO SI PONGANO DETERMINATI INTERROGATIVI, MA NON È COSÌ: il 28 aprile del 1955, a dieci anni dalla fine del secondo conflitto mondiale l’Unione culturale greco-francese organizzò ad Atene un incontro proprio su Il futuro della civiltà europea, e quel confronto intellettuale ebbe una risonanza particolare perché invitato a parlare di Europa fra antiche ferite e nuove speranze era lo scrittore francese, nonché filosofo, uomo di teatro, giornalista, militante politico Albert Camus (1913 - 1960), autore di Lo straniero che due anni dopo gli valse il Premio Nobel, e di altri capolavori quali La Peste e Il mito di Sisifo.
L’editore Castelvecchi propone ora il testo della conferenza (Albert Camus, Il futuro della civiltà europea, pagine 54, euro 7,00), tradotto e curato da Alessandro Bresolin, saggista e specialista di Camus. Il volume ci permette di apprezzare l’approccio di un intellettuale in grado di affrontare, come nessun altro, i nodi cruciali del suo tempo e che, attingendo al proprio patrimonio culturale di «uomo europeo», parla a un’Europa che ancora stenta a risollevarsi dalla distruzione bellica.
Questa civiltà - a suo avviso - si fonda in primo luogo sul pluralismo, in quanto essa «è il luogo della diversità delle opinioni, delle contrapposizioni, dei valori contrastanti e della dialettica che non arriva a una sintesi».
Lo scrittore ci appare interessato al presente, inteso come «qualcosa che va al di là del giorno o dell’anno in cui siamo», alla sopravvivenza della civiltà europea, prima ancora che al suo futuro. Constata infatti, dopo due guerre mondiali, «la strana sconfitta morale di questa civiltà», e ritiene che si debba comprendere da dove proviene questa sconfitta, curare le ferite ancora aperte, prima di guardare oltre.
Fin dai tempi della guerra e della Resistenza cui aveva preso parte attiva, Camus concepiva l’Europa come un’unità geografica e culturale. Persisteva pertanto nel dichiararsi contrario alla divisione del continente in aree di influenza, pur consapevole del fatto che la storia stava andando in direzione opposta.
Da autentico socialista libertario, nutriva un’immensa fiducia nel federalismo europeo e mondiale, convinto che, per giungere alla pace, l’Europa dovesse da subito unirsi in un forte modello federale e non in una «tiepida» confederazione di Stati che avrebbe lasciato inalterato quell’anacronismo rappresentato dalle sovranità nazionali, specie in un contesto mondiale segnato dall’internazionalizzazione dell’economia.
Per sopravvivere, una società deve rispettare l’individuo, e di conseguenza difendere il pluralismo, elemento essenziale di un’unità rispettosa delle diversità. L’unificazione europea, per lui, andava pertanto subito realizzata, e constatava che nel decennio seguito alla Liberazione nel 1945, gli Stati non avevano fatto «altro che ristrutturarsi e organizzarsi, accordandosi solo per una blanda unione economica». Forse anche per questo motivo, dopo gli entusiasmi federalisti del 1944 - 1948, Camus si allontanò in seguito dalla politica europea, evitando qualsiasi commento sulla notizia della firma del Trattato di Roma nel 1957.
Da allora si sono compiuti molti passi in avanti, ma di fatto l’Europa è rimasta quella confederazione di Stati sovrani in cui ciascuno porta vanti «la propria politica e il proprio sterile patriottismo». In quest’ottica le parole di Camus appaiono di una stupefacente attualità: «L’Europa è costretta in una ventina di lacci in un quadro rigido all’interno del quale non riesce a respirare».
-
>Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. --- LA GRANDE FORESTA ("INGENS SYLVA") E LA STORIA DEI LEMURI: LA LEZIONE DI VICO, OGGI.23 febbraio 2013, di Federico La Sala
 Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni ...
Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni ...
 L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova"
L’ITALIA AL BIVIO: VICO E LA STORIA DEI LEMURI (LEMURUM FABULA), OGGI. Un invito alla (ri)lettura della "Scienza Nuova"
 Potrai facilmente, o Leggitore, intendere la bellezza di questa divina Dipintura dall’orrore, che certamente dee farti la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria.
Potrai facilmente, o Leggitore, intendere la bellezza di questa divina Dipintura dall’orrore, che certamente dee farti la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria.
-
> Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. --- Goethe, il dominio mondiale del denaro, e il Faust digitale del nuovo capitalismo (di Ulrick Beck)23 febbraio 2013, di Federico La Sala
Il Faust digitale del nuovo capitalismo
di Ulrick Beck (la Repubblica, 23.02.2013
SULL’HOMO oeconomicus, sull’ideologia neoclassica o neoliberale è stato detto tutto - ma non da tutti. Già nel 1832 Goethe, il poeta tedesco prediletto, aveva preconizzato - in versi! - nella seconda parte del suo Faust il dominio mondiale del denaro. Eppure, all’inizio del XXI secolo dobbiamo aggiungere qualcosa di essenziale, di nuovo, di originale: il “Faust digitale” o, più precisamente, la temerarietà e la cecità “faustiani” dell’ego-capitalismo.
Frank Schirrmacher, condirettore della Frankfurter Allgemeine Zeitung, nel suo libro Ego, appena uscito, descrive come l’implementazione di questo “nuovo” egoismo acquisti un carattere normativo e dopo la guerra fredda suggelli la vittoria della teoria della rational choice fin nei più piccoli dettagli del mondo della vita. Anzi, addirittura fin nell’anima digitale dell’“homo novus”. Perfino la formula della mauvaise foi coniata da Jean-Paul Sartre non va abbastanza a fondo, poiché presuppone pur sempre la libertà della scelta di se stessi. L’Io colonizzato dal capitalismo ha però perduto questo orizzonte di alternatività. Naturalmente, gli economisti dicono quello che dicono sempre: si tratta soltanto di modelli. L’homo oeconomicus non è altro che un’ipotesi. Chiaramente, lo era prima di diventare un soggetto che agisce mediante sistemi operativi.
Il real drama dal finale aperto, di cui noi tutti siamo oggi attori e spettatori, vittime e complici, ruota attorno a come l’“homunculus oeconomicus” - un cyborg, un androide, una figura artificiale, un essere uomomacchina - sia uscito dai “laboratori frankensteiniani di Wall Street”. Questa narrazione drammatica trae forza anche dalla brutale semplicità con la quale all’ipercomplessità del mondo si reagisce con 1 e 0, sì e no, accendere e spegnere; questo, per le persone ridotte a codici informatici, significa “agire” in base alle leggi degli economisti. L’individuo individualizzato, astratto, è altrettanto poco complesso e altrettanto poco sociale quanto i pezzi degli scacchi, che servono a ingannare strategicamente l’altro.
Non si crede più a nulla, ma solo a ciò che si vuole. Da qui la sfiducia di tutti nei confronti di tutti, dalla quale si diffonde ovunque il male. Qui sta il paradosso: nel momento storico in cui le istituzioni del welfare, i mercati finanziari e il rapporto con l’ambiente naturale sono entrati in una crisi fondamentale, nascono le “ego-monadi”. La loro funzionalità non consiste soltanto nel mettere in ombra le conseguenze del proprio agire per gli altri. Esse vanno anche decifrate come strategia di schivamento del rischio in un mondo di rischi globali - come patologia sociale dell’ego- capitalismo.
La crisi finanziaria e dell’euro dischiude soltanto un primo sguardo su questo accecamento del Faust digitale. I mercati finanziari sono soltanto i primi mercati automatizzati. Ma altri ne seguiranno. Comunicazione sociale, big data, i servizi segreti, il controllo dei consumatori, i veri o presunti terroristi, le università nella vertigine delle riforme neoliberali, le relazioni d’amore digitalizzate, gli scontri tra le religioni mondiali nello spazio digitale, ecc.
Cosa c’è di nuovo nel Faust digitale? Nel Medioevo gli alchimisti cercavano di trasformare metalli non nobili in oro. Gli odierni “alchimisti del mercato” (Schirrmacher) trasformano ipoteche tossiche e altamente rischiose in prodotti di prima classe, classificati come tanto sicuri da venire acquistati dai fondi-pensione. Si può comperare una casa senza denaro e continuare a spendere il denaro che non esiste? Sì, si può, ribattono i giocolieri neoalchimisti delle banche too-big-to-fail che operano in tutto il mondo.
Quanto al resto: la religione, Freud, la poesia - tutto nel museo delle idee morte dell’umano! Dinanzi a noi sta il nuovo mondo della manipolazione digitale dell’anima.
L’hybris di potenza faustiana confina con il filisteismo. Innumerevoli, spesso stolidi attori digitali sono così innamorati delle loro idee da non accorgersi che da ingredienti come il proprio tornaconto, la ricerca del profitto ad ogni costo e la capacità di escogitare trucchi nascono mostri. Anche mostri politici. La politica del risparmio, con la quale attualmente l’Europa risponde alla crisi finanziaria scatenata dalle banche, viene percepita dai cittadini come una mostruosa ingiustizia. Per la leggerezza con la quale le banche hanno polverizzato somme inimmaginabili essi devono pagare con la moneta sonante della loro esistenza.
I tecnocrati della finanza, questi interpreti della mostruosità, hanno sviluppato un linguaggio curiosamente terapeutico. I mercati sono “timidi” come caprioli, dicono. Non si lasciano “ingannare”. Ma gli inappellabili giudici economici, chiamati “agenzie di rating”, che professano anch’essi la religione mondana della massimizzazione dei profitti, emettono, in base alle leggi dell’ego-capitalismo, sentenze che colpiscono interi Stati al cuore della loro economia - perlomeno quella dell’Italia, della Spagna e della Grecia.
“Ognuno deve diventare il manager del proprio Io” (Schirrmacher). È passato il tempo nel quale gli imprenditori erano imprenditori e i lavoratori lavoratori. Ora, nello stadio dell’ego-capitalismo, è sorta la nuova figura sociale dell’“imprenditore di se stesso”; ossia, l’imprenditore scarica sull’individuo la coazione all’autosfruttamento e all’autooppressione e questo dovrebbe suscitare entusiasmo, poiché questo è l’uomo nuovo, generato nel bel mondo nuovo del lavoro. L’imprenditore di se stesso diventa, per così dire, la “pattumiera” dei problemi insoluti di tutte le istituzioni. E deve trasformare a sua volta la pattumiera, questo garbage can a cui è stasione to ridotto, in un processo creativo di se stesso.
E tuttavia l’“individualizzazione”, intesa in senso sociologico, è ben più di questo: è “individualismo istituzionalizzato”. Non si tratta soltanto di un’ideologia sociale o di una forma di percezione del singolo, ma di istituzioni centrali della società moderna, come ad esempio i diritti civili, politici e sociali fondamentali, che hanno tutti per destinatario l’individuo. Nasce così una generazione global, interconnessa in una rete transnazionale e avviata a sperimentare come l’individualismo e la morale sociale possano tornare ad accordarsi tra loro e come la libera volontà e l’individualità si possano conciliare con il mettersi a disposizione degli altri.
Molti ragazzi non sono più disposti a essere soldati che eseguono le direttive gerarchiche delle organizzazioni assistenziali o a dare, o meglio a consegnare il loro voto come soldati di partito che devono soltanto fare numero. Al contrario: le istituzioni - sindacati, partiti politici, chiese - stanno diventando cavalieri senza cavalli. La ribellione e la critica contro il capitalismo che si stanno diffondendo nel mondo nascono da entrambi questi fattori e dalla loro collisione:l’individualizzazione dei diritti fondamentali e la mercatizzazione dell’Io, conseguenza di regole economiche cristalline.
Al più tardi a partire dalla fusione del nocciolo del capitalismo finanziario il messaggio con il quale l’ideologia neoliberale aveva conquistato il mondo dopo il crollo del comunismo è andato in pezzi. I profeti del mercato non predicavano semplicemente l’economia di mercato, ma promettevano il socialismo migliore. Questa visione così ambiziosa dell’ego-capitalismo sopravvive soltanto nei circoli degli incrollabili fondamentalisti del mercato. E anche qui non è più così monolitica, come dimostrano i recenti contrasti tra i repubblicani negli Usa, alcuni dei quali si stanno convertendo a una regolazione statale dei mercati finanziari.
Il rischio sempre più palpabile del crollo ha anche ridestato il sogno di una nuova Europa. “Unione bancaria” è una delle parole di speranza. L’idea-guida si basa sull’assunto che la catastrofe anticipata comporti l’imperativo cosmopolitico: applica regole internazionali, cambia l’ordine esistente del politico! Ovunque sono all’opera rivoluzionari part-time che lavorano in questa direzione - mi limito a citare Mario Monti, impegnato nel far cambiare rotta alla Banca centrale europea.
Viviamo in un’epoca nella quale è accaduto qualcosa di inimmaginabile fino a poco tempo fa, ossia che i fondamenti del capitalismo globale allora “razionale” ma adesso “irrazionale” siano diventati sempre più politici, cioè problematici, cioè politicamente configurabili. Esistono versioni radicalmente differenti del futuro dell’Occidente, dove ormai è in corso quasi una guerra fredda interna: da un lato c’è chi vuole un capitalismo regolabile, che cerca il compromesso con i movimenti sociali ed è aperto alle questioni ambientali e dall’altro c’è chi punta sull’autoregolazione dell’ego-capitalismo globalizzato e su un’intensificazione degli interventi militari, nel tentativo di creare la coesione nazionale mediante schemi amico-nemico - questo è il nocciolo del conflitto.
I rischi globali sono una sorta di memoria collettiva forzata - del fatto che il potenziale di annientamento a cui siamo esposti reca in sé le nostre scelte e i nostri errori. Essi compenetrano ogni ambito della vita, ma nello stesso tempo dischiudono nuove opportunità per riorganizzare il mondo. Questo è il paradosso dell’incoraggiamento che viene dai rischi globali. Qui sta l’opzione europea: nel porre sistematicamente la questione dell’alternativa all’ego- capitalismo digitale. Ossia la questione di come siano possibili una maggiore libertà, una maggiore sicurezza sociale e una maggiore democrazia grazie a un’altra Europa.
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- NEW HARMONY. L’utopia di Robert Owen, quel socialismo che abbiamo smarrito (di Lucio Villari).22 febbraio 2013, di Federico La Sala
L’utopia di Owen quel socialismo che abbiamo smarrito
di Lucio Villari (la Repubblica, 21 febbraio 2013)
Nel 1816, nel pieno della rivoluzione industriale inglese, Ugo Foscolo si trasferì in esilio volontario a Londra. Veniva da un agitato e povero soggiorno in Svizzera e non voleva ritornare nella Milano austriaca. E a Londra fu accolto con affetto e onore da politici e letterati cui era giunta la sua fama. Era fuggito dall’Italia lasciando incompiuto il poema Le Grazie dove avrebbe voluto raccontare in versi l’Armonia e «idoleggiare le idee metafisiche del Bello».
A Londra però l’attendevano altri impegni: la ricerca letteraria e critica, un’attività giornalistica come collaboratore di riviste inglesi e le inquietudini di osservatore della realtà sociale del paese che lo aveva accolto. Curioso delle macchine e dei progressi industriali in corso, visitò nel 1822 Manchester e Liverpool, fumanti di ciminiere, tra fragori di officine, soprattutto tessili, e rumorosi cantieri e fu una folgorazione: al poeta della bellezza si apriva lo scenario brutale dell’industrializzazione e del profitto capitalistico.
Scrisse a una amica: «I vostri figli, o al più tardi i vostri nipoti si accorgeranno che la vera rivoluzione sarà qui tacitamente prodotta da un lato dalla disperata miseria della moltitudine, e dall’altro dalla potenza economica dei plebei arricchiti». E, alla fine, concludeva, si impianterà «la più terribile delle tirannidi, quella degli Oligarchi padroni delle manifatture che non hanno altra idea, altro sentimento che quello di fare fortuna».
Foscolo anticipava di vent’anni l’ansia di Leopardi per l’incalzare di «macchine al cielo emulatrici»; a cominciare dall’«Anglia tutta con le macchine sue» della Palinodia. I due poeti forse credevano di essere soli o tra pochissimi uomini di cultura a rimanere perplessi e sgomenti di fronte alle contraddizioni del progresso industriale, ma non era così perché proprio in quei vent’anni, anche in piena ideologia del libero mercato, stavano maturando, soprattutto in Inghilterra, riflessioni molto critiche sui limiti e i difetti di quella rivoluzione economica.
E non era il lamento di aristocratici conservatori, di proprietari terrieri scalzati dal progresso (in un’inchiesta del 1811 risultava che i lavoratori dell’Inghilterra, della Scozia e del Galles occupati nell’industria e nel commercio superavano ormai di una volta e mezza quelli dell’agricoltura), ma di uomini d’affari e imprenditori intelligenti, non appartenenti ai «plebei arricchiti», e di studiosi attenti della società.
Saranno questi a gettare i primi semi di un mondo nuovo, diverso, progredito ma civile. In particolare uno di loro, Robert Owen, finito stranamente tra gli "utopisti" forse perché verrà accomunato nel Manifesto dei comunisti di Marx e Engels a quei singolari pensatori (ad esempio, Fourier e Saint-Simon) che «emergono nel primo periodo, non sviluppato, della lotta tra proletariato e borghesia».
In verità, nella descrizione precisa e nella critica del capitalismo industriale, Marx ed Engels sono arrivati dopo di lui e comunque senza Owen non sarebbe nato il socialismo in Inghilterra e non sarebbero iniziate l’esplorazione e la diagnosi del modo di produzione industriale, delle condizioni di vita e di salute degli uomini, delle donne e dei bambini impegnati nelle officine e nelle miniere, né sarebbe apparsa, nella polemica politica di quegli anni, la possibilità che la società industriale potesse essere più vivibile di quella che si era venuta formando.
Non risponde dunque a verità storica il fatto che l’avere Owen creduto in quella "possibilità" ne facesse l’esponente di un sogno utopistico, lontano dalla conoscenza dei rapporti effettivi di produzione e in assenza della lotta di classe dal cui esito vittorioso per il proletariato avrebbe potuto essere rovesciato quel mondo di povertà e di sfruttamento.
Anzi, pensando all’utopia "possibile" del tempo di Owen e del contemporaneo Henri de Saint-Simon (di cui è recente in Francia la riedizione degli scritti dove è limpidamente disegnato un futuro reale, non un sogno) si rimane sgomenti della contraddizione intellettuale e politica in cui si trova l’Europa attuale.
Qui sembra perduta per sempre ogni ipotesi di riforma e di cambiamento che guardi oltre il presente, che osi immaginare, come fece Saint-Simon nel 1814 nel volume La riorganizzazione della società europea, un socialismo creativo in una «stretta eguaglianza di ordinamenti, di interessi e di istituzioni».
Una Europa dunque senza riferimenti, attraversata e accomunata dalla paura, dal rifiuto per tutto ciò che non sia una razionalizzazione dell’esistente. Eppure nessun futuro sembra dispiegarsi davanti a noi se non riprendendo proprio l’intelligenza delle cose, quel filo che qualcuno aveva cominciato a svolgere proprio ai primi dell’Ottocento.
Infatti, duecento anni or sono, nel 1813, Owen aveva pubblicato un saggio che fece scalpore, Per una concezione nuova della società. Segnava l’inizio di una stagione di idee riformatrici che nel 1815, un anno prima della visita di Foscolo a Manchester, saranno più visibili nel saggio Osservazioni sugli effetti del sistema industriale. I titoli dicono molto perché Owen sapeva benissimo di cosa parlava.
A vent’anni, nel 1791, aveva diretto una delle più grandi filande del Lancashire, dove lavoravano cinquecento operai e poco dopo, ormai ricco industriale e membro tra i più autorevoli della Società letteraria e filosofica di Manchester, era divenuto proprietario delle più moderne filande di New Lanarck, in Scozia.
La sua azienda era fiorente e per venticinque anni Owen sperimentò un modello di società industriale dove il ruolo dell’imprenditore-capitalista fosse non solo quello di creare oggetti, ma di avere per collaboratori soggetti (i lavoratori e le loro famiglie) sani, ben retribuiti, felici del loro lavoro, partecipi delle sorti del tessuto civile e sociale della comunità. Insomma, l’industria come un servizio sociale e tramite di crescita culturale e morale senza bisogno della «lotta tra proletariato e borghesia» di cui parlerà il Manifesto.
Che il progetto, realizzato, fosse unico, inedito, sorprendente lo prova il fatto che a New Lanarck affluirono visitatori e osservatori da tutto il mondo per vedere come mai gli alti salari, le ore di lavoro ridotte, la protezione delle donne e dei minori impegnati nel lavoro, buone case, cibi e vestiti decenti, fabbriche areate e circondate dal verde, l’educazione scolastica dei bambini ispirata al laicismo, all’ateismo, alla conoscenza e alla solidarietà, producessero così grandi guadagni al proprietario.
Tanto più che Owen aveva dato un limite al profitto del suo capitale e aveva deciso che i profitti eccedenti fossero tradotti in servizi sociali a favore dei lavoratori della fabbrica. Ebbene, il saggio Per una concezione nuova della società e lo scritto successivo destinato a correggere «le parti più dannose alla salute e alla morale» dei lavoratori del sistema industriale non erano altro che il risultato dei piani di Owen per le sue fabbriche "umanizzate". Se poteva apparire un’utopia essa era tale che, attuata nella vita sociale, avrebbe, come scrisse lo storico Maurice Dobb, «spazzato via in breve tempo il capitalismo e il sistema concorrenziale».
Il prestigio di cui godeva Owen impedì che la sua visione rivoluzionaria venisse subito spazzata via dai difensori dell’altro capitalismo. Si attese che egli, nella sua intensa attività pubblicistica e di divulgatore delle sue idee a tutti i livelli delle istituzioni politiche, si scontrasse finalmente con le chiusure conservatrici della Chiesa. Allora fu attaccato frontalmente e decise di recarsi negli Stati Uniti dove, nel 1825, fondò la comunità New Harmony (il nome sarebbe piaciuto a Foscolo) e poi organismi sindacali, cooperative, scuole dando un corpo concreto all’owenismo. Furono anni di speranze, di sconfitte, di illusioni perdute contro gli orrori della rivoluzione industriale e nel sogno di una società di persone felici del loro lavoro, non inchiodate dal bisogno e dallo sfruttamento. Ebbe fino all’ultimo (morirà nel 1858) l’intelligenza e la curiosità di forzare l’enigma di un progresso necessario, ma fonte di ingiustizie, di crisi, di inquinamento. Un enigma in attesa, duecento anni dopo, di essere risolto.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- UN RINASCIMENTO PER L’EUROPA. La dichiarazione di Torino del vertice dei Progressisti europei.11 febbraio 2013, di Federico La Sala
 La dichiarazione di Torino: un rinascimento per l’Europa
La dichiarazione di Torino: un rinascimento per l’Europa
 Pubblichiamo l’atto finale del vertice dei Progressisti europei, concluso sabato a Torino
Pubblichiamo l’atto finale del vertice dei Progressisti europei, concluso sabato a Torino «Per una Unione democratica di pace, prosperità e progresso»
«Per una Unione democratica di pace, prosperità e progresso» Completare un’autentica Unione economica e monetaria richiede una revisione dei Trattati
Completare un’autentica Unione economica e monetaria richiede una revisione dei Trattati
 Una Unione democratica è indispensabile per dare agli europei la possibilità di incidere sul mondo *
Una Unione democratica è indispensabile per dare agli europei la possibilità di incidere sul mondo *Il 2013 è un anno cruciale per l’Europa progressista. Dopo le vittorie dei socialisti in Slovacchia, Francia e Romania nel 2012, le elezioni in Italia e Germania potrebbero cambiare gli equilibri in seno al Consiglio europeo, aprendo la strada a una maggioranza progressista dopo le elezioni europee del 2014. La dichiarazione di Parigi e il lancio dell’iniziativa Renaissance for Europe nel marzo 2012 si sono concentrate sulla necessità di andare oltre le politiche di austerità, delineando i tratti di un nuovo e più equilibrato corso per un’Europa basata su stabilità, crescita e solidarietà. A Torino vogliamo elaborare la nostra visione dell’Europa politica: una Unione della democrazia basata su una sovranità condivisa, che costituisce la condizione essenziale per affrontare la crisi e per restituire potere ai cittadini e fiducia nel progetto europeo. Ciò che vogliamo realizzare è una Unione di progresso e prosperità per tutti, con un forte mandato da parte dei cittadini europei.
RIDEFINIRE I FONDAMENTI: SVILUPPARE LA DEMOCRAZIA
La crisi economica e finanziaria ha evidenziato la debolezza della governance dell’euro. L’introduzione di una moneta comune non è stata seguita dal completamento di una vera unione economica. Quindi, nonostante l’euro sia divenuto un simbolo importante del progresso nell’integrazione, esso non è diventato sinonimo di sicurezza, stabilità e controllo democratico. L’assenza di una adeguata architettura istituzionale si è riflessa in un compromesso tra l’intergovernativismo delle risorse da un lato, e il metodo comunitario delle regole dall’altro. Il primo ha implicato la canalizzazione dell’aiuto finanziario da parte degli Stati membri attraverso organismi intergovernativi. Il secondo, invece, si è tradotto in regole più severe di disciplina fiscale al livello europeo, con la conseguente attuazione delle politiche di austerità.
Questo impianto si è dimostrato inefficace, sia politicamente che economicamente. Non ha migliorato la stabilità finanziaria e la sostenibilità fiscale. Al contrario, ha innescato un circolo vizioso di recessione e peggioramento dei conti pubblici, le cui conseguenze economiche e soprattutto sociali sono devastanti. Il deficit democratico delle politiche europee è arrivato fino agli Stati membri, erodendo il consenso pubblico non solo nei confronti del progetto europeo, ma anche delle stesse democrazie nazionali.
Un’Unione di regole fiscali gestita da tecnocrati non può andare oltre l’austerità e priva i cittadini del proprio diritto all’autodeterminazione. La disciplina di bilancio deve trasmettere un senso di sicurezza, attraverso meccanismi sostenibili e non soggetti a continue negoziazioni tra gli Stati membri e al loro interno. La continua trattativa non fa che minare ulteriormente la solidarietà europea, incentivando un modello di governance fondato sugli equilibri di potere e una gerarchia basata sulla ricchezza, e portando al tempo stesso le democrazie nazionali in rotta di collisione l’una con l’altra, divise tra chi sente di pagare portando il peso delle altre e quante, invece, si sentono governate dalle prime.
Il paradosso è che il tentativo di proteggere la sovranità nazionale ed evitare i trasferimenti fiscali ha generato un sistema di governance meno efficace, più invadente e meno rispettoso della sovranità degli Stati di ogni altro modello federale esistente, e al tempo stesso più oneroso per i contribuenti.
RISTABILIRE LA LEGITTIMITÀ: PIÙ POTERE AGLI EUROPEI
Una autentica Unione economica e monetaria richiede di un diverso modello di governance, che si basi sui seguenti elementi: a) un’attuazione equilibrata del Patto di stabilità e crescita, che riconcili la responsabilità fiscale con la crescita e l’occupazione, salvaguardando gli investimenti e i servizi pubblici e, allo stesso tempo, perseguendo la riduzione del deficit e del debito; b) un coordinamento più forte e più equilibrato delle politiche economiche al livello di Uem e politiche europee nuove e potenziate; c) un’unione bancaria completa, una Banca centrale europea attiva nella promozione della stabilità finanziaria e una effettiva regolamentazione dei mercati, che incentivi gli investimenti a lungo termine e scoraggi la speculazione; d) le politiche economiche devono essere accompagnate da un robusto sistema di politiche sociali responsabili, che divengano obiettivi vincolanti e rispondano agli impegni presi per il progresso e la prosperità.
Questa è la ragione per cui deve essere elaborato un nuovo patto sociale che divenga una garanzia per tutti gli europei. L’autonomia dei partner sociali e il loro ruolo devono essere salvaguardati e rafforzati, favorendo l’emergere di un dialogo sociale europeo; e) un bilancio dell’Unione adeguato, fondato su risorse proprie, per promuovere la crescita e la competitività, per affrontare gli squilibri ciclici e quelli strutturali e sostenere la coesione sociale e territoriale; f) una capacità di emettere eurobond, per dare fondamenta più solide alla solidarietà finanziaria e facilitare il riscatto del debito.
Questo modello di governance richiede una migliore e più chiara divisione delle competenze e delle risorse tra l’Unione e gli Stati membri, oltre a una maggiore legittimità democratica e responsabilità a entrambi i livelli. Non deve fondarsi sul metodo intergovernativo, ma sulle istituzioni europee e sul «metodo comunitario», con una Commissione europea forte da un lato, che agisca come un vero e proprio governo, e una piena codecisione tra il Consiglio e il Parlamento europeo dall’altro. Il bilancio dell’Ue e dell’Uem deve venire da risorse proprie chiaramente legate alla ricchezza generata all’interno dell’Unione e alle specifiche funzioni regolatrici connesse alle competenze dell’Unione stessa. Gli Stati membri devono mantenere la responsabilità dell’attuazione delle linee-guida di politica economica co-decise a Bruxelles e dei bilanci nazionali all’interno dei limiti del quadro fiscale europeo.
Condividere la sovranità su una base democratica è l’unico modo per ripristinarla e dare potere ai cittadini. Il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali dovranno essere le forze motrici di questo processo e dovranno cooperare strettamente, esercitando al tempo stesso le rispettive prerogative sulla base del principio che la legittimità e il controllo democratico devono essere assicurati al livello in cui le decisioni vengono prese e attuate. Il completamento di un’autentica Unione economica e monetaria richiede una revisione dei Trattati. Noi chiediamo la convocazione di una Convenzione nel corso della prossima legislatura, che possa costituire l’avvio di una nuova fase deliberativa sul futuro dell’Europa. Un simile obiettivo deve essere preparato facendo un pronto e pieno ricorso agli strumenti previsti dai Trattati esistenti (dalla cooperazione rafforzata all’articolo 136 del Tfue, alla clausola di flessibilità) e con un ampio dibattito pubblico che coinvolga la società civile, le parti sociali, i partiti politici, il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali. Le fondazioni di ispirazione progressista promuoveranno tale dibattito, fornendo il proprio contributo e le proprie proposte per una vera Unione economica e monetaria in un’Unione democratica.
RIACCENDERE L’AMBIZIONE: RIDARE SPERANZA
Politiche europee migliori e più forti non sono possibili senza una vera politica europea. Un’unione fiscale ed economica, infatti, richiede un’unione politica. Deve emergere una sfera pubblica davvero europea, che valorizzi il ruolo della società civile. Questa unità dei cittadini d’Europa dovrà rispettare pienamente e utilizzare al meglio i valori del pluralismo culturale e della diversità nazionale, portando il dibattito e il processo decisionale dell’Unione lungo assi politico-ideologici transnazionali, invece che lungo le tradizionali divisioni nazionali.
Le elezioni legislative nazionali devono essere concepite come parte integrante del processo politico europeo. A loro volta, le elezioni europee non devono essere più considerate come test di metà mandato per i partiti nazionali nei 28 Paesi membri, bensì come il momento in cui il cittadino europeo sceglie la direzione per l’Europa, offrendo un mandato democratico al Parlamento e al governo europeo.
Il Pse ha già deciso di indicare, prima delle elezioni, il proprio candidato «di punta» per il ruolo di Presidente della Commissione. Invitiamo tutti i partiti europei a fare lo stesso, conformandosi alla risoluzione approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo. La nomina di tali candidati deve essere collegata alla presentazione agli elettori di programmi basati su politiche europee alternative, sottoscritti dai partiti nazionali e dai loro candidati al Parlamento europeo.
La politicizzazione della Commissione e l’europeizzazione delle elezioni del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali sono tappe cruciali verso una Unione politica, ma non sono sufficienti. È necessario promuovere e rafforzare la partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale europeo. L’Iniziativa cittadina europea deve diventare uno strumento ordinario per coinvolgere la società civile e i partiti politici in campagne su base transnazionale. Gli scioperi e le lotte sociali devono essere condotti a livello europeo, controbilanciando con il ruolo dei cittadini e dei lavoratori il crescente peso delle lobby e degli interessi costituiti nelle decisioni dell’Unione. I gruppi socialisti e democratici al Parlamento europeo e nei Parlamenti nazionali devono promuovere una stretta cooperazione sia con il Pse che con i partiti nazionali.
I giovani devono essere la forza portante del processo di costruzione di una vera società europea. Quindi, iniziative fondate su pari e qualificanti opportunità, come la Garanzia europea per i giovani o il programma Erasmus devono essere visti come un investimento nel futuro collettivo dell’Unione. I progressisti devono collaborare per promuovere un dialogo transnazionale e programmi di scambio, che favorirebbero la circolazione orizzontale delle buone pratiche e delle esperienze nazionali, rafforzando lo spirito europeo e la famiglia progressista. È un modo per recuperare il senso della militanza, arricchendola e conferendo una dimensione paneuropea all’attivismo politico. Ciò si potrà realizzare attraverso l’istituzione di un Erasmus progressista militante che, grazie allo sforzo collettivo dei partiti europei, potrà dare la possibilità di effettuare stage e scambi di attivisti tra le organizzazioni nazionali.
L’economia globale richiede una democrazia sovranazionale. Una Unione politica è la condizione per poter dare all’Europa un modello di governance efficace e legittimo, che promuova stabilità, crescita e solidarietà. Una Unione democratica è indispensabile per dare agli europei una voce e la possibilità di incidere sul mondo in cui vivono. L’impegno di «un nuovo Rinascimento per l’Europa» è proposta credibile su come realizzare questo sogno ambizioso.
* l’Unità 11.02.2013
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- L’Europa è casa tua L’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e il Miur lanciano il concorso sull’Europa dedicato agli studenti.9 febbraio 2013, di Federico La Sala
L’Europa è casa tua
L’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e il Miur lanciano il concorso sull’Europa dedicato agli studenti *
Dove è l’Europa? Quanto è lontana da noi? Quali sono le differenze tra noi e gli altri cittadini europei? Quali diritti acquisiamo in qualità di appartenenti all’Unione Europea? Il concorso “L’Europa è casa tua”, bandito dall’ Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è un chiaro invito a trovare risposte alle questioni sollevate utilizzando diverse declinazioni artistiche.
Elaborati musicali, reportage video, reportage fotografico sono le categorie del concorso aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado. Sarà possibile presentare lavori individuali o di gruppo. Per partecipare bisognerà registrarsi sul sito (http://europacasatua.eu/) entro il 28 febbraio. A partire dal 1 marzo ed entro il 1 aprile chi si è registrato potrà inviare il proprio elaborato.
Gli esiti delle selezioni verranno comunicati ai partecipanti entro il 15 aprile attraverso avviso pubblico sul sito del MIUR e sul sito del concorso e sulle pagine facebook e twitter.
Gli elaborati saranno valutati da una giuria di esperti composta da giovani esponenti di gruppi musicali emergenti, fotografi e videomakers. Per ciascuna delle tre categorie verrà decretato un vincitore. Ai tre finalisti di ogni categoria sarà offerto un viaggio-studio a Bruxelles. I vincitori riceveranno un tablet. Inoltre una menzione speciale sarà assegnata all’elaborato che riceverà più like sul sito del concorso.
“Attraverso il concorso l’“Europa è casa tua” cerchiamo di stimolare la creatività dei giovani studenti italiani per permettergli di raccontarci l’Europa attraverso i loro occhi - ha affermato la Prof.ssa Federiga Bindi, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles - Speriamo possano partecipare in tanti per raccogliere quelle tracce d’Europa presenti nella loro vita quotidiana."
Per Info: stampa.iicbruxelles@esteri.it
* FONTE: IL BLOG DI GIANNI VATTIMO
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Cittadinanza, un termine abusato, ma speranze intatte (di Allan Popelard)31 gennaio 2013, di Federico La Sala
Cittadinanza, un termine abusato, ma speranze intatte
di Allan Popelard, geografo presso l’Istituto francese di geopolitica, Università Paris-VIII
 (traduzione dal francese di José F. Padova)
(traduzione dal francese di José F. Padova)- Straordinaria conquista in un XVIII secolo monarchico, la democrazia rassomiglia a un monumento incompiuto, il cui architetto sarebbe scomparso. La rappresentanza politica gira a vuoto, l’astensionismo degli elettori aumenta, la crisi sociale rende fragile il cittadino... Un ritorno alla storia e a qualche concetto-chiave permette di individuare le crepe, nella prospettiva dei lavori di recupero.
Alienata dal «triangolo di ferro» (1) costituito dall’alleanza fra i dirigenti politici, economici e mediatici, divisa da quell’ «odio della democrazia» (2) che separa i cittadini che si mantengono all’interno del «cerchio della ragione» liberista da quelli che ne sono esclusi, limitata non più soltanto dalle Costituzioni, ma anche dalle «costrizioni esterne» della mondializzazione, la sovranità popolare sembra non essere più altro che una fonte di legittimità fra le tante altre. Se questa espropriazione democratica è stata possibile lo si deve al fatto che le forme istituite della cittadinanza - questo strumento della sovranità - non erano sufficientemente equipaggiate per opporvisi. La delegazione del potere, costitutiva delle democrazie, non permette ai cittadini di controllare i loro rappresentanti se non a priori, su un programma politico, e a posteriori, su un resoconto. Fra i due termini del mandato la delegazione del potere è un esproprio. Come controllare l’azione dei rappresentanti se non esiste né mandato revocabile né mandato imperativo? Come esprimere la propria rivolta se il voto in bianco non è preso in considerazione e se «la piazza non governa»?
Lo stesso controllo dell’elezione si rivela più che limitato, tanto la libertà del cittadino sembra essere predeterminata da un insieme di dispositivi il cui scopo è quello di orientare la sua scelta. Poggiata sulla forza di sondaggi che addobbano le manipolazioni con i ghingheri della scientificità, il richiamo al «voto utile» tende così ad annullare la possibilità di rompere il circuito chiuso del campo politico. In democrazia, ciò che il popolo ha fatto il popolo può disfare. Ma nel nome di presunte minacce, come la crescita dei «populismi», che concorrono a creare uno stato di eccezionalità che favorisce paura e inerzia, il voto utile chiude con il lucchetto l’ordine politico.
Di alternanza in alternanza, non vi è alcuna casualità, quindi, nel fatto che la maggior parte dei Paesi sviluppati si sono trasformati in «democrazie dell’astensionismo» (3). Fino agli anni ’80, se si prende il caso della Francia, il tasso di astensioni alle elezioni legislative superava raramente il 20%. In seguito è raddoppiato. Se vi si aggiungono i non-iscritti (circa il 10%), prende il volo. I cittadini che partecipano sono sempre meno, mentre un «censo nascosto» opera una distinzione socio-spaziale all’interno del corpo elettorale. Ormai le classi popolari si astengono ampiamente, mentre un tempo votavano sopra alla media.
Certamente l’offerta elettorale e ciò che molti hanno vissuto come rinunce di una parte della sinistra spiegano questa smobilitazione. Ma le trasformazioni neoliberiste della società e la «de-istituzionalizzazione» della cittadinanza che ne è risultata restano i fattori determinanti. I suoi tratti salienti sono la società resa precaria, la destrutturazione del luogo di lavoro, l’indebolimento delle organizzazioni (partiti, sindacati) e degli spazi popolari (periferie «rosse»), l’allentamento dei quadri militanti. Contrariamente alle illusioni dello spontaneismo in politica, la cittadinanza ha dunque bisogno di essere «ri-istituita» in organizzazioni, se vuole poter essere rifondata grazie alle lotte elettorali e sociali.
Condividere un destino comune
Le conquiste sociali sono conquiste civiche. L’uso delle libertà politiche rimane vano senza le condizioni di vita materiali necessarie alla loro realizzazione: abitazione, scuola gratuita, reddito che permette di ricostituire la propria forza di lavoro, ma anche di divertirsi e accedere alla cultura, tempo libero per amare, riflettere e creare, assicurazioni [assistenziali] contro le vicissitudini dell’esistenza. La riduzione delle ineguaglianze sociali mediante le imposte, da parte sua, è un requisito preliminare alla formazione di una comunità di cittadini sufficientemente simili per condividere un destino comune. La distinzione marxista fra cittadinanza formale e cittadinanza reale sottolinea così che non può esistere cittadino sovrano nella città se non lo è anche nell’impresa. La cittadinanza reale implica l’abolizione dello sfruttamento.
Gettando nella povertà i salariati europei, l’austerità mette in pericolo la cittadinanza. Altrettanto fa nei confronti dello smantellamento degli Stati assistenziali, che essa provoca. Di tutti i servizi pubblici la scuola concorre specificatamente alla formazione dei cittadini. Non ve ne possono essere, se non sono istruiti. Ora, la privatizzazione e la precarizzazione di cui la scuola è vittima contribuiscono a ostacolare la sua funzione civile. Parallelamente sono scomparsi gli altri punti che contribuivano all’emancipazione popolare. Le scuole dei partiti politici costituivano luoghi di politicizzazione della classe operaia, come pure fortini eretti contro gli assalti del pensiero borghese.
Quali potrebbero essere oggi queste contro-strutture di massa suscettibili di opporsi a mezzi di comunicazione di massa che erodono le basi della deliberazione democratica? Il pensiero unico, dappertutto, corrompe la lingua, costruisce una società del consenso che spossessa i cittadini del potere di chiamare il mondo, di condividerne il significato, di trasformarlo.
Il termine di cittadino è di quelli che la «sensura» [ndt.: neologismo da “senso” e “censura”] - per riprendere il neologismo immaginato dallo scrittore Bernard Noël - ha disinnescato. Nel momento in cui la disoccupazione di massa imperversava è servito come parola-schermo dietro la quale i conservatori riponevano l’idea di repubblica sociale. Da allora nulla giustificava più il fatto che la classe operaia porta in sé l’interesse generale. Il termine di cittadino, strappato alla sua storia rivoluzionaria, è stato passato alla lisciva nel capitalismo: tutto divenne «cittadino», ivi compresi i prodotti di consumo. Così sprofondavano le due immagini del popolo. Jean-Jacques Rousseau ne aveva fatto il soggetto della sovranità, Karl Marx quello della lotta di classe. Il posto che quest’ultima occupava nei sistemi di rappresentazione ideologica fu molto presto conquistato da un popolo di altro tipo. L’ethnos sostituì il demos; la ricerca della diversità quella dell’eguaglianza.
Il peso dei territori
Il filo della storia era stato riannodato con la tradizione degli «anti-Lumi» (4) [ndt.: = gli avversari dell’Illuminismo], i quali sin dal XVIII secolo magnificavano un’ «altra modernità». Mentre Rousseau e Immanuel Kant «volevano liberare gli individui dalle costrizioni della storia», i nemici dei Lumi teorizzarono un altro concetto di società fondata sul «culto del particolare e il rifiuto dell’universale». Pertanto la Repubblica non ha mai considerato il cittadino astratto come un nemico dell’individuo concreto. Al contrario, si è applicata a proteggere l’uno dall’altro, separando il dominio pubblico del dominio privato. Non riconoscendo alcuna opzione spirituale, la laicità permette così a ogni individuo di scegliere nel suo animo e nella sua coscienza quella che meglio gli conviene. Ma essa costituisce anche uno strumento democratico che protegge le deliberazioni degli uomini dalle rivelazioni della religione.
Per la Repubblica non esiste politica se non nell’universale e mediante l’universale. Ora, la decentralizzazione ha ugualmente rafforzato l’approccio culturale della cittadinanza. Avrebbe anche favorito - si dice - la cittadinanza locale. Se il peso dei territori locali si è effettivamente con essa rafforzato, gli esecutivi ne hanno approfittato ben più dei cittadini. Pertanto il Larzac (5) ieri o Notre-Dame-des-Landes oggi (6) [ndt.: famosi episodi di ribellione civile in Francia, a Larzac per impedire l’occupazione militare della terra - 1971-1981 - e a N.D. des Landes per opporsi a un aeroporto] dimostrano che certe forme di organizzazione e di lotta possono rivitalizzare la cittadinanza a livello locale. D’altra parte esse giungono talvolta, dalla Comune di Parigi [ndt.: La Comune, insurrezione del 1870] a Lorraine Coeur d’Acier (7) cent’anni dopo [ndt.: famosa emittente radio “ribelle” a Longwy, 1979 segg.], a rovesciare i rapporti sociali di classe. Ma come estendere poi alla comunità dei cittadini le conquiste di una lotta locale?
L’Unione Europea, da parte sua, ambisce a una cittadinanza senza fondamento. Mentre l’astensionismo alle elezioni europee prova che il deficit democratico dell’U.E. è strutturale, si moltiplicano i «colpi di Stato» dei quali essa è all’origine (8), metamorfosi di una lunga storia tecnocratica e burocratica (dal Trattato di Lisbona all’attuale Trattato sui bilanci). Senza strumenti con i quali esercitare la loro sovranità, i popoli europei non possono opporsi, nel quadro delle sue istituzioni, alla piega autoritaria che essa prende.
A condizione che i cittadini si riapproprino - con l’appoggio di partiti, sindacati, associazioni - della sovranità della quale sono stati spogliati, la storia non è ancora stata scritta. Disobbedire quando la legalità non è più legittima; conquistare l’apparato dello Stato; mettere insieme le condizioni per un’assemblea costituente, auto-costituire la comunità dei cittadini come lo fanno, per esempio, gli «indignati», ecco qualcuna delle vie svariate e non esclusive di una sovranità e di una cittadinanza rifondate. «Spazio al popolo», come scriveva Jules Vallès, perché, senza implicazione diretta, l’Europa democratica non esisterà.
 (1) Expression du sociologue américain Charles Wright Mills (1916-1962).
(1) Expression du sociologue américain Charles Wright Mills (1916-1962).
 (2) Jacques Rancière, La Haine de la démocratie, La Fabrique, Paris, 2005.
(2) Jacques Rancière, La Haine de la démocratie, La Fabrique, Paris, 2005.
 (3) Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen, La Démocratie de l’abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire, Gallimard, Paris, 2007.
(3) Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen, La Démocratie de l’abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire, Gallimard, Paris, 2007.
 (4) Zeev Sternhell, Les Anti-Lumières. Du XVIII’ siècle à la guerre froide, Fayard, Paris, 2006. Les citations qui suivent sont tirées de l’introduction du livre.
(4) Zeev Sternhell, Les Anti-Lumières. Du XVIII’ siècle à la guerre froide, Fayard, Paris, 2006. Les citations qui suivent sont tirées de l’introduction du livre.
 (5) Zone rurale où furent menées, de 1971 1981, d’intenses mobilisations contre l’extension d’un camp militaire.
(5) Zone rurale où furent menées, de 1971 1981, d’intenses mobilisations contre l’extension d’un camp militaire.
 (6) Commune française où est prévue la construction d’un aéroport qui soulève une forte opposition.
(6) Commune française où est prévue la construction d’un aéroport qui soulève une forte opposition.
 (7) Radio «libre» fondée en 1979 pour lutter contre les fermetures d’usines sidérur-giques.
(7) Radio «libre» fondée en 1979 pour lutter contre les fermetures d’usines sidérur-giques.
 (8) Lire Raoul Marc Jennar, «Deux traités pour un coup d’Etat européen», Le Monde diplomatique, juin 2012.
(8) Lire Raoul Marc Jennar, «Deux traités pour un coup d’Etat européen», Le Monde diplomatique, juin 2012.* Le Monde Diplomatique, settembre 2012, Supplemento, pagg. 3-4
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- L’ALBERO DELL’ULIVO DI ATENA E I "SEGNI DI PACE". Dal ramo d’ulivo alla colomba così la non violenza lascia il segno (di Enrico Franceschini)29 gennaio 2013, di Federico La Sala
Come sono nati e cosa significano quei simboli raffigurati in tutto il mondo su bandiere e manifesti
Un libro ne ricostruisce la storia dall’antica Grecia al movimento hippie, fino a oggi
Dal ramo d’ulivo alla colomba così la non violenza lascia il segno
Nell’Enciclopedia visuale anche l’arcobaleno e i fiori nei cannoni e le loro evoluzioni
di Enrico Franceschini (la Repubblica, 29.01.2013)
LONDRA Si può dirlo con le parole: "La pace sia con te", "Pace e bene", "Fate la pace non fate la guerra". Ma si può dirlo anche con le immagini: il ramoscello d’ulivo, la colomba, l’arcobaleno, il fucile con i fiori nella canna. E poi il segno che tutti conoscono per averlo visto sulle bandiere, sui muri, sui manifesti, il cerchio con dentro una riga verticale incrociata da due mezze diagonali. Ha tanti simboli, la pace, l’obiettivo che l’uomo da un lato rincorre dalla notte dei tempi, dall’altro fa di tutto per calpestare.
Ma da dove vengono, come sono nati, cosa significano esattamente? Mentre si combatte in Mali e si rischia una nuova grande guerra in Medio oriente a causa del programma nucleare iraniano, mentre conflitti piccoli e grandi sconvolgono la quiete sociale delle nostre esistenze, un libro prova a rispondere a queste domande.
In "Signs for peace: an impossible visual encyclopedia" (Segni di pace: un’enciclopedia visuale impossibile), il disegnatore grafico Ruedi Baur e sua moglie, la sociologa Vera Bauer Kockot, ripercorrono la storia degli emblemi del pacifismo, e di come si sono evoluti a seconda delle situazioni.
Tutto comincia con la mitologia greca, con la lotta tra Poseidone e Atena, lui con il tridente apre una fonte d’acqua salata sul terreno, lei risponde piantando un ulivo, l’albero rappresenta pace e prosperità. La dea ha la meglio grazie all’astensione di Zeus, dà il suo nome ad Atene, la città più grande della Grecia, e da quel momento il suo ulivo diventa il simulacro universale della pace.
Beninteso, il merito non è solo di Atena: se la faccenda fosse finita lì, vedendo un ramoscello d’ulivo avremmo pensato solo alle olive e all’olio che se ne ricava in tutto il Mediterraneo. Ma fu adottato come simbolo di pace anche dall’Impero romano, Virgilio vi fa riferimento in tal senso nell’Eneide, mentre Eirene, la dea romana della pace, veniva spesso disegnata con un ramoscello in mano. La tradizione è rimasta fino al 1600, quando poeti e artisti lo usavano come motivo di pace, quindi è finito ad adornare varie monete, poi è apparso in innumerevoli contesti ufficiali, dal Gran Sigillo degli Stati Uniti nel 1782 alla bandiera delle Nazioni Unite nel 1946. Oggi chiunque sa cosa vuol dire passare di mano in mano un ramo d’ulivo.
E proprio il ramo d’ulivo ha introdotto un altro simbolo di pace: nel racconto biblico, la colomba che lascia l’Arca di Noè e poi torna per annunciare la fine del diluvio e l’inizio di una nuova era ne ha appunto uno in bocca. Il volatile ha dovuto attendere più a lungo per diventare sinonimo di pace: lo utilizzavano a questo scopo i primi movimenti pacifisti del 19esimo secolo.
Ma la sua più famosa incarnazione è la colomba disegnata da Pablo Picasso tra il 1940 e gli anni Cinquanta, in una serie di poster per il Congresso mondiale della Pace. Di simboli ce ne sono tanti altri nelle pagine dell’"Enciclopedia Visuale", dall’arcobaleno (in seguito diventato l’immagine del movimento gay) al "mettete dei fiori nei vostri cannoni", ossia nelle canne dei fucili, inno degli hippie realizzato nella rivoluzione dei garofani in Portogallo nel 1975, fino a segni più religiosi, come gli angeli.
Ma il più noto oggi, anche più di ulivo e colomba, è probabilmente il "segno di Holtom", disegnato nel 1958 da un attivista disoccupato del movimento contro le armi nucleari, obiettore di coscienza e disegnatore, per conto della Campagna per il Disarmo nucleare, un’associazione pacifista inglese. Avevano dato l’incarico a lui, pensava di disegnare una croce ma ci furono obiezioni, non gli veniva un’altra idea, «ero disperato, assolutamente disperato», ricordava, «così disegnai me stesso, il rappresentante di un individuo preso da totale disperazione, con le braccia allargate come i condannati nella scena della fucilazione di Goya, formalizzai il disegno e lo misi dentro un cerchio».
Ecco fatto. Si poteva leggere come una dichiarazione politica, perché quella linea verticale e le due diagonali erano i simboli delle lettere N e D nell’alfabeto semaforico, dunque significavano Nuclear Disarmament, Disarmo Nucleare. Altri hanno interpretato il simbolo come "la morte dell’uomo" e il cerchio come "il bambino mai nato".
Come che sia, il suo autore non mise alcun copyright al disegno, che ebbe un impatto memorabile, prima per la causa dell’anti-nucleare, poi per la pace in generale. Attraversò subito l’Atlantico, finì alle manifestazioni di Martin Luther King per i diritti civili dei neri americani, quindi alle proteste contro la guerra in Vietnam e da lì in avanti non si fermò più, apparve sulle strade di Praga invasa dai carri armati sovietici nel 1968, sul muro di Berlino, sulle tombe delle vittime delle dittature, dai colonnelli greci alla giunta argentina a Timor Est. Oggi è dappertutto.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- PLATONE, SAN PAOLO, E LA RICOSTITUZIONE DEL ’PARTITO’ SACERDOTALE.29 gennaio 2013, di Federico La Sala
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- È venuta l’ora di riesaminare quel che vien chiamato interventismo umanitario, democratico, antiterrorista (di Barbara Spinelli - L’Europa bendata alla guerra d’Africa)24 gennaio 2013, di Federico La Sala
L’Europa bendata alla guerra d’Africa
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 23 gennaio 2013)
Impressionante il mutismo che regna, alla vigilia delle elezioni in Italia e Germania, su un tema decisivo come la guerra. Non se ne parla, perché i conflitti avvengono altrove. Eppure la guerra da tempo ci è entrata nelle ossa. Non è condotta dall’Europa, priva di un comune governo politico, ma è ormai parte del suo essere nel mondo. Se alla sterminata guerra anti-terrorismo aggiungiamo i conflitti balcanici di fine ’900, sono quasi 14 anni che gli Europei partecipano stabilmente a operazioni belliche. All’inizio se ne discuteva con vigore: sono guerre necessarie oppure no? E se no, perché le combattiamo? Sono davvero umanitarie, o distruttive? E qual è il bilancio dell’offensiva globale anti-terrore: lo sta diminuendo o aumentando? I politici tacciono, e nessuno Stato europeo si chiede cosa sia quest’Unione che non ha nulla da dire in materia, concentrata com’è sulla moneta. L’Europa è entrata in una nuova era di guerre neo-coloniali con gli occhi bendati, camminando nella nebbia.
Le guerre - spesso sanguinose, di rado proficue - non sono mai chiamate per nome. Avanzano mascherate, invariabilmente imbellite: stabilizzeranno Stati fatiscenti, li democratizzeranno, e soprattutto saranno brevi, non costose. Tutte cose non vere, nascoste dalla strategia del mutismo. A volte le operazioni sono decise a Washington; altre volte, come in Libia, son combattute da più Stati europei. Quella iniziata il 12 gennaio in Mali è condotta dalla Francia di Hollande, con un appoggio debole di soldati africani e con il consenso - ex post - degli alleati europei. Nessun coordinamento l’ha preceduta, in violazione del Trattato di Lisbona che ci unisce (art. 32, 347). Quasi automaticamente siamo gettati nelle guerre, come si aprono e chiudono le palpebre. La mente segue, arrancando. C’è perfino chi pomposamente si chiama Alto rappresentante per la politica estera europea (parliamo di Katherine Ashton: quando sarà sostituita da una personalità meno inutile?) e ringrazia la Francia ma subito precisa che Parigi dovrà fare da sé, «mancando una forza militare europea». Fotografa l’esistente, è vero, ma occupando una carica importante potrebbe pensare un po’ oltre.
Molte cose che leggiamo sulle guerre sono fuorvianti: simili a bollettini militari, non sono discutibili nella loro perentoria frammentarietà. Invitano non a meditare l’evento ma a constatarlo supinamente, e a considerare i singoli interventi come schegge, senza rapporti fra loro. Anche in guerra prevalgono esperti improvvisati e tecnici. L’interventismo sta divenendo un habitus europeo, copiato dall’americano, ma di questa trasformazione non vien detta lastoria lunga, che connetta le schegge e rischiari l’insieme. Manca un pensare lungo e anche ampio, che definisca chi siamo in Africa, Afghanistan, Golfo Persico. Che paragoni il nostro pensare a quello di altri paesi. Che studi la politica cinese in Africa, così attiva e diversa: incentrata sugli investimenti, quando la nostra è fissa sul militare. Scarseggia una veduta cosmopolita sul nostro agire nel mondo e su come esso ci cambia.
Una vista ampia e lunga dovrebbe consentire di fare un bilancio freddo, infine, di conflitti privi di obiettivi chiari, di limiti spaziali, di tempo: che hanno dilatato l’Islam armato anziché contenerlo, che dall’Afghanistan s’estendono ora al Sahara-Sahel. Che nulla apprendono da errori passati, sistematicamente taciuti. I nobili aggettivi con cui agghindiamo l’albero delle guerre (umanitarie, democratiche) non bastano a celare gli esiti calamitosi: gli interventi creano non ordine ma caos, non Stati forti ma ancora più fallimentari. Compiuta l’opera i paesi vengono abbandonati a se stessi, non senza aver suscitato disillusione profonda nei popoli assistiti.
Poi si passa a nuovi fronti, come se la storia delle guerre fosse un safari turistico a caccia di esotici bottini. Il Mali è un caso esemplare di guerra necessaria e umanitaria. In questo decennio l’aggettivo umanitario s’è imbruttito, ha perso l’innocenza, e annebbia la storia lunga: le politiche non fatte, le occasioni mancate, le catene di incoerenze. Era necessario intervenire per fermare il genocidio in Ruanda, nel ’94, e non si agì perché l’Onu ritirò i soldati proprio mentre lo sterminio cominciava. Fu necessario evitare l’esodo - verso l’Europa - dei kossovari cacciati dall’esercito serbo. Ma le guerre successive non sono necessarie, visto che manifestamente non fermano i terroristi. Non sono neppure democratiche perché come si spiegano, allora, l’alleanza con l’Arabia Saudita e l’enormità degli aiuti a Riad, più copiosi di quelli destinati a Israele? Il regno saudita non solo non è democratico: è tra i più grandi finanziatori dei terrorismi.
La degenerazione del Mali poteva essere evitata, se gli Europei avessero studiato il paese: considerato per anni faro della democrazia, fu sempre più impoverito, portandosi dietro i disastri delle sue artificiali frontiere coloniali. Aveva radici antiche la lotta indipendentista dei Tuareg, culminata il 6 aprile 2012 nell’indipendenza dell’Azawad a Nord. Per decenni furono ignorati, spregiati. Per combattere un indipendentismo inizialmente laico si accettò che nascessero milizie islamiche, ripetendo l’idiotismo esibito in Afghanistan. Sicché i Tuareg s’appoggiarono a Gheddafi, e poi agli islamisti: unico punto di riferimento, furono questi ultimi a invadere il Nord, all’inizio 2012, egemonizzando e stravolgendo - era prevedibile - la lotta tuareg. È uno dei primi errori dell’Occidente, questa cecità, e quando Prodi approva l’intervento francese dicendo che «non esistevano alternative all’azione militare», che «si stava consolidando una zona franca terroristica nel cuore dell’Africa», che gli indipendentisti «sono diventati jihadisti», dice solo una parte del vero. Non racconta quel che esisteva primche la guerra fosse l’unica alternativa. I Tuareg non sono diventati terroristi; blanditi dagli islamisti, sono stati poi cacciati dai villaggi che avevano conquistato. La sharia,nella versione più cruenta, è invisa ai locali e anche ai Tuareg (sono tanti) non arruolati nell’Islam radicale. Vero è che all’inizio essi abbracciarono i jihadisti, e un giorno questa svista andrà meditata: forse l’Islam estremista, col suo falso messianismo, ha una visione perversa ma più moderna, della crisi dello Stato-nazione. Una visione assente negli Europei, nonostante l’Unione che hanno edificato.
Ma l’errore più grave è non considerare le guerre dell’ultimo decennio come un tutt’unico. L’azione in un punto della terra ha ripercussioni altrove, i fallimenti in Afghanistan creano il caso Libia, il semifallimento in Libia secerne il Mali. Il guaio è che ogni conflitto comincia senza memoria critica dei precedenti: come scheggia appunto. In Libia il trionfalismo è finito tardi, l’11 settembre 2012 a Bengasi, quando fu ucciso l’ambasciatore Usa Christopher Stevens. Solo allora s’è visto che molti miliziani di Gheddafi, tuareg o islamisti, s’erano trasferiti nell’Azawad. Che la guerra non era finita ma sarebbe rinata in Mali, come in quei film dell’orrore dove i morti non sono affatto morti.
È venuta l’ora di riesaminare quel che vien chiamato interventismo umanitario, democratico, antiterrorista. Un solo dato basterebbe. Negli ultimi sette anni, il numero delle democrazie elettorali in Africa è passato da 24 a 19. Uno scacco, per Europa e Occidente. Intanto la Cina sta a guardare, compiaciuta. La sua presenza cresce, nel continente nero. Il suo interventismo per ora costruisce strade, non fa guerre. È colonialismo e lotta per risorse altrui anch’esso, ma di natura differente. Resilienza e pazienza sono la sua forza. Forse Europa e Stati Uniti si agitano con tanta bellicosità per contendere a Pechino il dominio di Africa e Asia. È un’ipotesi, ma se l’Europa cominciasse a discutere parlerebbe anche di questo, e non sarebbe inutile.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- LA SHOAH E LA GIORNATA DELLA MEMORIA. Georges Bensoussan: È l’Europa contro la notte della ragione (di Alberto Mattioli)22 gennaio 2013, di Federico La Sala
Non si può insegnare la Shoah ai bambini
 Nell’anniversario della liberazione di Auschwitz, domenica 27 gennaio si commemorano le vittime dell’Olocausto. Parla lo storico Bensoussan
Nell’anniversario della liberazione di Auschwitz, domenica 27 gennaio si commemorano le vittime dell’Olocausto. Parla lo storico Bensoussan Di questa tragedia si parla troppo perché se ne parla male, in maniera compassionevole per le vittime
Di questa tragedia si parla troppo perché se ne parla male, in maniera compassionevole per le vittime Invece si tratta di una grande questione politica e antropologica che rappresenta una cesura, una rottura nella civiltà occidentale
Invece si tratta di una grande questione politica e antropologica che rappresenta una cesura, una rottura nella civiltà occidentaledi Alberto Mattioli (La Stampa, 22.01.2013)
- Storico e responsabile editoriale del Mémorial de la Shoah di Parigi, Georges Bensoussan è l’autore di una sintetica ma assai ben fatta Storia della Shoah che La Giuntina ha appena tradotto e pubblicato in Italia (pp. 168, € 12).
Professore, il 27 è la Giornata della Memoria.
«È importante celebrarla. Ma bisogna avere ben chiaro che in realtà l’Unione Europea l’ha istituita per celebrare la rifondazione dell’Europa. L’unità europea è stata costruita sull’antinazismo e il simbolo del nazismo, ciò che lo differenzia dall’altro grande totalitarismo, il comunismo, è appunto la Shoah. È la Giornata della Memoria europea, non ebrea. È l’Europa dei lumi contro la notte della ragione».
Sulla memoria, la Francia ha ancora del lavoro da fare?
«L’idea della complicità di Vichy, dunque dello Stato francese, è recente. Nel ’73 fu uno storico americano, Robert Paxton, a pubblicare i primi studi sull’argomento. Ormai la tradizionale visione binaria Resistenza-collaborazionismo non regge più. In mezzo c’è una vasta zona grigia. All’inizio della persecuzione, la maggioranza dei francesi, e le élite in particolare, non protestarono affatto. Anche se è difficile valutare l’evoluzione dell’opinione pubblica in un regime dittatoriale, la svolta avvenne nel 1942 quando iniziarono le rafles, le retate. La caccia all’ebreo indignò molti francesi. Ma, in generale, è sbagliato avere una visione monocolore. La Francia non è stata solo Vichy e non è stata solo la Resistenza. E per fortuna circa tre quarti degli ebrei francesi si sono salvati».
Perché?
«Intanto perché la Francia è grande e fatta anche di foreste e di montagne. E poi non dimentichiamoci che la Francia del Sud, la cosiddetta zona libera, fu occupata solo per venti mesi. Infine, parte di questa zona fu occupata dagli italiani. I documenti tedeschi sono pieni di lamentele contro gli italiani che proteggono gli ebrei e addirittura li sottraggono alle retate della polizia francese».
Lei ha polemizzato con Nicolas Sarkozy che aveva proposto che ogni bimbo francese ricostruisse la storia di un bimbo ebreo deportato.
«Semplicemente, da storico ho fatto presente che l’idea era benintenzionata ma assurda. Non si può insegnare la Shoah ai bambini, non si può mostrare loro Treblinka. Perché è una memoria troppo pesante, troppo dura da portare e finisce per colpevolizzarli. Si può, anzi si deve, insegnare loro cosa c’è intorno alla Shoah, cosa sono il razzismo o l’intolleranza. Alle elementari puoi parlare di Anna Frank. Delle camere a gas, no».
Sulla memoria, c’è qualcosa che si potrebbe fare e non si fa?
«Forse avere ben presente che, dal punto di vista storico, la memoria è una trappola. La memoria non è la storia, è una religione. E non serve a ricordare, ma a dimenticare, perché è fatalmente selettiva. Per questo lo storico è disincantato e deve esserlo. Mi spiego con un esempio che non c’entra con la Shoah. Nel 1985 furono ricordati con grande riprovazione i 300 anni della revoca dell’editto di Nantes, quello che aveva concesso agli ugonotti la libertà di culto. Tre anni dopo, lessi il Code noir, cioè l’insieme delle leggi che regolavano la schiavitù nelle colonie francesi. Bene. Sa in che anno Luigi XIV l’aveva promulgato? Nel 1685. Solo che il suo terzo centenario non l’aveva ricordato nessuno».
Insomma, della Shoah si parla troppo?
«Se ne parla troppo perché se ne parla male. Cioè se ne parla in maniera compassionevole per le vittime, mentre la Shoah è un’enorme questione politica e antropologica. Politica, perché pone il problema di come un popolo civilizzato abbia scientemente deciso di eliminarne un altro. Antropologica, perché rappresenta una cesura, una rottura nella civiltà occidentale. Lo capirono per primi certi intellettuali cattolici del dopoguerra, come Maritain, Claudel o Julien Green. Poi il tema è stato ripreso dagli Anni 70 con uno studio della Shoah che si è giovato di nuovi strumenti, per esempio la psicanalisi».
Ma a livello mediatico, lei dice, è troppo presente.
«C’è una saturazione della memoria. Il discorso sulla Shoah, sui giornali, nei film, in televisione, è talmente invadente e basato soltanto sul pathos da diventare banalizzante. La nostra è una società compassionevole, dove lo status di vittima è quello più ambito. Dunque ognuno vuole avere la sua Shoah. E Auschwitz viene continuamente evocato per situazioni completamente diverse. Fino al paradosso di paragonare sulla questione palestinese i nazisti di ieri agli israeliani di oggi, che è una bestialità».
Ultima domanda e anche personale. La Shoah non è un soggetto troppo duro per dedicarle la vita intera?
«È sicuramente un soggetto sconvolgente. Ci si salva con un humour nero che per i non addetti ai lavori potrebbe risultare scandaloso, politicamente molto poco corretto. È lo stesso che hanno i medici o chi è tutto il giorno e tutti i giorni alle prese con la sofferenza. Però vivere quotidianamente a contatto con la Shoah ti rende anche molto acuto sulla realtà di oggi. Ti si drizzano le antenne, stai più attento a quel che senti. E capisci che le parole sono sempre la prima tappa della tragedia».
*
In libreria
Molti, come sempre, i titoli che gli editori mandano in libreria in occasione del Giorno della Memoria. Tra gli altri segnaliamo:
Hans Keilson, Commedia in minore , Mondadori (p.136, € 10); Bruno Apitz, Nudo tra i lupi , Longanesi (pp. 461, € 18,60); Sam Pivnik, L’ultimo sopravvissuto. Una storia vera (Newton Compton, pp.326, € 9,90); Janusz Korczak, Diario del ghetto (Castelvecchi, pp. 118, € 14); Francesco Roat, I giocattoli di Auschwitz (Lindau, pp. 294, € 19,50); Lia Levi, Lungo il cammino delle stelle e Maria Konopnicha, Mendel di Danzica (entrambi Sipintegrazioni); Lena Muchina, Il diario di Lena (pp. 372, € 16,50); Léon Poliakov, Storia dell’antisemitismo (Bur, pp. 350, € 14,50); Fabio Amodeo e Mario José Cereghino, La lista di Eichmann (Feltrinelli, pp. 201, € 16); Göran Rosenberg, Una breve sosta nel viaggio da Auschwitz (Ponte alle Grazie, pp. 354, € 15,80); Sami Modiano, Per questo ho vissuto. La mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili (Rizzoli, pp. 280, € 18). Infine torna in versione fumetto, realizzato da Vincent Bailly e Kris e con prefazione di Walter Veltroni, il romanzo di Joseph Joffo Un sacchetto di biglie ( Rizzoli Lizard, pp. 128, € 15).
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- 2013 Anno europeo dei cittadini - European Year of Citizens.20 gennaio 2013, di Federico La Sala
Grande dibattito sull’UE
“Occorre lanciare un ampio dibattito in tutta Europa, che si svolga prima che siano convocate una convenzione e una conferenza intergovernativa: un dibattito di dimensioni autenticamente europee. Non possiamo continuare a tentare di risolvere problemi europei con soluzioni puramente nazionali. Questo dibattito si deve svolgere nelle nostre società e tra i nostri cittadini”. (Il Presidente José Manuel Barroso)
Europa
2013 Anno europeo dei cittadini *
Anno europeo dei cittadini 2013Cittadini europei, l’anno appena iniziato è il nostro anno. Lo ha stabilito la Commissione europea, che lancia ufficialmente oggi il 2013 come ’European Year of Citizens’.
Il presidente della Commissione José Manuel Barroso e la vicepresidente Viviane Reding insieme al primo ministro irlandese Enda Kenny e al ministro irlandese per gli Affari europei Lucinda Creighton inaugurano l’anno dedicato ai diritti legati alla cittadinanza dell’Unione - riconosciuta 20 anni fa con il trattato di Maastricht - con un dibattito pubblico con i cittadini a Dublino, in Irlanda, alla guida del del Consiglio dell’Unione europea per il semestre appena iniziato.
Sono infatti all’insegna del dialogo e del confronto tra istituzioni e cittadini dell’Unione tutti gli appuntamenti e le iniziative - come conferenze e seminari a livello europeo, nazionale e locale - in programma per il 2013.
L’obiettivo è capire, anche in vista delle elezioni per il Parlamento europeo dell’anno prossimo, e grazie ai contributi dei cittadini, come valorizzare e implementare le prerogative legate ai diritti di cittadinanza europea. Che è, come ha spiegato nei giorni scorsi la Reding, «più di un concetto teorico: è una realtà pratica che porta benefici tangibili ai cittadini».
La Commissione europea, infatti, prosegue Reding, in questo anno dedicato ai cittadini Ue desidera anche aiutare le persone a comprendere come poter beneficiare direttamente dei loro diritti’ e, al tempo stesso, ’ascoltare le loro opinioni su dove stia andando l’Europa’ attraverso i dibattiti con i rappresentanti politici europei e locali.
I dibattiti pubblici si possono seguire on line sul sito http://ec.europa.eu/european-debate/index_it.htm, il programma completo delle iniziative è consultabile sul sito dedicato dall’Ue all’anno dei cittadini europei.
Tutte le informazioni sull’iniziativa e sui suoi obiettivi sono consultabili anche sul sito del Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Il cammino «sbagliato» dell’Europa. Il Nobel Amartya Sen: «Troppa austerità Non c’è spazio per crescita e sviluppo» (di Bianca Di Giovanni - L’Europa infelice).19 gennaio 2013, di Federico La Sala
L’Europa infelice
Il Nobel Amartya Sen: «Troppa austerità Non c’è spazio per crescita e sviluppo» Ospite del Festival delle Scienze a Roma, quest’anno dedicato al tema della felicità, il docente spiega la sua vicinanza con il pensiero di Gramsci e con la sua filosofia spontanea. «Economia sociale e di mercato sono complementari»
di Bianca Di Giovanni (l’Unità, 19.01.2013)
DEVE APPARIRE UN CONTINENTE DAVVERO INFELICE, L’EUROPA DI OGGI, AGLI OCCHI DI AMARTYA SEN. OSPITE DEL FESTIVAL DELLE SCIENZE (IN CORSO ALL’AUDITORIUM DI ROMA) dedicato quest’anno al tema della felicità, il premio Nobel dell’economia nel 1998 concentra tutta la sua attenzione sulla nostra parte di mondo. Usa termini inequivocabili: il «pasticcio», di più, il «disastro», il cammino «sbagliato» dell’Europa. Un percorso perseguito con cieca ostinazione, trasformandosi, secondo Sen, nella negazione della scienza economica. «L’economia insegna che se provi una cosa, e non funziona, la riprovi e ancora non funziona, allora devi imparare qualcosa e non continuare».
Lo hanno fatto gli Stati Uniti negli anni 30, lo ha fatto il Giappone. Invece l’Europa non si ferma sulla strada dell’austerità che mette a rischio la sua storia, fatta di welfare state, la sua democrazia, inibìta da decisioni prese senza confronto pubblico, e infine il principio stesso di solidarietà su cui si fondava l’idea dell’unione nel manifesto di Ventotene.
Oggi «i tedeschi odiano i greci e viceversa», osserva il premio Nobel. Tutto questo a causa del rigore che oggi si confonde e si coniuga con le riforme. Qui sta l’errore. «L’austerità è una cosa, le riforme un’altra spiega -. L’Europa ha certamente bisogno di riforme, quella delle pensioni, quella dell’imposizione sui redditi. Ma non ha bisogno di austerità». Su questo punto, purtroppo, manca ancora un pensiero politico ragionato, una proposta alternativa riconoscibile.
Nell’incontro con la stampa che precede la lectio magistralis anticipa che la sua teoria della felicità è antitetica a quella di Jeremy Bentham e alla schiera dei suoi allievi. L’approccio degli utilitaristi è «ristretto, limitato, formale». Il tema è ben più complesso e articolato della lotta per i diritti che caratterizzò il pensiero degli utilitaristi. E molto, molto più ampio. «Più che a Bentham spiega Sen la mia ispirazione si rifà a Antonio Gramsci e alla sua filosofia spontanea» Difficile tracciare una differenza tra felicità di destra o di sinistra. «Molto dipende dalla definizione che si dà, che fin dai tempi antichi è stata molto fluida continua Sen Per esempio per Aristotele la felicità è ciò per cui la vita vale la pena di essere vissuta».
All’interno di questa vasta gamma di attributi, può essere compresa la libertà umana. «E la disoccupazione, ad esempio è un fattore della libertà aggiunge pertanto economia e felicità sono collegate. Io affermo ad esempio che l’Europa è infelice a causa dell’economia. Diverso è quando affermo che l’Europa sbaglia, perché in questo caso do un giudizio personale».
Ma quella distinzione tra felicità per la destra e per la sinistra esiste eccome. E risiede nelle priorità di ciascuna parte. «La sinistra ha sempre fatto più attenzione alle diseguaglianze e all’equità spiega ancora l’economista La destra in passato alla proprietà, oggi alla libertà. Io mi colloco sicuramente a sinistra, ma non per questo non credo che il tema della libertà non sia importante. Non c’è conflitto, ma restano valide le distinzioni, soprattutto sul ruolo dello Stato. È noto che la destra è sempre stata ostile all’intervento dello Stato nell’economia. Io credo che oggi ci sia bisogno di studiare attentamente questi due programmi. E trovo deprimente che nel Paese natale di Gramsci non si veda un’agenda di sinistra ben riconoscibile». Poi il pensiero torna ai mali d’Europa, di cui aveva scritto nel 2011, poi nel 2012 e oggi le cose non sono cambiate. Il baratro in cui l’Europa si ritrova lo raccontano due telefonate, ricevute da Sen la stessa mattina.
La prima dall’India. «Ha visto professore lo scenario deprimente dell’economia indiana, che quest’anno cresce solo del 6%?», gli chiede il giornalista. «Evidentemente prima cresceva di più», osserva Sen. Seconda chiamata da Parigi: «L’economia europea quest’anno è a zero, non le sembra che dobbiamo rallegrarci?» «Se questa è la domanda continua Sen l’Europa ha un problema». L’austerità sta danneggiando i Paesi periferici, ma oggi anche la Germania, che non riesce più a mantenere l’export se gli altri si impoveriscono. Berlino sta subendo un poderoso effetto boomerang, perché «le politiche deflazionistiche danneggiano non solo la domanda interna, ma anche quella estera. Lo sa l’Italia, ma lo sa bene anche la Gran Bretagna, che non aveva alcun bisogno di austerità».
Quello che manca per fronteggiare questo disastro è una voce politica ragionata contro «quello che sembra essere un consenso tra i leader sulla politica finanziaria. Se fossi impegnato immagina Sen direi che occorre una dichiarazione congiunta paneuropea, dalla Spagna, dal Portogallo, dall’Irlanda, dall’Italia, insomma di tutti. Ma per ora non la vedo. Occorrerebbe una visione che contrasti questi problemi, ma non c’è». La nuova visione economica è il leitmotiv da cui Sen non si allontana. Si irrita quasi con chi chiede se i tassi vanno abbassati, se l’euro è troppo forte. «Il problema non è qui. Potrei anche rispondere di sì, che i tassi vanno abbassati, e persino spiegarlo aggiunge Ma il disastro europeo non nasce qui, nasce dall’austerità».
Vero è che il processo, secondo Sen, è nato male: per lui serviva prima l’integrazione politica e sociale, e solo dopo doveva arrivare la moneta. Si è fatto il contrario, ma l’euro comune senza politiche di bilancio integrate non fa altro che creare tensioni. Ma oggi sotto tiro c’è quel rigore che dimentica di coniugare l’economia di mercato al sociale. «Come diceva Adam Smith spiega il professore un mercato buono aumenta il reddito delle persone, una vita buona aumenta le entrate dello Stato per i servizi sociali e per la buona società. In questo economia di mercato e sociale sono complementari. Questa è in realtà la tradizione europea, quella che ha creato il servizio sanitario nazionale, che ha creato il welfare, e lo ha insegnato al resto del mondo. Ma oggi sembra tutto dimenticato».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Il modello «Merkiavelli»: «Das deutsche Europa». (di Paolo Lepri - Il sociologo Beck: «L’euronazionalismo tedesco è il nuovo pericolo»)18 gennaio 2013, di Federico La Sala
Il sociologo Beck: «L’euronazionalismo tedesco è il nuovo pericolo»
di Paolo Lepri (Corriere della Sera, 18.01.2013)
BERLINO - Ulrich Beck non ha dubbi. Nell’Unione Europea il nazionalismo è il peggiore nemico degli Stati e un allontanamento della Gran Bretagna dal club al quale ha aderito nel 1973 sarebbe un «suicidio». Londra perderebbe la sua relazione speciale con gli Stati Uniti, «cosa di cui peraltro è stata già avvertita», e finirebbe per dover dare l’addio anche alla Scozia e al Galles. Ma c’è un altro tipo di nazionalismo, altrettanto pericoloso. È quello che si realizza imponendo in Europa la propria forza. Questo è il caso della Germania.
Mentre il governo Cameron «ripensa» la sua politica europea, l’analisi delle mosse britanniche si lega quindi alle riflessioni che il grande sociologo tedesco sta compiendo da tempo sulla crisi che ha destabilizzato il Vecchio Continente. Al centro della sua attenzione c’è soprattutto il rischio di una deriva «euronazionalista» che può essere il risultato della politica di Angela Merkel e che può diventare la prosecuzione di quel «nazionalismo del marco» su cui è stata costruita l’identità del Paese nel dopoguerra. Il predominio tedesco manca tra l’altro di una autorità formale, all’interno di un’Europa della quale vanno invece vanno ripensate le istituzioni. «Oggi - dice Beck - il numero di telefono per chiamare l’Europa è quello di Angela Merkel».
L’autore di «La società del rischio» teme il rinascere di quel concetto di «Europa tedesca» contro il quale aveva messo in guardia, sessanta anni, fa uno scrittore come Thomas Mann. Era stato anche Helmut Kohl, il cancelliere dell’Unità, a citare l’autore della Montagna incantata per rivendicare le ragioni di una «Germania europea». Nell’analisi di Beck lo scenario di una egemonia tedesca in Europa non viene perseguito direttamente, ma può essere la conseguenza del «potere speciale» che Berlino ha ottenuto nell’Ue. «Siamo - ha osservato - i grandi vincitori della crisi».
Qualche mese fa, in occasione della pubblicazione del suo libro «Das deutsche Europa», Beck aveva parlato di modello «Merkiavelli», individuando un’affinità tra la cancelliera tedesca e Niccolò Machiavelli nella concezione dell’esercizio del potere. Ma non si tratta soltanto di una «scaltra combinazione» tra la difesa in Germania di una politica di concertazione e il sostegno nel resto d’Europa a programmi «neoliberisti».
C’è qualcosa di più. A giudizio di Beck, che è tornato ieri su questi temi in un’ampia intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, il «metodo» che la cancelliera ha in comune con il grande pensatore e letterato fiorentino è «la tendenza alla non azione, all’agire dopo, all’esitare intenzionalmente» per consolidare nel suo caso il potere della Germania rafforzando la dipendenza dei Paesi deboli dalla scelte tedesche.
In questo scenario, il nodo centrale della posizione tedesca in Europa è legato anche al rapporto con l’opinione pubblica e al grado di novità delle scelte che possono essere condivise. Beck dà atto alla cancelliera di essere riuscita a consolidare l’impegno della Germania nonostante la crescente disaffezione dell’elettorato. Ma è riuscita a farlo, a suo giudizio, grazie anche alla politica «merkiavellistica» e alla capacità di compiere passi avanti e indietro sui grandi temi dell’Unione.
È un’analisi che lascia aperti molti interrogativi sul futuro, particolarmente in un anno dominato dalla scadenza delle elezioni di settembre. Il rischio è che la politica del rinvio, oltre che una strategia, possa diventare una necessità. In grado di bloccare completamente il cammino dell’integrazione.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Il modello «Merkiavelli»: «Das deutsche Europa». (di Paolo Lepri - Il sociologo Beck: «L’euronazionalismo tedesco è il nuovo pericolo»)19 gennaio 2013
 IL CASO
IL CASO“La Germania ritira l’oro dall’estero”
Attualmente nelle riserve di Francoforte è custodito solo il 31% delle riserve di oro
Nei piani della Bundesbank c’è la riduzione delle quantità depositate a New York e il rimpatrio di tutto il metallo giallo custodito a Parigi *
berlino
La Bundesbank si appresta a rimpatriare una parte dei propri depositi di oro custoditi all’estero. Il quotidiano economico “Handelsblatt” scrive che domani la Buba darà l’annuncio ufficiale di voler ridurre la quantità di oro depositata a New York e di ritirare completamente il metallo giallo custodito nei forzieri parigini della Banque de France.
Attualmente le riserve di oro tedesco depositate all’estero sono ripartite nei forzieri della Fed a New York, dove è custodito il 45% delle riserve auree tedesche ammontanti a 3.396 tonnellate, con il 13% giacente presso la Bank of England a Londra e l’11% presso la Banque de France. Nella sede della Bundesbank di Francoforte giace invece il 31% delle riserve.
* La Stampa, 15/01/2013
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Brasile. Fine della riforma agraria. Il governo di Dilma Rousseff promuove il trionfo dell’agricoltura destinata al business e all’export. Cancellati cinquant’anni di lotte contadine per la riforma agraria e la sovranità alimentare (di Raúl Zibechi).18 gennaio 2013, di Federico La Sala
Brasile. Fine della riforma agraria
- Gran parte delle migliori terre coltivabili del Brasile serve a produrre soia, canna da zucchero e mais transgenico. Il governo progressista di Dilma Rousseff promuove il trionfo dell’agricoltura destinata al business e all’export. Cancellati cinquant’anni di lotte contadine per la riforma agraria e la sovranità alimentare. Il Partido dos Trabalhadores getta alle ortiche anche la sua lunga storia di lotta al latifondo. Nel territorio della più grande potenza del Sudamerica viene consumato un quinto dei prodotti agricoli tossici del mondo.
di Raúl Zibechi*
La riforma agraria, come politica di sviluppo, è stata abbandonata. Al suo posto c’è l’agro-business. Dopo mezzo secolo, si conclude un lungo ciclo di lotte per la re-distribuzione della terra dal latifondo improduttivo ai contadini senza terra. È stato un cardine per tutte le politiche di sinistra nel continente. Per ironia della sorte, la rottura delle politiche di distribuzione della terra avviene sotto il governo del Partido dos Trabalhadores (Pt) che, in altri tempi, è stato il più attivo sostenitore di una riforma agraria radicale.
Il governo di Dilma Rousseff sta promuovendo cambiamenti profondi nell’Instituto nacional de colonização e reforma agrária (Incra) al fine di decentrarlo e prendersi cura dei contadini che già possiedono terreni per quel che riguarda l’abitazione, l’energia elettrica e l’assistenza alla produzione. Si tratta, spiega un resoconto del quotidiano O Estado de São Paulo, della “modernizzazione amministrativa dell’Incra, legata a un cambiamento progressivo del profilo della riforma agraria” che si riassume nel sostenere la produzione “integrando i piccoli agricoltori nell’agro-business” (O Estado de São Paulo, 5 gennaio 2013).
L’Incra perde diverse funzioni, tra le quali l’autorità per selezionare le famiglie beneficiarie. Buona parte dei suoi compiti saranno assunti da municipi e ministeri (come quello dello sviluppo agricolo e quello dello sviluppo sociale e delle città). L’istituto si concentrerà su quello che già ha cominciato a considerare prioritario: le risorse per espropri di terra sono infatti calate dell’11,5 per cento tra il 2011 e il 2012, mentre il bilancio preventivo per l’assistenza tecnica è cresciuto del 123 per cento.
Il quotidiano conservatore paulista si congratula con la decisione governativa: “L’idea è prendersi cura meglio degli agricoltori insediati ufficialmente invece di investire nella creazione di vere e proprie favelas rurali, che è poi quello che sono diventati molti insediamenti creati per dare soddisfazione ai cosiddetti ‘movimenti sociali’”.
Che la destra esprima elogi non sorprende. In fondo, dall’inizio del governo Lula, proprio dieci anni fa, l’agro-business è stata un’opzione categorica del Pt, con la tesi secondo cui le esportazioni di commodities offrono un ampio surplus commerciale che produce benefici per il Paese riducendo la sua vulnerabilità esterna. La “re-primatizzazione” (un neologismo che indica il recupero dell’importanza dei settori primari dell’economia, ndt) del modello di esportazione e il calo delle esportazioni industriali non sono riusciti a modificare la volontà politica delle autorità intenzionate a favorire l’agro-business come locomotiva dell’economia e a trasformare la riforma agraria in una politica assistenziale.
Il continuo consolidamento di questa politica mette nei guai i movimenti contadini e, soprattutto, il Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Mst). João Pedro Stedile, del Coordinamento nazionale, ha ribadito che ci sono 150 mila famiglie accampate che stanno lottando per la terra e 4 milioni di famiglie povere che nei campi stanno ricevendo il programma Bolsa Familia per evitare la fame (Carta Capital, 7 dicembre 2012). L’85 per cento delle migliori terre del paese vengono utilizzate per la coltivazione di soia, mais transgenico e canna da zucchero; il 10 per cento dei proprietari rurali con oltre 500 ettari di terra controlla l’85 per cento della produzione agricola e zootecnica destinata all’esportazione senza alcun valore aggiunto.
Il peggio è che il Brasile conta il 5 per cento della produzione agricola mondiale ma consuma il 20 per cento dei prodotti agricoli tossici del mondo. Secondo l’Istituto nazionale dei tumori, ogni anno 400 mila persone contraggono la malattia, la maggior parte di essi si ammala a causa del consumo di alimenti contaminati da veleni agricoli. Intanto, il rapporto annuale della Commissione pastorale della terra (Cpt) rileva che il numero di famiglie insediate nel 2012 è il più basso dal 1994.
La Cpt stima che “l’agro-business si è consolidato nelle campagne come modello preferenziale del governo”, denuncia l’abbandono dei popoli tradizionali, tra i quali spiccano tremila comunità quilombolas (afrodiscendenti), sulle quali si è concentrata la violenza dell’agro-business al fine di sottrarre loro la terra. La mappa della violenza cresce inoltre con le grandi opere delle infrastrutture (dighe, porti) e con i progetti minerari a cielo aperto.
In agosto, a Brasilia si è tenuto l’Incontro unitario dei lavoratori e delle lavoratrici e dei popoli delle campagne, dell’acqua e dei boschi. Ha riunito 7 mila persone appartenenti a 33 movimenti rurali. Non servirà a far cambiare politica al governo, così come non lo fece Lula, malgrado la foto che lo ritraeva con il cappello con il simbolo del Mst. Anche Dilma Rousseff, nel Forum sociale mondiale realizzato nel 2012 a Porto Alegre, si era impegnata a insediare contadini senza terra nei nuovi progetti di irrigazione nel nordest, gli stessi che ora sta offrendo ai grandi imprenditori dell’export.
Le sue sono state parole che non si tradurranno in cambiamenti politici. Perché questo possa avvenire, sarebbe necessaria una nuova ondata di mobilitazioni e di movimenti come quella degli anni Settanta. Adesso invece le politiche sociali e la promozione sociale (limitata naturalmente) stanno disgregando i movimenti, ai quali, nel migliore dei casi, offrono briciole in forma di credito per la produzione e per le abitazioni. La Cpt ricorda nel suo rapporto che “lo Stato ha già preso posizione di fronte al contesto agricolo brasiliano” e che “viviamo un tempo in cui è necessario scegliere un nuovo modo di pensare e di vivere”.
È qui che, a mio parere, l’esperienza delle comunità zapatiste ha qualcosa da insegnarci. Non possiamo continuare a pensare che lo Stato possa essere garante dell’alimentazione, della casa, della salute, dell’educazione e di tutto ciò che serve ai ceti popolari per sopravvivere. Quella epoca è passata alla storia. È stata sepolta dal capitale quando ha deciso di liberarsi del welfare e della sovranità nazionale, considerati entrambi ostacoli alla sua accumulazione (del capitale, ndt), oggi accumulazione da guerra. I movimenti che continueranno a sperare che sia lo Stato a risolvere i problemi della vita dei suoi cittadini sono condannati a perdere il loro carattere anti-sistemico.
* Traduzione per Comune-info m.c. - 16.01.2013
Questo articolo è stato scritto anche il quotidiano messicano per La Jornada
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Chi ha dimenticato l’Europa dei diritti (di Barbara Spinelli)16 gennaio 2013, di Federico La Sala
Chi ha dimenticato l’Europa dei diritti
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 16 gennaio 2013)
Da lontano Castello che era, affidato a guardiani poco visibili, l’Europa è divenuta in questi anni presenza più che mai tangibile. E più del previsto soverchiante. È entrata nel linguaggio di ciascuno, insediandosi imperiosa nelle nostre menti: sotto forma di incubo purtroppo, anziché di speranza.
Chissà, forse il Nobel le è stato attribuito proprio per questo: perché davvero è nostra patria, anche se fatta nascere col forcipe, forza che coarta senza sostenere. Perché ci è diventata, come il dolore, in Rilke: luogo, campo, suolo, dimora, nostro cupo sempreverde. Forse era tanto più apprezzata quando era lontana dalle sue genti, quando era assente nel discorso pubblico e i popoli non la percepivano ancora come madre matrigna, ma madre pur sempre. Se c’è un vantaggio, nella crisi che sperimentiamo, è questo nostro entrare, obtorto collo, nel Castello fino a ieri così impenetrabile.
È un vantaggio perché finalmente possiamo discuterla, quest’Unione che d’un colpo irrompe nelle nostre vite e di continuo ci fa ripetere, come automi: «Ce lo dice l’Europa». Lo abbiamo visto in Grecia, Spagna, Francia; lo constatiamo in Italia, in Germania: non c’è elezione, ormai, dove il linguaggio dei politici non sia costretto a farsi europeo. In Italia lo dobbiamo alla fine del berlusconismo, alla biografia di Monti. Ma non siamo gli unici a vivere questa trasformazione, che tanti subiscono con risentimento. Il cambio di pelle non sembra far altro che impoverire le genti, e perfino le loro Costituzioni. Discutere l’Europa vuol dire non considerare fatale, indiscutibile, questo chiudersi di orizzonti.
Chi sente con dolore tale metamorfosi non ha tutti i torti, perché è vero che l’euro e i suoi custodi non sono affiancati da un potere politico egualmente comune, che raddrizzi squilibri e disuguaglianze fra nazioni e dentro le nazioni, che eviti la riduzione dei governi a comitati d’affari. Resta che l’Unione non è solo la moneta, come pretendono le agende dei partiti nazionali; né è solo una storia di conti da tenere in ordine, di debiti pubblici da abbattere con l’ascia fredda della Signora morte. Fin da ora essa è più ricca, vasta.
Ha un Parlamento dove ci si esercita a parlare europeo. È custode della democrazia pluralista, più che di un’ortodossia finanziaria. Ha strumenti come la Carta dei diritti fondamentali, approvata nel 2000 e divenuta pienamente vincolante nel 2009, quando entrò in vigore il Trattato di Lisbona.
Sono anni che Stefano Rodotà insiste su questa realtà, volutamente negletta, se non sprezzata, dai singoli governi. Ancora di recente, il 12 gennaio su Repubblica, lo ha ricordato, parlando del diritto degli omosessuali a unirsi e adottare figli: la Carta europea dei diritti ha lo stesso valore giuridico dei trattati, dei Fiscal compact, ed esiste per proteggere ogni minoranza etnica, religiosa; ogni stile di vita che non offenda la collettività. Corregge le indiscipline democratiche, non solo quelle contabili. È colpa dei politici nazionali se tale realtà è occultata; se solo i lacci economici sono l’obbligazione che ci lega. Se la lunga, complessa storia europea si riduce a un Decalogo finanziario.
Questo significa che l’Europa ci soverchia, sì, ma in maniera selettiva. Che il suo potere è troppo debole, non troppo forte. Che ancora deve nascere e imporsi come Stato di diritto, come garante sovranazionale della laicità, chiamato a proteggere i cittadini da interferenze di chiese e sette che si nutrono della fatiscenza dei vecchi Stati nazione. In Francia tutte le religioni, esclusa la buddista, si mobilitano compatte contro un disegno di legge sul matrimonio gay. È segno che gli Stati, meno sovrani, fronteggiano più faticosamente le ingerenze di lobby e chiese. Di qui l’importanza della Carta dei diritti, adottata non a caso nel mezzo della crisi.
L’Europa è un’impresa incompiuta ma non priva di forza, se solo volesse usarla e difendere un pluralismo gravemente danneggiato. Potrebbe farsi sentire sui matrimoni gay, sui nuovi modelli di famiglia: l’articolo 9 della Carta dei diritti non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. Potrebbe obbligare a rispettare i diritti delle proprie minoranze etniche: in particolare i 10-12 milioni di rom e sinti che abitano l’Unione. Siamo in un’epoca di transizione, come ai tempi di Dante: «Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?».
Nel maggio scorso l’Europa ha ordinato agli Stati di integrare meglio i rom, e predisposto fondi a questo scopo. Ben poco è stato fatto, disattesi sono gli articoli 15, 18, 52 della Carta, e i rom continuano a soffrire discriminazioni, soprusi, deportazioni forzate, nell’Occidente europeo e soprattutto in Est Europa.
La fine dell’impero sovietico non ha messo fine alle loro pene. Le ha enormemente acuite. In Slovacchia, Romania, Ungheria, i rom e i sinti sono trattati come reietti, man mano che dilaga la crisi, ed esposti a violenze crescenti. Risale all’inizio del 2013 un articolo di Zsolt Bayer, amico personale del Premier Viktor Orbán e fondatore con lui del partito Fidesz, che commentando una rissa di Capodanno scoppiata presso Budapest ha concluso che i rom «sono un’etnia inadatta a coesistere con le persone. Sono zingari che sfruttano i ‘progressi’ di un occidente idiotizzato. Sono animali e si comportano da animali. Animali che non dovrebbero avere il diritto di esistere. Una soluzione s’impone: immediatamente e quale che sia il metodo ». Il partito di governo non ha pronunciato una sola parola di condanna della soluzione finale proposta dall’amico Bayer. Ma non solo in Est Europa i rom sono ritenuti liquidabili.
Indagini europee descrivono maltrattamenti anche in Italia, Francia. Nel nostro paese già conosciamo la xenofobia della Lega: siamo i precursori di un fenomeno ormai continentale. Lo ha ricordato l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, in una lettera pastorale del settembre scorso.
Chiedendosi se sapremo garantire diritti e dignità alla più numerosa minoranza europea ha detto: «Sento la vergogna di campi più o meno autorizzati che sono al di sotto della soglia di vivibilità, in cui crescono violenza e delinquenza». La «sempre più bassa aspettativa di vita dei Rom, in un Paese longevo come il nostro», è indice del loro stato di abbandono e povertà. Decerebrata, l’Europa dimentica perché decise di unirsi, dopo la guerra: lo fece perché non si ripetesse l’annientamento degli ebrei, dei Rom e Sinti, dei gay, dei malati di mente. L’Europa non può, senza perdersi, fare il muso duro con Atene e non con Budapest. Minacciare di cacciare l’una, non l’altra.
Il 2013 è stato proclamato Anno europeo dei cittadini, dunque dei diritti-doveri che comporta per ognuno l’acquisizione della cittadinanza europea, accanto a quella nazionale. Bruxelles ne è consapevole quando negozia l’adesione degli Stati, ponendo condizioni democratiche stringenti.
Grecia, Spagna, Portogallo, e poi tutto l’Est Europa, entrarono nella Comunità quando si liberarono delle dittature. È il dopo-ingresso che non viene seguito, vigilato. Una volta dentro tutto diventa possibile: il ritorno dell’intolleranza, le Costituzioni democratiche offese, le chiese che reclamano nuovi poteri che non dovrebbero avere (sui corpi dei cittadini in primis: nascita, sesso, morte).
La Carta dei diritti, il trattato di Lisbona, i parametri del Fiscal compact: l’Europa è tutte queste cose insieme. Solo così vien tolta centralità assoluta all’economia, e rimesso al centro quel che tocca a ogni costo salvare: lo Stato di diritto. Altrimenti non ci resta che l’Europa matrigna, e l’accidiosa rinuncia di cui parla Karl Popper: «Se la democrazia è distrutta, tutti i diritti sono distrutti. Anche se fossero mantenuti certi vantaggi economici goduti dai governati, essi lo sarebbero solo sulla base della rassegnazione».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Rapporto sulla povertà. Un Commissario dell’Unione Europea mette in guardia dalla spirale discendente - Uno studio del World Economic Forum (da "Der Spiegel")11 gennaio 2013, di Federico La Sala
Der Spiegel, Hamburg - 8 gennaio 2013
Rapporto sulla povertà
Un Commissario dell’Unione Europea mette in guardia dalla spirale discendente
(traduzione dal tedesco di José F. Padova)
L’Unione Europea si divide in un Nord ricco e in un Sud povero. Secondo la Commissione europea questa tendenza si è aggravata durante i trascorsi cinque anni. “Il 2012 per l’Europa è stato un anno molto brutto”, dice il Commissario alle questioni sociali Andor.
Bruxelles - l’Europa meridionale soffre per povertà e disoccupazione, i Paesi del Nord traggono da questa situazione vantaggi economici. La Commissione europea ha presentato un Resoconto sociale che indica come negli ultimi cinque anni la spaccatura dell’Europa si è acuita. Il Commissario alle questioni sociali Lázsló Andor ha parlato di una “nuova crepa” e ne ha dato una tetra rappresentazione: sembra che gli Stati limitrofi “siano del tutto prigionieri di una declinante spirale fatta di diminuzione della produttività, di disoccupazione in rapida salita e di redditi sottoposti a erosione”.
La quota dei senza lavoro nell’eurozona è salita all’ 11,8 percento. Si tratta del dato più alto da quasi vent’anni. Cinque anni fa la quota percentuale di Nord e Sud era quasi equivalente. Oggi il differenziale è di 7,5 punti percentuali. In Grecia la quota è salita in un anno a 7,1 %. La Germania, con una percentuale di disoccupazione del 5,4 percento, appartiene ai Paesi nei quali il mercato del lavoro è più stabile. Anche per quanto riguarda la disoccupazione giovanile la Germania - come l’Austria e l’Olanda - sta bene. Qui meno di una su dieci persone sotto ai 25 anni è senza lavoro.
Per quanto riguarda i disoccupati di lungo periodo la quota per tutti i Paesi dell’Unione Europea è salita dal 3 al 4,6 %. Particolarmente colpiti sono Slovacchia, Spagna, Grecia, Irlanda e gli Stati baltici Estonia, Lettonia e Lituania, dove più di un settimo della popolazione attiva si trova durevolmente disoccupato.
Parallelamente a questa situazione in due terzi degli Stati membri sono calati i redditi reali [in potere d’acquisto] delle famiglie. In Grecia rispetto al 2009 le famiglie hanno quasi un quinto di soldi in meno, in Spagna otto e a Cipro sette percento meno. Al contrario nei Paesi del Nord, in Germania, Francia e Polonia le persone, nonostante la crisi, hanno più soldi in tasca. “Il 2012 per l’Europa è stato un altro anno cattivo, per quanto riguarda il peggioramento della situazione sociale”, ha detto Andor.
Il Rapporto sula situazione sociale attribuisce anche ai salvatori dell’Europa un esito che sgomenta. Da una parte è “urgentemente necessaria” la stabilizzazione delle economie politiche mediante meccanismi ora in discussione per l’approfondimento dell’unione monetaria. Questi consisterebbero proprio in un trasferimento da Nord a Sud, a grandi linee mediante un bilancio speciale, che la Commissione europea e il Presidente del Consiglio europeo Herman van Rompuy richiedono energicamente, ma che la Germania respinge. Fra le idee proposte vi è anche un’assicurazione europea contro la disoccupazione. La pressione su Berlino per ottenere maggiore solidarietà potrebbe aumentare considerevolmente.
Elogio delle Riforme Hartz
Dall’altra parte le chance di lavoro nei Paesi che hanno adottato riforme sostanziali del mercato del lavoro sono rimaste molto migliori, argomenta Andor. Le Riforme Hartz (ndt.: v. fra l’altro http://vocidallagermania.blogspot.it/2012/08/hartz-iv-compie-10-anni.html) dell’ex Cancelliere Gerhard Schröder (SPD) nel Rapporto sono citate quattro volte come piattaforma per la buona situazione in Germania.
Con questo Andor spiega implicitamente ulteriori svolte per il modello da applicare agli Stati in crisi. “Adeguate riforme del mercato del lavoro e sistemi sociali meglio realizzati possono accelerare l’uscita dalla crisi”. Tuttavia un sistema garantito non c’è, afferma il Commissario. Quali importanti elementi cita uno spostamento del gravame fiscale dal lavoro ad altre fonti come le emissioni di CO2 o le proprietà immobiliari e un “salario minimo adeguato”. Quest’ultimo potrebbe anche contribuire a ridurre la divergenza fra alti e bassi redditi, ulteriormente aumentata, e anche la disparità delle retribuzioni di uomini e donne.
Der Spiegel, 8 gennaio 2013
Uno studio del World Economic Forum
La frattura fra povero e ricco mette in pericolo l’economia mondiale
(traduzione dal tedesco di José F. Padova)
- Mutamenti climatici, fallimenti di Stati, penuria di acqua: in tutto il mondo cresce il pericolo di crisi, denuncia un rapporto del Foro mondiale per l’economia. Gli esperti interpellati, un migliaio in tutto, mettono in guardia soprattutto dalle differenze estreme fra i redditi - perché danneggiano l’economia.
Amburgo - Che cosa minaccia il mondo? All’approfondimento di questa domanda si dedica ogni anno un gruppo di lavoro per conto del Foro mondiale per l’economia. Consulta un migliaio di esperti di economia, scienziati, politici e membri di organizzazioni sociali - e presenta i risultati nel suo "Global Risks Report".
Secondo il più recente studio il mondo nel 2013 appare un poco più fosco che nel 2012. Sono aumentati molti rischi, vi è detto. Gli esperti valutano complessivamente che nei dieci anni prossimi le probabilità sia dell’avvento di scenari definiti di crisi, sia delle loro possibili gravi conseguenze, siano più alte di quelle descritte nel precedente rapporto. «Questi rischi globali sono un avvertimento salutare per i nostri più importanti sistemi», così si cita Lee Howell, un autore dello studio. Perciò ogni Paese dovrebbe lavorare per diventare più resistente contro simili rischi.
Al primo posto nell’elenco dei 50 più grandi pericoli per il mondo si trovano ancor sempre i problemi economici:
Quale rischio più grande si indica una diseguaglianza dei redditi, crescente in misura sempre più ingente. Di tutti gli scenari considerati questo è quello che più verosimilmente si attuerà nei prossimi dieci anni. Il tema dell’ineguaglianza suscita da qualche tempo le discussioni più accese - anche perché il crescente abisso fra povero e ricco acquista sempre maggiore rilievo come più sostanziale fattore scatenante di possibili crisi.
Al secondo posto si trova l’indebitamento pubblico. Per gli specialisti uno squilibrio cronico dei bilanci statali è alquanto meno probabile di come lo sia stato nell’anno scorso - probabilmente sotto l’impressione del recente, evidente ridursi della crisi dell’euro. Tuttavia ne stimano le possibili conseguenze come ancora più drammatiche.
Il terzo posto dell’elenco dei rischi è occupato da un tema ambientale. Le crescenti emissioni nocive per il clima preoccupano quest’anno gli esperti, ai loro occhi il pericolo del fallimento delle trattative per la difesa del clima è fortemente aumentato. Anche il recente, ultimo vertice sul clima tenutosi a Doha si è concluso con un consenso minimo.
Secondo la ricerca del Forum il massimo pericolo sociale è la crescente scarsità di acqua in molti Paesi della Terra - nessun altro rischio potrebbe avere conseguenze altrettanto drammatiche.
Al quinto posto si trova l’errato approccio al problema dell’ invecchiamento della popolazione. Si annuncia qui l’insuccesso delle reazioni ai costi in aumento e alle sfide sociali per il mutamento demografico.
Gli esperti considerano soprattutto pericolosa la combinazione dei problemi che si presentano nel sistema economico e in quello ambientale: «Se entrambi i sistemi fossero esposti parallelamente a un rifiuto [di risolverli], si verificherebbe la “perfetta tempesta globale” con conseguenze potenzialmente devastanti», è scritto nel rapporto. Per la crisi dell’economia sono mancate le risorse per affrontare effettivamente problemi come il cambiamento climatico.
Quale ulteriore scenario di crisi il rapporto indica eventi con inaspettate, gravi conseguenze. Fra questi si conterebbero “incendi [sociali] di vaste proporzioni in un mondo eccessivamente collegato in Rete”, come per esempio il film anti-islamico «L’innocenza dei musulmani» su YouTube, che ha suscitato in tutto il mondo violente proteste.
Inoltre sussiste il pericolo che problemi apparentemente già risolti vadano fuori controllo. Come esempio il rapporto cita la possibilità che una gran parte degli antibiotici oggi in uso perdano i loro effetti a causa di un impiego eccessivo.
La valutazione di disuguaglianza, indebitamento e cambiamento climatico come i più importanti rischi globali non è cambiata rispetto al World Risk Report del 2012. Tuttavia nel corso degli ultimi anni la classifica è molto mutata - evidentemente influenzata dal predominio dei singoli temi nel pubblico dibattito.
Così l’ineguaglianza ai tempi della crisi finanziaria fra il 2008 e il 2010 era un tema poco rilevante, come il cambiamento climatico. Invece di questo una caduta dei prezzi nel campo patrimoniale era considerata ancora un grande rischio, in rapporto sia alla sua probabilità che ai suoi potenziali effetti. Anche un indebolimento della congiuntura cinese e le malattie croniche facevano parte, secondo lo studio, dei rischi al top.
Il rapporto sui rischi deve essere discusso fra due settimane durante il vertice di Davos. Vi sono attesi nuovamente politici di alto rango - fra cui la Cancelliera Angela Merkel e il primo ministro russo Dimitri Medvedev.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Il dio delle armi e la religione dell’America (di Massimo Faggioli)16 dicembre 2012, di Federico La Sala
Il dio delle armi e la religione dell’America
Quindicimila morti all’anno. L’attaccamento a bibbia e fucile vanno spesso insieme
di Massimo Faggioli (l’Unità, 16.12.2012)
NON SI SA ANCORA SE LA STRAGE DI NEWTOWN CAMBIERÀ L’ATTEGGIAMENTO DELL’AMERICANO MEDIO nei confronti delle armi: quelle precedenti, specialmente da Columbine High School nel 1999 in poi, non ci sono riuscite. Negli Stati Uniti si contano oltre 15.000 morti per armi da fuoco ogni anno (le cifre variano) ed è un paese da sempre assuefatto alla violenza. Le statistiche dicono che negli Stati Uniti c’è meno violenza rispetto ai decenni precedenti, e che nel paese circolano più armi, ma quelle stesse armi sono nelle mani di una parte numericamente decrescente di americani: una minoranza, ma sempre più armata.
Anche per questo motivo il caso di Newtown non rappresenta un’eccezione alla regola, ma esattamente la regola di un’America in cui il feticcio dell’arma (non solo pistole e fucili, ma di recente anche supertecnologici archi e frecce) tende a rintanarsi in fasce ristrette della popolazione.
Ridurre la genesi dell’attentato alla mentalità disturbata dell’attentatore equivarrebbe ad ignorare uno degli elementi tipici dello scenario morale americano.
Nel suo Democrazia in America, Alexis de Tocqueville aveva descritto il viaggio alla conquista del nuovo mondo come l’avventura into the wild dell’uomo americano armato di «una Bibbia, un’ascia, e un giornale». Da allora il mondo americano è assai cambiato, ma non si è attenuata la radicale differenza con il mondo europeo quanto a percezione morale della violenza e della detenzione delle armi.
Ma accanto a questa differenza tra la mentalità americana e quella del resto del mondo sulle armi in mano alla popolazione civile, è cresciuta anche la distanza tra le due estreme della morale americana, frutto della polarizzazione culturale del paese: quella pro-guns e anti-abortion da un lato, e quella anti-guns e pro-abortion dall’altra.
Da una parte i liberals credono nella necessità di un maggiore controllo sulla circolazione delle armi sul territorio degli Stati Uniti e nella totale libertà di scelta della donna circa l’aborto; dall’altra, gli attivisti anti-abortisti sono tra i più affezionati a quell’interpretazione al secondo emendamento della Costituzione americana che dà ai cittadini il diritto di portare armi.
Ma la giurisprudenza costituzionale sul secondo emendamento risente di un fondamentalismo giuridico che è passato dalla Bibbia alla Costituzione anche grazie ai giudici cattolici della Corte Suprema, oggi ben sei su nove. Si dimentica che la mens di quel secondo emendamento intendeva dare ai cittadini il diritto di armarsi non per difendersi dal crimine o dalle violenze domestiche, ma dagli abusi del governo in un’America da sempre diffidente del potere, specialmente di quello del governo federale.
Gli Stati Uniti d’America sono un paese eccezionale rispetto al mondo intero quanto a intensità del sentimento religioso e quanto a fascinazione per la violenza e la morte: le due cose sono collegate.
L’attaccamento alla Bibbia e al fucile vanno spesso insieme: non è un caso che il Mosè di Hollywood, Charlton Heston, sia diventato il più famoso portavoce della National Rifle Association, la lobby capace di far eleggere deputati e senatori e capace di bloccare qualsiasi tentativo di approvare leggi sul controllo delle armi.
Il presidente degli Stati Uniti, sommo pontefice della religione americana, sopraffatto dall’emozione è l’immagine dell’impotenza di quel pontefice di avere ragione non solo della lobby della Nra, ma anche di quella larga fetta di americani che vedono nel diritto di portare armi l’ultima linea di difesa simbolica contro il governo, la politica, gli intellettuali, i gay, i mass media, il cosmopolitismo.
Quei bambini morti, le lacrime dei loro genitori e di tutti i genitori d’America sono i sacrifici umani che l’America si lascia imporre dalla religione del fucile. Finora le chiese americane sono state timide sulla questione delle armi, molto più timide che sulle altre questioni pro life: è tempo che il controllo delle armi entri a far parte della «cultura della vita» nell’America religiosa. Fino ad allora, la religione delle armi continuerà a mietere vittime.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Il Nobel per la Pace all’Europa delle armi (di Maurizio Chierici)11 dicembre 2012, di Federico La Sala
Il Nobel per la Pace all’Europa delle armi
di Maurizio Chierici (il Fatto, 11.12.2012)
MONTI MALINCONICO a Oslo dove Europa e Italia ricevono il Nobel della Pace per aver riconciliato un continente e difeso i diritti umani anche se non conviene precisare di chi. Non della Serbia “bombardata per amore della libertà” come ripeteva fra uno scoppio e l’altro il vescovo generale dei nostri cappellani militari. Nobel della Pace alla Francia di Sarkozy? Prima lancia i missili poi fa sapere in Tv d’aver dichiarato guerra al colonnello del terrore.
Nobel della Pace all’Europa che fabbrica e vende armi per accendere rivolte contro dittatori che diventano infidi appena cambiano idea su petrolio e affari? Non sempre i premiati sono stinchi di santo. Kissinger, incoronato nel ’73 per la mediazione nell’apocalisse Vietnam, sorride a Oslo mentre programma la morte di Salvador Allende. Ma sono le armi a consolare l’Europa delle Borse. L’Italia ne proibisce il commercio con paesi dalle guerre endemiche e violazioni dei diritti umani: espropri case e proprietà con l’arroganza delle mitraglie. Sciocchezze per il governo Berlusconi-La Russa. Nel 2005 firma con Israele importazioni, esportazioni e “transito di materiali militari”, cooperazione articolata in due memorandum, uno pubblico l’altro segreto: nasconde sviluppo e produzione belliche, addestramenti comuni.
Le spiate di Wikileaks fanno sapere dei messaggi tra l’ambasciata di Roma e il ministro della Difesa Robert Gates: “La Russa è l’uomo giusto. Strenuo difensore dell’aumento delle spese militari. Protagonista chiave per potenziare le basi Usa”. Dopo un po’ arriva il governo dei tecnici, ministro della Difesa l’ammiraglio Giampaolo Di Paola. Fino al 17 novembre 2011 faceva il presidente del Comitato Militare della Nato e il giorno dopo (divisa ancora tiepida) giura nelle mani di Napolitano. 24 ore non bastano per ripensare una cultura faticosamente decorata negli anni. E le spese non cambiano. Di Paola insiste per avere i suoi F-35 con testata nucleare. Li riduce da 121 a 90, ma intanto i prezzi aumentano: 123 miliardi e 390 milioni di dollari, 123 volte l’Imu di Roma più l’Imu di Milano.
L’EREDITÀ DEGLI ACCORDI con Israele viene confermata malgrado l’operazione Piombo Fuso a Gaza, 1400 morti, 422 bambini bruciati dal fosforo bianco che l’Onu documenta con ordigni non esplosi. Mentre si preparava il finimondo per punire la stupidità fanatica di chi da Gaza spara razzi che fanno solletico agli arsenali atomici, Italia e Israele giocano alla guerra nelle esercitazioni aeronavali della Sardegna e nel Negev, missili aria-terra e bombe a caduta libera. Quanto vale un’ora di volo di una superfortezza? Più di 40 mila ticket sanitari.
Monti va in Israele con Di Paola per vendere 30 velivoli da addestramento avanzato, affare da un miliardo compensato dall’acquisto in Israele di tecnologie, missili aria-terra anticarro, antifanteria, apri bunker e due velivoli di pronto allarme: 1 miliardo e 230 milioni. Respirano gli operai delle industrie della morte: nessuna crisi, posto che non corre pericolo: il lavoro li rende liberi. Ma chi trema sotto le loro bombe, cosa può pensare del Nobel della Pace?
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO".--- Il Nobel per la pace ai rappresentanti dell’Europa.10 dicembre 2012, di Federico La Sala
 Il Nobel per la pace ai rappresentanti dell’Europa
Il Nobel per la pace ai rappresentanti dell’Europa
 Monti con Merkel e Hollande, assente Cameron
Monti con Merkel e Hollande, assente Cameron- Il diploma e la medaglia simbolo del riconoscimento consegnati a Oslo nelle mani di Van Rompuy, Barroso e Schulz. Il premio in denaro, integrato fino a 2 milioni di euro, sarà devoluto in beneficenza ai bambini vittime delle guerre. Presenti i principali leader europei, tranne il premier britannico che ha inviato il suo vice *
OSLO - Il premio Nobel per la Pace 2012 assegnato all’Unione Europea è stato consegnato dal presidente del Comitato del Nobel Thornbjoern Jagland, durante la tradizionale cerimonia nel muncipio di Oslo, al presidente del Consiglio Europeo, Herman Van Rompuy, il presidente della commissione Europea, Jose Manuel Barroso e il presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.
"Voglio rendere omaggio a tutti gli europei che hanno sognato un continente di pace e a quelli che lo hanno reso una realtà", ha detto il presidente Van Rompuy al discorso di accettazione del premio Nobel, sottolineando come la pace dopo la seconda guerra mondiale non sarebbe stata forse "così duratura" se non vi fosse stata l’Unione europea.
Nel suo discorso Van Rompuy ha anche voluto riparare con garbo a una gaffe dello staff del Consiglio europeo che in una videostoria preparata ad hoc per la cerimonia in un primo tempo aveva dimenticato di citare l’Italia, tra i Paesi fondatori: "I leader di sei stati si riunirono a Roma ’città eterna’ (in italiano, ndr) per cominciare un nuovo futuro", è stata infatti la prima di una serie di ’immagini’ sulle origini e la storia dell’Unione citate da Van Rompuy nel suo discorso durante la cerimonia di consegna del Nobel.
L’Unione Europea ha reso noto che devolverà la somma ricevuta con il premio Nobel a progetti umanitari a favore di bambini vittime della guerra e dei conflitti integrandola con un importo equivalente per raggiungere i 2 milioni di euro. Ad assistere alla cerimonia re Harald e la famiglia reale di Norvegia, e molti capi di stato e di governo dei 27. Tra questi il premier Mario Monti, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Francois Hollande, il premier spagnolo Mariano Rajoy.
Presente anche il presidente della Bce Mario Draghi. Ma vi sono anche assenze illustri, che hanno già fatto discutere, come il premier britannico David Cameron, che ha inviato il suo vice più europeista, Nick Clegg, e gli euroscettici Freidrik Reinfeldt e Vaklav Klaus, rispettivamente premier di Svezia e della Repubblica Ceca.
Accanto ai leader della Ue sul palco di Oslo anche i giovani europei che hanno vinto un concorso indetto dalla Ue per i migliori tweet sul tema "Pace, futuro, Europa", tra i quali la 16enne milanese Elena Garbujo.
* la Repubblica, 10 dicembre 2012
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO".--- "Cambiare l’Italia, riformare l’Europa" promette cambi drastici negli Stati ma in Europa una diplomazia graduale (di Barbara Spinelli - Moderatamente europeo)27 dicembre 2012, di Federico La Sala
Moderatamente europeo
di BARBARA SPINELLI *
Ancora non è chiaro cosa significhi, nelle parole di Monti, il centrismo radicale proposto come Agenda di una futura unità nazionale: un ordine nuovo, addirittura, dove le classiche divisioni fra destra e sinistra sfumerebbero. Non è chiaro cosa significhi in particolare per l’Europa: presentata come suo punto più forte. Punto forte, ma stranamente sfuggente.
Centrista, sì, ma radicale non tanto. Lo stesso titolo dell’Agenda tradisce l’assenza di un pensiero che si prefigga di curare alle radici i mali presenti. "Cambiare l’Italia, riformare l’Europa" promette cambi drastici negli Stati ma in Europa una diplomazia graduale, senza voli alti, senza i radicalismi prospettati in patria. Se Monti avesse voluto davvero volare alto, ed esser veramente progressista come annunciato domenica in conferenza stampa, avrebbe dato all’Agenda un titolo meno anfibio, più trascinante: non riformare, ma "cambiare l’Europa per cambiare l’Italia".
La formula prescelta è in profonda contraddizione con l’analisi cupa di una crisi che ha spinto e spinge l’Italia e tanti paesi su quello che troppo frequentemente, troppo ossessivamente, vien chiamato orlo del baratro. Una crisi che continua a esser vista come somma di politiche nazionali indisciplinate; mai come crisi - bivio necessario, presa di coscienza autocritica - del sistema Europa, moneta compresa. È come se contemplando un mosaico l’occhio fissasse un unico tassello, senza vedere l’insieme del disegno. I problemi che abbiamo, questo dice l’Agenda, ciascuno ha da risolverli a casa dentro un contenitore - l’Unione - che essenzialmente funziona e al massimo va corretto qui e lì.
L’Agenda propone qualcosa di ardito, è vero: il prossimo Parlamento europeo dovrà avere un "ruolo costituente". Dunque c’è del guasto, nel Trattato di Lisbona: siamo sprovvisti di una Costituzione sovranazionale. Ma resta nella nebbia quel che debba essere la Costituzione a venire, e drammatica è l’assenza di analisi sul perché il Trattato vigente non sia all’altezza delle odierne difficoltà e del divario apertosi fra Nord e Sud Europa. Più precisamente, manca il riconoscimento che stiamo vivendo una crisi economica, politica, sociale dell’Unione intera (una crisi sistemica), che non si supera limitandosi a far bene, ciascuno per proprio conto, "i compiti a casa" come prescrive l’ortodossia tedesca. Nella storia americana, Alexander Hamilton ebbe a un certo punto questa presa di coscienza: decise che il potere sovranazionale si sarebbe fatto carico dei singoli debiti, e fece nascere dalla Confederazione di Stati semi-sovrani una Federazione, dotata di risorse tali da garantire, solidalmente, una più vera unità. È il momento Hamilton - non centrista-moderato ma radicale - che non si scorge né a Bruxelles, né nell’Agenda Monti.
Unici impegni concreti sono il pareggio di bilancio e la riduzione del debito pubblico in Italia: dunque la nuda applicazione del Fiscal compact, del Patto di bilancio del marzo 2012, corredato fortunatamente da un reddito di sostentamento minimo e forme di patrimoniale. Certo, fare l’Europa è anche questo. Certo: è giunta l’ora di dire che la crescita di ieri non tornerà tale e quale ma dovrà mutare, in un’economia-mondo non più dominata dai vecchi paesi industrializzati. Quel che si nasconde, tuttavia, è che non esistono solo due linee: da una parte Monti, dall’altra i populismi antieuropei. Esistono due europeismi: quello conservatore dell’Agenda, e quello di chi vuol rifondare l’Unione, e perfino rivoluzionarla. Tra i sostenitori di tale linea ci sono i federalisti, i Verdi tedeschi che chiedono gli Stati Uniti d’Europa, molti parlamentari europei. Ma ci sono anche quelle sinistre (il primo fu Papandreou in Grecia, e il Syriza di Tsipras dice cose simili) secondo le quali le austerità sono socialmente sostenibili a condizione che l’Europa cambi volto drasticamente, e divenga il sovrano garante di un’unità federale, decisa a schivare il destino centrifugo della Confederazione jugoslava.
I fautori della Federazione (parola evitata da Monti) non si concentrano solo sulle istituzioni. Hanno uno sguardo ben diverso sulla crisi, su come cambia la vita dei cittadini. Hanno una visione più tragica, meno liberista-tecnocratica: non saranno il Fiscal compact e il rigore a sormontare i mali dell’ineguaglianza, della povertà, della disoccupazione, ma una crescita ripensata da capo, e la consapevolezza che le diseguaglianze crescenti sono la stoffa della crisi. L’Agenda è fedele al più ortodosso liberismo: tutto viene ancora una volta affidato al mercato, e l’assunto da cui si parte è che finanze sane vuol dire crescita, occupazione, Europa forte: non subito forse, ma di sicuro. Immutato, si ripete il vizio d’origine dell’Euro. Quanto all’Italia, ci si limita a dire che il rispetto riguadagnato in Europa dipenderà dalla sua credibilità, dalla sua capacità di convincere gli altri partner. Convincere di che? Non lo si dice.
L’idea alternativa a quella di Monti è di suddividere i compiti, visto che gli Stati, impoveriti, non possono stimolare sviluppo e uguaglianza. Se a questi tocca stringere la cinghia, che sia l’Unione a assumersi il compito di riavviare la crescita, di predisporre il New Deal concepito da Roosevelt per fronteggiare la crisi degli anni ’30, o la Great Society proposta negli anni ’60 da Johnson "per eliminare povertà e ingiustizia razziale". L’idea di un New Deal europeo circola dall’inizio della crisi greca, ma non sembra attrarre Monti. È un progetto preciso: aumentare le risorse del bilancio dell’Unione a sostegno di piani europei nella ricerca, nelle infrastrutture, nell’energia, nella tutela ambientale, nelle spese militari. Non mancano i calcoli, accurati, dei vasti risparmi ottenibili se le spese dei singoli Stati verranno accomunate.
Per tale svolta occorre tuttavia che il bilancio dell’Unione non sia striminzito come oggi (l’1% del pil. Nel bilancio Usa la quota è del 23). Che aumenti alla grande, grazie all’istituzione di due tasse, trasferite direttamente dal contribuente alle casse dell’Unione: la tassa sulle transazioni finanziarie e quella sull’emissione di diossido di carbonio. La carbon tax (gettito previsto: 50 miliardi di euro) segnalerebbe finalmente la volontà di far fronte a un disastro climatico già in corso, non ipotetico. Cosa ne pensa Monti? Sappiamo che vuol tassare le transazioni finanziarie, ma gli eventuali introiti già sono accaparrati dal Tesoro nazionale.
Perché l’Agenda vola così basso? Perché Monti è europeo, ma moderatamente. Perché, scrive Marco D’Eramo nel suo Breve lessico dell’ideologia italiana, la moderazione del centrista "è quella che modera le altrui aspettative e l’altrui livello di vita. Modera la nostra fiducia nel futuro" (Moderato sarà lei, Marco Bascetta e Marco D’Eramo, Manifestolibri 2008). E perché la sua dottrina dell’union sacrée è la fuga patriottico-centrista dalle contrapposizioni anche aspre che sono il lievito della democrazia dell’alternanza.
L’unione sacra che Monti preconizza da anni idoleggia l’unanimità: proprio quel che sempre in Europa produce accordi minimalisti. Non è un inevitabile espediente (come nella Germania citata dal Premier) ma ilfinale e migliore dei mondi possibili. Di qui la sua ostilità alla divisione destra-sinistra: un’avversione che come oggetto ha la divisione stessa, la pacifica lotta fra idee alternative. È significativa l’assenza di due vocaboli, nell’Agenda. Manca la parola democrazia (tranne un riferimento alle primavere arabe e alle riforme europee "democraticamente decise e controllate") e manca la laicità: separazione non meno cruciale in Italia.
Diceva Raymond Aron di Giscard d’Estaing, l’ispettore delle Finanze divenuto Presidente nel ’74: "Quest’uomo non sa che la storia è tragica". Qualcosa di simile accade a Monti, e un esempio è il modo in cui pensa di risolvere la questione Vendola, espellendolo dall’union sacrée perché le sue idee "nobili in passato, sono perniciose oggi". Quel che il Premier non sa, è che Vendola impersona la questione sociale che fa ritorno in Occidente, assieme alla questione dei diritti e di un’altra Europa. Quel che pare ignorare, è che pernicioso non è Vendola. È il malessere che egli denuncia. Della sua voce abbiamo massimo bisogno.
Non sono semplicemente idee, quelle bollate come perniciose. Sono il vissuto reale in Grecia, Italia, Spagna. Roosevelt lo capì: e aumentò ancor più le spese federali, investì enormemente sulla cultura, la scuola, la lotta alla povertà, l’assistenza sanitaria. Non c’è leader in Europa che possegga, oggi, quella volontà di guardare nelle pieghe del proprio continente e correggersi. Non sapere che la storia è tragica, oggi, è privare di catarsi e l’Italia, e l’Europa.
* la Repubblica, 27 dicembre 2012
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Oslo, il premio Nobel alla Ue. Proteste con Syriza e no global10 dicembre 2012, di Federico La Sala
 Oslo, il premio Nobel alla Ue.
Oslo, il premio Nobel alla Ue.
 Proteste con Syriza e no global
Proteste con Syriza e no global- Fiaccolata nel pomeriggio contro l’assegnazione del riconoscimento per la pace all’Unione europea. Partecipa la sinistra greca insieme al gruppo Attack, oltre al "tea party" norvegese e ad altri gruppi. Van Rompuy: "Europa ce la farà, uscirà dalla crisi più forte"
OSLO - Contestazioni ad Oslo per il premio Nobel per la pace assegnato alla Unione europea. Nel pomeriggio è in programma una fiaccolata di protesta in una delle piazze centrali della capitale norvegese cui partecipano anche i greci della sinistra di Syriza, insieme ai no-global del gruppo Attack.
Tra le organizzazioni che prendono parte alla manifestazione vengono indicate anche il tea party di Norvegia ed i gruppi Attack di Islanda, Svezia, Francia, Austria, Novergia. Principale organizzatore il gruppo norvegese ’Nei til eu’ (No alla Ue) di opposizione all’Unione Europea: la Norvegia alla fine degli anni ’80 aveva chiesto l’ingresso nella Ue, respinto con due referendum popolari l’ultimo dei quali nel 1994, vinto dal no con il 51%. Gli ultimi sondaggi danno il no attorno al 70%.
In città sono intanti giunti il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, il presidente della Commissione Ue Manuel Barroso e il presidente del Parlamento Europeo Martin Schultz. E’ "sicuro che ce la faremo" e che l’Unione europea "sarà più forte di prima", ha detto Van Rompuy, nel suo intervento di apertura della conferenza stampa tenuta con il presidente della Commissione e del Parlamento europeo, Martin Schulz, alla vigilia della consegna del Premio Nobel per la pace all’Ue. "L’Unione - ha sottolineato - sta attraversando un periodo difficile, certamente lo supereremo, uscendo più forti dalla recessione e dall’incertezza". Barroso ha poi sottolineato il bisogno di maggiore integrazione e autorità per risolvere i problemi, inclusi quelli economici dell’eurozona.
A Oslo le celebrazioni prendono il via già oggi, tra divisioni e qualche gaffe, come quella del video realizzato per il premio, in cui in un primo momento non c’era alcuna traccia dell’Italia tra i padri fondatori dell’Europa unita, né riferimenti al ruolo del nostro Paese nella storia dell’integrazione europea. Dopo le proteste della diplomazia italiana, il video è stato corretto, con le scuse ufficiali di Van Rompuy.
* la Repubblica, 09 dicembre 2012
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ...La buona-esortazione del BRASILE. --- Addio a Oscar Niemeyer il visionario di Brasilia. Il maestro dell’architettura è morto ieri notte a 104 anni (di Franco La Cecla).6 dicembre 2012, di Federico La Sala
 Addio a Oscar Niemeyer il visionario di Brasilia
Addio a Oscar Niemeyer il visionario di Brasilia
 Il maestro dell’architettura è morto ieri notte a 104 anni
Il maestro dell’architettura è morto ieri notte a 104 anni di Franco La Cecla (la Repubblica, 6.12.2012)
di Franco La Cecla (la Repubblica, 6.12.2012)RIO DE JANEIRO - Il grande architetto brasiliano Oscar Niemeyer è morto ieri sera nell’ospedale Samaritano di , dove era ricoverato da oltre un mese. Aveva 104 anni, ne avrebbe compiuti 105 il 15 dicembre. Lascia la seconda moglie Vera Lucia Cabreira, quattro nipoti, e 19 bisnipoti. Aveva perso da poco l’unica figlia, Annamaria.
OSCAR Niemeyer è stato l’ultimo grande maestro del movimento moderno di quel razionalismo in architettura di cui furono antesignani Gropius, Mies Van der Rohe e Le Corbusier. Di quest’ultimo Oscar Niemeyer fu giovane allievo, quando Le Corbusier venne chiamato nel 1934 a realizzare a Rio la costruzione del nuovo ministero dell’Educazione e della Sanità. E fu con lui nella concezione del nuovo Palazzo delle Nazioni Unite a New York, il cui progetto fu poi sottratto nella costruzione finale all’architetto svizzero.
Le opere di Oscar Niemeyer, una produzione ricchissima che copre ottant’anni di lavoro, sono diventate simbolo di una maniera visionaria, provocatoria di applicare il verbo del movimento moderno molto spesso sovvertendolo. Alle linee rette e alla freddezza di molte opere europee del razionalismo architettonico Niemeyer contrappone linee curve, sensualità di onde, ellissi, ovali, curve di donna che diventano case della musica, ministeri, cattedrali.
Quello che ne fa un maestro della generazione dei primi architetti moderni è l’assoluta mancanza di dubbi, l’assertività, un’architettura che proclama costantemente il trionfo delle forme, le superfici bianche curve che si aprono in vetrate, vengono servite da iperboliche passerelle lanciate nel vuoto. Come se nella architettura di Niemeyer trionfasse la linea di matita continua che non si stacca mai dal foglio. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho nasce il 1907 a Rio, da una famiglia che per parte di madre ha delle radici in Germania. Cresce in una città piena di fermenti culturali ed in piena espansione.
È della stessa generazione di Vinicius de Moraes, l’inventore della Bossa Nova (c’è un video di Chico Buarque, «As Cidades», «Le città», dove il maestro viene intervistato dal cantante a questo proposito) e fa parte di un mondo progressista che guarda all’Europa come ad un luogo cui ispirarsi per creare un paese moderno.
Diventa comunista e questo gli costa un ventennio di esilio volontario in Europa durante il regime dei colonnelli. A Parigi dove risiede per un certo tempo realizza la straordinaria sede del Partito Comunista, una cupola bianca che emerge da un prato in declivio e che copre un’enorme sala assembleare dalle pareti scoscese. La sua fede marxista non gli impedirà di lavorare per ogni tipo di cliente, con una sicurezza che fa parte anch’essa del suo stile di maestro indiscusso.
Torna negli anni 80 in Brasile e produce una serie di progetti mirabolanti, come il museo d’arte contemporanea di Niteroi, vero e proprio disco volante poggiato su un pilastro da cui sembra che stia per spiccare il volo verso la Baia di Guanabara. Il suo stile diventa sinonimo di una architettura «del futuro» a tal punto da ispirare film ironici come uno famoso con Jean Paul Belmondo (L’uomo di Rio) dove le forme concave, convesse, le iperboli diventano il paesaggio di un futurismo lunare. Perfino nel film il dormiglione di Woody Allen il futuro viene rappresentato con architetture che sono una copia di quelle di Niemeyer.
Lavora in tutto il mondo, Israele, Libano, Algeria, Bolivia, Francia, Portogallo e in Italia realizza su incarico di Giorgio Mondadori la sede della Mondadori a Segrate e quella della fabbrica della Fata Engineering a Pianezza e della cartiera Burgo a San Mauro Torinese. È una fioritura continua di opere che non si arresta nemmeno quando il maestro compie novant’anni e realizza alcune opere di una purezza formale straordinaria, come il museo Oscar Niemeyer a Curitiba e nelle Asturie in Spagna e il museo nazionale del Brasile a Brasilia.
Brasilia rimane la città a cui ha dato i segni più forti del suo stile, a partire dagli edifici realizzati negli anni ‘50 dentro al piano della nuova città concepito dal mestro di Niemeyer, Lucio Costa. Il palazzo del governo a Brasilia, con le sue due coppe una concava ed una convessa e l’edificio alto in mezzo sono state descritte dal musicista Gilberto Gil come una composizione musicale che ricorda samba e bossa nova.
Viene invitato, quasi centenario a realizzare a Ravello una casa della Musica che riproporrà l’ovale dell’occhio del museo di Curitiba, ma questa volta con uno sguardo mozzafiato sul mare campano. Negli ultimi anni di attività alcuni critici hanno rinvenuto nelle ultime opere un manierismo che rappresenterebbe un inaridimento della creatività del maestro. Anche se è difficile non essere impressionato dall’audacia del progetto di una cupola di sessanta metri d’altezza per la nuova Catedral do Cristo Rei e il Santuario della Divina Misericordia a Belo Horizonte.
È difficile dare ragione ai critici, proprio perché l’energia, l’assertività, la sicurezza assoluta di Niemeyer sono ancora dentro ad un’idea di «purezza» del messaggio architettonico come messaggio di progresso e di pace. Niemeyer somiglia in questo a Picasso. Entrambi personaggi complessi, contraddittori, comunisti ricchissimi e militanti mondani, con un rapporto fertile e vorace con il mondo femminile, eppure talmente convinti di essere «alla guida» che qualunque loro scelta sembra parte di una coerenza imbattibile.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! La buona-esortazione del BRASILE. --- SAN PAOLO. E’ morto Oscar Niemeyer, l’architetto noto come il padre di Brasilia. Aveva 104 anni.6 dicembre 2012, di Federico La Sala
 Addio a Oscar Niemeyer
Addio a Oscar Niemeyer
 l’architetto padre di Brasilia
l’architetto padre di Brasilia Era nato a Rio de Janeiro 104 anni fa. Si è sempre ispirato alla natura.
Era nato a Rio de Janeiro 104 anni fa. Si è sempre ispirato alla natura.
 Influenzato da Le Corbusier, ha sfruttato al massimo le possibilità del cemento armato.
Influenzato da Le Corbusier, ha sfruttato al massimo le possibilità del cemento armato.
 Lavorò anche al Palazzo di Vetro dell’Onu.
Lavorò anche al Palazzo di Vetro dell’Onu.
 Comunista, fu costretto all’esilio a Parigi durante la dittatura militare *
Comunista, fu costretto all’esilio a Parigi durante la dittatura militare *SAN PAOLO - E’ morto l’architetto brasiliano Oscar Niemeyer, noto come il padre di Brasilia. Aveva 104 anni. Il decesso è avvenuto nell’ospedale samaritano di a Rio de Janeiro in cui era ricoverato dal 2 novembre scorso.
"L’architettura è il mio hobby - diceva spesso - una delle mie allegrie: creare la forma nuova e creatrice che il cemento armato suggerisce, scoprirla, moltiplicarla, inserirla nella tecnica più d’avanguardia. Questo è per me inventare lo spettacolo dell’architettura". E la forma da creare, il suo credo stilistico, la sintetizzava in poche parole: "Non è l’angolo retto che mi attrae, né la linea diritta, dura, inflessibile, creata dall’uomo. Quello che mi affascina è la curva libera e sensuale: la curva che trovo sulle montagne del mio paese, nel corso sinuoso dei suoi fiumi, nelle onde dell’oceano, nelle nuvole del cielo e nel corpo della donna preferita".
Niemeyer nasce a Rio de Janeiro nel 1907. Nel 1928 si sposa con Annita Baldo, figlia di emigranti di Padova. Nel 1934 si laurea ingegnere architetto ed va a lavorare nello studio di Lucio Costa, futuro disegnatore del piano di Brasilia. "Non volevo, al contrario della maggior parte dei colleghi, adattarmi a questa architettura commerciale che vediamo dappertutto - diceva ricordando quei tempi - Nonostante non avessi un soldo, ho preferito lavorare gratuitamente nello studio di Costa dove trovavo le risposte ai miei dubbi di giovane studente". E’ di quegli anni il contatto con Le Corbusier che ha influenzato molto il suo stile basato sulle estreme possibilità del cemento armato.
Nel 1945 entra nel partito comunista brasiliano e vi è rimane fino alla morte. Nel 1947 va a New York per lavorare al Palazzo di Vetro dell’Onu. Ma è nel 1951 che l’originalità delle linee rotonde che contraddistinguono il suo stile si impone a livello mondiale. In quell’anno disegna a San Paolo il Parco Ibirapuera, con la sede della Biennale e la Oca, una struttura in cerchio derivata dalle capanne degli indios, e l’edificio Copan.
Cinque anni dopo vince con Lucio Costa il concorso per il piano pilota della nuova capitale, che sostituirà Rio de Janeiro con una città avveniristica spostata più a nord, al centro della savana brasiliana, inaugurata nel 1960. Niemeyer vi realizza decine di edifici. I più famosi sono il Palazzo dell’Alvorada e quello del Planalto, sedi del presidente della repubblica, le cupole convessa e concava del Congresso, il palazzo di Itamaraty, sede del ministero degli Esteri, e la cattedrale, ancora oggi considerata il suo capolavoro: "Ho evitato le soluzioni delle vecchie cattedrali buie, che ricordano il peccato. Al contrario ho fatto scura la galleria di accesso alla navata, e questa l’ho voluta tutta illuminata, colorata, rivolta con le sue belle vetrate allo spazio infinito".
Nel 1964 soffre sulla sua pelle il golpe militare. "Durante la dittatura tutto è stato differente - raccontava - Il mio studio è stato saccheggiato. I miei progetti poco a poco hanno cominciato ad essere rifiutati. Il posto di un architetto comunista è a Mosca, mi disse un giorno un ministro". E’ di quegli anni la celebre frase di Fidel Castro: "Niemeyer ed io siamo gli ultimi comunisti rimasti a questo mondo". Nel 1967 va esule a Parigi. Dell’anno seguente è il suo più famoso progetto in Italia: la sede della Mondadori a Segrate. Torna in Brasile alla fine della dittatura e progetta il Memorial da America Latina a San Paolo, e il Museo di Arte Contemporanea a Niteroi, città di fronte a Rio de Janeiro. Negli Stati Uniti vince nel 1988 il premio Pritzker, il Nobel dell’architettura.
Nel 1996 riceve il Leone d’Oro della Biennale di Venezia e nel 2000 disegna il progetto dell’auditorium di Ravello, inaugurato nei primi mesi del 2010. Nel 2005 è stato inaugurato dalla Tim l’auditorium del Parco Ibirapuera, a San Paolo, un progetto del 1954 rimasto per anni nel cassetto.
Nel novembre del 2006 Niemeyer si risposa all’età di 98 anni con la sua segretaria Vera Lucia Cabreira, più giovane di lui di 38 anni. Lo fa contro il volere di Anna Maria, l’unica figlia (morta nel giugno scorso all’età di 82 anni), ma gli amici le spiegano che il padre "si era innamorato". Ha lavorato fino all’ultimo nel suo studio panoramico davanti alla spiaggia di Copacabana.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Europa-Asia come si inventa il nemico. Per accreditare l’idea di un antagonismo eterno si risale fino a Troia e alle guerre persiane (di Luciano Canfora).5 dicembre 2012, di Federico La Sala
- PIANETA TERRA. PER UN "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. Fine della Storia o della "Preistoria"? L’EUROPA E TROIA: UN CERCHIO CHE SI CHIUDE.
Europa-Asia come si inventa il nemicoPer accreditare l’idea di un antagonismo eterno si risale fino a Troia e alle guerre persiane
di Luciano Canfora (La Stampa, 3.12.2012)
I procedimenti mentali intesi a dare alla nozione di Europa un contenuto storico, o addirittura politico, organicamente unitario sono votati al fallimento: questo non impedisce, ovviamente, che abbiano successo come pseudoconcetti della retorica comiziale.
Tentativi del genere si ripetono nel tempo, e prendono le mosse dagli spunti più diversi. Tra le risorse più utilizzate vi sono, com’è noto, due remotissimi avvenimenti storici, la guerra di Troia (circa 1200 a. C.) e le guerre persiane (490 e 480-478 a. C.). Entrambi proverebbero che Europa e Asia si sono scontrate da sempre, e comunque ab immemorabili tempore, e che dunque oggi - in tempi di crescita esponenziale dell’economia indiana e, ancor più, di quella cinese - è giunto il momento della riscossa europea ancora una volta contro l’Asia: «fare fronte» (come dicevano un tempo gli attivisti dell’ultradestra eversiva) nel nome di Agamennone e di Menelao e, perché no, di Temistocle. Né importa che proprio lui, Temistocle, il vincitore di Serse a Salamina (con buona pace degli «europeisti da comizio») sia poi fuggito in Persia ostracizzato dagli Ateniesi, e ospite di Artaserse fino alla fine dei suoi giorni, in qualità di governatore della satrapia persiana di Magnesia al Meandro per ordine di Artaserse I. La storia, si sa, è complicata, e, se studiata da presso, smentisce la retorica comiziale.
Mette conto osservare, peraltro, che l’operazione di collegare passato e presente per cavarne insegnamenti attuali fu già compiuta in antico, ma non tanto a sostegno della presunta polarità Europa/Asia quanto, semmai, per suffragare il fondamento antico dell’antagonismo Grecia/Asia e portare argomenti alle aspirazioni egemoniche imperiali di chi voleva dominare sui Greci e accampava di chiamarli a raccolta per proseguire la storica, inestinguibile guerra contro l’Asia.
Un tale argomento fu il cemento ideologico dell’impero ateniese nel V secolo e fu ripreso e amplificato - con l’aiuto di devoti propagandisti - da Filippo di Macedonia nel secolo seguente. Ma in un caso come nell’altro si trattava per l’appunto di una copertura propagandistica delle aspirazioni egemoniche sul mondo greco tanto da parte di Atene quanto da parte di Filippo.
Un bell’esempio di come poté svilupparsi questo genere di operazioni ideologiche a base storiografica è dato dalla tardiva nascita della «cornice» dell’opera di Erodoto. Per quanto la prudenza si imponga quando si cerca di stabilire attraverso indizi la stratigrafia compositiva di un’opera antica (per la quale in genere mancano informazioni esterne che rivelino il cammino compiuto dall’autore), è tuttavia ragionevole pensare che la «cornice» riassuntiva iniziale mirante a proiettare molto indietro nel tempo le radici del conflitto greco-persiano sia nata per l’appunto quando il racconto erodoteo si è concentrato, negli ultimi libri, sulle due invasioni persiane della Grecia.
A quel punto si sono verificati, in modo convergente, alcuni fenomeni che hanno contribuito a far nascere quella «cornice» che solo molto tardi Erodoto deve aver collocato al principio della sua opera. E cioè: (a) il dilatarsi oltre misura del racconto di quelle due guerre e soprattutto dell’invasione di Serse, la più pericolosa e la più durevole; (b) il fatto che dunque tale racconto veniva a costituire la metà almeno dell’intera historíae; (c) il fatto che la vittoria sui Persiani venisse da tempo e stabilmente adoperata da Atene per giustificare il proprio impero imposto agli alleati greci; (d) la crescente insofferenza dei Greci verso tale uso imperialistico della vittoria sui Persiani, «nemico storico», nemico «di sempre»; (e) la scelta di Erodoto di far propria quella propaganda nel momento in cui Pericle stava portando Atene verso un micidiale conflitto intergreco; (f) la necessità propagandistica di dare al conflitto da cui la potenza imperiale ateniese era sorta lo sfondo storico mitico di un conflitto eterno, di una minaccia sempre presente da cui Atene aveva salvato i Greci tutti, ivi compresi quelli che ora le si opponevano o le si ribellavano.
Di qui la «cornice» in cui quel conflitto «eterno» viene teorizzato ed esemplificato: una cornice che dà unità a tutta l’opera imponente dello storico di Alicarnasso fattosi ateniese di adozione e pericleo di simpatie politiche.
Grecia e Asia, dunque: non Europa e Asia, stante che l’«Europa» di Erodoto è una Grecia un po’ più vasta, non un continente.
Erodoto è consapevole del carattere ideologico di una tale impostazione. In lui il propagandista generoso della giustificazione periclea dell’impero convive con l’etnografo che sa bene quanto Asia e Grecia e Africa siano realtà compenetrate, non contrapposte, e quanto, semmai, la Grecia debba a quegli altri due mondi, coi quali sin dal principio aveva convissuto mescolandosi.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- In quel posto segreto del bosco (di di Claudio Magris - Le Storie, preghiere che aiutano a vivere)2 dicembre 2012, di Federico La Sala
Le Storie, preghiere che aiutano a vivere
di Claudio Magris (Corriere della Sera, 1 dicembre 2012)
Nel famoso romanzo di Nabokov, Humbert-Humbert dice: «Oh, Lolita mia, io ho soltanto parole con cui giocare». Soltanto parole - le quali dunque non dicono, non contengono la vita, bensì possono solo alludere alla sua assenza, dire la mancanza dell’essenziale e ridursi a frantumi con cui dolorosamente giocare. Gran parte della letteratura moderna è caratterizzata da questo malinconico divario fra la parola e la vita, dall’insufficienza della parola a dire la vita. «Lingua mortal non dice / quel ch’io sentiva in seno», o, prima ancora, Shakespeare: «Words, words, words». Il racconto che apre il Novecento letterario, la Lettera di Lord Chandos di Hofmannsthal, è la storia di uno scrittore che si vota al silenzio perché le parole - segni astratti e convenzionali, funghi ammuffiti - non dicono il fluire dell’esistenza.
C’è una tradizione, tuttavia, in cui «soltanto», a proposito delle parole, non è una limitazione negativa, non indica insufficienza e aridità, come per il protagonista di Nabokov. È la tradizione chassidica, la corrente mistica e gioiosa dell’ebraismo orientale, in cui parabole e leggende sono preghiere, racconti di verità. In una di queste parabole, riportata da Gershom Scholem, il più grande storico di mistica ebraica, si narra che quando Baàl-shem, il santo e maestro, doveva assolvere un compito difficile per il bene delle creature, andava in un posto speciale e segreto del bosco, accendeva magicamente un fuoco, diceva preghiere particolari e otteneva da Dio ciò che chiedeva.
Una generazione dopo, un suo successore, il Maggìd di Meseritz, quando si trovava dinanzi allo stesso compito, si recava in quel posto segreto del bosco e diceva quella speciale preghiera, ma non conosceva più il modo di accendere il fuoco, e otteneva ciò che chiedeva. Ancora una generazione dopo, un altro grande maestro non sapeva più né come accendere il fuoco né quale preghiera dire, ma si recava in quel luogo nascosto del bosco, ottenendo ciò che chiedeva.
Ma, ancora una generazione dopo, un altro maestro che aveva la stessa esigenza, diceva di non conoscere più né l’arte di accendere quel fuoco né le formule di quella preghiera e nemmeno dove si trovasse quel luogo nel bosco, ma aggiungeva che di tutto questo poteva raccontare la storia e, raccontandola, otteneva ciò che chiedeva. E ogni volta che, nella cerchia dei chassidim, il narratore narra la storia di questa progressiva perdita, il suo racconto ottiene da Dio il dono richiesto; di quella realtà restano soltanto le parole, ma le parole che narrano la storia di quella perdita la superano, perché hanno la stessa efficacia delle azioni compiute da quei santi nel passato.
Le storie, in questo senso, assomigliano alle preghiere: stabiliscono legami - religione deriva da religio, ciò che collega - trasmettono valori, dicono il senso delle errabonde vicende umane. Poche cose infatti uniscono, creano legami e amicizia, come raccontare storie, accadute a noi stessi o a qualche altro, ma che sono divenute parte di noi e che, rinarrate, diventano anche di altri, entrano nella loro vita. La cerchia chassidica in cui si raccontano storie è un coro in cui una voce si riconosce nelle altre, distinguendosi, ma anche confondendosi con le altre, in un epico scambio fra il mio e il tuo. Anche fra noi amici, talora non sappiamo bene cosa è accaduto all’uno o all’altro. Ma abbiamo le storie; le parole, non soltanto le parole.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- DOBBIAMO VIVERE INSIEME. Razzismo e multicullturalità (di Ernesto Balducci - don Aldo Antonelli).14 novembre 2012, di Federico La Sala
DOBBIAMO VIVERE INSIEME
di Ernesto Balducci (Il Secolo XIX, 26 gennaio 1992) *
Il moltiplicarsi degli episodi di «razzismo» in tutta l’area occidentale (ma bisogna prepararsi: ne avremo presto anche nell’Est europeo, in fase rapida di omologazione) pone uno dei problemi radicali con cui deve confrontarsi ogni progetto politico, da quello di una semplice amministrazione civica a quello della Comunità europea. Non bisogna lasciarsi ingannare dalle simbologie e dalle fraseologie, spesso antisemitiche, che rimandano al razzismo ideologico hitleriano. Niente di strano che gli automatismi del razzismo prebellico continuino a funzionare: essi forniscono l’orizzonte immaginario di maniera a cui ricorre preferibilmente l’incultura. Ma l’impianto della nuova forma di razzismo, che io chiamo «fascismo etnologico», e, a mio giudizio, del tutto diverso.
Esso ha radici nell’ancestrale paura del diverso, e trova le sue ragioni immediate nella difesa della condizione di privilegio minacciata dall’arrivo di nuovi ospiti, gli immigrati dal ,Sud. Essi non sono più gli immigrati di altri tempi, destinati prima o poi all’assimilazione dentro la cultura che li accoglieva. Quando essi arrivano, trovano già uno spazio culturale omogeneo a quello d’origine. Il fatto nuovo è che la società capitalistica, in forza della stessa legge di mercato che ha fatto la sua fortuna, è costretta a ospitare vere e proprie comunità etnicamente aliene dalla sua cultura. [...]
Io sono tra quelli che ritengono inevitabile e, alla fine, provvidenziale un’Europa multietnica, ma mi rendo conto che questa previsione è un lusso da intellettuale, che rischia di mettere a pié pari la drammaticità del processo che la metamorfosi presuppone. E infatti il processo non avviene all’interno di una cultura della solidarietà, come quella che, grazie a Dio, sta crescendo negli ambienti cristiani; avviene dentro una cultura della competizione, giunta al massimo della sua diffusione.
I protagonisti degli atti di neorazzismo sono infatti quasi sempre dei «balordi», che recepiscono e trasmettono a livello istintuale una provocazione che andrebbe mediata da una cultura illuminata. Sono i prodotti tipici della «pedagogia» televisiva, in cui dominano i forti e i bravi; in cui, per dirla tutta (penso agli spot televisivi), il modello d’uomo è un mammifero vorace, dai muscoli efficienti, pronto al successo quale che sia.
Questa ideologia, svuotata di ogni lume di ragione, fa presa con la voglia di affermazione il cui sbocco preferito appunto, l’atto aggressivo contro il diverso. Infatti, se si spoglia l’uomo di ogni struttura culturale resta in lui la paura dell’altro, la percezione che la propria identità e messa in rischio dalla presenza dell’alterità.
Che siano, in molti casi, i poveri, i disoccupati, i sottoproletari, gli emarginati di casa nostra a farsi protagonisti di gesti deplorevoli non deve far meraviglia: sono proprio gli incolti a subire i riflessi di insicurezza causati dalla presenza dei diversi. Con una proiezione elementare essi riversano su chiunque rappresenti la diversità, magari con il colore della pelle, la brutale aggressività con cui scongiurare la paura, capovolgendola nel trionfo. La bravata li solleva subito al rango degli uomini di successo, i veri eroi della cultura dominante.
Detto questo, mi si permetta di definire col massimo della semplicità la questione etico-politica sollevata dalla cronaca del neorazzismo in un momento come questo, in cui l’Europa, a dispetto dei suoi trionfi, soffre di una drammatica assenza di progettazione del proprio futuro. Dato per scontato che la presenza dei gruppi etnici diversi dal nostro si farà più massiccia, si aprono due vie: quella della lenta assimilazione, di modo che in una o due generazioni gli immigrati diventino in tutto come noi, fuori che nel colore della pelle; o quella della convivenza tra gruppi etnicamente e culturalmente diversi.
Come ho detto, io credo che la via giusta - una via che ci porta oltre il mondo moderno, in una postmodernità dal profilo inafferrabile - sia quella della convivenza. Ma se questo è vero, dobbiamo affrettarci a predisporre gli strumenti necessari - a cominciare dalla scuola - perché questo futuro si avveri senza traumi. Sarà anche giusto mettere in prigione i balordi dalla testa rapata, ma quel che occorre è una rapida instaurazione della cultura della diversità. Le culture che si chiudono su di se sono condannate a morire. La nostra non fa eccezione.
* Il neorazzismo di casa nostra
Carissimi,
di fronte alle tristi cronache di eggressione e di pestaggi di cui hanno riferito le cronache locali di questi giorni, penso sia doveroso fermarsi a riflettere e interrogarci.
Per aiutarvi allego un bellissimo articolo di Padre Balducci che fu pubblicato dal giornale Il Secolo XIX nel 1992.
Io l’ho trovato molto profondo ed ATTUALE.
E’ intitolato "Dobbiamo vivere insieme"!
Un abbraccio a tutte e tutti.
Aldo [don Antonelli]
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- “Da Parigi a Berlino, contaminiamo le idee per realizzare finalmente una vera unità” (di Albert Camus)11 novembre 2012, di Federico La Sala
“Da Parigi a Berlino, contaminiamo le idee per realizzare finalmente una vera unità”
di Albert Camus (la Repubblica, 11.11.2012)
- Nel 1955 il grande scrittore francese intervenne ad Atene
 parlando di Europa tra antiche ferite e nuove speranze
parlando di Europa tra antiche ferite e nuove speranze
 C’è bisogno di respiro, di grazia i valori sono isolati
C’è bisogno di respiro, di grazia i valori sono isolati
 La sovranità ha messo i bastoni tra le ruote della storia
La sovranità ha messo i bastoni tra le ruote della storia
 La nostra è in primo luogo una civiltà pluralista
La nostra è in primo luogo una civiltà pluralista
Se riteniamo che la civiltà occidentale consista soprattutto nell’umanizzazione della natura, cioè nelle tecniche e nella scienza, l’Europa non solo ha trionfato, ma le forze che oggi la minacciano hanno mutuato dall’Europa occidentale le sue tecniche o le sue ambizioni tecniche e, in ogni caso, il suo metodo scientifico o di ragionamento. Vista così, in effetti, la civiltà europea non è minacciata, se non da un suicidio generale e da se stessa, in qualche modo. Se, viceversa, riteniamo che la nostra civiltà si sia sviluppata sul concetto di persona umana, questo punto di vista, che può essere altrettanto valido come lei ha ragione di sottolineare, porta a una risposta del tutto diversa. Vale a dire che probabilmente, dico probabilmente, è difficile trovare un’epoca in cui la quantità di persone umiliate sia così grande.
Tuttavia non direi che quest’epoca disprezzi l’essere umano in modo particolare. Infatti contemporaneamente a queste forze, che definirei del male per semplificare le cose, non c’è dubbio che nel corso dei secoli si è progressivamente diffusa una reazione della coscienza collettiva e in particolare della coscienza dei diritti individuali.
Due guerre mondiali l’hanno soltanto un po’ logorata e credo sia ragionevole rispondere che la nostra civiltà viene minacciata nella misura esatta in cui oggi un po’ ovunque l’essere umano, viene umiliato. A quest’utile distinzione posso aggiungere che potremmo chiederci, e parlo sempre al condizionale, se proprio il singolare successo della civiltà occidentale nel suo aspetto scientifico non sia in parte responsabile del singolare fallimento morale di questa civiltà.
Per dirla diversamente se, in un certo senso, la fiducia assoluta, cieca, nel potere della ragione razionalista, diciamo nella ragione cartesiana per semplificare le cose, perché è lei al centro del sapere contemporaneo, non sia responsabile in una certa misura del restringimento della sensibilità umana che ha potuto, in un processo evidentemente troppo lungo da spiegare, portare poco alla volta a questo degrado dell’universo personale.
L’universo tecnico in se stesso non è una brutta cosa, e sono assolutamente contrario a tutte quelle teorie che vorrebbero un ritorno alla carrucola o all’aratro trainato da buoi. Ma la ragione tecnica, posta al centro dell’universo, considerata come l’agente meccanico più importante di una civiltà, finisce per provocare una specie di perversione, al contempo nell’intelligenza e nei costumi, che rischia di portare al fallimento di cui abbiamo parlato. Sarebbe interessante cercare di capire in che modo.
(...) Quali sono, innanzitutto, gli elementi che costituiscono la civiltà europea? Rispondo di non saperlo. Ognuno di noi però ha una prospettiva privilegiata, sentimentale in qualche modo, che d’altronde può essere ragionata e fondata su osservazioni, la quale ci fa preferire uno di questi elementi agli altri. Secondo me, e per una volta potrò rispondere in modo netto, la civiltà europea è in primo luogo una civiltà pluralista. Voglio dire che essa è il luogo della diversità delle opinioni, delle contrapposizioni, dei valori contrastanti e della dialettica che non arriva a una sintesi. In Europa la dialettica vivente è quella che non porta a una sorta di ideologia al contempo totalitaria ed ortodossa. Il contributo più importante della nostra civiltà mi sembra sia quel pluralismo che è sempre stato il fondamento della nozione di libertà europea. Oggi per l’appunto è questo ad essere in pericolo ed è ciò che bisogna cercare di preservare.
L’espressione di Voltaire che credo dicesse: «Non la penso come voi, ma mi farò ammazzare per lasciarvi il diritto di esprimere la vostra opinione», è evidentemente un principio del pensiero europeo. Non c’è dubbio che oggi sul piano della libertà intellettuale, ma anche sugli altri piani, questo principio viene messo in discussione, viene attaccato e mi sembra che vada difeso.
Rispetto alla questione di sapere se alla fine si salverà e se il futuro sarà nostro, come si dice, ebbene a questo tipo di domande rispondo allo stesso modo in cui rispondo ad altre, che pongo a me stesso in situazioni simili. In alcune circostanze, mi sembra che un uomo possa rispondere: «Questa cosa è vera, secondo me, o probabilmente vera. Questa cosa dunque deve vivere. Non è sicuro che io possa farla vivere, non è sicuro che la morte non attenda ciò che mi sembra essenziale. Comunque, l’unica cosa che posso fare, è lottare perché viva».
Penso, che in questa fase l’Europa sia chiusa in un quadro rigido all’interno del quale non riesce a respirare. Dal momento che Atene dista sei ore da Parigi, che in tre ore da Roma si va a Parigi, e che le frontiere esistono solo per i doganieri e i passeggeri sottomessi alla loro giurisdizione, viviamo in uno stato feudale. L’Europa, che ha concepito di sana pianta le ideologie che oggi dominano il mondo, che oggi le vede voltarsi contro di essa, essendosi incarnate in paesi più grandi e più potenti industrialmente, quest’Europa, che ha avuto il potere e la forza di teorizzare tali ideologie, allo stesso modo può trovare la forza di concepire i concetti che permetteranno di controllare o equilibrare queste ideologie.
Semplicemente ha bisogno di respiro, di grazia, di modi di pensare che non siano provinciali, mentre al momento tutti i nostri modi di pensare lo sono. Le idee parigine sono provinciali; quelle ateniesi anche, nel senso che abbiamo estrema difficoltà ad avere abbastanza contatti e conoscenze, a contaminare quanto basta le nostre idee affinché si fecondino mutualmente i valori erranti, che sono isolati nei nostri rispettivi paesi.
Ebbene, credo che quest’ideale verso il quale noi tutti tendiamo, che dobbiamo difendere e per il quale dobbiamo fare tutto ciò che è possibile, non si realizzerà subito. La «sovranità» per molto tempo ha messo bastoni in tutte le ruote della storia internazionale. Continuerà a farlo. Le ferite della guerra così recente sono ancora troppo aperte, troppo dolorose perché si possa sperare che le collettività nazionali facciano quello sforzo di cui solo gli individui superiori sono capaci, che consiste nel dominare i propri risentimenti.
Ci troviamo dunque, psicologicamente, davanti a ostacoli che rendono difficile la realizzazione di questo ideale. Detto questo, (...) bisogna lottare per riuscire a superare gli ostacoli e fare l’Europa, l’Europa finalmente, dove Parigi, Atene, Roma, Berlino saranno i centri nevralgici di un impero di mezzo, oserei dire, che in un certo qual modo potrà svolgere il suo ruolo nella storia di domani.
La piccola riserva che introdurrò è la seguente. Ha detto che non si può affrontare dal punto di vista intellettuale il problema del futuro europeo, che non ci si può riflettere finché non avremo quella struttura a cui potremo fare riferimento. La mia riserva sta dunque nel dire: dobbiamo comunque affrontare il problema, dare un contenuto ai valori europei, anche se l’Europa non si farà domani. Mi ha colpito l’esempio che ha fatto poco fa. Lei ha sostenuto: «La Germania quando non era unita, non era una potenza». È verissimo. Nondimeno possiamo sostenere che la maggior parte delle ideologie contemporanee si è formata sull’ideologia tedesca del Diciannovesimo secolo, e che tutti i filosofi tedeschi che hanno fatto nascere quella nuova forma di pensiero precedono l’unificazione tedesca, naturalmente se consideriamo che l’unità tedesca si realizza nel 1871. Perciò è possibile influire su una civiltà, anche dallo stato di abbandono e povertà in cui siamo.
Il ruolo degli intellettuali e degli scrittori è in un certo senso quello di continuare a lavorare nel loro ambito, cercando di spingere la ruota della storia se possono farlo e se ne hanno il tempo, affinché al momento dovuto i valori necessari, non dico siano pronti, ma possano già servire come fermenti. (...) La libertà senza limiti è il contrario della libertà.
Solo i tiranni possono esercitare la libertà senza limiti; e, per esempio, Hitler era relativamente un uomo libero, l’unico d’altronde di tutto il suo impero. Ma se si vuole esercitare una vera libertà, non può essere esercitata unicamente nell’interesse dell’individuo che la esercita. La libertà ha sempre avuto come limite, è una vecchia storia, la libertà degli altri. Aggiungerò a questo luogo comune che essa esiste e ha un senso e un contenuto solo nella misura in cui viene limitata dalla libertà degli altri.
Una libertà che comportasse solo dei diritti non sarebbe una libertà, ma una tirannia. Se invece comporta dei diritti e dei doveri, è una libertà che ha un contenuto e che può essere vissuta. Il resto, la libertà senza limiti, non viene vissuta e ha come prezzo la morte degli altri. La libertà con dei limiti è l’unica cosa che faccia vivere allo stesso tempo colui che la esercita e coloro a favore dei quali viene esercitata.
 (Traduzione di Alessandro Bresolin)
(Traduzione di Alessandro Bresolin)
 © Éditions Gallimard, 2008 Tratto da Il futuro della civiltà europea, Castelvecchi editore 2012
© Éditions Gallimard, 2008 Tratto da Il futuro della civiltà europea, Castelvecchi editore 2012 - Nel 1955 il grande scrittore francese intervenne ad Atene
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ----Gli Economisti Costernati mettono in guardia contro il Trattato di Bilancio di ("Atterres.org" - Trad. di José F. Padova).9 novembre 2012, di Federico La Sala
Comunicati
Gli Economisti Costernati mettono in guardia contro il Trattato di Bilancio
 18 settembre 2012
18 settembre 2012Trad. di José F. Padova
Noi interveniamo qui, come economisti, per mettere in guardia contro i pericoli che comporta il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione economica e monetaria. Questo Patto di bilancio segna una nuova tappa delle due offensive, quella dei liberisti contro la pratica keynesiana della politica economica e quella delle istituzioni europee contro l’autonomia delle politiche nazionali di bilancio.
Questo Trattato non affronta le cause della crisi finanziaria: la cecità e l’avidità dei mercati finanziari, l’esplosione delle bolle finanziarie e immobiliari indotte dalla finanziarizzazione, l’ingigantirsi delle disuguaglianze dei redditi consentita dalla sfrenata concorrenza fra Paesi favoriti dalla mondializzazione.
Non affronta le cause della crisi della Zona euro: l’assenza di un reale coordinamento delle politiche economiche che hanno l’occupazione come obiettivo [primario], lo squilibrio provocato dalla esigenza di ottenere eccedenti [di bilancio] da parte dei Paesi del nord, il divieto iscritto nella Costituzione europea del finanziamento degli Stati da parte della BCE, ciò che permette alla speculazione di scatenarsi, quando invece è impotente nei confronti degli Stati Uniti, del Giappone e del Regno Unito, che pure sono più indebitati della Zona euro.
Il Trattato ratifica le politiche di austerità, in atto da tre anni, che affossano l’Europa in una recessione senza fine, che aggravano la chiamata in causa del modello sociale europeo, che immergono milioni di europei, in primo luogo i giovani, nella disoccupazione e milioni di famiglie nella povertà. Il Patto di bilancio si fonda su una diagnosi errata. Il colpevole sarebbe la mancanza di disciplina di bilancio. Tuttavia, prima della crisi i Paesi della Zona euro non si distinguevano per deficit di bilancio pubblico particolarmente forti: nei tre anni precedenti la crisi (2004-2007), gli Stati Uniti avevano un deficit del 2,8% del PIL, il Giappone del 3.6%, la Zona euro dell’1,5%, nettamente inferiori agli importi degli investimenti pubblici o al livello richiesto per stabilizzare il debito. Solamente la Grecia presentava un deficit pubblico elevato. In realtà, le istituzioni europee, polarizzate sul cieco rispetto di norme arbitrarie, preoccupate di affermare il loro controllo sulle politiche nazionali, hanno lasciato che in Europa crescessero gli squilibri fra i Paesi del nord, che accumulavano gli avanzi di bilancio, e i Paesi del sud, trascinati in basso da una bolla immobiliare. Gli organismi europei hanno negato i pericoli che la deregolamentazione finanziaria faceva correre.
Secondo l’Articolo 1 del Trattato (vedi: http://european-council.europa.eu/media/639226/10_-_tscg.it.12.pdf ) le regole sarebbero destinate a « a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio, a potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale». Ma costrizioni numeriche su debiti e deficit pubblici, che non tengono conto della situazione economica, non possono essere considerate come un coordinamento delle politiche economiche.
Secondo l’art. 3 i Paesi dovranno mantenere un quasi equilibrio delle finanze pubbliche (ovvero un deficit pubblico strutturale inferiore allo 0,5% del PIL), ciò che non ha alcun fondamento economico. La vera «regola d’oro delle finanze pubbliche» giustifica, al contrario, che gli investimenti pubblici siano finanziati dall’indebitamento. Nel caso della Francia, questo autorizza un deficit pubblici strutturale dell’ordine del 2,4% del PIL.
Il medesimo articolo impone ai Paesi «una rapida convergenza verso questo obiettivo», convergenza che verrebbe proposta dalla Commissione europea, senza tenere conto della situazione congiunturale. I Paesi perderebbero quindi la loro libertà d’azione. Così, per il 2013, la Francia si vede costretta a raggiungere un deficit del 3% del PIL, dunque a praticare una politica recessiva in periodo di depressione. Tanto più recessiva quanto più sono deboli le previsioni economiche.
Per ridurre il deficit sarebbe messo in opera un meccanismo automatico. Ancora una volta, in questo caso un Paese vedrebbe essergli imposta la sua politica di bilancio. Se ha un deficit strutturale di 3 punti del PIL, l’anno successivo dovrà avere un deficit strutturale di 2 punti e poi fare sforzi per raggiungere 1 punto del PIL, quale che sia l’evoluzione economica. Un Paese colpito da un rallentamento economico non avrà il diritto di applicare una politica di sostegno.
L’obiettivo del Trattato è proprio quello di realizzare il sogno di sempre dei liberisti: paralizzare le politiche di bilancio, imporre a ogni costo l’equilibrio del bilancio. Esso volta le spalle agli insegnamenti di 75 anni di teoria macroeconomica.
Il Trattato si fonda sulla nozione di deficit strutturale, vale a dire il saldo [di bilancio] pubblico corretto dal saldo congiunturale. Il Paese si troverebbe di fronte al deficit delle sue finanze pubbliche se la sua produzione fosse al suo livello d’equilibrio, cioè la sua produzione potenziale. Esso deve essere valutato, secondo diverse teorie, con metodi differenti. La sua misura dipende dal metodo impiegato; essa è più che problematica, in particolare nei periodi cruciali, quelli di depressione o di shock macroeconomici. In realtà sono le valutazioni della Commissione che dovranno essere impiegate. Ora, queste hanno due difetti: variano fortemente nel corso del tempo e così le stime di produzione potenziale fatte per il 2006 sono state fortemente ridotte nel 2008: sono sempre vicine alla produzione effettiva, perché questo metodo considera come strutturale la diminuzione del capitale dovuta alla caduta dell’investimento durante una crisi; sottostima il deficit congiunturale e obbligherebbe ad applicare politiche pro-cicliche. Così la Commissione stima che la differenza di produzione (la differenza fra produzione potenziale e produzione effettiva) nel 2012 per la Francia sia soltanto del 2,8% (ossia un deficit strutturale del 3%), mentre altri metodi giungono a una differenza di produzione dell’8% (e quindi a un deficit strutturale dello 0,5%). Può la politica economica dipendere da simili stime?
L’obiettivo di deficit strutturale potrà essere abbassato all’1% se il debito pubblico è al disotto del 60% del PIL. Un Paese che ha in media una crescita del 2% all’anno e un’inflazione del 2% e che mantiene indefinitamente un deficit dell’1% del PIL vede il suo debito convergere verso il 25% del PIL. Ora nulla garantisce che l’equilibrio macroeconomico possa essere assicurato con valori a priori: un debito del 25% del PIL, un deficit dell’1% del PIL! Inserire questo nella Costituzione è altrettanto fondato che scrivervi: «Gli uomini dovranno pesare 70 kg e le donne 50».
Gli Stati membri dovranno iscrivere la regola dell’equilibrio di bilancio e il meccanismo di correzione automatica nella loro Costituzione o, se ciò non è possibile, in un dispositivo cogente e permanente. In questo modo dispositivi indefiniti, inapplicabili, senza fondamento economico, verrebbero scolpiti nel marmo.
I Paesi membri dovranno mettere in opera istituzioni indipendenti incaricate di verificare il rispetto della regola dell’equilibrio di bilancio e della traiettoria dell’aggiustamento. Si tratta di un passo ulteriore verso la completa tecnocratizzazione della politica economica. Queste istituzioni indipendenti avranno il diritto di rimettere in discussione la regola, se questa non corrisponde alle necessità della congiuntura?
Secondo l’art. 4 un Paese, il cui rapporto debito/PIL supera il 60% del PIL, dovrà ridurlo ogni anno di almeno un ventesimo della differenza con il 60%. Questo presuppone che un rapporto del 60% sia una cifra ottimale realizzabile da tutti i Paesi. Ora, Paesi come l’Italia o il Belgio avevano da decenni debiti pubblici del 100% del PIL (il Giappone perfino del 200%) senza squilibri, perché questi debiti corrispondono a forti tassi di risparmio delle famiglie.
Secondo l’art. 5 un Paese sottoposto a una «procedura per debito eccessivo» (PDE) dovrà sottoporre il budget e un programma di riforme strutturali alla Commissione e al Consiglio, che dovranno approvarli e seguirne l’applicazione. Questo articolo è una nuova arma per permettere d’imporre ai popoli riforme liberiste. Oggi la quasi totalità dei Paesi dell’Unione Europea (21 su 27) sono sottoposti a PDE; essi non hanno bisogno di riforme liberali, ma di crescita sociale ed ecologica. A meno che per “riforme strutturali” il Trattato intenda provvedimenti miranti a rompere il dominio dei mercati finanziari, ad aumentare le imposte sui più ricchi e sulle grandi imprese, a finanziare la transizione ecologica.
Secondo l’art. 7 le proposte della Commissione saranno adottate automaticamente, salvo che si verifichi contro di esse una maggioranza qualificata [di Stati], poiché il Paese in questione non vota. Così, in pratica, la Commissione avrà sempre l’ultima parola.
Questo progetto impone politiche di bilancio quasi automatiche, vieta ogni politica di sostegno dell’attività [economica]. Ma queste ultime sono indispensabili per la stabilizzazione economica. Alla fine del 2008 il FMI, il G20 e la Commissione europea hanno chiesto ai Paesi di intraprendere simili politiche. Occorre vietarle quattro anni dopo?
Secondo il Trattato ogni Paese deve prendere isolatamente misure restrittive, senza tenere conto della sua situazione congiunturale e delle politiche dei partner. Il Trattato fa l’implicita ipotesi che il moltiplicatore keynesiano sia nullo, che le politiche di bilancio restrittive non abbiano alcun impatto sull’attività economica. Oggi, a metà del 2012, questo impone che la maggior parte dei Paesi pratichino politiche di austerità mentre la causa dei debiti pubblici è globalmente un livello insufficiente di produzione e di occupazione dovuto all’esplosione della bolla finanziaria.
Il desiderio del nuovo governo francese [ndt.: di François Hollande] di rinegoziare il Trattato è giunto il 29 giugno a un Patto per la crescita e l’occupazione. Malgrado il suo titolo esso non è simmetrico al Patto di bilancio. Non comporta alcun obiettivo preciso in termini di occupazione o di crescita. Nell’essenziale non fa che riprendere progetti già avviati, generalmente d’ispirazione liberista: la strategia per l’Europa 2020, la necessità di garantire la efficacia dei sistemi di pensionamento (vale a dire di prolungare l’età del pensionamento o di ridurre il livello delle pensioni), di migliorare la qualità della spesa pubblica (ciò che significa spesso ridurre le spese sociali giudicate improduttive, aumentando gli aiuti alle imprese), di favorire la mobilità della mano d’opera, di aprire la concorrenza in materia di servizi, di energia, di mercato pubblico. Il Patto riconosce che non vi è accordo circa una tassa sulle transazioni finanziarie; non fa che aprire la porta a una cooperazione rafforzata, a un accordo fra alcuni Paesi, senza il Regno Unito e il Lussemburgo, cosa che ne limita fortemente la portata. Le misure di rilancio, a dire il vero, sono limitate, per non dire inesistenti. Si tratta di 120 miliardi ossia l’1% del PIL della Zona, ma su un lasso di tempo indefinito, quando i programmi di austerità nazionale rappresentano 240 miliardi all’anno. Questi 120 miliardi si articolano su un previsto aumento, di 60 miliardi, della capacità di prestito della Banca Europea d’Investimenti mediante un aumento di 10 miliardi del suo capitale, un’emissione progettata di 5 miliardi di obbligazioni su progetti destinati a finanziare infrastrutture e infine lo stanziamento, per «misure destinate a rendere dinamica la crescita», di 55 miliardi di fondi strutturali, che erano già disponibili. Nulla garantisce che nei tre anni vi saranno effettivamente impegnati fondi supplementari. In questo modo il Patto appare soprattutto come una concessione di facciata, che permette al governo francese di ratificare il Trattato di Bilancio.
Il Trattato non rimette in discussione l’assenza di garanzia dei debiti pubblici da parte della BCE; non prevede l’emissione di euro-bond; il Meccanismo europeo di Solidarietà non prevede di aiutare se non i Paesi che avranno ratificato e rispettato il Trattato. Il Paese aiutato perderà tutta la sua autonomia, dovrà sottoporre la sua politica economica alla «troika» (Commissione, BCE, FMI) e impegnarsi a una politica restrittiva, che come gli esempi di Grecia, Portogallo e Irlanda dimostrano, lo precipiterà nella recessione e nella miseria. Il dispositivo messo in piedi non stronca la speculazione. La BCE subordina il suo sostegno ai Paesi i cui tassi d’interesse salgono a riforme liberiste e a piani di austerità sempre più drastici, che li immergono nella depressione.
Il Trattato di bilancio impone l’adozione in Europa nel lungo periodo di politiche di austerità che non soltanto manderanno in pezzi l’attività economica della Zona, aggraveranno ancor più gli squilibri nei Paesi più fragili, aumenteranno le tensioni [sociali], ma bloccheranno ambiziose politiche d’investimenti ecologici nell’avvenire. Gli Stati membri possono rassegnarsi a un Trattato che paralizza per sempre le loro politiche di bilancio, per convincere i mercati della loro disciplina di bilancio futura? Possono risolversi a vedersi confiscare le redini del bilancio dopo aver perduto quelle della politica monetaria?
 Il gruppo di una trentina di docenti e ricercatori in materie economiche, che si è denominato “Economisti costernati”, espone le sue idee e aspirazioni nel sito http://www.atterres.org/, dove si possono ottenere informazioni circa gli statuti, il manifesto, le pubblicazioni e altro. La politica economica che suggeriscono NON è quella attuale della Burocrazia europea, che oltretutto NON è legittimata da elezioni popolari.
Il gruppo di una trentina di docenti e ricercatori in materie economiche, che si è denominato “Economisti costernati”, espone le sue idee e aspirazioni nel sito http://www.atterres.org/, dove si possono ottenere informazioni circa gli statuti, il manifesto, le pubblicazioni e altro. La politica economica che suggeriscono NON è quella attuale della Burocrazia europea, che oltretutto NON è legittimata da elezioni popolari. EUROPA - Trattato di Lisbona - Testo completo del trattato
EUROPA - Trattato di Lisbona - Testo completo del trattato
 http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_it.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_it.htm -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- AL DI LA’ DI UN MITO CHE SI E’ FATTO STORIA. La culla dell’Europa sotto le mura di Troia. Un’identità che nasce con i poemi di Omero31 ottobre 2012, di Federico La Sala
 PIANETA TERRA. PER UN "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. Fine della Storia o della "Preistoria"?
PIANETA TERRA. PER UN "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. Fine della Storia o della "Preistoria"?
 L’EUROPA E TROIA: UN CERCHIO CHE SI CHIUDE. Sul filo dei lavori di Alessandro Fo e di Simon Price e Peter Thonemann, Paolo Mieli ripercorre le tappe di un mito che si fa storia
L’EUROPA E TROIA: UN CERCHIO CHE SI CHIUDE. Sul filo dei lavori di Alessandro Fo e di Simon Price e Peter Thonemann, Paolo Mieli ripercorre le tappe di un mito che si fa storia
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- Le frottole del «win-win». Quando l’Europa impone il suo credo La competitività, un mito in voga (di Gilles Ardinat)9 novembre 2012, di Federico La Sala
 Quando l’Europa impone il suo credo
Quando l’Europa impone il suo credo
 La competitività, un mito in voga
La competitività, un mito in voga di Gilles Ardinat
di Gilles Ardinat
 (traduzione dal francese di José F. Padova) *
(traduzione dal francese di José F. Padova) *- Per uscire da una crisi scatenata dalla finanza vi erano molte vie: reprimere la speculazione, regolamentare i mercati, sanzionare i banchieri... Col sostegno di un crescente numero d’industriali, l’Unione Europea ha formulato un’altra priorità che già impone ai Paesi in difficoltà: accrescere la «competitività» del mercato del lavoro. Ma che cosa significa questo termine, che dirigenti di sinistra come di destra sembrano aver istituito come nuovo Graal?
- Gilles Ardinat, geografo. Questo articolo si fonda sulla sua tesi di dottorato «Geografia della competitività», Università Paul-Valéry, Montpellier.
 (traduzione dal francese di José F. Padova)
(traduzione dal francese di José F. Padova)
Singolare unanimismo. L’ex ministro degli Affari esteri Alain Juppé rivelava, il 28 agosto scorso, « il vero problema dell’economia francese»: la sua mancanza di competitività (edizione mattutina di France Inter). Un mese prima, all’annuncio di ottomila licenziamenti da parte del gruppo Peugeot (PSA), Jean Copé, segretario generale dell’Unione per un movimento popolare (UMP), aveva già identificato una «priorità assoluta», «la competitività della nostra industria», prima che il senatore ed ex primo ministro Jean-Pierre Raffarin esprimesse l’auspicio di uno «choc di competitività», il solo capace di stimolare l’economia dell’Esagono (=la Francia).
Il perfetto accordo dei tenori dell’UMP faceva un sorprendente eco a quello delle stanze del potere, a Bercy e a Matignon. Il primo ministro Jean-Marc Ayrault non aveva forse concluso la «conferenza sociale» del 9 e 10 luglio con i partner sociali fissando un obiettivo fondamentale: «Migliorare la competitività delle nostre imprese»? Su questo punto non vi è alcuna cacofonia nel governo. Il ministro socialista dell’Economia e delle finanze Pierre Moscovici precisava: «Ci saremo per dire che il governo è assolutamente deciso ad affrontare la sfida economica della competitività, perché soltanto rafforzando le nostre capacità di crescita vinceremo la battaglia dell’occupazione (1)».
Dalla strategia di Lisbona che, nel 2000, fissava un «nuovo obiettivo» all’Unione Europea - «diventare l’economia del sapere più competitiva e più dinamica del mondo» - agli «accordi competitività-impiego», lanciati dal presidente Nicolas Sarkozy alla fine del suo mandato, dalle ingiunzioni alla «competitività fiscale» del patronato britannico ai piani di «competitività industriale» del suo omologo spagnolo, la parola corre su tutte le labbra. D’ora in poi non si tratta più unicamente di gestione d’impresa: le città, le regioni e più ancora le nazioni dovrebbero ugualmente concentrare le loro energie su questo obiettivo prioritario.
Per accertarsene, i nostri consiglieri comunali e governanti sono invitati a ispirarsi alle teorie del management sviluppate dalle scuole commerciali americane (2): controllo dei costi di produzione («competitività-costo»), benchmarking (i Paesi sono confrontati e classificati come imprese in ambiente concorrenziale), marketing territoriale (i territori devono «vendersi») (3), ricerca di finanziamenti (attrazione dei capitali)... A mano a mano che si diffonde l’impiego di un simile armamentario, la competitività s’impone come il nuovo criterio [per la misura] della prestazione dei singoli territori nella mondializzazione. Ma come lo si misura?
Nella sua accezione più ampia, il termine definisce la capacità di affrontare con successo la concorrenza. Applicata a territori, questa nozione misurerebbe quindi la riuscita del loro inserimento nella geografia economica mondiale. Eppure è sufficiente consultare opere e articoli - abbondanti - dedicati a questa questione perché si manifesti un primo paradosso: malgrado l’infatuazione che suscita, questo concetto si rivela particolarmente fragile sul piano scientifico. Esso traspone una nozione micro-economica (la competitività dei prodotti e delle imprese) nella sfera politica (la competitività dei territori). Questa analogia è rilevata dall’economista Paul Krugman, insignito nel 2008 del Premio in Scienze economiche della Banca di Svezia in memoria di Alfred Nobel: «La competitività è un termine privo di senso quando è applicato alle economie nazionali. L’ossessione della competitività è a un tempo falsa e dannosa (4)».
Riciclo di antiche gerarchie
Numerosi specialisti hanno tentato di porre rimedio a questa carenza facendo emergere una definizione più basata sul consenso, come l’economista austriaco Karl Aiginger, per il quale questo termine descrive sempre più una «attitudine a produrre benessere» in ambiente concorrenziale. Esso indica che «il reddito e l’impiego sono generati attraverso un processo nel quale la rivalità e la performance relativa svolgono un loro ruolo (5)». Questo concetto suppone però che la concorrenza generalizzata fra territori sia compatibile con il miglioramento del livello di vita. Ma è questo veramente il caso?
E poi, rimane sempre un problema: si può veramente ipotizzare che territori e imprese siano della medesima natura? Un territorio, spazio definito e delimitato da una frontiera, offre a un popolo il suo supporto fisico e anche una buona parte dei suoi riferimenti culturali e politici. Non si riduce a meri dati, anche se fossero macro-economici. Le note valutative (compito delle agenzie di rating), i tassi (d’inflazione, interesse, disoccupazione, ecc.) o i saldi (commerciale, di bilancio, ecc.) riflettono solamente un aspetto, superficiale e materiale, della nazione. Contrariamente a un’impresa, questa non cerca di attuare profitti. La sua azione s’iscrive nel tempo lungo della storia, non in quello immediato dei mercati. Infine, una nazione non deposita il suo bilancio così che la si possa mettere in liquidazione.
Tuttavia è proprio su questa assimilazione che si costruisce la teoria della competitività, un processo che attinge alle sorgenti della mondializzazione. Applicata ai territori, questa nozione segna una nuova tappa della mercerizzazione del mondo. Essa sottintende che esiste un mercato dei territori dove le imprese possono scegliere la loro localizzazione mettendo in gioco la concorrenza. In un mondo dove tutto, o quasi, può essere quotato in Borsa (diritti a inquinare, titoli di debito pubblico, materie prime...) per gli investitori fa le veci della bussola: valuta la performance presunta di un territorio.
Resta il fatto che l’esigenza di competitività diretta alle nostre società porta legittimamente a interrogarsi. Quali sono i territori competitivi? Secondo quali criteri? Le classificazioni (si parlerà di ranking) in questi ultimi anni si sono moltiplicate.
 La più celebre, il Rapporto sulla competitività mondiale («Global competitiveness report») risulta dai lavori degli esperti del Forum economico mondiale (FEM).
La più celebre, il Rapporto sulla competitività mondiale («Global competitiveness report») risulta dai lavori degli esperti del Forum economico mondiale (FEM).Questo documento annuale, che passa per punto di riferimento, classifica circa centotrenta Paesi sulla base di valutazioni che oscillano fra 0 e 7. Ora, non vi si trova nulla di specifico, né nei suoi metodi (utilizzo di indici compositi aggreganti numerosi criteri [6]), né nelle sue conclusioni. In fondo, L’industria della produzione di rapporti sulla competitività, segnalata da Krugman, si accontenta di riciclare e ricondizionare gerarchizzazioni economiche sviluppate altrove: rischio-Paese (lavori della società di assicurazioni Coface), classificazioni del PIL per abitante o del clima degli affari (indice Doing Business della Banca Mondiale).
Tutte le catalogazioni relative alla performance delle nazioni presentano il medesimo schema: un centro competitivo formato da tre poli (America del Nord, Europa, Asia-Pacifico), ai quali si aggiungono i Paesi arabi del Golfo. Questo boom delle petro-monarchie resta la principale originalità di questo tipo di classificazione. In Europa, la Germania, i Paesi Bassi e gli Stato scandinavi delimitano un iper-centro altrettanto competitivo degli Stati Uniti, del Giappone o di Singapore. Oggi la competitività si degrada (differenti zone periferiche più o meno performanti) fino ai margini estremi di questo sistema, con alcuni Paesi dell’Asia e la quasi totalità dell’Africa sub-sahariana. Soltanto la posizione dei due grandi emergenti (Cina e India) differisce fortemente in funzione delle classificazioni.
Questa visione gerarchica rivela un altro paradosso: queste graduatorie hanno poco valore predittivo. Per la maggior parte del tempo i Paesi giudicati competitivi presentano i più deboli tassi di crescita, forti deficit di bilancio e commerciali, come altri problemi multipli (delocalizzazioni, deindustrializzazione). Di fatto, la crescita mondiale è attualmente portata avanti in gran parte da Paesi che il FEM considera periferici. Fino alla crisi finanziaria del 2007-2008, l’Irlanda, l’Islanda e Dubai venivano presentati come estremamente competitivi. Dopo, tutti tre sono apparsi molto sensibili alle crisi (smisurata speculazione, mancanza di regolamentazione finanziaria, problemi di indebitamento).
Su un piano generale, i Paesi anglosassoni svolgevano il ruolo di modelli di sviluppo. Ora i recenti avvenimenti hanno squalificato questa analisi: i virtuosi modelli della competitività si sono rivelati idoli fragili. Questa mancanza di pertinenza deriva specialmente dai metodi impiegati per realizzare classificazioni costruite, essenzialmente, a partire da sondaggi realizzati fra i quadri delle grandi imprese (7). Si tratta di una rappresentazione, molto marcata sociologicamente, e non di una misura per poter parlare come si deve di risultati ottenuti.
Ma atteniamoci alle dichiarazioni ufficiali: dopare la competitività porterebbe ad accrescere l’occupazione, la produttività e il livello di vita. Secondo gli esperti incaricati dalla Commissione Europea, «la concorrenza è quindi l’alleata, e non la nemica, del dialogo sociale (8)». La mondializzazione offrirebbe all’Occidente la possibilità di sbarazzarsi delle attività manifatturiere e dei mestieri a scarso valore aggiunto, a favore di occupazioni altamente qualificate e meglio remunerate.
Un’operazione «win-win» [ndt.: una soluzione vantaggiosa per tutti - Diz. Collins], insomma: da un lato, i Paesi industrializzati beneficerebbero di una specializzazione nei servizi e nel high tech («competitività fuori prezzo», che dipende dalla capacità d’innovazione e dallo sfruttamento della proprietà intellettuale); dall’altro, il Terzo mondo uscirebbe dalla povertà grazie alle delocalizzazioni, guidate dalla «competitività del prezzo»: la riduzione del prezzo dei prodotti mediante la riduzione dei costi salariali, la svalutazione della moneta e un credito buon mercato.
Questo quadro - che certi «Paesi-fabbrica», raffigurati come semplici territori low cost, non giudicherebbero forse molto lusinghiero - ha un minimo di rapporti con la realtà? Nessuna economia, fosse pure altamente sofisticata, può emanciparsi dal problema dei costi. La Germania, tanto spesso citata come esempio, è un Paese di tradizione industriale molto forte. Tuttavia essa ha aumentato la sua competitività di traverso, mediante la stagnazione salariale e una IVA detta «sociale» (una riduzione delle quote contributive delle imprese compensata dall’aumento delle imposte sui consumi delle famiglie). Questi provvedimenti unilaterali coincidono con l’ascesa dell’avanzo del suo bilancio commerciale. D’altra parte, a dispetto dei miti sul loro insormontabile ritardo, i Paesi emergenti si rivelano sempre più performanti nelle filiere innovatrici (informatica in India, energie rinnovabili in Cina...).
Non è quindi illusorio dividere il mondo fra Paesi della competitività fuori prezzo (chiamata anche «strutturale») e quelli della competitività del prezzo, condannati a essere soltanto i piccoli manovali della mondializzazione? Non importa! Il Libro Bianco del 2004, che ha ispirato la politica francese dei poli di competitività, afferma che «per ritrovare un vantaggio comparativo la nostra economia ha la scelta: allinearsi sul modello sociale asiatico o mettersi a correre fra i primi nell’innovazione (9)». Sulla base di questa visione binaria, i dirigenti della zona euro-atlantica convalidano le delocalizzazioni degli ultimi decenni. Nei loro discorsi non entra se non raramente la questione se fare rimpatriare i posti di lavoro perduti nel tessile, nella siderurgia o nell’industria dei giochi. I Paesi la cui produzione è scivolata verso l’Est sarebbero condannati dalla «fatalità economica» a reimportare questi prodotti e a specializzarsi nei servizi e nella ricerca.
Le frottole del «win-win»
Ma questa strategia della competitività fuori prezzo non è l’altro nome della rinuncia politica? Al di là delle stupidaggini del «win-win» e della promessa di un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione, si tratta più spesso d’imporre misure impopolari di aumento dell’IVA, moderazione salariale, austerità di bilancio, ecc. Così, è nel nome della competitività che l’Unione Europea e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno preteso la riduzione dei salari in Grecia (10). Meno performante dei suoi vicini, il Paese doveva ridurre massicciamente la remunerazione del lavoro, i piani di salvataggio a garanzia provvisoria del capitale, vale a dire degli interessi percepiti dal sistema finanziario. In questo senso la competitività fornisce una garanzia a ciò che in realtà assomiglia a un dumping generalizzato.
Dopo gli anni ’80 già era stata abbandonata l’espressione «dumping monetario» (in teoria segnalato dal FMI) preferendole quella di «svalutazione competitiva», un’operazione che consiste nel mantenere il corso di una moneta artificialmente basso allo scopo di favorire le esportazioni nazionali. Eppure, poiché il termine «dumping» mantiene un carattere peggiorativo, sembrerebbe che lo si sia ormai sostituito con quello di «competitività», sufficientemente rispettabile per autorizzare un governo a prendere misure antisociali senza temere l’obbrobrio. Insomma, questo termine permette di formulare in maniera politicamente accettabile l’ingiunzione ad adattarsi alla concorrenza, una strategia che la popolazione non ha necessariamente scelto e che sottintende la mondializzazione neoliberale.
Promessa di prosperità che conduce a politiche di dumping: questo doppio discorso paradossale si fonda sul dogma della concorrenza fra sistemi produttivi. Se l’idea di una «concorrenza libera e perfetta» ha ispirato una molteplicità di leggi antitrust e antidumping (11), la sua trasposizione ai territori pone alcuni problemi. Innanzitutto non esiste alcuna autorità credibile di regolamentazione della concorrenza fra nazioni. Né l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC-WTO), né l’Ufficio internazionale del lavoro (BIT) sembrano essere in grado di inquadrare i differenti dumping. Così, la Cina può accumulare liberamente il dumping sociale (bassi salari), ambientale («oasi di polluzione» per le industrie), monetario (svalutazione deliberata dello yuan), regolamentare (lassismo delle norme) e fiscale (debolezza dello Stato previdenziale e moltiplicazione delle zone esentasse). La legge del mercato, applicata ai territori, si rivela fondamentalmente errata.
Il discorso sulla competitività tenta di mascherare questo stato di fatto, correggendo, in margine, le disparità fra i luoghi di produzione. Questi sforzi sembrano d’altronde derisori, tenuto conto dei giganteschi differenziali dei costi: il blocco dei salari in Occidente è realmente in grado di rendere la remunerazione degli operai francesi paragonabile a quella dei loro omologhi vietnamiti? Mancando di raggiungere questo obiettivo ufficiale («vincere la battaglia della competitività»), queste politiche rispondono alle attese del padronato in materia di riduzione dei costi del lavoro. Caso sorprendente, la ricerca della competitività, assai poco concludente nella sua lotta contro le delocalizzazioni, offrirebbe così un comodo alibi per gonfiare la remunerazione del capitale... In questo senso l’invocazione del «territorio» o della «nazione» costituirebbe un artifizio retorico, perché il guadagno non è collettivo (nozione d’interesse generale o nazionale), bensì di categoria (aumento dei profitti di alcuni). D’altra parte, mettere in concorrenza frontale i sistemi produttivi comporta forzatamente un effetto depressivo sui salari, le entrate fiscali e la protezione sociale, anch’essi obbligati ad adattarsi al ribasso.
Questo fenomeno non penalizza unicamente i salariati (perdita del potere d’acquisto) e gli Stati (diminuzione delle entrate fiscali); provoca anche un’atonia della domanda. Senza contare che, se tutti i Paesi decidessero simultaneamente di contrarre la loro domanda, precipiterebbero in una grave depressione. Allo stesso modo non tutti possono realizzare eccedenze commerciali nello stesso tempo: ci vogliono necessariamente Paesi in rosso perché altri siano in verde (12). L’ossessione di una «convergenza delle competitività» sul modello tedesco non è quindi altro che una favola.
Non appena si constata la fragilità teorica del discorso sulla competitività - che conduce a diagnosi errate e a un dumping dissimulato - come spiegare il suo successo fra i dirigenti politici? Forse per il fatto che esso risponde alle ingiunzioni delle imprese e dei mercati internazionali. Adesso, dopo essersi privati dei mezzi per controllare le une e gli altri, gli eletti si adattano ormai alle esigenze di imprese e mercati. In definitiva, l’oggetto della competitività maschererebbe una perdita d’autorità e di sovranità degli Stati-nazione e permetterebbe di estromettere, nell’azione politica, qualsiasi possibilità di protezione [sociale]. Mentre il territorio, con le sue frontiere e le sue istituzioni politiche, appariva tradizionalmente come un bastione di fronte alle minacce esterne (siano esse militari o commerciali), questa funzione protettrice si attenuerebbe ormai con l’indebolimento delle barriere doganali e delle prerogative dello Stato.
 (1) Thomas Wieder, «Le flirt discret de l’Elysée avec les patrons», Le Monde, 29 août 2012.
(1) Thomas Wieder, «Le flirt discret de l’Elysée avec les patrons», Le Monde, 29 août 2012.
 (2) Michael E. Porter, L’Ayfintage concurrentiel des nations, IntérEditioris, Prf,
(2) Michael E. Porter, L’Ayfintage concurrentiel des nations, IntérEditioris, Prf,
 (3) Lire François Cusset, « La foire aux fiefs », Le Monde diplomatique, mai 2007.
(3) Lire François Cusset, « La foire aux fiefs », Le Monde diplomatique, mai 2007.
 (4) Paul Krugman, o Competitiveness : A dangerous obsession», Foreign Affairs, New York, vol. 73, n° 2, mars-avril 1994; «The competition myth », The New York Times, 23 janvier 2011.
(4) Paul Krugman, o Competitiveness : A dangerous obsession», Foreign Affairs, New York, vol. 73, n° 2, mars-avril 1994; «The competition myth », The New York Times, 23 janvier 2011.
 (5) Karl Aiginger, « Competitiveness : From a dangerous obsession to a welfare creating ability with positive externalities», Journal of Industry, Competition and Trade, vol. 6, n°2, Dordrecht (Pays-Bas), juin 2006.
(5) Karl Aiginger, « Competitiveness : From a dangerous obsession to a welfare creating ability with positive externalities», Journal of Industry, Competition and Trade, vol. 6, n°2, Dordrecht (Pays-Bas), juin 2006.
 (6) La note finale est obtenue en compilant des « exigences de base» (institutions politiques, infra-structures, stabilité macroéconomique, santé, éducation) et des facteurs plus complexes, tels l’enseignement supérieur, le niveau de concurrence interne au marché, la recherche et développement...
(6) La note finale est obtenue en compilant des « exigences de base» (institutions politiques, infra-structures, stabilité macroéconomique, santé, éducation) et des facteurs plus complexes, tels l’enseignement supérieur, le niveau de concurrence interne au marché, la recherche et développement...
 (7) Sanjaya Lall, « Competitiveness indices and developing countries : An economic evaluation of the "Global competitiveness report"», World Development, vol. 29, no 9, Elsevier, Amsterdam, septembre 2001.
(7) Sanjaya Lall, « Competitiveness indices and developing countries : An economic evaluation of the "Global competitiveness report"», World Development, vol. 29, no 9, Elsevier, Amsterdam, septembre 2001.
 (8) Alexis Jacquemin et Lucio Pench, Pour une compétitivité européenne. Rapports du Groupe consul-tatif sur la compétitivité, De Boeck, Bruxelles, 1997.
(8) Alexis Jacquemin et Lucio Pench, Pour une compétitivité européenne. Rapports du Groupe consul-tatif sur la compétitivité, De Boeck, Bruxelles, 1997.
 (9) Christian Blanc, Pour un écosystème de la crois-sance. Rapport au premier ministre, La Documen-tation française, Paris, 2004.
(9) Christian Blanc, Pour un écosystème de la crois-sance. Rapport au premier ministre, La Documen-tation française, Paris, 2004.
 (10) Lire Anne Dufresne, «Le consensus de Berlin», Le Monde diplomatique, février 2012.
(10) Lire Anne Dufresne, «Le consensus de Berlin», Le Monde diplomatique, février 2012.
 (11) Les Etats-Unis ont par exemple voté le Sherman Anti-Trust Act (1890) et le Clayton Anti-Trust Act -(1914) afin d’améliorer le fonctionnement du marché.
(11) Les Etats-Unis ont par exemple voté le Sherman Anti-Trust Act (1890) et le Clayton Anti-Trust Act -(1914) afin d’améliorer le fonctionnement du marché.
 (12) Lire Till Van Treeck, «Victoire a la Pyrrhus pour l’économie allemande», Le Monde diplomatique, septembre 2010.
(12) Lire Till Van Treeck, «Victoire a la Pyrrhus pour l’économie allemande», Le Monde diplomatique, septembre 2010.
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- QUEL SUGGESTIVO “PAESAGGIO DELLA MEMORIA” CHE CARATTERIZZA IL CENTRO STORICO DELL’ODIERNA BERLINO. Un monumento per l’Olocausto di Rom e Sinti28 ottobre 2012, di Federico La Sala
La memoria ritrovata
A Berlino un monumento per l’Olocausto di Rom e Sinti
Dopo vent’anni di polemiche e tensioni la Germania celebra lo sterminio negato e chiede ufficialmente scusa al popolo zingaro
di Gherardo Ugolini (l’Unità, 28.10.2012)
BERLINO A CIASCUNO IL SUO MEMORIALE. IN QUEL SUGGESTIVO “PAESAGGIO DELLA MEMORIA” CHE CARATTERIZZA IL CENTRO STORICO DELL’ODIERNA BERLINO, precisamente nell’area nevralgica dove si levano la sede del Reichstag e la Porta di Brandeburgo, gli altari del ricordo collettivo si susseguono uno dopo l’altro. C’è quello dell’Armata Rossa con i carri armati sovietici che per primi violarono la capitale del Reich nella primavera del 1945. Ci sono qua e là frammenti del Muro che per tre decenni è stato l’emblema indiscusso della guerra fredda. C’è l’immenso cimitero di steli grigie, disposto da Peter Eiseman per onorare il ricordo dei milioni di ebrei vittime della Shoah. Più nascosto tra i cespugli e gli alberi del Tiergarten, il grande parco cittadino un tempo riserva di caccia della casa reale, si trova il monumento in onore degli omosessuali perseguitati dal nazismo.
Dallo scorso mercoledì la mappa berlinese del ricordo storico si è arricchita ulteriormente. Ci sono voluti oltre vent’anni di discussioni, polemiche a tratti roventi, promesse non mantenute e rinvii inspiegabili, ma finalmente anche gli zingari hanno in Germania un loro monumento che ricorda le deportazioni e i massacri patiti durante gli anni del Terzo Reich.
«Lo dobbiamo ai morti e lo dobbiamo ai vivi» ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel nel discorso ufficiale durante l’inaugurazione. Una volta tanto i discorsi non sono stati né rituali né vacuamente retorici. «Lo sterminio di quel popolo ha lasciato tracce profonde e ferite ancora più profonde» ha affermato la cancelliera invitando a considerare il nuovo memoriale come un monito contro ogni forma di discriminazione etnica e razziale.
E rivolgendosi ai rappresentanti delle comunità di sinti e rom presenti all’inaugurazione, Merkel non ha nascosto i pregiudizi e i problemi di convivenza che tuttora si riscontrano nella società tedesca, evidenziando come sia «compito tedesco ed europeo sostenervi nell’esercizio dei vostri diritti». Un discorso tutto sommato coraggioso, anche se qualcuno ha fatto osservare come sia stato proprio il governo di Frau Merkel non più tardi di due anni orsono ad espellere - nonostante le blande proteste del Consiglio d’Europa e nella più assoluta indifferenza dell’opinione pubblica - oltre diecimila rom kosovari, rifugiatisi alla fine degli anni Novanta nel territorio della Bundesrepublik.
Quello dei rom e dei sinti è stato un destino davvero disgraziato. La loro persecuzione da parte dei nazisti iniziò fin da subito e fu portata avanti con una sistematicità e una violenza del tutto analoghe a quelle impiegate contro gli ebrei. Considerati una «razza inferiore», degenerazione di quella ariana, geneticamente predisposta al nomadismo, all’asocialità e alla delinquenza, gli zingari furono deportati in massa nei campi di concentramento badando anche a tenerli isolati dagli altri prigionieri: per questo ad Auschwitz fu istituito un apposito Zigeunerlager, ovvero un «campo per gli zingari».
Per risolvere la «questione zingara» il nazismo dapprima approvò una serie di leggi e provvedimenti fortemente persecutori, quindi avviò la pratica della sterilizzazione coatta (una sorta di sterminio dilazionato nel tempo), per passare, infine, nel 1942 alla «soluzione finale», ovvero il trasferimento obbligatorio di tutti gli zingari ad Auschwitz in vista del definitivo annientamento. Ne morirono almeno 500mila, ma gli storici calcolano che probabilmente furono molti di più: data la loro natura nomade è difficile stabilire con precisione quanti zingari risiedessero nel territorio della Germania e delle zone occupate dai nazisti.
Anche dopo la fine della guerra i patimenti non sono cessati. Per decenni nel Dopoguerra il loro sterminio è stato negato o minimizzato. Nei processi contro i criminali nazisti - a partire da quello di Norimberga - mai nessuno decise di sentire testimonianze di rom e sinti. E nonostante la Convenzione di Bonn - imposta dagli Alleati alla Germania nel 1945 - prescrivesse il pagamento di indennizzi a quanti erano stati perseguitati per motivi razziali, nel caso dei rom e dei sinti tutte le istanze di risarcimento furono eluse dalla magistratura tedesca.
La ferita del «genocidio negato» ha bruciato toppo a lungo, come ha denunciato pochi giorni fa Romani Rose, presidente del Consiglio centrale dei popoli sinti e rom in Germania. Si dovette attendere fino al 1982 perché un’autorità politica tedesca, il cancelliere socialdemocratico Helmut Schmidt riconoscesse le loro ragioni e chiedesse ufficialmente scusa a nome del popolo tedesco. E quindici anni dopo fu il presidente federale Roman Herzog a sottolineare l’analogia tra ebrei e nomadi per quanto riguarda le pratiche di sterminio del Terzo Reich.
Il memoriale che ricorda la loro tragedia sorge ora nel cuore di Berlino e mette una pezza su una parabola fatta di tormenti e dimenticanze. Le comunità degli zingari residenti in Germania lo hanno fortemente voluto come segnale di pacificazione, ma sono stati necessari due decenni perché si superassero incomprensioni e impedimenti e il progetto diventasse realtà.
L’artista israeliano Dani Karavan lo ha realizzato dandogli la forma di una vasca circolare dal fondale nero, con un triangolo vuoto nel centro da cui ogni giorno emerge una stele con un fiore sulla sommità. A chi lo guarda trasmette la sensazione di sprofondamento nell’abisso, quella sensazione che si provava all’ingresso dei lager, come rievocato dai versi del poeta italiano di etnia Rom Santino Spinelli incisi sul bordo della vasca.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO".Intevista a Zygmunt Bauman: «Al bivio tra sopravvivere o disgregarsi. Per questo serve una Confederazione» (di Paolo Valentini).21 ottobre 2012, di Federico La Sala
Bauman: «Al bivio tra sopravvivere o disgregarsi. Per questo serve una Confederazione».
di Paolo Valentini (Corriere della Sera, 20 ottobre 2012)
»ROMA - «L’Europa è a un crocevia. Non è la prima e non sarà l’ultima volta. La sua intera storia è un’avventura infinita. Giovedì sono stati fatti piccoli passi verso una sorta di integrazione finanziaria, attraverso la creazione di una vigilanza bancaria comune. È promettente, ma ci sono grossi punti interrogativi: il diavolo si nasconde nei dettagli. E questo è solo l’aspetto economico, che in fondo è quello affrontato con più attenzione. Ma la speranza che l’integrazione politica seguirà quella economica è infondata, potrà farlo come potrà non farlo. Gli interessi delle diverse aree d’Europa sono troppo contrastanti».
Zygmunt Bauman è il teorico della società liquida, il filosofo che ha individuato e descritto l’essenza proteiforme e instabile della modernità, orfana delle grandi narrazioni metafisiche delle ideologie e strutturalmente precaria. Ma per essere filosofo e sociologo, Bauman è anche molto attento ai processi politici concreti e in particolare a quelli dell’Europa, che per lui, ebreo polacco fuggito dall’occupazione sovietica, vissuto in Israele e Inghilterra, è il grande progetto del Ventunesimo secolo.
Bauman è a Roma, dove oggi terrà una «lectio magistralis» in apertura di InNovaCamp, seminario a più voci organizzato dall’Associazione ItaliaCamp, in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense, dal titolo «Salvezza o dannazione - proposte e soluzioni anticrisi». All’evento partecipano anche i ministri della Giustizia e del Lavoro, Paola Severino e Elsa Fornero, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà.
Per Bauman, l’integrazione politica europea è «questione di vita o di morte, di sopravvivenza o disgregazione». A fargli soprattutto paura è la «discrepanza tra l’immensità della sfida e la mediocrità dei mezzi a disposizione». «Quando ero giovane - spiega - la domanda era: che fare? Oggi è chiaro cosa fare, ma la vera domanda è: chi lo farà? Allora tutti pensavano che una volta individuate le cose da fare, il governo onnipotente se ne farà carico. Oggi il governo è l’ultima istituzione che ci aspettiamo le faccia. Fino a quando questo gap non sarà colmato, siamo nei guai».
Perché è così importante l’unificazione politica?
«Perché senza una qualche forma di Confederazione, con organi decisionali comuni che decidono sulla politica economica e finanziaria, estera e di sicurezza, non credo che i vantaggi che l’Europa è in grado di offrire ai suoi membri possano diventare realtà. La casa europea non va a detrimento delle culture nazionali, ma provvede a una sorta di tetto comune a tradizioni, valori, differenze locali. E il paradosso è che ogni singolo Paese è molto più a rischio di perdere la sua identità specifica, se si espone senza protezione, cioè senza questo scudo europeo, alle forze globali, che sono violentemente e spudoratamente sovranazionali, ignorano i temi e le specificità locali».
Come si può colmare il deficit democratico dell’Europa?
«Lo Stato moderno per emergere ha dovuto combattere, spesso anche in modo violento, contro gli interessi locali. Ci sono voluti cento anni perché questo processo venisse a compimento: ma non furono i poteri locali che rinunciarono a pezzi di sovranità, al contrario questa venne loro tolta poco alla volta, spesso contro una resistenza feroce. Sta succedendo di nuovo, abbiamo 27 nazioni e vogliamo organizzare una nuova organizzazione superiore. Ci vuole tempo e temo che andrà così anche con l’unificazione politica dell’Europa. Non sarà semplice ricreare vere istituzioni democratiche a livello europeo».
Ma cosa dire alla gente per averne il consenso?
«Che l’Europa è la sola chance che hanno di difendere e proteggere la loro identità nazionale. Dobbiamo ripensare le istituzioni europee in modo completamente nuovo. Dovranno avere l’abilità a condensare e unificare un volere popolare europeo altrimenti sparso e diversificato. Esattamente ciò che fanno i Parlamenti locali: far emergere un interesse nazionale da spinte diverse. Solo così possiamo colmare il deficit democratico, che nasce dal fatto che le attuali istituzioni politiche non godono più della fiducia popolare. C’è uno scarto tra la natura generale dei nostri problemi e quella individuale delle nostre soluzioni».
La Rete può aiutare a colmare il deficit democratico?
«Non c’è nulla di specifico che ne faccia strumento naturale per la democrazia, potrebbe anche essere strumento di un regime totalitario. Quindi, invece che in favore dell’unificazione dell’Europa, potrebbe lavorare in favore della sua separazione. Non credo nel determinismo tecnologico. Conta ciò che noi facciamo con la tecnologia. Spostare verso la Rete i compiti che sono nostri, quelli di promuovere democrazia e libertà, è molto pericoloso. Perché ci deresponsabilizza».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- DIETRO IL NOBEL, UN’IDEA DI EUROPA, UNITA E IN PACE. Da Einstein in poi la sfida per l’unità dell’Europa (di Pietro Greco).18 ottobre 2012, di Federico La Sala
 Dietro il Nobel. Terra di pace e di scienza
Dietro il Nobel. Terra di pace e di scienza
 Da Einstein in poi la sfida per l’unità dell’Europa
Da Einstein in poi la sfida per l’unità dell’Europa
 Il ruolo degli scienziati per costruire un continente finalmente senza guerre. Dall’appello del fisico di Ulma alla proposta visionaria di Edoardo Amaldi fino al Cern
Il ruolo degli scienziati per costruire un continente finalmente senza guerre. Dall’appello del fisico di Ulma alla proposta visionaria di Edoardo Amaldi fino al Cern di Pietro Greco (l’Unità, 18.10.2012)
di Pietro Greco (l’Unità, 18.10.2012)«NOI DICHIARIAMO QUI PUBBLICAMENTE LA NOSTRA FEDE NELL’UNITÀ EUROPEA: UNA FEDE CHE NOI CREDIAMO CONDIVISA DA MOLTI». PRIMAVERA 1915. L’EUROPA È IN FIAMME. DA SEI MESI È INIZIATA LA PRIMA GUERRA MONDIALE. Da qualche mese la Germania ha invaso il neutrale Belgio e l’esercito tedesco è giunto a 40 chilometri da Parigi. Sui fronti di un intero continente infuria una battaglia che è, letteralmente, senza esclusione di colpi. A Berlino due scienziati, un fisico e un fisiologo, fanno circolare un pericolo appello: è l’Aufruf an die Europäer. Il Manifesto agli Europei, in cui si chiede di smetterla di combattersi come nemici e iniziare a vivere come fratelli.
Il fisico è Albert Einstein. E il suo appello, redatto con il fisiologo di origine russa Georg Friedrich Nicolai, sostiene che se i popoli del Vecchio Continente vogliono salvare la loro civiltà, il loro livello di benessere e vivere in pace, devono unirsi. Devono creare un’Unione Europea.
L’appello non ha grande fortuna. Raccoglie solo altre due firme, oltre quella dei proponenti. Tutti rischiano la prigione. Ma l’Aufruf an die Europäer (ri)conferma due cose. Che Einstein non è solo un grande fisico, ma anche un fine politico: il suo appello arriva trent’anni prima di quello, redatto in condizioni non meno drammatiche, a Ventotene da Altiero Spinelli. E dimostra, anche, che nell’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2012 all’Unione Europea, che ha assicurato oltre 60 anni di (quasi) assenza di conflitti per la prima volta nella storia del Vecchio Contenente, la scienza o meglio, gli scienziati hanno avuto un ruolo notevole: sia perché la scienza è stata ed è tuttora uno dei grandi collanti nella costruzione dell’identità europea, sia perché la scienza ha sempre preceduto la politica nel realizzare concretamente le istituzioni dell’Europa unitarie.
È possibile individuare un secolo in cui è nata la scienza moderna, il Seicento. Ma, sosteneva Paolo Rossi, il grande storico delle idee scientifiche scomparso nei mesi scorsi, non è possibile individuare un luogo, perché quel luogo è semplicemente l’Europa. Nel Seicento nasce una comunità la Repubblica della Scienza formata da italiani, francesi, inglesi, tedeschi, polacchi, belgi, olandesi che hanno che hanno i medesimi interessi e i medesimi valori. Uniti nel tener fuori dalla porta della loro peculiare dimensione la politica e la religione. Gli interessi dei membri di questa Repubblica virtuale, riguardano la conoscenza intorno alla natura. I valori sono certo quelli indicati da Robert Merton: il comunitarismo, l’universalismo, il disinteresse, l’originalità e lo scetticismo sistematico. Ma anche il «pensare europeo» il sentirsi membri di un’unica cultura e il pensare «per la pace», perché, come diceva Francis Bacon, la scienza non deve essere a beneficio di questo o di quello, ma dell’intera umanità.
All’origine della scienza c’è dunque un’idea di Europa, unita e in pace. Un’idea tanto più singolare, perché nata mentre l’Europa, proprio come nel 1915, si trova divisa e in fiamme. Mentre sono in corso guerre, come quella dei trent’anni, che mietono vittime a milioni. La scienza offre agli Europei del Seicento una visione alternativa a quella del continuare a combattersi.
La stessa cosa accade con l’appello di Einstein. E poi ancora, alla fine della seconda guerra mondiale, con la proposta, visionaria, di uno scienziato italiano: Edoardo Amaldi. Dobbiamo uscire dalla logica della divisione e del conflitto, pensa il «fanciulletto» di via Panisperna, dobbiamo costruire ponti di pace. E non c’è nulla di meglio per realizzare il primo ponte di pace nell’Europa uscita distrutta dalla guerra che unire tutti i fisici del continente in un unico, grande laboratorio. In un laboratorio europeo. Anzi, in un laboratorio che esprime l’unità europea. Le idee maturate da Amaldi alla fine degli anni ’40 incontrano fiere opposizioni, anche tra i fisici. Sia americani che europei. Ma alla fine la sua tenacia, unita a quella di pochi altri colleghi ma anche politici, si realizzano. Nel 1952 il grande laboratorio viene realizzato a Ginevra, frutto dello sforzo comune di 12 paesi europei che sette anni prima erano ancora in guerra tra loro. Amaldi è il primo direttore generale del laboratorio.
Infine, il 29 settembre 1954, nasce ufficialmente il Cern, il Centro europeo di ricerche nucleari. È la prima istituzione dell’Europa unita. È la prima prova provata che Einstein aveva ragione: l’Europa può costruirsi in pace e costruire la pace. Il premio Nobel per la pace all’Unione Europea giunge nel 2012. Un anno in cui l’idea di unione europea ha subito, forse, la massima erosione da sessant’anni a questa parte. Ma anche l’anno in cui a Ginevra il Cern il più grande laboratorio di fisica al mondo ha raggiunto quello che potrebbe rivelarsi il suo massimo risultato: aver dimostrato l’esistenza del bosone di Higgs. Ancora una volta la scienza sembra indicare la strada all’Europa.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Le motivazioni del premio Nobel per la pace 2012 alla Unione Europea.12 ottobre 2012, di Federico La Sala
 "Grazie agli sforzi dell’Unione
"Grazie agli sforzi dell’Unione
 l’Europa è un continente di pace"
l’Europa è un continente di pace" Le motivazioni del premio Nobel per la pace 2012, secondo il comitato norvegese.
Le motivazioni del premio Nobel per la pace 2012, secondo il comitato norvegese.
 Riconosciuti gli sforzi per la riconciliazione, a favore della democrazia e dei diritti umani, "coronati dal successo"
Riconosciuti gli sforzi per la riconciliazione, a favore della democrazia e dei diritti umani, "coronati dal successo"Ecco le motivazioni del premio Nobel per la pace 2012, attribuito dal comitato norvegese alla Unione Europea.
"Il Comitato ha deciso di assegnare il premio Nobel per la pace 2012 all’Unione Europea. L’Unione e i suoi membri per oltre sei decenni hanno contribuito al progresso della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa", si legge nel testo di assegnazione del premio Nobel per la pace all’Ue.
"Durante gli anni della guerra, il comitato norvegese per il Nobel ha assegnato il riconoscimento a persone che hanno lavorato per la riconciliazione tra Germania e Francia. Dal 1945, la riconciliazione è divenuta realtà. La sofferenza terribile patita durante la Seconda Guerra mondiale ha dimostrato la necessità di una nuova Europa. In 70 anni Germania e Francia hanno combattuto tre guerre. Oggi un conflitto tra Berlino e Parigi è impensabile. Ciò dimostra come, attraverso sforzi ben mirati e la costruzione di una fiducia reciproca, nemici storici possano divenire partner.
Negli Anni ’80, Grecia, Spagna e Portogallo sono entrati nell’Unione. L’instaurazione della democrazia è stata la condizione per la loro adesione. La Caduta del Muro di Berlino ha reso possibile l’ingresso a numerosi Paesi dell’Europa centrale e orientale, aprendo una nuova era nella storia d’Europa. Le divisioni tra Est e Ovest sono in gran parte terminate, la democrazia è stata rafforzata, molti conflitti su base etnica sono stati risolti. L’ammissione della Croazia, il prossimo anno, l’apertura di negoziati con il Montenegro, e il riconoscimento dello status di candidato, sono passi per rafforzare il processo di riconciliazione nei Balcani. Nell’ultimo decennio, la possibilità di una adesione della Turchia hanno fatto progredire la democrazia e i diritti umani nel Paese.
L’Ue sta affrontando una difficile crisi economica e forti tensioni sociali. Il Comitato per il Nobel vuole concentrarsi su quello che considera il più importante risultato dell’Ue: l’impegno coronato da successo per la pace, la riconciliazione e per la democrazia e i diritti umani. Il ruolo di stabilità giocato dall’Unione ha aiutato a trasformare la gran parte d’Europa da un continente di guerra a un continente di pace. Il lavoro dell’Ue rappresenta la "fraternità tra le Nazioni", e costituisce una forma di "congressi di pace" ai quali si riferiva Alfred Nobel nel 1895 come criterio per il premio Nobel per la pace".
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Gli europei non sono consapevoli della felicità conquistata con la pace (di Pietro Citati)13 ottobre 2012, di Federico La Sala
Gli europei non sono consapevoli della felicità conquistata con la pace
di Pietro Citati (Corriere della Sera, 13 ottobre 2012)
Il comitato per il premio Nobel ci richiama alla memoria quello che molti hanno dimenticato: gli anni terribili che l’Europa ha conosciuto della prima metà del Ventesimo secolo.
Non si può immaginare nulla di più assurdo della Prima guerra mondiale, nella quale Germania e Russia, Austria Ungheria e Francia, Inghilterra e Italia hanno distrutto se stessi in nome di mediocrissimi interessi nazionali. Nulla di più tenebroso degli anni dal 1919 al 1945, quando l’Europa ha conosciuto contemporaneamente il trionfo del fascismo, del nazismo e del comunismo.
In un certo senso, è preoccupante che le generazioni più giovani ma anche quelle più mature, dei sessantenni e dei settantenni, non abbiano la minima impressione fisica e visiva di quale sia stata la vita europea nel corso di quegli anni. Dovrebbero studiare profondamente quel passato, per conoscere e apprezzare la condizione nella quale viviamo.
Questa condizione è, per usare una parola, semplicemente di felicità, sebbene di questa felicità non siamo consci e consapevoli. Non ne siamo consci: perché ancora oggi i francesi non comprendono i tedeschi, i tedeschi non comprendono i francesi, gli inglesi non comprendono gli italiani, gli italiani non comprendono gli inglesi. Dovremmo conoscerci molto meglio: mentre la letteratura dedicata dagli europei ai diversi Paesi europei è singolarmente mediocre e piena di pregiudizi e rancore.
Viaggiamo moltissimo, come mai abbiamo viaggiato, eppure ignoriamo i caratteri del Paese che attraversiamo o dove viviamo. Mi chiedo perché. Forse l’unica risposta è che, malgrado la conciliazione e l’unificazione, gli europei hanno perduto quel dono di intelligenza vicendevole che avevano i greci nel tempo di Erodoto o i romani nel tempo di Apuleio. Abbiamo perduto doni essenziali come l’intuizione psicologica, il senso del diverso e dell’altro. Tutte le ridicole polemiche sull’euro, che si sono svolte negli anni scorsi e continuano a svolgersi, lo dimostrano.
È ancora lontano il momento in cui l’italiano vivrà a Parigi, o a Londra o a Berlino, con lo stesso amore che si può avere per le cose di casa propria: il momento in cui il cosiddetto straniero sarà più intelligente e comprensivo del connazionale. Non so quali possano essere i rimedi. Certo, lo sviluppo e il perfezionamento delle istituzione europee, per quanto sia desiderabile, non è sufficiente.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- RITORNARE AL SOGNO. L’Europa è un sogno antico, ma è nel ’900 che diventa progetto pratico, necessità, dando vita a un’istituzione statuale (di Barbara Spinelli).13 ottobre 2012, di Federico La Sala
Ritornare al sogno
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 13.10.2012)
FU UNA di quelle opere - l’unità fra europei edificata nel dopoguerra - che gli uomini compiono quando sull’orlo dei baratri decidono di conoscere se stessi: quando vedono i disastri di cui sono stati capaci, esplorano le ragioni d’una fallibilità troppo incallita per esser feconda E tuttavia non si fanno sopraffare dall’indolenza smagata che secondo Paul Valéry fu la malattia dello spirito europeo all’indomani del ’14-18: la «noia di ricominciare il passato», l’inattitudine a riprendersi e ri-apprendere.
Il Nobel della pace è stato dato ieri a quel ricominciamento della storia, e alla svolta che fu la riconciliazione tra Francia e Germania, che in soli 70 anni avevano combattuto tre guerre. Dalla messa in comune di risorse vitali per i due paesi - il carbone e l’acciaio, fonti di ricchezza e morte - nacque l’Unione che abbiamo oggi.
Mai era apparso così chiaro, nell’attribuzione dei Nobel, il nesso fra pace, democrazia, diritto. Come se l’invenzione d’Europa fosse la conferma vivente che firmare le tregue non è fare la pace. Che per tenere insieme su scala continentale i tre obiettivi - pace, democrazia, diritto - occorre andare oltre i trattati fra Stati, oltre la non belligeranza fra sovrani che non riconoscono potere alcuno, né legge, sopra di sé.
Quando propose e creò la Comunità del carbone e dell’acciaio, Jean Monnet spiegò il ragionamento che lo aveva ispirato: «Quando si guarda al passato e si prende coscienza dell’enorme disastro che gli europei hanno provocato a se stessi negli ultimi due secoli, si rimane letteralmente annichiliti. Il motivo è molto semplice: ciascuno ha cercato di realizzare il suo destino,o quello che credeva essere il suo destino, applicandole proprie regole».
Fu grazie a questa consapevolezza che l’unità degli europei divenne un modello, e per gran parte del mondo ancora lo è: dalle stragi etniche o razziali, dagli scontri fra culture o religioni, si esce solo se gli Stati nazione smettono l’illusione di bastare a se stessi - la regola della sovranità assoluta - e creano comuni istituzioni politiche che realizzino il destino di più paesi associati, non di uno soltanto.
In Asia, in Medio Oriente, il metodo comunitario resta la via aurea per superare i nazionalismi: molto più della solitaria potenza americana. Fu una sorta di conversione, quella sperimentata dagli Europei. Al posto dello sguardo nazionale, lo sguardo cosmopolita; al posto dei trattati fra Stati, un’unione sin da principio parzialmente federale, cui le vecchie sovranità assolute venivano delegate.
L’Europa è un sogno antico, ma è nel ’900 che diventa progetto pratico, necessità, dando vita a un’istituzione statuale. Un’istituzione che affianca Stati che si riconoscono non solo fallibili ma pericolosi per se stessi, se consegnati alle dismisure nazionaliste.
Solo dopo la propria guerra dei trent’anni (quella che dal 1914 va al 1945) il continente scopre che non basta deporre le armi ma che urge capire perché insorgono i conflitti di sangue. «Insorgono a causa della facilità con cui gli Stati rimettono in causa il funzionamento delle loro istituzioni», disse ancora Monnet. Bene saperlo fin d’ora: le guerre divorano le democrazie, ma è il degradare delle democrazie e delle loro istituzioni che getta popoli senza più nocchieri nelle guerre. Si trattava dunque di cessare i conflitti bellici e al tempo stesso di ridar forza alle istituzioni, di renderle meno discontinue.
L’unità nasce dicendo no ai nazionalismi ma anche a quel che li fa impazzire: la povertà, la democrazia corrosa, il rarefarsi dello Stato di diritto prima ancora che dei diritti umani. Conferito in questi giorni, il premio è singolare. Quasi sembra che faccia dell’ironia, anche se difficilmente immaginiamo una giuria ironica. È come se non suggellasse un progresso, ma indicasse come rischiamo di perderlo. Mostra quel che l’Europa ha voluto essere, e non è ancora o non è più. Gli scontri sull’euro, la Grecia trasformata in capro espiatorio, il peso abnorme di un solo Stato (Germania): non è l’unione cui si è aspirato per decenni, ma una costruzione che si decostruisce e arretra invece di completarsi.
È come se la giuria ci dicesse, fra le righe: «Voi europei avete inventato qualcosa di grande, ma non siete all’altezza di quel che oggi premiamo. Siete una terra promessa, ma voi abitate ancora il deserto come gli ebrei fuggiti dall’Egitto».
Se l’Europa si compiacerà del premio vorrà dire che dell’evento avrà visto solo la superficie celebrativa, non il caos che ribolle sotto la superficie. Un premio così non si riceve soltanto. Lo si medita, lo si interroga, come nella Grecia antica s’interpellava l’oracolo di Delfi. Anche perché il responso non muta, nei millenni: conosci te stesso, ripeterà. Conosci il tradimento delle promesse iniziali e il ridicolo delle tue apoteosi. Prova a capire come mai l’Unione non sveglia più speranze ma diffidenza, paura, a volte ribrezzo. Rimasta a metà cammino, l’Europa non è ancora l’istituzione sovranazionale che preserva la democrazia e lo Stato sociale. Viene identificata con uno dei suoi mezzi - l’euro - come se la moneta e le misure fin qui congegnate fossero la sua
finalità, salvataggio finanziario e il rifiuto di ogni via alternativa hanno fatto perdere di vista la democrazia, e la solidarietà, e l’idea di un’Europa che, unita, diventa potenza nel mondo. L’ideale sarebbe se l’Europa non andasse a prendere il premio, e comunicasse al Comitato Nobel che i propri cittadini (non gli Stati, ben poco meritevoli) verranno a ritirarlo quando l’opera sarà davvero voluta, e di conseguenza compiuta. Quando avremo finalmente una Costituzione che - come nella Federazione americana - cominci con le parole «Noi, cittadini....». Quando ci si rimetterà all’opera, e ci si spoglierà della noia di ricominciare la storia. I sotterfugi tecnici non durano: durano solo le istituzioni. La svolta è politica, mentale, e proprio come nel 1945, è la massima di sant’Agostino che toccherà adottare: Factus eram ipse mihi magna quaestio - Io stesso ero divenuto per me un grosso problema, e un grosso enigma.
-
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Strage di Stazzema. Il debito immenso che la Germania nega (di Furio Colombo) - La confessione dell’ex SS. “È vero, uccisi 25 donne” (di Niccolò Zancan).7 ottobre 2012, di Federico La Sala
 Strage di Stazzema
Strage di Stazzema
 Il debito immenso che la Germania nega
Il debito immenso che la Germania nega di Furio Colombo (il Fatto, 07.10.2012)
di Furio Colombo (il Fatto, 07.10.2012)Un gentile ministro tedesco di passaggio da Palazzo Chigi ha voluto porre un rimedio alla sentenza del Tribunale di Stoccarda che ha deciso di non poter processare i superstiti responsabili del massacro di Sant’Anna di Stazzema con le parole: “Mancano le prove”. L’intero processo di Norimberga avrebbe potuto concludersi così. Ha detto il ministro come per rassicurarci: “La legge non cancella Storia”. Ma la Storia trascina pesi, rinfaccia debiti. In un’epoca come questa “debito” è la parola chiave.
È possibile che Spagna e Italia meritino diffidenza per lo stato della loro economia e (come nel caso italiano) per l’ammontare troppo grande del debito. È possibile che questi sguardi sospetti e - a momenti - decisamente ostili e non privi di compatimento e di un disprezzo appena velato dalle buone maniere, vengano dalla Germania, Paese definito spesso “virtuoso” a causa dei conti in ordine e della produzione ben organizzata che continua a fare profitto. È bene ricordare che prima viene la Grecia ad aprire la lista nera di coloro che hanno troppi debiti non pagati e forse non pagabili. La Grecia, considerata ormai, senza tanti riguardi, un Paese non rispettabile da una Unione europea del tutto sottomessa al rigore tedesco dei conti in ordine. Sicuri che Berlino abbia i conti in pari?
Qui cominciano due discorsi. Il primo porta domande senza risposta sul carattere che l’Europa dovrebbe avere e mostrare. Come mai la voglia di punizione e di espulsione prevale oggi con tanta forza sulla ricerca, per quanto difficile, di soluzioni? Perché è più facile e normale e frequente sentire parlare della “fine della Grecia” piuttosto che di un patto comune per salvarla e trattenerla in Europa? L’altro discorso porta a un’altra domanda, che stranamente non viene mai posta (anche perché tutto lo spazio e il tempo è occupato da lodi e glorificazioni): davvero la Germania non ha debiti? E se li ha avuti, li ha pagati? Questo non è un modesto e maldestro tentativo di sviare il discorso in difesa di economie sgangherate. Purtroppo riguarda fatti ed eventi realmente accaduti, persone realmente esistite e realmente eliminate con crudeltà, con violenza e in massa.
Un fatto è appena accaduto. Una Corte tedesca (Stoccarda) ha rifiutato di considerare come avvenuto e come tedesco il massacro di Sant’Anna di Stazzema (uomini, donne, molti bambini, il prete, tutti uccisi davanti alla chiesa) perché “mancavano le prove”, ovvero non era stata rilasciata ricevuta per quel debito senza senza limiti, e non c’era dunque ragione di considerare qualcuno come responsabile.
Negli stessi giorni, i giorni in cui in Italia è morto Shlomo Venezia, per anni operaio gratuito (il compenso: restare provvisoriamente in vita) nella fabbrica della morte detta Auschwitz Birkenau, un sopravvissuto che solo adesso, morendo, ha finito di raccontare la sua storia pazzesca, il deputato Emanuele Fiano ha informato il Parlamento italiano di questo evento: “Mi ferisce in maniera indicibile, a me che sono figlio di un sopravvissuto di Auschwitz, che si possa permettere, in questo Paese, che un sito neonazista, nella giornata di ieri, in concomitanza con la morte di Shlomo Venezia, abbia potuto aprire una pagina dedicata alla festa per la sua morte”. Questo squallido episodio dimostra ancora una volta che il danno prodotto nella vita e nella cultura europea dai vuoti e dalle negazioni della storia è altrettanto grave quanto i delitti compiuti negli anni spaventosi della persecuzione e della guerra.
Per esempio, a pochi chilometri da quella festa, appena un po’ prima dell’evento nazista, si può trovare la rappresentazione fisica di un estremismo più psichico che politico: il monumento-mausoleo di un grande criminale di guerra e di strage, il generale Rodolfo Graziani. L’episodio è moralmente indecente, storicamente assurdo, ma anche frutto di corruzione. Il monumento a Graziani, infatti, è stato pagato con fondi illecitamente ottenuti dalla Regione. È ciò che ci ha fatto giudicare corrotti e non affidabili, fino a poco fa, in Europa. È qui che torniamo al debito, e al senso del debito della Germania.
Quando il Tribunale di Stoccarda, il tribunale di un Paese rispettato che fa da motore a questa Europa, nega, con il peso della sua credibilità e del suo prestigio, che sia accaduta la strage di Sant’Anna di Stazzema, non nega solo un episodio fra tanti di una guerra crudele e terribile. Nega il suo immenso debito e stabilisce una distanza pericolosa. La bella e moderna Germania di oggi non deve, non può sfiorare quel passato senza rendersi conto di quanto sia grave evocare un debito mai saldato, e rifiutare di saldarlo, sia pure, ormai, solo come gesto simbolico. Meglio essere amico degli amici ritrovati e tentare insieme la salvezza di tutti.
 La confessione dell’ex SS “È vero, uccisi 25 donne”
La confessione dell’ex SS “È vero, uccisi 25 donne”
 Ma per la strage di Sant’Anna di Stazzema la Germania lo ha assolto
Ma per la strage di Sant’Anna di Stazzema la Germania lo ha assolto «Non può finire così: da noi le condanne sono state confermate in Appello e in Cassazione»
«Non può finire così: da noi le condanne sono state confermate in Appello e in Cassazione»
 "Svuotai un’intera cartuccera. Erano solo donne, donne di ogni età"
"Svuotai un’intera cartuccera. Erano solo donne, donne di ogni età" di Niccolò Zancan (La Stampa, 07.10.2012)
di Niccolò Zancan (La Stampa, 07.10.2012)Eppure c’è chi ha ammesso. Parola per parola. Orrore su orrore. «Verso la parte terminale del pianoro, dove ricominciava la salita, vi erano due case. Si trattava di case piuttosto piccole, erano rivestite in muratura, ma avevano un aspetto misero. Di fronte a queste case, sedevano in cerchio circa 25 donne».
Questa è la voce di Ludwig Göring nato a Itterbash, Germania, il 18 dicembre 1923, tornitore di casse d’orologio in pensione. Ma, soprattutto, «impiegato alla mitragliatrice» nelle Waffen SS come da dizione giudiziaria tedesca durante la seconda guerra mondiale. E quello che ha messo a verbale davanti alla procura della Repubblica di Stoccarda - e poi anche davanti alla procura militare italiana - è il suo ricordo della strage di Sant’Anna di Stazzema. L’avevano chiamata «operazione antipartigiani». Dopo la notte trascorsa vicino a La Spezia, si ritrovarono di fronte a quelle donne disarmate.
«L’ufficiale di grado più elevato era molto impaziente - racconta Göring - ci sollecitò a fare presto. Urlò: “Posizionare la mitragliatrice! ”. Dopo l’ordine di fare fuoco, sparai sulle donne. Durò pochissimo. Tre uomini cosparsero di benzina i cadaveri e vi appiccarono il fuoco. Improvvisamente vidi che dalla catasta in fiamme si levava correndo un bambino, un ragazzo di circa 10-11 anni, che si allontanò subito di corsa, scomparendo dietro la scarpata che distava circa tre metri. Non avevo visto prima il bimbo. Neanche mentre sparavo avevo notato che vi fosse un bambino con le donne».
Ha ammesso in piena consapevolezza, di fronte al preciso avvertimento avanzato dal procuratore generale Bernard Häubler: «Al testimone si fa rilevare che, qualora sostenga di aver sparato, diviene indiziato di concorso di omicidio e potrebbe rendersi perseguibile per concorso in omicidio doloso semplice o omicidio doloso grave». Ludwig Göring risponde così: «Devo parlare, non importa cosa accadrà. Ora voglio dire la verità. In quello spiazzo si trovava una sola mitragliatrice, azionata da me e dall’artigliere addetto alle munizioni... Ero consapevole che una simile fucilazione era proibita. Ma non avevo scelta: un ordine è un ordine».
C’è, dunque, un reo confesso. Eppure il 1° ottobre anche la posizione di Ludwig Göring è stata archiviata dalla Procura di Stoccarda, insieme a quella degli altri soldati nazisti indagati per la strage del 12 agosto 1944, in cui furono trucidati 560 innocenti. Una sentenza che il presidente Giorgio Napolitano ha definito «sconcertante». E che si è basata, per quanto si è potuto capire, proprio sull’impossibilità di ricondurre le singole azioni criminali a precise responsabilità individuali. E invece ci sono i ricordi lucidi del caporalmaggiore Göring, c’è la sua mano che spara: «Quella mattina la mia compagnia si mise in marcia compatta. Si recò sui monti, formando una linea di fucilieri. La distanza fra i soldati era di circa 10 metri. Io trasportavo la mitragliatrice».
A un certo punto fa addirittura un disegno, indica le posizioni: il pianoro, il bosco, le donne costrette a sedersi in cerchio. Aggiunge: «Stavamo a cinque metri da loro. Tutti spararono. Io svuotai un’intera cartucciera, che non fu ricaricata. Altri soldati spararono con il mitra... Erano solo donne, donne di ogni età, ma non le osservai in modo dettagliato... Mentre ci allontanavamo, i cadaveri stavano ancora bruciando». Gli chiedono: «Ha mai parlato con qualcuno di questi fatti dopo l’accaduto? ». Göring risponde: «Sì, circa quattro settimane fa con mia moglie. Quando ricevetti la convocazione della Procura, me ne chiese il motivo». Gli domandano: «Perché adesso è disposto a raccontare questi accadimenti? ». E lui: «Perché li ho sempre davanti agli occhi, in continuazione, da quando sono accaduti. E specie da quando si parla in televisione di attacchi terroristici, questi fatti mi tornano alla mente. Non riesco a liberarmene».
Il verbale è datato 25 marzo 2004. Una ricostruzione confermata successivamente anche davanti al capo della procura militare italiana, Marco De Paolis. Per la stessa strage ha ottenuto dieci condanne. «Senza mancare di rispetto a nessuno - spiega adesso - non può finire così. C’è qualcosa che stride. Da noi la sentenze di condanna sono state confermate in appello e in Cassazione. E tutte si sono basate su prove documentali e testimoniali». Anche sulla confessione tardiva del caporalmaggiore Göring.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Strage di Stazzema. La politica delle stragi non è un’invenzione della storiografia, fece parte della strategia della Wehrmacht, e non solo delle Ss (di Enzo Collotti - La memoria non si archivia)7 ottobre 2012, di Federico La Sala
La memoria non si archivia
di Enzo Collotti (il manifesto, 3 ottobre 2012)
La sentenza con la quale la magistratura di Stoccarda ha disposto l’archiviazione del procedimento contro gli appartenenti al reparto delle Watten-Ss imputati della strage di Sant’Anna di Stazzena e già condannati dalla giustizia italiana ripropone vecchi interrogativi e ne apre di nuovi sia sul terreno tecnico sia dal punto di vista etico e politico. Si presenta anzitutto un conflitto tra magistrature: è possibile che la magistratura tedesca non sia in grado di accertare quanto appurato dai giudici italiani? La difformità di valutazioni, a parte produrre le conclusioni abnormi che sono sotto gli occhi di tutti, rischia di incrinare ogni fiducia delle popolazioni nei confronti della giustizia.
Poiché non è la prima volta che questo accade, nella prospettiva di una unione europea segnala a dir poco una incongruenza che richiede sicuramente un intervento riparatore. Come si può pensare che, indipendentemente dalla dimostrazione delle responsabilità dei singoli militari delle Waffen-Ss, la popolazione dell’area teatro della strage prenda per buona l’ipotesi di essere stata vittima di un’azione non premeditata? L’archiviazione giudiziaria non archivia la memoria e rischia di inasprire ferite che solo con una lenta opera di riconciliazione, di cui sono stati e sono protagonisti anche cittadini e politici tedeschi, erano e sono in via di superamento.
Ma c’è ancora un altro versante del discorso che va considerato. Il conflitto tra la giustizia e la storia. Risulta veramente strano che la magistratura di Stoccarda, alla luce dell’esperienza pluridecennale della giustizia tedesca con crimini commessi dai nazisti in Europa non sia in grado di inquadrare la strage di Sant’Anna nel suo contesto storico. È ben vero che il giudice deve provare le responsabilità individuali ma è altrettanto incontestabile che queste si collocano all’interno di precisi contesti.
Il giudice non è tenuto a compiere lui un’indagine storica, ma certo è tenuto a non ignorare che esiste un’ampia letteratura che può aiutarlo a valutare. Che una strage di centinaia di persone, con centinaia di vittime tra donne e bambini, non gli suggerisca che di ben altro si trattava che non di caccia ai partigiani, è un fatto che non denota insufficienza di informazioni ma piuttosto l’inadeguatezza (per non dire l’incompetenza) del giudice.
La politica delle stragi non è un’invenzione della storiografia, fece parte della strategia della Wehrmacht, e non solo delle Ss, nel tentativo di controllare i territori occupati dell’Europa intera e di intimidire le popolazioni insofferenti dell’oppressione dei nazisti e dei loro collaboratori. Nel caso dell’Italia, la brutalità delle violenze naziste dopo l’8 settembre 1943 non fu soltanto reazione alla secessione dal conflitto dell’alleato fascista, fu tra le opzioni tattiche strategiche adottate per superare le difficoltà del controllo del territorio.
La guerra ai civili non è stata studiata soltanto da storici italiani, su di essa hanno attirato l’attenzione studiosi tedeschi - da Friedrich Andrae a Gerbard Schreiber, a Luiz Klinkhammer: essa caratterizzò la fase più acuta della campagna d’Italia, quando i tedeschi pensavano di non avere più nulla da perdere.
Se i giudici di Stoccarda avessero tenuto presente questo contesto certo non sarebbe sfuggito loro che l’eccidio di Sant’Anna non era avvenuto per caso. Quali che possono essere le cause che hanno reso ulteriormente difficile la valutazione di questo caso - e certo i colpevoli ritardi della giustizia italiana causati dall’armadio della vergogne vanno messi nel debito conto - il comportamento della magistratura tedesca risulta inspiegabile. Per le popolazioni direttamente colpite suona come la capitolazione di fronte all’inesplicabilità della storia e alla viltà di uomini che oggi mentono senza scrupoli come senza scrupoli allora ammazzarono.
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Quale democrazia per l’Europa? Una risposta a Habermas (di Etienne Balibar)20 settembre 2012, di Federico La Sala
Quale democrazia per l’Europa? Una risposta a Habermas
di Etienne Balibar (il manifesto, 20 settembre 2012)
Jürgen Habermas ha parlato alto e chiaro sulla situazione europea e le decisioni che essa esige nell’articolo scritto assieme all’economista Peter Bofinger - membro del Consiglio tedesco dei saggi - e all’ex ministro bavarese Julian Nida-Ruemielin, uscito sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung il 3 agosto scorso (in italiano su Repubblica del 4 agosto) con il titolo «Rifiutiamo una democrazia di facciata», nel quale prende di mira le allusioni di alcuni membri del governo sulla elezione a suffragio universale di un presidente dell’Europa per legittimare il patto di bilancio europeo.
Nell’essenziale la tesi di Habermas è che la crisi non ha nulla a che vedere con le «colpe» degli Stati spendaccioni che gli stati «economi» stenterebbero a risanare (in tedesco «Schuld» significa sia «debito» sia «colpa»). Ha invece tutto a che vedere con l’incapacità degli Stati, messi in concorrenza dagli speculatori, di neutralizzare il gioco dei mercati e a premere per una regolamentazione mondiale della finanza. Per cui non si uscirà dalla crisi se l’Europa non si decide a «varcare il passo» verso l’integrazione politica che permetterebbe insieme di difenderne la moneta e affrontare le politiche di riduzione delle inuguaglianze al proprio interno che è la sua ragione di esistere. Terreno naturale di questa trasformazione è il «nocciolo europeo» (Kerneuropa), cioè l’eurozona più gli Stati che dovrebbero entrarvi (in particolare la Polonia). Ma la condizione sine qua non è una democratizzazione autentica delle istituzioni comunitarie, che Habermas intende essenzialmente come formazione d’una rappresentanza parlamentare dei popoli finalmente effettiva (attraverso un sistema a due livelli che egli distingue dal «federalismo» di tipo tedesco), dotata di poteri di controllo politico a livello continentale, in particolare sulla dimensione e l’utilizzazione delle imposte che sosterrebbero la moneta comune, secondo il principio degli insorti americani: «No taxation without representation!»
Bisogna felicitarsi di questo intervento e non lasciarlo isolato. Esso viene dopo una serie di coraggiose prese di posizione con le quali Habermas ha attaccato «il nuovo nazionalismo della politica tedesca e i pregiudizi unilaterali» che esso copre. E comporta un notevole sforzo per tenere assieme il piano politico, quello economico e quello sociale, come a prefigurare il contributo che l’Europa potrebbe portare a una strategia di uscita dalla crisi su scala mondiale, basata sugli imperativi d’una protezione dei diritti sociali (che non significa la loro immutabilità) e d’una regolazione dei meccanismi di credito che proliferano «sopra la testa» dell’economia reale. Per ultimo, Habermas afferma senza ambiguità che un’Europa politicamente unificata (la si chiami o no «federale») non è possibile che a condizione d’una democrazia sostanziale che investa la natura stessa dei suoi poteri e della loro rappresentatività, dunque legittimità. Da parte mia, da tempo sostengo una tesi più radicale (qualcuno dirà più vaga): una Europa politica, senza la quale non c’è che declino e impotenza per le popolazioni del continente, non sarà legittima, e quindi possibile, se non sarà più democratica delle nazioni che la compongono, se non farà un passo avanti rispetto alle loro conquiste storiche in tema di democrazia.
Un New Deal europeo
Il ragionamento del filosofo di Francoforte comporta tuttavia, ai miei occhi, due punti deboli fra loro connessi. Il primo è che non tiene in conto il tempo passato, e dunque la congiuntura: come se la crisi non si dispiegasse da anni; come se si potessero riportare indietro gli effetti che ha prodotto e realizzare ora quel che sarebbe stato necessario fare per evitarla, essenzialmente al momento di mettere in atto il sistema monetario europeo. Non credo che sia così. Converrebbe almeno sviluppare l’indicazione di Habermas relativa alla accettazione dell’imposta e il controllo del suo uso. Non ci sarà uscita dalla crisi, né in Europa né altrove, senza una «rivoluzione fiscale» che implica non solo imporre tasse su scale continentale e vegliare sulla loro giusta ripartizione, ma di utilizzarle in un’ottica diretta alla crescita dell’occupazione che la crisi ha devastato, alla riconversione delle attività produttive e alla riorganizzazione del territorio europeo. Qualcosa come un New Deal o un piano Marshall intereuropeo. Cosa che implica il ritorno a una politica monetaria equilibrata fondata sul circuito di scala non meno che su quello bancario (che è, vedi caso, quello che alimenta la speculazione).
Il secondo punto debole dell’argomentazione di Habermas è che si attiene a una concezione esageratamente formale della democrazia - sempre meno soddisfacente in una fase in cui sono in atto potenti processi di «sdemocratizzazione» nella nostre società, che derivano anche dalla crisi, ragioni di opportunità ed efficacia a favore di una «governance» dall’alto. Non si tratta soltanto di correggerli, occorre contrastarli e opporre loro delle innovazioni democratiche «materiali». Non mi si fraintenda: non ricuso affatto il bisogno di rappresentanza. Al contrario, la storia del 20mo secolo ne ha dimostrato assieme la necessità e i margini di fluttuazione, fra la semplice delega di potere e il controllo effettivo. Bisogna approfondire questo dibattito su scala europea. Ma anche introdurre altre modalità di democrazia, o meglio di democratizzazione dell’istituzione politica. È la chiave per risolvere la famosa aporia del «demos europeo». Il demos non preesiste come condizione della democrazia, ne deriva come un effetto. Ma neanch’essa esiste se non nel corso e nelle forme delle diverse pratiche di democratizzazione. Come democrazia rappresentativa, certo, ma anche come democrazia partecipativa, il cui orizzonte è il comunismo autogestito («la costruzione dei comuni», direbbe Negri), e come democrazia conflittuale («contro-democrazia», direbbe Rosanvallon), che vive di rivendicazioni e proteste, di resistenze e di indignazioni. Unità del molteplice
Sono modalità in equilibrio instabile - è vero - che ci allontana da un costituzionalismo «normativo». Non potrebbero esser messe in atto da decisioni prescrittive, quale che ne sia il modo di legittimazione (come altri, Habermas evoca con insistenza la possibilità del referendum sul futuro dell’euro e dell’Europa). Può perfino sembrare che andando oltre la possibilità di una gestione da parte dei governi, dando vita alle virtualità dell’autonomia o del dissenso, esse vadano incontro all’obiettivo di una «rifondazione» dell’Unione europea: come fare unità con la molteplicità e la contraddizione, stabilità con l’incertezza, legittimità con la contestazione? Ma inversamente, si può chiedere a Habermas, come immettere democrazia nella costruzione europea senza un «salto» o un «passo di lato» rispetto alle strutture e procedure che sono state concepite per escluderla, neutralizzarla, e che i metodi di gestione della crisi, essenzialmente destinati a evitare l’intervento dei cittadini, hanno sistematicamente bloccato? Bisognerà pure che, su questo e altri punti («l’Europa sociale») si faccia avanti qualcosa come un’opposizione o un movimento.
Non lasciamo passare l’occasione che Habermas e suoi colleghi ci offrono di un dibattito sull’Europa per gli europei e fatto dagli europei. Esso si delinea in forme diverse dovunque è imposto dalla gravità della crisi: in Grecia, in Spagna, pochissimo in Francia malgrado l’allarme che dovrebbe provocare la valanga (di chiusure industriali e di polemiche) del rientro dall’estate, che sembra un remake delle campagne del 1992 e del 2005, con la sola differenza che non è previsto nessun referendum. Nulla che esca dalle frontiere nazionali. Nulla, quindi, che spinga la politica al livello che esigerebbero sia le urgenze sia i principi.
(Pubblicato sul quotidiano francese Liberation il 3 settembre 2012)
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- IL MEDITERRANEO SENZA EUROPA. Senza idee né risorse, senza un comune governo per affrontare le crisi mondiali, e questo spiega il nostro silenzio, o l’inane balbettio dei rappresentanti europei.19 settembre 2012, di Federico La Sala
Il Mediterraneo senza Europa
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 19 settembre 2012)
Scrive il narratore greco Petros Markaris che l’Europa vive una strana insidiosa stagione: del suo sconquasso non parlano che gli economisti, i banchieri centrali. Con il risultato che la moneta unica diventa la sostanza stessa dell’Unione, non uno strumento ma la sua ragion d’essere, l’unica sua finalità: «L’unità dell’Ue è stata sostituita dall’unità dell’eurozona. Per questo il dibattito rimane così superficiale, come la maggior parte dei dirigenti europei, e unidimensionale, come il tradizionale discorso degli economisti ». Priva di visione del mondo, l’Europa ha interessi senza passioni, e non può che dividersi tra creditori nobili e debitori plebei. «Stiamo correndo verso una sorta di guerra civile europea».
Come un improvviso sparo nel silenzio è giunto il nuovo sisma nei paesi musulmani, sotto forma di una vasta offensiva dell’integralismo musulmano contro l’Occidente e i suoi esecrabili video: la violenza s’addensa nel Mediterraneo, e l’Europa - in proprie casalinghe faccende affaccendata - d’un tratto s’accorge che fuori casa cadono bombe. S’era addormentata compiaciuta sulle primavere arabe, ed ecco irrompe l’inverno. Aveva immaginato che le liberazioni fossero sinonimo di libertà, e constata che le rivoluzioni son sempre precedute da scintille fondamentaliste (lo spiega bene Marco d’Eramo, sul Manifesto di ieri), prima di produrre istituzioni e costituzioni stabili. Come Calibano nella Tempesta di Shakespeare, i manifestanti ci gridano: “Mi avete insegnato a parlare come voi: e quel che ho guadagnato è questo: ora so maledire. Vi roda la peste rossa per avermi insegnato la vostra lingua!”.
L’Europa potrebbe dire e fare qualcosa, se non continuasse ad affidare i compiti all’America: non solo in Afghanistan, dove molti europei partecipano a una guerra persa, non solo in Iran, ma nel nostro Mediterraneo. È da noi che corrono i fuggitivi dell’Africa del Nord, quando non muoiono in mare con una frequenza tale, che c’è da sospettare una nostra volontaria incuria. L’Europa potrebbe agire se avesse una sua politica estera, capace di quel che l’America lontana non sa fare: dominare gli eventi, fissare nuove priorità, indicare una prospettiva che sia di cooperazione organizzata e non solo di parole o di atti bellici.
Ormai evocare la Federazione europea non è più un tabù: ma se ne parla per la moneta, o per dire nebulosamente che così saremo padroni del nostro destino.
Ma per quale politica, che vada oltre l’ordine interno, si vuol fare l’Europa? Con quale idea del mondo, del rapporto occidente- Islam, dell’Iran, di Israele e Palestina, del conflitto fra religioni e dentro le religioni?
Più che una brutta scossa per l’Unione, l’inverno arabo rivela quel che siamo: senza idee né risorse, senza un comune governo per affrontare le crisi mondiali, e questo spiega il nostro silenzio, o l’inane balbettio dei rappresentanti europei. Difficile dire a cosa serva Catherine Ashton, che si fregia del pomposo titolo di Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione. Nessuno sa cosa pensino 27 ministri degli Esteri, ibridi figuranti di un’Unione fatta di Stati non più sovrani e non ancora federali. Quanto ai popoli, non controllano in pratica più nulla: né l’economia, né il Mediterraneo, né le guerre mai discusse dall’Unione.
Per la storia che ha alle spalle (una storia di democrazie e Stati restaurati grazie all’unione delle proprie forze, dopo secoli di guerre religiose e ideologiche), l’Europa ha gli strumenti intellettuali e politici per divenire un alleato delle primavere arabe in bilico, e di paesi che faticano a coniugare l’autorità indiscussa dello Stato e la democrazia. E resta un punto di riferimento laico per i tanti - in Libia, Egitto, Tunisia - che vedono la democrazia o catturata dai Fratelli musulmani, o minacciata dai fondamentalisti salafiti.
La via di Jean Monnet, nel dopoguerra, fu la combinazione fra gli interessi e le passioni, dunque la messa in comune delle risorse (carbone e acciaio) che dividevano Germania e Francia. La Comunità del carbone e dell’acciaio (Ceca), fu nel 1951 l’embrione dell’Unione: gli Stati non si limitavano più a cooperare, ma riconoscevano in istituzioni sovranazionali un’autorità superiore alla propria. In seguito le istituzioni si sarebbero democratizzate, con l’elezione diretta di un Parlamento europeo sempre più influente. Così potrebbe avvenire tra Europa e Sud Mediterraneo, grazie a una Comunità non basata sul carbone e l’acciaio, ma sull’energia (o in futuro sull’acqua).
Un piano simile è stato proposto, nell’ottobre 2011, da due economisti di ispirazione federalista, Alfonso Iozzo e Antonio Mosconi. L’idea è che Washington non sia più in grado di garantire stabilità e democrazia, nel Mediterraneo e Medio Oriente. Di qui l’urgenza di una Comunità euromediterranea dell’energia: energia spesso potenziale, difficilmente valorizzabile senza aiuti finanziari e tecnologici europei: «Il principio di una Comunità tra eguali è essenziale e ricorda la rivoluzione realizzata dall’Eni di Enrico Mattei, che ruppe il monopolio delle “sette sorelle” petrolifere concedendo per la prima volta alla Persia la gestione in parità delle risorse petrolifere del paese». La nuova Comunità deve «riconoscere ai paesi associati la proprietà delle risorse energetiche e degli impianti, dando all’Europa diritti di utilizzazione su una quota dell’energia prodotta, per un periodo determinato con aumento progressivo della quota utilizzata localmente, in cambio delle tecnologie e degli investimenti effettuati». Si dirà che è solo una comunità di interessi. Lo si disse anche per la Ceca. In realtà l’ambizione politica è forte: sostituire il modello egemonico con un modello paritario e chiedere agli associati precisi impegni democratici, controllati da una comune Assemblea parlamentare.
Sostituire o affiancare il potere Usa nel Mediterraneo vuol dire prendere atto che quel modello non funziona: ha creduto di esportare democrazia con le guerre, creando Stati fallimentari e rafforzando Stati autoritari. Le democrazie (Israele compresa) hanno sostentato per anni i fondamentalisti (i talebani contro l’Urss, Hamas contro l’Olp) e volutamente ignorano una delle principali fonti delle crisi odierne: l’Arabia Saudita, finanziatrice dei partiti salafiti che minano le barcollanti, appena nate democrazie arabe.
Obama è alle prese con importanti insuccessi. Nonostante il discorso di apertura all’Islam tenuto nel 2009 al Cairo, il diritto della forza prevale spesso sulla forza del diritto, come per Bush. Abbiamo già citato l’Arabia Saudita, non meno pericolosa dell’Iran e tuttavia esente da obblighi speciali.
Permane l’influenza della destra israeliana su Washington, con effetti nefasti sul Medio Oriente. Guantanamo non è stata chiusa come promesso (risale all’8 settembre la morte di un prigioniero, Adnan Latif, torturato per 10 anni senza processo, nonostante l’ingiunzione dei tribunali a rilasciarlo). L’Iraq è liberato, e nessuno protesta contro i pogrom polizieschi della popolazione gay, testimoniati in questi giorni da un documentario della Bbc. Le guerre scemano, ma sotto Obama l’uso di droni senza piloti è sistematico, in Pakistan, Somalia, Yemen: le uccisioni mirate in zone non belliche «distruggono 50 anni di legge internazionale», sostiene l’investigatore Onu Christof Heyns. La questione ci concerne. Obama risponderà all’attentato di Bengasi con droni che forse partiranno da Sigonella, e sul loro uso il governo italiano non potrà tacere.
Tocca all’Europa dare speranze al Mediterraneo, difendere le sue democrazie. Se si dà un governo, l’Unione avrà l’euro e una politica estera. Solo in tal caso il colpo di fucile che udiamo nei paesi arabi potrà svegliare, come nella poesia di Montale, un’Europa il cui cuore «ogni moto tiene a vile, raro è squassato da trasalimenti».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- Stati uniti d’Europa, non semplice federazione di Stati (di Pino Arlacchi)17 settembre 2012, di Federico La Sala
Stati uniti d’Europa, non semplice federazione di Stati
di Pino Arlacchi, Eurodeputato Pd Membro commissione esteri (l’Unità, 17.09.2012)
«L’UNIONE EUROPEA DEVE EVOLVERSI. NON ABBIAMO PAURA DELLE PAROLE : DOVREMO DIRIGERCI VERSO UNA FEDERAZIONE DI STATI-NAZIONE. Di questo abbiamo bisogno. Non di un super-stato. Una federazione democratica di stati che possa fare fronte ai nostri problemi comuni attraverso la condivisione della sovranità». Così il presidente della Commissione ha rilanciato il progetto europeo fornendo una prima risposta a chi chiedeva un salto di qualità politico nella via di uscita dalla crisi.
Anche la delegazione italiana al Parlamento europeo aveva chiesto a Barroso di muoversi in questa direzione, ma con una differenza: l’obiettivo del dopo-crisi non deve essere una semplice federazione di stati, ma gli Stati Uniti d’Europa nel vero senso della parola. Noi pensiamo a un assetto fondato sulla cessione completa della sovranità nei campi strategici dell’azione di governo. Pensiamo a un forte centro comune, e alla presenza di una sovranità subordinata nelle sfere minori. Sulla falsariga della gerarchia tra governo federale e singoli stati dell’unione negli Usa.
Nel dibattito seguito al discorso del presidente della Commissione, il leader dei liberali, Guy Verofstadt, ha colto il punto più debole della proposta Barroso. Una semplice federazione di stati che «condivida» solo dei pezzi di sovranità potrebbe essere una soluzione peggiore dell’assetto attuale, basato sul dualismo tra Consiglio e Commissione, dove quest’ultima rappresenta quel polo comunitario e non intergovernativo che è il nucleo dei futuri Stati Uniti d’Europa.
La proposta Barroso non prevede la creazione di un governo federale centrale che goda di sovranità in materia di politica estera e di difesa, nonché nella sicurezza interna e in materia fiscale, monetaria e di protezione sociale. La sua è un’Europa dove esiste un maxi-Consiglio degli stati membri senza Commissione e senza Parlamento dotati di poteri effettivi. Un’Europa minata alla radice dall’assenza di una amministrazione comune, e dalla mancanza di un meccanismo di bilanciamento dello squilibrio tra grandi e piccoli stati della federazione.
L’idea che sta prendendo corpo all’interno della delegazione italiana è che si debba andare verso un assetto bicamerale e verso un governo europeo vero e proprio. Il Parlamento eletto a suffragio universale dai cittadini europei c’è già. Il Consiglio europeo andrebbe trasformato in camera degli stati sul modello del Senato americano dove sono presenti due senatori per ciascuno di essi senza riguardo a popolazione e territorio. E la Commissione dovrebbe rappresentare l’organo esecutivo delle due camere con un unico presidente eletto dai cittadini europei.
Proponiamo un modello che ricalca quello degli Usa, ma con due differenze: niente presidenzialismo e più potere ai cittadini che eleggono i membri del Parlamento. La tradizione europea di governo con l’eccezione francese si basa sulla distinzione tra un presidente che svolge funzioni di alta rappresentanza e garanzia costituzionale e un primo ministro che governa con ministri che possono o no appartenere al Parlamento. Poiché questa formula si è dimostrata capace di garantire i più alti livelli di democrazia e di benessere del pianeta, non c’è ragione di stravolgerla, copiando integralmente altri assetti.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- L’EUROPA NON E’ SOLO MANUTENZIONE. L’Europa unita si farà solo con i popoli, e solo se la politica riacquisterà il primato ceduto negli anni ’70 ai mercati. (di Barbara Spinelli).13 settembre 2012, di Federico La Sala
L’Europa non è solo manutenzione
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 12.09.2012)
Una intuizione sul presente disagio della civiltà europea: sulla sfiducia, sul risentimento che monta contro l’Unione. Quel che non convince è il linguaggio dei proponenti, ed è il vuoto di iniziative che l’annuncio prefigura. Non basta affibbiare agli antieuropei un epiteto - populista - che svilisce ogni loro argomento ed è quindi inadatto a reintegrare quel che si sta disgregando. Anche la bellicosa parola lotta è incongrua, soprattutto quando la strategia si riduce a quella che Monti chiama «manutenzione psicologica e politica» di tanto diffuso malessere. Manca l’analisi dei motivi per cui si moltiplicano i moti di rigetto, nati da un’austerità che ha sin qui generato recessione e povertà. Manca soprattutto una rifondazione dell’Unione che vada oltre la manutenzione.
«Io penso semplicemente a una riflessione, non al percorso successivo», così Monti a Sarajevo: come se fosse sufficiente un dibattito, nel quale i medici d’Europa si chinano, sicuri delle proprie ricette, sui pazienti che giacciono ai loro piedi sempre più infermi e meno pazienti. Se così stanno le cose è proprio il percorso successivo che conta, ben più del dibattito. Se quasi tutto un popolo, in Germania, attende il verdetto che domani darà la Corte costituzionale su Fiscal compact e Fondo salva-Stati, e se l’attende nella convinzione che la sovranità del Paese e del suo Parlamento siano stati lesi in nome dell’Europa, vuol dire che siamo in un’epoca di nervosità, di torbidi, nella quale ciascuno Stato e ciascun popolo è in lotta contro il presunto nemico del bene. Chi combatte tali nemici non ha bisogno di mettere se stesso in questione, di inventare farmaci diversi. La colpa è tutta dei populisti, dicono in Italia. È tutta dei debitori, dicono in Germania. Non dimentichiamo che Schuldin tedesco significa due cose, debito e colpa: spostata sul terreno morale, la battaglia si fa cruenta. Non dimentichiamo che Weidmann, governatore della Bundesbank, è sconfitto nella Bce ma vincitore politico in patria.
Occorre dunque che i capi di governo e le comuni istituzioni facciano l’Europa veramente, ne discutano con le società (Parlamenti nazionali, Parlamento europeo), e non si limitino alla gestione psico-politica di popoli minorenni o depressi. Occorre, da parte dei comandanti d’Europa, quella che Albert Hirschmann chiama auto-sovversione, auto-confutazione: non sono fallite solo le misure ma anche le dottrine dominanti, avendo prodotto un’Unione divisa fra creditori e debitori, e aumentato disuguaglianze e povertà. Una lotta d’altro genere s’impone, che conduca all’Europa politica: rifondando ed estendendo i perimetri geografici dell’agire politico, partitico, democratico. Dando all’Unione una costituzione vera, scritta dai popoli rappresentati nel Parlamento europeo e sottratta al “possesso” degli Stati. L’obiettivo non è astratto. Urgono piani di investimento, e una crescita che sarà duratura a patto di cambiare natura (puntando su ricerca, energie alternative, istruzione, comune difesa): solo un governo europeo può farlo - con un bilancio consistente approvato da un comune Parlamento - visto che gli Stati non hanno più soldi. Gli esperti concordano nel dire che i risparmi sarebbero enormi se la crescita fosse fatta in comune, e consentirebbero cali di tasse nei singoli Paesi.
Solo così si dimostrerà che a comandare non sono lontani oligarchi, e che le terapie adottate sono confutabili come è confutabile in democrazia ogni politica, ogni leadership. L’ultima mossa di Mario Draghi è ottima, ma finché a muoversi è un organo tecnico, per legge a-politico, non affiancato da un governo, un Tesoro, un fisco europeo, è mossa insufficiente. Se i politici pensano che il grosso è fatto, grazie a Draghi, si sbagliano: perché tocca a loro l’azione decisiva, e il grosso non consiste né nella lotta ai populisti né nella cura di mantenimento. L’una e l’altra mantengono lo status quo e fanno morire la politica, che in democrazia è ricerca di alternative e conquista di consenso popolare, non di consenso dei mercati. Quelli che vengono definiti populismi sono figli di questo status quo, e di questa morte. Ci s’indigna quando Grillo dice: «I politici sono morti che camminano». Sono parole fatue, essendo rivolte indiscriminatamente a tutti. Ma sono vivi i politici, e la sinistra, e la destra? Se tutti aspettano i governatori della Bce o i giudici di Karlsruhe come si aspetta Godot, vuol dire che c’è del vero nell’ira gridata da Grillo: sono quattro anni che i governi sono impelagati in politiche sterili, che hanno portato paesi come la Grecia a una contrazione di redditi e servizi pubblici senza eguali nel dopoguerra, che hanno azzerato il controllo democratico sui rimedi dell’Unione, e dilatato l’imperio di oligarchie allergiche alla politica per obbligo o per scelta. Che è la manutenzione dell’esistente, se non perpetuare la tara dell’euro-senza-Stato?
L’Europa unita si farà solo con i popoli, e solo se la politica riacquisterà il primato ceduto negli anni ’70 ai mercati. Rinascerà - la politica come professione- se si trasforma alle radici, se le scelte fatte sono riconosciute sterili, come il chicco di grano che solo morendo produce molto frutto. La via non è abolire i partiti, o il contrasto classico destra-sinistra. Il liberalismo si nutre del conflitto fra idee alternative della società, della politica, dell’economia. Il migliore è selezionato nella gara, nella disputa. Dai tempi di Pericle questo è democrazia: «Qui a Atene noi facciamo così. Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. Benché in pochi siano in grado di dare vita a una politica, tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla». Come giudicarla, se chi confuta è ostracizzato come populista? Resta che la disputa dovrà mutare volto, e rotta. Sinistre, destre, partiti, sindacati dovranno dare una dimensione europea a programmi e delibere, e imparare l’agorà dell’Unione. Non possono nascondere a militanti e cittadini che in Europa gli Stati nazione non hanno più gli strumenti per fronteggiare la crisi, che sono troppo piccoli nell’economiamondo. Mai le sinistre riusciranno a salvaguardare il modello sociale e democratico della Comunità postbellica, se l’ottica resta nazionale.
Sovvertire se stessi non significa abolire destra e sinistra, e sognare comitati d’affari che curino, al posto di inetti politici, interessi e poteri di industrie obsolete. Anche questo va ricordato: sono i comitati d’affari che, fidando per trent’anni nelle virtù riequilibratrici dei mercati, hanno causato la crisi del 2007-2008. Auto-confutarsi serve a scoprire quali sono le nuove linee divisorie: tra forze che chiedono un’Unione federale, eforze aggrappate a sovranità nazionali fasulle. Prendere il potere in Europa e non più nella nazione, visto che è lì e non qui che esso si esercita: ecco la missione per sinistre e destre. Un vertice dell’auto-sovversione: questo sì sarebbe benvenuto!
Napolitano ha detto proprio questo, il 6 settembre a Mestre, parlando di nuove mapped’Europa: nell’Unione non esistono discorsi simili, lungimiranti e severi sulle cose fatte e da farsi. Il Presidente ha denunciato i limiti delle misure anti-crisi, e indicato la via d’uscita. I partiti (parafrasando Paul Reynaud, fondatore con Monnet della Ceca) devono europeizzarsi o perire. Non cadono infatti dal cielo, «il ripiegamento, l’immeschinimento, la perdita di autorità della politica». O l’«impoverimento ideale (delle forze politiche), gli arroccamenti burocratici, l’infiacchimento della loro vita democratica, il chiudersi in logiche di mera gestione del potere e di uno scivolare verso forme di degenerazione morale».
Di questo degenerare sono artefici i partiti, non il mercato, e a loro spetta sanarlo, cessando di stipare l’Unione negli armadi della politica estera. Le parole di Napolitano sono altamente realistiche, non retoriche. Invocando l’europeizzazione di Stati, partiti, movimenti, egli cita un padre del federalismo, Mario Albertini: «Il “punto di non ritorno” (dell’unità europea) non potrà essere che propriamente politico. È il momento in cui la lotta politica diviene europea, in cui l’oggetto per il quale lottano uomini e partiti sarà il potere europeo».
Lottare per la conquista del potere in Europa e per il suo controllo democratico: non è missione piccola, per una sinistra che voglia salvare i due pilastri dell’unità europea concepiti nel pieno dell’ultima guerra; il pilastro antinazionalista e quello dello Stato sociale, il Manifesto di Ventotene dell’agosto ‘41 e il rapporto Beveridge sul Welfare del novembre ’42. Anche le destre hanno contribuito al doppio pilastro (da Adenauer e De Gasperi a Kohl): oggi constatiamo che son divenuti custodi delle vecchie sovranità nazionali. È un buon programma, per una sinistra che non vuol perire, come ha fatto per decenni, dedicandosi alla pura manutenzione.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- PER LA GRECIA: EUROPA, VERGOGNA! "Europas Schande":Intristirà il tuo spirito, privato della terra / dal cui spirito, Europa, tu fosti concepita (di Günter Grass).20 agosto 2012, di Federico La Sala
Europas Schande
Ein Gedicht
von Günter Grass *
 Dem Chaos nah, weil dem Markt nicht gerecht,
Dem Chaos nah, weil dem Markt nicht gerecht,
 bist fern Du dem Land, das die Wiege Dir lieh.
bist fern Du dem Land, das die Wiege Dir lieh. Was mit der Seele gesucht, gefunden Dir galt,
Was mit der Seele gesucht, gefunden Dir galt,
 wird abgetan nun, unter Schrottwert taxiert.
wird abgetan nun, unter Schrottwert taxiert. Als Schuldner nackt an den Pranger gestellt, leidet ein Land,
Als Schuldner nackt an den Pranger gestellt, leidet ein Land,
 dem Dank zu schulden Dir Redensart war.
dem Dank zu schulden Dir Redensart war. Zur Armut verurteiltes Land, dessen Reichtum
Zur Armut verurteiltes Land, dessen Reichtum
 gepflegt Museen schmückt: von Dir gehütete Beute.
gepflegt Museen schmückt: von Dir gehütete Beute. Die mit der Waffen Gewalt das inselgesegnete Land
Die mit der Waffen Gewalt das inselgesegnete Land
 heimgesucht, trugen zur Uniform Hölderlin im Tornister.
heimgesucht, trugen zur Uniform Hölderlin im Tornister. Kaum noch geduldetes Land, dessen Obristen von Dir
Kaum noch geduldetes Land, dessen Obristen von Dir
 einst als Bündnispartner geduldet wurden.
einst als Bündnispartner geduldet wurden. Rechtloses Land, dem der Rechthaber Macht
Rechtloses Land, dem der Rechthaber Macht
 den Gürtel enger und enger schnallt.
den Gürtel enger und enger schnallt. Dir trotzend trägt Antigone Schwarz und landesweit
Dir trotzend trägt Antigone Schwarz und landesweit
 kleidet Trauer das Volk, dessen Gast Du gewesen.
kleidet Trauer das Volk, dessen Gast Du gewesen. Außer Landes jedoch hat dem Krösus verwandtes Gefolge
Außer Landes jedoch hat dem Krösus verwandtes Gefolge
 alles, was gülden glänzt gehortet in Deinen Tresoren.
alles, was gülden glänzt gehortet in Deinen Tresoren. Sauf endlich, sauf! schreien der Kommissare Claqueure,
Sauf endlich, sauf! schreien der Kommissare Claqueure,
 doch zornig gibt Sokrates Dir den Becher randvoll zurück.
doch zornig gibt Sokrates Dir den Becher randvoll zurück. Verfluchen im Chor, was eigen Dir ist, werden die Götter,
Verfluchen im Chor, was eigen Dir ist, werden die Götter,
 deren Olymp zu enteignen Dein Wille verlangt.
deren Olymp zu enteignen Dein Wille verlangt. Geistlos verkümmern wirst Du ohne das Land,
Geistlos verkümmern wirst Du ohne das Land,
 dessen Geist Dich, Europa, erdachte.
dessen Geist Dich, Europa, erdachte.Vituperio dell’Europa
 Ad un passo dal caos, perché inetta ai mercati, Europa,
Ad un passo dal caos, perché inetta ai mercati, Europa,
 hai preso le distanze dalla terra che ti ha dato la culla...
hai preso le distanze dalla terra che ti ha dato la culla... quella che sostenevi di «cercare», e trovare «con l’anima»,
quella che sostenevi di «cercare», e trovare «con l’anima»,
 e che liquidi adesso quasi fosse un rottame.
e che liquidi adesso quasi fosse un rottame. Messa nuda alla gogna come una debitrice, soffre la terra
Messa nuda alla gogna come una debitrice, soffre la terra
 cui un luogo comune ti voleva obbligata dalla riconoscenza...
cui un luogo comune ti voleva obbligata dalla riconoscenza... Dannata alla miseria, la terra che i musei arricchisce
Dannata alla miseria, la terra che i musei arricchisce
 dei suoi tesori - preda gelosamente custodita.
dei suoi tesori - preda gelosamente custodita. Fin quelli che con la forza delle armi han funestato
Fin quelli che con la forza delle armi han funestato
 la terra cinta d’isole, con l’uniforme portavano Hölderlin dentro gli zaini!
la terra cinta d’isole, con l’uniforme portavano Hölderlin dentro gli zaini! Ben poca tolleranza or hai per quella terra,
Ben poca tolleranza or hai per quella terra,
 eppur ne tollerasti come alleati, un tempo, i colonnelli!
eppur ne tollerasti come alleati, un tempo, i colonnelli! Al Paese spogliato di tutti i suoi diritti, un Potere
Al Paese spogliato di tutti i suoi diritti, un Potere
 prepotente fa stringere sempre di più la cintola.
prepotente fa stringere sempre di più la cintola. A sfida, veste Antigone di nero; per tutto un Paese
A sfida, veste Antigone di nero; per tutto un Paese
 in lutto è quel popolo, la cui ospitalità tu hai goduto.
in lutto è quel popolo, la cui ospitalità tu hai goduto. Fuori dai suoi confini, un codazzo di Cresi ha cumulato
Fuori dai suoi confini, un codazzo di Cresi ha cumulato
 tutto l’oro che luce dentro i tuoi caveau...
tutto l’oro che luce dentro i tuoi caveau... «Vuota la coppa, avanti!» ti grida la claque dei commissari.
«Vuota la coppa, avanti!» ti grida la claque dei commissari.
 Ma, colma fino all’orlo, con sdegno, Socrate la respinge.
Ma, colma fino all’orlo, con sdegno, Socrate la respinge. Malediranno in coro tutto quanto possiedi
Malediranno in coro tutto quanto possiedi
 gli dèi di cui pretendi espropriare l’Olimpo.
gli dèi di cui pretendi espropriare l’Olimpo. Intristirà il tuo spirito, privato della terra
Intristirà il tuo spirito, privato della terra
 dal cui spirito, Europa, tu fosti concepita.
dal cui spirito, Europa, tu fosti concepita.* ([Testo di Günter Grass, pubblicato il 25/5/2012 sul Sueddeutsche Zeitung. Traduzione di Franco Farina)
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- La storia d’Europa sta precipitosamente cambiando.l nuovo feudalesimo e la sovranità perduta (di Guido Rossi)6 agosto 2012
Il nuovo feudalesimo e la sovranità perduta
di Guido Rossi (Il Sole-24 Ore, 05 agosto 2012)
È ora evidente che, dopo la presa di posizione della Bce in difesa dell’euro e per il sostegno dei titoli del debito pubblico dei Paesi che ne richiedano un intervento, la storia d’Europa sta precipitosamente cambiando.
Una vera ambigua battaglia si è scatenata fra la troika (composta dalla Bce, l’Fmi e le istituzioni europee dominate dall’ideologia cultural-politica tedesca, che impone punizioni e austerità agli Stati peccatori) e l’amica/nemica della troika, la grande speculazione finanziaria la quale, come s’è visto nei giorni scorsi, toglie ogni credibilità al dio mercato, in un’altalena di perdite e guadagni razionalmente ingiustificata.
Che una decisa politica anti-spread rivendicata dalla Bce possa in qualche misura osteggiare la speculazione è conseguenza indiscutibile, ancorché in difetto di un’Europa politicamente unita e democratica il prezzo che si fa pagare ad alcuni Stati membri è altissimo. Oltre alle misure di politica economica e sociale, rovinose e depressive, e già imposte, dal fiscal compact alla spending review, altre ne saranno intimate agli Stati che chiederanno l’aiuto contro lo spread per mantenere il pareggio di bilancio. Tra quelli che, per molti versi non parevano ancora, fino a non molto tempo fa, destinati al fallimento, v’è ora la Spagna e poi probabilmente, nonostante le sovente contraddittorie, ma sempre ostentate dichiarazioni, l’Italia.
Si sta così ripetendo un fenomeno che Montesquieu, commentando le leggi feudali dell’Europa medievale, le considerava un avvenimento accaduto una volta sola nel mondo e «che forse non accadrà mai più». Ebbene, Montesquieu si sbagliava. Infatti, allora come oggi, insieme alla brutalità del comando, è determinante il dominio dell’economia sulla vita pubblica e sui diritti e soprattutto la confusione fra la ricchezza e l’autorità. Allora si trattava della ricchezza terriera, oggi della ricchezza finanziaria.
Come allora, il presupposto si giustifica con lo "Stato di eccezione", teorizzato da Karl Schmitt, che comporta la rigida soggezione economica della moltitudine ad alcuni potenti, siano essi finanzieri, tecnici o burocrati, poco importa. Quella attuale è la nuova forma di feudalesimo, che sottrae la sovranità agli Stati e alle sue istituzioni: si potrà forse dire non schiave, ma ridotte spesso, con ingiustificata presunzione, a semplici esecutori di politiche economiche, monetarie e sociali, imposte non certo democraticamente dal di fuori.
Il trasferimento della sovranità dello Stato democratico al Leviatano tecnocratico della troika, passaggio invero che sembra obbligato per arrivare all’unica possibile soluzione di un’Europa politicamente unita e democratica, comporta quindi una revisione totale dei diritti dei cittadini e delle istituzioni democratiche, assopite nelle loro funzioni e dedite ormai solo all’esecuzione delle decisioni di gerarchie esterne e fuorvianti.
È così che i problemi del rispetto dei diritti umani e della giustizia sociale, insieme con i mali peggiori delle disuguaglianze, tra le quali domina la disoccupazione, diventano trascurabili e importano solo un vago richiamo a parole che han perso il loro significato, sicché secondo il pensiero del grande poeta W. Auden: «When words lose their meaning, physical force takes over». E qui la forza è quella del feudalesimo della troika, poiché ciò che conta è solo l’imposizione dell’austerità, sempre più regina della depressione economica.
Pare allora persino inutile, come già ricordai altra volta avevano fatto Benedetto Croce e Luigi Einaudi, scagliarsi ai tempi delle crisi contro i governi tecnici, poiché, come appare evidente, l’insieme dei partiti politici, per quel che riguarda non solo noi, ma anche altri Paesi, sono in devastante disgregazione programmatica e sempre più portati a vaniloquio politico, alimentato da conflitti interni di modesta levatura. Tecnici e politici di professione son del tutto eguali.
Questa inquietante crisi della democrazia politica, alla quale il degrado culturale della nostra classe dirigente non ha opposto alcuna resistenza, mette sempre più in pericolo sia la democrazia, sia la giustizia sociale. Il fenomeno non pare affatto destinato a processi di inversione, che solo una politica di unificazione europea potrebbe modificare, o un radicale rinnovamento di fronte alle prossime scadenze elettorali del personale politico.
Per il momento, tuttavia, ancora una volta, la descrizione più appropriata della nostra stagione politica ci viene dai noti versi di Giuseppe Ungaretti: «Si sta come / d’autunno / sugli alberi / le foglie», al quale può fare oggi giusta eco Vincenzo Cardarelli: «Autunno. Già lo sentimmo venire / nel vento d’agosto».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- L’appello alla morale naturale non sempre è sufficiente. Gli egoisti solidali. Se all’Europa conviene aiutare i paesi più deboli (di Tzvetan Todorov)1 agosto 2012, di Federico La Sala
 Gli egoisti solidali.
Gli egoisti solidali.
 Se all’Europa conviene aiutare i paesi più deboli
Se all’Europa conviene aiutare i paesi più deboli di Tzvetan Todorov (la Repubblica, 1 agosto 2012)
di Tzvetan Todorov (la Repubblica, 1 agosto 2012)La popolazione degli stati europei è costantemente sollecitata a venire in aiuto di coloro che stanno peggio, vittime di catastrofi naturali, o di guerre civili e internazionali, o dell’incuria dei loro dirigenti. Ma dove trovare delle ragioni per andare a soccorrere gli altri, e dunque accettare dei sacrifici?
Prima risposta suggerita: nella morale. La grande tesi delle religioni monoteiste, ripresa dalla maggioranza delle correnti filosofiche, è che la natura umana è cattiva: se l’uomo fosse subito virtuoso, a che pro caricarsi un dio? In quest’ottica, la morale è un’acquisizione tardiva e artificiale; il comportamento delle bestie è inevitabilmente bestiale, il progresso dell’umanità consiste nel distaccarci dalla nostra condizione animale. Senza costrizione, controllo, educazione, gli esseri umani si comportano da puri egoisti, come aggressori senza scrupoli, impegnati a lottare, nel corso della loro intera esistenza, per la conquista di un posto migliore.
Questa opposizione tra natura e morale, realtà e volontà, comporta un rischio: che rinunciamo a costruire una diga per frenare i nostri desideri e scegliamo invece di conformarci a ciò che la scienza ci insegna sulla natura del mondo. I difensori di questa opinione hanno creduto di trovare un solido appoggio nelle teorie di Darwin e dei suoi discepoli sull’evoluzione delle specie. Dato che, per migliorare la specie, i deboli e i “difettosi” vengono eliminati presso le altre specie animali, non dovremmo procedere allo stesso modo anche nel caso degli umani?
Nei primi decenni del secolo XX, numerosi paesi occidentali (Stati Uniti, Canada, paesi scandinavi) hanno già votato delle leggi eugeniste e proceduto a delle sterilizzazioni forzate. La Germania nazista ha adottato una politica di sterminio di individui e di razze ritenuti inferiori. Ai nostri giorni, trasferiamo gli stessi principi in altri campi: dato che la competizione dice la verità della vita, affermano i teorici del neoliberalismo, la società migliore è quella che lascia libero corso alla concorrenza e al mercato libero da ogni costrizione.
In realtà, la posizione di Darwin è molto più complessa. Rinunciando decisamente a qualsiasi idea di progetto divino e quindi anche di progresso, sia esso dovuto alla provvidenza o alla storia, egli insiste sul fatto che la differenza tra gli animali e gli uomini è di grado, non di natura. Anche le basi della morale si ritrovano già presso le altre specie. E, da qualche decennio, dei lavori pionieristici condotti dai primatologi, da specialisti della preistoria o da antropologi che lavorano su popolazioni di cacciatori-raccoglitori hanno constatato la presenza, dalle origini della specie umana, di atteggiamenti di compassione e di cooperazione, senza i quali i nostri antenati non sarebbero riusciti a sopravvivere.
Allo stesso tempo, basta guardarsi intorno per constatare che i rapporti umani non si reggono solo sulla cooperazione generosa. La natura non ci impone la guerra di tutti contro tutti, ma nemmeno la benevolenza sistematica. Il buon selvaggio è tanto immaginario quanto il cattivo selvaggio. Bisogna ammettere che questi due tipi di comportamento trovano origine nella nostra natura animale, ma che il predominio dell’uno o dell’altro dipende dalle circostanze. L’errore consiste, innanzi tutto, nell’ignorarne uno a detrimento dell’altro.
È come nell’eterna disputa tra innato e acquisito, donato e voluto: attenersi a uno dei termini escludendo l’altro può comportare delle conseguenze disastrose. Alla riduzione degli individui alla loro eredità biologica presso i nazisti, corrisponde presso i bolscevichi la convinzione che la volontà non trovi alcun limite e che, sia con le piante che con gli uomini, possiamo sempre ottenere il risultato voluto. È così che la Russia si è coperta di una rete di campi che avrebbero dovuto assicurare la rieducazione del popolo.
Le reazioni morali di compassione e di cooperazione dipendono in particolare da tre variabili: il grado di prossimità tra il benefattore e il beneficiario; il posto che occupa la vittima nella scala del potere; la gravità del disastro. L’aiuto reciproco va da sé tra membri intimi di una famiglia, è scritto nella legge tra concittadini (solidarietà nei confronti degli anziani e dei malati), è presente ma problematico tra le nazioni dell’Unione Europea; e, per quanto riguarda il resto dell’umanità, è presente solo nel caso di un’immensa sventura, tsunami o genocidio, o di vittime impotenti, come i bambini. D’altro canto, la caduta di chi era potente, lungi dal provocare la compassione, suscita nella maggior parte di noi una sorta di godimento, come se l’ordine del mondo fosse stato ristabilito. Gli uomini-formica non hanno compassione per le disgrazie degli uomini-cicala, ritenuti responsabili del loro destino.
L’appello alla morale naturale non sempre è sufficiente per superare il nostro egoismo. La ragione può intervenire a sua volta, dimostrandoci che seguire solo i nostri interessi immediati ci impedisce di favorire i nostri interessi a lungo termine. Il puro egoismo distrugge gli altri intorno a noi, ma la nostra felicità dipende da loro: abbiamo bisogno di essere amati e di amare a nostra volta. (Traduzione di Luis E. Moriones)
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Alle origini del nome Europa. Da dove viene? (di Bruno Bongiovanni)1 luglio 2012, di Federico La Sala
Alle origini del nome Europa
di Bruno Bongiovanni (l’Unità, 01.07.2012)
- L’EUROPA, NONOSTANTE I TIMORI DEI GIORNI SCORSI, E LE MOSTRUOSE VOLGARITÀ DEI QUOTIDIANI BERLUSCONOIDI, HA FATTO UN PASSO AVANTI.
Da dove viene? Il toponimo arriva dal greco «Europe», che significa qualcosa di simile ad Occidente, tanto è vero che, pur non riferendosi sempre allo stesso spazio quando ne discorrevano, sin dall’inizio i geografi hanno considerato l’Europa, più che un continente autonomo, la penisola occidentale dello sconfinato Oriente asiatico. Tale penisola si protende dagli Urali per arrivare sino all’Atlantico. Dal che si deduce che questo eurospazio non è stato un’invenzione di De Gaulle.
L’Europa è stata, del resto, anche una figura della mitologia greca. Zeus la rapì. Ebbero tre figli, tra cui Minosse, che diede vita alla civiltà cretese. Il nome Europa, da quel momento, indicò le terre poste a nord del Mediterraneo. Già gli Assiri, comunque, avevano definito Ereb (Europa?) ciò che per loro era l’Occidente. E Asu (Asia ?) i paesi del Sol Levante.
Il termine compare poi anche in latino e per Plinio è la parte del mondo che si protende dall’Ellesponto sino all’Atlantico. Né manca l’Euro, che non è solo la (quasi) comune moneta dell’Unione, in circolazione dal gennaio 2002, ma anche il vento che spira da sud-est, tanto da essere sinonimo di Levante (la parte dell’orizzonte dove si leva il Sole). Esiste inoltre, onde cogliere il legame tra le due realtà, il termine Eurasia. Non è stato d’altra parte precoce l’uso moderno e politico del termine Europa. La quale, in particolare dopo l’invasione dei Balcani da parte dei turchi, era il mondo cristiano in contrasto con l’Islam.
L’autonomizzazione del termine politico-diplomatico-pluristatale Europa, rispetto al termine geo-religioso-civilizzatore cristianità, si ebbe nel ‘700. Fu questo il periodo del rafforzarsi degli Stati, dell’inizio della globalizzazione contemporanea. Non a caso l’aggettivo europeo comparve nello stesso ‘700. Per la sua semantizzazione unitaria si è iniziato nel 1992 dall’economia. Ma è la politica il fine.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- GRECIA. NOI E LORO (di Luciano Canfora) - Oreste, Ulisse, Antigone: quei modelli che orientano ancora il nostro presente (di Eva Cantarella)17 giugno 2012, di Federico La Sala
 Grecia. Noi e loro
Grecia. Noi e loro
 Dall’ideale democratico alla tirannide dei molti
Dall’ideale democratico alla tirannide dei molti
 Il moderno lessico politico forgiato sull’Acropoli
Il moderno lessico politico forgiato sull’Acropolidi Luciano Canfora (Corriere della Sera, 17.06.2012)
Un bell’insegnamento del pensiero politico ateniese è che non si deve rischiare di cadere in schiavitù per debiti. Fu Solone (arconte nel 594/3 a. C.) a far sì che si affermasse questo principio. Egli cancellò i debiti per i quali il pegno era il terreno del debitore o addirittura la sua libertà personale. Il debito non può essere un’ipoteca su esseri umani e perciò, in nome della libertà, va cancellato. Questo principio coraggioso imbarazzerebbe molti «finanzieri» del tempo nostro nonché i responsabili delle strutture bancarie, che sull’altrui indebitarsi prosperano. Del resto una forte corrente di pensiero politico moderno, nella seconda metà del secolo XX, su impulso di una figura notevole come François Mitterrand, pose il problema della cancellazione del debito di alcuni Paesi del Terzo e Quarto Mondo. Fu una scelta schiettamente «soloniana» che, nel tempo, ha dato frutti positivi.
Solone seppe anche andare ad imparare dagli altri, da popoli di antichissima civiltà come gli Egizi. Una scelta - questa - che si pone agli antipodi rispetto all’autosufficienza miope. Solone fu anche allarmato preconizzatore dei rischi del potere personale, della «tirannide». «Tirannide» - termine che vive in tutte le civiltà politiche - è parola greca dal significato, in origine, non negativo. Indicò dapprima un ruolo di mediatore piuttosto che di despota.
Caratteristica del «tiranno» era, in ogni caso, l’assunzione di un ampio potere, fondato su di un iniziale consenso ma ben presto protratto senza limiti di tempo e sorretto con strumenti quali la guardia del corpo armata e la violenza contro gli oppositori non remissivi. Solone previde questo sviluppo della «tirannide» che un abile demagogo, Pisistrato, era riuscito ad assumere in Atene (561-527 a. C. con un intervallo ed un plateale «rientro»). Inizialmente era stato lo stesso demo di Atene (il popolo sovrano) ad attribuirgli una guardia del corpo armata come strumento e garanzia di potere. Per noi «tirannide» è nozione totalmente priva di sfumature positive. Ed anzi, come afferma il nipote di Pericle, Alcibiade, parlando, da fuggiasco, al cospetto degli Spartani (415 a.C.), «la democrazia si è costituita e ha preso forma e nome, in Atene, come antitesi della tirannide» (Tucidide, VI, 89, 4).
Nel lessico ateniese «popolo» (demo) e «democrazia» sono sinonimi: anzi «popolo» è parola che indica al tempo stesso sia il soggetto sociale della democrazia (il popolo) che il regime politico fondato sul potere popolare (democrazia). Spesso si dimentica questa peculiarità lessicale, che è anche sostanza. La legittimità della democrazia ad Atene è fuori discussione nel momento in cui essa è la forma politica che si identifica con la comunità stessa.
Che la tirannide nascesse da un significativo consenso popolare era però fenomeno imbarazzante. I critici della democrazia ponevano perciò l’accento proprio sull’elemento tirannico insito, a loro giudizio, nella democrazia. Elemento tirannico che si presenta sotto due aspetti: la incontrollata imposizione di una volontà popolare (la «dittatura di maggioranza» che si pone al di sopra della legge) e la nascita dall’interno stesso del meccanismo assembleare-democratico di figure demagogiche particolarmente influenti e carismatiche, che realizzano di fatto una forma di «tirannide», o meglio di potere che gli avversari ritengono di poter definire tirannide.
Naturalmente tutto ciò appare a noi oggi come esperienza tutt’altro che remota, anzi senz’altro vivente e attuale. Oltre tutto le parole con cui tutto questo genere di fenomeni si esprime sono le medesime che adoperiamo noi oggi, e nelle più diverse lingue (democrazia in particolare è diventata sic et simpliciter anche parola turca). Ma una avvertenza è necessaria: la diretta gestione del potere da parte di una «assemblea popolare» (assemblea dei detentori della piena cittadinanza) è tutt’altra cosa rispetto alla procedura elettiva che produce una rappresentanza (cui, quando esisteva la piena sovranità nazionale, gli elettori delegavano il potere esecutivo). Resta il fatto che anche la viva percezione dei modi, talvolta sottili e graduali, onde un regime politico trapassa in un altro era ben viva nella teoria politica greca.
Ciò si coglie non solo nella creazione di «doppi» negativi di forme politiche positive (monarchia/tirannide; aristocrazia/oligarchia; democrazia/oclocrazia) ma soprattutto nella descrizione del «ciclo», che è implicito già nel dialogo costituzionale erodoteo e culmina nella formulazione esplicita e quasi pedantesca di Polibio (nel VI libro delle Storie). Una formulazione talmente chiara e completa da apparire illuminante al Machiavelli che la immise di peso nel primo libro dei Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio. Ma proprio questo arrovellarsi intorno al modo in cui la «volontà popolare» può lasciarsi deviare fino ad autodistruggersi è problematica nostra e sommamente moderna. Anche noi oggi sappiamo bene che il trapasso da un modello politico in un altro di segno ben diverso può avvenire per progressivi slittamenti, non necessariamente per bruschi salti.
Il pensiero politico greco si è anche posto il problema del valore di una nozione a prima vista solo numerica quale «maggioranza». I critici (ed erano numerosi) della procedura decisionale a maggioranza (cioè democratica) ponevano, in toni talora accesi talora pacati, la questione della competenza come pietra miliare da opporre alla mera legge del numero. Né si può dire che siano stati escogitati argomenti particolarmente convincenti in antitesi a tale obiezione. (Semmai si può osservare che Aristotele, nella Politica, approda alla svalutazione della «legge del numero» per altra via, quando osserva che democrazia non è il governo della maggioranza ma il governo dei poveri, i quali peraltro - soggiunge - spesso sono anche maggioranza).
L’istanza ricorrente del necessario predominio della competenza era tipica della critica oligarchica alla democrazia (Platone, Crizia etc.). Di fatto però competenza era un modo eufemistico per dire ricchezza. In tempi a noi più vicini quella istanza divenne l’architrave della critica di parte liberale alla democrazia (per tutto il secolo XIX questa fu la contrapposizione dominante, specie in Europa). In tempi a noi ancor più vicini la prevalenza del principio democratico su quello liberale, affermatasi ad es. nelle codificazioni «costituzionali» del secondo dopoguerra, è venuta declinando, e ha ceduto il passo al ritorno in grande stile del predominio dei «competenti»: o di coloro che, intrinseci al mondo arduo della finanza, si pretendono tali.
Oreste, Ulisse, Antigone: quei modelli che orientano ancora il nostro presente
di Eva Cantarella (Corriere della Sera, 17.06.2012)
Parlare dell’eredità che i greci ci hanno lasciato è il minimo che si possa fare, in giorni come questi. Quali che siano le condizioni, gli errori e le responsabilità di ciascuno di noi, sarebbe non solo ingiusto ma profondamente sbagliato dimenticare che senza quello che i greci ci hanno insegnato noi non saremmo quello che siamo. Il che non significa, sia ben chiaro, tornare a mitizzarli, come per troppo tempo si è fatto parlando dei loro presunti valori universali e della altrettanto presunta eternità di questi.
Quel che dobbiamo fare, insomma, non è tornare a parlare della Grecia a proposito della quale, per intendersi, i libri di scuola parlano ancora, talvolta, di «miracolo greco». Di quella Grecia mitizzata la storiografia da alcuni decenni ha dimostrato l’irrealtà. È a un’altra Grecia che ci lega il nostro debito, quella vera, finalmente sottratta al mito, lontana e diversa da noi; ma nella quale affondano, tuttavia, alcune tra le più importanti conquiste del nostro pensiero, e le origini delle nostre istituzioni politiche e giuridiche. Come stanno a dimostrarci - tra l’altro - i loro miti. A cominciare da quello messo in scena da Eschilo, nel 458 a. C.: il mito di Oreste.
Agamennone, racconta Eschilo nell’Orestea, torna vittorioso dalla guerra di Troia. Sua moglie Clitennestra, diventata nel frattempo l’amante del cognato Egisto, con la complicità di questo lo uccide. A indurla a farlo, oltre alla smania di potere, sta il fatto che Agamennone ha ucciso la figlia Ifigenia, sacrificandola agli dei per ottenere un vento favorevole alla navigazione verso Troia, e tornando dalla guerra ha portato con sé una concubina, che Clitennestra uccide insieme a lui. Ma vendetta chiama vendetta, e Oreste, figlio di Clitennestra e di Agamennone, vendica il padre uccidendo la madre. Ed ecco le Erinni, le antiche dee della vendetta, esigere altro sangue in cambio del sangue di Clitennestra. Gli implacabili mostri, che stillano sangue dagli occhi, perseguitano Oreste, ovunque egli vada. Sino al momento in cui interviene Atena: a risolvere la questione, dice la dea, istituirò un tribunale, nel quale siederanno come giudici i migliori cittadini, estranei ai fatti e imparziali, che giudicheranno dopo aver accertato i fatti, valutando colpe e responsabilità. Il mondo della vendetta è finito. La narrazione mitica celebra l’avvenimento che ha segnato una tappa fondamentale della storia non solo di Atene, ma della nostra civiltà giuridica: non esiste responsabilità senza colpa regolarmente accertata da un organo giudicante.
Ma dal mito non vengono solo insegnamenti fondamentali come questo. In esso troviamo anche degli archetipi che ci accompagnano ancora, nei quali riconosciamo le motivazioni dei nostri comportamenti e le caratteristiche della nostra personalità.
Prendiamo ad esempio il mito di Ulisse. Itaca, come ben noto, è stata spesso intesa come una metafora: «Se cerchi la tua strada verso Itaca - scrive Kavafis, in una bellissima poesia - spera in un viaggio lungo,/avventuroso e pieno di scoperte./ I Lestrigoni e i Ciclopi non temerli/non temere l’ira di Poseidone./...Non hai bisogno di affrettare il corso/fa che il tuo viaggio duri anni, bellissimi,/e che tu arrivi all’isola ormai vecchio,/ricco di insegnamenti appresi in via...». Non è volontà di un dio (come fu, per Ulisse, l’ira di Poseidone), a determinare il tuo viaggio: sei tu l’artefice della tua sorte - dice Kavafis - sei tu il padrone della tua vita. Quanti sono, oggi, gli Ulisse che affrontano pericoli apparentemente insuperabili, come fece Ulisse affrontando i Lestrigoni e i Ciclopi? Quanti sono coloro che si avventurano verso incontri con un inconoscibile che invece si può conoscere? Come Ulisse entrò nell’Ade, il mondo dei morti, noi, oggi, ci confrontiamo con le conquiste e i misteri delle scienze e della tecnologia. Ulisse è tra noi, Ulisse siamo noi, possiamo incontrarlo. Esattamente come incontriamo Antigone o Creonte, i protagonisti della tragedia più bella di Sofocle e, forse, di tutte le tragedie greche.
Nata dal matrimonio incestuoso tra Edipo e sua madre Giocasta, dopo la tragica fine dei genitori Antigone vive a Tebe, governata dallo zio Creonte, fratello di sua madre, ed è fidanzata con il figlio di questi, Emone. I suoi due fratelli, Eteocle e Polinice, in lotta per il potere sulla città, si sono affrontati in battaglia e sono morti: Eteocle difendendo una delle sette porte della città, Polinice dandole l’assalto. E Creonte decreta: chi oserà dar sepoltura al suo cadavere sarà lapidato. Ma Antigone viola il divieto, per lei il dovere di dare sepoltura al fratello è più forte di ogni legge umana. E quando viene scoperta difende le sue ragioni di fronte a Creonte, che sostiene le proprie. Creonte afferma il dovere, anche per lui, di rispettare le «leggi scritte», che gli impongono di metterla a morte. Ma a queste leggi, dettate dal potere politico, Antigone oppone quelle «non scritte», vale a dire le regole etiche da lei sentite come imprescindibili.
Sono due sistemi di regole diverse: qui sta il dilemma tragico. Nessuno dei due contendenti ha ragione, nessuno dei due ha torto. O meglio: ambedue hanno ragione, ambedue hanno torto. Creonte è un politico con un forte senso dello Stato, Antigone non è non un’anarchica, ma rifiuta di rispettare una regola a suo giudizio senza fondamento etico. La tragedia si conclude, inevitabilmente, con la fine di ambedue i contendenti. Antigone, condannata a morire, si impicca. Il suo fidanzato, Emone, si uccide sul cadavere di lei. Alla notizia della morte del figlio si uccide anche Euridice, la moglie di Creonte: un uomo finito, ormai, moralmente annientato. Una storia, greca, anch’essa presente fra noi: la morte fisica di Antigone e quella morale di Creonte sono la fine inevitabile del conflitto che si ripropone quando un individuo, un gruppo, un popolo non riconoscono il fondamento etico di una regola di diritto, anche in un sistema legittimo e «giusto». Anche per questo i greci sono presenti tra noi, ecco perché senza di loro saremmo diversi.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- GRECIA. NOI E LORO. Da Byron a Foscolo, quando l’Europa romantica lottava (e moriva) per l’indipendenza di Atene (di Antonio Ferrari)17 giugno 2012, di Federico La Sala
Da Byron a Foscolo, quando l’Europa romantica lottava (e moriva) per l’indipendenza di Atene
di Antonio Ferrari (Corriere della Sera, 17.06.2012)
Il più grande e celebrato è sempre l’inglese Lord Byron: del suo nome, adorato dai greci come un eroe della mitologia, c’è traccia autografa persino sulle pietre del tempio di Poseidone, nella magica cornice di capo Sounion, a meno di un’ora d’auto dal centro di Atene. Il più struggente è Eugène Delacroix, il pittore che fu il leader della scuola romantica francese: i suoi dipinti più ammirati e amati in assoluto sono «La Grecia sulle rovine di Messolonghi» (1826) e il «Massacro di Chios» (1824).
Ma non ci sono solo Lord Byron e Delacroix a contendersi il cuore di un intero Paese negli anni frenetici ed esaltanti della conquista della libertà. Ah, quanto genuino trasporto europeo e quanta passione romantica, all’inizio dell’800, per la Grecia, considerata non soltanto un Paese con una storia grandiosa, ma un prezioso e irrinunciabile valore collettivo! Soprattutto vi erano calore e partecipazione alla sua lotta per conquistare finalmente l’indipendenza, liberandosi dall’occupante turco che aveva obbligato la culla del pensiero classico, della filosofia, della scienza a sopportare i ceppi dell’oppressione ottomana. Il movimento filellenico, guida di una rivolta ideale, fu infatti l’elisir politico che attraversò quasi l’intera Europa, esaltata dalla rivoluzione napoleonica e assetata di grandi ideali e di nuovi equilibri.
È interessante e curioso, per esempio, che in quegli anni di travolgenti e contagiose passioni, si sia stretto un roccioso legame di fratellanza (che poi resisterà a prove assai più ardue nel secolo successivo, con la guerra insensata e fatale di Mussolini) tra la Grecia e l’Italia, unite entrambe da pulsioni indipendentiste e dal desiderio di creare una sorta di alleanza mediterranea. Quell’alleanza di cui sentiamo la lancinante mancanza oggi, con il predominio degli interessi del Nord Europa, convinto d’essere il baricentro, quindi l’esclusivo cuore pulsante dell’Unione.
Un uomo, un piemontese, un nobile italiano, diventato una bandiera di quel momento storico, il conte Santorre De’ Rossi di Santarosa, cadde in Grecia combattendo, armi in pugno, per la libertà del Paese che era andato generosamente a soccorrere, e per cementare i primi vagiti del nostro Risorgimento. Lo ammazzarono sull’isola di Sfacteria, non lontano da Navarrino. Forse - così almeno raccontano i reporter dell’epoca - i vincitori ottomani lo avrebbero risparmiato se ne avessero avuto dei vantaggi. Ma il conte non era benestante. L’unica ricchezza erano il suo cuore e il suo coraggio di combattente e di resistente.
Santarosa, troppo spesso dimenticato, rappresenta in sostanza la presenza italiana all’interno di quella comunità liberale che riconosceva alla Grecia un ruolo essenziale per la cultura europea. Nasce così il filoellenismo, che si nutre della straordinaria influenza di un mondo intellettuale e borghese che non vede l’ora di mobilitarsi per sostenere una causa nobile.
All’inizio dell’800, e precisamente nel 1819, uno dei massimi poeti italiani, Ugo Foscolo, diventò autorevole portavoce delle aspirazioni greche. La madre di Foscolo era greca, la terra e il mare che amava erano quelli della sua piccola Zante. Tuttavia, al di là dell’appartenenza familiare, vi era nel poeta, già celeberrimo nei salotti di tutta Europa, il desiderio di lasciare il suo sigillo nel corpo fragile di una causa giusta. A Milano, Venezia, Torino, Genova, Parigi e Londra i suoi straordinari Sepolcri, pubblicati in una prima edizione di 102 copie dall’editore-stampatore Nicolò Bettoni di Brescia, gli avevano assicurato una fama che diventerà quasi immortale. La produzione del poeta, assai contenuta rispetto agli altri grandi della letteratura italiana, era la preziosa dote della grandezza dell’autore. Estroverso, passionale, travolgente, infantile, a volte rancoroso, soprattutto nei confronti dell’uomo che in tante occasioni l’aveva trattato con affetto e comprensione quasi filiale: Vincenzo Monti.
Foscolo, da un episodio apparentemente marginale, cioè un cinico scambio, come spesso è accaduto nella storia, si schiera senza se e senza ma a fianco della Grecia. L’episodio è la cessione ai turchi, da parte degli inglesi, del villaggio di Parga, per ottenere come contropartita il protettorato delle isole dello Ionio. Foscolo, che adorava la sua terra materna, scrisse allora un duro ma colto e appassionato articolo sulla Edinburgh Review, confutando, punto per punto, la decisione di Londra, e trasformando Parga, villaggio frontaliero di dubbia fama (secondo i britannici) in una avanzata diga occidentale contro lo strapotere imperiale ottomano.
In realtà, più che il contenuto, è rilevante un dettaglio: che in quel clima intellettuale davvero cosmopolita, un italiano si occupasse della causa greca scrivendo con competenza e prestigio su una rivista inglese. In una prestigiosa e recente pubblicazione sul blog «La Storia contemporanea», si attinge ad una fonte assai importante. Si tratta del Risorgimento in esilio, a cura del professor Maurizio Isabella, tra i maggiori storici internazionali. Nel testo si parla con documentata profondità del dissidio dell’epoca fra filelleni italiani e inglesi, riguardo - ci risiamo - «alla gestione del denaro raccolto dal London Greek Committee a favore dei greci». Infatti, da un lato vi sono i leader inglesi, dall’altro gli italiani: «I primi - scrive Storia contemporanea - puntano a far sì che il denaro venga gestito direttamente dal Comitato, non fidandosi dell’uso che ne avrebbero fatto i greci. I quali invece, secondo gli italiani, dovevano gestire direttamente i fondi». In sostanza, «dietro lo scontro vi è l’obiettivo degli italiani di veder nascere un governo greco forte e indipendente; per gli inglesi, invece, la questione dell’indipendenza era assolutamente secondaria. Lo scopo era che in Grecia si affermassero i diritti civili».
Eppure, nonostante queste divergenze, è stato proprio un inglese a legare la sua vita e il suo destino all’indipendenza greca. Proprio quel Lord Byron, che fu celebrato in vita per i suoi eccessi (enormi debiti, storie d’amore travolgenti, scandali) ma anche per la sua incontenibile generosità. Morì durante la battaglia di Missolungi. Non colpito dal fuoco nemico ma da una malattia. Un’infezione fatale. Se ne andò giovanissimo, a 36 anni, come tanti eroi. Il suo nome è stato scolpito nel marmo, assieme a tutti coloro che contribuirono alla guerra per l’Indipendenza greca. È la lista di filelleni che il Museo storico di Atene mostra con fierezza ai visitatori. Oggi, in uno dei momenti più difficili della storia del Paese, la Grecia corre però un rischio serio, quello di dividere l’intero universo del 2012 in due squadre: filelleni e antielleni. Il significato è evidente: amici o nemici. Il sottinteso è altrettanto chiaro: chi ci critica duramente è un nemico. Come se tutte le ragioni fossero di Atene, e tutti i torti degli altri.
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- UNA INIZIATIVA E UN APPELLO. "Siamo tutti ebrei greci" ... Se non saremo in grado di realizzare il Sogno Europeo, saremo condannati allo stesso incubo in Grecia e nel resto d’Europa.28 maggio 2012, di Federico La Sala
"Siamo tutti ebrei greci"
Iniziativa antirazzista in Europa
- Un gruppo di intellettuali, politici, attivisti per la difesa dei diritti umani lancia con questo editoriale, pubblicato in contemporanea su varie testate europee, un appello alla mobilitazione contro le spinte razziste, antisemite, xenofobe che stanno emergendo in vari Paesi dell’Unione. A partire dal successo elettorale di Alba dorata in Grecia. Ecco il testo, cui seguirà la pubblicazione online di un appello aperto alle firme del pubblico *
Uno scossone: il 6 maggio il partito neo nazista Alba dorata ha fatto il suo ingresso nel Parlamento greco. Il partito "Alba Dorata"- con il suo emblema ispirato alla svastica, il saluto hitleriano Mein Kampf come riferimento, l’ideologia razzista e anti semita, il negazionismo, la sua violenza nei confronti di immigrati, la sua lotta contro il giornalismo, il suo culto della personalità - è l’erede diretto del partito nazionalsocialista che ha portato l’Europa e il mondo intero verso il caos e l’eccidio.
La Grecia, purtroppo non è l’unico paese con questa tendenza al ritorno all’ideologia nazista. In Lituania, quest’anno, per la prima volta, il Presidente della Repubblica ha sostenuto la marcia annuale delle Waffen SS nonostante le forti critiche sollevate.
In Austria il Partito delle Libertà Austriaco - FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs; un’organizzazione estrema di destra - che nutre nostalgia per il Terzo Reich è tra i favoriti nei sondaggi per le prossime elezioni parlamentari. In Ungheria il "Movimento della Guardia ungherese" discendente del Partito delle Croci Frecciate - la precedente milizia responsabile dello sterminio di ebrei e nomadi - ha avuto la responsabilità diretta di attacchi e omicidi contro nomadi e terrore nei confronti delle popolazioni ebraiche.
Questa rinascita è stata possibile grazie all’attacco sistematico da parte di partiti di estrema destra all’aspirazione di "unione", l’ideale repubblicano secondo cui tutti appartengono alla comunità nazionale. Questa campagna contro "l’unione" è modellata sulla strategia di Geer Wilder per il suo partito per la libertà agli inizi del 2000. Il nucleo di questa strategia è di nascondere il discorso della disuguaglianza delle razze dietro la maschera culturale della lotta contro la cosiddetta "islamizzazione dell’Europa".
Nel contesto di crisi economica e sociale in cui viviamo, un contesto che favorisce la ricerca frenetica di capri espiatori, e che rafforza il timore del declino del Vecchio Continente, questa strategia si è dimostrata, purtroppo efficiente a livelli preoccupanti.
Inoltre ha consentito presumibilmente il processo di legittimazione dei partiti di estrema destra nel sostenere o addirittura diventare membri di coalizioni governative e ha favorito la "normalizzazione" di discorsi razzisti e antisemiti in Europa.
Infine, il presunto Diritto Estremo "nuovamente nobilitato" ha aperto la strada alle organizzazioni con cui condivide il razzismo e l’ideologia antisemita. E proprio come nel caso del partito "Alba Dorata" può, oggi, ottenere voti mentre promuove apertamente l’incitamento all’odio.
Davanti a questa terrificante situazione - esemplificata con i deputati neo nazisti nel Parlamento greco - noi esprimiamo la nostra solidarietà : "Siamo tutti ebrei greci!"
Rifiutiamo che in Grecia - come in qualsiasi altra parte d’Europa - ebrei, immigrati, musulmani, nomadi o persone di colore possano temere per le proprie vite a causa di ciò che sono. Invitiamo tutti i cittadini, partiti politici, sindacati, attori della società civile, intellettuali e artisti a combattere il diritto estremo promuovendo e facendo vivere il Sogno europeo.
Dobbiamo sempre ricordare che il Sogno europeo, per il quale ci stiamo battendo, è nato sulle rovine del nazismo. Non dobbiamo mai dimenticare la Shoah. Il nostro sogno è un continente libero dal razzismo e da ogni forma di antisemitismo. E’ il progetto di una società basata sulla "unione". Oltre i confini.
Per vedere di nuovo questo sogno realizzarsi, è necessario porre fine a due dogmi.
Primo: dobbiamo rifiutare il dogma secondo il quale l’austerità è responsabile di terribili danni, creando le condizioni che spiegano il successo dei partiti populisti e che limita il futuro dei giovani in Europa al pagamento dei debiti -come se intere generazioni debbano sacrificarsi sull’altare dell’austerità perpetua.
Secondo: dobbiamo rifiutare il dogma della "Fortezza Europea": questo concetto favorisce la diffusione di discorsi contro gli immigrati e il blocco verso il basso delle frontiere europee, minando l’elemento portante dell’identità europea del dopo guerra: il sistema sociale del welfare - che considera l’immigrazione un elemento sostenibile.
E’ di estrema importanza per le istituzioni europee rinnovarsi con la ricerca della democrazia, del progresso sociale e della promozione dell’uguaglianza; con la tutela di quei cittadini che - ancor più in tempo di crisi- sono l’obiettivo di violenza razziale e sociale.
Il concetto di Europa è spesso criticato. Lungi dal rinunciare all’Europa, crediamo fermamente che sia necessario lavorare per un’Europa più forte, dando cosi nuovo slancio e una nuova portata al Sogno Europeo.
Se non saremo in grado di realizzare il Sogno Europeo, saremo condannati allo stesso incubo in Grecia e nel resto d’Europa.
 Benjamin Abtan, President of the European Grassroots Antiracist Movement - EGAM, Dario Fo, Literature Nobel Prize, Svetlana Gannushkina, Leader of Memorial in Russia, Anthoy Giddens, Sociologist, Amos Gitaï, Director, Béate et Serge Klarsfeld, President of the " Fils et filles de déportés juifs de France", Bernard Kouchner, Former French Minister of Foreign Affairs, Bernard-Henri Lévy, Philosopher, writer, Adam Michnik, Historian, essayist, journalist, former member of Solidarnosc, Dominique Sopo, President of SOS Racisme, Oliviero Toscani, Photographer, Elie Wiesel, Peace Nobel Prize, writer, A. B. Yehoshua, Writer, essayist
Benjamin Abtan, President of the European Grassroots Antiracist Movement - EGAM, Dario Fo, Literature Nobel Prize, Svetlana Gannushkina, Leader of Memorial in Russia, Anthoy Giddens, Sociologist, Amos Gitaï, Director, Béate et Serge Klarsfeld, President of the " Fils et filles de déportés juifs de France", Bernard Kouchner, Former French Minister of Foreign Affairs, Bernard-Henri Lévy, Philosopher, writer, Adam Michnik, Historian, essayist, journalist, former member of Solidarnosc, Dominique Sopo, President of SOS Racisme, Oliviero Toscani, Photographer, Elie Wiesel, Peace Nobel Prize, writer, A. B. Yehoshua, Writer, essayist* la Repubblica, 28 maggio 2012
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- ALLA GRECIA: LETTERA APERTA A ALEXIS TSIPRAS ... Ti scriviamo come cittadine e cittadini di paesi europei, colpiti come la Grecia dall’offensiva “debitocratica” dei poteri finanziari e oligarchici di Europa.25 maggio 2012, di Federico La Sala
Lettera aperta a Alexis Tsipras
Stimato compagno Alexis Tsipras,
Ti scriviamo come cittadine e cittadini di paesi europei, colpiti come la Grecia dall’offensiva “debitocratica” dei poteri finanziari e oligarchici di Europa.
Ci rivolgiamo a te, e attraverso te, alle migliaia di cittadine e cittadini della Grecia, che hanno affidato il loro voto alla vostra organizzazione politica, per esprimere la nostra gratitudine, la solidarietà e il nostro sostegno nei confronti della vostra resistenza, contro la devastazione neoliberista delle condizioni materiali di vita e delle condizioni politiche di convivenza, e nei confronti della vostra lotta per un’alternativa di giustizia, dignità e democrazia in favore del popolo greco e per tutti i popoli che compongono l’Unione europea.
Applaudiamo con entusiasmo al vostro risultato nelle ultime elezioni greche, come plaudiamo al modo con cui state gestendo questo risultato, e vi esortiamo ad insistere su questo impegno, che sta già costituendo un esempio e una speranza per milioni di donne ed uomini in tutta Europa.
Desideriamo condividere con te, con le donne e gli uomini della tua organizzazione e con le cittadine e i cittadini greci che, pur appartenendo ad altre organizzazioni politiche, sindacali o sociali, compartecipano al progetto di una convivenza di libertà e di solidarietà, le aspettative piene di speranza con cui, in tutta Europa, si contempla la possibilità che, in un breve lasso di tempo, un nuovo governo greco di unità popolare affronti la dittatura dei mercanti e dei burocrati di questa Europa sequestrata.
Noi consideriamo l’attuale congiuntura greca come un punto di svolta, che può condurre ad una trasformazione radicale dell’ordine politico ed economico europeo.
Abbiamo bisogno di una nuova Europa, che sia quella dei suoi cittadini ed abitanti e non di un’Europa delle brutali politiche di austerità, che assumono come prioritario il pagamento del debito odioso, illegale ed illegittimo, che impedisce l’umano sviluppo delle nostre comunità.
Questo è l’appello che lanciamo in questi giorni dalle nostre piazze di Europa, dalla Porta del Sol di Madrid a Piazza Syntagma di Atene, e da tante altre piazze distribuite dovunque nella carta geografica europea, piazze liberate, che sono sementi e fondamento costituente della democrazia reale che noi, donne e uomini di Europa, aspiriamo a costruire tutti insieme.
La lotta contro l’autoritarismo neoliberista, che ipoteca il presente e il futuro dei nostri popoli, può risultare vittoriosa a livello europeo. Sempre a livello europeo, è indispensabile dotarci di istituzioni veramente democratiche, che contribuiscano alla libertà e alla solidarietà dei diversi popoli di Europa, di fronte all’attuale Direttorio oligarchico neoliberista e al suo stato di eccezione economica e politica permanente.
“E dopo avere aspettato tanto, tanto / infine è arrivata l’ora di salpare”, così recita il vostro e il nostro poeta, cittadino Aléxandros Panagoulis.
Noi, donne e uomini d’Europa, abbiamo tanto sperato, e sopportato ancor di più. E una volta ancora, spetta al popolo greco, così avvezzo alle cose di mare, ma anche a quelle della libertà, la responsabilità di aprire la strada a questa nuova Europa, che intravediamo nelle nostre piazze e nelle nostre voci ribelli. Per questo, mettiamoci fianco a fianco, per intraprendere insieme, come assemblea di popoli fratelli, questa navigazione pericolosa, di lotta, ma anche tanto ricca di speranza.
Con un abbraccio pieno di riconoscenza e fraterno,
- Per firmare questa lettera, scrivere una e-mail a cartatsipras@gmail.com indicando nome, cognome, luogo di residenza, attività ed appartenenza ad organizzazioni.
 Questa lettera verrà diffusa sui media greci, con tutte le firme raccolte entro il 1 giugno 2012.
Questa lettera verrà diffusa sui media greci, con tutte le firme raccolte entro il 1 giugno 2012.
 Seguono centinaia di firme di intellettuali, accademici e attivisti da tutta Europa.
Seguono centinaia di firme di intellettuali, accademici e attivisti da tutta Europa.
 Per aderire: cartatsipras.blogspot.it/p/lettera-aperta-alexis-tsipras.html
Per aderire: cartatsipras.blogspot.it/p/lettera-aperta-alexis-tsipras.html - Per firmare questa lettera, scrivere una e-mail a cartatsipras@gmail.com indicando nome, cognome, luogo di residenza, attività ed appartenenza ad organizzazioni.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Cittadini si diventa: in piazza Dall’agorà greca alla Tahrir del Cairo un luogo emblematico che mette in gioco i rapporti tra spazio e società (di Carlo Olmo)21 maggio 2012, di Federico La Sala
Cittadini si diventa: in piazza
Dall’agorà greca alla Tahrir del Cairo un luogo emblematico che mette in gioco i rapporti tra spazio e società
di Carlo Olmo (La Stampa, 21.05.2012) *
I fili che si intrecciano quando si ragiona sui possibili legami tra la piazza e le espressioni della cittadinanza sono davvero tanti e molto ingarbugliati. Sono fili complessi e contradditori, non solo perché attraversano geografie e cronologie.
Sin dalle prime tracce scritte che noi abbiamo - la riflessione di Aristotele sulla griglia di Ippodamo da Mileto nella Politica - la piazza costituisce insieme l’eccezione e l’enfasi di un disegno urbano che esprimeva assieme un’egual distribuzione delle opportunità per tutti i cittadini e una forma di controllo sociale attraverso lo spazio. Nel ragionamento che Aristotele costruisce e che ha nella vicenda di Thurii il suo esempio più controverso, la griglia è una proposta costituzionale che prevede una redistribuzione dei profitti derivanti dagli usi del suolo funzionale alla organizzazione delle classi sociali.
L’agorà, in questa prospettiva, diventa un luogo «eccezionale», volutamente lasciato a funzionare ambiguamente come spazio rituale (in cui il passaggio è anche dal sacro al pubblico) e come spazio sociale (del confronto, del conflitto e della mediazione). Quest’impostazione ha una storia che arriva sino a oggi, con momenti di grande enfasi, quando sarà fatta proprio da diversi pensieri utopici, o quando la griglia diventa il paradigma fondamentale su cui si costruiscono le città di fondazione e la piazza il luogo ancor più caricato del dover essere «costituzionale» e non solo funzionale.
Un secondo filo dalla storia non meno antica è quello che può essere riassunto in un apparente paradosso, The Roman Bazaar, seguendo il lavoro prezioso di Peter Fibiger Bang. La piazza come il luogo del mercato, come il luogo dove lo scambio attraversa tutte le sue declinazioni: sociali (di integrazione e legittimazione di chi opera lo scambio), simboliche (nel passaggio dallo scambio tra beni a quello tra beni e monete, a quello tra monete), antropologiche (con il problema centrale del rapporto tra il denaro e il sacro e del problema di chi gestisce il credito... e l’usura).
L’esempio più noto, una specie di incipit occidentale, è la piazza delle corporazioni a Ostia, un altro è la strada-piazza del Gran Bazar a Istanbul. La piazza come luogo del mercato segue, è quasi ovvio dirlo, l’evoluzione della funzione, ma anche della rappresentazione, del mercato nelle società. Questa «piazza» rappresenta anche, occorre sottolinearlo, il luogo per eccellenza dove le regole informali che le società si danno prevalgono su quelle formali (e sulla gestione repressiva o meno della loro applicazione).
Esiste poi un terzo filo rosso altrettanto importante, quello che separerebbe la piazza disegnata, espressione di una volontà di forma, e la piazza che si costruisce per successive addizioni. Tra queste ultime, la piazza del Campo nel dipinto di Ambrogio Lorenzetti e, se si preferisce al posto di una rappresentazione un luogo reale, quella che sorge a Lucca sulle tracce dell’anfiteatro romano. Tra quelle disegnate, la Piazza ideale dell’Anonimo fiorentino conservata oggi a Baltimora, oppure la piazza Pio II a Pienza o le places royales, in primis la place des Vosges a Parigi. Una contrapposizione che ha fatto la fortuna del modello di piazza «italiana» sino a farla diventare quasi
il paradigma della piazza in cui si riconosce una comunità, mentre la piazza disegnata è diventata la rappresentazione dello Stato assolutista. Con ulteriori e interessanti paradossi che ne accompagnano la storia. La piazza «medievale» può diventare il cavallo di battaglia di chi combatte la modernità e rifiuta un concetto universalista di società - così è ad esempio per Léon Krier e per il principe Carlo - mentre la piazza disegnata è diventata l’ultima espressione di una ormai morente cultura modernista: la piazza del Campidoglio a Chandigarh di Le Corbusier o la piazza della Sovranità di Niemeyer a Brasilia ne sono gli esempi più conosciuti.
Dietro tutti questi intrecci sta una riflessione sempre estremamente contraddittoria e complessa sul rapporto che può esistere tra spazio e società, che mette in discussione facili genealogie. Proprio lo studio di come si costruisce realmente ad esempio la place des Vosges mette in luce come quella che appare il paradigma di una volontà assolutista di forma nasca dal riconoscimento - siamo nel 1616 - che l’uniformità sociale costituisca un problema per il funzionamento della città. Mentre saranno studi - soprattutto statunitensi e bostoniani - a cercar di definire il disegno urbano come strumento inatteso di una possibile Urban Democracy.
Ma è proprio la piazza, anche in quelle riflessioni storiografiche e critiche, che rimane il luogo più ambiguo.La piazza delle Tre Culture a Città del Messico, plaza de Mayo a Buenos Aires, oggi piazza Tahrir al Cairo sono entrate nell’immaginario politico e culturale come luoghi dove si rappresenta (non tanto si organizza) il dissenso. Sono piazze «fuori scala», scarsamente vissute come tali, che diventano, proprio come luoghi fortemente ambigui, scene di una rappresentazione sociale. In realtà, il rapporto tra piazza ed espressione della cittadinanza è nella storia urbana ben più complesso.
L’esempio forse più immediato rimane l’attuale place de la Concorde. Pensata come piazza destinata a ospitare la statua equestre di Luigi XV, viene localizzata dove sarà costruita dopo un doppio concorso che vede coinvolti quasi tutti i quartieri di Parigi, fondamentalmente perché quel luogo comprendeva il primo grande fallimento di una finanziarizzazione della rendita urbana: quello di John Law.
La piazza rimane una piazza aperta verso la Senna, costruendo diverse prospettive visuali, proprio il contrario della piazza chiusa, mito e simbolo delle piazze espressione di un potere monocratico. Diventa con la rivoluzione la piazza delle esecuzioni, poi lo snodo delle processioni rivoluzionarie, per diventare l’inizio del più importante progetto di disegno urbano della Parigi di prima metà dell’Ottocento, rue de Rivoli, sino a essere vissuta oggi come un’immensa rotonda automobilistica che ha perso persino il suo statuto di piazza.
Le metafore aiutano a semplificare questioni complesse. Piazza può essere usata provocatoriamente per semplificare ad esempio nuove forme di comunicazione, ma, come tutte le parole, si porta dietro un’avventura più ricca e forse più interessante del suo uso come semplice metafora.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Non solo di economia si tratta, quando si parla della Grecia. Si tratta anche del nostro presente e di quello che esso è grazie ai greci e alla loro storia (di Eva Cantarella)19 maggio 2012, di Federico La Sala
Una fanciulla rapita da Zeus L’Europa inventata dai greci
di Eva Cantarella (Corriere della Sera, 19.05.2012)
L’Europa senza la Grecia: se ne parla come se fosse una possibilità, spiegando le tragiche conseguenze economiche che questo porterebbe con sé. Ma non solo di economia si tratta, quando si parla della Grecia. Si tratta anche del nostro presente e di quello che esso è grazie ai greci e alla loro storia: grazie a quella Grecia, vale a dire, la cui presenza è ancora parte essenziale della nostra vita, a cominciare come ben noto dal nostro vocabolario. Da dove vengono, se non da quella Grecia, parole come mito, teatro, diavolo, politica, democrazia, demografia, apoteosi, antropologia, geografia, psichiatria, telefono, diagnosi, terapia (solo alcuni tra gli innumerevoli esempi, pochi nomi a caso, tra i primi che vengono alla mente). Ma il lascito linguistico non è che una delle tante loro eredità che (anche se non lo sappiamo o non ci pensiamo) ci accompagnano nella vita quotidiana. Per ricordare le quali, o almeno parte delle quali, proviamo, in modo semiserio, a immaginare l’inimmaginabile: come sarebbe la nostra vita oggi, come e cosa sarebbe l’Europa se non fosse mai esistita «quella» Grecia? Quella di Omero e di Eschilo, della battaglia di Maratona e di Pericle, di Zeus, degli dèi dell’Olimpo e dei miti...
Per prima cosa, il nostro continente non si chiamerebbe Europa. A farci sapere perché ci chiamiamo europei, infatti, è un mito (ovviamente greco): quello della ragazza Europa, figlia di Antenore, re della città fenicia di Tiro, sulle coste dell’Asia minore. Un giorno, mentre giocava con le compagne sulla spiaggia, Europa venne rapita dal solito Zeus che, colpito dalla sua bellezza, assunse le sembianze di un bellissimo toro bianco, dalle corna così lucenti che sembravano spicchi di luna. Bello e apparentemente mansueto l’animale andò a sdraiarsi ai piedi di Europa che, fiduciosa, sedette sulla sua groppa. E subito Zeus-toro, rizzatosi sulle zampe, si gettò in mare, raggiungendo a nuoto le coste di Creta, ove si unì a Europa sotto dei platani cui, da quel giorno, fu concesso di non perdere mai le foglie. Potenza del mito: vicino alla città cretese di Gortina esiste un platano, ove tuttora i giovani sposi si recano in pellegrinaggio, la sera del matrimonio...
Ma prescindiamo pure dal nome. Difficile ricordare le infinite cose che mancherebbero alle nostre vite in una immaginaria Europa della quale Grecia non avesse contribuito a fare la storia: non potremmo leggere Omero, Saffo, la lirica, i grandi tragici, Erodoto e Tucidide, e non mi pare cosa da poco.
Non avremmo i templi di Paestum e di Selinunte. I musei (tutti, non solo quelli europei) sarebbero infinitamente più poveri: niente frontone del Partenone al British Museum, niente arte greca al Louvre e al Metropolitan, niente altare di Pergamo al Pergamon Museum di Berlino... Chissà se Frau Merkel lo ha mai visto. Non c’è momento e aspetto della nostra vita che non ci riconduca all’esistenza dei greci. Un solo esempio, la psicoanalisi (che ovviamente avrebbe un altro nome): come avrebbe fatto Freud a spiegare i misteri della nostra psiche senza Edipo? E per finire, ma solo per ragioni di spazio, e tralasciando, sempre per motivi di spazio, i loro lasciti in campo scientifico, come sarebbe l’Europa se nel 490 a.C. l’immane esercito persiano non fosse stato sconfitto nella piana di Maratona da Milziade a capo di 10.000 opliti ateniesi?
La storia non si fa con i se, lo sappiamo bene, ma una cosa è certa: i greci combatterono e vinsero per difendere la loro libertà di cittadini, per non essere sottomessi a un impero dove esistevano solo dei sudditi. E nel farlo consentirono a noi di conoscere e di ereditare la democrazia. Come sarebbe stata la nostra storia, se essi non l’avessero sperimentata e non ce ne avessero insegnato il valore? Come saremmo, oggi, se non ci avessero trasmesso l’orgoglio di essere noi, i cittadini, i titolari della sovranità?
Che mondo povero sarebbe il nostro, senza quella Grecia. Eppure, nel discutere la possibilità (pur cercando di scongiurarla) di escludere la Grecia di oggi dall’Eurozona, tutto quello cui si pensa è l’aspetto economico del problema. Che è, ovviamente, assolutamente fondamentale. Ma, accanto a esso, la Grecia non meriterebbe che venisse preso in qualche considerazione anche tutto quello che le dobbiamo? Quanta ingratitudine, oggi, per la ragazza Europa.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- La preghiera di Aiace a Zeus (di Barbara Spinelli)16 maggio 2012, di Federico La Sala
La preghiera di Aiace
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 16.05.2012)
Ci abituiamo talmente presto ai luoghi comuni che non ne vediamo più le perversità, e li ripetiamo macchinalmente quasi fossero verità inconfutabili: la loro funzione, del resto, è di metterti in riga. Il pericolo di divenire come la Grecia, per esempio: è una parola d’ordine ormai, e ci trasforma tutti in storditi spettatori di un rito penitenziale, dove s’uccide il capro per il bene collettivo.
Il diverso, il difforme, non ha spazio nella nostra pòlis, e se le nuove elezioni che sono state convocate non produrranno la maggioranza voluta dai partner, il destino ellenico è segnato. Lo sguardo di chi pronuncia la terribile minaccia azzittisce ogni obiezione, divide il mondo fra Noi e Loro. Quante volte abbiamo sentito i governanti insinuare, tenebrosi: «Non vorrai, vero?, far la fine della Grecia»? La copertina del settimanale Spiegel condensa il rito castigatore in un’immagine, ed ecco il Partenone sgretolarsi, ecco Atene invitata a scomparire dalla nostra vista invece di divenire nostro comune problema, da risolvere insieme come accade nelle vere pòlis.
L’espulsione dall’eurozona non è ammessa dai Trattati ma può essere surrettiziamente intimata, facilitata. In realtà Atene già è caduta nella zona crepuscolare della non-Europa, già è lupo mannaro usato per spaventare i bambini. Chi ha visto la serie Twilight zone conosce l’incipit: «C’è una quinta dimensione oltre a quelle che l’uomo già conosce. È senza limiti come l’infinito e senza tempo come l’eternità. È la regione intermedia tra la luce e l’oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l’oscuro baratro dell’ignoto e le vette luminose del sapere». Lì sta la Grecia: lontana dalle vette luminose dell’eurozona, usata come clava contro altri.
L’editorialista di Kathimerini, Alexis Papahelas, ha detto prima delle elezioni: «Ci trasformeranno in capro espiatorio. Angela Merkel potrebbe punire la Grecia per meglio convincere il suo popolo ad aiutare paesi come Italia o Spagna». Il tracollo greco è «un’opportunità d’oro» per Berlino e la Bundesbank, secondo l’economista Yanis Varoufakis: nell’incontro di oggi tra la Merkel e Hollande, l’insolvenza delle Periferie europee (Grecia, e domani Spagna, Italia) «sarà usata per imporre a Parigi le idee tedesche su come debba funzionare il mondo». Agitare lo spauracchio ellenico è tanto più indispensabile, dopo la disfatta democristiana in Nord Reno-Westfalia e il trionfo di socialdemocratici e Verdi, pericolosamente vicini a Hollande. La speranza è che Berlino intuisca che la sua non è leadership, ma paura di cambiare paradigmi.
Può darsi che la secessione greca sia inevitabile, come recita l’articolo di fede, ma che almeno sia fatta luce sui motivi reali: se c’è ineluttabilità non è perché il salvataggio sia troppo costoso, ma perché la democrazia è entrata in conflitto con le strategie che hanno preteso di salvare il paese. Nel voto del 6 maggio, la maggioranza ha rigettato la medicina dell’austerità che il Paese sta ingerendo da due anni, senza alcun successo ma anzi precipitando in una recessione funesta per la democrazia: una recessione che ricorda Weimar, con golpe militari all’orizzonte. Costretti a rivotare in mancanza di accordo fra partiti, gli elettori dilateranno il rifiuto e daranno ancora più voti alla sinistra radicale, il Syriza di Alexis Tsipras. Anche qui, i luoghi comuni proliferano: Syriza è forza maligna, contraria all’austerità e all’Unione, e Tsipras è dipinto come l’antieuropeista per eccellenza.
La realtà è ben diversa, per chi voglia vederla alla luce. Tsipras non vuole uscire dall’Euro, né dall’Unione. Chiede un’altra Europa, esattamente come Hollande. Sa che l’80 per cento dei greci vuol restare nella moneta unica, ma non così: non con politici nazionali ed europei che li hanno impoveriti ignorando le vere radici del male: la corruzione dei partiti dominanti, lo Stato e il servizio pubblico servi della politica, i ricchi risparmiati. Tsipras è la risposta a questi mali - l’Italia li conosce - e tuttavia nessuno vuol scottarsi interloquendo con lui.
Neanche Hollande ha voluto incontrare il leader di Syriza, accorso a Parigi subito dopo il voto. E avete mai sentito le sinistre europee, che la solidarietà dicono d’averla nel sangue, solidarizzare con George Papandreou quando sostenne che solo europeizzando la crisi greca si sarebbe trovata la soluzione? Chi prese sul serio le parole che disse in dicembre ai Verdi tedeschi, dopo le dimissioni da Primo ministro? «Quello di cui abbiamo bisogno è di comunitarizzare il nostro debito, e anche i nostri investimenti: introducendo una tassa europea sulle transazioni finanziarie, e sulle energie che emettono biossido di carbonio. E abbiamo bisogno di eurobond per stimolare investimenti comuni». L’idea che espose resta ancor oggi la via aurea per uscire dalla crisi: «Agli Stati nazionali il rigore, all’Europa le necessarie politiche di crescita».
La parole di Papandreou, ascoltate solo dai Verdi, caddero nel vuoto: quasi fosse vergognoso oggi ascoltare un Greco. Quasi fosse senza conseguenze, l’ebete disinvoltura con cui vien tramutato in reietto il Paese dove la democrazia fu inaugurata, e le sue tragiche degenerazioni spietatamente analizzate. Sono le degenerazioni odierne: l’oligarchia, il regno dei mercati che è la plutocrazia, la libertà quando sprezza legge e giustizia.
Naturalmente le filiazioni dall’antichità son sempre bastarde. Anche la nostra filiazione da Roma lo è. Ma se avessimo un po’ di memoria capiremmo meglio l’animo greco. Capiremmo lo scrittore Nikos Dimou, quando nei suoi aforismi parla della sfortuna di esser greco: «Il popolo greco sente il peso terribile della propria eredità. Ha capito il livello sovrumano di perfezione cui son giunte le parole e le forme degli antichi. Questo ci schiaccia: più siamo fieri dei nostri antenati (senza conoscerli) più siamo inquieti per noi stessi». Ecco cos’è, il Greco: «un momento strano, insensato, tragico nella storia dell’umanità». Chi sproloquia di radici cristiane d’Europa dimentica le radici greche, e l’entusiasmo con cui Atene, finita la dittatura dei colonnelli nel 1974, fu accolta in Europa come paese simbolicamente cruciale.
Il non-detto dei nostri governanti è che la cacciata di Atene non sarà solo il frutto d’un suo fallimento. Sarà un fallimento d’Europa, una brutta storia di volontaria impotenza. Sarà interpretato comunque così. Non abbiamo saputo combinare le necessità economiche con quelle della democrazia. Non siamo stati capaci, radunando intelligenze e risorse, di sormontare la prima esemplare rovina dei vecchi Stati nazione. L’Europa non ha fatto blocco come fece il ministro del Tesoro Hamilton dopo la guerra d’indipendenza americana, quando decretò che il governo centrale avrebbe assunto i debiti dei singoli Stati, unendoli in una Federazione forte. Non ha fatto della Grecia un caso europeo. Non ha visto il nesso tra crisi dell’economia, della democrazia, delle nazioni, della politica. Per anni ha corteggiato un establishment greco corrotto (lo stesso ha fatto con Berlusconi), e ora è tutta stupefatta davanti a un popolo che rigetta i responsabili del disastro.
Le difficoltà greche sono state affrontate con quello che ci distrugge: con il ritorno alle finte sovranità assolute degli Stati nazione. È un modo per cadere tutti assieme fuori dall’Europa immaginata nel dopoguerra. Ci farà male, questa divaricazione creatasi fra Unione e democrazia, fra Noi e Loro. La loro morte sarebbe un po’ la nostra, ma è un morire cui manca il conosci te stesso che Atene ci ha insegnato. Non è la morte greca che Aiace Telamonio invoca nell’Iliade: «Una nebbia nera ci avvolge tutti, uomini e cavalli. Libera i figli degli Achei da questo buio, padre Zeus, rendi agli occhi il vedere, e se li vuoi spenti, spegnili nella luce almeno».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- Un’altra Europa, assai diversa dalla prepotente Europa economica e dall’evanescente Europa politica. È quella dei diritti, troppo spesso negletta e ricacciata nell’ombra.12 maggio 2012, di Federico La Sala
La nuova stagione dei diritti
di Stefano Rodotà (la Repubblica, 12.05.2012)
Il fronte dei diritti si è appena rimesso in movimento. Obama ha affrontato senza reticenze il tema difficile dei matrimoni omosessuali, e lo stesso ha fatto François Hollande inserendolo nel suo programma e mettendo all’ordine del giorno quello ancor più impegnativo del fine vita. Di questa rinnovata centralità dei diritti dobbiamo tenere conto anche in Italia.
In che modo, però, e con quali contenuti? Qualche esempio. La recente sentenza della Corte di Cassazione sui matrimoni gay è un dono dell’Europa. Così come lo è l’avvio dell’estensione alla Chiesa dell’obbligo di pagare l’imposta sugli immobili. Così come può diventarlo l’utilizzazione degli articoli 10 e 11 del Trattato di Lisbona.
Mi spiego. La Cassazione ha potuto legittimamente mettere in evidenza il venir meno della "rilevanza giuridica" della diversità di sesso nel matrimonio, e il conseguente diritto delle coppie dello stesso sesso ad una "vita familiare", proprio perché queste sono le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e soprattutto dell’innovativo articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Sappiamo, poi, che la norma sul pagamento dell’Ici da parte della Chiesa è andata in porto solo perché erano ormai imminenti sanzioni da parte della Commissione europea. E la discussione sui rapporti tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, tornata con prepotenza in Italia anche per effetto degli ultimi risultati elettorali, trova nel Trattato chiarimenti importanti, a cominciare dal nuovo potere che almeno un milione di cittadini può esercitare chiedendo alla Commissione di intervenire in determinate materie. Lo ha appena fatto il Sindacato europeo dei servizi pubblici che si accinge a raccogliere le firme perché l’Unione europea metta a punto norme che riconoscano come diritto fondamentale quello di accesso all’acqua potabile.
Scopriamo così un’altra Europa, assai diversa dalla prepotente Europa economica e dall’evanescente Europa politica. È quella dei diritti, troppo spesso negletta e ricacciata nell’ombra. Un’Europa fastidiosa per chi vuole ridurre tutto alla dimensione del mercato e che, invece, dovrebbe essere valorizzata in questo momento di rigurgiti antieuropeisti, mostrando ai cittadini come proprio sul terreno dei diritti l’Unione europea offra loro un "valore aggiunto", dunque un volto assai diverso da quello, sgradito, che la identifica con la continua imposizione di sacrifici.
Questa è, o dovrebbe essere, una via obbligata. Dal 2010, infatti, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati, ed è quindi vincolante per gli Stati membri. Bisogna ricordare perché si volle questa Carta. Il Consiglio europeo di Colonia, nel giugno del 1999, lo disse chiaramente: «La tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore dell’Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità. Allo stato attuale dello sviluppo dell’Unione, è necessario elaborare una Carta di tali diritti al fine di sancirne in modo visibile l’importanza capitale e la portata per i cittadini dell’Unione». Sono parole impegnative. All’integrazione economica e monetaria si affiancava, come passaggio ineludibile, l’integrazione attraverso i diritti. Fino a che questa non fosse stata pienamente realizzata, al già mille volte rilevato deficit di democrazia dell’Unione europea si sarebbe accompagnato addirittura un deficit di legittimità. Si avvertiva così che la costruzione europea non avrebbe potuto trovare né nuovo slancio, né compimento, né avrebbe potuto far nascere un suo "popolo" fino a quando l’Europa dei diritti non avesse colmato i molti vuoti aperti da quella dei mercati.
Negli ultimi tempi questo doppio deficit si è ulteriormente aggravato. L’approvazione del "fiscal compact", con la forte crescita dei poteri della Commissione europea e della Corte di Giustizia, rende ancor più evidente il ruolo marginale dell’unica istituzione europea democraticamente legittimata - il Parlamento. Oggi si levano molte voci per trasformare la crisi in opportunità, riprendendo il tema della costruzione europea attraverso una revisione del Trattato di Lisbona. In questa nuova agenda costituzionale europea dovrebbe avere il primo posto proprio il rafforzamento del Parlamento, proiettato così in una dimensione dove potrebbe finalmente esercitare una funzione di controllo degli altri poteri e un ruolo significativo anche per il riconoscimento e la garanzia dei diritti.
Non è vero, infatti, che l’orizzonte europeo sia solo quello del mercato e della concorrenza. Lo dimostra proprio la struttura della Carta dei diritti. Nel Preambolo si afferma che l’Unione "pone la persona al centro della sua azione". La Carta si apre affermando che "la dignità umana è inviolabile". I principi fondativi, che danno il titolo ai suoi capitoli, sono quelli di dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia, considerati come "valori indivisibili". Lo sviluppo, al quale la Carta si riferisce, è solo quello "sostenibile", sì che da questo principio scaturisce un limite all’esercizio dello stesso diritto di proprietà.
In particolare, la Carta, considerando "indivisibili" i diritti, rende illegittima ogni operazione riduttiva dei diritti sociali, che li subordini ad un esclusivo interesse superiore dell’economia. E oggi vale la pena di ricordare le norme dove si afferma che il lavoratore ha il diritto "alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato", "a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose", alla protezione "in caso di perdita del posto di lavoro". Più in generale, e con parole assai significative, si sottolinea la necessità di "garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti". Un riferimento, questo, che apre la via all’istituzione di un reddito di cittadinanza, e ribadisce il legame stretto tra le diverse politiche e il pieno rispetto della dignità delle persone.
Tutte queste indicazioni sono "giuridicamente vincolanti", ma sembrano scomparse dalla discussione pubblica. Si apre così una questione che non è tanto giuridica, quanto politica al più alto grado. Il riduzionismo economico non sta solo mettendo l’Unione europea contro diritti fondamentali delle persone, ma contro se stessa, contro i principi che dovrebbero fondarla e darle un futuro democratico, legittimato dall’adesione dei cittadini. Da qui dovrebbe muovere un nuovo cammino costituzionale. Se l’Europa deve essere "ridemocratizzata", come sostiene Jurgen Habermas, non basta un ulteriore trasferimento di sovranità finalizzato alla realizzazione di un governo economico comune, perché un’Unione europea dimezzata, svuotata di diritti, inevitabilmente assumerebbe la forma di una "democrazia senza popolo". Da qui dovrebbero ripartire la discussione pubblica, e una diversa elaborazione delle politiche europee.
Conosciamo le difficoltà. L’emergenza economica vuole chiudere ogni varco. Dalla Corte di Giustizia non sempre vengono segnali rassicuranti. Lo stesso Parlamento europeo ha mostrato inadeguatezze sul terreno dei diritti, come dimostrano le tardive e modeste reazioni alla deriva autoritaria dell’Ungheria. Ma l’esito delle elezioni francesi, e non solo, ci dice che un’altra stagione politica può aprirsi, nella quale proprio la lotta per i diritti torna ad essere fondamentale. Di essa oggi abbiamo massimamente bisogno, perché da qui passa l’azione dei cittadini, protagonisti indispensabili di un possibile tempo nuovo.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- La politica dei “desaparecidos” del dittatore argentino Videla. Il Vaticano sapeva. Così risulta da un documento rinvenuto nell’archivio della Conferenza episcopale (di Horacio Verbitsky)11 maggio 2012, di Federico La Sala
 Il Vaticano sapeva
Il Vaticano sapeva Videla e i silenzi del Vaticano
Videla e i silenzi del Vaticano La politica dei “desaparecidos” che il dittatore Jorge Videla ha ammesso anche in tribunale, era nota fin dal 10 aprile 1978 alla Chiesa cattolica
La politica dei “desaparecidos” che il dittatore Jorge Videla ha ammesso anche in tribunale, era nota fin dal 10 aprile 1978 alla Chiesa cattolica Così risulta da un documento rinvenuto nell’archivio della Conferenza episcopale
Così risulta da un documento rinvenuto nell’archivio della Conferenza episcopale
 Desaparecidos: documento della Santa Sede ritrovato. Scritto dopo un pranzo con i vescovi e il dittatore argentino
Desaparecidos: documento della Santa Sede ritrovato. Scritto dopo un pranzo con i vescovi e il dittatore argentinodi Horacio Verbitsky (il Fatto, 11.05.2012)
Buenos Aires. La politica dei “desaparecidos” che il dittatore Jorge Videla ha finito per ammettere con diverse dichiarazioni e in tribunale, era nota fin dal 10 aprile 1978 alla Commissione esecutiva della Chiesa cattolica che, però, si guardò bene dall’informare l’opinione pubblica. Tutto questo risulta da un documento rinvenuto nell’archivio della Conferenza episcopale.
IL DOCUMENTO porta il numero 10.949 e già il numero dà un’idea della quantità di informazioni sulle quali la Chiesa continua a mantenere il segreto. Il documento fu redatto a cura del Vaticano al termine di un pranzo con Videla ed è conservato nel fascicolo 24-II. Sono riuscito a visionare il documento in maniera surrettizia dopo che a una formale richiesta le autorità ecclesiastiche avevano risposto con la sorprendente affermazione secondo cui l’Episcopato non avrebbe archivi.
Quando incontrava esponenti della Chiesa cattolica, Videla parlava con la franchezza in uso tra amici. L’allora presidente dell’Episcopato, il cardinale Raul Francisco Primatesta, comunicò all’Assemblea Plenaria che lui e i suoi due vicepresidenti, l’arcivescovo Vicente Zazpe e il cardinale Juan Aramburu, avevano parlato a Videla dei casi di prigionieri apparentemente rimessi in libertà, ma in realtà assassinati, si erano interessati dei sacerdoti desaparecidos, quali Pablo Gazzarri, Carlos Bustos e Mauricio Silva, e di altre persone scomparse nei giorni precedenti all’incontro con Videla.
Secondo il documento episcopale “il presidente ha risposto che apparentemente sarebbe ovvio affermare che sono già morti; si tratterebbe di varcare una linea di demarcazione: questi sono scomparsi, non ci sono più. Questo sarebbe il più chiaro, comunque ci porta a una serie di considerazioni in ordine a dove sono stati sepolti: in una fossa comune? E in tal caso chi li avrebbe sepolti in questa fossa? Una serie di domande alle quali le autorità di governo non possono rispondere sinceramente in quanto la cosa coinvolge diverse persone”, un eufemismo per alludere a coloro che avevano svolto il lavoro sporco di sequestrarli, torturarli, ucciderli e fare sparire le spoglie. L’atteggiamento del clero aveva sfumature sottili. Zazpe chiese: “Cosa rispondiamo alla gente visto che c’è un fondamento di verità in quanto sospettano? ”. E Videla “ammise che era vero”. Aramburu spiegò che “il problema è di rispondere in modo che la gente non continui a chiedere spiegazioni”.
PRIMATESTA spiegò che “la Chiesa vuole capire, collaborare, è consapevole che il Paese versava in uno stato di caos” e che ha misurato le parole perché sapeva benissimo “il danno che poteva arrecare al governo”. Anche Primatesta ha insistito sulla necessità di arrivare a una qualche soluzione in quanto prevedeva che alla lunga il metodo consistente nel far sparire le persone avrebbe prodotto “effetti negativi” considerata “l’amarezza che affligge molte famiglie”. Questo dialogo di straordinaria franchezza mostra che sia Videla sia la Chiesa conoscevano benissimo i fatti e sottolinea la complicità con cui valutavano e decidevano in che modo rispondere alle denunce della gente avvertite da entrambe le parti come una minaccia comune.
Nello scegliere questa politica di omicidi clandestini, che Videla ora definisce “comoda” perché sollevava dal fornire spiegazioni, la giunta militare gettò un’ombra di sospetto su tutti i quadri delle Forze armate e delle forze di sicurezza, ombra che cominciò a dissiparsi con la riapertura dei processi che hanno consentito di accertare le responsabilità individuali che la giunta aveva coperto. Fino ad oggi ci sono state 253 sentenze di condanna e 20 di assoluzione, la qual cosa dimostra che in democrazia nessuno viene condannato pregiudizialmente e senza poter esercitare il suo diritto alla difesa. Fino ad oggi solo un cappellano militare, Christian von Wernich, è stato condannato per complicità in casi di tortura e omicidio.
ZAZPE è morto nel 1984, Aramburu nel 2004 e Primatesta nel 2006. Nel 2011 ha rinunciato per sopraggiunti limiti di età, Jorge Casaretto, l’ultimo vescovo di quei tempi ancora in attività. Tuttavia la Chiesa continua a mantenere un ostinato silenzio che talvolta sottolinea la sua crescente irrilevanza nel panorama della società argentina. La scarsa influenza della Chiesa si è vista con chiarezza l’anno scorso quando, malgrado la sua mobilitazione, il Congresso ha modificato il codice civile per consentire il matrimonio a tutte le persone indipendentemente dal sesso dei contraenti.
 Traduzione di Carlo Antonio Biscotto
Traduzione di Carlo Antonio Biscotto -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- Arrabbiati. Che cosa succede all’Europa se si spezza la coesione sociale (di Barbara Spinelli)10 maggio 2012, di Federico La Sala
Arrabbiati.Che cosa succede all’Europa se si spezza la coesione sociale
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 10 maggio 2012)
"Disperazione sociale": gli storici della Germania nazista danno questo nome, all’ansia che caratterizzò gli anni 30 e sfociò nel nazismo. Disperazione e rabbia per un collasso economico che travolgeva gli averi e le esistenze degli uomini. Disperazione che non tollerava più i corrotti compromessi della politica. Presentendo tempeste, Nietzsche aveva già parlato di un risentimento che come veleno corrode le scale dei valori. Nel Zarathustra, descrive una speciale forma di stanchezza, «che d’un sol balzo vuol attingere le ultime cose, con salto mortale: una misera ignorante stanchezza, che non vuol più nemmeno volere: essa ha creato tutti gli dèi e i mondi dietro il mondo».
È fatta di questo risentimento, la rabbia che si è fatta strada nelle ultime elezioni in Francia, Grecia, Italia, Germania. C’è questa stanchezza di una politica del rigore che colpisce senza aggiustare, e di un’Europa-Leviatano che soggioga senza dare sicurezza. Non sono tutti antieuropei né antipolitici, i partiti nei quali tanti arrabbiati si riconoscono. Ma tutti mettono in questione l’autorità castigatrice che è divenuta l’Unione europea, l’ossessione contabile che la anima. Tutti denunciano il potere anchilosato (l’impotenza, in realtà) di classi politiche che non hanno occhi né orecchie per capire quel che la crisi sta suscitando nelle società, sotto forma di dolori ma anche di speranze, innovazioni, reinvenzioni. Soprattutto le forze centriste sono sotto accusa, ovunque, perché non sono né calde né fredde ma tiepide, e gli arrabbiati vogliono l’estremo. Sono gli orfani dello scontro svanito fra vecchio e nuovo, reazione e cambiamento, destra e sinistra: tutte categorie che il centrismo, le Terze Vie, hanno gettato a mare. È quando questa contrapposizione manca che con un balzo mortale si anela alle ultime cose.
C’è chi si rifugia nei nazionalismi xenofobi, come in Francia e Grecia. Chi vede la salvezza nella fine dell’Euro. I Pirati, in Germania, cercano di presidiare nella crisi la libertà di un’informazione che aiuti i cittadini a conoscere quel che non sanno, a influire sulla politica non ogni 4-5 anni ma in permanenza. La collera imbocca vie diverse ma una cosa le accomuna: il desiderio di una politica che ridiventi lotta, il rigetto di numeri di bilancio assurti a valori supremi, non negoziabili.
Ci sono stati momenti profetici, nella campagna elettorale francese: momenti di acuta coscienza dei pericoli. Uno di questi s’è avvertito quando il centrista François Bayrou ha detto che avrebbe votato Hollande. È stato un inatteso autoaffondamento del centrismo. Bayrou non condivide praticamente nulla della politica economica di Hollande, ma si è esposto perché - ha detto- ritiene che i princìpi repubblicani e democratici siano più importanti delle cifre economiche. Una cosa simile ha detto il gollista Dominique de Villepin: «La sinistra mi inquieta, ma la destra mi spaventa».
Sono momenti profetici perché rivelatori: dicono lo spavento che ti può afferrare quando princìpi sin qui prioritari vengono retrocessi. Dicono le radici di una collera che è stanca della propria impotenza (speculare a quella del potere costituito) e o fugge non votando più, o urla, o s’inventa nemici come lo straniero, o escogita modi non ortodossi di far politica.
Un’economia più espansiva come quella di Hollande inquieta i mercati o i dogmi tedeschi, ma non sarà mai spaventosa come una democrazia che decade, o un popolo che si erge contro la grande conquista che è stata l’unità degli europei, il loro trionfo su se stessi. Keynes l’aveva detto dopo il ’14-18: il castigo economico umilierà i tedeschi, li precipiterà nel baratro.
Le cifre contabili saranno essenziali, ma le costituzioni democratiche ancora di più. Hollande ha vinto perché ha promesso di salvare le istituzioni, lo Stato sociale, la scuola pubblica, la convivenza con lo straniero, e, se non la società affluente, almeno il riparo dall’ingiustizia sociale. A che serve lo Stato, se non a custodire questi progressi? E l’Europa stessa, che nel dopoguerra spense i nazionalismi e costruì il Welfare contro la disperazione sociale: a che serve se si trasforma in un’enorme funesta Equitalia?
Il voto dei popoli dice questo, ai governanti: c’è bisogno di un’altra politica, che includa le persone nei parametri finanziari. Anche perché se entriamo nella logica dei numeri ne scopriremo di mortiferi: 36 suicidi in Italia dall’inizio del 2012, più di 1750 in Grecia dal 2009. Anche il suicidio causato dalla crisi è sete di estremo.
Ripensare l’Europa non può che partire da questa protesta, tutt’altro che omogenea. La rivolta di Grillo non ha nulla a vedere con la destra di Marine Le Pen. La sinistra radicale in Grecia chiede un’Europa diversa e non vuol uscire dalla moneta unica. I Pirati tedeschi prendono voti a sinistra come a destra, e conducono una battaglia antichissima: la battaglia che emancipa l’uomo dandogli informazione e libertà di giudizio.
Si parla di insolvenza degli Stati, ma esiste anche l’insolvenza della politica: soprattutto di quella moderata, che è stata l’ultima a vedere l’arrivo della crisi e a capirla. La democrazia regge in Francia (mentre è ingovernabile in Italia e Grecia) perché la contrapposizione destra-sinistra è preservata, anche se le linee divisorie mutano col tempo e l’esperienza. Hollande non è andato a caccia di centristi. Ne ha conquistati molti, ma prima si è preoccupato di radunare tutta la sinistra, compresa quella radicale.
Per molti anni, la parola d’ordine in Europa è stata la cultura della stabilità, dell’affidabilità economica. Adesso si tratta di darle una cultura politica: dunque un potere veramente sovrano, un Parlamento veramente europeo, un Tesoro veramente unico. E un’agorà, uno spazio di discussione dove le idee più antagoniste sull’Europa da edificare possano liberamente competere. L’Unione non può sopportare, senza autoaffondarsi, di buttare dalla nave gli Stati deboli, o i partiti e movimenti che chiedono un’Europa differente. Troppo grande e distruttiva è la stanchezza generata dal vuoto di alternative. Troppo spaventosa la collera che ti fa dire, con Rilke: «Alle somme indicibili aggiungi te stesso, e distruggi il numero».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- IL CICLONE DI PARIGI. François Hollande vince le elezioni francesi : è il nuovo Presidente della Repubblica.7 maggio 2012, di Federico La Sala
Il ciclone di Parigi
di Cesare Martinetti (La Stampa, 07.05.2012)
François Hollande vince le elezioni francesi e subito manda ad Angela Merkel il messaggio che molta parte dell’Europa (Italia compresa) si aspettava: l’austerità «non è una fatalità» e la costruzione europea deve essere riorientata verso la crescita. È stato il grande tema della sua campagna elettorale, la questione si apre a Bruxelles e Berlino, Hollande ha la sfrontatezza tutta francese di dire che la sua vittoria accende una speranza e una nuova prospettiva per molti Paesi. Ma, di nuovo rispetto al vecchio socialismo francese, sa anche dire che i conti vanno raddrizzati per ridurre il deficit e in prospettiva tagliare il debito. Insomma, la sfida è alta, vedremo presto.
Oggi dobbiamo registrare un risultato elettorale clamoroso anche se non inatteso. François Hollande è il nuovo Presidente della Repubblica, diciassette anni dopo François Mitterrand un socialista torna all’Eliseo. Le circostanze sono simili: allora fu Valéry Giscard d’Estaing a mancare la rielezione dopo il primo mandato, questa volta è Nicolas Sarkozy, il giovane Presidente della «rupture», l’uomo che aveva promesso di rinnovare la destra francese e la Francia intera dopo gli incolori anni di Chirac.
Per Sarkozy la sconfitta è bruciante, direttamente proporzionale all’investimento emotivo e politico che quest’uomo frenetico e impulsivo aveva buttato in campo. I francesi hanno rifiutato il suo bonapartismo da parvenu e l’unica vera rupture evidente dopo cinque anni di potere è stata tra il Presidente e i francesi. Sarkozy ha riconosciuto la sconfitta e si è preso tutte le responsabilità. Non ha annunciato il ritiro dalla politica, ma ha detto che torna «un francese tra i francesi». Difficile immaginare un suo futuro, oggi come oggi. Certo il suo partito appare sconquassato in vista delle legislative che saranno tra un mese.
All’Eliseo arriva un uomo che si è presentato alla Francia come «normale» per contrapporsi agli eccessi caratteriali del suo antagonista. Hollande è stato detto anche «grigio», «molle» come un budino, incolore, l’eterno secondo. In questa campagna ha dimostrato invece qualità culturali, un progetto politico riconoscibile non soltanto dalla gauche e una tenuta temperamentale invidiabile nel momento clou dello scontro con Sarkò, il duello televisivo di mercoledì scorso. Tutti pensavano che Sarkozy se lo sarebbe mangiato, e invece è successo esattamente il contrario: il Presidente è apparso fragile come mai era accaduto in tutta la sua carriera politica, in difesa e indifeso di fronte al modesto bilancio della sua presidenza, incapace di replicare all’antagonista che con pacata, ma studiata sfrontatezza ha ripetuto come un mantra: «Moi, le Président de la République, si... ». Un artificio retorico molto mitterrandiano.
Il risultato del voto ha una dinamica essenzialmente franco-francese, come si dice a Parigi, ma potrebbe trasformarsi in un ciclone a Bruxelles e Berlino. Hollande, un europeista convinto, figlio politico di Jacques Delors, che rimane tuttora il più prestigioso presidente della Commissione, ha fatto della rottura del rigore da copyright di Angela Merkel (al quale Sarkozy si era accodato più per tattica difensiva che per convinzione) il principale obiettivo di politica europea.
Come lo farà lo vedremo presto. Il calendario è serrato: il 18 ci sarà il passaggio dei poteri, il nuovo Presidente scioglierà l’Assemblée e convocherà la elezioni politiche. Ma intanto si formerà un nuovo governo. I candidati al ruolo di primo ministro sono due: Martine Aubry, segretaria del Ps ed ex ministro del Lavoro del governo Jospin (la donna che ha firmato la legge delle 35 ore) e Jean-Marc Ayrault, professore di tedesco, sindaco di Nantes, capogruppo all’Assemblée e fedelissimo di Hollande.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Il new deal dell’Europa (di Barbara Spinelli)25 aprile 2012, di Federico La Sala
Il new deal dell’Europa
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 25 aprile 2012)
L’Europa è talmente malmessa, che non può permettersi alla guida degli Stati uomini senza nuovi progetti sull’Unione, che proseguano con avaro nazionalismo i falsi movimenti di salvataggi inesistenti. Ha bisogno di pensare in grande il doppio sconquasso che l’assedia: la crisi che minaccia l’euro, e la crisi di rappresentanza politica che minaccia la democrazia. Questo il messaggio che domenica è venuto dal primo turno delle presidenziali francesi.
Il rigetto di Sarkozy, il successo della xenofobia antieuropea di Marine Le Pen, confermano che esiste ormai un tragico divario, non solo in Francia, fra la gestione contabile dei debiti pubblici e le passioni democratiche dei cittadini.
È finita l’epoca in cui l’economia determinava ogni cosa. È l’economia, stupido! disse nel ’92 uno stratega di Clinton, sicuro che Bush padre non avrebbe vinto con i suoi discorsi sul dopo-guerra fredda. Per vent’anni le menti sono state prigioniere di quel motto fatale, cattivando gran parte delle sinistre europee, ed ecco che fa irruzione una questione che credevamo chiusa, morta: la questione sociale. Sarkozy è sorpassato al primo turno da Hollande e dal Fronte Blu-Marine Le Pen per aver ignorato questa novità, pur visibile da tempo. Dalla Francia profonda gli giunge l’annuncio: È il sociale, stupido!
È il sociale come nel 1933-37, quando Roosevelt avviò il New Deal, in reazione alla Grande Depressione del ’29, e non solo predispose ingenti piani di investimento ma corresse anche la democrazia americana: a fatica impose le sue proposte, avversato sia dalla Corte suprema, sia da singoli Stati che ritenevano violate le loro prerogative ed eccessivo l’intervento dello Stato federale. Lo stesso sta accadendo da noi. Pensare in grande, oggi, significa pensare europeo, non limitarsi a escogitare ombrelli temporanei che riparino dalle bancarotte gli Stati periferici.
Alla Grande Contrazione dei redditi e dei diritti, e alla disperazione sociale che dilaga, si può rispondere solo con un New Deal, un Nuovo Patto che sia federale e sovra-statale come quello di Roosevelt. François Hollande non ha forse la stoffa di Roosevelt (chi ha la stoffa di un grande, prima di provare?) e l’Europa federale ancora non c’è. Durante tutta la crisi Sarkozy ha impedito questo sviluppo, vantandosi d’aver riportato l’Europa nelle capitali, lontano da Bruxelles.
Ma se Hollande la spuntasse, al secondo turno, qualcosa potrebbe cominciare a muoversi. Se le parole che ha detto pesano, l’immobile pigrizia di Merkel e Sarkozy un poco s’incrinerebbe. Non dimentichiamo che tanti Europei lo chiedono: i socialdemocratici e liberali tedeschi (che hanno appena iscritto la Federazione nel programma del partito), il Consiglio degli esperti economici in Germania, i governi polacco e spagnolo, e uomini come Cohn Bendit, Verhofstadt, infine Delors, secondo cui l’odierna politica «uccide l’Europa». Lo chiede anche Mario Monti.
La tesi di Hollande è che il Patto di bilancio franco-tedesco, approvato il 2 marzo da 25 Stati dell’Unione, è una tappa necessaria («Io accetto la disciplina», ha detto ai socialisti europei, in marzo a Parigi) ma fallimentare se non affiancata da una politica europea di investimenti e occupazione. Delors aggiunge: se non abbinata a un’Europa più federale e a un diverso modello di sviluppo.
L’iniziale idea di rinegoziare il Patto di bilancio è stata abbandonata, e la battaglia di Hollande ha ora altri obiettivi: non più la trasformazione dei debiti sovrani in debito comune, ma il potere dato alle istituzioni sovranazionali europee «di finanziare nuovi progetti di sviluppo». Il candidato chiede inoltre che nel Fiscal compact sia introdotta una clausola, perché i fondi per le regioni povere siano meglio usati e la Banca europea degli investimenti diventi più attiva.
Il Fondo salva-stati (Firewall, muro antincendio) è criticato con forza. L’ha criticato anche Robert Zoellick, Presidente uscente della Banca Mondiale, il 16 aprile in un articolo sul Financial Times: «L’agitazione sul Firewall distrae dalla questione fondamentale: che può fare l’Unione per aiutare Italia e Spagna ad attuare le riforme senza perdere il consenso politico? Invece d’azzuffarsi sul muro antincendio, gli Europei dovrebbero aggiungere almeno una frazione - circa 10 miliardi di euro - al capitale della Banca europea degli investimenti».
La vittoria di Hollande potrebbe mitigare le rigidità della Merkel, far da contrappeso a un dominio continentale di Berlino al contempo prepotente e abulico, che mai è stato sottoposto a vere sfide da Sarkozy, affamato di appoggi alle elezioni. Chi presagisce la fine dell’asse franco-tedesco con Hollande all’Eliseo non ha memoria nel cervello: Parigi e Berlino sono un tandem, per necessità. Resta che il grosso dello sforzo toccherà alla Francia, più che mai. È qui che ci si aggrappa più accanitamente alla sovranità assoluta degli Stati. Per mezzo secolo Parigi ha fatto e disfatto l’Unione ben più capricciosamente della Germania. Il federalismo, antica vocazione tedesca, è inviso in Francia. Hollande denuncia il rigore senza crescita, non il tabù della sovranità nazionale. Delors è un’eccezione alla regola.
Il non-detto in Europa è che la crisi non è una buia manovra speculativa. Nasce da una dislocazione planetaria dell’economia. La verità taciuta dai governi è che la crescita di ieri da noi non tornerà: che converrà dipendere meno da vecchie industrie, non più competitive in Asia e America latina, e puntare su energie rinnovabili, ecologia, ricerca.
Un’altra verità occultata è l’organizzazione della ripresa. È per risparmiare soldi che il Nuovo Patto deve partire dall’Unione, non dagli Stati. Come ha detto Alfonso Iozzo, ex presidente della Cassa Depositi e Prestiti e federalista europeo, in una riunione romana di EuropEos a marzo: agli Stati incombe l’obbligo del rigore, «all’Europa lo sviluppo con un New Deal». I primi infatti «non possono più sostenere piani nazionalmente troppo costosi». Dice Passera che non possiamo aspettarci ideone dai governi. Ma di ideone c’è bisogno disperato - lo attesta il trionfo dei nazionalismi xenofobi europei - e il New Deal è una di esse.
Si dirà che mancano i soldi. Ma l’Europa può trovarli, accrescendo il proprio bilancio. Secondo i federalisti, l’aumento delle comuni risorse deve passare dall’1 per cento del prodotto interno lordo al 2. E deve poter essere usata la tassa sulle transazioni finanziarie, oggi solo annunciata, per sostenere i lavoratori colpiti dalla globalizzazione e i giovani esclusi dal lavoro.
L’Europa di Merkel e Sarkozy non ha sanato ma aggravato nell’Unione la sofferenza economica e democratica, accentuando populismi e chiusure nazionaliste. Perfino il trattato di Schengen è messo in causa, spiega Monica Frassoni, deputata europea dei Verdi, sul sito Linkiesta.it: è recente un appello inviato dai ministri dell’Interno di Francia e Germania al Presidente del Consiglio dei Ministri europeo, perché vengano reintrodotti i controlli alle frontiere nazionali contro i migranti illegali. Sarkozy spera di strappare voti a Marine Le Pen. Domenica abbiamo visto che l’originale, almeno per ora, è preferito alla copia.
Può darsi che manchino oggi leader come Roosevelt. Ma la constatazione s’è fatta stantia. Importante è smettere di dire che l’Europa funziona così com’è: che basta - l’ha detto Monti in gennaio alla Welt - la sussidiarietà (se i nodi non sono sciolti nazionalmente si passa al livello sovranazionale o regionale). La sussidiarietà è un metodo, che si usa ad hoc. Non è l’istituzione che dura nel tempo e «pensa tutto il giorno all‘Europa», invocata da Delors. Altrimenti l’Europa sarà la bella statua di Baudelaire: sogno di pietra troneggiante nell’azzurro, nemica di ogni movimento che scomponga le linee. «E mai piange, mai ride».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Il male oscuro dell’Europa (di Barbara Spinelli)21 marzo 2012, di Federico La Sala
Il male oscuro dell’Europa
di BARBARA SPINELLI *
TUTTI ci stiamo trasformando, senza quasi accorgercene, in tecnici della crisi che traversiamo: strani bipedi in mutazione, sensibili a ogni curva economica tranne che alle curve dell’animo e del crimine. L’occhio è fisso sullo spread, scruta maniacalmente titoli di Stato e Bund, guata parametri trasgrediti e discipline finanziarie da restaurare al più presto. Fino a quando, un nefasto mattino, qualcosa di enorme ci fa sobbalzare sotto le coperte del letto e ci apre gli occhi: un male oscuro, che è secrezione della crisi non meno delle cifre di bilancio ma che incide sulla carne viva, spargendo sangue umano. La carneficina alla scuola ebraica di Tolosa è questo sparo nel deserto, che ci sveglia d’un colpo e ci immette in una nuova realtà, più vasta e più notturna.
Come in una gigantesca metamorfosi, siamo tramutati in animali umani costretti a vedere quello che da mesi, da anni, coltiviamo nel nostro seno senza curarcene. Il naufragio del sogno europeo, emblema di riconciliazione dopo secoli di guerre, e di vittoria sulle violenze di cui Europa è stata capace, partorisce mostri. Non stupisce che il mostro colpisca ancora una volta l’ebreo, capro espiatorio per eccellenza, modello di tutti i capri e di tutti i diversi che assillano le menti quando son catturate da allucinazioni di terrene apocalissi.
In tedesco usano la parola Amok (in indonesiano significa "uccisione-linciaggio in un impulso d’ira incontrollata"), e tale è stato l’attacco di lunedì alla scuola di Tolosa. Uno squilibrato, ma abbastanza freddo da uccidere serialmente, ammazza in 15 minuti il maestro Jonathan Sandler, due suoi figli di 4 e 5 anni (Gabriel e Arieh), una bambina di 7, Myriam. Chi cade preda dell’amok è imprevedibile e socialmente reietto, ma se ha potuto concepire il crimine (e spesso parlarne sul web) vuol dire che per lungo tempo non si è badato al pericolo, che l’ambiente da cui viene era privo di difese immunitarie. I massacri nelle scuole sono considerati episodi tipici del comportamento amok. Nella cultura malese l’assalto amok evoca lo stato di guerra, ma l’omicida seriale interiorizza la guerra. La spedizione militare è condotta da individui che vivono nel nascosto, ed escono allo scoperto in una sorta di raptus.
Non dimentichiamo che il nazismo quando prese il sopravvento aveva caratteristiche affini, e assecondava la furia amok: "Marcia senza approdo, barcollamento senza ebbrezza, fede senza Dio", così lo scrittore socialdemocratico Konrad Heiden descriveva, nel 1936, la caduta di milioni di tedeschi nel nazismo e nell’"era dell’irresponsabilità". È nelle furie di quei tempi che hanno radice i contemporanei massacri palingenetici, e anche lo spavento stupefatto che scatenano. Non era stato detto, a proposito delle fobie annientatrici: "Mai più?". Invece tornano, perché un tabù infranto lo è per secoli ancora. Il piccolo racconto di Zweig (Amok è il titolo) racconta proprio questo: l’esplosione in mezzo a bonacce apparenti di una "follia rabbiosa, una specie di idrofobia umana... un accesso di monomania omicida, insensata, non paragonabile a nessun’altra intossicazione alcolica". Un torbido passato ha fatto del medico protagonista un mutante: nella solitudine si sente "come un ragno nella sua tela, immobile da mesi". Amok è scritto nei primi anni Venti: un’epoca non meno vacillante della nostra. Già prima del ’14-18, Thomas Mann vedeva l’Europa sommersa da "nervosità estrema".
"L’amok è così - spiega Zweig nel racconto - all’improvviso balza in piedi, afferra il pugnale e corre in strada... Chi gli si para davanti, essere umano o animale, viene trafitto dal suo kris (pugnale, in malese, ndr), e l’orgia di sangue non fa che eccitarlo maggiormente... Mentre corre, ha la schiuma alle labbra e urla come un forsennato... ma continua a correre e correre, senza guardare né a destra né a sinistra, corre e basta. L’ossesso corre senza sentire... finché non lo ammazzano a fucilate come un cane rabbioso, oppure crolla da solo, sbavando". Ci furono opere profetiche, negli anni ’20-’30: i film Metropolis e Dottor Mabuse di Fritz Lang, o il racconto di Zweig. Dove sono oggi opere che abbiano quell’orrida e precisa visione del presente? Se fosse un caso isolato non ne parleremmo come di un fatto di cultura, colmo di presagi. Ma non è un evento isolato, solo criminale. Quest’odio del diverso (dell’ebreo o del musulmano o del Rom: tre figure di capro espiatorio) pervade da tempo l’Europa, mescolando storia criminale e storia politica. E ogni volta è una fucilata subitanea, che interrompe finte normalità. Fu così anche quando nella composta Norvegia scoppiò la demenza assassina del trentaduenne Behring Breivik, il 22 luglio 2011. L’attentato che compì a Oslo fece 8 morti. Il secondo, nell’isola Utoya, uccise 69 ragazzi.
Fenomeni simili, non immediatamente mortiferi, esistono anche in politica e mimeticamente vengono imitati. Nell’America degli odii razziali, in prima linea: l’odio suscitato da Obama meteco tendiamo a sottovalutarlo, a scordarcene. Ma l’Europa è terreno non meno fertile per queste idrofobie umane, peggiori d’ogni intossicazione alcolica. Colpisce la loro banalizzazione, più ancora del delitto quando erompe. In Italia abbiamo la Lega, e banalizzati sono i suoi mai sconfessati incitamenti ai linciaggi. Nel dicembre 2007, il consigliere leghista Giorgio Bettio invita a "usare con gli immigrati lo stesso metodo delle SS: punirne dieci per ogni torto fatto a un nostro cittadino". Lo anticipa nel novembre 2003 il senatore leghista Piergiorgio Stiffoni, che menzionando un gruppo di clandestini sfrattati prorompe: "Peccato. Il forno crematorio di Santa Bona è chiuso". Il gioco di Renzo Bossi (vince chi spara su più barche d’immigrati) è stato tolto dal web ma senza autocritiche.
Com’è potuto succedere che gli italiani divenissero indifferenti a esternazioni di questa natura? Com’è possibile che l’Europa stessa guardi a quel che accade in Ungheria alzando appena le sopracciglia? Eppure il premier Viktor Orbán, trionfalmente eletto nell’aprile 2010, non potrebbe esser più chiaro di così. Il suo sogno è di creare un’isola prospera separata dal turbinio del mondo: una specie di autarchia nordcoreana. A questo scopo ha pervertito la costituzione, le leggi elettorali, l’alternanza democratica, scagliandosi al contempo contro l’etnicamente diverso. A questo scopo persegue una politica irredentista verso la diaspora ungherese in Europa. Il sacrificio di due terzi del territorio nazionale, imposto al Paese vinto dal trattato di Trianon del 1920, è definito "la più grande tragedia dell’Ungheria moderna". Ben più tragica dello sterminio di 400.000 ebrei e zigani nel 1944. Il vero scandalo dei tempi presenti è la punizione inflitta alla democrazia greca, e la non-punizione dell’Ungheria di Orbán. I parametri economici violati e gli spread troppo alti pesano infinitamente più dell’odio razzista, della banalizzazione del male che s’estende in Europa, della democrazia distrutta.
In due articoli sul Corriere della Sera, il 7 e 12 marzo, lo storico Ernesto Galli della Loggia ha difeso lo Stato-nazione oggi derubato di sovranità: lo descrive come "unico contenitore della democrazia", poiché senza di lui non c’è autogoverno dei popoli. È una verità molto discutibile, quantomeno. Lo Stato nazione è contenitore di ben altro, nella storia. Ha prodotto le moderne democrazie ma anche mali indicibili: nazionalismi, fobie verso le impurità etnico-religiose, guerre. Ha sprigionato odii razziali, che negli imperi europei (l’austro-ungarico, l’ottomano) non avevano spazio essendo questi ultimi fondati sulla mescolanza di etnie e lingue. La Shoah è figlia del trionfo dello Stato-nazione sugli imperi. Vale la pena ricordarlo, nell’ora in cui un fatto criminoso isolato, ma emblematico, forse ci risveglia un po’.
* la Repubblica, 21 marzo 2012
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- «L’Europa è il nostro patrimonio». Un’altro cammino per l’Europa è possibile. Il documento alla base dell’incontro di Parigi.17 marzo 2012, di Federico La Sala
Il documento alla base dell’incontro di Parigi: «L’Europa è il nostro patrimonio»
Lavoro, solidarietà giustizia fiscale: così l’Europa può rinascere
- Il testo alla base dell’incontro dei Progressisti a Parigi: la sfida per rilanciare l’Unione su basi di maggiore democrazia ed equità. Il ruolo delle tecnologie, delle infrastrutture e della ricerca. La scommessa di una nuova governance
- Pubblichiamo il testo «Rinascita europea. Crescita, solidarietà, democrazia: un nuovo percorso è possibile» che è alla base dell’incontro di Parigi. Alla stesura hanno partecipato la Fondazione europea di studi progressisti, vicina al Partito Socialista Europeo, la Fondazione Jean Jaurès, vicina al Partito Socialista francese, la Fondazione Italianieuropei, vicina al Pd italiano e la Fondazione Friedrich Ebert, vicina alla Spd tedesca. *
- A settembre 2011, i socialdemocratici danesi sono tornati al governo. Nel novembre 2011 il governo conservatore italiano ha rassegnato le dimissioni. A dicembre 2011 un primo ministro socialista è stato designato in Belgio. Nel 2012 e 2013 le elezioni in Francia, in Italia e in Germania possono rivelarsi decisive per intraprendere un nuovo percorso per l’Europa, sostenuto da una vasta alleanza dell’insieme delle forze socialiste, progressiste e democratiche.
L’Europa è il nostro patrimonio
comune. Il nostro compito è di perseguire la costruzione di un’Europa più unita e democratica. Prendiamo atto che l’assenza di una governance economica europea democratica ed efficace minaccia di trascinare l’Europa in recessione. Privilegiando la deflazione salariale, omettendo di condurre politiche per la crescita e l’occupazione, trascurando la solidarietà e la lotta contro le disparità, riducendo l’Europa a uno spazio di vigilanza e di sanzioni, trascurando il dialogo sociale e la democrazia, si voltano le spalle sia alla necessità di lottare contro la crisi che allo stesso progetto europeo.
Adesso spetta all’Unione europea fornire risposte appropriate. La responsabilità di bilancio e la disciplina fiscale sono degli imperativi per la stabilità nella zona euro e per rilanciare il modello sociale europeo. In ogni Stato dovrebbe essere istituito un percorso che garantisca la riduzione del deficit e dell’indebitamento. È indispensabile ridurre l’indebitamento sovrano in Europa. Ciò andrebbe fatto in modo responsabile, nel rispetto delle regole democratiche di una nuova sovranità europea condivisa e in accordo con i principi di uguaglianza e giustizia sociale. Dovrebbero essere adottate quanto prima iniziative, a livello di Unione europea, per stimolare una crescita sostenuta e sostenibile. Andrebbero rafforzati in questa direzione gli interventi della Banca Europea per gli Investimenti (Bei). Nella fattispecie, le priorità dovrebbero essere la creazione di posti di lavoro e la lotta contro la segmentazione del mercato del lavoro, in particolare nei confronti dei giovani e delle donne.
La politica industriale deve essere reinventata. Essa deve essere messa al servizio dello sviluppo dei grandi progetti industriali, tecnologici, infrastrutturali, di ricerca di innovazione, che favoriscano la conversione ecologica dell’Europa. La politica industriale dovrà favorire un’industria sostenibile («sobria in carbone») basata sulle tecnologie verdi, che assicuri impieghi duraturi e qualificati . Ci sembra inoltre fondamentale appoggiare la diffusione generale e l’armonizzazione dei «certificati verdi» già esistenti in alcuni Paesi dell’Unione europea, per contribuire alla lotta contro il riscaldamento climatico. Devono essere create nuove risorse. Dovrebbe essere subito adottata dal Consiglio la proposta difesa da tempo dai progressisti europei e presentata recentemente dal gruppo dell’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici al Parlamento europeo che punta a istituire una tassa sulle transazioni finanziarie.
Questa consentirà un rincaro del costo delle operazioni speculative, il riequilibrio della tassazione del capitale e del lavoro e faciliterà la lotta contro l’ingiustizia fiscale. Questa tassa assicurerà inoltre che al rilancio dell’economia contribuiscano gli stessi soggetti che hanno provocato la crisi finanziaria. L’Unione Europea dovrebbe assumere iniziative sulle relazioni con i «paradisi fiscali», con l’obiettivo di lottare contro l’evasione fiscale e contribuire a sanare le finanze pubbliche. Al tempo stesso, sarebbe opportuno affrontare seriamente i profondi squilibri macroeconomici e sociali all’origine della crisi nella zona euro.
Il miglioramento della competitività dei Paesi in situazione di deficit commerciale dovrebbe essere accompagnato da sforzi reciproci da parte dei Paesi che invece hanno eccedenze, stimolando la loro domanda interna. Ciò contribuirebbe ad invertire la tendenza alla distribuzione impari della ricchezza di questi ultimi decenni. Sarebbe necessario inoltre distinguere le spese per gli investimenti dalle spese di funzionamento.
La solidarietà deve essere posta al centro delle politiche europee. In questo modo sarà garantita la stabilità della nostra moneta. Proponiamo di prendere in considerazione il rafforzamento di una responsabilità comune europea per una parte del debito sovrano. Le euro-obbligazioni contribuirebbero a un nuovo fondo per il riassorbimento del debito e permetterebbero un riequilibrio delle finanze pubbliche. Il fallimento dei tentativi di rispondere alla crisi nella zona euro da parte dei governi conservatori in Europa, ha portato la Banca centrale europea a svolgere un ruolo attivo nei mercati finanziari. Se questo deficit di leadership politica persistesse, la Bce sarebbe, alla fine, obbligata a svolgere un ruolo ancora più forte per combattere la crisi finanziaria. Questo riorientamento delle politiche economiche in Europa non può comunque essere concepito senza un vero regolamento finanziario, che rimetta i mercati finanziari al servizio dell’economia reale e ristabilisca gli opportuni legami tra finanza ed economia.
Tutto ciò richiede il rafforzamento di una vera democrazia su scala europea. Per questo motivo, l’Unione europea dovrebbe rafforzare le proprie competenze e dotarsi di una vera governance. I cittadini europei dovrebbe essere messi nelle condizioni di poter decidere chiaramente gli orientamenti politici dell’Unione. Il metodo intergovernativo perseguito dai governi conservatori non aiuta. Converrebbe invece estendere la codecisione alle scelte fondamentali di politica economica e sociale. Ciò implica una democrazia europea basata sul metodo comunitario e su un ruolo più decisivo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali fondata sulla sussidiarietà e la partecipazione dei cittadini e accompagnata dal rafforzamento dell’influenza di veri partiti politici europei. A questo proposito, i partiti progressisti europei dovrebbero proporre un candidato comune alla presidenza della Commissione europea. In questo modo, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali, un’altro cammino per l’Europa diventa possibile.
* l’Unità, 17.03.2012
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- L’Europa dei cittadini. Più democrazia meno mercati finanziari (di Jürgen Habermas)12 marzo 2012, di Federico La Sala
Il filosofo tedesco contro le politiche di Angela Merkel. Tiepide verso una maggiore integrazione. Arroganti con i popoli. Succubi degli speculatori
L’Europa dei cittadini. Più democrazia meno mercati finanziari
di Jürgen Habermas (la Repubblica, 12.03.2012)
Nel processo dell’integrazione europea vanno distinti due piani. L’integrazione degli stati affronta il problema di come ripartire competenze tra l’Unione da un lato e gli stati membri dall’altra. Questa integrazione riguarda dunque l’ampliamento di potere delle istituzioni europee. Invece l’integrazione dei cittadini riguarda la qualità democratica di questo crescente potere, ossia la misura in cui i cittadini possono partecipare a decidere i problemi dell’Europa. Per la prima volta dall’istituzione del Parlamento europeo, il cosidetto «fiscal compact» che si sta varando in queste settimane (per una parte dell’Unione) serve a far crescere l’integrazione statale senza una corrispondente crescita dell’integrazione civica dei cittadini. (...)
La tesi che vorrei difendere in questa sede è presto detta. Solo una discussione democratica che affronti a trecentosessanta gradi il futuro comune della nostra cittadinanza europea potrebbe produrre decisioni politicamente credibili, capaci cioè di imporsi ai mercati finanziari e agli speculatori che puntano sulla bancarotta degli stati. (...) Finora, pur cercando di armonizzare accortamente (quanto meno nell’eurozona) le loro politiche fiscali ed economiche, gli stati membri non sono andati al di là di retoriche proclamazioni. L’integrazione degli stati diventerà credibile solo quando potrà appoggiarsi a una integrazione dei cittadini in cui si manifestino maggioranze dichiaratamente pro-europee. In caso contrario, la politica non riguadagnerà più la sua autonomia di contro alle agenzie di rating, grandi banche ed hedgefounds. (...)
Dal mio punto di vista, sul piano della politica europea, il governo tedesco sta facendo poche cose giuste e molte cose sbagliate. Lo slogan Più Europa è la risposta giusta a una crisi dovuta a un difetto di costruzione della comunità monetaria. La politica non riesce più a compensare gli squilibri economici che ne sono nati. Sul lungo periodo, il riassetto dei divergenti sviluppi economico-nazionali è realizzabile solo in termini di collaborazione, nel quadro di una responsabilità democraticamente organizzata e condivisa, capace di legittimare anche un certo grado di redistribuzione che oltrepassi le frontiere nazionali.
Da questo punto di vista, il «fiscal compact» è certamente un passo nella direzione giusta. Fin dalla sua definizione ufficiale - trattato «per la stabilità, l’armonizzazione e la governance» - si vede come questo patto sia costituito da due diversi elementi. Esso obbliga i governi per un verso a rispettare le discipline di bilancio nazionali, per l’altro verso a istituzionalizzare una governance di politica economica avente per obbiettivo di eliminare gli scompensi economici (quanto meno nell’eurozona). Come mai però Angela Merkel festeggia solo la prima parte del patto, quella mirante a penalizzare le infrazioni di bilancio, mentre non spende una parola sulla seconda parte, mirante a una concertazione politica della governance economica? (...) Il governo tedesco, pur riconoscendo a parole il bisogno di una integrazione ulteriore, di fatto contribuisce a lasciar marcire la crisi. A questo riguardo mi limito a quattro brevi considerazioni.
In primo luogo non occorre farla lunga, in termini di politica economica, per capire che una unilaterale politica restrittiva, come quella caldeggiata nella Ue dal governo tedesco, spinge nella deflazione i paesi più sofferenti. Ove non si integrino le politiche restrittive con politiche di sviluppo, la pace sociale delle nazioni poste sotto tutela finirà per essere disturbata non soltanto dai pacifici e ordinati cortei dei sindacati.
In secondo luogo, la politica restrittiva risponde all’idea sbagliata secondo cui tutto si risolverà nel momento in cui gli stati membri sapranno accettare questo nuovo patto di stabilità e crescita. Di qui la fissazione di Angela Merkel nel voler imporre sanzioni: una postura minacciosa assolutamente superflua nel momento in cui si riuscissea inserire nella legislazione ordinaria della Ue una governance economica condivisa. Continua invece a imperversare l’idea per cui basterebbe istituire una «giusta» costituzione economica - dunque «regole» sovratemporali - per risparmiarci le fatiche di una concertazione politico-economica nonché i costi derivanti da una legittimazione democratica dei programmi di redistribuzione.
In terzo luogo, Merkel e Sarkozy operano sostanzialmente sul piano di una politica intergovernativa, mirando a spingere avanti, senza troppo rumore, l’integrazione degli stati e non quella dei cittadini. I capi di governo dei 17 paesi rappresentati nel Consiglio dei ministri dovrebbero tenere in pugno il bastone di comando. Sennonché, una volta dotati delle competenze di governance economica, essi svuoterebbero la sovranità economica dei parlamenti nazionali.
La conseguenza sarebbe un rafforzamento postdemocratico degli esecutivi dalle conseguenze imprevedibili. Allora, l’inevitabile protesta dei parlamenti spodestati avrebbe almeno il vantaggio di portare in luce quel deficit di legittimazione che solo una riforma democratica degli organi di governo comunitari potrà colmare. In quarto luogo, le parole d’ordine del governo tedesco in fatto di bilancio suscitano all’estero il sospetto che la Germania federale persegua mire nazionalistiche. «Nessuna solidarietà, se prima non si garantisce stabilità».
La proposta lanciata da Berlino di mandare un commissario plenipotenziario ad Atene - dove già ci sono, con analoghe funzioni di controllo, tre commissari appena giunti dalla Germania- dimostra un’incredibile insensibilità nei confronti di un paese in cui non si è ancora spento il ricordo delle efferatezze compiute dalle Ss e dalla Wehrmacht. Helmut Schmidt, in un appassionato discorso, ha deplorato che il governo attuale stia dilapidando il prezioso capitale di fiducia che la Germania si era guadagnata presso i vicini nel corso degli ultimi cinquant’anni.
L’impressione generale - che si ricava da questa sciocca arroganza, per un verso, e dalla troppo timida risposta al ricatto dei mercati finanziari, per l’altro - è che la politica europea non abbia ancora raggiunto il livello di una vera «politica interna». (...)
Queste prudenze non sono neppure giustificabili dal vecchio argomento secondo cui l’integrazione è destinata a fallire per mancanza di un popolo europeo e di una sfera pubblica europea. Nelle idee di «nazione»e di «popolo» avevamo a che fare con fantastici soggetti omogenei: ideali che solo nel corso dell’Ottocento, canalizzati dalle scuole pubbliche e dai mass media, si erano impadroniti dell’immaginario popolare. Sennonché le catastrofi del ventesimo secolo non hanno lasciato indenni le ideologie storiografiche dei vari nazionalismi. Oggi l’Europa deve fare i conti non tanto con popoli illusoriamente omogenei, quanto piuttosto con stati-nazione concreti, con una pluralità di lingue e di sfere pubbliche.
Pur associandosi sempre più strettamente sul piano europeo, gli stati nazionali conservano funzioni specifiche. Essi non devono affatto dissolversi in uno stato federale d’Europa, ma conservare un ruolo di garanzia per i livelli di democrazia e di libertà fortunatamente già raggiunti. Ciascuno di noi unisce in petto due ruoli: quello di cittadino del proprio stato e quello di cittadino dell’Unione. E nella misura in cui i cittadini dell’Unione capiranno quanto profondamente le decisioni europee modificano la loro vita, tanto più si sentiranno coinvolti in una politica europea che può anche chiedere di spartire sacrifici. (...) Si dice che la repubblica di Weimar sia fallita perché i suoi difensori democratici erano troppo pochi. Fallirà l’Unione europea per i troppi sostenitori troppo tiepidi?
 Traduzione di Leonardo Ceppa e Walter Privitera
Traduzione di Leonardo Ceppa e Walter Privitera -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Tocca prendere in mano il nostro destino, se non si vuol ripetere l’inerzia e il non-pensiero che ci contraddistingue da vent’anni e più (di Barbara Spinelli - La cecità dell’Europa).7 marzo 2012, di Federico La Sala
La cecità dell’Europa
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 7 marzo 2012)
Se è vero quello che disse una volta Jean Monnet -«l’Europa si fa nelle crisi» -siamo davanti a un ’occasione unica per diventare un’Unione autentica, capace di pensare e agire con la propria testa. Unione non determinata all’esterno da Stati-tutori, non corrosa all’interno dai vecchi imperativi dell ’equilibrio fra potenze. È in crisi la sua economia, lo sappiamo. Ma è in crisi anche la sua democrazia, perché pluralismo e alternanza sono sempre più visti come ostacoli alle decisioni rapide, prese da pochi competenti: lo comprova il disastro greco, e anche i timori che alcuni governi (Berlino in testa) sembrano nutrire verso la possibile sconfitta di Sarkozy in Francia.
È poi in crisi la laicità, che della democrazia è condizione, perché le chiese quando scorgono Stati fragili «si organizzano per vincere» (sono parole recenti del cardinale Martini), non per affinare la capacità profetica, guardando lontano e profondo. Il primato dato a non-negoziabili valori bioetici, il disinteresse manifestato soprattutto in America per l’equità sociale, sono elementi di una lotta solo di potere.
Infine è in crisi la politica estera, legata in Europa agli schemi del dopoguerra e della guerra fredda. Ignari delle mutazioni mondiali, gli europei faticano a prender atto che i centri di potere si sono moltiplicati, che l’Occidente non è più ombelico dell’universo. Sono abituati a seguire Washington, ma Washington non è più né l’autorità che ci garantisce come nella guerra fredda, né il solo potere globale come supponevano Bush padre, Clinton, Bush figlio.
Che posizione hanno gli europei sul Mediterraneo, e su Israele, sull’Iran, sullo scontro fra Stati sciiti e sunniti? Per ora non ne hanno alcuna: anche in politica estera esiste la tentazione del laissez-faire (il mondo tolemaico che ruota attorno alla terra americana pensa per tutti noi). Ma la svolta è vicina, anzi è già presente. Tocca prendere in mano il nostro destino, se non si vuol ripetere l’inerzia e il non-pensiero che ci contraddistingue da vent’anni e più.
Se guardassero oltre il proprio naso, gli europei vedrebbero quel che sta succedendo nelle presidenziali Usa. Vedrebbero che l’America è uno Stato debole, esposto a ogni sorta di pressioni, e ansioso di liberarsene. Vedrebbero, sulla vicenda Iran, un’amministrazione che ha proprie idee ma stenta ad attuarle perché incapace di imporre la condotta che ritiene razionale a un minuscolo Stato
 Israele - che ha il potere di condizionarla. Un potere abnorme, alla lunga non sostenibile, dunque
pericoloso per Israele stesso. Secondo Gideon Levy, commentatore del giornale Haaretz, il peso è
senza precedenti storici e finirà col ritorcersi contro lo Stato ebraico. Non fosse altro perché chi
difende Israele negli Usa (l’AIPAC, Comitato Israele-America per gli Affari pubblici) rappresenta
solo una parte del paese: i conservatori, avvinti all’occupazione dei Territori da 45 anni.
Israele - che ha il potere di condizionarla. Un potere abnorme, alla lunga non sostenibile, dunque
pericoloso per Israele stesso. Secondo Gideon Levy, commentatore del giornale Haaretz, il peso è
senza precedenti storici e finirà col ritorcersi contro lo Stato ebraico. Non fosse altro perché chi
difende Israele negli Usa (l’AIPAC, Comitato Israele-America per gli Affari pubblici) rappresenta
solo una parte del paese: i conservatori, avvinti all’occupazione dei Territori da 45 anni.In tre anni, Obama ha ceduto a tali pressioni, fino a seppellire i piani sullo Stato palestinese. Ora Netanyahu lo spinge a posizioni bellicose sull’Iran, nel preciso momento in cui l’America, spezzata da guerre perdute e inferma economicamente, non è pronta a nuovi atti militari. La visita di Netanyahu a Washington, lunedì, ha confermato questo divario di esperienze e intenti, dando l ’impressione - falsa - di due potenze simmetriche. Domenica, all’AIPAC, Il Presidente ha detto che «tutte le opzioni sono sul tavolo» (guerra inclusa), ma ha avversato «incontrollati discorsi bellici»: «Per il bene della sicurezza di Israele, della sicurezza Usa, della pace e della sicurezza del mondo, questo non è il momento di fare i gradassi». Netanyahu è avvisato: l’America non si farà trascinare in conflitti incontrollati, e senza lei Netanyahu penerà a gettarsi in azioni militari. Resta il fatto che il suo governo entra nelle elezioni Usa come primo attore, puntando su Obama disfatto.
Non è l’unico gruppo di pressione a operare in tal modo, profittando dell’indebolita democrazia americana. Altre lobby (etniche, confessionali, finanziarie) la comprimono: ricordiamo gli evangelicali o i cattolici. A proposito di questi ultimi sono preziose le analisi di Massimo Faggioli, professore di teologia in Minnesota, sui giornali L’Europa o L’Unità. In maniera abnorme, anche qui, la Chiesa influenza il voto Usa: con i cattolici bianchi attratti dai valori bioetici (lacontraccezione, oggi) e i cattolici non bianchi (neri, ispanici) «più attenti alle esigenze di giustizia sociale che alla morale sessuale».
L’affievolirsi della sovranità politica americana, la sua dipendenza da poteri esterni e lobby interne: sono deperimenti che dovrebbero indurre l’Europa a divenire potenza sovrannazionale non solo economicamente, non solo per fare dei singoli debiti sovrani un comune debito dell’Unione, ma anche in politica estera, di difesa. Così come non potremo in futuro affidare il mondo multipolare a una moneta di riserva internazionale, il dollaro, che riflette i bisogni di una sola nazione, così non possiamo affidare la nostra politica estera a una potenza fattasi più influenzabile da paesi, chiese, interessi economici coi quali dobbiamo imparare a costruire un nostro rapporto, fondato sulla lealtà e la storia d’Europa - compresa la storia degli ebrei d’Europa - ma anche sulla laicità (esiste un imperativo di deconfessionalizzazione del mercato e delle diplomazie, oltre che delle chiese). Il caso della Chiesa cattolica è significativo; nonostante gli irrigidimenti anti-conciliari, in Europa è più difficile che i cattolici trascurino l’equità sociale come in America.
L’America stessa non potrà farsi guidare da lobby sino a divenire loro ombrello e collettore. Dovrà trovare se stessa, e - l’abbiamo visto - questo potrebbe sfociare in uno scontro con Israele. Tornando a Teheran: la politica che s’impernia sul ricorso ineluttabile alle armi potrebbe esser sostituita in un secondo tempo da altre visioni, fondate sull’arbitrato anziché la guerra. La nuclearizzata Corea del Nord non minaccia il Giappone meno esistenzialmente di quanto l’atomica iraniana insidi Israele - eppure Tokyo non ha lo stesso peso sulla politica statunitense. Il 29 febbraio si è aperta una fase negoziale, giudicata con interesse dall’Economist, ma Pyongyang non rinuncia alle testate che ha. Promette di congelare l’arricchimento dell’uranio - in una sola centrale - in cambio di copiosi aiuti alimentari. Perché lo stesso non potrebbe avvenire con l’Iran, un giorno? Perverso, nella storia nordcoreana, è che dotarsi di bombe è stato propedeutico ai negoziati odierni. Questo conferma che nessuno Stato può sopportare la spada di Damocle di una guerra preventiva continuamente minacciata. Prima o poi, fatalmente, desidererà dotarsi dell’atomica e santuarizzarsi, proprio per poter meglio trattare e aprirsi. È quel che ha fatto il Nord Corea. È quel che forse medita il governo iraniano.
Dipendere dall’America significa oggi, per l’Europa, dipendere da una democrazia scossa, da un ’economia fragile, da una difesa non più prodiga di garanzie. Vale la pena, per l’Europa come per Israele, uscire dai ghetti e cominciare a costruire il proprio destino etsi deus non daretur, come se non esistesse un Dio-custode oltre Atlantico. Quale amministrazione scegliere, migliore di quella di Obama?
Nel 2014, cioè domani, si voterà per il nuovo Parlamento europeo. È sperabile che fra tanti partiti ce ne sia uno che abbandoni gli occhiali nazionali (non fanno vedere più nulla) e inforchi gli occhiali cosmopolitici che vedano e progettino gli Stati Uniti d’Europa. La non - Europa già ci è costata tanto, troppo. Il federalismo non è un’opzione tra le altre: è una via obbligata. Gli Stati-nazione sono più gracili di un’unione. La storia americana, e i suoi regressi, ce lo mostrano con evidenza.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Non è troppo tardi per l’Italia e per l’Europa: ci sono ancora margini per recuperare il terreno perduto, ma c’è davvero poco tempo da perdere (di Pier Luigi sacco - Un appello all’Europa della cultura)..4 marzo 2012, di Federico La Sala
Un appello all’Europa della cultura
di Pier Luigi Sacco (Il Sole-24 Ore, 4 marzo 2012)
L’Italia, e in grande misura l’intera Europa, deve oggi fronteggiare una sfida non semplice: quella di ritrovare la via della crescita. È una sfida che non può esaurirsi nella messa a punto di vecchi modelli, e che richiede invece in larga misura un atto di coraggio e di visione; due ingredienti che mancano ormai da troppo tempo nelle pentole in cui si cucinano le ricette della politica economica nazionale e continentale. Che la cultura debba far parte in modo importante del nuovo scenario è una opinione ancora minoritaria ma sempre più diffusa; e prova ne è la sorprendente risposta suscitata dal Manifesto pubblicato da questo giornale due settimane orsono, e che è stato sottoscritto entusiasticamente non soltanto da gran parte del mondo culturale italiano, ma anche da esponenti di primo piano della scena europea come il commissario all’Istruzione e alla cultura Vassiliou e il ministro danese della Cultura Elbaek: una eventualità difficile da pronosticare anche per i più inguaribili ottimisti.
Nell’opinione di molti la cultura è tutt’altro che una leva di crescita, è piuttosto un buco che risucchia risorse invece di produrne e che non a caso è quindi destinata a subire tagli selvaggi in tempi di crisi. Ma questo punto di vista, che peraltro fa riferimento a una concezione decisamente obsoleta del ruolo economico e sociale della cultura, è decisamente smentito dai fatti. Come dimostrano gli studi prodotti in questi ultimi anni su iniziativa della Commissione europea, e replicati in modo sempre più articolato e particolareggiato a livello nazionale e regionale, il sistema della produzione culturale e creativa è non soltanto un meta-settore industriale a tutti gli effetti, ma anche uno dei più grandi, superiore per fatturato ai principali comparti del manifatturiero e alla maggior parte dei comparti del terziario avanzato; non a caso, già nel 2005 esso si attestava in Europa a un livello doppio di quello dell’industria automobilistica, un divario che col tempo è andato peraltro ampliandosi piuttosto che ridursi. Non soltanto: questi stessi studi dimostrano chiaramente che la produzione culturale e creativa è uno dei maggiori e più promettenti terreni di coltura della nuova ondata imprenditoriale di prima generazione non soltanto in Europa ma anche in molte economie emerse ed emergenti dell’Asia, e persino in contesti in via di sviluppo come quello africano.
Ciò malgrado, sia in Italia sia in Europa si fa fatica a cogliere il senso di questo scenario e delle opportunità che porta con sé. In Italia, la cultura subisce tagli che rischiano di comprometterne la sostenibilità, mentre nel nostro continente essa stenta a trovare uno spazio e un ruolo all’altezza del suo potenziale nella strategia di Europa 2020, come conferma purtroppo anche l’esclusione del patrimonio culturale dal prossimo Ottavo Programma Quadro della Ricerca e Innovazione; a differenza di quanto accade per settori di attività più legittimati e più strettamente legati nell’opinione corrente ai temi dello sviluppo e della crescita.
È particolarmente singolare che ciò avvenga in un Paese come il nostro, che ha una dotazione di capitale culturale tangibile e intangibile del tutto formidabile e una identità nazionale legata come poche altre alle tematiche della cultura nell’immaginario globale. Le opportunità connesse alla valorizzazione di questo patrimonio nell’ottica di un nuovo modello di crescita sono enormi, e non passano soltanto dal turismo culturale, ma anche e, in prospettiva, soprattutto dalla produzione di cultura: in una fase in cui la ricchezza si genera appunto soprattutto attraverso la capacità di dar vita a piattaforme digitali di contenuti che si inseriscono in modo sempre più immersivo nella esperienza quotidiana di tutti noi - dalla progettazione allo shopping, dall’informazione allo svago, dallo studio all’organizzazione e alla gestione dei processi produttivi -, la ’materia prima’ che alimenta queste nuove catene del valore in rapidissima crescita dimensionale ed economica è appunto la cultura in tutte le sue molteplici forme, per cui i Paesi che sono ricchi di patrimonio storico-artistico e sono disposti a mettersi in gioco sulla frontiera dell’innovazione coniugando creatività tecnologica e culturale possono costruire su tali premesse una leadership competitiva che può davvero avviare un nuovo e robusto ciclo di crescita. Non è un caso se economie emergenti quali la Cina o il Brasile stanno investendo sullo sviluppo della propria industria culturale e creativa risorse ingentissime, e se alcune delle economie avanzate di maggior successo e in grande crescita quali ad esempio la Corea del Sud o l’Australia si stanno profilando in modo molto efficace e aggressivo proprio nei settori della cultura e della creatività, attraendo investimenti e talento.
Non è troppo tardi per l’Italia e per l’Europa: ci sono ancora margini per recuperare il terreno perduto, ma c’è davvero poco tempo da perdere. E per vincere questa sfida è necessario in primo luogo superare gli sterili dibattiti circa il ruolo e la responsabilità del pubblico piuttosto che del privato nell’investire in cultura. Tutti e due possono e debbono avere un ruolo ben preciso. Quello dello Stato è investire nei settori che non possono assicurare margini di profittabilità tali da rendere sostenibile un investimento esclusivamente privato, ma che nondimeno sono fondamentali per alimentare le ricerche più innovative e sperimentali dalle quali si approvvigionano le forme di produzione più profittevoli e orientate al mercato. Quello del privato è, da un lato, il sostegno a quelle forme di produzione culturale che si legano in maniera più strategica ai propri settori di attività e ai propri territori di riferimento e, dall’altro, quello di sviluppare il più possibile il macro-settore dell’industria culturale e creativa, fornendo energie imprenditoriali, capitali e talento nella consapevolezza che nell’economia globale dei prossimi vent’anni questo è uno degli ambiti nei quali potremo ancora essere protagonisti, rimanendo sulla frontiera dell’innovazione e competendo su un mercato enorme e in rapida crescita, ricco di nicchie molto diversificate e in alcuni casi decisamente profittevoli. Tanto per il pubblico che per il privato, c’è una responsabilità congiunta nella salvaguardia del nostro patrimonio culturale, che non è soltanto un archivio straordinario e insostituibile di creatività, valori estetici, idee senza tempo, ma anche una materia viva, che continua a costruirsi e a evolvere ogni giorno, sotto i nostri occhi, tanto più quanto più la nostra creatività è all’altezza del passato da cui si alimenta.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- L’Europa, insomma, cancella la sua propria scaturigine, elide la matrice da cui è sorta, uccide simbolicamente la madre Grecia.29 febbraio 2012, di Federico La Sala
L’Europa uccide la madre Grecia
di Angelo d’Orsi (il Fatto, 29.02.2012)
Si susseguono appelli per la Grecia: gli ultimi due, in ordine di tempo, assai accorati, sono di una dozzina di intellettuali francesi e di un gruppo di cittadini greci. L’uno e l’altro chiedono adesioni a livello internazionale, sottolineando la gravità della situazione, ossia individuando nella Grecia una sorta di capro espiatorio su cui i corvi della grande finanza internazionale si aggirano sperando muoia, o si sottometta a un regime iugulatorio, che espropria non solo lo Stato greco, ma l’intera popolazione di qualsivoglia diritto a una esistenza dignitosa, e indipendente. La Grecia come modello della “nuova Europa”, davvero delle Banche, sia che Atene resti dentro il recinto dell’Unione, sia, preferibilmente, che ne esca: a quel punto si potrà persino accelerare il processo di unificazione, nel quale sta emergendo l’inedito accoppiamento tra tecnocrati e poliziotti: il potere gelido, apparentemente imparziale, dell’eurodollaro, gestito da asettici e quasi invisibili personaggi, sorretto dal visibilissimo potere del manganello: si sta facendo ricorso, dappertutto, a un impiego forsennato di forza pubblica (al servizio di interessi privati, della voce di chi è più forte), in azioni di “contenimento” sempre più dure, che vogliono sottolineare come il potere del dio denaro è intoccabile e non può essere sfiorato dal dubbio, dalla contestazione, dalla messa in discussione.
LA GRECIA come cavia di un esperimento che mira a costruire una società di spaventose disuguaglianze, di dominio dei ricchi sui meno ricchi, e subordinazione ed emarginazione totale dei poveri, di cancellazione del welfare, di erosione dei diritti politici e civili e, infine, di “superamento” della forma democratica, nonché di messa in mora della sua sostanza. Sì, la Grecia rappresenta un momento devastante della nostra storia, come si legge in uno di questi appelli. Come difenderla? Come difenderci? Probabilmente, in questa situazione, gli appelli, nobili e certo importanti, forse anche necessari, suonano forse già fuori tempo massimo. Mi chiedo, mentre li sottoscrivo, a che cosa possano servire. Forse più che a salvare quel paese (ma da cosa? Da se stesso? O piuttosto dalle rapaci mani della “Troika”?), mirano a salvare la nostra anima: quasi che pregassimo un qualche iddio dopo aver consumato il crimine.
PERCHÉ di questo si tratta; e del più efferato tra i crimini: l’uccisione della madre. E v’è, in quello che sta accadendo, una sorta di paradossale, involontario richiamo alla tragedia greca: è un dramma degno di Sofocle o di Euripide questa Europa che fa a pezzi, e si accinge a sbranare la madre Europa, in nome di se stessa, della sua unità, della moneta unica, della pretesa sua identità “giudaico-cristiana” (una delle tante sciocchezze che ci hanno ammannito in questi anni: e le culture pagane, a cui erano informate tanto la Grecia quanto Roma? E la cultura islamica, che ha colonizzato ampiamente il Continente? E le culture dei tanti popoli “barbari” del Nord?).
L’Europa, insomma, cancella la sua propria scaturigine, elide la matrice da cui è sorta, uccide simbolicamente la madre Grecia, quella che addirittura ha partorito il suo nome, e il mito fondativo: la giovinetta Europa, la bellissima fanciulla rapita da Zeus sulla spiaggia di Tiro (o di Sidone, le due note città libanesi), sotto le spoglie di un bianco toro, che la portò, seduta sulla sua groppa, nel mare Egeo, giungendo fino all’isola di Creta, dove si accoppiò con lei sotto le fronde di un platano. Da loro nacquero tre figli, tra cui Minosse, che di Creta divenne re, e in suo onore, e di sua madre dai grandi occhi (tale il significato del termine, secondo un’etimologia peraltro incerta), fu dato il nome di Europa alle terre a nord del Mediterraneo.
Ebbene, ora quelle terre, guidate in modo dittatoriale da una leadership algida e feroce, sulla madre Europa gettano il peso della loro spada pesantissima, chiedendo in cambio non soltanto oro - come fece Brenno, il capo dei Galli, nella Roma conquistata e saccheggiata -, bensì il sangue e la dignità di un popolo. Che per ora è quello greco, domani sarà il nostro.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- LA VERA MALATTIA CHE PIEGA L’EUROPA (di Paul Krugman)28 febbraio 2012, di Federico La Sala
La vera malattia che piega l’Europa
di Paul Krugman (la Repubblica, 28 febbraio 2012)
La situazione in Portogallo è terribile, ora che la disoccupazione vola addirittura oltre il 13 per cento. Ma va anche peggio in Grecia, Irlanda e probabilmente Spagna. Nel suo complesso tutta l ’Europa pare scivolare nuovamente nella recessione. Perché l’Europa è diventata il malato dell ’economia mondiale? La risposta è nota a tutti.
Purtroppo, però, buona parte di ciò che si sa non è attendibile, e le false voci sui guai europei stanno snaturando il nostro dibattito economico. È assai probabile che chi legge un articolo d’opinione riguardante l’Europa - oppure, troppo spesso, una presunta cronaca giornalistica degli avvenimenti - possa imbattersi in una di due possibili interpretazioni, alle quali penso in termini di variante repubblicana e variante tedesca. In verità, nessuna delle due rispecchia la realtà.
Secondo la versione repubblicana di come stanno le cose - uno dei temi centrali sui quali batte la campagna elettorale di Mitt Romney -, l’Europa si trova nei guai perché ha esagerato nell’aiutare i meno abbienti e i disgraziati, e staremmo quindi assistendo all’agonia del welfare state. Questa versione dei fatti, a proposito, è una delle costanti preferite della destra: già nel 1991, quando la Svezia si angosciò per una crisi delle banche innescata dalla deregulation (vi suona familiare?), il Cato Institute pubblicò un trionfante articolo su come ciò che stava accadendo di fatto confermasse il fallimento dell’intero modello del welfare state.
Vi ho già detto che la Svezia - che ha ancora oggi un generoso welfare - è al momento una delle migliori performer e ha una crescita economica più dinamica di qualsiasi altra ricca nazione? Ma procediamo con sistematicità: pensiamo alle 15 nazioni europee che usano l’euro (lasciando in disparte Malta e Cipro) e proviamo a classificarle in rapporto alla percentuale di Pil che hanno speso in programmi di assistenza sociale prima della crisi. Le nazioni Piigs (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna) che oggi sono nei guai spiccano davvero in tale classifica per il fatto di avere uno stato assistenziale insolitamente generoso? Niente affatto. Soltanto l’Italia rientra nelle prime cinque posizioni della classifica, ma anche così il suo welfare state è inferiore a quello della Germania. Ne consegue che i problemi non sono stati causati da grandi welfare.
Passiamo ora alla versione tedesca, secondo la quale tutto dipende dall’irresponsabilità fiscale. Questa opinione pare adattarsi alla Grecia, ma a nessun altro Paese. L’Italia ha avuto deficit negli anni antecedenti alla crisi, ma erano di poco superiori a quelli tedeschi (l’enorme indebitamento dell ’Italia è un’eredità delle irresponsabili politiche di molti anni fa). I deficit del Portogallo erano significativamente inferiori, mentre Spagna e Irlanda in realtà avevano plusvalenze.
Ah: non dimentichiamo che Paesi non appartenenti alla zona euro sembrano proprio in grado di avere grandi deficit e sostenere un forte indebitamento senza affrontare alcuna crisi. Gran Bretagna e Stati Uniti possono prendere in prestito capitali a un tasso di interesse che si aggira intorno al 2 per cento. Il Giappone - di gran lunga più indebitato di qualsiasi Paese europeo, Grecia inclusa - paga soltanto l’1 per cento. In altre parole, il processo di ellenizzazione del nostro dibattito economico - secondo il quale tra uno o due anni soltanto ci troveremo nella stessa situazione della Grecia - è del tutto sbagliato.
Che cosa affligge, dunque, l’Europa? La verità è che la questione è in buona parte legata alla moneta. Introducendo una valuta unica senza aver preventivamente creato le istituzioni necessarie a farla funzionare a dovere, l’Europa in realtà ha ricreato i difetti del gold standard, inadeguatezze che rivestirono un ruolo di primo piano nel provocare e far perdurare la Grande Depressione. Andando più nello specifico, la creazione dell’euro ha alimentato un falso senso di sicurezza tra gli investitori privati che ha dato briglia sciolta a enormi e insostenibili flussi di capitali nelle nazioni di tutta la periferia europea. In conseguenza di questi flussi, le spese e i prezzi sono aumentati, la produzione ha perso in competitività e le nazioni che nel 1999 avevano a stento raggiunto un equilibrio tra importazioni ed esportazioni hanno iniziato invece a incorrere in ingenti deficit commerciali. Poi la musica si è interrotta.
Se le nazioni della periferia europea avessero ancora le loro valute potrebbero ricorrere alla svalutazione - e sicuramente lo farebbero - per ripristinare quanto prima la propria competitività. Ma non le hanno più, e ciò significa che sono destinate a un lungo periodo di disoccupazione di massa e a una lenta e faticosa deflazione. Le loro crisi debitorie sono per lo più un effetto collaterale di questa triste prospettiva, perché le economie depresse portano a deficit di budget e la deflazione aumenta l’incidenza del debito.
Diciamo pure che comprendere la natura dei guai europei offre agli europei stessi benefici soltanto assai limitati. Alle nazioni colpite, in particolare, non resta granché al di là di scelte difficili: o soffrono le pene della deflazione oppure prendono la drastica decisione di abbandonare l’euro, il che non sarà praticabile da un punto di vista politico fino a quando - o a meno che - ogni altra cosa non avrà fallito (punto verso il quale pare che si stia avvicinando la Grecia). La Germania potrebbe dare una mano facendo dietrofront rispetto alle sue stesse politiche di austerità e accettando un ’inflazione più alta, ma non lo farà.
Per il resto di noi, tuttavia, capire bene come stanno le cose in Europa fa una bella differenza, in quanto circolano su di essa false teorie utilizzate per spingere avanti politiche che potrebbero rivelarsi aggressive, distruttive o entrambe le cose. La prossima volta che sentirete qualcuno invocare l’esempio dell’Europa per chiedere di far piazza pulita delle nostre reti di sicurezza sociale o per tagliare la spesa a fronte di un’economia gravemente depressa, ricordate di tenere bene a mente che non ha idea alcuna di ciò di cui sta parlando.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Manca ogni visione del mondo, e la cultura non è più quella del ’45-’50 (di Barbara Spinelli - .22 febbraio 2012, di Federico La Sala
La tentazione del muro
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 22.02.2012)
Con molta, troppa facilità ci stiamo abituando a dire che la bancarotta greca non sarebbe poi la catastrofe paventata da anni. Il male, incurabile, basterebbe allontanarlo, asportando Atene dall’Eurozona come si fa con un’appendicectomia. Quel che conta è evitare il contagio, e non a caso il Fondo salva Stati si chiama d’un tratto Firewall, muro parafuoco che serve a proteggere i sistemi informatici dalle intrusioni: che salverà chi è ancora dentro (l’Italia, per esempio) da chi, nell’ignominia, sta cadendo fuori.
Come la linea Maginot che i francesi eressero per proteggersi dagli assalti tedeschi negli anni ‘20-’30, Firewall evoca gli universi chiusi della clinica e della guerra: il miraggio d’un muro inviolabile rassicura, anche se sappiamo bene come finì il fortilizio francese. Cadde d’un colpo. Lo storico Marc Bloch parlò di strana disfatta perché il tracollo era avvenuto negli animi, prima che lungo la Maginot: «nelle retroguardie della società civile e politica», prima che al fronte.
In realtà nessuno ci crede, al chimerico Firewall che abita le fantasie e fiacca la ragione. Altrimenti l’Unione non avrebbe deciso, ieri, un ennesimo importante prestito alla Grecia. Altrimenti non ci sarebbe chi pensa, allarmato, a una nuova architettura dell’Unione: più federale, dotata di un governo europeo cui gli Stati delegheranno sovranità crescenti. Ci stanno pensando Berlino e forse Roma, anche se Monti ha appena firmato una lettera con Cameron e altri europei in cui non si parla affatto di nuova Unione, ma di completare il mercato unico. Così le cose procedono lente, e il problema cruciale (le risorse di cui disporrà l’Unione, per un possente piano di investimenti) nessuno l’affronta. In parte la lentezza è dovuta a corti calcoli prudenziali: ogni leader ha le sue elezioni. In parte si vuol vedere l’esito del dramma ellenico, e qui comincia la parte più torbida della storia europea che si sta facendo.
Ci sono momenti in cui sembra che i governi forti aspettino la bancarotta greca, per costruire l’Unione che dicono di volere. È la tesi dell’economista Usa Kenneth Rogoff, intervistato da Spiegel: una volta espulsa Atene, gli Stati Uniti d’Europa si faranno prima del previsto, grazie alla crisi. C’è, nell’aria, odore di capri espiatori. Ma è proprio vero che l’autodafé della Grecia genererebbe la nuova Unione? E quale Europa nascerebbe, se svanirà la pressione della crisi greca? Per ora, una cosa pare certa: Atene è in tumulto, e a forza di piani a breve termine mina l’eurozona e l’idea stessa di un’Europa solidale nelle sciagure. Difficile che quest’ultima si costituisca in federazione, se il primo atto consisterà nel gettare a mare i Paesi che non ce la fanno. L’operazione Firewall non è indolore per la Grecia, ma neppure per l’Europa.
È quello che hanno scritto sull’Economist Mario Blejer e Guillermo Ortiz, ex banchieri centrali dell’Argentina e del Messico, in un appello in cui si ricorda agli europei il costo della bancarotta di Buenos Aires nel 2002, e la diversità tra quel fallimento e quello temuto in Grecia. L’Argentina conobbe in effetti sei anni di crescita dopo la svalutazione del peso e lo sganciamento dal dollaro, ma nel mondo non c’era la recessione odierna, il risanamento fu distribuito lungo una decina d’anni, e il peso esisteva ancora. Invece la dracma non c’è più, e ricrearla sarebbe un salasso terribile (i debiti greci sono in euro: come ripagarli con dracme svalutate?). Infine, aggiungono i banchieri centrali, s’è persa memoria della veduta breve del Fondo Monetario, e di un tracollo che fu «straziante» per gli argentini. La loro bancarotta era obbligata mentre non lo è per la Grecia, che è pur sempre nell’Unione: «Chi propone l’uscita di Atene dall’eurozona sottovaluta le conseguenze devastanti che avrebbe. L’esperienza argentina dovrebbe servire non come esempio, ma come deterrente contro ogni idea di fuoriuscita».
Un avvertimento simile viene in questi giorni da Lorenzo Bini Smaghi. Sul sito del Financial Times, il 16 febbraio, l’ex membro dell’esecutivo Bce fa capire, senza dirlo chiaramente, che così come l’Europa oggi è fatta, così come fa sgocciolare le sue imperfette misure, il male non sarà curato. Esiziale, comunque, è la falsa sicurezza che si ostenta di fronte a un possibile fallimento, simile a quella esibita ottusamente nel 2008 quando fallì la società Lehman Brothers: «Il contagio finanziario opera in modi inaspettati, specie dopo gravi traumi come il fallimento d’una grande istituzione finanziaria o d’un Paese».
Il trauma colpirebbe la Grecia, ma anche le istituzioni europee: esse dimostrerebbero infatti una strutturale «incapacità di risolvere i problemi». Di qui la convinzione che il modello Fondo Monetario sia migliore: la sua assistenza è egualmente condizionale, ma almeno è prevedibile e prolungata. Non così l’Europa, che tiene Atene sotto la minaccia di continuo fallimento: una minaccia che «sfinisce il sostegno politico di cui (la disciplina richiesta) ha bisogno, e alimenta l’instabilità sui mercati finanziari». Forse è tardi per cambiar metodo, ma «se si vuol evitare un disastro non è mai troppo tardi».
Il piano europeo non può essere solo tecnico, mi dice Bini Smaghi: «Cosa succederà della Grecia se c’è un default? Una crisi sociale e politica nel cuore dell’Europa, con la democrazia di quel Paese a rischio. Il fallimento non sarebbe solo tecnico ma anche politico, perché se c’è la povertà e un regime autoritario il fallimento dell’Europa diventerebbe ovvio. Quale modello potrebbe rappresentare l’Europa agli occhi del mondo se uno dei suoi membri torna indietro nella storia?».
Ma com’è fatta esattamente l’Europa, per stare così male? È l’economia che vacilla, o sono malate le sue classi politiche, la sua cultura? Tutte e tre le cose in realtà barcollano, e l’Europa che uscirà da questa prova sarà forte o degenererà a seconda del modo in cui i tre mali insieme - economia, cultura, politica - saranno curati.
Culturalmente, stiamo ricadendo indietro di novant’anni, nei rapporti fra europei. Ad ascoltare i cittadini, tornano in mente le chiusure nazionali degli anni ’20-’30, più che la ripresa cosmopolitica del ’45. Sta mettendo radici un risentimento, tra Stati europei, colmo di aggressività. Le prime pagine dei giornali greci, da mesi, dipingono i governanti tedeschi come nazisti. Intanto Atene riesuma le riparazioni belliche che Berlino deve ancora pagare all’Europa occupata da Hitler. Dimenticata è la tappa del ’45, quando si ridiede fiducia alla nazione tedesca e ci si accinse a unire l’Europa. Quella fiducia aveva un preciso significato, anche finanziario: la Germania non doveva più risarcire nella sua totalità le distruzioni naziste. La politica delle riparazioni, che era stata la sua maledizione nel primo dopoguerra e l’aveva gettata nella dittatura, non doveva più esistere (Israele costituì un caso a parte).
Proprio questo si rimette in discussione, ed è la ragione per cui assistiamo a un formidabile arretramento. Quel che si fece nel ’45 verso la Germania, per motivi strategici e perché era mutata la cultura politica, non si è in grado di farlo con la Grecia. Gli errori commessi da Atene non sono crimini, e tuttavia urge espiare oltre che pagare. Son guardate con fastidio perfino le sue elezioni. La politica di riparazioni che le si infligge è feroce, crea ira, risentimento. E questo perché? Evidentemente non si vedono motivi strategici perché la Grecia resti in Europa: manca ogni visione del mondo, e la cultura non è più quella del ’45-’50.
La regressione ha effetti rovinosi sulla politica. Come può nascere l’Europa federale, se vince una cultura che ha poco a vedere con quello che gli europei appresero da due guerre? La scelta di un Presidente come Joachim Gauck, in Germania, è una buona notizia, perché la popolazione tedesca ha contribuito a questo clima di sospetti, anche se non sempre immotivati (perché assistere Paesi del Sud prigionieri volontari di una corruzione che a Nord si combatte?). L’Europa ha bisogno di popolazioni illuminate, non di capri espiatori, e Gauck che usa parlar-vero potrà aiutare. L’Europa ha bisogno di una crescita diversa, comune, non di anni e anni di recessione, di odi interni, di sospensioni della democrazia. Altrimenti la sua disfatta sarà di nuovo strana: nata nelle retroguardie civili, prima che nell’armata schierata lungo i muri anti-contagio
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Divenire Stati Uniti d’Europa significa non copiare l’America, ma imparare da essa (di Barbara Spinelli - Quanto costa la non-Europa)15 febbraio 2012, di Federico La Sala
Quanto costa la non-Europa
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 15 febbraio 2012)
Sembrano passati cinquant’anni e invece ne sono passati solo cinque, da quando i capi d’Europa, riuniti a Berlino per commemorare i Trattati di Roma, firmarono una dichiarazione in cui è scritto che «noi, cittadini dell’Unione siamo, per la nostra felicità, uniti». E ancora: «L’unificazione europea ci ha permesso di raggiungere pace e benessere... È stata fondamento di condivisione e superamento di contrasti... Aspiriamo al benessere e alla sicurezza, alla tolleranza e alla partecipazione, alla giustizia e alla solidarietà... L’Unione si fonda sulla parità, sull’unione solidale... sul giusto equilibrio di interessi tra Stati membri».
Era bello, pensare positivo e non prevedere nulla. È la stoffa di cui è fatta la crisi odierna. Ben altro campeggia davanti ai nostri occhi, con Atene che s’incendia e precipita nella punizione dell’impoverimento: non la felicità ma il sospetto reciproco, il bruto squilibrio d’interessi, l’intolleranza che dilaga in Italia, Ungheria, Danimarca, Olanda. E in Grecia non la pace ma la guerra civile, che non turba L’Europa ma è pur sempre ritorno della guerra, dei suoi vocabolari minatori. Nel difendere un’ennesima contrazione dei redditi, il premier Papademos ha brandito l’arma della paura, non della speranza: «Una bancarotta disordinata provocherebbe caos e esplosioni sociali. Lo Stato sarebbe incapace di pagare salari, pensioni, ospedali, scuole. L’importazione di beni basilari come medicine, petrolio, macchinari sarebbe problematica». Parafrasando Joyce: ecco Europa, un incubo dal quale non sappiamo svegliarci.
Potrebbero andare in altro modo le cose, se i responsabili europei riconoscessero che il male non è l ’inadempienza ellenica. Se capissero, come scrive l’economista greco Yanis Varoufakis, che malata è l’eurozona, con o senza Atene. Certo Atene è stata «un paziente recalcitrante»: ma è stata usata per velare il vizio d’origine, che è il modo in cui l’eurozona «ha aggravato gli squilibri, non ha assorbito il collasso finanziario del 2008».
In Grecia e altrove la Germania è descritta come cerbero, istupidito dai propri trionfi: quasi avesse dimenticato la disastrosa politica di riparazione che le inflissero i vincitori dopo il ’14-18. La sofferenza sociale dei tedeschi fu tale, che s’aggrapparono a Hitler. C’è del vero in quest’analisi - difesa nel ’19 da Keynes - ma le menti tedesche sono più complesse e incorporano anche il ricordo del ’45. Il ’45 seppellì l’era delle punizioni e aprì quella della fiducia, della cooperazione, creando Bretton Woods e l’Europa unita.
Angela Merkel deve essersi accorta che qualcosa sta andando molto storto se il 7 febbraio, in un incontro con gli studenti, ha confessato, in sostanza, che senza rifare l’Europa via d’uscita non c’è e il tesoro di fiducia svanisce. Non ha menzionato gli Stati uniti d’Europa, ma il suo progetto ha gli elementi tutti di una Federazione. L’Unione - ha detto - deve cambiar pelle. Gli Stati per primi dovranno farlo, e decidersi a un abbandono ben più vasto di sovranità: anche se per ciascuno, Berlino compresa, la scelta è «molto difficile». Così come difficili, ma non più rinviabili, sono l ’abolizione del diritto di veto e l’estensione del voto a maggioranza. La Commissione di Bruxelles dovrà trasformarsi in autentico governo, con i nuovi poteri delegati, e «rispondere a un forte Parlamento europeo».
Ridimensionato, il Consiglio dei ministri sarebbe «una seconda Camera legislativa» - simile al Senato americano - e massima autorità diverrebbe la Corte di giustizia: «Vivremo meglio insieme se saremo pronti a trasferire le nostre competenze, per gradi, all’Europa». Che altro si prospetta, se non quegli Stati Uniti che Monti aveva escluso, nell’intervista alla Welt dell’11 gennaio? E come parlare di una Germania despota d’Europa, se vuol abbandonare le prevaricazioni del liberum veto? Non solo. Senza esplicitamente nominarlo, il Cancelliere ha ricordato che Kohl vide subito i pericoli di una moneta senza Stato: «Oggi tocca creare l’unione politica che non fu fatta quando venne introdotto l’euro», senza curarsi delle «molte dispute» che torneranno a galla. Ci sono dispute più istruttive delle favole sulla felicità, perché non menzognere. Kohl, allora, chiese l’unione politica e la difesa comune: Mitterrand rispose no.
Può darsi che la Merkel parli al vento, un po’ per volubilità un po’ perché tutti tacciono. Comunque l’ostacolo oggi non è Berlino. Come ai tempi di Maastricht, chi blocca è la Francia, di destra e sinistra. È accaduto tante volte: nel ’54 per la Comunità di difesa, nel 2005 per la Costituzione Ue. Tanto più essenziale sarà l’appoggio di Monti a questo timido, ma cocciuto ritorno del federalismo tedesco.
Creare un’Europa davvero sovranazionale non è un diversivo istituzionale. Già Monnet diceva che le istituzioni, più durevoli dei governi, sono indispensabili all’azione. Oggi lo sono più che mai, perché solo prevalendo sui veti nazionali l’Europa potrà fare quel che Berlino ancora respinge: affiancare alla cultura della stabilità, che pure è prezioso insegnamento tedesco, una sorta di piano Marshall intra-europeo, incentrato sulla crescita. Il patimento greco lo esige.
Ma lo esige ciascuno di noi, assieme ai greci. La loro sciagura infatti non è solo l’indisciplina: è un accanimento terapeutico che diventa unica strategia europea, indifferente all’ira e alle speranze dei popoli. I dati ellenici, terribili, sono così riassunti da Philomila Tsoukala, di origine greca, professore a Washington: l’aggiustamento fiscale è già avvenuto (6 punti di Pil in meno di un anno, in piena recessione). Salari e pensioni sono già ai minimi, e le entrate aumentano ma colpendo i salariati, non gli evasori. Centinaia di migliaia di piccole imprese sono naufragate, la disoccupazione giovanile è salita al 48%, una persona su tre è a rischio di povertà. I senzatetto sono 20.000 nel centro di Atene. «La pauperizzazione delle classi medie è tale, che aumenta il numero di chi non teme più il default, non avendo nulla da perdere». A ciò si aggiungano losche pressioni esercitate ultimamente su Atene, perché in cambio di aiuto comprasse armi tedesche e francesi. È vero, la sovranità è oggi fittizia. Ma non può risolversi nel ricatto dei forti, e nell’umiliazione dei declassati.
È il motivo per cui l’Europa deve farsi, con istituzioni rinnovate, promotrice di crescita. E ai cittadini va detta la verità: se siamo immersi in una guerra del debito (in Europa, Usa, Giappone) è perché i paesi in ascesa (Asia, America Latina) non sopportano più un Occidente che domina il mondo indebitandosi. Alla loro sfida urge rispondere con conti in ordine, ma anche con uno sviluppo diverso, senza il quale la concorrenza asiatica ci schiaccerà. È lo sviluppo cui pensava Jacques Delors, con il suo Piano del ’93. Napolitano l’ha riproposto, venerdì a Helsinki: «Abbiamo bisogno di decisioni e iniziative comuni per la produttività e la competitività».
L’Europa può farlo, se oltre agli eurobond introdurrà una tassa sull’energia che emette biossido di carbonio (carbon tax), una tassa sulle transazioni finanziarie, un’Iva europea: purché i proventi vadano all’Unione, non agli Stati. È stato calcolato che i nuovi investimenti comuni - in energie alternative, ricerca, educazione, trasporti - genererebbero milioni di occupati e risparmi formidabili di spesa.
Divenire Stati Uniti d’Europa significa non copiare l’America, ma imparare da essa. Lo ricorda l ’economista Marco Leonardi sul sito La Voce: subito dopo la guerre di indipendenza, e prima di avere una sola Banca centrale e un’unica moneta, il ministro del Tesoro Alexander Hamilton prese la decisione cruciale: l’assunzione dei debiti dei singoli stati da parte del governo nazionale. Di un Hamilton ha bisogno l’Europa, che sommi più persone spavalde. Il loro contributo può essere grande e l’impresa vale la pena: perché solo nella pena riconosciamo l’inconsistenza, i costi, la catastrofe delle finte sovranità nazionali.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Il diktàt dell’Unione Europea trascina la Grecia alla rovina. Die Zeit, Hamburg:Lasciate in pace i greci - L’affronto di Merkozy contro la democrazia.13 febbraio 2012, di Federico La Sala
Die Zeit, Hamburg - Crisi del debito *
Lasciate in pace i greci
Il diktàt dell’Unione Europea trascina la Grecia alla rovina. Invece di tagli brutali il Paese ha bisogno di un programma di ricostruzione - anche nell’interesse dei tedeschi.
 (traduzione dal tedesco di José F. Padova)
(traduzione dal tedesco di José F. Padova)
 http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-02/griechenland-sparpolitik
http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-02/griechenland-sparpolitikNotizie da un’Europa divisa: per la prima volta la Germania aumenta le sue esportazioni a mille miliardi di euro. La congiuntura progredisce, aumentano gli introiti delle imposte, cala la disoccupazione, la IG Metall, per la buona situazione dei guadagni, propone aumenti di salari del 6,5 percento. Germania: un’isola di appagati.
La Grecia al contrario: un Paese alla rovina e in tumulto. Il governo di transizione decide, sotto la pressione della troika di Unione Europea, BCE e FMI, un nuovo drastico pacchetto di tagli. I salari devono diminuire dal 20 fino al 30 percento. L’Amministrazione statale licenzia 150.000 persone da qui al 2015. L’economia si riduce, forse quest’anno perfino più dell’8 percento. Il Paese si trova costantemente sull’orlo della bancarotta.
Ciononostante è tenuto in sospeso il secondo pacchetto di aiuti dell’Unione Europea per un ammontare di 130 miliardi di euro. I ministri delle Finanze dell’euro dubitano che il governo Papademos e i partiti che lo sostengono riescano effettivamente a imporre le misure di risparmio annunciate. A ragione. Infatti i tagli già decisi non la spuntano. Perché acutizzano soltanto i problemi. E perché comprensibilmente la resistenza dei greci contro il programma d’impoverimento e d’interdizione del loro Paese è molto grande.
È questa la prospettiva di un’Europa unita? Un Paese all’origine della cultura occidentale e della democrazia che diviene di fatto un protettorato di Bruxelles - senza speranza di miglioramento. Un continente che si spacca sempre più in un Nord benestante e in un Sud in miseria, dove le persone non sanno più come poter pagare il loro pane quotidiano. Mentre in Germania la coalizione di governo pensa seriamente ad abbassare le imposte nel mezzo della più pesante crisi finanziaria da decenni.
Eppure quanto accade nel resto del Continente, intorno a noi [tedeschi], non può esserci indifferente. Non soltanto perché fomenta una pericolosa radicalizzazione politica e un ritorno dei nazionalismi, come si va dimostrando per le prossime elezioni del nuovo Parlamento greco. Ci dovremmo anche preoccupare perché questa evoluzione, fatale e sostanzialmente accelerata da parte del governo tedesco, mette in pericolo il nostro stesso modello di successo: l’economia della Germania vive un boom soltanto perché le nostre aziende fanno affari e guadagni a spese dei Paesi più deboli. Perché lì i salari in rapporto alla produttività molto inferiore sono (ancora) troppo alti, mentre contemporaneamente, a causa della imponente pressione dei tagli, la domanda interna si riduce. Mentre al contrario qui in Germania per lunghi anni i moderati aumenti delle tariffe salariali e le riforme del mercato del lavoro realizzate dai governi rosso-verdi [ndt.: SPD + Grünen] hanno reso l’economia tedesca tanto competitiva da minacciare gli altri Paesi dell’Unione Europea, come la stessa Francia.
Ma chi in futuro comprerà ancora le merci tedesche? Non abbiamo più bisogno degli Stati in crisi soltanto perché ci costano il nostro buon denaro? Chi la pensa così non discerne: non già la Grecia approfitta maggiormente dei programmi di salvataggio dell’euro, della moneta comunitaria e del mercato comune, ma la Germania. Se la Grecia dichiarasse l’evidente fallimento dello Stato, (anche) le banche tedesche dovrebbero ancora una volta ammortizzare perdite per miliardi e i contribuenti tedeschi accollarsene alla fine il carico. Se l’euro fosse abolito e reintrodotto il DM [die deutsche Mark], questo sarebbe drasticamente rivalutato. La conseguenza, così valutano gli esperti, sarebbe il rincaro del 40% delle merci tedesche. Sarebbe la fine del modello di crescita tedesco basato sull’esportazione.
Nel Sud dell’Europa, non solamente in Grecia, si diffonde un minaccioso stato d’animo, che si rivolge soprattutto contro la Germania. Quasi 70 anni dopo la fine della guerra la Germania è percepita di nuovo come una potenza nemica. Vi sono già voci che gridano alte chiedendo provvedimenti radicali contro la dipendenza da Buxelles e da Berlino.
Chi vorrebbe dare torto a quelle persone schiacciate nella miseria! Dovrebbero ancora vedere come sfuma nel nulla il loro modesto benessere e come i loro politici diventano esecutori di ordini altrui? Soltanto perché in questo modo le banche e gli speculatori non debbano annullare completamente i loro crediti, che volontariamente contro succosi interessi hanno concesso per anni ai Paesi deboli.
No, questa non può essere l’Europa nella quale desideriamo vivere. Un’Europa nella quale banche e hedge-funds decidono quali Paesi possono sopravvivere e quali no.
Il prezzo della politica di austerità e tagli, unilateralmente portata avanti dalle finanziarie e dalla Merkel, è la disintegrazione dell’Europa. E una depressione lungamente impiantata, che prima o poi colpirà anche la Germania. Perché noi non viviamo affatto su un’isola di privilegiati.
La Grecia ha bisogno della nostra solidarietà, di una totale estinzione del debito e di un programma di ricostruzione, invece di sempre nuovi pacchetti di tagli e di aiuti. Perché mediante ciò il Paese ottenga una possibilità di rimettersi sui suoi piedi in dieci o vent’anni e ridiventi un membro dell’Unione con pari diritti.
Un simile pacchetto di crescita europea non costerebbe di più, ma darebbe nuovamente una prospettiva alle persone, in Grecia e in Europa. Per questo vale la pena lottare. Non per l’esclusione della Grecia dall’eurozona e dalla comunità di aiuti europea. Noi abbiamo bisogno della Grecia - come esempio perché l’Europa rifletta su sé stessa.
Die Zeit, HamburgL’affronto di Merkozy contro la democrazia
Mettere la gestione del bilancio greco sotto tutela corrisponderebbe alla logica di aiuto dell’Unione Europea. Eppure sarebbe una trasgressione delle regole democratiche, commenta A. Endres.
 (traduzione dal tedesco di José F. Padova)
(traduzione dal tedesco di José F. Padova) http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-02/demokratie-griechenland-sonderkonto
http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-02/demokratie-griechenland-sonderkontoIn una democrazia il più esclusivo diritto del parlamento è questo: decidere dove i mezzi finanziari del Paese sono impiegati. Soltanto chi dispone del denaro può dare forma alla politica. Colui al quale viene sottratta la facoltà di disporre del bilancio perde il suo potere. Se il controllo budgetario passa attraverso un’istituzione, sulla quale il sovrano [lo Stato] non ha possibilità di influire, si tratta di una delicata intromissione nei diritti democratici.
Perciò è tanto più rilevante ciò che adesso accade con la Grecia. Se la Cancelliera federale Angela Merkel e il presidente francese Nikolas Sarkozy richiedono al governo di Atene di istituire un conto speciale, sul quale i greci non possono avere alcun accesso, questo tocca i fondamenti della democrazia - anche se soltanto una parte del bilancio greco dovesse passare su quel conto.
Presumibilmente la richiesta di Merkel e Sarkozy ha molto a che fare con la campagna elettorale francese. Tuttavia la si deve prendere sul serio: dopo quella di un commissario ai tagli, la proposta di un conto speciale è soltanto l’ultima di una serie di tentativi di immischiarsi in modo inammissibile negli affari della Grecia. Quale sarà il prossimo?
Chi paga ha il potere
L’obiezione che l’incapacità greca di effettuare riforme metterebbe in pericolo l’intera Europa, e perciò che l’Europa avrebbe anche il diritto di imporre ordini ai greci, non tiene; altrettanto poco convince l’argomento che chi volesse a lungo termine una politica economica europea coordinata con maggior efficacia dovrebbe mantenere questo genere di ingerenza. Nessuna istituzione europea ha proposto tale conto speciale e anche nessun rappresentante della Troika [UE, BCE, FMI]. Merkel e Sarkozy hanno agito soltanto nella loro funzione di capi di governi nazionali. Con quale legittimazione?
Chi ha denaro ha potere - questo naturalmente vale anche per gli Stati e le organizzazioni che hanno concesso crediti alla Grecia. Essi sono nella posizione di porre condizioni: senza riforme niente prestiti. A ragione!, si potrebbe dire, alla fine si tratta del loro denaro e di quello dei loro contribuenti fiscali, ai quali essi sono tenuto a rendere conto. Anche questo è democrazia. E i greci non sono forse essi stessi responsabili della loro miseria, non devono forse anche subirne le conseguenze?
In linea di principio si tratta di buoni argomenti. Solo che, semplicemente, l’istituzione di un conto speciale è il contrario della responsabilità propria. E se i ricchi europei veramente temono tanto di perdere il denaro lì investito, sarebbe più onesto e coerente interrompere gli aiuti, finché la Grecia si mostra incapace di fare le riforme. Oppure abituarsi al pensiero di dover accollarsi le possibili perdite, per salvare il Paese e l’euro.
Questo è il grande dilemma della politica europea: mettere la Grecia sotto tutela politico-finanziaria corrisponde alla logica dei mercati finanziari e servirebbe a placarli. Quindi questo può apparire necessario per preservare l’Europa dall’andare in pezzi. Ma si scontra anche con le basi democratiche dell’Unione. È ora ormai che gli europei discutano se vogliono un’Europa di questo genere.
* IL DIALOGO, 13.02.2012
 http://www.ildialogo.org/cEv.php?f=http://www.ildialogo.org/estero/articoli_1329145131.htm
http://www.ildialogo.org/cEv.php?f=http://www.ildialogo.org/estero/articoli_1329145131.htm -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Quando i Macedoni misero Atene sotto tutela (dLuciano Canfora)i12 febbraio 2012, di Federico La Sala
Cassandro nel 322 a. C. impose alla polis di limitare i suoi diritti
Quando i Macedoni misero Atene sotto tutela
Nonostante l’Europa sia debitrice di quasi tutto ai Greci e alla loro straordinaria civiltà, pochi grandi popoli hanno dovuto subire, nella loro storia, la pratica asfissiante della tutela da parte di altre potenze.
di Luciano Canfora (Corriere della Sera, 12.02.2012)
Centottanta anni fa, nel febbraio 1833, la Grecia finalmente «indipendente» si vedeva regalare dal concerto delle grandi potenze europee un sovrano tedesco, per l’esattezza bavarese: Ottone di Wittelsbach, scortato, poiché ancora in minore età, da un consiglio di reggenza tutto formato da bavaresi. Non sappiamo se Angela Merkel conosca la tremenda storia della Grecia moderna: ma certo il precedente la ingolosirebbe non poco. Nonostante l’Europa, a cominciare dagli antichi romani, sia debitrice di quasi tutto ai Greci e alla loro straordinaria civiltà filosofica, scientifica, letteraria ecc. (ma questi debiti per la Bce non contano), pochi grandi popoli hanno dovuto subire, come i Greci, nella loro storia, la pratica asfissiante della tutela da parte di altre potenze.
Si potrebbe risalire molto indietro nel tempo, quando, dopo l’ultima insurrezione contro l’egemonia macedone sulla penisola (322 a.C.), agli Ateniesi, promotori dell’insurrezione, fu imposto, dal vincitore Cassandro, di cambiare il loro ordinamento politico e di limitare il diritto di cittadinanza a sole 9000 persone. Alla città che aveva dato vita al "modello democratico" fu imposto allora, dalla grande potenza dominatrice, un ordinamento timocratico, che limitava i diritti politici ai soli benestanti.
La tesi dottorale di Fustel de Coulanges si intitolava: «Polibio, ovvero la Grecia conquistata dai Romani» (1858). Il grande storico francese ricostruiva con efficacia e in modo essenziale quel lungo processo storico onde la Grecia divenne politicamente un satellite di Roma, anche se culturalmente fu Roma a ellenizzarsi. (Perciò fu detto che il vinto aveva acculturato il «feroce vincitore»). La dinamica non fu dissimile da quanto era accaduto centocinquant’anni prima con i Macedoni. Il conflitto sociale era aspro, e i ricchi, per spuntarla, invocarono la protezione della potente macchina militare della repubblica oligarchica per eccellenza: la repubblica romana. Così, la Grecia fu ancora un volta sotto tutela.
E’ quello che, scavalcando i millenni, si tenta di fare oggi. Chi oggi, infatti, in Grecia più patirà delle imposizioni della «trimurti» (Ue, Bce, Fmi), sarà la povera gente, non certo i miliardari cosmopoliti. Un dato solo può rendere l’idea: l’assistenza medica è stata di fatto eliminata, ora che ad ogni cittadino greco è garantita fornitura gratuita di medicinali fino ad un massimo di 23 euro l’anno (meno di una medicina a testa per anno).
Il fine è quello di tenere in vita l’euro. Ma ai Greci - come del resto agli Italiani - non fu chiesto per referendum se desiderassero o meno «entrare» nella moneta unica che ormai viene difesa con la forza pubblica e col ricatto. Giunti a questo punto infatti ogni alternativa diventa, a dir poco, traumatica. Ma non dovrebbe sfuggire, che, se è la Germania che fa la voce grossa affinché nessuno dei popoli «discoli», che non ce la fanno più, esca dall’euro, ciò significa che è la sua economia a trarre il maggior vantaggio da questa «fortezza Europa» (come la chiamava il Führer) visto che gran parte delle sue esportazioni è in direzione dell’eurozona. (E un ritorno alle «svalutate» e abrogate monete nazionali ridarebbe alle merci dei Paesi liberati dall’euro non lieve forza concorrenziale). Non sarà facile per nessuno uscire dalla «gabbia d’acciaio», a meno che non sia la Germania stessa a calcolare che non le conviene più tenere serrati i chiavistelli.
Ma torniamo alla Grecia, vittima precipua di questa situazione il cui rimedio viene «spalmato» (come oggi si usa dire) sui prossimi vent’anni. La cattiva coscienza delle potenze europee verso la Grecia si è manifestata in un ampio arco di tempo. L’episodio emblematico dell’insediamento di Ottone era il punto d’arrivo di un ciclo apertosi per lo meno con l’attacco di Bonaparte all’Egitto (1798): colpo non da poco all’impero turco, salutato, allora, come prima tappa per la liberazione della Grecia, stroncato immediatamente dall’Inghilterra con la vittoria di Nelson ad Abukir, salvifica per la «Sublime Porta» ottomana. E quando, vent’anni dopo, esplose l’«Epanastasi», la grande rivolta nazionale dei Greci, se è vero che schiere di europei filogreci accorsero a sostegno, l’elemento decisivo fu alla fine il gioco cinico delle cancellerie europee.
Nel secolo seguente, la Grecia sperimentò per prima, e sulla propria pelle, gli effetti devastanti della guerra fredda: i partigiani greci, che avevano dato filo da torcere ai nazisti, si trovarono, a guerra mondiale ormai conclusa, a combattere contro gli inglesi, ritenendo la Gran Bretagna la Grecia di sua spettanza nella spartizione dell’Europa. E la guerra, per i Greci, proseguì fin quasi all’anno «santo» 1950. Da allora il paese fu in stato di semi-occupazione e sotto stretta tutela. Quando, dopo quindici anni il vecchio Papandreu, il patriarca della dinastia, giunse al potere scalzando finalmente i governi-sgabello del dopoguerra, la libertà riconquistata durò assai poco. E nell’aprile ’67 alla Grecia vennero imposti i colonnelli.
Sappiamo bene quanto limitata fosse per tutti la sovranità in quegli anni, ma solo alla Grecia fu inflitto, per tenerla sotto, un nuovo fascismo. Un grande filologo francese, oggi novantenne, Bertrand Hemmerdinger, espresse molti anni addietro, regnanti ancora i colonnelli, la propria passione per la Grecia definendosi «internazionalista e patriota greco». Non poteva prevedere che ai colonnelli sarebbero subentrati i banchieri.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Chi ha scritto la tragedia greca (di Paolo Soldini)13 febbraio 2012, di Federico La Sala
Chi ha scritto la tragedia greca
di Paolo Soldini (l’Unità, 13.02.2012)
Sembra il finale di un film dell’orrore. Di quelli in cui gli incubi sembrano superati grazie al coraggio e all’intelligenza dei “nostri” ma nell’ultimissima scena un particolare, un mostro che si risveglia, un’astronave aliena che punta sulla terra, fa capire allo spettatore che no, non era così. L’umanità è ancora in pericolo.
Ieri sera, mentre nella più grande confusione il parlamento ad Atene votava il pacchetto di tagli selvaggi dettati, per interposta troika, dal Fmi, dalla Bce e (ahinoi) dalla Commissione europea, il finale del film dell’orrore greco era ancora tutto da scrivere. Se le istituzioni europee, e soprattutto i governi, e massimamente il governo tedesco, decideranno che i tagli vanno bene e bastano, Atene riceverà la sua tranche di aiuti, altrimenti a metà marzo, fra poco più di un mese, lo Stato non sarà più in grado di pagare stipendi e spese correnti e sarà il fallimento. Pleite in tedesco. Default nell’anglo-francese che va di moda. Apotuchia, nel greco in cui fu tradotta l’Apocalisse. Eppure questo film lo abbiamo già visto.
È dal 2009 che la Grecia incombe come un incubo sull’Europa perché l’Europa incombe come un incubo sulla Grecia. Sono almeno due anni e mezzo che ad Atene si chiedono tagli, riforme e aggiustamenti che nessun Paese, nessuna classe dirigente sarebbe in grado di gestire senza mettere nel conto il proprio disastro. Si è messo in ginocchio uno Stato e contemporaneamente gli si è chiesto di rialzarsi da solo, gli si è tolta ogni minima chance di ripresa economica e nello stesso tempo si pretende che paghi i debiti e risani le finanze. E come?
L’elenco degli errori compiuti dall’Europa (istituzioni e governi) nella gestione della crisi greca figurerà forse, un giorno, nei manuali di economia come esempio di tutto quello che non si deve fare. A cominciare dal coinvolgimento nella ristrutturazione del debito delle grandi banche private, delle assicurazioni e dei fondi che fu deciso a Deauville da Merkel e Sarkozy. Oggi ogni strategia di soluzione della crisi viaggia su un doppio binario: la trattativa con la troika e quella con l’Institute of International Finance, la lobby delle grandi banche guidata da due negoziatori feroci, il presidente americano Charles Dallara e il capo della Deutsche Bank Josef Ackermann. E non è affatto detto che i binari corrano davvero paralleli.
A fasi alterne, poi, si è ritenuto possibile una ristrutturazione del debito che di fatto corrispondeva a un default e si è esclusa formalmente questa possibilità perché le conseguenze sarebbero incontrollabili. E intanto ci si è guardati bene dal tirare fuori i fondi che sarebbero stati necessari per escludere davvero la bancarotta, cosicché si è di fatto ammiccato ai mercati che facevano volare i tassi perché la ritenevano possibile, e anzi probabile.
Quando finirà questo bruttissimo film? Uno dei motivi che stanno dietro all’incapacità europea a gestire la crisi del debito di un piccolo Paese è la tendenza evidente a considerare la questione in termini di politica interna in Francia e soprattutto in Germania. Il «non pagheranno i nostri cittadini i vizi altrui» è stato l’argomento d’una specie di demagogia di stato che ancora ieri dava possenti prove di sé nelle dichiarazioni del ministro delle Finanze di Berlino Wolfgang Schäuble, in quelle dei ministri liberali Philipp Rösler e Guido Westerwelle, nonché nell’incredibile richiesta del Ministerpräsident della Baviera di convocare un referendum tra i tedeschi per far decidere a loro se la Grecia va aiutata o no. Ma proprio questo viziaccio, diffuso a Berlino e Parigi, non sconosciuto a Bruxelles, potrebbe offrire, paradossalmente, un ombrello di protezione ai dirigenti greci. Diamo un’occhiata al calendario: il 22 aprile si terrà il primo turno delle elezioni presidenziali francesi.
È dubbio che Nicolas Sarkozy, già in difficoltà nei sondaggi, voglia arrivarci sull’onda delle grandissime incertezze e tensioni che un default di Atene scatenerebbe sui mercati e sulle istituzioni europee. Ed è probabile che la cancelliera Merkel sostenga anche su questo il suo referente a Parigi, considerata la paura che prova davanti a una possibile vittoria di François Hollande con la sua dichiarata ostilità al trattato intergovernativo sul fiscal compact.
C’è da pensare che tanto a Parigi quanto a Berlino ci si stia orientando comunque a concedere altro tempo ad Atene. Ma il problema resta tutto, e si ripresenterà tale e quale dopo aprile. Senza contare che, come la storia ci ha mostrato più volte, certe dinamiche di crisi tendono a sfuggire clamorosamente a chi dovrebbe governarle, soprattutto se non si hanno in mano tutti gli strumenti (per esempio le lobby bancarie e i meccanismi di mercato). Le guerre, spesso, sono cominciate così.
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- L’antica Atene plasmò l’identità europea. Ma fu il nostro Sud a rivelarne i valori (di Francesca Bonazzoli)31 gennaio 2012, di Federico La Sala
Il mito dentro
L’antica Atene plasmò l’identità europea Ma fu il nostro Sud a rivelarne i valori
È nel nostro mito che dobbiamo calcolare lo spread tra la nostra vita di consumatori e il soddisfacimento dei bisogni umani.
di Francesca Bonazzoli (Corriere della Sera, 31.01.2012)
Nell’Europa dell’euro in cui l’economia ha rinunciato a pensare la società e la società si pensa in termini di economia, si sta facendo sentire sempre più forte il bisogno di tornare a riflettere sui valori che ci tengono insieme. Per noi europei c’è un luogo fondante dove andarli a cercare: il mito, perché il simbolo, trasformato in narrazione e poi in filosofia e storia, non è raccontato una volta per tutte, ma genera una continua stratificazione di sensi e reinterpretazioni (a differenza della religione che offre un’unica verità) ed è, come ci ha mostrato Freud, per esempio attraverso la figura di Edipo, sempre contemporaneo. Il nostro futuro non può dunque che essere già lì, nel nostro cuore più antico.
Tutti i Paesi, in Europa, hanno partecipato nei secoli alla creazione del nostro mito comune, ma sono proprio i due Paesi oggi additati come i colpevoli della crisi dell’Europa finanziaria, quelli da cui ha avuto inizio la formazione della nostra identità: la Grecia e l’Italia. Da essi sono riverberate in tutto il mondo le domande fondamentali sulla vita, l’immortalità, la virtù, il potere, la civiltà, la bellezza, il destino, la pietas, la giustizia, il dovere morale, la tirannia, la democrazia, il diritto e così via.
Tutto è nato in Grecia, ma, come sintetizzò Orazio, quando Roma mise fine alla libertà delle polis greche: «Una volta conquistata, la Grecia conquistò i suoi selvaggi vincitori, e portò le arti fra i contadini del Lazio». Poi, attraverso l’impero di Roma, la Grecia capta, che già Alessandro aveva portato ai confini dell’India, conquistò anche l’intera Europa. In questo processo di ellenizzazione che ha formato l’identità dell’Europa, l’Italia è stata la torcia che ha fatto divampare l’incendio in ben due occasioni fondamentali. Senza l’impero romano e senza il Rinascimento, infatti, il nostro cuore più antico oggi si sarebbe probabilmente perso. Basti pensare che fino al Settecento l’arte greca era ancora conosciuta solo grazie alle copie romane e soltanto nel corso dell’Ottocento e del Novecento cominciò la riscoperta degli originali ellenici.
Ma c’è ancora un’altra particolarità che rende speciale il legame dell’Italia con la Grecia: la Magna Grecia, la fondazione di città greche nell’Italia meridionale. È lì che ha avuto inizio l’infatuazione millenaria per la grecità da cui furono sedotti per primi gli etruschi che compravano i manufatti attraverso i greci insediatisi nel nostro Meridione. Dopo gli etruschi ne furono ammaliati i romani i quali importarono opere d’arte, artisti e produssero migliaia di copie di statue greche. Per ultimi, nel Settecento, caddero nelle reti della bellezza greca tedeschi, inglesi e francesi. I più temerari di questi si spinsero fino in Sicilia sulle tracce del mito.
Un’esperienza che cambiò Goethe «fino al midollo»: «Sicilia e Nuova Grecia mi fanno sperare in una novella vita», scrisse. E fu un tedesco, Joachim Winckelmann, che pure non aveva mai visto un originale greco ma solo copie romane, a redigere una narrazione per la prima volta scientifica della storia dell’arte greca. Gli inglesi, dal canto loro, furono i maggiori acquirenti di antichità e dall’esperienza del Grand Tour riportarono in patria la nuova visione neoclassica dell’architettura che si ispirava a Palladio e dunque all’antico.
Purtroppo questa passione per Atene riaccesasi nel Settecento si espresse attraverso il saccheggio di opere d’arte come l’ancora controverso acquisto (autorizzato dai dominatori turchi) dei marmi del Partenone da parte di lord Elgin definito già da Byron «il predone di una terra sanguinante». Nel 1816, tuttavia, esposti al British Museum, i marmi (che, detto tra parentesi, non hanno più motivo di essere tenuti prigionieri a Londra) ebbero un enorme impatto sia popolare sia sugli studi archeologici e furono almeno, se può essere di consolazione, sottratti al vandalismo cui i turchi sottoponevano l’Acropoli. Un altro razziatore fu Napoleone che saccheggiò in particolare le collezioni italiane di arte antica, primo fra tutti il museo pontificio. Ma ancora una volta il destino della Grecia capta era stato quello di conquistare i suoi conquistatori.
Chi pensa che sia sentimentalismo riflettere su questi reciproci legami mentre nella City e a Wall Street guardano con sufficienza un piccolo grande popolo come quello greco devastato dalle politiche economiche, non valuta quanto stiamo distruggendo insieme ai greci l’intera Europa.
«Prima di agire, l’uomo antico avrebbe sempre fatto un passo indietro, alla maniera del torero che si prepara al colpo mortale. Egli avrebbe cercato nel passato un modello in cui immergersi come in una campana di palombaro per affrontare così, protetto e in pari tempo trasfigurato, il problema del presente. La mitologia del suo popolo non soltanto era per lui convincente, aveva cioè senso, ma era anche chiarificatrice, vale a dire dava senso», ha scritto Kàroly Kerényi, che allo studio della mitologia greca dedicò la vita.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Il primo festival culturale con Jaspers, Benda e Contini. Filosofi e studiosi si videro nel 1946 per cercare di ricostruire l’identità continentale dopo la guerra. Ponendosi problemi molto simili a quelli di oggi (di Roberto Esposito).11 gennaio 2012, di Federico La Sala
Torna il reportage che il critico italiano fece sull’incontro tra intellettuali europei
Il primo festival culturale con Jaspers, Benda e Contini
Filosofi e studiosi si videro nel 1946 per cercare di ricostruire l’identità continentale dopo la guerra. Ponendosi problemi molto simili a quelli di oggi
di Roberto Esposito (la Repubblica, 11.01.2012)
La prima sensazione che procura la lettura del brillantissimo reportage giornalistico, redatto da un giovane Gianfranco Contini, dell’incontro internazionale tra intellettuali europei svoltosi a Ginevra nel 1946 - adesso edito da Quodlibet con il titolo Dove va la cultura europea?, per la cura di Luca Baranelli e con un’introduzione di Daniele Giglioli - è quella di un contrasto acuto tra la marcata lontananza dell’orizzonte postbellico, e anche dei protagonisti, e la singolare attualità di alcune notazioni del «critico nelle spoglie del cronista», come egli stesso si presenta.
Notazioni profonde, nei confronti di un evento certo non anodino, come poteva essere il primo dibattito europeo dopo la sconfitta non solo del nazismo, ma per certi versi dell’intera l’Europa; ma insieme caustiche, espresse in punta di penna e senza reticenze diplomatiche, da parte di un "inviato" del calibro di Contini, appena reduce dalla lotta partigiana e anche da una personale esperienza di governo nella breve stagione repubblicana dell’Ossola, come ricordato nel libro in forma di intervista Diligenza e voluttà. Ludovica Ripa di Meana interroga Gianfranco Contini (Mondadori 1989).
Sembra quasi di vedere, nello scenario svizzero ricostruito con incomparabile verve narrativa dall’autore, «l’erta canizie romantica» del «simpatico ed eruditissimo» Francesco Flora «fra le tante teste pettinate (come, molto affettata, la perdurante frangia ascetica di Benda)» o il contrasto, non solo di idee, tra Karl Jaspers, «gentiluomo altissimo, esile, pallido e canuto, figurino impeccabile in nero e grigio» e «il piccolo Lukács, col suo volto di asceta magro e duro, con la bocca larghissima e piatta, gli occhiali ampi?, la zazzera centroeuropea appena contenuta e un vestitino color senape».
Il tutto non senza notare, da parte del critico-cronista, la vistosa carenza di italiani, rappresentati dal solo Flora, dal momento che Croce, alla notizia di una probabile "calata di Sartre", aveva esclamato «E allora che ci andiamo a fare ?». D’altra parte non c’era poi da sorprendersi che i francesi, veri padroni di casa, non avessero fatto ponti d’oro a coloro che, con Hitler quasi a Parigi, li avevano aggrediti alle spalle. Il che non toglie che Contini potesse legittimamente lamentare l’assenza non solo dei Moravia, degli Alvaro o dei Bacchelli, ma anche dei "giovani filosofi" Calogero e Capitini, Antoni e Bobbio, Luporini e Del Noce - tutti, ad eccezione degli ultimi due, della sua stessa provenienza azionista.
Davanti alle macerie ancora fumanti della guerra, a un anno dalla scoperta di Auschwitz e dall’esplosione di Hiroshima, la domanda intorno a cui ruotano le giornate di Ginevra non è poi tanto diversa da quella del primo Congresso degli scrittori antifascisti tenutosi alla Mutualité di Parigi nel giugno del ’35 (su cui si veda Per la difesa della cultura. Scrittori a Parigi nel 1935, a cura di Sandra Teroni, Carocci 2002). Dal resto il motivo della décadence europea era stato intonato da tempo, prima ancora che dai vari Husserl, Heidegger, Spengler, da un ispirato Valéry, all’epilogo dell’altra guerra, quando, all’interrogativo «Che cosa è, dunque, questa Europa», poteva già rispondere che essa «è una sorta di capo del vecchio continente, una appendice occidentale dell’Asia» in La Crise de l’esprit. Note (o L’Européen).
Certo, rispetto ad allora un’orda di barbari aveva passato il Reno minacciando di travolgere una civiltà bimillenaria. E già s’intravedeva, tra i vincitori americani e russi, uno scontro di egemonia, foriero, se scatenato, di una catastrofe ancora peggiore. È in questo quadro incandescente e incerto che Contini esercita la propria critica affilata, prendendo debita distanza innanzitutto dal proposito, in quell’occasione un po’ goffo, prima ancora che reazionario, di tenere a riparo la cultura europea dal vento della politica.
Da qui, da questa opzione esplicita a favore di un impegno sobrio ma fermo, discendono tutti i suoi giudizi. Da quello, impietoso, per «l’ircocervo di sciocchezze, di logica e finezza victorhughiane» di Bernanos, «clown perfetto» con la sua «oratoria catastrofica di cassandra non inascoltata» a quello, rispettoso, nei confronti del marxista Lukács, nonostante la netta distanza ideologica che li separava; a quello, aperto ma perplesso, su Jaspers, ricco di pathos esistenziale, ma privo di coerenza interiore e di necessità speculativa. Ciò cui, contro le ipotesi totalizzanti di destra come di sinistra, Contini sembra piuttosto rimandare, nell’ora della ricostruzione, è il senso del limite e dell’equilibrio tra le polarità opposte che, nella loro dialettica, hanno costituito la risorsa profonda della storia europea - l’oscillazione continua tra ragione e fede, autorità e libera ricerca, ordine e rivoluzione. La stessa Resistenza, nella memoria freschissima dell’autore, si configura come una vicenda fatta di ingredienti diversi, ma non priva, nella sua vocazione al sacrificio, di un impulso religioso.
Ma perché l’Europa possa ancora attingere a quella fonte, apparentemente inaridita - questa mi pare la conclusione che possiamo trarre dalle terse pagine di Contini - deve rinnovare radicalmente, prima ancora che il rapporto con le potenze che la circondano, quello con se stessa. Non solo vincere il demone nazionalista che per troppo tempo ha portato dentro rischiando di farsene strangolare, ma anche ripensare a fondo la fatale categoria di sovranità, allargandola progressivamente dai confini dei singoli Stati a quello dell’intera comunità europea. Nella relazione di apertura dell’incontro di Ginevra (oggi interamente leggibile in rete) Julien Benda pronuncia parole che, a sessantacinque anni di distanza, non hanno perso nulla della loro pregnanza: «oggi l’idea di nazione sembra aver terminato la sua carriera, a favore dell’idea di Europa. Ma non facciamoci illusioni; non crediamo che tale idea trionferà naturalmente; sappiamo che essa troverà, da parte di quella che intende detronizzare, una forte opposizione e una resistenza tenace. La verità è che le nazioni, per fare veramente l’Europa, dovranno abbandonare, non certo tutto, ma qualcosa della loro particolarità in favore di un’entità più generale».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- Ora, in Grecia e in Italia, la Grande Trasformazione si è guadagnata un altro nome: si chiama la Grande Perversione (di Leonard Boff)8 dicembre 2011, di Federico La Sala
La grande perversione
di Leonardo Boff *
Per risolvere la crisi economico-finanziaria della Grecia e dell’Italia è stato costituito, per esigenza della Banca Centrale Europea, un governo di soli tecnici senza la presenza di politici, nell’illusione che si tratti di un problema economico che deve essere risolto economicamente. Chi capisce solo di economia finisce col non capire neppure l’economia.
La crisi non è di economia mal gestita, ma di etica e di umanità. E queste hanno a che vedere con la politica. Per questo, la prima lezione di un marxismo minimo è capire che l’economia non è parte della matematica e della statistica, ma un capitolo della politica. Gran parte del lavoro di Marx è dedicato alla destrutturazione dell’economia politica del capitale. Quando in Inghilterra si visse una crisi simile all’attuale e si creò un governo di tecnici, Marx espresse con ironia e derisione dure critiche perché prevedeva un totale fallimento, come effettivamente successe. Non si può usare il veleno che ha creato la crisi come rimedio per curare la crisi.
Per guidare i rispettivi governi di Grecia e Italia hanno chiamato gente che apparteneva agli alti livelli dirigenziali delle banche. Sono state le banche e le borse a provocare l’attuale crisi che ha affondato tutto il sistema economico. Questi signori sono come talebani fondamentalisti: credono in buona fede nei dogmi del mercato libero e nel gioco delle borse. In quale punto dell’universo si proclama l’ideale del greed is good, ovvero l’avidità è un bene? Come fare di un vizio (e diciamo subito, di un peccato) una virtù? Questi signori sono seduti a Wall Street e alla City di Londra. Sono volpi che non si limitano a guardare le galline, ma le divorano. Con le loro manipolazioni trasferiscono grandi fortune nelle mani di pochi. E quando è scoppiata la crisi sono stati soccorsi con miliardi di dollari sottratti ai lavoratori e ai pensionati. Barack Obama si è dimostrato debole, inchinandosi più a loro che alla società civile. Con i soldi ricevuti hanno continuato la baldoria, giacché la promessa regolazione dei mercati è rimasta lettera morta. Milioni di persone vivono nella disoccupazione e nel precariato, soprattutto i giovani che stanno riempiendo le piazze, indignati contro l’avidità, la disuguaglianza sociale e la crudeltà del capitale.
Persone formate al catechismo del pensiero unico neolibersita tireranno fuori la Grecia e l’Italia dal pantano? Quello che sta succedendo è il sacrificio di tutta una società sull’altare delle banche e del sistema finanziario.
Visto che la maggioranza degli economisti dell’estabilishment non pensa (né ha bisogno), tentiamo di comprendere la crisi alla luce di due pensatori che nello stesso anno, il 1944, negli Stati Uniti, ci hanno fornito una illuminante chiave di lettura. Il primo è il filosofo ed economista ungaro-canadese Karl Polanyi con il suo La grande trasformazione (1944; Einaudi, 1974), un In che consiste? Consiste nella dittatura dell’economia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale che ha aiutato a superare la grande Depressione del 1929, il capitalismo ha messo a segno un colpo da maestro: ha annullato la politica, mandato in esilio l’etica e imposto la dittatura dell’economia. A partire dalla quale non si ha più, come si era sempre avuta, una società con mercato, ma una società di solo mercato. L’ambito economico struttura tutto e fa di tutto commercio, sorretto da una crudele concorrenza e da una sfacciata avidità. Questa trasformazione ha lacerato i legami sociali e ha approfondito il fossato fra ricchi e poveri in ogni Paese e a livello internazionale.
L’altro pensatore è un filosofo della scuola di Francoforte, esiliato negli Usa, Max Horkheimer, autore de L’eclissi della ragione (1947; Einaudi 1969). Qui si danno i motivi per la Grande Trasformazione di cui parla Polanyi che consistono fondamentalmente in questo: la ragione non è più orientata dalla verità e dal senso delle cose, ma è stata sequestrata dal processo produttivo e ridotta ad una funzione strumentale «trasformata in un semplice meccanismo molesto di registrazione dei fatti». Deplora che concetti come «giustizia, uguaglianza, felicità, tolleranza, per secoli giudicati inerenti alla ragione, abbiano perso le loro radici intellettuali». Quando la società eclissa la ragione, diventa cieca, perde significato lo stare insieme, rimane impaludata nel pantano degli interessi individuali o corporativi. È quello che abbiamo visto nell’attuale crisi. I premi Nobel dell’Economia, i più umanisti, Paul Krugman e Joseph Stiglitz hanno scritto ripetutamente che i “giocatori” di Wall Street dovrebbero stare in carcere come ladri e banditi.
Ora, in Grecia e in Italia, la Grande Trasformazione si è guadagnata un altro nome: si chiama la Grande Perversione.
* Teologo e filosofo
* Adista/Segni Nuovi, n. 92 del 10/12/2011
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- IL CENTRO NON E’ PIU’ L’EUROPA (di Filippo Gentiloni).20 novembre 2011, di Federico La Sala
Il centro non è più l’Europa
di Filippo Gentiloni (il manifesto, 20 novembre 2011)
La storia delle religioni, come è ormai ben noto, segue la storia della politica e anche quella della economia. Un discorso che vale, ovviamente, anche per il cristianesimo: i suoi centri, i suoi "palazzi" non si trovano più dove si trovavano una volta, cioè in Europa o negli Stati Uniti, culturalmente dipendenti dall’Europa: si trovano ormai là dove nasce il mondo che è nuovo sotto tutti gli aspetti, compreso quello religioso.
È il mondo asiatico, quello che unisce Cina e India, "L’impero di Cindia", come lo ha definito Federico Rampini: «Sono tre milioni e mezzo. Sono più giovani di noi , lavorano più di noi. Hanno più risparmi e più capitoli di noi da investire. Cindia è il nuovo centro de mondo, dove si decide il futuro dell’umanità». Il discorso vale, ovviamente, anche per le religioni, che fanno parte delle società in cambiamento e in piena evoluzione. Roma, anche se a malincuore, deve tenerne conto.
L’Asia, d’altronde, sta riportando in primo piano le sue antiche posizioni religiose. Il buddismo, ad esempio, sta riconquistando posizioni importanti dovunque. Cristianesimo e anche islam appaiono, invece, fermi sulle posizioni tradizionali. Il vecchio occidente è già oggi molto meno importante di quanto non appaia a Roma, a Londra o a New York.
Quello che sta accadendo in Cindia è importante anche per tutti i poveri del mondo. E per tutte le chiese. Ancora Rampini: «È finita l’era in cui l’uomo bianco - una piccola minoranza sul pianeta - poteva vivere di rendita sulla sua superiorità scientifica e tecnologica, industriale e militare» e, possiamo aggiungere, anche religiosa. Lo devono tenere presente anche le chiese cristiane, cattoliche, protestanti e ortodosse. I loro confini saranno sempre più precisi e limitati. Il loro universalismo sempre più teorico che pratico.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Le Monde: «La Grèce est-elle un pays européen?». Si può amputare l’Europa? (di Bernardo Valli - Grecia, se l’Europa espelle Platone).18 novembre 2011, di Federico La Sala
 Grecia, se l’Europa espelle Platone
Grecia, se l’Europa espelle Platone È chiaro che siamo lontani dagli antichi modelli di bellezza. Ma non è possibile negare che è all’origine di tutto
È chiaro che siamo lontani dagli antichi modelli di bellezza. Ma non è possibile negare che è all’origine di tutto
 La reazione stizzita di Milan Kundera quando la moglie gli mostra la prima pagina del giornale
La reazione stizzita di Milan Kundera quando la moglie gli mostra la prima pagina del giornale di Bernardo Valli (la Repubblica, 18.11.2011)
di Bernardo Valli (la Repubblica, 18.11.2011)PARIGI. Nel caffé affacciato sulla bocca del métro Sèvres-Babylone, entrano i coniugi Kundera, Eva e Milan. Lei ha in mano una copia di Le Monde appena acquistato nella vicina edicola. Lo stende sul tavolino e gettata un’occhiata ai titoli di prima pagina non trattiene un’esclamazione di sdegno.Gira il giornale affinché il marito possa leggere il motivo della sua indignazione; e infatti lo scrittore ha la stessa reazione, seguita da un gesto desolato della mano. Non conosco la lingua ceca e quindi non riesco a capire le parole che si scambiano, ma incuriosito dalla breve, agitata mimica dei coniugi Kundera, corro a comperare il quotidiano, e mi salta subito agli occhi quel che ha provocato il loro lampo di collera. È un titolo, nel quale ci si chiede se la Grecia sia un paese europeo. «La Grèce est-elle un pays européen?»
Anch’io vengo colto da un risentimento improvviso nei confronti di chi ha preparato il terreno a quella bestemmia di dimensione storica. Bestemmia che mette in dubbio con tracotanza, con smisurato, indecente orgoglio (l’aristotelica hybris) l’essenza dell’Europa. Vale a dire dell’Occidente, che non a caso è la traduzione greca di Europa; e il cui pensiero originale, non solo il nome, viene da quella terra della quale si mette in discussione il carattere europeo.
È facile scorgere in questa reazione un’eccessiva dose di retorica. Infatti c’è. È un po’ come scandire: siamo tutti greci europei. Perché no? Affidarsi ai tradizionali punti di orientamento offertici dalla storia per muoversi nel presente conduce in una sfera metafisica. La Grecia non produce più gli eterni modelli della bellezza. È chiaro. Cosi come Roma non è più la patria del diritto, né del medioevo ascetico e trascendente, né del Rinascimento che ha elevato il significato della vita terrena. È chiarissimo. Lo stesso vale per tanti altri centri della civiltà europea. Tutti quei passati non appartengono tuttavia al dominio delle nazioni o degli Stati di oggi, ma al (crociano) "regno della verità". Costituiscono nel loro insieme, con le loro differenze e contraddizioni, il comun denominatore culturale dell’Europa odierna, multilingue ma con idee affini che si sono influenzate a vicenda, formando attraverso i secoli una forte corrente di pensiero. Affidarsi unicamente al livello dei redditi, alle peripezie finanziarie e alle oscillazioni della moneta unica per determinare l’appartenenza all’Europa e di conseguenza alla sua civiltà, è semplicemente un delitto.
È uno dei punti più alti toccati dalla nostra ignoranza di europei del XXI secolo. Pensare che la Grecia del presente non possa coabitare, per la sua struttura economica e sociale, alla zona dell’euro è un conto. Ma nessuno ha il diritto di pensare che essa non sia più europea. Il suo passato, quel che della sua civiltà è vivo nel nostro pensiero, nella nostra cultura, appartiene appunto al "regno della verità", di cui noi tutti europei facciamo parte. La Grecia più di qualsiasi altro paese poiché è stata l’origine di tutto. Si può amputare l’Europa?
Milan Kundera è un europeo che può capire più di altri cosa significa essere escluso dall’Europa. Come cecoslovacco ha vissuto il tradimento dell’Europa che nel 1938, con l’accordo di Monaco, abbandonò il suo paese alla Germania di Hitler. E dieci anni dopo ha vissuto la separazione della "cortina di ferro", tra l’Europa dell’Est e quella dell’Ovest. La tragedia cecoslovacca si è ripetuta nel ’68, quando i comunisti hanno cercato di dare "un volto umano" (ossia "europeo", cosi dicevano) al regime imposto da Mosca. La quale, puntuale, mandò i carri armati, senza che nessuno si muovesse in Occidente. Era dunque facile da interpretare la stizza di Milan Kundera nel caffè di Sèvres-Babylone, davanti al titolo provocatorio sulla Grecia. Gli veniva spontaneo identificarsi con quel paese. Non poteva non indignarsi e non spazzar via con un gesto della mano l’interrogativo che metteva in dubbio il carattere europeo della Grecia, madre culturale d’Europa. Nessun carro armato minaccia Atene. Le calamità che possono abbattersi, e che già si abbattono, sulla Grecia sono di un’altra natura. Quelle visibili, concrete, sono economiche. Ma c’è l’umiliazione che è altrettanto pesante.
E i greci sono orgogliosi. Dopo secoli di occupazione ottomana sono ritornati in Europa, pagando un altissimo prezzo di sangue. Byron e Chateaubriand si sono associati alla loro lotta. Delacroix gli ha dedicato quadri che all’epoca equivalevano a romanzi. E Mussolini la pagò cara, e con lui gli italiani, quando pensò di poter "rompere la schiena"alla Grecia. La resistenza al regime dei colonnelli, impossessatisi del potere nel 1967, fu aspra e coraggiosa. L’ho seguita per anni con passione e rispetto. Quando negli ultimi Settanta la fragile, disordinata democrazia greca chiese di entrare nella Comunità europea, Valéry Giscard d’Estaing, allora presidente della repubblica in Francia, replicò agli oppositori che non si poteva «chiudere la porta in faccia a Platone». La logica di quella decisione era essenzialmente politica, poiché la Grecia non aveva tutti i requisiti.
Ma c’era l’aspetto simbolico. Ad Atene era nata la democrazia, la politica, il teatro, la poesia, la filosofia, la bellezza. Il paese rurale e depresso, dove gli armatori miliardari non pagavano le tasse, restava sinonimo di cultura. Non lo si poteva certo lasciare fuori dalla porta. I suoi abitanti rappresentano poco più di un millesimo della popolazione mondiale. I suoi monumenti e le sue opere letterarie e filosofiche costituiscono una porzione assai più grande come vestigia della civiltà occidentale. Di cui sono le fondamenta. Senza le quali il denominatore comune culturale alla base dell’Europa non esisterebbe.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- IO SONO EUROPEO.3 novembre 2011, di Federico La Sala
Io sono europeo
di Vittorio Cristelli (“vita trentina”, 6 novembre 2011)
Se qualcuno in una ipotetica intervista, volendo sapere la comunità di appartenenza, ci ponesse a bruciapelo la domanda “chi sei?”, molti risponderebbero: “Sono trentino, sono altoatesino, sono italiano”. Qualcuno provocatoriamente potrebbe rispondere “sono padano”. Ma nessuno probabilmente risponderebbe “sono europeo”. Eppure è a questa coscienza che dobbiamo tendere, specie oggi di fronte alla globalizzazione che dovrebbe progressivamente farci sentire cittadini del mondo. A questo ho pensato in questi giorni di fronte alla “lettera di intenti” che il Capo del governo italiano ha dovuto consegnare ai 27 Paesi dell’Eurozona e alla Commissione di Bruxelles e leggendo i relativi giudizi e reazioni.
È certo che si è trattato di un commissariamento dell’Europa nei confronti dell’Italia e del suo governo che aveva fissato tutt’altri itinerari. Le reazioni, del tipo “non prendiamo lezioni da nessuno” denotano orgoglio nazionale antistorico e ignoranza della stessa protezione che può derivare dall’appartenenza alla famiglia europea. C’è stato perfino chi ha maledetto l’Euro. Figuratevi se questi direbbero “sono europeo”!
Io non entro nel merito dei singoli provvedimenti contenuti nella lettera, che anzi qualcuno, come quello dei licenziamenti facili, può essere criticato esattamente perché non è affatto “europeo”. Si pensi, solo per un attimo a quello che Jeremy Rifkin chiama “sogno europeo” da preferire a quello americano, proprio perché condito di solidarietà specie con i più deboli. Ma scalciare perché l’Europa interviene onde impedire che l’Italia faccia fallimento, è comportarsi come un bambino che strattona e prende a calci chi lo agguanta per impedirgli di cascare nel fiume.
È vero che i richiami all’Italia sono venuti non dall’Europa politica ma dalla Banca centrale (Bce) e quindi dal mondo finanziario, ma è vero pure che finora si è realizzata solo l’Europa economica e finanziaria. L’Europa politica e culturale è ancora di là da venire. Già, parecchi anni fa Jean Monnet, uno dei fondatori della nuova Europa ebbe a dire: “Se si partisse adesso incomincerei dalla cultura”.
Questo discorso vale anche per le Chiese, che sono in ritardo rispetto all’ideale che si erano proposte. Il vescovo di Piacenza Gianni Ambrosio, delegato italiano negli Episcopati europei, così si esprime in una recente intervista: “In questo momento l’attenzione più importante è fare sì che la dizione Unione Europea diventi parte di una mentalità comune e diffusa”. Non un’Unione astratta e senza anima, ma “una vera comunità capace di solidarietà e attenta al principio di sussidiarietà”. Già, la sussidiarietà che non significa solo che non debbono fare le entità superiori quello che riescono a fare gli enti di base, ma anche che quelle devono fare ciò che gli enti inferiori non riescono a portare a termine. Donde il diritto-dovere dei richiami.
Ma le Chiese europee tutte, dalle cattoliche alle protestanti, dalle ortodosse alle anglicane hanno sottoscritto già nel 1989 a Basilea il loro progetto europeo in cui definivano l’Europa “casa comune, guidata dallo spirito di cooperazione e non di competizione”. Le “regole di casa” erano: il principio di uguaglianza di tutti quelli che vivono nella casa; la tolleranza, la solidarietà e la partecipazione; “porte e finestre aperte” e cioè contatti personali, scambi di idee, dialogo anziché violenza nella risoluzione dei conflitti. Casa aperta anche verso il futuro del mondo e del creato.
Se non ci siamo ancora è segno che anche le Chiese si sono fermate ai blocchi di partenza. “Io sono europeo” significa identificarsi in quello che Rifkin chiama “sogno europeo”. Chi non sogna però è già vecchio. Oggi si direbbe che è da rottamare.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- USCIRE DAL "CERCHIO DEI CERCHI" DELLA FILOSOFIA DI HEGEL, LA FILOSOFIA E’ IN UNO STATO COMATOSO!!!24 giugno 2011
SAPERE AUDE! USCIRE DAL "CERCHIO DEI CERCHI" DELLA FILOSOFIA DI HEGEL.
PAROLA DI ENRICO BERTI: Più realista, e meno illuminista, di Kant è stato Hegel, il quale ha criticato i pedagogisti suoi contemporanei che volevano insegnare a «pensare con la propria testa».
E’ talmente vero quello che pensa Berti (e, con lui, la maggioranza dei suoi colleghi di filosofia e storia della filosofia) che qualsiasi studente e ogni studentessa per educarsi all’uso della sua propria intelligenza e alla sua "facoltà di giudizio" deve ricorrere non alle sue (e loro) letture di Kant, ma a qualche perito o a qualche manuale di estimo: l’estimo è la disciplina che ha la finalità di fornire gli strumenti metodologici per la valutazione dei beni per i quali non sussiste un apprezzamento univoco!!!
MATERIALI SUL TEMA, NEL SITO, IN:
Gioacchino - da Fiore!!!
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- DEMOCRAZIA REALE SUBITO: "DEMOCRACIA REAL YA"!!! NOTIZIE DALLA SPAGNA.20 maggio 2011, di Federico La Sala
 PIANETA TERRA. EUROPA .....
PIANETA TERRA. EUROPA .....
 DEMOCRAZIA REALE SUBITO: "DEMOCRACIA REAL YA"!!! NOTIZIE DALLA SPAGNA.. La protesta degli «indignados» si è estesa un po’ in tutto il paese. Sul banco degli accusati c’è tutta la classe politica.
DEMOCRAZIA REALE SUBITO: "DEMOCRACIA REAL YA"!!! NOTIZIE DALLA SPAGNA.. La protesta degli «indignados» si è estesa un po’ in tutto il paese. Sul banco degli accusati c’è tutta la classe politica.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- Fare dell’Europa e del bacino del Mediterraneo un’unica grande comunità (di Guido Viale - Deriva europea)..13 maggio 2011, di Federico La Sala
Deriva europea
di Guido Viale (il manifesto, 10.05.2011)
Volevano liberare il territorio patrio, e quello delle nazioni conquistate - il loro Lebensraum - dalla presenza degli ebrei; per impedire che gli contaminassero razza e costumi; ma non pensavano ancora allo sterminio. Prima avevano cercato di chiuderli nei ghetti: ma «loro» erano troppi e ancora troppo visibili. E si erano resi conto che con i pogrom - famoso è quello della notte dei cristalli - non avrebbero mai risolto il «loro» problema. Poi avevano pensato di deportarli in un paese lontano, in Madagascar; ma era troppo difficile, soprattutto in tempo di guerra. Allora hanno cominciato a ucciderli dove li avevano appena rastrellati, fucilandoli sull’orlo delle fosse comuni che gli avevano fatto scavare. Ma lo spettacolo era sconvolgente e gli schizzi di sangue gli macchiavano le divise. Alla fine hanno inventato le camere a gas e i campi di sterminio: un sistema «asettico», dove hanno convogliato per sopprimerli sei milioni di ebrei. È la storia della Shoah.
Anche noi - sembra - dobbiamo preservare i nostri territori dall’invasione di popoli inferiori ed estranei alle nostre radici giudaico-cristiane. Prima abbiamo usato una legislazione ad hoc e le questure, equiparando la loro esistenza a un crimine e vessandoli in ogni modo con la speranza che se ne andassero. Non ha avuto successo. Poi abbiamo cominciato a internarli in vere e proprie galere, fingendo che fossero luoghi di transito. Ma le hanno riempite tutte subito; e gli altri sono rimasti fuori. Poi siamo andati a bruciare i loro campi e le loro catapecchie, sotto la guida della Lega nelle città del Nord e della camorra in quelle del Sud; o a radere al suolo con i bulldozer campi e fabbriche dismesse dove si insediano sotto la guida di molti sindaci sia del Nord che del Sud; ma ritornano sempre, accampandosi da qualche altra parte. Per questo abbiamo pensato di affidare ai nostri dirimpettai del Mediterraneo, pagandoli, blandendoli e sottoponendoci a umilianti rituali - senza però mai trascurare gli affari - il compito di fermarli prima che toccassero il nostro bagnasciuga. Erano campi di sterminio quelli che finanziavamo, anche se lo sterminio era affidato alle angherie di svariate polizie e non a un’organizzazione scientifica come quella dei Lager. Poi la diga si è rotta e quelli che avevamo addestrato perché li bloccassero si sono messi ad organizzare le loro partenze in massa.
Così ci siamo ritrovati in guerra contro il tiranno che avevamo blandito fino al giorno prima. Abbiamo anche provato a rimandarli indietro: in aereo, in nave, in treno; o a spedirli oltre frontiera, sperando che se li prendesse qualcun altro; ma è come svuotare il mare con un secchiello. Alla fine qualcuno ha proposto di sparare direttamente sui barconi per affondarli: in un mare che nel corso degli anni ha già inghiottito trentamila migranti. Niente di più facile, d’altronde: sfiorano sui loro barconi con i motori in avaria le navi che bombardano le truppe di Gheddafi (ben armate, queste, dalla nostra industria bellica); e quelle nemmeno si accostano per raccoglierli. Quale sarà, allora, il prossimo passo di questa deriva?
La politica dei respingimenti è fallita sotto i nostri occhi. Il governo italiano aveva pensato di poterla perseguire per conto suo, in combutta con Gheddafi, per non renderne conto ai partner dell’Ue, a suo tempo definita «Forcolandia» per aver promosso una legislazione antirazzista sgradita alla Lega (bei tempi! Oggi l’Unione accetta senza fiatare la nuova costituzione ungherese, che del razzismo è un’epitome). Adesso il governo italiano piange perché i paesi che aveva appena finito di insultare non vogliono condividere il «fardello» caduto addosso al povero ministro Maroni, diventato in poco tempo il nemico numero uno della sua base più incarognita. Ma sulle menzogne della politica dei respingimenti sono stati costruiti per anni successi politici truffaldini e maggioranze di governo ad personam. E carriere ancora più facili di quelle delle tante ragazze trasformate in ministro, parlamentare, consigliere regionale o dirigente politico per aver fatto sesso con Berlusconi. Pensate al «Trota», il figlio di Bossi, diventato consigliere regionale dopo ben tre bocciature negli esamifici più screditati della Padania, che nel suo curriculum aveva solo un videogioco intitolato «Rimbalza il clandestino». Forse che - progressi tecnologici a parte - film e libri come Süss l’Ebreo, che hanno spianato la strada alla Shoah, avevano un’ispirazione diversa?
Purtroppo, in questa deriva l’Italia non è che l’avanguardia di un processo che sta investendo tutta l’Europa, mettendo alle corde tanto la sua politica (la capacità di scelte condivise), quanto il suo bagaglio culturale: esattamente come a suo tempo il razzismo antiebraico (largamente recepito sia ad est che ad ovest della Germania nazista) aveva sconfessato secoli di cultura tedesca e sprofondato il suo popolo in una vergogna che l’oblio non ha ancora sanato. L’Italia e l’Europa, peraltro, possono ancora incattivire parecchio: la strada verso una qualche «soluzione finale» è ancora lunga. Ma è già tracciata fin da quando Oriana Fallaci è assurta al ruolo di profeta della nuova Europa razzista.
Dunque è chiaro, anche se tutt’altro che evidente e condiviso, che al di là dei successi elettorali e delle facili carriere, la politica dei respingimenti non paga. Con essa l’Italia e l’Europa stanno rapidamente perdendo ogni posizione di vantaggio nell’arena della democrazia. L’alba di un rovesciamento delle parti già si intravvede: in Tunisia, in Egitto, in Siria, in Barhein, in Algeria; forse persino in Yemen; là dove un popolo di giovani scolarizzati e disoccupati sta riuscendo in quello che in Italia non riusciamo più a fare e molti di noi nemmeno a sperare: liberarsi da una tirannia mascherata da democrazia: niente di molto diverso dai regimi di Ben Alì, Mubarak o Assad.
Ma la storia avrebbe potuto imboccare, e forse può ancora imboccare, un’altra strada. Se respingere è irrealizzabile, e le conseguenze sono un danno per tutti, bisogna attrezzarsi per accogliere. Agire come se vivessimo in un’unica grande «patria» (non la «nazione», continuamente invocata a sproposito da Ernesto Galli della Loggia; e nemmeno uno Stato, nazionale o sovranazionale, che è da tempo un organo senza più poteri, ma solo con funzioni di copertura e saccheggio); bensì un’area di relazioni in grado di arricchire tutti: chi è qui e chi resta là. Una società dove a tutti venga offerto un ricovero e un’alimentazione decente (non sarebbe un grande sforzo: in Italia siamo soffocati dal cemento e buttiamo via quasi metà degli alimenti che compriamo). Un’integrazione fondata sull’accesso alla scuola e all’educazione di tutti, fornita dei supporti necessari per fare di ogni allievo, bimbo, giovane o adulto, un veicolo di reciproca accettazione. Un’economia aperta a tutti su un piede di parità: dove venga meno la possibilità di sfruttare il lavoro irregolare, ma anche il «vantaggio competitivo» di chi lavora in condizioni e per salari indecenti perché è irregolare (nella clandestinità c’è sempre posto per tutti; anche ai livelli di vita più degradati; per questo è una «calamita» di disperati. Ma quando si aprono le porte agli ingressi è possibile che molti, ai rischi di una traversata pericolosa preferiscano aspettare un secondo turno, se turni ci sono; anche se i turni, ovviamente, non sono la risposta ai problemi più urgenti). E poi, una produzione sostenibile e replicabile: per poter fare anche là, senza dipendere più di tanto da aiuti o capitali stranieri, quello che si potrebbe imparare a fare qua: con le energie rinnovabili, la piena utilizzazione delle risorse locali, la sovranità alimentare, la cura del territorio, la valorizzazione del patrimonio culturale; tante «cose» che rendono produttivi anche e soprattutto i rapporti interpersonali. Non ci sono solo profughi alla ricerca di un futuro; ci sono anche molti migranti che hanno imparato un mestiere, costruito un’impresa, creato una rete di relazioni; pronti a riportare nel paese di origine il piccolo o grande «capitale umano» che hanno acquisito. Certo sono meno di quelli che arrivano; ma possono essere un vettore di uno «sviluppo più sostenibile», che nessun programma di cooperazione ministeriale potrà mai realizzare.
Un approccio del genere è mancato per una nostra debolezza culturale. Eppure avrebbe potuto accelerare la democratizzazione in corso in molti paesi del Mediterraneo; rallentare la spinta all’emigrazione (forse non quella sospinta dalla miseria e dalle guerre; ma certamente quella promossa dalla curiosità per una vita diversa); promuovere desideri di un ritorno in patria in migranti portatori di un nuovo corredo di professionalità, di conoscenze, di esperienze e persino di capitali. Soprattutto, avrebbe potuto, e ancora potrebbe, fare dell’Europa e del bacino del Mediterraneo un’unica grande comunità.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- LO SCUDO DI ACHILLE. L’epos greco fonda l’Occidente. Uno spirito laico differenzia la polis dal misticismo degli asiatici di Eva Cantarella (di Eva CAntarella)1 maggio 2011, di Federico La Sala
L’epos greco fonda l’Occidente Uno spirito laico differenzia la polis dal misticismo degli asiatici
di Eva Cantarella (Corriere della Sera, 01.05.2011)
«Che i poemi omerici siano grandissima poesia, è superfluo dire. Che siano un documento storico è cosa meno nota, che ha dato origine a non poche controversie: si può credere» , chiedeva ad esempio lo storico Henri-Irénée Marrou, al racconto di eventi proiettati in un passato così irreale nel quale «persino le bestie parlano» ? Cosa, questa (che le bestie parlino, in Omero) assolutamente innegabile. Non solo parlano, conoscono anche il futuro: Xanto, il cavallo di Achille, predice al suo padrone la morte. Ma questo non toglie che l’epos sia un documento storico.
Precorrendo non di poco l’idea che la storia vada intesa come il patrimonio culturale di una comunità, già Vico (Principi di Scienza nuova), scriveva che Omero è «il primo storico, il quale ci sia giunto di tutta la gentilità» . Nella specie, lo storico che trasmette la memoria di quella Grecia nella quale, scrive Gaetano Parmeggiani, affondano le radici «della nazionalità europea» : la Grecia della ragione, radicalmente diversa dall’Oriente istintivo e mistico, dalla quale parte «quel filone di pensiero che corre da epoca e luoghi remoti - la Tessaglia o la Ionia sullo scorcio del secondo millennio avanti la nostra era- fino ai giorni di cui abbiamo diretta esperienza» . Affermazione, bisogna dire, non poco perigliosa. Contrapporre la ragione greca alla cultura orientale è facilmente classificabile come eurocentrismo.
Ma proprio per questo, oggi, è interessante leggere un libro così decisamente controcorrente (Gaetano Parmeggiani, Lo scudo di Achille, Sellerio). La razionalità dei greci, come ben noto, venne messa in discussione - sono ormai quarant’anni- da I greci e l’irrazionale di Eric Dodds, che avanzava forti dubbi sul fatto che la Grecia fosse l’unico isolotto di razionalità nel gran mare teistico della cultura antica. Il libro contribuì non poco a smantellare la credenza nel cosiddetto «miracolo greco» , alla cui storicità, successivamente, sferrò un attacco feroce un libro di Martin Bernal: Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilisation. Secondo Bernal quelle che abbiamo sempre considerato conquiste intellettuali dei greci, dalla filosofia alla teoria politica, dall’arte alla storiografia, nacquero, in realtà, per merito delle popolazioni asiatiche e africane. I greci si sarebbero limitati a recepirle. Le radici della civiltà occidentale, insomma, andrebbero cercate nella cultura afroasiatica.
La nostra convinzione che le origini della civiltà occidentale siano indoeuropee sarebbe la conseguenza di una falsificazione storiografica, perpetrata a partire dalla fine del Settecento, quando l’Europa- escludendo «altri» , che europei non erano- volle costruire un monumento a se stessa, facendo della Grecia il luogo della sua prodigiosa adolescenza. Impossibile ripercorrere il dibattito che seguì, al termine del quale (al di là della denuncia degli eccessi e dei non pochi veri e propri errori di Bernal) a Black Athena è giusto e doveroso, comunque, riconoscere di aver non poco contribuito a far accettare, anche ai più recalcitranti, l’innegabile esistenza di influssi orientali sulla cultura greca.
Ma Parmeggiani la pensa diversamente: furono i filosofi greci, scrive, che nel VI secolo a. C. innalzarono «quel baluardo che difenderà a lungo l’Occidente dal misticismo orientale» . Ed è greco «quell’umanesimo laico, limpido, che è la matrice del pensiero moderno» , a suo giudizio già presente nell’epos: i poemi omerici, sostiene, sono laici. E al di là di ogni discussione sui debiti della Grecia verso l’Oriente (sulla cui misura si possono avere opinioni diverse, ma che non possono essere negati), su questo punto ha molte ragioni dalla sua. Il comportamento dell’individuo omerico è ispirato alla necessità sociale di ottenere dai suoi pari il riconoscimento dell’onore (time). Null’altro esiste, per lui, dopo la morte, se non il ricordo dei posteri. Questo rivelano i poemi, «raffinata, coerente e organica enciclopedia che raccoglie il bilancio di un’epoca» , scrive Luciano Canfora nella introduzione al libro.
E lo scudo di Achille, è, a ben vedere, il cuore di questa enciclopedia. Le scene di vita cittadina, su di esso scolpite, sono i momenti fondamentali della vita di una polis: un matrimonio, un processo, l’aratura di un campo, una vendemmia... È una polis interamente antropocentrica, quella omerica, «in cui gli dèi non sono che uomini, appena un po’ più grandi del vero» . Che le opinioni certamente radicali del suo autore vengano o meno condivise, vale la pena leggere questo libro che- pregio non da poco- induce a ragionare e ripensare criticamente molte delle proprie certezze. Anche se alla fine ne dovessero uscire confermate.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- LA CITTA’ DIVISA. Il capolavoro di Nicole Loraux.15 giugno 2016, di Federico La Sala
SCHEDA *
La città divisa
Nicole Loraux
Neri Pozza Editore, pagg.448, Euro 40,00
IL LIBRO - Questo libro è il capolavoro di Nicole Loraux, la grande antichista francese da poco scomparsa. Esso tenta di ripensare da capo la polis greca, questo modello prestigioso di tutta la tradizione politica occidentale. La scoperta della Loraux è che a fondare la città greca, a fungere da paradigma alla democrazia, non sono né la libertà, né l’unità, né la comunità, ma qualcosa come un paradossale legame attraverso la divisione. Si tratta, cioè, di ripensare Atene sotto il segno della “stasis”, della guerra intestina, che divide e insanguina non solo la città, ma anche, l’”oikos”, la famiglia -o, piuttosto, circola, in un movimento incessante, dalla famiglia alla città, dai fratelli rivali ai cittadini nemici. La guerra civile non è, però, soltanto rottura e anomia, ma costituisce il legame politico segreto che anima e segna profondamente la vita e le istituzioni della democrazia greca, dal giuramento all’amnistia, dalla vendetta alla riconciliazione. Una città divisa deve essere, infatti, capace non solo di ricordare, ma anche di dimenticare, di ricomporre attraverso l’oblio (l’amnistia) l’unità perduta. E a poco a poco, come in ogni grande libro di storia, l’analisi del passato permette di guardare in una nuova luce le divisioni e i conflitti, la memoria e la smemoratezza della società in cui viviamo.
DAL TESTO - “La città degli antropologi [...] non agisce nel tempo dell’evento, ma in quello ripetitivo delle pratiche sociali - il matrimonio, il sacrificio -, in cui fare è ancora un modo di pensare. Di pensare se stessi assegnando (tentando di assegnare) un posto all’altro, a tutti gli altri e, di conseguenza, al medesimo: ricollegando i margini al centro, a quegli “andres” che sono la città ma hanno bisogno, per esempio, delle donne per costituirla veramente. Così il matrimonio fonda la città assicurandone la riproduzione. Dopodiché, una volta costituitasi la “polis” in società umana, la si può situare in rapporto a un altrove. O meglio: di questo altrove, tempo degli dei, mondo selvaggio delle bestie, la città proclama la distanza per meglio farlo, mettendolo al posto opportuno. La città ha assorbito il suo fuori, e il sacrificio fonda la “polis”: lontani dagli dei, ma dotati della cultura, gli uomini sacrificano loro un animale, e questo gesto distribuisce il sistema di esplosioni e integrazioni intorno al nucleo degli “andres”. Dal taglio sacrificale e della sua interpretazione in atto nascerebbe a ogni cerimonia il politico: ugualitario come la condivisione, isomorfo... Diremo anche neutralizzato? Il politico come circolazione immobile, o la città a riposo”.
L’AUTORE - Nicole Loraux (1943-2003) ha insegnato «Histoire et anthropologie de la cité greque» presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales dal 1981 al 1994. Dei suoi numerosi libri, in italiano sono apparsi: “Come uccidere tragicamente una donna” (Laterza, 1988), “Il femminile e l’uomo greco” (Laterza, 1991), “Le madri in lutto”(Laterza, 1991), “Nati dalla terra. Mito e politica ad Atene” (Meltemi, 1998) e “La voce addolorata. Saggio sulla tragedia greca”(Einaudi, 2001).
INDICE DELL’OPERA - Introduzione, di Gabriella Pedullà - Prefazione - La città divisa: sopralluoghi - I. L’oblio nella città - II. Ripoliticizzare la città - III. L’anima della città - Sotto il segno di Eris e di alcuni suoi figli - IV. Il legame della divisione - V. Giuramento, figlio di Discordia - VI. Dell’amnistia e del suo contrario - VII. Su un giorno vietato del calendario ateniese - Politiche della riconciliazione - VIII. La politica dei fratelli - IX. Una riconciliazione in Sicilia - X. Della giustizia come divisione - XI. E la democrazia ateniese dimenticò il “kratos” - Ringraziamenti - La guerra nella famiglia
* http://www.archiviostorico.info/Rubriche/Librieriviste/recensioni6/Lacittadivisa.htm
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- IL TEMPO DEI PROFETI (di Barbara Spinelli).12 aprile 2011, di Federico La Sala
Il tempo dei profeti
di Barbara Spinelli (la Repubblica, 12 aprile 2011)
Il Presidente Napolitano, che quando parla d’Europa usa veder lontano e ha sguardo profetico, ha fatto capire nel giorni scorsi quel che più le manca, oggi: il senso dell’emergenza, quando una crisi vasta s’abbatte su di essa non occasionalmente ma durevolmente; l’incapacità di cogliere queste occasioni per fare passi avanti nell’Unione anziché perdersi in «ritorsioni, dispetti, divisioni, separazioni».
Son settimane che ci si sta disperdendo così, attorno all’arrivo in Italia di immigrati dal Sud del Mediterraneo. Numericamente l’afflusso è ben minore di quello conosciuto dagli europei nelle guerre balcaniche, ma i tempi sono cambiati. Lo sconquasso economico li ha resi più fragili, impauriti, rancorosi verso le istituzioni comunitarie e le sue leggi. Durante il conflitto in Kosovo la Germania accolse oltre 500mila profughi, e nessuno accusò l’Europa o si sentì solo come si sente Roma. Nessuno disse, come Berlusconi sabato a Lampedusa: «Se non fosse possibile arrivare a una visione comune, meglio dividersi». O come Maroni, ieri dopo il vertice europeo dei ministri dell’Interno che ha isolato l’Italia: «Mi chiedo se ha senso rimanere nell’Unione: meglio soli che male accompagnati». La sordità alle parole di Napolitano è totale.
La democrazia stessa, che contraddistingue gli Stati europei e spinge i governi a preoccuparsi più dell’applauso immediato che della politica più saggia, si trasforma da farmaco in veleno. Di qui la sensazione che l’Unione non sia all’altezza: che viva le onde migratorie come emergenza temporanea, non come profonda mutazione. Governi e classi dirigenti sono schiavi del consenso democratico anziché esserne padroni e pedagoghi con visioni lunghe. Non a caso abbiamo parlato di spirito profetico a proposito di Napolitano. È la schiavitù del consenso a secernere dispetti, rancori, furberie. Tra le furberie che ci hanno isolato c’è la protezione temporanea eccezionale che il nostro governo ha concesso a 23.000 immigrati. La protezione è prevista dal Trattato di Schengen, ma solo per profughi scampati a guerre e persecuzioni: non vale per i tunisini, come ci hanno ricordato ieri la Commissione e gli Stati alleati. Non è violando le regole che l’Italia suscita solidarietà. Può solo acutizzare le diffidenze: un altro veleno che mina l’Unione.
Per questo vale la pena soffermarsi sul significato, in politica, dello spirito profetico. Vuol dire guardare a distanza, intuire le future insidie del presente, ma innanzitutto comporta un’operazione verità: è dire le cose come stanno, non come ce le raccontiamo e le raccontiamo per turlupinare, istupidire, e inacidire gli elettori. Di questo non è capace Berlusconi ma neanche gli altri Stati e le istituzioni europee: i primi perché sempre alle prese con scadenze elettorali, le seconde perché intimidite dalle resistenze nazionali. La lentezza con cui si risponde alle rivoluzioni arabe non è la causa ma l’effetto di questi mali.
La prima verità non detta è quasi banale, e concerne l’intervento in Libia e il nostro voler pesare sui presenti sconvolgimenti arabi e musulmani. Condotta con l’intento di apparire attivi, la guerra sta confermando il contrario: una grande immobilità e vuoto di idee. È un attivarsi magari sensato all’inizio, ma che mai ha calcolato le conseguenze (compresa un’eventuale vittoria di Gheddafi) sui paesi arabi-africani e sui nostri. Fra le conseguenze c’è l’esodo di popoli. Un esodo da assumere, se davvero vogliamo esserci in quel che lì si sta facendo. Invece siamo entrati in guerra senza pensarci, né prepararci.
La seconda verità, non meno cruciale, riguarda l’Europa e i suoi Stati. L’occultamento è in questo caso massiccio, ed è il motivo per cui il capro espiatorio della crisi migratoria non è l’Italia come gridano i nostri ministri ma - se non si inizia a parlar chiaro - l’Unione stessa. L’evidenza negata è che da quando vige il Trattato di Lisbona, molte cose sono cambiate nell’Unione. Le politiche di immigrazione erano in gran parte nazionali, prima del Trattato. Ora sono di competenza comunitaria, e la sovranità è passata all’Unione in quanto tale. Questo anche se agli Stati vengono lasciati, ambiguamente, ampli spazi di manovra, in particolare sul «volume degli ingressi da paesiterzi». Risultato: l’Unione, anche perché guidata a Bruxelles da un Presidente debole, prono agli Stati, non sa che fare della propria sovranità. Non ha una politica verso i paesi arabi, di cooperazione e sviluppo.
Tuttora non ha norme chiare sull’asilo, sull’integrazione dei migranti, né possiede il corpo comune di polizia di frontiera che aveva promesso. Ma soprattutto, non ha le risorse per tale politica perché gli Stati gliele negano, riducendo la sovranità delegata a una fodera senza spada. Per questo alcuni spiriti preveggenti (l’ex ministro socialista Vauzelle, il presidente del consiglio italiano del Movimento europeo Virgilio Dastoli) propongono una cooperazione euro-araba gestita da un’Autorità stile Ceca (la prima Comunità del carbone e dell’acciaio). Come allora viviamo una Grande Trasformazione, e Monnet resta un lume: «Gli uomini sono necessari al cambiamento, le istituzioni servono a farlo vivere».
Se il Trattato di Lisbona significasse qualcosa, non dovrebbero essere Berlusconi e Frattini a negoziare con Tunisia o Egitto, con Lega araba o Unione africana. Dovrebbero essere il commissario all’immigrazione Cecilia Malmström e il rappresentante della politica estera Catherine Ashton. Resta che per negoziare ci vogliono progetti, iniziative: e questi mancano perché mancano risorse comuni. La condotta dei governi europei è schizoide, e tanto più menzognera: gli Stati hanno avuto la preveggenza di delegare all’Europa una parte consistente di sovranità, su immigrazione e altre politiche, ma fanno finta di non averlo fatto, e ora accusano l’Europa come se gli attori del Mediterraneo fossero ancora Stati-nazione autosufficienti.
La terza operazione-verità, fondamentale, ha come oggetto l’immigrazione e il multiculturalismo. È forse il terreno dove il mentire è più diffuso, tra i governanti, essendo legato alla questione della democrazia, del consenso, della mancata pedagogia, degli annunci diseducativi. Risale all’ottobre scorso la dichiarazione di Angela Merkel, secondo cui il multiculturalismo ha fatto fallimento. Poco dopo, il 5 febbraio in una conferenza a Monaco sulla sicurezza, il premier britannico Cameron ha decretato la sconfitta di trent’anni di dottrina multiculturale. Il fatto è che il multiculturalismo non è una dottrina, un’opinione. È un mero dato di fatto: in nazioni da tempo multietniche come Francia Inghilterra o Germania, e adesso anche in Italia e nei paesi scandinavi. L’operazione verità non consiste nel proclamare fallito il multiculturalismo: se un dato di fatto esiste, fallisce solo se se estirpi o assimili forzatamente i diversi. Se fossero veritieri, i governi dovrebbero dire: il multiculturalismo c’è già, solo che noi - Stati sovrani per finta - non abbiamo saputo né sappiamo governarlo.
Dire la verità sull’immigrazione è essenziale per l’Europa perché solo in tal modo essa può osare e fare piani sul futuro. Urge cominciare a dire quanti immigrati saranno necessari nei prossimi 20 anni, e quali risorse dovranno esser mobilitate: sia per mitigare gli arrivi cooperando con i paesi africani o arabi, sia edificando politiche di inclusione per gli immigrati economici e per i profughi (la frontiera spesso è labile: la povertà inflitta è una forma di guerra).
Tutto questo costerà soldi, immaginazione, pensiero durevole. Comporterà, non per ultimo, un ripensamento della democrazia. Ci sono cose che non si possono fare perché maturano nei tempi lunghi e l’elettorato capisce solo i risultati immediati, spiega l’economista Raghuram Rajan in un articolo magistrale sulle crisi del debito (Project Syndacate, 9 aprile 2011). Il bisogno di immigrati che avremo fra qualche decennio in un’Europa che invecchia è, paradossalmente, quello che dà forza ai nazional-populisti: in Italia, Francia, Belgio, Olanda, Ungheria, Svezia, Finlandia.
Il dilemma delle democrazie è questo, oggi. Esso costringe governanti e governati a fare quel che non vogliono: smettere l’inganno delle sovranità nazionali, guardare alto e lontano, insomma pensare. E far politica, ma con lo spirito profetico che vede la possibile rovina (il «passo indietro» paventato da Napolitano) e la via d’uscita non meno possibile, se è vero che il futuro non cessa d’essere aperto.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- GRAN CONFUSIONE NEI CIELI D’EUROPA. ... sui concetti che sembravano chiari, sul significato di parole che sembravano univoche, su valori che sembravano condivisi: il fondamento della morale, il pacifismo, la democrazia, la dignità della donna. Perfino la libertà. Perfino l’eguaglianza. Perfino i diritti e i doveri (di Eugenio Scalfari)..27 marzo 2011, di Federico La Sala
Gran confusione nei cieli d’Europa
di EUGENIO SCALFARI *
GIORNALI di tutto il mondo, i nostri compresi, scrivono da giorni che c’è grande confusione. Lo dicono anche i governi, gli stati maggiori delle varie forze armate, i politici e le persone interrogate per strada.
C’è grande confusione sulla guerra di Libia, sulle sollevazioni africane e mediorientali (alle quali proprio in queste ore si sono aggiunte la Siria e la Giordania), sull’uso del nucleare, sui debiti sovrani, sugli schieramenti internazionali, sui flussi migratori. I grandi paesi emergenti, Cina India Brasile Russia Sudafrica, cominciano ad elaborare una posizione politica comune che sia alternativa a quella dell’occidente, cioè del Nord- America. L’Europa, come sempre, è divisa in due, forse in tre se non addirittura in quattro pezzi. Divisa su tutto: sul caso Gheddafi, sull’immigrazione, sull’energia atomica, sull’economia.
Ma c’è grande confusione anche sui concetti che sembravano chiari, sul significato di parole che sembravano univoche, su valori che sembravano condivisi: il fondamento della morale, il pacifismo, la democrazia, la dignità della donna. Perfino la libertà. Perfino l’eguaglianza. Perfino i diritti e i doveri.
Si direbbe che, quasi d’improvviso, il gomitolo della storia non riesca più a svolgersi, i fili si sono imbrogliati inestricabilmente, i nodi sono arrivati al pettine tutti insieme, la cruna dell’ago è ostruita. Babele trionfa e trionfano la ferocia l’astuzia la Suburra.
Bisogna dunque cercare il capo del filo e svolgerlo per poter capire qualche cosa.
E il capo del filo, sul terreno concreto, oggi sta in Europa perché è proprio qui in Europa che il groviglio è diventato più inestricabile e la confusione ha raggiunto il massimo.
***
La risoluzione dell’Onu ha stabilito che la popolazione civile della Libia sia protetta dalla Comunità internazionale contro le operazioni poliziesche e militari di Gheddafi. Protetta con tutti i mezzi disponibili ed efficaci per fermare Gheddafi, con l’esclusione di sbarcare truppe a terra. La "no fly zone" è uno degli strumenti, ma non il solo, anche perché porta con sé logicamente la distruzione degli impianti gheddafiani a terra e in volo: aeroporti, flotta aerea, installazioni radar, batterie contraeree. Ma poiché l’obiettivo è quello di tutelare la popolazione civile bisogna anche distruggere il sistema dei trasporti militari, le armi pesanti di cannoneggiamento, i mezzi blindati. Insomma bisogna disarmare Gheddafi. Infine, sempre ottemperando alla risoluzione dell’Onu fatta propria dall’Unione europea, bisogna applicare sanzioni economiche e impedire che il raìs riceva rifornimenti di armi. In teoria tutti si sono dichiarati d’accordo con questi obiettivi salvo alcuni membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu (Russia, Cina, India, Brasile, Germania) che però, astenendosi, hanno consentito che l’operazione "protettiva" partisse.
Tralasciamo la bega tra Italia e Francia sul comando dell’operazione: ormai è stato deciso che il comando sarà affidato alla Nato. Ma questo non cambia granché, salvo forse un rallentamento burocratico-operativo sul terreno.
Resta il problema di fondo: che farà Gheddafi?
Se la risoluzione dell’Onu sarà interpretata in modo limitato, Gheddafi resterà al potere a Tripoli e aspetterà che la presenza degli stranieri nei cieli libici e nel mare cessi. La "no fly zone" non potrà durare in eterno, prima o poi la coalizione dei "protettori" si scioglierà, il dispositivo militare sarà smantellato e tutti se ne torneranno a casa. Tutti salvo ovviamente Gheddafi e il suo esercito mercenario. I rifornimenti di armi riprenderanno e in Libia tutto ricomincerà da capo salvo l’alleanza dei "protettori" che una volta sciolta non si riformerà più. Prima che ciò avvenga bisogna dunque avviare un negoziato.
***
Questa sequenza l’hanno capita tutti, più o meno tardivamente. L’hanno capita gli americani, l’Onu, la Nato, i francesi, gli italiani, la Turchia, la Lega araba, la Lega africana. Tra il capire e il fare c’è però di mezzo... Gheddafi. Non se ne andrà in esilio se non sarà con le spalle al muro. Farà ogni sorta di promesse, giurerà di "fare il buono", accetterà di emanare una Costituzione democratica e libere elezioni, lo giurerà sulla testa dei figli e dei nipoti. Tutto, pur di restare al comando. L’esilio no, non lo accetterà se non sarà ridotto all’impotenza. Nel suo caso l’impotenza significa: senza più esercito, senza più mercenari, senza più consenso, senza più macchina di propaganda, senza più ricchezze se non quanto necessario al suo (lauto) sostentamento. Di fatto prigioniero nel suo bunker e con la denuncia alla Corte dell’Aia per crimini contro l’umanità pendente sul suo capo come avvenne per Milosevic.
Solo se ridotto in queste condizioni accetterà l’esilio come salvavita. Perciò se la risoluzione dell’Onu di protezione della popolazione civile libica deve essere rispettata il solo modo praticabile è quello di ridurre Gheddafi in quella condizione. Altrimenti diciamo che è stato tutto un macabro e dispendiosissimo scherzo. È pienamente comprensibile che i Paesi definiti dalla sigla Bric (Brasile, Russia, India, Cina) puntino a questo risultato: l’umiliazione degli Usa, dell’Europa, di quello che un tempo si definiva Occidente. Ma che sia questo anche l’obiettivo della Germania è incomprensibile a meno che, per la Germania, l’umiliazione della Unione europea sia un punto di passaggio per instaurare l’egemonia tedesca sull’Europa. Egemonia non soltanto economica (quella già c’è) ma anche politica.
Quell’egemonia ha ormai un solo ostacolo: la Francia, guidata da un leader che qualcuno descrive come un personaggio da avanspettacolo. Quanto a noi, in fatto di avanspettacolo non accettiamo lezioni da nessuno. Infatti siamo noi che, dopo i primi tentennamenti, abbiamo considerato la Francia come il nemico o almeno il rivale numero uno. Sarkozy forse fa ridere ma la Francia è la Francia e purtroppo noi facciamo ridere tutti anche in circostanze nelle quali si dovrebbe piangere.
***
In realtà la sola questione che interessa chi detiene la "golden share" del governo italiano, cioè Bossi, è quella degli immigrati. Lampedusa è stata fin qui l’agnello sacrificale: è stata lasciata sola perché si è voluto che rappresentasse visibilmente, sotto gli occhi delle televisioni di mezzo mondo, una popolazione di cinquemila abitanti ridotti allo stremo ed una popolazione di ottomila immigrati ridotti in condizioni disumane.
Alla fine anche Maroni, che aveva vaticinato l’apocalisse senza aver preparato nulla per fronteggiarla, si è reso conto che la soglia dell’insopportabilità era stata varcata e ha preso (apparentemente) le misure per fronteggiarla requisendo due navi da crociera per sgombrare l’isola. Ci vorrà una settimana ma la sgombrerà, ma fino all’altro ieri non l’aveva fatto. Perché? Non ci vuole una gran fantasia ma a lui non era venuto in mente nulla.
Resta tuttavia un mistero: dove sistemerà, sia pure provvisoriamente, gli ottomila immigrati? E come fronteggerà quelli che nel frattempo continueranno ad arrivare?
Finora sono arrivati dalla Tunisia o meglio dai campi allestiti al confine tra Libia e Tunisia dove novantamila profughi si sono accalcati da quando in Libia è scoppiata la guerra civile. Ma ora le partenze sono cominciate anche dalla costa libica, dai campi di concentramento allestiti da Gheddafi dove a questo punto tutti i paletti sono saltati.
Questi campi erano un inferno e c’era gente di ogni provenienza: africani di Eritrea e di Etiopia, sudanesi e perfino neri provenienti dall’Africa equatoriale e subsahariana. La strada era di migliaia di chilometri e la Libia era la tappa verso il Mediterraneo.
Gheddafi faceva il carceriere. Berlusconi lo pagava per questo, petrolio a parte. Adesso il raìs ha altre cose cui pensare e semmai si serve del flusso di migranti per dimostrare la necessità di rimettere in sella un carceriere della sua stazza.
Voglio qui trascrivere un pensiero di Luigi Einaudi, un liberale conservatore che in realtà fu una grande persona che fa onore al nostro Paese.
 "Le barriere giovano soltanto a impoverire i popoli, a inferocirli gli uni contro gli altri, a far parlare a ciascuno di essi uno strano e incomprensibile linguaggio, di spazio vitale, di necessità geopolitiche e a far pronunciare ad ognuno di essi esclusive scomuniche contro gli immigrati stranieri, quasi che fossero lebbrosi e quasi il restringimento feroce d’ogni popolo in se stesso potesse, invece di miseria e malcontento, creare ricchezza e potenza".
"Le barriere giovano soltanto a impoverire i popoli, a inferocirli gli uni contro gli altri, a far parlare a ciascuno di essi uno strano e incomprensibile linguaggio, di spazio vitale, di necessità geopolitiche e a far pronunciare ad ognuno di essi esclusive scomuniche contro gli immigrati stranieri, quasi che fossero lebbrosi e quasi il restringimento feroce d’ogni popolo in se stesso potesse, invece di miseria e malcontento, creare ricchezza e potenza".Questo scrisse Einaudi in un discorso pronunciato all’Assemblea Costituente il 29 luglio del 1947. Parole che sembrano scritte oggi. Gettate al vento in un Paese del quale fu il primo presidente della Repubblica appena nata.
***
Questa è la deplorevole, mortificante, lacerante situazione in cui ci troviamo mentre il Parlamento, forte d’una maggioranza che sta in piedi solo perché una ventina di deputati ricatta con successo il presidente del Consiglio, si occupa dei problemi giudiziari dell’imputato Silvio Berlusconi: cancellare i processi colpendoli con la legge "ad personam" sulla prescrizione brevissima, sollevare il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, intimidire i magistrati con la responsabilità civile personale.
La Lega acconsente perché ha il suo tornaconto e passa all’incasso. Almeno il suo è un ricatto politico ma gli altri sono ricatti di altro genere. Passano all’incasso gli "irresponsabili" dei vari gruppi di parlamentari comprati con cambiali che ora debbono esser pagate per non andare in protesto; passano all’incasso le veline e le escort, passano all’incasso i difensori d’ufficio e anche gli esiliati "pro tempore" come Scajola.
A me a volte Berlusconi fa tenerezza. Ma se penso allo scempio che ha fatto di questo Paese la tenerezza cede il posto ad un sentimento di giustizia che non saranno le aule giudiziarie a soddisfare ma l’isolamento morale e la disfatta politica che le sue azioni e omissioni si sono ampiamente meritate.
* la Repubblica, 27 marzo 2011
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Radici europee prima di Cristo Dalle origini greco-romane all’apporto essenziale del Vangelo (di Giuseppe Galasso).18 febbraio 2011, di Federico La Sala
Radici europee prima di CristoDalle origini greco-romane all’apporto essenziale del Vangelo
di Giuseppe Galasso (Corriere della Sera, 18.02.2011)
Periodicamente le «origini cristiane dell’Europa» tornano all’ordine del giorno sia sul piano culturale che, forse, più ancora, su quello politico; e sempre si contrappongono chi crede che quel carattere cristiano sia indiscutibile e chi crede che lo si debba negare; e, come spesso accade in simili casi, è proprio questa contrapposizione a fuorviarne i discorsi. Chiediamoci, piuttosto: la tradizione europea è nata col cristianesimo oppure ha già una sua delineazione precristiana? La risposta si presta a pochi dubbi.
Nell’antica storia mediterranea, e in specie in Grecia e in Roma, hanno le origini e le prime forme, spesso altissime, punti decisivi dell’identità europea. Tali sono lo spirito critico, il razionalismo storico e filologico, la filosofia, concetti basilari dell’etica e della politica (dignità dell’uomo, libertà, democrazia) così come dello spirito religioso, espressioni fondative nella tradizione poetico-letteraria e artistica, un’amplissima terminologia nei più vari campi dello scibile, elementi centrali nella contrapposizione tra Occidente e Oriente, vicende storiche (di Grecia e di Roma) che sono servite poi sempre agli europei da modelli o da materia di riflessione, una mitologia che ha nutrito per secoli l’immaginario europeo...
Una eredità di enorme e determinante spessore, di cui, tra l’altro, anche la radicale rivoluzione cristiana è largamente vissuta. Si può ignorare tutto ciò in qualsivoglia visione del passato e dei «fondamenti» dell’Europa, senza privare le «origini» europee di connotati imprescindibili, e senza, quindi, impoverire fortemente qualsiasi concezione della storia e della realtà europea?
Altra cosa sono, invece, è ovvio, la parte del cristianesimo nella storia europea e il suo contributo a questa storia. Parte e contributo tali che per moltissimi secoli «europeo» e «cristiano» sono stati termini equivalenti e interscambiabili, e le innovazioni e gli sviluppi della civiltà europea si sono largamente modellati nello stampo cristiano.
Sul piano dell’etica, in specie, l’Europa moderna ha ricevuto un’impronta cristiana profonda, indiscutibile (e perciò un pensatore del tutto laico come Benedetto Croce affermava che «non possiamo non dirci cristiani» , mostrando in ciò ben altra intelligenza rispetto ai tanti che, come Bertrand Russell, pensavano che «non possiamo dirci cristiani» ). Cose ovvie, se si vuole, ma non perciò meno meritevoli di essere ribadite; e il discorso sarebbe, così, chiuso, se con quanto si è qui detto non interferissero a fondo altri elementi. Eccone qualcuno.
 In primo luogo, il cristianesimo non è mai stato un monolite indifferenziato. Ci sono almeno tre confessioni cristiane in Europa, e in ognuna di esse le differenziazioni interne sono non poco rilevanti.
In primo luogo, il cristianesimo non è mai stato un monolite indifferenziato. Ci sono almeno tre confessioni cristiane in Europa, e in ognuna di esse le differenziazioni interne sono non poco rilevanti.
 In secondo luogo, nel corso dei secoli l’Europa ha largamente importato dall’esterno concetti fondamentali e altrettanto differenziati e diversi per la sua identità e per il suo patrimonio storico, morale e culturale. Rilevanti e importanti sono state soprattutto le derivazioni dal mondo dell’Islam.
In secondo luogo, nel corso dei secoli l’Europa ha largamente importato dall’esterno concetti fondamentali e altrettanto differenziati e diversi per la sua identità e per il suo patrimonio storico, morale e culturale. Rilevanti e importanti sono state soprattutto le derivazioni dal mondo dell’Islam.
 In terzo luogo, non solo confessioni cristiane e derivazioni dall’esterno non sono blocchi monolitici, ma non sono nemmeno costanti o, all’opposto, dati una volta per tutte, poiché hanno avuto intensità molto varie nel tempo.
In terzo luogo, non solo confessioni cristiane e derivazioni dall’esterno non sono blocchi monolitici, ma non sono nemmeno costanti o, all’opposto, dati una volta per tutte, poiché hanno avuto intensità molto varie nel tempo.
 In quarto luogo, nella storia europea si è formata una sempre più consolidata tradizione umanistica, laica, scientifica, più o meno lontana da quella cristiana, o anche vicina a essa, o perfino conforme, nella quale è di certo un altro tratto fondante dell’identità europea. E, tutto ciò, a non parlare del crescente processo di secolarizzazione, che ormai da un paio di secoli ha investito l’Europa, e che certo è nato anch’esso dalle viscere della realtà europea e ne è parte costitutiva. In realtà, a ben riflettere, è il concetto stesso di origini a non attagliarsi alla discussione.
In quarto luogo, nella storia europea si è formata una sempre più consolidata tradizione umanistica, laica, scientifica, più o meno lontana da quella cristiana, o anche vicina a essa, o perfino conforme, nella quale è di certo un altro tratto fondante dell’identità europea. E, tutto ciò, a non parlare del crescente processo di secolarizzazione, che ormai da un paio di secoli ha investito l’Europa, e che certo è nato anch’esso dalle viscere della realtà europea e ne è parte costitutiva. In realtà, a ben riflettere, è il concetto stesso di origini a non attagliarsi alla discussione.Le origini, si sa, sono sempre, per lo più, un mito, anche se dei più essenziali e fondanti nella vita degli uomini. Nell’epoca romantica l’identità, la nascita e lo sviluppo di una realtà e coscienza europea sul fondamento della fede cristiana, e, meglio, cattolica, furono elaborati nelle loro versioni più alte e feconde. È dubbio che la stessa altezza di pensiero e fecondità di svolgimenti abbia o possa avere quella tesi oggi, in un mondo e in un’Europa tanto mutati. Il che non toglie, peraltro, che si debba appieno riconoscere alla tradizione cristiana in Europa il luogo eminente, anche se non monopolizzante, che essa ha avuto, e continua, in altro modo e misura, ad avere.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- BRASILE 2010, ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 3 0TT0BRE: LA LEZIONE DI UNA GIOVANE DEMOCRAZIA (di Gloria Origgi - Brasile 2010: elezioni tutte a sinistra)1 ottobre 2010, di Federico La Sala
Brasile 2010: elezioni tutte a sinistra
di Gloria Origgi (da Micromega, settembre 2010) *
Lo sguardo di chi arriva dalla vecchia e perfida Europa delle identità nazionali, dell’aziendalizzazione di scuole e ospedali, del mercato onnipresente che soffoca qualsiasi ideale, qualsiasi slancio, è incredulo: seduta davanti alla televisione giovedì 23 settembre per il terzo dibattito elettorale, mi trovo davanti a quattro, ben quattro candidati alla presidenza del Brasile tutti di sinistra! E’ mai possibile? Forse ho sbagliato canale e sto guardando la telenovela delle otto di sera di RedeGlobo, quella che fa sognare più di 100 milioni di brasiliani ogni giorno ... ma no: è proprio la diretta dall’università cattolica di Brasilia e sono proprio loro che sfilano, Dilma Rousseff (PT, Partito dei Lavoratori, e soprattutto partito di Lula) José Serra (PSDB, Partito Socialdemocratico Brasiliano) Marina Silva (PV, Partito Verde) e addirittura il vecchio Plinio de Arruda Sampaio, ottant’anni di militanza socialista, ora candidato del PSOL, Partito del Socialismo e della Libertà, nato nel 2004 da un gruppo di dissidenti del PT che erano stati espulsi dal partito.
Dibattito all’americana, organizzato in quattro blocchi, ognuno di 15 minuti, il primo blocco dedicato alla presentazione dei programmi, tre minuti a testa, poi a rispondere alle domande degli accademici, poi dei giornalisti e infine a farsi domande tra di loro. E’ la festa della democrazia soprattutto, dice fiero il presentatore: non dimentichiamo che siamo in Sudamerica, che le democrazie qui sono quasi tutte giovani, nate dopo decenni di dittature violente. Il Brasile ha conosciuto la dittatura dal 1964 al 1985, un regime di “capitalismo autoritario” meno feroce delle dittature vicine, come L’Argentina o il Cile, ma con l’eliminazione dei partiti politici, la censura, la persecuzione degli oppositori, tra i quali ben tre dei quattro candidati oggi alla presidenza. Il golpe del 1964 fu realizzato con l’appoggio dei militari americani, in “debito” con l’esercito brasiliano, che mandò 25 000 soldati brasiliani, la Força Expedicionaria Brasileira, a combattere sulla Linea Gotica a fianco di americani e partigiani (ci sono un paio di piccoli cimiteri negli Appennini e un monumento a Pistoia a ricordare questa storia). Ma la storia precedente del Brasile non era certo una storia democratica: alti e bassi tra tentativi di repubblica controllata dall’oligarchia dei grandi proprietari terrieri, e regimi liberali, ma senza opposizione, come quello del tanto amato Gétulio Vargas, che dal 1930 al 1954 aveva fatto il bello e il cattivo tempo in perfetto stile peronista. La giovane democrazia brasiliana, che compie quest’anno 25 anni, è dunque davvero un trionfo, e i candidati, così come l’intero popolo brasiliano, ne sono fieri.
Dilma Rousseff è la favorita nelle elezioni del 3 ottobre. I sondaggi dicono che non ci sarà nemmeno il secondo turno, previsto per il 15 novembre: elezione secca con il 50% più un voto il 3 ottobre. L’effetto Lula è oggi così forte (80% dei consensi) che la meno carismatica delfina può sperare di cavalcare l’onda. Il suo progetto è la continuità con gli otto anni di “miracolo lulista”. Luiz Ignacio Lula da Silva lascia un’eredità di crescita economica colossale, di politiche sociali innovative, e, per la prima volta, di ruolo internazionale del Brasile, che reclama un posto a pieno titolo tra i potenti della Terra, e che ha giocato un ruolo di negoziatore nelle crisi recenti di Haiti e in Africa. Come ovunque, in un mondo in cui non ci si può fidare più di nessun valore, il carisma di Lula è frutto della sua traiettoria personale.
Figlio di una famiglia povera del Nordest, la regione più miserabile del Brasile, Lula nasce nel 1945, a Garanhuns, nel Sertao. Quando ha 7 anni, la madre si trasferisce con i sue sette figli a San Paolo, un viaggio di 13 giorni, nel retro di un camion, che Lula ricorderà per tutta la vita. A San Paolo il giovane Luìz Ignacio vende arance e lucida scarpe, ma a 15 anni riesce ad ottenere un diploma di perito metallurgico e comincia a lavorare in fabbrica. A 25 anni diventa sindacalista a tempo pieno e nel 1975, presidente del sindacato degli operai metallurgici. E’ uno dei protagonisti dei grandi movimenti sindacali che fanno vacillare la dittatura nei primi anni Ottanta.
Oratore senza pari, Lula comincia una carriera politica brillante, che lo vede candidato alle presidenziali più volte, nel 1989 contro Fernando Collor, e nel 1994 e 98 contro il sociologo Fernando Henrique Cardoso, che governerà il paese con rigore fino al 2002 e sarà il fautore di riforme finanziarie essenziali (come l’introduzione della nuova moneta: il real) che rimetteranno in sesto la fragile e complicata economia brasiliana dopo gli anni di politica corrotta di Collor. Negli anni, Lula ha imparato a sedurre la classe media: è simpatico, parla fuori dai denti, ha capito che il nuovo Brasile non è fatto solo di miserabili e di grandi ricchi, ma di gente qualunque che lavora, guadagna, viaggia, guarda il calcio alla tivù ed è orgogliosa di essere brasiliana. Il miracolo di questo continente sterminato, più grande dell’Europa, con differenze etniche, sociali e culturali che noi europei non possiamo nemmeno immaginare, è che esiste un’identità brasileira, un modo di essere, di vivere e di pensare che si ritrova dalle steppe aride del Nord al ricco centro agrario, all’industralizzato e freddo Sud.
In un misto di sindacalismo operaio e cattolicesimo di sinistra, Lula predica una società egualitaria: “Nessun attore della società deve restare escluso: è questa la mia eredità”. E il piano riesce, anche se in mezzo a tanti compromessi: il Brasile non va avanti senza i fazenderos e una politica economica che faccia crescere la ricchezza che resta comunque in poche mani. La riforma agraria che era al centro della sua campagna non gli riesce: le terre restano nelle mani di pochi. Lula si sottomette quindi a un realismo economico ormai obbligatorio nei mercati globali, Ma i progetti di costruzione di case, ospedali, scuole, scuole professionali proliferano in tutti gli stati. E’ Dilma Rousseff, capa della Casa Civil, il gabinetto della presidenza e il posto più importante dopo il presidente, che si incarica del progetto Minha casa, minha vida, costruzione di case per tutti, ma anche ristrutturazione delle villas che non si chiamano più favelas, perché è inutile pensare di svuotare questi immensi villaggi e deportare gli abitanti in palazzoni nuovi, che diventerebbero teatro di degrado e di esclusione altrettanto violento. Meglio rimetterle a posto, portare acqua, fognature, elettricità, far partecipare gli abitanti alla ristrutturazione.
Le favelas hanno una storia antica e violenta che è legata alla storia del Brasile, all’eliminazione tardiva della schiavitù nel 1888 e alla mancanza di progetto per i milioni di schiavi neri e indios che si trovarono liberi, ma senza alcuna risorsa e ancora discriminati. Ritiratisi sulle colline attorno alle città, in ghetti di miseria e risentimento, gli abitanti delle favelas non sono solo disperati alla ricerca di fortuna nelle megalopoli brasiliane, ma gente con un sistema di vita, un orgoglio, una storia di odio e violenza che va capita, come Lula ha saputo capire, e non solo spazzata via.
A Dilma Rousseff, il candidato dell’opposizione José Serra, battuto da Lula nel 2002, rimprovera di non avere mai avuto un mandato dagli elettori. La carriera di Dilma, la dama di ferro del governo Lula, è all’ombra del presidente e voluta dal presidente: non è mai dipesa dagli elettori, e certo, questa è un’insufficienza politica importante. Ma anche qui è la storia personale di questa economista borghese del Minas Gerais, a riscattarla dai dubbi. Giovane studentessa universitaria, entra nella militanza politica dopo il golpe del 1964 ed è costretta alla clandestinità; quando viene arrestata nel 1970 a San Paolo, ha un’arma su di sé, che le costerà 22 giorni di tortura e quattro anni di prigione.
Certo il socialdemocratico José Serra dello stesso partito del buono e serio Cardoso, ha un’esperienza politica più consistente. Più volte ministro con Cardoso, sindaco di San Paolo, governatore dello stato di San Paolo, Serra è responsabile di riforme importanti, come quella della sanità, e della lotta contro le multinazionali per ottenere i farmaci generici. E’ un uomo gentile e con un’aria di una certa modestia: durante il suo mandato di governatore, insegnava ogni settimana nella scuola pubblica (ve li vedete Bossi o Formigoni fare lo stesso?).
La grande novità della campagna è la candidatura di Marina Silva, ex-ministro dell’ambiente del governo Lula, che ha lasciato le sue funzioni nel 2008 (anche questo: ve lo immaginereste in Italia?) perché Lula non appoggiava abbastanza la sua politica dello sviluppo sostenibile. Figlia della foresta amazzonica, cresce in una poverissima comunità di seringueiros, raccoglitori di gomma. E’ meticcia, ha una testa piccola, felina: grazie alla militanza in un gruppo marxista di intellettuali sindacalisti dalle idee verdi, riesce a studiare, arrivare all’università e diventare professore di storia e a 35 anni è eletta la più giovane senatrice del Brasile. L’educazione è il suo cavallo di battaglia: “Io sono un miracolo dell’educazione: senza educazione pubblica non potrei essere qui stasera come candidata alle elezioni del Brasile” dice fiera durante il dibattito, e poi la sua foresta: lo sviluppo sostenibile, l’uso delle immense risorse naturali del Brasile per pensare a un futuro ecologicamente responsabile.
E infine Plinio, il vero avversario, anche se senza nessuna chance, contro i tre che comunque restano allineati sulla necessità di far parte del mercato, sulla necessità di un’economia capitalista. Plinio no: serio e con l’autorità dei suoi ottant’anni, dice chiaro che lui è contro il capitalismo, che la società va rifatta da zero, che la riforma agraria è un’evidenza: la terra deve essere ridistribuita equamente, parole vietate in un Brasile che si porta dietro una storia coloniale tutta a parte, in cui nel Cinquecento il re del Portogallo fu costretto a far spartire l’immenso territorio brasiliano, che non interessava a nessuno, tra dodici avventurieri, militari, ebrei recentemente convertiti, dando loro potere assoluto sulle loro terre, lasciandoli liberi di mescolarsi con le donne locali e che lasciarono la marca indelebile del latifondo alla geopolitica del paese.
Ma c’è un’aria di famiglia nonostante tutto tra questi quattro candidati: le parole più ricorrenti nella bocca di tutti loro sono: pubblico, scuola pubblica, salute pubblica, strutture pubbliche... tutti e quattro sanno bene che non si spende per la scuola o per la salute: si investe nella scuola e nella salute, parole semplici, ovvie addirittura, ma che nell’Europa egoista di oggi, dei Sarkozy e dei Berlusconi, suonano come una musica nuova. E di colpo mi chiedo: ma cosa ci è successo? Cosa mi è successo? Perché ho ascoltato inerte quei discorsi di finto realismo, contro tutti gli ideali, che hanno fatto tirare la cinghia solo ai migliori, ai poveri, ai maestri di scuola, ai lavoratori del sociale, ai funzionari dello stato, ai professori, agli educatori e hanno ingrassato le tasche oscene della nuova borghesia che è fiera del suo grasso che cola perché se l’è meritato, e lo lascia colare fuori dalle porte blindate, ben inchiavardate contro il rischio che qualche emigrante assalti la brutta figlia bianca e grassoccia, ma non lo spartisce con nessuno?
Vabbé, qualche amico bravo economista, magari pure di sinistra, mi dirà che non ho capito nulla di questo paese in pochi giorni, che il Brasile vince oggi perché Lula è riuscito a iscriversi nell’ortodossia macroeconomica, perché i tassi di interesse sui titoli del tesoro sono scesi costantemente e perché il coefficiente GINI che misura l’ineguaglianza in un paese è continuato a scendere...
Ma non sarà che pronunciare quelle parole seriamente, poter dire “servizio pubblico” senza scandalizzare i benpensanti, credere alle persone più che ai coefficienti, sia servito a qualcosa?
Solo una raccomandazione a politici, economisti e benpensanti europei: non usate più come insulto espressioni come “la sudamericanizzazione o, peggio, la brasilianizzazione, dell’Italia o della Francia, o della Grecia”, perché sarebbe una fortuna, un gran privilegio, oggi, essere capaci degli ideali di questa giovane democrazia.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- VIVIAMO TRE CRISI. Dopo la crisi finanziaria è esplosa una crisi monetaria ed economica, che si è rivelata una crisi politica (di Alain Tourain - La terza crisi dell’Europa rimasta senza futuro).29 settembre 2010, di Federico La Sala
La terza crisi dell’Europa rimasta senza futuro
di Alain Touraine (la Repubblica, 29.09. 2010)
Viviamo tre crisi. Questa formula sembra una costruzione artificiale, ma non lo è. Dopo la crisi finanziaria è esplosa una crisi monetaria ed economica, che si è rivelata una crisi politica. Ma i nostri Paesi europei si mostrano incapaci di pensare e di organizzare il proprio futuro - e qui sta la terza crisi. La prima, la più visibile, è stata la crisi finanziaria (preparata da una serie di crisi regionali e settoriali, e dall’esplosione della bolla di Internet): quella dei subprimes.
La crisi del credito ipotecario, culminata nel 2008 col tracollo della banca Lehman Brothers a New York, ha colpito più duramente gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ma anche l’Europa continentale. Per converso, le altre parti del mondo hanno ripreso quota in brevissimo tempo, riuscendo persino a conseguire alti livelli di crescita.
C’era chi credeva la crisi ormai superata e la ripresa assicurata quando, all’inizio del 2010, è esplosa una crisi economica e di bilancio, soprattutto europea. È incominciata con un boato: la Grecia era sull’orlo del fallimento. Si è dovuto ricorrere alla mobilitazione dei grandi Paesi europei e dell’Fmi, per scongiurare una catastrofe che rischiava di estendersi ad altri Paesi.
Abbiamo così scoperto la gravità delle nostre malattie: i giganteschi deficit di bilancio, il rapido aumento del debito pubblico, e quasi ovunque l’incapacità di ridurre gli alti livelli della disoccupazione. Questa crisi è innanzitutto politica, dato che pone in luce l’impotenza dei Paesi europei, incapaci di gestire le loro economie, ridurre la spesa pubblica, migliorare il gettito fiscale, e soprattutto di far ripartire la crescita, senza la quale nessun risanamento dei bilanci è possibile. Se la Gran Bretagna, il cui sistema bancario è stato praticamente nazionalizzato dopo il 2008, ha saputo lanciare un rigoroso programma di austerità, non si può dire altrettanto della Francia e dell’Italia - per non parlare della Spagna, schiacciata da una disoccupazione del 20%.
Italia e Francia non hanno commesso errori giganteschi in politica economica; le cause della loro incapacità di ripresa sono essenzialmente politiche. I governi si sono dimostrati impotenti; hanno mancato di elaborare un’analisi solida con progetti precisi. I due presidenti, Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy, sono attaccati sul piano personale più che per la loro gestione economica. Ma sia in Italia che in Francia, i partiti d’opposizione si sono rivelati non meno deboli dei governi. E la debolezza delle sinistre politiche ha aiutato i governi di destra ad accollare ai lavoratori dipendenti il peso delle misure da adottare.
La terza crisi dell’Occidente è l’assenza di un progetto di civiltà. Per secoli l’Occidente europeo ha concentrato tutte le sue risorse nelle mani di un’élite dirigente: quella delle monarchie assolute, e quindi del grande capitalismo. E ha potuto così, nell’arco di pochi secoli, conquistare gran parte del mondo. Questo modello vincente si reggeva però su due situazioni pericolose. In primo luogo, su una società che nel suo insieme era brutalmente assoggettata al potere dei dirigenti. Dai sudditi del re agli operai delle industrie, dai colonizzati alle donne e ai bambini, tutte le categorie della popolazione hanno subìto forme di dominio estreme. Altra sua debolezza: è servito alla formazione degli Stati nazionali per secoli in guerra tra loro, finché nel 900 l’Europa si è autodistrutta con le due guerre mondiali e l’ondata dei regimi totalitari.
Le lotte tra gli Stati nazionali europei sono cessate solo con l’egemonia americana e la creazione di un’Unione europea che si reggeva sull’indebolimento degli Stati. Il sistema sociale europeo si è indebolito più lentamente. I popoli avevano rovesciato i re, i lavoratori avevano conquistato diritti sociali, le colonie si erano liberate, le donne avevano ottenuto alcuni diritti, pur senza riuscire a porre fine alle disuguaglianze a loro danno. Ma ora l’Europa si ritrova senza un modello di sviluppo, senza un progetto per il suo futuro.
Eppure non sarebbe impossibile. Conosciamo fin d’ora le grandi priorità del secolo a venire: gli ecologisti ci hanno convinto della necessità di far convergere i diritti dell’economia con quelli della natura; alcuni movimenti culturali ci hanno insegnato che occorre non solo portare al governo la maggioranza, ma anche rispettare i diritti delle minoranze. Le donne, su un piano più privato che pubblico, hanno iniziato a costruire una società il cui principale obiettivo è riconciliare gli estremi opposti, dando la priorità all’integrazione interna e non alla conquista esterna. Ma questi grandi progetti hanno più forza presso l’opinione pubblica che in seno ai governi. Siamo troppo consapevoli delle disastrose conseguenze delle idee spengleriane sul declino dell’Occidente, che a suo tempo alimentarono la politica nazista, per riesumare quell’espressione; ma in un mondo in crescita, con nuove grandi potenze in via di formazione, la stagnazione, se non il regresso dell’Europa rappresenta un dato di fatto.
L’Unione europea ha affrontato il compito necessario di integrare un continente che la volontà di Stalin aveva spaccato in due; ma non ha saputo offrire agli europei un progetto per il futuro, e neppure nuove idee e nuove urgenze, un nuovo posto nel mondo. Eppure, in Europa come negli Stati Uniti, la vita esiste ancora, non già al disopra, ma sotto il livello dei governi; ed è sul web che si sono formati i grandi movimenti più entusiasti, quali Move on negli Stati Uniti o i Viola in Italia.
Ma se è possibile inventare un futuro, oggi non abbiamo più gli strumenti politici, e ancor meno intellettuali, che servirebbero per superare le crisi. Nel mondo economico c’è un unico settore che è riuscito a riprendersi rapidamente e con forza: quello del capitale finanziario. Al tempo stesso però, le disuguaglianze sociali sono nuovamente in aumento; l’economia produttiva è trascinata fuori dall’Europa; il dibattito politico non ha ripreso vita in nessuno dei Paesi europei.
Non possiamo più addebitare alla crisi la nostra impotenza politica e persino intellettuale, che di fatto ne costituisce la principale causa. Questa constatazione ci indica chiaramente le nostre priorità: non usciremo dalla crisi economica se prima non saremo usciti dalla crisi politica e da quella culturale. Da qui l’urgenza di un riassestamento politico, e più ancora di una rinascita intellettuale e culturale. Il Belgio e l’Olanda sono devastati dal populismo sciovinista e dalla xenofobia. In Italia e in Francia la vita politica è allo sfascio, e va completamente ricostruita.
Dato il ruolo dominante degli Stati Uniti, abbiamo tutti bisogno di una vittoria di Obama su un partito repubblicano trainato dalla sua area più reazionaria e ottusa. Sono stati i migliori economisti ad insegnarci l’importanza prioritaria delle soluzioni sociali e politiche per superare le crisi economiche; ma sembra che i politici siano ben lontani dall’ascoltarli. Non possiamo più avanzare a piccoli passi, anche perché non sappiamo neppure se stiamo avanzando o indietreggiando. Abbiamo urgente bisogno di immaginare, di pensare, di costruire il nostro avvenire, al di là delle nebbie e dei silenzi che ci impediscono di scoprire gli strumenti politici indispensabili alla sua costruzione.
Traduzione di Elisabetta Horvat
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- I Rom e l’Europa meticcia. L’Europa meticcia non può rifiutare i rom (di Jacques Le Goff).23 settembre 2010, di Federico La Sala
I Rom e l’Europa meticcia
L’Europa meticcia non può rifiutare i rom
di Jacques Le Goff (la Repubblica, 23.o9.2010)
La direttiva del governo francese riguardo alle espulsioni era concepita in modo inammissibile: mettendo l’accento sull’identità dei rom risultava un’operazione discriminatoria e, al limite, razzista. Certo, la vicepresidente della commissione europea Viviane Reding, comparando la misura ai provvedimenti tedeschi durante la seconda guerra mondiale, ha evidentemente esagerato.
Ora, al di là delle reciproche scuse, è chiaro che in Europa esiste un problema e una questione dei rom.
È mia convinzione che questo problema debba essere regolato attraverso una politica specifica concordata in sede europea. Occorre varare un regolamento al cui rispetto siano tenuti tutti i paesi dell’Unione, al di là del fatto che il numero dei rom sia diverso in ciascun paese e che i governi europei oggi siano divisi tra quelli che hanno un atteggiamento piuttosto accogliente e quelli invece (come l’italiano) che sembrano porsi in maniera tendenzialmente ostile.
Penso che la cosa più importante da fare oggi sia aprire un confronto tra i rappresentanti di tre diverse parti: le diverse comunità rom, i governi nazionali e l’Unione europea.
Un tavolo di dialogo dovrebbe individuare, prima di tutto, dei luoghi deputati all’insediamento delle diverse comunità rom. Luoghi che i governi devono far rispettare ma che devono rispettare anche le stesse comunità rom. C’è comunque nella storia una tendenza dei rom a installarsi e rimanere in luoghi specifici.Il problema è reso più acuto dal fatto che i paesi europei dove i rom sono più numerosi - in particolare la Romania - sono anche quelli in cui la disoccupazione è più alta. Per questo credo che nei colloqui si dovrebbe affrontare anche il tema dell’occupazione.
Oggi l’attrito tra rom e gruppi di cittadini europei nasce da diverse questioni ancora insolute: una di queste è la resistenza di alcuni rom a far frequentare le scuole pubbliche nazionali ai propri figli. Io sono favorevole alla maggiore integrazione possibile dei rom nelle culture dei diversi paesi in cui risiedono, ma credo anche che potremo lasciare loro il compito di organizzare essi stessi l’educazione dei loro figli, a condizione che funzionari pubblici di diversi paesi possano sovrintendere al rispetto di alcune regole fissate di comune accordo.
Dunque lascerei ai rom libertà nella scelta dei docenti degli orari e dei metodi dell’insegnamento ma con l’impegno che questo stesso insegnamento sia oggetto di una verifica da parte degli stati nazionali. Anche nel settore della sanità e della salute occorre cercare un compromesso tra la libertà dei rom di dove e come farsi curare e la verifica che queste cure siano effettivamente svolte.
Come storico credo che una progressiva realizzazione di una sempre più forte unione europea sia la strada giusta per risolvere il problema. Per riprendere un espressione di Jacques Delors il nostro spazio politico ha scelto di costruirsi come «Europa delle nazioni». E i rom si possono considerare a tutti gli effetti una nazione. Ecco perché credo che almeno una parte importante delle regole che si applicano alle nazioni europee potrebbero essere applicate ai rom. Tenendo conto che l’Europa è un insieme di diversità, anche se con forti somiglianze tra diversi paesi che la compongono.
Insomma, mi pare che l’essenziale sia la voglia di pervenire ad un accordo che non può che essere un compromesso, frutto di un dialogo. Naturalmente c’è un problema linguistico: i rom parlano sia lingue specifiche sia la lingua del paese in cui risiedono, dunque la loro nazione non si distingue per un’unica lingua. Ma questo è un problema che esiste anche altrove in Europa e anch’esso può trovare una ragionevole soluzione.
Come storico credo che ciò che ha contraddistinto l’esperienza millenaria dell’Europa siano stati il meticciato, la mescolanza delle culture e la loro progressiva integrazione.
L’Europa è nata dalla fusione tra i popoli cosiddetti romani o gallo romani o ispano romani (cioè quelli che diedero luogo a una prima integrazione) e i cosiddetti «barbari», una parola oggi bandita dagli storici. Oggi fortunatamente non disprezziamo più chi non pratichi una cultura cosiddetta superiore: gli storici e tutti coloro che hanno influenza sulla società dovrebbero mostrare come la caratteristica tipica dell’Europa sia proprio la sua capacità di integrazione nel rispetto delle diversità: una strada difficile ma possibile.
Certo, le difficoltà di accogliere gli stranieri che si manifestano oggi in Europa nascono anche dal fatto che negli ultimi anni il numero di immigrati è cresciuto. Ma non dovremmo dimenticarci che nel periodo dell’antichità tardiva o del Medioevo le cifre relative ai cosiddetti barbari, celti, germani o slavi che si spostarono sul territorio europeo erano assai più grandi. A quell’epoca l’integrazione più importante fu quella provocata dalla cristianizzazione.
Oggi la religione di per sé non può essere lo strumento principale di integrazione. Serve un progetto culturale comune nello spazio europeo: un progetto scientifico ma anche educativo. E poi è necessario lavorare anche sul regime politico: la forza dell’Europa è anche quella di essere composta da stati che con tutti i loro limiti sono tutti democrazie.
La sinistra in particolare deve saper rispondere con maggior forza alla destra su questo tema. Il suo limite oggi è che purtroppo non riesce a combinare la giusta ostilità alle cattive politiche di discriminazione con un’alternativa efficace, capace di offrire soluzioni di ricambio concrete percorribili. Forse la nozione più falsa e pericolosa veicolata dal nazismo è proprio quella della purezza etnica.
C’è bisogno oggi di un grande progetto capace di rifarsi proprio all’originalità dell’esperienza storica europea, capace cioè di ritrovare l’ingrediente storico della sua forza: il suo multiculturalismo, la sua abitudine al meticciato. Il presidente della repubblica francese - per fare solo un esempio - dovrebbe ricordarsi di essere ungherese.
*Intervento raccolto da Giuseppe Laterza e pubblicato su www. laterza. it, il sito web della casa editrice da oggi rinnovato nei contenuti
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- ROM, UN PROBLEMA COMUNE, UN PROBLEMA COMUNITARIO. Contro il risorgere del razzismo in mezzo a noi, inventare un’Unione migliore (di Etienne Balibar). .18 settembre 2010, di Federico La Sala
Rom, questione comune
di Etienne Balibar (il manifesto, 18.09.2010)
Dal punto di vista dei rom, il processo di unificazione europea ha di sicuro aperto delle possibilità di comunicazione nella comunità finora inesistenti e ha dato la possibilità di reclamare i propri diritti in modo più efficace e legittimo. Ma non ha modificato la configurazione di base della persecuzione, o addirittura può aver dato ad essa una nuova dimensione. Si tratta di una storia affascinante: quello che era ampiamente invisibile è diventato visibile e un’intera parte della storia d’Europa diventa comprensibile.
Ed è una questione vitale per il futuro dell’Europa: essa non può essere costruita sull’esclusione, non è un Impero. Ufficialmente, presenta se stessa come uno spazio per la realizzazione dei diritti democratici e del benessere comune delle sue popolazioni. In pratica, conquisterà legittimità nelle menti e nei cuori dei cittadini (una cosa più difficile di quanto immaginato all’inizio) soltanto se comporterà un avanzamento verso istituzioni più democratiche e una cultura di maggiore - e non di minore - solidarietà.
Sotto questo punto di vista, la persecuzione dei rom in Europa, trasmettendosi da un Paese all’altro in un processo di emulazione negativa come nel passato, non è un problema che riguarda ogni paese separatamente, ma è un problema "comune", un problema "comunitario".
Affrontandolo in questo modo - e lavorando contro le proprie inclinazioni - gli europei eliminerebbero non solo una fonte di conflitti interni e di violenza che può diventare insopportabile, ma costruirebbero una comune cittadinanza. Inoltre reclamando i loro diritti, elevando il discorso dal livello culturale a quello civile, trovando gli interlocutori istituzionali e gli alleati di cui hanno bisogno tra la popolazione, i rom di tutta Europa conquisterebbero un’integrazione che ci riguarda tutti, collettivamente. Non essendo un esperto di storia e sociologia rom, ma in quanto cittadino europeo e filosofo che ha lavorato su altri aspetti dell’esclusione e sul loro impatto sullo sviluppo della democrazia, vorrei affrontare le tre principali questioni in discussione.
La prima riguarda l’esclusione e la cittadinanza e la loro trasformazione a livello paneuropeo. I rom sono privi di alcuni diritti di base in molti paesi europei e nello spazio europeo, malgrado il fatto che siano cittadini europei, essendo di pieno diritto cittadini degli stati membri. Questi diritti di base includono il diritto di circolazione, di residenza, di lavoro, il diritto alla scuola, alla salute e alla cultura. I rom sono costretti a risiedere in determinate aree, dalle quali del resto possono anche venire arbitrariamente espulsi. Sono definiti o come "nomadi" o come cittadini che provengono da determinati paesi. Sono a priori considerati come delinquenti o come una popolazione pericolosa. Non vengono mai ammessi o sono ampiamente sottorappresentati nella maggior parte delle professioni, sia manuali che intellettuali (con tassi di disoccupazione che toccano i massimi). È inutile dire che questo riguarda anche gli impieghi pubblici. Questo fenomeno è illegale o legale, con la scusa di norme e di accordi interstatali che riguardano l’igiene, la previdenza sociale, le politiche per l’occupazione e le norme culturali. Hanno luogo su uno sfondo di una persistente estrema violenza "popolare", che è alimentata anche da gruppi neofascisti e da bande criminali, solo verbalmente condannati da molti stati membri dell’Unione europea. Solo i più vergognosi pogrom diventano una notizia per la stampa nazionale o internazionale.
La costruzione dell’Ue ha avuto degli effetti estremamente contraddittori. Ha prodotto una categorizzazione dei rom a livello europeo, dal momento che per la Ue sono stati considerati un "problema" nel loro stesso diritto a farne parte. Questo è uno scalino preliminare nella nuova razzializzazione dei rom. Li mette nella stessa categoria dei "migranti" di origine extracomunitaria, in un quadro generale che ho definito come l’emergente apartheid europeo, il lato oscuro dell’emergenza di una «cittadinanza europea». La differenza proviene dal fatto che i "migranti" (e i discendenti di migranti) sono visti come un altro esterno, mentre gli tzigani come un altro interno. Ciò d’altronde rafforza il vecchio stereotipo del nemico interno, che ha effetti sanguinosi.
Malgrado gli enormi cambiamenti storici e sociali - specialmente dopo la seconda guerra mondiale e la fine della guerra fredda - che hanno portato l’Europa molto lontana dal proprio passato, questo fenomeno è testimone di una traccia durevole delle persecuzioni nella storia europea. È inevitabile la comparazione con il caso, di cui si è parlato molto di più, della persecuzione di un "gruppo razziale" nella storia europea, cioè gli ebrei. I due "gruppi paria" sono stati il bersaglio congiunto del genocidio nazista (come altre popolazioni "devianti"). Rappresentano casi completamente diversi di traiettoria religiosa ed economica, ma - è importante sottolinearlo - entrambi hanno svolto un ruolo centrale nello stabilire delle connessioni tra diverse culture europee (specie nel campo artistico, nel caso degli tzigani) incarnando l’elemento "cosmopolita" senza il quale le culture "nazionali" restano isolate e sterili.
Questo mi porta a prendere in considerazione una seconda questione, che riguarda più specificamente le tendenze di razzializzazione in Europa. Alcuni anni fa mi ero chiesto se bisognasse ammettere che esiste un razzismo o neo-razzismo "europeo" che avrebbe avuto, rispetto alla costruzione "sopra-nazionale", la stessa relazione di complementarità ed eccesso che il razzismo tradizionale (antisemitismo, razzismo coloniale, ecc) aveva con lo stato-nazione e le classiche costruzioni imperialiste. Bisogna essere molto prudenti a proporre questo tipo di ipotesi. Nondimeno, ci sono dei fenomeni inquietanti che possono dare credito a questa ipotesi, ponendo i rom nella scomoda posizione di caso test. In conclusione, possiamo dire che l’unificazione dell’Europa ha reso la razzializzazione del "problema tsigano" più visibile, perché mostra l’evidente contraddizione con la tendenza generale e ufficiale verso il superamento dei pregiudizi etnici e nazionali sulla quale è costruita la "nuova Europa". Da questo punto di vista, ci sono almeno tre fenomeni che mi paiono rilevanti:
1. La tendenza delle nazioni europee a proiettare sui rom i pregiudizi verso altre nazioni. Per esempio, la stampa francese è più attenta a riferire dei pogrom che hanno luogo in Italia o in Ungheria, o delle discriminazoni in Romania, ma resta quasi silenziosa sul modo in cui i comuni in Francia respingono i "nomadi" dal loro territorio, o sul modo in cui la polizia di frontiera francese espelle cittadini rumeni e bulgari per alimentare le statistiche ufficiali, pur sapendo benissimo che, in quanto cittadini europei, essi torneranno al più presto.
2. Arriviamo al fenomeno della costruzione del capro espiatorio e, più precisamente, al modo in cui le "nazioni" europee si considerano ufficialmente l’un l’altra come membri di una stessa comunità. Dopo aver superato le antiche ostilità, esse restano nei fatti piene di mutuo risentimento e sospetto reciproco - cosa che, fino ad un certo punto, dipende dal fatto che la costruzione europea è rimasta in mezzo al guado. Questo risentimento e sospetto reciproco tende a venire proiettato verso gruppi "devianti". I rom sono come una nazione in eccesso in Europa, che si distingue per l’odio che suscita non solo perché travalica i confini ma anche perché incarna l’archetipo delle popolazioni senza stato, che fanno resistenza alle norme di territorializzazione e di normalizzazione culturale (per ironia della sorte, sotto molti aspetti, questa singolarità è essa stessa frutto delle persecuzioni).
3. Questo problema, come sappiamo, diventa eccezionalmente acuto quando vengono prese in considerazione le relazioni tra Europa occidentale ed Europa dell’est. Il fatto che i regimi di tipo sovietico in Europa dell’est durante la guerra fredda, in paesi che hanno anche un’importante popolazione rom, avessero combinato una politica coercitiva e normativa con programmi di integrazione economica, ha comportato la definizione di "protégés del socialismo" in paesi dove (per quanto tempo ancora?) la maggioranza della popolazione vede l’ammissione alla Ue come la strada più rapida verso la liberalizzazione economica e sociale. Nell’altra metà del continente, i paesi occidentali e la loro opinione pubblica li percepiscono come la perfetta illustrazione della povertà e della deregulation con le quali l’Ue sfida i vecchi membri. In entrambi i casi, sono rigettati e visti più come "orientali" che come veramente europei.
Se la relegazione dei rom nella condizione di comunità senza stato prosegue (de facto più che de jure: vivono, certo, sotto la giurisdizione degli stati, ma sono visti sia come inadatti che ostili ad entrare nella costruzione di uno stato moderno), cosa che ci riporta all’origine della loro discriminazione, essa rivela al tempo stesso i limiti della costruzione della sfera pubblica in Europa. Essa può essere paragonata a uno statalismo senza stato.
Questa situazione poco chiara, combinata con altri fattori, tende ad esacerbare varie forme di razzismo popolare, in particolare sotto la forma dell’ossessione della sicurezza. Dall’altro lato, ha portato alla creazione di una piuttosto densa rete di istituzioni e organizzazioni che hanno a vedere con la "questione rom" a livello europeo. Alcune di queste organizzazioni ed iniziative governative possono favorire lo sviluppo di una coscienza autonoma e di una pratica civile nella comunità rom, mentre altre tendono a ridurli allo stato di un gruppo sotto controllo, protetto e piazzato sotto sorveglianza.
Questo dilemma, secondo me, porta a prendere in considerazione un altro problema cruciale, che riguarda le vie dell’emancipazione proposte alle popolazioni rom in Europa. Parlando da un punto di vista astratto, ci sono due strade, come in altri casi simili. Una può essere definita "maggioritaria" e comporta la richiesta della fine dell’ "eccezione", il riconoscimento dei diritti di base che, di principio, appartengono ad ogni cittadino. L’altra può essere definita "minoritaria" e si basa su un crescente senso di identità e di solidarietà tra le popolazioni rom, attraverso i confini nazionali, che porta verso una maggiore autonomia culturale e, di conseguenza, verso una maggiore visibilità come gruppo "quasi nazionale" che lotta contro l’esclusione all’interno di un’Europa multi-nazionale.
La prima strada dipende soprattutto dai passi avanti più generali sui diritti umani e da un ritorno a politiche sociali che riescano ad arginare la corrente neo-liberista, mentre la seconda dipende dalla capacità di utilizzare il discorso e le istituzioni dell’Unione europea affinché i rom arrivino a costruirsi una voce autonoma. Nessuna delle due strade è facile, né probabilmente sufficiente. Sarà responsabilità dei rom stessi articolare una combinazione efficace. Ma è anche nostra responsabilità - e nostro interesse - in quanto democratici europei, aiutarli in questo processo, lottando contro il risorgere del razzismo in mezzo a noi, inventando un’Unione migliore.
* Questo testo è una rielaborazione, per gentile concessione di Etienne Balibar, dell’introduzione al volume «Romani Politics in Contemporary Europe» (Palgrave ed. dicembre 2009), una raccolta di saggi sulla questione dei rom e l’Europa a cura di Nando Sigona e Nidhi Trehan. La traduzione è stata curata da Anna Maria Merlo
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- NIENTE SOFISMI, SUI ROM E’ RAZZISMO ...questo è razzismo nella sua forma più rozza e più pura. È tutto qui. Ma è come diagnosticare, nel cuore dell’Europa, il peggiore dei mali (di Furio Colombo).19 settembre 2010, di Federico La Sala
Niente sofismi, sui Rom è razzismo
di Furio Colombo (il Fatto, 19.09.2010)
Che storia è? Che cosa è accaduto? Guerra della Repubblica francese contro gli zingari? Tutto è possibile, sappiamo che conta la paura, pesa il pregiudizio e che la politica è fatta anche di quel brutto ingrediente che è il populismo, ovvero la voglia di piacere alle maggioranze facendo qualcosa di cattivo e di ingiusto ai danni delle minoranze. Ma due cose non tornano in questa vicenda. La prima è che la presenza nomade degli zingari, gitani, rom dura da secoli in Europa, come testimoniano storiografia, letteratura, poesia, musica, folklore, proverbi e costumi.
Ci sono sempre momenti in cui qualcuno crede di scoprire ciò che c’è sempre stato e pensa di denunciarlo come intollerabile. La seconda è che i rom gitani o zingari dispersi per l’Europa sono pochissimi. Poche decine di migliaia di persone in comunità (campi) che spesso non arrivano a cento persone.
Come è possibile che un fatto così antico e così piccolo colpisca prima l’attenzione, poi l’ira, infine produca l’editto di cacciata dal Paese del presidente di una grande Repubblica? La cosa è ancora più difficile da capire perché il Paese è la Francia e il presidente è Sarkozy. Era sempre sembrato in grado di tenere in equilibrio il suo temperamento nervoso di uomo iperattivo con le esigenze di personaggio al sommo delle istituzioni francesi. Certo, alcuni aspetti del suo passato politico non sono un buon preannuncio, come le violenze di tipo leghista scatenate anni fa dalla sua polizia nelle banlieu parigine, contro giovani figli di immigrati, cittadini francesi. Ma, da presidente del Paese che si identifica con il valore della libertà e dei diritti civili, Sarkozy aveva dimostrato di saper tenere a distanza le squilibrate spinte a certi tipi di azione e persecuzione della destra di Le Pen e dei suoi eredi. Zingari, sfogo ideale
QUALCOSA è scattato, vuoi nella vita pubblica (sondaggi, popolarità in declino) vuoi nella vita privata di Sarkozy (di questo non sappiamo nulla e non ospiteremo cattiverie suggerite da francesi malevoli) per rompere in modo così clamoroso l’equilibrio della più alta istituzione francese, dunque del suo governo, dunque dei suoi ministri e della sua polizia. Un percorso utile per capire ciò che sta accadendo è la vicenda giudiziaria che da qualche tempo insegue Sarkozy (fondi illegali versati alla sua campagna elettorale). I giudici francesi non mollano. Molte cose sono possibili quando si confrontano il senso di impotenza di qualcuno molto potente con una comunità di persone (i rom) senza potere e senza rappresentanza e del tutto privi di difesa.
Per lo sfogo d’ira di Sarkozy, per lo stato di non equilibrio in cui, per qualche ragione, il presidente francese è caduto, gli zingari sono l’ideale. Primo, distruggere i campi, che non sono certo di cemento armato. Secondo, forzarli a “tornare a casa”, come se dei nomadi avessero una casa. Terzo, trasportarli verso Paesi dell’Est, certe volte individuati a caso,badandobeneafingerechesi tratti di “rimpatrio” (raramente i rom fanno conferenze stampa per smentire); badando a far notare la elargizione di una buonuscita di 300 euro per famiglia, alla presenza delle telecamere, in modo che i detrattori del presidente siano serviti. Si tratta di partenze “assistite” e “spontanee”. In tal modo siamo costretti a vedere di che cosa è capace il presidente Sarkozy quando gli va la mosca al naso. Ecco uno che non scherza. Un vero uomo, direbbe se potesse dire tutto, Sarkozy, di se stesso.
Amici in Italia, estranei in Europa
MA SIAMO solo a metà della storia. Segue prima l’imbarazzo, poi la condanna europea. E quando la Commissione Europea, con il presidente Barroso gli resiste, i presenti al summit di Bruxelles parlano di uno scontro con scambio di urla. Una vera scenata del sempre meno equilibrato Sarkozy contro quel punto debole - però simbolico - che è la Commissione Europea. Forse la situazione di squilibrio e quel volare di insulti hanno attratto l’attenzione di Berlusconi, che si unisce subito, nel senso che anche lui (unico in Europa) proclama non solo che l’iniziativa di Sarkozy è sacrosanta, ma che lo farà anche in Italia: persecuzione degli zingari, che non hanno alcun governo per proteggerli e alcuna forza politica. Del resto quella persecuzione è già in atto a pieno regime a Roma e a Milano, oltre che in tutti “territori” della Lega.
Dunque Berlusconi si pronuncia ma gli accade il solito incidente che lo tormenta fuori dall’Italia. Non solo la stampa francese (o quella europea) non fanno cenno della Santa Alleanza: tutta la Francia e tutta l’Italia contro i rom. Ma si dà un caso curioso. Sarkozy, che nella disciplinata stampa italiana ringrazia ripetutamente Berlusconi (testualmente: “E’ così che si vedono i veri amici”) nella irata conferenza stampa a Bruxelles non lo nomina mai. Questa battaglia è sua e se la gestisce lui. Qui però finiscono la parte mondana e quella giornalistica della insolita e stupefacente vicenda. E comincia la verifica, non secondo principi umani e morali, che non sarebbe male includere in questa storia. Ma comincia la riflessione del buon senso.
Cittadini da secoli
BASTA riprendere la storia dall’inizio. Abbiamo detto che la Francia (e poi la Francia e l’Italia, 150 milioni di persone in due dei paesi più ricchi del mondo) si schierano contro i rom. Deve trattarsi di un rischioso progetto: liberare i rispettivi paesi dalla invasione degli zingari. Ci sarebbe un primo ostacolo: gli zingari sono cittadini europei. Qui dovrebbe soffermarsi il diritto. Il buon senso si ferma molto prima. Il buon senso avverte che i rom - sommando i due paesi - non sono neppure 400 mila, dispersi in campi di poche centinaia, a volte decine di persone. Metà sono donne, metà sono bambini. C’è un altro dettaglio che attrae l’attenzione del buon senso e avverte che qualcosa non va nell’equilibrio di questi due stati: una buona metà dei perseguitati sono cittadini francesi o cittadini italiani da secoli.
Qui, nella guerra ai rom, mancano le ragioni (vere e false) con cui gli untori scatenano la guerra contro l’immigrazione. Ti dicono che sono tanti, che sono troppi che prenderanno il sopravvento e imporrano il giogo islamico. I rom sono pochi, sono cristiani, sono in giro da secoli, sono cittadini europei e, spesso, sono cittadini dei paesi in cui ormai vivono con cui condividono scuola e lingua. Purtroppo tutto ciò ci porta verso un’unica, triste, squallida spiegazione: questo è razzismo nella sua forma più rozza e più pura. È tutto qui. Ma è come diagnosticare, nel cuore dell’Europa, il peggiore dei mali.
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- Per un nuovo capitolo della storia: economico, culturale e antropologico (di Barbara Spinelli - Con la a crisi democrazie a rischio)20 giugno 2010, di Federico La Sala
Con la crisi democrazie a rischio
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 20/6/2010)
In un incontro a porte chiuse con i sindacati europei, l’11 giugno, il presidente della Commissione Barroso avrebbe espresso grande inquietudine sul futuro democratico di Paesi minacciati dalla bancarotta come Grecia, Spagna e Portogallo. Secondo il Daily Mail, avrebbe parlato addirittura di possibili tumulti e colpi di Stato. La Commissione europea ha smentito le parole attribuite al proprio Presidente, ma l’allarme non è inverosimile e molti lo condividono.
Al momento, per esempio, l’ansia è intensa in Grecia, dove il governo Papandreou sta attuando un piano risanatore che comporterà vaste fatiche e rinunce. L’ho potuto constatare di persona, parlando qualche settimana fa con il direttore del quotidiano Kathimerini, Alexis Papahelas: «Le misure di austerità, inevitabili e necessarie, sono irrealizzabili senza una democrazia funzionante e una classe politica incorrotta. Ambedue le cose mancano in Grecia, a causa di una storia postbellica caratterizzata da profonda sfiducia verso lo Stato e da una cultura della legalità inesistente». Papahelas non parla di colpi di Stato - l’esperienza, disastrosa, già è stata fatta a Atene fra il ’67 e il ’74 - ma di movimenti populisti, nazionalisti, «anelanti a falsi Messia».
La tentazione che potrebbe farsi strada è quella di considerare la democrazia come un lusso che ci si può permettere in tempi di prosperità, e che bisogna sospendere nelle epoche d’emergenza che sono le crisi. Apparentemente il regime democratico resterebbe al suo posto: la sua natura liberatoria verrebbe anzi esaltata. Ma resterebbe sotto forma impoverita, stravolta: il popolo governerebbe eleggendo il governo, ma tra un voto e l’altro non avrebbe strumenti per vigilare sulle libertà dei governanti. La democrazia verrebbe sconnessa dalla legalità, dai controlli esercitati da istituzioni indipendenti, dalle Costituzioni: tutti questi strumenti degraderebbero a ammennicoli dispensabili, e la libertà sarebbe quella dei governanti.
Gli italiani sanno che l’allergia alla legalità e ai controlli è un fenomeno diffuso anche da noi, oltre che in Grecia. Sanno anche, se guardano in se stessi, che il bavaglio protettore dell’illegalità è qualcosa che molti si mettono davanti alla bocca con le proprie mani, prima che intervengano leggi apposite. In questi giorni si discute delle intercettazioni: converrebbe non dimenticare che una legge assai simile (la legge Mastella) fu approvata quasi all’unanimità dalla Camera, nell’aprile 2007. Che un uomo di sinistra come D’Alema disse, a proposito di giornali da multare: «Voi parlate di multe di 3 mila euro(...) Li dobbiamo chiudere, quei giornali» (Repubblica, 29-07-06).
La crisi in cui viviamo da tre anni mostra una realtà ben diversa. Se si fonda su una educazione complessa alla legalità e non è plebiscitaria (cioè messianica), la democrazia è parte della soluzione, non del problema. La bolla scoppiata nel 2007 era fatta di illusioni tossiche, di un’avidità sfrenata di ricchezza, e anche della mancanza di controlli su illusioni e avidità. Uscirne comporta sicuramente sacrifici ma è in primo luogo una disintossicazione, un ristabilire freni e controlli. Tali rimedi sono possibili solo quando la democrazia coincide con uno Stato di diritto solido, con istituzioni e leggi in cui il cittadino creda. In Grecia, questi ingredienti democratici sono da ricostituire in parallelo con il risanamento delle finanze pubbliche e i sacrifici, e forse prima. Anche in America, non è con un laissez-faire accentuato che si sormontano le difficoltà ma con più stretti controlli sui trasgressori.
È il motivo per cui Grecia e Stati Uniti concentrano l’attenzione sui due elementi che indeboliscono simultaneamente economia e democrazia: da una parte l’impunità di chi interpreta il laissez-faire come licenza di arricchirsi senza regole, dall’altra l’impotenza dello Stato di fronte alle forze del mercato. Abolire l’impunità e restituire credibilità allo Stato sono giudicati componenti essenziali sia della democrazia, sia della prosperità. Difficile ritrovare la prosperità se intere regioni o intere attività economiche sono dominate da forze che sprezzano la legalità, che si organizzano in mafie, o che immaginano di annidarsi in chiuse identità micronazionaliste. La storia dell’Europa dell’Est e della Russia confermano che senza libertà di parola e senza un indiscusso imperio della legge viene meno il controllo, e che senza controllo proliferano gli affaristi e i mafiosi.
In Grecia, la lotta all’impunità è fattore indispensabile della ripresa, ci ha spiegato Papahelas: «La cura vera consiste nell’approvazione, da parte di tutti i politici, di un emendamento costituzionale che annulli l’immunità garantita a ministri o parlamentari passati e presenti, e che porti davanti alle corti o in prigione i truffatori e gli evasori fiscali. Si tratta di imbarcarsi in un nuovo capitolo della storia: economico, culturale e antropologico».
In America vediamo con i nostri occhi quanto sia importante il controllo sulle condotte devianti di chi si sottrae alle regole: l’audizione al Congresso dell’amministratore delegato di British Petroleum, Tony Hayward, è severissima e trasmessa da tutte le tv. Dice ancora Papahelas: «Il vecchio paradigma - quello di uno Stato senza leggi, in cui regnano ruberie e nepotismi - sta precipitando».
Impunità e allergia alla cultura del controllo (esercitato da istituzioni e da mezzi d’informazione) sono radicate anche in Italia, e anche qui la democrazia è vicina al precipizio. Le innumerevoli leggi varate a protezione di singole persone o gruppi di persone, l’arroccamento identitario-etnico di regioni a Nord e a Sud del Paese: questi i mali principali. La stessa proposta di rivedere l’articolo 41 della Costituzione contiene i germi di un’illusione: l’illusione che l’economia ripartirà, se solo si possono iniziare attività senza controlli preventivi. L’illusione che l’eliminazione di tali controlli sia un bene in sé, anche in Paesi privi di cultura della legalità.
La costruzione dell’Europa non è estranea alla degradazione dello stato di diritto in numerosi Paesi membri. Non tanto perché essa ha sottratto agli Stati considerevoli sovranità (sono sovranità chimeriche, nella mondializzazione) ma perché ha ritardato l’ora della verità: quella in cui occorre reagire alla crisi di legittimità con una rifondazione del senso dello Stato, e non con una sua dissoluzione. Se i politici fanno promesse elettorali non mantenibili, se si conducono come dirigenti non imputabili, è inevitabile che i cittadini e i mercati stessi traggano le loro conclusioni non credendo più in nulla: né nell’Europa, né nei propri Stati, né nei piani di risanamento economico.
Non è un caso che si moltiplichino in Europa le condanne della legge italiana sulle intercettazioni (appello dei liberal-democratici del Parlamento europeo, firmato da Guy Verhofstadt, appello dell’Osce e di Reporter senza frontiere). Un’informazione e una giustizia imbavagliate o dissuase minano la democrazia. Reagiscono alla crisi proteggendo il vecchio paradigma dell’avidità senza briglie. Conservano uno status quo che ha già causato catastrofi nell’economia e nelle finanze.
L’esplosione della piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico è stata paragonata a una guerra. Anche la crisi è una specie di guerra. Se ne può uscire alla maniera di Putin: rafforzando quello che a Mosca viene chiamato il potere verticale, imbrigliando giudici e giornalisti, consentendo a mafie e a segreti ricattatori di agire nell’invisibilità, nell’impunità. Oppure se ne può uscire come l’Europa democratica del dopoguerra: con istituzioni forti, con uno Stato sociale reinventato, con la messa in comune delle vecchie sovranità, con un nuovo patto fra cittadini e autorità pubblica.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- "L’Europa operi come soggetto unitario nello scenario internazionale" ( il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano - inaugurazione della nuova sede degli Archivi Storici UE a Firenze).19 dicembre 2009, di Federico La Sala
"L’Europa operi come soggetto unitario nello scenario internazionale" *
"L’Europa in quanto tale è destinata all’irrilevanza, al declino se non riesce ad operare come soggetto unitario nello scenario internazionale". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rispondendo alla domanda di un giovane ricercatore all’Istituto Europeo Universitario nell’ambito della cerimonia di inaugurazione della nuova sede degli Archivi Storici UE a Firenze.
Il Presidente Napolitano ha anche affrontato - rispondendo alle domande di altri studenti - il tema dell’immigrazione affermando che "è molto importante avere un coordinamento europeo sulle politiche dell’immigrazione. Questa è la via da seguire".
Il Presidente, osservando che "spesso c’è una sovrapposizione impropria tra diritto d’asilo e immigrazione" , ha ribadito che "il diritto d’asilo è riconosciuto da principi imprescindibili sanciti non solo dagli stati ma dalle convenzioni internazionali". Per quanto riguarda l’immigrazione regolare l’Italia si è affidata a un sistema di accesso per quote mentre altri paesi hanno scelto strade diverse ma "l’importante è che ci si regoli secondo principi fondamentali, fissati in norme comuni. Anche per questo - ha detto il Presidente - occorre volontà politica, volontà di dare luogo a un coordinamento delle politiche nazionali sull’immigrazione. Per le istanze di appello - ha inoltre osservato - a livello europeo operano la Corte di Giustizia europea e quella dei diritti umani".
Il Capo dello Stato ha auspicato una implementazione del Trattato di Lisbona: "Spero che l’Italia dia il suo contributo, ci sono gli strumenti ma ho paura che la volontà politica sia spesso mancante. Ci sono state troppo esitazioni dei paesi membri nel fare i passi necessari".
Tra le opportunità offerte dal Trattato di Lisbona "dobbiamo vedere se può essere realizzata - ha ricordato il Presidente - una cooperazione strutturata nel campo della difesa: penso sia necessario integrare i bilanci degli stati membri dell’Unione europea. Abbiamo clamorose duplicazioni e frammentazioni che impediscono una più forte produttività nel campo della difesa europea".
Il Capo dello Stato ha indicato anche l’esigenza di "unificare le quote di cui dispongono gli Stati europei in seno al Fondo Monetario Internazionale. L’unificazione delle quote darebbe un peso nuovo all’Europa nello scenario internazionale. Ma questa unificazione incontra resistenze difficilmente superabili".
Ad una domanda sul contributo che i nuovi Stati membri possono dare all’Unione europea, il Presidente Napolitano ha risposto che "i paesi dell’Europa dell’est entrati nell’Unione Europea sono paesi membri come tutti gli altri. Si devono liberare del complesso di essere considerati come una categoria a parte, che possono diventare una seconda classe dell’Europa. Devono essere coerenti con gli impegni assunti che prevedono una cessione alla UE di una parte della loro sovranità e non devono avere timore di essere trascinati in politiche più avanzate".
* Fonte: www.quirinale.it
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- E’ impressionante la forza che possiede la stupidità, nella vita degli Stati europei e in quella dell’Unione (di barbara Spinelli - Il sorriso ottuso dell’Europa).16 maggio 2010, di Federico La Sala
Il sorriso ottuso dell’Europa
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 16/5/2010)
E’ impressionante la forza che possiede la stupidità, nella vita degli Stati europei e in quella dell’Unione. La crisi economica iniziata nel 2007 avrebbe dovuto insegnar loro un po’ d’intelligenza supplementare, e persuaderli che i tempi dell’incertezza erano finiti, che la politica doveva riacquistare un primato, che l’ora di un governo europeo era infine sopraggiunta. Invece si direbbe che la crisi non abbia impartito lezione alcuna, nonostante le grandi spese che l’Unione si sta sobbarcando.
Si versano soldi in quantità e nelle nazioni si predispongono piani di sacrifici dolorosi, ma come dissero a suo tempo Fruttero e Lucentini: la cretineria prevale, e quel che l’Europa sa far meglio è l’ottusa «manutenzione del sorriso». L’euro vacilla sempre più, ma i capi di governo fingono letizia, immaginando di suggestionare i mercati col buon umore. Della tempesta non parlano, per non dover parlare delle proprie responsabilità, e sperano che come per miracolo i mercati si calmino. Intanto pagano e questo non è male, ma pagare non è tutto quel che occorre. La politica, hanno l’impressione di averla già fatta. La leadership, di averla già esercitata: con il trattato di Lisbona, con qualche vertice fra i governi più importanti. Così vivacchiano ancor oggi, grosso modo soddisfatti.
La costituzione è fallita in questi anni, ma il trattato di Lisbona ha preso il suo posto e il grosso è fatto. L’unico elemento positivo della crisi è che i governi non se la prendono più con gli eurocrati di Bruxelles, d’un tratto. In cuor loro sanno perfettamente che se l’Europa è considerata nel mondo un’impresa minacciata di morte, la colpa è degli Stati e dei politici nazionali. Il cretino molto spesso si dissimula dietro le vesti del pragmatico, del moderato, di chi pretende di aver appreso la feconda arte della disillusione, dello spirito blasé. Nessuna passione lo agita più, nessuna grande idea innovatrice, se non il desiderio di posti e di cariche.
L’Inghilterra è maestra in quest’arte solo apparente del disincanto, impastata in realtà di illusioni e incanti: illusione di potercela fare da sola, come nazione erede di un impero; incanto che occulta i fatti reali e riempie il vuoto con l’affaccendarsi più che col fare. In questi giorni c’è chi parla addirittura di rivoluzione in Gran Bretagna, e tutti sono eccitati perché per la prima volta gli inglesi fanno l’esperienza, molto continentale, di un governo di coalizione. Ma al momento, l’esperienza è un guscio vuoto. Tutto quello che i liberal-democratici di Clegg hanno fatto è retrocedere nella loro battaglia europeista, pur di fare un governo giovane, fotogenico e ilare con Cameron, l’antieuropeista. Il colmo è stato raggiunto, il giorno dell’accordo, da Graham Watson, deputato liberale al Parlamento europeo. «Sull’Europa non c’è problema», ha detto alla Bbc: primo perché nell’euro l’Inghilterra non entrerà comunque; secondo perché l’Unione ha già operato tali e tanti cambiamenti, da quando ha approvato il trattato di Lisbona, che il riposo e le pantofole sono più che legittimi. Per un bel po’ di tempo, ha aggiunto, altri trasferimenti di sovranità non sono né previsti né auspicati.
Così ragionano i pragmatici, o meglio i rinunciatari, quasi camminassero in una fresca radura e non in mezzo a incendi. Proprio ora ci vorrebbero nuovi trasferimenti di sovranità, perché l’Europa diventi finalmente un soggetto politico credibile (credibile davanti ai mercati, agli Stati Uniti, alla Cina, all’India) e proprio ora i suoi dirigenti dicono, come quando ti si accampano davanti un secondo e un terzo mendicante: «Abbiamo già dato». Eppure quasi ogni giorno la cosa appare evidente: la crisi che traversiamo e i sacrifici che saranno chiesti ai cittadini sono tali, che senza trasformazioni decisive dell’Unione c’è poco da sperare. Non lo affermano solo i mercati, che non sembrano credere nell’Europa ma di cui si può pensare: hanno l’istinto del gregge, ascoltano il primo che passa.
L’Europa e l’euro sono ritenuti moribondi anche da politici americani di primo piano come Richard Haass, direttore del Council of Foreign Relations e consigliere di vari presidenti. Anche dall’ex governatore della Federal Reserve Paul Volcker. Lo storico Niall Ferguson, esperto in declini di imperi (romano, britannico, americano), lo dice a chiare lettere, su Newsweek: «La grande decisione che l’Unione deve prendere non è se salvare la Grecia. È se trasformarsi in Stati Uniti d’Europa, o essere una versione moderna del sacro romano impero, una bislacca accozzaglia “a geometria variabile” che prima o poi si frantumerà».
Economicamente l’Europa sta meglio degli Stati Uniti. Ma questi non muoiono perché sono un sistema politico federale, dunque un soggetto visibile. Dietro il dollaro c’è uno Stato, che riequilibra le disparità interne: «In America il salvataggio del Michigan viene fatto dal Texas in modo automatico, attraverso la ridistribuzione del reddito e i proventi della tassa sulle imprese». Dietro l’euro c’è un’armatura e dentro l’armatura un cavaliere inesistente. Bisogna davvero esser lenti a capire e sconfinatamente svogliati, per pensare dopo il tremendo biennio 2007-2009 che i mercati e l’economia siano tutto, e talmente bravi ed efficaci da dettar legge. Che la moneta unica e la prosperità del vecchio continente possano sussistere senza un potere politico, alle spalle, che coincida con l’area dell’euro. Che mercati e agenzie di rating restino infallibili, abilitati a ripetere i disastri e le bolle speculative degli ultimi anni. Nonostante questo suo impazzimento, l’economia continua a essere l’idolo davanti al quale la politica, svuotata dal di dentro, senza timoniere, molto pragmaticamente si adatta.
È come se l’Europa non avesse, nel proprio bagaglio, una grande cultura fatta di scetticismo verso i mercati e il predominio dell’economia: una cultura che ha prodotto guerre fratricide ma ha anche saputo difendersi da esse inventando la democrazia, la separazione dei poteri, l’autonomia della politica, lo Stato sociale. Una cultura che nel dopoguerra ha dato vita a un’unione di Stati consapevoli dei propri limiti e decisi a mettere insieme le proprie vecchie sovranità. Un’unione che ha custodito inoltre il Welfare, in modo da spegnere in anticipo gli estremismi scatenati nel secolo scorso dalla questione sociale. È come se nella nostra storia non ci fosse stata, contro il predominio del mercato e dell’economia, una lunga tradizione che va dalle visioni etiche e politiche di Condorcet e Adam Smith alle proposte sociali e politiche di Beveridge e Keynes. È dal Settecento che l’Europa produce idee in questo campo, oggi dimenticate. Condorcet, che pure credette nella razionalità degli economisti a lui contemporanei, vide già allora i pericoli: «Agli occhi di una nazione avida, la libertà non sarà più che la condizione necessaria alla sicurezza delle operazioni finanziarie».
L’euro è nato con questo vizio, fondamentale. Il mercato e le banche erano tutto, il grande demiurgo era a Francoforte. La politica era chiamata a garantire la libertà necessaria alla sicurezza delle operazioni finanziarie. L’armonia si sarebbe imposta spontaneamente, e al peggio non urgeva pensare. Invece il peggio è venuto. È già qui fra noi. Si può fingere che non esista, e dare alla finzione il nome di pragmatismo. Ma il pragmatismo senza una trasformazione dell’Europa non è pragmatismo né tanto meno disincanto. È un’ideologia con aspirazioni egemoniche acutissime. Ha la forza della stupidità quando impigrisce. La forza di bloccare i nuovi necessari trasferimenti di sovranità, come nei desideri degli inglesi o della Corte costituzionale tedesca. Ha il potere, magari gratificante ma enormemente inutile, di chi è addetto alla manutenzione del sorriso mentre la crisi economica si abbatte sulle società e le democrazie per spezzarle.
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. --- Minareti. Perché l’Occidente non deve averne paura (di Piero Coda).3 dicembre 2009, di Federico La Sala
Minareti. Perché l’Occidente non deve averne paura
L’atteggiamento sbagliato di chi vuole godere tutti i benefici materiali della globalizzazione, ma non ha alcuna intenzione di affrontare i rischi che questa porta con sé
La coabitazione tra popoli culture, esigenze sociali e religioni è un fenomeno che è sempre esistito Ma oggi assume un ritmo molto più accelerato e connotati inediti
La proibizione sancita dal referendum svizzero e le posizioni della Lega riaccendono lo scontro sui temi della tolleranza e della coesistenza tra religioni diverse
di Piero Coda (la Repubblica, 03.12.2009)
L’esito del referendum svoltosi in Svizzera la scorsa domenica circa la costruzione di nuovi minareti è il risultato eclatante della superficialità culturale con cui le nostre società stanno affrontando uno dei fenomeni più ingenti e sfidanti del nostro tempo. Ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi - e le analisi sociologiche e i dati statistici, insieme alla cronaca quotidiana, ce ne danno evidente documentazione - è un profondo rimescolamento delle carte per quanto concerne la relazione e la coabitazione tra i popoli, le culture, le esperienze sociali, le religioni. Un fatto che c’è sempre stato, ma che oggi assume dei connotati inediti e pervasivi, oltre che un ritmo accelerato. Il disagio nell’affrontare questa sfida, molto concreta e oltremodo impegnativa, è comprensibile. Ma non lo è l’assenza, a livello pubblico, di un approfondimento e di un dialogo serio e responsabile, capace di aiutarci ad andare al di là della reattività immediata e di leggere il significato profondo di quanto accade e ci interpella, al fine d’individuare strategie culturalmente attrezzate e operativamente praticabili. L’esito e, prima ancora, la proposizione di un referendum come quello di domenica in Svizzera denuncia in modo grave e inequivocabile quest’assenza. E c’è solo da augurarsi che provochi quello choc salutare capace d’innescare un processo ponderato di discernimento della vera questione che è in ballo.
L’esperienza di questo referendum ci dice infatti che cosa non dobbiamo e non possiamo fare, in virtù della tradizione culturale e giuridica su cui si regge la civiltà occidentale e in riferimento all’inedito che bussa alla nostra porta e che chiede di dar nuova forma - senza rinnegare assolutamente il positivo delle acquisizioni con fatica sin qui raggiunte - alla convivenza civile e all’assetto giuridico delle nostre società. Innanzi tutto, non è più possibile -- pena il ritorno a un passato che è improponibile - legiferare impedendo la legittima espressione pubblica delle diverse fedi religiose. Le quali non possono in nulla derogare dalle norme fondamentali e riconosciute della società in cui si esplicano, ma che altrettanto non possono esser relegate nella sfera del privato. È questo un guadagno irrinunciabile della civiltà occidentale, cui non è estraneo l’apporto per molti versi decisivo della fede cristiana e della cultura che ad essa s’ispira.
C’è voluto tempo e si sono combattute aspre battaglie, con chiusure e resistenze su ambedue i fronti, ma alla fine il principio secondo cui occorre dare a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare è diventato, per lo Stato moderno e per la Chiesa, un principio almeno formalmente inderogabile. Tanto che il Concilio Vaticano II ha emanato una dichiarazione sulla libertà civile e sociale in materia religiosa, la Dignitatis humanae. Dichiarazione per nulla scontata, sino a quel momento, nello stesso ambito cristiano, e che proprio per questo - al dire di Paolo VI - «resterà senza dubbio uno dei più grandi documenti di questo Concilio». Un’altra cosa che è non solo strategicamente sbagliata, ma culturalmente del tutto inadeguata oltre che controproducente, è contrapporre rozzamente Occidente e Islam, facendo loro vestire i panni di due civiltà inconciliabili.
Certo, le differenze non mancano e sono anche rilevanti: ma la contrapposizione escludente non favorisce mai l’evoluzione dei dati positivi presenti in un dato sistema culturale e sociale. Senza dire che l’identità sana e matura non si promuove contro quella dell’altro, chiunque egli sia, ma nella fatica di stabilire con lui il giusto rapporto. E senza sottovalutare il fatto che una presa di posizione come quella che si è espressa nel referendum sui minareti segnala un’insuperabile contraddizione: quella di chi vuol godere di tutti i benefici della globalizzazione a livello materiale, senza aprirsi al rischio ma anche al guadagno culturale che essa può produrre.
Detto questo, si può guardare con serenità e spirito costruttivo alla delicata questione di che cosa necessitino gli atteggiamenti fondanti della nostra cultura e le regole procedurali e sostanziali della nostra convivenza per farsi capaci di apparecchiare uno spazio pubblico condiviso e accogliente. Insomma, se, per me che sono cristiano, il campanile e il suono delle campane fanno casa e nutrono il sentimento della mia identità, perché non debbo riconoscere che il minareto e l’invito alla preghiera del muezzin fanno altrettanto per gli amici musulmani?
L’essenziale è che il suono della campana e l’invito del muezzin non siano assordanti e impositivi. Del resto, non sono stati pochi né brevi i periodi della storia passata né a tutt’oggi sono del tutto spariti i luoghi ove sinagoghe, chiese e moschee convivono pacificamente e arricchiscono le rispettive identità del dono prezioso che viene dall’altro.
Dobbiamo senz’altro essere realisticamente consapevoli che tutto ciò non è scontato né facile. Ma è questa la frontiera culturale che dobbiamo attraversare insieme. Aiutandoci gli uni gli altri, con apertura e insieme con rigore, a disinnescare in radice ogni forma di tentazione fondamentalista e omologatrice. Promuovendo, di concerto con coloro - e non sono pochi - che non aderiscono a nessuna tradizione religiosa, una laicità matura che si faccia spazio propizio di dialogo e incontro, nella cornice del rispetto della dignità e dei diritti/doveri inalienabili della persona.
Senza indulgere a quel falso irenismo che mettendo sullo stesso piano tutte le convinzioni, in realtà le rende indifferenti l’una verso l’altra inibendo quell’inesausta ricerca di bene, di verità e di pace che muove la coscienza e la libertà verso orizzonti sempre più ricchi e condivisibili. Riuscire a convivere così, nei Paesi europei così come in quelli islamici, non è, per chi aderisce a una fede religiosa, abdicare alla propria identità né sognare idealisticamente un’utopia, ma testimoniare con coerenza e senza sconti la propria apertura verso Dio e la propria responsabilità verso l’altro.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- I CARCERIERI DI DURRENMATT (di Beppe Sebaste)1 dicembre 2009, di Federico La Sala
I carcerieri di Dürrenmatt
di Beppe Sebaste (l’Unità, 01.12.2009)
Claustrofobia è un concetto che si usa poco in politica, eppure è proprio questo che provocano i regimi chiusi e totalitari, a diversi gradi del loro insediamento. Gli ingredienti sono sempre gli stessi: chiusura, appunto, omogeneizzazione, ripiegamento sulla propria identità; identità che, a diversi livelli di fascistizzazione, si basa sulla comunanza del suolo oppure del sangue. L’appartenenza religiosa ha pure un ruolo importante in questa marca di identità.
In Svizzera, storicamente terra d’asilo e di rifugiati politici e religiosi, dove un referendum populista ha proibito l’edificazione di minareti, nel 1990 il grande Friedrich Dürrenmatt pronunciò un discorso d’indimenticabile e feroce ironia contro la politica claustrofobizzante del suo Paese. Descrisse la Svizzera come una paradossale prigione nella quale gli svizzeri sono carcerati e al tempo stesso carcerieri di se stessi, «per dimostrare la propria libertà». In tale prigione, disse, «gli Svizzeri si sono rifugiati (...) perché soltanto lì essi sono sicuri di non essere aggrediti».
Vale la pena di ricordare alla lettera un passo del discorso di Dürrenmatt: «C’è un solo problema in questa prigione, quello di provare che non è una prigione ma il rifugio della libertà, poiché, dall’esterno, una prigione è una prigione e quelli che sono dentro sono carcerati, e chi è carcerato non è libero: agli occhi del mondo esterno, solo i carcerieri sono liberi, poiché se non fossero liberi sarebbero carcerati. Per risolvere questa contraddizione i carcerati hanno introdotto l’obbligo generale di essere guardiani: ogni carcerato dimostra di essere libero facendo lui stesso il proprio carceriere. Ciò che dà agli svizzeri il vantaggio dialettico di essere al tempo stesso liberi, carcerati e carcerieri». Le sue parole valgono oggi più che mai per l’Italia, da quando a fare le leggi c’è un paradossale «Popolo delle libertà», guidato dai carcerati-carcerieri della Lega. Non so voi, ma la ma claustrofobia sta superando il livello di guardia.❖
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- LUGANO. Uno schiaffo ai musulmani finora mai visto, in Europa (di Franco Zanotelli - La Svizzera dice no ai minareti)30 novembre 2009, di Federico La Sala
La Svizzera dice no ai minareti
La Lega esulta: ora la croce nel tricolore
di Franco Zanotelli (la Repubblica, 30.11.2009)
LUGANO - Uno schiaffo ai musulmani finora mai visto, in Europa. Lo hanno dato ieri gli elettori svizzeri, votando contro la costruzione di nuovi minareti. Secondo il 57% dei cittadini, bastano e avanzano i quattro attualmente esistenti a Ginevra, Zurigo, Winterthur e Wangen bei Olten.
A scagliarsi contro i minareti, ritenuti "un simbolo di potere politico-religioso", erano stati diversi esponenti della destra e dell’estrema destra elvetica che, dopo aver lanciato una petizione popolare, raccogliendo oltre 113 mila firme (nonostante l’opposizione del Governo e della maggioranza del Parlamento), hanno portato i cittadini alle urne e ottenuto un successo assolutamente imprevisto. I sondaggi indicavano infatti una facile vittoria dei no alla proibizione dei minareti.
In realtà è stata sottovalutata la presa degli slogan branditi dai promotori. Come la citazione di un discorso tenuto nel ?97 dal premier turco Erdogan, il quale dichiarò che «le moschee sono le nostre caserme, i minareti le nostre baionette». Slogan che però, curiosamente, a Zurigo, Winterthur e Ginevra, dove sorgono tre dei quattro minareti svizzeri, non hanno trovato orecchie: lì, infatti, l’iniziativa è stata respinta.
Come scriveva di recente lo Spiegel, «ne è passato di tempo da quando, negli anni ?60 e ?70, i sindaci di Zurigo e di Ginevra salutavano come simboli di apertura l’inaugurazione di una moschea nelle loro città». Oggi il clima è cambiato. Lo testimoniano episodi come la recente intervista televisiva di un cittadino di Wangen bei Olten, dove nel gennaio scorso è stato inaugurato l’ultimo minareto svizzero, che non ha esitato a definire l’edificio «un primo passo verso la sharia».
Ieri la ministra di Giustizia, Eveline Widmer Schlumpf, ha riconosciuto che sono state sottovalutate le «paure diffuse nella popolazione nei confronti di correnti islamiche fondamentaliste, che potrebbero rifiutare le nostre tradizioni statali e non riconoscere il nostro ordinamento giuridico». La Widmer Schlumpf ha quindi, tentato di rassicurare gli oltre 350 mila musulmani residenti in Svizzera, affermando che il voto di ieri non va inteso come «un rifiuto della comunità dei musulmani, della loro religione e della loro cultura». Ma il presidente del Coordinamento delle organizzazioni islamiche in Svizzera, Farhad Afsahar, dichiara che «quello che più ci fa male non è il rifiuto del minareto ma, piuttosto, il segnale che arriva dalle urne». «Amo la Svizzera e questo risultato getta un’ombra di vergogna su un Paese che amo», ha detto dal canto suo Hafid Ouardiri, ex-portavoce della moschea di Ginevra. Non è un caso se, in ottobre, Ouardiri arrivò a denunciare per discriminazione razziale uno dei promotori dell’iniziativa anti-minareti, il parlamentare dell’Unione Democratica di Centro Oscar Freysinger, che durante un congresso del suo partito, azzardo` un paragone tra islam e nazismo.
Mentre Freysinger e gli altri fautori dell’iniziativa festeggiano, perplessità arrivano anche dalla Conferenza episcopale elvetica, tramite il suo segretario generale, monsignor Gmur: «Quelli che sostenevano il referendum dicono che la religione deve essere una cosa privata, che ognuno può pregare dove vuole ma non in luoghi pubblici. Nello stesso tempo si dicono cristiani. Ma per un cristiano il culto non può essere solo un fatto privato». Inoltre, rincarano i vescovi, l’esito del voto «aumenta i problemi della coabitazione tra religioni e culture».
In Italia, invece, la Lega Nord esulta. E per bocca del viceministro Castelli, che parla di «un messaggio di civiltà», propone di «mettere la croce nel Tricolore».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- LUGANO. Uno schiaffo ai musulmani finora mai visto, in Europa (di Franco Zanotelli - La Svizzera dice no ai minareti)1 dicembre 2009, di Biasi
Precisamente il 57,5% dei votanti (e cioè circa il 54 % degli aventi diritto) hanno votato contro la costruzione dei minareti e non il 57 % degli svizzeri, come si vorrebbe far intendere...
Poichè vivo in questo Paese, sarebbe interessante conoscere come hanno votato gli italiani, residenti nella Confederazione, che hanno la doppia cittadinanza...
Nella Svizzera Italiana la percentuale dei contro ha raggiunto il 68.1% !!
Bisognerebbe veramente ripensare l’Europa, perchè quella immaginata dai benpensanti e politici chiacchieroni e mangiasoldi è, a quanto pare, ben lontana dalle esigenze della gente comune del vecchio continente.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Se l’Islam fa paura agli ignoranti (di Tahar Ben Jelloun)1 dicembre 2009, di Federico La Sala
Se l’Islam fa paura agli ignoranti
di Tahar Ben Jelloun (la Repubblica, 1.12.09)
La democrazia diretta, praticata nella Confederazione elvetica, è a volte fonte di aberrazioni. È accaduto domenica: il referendum contro i minareti ha ottenuto più del 57 per cento dei sì. Che cosa vuol dire? Che si accolgono volentieri i musulmani in territorio svizzero, purché si rendano invisibili, discreti fino a scomparire dal paesaggio. E rinuncino a erigere qualsiasi segno o simbolo che ostenti la loro presenza. Vuol dire che l’islam continua a far paura. E che questa diffidenza, questa fobia è basata sull’ignoranza. I manifesti diffusi dai fautori della campagna referendaria sono abbastanza eloquenti: raffigurano minareti neri a forma di missili, piantati su una bandiera svizzera accanto a una donna in burqa. Per quanto si sia detto e ripetuto che il burqa - usanza di certe tribù afgane o pachistane - non ha nulla a che vedere con l’islam e non è mai menzionato nei suoi testi, c’è sempre chi continua a confonderlo con una religione.
Quel manifesto è al limite del razzismo: suggerisce idee e minacce che il buon cittadino percepisce come un avvertimento. Quanto al voto, non risolverà nulla, ma al contrario non farà che accentuare i contrasti tra la comunità musulmana, diversa e simile, e gli elvetici.
Sopprimere i minareti vuol dire attaccare un simbolo che è il segno di una presenza, e non ha in sé nulla di aggressivo, né di politico. E in nessun caso incide sui «diritti fondamentali in Svizzera», secondo quanto afferma il partito della destra populista.
Come ha detto alla televisione francese una giovane musulmana: ieri il velo, oggi il burqa, ed ecco anche il minareto! È vero che il disagio esiste: l’islam, anche quello pacifico - peraltro maggioritario - continua a dar fastidio. Meglio allora riprendere i testi e non ascoltare i falsificatori, i provocatori che utilizzano il dogma per istigare all’odio tra i popoli.
Con quest’attacco ai minareti, la Svizzera prende di mira il simbolo di una religione che vorrebbe far scomparire dal proprio contesto. Ma il referendum, lungi dal raggiungere il suo scopo, non fa che esacerbare le passioni, anche al di là dei confini elvetici. In Francia, il Fronte nazionale ha applaudito all’esito del voto e si augura di poter esercitare un giorno questa forma di democrazia diretta e popolare per esprimere il rifiuto dell’islam in Francia.
Dello stesso ordine è il dibattito italiano sul crocifisso nelle scuole: un simbolo che non fa male a nessuno, ma nel momento in cui si vuole caricarlo di altri messaggi tutto si complica e si politicizza. Come nel caso del dibattito francese sull’«identità nazionale», che arriverà anche in Italia. Questa questione dell’identità si pone dal momento in cui si avverte un cambiamento nei colori e nelle componenti del paesaggio umano di un dato Paese. È una questione che riguarda tutta l’Europa, perché dovunque l’immigrazione è una realtà, e i figli degli immigrati sono europei, talora musulmani ma anche animisti o senza religione. Bisogna pure accettarla, questa realtà. Non serve a nulla organizzare votazioni per eliminarla dal paesaggio o correggerla. Evidentemente, la convivenza è qualcosa che si impara. E questo è possibile solo nel rispetto reciproco, che è anche rispetto delle leggi e del diritto.
Infine, un ultimo punto: gli immigrati e i loro figli non se ne andranno. Fanno parte della storia europea. Sono persone che hanno bisogno della propria cultura, del proprio culto, come qualunque cittadino di accertate origini europee. Traduzione di Elisabetta Horvat
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Come favorire l’integrazione dei musulmani di seconda generazione (di Paolo Branca - il coraggio di essere diversi).1 dicembre 2009, di Federico La Sala
 Musulmani di seconda generazione: a Torino si discute su come favorirne l’integrazione
Musulmani di seconda generazione: a Torino si discute su come favorirne l’integrazione
 La scommessa dei figli- Riuscire a essere moderni senza rinunciare alla propria tradizione
La scommessa dei figli- Riuscire a essere moderni senza rinunciare alla propria tradizioneIl coraggio di essere diversi: la sfida dei ragazzi 2G
 Come favorire l’integrazione dei musulmani di seconda generazione è il tema di un convegno che si tiene oggi e domani a Milano.
Come favorire l’integrazione dei musulmani di seconda generazione è il tema di un convegno che si tiene oggi e domani a Milano.
 L’islamista Paolo Branca ci racconta quali sono le sfide dei ragazzi 2G.
L’islamista Paolo Branca ci racconta quali sono le sfide dei ragazzi 2G. di Paolo Branca (l’Unità, 1.12.2009)
di Paolo Branca (l’Unità, 1.12.2009)La seconda generazione di giovani musulmani, nati in Italia o arrivatici in tenera età, non si trovano nella stessa situazione dei loro genitori da nessun punto di vista. Lingua e cultura d’origine sono per loro essenzialmente quelle del Paese in cui sono nati, cresciuti e andati a scuola. Anche se in casa e coi parenti rimasti nella terra d’origine parla- no arabo, l’italiano è l’idioma che conoscono meglio, che approfondiscono e sviluppano nel percorso educativo e del quale si fanno interpeti in varie occasioni verso madri troppo confinate nel ruolo domestico e addirittura rispetto ai padri che ancora sbagliano qualche pronuncia o coniugazione.
La cultura, essendo codificata assai meno rigidamente della grammatica, è un campo di mediazione molto più ampio e variabile. In fondo, ogni famiglia anche italiana, ha propri riti, abitudini, persino tabù propri che i piccoli imparano ad accogliere come un dato di fatto, poco problematico proprio perché condiviso nel ristretto gruppo casalingo, dove il mutuo affetto incide in modo decisivo sull’accettazione reciproca. La religione, specie nelle sue manifestazioni esterne, visibili agli altri e riconoscibili, diventa presto per loro qualcosa su cui decidere: una scelta personale, cosa che nel paese originario della famiglia non sarebbe accaduta in quanto essere musulmani è là la condizione normale della maggioranza, per cui ci si può considerare tali per tradizione e/o abitudine. Non è una differenza da poco.
INDIVIDUO E GRUPPO
Anzi, dato il carattere tradizionalista delle società originarie sono proprio le articolazioni e le gerarchie tra individuo e gruppo a rappresentare il punto di maggior distinzione rispetto a un contesto laico, secolarizzato e moderno.
Quest’ultimo, pur essendo nello stesso Occidente qualcosa di relativamente recente, è ormai a tal punto consolidato da aver profondamente trasformato concetti quali «autorità» e «obbedienza» e forse definitivamente archiviato pratiche conformistiche dipendenti da quello che la gente potrebbe pensare nel caso le sue scelte fossero parzialmente o totalmente in dissonanza da quelle altrui. Non tutti e non sempre colgono l’occasione o accettano la sfida. L’opzione di rimanere ancorati a regole e usi del mondo da cui si proviene e al quale si vuol restare fedeli può anche condurre a concepirsi e porsi come alternativi o antagonisti rispetto al contesto. Ma, inevitabilmente, sarà ancora una volta qualcosa da ridecidere e riaffermare ogni volta soprattutto in quanto individui, salvo casi estremi e molto rari di autoconfinamento totale all’interno di gruppi autoreferenziali.
Non si può tuttavia negare che, con il pretesto del rispetto della loro diversita culturale e religiosa, alcuni adulti pretendono non solo di continuare a vivere come se fossero nel villaggio natio, ma addirittura di polemizzare su cose che in patria avrebbero accettato senza discutere. Qualche papà si rifiuta di parlare con insegnanti donne, relega la propria moglie a svolgere compiti domestici impedendole di uscire e di imparare la lingua locale che l’aiuterebbe invece ad occuparsi meglio dell’educazione e della salute dei figli.
Ciò rischia in qualche caso di favorire nei giovani una sorta di doppia morale, in casa formalmente rispettosa di tradizioni ataviche mai messe in discussione, fuori varie forme di compromesso delle quali quelle assimilazioniste non sono sempre necessariamente migliori di quelle conservatrici: portarsi nella borsa abiti con cui cambiarsi appena fuori dalla portata dello sguardo paterno può preludere a esiti peggiori che un velo autonomamente indossato, per convinzione o per far piacere ai genitori.
Anzi, in questo caso, dover affrontare le non poche riserve dei coetanei e dell’ambiente in un’età delicata dove prevale lo spirito del branco e l’acritico uniformarsi all’ultima moda può perfino produrre effetti positivi sulla formazione di un carattere indipendente più di qualsiasi microgonna portata con disinvoltura. Il coraggio di essere diversi, diversi davvero e per questo magari dileggiati, accettare di essere minoranza non è cosa da poco: tingersi i capelli di verde, mettersi un piercing o tatuarsi come un aborigeno è in fondo molto più semplice.
Nella maggioranza dei casi, di volta in volta e in base al contesto, una continua mediazione viene operata con successo, benché senza escludere qualche scossone che fa parte del naturale «conflitto» generazionale. Riuscire ad essere ragazze e ragazzi moderni, spigliati e persino alla moda senza rinnegare valori e credenze tradizionali è una sfida quotidiana e silenziosa che molti affrontano e superano nella totale indifferenza della società circostante e soprattutto dei media. Eppure è una notizia di non poco conto, oltre che l’unica vera alternativa ai rari ma drammatici casi che sfociano in tragedia, come accade anche a famiglie «nostrane» quando sono lasciate sole.❖
-
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! --- Napolitano: "Europa davanti a un bivio, sia più unita e integrata o sarà declino".14 novembre 2009, di Federico La Sala
 L’Orientale di Napoli ha conferito una laurea honoris causa al presidente della Repubblica
L’Orientale di Napoli ha conferito una laurea honoris causa al presidente della Repubblica
 in Politiche e istituzioni europee: "Mai stata solo mercato comune"
in Politiche e istituzioni europee: "Mai stata solo mercato comune" Napolitano: "Europa davanti a un bivio
Napolitano: "Europa davanti a un bivio
 sia più unita e integrata o sarà declino" *
sia più unita e integrata o sarà declino" *NAPOLI - La laurea honoris causa in Politiche e istituzioni dell’Europa è stata conferita questa mattina al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dall’università Orientale di Napoli. "Una Europa più unita, più consapevole delle proprie virtù e potenzialità, più risoluta ad avanzare sulla via dell’integrazione", oppure noi europei "diventeremo spettatori" sulla scena internazionale, e il progetto europeo e tutti i Paesi che ne fanno parte andranno verso "il declino". E’ questo il bivio di fronte al quale si trova l’Unione europea secondo il Capo dello Stato, come ha spiegato nella lectio magistralis dal titolo "L’Europa nel mondo di metà Novecento e nel mondo d’oggi".
Con l’atto di nascita dell’Europa comunitaria, ha detto Napolitano, "si è intrapreso un cammino che non è mai stato dettato solo da motivazioni economiche", anzi "l’origine e l’impronta del processo di integrazione europea sono state eminentemente politiche". E per i sei Paesi che sottoscrissero la dichiarazione di Schumann "il valore supremo" era la pace, "da garantire attraverso il superamento degli antagonismi nazionali e dei conflitti di interesse che avevano acceso per due volte il fuoco di una guerra mondiale nel cuore dell’Europa".
Il presidente della Repubblica ha quindi sollecitato l’Europa al negoziato con la Croazia e, in modo particolare, con la Turchia nella prospettiva di un allargamento dell’Unione europea. Napolitano ha riconosciuto le "valutazioni e preoccupazioni" che hanno accompagnato l’allargamento dell’Ue da 15 a 27 ma ha sollecitato "un chiarimento che deve venire dai vertici dell’Unione quale essa oggi è. Accanto alle risposte che si attendono dalla Turchia su tutte le materie del negoziato, tocca all’Ue mostrarsi netta e coerente su quel che intende essere: una tradizionale alleanza tra Stati, se retta da regole di libero scambio in un mercato più o meno unificato, o un sistema di integrazione fondato sull’esercizio in comune di una sovranità condivisa in campi fondamentali" ha concluso Napolitano che nella lectio magistralis ha citato tre volte un discorso del ministro degli Esteri britannico, David Miliband, uno dei candidati alla nomina di ministro degli Esteri dell’Ue, carica cui aspira anche Massimo D’Alema.
Napolitano è stato accolto nell’aula magna dell’Università partenopea dal rettore Lida Viganoni e dal preside della facoltà di Scienze politiche, Amedeo Di Maio, dal sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, e dal governatore della Regione Campania, Antonio Bassolino. Nel discorso di saluto il rettore Viganoni ha espresso, a nome dell’ateneo, "l’ammirazione nei confronti di un Capo dello Stato che è indiscutibilmente uno dei grandi uomini del nostro Paese e della città di Napoli, cui è rimasto sempre profondamente e intensamente legato".
* la Repubblica, 14 novembre 2009
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- L’AMORE ("CHARITAS"), LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. ... E LE RADICI "CRISTIANE" DI BENEDETTO XVI.11 novembre 2009, di Federico La Sala
L’UDIENZA Il Papa: «L’Europa riscopra
Il Papa: «L’Europa riscopra
 e difenda le radici cristiane» (Avvenire, 11 Novembre 2009)
e difenda le radici cristiane» (Avvenire, 11 Novembre 2009)"Tutti coloro che hanno a cuore l’autentico umanesimo e il futuro dell’Europa sappiano riscoprire, apprezzare e difendere il ricco patrimonio culturale e religioso di questi secoli". Con questo appello il Papa a concluso la catechesi generale dell’udienza di oggi, interamente dedicata al "contributo importante e prezioso" apportato dalla riforma cluniacense al "processo di formazione dell’identità europea", che mille anni fa era in pieno svolgimento.
Quando l’Ordine di Cluny era in "piena espansione", ha ricordato infatti Benedetto XVI, tale riforma nel processo di "lunga gestazione" dell’identità del nostro Continente "ha portato a riconoscere in modo sempre più chiaro due elementi fondamentali per la costruzione della società: il valore della persona umana e il bene primario della pace". "Mille anni fa - le parole del Pontefice - mentre era in pieno svolgimento il processo di formazione dell’identità europea, la riforma di Cluny ha dato un contributo importante e prezioso: ha richiamato il primato dei beni dello Spirito, ha tenuto desta l’attenzione verso il primato di Dio, ha favorito nelle istituzioni la promozione dei valori umani, ha educato ad uno spirito di pace".
“La riforma cluniacense - ha detto Benedetto XVI ai 9 mila fedeli riuniti nell’Aula Paolo VI - ha avuto effetti positivi non solo per la purificazione e il risveglio della vita monastica, ma della vita della Chiesa universale”. In particolare, il movimento partito dall’abbazia di Cluny - che nel XII secolo, “momento della sua massima espansione”, contava quasi 1.200 monasteri - rappresentò “uno stimolo a combattere due grandi mali”, tipici della Chiesa dell’epoca: “la simonia, cioè l’acquisizione di cariche pastorali dietro compenso, e l’immoralità del clero secolare”. ”Con la loro autorevolezza morale”, ha sottolineato il Papa, gli abati di Cluny sono stati “protagonisti di un imponente azione di rinnovamento spirituale”; in particolare, “il celibato sacerdotale tornò ad essere stimato e furono introdotte procedure più trasparenti” nell’attribuzione delle cariche ecclesiastiche. Molti, inoltre, i “benefici” portati da tale movimento monastico “alla società”, soprattutto con due istituzioni tipicamente medioevali: le “tregue di Dio” e la “pace di Dio”. “In un’epoca dominata dalla violenza e dallo spirito di vendetta - ha ricordato il Papa - le tregue di Dio assicuravano lunghi periodi di non belligeranza, e con l pace di Dio si chiedeva, pena la sanzione canonica, di rispettare le persone inermi e i luoghi santi”.
Grazie al “grande movimento monastico” di Cluny - è in sintesi l’analisi del Papa - si formò “un’Europa dello Spirito” nelle varie regioni del nostro continente, come in Francia, Italia, Germania, Spagna e Ungheria. “Un successo assicurato - ha precisato Benedetto XVI - dalla spiritualità elevata, ma anche da alcune condizioni che ne garantirono lo sviluppo”. Tra queste, il Pontefice ha citato il fatto che i monasteri che facevano capo a Cluny erano “esenti dalla giurisdizione del vescovo e sottoposti direttamente a quella del Pontefice”. Proprio grazie a questo “legame speciale con la sede di Pietro” l’Ordine di Cluny poté mantenere e diffondere il suo “ideale di purezza e di fedeltà” evangelica, “senza alcuna ingerenza delle autorità civili”. Fra le caratteristiche della riforma cluniacense che hanno portato ad un “profondo rinnovamento della vita monastica”, il Papa ha menzionato la “tanta importanza” riservata alla liturgia. “Per custodire e alimentare il clima di preghiera”, ha aggiunto il Pontefice, l’Ordine di Cluny “accentuò l’importanza del silenzio, a cui i monaci si sottoponevano volentieri, convinti che la purezza delle virtù a cui aspiravano richiedessero un intimo e costante raccoglimento”. I monaci cluniacensi arricchirono, infine, il calendario liturgico, inserendovi ad esempio la festività dei Defunti.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Un incontro con Theo Angelopulos (diMario Serenellini).8 novembre 2009, di Federico La Sala
l’incontro
Uomini contro
Theo Angelopulos
 Per tutta la sua vita da regista ha teso trappole al tempo che passa. Il tempo ibernato nel marmo della sua Grecia e quello del Novecento che ha vissuto da protagonista. E oggi che l’Europa affonda nella sua mancanza di identità, ripete: "Siamo sempre alla storia di Omero, all’Odissea, si decide di partire e si finisce per tornare. Anche se non si sa, alla fine, se si è tornati davvero"
Per tutta la sua vita da regista ha teso trappole al tempo che passa. Il tempo ibernato nel marmo della sua Grecia e quello del Novecento che ha vissuto da protagonista. E oggi che l’Europa affonda nella sua mancanza di identità, ripete: "Siamo sempre alla storia di Omero, all’Odissea, si decide di partire e si finisce per tornare. Anche se non si sa, alla fine, se si è tornati davvero" Credevamo che saremmo rinati a nuova vita, ma tutto quello che ci aspettavamo di fare e di ottenere è precipitato Non siamo riusciti a cambiare il mondo
Credevamo che saremmo rinati a nuova vita, ma tutto quello che ci aspettavamo di fare e di ottenere è precipitato Non siamo riusciti a cambiare il mondodi Mario Serenellini(la Repubblica, 08.11.2009)
MONTREAL . «Tutto esiste già prima di un film: linee, forme, ritmi, la musica che ci portiamo dentro. Realizzare un’opera d’arte significa ritrovare questo tutto preesistente. Non al cinquanta per cento, altrimenti è un fallimento, ma al cento per cento». Nel suo quasi mezzo secolo di cinema, Theo Angelopoulos ha ogni volta cercato d’inghiottire per intero quel tutto e, film dopo film, di riconsegnarcelo intatto: non solo negli intrecci spaziali, ma nella sua anima più intima e inafferrabile, il tempo. Angelopoulos, per tutta la vita, ha teso trappole al tempo. Contraendolo in simultaneità visionarie («Il passato è solo il presente in altra forma», dice, citando Brecht) o, talvolta, cogliendolo di sorpresa, strappando alla sua immutabile, regolata macina d’ore supplementi inattesi, tipo L’eternità e un giorno. Tutto, nel cinema di Angelopoulos, è tempo e oltre il tempo, come quel giorno in più, aggiunto a un cronologico infinito.
In La recita, il film di quattro ore che nel 1975 l’ha introdotto trionfalmente nel nuovo cinema europeo, quattordici anni di storia nazionale (1939-1952) diventano un viavai tra teatro, politica e vita privata, scheggia di memoria collettiva da Elettra a Hitler, dalla Resistenza all’occupazione angloamericana. Memoria che si amplifica nei film successivi, da Viaggio a Citera a Un paesaggio nella nebbia, a Lo sguardo di Ulisse, disponendo i tasselli di ieri sempre più lontani e di domani incombenti in un eterno presente: «In Grecia il passato è solido marmo, è presente sempre, sin dalla nascita, sia nella gente comune che nei poeti, come Kavafis, Seferis, che non han fatto che dialogare con l’antichità. Nel mio nuovo film, La polvere del tempo, è come se il tempo non esistesse e tutto fosse al presente. Come scrive Eliot, il tempo non è passato né futuro ma presente: il presente è il futuro al passato».
Proiettato a Montreal al Festival des Films du Monde, dopo la partecipazione alla Berlinale, secondo episodio dell’ennesima trilogia sui "sogni infranti", aperta nel 2004 da La sorgente del fiume, il film è una saga visiva sulla perdita di ogni illusione di un mondo migliore, riassunta dalla sequenza glaciale, all’alba del Duemila, della neve che cade silenziosa su una Berlino deserta e un’era consunta.
La polvere del tempo, coprodotto dall’Italia, è un nuovo, lungo viaggio dentro la storia, dilatato al Novecento più sanguinoso e cieco, nazismo, Stalin, Vietnam, fino alla caduta del Muro di Berlino. «Sono un maratoneta del cinema», scherza il regista greco, accolto dal pubblico canadese con una standing ovation alla prima del film. «A Maratona ho la mia casa di campagna, scampata di poco all’incendio che ha devastato la nostra estate. I miei film sono percorsi tenaci, senza traguardi possibili, dentro il mio secolo, devastato da altri incendi, altre tragedie. Il Novecento è la mia storia. Sono nato ad Atene il 27 aprile 1935 e mi sono trovato faccia a faccia con la prima dittatura in Grecia, quella del generale Matexas. Trentadue anni dopo, golpe e regime Papadopoulos. Poi, la destra di Karamanlis. Ora riecco Papandreu, che però non ha nulla a che fare con la politica di suo padre. Ogni volta, impossibile rimanere solo spettatori: sono avvenimenti di cui abbiamo subìto ogni minima conseguenza, i greci, la mia famiglia, io. La mia vita s’è iscritta in questa vergogna, come quella di mia madre, delle nostre famiglie: ecco la storia, la nostra e quella degli altri».
La sua, in particolare? «Ad Atene ho seguito i corsi di diritto, ma senza l’ambizione di divenire avvocato. È stato solo un modo di congelare l’attesa, prima di partire. Mi sono sorbito anche il servizio di leva: due anni. È stata la prima volta che mi sono sentito lontano dalla Grecia, Paese di luce, dove, secondo i più allettanti slogan turistici, il sole splende sempre. Da soldato, sono stato sballottato in posti senza sole, senza amici, ricoperti di neve e solitudine».
La fuga? «A venticinque anni. Sono partito con il biglietto in tasca: e nient’altro. Sono arrivato a Parigi, nel 1960, in piena Nouvelle Vague, utopia di cinema, di cultura, di politica. Ognuno aveva l’impressione che tutto sarebbe cambiato, che saremmo rinati a nuova vita».
E invece? «Quel che oggi gli spettatori apprezzano nel mio cinema, cioè l’afflato poetico, un lirismo estenuato, è solo un profondo senso di disillusione: tutto quel che ci aspettavamo di fare e di ottenere è precipitato, non siamo riusciti a cambiare il mondo.
Anche La polvere del tempo, come i film precedenti, è una dichiarazione di disfatta: se il pubblico non lo percepisce, è perché, come diceva François Truffaut, il cinema è sempre meno di quel che abbiamo voluto dire. In quella Parigi di paradiso, ho trascorso quattro anni, seguendo corsi di letteratura e antropologia alla Sorbonne e studiando cinema all’Idhec, dove ho conosciuto Jean Rouch. Sono tornato in Grecia nel 1964, critico cinematografico d’un quotidiano di sinistra, Allaghi, chiuso tre anni dopo dai colonnelli».
Spezzata la stagione di critico, inizia quella di cineasta, già assaggiata con un paio di corti e prove d’attore. «Sono passato dietro la cinepresa per fare politica sotto forma di cinema, con ampio ricorso, dati i tempi, alla metafora. Sin dal primo titolo, nel 1970, Ricostruzione di un delitto, girato con una manciata di soldi, in bianco e nero, in acrobatica clandestinità, ho inserito numerose allusioni alla Grecia contemporanea. Prima proiezione, al Forum della Berlinale, dove l’ho portato senza permesso, le pizze nascoste in una valigia di metallo. In Grecia, dove ho poi partecipato al Festival di Salonicco, sono rientrato senza più preoccuparmi di occultare le pizze. La condizione di clandestinità che ha segnato le riprese di vari miei film, l’ho trovata sempre eccitante: avevo l’impressione di prender parte, in altro modo, alla Resistenza. Sensazione captata da alcune scuole di cinema, come prova il giudizio espresso da Andrzey Wayda quando ha visto La recita a Parigi: "È fondamentale che il film sia stato girato in clandestinità, costruendosi all’interno di sé"».
Clandestino è oggi l’allarme d’una realtà più cruda, che non riguarda più il cinema ma la nostra quotidianità, in Italia come in Grecia. «Il mio Paese non è l’ultimo approdo, ma solo una tappa dell’immigrazione che si rovescia sull’Europa. Da noi arrivano dalla Turchia, in fuga soprattutto dall’Afghanistan, esodo iniziato quando gli Usa vi hanno portato la guerra. Sono soprattutto i giovani che partono, per non morire nel proprio Paese. Purtroppo, è stato ora distrutto un villaggio di rifugiati a Patrasso, punto di partenza, magari su camion di trasporto merci dove i clandestini spesso soccombono, per l’Italia e altri paesi del miraggio-Europa. È l’Unione Europea che dovrebbe intervenire, affrontando il problema di questi viaggi della morte, stabilendo regole precise contro le attuali allergie razziste agli sbarchi».
Il suo cinema è stato subito sensibile a queste emergenze. «Come ignorarle? Stiamo attraversando un periodo di grandi immigrazioni, come nel Medioevo. Fin dal 1991, con Il passo sospeso della cicogna, ambientato in un villaggio straripante di rifugiati, alla frontiera di due paesi immaginari, ero ricorso al paradosso per mostrare l’assurdo delle divisioni artificiali, razziali, religiose, politiche, tra gli uomini, facendo unire in matrimonio gli sposi, uno al di qua, l’altro al di là del confine. L’idea m’era venuta durante un viaggio a New York, quando ho visto nel Bronx due neri che in perfetta sincronia danzavano ai due lati opposti d’una strada. Ciò mostra tra l’altro l’imprevedibilità dell’ispirazione. Occorre avere sempre occhi aperti e mente sveglia: solo se si è ricettivi si riceve».
Non è anche Angelopoulos, con i suoi viaggi continui, gli espatri, gli andirivieni grande schermo tra miti antichi e realtà contemporanea, un uomo diviso, di frontiera? «Non ho mai lasciato davvero la Grecia, se non per studi o per lavoro. Viaggio molto, è vero, ma in una maniera che definirei brutale: due giorni in un posto, e via. Attraversare un paese: l’espressione abituale per definire un viaggio va presa, nel mio caso, alla lettera. La mia identità è dunque integra. Ma da rivedere alla luce di quel che mi hanno fatto capire in Sardegna, quando ho presentato Alessandro il Grande all’Università di Cagliari: "Non c’è Grecia, non c’è Italia, non c’è Spagna né Francia, c’è il Mediterraneo. Quel che conta è l’affinità di temperamenti". Dunque, dovrei definirmi, prima ancora che greco, meridionale. Sarà per questo che mi sono divenuti subito familiari, quasi fratelli, gli attori italiani con cui ho lavorato, Omero Antonutti, Marcello Mastroianni, Gian Maria Volonté, e il mio sceneggiatore del cuore, Tonino Guerra. E sarà soprattutto per questo che un caffè così, non riesco proprio a berlo!», ride Angelopoulos, fissando il suo espresso canadese, derelitto sul fondo d’una tazza gigante.
Il suo cinema non è anche una risposta a questo caffè, ibrido clone? Attento alle ferite del distacco, della distanza, spaziale e temporale, non è un cinema d’esilio, magari interiore? «Heidegger dice che la nostra identità è la lingua di nostra madre. Ma anche l’aroma dell’infanzia, i suoni, i visi, i profumi, contribuiscono a creare un’identità, che non è, si voglia o no, quella dichiarata. Siamo sempre alla storia di Omero, all’Odissea: si decide di partire e si finisce per tornare. Anche se non si sa, alla fine, se si è tornati davvero».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- No a crocifisso in classe Strasburgo: lede libertà. E’ quanto ha stabilito oggi la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo nella sentenza su un ricorso presentato da una cittadina italiana.3 novembre 2009, di Federico La Sala
 No a crocifisso in classe Strasburgo: lede libertà
No a crocifisso in classe Strasburgo: lede libertà
 Il Vaticano, "Dobbiamo valutare la sentenza"
Il Vaticano, "Dobbiamo valutare la sentenza" Ansa03 novembre, 15:29
Ansa03 novembre, 15:29STRASBURGO - La presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche costituisce "una violazione dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni" e una violazione alla "libertà di religione degli alunni". E’ quanto ha stabilito oggi la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo nella sentenza su un ricorso presentato da una cittadina italiana.
Il caso era stato sollevato da Soile Lautsi, cittadina italiana originaria della Finlandia, che nel 2002 aveva chiesto all’istituto statale "Vittorino da Feltre" di Abano Terme (Padova), frequentato dai suoi due figli, di togliere i crocefissi dalle aule. A nulla, in precedenza, erano valsi i suoi ricorsi davanti ai tribunali in Italia. Ora i giudici di Strasburgo le hanno dato ragione.
La sentenza emessa oggi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sul ricorso presentato da Soile Lautsi, cittadina italiana di origine finlandese, contro l’esposizione dei crocefissi nelle scuole ha previsto che il governo italiano dovrà pagare alla donna un risarcimento di cinquemila euro per danni morali. La sentenza, rende noto l’ufficio stampa della Corte, è la prima in assoluto in materia di esposizione dei simboli religiosi nelle aule scolastiche.
Il governo italiano ricorrera’ contro la sentenza emessa oggi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo relativa al caso dei crocifissi nelle aule scolastiche. Lo ha dichiarato all’ANSA il giudice Nicola Lettieri, che difende l’Italia davanti alla Corte di Strasburgo. Se la Corte accoglierà il ricorso del governo italiano, il caso verrà ridiscusso nella Grande Camera. Qualora il ricorso del governo non dovesse essere accolto, la sentenza emessa oggi diverrà definitiva tra tre mesi, e allora spetterà al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa decidere, entro sei mesi, quali azioni il governo italiano deve prendere per non incorrere in ulteriori violazioni legate alla presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche.
"Per noi è una novità. Prenderemo visione della sentenza poi la scuola prenderà una decisione": questa la posizione espressa dalla dirigenza della scuola media "Vittorino da Feltre", ad Abano Terme (Padova), di fronte al pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla vicenda dei crocifissi nelle classi. Una questione sollevata nel 2002 da Soile Lautsi, una donna finlandese ma residente e sposata in Italia da una ventina d’anni, i cui figli frequentavano all’epoca l’istituto padovano. "Chiaramente - dicono ancora dalla scuola - i figli della signora non sono più qui. Speriamo che adesso siano all’Università. In ogni caso abbiamo tenuto sempre ferma la disponibilità alle decisioni di legge che sono state prese sulla vicenda sollevata dalla madre degli alunni". Un iter giudiziario che il consiglio di Stato nel 2006 aveva in qualche modo chiuso con una sentenza che indicava il valore di simbolo del crocifisso anche su un piano di valori civili.
NO COMMENT DAL VATICANO, PER LA CEI DECISIONE ’IRRESPONSABILE’
Il Vaticano vuole leggere la motivazione, prima di pronunciarsi sulla sentenza oggi della Corte europea di Strasburgo che ha condannato la presenza dei crocifissi nelle aule come una "violazione" delle convinzioni religiose dei genitori. "Credo che ci voglia una riflessione, prima di commentare", ha detto padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede, durante una conferenza stampa per presentare un prossimo convegno sull’immigrazione. Anche mons. Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio consiglio della pastorale per i migranti, presente in conferenza stampa, si è unito alla linea di padre Federico Lombardi. "Preferisco non parlare della questione del crocifisso perché sono cose che mi danno molto fastidio", ha detto di fronte alle insistenze dei giornalisti. Prima di commentare la sentenza della corte di Strasburgo, mons. Veglio’ ha premesso che ’’e’ una fortuna vivere in un mondo multiculturale’’ e che la convivenza tra diverse religioni ’’e’ una ricchezza’’. Tuttavia a proposito del ’no’ europeo al crocifisso nelle aule italiane il presule ha ribadito che la sentenza ’’e’ un po’ forte’’ e lo infastidisce perche’ ’’l’identita’ nostra bisogna pure conservarla’’. Pur affermando di rispettare comunque le decisioni della giustizia, ha aggiunto di sperare che si trovi una soluzione per preservare la cultura di un Paese.
Il crocifisso rappresenta "una dimensione anche di peso culturale ed educativo che è davvero irresponsabile voler cancellare". Lo ha affermato in un’intervista alla Radio Vaticana, mons. Vincenzo Paglia, responsabile della commissione Cei per il dialogo interculturale, commentando la sentenza della Corte europea di Strasburgo. "A me pare - ha aggiunto mons. Paglia a proposito della sentenza - che parta da un presupposto di una debolezza umanistica oltre che religiosa del tutto evidente: perché la laicità - ha spiegato - non è l’assenza di simboli religiosi ma la capacità di accoglierli e di sostenerli di fronte al vuoto etico e morale che spesso noi vediamo anche nei nostri ragazzi". "Pensare di venire in loro aiuto facendo tabula rasa di tutto - ha proseguito - mi pare davvero miope anche perché presuppone una concezione di cultura che è libera solo nella misura in cui non ha nulla o ha solo quello che rimane sradicando da ogni storia, tradizione, patrimonio". Il presule ha ricordato che i luoghi pubblici italiani sono stracolmi di crocefissi: "non credo - ha osservato - che ci sia nessuno che pretenda di distruggere i simboli religiosi nelle strade e nelle piazze italiane perché levano la libertà di religione". Mons. Paglia, responsabile Cei per il dialogo interreligioso (e non interculturale come scritto precedentemente), ha respinto l’argomentazione secondo cui il crocifisso nelle aule scolastiche rappresenti un’imposizione. "Non lo credo - ha spiegato -. E’ un ricordo di che cosa accade all’uomo quando la giustizia non viene rispettata e da cui emerge un valore di gratuità di cui tutti abbiamo bisogno a qualunque fede appartiamo". "In questo senso - ha concluso - c’é una dimensione anche di peso culturale ed educativo che è irresponsabile davvero voler cancellare".
GELMINI, RAPPRESENTA TRADIZIONI
"La presenza del crocifisso in classe non significa adesione al cattolicesimo ma è un simbolo della nostra tradizione". Lo ha affermato il ministro dell’istruzione Mariastella Gelmini in relazione alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo sulla presenza del crocifisso nelle classi.
CORO DI NO DAL CENTRODESTRA
"In attesa di conoscere le motivazioni attraverso le quali la Corte di Strasburgo ha deciso che i crocifissi offenderebbero la sensibilità dei non cristiani, non posso che schierarmi con tutti coloro, credenti e non, religiosi e non, cristiani e non, che si sentono offesi da una sentenza astratta e fintamente democratica". Così il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia interviene in merito alla notizia della sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo sui crocefissi nelle scuole. "Chi offende i sentimenti dei popoli europei nati dal cristianesimo è senza dubbio la Corte di Strasburgo. Senza identità non ci sono popoli, e senza cristianesimo non ci sarebbe l’Europa. Che destino paradossale: proprio coloro che dovrebbero tutelare il senso comune si danno da fare per scardinare la nostra civiltà. Si vergognino!".
’’Trovo assurda e gravissima la sentenza della Corte di Strasburgo contro la presenza del crocefisso nelle scuole italiane. Gia’ il Tar ed il Consiglio di Stato si erano pronunciati sulla vicenda rigettando le richieste della cittadina finlandese e dichiarando che: ’il crocifisso e’ il simbolo della storia e della cultura italiana, e di conseguenza dell’identita’ del Paese, ed e’ il simbolo dei principi di eguaglianza, liberta’ e tolleranza e del secolarismo dello Stato.’ Un pronunciamento ineccepibile che viene completamente sovvertito dalla Corte europea’’. E’ quanto dice Gabriella Carlucci, vice Presidente della Commissione Bicamerale per l’Infanzia. ’’Ancora una volta un organismo europeo, entra a gamba tesa nelle questioni interne del nostro Paese, calpestando valori e principi su cui si fondano la nostra societa’, la nostra cultura, la nostra identita’. Lo Stato italiano deve opporsi in giudizio a questo pericolosissimo precedente’’, conclude.
’’La Corte europea dei diritti dell’uomo, con questa sentenza, ha calpestato i nostri diritti, la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni e i nostri valori. In ogni caso, i crocifissi da noi resteranno sulle pareti delle nostre scuole, dove sono sempre stati, cosi’ come continueremo ad avere i presepi o a festeggiare il Natale. Perche’ siamo orgogliosi di questi nostri simboli e del loro significato e perche’ fanno parte di ognuno di noi’’. Lo afferma Roberto Calderoli, ministro per la Semplificazione Legislativa commentando la sentenza della Corte europea di Strasburgo.
CASINI, CONSEGUENZA PAVIDITA’ UE
"La scelta della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di bocciare la presenza del crocifisso nelle scuole è la prima conseguenza della pavidità dei governanti europei, che si sono rifiutati di menzionare le radici cristiane nella Costituzione Europea". Lo afferma il leader dell’Udc Pier Ferdinando Casini in un’intervista al Tg2. "Comunque, nessun crocifisso nelle aule scolastiche ha mai violato la nostra libertà religiosa, né la crescita e la libera professione delle fedi religiose. Quel simbolo - conclude - è un patrimonio civile di tutti gli italiani, perché è il segno dell’identità cristiana dell’Italia e anche dell’Europa".
MURA (IDV), ADEGUARE SCUOLA A SOCIETA’ MULTIETNICA
"La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo può legittimamente suscitare reazioni di segno profondamente diverso motivate da un lato dalla tradizione, dalla storia e dalla cultura del nostro paese, dall’altro invece da una sentenza, approvata all’unanimità, da un autorevole tribunale europeo. Ma la cosa più sbagliata che si può fare è quella di dar vita ad una accesa battaglia tra chi vuole il crocifisso nelle aule e chi non lo vuole, perché non è questo il vero problema da risolvere nella scuola italiana". Lo dichiara Silvana Mura, deputata di Idv. "La questione fondamentale invece riguarda una scuola destinata ad avere studenti che sempre di più saranno di etnie e culture diverse. L’offesa nei confronti di studenti di religioni diverse da quella cattolica non credo sia rappresentata tanto da un crocifisso appeso al muro, ma piuttosto da programmi che non si pongano il problema di conciliare le caratteristiche fondamentali che l’insegnamento di stato deve avere con la nuova realtà multiculturale e multietnica che in futuro sarà rappresentata dagli studenti della scuola italiana", conclude.
FRANCO (PD), E’ RISPETTO LIBERTA’ RELIGIOSA
"Il crocifisso non è e non può essere considerato unicamente espressione delle tradizioni italiane, come sostiene il ministro Gelmini, a meno di non voler svalutare questo simbolo religioso. Certo, fa parte della nostra storia. Ma di fronte a questa sentenza è chiaro che occorre riflettere sui modi migliori di promuovere la convivenza civile tra la molteciplicità di culture e religioni che caratterizzano attualmente la popolazione che vive in Italia". Lo dice la senatrice Vittoria Franco, responsabile nazionale Pari Opportunità del Pd. "Invece di arroccarsi nella difesa e nella conservazione - prosegue Vittoria Franco - la vera riflessione da promuovere è come arrivare a favorire ancora meglio, nelle nostre scuole che ospitano da tempo bambini portatori di molteplici culture e religioni, la convivenza pacifica e il rispetto. Mi sorprende dunque il ministro Gelmini, che si preoccupa delle tradizioni anziché pensare al fatto che le classi italiane sono multietniche da tempo. La Corte europea - ha concluso Vittoria Franco - ha semplicemente richiesto allo Stato italiano il rispetto della libertà religiosa e non mi pare che questo sia in contrasto con la nostra Costituzione come sostiene il ministro Gelmini".
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- ACROPOLI. Inaugurato ad Atene il nuovo museo che ospita i marmi del Partenone I greci tornano a chiedere la restituzione dei tesori trafugati ed esposti a Londra.22 giugno 2009, di Federico La Sala
 Acropoli
Acropoli
 Ecco il museo e riparte la sfida al British
Ecco il museo e riparte la sfida al British Inaugurato ad Atene il gigantesco spazio che ospita i marmi del Partenone I greci tornano a chiedere la restituzione dei tesori trafugati ed esposti a Londra
Inaugurato ad Atene il gigantesco spazio che ospita i marmi del Partenone I greci tornano a chiedere la restituzione dei tesori trafugati ed esposti a Londra la Repubblica, 22.o6.2009
la Repubblica, 22.o6.2009Hanno fatto le cose in grande, all’antica: con una cerimonia solenne, evocativa. Un po’ come quando Delfi e Olimpia chiamavano qui, in Grecia, l’intero mondo di allora e tutti arrivavano. Adesso la Grecia aveva una sorpresa grande da mostrare: eccoli tutt’insieme i Marmi del Partenone, nel Nuovo Museo dell’Acropoli, ricomposti per la prima volta dopo più di due secoli dallo smembramento.
L’hanno voluta far conoscere, invitando presidenti, ministri della cultura, e Josè Manuel Barroso, presidente della Commissione europea, e il direttore generale dell’Unesco. E l’hanno spiegato a tutti che questo è il Sancta Sanctorum dell’arte ateniese e che quelle sculture messe lì, così - con gli originali incastrati tra le copie dei pezzi ancora esposti al British Museum - per loro sono ancora sacre: erano meta della processione più affollata, del rito più sentito nell’Atene democratica di Pericle. Si saliva fino al Partenone, per ringraziare, nel giorno del suo compleanno, Athena Vergine (Parthenos) di aver scelto l’Attica, di averle donato l’ulivo e assicurarsi che continuasse a benedire la sua città.
Fu proprio Pericle a voler così bello il Partenone. Due architetti - Ictino e Callicrate - in 15 anni, dal 447 al 432 a.C., glielo realizzarono, fastoso come non mai: 69 metri e 54 centimetri per 30,87, con 17 colonne di 10 metri sui lati lunghi e otto sui lati corti. Ci pensò Fidia a farne un capolavoro di arti sacre: due frontoni scolpiti; un fregio che correva tutt’intorno scandito da bassorilievi mai visti prima così belli, e 92 metope che giocavano con il sole. All’interno una statua della dea - 12 metri di oro e avorio - stupì il mondo.
Il marmo delle sculture, con i millenni, ha perso i colori squillanti con cui era dipinto: si è fatto dei toni dell’ambra, quasi terroso. E così ora - ricomposto al terzo piano del museo - ritma con evidenza il gesso candido della settantina di copie inserite tra gli originali per reintegrare le composizioni: son messe lì a denunciare - con un solo colpo d’occhio - tutte le parti squartate via. È un bianco che urla: le copie in gesso son lì, ma pronte a esser smontate via per lasciar posto agli originali.
L’appello del presidente greco Karolos Papoulias - «È tempo che i Marmi tornino a casa!» - ha segnalato che il conto alla rovescia per il rientro in patria dei reperti più contesi del mondo comincia oggi.
I Greci ce l’hanno fatta a squassare la storia infinita, con loro che supplicano, cuore in mano, e il British imperiale che nicchia, cincischia, promette, delude. Stavolta giocano duro: ci hanno investito 130 milioni di euro, puntati tutti sul progettone di Bernard Tschumi, una delle star dell’architettura mondiale che - con il collega Michael Photiadis e Dimitrios Pandermalis, archeologo classico - ha studiato il modo per sistemare oltre 4000 pezzi: fregi enormi, e ceramiche di pochi grammi, roba da cerimonia e trofei assai profani.
Adesso il nuovo museo è lì - a 300 metri dalla spianata dei templi, proprio sotto l’Acropoli inquadrata nei suoi finestroni - pronto per 10 mila visitatori al giorno. Modernissimo, pieno di luce, con pavimenti trasparenti (per mostrare uno strato archeologico che era un peccato nascondere) è pronto a dar battaglia.
Qualche scaramuccia l’ha già affrontata: c’è chi l’ha attaccato perché troppo grande, troppo caro, troppo estraneo al quartierino in cui questo mastodonte di 23 mila metri quadri è atterrato: tre parallelepipedi rettangolari sovrapposti, con l’ultimo sfalsato per esser parallelo al Partenone.
Ma l’arte greca non si era mai vista così bene come qua dentro. Le polemiche ateniesi son nulla rispetto alla missione che l’intero paese gli affida: sconfiggere le resistenze del British Museum - polverizzare l’obiezione che Atene non aveva un museo all’altezza dei Marmi - e convincere i suoi manager (lasciati soli dal governo inglese. «Fatti loro!» han detto proprio ieri) a restituire ciò che Thomas Bruce, settimo conte di Elgin, ambasciatore inglese presso la Sublime Porta, fece segar via dal Partenone, accordandosi con i Turchi che allora occupavano la Grecia.
Era il 1801 quando si cominciò a sezionarlo, pezzo a pezzo: 56 lastre dal fregio (due terzi del totale), 15 metope, enormi schegge dai frontoni, una cariatide dell’Eretteo lì a fianco, furono staccate e imbarcate per la Gran Bretagna. Il conte pensava al business. Poi nel 1816, pieno di debiti, accettò di vendere - per l’equivalente di due milioni di euro - i reperti al governo inglese che li donò al British.
La Grecia cominciò a soffrirne allora. Lord Byron soffrì con lei. «Sono testimonianze della nostra prima democrazia», protestò al mondo nel 1982 Melina Mercouri, riaprendo il contenzioso.
Sarà che gli due ultimi millenni - tra Romani, Goti, Bizantini, Turchi, Nazisti e Colonnelli - non sono andati granché, quell’Atene di Pericle, Fidia & C. che il Partenone vollero lì, così, è rimasta viva, vicina. E santa è stata sempre, per più di 20 secoli, la Rocca della Vergine. Il suo Partenone divenne la Chiesa di Nostra Signora di Atene, poi moschea. I cannoni dei veneziani, all’arrembaggio qui nel 1687, decretarono l’inizio della fine.
Il fregio del corteo sacro per Athena fissa, come in un’istantanea, chi vi partecipava: gli efebi sono tornati a cavalcare, sfilano anche i portatori d’acqua. Più in là i ragazzi con i tori per il sacrificio. Ma i primi sono copie, i secondi son quelli originali, i terzi - anch’essi bianchissimi - riproduzioni. Ed è qui, al terzo piano - di fronte alla materializzazione anche cromatica di una separazione grottesca, con mezzo Partenone qui e mezzo lì, a 2000 chilometri - che il nuovo museo vince la guerra psicologica per cui è nato.
Il direttore del British Museum - pur invitato - non era presente all’inaugurazione.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Atene. Apre il super museo dell’Acropoli. Oggi il debutto, ma i marmi del Partenone restano in Gran Bretagna20 giugno 2009, di Federico La Sala
Atene
Inaugurazione dopo 30 anni. Il British Museum: vi prestiamo i pezzi mancanti se riconoscete che sono nostri
Apre il super museo dell’Acropoli
Oggi il debutto, ma i marmi del Partenone restano in Gran Bretagna
di Antonio Ferrari (Corriere della Sera, 20.06.2009)
ATENE - L’ombra sinistra dello scozzese Thomas Bruce, settimo conte di Elgin, che nel 1799 fu nominato ambasciatore britannico presso il sultano di Costantinopoli, si allunga e violenta la luce che illumina le vetrate del nuovo museo dell’Acropoli, che verrà inaugurato stamane. È un’ombra sinistra perché Lord Elgin, con il permesso dell’impero ottomano, che allora occupava la Grecia, sottrasse dalla collina più celebre del mondo le statue più preziose, per inviarle a Londra. Dove si trovano ancora, esposte al British Museum.
Decenni di sforzi per ottenerne la restituzione, nei quali si impegnarono da Lord Byron all’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, sono stati vani. Ma i greci non hanno intenzione di rinunciare. Anzi, l’inaugurazione di stamane, di fronte ad alcuni potenti della terra, è diventata l’occasione per rilanciare l’operazione-recupero, con la speranza di vederla realizzata in occasione delle Olimpiadi del 2012, che si svolgeranno a Londra. Far tornare a casa i preziosi marmi, quando il mondo celebrerà l’ennesima festa dello sport, nata nell’antica Grecia, sarebbe davvero un bel gesto. Ma sul risultato è assai azzardato scommettere.
Per Atene le Olimpiadi, il Partenone, l’Ortodossia, la bandiera e i confini nazionali sono valori che non conoscono schieramenti politici né sociali. Per difenderli, l’orgoglioso Paese è pronto a tutto. Pur di cancellare, proprio con la vicenda dei marmi rimossi, quello che è stato definito un «crimine culturale». Un conto, infatti, è l’asportazione di opere d’arte nella loro interezza, come è accaduto durante tutte le guerre, le rivoluzioni, e le occupazioni. Un conto è mutilare un corpo unico delle sue parti, come è accaduto con il Partenone. Ecco perché l’inaugurazione del Museo dell’Acropoli (3 livelli; 21000 metri quadrati, di cui 14000 riservati all’esposizione), ideato dall’architetto franco-svizzero Bernard Tschumi, è diventata la rampa di lancio dell’attacco decisivo a un recupero che i greci ritengono non possibile ma doveroso.
Per ora i contatti con Londra sono gelidi. Il British Museum ha annunciato d’essere disponibile alla restituzione dei marmi, in cambio di un accordo che ne garantisca la proprietà. Come dire: noi ve li prestiamo, ma sono nostri. La risposta è stata un rifiuto secco. La Grecia avanza un nugolo di ragioni, e non soltanto perché quello compiuto da Lord Elgin viene ritenuto quasi un tollerato furto, visto che il sultano di Costantinopoli fu spinto ad accettare la richiesta dell’ambasciatore per piaggeria nei confronti di Londra; ma perché, più volte, la Gran Bretagna aveva opposto alle reiterate pressioni una sola risposta: «Nessun luogo in Grecia è adatto per difendere e proteggere dall’incuria del tempo le statue». Questa poteva essere una comprensibile giustificazione. Ma dopo aver atteso 30 anni, Atene oggi può offrire il più grande e moderno museo del pianeta, ai piedi dell’Acropoli, per offrire un confortevole, sicuro e definitivo rifugio ai suoi preziosi cimeli.
La Grecia è attraversata, in queste ore, da brividi di orgoglio nazionale, che non si avvertivano dal 2004 quando, in pochi mesi, la squadra di calcio vinse a sorpresa l’Europeo, e i giochi olimpici, dopo un’attesa durata oltre cent’anni, tornarono a casa e offrirono un’edizione che tutti gli osservatori, persino coloro che ironizzavano sulle capacità organizzative del Paese, giudicarono perfetti, spendendo giudizi ammirati. Ora la battaglia è sui marmi del Partenone, e se si fa un pensiero all’ostinazione di Atene nell’impedire che la repubblica ex-jugoslava di Macedonia possa fregiarsi del titolo di Macedonia (come il nome storico della regione greca dove nacque Alessandro Magno) si può concludere che pensare a qualche parziale compromesso è quasi impossibile.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Atene inaugura il nuovo museo dell’Acropoli (di Stefano Miliani).18 giugno 2009, di Federico La Sala
La battaglia diplomatica
Atene inaugura il nuovo museo dell’Acropoli
di Stefano Miliani *
Più o meno 2.500 anni fa la democrazia ateniese guidata da Pericle costruì il tempio alla dea Atena: il Partenone, che nell’equilibrio, nella misura e nella bellezza delle colonne e delle sculture ha trasmesso l’idea della civiltà e del pensiero in cui nasceva la concezione della democrazia ancora oggi così spesso tradita e vilipesa. Era il V secolo A. C., Ictino fu l’architetto, Fidia lo scultore principale di capolavori in parte perduti. Sabato 20 giugno Atene inaugura il nuovo museo dell’Acropoli a 300 metri a sud est dal tempio: è un edificio inondato di luce filtrata da ampie vetrate, fatto di marmi, cemento e colonne d’acciaio e l’apertura riaccende una questione che investe la diplomazia e perfino l’idea di democrazia stessa. La faccenda riguarda le parti del Fregio che decoravano il Partenone conservate al British Museum di Londra e chiamate “marmi di Elgin”.
La questione è: la Gran Bretagna dovrebbe restituire quei i marmi alla Grecia? È democratico che non restituisca quanto prese a inizio ’800 lord Elgin? Il nuovo museo, e un documentato libro di un giornalista britannico, Christopher Hitchens, danno un robusto sostegno al partito del sì. L’istituto londinese continua a trincerarsi dietro il “no”.
Partiamo dal museo: sostituisce quella trista raccolta in un edificio accanto al tempio, è vicinissimo al Partenone, nella zona di Makryianni, l’ha progettato lo studio dell’architetto svizzero Bernard Tschumi, ha tre piani principali e due intermediari, 14mila metri quadri di superficie espositiva, un’intera facciata di vetro. Nell’orientamento rispecchia la pianta del Partenone. Espone statue, vasi, il tesoro di Afrodite, cariatidi e quant’altro dall’antichità in poi. Soprattutto ha una galleria per il Fregio ricomposto nelle parti originali aggiungendovi, in copia, quelle di Londra. Il Fregio infatti era formato da 115 blocchi. In tutto era lungo 160 metri e alto appena più di un metro. Raffigura 378 figure umane e divinità dai corpi e dai panneggi stupendi e oltre 200 animali. È una processione sacra che porta agli ateniesi il culto di Atena. Di questo Fregio scolpito da Fidia e dai suoi aiutanti una cinquantina di metri è nell’Acropoli, un’ottantina di metri (con sculture non meno notevoli e commoventi) è al British, un blocco è al Louvre, frammenti vari sono a Palermo, in Vaticano, ad Heidelberg, Vienna e Monaco. Dai primi anni 80, a partire da Melina Mercouri quando era ministro per la cultura, la Grecia ha insistito per riavere il resto del Fregio. Invano.
Londra ha sempre risposto negativamente. Con varie motivazioni. Una è che al British quei marmi sono più al sicuro e si sono conservati meglio al riparo, ad esempio, dall’inquinamento terribile di Atene. Poi la restituzione creerebbe un “precedente”: ogni museo del mondo rischia di essere svuotato, e rischiano di trionfare le rivendicazioni puramente nazionaliste, se ogni paese rivuole indietro opere uscite dai confini nel passato remoto. Altro argomento: a Londra l’hanno visto e possono vederlo più persone che non ad Atene, della qual cosa ha beneficiato la conoscenza delle arti classiche. Ancora: i “Marmi Elgin” sono al museo dal 1817 dove si entra gratis: quindi sono per tutti. I Trustees del British ribadiscono: “Le sculture appartengono all’umanità e trascendono i confini nazionali. L’attuale divisione dell’opera permette di raccontare storie diverse e complementari, affermando inoltre l’eredità universale dell’antica Grecia”. Prima veniva anche detto che Atene non aveva un posto adatto per tutto il Fregio. Vero. Ma ora ce l’ha.
Il presunto atto di acquisto di Elgin. Tra il 1801 e l’inizio del 1803 lord Elgin, ambasciatore di sua Maestà presso l’impero ottomano, stacca - causando danni - e sega pezzi del Partenone per portarseli in Scozia insieme a reperti da Corinto, Micene e altri siti. Ufficialmente ha avuto un’autorizzazione, un “firmano”, dall’autorità turca che allora dominava la Grecia. Nel suo libro I marmi del Partenone (uscito ora in italiano per Fazi Editore, 163 pagine, 19,50 euro) Christopher Hitchens dimostra due o tre fatterelli di un discreto rilievo. Primo: Elgin agì per interesse personale e vendette le sculture al British solo in seconda battuta dovendo pagare debiti al Regno. Secondo fatterello, fondamentale: per ragioni di politica internazionale contingente lord Elgin ebbe un “firmano”, ovvero un’autorizzazione ufficiale dai turchi. Intanto - domanda Hitchens - come può avere forza morale un permesso concesso dagli occupanti ottomani ai danni degli occupati? Elgin, insiste citando lettere e documenti, agì “per cupidigia”, perché voleva abbellire la sua dimora in Scozia, non per amore dell’arte. Ma il punto più grave è che, scrive il giornalista comparando fatti e datte, quel permesso sarebbe stato scritto a posteriori, cioè dopo la razzia, non prima. Infine ricorda: il Fregio non è un quadro, racconta una storia, è un poema per immagini brutalmente interrotto. Non andrebbe ricomposto?
Diplomaticamente, i responsabili del museo a partire dal curatore Dimitrios Pandermalis fanno rispondere a l’Unità di non voler dichiarare nulla in proposito. Tacitamente però sanno di incassare, con questo edificio, un bel credito sulla scena internazionale. Conoscono il anche il libro e se ne rallegrano. Tanto più che l’ha scritto un cittadino britannico. Siglando un gol in casa avversaria, calcisticamente parlando.
Info pratiche: Il nuovo museo dell’ACropoli apre al pubblico da domenica 21 al 23 solo a chi ha comprato un e-ticket, dal 24 biglietti normali. Fino al 31 dicembre 2009 l’ingresso costa un euro. Orario 8-20 chiuso lunedì. www.newacropolismuseum.gr
Le foto del museo e delle sue opere sono di Nikos Daniilidis, Nuovo Museo dell’Acropoli, Atene
* l’Unità, 18 giugno 2009
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- "Serve più Europa, non meno Europa". Questa la presa di posizione dei Presidenti di Italia, Germania, Austria, Portogallo ed Ungheria che hanno partecipato al Vertice informale di Napoli.16 giugno 2009, di Federico La Sala
Concluso il Vertice informale dei cinque Capi di Stato a Napoli: "Serve più Europa, non meno Europa". *
"Serve più Europa, non meno Europa". Questa la presa di posizione dei Presidenti di Italia, Germania, Austria, Portogallo ed Ungheria che hanno partecipato al Vertice informale di Napoli. Giorgio Napolitano, Horst Koheler, Heinz Fischer, Laszlo Solyom ed Anibal Cavaco Silva hanno espresso la comune preoccupazione per la bassa partecipazione alle elezioni europee del 6 e 7 giugno.
Il Presidente Napolitano, riferendo in una conferenza stampa la posizione comune ai cinque Capi di Stato europei, ha rilevato che spesso "i cittadini europei vedono l’Europa come un capro espiatorio". Di qui l’auspicio di "un coinvolgimento più forte e sistematico che si basi su un coinvolgimento che parta dal basso verso l’alto", con una "nuova motivazione, una più ampia visione del progetto europeo".
Il Presidente Napolitano ha anche espresso l’apprezzamento per "l’orientamento annunciato dal nuovo Presidente americano Obama durante il recente viaggio in Europa a favore di un nuovo round negoziale per il disarmo nucleare e anche per il suo orientamento a ricercare sempre soluzioni negoziali alternative all’impiego della forza nelle crisi internazionali". "Lo facciamo - ha spiegato Napolitano - vedendo maggiori opportunità per l’Europa di svolgere il proprio ruolo" senza sottovalutare "le responsabilità proprie dell’Europa su tutti i piani anche riguardo alla politica di sicurezza comune".
Rispondendo alla domanda di un giornalista, il Presidente Napolitano ha detto: "Dobbiamo aver fiducia nell’attaccamento dei nostri popoli e delle nostre opinioni pubbliche ai principi liberali e democratici su cui poggia la Costituzione europea, compreso e non ultimo il principio della libertà e del pluralismo dell’informazione".
* Fonte: Sito della Presidenza della Repubblica.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Il problema dell’Europa è la demenza senile (di Franco Berardi - "Bifo")11 giugno 2009, di Federico La Sala
Il problema dell’Europa è la demenza senile
di Franco Berardi Bifo
[11 Giugno 2009]
Non sempre ci sono spiragli. In Europa ora è chiaro, di spiragli non ce n’è più. Non ho mai creduto in quella vecchia pippa dell’ottimismo della volontà. L’ottimismo della volontà è isterismo.
Quello che ora ci occorre è una intelligenza spregiudicata e coraggiosa.
Il problema d’Europa non è politico. Il problema d’Europa è la demenza senile. L’epoca moderna realizzò un equilibrio delicatissimo tra sfera del conoscibile, infosfera e ragione. La volontà politica agiva razionalmente perché questo equilibrio lo rendeva possibile.
L’accelerazione dell’emissione semiotica, l’infittirsi dell’Infosfera hanno prodotto alla lunga un effetto di sovraccarico, di indecidibilità ansiogena, di panico. Al tempo stesso l’Europa è invecchiata abnormemente. Si tratta di un problema demografico, prima di tutto, ma non soltanto. Un paese di vecchi che si abbarbicano penosamente alla vita, non perché la amino, ma perché è di loro proprietà. Un paese di vecchi bisognosi di giovani badanti filippine moldave o marocchine, vecchi idioti terrorizzati dall’agilità sprezzante dei popoli giovani che hanno sofferto talmente per colpa nostra, da non temere più nessuna sofferenza.
La demenza senile [perdita di memoria, incapacità di giudizio, paura irragionevole di ciò che non si conosce] si diffonde in tutti gli ambiti generazionali di questa società culturalmente decrepita, socialmente declinante. I ventenni che votano per Beppe Grillo o per Umberto Bossi non sono meno senilmente dementi, incapaci di elaborare un pensiero che li conduca fuori dal buio in cui si aggirano psicopatici.
Come andrà a finire, ora è facile prevederlo. I vecchi sono superarmati e uccideranno. Il pogrom, la violenza, la guerra civile interetnica.
Questo è il futuro d’Europa. Dovremmo cercare un modo per tradurre in termini laici, materialisti ed autonomi quel concetto che i cristiani esprimono con la parola: rassegnazione. Cosa si fa quando non c’è più niente da fare? Come restare liberi e felici quando la demenza aggressiva si cela in ogni anfratto? Come creare zone di resistenza umana, quando una macchina da guerra è nascosta in ogni nicchia?
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Incapaci di pensare europeo (di Barbara Spinelli).7 giugno 2009, di Federico La Sala
Incapaci di pensare europeo
di BARBARA SPINELLI (La Stampa, 7/6/2009)
Possiamo già prevedere le parole che verranno dette, in molte capitali del continente, subito dopo le elezioni europee: è mancato, ancora una volta, quel che viene chiamato spirito o comune sentire europeo. In ogni Stato si vota su temi nazionali, ogni elettore tende a giudicare il proprio governo o la propria opposizione, non quello che le istituzioni europee hanno fatto o faranno. Alcuni vedranno confermata una loro persistente convinzione: non esiste un popolo - un demos - dell’Unione. L’Europa intesa come comune governo, affiancato ai governi nazionali, è un’utopia nata nell’ultima guerra che ha fatto naufragio anche se gli elementi statuali dell’edificio comunitario sono ormai inconfutabili.
Tutti questi ragionamenti hanno un difetto. La realtà, continuano a vederla attraverso l’unica lente che conoscono: quella dello Stato-nazione. Ogni giorno i fatti dimostrano che la lente è inadatta, senza tuttavia intaccare la monotona routine. È come se nella pittura fossimo rimasti alle figure bidimensionali, ricusando la prospettiva di Piero della Francesca. La vecchia lente garantisce all’osservatore comodità, sforzo minimo, potere: perché abbandonarla?
Eppure i fatti sono chiari: più della metà delle decisioni che determinano la nostra vita quotidiana non sono più prese nello spazio nazionale, ma in quello europeo; e l’Europa è imprescindibile non solo dove c’è stato trasferimento di sovranità (moneta, commercio, frontiere) ma anche in materie gelosamente custodite dagli Stati come clima, energia, immigrazione, politica estera. Infine non è vero che lo Stato, per funzionare, deve avere prima una nazione, un demos. Antonio Padoa-Schioppa, studioso di diritto europeo, ha ricordato, il 7 maggio a un convegno della Regione Lombardia, che solo nella mente dei giuristi ottocenteschi lo Stato coincide esclusivamente con la nazione: «L’analisi storica mostra che in Paesi come Francia, Inghilterra, Spagna l’identità nazionale si è formata dopo la nascita degli Stati, non prima».
Detto questo, è innegabile che lo spirito europeo sia oggi in declino: lo certifica l’astensionismo elettorale, in aumento dalla prima elezione diretta del Parlamento di Strasburgo nel 1979. Allora era il 63% a votare, oggi non più del 30-40. Particolarmente bassa è la partecipazione degli europei dell’Est, entrati da poco nell’Unione. Il fatto è che anche dove c’è spirito europeo, esso non produce affluenza alle urne né demos. Avviene anzi il contrario, e in questo il comportamento dell’Est è emblematico. Lo spirito europeo, qui, è vivo. Risale ai tempi totalitari, quando il Centro Europa, come disse nel 1983 Milan Kundera, fu «sequestrato a Est» malgrado il suo cuore e la sua storia fossero a Ovest. I cittadini bulgari, scrive il giornalista Ivo Indjev, sono tra i più europeisti nell’Unione. Tuttavia pare si asterranno in massa. Così in altre zone o ambienti dove lo spirito europeo, pur radicato, non si traduce in impegno elettorale pratico.
Lo spirito dunque non basta. Il sentire europeo può essere intenso, ma non implica, automaticamente, pensare europeo. Pensare è un’altra cosa, come spiega bene il Programma per l’Europa Politica elaborato dall’associazione Impresa Domani (Idom): un’autentica politica europea non nascerà «dalla sommatoria di debolezze nazionali», ma dovrà essere «il frutto del pensare europeo». E pensare non significa esser sensibili, ma «porsi immediatamente l’obiettivo del passaggio dei poteri a quelle istituzioni dove soltanto può formarsi un pensiero politico europeo». Non significa neppure «avere un’idea del mondo, ma avere un programma per il governo del mondo». Altrimenti abbiamo il paradosso bulgaro: più ti senti europeo, meno agisci. Non è l’unico paradosso di queste elezioni. Egualmente pernicioso è il paradosso d’un Parlamento che ha sempre più poteri (può sfiduciare la Commissione, il suo parere è vincolante su molte leggi), e nonostante ciò l’astensione cresce. Anche qui c’è discrepanza: più potere, meno pensiero.
I poveri cittadini non sono responsabili in prima linea di questi paradossi. Quando possono, reclamano un’Europa potenza. Sono responsabili gli Stati, le amministrazioni, i partiti, i giornali. Sono loro a monopolizzare l’informazione europea, a farsi impigrire dalle vecchie lenti. Negli Stati la politica è mutata radicalmente: le battaglie sono personalizzate, i partiti selezionano ormai grandi oratori, grandi caratteri. Solo le istituzioni europee rimangono immobili. Se avessero innovato, oggi voteremmo anche in Europa forti personalità, censurando i malgoverni. Ogni schieramento avrebbe un candidato alla presidenza della Commissione, e i partiti si organizzerebbero come partiti europei giudicando la scorsa legislatura. Non mancano d’altronde eccellenti candidati in pectore. Chi denuncia l’ignavia o l’opportunismo del presidente della Commissione Barroso, ad esempio, avrebbe potuto schierare europeisti come Guy Verhofstadt ex premier belga, o Pascal Lamy direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio. Una vasta coalizione impedisce tali progressi, e di essa fanno parte Stati e giornali, partiti di sinistra e di destra. Scrive ancora l’Idom: «Essere un partito europeo è avere un programma sull’Europa, un’organizzazione su base sovrannazionale, e proporre propri candidati per le istituzioni dell’Unione».
I veri utopisti sono coloro che s’illudono, credendo che lo Stato resti sovrano assoluto come immaginava nel secolo scorso Carl Schmitt. Parafrasando Keynes, «sono generalmente schiavi di qualche giurista o politologo defunto». Si definiscono realisti, ma sono abitudinari e senza inventiva. I fatti non li smuovono, staccarsi dalla routine li strema. Tra sentire e pensare usano dare il primato non al pensiero difficile ma al consolatorio, inerte sentimentalismo.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Io, quando scrivo dell’Europa, penso a un progetto ininterrotto (di Zygmunt Bauman - C’è un tesoro a Bruxeles).2 giugno 2009, di Federico La Sala
C’è un tesoro a Bruxelles
di Zygmunt Bauman *
Come possiamo rendere il mondo ospitale per gli europei? Pongo questa domanda, perché è evidente che noi, europei, nel mondo attuale non ci sentiamo a nostro agio. Heidegger dice che si comincia a riflettere su un problema quando le cose iniziano improvvisamente a comportarsi in maniera inaspettata. È solo allora che le trasferiamo dalla sfera dell’azione a quella del dibattito. Prima le cose ci vengono fornite nella nostra esperienza quotidiana, e in genere non ne avvertiamo l’esistenza. Quando invece smettono di funzionare le trasferiamo nella sfera delle complicazioni e delle incombenze.
Oggi le cose ci tirano brutti scherzi, perché ha smesso di funzionare qualcosa che prima andava benissimo. È quanto è avvenuto con l’accoglienza. L’idea dell’accoglienza è antica, ma ad attirare la mia attenzione è stato un libricino scritto da Kant nel 1784. Riflettendo sulla questione della “Perfetta unione civica del genere umano”, Kant deduceva che l’ospitalità reciproca sia decretata dalla natura, che ci ha posti sulla superficie di una sfera, quale è la Terra. Se ci muoviamo su di essa non possiamo allontanarci l’uno dall’altro - se ci allontaniamo in una direzione ci avviciniamo dall’altra - e dunque esiste un momento nella nostra storia in cui siamo condannati all’ospitalità reciproca.
Il librino se ne stava lì ancora intonso a prendere polvere nella mia biblioteca finché all’improvviso è stato riscoperto. Di colpo è venuto fuori che l’ospitalità è un problema da risolvere, che non è una cosa naturale, come poteva sembrare quando lo scrittore svizzero Denis de Rougemont affermava che l’Europa aveva scoperto i continenti, e non i continenti l’Europa, che l’Europa aveva conquistato un continente dopo l’altro, ma nessun continente l’aveva conquistata. E che infine l’Europa, essa sola, aveva inventato un modo di essere che tutti avevano trovato degno d’imitazione. Ma che lei, l’Europa, non aveva mai provato a imitare paesi ad essa estranei.
Ryszard Kapuscinski, il più grande reporter del Ventesimo secolo, capace di penetrare con rara sensibilità le correnti sotterranee del mondo, notò - una decina di anni fa- che l’atteggiamento del mondo nei confronti dell’Europa era cambiato, all’improvviso. Una volta, visitando i paesi fuori dal nostro continente, gli capitava spesso di essere fermato per strada, perché qualcuno, afferrandogli un bottone della giacca, gli chiedeva: "Ci dica cosa succede in Europa".
Dieci anni fa invece Kapuscinski cominciava ad accorgersi che nessuno lo fermava più, e che nessuno gli faceva domande. Kapuscinski parlava anche di quello che lui chiamava "un cambiamento nella qualità". Un tempo un europeo qualunque, un individuo che non aveva nella propria società una posizione particolarmente elevata, una volta approdato in Tanzania o in Malesia diventava di colpo “signore”. Anche questo è finito. Oggi tutti i Paesi hanno una propria élite istruita e non si aspettano che gli europei possano apportare qualcosa di nuovo nella risoluzione dei problemi con cui si confrontano. Kapuscinski notò anche che un tempo gli europei trattavano il resto del mondo come un parco giochi; oggi ovunque vedono invece il pericolo.
La situazione è simile a quella che avvertiva l’Impero romano alla vigilia della sua fine. Ai confini delle sue carte geografiche indicava: ’Hic sunt leones’, ovvero vi sono Paesi selvaggi in cui è meglio non avventurarsi. Siamo dunque condannati a vivere nel cortile di casa? Siamo stati sfrattati per sempre? Quello stadio dell’avventura in cui l’Europa, bene o male, dettava il percorso della storia mondiale è per sempre alle nostre spalle? L’Europa non avrà mai più un’accoglienza ospitale?
Io, quando scrivo dell’Europa, penso a un progetto ininterrotto, non realizzato fino in fondo ma che, nonostante tutto, ha dettato il ritmo dei cambiamenti indicando l’orizzonte di aspettative a cui l’Europa per l’appunto mirava. E mi domando se esista un qualche orizzonte verso cui l’Europa potrebbe mirare oggi. Ricrearne la potenza militare rendendola paragonabile, ad esempio, a quella degli Stati Uniti, è impensabile. Sono pure infime le chance di poter paragonare la dinamica dello sviluppo economico dell’Europa a quello dell’America Latina o della Cina. Il Vecchio Continente non è in grado neanche di dare il tono allo sviluppo della scienza, dell’arte e della cultura. Cosa potremmo dunque consegnare in dote al pianeta? C’è qualcosa che possediamo di cui gli altri hanno bisogno e che potrebbero imparare da noi?
Lo scrittore George Steiner sostiene che il compito dell’Europa ha carattere spirituale e intellettuale. Nelle sue opere Steiner si occupa dei contrassegni comuni dei popoli europei, fra cui il lascito culturale del mondo ellenico e di quello ebraico. Sottolinea che Europa significa massima diversità linguistica e culturale, un mosaico insolito di modi di vita differenti. Nel nostro continente spesso neanche 20 chilometri separano fra loro mondi diversi. Hans-Georg Gadamer ritiene che l’abbondanza di diversità sia il tesoro più grande che l’Europa è riuscita a salvare e che possa offrire al mondo. La vita con l’Altro e per l’Altro è uno dei compiti fondamentali dell’essere umano. Forse è da qui che origina la peculiare superiorità dell’Europa, che ha dovuto apprendere l’arte di vivere in questo modo.
In Europa l’Altro è sempre vissuto, in modo metaforico ma anche letterale, a portata di vista o di mano, L’Altro è, in Europa, il vicino più prossimo. Nonostante le differenze che ci separano, agli europei spetta negoziare le condizioni di questa vicinanza. Il nostro paesaggio è caratterizzato dalla pluralità di linguaggi, dalla contiguità dell’Altro, ma anzitutto dal fatto che egli, in uno spazio fortemente limitato, sia considerato in modo paritario. L’Europa sarebbe dunque una sorta di laboratorio in cui si elabora un determinato modello dell’arte di vivere di persone che appartengono a diverse confessioni, lingue, che hanno diversi modi di essere felici. Anche la convivenza pacifica, utile per tutti, è possibile non solo nonostante la disuguaglianza, ma grazie ad essa. Questa è la fonte dello sviluppo, del cambiamento di opinioni, delle nuove idee. Qui scaturisce l’ispirazione per la soluzione dei problemi.
Una delle incognite da sottoporre a sperimentazione in questo laboratorio è il modo di uscire dai limiti imposti dalla lunga storia contemporanea dello Stato-nazione. L’integrazione della società, l’integrazione della molteplicità ovvero la costruzione di Stati e popoli moderni hanno costituito due processi paralleli e interdipendenti. Brandeburghesi e bavaresi si sono trovati a essere improvvisamente parte di uno stesso popolo (il popolo tedesco), così come in Francia i savoiardi e i bretoni. È difficile immaginare che sorta di sconvolgimento nel pensiero dei popoli sparsi per l’Europa sia stato allora il passaggio dalle comunità locali a quelle nazionali.
Oggi abbiamo di fronte a noi una fase successiva dell’avventura europea: il passaggio da una forma di integrazione, così come ci è nota dal funzionamento dell’Unione europea, alla creazione di un piattaforma stabile, funzionale alla comune risoluzione dei problemi planetari, alla creazione di meccanismi di solidarietà umana universale.
Siamo lontani da questa meta. Franz Kafka, uno dei più straordinari sociologi che mi sia mai capitato di leggere, in un contesto differente (non pensava allora all’Europa ma in genere al destino e alle opere degli uomini nel nostro mondo), scrisse: "Se dunque non trovi niente qui nei corridoi, apri le porte, se non trovi nulla lassù, non c’è problema, sali per nuove scale. Fin tanto che non smetti di salire, non finiscono i gradini, crescono verso l’alto sotto i tuoi piedi che salgono" ( Difensori, traduzione di Giulio Raio).
Lo storico Reinhart Koselleck, nel descrivere ciò che avvenne in Europa tra il Seicento e il Settecento, usò invece la metafora della scalata di un valico alpino. Nessuno di coloro che si arrampicavano aveva la benché minima idea di cosa ci sarebbe stato dall’altra parte; questa gente non poteva neanche immaginarsi l’Europa futura, perché mancavano loro parole e concetti per descrivere i processi messi in moto.
Mi attrae in questa metafora non tanto il fatto che dall’altra parte possa esserci il paradiso terrestre (questo non possiamo saperlo) ma che, fintanto che ci inerpichiamo verso il valico lungo una parete molto scoscesa, una sola cosa è certa: non possiamo fermarci. Bisogna andare avanti, perché se cerchiamo di piantare una tenda su quella parete basterà il primo alito di vento a spazzarla via.
Forse sono un visionario, forse sono un ottimista nato: in ogni caso la mia speranza è radicata nella logica. Non tanto nella buona volontà degli europei, quanto nel fatto che semplicemente non c’è altra via d’uscita perché con il livello attuale di reciproca interdipendenza di tutti i popoli che abitano il pianeta il futuro dipende dalla nostra capacità di collaborare. È una questione di vita o di morte.
Ma poi ci sono i conflitti... Mi domando se essi derivino dalla nascita degli Stati-nazione, o se siano altrettanto intensi nell’ambito di una sola nazione. All’interno degli Stati nazionali abbiamo imparato come risolvere i conflitti di questo tipo, ora si tratta di imparare a risolverli a un gradino superiore. È una differenza quantitativa. Ma è anche una differenza qualitativa? Forse sì.
Cosa c’è dall’altra parte del valico? Non ne ho idea. Sono certo di una cosa sola: quello che scorgeremo laggiù non sarà simile alle istituzioni che siamo soliti identificare con l’essenza della democrazia, della convivenza pacifica ecc., dimentichi del fatto che esse costituiscono solamente le nostre finora assai effimere scelte. Immagino che se invitassimo Aristotele al Bundestag tedesco o alla Dieta polacca le sedute susciterebbero il suo interesse. Forse addirittura correrebbe a casa per scrivere un ulteriore tomo della sua ’Politica’.
traduzione Laura Quercioli Mincer
* Fonte: L’Espresso, 4 giugno 2009
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- NOZZE D’EUROPA (di Raniero La Valle).2 giugno 2009, di Federico La Sala
NOZZE D’EUROPA
di Raniero La Valle *
Articolo della rubrica “Resistenza e pace” in uscita sul prossimo numero del quindicinale di Assisi, Rocca (rocca@cittadella.org ) *
È stato detto che nella campagna per le elezioni europee di tutto si è parlato tranne che dell’Europa: si è parlato della tragica figura di Berlusconi, che rischia di essere travolto dalle sue ricchezze e dalla loro intrinseca forza di corruzione; si è parlato della deriva del Partito democratico, che dice di voler essere grande per combattere la destra ma si ostina a voler restare nel suo piccolo per correre da solo, fino all’assurda decisione di votare “sì” al referendum del 21 giugno; si è parlato della sinistra divisa, o meglio della sinistra “nuova” e suicida che per vivere si è proposta di distruggere (di “buttare”) la sinistra vecchia da cui era uscita; ma non si è parlato di che cosa andare a fare in Europa.
Questo però non è del tutto vero. È vero per quanto della politica appare dalla TV e dai giornali, che però rappresentano sempre meno la politica del Paese. Ma non è vero per molti altri protagonisti e dibattiti che in queste settimane hanno attraversato il Paese reale; e non è stato vero per me, che ho suggerito tre cose.
La prima è che l’Europa ponga termine alla fase introversa della sua costruzione come mercato interno e come spazio chiuso di comunitari contro extra-comunitari, e vada alle nozze col mondo. Non come le mitiche nozze con Giove da cui fu rapita, ma come scelta politica e libera. Ripudiata la guerra, l’Europa deve sposare la terra. Lì è la sua origine, e lì è il suo destino, che non è solo suo, ma è comune con tutti. L’Europa non è una “città sul monte”, come i Padri fondatori degli Stati Uniti vollero fare dell’America, per dare lezioni a tutti i popoli; l’Europa è una città sul mare, e il mare è una via, senza mura, per la quale si va e si viene. Dal mare, sconosciuti, arrivarono Enea e i Fenici; perseguitati e naufraghi arrivarono Pietro e Paolo; per mare sono partiti Marco Polo, Cristoforo Colombo, Vasco da Gama; per mare le lingue d’Europa si sono sparse sulla terra nella ultima Pentecoste che è la Pentecoste dei pagani. Se l’Europa non si fa patria del mondo, e non riconosce il mondo come sua patria, essa è finita.
La seconda è che l’Europa faccia uno Statuto del lavoro, come in Italia si fece uno Statuto dei lavoratori. Quello significò per l’Italia estirpare il lavoro dal regime privatistico nel quale era gestito come merce, e immetterlo in uno spazio pubblico nel quale i diritti erano messi in salvo, il conflitto sociale era tutelato e una vita accettabile doveva essere garantita per tutti.
Non a caso oggi è sotto attacco. Uno Statuto del lavoro in Europea significherebbe togliere il lavoro dall’occhio del ciclone della crisi, e assicurare diritti di base e un reddito minimo per tutti, lavoratori fissi e precari, cittadini e stranieri, anche forzando le legislazioni nazionali; e vorrebbe dire riconoscere il diritto al lavoro come innato e appartenente all’essere umano come persona.
Sarebbe bella un’Europa “fondata sul lavoro”, come l’Italia è nella nostra Costituzione; sarebbe davvero un modo di andare alle radici cristiane dell’Europa, se l’evento fondatore del cristianesimo è stato un Dio che si è fatto uomo, si è fatto servo, e perciò ha assunto e reso divino il lavoro, che era l’opera propria ed esclusiva del servo. Allora il primo articolo della Costituzione europea potrebbe essere: “L’Europa è una comunità democratica di persone e di Nazioni unite, fondata sul lavoro”.
La terza cosa è’ uno “Statuto dell’esule”. Anche qui le “radici cristiane” dovrebbero farci ricordare che anche noi siamo stati esuli in ogni Paese, come lo furono gli Ebrei in Egitto; dovrebbero far pensare l’Europa come a una “città di rifugio”, simile a quelle istituite nella terra di Canaan perché i fuggiaschi vi potessero trovare riparo sottraendosi ai “vendicatori del sangue”; dovrebbero suggerire di fare dell’Europa la sperata “casa di accoglienza per tutti i popoli”.
E il primo articolo di questo Statuto dovrebbe dire così: “Nessun esule deve annegare nel Mediterraneo”.
Raniero La Valle
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Una e molteplice - Ripensare l’Europa (pagine conclusive del libro di G.Bocchi - M.Ceruti).1 giugno 2009, di Federico La Sala
Ripensare l’Europa “provincia globale” *
di G.Bocchi - M.Ceruti
Le frontiere esterne dell’Europa e il ruolo dell’Europa nel mondo sono due aspetti della medesima questione. Il mondo, sempre più policentrico, è oggi dominato dalle politiche e dalle strategie di veri e propri attori globali - Stati Uniti, Russia, Cina, India, e forse in un prossimo futuro anche Brasile e Australia. Tali attori giocano a tutto campo, tessono una complessa rete di coopetition (conflittualità, ma anche collaborazioni in molti ambiti) e sono sempre più interdipendenti.
L’Europa è oggi sul punto di diventare a sua volta un attore globale in grado di stabilire rapporti paritari con gli altri attori globali già consolidati. Proprio per questo va in cerca di una politica estera comune e coerente, e di regole di governo atte a superare il particolarismo delle singole prospettive nazionali.
Ma l’Europa potrà raggiungere tali obiettivi solo valorizzando i tratti specifici della sua identità e della sua storia.
Frontiere interne ed esterne del continente europeo sono permeabili. In Europa non si danno spazi, stati, luoghi privilegiati, che incarnino meglio di altri valori comuni, staticamente intesi, che sarebbero definitori della civiltà europea. Se oggi molti valori sono effettivamente condivisi dalla gran parte degli stati e dei popoli europei è perché sono stati elaborati insieme, attraverso lunghi e tormentati processi storici, attraverso interazioni e conflitti, cooperazioni e incomprensioni fra attori diversi e talvolta eterogenei, alle origini come ai nostri giorni.
Questo spiega perché, nelle varie fasi dei suoi sviluppi e delle sue espansioni, l’Unione europea abbia continuato a definirsi come un progetto e non come, un territorio, a definirsi come entità politica e non geografica, a definire i suoi confini momentanei attraverso il buon esito di pragmatici negoziati con gli interlocutori del momento e non attraverso dichiarazioni di principio sulle demarcazioni ultime della civiltà europea.
Questo è un progetto scaturito dalla storia e dalle memorie europee, e soprattutto dalle catastrofiche esperienze delle due guerre mondiali e della Guerra fredda che ne è seguita. Un valore ha accomunato i padri fondatori del nucleo dell’Unione europea nell’immediato dopoguerra e le generazioni successive, che hanno operato per la riunificazione politica del continente: è l’opposizione ai totalitarismi e agli autoritarismi che avevano portato l’intera civiltà europea a un passo dal crollo completo. Tale opposizione si è però subito definita in positivo, con l’impegno a valorizzare e attuare, nelle politiche europee, quella dichiarazione dei diritti umani che è stato uno degli esiti più importanti della reazione antitotalitaria. A tale impegno i governi dell’Unione sono stati in gran parte fedeli, anche in occasione di problematici negoziati con stati e governi non ancora a loro volta compiutamente impegnati nella difesa dei diritti umani.
L’Unione europea ha preso il via proprio nel momento dell’ultimo, definitivo fallimento delle prospettive europee di controllo del mondo. Il primo nucleo delle attuali istituzioni europee si delineò in quegli stessi anni dell’immediato dopoguerra in cui si disgregò l’impero più esteso che la storia europea abbia mai conosciuto: l’impero britannico, che allora dovette concedere l’indipendenza ai suoi possedimenti indiani. Destino analogo segnò, con una sincronia quasi perfetta, i resti di altri ordini coloniali, come quello francese e olandese. L’Europa, dunque, non è più dominatrice: è diventata una provincia del mondo, peraltro sempre meno importante per peso demografico, forza militare, risorse energetiche e minerali.
Proprio per questo, il ruolo dell’Europa nel governo dei processi di globalizzazione è unico e irrinunciabile: non più centro del mondo, volto a esercitare il controllo degli scenari internazionali, ma sua «provincia», tesa ad affrontare le difficoltà e le controversie che i processi di globalizzazione comportano, e nella condizione di sperimentarne soluzioni innovative, attraverso la specificità della sua storia e della sua identità, che è una e molteplice.
Proprio per la sua storia, per la sua identità, una e molteplice, e per la sua attuale condizione di «provincia globale», l’Europa può essere laboratorio di innovazione istituzionale e culturale, per affrontare le sfide cruciali del «mondo globale»: governare i disordinati processi di globalizzazione economica; prospettare modalità di integrazione dinamica tra pubblico e privato, laddove hanno fallito sia il liberismo sia il dirigismo unilaterali; sviluppare la qualità della vita degli individui e delle collettività attraverso le opportune riforme ed estensioni del welfarestate; riannodare i legami sociali e difendere le specificità culturali; concepire relazioni sostenibili fra la specie umana e gli ecosistemi; porre un termine all’età delle energie fossili e rendere economicamente produttive le energie rinnovabili; intervenire sul riscaldamento globale e stabilizzare il clima del pianeta...
L’Europa ha imparato, dalla sua storia remota e recente, a pensare insieme, come complementari e non opposte, identità e diversità, unità e molteplicità; ha iniziato a concepire ogni identità come incompiuta ed evolutiva, come irriducibilmente multipla, generata dall’intreccio di molteplici storie; ha compreso che la valorizzazione delle diversità delle culture e delle persone nonché della biodiversità è la vera opportunità antropologica e politica dell’età globale; ha elaborato il nucleo di un umanesimo planetario, imperniato sulla coscienza della comunità di destino di tutti i popoli della Terra, e di tutta l’umanità con la Terra stessa.
G.Bocchi - M.Ceruti
* pagine conclusive del libro di
 Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti
Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti
 Una e molteplice - Ripensare l’Europa
Una e molteplice - Ripensare l’Europa
 Tropea Editore 2009, pp. 90, € 8,00
Tropea Editore 2009, pp. 90, € 8,00 Articolo tratto da:
Articolo tratto da: FORUM (101) Koinonia
FORUM (101) Koinonia http://www.koinonia-online.it
http://www.koinonia-online.it Convento S.Domenico - Piazza S.Domenico, 1 - Pistoia - Tel. 0573/22046
Convento S.Domenico - Piazza S.Domenico, 1 - Pistoia - Tel. 0573/22046 -
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- «8 marzo: una bambina, una donna, senza chiesa» (dal Brasile, una riflessione della Comunità “Evangelho è Vida” del Bairro Rio Vermelho di Goiás - a cura di Paolo Farinella, prete).8 marzo 2009, di Federico La Sala
«8 marzo: una bambina, una donna, senza chiesa»
a cura di Paolo Farinella, prete
Ricevo dagli amici della Comunità “Evangelho è Vida” del Bairro Rio Vermelho di Goiás (Brasile), datata «Giorno per giorno» 6 marzo 2009, questa amara riflessione sulla bambina di 9 anni violata e il vescovo spietato. Ve la comunico senza commenti come antidoto alla stupidaggine dell’8 marzo, un altro inganno per le donne che ci cascano anche. Il titolo in cima è mio. (Paolo Farinella)
Carissimi,
“Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna” (Mt 5, 20-22). Parole severe quelle di Gesù. Non dissimili da quelle di alcuni maestri del suo tempo, che ricordavano: il comandamento è di non spargere il sangue, ora, chiunque umilia il suo prossimo, chiunque lo fa arrossire di vergogna, è come se ne spargesse il sangue, è perciò lui stesso omicida.
La mattina, alla preghiera, noi non siamo molti, sei, sette, otto persone al massimo. Che oggi, quando, in apertura, si è fatta la memoria della vita, erano tutte, tra lo smarrito e l’indignato. Perché noi non siamo abituati a pastori così. Come quello che è entrato, alla stregua di un carro armato, in una storia, già di per sé fin troppo dolorosa, triste e drammatica.
La storia parla di una bambina di nove anni che, assieme alla sorella quattordicenne (handicappata psichica), era costretta da tre anni a subire le violenze del giovane patrigno. Tali violenze si sono tradotte negli ultimi tempi in una gravidanza gemellare per la bambina più piccola, un fuscello di trentasettechili di peso. Che sua madre, il giorno in cui questa accusa forti dolori al ventre, porta in ospedale a Recife. E lì viene fuori la verità, amarissima. Con tutto ciò che ne segue. L’arresto del patrigno e la decisione di interrompere la gestazione della bimba.
La storia potrebbe anche chiudersi qui, con in più, soltanto, il rispetto, il silenzio, l’abbraccio umano di quanti sono ancora capaci di voler bene. Tra cui, sperabilmente la gente di chiesa. Per alleviare, se mai fosse possibile, l’eccesso del dolore. E invece. Invece arriva fuori lui, il pastore, che da Gesù dovrebbe aver imparato il primato della misericordia, l’invito a non giudicare, la generosità fino al dono della vita. Ma che, sfortunatamente, “mica tutti ne sono capaci”. E così lui sale in cattedra, non sia mai per denunciare i potenti, ma per umiliare e schiacciare i poveri e chi si è fatto toccare dall’enormità della loro sofferenza. E scomunica quanti, per altro, hanno agito nel rispetto della legge: la direzione dell’ospedale dove si è svolto l’intervento, l’equipe medica che lo ha realizzato, la madre che lo ha autorizzato. La bambina non ha invece potuto formalmente scomunicarla, ma solo perché è minorenne.
Fosse stato per lui, chissà! Del resto lui è lo stesso “pastore” inviato nel 1985 all’archidiocesi di Olinda e Recife, per sostituire dom Helder Câmara, normalizzare quella chiesa, demolire sistematicamente il lavoro pastorale del profetico arcivescovo dei poveri.
Il medico che ha coordinato l’intervento, il dott. Rivaldo Mendes de Albuquerque, cattolico, ha dichiarato: “Non riceviamo un solo centesimo per questo tipo di operazioni. Lo facciamo per il rispetto che una donna (in questo caso una bambina!) vittima di violenza merita, e che l’arcivescovo, sfortunatamente, tratta senza nessuna misericordia. È curioso che chi ci ha condannato alla scomunica non ha proferito una sola parola diretta all’uomo che ha stuprato questa bambina. Per dom José Cardoso Sobrinho, l’unica cosa che conta è il Diritto Canonico. Gli manca il cuore. Ho compassione del nostro arcivescovo, che non ha saputo essere misericordioso con una bambina innocente”.
Ha ragione il dott. Rivaldo: non smarrimento, non indignazione, solo compassione. Chissà che domani, salendo all’altare quel vescovo riesca a ricordare la frase di Gesù: “Se presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono” (Mt 5, 23-24), e magari, tutto paramentato, vada a cercare quella madre e le sue bimbe, e gli si inginocchi davanti e chieda loro perdono. Per intanto facciamolo noi, ci sarà rimasto qualche cristiano nella chiesa di Olinda e Recife, vero?
Il Postino della Comunità del Bairro
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! ---- UE, NAPOLITANO: UNIONE POLITICA UNICA STRADA POSSIBILE - La frase che più colpisce è l’invito ai governi nazionali a non fare dell’Unione Europea "un caprio espiatorio" delle proprie colpe. Ma non è il solo richiamo. Giorgio Napolitano ha invitato anche a non perdere il treno del Trattato di Lisbona, delle riforme urgenti, necessarie, indispensabili. Senza di esse dovremmo rassegnarci a non contare nel mondo e a vedere svanire le conquiste di 50 anni di integrazione che non sono acquisite una volta per tutte, come si è portati erroneamente a credere (Ansa).21 giugno 2008, di Federico La Sala
Ansa» 2008-06-21 20:44
UE, NAPOLITANO: UNIONE POLITICA UNICA STRADA POSSIBILE
dell’inviato Alberto Spampinato
LIONE - La frase che più colpisce è l’invito ai governi nazionali a non fare dell’Unione Europea "un caprio espiatorio" delle proprie colpe. Ma non è il solo richiamo. Giorgio Napolitano ha invitato anche a non perdere il treno del Trattato di Lisbona, delle riforme urgenti, necessarie, indispensabili. Senza di esse dovremmo rassegnarci a non contare nel mondo e a vedere svanire le conquiste di 50 anni di integrazione che non sono acquisite una volta per tutte, come si è portati erroneamente a credere. In un discorso forte, accorato, pronunciato in francese agli Stati Generali d’Europa riuniti a Lione, presenti Romano Prodi, Mario Monti, Tommaso Padoa-Schioppa, il vice presidente della Commissione Europea Jacques Barrot e l’ex premier belga Guy Verhofstadt, il presidente della Repubblica ha affrontato innanzi tutto il nodo del ’no’ irlandese al Trattato, ha chiesto di superare le resistenze e di completare l’integrazione europea con nuove regole e con il capitolo decisivo delle politiche comuni. "E’ giunto il momento della prova". Se non fosse possibile approvare il nuovo nuovo Trattato, ha detto, per superare lo stallo i Paesi che danno vita all’Euro dovrebbero costituirsi come gruppo di avanguardia per fare "scelte più avanzate di integrazione e di coesione".
Occorre capire, ha aggiunto, che il voto irlandese più che un problema di rifiuto dell’Europa pone "il grande problema della partecipazione e del consenso dei cittadini" al progetto europeo", problema eluso da "troppi governi nazionali", che non hanno coinvolto adeguatamente cittadini e Parlamenti in queste scelte e "anzi hanno dissimulato le posizioni da essi sostenuta in sede europea chiamando in causa l’Europa, in particolare la Commissione, la ’burocrazia di Bruxelles’, come caprio espiatorio per coprire loro responsabilità e insufficienze. E’ mancato un discorso di verità con i cittadini". Invece, occorre "una piena assunzione di responsabilità da parte dei governi e delle forze politiche", poiché non si può pretendere dai cittadini che si orientino da soli in materie così complesse. "Occorre battere queste strade senza ulteriori incertezze, ambiguità e ripensamenti".
L’Italia confida nel semestre di presidenza francese che inizia a luglio e sosterrà con convinzione gli sforzi di Parigi. Napolitano ha indicato la necessità di tornare alla ispirazione dei ’padri fondatori’ che hanno indicato il traguardo dell’unione politica, "la sola strada percorribile", tanto più necessaria oggi in un mondo globalizzato in cui nessuno stato nazionale da solo "può risolvere i suoi problemi né dare un valido contributo al superamento delle sfide globali". "Non c’é pretesa di autosufficienza, non c’é illusione protezionista che possa mettere l’Italia o la Francia o la Germania al riparo dalla globalizzazione". Esplicito il rimpianto per la mancata approvazione del Trattato Costituzionale che conteneva le riforme e le regole indispensabili in una Europa a 27.
Poiché quei contenuti sono stati fatti salvi "in larghissima misura" nel nuovo Trattato, bisogna approvarlo. In una giornata dominata ancora dallo scontro fra politica e giustizia, il capo dello Stato si è tenuto alla larga dalle polemiche di casa nostra, riservandosi di occuparsene al rientro a Roma, previsto in serata. Sul tema europeo, Napolitano ha volato atto sulle residue resistenze di alcuni settori politici, in particolare della Lega Nord, che pure nei giorni scorsi ha assicurato che voterà a favore della ratifica parlamentare del Trattato. E se il discorso sui capri espiatori può riferirsi in parte anche al governo italiano, il passaggio appare formulato più che altro come un’esortazione.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- Il Parlamento europeo ha votato la direttiva dell’Unione sull’immigrazione, forse la peggiore, la più crudele e più stupida del mondo civile (di FURIO COLOMBO).20 giugno 2008, di Federico La Sala
Il giorno nero dell’Europa
di Furio Colombo *
Il Parlamento europeo ha votato la direttiva dell’Unione sull’immigrazione, forse la peggiore, la più crudele e più stupida del mondo civile.
Di solito uno Stato nuovo o una nuova istituzione internazionale nascono con grandi e generose ambizioni. Spesso il tempo e le vicende del mondo impongono cambiamenti, indurimenti, negazione dei principi alti, come risposte di brutale realismo che vengono adottati con un esplicito o implicito avvertimento: non stiamo negando i nostri princìpi.
Stiamo solo fronteggiando un momento difficile. Tipicamente si invoca l’emergenza che è sempre una condizione di cui si aspetta e si invoca la fine.
Due esempi. Molti di noi che hanno sempre creduto nelle Nazioni Unite, hanno subìto delusioni pesanti, dall’inutilità dell’Unesco alla gravissima inadeguatezza della Fao. Per non parlare della strage di Srebrenica, una crudele operazione di pulizia etnica avvenuta sotto gli occhi di inerti soldati dell’Onu.
Ma l’Onu si identifica per sempre con la Carta dei Diritti dell’uomo, che ha avuto un senso e un peso grandissimo nella storia del mondo contemporaneo. E con la Carta di San Francisco a protezione dei diritti dei bambini. In altre parole, l’Onu che pure ha vissuto brutte pagine (fino ad avere un segretario generale - Kurt Waldheim - con un passato nazista), ha posto al suo inizio principi, propositi, impegni così alti da costituire riferimenti e speranze che durano ancora.
L’altro esempio, il più grande, è quello degli Stati Uniti. Si sono dati, alla nascita, una Costituzione e un “bill of rights” (carta dei diritti) talmente alti e nobili da ispirare, lungo i due secoli e mezzo della loro esistenza, tutte le azioni, iniziative e movimenti che si sono impegnati a migliorare il Paese e a correggere dislivelli gravi come il razzismo. Persino di fronte alle tragiche imprese del Ku klux Klan, Martin Luther King ha potuto invocare gli alti principi della Costituzione, ricevendo il sostegno dei tribunali e dei giudici chiamati a decidere sulla lunga sequenza del razzismo.
Persino oggi, persino mentre il 70 per cento dei cittadini americani sono contro la politica del Presidente Bush e la tragedia in Iraq, ognuno di quei cittadini è orgoglioso di essere americano perché può vantare nel mondo la sua la sua Costituzione e la sua Carta dei Diritti che recita: «E’ evidente e di immediata comprensione (self evident) che tutti gli uomini sono stati creati uguali». Quell’orgoglio di essere americano si manifesta oggi nel momento in cui un giovane senatore nero, figlio di immigrati, è candidato, con molto seguito, alla presidenza degli Stati Uniti.
* * *
Ecco qualcosa che non potrà mai accadere in una Europa gretta e spaventata, che inizia la sua esistenza politica con una serie di direttive sull’immigrazione dettate dal versante stupido della paura, un insieme di percezione ottusa e di cattiveria, magari non voluta ma che sventola come una bandiera nera su questo aggregato di Stati detto “Unione Europea”. Avrebbe dovuto essere un nuovo futuro, il superamento e la cancellazione delle xenofobie dei singoli Stati, delle miserie dei confini e del continuo affermare, fino al ricorso alle armi, la superiorità di ognuno sugli altri.
Partendo così in basso, con principi così barbari, che negano il diritto d’asilo, prevedono la cacciata dei bambini (l’esecuzione di un simile provvedimento violerà ogni principio della civiltà di cui ci vantiamo, oltre a tutte le leggi di tutti i Paesi membri) e mettono al centro della nuova Giustizia europea un anno e mezzo di carcere per il delitto di immigrazione. Niente poteva essere pensato in modo più vergognoso e umiliante. Impedisce fin dall’inizio che l’Europa diventi simbolo e riferimento di qualcosa di buono e di nuovo.
L’Europa debutta sulla scena già triste del mondo con il volto indifferente e volgare della vecchia burocrazia.
furiocolombo@unita.it
* l’Unità, Pubblicato il: 20.06.08, Modificato il: 20.06.08 alle ore 8.37
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". ---- Qui urge ancora un po’ d’eroismo. I più determinati oggi non sono gli eroi ma i rinunciatari, i pavidi, gli uomini impagliati di Eliot: «La sanguigna marea s’innalza e ovunque / annega la cerimonia dell’innocenza; / i migliori mancano d’ogni convincimento, / mentre i peggiori son colmi d’appassionata intensità» (di Barbara SPINELLI)..15 giugno 2008, di Federico La Sala
Le false favole europee
di Barbara Spinelli (La Stampa, 15/6/2008)
Quasi tutte le parole che descrivono la bancarotta del referendum irlandese sull’Europa suonano false e fanno pensare a quel che Macbeth dice del mondo, quando viene a sapere che la sposa è morta: come la vita, anche le parole sono «una favola narrata da un idiota, piena di rumore e furore, che non significa nulla».
Non significa nulla lamentare con enfasi la democrazia assente nell’Europa, la sua lontananza dai popoli, perché l’Unione non è uno Stato pienamente funzionante, con cui i popoli sono in vero rapporto dialettico. È un edificio ancora da fabbricare o comunque completare, anche se le nostre società sono già europeizzate e le leggi nazionali soggiacciono in larga misura a quelle comunitarie. Il Trattato di Lisbona non è d’impedimento alla democrazia e anzi l’accentua notevolmente, coinvolgendo più che in passato il parlamento europeo e anche i parlamenti nazionali. Gli avversari odierni del trattato, come quelli che osteggiarono la costituzione nel 2005, lo sanno alla perfezione ed è contro questi miglioramenti che si battono. Si battono contro l’accresciuto potere di decisione affidato al parlamento europeo in 40 nuove politiche, e perfino contro la maggiore influenza dei deputati nazionali. Lottano contro la votazione diretta dei futuri presidenti della Commissione: pur proponendoli, gli Stati devono, secondo il trattato, tener conto degli equilibri creatisi nelle elezioni europee.
E’ una favola che non significa nulla dire che l’Europa viene regolarmente bocciata perché non ha peso su questioni cittadine vitali. Il trattato di Lisbona è colmo di difetti (ha cancellato la parola costituzione e i simboli di un soggetto politico nuovo) ma i progressi non sono trascurabili: il trattato unifica le politiche di sicurezza, immigrazione, terrorismo. In questi come in altri ambiti sostituisce all’unanimità il voto a maggioranza, il che vuol semplicemente dire che comuni politiche europee divengono realizzabili, come già accade nell’agricoltura, nel commercio, nella moneta. I propagandisti del No mentono sapendolo: denunciano un’Europa assente su immigrati o sicurezza, e uccidono la possibile sua presenza. Questo vuol dire che non vogliono affatto quello che pretendono. Vogliono preservare un potere, anche se ormai irrilevante. Come gli uomini impagliati di Eliot, hanno le mascelle spezzate di regni perduti: regni che si spengono «non già con uno schianto ma con un lamento».
È una favola che non significa nulla ripetere, come automi addestrati, che l’Europa è incapace di comunicazione. Della comunicazione sono responsabili i comunicatori, i destinatari della comunicazione, e chi è in mezzo: i media. I referendum falliti segnalano che la catena non ha funzionato, che nelle mani del popolo è stato messo quel che politici e media non sanno maneggiare. Il giorno prima del voto irlandese, Rai 1 neppure nominava un referendum che riguardava 490 milioni di europei. Il giorno dopo era perentoriamente sapiente su quel che aveva ignorato. Molto spesso i plebisciti danno risposte a domande che nel quesito referendario neppure son formulate: è il motivo per cui democrazie memori di referendum liberticidi, come la Germania, li vietano.
Non meno insignificante è la favola sull’identità europea inesistente: narrata da chi, dell’Unione, non scorge il nuovo, inedito incrociarsi tra locale, nazionale, soprannazionale. Tra costoro Marcello Pera: interrogato da Giacomo Galeazzi su La Stampa, piange l’Europa atea «giustamente punita». L’Europa è fatta di molte identità, lo dimostra proprio il referendum. In Irlanda hanno votato contro cattolici spaventati da aborto e eutanasia, ma anche anticapitalisti non religiosi. L’Europa sarà sempre più meticcia: l’intera sua storia è un Bildungsroman, un romanzo di formazione che ci educa al coesistere di più appartenenze (etniche, culturali, religiose). Obama somiglia a tale romanzo più di quanto gli somigli Pera.
È insignificante poi la favola che indica colpe e difetti delle istituzioni soprannazionali di Bruxelles. Nel trionfo dei No non c’è un responsabile ma ce ne sono tanti, e Bruxelles è il meno colpevole. Responsabili sono Stati, partner europei e atlantici, classi dirigenti, elettori. Questi ultimi non vanno vituperati ma giudicarli non è blasfemo.
Non significa nulla infine parlare di rottura e chiusura di un’epoca eroica. L’epoca eroica dell’Unione non è conclusa, i compiti oggi non sono meno grandi di quelli del dopoguerra. Ieri era questione di pace e guerra, dopo due smisurati conflitti. Oggi è questione del peso di questo continente nel mondo, della penuria planetaria di cibo ed energia, della catastrofe climatica, del conflitto fra culture. Ancora non è stata escogitata sul pianeta una costruzione politica capace di superare le inadeguatezze dei vecchi piccoli Stati-nazione, e l’invenzione dell’Europa resta un unicum esemplare.
Non è dunque l’Europa federale che naufraga periodicamente ma l’Europa dei falsi Stati sovrani: a Parigi, L’Aja, Dublino. Rischia il naufragio anche a Roma, dove un cruciale partito governativo, la Lega, imita il No irlandese (anche se i partiti principali a Dublino erano per la ratifica). La divisione sull’Europa è ben più grave dei contrasti su Afghanistan e Usa nel governo Prodi, non fosse altro perché la disapprovazione di Bush è diffusa in America e nel mondo: l’elogio del «clima più costruttivo» fatto dal Quirinale suona come una critica gratuita a Prodi. I giornali che hanno dilatato per due anni tali contrasti hanno appena accennato all’offensiva leghista contro l’Europa.
Una cosa poco promettente è che gli europei sembrano non imparare dalle crisi, nonostante quel che si dice su disastri e colpe felici. I disastri sono istruttivi solo per uomini con forte senso del futuro, del bene comune. Jean Monnet ad esempio diceva che «le crisi sono grandi opportunità»: di rompere col passato, di tentare il nuovo («Nulla è pericoloso come la vittoria», ripeteva). Alla Francia il referendum non ha insegnato molto. Pochi giorni prima del referendum, il ministro degli Esteri Kouchner ha vilipeso, sprezzante, gli irlandesi. Ha facilitato il No: per incompetenza, ignoranza, megalomania francese, come quando Chirac insultò gli europei orientali nel 2003. Comunicare bene e astutamente vuol dire parlar chiaro, ma non a vanvera.
In realtà non siamo di fronte a una storia eroica che finisce ma a una grande illusione che continua. L’illusione che gli Stati-nazione possano farcela da soli, in un mondo dove ciascuno dipende dal vicino e dal lontano. L’illusione che sia sovranità autentica, quella che Stati promettono di custodire. Tale sovranità non esiste, l’Irlanda lo conferma. Il militante più potente dei No è un ricchissimo industriale, Declan Ganley, che s’è preparato dal 2007 fondando l’associazione Libertas. Libertas riceve finanziamenti ingenti da neo-conservatori Usa e dal Foreign Policy Research Institute di cui Ganley - presidente di una ditta Usa specializzata in contratti bellici privati - è membro da anni: lo ha ricordato venerdì in un convegno parigino l’europeista liberal-democratico inglese Andrew Duff. Così come la natura, anche l’Unione ha orrore del vuoto. Quando non siamo noi a farla, è fatta da altri: in particolare, da chi teme l’Europa-potenza e vuol estrometterla.
Eppure di tutte queste parole false sono tanti a bearsi, compiacendosi del nulla. Chi resiste come Giorgio Napolitano o la Commissione o Sarkozy e la Merkel dice che un’avanguardia deve insistere, e pragmaticamente proseguire le ratifiche. Saggio consiglio, ma tutt’altro che pragmatico. Qui urge ancora un po’ d’eroismo. I più determinati oggi non sono gli eroi ma i rinunciatari, i pavidi, gli uomini impagliati di Eliot: «La sanguigna marea s’innalza e ovunque / annega la cerimonia dell’innocenza; / i migliori mancano d’ogni convincimento, / mentre i peggiori son colmi d’appassionata intensità».
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". --- TRATTATO UE, NAPOLITANO: LASCIARE FUORI CHI BLOCCA ... Il No ha vinto il referendum irlandese sul Trattato di Lisbona con il 53,4% dei voti, contro il 46,6 del Sì. Lo ha annunciato la rete pubblica Rte. Per il No hanno votato in 862.415, per il Sì 752.451. L’affluenza è stata del 51,26% degli aventi diritto.13 giugno 2008, di Maria Paola Falqui
TRATTATO UE, NAPOLITANO: LASCIARE FUORI CHI BLOCCA *
Il No ha vinto il referendum irlandese sul Trattato di Lisbona con il 53,4% dei voti, contro il 46,6 del Sì. Lo ha annunciato la rete pubblica Rte. Per il No hanno votato in 862.415, per il Sì 752.451. L’affluenza è stata del 51,26% degli aventi diritto.
NAPOLITANO: LASCIARE FUORI CHI BLOCCA - "E’ l’ora di una scelta coraggiosa da parte di quanti vogliono dare coerente sviluppo alla costruzione europea, lasciandone fuori chi - nonostante impegni solennemente sottoscritti - minaccia di bloccarla". E’ quanto afferma il Capo dello Stato Giorgio Napolitano dopo il no al referendum Irlandese. "Se non si supera la regola dell’unanimità per la ratifica dei trattati, l’Unione europea è condannata alla paralisi e alla dissoluzione. Le forze politiche e i governi di tradizione europeista hanno la responsabilità storica - nei confronti delle future generazioni - di impegnarsi a scongiurare un simile rischio, a preservare il patrimonio di cinquant’anni di inestimabili conquiste".
NON RIPARTIRE DA ZERO - "Per ben sei anni, i governi di tutti gli Stati attualmente membri dell’Unione si sono confrontati e hanno condotto negoziati su un nuovo Trattato: quello costituzionale, di cui non si completò il processo di ratifica, e poi quello di Lisbona. Entrambi i Trattati furono sottoscritti dai Capi di governo di tutti gli Stati membri. Non si può ora neppure immaginare di ripartire da zero. Né si può pensare che la decisione di poco più della metà degli elettori di un Paese che rappresenta meno dell’1% della popolazione dell’Unione possa arrestare l’indispensabile, ed oramai non più procrastinabile, processo di riforma". Lo afferma il presidente della Repubblica.
FRATTINI,GRAVE COLPO A COSTRUZIONE EUROPEA - "Si tratta di un grave colpo alla costruzione europea, che per ora non consente l’adozione di decisioni essenziali sulla sicurezza, la gestione dell’immigrazione, la politica energetica o la protezione dell’ambiente". Così il ministro degli Esteri Franco Frattini commenta la bocciatura irlandese di oggi del Trattato di Lisbona.
VINCE MR.GANLEY, IL ’SIGNOR NO’ D’IRLANDA
(di Patrizio Nissirio)
LONDRA - Si chiama Declan Ganley, e fino a poco tempo fa era solo un ricco uomo d’affari, totalmente sconosciuto fuori dal suo ambiente, che trattava soprattutto con l’estero. Oggi, da leader della campagna referendaria, è il vincitore indiscusso del referendum col quale l’Irlanda ha bocciato il Trattato di Lisbona. Il ’Signor No’, com’é ormai viene chiamato in Irlanda, è stato la forza propulsiva dietro l’aggressiva campagna che ha chiesto agli irlandesi di votare No. Il suo movimento, Libertas, ha tappezzato le strade di poster e ha noleggiato elicotteri che hanno trascinano enormi striscioni chiedendo di votare contro il Trattato. "Tenete l’Europa fuori dal campo - Votate No", recitava uno che sorvolava lo stadio di Croke Park nei giorni scorsi durante una partita. Ganley, 39 anni, vive in una lussuosa villa a Galway, gira in Rolls Royce, in Mercedes e in elicottero. La sua tesi è: "L’Irlanda è un paese pro-Europa. Vogliamo che l’Irlanda sia al centro dell’Europa, ma vogliamo un’Europa democratica e che si prenda le sue responsabilità. Il Trattato è l’esatto opposto di questo". Per Ganley, il documento danneggia l’economia nazionale, minacciando di alzare le tasse per le imprese. E col Trattato, Dublino avrà meno peso a Bruxelles. Il ’pasionario’ del No ha creato la sua fortuna facendo affari con gli Usa e la Russia. E poi in Bulgaria e Lettonia, dove è stato anche consulente del governo. Ma, ha osservato l’Independent, Ganley ha stretti rapporti d’affari con il complesso militare-industriale statunitense: alcuni, nel Fronte del Sì, lo dipingono come una figura poco chiara con connessioni con i neoconservatori Usa, che accoglie soldi di dubbia provenienza dall’estero per la sua campagna. Una fonte citata dal giornale, nei giorni scorsi, diceva: "Li prendono dalla Cia, dal Partito britannico per l’Indipendenza (Ukip, euroscettico), o dai loro amici nelle forze armate americane?". Ganley, in una campagna in cui i più dicono di non aver letto il corposo Trattato (persino il premier Brian Cowen ha ammesso di non averlo finito), si è fregiato del motto: "L’uomo che ha letto il Trattato". Grazie a questa sua asserita, profonda conoscenza, i manifesti anti-Lisbona di Libertas hanno urlato slogan che vanno da "Non vogliamo l’espansione militare dell’Ue" (si è arrivati a dire che ci sarà una leva europea), a "Non vogliamo la tassazione Ue" a "C’é chi è morto per la tua libertà, vota No".
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU - ROPEUO". --- TRATTATO UE: IRLANDA, HA VINTO IL NO... I risultati definitivi sono attesi nel pomeriggio. Non ci sono dati sull’affluenza, ma Rte afferma che sarebbe attorno al 40%. L’Irlanda è il solo paese dell’Ue a sottoporre il Trattato a un referendum. Una bocciatura getterebbe l’Unione in una nuova fase di incertezza, impedendo alla riforma dei meccanismi comunitari di entrare in vigore (Ansa).13 giugno 2008, di Federico La sala
ANSA» 2008-06-13 13:14
TRATTATO UE: IRLANDA, HA VINTO IL NO
Esponenti del governo e dei partiti sentiti dalla televisione pubblica irlandese Rte hanno detto di aspettarsi, a questo punto, una vittoria del No nel referendum sul Trattato di Lisbona.
I risultati definitivi sono attesi nel pomeriggio. Non ci sono dati sull’affluenza, ma Rte afferma che sarebbe attorno al 40%. L’Irlanda è il solo paese dell’Ue a sottoporre il Trattato a un referendum. Una bocciatura getterebbe l’Unione in una nuova fase di incertezza, impedendo alla riforma dei meccanismi comunitari di entrare in vigore.
BRUXELLES, ABBIAMO FATTO CIO’ CHE DOVEVAMO - La Commissione europea "ha fatto quello che poteva e doveva: la ratifica è un passaggio che compete esclusivamente agli stati membri". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Johannes Laitenberger, a proposito dell’esito del referendum per la ratifica de Trattato di Lisbona voltosi in Irlanda. Laitenberger, in attesa di conoscere i risultati definitivi del referendum, non ha voluto fare altri commenti. Per il pomeriggio è attesa una dichiarazione del presidente della Commissione Ue José Manuel Barroso
FINI, SE IRLANDA LO BOCCIA GRAVE CRISI - "Siamo in attesa del referendum irlandese sul Trattato di Lisbona. Se davvero lo bocciassero ci troveremmo in una situazione di crisi senza precedenti. Per questo auspichiamo un esito positivo". Lo ha detto il presidente della Camera, Gianfranco Fini intervenendo a un convegno sulla partecipazione dei lavoratori all’impresa.
CALDEROLI, GRAZIE IRLANDA PER IL SUO NO - "Un grazie al popolo irlandese per il suo voto. Tutte le volte in cui i popoli sono stati chiamati a votare hanno bocciato clamorosamente un modello di Europa che viene vista lontana dai popoli stessi". Il leghista Roberto Calderoli, ministro per la Semplificazione normativa, si dice convinto di un esito negativo della consultazione sul trattato di Lisbona e sostiene che "i popoli, ancora una volta, hanno dimostrato di avere maggiore saggezza rispetto a governi e parlamenti". "Questo referendum tenutosi in Irlanda - osserva Calderoli - conferma la posizione tenuta da sempre dalla Lega Nord, ovvero che la sovranità appartiene ai popoli e che solo i popoli possono decidere di rinunciare ad essa e conferma che, come sostenuto anche dal presidente emerito Cossiga e dal professor Guarino, l’approvazione di questo Trattato da parte del solo Parlamento avrebbe rappresentato un atto incostituzionale per gli articoli 1 e 11 della Costituzione, perché avrebbe affidato i nostri destini nelle mani dei burocrati e non degli eletti dal popolo".
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU - ROPEUO". --- Trattato di Lisbona, Irlanda al voto. Primi risultati... I "no" alla ratifica del Trattato di Lisbona sono in testa. Lo hanno riferito alcuni scrutatori all’agenzia Reuters: in cinque circoscrizioni della capitale Dublino, che conta un quarto dell’elettorato,13 giugno 2008, di Maria Paola Falqui
Secondo stime non ufficiali avrebbe votato solo il 40% degli aventi diritto Preoccupati gli osservatori internazionali. Il documento è stato già ratificato da 18 paesi
 Trattato di Lisbona, Irlanda al voto
Trattato di Lisbona, Irlanda al voto
 Primi risultati, in vantaggio i "no"
Primi risultati, in vantaggio i "no"Stando ai primi dati gli irlandesi sarebbero contrari a ratificare il documento Le conseguenze sull’economia: l’euro tocca sul dollaro il minimo mensile a 1,5307
DUBLINO - I "no" alla ratifica del Trattato di Lisbona sono in testa. Lo hanno riferito alcuni scrutatori all’agenzia Reuters: in cinque circoscrizioni della capitale Dublino, che conta un quarto dell’elettorato, il fronte del "sì" resta indietro; in tre si registra un sostanziale pareggio e soltanto in una sono in vantaggio i favorevoli al Trattato. Anche nelle altre regioni del paese gli iralndesi si sono espressi negativamente. Secondo l’emittente pubblica Rte i distretti operai hanno votato massicciamente contro il documento. Il vantaggio dei voti contrari è forte nei distretti di Mayo, Limerick, Galway, Sligo e Louth. A Donegal, nel nord-est, dove sono state scrutinate il 10% delle urne, in nessun caso ha vinto il "sì". La pagina web del quotidiano "Irish Time" conferma che in tutte le circoscrizioni della capitale i "no" prevalgono con una media di 60 contro 40 dei "sì", con picchi di 70 contro 30 nella circoscrizione sudorientale.
Sono questi i primi dati sulla consultazione per la ratifica del Trattato di Lisbona in Irlanda. Risultati che hanno avuto già avuto conseguenze sull’economia. L’euro ha toccato nei confronti del dollaro Usa il minimo mensile a 1,5307 dopo le notizie diffuse.
"Il sì sembra forte in alcune delle aree di classe media ma onestamente non credo che sia sufficiente a battere il no", ha commentato Joan Burton, deputata della capitale per il Labour, terzo partito dell’Eire. Dello stesso parere è Dick Roche, ministro irlandese per gli Affari europei, che da Wicklow ammette: "Le cose non si mettono bene per il sì. Qui si parla di un testa a testa e a quanto mi risulta siamo nel collegio più favorevole al sì. Ma le cose altrove stanno andando diversamente. Continuo a tenere le dita incrociate. La situazione potrebbe capovolgersi durante la giornata".
No comment dell’Unione europea sulle prime proiezioni. Durante il quotidiano briefing coi giornalisti il portavoce della Commissione ha detto che l’esecutivo europeo ’’ha fatto tutto quel che poteva e doveva. Ora è il momento di aspettare la fine dello spoglio e la proclamazione del risultato’’.
Occhi puntati dunque sull’Irlanda. Nel pomeriggio dovrebbero conoscersi i dati ufficiali sui 43 distretti elettorali. Intanto un dato preoccupa gli osservatori internazionali: stime non ufficiali riferiscono di una bassa affluenza alle urne, pari a circa il 40%, che potrebbe favorire gli antieuropeisti. Secondo il quotidiano "Irish Times" avrebbe votato il 50% dei 3,1 milioni di aventi diritto.
Dei ventisette paesi dell’Unione, l’Irlanda è l’unico che ha affidato ratifica del documento a una consultazione popolare, ma i sondaggi parlano di un’opinione pubblica spaccata e di un’alta percentuale di indecisi. La scarsa partecipazione alle cunsultazioni, però, sembrerebbe favorire il fronte del "no".
Già nel 2001 gli elettori irlandesi respinsero con un referendum il trattato di Nizza, approvandolo poi in una nuova consultazione l’anno successivo. La vittoria del "no" potrebbe creare degli attriti all’interno dell’Unione Europea, dove il trattato è già stato ratificato dai parlamenti di 18 paesi. Non è escluso che l’Ue decida di applicare comunque il patto di Lisbona, ma non è chiaro come l’Irlanda potrebbe rapportarsi agli altri stati membri.
Se i cittadini irlandesi bocciassero il documento ’’ci troveremmo in una situazione di crisi senza precedenti per le istituzioni europee’’, ha commentato il presidente della Camera, Gianfranco Fini. L’ipotesi di un risultato negativo piace invece a Roberto Calderoli, ministro per la Semplificazione normativa e coordinatore delle segreterie nazionali della Lega Nord.
"Un grazie agli irlandesi per il loro voto. Tutte le volte in cui i popoli sono stati chiamati a votare hanno bocciato clamorosamente un modello di Europa che viene vista lontana dai popoli stessi, dimostrando di avere maggiore saggezza rispetto a governi e parlamenti", ha dichiarato il ministro ancor prima dei risultati. La vittoria del "no" sarebbe in linea con "la posizione tenuta da sempre dalla Lega Nord - ha aggiunto Calderoli - ovvero che la sovranità appartiene ai popoli e che, come sostenuto anche dal presidente emerito Cossiga e dal professor Guarino, l’approvazione di questo trattato da parte del solo Parlamento avrebbe rappresentato un atto incostituzionale per gli articoli 1 e 11 della Costituzione, perché avrebbe affidato i nostri destini nelle mani dei burocrati e non degli eletti dal popolo".
* la Repubblica, 13 giugno 2008.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU - ROPEUO". ---- TRATTATO: IRLANDA AL VOTO, EUROPA CON IL FIATO SOSPESO .. Si sono aperti stamattina alle 07:00 locali (08:00 in Italia) i seggi in Irlanda per il referendum sul trattato di Lisbona, la nuova costituzione dell’Unione europea. Gli occhi dell’Europa sono tutti puntati su Dublino. L’Irlanda è infatti l’unico dei 27 Paesi dell’Ue dove il trattato è sottoposto a referendum, il cui esito è incerto, visto che gli ultimi sondaggi danno il fronte del ’no’ e quello del ’si’’ praticamente testa a testa (di Patrizio Nissirio).12 giugno 2008, di Maria Paola Falqui
Ansa» 2008-06-12 08:27
TRATTATO: IRLANDA AL VOTO, EUROPA CON IL FIATO SOSPESO
dall’inviato Patrizio Nissirio
DUBLINO - Si sono aperti stamattina alle 07:00 locali (08:00 in Italia) i seggi in Irlanda per il referendum sul trattato di Lisbona, la nuova costituzione dell’Unione europea. Gli occhi dell’Europa sono tutti puntati su Dublino. L’Irlanda è infatti l’unico dei 27 Paesi dell’Ue dove il trattato è sottoposto a referendum, il cui esito è incerto, visto che gli ultimi sondaggi danno il fronte del ’no’ e quello del ’si’’ praticamente testa a testa. Più della metà dei 27 ha già ratificato il trattato di Lisbona; ultimi in ordine di tempo, ieri, Estonia, Finlandia e Grecia. Il risultato non si saprà prima di domani: lo scrutinio inizierà infatti solo domani mattina, con i risultati attesi nel tardo pomeriggio.
Un referendum che negli ultimi giorni è diventato una vera battaglia tra i due fronti contrapposti, uno scontro che continua per le strade della capitale anche oggi, in teoria giornata del ’silenzio’ prima del voto.
La città è letteralmente tappezzata di manifesti che gridano ’Yes’ e ’No’ al Trattato. Ogni singolo palo della luce, segnale stradale, lampione ha sopra almeno due poster degli schieramenti contrapposti: il fronte del Sì spiega che il Trattato manterrà l’elevato livello di benessere raggiunto dall’Irlanda soprattutto grazie ai fondi Ue, mentre un No marginalizzerà l’Irlanda; quello del No ammonisce che l’Europa porterà via la sovranità di Dublino nella difesa, sull’aborto, sulle tasse e sul mercato del lavoro.
Nella centralissima College Street un gruppo di ’Giovani irlandesi per il Si’ europeò, invita i passanti (a dir poco scarsamente interessati) a votare a favore di Lisbona, urlando in un megafono. Poco distante sull’O’Connell Bridge, che attraversa lo scuro fiume Liffey, due ragazze sorridenti indossano magliette celesti con una Vittoria alata circondata dalle stelle dell’Europa, e distribuiscono volantini: ma a dispetto della simbologia, non sono messaggi a favore del Trattato.
E’ un volantino di Libertas, il misterioso gruppo messo in piedi dall’imprenditore Declan Ganley, che nelle ultime settimane con la sua campagna martellante ha portato il No a superare per la prima volta il Sì nei sondaggi. Una campagna, dicono i fautori del Sì (tutti i principali partiti di governo e opposizione, fatta eccezione per il Sinn Fein), che ha usato bugie e mistificazioni per spaventare i cittadini e convincerli a respingere il Trattato.
Libertas, e i suoi alleati (che vanno dalla sinistra estrema, ai nazionalisti, agli ultrà cattolici), prendono a cannonate numerosi aspetti del ponderoso documento (Ganley dice di essere uno dei pochi ad averlo letto tutto). Dimezzerà il peso del voto irlandese nell’Ue - ammoniscono - toglierà il commissario europeo a Dublino per cinque anni, sottometterà la legge irlandese a quella comunitaria (in particolare, sottolineano, ’obblighera’ l’Eire a legalizzare l’abortò), e in generale consegnerà a Bruxelles il potere in 60 aree finora appannaggio del governo nazionale. E concludono con il loro slogan: "Vota No a Lisbona, sbagliato per l’Irlanda, sbagliato per l’Europà. Contro queste affermazioni è sceso in campo Micheal Martin, ministro degli Esteri, che ha spiegato la crescita dei No nei sondaggi proprio con la campagna negativa fatta dai fautori della bocciatura: "Ci sono affermazioni false fatte dai sostenitori del No, in particolare quelle fatte da estremisti di destra sulle questioni sociali, come quando dicono che il Trattato avrebbe influenza sulla legge irlandese sull’aborto. O quando si dice che ci costringerà ad abbandonare la neutralità".
Il ministro se la prende in particolare con l’organizzazione Libertas, che definisce "un gruppo che nessuno conosceva, venuto fuori da nulla con forti finanziamenti, che ha fatto affermazioni false ed instillato dubbi sul Trattato di Lisbona... noi abbiamo dovuto demistificare questi miti. Per esempio, sulla difesa comune, noi abbiamo un divieto costituzionale a parteciparvi, a meno che non si tenga un referendum. Ma penso che la campagna del No abbia dato tutto... credo che vinceremo". Ma al di là dell’ottimismo di Martin, nessuno se la sente davvero di fare previsioni, viste le percentuali dei Sì e No nei sondaggi, di fatto testa a testa. E per giunta, l’Ue non saprà neanche oggi a fine voto se il tentativo di riforma sarà stato silurato o meno dagli irlandesi, che sono circa l’1% della sua popolazione. Lo scrutinio inizierà infatti solo venerdì 13, al mattino, con i risultati attesi nel tardo pomeriggio. Fino ad allora, il Trattato di Lisbona resterà appeso a un filo.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU - ROPEUO". ---- IL REFERENDUM IRLANDESE. QUESTA «FREDDA» EUROPA RISCHIA GROSSO... Se da Dublino verrà un pur stiracchiato via libera, si potrà pensare a qualche rimedio. In caso di un bruciante «no», l’Europa dovrà fronteggiare una crisi di non facile soluzione. In cui diventerà probabile, se non inevitabile, il ricorso a qualche forma di ’doppia velocità’ (di Andrea Lavazza).12 giugno 2008, di Maria Paola Falqui
IL REFERENDUM IRLANDESE
QUESTA «FREDDA» EUROPA RISCHIA GROSSO
di ANDREA LAVAZZA (Avvenire, 12.06.2008)
Nell’era dell’informazione in tempo reale, dei media che svelano dettagli e retroscena del potere, dei blog su Internet che offrono un ampio panorama di versioni ’alternative’, in Irlanda si sta consumando un colossale cortocircuito comunicativo. Le cui responsabilità si dividono equamente tra l’Unione Europea e gli attivisti del «no» all’approvazione del Trattato di Lisbona. Il processo di integrazione continentale, ormai è noto, resta appeso al referendum odierno: 4,2 milioni di cittadini sono chiamati a esprimersi sulla nuova Carta, varata con fatica dopo la bocciatura della precedente a opera degli elettori francesi e olandesi nel 2005. Alla vigilia, i sondaggi danno un equilibrio tra i due fronti e una notevole quota di indecisi. Una bocciatura, anche per pochi voti (comunque un’inezia rispetto alla popolazione dei 27 Paesi membri), non è più irrealistica e basterebbe a fermare l’entrata in vigore del nuovo assetto istituzionale della Ue, previsto per l’inizio del 2009. Le altre nazioni hanno optato per la ratifica parlamentare; Dublino è vincolata dalla propria Costituzione a un passaggio plebiscitario. Che Bruxelles abbia sottovalutato la consultazione irlandese e non sia riuscita a trasmettere il senso del Trattato è un fatto lampante, così come la confusione e l’ignoranza che hanno regnato nella campagna che ha preceduto l’andata alle urne.
Il partito dei contrari fa leva sulla presunta perdita di influenza del governo, su una non documentata impennata della tassazione e su una fantomatica imposizione di norme comunitarie più permissive in materia di aborto ed eutanasia per arrivare alle leggende di un esercito europeo che imporrà la leva obbligatoria ai giovani del Paese. I sostenitori del «sì» avrebbero avuto buon gioco a ricordare che la cosiddetta Tigre celtica è diventata una delle nazioni più ricche e dinamiche proprio grazie ai trasferimenti ottenuti dall’Europa (40 miliardi netti di euro) e dall’ingresso nel mercato unico, con agevolazioni e deroghe normative, che hanno fatto dell’isola di smeraldo (dal colore delle sue campagne) un modello di innovazione e competitività economica. Se il reddito pro capite è tra i primi dell’Unione, ci si aspetterebbe un po’ di gratitudine. Ma il punto che molti analisti non hanno colto è che i nobili sentimenti (dei quali gli irlandesi non sono certo privi) necessitano di soggetti identificabili verso cui esprimersi e manifestarsi. E il problema della Ue sta proprio nella sua natura di ectoplasma burocratico, cui spesso sembrano mancare carne e sangue, progetti e slanci, capaci di suscitare, se non l’entusiasmo, almeno la dedizione dei suoi cittadini.
Fare propaganda alla Carta di Lisbona avrebbe, allora, voluto dire che non si va a costruire un moloch impersonale, distruttore di autonomie e tradizioni nazionali, ma si dà invece maggiore snellezza ed efficacia a istituzioni - la Commissione in particolare - che possono ben integrare le politiche di ciascun Paese membro.
Due esempi: iniziative coordinate per fare fronte alla tempesta energetica, con il petrolio che schizza a prezzi mai raggiunti e ’brucia’ il benessere di molti europei; una diplomazia continentale più determinata e credibile, capace di farsi valere su alcuni fronti internazionali, magari quelli delle emergenze umanitarie, a partire dal genocidio in Darfur fino alla Birmania doppiamente provata dalla repressione del regime e dalla mancanza di aiuti dopo le devastazioni del ciclone.
Se da Dublino verrà un pur stiracchiato via libera, si potrà pensare a qualche rimedio. In caso di un bruciante «no», l’Europa dovrà fronteggiare una crisi di non facile soluzione. In cui diventerà probabile, se non inevitabile, il ricorso a qualche forma di ’doppia velocità’. L’integrazione camminerà sulle gambe di quelle nazioni che hanno compreso la posta in gioco e sono disponibili ad ’animare’ l’Unione come vera risorsa e non come peso da sopportare (o boicottare).
-
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU - ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. ----- "Ripensare il cristianesimo. De Europa" di Vincenzo Vitiello (rec. di Francesco Tomatis).16 maggio 2008, di Federico La Sala
Vitiello: la pretesa di creare il Regno di Dio in terra, negando il rapporto col divino, porta violenza nella storia. Anche nazismo e comunismo sono figli degeneri della secolarizzazione delle radici greco-cristiane d’Europa
Ecco perché la bontà «impazzita» genera mostri e tiranni
di FRANCESCO TOMATIS (Avvenire, 16.05.2008).
Da molti anni e con molti libri il filosofo Vincenzo Vitiello ha percorso e sperimentato una propria personale via ad approfondire il cristianesimo: non solo la teologia ma anche la nuda fede. Mai come nel suo ultimo volume, Ripensare il cristianesimo. De Europa (Ananke, pp. 288, euro 16,50), ha tuttavia affrontato direttamente e ampiamente il nesso inscindibile, benché spesso contradditorio, fra cristianesimo ed Europa, nonché fra cristianità e grecità e ancora più a fondo fra Grecia e Asia. L’interrogativo e la cornice storica da cui Vitiello avvia la sua indagine è la conclusione di un’età recente, quella apertasi nel 1789 e chiusasi con il 1989, cioè fra la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e la caduta del Muro di Berlino.
Età del «grande e nobile ideale dell’autofondazione umana della comunità e della storia», la cui più alta teorizzazione sta nella concezione hegeliana dello Stato, ideale che tuttavia «non ha retto alla prova della storia», dimostrando come «un’ideologia fondata sui valori più alti della solidarietà umana sia capace della più spietata oppressione dei diritti dell’uomo ». Il filosofo napoletano dichiara subito la necessità di andare a scavare le radici remote di tale catastrofica tragedia europea. Nazifascismo e comunismo non sono che figli, benché degeneri, della secolarizzazione delle radici cristiane e greche dell’Europa e ad esse dunque occorre volgere lo sguardo interrogativo, «per capire se non si celi proprio in esse quel ’male necessario’ che sottraendosi alla vista ci ha confuso e sviato».
Le prime tracce sono individuabili - secondo Vitiello - già in quelle teologie della storia che, secolarizzando il cristianesimo di Gesù, ne riducono la carica redentiva, efficacemente attribuita invece dal Cristo all’istante stesso, secondo una convergenza con la riflessione platonica, come ben comprese Kierkegaard. Vitiello individua in certe interpretazioni delle epistole di san Paolo la originaria pretesa di realizzare il Regno di Dio in terra, negando il rapporto verticale con il divino in una sua completa umanizzazione e storicizzazione. Se si storicizza l’éschaton, facendone un futuro programmato, la violenza entra nella storia come necessaria al bene, senza possibilità, da ultimo, di arginare veramente il male.
Secondo Vitiello non c’è religione senza che il rapporto reciproco fra gli uomini, la dimensione comunitaria orizzontale, lo stare assieme, sia ad un tempo apertura all’obbligo verticale, al divino mai umanizzabile, benché proprio umanamente rivelatosi, ma appunto attraverso il paradosso, l’antinomia, la lacerazione di cui non può privarsi un cristianesimo veramente salvifico, non secolarizzato, umanizzato, annichilizzante e annichilito. Un cristianesimo evangelico e quindi ecclesiale assieme, che colga il senso giovanneo dell’escatologia: «Viene l’ora ed è adesso» (Gv. 5, 25), è per Vitiello la possibile esperienza nell’istante della stessa parousía del Dio vivente: uno stare-accanto a tutti gli altri uomini, senza violenze storicizzatrici, di fronte all’accomunante grande mistero. Quello stesso mistero rivelato sulla croce dal Dio senza braccia nell’abbandono, che è assieme un uomo abbracciante a sé ogni straniero.
-
> RIPENSARE L’ EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU - ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. ... GRECIA: Brucia l’Arcadia, Atene in piazza contro il governo.30 agosto 2007, di Federico La Sala
Brucia l’Arcadia, Atene in piazza contro il governo *
Non cessano di ardere le campagne e i boschi della Grecia. Molti roghi si sono riaccesi nel Peloponneso e continuano a bruciare ancora giovedì mattina devastando vaste zone boschive tra la prefettura di Ilia e quella di Arcadia, nel Peloponneso centro-occidentale. In queste aree mercoledì sera si è reso necessario evacuare i residenti di cinque villaggi minacciati dalle fiamme. Ma le radio ateniesi, citando un portavoce del comando dei pompieri, raccontano che molti abitanti dei paesi si sono rifiutati di abbandonare le proprie abitazioni giungendo al punto di barricarsi dentro. Nella zona dove gli incendi ora divampano con maggior vigore sono operativi centinaia di pompieri appoggiati da cinque aerei e quattro elicotteri anti incendio. Tutti gli altri roghi ancora attivi nel Peloponneso sono invece di bassa intensità e dovrebbe essere possibile circoscriverli e domarli senza troppe difficoltà a meno di un improvviso rafforzamento del vento. Un altro incendio di vaste proporzioni continua intanto a bruciare nella parte centrale dell’isola di Eubea, la terza isola greca per grandezza a nord-est di Atene, ma almeno per il momento le fiamme non minacciano alcun villaggio.
Il bilancio dei roghi che da venerdì scorso hanno distrutto alcune delle più belle zone della Grecia è per ora fermo a 63 vittime ma si teme che possano essere molte di più perché si registrano ancora decine di dispersi.
E scatta l’indignazione popolare. Mercoledì sera oltre 10mila persone, in maggior parte vestite di nero e con cartelli con scritto «No alla distruzione della natura», si sono radunate all’esterno della sede del Parlamento nel centro di Atene per una protesta silenziosa. Alcuni manifestanti hanno fischiato e insultato la polizia in assetto antisommossa, che ha risposto lanciando granate stordenti. Altre mille persone hanno organizzato un’analoga manifestazione a Salonicco. Le manifestazioni pare siano state organizzate da un non meglio precisato gruppo di «cittadini» che si sono passati parola con sms o messaggi e-mail. E alla fine qualche centinaio di manifestanti hanno attaccato la polizia con pietre e bastoni. Gli agenti hanno risposto col lancio di lacrimogeni.
Sempre ieri anche il papa Benedetto XVI, in mattinata al termine dell’udienza generale, ha invitato «a pregare per le vittime» delle inondazioni in Asia e dei «disastrosi incendi in Grecia, in Italia e in altre nazioni europee». E ha lanciato un anatema contro le «azioni criminose» dei piromani e contro «l’irresponsabile comportamento» di chi provoca disastri naturali mettendo «a rischio l’incolumità delle persone» e distruggendo «il patrimonio ambientale, bene prezioso dell’intera umanità».
Il governo di Atene ha concesso prestiti immediati sulla fiducia tramite gli istituti di credito per risarcire i cittadini dai danni degli incendi di questa settimana. Nella sola giornata di sono stati distribuiti 24 milioni di euro. E oggi migliaia di sportelli bancari sono stati presi letteralmente d’assalto da folle di persone che chiedevano i risarcimenti: fino a 3 mila euro senza dover esibire prove dell’effettivo danneggiamento.
Si tratta di un provvedimento con cui il governo conservatore di Caramanlis cerca di recuperare rapidamente consensi per le elezioni politiche che restano firmate per il 16 settembre prossimo. Ma nello stesso tempo, come segnalano alcuni direttori di filiali bancarie, è un provvedimento che si espone a frodi molto facili.
* l’Unità, Pubblicato il: 30.08.07, Modificato il: 30.08.07 alle ore 16.29
-
> EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU - ROPEUO". Ri-prendere la Parola!!!24 maggio 2007, di Federico La Sala
INTERVISTA
Il massmediologo francese mette in guardia: «Necessario è il verbo, mettiamo un freno al dilagare dell’immagine, altrimenti il domani sarà segnato da paure, da nuovi totalitarismi. E anche l’arte e l’estetica moriranno» Virilio: ritornare alla parola
di Antonio Giorgi (Avvenire, 23.05.2007)
«Torniamo al verbo, alla parola. Mettiamo un freno al dilagare e al predominio asfissiante dell’immagine, altrimenti il domani sarà segnato da paure incontrollabili, dal rischio di nuovi totalitarismi, dalla prospettiva di sanguinose guerre civili». Conversare con Paul Virilio è sempre uno stimolante esercizio di approfondimento e verifica della realtà che circonda l’uomo metropolitano di oggi. Filosofo, politologo, urbanista e mass-mediologo lo studioso francese è oggi uno dei più raffinati interpreti della cultura transalpina moderna; nel suo buen retiro della Rochelle, ai bordi dell’Atlantico, dove si è appartato al termine di una intesa carriera parigina, si è dato l’impegno di vivere da cittadino del mondo indifferente alle lusinghe anche sotterranee del nazionalismo, consapevole che la globalizzazione «va vissuta con i suoi rischi ma anche con le sue speranze». Scrive molto, Virilio. Il suo ultimo saggio L’Art à perte de vue (pubblicato in Italia da Raffaello Cortina con il titolo L’arte dell’accecamento, pagine 104, euro 8,50) è una articolata denuncia dei mali indotti dalla ricorrente sovraesposizione mass-mediatica, dove il sensibile è diventato il fotosensibile, l’obiettività una teleobiettività. «È accaduto - lamenta l’autore del pamphlet - ciò che era inevitabile, abbiamo disappreso l’arte di vedere».
Affermazione paradossale, la sua. Non è questa la stagione dell’immagine? Non viviamo sommersi dalla realtà fotografica e da quella catodica?
«Appunto. Anneghiamo nelle immagini della tv, ma la parallela restrizione del campo ottico al solo teleschermo induce una perdita della lateralità. È come se avessimo il glaucoma, ci manca la percezione della sconfinata realtà che sta a lato del televisore, o anche del telescopio, o del telefonino, o del computer. Lo schermo rimpiazza l’orizzonte, e per contro il nostro orizzonte è limitato allo schermo. Ci illudiamo di vedere tutto, invece l’occhio non scorge quasi nulla».
Con quali conseguenze, dirette e indirette?
«Si parla sempre di obiettività, nel campo dell’informazione la si invoca a proposito e a sproposito, ma ormai stiamo transitando dall’obiettività alla teleobiettività, nel senso che la visione lontana nasconde quella vicina con imponenti ricadute sulla intersoggettività. La prospettiva del tempo reale presentata dallo schermo tv domina e vela la prospettiva dello spazio reale della vita, che ha fondato l’arte contemporanea. Intendiamoci, questa dominanza non coinvolge solo la rappresentazione artistica, non è unicamente un fatto estetico. Ne viene coinvolta la natura. Ne è toccata perfino la politica. Non ci rendiamo conto che la politica di questi anni è sempre più interconnessa al fattore paura?»
Nel senso che il potere nelle sue articolazioni sfrutta paure private e collettive per liberarsi dai lacci del controllo democratico e agire con mano libera?
«Anche. Infatti siamo passati dall’epoca della dissuasione militare - che si reggeva sull’equilibrio del terrore degli ultimi decenni del secolo scorso - alla stagione della dissuasione civile che trae alimento da infinite paure, non solo quella terroristica dopo l’11 settembre. Pensiamo alla paura di perdere il lavoro in epoca di globalizzazione, alla paura dell’emigrazione (io sono figlio di emigrati italiani, tengo a dirlo) e a tutti gli altri timori e incubi che agitano i nostri sonni. La paura è diventata il cuore del politico, cioè di tutto quanto è politico. Non è più un fatto individuale, perché allora puoi reagire con il coraggio. La paura si è fatta collettiva, e puoi solo subirla come la subivo io quando ero ragazzo durante la guerra. Ha svariati nomi: globalizzazione, delocalizzazione produttiva, disoccupazione, perdita della casa, inflazione, arrivo massiccio degli stranieri... Tutte le paure però convergono, sicché agli incubi della guerra fredda sono subentrate le angosce di una condizione generalizzata che definisco di panico freddo».
In questo orizzonte fosco riesce a cogliere elementi capaci di alimentare la speranza di un futuro migliore? Oppure l’avvenire dell’umanità è segnato?
«Alla disperazione non bisogna mai cedere. Trovo molto bella quell’affermazione di Churchill che dipingeva l’ottimista come un uomo che sa vedere una opportunità in ogni calamità. Io sono cristiano praticante, fervente, convertito da adulto; si figuri se posso vivere senza speranza. La stessa globalizzazione ne racchiude vari alcuni germi, non neghiamolo».
Quale vuol essere allora il messaggio autentico che proporre il suo saggio sull’accecamento massmediatico della società contemporanea?
«Mentre l’arte di vedere è diventata una vittima della modernità non posso non sottolineare che vedere e sapere erano i principi attorno ai quali si articolava la ricerca scientifica e la speculazione culturale dopo il secolo dei lumi. Vedere e potere assumono identica valenza nel XXI secolo, ora che siamo passati dal telescopio di Galileo e di Newton alla tele-percezione politica. Non dimentichiamo che se le società totalitarie hanno tentato di imporre politiche pan-ottiche, di per sé massificanti, anche la società globale che si annuncia possiede i mezzi audio e televisivi che possono indurla a ripetere errori costati cari all’umanità. Dunque il problema non è la gestione più o meno centralizzata della visione planetaria in chiave di Weltanschaung, ma l’affermazione di una nuova filosofia della tele-visione del mondo capace - grazie alla corretta interpretazione della realtà vicina e lontana - di far sopravvivere la democrazia e ricostruire un clima generale di pace civile. Dietro la più parte delle paure c’è la minaccia della guerra. Civile, non tradizionale. Civile, e pertanto più tragica».
La scuola, l’università, la cultura che apporto possono offrire al superamento della cecità provocata dal dilagare dell’immagine?
«Questi tre soggetti devono battersi per il ritorno al verbo, alla parola. La politica, "il politico" è fondato sulla parola, sul verbo, sulla scrittura. È sempre stato così, dalla polis greca al mondo contemporaneo. Quando, come rischia di accadere oggi, l’immagine istantanea trionfa sul verbo, è la tirannide. Tirannide del tempo reale, tirannide mediatica, dell’ubiquità, dell’immediatezza cronologica. La democrazia soffoca e si impone la babele, confusione di lingue e di immagini. Mentre l’immagine domina e la fa da padrona assoluta, la parola cade in una condizione di sudditanza e nascono i guai. Tocca a noi far vincere il verbo».
-
> EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU - ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una ’memoria’ sul referendum del 2005, per le celebrazioni della nascita della Unione Europea (2007) - di Federico La Sala.21 maggio 2007, di Federico La Sala
Dittature dell’Est contro l’Europa
di Barbara Spinelli (La Stampa, 21.05.2007)
E’ importante quel che accade lungo la frontiera Est dell’Unione, nel momento in cui a Parigi c’è un nuovo Presidente che promette di metter fine all’inedia che affligge l’Europa dal 2005, quando la costituzione fu bocciata in Francia e Olanda. È una frontiera dove stanno mettendo radice nazionalismi autoritari, che avvalendosi del diritto di veto insidiano mortalmente il farsi dell’Europa e il suo guarire. Sarkozy e il ministro degli Esteri Kouchner dicono che Parigi cambierà politica, difendendo i diritti dell’uomo nel mondo e combattendo le dittature. Ma la vera battaglia inizia in casa, se davvero la si vuol fare: il male è dentro l’Europa, ed è letale e contagioso. Le periferie dell’Est sono le nostre marche di confine, da quando la comunità s’è allargata, e questa loro condizione - l’esser baluardi orientali dell’Unione, come la Germania occidentale nella guerra fredda - le rende determinanti in politica estera e militare. Sono i governi dell’Est a decidere come e se l’Europa comincia a negoziare con il retroterra russo. Sono loro a influire sui rapporti con Washington, a meno d’un tempestivo chiarimento.
Chi vive nel cuore dell’Unione ha meno preoccupazioni politiche e strategiche di chi presidia le frontiere: questo è il dato da cui conviene partire quando si esamina quel che succede a Varsavia, Bratislava, Budapest, Bucarest, nei Baltici. I governi dell’Est hanno utilizzato questa carta (l’acuta coscienza delle marche di confine) ma col tempo il ragionamento strategico è divenuto un pretesto per insediare nazionalismi intolleranti che con le regole e la storia dell’Unione sono incompatibili. Il bisogno d’America che essi esprimono - su Iraq, sullo scudo anti-missili Usa, su ulteriori allargamenti a Est auspicati da Washington - è un mezzo per impantanare l’Europa con tre armi: il nazionalismo, l’appello al cristianesimo, la politica dei valori.
Il caso Polonia è il più significativo, ma il suo esempio fa scuola attorno a sé. Da quando i gemelli Kaczynski sono al potere, dopo le legislative e presidenziali del settembre-ottobre 2005, Varsavia è precipitata in un nazionalismo prevaricatore e religioso. Quel che conta per i due fratelli (Lech presidente, Jaroslaw premier) è opporre la democrazia al liberalismo, non solo economico ma istituzionale e dei diritti cittadini. Solo due idoli contano per loro - la legittimità popolare, i Valori - e su essi nulla deve prevalere: né le norme né la Costituzione, né le istituzioni né la divisione dei poteri. Una dopo l’altra, le istituzioni indipendenti sono state politicamente asservite (Banca Centrale, Corte costituzionale,Vigilanza sull’audiovisivo). Uno svuotamento democratico accentuato dal regolamento dei conti con la generazione dissidente, che nell’89 liberalizzò economia e politica negoziando con i comunisti (un metodo rischioso, che garantì alle nomenclature impunità e oblio del passato). Il regolamento dei conti secerne oggi la più vendicativa delle epurazioni.
La legge entrata in vigore a marzo si propone di epurare ben 700 mila persone. Secondo i calcoli fatti da Aleksandr Smolar, presidente della Fondazione Batory a Varsavia (filiale della fondazione Soros), sono 3 milioni i cittadini messi in pericolo dalla lustrazione, se si includono le famiglie dei 700 mila. Ha fatto impressione la ribellione di Geremek, leader di Solidarnosc negli Anni 80 e ministro degli Esteri fra il ’97 e il 2000: il deputato europeo si è rifiutato di firmare un’umiliante dichiarazione in cui negava d’aver collaborato con i servizi comunisti. Ma tanti si son rifiutati, perché l’epurazione non minacciava di licenziamento solo politici o giudici (come la legge del ’97) ma studenti, professori, giornalisti. La Corte costituzionale ha invalidato la legge, l’11 maggio, affermando che i governi «non regnano sulla Costituzione» e i diritti individuali. Di fatto sono forme neo-fasciste che s’installano a Est.
Un neofascismo che usa la politica dei valori per imporre società chiuse, ostili alle diversità: per colpire chi difende gli omosessuali, chi avversa la pena di morte, chi si schiera per un’Europa che i Kaczynski considerano atea, permissiva, materialista, decadente moralmente. È in nome delle radici cristiane che i gemelli si ergono contro un’Unione sovrannazionale, e legittimano l’arbitrio nazionalista: chi in Europa occidentale inalbera bellicosamente i Valori, ha interesse a vedere quel che succede qui. I grandi nemici dei Kaczynski sono la Russia ma anche la Germania accusata di furia egemonica: le due nazioni sono messe sullo stesso piano, la battaglia per i diritti umani violati da Putin è contaminata. Ambedue le potenze si spartirebbero l’Europa centrale e minaccerebbero, come in passato, la sopravvivenza polacca. Paralizzata com’è, l’Europa di oggi non ha tuttavia strumenti d’intervento: né istituzionali né culturali. Non ha neppure volontà di capire. È tormentata dal falso dibattito sulle radici cristiane, non osa difendere una laicità vitale per la democrazia polacca. Fu vigilante nel 2000, quando Haider in Austria s’avvicinò al potere, ma quei tempi son tramontati e oggi, in una situazione ben più deteriore (un’estrema destra ai vertici del potere), impensabili. La vigilanza d’allora fu ingiustamente criticata, ritenuta inefficace. In realtà l’Unione influì grandemente su Vienna. Il cancelliere democristiano Schüssel fu abile, nell’assorbire Haider invece di demonizzarlo. Ma mai sarebbe riuscito nell’impresa, senza il vigile occhio esterno dell’Unione. Oggi l’occhio è cieco.
A bloccare l’Europa è la stasi istituzionale, ingovernabile da quando l’Unione è composta di 27 Stati: sulle decisioni cruciali occorre l’unanimità, e al veto gli orientali s’aggrappano rabbiosamente, perché il diritto di nuocere e interdire dà loro lo smalto di mini-potenze. Smalto fittizio, ma pur sempre smalto. Senza che l’Unione possa impedirlo, ci sono deputati polacchi nel Parlamento europeo che impunemente elogiano Franco (uno «statista cattolico eccezionale») o Salazar. Il deputato europeo Maciej Gyertich ha pubblicato un pamphlet antisemita, edito dal Parlamento europeo (Guerra delle civiltà in Europa: gli ebrei, «biologicamente differenti», avrebbero scelto volontariamente i ghetti). Maciej è padre di Roman Gyertich, il ministro dell’Educazione che vorrebbe escludere Darwin dall’insegnamento, che avversa gli omosessuali e appartiene alla Lega della Famiglie Polacche, una formazione che governa con i Kaczynski e l’estrema destra di Lepper (partito dell’Autodifesa).
La Carta dei Diritti potrebbe essere uno strumento europeo: ma non è vincolante senza approvazione della Costituzione. È sperabile che Kouchner si batta per non estrometterla dal mini-trattato che sarà presentato in Parlamento. L’Unione è inerme: ha contato molto durante la presidenza Prodi, quando Bruxelles impose una democrazia fondata sulla separazione dei poteri in cambio dell’adesione. Ma appena ottenuto l’ingresso, i dirigenti che l’avevano voluto sono caduti: a Varsavia, Praga, Budapest, Bucarest. Lo slogan s’è fatto nichilista: adesso che siamo entrati, tutto è permesso. Jacques Rupnik, storico della Cecoslovacchia, parla di sindrome da decompressione. «Ora possiamo far loro vedere chi siamo veramente», avrebbero detto i Kaczynski. Quasi nessuno di questi Paesi entrerebbe oggi nell’Unione: né la Polonia né l’Estonia, che critica non senza motivi Putin ma che smantella provocatoriamente monumenti ai morti dell’ultima guerra e vieta alle consistenti minoranze russe (40 per cento della popolazione) una cittadinanza che dovrebbe esser normale (lo stesso accade in Lettonia).
L’Europa ha oggi bisogno di istituzioni forti, ma per edificarle dovrà capire l’emergenza veto creatasi a Est. Ha bisogno di laicità, per arrestare le proprie derive autoritarie-religiose. Ha bisogno di trattare seriamente con Mosca, e di avere una politica energetica comune anziché molte politiche e sterili veti alla trattativa. Uno straordinario articolo di Piero Sinatti, sul Sole-24 Ore, spiega bene come la Polonia rischi, bloccando il negoziato euro-russo, d’impedire che una risoluta politica comune nasca. L’emergenza veto dovrebbe ricordare qualcosa ai polacchi. Quando introdusse il liberum veto, nel XVII secolo, la Polonia preparò la propria rovina: ogni deputato della Dieta poteva interrompere sessioni e decisioni con le parole «Non permetto». Nel secolo successivo sarebbe scomparsa dal continente. È grave che oggi Varsavia usi la stessa carta per far scomparire l’Europa, nell’illusione di salvarsi come finta nazione sovrana.
-
> EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU - ROPEUO".... IGNOTI A SE’ STESSI ...ED ESPORTATORI DI ’CRISTIANESIMO’ E DI ’DEMOCRAZIA’!!!16 maggio 2007, di Federico La Sala
In onore di Francesco e Chiara d’Assisi, dei Francescani (Dante Alighieri, compreso!) ... e di Leonard Boff
IGNOTI A SE’ STESSI ...ED ESPORTATORI DI ’CRISTIANESIMO’ E DI ’DEMOCRAZIA’!!!
di Federico La Sala *
La ’lezione’ (di Nietzsche e) di un aborigeno canadese ai ’registi’ della politica ’cattolica’ (e ’laica’).
Credo che ormai siamo proprio e davvero al capolinea - nella totale ignoranza di se stessi i componenti della Gerarchia della Chiesa ’cattolica’ si agitano ... alla ’grande’!!! Non hanno proprio più nulla da dire, evidentemente! Sono scesi in campo ... ma contro Chi?!, contro che cosa?! Contro lo spirito francescano!!!
In segno di solidarietà, qui ed ora - 2005 dopo Cristo, con i francescani in carne ed ossa, oggetto di un richiamo, con un Motu proprio, da parte dell’ex- prefetto ’kantiano’ Ratzinger, il papa Benedetto sedicesimo, forse non è inutile un breve commento a margine... per cercare di stare svegli e di svegliarci, possibilmente - tutti e tutte!
Dennis McPherson, un aborigeno (che ormai "ci" conosce bene, evidentemente!) canadese, ecco cosa (sapientemente e sorprendentemente - per noi, occidentali!!!), alla domanda - “qual è l’essenza dell’essere umano? E’ una creatura speciale con una missione speciale?” - di un’antropologa-intervistatrice, ha risposto:
“ Ha mai sentito parlare di Emanuele Kant? Certo che sì! Sa qual è l’asserzione più importante di Kant? E’ che non può: Kant = can’t (gioco linguistico tra il nome del filosofo e il verbo inglese, che hanno lo stesso suono). Questo sta cercando di fare lei. Sa perché? Perché sta cercando di capire la cultura aborigena! Siete lontano migliaia di anni, siete nell’età dell’oscurantismo”(Rita Melillo, Tutuch (Uccello tuono). A colloquio con gli aborigeni del Canada, Presentazione di D. A. Conci, Mephite s.r.l., Atripalda (AV) 2004, p. 211 e p. 217).
Se teniamo presente le famose parole “De nobis ipsis silemus [...]”(di Francesco Bacone), messe da Kant sopra (come una pietra tombale) e prima di iniziare il suo discorso della e nella Critica della ragion pura, si può dire che il ’nostro’ aborigeno ha capito e visto più che bene - e meglio di tutti i filosofi e teologi dell’Occide[re]nte!!! E ’ce’ lo ha detto in faccia - ’papale’, ’papale’: basta!!!
Noi che non conosciamo ancora noi stessi (Nietzsche) .... e che navighiamo nel più grande “oscurantismo” - quello (più importante!!!) relativo a noi stessi, vogliamo pure dare lezioni ed esportare ’cristianesimo’ e ’democrazia’ in tutto il mondo!? “Mi”!?, e “Mah”!!!?
Federico La Sala
* www.ildialogo.org/filosofia, Martedì, 22 novembre 2005
-
> EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU - ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una ’memoria’ sul referendum del 2005, per le celebrazioni della nascita della Unione Europea (2007) - di Federico La Sala.18 aprile 2007, di Federico La Sala
Usa, moratoria per le stragi
di Furio Colombo *
Da molti anni, ormai, dagli anni di Reagan, la vita interna americana è stretta in una morsa che blocca l’immagine democratica di quel Paese e ne limita il valore di modello nel mondo. Sto descrivendo il corrispondersi, simmetrico e tragico, della pena di morte, ovvero della morte data «per ragioni giuste» dallo Stato, e della libera e impetuosa circolazione della armi.
Armi (personali, semiautomatiche e automatiche) che rendono possibile a singoli individui - non importa per quali ragioni - di eseguire, anche in dimensioni impressionanti, una propria “giusta” sentenza, legittimata dall’orgoglioso possesso dell’arma e dal sentirsi parte di uno Stato che ha l’autorità di uccidere. Occorre cominciare di qui, dalla pena di morte e dalla morte di Stato, che purtroppo segna ancora la vita americana, per provare a riflettere sulla spaventosa carneficina nel Campus del Virginia Technological Institute, uno dei più avanzati centri di formazione tecnico-scientifica negli Stati Uniti e forse nel mondo.
Come si vede il livello altissimo della migliore cultura scientifica sfiora, senza vederlo, il problema del pericolo che incombe sempre sulla protezione della vita. L’esempio allarmante è in quella fotografia mostrata la sera del 16 aprile nel programma «Controcorrente» di Corrado Formigli. Si vede il preside di una facoltà del Technological Institute della Virginia che riceve un vistoso premio in danaro per la sua scuola dalla National Rifle Association, la potente lobby americana delle armi. Che cosa ha fatto il preside per meritare quel premio? Ha creato o aiutato a creare nel suo Stato (ed evidentemente impiegando risorse e personale della Università colpita dalla strage) una serie di club o centri per i ragazzi e adolescenti. Hanno il macabro nome di «Shooting Educational Centers» luoghi in cui - tra i dodici e i quattordici anni - ragazzi e bambine imparano a usare “correttamente” le armi da fuoco. “Correttamente” - ti dicono - vuol dire imparare a non usare le armi a sproposito. Ma il senso vero, specialmente se impersonato da un educatore-tiratore traspare facilmente: “corretto” è il tiro che centra il bersaglio. Lo sparatore del Virginia Tech ne ha centrati trentatré, senza contare i feriti.
* * *
Spostiamoci ora sull’altro lato della tenaglia, la pena di morte che continua ad essere eseguita in trentasei Stati americani, nonostante vistose prove e documentazioni di errori giudiziari, di condannati innocenti e di esecuzioni lunghe e terribili dovute a macabri errori.
Viene dall’Italia il messaggio che potrebbe interrompere la sequenza senza sfidare l’orgoglio e la legittima rivendicazione del diritto di decidere degli Stati che - come l’America - continuano a credere nella pena capitale. Il messaggio - è necessario ricordarlo - è di Marco Pannella. Da 25 giorni digiuna per dire: «fermatevi. Non occorre rivedere alcuna legge, aprire alcuna disputa, discutere principi che alcuni ripugnano e ad altri appaiono sacri. Fermarsi vuol dire solo smettere di eseguire le condanne. Il termine è “moratoria”». Moratoria universale per la pena di morte nel mondo.
Il senso è «Io non pretendo di essere più giusto di te. Ti chiedo solo di fermarti e dare spazio e tempo al confronto di idee». A chi lo sta dicendo Pannella con la sua testarda manifestazione che sembra locale e riguarda il mondo e stranamente provoca meno attenzione del premio di maggioranza alla tedesca? Lo sta dicendo al governo italiano affinché presenti - insieme a molti altri governi che condividono la civiltà della proposta - una risoluzione che la Assemblea generale delle Nazioni Unite potrebbe votare (ci si è quasi riusciti in passato) in questa sessione. Cioè subito. È ovvio che non stiamo parlando di un simbolo. La moratoria che dice “Basta morte di Stato” è un messaggio che si estende all’impegno di far prevalere la politica sulla guerra, la trattativa sull’ultimatum, la forza del diritto sulla forza delle armi. E qui, all’altro capo della grande questione troviamo l’enorme fenomeno della libera circolazione delle armi. E noi, che in Italia ne fabbrichiamo di ottime e ci vantiamo che vadano forte sui mercati di Stato di Usa e Cina, non possiamo chiuderci in un comodo giudizio di condanna della “solita violenza americana”.
* * *
Un argomento è che la moratoria o riguarda il mondo o non riguarda nessuno e dunque ci collega in modo attivo e intelligentemente interventista all’orrore delle stragi, che sono esecuzioni informali.
Un altro argomento - e qui so di forzare le motivazioni assai più ecumeniche e rispettose della moratoria sulle esecuzioni delle condanne a morte invocata da Pannella - è che è urgente spezzare una cultura della destra che salda l’uomo “giusto” che distribuisce pene eque (la vita si paga con la vita) con l’uomo “giusto” che viene avanti dalla prateria dotato di armi adeguate, fiero del diritto di portare quelle armi, implicitamente consapevole del diritto a usarle.
* * *
Cominciano insieme, nella recente storia politica americana, il ritorno (dopo un lungo intervallo senza esecuzioni) della pena di morte, principio e pratica, e il riaffermare intenso, continuo, fanatico del diritto di portare le armi, che risponde alle esigenze di una vasta e moderna produzione di pistole e fucili molto più che al principio costituzionale vecchio di secoli e tutt’altro che invocato da gran parte degli americani. Il debutto avviene nel 1988 quando, nel corso della campagna elettorale del democratico Dukakis, allora governatore del Massachusetts contro George Bush padre, un detenuto nero condannato per stupro ha stuprato e ucciso mentre era in permesso fuori dal carcere. L’evento ha stroncato Dukakis, riaperto la strada alla pena di morte e - nel corso della stessa campagna elettorale - rilanciato il diritto dei cittadini liberi e “giusti” di portare armi. Si tratta di armi leggere dell’ultima generazione. Ma tutto è avvenuto lungo un percorso promozionale in quattro tappe: prima la pistola per difesa, poi il fucile per la caccia, quindi il semiautomatico che, con lievi modifiche artigianali diventa arma automatica da guerra. Infine il diritto di portare “concealed weapons”, armi nascoste sulla propria persona. Ovvero il diritto di girare armati. Anche questo ritorno di fiamma della libera circolazione delle armi ha il suo momento di triste celebrazione: il capo di una setta cristiana detta “davidica” , David Koresh, che era ricercato dallo Fbi perché aveva fatto apertamente incetta di armi automatiche nella sua chiesa-fortino di Waco, Texas, è sfuggito all’assedio della polizia facendosi saltare in aria con più di 80 fedeli fra cui 19 bambini. Era il 19 aprile 1993. L’evento è stato visto e denunciato come un tentativo del governo federale di impedire agli “uomini giusti” di armarsi. Ed è stato brutalmente vendicato.
Lo stesso giorno, nel 1995, il soldato McVeigh (non si sa con quali complicità) ha fatto saltare in aria l’edificio federale di Oklahoma City: centosessantotto morti fra cui 19 bambini, lo stesso numero delle piccole vittime di Waco. Contro le richieste dell’intero mondo giuridico americano, McVeigh è stato condannato a morte. Neppure l’esecuzione della condanna ha chiuso il caso. La memoria di Oklahoma a destra è cancellata, ma non l’episodio di Waco che è ancora citato come esempio del delitto di perseguitare chi “legittimamente” vive armato. Come si è detto, la parte sanguinosa di questa storia è coperta dalla parte promozionale, “Educational Shooting”, avviare i ragazzi a sparare. I parlamentari americani per ora non si oppongono perché la lobby delle armi non scherza nel diffamare chi vuole porre un freno al loro mercato, come è accaduto nelle ultime elezioni al candidato democratico ed eroe di guerra John Kerry, come è accaduto negli otto anni della sua presidenza a Bill Clinton, ostinato avversario della libera circolazione delle armi. La strage di Virginia Tech provocherà una rivolta dell’America che si oppone? Lo abbiamo detto: molto, forse tutto, dipende dalla moratoria universale sulla pena di morte, il congelamento del simbolo, della bandiera, della cultura delle armi. Sarebbe immensamente importante per tutta la cultura democratica nel mondo. E molto più efficace della ricorrente esecrazione, dopo ogni vittima della morte di Stato e della morte di mercato. Sarebbe il segnale di una vera campagna popolare contro la circolazione delle armi e il presunto e folle diritto di uccidere. furiocolombo@unita.it
* l’Unità, Pubblicato il: 18.04.07, Modificato il: 18.04.07 alle ore 9.17
-
> Per la rinascita dell’EU-ROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una ’memoria’ sul referendum del 20053 marzo 2007, di Federico La Sala
Scienza e tecnica non bastano a creare il progresso:«L’Europa ha decollato col diritto e la teologia». Parla il filosofo Brague
«Moderni» sì, ma fino in fondo
Da Parigi Daniele Zappalà (Avvenire, 02.03.2007)
«L’Europa non ha digerito ciò che riceveva dalle altre culture, ma l’ha incluso. Ha riconosciuto il suo debito e ha conservato la coscienza di ciò che prendeva in prestito». Per il filosofo francese Rémi Brague si tratta della mossa vincente che ha innescato lo sviluppo europeo. Un riferimento utile da tenere a mente.
Professore, lei sostiene che il confronto con le altre culture è stato decisivo per l’Europa. In che senso?
«Tutte le civiltà hanno ricevuto dall’esterno. Ma l’originalità dell’Europa riguarda principalmente tre aspetti. Anzitutto, ciò che assorbiva, ad esempio la cultura greca, non è stato assimilato, ma integrato salvaguardando un certo carattere di estraneità. Così gli eruditi europei non hanno semplicemente fatto tradurre i testi greci, hanno appreso la lingua. In seguito, l’Europa ha dato prova di curiosità verso le altre civiltà; fin dal XIII secolo ha divorato racconti di viaggiatori in Paesi lontani. Infine, l’Europa si è chiesta ciò che gli altri pensavano di lei. Anzi, ciò che potevano insegnarle sulla sua stessa natura. Ha cercato di osservare attraverso altre lenti. E ciò molto prima di Montesquieu o dello stesso Colombo, fin dal XV secolo».
Ora la globalizzazione richiede all’Europa nuove integrazioni?
«La globalizzazione non esige né di trattenere ciò che si ha, né di gettarsi ingenuamente su quanto giunge da lontano. Occorre piuttosto interrogarsi su ciò che è bene o è male, che sia nostro o di un’altra cultura».
La globalizzazione viene associata al rischio di un’omogeneizzazione culturale. L’Europa saprà evitarla?
«Una certa uniformizzazione è innegabile. Ma occorre distinguere. Le boutiques degli aeroporti sono più o meno dappertutto le stesse. Al contrario, la cultura popolare non scompare più, o quanto meno vegeta nella formula del folklore. L’Europa non manca di risorse nel resistere a un’omogeneizzazione che avanza in gran parte a suo vantaggio, ma piuttosto per cessare di odiarsi e per voler vivere. L’omogeneizzazione non è una causa, è un effetto: si cerca di confondersi nella massa quando si ha voglia di scomparire».
L’epoca ellenistica avvicinò l’Asia al Mediterraneo. Oggi l’ascesa economica di Cina ed India accentua gli scambi fra Asia e Europa. Ci avviciniamo al vecchio sogno politico di Leibniz di un «matrimonio» ideale fra Oriente e Occidente?
«Tutto cominciò con Alessandro Magno, che spinse l’ellenismo fino all’Indo. I Romani dovettero confrontarsi coi Parti. Poi, la conquista araba s’interpose come un cuneo fra Mediterraneo ed Estremo Oriente e l’islam recuperò i circuiti commerciali Est-Ovest fino all’epoca di Vasco de Gama, che ristabilì il contatto circumnavigando l’Africa. Il sogno di Leibniz era legato all’infatuazione ingenua della sua epoca per la Cina, le sue porcellane, la sua saggezza. Questo sogno fu ancora quello di Napoleone al momento della spedizione d’Egitto (1798), eccetera. L’India e la Cina hanno un gran vantaggio: attendono da noi benessere materiale e tecnologia. Vogliono venderci i loro prodotti, senza conquistarci né convertirci. Osserviamoli a testa fredda, senza sognare. Diffido di chi dice: il pensiero cinese non ha nulla a che vedere con le categorie occidentali, e così via. Ciò vorrebbe dire: compriamo dai cinesi e lasciamoli trattare gli operai, i dissidenti e l’ambiente come vogliono».
Le università asiatiche sfornano oggi più ingegneri e scienziati di quelle europee. La razionalità sta slittando verso Levante?
«La ragione non si limita al metodo sperimentale e ancor meno al calcolo tecnico. Complimentiamoci con l’Oriente per i loro progressi, ma non dimentichiamo che la ragione tecnica può anche mettersi al servizio di assurdità criminali: gli uomini dell’11 settembre sapevano pilotare un aereo e molti fondamentalisti sono esperti d’informatica e di telecomunicazioni. L’Europa non ha inaugurato il suo decollo intellettuale con la scienza e la tecnica, ma, fin dall’XI secolo, co l diritto e la teologia. Essa ha innanzitutto applicato la ragione alla ricerca di buone soluzioni per i rapporti fra gli uomini e degli uomini con Dio».
L’islam è spesso presentato come un unico blocco. Eppure, la frattura fra modernismo e tradizionalismo sembra accentuarsi. Siamo alla vigilia di grandi svolte?
«Il mondo che un po’ frettolosamente viene chiamato islamico è unificato dalla religione. Per tutto il resto, invece, è mutevole. Le tensioni nel mondo islamico non sono semplici da comprendere: il sogno dei fondamentalisti è di accettare la tecnica occidentale rifiutando il resto. Usando un simbolo, la giovane donna in chador piegata su un microscopio elettronico. Essi riducono il "resto" a cose che dovrebbero imbarazzare anche l’Europa, come la pornografia o il suicidio demografico, ma non ad aspetti come lo spirito critico, il metodo storico, un diritto che si reclama solo di un Dio che parla alla coscienza. Ogni "modernismo" che vuole evitare di andare fino in fondo mi sembra una menzogna e un sogno impossibile».
-
> Per la rinascita dell’EU-ROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una ’memoria’ sul referendum del 200523 giugno 2007, di Federico La Sala
INTERVISTA
Il filosofo Tzvetan Todorov: «Ognuno di noi può dirigersi verso l’universale, ma attraverso la padronanza della propria cultura»
Il «global» funziona se il mondo è paese
Per l’intellettuale franco-bulgaro,che riceverà domani il premio Grinzane Cavour, «è pericolosa la prospettiva di una sorta di rinuncia generalizzata alle proprie radici. Ma anche l’idea di un’identità unica e immutabile»«Sono le vecchie terre cattoliche come Francia e Italia quelle più tolleranti e capaci di dibattito. Il che nel mondo islamico è ancora un’illusione»
Da Parigi Daniele Zappalà (Avvenire, 22.06.2007)
«Credo nell’unità della civiltà, che è ciò che si oppone alla barbarie; ma credo anche nella pluralità delle culture, le quali possono condurre tutte all’universale». È la ferma convinzione maturata dopo decenni di investigazioni intellettuali dal grande filosofo e saggista Tzvetan Todorov, uno degli studiosi più fecondi ed ammirati della sua generazione, sul filo di ricerche spesso trasversali fra i campi della linguistica, della teoria letteraria, della sociologia transculturale e della storia delle idee. Intellettuale internazionale come pochi, Todorov riceverà domani il premio speciale Grinzane Cavour per il "Dialogo fra i continenti".
Professore, quello di "dialogo" fra le culture, i popoli ed altro ancora è un concetto sempre più impiegato. A ragione?
«Fin dall’epoca in cui mi concentravo soprattutto sulla teoria letteraria, mi sono interessato alla prospettiva dell’uomo come essere in dialogo. Ho la convinzione che non si possa mai comprendere l’individuo in modo isolato, ovvero considerandolo come autosufficiente. Con un’espressione un po’ dotta, si può dire che l’interumano precede l’umano. Quest’approccio si rivela fecondo anche per comprendere le relazioni fra società. Ogni cultura è un luogo d’incrocio d’interazioni fra culture, anche se non amo molto certe grandi formule all’insegna del dialogo astrattamente impiegate talora dalle organizzazioni internazionali. Personalmente, a un livello più concreto, ammiro molto i grandi specialisti della traduzione o della mediazione fra culture».
Lei ha insegnato a lungo in «città-mondo» come New York e Parigi. Cosa pensa di questi contesti multiculturali?
«Mi paiono soprattutto un simbolo di quanto sta accadendo nel mondo, ovvero il contatto accelerato fra culture, piuttosto che un mezzo. La cultura metropolitana è stata sempre un po’ speciale, a Roma come a Berlino o a Londra. Queste capitali hanno sempre attirato persone del mondo intero illustrando la fecondità di questi incroci. Le metropoli hanno la voca zione di apparire come un laboratorio di ciò che potrebbe prodursi in modo più generale».
Dei laboratori «antropologici», come sosteneva Senghor?
«Sì, e come in ogni laboratorio vi sono talvolta dei conflitti. Questa promiscuità fra rappresentanti di varie culture provoca talvolta tensioni. Ma è meglio cercare di comprendere la natura di queste tensioni che eluderle vivendo nell’illusione di potersi rinchiudere in un’identità unica e immutabile. Ciò produce inevitabilmente solo paura e disprezzo».
Quale sguardo porta sull’idea, sostenuta da alcuni intellettuali «mondialisti», secondo cui occorre trovare dei simboli e valori per l’umanità intera?
«Non mi pare la pista di ricerca più fruttuosa. Ciascuno nasce all’interno di una lingua e di una cultura che ci vengono trasmesse da chi ci sta vicino. Credo che ciascuno di noi possa dirigersi verso l’universale, ma attraverso una padronanza della propria cultura. Mi pare pericolosa la prospettiva di una sorta di de-culturazione generalizzata. Quando persone molto giovani vengono strappate al loro Paese di origine e trasportate in un altro contesto in cui si ritrovano ostracizzate, rischiano fortemente di non padroneggiare più né la cultura d’origine né quella nuova. Al contrario, quando si approfondisce sufficientemente la propria cultura, si può toccare l’universale. Dante fu per molti aspetti lo scrittore più italiano di sempre e al contempo resta il più universale. Dostoevskij non ha cercato simboli non russi, ma le sue opere hanno elevato tanti russi verso l’universale».
Quale ruolo possono svolgere le religioni nel dialogo fra le culture?
«Le religioni rappresentano una grande parte della cultura. È certamente auspicabile una crescente riflessione su certi principi universali presenti in tutte le religioni, accanto a una maggiore tolleranza fra i fedeli di religioni diverse. Ma mi pare al contempo inimmaginabile la riduzione delle religioni attuali a un minimo denominatore comune. Esse hanno bisogno delle prop rie particolarità. La religione cristiana ha bisogno delle sue narrazioni, dei suoi simboli, delle sue rappresentazioni di cui ad esempio Paesi come l’Italia sono ricoperti. Un insieme incolore e generale di massime non potrà mai svolgere il ruolo autentico di una religione».
Nel processo di avvicinamento delle culture, regioni del mondo dalla storia tanto densa e sofferta come l’Europa hanno responsabilità particolari?
«Quando delle vecchie terre cristiane e in particolare cattoliche come la Francia e l’Italia si mostrano tolleranti, capaci di accogliere il dibattito e di evitare ogni stigmatizzazione inutile dei fedeli di altre religioni, ciò ha indubbiamente un’influenza maggiore rispetto a quanto potrebbe accadere in regioni dove la religione non ha svolto questo ruolo. In modo analogo, nel mondo islamico, sono i Paesi detentori dei luoghi santi e della tradizione teologica più ricca quelli che dovrebbero mostrare i segnali di apertura più forte, anche se ciò può spesso apparire ancora come una pia illusione. In ogni caso, penso che ogni autentica forma di umanesimo potrà sempre nutrirsi del confronto con le altre culture. Ogni altra cultura ha sempre qualcosa da insegnarci».
-
> Per la rinascita dell’EU-ROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una ’memoria’ sul referendum del 200526 agosto 2007, di Federico La Sala
 Il fuoco ha lambito il sito archeologico. In mille circondati dai roghi in Arcadia
Il fuoco ha lambito il sito archeologico. In mille circondati dai roghi in Arcadia
 Filmati due piromani nella periferia di Atene. Arrestati quattro sospetti
Filmati due piromani nella periferia di Atene. Arrestati quattro sospetti Il Peloponneso brucia ancora
Il Peloponneso brucia ancora
 Fiamme vicino all’antica Olimpia
Fiamme vicino all’antica Olimpia Almeno 57 morti. Il governo fissa una taglia di un milione di euro sugli incendiari
Almeno 57 morti. Il governo fissa una taglia di un milione di euro sugli incendiari
 La Farnesina assicura che nessun italiano dei 20 mila in Grecia è tra le vittime*
La Farnesina assicura che nessun italiano dei 20 mila in Grecia è tra le vittime*ATENE - Non accenna a diminuire la violenza distruttiva degli incendi che da tre giorni devastano il Peloponneso. Il governo ha deliberato lo stato d’emergenza e fissato una taglia di un milione di euro a chi fornirà informazioni per identificare gli incendiari. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime, almeno 57; decretati tre giorni di lutto. Le fiamme hanno sfiorato anche il sito archeologico dell’antica città di Olimpia, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. L’incendio è arrivato a pochi metri dal famoso e antichissimo stadio lambendo le rovine che secondo una fonte del ministero della Cultura greco "sono state però salvate". In quella zona sono in azione oltre 1.000 pompieri e circa 400 militari con l’appoggio di diversi aerei ed elicotteri antincendio. E nel villaggio di Andristena, nella prefettura dell’Arcadia, circa mille persone si sono radunate nella piazza principale per sfuggire alle fiamme che hanno circondato tutto l’abitato. "La situazione è ancora molto critica", ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco.
Un milione di euro sugli incendiari. Il ministero ellenico per l’ordine pubblico ha offerto una ricompensa variabile da 100.000 a un milione di euro "a chiunque fornirà informazioni che conducano all’identificazione e all’arresto degli appartenti ad una organizzazione criminale che si sono resi responsabili degli incendi divampati nel paese dal 1 luglio ad oggi".
Video degli incendiari. La polizia ha arrestato quattro persone, sospettate di incendio doloso. E a riprova dell’origine dolosa degli incendi, la tv privata Antenna ha trasmesso alcune immagini che riprendono due sconosciuti mentre appiccano il fuoco alla periferia di Atene. Nei fotogrammi, filmati ieri - ha precisato l’emittente - si vedono distintamente due individui di spalle che armeggiano nei pressi di alberi e cespugli sul monte Imetto, alla periferia orientale della capitale. Dopo alcuni secondi, davanti ai due uomini comincia a sprigionarsi fumo e i due si danno alla fuga. Antenna non ha precisato se i due piromani siano stati identificati e arrestati.
Nessun italiano tra le vittime. Il bilancio delle vittime è purtroppo ancora provvisorio perché vi sono fondati timori che molte persone si siano barricate nelle abitazioni per sfuggire alle fiamme e che siano morte asfissiate dal fumo. La Farnesina assicura che nessun italiano è rimasto vittima degli incendi. Secondo le stime in possesso del ministero degli Esteri sarebbero circa 20 mila gli italiani presenti in questi giorni in tutta la Grecia.
Danni incalcolabili. I danni provocati dagli incendi sono incalcolabili. Al momento si ritiene che siano bruciate almeno 500 abitazioni oltre a migliaia di ettari di campi coltivati a grano, uliveti e alberi da frutta, foreste di pini, abeti e platani.
Il fuoco avanza. Oltre alla situazione critica nella zona dell’antica Olimpia, gli incendi continuano ad avanzare intanto nei pressi di Megalopoli, nel centro del Peloponneso, e le fiamme sono arrivate a minacciare anche la periferia di Kalamata, una cittadina di 40.000 abitanti sulla costa occidentale. Frattanto bruciano ancora altre zone della Grecia come l’isola di Evia, a Nord-Ovest di Atene, dove diverse località balneari sono state fatte evacuare, come pure sono stati evacuati diversi piccoli paesi nella zona di Keratea, sulla costa ateniese.
Aiuti dalla Ue. In Grecia sono frattanto cominciati ad arrivare gli aiuti dell’Unione europea per dare manforte ai pompieri locali: in giornata si uniranno alle operazioni di spegnimento altri cinque Canadair (due italiani e tre francesi), una sessantina di vigili del fuoco francesi e circa 30 mandati da Cipro.
* la Repubblica, 26 agosto 2007.
-
> Per la rinascita dell’EU-ROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. ... Grecia: 56 morti negli incendi. Salva Olimpia.26 agosto 2007, di Federico La Sala
Grecia: 56 morti negli incendi. Salva Olimpia *
I vigili del fuoco greci hanno annunciato di aver trovato altri 5 corpi privi di vita sull’isola d Evia, nel mare Egeo, facendo salire a 56 morti il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando il Peloponneso, nel sud della Grecia. Un bilancio terribile, che fa degli incendi scoppiati in questi giorni nella penisola greca una delle catastrofi di questo genere più gravi della storia.
Ad un certo punto si era temuto che l’incendio potesse distruggere i resti della città di Olimpia. La polizia aveva dettio che le fiamme erano giunte a lambire i bordi del sito archeologico, uno dei più importanti del mondo. Ma in serata l’annuncio che le rovine di Olimpia erano state «salvate» dalle fiamme. «Il nuovo museo archeologico è stato salvato e le fiamme non sono penetrate nel sito dell’antica Olimpia», ha dichiarato Christos Zahopoulos, segretario generale del ministero della Cultura. La notizia è stata confermata anche dai vigili del fuoco sul luogo: «Le fiamme hanno raggiunto la collina sovrastante l’antica Olimpia ma sono state fermate poco prima che attaccassero il sito archeologico», ha dichiarato un portavoce dei pompieri che ha specifcato che «sei aerei, due elicotteri e 15 autobotti sono impegnati in appoggio ai 45 pompieri sul posto». Da Atene il ministero della Cultura aveva fatto sapere che era stato evacuato il museo archeologico che sorge a poche decine di metri dal tempio che anticamente ospitava la statua del padre degli dei realizzata da Fidia, una delle sette meraviglie del mondo antico. Olimpia è considerata patrimonio universale dell’umanità secondo l’Unesco e rappresenta uno dei siti storici più importanti per la Grecia. Abitata dai tempi preistorici a partire dal decimo secolo avanti Cristo divenne un centro dedicato al culto di Zeus. Accanto al tempio restano le vestigia delle strutture dove a partire dal 776 A.C. si svolgevano ogni quattro anni i giochi in onore di Giove.
La lotta contro le fiamme in Grecia è diventata rapidamente un affare internazionale. La Grecia ha annunciato di avere chiesto e ottenuto, anche l’aiuto degli Stati Uniti e della Russia per fare fronte agli incendi. Il ministro degli Esteri greco, Dora Bakoyannis, ha anche voluto anche ringraziare tutti i Paesi europei che hanno risposto agli appelli d’aiuto lanciati da Atene fin da venerdì. La «loro risposta è stata immediata, e generale», ha sottolineato il ministro aggiungendo che anche Israele ha inviato aiuti. Stando a quanto riferisce il ministero degli Esteri, sono stati messi a disposizione dai Paesi vicini e dell’Ue 14 aerei e 10 elicotteri, mentre Cipro ha messo a disposizione sei veicoli e ha inviato 60 vigili del fuoco.
* l’Unità, Pubblicato il: 26.08.07, Modificato il: 26.08.07 alle ore 18.46
-
> Per la rinascita dell’EU-ROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. ... Grecia in fiamme. Salva Olimpia ... Come dire che è l’Occidente stesso che sta andando a fuoco. Intervista a Eva Cantarella.28 agosto 2007, di Federico La Sala
Eva Cantarella: «Tutti pazzi per la Grecia ma ha anche facce oscure»
di Giuliano Capecelatro *
«Olimpia? Ma è il simbolo stesso della grecità. Il luogo in cui i Greci si sentivano per una volta nazione». Risponde da una barca. Casualmente proprio davanti alle coste greche. Per sua fortuna, a considerevole distanza dalle terre devastate dalle fiamme. Eva Cantarella, ordinario di Istituzioni di diritto romano e di Diritto antico greco alla Statale di Milano, è in vacanza. Ma l’argomento, che da decenni è al centro dei suoi interessi, e su cui ha scritto libri importanti, la stuzzica troppo perché si sottragga alle domande che rimbalzano da Roma via cellulare. Olimpia simbolo della grecità, che informa la civiltà moderna. Come dire che è l’Occidente stesso che sta andando a fuoco.
«Io eviterei certi luoghi comuni. Sì, Olimpia rappresentava la grecità. Qui i Greci, impegnati di solito a guerreggiare tra loro, concludevano la pace olimpica per la stagione della gare, due mesi. Ma lo spirito con cui si andava ad Olimpia era del tutto differente da quello dei nostri giochi olimpici».
Vuol dire che non strombazzavano, come si fa oggi sotto la sferza degli sponsor, di sport che affratella?
«Al contrario. Si andava ad Olimpia ben determinati a vincere. La vittoria faceva addirittura parte dell’etica del cittadino. Vincere se stessi e gli altri rappresentava un valore positivo. Significava aver dato il meglio di sè. E le gare atletiche mostravano la virtù di un uomo. La percezione della Grecia è molto legata ad una visione storiografica superata. Il miracolo greco. Atene dove tutto fiorisce, la Grecia culla della civiltà. Una concezione romantica alla Winkelmann».
È indubbio, però, che quei valori sono arrivati fino ad oggi.
«In realtà quando De Coubertin ha rispolverato i giochi olimpici, ha inventato un motto che è proprio l’antitesi di quello che pensavano i greci. Per loro non era importante partecipare, ma soltanto vincere. Il poeta Pindaro scrive che chi perde a Olimpia torna a casa per sentieri obliqui».
Insomma i costumi erano alquanto degenerati rispetto ai tempi degli eroi di Omero.
«E perché? Gli eroi di Omero fanno a gara a chi ammazza di più. L’eroe è il più forte, quello che vince. Solo in seguito questa concezione sarà stemperata da valori collaborativi, come l’idea di giustizia».
Che peraltro non ha mai prodotto una costruzione monumentale simile al diritto romano.
«Il diritto greco è stato qualcosa di molto diverso. Non c’è stata una scienza giuridica. Soltanto pratica. Non si faceva riflessione teorica. Era un compito riservato ai soli filosofi. Quel poco che sappiamo, lo abbiamo appreso per lo più da opere letterario. Il che ha un suo fascino. La giustizia era il campo in cui si cimentavano i grandi retori. Che scrivevano discorsi, difese e accuse, che i loro clienti ripetevano poi a memoria davanti al giudice. Bisognava incantare i giudici popolari, che in qualche processo ad Atene arrivavano alla bella cifra di cinquecentouno. E i retori erano abilissimi a imbrogliare le carte. Anche perché i giudici non conoscevano la legge. Era la parte che doveva esporgliela, come elemento di prova».
Sembra di scorgere qualche ombra su quella che acriticamente viene considerata un’epoca dell’umanità luminosa.
«Tantissime ombre. Intanto era una società fondata sullo schiavismo. Con Aristotele che teorizzava convinto l’inferiorità naturale dello schiavo. Riservando lo stesso trattamento alla donna. Cui si assegnava una capacità di deliberare di poco superiore a quella di uno schiavo. Persino nella riproduzione le veniva assegnato un ruolo passivo. Un recipiente. Il vero genitore era il padre».
Non si può disconoscere, però, che la civiltà moderna debba tanto all’Ellade.
«Certo. Ma non era tutta farina del loro sacco. I Greci avevano debiti cospicui. Con la civiltà mediorientale. Fino a qualche tempo fa si ammetteva solo qualche lascito dagli ittiti, popolo indoeuropeo, perché dominava una concezione eurocentrica. Oggi sappiamo bene che i debiti c’erano anche con le civiltà semite, con l’Egitto. La mitologia riprende temi orientali. Crono che castra Urano è presente anche nelle mitologie mediorientali. Non sono figure che sorgono autonomamente dappertutto. E l’alfabeto fenicio viene rielaborato, reso più duttile, ma è sempre una derivazione».
Dunque, non una ma tante Grecie quanto erano le città-Stato. Cosa rappresentavano e cosa possono rappresentare per l’uomo moderno?
«Atene è senza dubbio la democrazia. E la democrazia è anche l’arte, la bellezza. Tanto grande da non farci vedere le ombre, che appunto ci sono. Sparta... Sparta è il simbolo dell’aristocrazia. ma anche del rigore morale. Delle madri che davano lo scudo al figlio che partiva per la guerra e dicevano: o con questo o su questo. Delfi si identificava con la Pizia, le profezie, l’al di là...»
Il lato oscuro che spesso trascurato, l’orfismo...
«Ma c’era anche un aspetto positivo in questo. Costruttivo. Si andava dall’oracolo per avere un responso su una città da fondare. Un elemento razionale. Non era tutto concentrato sui fumi che uscivano dalla terra».
E all’uomo moderno cosa può dire ancora quella civiltà, oltre alla visione dei suoi resti?
«Agli italiani, agli europei, che hanno una superiore cultura classica, molto. Il Partenone, anche se mitizzato, resta un simbolo unico della bellezza e della civiltà. Salire sull’Acropoli di Atene è sempre una grandissima emozione. Fa penetrare una luce nelle coscienze».
* l’Unità, Pubblicato il: 28.08.07, Modificato il: 28.08.07 alle ore 8.21
-
> Per la rinascita dell’EU-ROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. ... Una riflessione sul futuro della nostra civiltà (di Dario Antiseri).9 agosto 2008, di Federico La Sala
anticipazioni
Europa, la forza di una storia antica
Dai Greci alla rivoluzione cristiana: ragione critica, pluralismo, valore sacro della persona hanno formato i tratti costitutivi dell’identità europea. Una riflessione sul futuro della nostra civiltà
DI DARIO ANTISERI (Avvenire, 09.08.2008)
Non pochi intellettuali, sicuramente ben intenzionati, hanno a più riprese sottolineato il fatto che l’Europa non ha avuto e non ha oggi e ancor più non avrà domani una filosofia unica, una fede unica, un’unica morale. Ed hanno visto e vedono in ciò la debolezza dell’Occidente, la fragilità dell’Europa.
L’Europa, insomma, sarebbe debole senza una simile «idea portante ed unitaria, una fede unica» da contrapporre con orgoglio ad altre culture ben più monolitiche e dogmatiche. Siffatta opinione, largamente diffusa è, in qualche modo, comprensibile.
Tuttavia, ha scritto non molti anni fa Karl Popper: «Io la reputo fondamentalmente errata. Dovremmo essere orgogliosi di non possedere un’unica idea, bensì molte idee, buone e cattive, di non avere una sola fede, un’unica religione, quanto piuttosto parecchie fedi, buone e cattive. È un segno della superiore energia dell’Occidente il fatto che ce lo possiamo permettere. L’unità dell’Occidente su un’unica idea, su un’unica fede, su un’unica religione, sarebbe la fine dell’Occidente, la nostra capitolazione, il nostro assoggettamento incondizionato all’idea totalitaria» L’Europa è la sua storia. E la storia d’Europa non è la storia di un’unica idea, di una tradizione monolitica. La storia dell’Europa è piuttosto la storia - certo punteggiata anche di errori, di soprusi, di massacri - di una tradizione in cui nascono, si sviluppano, si incontrano e si scontrano più idee filosofiche e più idee religiose, svariate proposte politiche e più visioni del mondo: buone e cattive.
L’Europa è la sua storia. E questa storia non è la storia di un’idea che permette una sola tradizione, ma è la storia di una tradizione che permette le idee più diverse ed azzardate. Non è la storia di una prigione mentale; è piuttosto la storia - talvolta dolorosa, talvolta impazzita - della provincia del mondo che ha conosciuto la fioritura più varia e ricca di idee (buone e cattive) spesso in contrasto tra di loro. Ed è proprio questo ciò che distingue l’Europa e la sua storia dalla storia di altre culture.
Qui sta, appunto, il destino comune dell’Europa: ragione critica, pluralismo, tolleranza. La nostra civiltà - è Popper a parlare ancora - è la migliore perché la più capace di autocorreggersi. Si autocorregge perché guidata dal valore della ragione critica - e perché critica è anche tollerante. Ragione critica, pluralismo, rispetto delle diversità, e tolleranza sono elementi che, in una storia travagliata, hanno contribuito a delineare i tratti dell’identità europea. Una consapevolezza, questa, che va da Strabone, il quale parlava dell’Europa come di «una nazione dai cento volti»; a santo Stefano, il re di Ungheria, che nei Monita ai suoi eredi faceva presente che « unius linguae uniusque moris regnum fragile est »; giù giù sino a Jakob Burckhardt.
Ragione critica, pluralismo e tolleranza - linee portanti della nostra tradizione. Esiti essi stessi di tentativi e di errori, non sempre egemoni, questi valori, qui o là, per periodi più o meno lunghi, sono stati avversati, messi in ombra, calpestati. Ma sono di continuo riemersi. L’albero tagliato è rinato; le sue radici erano solide. Ed esse affondano nella cultura greca da una parte e nel messaggio cristiano dall’altra. È un pensatore laico come Popper a riconoscere il valore che la tradizione cristiana attribuisce alla coscienza dei singoli individui. Per un umanitario, e soprattutto per un cristiano, egli scrive «non esiste uomo che sia più importante di un altro uomo». E ancora: la coscienza di ogni singola persona, unita con l’altruismo, «è diventata - scrive Popper la base della nostra civiltà occidentale ». È la dottrina centrale del Cristianesimo («ama il prossimo tuo», dice la Scrittura, e non «ama la tua tribù») ed è il nucleo vivo di tutte le dottrine etiche che sono scaturite dalla nostra civiltà e l’hanno alimentata.
È anche, per esempio, la dottrina etica centrale di Kant («devi sempre riconoscere che gli individui umani sono fini e che non devi mai usarli come meri mezzi ai tuoi fini»). Non c’è alcun altro pensiero che abbia avuto tanta influenza nello sviluppo morale dell’uomo.
Ho richiamato questi pensieri di Popper sul valore che il Cristianesimo dà alla libera e responsabile coscienza di ogni singola persona, perché l’idea cristiana di uomo «fatto ad immagine e somiglianza di Dio» ha creato, a livello politico, una tensione che attraversa tutta la storia. Si tratta, infatti, di un ideale che, pur tra vicissitudini compromissorie anche torbide, tra tentazioni «teocratiche» o rifiuti satanocratici del potere politico, ha esercitato, nell’evoluzione storica, una pressione a volte travolgente sull’elemento mondano antitetico. «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio»: con ciò entrava nella storia il principio che Káysar non è Kýrios - il potere politico veniva desacralizzato, l’ordine mondano relativizzato, e le richieste di Cesare sottoposte ad un giudizio di legittimità da parte di una inviolabile coscienza.
Káysar non è Kýrios: una spina nella carne nelle pretese onnivore del potere politico, principio religioso ed insieme etico, sorgente inesauribile di una miriade di corpi intermedi (ospedali, orfanotrofi, associazioni di carità, ordini religiosi, confraternite, monti frumentari, scuole cattedrali, università, scuole professionali, cooperative, movimenti politici, casse di risparmio, giornali diocesani, organizzazioni giovanili, ecc.) che, pur tra cedimenti e collusioni, hanno rappresentato nella storia dell’Occidente il presidio di iniziative libere di libere persone.
Da questa prospettiva il Cristianesimo è stato l’evento politico più importante dell’Occidente: per decreto religioso lo Stato non può essere tutto. La teocrazia, in questo modo, non fa parte del destino dell’Europa. Ê questo un tratto che distingue quella dell’Europa da altre civiltà. È, appunto, nel messaggio cristiano che affondano le radici di quel grande principio di libertà che è il principio di sussidiarietà. D a parte sua, un pensatore laico come Benedetto Croce ha precisato, «per semplice osservanza della verità», che «il cristianesimo è stata la più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuto» - e ciò «per la ragione (...) che la rivoluzione cristiana operò nel centro dell’anima, nella coscienza morale, e, conferendo risalto all’intimo e proprio di tale coscienza, quasi parve che le acquistasse una nuova virtù, una nuova qualità spirituale, che fino ad allora era mancata all’umanità». In realtà, con il Cristianesimo viene al mondo il concetto di uomo come persona: persona libera, responsabile, con una coscienza inviolabile. I Greci avevano avvicinato, tramite l’idea di psyche, una simile prospettiva, ma non l’avevano raggiunta. E il valore infinito, sacro, di una persona, di un uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio implica e trascina con sé il ridimensionamento dell’ordine politico.
Considerazioni del genere - ed altre se ne potrebbero aggiungere rendono impossibile dar torto a Thomas S. Eliot allorché scrive che «se il cristianesimo se ne va, se ne va tutta la nostra cultura. E allora si dovranno attraversare molti secoli di barbarie». Stando così le cose, è davvero incomprensibile, da una prospettiva puramente culturale e «per semplice osservanza della verità», la posizione di quanti si sono ostinati a non voler inserire nella Costituzione europea il richiamo alle radici cristiane dell’Europa. Chi, quale cultura rappresentano costoro? In quale storia si sentono inseriti?
Certo, la nostra Europa è già plurietnica e multiculturale e sempre più lo sarà nei prossimi decenni. Ma perché simile realtà possa dare i frutti di un fecondo dialogo e magari di «felici contaminazioni», è più che mai urgente non perdere la consapevolezza della nostra identità. Come ha insegnato Hans Georg Gadamer, «ci si può comprendere soltanto se si è diversi», unicamente se si è consapevoli dei tratti della nostra identità. Il rispetto nei confronti degli altri, il dovuto rispetto nei confronti delle tradizioni «altre» non implica la cancellazione della nostra tradizione. Rispettare gli altri non equivale ad annientare noi stessi. E gli altri, alcuni «altri», dovrebbero capire che sono rispettati anche e soprattutto perché c’è chi ha accettato e accetta il messaggio di Colui che è morto in croce
-
-
-
-
