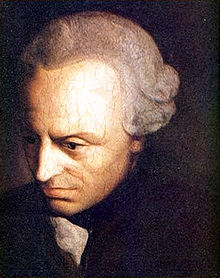
LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? Una riflessione di Angelo Casati - a cura di Federico La Sala
- [...] Qualcuno di noi forse ricorda che don Primo Mazzolari era solito dire che rimettersi totalmente, ciecamente a un uomo, per autorevole che fosse, era come dimettersi da uomo. E agli uomini della sua parrocchia puntualmente ricordava: "Quando entrate in chiesa vi togliete il cappello, non la testa". Togliersi la testa, o per paura di pensare o per fatica di pensare, non è fare opera gradita a Dio, che ha fatto dono dell’intelligenza ai suoi figli [...]
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO (E DELLA SUA COSMOTEANDRIA): "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
Libera parola. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? Ovvero della paura di pensare
di Angelo Casati (mosaico di pace, novembre 2010)
Leggo da bastian contrario la parabola dei tre che un giorno si trovarono nelle mani una somma di denaro da capogiro, una cifra smisurata, solo che si pensi che un talento in quei tempi corrispondeva verosimilmente alla paga di sudore di anni di dura fatica. Uno di loro di talenti se ne trovò tra le mani cinque, uno tre, il terzo un talento, e non era poco! Il loro signore era in partenza per un viaggio, consegnava alla fantasia delle loro mani una parte ingente dei suoi beni. Era uno che credeva nelle loro capacità. Così è Dio. È un generoso, ha fiducia. Non è di quelli che ti stanno con il fiato sul collo, con mille controlli, non è della razza sospettosa dei sorveglianti, lui se ne va, si fida. Vuole che, se tu ti dai da fare, non sia per occhi di padrone, ma per risposta a una fiducia.
Sappiamo anche che per i primi due quella fiducia fu come spinta di vento nelle vele di una barca. Il loro signore al ritorno li vide arrivare con un lago di gioia negli occhi, tenevano in mano l’attestato di un raddoppio dei talenti. E, come fossero riusciti a tanto, forse non sarebbe stato facile nemmeno per loro spiegare. Che poi il loro signore fosse un generoso ne ebbero la riprova appena lo sentirono reagire: non solo non esigeva il ritorno dei talenti, anzi li faceva partecipi della gestione del suo patrimonio. E non solo del patrimonio, anche della sua gioia. Ognuno dei due se lo sentì dire, le parole erano queste: "Prendi parte alla gioia del tuo padrone". Quelle parole cantavano nell’anima. C’era da stropicciarsi gli occhi. Così fa Dio.
Ma il terzo? Lo videro quello stesso giorno arrivare senza festa, aveva un lago buio negli occhi. Quando prese a parlare si accorse che le parole gli uscivano come legate e precipitose insieme, aspre, aspre come il cuore che gli martellava dentro, disse: "Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Ecco ciò che è tuo!".
Ho letto la parabola e ti confesso che mi sono fermato qui, come ci fosse un inciampo di dolore. Quasi non mi interessasse, più di tanto, proseguire. Da un lato misuravo la ferita, la ferita di quel signore - già, tu lo sai, le parole a volte sono lama e nemmeno immagini dove fanno strazio. Erano parole che rovesciavano impudenti l’immagine, quella del signore della parabola e quella di Dio. E tu ci rimani male, male da morire quando rovesciata è la tua immagine, con un’accusa di durezza. Dio uomo duro?
Ma a fermarmi nella lettura, ti dirò, anche le parole a seguire: "Ho avuto paura, sono andato a nascondere sotto terra...". Mi riportavano d’istinto ad altre parole, quelle delle origini, quelle di Adamo di risposta a Dio quando lui e la sua donna udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno: "Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto" (Gn 3, 8).
Sorprendenti assonanze. "Ho avuto paura e mi sono nascosto". "Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra". La paura che ci fa nascondere, la paura che fa nascondere i talenti! La paura fa nascondere sotterra la nostra intelligenza. Quasi fosse attentato all’umiltà o arroganza dello spirito il pensare con la propria testa.
non è in cielo
Qualcuno di noi forse ricorda che don Primo Mazzolari era solito dire che rimettersi totalmente, ciecamente a un uomo, per autorevole che fosse, era come dimettersi da uomo. E agli uomini della sua parrocchia puntualmente ricordava: "Quando entrate in chiesa vi togliete il cappello, non la testa".
Togliersi la testa, o per paura di pensare o per fatica di pensare, non è fare opera gradita a Dio, che ha fatto dono dell’intelligenza ai suoi figli. In un midrash della letteratura rabbinica si narra di alcuni rabbini che un giorno si misero a disputare accesamente su un punto della legge. Rabbi Eliezer produsse argomenti possibili per dimostrare il suo punto di vista. Ma gli altri rabbini non si lasciavano convincere dagli argomenti di Rabbi Eliezer. Alla fine una voce celeste sembrò confermare il pensiero di Rabbi Eliezer. Ma Rabbi Joshua subito esclamò: "Non è in cielo". Che cosa significava quella citazione del Deuteronomio "non è in cielo"? Rabbi Jirmijah spiegò: "La Torah fu rivelata sul monte Sinai. Perciò non occorre che continuiamo a occuparci di voci celesti: la Torah del Sinai contiene già il principio che decisivo è il voto della maggioranza".
Il midrash sulla accesa disputa tra rabbini si conclude raccontando che quel giorno Rabbi Nathan incontrò il profeta Elia. E gli domandò che cosa avesse fatto Dio in quel momento. Il profeta rispose: "Dio ha sorriso e ha detto: I miei figli mi hanno superato! I miei figli mi hanno superato!". Che il Dio della Bibbia abbia il volto del Dio che sorride per i figli, per i figli che mettono in campo tutta la loro arte di interrogare e di interrogarsi, e non per i figli che sonnecchiano pigri accettando tutto passivamente, è buona notizia. È notizia di un Dio che onora ed è onorato dall’intelligenza, un’intelligenza che è incantamento davanti al mistero, che è la gioia di dare un nome alle cose, ma nello stesso tempo di percepire quel nome "relativo", segnato da una povera misura e subito ricorrere a un altro nome e a un altro ancora, in una ricerca inesausta.
oltre le ombre
Oggi tra i lamenti che succede sempre più spesso di ascoltare c’è pure il risentimento contro una stagione come la nostra, in cui verità che sembravano assolute, indubitabili, immobili, agli occhi di molti non appaiono più tali e ciò crea in non pochi una sorta di spaesamento.
Mi chiedo se, anziché allungare la serie delle lamentazioni sulla nequizia dei tempi, non potremmo riconoscere in questa nuova situazione quasi un’opportunità per il nostro essere credenti: sbenda la tua intelligenza! Sbendala, secondo l’ammonimento poco ricordato, quasi cancellato, di Gesù che invitava pressantemente a mettere in gioco tutta la nostra intelligenza, la capacità di ragionare con la propria testa, lontani da ogni pur velata forma di resa e di delega. Quel giorno alle folle, e dunque a tutti, diceva: "Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così succede. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, è così accade. Ipocriti, sapete giudicare l’aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?" (Lc 12, 56-57). Da voi stessi.
Non perdiamo tempo a fare lamento sulla notte e sulle ombre. Sarò un bastian contrario, ma mi è cara questa dimensione umbratile della vita e vorrei pregare Dio che me ne lasciasse una qualche misura, anche nell’al di là. Ricordo che in un vespero, in faccia a monti che amo, stupito dal lento intenerirsi del cielo, mi venne di pregare:
 "E se sarà un giorno
"E se sarà un giorno
 luce piena nel tuo regno,
luce piena nel tuo regno,
 non negare, o Dio,
non negare, o Dio,
 a questi poveri occhi
a questi poveri occhi
 il crepitare segreto
il crepitare segreto
 delle ombre.
delle ombre.
 Abito città
Abito città
 dove il sole
dove il sole
 è sempre già alto".
è sempre già alto".
Anche la notte non è immobile, anche le ombre non sono ferme. Può sembrare un pensiero bizzarro, ma forse non lo è del tutto se il cardinale Martini, nella prefazione al suo libro-intervista "Conversazioni notturne a Gerusalemme", riferendosi al fatto che quelle conversazioni tennero le ore della notte, dice: "di notte le idee nascono più facilmente che nella razionalità del giorno". Capite, notte come grembo. Grembo dice nascita, dice vita, e non stanca ripetizione.
Perché non avere occhi, dunque, per il crepitare segreto delle cose? È vero, forse si era più tranquilli quando ci si chiudeva in una stanza, la nostra, e si pensava che il cielo fosse contenuto in una stanza. Meno problemi, forse, meno interrogativi, meno spaesamento. Ci si poteva anche concedere il lusso di non pensare. Ma a quale prezzo? A prezzo della negazione dell’oltre dell’orizzonte, a prezzo dell’impoverimento della visione, a prezzo del soffocamento del brivido della ricerca. Chiusi nella prigione di una verità monolitica e spenta, ma chiusi anche nella stanza purtroppo del proprio risentimento, incapaci di dialogo, incapaci di cuore.
Fermi, immobili nel pensiero, quasi bastassimo a noi stessi. Mi ritornano al cuore e me lo aprono, mi aprono cuore e intelligenza, le parole di uno dei più limpidi testimoni cristiani in terra di dialogo, il vescovo Pierre Claverie, che diceva: "Credo in Dio, ma non pretendo di possedere quel Dio. Non si possiede Dio. Non si possiede la verità e io ho bisogno della verità degli altri".
Onorare l’intelligenza, stare in faccia alle montagne o chiudersi nella scatola di un appartamento? Ho sorpreso le immagini nelle parole rivolte da Tiziano Terzani ad Oriana Fallaci, in "Lettere contro la guerra": "Mi piace essere in un corpo che ormai invecchia. Posso guardare le montagne senza il desiderio di scalarle. Quand’ero giovane le avrei volute conquistare. Ora posso lasciarmi conquistare da loro. Le montagne, come il mare, ricordano una misura di grandezza dalla quale l’uomo si sente ispirato, sollevato. Quella stessa grandezza è anche in ognuno di noi, ma lì è difficile riconoscerla. Per questo siamo attratti dalle montagne. Per questo, attraverso i secoli, tantissimi uomini e donne sono venuti quassù nell’Himalaya, sperando di trovare in queste altezze le risposte che sfuggivano loro restando nelle pianure. E continuano a venire.
L’inverno scorso davanti al mio rifugio passò un vecchio Sanyasin vestito d’arancione. Era accompagnato da un discepolo, anche lui rinunciatario. ’Dove andate, Maharaj?’ gli chiesi. A cercare Dio’, rispose, come fosse stata la cosa più ovvia del mondo. (...)
Per questo sto, Oriana, anch’io ritirato in questa sorta di baita nell’Himalaya indiana, dinanzi alle montagne più divine del mondo. Passo ore, da solo, a guardarle, lì maestose e immobili, simbolo della più grande stabilità, eppure anche loro, col passare delle ore, continuamente diverse e impermanenti, come tutto nell’universo. La natura è una grande maestra, Oriana, e ogni tanto bisogna tornare a prendere lezione. Tornaci anche tu. Chiusa nella scatola di un appartamento dentro la scatola di un grattacielo, con dinanzi altri grattacieli pieni di gente inscatolata, finirai per sentirti sola davvero; sentirai la tua esistenza come parte di un tutto molto, molto più grande di tutte le torri che hai davanti e di quelle che non ci sono più. Guarda un filo d’erba al vento, e sentiti come lui. Ti passerà anche la rabbia e sentirai l’amore".
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
 PARRHESIA EVANGELICA: IL FARISEISMO CATTOLICO-ROMANO E LA NOVITA’ RADICALE DELL’ANTROPOLOGIA CRISTIANA. PARLARE IN PRIMA PERSONA, E IN SPIRITO DI CARITA’.
PARRHESIA EVANGELICA: IL FARISEISMO CATTOLICO-ROMANO E LA NOVITA’ RADICALE DELL’ANTROPOLOGIA CRISTIANA. PARLARE IN PRIMA PERSONA, E IN SPIRITO DI CARITA’.
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
Federico La Sala
Forum
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. --- ANTROPOLOGIA E CRISTIANESIMO: ERMANNO OLMI E "IL VILLAGGIO DI CARTONE". L’INVITO AA FARE "COME DIO", A "DIVENTARE UOMO".9 maggio 2024, di Federico La Sala
VITA E #FILOSOFIA: KANT ("LA FINE DI TUTTE LE COSE", 1794) E L’HEGELIANO " #DESTINO DEL #CRISTIANESIMO" (ERMANNO #OLMI, 2011). Appunti sul tema.
- Un invito a rileggere l’opera di Immanuel Kant, "La fine di tutte le cose" e a rivedere il film di Ermanno Olmi, "Il villaggio di cartone".
- In memoria di Enzo Paci e di Carlo Maria Martini...
"VA’, RIPARA LA MIA CASA": LA SOLLECITAZIONE FATTA A FRANCESCO D’ ASSISI (SENZA PIU’ NEMMENO LA CHIARIFICAZIONE DI QUELLA DI DANTE ALIGHIERI), E’ RIMASTA NELLA "CADUTA", ALL’INFERNO, NELL’ORIZZONTE DELLA #TRAGEDIA.
"CENTOCHIODI"(Ermanno Olmi, 2007): UNA INDICAZIONE PER L’ USCITA DAL MILLENARIO CIRCOLO VIZIOSO DEL TRADIZIONALE #ANDROCENTRISMO DELLA TEOLOGIA PLATONICO-PAOLINA E COSTANTINIANA (DEL "CRISTO RE DELL’UNIVERSO", DEL "PADRONE GESù", DEL "DOMINUS IESUS") E PER L’APERTURA DI UN CIRCOLO VIRTUOSO DI UNA #ANTROPOLOGIA E DI UNA TEOLOGIA DEGNA DELL’ "ECCE HOMO" ("#ANTHROPOS"), CAPACE DI INVITARE A FARE "COME DIO", A "DIVENTARE #UOMO", E A FAR SI’ CHE OGNI ESSERE UMANO, OGNI #PERSONA, SAPPIA E POSSA DIRE ALLA LUCE DEL SOLE: "IO SONO L’ALFA E L’OMEGA".
ANTROPOLOGIA (KANTIANA) E CHIESA CATTOLICA (COSTANTINIANA): #NICEA 325 ED #EUROPA 2025. Lezione di #ErmannoOlmi:
- "[...] Ciascuno di noi è la vera chiesa. C’è qualcosa che mi fa dire in questo momento: «Cristiani svegliamoci! È il nostro momento». È il momento di presentarci agli altri dicendo all’altro «Ecco il volto di Cristo!»" ("“Ciascuno è la vera chiesa”, intervista ad Ermanno Olmi, a cura di #AriannaPrevedello, “settimana” - attualità pastorale, 4 marzo 2012).
- Nota:
- MEMORIA, #CINEMA E #STORIA: ERMANNO OLMI. "Ermanno Olmi (Bergamo, 24 luglio 1931 - Asiago, 7 maggio 2018) è stato un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, direttore della fotografia, montatore e scrittore italiano. [...]".
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. --- COSTANTINO, IL CONCILIO DI NICEA (325 -2025), E IL "PATRIARCA D’OCCIDENTE" (2024). La possibilità di celebrare insieme i 17 secoli dal Concilio di Nicea, come per un nuovo inizio.13 aprile 2024, di Federico La Sala
Santa Sede.
Il Papa torna a essere “patriarca d’Occidente”: che cosa vuol dire
di Redazione Catholica (Avvenire, giovedì 11 aprile 2024)
Il Papa torna a essere anche patriarca d’Occidente.
 Lo spiega l’agenzia Fides osservando come il titolo compaia nell’Annuario pontificio del 2024, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Tale definizione era scomparsa nel 2006 su disposizione di Benedetto XVI. Nel comunicato diffuso allora dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei cristiani si chiariva che il titolo di «patriarca d’Occidente» era stato adoperato nell’anno 642 da Papa Teodoro I. In seguito, il suo utilizzo aveva preso piede nel XVI e XVII secolo, «nel quadro del moltiplicarsi dei titoli del Papa» nell’’Annuario Pontificio esso era apparso per la prima volta nel 1863. Il termine “Occidente” - proseguiva il comunicato «non intende descrivere un territorio ecclesiastico né esso può essere adoperato come definizione di un territorio patriarcale». Quindi il titolo «patriarca d’Occidente» - prosegue Fides citando il comunicato del 2006 «descriverebbe la speciale relazione del Vescovo di Roma a quest’ultima, e potrebbe esprimere la giurisdizione particolare del Vescovo di Roma per la Chiesa latina». Tuttavia, la soppressione di tale titolo non sottintendeva “nuove rivendicazioni” papali rispetto alle Chiese d’Oriente, ma era espressione di un “realismo storico e teologico” che spingeva a mettere da parte un titolo considerato obsoleto.
Lo spiega l’agenzia Fides osservando come il titolo compaia nell’Annuario pontificio del 2024, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Tale definizione era scomparsa nel 2006 su disposizione di Benedetto XVI. Nel comunicato diffuso allora dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei cristiani si chiariva che il titolo di «patriarca d’Occidente» era stato adoperato nell’anno 642 da Papa Teodoro I. In seguito, il suo utilizzo aveva preso piede nel XVI e XVII secolo, «nel quadro del moltiplicarsi dei titoli del Papa» nell’’Annuario Pontificio esso era apparso per la prima volta nel 1863. Il termine “Occidente” - proseguiva il comunicato «non intende descrivere un territorio ecclesiastico né esso può essere adoperato come definizione di un territorio patriarcale». Quindi il titolo «patriarca d’Occidente» - prosegue Fides citando il comunicato del 2006 «descriverebbe la speciale relazione del Vescovo di Roma a quest’ultima, e potrebbe esprimere la giurisdizione particolare del Vescovo di Roma per la Chiesa latina». Tuttavia, la soppressione di tale titolo non sottintendeva “nuove rivendicazioni” papali rispetto alle Chiese d’Oriente, ma era espressione di un “realismo storico e teologico” che spingeva a mettere da parte un titolo considerato obsoleto.La scelta di papa Francesco di ripristinare il titolo di patriarca d’Occidente - prosegue ancora Fides - può essere collegata alla sua insistenza sulla importanza della sinodalità, e alla sollecitudine ecumenica che spinge a guardare sempre ai primi secoli del cristianesimo, quando tra le Chiese non c’erano lacerazioni di carattere dogmatico. Il titolo di patriarca d’Occidente richiama in qualche modo anche l’esperienza del Primo Millennio cristiano, quando le cinque sedi della cristianità antica (Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme), pur nella differenza delle rispettive storie e dei diversi accenti spirituali, rivestivano un rilievo particolare per il vincolo che le univa alla Tradizione apostolica. I rapporti di queste cinque sedi, nella comunione, apparivano strutturati nella prassi che gli studi di storia della Chiesa definiscono come “Pentarchia”.
In un momento storico segnato dal dilagare di conflitti che spingono i popoli verso il baratro di una terza guerra mondiale, la sollecitudine ecumenica vede come occasione propizia l’approssimarsi del 17° centenario del Concilio di Nicea, svoltosi nel 325 dopo Cristo. I cristiani - come ha suggerito Papa Francesco già il 6 maggio 2022 - hanno la possibilità di riunirsi e celebrare insieme i 17 secoli dal Concilio di Nicea, come per un nuovo inizio. E nel 2025, tutti i cristiani per coincidenze di calendario, tutti i cristiani celebreranno la Pasqua nello stesso giorno, domenica 20 aprile.
Dunque, nell’Annuario pontificio, i titoli del Papa sono: vicario di Gesù Cristo, successore del principe degli apostoli, Sommo Pontefice della Chiesa universale, patriarca d’Occidente, primate d’Italia, arcivescovo e metropolita della provincia romana, sovrano dello Stato della Città del Vaticano, servo dei servi di Dio.
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. ---FACOLTÀ DI GIUDIZIO, FILOLOGIA (LOGOS): COME "PERDERE LA TESTA", SENZA NEMMENO ACCORGERSENE: DALL’EVANGELO AL "VANGELO"9 gennaio 2024, di Federico La Sala
FACOLTÀ DI GIUDIZIO, FILOLOGIA (LOGOS), E MESSAGGIO EVANGELICO.
ALCUNE NOTE SUL "SÀPERE AUDE" ("RISOLVITI AD ASSAGGIARE") E SUL SONNODOGMATICO...
- RITORNO AL #FUTURO, 8: CON #GALILEO #GALILEI E #IMMANUEL #KANT, #PROVARE PER #CREDERE... #8Gennaio 2024
- In #memoria dell’apostolo Tommaso e del teologo Tommaso d’Aquino, e del filosofo Immanuel Kant:
a) NOTIZIA DELL’APOSTOLO #TOMMASO DALL’#EVANGELO DI GIOVANNI: " Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò»" (Gv. 24-25).
b) NOTIZIA BIOGRAFICA DI TOMMASO D’AQUINO: " [...] La famiglia d’Aquino era in rapporti con #FedericoII di Svevia che aveva istituzionalizzato la #ScuolaMedicaSalernitana, primo centro di fruizione culturale degli scritti medici e filosofici di #Avicenna e #Averroè, noti al Dottore Angelico.
 Stabilendosi presso la sorella Teodora al castello dei Sanseverino, tenne una serie di lezioni straordinarie nella celebre Scuola Medica che aveva sollecitato l’onore ed il decoro della parola dell’Aquinate. A memoria del suo soggiorno, nella chiesa di San Domenico si conservano la reliquia del suo braccio e le spoglie delle sorelle.
Stabilendosi presso la sorella Teodora al castello dei Sanseverino, tenne una serie di lezioni straordinarie nella celebre Scuola Medica che aveva sollecitato l’onore ed il decoro della parola dell’Aquinate. A memoria del suo soggiorno, nella chiesa di San Domenico si conservano la reliquia del suo braccio e le spoglie delle sorelle.
 Il 29 settembre 1273 egli partecipò al capitolo della sua provincia a Roma in qualità di definitore. Ma alcune settimane più tardi, mentre celebrava la messa nella cappella di San Nicola, Tommaso ebbe una sorprendente visione tanto che dopo la messa non scrisse, non dettò più nulla e anzi si sbarazzò persino degli strumenti per scrivere. A Reginaldo da Piperno, che non comprendeva ciò che accadeva, Tommaso rispose dicendo: «Non posso più. Tutto ciò che ho scritto mi sembra #paglia in confronto con quanto ho #visto» [...]".
Il 29 settembre 1273 egli partecipò al capitolo della sua provincia a Roma in qualità di definitore. Ma alcune settimane più tardi, mentre celebrava la messa nella cappella di San Nicola, Tommaso ebbe una sorprendente visione tanto che dopo la messa non scrisse, non dettò più nulla e anzi si sbarazzò persino degli strumenti per scrivere. A Reginaldo da Piperno, che non comprendeva ciò che accadeva, Tommaso rispose dicendo: «Non posso più. Tutto ciò che ho scritto mi sembra #paglia in confronto con quanto ho #visto» [...]".c) "RISPOSTA ALLA DOMANDA: CHE COS’E’ L’ILLUMINISMO?" (I. Kant, 1784): «L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto d’intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell’Illuminismo.».
- NOTA
- COME "PERDERE LA TESTA", SENZA NEMMENO ACCORGERSENE:
DALL’EVANGELO AL "VANGELO"...
"Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù" ... Tenendo presente che #DIDIMO= #GEMELLO, il #messaggio evangelico (dell’apostolo Giovanni) è più che chiaro e senza equivoci, e, la sottolineatura interpretativa del "fratello-gemello" è stata fornita ed è stata "salvata": chi ha orecchie per intendere, intenda. A non cogliere queste apparenti (e non illusorie, kantianamente) "sfumature" filologiche, si rischia di restare e permanere nel "VAN-#GELO" del "giocastolaio" (l’erede paolino-romano della "caduta" biblica e della "tragedia" greca), e dell’EVANGELO, dell’EV-ANGELO (#EU-ANGELO - "#BUONA-NOVELLA"), e, infine, perdere per sempre la "E" ("la via, la vita, la verità"). In principio era il Logos, non il logo...
CINEMA, FILOLOGIA, TEATRO, METATEATRO, E PSICOANALISI DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA.
- "RITORNO AL FUTURO", 9:
A CARMELO BENE, IN MEMORIA...
Ricordando il film "Salomé" (1972), sollecitato da uno "strano" omaggio di uno studioso di #filosofia, appassionato di cinema, che voleva rendere onore alla tradizione culturale del Sud: " Come disse Carmelo Bene, solo i meridionali pensano", ho pensato che, probabilmente non è stata ancora aggiornata la #storiografia antropologica e cinematografica sulla qualità dell’opera teatrale e della cinematografia dello stesso Carmelo Bene , e, non si è ancora ben riflettuto sulla memoria semantica delle parole "CARMELO" e "BENE".
CUM GRANO SALIS. Cosa significa "carmelo", cosa "bene"?! Forse è non è bene interrogarsi ANCORA (di nuovo e meglio) sul "#sàpere aude" di Quinto #Orazio Flacco e di Immanuel Kant: provare per credere, per non "perdere la testa" (la vita stessa nelle illusioni della #propaganda).
(#8gennaio2024).
- Nota:
"SAPERE AUDE!" (KANT). #TEATRO, #FILOLOGIA E #PSICOANALISI. ALLA #LUCE DELLA EPIFANIA 2024 E DELLE APPARENZE DEL PRESENTE, utile #ricordarsi di Chi ("X") associava nel suo #Nome, #Carmelo e #Bene, e #cercare di #sapere dell’#Uno e dell’#Altro ("provare per credere").
MEMORIA E STORIA DEL CAMMINO DELL’UNITÀ LINGUISTICA E POLITICA ITALIANA:
- RITORNO AL FUTURO, 10....
"SÀPEREAUDE!" (ORAZIO-#KANT). UN APPUNTO IN RICORDO DI DUE CITTADINI DI #CERIGNOLA, UNITI DALLA PASSIONE DELLA #PAROLA E DALLA #POLITICA, E , SOPRATTUTTO DAL VOCABOLARIO: *
NICOLA ZINGARELLI (Cerignola 28 Agosto 1860 - †Milano 7 Giugno 1935) filologo e linguista italiano, autore dell’omonimo "Vocabolario della lingua italiana".
E
GIUSEPPE DI VITTORIO (Cerignola, 11 agosto 1892 - Lecco, 3 novembre 1957), sindacalista, politico e antifascista italiano. (Fondatore e segretario generale della CGIL fino alla morte e presidente della federazione sindacale mondiale.
*
LA SCOPERTA DEL VOCABOLARIO: "[...] Peppino diventa grande da molti punti di vista, dirige decine di migliaia di operai e braccianti, scrive lettere e corrispondenze per i giornali e ancora non sa dell’esistenza del vocabolario. Come egli stesso raccontava, l’ignoranza gli costa tanta fatica, lo costringe a sfogliare giornali e libri per ore nella speranza di trovare la parola che intende scrivere per poterla usare senza commettere errori.
 La scoperta, come racconta Felice Chilanti nella biografia pubblicata a puntate nel 1953 su Lavoro, settimanale della CGIL e ripubblicata su Rassegna.it in occasione del centenario della confederazione, avviene un giorno a #Barletta, lungo il bel viale della stazione. "Di Vittorio vide una bancarella di libri e cominciò a chiedere i prezzi, a scorrere gli indici, a calcolare le sue possibilità. In un angolo del banchetto vi era un grosso volume che Di Vittorio cominciò a sfogliare: era un libro vecchio, molto usato e anche sudicio. Scorrendo le pagine scoprì che conteneva lungi elenchi di parole e che accanto ad ogni parola era indicato il significato. [...] Era il libro che da tanto tempo cercava, lesse sulla copertina la nuova parola: vocabolario. Chiese al venditore il prezzo [...]: lire 3,75. Fu un grave colpo per lui: non aveva in tasca che una lira e settantacinque centesimi, e con estrema amarezza confidò la cosa al libraio. «Datemi almeno due lire e cinquanta» disse questi. Ma Di Vittorio non possedeva neppure un soldo di più. E già se ne stava andando amareggiato quando il libraio lo richiamò: «Nemmeno due lire volete darmi?». «Se volete vi dò la giacca, ma in tasca ho soltanto una lira e settantacinque».
La scoperta, come racconta Felice Chilanti nella biografia pubblicata a puntate nel 1953 su Lavoro, settimanale della CGIL e ripubblicata su Rassegna.it in occasione del centenario della confederazione, avviene un giorno a #Barletta, lungo il bel viale della stazione. "Di Vittorio vide una bancarella di libri e cominciò a chiedere i prezzi, a scorrere gli indici, a calcolare le sue possibilità. In un angolo del banchetto vi era un grosso volume che Di Vittorio cominciò a sfogliare: era un libro vecchio, molto usato e anche sudicio. Scorrendo le pagine scoprì che conteneva lungi elenchi di parole e che accanto ad ogni parola era indicato il significato. [...] Era il libro che da tanto tempo cercava, lesse sulla copertina la nuova parola: vocabolario. Chiese al venditore il prezzo [...]: lire 3,75. Fu un grave colpo per lui: non aveva in tasca che una lira e settantacinque centesimi, e con estrema amarezza confidò la cosa al libraio. «Datemi almeno due lire e cinquanta» disse questi. Ma Di Vittorio non possedeva neppure un soldo di più. E già se ne stava andando amareggiato quando il libraio lo richiamò: «Nemmeno due lire volete darmi?». «Se volete vi dò la giacca, ma in tasca ho soltanto una lira e settantacinque».
 Come avrete già immaginato, il libraio diede il vocabolario a Peppino, che passò la notte a sfogliarlo pagina dopo pagina. Ma la storia non finisce qui. Perché Di Vittorio il giorno dopo cominciò a segnare su un block notes tutte le parole sconosciute, udite negli incontri casuali, in treno, lette in un giornale o in un libro. «Ricordo ancora alcune di quelle parole - racconta egli stesso a Chilanti - come ad esempio idraulica, bigamia. Quando tornavo a casa ne apprendevo il significato sul vocabolario e lo trascrivevo con parole mie sul notes. Questo metodo mi aiutava molto. Con un metodo di poco diverso, molti anni dopo ho imparato il francese». (cfr. Vincenzo Moretti, "Il vocabolario di Peppino. Giuseppe Di Vittorio e il valore della conoscenza", La Stampa/Scuola, 19/6/2007).
Come avrete già immaginato, il libraio diede il vocabolario a Peppino, che passò la notte a sfogliarlo pagina dopo pagina. Ma la storia non finisce qui. Perché Di Vittorio il giorno dopo cominciò a segnare su un block notes tutte le parole sconosciute, udite negli incontri casuali, in treno, lette in un giornale o in un libro. «Ricordo ancora alcune di quelle parole - racconta egli stesso a Chilanti - come ad esempio idraulica, bigamia. Quando tornavo a casa ne apprendevo il significato sul vocabolario e lo trascrivevo con parole mie sul notes. Questo metodo mi aiutava molto. Con un metodo di poco diverso, molti anni dopo ho imparato il francese». (cfr. Vincenzo Moretti, "Il vocabolario di Peppino. Giuseppe Di Vittorio e il valore della conoscenza", La Stampa/Scuola, 19/6/2007). -
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? --- "Dynamic models of segregation" (Thomas Schelling). La "mano invisibile", la trave e la pagliuzza (di Luigino Bruni).7 novembre 2021, di Federico La Sala
Logica carismatica / 8.
La trave e la pagliuzza
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 6 novembre 2021)
- Alle radici dell’odierno nostro disagio c’è proprio la sottile sensazione d’impotenza, l’idea di rincorrere affannosamente qualcosa che di continuo si sottrae alla nostra comprensione
- Mario Pomilio, Taccuino industriale
La nostra civiltà ama moltissimo la libertà individuale, protegge con tutte le sue forze la sfera privata delle preferenze delle singole persone. La stessa società occidentale moderna da almeno mezzo secolo ha sviluppato teorie e analisi per studiare anche i fallimenti della sovranità dell’individuo. Quei casi nei quali il gioco delle scelte basate sulle preferenze individuali produce effetti collettivi perversi. Perché non sempre la "mano invisibile" che trasforma e aggrega le scelte dei singoli genera buone trasformazioni collettive, né per gli individui né la per le società.
 Un pioniere e un classico di questi studi è il premio Nobel per l’Economia Thomas Schelling, che ha mostrato, tra l’altro, che la cultura che si afferma in una comunità è diversa dalle preferenze dei singoli membri che la compongono. Noto è il suo studio sull’auto-segregazione razziale involontaria nelle scelte abitative ("Dynamic models of segregation", 1971), dove dimostrò che affinché in una città si formino quartieri segregati di soli bianchi e quartieri di soli neri, non c’è bisogno che le singole persone pensino: "Io voglio stare in un quartiere di soli bianchi" o di "soli neri". È invece sufficiente che gli abitanti bianchi (o neri) pensino: "Non voglio abitare in mezzo a due case di famiglie di neri (o di bianchi)", e in certi casi è sufficiente: "Non voglio vivere accanto a tre famiglie diverse da me". Queste preferenze individuali, che in sé non sembrerebbero radicali, producono invece un esito radicale, e ci si ritrova in un mondo che nessuno vorrebbe e voleva.
Un pioniere e un classico di questi studi è il premio Nobel per l’Economia Thomas Schelling, che ha mostrato, tra l’altro, che la cultura che si afferma in una comunità è diversa dalle preferenze dei singoli membri che la compongono. Noto è il suo studio sull’auto-segregazione razziale involontaria nelle scelte abitative ("Dynamic models of segregation", 1971), dove dimostrò che affinché in una città si formino quartieri segregati di soli bianchi e quartieri di soli neri, non c’è bisogno che le singole persone pensino: "Io voglio stare in un quartiere di soli bianchi" o di "soli neri". È invece sufficiente che gli abitanti bianchi (o neri) pensino: "Non voglio abitare in mezzo a due case di famiglie di neri (o di bianchi)", e in certi casi è sufficiente: "Non voglio vivere accanto a tre famiglie diverse da me". Queste preferenze individuali, che in sé non sembrerebbero radicali, producono invece un esito radicale, e ci si ritrova in un mondo che nessuno vorrebbe e voleva.Tutto ciò vale per la segregazione etnica ma anche per ogni forma di intolleranza collettiva, perché una cultura radicalmente razzista e intollerante può essere generata da persone non così razziste e intolleranti se prese una a una. Quella piccola "soglia" di chiusura che mi impongo, che alla mia coscienza non appare particolarmente intollerante, combinata con le piccole soglie degli altri finisce per diventare un alto muro. Come se in quel limite che metto alla mia tolleranza e diversità si insinuasse un tarlo che interagendo con i tarli degli altri erode la radice della convivenza civile. Per evitare questi esiti tristi e involontari dovremmo educarci a tenere le soglie di intolleranza molto basse, magari eliminarle - sta in buona parte qui ogni sfida educativa. Perché questi studi ci dicono che le collettività amplificano le barriere dei singoli, non le riducono. La pagliuzza nell’occhio dell’«io» diventa una trave del «noi»; e una volta creata, quella trave prende il posto della pagliuzza e impedisce la vista a tutti.
 Le analisi di Schelling sono tra le più importanti nelle scienze sociali contemporanee. Oggi sono applicate ai fenomeni climatici e alle scelte in materia di consumo, dove ci si ritrova con esisti collettivi e globali molto gravi e insostenibili anche quando le preferenze delle singole persone sarebbero più ecologiche. Questi esiti non dipendono soltanto dagli effetti indiretti delle nostre scelte (le note "esternalità"), ma da fenomeni più complessi che scattano aggregando le preferenze dei singoli individui.
Le analisi di Schelling sono tra le più importanti nelle scienze sociali contemporanee. Oggi sono applicate ai fenomeni climatici e alle scelte in materia di consumo, dove ci si ritrova con esisti collettivi e globali molto gravi e insostenibili anche quando le preferenze delle singole persone sarebbero più ecologiche. Questi esiti non dipendono soltanto dagli effetti indiretti delle nostre scelte (le note "esternalità"), ma da fenomeni più complessi che scattano aggregando le preferenze dei singoli individui.Tutto ciò è particolarmente rilevante anche per ogni tipo di organizzazione e comunità. Ogni comunità genera una sua cultura collettiva e una identità che è molto evidente a chi la osserva da fuori - un po’ meno a chi la guarda dal di dentro. Anche qui succede che la cultura e le prassi che si generano siano più radicalizzate delle preferenze dei singoli membri. La cultura comunitaria che noi osserviamo non è la foto della cultura dei singoli. Ogni comunità sviluppa un suo stile, una sua personalità spirituale, un proprio linguaggio e gergo con tratti specifici ed espressioni comprensibili solo dai membri della comunità; genera modi di pregare, di muoversi, ammiccamenti, gesti, uno stile di abbigliamento... che si auto-rafforzano con il passare del tempo. Questi tratti collettivi non sono né la media né la somma né il prodotto dei comportamenti dei singoli, né il risultato dell’imitazione che tutti fanno di un leader (come accade invece nelle mode). Certamente, diversamente da altre istituzioni e organizzazioni, nelle comunità carismatiche il fondatore ha un ruolo speciale, ma la cultura collettiva non è la gigantografia del fondatore, né è da questi voluta - in questi processi il fondatore pesa più degli altri, ma non abbastanza da determinare la cultura collettiva. Le stesse correnti interne che si formano nelle comunità, cioè i circoli minori e i sotto-gruppi, che arrivano fino alla composizione dei tavoli nella mensa, sono risultati sovente generati da persone che, prese una a una, sarebbero più aperte e dialogiche dei gruppi chiusi cui danno vita. L’isolamento e auto-referenzialità, che all’esterno appaiono come tratti importanti e caratteristici delle comunità carismatiche, sono spesso fenomeni di auto-isolamento involontario.
Affinché nascano comunità segregate, dove i membri incontrano sempre le persone della propria comunità, non c’è bisogno di persone che non amino le relazioni sociali esterne alla comunità. È sufficiente, mantenendo i parametri del modello di Schelling e estendendone la logica, che i singoli membri inizino a pensare: "A me piace frequentare persone di altri gruppi e comunità, ma ogni due o tre incontri almeno uno lo voglio fare solo nella mia comunità". Una preferenza individuale, anche qui, non particolarmente chiusa e anti-sociale che però può generare involontariamente forti chiusure collettive e auto-segregazioni. Ciò spiega, tra l’altro, un fatto frequente e per molti misterioso, comunità che nel loro insieme si presentano (e spesso sono) chiuse e auto-referenziali, che però quando incontri le singole persone ed entri in un rapporto di confidenza con esse, scopri che individualmente sono molto aperte e socievoli. Al punto che qualche volta viene da esclamare: "Ma come ha fatto una persona così a finire in una tale comunità"? A questa esclamazione Schelling potrebbe rispondere: "Guarda, nemmeno la comunità voleva finire in questa comunità! C’è finita involontariamente".
Ma queste malattie e nevrosi sono prevenibili o curabili? Innanzitutto, se vogliamo essere onesti, le comunità carismatiche sviluppano questi esiti quasi inevitabilmente, sono forme di malattie auto-immuni, ma possono essere più o meno gravi in base alle misure che si adottano. Per prevenirle davvero - dato che la cura ex-post è quasi impossibile - dovremmo avere persone con soglie di apertura molto basse (1 su 5, ad esempio), o con soglie zero. Ma nessuna comunità nasce se i membri non si incontrano tra loro e se non rinunciano a qualche grado di libertà della loro socialità precedente. E più le comunità hanno bisogno di legami forti di appartenenza, più sono probabili le auto-segregazioni, dove il grado di parziale apertura iniziale del singolo diventa, collettivamente, chiusura. Così, molte persone entrano in comunità con il desiderio genuino di continuare ad avere appartenenze ad altri mondi vitali e a coltivare altre relazioni esterne, e poi si ritrovano in comunità dove incontrano soltanto persone della stessa comunità; inoltre - questo è un punto interessante - ciò accade senza che le persone abbiano cambiato preferenze individuali. Anche se con il passare del tempo è possibile e probabile che le preferenze individuali cambino inconsapevolmente giorno dopo giorno, e si allineino alla prassi collettiva.
Infine, questi meccanismi involontari possono spiegare (o quantomeno offrire intuizioni) altri fenomeni simili che si verificano al livello della singola persona e all’interno delle comunità. Qualche volta mi è successo di venire in contatto con comunità religiose dove era molto difficile "toccare" l’anima delle singole persone, che preferivano passare molte ore in preghiera o in adorazione piuttosto che parlare qualche minuto con me o con gli altri membri della loro comunità. La preghiera diventava una sorta di immunitas che proteggeva dalla communitas, una cortina invisibile che immunizzava dall’incontro autentico e immediato con gli altri. Questi esiti si possono (in parte) spiegare con la stessa logica: affinché una comunità si ritrovi soltanto con persone che trascorrono tutto il tempo libero in cappella e non interagiscono più tra di loro, è sufficiente che ciascuno coltivi questo tipo di preferenza: "Mi piace stare con le altre persone della comunità, certo, ma ogni due-tre incontri, un ’incontro’ lo voglio fare da sola in cappella". Anche in questo caso, preferenze individuali "leggère", una volta aggregate collettivamente generano persone auto-segregate - un’altra forma di "morte" o di malattia grave di una comunità. E si capisce anche perché è comune che i membri delle comunità carismatiche riducano col passare degli anni la rete di relazioni profonde di amicizia, all’interno e all’esterno.
Le buone regole, le norme sociali, i regolamenti delle comunità hanno anche lo scopo di prevenire queste malattie. Ma in un tempo in cui la sovranità dell’individuo e il rispetto (necessario) della privacy sono finalmente diventate importanti anche all’interno delle comunità spirituali, diventa sempre più difficile implementare azioni e norme che spezzino queste trappole involontarie. La vera prevenzione possibile è allora lavorare sulla consapevolezza dell’esistenza di simili meccanismi di chiusura involontaria.
 Tutti i membri di una comunità dovrebbero regolarmente chiedersi: quali sono i paletti invisibili che ho posto alle mie relazioni? Quanti rapporti sto vivendo con "soglie interiori"? Quante comunità vitali di ieri sto progressivamente perdendo? Quale è la varianza delle mie relazioni? Quali e quanti gradi di intolleranza sto coltivando dentro di me? Auto-test di discernimento difficili, ma non impossibili, soprattutto se la comunità offre strumenti per farli, magari insieme, anche quando non se ne avverte il bisogno. Nelle comunità si dovrebbero inserire procedure simili agli "screening" sanitari che le persone devono effettuare quando superano una certa età, a prescindere dai sintomi, al solo scopo preventivo. Scelte non facili per i responsabili, perché avvertono il rischio che qualcuno dopo il test scopra la malattia, che rispondendo a queste domande difficili vada in crisi, e magari finisca per lasciare la comunità.
Tutti i membri di una comunità dovrebbero regolarmente chiedersi: quali sono i paletti invisibili che ho posto alle mie relazioni? Quanti rapporti sto vivendo con "soglie interiori"? Quante comunità vitali di ieri sto progressivamente perdendo? Quale è la varianza delle mie relazioni? Quali e quanti gradi di intolleranza sto coltivando dentro di me? Auto-test di discernimento difficili, ma non impossibili, soprattutto se la comunità offre strumenti per farli, magari insieme, anche quando non se ne avverte il bisogno. Nelle comunità si dovrebbero inserire procedure simili agli "screening" sanitari che le persone devono effettuare quando superano una certa età, a prescindere dai sintomi, al solo scopo preventivo. Scelte non facili per i responsabili, perché avvertono il rischio che qualcuno dopo il test scopra la malattia, che rispondendo a queste domande difficili vada in crisi, e magari finisca per lasciare la comunità.Ma più forte dovrebbe essere in loro la coscienza dei danni prodotti dalla mancanza di questa prevenzione, tra questi l’estinzione della comunità stessa. Perché mentre nella prima fase di sviluppo della comunità, le preferenze delle singole persone sono meno rigide della cultura collettiva, a partire dalla seconda generazione le persone sono attratte soprattutto da quella cultura collettiva che si è generata involontariamente. E così, senza che nessuno lo voglia, le poche nuove "vocazioni" che arrivano sono in genere più chiuse di quanto non fossero i membri della prima ora - una volta diventati un quartiere di "soli bianchi" avremo soltanto nuovi vicini di casa bianchi. I nuovi arrivati con soglie più alte fanno crescere la chiusura della comunità, dando vita a circoli viziosi degenerativi. È così che spesso le comunità scompaiono involontariamente, se non si interviene decisamente e in tempo, in direzione ostinata e contraria.
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? --- Pinocchio ridotto a lavoratore e consumatore? La lezione di Rubem Alves (di Roberto Carnero).19 giugno 2021, di Federico La Sala
Pinocchio ridotto a lavoratore e consumatore?
Una rilettura del personaggio di Collodi da parte del brasiliano Rubem Alves: un ragazzino si trasforma in burattino. Un duro attacco alle odierne strutture educative, che tendono a fabbricare bambini su misura
di Roberto Carnero (Avvenire, 16.06.2021).
Molti sono convinti di conoscere"Pinocchio" perché hanno visto il cartone animato di Walt Disney o se va bene, da bambini hanno letto una versione scorciata del romanzo in edizione illustrata. Eppure Le avventure di Pinocchio e un grande classico della letteratura italiana, che andrebbe letto ascuola, come si fa con I promessi sposi e la Divina Commedia. Perché a riprova del suo valore - il romanzo di Collodi è una delle opere italiane più tradotte nel mondo ed è un testo dai significati complessi e stratificati. Collodi, infatti, è stato capace, grazie alla sua vena fantastica, di evocare atmosfere diverse, sperimentando soluzioni narrative assai ricche, con molti episodi che ben figurerebbero in un romanzo picaresco, altri in uno d’avventura, altri ancora in una narrazione "nera", e non è cosa da poco per un libro scritto per i ragazzi. Tra le disavventure del burattino, le sue cadute e risalite, Collodi non rinuncia mai alla dimensione irrazionale e magica del racconto e alla perfetta fusione di fiabesco e quotidiano: quello di Pinocchio è una sorta di viaggio dantesco tra umano e soprannaturale, in cui la fantasia e l’immaginazione si compenetrano alla perfezione con la realtà di un’umanità concreta, perfino dolorosa. Non stupisce perciò che fin dal suo primo apparire sul "Giornale per i bambini" (a puntate, dal 1881 al 1883) questo romanzo sia stato oggetto di numerose interpretazioni e anche di "riscritture": il destino, quest’ultimo, tipico dei grandi classici.
L’ultima in ordine di tempo è un Pinocchio alla rovescia (a cura di Paolo Vittoria, Marletti 1820, pp. 56, curo 7,00) di Rubem Alves (1933-2014), uno dei maggiori scrittori brasiliani del Novecento. Filosofo, storico, poeta, pedagogista, psicanalista e autore di racconti per bambini, con il suo saggio Teologia della speranza umana (in Italia pubblicatonel 1971 da Queríniana) era stato uno degli ispiratori della teologia della liberazione.
 Nel 2010,invece, ha riscritto il capolavoro di Collodi "al contrario". Il suo Pinocchio non è più un burattino che diventa bambino, bensì un bambino, di nome Felipe, che si trasforma in burattino. In che modo? Adeguandosi ai meccanismi e agli ingranaggi sociali che, sin dalla scuola, richiedono al singolo di uniformarsi e omologarsi.
Nel 2010,invece, ha riscritto il capolavoro di Collodi "al contrario". Il suo Pinocchio non è più un burattino che diventa bambino, bensì un bambino, di nome Felipe, che si trasforma in burattino. In che modo? Adeguandosi ai meccanismi e agli ingranaggi sociali che, sin dalla scuola, richiedono al singolo di uniformarsi e omologarsi.Attraverso questa vicenda metaforica e simbolica, Alves lancia un duro atto d’accusa nei confronti delle odierne strutture educative, tutte tese alla standardizzazione dei percorsi formativi, alla certificazione di conoscenze, competenze e abilità, e, se serve, persino alla medicalizzazione, di fronte al disagio di quei ragazzi che, per le loro caratteristiche personali, non riescono a integrarsi in itinerari prestabiliti e uguali e per tutti. Ecco la risposta della maestra al piccolo protagonista: «La scuola non serve a imparare quello che vuoi, ma a imparare quello che devi imparare. Quello che devi imparare è ciò che hanno detto gli uomini intelligenti del Governo. Tutto nel giusto ordine. Una cosa alla volta. Tutti i bambini allo stesso tempo e con la stessa velocità...». E l’idolatria dei programmi,ammanniti ogni anno uguali a sé stessi,senza che siano mai suscettibili di una vera disamina critica.
Così Alves definisce il "disturbo dell’attenzione": «Disturbo dell’attenzione è quando l’attenzione sta nel luogo dove il cuore desidera e non nel luogo dove il maestro comanda». Ma una scuola simile sembra esistere solo «per trasformare i bambini che giocano in adulti che lavorano». Questo di Alves è un breve libretto che dovrebbe essere letto dai docenti, dagli educatori, dagli psicologi, dai genitori. Innanzitutto per una riflessione su che cosa dovrebbe essere la scuola: una macchina burocratica da far funzionare alla perfezione oppure un luogo, unico e straordinario, in cui scoprire i talenti e liberare le energie? E insecondo luogo per comprendere che in ogni vicenda educativa al centro deve essere posto sempre il ragazzo: solo così possiamo evitare di trasformarlo in un burattino.
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? -- Memoria. Giornata Mondiale della Felicità - ONU.20 marzo 2019, di Federico La Sala
RICORDARE! Oggi, il 20 marzo è la Giornata Mondiale della Felicità, istituita dall’ONU nel 2012 .....
Se «La felicità (εὐδαιμονία) è un buon dèmone (δαίμων)» (Marco Aurelio, "Pensieri"), l’ Evangelo, composto dalle radici greche εὐ (eu, "buono") e ἄγγελμα (angelma, "novella", "messaggio"), è quindi una buona novella, non un semplice "vangelo" (un "messaggio" con le istruzioni relative alla destinazione - van-gelo)!
Federico La Sala
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. -- SINODO DEI GIOVANI, 2018. Sabato e domenica l’incontro del Papa con i giovani delle diverse}} diocesi d’Italia.8 agosto 2018, di Federico La Sala
LA PARABOLA DEi "TALENTI", I "DUE CRISTIANESIMI", E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO.... *
Destinazione sinodo/18.
Dall’ascolto all’incontro. È la gioventù del Papa
di Stefania Falasca (Avvenire, mercoledì 8 agosto 2018)
Una generazione fa, nell’estate del 2013, di fronte alla marea di più di tre milioni di giovani assiepati sulla spiaggia di Copacabana per la Giornata mondiale della gioventù di Rio, papa Francesco era rimasto per un attimo in silenzio spaziando con lo sguardo su quella sconfinata folla di ragazzi sul bordo dell’oceano. Gli parve di vedere «guardando il mare, la spiaggia e tutti voi», disse, quel momento dell’inizio della storia cristiana sulla riva del mare di Galilea quando i primi due, alle quattro del pomeriggio, avevano incontrato Gesù. Gli erano andati dietro attratti da lui. E Gesù a questi due ragazzi - Andrea era sposato, quindi avrà avuto qualche anno di più, ma Giovanni era proprio un ragazzino -, voltandosi aveva domandato: «Che cosa cercate?». E questi non gli risposero ’cerchiamo la verità’, o ’cerchiamo la felicità’, non gli dissero neppure ’cerchiamo il Messia’. Quello che il cuore cercava lo avevano davanti. Allora a quella domanda - «Che cosa cercate?» - risposero chiedendo l’unica cosa che si può domandare: «Maestro dove abiti?», cioè ’dove rimani?’, dove rimani perché possiamo stare con te?
Sono passati cinque anni da quell’esordio vis-à-vis di Papa Francesco con i giovani di tutto il mondo in Brasile, e l’attualità ne resta intatta, anche se è cambiata nel frattempo la generazione dei «nati liquidi», come titola l’opera postuma di Zygmunt Bauman dedicata a queste ultime generazioni considerate sempre più «come bidone dei rifiuti per l’industria dei consumi» e «come un ulteriore fardello sociale», giovani che «hanno smesso di essere inclusi dalla promessa di un futuro migliore», sempre più «parte di una popolazione smaltibile la cui presenza minaccia di richiamare alla mente memorie collettive rimosse della responsabilità adulta». «Vuoti a perdere» a rischio «rottamazione», quelli che escono dalla lucida analisi dell’autore della società liquida, «gli scartati dall’impero del Dio denaro» da parte di chi divora la dignità umana e di cui gli Stati nascondono le stime crescenti dei suicidi. Giovani che sempre più non sanno cosa sia la Chiesa, anzi, che sempre più sono figli e nipoti di generazioni che non sanno più niente della religione.
Ma il dialogo intrapreso da Francesco da quel primo incontro sulla spiaggia di Copacabana si è fatto in questi anni serrato, spesso confidente, nel quale ai sermoni il Papa ha preferito domande e risposte a braccio come espressione di conversazioni dirette, di incontri. «Anche le migliori analisi sul mondo giovanile, pur essendo utili - sono utili -, non sostituiscono la necessità dell’incontro faccia a faccia. Parlano della gioventù d’oggi. Cercate per curiosità in quanti articoli, quante conferenze si parla della gioventù di oggi. Vorrei dirvi una cosa. La gioventù non esiste, esistono i giovani», ha detto di recente Francesco, tanto per essere chiaro. «Esistono le singole storie, i volti, gli sguardi, le illusioni, esistono i giovani... tu, tu.... Parlare della gioventù - ha ripreso in altra occasione - è facile: si fanno astrazioni, percentuali», invece «bisogna interloquire con loro», incontrarli «a tu per tu». Sono ormai decine i colloqui intrapresi non solo nell’ultima Gmg a Cracovia come in ogni viaggio apostolico nel mezzo delle crisi del mondo.
 Forse anche da questi dialoghi è nata la decisione di un Sinodo non su ma dei giovani, per andare insieme. Camminando in controtendenza ha aperto le porte. E ha rotto la divisione noi-voi:
Forse anche da questi dialoghi è nata la decisione di un Sinodo non su ma dei giovani, per andare insieme. Camminando in controtendenza ha aperto le porte. E ha rotto la divisione noi-voi:
 «Nella Chiesa - sono convinto - non dev’essere così: chiudere la porta, non sentire. Il Vangelo ce lo chiede: il suo messaggio di prossimità invita a incontrarci e confrontarci, ad accoglierci e amarci sul serio, a camminare insieme e condividere senza paura» ha ribadito anche nell’ultima riunione in vista del Sinodo di ottobre. «Questa riunione presinodale - ha aggiunto - vuol essere segno di qualcosa di grande: la volontà della Chiesa di mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno escluso.
E questo non per fare politica. Non per un’artificiale ’giovano-filia’, no, non per adeguarsi, ma perché abbiamo bisogno di capire meglio quello che Dio e la storia ci stanno chiedendo. Se mancate voi, ci manca parte dell’accesso a Dio».
«Nella Chiesa - sono convinto - non dev’essere così: chiudere la porta, non sentire. Il Vangelo ce lo chiede: il suo messaggio di prossimità invita a incontrarci e confrontarci, ad accoglierci e amarci sul serio, a camminare insieme e condividere senza paura» ha ribadito anche nell’ultima riunione in vista del Sinodo di ottobre. «Questa riunione presinodale - ha aggiunto - vuol essere segno di qualcosa di grande: la volontà della Chiesa di mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno escluso.
E questo non per fare politica. Non per un’artificiale ’giovano-filia’, no, non per adeguarsi, ma perché abbiamo bisogno di capire meglio quello che Dio e la storia ci stanno chiedendo. Se mancate voi, ci manca parte dell’accesso a Dio».E se ha tenuto conto di tutte le realtà, il Papa più volte ha ribadito la volontà di lasciarsi interpellare da loro e di vederli protagonisti: «Siamo insieme parte della Chiesa, anzi, diventiamo costruttori della Chiesa e protagonisti della storia. Ragazzi e ragazze, per favore: non mettetevi nella ’coda’ della storia. Siate protagonisti. Costruite un mondo migliore, un mondo di fratelli, un mondo di giustizia, di amore, di pace, di fraternità, di solidarietà».
Ma perché la richiesta di questo protagonismo? «In tanti momenti della storia della Chiesa, così come in numerosi episodi biblici, Dio ha voluto parlare per mezzo dei più giovani: penso, ad esempio, a Samuele, a Davide e a Daniele. A me piace tanto la storia di Samuele, quando sente la voce di Dio. La Bibbia dice: ’In quel tempo non c’era l’abitudine di sentire la voce di Dio. Era un popolo disorientato’. È stato un giovane ad aprire quella porta. Nei momenti difficili, il Signore fa andare avanti la storia con i giovani. Dicono la verità, non hanno vergogna».
 E se nella storia della salvezza il Signore si fida dei giovani, nell’incontro pre-sinodale del 19 marzo il Papa ha anche detto che il Sinodo di ottobre sarà anche un appello rivolto alla Chiesa, perché «riscopra un rinnovato dinamismo giovanile». Così come nell’udienza del gennaio 2017 ai partecipanti a un convegno dell’Ufficio Cei per la pastorale delle vocazioni aveva ripetuto che «sono le nostre testimonianze quelle che attirano i giovani. È la testimonianza: che vedano in voi vivere quello che predicate. Quello che vi ha portato a diventare preti, suore, anche laici che lavorano con forza nella Casa del Signore. E non gente che cerca sicurezza, che chiude le porte, che spaventa gli altri, che parla di cose che non interessano, che annoiano, che non hanno tempo... No. Ci vuole una testimonianza grande!».
E se nella storia della salvezza il Signore si fida dei giovani, nell’incontro pre-sinodale del 19 marzo il Papa ha anche detto che il Sinodo di ottobre sarà anche un appello rivolto alla Chiesa, perché «riscopra un rinnovato dinamismo giovanile». Così come nell’udienza del gennaio 2017 ai partecipanti a un convegno dell’Ufficio Cei per la pastorale delle vocazioni aveva ripetuto che «sono le nostre testimonianze quelle che attirano i giovani. È la testimonianza: che vedano in voi vivere quello che predicate. Quello che vi ha portato a diventare preti, suore, anche laici che lavorano con forza nella Casa del Signore. E non gente che cerca sicurezza, che chiude le porte, che spaventa gli altri, che parla di cose che non interessano, che annoiano, che non hanno tempo... No. Ci vuole una testimonianza grande!».Ritorniamo così all’inizio, all’incontro dei primi due discepoli con Gesù. Anche questa dinamica di come si diventa e si rimane cristiani percorre tutto il magistero di Francesco, ed è sempre la stessa - sempre nuova - che attraversa i tempi, le crisi e le generazioni, così che quell’episodio di Giovanni e Andrea raccontato a Copacabana è ripetuto ancora nell’ultimo intervento per il Sinodo di ottobre. E affinché l’assemblea non si trasformi in occupazione momentanea per monsignori forse sarà necessario non lasciarsi andare a una banale sociologia, e assumere invece queste intramontabili provocazioni evangeliche.
Sabato e domenica ci sarà l’incontro del Papa con i giovani delle diverse diocesi d’Italia. In molti sono già in cammino verso Roma per il pellegrinaggio, si parla di 40mila ragazzi. Marta, parte di un gruppo di universitari milanesi, parlando davanti a una pizza insieme agli altri dice che non le interessa niente dei discorsi sui giovani, e che non parte per sentire discorsi ma spinta da un incontro, che l’ha attirata e vuole vedere. Papa Francesco ha fatto sentire più volte come anche duemila anni fa un ragazzo e una ragazza, Giuseppe e Maria, hanno visto Dio con gli occhi e non in una visione mistica. Maria l’ha partorito, Giuseppe e lei lo hanno guardato. È iniziata così la storia cristiana. Sono stati lì a guardare Dio.
 Francesco ha messo bene in evidenza come sia la grazia che crea la fede. Per questo la vita cristiana è semplice. La fede è il riconoscimento di questa attrattiva, di un incontro. E la grazia crea la fede non solo quando la fede inizia ma per ogni momento in cui la fede rimane. In ogni momento, non solo all’inizio, l’iniziativa è Sua, dice sant’Agostino. Solo a partire da questo cuore la Chiesa ringiovanisce e attrae. Il prossimo incontro con i giovani a Roma, come anche il Sinodo, può essere l’occasione per chiedere, per ciascuno, che questo avvenga e continui ad accadere.
Francesco ha messo bene in evidenza come sia la grazia che crea la fede. Per questo la vita cristiana è semplice. La fede è il riconoscimento di questa attrattiva, di un incontro. E la grazia crea la fede non solo quando la fede inizia ma per ogni momento in cui la fede rimane. In ogni momento, non solo all’inizio, l’iniziativa è Sua, dice sant’Agostino. Solo a partire da questo cuore la Chiesa ringiovanisce e attrae. Il prossimo incontro con i giovani a Roma, come anche il Sinodo, può essere l’occasione per chiedere, per ciascuno, che questo avvenga e continui ad accadere.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?!
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
- GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA!
LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola?
I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?
Federico La Sala
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. -- Il "Giuramento del Banchiere" e le «Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones». Verso una nuova finanza (di Stefano Zamagni).13 giugno 2018, di Federico La Sala
TEOLOGIA, ECONOMIA, E STORIA ..... *
Il documento vaticano.
Verso una nuova finanza: il cammino ora è segnato
Il testo della Congregazione per la Dottrina della Fede «Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones» offre spunti per un discernimento etico sul sistema attuale e offre soluzioni per il bene comune
di Stefano Zamagni (Avvenire, martedì 12 giugno 2018)
«Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones» (Opq) è un documento - reso di dominio pubblico il 17 maggio 2018 - originale e intrigante.
Originale per il taglio espositivo e soprattutto perché è la prima volta che la Congregazione per la Dottrina della Fede - la cui competenza copre anche le questioni di natura morale - interviene su una materia di Dottrina Sociale della Chiesa. Il lavoro congiunto tra Congregazione e Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è già di per sé qualcosa che non può passare inosservato e che lascerà il segno.
Opq è poi un contributo intrigante per il modo e per lo spessore con cui affronta una tematica che, come quella della nuova finanza, è oggi al centro delle preoccupazioni della Chiesa e della società in generale. (Papa Francesco ha approvato il Documento che entra pertanto nel Magistero ordinario). Come recita il sottotitolo («considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario» - corsivo aggiunto), non ci troviamo di fronte ad una sorta di esortazione apostolica o ad un testo di taglio pastorale. Piuttosto, vi si legge un’analisi, scientificamente fondata, delle cause remote dei disordini e dei guasti che l’architettura dell’attuale sistema finanziario va determinando.
Si legge al n. 5: «La recente crisi finanziaria poteva essere l’occasione per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria, neutralizzandone gli aspetti predatori e speculativi (sic!) e valorizzandone il servizio all’economia reale. Sebbene siano stati intrapresi molti sforzi positivi... non c’è stata però una reazione che abbia portato a ripensare quei criteri obsoleti che continuano a governare il mondo».
 A scanso di equivoci, è bene precisare che il documento non parla affatto contro la finanza, di cui riconosce la rilevanza e anzi la necessità (e non potrebbe essere diversamente, se si considera che la finanza moderna nasce entro l’alveo del pensiero economico francescano). Esso prende piuttosto posizione nei confronti di una realtà efficacemente descritta dal seguente dato: nel 1980, l’insieme degli attivi finanziari a livello mondiale era pressoché eguale al Pil sempre mondiale; nel 2015 la prima variabile era diventata dodici volte superiore alla seconda.
A scanso di equivoci, è bene precisare che il documento non parla affatto contro la finanza, di cui riconosce la rilevanza e anzi la necessità (e non potrebbe essere diversamente, se si considera che la finanza moderna nasce entro l’alveo del pensiero economico francescano). Esso prende piuttosto posizione nei confronti di una realtà efficacemente descritta dal seguente dato: nel 1980, l’insieme degli attivi finanziari a livello mondiale era pressoché eguale al Pil sempre mondiale; nel 2015 la prima variabile era diventata dodici volte superiore alla seconda.Il punto centrale dell’argomento sviluppato nel Documento è l’affermazione del principio secondo cui etica e finanza non possano continuare a vivere in sfere separate. Ciò implica il rigetto della tesi del Noma (Non Overlapping Magisteria) per primo formulata in economia nel 1829 da Richard Whateley, cattedratico all’Università di Oxford e vescovo della Chiesa Anglicana.
 Secondo questa tesi, la sfera dell’economia va tenuta separata sia dalla sfera dell’etica sia da quella della politica, se si vuole che l’economia ambisca a vedersi riconosciuto lo statuto di disciplina scientifica. E così è stato, almeno fino a tempi recenti, quando si è cominciato a parlare con Amartya Sen e altri, di economia e etica.
Secondo questa tesi, la sfera dell’economia va tenuta separata sia dalla sfera dell’etica sia da quella della politica, se si vuole che l’economia ambisca a vedersi riconosciuto lo statuto di disciplina scientifica. E così è stato, almeno fino a tempi recenti, quando si è cominciato a parlare con Amartya Sen e altri, di economia e etica.
 I paragrafi 7-12 di Opq si soffermano con grande incisività a descrivere come dall’accettazione del principio del Noma sia derivato l’accoglimento dell’assunto antropologico (di ascendenza Hobbesiana) dell’homo homini lupus, posto a fondamento della figura dell’homo oeconomicus.
I paragrafi 7-12 di Opq si soffermano con grande incisività a descrivere come dall’accettazione del principio del Noma sia derivato l’accoglimento dell’assunto antropologico (di ascendenza Hobbesiana) dell’homo homini lupus, posto a fondamento della figura dell’homo oeconomicus.Ben diverso è l’assunto antropologico da cui parte il paradigma dell’economia civile - fondato da Antonio Genovesi nel 1753 a Napoli - che, rifiutando esplicitamente il Noma, riconosce che homo homini natura amicus. («L’uomo è per natura amico dell’altro uomo»).
Seconda novità di rilievo del Documento è la rilevanza attribuita al principio della responsabilità adiaforica, di cui quasi mai si fa cenno. Il par. 14 recita: «Ad li là del fatto che molti operatori siano singolarmente animati da buone e rette intenzioni, non è possibile ignorare che oggi l’industria finanziaria, a causa della sua pervasività e della sua inevitabile capacità di condizionare e di dominare l’economia reale, è un luogo dove gli egoismi e le sopraffazioni hanno un potenziale di dannosità della collettività che ha pochi eguali».
È questo un esempio notevole di struttura di peccato, come la chiamò, per primo nella Dottrina Sociale della Chiesa, Giovanni Paolo II nella sua Sollecitudo Rei Socialis (1987). Non è il solo operatore di borsa, o banchiere o uomo d’affari ad essere responsabile delle conseguenze delle azioni che pone in atto. Anche le istituzioni economiche, se costruite su premesse di valore contrarie ad un’etica amica dell’uomo, possono generare danni enormi a prescindere dalle intenzioni di coloro che in esse operano. Per meglio comprendere la ragione di ciò, conviene fissare l’attenzione su tre caratteristiche specifiche della nuova finanza.
La prima è l’impersonalità dei contesti di mercato, la quale oscura il fatto che da qualche parte vi è sempre un qualcuno sull’altro lato dell’affare. La seconda caratteristica è la complessità della nuova finanza che fa sorgere problemi di agentività indiretta: il principale si riconosce moralmente disimpegnato nei confronti delle azioni poste in essere dal suo ’ingegnere finanziario’, cioè dall’esperto cui affida il compito di disegnare un certo prodotto, il quale a sua volta si mette il cuore in pace perché convinto di eseguire un ordine.
Accade così che ognuno svolge il suo ruolo separando la propria azione dal contesto generale, rifiutandosi di accettare che, anche se solo amministrativamente, era parte dell’ingranaggio. Infine, la nuova finanza tende ad attrarre le persone meno attrezzate dal punto di vista etico, persone cioè che non hanno scrupoli morali e soprattutto molto avide. Riusciamo così a comprendere perché il problema non risiede unicamente nella presenza di poche o tante mele marce; ma è sulla stessa cesta delle mele che si deve intervenire.
Il Documento in questione, infine, prende definitiva ed esplicita posizione contro la tesi della doppia moralità - purtroppo diffusa anche tra alcune organizzazioni di tipo finanziario che dichiarano di ispirarsi alla Dottrina Sociale della Chiesa. Per capire di che si tratta conviene partire dal saggio di Albert Carr, ’Is business bluffing ethical?’ pubblicato sulla prestigiosa Harvard Business Review nel 1968. È questo il saggio che, più di ogni altro, ha guidato fino ad oggi la riflessione etica nel mondo degli affari. Vi si legge che l’uomo d’affari di successo deve essere guidato da «un diverso insieme di standars etici», poiché «l’etica degli affari è l’etica del gioco [d’azzardo], diversa dall’etica religiosa». Assimilando il business al gioco del poker, il noto economista americano conclude che «gli unici vincoli di ogni mossa nel business sono la legalità e il profitto.
Se qualcosa non è illegale in senso stretto (sic!) ed è profittevole allora è eticamente obbligante che l’uomo d’affari lo realizzi». I paragrafi dal 22 al 34 di Opq si soffermano sul faciendum: che fare per cercare di invertire la situazione? Parecchie le proposte - tutte realizzabili - che vengono avanzate. Dal sostegno a istituti che praticano la finanza non speculativa, come le Banche di Credito Cooperativo, il microcredito, l’investimento socialmente responsabile, alle tante forme di finanza etica. Dalla chiusura della finanza offshore e dalle forme di cannibalismo economico di chi, con i credit default swaps, specula sul fallimento altrui, alla regolamentazione dello shadow-banking, soggetti finanziari non bancari che agiscono come banche ma operando al di fuori di ogni quadro normativo ufficiale.
L’obiettivo da perseguire è quello di assicurare una effettiva biodiversità bancaria e finanziaria. Di speciale interesse è inoltre la proposta di affiancare ai Cda delle grandi banche Comitati Etici costituiti da persone moralmente integre oltre che competenti - così come già accade nei grandi policlinici. Nell’aprile 2015 la ’Dutch Banking Association’ (l’Associazione di tutte le banche olandesi) stabilì di esigere dai dipendenti delle banche (circa 87.000 persone) il ’Giuramento del Banchiere’, stilato sulla falsariga del giuramento ippocratico per i medici.
Il giuramento consta di otto impegni specifici. Ne indico solamente un paio: «Prometto e giuro di mai abusare delle mia conoscenze»; «Prometto e giuro di svolgere le mie funzioni in modo etico e con cura, adoperandomi di conciliare gli interessi di tutte le parti coinvolte: clienti, azionisti; occupati; società». Si opera dunque a favore di tutte le classi di stakeholder e non solamente di quella degli azionisti. Sarebbe bello se sull’esempio dell’Olanda - un Paese non certo sprovveduto né arretrato in materia finanziaria - anche l’Italia volesse seguirne la traccia.
Delle tre principali strategie con le quale si può cercare di uscire da una crisi di tipo entropico - quale è l’attuale - e cioè quella rivoluzionaria, quella riformista, quella trasformazionale, il Documento Opq sposa, in linea con il Magistero di papa Francesco, la terza. Si tratta di trasformare - non basta riformare - interi blocchi del sistema finanziario che si è venuto formando nell’ultimo quarantennio per riportare la finanza alla sua vocazione originaria: quella di servire il bene comune della civitas che, come ci ricorda Cicerone, è la «città delle anime», a differenza dell’urbs che è la «città delle pietre». È questa la strategia che vale, ad un tempo, a scongiurare il rischio sia di utopiche palingenesi sia del misoneismo, che è l’atteggiamento tipico di chi detesta la novità e osteggia l’emergenza del nuovo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA. Tutti a scuola in Vaticano, per aggiornamenti. Materiali per approfondire
STORIA D’ITALIA. INTELLETTUALI E SOCIETA’....
 VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggere
VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggereGUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? --- "Maria Maddalena. Esercizi spirituali" (Carlo M. Martini).16 marzo 2018, di Federico La Sala
Il Vangelo dalla parte della Maddalena
Escono in un libro gli esercizi spirituali che il cardinale Carlo Maria Martini tenne in Israele tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007. Sono dedicati alla figura della santa peccatrice
di Vito Mancuso (la Repubblica, 16.03.2018)
La simpatia del cardinal Martini per Maria Maddalena appare evidente dalla prima all’ultima parola degli esercizi spirituali da lui tenuti in Israele tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007, come evidente è la sua simpatia per le consacrate dell’Ordo Virginum della diocesi di Milano per le quali aveva preparato gli esercizi e alle quali diceva: «Vi riconosco nella vostra bellezza interiore ed esteriore, perché quando l’anima rimane nella sua costante proposta di servizio a Dio, rimane bella e questa bellezza si diffonde».
 Io penso sia proprio così, e penso che Martini sia stato a sua volta un esempio di questa misteriosa connessione tra etica ed estetica avvertita già dagli antichi greci con l’ideale della kalokagathía, perché il morbo di Parkinson contro cui già allora combatteva, e che l’avrebbe portato alla morte il 31 agosto 2012, non giunse mai a privarlo della sua originaria e nobile bellezza.
Io penso sia proprio così, e penso che Martini sia stato a sua volta un esempio di questa misteriosa connessione tra etica ed estetica avvertita già dagli antichi greci con l’ideale della kalokagathía, perché il morbo di Parkinson contro cui già allora combatteva, e che l’avrebbe portato alla morte il 31 agosto 2012, non giunse mai a privarlo della sua originaria e nobile bellezza.
 Cosa siano gli esercizi spirituali lo spiega lo stesso Martini dicendo che non sono un corso di aggiornamento, né una lettura spirituale della Bibbia, né un’occasione di preghiera; sono invece “un ministero dello Spirito Santo”, nel senso che “è lo Spirito Santo che parla al mio cuore per dirmi ciò che vuole da me adesso”.
Cosa siano gli esercizi spirituali lo spiega lo stesso Martini dicendo che non sono un corso di aggiornamento, né una lettura spirituale della Bibbia, né un’occasione di preghiera; sono invece “un ministero dello Spirito Santo”, nel senso che “è lo Spirito Santo che parla al mio cuore per dirmi ciò che vuole da me adesso”.Gli esercizi spirituali sono quindi un tempo di ascolto e di raccoglimento per capire la propria situazione qui e ora, e come tali prevedono «un silenzio assoluto a tavola e anche negli altri momenti», perché, avverte Martini, «soltanto una parola detta qua e là disturba tutti».
Maria Maddalena è «il segno dell’eccesso cristiano, il segno dell’andare al di là del limite, il segno del superamento»: nell’eccedere della sua vita travagliata ma sempre dominata dall’amore, si dà per Martini la chiave privilegiata per «essere introdotti nel cuore di Dio».
Il cuore di Dio. Mediante la storia della Maddalena, Martini giunge a parlare di Dio, e parlando di Dio giunge a illuminare la logica e il ritmo dell’essere, cogliendo nell’amore il suo segreto più profondo: «Dio è tutto dono, è tutto al di là del dovuto e questo è il segreto della vita».
 Individuare “il cuore di Dio” significa quindi per Martini individuare “il segreto della vita”. In questa prospettiva egli illumina magistralmente il paradosso dell’esistenza segnalando la dinamica profonda secondo cui ci si compie superandosi, ci si arricchisce svuotandosi, si raggiunge l’equilibrio perdendolo.
Individuare “il cuore di Dio” significa quindi per Martini individuare “il segreto della vita”. In questa prospettiva egli illumina magistralmente il paradosso dell’esistenza segnalando la dinamica profonda secondo cui ci si compie superandosi, ci si arricchisce svuotandosi, si raggiunge l’equilibrio perdendolo.
 È la pazzia evangelica. La quale però, in quanto verità dell’essere, è universale, e quindi è avvertita anche al di là del cristianesimo, per esempio già da Platone che coglieva la medesima logica di eccedenza scrivendo che «la mania che proviene da un dio è migliore dell’assennatezza che proviene dagli uomini» ( Fedro 244 d). Maniaca in senso platonico, la Maddalena è definita da Martini “amante estatica”, cioè letteralmente “fuori di sé” e in questo modo è indicata quale via privilegiata per accedere al cuore di Dio.
È la pazzia evangelica. La quale però, in quanto verità dell’essere, è universale, e quindi è avvertita anche al di là del cristianesimo, per esempio già da Platone che coglieva la medesima logica di eccedenza scrivendo che «la mania che proviene da un dio è migliore dell’assennatezza che proviene dagli uomini» ( Fedro 244 d). Maniaca in senso platonico, la Maddalena è definita da Martini “amante estatica”, cioè letteralmente “fuori di sé” e in questo modo è indicata quale via privilegiata per accedere al cuore di Dio.
 Per lui è infatti evidente che «non può comprendere Dio chi cerca solo ragioni logiche», mentre lo può comprendere «chi vive qualche gesto di uscita da sé, di dedizione al di fuori di sé, al di fuori del dovuto», perché Dio, simbolo concreto del mistero dell’essere, “è uscita da sé”, “dono di sé”.
Per lui è infatti evidente che «non può comprendere Dio chi cerca solo ragioni logiche», mentre lo può comprendere «chi vive qualche gesto di uscita da sé, di dedizione al di fuori di sé, al di fuori del dovuto», perché Dio, simbolo concreto del mistero dell’essere, “è uscita da sé”, “dono di sé”.
 In questa prospettiva la Maddalena, perfetta esemplificazione della logica evangelica, fa capire che “solo l’eccesso salva”. Per “eccesso” Martini intende “uno squilibrio dell’esistenza”. E proprio questo è il punto: che la vita si alimenta di tale squilibrio. Il nostro universo non viene forse da un eccesso, cioè dalla rottura di simmetria all’origine del Big Bang? E la vita non è a sua volta squilibrio, essendo la morte, come disse Erwin Schrödinger nelle lezioni al Trinity College di Dublino, “equilibrio termico”? E cosa sono l’innamoramento e le passioni di cui si nutre la nostra psiche, se non, a loro volta, squilibrio?
In questa prospettiva la Maddalena, perfetta esemplificazione della logica evangelica, fa capire che “solo l’eccesso salva”. Per “eccesso” Martini intende “uno squilibrio dell’esistenza”. E proprio questo è il punto: che la vita si alimenta di tale squilibrio. Il nostro universo non viene forse da un eccesso, cioè dalla rottura di simmetria all’origine del Big Bang? E la vita non è a sua volta squilibrio, essendo la morte, come disse Erwin Schrödinger nelle lezioni al Trinity College di Dublino, “equilibrio termico”? E cosa sono l’innamoramento e le passioni di cui si nutre la nostra psiche, se non, a loro volta, squilibrio?
 Afferma Martini: «Quando definisco me stesso, mi definisco di fronte al mistero di Dio e mi definisco come qualcuno che è destinato a trovarsi nel dono di sé... e tutto questo si dà perché Dio è dono di sé». Prosegue dicendo che molti non capiscono Dio perché non lo collegano a questa dinamica di uscita da sé, visto che «soltanto quando accettiamo di entrare in questa dinamica della perdita, del dare in perdita, possiamo metterci in sintonia con il mistero di Dio».
Afferma Martini: «Quando definisco me stesso, mi definisco di fronte al mistero di Dio e mi definisco come qualcuno che è destinato a trovarsi nel dono di sé... e tutto questo si dà perché Dio è dono di sé». Prosegue dicendo che molti non capiscono Dio perché non lo collegano a questa dinamica di uscita da sé, visto che «soltanto quando accettiamo di entrare in questa dinamica della perdita, del dare in perdita, possiamo metterci in sintonia con il mistero di Dio».
 In questa prospettiva Martini giunge a parlare di Dio secondo una teologia della natura che avrebbe fatto felice il confratello gesuita Pierre Teilhard de Chardin, riferendosi a «quella forza che potremmo dire trascendente, perché è in tutta la natura fisica, morale, spirituale ed è la forza che tiene insieme il mondo... la forza che si può concepire come una lotta continua contro l’entropia e il raffreddamento».
In questa prospettiva Martini giunge a parlare di Dio secondo una teologia della natura che avrebbe fatto felice il confratello gesuita Pierre Teilhard de Chardin, riferendosi a «quella forza che potremmo dire trascendente, perché è in tutta la natura fisica, morale, spirituale ed è la forza che tiene insieme il mondo... la forza che si può concepire come una lotta continua contro l’entropia e il raffreddamento».
 Anche il voto di verginità delle consacrate alle quali rivolgeva i suoi esercizi appare a Martini un segno di quell’eccesso di amore che fa sì che nel mondo non vi sia solo la forza di gravità che tira verso il basso, ma anche «una forza che tira verso l’alto, verso la trasparenza, la complessità e anche verso una comprensione profonda di sé e degli altri fino ad arrivare a quella trasparenza che è la rivelazione di ciò che saremo». Ovvero, conclude Martini, “la vita eterna”.
Anche il voto di verginità delle consacrate alle quali rivolgeva i suoi esercizi appare a Martini un segno di quell’eccesso di amore che fa sì che nel mondo non vi sia solo la forza di gravità che tira verso il basso, ma anche «una forza che tira verso l’alto, verso la trasparenza, la complessità e anche verso una comprensione profonda di sé e degli altri fino ad arrivare a quella trasparenza che è la rivelazione di ciò che saremo». Ovvero, conclude Martini, “la vita eterna”.
La categoria dell’eccesso
Maria Maddalena secondo il cardinale Martini *
L’eccesso è per Martini la “categoria” che ci consente non solo di comprendere il mistero di Dio adombrato nella passione, morte e risurrezione di Gesù, ma ciò che esprime il senso profondo dell’essere cristiano, della maturità cristiana.
Ancora una volta è attraverso i personaggi di Giovanni che Martini costruisce questa sua visione, in particolare è Maria di Magdala a guidarci in questo ultimo tratto di cammino. «Maria di Magdala è una figura particolarmente importante nei Vangeli, è il prototipo della persona che accede alla fede nel Risorto. Se gli altri due episodi narrati da Giovanni rappresentano piuttosto una comunità che accoglie il mistero della Risurrezione, l’episodio che ha per protagonista la Maddalena è piuttosto dedicato al singolo credente o meglio al non credente che diventa credente».
Chi è Maria Maddalena? Tutti i vangeli la annoverano tra le donne che si recano al sepolcro. Forse, dice Martini, tale menzione indica «una qualche funzione di leadership», ma non abbiamo elementi sufficienti. Compare inoltre nei racconti della passione e nella vita pubblica di Gesù, dove è messa «sullo stesso piano dei discepoli». La sua figura però si può comprendere anche grazie al confronto con altre figure femminili presenti nel vangelo. Per esempio la peccatrice in casa di Simone, le «Marie di Betania» e, infine, la sposa del Cantico; come lei, la Maddalena «ha cercato Gesù con una passione inesausta, con una perseveranza invincibile e di conseguenza è una figura della ricerca di Gesù e del Signore risorto». Tutte rimandano in qualche modo a un «eccesso d’amore».
Nel testo si legge che il primo giorno dopo il sabato Maria si reca al sepolcro «di buon mattino», quando era ancora buio. Un atteggiamento inusuale e anche un po’ rischioso, che la dipinge fin da subito come una «donna che supera le convenzioni». Esce di casa perché non si dà pace e non si preoccupa di ciò che può capitarle o di ciò che può pensare la gente. Quando arriva al sepolcro ha una prima intuizione degli eventi, ma ancora parziale, distorta. -Sconvolta, va da Simon Pietro e dagli altri discepoli, ma, fa notare Martini, riferisce una sua versione dei fatti. In fondo cosa ha visto? La pietra ribaltata e il sepolcro vuoto; su questi elementi costruisce una storia; il corpo di Gesù è stato rubato. L’inquietudine di non sapere dove lo hanno portato non le dà pace.
* L’Osservatore Romano, 17 luglio 2017
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- EU-ANGELO, BUONA-NOTIZIA. "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16). «Et nos credidimus Charitati...»!!!!
 "DIO NON E’ CATTOLICO". "Dio è al di là delle frontiere che vengono erette". Accorato appello del Cardinale Carlo M. Martini alla Chiesa per una sua rapida e profonda riforma
"DIO NON E’ CATTOLICO". "Dio è al di là delle frontiere che vengono erette". Accorato appello del Cardinale Carlo M. Martini alla Chiesa per una sua rapida e profonda riforma
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA .... DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
Federico La Sala
- EU-ANGELO, BUONA-NOTIZIA. "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16). «Et nos credidimus Charitati...»!!!!
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. - RESPONSABILITÀ. Hans Jonas, la ricerca della vita buona (di Simone Paliaga).10 febbraio 2018, di Federico La Sala
Inediti.
Hans Jonas, la ricerca della vita buona
Secondo il pensatore tedesco l’uomo si realizza in un sano pensiero filosofico, evitando gnosticismo e storture scientiste. Per non diventare «formiche tecnologiche»
di Simone Paliaga (Avvenire, venerdì 9 febbraio 2018)
- Il filosofo Hans Jonas (1903-1993)
 Hans Jonas, "Sulle cause e gli usi della filosofia e altri scritti inediti", Ets, 120 pagine, 10 euro
Hans Jonas, "Sulle cause e gli usi della filosofia e altri scritti inediti", Ets, 120 pagine, 10 euro
«Che l’immagine dell’uomo non vacilli, si offuschi e sbiadisca, che gli uomini non si riducano a formiche tecnologiche o edonisti senza anima o marionette frastornate dal nostro furibondo potere». A cosa attingere per evitare questa deriva? All’uso adeguato della filosofia che instrada verso la vita buona e all’esercizio della virtù? Sono dilemmi che hanno il sapore dell’attualità benché sollevate da Hans Jonas nel 1955. Potrebbe d’altro canto essere diversamente se «le questioni filosofiche - puntualizzava il pensatore sei anni prima - si ripropongono ad ogni nuova epoca tanto daccapo, quanto alla luce della loro intera vicenda storica antecedente?». Le citazioni provengono dalle annotazioni del filosofo appartenenti alla sua stagione canadese, dal 1949 al ’55.
A lungo conservate all’Hans Jonas Nachlass dell’università di Konstanz sono state ripescate e raccolte in anteprima mondiale da Fabio Fossa in questo libro (Sulle cause e gli usi della filosofia e altri scritti inediti, Ets, pp. 120, euro 10). Hans Jonas non è tra gli autori più conosciuti al grande pubblico eppure il suo curriculum scintilla. Dopo gli studi con Rudolf Bultmann e Martin Heidegger nella Germania degli anni Trenta, prende la via dell’esilio, lontano dall’Europa.
La sua vita però non si riduce a studio e contemplazione. Anzi l’agire ne costituisce una cifra di rilievo. Lo prova, nel corso della Seconda guerra mondiale, la scelta di arruolarsi nella Jewish Brigade, inquadrata nell’esercito britannico e operativa sul suolo italiano. I rapporti con la penisola scandiscono la vita di Jonas. Sarà proprio al rientro dall’Italia, nel 1993, dopo avere ricevuto il Premio Nonino dedicato ai maestri del nostro tempo, che il filosofo tedesco naturalizzato americano si spegnerà a New York all’età di novant’anni.
Il nome di Jonas comincia a uscire dai cenacoli dotti appena pubblica Il principio responsabilità, dove traccia un’etica all’altezza della civiltà tecnologica. Siamo, con Jonas, lontani anni luce dalle prefiche apocalittiche. La Guerra fredda imperversa (è il 1979) e molti continuano a gridare al pericolo rosso, pronto a sbarcare in Afghanistan. Pochi invece si curano dei potenziali sviluppi distruttivi della civiltà a più alto tasso tecnologico mai esistita. Eppure la riflessione sul ’Prometeo scatenato’ occhieggiava già da tempo tra le note di Jonas. Lo testimoniano gli scritti del soggiorno canadese che sono tutt’altro che una parentesi nel cammino di pensiero di Jonas. Già con il breve Introduzione alla filosofia e con Virtù e saggezza in Socrate prepararti nell’inverno del 1949 per i corsi del Dawson College della McGill University, emerge la costante attenzione all’uomo e alla vita buona, medicina per non trasformarsi in «formiche tecnologiche».
«L’uomo è il risultato delle sue azioni passate - scrive nel 1949 in Introduzione alla filosofia -. Intendo il passato culturale della stirpe, custodito nella memoria storica; e solo fintantoché questo passato è realmente ricordato l’uomo è davvero consapevole del proprio esistere presente e, di conseguenza, dell’autentico significato attuale dei propri problemi esistenziali». È questa dimensione storica che gli consente di porsi di là del dualismo tra intelletto e vita, tipico della filosofia greca. Ma la sua storicità non garantisce nulla se non un punto di partenza. Occorre, all’uomo, inseguire la vita buona e praticare la virtù, rovello dello sforzo teoretico di Jonas. Agire eticamente nel mondo storico perseguendo la virtù consente di evitare le spirali dello gnosticismo o le storture del sogno scientista che «promuove la massima realizzazione di tutti i fini desiderabili attraverso la semplice messa a disposizione dei mezzi».
Occorre ricucire lo strappo tra intelletto e vita. «L’approccio dualistico alla costituzione sostanziale dell’uomo - scrive già nel 1950 - rende conto del fatto che tanto la comprensione quanto la realizzazione del fine dell’uomo non dipendono da un processo di sviluppo spontaneo, ma dall’esercizio della virtù etica». Virtù che non può rimanere chiusa nell’autosufficienza dell’intelletto e che nello Jonas maturo assume i tratti della responsabilità nei confronti delle generazioni a venire. Responsabilità che faticherebbe a farsi largo senza la «fatica della filosofia, che deve sempre ripartire da capo, fondata com’è sulla ragione; e la ragione non è il freddo, impersonale intelletto, ma è pervasa dalla passione dell’amore o dell’onestà».
DOC.:QUELLA COTTA PER LA ARENDT DI HANS JONAS
A dieci anni dalla sua scomparsa esce la sua autobiografia
di Paola Sorge (la Repubblica, 29 luglio 2003)
La notorietà arrivò tardi per Hans Jonas: il filosofo aveva 75 anni quando «Il principio responsabilità - Un’etica per la civiltà tecnologica» - un libro che ebbe una diffusione rapida e vastissima come pochi altri nel mondo del pensiero - gli diede fama internazionale; da allora, era il 1979, il pensatore originario di Monchengladbach che aveva studiato con Husserl e Heidegger, l’ insegnante entusiasta e appassionato che faceva della filosofia qualcosa di vivo e affascinante, divenne estremamente popolare, onnipresente nei dibattiti sul futuro del mondo.
La sua intensa vita che abbraccia quasi tutto il Novecento (dal 1903 al 1993) la racconta lui stesso in maniera semplice e disarmante in un volume uscito ora in Germania (Hans Jonas: Erinnerungen, ed. Insel,pagg. 500); nulla di accademico né di costruito nelle memorie di questo grande filosofo che paiono piuttosto le confidenze di un amico che sente il bisogno di confessarsi, di rivelare con estrema franchezza non solo le tappe del suo iter intellettuale - dalla analisi della spiritualità antica a quella della tecnologia moderna fino alla preoccupazione per il futuro dell’ umanità - , ma anche le sue vicende personali, gli aspetti meno conosciuti della sua formazione e della sua carriera, i lati oscuri della sua personalità. Jonas rievoca con dovizia di particolari la sua infanzia, il rapporto con il padre, un agiato fabbricante tessile che stenta a capire le aspirazioni e le tensioni spirituali del figlio e il suo impegno per il sionismo, il tenero legame con la madre e la ferita sempre aperta per la sua tragica morte a Auschwitz; come la maggior parte dei suoi compagni di studi, Hans prova una forte attrazione per Hannah Arendt, conosciuta a Marburg nel 1924, ma lei gli confessa subito la sua relazione con Heidegger per non illuderlo e ne fa il suo confidente e amico per la vita.
La descrizione dell’ ambiente universitario di Friburgo e poi di Marburg e delle lezioni tenute dai due grandi, allora mitici maestri di Jonas, Husserl e Heidegger, è a dir poco disincantata. Il primo, fondatore della fenomenologia, riteneva che tutti i pensatori dell’ era moderna, da Descartes in poi, non erano riusciti a risolvere certi problemi della consapevolezza o della teoria della conoscenza perché non conoscevano il suo metodo, l’ unico che dava soluzioni. Tra l’ altro, si diverte a ricordare Jonas, era presente alle lezioni la moglie di Husserl che, come un cerbero, controllava che gli studenti fossero attenti e prendessero appunti.
Quanto a Heidegger, il giovane Hans ne riconosce il grande valore e la suggestione esercitata dalla sua personalità, ma non esita a dichiarare che spesso non lo capiva: il suo messaggio era cifrato, destinato a pochi iniziati e inoltre, intorno a lui, si avvertiva un’ atmosfera «malsana» dovuta agli adoratori del filosofo. «Non riuscivo a sopportare quella congrega di cultori di Heidegger dall’ atteggiamento bigotto e altezzoso» - osserva Jonas ricordando i seminari frequentati a Marburgo dal 1924 - «essi credevano di possedere la verità rivelata: quella non era filosofia ma qualcosa di settario, quasi una nuova fede...».
Queste prime, sgradevoli impressioni saranno poi rafforzate dal celebre discorso tenuto da Heidegger nel ’33 in favore di Hitler e dal suo vergognoso comportamento nei riguardi di Husserl. In realtà per il giovane studente pieno di ideali, che credeva che la filosofia dovesse proteggere l’uomo da errori, migliorarlo e nobilitarlo, l’inaspettata adesione del grande filosofo al nazismo non significa solo il crollo di un idolo, ma anche il fallimento catastrofico della filosofia stessa, «la bancarotta del pensiero filosofico».
Dopo la guerra Hans Jonas si distaccherà definitivamente dalla filosofia dell’ esistenzialismo contrapponendole la «filosofia della vita»; a differenza della Arendt, non perdonerà mai colui che ritiene il più profondo pensatore del suo tempo, anche se accetterà di incontrarlo brevemente nel 1969, in occasione del suo ottantesimo compleanno. «Ma tra noi ci fu solo uno scambio di ricordi del tempo di Marburg», nota Jonas.
Dopo la notizia dell’ avvento di Hitler al potere appresa durante un’ allegra festa in maschera, Hans si rifugia a Gerusalemme, partecipa alla seconda guerra mondiale arruolandosi nell’ esercito inglese, combatte in Italia, a Taranto, a Forlì, a Udine, e rimane piacevolmente sorpreso nel constatare che la popolazione protegge e nasconde gli ebrei in barba alle leggi razziali.
Quando nel ’45 torna in Germania e vede le città tedesche rase al suolo - città fantasma che sembravano paesaggi lunari, piene di crateri e di rovine - , prova una gioia incontenibile per la vendetta che si è compiuta: «E’ qualcosa che non vorrei mai più provare», confessa Jonas, « ma che non voglio tacere». E, senza remore aggiunge che per molti anni quello è stato per lui il momento di più intensa felicità. «Oggi non lo potrei più dire «, nota il filosofo « perché nella mia vita ho vissuto momenti ben più felici».
A New York, dove dal 1955 ha la cattedra di filosofia, ritrova Hannah Arendt e frequenta la sua cerchia di amici a Manhattan fino a quando la pubblicazione degli articoli della scrittrice sul processo di Eichmann a Gerusalemme lo sconvolge profondamente: Jonas non crede ai suoi occhi, non riesce a capacitarsi delle dure critiche mosse dalla Arendt agli stessi ebrei, del tono tagliente e sarcastico da lei usato nei loro confronti, della sua posizione antisionista. Lo scontro fra i due amici di un tempo è inevitabile: Hans rimprovera a Hannah - che non ha mai letto la Bibbia - la sua ignoranza sulla religione e sulla storia ebraica antica, tenta inutilmente di farla desistere dalle sue posizioni, si rifiuta infine di vederla. Solo dopo due anni riprenderà i contatti con la donna da lui stesso definita «un genio dell’ amicizia».
- Il filosofo Hans Jonas (1903-1993)
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? -- L’ordinario fascismo delle ragazzate. Ma che cosa in Italia ha reso possibile questa plausibilità del discorso fascista?29 novembre 2017, di Federico La Sala
L’ordinario fascismo delle ragazzate
di Luca Baldissara (Il Mulibo, 28 novembre 2017)
Non c’è quotidiano o sito d’informazione che nei giorni scorsi non abbia ripreso la notizia del saluto fascista col quale un calciatore ha esultato sul campo di calcio di Marzabotto, esibendo la t-shirt con la bandiera della Repubblica di Salò indossata sotto la maglia della squadra. Al gesto fascista - presumiamo programmato, a meno che il giovane non sia solito indossare magliette con l’effige saloina e non sia affetto dalla sindrome di Stranamore - segue l’ormai usuale e collaudata ritualità: indignazione (dell’Anpi e dell’amministrazione comunale in primis, poi di vari esponenti politici), scuse goffe e poco credibili del protagonista (avrebbe inteso salutare il padre in tribuna), presa di distanza della squadra e della società (immaginiamo la vestizione tenuta nascosta dell’aspirante saloino nella nota segretezza dello spogliatoio), denuncia da parte della destra degli eccessi d’attenzione strumentale delle “maestranze antifasciste” (così le ha definite Forza Nuova), espiazione in forma di visita al sacrario delle vittime.
Atti del genere non sono nuovi, tutt’altro. Anzi, dobbiamo riconoscere che dal 2005 - quando l’allora giocatore della Lazio Paolo Di Canio più volte sotto la curva dei tifosi compì questo stesso teatrale gesto (e non era la prima volta) - sono ricorrenti e sempre più frequenti. Intendiamoci: l’indignazione è sacrosanta. E doverosa - quanto, assai probabilmente e sulla base di precedenti simili, priva di esiti giudiziari concreti - è la denuncia per apologia di fascismo a norma della legge Scelba del 1952 da parte dei carabinieri. Condivisibili pure le parole - non troppe, in verità - di condanna ed esecrazione del gesto.
Questa procedura rituale fondata sulla sequenza colpa (il gesto), condanna (l’indignazione pubblica), assoluzione (le scuse e l’atto riparatore) ha probabilmente a che fare con le modalità esteriori della confessione/assoluzione di un cattolicesimo volgarizzato nelle sue forme esteriori, ma ha certo molto di più a che vedere con il moralismo sarcasticamente criticato da Charles Baudelaire nei suoi Diari intimi: ⪻Tutti gli imbecilli della Borghesia che pronunciano continuamente le parole: immorale, immoralità, moralità nell’arte e altre bestialità mi fanno pensare a Louise Villedieu, puttana da cinque franchi, che accompagnandomi una volta al Louvre, dove non era mai stata, si mise ad arrossire, a coprirsi la faccia, e tirandomi a ogni momento per la manica, mi domandava davanti alle statue e ai quadri immortali come si potessero esporre pubblicamente simili indecenze⪼.
Nel senso che il rituale conformista con cui gesto dopo gesto, saluto romano dopo saluto romano, si rinnova la pubblica esecrazione non appare in grado di cogliere le ragioni di questo infittirsi di comportamenti inneggianti il fascismo, né tantomeno di evitarne il ripetersi. Anzi, sembra ipocritamente e moralisticamente distogliere lo sguardo, proprio come Louise Villedieu, dalle sconcezze che prendono forma e visibilità.
C’è infatti da chiedersi se i sempre più numerosi saluti a braccio teso nel calcio non costituiscano tanto il problema in sé, quanto piuttosto la spia di un nuovo senso comune, sempre più solido e sempre più diffuso, che, insieme ad altre manifestazioni esteriori di fascismo (dall’intitolazione di strade e piazze alla gestione di “spiagge fasciste”, alle bandiere di Salò sventolate in cima alle Apuane), sempre più spesso evoca il fascismo quale dimensione “altra”, autentica, di valori ormai perduti in questa società senza bussola, materialista e in crisi di identità.
Vi saranno, certo, i nostalgici del passato. E vi saranno i convinti assertori dell’ideologia fascista in tutte le sue forme e declinazioni. Ma vi è anche, e soprattutto, chi in questa rappresentazione di fascismo intravvede la difesa di identità minacciate dai tumultuosi processi di mutamento del presente, l’attenzione per gruppi sociali abbandonati a se stessi dalle istituzioni e dalla sinistra, il rigore contro una classe politica che appare corrotta nel suo insieme, la concretezza di contro alle tante vuote ed ipocrite parole, la prospettiva potenziale di una solidarietà comunitaria contro il cosmopolitismo vacuo e astratto dei buoni sentimenti. Una società confusa, incerta, preoccupata, attraversata dall’ansia del futuro cerca risposte credibili. E sempre più la credibilità sembra fondarsi nella semplificazione, mentre ogni richiamo alla complessità del presente appare una forma di inganno, una truffa retorica. La logica binaria del pensiero - e della propaganda - di destra sembra dunque più sincera, più fondata, più autentica. La recente affermazione elettorale di CasaPound a Ostia è solo l’ultimo indicatore in ordine di tempo di tale fenomeno.
Ma che cosa in Italia - pur in un contesto europeo del fenomeno - ha reso possibile questa plausibilità del discorso fascista? Il fatto che dopo il 1989-91, dopo la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell’Urss, dopo l’implosione del sistema dei partiti e la scomparsa del Pci, il fascismo è stato “normalizzato”, reso un regime tra i regimi. Certo, esso è stato ricompreso in una famiglia autoritaria e totalitaria di cui erano parte allo stesso titolo il nazismo quanto il comunismo, quasi si trattasse di un virus che nella parte centrale del Novecento ha colpito taluni Paesi e diffuso rapidamente la malattia. Ma nella sua quotidianità il fascismo, a parte alcuni eccessi, peraltro condivisi appunto con altri regimi dell’epoca, ha in fondo governato il paese come altri governi in precedenza avevano fatto e altri avrebbero fatto in seguito. Violenza e repressione, antidemocrazia e aggressività nazionalista, erano presentati come frutto dei tempi, più che tratti distintivi. Tale visione politico-culturale di un fascismo normalizzato a partire dagli anni Novanta si è accompagnata anche alla sua banalizzazione nel discorso pubblico, consentendo ad esempio di descrivere Mussolini come “un grande statista”.
Tutto ciò mentre la volontà di costruire un’Europa capace di ricomprendere le due Europe, dell’Est e dell’Ovest, con le loro storie così diverse, conduceva a inventare una comune (e inesistente) identità antitotalitaria, indebolendo sistematicamente quella cultura dell’antifascismo che aveva rappresentato l’unico cemento coesivo di classi dirigenti politicamente divise al loro interno, consentendo loro di costruire la democrazia rappresentativa di massa nell’Europa occidentale, Italia compresa. Indebolito e delegittimato l’antifascismo, da allora sono andati rapidamente riemergendo lo sciovinismo, il nazionalismo, l’elitismo classista, il corporatismo sociale.
In Italia, dove la fine del bipolarismo ha coinciso con la fine del sistema dei partiti sorto con il crollo del fascismo, il passaggio alla cosiddetta “Seconda Repubblica” ha visto non solo l’indebolirsi, come in tutta Europa, della cultura dell’antifascismo, ridotto a un astorico antitotalitarismo, a una generica lotta per la libertà, dove fascismo e comunismo venivano accostati (ci si ricorda ancora del dibattito Fini-Violante sui ragazzi di Salò?). Ma ha identificato nello stesso sistema ciellenistico dei partiti antifascisti (la partitocrazia) l’origine del clientelismo e della corruzione che ne avrebbero provocato il crollo. Cosicché, critica e decostruzione dell’antifascismo hanno corrisposto allo sdoganamento del fascismo, non tanto nei suoi termini immediatamente politici (che pure non sono mancati), quanto nella sua ordinaria banalizzazione e normalizzazione. Così che qualcuno ha potuto immaginare un fascismo quale forma di anticomformismo, di possibile risposta all’inanità e alla corruzione delle classi dirigenti e del ceto politico.
Se Berlusconi nel 2005 poteva dunque sorridere al gesto di Di Canio, giudicandolo ⪻un ragazzo per bene, non è fascista⪼, il cui gesto era fatto ⪻solo per i tifosi, non per cattiveria⪼, così oggi Salvini, commentando il fatto di Marzabotto, può dichiarare che ⪻fa molti più danni la legge Fornero di un saluto al Duce⪼ e che ⪻uno può salutare col braccio teso o col pugno chiuso, rappresentano lo stesso autoritarismo, hanno lo stesso valore. Non torneranno più né il fascismo, né il comunismo⪼. Così Morris Battistini, il capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale a Marzabotto, può sostenere che ⪻da moderati e liberali quali siamo, esprimendo una ferma condanna verso l’esibizione di una maglietta che soprattutto in questo territorio non andava portata, non riteniamo però utile un linciaggio mediatico che ha il sapore di vetrina politica⪼.
Insomma, sono ragazzate. Come ha scritto il giovane calciatore dal braccio teso, un’azione compiuta ⪻con leggerezza, senza pensare alle conseguenze⪼. Del resto, come Giacomo Matteotti ricordava a Giolitti nella seduta della Camera del 31 gennaio 1921, con questi termini il questore di Bologna aveva bollato l’assalto fascista alla Camera del lavoro.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? Una riflessione di Angelo Casati
Federico La Sala
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. -- UNA "BUONA NOTIZIA" ANCORA NELLA TRAPPOLA DEL "SERVO PADRONE"!!!18 novembre 2017, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO E ILLUMINISMO, OGGI: "SAPERE AUDE!" (I. Kant). AL DI LA’ DELLA LOGICA E DELLA DIALETTICA "SERVO-PADRONE"...
La parabola dei talenti
di ENZO BIANCHI (Monastero di Bose, 19 novembre 2017)
- XXXIII domenica del tempo Ordinario
- Mt 25,14-30
- In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «14 Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 15 A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito 16 colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. 17 Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 18 Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.
 19 Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. 20 Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: «Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque». 21 «Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».
19 Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. 20 Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: «Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque». 21 «Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».
 22 Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due». 23 «Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».
22 Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due». 23 «Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».
 24 Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. 25 Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo».
24 Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. 25 Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo».
 26 Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. 28 Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 29 Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. 30 E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti».
26 Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. 28 Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 29 Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. 30 E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti».
La parabola dei talenti proposta dalla liturgia odierna è una parabola che, secondo il mio povero parere, oggi è pericolosa: pericolosa, perché più volte l’ho sentita commentare in un modo che, anziché spingere i cristiani a conversione, pare confermarli nel loro attuale comportamento tra gli altri uomini e donne, nel mondo e nella chiesa. Dunque forse sarebbe meglio non leggere questo testo, piuttosto che leggerlo male...
In verità questa parabola non è un’esaltazione, un applauso all’efficienza, non è un’apologia di chi sa guadagnare profitti, non è un inno alla meritocrazia, ma è una vera e propria contestazione verso il cristiano che sovente è tiepido, senza iniziativa, contento di quello che fa e opera, pauroso di fronte al cambiamento richiesto da nuove sfide o dalle mutate condizioni culturali della società. La parabola non conferma neppure “l’attivismo pastorale” di cui sono preda molte comunità cristiane, molti “operatori pastorali” che non sanno leggere la sterilità di tutto il loro darsi da fare, ma chiede alla comunità cristiana consapevolezza, responsabilità, laboriosità, audacia e soprattutto creatività. Non la quantità del fare, delle opere, né il guadagnare proseliti rendono cristiana una comunità, ma la sua obbedienza alla parola del Signore che la spinge verso nuove frontiere, verso nuovi lidi, su strade non percorse, lungo le quali la bussola che orienta il cammino è solo il Vangelo, unito al grido degli uomini e delle donne di oggi quando balbettano: “Vogliamo vedere Gesù!” (Gv 12,21).
Leggiamo allora con intelligenza questa parabola la cui prospettiva - lo ripeto - non è economica né finanziaria; essa non è un invito all’attivismo ma alla vigilanza che resta in attesa, non contenta del presente ma tutta protesa verso la venuta del Signore. Egli non è più tra di noi, sulla terra, è come partito per un viaggio e ha affidato ai suoi servi, ai suoi discepoli un compito: moltiplicare i doni da lui fatti a ciascuno. Nella parabola, a due servi il Signore ha lasciato molto, una somma cospicua - cinque lingotti di argento a uno, due a un altro -, affinché la facciano fruttificare; a un terzo servo ha lasciato un solo lingotto, che comunque non è poco. In tutti egli ha messo la sua fiducia senza limiti, confidando loro i suoi beni. Spetta dunque ai servi non tradire la grande fiducia del padrone e operare una sapiente gestione dei beni, non di loro proprietà ma del padrone, il quale al suo ritorno darà loro la ricompensa. A ciascuno il padrone da in funzione della sua capacità, e il suo dono è anche un compito: custodire e far fruttificare.
Al di là dell’immagine dei talenti, che cos’è questo dono, in definitiva? Secondo Ireneo di Lione è la vita accordata da Dio a ogni persona. La vita è un dono che non va assolutamente sprecato, ignorato o dissipato. Purtroppo - dobbiamo constatarlo - per alcuni la vita non ha alcun valore: non la vivono, anzi la sprecano e la sciupano “fino a farne una stucchevole estranea” (Konstantinos Kavafis), e così si lasciano vivere. Eppure si vive una volta sola e il farlo con consapevolezza e responsabilità è decisivo al fine di salvare una vita o perderla! Secondo altri padri orientali, i talenti sono le parole del Signore affidate ai discepoli perché le custodiscano, certo, ma soprattutto le rendano fruttuose nella loro vita, le mettano in pratica fino a seminarle copiosamente nella terra che è il mondo. Di nuovo, è questione di vita, di “scegliere la vita” (cf. Dt 30,19).
“Dopo molto tempo” - allusione al ritardo della parusia, della venuta gloriosa del Signore (cf. Mt 24,48; 25,5) - il padrone ritorna e chiede conto della fiducia da lui riposta nei suoi servi, i quali devono mostrare la loro capacità di essere responsabili, in grado cioè di rispondere della fiducia ricevuta. Eccoli dunque presentarsi tutti davanti a lui. Colui che aveva ricevuto cinque talenti si è mostrato operoso, intraprendente, capace di rischiare, si è impegnato affinché i doni ricevuti non fossero diminuiti, sprecati o inutilizzati; per questo, all’atto di consegnare al padrone dieci talenti, riceve da lui l’elogio: “Bene, servo buono e fedele, ... entra nella gioia del tuo Signore”. Lo stesso avviene per il secondo servo, anche lui in grado di raddoppiare i talenti ricevuti. Per questi due servi la ricompensa è proporzionalmente uguale, anche se le somme affidate erano diverse, perché entrambi hanno agito secondo le loro capacità.
Viene infine colui che aveva ricevuto un solo talento, il quale mette subito le mani avanti, manifestando il pensiero che lo ha paralizzato: “Da quando mi hai dato il talento, io sapevo che sei un uomo duro, esigente, arbitrario, che fa ciò che vuole, raccogliendo anche dove non ha seminato”. Con queste sue parole (“dalle tue parole ti giudico”, si legge nel testo parallelo di Lc 19,22) il servo confessa di essersi fabbricato un’immagine distorta del Signore, un’immagine plasmata dalla sua paura e dalla sua incapacità di avere fiducia nell’altro: egli considera il padrone come qualcuno che gli fa paura, che chiede una scrupolosa osservanza di ciò che ordina, che agisce in modo arbitrario. Avendo questa immagine in sé, ha scelto di non correre rischi: ha messo al sicuro, sotto terra, il denaro ricevuto, e ora lo restituisce tale e quale. Così rende al padrone ciò che è suo e non ruba, non fa peccato... Ma ecco che il Signore va in collera e gli risponde: “Sei un servo malvagio (ponerós) e pigro (oknerós). Malvagio perché hai obbedito all’immagine perversa del Signore che ti sei fatta, e così hai vissuto un rapporto di amore servile, di amore ‘costretto’. Per questo sei stato pigro, inaffidabile, non hai avuto né il cuore né la capacità di operare secondo la fiducia che ti avevo accordato. Non hai fatto neanche lo sforzo di mettere il talento in banca, dove sarebbe stato fruttuoso, dandomi interessi. Non hai avuto cura del mio bene affidato a te”.
Sì, lo sappiamo: è più facile seppellire i doni che Dio ci ha dato, piuttosto che condividerli; è più facile conservare le posizioni, i tesori del passato, che andarne a scoprire di nuovi; è più facile diffidare dell’altro che ci ha fatto del bene, piuttosto che rispondere consapevolmente, nella libertà e per amore. Ecco dunque la lode per chi rischia e il biasimo per chi si accontenta di ciò che ha, rinchiudendosi nel suo “io minimo”. Questo servo non ha fatto il male; peggio ancora, non ha fatto niente! Dunque davanti a Dio nel giorno del giudizio compariranno due tipi di persone:
chi ha ricevuto e ha fatto fruttificare il dono,
chi lo ha ricevuto e non ha fatto niente.
I servi fedeli entreranno nella gioia del Signore; chi invece è stato “buono a nulla” (achreîos) sarà spogliato anche dei meriti che pensava di poter vantare!
Ma a me piacerebbe che la parabola si concludesse altrimenti: così sarebbe più chiaro il cuore del padrone, mentre il cuore del discepolo sarebbe quello che il padrone desidera. Oso dunque proporre questa conclusione “apocrifa”:
Venne il terzo servo, al quale il padrone aveva confidato un solo talento, e gli disse: “Signore, io ho guadagnato un solo talento, raddoppiando ciò che mi hai consegnato, ma durante il viaggio ho perso tutto il denaro. So però che tu sei buono e comprendi la mia disgrazia. Non ti porto nulla, ma so che sei misericordioso”. E il padrone, al quale più del denaro importava che quel servo avesse una vera immagine di lui, gli disse: “Bene, servo buono e fedele, anche se non hai niente, entra pure tu nella gioia del tuo padrone, perché hai avuto fiducia in me”.
Anche così la parabola sarebbe buona notizia!
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? Una riflessione di Angelo Casati
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. -- Il rapporto tra padre e figlio. La domanda che conta.18 novembre 2017, di Federico La Sala
Un uomo che non ha avuto una vita.
La domanda che conta: dov’è adesso Riina?
di Ferdinando Camon (Avvenire, sabato 18 novembre 2017)
Nessun giornale che si faccia la domanda ovvia, inevitabile, l’unica che abbia un senso in questo momento: e adesso dov’è Salvatore Riina? Che ne è di lui? Ha giocato a fare l’invincibile con la giustizia terrena, nei colloqui che credeva segreti diceva alla moglie: «Non mi piegheranno mai, possono anche darmi tremila anni di ergastolo, non mi piegherò».
Voleva uscire dalla vita come un vincitore. Lo diceva sempre nei colloqui segreti (che invece eran registrati), a un figlio: «Tu hai un padre invincibile». Invincibile vuol dire due cose: 1) che ha vinto, 2) che nessuno gli strapperà la vittoria.
Ma la vita che aveva vissuto fino all’arresto era una vittoria? S’era sposato, ma di nascosto. Che matrimonio è? Viveva, ma sotto falso nome. Che vita è? Con i figli parlava di sciocchezze, anche quando la tv mostrava le sue stragi. È parlare, questo? Se la città o la regione è scossa da una tragedia, parlare a tavola con moglie e figli di sciocchezzuole vuol dire portare moglie e figli fuori dal mondo, in un altro mondo, che non è quello dell’umanità, vivere in un mondo che non c’è, chiudersi in un delirio. È vita, questa? È una famiglia, questa? È un padre, questo?
L’ultima domanda la pongo perché il figlio Salvo dichiara a voce e scrive su Facebook: «Per me non sei niente di quel che dicono, per me sei soltanto mio padre». Salvo ha vissuto nella mia città, era molto discreto e nascosto, ha scritto anche un libro, l’ho letto, e m’ha inquietato. Perché parla di tutto, tranne che della realtà. È come se la realtà non esistesse. Ha reazioni che nessuno di noi avrebbe.
Chi di noi, se avesse il padre che vien portato via dalla polizia e finisce in un carcere duro, andandolo a trovare e vedendolo di là dal vetro, non gli chiederebbe: «Papà, perché sei qui? Cos’hai combinato?». Questa domanda il figlio, i figli di Salvatore Riina al padre non la pongono mai. Gli esperti di mafia spiegano che questa è la mafia, questo è lo spirito mafioso.
 Ma se questo è il rapporto tra padre e figlio, il padre che impone questo rapporto non è un padre. Un padre è per definizione colui che consegna il mondo al figlio e il figlio al mondo. In questo modo, crea nel figlio il proprio continuatore. Quando morirà, la sua opera continuerà, e questo è bene per l’umanità, è per questo che la nascita di un figlio è considerata un lieto evento.
Ma se questo è il rapporto tra padre e figlio, il padre che impone questo rapporto non è un padre. Un padre è per definizione colui che consegna il mondo al figlio e il figlio al mondo. In questo modo, crea nel figlio il proprio continuatore. Quando morirà, la sua opera continuerà, e questo è bene per l’umanità, è per questo che la nascita di un figlio è considerata un lieto evento.Ma un padre mafioso, che continua a essere mafioso anche in carcere, anche nel carcere duro, anche nelle malattie più gravi, anche prima di un intervento chirurgico rischioso, anche quando riemerge dall’incoscienza dell’anestesia, un padre che è mafioso sempre e comunque, anzi il capo dei capi della mafia, non consegna ma nega il mondo ai figli, gli dà un anti-mondo, senza scuola, senza libere amicizie, senza cognome e quindi senza identità, un mondo costruito a parte, un para-mondo, una paranoia.
C’è vita, nella paranoia? C’è potere? Sappiamo di un altro boss mafioso che ordinava malaffari, aveva i suoi scagnozzi che obbedivano, ma lui viveva alla macchia in un casolare diroccato e disperso, da solo, su una branda con una coperta, ma senza lenzuola, e mangiava formaggi che un pastore gli buttava su una ciotola accanto alla porta. I poliziotti che osservavano il casolare da lontano col binocolo una mattina videro spuntare dalla porta una mano e afferrare dalla ciotola una mozzarella. Era la mano del boss. Era straricco e manovrava milioni, ma viveva come un animale selvaggio. È potere, questo? È il potere dell’altro mondo, dell’anti-mondo, del mondo del male.
Chiuso nel suo antimondo, Riina si teneva dentro un sacco di segreti. Lui sapeva, delle stragi, tante cose che noi non sappiamo. Sapere quelle cose ci aiuterebbe a fare giustizia e migliorerebbe la nostra vita. Non rivelandole Riina ha peggiorato la propria morte. C’è un tempo che non conosciamo della sua morte, ed è il tempo della sua noncomunicazione con noi, alla riemersione dai pesanti interventi chirurgici. Anche se avesse voluto, non avrebbe più potuto dirci nulla. Ma spero che abbia voluto. Non per noi, ma per lui. La vita è questa coscienza. Riina è nato ed è morto, ma non ha avuto una vita.
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. ---- IL BENE E’ PIU’ DELLA FEDE. La fede è fare del bene, non è dire "ho fede"! Intervista ad Ermanno Olmi.4 marzo 2012, di Federico La Sala
“Ciascuno è la vera chiesa”
intervista ad Ermanno Olmi
a cura di Arianna Prevedello (“settimana” - attualità pastorale, 4 marzo 2012)
“Cinema, specchio della vita” è il titolo di una serie di iniziative della diocesi di Padova che, attraverso la "settima arte", mette a confronto registi, presbiteri e operatori pastorali su tematiche di forte attualità per la comunità ecclesiale. Ecco un estratto del primo incontro avvenuto il 13 febbraio. Successivamente alla proiezione de Il villaggio di cartone i presbiteri diocesani hanno intensamente dialogato con il regista Ermanno Olmi.
 Maestro Olmi, lei è uno sposo da tanti anni, eppure con questo film ha saputo raccogliere il sentimento interiore di moltissimi sacerdoti. Dove ha trovato ispirazione?
Maestro Olmi, lei è uno sposo da tanti anni, eppure con questo film ha saputo raccogliere il sentimento interiore di moltissimi sacerdoti. Dove ha trovato ispirazione?Non si sa mai da che parte arrivi l’ispirazione. È come quel vento dello Spirito che non si sa da dove viene e dove vada. Pensate quando, alla fine di alcuni appuntamenti di tipo culturale, ci accorgiamo di aver ascoltato cose interessanti fuori dalla nostra aspettativa.
Quando Picasso disse «vorrei dipingere come i bambini», intendeva dire che i bambini non hanno la consapevolezza necessaria ad amministrare la loro potenzialità comunicativa. Sentono l’esigenza di comunicare senza preoccuparsi della forma. Dovremmo arrivare all’età della libertà, come per esempio la mia, attrezzati in questo senso e pretendendo di essere ascoltati con l’innocenza dei bambini. Quindi, l’ispirazione non sai da dove arriva. Arriva, e senti che lì ci sono domande che ti poni e tenti di dare alcune risposte, ma non è mai "la" risposta. Il modo di pronunciare una frase cambia il senso di ciò che vuoi comunicare. Pur essendo rigidamente confezionata in un testo, la frase cambia di significato a seconda di come tu cambi. Lo stesso Vangelo cambia a seconda di come noi cambiamo. Nel momento in cui non lo leggiamo più perché pensiamo di conoscerlo o di poterlo ripetere a memoria, quello è il momento del fallimento. È come se, amando una persona, dicessimo «adesso non ho più parole d’amore». Quando senti che non hai più parole, vuol dire che hai perduto quell’amore.
La religione si basa come intima convinzione su alcuni principi che abbiamo ascoltato, condiviso e che ora manteniamo vivi. È davvero così se ogni giorno, leggendo una frase di quella religione, sentiamo che quella frase cambia significato. Altrimenti è un fatto puramente amministrativo e, se fossi il Padre eterno, mi incavolerei, perché ha dato la possibilità di vivere la realtà come la più bella opportunità di scoperta delle grandi manifestazioni che abbiamo sotto gli occhi. Altrimenti le religioni rischiano di essere delle gabbie mortificanti.
 Perché un film come il suo è scomparso subito dalle sale?
Perché un film come il suo è scomparso subito dalle sale?Il problema non è che questo film è scomparso dalle sale, ma che capita a questo film e a molti altri film più belli del mio, come il Faust, Leone d’Oro a Venezia, o Una separazione, Orso d’Oro a Berlino. In realtà, nell’ultima stagione ci sono state produzioni italiane che hanno incassato bene e che rispetto ma sono tutti film di genere "spensierato".
Le persone cercano rifugio in occasioni - e lo capisco - che non danno il tempo di soffermarsi sulla gravità di problemi che dovremo arrivare ad affrontare. Prima di tutto la chiesa! Nel vedere ogni giorno la realtà che abbiamo intorno, per alcune cose pensiamo di poter rispondere, per altre veniamo interrogati e non abbiamo risposte. Un’infinità di interrogativi irrisolti, e allora io chiamo il Maestro. Se tu, Cristo, fossi al mio posto, cosa faresti? Secondo voi, Cristo si preoccuperebbe del cattolicesimo o di quella religione del perdono per relazionarci agli altri, per renderci disponibili agli altri. Se io guardo il suo percorso, ogni giorno c’è sempre un insegnamento che mi riguarda.
Il cattolicesimo - come apparato - oggi è diventato forse troppo ingombrante. So che qualcuno non è d’accordo con me... e va bene. Non pretendo questo, ma mi domando qual è il cristianesimo di oggi. Tante volte dico ai cattolici: «ricordatevi che siete anche cristiani».
 Qual è oggi il modello di Cristo? Cristo ha chiamato Pietro e gli ha detto «chi dici che io sia?». Chi diciamo che sia questo Cristo? Un orpello appeso ai punti apicali delle volte delle chiese? O è quell’altro che non osa entrare in chiesa perché non ha i panni adatti?
Qual è oggi il modello di Cristo? Cristo ha chiamato Pietro e gli ha detto «chi dici che io sia?». Chi diciamo che sia questo Cristo? Un orpello appeso ai punti apicali delle volte delle chiese? O è quell’altro che non osa entrare in chiesa perché non ha i panni adatti?La chiesa di questo film è chiesa quando si è svuotata dagli orpelli, quando qualcuno che non è cristiano ha bisogno di aiuto. Gli devo chiedere «sei cristiano? cattolico? Allora entra, se no stai fuori...». Cristo dice «Tu che sei Pietro, tu sei pietra». Tu! Ciascuno di noi è la vera chiesa. C’è qualcosa che mi fa dire in questo momento: «Cristiani svegliamoci! È il nostro momento». È il momento di presentarci agli altri dicendo all’altro «Ecco il volto di Cristo!». Quando rincasiamo, possiamo dire alla sera: oggi ho visto Cristo? Oppure, ho visto il ragioniere, l’architetto, il neretto all’angolo della strada? Quale volto di Cristo abbiamo visto in ogni giorno della nostra vita?
Ecco perché non rispondo a chi si preoccupa se sono o meno cristiano, io non mi preoccupo se loro lo sono. Mi basta guardarti, sei una creatura di Dio. E poi, quando ci innamoriamo, è il massimo. E l’estasi dell’umanità. Anche quel prete nel film che guarda gli occhi di una fanciulla. E perché no? Quanti preti innamorati infelici! Io credo che l’innamoramento sia una chiamata, certo che poi dobbiamo comportarci di conseguenza. Rispetto all’innamoramento, c’è un passaggio difficile da accettare: quando il prete dice al Cristo della piccola Pietà «sei troppo lontano nel tempo perché io possa amarti come dovrei». Ma che cosa, allora, si riconosce di quel piccolo Cristo? Anche Cristo ha conosciuto la solitudine dell’ultimo istante. Dio, che è venuto e ha parlato a profeti e ad angeli, non ha parlato a Cristo nel silenzio dell’ultimo respiro. Come mai? Avrebbe - credo - intaccata la santa, la sacra eroicità della donazione. Dobbiamo accettare la solitudine dell’ultimo respiro.
 Nel film il prete sintetizza tante epoche, stagioni e passaggi della vita. Alla fine cos’è diventato quel prete?
Nel film il prete sintetizza tante epoche, stagioni e passaggi della vita. Alla fine cos’è diventato quel prete?All’inizio il prete rimpiange il fatto che non sarà più quel prete lì, perché gli manca lo strumento della sua pratica sacerdotale. Quando non c’è più un fedele, lui fa quella predica alle panche vuote, si confida con esse. Dice «quante volte qui alla domenica, quando la chiesa era piena di fedeli... eppure ogni tanto avevo il dubbio!». Guai ad avere le certezze assolute. Ti siedi comodamente su queste certezze e rinunci alla tua vita come continua curiosità della riscoperta. Se qualcuno mi dice che crede in Dio, prega Dio, ama Dio in maniera così graniticamente definitiva, ho l’impressione che non conosca il termine amore. L’amore è una lotta continua, un travaglio che non ci dà tregua.
All’inizio il prete si accontentava di avere la chiesa piena di fedeli. Nel momento in cui essa diventa vuota, scopre che cosa significa essere prete. Anche grazie alle circostanze che è costretto a vivere con un gruppo di pellegrini erranti che sostano nella sua chiesa mettendo in piedi quel villaggio di cartone di chi è continuamente in cammino e che non è affatto di cartone. Di cartone sono i muri di cemento armato. Anche Cristo ci dice «non ho nemmeno una pietra su cui poggiare il capo». Tutte cose di cui il prete non si poneva più una domanda, ma era fermamente convinto della giustezza delle risposte. Finalmente avverte l’idea del porsi la domanda. Quale volto di Cristo ho incontrato? Tutti i giorni la medesima domanda, perché infinite sono le risposte. La risposta che il prete dà al sacrestano: «mi sono fatto prete per fare del bene. Ho capito che il bene è più della fede».
Perché il bene è più della fede? Lo dico in maniera grezza: quando recitiamo le nostre preghiere, abbiamo la sensazione di compiere un atto di fede; poco dopo usciamo ed abbassiamo lo sguardo senza guardare in faccia l’umanità. Allora la fede è fare del bene o è dire "ho fede"? Si riesce perfino a pregare pensando ad altro. Il prete a quel nero che lo ringrazia per averli accolti dice «anch’io sto tornando alla casa del Padre». Questo è l’atto di fede. Sapere che il Padre è lì che mi aspetta. Siamo tutti dei "figliol prodigo". L’importante è capirlo e tornare a lui.
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. ---- La Chiesa non deve tacere (di Angelo Bertani).27 novembre 2010, di Federico La Sala
La Chiesa non deve tacere
di Angelo Bertani (Europa, 26 novembre 2010)
Se oggi siamo a questo punto è perché in passato non sono ascoltate le voci libere che invitavano a raddrizzare la schiena. Già il 6 dicembre 1995 il cardinale Martini afferma che «la Chiesa non deve tacere perché [in Italia] è in gioco la sopravvivenza dell’ethos politico. Non è la Chiesa come tale a essere in pericolo; è la natura stessa della politica e quindi della democrazia».
Nell’ottobre 2003 Franco Monaco scrive una lettera aperta (Jesus, ottobre 2003): «Cari Vescovi, perché tanto silenzio sull’Italia?» E segnala i punti di sofferenza tra i quali il principio. Il mese dopo Jesus torna sul tema con un dossier: “Emergenza Democrazia. Padre, perché non parli? I silenzi della Chiesa sulle piaghe della nostra democrazia”. M.C. Bartolomei, Melloni, Bettazzi, Antiseri, Bregantini, Giuntella, Canobbio scongiurano la Chiesa italiana di non restare in silenzio. Nel marzo 2004 padre Sorge (Aggiornamenti sociali, marzo 2004) scrive un editoriale coraggioso (www.gesuiti.it/ag_ sociali): «Non c’è dubbio che alla base della Chiesa italiana vi sia un certo malessere per il silenzio dei vescovi sulla grave situazione del paese ».
Tra i vescovi coraggiosi c’è Tommaso Valentinetti. Nel 2006 Bondi aveva inondato le parrocchie con un opuscolo di Forza Italia sui: «Cinque anni di governo Berlusconi letti alla luce della dottrina sociale della Chiesa ». Il vescovo risponde: «Non possiamo tacere lo sconcerto e lo stupore per questa pubblicazione. ... Non possiamo accettare che alcun partito si presenti come garante della dottrina sociale della Chiesa... Non si tenti di comprarci. Rispettate la nostra libertà di coscienza». E Pax Christi aggiunge: «Ci indigna l’arroganza, la mancanza di pudore, la presunzione nel presentarsi come interpreti fedeli del magistero...».
La nostalgia non serve: «Non c’è alcuna cara vecchia Italia da conservare, da recuperare, alla quale tornare » (Europa,17 novembre ). Ma neanche il presente è incoraggiante, ma ci sono segni nuovi e importanti: Bagnasco ammonisce che «non c’è una buona politica senza un vivere retto». E anche Ruini auspica che i cattolici siano uniti «non in un solo partito, ma intorno a valori come la difesa della vita, aiuto ai più bisognosi, sostegno alla famiglia, libertà religiosa e... stili di vita moralmente ineccepibili » (Repubblica, 20 nov.).
Famiglia Cristiana (21 nov.) riassume: «I cristiani non hanno la pretesa di essere, essi soli, i salvatori della patria; ma sono consapevoli che l’Italia non potrà uscire dalla difficile situazione in cui si trova senza l’apporto dei cattolici». Ripartiamo da qui.
-
> LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? Una riflessione di Angelo Casati - a cura di Federico La Sala24 novembre 2010, di John Mazzei
una “parabola” è un paragone o una similitudine, una breve narrazione, di solito immaginaria, da cui si ricava una morale o una verità spirituale.
Le illustrazioni o parabole servono come efficace mezzo didattico in almeno cinque modi: (1) Colpiscono e tengono viva l’attenzione; poche cose suscitano interesse come un’esperienza o un racconto. Chi non conosce le illustrazioni del figlio prodigo e della pecora smarrita? (2) Stimolano la facoltà di pensare; uno dei migliori esercizi mentali è scoprire il significato di un paragone, per cogliere le verità astratte così presentate. (3) Fanno leva sui sentimenti e, dal momento che in genere le verità vengono applicate in maniera pratica, toccano la coscienza e il cuore dell’ascoltatore. (4) Aiutano a ricordare; in seguito si può ricostruire la storia e farne un’applicazione. (5) Preservano la verità, poiché sono sempre applicabili e comprensibili in qualunque momento ed epoca. Ciò avviene perché si basano sulle realtà della vita e della natura, mentre semplici parole possono cambiare significato. Questa è una delle ragioni per cui le verità della Bibbia conservano ancora tutta la loro freschezza, come all’epoca in cui furono pronunciate o scritte.
Come si è già detto, lo scopo principale delle illustrazioni è quello di insegnare. Ma le illustrazioni della Bibbia si prefiggono anche altri obiettivi:
(1) Il fatto che a volte bisogna andare a fondo per afferrarne il pieno, profondo e toccante significato tende a scoraggiare coloro che non amano Dio e che mostrano un interesse solo superficiale, cioè quelli che non desiderano sinceramente conoscere la verità. (Mt 13:13-15) Dio non intende radunare persone del genere. Le illustrazioni spingevano gli umili a chiedere ulteriori spiegazioni, ma non gli orgogliosi. Gesù disse: “Chi ha orecchi ascolti”. Mentre la maggior parte delle folle, dopo aver sentito parlare Gesù, se ne andavano, i discepoli rimanevano per chiedergli spiegazioni.
Invictus William Henley
Dal profondo della notte che mi avvolge, buia come il pozzo più profondo che va da un polo all’altro,, ringrazio quali che siano gli dei per la mia inconquistabile anima.
Nella morsa delle circostanze, non mi sono tirato indietro, ne’ ho pianto. Sotto i colpi d’ascia della sorte, il mio capo sanguina, ma non si china.
Più in là, questo luogo di rabbia e lacrime appare minaccioso ma l’orrore delle ombre, e anche la minaccia degli anni non mi trova, e non mi troverà spaventato.
Non importa quanto sia stretta la porta... quanto piena di castighi la vita. Io sono il padrone del mio destino. Io sono il capitano della mia anima.
Distinti saluti a TUTTI